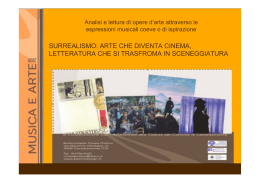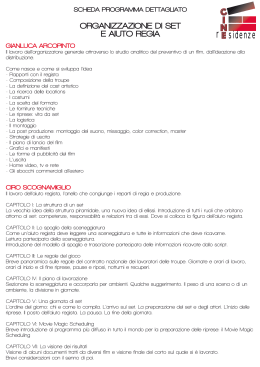1 LOST& found c a p ol a v o r i “ r i t r o v a t i ” d i Michael Mann The jericho mile 12|01 Jacques Demy les parapluies de cherbourg 19|01 J o h n W oo T h e K ILLER 2 6 | 0 1 J e a n E u st a c h e la maman et la putain 02|02 J o h n C a ss a v e t e s UNA MOGLIE 0 9 | 0 2 B i ll y W i l d e r NON PER SOLDI . . . MA PER DENARO 1 6 | 0 2 David Lynch ERASERHE a d . l a m e n t e c h e c a n c e l l a 2 3 | 0 2 P e d r o Almo d ó v a r pepi, luci, bom e le altre ragazze del mucchio 02|03 Marco Ferreri chiedo asilo 09|03 F r a n c i s Fo r d Co p p ol a terrore alla tredicesima ora 16|03 Ab e l F e r r a r a fratelli 23|03 John Carpenter d i s t r e tt o 1 3 . l e b r i g a t e d e l l a m o r t e 3 0 | 0 3 u n r a ss e g n a c i n e m a to g r a f i c a a c u r a d i cineforum2 & sentieri selvaggi 3 Non sono proprio degli invisibili. Ma si tratta di film di grandi autori, registi molto conosciuti a livello internazionale, che sono passati fuggevolmente in TV e non si vedono da molti anni oppure di pellicole che, dopo aver avuto un enorme successo quando sono uscite, sono praticamente scomparse da moltissimo tempo. Si tratta ovviamente di momenti decisivi nella carriera di molti di questi cineasti, di opere dove il loro stile è immediatamente riconoscibile e che hanno costituito un modello per altri registi più giovani o degli autentici “colpi di fulmine” per la critica che ci ha visto un nuovo modo di raccontare e soprattutto uno sguardo originale, a volte sperimentale, a volte apparentemente più classico ma comunque subito di rivelare nuove identità, capace di individuare anche da una sola inquadratura chi l’ha girato. Lost & Found è un’altra rassegna tematica che, in linea con le precedenti, vuole essere ancora un viaggio nello spazio e nel tempo. Forse stavolta ancora di più rispetto le precedenti edizioni. Se negli anni scorsi sono stati proiettati, comunque, dei film che costituivano delle tappe obbligatorie nella Storia del cinema, stavolta si è seguito un percorso diverso e si è partiti dai registi. Si è in linea quindi con quella che François Truffaut chiamava “la politique des auteurs”. In alcuni, come Jacques Demy (Les parapluies de Cherbourg), John Woo (The Killer), Jean Eustache (La maman et la putain) si è accostato al cineasta uno dei titoli più famosi della loro filmografia se non il più celebre. Il primo, Palma d’oro a Cannes, è forse uno dei più alti esempi di musical europeo, interamente cantato, sospeso tra esaltazione e tristezza, con Catherine Deneuve che si confonde in mezzo a cromatismi molto accesi, dove ogni fotogramma sembra sempre sul punto di 2 scoppiare perché troppo pieno di luce e caratterizzato dal leit motiv musicale di Michel Legrand che entra in testa e non esce più. Il secondo è il capolavoro di Woo realizzato a Hong Kong, un balletto coreografico con il ritmo dell’azione spinto al massimo che si alterna però anche con la malinconia del noir e del melodramma. Con dentro i fantasmi di Sam Peckinpah, ma anche un film sull’amicizia e l’eroismo con quel pessimismo di fondo di JeanPierre Melville. Il terzo infine è uno dei film francesi più significativi degli anni ‘70, forse uno dei testamenti del Sessantotto della Nouvelle Vague nelle sue continue morti e rinascite, con Jean-Pierre Léaud simbolo di quel cinema e Bernadette Lafont tra gli attori più importanti di quella decisiva e felice stagione e Saint-Germain-des-Près che diventa luogo di continui nomadismi. Si tratta del film più famoso di Eustache, libero, intenso e disperato, che poi morì suicida nel 1981 a 43 anni. In altri casi si tratta di passaggi importanti nelle carriere degli autori come nel caso di Una moglie di John Cassavetes, potentissimo nel mostrare la crisi di coppia e quindi della famiglia e definito da Morandini come “un grande film d’amore e follia”; Fratelli di Abel Ferrara che è forse l’opera in cui il cineasta trova un equilibrio perfetto tra le forme della tragedia classica e le istanze religiose spesso sottolineate dalla scrittura dello sceneggiatore Nicholas St. John; Distretto 13. Le brigate della morte, opera seconda di John Carpenter che è un autentico western metropolitano (rappresenta infatti la rivisitazione di Un dollaro d’onore di Hawks), claustrofobico e con un livello di tensione ai livelli massimi e il trasgressivo. Poi c’è Billy Wilder con Non per soldi...ma per denaro, Walter Matthau e Jack Lemmon che sono bombe ad orologeria, la sceneggiatura del regista e del fedele I.A.L. Diamond che dovrebbe essere presa a modello nelle scuole di cinema e l’esempio di una commedia cinica che resiste alla grande al tempo. Alcuni percorsi sono poi da riscoprire come il Ferreri di Chiedo asilo, in cui il grottesco è attenuato da uno spirito alienato ma anche di una vitalità contagiosa con Roberto Benigni nei panni di un maestro elementare che rappresenta quasi il predecessore dell’incarnazione visionaria stralunata del suo personaggio in La voce della luna di Fellini. Infine, quattro folgoranti esordi nel lungometraggio: il teso carcerario Jericho Mile di Michael Mann, l’allucinante, surreale Eraserhead. La mente che cancella di David Lynch, il delirante e trasgressivo Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio di Pedro Almodóvar e il thriller “cormaniano” Terrore alle tredicesima ora di Francis Ford Coppola. Tutto a cavallo tra (molto) cinema statunitense, europeo e tracce di quello orientale. Un percorso in cui immergersi, in alcuni casi quasi delle sedute psicanalitiche. Non resta che partire e farsi inghiottire nel vortice. simone emiliani sentieri selvaggi stefano cipriani cineforum2 THE JERICHO MILE 12 gennaio 2011 the jericho mile Regia: Michal Mann. Soggetto e sceneggiatura: Patrick J. Nolan, Michael Mann. Fotografia: Rexford L. Metz. Montaggio: Arthur Schmidt. Scenografia: William K. Jolley. Musiche originali: Jimmie Haskell. Interpreti e personaggi: Peter Strauss (Larry “Rain” Murphy), Richard Lawson (R.C. Stiles), Roger E. Mosley (Cotton Crown), Brian Dennehy (Dr. D), Geoffrey Lewis (Dr. Bill Janowski), Billy Green Bush (Warden Earl Gulliver), Ed Lauter (Jerry Beloit), Beverly Todd (Wylene). Origine: USA, 1979. Durata: 97’. 4 Nel penitenziario di Folson (California), un ergastolano parricida cerca di sopravvivere, esercitandosi nella corsa. Quando i dirigenti del carcere scoprono che corre il miglio in 4 minuti, gli procurano un allenatore: potrebbe vincere le selezioni olimpiche. Sarà discriminato, ma corre ugualmente in 3’ 50” la sua gara vittoriosa. Girato per la TV, arrivò in Italia nel 1981 dopo aver vinto un Emmy e un premio al Festival di Deauville. Folsom Prison Blues, si chiamava una canzone di Willie Nelson e Johnny Cash. Mann parte da qui: prende una classica messa in situazione carceraria, le sovrappone un racconto sportivo ed esalta il tutto con un velo di anelito libertario. Quasi un suggello agli anni Settanta che vanno a finire, anche, con la tardiva celebrazione di Hair, a un decennio battagliero e scandalosamente idealista. La scelta dell’ispirato Peter Strauss, una delle immagini simbolo (Soldato blu) della mitologia ribellistica, è emblematica, coi fluenti capelli da Cristo hippy e i baffi stile Eagles. Un profumo spiccatamente West Coast si sprigiona dall’ambientazione californiana: una California tutta rinchiusa dentro Folsom, la California delle ambizioni sbagliate, finita dall’on the road alla cattività forzata. Non a caso l’incandescente violenza del cinema statunitense anni Settanta è seguita agli omicidi dei Kennedy e di Luther King, al crollo delle certezze e della fiducia delle istituzioni nei Sixties. Non a caso l’ansia di libertà di “Rain” è individuale, tenacemente solipsistica, e accompagnata da un saldo senso della sua concreta realtà attuale. La sua corsa, torso nudo e capelli al vento nei campi o sulla pista sterrata nel cortile è il vessillo motorio di una fuga tutta interiore. La corsa introduce la tematica sportiva, tasto quanto mai rischioso quando applicato al cinema: un mondo a se stante, dalle regole prestabilite come uno sport, raramente trova un’adeguata trasposizione filmica. Tra le discipline sportive, comunque, la corsa è forse quella che ha più tentato gli uomini di cinema, per la sua dimensione individuale, in cui la sfida è prima con se stessi (e col mondo, semmai) che con gli avversari. Specialmente gli inglesi, popolo di grande tradizione sportiva, ne hanno avvertito il fascino: dal free cinema di Tony Richardson (Gioventù, amore e rabbia, dove il ribelle Tom Courtenay, rinchiuso in riformatorio, si sfoga nella corsa) al manifesto chic della British Renaissance, Momenti di gloria di Hugh Hudson. Forse per la sua semplicità di svolgimento, per la componente cinetica o le implicazioni morali (la resistenza, il non dipendere da altro che dalle personali capacità fisiche, il suo essere veicolo di affermazione sociale). Infine c’è il film carcerario, cornice generale che giustifica gli avvenimenti descritti e li contiene in una tradizione riconoscibile. In particolare, la sinergia carcere-sport richiama un paio di titoli temporalmente adiacenti a quello di Mann: Quella sporca ultima meta di Robert Aldrich, tipico Seventy film con squadra di football americano di detenuti – da cui ritiene un attore, Ed Lauter nel ruolo di Beloit – e Fuga per la vittoria di John Huston, sfida di calcio nazisti-prigionieri, che sfiora coraggiosamente il ridicolo con una squadra che schiera in porta Stallone e in attacco Pelè. In questi film lo sport dà ai reclusi la possibilità di un’affermazione personale, una vittoria sulla costrizione coercitiva della loro condizione, in vista di una fuga materiale o del simbolico crollo delle mura di Jericho. Mann, pur ancora fedele al “maestro” Siegel, alla sua sinteticità classicheggiante, non rinuncia a presentarsi autonomamente. Abbastanza scontato, ma a ben vedere tutto all’interno di coordinate care al regista (la dialettica degli schieramenti) il tratteggio d’ambiente. Il sistema carcerario e i sottosistemi divisi in gruppi (precisati nei titoli di coda, come poi in Strade violente): Black Brotherhood (alla ricerca della perfetta armonia di mente e corpo “come stabilito dal nostro profeta Al Rashid”), The Mean Ones (i chicani di Rubio), White People Party (catalizzatori dei traffici sporchi). I giochi di economia (Doctor D si autodefinisce capitano d’industria), i conflitti e le invasioni territoriali, le rivalità e le solidarietà temporanee (la commovente offerta di cibi in mensa, generoso segno di rispetto verso “Rain”). L’inevitabile folklore dei soprannomi: Gambe da corsa (come poi Dente di fata, Occhio di falco), Cotton, Joker, ecc. Le figure di contorno, schizzate velocemente, sono sì stereotipizzate, ma ravvivate sempre da qualche gesto inedito o sviluppo inatteso: Doctor D, l’acerrimo nemico di “Rain”, è il primo a cogliere il senso della sua ultima impresa, le sue Olimpiadi private. (Una puntualizzazione: anche se gli fosse stato consentito di partecipare alle qualificazioni, il boicottaggio americano delle Olimpiadi di Mosca Scheda di ALESSANDRO BORRI 1980 lo avrebbe escluso dai Giochi, non avrebbe comunque potuto fare il saluto della prigione dal podio. Inoltre il miglio è una distanza particolare, da paesi anglosassoni, convertita alle Olimpiadi nel sistema metrico decimale). Si capisce però che a Mann preme principalmente il tratteggio del suo tenace, sovrumano – e troppo umano – eroe, che si staglia con forza sul convenzionale quadro che lo circonda e ne fa emergere ancor più l’eccezionalità, come una statua greca in un viale di Downtown L.A. Il miglio di Jericho è una vittoria segreta e definitiva oltre cui non può esservi altro: il cronometro si infrange sulle mura, il tempo vivrà in “Rain”, come tatuato sotto la pelle. Perciò, oltre a essere un film “sulla funzione dello sport inteso come recupero dell’uomo e come veicolo di riabilitazione sociale” 4, Jericho Mile è anche, e soprattutto, una parabola laica di caduta e resurrezione. da Micheal Mann. Frammenti di un autore, Falsopiano, Alessandria 2000 the jericho mile 12 gennaio 2011 5 19 gennaio 2011 Les parapluies de Cherbourg Les parapluies de Cherbourg 6 Regia, soggetto e sceneggatura: Jacques Demy. Fotografia: Jean Rabier. Montaggio: Anne-Marie Cotret e Monique Teisseire. Musiche: Michel Legrand. Scenografia: Bernard Evein. Interpreti e personaggi: Catherine Deneuve (Geneviève Emery), Nino Castelnuovo (Guy Foucher), Anne Vernon (Madame Emery), Marc Michel (Roland Cassard) Ellen Farner (Madeleine), Mireille Perrey (Zia Élise). Origine: Francia, 1964. Durata: 91’. Nel 1957 Geneviève, figlia di un’ombrellaia, ama il garagista Guy che nel 1958 parte soldato per l’Algeria. Incinta e senza notizie da Guy, Geneviève accetta di sposare il ricco Roland, gradito a sua madre. Nel 1959 Guy rientra, ferito, e si sposa. Alla vigilia di Natale del 1962 i due s’incontrano per caso e non hanno nulla da dirsi. Una delizia di film interamente cantato su musiche di Michel Legrand. Grande successo in Francia, Palma d’oro a Cannes, premio Delluc e 5 candidature ai premi Oscar. Les Parapluies de Cherbourg e Les Demoiselles de Rochefort costituiscono forse gli unici esempi davvero riusciti di musical europeo. Suddiviso in tre atti (Partenza, Assenza e Ritorno), il primo musical di Demy è un curioso ed amarissimo apologo sull’amore e sulla perdita, sull’imprevedibilità del caso e sulle tristezze e delusioni della vita. Geneviève (una luminosa Deneuve), figlia di una venditrice di ombrelli della uggiosa città di Cherburg, si innamora di Guy (un fascinoso Nino Castelnuovo), meccanico insoddisfatto. Dopo aver superato le obiezioni della madre, decide di sposarlo. Ma la guerra di Algeria strappa alla ragazza il suo uomo. L’assenza dell’uomo amato fa sorgere in Geneviève laceranti dubbi esistenziali, che culmineranno nella scelta di sposare un ricco gioielliere di lei perdutamente innamorato presa dopo aver scoperto di aspettare un bambino da Guy. Quest’ultimo, ritornato dall’Algeria, viene a conoscenza del matrimonio e della partenza di Geneviève dalla città normanna. Una dolce amica d’infanzia saprà consolarlo. Molti anni dopo i due ex amanti si incontreranno casualmente sotto la neve di Cherbourg, ma sarà solo per dirsi definitivamente addio. Le traiettorie della vita di Guy e Genevieve, incrociatesi per un momento, hanno preso, irrimediabilmente, direzioni differenti. Dei due musical questo è probabilmente il più conosciuto. In Italia, a differenza del secondo, è uscito senza tagli. Anche grazie ad un uso davve- ro rivoluzionario del colore, teso a rendere visibili i sentimenti dei protagonisti, col décor impregnato di vibranti tonalità regolate dalle “intermittenze del cuore” (rosso, rosa saturi nei momenti di gioia, mesti verdi, blu e neri nei momenti di tristezza e di sconforto), il regista riesce ad andare al di là del genere facendo vivere allo spettatore una singolare esperienza audiovisiva. Primo musical in senso stretto (nel film non si parla, si canta…), anticonvenzionale proprio perché osa ridefinire i caratteri del genere senza tener conto delle esigenze del mercato, Gli ombrelli di Cherbourg fu un successo in patria, ma, cosa ampiamente prevedibile, funzionò meno all’estero (in Italia lo si è visto poco, mai in tv). Per la prima volta la musica e le canzoni non fungono da cassa di risonanza, con prevalente funzione connotativa, del già detto ma sono il fulcro stesso dal quale si irradia il senso dell’opera. Nel cantato confluiscono sia il detto-dicibile, sia il pensatopensabile, mentre nel musical tradizionale solo i sentimenti reconditi vengono di regola esteriorizzati per mezzo di suadenti melodie. Demy non ha alcun timore di eccedere in sentimentalismo, anzi, partendo dall’esempio imprescindibile del mélo hollywoodiano, sembra volerlo superare attraverso una sistematica estremizzazione dei sentimenti, una caricaturale accentuazione e cristallizzazione delle passioni che sommuovono gli animi dei personaggi ed un uso dell’ellissi che sfiora la crudeltà. Con queste ultime, l’autore pone l’accento sull’assoluta non linearità del sentimento amoroso, sulla cecità del caso. I topoi flamboyants del melò vengono smaccatamente portati alla ribalta ed estremizzati, fino a rivelarne, in una non palese opera di demistificazione, l’assoluta irrealtà. Non è un caso che le parti dell’idillio amoroso siano le più eccessive ed impossibili (benché credibili) e che l’ultima parte, quella della disillusione e della morte del sogno amoroso, sia visivamente più aderenti al reale cherbourghiano. MiScheda di manuel billi chel Legrand, autore delle musiche, fonde opera e jazz con una raffinatezza non comune, molto lontana dalla ruvida immediatezza dei testi musicali hollywoodiani. da www.spietati.it Les parapluies de Cherbourg 19 gennaio 2011 7 the killer 26 gennaio 2011 The Killer Regia, soggetto e sceneggiatura: John Woo. Fotografia: Peter Pau, Wing-Hung Wong. Montaggio: Kung Wing Fan. Scenografia: Chun-Ching Tai. Musiche originali: Lowell Lo. Interpreti e personaggi: Yun-Fat Chow (Ah Jong), Danny Lee (Isp. Li Ying), Sally Yeh (Jennie), Kong Chu (Fung Sei), Kenneth Tsang (Sgt. Tsang Yeh), Fui-On Shing (Wong Hoi), Wing-Cho Yip (Wong Dung-Yu), Fan Wei Yee (Paul Yau), Barry Wong (Capo Isp. Dou), Parkman Wong (Isp. Chan Bok), Siu-Hung Ng (un killer). Origine: Hong Kong, 1989. Durata: 111’. 8 Spiccio, serafico. Non ha molto da dire il sicario, nel compimento del suo ennesimo atto: l’accettazione di un nuovo incarico. Esce sotto la pioggia e si avvia, senza voltarsi verso colui che gli da lavoro, per altro suo migliore amico, verso una nuova avventura, verso un nuovo incontro con la morte. Si mette il cappuccio nero, impugna la falce e va a fare visita a chi ha già timbrato il suo biglietto per l’inferno. Si avvia, dentro al locale, capelli perfettamente pettinati, sciarpa bianca, sul cappotto nero. È un’immagine di purezza, questa, contrapposizione ossimorica alla dubbiosa moralità dei suoi gesti. Inizia così The Killer, con un montaggio alternato dove i movimenti della camera da presa indugiano sui volti dei protagonisti, al ritmo di una canzone dal tono triste che risulterà essere l’accompagnamento musicale di tutta la vicenda. Inizio questo, di una pellicola che è forse il film di punta della filmografia di John Woo. Collocabile cronologicamente più o meno al centro del percorso filmico del regista di Hong Kong (fece altri tre film in patria e poi emigrò negli States), The Killer, almeno idealmente assurge a un ruolo più preponderante. In molti hanno definito quest’opera come il capolavoro massimo di John Woo, altri – una certa schiera di detrattori – lo posizionano sicuramente al di sotto di un’altra sua notevole prova, Bullet In The Head, e forse anche su un gradino inferiore rispetto alla grezza veracità di A Better Tomorrow (sua prima prova nel genere action). Distribuito nel 1989, oltre a essere il film che ha fatto conoscere John Woo all’Occidente, vantando recensioni entusiastiche di gran parte della stampa specializzata, The Killer è anche il risultato di una lunga e difficoltosa gestazione. Durante le riprese in pochi erano realmente a conoscenza di quale sarebbe stato il risultato ultimo e il montaggio finale è il frutto di una quasi esclusiva visione del regista. In questo senso The Killer è sicuramente il film più autentico e personale di John Woo. Film dalla genesi travagliata, dunque (anche a causa dei continui alterchi tra il regista e il produttore Tsui Hark), The Killer è opera di grande coerenza formale, una pellicola dove l’azione, “paradossalmente”, non è il fine ultimo della messinscena, ma è un mezzo che John Woo utilizza per esprimere ciò che gli sta più a cuore. Non è un caso che le emozioni più intense non siano appannaggio delle lunghe, articolate sparatorie bensì facciano breccia nell’animo dello spettatore proprio nei momenti post-battaglia e nel preludio dell’azione. Hong Kong, fotografata in uno stato di travagliata “notturnità”, si è vista e si vedrà solo in alcune pellicole di Johnnie To (regista simile eppur diverso, ma ugualmente geniale). L’isola fa da contrappunto alle vicende dei protagonisti, configurandosi un po’ come territorio di passaggio – il film inizia e finisce nello stesso luogo, una chiesetta ai margini della metropoli – con le sue luci avvolgenti nella notte stradale, con i suoi continui ritmi stressati, imprigionata in un costante, irrefrenabile movimento: la scena dell’inseguimento di Eddy Wong, da parte del detective Dan, si conclude su un autobus affollato, magistralmente fotografato tra ralenti estremi e l’eliminazione dell’audio ambientale (che conferisce alla scena maggiore suspense). Ma The Killer non è solo questo, non è solamente una splendida dimostrazione di cinema d’azione, è un film che va ben aldilà della semplice definizione di action movie. Partendo da una trama piuttosto esile e scontata, John Woo ne approfondisce i sottotesti, amalgamandoli in un’unica soluzione, in un tutt’uno dove forse il risultato finale è anche il cardine principale del suo cinema: l’amicizia virile. Malato di ipertrofia dell’eccesso, questo film vive tra attimi di pacato sentimentalismo e improvvisi quanto devastanti scoppi di violenza (nessuno spara mai meno di tre o quattro volte contro il corpo martoriato del Scheda di MASSIMO VERSOLATTO nemico). Pur nella sua violenza efferata The Killer segue una sua precisa morale, dove anche un sicario della malavita ha un suo senso dell’onore e crede fermamente nell’amicizia – il ruolo dell’amico e committente, interpretato da Chu Kong, viene rivalutato verso il finale quando questi, ferito gravemente, si aggiusta il nodo della cravatta e risponde a chi lo accusa d’essere un cane: «i cani sono più fedeli degli essere umani». Con questo film John Woo consacra il mito dell’eroe decadente, lo adatta alla figura straordinaria del suo attore feticcio (Chow Yun-Fat) e ne accentua i lati più deboli e oscuri. Con un uso sapiente e per nulla misurato del ralenti, spinge la dimensione filmica dell’azione a livelli quasi liturgici. Mai smisurato ma sì estremo nella rappresentazione della violenza, riesce nella difficile impresa di dare un nuovo volto al cinema noir. su www.ondacinema.it The Killer 26 gennaio 2011 9 La maman et la putain 2 febbraio 2011 La maman et la putain Regia, soggetto e sceneggiatura: Jean Eustache. Fotografia: Pierre Lhomme. Montaggio: Denise Decasabianca, Jean Eustache. Interpreti e personaggi: Bernadette Lafont (Marie), Jean-Pierre Léaud (Alexandre), Françoise Lebrun (Veronika), Isabelle Weingarten (Gilberte), Jacques Renard (amico di Alexandre), Jean-Noël Picq (fan di Offenbach). Origine: Francia, 1973. Durata: 217’. 10 Alexandre è un dandy parigino che passa le giornate a leggere e passeggiare per Sain-Germaindes-Près. Convive con una commessa, Manie, più anziana di lui, ma è anche l’innamorato di una studentessa, Gilberte. Un giorno conosce un’infermiera di costumi un po’ facili, Veronika, si invaghisce di lei e l’insedia in casa di Marie, che non è troppo Contenta di questa coabitazione, ma ci si adatta. Tra due donne che gli sono ugualmente cane, Alexandre non sa bene quale scegliere... Poi Veronika rimane incinta, e forse si profila una qualche separazione. Cosa dire di questo film? Tutto, niente, è già il film stesso a criticarsi, a parlare di sé lungo i suoi 210 minuti che non pesano neanche un po’, e che ci introducono nella vita dell’uomo qualunque, dell’homme de la rue, interpretato da Jean-Pierre Lèaud, attore feticcio della Nouvelle Vague, di Truffaut certo, ma non solo. Siamo nel 1973, e il regista Jean Eustache, morto suicida nel 1981, gira il film che per Jean Douchet racchiude, e spazza via aggiungeremmo, il Maggio ’68. La storia non ha alcuna importanza, perché si tratta di un film di situazioni, di finzioni, di rimandi, di cinefilia (quattro film al giorno alla Cinémathèque), di nulla appunto. Raccontare il nulla è in effetti quanto di più difficile ci sia. La maman et la putain più che un film, è la messa in scena di un qualcosa che sta au bord del film, fra film e profilmico, fra un ciak e l’altro, fra il racconto e il silenzio. Non solo il concetto di caméra-stylo giunge qui ai limiti estremi, ma è la natura stessa del racconto autoriale che prende le forme di un’autobiografia sfilacciata, quanto menzognera. Tutto è possibile lungo le tre ore e mezzo, perché non c’è limite ai ricordi, nemmeno regole per raccontarli. Molti silenzi, lunghe discussioni durante le quali viene fuori la banalità del quotidiano, la natura insulsa del confronto sociale, umano, amoroso. Ma lentamente lo si accetta perché è questa la regola del gioco. I rimandi letterari sono più che evidenti: Proust per quel che riguarda l’uso liberissimo della narrazione e del tempo dilatato, bergsoniano quanto si vuole. Céline, per i dialoghi surreali, senza freni inibitori, per l’uso critico dell’argot (non a caso in una scena Alexandre confessa che gli piacerebbe saper parlare con la dizione francese propria degli stranieri che imparano la lingua, così attenti ad articolare bene ogni sillaba). Ma l’eredità più importante, quella che pesa maggiormente e che finisce per permeare l’intera pellicola è quella della Nouvelle Vague, di cui Eustache ha respirato gli effluvi, senza assorbire stili o stilemi linguistici. Quel che ha appreso da Rivette, Godard Truffaut, Chabrol, Rohmer, è soprattutto una forma mentis, un approccio al cinema, che è del tutto personale, autoriale. Un film è per forza una parte di se stessi. Ma ciò che sorprende di Eustache è il percorso di lavoro che lo porta a filmare: «Non c’è mai una vera indicazione di azione o di plan, di inquadratura. Per La maman et la putain, quando sono arrivato sul set, non sapevo dove mettere la macchina da presa e gli attori. E poi, in pochi istanti, prima di girare l’inquadratura, dicevo: “La macchina va qui e gli attori là”. Ma non avevo in mente quello che avrei fatto nell’inquadratura successiva. Facendo qualche prova, vedevo se le cose funzionavano e dove bisognava finire l’inquadratura. Il problema di dove mettere la macchina si riproponeva ad ogni inquadratura. Così ho fatto La maman et la putain in un tempo minimo: quattro settimane di riprese per un film di tre ore e quaranta, che vuol dire più o meno dai dodici ai quindici minuti utili ogni giorno» (da un’intervista di Sylvie Blum e Jérôme Prieur, “Scénario”, pubblicata nel Settembre 1983). Questa è la libertà narrativa conquistata da Eustache a discapito di successi commerciali. Bisogna andare oltre però. Non è infatti la biografia o l’auto-biografia a delimitare il campo di interesse del film. Come si evince dalle dichiarazioni dello stesso autore, è piuttosto la messa in scena di un processo non ben identificato: potrebbe essere linguistico, nel senso che analizza il valore neutrale e superficiale della parola come disgregazione del senso, oppure strettamente cinematografico, quale ricerca di una (s)personalizzazione dell’immagine che non può che rimandare, come segno, solo a se stessa, un po’ come nell’iperrealtà di Baudrilliard. Non è chiaro, ma è proprio questo il bello. Dopo due ore passate a stretto contatto con questi personaggi, la familiarità ci porta a guardarli come persone in carne ed ossa, e questa esperienza ha un duplice valore: da una parte ci ha resi più che osservatori, piuttosto dei compositori, che hanno il bisogno automatico ma assoluto, pena la noia, di ricostruire nella propria mente la “loro” storia di Alexandre, Marie e Véronika. Scheda di FRANCESCO CRAPANZANO La maman et la putain 2 febbraio 2011 11 Dall’altro significa che gli attori si sono spinti al limite della recitazione, pur mantenendo una sorta di neutralità del tono e dell’espressione. Sono rarissimi infatti i momenti di recitazione, si tratta semmai di partecipazione all’evento filmato. Dopo i 210 minuti però ci si accorge subito di aver assistito a qualcosa di più che una semplice sperimentazione. La maman et la putain è il contenitore, pieno, di qualcosa che è vuoto (la generazione post-sessantottina? I giovani tout court?), e per questo, solo per questo, che il film appare vuoto, privo di forma, ma non è così. La nudità dei personaggi, della loro storia, così come la nostra nudità (purezza) mentale, dimostra il contrario. Perché un’esperienza visiva nuova è già contenuto, è già concetto. da www.cineforme.it UNA MOGLIE 9 febbraio 2011 Una moglie Titolo originale: A Woman Under the Influence. Regia, soggetto e sceneggiatura: John Cassavetes. Fotografia: Mitch Breit, Al Ruban. Montaggio: David Armstrong, Sheila Viseltear. Musiche: Bo Harwood. Scenografia: Phedon Papamichael, Kevin Joyce, Steve Hitter. Interpreti e personaggi: Gena Rowlands (Mabel Longhetti), Peter Falk (Nick Longhetti), Katherine Cassavetes (Margareth Longhetti), Matthew Laborteaux (Angelo Longhetti), Matthew Cassel (Tony Longhetti), Christina Grisanti (Maria Longhetti). Origine: Francia, 1974. Durata: 155’. 12 Sposata a Nick Longhetti, titolare di un’impresa di sterro, madre di tre bambini, la casalinga Mabel, un po’ mattocchia, entra in depressione e passa sei mesi in una clinica psichiatrica dalla quale esce pronta a riprendere il suo ruolo di moglie e madre subalterna e suggestionabile, ma cambiata. Ma è cambiato anche il marito. Grande film d’amore e di follia, sulla follia come differenza e rivolta. Importante film sul malessere della società americana vista attraverso la famiglia e la coppia (etnicamente disparata: lui plebeo italoamericano, lei yankee di origine svedese). La parte che precede il finale “lieto” (ma problematico) è di straordinaria forza emotiva tra il tenero e il feroce. Rowlands e Falk fuori dal comune. Se ne accorsero persino a Hollywood, dove J. Cassavetes autore è sempre stato sottovalutato: 2 nomination agli Oscar per la regia e la Rowlands. Il matriarcato americano è stato per decenni un cavallo di battaglia della sociologia antifemminista che registrava con qualche fastidio la virtù delle madri e delle mogli di far marciare l’America a bacchetta. In realtà già negli anni Trenta un osservatore attento come Emilio Cecchi consigliava di parlare anche della tristezza e umiliazione della donna americana. A dar retta al cinema, negli ultimi tempi la situazione è precipitata: lungi dall’impugnare il bastone di comando, la casalinga porta sulle spalle il carico di tutte le nevrosi d’un mondo che tanto più soffre di solitudine quanto più ha mitizzato la felicità domestica. Vediamo il caso di Mabel Longhetti. Sposata a un capo-cantiere, sembra un angelo del focolare e una madre soddisfatta: non dovrebbe avere ragioni di scontento. In realtà è alle soglie della follia, perché è priva di luce propria, a somiglianza d’un pianeta, riceve la vita dagli altri: dal marito Nick, che pur l’ama, dai figli, dalla suocera, dagli amici di casa, dai riti della famiglia. Quando le stanze sono vuote, il marito è al lavoro e i bambini sono in vacanza, Mabel è come spossessata di affetti. È tanto libera da sentirsi in gabbia. La sera che per un impegno improvviso Nick ha mancato alla promessa di festeggiare con lei il loro anniversario può accadere di cercare il calore della vita in un bar e in qualche bicchiere di troppo, persino di portarsi a letto uno sconosciuto, e poi di crederlo Nick. Un’altra sera che il marito ha aperto la casa ad amici allegroni, può accaderle di comportarsi in un modo che lui considera sconveniente. Mabel andrà in clinica psichiatrica, convinta essa stessa che soltanto una pazza può infrangere le regole delle buone creanze familiari, ma le cure del medici non l’avranno guarita. Ora si sente in colpa, ha sempre paura dl sbagliare, e Nick continua, per amore, a pretenderla come non è. Fin quando Mabel, davanti ai bambini, tenta il suicidio e l’uomo la salva. Chi salva, perché? Non sappiamo il futuro di casa Longhetti. Vediamo una moglie che, mite, si accetta. Vediamo un marito che teneramente le porge una mano. Sono insieme sull’orlo d’una rassegnazione che può anche tingersi di sorriso. Una moglie dura due ore e mezzo, ma quando finisce lascia la voglia di rivederlo. È un film che domani sarà fra i classici, insieme a Bergman, del cinema sulla coppia e sulla donna. Uno dei più acuti e toccanti che l’America degli indipendenti abbia prodotto, in lontana polemica con gli stucchevoli “woman’s films” hollywoodiani degli anni Trenta e Quaranta, per esprimere la condizione femminile di servitù in cui si rispecchia il rovescio di una società che vanta la libertà della donna e l’equilibrio da essa raggiunto. Va da sé che Mabel è una donna americana, non la donna. Ma le femministe avranno ragione se in questo campione della middle-class, sposata a un italo-americano, ci inviteranno a leggere la sconsolatezza di quante, educate non già a essere se stesse ma a farsi possedere dalla famiglia, cadono in quella irrealtà che la clinica psichiatrica istituzionalizza quando temono di non poter più svolgere il loro ruolo di subalterne. Mabel è a suo modo una persona finché ha da compiere i lavori domestici. Se il patto sociale che la lega alla casa si rompe perché la sua devozione è fraintesa, essa perde la propria identità. Probabilmente sarà ancora una buona moglie e una brava madre, ma le verrà meno la certezza di meritare la carezza che il padrone fa alla schiava: la famiglia l’ha tradita. Ripercorrendo per qualche verso il tragitto del Diario d’una casalinga inquieta di Frank Perry, Una moglie porta allo spasimo la partecipazione fra cinema e pubblico, li propone come due momenti d’una realtà che si manifesta pienamente nel connubio fra naturalezza e finzione. Mabel non è un’attrice che recita ma una donna in carne ed ossa: è la rappresentazione toScheda di GIOVANNI GRAZZINI tale di idee e sentimenti in cui l’aneddoto si fa storia e il gesto rivela un destino. Quanto amaramente irragionevole, giacché la famiglia sembra veicolo di follia, si legge negli occhi curiosi e spauriti dei figlioletti nell’ora del tentato suicidio. Quanto desolato si scorge nell’affannoso correre al ripari di Nick, un marito che non sa cosa rimproverarsi: e qui sta il dramma della vita in due, il dramma di amarsi. Ogni film dl Cassavetes ha negli interpreti altrettanti coautori. Qui ne danno luminosa riprova un po’ tutti (anche le vecchie signore, anche i ragazzi che conferiscono all’opera il sapore del fatto in casa), ma sopra ogni altro Gena Rowlands, una Mabel che svaria dal doloroso all’eccentrico, dal violento al disperato, lungo tutta la gamma della teneressa e del rimorso, con incantevole tensione emotiva. Insieme al bravo Peter Falk – il quale anche senza le inflessioni meridionali attribuitegli dal doppiaggio lascia intuire nel comportamento le antiche radici italiane del personaggio – forma una coppia che non si dimentica. Se non si voglia dimenticare se stessi, negare l’oroscopo. da “Corriere della Sera”, 7 maggio 1978 Una moglie 9 febbraio 2011 13 16 febbraio 2011 Non per soldi… ma per denaro non per soldi... ma per denaro 14 Titolo originale: The Fortune Cookie. Regia: Billy Wilder. Soggetto e sceneggiatura: Billy Wilder, I.A.L. Diamond. Fotografia: Joseph LaShelle. Montaggio: Daniel Mandell. Scenografia: Edward G. Boyle. Musiche originali: André Previn. Interpreti e personaggi: Jack Lemmon (Harry Hinkle), Walter Matthau (Willie Gingrich), Ron Rich (Luther “Boom Boom” Jackson), Judi West (Sandy Hinkle), Cliff Osmond (Purkey), Lurene Tuttle (Madre Hinkle), Harry Holcombe (O’Brien), Les Tremayne (Thompson), Lauren Gilbert (Kincaid), Marge Redmond (Charlotte Gingrich), Noam Pitlik (Max), Harry Davis (Dr. Krugman), Ann Shoemaker (Suor Veronica). Origine: USA, 1966. Durata: 125’. Harry Hinkle è un operatore della televisione americana che viene inviato, con la sua telecamera portatile, a riprendere una partita di rugby. Mentre sta lavorando viene travolto e scaraventato a terra da un giocatore, Luther Jackson. Il cognato di Harry, Willie, che è un avvocato, lo convince a sfruttare l’occasione favorevole e, malgrado l’incidente non sia stato grave, a chiedere un cospicuo rimborso all’assicurazione. Harry accetta sperando di coronare il suo sogno di diventare ricco per poter così riconquistare la moglie Sandy, fuggita con un batterista. L’assicurazione, subodorato l’inganno, invia, senza successo, sulle loro tracce il detective Purkey. Intanto Luther, stretto dal rimorso, circonda Harry di mille premure e i due diventano in breve tempo amici. Tuttavia, nonostante i soldi dell’assicurazione e il ritorno di Sandy, Harry non riesce a essere felice. The Fortune Cookie si articola in 16 capitoletti, ognuno caratterizzato da un breve titolo: 16 piccole, folgoranti “moralità” che percorrono un universo balzachiano del “comportamento economico”. Il primo capitolo (L’incidente) pone le basi di tutto, della story e delle sue connotazioni. Nello stesso primo capitolo, avviene l’incidente, lo scontro fortuito tra il cameraman e “Boom Boom” Jackson (Ron Rich) giocatore nero dei Cleveland, in seguito al quale Hinkle rimane esanime sul terreno, e viene portato all’ospedale. Di qui, discende tutto lo sviluppo dei temi temi del film: a. la simulazione. Era già il tema di Double Indemnity: lì una falsa ingessatura alla gamba costituiva il supporto dello scambio di persona per il delitto; qui un vero busto serve a contenere il corpo simulatore della falsa paralisi. Hinkle, da piccolo, era caduto da un terrazzo, e gli era rimasta una vecchia incrinatura ad una delle vertebre della spina dorsale. Poiché nessuno è in grado di rendersi conto se una simile incrinatura sia vecchia o nuova, ecco prospettarsi a Hinkle, purché simuli per un certo tempo la paralisi degli arti inferiori, l’occasione di chiedere alla compagnia di assicurazioni un risarcimento favoloso. L’idea, come si sarà compreso, non è del mite e candido Hinkle, il quale per parte sua sarebbe già disposto a saltare giù dal letto d’ospedale e dimenticare l’incidente, bensì di suo cognato, l’avvocato fallito Willie Gingrich (Walter Matthau) che per invogliare il recalcitrante Hinkle, non tanto gli prospetta l’idea dei soldi in sé, quanto la possibilità che, nel momento in cui non fosse più un povero cameraman senza avvenire, sua moglie Sandi (Judi West), che l’aveva da tempo piantato e che egli in fondo ama ancora, finisca col tornare da lui. Qui, come notava M. Ciment in una recensione del film sul n. 87 di “Positif” Walter Matthau disegna un personaggio memorabile, costantemente all’altezza dei gag più maligni di Groucho Marx. Wilder e l’operatore Joseph LaShelle ne mettono in risalto, con l’illuminazione, il naso sporgente, connotante l’abilità nel cogliere le occasioni, sfruttare le situazioni ecc.; il suo cappello, profondamente calcato, si alza e si abbassa con l’alzarsi e l’abbassarsi della fronte, quando qualcosa desta la sua attenzione di piccolo segugio, famelico di denaro; alla fine, l’istrionismo, l’esibizionismo, il cinismo, appaiono in lui così sfrontati, diretti, in fondo “sinceri”, da risultare accattivanti, specie se confrontati con il perbenismo ipocrita, molto più pericoloso e antipatico, delle tre “aquile del foro”, gli avvocati di grido avversari di Matthau. Nella cordiale antipatia di cui li gratifica Wilder, essi sono da mettere insieme ai “luminari della medicina”, pomposi e inconcludenti che visitano Hinkle: luminari tra i quali non può mancare un “austriaco” iroso e maniacale che ripete solo e continuamente: «Simula!». b. la coppia maschile. Tra le «strane coppie» wilderiane, quella formata dal falso paralitico Harry Winkle e dal rugbista nero Boom Boom Jackson è una delle più emblematiche. Dapprima, Boom Boom apapre semplicemente preoccupato e dispiaciuto per l’incidente che crede di aver causato. Quando Hinkle porrà fine ad una finzione che ormai lo ripugna e raggiungerà l’altro sul campo di rugby, in un invito a giocare che ricorda il gioco alle carte con cui si chiude L’appartamento, non si tratta affatto di un finale idillico e consolatorio: il gioco solitario dei due, nel grande stadio vuoto e notturno, sancisce la presa d’atto definitiva di una diversità e di una esclusione. c. la registrazione, la ripetizione, lo spettacolo. Si comincia proprio con lo spettacolo del rugby, che la televisione doppia. Quando si configureranno gli estremi dell’azione legale promossa da Harry, le aquile del foro assoldano un investigatore privato, Mr. Purkey, con l’incarico di seguirlo costantemente con cinepresa, teleobiettivo e registratori, per prenderlo in Scheda di ALESSANDRO CAPPABIANCA castagna e smascherarlo. Ecco quindi il tema dell’oggetto nascosto e della traccia che lo fa scoprire. Non si capisce come, per questo film, si sia potuto parlare di sentimentalismo. Ben dice Anchisi (cit.): «Le carezze di Billy Wilder hanno la stessa dolcezza di un colpo di rasoio: un sorriso di Sandy a Harry, una sua frase d’amore, hanno la stessa tenerezza del colpo di forbici di Jan Sterling in The Big Carnival, e forse una maggiore crudeltà». Senza rinunciare mai alla fiction, Wilder la sbeffeggia come tale, e mette in luce senza pudori gli strumenti che la rendono possibile. Nel gioco spericolato, il residuo che salva sempre e comunque la “credibilità” favolistica, è nella spericolatezza stessa del gioco; Wilder è il magicien più audace, che svela qua e là qualche trucco con tanta improntitudine da far sì che non si creda ai propri occhi e si mettano tra parentesi, rimuovendoli, questi scomodi «momenti della verità». da Billy Wilder, Il Castoro, 1995 Non per soldi… ma per denaro 16 febbraio 2011 15 23 febbraio 2011 Eraserhead. La mente che cancella ERASERHEAD. la mente che cancella 16 Regia, soggetto e sceneggiatura: David Lynch. Fotografia: Herbert Cardwell, Frederick Elmes. Montaggio: David Lynch. Effetti speciali: Frederick Elmes, David Lynch. Musiche: David Lynch, Fats Waller. Scenografia: David Lynch. Interpreti e personaggi: Jack Nance (Henry Spencer), Charlotte Stewart (Mary X), Allen Joseph (padre di Mary), Jeanne Bates (madre di Mary), Jean Lange (nonna di Mary), Laurel Near (donna nel termosifone), Judith Anna Roberts (donna nella stanza), Jack Fisk (l’uomo nel pianeta), Thomas Coulson (il ragazzo), John Monez (Bum), Darwin Joston (Paul), Neil Moran (il Boss), Hal Landon Jr. (operatore del cancellatore), Jennifer Chambers Lynch (se stessa). Origine: USA, 1977. Durata: 89’. Raccontare la trama di Eraserhead è impresa ardua soprattutto perché il film non è, per sua natura, raccontabile. L’insieme surreale e caotico di gesti, suoni, corpi, immagini che costituiscono l’opera richiede di essere vissuto, e più volte verificato, dallo spettatore al fine di ricavarne una logica successione. Eraserhead verrà ultimato nella completa indigenza economica del regista che al film sacrificherà la propria vita privata nell’ossessione di terminarlo. Fu molto amato da Kubrick, che lo proiettava durante la lavorazione di Shining per trasmettere inquietudine ai propri attori. La testa di Henry, sulla quale si sovraimprime un pianeta. Un uomo ricoperto di cicatrici aziona delle leve su un macchinario, un feto è sparato in una pozza di liquido scuro. La m.d.p. attraversa un cratere e si ferma sul volto del protagonista: Henry che torna a casa. Sul pianerottolo del suo appartamento la vicina gli dice che Mary ha chiamato e lo aspetta a cena a casa sua. Lui non la vedeva da tempo e conservava ancora una sua foto, strappata in due pezzi. A cena Mary gli presenta la sua famiglia, composta di una madre e di un padre, ed una nonna che in stato catatonico fuma sigarette senza muovere nemmeno le labbra. A tavola gli viene servito un pollo sintetico che si rianima non appena Henry prova a tagliarlo, mentre la madre di Mary è colta da un attacco epilettico brevissimo. Chiamato in disparte da quella, Henry è messo al corrente che Mary ha partorito un feto prematuro e che la coppia deve sposarsi. Mary ed Henry vanno così a vivere insieme, e lei trascorre le giornate ad accudire il feto-embrione che ha partorito. Una notte Mary decide di andarsene via di casa perché non riesce a dormire a causa dei pianti del feto ed i due litigano definitivamente. Rimasto solo, la mattina dopo Henry si accorge che il feto sta male, ma non sa che fare. La notte, sogna una donna con due tumori sul viso che balla su un piccolo palco mentre intona una canzone che parla della bellezza del Paradiso. Ai suoi piedi c’è il feto che la donna calpesta alla fine della canzone. Henry si risveglia e trova la moglie accanto a lui che espelle altri feti e lui li getta tutti contro la parete. Prende allora un verme che custodiva in un cassettino e vede che questo si anima fino a che nel suo lamento egli non si ritrova, come se stesse nello steso appartamento ma in una situazione differente. Di- fatti la moglie è sparita e la sua vicina di casa gli chiede se può dormire da lui visto che è rimasta chiusa fuori e mentre i due si baciano a letto, affondano fra le coperte, in un liquido biancastro. Sogna ancora una volta la donna con il tumore alle guance, e questa volta è con lei sul palco. La testa di Henry schizza via ed al suo posto spunta quella del figlio-feto. La sua testa vera invece, cade dal cielo sulla strada dove un bambino la raccoglie e la vende ad una fabbrica che ne produrrà gomma per matite. Henry si sveglia ancora, solo in casa questa volta ed ancora con il feto. Prova a bussare alla porta della vicina ma questa in un primo momento è fuori e poi fa ritorno con un altro uomo. Henry decide allora di tagliare le fasce del feto e dopo uccide quello pugnalandolo con le forbici. Dal corpo del feto è espulsa una sostanza che minaccia invadere la stanza. Il pianeta che all’inizio era in sovrimpressione sulla sua testa, esplode, mentre l’uomo addetto alle leve non riesce più a controllarle. Immerso dalla luce, Henry abbraccia la donna con i tumori. «Raccontare la trama di Eraserhead è impresa inevitabilmente votata al fallimento» (Riccardo Caccia, David Lynch, Il Castoro cinema). Il primo lungometraggio del regista americano, è un parto difficile e lungo, totalmente visionario e avanguardista. Quando vi fu la prima (a quattro anni dall’inizio dei lavori) “Variety” pubblicò la recensione concludendo: «Prospettive commerciali nulle». Concentrato a raccontare attraverso il postmoderno (linguaggio cinematografico e l’ambiente nel quale si muovono i protagonisti) una storia che è un inestricabile rompicapo, un insieme di scatole cinesi che aprono sempre sulla prospettiva del dubbio, e sul quale incombe un’incongruenza di suoni off (e nemmeno tali in realtà) Eraserhead è un film che immerge spettatore e protagonista nel medesimo vuoto. Fu proprio nel circuito off, quello dei midnight movie che in quel periodo faceva grande un film come The Rocky Horror Picture Show (1975) di Jim Sharman, che la pellicola ottenne successo sino a raggiungere il livello di cult movie. In questo viaggio onirico nel realismo postindustriale, il cinema di Lynch si mostra asciutto ed al tempo stesso ridondante, corretto ed al tempo stesso baro. In questa pellicola, il regista ha riassunto la maggior parte delle idee, degli embrioni, che più in la svilupperà con estro a volte maggiore: tema dell’alterità (inteso non come l’altro, ma come Scheda di MARIO BUCCI insieme di diversi e dove non esiste l’idea della normalità); partecipazione degli oggetti, delle cose, come se potessero animarsi (ed a volte lo fanno davvero), oggetti che prendono e perdono il loro significato ordinario; modello noir fatto di vuoti, bui, mancanze e neri dai quali affiorano pallidi personaggi; predilezione per la composizione del film e non solo per il girato. Un matrimonio forzato, un parto non voluto, la morte di una famiglia, Eraserhead è anche un brandello della memoria biografica del regista, l’esperienza con la prima moglie Peggy e la figlia, a Philadelphia, vissuta in un quartiere ghetto e ricco di violenza. Eraserhead è una pellicola che ha la sua forza però, nel quasi paranoico rispetto delle regole cinematografiche (tutte le inquadrature ripetono un modello non originale senza interventi davvero visionari) dilatate in tempi che le trasformano in non cinematografiche, non commerciali, addirittura violente. Suono e tempo sono i veri elementi che scuotono lo spettatore, producono angoscia, in un mondo che il regista mostra come assolutamente normale. Lynch ha definito questa pellicola come un «sogno di cose oscure e inquietanti» (il Morandini 2003 – Dizionario dei film). Lynch non ha mai voluto dire come egli stesso abbia realizzato gli effetti speciali per il feto. Jack Fisk, amico di vecchia data e collaboratore del regista, è l’uomo con le cicatrici addetto alle leve. da www.cinemah.it Eraserhead. La mente che cancella 23 febbraio 2011 17 18 pepi, luci, bom e Le altre ragazze del mucchio Titolo originale: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Regia, soggetto e sceneggiatura: Pedro Almodóvar. Fotografia: Paco Femenia. Montaggio: Josè Salcedo. Musiche: Monna Bell, Maleni Castro. Costumi: Manuela Camacho. Interpreti e personaggi: Carmen Maura (Pepi), Félix Rotaeta (Poliziotto/suo fratello gemello), Olvido Gara (Bom), Eva Siva (Luci), Concha Grégori (Charito, la vicina di Luci), Kiti Manver (La ragazza che è modella e cantante ma non è un puttana), Cecilia Roth (Ragazza dell’annuncio Bragas Ponte), Julieta Serrano (Donna vestita come Scarlett O’Hara), Cristina Sánchez Pascual (Donna barbuta). Origine: Spagna, 1980. Durata: 82’. Pepi coltiva pianticelle di marijuana sul balcone. Un poliziotto la scopre e accetta di non denunciarla in cambio della sua verginità. Per vendicarsi, Pepi chiede aiuto all’amica Bom che seduce la moglie masochista del poliziotto e lo fa bastonare dagli amici, che sbagliano e pestano il suo gemello. Opera prima del trasgressivo regista spagnolo, ex impiegato della SIP, omosessuale e rockettaro, girata in 16mm nel 1978, è un divertente, caotico, ironico quadro di un microcosmo che riesce a far ridere, a scandalizzare o imbarazzare con canagliesca grazia amorale. 7 ottobre 1980. Esce, in Spagna, il film che, approssimando filologicamente, possiamo definire la folgorante opera prima di Pedro Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Approssimazione relativa non a “folgorante”, quanto alla collocazione della pellicola nel percorso del regista. Il film non rappresenta né il primo 35mm, che data 1976 (ma trattasi di un corto, Muerte en la carrettera, per giunta disconosciuto), né il primo lungometraggio, girato nel ’78, ma in super-8. Se Pepi, Luci, Bom, presentato al Festival di San Sebastián, viene considerato l’esordio del ragazzaccio mancego è perché segna, fuor di dubbio, l’uscita dagli scantinati dell’underground e l’ingresso nei circuiti del cinema “ufficiale”. E, per noi, l’incipit di una relazione amorosa che, tra film più o meno belli, capolavori o capitomboli, dura da ormai trent’anni. Girato in condizioni di fortuna in 16mm e gonfiato, a fine riprese, a 35, Pepi, Luci, Bom è un prodotto già sfacciatamente almodovariano. E se basta scorrere i titoli licenziosi dei lavori amatoriali, per intuire la continuità fra i bagordi delle chicas e le intemperanze degli anni ’70, la pellicola guadagna, oggi, un significato aggiuntivo, se ripensata come germinatoio delle opere successive. E non, come vedremo, per la sola presenza delle attrici di Pedro (Maura, Roth, Siva, Serrano), o di José Salcedo, accreditato come Pepe, al montaggio. Il soggetto, nato per un fotoromanzo porno, è indubbiamente gracile, e pretestuoso. Come dare torto a Daniela Aronica, che identifica il distintivo di Pepi in una «vistosa mancanza di sintesi e unitarietà» (Pedro Almodóvar, Il Castoro, 1994)? La trama, in fondo, è soltanto una farragine balzana di tessere, dalla cui composizione deriva un mosaico policromo e dissacrante della Movida post-franchista: rock, stupefacen- ti, copule selvagge, travestiti e devianze d’ogni sorta. Ritratto esasperato di una generazione e di un Paese in cui la repressione autoritaria di energie creative ha ceduto il passo a una riappropriazione di sé edonistica, trasgressiva, e perdutamente fatua, per la totale latitanza di ideali palingenetici: «non esisteva il minimo senso di solidarietà, né politico, né sociale, né generazionale. Le droghe mostravano solo la loro parte ludica e il sesso era qualcosa d’igienico», affermerà lo stesso regista. Istantanee da una Spagna «presente e assente insieme», per citare Jean-Max Méjean (Pedro Almodóvar, Gremese, 2007), perché di Madrid nessun luogo simbolo ci viene mostrato (al massimo, nei fotogrammi finali, l’autostrada ripresa dal cavalcavia dell’ospedale, apoteosi del non luogo), mentre a dominare il campo sono le scenografie kitsch degli interni. Interni in cui (fi)brillano loro: le donne. La femminilità almodovariana perennemente sull’orlo di una crisi di nervi, fantasiosa, debordante, assetata di vita. Pepi sarà, in futuro, Sexilia, Pepa, Kika, Raimunda. O Patty Diphusa, l’eroina del feuilleton osè scritto da Almodóvar per la rivista “La Luna” fra ’83 e ’84. Nulla di hard vi è, invece, nel film: i pochi amplessi e l’unica fellatio (figura dominante l’immaginario erotico almodovariano) sono farseschi e bozzettistici ai limiti dell’incorporeità. Ciò che colpisce, che frastorna, ancora oggi, è piuttosto la travolgente misticanza, cialtrona e post-moderna, di riferimenti iconico-culturali attinti ai generi e ai media più disparati, all’insegna di quel citazionismo di cui Almodóvar sarà ambasciatore, e che qui è già degnamente rappresentato da incursioni nel linguaggio televisivo (gli spot demenziali della biancheria Ponte con Cecilia Roth, all’altezza della réclame del detersivo lava-sangue di Mujeres, ‘88), nel musical (da antologia la scena del pestaggio), nel cinema melò, fulcro della cinefilia almodovariana, con una moglie trascurata che fa il verso, nelle lagnanze coniugali, a Liz Taylor nella Gatta sul tetto che scotta. E fra esibizioni generose d’incontinenze scatologiche (due anni dopo, in Labeirinto de pasiones, sarà la volta della portinaia incalzata dal lassativo), spuntano anche, alla stadio larvale, temi che troveranno una declinazione assai più elevata. Il tema del doppio, ancora lungi da implicazioni esistenziali e metafisiche (i due Esteban, la Morte e la Vita, di Todo sobre mi madre, ‘99), è già presente, per Scheda di DARIO GIGANTE quanto affrontato in termini meramente visivi: il gemello del poliziotto anticipa il “raddoppiamento” di Sexilia in Labeirinto. Anche i risvolti metacinematografici (Pepi che, vaneggiando di realizzare un film sulla vicenda di Bom e Luci, arricchita di sviluppi sgangherati, diviene alter ego di Almodóvar e interprete dello stesso gusto per l’eccesso) non sono che l’anticamera di esiti più maturi; ma, mi si perdoni la franchezza, talvolta stucchevoli (Los abrazos rotos, 2009). Alla luce di tutto ciò, sarà il valore di testimonianza storica, o il divertimento che ancora ci procurano, credo che le ragazze del mucchio, trent’anni, se li portano bene. E allora, buon compleanno, chicas! da www.cinezapping.it Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio 2 marzo 2011 2 marzo 2011 Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio 19 chiedo asilo 9 marzo 2011 Chiedo asilo Regia: Marco Ferreri. Sceneggiatura: Roberto Benigni, Gérard Brach, Marco Ferreri. Fotografia: Pasquale Rachini. Montaggio: Mauro Bonanni. Musiche: Philippe Sarde. Costumi: Nicoletta Ercole. Interpreti e personaggi: Roberto Benigni (Roberto), Francesca De Sapio (Chiara), Dominique Laffin (Isabella), Luca Levi (Luca), Girolamo Marzano (Mario), Carlo Monni (Paolo), Chiara Moretti (Irma), Roberto Amaro (Robertino). Origine: Italia/Francia, 1979. Durata: 110’. 20 Roberto, maestro d’asilo, è accolto bene dalle colleghe, amato dai bimbi, ma ostacolato dai genitori che non capiscono i suoi rapporti con i loro figli. Nasce un legame particolare con un bimbo psichicamente disturbato. C’è un mercato del bambino ma a nessuno interessano i bambini. Interessa l’uso del bambino come immagine per agitare certi sentimenti, anche il bambino di Chiedo asilo, che è un campione, e tutti parlano di lui... Il mio non è un cinema di problemi ma è un cinema di sensazioni. lo voglio mettere insieme le fotografie delle sensazioni, che sono generali; voglio dare le immagini della gente e che ognuno interpreti queste immagini, se le analizzi per conto suo... In parole povere ognuno prenda dal film quello che vuole per quello che gli interessa... Ma se tu parli dei bambini nessuno si ritrova, come se i bambini fossero marziani... e di fatti sono messi nei posteggi in attesa di diventare uomini. Un bambino è un fenomeno sociale, però in posteggio, e diventa interessante quando comincia ad avere le stesse reazioni di tutti, quando ha vent’anni. Marco Ferreri Chiedo asilo è l’unico film di Ferreri sulla salute: una calma dei percorsi laterali (asilo, periferia, vecchio cinema disattivato) che aggira e assorbe il malessere odierno, con una sorta di stupore non innocente di fronte alla impossibilità di cambiare e alla inutilità delle utopie. La salute sta in questa coscienza della negatività dell’utopia se presa alla lettera, se scambiata in un baratto totale con il reale; è salute la rinuncia al giudizio, alla parola, alle versioni aggiornate dell’ideologia, alle trovate rocambolesche di una cultura in disuso, clinica della chiacchiera. Maurizio Grande Una delle ultime inquadrature del film mette in strettissima relazione l’azione di Roberto e di Gian Luigi, un originale maestro d’asilo il primo, un bambino che si è ostinato per tutta la durata della pellicola a non mangiare e a non parlare il secondo, con la simbolica presenza di una rana dentro una vasca trasparente. Il maestro e il bambino si trovano, infatti, su una spiaggia e si apprestano ad entrare in mare, chiedendosi se veramente sia la mamma di tutti gli esseri viventi. Le due immagini esibite sono sovrapposte attraverso la trasparenza della vaschetta in cui si trova la rana. Il senso che si genera, alla luce di quanto narrato fino a quel momento, viene rafforzato ulteriormente dal pianto del bambino partorito da Isabella che si affaccia prepotentemente alla vita. Roberto e il piccolo Gian Luigi scompaiono dall’inquadratura e si eclissano nel mare, ritornando a quell’origine della vita che i condizionamenti imposti dall’educazione canonizzata, dalla società e dalle istituzioni che trattano i bambini con distacco, quasi fossero dei criminali e non delle potenziali vittime indifese, hanno reso necessaria per ricongiungersi sensibilmente con la natura e l’innocenza. Il pianto del bambino che Isabella ha partorito, suono che si sente mentre Ferreri continua a mostrare il mare al tramonto privo della presenza del maestro e di Gian Luigi, è l’emblema di un ciclo vitale in perenne movimento ed evoluzione, pronto a rinascere ogni volta dalle sue stesse ceneri mostrando apertamente il miracolo della vita che si rinnova, simbolo ribadito dalla rana originatasi da uno dei girini, l’unico sopravvissuto, che i bambini custodivano all’interno del loro asilo. Roberto incarna l’uomo lunare, colui che evita di imporre un’educazione ai bambini, scegliendo invece di proporre momenti reali di conoscenza e sperimentazione effettiva della realtà (la gita nella città industriale, l’asino lasciato alla curiosità dei pargoli per un’unione concreta delle varie componenti presenti nella natura). Perfettamente consapevole di come i bambini siano l’ultimo baluardo nei confronti di una società indifferente, alienata, ostile («Ora e sempre resistenza», gridano i piccoli a più riprese) e attenta alle apparenze (al maestro viene sconsigliato di utilizzare Luca come animatore perché troppo “differente”), Roberto si fa cantore di un ritorno alla piena spon- Chiedo asilo 9 marzo 2011 21 taneità, per un completo annichilimento dei retaggi culturali che impongono ruoli, abitudini e comportamenti innaturali, scarsamente vitalistici ed impostati. Le altre maestre della scuola materna, pienamente parte della società, vengono annullate sullo sfondo della narrazione, incapaci di carpire l’essenza gioviale dell’esistenza infantile, inabili nell’affidarsi totalmente alla vivacità e all’esuberanza della poesia, e quindi assolutamente impossibilitate ad essere assorbite in modo incondizionato dalla sostanza stessa della natura. Giampiero Frasca da www.minori.it 16 marzo 2011 Terrore alla tredicesima ora TERRORE ALLA TREDICESIMA ORA 22 Titolo originale: Dementia 13. Regia: Francis Ford Coppola. Sceneggiatura: Francis Ford Coppola e Jack Hill. Fotografia: Charles Hannawalt. Montaggio: Stuart O’Brien e Morton Tubor. Musiche: Ronald Stein. Scenografia: Al Locatelli e Eleanor Coppola. Interpreti e personaggi: William Campbell (Richard Haloran), Bart Patton (Billy Haloran), Peter Read (John Haloran), Eithne Dunne (Signora Haloran), Barbara Dowling (Kathleen Haloran), Luana Anders (Louise Haloran), Mary Mitchel (Kane), Patrick Magee (Justin Caleb), Karl Schanzer (Simon), Ron Perry (Arthur), Derry O’Donavan (Lillian). Origine: USA, 1973. Durata: 75’. I nobili Halloran si ritrovano presso la loro imponente e antica magione irlandese in memoria di Kathleen, una bambina annegata otto anni prima che però pare non aver trovato pace: infatti, bambole scomparse riemergono dal laghetto, sul fondo del quale è posta una pietra tombale. Un maniaco armato d’ascia colpisce impietosamente chi cerca di venire a capo del mistero... L’impatto col “genere” povero, Coppola lo deve alla scuola di Corman. Corman lo chiama quando ha bisogno di un aiuto che costi poco: assistente alla regia, tecnico del suono, direttore dei dialoghi, regista della seconda unità, sceneggiatore. Con questo bagaglio tecnico, Coppola realizza il suo primo film. Durante le riprese di The Young Racers, Francis è in Irlanda con la troupe di Corman (cast, maestranze e tecnici sono agli Ardmore Studios). Qui gioca la sua prima carta alta: non solo perché incontra la futura moglie Eleanor, ma perché, lancia in resta, si fa in quattro per realizzare un progetto di cui ha soltanto l’intuizione originale. Che non è poi altro se non la politica di Corman di perseverare in un prodotto di cassetta, di realizzare un film con gli scarti di un altro. Strappa così a Corman un finanziamento di 20 mila dollari, dati a condizione che il film porti un titolo commerciale e sia realizzato rapidamente. Francis scrive la sceneggiatura in tre giorni e mezzo. Gli attori saranno gli stessi del film di Corman, Luana Andrews e Patrick Magee. Nel frattempo, l’abilissimo giovane cineasta riesce a vendere a un produttore inglese (Raymond Stross) che abita a Dublino i diritti della distribuzione del film in Inghilterra: sono altri 20 mila dollari, che raddoppiano il budget del film. Dementia 13 ora si può fare. Il ventiduenne regista può affrontare la sua prova impegnativa anche se i modi sono ancora quelli dello studente entusiasta: gli amici arrivano dall’America a spese proprie per dare una mano. Il risultato finale è il film più divertente che Coppola abbia mai fatto, secondo quanto il regista confessa, ma certamente non un capolavoro. In Terrore alla tredicesima ora ci sono tutti gli elementi del genere tradizionale, stavol- ta l’horror. C’è il castello dal gusto gotico, i sanguinolenti omicidi, le bambole, la figura di cera (un topos classico del film dell’orrore) e tombe sospette, chiari di luna paurosi, acque torbide. C’è però, tra le righe, anche una dose di ironia. Il regista si muove a suo agio tra gli stereotipi del “gotico” sfruttando con abilità e immaginazione gli spazi che il genere gli concede; poi però ammicca, attraverso quell’iperrealismo, quella poetica dell’“eccesso” che gli sarà sempre più cara. Nel divertissement di Coppola ci sono anche alcuni spunti seri: la patologia dello psicopatico che uccide per un trauma infantile, un luogo classico dell’orrore, riletto però con le possibili interpretazioni colte (di tipo psicoanalitico) dei film di Hitchcock come Psycho. E ancora: la patologia della “normale” Louise (contrapposta al “diverso” Bill) nevrotico prodotto della società, disumanizzata dalle logiche del denaro e della proprietà, sino a snaturare gli affetti basilari; e la patologia, in generale, di questa simbolica famiglia di matti, dove esplodono – innescati dai due motivi-motore della morte (e della memoria della morte) e dell’eredità – delle violenze latenti, gli umori clandestini del clan divorato dall’odio e dal sospetto reciproco. Non si deve pretendere, evidentemente, di leggere Terrore alla tredicesima ora con il senno di poi, e attribuirgli meriti di precocità che il film non ha e non vuole avere: Terrore alla tredicesima ora è un ottimo compito in classe dell’allievo di Corman, fatto con pochi soldi (è quello che più conta), con buoni ingredienti e con una relativa dose di autonomia creativa. Il risultato è la confezione di un macabro genuino e un uso maturo dello spazio tecnico, della macchina da presa e dei ritmi del montaggio. Ciò non toglie, però, che si possa vedere in questo film quell’esigenza di espressione del “personale” che prenderà corpo col prodotto successivo. Salta agli occhi, su tutto, la continuità tra la follia della famiglia (dichiaratamente “anormale”) degli Haloran, e quella della famiglia (apparentemente “sana”) Chanticleer, i genitori (e il cane) di Bernard in Buttati Bernardo. Normalità e follia, nelle famiglie e nella società, sono difficili da Scheda di VITO ZAGARRIO distinguere, pare suggerire Coppola, con alla mano Laing e Cooper; e nel mettere in scena due famiglie “classiche”, la famiglia convenzionale della letteratura gotica e quella “media” della società americana negli anni Sessanta, si affranca anche dai suoi personali retaggi familiari, supera le dipendenze edipiche dai personaggi scomodi della sua famiglia. da Francis Ford Coppola, Editrice Il Castoro, Milano 1995 Terrore alla tredicesima ora 16 marzo 2011 23 FRATelli 23 marzo 2011 fratelli Titolo originale: The Funeral. Regia: Abel Ferrara. Soggetto e sceneggiatura: Nicholas St. John. Fotografia: Ken Kelsch. Montaggio: Mayin Lo. Musiche: Joe Delia. Interpreti e personaggi: Christopher Walken (Ray Tempio), Chris Penn (Chez Tempio), Annabella Sciorra (Jeannette), Isabella Rossellini (Clara Tempio), Vincent Gallo (Johnny Tempio), Benicio Del Toro (Gaspare), Gretchen Mol (Helen), Frank John Hughes (Bacco). Origine: USA, 1996. Durata: 99’. 24 I fratelli Ray e Chez Tempio, gangster nella mala di New York negli anni ‘30, si trovano con le loro famiglie per il funerale del loro terzo fratello Johnny, che si crede assassinato dal loro rivale Gaspare. Il funerale è l’occasione per ripercorrere la storia della loro famiglia e per fare un bilancio della loro vita di crimini e sangue. Ray è determinato a cercare la vendetta ad ogni costo, nonostante l’avvertimento di sua moglie Jeanette secondo la quale la violenza scatena solo altra violenza, mentre Chez comincia a perdere il suo flebile legame con la realtà, facendone subire le dirette conseguenze a sua moglie Clara. Il percorso di redenzione porterà ad un drammatico finale. Coppa Volpi a Venezia per Chris Penn. Duro come sempre, Ferrara, cupo e senza speranza. C’è il consueto, terribile rapporto con la religione cattolica: il crocefisso è presente quasi in ogni inquadratura, ma non è mai, nemmeno per un attimo, liberatorio. Al contrario schiaccia i protagonisti in una dimensione di colpe e paure, in un’angoscia esistenziale che trascende la loro condizione di gangster, di marginali della società. Veri vincitori, ancora una volta, sono il Male, l’impossibilità di vivere, amare, rapportarsi con gli altri Tre colpi di pistola, fulminei. Poi un quarto, esploso in bocca. Così Chez spezza il cerchio che l’ha tenuto prigioniero insieme con Ray, Johnny e le loro donne, e che prima ancora ha costretto nella propria chiusura il padre e certamente anche il padre del padre. Ora, finalmente, il sangue che gli copre il viso sembra placare quello che i Tempio hanno sparso, e anche quello che dei Tempio è stato sparso, in una specularità mimetica mai terminabile: sangue per sangue per sangue per sangue... Fratelli è colmo di riferimenti a una colpa pesante, funerea e buia, legata al senso cattolico dei peccato. Eppure, la sua grandezza – perché, con ogni probabilità, di grandezza si tratta – sta altrove: in un’atmosfera, che sembra precristiana, di necessità insuperabile. I fratelli Tempio non pagano per le azioni che hanno compiuto. O meglio: non pagano perché le hanno compiute. Né, del resto, è loro concesso di riscattare la loro condizione con altre e diverse azioni. Come capita agli eroi tragici, possono opporre alla necessità niente più che il coraggio impotente della consapevolezza. In ogni caso, per quanto facciano e dicano, sanno che l’unica libertà che loro appartenga consiste nel cercare di mantenersi all’altezza del fato. Naturalmente, c’è molto altro in Fratelli. C’è storia e c’è sociologia. C’è l’America dell’alleanza fra politica e mafia. C’è il sindacalismo gangsteristico che fu anche di Jimmy Hoffa. C’è la memoria dell’immigrazione, forte e ricca come in tutti i grandi autori italoamericani: Francis Ford Coppoia, Michael Cimino, Martin Scorsese. Venendo nel nuovo mondo dal vecchio, centinaia di migliaia tra uomini e donne rimasero per così dire a metà strada, incapaci di mettere radici in America e ormai privi della forza vitale di quelle lasciate in Europa, in Italia, in Sicilia... E ci sono, ancora, un cattolicesimo inquieto e un desiderio reso funereo dall’ossessione del peccato. Sentimenti e angosce che, certo, si trovano anche nei film precedenti, da L’angelo della vendetta (1981) a Il cattivo tenente (1991) e Occhi di serpente (1993). Ma in quelli religiosità, sesso e colpa erano come infilati e tenuti a forza in un cinema scomposto e urlato, quasi che il regista temesse di non poter mostrare altrimenti la sua misura d’autore. Qui invece tutto è distanziato e reso “classico” da un dominio pacificato del racconto. Insomma, non atteggiandosi più ad autore, Ferrara si porta a compimento come autore, e anzi (fino a prova contraria) come grande autore. Ma la cosa che più sorprende in Fratelli non è nemmeno questa capacità di Ferrara di prendere congedo dai suoi antichi furori espressivi. La cosa che più sorprende è semmai quel che ce ne resta in mente. Ripensando a Ray, Chez e Johnny, ci scopriamo a non vederli come la vicenda in se stessa li vorrebbe: uomini senza più radici, gangster violenti, mafiosi cinici. Tutto infatti sfuma, si perde sullo sfondo. Johnny è, o immagina d’essere, comunista e rivoluzionario. Chez è, o immagina d’essere, un sensato uomo d’affari. Ray è, o immagina d’essere, il custode d’una memoria atavica crudele e realistica, fissata in lui dall’omicidio cui, appena ragazzo, lo costrinse il padre. Tutti e tre stanno in questi ruoli come prigionieri in attesa d’una liberazione in cui, tuttavia, non sperano. Anche il film sta in una prigione, e senza vie di fuga che non siano i flashback, memorie “chiamate” da una situazione narrativa che, per altro, resta immobile e chiusa. Ferrara lo tiene quasi tutto dentro il nero d’una sola notte, per lo più in interni cupi, oppressivi. Solo ai volti – soprattutto a quello di Ray e a quello di Johnny, nella bara – è concesso di conquistarsi un po’ Scheda di ROBERTO ESCOBAR FRATELLI 23 marzo 2011 25 di luce, di uscire dal nero, in primo piano. E con i volti, appunto, in primo piano emerge il tragico in senso forte. Ossia: la coscienza dolorosa d’una illibertà totale, d’un male e d’un bene di cui neppure Dio, e anzi – come vien voglia di scrivere – di cui neppure gli dèi riescono a dar conto. Qualunque cosa abbiano fatto, qualunque cosa facciano questa notte, i fratelli Tempio pagano una colpa che non è la loro, e che si può esprimere come trionfo “cosmico” della morte. L’inferno ci attende, dice Ray all’assassino di Johnny, pochi istanti prima di sparargli: dunque, conclude, conviene abituarcisi subito, adesso. Oppure, direbbe Chez, si può anticipare l’inferno, si può eludere la circolarità interminabile della morte scegliendo la morte. Fratelli, dunque, finisce con quattro colpi di pistola, da lungo attesi eppure tanto immediati da essere ancor più sconcertanti che drammatici. Una conclusione, questa, che forse sarebbe piaciuta al pubblico che, sin dalle prime luci dell’alba, gremiva i teatri nelle pòleis greche, attendendo di vedere e sentire una volta di più gli eroi tragici del mito vivere e morire pagando la colpa d’esser nati. da “Il Sole 24 Ore” Il Castoro, Milano 1995 26 distretto 13. le brigate della morte Titolo originale: Assault on Precinct 13. Regia, soggetto e sceneggiatura: John Carpenter. Fotografia: Douglas Knapp. Montaggio: John T. Chance. Effetti speciali: Richard Albain, Ken Speed. Musiche: John Carpenter. Scenografia: Tommy Wallace. Trucco: Don Bledsoe. Interpreti e personaggi: Austin Stoker (Ethan Bishop), Darwin Joston (Napoleone Wilson), Laurie Zimmer (Leigh), Martin West (Lawson), Tony Burton (Wells), Charles Cyphers (Starker), Nancy Kyes (Julie), Peter Bruni (gelataio), Henry Brandon (agente Chaney), Kim Richards (Kathy), John J. Fox (Warden). Origine: USA, 1976. Durata: 91’. Quasi in “tempo reale” (dal tramonto alla sera) assistiamo all’agguato teso da una banda di teppisti assassini e fanatici ad un isolato commissariato di polizia, alla periferia di Los Angeles. Dentro ci sono una tenente di colore, due funzionari, tre malviventi in guardina, tra i quali un condannato a morte, e un “pacifico” signore al quale i teppisti hanno fatto fuori una figlia a sangue freddo e lui si è vendicato uccidendo uno di loro. Sia gli assediati che gli assedianti assottigliano le rispettive file nel corso di assalti violentissimi e sanguinosi, che verranno poi risolti grazie all’intervento, che pareva sempre più improbabile, di una forza esterna. Con la sua pellicola di esordio datata 1976 (il lungometraggio Dark Star è da considerarsi come l’ampliamento del saggio di fine corso della Scuola di Cinema) Carpenter viene immediatamente conosciuto e riconosciuto come uno dei nuovi nomi che si impongono nel panorama cinematografico internazionale. Tesissimo, ritmato, ironico, evocativo, angoscioso e violento (la crudele e secca uccisione della bambina in una scena che incontrerà grossi problemi con la censura americana è quanto mai dura perché filmata con occhio impietoso), Distretto 13 offrirà al suo stesso autore, e non solo, un modello eccellente e ben collaudato di cinema che riesce a fondere insieme vari generi incorporandoli in uno schema semplice ma d’indubbia efficacia. Un fatiscente distretto che sta per essere abbandonato deve resistere ad un ultimo assalto che durerà tutta una notte; un tenente e due giovani segretarie dovranno divenire eroi loro malgrado alleandosi con dei detenuti per resistere alla carica di una micidiale banda metropolitana da cui vengono assediati. Fuori la squallida e assolata periferia di Los Angeles popolata da uomini insensatamente violenti; un inferno dove anche fermarsi a mangiare un gelato può diventare un gesto mortale… Il tutto cadenzato da una musica tribale e metropolitana al tempo stesso, di cui è autore lo stesso regista. «Non c’è azione che quando c’è pericolo. Vivere o morire è il nostro più grande dramma» (Howard Hawks). Un assedio, dunque. Un assalto violento dal “di fuori” che tende a minare “un dentro” costretto a reagire in modo ancor più violento per difendersi. Un western metropolitano evidente e dichiarato che non trattiene Carpenter dal pa- lesare un rapporto di continuità e di filiazione con un grande del passato: Howard Hawks. È il genere western, infatti, che si ritrova travestito in molti dei suoi film, dai primi fino a Vampires; un genere tanto amato ma che non è mai riuscito a concretizzarsi direttamente in un progetto filmico. Usando lo pseudonimo di John T. Chance per firmare il montaggio (nome del personaggio interpretato da John Wayne per il quale Carpenter aveva scritto la sceneggiatura di El Diablo, progetto poi non realizzato a causa della morte dell’attore), Carpenter fa del suo Distretto 13 una rivisitazione moderna di Un dollaro d’onore (Rio Bravo, 1959), esaltando il pericolo con la suggestione di un ritmo frenetico proprio come accadeva nell’originale di Hawks, il quale riusciva a dominare la macchina da presa forzandola in nuovi e audaci punti di vista. Ma anche le tematiche care al vecchio regista vengono riprese e ricontestualizzate da Carpenter: uno spaccato di vita duro ed esaltante, le dinamiche che si scatenano all’interno di un gruppo nei momenti di massima tensione e una particolare intesa virile. «Mi sono identificato con il lato oscuro del male». Carpenter racconta di essere cresciuto nella parte meridionale del paese denominata “Cintura della Bibbia” in cui i suoi famigliari, di inclinazione democratica e di ideali rivoluzionari, erano considerati da tutti outsider. Incredibili pregiudizi e un odio tipico delle terre di confine facevano sentire il giovane John assediato, attaccato dalla violenza degli altri, che lo obbligavano a cercare rifugio nel suo chalet famigliare. Maturando questa esperienza infantile, l’assedio si configurerà come una tematica fondamentale nella sua poetica. In tutte le sue pellicole il Male che sopraggiunge dall’esterno assume il valore metaforico di un incubo insensato e angoscioso perché di origine sconosciuta, dove la visione del regista finisce per essere sempre un’analisi sul mistero dello sguardo e un’apertura sull’invisibile. Da La Cosa, dove il male è un’entità orribile che s’incarna e s’impossessa del corpo umano, fino a Il signore del male, pellicola apocalittica e metafisica che suggerisce l’unicità di Dio e del diavolo, Carpenter fa del genere horror un portavoce dell’angoscia umana consapevole del grande valore catartico della paura; valore attinto dalla letteratura, altra sua grande passione giovanile. In particolare forte è il legame che lo unisce Scheda di GIORGIA BERNONI allo scrittore gotico H.P. Lovercraft che viene direttamente omaggiato nel bellissimo Il seme della follia. Fedele alla sua indipendenza di spirito anche quando lavora nella grande produzione hollywoodiana (1997: fuga da New York, Starman, Grosso guaio a Chinatown), Carpenter non ha mai smesso di prendere sul serio i generi del fantastico attraverso il suo pudore e la sua sensibilità morale; reinventando il cinema dell’orrore come genere moderno, come spazio di libertà, di riflessione, e soprattutto di sperimentazione. da www.zabriskiepoint.net Distretto 13. Le brigate della morte 30 marzo 2011 30 marzo 2011 Distretto 13. Le brigate della morte 27 i registi Michael Mann Jacques Demi Nato a Chicago (IL) nel 1943, si trasferisce da giovane in Inghilterra per frequentare la London’s International Film School di Londra. Terminati gli studi torna negli Stati Uniti ed inizia a dirigere alcuni documentari e cortometraggi di sfondo sociale, curando poi la sceneggiatura di alcuni episodi di serie televisive di genere poliziesco, tra le quali Starsky e Hutch. Nel 1983 gira il suo unico semi-horror, La Fortezza, tratto da un romanzo di F. Paul Wilson, nel quale agiscono forze misteriose in una fortezza nazista. Successivamente è il turno di Manhunter – Frammenti di un omicidio, film che segna la nascita cinematografica del personaggio di Hannibal Lecter, lo psicologo-cannibale, interpretato da Brian Cox. Nel contempo Mann crea e produce Miami Vice (1984-1989), serie televisiva di grandissimo successo, e scrive e dirige il film per la televisione Sei solo, agente Vincent (1989), che porterà poi al cinema, con alcune modifiche, col titolo di Heat – La sfida sei anni dopo, nel 1995. Il film è un noir metropolitano pieno di incroci fra storie e attori come Val Kilmer, Jon Voight, Ashley Judd ed una giovanissima Natalie Portman, oltre ai due protagonisti, per la prima volta contemporaneamente sulla scena, Robert De Niro ed Al Pacino. I due si erano già trovati insieme sul set ne Il padrino di Francis Ford Coppola, ma non avevano girato insieme neppure una ripresa. Filmografia: Jaunpuri (1971), corto; 17 Days Down the Line (1972), corto; La corsa di Jericho (The Jericho Mile) (1979), Film TV; Strade violente (Thief) (1981); La fortezza (The Keep) (1983); Manhunter – Frammenti di un omicidio (Manhunter) (1986); Sei solo, agente Vincent (L.A. Takedown) (1989), Film TV; L’ultimo dei Mohicani (The Last of the Mohicans) (1992); Heat – La sfida (Heat) (1995); Insider – Dietro la verità (The Insider) (1999); Alì (2001); Collateral (2004); Miami Vice (2006); Nemico pubblico – Public Enemies (Public Enemies) (2009). Pontchâteau 5 Giugno 1931 - Parigi, 27 Ottobre 1990. Dopo aver frequentato l’Accademia di belle arti, compie i primi passi come aiutoregista di documentari, girando contemporaneamente alcuni cortometraggi a soggetto in cui mostra, al tempo stesso, la sua prossimità e la sua distanza dalle atmosfere e dai modi della Nouvelle Vague, da un lato rifiutando la cosiddetta sceneggiatura «di ferro», dall’altro lasciando trasparire una passione non puramente filologica per il grande cinema americano. Filmografia: Le sabotier du Val de Loire (1956), documentario; Le bel indifférent (1957), corto; Musée Grévin (1958), corto; La mère et l’enfant (1959), corto; Ars (1959), corto; Donna di vita (Lola) (1961); I sette peccati capitali (segmento “La Luxure”) (1962); La grande peccatrice (La baie des ange) (1963); Les parapluies de Cherbourg (1964); Josephine (1967); L’amante perduta (Model Shop) (1969); La favolosa storia di pelle d’asino (Peau d’âne) (1970); Il pifferaio di Hamelin (The Pied Piper) (1972); Niente di grave, suo marito è incinto (L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune) (1973); Lady Oscar (1979); La naissance du jour (1980), Film TV; Una camera in città (Une chambre en ville) (1982); Louisiana (1984), Film TV; Parking (1985); Trois places pour le 26 (1988). Michael Mann The jericho mile 12|01 Jacques Demy les parapluies de cherbourg 19|01 J o h n W oo T h e K ILLER 26|01 J e a n E u st a c h e la maman et la putain 02|02 J o h n C a ss a v e t e s UNA MOGLIE 09|02 B i ll y W i l d e r NON PER SOLDI . . . MA PER DENARO 16|02 David Lynch ERASERHE a d . l a m e n t e che cancella 23|02 P e d r o Almo d ó v a r pepi, luci, bom e le altre ragazze del mucchio 02|03 Marco Ferreri chiedo asilo 09|03 F r a n c i s Fo r d Co p p ol a terrore alla tredicesima ora 16|03 Ab e l F e r r a r a fratelli 23|03 John Carpenter d i s t r e tt o 1 3 . l e b r i g a t e della morte 30|03 28 John Woo Nasce a Canton nel 1946. La sua famiglia si trasferisce nei primi anni cinquanta ad Hong Kong. Nel 1969 viene assunto come supervisore di sceneggiatura al Cathay Film Studio e due anni più tardi come aiuto-regista per la Shaw Brothers, casa di produzione specia- lizzata in film di arti marziali. Il suo periodo hongkonghese è contrassegnato dall’utilizzo frequente del suo attore feticcio Chow Yun-Fat. Alla 67ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia gli è stato assegnato il Leone d’Oro alla carriera. Filmografia hongkonghese: Fist to Fist (Chu ba) (1973); Ninja Kids (Tie han rou qing) (1974); Princess Chang Ping (Dinü hua) (1975); The Dragon Tamers (Nu zi tai quan qun ying hui) (1975); Hand of Death (Shaolin Men) (1976); Money Crazy (Fa qian han) (1977); The Brave Lion (1977); Hello, Late Homecomers (Ha luo, ye gui ren) (1978); Follow the Star (Da sha xing yu xiao mei tou) (1979); Last Hurrah for Chivalry (Hao xia) (1979); From Riches to Rags (Qian zuo guai) (1980); To Hell with the Devil (Mo deng tian shi) (1981); Laughing Times (Hua ji shi dai) (1981); Lam Au Chun No. 3 (Ba cai Lin Ya Zhen) (1982); The Time You Need a Friend (Xiao jiang) (1984); Run Tiger Run (Liang zhi lao hu) (1985); Heroes Shed No Tears (Ying xiong wei lei) (1986); A Better Tomorrow (Ying huang boon sik) (1986); A Better Tomorrow II (Ying huang boon sik II) (1987); The Killer (Die xue shuang xiong) (1989); Tragic Heroes (Yi dan qun ying) (1989); Bullet in the Head (Die xue jie tou) (1990); Once a Thief (Zong heng si hai) (1991); Hard Boiled (Lashou shentan) (1992). Filmografia hollywoodiana: Senza tregua (Hard Target) (1993); Nome in codice: Broken Arrow (Broken Arrow) (1996); Soluzione estrema (Once a Thief) (1996); Face/Off – Due facce di un assassino (Face/ Off) (1997); Blackjack (1998); Mission: Impossible II (2000); Windtalkers (2002); Hostage (2002), corto; Paycheck (2003); Song Song and Little Cat, episodio di All the Invisible Children (2005); La battaglia dei tre regni (Chi bi) (2009). Jean Eustache Pessac, 30 novembre 1938 - Paris, 3 novembre 1981. Poco si sa della sua vita, in particolare del periodo precedente al suo arrivo a Parigi e all’avvio della carriera registica. Si pensa che ciò fosse dovuto ad un’infanzia scarsamente felice (elemento che lo accomunerebbe all’amico François Truffaut). Verso la fine degli anni cinquanta si trasferì nella ca- pitale francese, ove entrò nel circolo dei critici dei “Cahiers du cinéma“ (senza però diventare mai un critico) stringendo amicizia con Truffaut ed Éric Rohmer. Successivamente intraprese la carriera registica fiancheggiando la Nouvelle Vague più che farne pienamente parte. Si uccise dopo essere stato immobilizzato per mesi in seguito ad un incidente automobilistico. Filmografia: La soirée (1961), incompiuto; Les Mauvaises Fréquentations (1963), 42 min. (primo titolo, film in 16mm), conosciuto anche come Du côté de Robinson (secondo titolo, film gonfiato a 35mm); Le Père Noël a les yeux bleus (1966), 47 min.; La Rosière de Pessac (1968), 65 min.; Sur Le Dernier des hommes di Murnau (1969), Film TV, 26 min.; A propos de La petite marchande d’allumettes di Jean Renoir (1969), Film TV, 26 min.; Le Cochon (1970), 65 min., co-realizzato con JeanMichel Barjol; Numéro zéro (1971), 1h50m (versione televisiva accorciata intitolata Odette Robert, 54 min.); La Maman et la Putain (1973); Mes petites amoureuses (1974); Une sale histoire (1977), parte documentario (22 min.) e parte fiction (28 min.); La Rosière de Pessac (1979), 67 min.; Le Jardin des délices de Jérôme Bosch (1980), 34 min.; Offre d’emploi (1980), 18 min.; Les Photos d’Alix (1980), 18 min. John Cassavetes New York, 9 dicembre 1929 - Los Angeles, 3 febbraio 1989. Attivo nel campo cinematografico, teatrale e televisivo, è stato uno dei primi registi indipendenti. Fin dall’inizio affiancò alla recitazione la ricerca narrativa come regista di film indipendenti; fu epigono e al tempo stesso migliore esponente della corrente della “Scuola di New York” che assunse come criteri stilistici e contenutistici il realismo, il documentarismo, l’improvvisazione, la povertà di mezzi produttivi, con richiami a volte espliciti alla “poetica del pedinamento” di Cesare Zavattini. Il suo stile di regia è noto per l’improvvisazione degli attori e per la sua capacità di narrare storie realistiche. Il suo è stato un cinema “familiare” (nei suoi film hanno recitato amici come Seymour Cassel, Ben Gazzara e Peter Falk, la moglie Gena Rowlands, la madre, la suocera e i figli) che ha raccontato storie di coppie in crisi o di problemi della vita metropolitana. È stato sposato con l’attrice Gena Rowlands, dalla quale ha avuto tre figli. Uno di essi, Nick, è oggi un regista. Filmografia: Ombre (Shadows) (1959-1960); Blues di mezzanotte (Too Late Blues) (1961); Gli esclusi (A Child is Waiting) (1963); Volti (Faces) (1968); Mariti (Husbands) (1970); Minnie e Moskowitz (Minnie and Moskowitz) (1972); Una moglie (A Woman Under the Influence) (1975); L’assassinio di un allibratore cinese (The Killing of a Chinese Bookie) (1976); La sera della prima (Opening Night) (1977); Gloria – Una notte d’estate (Gloria) (1980); Love Streams – Scia d’amore (Love Streams) (1983); Il grande imbroglio (Big Trouble) (1985). Billy Wilder Sucha, 26 giugno 1906 – Los Angeles, 27 marzo 2002. Nato in una città della Galizia situata nell’attuale Polonia, ma all’epoca parte dell’Impero Austro-Ungarico, da una famiglia abbastanza agiata, dopo gli studi a Vienna in giurisprudenza negli anni Venti, durante i quali fa il giornalista sportivo per “Die Stunde”, si trasferisce a Berlino, dove lavora come giornalista di cronaca per e comincia a interessarsi di cinema, all’inizio soprattutto in qualità di sceneggiatore. Mentre fa anche il ballerino in prestito per sbarcare il lunario, a Berlino partecipa anche alla lavorazione di Menschen am Sonntag, un film quasi documentario di Robert Siodmak, Fred Zinnemann e altri. Per Siodmak scrisse ancora L’uomo che cerca il suo assassino (1930), ma lavorò anche con altri registi, come Hanns Schwarz, Gerhard Lamprecht, Paul Martin, Hans Steinhoff ecc. Quando Adolf Hitler nel 1933 prende il potere, Wilder, che era ebreo, decide di espatriare, prima a Parigi e poi negli Stati Uniti. Sua madre, il patrigno e la nonna morirono nel campo di sterminio di Auschwitz. In Francia, prima del salto oltre oceano, gira il suo primo film da regista (insieme a Alexander Esway), Mauvaise graine (Amore che redime, 1933), di scarso successo. Grazie I REGISTI 29 30 al supporto di altri emigrati di origine ebraicotedesca (fra i quali l’attore Peter Lorre, i registi Ernst Lubitsch, William Dieterle, Wilhelm Thiele e Joe May), negli USA Wilder prosegue la sua attività di sceneggiatore, riscuotendo significativi successi e ottenendo nel 1939 la prima nomination al Premio Oscar per il film Ninotchka, interpretato da Greta Garbo. Tra le collaborazioni vanno ricordate anche quelle con Raoul Walsh, Edward Ludwig, Mitchell Leisen, Theodore Reed, Howard Hawks (per Colpo di fulmine), Victor Schertzinger (per Rhythm on the River, con Bing Crosby) e alti registi, ma soprattutto con lo sceneggiatore Charles Brackett con il quale collaborerà per anni anche da regista. Se già dal 1934 aveva quindi debuttato come regista in Francia, è di fatto solo nel 1942 che riesce a girare il suo primo vero film, quel Frutto proibito interpretato da Ginger Rogers e Ray Milland che, a forza di equivoci e travestimenti da commedia, segnerà uno stile di racconto che si farà per lui consueto e magistrale. Nello stesso anno ottiene altre due nomination all’Oscar per la sceneggiatura dei film Venere e il professore e La porta d’oro. A trentasei anni, Wilder è consacrato come uno dei più dotati ed eclettici scrittori di Hollywood. Filmografia: Amore che redime (Mauvaise graine), in co-regia con Alexander Esway (1934); Frutto proibito (The Major and the Minor) (1942); I cinque segreti del deserto (Five Graves to Cairo) (1943); La fiamma del peccato (Double Indemnity) (1944); Death Mills, cortometraggio documentaristico (1945); Giorni perduti (The Lost Weekend) (1945); Il valzer dell’imperatore (The Emperor Waltz) (1948); Scandalo internazionale (A Foreign Affair) (1948); Viale del tramonto (Sunset Boulevard) (1950); L’asso nella manica (Ace in the Hole) (1951); L’inferno dei vivi (Stalag 17) (1953); Sabrina (1954); Quando la moglie è in vacanza (The Seven Year Itch) (1955); L’aquila solitaria (The Spirit of St. Louis) (1957); Arianna (Love in the Afternoon) (1957); Testimone d’accusa (Witness for the Prosecution) (1957); A qualcuno piace caldo (Some Like It Hot) (1959); L’appartamento (The Apartment) (1960); Uno, due, tre! (One, Two, Three) (1961); Irma la dolce (Irma La Douce) (1963); Baciami, stupido (Kiss Me, Stupid) (1964); Non per soldi... ma per denaro (The Fortune Cookie) (1966); Vita privata di Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes) (1970); Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (Avanti!) (1972); Prima pagina (The Front Page) (1974); Fedora (1978); Buddy Buddy (1981). David Lynch Missoula, 20 gennaio 1946. Durante la sua lunga carriera, Lynch ha sviluppato un nuovo stile narrativo e visivo, che ha reso i suoi film riconoscibili al pubblico di tutto il mondo per la loro forte componente surrealista, le loro sequenze angosciose e oniriche, le immagini crude e strane, e il sonoro estremamente suggestivo. Spesso i suoi lavori esplorano il lato oscuro delle piccole città americane, (la serie televisiva Twin Peaks) e delle metropoli caotiche. Ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera durante la 63ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 6 settembre 2006. Filmografia – Lungometraggi: Eraserhead – La mente che cancella (1977); The Elephant Man (1980); Dune (1984); Velluto blu (Blue Velvet) (1986); Cuore selvaggio (Wild at Heart) (1990); Fuoco cammina con me (Twin Peaks: Fire Walk with Me) (1992); Strade perdute (Lost Highway) (1997); Una storia vera (The Straight Story) (1999); Mulholland Drive (2001); Inland Empire – L’impero della mente (2006). Cortometraggi: i cortometraggi raccolti in The Short Films of David Lynch: Six Figures Getting Sick (1966); The Alphabet (1968); The Grandmother (1970); The Amputee (1974); The Cowboy and the Frenchman (1988), episodio della serie Les Français vu par...; Lumière: Premonitions Following an Evil Deed (1996), episodio di Lumière et compagnie; I cortometraggi raccolti in The lime green set: Absurd encounter with fear (1967); Fictitious anacin commercial (1967); Altro: Ballerina (2006); Scissors (2007), Quinoa (2007); Lady Blue Shanghai (2010), corto promozionale per Dior. Lavori per la TV: I segreti di Twin Peaks (Twin Peaks) (1990-1991), pilota ed episodi 1.00, 1.03, 2.01, 2.02, 2.07 e 2.22; American Chronicles (1990), serie di documentari TV; On the Air (1992), serie TV; Hotel Room (1993), film TV in tre episodi, di cui due diretti da Lynch. Cortometraggi su DavidLynch.com: Head with hammer (2001); Pierre and Sonny Jim (2001); Cannes diary (2002); Does that hurt you? (2002); Where are the bananas? (2002); Darkened room (2002); Industrial soundscape (2002); The pig walks (2002); The disc of sorrow is installed (2002); Dead mouse with ants (2002); Bug crawls (2004); Wow wow (2004); The green room in lodz (2006); Boat (2007); Serie su DavidLynch.com: Out yonder (2001), episodi: Neighbor Boy, Teeth, Chicken; Axxon N. (2002), 9 cortometraggi; Rabbits (2002), 8 cortometraggi; Dumbland (2002), 8 cortometraggi d’animazione; Bees (2002), 4 cortometraggi; Coyote (2002), 2 cortometraggi; Water circus (2002), 3 cortometraggi; Lamp (2003), 6 cortometraggi; Agave (2003), 5 cortometraggi; Intervalometer experiment (2007), episodi: Sunset #1, Step, Interior Dinning Room. del mio segreto (La flor de mi secreto) (1995); Carne tremula (Carne trémula) (1997); Tutto su mia madre (Todo sobre mi madre) (1999); Parla con lei (Hable con ella) (2002); La mala educación (2004); Volver (2006); Gli abbracci spezzati (Los abrazos rotos) (2009). Marco Ferreri Pedro Almodóvar Calzada de Calatrava, 24 settembre 1949. Emigrato in Estremadura all’età di 9 anni, ha studiato presso i frati Francescani e Salesiani. A sedici anni si trasferì a Madrid per studiare alla scuola nazionale di cinema. Tale esperienza, però, gli sarà preclusa dalla chiusura della scuola, voluta dal dittatore Francisco Franco. Lavorò per dodici anni nella Compagnia Telefonica Nazionale Spagnola e contemporaneamente si interessava di cinema e di teatro d’avanguardia ed era membro del gruppo teatrale Los Goliardos. I suoi primi cortometraggi risalgono al 1972; successivamente divenne uno dei protagonisti della movida madrileña. Nel 1985 fondò con il fratello Agustín la società di produzione El Deseo, che produsse i suoi primi film e finanziò l’opera di altri registi spagnoli; allo stesso tempo fondò con l’amico McNamara un gruppo musicale. Nel 1989 ha vinto il Nastro d’Argento ed il David di Donatello come miglior regista; nel 1999 ottenne il premio per la migliore regia al Festival di Cannes per Tutto su mia madre, vincitore, nel 2000, anche dell’Oscar come miglior film straniero. Nel 2003 ha ottenuto un altro Oscar per la sceneggiatura originale di Parla con lei. Filmografia: Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón) (1980); Labirinto di passioni (Laberinto de pasiones) (1982); L’indiscreto fascino del peccato (Entre tinieblas) (1983); Che ho fatto io per meritare questo? (¿Qué he hecho yo para merecer esto?) (1984); Matador (1986); La legge del desiderio (La ley del deseo) (1987); Donne sull’orlo di una crisi di nervi (Mujeres al borde de un ataque de nervios) (1988); Légami! (¡Átame!) (1989); Tacchi a spillo (Tacones lejanos) (1991); Kika – Un corpo in prestito (Kika) (1993); Il fiore Milano, 11 maggio 1928 - Parigi, 9 maggio 1997. Dopo aver condotto studi regolari a Milano s’iscrive alla facoltà di Veterinaria senza raggiungere la laurea. Nel 1951 fonda insieme a Riccardo Ghione la rivista “Documento mensile” che fallisce dopo appena due mesi. Dopo aver fatto la comparsa nei film di Alberto Lattuada Il cappotto (1952) e La spiaggia (1953), Ferreri viaggia tra Italia, Francia e Spagna come pubblicitario. Nel 1958 a Barcellona incontra Rafael Azcona e i due dirigono il film El pisito (1958) a cui seguono Los chicos (1959) e El cochecito (1960). Il discreto successo di questa triade spagnola consente a Ferreri e Azcona di tornare in Italia. In patria Ferreri dirige due degli undici episodi di Le italiane e l’amore (1961) scritti da Azcona che divenne il suo sceneggiatore. Filmografia: Los chicos (1959); L’appartamentino (El pisito) (1959); La carrozzella (El cochecito) (1960); Le italiane e l’amore, episodio L’infedeltà coniugale (1961); Una storia moderna (1963); Controsesso, episodio Il professore (1964); La donna scimmia (1964); Oggi, domani e dopodomani, episodio L’uomo dei 5 palloni (1965); Marcia nuziale (1965); Corrida! (1966), documentario; L’harem (1967); Dillinger è morto (1969); Il seme dell’uomo (1969); Perché pagare per essere felici (1971), documentario; L’udienza (1971); La cagna (1972); La grande abbuffata (1973); Non toccare la donna bianca (1974); L’ultima donna (1976); Yerma (1978), Film TV; Ciao maschio (1978); Chiedo asilo (1979); Storie di ordinaria follia (1981); Storia di Piera (1983); Il futuro è donna (1984); I Love You (1986); Come sono buoni i bianchi (1988); Il banchetto di Platone (1989), Film TV; La casa del sorriso (1991); La carne (1991); Diario di un vizio (1993); Nitrato d’argento (1996). Francis Ford Coppola Detroit, 7 aprile 1939. Nasce da una famiglia di origine lucana. Suo padre Carmine era un noto musicista jazz; sua madre, Italia Pennino, era figlia del proprietario di una sala cinematografica a Brooklyn. Suo fratello August, professore di letteratura, è il padre di Nicolas Cage, mentre sua sorella è l’attrice Talia Shire. L’infanzia di Francis fu segnata dalla poliomielite, che lo costrinse in casa per lunghi periodi, durante i quali sviluppò la passione per i teatrini di marionette e realizzò, a partire dall’età di 10 anni, i primi film amatoriali con la cinepresa da 8mm di suo padre. Verso la fine degli anni sessanta, iniziò la sua carriera professionistica realizzando film a basso costo con Roger Corman e iniziò a scrivere sceneggiature. Nel 1971 vinse il Premio Oscar per la sua sceneggiatura di Patton, generale d’acciaio. Ma la consacrazione arrivò come co-autore e regista de Il padrino (1972) e Il padrino – Parte II (1974), che vinsero entrambi l’Oscar come Miglior Film. Poco dopo girò La conversazione, con il quale si aggiudicò il Grand prix du festival a Cannes e che venne candidato a tre oscar. Durante questo periodo scrisse anche una sceneggiatura per il remake del 1974 di Il grande Gatsby e produsse i primi due film di George Lucas, L’uomo che fuggì dal futuro e American Graffiti. Dopo il successo della saga de Il padrino, Coppola diede inizio all’ambizioso progetto di girare una pellicola ispirata al capolavoro di Joseph Conrad Cuore di Tenebra, ambientata, però, nel periodo della guerra del Vietnam. Il film, intitolato Apocalypse Now (1979), ebbe una produzione molto travagliata, inclusi un paio di tifoni; inoltre alcuni attori e Coppola stesso soffrirono per abusi di droga e crisi nervose. La produzione venne ritardata più volte, ma il film apparve lo stesso sugli schermi, ottenendo un grande successo e diventando un film di culto. Si aggiudicò la Palma d’oro ex-aequo con Il tamburo di latta e ottenne 8 nominations agli Oscar: miglior film, regia, attore non protagonista, sceneggiatura non originale, fotografia (vinto), montaggio, scenografia e sonoro (vinto). Nonostante i problemi e le difficoltà sofferte, Coppola portò avanti i suoi progetti, producendo assieme a George Lucas Kagemusha – L’ombra del guerriero di Akira Kurosawa e presentando nel 1981 una versione restaurata del film del 1927 Napoléon, di Abel Gance, che uscì negli Stati Uniti per la American Zoetrope. Nel 1986, Coppola diresse con George Lucas il film con Michael Jackson per i parchi a tema Disney Captain Eo, che all’epoca risultò il film più caro al minuto della storia (durata: 17’, costo al minuto: circa 1 milione di dollari). Nel 1992 realizza l’ennesimo film importante: Bram Stoker’s Dracula, vincitore di tre premi Oscar (miglior trucco, migliori costumi, migliori effetti speciali. Nello stesso anno, gli viene conferito il Leone d’oro alla carriera alla 49ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2001 ha messo mano nuovamente a Apocalypse Now per trarne una nuova versione, Apocalypse Now Redux, nel quale sono state inserite scene tagliate all’epoca ed un finale diverso. Filmografia – Cortometraggi e medionetraggi: Aymonn the Terrible (1960); The Peeper, the Wide Open Spaces (1960); The Belt Girls and the Playboy (1962); Rip van Winkle (1985); Captain EO (1986). Lungometraggi: Tonight for Sure (1962); Terrore alla tredicesima ora (Dementia 13) (1963); Buttati Bernardo! (You’re a Big Boy Now) (1967); Sulle ali dell’arcobaleno (Finian’s Rainbow) (1968); Non torno a casa stasera (The Rain People) (1969); Il padrino (The Godfather) (1972); La conversazione (The Conversation) (1974); Il padrino – Parte II (The Godfather: Part II) (1974); Mario Puzo’s The Godfather: the Complete Novel for Television (1977), Miniserie TV; Apocalypse Now (1979); Un sogno lungo un giorno (One from the Heart) (1982); I ragazzi della 56ª strada (The Outsiders) (1983); Rusty il selvaggio (Rumble Fish) (1983); Cotton Club (The Cotton Club) (1984); Peggy Sue si è sposata (Peggy Sue Got Married) (1986); Giardini di pietra (Gardens of Stone) (1987); Tucker, un uomo e il suo sogno (Tucker, the Man and His Dream) (1988); La vita senza Zoe (Life without Zoe), episodio di New York Stories (1989); Il padrino – Parte III (The Godfather: Part III) (1990); Dracula di Bram Stoker (Bram Stoker’s Dracula) (1992); Jack (1996); L’uomo della pioggia (The Rainmaker) (1997); Apocalypse Now Redux (2001); Un’altra giovinezza (Youth Without Youth) (2007); Segreti di famiglia (Tetro) (2009). I REGISTI I REGISTI 31 I REGISTI 32 Abel Ferrara way Stories – Cronache metropolitane (SUBWAYStories: Tales from the Underground), episodio Love on the Train (1997); New Rose Hotel (1998); Il nostro Natale (R-Xmas) (2001); Mary (2005); Go Go Tales (2007); Chelsea on the Rocks (2008), documentario; Mulberry St. (2009), documentario; Napoli Napoli Napoli (2009), documentario. New York, 19 luglio 1951. Nasce nel quartiere del Bronx. Il padre è un allibratore del posto, sempre nei guai. Alla sua educazione provvede quindi il nonno, un immigrato originario di Sarno. A quindici anni Ferrara conosce Nicholas St. John, quello che sarà lo sceneggiatore dei suoi film più famosi, con il quale avrà un’amicizia molto lunga. Insieme formano un gruppo musicale, con Ferrara come cantante. Nel 1977 Ferrara girò il suo primo film. Si tratta di un porno, intitolato Nine Lives of a Wet Pussy. Il film è firmato con lo pseudonimo Jimmy Boy L. Ferrara è presente anche come attore (ma non è stato mai chiarito se partecipa alle scene porno), con lo pseudonimo Jimmy Laine, che userà nei suoi primi film. Per quasi tutta la sua carriera Ferrara è dovuto scendere molte volte a compromessi con i produttori, ma quando ha avuto il controllo di un film si è spinto fino in fondo senza ripensamenti. Come nel cinema di Martin Scorsese, che Ferrara ama molto, peccatori ed emarginati incontrano una speranza di redenzione. Ferrara rimane ancorato al proprio substrato culturale, alle storie di malavita newyorkese, per raccontare la voglia di redenzione di ogni uomo. Parla di peccatori a contatto con il peccato, e della loro voglia di liberarsene. Il suo campo d’azione privilegiato è il noir, ambientato in città cupe e violente in cui si aggirano personaggi drogati, peccatori, alcolizzati e gangster. Altra presenza costante nei suoi film è la religione. Filmografia: Nicky’s Film (1971), corto; The Hold-Up (1975), corto; Could This Be Love (1975), corto; Not Guilty: For Keith Richards (1977), corto; Nine Lives of a Wet Pussy (1977); The Driller Killer (1979); L’angelo della vendetta (Ms. 45) (1981); Paura su Manhattan (Fear City) (1984); Miami Vice, episodi Gli invasori della casa e Una donna senza onore (1984), serie TV; Il Gladiatore (The Gladiator) (1986), Film TV; Crime Story, episodio pilota Vite sbagliate (1986), serie TV; China Girl (1987); The Loner (1988), Film TV; Oltre ogni rischio (Cat Chaser) (1989); King of New York (1990); Il cattivo tenente (Bad Lieutenant) (1992); Ultracorpi – L’invasione continua (Body Snatchers) (1993); Occhi di serpente (Dangerous Game) (1993); The Addiction – Vampiri a New York (The Addiction) (1995); Fratelli (The Funeral) (1996); California (1996), Videoclip per la canzone Mylène Farmer; Blackout (The Blackout) (1997); Sub- John Carpenter Nato a Carthage (NY), nel 1948, Carpenter cresce a Bowling Green, nel Kentucky. Si diploma alla Western Kentucky University, dove il padre insegna musica. Durante questi anni inizia a lavorare ad una serie di cortometraggi come Revenge of the Colossal Beasts, che sono i suoi primi lavori: viene dato scarso rilievo a queste opere, che invece già codificano i temi tipicamente “carpenteriani”. Nel 1969, Carpenter si laurea alla University of Southern California, mentre nel 1970 gira il suo primo cortometraggio ufficiale, The Resurrection of Broncho Billy, scritto insieme a Nick Castle. Castle instaurerà poi un rapporto di grande amicizia con Carpenter, tanto che interpreterà Michael Myers in Halloween. La pellicola gli fa guadagnare un premio come miglior cortometraggio e lo rende noto nel campo del cinema indipendente. Carpenter si mette al lavoro – insieme all’amico Dan O’ Bannon (regista di Il ritorno dei morti viventi e sceneggiatore di Alien) – su un’opera che unisca le tematiche di 2001: Odissea nello spazio e Il dottor Stranamore. Il risultato è Dark Star, una commedia fantascientifica in cui il protagonista vero e proprio è una bomba mandata nello spazio siderale da un gruppo di astronauti. Nel ‘76, pesantemente influenzato dal film Un dollaro d’onore di Howard Hawks, Carpenter concepisce Distretto 13: le brigate della morte. Girato in soli 20 giorni, il film guadagna $ 20.040.895 e viene ritenuto da molti critici uno dei migliori film di genere statunitensi degli anni settanta. Anche la colonna sonora del film è rimasta scolpita nelle generazioni e riesce ancora oggi a ricreare la tensione di allora. Filmografia: Revenge of the Colossal Beasts (1962); Terror from Space (1963); Gorgon, the Space Monster (1969); Gorgo versus Godzilla (1969); Warrior and the Demon (1969); Sorceror from Outer Space (1969); Dark Star (1974); Distretto 13: le brigate della morte (Assault on Precinct 13) (1976); Halloween, la notte delle streghe (Halloween, 1978); Pericolo in agguato: procedura ossessiva (Someone is watching me!) (1978), film TV; Elvis, il re del rock (Elvis) (1979), film TV; Fog (The Fog, 1980); 1997: fuga da New York (Escape from New York, 1981); La cosa (The Thing, 1982); Christine, la macchina infernale (Christine, 1983); Starman (1984); Grosso guaio a Chinatown (Big Trouble in Little China, 1986); Il signore del Male (Prince of Darkness, 1987); Essi vivono (They Live, 1988); Avventure di un uomo invisibile (Memoirs of an Invisible Man, 1992); Body Bags – Corpi estranei (Body Bags) (1993), film TV; Il seme della follia (In the Mouth of Madness) (1995); Villaggio dei dannati (Village of the Damned) (1995); Fuga da Los Angeles (Escape from L.A., 1996); Vampires (1998); Fantasmi da Marte (Ghosts of Mars) (2001); Masters of Horror, stagione 1 - episodio Cigarette Burns – Incubo mortale (2005); Masters of Horror, stagione 2 - episodio Il seme del male (2006).
Scaricare