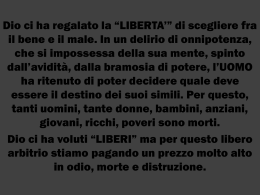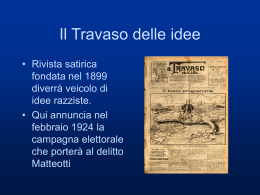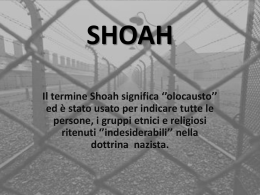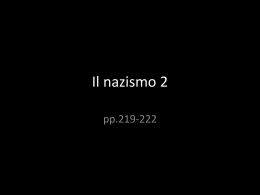file:///E|/Ftp/primaPagina.htm [18/05/2003 16.39.02] Il volume è frutto delle ricerche svolte nell’a.s. 1998-1999 dalla classe 5C del Liceo Scientifico della SS. Annunziata di Firenze e beneficia per la pubblicazione del contributo del Consiglio di Amministrazione dell’Educandato Statale della SS. Annunziata. Redazione dei testi a cura di Daniele Apicella Coordinamento scientifico: Alessandro Bussotti 2 ISTITUTO STATALE SS. ANNUNZIATA DI FIRENZE IL NOVECENTO. I GIOVANI E LA MEMORIA Progetto realizzato dalla classe Quinta Liceo Scientifico SS. Annunziata di Firenze a.s. 1998-1999 Prefazione di Roberto Salvadori Introduzione di Alessandro Bussotti 3 4 INDICE Roberto Salvadori Prefazione pag. 7 Alessandro Bussotti Introduzione “ 11 Francesco Lucci Il Poggio Imperiale negli anni della guerra “ 17 Giuseppe Citino Gli ebrei italiani dalle leggi antisemite allo sterminio “ 21 Francesco Lucci La persecuzione contro gli ebrei a Firenze “ 39 Andrea Mirchioni La Chiesa, Firenze, gli ebrei “ 64 Lorenzo Grotti “Nascosti da qualche parte”. Una storia ferrarese “ 80 Federico Ferruzzi Gli ebrei nella Ferrara fascista (1938-1945) “ 96 Antonio Concutelli Roma, città aperta? “ 106 Daniele Apicella Verità diverse. La deportazione femminile “ 132 5 Olivia Zorzet La condizione femminile nei lager pag. 143 Enrica Della Martira I bambini ebrei nell’Europa occupata dai nazisti “ 172 Francesco Martelli Internati militari italiani “ 217 Pier-Filippo Masi Una scelta morale “ 227 Noël Nicolaus La sindrome teutonica. Vertigini di coscienza “ 235 Tommaso Signorini Il razzismo: teoria e ideologia “ 247 Martino Manetti L’ideologia nazista e l’emigrazione ebraica “ 268 Jacopo Venerosi Pesciolini Gli ebrei in Svizzera “ 280 Lorenzo Bertocci “Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?” “ 308 Pietro Poli Trieste e la Risiera: finis Europae? “ 317 6 PREFAZIONE La Shoah - la “catastrofe” a cui è andato incontro il popolo ebraico (e non soltanto quello) nel corso della seconda guerra mondiale - ha dimensioni tali che non può essere capita, sia in senso letterale che in senso figurato, dalla mente umana. La Shoah si rifiuta di venir narrata, descritta. Coloro stessi che vi sono passati attraverso, come vittime per un verso e come carnefici per un altro, ne sono usciti sopraffatti, stravolti. I primi sono stati trattati come non-uomini, come spregevoli oggetti viventi sui quali era possibile e legittimo infierire in ogni modo; i secondi, non-uomini lo sono divenuti nell’atto stesso in cui decidevano di essere, o di accettare di essere, degli aguzzini. Affermazioni come queste sono state tante volte ripetute, nelle più varie forme, da divenire desolatamente banali. Non c’è solo da fare i conti con il silenzio di Dio ad Auschwitz, ma anche con questa impossibilità dell’uomo di dire, di parlare, di raccontare. Dall’altro lato la necessità, dolorosa, di ricordare. Di ricordare non per sé, ma per gli altri. Ed in ispecie per quegli altri particolarmente importanti che sono i giovani. Perché sappiano, certamente, ma anche e soprattutto per metterli sull’avviso: ogni reale è possibile. Secondo un ammonimento celeberrimo di Primo Levi, se questo è avvenuto, vuol dire che può avvenire ancora. In altra forma. Per vie diverse. Mascherandosi insidiosamente. I saggi che sono contenuti in questa pubblicazione hanno molti meriti proprio per il fatto che sono scritti di giovani i quali cercano di unire il racconto alla testimonianza e cioè se stessi, quello che hanno appreso, con il ricordo altrui. Si tratta di una scelta felice, degna di essere sottolineata; ogni trattazione ha due versanti: quello della documentazione storica e quello dell’ascolto della voce di chi ha visto, sentito, vissuto. L’incontro dell’oggettività con la soggettività determina una compensazione dei loro rispettivi limiti e si rivela particolarmente importante e fecondo. 7 È noto: non esiste una sola Shoah. Ve ne sono tante quante sono le persone che vi sono state coinvolte. Ognuno la sua, inconfondibile. E si arretra dinanzi al pensiero di quelle esperienze - a centinaia di migliaia, a milioni - che una morte, quasi sempre atroce, ha cancellato. Chi ricorda è obbligato a farlo anche per coloro dei quali si è perduta ogni traccia. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di comprendere, nei limiti del possibile, ciò che unisce queste storie tra loro tanto diverse per cogliervi, oltre la differenza, anche che cosa le ha generate. Abbiamo bisogno non solo di conoscere ma anche di spiegare e di interpretare. Di vedere una realtà - che è poi sempre la stessa - ora come bosco, ora come singoli alberi. L’impegno degli studenti del Liceo della SS. Annunziata di Firenze è andato in questa direzione. Non hanno introdotto qualcosa di nuovo sul piano della ricerca (e, del resto, non era questo che si chiedeva loro), ma hanno saputo avvicinarsi, con gli strumenti propri della cultura, alcuni dei momenti fondamentali della tragedia e porgerli agli altri. Chiunque ha qualcosa da apprendere dai loro racconti. I temi toccati, infatti, sono molto vari. Gli ebrei, ma anche i militari italiani internati. L’ideologia nazista, ma anche la sua traduzione nella prassi. La condizione particolare delle donne o dei bambini nei Lager. Gli scenari che cambiano a seconda dei luoghi: il campo di sterminio, ma anche Firenze, Roma, Ferrara, il confronto fra il prima e il poi… Tutto questo conservando una sostanziale omogeneità di linguaggio e rispettando lo stesso modulo semplice ed efficace: un’introduzione storica, qualche sobrio commento, la documentazione proveniente dalle testimonianze. Un criterio che è anche di notevole significato didattico e che ha richiesto certamente non solo al prof. Alessandro Bussotti (che di tutto questo è stato il coordinatore) e ai suoi alunni, ma alla scuola nel suo insieme una presenza e un’attenzione costante. Il lavoro è stato presentato al giudizio della Fondazione “Primo Levi” di Firenze che aveva organizzato, anche per il 19981999 come per gli anni scolastici precedenti, un concorso riserva- 8 to agli studenti delle scuole medie superiori toscane, su temi ben definiti di argomento ebraico. L’apposita commissione - composta da Liana Elda Funaro, Luigi Tassinari, Lionella Viterbo e presieduta da Roberto G. Salvadori - ha subito e unanimemente rilevato la piena validità del contributo che veniva dal Liceo della SS. Annunziata e, rammaricata di non poterlo premiare, perché presentato fuori concorso su temi diversi da quelli proposti, ha ritenuto di doverlo segnalare nel corso della premiazione e di raccomandarne la pubblicazione. Oggi si dichiara lieta che i suoi voti siano stati adempiuti e auspica la maggior diffusione possibile di questo volume, soprattutto fra i giovani. Roberto Salvadori Università di Siena Arezzo 9 10 INTRODUZIONE La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico col passato storico del tempo in cui essi vivono. Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1995, pp. 14-15. Questo fenomeno - prosegue Hobsbawm - fa sì che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri dimenticano, siano ancora più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo siano state nei secoli scorsi. Vorremmo aggiungere che il compito di rendere e mantenere viva la memoria storica compete ad ogni uomo, che può svilupparsi come agente morale e politico solo nel contesto di una comunità. In tal senso, l’identità di una persona, la quale si colloca in un rapporto di presupposizione reciproca con l’intelligibilità e la responsabilità delle proprie azioni e, in parte, delle azioni altrui, non è indipendente dal contesto a cui appartiene: ogni contesto ha una storia, al cui interno le storie dei singoli soggetti, per essere comprensibili, debbono essere collocate. La storia di ogni vita umana è sempre inserita nella storia di una comunità da cui ciascun uomo trae parte della sua identità: ciò che rende intelligibile l’azione umana non è mai solamente la storia personale del singolo, ma anche l’appartenenza di questi ad una specifica comunità, con le sue tradizioni che vivono nella storia di una società. Agire significa infatti entrare in relazione non solo con i nostri contemporanei, ma anche con coloro che ci hanno preceduto, 11 in una ineliminabile continuità storica: tutti gli uomini nascono con un passato che intreccia rapporti con il presente. Ogni uomo è in larga parte ciò che ha ereditato. La memoria, collettiva e storica, consente all’uomo di cogliere quelle possibilità future che il passato ha messo a disposizione del presente, di intervenire su questo stesso presente e di proseguire una narrazione non ancora compiuta sulla base di caratteri determinabili grazie all’eredità del passato. Il recupero della memoria della Shoah - la cui considerazione da parte nostra è l’esito necessario di un itinerario che ha trovato avvio nell’a.s. 1998/99 con l’adesione al presente progetto da parte della classe 5C del Liceo Scientifico della SS. Annunziata di Firenze - è un ineliminabile punto di riferimento per una disamina globale della violenza, individuale e collettiva, di ogni tempo e di ogni luogo, e per una riflessione sulla propria identità e di quella identità sociale di cui ogni uomo è latore, consapevolmente o meno. Il presente progetto, nello spirito che anima l’iniziativa promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione in commemorazione del sessantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, si è proposto di contribuire ad una conoscenza diretta dei fattori e degli elementi che resero possibile la catastrofe e ad una riflessione critica sul perché si sia prodotta una simile esplosione di violenza, sollecitando l’acquisizione della consapevolezza dei rischi a cui l’uomo è condotto da ogni scelta che non sia orientata da un radicale rifiuto della violenza e dell’intolleranza. In quest’ottica, un momento qualificante del presente progetto è stata la raccolta di fonti orali curata dagli allievi con un procedimento di ricerca non astratto, ma costantemente riferibile al “vissuto quotidiano”, che ha consentito loro di “rispecchiarsi” nel racconto, nel ricordo, nella memoria dell’interlocutore. La memoria, individuale e collettiva, intesa come possibilità di disporre delle conoscenze passate, è costituita nelle sue dimensioni (orale, scritta, visiva) da due momenti distinti: la conserva- 12 zione e la persistenza delle conoscenze passate che, per il loro essere trascorse, possono essersi sottratte allo sguardo del presente; la possibilità di richiamare tali conoscenze, rendendole così attuali e presenti. Quest’ultima condizione, che esprime il carattere attivo della deliberazione e della scelta, anche in vista dell’azione, definisce ciò che propriamente è il ricordo. Il presente progetto ha inteso tener presente tale duplice livello della memoria, ponendo pertanto attenzione al delinearsi di un ricordo che potrebbe essere definito “diretto” delle esperienze che la persona ha vissuto in prima persona e all’esplicarsi di un ricordo per così dire “traslato”, il cui carattere essenziale parrebbe consistere nel momento della narrazione e del racconto di esperienze vissute. Gli allievi hanno pertanto provveduto a raccogliere testimonianze da persone che subirono le persecuzione razziali, che hanno conservato ricordi di quel periodo storico o che hanno conoscenza del periodo anche grazie alla trasmissione orale a livello familiare, individuando alcuni temi specifici lungo i quali si sono sviluppati il racconto e il dialogo, senza vincolo per la libertà di impostazione della ricerca e lasciando aperti spazi di intervento e di arricchimento personale. Questo ci è sembrato tanto più significativo in quanto ciò che assume rilievo in un’ottica metodologica è non solo il rapporto che si stabilisce tra l’esperienza storica dell’individuo e la capacità che questi ha di comprendere la storia collettiva, ma lo stesso significato di memoria che se ne può trarre: in tal senso, ricordare è un’attività intesa a creare, che se, da un lato, si volge al passato, dall’altro, attua l’esperienza trascorsa facendola vivere nel presente. L’atto narrante in cui si esplica il ricordo diviene, oltre che memoria di sé, una tradizione vivente, cioè una riformulazione di ciò che si è ricevuto dalle generazioni precedenti e che si vuol trasmettere a quelle future. L’analisi e la valutazione delle fonti hanno consentito di sviluppare corrispondenze tra narrazione ed eventi storici, relazioni 13 tra racconto e testi storici, personali valutazioni ed interpretazioni dei fatti narrati ed anche, mediante confronti con altre testimonianze, fonti documentarie ed approfondimenti bibliografici, una valutazione problematica circa la possibilità di inserire la dimensione storica individuale e dei singoli eventi nella prospettiva generale del contesto storico. Il momento conclusivo e più significativo di questa ricerca è stata la visita al Civico Museo della Risiera di San Sabba a Trieste, il 4 giugno 1999 a cura del dott. Fattorini dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-VeneziaGiulia di Trieste, integrata dalla visita al Museo della Comunità ebraica “Carlo e Vera Wagner”, a cura del direttore del Museo, dott. Ariel Haddad. Il Polizeihaftlager della Risiera di San Sabba a Trieste fu costituito nell’ottobre del 1943 ed assolse a diverse funzioni: campo di smistamento degli ebrei verso Auschwitz, campo di raccolta dei beni estorti alla comunità ebraica, luogo di detenzione e tortura del partigianato italiano e jugoslavo, campo di eliminazione per i resistenti. I motivi che ci hanno spinto a questa scelta sono stati diversi. Tra questi ne vorremmo ricordare due. La Risiera di San Sabba è l’unico campo di sterminio nazista presente in Italia; ci è sembrato importante visitare un luogo forse poco conosciuto in Italia, sicuramente meno di altri lager all’estero, ma importante per comprendere un aspetto di una realtà storico-geografica del nostro territorio nazionale considerata comunemente - anche se impropriamente - “periferica”. Il Museo della Risiera di San Sabba è sede di un centro di ricerca che presta grande attenzione alla ricostruzione delle vicende biografiche di quelle persone, soprattutto - ma non solo - giovani e bambini, che transitarono dalla Risiera o chi vi trovarono la morte, nell’intento di restituire loro quella dignità e quell’identità che i nazisti vollero offendere ed annientare. 14 Vorrei qui esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto. Ho un incolmabile debito di gratitudine nei confronti di quanti, sempre con sensibilità e disponibilità straordinarie, hanno permesso, con le loro testimonianze, la realizzazione di tale lavoro: i loro nomi sono citati nel volume. Sono riconoscente alla Comunità Ebraica di Firenze che ci ha accolto con tanta ospitalità e alla Fondazione “Primo Levi” di Firenze che ci ha insignito di un riconoscimento di cui siamo orgogliosi. In particolare, ringrazio la prof.ssa Liana Elda Funaro, il prof. Luigi Tassinari, la prof.ssa Lionella Viterbo e il prof. Roberto Salvadori, autore della presentazione e di preziosi suggerimenti, che hanno accettato di seguire la pubblicazione. Un ringraziamento alla Commissione Provinciale di Storia, presieduta dal prof. Mario G. Rossi, che ha approvato il progetto e ha contribuito al suo finanziamento. Desidero ringraziare il Liceo e l’Educandato della SS. Annunziata. I nostri ringraziamenti vanno alla prof.ssa Maria Pampinella, preside del Liceo e direttrice dell’Educandato, che ci ha invitato ad aderire al progetto, e al Consiglio di Istituto del Liceo, che ha finanziato il viaggio e il soggiorno a Trieste. Vorrei sottolineare il ruolo essenziale svolto dal Consiglio di Amministrazione dell’Educandato, segnatamente nelle persone della dott.ssa Luciana Gasbarre, il cui sostegno è stato di fondamentale importanza, e del presidente, prof. Umberto Cantabrini, il quale ha appoggiato con convinzione la pubblicazione di questo testo, realizzata grazie al contributo del Consiglio di Amministrazione. Vorrei rivolgere un ringraziamento al sig. Carmine Spatafora, per l’assistenza tecnica, e alle signore Mariangela Piras e Maria Laura Galante, che ci sono state di ausilio prezioso. Desidero ringraziare tutti quei colleghi che ci hanno incoraggiato ed aiutato: tra questi, in particolare, la prof.ssa Rossella Rossi, che ha partecipato all’iniziativa con entusiasmo e passione; la prof.ssa Elvira Valleri, a cui sono grato per l’intelligenza e la 15 competenza con cui ci ha offerto i suoi suggerimenti; il prof. Nazzareno Santini, che, sin dall’inizio, si è dichiarato disponibile a condividere l’esperienza della visita al Museo della Risiera di San Sabba. Un ringraziamento alla prof.ssa Rosanna Grazzini, alla prof.ssa Stefania Filippelli, al prof. don Sergio Pacciani, alla prof.ssa Erminia Zampano, che hanno collaborato a questa iniziativa, in vario modo. La visita alla Risiera non sarebbe stata un momento così toccante se non avessimo potuto avvalerci della lucida e coinvolgente guida del dott. Fattorini. Vorrei qui esprimere i nostri ringraziamenti ai signori De Polo per la loro gentilezza e al dott. Ariel Haddad per la sua ospitalità. Molte sono le persone che ci hanno aiutato ad avviare le ricerche e a stabilire contatti: vorrei ricordare la prof.ssa Marta Baiardi, il sig. Alberto Nirestein, la prof.ssa Paola Pandolfi, la prof.ssa Antonietta Rotondi, il sig. Sergio Russic de Moscati, il sig. Alfredo Tonelli. In ultimo, certamente non perimportanza, vorrei ringraziare la prof.ssa Rita Levi Montalcini che ha cortesemente incontrato alcuni studenti, concedendo loro un colloquio, la Camera dei Deputati, e il suo il Presidente On. Luciano Violante. Ringrazio per la sua cortesia il dott. Stefano Rizzo della Segreteria Generale della Camera dei Deputati. Desidero rivolgere agli studenti che hanno lavorato a questo progetto i miei auguri per un futuro sereno e proficuo. Vorrei infine sottolineare che l’edizione di questo lavoro è stata resa possibile grazie alle cure attente ed acute di Daniele Apicella, al quale va il mio grazie più sentito. Alessandro Bussotti Liceo SS. Annunziata 16 IL POGGIO IMPERIALE NEGLI ANNI DELLA GUERRA Francesco Lucci Le tristi vicende della persecuzione antisemita che si abbatterono su Firenze non risparmiarono neppure l’Educandato della SS. Annunziata, nella villa del Poggio Imperiale, alle porte della città, sul colle di Arcetri. 1 Come accadde nel resto d’Italia, anche a Firenze le leggi razziali e la guerra, in un primo momento, e il pericolo della deportazione, in seguito, giunsero inaspettate e con incredibile rapidità; così risultò estremamente difficile organizzare l’allestimento di rifugi che potessero essere sufficientemente sicuri. Anche per questo motivo il ministro dell’istruzione suggerì a tutti gli educandati d’Italia di sospendere momentaneamente le lezioni e di rimandare ogni collegiale alle proprie famiglie, per evitare qualunque responsabilità. La Direttrice, anche contro il parere del Presidente dell’Educandato della SS. Annunziata e di alcuni genitori, preferì continuare il normale svolgimento delle lezioni. Furono effettuate velocemente varie modifiche alla struttura seicentesca: furono create uscite di sicurezza, sia nella parte antistante che in quella retrostante; fu allestito un rifugio sfruttando i sotterranei dell’edificio che, con le loro massicce volte, risultavano particolarmente resistenti anche ai bombardamenti più pesanti. Il rifugio poteva ospitare circa duecento persone e, oltre ad avere più entrate, godeva di quattro farmacie, una toilette, un telefono ed una Cappella che, in casi di emergenza, avrebbe dovuto sostituire quella più grande al piano superiore; inoltre, il rifugio disponeva di banchi, cattedre e lavagne per permettere, per quanto possibile, il proseguimento delle lezioni. 1 Per questo lavoro è stato utilizzato E. Dini, Cento anni di vita del Poggio Imperiale, Giunti, Firenze, s.d. 17 La necessità di procurarsi metalli da parte dello stato colpì anche l’Educandato: il Presidente e la Direttrice furono costretti a cedere una grande quantità di maniglie metalliche che dovettero essere sostituite da altre di porcellana; inoltre quasi tutte le vettovaglie della cucina (653 Kg. di rame) andarono perse. Fortunatamente la cancellata non fu ceduta perché fu presentata come una garanzia di sicurezza. Anche al forte tesseramento alimentare il Poggio trovò una soluzione impiantando una conigliera in giardino e creando un grande orto in un podere vicino. Verso la fine del ’42 il Presidente Romei Longhena dovette lasciare Firenze perché ormai anziano e soprattutto perché l’unica figlia reclamava la sua presenza a casa, visto il momento di particolare tensione. La presidenza fu affidata al prof. Jacopo Mazzei, il quale trovò una situazione molto difficile che si aggravò dopo l’8 settembre con l’invasione dei tedeschi. Il 24 settembre la villa del Poggio fu occupata da un reparto dell’aviazione tedesca: in Collegio erano rimaste solo ventitré educande, per motivi di sicurezza. I centocinquanta tedeschi che occuparono l’edificio chiesero la disponibilità di tutti i locali; ma la Direttrice si oppose fermamente: così fu ceduto solo il grande salone e alcune sale al piano superiore, riuscendo a salvare la cucina e il refettorio; il giardino invece fu praticamente invaso dai mezzi corazzati dei tedeschi. La Direttrice prese quindi la decisione di trasferire le educande nel vicino Collegio del Sacro Cuore. Fortunatamente il 2 ottobre l’Educandato fu sloggiato. Ma fu nuovamente occupato il 24 novembre dall’organizzazione Tod, con l’ordine a tutto il personale di lasciare i locali entro dieci giorni. La Direttrice, con l’aiuto di alcune istitutrici, delle contadine del podere, delle cameriere, cercò di salvare il salvabile: biancheria, approvvigionamenti, masserizie di prima necessità, oggetti di valore. Le cose più preziose furono momentaneamente depositate in case ospitali; ciò che non fu possibile portare via fu sistemato in soffitta; in altri casi si preferì murare le porte perché non era possibile trasportare i pesanti armadi. Ad un certo momento 18 sembrò che la villa di Pozzolatico potesse ospitare le Poggioline; invece la Direzione concesse solo alcuni locali adibiti a magazzino. Fortunatamente fu ceduta provvisoriamente alla SS. Annunziata la villa del Belvedere di Bellosguardo; così gran parte della roba depositata fu trasportata lì. L’organizzazione Tod l’8 dicembre ricevette l’ordine di sgombrare il Poggio; il 13 dicembre la villa fu definitivamente liberata. Comunque la vita non fu tanto più agiata: le lezioni, che peraltro non si erano mai interrotte, continuavano il loro svolgimento; spesso, però, i professori, che avevano lasciato la città per trovare alloggi più sicuri in periferia, dovevano raggiungere i loro posti di lavoro con estrema difficoltà per i continui bombardamenti e spesso erano costretti a trovare rifugi occasionali. Il Collegio, nell’anno scolastico 1943-44, aprì la scuola all’esternato e fu una scelta positiva, visto che molti, a causa dei bombardamenti, preferirono lasciare le scuole in città iscrivendosi invece a quelle di periferia, tra cui il Poggio. Nella primavera del 1944 restava comunque la preoccupazione per eventuali rappresaglie da parte dei tedeschi e tutti gli uomini erano costretti a rimanere nascosti per non correre il rischio di essere deportati. Nel maggio del ’44 alcune bombe furono sganciate a una brevissima distanza dall’edificio solo qualche attimo dopo l’allarme: la villa tremò dalle fondamenta, i pochi vetri rimasti intatti caddero in frantumi, tutti scapparono nel rifugio. Dopo questo episodio diverse educande preferirono lasciare l’Educandato; in Collegio rimasero solo due bambine verso le quali si indirizzavano tutte le premure della Direttrice, che si sentiva particolarmente responsabile della loro sorte. Prima pensò di portarle al Seminario di Cestello, che si rivelò poco dopo una scelta poco sicura, visto che un proclama dei tedeschi aveva ordinato che tutti i cittadini che abitavano nei pressi dei Lungarni lasciassero le proprie abitazioni a causa del probabile bombardamento dei ponti. Infatti tutti ponti, tranne Ponte Vecchio, furono minati e completamente distrutti. La Direttrice preferì così far tornare le 19 due Poggioline al Collegio per poterle controllare direttamente. I bombardamenti continuarono per qualche altro giorno, visto che l’arrivo degli Alleati era sempre più vicino; inoltre, le truppe tedesche dovevano difendersi anche dai gruppi partigiani, rafforzati da molti patrioti che si unirono per liberare la città. Quando infatti gli alleati giunsero a Firenze, i tedeschi erano già rifugiati sul colle di Fiesole da dove bombardavano, in direzione del Poggio, gli anglo-americani provenienti da San Casciano in Val di Pesa. Il Poggio uscì dal conflitto abbastanza disastrato, ma la volontà della Direttrice permise di ospitare nell’autunno del ’44 ben trentacinque educande (molte famiglie che avevano perso la loro abitazione o non si erano ancora riorganizzate preferirono mandare le proprie figlie in Collegio). Nel dicembre, la Delegazione Alleata Assistenza Emigrati, che era riuscita a salvare trecento figli di ebrei, chiese all’Educandato di ospitare due ragazze ebree: sarebbero rimaste fino alla loro partenza per la Palestina. Non si seppe mai chi fossero, ma non ricevettero mai un trattamento diverso rispetto alle altre. Purtroppo anche il Poggio ebbe le sue vittime: Sandra Settepassi, una ex Poggiolina, per essersi ribellata con altre giovinette a una squadra tedesca, fu barbaramente uccisa. Giovanna Paolozzi morì sotto il bombardamento della sua casa insieme al fratello: altre Poggioline persero il padre in guerra, altre ebbero trucidati dai tedeschi i fratelli perché partigiani. Nel gennaio del ’45, Lina Pieragnoli, insegnante da venti anni nel Collegio, crocerossina, fu investita da un camion americano e, quasi nello stesso tempo, Sofia Chiostri, insegnante di disegno, morì per le sofferenze subite nel periodo di emergenza. 20 GLI EBREI ITALIANI. DALLE LEGGI ANTISEMITE ALLO STERMINIO Giuseppe Citino Fino a poche settimane prima, ogni venerdì sera, all’accendersi della prima stella, si spalancavano le grandi porte della Sinagoga, quelle verso la piazza del Tempio. Perché le grandi porte, invece delle bussole laterali e un po’ recondite come tutte le altre sere? Perché invece degli sparuti candelabri a sette bracci, quello sfavillare di tutte quante le luci, che traeva fiamme dagli ori, splendore dagli stucchi - gli stemmi di Davide, i nodi di Salomone, le Trombe del Giubileo - e sontuosi bagliori dal broccato della cortina appesa davanti all’Arca Santa, all’Arca del Patto col Signore? Perché ogni Venerdì, all’accendersi della prima stella, si celebrava il ritorno del Sabbato. […] «Vieni, o amico, vieni incontro al Sabbato…» Era il mistico invito ad accogliere il Sabbato che giunge, che giunge come una sposa. Giungeva invece nell’ex-Ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l’agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. E’ venuta da Trastevere di corsa. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere, e questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco, e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi-famiglia ebrei, da portar via con tutte le famiglie.1 Così Debenedetti inizia il suo breve ma splendido 16 ottobre 1943. Ci parla della deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma, ma può essere l’esempio di una realtà molto più ampia e terribile, che coinvolse quasi tutta Europa. E’ forse il più sconvolgente degli esempi, se si considera che da questa città furono deportati circa mille ebrei in un solo giorno, ma non fu l’unico caso a livello nazionale, e neanche il peggiore. In totale, i deportati dal 1943 al 1945 furono in tutta Italia 7495. Di essi solo 610 riuscirono a tor- 21 nare dall’inferno dei Lager; 6885 vi trovarono la morte2. Ma per poter capire come sia potuta avvenire una cosa simile in un paese come l’Italia, con una popolazione che, pur avendo avuto pregiudizi religiosi contro gli ebrei, non aveva mai avuto tendenze antisemite, dobbiamo tornare alla situazione di qualche anno prima, al 17 novembre 1938, quando vennero emanate le leggi razziali. Queste, benché nel fascismo non ci fosse un programma di genocidio, di fatto anticiparono nel tempo e favorirono i tentativi di sterminio. Mussolini non può essere considerato per molti anni un antisemita. Sino al 1937 questa idea fu lontana da lui: gli ebrei italiani godevano la stessa “libertà” degli altri italiani; gli ebrei stranieri lo videro talora come un protettore che a volte li aiutò e aprì loro le porte d’Italia. Il sionismo non suscitò in lui particolare simpatia, ma neanche una particolare antipatia; era una delle tante pedine del suo gioco opportunistico da sfruttare al momento giusto. Nutriva diffidenza, come i nazionalisti, nei confronti degli ebrei stranieri, ma gli ebrei italiani erano per lui italiani, e a volte buoni fascisti. Il suo razzismo non aveva nulla a che vedere con quello nazista, mirava solamente alla vitalizzazione e al potenziamento fisico e morale degli italiani. La sua posizione mutò nel 1936, per diversi motivi: le posizioni antifasciste ebraiche in occasione della guerra d’Etiopia e di Spagna, il mito della “nuova civiltà” e i nuovi rapporti con la Germania. Mussolini voleva evitare che in Etiopia si mescolassero gli italiani con gli “inferiori” africani, come era successo in altre colonie europee. Voleva dare agli italiani una nuova coscienza “razziale” che ne facesse una razza di conquistatori in grado di far fronte alle conquiste che aveva in mente per “l’Italia imperiale”. Inoltre, l’antisemitismo servì per superare l’ultimo ostacolo che separava l’Italia fascista dalla politica della Germania nazista; per Mussolini l’antisemitismo era necessario per rendere totalmente vincolante l’alleanza con la Germania (e questo è la prova del carattere politico della sua scelta). Ma il razzismo di Mussolini 22 fu diverso da quello nazista di tipo biologistico (a quale si riallacciarono Guido Landra e Lidio Cipriani), che credeva in una razza superiore e pura, quella ariana. Il razzismo di Mussolini fu di tipo mistico spiritualista, nel senso teorizzato da Julius Evola: esiste uno spirito che, in tempi remoti, aveva fatto sì che gli italiani fossero superiori agli altri. L’intento era quello di non apparire come imitatore di Hitler, e di potersi, anzi, presentare come il propugnatore di un razzismo tutto diverso e con motivazioni ed obiettivi non materialistici, ma “spirituali”, appunto. È da notare, tuttavia, che, nei fatti, ad essere seguita non fu la linea di Evola che, nonostante alcuni approcci iniziali, non ebbe alcun ruolo di rilievo nella vicenda. Comunque, nonostante la decisione fosse stata presa essenzialmente per rafforzare l’Asse, è da escludere che su di essa i tedeschi abbiano influito con una richiesta esplicita. Tuttavia, il razzismo e l’antisemitismo avevano un’importanza troppo determinante in Germania perché un alleato non dovesse non adeguarvisi. La prima manifestazione ufficiale dell’antisemitismo fu la pubblicazione dell’Informazione diplomatica n. 14 del 16 febbraio 1938. Da questa appariva chiaramente che Mussolini stava preparando provvedimenti per gli ebrei stranieri rifugiati in Italia e voleva introdurre per quelli italiani la proporzionale, in base alla quale la presenza degli ebrei nell’amministrazione statale avrebbe dovuto essere proporzionale alla percentuale della popolazione ebraica rispetto a quella italiana. L’informazione diplomatica n. 14 servì di fatto a far capire che l’Italia aveva scelto di seguire una politica antisemitica sulle orme dell’alleata Germania, ma per lungo tempo, anzi, forse fino all’ultimo, non vi fu la coscienza del pericolo incombente. L’avversione contro i tedeschi era indubbiamente spiccatissima in tutti gli ebrei e, di conseguenza, quella contro l’alleanza italo-tedesca. Gli ebrei non erano preparati a tanto rigore e molti divennero antifascisti. A prendere posizioni ufficiali più severe si tardò ancora per vari motivi, specialmente perché 23 l’opinione pubblica italiana non era ancora preparata all’introduzione dei provvedimenti in questione, ma ancora di più si temeva l’impopolarità che il regime si sarebbe creato attorno a sé presso la Santa Sede e all’estero. Ad offrire la piattaforma scientifico-ideologica all’antisemitismo di Stato fu il Manifesto degli scienziati razzisti, pubblicato il 14 luglio. Tra gli autori furono il dottor Pende dell’Università di Roma, Cipriani e Landra; esso era diviso in 10 articoli: 1. Le razze umane esistono; 2. Esistono grandi razze e piccole razze; 3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico.; 4. La popolazione dell’Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana; 5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici; 6. Esiste ormai una pura “razza italiana”; 7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti; 8. È necessario fare una netta distinzione tra i mediterranei d’Europa (occidentali) da una parte, gli orientali e gli africani dall’altra; 9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana; 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. Il Manifesto, insieme ai primi provvedimenti, fu il primo vero shock politico dopo il delitto Matteotti, e per alcuni segnò l’inizio del divorzio dal fascismo. L’Informazione diplomatica n. 18 del 5 agosto 1938 introdusse lo slogan “discriminare ma non perseguitare”3; notificò che in Italia c’era un ebreo su mille abitanti (una delle percentuali più basse d’Europa) e che in tale proporzione doveva essere la loro partecipazione alla vita globale dello Stato. Si credeva che gli ebrei occupassero i gradini più alti della società, ma questa tesi fu poi smentita da accertamenti statistici che dimostrarono che gli ebrei erano equamente distribuiti ad ogni livello sociale, anche se questa notizia fu tenuta nascosta dai fascisti per ovvi motivi propagandistici. Superati gli scogli maggiori, soprattutto la Santa Sede, Mussolini poteva affermare al Gran Consiglio che si riunì a Roma la notte fra il 6 e il 7 ottobre ’38: «Ora l’antisemitismo è inoculato nel sangue degli italiani. Continuerà da solo a circolare e a svilupparsi.»4 24 I provvedimenti non suscitarono nella maggioranza degli italiani alcuna simpatia, anzi si può dire che il progetto propagandistico di Mussolini fallì, contro ogni sua aspettativa. Tutte le calunnie e le mostruosità ammannite quotidianamente dalla stampa senza risparmio sul conto degli ebrei non bastarono a convincere la grande maggioranza degli italiani che gli ebrei in generale e quelli italiani in particolare fossero veramente quel pericolo che si proclamava costituissero e, in ogni caso, che ci si dovesse difendere da essi in una maniera così barbara e crudele. Alcuni cambiarono opinione sul fascismo e iniziarono ad aprire gli occhi e a ragionare con la propria testa. Si può dire che la legislazione non andasse bene a nessuno: chi fino a quel momento non pensava molto al regime o non si occupava di politica, in molti casi divenne antifascista; addirittura, alcuni fascisti cercarono di aiutare gli ebrei, conservando loro con qualche espediente il posto di lavoro e aiutandoli a sistemarsi presso enti e ditte private. Le leggi razziali provocarono disgusto verso il fascismo, solidarietà verso gli ebrei, sfiducia nello Stato. La stampa e il PNF conducevano contro i «pietisti», cioè contro coloro che non approvavano l’antisemitismo di Stato e commiseravano e aiutavano gli ebrei, tutto il loro violento sdegno e tutta la loro rabbia. Il “pietismo” era definito dal regime come la perfetta antitesi dello spirito fascista, come una manifestazione e un contrassegno tipico della mentalità borghese. Sembrò quasi che la lotta contro gli ebrei dovesse cedere il posto a quella contro i “filogiudei”, contro i “meticci morali”. Il fascismo cercò di comportarsi come sempre aveva fatto: mise tutto a tacere e ignorò ufficialmente lo scontento. Ma questa volta tacere era impossibile. Lo scontento riguardava tutti e i “pietisti” erano numerosissimi anche nello stesso PNF. Nel giugno 1939 Starace si vedrà costretto a vietare, pena il ritiro della tessera (che serviva in pratica a sopravvivere), agli iscritti al partito di inoltrare raccomandazioni di qualsiasi genere a favore dei “giudei”. Ma gli aiuti conti- 25 nuarono ad esserci, specialmente nei momenti del bisogno. Mario Baer è un ebreo che si è salvato e che in un’intervista che ci ha concesso ha spiegato come gli ebrei potevano mettersi al sicuro, il più lontano possibile dalla spada di Damocle che pendeva sulla loro testa5. Baer li nascose in famiglie di “ariani” che sapevano benissimo quali rischi corressero nel compiere un gesto così umanitario, ma non si tirarono indietro; ad essi non importava molto avere qualche bocca in più da sfamare in casa (che in quegli anni significava privarsi del cibo), ma si comportavano semplicemente come fosse un loro dovere. Anche il famoso poeta Umberto Saba, durante l’occupazione nazista, visse nascosto in alcune famiglie fiorentine e fu ospite anche di Montale. Baer racconta di aver sistemato molti ebrei in monasteri; infatti, molti sacerdoti e istituzioni ecclesiastiche aiutarono attivamente gli ebrei. Il “pietismo” si manifestò in Italia, perché non c’era mai stato un forte sentimento antisemita o razzista nella popolazione italiana. Tra le diverse motivazioni, si potrebbe forse pensare che gli italiani fero stati “brava gente”, con forti principi morali e umanità. La grande maggioranza delle persone neanche capiva il perché di tale accanimento contro gli ebrei, che considerava (credo, fra l’altro, giustamente) uno dei tanti atti di follia che si compivano in quegli anni. I fascisti tentarono di evitare uno scontro aperto con i cattolici poiché un simile conflitto, a parte le gravi ripercussioni internazionali, non si sarebbe di certo limitato ai cattolici militanti dell’Azione cattolica, ma molto probabilmente si sarebbe esteso a vasti settori del paese, allargandosi dall’aspetto “razziale” ad altri aspetti della politica fascista, in primo luogo a quello della politica verso la Germania. Ma Alfieri, a quei tempi ambasciatore in Germania, sosteneva che era inutile preoccuparsi di questo scontro con la Santa Sede, e lo fece con tre argomentazioni: 1) i giornali cattolici hanno in Italia una circolazione limitatissima; 2) un intervento complicherebbe le cose perché giusto in questo momento stiamo esercitando una fortissima pressione sui pre- 26 detti giornali; 3) infine, significherebbe far loro troppo onore supponendo che possano porre seriamente in pericolo la solidità dell’Asse.6 Sembra chiaro, dietro questo tono diplomatico e apparentemente sicuro, il timore dei fascisti di dover giungere ad un aperto conflitto con i cattolici. I fascisti preferirono cercare di influire sull’opinione pubblica cattolica trattandola con le sue stesse armi e facendo leva sulle tradizioni e sugli spunti antisemiti che certo non mancavano tra i cattolici stessi, ad esempio il motivo secondo cui gli ebrei erano deicidi, poiché avevano ucciso Cristo. La Chiesa aveva sempre perseguitato gli ebrei; il fascismo dunque non solo non faceva nulla di nuovo, ma era nel solco della tradizione cattolica. Sembrava quasi che i veri cattolici fossero i fascisti. “Il regime fascista” del 28 agosto arrivò ad intitolare il suo fondo, Lezione di cattolicesimo ai cattolici. Farinacci dimostrava come l’antigiudaismo fosse stato fino a pochi anni prima una “costante” della politica e del pensiero cattolico e affermava che «se, come cattolici, siamo divenuti antisemiti, lo dobbiamo agli insegnamenti che ci furono dati dalla Chiesa durante venti secoli»7. E’ impossibile non notare tutta la falsità e tutta l’abilità tipiche dei fascisti nel volgere ogni cosa a proprio favore. Le gerarchie cattoliche e i giornali preferirono non correre rischi e, pur non accettandolo, cessarono quasi completamente ogni polemica pubblica contro l’antisemitismo. Ma se tacquero gli avversari dell’antisemitismo, non tacquero però gli antisemiti, che non mancavano tra i cattolici e tra gli stessi ecclesiastici. Questa volta il gioco dei fascisti, grazie alla propaganda di Farinacci, riuscì. Con l’adozione della legislazione antisemita, l’ebraismo italiano entrò in una gravissima crisi: gli uomini che dirigevano l’Unione delle Comunità ebraiche ritennero che la miglior difesa fosse la completa acquiescenza alla volontà governativa. Alcuni ebrei rimasero fedeli al fascismo, dimostrando il loro attaccamento all’Italia e al regime (ma essi furono una ristretta minoranza). Chi poteva, specie se aveva figli nell’età degli studi superiori, si orientò ben presto per l’idea di emigrare all’estero. Quelli che non 27 potevano o non volevano emigrare cercarono di trovare una nuova sistemazione che permettesse loro di vivere in Italia, sfruttando le possibilità loro rimaste e soprattutto la solidarietà dei loro compatrioti “ariani”. Parecchi, ancora increduli, preferirono aspettare ancora un po’ prima di decidere, per vedere intanto come si mettevano le cose. Chi in un modo, chi in un altro, tutti cercarono una soluzione ai propri problemi. La signora Volterra ci racconta come cinquemila ebrei poterono scappare negli Stati Uniti nonostante grandissime difficoltà. Infatti per gli ebrei non era possibile portare all’estero né denaro, né, tantomeno, oro8. Come potevano allora intraprendere un viaggio in paesi così lontani, dove nessun governo era disposto a mantenerli, nonostante sapessero che il non farlo avrebbe significato la condanna a morte? La signora Volterra ci spiega che l’unico modo umanamente possibile era quello dell’affidavit, cioè che una persona americana (a cui non mancasse il denaro) potesse sostenere finanziariamente gli ebrei, sempre che il governo lo ritenesse possibile. In Svizzera gli ebrei furono rinchiusi in campi per paura di un intervento nazista, ma dopo un po’ di tempo non furono più accolti, perché il governo aveva il timore che le risorse alimentari potessero terminare. Non ci fu, insomma, un paese che accogliesse apertamente gli ebrei, ed è per questo che, in particolar modo coloro che non erano molto ricchi incontrarono difficoltà enormi a scappare all’estero. Molti andarono a Roma, pensando che lì le persecuzioni non sarebbero state possibili, poiché Roma era “città aperta” e i nazi-fascisti non avrebbero osato sfidare l’autorità del papa, ma si sbagliavano. A livello individuale, le reazioni furono molte e, soprattutto in certi ambienti più integrati e professionalmente più inseriti nella tradizione e nella macchina burocratica dello Stato, moralmente traumatiche. Solo che in genere se ne è persa la memoria o questa è rimasta gelosamente circoscritta all’ambito familiare, così che spesso queste reazioni possono essere solo intuite o restano documentate in modo abbastanza vago. Guido Jung pare scrivesse ad un amico ebreo che viveva a New York “che il dovere degli 28 ebrei italiani era di venire in Italia e soffrire”9. Il R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 è stato da qualcuno considerato la “Magna Charta” del razzismo italiano. Il testo approvato dal Gran Consiglio era stato redatto con scarsissima conoscenza della realtà ebraica italiana. In secondo luogo, esso per differenziare il razzismo fascista da quello nazista e per poter realizzare la formula del “discriminare e non perseguitare” non aveva voluto imboccare decisamente la via “biologica”, che forse era l’unica possibile per chi avesse voluto un radicale antisemitismo, e si era, invece, mantenuto su un ibrido terreno un po’ biologico, un po’ religioso e un po’ politico, che seminò subito sulla strada di chi doveva legiferare e di chi doveva applicare tale legislazione tutta una serie di ostacoli e di contraddizioni. In terzo luogo - infine - il testo approvato dal Gran Consiglio, proprio perché in gran parte “politico”, fu ben presto superato dalla dinamica dell’antisemitismo fascista. Bastò poco tempo a dimostrare che il discriminare voleva dire o non “risolvere” il problema o perseguitare. Ma dopo essersene reso conto, Mussolini evitò di fare marcia indietro, anche per non creare sfiducia negli alleati tedeschi. Quindi, in un primo tempo, si cercò di attuare le deliberazioni del Gran Consiglio; poi, vista l’impossibilità di farlo senza perseguitare, si pensò di venir fuori dal vicolo cieco in cui ci si era cacciati allontanando tutti gli ebrei dall’Italia, ma si abbandonò ben presto anche questo progetto. La situazione precipitò. Agli ebrei a cui non era più possibile lasciar fare alcun tipo di professione, vennero imposti divieti a volte ridicoli come il divieto di frequentare luoghi di villeggiatura, di avere il proprio nominativo negli elenchi telefonici, di accedere negli uffici pubblici e altri ancora. Ma la cosa più immorale e contraria al diritto fu attribuire la facoltà al ministro dell’Interno di dichiarare, su conforme parere di una commissione composta di tre magistrati e di due funzionari del ministero stesso (il tribunale della razza), “la non appartenenza alla razza ebraica anche 29 in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile”. Il R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 all’art. 8 specificava ulteriormente che era di “razza ebraica” “colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera”; aggiungeva, tra i casi positivi, quello dei figli di madre ebrea e di padre ignoto; nonché, per i “misti”, considerava ebrei anche coloro che fossero iscritti ad una Comunità e coloro che avessero fatto “in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo”. Questo progetto di separazione netta tra ebrei e non ebrei, era inattuabile in un paese come l’Italia; gli ebrei erano profondamente assimilati col resto della popolazione, e, questo lo sappiamo bene, l’Ufficio per la demografia della razza, istituito il 25 luglio 1938, dovette affrontare non poche difficoltà nell’individuare gli ebrei di famiglie “miste”. Questo problema si scontrava anche con la linea politica fascista, che voleva il rafforzamento della famiglia e dei suoi valori e intendeva tutelare l’unità morale, spirituale e materiale di numerose famiglie “miste”. Sorsero problemi anche con la Chiesa. Infatti il fascismo proibì matrimoni fra ebrei e “ariani” e la Chiesa rispose affermando che il matrimonio riguardava soltanto la Santa Sede e non lo stato italiano. Tra il 1939 e il 1943, la propaganda antisemita sembrò non avere mai fine ed ebbe anche un discreto successo, come ci dimostra l’interesse suscitato dalla rivista La difesa della razza. Come ho già detto, fu grande l’aiuto degli italiani nei confronti degli ebrei, ma va detto anche che molti italiani, pur non aderendo all’antisemitismo, finirono per accettarlo come una delle tante stranezze del regime e stesero un complice velo di silenzio sulla persecuzione. I giovani fascisti erano esaltati dal razzismo - inteso in senso molto più spiritualistico che biologico - e volevano farne la forza spirituale aggregante della comunità nazionale, ma in prospettiva anche universale, che questi giovani inseguivano più di ogni altra cosa e ritenevano indispensabile per radicare veramente il fascismo nel popolo. La “scoperta della razza” costituì per questi giovani un fatto culturale importantissimo, offrendo loro 30 la chiave per “capire” finalmente la causa dell’inadeguatezza della cultura fascista e per proporre una sorta di nuovo fascismo più giusto, più sociale, più morale, in nome di nuovi valori. La caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, fu accolta dagli ebrei con giubilo anche maggiore di quello degli altri italiani: per essi significava una doppia liberazione, dalla tirannide fascista e dalla persecuzione, forse con eccessivo ottimismo. Infatti la Demografia e Razza continuò ad esistere e con lei la legislazione razziale; inoltre gli ebrei erano minacciati dalla presenza tedesca in Italia. Se qualcuno riuscì a trovare scampo, la maggior parte degli ebrei rimase in balìa della ferocia nazista. I tedeschi si affrettarono a rafforzare la loro presenza militare per prevenire, o punire, l’ormai prevedibile defezione. Quando, l’8 settembre, fu reso noto l’armistizio, essi stavano già procedendo a una sistematica occupazione di tutta la parte centro-settentrionale dell’Italia. Il 12 settembre 1943, un commando di paracadutisti tedeschi liberò Mussolini dalla prigionia di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Dopo poco tempo Mussolini dette vita a un nuovo stato fascista, la Repubblica Sociale Italiana. La politica antisemita della RSI fu determinata di fatto - come gran parte di tutta la vita del rinato regime fascista a Nord - dai tedeschi, direttamente o attraverso il loro uomo di fiducia, Giovanni Preziosi. L’intenzione di Mussolini era di concentrare sino alla fine della guerra tutti gli ebrei, il che voleva dire facilitarne la deportazione da parte dei tedeschi, e quindi sterminarli. Chi aderì alla RSI credeva di salvare l’onore italiano, ma in pratica si mise al servizio dei nazisti. Nei primi mesi la politica antisemita della RSI fu in un certo senso ancora abbastanza moderata, ma non si può dire altrettanto degli atti di violenza nazisti. I tedeschi pretendevano la consegna degli ebrei via via concentrati. Il 15 marzo 1944 fu creato alle dipendenze della presidenza del Consiglio un Ufficio per la razza, a capo del quale fu messo Giovanni Preziosi. Anche se la RSI ebbe, rispetto agli ebrei, un atteggiamento diverso da quello dei tedeschi, indubbiamente più umano e lontano da 31 ogni idea di sterminio in massa, è altresì un fatto che all’atto pratico la RSI non solo tollerò e assistette agli arresti indiscriminati, ai massacri, alle deportazioni praticati dai tedeschi in spregio alle sue leggi, ma, in innumerevoli casi, collaborò ad essi. Fu confermato il 9 ottobre 1943 che la Gestapo aveva deciso di estendere anche all’Italia la “soluzione finale”. Le autorità centrali fasciste contrapposero a parole la “loro” legislazione. In pratica, dovettero però rassegnarsi a subirla passivamente, macchiandosi così di una complicità di fatto dalla quale non potranno certo mai essere assolte. Quanto alle autorità periferiche, civili e militari, regolari e soprattutto autonome, esse parteciparono su vasta scala alla caccia all’ebreo, pur sapendo che essa andava ben oltre le leggi e le istruzioni del governo repubblicano e che agli ebrei catturati i tedeschi riservavano una sola sorte: la morte. I tedeschi pagavano un “premio” per ogni ebreo catturato e ciò attirò molti civili a questa caccia. Non bisogna tuttavia dimenticare che al processo di Gerusalemme è stato affermato che ogni ebreo italiano che è sopravvissuto deve la sua vita agli italiani10. Nonostante si sia messo in buona luce l’atteggiamento italiano in una situazione che certamente era divenuta assai peggiore altrove, non bisogna dimenticare che queste verità non rendono la persecuzione meno mostruosa. In un certo senso, anzi, ne aggravano il significato morale oltre che materiale e dimostrano come il fascismo avesse precipitato l’Italia in un baratro morale e materiale da cui era impossibile risalire e in cui si poteva solo sprofondare ulteriormente. Un baratro che ci rende in parte responsabili dello sterminio di oltre sei milioni di ebrei. La caccia agli ebrei fu condotta con sistematicità tutta tedesca con l’ausilio degli elenchi degli ebrei che erano stati redatti dopo il 1938 dalle questure e continuamente aggiornati su richiesta della Demografia e Razza. La questione dei suddetti elenchi è molto controversa, perché erano quanto di più arbitrario si possa immaginare, con inclusioni e omissioni ugualmente inspiegabili. Come siano stati compilati, e su quali indicazioni, nessuno è an- 32 cora riuscito a sapere. Dobbiamo escludere che gli elenchi siano stati presi dall’archivio della Comunità poiché vi figuravano solo i contribuenti, mentre negli elenchi dei tedeschi figuravano in prevalenza famiglie che non avevano mai pagato contributi. Chi crede che siano stati presi dai gruppi rionali fascisti, che si presume avessero liste complete dei “cittadini di razza ebraica” sarebbe smentito poiché quegli enti avevano subito gli assalti degli antifascisti dopo il 25 luglio e la stessa cosa era avvenuta ai Commissariati di PS. Ci sembra quindi inevitabile concludere che i tedeschi fossero ricorsi alla Direzione della Demografia e Razza presso il Ministero dell’Interno. Ma allora ci si domanda: perché dopo il 25 luglio non si pensò ad eliminare quei registri e quelle schede? E se non dopo il 25 luglio, perché non almeno dopo l’8 settembre, come in altri ministeri si fece per altri documenti? La negligenza del luglio diventa nel settembre criminosa responsabilità di una caccia di spietata crudeltà che segnò la sorte di migliaia di ebrei. Solo a Roma i razziati furono più di duemila e, come avevo detto all’inizio, in totale i deportati furono 7495, di cui solo 610 riuscirono a tornare. Il metodo che fu spesso adottato dai tedeschi fu quello di illudere prima gli ebrei di potersi salvare pagando, per poi deportarli, impadronendosi al tempo stesso dei loro beni. Dall’8 al 25 settembre ’43 gli ebrei romani non furono molestati. Il 26, improvvisamente, il presidente dell’Unione Almansi e il presidente della Comunità Foà furono convocati “per comunicazioni” presso l’ambasciata tedesca dal comandante della polizia, il famigerato maggiore delle SS Kappler. La richiesta dei tedeschi era dura e secca: entro 36 ore gli ebrei avrebbero dovuto versare all’ambasciata tedesca 50 kg d’oro che sarebbero serviti per rifornire di armi il loro esercito. Quando fu chiesto se venissero fatte distinzioni Kappler rispose secco: “Io non faccio distinzione fra ebreo ed ebreo. Iscritti alla Comunità o dissociati, battezzati o misti, tutti coloro nelle cui vene scorre una goccia di sangue ebraico sono per me uguali. Sono tutti nemici11. L’unica con- 33 cessione da parte del maggiore fu quella di accettare il pagamento anche in sterline e in dollari, ma non in lire, poiché di queste posso stamparne da me quanta ne voglio12.” Ebbe così inizio la raccolta dell’oro. La Santa Sede fece sapere di essere disposta a dare l’oro che fosse eventualmente mancato e che la Comunità non si preoccupasse per la restituzione, ma di questo aiuto non vi fu bisogno: furono raccolti per tempo quasi ottanta chili d’oro (la differenza fu messa in salvo), in buona parte erano effetti personali che costituivano tutto ciò che le povere famiglie del ghetto romano possedevano. Alla consegna i tedeschi cercarono di imbrogliare, non ci riuscirono e, preso l’oro, si rifiutarono però di rilasciare qualsiasi ricevuta dell’avvenuta consegna. Ottenuto l’oro, i tedeschi misero subito in atto la seconda parte del loro piano criminoso. La Comunità e la Sinagoga furono saccheggiate, il furto dei preziosissimi libri della biblioteca della Comunità fu lasciato impunito. Finché non si giunse all’alba del 16 ottobre 1943. Per descrivere cosa avvenne quella mattina, preferisco riportare il rapporto ufficiale inviato, a firma di Kappler, via radio al generale delle SS Wolff da Roma: “Oggi è stata iniziata e conclusa l’azione antigiudaica seguendo un piano preparato in ufficio che consentisse di sfruttare le maggiori eventualità. Sono state messe in azione tutte le forze a disposizione della polizia di sicurezza e di ordine. In vista della assoluta sfiducia nella polizia italiana, per una simile azione, non è stato possibile chiamarla a partecipare. Perciò sono stati possibili singoli arresti con 26 azioni di quartiere in immediata successione. Non è stato possibile isolare completamente delle strade, sia per tener conto del carattere di Città Aperta sia, e soprattutto anche per l’insufficiente quantità di poliziotti tedeschi in numero di 365. Malgrado ciò, nel corso dell’azione che durò dalle 5.30 fino alle 14.00, vennero arrestati in abitazioni giudee 1259 individui, e accompagnati nel centro di raccolta della Scuola Militare. Dopo la liberazione dei meticci e degli stranieri (compreso un cittadino vaticano), delle famiglie di matrimoni misti compreso il coniuge ebreo, del personale di casa ariano e dei subaffittuari, rimasero presi 1007 Giudei. Il trasporto fissato per lunedì 18 ottobre ore 9. Accompagnamento di 30 uomini della polizia di ordine. Comportamento della popolazione italiana chiaramente di resistenza passiva; che in un gran numero di casi singoli si è mutata in prestazioni di aiuto attivo. 34 Per es. in un caso, i poliziotti vennero fermati alla porta di un’abitazione da un fascista in camicia nera, con un documento ufficiale, il quale senza dubbio si era sostituito nella abitazione giudea usandola come propria un’ora prima dell’arrivo della forza tedesca. Si poterono osservare chiaramente anche dei tentativi di nascondere i giudei in abitazioni vicine, all’irrompere della forza germanica ed è comprensibile che, in parecchi casi, questi tentativi abbiano avuto successo. Durante l’azione non è apparso segno di partecipazione della parte antisemita della popolazione: ma solo una massa amorfa che in qualche caso singolo ha anche cercato di separare la forza dai giudei. In nessun caso si è fatto uso di armi da fuoco.”13 Nei giorni successivi la razzia continuò ancora. Molti ebrei però erano stati informati e riuscirono a mettersi in salvo in tempo. Altri invece, per sottrarsi all’arresto, si uccisero; alcuni, malati, morirono per la paura. A guerra finita, di questa massa di infelici non ne sarebbero tornati che quindici, quattordici uomini e una donna, Settimia Spizzichino. Per valutare l’aiuto prestato dalla popolazione italiana agli ebrei nel periodo della Repubblica Sociale Italiana e dell’occupazione tedesca dell’Italia è opportuno partire da una considerazione di tipo statistico. Secondo le stime più attendibili, elaborate dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, in tale periodo circa 1000 ebrei militavano nella Resistenza, dai 500 ai 600 erano passati in Svizzera, quasi 4000 erano già presenti o erano riusciti a raggiungere le regioni meridionali liberate dagli Alleati, circa 7000 infine, furono i deportati o gli uccisi in Italia. Gli ebrei salvatisi nelle zone controllate dalla RSI e dai tedeschi sarebbero stati quindi circa 27000. Un numero in sé non elevatissimo, ma significativo, specie in confronto alle altre situazioni nazionali, e che si può spiegare in gran parte solo grazie alla solidarietà mostrata verso gli ebrei, italiani e stranieri, dalla popolazione italiana. Contribuirono in particolar modo a questo salvataggio le popolazioni contadine e umili dell’Italia centrosettentrionale. Sebbene al loro interno non mancassero elementi filofascisti o timorosi delle gravi sanzioni previste a carico 35 di coloro che avessero ospitato o aiutato gli ebrei, l’opera solidale delle popolazioni rurali, fu fondamentale perché gli ebrei rifugiatisi in quelle zone potessero sottrarsi alle persecuzioni e ai disagi dell’ambiente. Nessuna indagine è stata finora compiuta per individuare e studiare le ragioni di questo atteggiamento, ed è anche per questo che mi sono interessato personalmente a fare una ricerca volta a contattare persone che hanno nascosto e salvato diversi ebrei dalla strage. Mi sembra doveroso nominare di nuovo in proposito Mario Baer, che a Firenze riuscì da solo a salvare centinaia di ebrei nascondendoli in famiglie di gente comune, disposta a fare enormi sacrifici per salvare la vita ad un ebreo, o per meglio dire ad un uomo. L’ebreo perseguitato appariva immune da colpe, e, in quanto tale, meritevole di aiuto. Bisognava aiutare compromettendosi il meno possibile per salvare la propria roba, che era indispensabile per la sopravvivenza, vera e unica ragione di vita. Motivi dell’aiuto possono essere quello dell’ostilità alla guerra e a chi l’aveva scatenata, nelle popolazioni alpine l’ostilità nei confronti dei tedeschi, la convinzione di alcuni che credevano che gli ebrei rappresentassero un esempio di correttezza e di onestà che andava ricambiato, o più semplicemente per lo spirito umanitario della gran parte della gente umile. Tutto questo spinse ad aiutare gli ebrei ridotti alla condizione di fuggiaschi. La Chiesa aiutò molti ebrei più nelle città che nelle campagne, dove l’aiuto era fornito quasi esclusivamente dai contadini. L’atteggiamento del Vaticano fu eccessivamente moderato, fin dal 1938, fino a raggiungere lo scandalo il 16 ottobre 1943, quando circa duemila ebrei furono portati via sotto gli occhi del papa, senza che questi facesse niente. Giacomo Debenedetti ricorda così quei momenti in cui i giovani nazisti stavano trasportando gli ebrei attraverso la città. A taluni di quei giovanotti (i nazisti) non sembrò vero di poter disporre di un automezzo, sia pure carico di ebrei razziati, per fare un po’ di giro turistico della città. Sicché, prima di raggiungere il luogo di concentramento, i disgraziati che stavano nell’interno dovettero subire le più ca- 36 pricciose peregrinazioni, sempre più incerti sul loro destino e, ad ogni nuova svolta, ad ogni nuova via che infilassero, assaliti da diverse e tutte inquietanti congetture. Naturalmente, la meta più ambita di quei camion era Piazza S. Pietro, dove parecchi dei camion stazionarono a lungo. Mentre i tedeschi secernevano i “wunderbar” da costellarne il racconto che si riservavano di fare, in patria, a qualche Lili Marleen, dal di dentro dei veicoli si alzavano grida e invocazioni al Papa, che intercedesse, che venisse in aiuto. Poi i camion ripartivano, e anche quest’ultima speranza era svanita.14 NOTE 1 Cfr. G. Debenedetti, 16 ottobre 1943, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 21-22. Per il presente lavoro, oltre al citato testo di Debenedetti, si sono tenuti presenti anche: R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1994 e AA. VV., La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 1938, Camera dei Deputati, Roma, 1998. 2 Cfr. De Felice, op. cit., pp. 456-466. 3 Informazione diplomatica n.18 del 5 agosto 1938 in R. De Felice, op cit., p. 293. 4 Ivi, p. 304. 5 L’intervista a Mario Baer è in F. Lucci, “La persecuzione contro gli ebrei a Firenze”, in questo volume. 6 Ivi, p. 321. 7 Cfr. R. Farinacci, La Chiesa e gli Ebrei, Roma XVII (dicembre 1938), in R. De Felice, op cit., p. 322. 8 L’intervista a G. Volterra è in M. Manetti, “L’ideologia nazista e l’emigrazione ebraica”, in questo volume. 9 Cfr. De Felice, op. cit., p. 338. 10 Ivi, p. 461. 11 Ivi, p. 467. 12 Ibidem. 37 13 Il documento è stato presentato dall’accusa al processo contro A. Eichmann , Cfr. R. De Felice, op. cit., pp. 469-470. 14 Cfr. G. Debenedetti, op. cit., pp. 59-60. 38 LA PERSECUZIONE CONTRO GLI EBREI A FIRENZE Francesco Lucci Prima di tutto credo sia necessario capire quali difficoltà si possano incontrare durante le ricerche su tali eventi, quali la deportazione o la persecuzione degli ebrei, difficoltà che derivano da più fattori: non esistono documenti contemporanei dei fatti, dal momento che le catture avvenivano in completa segretezza; solo dopo la Liberazione si è potuto accertare il numero degli ebrei residenti e deportati a Firenze, ma il risultato è comunque molto generico perché non tiene conto di tutti quegli ebrei provenienti da altre località italiane ed estere, un numero tra l’altro notevole, visto che Firenze era considerata come una “città libera”. Le principali testimonianze sono fornite dai documenti raccolti sia presso il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, sia presso l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana di Firenze (logicamente nessun dato viene fornito dalla stampa fascista che invece condannava sia gli ebrei che i “pietisti”, coloro cioè che cercavano di aiutare gli ebrei stessi).1 LA COMUNITÀ EBRAICA FIORENTINA ALLA VIGILIA DELL’OCCUPAZIONE NAZISTA DI FIRENZE 1) La situazione degli ebrei fiorentini La vita degli ebrei italiani era già stata sconvolta da cinque anni di rigida applicazione delle leggi razziali emanate nel 1938 e nella prima metà dell’anno successivo. Ma forse i provvedimenti più drastici giunsero dalle autorità locali che, spinte dalla legislazione fascista, si sentirono in diritto di considerare gli ebrei come cittadini di seconda categoria, aumentando così i divieti e le proibizioni. 39 Inizialmente le leggi razziali giunsero completamente estranee non solo agli ebrei, che si erano integrati perfettamente nella società, ma anche agli italiani che non avevano mai dimostrato rancori verso di loro. Ormai gli ebrei erano e si sentivano a tutti gli effetti italiani. Prima del fascismo e durante i suoi primi anni di esistenza, l’antisemitismo era quindi un fenomeno sconosciuto in Italia; c’era solamente qualche sporadica manifestazione, frutto più di scontri sociali che di ideologie razziali. Con la legislazione antisemita nacque un senso di tradimento negli ebrei, soprattutto perché moltissimi italiani, per paura di essere condannati come pietisti, preferirono dimostrarsi antisemiti. Questa mancanza di solidarietà fu il maggiore risultato della legislazione fascista antisemita la quale poggiava molto sul mettere in ridicolo coloro che portavano aiuto a persone considerate socialmente e moralmente inferiori. Il fascismo volle colpire anche economicamente gli ebrei: un documento della “Direzione Generale per la Demografia e Razza” afferma che gli ebrei appartenenti alle categorie che vivevano solo con il ricavato del proprio lavoro non potevano più procacciarsi il fabbisogno per il sostentamento delle proprie famiglie (la disoccupazione tra gli ebrei giunse ad un 40%). Con il sopraggiungere della guerra le condizioni degli ebrei peggiorarono perché il fascismo sfruttava ogni minima occasione per presentare agli italiani “l’internazionale ebraica” come “mortale millenaria nemica della romanità e della cristianità”.2 Il 4 giugno 1940 il Ministero dell’Interno ordinò di compilare gli elenchi di tutti quegli ebrei ritenuti potenzialmente in grado di compiere propaganda antifascista. Il 6 maggio 1942, il ministro dell’interno ordinò la precettazione civile a scopo di lavoro per tutti gli appartenenti alla “razza ebraica” compresi tra un’età di 18 e 55 anni, un provvedimento nato per porre fine al malcontento popolare per “la scandalosa situazione di privilegio goduta dagli ebrei, esclusi dal servizio militare e dediti all’affarismo e 40 all’ozio”.3 Così nella prima metà del 1943, furono avviati al lavoro coatto dai cinquanta ai cento ebrei al mese. L’antisemitismo fascista indusse molti ebrei che erano in grado di farlo ad abbandonare l’Italia; principalmente furono i sionisti più convinti a partire (Firenze con Trieste erano le due città italiane con il maggior numero di sionisti). Così negli anni che seguirono la legislazione razziale, la popolazione fiorentina ebraica, ed in genere quella italiana, subì una netta diminuzione. 2) La comunità israelitica di Firenze Le leggi del 1938-39 colpivano gli ebrei come persone, ma lasciavano in vigore la legge del 30 ottobre del 1930 sull’organizzazione delle singole Comunità e dell’Unione delle comunità. Anche a Firenze quindi, la Comunità Israelitica poté continuare ad esistere ufficialmente e a svolgere la propria attività. Tuttavia le ripercussioni dell’antisemitismo furono gravi sia direttamente che indirettamente con l’allontanamento dei suoi principali membri. In un primo momento alcune comunità cercarono di ammansire la legislazione fascista schierandosi a favore di essa; ma poi i principali esponenti antifascisti, momentaneamente emarginati dalla precedente linea politica, sentirono il bisogno di una riscossa morale. Anche la comunità israelitica fiorentina, sotto la guida di tali uomini, fu rinnovata: nei primi anni della guerra tutti gli alunni ebrei poterono frequentare i corsi scolastici, anche universitari; a molti disoccupati fu ritrovato lavoro; vennero organizzati centri estivi per i giovani; non mancarono fondi a favore degli ebrei stranieri ed infine la cattedra rabbinica fu presa da un giovane di eccezionale levatura: Nathan Cassuto.4 3) I 45 giorni di Badoglio Con la caduta del fascismo gli ebrei sperarono in un miglioramento; purtroppo Badoglio, anche se abolì i provvedimenti più tipicamente fascisti, non revocò la legislazione razziale. Il mantenimento di tutto l’apparato antisemita avrebbe agevolato ben pre- 41 sto il vero e proprio sterminio da parte dei nazisti. L’abolizione dell’antisemitismo era un provvedimento che avrebbe dovuto avere la priorità su tutti gli altri: il Partito d’Azione affermò a Firenze che, caduto il fascismo, il popolo italiano non poteva più tollerare l’esistenza dell’antisemitismo, e ribadì inoltre che, se tale mentalità non fosse stata distrutta, il regime ed il suo partito non sarebbero scomparsi. La conclusione giunse necessaria: uguaglianza assoluta di tutti i cittadini senza distinzione di razza o di religione. Queste richieste non ebbero nessuna influenza sul governo Badoglio, il quale si limitò a fare concessioni di poco conto. Rimasero quindi di fondo i sospetti antiebraici: ne è testimonianza una circolare inviata l’11 agosto ai questori della Toscana sulle revoche delle limitazioni al soggiorno turistico; il 18 dello stesso mese il questore di Pistoia chiedeva ai carabinieri dei principali centri della provincia una documentazione sulle finanze degli ebrei di tali località, motivando la richiesta con esigenze di mobilitazione di lavoro. Un altro provvedimento, purtroppo giunto tardivo, fu la parificazione per le pratiche di rilascio del passaporto. Quindi, l’unica decisione importante fu quella di restituire la libertà agli ebrei che erano stati confinati o internati in campi. Ma in pratica i principali benefici in questi quarantacinque giorni gli ebrei li trassero dalla tolleranza delle nuove autorità locali che spesso non applicarono le disposizioni legali. A Firenze, per esempio, poté essere costituita in via dei Rustici una sezione della DELASEM dei Piccoli.5 Eppure i dirigenti dell’ebraismo non cercarono mai di opporsi efficacemente alle inique leggi; anche i contatti tra le comunità e il governo, seppur molto scarsi, non ebbero alcun frutto positivo. Comunque, le poche concessioni e la cessazione della propaganda antisemita erano i primi segni di un ritorno alla normalità. Ciò che frenò l’abolizione delle leggi razziali fu l’alleanza italo-tedesca: essa infatti si sarebbe automaticamente spezzata con la fine dell’antisemitismo italiano. Fu proprio in questo momento che gli ebrei dimostrarono una fortissima soli- 42 darietà (la salvezza della collettività sarebbe stata quella dei singoli). In conclusione, coloro che non hanno attenuanti di alcun genere furono Badoglio e il re Vittorio Emanuele III, prima di tutto per aver mantenuto i vecchi documenti fascisti sugli ebrei. 4) L’affluenza degli ebrei stranieri Per lo più, i primi ebrei emigrati in Italia furono tedeschi, dopo l’ascesa di Hitler: alcuni si fermarono solo momentaneamente per poi spostarsi in altri paesi. Altri si stabilirono soprattutto nelle città, più industriali, nate nel nord. In primo momento, il fascismo non li ostacolò, ma già il 7 settembre 1938 vietò agli ebrei stranieri la stabile dimora in Italia ed intimò ai circa diecimila che già vi si trovavano di lasciare il paese entro sei mesi. Nel giugno del ’40 fu infine disposto l’internamento degli ebrei stranieri in campi nati appositamente nel centro-sud d’Italia. Nonostante tutto, molti ebrei continuarono ad affluire, compresi coloro ai quali era ufficialmente vietato. L’Italia rappresentò fino al settembre del ’43 una tappa verso la salvezza (la sola DELASEM tra il 1939 e il 1943 fece emigrare cinquemila ebrei soprattutto verso la Spagna e il Portogallo). Da questo flusso migratorio Firenze rimase piuttosto ai margini, probabilmente per la sua posizione decentrata rispetto agli itinerari che portavano verso i grandi porti italiani. La situazione cambiò nel settembre 1943: infatti, con le trattative di armistizio portate avanti da Badoglio con gli alleati, tutti quegli ebrei dei territori conquistati dal fascismo, quali la Francia, la Grecia, la Tunisia, nei quali avevano fino adesso vissuto sotto protezione delle autorità locali e del fascismo stesso, cominciarono a fuggire verso l’Italia per evitare il dominio nazista. Così, circa duemilacinquecento ebrei, provenienti soprattutto dalla Savoia francese, cercarono la salvezza nel nostro paese. Si rivelò però un tragico errore: infatti, quando i nazisti entrarono in Italia, dodicimilacinquecento ebrei stranieri non erano ancora riusciti a scappare. Molti ebrei cercarono di raggiungere i territori già libe- 43 rati dagli alleati; ecco perché a questo punto Firenze divenne una tappa obbligata. GLI EBREI A FIRENZE DALL’ 8 SETTEMBRE AL DICEMBRE 1943 1) I primi giorni dell’occupazione nazista Alle 19.30 dell’8 settembre fu trasmesso il messaggio di Badoglio che annunciava l’armistizio. Firenze, come tutta l’Italia, accolse la notizia con gioia commossa. Ma la fuga in gran segreto di Badoglio e del re fu causa di disillusione. I partiti appena ricostituiti furono i primi ad accorgersi della grave situazione; essi, anche a Firenze, prima si unirono nel Comitato interpartitico fiorentino e subito dopo nel Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, e lo stesso 9 settembre invitarono i fiorentini alla resistenza. Ma l’esercito italiano era ormai allo sfascio ed occupato anche nel placare le sommosse popolari. Quindi l’11 settembre una truppa di tedeschi occupò senza opposizione la città, scendendo da via Bolognese. Nelle prime settimane di assedio, i nazisti non eseguirono un rastrellamento sistematico degli ebrei, sia perché impegnati nell’arrestare l’avanzata alleata, sia per non provocare sommosse o rivoluzioni popolari. Con l’occupazione tedesca, si fecero nuovamente avanti i fascisti che non tardarono, il 13 settembre, a sfilare per la città inneggiando al duce; fu addirittura ricostituita la 92° legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che costituì anche un vero e proprio “Ufficio politico investigativo” noto come banda Carità.6 Anche il partito si ricostituì rapidamente, con Onorio Onori prima, e Raffaele Manganiello dopo. Il 28 ottobre si tenne una manifestazione in piazza in ricordo del 21° anniversario della marcia su Roma: testimonia Berenson “appena duecento camicie nere in corteo, per lo più monellacci di strada”.7 Logicamente il fascismo repubblicano fiorentino riprese appieno l’antisemitismo, spesso di propria iniziativa o in collaborazione con i nazisti nei confronti dei quali mostrò un estremo servilismo. 44 In un primo momento gli ebrei non videro l’imminente problema e non si immaginarono ciò che li aspettava. Fu un atteggiamento piuttosto strano visto anche che l’eco degli avvenimenti accaduti in Germania e in Polonia doveva ormai essere arrivata. Probabilmente le notizie giungevano frammentarie e soprattutto sembravano troppo mostruose per essere vere; un’ebrea del tempo afferma: “....credevamo fosse solo propaganda; al tempo stesso credevamo che la situazione degli ebrei d’Italia fosse speciale....”.8 Gli ebrei pensavano che al massimo sarebbero stati costretti al lavoro coatto o internati in campi di concentramento italiani; addirittura i “discriminati”, coloro cioè in condizioni più agiate, credettero di poter mantenere le solite condizioni di privilegio (in fondo il regime aveva dato l’opportunità di vivere, e così si sperava di continuare a fare). A Firenze il rabbino Cassuto capì subito l’imminente catastrofe. Contro tutte le aspettative, i tedeschi applicarono fermamente la loro logica antiebraica senza risparmiare nessuno. Il problema maggiore fu capire quali mutamenti fossero necessari per tentare la salvezza: molti infatti si limitarono a ritirarsi nell’ombra con l’aiuto della popolazione, ma non bastò. Anche per la paura dei bombardamenti, molti si rifugiarono nelle campagne, una fuga che numerosi ebrei non poterono attuare perché non erano in grado di mantenersi a lungo nascosti. Ancora una volta, spicca il rabbino Cassuto che cercò, prima di tutto, di avvertire del pericolo le persone a rischio (fu forse grazie a quest’uomo che a Firenze non furono deportati tanti ebrei quanti in altre città italiane). Il problema più urgente rimaneva sempre l’afflusso di ebrei stranieri che, tra l’altro, conoscevano la ferocia nazista; privi di appoggi, chiedevano aiuto alla Comunità. Cassuto riunì intorno a sé un piccolo gruppo di persone le quali avevano contatti con le Comunità estere che si sarebbero rivelati particolarmente utili; la Comunità appoggiò appieno questo gruppo mettendo a disposizione fondi e locali attrezzati per l’alloggio (grazie anche all’aiuto di Artom, sempre in lotta contro l’antisemitismo).9 45 Mentre si cercava di portare avanti questi progetti, iniziarono a circolare voci riguardo ad una richiesta di una lista di ebrei in cui compariva anche il nome di Artom: quest’ultimo decise prudentemente di chiudere il centro di accoglienza profughi. Molte famiglie che da anni ormai contavano sull’appoggio della Comunità si trovarono abbandonate in un momento particolarmente difficile; si cercò di rimediare dando loro un sussidio per tre mesi (fu il massimo che la Comunità poté fare, accollandosi prestiti per un ammontare di quarantamila lire). 2) La nascita del comitato di ebrei e cattolici e la sua azione in favore degli ebrei stranieri La chiusura della Comunità aggravava il problema di assistenza agli ebrei stranieri che continuavano ad affluire a Firenze. Il gruppo di Cassuto, nonostante l’impegno, non riusciva più a gestire la situazione. Così Cassuto e Matilde Casini, un’altra esponente dell’organizzazione, decisero di chiedere aiuto alla Chiesa cattolica fiorentina; i contatti con il cardinale Elia Dalla Costa furono tenuti tramite Giorgio La Pira, che abitava allora nel convento di San Marco. L’appoggio giunse ed il cardinale convocò immediatamente il padre domenicano Cipriano Ricotti di San Marco e poi don Letto Casini di Varlungo: incaricò entrambi di trovare alloggi ai profughi presso istituti o conventi della diocesi. Grazie a Ricotti e a Casini, che entrarono nel comitato, l’assistenza assunse in breve proporzioni notevoli (testimonia padre Ricotti che capitò addirittura di cercare alloggi durante i bombardamenti sul Campo di Marte il 25 settembre). Il primo compito del comitato era quello di contattare i profughi, accoglierli alla stazione, smistarli verso i rifugi; talvolta, i profughi arrivavano alla Comunità dove era rimasto Cassuto. Se non c’erano rifugi pronti, venivano mandati al Seminario minore, un luogo reso abbastanza sicuro come rifugio provvisorio. I luoghi di ospitalità definitivi erano per la maggiore conventi e istituti religiosi (oggi ne conosciamo ventuno, ma forse ve n’era- 46 no di più). Questa ospitalità era particolarmente rischiosa, ma la solidarietà umana e una forte pietà ebbero la meglio. Comunque non mancarono esempi contrari, come quello di una suora del convento delle Suore Filippine di via Giusti che scacciò un gruppo di profughi in un primo momento accolti da una consorella, affermando di non volere accogliere né uomini, né ebrei e minacciando la denuncia ai tedeschi. Proprio quel gruppo di 25-30 uomini fu sistemato in un posto meno sicuro e così fu catturato dai nazisti. Spesso, i profughi vennero accolti nelle parrocchie di campagna, una iniziativa presa quasi sempre autonomamente dai parroci; in città furono adattati garage o cercate camere in affitto, che difficilmente furono trovate perché in pochi ebbero il coraggio di sfidare i nazisti. Oltre all’alloggio, fu necessario trovare il vestiario, i viveri e documenti falsi per coloro che volevano continuare la fuga. Per i viveri ed il vestiario era principalmente il comitato che li inviava direttamente ai rifugi, oppure forniva loro i soldi necessari per comprarli (sembra che per un breve periodo abbia funzionato anche una mensa); Casini stesso afferma di essere stato a Prato a comprare i vestiti a poco prezzo. I documenti falsi invece erano stampati da una tipografia di Bologna, ed arrivavano a Firenze tramite Mario Finzi, membro della DELASEM bolognese. Poi anche padre Ricotti riuscì ad avere documenti falsi tramite contatti con la Resistenza (solitamente si facevano comparire questi documenti come emessi dai comuni del sud perché già occupati dagli alleati). I contributi finanziari comunque arrivarono prevalentemente da organizzazioni ebraiche, oppure da ricchi ebrei che mettevano a disposizione i loro patrimoni in cambio di protezione. Chi reperiva ed amministrava i fondi era Raffaele Cantoni (per tre volte fornì Casini di 75000 lire invitandolo a spenderle senza parsimonia). Quantificare quanti ebrei siano stati effettivamente aiutati dal Comitato non è facile, data la mancanza di documenti, anche 47 perché alla fine di novembre del ’43 furono arrestati quasi tutti i suoi membri. Da un unico elenco rimasto dell’Arcivescovado, gli ebrei aiutati sembrano essere stati 220, ma secondo altre testimonianze che considerano anche gli ebrei italiani, sembrano essere stati 300-400, soltanto nel periodo tra ottobre e novembre del ’43. INTERVISTA A MARIO BAER Credo sia necessario prima di tutto premettere che gli ebrei italiani erano perfettamente inseriti nella società e che poterono salvarsi solo coloro che ebbero disposizione di mezzi (soprattutto soldi). Mio padre aveva un’azienda di tessuti a Prato, la “Magnolfi”, con 120 telai, quindi molto grande. Purtroppo mio padre morì per malattia mentre ero con la mia famiglia nascosto all’Abetone: eravamo nel 1942. La nostra abitazione era in piazza D’Azeglio; dovemmo però cambiare casa e così tornammo in via Romana da mia sorella. Quando iniziarono ad arrivare gli ebrei profughi dalla Francia, riuscii a salvare circa 120 persone nascondendole o nei monasteri o nelle case: la popolazione fiorentina si è comportata molto bene: per esempio, alla Certosa del Galluzzo, dove era nascosta anche mia sorella, una suora riuscì a nascondere un bambino sotto la gonna impedendo così che le SS lo catturassero. Nonostante l’illusoria felicità, dopo l’8 settembre 1943, tutti si immaginavano il probabile arrivo dei tedeschi. Fu proprio con il loro arrivo che anche i fascisti assunsero un comportamento molto più rigidamente razziale aiutando in primo luogo le SS a trovare gli ebrei. Mi ricordo quando Carità venne da me dicendomi di avere abbandonato i fascisti e le SS e che adesso avrebbe invece voluto aiutare gli ebrei; ingenuamente, io non capii che in realtà, tramite me, voleva scoprire altri profughi nascosti. Lo feci dormire un paio di notti nella casa di via Romana. Disse poi di dover andare via. Ma ben presto tornò con una delle sue squadracce: io ero riuscito a calarmi dalla finestra nel giardino di Boboli, ma mio cognato e suo suocero furono catturati. Mia mamma era malata, così loro la lasciarono nel suo letto; purtroppo quando tornai, lei era già morta. Credo che 48 il momento più emozionante fu quando i tedeschi iniziarono la vera e propria caccia all’ebreo. Fu allora che ebbi per tre mesi contatti con il rabbino Cassuto; non ero però a conoscenza del suo vero operato: non so se riusciva a procurare documenti falsi agli ebrei che in continuazione arrivavano alla sinagoga in cerca di aiuto soprattutto dall’estero, i quali erano molto più consapevoli degli ebrei italiani di cosa fossero capaci le SS. Di Nathan Cassuto so solo che fu poi catturato dalle SS, probabilmente perché si nascose male, cioè non si rese conto di avere vicino persone che gli volevano del male. Nel dicembre del 1944 fui costretto a scappare anch’io; andai a Roma dove avevo un buon negozio insieme ad un altro socio ariano. Fu grazie a lui che riuscii a salvarmi perché mi dette la possibilità di nascondermi e mi fornì dei soldi: Va sottolineata la generosità delle persone che aiutarono gli ebrei, pur sapendo quali rischi correvano. Non è un caso infatti che la maggior parte degli ebrei catturati in Italia fossero uomini, e che venissero arrestati soprattutto all’inizio perché colti di sorpresa e prelevati all’improvviso dalle loro case. A Roma mi nascosi in un grande palazzo in centro indicatomi dal mio socio; restai qui praticamente fino alla fine della guerra. Proprio qui vissi un episodio particolarmente emozionante: arrivarono i tedeschi e cominciarono a perquisire l’intero palazzo. Ero nascosto all’ultimo piano; loro si fermarono al penultimo perché trovarono altri ebrei nascosti e credettero non ve ne fossero più lì. Comunque vi furono alcune SS che non necessariamente volevano catturare gli ebrei: mi ricordo per esempio a Firenze di aver portato due ufficiali tedeschi alla sinagoga; loro entrarono, cominciarono a leggere le scritture che vi sono tutt’oggi e poi andarono via senza catturare nessuno; probabilmente saranno stati due studiosi della cultura ebraica. Mario Baer è senza dubbio un esempio di come la solidarietà e il coraggio di un uomo siano in grado di sconfiggere qualsiasi tipo di maltrattamenti o di ideologie razziali, portate avanti con assurda irrazionalità e disumanità proprio da coloro che credono che l’uomo ariano sia il più grande essere sulla terra, un dominatore incontrastato su tutti gli altri uomini. Se tutti avesse- 49 ro seguito l’esempio di Baer, se ognuno avesse dato il suo contributo all’umanità e forse prima ancora alla sua stessa coscienza, si sarebbe potuta evitare la strage, ormai nota a tutti, dell’Olocausto? Credo sia sostanzialmente inutile ricostruire un possibile andamento dei fatti, ma forse sarebbe di fondamentale importanza che tutti capissero che nella nostra società esistono ancora persone che non restano indifferenti al deturpamento di un valore inviolabile quale quello della vita. Baer non è un superuomo o un missionario, ma una persona che davanti alla follia che talvolta nasce nell’umanità ha saputo farsi guidare dalla sua volontà piuttosto che dalla paura, ed è riuscito a non cadere, come molti altri, nell’egoismo e nell’omertà che, in un primo momento, liberano da ogni tipo di responsabilità, ma poi rendono tristemente colpevoli, consci della propria codardia. Che senso ha la vita se ogni uomo la vive in modo autonomo? Esiste forse un valore che è tale senza essere messo a confronto con altre persone? E non è forse vero che un vero valore è quello che può essere portato avanti senza danneggiare quello di un altro? 3) Ottobre 1943: estensione all’Italia della “soluzione finale”. La situazione a Firenze La protezione accordata agli ebrei dalle autorità nelle zone di occupazione italiana suscitò naturalmente il malcontento dei tedeschi. Comunque, questi non si espressero mai ufficialmente prima del febbraio del ’43, cioè quando richiesero che anche l’Italia prendesse misure radicali contro gli ebrei. In seguito a queste pressioni, il Ministero degli esteri fece rimpatriare gli ebrei che abitavano in Germania e nei territori occupati e tutti coloro che poterono dimostrare di essere italiani. L’unica concessione che i nazisti riuscirono ad ottenere fu quella di inviare in Italia degli specialisti sulla questione ebraica in qualità di consiglieri: il loro operato diventerà tragico dopo l’8 settembre. Il fatto che il fascismo opponesse una certa resistenza ai nazisti significava solo che Mussolini voleva ancora una certa indipendenza dall’alleato. I 50 nazisti tollerarono questa situazione solo perché non volevano per ora peggiorare i rapporti con l’Italia: ad una conferenza a Berlino il 20 gennaio 1942, si stabilì che l’andamento degli eventi della guerra avrebbe definito il trattamento da riservare agli ebrei italiani. L’occasione attesa giunse con l’armistizio di Badoglio stipulato con gli anglo-americani: i nazisti, diffidando a questo punto di tutti gli italiani, compresi i fascisti, presero l’iniziativa contro gli ebrei, accusati tra l’altro di avere fatto crollare il fascismo (anche Preziosi era d’accordo).10 Già nella seconda metà di settembre fu ordinato a Kappler di catturare e deportare tutti gli ebrei di Roma, accusati di avere collaborato con Badoglio. L’azione nazista in Italia ebbe una caratteristica che in nessun altro territorio occupato si è riscontrata: infatti, in Italia la deportazione, e quindi lo sterminio, non fu preceduto da provvedimenti restrittivi. Questo dipendeva da tre motivi: il pericolo imminente delle forze angloamericane che avanzavano dal sud; lo scarso numero della popolazione ebraica; provvedimenti preparatori avrebbero scaturito probabilmente proteste da parte del popolo italiano. Ecco perché fu preferita un’azione a sorpresa, purtroppo con buoni risultati. Ai primi di ottobre i tedeschi avevano in pugno le regioni a nord di Napoli e rallentavano l’avanzata nemica. Mussolini dette una parvenza di governo al fascismo. Sono di questo periodo le razzie più tragiche: il 9 ottobre 200 ebrei a Trieste, città che praticamente dal 25 settembre era annessa al Reich; lo stesso giorno ci fu l’irruzione nella sinagoga di Ancona, fortunatamente deserta; il 16 ottobre avvenne a Roma il più triste e “redditizio” episodio italiano di razzia. Arrestati soprattutto nella zona del ghetto, 1007 ebrei la mattina del 18 partirono con dei carri per la Germania: fu il primo convoglio a lasciare l’ Italia per sempre. Nello stesso giorno a Milano i nazisti approfittarono del coprifuoco per prelevare dalle loro case duecento ebrei. In tutte queste razzie comunque i nazisti fecero sempre affidamento agli elenchi continuamente aggiornati dall’ufficio di “Demografia e Razza”. Firenze nel mese di ottobre non conobbe però i tragici episodi di Trieste, Milano, 51 Roma; forse giovarono i provvedimenti precauzionali presi da Artom; ma forse perché a Firenze i nazisti non disponevano di uomini di esperienza riguardo agli ebrei (a capo delle SS c’era Alberti, un altoatesino) ed inoltre dovevano contrastare le forze partigiane. Fu fondamentale anche l’opera del rabbino Cassuto che non tardava mai ad avvertire dei momenti di pericolo. Purtroppo, i primi a cadere in mano dei nazisti furono i malati che non potevano resistere in condizioni di clandestinità e i poveri che non potevano permettersi di fuggire. In questa situazione il comitato dovette intensificare la propria azione di soccorso, anche perché cominciarono ad affluire ebrei dalle città italiane occupate, sperando di poter fuggire verso i territori già in mano degli alleati. A tutti questi si sommavano gli ebrei poveri fiorentini che non avevano più di che vivere; a questo si cercò di rimediare dando, a chi ne necessitava, un sussidio settimanale di 10 lire. 4) Gli arresti nei primi giorni di novembre La prima operazione antisemita a Firenze avvenne nei giorni 6 e 7 novembre e coinvolse non meno di 200 ebrei. Purtroppo, le notizie sull’accaduto sono scarse: come dire il Berenson nel suo diario, il console tedesco affermò il giorno seguente che duecento ebrei tedeschi e polacchi erano stati catturati e portati in Germania e che la razzia era stata possibile grazie all’aiuto della milizia fascista ubriaca. Il numero degli arresti era ancora esiguo, grazie al soccorso offerto dalla popolazione. Altre fonti indicano un numero più alto di deportati, catturati soltanto nella sinagoga. Questa è la probabile ricostruzione dei fatti: la mattina del 6 novembre le SS, forse guidate da Alberti, fecero irruzione nella sinagoga, trovandola però vuota (era rimasto solo il custode Gino Tedeschi), perché il tempio era stato chiuso al culto già da un mese. Quindi gli arresti furono eseguiti all’interno dei locali adiacenti la sinagoga, usati da sempre come alloggio provvisorio per gli ebrei profughi appena arrivati. “Quei locali erano i primi alloggi dove venivano accolti i profughi per una notte al massimo; ogni notte si sperava 52 che i tedeschi non arrivassero, ma quella notte purtroppo non fu così” come mi ha riferito la prof.ssa Lionella Viterbo. Oltre agli ebrei, in questi locali, furono probabilmente arrestati anche quelli che, arrivati da poco, si recarono ignari del pericolo a pregare nel tempio. Ma, nello stesso giorno, le SS, senza dubbio guidate dai fascisti, cercarono di cogliere di sorpresa gli ebrei fiorentini nelle proprie case. Infine, nella notte tra il 6 e il 7, i nazisti entrarono nel garage in cui era stato sistemato il gruppo di 25-30 ebrei polacchi scacciati dal convento delle suore Filippine. Tutti gli arrestati partirono da Firenze il martedì successivo, 9 novembre, con il secondo convoglio di deportati dall’Italia; ivi erano stati rinchiusi più di trecento ebrei, fra cui 85 italiani e non meno di duecento catturati a Firenze insieme a 40 tra fiorentini e italiani che per vari motivi si trovavano nella città; ce n’erano inoltre 20 arrestati a Montecatini, e a Bologna si aggiunsero 17 italiani e un numero imprecisato di stranieri. Tutti erano diretti al campo di Auschwitz-Birkenau dove furono selezionati: solo 13 uomini e 94 donne furono mandati nei campi di lavoro (spesso anche chi superò la selezione trovò la morte, soprattutto nel ‘44-’45 durante i trasferimenti da un campo all’altro). Non mancarono episodi in cui le bande Carità si resero protagoniste di razzie nelle case. Ormai gli ebrei fiorentini vivevano nascosti, dovendosi difendere dai nazisti e dai fascisti delle bande Carità che avevano iniziato la loro opera di fiancheggiamento. Contemporaneo a questi eventi fu il primo articolo su “Repubblica”11, scritto da Gian Forzino, che sosteneva che gli ebrei erano i primi nemici dell’Italia, fonte di ogni male e che non si poteva parlare di pace fin quando non fosse stato eliminato l’ebreo. In conclusione, con il consenso di Preziosi, si vedeva nella Germania l’unica nazione che poteva considerarsi veramente libera e svincolata da ogni possibile opposizione nemica. 5) La seconda ondata di arresti alla fine di novembre. a) L’arresto dei membri del Comitato Le razzie del 6-7 novembre non rallentarono l’attività del Comitato, adesso più propenso ad aiutare coloro che già si trova53 vano nella città; gli arrivi di profughi infatti erano notevolmente diminuiti, poiché i fatti avevano dimostrato che neppure Firenze era una città sicura. Le persecuzioni raddoppiarono e costrinsero Matilde Cassin, ormai troppo conosciuta come ebrea, a nascondersi, mentre padre Cipriano Ricotti fu trasferito a Prato dove comunque cercò di continuare nella sua attività. Ma di fatto restavano impegnati direttamente Cassuto e pochi altri. Da qualche tempo si era inserito un giovane torinese, Felice Ischio: si capì dopo che era una spia delle SS. Probabilmente alcune razzie, forse anche quelle del 6-7 novembre, furono fatte grazie alla sua complicità; rimangono invece misteriosi i motivi che poco dopo lo portarono a gettare la maschera. Nel tardo pomeriggio del 26 novembre il Comitato tenne un’assemblea in via Pucci: fu interrotta da un’improvvisa irruzione di alcune SS guidate da un capitano (Alberti?). Dopo essere stati perquisiti, i componenti furono portati al numero 88 di via Bolognese, di fronte allo stabile, conosciuto come “Villa Triste”. Sotto la minaccia delle armi e sotto percosse furono probabilmente costretti a parlare; purtroppo l’unica testimonianza è quella di Casini, al quale non restò altro che ammettere di aver procurato i documenti falsi agli ebrei. b) Le retate nei conventi Nella stessa notte, i nazisti, ancora una volta guidati dai repubblichini, fecero irruzione nel convento delle Suore Francescane di piazza del Carmine dove erano stati ospitati trenta donne ed un numero imprecisato di bambini. Le SS armate perquisirono tutti i locali e riuscirono a catturare tutti, arrestando pure la madre superiora. Riuscì a salvarsi solo una giovane, concedendosi ad un fascista. Le SS e i fascisti irruppero anche nell’oratorio detto di San Giuseppe, situato in via Domenico Cirillo: anche qui si salvò solo un uomo, restando immobile sotto una panca. L’ultima razzia fu fatta nel convento in via Gioberti: non si conosce quante donne con le figlie fossero nascoste qui e non si conosce neppure il numero delle arrestate, tra le quali sembra ci 54 fosse stata anche la madre superiora: alcune donne probabilmente si salvarono indossando gli abiti delle suore. Le due suore catturate furono rilasciate pochi giorni dopo, sembra grazie al cardinale Elia Dalla Costa, che si presentò direttamente agli ufficiali tedeschi. Tutti gli ebrei arrestati furono prima messi nelle carceri fiorentine e poi trasferiti a Verona dove presero la strada per il campo di Auschwitz-Birkenau. Dei 600 ebrei sul convoglio solo 61 uomini e 39 donne superarono la selezione; dei tre reduci nessuno era stato catturato a Firenze. c) Altri arresti I membri del comitato invece furono tenuti in carcere molto più a lungo e più volte interrogati: non sappiamo se siano anche stati torturati; Casini, l’unico superstite, non subì mai torture. Una sua testimonianza ci dice che i tedeschi, approfittando della giovane età di due sorelle, le convinsero a parlare, promettendo loro la libertà. Le due giovani non erano a conoscenza dei fatti più importanti o seppero tenerli nascosti: di fatto non ci furono conseguenze per i conventi ancora non razziati. Le due sorelle furono rimandate a casa dove vennero arrestate con la famiglia e deportate: entrambe trovarono presto la morte. Due membri, tra cui Felice Ischio, conosciuto come Marco, furono rilasciati, avendo dimostrato di essere ariani. In realtà, fu una mossa delle SS per permettere a Marco di continuare la sua attività di spia a spese dell’altro liberato, Joseph Ziegler.12 Anna di Gioacchino Cassuto e la cognata Hulda Cassuto Campagnano con i figli erano rifugiati in un convento. Saputa la notizia dell’arresto di Nathan Cassuto, cercarono sue notizie con la collaborazione di Saul Campagnano e Raffaele Cantoni; essi riuscirono a fissare un appuntamento con Ziegler, appena uscito dal carcere con Marco, ma fu proprio quest’ultimo a farli catturare dai tedeschi. Furono portati in via Bolognese nella sede del comando delle SS: qui fu Marco che interrogò di persona Anna di Gioacchino, la quale non ammise comunque di essere ebrea. Saul Campagnano e Cantoni vennero subito 55 dopo trasferiti a Verona e partirono per Auschwitz con il convoglio del 6 dicembre. Campagnano superò la prima selezione, ma morì poco dopo in un campo di lavoro. Cantoni invece riuscì a saltare dal treno al confine dell’Italia con la Svizzera. Cantoni, quando era in carcere a Firenze, era riuscito a mandare una lettera a Matilde Cassin, informandola che Marco era una spia. Il giovane si era già accorto che non era più di aiuto ai tedeschi; consegnò così lo Ziegler e la sua famiglia in mano ai tedeschi, indicando loro il luogo dove erano nascosti (la casa del giardiniere del seminario minore) e si impadronì di tutti i preziosi della ricca famiglia scappando poi a Torino. I tedeschi ne vennero presto a conoscenza, lo raggiunsero e lo arrestarono. Gli Ziegler furono anch’essi mandati a Milano e poi partirono con il convoglio del 30 gennaio 1994. Joseph fu uno dei pochi superstiti di quel treno. d) Le vicende dei coniugi Cassuto e di altri deportati Dalle lettere che Anna e Nathan Cassuto riuscirono a fare arrivare ai parenti dal carcere spicca la grande forza d’animo dei due coniugi e il loro ottimismo, manifestato nella speranza di tranquillizzare coloro che ancora riuscivano a rimanere nascosti. Chiedevano di stare vicino ai bambini e di farli crescere secondo un basilare insegnamento religioso; i parenti non dovevano preoccuparsi della loro sorte perché la loro fede li avrebbe sicuramente protetti da ogni crudeltà. Furono entrambi trasferiti a Milano per poi essere deportati; insieme a loro vi erano molti altri fiorentini, tutti rimasti in carcere per poco tempo. Tra loro vi era anche la famiglia Calò (con la madre Ida Spizzichino) e Gilda Coen la quale, quando i tedeschi la catturarono, tentò il suicidio. La quantità di cianuro ingerita non fu sufficiente per morire: i tedeschi la fecero curare e, una volta guarita, fu mandata a Milano per prendere il convoglio. I coniugi Cassuto partirono insieme ed entrambi passarono le prime selezioni ad Auschwitz. Nathan girò diversi sottocampi e trovò poi la morte in quello di Gross Rosen, quando l’arrivo dei sovietici era diventato imminente. Anna invece riuscì 56 a salvarsi il 9 maggio del ’45, anche se malata, per l’arrivo degli alleati. Giunse a Firenze il 6 agosto con mezzi di fortuna e a piedi.13 Cercò subito i suoi figli: la più piccola era morta, gli altri erano in salvo dai nonni paterni a Gerusalemme grazie alla zia Hulda Campagnano. INTERVISTA A WANDA LATTES Nel 1938 forse solo quelli direttamente coinvolti in politica avevano un’idea della tempesta che stava avvicinandosi, ma tutti gli altri assolutamente no; e poi vennero quelle leggi razziali che sono state molto dure e, a ripensarci adesso, furono oltre che di una disumanità terribile, anche di una illogicità assoluta, perché gente che fino al giorno prima non aveva avuto la benché minima persecuzione adesso vedeva stravolta la propria vita: i ragazzi furono buttati fuori dalla scuola, la maggior parte delle persone furono buttate fuori dalle loro professioni, tutta una serie di professori universitari, medici o avvocati per non dire commercianti, negozianti, impiegati furono tutti privati del loro lavoro da un giorno all’altro senza nessuna preparazione. Io andavo a scuola, stavo per passare in prima liceo, mentre mia sorella faceva appena la seconda elementare, quando un giorno improvvisamente mio padre, che era funzionario di banca a Napoli, piangendo ci disse di aver perso il lavoro; ma questo devo dire che a noi bambine non fece poi grande stupore, non capimmo la gravità del fatto. Così come noi non potevamo più andare a scuola, molti altri ragazzi erano nelle nostre solite condizioni; ma tutto questo ancora non era altro che un primo avvertimento. Con la perdita del lavoro di mio padre, perdemmo la casa a Napoli, tutte le nostre amicizie, il nostro tessuto di vita; poi, tramite vari passaggi siamo arrivati a Firenze, dove io ero nata e dove i miei genitori avevano qualche parente. Così riprendemmo una casa lì per lì, e mio padre, da distinto funzionario di banca quale era stato, fu costretto ad andare a giro con una valigia a fare il rappresentante di cose di cui non aveva minima conoscenza; doveva ringraziare Dio se poteva ancora lavorare, visto che molti altri erano 57 già stati privati delle loro occupazioni e messi in condizioni di non averne altre. Alcuni parenti di mia madre invece andarono all’estero, così come molte altre persone che lo poterono fare; ma noi bambine non capivamo cosa stava succedendo, pareva che tutto dovesse durare per poco tempo. Io continuai a studiare e allo stesso tempo continuai anche a lavorare per guadagnare qualche soldo visto la necessità di aiutare in casa. E riuscii anche a prendere la maturità perché privatamente si poteva prenderla. Si arrivò al famoso 8 settembre: a quel punto la vita che fino ad ora era stata faticosa e umiliante, anche se per dire la verità negli ambienti «pagani» non trovavamo ostilità, divenne veramente impossibile, su uno sfondo di continuo terrore. Certamente le persone grandi batterono più fortemente la testa di noi bambini e quindi furono maggiormente colpite da tale situazione; ma comunque trovammo molti amici nelle nostre solite condizioni: ci era proibito andare al mare o in montagna, o in qualsiasi luogo di villeggiatura, ma mi ricordo che riuscivo insieme a dei miei amici ad andare ugualmente trovando vari metodi: per esempio invece di andare al mare al Forte dei Marmi andavamo lì vicino e poi con la bicicletta andavamo in spiaggia. Ma questi non erano i veri problemi, anche se all’epoca ci sembravano tali; il dramma era che i tedeschi sarebbero dopo l’8 settembre ben presto arrivati e avrebbero iniziate le loro razzie. Non sapevamo niente dei campi di concentramento e di sterminio; fortunatamente, già da qualche tempo avevo fatto amicizia con dei ragazzi antifascisti: furono loro infatti ad avvertirmi che se i tedeschi ci avessero trovato ci avrebbero uccisi. Così cominciai insieme alla mia famiglia una serie di fughe prima alla Consuma, poi a Stia sempre in cerca di aiuto. Tornammo poi a Firenze nella villa dove tutti i miei parenti si erano radunati; qui ci dissero che sarebbero arrivati i tedeschi a prenderci. Ci si può immaginare che nottata fu quella. Fortunatamente avevamo degli amici che ci dissero di fuggire prima della mattina seguente. In città, mio padre prese un carretto, ci mise sopra le nostre valige, due materassi e si scese da Bellosguardo cercando un posto per andare a sbattere la testa. Arrivati in piazza del Carmine mio babbo aveva sete, si fermò e vide una scritta di un sarto che aveva conosciuto in precedenza. Suonò alla sua porta: questo quando ci vide noi quattro, con 58 mia madre che piangeva, si mise a piangere pure lui e ci disse: «Salite, perché non vi posso abbandonare». Ci trovò poi un posto sicuro. Dal quel momento cominciò lo stillicidio degli arresti, tra cui due fratelli di mia madre, delle deportazioni. Noi fummo molto fortunati, non avendo neanche radici a Firenze, non avevamo fatto né le elementari, né le medie e però si vede che eravamo così benvoluti che ci nascosero o ci aiutarono: per esempio noi avevamo un’altra casa in via Marconi e qui due ragazze che abitavano al piano di sopra ci portarono di nascosto alcune tessere per gli alimenti che loro avevano per errore. Altri miei amici ne dettero altre che prendevano in casa o, per chi lavorava in comune, che riusciva a rubare: per esempio c’era un ragazzo che lavorava nel comune di Montespertoli che ne riuscì a portare via molte. Un altro invece ci dava marmellate prese dalla ditta di suo padre. Il dolore più grande di mia mamma fu la perdita dei suoi due fratelli di appena quaranta anni uno e cinquanta l’altro: erano nascosti in una casa e quando sentirono arrivare i tedeschi si gettarono per lo spavento dalla finestra; non si ammazzarono (come forse sarebbe stato meglio) ma le SS li sentirono e li catturarono. INTERVISTA A LIONELLA VITERBO Sono nata a Firenze il 16 febbraio 1931; nel 1934 mi trasferii con la mia famiglia a Roma. La mia infanzia fu molto tranquilla e rosea: mio padre era un insegnante ed aveva un buon posto di lavoro; quindi, tutto sommato, le nostre condizioni di vita potevano considerarsi agiate: mi accorsi che stava cambiando quando la mia tata se ne andò; mio padre poi perse il lavoro perché venne espulso dal suo impiego. Ma l’incubo più grande era il sentir dire che saremmo dovuti partire, scappare. Anche a scuola i cambiamenti furono radicali e improvvisi: io, come tanti altri bambini, fui costretta a fare la prima e la seconda elementare con mio fratello più piccolo; ma non solo: fui costretta a dare l’esame isolata in una stanza diversa da quella in cui tutti gli altri ragazzi avevano dato il loro. Nel ‘41 tornai di nuovo a Firenze e continuai a studiare. Il gover- 59 no permetteva le lezioni agli ebrei, ma solo se tenute da insegnanti ebrei, in orari e luoghi diversi da quelli della scuola «normale». Comunque avevamo il vantaggio di avere dei docenti molto bravi perché erano per lo più quelli espulsi dalle loro cattedre, spesso in università o licei molto ambiti. La popolazione fu fortunatamente molto disponibile con gli ebrei, nessuno tra la gente rispettò effettivamente le leggi razziali. Mi ricordo quando il 25 luglio 1943 mi trovavo alla Consuma e, giunta la notizia della caduta del fascismo, le persone cominciarono a fare grandi festeggiamenti, quando magari pochi mesi prima avevano acclamato Mussolini (forse questo è stato e rimarrà un lato incomprensibile riguardo al consenso del fascismo). L’8 settembre invece ero all’Impruneta; i festeggiamenti durarono a lungo, ma la mattina seguente mio padre ci telefonò invitandoci a tornare a Firenze perché i tedeschi avevano già preso il sopravvento in città, l’esercito si era ormai sfaldato e sembrava che ovunque regnasse il caos. Riguardo alla conoscenza dei campi di concentramento e di sterminio non sapevamo niente, ma spesso non volevamo credere alle mostruosità che gli ebrei profughi raccontavano di aver visto. Dopo la razzia di Roma il rabbino di Firenze, Nathan Cassuto, prese provvedimenti più rapidi e incitò tutti gli ebrei fiorentini a scappare, e soprattutto di evitare assolutamente di recarsi alla sinagoga. I nascondigli erano molto casuali; ma oltre alla difficoltà di trovare un posto dove poter passare la notte, c’era anche il grosso problema di trovare il cibo: spesso ci rivolgevamo ai ristoranti dove potevamo ricevere almeno un po’ di pane. Riuscimmo a trovare un alloggio sopra un negozio di persone che collaboravano con i partigiani, ma poi ci trasferimmo ad Anghiari, un paesello vicino ad Arezzo. Qui trovammo una grandissima disponibilità e solidarietà e soprattutto da parte del preposto, il quale cercò di convincere i suoi compaesani ad aiutare gli ebrei, o comunque le persone più a rischio. Il pericolo non erano solo le SS, ma anche i ragazzi che militavano nella milizia fascista e che non si facevano scrupoli a denunciare gli ebrei nascosti alle autorità tedesche. Il paese era vicino alla linea gotica; l’avanzata degli alleati fu particolarmente lenta, dovuta al fatto che i tedeschi avevano minato strade ed ogni altro mezzo di comunicazione. Per un mese ci furono bombardamenti continui. La riti- 60 rata tedesca fu devastante poiché minarono praticamente tutto ciò che trovarono lungo il loro cammino. Infine tornai a Firenze, quando fu liberata definitivamente dall’arrivo delle truppe alleate. Spesso i libri trattano gli eventi storici estraniandoli completamente dal quadro in cui si svolgono, senza capire che la storia delle guerre, delle rivoluzioni, delle svolte politiche, prima di tutto ha modificato, spesso profondamente, la vita di tutti coloro identificati nei manuali con il termine di “masse”. Difficilmente esse sono prese in considerazione ed i motivi sono sicuramente molteplici: è sicuramente difficile ricercare notizie riguardo alla gente comune; ma poi credo che spesso i libri sono scritti più per essere venduti che per essere letti, di conseguenza è molto più «commerciale» la Storia «dei grandi» di quanto non lo sia quella di una famiglia qualunque. In realtà, penso che, chi veramente abbia modellato ogni evento storico, ma soprattutto chi li ha vissuti in prima persona, siano proprio le masse. Queste due interviste ne sono un esempio eclatante e mettono in una posizione di subordinazione le cifre, le date o tutti i discorsi scontati e retorici ormai, talmente noti a tutti da essere diventati banali, indipendentemente dal loro triste contenuto. Mi ritengo quindi più che fortunato ad avere avuto la possibilità di ascoltare una testimonianza di due donne che sono state investite direttamente dalle tragiche manifestazioni di violenza ad opera del fascismo e del nazismo. Sono state semplici le loro parole, non ridondanti come quelle dei libri, ma sicuramente di una grande efficacia. In conclusione, ritengo molto più utile, al fine di una esperienza che possa far riflettere e che lasci un segno, una «chiacchierata» con coloro che la Storia l’hanno vista passare sui propri volti, con coloro che si sono visti depredare dei loro beni ingiustamente, con coloro che hanno visto soffrire i propri genitori in un momento in cui la vita dovrebbe essere un prato fiorito. 61 NOTE 1 Per la presente relazione sono stati consultati i seguenti testi: R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1993; AA.VV., La persecuzione degli ebrei durante il fascismo, Camera dei Deputati, Roma, 1998; G. Mayda, Ebrei sotto Salò, Feltrinelli, Milano, 1978; P. Pandolfi, Ebrei a Firenze nel 1943; Persecuzione e deportazione, «Argomenti storici», n°5, Firenze, 1980; S. Zuccotti, L’olocausto in Italia, Tea, Milano, 1995; AA. VV., La memoria della persecuzione degli ebrei, A.N.F.I.M., Firenze, 1989. 2 Cfr. P. Pandolfi, op. cit., p. 10. 3 Ivi, p. 11. 4 Nathan Cassuto era nato a Firenze nel 1909. Dopo essersi laureato in medicina e chirurgia nel 1933, per qualche tempo prestò servizio come ufficiale medico. Incominciò quindi quella che prometteva di essere una carriera brillante, dedicandosi all’esercizio della professione, alla ricerca e all’insegnamento. Pubblicò tra l’altro diversi articoli importanti. Nel 1938 vinse una borsa di studio del prestigioso Rockfeller Institute di New York. Cfr. S. Zuccotti, op. cit., pp. 174 ss. 5 La DELASEM (Delegazione Assistenza Emigranti Ebrei) si occupava dei numerosi ebrei stranieri presenti in Italia. Era nata nel 1939, in sostituzione di una analoga organizzazione, il COMASEBIT, soppressa dal fascismo pochi mesi prima. Il motivo per cui il regime concesse la nascita della DELASEM fu che sollevava dal pesante e fastidioso problema di provvedere ai numerosi ebrei che continuavano ad affluire in Italia malgrado i divieti ufficiali; inoltre era finanziata dagli Stati Uniti e il regime fascista non volle privarsi di una fonte di valuta così forte e pregiata. Cfr. R. De Felice, op. cit., pp. 417 ss. 6 Mario Carità era il maggiore di una banda omonima, composta da circa duecento individui; operava senza restrizioni contro gli ebrei antifascisti; un ufficiale tedesco che ne ispezionò il comando lo trovò grondante del sangue delle vittime delle torture, al punto che insistette perché la banda lasciasse la città. Carità si trasferì a Padova. Una banda simile fu instituita anche a Roma ad opera di Pietro Koch, figlio di un ex ufficiale tedesco. Cfr. S. Zuccotti, op. cit., p. 166. 7 Cfr. P. Pandolfi, op. cit., p. 166. 8 Ivi, p. 31. 9 Eugenio Artom era già impegnato in politica come rappresentante del Partito Liberale Italiano; al momento dell’occupazione dei tedeschi i membri della Comunità erano assenti dalla città o già in una condizione di non poter più operare liberamente; così la direzione della comunità fu assunta da Artom. In passato non aveva mai preso iniziative in favore degli ebrei, ma dopo le leggi razziali del ‘38 si impegnò attivamente per la questione ebraica e fu uno degli uomini che favorirono 62 dopo il ‘38 la ripresa della Comunità. Cfr. P. Pandolfi, op. cit., p. 76. 10 Giovanni Preziosi fu uno dei più convinti razzisti italiani, tanto da criticare lo stesso Mussolini davanti a Hitler accusandolo di avere portato avanti una politica di compromessi, sia nei confronti degli ebrei, sia nei confronti dei massoni. Fu così che Preziosi divenne una figura fondamentale nella Repubblica di Salò: fu messo a capo dell’Ufficio della Razza proponendo anche la soluzione finale degli ebrei. Prete spretato, fanatico antisemita, nazionalista e fascista dal 1920, Preziosi pubblicava negli anni Venti il giornale antisemita «La vita italiana». Nel 1921 tradusse e diffuse in Italia i famigerati «Protocolli degli anziani di Sion», un documento falso che mirava a provare l’esistenza di una cospirazione degli ebrei per dominare il mondo. Sembra che Mussolini detestasse Preziosi, ma questi aveva alcune importanti conoscenze presso i nazisti tedeschi, che si rilevarono particolarmente efficaci in un secondo tempo. Comunque durante gli anni ‘20 e ‘30 fu considerato dai fascisti stessi solo un fanatico e quindi fu tenuto in una posizione marginale. Cfr. S. Zuccotti, op. cit., pp. 55 e 190 ss.; R. De Felice, op. cit. 11 «Repubblica» era un giornale nato durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana. 12 Joseph Ziegler era un ricchissimo profugo di origine ungherese, giunto a Firenze con tutta la famiglia: la moglie, due figlie di quattro e sei anni e la suocera. Furono tutti nascosti provvisoriamente nel seminario minore, e per volontà di Ziegler, vi si fermarono più a lungo, una decisione che sarebbe costata loro molto cara. Cfr. P. Pandolfi, op. cit., p. 36 e p. 59. 13 Anna di Gioacchino morì tre anni più tardi: il 13 aprile 1948, mentre si recava con un convoglio blindato all’ospedale Hadassa di Gerusalemme, dove lavorava, rimase uccisa in un attentato insieme ad altre 70 persone. Cfr. P. Pandolfi, op. cit., p. 86. 63 LA CHIESA, FIRENZE, GLI EBREI Andrea Mirchioni La situazione degli ebrei in Italia subì un tragico sconvolgimento a partire dai provvedimenti emanati nel 1938, che portarono a considerare gli ebrei come una classe inferiore della società.1 Tra le cause è anche la forte influenza che la Germania ebbe sull’Italia alle soglie della seconda guerra mondiale. Inizialmente, le leggi razziali nei confronti degli ebrei giunsero completamente estranee non solo a questi, ma anche al resto della società italiana che non aveva mai provato alcun tipo di rancore verso di loro. Quindi è facile intuire che durante i primi anni del fascismo queste concezioni venissero manifestate solo sporadicamente da alcuni. Con la legislazione antisemita gli ebrei si sentirono traditi dagli italiani che, per non essere considerati dei “pietisti”, si adeguarono alle regole imposte dal regime. Ciò comportò anche un forte fenomeno di emigrazione verso la Palestina e gli Stati Uniti. IL CARDINALE ELIA DALLA COSTA Sullo scenario dell’ultima guerra, nell’ambito della Chiesa fiorentina, appare fondamentale la presenza del vescovo, il cardinale Elia Dalla Costa. La sua figura si misura e si valuta sulle scelte e sugli interventi di cui si assunse personale responsabilità e che, ogni volta, apparvero dettati da opportunità di circostanze o da urgenze che richiesero decisioni tempestive. 1 Questa relazione si è basata sui seguenti lavori, da cui sono tratte anche le citazioni: Preti fiorentini, Giorni di guerra, a cura di G. Villani, L.E.F., Firenze, 1992; AA.VV., Le Chiese toscane, L.E.F., Firenze, 1972 64 Sono fatti e momenti documentati in prevalenza nel “Bollettino della arcidiocesi di Firenze” (BAF) dove risuona la sua voce autorevole di vescovo che sospinge alla riflessione e alla coerenza cristiana. Fin dal 1938, più precisamente a pochi giorni dall’accordo di Monaco, che sembrò arrestare lo scoppio della guerra, il cardinale, con severi appelli, richiamò i fondamenti della pace vera e durevole e, nel clima di infatuazione bellica, artificiosamente costruito, fece risuonare gli accenti accorati che riflettevano la trepidazione dell’umanità. Dal 1939, il suo magistero fu una ininterrotta riflessione sui tragici avvenimenti, illuminata dalla fede e dalla carità. E’ una continua meditazione sul male e sul dolore, un richiamo ad una condotta severa, un invito alle opere di solidarietà cristiana. Con l’entrata in guerra dell’Italia, il suo discorso rappresentò una lezione di spiritualità i cui temi erano suggeriti dalle dolorose circostanze, perché il suo popolo leggesse in chiave cristiana i tragici eventi, nella convinzione che tale sapienza fosse l’unica capace di illuminare il buio del presente. Egli, attraverso vari scritti, cercò di riportare alla mente dell’umanità il senso reale della parola di Dio che è stata brutalmente violata con lo scoppio della guerra, e di cercare di trovare le forze e il coraggio di fare del bene ai più bisognosi, ai più fragili che risentono in modo maggiore le conseguenze di questo disastroso evento, da parte di coloro che hanno coscienza e consapevolezza del problema perché rifugiatisi nella parola del Signore. Il messaggio del cardinale non fu solo rivolto al suo “gregge” ma anche a tutti gli altri uomini di Dio che dovevano uscire da quella che poteva essere una situazione di indifferenza e rendersi disponibili di fronte alle problematiche della guerra, con virtù, operosità e dedizione. Per ottenere questo, il Cardinale instaurò un colloquio di generosa corrispondenza con i suoi fratelli. Le parole che sono riportate dal Cardinale nelle sue innumerevoli lettere sono anche 65 aspre e piene di rabbia. Egli denunciò i crimini, le atrocità, gli egoismi della guerra, senza mezzi termini e non risparmiò ai colpevoli l’avvertimento dei rigori della giustizia divina. Le sue parole espressero anche la tristezza dell’animo e l’invito alla solidarietà. Egli rivelò l’instancabile intento di limitare i mali e offrire il più largamente possibile protezione e aiuto. Il Cardinale, che trattava con gli alleati per salvare la città e con le autorità militari a favore dei condannati a morte, cercava di dare protezione a chi si trovava in pericolo, teneva presente le preoccupazioni quotidiane della gente e si faceva scrupolo di non poter arrivare a tutto. Egli era mosso da un unico proposito: alleggerire in ogni modo le sofferenze di tutti e impedire ulteriori sciagure. Le idee del Cardinale non rimasero solo parole di conforto per una popolazione abbandonata alla disperazione, ma si concretizzarono nel corso della guerra ed anche oltre. Egli organizzò aiuti umanitari per chiunque ne avesse bisogno, senza alcuna distinzione di ceto o razza o religione. Tutti i monasteri, edifici di proprietà del clero, furono completamente abilitati a questo scopo. Duramente perseguitati, gli ebrei di Firenze trovarono nel cardinale Dalla Costa un protettore e un amico. Egli chiese ai collaboratori e ai suoi preti di fare il possibile per sottrarli alla caccia e alla deportazione, nonostante i rischi a cui andavano incontro: “…arcivescovado, canoniche, conventi e sedi di organizzazione religiose, furono aperti alla più numerosa assistenza a perseguitati, israeliti, sofferenti. E se in quasi tutte le città d’Italia furono ben atte le benemerenze della Chiesa, in questo campo a Firenze, furono anche più apprezzabili per le drammatiche prove di una lunga emergenza durata circa 40 giorni…”. In data 25 aprile, il cardinale Dalla Costa, con una memoria dal titolo “Storia vera di Firenze città aperta”, intese informare direttamente e compiutamente sull’opera svolta per risparmiare a Firenze le ferite della guerra: “… per Firenze città aperta i 66 germanici ebbero buone parole, ma non altro che parole. Si fece loro conoscere che per la “città aperta” che essi dicevano di volere, sopra tutto dovevano essere allontanati da Firenze i comandi e le truppe tedesche e purtroppo questo non avvenne mai. Davanti a questa sconfortante realtà … potei richiamare il governo tedesco sul grave argomento, anzi… mi riuscì di far arrivare la voce di Firenze fino a Hitler ed averne, con lettera del suo luogotenente generale, in data 12 Maggio 1944, le seguenti testuali dichiarazioni: “Il Führer, onde non omettere alcuna misura di protezione della città di Firenze, la cui conservazione è considerata dalla Germania come uno dei più alti doveri che incombono alla cultura europea, ha ordinato l’evacuazione da Firenze di tutti gli edifici militari tedeschi superflui …”. Purtroppo queste rimasero solo parole, in quanto i tedeschi, nella notte del 4 agosto, fecero saltare cinque ponti sull’Arno, compreso il ponte di S. Trinita, uno dei più ammirati d’Europa. E per il crollo fragorosissimo dei ponti venivano distrutti case e numerosi palazzi. Seguirono i lugubri giorni e le eterne notti dei cannoneggiamenti nemici accompagnati dalla privazione d’acqua, luce, di medicine e dal pericolo sempre imminente e sempre terribile delle deportazioni, così che per le contrade della città, aventi un aspetto cimiteriale, non si vedevano che donne meste e fanciulli sgomenti erranti in cerca di acqua e di qualche alimento. In città nessuna chiesa fu distrutta. Con l’eccezione dei ponti e dei palazzi dei Lungarni, furono salvate innumerevoli opere d’arte. Si può affermare che, nonostante le gravi e dolorose ferite di cui Firenze ha sofferto, si deve in gran parte alle persone che con la loro opera generosa fecero sia indietreggiare alcuni che esitare altri che questo gioiello del mondo si salvò dalla distruzione totale. La città di Firenze volle dare pubblico riconoscimento al cardinale Dalla Costa e lo fece conferendogli, con decreto del 23 luglio 1945, la cittadinanza onoraria: “Ricordando che durante il tragico periodo della dominazione fascista S.E. il cardinale Elia Dalla Costa, arcivescovo di Fi- 67 renze, difese con zelo e coraggio la popolazione della diocesi contro la prepotenza, l’arbitrio e la protervia teutonica; ricordando altresì come nell’espletamento di questa nobilissima missione il cardinale Elia Dalla Costa non tralasciò occasione per intervenire a favore dei perseguitati politici a qualunque partito appartenessero, salvandone diversi da morte sicura. Memore dell’azione efficace svolta a tutela della città di Firenze, diretta a preservare il patrimonio artistico di valore universale, azione che culminò nella coraggiosa richiesta del 30 luglio 1944 con cui il comando tedesco veniva posto nella condizione di dimostrare le sue reali intenzioni sulla sua precedente dichiarazione di “città aperta”. Considerando infine la perseveranza con cui Egli insistette con il comando tedesco, perseveranza tanto più degna di apprezzamento in quanto diretta ad un avversario sordo a qualunque comprensione dei diritti umani e civili e soltanto animato di combattere una guerra distruttiva, delibera di conferire a S.E. il cardinale Elia Dalla Costa la cittadinanza onoraria di Firenze a titolo di riconoscimento delle Sue alte benemerenze civili.” Per la morte del cardinale Dalla Costa, Firenze rievocò i giorni della prova confortati dalla sua presenza. Il sindaco, professor Giorgio La Pira, con un manifesto, ricordò ai fiorentini “di quale tempra di padre e di pastore, Dio aveva dotato il popolo di Firenze e la città di Firenze “. Il consiglio comunale convocato in seduta straordinaria rese omaggio alla memoria del cardinale e attraverso la voce del sindaco e dei rappresentanti di tutte le parti politiche, testimoniò di quanto Elia Dalla Costa “fece e insegnò per la difesa, la pace e il bene del popolo fiorentino”. IL CLERO E I PARROCI L’arcivescovo volle dai suoi preti che aiuto e assistenza fossero dati a tutti, senza riserve e discriminazioni, con spirito di 68 autentica carità evangelica. Nel 1992 è stato pubblicato il volume che raccoglie lettere e relazioni, duecentotrentotto, inviate dai preti fiorentini al loro vescovo, tra il 1943 e 1945. Esse rappresentano un documento prezioso, in quanto contengono dati attendibili della dedizione operosa e generosa del clero fiorentino e delle comunità parrocchiali, di un periodo segnato da un diluvio di sofferenze, ma anche aperto a una promettente rinascita. Nei territori delle parrocchie di città e di campagna la figura del parroco si consolidò, come un punto di riferimento sicuro, come l’unica autorità che condivideva quotidianamente ansie e drammi, lutti, sofferenze e disagi, che era in grado di organizzare aiuti, capaci di suscitare comportamenti di solidarietà. Fu così anche per “l’austero e intrepido esempio del cardinale Dalla Costa che le belle canoniche e le belle pievi della Toscana si trasformarono in asili per militari stranieri e per tutti i perseguitati; nei conventi e nei monasteri si nascondevano ebrei, ricercati dalla polizia politica, prigionieri alleati, ma non di rado vi si raccoglievano viveri per le bande armate; non di rado la canonica di un paesello sperduto divenne la sede di un comando partigiano; e che vari sacerdoti furono deportati, torturati, uccisi, alle volte anche come vittime innocenti offertisi per salvare altri del loro popolo”. Il ruolo del clero dunque si rivelò importante anche nelle vicende della resistenza e il suo contributo assunse un significato politico particolarmente importante. Il clero contribuì, infatti, anche a Firenze e in Toscana, “a favorire il processo unitario della resistenza e ad ampliarne la base, determinando in certi casi l’atteggiamento della popolazione verso il movimento”. I preti della diocesi di Firenze nel loro operato riflettono, almeno nella gran maggioranza, la linea del vescovo. Anche le scelte di fiancheggiamento ai partigiani avvengono non come scelte di parte, ma nello spirito della carità evange- 69 lica che richiedeva una collaborazione anche rischiosa, contro la violenza, la sopraffazione, l’ingiusto oppressore. Si sa che gran parte della lotta di liberazione è avvenuta nelle campagne: se le parrocchie non fossero state di incoraggiamento o asilo di rifugio, tutto sarebbe stato più difficile. La partecipazione delle parrocchie fiorentine alla resistenza si manifestò in modi diversi. Si aprirono le canoniche per ospitare i Comitati di liberazione Nazionale, si dette rifugio agli ebrei ed ai renitenti alla leva della repubblica fascista, si organizzarono organismi di sostegno anche materiale alla popolazione, vennero allestiti posti di pronto soccorso ed ospedali da campo. Gran parte di questa partecipazione fu proprio l’espressione di un’esigenza di carità. Le parrocchie si presentarono negli anni ‘43-’44 come l’unico tessuto della vita civile, oltre che della vita religiosa. La costruzione fittizia delle strutture civili e politiche fasciste (le case del fascio, le associazioni di categoria, i dopolavoro, ecc.) che avevano preso il posto delle soppresse società di mutuo soccorso, delle cooperative, dei circoli operai, delle leghe, si disciolsero completamente. La parrocchia rimase il solo centro autentico di vita comunitaria oltre alle centrali clandestine del movimento di liberazione. Una delle pagine più commoventi, nell’ambito delle parrocchie fiorentine, fu scritta da madre Maddalena Cei che, esponendosi al rischio di rappresaglie tedesche, ospitò nel suo convento in Via Faentina dodici bambine ebree, polacche, francesi, belghe e di molte altre nazionalità europee. Quando le giovani arrivarono presso la madre generale, avevano negli occhi l’orrore dello sterminio dei loro parenti, così madre Maddalena condivise con loro quel poco di vitto e vestiario che possedeva. Per salvarle le introdusse nel collegio, dove furono mescolate alle altre collegiali fino alla fine della guerra. Non bisogna dimenticare che, durante la guerra, non solo la Chiesa si operò per la salvaguardia e la protezione degli ebrei, ma 70 anche i cittadini fiorentini, delusi dal regime fascista, si adoperarono per ospitare e proteggere il maggior numero di persone in difficoltà, rischiando spesso la loro stessa vita. L’ESPERIENZA DI JENNY BASSANI LISCIA Non strettamente connessa al tema trattato nelle pagine precedenti, ma di grande interesse, è la presente testimonianza, gentilmente concessami da Jenny Bassani Liscia nel corso di un incontro presso la Comunità Ebraica di Firenze. Tale testimonianza è stata integrata, su indicazione della stessa signora Bassani Liscia, sulla base del suo libro di memorie, “L’anzulon”, Edizioni Mallo delle Fate, Signa, 1997. La mia famiglia si era stabilita a Ferrara, già dal Cinquecento per sfuggire alla grande inquisizione spagnola. I miei antenati erano stati accolti benevolmente dagli Estensi per ragioni commerciali e la loro vita si svolgeva tranquilla, finchè, per una bolla papale, nel 1626, furono rinchiusi nel ghetto. Vissero così fino al 1870, anno in cui, dopo le guerre di indipendenza, con la proclamazione del regno d’Italia, i cancelli dei ghetti furono abbattuti definitivamente. In quel periodo abitavano nel ghetto due famiglie: i Bassani e i Minerbi. I miei nonni, David Bassani e Cesare Minerbi, nacquero entrambi molto poveri, ma grazie alle loro capacità, riuscirono ad affermarsi diventando il primo un industriale e il secondo un medico. I miei genitori, Dora ed Enrico, si conobbero poiché il nonno Minerbi divenne il medico di famiglia dei Bassani; si sposarono nel 1915, anno in cui scoppiò la prima guerra mondiale. Nel 1916 nacque mio fratello Giorgio, nel 1920 Paolo ed infine nel 1924 io. Mio papà era partito volontario per la guerra e quando tornò dopo quattro anni era stato costretto, per la morte del suo primario, a lasciare il posto alla clinica ginecologica di Firenze. 71 Intanto il nonno David era morto e mio padre, trovandosi disoccupato, prese in mano la ditta di suo padre. La diresse con bravura per alcuni anni sperando sempre di poter riprendere la sua professione di ginecologo ma, a causa di un’ulcera gastrica molto grave, fu costretto a diminuire il suo lavoro, poiché la malattia lo invecchiò precocemente. Fortunatamente, avendo ereditato il cospicuo patrimonio del padre, potevamo vivere agiatamente e permetterci tutti e tre di frequentare gli studi classici. In quegli anni aveva conquistato il potere il fascismo capeggiato da Mussolini. Anche il papà, reduce dalla guerra, in principio aveva creduto in lui, fino a quando, non fece assassinare il deputato socialista Matteotti. Nel settembre del 1938, subendo le pressioni di Hitler, Mussolini promulgò le leggi razziali con il favore dell’inetto Vittorio Emanuele di Savoia, tradendo la costituzione. Cominciò così, da parte di tutta la stampa, una profonda campagna denigratoria nei nostri confronti, per convincere in poco tempo la popolazione che gli ebrei erano traditori della patria, persone avide di denaro, infide e da tenere lontane. Nel 1938 io avevo quattordici anni ed in quell’anno furono applicate tutte le leggi razziali, ci fu proibito di frequentare le scuole pubbliche, e via via vietarono agli ebrei un’infinità di cose: furono espulsi da tutti i luoghi pubblici e da tutti gli impieghi statali e molte altre atrocità. Per noi fu la morte civile. Per me cambiarono molte cose: le mie amiche, che fino al giorno prima, erano compagne di banco, adesso non mi parlavano più ed i nostri genitori, per farci studiare, furono costretti ad organizzarsi per formare una piccola scuola. Fui costretta a ripetere la quarta poiché ero l’unica ragazza di quinta e non potevo pretendere di avere dei professori che sprecassero il loro tempo solo per me. Fra i miei professori c’era anche mio fratello Giorgio che nel frattempo era riuscito a laurearsi in Lettere. La nostra classe era molto affiatata ed essendo molto giovane, nemmeno le persecuzioni riuscivano a soffocare la nostra gioia di vivere. 72 Alla fine di ogni anno scolastico eravamo obbligati a dare l’esame nella scuola pubblica ed i professori spesso infierivano su di noi con interrogazioni pesanti e vili allusioni. Nonostante le molte difficoltà, trascorsero quattro anni dallo scoppio della guerra e noi non sapevamo ancora il nostro futuro; l’Italia, alleata della Germania, stava perdendo pezzi e dalla nostra piccola radio, che tenevamo nascosta perché a noi ebrei era vietato possederne una, prendevamo delle boccate di ottimismo. Mio fratello Giorgio aveva aderito al movimento antifascista e si recava spesso a Bologna dove teneva delle riunioni segrete. Mio padre fu arrestato, ma grazie all’intervento di mia madre, fu liberato da un gerarca fascista che prima era amico di famiglia; nel maggio del ’43 anche Giorgio fu arrestato fino alla caduta del fascismo. Per noi gli eventi stavano precipitando, tuttavia il 25 luglio del’43 la notizia che Mussolini aveva perso il potere ci aveva fatto gioire, anche se solo temporaneamente. Mio fratello fu liberato alcuni giorni dopo ed avendo intuito le intenzioni di Hitler, si sposò di lì a poco con la sua fidanzata e partì immediatamente per Firenze, raccomandandoci di seguire il suo esempio. Paolo intanto si era nascosto a Bologna dove tramite una sua amica, aveva trovato lavoro presso una fabbrica di radio. La mia famiglia cercò inutilmente di convincere gli altri ebrei della comunità dell’incombente pericolo, ma non volevano crederci, d’altra parte ora mi rendo conto che era impossibile prevedere quello che i nazisti fecero nei nostri confronti, e di coloro che successivamente vennero arrestati e deportati in Germania. La situazione peggiorò ancora quando i tedeschi invasero Ferrara. Durante la notte tememmo il peggio: i miei genitori si rifugiarono a casa del nonno mentre io scappai durante il giorno e mi recai da alcuni miei amici che vivevano in campagna. Il mattino seguente arrivò alla villa la notizia che nella piazza di Ferrara erano state fucilate undici persone fra ebrei e antifascisti. Decisi allora di andare a casa dei nonni per preparare insieme a i miei genitori un piano di fuga. L’unico modo per uscire dalla città era 73 prendere un treno dalla stazione di Porto Maggiore, a circa trenta chilometri da Ferrara, per poi arrivare a Bologna e da lì a Firenze, dove abitava Carlotta Giuliani, collega di mio padre. Partimmo la mattina presto, così che il buio ci avrebbe celato agli occhi indiscreti di eventuali spie. Durante il tragitto, mio padre incontrò un certo dott. Balboni, che si offrì di ospitarci a casa e di accompagnarci con l’automobile a Porto Maggiore. Fortunatamente arrivammo a Firenze senza incidenti la mattina presto; subito andammo a trovare Giorgio che era riuscito a trovare una camera in via Palazzuolo che ci lasciò come rifugio durante la nostra permanenza. Il pomeriggio seguente andammo a trovare Carlotta Giuliani per parlare dei nostri problemi. Tutti eravamo d’accordo che per salvarci dovevamo dividerci, così chiedemmo se sarebbe stato possibile trovarmi un posto di bambinaia o di cameriera in una casa qualunque. Carlotta propose di assumermi come tuttofare in cambio della sua ospitalità: abitava in via Nazionale in una casa piccola e dovetti lavorare per giorni per portarla ad uno stato vivibile. Il resto dei componenti della famiglia erano il marito, che lei chiamava con il suo cognome, Gugliarini, ed un figlio sedicenne di nome Guido. Le mie giornate scorrevano lavorando la mattina e incontrando i miei genitori il pomeriggio. Il papà e la mamma vivevano con poco e la domenica andavano in chiesa per non dare nell’occhio. Una mattina, mentre attraversavo Piazza San Lorenzo, vidi venire verso di me un uomo. Lì per lì, non me ne ero resa conto, ma poi, incrociandolo, mi ricordai che si trattava di Adolfo Liscia, da cui ero stata ospite a Viareggio, presso la sua famiglia. Quando lo fermai, mi guardò terrorizzato, ma quando mi presentai cominciammo a farci domande reciproche sui nostri rispettivi parenti. Presi appuntamento con i miei genitori per ritrovarci al bar Boitani a prendere un caffè alle 14 del giorno seguente. Quando arrivai rimasi sbalordita. C’erano tutti: il papà, la mamma, lo zio Nino Corcos, Lea, Adolfo Liscia e l’altro loro figlio Rodolfo. Erano seduti tutti intorno ad un tavolino, tranne Rodolfo che stava sdraiato su di una poltroncina di metallo, non sembrava che avesse soltanto venticinque anni e l’impres- 74 sione iniziale fu che fosse molto antipatico, superbo e maleducato. Rodolfo si era laureato in medicina e lavorava di nascosto all’Istituto di Fisiologia dell’Università di Firenze, per il prof. Spadolini. Quel giorno Lea, rivolgendosi a me mi invitò ad accompagnare Rodolfo al lavoro. Non ricordo di che cosa parlammo, ma, al momento di lasciarci, mi invitò ad andarlo a prendere alla fine del lavoro. Divenne per noi un’abitudine vederci quasi tutti le sere e colui che mi era sembrato antipatico ora mi appariva anche bello. Dopo un mese di amicizia con Rodolfo, egli decise di dichiararmi il suo amore. Intanto Giorgio, prima di partire per Roma, aveva ordinato delle carte di identità false per me e per i miei genitori. La tessera falsa per Rodolfo non era ancora arrivata, ma aspettavamo che ce la consegnassero quanto prima. Avevamo assunto l’identità della sorella della mamma che era residente a Roma, così prudentemente, in caso me lo avessero chiesto, studiai la cartina di Roma, imparandola a memoria. Un giorno, probabilmente per una spiata, la questura si presentò per una perquisizione, poiché Gugliarini era coinvolto in un traffico di borsa nera e di passaporti per quelli che volevano espatriare. Cinque uomini entrarono prepotentemente ed incominciarono ad interrogare me e Carlotta. Trovarono un libro di preghiere in ebraico in cui era inserita la tessera di identità di Giorgio, ricercato dalla polizia fascista. Le stanze erano tutte sottosopra per la minuziosa perquisizione e non trovando altro, i poliziotti, convinti che si trattasse di una famiglia antifascista si stabilirono in casa per alcuni giorni, sperando di riuscire ad incastrare Gugliarini. Presa dal panico, cercai in tutte le maniere di contattare i miei genitori per evitare che, preoccupati per la mia assenza, si recassero a casa di Carlotta, così decisi di scrivere su un foglio un messaggio nel quale pregavo di avvertire i miei genitori di quello che era successo. Fortunatamente la signora che abitava di sotto recapitò il messaggio, così riuscii a salvare i miei genitori. 75 Il giorno dopo, fidandomi ormai dello sconosciuto alleato, le affidai i gioielli di famiglia che custodivo nel petto, con lo stesso metodo. Trascorso qualche giorno, Carlotta venne interrogata in questura e fu riportata a casa, il quinto giorno toccò a me; il più vecchio degli agenti mi accompagnò a “Villa triste”, un villino sulla via Bolognese, così chiamato per le torture efferate che vi si perpetravano. Durante il tragitto mi disse delle oscenità pornografiche che mai nella mia vita avevo sentito, né immaginato. Quando entrai nella villa ero spaventatissima e dopo qualche minuto di attesa egli cominciò l’interrogatorio. Volevano sapere perché ero venuta via da Roma verso il nord e perché avevo l’accento emiliano. Risposi che avevo paura degli americani che volevo ricongiungermi con i miei parenti in Emilia. Mi chiesero, come avevo immaginato, in che punto di Roma si trovasse la mia abitazione. E io, che mi ero studiata la mappa di Roma, potei rispondere dando indicazioni precise. Mi trattennero ancora e poi mi fecero passare nell’ufficio per farmi firmare il verbale. Firmai con scrittura malferma da analfabeta, mostrando di non interessarmi a quello che c’era scritto sul foglio, ma non sapevo se ero riuscita a convincerli che avevo niente a che fare con i traffici sovversivi dei Gugliarini. Intanto era suonato l’allarme aereo e pregavo Dio di rimanere uccisa sotto le bombe. L’agente mi riportò a casa. Si stette ancora sorvegliate per un giorno e poi improvvisamente i poliziotti se ne andarono senza dirci niente. Io e Carlotta pensavamo che fosse una finta per trarci in inganno, perciò per un giorno ancora non ci si mosse di casa, però volevo avvertire Rodolfo. Decisi allora di chiedere ai coinquilini del nostro pianerottolo di poter telefonare. Riuscii a contattarlo e lo rassicurai sul mio stato e su quello di Carlotta. Durante questo periodo sorse un altro problema. Infatti, un questurino che pattugliava la nostra zona si era innamorato di me e mi asfissiava con telefonate e pedinamenti, così decisi che era più prudente cercarmi una nuova collocazione. La nostra cuoca, Ines, aveva trovato un posto presso una ricca famiglia di Firenze, così con le mie due valigie mi trasferii nel loro palazzo 76 in via del Proconsolo. La mia contessa era una piccola donna sulla cinquantina e mi spiegò i miei compiti che comprendevano il lavare i piatti con le bucce di limone nell’acqua fredda. Tutte le sere veniva una sua amica dall’aspetto mascolino e io ne dedussi che erano lesbiche. Comunque svolgevo il mio lavoro con passione ed impegno. Il poliziotto non mi dava pace e così decisi di trasferirmi per la terza volta. Il mattino seguente mi congedai dalla contessa con suo grande disappunto, poiché non capiva la mia improvvisa decisione. L’Ines mi trovò un altro lavoro presso i signori De Boni, dove lavorava lei stessa; essi abitavano sul lungarno Corsini, in una bella casa elegante e luminosa. Se prima mi sembrava di lavorare troppo, adesso mi stancavo davvero, infatti non mi fermavo tutto il giorno, dovevo servire durante i pasti, inoltre dovevo mantenere pulita tutta la lussuosa casa. Poiché ero riuscita a far perdere le mie tracce, ripresi i contatti con Rodolfo e con i miei. La guerra intanto continuava e i tedeschi, pressati sempre più dagli alleati, aumentarono le persecuzioni nei nostri confronti. La contessa, che aveva saputo da un’amica che chi proteggeva un ebreo veniva punito lui stesso, incominciò ad insospettirsi nei miei confronti e così ritenni più opportuno andare a casa dei miei genitori in via Palazzuolo. I tedeschi avevano fatto saltare i ponti, così non c’era più acqua ed ero costretta a fare lunghe code per racimolare qualche fiasco. Sentivamo il rombo dei cannoni alleati sempre più vicino e la speranza aumentava. Intanto Rodolfo aveva lasciato l’Istituto Spadolini per riunirsi con i suoi in via della Mattonaia; anche Renato si era unito a loro ed insieme a Rodolfo dormiva in soffitta. Andavo tutti i giorni a trovare Rodolfo che non si poteva muovere da casa; ogni giorno il rumore delle cannonate e il fragore degli spari ci piacevano sempre più. Eravamo in agosto e i Tedeschi, preparandosi alla fuga, avevano istituito il coprifuoco totale: solo le donne potevano uscire in orari stabiliti per procurarsi l’acqua. Dalle persiane scorgevamo gli americani e gli inglesi al di là dell’Arno mentre i tedeschi scappavano con biciclette rubate. 77 Poi il silenzio assoluto. Nessuno aveva il coraggio di uscire ma la curiosità era talmente grande che la gente si riversò nelle strade, così, benchè i miei genitori non volessero, mi recai in via della Mattonaia: per me era una sorpresa vedere per le strade molti giovani che dopo anni bui uscivano alla luce del sole. I soldati alleati ci apparivano come eroi: belli, alti, biondi e vestiti bene, portavano oggetti come sigarette e alimenti come la cioccolata e il caffè sognati da noi durante tutta la guerra. I tedeschi erano ancora molto vicini: dal Mugnone cannoneggiavano Firenze e ci vollero molti altri giorni per stanarli definitivamente. Pur essendo felici non avevamo più notizie, da molto tempo, dei miei fratelli Giorgio e Paolo. Sapevamo che Paolo era nascosto a Bologna e che Giorgio si trovava a Roma, ma era passato ormai un anno dai nostri ultimi contatti. La vita riprese normalmente, Rodolfo era rientrato presso l’Istituto Spadolini mentre i Liscia pensavano ad un loro rientro a Livorno. Mio padre cercava inutilmente di vendere un paio di guanti per procurarsi del cibo, ma la povertà era molto diffusa, ero costretta per sopravvivere ad attraversare l’Arno a nuoto per procurarmi la verdura di cui avevamo bisogno. Gli alleati, che si erano ormai stabiliti a Firenze, distribuivano tutti i giorni del cibo ma dovevo sempre recarmi io a fare la fila poiché mio padre, signore come era, si vergognava ad elemosinare. Il bollito che distribuivano mi sembrava il piatto più buono che avessi mai assaggiato, e con i piselli secchi ed i tuorli d’uovo in polvere mia madre si ingegnava a cucinare sempre piatti nuovi. Intanto avevamo cambiato più volte abitazione, prima in viale Volta e in un secondo tempo in viale Principe Eugenio; venne anche Rodolfo ad aiutarci e l’appartamento assunse un aspetto decente. C’era stata una cerimonia al Tempio per la prima volta, dopo la guerra, molto commovente e durante la benedizione cantata con sentimento dal rabbino, risuonavano i pianti strazianti di coloro che avevano 78 avuto parenti deportati o uccisi. Mentre mio padre, ostinato, continuava a cercare di vendere invano i guanti, io avevo trovato un lavoro dove avevo il compito di colorare delle stampe per un rivenditore di un barroccino. Ma anche questo lavoro finì, così mi iscrissi all’Accademia delle Belle Arti: però purtroppo fui cacciata per aver partecipato ad una dimostrazione studentesca. Finalmente avevamo ricevuto notizie da Paolo e Giorgio che ci rassicurarono riguardo le loro condizioni, quindi potevamo tornare a Ferrara a vedere che cosa fosse successo durante la nostra assenza forzata. Una mattina, alle 5, mi recai sulla via Bolognese per aspettare che un camion mi desse un passaggio. Il viaggio fu bellissimo attraverso i campi maturi e quando arrivai a Ferrara, siccome era sera, andai a dormire dal nonno. La mattina dopo mi recai alla nostra casa: mancavano tutti i mobili ed era completamente distrutta al suo interno: l’unica cosa che avevano lasciato era una statua di gesso mutilata, “l’anzulon”, che il nonno David aveva comprato per illuminare le scale. Nei giorni successivi andai a cercare la nostra roba per la città con vaghe indicazioni. Trovai solo delle fotografie della nostra famiglia e dei mobili ammassati alla nostra Comunità, dove i tedeschi gettavano gli oggetti che ritenevano inutili; i libri di mio padre erano stati rubati da un generale che aveva ritenuto più utile portarli via che bruciarli in un falò. I miei genitori ritornarono a stare a Ferrara, mentre Giorgio si stabilì a Roma e Paolo a Bologna, dove continuò a lavorare nella fabbrica di radio. Io mi sposai con Rodolfo ed andai a stare a Livorno. 79 “NASCOSTI DA QUALCHE PARTE”. UNA STORIA FERRARESE Lorenzo Grotti La presenza di una cospicua comunità ebraica contribuì in modo rilevante allo sviluppo della città di Ferrara che, divenuta nel 1267 signoria degli Estensi, fu uno dei principali centri culturali, economici ed artistici del Rinascimento. Le prime notizie certe riguardanti gli ebrei di Ferrara risalgono al 1275, anno in cui il podestà di Ferrara, Obizzo D’Este, conferì loro immunità e protezione, in virtù della loro utilità per la città.1 Nei secoli successivi, con il rafforzarsi della signoria degli Estensi, la situazione degli ebrei andò facendosi sempre più florida, non solo per merito dei banchi di credito. Tra il 1400 e il 1500, prima sotto il duca Borso e più tardi sotto Ercole I, vennero benevolmente accolti in città profughi provenienti dalla Spagna, dal Portogallo e, sotto Ercole II, anche dall’Europa orientale. Ferrara divenne in quegli anni un crogiuolo di varie culture e il livello sociale, finanziario e culturale fu altissimo. La situazione favorevole nei riguardi degli ebrei si deteriorò nel 1597 quando, morto il duca Alfonso senza eredi maschi, Ferrara passò al papato. Iniziò cosi un’epoca di mortificazioni e nel 1627 gli ebrei vennero rinchiusi nel ghetto. Il vocabolo “ghetto” deriva dal nome comunemente usato a Venezia per indicare l’area urbana della città ad uso esclusivo delle famiglie israelite; questo quartiere era situato vicino ad una fonderia e all’epoca fondere si diceva “gettare”. A Ferrara l’area del ghetto comprendeva la zona tra via Mazzini, chiamata anticamente via dei Sabbioni perché sorta sul letto prosciugato di un corso d’acqua, via Vignatagliata e via della Vittoria. Questa zona venne chiusa da cinque cancelli tra il 1624 e il 1627 e designata come l’unico spazio concesso agli ebrei resi- 80 denti nella Ferrara dell’epoca. Con tale provvedimento anche Ferrara si allineava alla politica papale vigente che aveva l’obiettivo di limitare l’unione tra le famiglie ebraiche e quelle cattoliche chiudendo le vie già abitate per la maggior parte da famiglie ebraiche e consentendo loro libera circolazione in città solo nelle ore dall’alba al tramonto. Nel microcosmo che si venne a creare con il ghetto, gli ebrei si concentrarono nello studio e nella riflessione e numerosi furono i rabbini e gli studiosi. Nel ghetto, spesso vittime di angherie e pressioni, gli ebrei rimasero fino alla fine del potere temporale, con due brevi parentesi di libertà: la prima in corrispondenza dell’epoca napoleonica, quando l’editto emanato il 16 Fruttidoro dell’anno 4 (8 settembre 1796) dal commissario del Direttorio esecutivo Salicetti decretò che “gli ebrei di Ferrara ci goderanno i medesimi diritti che gli altri cittadini di questa Legislazione”; la seconda nel 1848.2 I cancelli vennero abbattuti definitivamente nel 1859. Da quell’anno, pur avendo trascorso due secoli e mezzo nel ghetto, gli ebrei ferraresi si integrarono rapidamente nella comunità cittadina, a tutti i livelli e in tutti i settori.3 Le restrizioni a cui erano stati sottoposti avevano lasciato in essi un forte desiderio represso di assimilazione: per certi versi gli ebrei di Ferrara erano più ferraresi dei concittadini cattolici. Il loro dialetto ricalcava in larga misura il dialetto ferrarese del Rinascimento; infatti a causa del totale isolamento, gli ebrei quando uscirono dal ghetto parlavano più o meno la stessa lingua di quando vi erano stati rinchiusi. L’avvento del fascismo non interruppe il processo di integrazione. Giorgio Bassani ha ripetuto più volte che non ricorda, in tutto il corso della giovinezza a Ferrara, un solo ebreo che non fosse fascista; secondo lui molti ebrei ferraresi, proprietari terrieri, furono attivi sostenitori del fascismo fin dall’inizio. Nonostante i legami profondi fra il fascismo e gli ebrei ferraresi, però, la sua descrizione è come minimo parziale: anche tra gli ebrei più facoltosi della città c’era un gruppo di coraggiosi antifascisti, ad alcuni dei quali, ad esempio, fu tolta la possibilità di lavorare in 81 quanto non aderirono al partito fascista: altri furono arrestati e mandati all’estero.4 Nel 1938 iniziarono le discriminazioni razziali. Di queste restrizioni, avvertite all’inizio qui forse più acutamente che in altri centri più grandi o dove gli ebrei partecipavano meno attivamente alla vita cittadina, ci parla con straordinaria efficacia Giorgio Bassani nei suoi racconti e nel celebre Il giardino dei Finzi Contini. Nello stesso anno, all’età di due anni, Guido Fink giunse a Ferrara: La famiglia di mio padre, Fink, proveniente dalla Russia, è andata ad abitare a Gorizia quando ancora c’era l’impero austro-ungarico. Successivamente si è trasferita a Ferrara, in quanto mio nonno ha ricevuto un lavoro come cantore in una sinagoga della città. Così mio padre è partito da Gorizia per andare a trovare i suoi genitori e qui ha conosciuto mia madre, anche lei ebrea, ma di origine italiana. Si sono sposati ed hanno unito così due tradizioni molto differenti.5 Io sono nato a Gorizia nel 1935. Con le leggi razziali mio padre ha perso il lavoro, ha lasciato Gorizia ed io e mia madre siamo andati a Ferrara dal nonno, visto che la nonna era morta ed aveva una grande casa dove stavano pure i due fratelli di mia mamma. Mio padre lavorava come contabile da degli amici cattolici, un po’ a Roma, un po’ a Tarquinia; veniva a casa quando poteva e pure i suoi genitori erano a Ferrara, così sono cresciuto tra queste due famiglie. Io, come tutti i piccoli, ero molto più attaccato a mia madre. La famiglia di mio padre pensava che peggio che in Russia non si potesse stare, quindi erano contenti di essere a Ferrara. Pur avendo dei nonni molto religiosi, sia dalla parte paterna, Fink, che dalla parte materna, Bassani, io non ho mai avuto un’educazione troppo religiosa; inoltre sia mio padre, sia mia madre appartenevano alla generazione abbastanza laica e ribelle degli anni ’30. Ad imitazione delle leggi razziali naziste, anche nell’Italia fascista furono decretati nel 1938 una serie di provvedimenti che limitavano gravemente i diritti e la dignità della minoranza ebraica, che contava a quell’epoca circa 45 mila persone. Alla data del 82 1 ottobre XVI dell’era fascista con tale legislazione si arrivò alla proibizione dei matrimoni misti, vennero espulsi gli ebrei dalle forze armate, dalle industrie, dai commerci, dalle professioni, dagli enti pubblici. Si pose un limite alle proprietà immobiliari, si diminuì la capacità nel campo testamentario, in materia di patria potestà, di adozione, di tutela e di affiliazione. Venne vietato qualsiasi tipo di lavoro e il 6 maggio del 1942 venne decisa la precettazione civile a scopo di lavoro, in base alla quale gli ebrei di età compresa tra i 18 e i 55 anni potevano essere precettati per il lavoro. Salvo alcune donne impiegate in aziende cartiere, tessili e alimentari, la maggioranza degli ebrei avviati al lavoro fu impiegata in aziende agricole e soprattutto in lavori stradali di sterratura e di ripulitura degli argini dei fiumi.6 Le leggi razziali rimasero in vigore anche dopo il 25 luglio 1943, poiché la caduta del regime fascista non portò alcuna modifica allo stato giuridico degli ebrei, in quanto le leggi razziali non vennero abrogate dal governo Badoglio. Ciò costò la vita a circa ottomila ebrei italiani che furono catturati dai fascisti o dai nazisti e successivamente deportati nei campi di sterminio, da cui solo qualche centinaio fece ritorno. Quando furono istituite le leggi razziali, avevo due anni, così le elementari le ho fatte in una scuola ebraica a cura della comunità ferrarese; alcune autorità erano contrarie, non volevano che gli ebrei avessero l’opportunità di studiare, altri credevano che fosse una cosa positiva radunare tutti gli ebrei nella scuola, così si potevano controllare meglio. Gli insegnanti erano tutti ebrei: mia madre insegnava disegno e lo scrittore Giorgio Bassani, appena laureato, insegnava italiano al liceo.7 Dal’38 il lavoro diventò obbligatorio per gli ebrei ed i fascisti li utilizzavano per le pulizie dei boschi e dei prati. Proprio per questo, mio padre perse il suo lavoro e così dovette accontentarsi di lavoretti saltuari, mentre mia madre si arrangiava nel fare dei paralumi. L’atmosfera prima del ’43 non era così pesante. Io nel ’40 sono andato a scuola a sei anni e mi ricordo che, una volta, dei ragazzi mi sono corsi dietro perché ero ebreo e allora io, che correvo rapido, sono 83 scappato via. Mia madre insegnava nella mia stessa scuola ma non ho mai voluto andare con lei, altrimenti sarei apparso agli altri ragazzi troppo mammone. Noi vivevamo dentro al ghetto, la casa dei miei nonni era di fronte alla sinagoga, mentre quella dei nonni Fink era a pochi metri di distanza. Durante l’entrata in guerra dell’Italia, noi stavamo dai nonni Bassani, antifascisti, ed eravamo un po’ più fortunati, perché avevamo lo zio medaglia d’argento ed essendo cieco ed invalido di guerra, avevamo diritto a tenere la donna di servizio, la radio, la televisione e tutte le cose che agli altri ebrei erano state tolte. Non avevamo una vita terribile, aspettavamo solo che la guerra finisse; mi ricordo che il 25 luglio con la caduta del fascismo, abbiamo fatto grandi feste credendo che fosse la fine della guerra. Mi ricordo inoltre la notte dell’8 settembre, quando dei soldati hanno suonato alla porta per chiedere vestiti borghesi per poter scappare. La famiglia di mia madre, Bassani, era sicura che non le potesse accadere niente, perché erano industriali conosciuti da tutti, pure dalle autorità fasciste. Inoltre Ferrara era comandata da un gerarca, Italo Balbo, che aveva dichiarato apertamente la sua simpatia per gli ebrei.8 C’era solo una persona che stava avvertendo il pericolo e pensava che si dovesse fare qualcosa, mia madre, considerata troppo pessimista sia dalla famiglia Fink, che da quella Bassani. Non sapevamo cosa sarebbe poi capitato, al massimo credevamo che ci avrebbero portato nei campi di lavoro o di concentramento, ma tutti insieme. D’altronde dicevamo: “siamo tutti uguali.” A Roma il 16 ottobre ’43 c’era stata la razzia9 e queste cose nessuno le sapeva ed era molto strano anche che non ci fosse stato un passaparola, i passaporti non ce li aveva nessuno; per spostarsi bisognava chiedere il permesso in questura. A Verona, il 14-15 novembre del ’43 ci fu un grosso convegno fascista e il federale fascista di Ferrara, il Ghisellini, partì in macchina per andare a questo convegno, ma fu ammazzato. Non si sapeva se fossero stati gli stessi fascisti o i partigiani: fatto sta che quando tale notizia arrivò a Verona, molti fascisti partirono per Ferrara per punire gli antifascisti ebrei e c’è stata una lunga notte di 84 strage (ne è uscito anche un racconto ed un film).10 Igino Ghisellini, valoroso combattente, veterinario di professione, uomo incline alla moderazione, durante la sua breve gestione della federazione era entrato in contrasto, da una parte, con alcuni vecchi gerarchi fascisti perché pare stesse indagando sul loro conto e dall’altra con i giovani estremisti che pretendevano maggiore durezza nei confronti degli antifascisti. Dalle prime indagini condotte dai carabinieri risultò che Ghisellini era stato ucciso al bivio dell’Alberazza, a un paio di chilometri da Cento, anche se l’auto con il cadavere a bordo era stata condotta al di là del Reno, abbandonata in mezzo alla campagna per ritardare la scoperta. Nessun indizio sugli autori dell’omicidio, ma subito emerse un particolare sconcertante: i colpi di pistola erano stati sparati da dentro la macchina. La conclusione parve ovvia. Il federale era stato assassinato da qualcuno che era salito a bordo durante il tragitto, qualcuno che probabilmente Ghisellini conosceva e di cui si fidava. Per stroncare ogni illazione, i fascisti arrestarono il viceprefetto Atto Marolla, il vicequestore Giuseppe Poli e il tenente dei carabinieri Giulio Caroppo. Diffusa la notizia di tale assassinio, le squadracce di Verona e di Padova giunsero a Ferrara verso le 20 attraversando in camion le vie deserte del centro. Era una sera livida. Il rotolio degli autocarri e i canti degli uomini in camicia nera giunsero attutiti dalla nebbia, alla gente costretta nelle case dal coprifuoco. In poche ore i fascisti strapparono dalle case settantaquattro persone, appartenenti a tutti i ceti sociali, metà delle quali ebrei e l’altra metà sospettate di essere antifascisti. Non cercarono di arrestare tutti gli ebrei di Ferrara, ma si limitarono a prelevare un certo numero di capifamiglia per dimostrare alla città che il nuovo governo faceva sul serio. Poche ore più tardi, ai piedi del Castello Estense, undici antifascisti vennero abbattuti a raffiche di mitra e fra loro ci furono quattro di quegli ebrei che la Costituente di Verona aveva dichiarato appartenenti “a nazionalità nemica “.11 Noi, prima di questa notte tragica, eravamo stati avvertiti; infatti 85 alle ore 14 eravamo a casa Bassani a pranzo; suonò il campanello e chiesero di mia madre; probabilmente era la moglie di un poliziotto, la quale aveva avvertito di far scappare il marito e i suoi fratelli, nel caso fossero lì, perché quella notte ci sarebbe stato un arresto in massa degli ebrei. Infine disse: ”io non ho detto niente, lei non ha visto nessuno.” Mia madre organizzò tutto, mandò mio padre da degli amici cattolici, il fratello, l’industriale, lo mandò altrove e l’altro fratello, quello cieco, lo lasciò a casa, pensando che non gli potessero fare niente. Mia madre ed io andammo fuori città in una vecchia fabbrica del fratello industriale, lì ci nascondemmo e per tutta la notte sentimmo sparare; vennero anche a bussare chiedendo se ci fossero degli ebrei ed il custode rispose di no. Mia madre fu bravissima a distrarmi, raccontandomi gli ultimi film che aveva visto. La mattina dopo, se Dio vuole, la notte era passata, arrivò in bicicletta la figlia diciottenne di mio zio cieco, con delle brutte notizie: “hanno preso sia mio padre, anche se cieco, che mia madre”. Fu l’unica donna arrestata, non poteva lasciare il marito cieco, ma naturalmente il marito andò nel carcere maschile e la moglie in quello femminile. Inoltre, ci avvertì dell’arresto di mio padre, mia madre, incredula, si chiese come fosse possibile visto che era via, la ragazza le rispose che lo avevano preso perché era tornato a casa. A questo punto facemmo ritorno a casa e lì trovammo la donna di servizio in lacrime, perché aveva visto molti cadaveri mentre stava andando a fare la spesa. I fascisti non volevano che venissero sepolti perché tale macabro spettacolo doveva essere un chiaro messaggio alla cittadinanza; per fortuna, in seguito il vescovo di Ferrara riuscì a convincerli a seppellirli. Era passato l’8 settembre e i tedeschi erano già in città e rimproverarono moltissimo i fascisti per quello che avevano fatto, perché era una cosa non necessaria e violenta. Mia madre iniziò un periodo molto angoscioso; non mi voleva mai lasciare da solo, mi portava sempre con lei: il giovedì, a colloquio con mio padre in carcere, che affermava di essere proprio fortunato perché, in principio, lo avevano preso per fucilare e poi hanno smesso le fucilazioni in quanto i morti erano sufficienti. Mia madre cercava di far uscire la cognata, ovvero la moglie del fratello cieco; mi ricordo questo fascista 86 orrendo, da cui mia madre mi aveva portato, che diceva:”Se lei è venuta volontaria vuol dire che le piace, la lasci ben lì!.” A Ferrara i fascisti concentrarono in un’ala delle carceri gli ebrei “puri” che rientravano nelle categorie di cui la RSI aveva, appunto, ordinato l’internamento. Quando, in uno dei bombardamenti subiti dalla città, l’edificio riportò vari danni, gli ebrei uscirono, ma, finito il bombardamento, vi si ripresentarono, tanto che fu stabilita una specie di modus vivendi: quando gli alleati bombardavano, gli ebrei si rifugiavano dove volevano, poi rientravano. Quelli che approfittarono di queste occasioni per fuggire furono pochissimi, i più rispettarono scrupolosamente il patto e finirono in un secondo tempo a Fossoli.12 Mi ricordo che mia madre, durante l’ultimo colloquio in prigione, chiese a mio padre cosa avremmo dovuto fare qualora ci fosse stato pericolo, e lui le rispose: ”Scappate”. E così abbiamo fatto, anche se i nonni Fink non erano d’accordo perché c’era questa idea tribale, bisognava per loro stare tutti insieme. La situazione degli ebrei in Germania e in Polonia, non la conoscevamo chiaramente, ma correvano voci. Erano i profughi che passavano per Ferrara che mettevano in guardia gli ebrei ferraresi su quel che stava accadendo in Germania e quello che sarebbe accaduto in Italia. Una delle frasi ricorrenti che si sentivano fino all’ultimo era: ”Quello che è accaduto in Germania non è possibile che accada in Italia”. C’era l’idea di scappare in Svizzera e ricordo mio padre che diceva: “Per carità, con un bambino piccolo come si fa! Bisogna camminare, non possiamo.” Noi avevamo dei parenti cattolici, tra cui una zia molto ricca, la sorella di mio nonno, che si chiamava Elisa, la quale possedeva molte terre e varie fattorie. Mia madre, già qualche settimana prima di questi arresti, era andata dalla zia e le aveva chiesto se poteva mettere due letti dentro la fattoria più isolata, dove non c’era né acqua, né elettricità e lì aveva portato i suoi mobili della casa di Gorizia, che ancora ho. Notevoli sono stati gli aiuti dei contadini e dei montanari italiani; centinaia di famiglie ebree furono da essi ospitati con semplicità e altruismo. Se gli ebrei rifugiati in montagna avessero 87 dovuto trascorrere due inverni senza tetto, senza coperte, sicuramente sarebbero morti di freddo e di fame; per fortuna ci sono stati gli aiuti delle popolazioni di montagna le quali con generosità ammirevole divisero con loro le poche risorse di cui disponevano. Il momento più difficile per i rifugiati si verificò quando fu ordinata la denuncia degli inquilini e l’indicazione sulla porta di casa delle generalità di ogni singolo locatario. A causa di tale disposizione, molti dovettero abbandonare le case in cui abitavano e ritirarsi in baite sperdute prive spesso di porte e di finestre; pure in questo caso le popolazioni circostanti prestarono il loro aiuto fornendo loro attrezzi e viveri, evitando a questi infelici la morte per inedia e per freddo.13 Siamo arrivati lì vicino a Ferrara e non sapevamo cosa stesse accadendo e cosa fosse successo agli altri. Questi parenti cattolici andavano in città e forse avevano saputo, ma non ci hanno detto cosa stesse succedendo. Non ricordo un momento in cui siamo rimasti soli, io e mia madre. Eravamo presso questi contadini che avevano capito tutto di noi ebrei, perché noi sentivamo i loro discorsi e loro parlavano degli ebrei come cosa negativa, visto che erano stati loro, quelli ricchi, a volere la guerra. In seguito abbiamo capito che avevano questa idea astratta dell’ebreo nemico, ma poi quando dei loro amici provenienti dalla città dicevano loro che forse quella donna e quel bambino (noi) erano ebrei, loro rispondevano “Come! Ma come! Voi credete che la signora Laura e quel bimbetto siano ebrei? Ma no!!”. Noi non eravamo un’idea astratta, avevamo una certa identità, poi ci volevano bene perché in fondo stavamo insieme a loro, io con i figli dei contadini e la mamma con gli adulti ad aiutarli; a scuola non ci andavo, non potevamo andare a messa e mi sentivo in colpa verso gli dei e mi domandavo cosa potessero pensare di me. Ad un certo punto, la fattoria non era più isolata, infatti avevano costruito una base militare tedesca accanto. Secondo me, un tedesco aveva capito la nostra situazione; mi dava delle sue razioni, del formaggio, della cioccolata, tutte cose introvabili allora. Io giocavo con gli altri bambini e mi chiedevo il motivo per il quale ne dava solo a me. Quando 88 questo soldato è partito mi è venuto a salutare ed ha fatto un lungo discorso in tedesco e mia madre ed io non riuscivamo a capire nulla; forse era un tedesco che non condivideva ciò che i nazisti stavano facendo. Io di nascosto studiavo l’inglese, perché mia madre diceva che almeno sarei stato in grado di salutare gli americani al loro arrivo; infatti così ho fatto, anche se, chi arrivò a salvarci, non erano americani, ma polacchi. I tedeschi che erano rimasti lì fino all’ultimo momento, avevano perso la testa: sparavano a vista. Avevamo avuto due o tre giorni di attraversamento del fronte, i tedeschi ci avevano mandato a dormire in un rifugio per diverse notti, avevano bruciato la casa ed avevano ucciso le nostre galline, l’unica cosa che ci dava da vivere; le avevamo acquistate in cambio della lana dei materassi. Quella notte uccisero pure delle persone, come i due gemelli della contadina ed una donna anziana; c’erano stati bombardamenti ed io avevo visto molti morti. Avevamo idea che saremmo tornati; ci è arrivata una cartolina di mio padre; c’era una grande paura, perché lui sapeva dove eravamo e, come avevano torturato la donna di servizio, probabilmente avrebbero potuto torturare pure lui. Dopo cinquanta anni, nel 1993, aprirono gli archivi della questura, io mi ci recai e ricevetti l’archivio Fink, non quello Bassani, perché non figuravo in quello stato di famiglia. C’era tutto il dossier su mio padre e su mio nonno e sulla copertina c’era scritto sottolineato due volte: ”Cercare assolutamente la moglie e il figlio, nascosti da qualche parte”. La cosa più terribile è stato quando ci consideravano sfollati, perché molta gente dalle città, che spesso venivano bombardate, veniva nelle campagne, bombardate in maniera minore. Noi eravamo arrivati prima, quando ancora i bombardamenti non erano iniziati, quindi la cosa era già un po’ meno sospetta. Avevamo i documenti falsi della donna di servizio con la foto sostituita e la tessera per il cibo che lei si era fatta ridare, affermando di averla persa. Un giorno è arrivato un messo del comune a cui apparteneva la fattoria, e chiese quanti sfollati ci fossero lì e voleva sapere i nomi e i 89 cognomi perché dovevano schedarli e allora mia madre diede questi nomi finti, però c’era una certa preoccupazione perché si sarebbero accorti che di Massari Edvige ce ne erano due: sia mia madre, che la nostra donna di servizio a Ferrara. Chiedemmo così aiuto a dei nostri parenti, convertiti da una generazione, i quali ci dissero che loro potevano trovare un posto in un convento, ma solo per me. Mia madre era decisa a salvarmi. Io avevo preparato la valigia perché dovevano venirmi a prendere, così ci furono tutti gli addii disperati tra me e mia mamma; ma la macchina non arrivò, forse fu destino. La mattina dopo arrivò in bici un’amica di mia mamma, l’unica che sapeva dove eravamo e mia madre le disse: ”Fammi un piacere, va’ in questura, dì che cerchi una tua amica con un nome qualsiasi, che sai che è nascosta da qualche parte qui vicino e chiedi se ti danno la lista delle persone nascoste perché la vuoi andare a trovare. Due o tre giorni dopo ci arrivò una cartolina su cui c’era scritto: “Assolutamente locali”. A questo punto la macchina non è più partita e così sono rimasto con mia madre fino alla fine. Quello è stato il momento in cui ho rischiato veramente di perderla. Siamo poi tornati a casa, che nel frattempo era stata bombardata, lì abbiamo ritrovato la donna di servizio ed era come aver ritrovato la famiglia. Erano i soldati americani che ci davano da mangiare. Nonostante una spietata caccia all’uomo, migliaia di ebrei riuscirono a salvarsi. Altre centinaia riuscirono a mettersi in salvo in Svizzera.14 Anche qui non mancarono i casi drammatici: le autorità elvetiche infatti accordarono asilo soltanto agli anziani e a chi aveva figli. Spesso i gendarmi di frontiera chiudevano un occhio e lasciavano entrare anche i giovani; numerosi furono tuttavia i casi di ebrei che, giunti all’agognata meta, vennero respinti. Nonostante tutto, anche per chi tentava l’espatrio in Svizzera (un passaggio spesso costava 2000 lire a persona e, qualche volta, ancora di più) c’era il rischio di essere traditi e venduti ai fascisti o ai tedeschi ad un prezzo che variava tra le 1000 lire e le 7000 lire. La massa degli ebrei, italiani e rifugiati, in Italia dovette però la sua salvezza soprattutto alla solidarietà ed all’aiuto della popolazio- 90 ne italiana. Nonostante le taglie e le rappresaglie tedesche e fasciste, dopo l’8 settembre si può dire veramente che ogni ebreo dovette la sua salvezza ad un italiano. Di ciò, il presidente dell’Unione delle Comunità Israelitiche Sergio Piperno ha dato ampiamente atto a tutti gli italiani in Campidoglio il 14 dicembre 1956, in occasione di una grande cerimonia di riconoscenza degli ebrei verso i concittadini cristiani che li soccorsero durante le persecuzioni: “Tutti si prodigarono; tutti quelli che in qualche modo erano in grado di seguire le mosse dell’occupante furono sollecitati ad avvertire le innocenti vittime predestinate; tutti gli amici, i conoscenti, i vicini di casa furono pronti a riceverli, nasconderli, ad aiutarli, tutti si affannarono a procurare agli ebrei falsi documenti ed a sviare le ricerche.”15 Le ventitré medaglie d’oro e le centinaia e centinaia di diplomi di benevolenza date nel dopoguerra dall’Unione delle Comunità e dalle varie Comunità, a coloro che, nel 1943-45, aiutarono gli ebrei spesso a costo della loro vita (sette delle medaglie d’oro sono alla memoria) non stanno ad indicare che una parte di questi casi di solidarietà umana.16 La sorella di mia madre a Bologna si era salvata, mentre tutti gli altri miei parenti, sia dalla parte Bassani, che Fink, sono stati portati via. C’era ancora l’idea che tornassero, magari malconci. Andavamo la sera in un posto, non in centro, davanti a delle scuole dove arrivavano i reduci e dei soldati e tutte le sere aspettavamo. Non è mai arrivato nessuno. Non c’è mai stato un momento in cui ho capito che mio padre era morto, credo che mia madre avesse già saputo qualcosa. E’ terribile lo so, ma non ho mai pianto, né per mio padre, né per gli altri miei parenti, anche se a tutti volevo molto bene; adoravo molto i miei nonni, i figli delle sorelle di mio padre e lo zio cieco, il quale aveva una splendida collezione di francobolli che però non poteva vedere e così io gliela custodivo. Adesso eravamo tutti più felici, visto che potevamo uscire per le strade liberamente, non c’erano più minacce, sparatorie, tedeschi che ti 91 potevano arrestare ed infine si poteva andare a scuola. Mia madre è stata una donna a cui sono stato molto legato, è sempre stata molto in gamba, attiva, in fondo aveva solo me, ha fatto di tutto per farmi laureare. Appena laureato, mi hanno chiamato in America e per fortuna aveva accanto sua sorella, rimasta vedova, e con lei ha passato gli ultimi anni della sua vita. A Ferrara sono ritornate dai lager quattro persone: Giorgio Ravenna, che forse è quell’uomo che ha parlato con mia madre e l’ha informata della morte di mio padre. Gli altri tre erano padre, madre e figlio della famiglia Schönheit. Questi ultimi partirono da Ferrara il 26 febbraio 1944 verso Fossoli che, da un campo di prigionia per inglesi durante la guerra, era diventato, nel 1943, il punto di raccolta degli ebrei italiani e dei detenuti politici. Questo campo, a metà febbraio passò dalla polizia italiana, sotto il comando delle SS. Dopo Fossoli, la madre fu mandata a Ravensbrück, mentre il padre ed il figlio a Buchenwald. E’ una cosa incredibile che tutti e tre si siano salvati.17 Quando tornammo a Ferrara, a casa non c’era più nessuno. Avevamo una casa enorme, era stato portato tutto via, era stato tutto sequestrato; casualmente abbiamo trovato una copia del verbale di sequestro in cui c’era persino scritto del sequestro delle biciclette; così con mia madre siamo andati a richiederle, visto che a quell’epoca erano un tesoro. Il militare ha detto: “Ah, questi ebrei non sono neppure contenti di essere vivi e rivogliono le bici!” e ci ha mandato via in malo modo. Inoltre mia madre ha fatto domanda per la pensione di guerra, perché dopo due o tre anni anche i deportati ed i morti ad Auschwitz sono considerati vittime civili e così mia madre avrebbe avuto diritto a tale pensione. L’anno scorso, nel 1998, mentre stavo vuotando la casa dove abitavo con mia madre, morta nel 1994, ho trovato un documento del ministro Scelba, del 1951; qui c’era scritto che mia madre non aveva diritto a tale pensione, in quanto non aveva specificato con precisione il giorno, il mese e l’anno del decesso ed il luogo della sepoltura di mio padre. Dopo la guerra, sono passato in prima media e l’atmosfera era ancora molto strana: i professori erano ancora abituati ad insegnare in un 92 certo modo, si capiva che erano ancora dalla parte di Mussolini. Molti miei compagni erano preoccupati che andassi all’inferno, così mi mettevano i santini nella cartella. Quando diventai adulto, all’età di tredici anni - abitavo ancora a Ferrara davanti alla sinagoga - iniziai a venire coinvolto nelle cerimonie religiose, qualora non fosse raggiunto il numero necessario, in quanto la religione ebraica, fondamentalmente maschilista, prevede che alle celebrazioni siano presenti almeno dieci adulti. Negli anni successivi alla guerra, nessuno aveva voglia di parlare degli orrori di cui eravamo stati testimoni. Ho iniziato ad occuparmi di ebraismo soltanto negli anni ’80, altre persone, come ad esempio Primo Levi, che lo hanno fatto si sono suicidate dalla disperazione, constatando che è stato tutto inutile: che gli orrori continuano ad accadere e le persone a soffrire così come abbiamo sofferto noi. Senza dubbio sono colpevole di aver rimosso molte cose per lungo tempo, anche se io non ho mai rinnegato nulla. Il grande cambiamento della mia vita è stato il trasferimento in America dopo la laurea, ad insegnare italiano; su dieci persone che conoscevo, nove erano ebrei ed era strano, perché anche in America gli ebrei erano solamente una percentuale minima della popolazione, una minoranza ridicola quantitativamente, però sono molto più riconoscibili; nell’università fra i docenti erano il quaranta per cento, fra gli studenti il trentacinque per cento. In queste parole non affiora né odio, né rancore: “Questa saggezza che avete avuto, come è nata? ”Io non parlerei di perdono, mi rendo conto che sono un po’ razzista anch’io. Una rete televisiva tempo fa mi ha chiesto se andavo a fare un dibattito con una persona sul razzismo, io non ci sono voluto andare, non lo volevo incontrare; so già che lui ha delle idee diverse dalle mie, perché ci sarei dovuto andare? L’odio per gli italiani no, sono stati sì dei fascisti, le cose che ho raccontato sono terribili ma ci sono stati degli episodi positivi, io non sarei qui se non mi avessero aiutato, poi l’odio credo che sia una reazione sbagliata. Purtroppo credo che queste cose succedano sempre e non lontano da noi, magari in maniera minore e meno organizzata rispetto ai tedeschi, 93 ma sempre terribili. Se poi esce sul giornale che Silone o Moravia sono stati fascisti, negli anni ’30 io dico “Beh, pure mio zio, quello cieco, non era fascista, ma monarchico”. Magari se qualcuno adesso dice di essere fascista e che hanno fatto bene i fascisti a fare quello che hanno fatto, no, allora non perdono, perché adesso si può sapere, allora era tutto all’oscuro. Infine, penso che l’odio sia qualcosa che faccia male, credo che transigere no, ma odiare sia una cosa molto brutta. NOTE 1 Tutte le dichiarazioni le ho avute tramite una conversazione all’Università con il prof. G. Fink. Per le informazioni riguardo agli ebrei di Ferrara cfr. A. Sacerdoti e A. Tedeschi Falco, Emilia Romagna. Itinerari ebraici, Marsilio, Venezia, 1992, pp. 6583 e A. Stille, Uno su mille, Mondadori, Milano, 1994, pp. 321-362. 2 Per la condizione sociale degli ebrei a Ferrara cfr. A. Sacerdoti e A Tedeschi Falco, op. cit., p. 68. 3 Per l’integrazione e l’assimilazione degli ebrei italiani cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1998, cap. I. 4 Per il rapporto tra gli ebrei e la politica secondo G. Bassani cfr. A. Stille, op. cit., pp. 324-326. 5 Per una rivisitazione letteraria dell’incontro tra il padre e la madre di Fink cfr. G. Bassani, Due fiabe in L’odore del fieno, Mondadori, Milano, 1991. 6 Per le informazioni sul lavoro obbligatorio per gli ebrei cfr. De Felice, op. cit., pp. 372-373. 7 Per l’esclusione degli ebrei dalle scuole del Regno cfr. De Felice, op. cit., pp. 280282; 308 ss. 8 Italo Balbo era nato a Quartesona (Ferrara) il 6 giugno 1896. Fu tra i principali esponenti del movimento fascista fin dal suo sorgere, quadrumviro ed uno dei collaboratori di Mussolini durante la marcia su Roma. Partecipò alle azioni delle squadracce in Emilia ed in Romagna e, nel 1926, fu nominato sottosegretario all’Aeronautica. In seguito la sua carriera fu rapidissima: a 32 anni divenne generale; dal 1929 al 1933 tenne il Ministero all’Aeronautica. In questo periodo compì le sue trasvolate oceaniche, imprese per le quali va famoso. Divenuto governatore generale della Libia nel 1933, allo scoppio della seconda guerra mondiale, assunse il comando di tutte le forze armate della colonia. Tuttavia, 94 proprio all’inizio della guerra, il 28 giugno 1940, il suo aereo, mentre sorvolava il porto di Tobruk, fu abbattuto, pare per errore, dalla contraerea italiana. Cfr. Storia illustrata. Enciclopedia dei personaggi storici, Arnoldo Mondadori, Milano, 1970, p. 67. 9 Per la razzia a Roma del 16 ottobre 1943, si veda G. Debenedetti, 16 ottobre 1943, Sellerio, Palermo, 1993. 10 G. Bassani, Una notte del ’43 in Dentro le mura, Mondadori, Milano, 1991; il film è La lunga notte del’43 (1960). Regia di Florestano Vancini. Con Belinda Lee, Gabriele Ferzetti, Enrico Maria Salerno, Gino Cervi. 11 Per le notizie riguardo l’assassinio di Ghisellini e la tragica notte del ’43 cfr. Storia illustrata, novembre 1983; G. Mayda, Gli ebrei sotto Salò, Feltrinelli, Milano, 1978, pp. 114-116. 12 . Per le informazioni sulla prigionia degli ebrei e sul campo di Fossoli cfr. G. Pisanò, Mussolini e gli ebrei, edizioni FPE, Milano, 1967, pp. 87-88. 13 Per gli aiuti agli ebrei da parte dei contadini italiani cfr. De Felice, op. cit., pp. 474 ss. 14 Per informazioni riguardo gli ebrei in Svizzera cfr. R. Broggini, La frontiera della speranza, Le Scie, Mondadori, Milano, 1998. 15 Cfr. R. De Felice, op. cit., p.472. 16 Per gli aiuti ricevuti dagli ebrei da parte dei concittadini italiani cfr. R. De Felice, op. cit., p. 472 e cap I. 17 Per le notizie sulla famiglia Schönheit cfr. A. Stille, op. cit., pp. 321-362. 95 GLI EBREI NELLA FERRARA FASCISTA (1938 - 1943) Federico Ferruzzi Alle ore 21.00 del 21 settembre 1941 una squadraccia del tutto simile per formazione e sistemi a quelle di vent’anni prima si recò in via Mazzini 95 e qui, agli ordini di taluni campioni del “manganellismo”, diede l’assalto con la consueta furia primitiva ai due soli locali che la Comunità, ormai molto ridimensionata, adibiva alternativamente al culto: il Tempio di rito tedesco, a cui si accede per la scala principale ed il cosiddetto “Oratorio Fanese” che è in cima ad una modesta scala a sinistra dell’ingresso.1 Essendo chiusi entrambi i locali, furono sfondate le porte, ma, trovando i locali disabitati, non rimase che distruggere marmi, vetri, mobilio, anticipando le devastazioni del 1943-1944. Il rabbino capo, Leone Leoni, abitando nell’appartamento che è di fronte all’Oratorio Fanese, si affacciò, allarmato dai rumori, e tentò di avere spiegazioni. Si sentì rispondere che era ora di finirla: il fascismo non poteva ulteriormente tollerare che gli ebrei invocassero il Padreterno, con chi sa quali diabolici scongiuri, e finì per buscarsi due ceffoni da uno dei condottieri a titolo di benservito. Il Padano. Corriere del Lunedì del 22 settembre ’41, a conclusione di un articolo di cinque colonne dove si esaltava la visita di un alto gerarca, così commentava: “Un gruppo di squadristi, attraversando via Mazzini, che fu un tempo il Ghetto ferrarese, ha compiuto un sopralluogo un po’ vivace nella sinagoga”. Numerosi i casi di persone o famiglie che abbandonarono Ferrara per trasferirsi in genere all’estero ovvero in grandi città italiane dove vi era maggiore possibilità di confondersi con la 1 Per questa relazione si sono tenuti presenti i seguenti testi: G. Mayda, Gli ebrei sotto Salò, Feltrinelli, Milano, 1978 e R. Bonfiglioli, Gli ebrei a Ferrara dal fascismo alla liberazione, in “Competizione Democratica”, 25 aprile 1955. 96 massa dei cittadini. Si può considerare che la comunità, il cui numero di iscritti, già dimezzato dall’altro dopoguerra, non superava le seicento persone, perdette in tal modo circa il 30 per cento dei presenti, anche se non sempre degli iscritti: taluno, in omaggio a legami familiari od altrimenti sentimentali, tenne a figurare in quell’elenco ed a soddisfare ai propri obblighi fiscali: ancora oggi, fra i non rimpatriati, vi è chi ha voluto conservare tale posizione. Rari i casi di “cancellazione”: gli ebrei cioè che, pure rimanendo tali, non intendevano però che il loro nome figurasse negli elenchi della Comunità. Più numerosi i casi di passaggio ad altra religione: grosso modo si può considerare, in totale, una ulteriore diminuzione del 4-5%. Per gli studenti universitari non rimase che la possibilità di proseguire gli studi all’estero, quando ciò fu materialmente possibile. Per le scuole medie invece, la comunità si mise quasi subito in condizione di ospitare i giovani nell’asilo infantile in via Vignatagliata: col grande conforto di trovare insegnanti ebrei già laureati o laureandi o comunque perfettamente idonei, tutti ferraresi o residenti. Chi aveva avuto titoli di merito durante il regime, ovvero durante la guerra, era riconosciuto meritevole di benevola attenzione, non gli si sequestrava l’apparecchio radio, purché non vi fosse in seno alla famiglia del discriminato alcun membro sospetto; i suoi beni immobili venivano esentati, almeno entro certi limiti, da eventuali sequestri o fermi o alienazioni obbligatorie. Dopo l’entrata in guerra, vi furono numerosi arresti di ebrei, a Ferrara, a partire dal 13 giugno. Gli arresti continuarono per tutto il mese di giugno, ma pochi vennero mandati in uno dei due campi (Urbicagli e Gioia del Colle) destinati agli ebrei italiani, mentre i più venivano avviati “al confino” cioè in paesetti dove la sorveglianza era agevole. La durata delle permanenze nei campi e nei luoghi di confino, variò molto: ve ne furono di brevi o brevissime e di lunghe o lunghissime. In totale, furono allontanate da Ferrara circa 25 persone. 97 Verso la fine del ’42 venne imposto l’obbligo di lavorare a un certo numero di ebrei. Datori di lavoro furono il C.A.L.E.F.O. e il Consorzio Agrario, nei loro uffici e nei loro magazzini. La cosa ebbe breve durata: per lo scarso rendimento, per l’illogica concorrenza a lavoratori qualificati, perché i capi magazzino non sapevano che cosa farsene di quegli operai, o per una certa svogliatezza che veniva dall’atmosfera sempre pesante. In un’ondata di arresti del ‘43, alla fine di maggio, furono presi alcuni giovani ebrei che effettivamente avevano svolto parte attiva nei movimenti disfattisti a carattere insurrezionale che l’antifascismo ferrarese svolgeva da qualche tempo. Gli ebrei furono tre, Giorgio Bassani, Matilde Bassani, Primo Lampronti, due dei quali insegnanti nelle scuole medie di via Vignatagliata, mentre il terzo, uno sportivo, lavorava nella ditta di un altro degli arrestati, G. Bianconi. Facevano parte tutti del Partito d’Azione e, assieme ai colleghi, non furono liberati che il 25 luglio. Curioso il fatto che fra gli arrestati del ‘43 non vi fosse alcuno di quelli del ‘40, e viceversa. L’OMICIDIO GHISELLINI E L’ECCIDIO DI FERRARA Al Congresso di Verona, domenica 14 novembre 1943, fu comunicato da Ciro Randi e Alessandro Benea che il federale di Ferrara, Igino Ghisellini, era scomparso dalla sera prima e si temeva che fosse stato ucciso. Pavolini rispose: “Si fucili un antifascista, ogni due ore fino al ritrovamento di Ghisellini, vivo o morto”. Ma il pomeriggio giunse la notizia, portata da altri due squadristi, Mirandola e Borellini, che il federale era stato rinvenuto, assassinato a colpi di rivoltella. Immediatamente Pavolini balzò in piedi: “Camerati!” – disse – “il commissario della federazione di Ferrara, che avrebbe dovuto trovarsi qui con noi, il camerata Ghisellini, è stato ucciso con sei colpi di pistola. Noi eleviamo a lui il nostro pensiero. Egli verrà subito vendicato!” Dal- 98 l’assemblea, salì un grido: “A Ferrara! Tutti a Ferrara!” Pavolini impose il silenzio: “Non si può gridare in presenza del morto. I lavori continuino. I rappresentanti di Ferrara raggiungano la loro città. Con essi vadano formazioni delle polizia federale di Verona e gli squadristi di Padova”. In realtà Igino Ghisellini era stato ucciso dai suoi camerati. Lo soppressero per contrasti interni di partito, per rivalità e anche perché il federale era un “moderato”, un seguace cioè della politica di Mussolini che, di fronte all’estendersi del movimento partigiano e all’agitazione delle masse operaie, puntava sulla carta della “pacificazione” e della “concordia nazionale” tentando di isolare quella ribellione che non sapeva reprimere. Ghisellini era colui che, nel settembre precedente, all’indomani dell’armistizio, aveva cercato un accordo politico con gli antifascisti ferraresi (soltanto i comunisti si erano rifiutati) e forse è proprio questo suo atteggiamento che lo ha posto in urto col neosquadrismo di Pavolini e di Farinacci, fautori di un ritorno al sistema totalitario in forma anche più intransigente, rigida e spietata: “Chi parla di dimenticare”, scrisse Il Fascio, organo della federazione milanese del partito fascista repubblicano (P.F.R.) “commette un delitto di lesa Patria e un secondo tradimento verso il fascismo”. Ghisellini fu assassinato a Castel d’Argile di Cento nelle prime ore di domenica 14 e subito, negli inquirenti, nacque il sospetto di un crimine originato da una faida di partito: il cadavere presentava sei ferite d’arma da fuoco alla nuca e la Topolino sulla quale viaggiava il federale aveva i vetri infranti dall’interno, segno che l’autore del delitto doveva essere una persona “amica” salita con lui sull’auto. Ma coloro che avanzarono cautamente questa ipotesi – il viceprefetto Atto Marolla, il vicequestore Giuseppe Poll e il tenente comandante della stazione dei carabinieri di Cento – vennero arrestati temporaneamente dagli squadristi e rinchiusi nelle carceri ferraresi di via Piangipane: la morte di Ghisellini doveva servire a dare un lezione e sanare con una strage il trionfo delle tesi estremistiche di Pavolini e nel suo concetto 99 di “fascismo delle squadre d’azione”. Così, poche ore più tardi, ai piedi del castello Estense, undici antifascisti ferraresi furono abbattuti a raffiche di mitra e fra loro vi saranno quattro ebrei: “Da allora”, dirà Piero Calamandrei in una celebre orazione, “la notte di Ferrara fu citata ad esempio. Nel linguaggio della stampa fascista entrò, per indicare quel procedimento esemplare, un nuovo delicato vocabolo: “ferrarizzare”. Il compito di tutti i buoni fascisti fu, da allora, di “ferrarizzare” l’Italia. Le squadracce di Verona arrivarono in città verso le 20.00. Nella sede della federazione si erano già insediati Franz Pagliani, ispettore regionale del partito, Enrico Vezzalini, che diverrà capo della provincia di Novara, e il console della milizia Giovanni Battista Riggio, tre dei futuri giudici di Galeazzo Ciano. Hanno dinanzi una “lista nera” di 84 antifascisti “sospetti”. Appena giunti, gli squadristi iniziarono le retate e in poche ore 75 cittadini sono raccolti nella caserma Littorio di piazza Fausto Beretta. I fermati appartenevano a tutti i ceti sociali, ma molti erano i professionisti e i benestanti, per la maggior parte israeliti: fra questi il dottor Umberto Ravenna, ottantenne, l’avvocato Giuseppe Bassani, l’ingegnere Silvio Finzi, il professore Mario Magrini, Vittorio e Mario Hanau, padre e figlio, l’uno di 65 e l’altro di 41, entrambi commercianti di pellami. Fra gli ostaggi c’era anche l’anziana maestra socialista Alda Costa, perseguitata per vent’anni dalla polizia fascista. Riuniti in un ufficio al primo piano della caserma, i fascisti tardarono a decidere perché erano sorti contrasti sulla misura da dare alla rappresaglia. Lo squadrista Carlo Govoni, sosteneva la “necessità di fucilare almeno trentasei antifascisti”; il console della milizia Randi propose di uccidere venti ostaggi al giorno fin quando non si fossero costituiti i responsabili della morte di Igino Ghisellini. I triumviri della federazione ferrarese, Caltura, Ghilardoni e Borellini, che stesero la “lista nera”, rifiutarono di scegliere i nomi delle vittime. “Allora faremo da soli”, replicò minaccioso Riggio, “e sarà peggio”. Le discussioni si conclusero 100 alle 5 del mattino; pochi minuti più tardi due squadristi entrarono nello stanzone, uno aveva in mano un foglio protocollo e lesse: “Emilio Arlotti, Mario Zanatto, Vittorio Hanau, Mario Hanau. Questi mi seguano”. L’altro milite si fece dare i documenti d’identità dei quattro arrestati e li controllò, erano le 5.20. Alla stessa ora una squadraccia capeggiata da Nino Furlotti bussò alla porta del carcere di via Piangipane e reclamò dal direttore, Gusmano, l’immediata consegna, senza alcuna formalità, di quattro detenuti politici: il dottor Pasquale Colagrande, l’avvocato Giulio Piazzi, il rappresentante di commercio Alberto Vita Finzi e l’avvocato Ugo Teglio. Il dottor Gusmano pretese che gli venisse presentato un ordine della magistratura, ma gli uomini di Furlotti si avventarono sul direttore e lo minacciarono di morte, finché Gusmano si arrese e consegnò i quattro detenuti, che erano in carcere dal 7 ottobre con altri ventisette antifascisti di Ferrara e della provincia. Erano ormai le 6 passate del lunedì 15 novembre. Prima l’uno, poi l’altro, i due gruppi furono condotti in corso Roma e spinti contro il parapetto del fossato del castello Estense. L’avvocato Zanatto fu ucciso per primo, poi spararono ad Arlotti; gli Hanau morirono con una raffica di mitra. Dieci minuti più tardi furono trucidati anche i quattro del carcere di via Piangipane, ma otto morti non bastarono: occorreva altro sangue. Gli squadristi prelevarono in stazione un manovale delle ferrovie, Cinzio Belletti, un giovane che non si era mai occupato di politica e lo trascinarono in piazza Boldrini. La decima vittima fu l’ingegner Girolamo Savonuzzi, cinquantottenne, ex assessore socialista; l’undicesima fu il ragionier Arturo Torboli, 54 anni, vecchio funzionario del Comune. Entrambi furono condotti sul Montagnone e assassinati. Gli uccisori li spogliarono di tutto, comprese le scarpe, poi andarono a derubare anche le altre vittime. Ai parenti che, angosciati, chiedevano notizie dei loro cari, i repubblichini risposero, impassibili: “Non vi preoccupate perché non tarderanno a rincasare”. Verso le ore 9 un gruppo di bimbi sbucò in corso Roma, era- 101 no tutti alunni delle elementari. Vicino al bar Sis i bambini scorsero gli otto corpi delle vittime riversi a terra lungo il muretto del Castello; terrorizzati cercarono di scappare, ma i militi di guardia li rincorsero, li fecero tornare in dietro e li costrinsero a proseguire la strada passando davanti ai cadaveri: “Dovete vedere!” urlò uno degli squadristi, “tutti in città debbono vedere!”. La strage di Ferrara, undici innocenti uccisi, doveva essere portata ad esempio, doveva servire da ammonimento anche per gli ebrei: nella stessa notte dell’eccidio un’anziana, Olga Hanau Nappi, che giaceva gravemente malata in una corsia dell’ospedale, fu trasferita al campo di concentramento di Fossoli. Malgrado la censura della stampa, in tutta Italia trapelò la verità sulla strage e si riseppe ben presto che gli assassini avevano trascorso parte della notte ad ubriacarsi in un’osteria accanto al Castello Estense e che il questore aveva informato la magistratura della strage con un telegrafico rapporto: “Stamani sono stati trovati undici cadaveri di sconosciuti. Si ignorano completamente le cause e gli autori di queste morti”. Mussolini definì il massacro di Ferrara “un atto stupido e brutale” e di lì a un mese dovrà riconoscere che “l’azione del neosquadrismo ha congelato la corrente di simpatia che si andava affermando attorno al regime” ma il gruppo estremista Pavolini-Farinacci-Preziosi non perse il minimo potere se, due settimane dopo, Salò realizzò la propria politica antisemita con l’ordine di internamento per tutti gli ebrei italiani e residenti in Italia. INTERVISTA A CARLA NEPPI All’età di sei anni, quando dovevo entrare a far parte del mondo scolastico, questo diritto mi fu negato. Io come ebrea, non potevo entrare a far parte della scuola. I miei genitori, assieme ad altri genitori di bambini ebrei, hanno formato una scuola, che inglobava alunni dalla prima elementare, fino 102 all’ultimo anno di liceo. Dopo cinque anni di scuole elementari, arrivai all’esame di ammissione per le scuole medie, che veniva svolto all’interno di una scuola statale; io ed altri bimbi ebrei credevamo di andare normalmente assieme a tutti gli altri, ed invece sbucò fuori dalla porta un uomo in divisa, che con voce tonante disse: “Tutti gli studenti di razza ebraica devono seguirmi perché devono essere isolati!”. Noi, impauriti, abbiamo seguito questo individuo; eravamo quattro bimbi e ci siamo ritrovati in un’immensa aula, ed abbiamo svolto il nostro esame di ammissione, nel completo isolamento, però abbiamo avuto la fortuna di avere degli insegnanti che ci hanno esaminato e che ci hanno dato coraggio. Erano molto disponibili, e quindi abbiamo visto la differenza fra la legge, che doveva essere eseguita e messa in atto e gli insegnanti che avevano un atteggiamento completamente diverso. Ho fatto questo paragone perché in Italia, durante le leggi razziali, la maggioranza della popolazione non le ha mai accettate, poiché noi avevamo una vita comune, una religione diversa, ma mio padre faceva il professionista, mio zio, il medico, e amici facevano gli insegnanti, quindi eravamo integrati nella società e con le leggi razziali queste persone, che erano abituate a vivere con noi, ad essere amici nostri, non accettarono questo muro che il regime fascista aveva costruito tra noi e gli altri italiani. Nel 30 novembre del ’43, sono iniziate le vere e proprie persecuzioni e allora c’è stata, logicamente, la disperazione di noi tutti, per poter salvare la nostra vita e quella dei nostri familiari. Gli ebrei non credevano che potesse esistere un genocidio di massa come quello che è stato messo in atto. Io con la mia famiglia siamo scappati, di notte, in maniera carambolesca, proprio per vedere di sfuggire a queste razzie. Noi abbiamo avuto fortuna perché ci siamo rifugiati nelle montagne bolognesi, dove una famiglia ci ha accolto, senza sapere che eravamo ebrei, avendoci scambiato per degli sfollati. C’erano delle persone che ci facevano molte domande, specie a me che ero la più piccola e logicamente io ho avuto la presenza di spirito di non rivelare mai che eravamo ebrei. Verso la fine della guerra siamo rimasti senza soldi, e allora mio padre, assieme a mia madre, la quale era fiorentina e aveva la famiglia a 103 Firenze, decise di attraversare la linea di confine e giungere a Firenze, per aspettare la liberazione di Ferrara. Gli americani ci hanno aiutato a superare la linea, ci hanno messo sui loro camion e finalmente siamo giunti a Firenze. Qui la famiglia di mia madre era sparita, così mio padre per mantenerci ha riaperto l’azienda del fratello di mia madre e per poter aspettare dall’ottobre del ’44 fin al maggio ’45, momento in cui è stata liberata Ferrara. Mio padre nel maggio del ’45 tornò a Ferrara, poi io sono tornata per la prima volta a Ferrara con mio padre a fine giugno del ’45; per giungere a Ferrara ho impiegato un giorno e mezzo e solo per percorrere 150 chilometri. Io provengo da una famiglia ferrarese da ben sette generazioni, quindi molto tradizionale, molto religiosa, per non dire addirittura ortodossa, ma mio padre aveva impostato la sua famiglia in un modo aperto, sempre molto osservante per quanto riguarda la religione ebraica, ma con delle idee completamente diverse dai suoi avi, infatti il patrimonio della mia famiglia paterna si trasmetteva da padre in figli maschi, noi invece siamo con due fratelli e una sorella più piccola che sono io; mio padre è morto nel ’55, ma non ha lasciato testamento e quindi il patrimonio è stato diviso normalmente in tre parti uguali; quindi mio padre ha iniziato un capovolgimento, per quanto riguarda la parte finanziaria e anche all’interno del rapporto familiare. Io ricordo che, nel momento in cui in una nottata avevamo deciso di scappare dalla nostra casa di campagna, poiché non potevamo più rimanerci, mio padre e mia madre si consultarono in maniera paritaria; si prendevano le stesse responsabilità e le decisioni le prendevano assieme. L’indirizzo non era soltanto paterno, tipico della cultura ebraica, ma era anche materno. 104 ……cadde sull’erba (Giuseppe Lionelli, partigiano di Filo d’Argento) …Sale le scale bussa alla porta «Signor Comandante, c’è un partigiano. Viene dall’acqua è molto stanco». «Fallo salire, ch’io possa sapere che cosa mi porta di bello o di brutto». Aveva nei piedi le scarpe rotte e sulla testa un cappello vecchio. Contro la spalla portava un fucile, come la vanga un contadino. Era bagnato d’acqua salata ed era sporco di terra nera. «Signor Comandante mi raccomando, mi dia risposta, non perda tempo. (Un colpo solo da un mitra nascosto). Si piegò avanti, cadde sull’erba. «Loro» mi aspettano, sono là chiusi, non sanno la strada» «Metti queste armi E tutte le armi gli restarono a torno come cani da guardia al morto padrone. sulle tue spalle: non ti fermare che «loro» aspettano e tu non arrivi». Da un albero secco cascò una foglia, ed una stella mutò posto in cielo. «Io la saluto signor comandante. Se faccio a tempo non moriremo». (da “Competizione Democratica”, 25 aprile 1955) Andava curvo sotto le armi, e camminava vicino al fosso. E dentro al fosso c’era un rumore: e lui correva per far più presto 105 ROMA, CITTA’ APERTA? Antonio Concutelli GLI EBREI A ROMA Gli ebrei possono vantare a Roma una presenza ininterrotta di oltre duemila anni: sulle rive del Tevere costituirono il primo insediamento ebraico in Italia e una delle comunità più antiche in Europa.1 Una comunità vi si insediò stabilmente tra il II ed il I secolo a.C.: come i greci ed i fenici, furono per lo più mercanti o schiavi liberati. Il nucleo originario si arricchì con l’arrivo dei prigionieri portati a Roma in seguito alle campagne di guerra di Pompeo in Giudea. I bassorilievi dell’Arco di Tito che raffigurano il corteo trionfale dell’imperatore, con il candelabro a sette bracci e gli arredi depredati dal Tempio, tramandano la memoria della conquista di Gerusalemme nel 70 d.C., in seguito alla guerra intrapresa da Vespasiano e conclusa dal figlio. Era l’inizio della dispersione degli ebrei nell’impero. Con l’arrivo degli schiavi portati da Tito e successivamente di numerosi esuli, la città divenne una delle più importanti comunità della diaspora con circa 50 mila ebrei presenti a Roma (il dieci per cento della popolazione). L’ebraismo fu una delle tante religioni che convivevano in quel crogiuolo di culture che era l’Impero e l’atteggiamento dei romani nei confronti degli ebrei fu inizialmente tollerante, anche se i rapporti con il potere subirono alterne vicende. Limitazioni del culto ebraico cominciarono a verificarsi sotto Domiziano, che temette il proselitismo, e durante l’impero di Adriano, che vietò la circoncisione e lo studio della Torah ed inoltre rase al suolo il Tempio di Gerusalemme. 106 Il soffocamento dell’identità ebraica in Palestina non impedì comunque il diffondersi dell’attività culturale e spirituale nella diaspora; illustri rabbini giunsero nella città e svolsero un ruolo importante per evitare ulteriori persecuzioni, ma solo con Caracalla, nel 212, gli ebrei ottennero la cittadinanza romana, garantita a tutti gli uomini liberi dell’Impero che ne erano ancora sprovvisti. La situazione cominciò a cambiare notevolmente con la conversione di Costantino nel 312 e con l’editto di Milano del 380, che ufficializzò il ruolo del cristianesimo nell’impero. Il concilio di Nicea del 325 aveva separato definitivamente le due religioni: come giorno di riposo al posto del sabato si istituì la domenica ed ai cristiani fu vietato tra l’altro di celebrare la Pasqua contemporaneamente agli ebrei e di frequentare le sinagoghe. Prese così avvio una politica di restrizioni e di divieti, non solo sul piano religioso: gli ebrei furono dichiarati inabili a testimoniare e subirono la confisca dei beni immobili, furono esclusi dall’esercito e dalle cariche pubbliche, si vietò loro di tenere schiavi. Rimasti praticamente l’unico gruppo non cristiano, dopo la conversione dei regni romano-barbarici tra il VI ed il VII secolo, gli ebrei appaiono citati per la prima volta negli editti come “setta nefanda, gente contaminata” che segue una “dottrina perversa”. Anche i papi mostrarono la loro presa di posizione nei Codici di Teodosio e di Giustiniano: salvaguardare la vita della collettività ebraica in seno alla società cristiana, pur creando una separazione che ne limitò contemporaneamente la libera espressione. Le notizie sugli ebrei di Roma, ridotti ad una esigua minoranza, in una popolazione diminuita a circa 40 mila abitanti stremati dalla fame, da devastazioni ed invasioni, diventano scarse fino all’XI-XII secolo, periodo in cui al maggior equilibrio nell’amministrazione politica ed economica della città fece riscontro un rinnovato sviluppo della vita ebraica. Nel XII secolo la comunità ebraica, di nuovo attiva e culturalmente vivace, era composta da circa 200 ebrei (capifamiglia) in posizione di grande rispetto nella 107 vita cittadina e per questo esentati da tributi: artigiani, commercianti, studiosi del Talmud, poeti e letterati, medici, amministratori di fiducia del papa, e, molto importanti, furono i copisti ebrei che contribuirono a recuperare ed a diffondere i rari codici del sapere ebraico, le opere di Maimonide, i testi filosofici e scientifici della cultura islamica e greca, stabilendo un prezioso ponte culturale tra le sponde del Mediterraneo. I principi di separazione e di limitazione ai danni degli ebrei stabiliti dalla Chiesa ripresero vigore sotto il pontificato di Innocenzo III: il IV Concilio Lateranense nel 1215 sancì per gli ebrei l’obbligo di portare un segno distintivo sugli abiti ed il divieto di ricoprire pubblici uffici. Gregorio IX, ordinando nel 1239 la confisca dei testi talmudici, considerati eretici e devianti rispetto alla dottrina cristiana, cui seguirono i primi roghi di libri ebraici, dette inizio ad una politica che avrebbe inferto nei secoli successivi durissimi colpi alla cultura degli ebrei. La comunità ebraica romana durante la peste del 1348 non risentì solo del decremento demografico e dell’impoverimento comune a tutto il resto della popolazione, ma anche del diffondersi di pregiudizi antiebraici, che a Roma, come nel resto d’Europa, attribuì agli ebrei la causa della diffusione del contagio e della crisi della città. Nel secolo successivo la comunità ebraica cominciò a cambiare configurazione a causa dell’arrivo a Roma di numerosi ebrei francesi, tedeschi e spagnoli, oltre agli ebrei che provenivano dal contado romano e dalle città pontificie. Questi gruppi eterogenei s’inserirono nella vita delle città, ma dai documenti appaiono in posizione economica subordinata rispetto alla maggioranza cristiana, ad eccezione del ruolo sempre di primo piano ricoperto dai medici e dagli archiatri pontifici. Questo afflusso di ebrei da tutta Europa non fu affatto ostacolato dai papi, che pur avendo promosso l’Inquisizione, permisero un insediamento controllato nella città. La consistenza della comunità ebraica quasi raddoppiò (1772 unità su circa 54 mila abitanti). Proprio a causa di tale 108 eterogeneità, i conflitti interni tra il nucleo ebraico originario e gli ebrei di varia provenienza, creati dalla difficoltà di far convivere mentalità, usi, tradizioni e culture differenti, furono frequenti e vivaci. Tra la fine del Quattrocento ed i primi del Cinquecento si assistette ad una complessiva rivitalizzazione del gruppo ebraico dal punto di vista demografico, economico e culturale: un parziale processo d’integrazione fu favorito dalla residenza nello stesso quartiere e dall’uso del volgare romanesco come lingua comune tra gli ebrei e nei rapporti con la società cristiana. Il Sacco di Roma del 1527 incise sulla collettività ebraica, come su quella cittadina, con un forte impoverimento ed un calo demografico. Con la Controriforma iniziò a Roma l’attività del Santo Uffizio e furono poste le basi dell’azione convertitrice della Chiesa attraverso la concessione di privilegi agli ebrei che si convertivano ed una tassa di dieci ducati d’oro ad ognuna delle sinagoghe dello Stato Pontificio. Con il rogo del Talmud a Campo dei Fiori, iniziò l’oppressione della cultura, che preannunciava quella degli uomini. Il 14 Luglio 1555 Paolo IV istituì il ghetto, che limitò la vita e l’attività degli ebrei di Roma con oltre tre secoli di reclusione fisica e di sottomissione morale; il ghetto fu istituito nella zona compresa tra il Tevere, all’altezza dell’Isola Tiberina, il Ponte Fabricio, il Portico d’Ottavia e la piazza delle Cinque Scole. Il ghetto o “piazza” come veniva chiamato dagli ebrei romani, è il punto di riferimento culturale ed emotivo, il luogo della memoria familiare e collettiva dove ci si riunisce per gli avvenimenti lieti o tristi, ci si incontra la sera o per le feste ebraiche. Il papa lo istituì dichiarando che ormai si era raggiunta una situazione assurda, nella quale gli ebrei si trovarono a vivere sempre a più stretto contatto con i cristiani, ed addirittura essi “si azzardano a vivere nelle vicinanze delle chiese senza alcuna distinzione d’abito…”. La motivazione però non fu meno violenta dei provvedimenti, elencati minuziosamente in quindici punti: 109 gli ebrei dovevano vivere in un quartiere separato e munito di portoni, non avere più una sinagoga, vendere tutti i beni immobili a cristiani, non tenere più servitù cristiana, portare il segno distintivo e, come attività economica, dovevano praticare i prestiti a tassi definiti; inoltre, la sola arte concessa loro fu il mestiere di venditore di stracci. La vita del ghetto cominciò a risentire del problema del sovraffollamento, quando Pio V obbligò gli ebrei a concentrarsi a Roma ed Ancona, escludendo tutte le altre città pontificie. Ma fu sul fronte religioso che l’azione della Chiesa si fece più dura: nel 1577 Gregorio XIII dette nuovo impulso all’attività conversionistica con l’obbligo per gli ebrei di assistere alle prediche cristiane. Comunque possiamo affermare che il rapporto tra ebrei e papa fu stretto, continuo ed ambivalente: si basò, da un lato, sul tentativo di salvaguardare la presenza ebraica come “popolo testimone” e come elemento economicamente utile, necessitante di una certa protezione, dall’altro, sul principio della separazione e della limitazione della vita sociale, economica e religiosa, poiché non era ammissibile che tale comunità potesse vivere libera e prospera in mezzo alla maggioranza cristiana nella città del papa. Tuttavia, per gli ebrei romani, il pontefice fu anche il sovrano a cui chiedere protezione, giustizia e l’attenuazione di rigidi divieti, così come la reclusione nel ghetto non impedì i contatti tra ebrei e cristiani durante il giorno, quando i cancelli erano aperti. Numerosi sono gli esempi che ci mostrano chiaramente la terribile condizione in cui gli ebrei erano costretti a vivere: dovevano rendere omaggio ad ogni papa neoeletto durante la cerimonia con la consegna della Torah per simbolizzare la loro sottomissione. Tutto ciò avveniva in mezzo ad una folla che si lasciava andare a manifestazioni di intolleranza e di violenza nei loro confronti. Altri episodi tristemente noti sono da collocare durante il periodo carnevalesco: alcuni giochi prevedevano che i contendenti cavalcassero sugli ebrei anziché sui cavalli; altri consistevano nel 110 far rotolare un ebreo in una botte chiodata dal colle di Testaccio; benché sostituiti da un ricchissimo tributo, i “ludi carnascialeschi” ripresero vigore nella via Lata, quando il papa assisteva alla “corsa dei berberi, dei bufali, dei somari e degli ebrei”, rimasti nel 1583 le sole “bestie bipedi” a correre nude tra il divertimento del popolino. Nel Seicento furono aboliti i banchi degli ebrei, all’inizio del Settecento, dei circa cinquanta banchieri ne erano rimasti solo tre, mentre permaneva il piccolo prestito su pegno; si svilupparono i mestieri caratteristici del ghetto: sarti, sellai, artigiani del cuoio, commercianti di tappeti, coralli e stoffe, venditori ambulanti, mercanti di stracci e panni usati, rammendatrici e ricamatrici; inoltre, il disagio economico fu accentuato dal pesante carico fiscale. La misera condizione del ghetto, uno dei quartieri più malsani della città, fu aggravata da calamità naturali: la carestia, gli straripamenti del Tevere e le epidemie di peste. Le idee di uguaglianza e di libertà propugnate dalla Rivoluzione francese non trovarono insensibili gli ebrei romani: quando, tra il 1798 ed il 1799, le truppe francesi proclamarono la Repubblica romana, gli abitanti del ghetto parteciparono attivamente, arruolandosi nella guardia civica, spinti dalla promessa della fine delle discriminazioni; tuttavia per gli ebrei di Roma l’emancipazione era ancora lontana. Infatti nel 1814 i francesi abbandonarono la città, dove pochi giorni dopo, ritornò Pio VII, in pieno clima di Restaurazione. L’emancipazione degli ebrei coincise con l’Unità d’Italia. Il ghetto rimase l’ultimo, emblematico segno della discriminazione in un’epoca di principi liberali e democratici: il 20 settembre 1870 la breccia di Porta Pia segnò contemporaneamente la fine del potere temporale dei papi, l’abolizione definitiva del ghetto e la completa equiparazione degli ebrei romani agli altri cittadini. L’inizio della libertà coincise però con un periodo tutt’altro che facile per gli ebrei: difficile fu l’accesso alle università, la burocrazia fu nettamente più lenta per gli ebrei che per i cittadini romani, così i 111 piccoli commercianti, i venditori ambulanti, i rigattieri, che erano la maggioranza, restarono legati alle attività nate durante il periodo delle discriminazioni. Vi furono anche problemi d’integrazione nella vita sociale, alimentati dal progressivo abbandono del ghetto, divenuto ormai inabitabile a causa del degrado, che fu definitivamente abolito nel 1904. Sempre nello stesso anno, con l’inaugurazione del Tempio sorto sull’area del ghetto demolito, l’ebraismo romano dette una nuova immagine di sé alla città, che nel 1907 avrebbe avuto un sindaco ebreo di grande prestigio, Ernesto Nathan. Nel 1938 le “Leggi per la difesa della razza” imposte dal regime fascista colsero di sorpresa la collettività ebraica, che dall’attiva partecipazione alla prima guerra mondiale in poi si era perfettamente integrata nella compagine cittadina e nazionale: a Roma l’improvvisa esclusione dal lavoro, dalla scuola, dalla vita pubblica richiamò alla memoria un passato che si pensava ormai superato. In poco più di un mese furono allestite le scuole ebraiche di ogni ordine e grado che ospitarono oltre 600 ragazzi, per garantire ai giovani la possibilità di proseguire gli studi, spesso sotto la guida di professori illustri, come Guido Castelnuovo, emarginati a loro volta dalle università. Nel 1941 l’essere diventati cittadini di “seconda categoria” comportò per gli ebrei di Roma un altro umiliante atto di asservimento al regime: la precettazione per il lavoro coatto lungo gli argini del Tevere. Pochi ebrei lasciarono la città o si nascosero all’arrivo delle truppe naziste, nella fiducia che in Italia, e soprattutto a Roma, per la presenza del Vaticano, non avrebbero mai potuto verificarsi arresti e deportazioni come in Germania. L’ORO DI ROMA Durante i mesi di settembre e di ottobre del 1943 gli ebrei romani decisero di stare in guardia, ma l’interpretazione dei segnali tedeschi continuava ad essere difficile.2 112 Gli occupanti trattavano i civili con cortesia e rispetto; acquistavano orologi, macchine fotografiche e souvenir dai negozianti del ghetto. Gli ebrei si sentivano rassicurati, appunto come volevano le SS. Il loro destino era già stato deciso. Il 12 settembre il maggiore delle SS Herbert Kappler3, capo della polizia tedesca a Roma, aveva ricevuto una comunicazione dal capo delle SS Heinrich Himmler, con la quale era stato informato che gli ebrei romani dovevano essere deportati. Il primo colpo dell’obiettivo nazista fu sferrato il giorno dopo, quando Almansi e Foà, dirigenti della comunità ebraica romana, furono convocati nell’ufficio di Kappler. Il maggiore li ricevette fin troppo cortese e distinto, scusandosi per aver recato loro disturbo; dopo qualche minuto di conversazione garbata ed oziosa, il suo tono si fece di colpo duro e minaccioso: ”Voi ed i vostri correligionari avete la cittadinanza italiana, ma di ciò me ne importa poco. Noi tedeschi vi consideriamo unicamente ebrei e come tali nostri nemici… E come tali dobbiamo trattarvi. Però non sono le vostre vite, né i vostri figli che vi prenderemo se adempirete alle nostre richieste. Noi vogliamo il vostro oro per dare nuove armi al nostro paese. Entro 36 ore dovrete versarmene 50 Kg. Se lo verserete non vi sarà fatto del male. In caso diverso, 200 fra voi verranno presi e deportati in Germania o al fronte russo…”.4 Per i nazisti gli ebrei di Roma erano doppiamente colpevoli: come italiani per il tradimento contro la Germania, e come ebrei in quanto tali. I due dirigenti ebrei chiesero ingenuamente se il provvedimento valesse solo per gli ebrei registrati nella Comunità oppure anche per quelli convertiti al cattolicesimo e per gli ebrei a metà. Kappler replicò sprezzante: ”Io non faccio distinzione tra ebreo ed ebreo, iscritti alla Comunità o dissociati, battezzati o misti, tutti coloro nelle cui vene scorre una goccia di sangue ebraico sono per me tutti uguali. Sono tutti nemici.”5 L’unica concessione fu sul pagamento: oltre all’oro si disse pronto ad accettare sterline e dollari, non però lire italiane: ” …del113 la vostra moneta non so che farmene, posso stamparne da me quanto ne voglio”.6 Kappler prorogò inoltre la scadenza a 44 ore. Per la Comunità ebraica respingere l’ultimatum sembrava molto più pericoloso che accettarlo. I 12.000 ebrei di Roma non erano preparati ad una fuga oppure ad un esodo di massa. Molti erano troppo vecchi, malati o poveri per lasciare le proprie case e vivere nascosti per un periodo indefinito; in tanti pensarono che Kappler aveva detto proprio quello che pensava: voleva semplicemente il loro oro, non le loro vite. La decisione di pagare era inoltre conforme alla millenaria esperienza degli ebrei, che nella storia erano sfuggiti centinaia di volte alle persecuzioni o all’espulsione versando tributi (spesso in oro) per riscattare il loro popolo. Viceversa, gli atti di sfida erano di solito sfociati in immani disastri. A Roma erano stati ricattati e minacciati da papi e principi, riuscendo sempre ad evitare il disastro, accettando dapprima le richieste più smodate e quindi cercando di negoziarle pazientemente. Questa strategia era certamente preferibile a qualche atto impulsivo che avrebbe potuto provocare una seconda Masada. Foà raccolse le offerte nel suo ufficio alla sinagoga. All’inizio la voce si sparse lentamente, ma già nel pomeriggio si era formata una lunga coda. Quasi tutti gli ebrei più ricchi s’erano nascosti o comunque erano irraggiungibili. Le offerte venivano fatte soprattutto dagli ebrei del ghetto e di Trastevere. C’era chi veniva a portare un anello o due, oppure una catenella; i bambini del ghetto correvano di qua e di là con rotoli di banconote, comprando oro sul mercato nero a due, tre ed anche quattro volte il prezzo normale: ”Le ore della raccolta furono piene d’inquietudine incessante, era una cosa terribile, drammatica, una sorta di gara che in caso di vittoria non avrebbe previsto alcuna sicurezza sul futuro”.7 Più tardi Foà ricordò che tutti si privarono di ogni più caro ricordo, di ogni prezioso gioiello per scongiurare l’immane strage. La fila si muoveva lentamente ed ancora più lentamente si 114 accumulava l’oro. Quando la notizia del ricatto si sparse, si unirono molti “ariani”, inclusi diversi preti; un ebreo romano che si trovava in sinagoga raccontò più tardi: ”Guardinghi, come temendo un rifiuto, come intimiditi di venire ad offrire dell’oro ai ricchi ebrei, alcuni ariani si presentarono. Entravano impacciati in quel locale adiacente alla sinagoga; non sapendo se dovessero togliersi il cappello o tenere il capo coperto, come notoriamente vuole l’uso degli ebrei. Quasi umilmente domandavano se potevano anche loro… se sarebbe stato gradito… Purtroppo non lasciarono i nomi”.8 Allo scadere del tempo concesso dai nazisti erano stati raccolti quasi 80 kg d’oro (la differenza, messa in salvo, fu nel dopoguerra versata per l’edificazione dello Stato d’Israele). L’oro così raccolto fu portato il 28 settembre a via Tasso, sede della Gestapo a Roma. Su richiesta dell’Unione, la polizia italiana concesse una scorta per il trasporto, ed in borghese vi era anche il commissario della Demografia e Razza. Al momento della pesatura dell’oro, fatta 5 kg alla volta, i tedeschi nella persona di un certo capitano Schutz cercarono di ingannare sul peso e di asserire che l’oro ammontava a 45 kg e non a 50 kg: solo grazie alle vive proteste dell’Almansi e del Foà, alla fine riconobbero che il quantitativo era giusto; si rifiutarono però di rilasciare qualsiasi ricevuta dell’avvenuta consegna. Gli ebrei trassero un sospiro di sollievo; dopotutto, i nazisti avevano dichiarato che volevano soltanto l’oro e così gli ebrei si sentirono tranquillizzati. Infatti se il loro odio antisemita era tristemente noto, non sembrava attribuibile ai tedeschi una frode tanto disonesta e disonorante. La crudeltà sì, la mancanza di parola no. I nazisti si presentavano come il simbolo di un ordine cieco ed assurdo, ma pur sempre ordine; e se per qualcosa erano ormai infelicemente conosciuti, era per la spietatezza con la quale esigevano che le regole venissero rispettate. L’idea di estorcere l’oro agli ebrei sembra fosse di Kappler, 115 ma le sue azioni sono soggette ad interpretazioni diverse. In una deposizione resa al tempo del processo contro Eichmann9, Kappler sostenne che aveva disapprovato l’ordine di deportare gli ebrei romani. Non giustificò questa opposizione con motivi morali. Piuttosto, considerava gli ebrei politicamente insignificanti, ed era riluttante a correre senza necessità il rischio d’irritare la popolazione ed il Vaticano. Kappler, poliziotto di professione, preferiva sfruttare le sue vittime come fonte di denaro per finanziare le attività di spionaggio. Inoltre, era convinto che gli ebrei fossero in contatto con gli alleati e rappresentassero quindi anche una fonte d’informazioni molto preziose. Il piano per estorcere l’oro, sostenne Kappler, aveva lo scopo di dimostrare ad Himmler le grandi potenzialità dello sfruttamento degli ebrei. Una seconda interpretazione dei moventi di Kappler è assai meno caritatevole. Kappler sapeva che l’ordine segreto per la liquidazione degli ebrei era stato intercettato a Roma; non sapeva fin dove si fosse sparsa la voce, ma sapeva benissimo che gli ebrei, una volta avvertiti, avrebbero cercato rifugio nelle centinaia di chiese, monasteri e conventi esistenti nella città ed in provincia. Il compito di catturarli sarebbe così divenuto per lui estremamente più difficile. Egli ideò quindi il piano del ricatto con l’intenzione precisa di rassicurare gli ebrei, in attesa che fossero completati i preparativi per la razzia. La teoria meno caritatevole sembra comunque la più probabile. Può darsi che Kappler considerasse la deportazione un errore tattico, ma è improbabile che avesse contestato gli ordini ricevuti. È altrettanto inverosimile che nel settembre 1943 Kappler ignorasse che le fanatiche SS di Himmler non si accontentavano di sfruttare gli ebrei: nella Russia occidentale le SS avevano chiesto l’annientamento sistematico di operai, contadini, artigiani e professionisti ebrei, cioè gli unici elementi, in una popolazione non specializzata, che avrebbero potuto sostenere effettivamente 116 l’impegno bellico della Germania in quei luoghi. Come poteva pensare Kappler che in Italia si sarebbero comportati diversamente? Dopo la guerra, i 50 kg d’oro furono trovati nell’ufficio di Kaltenbrunner, capo dell’Ufficio centrale della sicurezza del Reich. La cassa non era mai stata aperta. Anche la reazione di Pio XII al ricatto è soggetta ad interpretazioni diverse. Taluni affermano che s’indignò moltissimo e subito offrì un quantitativo d’oro. Altri sostengono che l’offerta fu accettata. I fatti come li riferì Foà appaiono comunque diversi:“[...] la Santa Sede, venuta subito a conoscenza del fatto fece spontaneamente sapere per via ufficiosa al Presidente della Comunità, che se non fosse stato possibile raccogliere nelle ore stabilite i determinati kg d’oro, avrebbe messo a sua disposizione la differenza, che sarebbe poi stata pagata senza nessuna fretta quando la Comunità fosse in grado di farlo”.10 L’offerta del Vaticano pare dunque un prestito e non un dono, che non fu però necessario per raggiungere i 50 kg. Spontaneo o no, comunque, il gesto del Vaticano fu molto importante, perché liberò i dirigenti ebrei dal terrore di un insuccesso e questa notizia rassicurò inoltre gli ebrei romani e li fece sentire meno soli. Purtroppo confermò loro la speranza che, alla fine, il papa sarebbe intervenuto in loro difesa e ciò fu un fattore determinante nelle decisioni di molte famiglie che scelsero di restare a Roma protette dall’ombra effimera del cupolone, che però ben presto le abbandonò al proprio terribile destino, del quale certo non possono essere ritenuti colpevoli i soli tedeschi. LA RAZZIA DEL 16 OTTOBRE Nel gergo della Gestapo, Eichmann chiamò Samstagschlang -“sorpresa del sabato”- il colpo sferrato agli ebrei proprio nel giorno della settimana che, per tradizione religiosa, essi dedicano al 117 riposo; così, come avvenne a Trieste e a Firenze, anche a Roma fu di sabato, il 16 ottobre 1943, che i tedeschi circondarono la zona del ghetto ed arrestarono 1.259 ebrei di ogni età e condizione, rinchiudendoli in una scuola militare nell’attesa di deportarli allo sterminio. In seguito, dopo un accurato esame dei vari documenti di riconoscimento, furono liberate 252 persone: coniugi e figli di matrimoni misti, i coinquilini ed il personale di servizio che risultarono ariani e gli ebrei stranieri. Lunedì 18, 1.007 deportati vennero caricati su di un treno merci per il loro ultimo viaggio, destinazione Auschwitz. Non si salverà nemmeno un bambino e torneranno soltanto quattordici uomini ed una donna, Settimia Spizzichino. La decisione di deportare e sterminare gli ebrei italiani, innanzitutto quelli di Roma, il nucleo più numeroso e compatto, risale probabilmente ad Hitler che incaricò Himmler dell’esecuzione: il 25 settembre 1943, inviò a tutte le autorità naziste in Italia un ordine segretissimo, col quale stabiliva per l’1 ottobre successivo “l’arresto di tutti gli ebrei nelle zone controllate dai tedeschi, senza alcun riguardo per la loro nazionalità, ed il loro invio in Germania.”11 Per quanto si riferiva in particolare a Roma Himmler comunicò a Kappler che “i recenti avvenimenti italiani impongono una immediata soluzione del problema ebraico e quindi di attuare senza indugi tutte quelle misure preliminari atte ad assicurare la fulmineità e la segretezza dell’operazione di Roma.”12 Tuttavia, già il giorno precedente, era stata la direzione generale della polizia nazista a precisare a Kappler quali sarebbero state le dimensioni dell’”Aktion”: tutti gli ebrei di Roma, senza distinzioni di nazionalità, sesso e condizioni, avrebbero dovuto essere trasferiti in Germania e “ivi liquidati” poiché “è noto che tale nucleo di ebrei ha collaborato attivamente col movimento badogliano e pertanto un sollecito allontanamento rappresenterà una necessaria misura di sicurezza atta a garantire l’indispensa- 118 bile tranquillità delle retrovie del fronte sud”13. Per coincidenza, Mussolini, nella sua “Corrispondenza repubblicana”, accusava gli ebrei ed i massoni di Roma di essere pronti ad accogliere a braccia aperte il nemico che avanzava lentamente dal meridione. Le comunicazioni tedesche insistevano molto sul fatto che “il successo dell’impresa doveva essere assicurato da una azione di sorpresa, ed era quindi necessario soprassedere ad applicazioni di eventuali misure antiebraiche, atte a suscitare nella popolazione il sospetto di una imminente azione”14. Nei piani di Himmler, comunque, questa “razzia” sarebbe stata solo l’inizio di un’operazione condotta su scala ben più vasta in tutte le regioni italiane controllate dai tedeschi. L’”Aktion” di Roma si svolse in tre fasi: dal 26 al 28 settembre con l’episodio della raccolta dell’oro; dal 29 settembre al 14 ottobre, i tedeschi rapinarono sistematicamente i beni pubblici degli israeliti, rubando dalla cassaforte della Comunità circa due milioni di lire ed impadronendosi della loro biblioteca; infine dal 16 al 18 ottobre ebbe luogo la “grande razzia” del ghetto. Tutto questo avvenne con il consenso e la complicità delle autorità fasciste. Nei giorni precedenti al 16 ottobre probabilmente le autorità fasciste erano già al corrente di ciò che i nazisti si apprestavano a fare. Il piano dell’operazione era infatti trapelato da tempo negli ambienti tedeschi della capitale; infatti, già da molti giorni era frequente un fitto scambio di comunicazioni tra Berlino e Roma. Quindi è probabile che il progetto di Himmler fosse ormai risaputo sia dall’esercito che dalla diplomazia. Proprio questo scambio di telegrammi indusse Eichmann ad inviare in Italia uno specialista in questioni ebraiche, il capitano SS Theo Dannecker, mettendo a sua disposizione un forte contingente di uomini; Dannecker fissò il suo quartiere generale in un modesto albergo, anziché alla sede della Gestapo, perché non voleva che trapelassero ulteriori indiscrezioni sull’”impresa” che stava per realizzare. 119 Di lì a pochi giorni arrivò a Roma anche un reparto speciale per la razzia, costituito da ufficiali e soldati delle “SS testa di morto”, direttamente dal fronte russo; con la massima segretezza, questi massacratori di professione si sistemarono nell’ex Collegio militare italiano. Sono numerose le ipotesi su come i tedeschi riuscirono in questi giorni ad avere nomi ed indirizzi delle famiglie ebree romane: c’è chi da una parte sostiene che sia i fascisti, che la polizia italiana siano stati di grande aiuto nel reperire tutti i nuclei ebraici; mentre altri affermano che i tedeschi avevano in mano le fatidiche liste ben prima di arrivare a Roma. Il rastrellamento ebbe inizio alle 5.30 del mattino. Gli ebrei dormivano nei loro letti, quando dalle strade cominciarono a sentirsi spari ed esplosioni. Da quanto era stato imposto il coprifuoco, non era insolito sentire dei colpi durante la notte, a causa dei vari scontri che avvenivano, ma mai gli spari erano giunti tanto vicini ed insistenti nella zona del ghetto, così da divenire una vera e propria sparatoria. I più coraggiosi si affacciarono alla finestra mentre le pallottole sibilavano ovunque e riuscirono a distinguere gli elmetti dei soldati tedeschi, che per il momento si limitavano a sparare in aria ed a gridare, tant’è che gli ebrei, interdetti, credettero che essi volessero unicamente spaventarli o far loro un dispetto. Quando la sparatoria si placò, tutti si tranquillizzarono dato che “non era capitato niente”, ma ben presto risuonò lungo le scale il passo pesante dei tedeschi. Era appunto l’alba quando pattuglie composte dai due ai sei militi, giunsero nelle case segnalate per prelevarne gli abitanti. Alle vittime venne presentato un biglietto dattiloscritto, in due lingue, che diceva: “1) Insieme alla vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti; 2) Bisogna portare con sé: viveri per almeno otto giorni, tessere annonarie, carte d’identità e bicchieri; 3) Si può portare via una valigetta con effetti e biancheria personali, coperte, denari e gioielli; 4) Chiudere a chiave l’appartamento e portare la chiave con sé; 5) Ammalati, anche se casi 120 gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo; 6) Venti minuti dopo la presentazione di questo biglietto la famiglia deve essere pronta per la partenza.”15 Bambini seminudi, vecchi, donne scarmigliate ancora in vestaglia, malati, neonati, tutti, senza alcuna eccezione, vennero sospinti giù dalle scale a colpi di calcio di fucile, caricati sui dei camion neri come la morte nel freddo di un’alba di una terribile giornata autunnale. Sono numerose le testimonianze di questa razzia, per esempio quelle di ebrei risparmiati dal rastrellamento perché usciti prestissimo per fare la fila per le sigarette e che, tornati a casa, non hanno più trovato la loro famiglia. I razziatori, muniti di nomi e d’indirizzi, andarono a colpo sicuro; se poi il numero dei catturati non fu quello che i nazisti speravano si deve senza alcun dubbio all’aiuto da parte della popolazione, come gli stessi tedeschi affermarono nelle loro comunicazioni: “Il comportamento dei cittadini italiani è stato caratterizzato da chiari sintomi di resistenza passiva, che in molti casi è sfociata addirittura in aiuto attivo: in un caso, ad esempio, le forze di polizia si sono imbattute in un fascista in camicia nera, munito di tessera, il quale senza alcun dubbio soltanto poco prima aveva ricevuto l’appartamento per mano ebrea ed ora lo mostrava come suo. Anche nei momenti in cui le forze tedesche irrompevano negli appartamenti si sono notati chiari tentativi, in molti casi riusciti, di nascondere gli ebrei in appartamenti adiacenti…”.16 La razzia durò tutta la mattina; fin verso le 11, infatti, i “camion della morte” (chiamati così dato che erano dipinti di nero e ricoperti di teloni dello stesso funebre colore), continuarono a circolare di strada in strada alla ricerca delle vittime e numerosi continuarono ad essere gli episodi di coraggio, che portarono la salvezza soprattutto ad alcuni bambini, presi da persone ariane dalle braccia delle mamme già catturate dai tedeschi. A mezzogiorno i razziati, 1.259 ebrei, erano tutti rinchiusi nell’angusto Collegio militare, dove si trovavano detenuti solo 121 pochi soldati. Le SS separarono gli ebrei, da una parte gli uomini e dall’altra donne e bambini; poi li spinsero nei locali dell’edificio, buttando della paglia per terra e sbarrando le finestre con assi chiodate; nel Collegio secondo numerose testimonianze furono visti aggirarsi con aria soddisfatta alcune camicie nere. La mattina di domenica 17 la SS Dannecker si rivolse ai prigionieri con le seguenti parole: “Voi partirete per un campo di lavoro in Germania. Gli uomini lavoreranno, le donne baderanno ai bambini e si occuperanno delle faccende di casa. Ma ciò che avete portato con voi, il denaro ed i gioielli, potrà servire a migliorare la vostra situazione. Comincerete col consegnare all’amministrazione, che si occuperà delle vostre sostanze, tutto il denaro ed i vostri preziosi. Se qualche ebreo intendesse invece conservarli nascosti sarà passato per le armi. Mettete dunque nella mano destra i gioielli e nella sinistra il denaro: passerete in fila e mi consegnerete tutto”.17 Durante la stessa mattinata Kappler informò Berlino con un telegramma del buon esito dell’operazione e spiegò che il minor numero di ebrei catturati era dovuto al fatto che era stato costretto a liberarne molti perché erano di sangue misto, cittadini del Vaticano ecc., quindi il numero definitivo degli ebrei razziati era 1.007. Fissava inoltre per il 18 ottobre la data della fatidica partenza. In seguito furono decise anche le ultime fasi della deportazione, cioè il trasporto dei prigionieri per ferrovia. Un convoglio con diciotto carri bestiame venne preparato a Roma Tiburtina e per motivi precauzionali la stazione fu sgombrata dai viaggiatori ed i treni in arrivo dirottati a Termini. Gli ebrei raggiunsero la stazione con i camion, furono caricati sul treno e lasciati ad aspettare che fosse completata l’operazione di trasporto; molti rimasero dieci ore in un vagone stipati al limite della sopportazione umana ed anche oltre, tanto che diverse persone morirono durante quella terribile attesa e lungo il viaggio, tra la disperazione di tutti che, per la prima volta, avevano visto morire molti di loro, cominciando così a convivere con lo spettro della morte. 122 A Roma le notizie della deportazione di mille ebrei sollevarono commozione ed indignazione. Soltanto i fascisti che si erano offerti di partecipare con propri reparti alla razzia, ma erano stati respinti, ne furono fieri e scrissero tutta la loro approvazione e felicità su “Il Messaggero”. La stampa clandestina di tutti i partiti, da quello d’Azione a quello comunista, fu concorde nel bollare l’azione tedesca come uno sporco delitto, voluto e favorito da servi, spioni e sicari che si nascondevano sotto la camicia nera. Questo diffuso sentimento di pietà e commozione entrò anche in Vaticano. Nel giorno della razzia un comunicato di un vescovo austriaco informava la forza tedesca di interrompere gli arresti nella zona di Roma, altrimenti il Papa si sarebbe trovato costretto a prendere posizione pubblicamente contro tali arresti, creando così una situazione molto pericolosa, in cui la propaganda anti-nazista si sarebbe rafforzata vedendo nelle sue fila la Chiesa. Questo comunicato infatti destò molte preoccupazioni a Berlino e l’alta dirigenza nazista prese atto del sentimento che muoveva la Curia; questo passo semi-ufficiale ebbe i suoi frutti in quanto Himmler decise di sospendere gli arresti a Roma. Oltre questo comunicato però il Papa non volle andare, destando scalpore anche tra gli stessi tedeschi, che in un comunicato assicuravano così Berlino: “Benchè premuto da più parti, il Papa non si è lasciato trascinare da alcuna riprovazione dimostrativa a proposito della deportazione degli ebrei di Roma”.18 L’unica reazione ufficiale di Pio XII fu uno sbiadito fondo sull’”Osservatore Romano” del 26 ottobre, quando la maggioranza degli ebrei deportati erano già morti nelle camere a gas di Auschwitz- Birkenau. Con uno stile contorto e confuso il giornale metteva in evidenza che il Papa beneficiava tutti della sua compassione, senza distinzione di nazionalità, di razza e di religione. Questo atteggiamento di Pio XII solleverà, nel dopoguerra, accese polemiche: da una parte si sosterrà che il Papa, con il suo intervento, avrebbe potuto, se non impedire la razzia, almeno li- 123 mitarne le proporzioni e le conseguenze estreme; dall’altra, si dirà che una denuncia aperta del genocidio avrebbe avuto, come unico risultato, la rottura tra il Vaticano e Berlino e l’indurimento delle pene per gli ebrei. Le testimonianze riportano però che gli ebrei sfuggiti alla cattura non chiedevano gesti spettacolari, ma di far loro avere notizie dei deportati e di far giungere loro dei soccorsi. I pochi tornati vivi dai campi di concentramento testimoniarono che la speranza di un intervento pontificio accompagnò ostinatamente ed inutilmente tutti i deportati fino alle porte delle camere a gas, che però si chiudevano con terribile puntualità alle loro spalle. INTERVISTA A SETTIMIA SPIZZICHINO L’intervista è stata effettuata a Roma da Daniele Apicella, Antonio Concutelli ed Olivia Zorzet. L’avvento del fascismo non fu vissuto male, solo dopo abbiamo conosciuto la sua vera natura, mio papà era repubblicano come quasi tutti gli ebrei romani, ma avevamo una grossa paura delle voci di confino che giungevano e quindi avevamo paura di parlare di politica anche in casa ed era anche nell’aria la “caccia all’ebreo” soprattutto dopo l’alleanza tra Hitler e Mussolini, ma non potevamo fare niente, soprattutto perché eravamo convinti che non ci potessero fare niente. Quando hanno promulgato le leggi razziali, io ero a Roma. Durante il fascismo non c’era evoluzione delle donne, stavamo a casa e le famiglie pensavano di sistemarle dandole il marito; per gli ebrei questa situazione era peggiore perché avevano una mentalità più stretta. Nel ’38 avevo 10 anni, a Roma non abbiamo capito molto le leggi, anche perché l’ambiente romano non era antisemita, la maggior parte dei romani veri era antifascista, non abbiamo avuto grosse difficoltà, neanche le persone grandi hanno capito queste leggi razziali e nemmeno io perché ero molto giovane. La prima cosa fu che i bambini ebrei dovettero lasciare la scuola, poi gli impiegati statali ed i professionisti; gli ebrei non potevano fare tanti lavori, allora 124 cominciò la sofferenza, queste leggi si facevano sentire, perché oltre a queste c’era molta povertà ed eravamo sotto le sanzioni a causa della guerra in Etiopia. Nel momento più difficile ci fu l’alleanza tra Mussolini e Hitler e da lì cominciarono le cose più atroci che potevano accadere. C’era molta sofferenza, c’era il coprifuoco, nei palazzi allora c’erano i portieri, i portieri dovevano essere degli agenti fiduciari del fascismo, segnalavano chi usciva, chi entrava, erano spie. La situazione era molto difficile, i soldi erano pochi perché la mia famiglia non era ricca, erano commercianti ed avevo sei fratelli e questa persecuzione si cominciava a sentire tanto. Ci fu l’occupazione nazista a Roma, e i tedeschi non rispettarono Roma “città aperta” e così cominciarono ad insorgere i partigiani che non volevano il presidio militare tedesco. Roma “città aperta” fu fatta per salvaguardare Città del Vaticano. Noi ebrei stavamo buoni, cosa potevamo fare? Certo chi aveva i mezzi, i soldi per scappare ha fatto presto a procurarsi un passaporto falso, si rifugiarono nei paesini, dicendo che erano degli sfollati. Mamma mia non volle fare nemmeno questo; le mie zie erano andate in questi paesini e dicevano anche a mia mamma di andare là, ma mia madre disse che noi stavamo bene a Roma e che non ci potevamo fare niente. Le cose andavano male e un giorno un comando tedesco andò in Sinagoga e chiesero agli ebrei 50 kg d’oro, altrimenti avrebbero preso degli ebrei; cominciò così la corsa all’oro, tutta la popolazione romana partecipò, anche i non ebrei; chi non aveva l’oro donava soldi con i quali si poteva comprare l’oro al mercato nero. Queste quarantotto ore furono tremende: “A quanti chili siamo? Quanto manca? Ce la faremo?” Quasi allo scadere del termine non avevamo raggiunto la quota fissata e così, quello che mancava, si offrì di prestarlo il Vaticano, al quale però fu restituito tutto dopo la guerra, quindi il Vaticano non ci diede niente. Gli ebrei romani tirarono un sospiro di sollievo, ma meno di un mese dopo … Io abitavo proprio nel ghetto, che era situato nella zona di Ponte Garibaldi, l’isola Tiberina, qui vi abitava la maggior parte degli ebrei perché quando Roma era dei papi in questa zona c’era veramente un ghetto che fu smantellato con l’arrivo di Garibaldi. A Roma per noi c’era doppio coprifuoco: eravamo in guerra ed in più eravamo ebrei. Appunto un mese dopo, il 16 ottobre, in una 125 calma e tranquilla notte si avvertiva che stava succedendo qualcosa, la notte cominciarono dei passi pesanti nel ghetto, strano perché c’era usualmente un silenzio di tomba a causa del coprifuoco ed inoltre perché i mezzi non c’erano, ed era ricco chi aveva una bicicletta: prima dell’alba mio papà si affacciò perché sentiva questi passi più forti e cominciava ad udire delle grida e guardando dalle persiane vide le case di fronte, i portoni - io abitavo in una via molto stretta, come quasi tute le vie del ghetto - appunto vide delle SS che portavano via famiglie intere; mio padre si è cominciato a preoccupare; anche perché stavano portando via delle famiglie anche del nostro palazzo e fece un atto di coraggio e ci radunò nell’ultima stanza della casa facendo così finta che fosse vuota, ma mia sorella più piccola, Giuditta, presa dal panico scappò di casa e si trovò di fronte ai tedeschi e così li portò da noi. Da lì ci fu la deportazione, prima nel Collegio Militare e dopo due giorni siamo partiti dalla stazione di Roma Tiburtina verso Auschwitz; un viaggio durato sei giorni, stipati nei carri bestiame; ci mettevano dentro come capitava, senza alcun criterio, dentro potevamo essere venti come cinquanta; il viaggio lo abbiamo fatto insieme, io con tutta la mia famiglia; c’era pure mia sorella che era a fare la fila per le sigarette ed allora noi le demmo la bambina di diciotto mesi, dicendo ai tedeschi che loro non erano della famiglia, ma lei si mise paura e praticamente ci venne a cercare e così fu presa anche lei con la bambina. C’è stato il calvario del viaggio, perché i tedeschi quando erano venuti a prenderci ci avevano dato venti minuti di tempo per raccogliere soldi, vestiti e cibo: soldi non ce n’erano, vestiti neanche perché era già qualche anno che c’erano i punti per i vestiti ed il mangiare era poco e guadagnato con la borsa nera; in viaggio la bambina ha pianto per tutti e sei i giorni ed è stata una tragedia per darle da mangiare, per lavarla, ecc. Il primo soccorso che abbiamo avuto è stato a Padova, dalla Croce Rossa, che ci ha dato una minestra ed un po’ d’acqua; durante il viaggio non ci davano niente e ci aprivano solo una volta al giorno in aperta campagna e con il tedesco con il mitra puntato; il viaggio già fu una tragedia grandissima, ma una tragedia ancor più grande fu l’arrivo ad Auschwitz, perché non sapevamo cosa ci aspettava, dove andavamo, nessuno immaginava né dove fossimo, né la nostra sorte; nel 126 treno eravamo tutti ebrei del ghetto e non; per esempio c’era anche una mia zia che abitava in periferia, perché quando i tedeschi razziarono la Sinagoga, presero gli indirizzi precisi di tutti gli ebrei. Ad Auschwitz cominciarono le selezioni, la prima uomini e donne, poi tra noi donne siamo state prese in cinquanta; io tenevo in braccio la bambina di mia sorella e la bambina stava buona, ma mia sorella volle prenderla ed in quel momento passò “l’angelo della morte” che scelse me e mia sorella più giovane; noi dovevamo capire dai cenni, ed io chiesi a mia mamma perché ci avevano scelto, e lei mi disse che eravamo le più giovani e potevamo lavorare, perché noi ancora non avevamo capito cosa ci stava succedendo e non ci chiedevamo perché se gli servivano i giovani per lavorare avessero preso anche vecchi e bambini; infatti a Roma si cercavano di mettere in salvo soprattutto i giovani ed invece poi presero tutti e se qualcuno avesse riflettuto sul perché forse si sarebbe trovata più facilmente una scappatoia. Dopo la selezione io e mia sorella salutammo mia mamma come la salutavamo la mattina prima di uscire di casa, e pensai che ci portavano a lavorare e che ci saremmo rivisti la sera; da quel giorno invece cominciò la vera tragedia. Eravamo cinquanta ragazze, la prima cosa fu il tatuaggio sul braccio, poi la doccia e si era fatta notte; eravamo terrorizzate, non capivamo la lingua e cominciarono le prime botte, perché i tedeschi pretendevano che li capissimo, ma non li abbiamo mai capiti; entrammo in baracca e ci misero in dieci in un letto di un metro e mezzo e naturalmente non riuscimmo a dormire. Poi arrivarono delle prigioniere che avevano saputo che era arrivato un treno dall’Italia, perché dentro il campo c’era la resistenza e s’informavano sui nuovi arrivi; dicemmo che eravamo di Roma e loro si stupirono dicendoci che Roma era “città aperta” e che gli Alleati stavano vicino, ma purtroppo per noi non erano così vicino; loro ci dissero che quelli che non erano entrati in baracca li stavano ammazzando tutti con il gas, cominciammo a dare in escandescenze e le credevamo pazze, ma il giorno dopo ci siamo accorte che avevano ragione. Nel campo c’erano appelli a non finire, ed eravamo sepolti dalla neve con degli stracci addosso; le mie compagne cominciarono a morire per malattia e per fame perché la brodaglia non ci veniva data se non avevamo la scodella ed il cucchiaio; poi la capobaracca 127 ce ne diede una e noi mangiavamo con la stessa scodella e cucchiaio, fin quando non cominciavano a girare le malattie e smettemmo di mangiare con questo metodo ed allora cominciò il mercato interno con i pochi mezzi che avevamo a disposizione. Ci facevano fare un lavoro inutile, solo per umiliarci e picchiarci; mia sorella era convinta di morire ed io le dicevo che non si doveva scoraggiare, perché io dovevo assolutamente tornare a Roma e chiedevo questa grazia a Dio per poter raccontare cosa era successo in questi campi, il mondo lo deve sapere. L’appello era una cosa drammatica, perché era generale e dovevamo aspettare ore ed ore nella neve sofferenti tutti di dissenteria ed altre malattie. Mia sorella voleva andare a tutti i costi in ospedale, che era però l’anticamera delle camere a gas, i primi che si prendevano erano loro, io andai in ospedale con lei - ospedale per dire perché non c’era una medicina, non c’era un medico - ci misero separate ed io finii in un letto a castello con una tedesca, noi non ci capivamo e non potevamo andare d’accordo. Una mattina vennero due uomini e si misero a parlare con questa tedesca ed io non potevo capire cosa dicessero, ma dai gesti mi resi conto che la tedesca diceva ai soldati di portar via l’italiana. Io mi ribellai, ma non servì a niente, perché il tedesco mi disse di scendere dal letto. Non potevo sapere dove stessi andando, io ho ubbidito; mi hanno messo addosso una coperta e mentre camminavo dentro la lunghissima baracca tutte le persone mi salutavano perché ormai tutti mi conoscevano dentro l’ospedale, dato che giravo spesso per la baracca cercando di trovare qualche cosa di utile nelle persone già morte. Io non capivo cosa stava succedendo, non era una selezione perché ero stata presa solo io, però i saluti commossi dei vicini mi mettevano in testa mille paure. Fuori mi fecero salire su una specie d’ambulanza e dopo dieci minuti sono scesa e mi sono accorta di essere arrivata ad Auschwitz che distava pochi chilometri dal mio campo che era Birkenau; un’infermiera mi ha portato in una stanza, mi ha fatto il bagno, mi ha dato una camicia da notte ed io ho visto dopo molto tempo un letto con le lenzuola; io mi chiedevo come fosse possibile tutto ciò e pensai che mi chiedessero le ultime volontà prima di uccidermi, nessuno mi diceva dove stavo e l’infermiera dopo avermi messo a letto se ne andò. C’era un lavandino alla parete, ma noi non potevamo 128 bere l’acqua di Auschwitz perché non era sana e quindi i tedeschi non volevano; avevo però troppa sete e mi misi a bere; arrivò la tedesca che mi vide e mi diede uno schiaffo e mi portò un bicchiere di latte ed io pensai che erano veramente folli. La mattina mi accorsi dove eravamo arrivati e mi avevano preso per fare esperimenti, esperimenti dolorosissimi e senza mai vedere nessuno, anche se sentivo tante voci nelle stanze vicine. Vennero delle greche che mi spiegarono che ero in un blocco per gli esperimenti e molte altre cose; mi dicevano che ero fortunata perché ormai i Russi erano vicini, ma i Russi arrivarono un anno dopo. Ad Auschwitz rimasi fino al gennaio del ’45 perché i Russi stavano veramente arrivando ed una mattina presto ci hanno portato in Germania nel campo di Bergen Belsen a piedi in pieno inverno. Buttavamo via il pane strada facendo perché pesava e chi rimaneva indietro era morto; abbiamo attraversato tanti villaggi e nessuno ci ha dato una mano, anzi ci insultavano. A Bergen Belsen è stato peggio di Auschwitz, perché la disfatta tedesca si faceva sentire pesantemente anche su di noi. Ho incontrato delle romane e stavo sempre con loro; la fame era diventata tremenda perché le cucine funzionavano solo per i tedeschi ed a noi non ci davano niente ed io di notte andavo a cercare nell’immondezza. Dopo pochi giorni hanno fatto un appello immenso e siamo state per tutto il giorno in piedi sotto la pioggia e la neve. Un altro fatto importante del campo è che alcuni italiani mi dissero di non girare di notte perché c’era il cannibalismo. Vicino alla baracca c’era una torretta con una SS di guardia e questa una mattina ha cominciato a sparare nella baracca, molte compagne furono uccise ma io fortunatamente mi salvai, ma ero terrorizzata. Avevano distrutto i forni e le camere a gas ed i morti venivano accumulati fuori ed io decisi che era meglio mettersi tra i morti perché se avessero sparato ancora lo avrebbero fatto sui vivi; io mi sono nascosta quindi in mezzo a loro e non so nemmeno quanti giorni ci sono stata; sentivo gli spari ed i bombardamenti, ma io non mi muovevo, finché un giorno, il 15 Aprile, sentii la greca che mi diceva che gli Alleati erano arrivati e mi costrinse ad uscire, ma io avevo paura perché non li vedevo e non ci credevo; infatti gli Alleati erano entrati nel campo ed erano andati via subito. L’indomani cominciarono ad arrivare i primi 129 aiuti inglesi anche se era poco perché ancora la guerra non era finita, anche se gli uomini cominciarono a rubare nelle campagne tedesche per portarci da mangiare, inoltre incontrammo un gruppo di soldati con i quali siamo stati fin quando non siamo ripartiti con gli stessi carri con cui eravamo stati deportati. Quando tornai a Roma ritrovai le mie amiche che avevo lasciato molto modeste, tutte truccate e vestite benissimo ed io mi sentivo in grosso disagio perché ero segnata dal campo oltre che psicologicamente anche fisicamente, in questi due anni c’era stata un’evoluzione che nemmeno m’immaginavo. All’inizio la gente non credeva ai racconti dei campi. Quando arrivai io a Roma gli alleati erano già ripartiti e la situazione era molto difficile, cercavo lavoro e non lo trovavo, ma dopo qualche mese trovai lavoro e piano piano cominciai a reinserirmi. Nel convoglio eravamo più di 2.000 persone e siamo tornati solo in 17, io ero l’unica donna. NOTE 1 Per la ricostruzione della storia della comunità ebraica a Roma si sono tenuti presenti: A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1992; B. Migliau e M. Procaccia, Lazio. Itinerari ebraici, Marsilio, Venezia, 1997. 2 Per la ricostruzione degli eventi occorsi a Roma nell’autunno 1943 sono stati tenuti presenti i seguenti testi: S. Zuccotti, L’olocausto in Italia, Tea, Milano, 1995, pp. 129-131; R. Loy, La parola ebreo, Einaudi, Torino, 1997, p. 127; G. Debenedetti, 16 Ottobre 1943, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 26-28; A. Stille, Uno su mille. Cinque famiglie ebraiche durante il fascismo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1991, pp. 216-218; R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1961, p. 455. 3 Herbert Kappler era il capo della polizia di sicurezza nazista a Roma; si mise in mostra nella capitale per la spietatezza con cui eseguiva gli ordini. Fu l’organizzatore del terribile eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui persero la vita 335 persone, in seguito all’attentato di via Rasella. Fu condannato all’ergastolo e rinchiuso nel penitenziario militare di Gaeta. Nel 1977 riuscì a fuggire dall’Ospedale Militare del Celio. Nello stesso anno morì in Germania. 4 Le parole di Kappler sono riprese da R. De Felice, op. cit., p. 455. 5 Cfr. S. Zuccotti, op. cit., p. 129. 130 6 Ibidem. 7 Cfr. A. Stille, op. cit., p. 217. 8 Cfr. G. Debenedetti, op. cit., p. 27. 9 K. A. Eichmann (1906-1962), si segnalò come abile realizzatore, freddo esecutore ed uno dei massimi responsabili della “soluzione finale”. Nel 1950 scappò in Argentina, dove fu raggiunto da agenti segreti israeliani, trasportato in Israele e condannato a morte. Per una riflessione sulla “terrificante normalità umana” di Eichmann, cfr. H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano, 1997. 10 Cfr. R. Loy, op. cit., p. 127. 11 Cfr. G. Mayda, Ebrei sotto Salò, Feltrinelli, Milano, 1979, pp. 96-110. 12 Cfr. G. Mayda, op. cit., p. 97. 13 Cfr. R. De Felice, op. cit., p. 455. 14 Cfr. G. Mayda, op. cit., p. 97. 15 Cfr. S. Zuccotti, op. cit., p. 131. 16 Cfr. G. Debenedetti, op. cit., p. 30. 17 Cfr. G. Mayda, op. cit., p. 104. 18 Cfr. R. Loy, op. cit., p.123. 131 VERITÀ DIVERSE. LA DEPORTAZIONE FEMMINILE Daniele Apicella Ogni qualvolta leggiamo un testo di storia o un saggio su un qualsiasi argomento è possibile rilevare la volontà dell’autore di esprimere un certo messaggio, di sottolineare determinati eventi al posto di altri. Questo fenomeno è del tutto normale in quanto è impossibile per la natura umana essere totalmente oggettivi e dare a ogni singolo evento la stessa importanza. L’esposizione dei fatti è influenzata non solo dal punto di vista di chi tratta l’argomento, ma anche dalla visione generale del periodo storico in cui la storia è scritta. Così, anche il fenomeno della Shoah è visto secondo l’ottica delle società occidentali nell’epoca della ricostruzione. Il neofemminismo comincia, in Italia, solo intorno agli anni ’70, quindi la visione della società italiana è ancora di tipo “maschilista”. Adesso che il processo di parificazione giuridica e sociale delle donne ha raggiunto un grado sufficientemente elevato, gli eventi storici sono rivisti e danno la giusta importanza al ruolo femminile. La Shoah, allora, non è più il fenomeno della persecuzione e della deportazione che i nazifascisti perpetrarono nei confronti degli ebrei, degli zingari e di tutti i loro avversari, ma la somma delle “esperienze” di uomini e donne di diversa origine che hanno subito tale fenomeno.* Giuliana Fiorentino Tedeschi ci ricorda che «la letteratura di testimonianza è stata prodotta quasi tutta da uomini, mentre le donne hanno parlato poco delle proprie esperienze. Forse per questo motivo si è ingenerata e diffusa l’opinione che le deportazioni maschili e femminili possano combaciare e anzi addirittura sovrapporsi»1. Anna Bravo riporta alcuni dati e cerca di spiegare il perché del silenzio femminile. Sulla memorialistica della deportazione dall’Italia, soltanto venti su centoquarantanove 132 sono opere di donne; «credo che molte donne non abbiano scritto o parlato anche perché ben poche e pochi si sono preoccupati di sollecitarle, di fare da catalizzatore e da amplificatore della loro memoria, di offrire sbocchi editoriali. Nel dopoguerra, le rarissime pubblicazioni sono orientate da criteri di rilevanza politico– culturale ancora più selettivi di quelli applicati ai testi maschili»2. Ad una lettura superficiale, le testimonianze delle donne sopravvissute alla deportazione potrebbero sembrare del tutto uguali o molto simili a quelle maschili. Tuttavia ciò non è assolutamente, in quanto la natura stessa delle donne è diversa da quella degli uomini, soprattutto perché si parla di generazioni che sono cresciute nella società fortemente patriarcale del regime fascista. Inoltre, il riconoscimento della diversità delle due nature è testimoniato dall’organizzazione del Convegno internazionale tenuto a Torino, il 20 e 21 ottobre 1994, dal Consiglio regionale del Piemonte e dall’Aned, che ha affrontato appunto questo tema. Già le affermazioni introduttive stampate sul cartoncino di invito delineano i punti principali dell’argomento: Estremamente dolorosa la condizione dei deportati nei Lager nazisti dove la sopravvivenza era l’eccezione dovuta prevalentemente al caso: estremamente dolorosa per uomini e donne ma ancor più per le donne. E così maggiori per le donne le difficoltà da superare per prendere parte alla Resistenza come partigiane o staffette, contro i pregiudizi dell’ambiente familiare e sociale. Anche il ritorno riserba alle donne spiacevoli sorprese per la diffusa incomprensione. Le relazioni di alcune sopravvissute che hanno partecipato al Convegno sostengono le constatazioni di questo testo, e danno un contributo significativo alla trattazione di questo problema. Sempre Anna Bravo spiega perché le esperienze delle donne sarebbero diverse da quelle maschili. «Certo è una tortura della femminilità. Essere prigioniere vuol dire esporre in pubblico, a sguardi di aguzzini, corpi abituati dal costume di cinquant’anni fa a un pudore rigoroso; vedere quelli di altre, magari anziane, e 133 restarne turbate; non potersi più riconoscere nella propria immagine fisica. Vuol dire vivere con bambini destinati a sparire, con compagne che arrivano incinte in Lager e si affannano per nutrire un figlio che verrà ucciso appena nato; scoprire nelle donne, anche in se stesse, una distruttività che non si sarebbe mai immaginata; subire, spinta all’estremo, una vita promiscua di cui non si ha alcuna esperienza, neppure quella che agli uomini viene dall’aver fatto il servizio militare e la guerra»3. E la stessa Tedeschi, con la sua esperienza personale alle spalle, ci conferma che «a quel tempo una donna teneva più di oggi alla propria riservatezza fisica, alla cura del proprio corpo, perfino alla ricerca estetica di armonia nel vestiario e non esibiva senza traumi la propria nudità. Eccola nel Lager, ha appena subito sul suo corpo la violenza di mani estranee che, con rasoi poco affilati, le hanno depilate le parti intime, le è stato impresso un marchio sul braccio sinistro, ha provato l’orrore del freddo metallico della macchinetta tosatrice sulla cute, ha visto le ciocche della sua capigliatura cadere morbidamente ai suoi piedi. […] Le mutande maschili non hanno elastici e cadono, le calze si ripiegano sulle gambe. […] Più fortunati gli uomini: essi hanno un’uniforme, che li difenderà poco dal freddo, ma permetterà di inserirli in una categoria, quella dei galeotti lavoratori. […] Per la donna non c’è tregua, perché il flusso mestruale si ripropone e non esiste materiale per difendersi. Chi è fortunata trova in terra uno straccio, se è costretta a lavare le mutande, deve indossarle bagnate. Lo stress per fortuna a poco a poco ci libera dal tributo mensile alla natura, ma si ha la sensazione di ridursi a esseri asessuati. […] E mentre la sessualità delle donne si spegne, proprio l’apparato genitale femminile attrae l’interesse dei criminali nazisti che si spacciano per scienziati. Da giovani prigioniere (anche diciottenni) e donne maritate si prelevano campioni di tessuto dell’utero per essere in grado di giungere a diagnosi tempestive di eventuali tumori, con raggi X si sterilizzano le ovaie, si pratica l’isterectomia, si inietta nell’utero un liquido (nitrato d’argento o 134 formalina?) a detta dei medici sterilizzante, pratiche queste che dovevano servire a sterilizzare le razze inferiori. […] La sperimentazione disponeva di un numero inesorabile di “cavie” ebree, costrette a sottoporsi a dolorosi interventi chirurgici, prive di anestesia, o con anestesia insufficiente»4. Ritornando al problema delle donne incinte, bisogna poi ricordare che a Birkenau, negli anni ’42-’43, queste venivano ammazzate, mentre, in seguito, potevano partorire e continuare a lavorare: il bimbo veniva soppresso con iniezioni di fenolo o soffocato in una tinozza d’acqua e quindi bruciato in una stufa. Chi partoriva segretamente era costretta a soffocare o avvelenare il proprio figlio. A questo punto risulta evidente quanto possano essere differenti le terrificanti esperienze di uomini e donne. Probabilmente i motivi che hanno spinto gli ex deportati a raccontare le loro “storie” sono gli stessi: “Mantenere il silenzio significa innanzitutto lasciare campo libero a coloro che negano questi fatti e, soprattutto, rafforzare la tesi di quelli che, per tranquillizzarsi a partire dalla fine della guerra, hanno considerato che c’era molta esagerazione e propaganda nelle rivelazioni sulla deportazione”5. Edith Bruck, riferendosi particolarmente alle donne, afferma che sono, “finché in vita, più o meno testimoni perché non possono farne a meno, perché non devono e non possono dimenticare, perché temono che si dimentichi, e perché sono inorridite di fronte alle mistificazioni, le rimozioni, se non addirittura alla negazione dell’accaduto e la sua realtà”6. Quello che viene detto, però, non è tutta la verità, non è tutto quello che è stato visto o vissuto. S. Saint-Clair afferma che «ci sono dei fatti che superano l’immaginabile a causa della loro ignominia, che la dignità di una donna si rifiuta di tradurre in parole: non volevo sporcare la mia penna rivelando l’infame sadismo e la bestialità mostruosa dei nostri carnefici»7. M. Maurel dedica le prime righe del suo libro a questo problema: «La realtà era molto tragica […] scrivendo mi sono imbattuta in alcuni ricordi chiusi che hanno rifiutato di aprirsi […]. Ho trovato un maggior numero di ricordi per le stagioni calde piuttosto che per quelle fredde, anche se que- 135 ste duravano più a lungo. Dei giorni più dolorosi mi ricordo le mattine, non le sere. Mi ricordo i tragitti del campo al lavoro, non i ritorni. Non so se la mia memoria rifiuta di evocarli o se non ha potuto registrarli perché ero troppo stanca»8. Un esempio dei ricordi tremendi di cui si preferisce non parlare può essere l’ispezione: “E per tutte le donne ugualmente vittime, la disinfestazione era uno degli eventi più umilianti; tutte nude in fila tremanti diventavano bersagli di sguardi sprezzanti, risate sfrenate, gara di sputi tra i soldati sui capezzoli, e non di rado oggetto di scherni con dei bastoni che frugavano nei nostri corpi. A tutto ciò si aggiungeva il rischio di essere messe da parte per una macchia sulla pelle, per un foruncolo, per l’età più visibile senza gli abiti, cose che all’arrivo, o durante le successive selezioni, comprese quelle del famigerato dott. Mengele, erano sfuggite agli sguardi affrettati”9. Sicuramente non è possibile sostenere a questo punto l’uguaglianza tra la deportazione femminile e quella maschile. Bruck stessa, però, afferma che le donne nei Lager «erano molto più forti degli uomini e sono sopravvissute più numerose, e più di tutte coloro che appartenevano alla maggioranza di origini modeste. Abituate alle privazioni, ai lavori più pesanti, alla cura dei numerosi figli, mariti, nonni»10. Comunque sia, questo non vuol dire che “solo” la natura della donna sia diversa: anche il trattamento nei campi era diverso. Uomini e donne erano divisi all’interno di uno stesso campo e a volte c’erano Lager esclusivamente maschili o femminili. Un esempio di quest’ultimo tipo di campo è il lager di Ravensbrück. Ravensbrück era un grande campo di concentramento femminile costruito nel 1939 nel Meclemburgo, a ottanta chilometri a nord di Berlino. Dal 1939 al 1945 vi furono imprigionate da centodieci a centoventimila donne di ogni nazionalità spesso solo temporaneamente, in attesa di ripartire per destinazioni più lontane, in Kommando esterni. […] Ravensbrück era un campo di livello 1, cioè sottomesso ad un regolamento paragonabile a quello di Buchenwald e Dachau, molto meno micidiali di quello dei campi di livello 3, come Mauthausen, Auschwitz 136 o Flossenburg. […] a Ravensbrück, grazie a Dio, gli omicidi con il gas furono molto più limitati (del milione ad Auschwitz), circa diecimila vittime in tutto11. È vero, Ravensbrück era un campo di livello “basso”, e per fortuna vi fu “limitato” l’uso del gas, ma, secondo le testimonianze di persone che scrutarono i lager nazisti potendo abbracciarne globalmente la vista, i campi femminili non erano proprio da “basso” livello. Lord Russell ricorda che il campo (Ravensbrück) fu meritatamente conosciuto dappertutto come “l’inferno delle donne”12; Hermann Langbein osserva: «Conformemente alla legge di Auschwitz - riservare ai più deboli la sorte più dura - le condizioni peggiori si trovavano nel Lager femminile di Birkenau»13; e Rudolf Höss, comandante ad Auschwitz tra il 1940 e il 1943, scrisse: «[..] per le donne ogni cosa era assai più dura, più oppressiva e più tremenda, perché le condizioni generali di vita erano assai peggiori nel campo femminile. […] Quei cadaveri ambulanti erano una visione orribile»14. All’interno del campo si potevano vivere esperienze diverse, per lo più estremamente negative. L’incredibile trasformazione delle persone riguardava, per esempio, anche le prigioniere ebree, considerate esseri appartenenti a una razza inferiore, che potevano diventare Kapò o altri tipi di funzionarie: esse erano più zelanti degli uomini, che avevano da fare cose più importanti; le Kapò erano delle rare sopravvissute ad anni di lager e obbedivano come delle macchine alla disciplina dei loro capi uomini e anche nelle loro crudeltà si mostravano più razionali, più maschili delle novelle funzionarie subito cattive, meschine, e irriconoscibili da un giorno all’altro. Un incredibile segno di una persistenza dell’umanità nel campo, derivato dalla natura umana, che aspira alla comunione sociale, è la presenza di quello che potrebbe essere definita come “università”: esse cercavano di unirsi in gruppo, soprattutto le letterate e nei momenti di pausa si scambiavano la ricchezza interiore. C’erano dibattiti la sera, sopra o sotto il tavolo a seconda se 137 l’argomento fosse o no lecito. Insieme stabilivano una sorta di strategia per la Resistenza interna e questi momenti erano oasi in mezzo all’incessante dolore del campo. Da tenere presente è un’altra realtà che indiscutibilmente concorre a enfatizzare la differenza tra le deportazioni maschili e femminili. “A parte la lotta per non morire, le donne, le più belle, le più giovani, rischiavano di essere selezionate per i bordelli, noi tutte per le sperimentazioni scientifiche sempre in agguato. […] Qualcuna, le più disprezzate e invidiate allo stesso tempo, sui luoghi di lavoro scomparivano all’improvviso e tornavano con uno scialle al collo, un paio di calzini di lana sui piedi congelati, o un paio di vecchi guanti sulle mani gonfie di gelo. Per questi fatti severamente proibiti, non si poteva non essere anche grati a un tedesco che si degnava di toccare una ebrea, che sembrava tutto meno che una donna”15. A questo punto non resta che riportare testimonianze che sostengano la partecipazione delle donne alla Resistenza. Anche in questo campo l’azione femminile fu diversa da quella maschile. Liana Millu sostiene questa affermazione. Che le donne resistessero al Lager in modo diverso e migliore degli uomini, è risaputo: lo affermò anche Rudolf Höss nelle sue memorie di comandante ad Auschwitz. […] sembra che nel Lager al femminile le “virtù quotidiane” prevalgono su quelle eroiche. […] Soltanto, chi può dire quanto silenzioso eroismo sia necessario per vivere la quotidianità senza lasciarsene distruggere? […] l’impegno politico le donne lo attuarono durante il lavoro quotidiano, nella fabbrica, facendo sabotaggio ogni volta che potevano, ricavandone la soddisfazione di un buon combattente16. In conclusione, anche se al lavoro donne e uomini erano uguali (le SS chiedevano lo stesso prezzo alle ditte per il loro sfruttamento), non c’è dubbio che le due realtà fossero diverse. Ma perché, allora, le opere di memorialistica di questo genere non vengono lette o recepite? A questa domanda Dominique Labbé risponde: «Quasi tutti questi racconti possiedono ancora un motivo comune, che merita di essere sottolineato. Le autrici non ci dicono quasi nulla del “prima” e del “dopo”. I libri si aprono sull’arresto e terminano generalmente quando il deportato ritrova i 138 suoi; il seguito è appena accennato con poche parole pudiche. Questa scelta è logica, nell’ottica della testimonianza, ma presenta due inconvenienti dal punto di vista della ricezione. In primo luogo, l’assenza quasi totale di elementi biografici che riguardano l’autrice rende più aleatoria la simpatia del lettore. Quest’ultimo “assiste” dall’esterno ad alcuni episodi che gli sono presentati più o meno chiaramente, ma è raramente messo nella condizione di condividere i sentimenti, le sensazioni di persone che conosce poco. Può provare della compassione, ma farà fatica a rappresentarsi il freddo, la fame, la paura. In secondo luogo, l’assenza di informazioni sul dopo–deportazione può indurre a credere che, a parte alcuni brutti ricordi, il deportato ne sia uscito più o meno indenne. Detto in un altro modo, questi racconti, a causa della loro stessa struttura, possono lasciar pensare che la deportazione sia stata una sorta di parentesi nella vita delle autrici»17. Alcuni estratti dell’intervista a Lina Saba Navarro, rilasciata per la Shoah Foundation di Spielberg, sottolineano aspetti che sono stati più o meno trattati nella relazione. Arrivo al lager: La prima cosa che noi abbiamo chiesto è stato: ci hanno diviso dalla mamma, dalla zia, dove li avranno messi? E lei poverina – dopo abbiamo capito la sua aridità perché poi lo eravamo diventate anche noi – ci ha detto guardate là: vedete quel camino che brucia? Ecco loro sono là dentro. La denudazione avveniva più volte, ogni giorno: Io mi sono trovata in una stanza vuota con tutte finestre e mi ha colpito che abbiamo visto tutti, una parte dei nostri ragazzi che erano nel nostro vagone, fuori incolonnati e ci potevano vedere, non ci osservavano, ci potevano vedere e ci hanno dato l’ordine di spogliarci completamente, di mettere i vestiti accanto a noi; per noi è stato un trauma forte, sapevamo che avevamo fuori parenti e estranei che ci vedevano, ma quello è stato l’ordine… E la prima cosa che hanno fatto, ci hanno rapato a zero tutto il corpo. 139 Sulle selezioni: (Le selezioni venivano fatte) a tutti noi ebrei; l’unica differenza che c’era fra noi ebrei e i politici, tutte le altre persone che non erano ebree, ma che si trovavano nel campo con noi, è che avevano lo stesso trattamento per mangiare, per tutto, per tutta la giornata lavorativa, tutto; solo che loro non avevano la selezione: quando andavano a fare la doccia, loro sapevano che era una doccia, e non selezione. Invece per noi, quando si andava a fare la doccia, ci si chiedeva: è doccia o selezione? Sul comportamento delle SS: Siamo andati a lavorare e quando siamo arrivati al lavoro (un soldato) ci ha fatto fermare un momento e ha cominciato a chiamare una ragazza, e la ragazza di Firenze… l’ha presa e col calcio del fucile la cercava di far cadere; non la cercava, proprio la spingeva per farla cadere, e questa ragazza cadeva sempre con la faccia in giù; e questo l’ha fatto per tantissime volte e imprecava e diceva parole che purtroppo non si capiva. Finché si è stancato, di questa ragazza, e l’ha lasciata andare e ne ha preso un’altra e le ha fatto la stessa cosa: con questo calcio del fucile cercava di buttarla giù; è riuscito a buttarla con il volto, con la schiena in giù e lui ha chiamato il cane, gli ha parlato, bisbigliato in tedesco. Il cane, come una persona, si è gettato sopra il corpo di questa ragazza. Il tedesco continuava a parlare e si capiva che lo incitava. Finché ha voluto il tedesco, è stato in questa posizione, poi il soldato ha fatto alzare il cane e la ragazza. Sul comportamento dei salvatori russi: Quando mia sorella si è rivolta a loro (prigionieri militari compagni di viaggio) per un aiuto di questo (soldato) russo che mi aveva preso, sono rimasti…, hanno avuto paura, non lo so… Mia sorella si è fatta un coraggio da leone, perché devo dire da leone ha fatto il coraggio, e mi ha strappata da lui; era ubriaco, non avrà avuto tanta forza dopo di reagire, insomma, mi è andata bene, mi è andata bene; ma però era un tormento continuo con questi soldati russi; in precedenza, violenze sessuali non ne avevamo mai subite. 140 Lina Saba accenna allo sfruttamento sessuale delle prigioniere ricordando che, durante il tragitto per andare al lavoro, vedeva dei blocchi che voci di campo dicevano essere la casa delle bambole, che servivano ai tedeschi per le donne. Accenna anche ai neonati: più di una volta le SS avevano messo i bambini dentro dei sacchi per lanciarli in aria e colpirli con bastoni o per tirare al bersaglio con le pistole. Riguardo, invece, al ritorno a casa, la testimonianza presenta punti molto positivi, ma anche tratti che lasciano veramente stupefatti. Il tempo trascorso in Polonia dopo la liberazione è un periodo felice, di rinascita. Questa positività è data soprattutto dalla grande ospitalità degli abitanti e dai servizi delle istituzioni: le ex deportate potevano sempre trovare un pasto gratuito e venivano trattate con grande rispetto dai cittadini. Una volta tornate in Italia, però, tutto questo finisce. Il primo impatto con la cittadinanza è subito negativo: il controllore del tram non fa salire due ex deportate che naturalmente non disponevano di soldi per il biglietto. Successivamente Lina Saba è cercata da amici e conoscenti che, però, vogliono esclusivamente conoscere cosa sappia dei loro parenti. Nessuno crede o ascolta i “racconti” di colei che per lungo tempo è stata lontana da casa e dice di aver subito torture inimmaginabili. Lina Saba, allora, come tutte e tutti gli altri ex deportati, preferisce non parlare, anziché vedere la terribile realtà calpestata e ritenuta menzogna. Rileggendola con attenzione, la stessa intervista a Settimia Spizzichino presenta quelle caratteristiche che contraddistinguono la sua esperienza in quanto donna. Occorre, tuttavia, tenere sempre presente che diversi punti sono solo accennati, e trattati meglio nel libro da lei scritto18. 141 NOTE * Questa relazione è stata svolta tenendo presenti i saggi contenuti in L. Monaco (a cura di), La deportazione femminile nei Lager nazisti, Consiglio regionale del Piemonte - Aned - FrancoAngeli, Milano, 1995. 1 Cfr. G. F. Tedeschi, “Caratteri specifici della deportazione femminile”, in L. Monaco, op. cit., p. 28. 2 Cfr. A. Bravo, “Relazione introduttiva”, in L. Monaco, op. cit., p. 17. 3 Cfr. A. Bravo, op. cit., p. 19. 4 Cfr. G. F. Tedeschi, op. cit., p. 29. 5 Cfr. D. Labbé, “Deportazione: le difficoltà della testimonianza”, in L. Monaco, op. cit., p. 47, corsivo mio. 6 Cfr. E. Bruck, “Le mie esperienze con le donne”, in L. Monaco, op. cit., p. 66, corsivo mio. 7 Cfr. D. Labbé, op. cit., p. 50. 8 Ibidem. 9 Cfr. E. Bruck, op. cit., p. 69, corsivo mio. 10 Ibidem. 11 Cfr. A. Postel Vinay, “Gli assassinii con il gas nel campo di Ravensbrück”, in L. Monaco, op. cit., p. 119-120, corsivo mio. 12 Cfr. Russell, Il flagello della svastica, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 183. 13 Cfr. H. Langbein, Uomini ad Auschwitz, Milano, Mursia, 1984, p. 100. 14 Cfr. R. Höss, Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico di Rudolf Höss, Torino, Einaudi, 1961, p. 125. 15 Cfr. E. Bruck, op. cit., p. 68, corsivo mio. 16 Cfr. L. Millu, “All’ombra dei crematori: la resistenza minimale delle donne”, in L. Monaco, op. cit., p. 131, corsivo mio. 17 Cfr. D. Labbé, op. cit., p. 55. 18 Isa di Nepi Olper (a cura di), Gli anni rubati, Comune di Cava dei Terreni, Cava dei Tirreni, 1996. 142 LA CONDIZIONE FEMMINILE NEI LAGER Olivia Zorzet A distanza di più di mezzo secolo dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla liberazione dei lager, è ancora molto difficile farsi un’idea di che cosa sia stata l’esperienza del campo di sterminio per milioni di persone che vi hanno perduto la vita e per i pochi che sono sopravvissuti.1 Il lager “anus mundi”: un incubo che, anche in un’ epoca di orrori come la nostra, si pone come un problema ancora insoluto, anche se sono ormai molte le opere che hanno testimoniato sulla vita quotidiana in quell’universo o che hanno indagato sulle sue radici storiche e sociologiche. Poche sono però le testimonianze femminili rispetto a quelle scritte maschili: non tanto per il timore che riemergesse il dolore, ma quanto per il fatto che nessuno si è mai occupato di sollecitarle, di fare da catalizzatore e da amplificatore alla loro memoria e di offrire loro sbocchi editoriali. Mio interesse è ora capire se la prigionia femminile ha avuto caratteri propri distinti da quelli maschili, se si può parlare di specificità di prigionia femminile, se le donne per la loro costituzione fisica, per la natura della loro psiche, sono state esposte a sofferenze più profonde e più disparate in confronto a quelle subite dai loro compagni in prigionia. Il punto non è affermare un di più di dolore, ma dar conto di un’esperienza diversa da quella maschile, e proprio della riflessione delle e sulle donne può venire una spinta allo studio della prigionia degli uomini in quanto maschi, della prigionia non solo come negazione dell’umano, ma 1 Per questo lavoro si sono utilizzati i seguenti testi: L. Beccaria Rolfi, Le donne di Ravensbrück. Testimonianza di deportazione, Einaudi, Torino, 1978; L. Borsi Rossi, Le donne di Ravensbrück, Einaudi, Torino, 1978; W. Kiedzynska, Il registro delle nascite a Ravensbrück, Varsavia, 1976; E. Lifton, I medici nazisti, Rizzoli, Milano, 1988; L. Sterpellone, Le cavie dei Lager. Gli esperimenti medici delle SS, Mursia, Milano, 1978. 143 come tortura inflitta alla mascolinità. “Essere prigioniere vuole dire dover esporre in pubblico, a sguardi aguzzini corpi abituati dal costume di cinquanta anni fa ad un pudore rigoroso; vedere quelli di altre, magari anziane e restarne turbate, subire la violenza per poter sopravvivere, non potersi più riconoscere nella propria immagine fisica. Vuol dire vivere con bambini destinati a sparire, con compagne che arrivano incinte in lager e si affannano per nutrire un figlio che verrà ucciso appena nato; scoprire nelle donne e anche in se stesse una distruttività che non si sarebbe mai immaginata.” Per le poche “fortunate” che sono riuscite a sopravvivere, il ritorno alla vita normale è stato difficilissimo, perché il danno psicologico si è protratto molto a lungo. Molte donne che hanno perso i bambini nel lager ne hanno voluti avere altri appena riconquistata la libertà, ma nella loro psiche hanno voluto che i nuovi nati fossero il più possibile simili a quelli perduti, condannandoli in questo modo, ad essere “le candele della memoria”, ossia, creature destinate a celebrare il ricordo dei familiari scomparsi. IL LAGER DI RAVENSBRÜCK. LA POPOLAZIONE FEMMINILE DALLA NASCITA DEL CAMPO ALLA LIBERAZIONE Il lager di Ravensbrück, unico nell’universo concentrazionario ad essere popolato da sole donne e bambini, nasce come campo di rieducazione per l’isolamento delle “diverse”, politiche, asociali, zingare, ladre, assassine, religiose; si sviluppa come serbatoio di schiave per la produzione bellica e termina come lager di sterminio quando le schiave non servono più alla produzione e pesano negativamente sul sistema economico. Ravensbrück è stato aperto ufficialmente il 18 maggio 1939 con 867 prigioniere di cui 860 tedesche e 7 austriache, fu costruito velocemente in una località situata a 80 km a nord-est di Berlino, 144 zona fredda e paludosa, in riva al lago Schwed. Le prime prigioniere che entrarono nel campo sono politiche e testimoni di Geova e subito dopo arrivano le zingare con i loro bambini. A ognuno di questi tre gruppi verrà assegnato un blocco e saranno contraddistinte con un triangolo colorato. Alla fine di settembre, poco dopo l’invasione della Polonia, giungono le prime prigioniere politiche polacche. Nell’aprile del 1940 le detenute sono già 3114 e ad agosto 4433; in questo periodo arrivano anche i primi trasporti dalla Cecoslovacchia. Dalla testimonianza di una donna, Margarete Bober Neumann, una delle fonti più importanti e attendibili per la conoscenza della storia di Ravensbrück, sappiamo che inizialmente il lager appariva come un luogo tranquillo, verde, quasi un “luogo di villeggiatura”: il Lagerplat ornato di aiuole fiorite, in direzione della porta del campo una baracca di legno, una grande gabbia con due pavoni, delle scimmie che fanno l’altalena sopra un portico e un pappagallo che ripete ininterrottamente “mamma” e poi dappertutto fiori, cascate di fiori. Ma di fronte allo zoo, dopo un grande prato verde e seminascosto da pini argentati, vi è l’unica costruzione in muratura del campo: il bunker, l’inferno del lager, mimetizzato agli occhi dei visitatori e, oltre questo, l’alto muro di cinta con la corrente ad alta tensione. Il campo non è però così come sembra: nel campo vige una disciplina ferrea, la vita si snoda all’insegna dell’ordine perfetto all’interno e all’esterno delle baracche. Gli sgabelli ordinati a soldatini, i pavimenti puliti più volte al giorno, asciugamani piegati a regola, stoviglie riposte secondo l’ordinamento, letti rifatti a cubo, abbigliamento impeccabile con il vestito a righe grigio e blu, il fazzoletto bianco legato in un certo modo senza la fuoriuscita di un capello, grembiule blu che copre completamente il vestito blu perfettamente stirato, andatura scattante, le braccia stese lungo il corpo durante gli appelli inter- 145 minabili. Questo è il periodo della rieducazione in cui ordine, lavoro, disciplina sono alla base di un buon processo rieducativo. Le detenute escono al lavoro dopo l’appello del mattino con la pala sulle spalle, allineate per cinque con sorveglianti che urlano e i cani che abbaiano e tornano alla sera ancora allineate per cinque dopo molte ore di lavoro nel bosco o nella sabbia a passo di marcia, cantando a squarciagola le canzoni idiote imposte dalle sorveglianti. Il tempo è scandito dalla sirena del lager: non un minuto è concesso per intrattenersi con le compagne, anche se, fin dal primo periodo, le detenute, quando in lager è suonato il silenzio, si raccolgono e si riuniscono per discutere. Ben presto però il lavoro rieducativo dei primi due anni si trasforma in lavoro produttivo: le detenute diventano schiave e sono vendute dalle SS alle industrie che ne fanno richiesta. Nel giugno del ’41 viene costruito all’interno del campo il primo stabilimento industriale per la confezione di divise militari destinate all’esercito tedesco: le industrie Hof. Lo stabilimento è di proprietà delle SS che iniziano a speculare e trarre profitto dalle detenute. Nello stesso periodo le detenute politiche tedesche iniziano ad essere utilizzate negli uffici, per economizzare materiale umano utile in altri settori. In agosto scoppia un’epidemia di poliomielite e le SS abbandonano il campo lasciando le detenute sole ad autoamministrarsi: Ravensbrück viene messo in quarantena con la proibizione di entrare o uscire per chiunque. Centinaia di ammalate vengono isolate in blocchi circondati da filo spinato e affidate alla cura di altre detenute. Il lavoro si blocca per alcune settimane e le detenute godono quasi di una semilibertà senza appelli, lavoro, fatiche, botte… A dicembre iniziano però le prime selezioni di anziane, malate e invalide, che saranno inviate a Buch e a Bernburg per essere eliminate. In ottobre arriva il primo grande trasporto di sovietiche. 146 Nel gennaio del 1942 è immatricolato il n° 9643. Durante tutto quest’anno ci sono numerose esecuzioni capitali e cominciano trasporti verso altri campi. Con la circolare Poul del 30 aprile i comandanti dei campi sono invitati ad aumentare la produzione senza tener conto degli orari e delle condizioni fisiche delle detenute. È il momento in cui Ravensbrück conosce il maggior sviluppo. Il Lager viene ingrandito con nuovi blocchi più grandi. Consta di 32 baracche, bunker, infermerie, alloggiamenti per le guardie, caserme, capannoni di stoccaggio, lavoratori vari; la ferrovia arriva fino all’esterno del Lager. Le deportate arrivano da tutti i paesi europei occupati: Russia, Ucraina, Jugoslavia, Grecia, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca e Norvegia. A ottobre immatricolano il n° 24588: oltre alle industrie presenti sul posto e nei vari Kommando dislocati nei dintorni, fornisce manodopera a fabbriche dipendenti da altri campi, dove le condizioni di vita delle detenute erano veramente incredibili. È sufficiente ricordare a questo proposito la miniera di sale di Beemoore dove le donne hanno lavorato alla produzione di pezzi di aeroplani in una fabbrica sotterranea installata a 600 m sottoterra in una vecchia miniera di sale. Durante il corso del ’44 il numero di immatricolazione cresce a dismisura fino ad arrivare nel dicembre al n° 91748. Le donne sono schiacciate in uno spazio sovraffollato e invivibile perché le strutture, i servizi, i posti letto, sono quelli del 1942 al momento dell’ampliamento del lager. La percentuale delle prigioniere presenti in appello va infatti sempre più diminuendo a causa della grande mortalità. Le italiane sono l’ultima nazionalità ad arrivare: il primo trasporto formato da 14 donne giunge il 30 giugno 1944 da Torino; ad esse, al momento della partenza, è stato detto che «sarebbero andate a lavorare in Germania». 147 Questo è il momento in cui il campo esplode e l’ordine, la disciplina, la perfezione tedesca saltano di fronte alla deportazione in massa e alla limitata capacità di ricezione delle strutture. In campo le italiane non hanno compagne che possano informarle sulle regole, sui pericoli e anche sulle tecniche di sopravvivenza. Non conoscono le lingue del lager: tedesco e polacco. Nessuno capisce l’italiano ma soprattutto nessuno vuole rispondere ad un’italiana che non si sa bene perché, per quale oscura ragione sia finita a Ravensbrück. Al primo trasporto di italiane fa seguito un secondo che arriva il 5 agosto, proviene da Verona e ha raccolto 50 deportate. Un terzo trasporto arriva l’11 ottobre e proviene da Bolzano con circa 110 donne. Le impressioni delle donne di tutti e tre i trasporti corrispondevano: lo smarrimento, lo sconforto di sentirsi non solo sottospecie umana, merce di proprietà esclusiva dei padroni SS, ma in più rifiutate all’inizio anche delle altre deportate, disperate come le italiane ma senza l’etichetta vergognosa di essere state alleate e quindi complici dei nazisti. Le notizie sull’Italia, la caduta del fascismo, il capovolgersi della guerra non arrivano fino a Ravensbrück, almeno non alla massa. A questo va aggiunto che le italiane arrivate a Ravensbrück non sono personaggi dell’antifascismo conosciuti a livello internazionale, con un nome da esibire come biglietto da visita, come è successo ad esempio ad alcuni deportati in certi lager maschili. Ad eccezione di Teresa Noce nessuna ha un passato eroico per essere accolta fra le grandi politiche del campo, quelle che hanno potere e godono rispetto e fiducia. Le italiane appartengono agli strati sociali più diversi: ci sono antifasciste con anni di militanza clandestina alle spalle, ci sono partigiane arrestate durante i rastrellamenti, ci sono staffette denunciate dalle spie, ma ci sono anche moltissime donne prese in 148 ostaggio al posto dei fratelli, dei mariti, dei figli, ricercati per attività clandestina. Ci sono interi nuclei familiari: madri e figlie, sorelle, anche donne arrestate senza motivo, ci sono ebree, operaie, insegnanti, poche borghesi, molte casalinghe. Sono per la maggioranza donne robuste, ben sfruttabili per lavorare. Queste italiane che provengono da estrazioni sociali e culturali diverse, che raramente hanno una formazione politica alle spalle, che hanno soltanto come unico elemento di coesione l’avversione, l’odio nei confronti dei nazisti e dei fascisti che le hanno arrestate e spesso torturate, queste italiane trovano forza di reagire, di non lasciarsi andare, di resistere alla disumanizzazione. Imparano il numero a memoria, subito imparano gli ordini in tedesco e in polacco, imparano a muoversi, a difendersi, sviluppano le tecniche di sopravvivenza, si passano i consigli e le informazioni necessarie per non cadere nelle trappole delle corvées più pesanti o dei Kommando più faticosi, imparano a sfuggire alle sorveglianti, si stringono insieme, sviluppano un rapporto di grande solidarietà, tipico delle piccole minoranze, e non si lasciano schiacciare dal desiderio, peraltro molto forte di lasciarsi andare, di gettare la spugna. Nessuna di loro arriverà ad avere in campo un posto buono, un posto importante, ma, nonostante la loro condizione, resistono. C’è stata in quella situazione estrema una grande solidarietà. Hanno maturato nel lager una coscienza democratica. Altri cinque trasporti arrivano tra il novembre del ’44 e il gennaio del ’45, ma di quelli non abbiamo molte notizie. Questo è anche il periodo in cui nel lager ormai regna il caos; inizia la terza fase: Ravensbrück diventa campo di sterminio. Le anziane sono selezionate e mandate in un campo esterno per essere eliminate. Viene costruito un secondo forno crematorio e allestita la camera a gas. La popolazione femminile diminuisce sempre più: in marzo 149 all’appello risultano 37699 donne, a metà aprile solo 11.000. E mentre la macchine di morte funzionano a pieno ritmo, le SS vengono a patti con i vincitori, liberano le norvegesi, danesi, alcune francesi, poi le belghe e le olandesi. Il 26 aprile, ad eccezione di alcune centinaia di donne gravemente malate, le ultime deportate rimaste in lager (russe, jugoslave, ungheresi, italiane, polacche) nella notte devono affrontare l’evacuazione. Nessuna ha più la forza di gioire della liberazione dopo quegli ultimi giorni d’inferno. Ravensbrück è liberato il 30 aprile dai Russi. Dopo la liberazione, le italiane rimangono sul territorio tedesco per più di quattro mesi: lo Stato italiano, a differenza di tutti gli altri Stati europei, non si preoccupa di ricercare i deportati e tanto meno le deportate. TESTIMONIANZA DI UNA DEPORTATA FRANCESE SULLA CONDIZIONE DELLE DONNE INCINTE E DEI NEONATI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI Marie Josè Gombart de Lauwe è una deportata NN, “Notte e Nebbia” (categoria destinata a scomparire), del campo di Ravensbrück. A questo gruppo di donne, fu negata la possibilità di essere liberate dall’avvicinarsi delle armate sovietiche perché, essendo in isolamento, non avevano il diritto di partecipare ai Kommando di lavoro fuori dal campo. Ma una ditta, la Siemens, si era installata all’interno di questo. Marie Josè Gombart de Lauwe fu assunta in questa ditta e poi trasferita a Mauthausen insieme a molte altre NN e a madri con figli di cui il capo del campo voleva sbarazzarsi. Fortunatamente venne presto la liberazione. Marie testimonia di aver visto a Ravensbrück dei convogli di bambini con le 150 loro madri o più spesso da soli, bambini la cui unica colpa era stata di nascere ebrei o zingari, destinati alla camera a gas o utilizzati come cavie di esperimenti pseudomedici. I capi della polizia il 6 maggio 1943 avevano decretato che nei campi di concentramento femminili non dovevano esserci donne incinte, né parti. Ciononostante, diverse testimonianze attestano che nei campi dell’est molti neonati furono uccisi alla nascita a Ravensbrück. Le donne tedesche non ebree andavano a partorire nelle maternità all’esterno del campo. Negli altri casi, o i medici SS del Revier (infermeria del campo) procedevano a degli aborti, anche in casi di gravidanze avanzate, senza la minima norma igienica, oppure i neonati venivano strangolati o annegati appena nati. A Ravensbrück ci furono dei parti clandestini nei blocchi fino all’autunno del 1944, ma i bambini non avevano alcuna possibilità di sopravvivere. A partire dal settembre ‘44 (momento in cui la nostra testimone fu scelta per occuparsi dei neonati) la situazione cambiò: i neonati dovevano essere mantenuti in vita. Il Kinderzimmer, la camera dei bambini, era una piccola stanza situata in un blocco per le ammalate. I bambini erano molto sporchi perché potevano essere cambiati raramente. Assumevano in fretta l’aspetto di vecchi. Ogni giorno il loro numero aumentava perché numerosi convogli di donne e bambini arrivavano per l’evacuazione di campi e prigioni a causa dell’avanzata degli Alleati. In mezzo a loro si trovavano le donne incinte che partorivano in una stanzetta del Revier in condizioni disumane. I neonati venivano subito portati al Kinderzimmer, vestiti con un camicino, un pannolino ed avvolti in uno scialle. Avevano un solo pannolino di ricambio. Molte donne organizzavano la solidarietà nel campo raccogliendo stracci e panni per poter cambiare i neonati. Alcune madri cercavano di rubare un po’ di carbone dal lavoro perché il calore nella stanza era totalmente insufficiente. 151 Per le madri la vita quotidiana e la morte dei loro bambini furono atroci. La giornata iniziava molto presto con una poppata prima dell’appello. Quelle che non avevano latte, ed i casi erano molto frequenti vista la loro alimentazione, nutrivano i loro figli con una miscela di latte e semola, accettabile solo dai più grandi. Quasi tutti i bambini morivano però prima di raggiungere i tre mesi. La solidarietà nel campo aiutò a procurare nuove bottigliette da utilizzare come biberon e molte madri che avevano ancora latte dopo la morte dei loro bimbi allattavano altri neonati. Quando le madri morivano, le infermiere adottavano i loro bambini. Le nascite e le morti dei bambini erano annotate in un «Geburtenbuch», registro delle nascite. Alla liberazione, in base alla mortalità media e ai posti occupati dai neonati al Kinderzimmer la dr. Marie Josè Gombart de Lauwe dice di aver stimato più di 800 bambini nati e quasi tutti morti a Ravensbrück. La cifra, presa dal registro delle nascite, è di 509 nomi di madri che hanno partorito al campo dal 19 settembre 1944 al 22 aprile 1945. Ogni bambino riceveva un numero. La percentuale di mortalità era circa il 74,8% ma questa non rende conto di tutta la realtà, dal momento che 1/4 dei bambini è morto a Bergen Belsen, vero campo di sterminio, dove regnava il tifo e dove furono spedite le bocche inutili, le ammalate, le donne anziane, le madri e i bambini. Abbiamo la certezza di una grande partenza il 27 febbraio 1945. Abbiamo due testimonianze riguardo a questo convoglio. Significativo penso che sia quello di Liliane Rozemberg che aveva 11 anni ed era con sua madre e due fratellini: «Durante il convoglio, a causa dei bombardamenti siamo stati trasferiti su alcuni camion; la mamma era stata incaricata di spostare tutto quello che restava sui vagoni. È un particolare atroce. Quello che doveva trasferire erano dei cadaveri di bambini. Ha dovuto prendere questi cadaveri e chiuderli negli scatoloni, poi mettere questi ultimi su dei camion. Mi ricordo di altre donne, incinte, a quel punto sono salite sul camion, felici di potersi sedere su questi scatoloni, di cui ignoravano il contenuto». 152 IL LAVORO E LA FABBRICA NEL LAGER FEMMINILE All’inizio della guerra i prigionieri dei lager, oltre che alle necessità operative dei campi, sono anche adibiti al lavoro dalle SS e, pur essendo ancora pochi, cominciano ad essere considerati una vera e propria forza lavorativa da utilizzare nelle grandi industrie belliche. Nel 1942, allargate enormemente le zone di occupazione, caduto il sogno della guerra-lampo, costretta a lottare contro una sempre più tenace resistenza, la Germania ha bisogno di manodopera per sopperire ai bisogni di materiale bellico e propone nell’aprile un decreto legge per «modificare nella struttura i campi di concentramento già esistenti mediante un mutamento radicale dei loro compiti per ciò che si riferisce all’impiego dei detenuti, tenendo conto del fatto che l’aspetto più importante dei campi è destinato a diventare quello economico». Circa 300 industrie aderiscono a questo decreto e i campi diventano fonte inesauribile di manodopera da cui le ditte tedesche attingono schiavi. Per le donne non esiste un posto differenziato dagli uomini. Chiuse nel grande campo femminile di Ravensbrück, vivono in un mondo eterogeneo, differenti tra loro per estrazione sociale e per cultura, diverse per etnia e per lingua, ma come gli uomini segnate dallo stesso destino e dalla stessa sofferenza. Per i tedeschi infatti l’identità femminile è del tutto irrilevante: non c’è differenza per il prezzo che le SS chiedono alle ditte, così come non c’è differenza per il lavoro. I rappresentanti delle ditte entrano nel campo e contrattano con le SS il numero delle prigioniere che necessitano alla loro fabbrica, controllano sommariamente la salute fisica delle donne che sono fatte sfilare nude davanti a loro. Una volta stipulato il contratto, le «schiave» vengono avviate ai diversi sottocampi per essere più vicine alle fabbriche nelle quali lavoreranno. La sistemazione nei campi più piccoli, anche 153 se è quasi identica alla prima, crea un certo sollievo; non c’è più la torre del forno crematorio che minaccioso e terribile sovrasta il grande campo. Per la maggior parte saranno occupate nell’industria pesante, quindi è necessario abbiano mani e braccia forti e in grado di maneggiare lamiere d’acciaio e di lavorare il ferro. E così per i primi giorni vengono inviate a tagliare legna nei boschi vicini in modo che le mani e le braccia si abituino prima al lavoro ingrato che le attende. Chi è destinata ad usare attrezzi pesanti dovrà invece reggere sulle braccia un certo numero di mattoni per ore e se il fisico non reggerà, altre subentreranno a chi soccombe. Le donne non conoscono la lingua dei mestieri, non sono capaci di reggere gli attrezzi che vengono loro messi in mano, non ne conoscono l’uso, eppure devono cercare di capire che cosa viene loro assegnato. Occorre, se vogliono sopravvivere, cancellare il passato. Il lavoro, di solito, veniva suddiviso in due turni, uno diurno di 10 o 12 ore e l’altro notturno, sempre di 12 ore. Prima di uscire dal campo le donne dovevano sottostare all’appello, poi spesso occorreva camminare per cinque in perfetto allineamento per tre o quattro km sotto la neve o l’acqua, perché non sempre la fabbrica era vicina al sottocampo in cui erano rinchiuse le prigioniere. Malgrado tutto, queste donne sanno ritrovare la loro più completa umanità e malgrado sia per loro difficile capirsi per la diversità della lingua, riescono a coniare un linguaggio fatto di cenni e di parole astratte. Si forma in questi lager una società pregna di solidarietà e pian piano si afferma una voglia mai sopita di ribellarsi e si ricorre al sabotaggio. Una testimone racconta: «Il sabotaggio l’abbiamo fatto un po’ tutte per il gusto di farlo, per il gusto di andare contro la legge concentrazionaria. Si sabotavano le macchine rompendo un pe- 154 dale, o tirando via una vite, poi magari si nascondeva il pezzo. Una volta lo facevo io, magari due ore dopo lo faceva un’altra e così minimo erano sempre tre macchine ferme per turno». Se queste donne fossero state sorprese sarebbero state accusate di sabotaggio e per loro era morte certa, ma lassù la vita aveva poco valore. Nell’ultimo anno le fabbriche, con l’avanzare dell’Armata Rossa devono cessare a poco a poco la loro attività e perciò non vi è più alcuna necessità di operai, tuttavia nei grandi campi il flusso di arrivi non cessa. C’è perciò una massa di donne che non lavora ma costa, che non può essere lasciata chiusa nei blocchi, ma deve essere occupata e quanto più il lavoro sarà pesante, tanto più facilmente verranno eliminate. Il lavoro duro, la mancanza di sonno, la fame, la sporcizia, l’avitaminosi, il terrore annienta ben presto lo spirito e il fisico di queste donne e i monti di cadaveri davanti ai forni aumentano e l’aria diventa irrespirabile per il fetore. Nel solo campo di Ravensbrück furono immatricolate 125.000 donne e di esse 92.000 perirono. Eppure il grande cancello di accesso al campo era sovrastato dalla scritta «Arbeit macht frei», «il lavoro rende liberi». LE DONNE SLOVENE NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI La Jugoslavia è entrata nella Seconda Guerra Mondiale il 6 aprile 1941 quando i nazisti bombardarono Belgrado. La guerra è durata poco ed è stata seguita dall’occupazione di praticamente tutto il territorio jugoslavo. La Slovenia, la parte settentrionale della Jugoslavia, fu divisa fra tre occupanti: i tedeschi presero la parte settentrionale, gli ungheresi una piccola porzione della Jugoslavia panonica e gli italiani la parte centrale. 155 La Germania considerò il territorio sloveno come propria eredità storica, per cui vi organizzò un piano di genocidio. Si trattava di evacuare gli sloveni più consapevoli, di germanizzare quel poco di popolazione che sarebbe rimasta e di colonizzare con i tedeschi i territori così evacuati. I tedeschi non riuscirono a realizzare questo progetto a causa della rivolta armata delle nazioni jugoslave. Seguirono arresti di massa: arresti di tutti coloro che erano sospettati di approvare il movimento di liberazione. I trasporti degli attivisti arrestati, uomini e donne, venivano avviati ad Auschwitz. Erano gli agenti della Gestapo a scoprirli: quanto agli ungheresi, essi imitarono il modello tedesco deportando gli sloveni considerati pericolosi nei loro campi di concentramento. Dopo l’occupazione dell’Ungheria i treni dei trasporti partirono da lì anche per Auschwitz. Nella «provincia di Lubiana» la resistenza fu molto assidua e così furono anche le razzie poliziesche. I trasporti partivano per Gonars, Treviso e altri campi. Le donne venivano evacuate per lo più nelle prigioni: a Venezia e alla Risiera di San Sabba a Trieste. Dopo la capitolazione dell’Italia le donne così imprigionate furono trasportate dai tedeschi nel campo di Ravensbrück. Dal mese di giugno 1941 al gennaio 1945 sono state deportate circa 4.300 donne slovene: 1700 ad Auschwitz e Birkenau, poco più di 2000 a Ravensbrück. Tutte le prigioniere erano deportate politiche e portavano il triangolo rosso. Prima del trasporto avevano passato qualche tempo in prigione, dove avevano affrontato interrogatori dolorosi e la salute della maggior parte era stata intaccata. Il tifo le uccise in gran numero. Nei campi le donne venivano private della loro dignità femminile: costrette a sfilare nude davanti alle SS armate e davanti ai medici SS. Costrette a fare i bisogni in loro presenza, sofferenti 156 per i loro bambini «rubati», spaventate dagli esperimenti di sterilizzazione, dopo i quali non avrebbero più potuto partorire. Le slovene si opponevano a questo con tutte le forze. Le dava coraggio una forte fiducia nell’imminenza della vittoria alleata. Le univa una solidarietà senza limiti e i legami con l’organizzazione internazionale di resistenza interna al campo rappresentavano per loro un grande sostegno. Nei sottocampi, i cui mezzi e le forze dell’organizzazione non giungevano, le sostenevano le precedenti esperienze di lavoro clandestino. Le poche slovene che lavoravano negli uffici del campo, o in altri posti di maggiore rilevanza facevano di tutto per alleviare la vita delle prigioniere. Dovunque era possibile cercavano di resistere a quelle circostanze avverse con l’attività culturale. Non una sola slovena ha posto termine alla propria vita con un suicidio sui fili. GLI ASSASSINII CON IL GAS NEL CAMPO DI RAVENSBRÜCK Gli assassinii di stato per mezzo di gas tossici nel III Reich dal 1939 al 1945 sono conosciuti come il crimine specifico dei nazisti. A Ravensbrück dal 1939 al 1945 vi furono imprigionate da 110.000 a 120.000 donne di ogni nazionalità, spesso solo temporaneamente, in attesa di ripartire per destinazioni più lontane, in Kommando esterni. Ravensbrück era un campo di livello 1 cioè sottomesso ad un regime paragonabile a quello di Buchenwald e Dachau, molto meno micidiale di quello dei campi di livello 3 come Mauthausen e Auschwitz. A Ravensbrück, gli omicidi con il gas furono molto più limitati, circa 10.000 vittime in tutto: da un lato le donne «pazze» poi in due brevi serie le donne malate, quelle sfinite, le anziane e le ebree. 157 La prima serie nel 1941-42 fece circa 1.600 vittime e la seconda all’inizio del 1945, 6.000. Le pazze erano rinchiuse nude in una stanzetta con il numero dipinto in viola sulla schiena. Periodicamente, quando arrivavano ad essere 50 o 60 venivano portate di notte fuori del campo, e uccise nella piccola camera a gas dello stabilimento psichiatrico del castello di Hartheim, in Austria dove venivano gassati i malati civili del Reich. Alla fine del 1941 e all’inizio del 1942, a Ravensbrück la selezione e le esecuzioni coinvolsero un ventaglio di donne molto più ampio, non più limitato alle malate mentali. Himmler, aveva deciso di includere i suoi campi nell’Aktion T4 che consisteva nella selezione e soppressione di numerosi malati di mente degli ospedali psichiatrici del Reich. Queste vittime civili erano liquidate in piccole camere a gas installate in sei grandi ospedali psichiatrici e istituti di eutanasia. Il castello di Hertheim, era uno di questi istituti. Il gas utilizzato era l’ossido di carbonio. I medici psichiatrici furono inviati ad andare a fare il loro lavoro di smistamento nei campi di concentramento. Questa nuova Aktion portava il nome in codice di Aktion 14f13. Himmler esigeva 2.000 vittime per campo. A Ravensbrück, dove alla fine del 1941 c’erano solo circa 8.000 donne, il medico psichiatrico scelto per fare la selezione delle detenute da sopprimere ignorava che la centrale di Berlino aveva richiesto 2.000 vittime per campo e fu sorpreso quando gli fu imposta questa cifra, dal momento che aveva trovato solo 259 donne affette da disturbi mentali che comparivano sul formulario che gli era stato dato: «minorate mentali», «epilettiche», «invalide», «incurabili», «incontinenti». Egli aggiunse tranquillamente le tubercolotiche, le sifilitiche e, per raggiungere il numero, numerose ebree. Visto che la guerra all’est si prolungava, l’Aktion 14f13 fu interrotta nell’aprile 1943 per la richiesta di nuova manodopera. 158 Solo le malate di mente continuarono ad essere soppresse. Da questa data numerosi furono i trasporti di donne e bambine che da Ravensbrück raggiungevano altri campi. Nell’estate del 1944 i campi sono sovrappopolati e a Ravensbrück si diffonde il disordine, la liberazione sembra vicina, la vigilanza delle prigioniere si allenta. Dal gennaio del 1945 numerose furono le selezioni generali nelle quali le donne dovettero passare davanti al gruppo delle autorità del campo, il comandante, il Lagerfuhrer, i medici SS e la capo infermiera. Alla fine di ogni selezione, la «misera colonna del camino», come venivano chiamate le selezionate, si avviava verso lo Jugendlager dove venivano uccise. La sorvegliante dello Jugendlager, Ruth Meudeck, di 22 anni, saliva sui camion con le due infermiere SS che vi gettavano sopra le donne. Queste erano scaricate al crematorio. C’erano gli uccisori a dare il cambio. Erano sei o sette SS venute espressamente da Auschwitz. Il capitano SS di Ravensbrück, Schwarzuber ha dichiarato al suo processo che era stata allestita una piccola camera a gas in una baracca degli attrezzi che si trovava a pochi metri dall’edificio del crematorio e che poteva contenere 150 persone. La gasazione si faceva con il Cyclon B, che era riversato nella camera a gas da un buco del tetto. Questo veleno era acido cianidrico fissato su alcune pietre porose contenute in barattoli metallici. Con il calore il gas si liberava. I corpi gassati venivano poi bruciati. Da alcune testimonianze sappiamo che a Ravensbrück era stata installata un’altra camera a gas, costruita in muratura, nuova e moderna, dai segnali acustici e ottici, fatta poi saltare all’inizio di aprile dalle SS. Questa camera a gas era doppia, aveva una sala dove si spogliavano le vittime, il disimpegno in cui dovevano passare, la sala di dissezione per i medici ed il piano inclinato per far scivolare i corpi in uscita. 159 Era situata all’esterno del campo, lungo il muro nord, dietro il Revier ed aveva il nome mimetizzato di «neue Wascherei» (nuova lavanderia). COME LE SS TRATTAVANO LE DONNE Testimonianza delle superstiti del gruppo di Rodi Quattro giovani donne, di nome Laura Hasson, Sara Benatar, Anna Cohem, e Giovanna Hasson hanno testimoniato la loro storia di donne ebree del gruppo di Rodi. Narrarono che il 20 e 21 luglio 1944 i tedeschi ordinarono a tutti gli uomini e donne ebree di presentarsi presso il Kommando tedesco: se uno solo non si fosse presentato tutti gli appartenenti alla razza ebraica sarebbero stati fucilati. Furono arrestati, sequestrati tutti gli oggetti di lavoro che erano stati fatti portare e poi imbarcati in piccole navi, chiusi nelle stive da carbone. Da Rodi al Pireo furono dieci giorni di viaggio, per i primi tre dei quali non fu dato loro da mangiare, poi vennero condotti ad Haydar dove furono separati gli uomini dalle donne. Queste ultime furono interamente e brutalmente denudate, a scopo di perquisizione, dai soldati della SS; si cercò se su di loro fossero nascosti oro o gioielli. Al minimo cenno di pudore esse venivano schiaffeggiate e fustigate sul viso. Spesso succedeva che se chiedevano qualcosa da mangiare ai soldati SS questi rispondevano che sarebbe stato possibile solo se fossero andate a letto con loro. Da Haydar furono condotte ad Atene poi partirono per Auschwitz (Polonia). Il viaggio si compì per ferrovia, in carro di bestiame, 70 persone (uomini e donne) in ogni vagone. Durante il viaggio, durato 15 giorni, fu loro permesso di scendere dal vagone solo tre o quattro volte. 160 Giunti ad Auschwitz, i medici SS procedettero alla selezione: i giovani in grado di lavorare da una parte, i vecchi, i bambini, e le donne con i bambini in braccio dall’altra. Il secondo gruppo fu condotto altrove e poi soppresso. Le donne ritenute idonee a lavorare furono condotte in una sporchissima baracca, dovettero svestirsi in presenza di tutti gli altri prigionieri e delle SS. Poterono prendere con sé solo un pezzo di sapone e lo spazzolino per i denti. Dopo essere state denudate, furono condotte in un’altra stanza e completamente rasate (non solo la testa, ma tutte le parti ricoperte da peli). In una stanza successiva furono disinfettate con uno straccio imbevuto di petrolio, molto irritante. Fecero una brevissima doccia, ma non furono dati loro asciugamani. Ebbero poi una veste stracciata, senza che fosse fatto alcun tentativo di conciliare l’ampiezza della veste con la corporatura. Non fu data loro biancheria. Ai piedi gli zoccoli di legno. Rimasero ad Auschwitz due mesi e mezzo. Ogni mattina dovevano stare, per molte ore, in ginocchio per terra con le braccia alzate in mezzo alla strada del blocco. I lavori che erano costrette a fare erano di facchinaggio: trasporto di tegole, di barili… Era vietato qualunque contatto tra internati di campi diversi anche se contigui; vietato soccorrersi o confortarsi a vicenda. Ed ecco l’alimentazione: al mattino c’erano solo due bidoni di caffè per 800 persone, cosicché pochissimi riuscivano a prenderne. A mezzogiorno v’era una specie d’appello per poter distribuire la zuppa. Il rancio arrivava alle ore più disparate, dalle nove del mattino alle cinque del pomeriggio, quindi non sapevano mai a che ora sarebbe avvenuta la distribuzione. Ogni cinque persone veniva data una gamella con un litro di minestra. Nessuno aveva un cucchiaio e così dovevano bere nella stessa ciotola, a sorsi. La zuppa era talmente disgustosa che 161 i primi giorni molte donne non mangiarono. Tutte le donne sopravvissute ad Auschwitz che lavoravano in cucina hanno affermato che una dottoressa SS metteva nelle caldaie un prodotto chimico, che dava alla zuppa un sapore acidulo e provocava nella bocca e poi nello stomaco e nelle visceri un vivo senso di bruciore, prurito esterno al ventre, gonfiore e macchiette rosse, che avevano l’apparenza di piccole abrasioni rettilinee. A tutte si manifestò un arresto immediato delle mestruazioni. Cercarono di sottrarsi perciò a questo tentativo di sterilizzazione operato da parte dei medici SS a scopo di esperimento, mangiando la minor possibile quantità di minestra, preferendo piuttosto alimentarsi di patate crude che riuscivano a sottrarre ai carri che le portavano in cucina. Le malattie più comuni nel lager erano: diarrea e dissenteria, in forme gravissime e spesso mortali. Quasi tutte avevano la bocca piena di sfoghi e la lingua crepata e solcata da tagli profondi, che impedivano perfino di mangiare. Tutte le donne sopravvissute sono concordi nel dichiarare che ciò era provocato dai prodotti chimici che venivano messi nella zuppa, perché mai in altri campi di concentramento il fenomeno si ripeté, per quanto malnutrite fossero. Nessun altro esperimento fu fatto su di loro. In tutto il loro periodo di prigionia furono loro tagliati completamente i capelli una sola volta. Le donne riuscivano però a tenersi più o meno pulite perché acquistavano il sapone, in cambio di pane, dagli uomini, i quali perciò erano molto più sporchi e pieni di pidocchi. Lasciarono la Polonia per essere condotte in Germania nel lager 2 e per vagare per diversi mesi in numerosi altri lager nei quali le condizioni di igiene, alimentazione, lavoro erano molto peggiori: «era un vero e proprio inferno». Dopodiché si misero in viaggio per Dachau, in carri bestiame e carri merci scoperti. Durante questo viaggio il convoglio fu più volte mitragliato e bombardato. 162 Riuscirono, aiutate dagli uomini, a gettarsi giù dal treno e a fuggire per la campagna. La maggioranza però fu ripresa dai tedeschi, morì per i mitragliamenti, o, scesa dal treno, restò agonizzante per debolezza estrema, sulle rotaie. Non appena una parte degli internati rimontò sul treno, questo ripartì all’improvviso, schiacciando tutti coloro che giacevano boccheggianti sulle rotaie. Il convoglio arrivò a Dachau il 28 aprile e le donne furono ricoverate in quel Lager che era sempre stato per soli uomini. Il giorno dopo il campo fu liberato dalle truppe americane. Le torture di queste uniche superstiti del gruppo di Rodi erano finite. ESPERIMENTI MEDICI DELLE SS Amputazioni e trapianti di arti in condizioni assurde. Iniezioni di pus nelle gambe e nelle mammelle delle partigiane polacche per “studiare” gli effetti dei sulfamidici. Acqua marina data da bere agli zingari per “sperimentare” la resistenza alla sete. Prigionieri lasciati per ore dentro vasche di ghiaccio per osservare gli effetti del freddo sull’organismo. Esperimenti medici questi? Secondo le SS sì. I medici che li eseguivano (poco più di un centinaio, rispetto ai 150.000 medici tedeschi “borghesi”) credevano nell’importanza che essi avrebbero avuto per la medicina del domani. Le vittime di questi esperimenti di una crudeltà inimmaginabile furono migliaia e migliaia di prigionieri di ogni parte d’Europa (gli ebrei ne furono solitamente esclusi perché “non degni”), alcuni dei quali considerati volontari, solo perché ingannevolmente coinvolti dietro la vaga promessa di un tozzo 163 di pane in più o di una liberazione che non avvenne mai. Di questi, i pochi sopravvissuti testimoniano tuttora con i loro corpi martoriati gli orrori subiti. Quelle sofferenze non servirono a nulla: è questa forse la conclusione più amara. ESPERIMENTI AD AUSCHWITZ E RAVENSBRÜCK SULLE DONNE Ad Auschwitz uno dei più grandi “esperti” del campo, il professor Clauberg ha inventato un nuovo metodo per sterilizzare le donne senza sottoporle ad intervento chirurgico o all’azione dei raggi X. Pratica una spruzzatina di un liquido sterilizzante, forse a base di nitrato d’argento commisto ad una sostanza radiologica di contrasto. A tutte le donne, infatti, dopo la sterilizzazione veniva praticata una radiografia. Questa “spruzzatina” viene operata direttamente sul cono dell’utero, nel corso di una visita ginecologica apparentemente innocua. Questo metodo provoca dolori intensissimi ed emorragie diffuse ai genitali. Le detenute urlano come dannate. Una volta scese dal lettino dove hanno subito il piccolo intervento sterilizzante, le donne, sotto la minaccia di venire uccise all’istante, debbono camminare diritte e uscire cantando dalla baracca. Hanno l’ordine categorico di non parlare di quanto accaduto con le compagne. Il giorno seguente, sempre perdendo sangue, queste donne sono costrette ad essere presenti agli appelli, ciascuno dei quali dura due-tre ore, all’alba e al tramonto e durante i quali sono obbligate a rimanere in piedi. Molte muoiono e vengono subito cremate. Le più gravi prima di partire, presagendo il loro destino, cer- 164 cano di lasciare qualche messaggio o almeno il loro nome alle compagne anziane e a quelle che non dovranno essere sterilizzate. Altre riusciranno a sopravvivere e lasceranno testimonianze allucinanti. Chopfemberg Chama, nata il 10 maggio 1907 a Varsavia, residente a Parigi, deportata dal 21 luglio 1943 con matricola 50344: “Il professor Clauberg mi sottopose a quattro iniezioni, a due prove del sangue e a diversi altri esperimenti al basso ventre, soprattutto all’utero. Non so dire che cosa mi sia stato fatto, perché mi bendavano gli occhi e mi minacciavano di uccidermi all’istante se avessi gridato. Nonostante dolori intensissimi, dopo ogni esperimento dovevo andare cantando al lavoro, col sorriso sulle labbra”. Bemguigli Fortunè, nata il 30 aprile 1904, abitante in Algeria, deportata dal 31 luglio 1943 con matricola 62301: “Senza anestesia, il professor Clauberg mi praticò ripetute iniezioni molto dolorose. Durante questa pratica mi tenevano ferma per le mani e i piedi e mi tappavano la bocca. Dopo le iniezioni sopravvennero dolori terribili al basso ventre, e rimasi nel letto quasi priva di conoscenza...”. Pleskoff Louise, nata il 5 ottobre 1907, residente a Seine, deportata dal 31 luglio con matricola 52338: “Le ovaie venivano bruciate da un liquido acre iniettato nell’utero. Insorgevano dolori tremendi che procuravano a Clauberg grande piacere. Da allora soffro al basso ventre e ai reni. Il ciclo mestruale non si è più normalizzato, le mie condizioni generali sono pessime”. Il metodo di Clauberg è senz’altro doloroso e per indurre una sterilizzazione definitiva deve essere praticato tre volte. Clauberg sembra provare un vero e proprio piacere sadico quando sente le donne urlare. Ma ad Auschwitz gli esperimenti di sterilizzazione non vengono condotti soltanto con il metodo ideato da Clauberg. Questo mostrava numerosi inconvenienti: i medici SS devono trattare 165 numerosissime detenute che presentavano gravi infezioni. C’è una sezione nella quale la sterilizzazione viene praticata con i raggi X. Le cellule germinative sono particolarmente sensibili ai raggi X. Basta infatti un’esposizione relativamente breve delle ovaie ai raggi X per rendere una donna sterile. Le dosi devono essere però sufficientemente forti affinché la funzione riproduttiva non sia bloccata solo temporaneamente. Per assicurare una sterilizzazione totale sono necessari 300350 r. Queste dosi naturalmente portarono alle donne reazioni collaterali, rappresentate da scomparsa di mestruazioni, disturbi metabolici, psichici, caduta di peli e capelli, ustioni cutanee. Ma ai medici SS poco importa: l’obbiettivo finale è raggiunto. Un altro esperimento praticato sempre ad Auschwitz è quello per rallentare l’evoluzione del cancro e degli stadi precancerosi del collo uterino. Ad ogni detenuta sospetta vengono fatti numerosi esami istologici e del sangue, radiografie e esami citologici della secrezione vaginale. Ad ognuna di esse poi, senza criteri ben precisi, verrà asportato il collo dell’utero. Altri chirurghi si “divertono” a provocare aborti al sesto-settimo mese di gravidanza e a praticare esperimenti per l’innesto di tessuto testicolare nelle donne. A Ravensbrück con l’aiuto di controlli radiografici si effettuano esperimenti mediante: frattura delle ossa, prelievo di tessuto osseo sano o precedentemente infettato, innesto di tessuto sano o infettato. Per quanto riguarda le ricerche sulle fratture ossee, i medici SS fratturano con uno o più colpi di martello le ossa delle gambe della paziente. Riuniscono poi i frammenti ossei all’osso cui appartengono. Per quanto invece riguarda i prelievi di tessuto osseo, questi vengono eseguiti secondo il metodo abituale, solo che non di rado vengono asportati per esempio interi frammenti ossei dal perone. 166 Ben presto le donne si rendono conto che quelle che vanno al Revier sono sottoposte a strane operazioni e che è difficile tornare alla baracca vive o totalmente sane. Le donne selezionate per gli esperimenti vengono ingannate: viene detto loro che non andranno al Revier ma solamente a lavorare in una fabbrica. Quelle che si ribellano vengono picchiate o direttamente gassate. Così testimonia una donna polacca sopravvissuta agli esperimenti scientifici nel lager di Ravensbrück: A quindici anni divenni membro del movimento di resistenza. Fui arrestata dalla Gestapo ed assegnata al campo di concentramento di Ravensbrück quando avevo sedici anni. A venti fui liberata dal campo. Quando giungemmo al campo di concentramento ci rasarono i capelli fino alla cute. Eravamo completamente calve. Pensavo: cosa sembrerò senza capelli, quando sarò libera? Cosa penseranno di me? Cinque anni dopo sono tornata con una treccia che mi arrivava alla vita. Tutti, eravamo condannati a morte. Non potevamo lasciare il Lager per il lavoro coatto. Eravamo NN, il nostro destino era la morte. Quando, prima del mio arresto, mio padre mi parlava della fame, non riuscivo ad immaginarmi di che cosa parlasse… Solo durante la mia prigionia nel Lager ho capito cosa era la fame ed ho capito anche cosa significa sognare pane. Questo era il nostro più gran desiderio e il nostro sogno più bello. Mi ricordo che una volta ho giurato a me stessa di conservare un pezzo di pane per un’amica che festeggiava il suo onomastico: era un sacrificio vero e proprio, ma lo feci per il bene della mia famiglia in Polonia, perché avevo sentito dire che tutti gli abitanti del distretto di Zamo venivano scacciati dalle loro case e deportati. Così ho pensato che se facevo questo sacrificio e non mangiavo la mia fetta di pane, dandola invece alla mia amica che soffriva la fame ancora più di me, forse questo sarebbe stato di aiuto ai miei… Non sapevo dove nascondere quel pezzo di pane. Avevo paura di lasciarlo nello scaffale in cui custodivamo le nostre gamelle scheggiate. Lì me l’avreb- 167 bero rubato subito. Di giorno nascondevamo il pane nelle borse di stoffa che portavamo attaccate alla cintura. Ma di notte? Pensavo che la cosa migliore sarebbe stata nasconderla sotto il mio pagliericcio. Ma avevo paura di mangiarlo durante la notte, incapace di dominare la mia fame… non ho dormito tutta la notte… Il pane aveva un così buono odore… Questo terribile pane di segatura… Sognavo di addentare il pane e di addormentarmi con la bocca piena di pane… Ma avevo promesso di resistere a questo pane per il bene della mia famiglia. E così non ho dormito tutta la notte. Soffrivo solo… E finalmente, quando alle quattro di mattina la sirena ululò, afferrai quel pezzetto di pane e corsi dalla mia amica per darglielo. Glielo gettai, quasi odiandola, ed esclamai: «Ecco, per la tua festa!» E subito mi precipitai via perché avevo paura che me lo sarei ripreso e l’avrei mangiato con lei. Era il giorno del mio patrono, l’8 maggio, Stanislao, il mio onomastico. Quando andai al lavoro quel giorno incontrai la nostra «piccola madre» del campo, la signora Lieberach. Mi diede cinque patate come regalo per la mia festa. Cinque patate, un dono da re nel Lager! Allora seppi che era la ricompensa per quello che avevo fatto. E forse, pensai, era un segno che la mia famiglia sarebbe sopravvissuta alla guerra… La vita normale mi sembrava una fiaba. L’aria libera e la natura mi mancavano tanto. Il Lager era circondato da alte mura e non potevamo vedere altro che il cielo e le cime degli alberi. Quello che vedevamo in realtà erano i camini dei crematori, dove la gente bruciava ed i loro corpi puzzavano. Sentivamo moltissimo la mancanza della natura, era altrettanto duro che patire la fame. Quando la BBC diffuse per la prima volta nelle sue trasmissioni per l’Europa notizie su operazioni ed esperimenti su detenute a Ravensbrück, vi fu una serie di perquisizioni nelle nostre baracche. È un fatto che queste notizie erano state trasmesse all’esterno da nostre compagne. Tutti seppero la verità su Ravensbrück e conobbero i nomi delle vittime. 168 Krystyna Czyc e Wanda Wojtasik trasmisero le notizie alla organizzazione clandestina in Polonia e da qui furono trasmesse per radio a Londra. Queste notizie pericolose venivano scritte dalle ragazze sulle cartoline postali che ognuna di noi poteva spedire a casa una volta al mese. Erano scritte tra le righe con un liquido invisibile di urina o di succo di cipolla. Naturalmente tutte le cartoline del Lager passavano la censura delle SS. Ma i nostri uomini del movimento di resistenza sapevano come trattare queste scritture per renderle visibili e leggibili. E qualche volta riuscivamo perfino a nascondere una lettera normale in una busta. La brigata femminile, che lavorava all’esterno del Lager, prendeva in consegna queste lettere. Così per esempio, quelle che lavoravano nel bosco davano le lettere alla guardia forestale, che le spediva ai vari indirizzi. Le selezionate per gli esperimenti erano solo ragazze giovani. Scolare e studentesse giovani. Arrivò tutta una serie di uomini SS e ci visitarono in un modo strano… guardavano le nostre mani e le nostre gambe… Ci fecero alzare le gonne… Ci osservarono attentamente… E dopo l’operazione venne Himmler in persona. Eravamo legate al tavolo e le nostre gambe non erano fasciate, in modo che si vedevano le ferite. Coprirono le nostre facce con coperte. Non volevamo essere operate. Chiedevamo che le nostre condanne a morte fossero eseguite, ma negavamo loro il diritto di operarci. Ma Himmler rispose che la cosa non era di sua competenza e di rivolgerci al comandante del campo. Ci rivolgemmo allora al comandante, che rispose:«Operazioni chirurgiche nel Lager? Non ne ho mai sentito parlare. Chi lo ha detto?» Disse che il nostro blocco violava le disposizioni, che noi eravamo le caporione e dovevamo essere punite. Se mai il fatto si fosse ripetuto, una su dieci di noi sarebbe stata immediatamente fucilata. E dieci furono scelte e gettate nella prigione del Lager. Furono operate là e come punizione le loro gambe non vennero lavate prima dell’operazione. Succedeva spesso che ci addormentavamo prima di un’operazione e che poi sopravveniva un contrattempo e allora quel giorno nessun 169 medico veniva nel lager per eseguire l’operazione, un giorno dopo l’altro, finché venni infine operata. Mi hanno ingessato le gambe. Mi sono svegliata nella stanza delle pazze. C’era una stanza in cui finestre e porte erano sempre sprangate… Queste malate mentali venivano operate alla colonna vertebrale, tagliavano loro le gambe. Subito dopo le liquidavano. Ho sofferto questo martirio per quattro o cinque giorni… senza poter dormire un solo istante. Non potevo pregare. Assolutamente. Dio non esisteva, altrimenti non avrebbe permesso tutto questo. Solo cinque o sei giorni dopo hanno permesso che venisse da me un’infermiera. Avevo un’infezione terribile, quando mi hanno portato via dalla stanza delle matte. È stato un miracolo che non sono stata liquidata insieme a loro. Nessuna di loro è sopravvissuta. Tutte le detenute operate dovevano venire fucilate all’uscita dall’ospedale. Su 74 donne polacche operate nel KL Ravensbrück per sperimentazioni, fino alla primavera del 1945 ne sopravvissero 61. (Dagli atti del processo dei medici di Norimberga) Io personalmente non andai al processo a Norimberga. A Norimberga i medici si difesero da soli. Dicevano che eravamo condannate a morte e saremmo state giustiziate comunque. E quindi, dissero, avrebbero tentato esperimenti che sarebbero stati utili per l’umanità. Ma quando videro le gambe di alcune «cavie» i loro difensori capitolarono. Dovettero rinunciare. E non posero domande ai testimoni. La categoria speciale di prigioniere su cui venivano compiute operazioni chirurgiche ed esperimenti cominciavano dal n° 5.000. Venivano designate nel Lager col nome polacco di “Krouki” che significava cavie umane. La loro baracca designata con la sigla NN (Nacht und Nebel = notte e nebbia). Questa sigla segreta compare nei documenti della Gestapo e delle SS accanto al nome di persone che dovevano essere eliminate e sulla cui sorte nessuno doveva sapere nulla. 170 Dovevano scomparire dalla faccia della terra e ogni loro traccia essere cancellata. Dovevano scomparire nella notte e nella nebbia. 171 I BAMBINI EBREI NELL’EUROPA OCCUPATA DAI NAZISTI Enrica Della Martira LE PRIME RESTRIZIONI Verso la fine degli anni Trenta, quando le nazioni europee assunsero posizioni sempre più bellicose, i giovani, «gentili» ed ebrei di tutta l’Europa, furono soggetti alle restrizioni dovute alle fasi preliminari e poi alla guerra che seguì. Ovviamente, tutti risentirono di quella situazione: il concetto stesso di un vero, tangibile nemico umano, il razionamento, i bombardamenti, l’effettiva presenza di truppe nemiche portavano tutta la popolazione a provare un senso di angoscia, smarrimento, paura. I giovani ebrei, come i gentili loro coetanei, assistettero a sconvolgimenti e orrori; ma oltre a tutto ciò, e affatto separato da questo, i primi iniziarono a sperimentare un proprio incubo personale. L’accerchiamento degli israeliti ebbe inizio con una definizione legale stabilita dai nazisti sulla base di un concetto di razza piuttosto che di religione; infatti, secondo l’ideologia nazionalsocialista, il giudaismo si ereditava dai genitori e dai nonni. Questo però non alterò particolarmente la vita dei giovani; fu invece la seconda ondata di restrizioni a infrangere la loro serenità e incoscienza. Il primo e più violento trauma fu l’espulsione degli studenti ebrei dalle scuole statali o finanziate dallo Stato poiché frequentare la scuola era la loro basilare norma sociale, l’attività fissa del mondo cui appartenevano. La violenta separazione dalla comunità condivisa con amici di fede diversa sollevò due distinte ma ovviamente collegate serie di problemi, e suscitò reazioni da due versanti. La risposta immediata fu il contraccolpo all’ostracismo e all’espulsione: improvvisamente, da una settimana all’altra, una struttura fondamentale della loro esperien- 172 za era crollata (e crollata solo per loro). La seconda reazione ebbe al centro la questione dell’identità ebraica. Molti giovani, per la prima volta nella loro vita, dovettero confrontarsi con il concetto di cosa significava essere ebrei, per se stessi e per la società di cui facevano parte. Non avevano scelta, dovevano accettare di essere stati espulsi dalla scuola unicamente perché ebrei. In molte città europee erano già operanti scuole elementari ebraiche ma quasi nulla esisteva a livello superiore. Per sopperire a questa necessità, un certo numero di comunità organizzarono allora scuole per i loro giovani assumendo insegnanti e professori universitari che avevano perso il posto in seguito alle leggi razziali. Gli studenti che sopravvissero alla guerra ricordano questa esperienza scolastica con affetto e con la sensazione di totale appartenenza a quell’ambiente; si sentivano a proprio agio l’uno con l’altro poiché c’era un ambiente piacevole e avevano ottimi insegnanti, non erano sottoposti a fenomeni di discriminazione e apparentemente la loro vita scorreva in modo normale. Comunque nell’interregno tra il primo stadio del triplice sistema repressivo (l’espulsione dalle scuole) e l’ultimo (la stella o gli editti che resero impossibile vivere normalmente), i giovani ebrei furono oggetto di un più o meno graduale processo di segregazione sociale. La politica pubblica di antisemitismo sconfinò nello spazio privato del loro stesso quotidiano sotto forma di discriminazioni personali da parte di precedenti amici e compagni; ragazzi ebrei che erano stati in relazioni amichevoli, o addirittura intimi amici, con coetanei di diversa fede si videro rifiutati, disprezzati. Per loro non si trattò quindi di una misura politica, una legge approvata da altri o un editto pubblicato dai giornali, bensì di un fatto personale. Assoggettati a questo sistema di segregazione, isolamento, ostracismo e umiliazione, l’imposizione della stella non rappresentò un evento inatteso né fu eccessivamente traumatico come può sembrare in retrospettiva. Di fatto, per molti di loro portare 173 la stella non rivestì in sé alcun significato simbolico negativo; non erano abbastanza adulti da capire che essere marchiati in quel modo significava la trasformazione da membri della comunità in stranieri. In ogni caso è indubbio che la stella portò un enorme cambiamento nella vita dei giovani. A preoccuparli non fu tanto il fatto di essere marchiati, quanto il potenziale pericolo fisico che poteva derivarne. E proprio quelle conseguenze fecero sì che molti giovani arrivassero a sentirsi terrorizzati: camminando per strada cercavano di nascondere la stella come potevano per paura di essere bersagli di scherzi e cattiverie. La serie di editti e regolamenti che oppressero e mortificarono la popolazione ebrea, condizionandone anche la più insignificante azione in ogni ambito della normale vita sociale, non risparmiò nemmeno i più giovani. Via via, le normali attività quotidiane si ridussero, così come i parametri del loro ambiente fisico. Diversamente dalla stella paventata per le sue conseguenze, l’insieme dei divieti comportò all’inizio che i ragazzi non potessero più andare al parco o allo zoo, in una gelateria oppure al cinema, al museo o in biblioteca. Né erano bene accetti come tifosi di sport; fu loro infatti vietato di assistere a eventi sportivi, revocato il diritto di usufruire di attrezzature pubbliche come piscine o campi da tennis. Spostarsi su mezzi pubblici, per un motivo qualunque o per recarsi ad attività consentite, si fece sempre più problematico; solo le biciclette erano ammesse, anzi approvate, e in metropolitana o in tram potevano occupare solo l’ultima carrozza. Viaggiare era comunque permesso solo in date ore del giorno, e più tardi fu vietato del tutto. Il loro universo diventò sempre più angusto; venne introdotto il coprifuoco, vietate le visite tra gentili e ebrei. Amici ebrei furono deportati o scomparvero. All’aperto, non vi era luogo dove i giovani potessero andare, né attività consentita all’esterno; restò loro soltanto la propria casa, il giardino o il cortile. Ma ancora avevano case, giardini e cortili. Nel primo periodo della guerra contro gli ebrei, i giovani poterono conservare la 174 propria casa, contare sulla famiglia, su amici non ebrei rimasti fedeli e sui compagni ebrei. Poi, giunse il momento della partenza, per andare a nascondersi, espatriare come profugo, trasferirsi nel ghetto, essere deportato. NASCOSTI Gli accordi per trovare un nascondiglio potevano essere stabiliti in due modi: informalmente, attraverso famiglie o reti di amici, oppure con l’aiuto di una delle tante organizzazioni. Vi era anche una terza, rara, possibilità, ossia che, indipendentemente da ogni accordo e organizzazione, un ragazzo riuscisse da solo a trovare un luogo dove nascondersi. Ognuna di queste soluzioni era precaria, non esisteva alcuna garanzia, ma nascondersi da solo, cavarsela da solo, fu sotto molti aspetti la meno sicura di tutte. Nella maggior parte dei casi, i bambini non erano in grado di agire autonomamente, dunque furono altri a decidere per loro. In genere, la soluzione veniva raggiunta attraverso contatti informali. Avere contatti «informali» significava che i genitori avrebbero chiesto a un amico o a un familiare imparentato per matrimonio con un gentile se questi era disponibile a nascondere, o aiutare a nascondere, la loro famiglia. Di norma il gruppo familiare veniva suddiviso in nascondigli diversi; qualcuno scelse volontariamente questa soluzione per ridurre il rischio di totale annientamento. Tuttavia i più si arresero all’impossibilità di restare tutti uniti, poiché più elevato era il numero delle persone nascoste, più alto era il rischio e più oneroso il compito. Inoltre, le famiglie dovettero smembrarsi perché esistevano maggiori opportunità per i più giovani piuttosto che per i genitori. Spesso li si faceva passare per parenti venuti ad abitare da loro, o per orfani di guerra provenienti da città bombardate e da zone evacuate. Comunque sia, l’inevitabile conclusione di queste considerazioni pratiche e logiche faceva sì che un bambino si trovasse solo, separato dalla famiglia. 175 Vi furono occasioni in cui reti politiche agirono come vere e proprie organizzazioni per porre in salvo i giovani. Il termine «organizzazione» può essere sviante; nel contesto della guerra e delle attività di resistenza significò essenzialmente trovare un luogo sicuro per i giovani attraverso una rete o un sistema di assistenza invece che grazie ad accomodamenti privati con famiglie di conoscenti o amici. Talvolta queste «organizzazioni» nacquero per iniziativa di singole persone o di una famiglia, come quella dei Boogaard, che costruì una propria rete nell’area di Haarlemmermeer in Olanda nascondendo centinaia di ebrei nella sua fattoria o in cascine del vicinato. In altri casi si trattò di gruppi composti da persone disparate, accomunate dalla causa di assistere gli ebrei; come per esempio, a Varsavia, lo Zegota, (Consiglio per l’Aiuto agli Ebrei) o, in Olanda, il Naamloze Venootschap. E infine, alcune istituzioni, già esistenti, si impegnarono a nascondere i giovani all’interno delle loro attività di resistenza: comunità protestanti e cattoliche, associazioni autonome come l’Ouvre de Secours aux Enfants (OSE), gruppi giovanili di scout, club studenteschi universitari e strutture di partiti politici. Commentando la situazione degli ebrei in Francia e in Belgio, lo storico Lucien Steinberg osserva a giusto titolo che «la maggioranza degli ebrei che sopravvisse, o non ebbe bisogno dell’aiuto di organizzazioni di assistenza ebree e non ebree, oppure si rivolse a loro solo raramente». E’ ovvio che quelle organizzazioni non potevano salvare l’intera popolazione ebraica. La gran parte degli ebrei che sopravvisse lo deve a iniziative personali. Sebbene non siano disponibili cifre esatte, il quadro d’insieme testimonia che questa fu la soluzione più diffusa in tutta Europa. In larga misura, la gran parte dei giovani ebrei trovò aiuto non attraverso reti organizzate ma grazie a contatti personali o familiari. Di fatto, prima di tutto, i giovani furono salvati dai genitori. Il gesto di separarsi da un bambino, di rinunciare al proprio figlio o figlia, riconoscere che non si è più in grado di difendere e pro- 176 teggere quel piccolo essere cui si è data la vita fu il primo ed essenziale anello della catena di salvataggio. Era un paradosso: per salvare un figlio si doveva ammettere la propria incapacità di aiutarlo e difenderlo. L’affidamento di un figlio o di una figlia ad un amico, un estraneo, un resistente, quell’atto di abdicazione fu il fondamentale inizio, che non può tuttavia sminuire la stima dovuta allo sforzo delle organizzazioni dedicate alla salvezza dei giovani ebrei, né la generosità dimostrata dalla gran parte delle famiglie «adottive» che li accolsero. Quasi uniformemente, donne e uomini impegnati in quel compito lo svolsero con tenacia e lealtà. Lo fecero perché lo ritennero giusto e ancora quasi cinquant’anni dopo non ritengono di aver compiuto nulla di straordinario, né si aspettano speciali encomi per le loro azioni. La verità è che il loro comportamento fu straordinario. Tuttavia, sarebbe scorretto affermare che solo a queste persone, per quanto ammirevoli, giuste, generose e disponibili siano indubbiamente state, i giovani debbano la vita. Furono i genitori a compiere il primo e più straziante passo. Nascondere quei giovani fu un’impresa estremamente complicata, ma vivere nascosti lo fu ancor di più. I problemi dei resistenti o delle famiglie «adottive» furono di ordine pratico, non erano in gioco personali convinzioni, principi o credenze religiose; agirono in tal modo perché lo ritennero giusto, si assunsero la responsabilità di quei giovani con generosità d’animo e in piena coscienza. Ma una cosa era salvare qualcuno, tutt’altra era essere il qualcuno che veniva salvato. I giovani ebrei non poterono ricorrere ad alcun valido modello che spiegasse la loro situazione; né la tradizione né il patrimonio culturale li aiutarono a farsi una ragione della loro posizione di vittime. Mai la persecuzione degli ebrei era giunta a tanto. Ogni tipo di esperienza che questi giovani affrontarono: l’aver vissuto nascosti (e invisibili) o «da nascosti» (ma visibili), fu molto problematica, ma la prima in modo più evidente, più 177 diretto e più brutale. Vivere nascosti significò troncare tutti, o quasi tutti, i legami con la società; in una soffitta di città o in una conigliera nella foresta, essi si trovarono letteralmente segregati dal pericolo mortale che il resto del mondo rappresentò; marchiati o isolati dalla Stella di David come «altri», «stranieri» e, infine, scacciati dalle loro stesse case, costretti ad abbandonare i pochi amici rimasti e spesso anche le famiglie, essi iniziarono una nuova e quanto mai alienata esistenza emarginata da ogni comunità, senza modo, né mezzi per accedere a beni o servizi (cibo, vestiti, scarpe, medicine, libri, cure mediche). Vivere nascosti fu una prova difficile, fisicamente e psicologicamente; trovarsi senza possibilità di soluzione estirpati dalla normale esistenza, troncare ogni abituale attività rappresentò un violento trauma che richiese radicali adattamenti. Il problema fondamentale fu quello di non lasciare prova, né segno della propria presenza, vivere senza traccia o residuo di esistenza; e ciò si rese possibile solo grazie a costanti e attente finzioni e dissimulazioni. Camuffare la realtà divenne un modo di vivere per gli ospiti come per gli ospitati, e la gamma dei diversi stratagemmi variò dalle tattiche più ovvie alle manovre più astruse; poiché teoricamente chi viveva nascosto non doveva esistere, non doveva essere visto. Era loro vietato accostarsi alle finestre per evitare di essere scorti dall’esterno, e quando c’erano visite venivano confinati in zone appartate dove erano costretti a restare immobili e in assoluto silenzio. Rinchiusi in un armadio o dietro una tenda, astenendosi da qualunque minimo movimento che li avrebbe fatti scoprire: oltre a non farsi vedere, non dovevano farsi sentire, perciò, per esempio, se il padrone di casa era in salotto, era vietato lavare i piatti in cucina; ogni segno di attività o rumore doveva potersi attribuire a coloro che ufficialmente abitavano in quella casa. Procurarsi generi di prima necessità per i giovani nascosti rappresentò un altro grave problema e implicò elaborate pianificazioni; se il bambino era sprovvisto di tessera annonaria non re- 178 stava altro che acquistare il cibo, a costi esorbitanti, sul mercato nero; come avrebbe osato una massaia presentare buoni per tre quando il fornaio sapeva perfettamente che da anni in casa sua vivevano solo due persone? Il cibo fu il fondamentale e costante problema, ma anche per procurarsi ogni altra cosa bisognava aggirare ostacoli ed escogitare stratagemmi. I libri, per esempio, tanto importanti per la gran parte dei ragazzi nascosti perché, oltre a far passare il tempo, leggere era un modo per evadere dai rigidi confini di quell’esistenza coatta. In breve, sia chi visse nascosto, sia chi nascose si sforzò costantemente per far sì che il proprio comportamento, dentro casa o nei rapporti con il mondo esterno, non lo tradisse; ma se entro i confini di quel sistema protetto vi era in qualche misura potere di controllo, non era possibile controllare le mosse dei tedeschi e dei loro alleati. Le razzie, le perquisizioni, non dipendevano in alcun modo da inconsapevoli autodenunce, erano una presumibile e tuttavia imprevedibile calamità: si sapeva in anticipo che sarebbero avvenute, ma non quando. Per far fronte a queste situazioni d’emergenza furono creati appositi, speciali nascondigli, e i ragazzi dovettero esercitarsi così da essere in grado di scomparire in pochi secondi. False pareti servirono a mimetizzare minuscoli recessi all’interno di armadi e ripostigli, in sottoscala e botole, in solai e cantine. Tenuto conto dei problemi pratici del vivere nascosti e la costrizione materiale di ogni attività, cosa facevano quei ragazzi durante tutto il giorno? O, per meglio dire, come passavano il tempo? Ovviamente, in età scolastica leggere e studiare furono le occupazioni più comuni; in mancanza di alternative e con tanto tempo a disposizione, l’attività intellettuale rappresentò una scelta naturale. Inoltre i giovani confidavano di poter ritornare a scuola; continuare a studiare fu per loro il modo elementare, fondamentale, per affermare che un giorno sarebbero rientrati nella società, per sostenere la convinzione che avrebbero ripreso la vita normale. Comunque il disagio principale nell’ambiente di «adozione» derivò essenzialmente, com’è del tutto ovvio, dalle circo179 stanze. La condanna a morte derivata dai nazisti costrinse gente non ebrea a offrire loro asilo così come costrinse i giovani ebrei a cercarlo. Non si trattò di un vero rapporto affettivo né di vera adozione; il nazismo, l’altruismo (per lo più), l’interesse (talvolta) e la necessità li tennero uniti. In quanto ebrei, essi erano ovunque disprezzati e perseguitati. Vivere nascosti, invisibili, fu una difficile esperienza: col passare del tempo, quando i mesi si trascinarono in un anno, e poi in due, tre, quattro, molti giovani caddero in preda a depressione e apatia; era una via senza uscita: al sicuro, per il momento, ma nella trappola dell’abitudine e dell’autoabnegazione. A quei giovani venne negata una normale infanzia, furono privati di tutto ciò che questa comporta: istruzione, sviluppo di capacità, modelli di relazioni familiari, processi di socializzazione. Soffrirono invece di persistenti incertezze psicologiche tra la (normalmente inespressa) asserzione del proprio diritto di vivere e la gratitudine nei confronti di chi si prese cura di loro. Altri giovani, nascosti ma visibili, dovettero superare anch’essi difficoltà analoghe a quelle sperimentate dagli «invisibili». In molti modi i due tipi di esistenza clandestina si possono considerare in parallelo; se è vero che i più piccoli tra coloro che vissero «da nascosti» godevano di maggiore libertà, e in qualche caso furono tanto fortunati da condurre una normale vita infantile, i più grandi, quelli in grado di capire (seppure vagamente) il pericolo della situazione, come gli altri vissero nel terrore di tradirsi o di essere denunciati. Per la salvezza di tutti era imperativo che l’ospite presentasse al mondo esterno una facciata da gentile senza incrinature; ogni minimo cedimento, un solo passo falso nel comportamento o nel linguaggio lo avrebbe tradito, e insieme avrebbe messo in pericolo la famiglia «adottiva» e la rete dei contatti che li aveva uniti. I più giovani che non avevano idea né memoria della vita ebraica crebbero come cristiani; quelli di poco più gran- 180 di, dai quattro-cinque anni in su, dovettero stare costantemente all’erta per evitare di scoprirsi. Per anni vissero una doppia realtà, all’interno ebrei, all’esterno cristiani; essere gentile tra gentili creò una frattura tra il precedente concetto di sé e la contingente realtà; generò distacco e isolamento: nessuno al di fuori dei parenti «adottivi» doveva sapere chi erano effettivamente, non bisognava fidarsi di nessuno. In alcuni di loro questa lacerazione fece nascere incertezze sul valore dell’identità ebraica. Col tempo si fecero strada interrogativi e dubbi; negli anni l’insormontabile barriera della propaganda antisemita che pesò sull’Europa occupata dai nazisti, e il costante sforzo di essere qualcun altro ottennero il loro effetto. Incidenti quotidiani, come udire un comune commento antisemita e, da ebreo, non essere in grado di controbatterlo, portarono a provare vergogna, vergogna per non aver saputo rispondere, vergogna della propria impotenza e, da ultimo, vergogna di essere ebreo. Questo conflitto fu ancora più esacerbato quando i giovani dovettero sostenere la finzione anche con i genitori «adottivi», e mantenere la propria identità interamente dentro se stessi. In conclusione abbiamo visto e analizzato l’esperienza di coloro che vissero nascosti e invisibili e di quelli nascosti ma visibili, i primi costretti a dissimulare la loro presenza fisica, i secondi la propria identità ebraica; ma tutti soggetti a gravi disagi psicologici. Nonostante questo, la loro condizione fu estremamente fortunata, rispetto alla maggior parte dei giovani ebrei che invece furono deportati nei campi di concentramento da cui non fecero più ritorno. I CAMPI DI STERMINIO Una volta entrati nel campo, nessuno fu più giovane, ogni traccia di vita giovanile scomparve. Vi furono solo adulti in giovane età e un’esistenza da schiavi. Tuttavia coloro che superaro- 181 no la selezione continuarono a vivere sino al momento in cui cedettero alle malattie e agli stenti, o vennero uccisi, o furono liberati. In circa mezzo secolo di memorie, letture, film, siamo stati messi in grado di capire quanto quei giovani si accingevano a sperimentare senza alcuno strumento o conoscenza. Ciononostante il mondo dei campi di concentramento ha assunto per noi un carattere quasi mitico, poiché essi costituirono (ai nostri occhi) un universo a sé che sfidò ogni elementare struttura a noi nota e ogni principio oggetto di fede. Ma per i giovani in procinto di varcarne l’ingresso, il campo non fu un «universo», bensì un’esperienza vissuta di orrori. Non un mondo da contemplare, ma una realtà da affrontare: selezioni, maltrattamenti, stenti, sovraffollamento, estrema durezza del lavoro, malattie dilaganti e morte furono per quei giovani impressionanti, inimmaginabili ma quotidiane realtà di vita. Per i giovani e le loro famiglie, il viaggio verso «l’ignota destinazione» cui furono deportati rappresentò l’introduzione all’inferno dove stavano per entrare. Per quanto terribili siano state le loro esperienze nei nascondigli, nei campi di transito o nei ghetti, quello era un inedito stadio di sofferenza. Gli stessi vagoni bestiame furono l’anticamera di Auschwitz; rinchiusi per interminabili giorni in carri piombati destinati al trasporto degli animali, con quattro piccoli finestrini per luce e aria, acqua e cibo scarsi e nessuna attrezzatura igienica, ebrei giovani e adulti raggiunsero i cancelli di Auschwitz. Se i carri bestiame furono per loro l’introduzione alle sofferenze del lager, non li prepararono affatto a quanto avrebbero subito: sensi e facoltà degli ebrei di ogni nuovo trasporto venivano stravolti non appena scesi dal treno; un disorientamento causato non solo da quanto era loro di fronte; vista, udito, olfatto erano violentati sin dal primo impatto. Era un altro mondo, una nuova dimensione, una sconosciuta e inimmaginabile materializzazione dell’orrore. Al centro della scena stava un medico ufficiale delle SS, Josef Mengele, incaricato di mante- 182 nere l’equilibrio della popolazione del campo. A lui spettava far lavorare appieno camere a gas e forni crematori, assicurare un costante rifornimento di operai schiavi, e impedire che l’affollamento del campo diventasse tale da sopraffare la terroristica disciplina delle guardie. Il criterio di scelta era sommario: quasi tutti i più giovani da una parte, i più anziani (o quelli che perlomeno all’apparenza erano più anziani perché avevano i capelli più bianchi) e i bambini piccoli dall’altra parte. Dopo aver ricevuto da Mengele la temporanea licenza di vita, giovani (e adulti) dovevano affrontare i riti di passaggio allo status di prigioniero. Lo scopo era cancellare ogni traccia di individualità e personalità negli esseri umani immessi in quel sistema, trasformarli in schiavi contrassegnati da un numero. Vennero spogliati nudi e rasati a zero, cui seguì la doccia, l’assegnazione del nuovo nome (il numero) e di nuovi vesti. Quella violenza fisica e morale senza precedenti fece nascere in loro un senso di disperazione esistenziale che sfociò in apatia emotiva. Ed è all’interno di questo contesto che va interpretato l’uso della parola «sopravvivenza» da parte dei giovani; non una strategia a lungo termine per resistere al regime nazista, ma una più o meno rudimentale formulazione di precetti basilari per aggirare i pericoli dell’esistenza quotidiana. Nell’universo di Auschwitz, «sopravvivere» non significò fare progetti per quando la guerra sarebbe finita, ma superare ora per ora il giorno. Questa risposta di mortificazione, di abbattimento e la conseguente concentrazione sul quotidiano fu la reazione pressoché generale. Nemmeno precedenti esperienze o provenienze nazionali modificarono quello schema comportamentale: giovani che avevano vissuto nascosti, in campi di transito, o nei ghetti, che provenivano da ogni parte dell’Europa occupata reagirono in modo analogo. In altri termini, differenze di cultura, classe, età, sesso, grado di osservanza religiosa, nazionalità o esperienze individuali nel tempo di guerra si dimostrarono irrilevanti. I giovani che accedettero al rango di operai schiavi, insieme al nome persero la propria gioventù, così come furono spogliati dei loro bagagli, de183 gli abiti e dei capelli. Dal momento in cui si trovarono inseriti nelle file degli schiavi non ebbero altra scelta se non quella di comportarsi da lavoratori adulti, poiché come tali erano stati selezionati. E questo valse non soltanto per il ruolo che sostennero nei confronti dei tedeschi ma anche a livello personale, tra figlio e padre o figlia e madre; il sistema stabilì i termini relazionali. I giovani non erano più nella posizione di figli rispetto ai genitori, e questi ultimi erano usciti sconfitti dalla battaglia in difesa della loro progenie. Insieme all’iniqua amministrazione del campo (maltrattamenti fisici, carenza di cibo, lunghe ore di Zahlappel, mancanza di abiti e scarpe degni di questo nome) che debilitò e indebolì i prigionieri, la struttura stessa di Birkenau, le condizioni materiali dell’esistere, furono un quotidiano attentato alle loro scarse possibilità di salvezza. Birkenau si suddivideva in diversi campi; ogni campo, o lager, chiuso da una recinzione di filo spinato, conteneva circa trentotto baracche o blocchi e ognuno dei campi, contrassegnati da lettere dell’alfabeto aveva specifiche funzioni. L’architettura esterna così come le spartizioni e le sistemazioni interne nei blocchi dei diversi campi erano pressoché identiche; la baracca tipo di Birkenau, ad esempio, non aveva finestre e un unico lucernario posto sotto la grondaia del tetto costituiva l’unica fonte di luce e aria. Lungo i muri perimetrali erano state ricavate delle nicchie che contenevano tre file sovrapposte di cuccette e al centro del blocco scendeva il condotto di riscaldamento: un tubo di mattoni alto circa un metro con una stufa alle due estremità; gabinetti e acqua corrente erano collocati all’esterno dei dormitori. La gran parte dei giovani di allora ricorda con estrema precisione ogni dettaglio di quelle baracche, e altrettanto nitidamente rammentano il sovraffollamento del campo dove i prigionieri erano costretti a dormire l’uno sull’altro, e quando qualcuno si rigirava, gli altri occupanti della cuccetta erano costretti a fare lo stesso. Nei blocchi la gente era tanto ammassata (di norma 400-500 184 persone, ossia il doppio dell’originaria prevista capacità) che se accadeva di avere un bisogno durante la notte, si era costretti a calpestare i compagni per raggiungere il bugliolo posto in fondo alla baracca. Ovunque quei giovani si trovassero, ad Auschwitz-Birkenau o in altri campi di lavoro forzato, la scadenza della temporanea sospensione di morte fu solo questione di tempo. Ad Auschwitz, dove Mengele e i suoi colleghi facevano sì che le camere a gas lavorassero sempre a pieno carico, venivano effettuate regolari selezioni non solo tra i nuovi arrivi, ma anche tra i prigionieri; un’ulteriore minaccia quotidiana sospesa su quei giovani, una lotteria che dipese dalla loro buona fortuna e dal capriccio di Mengele. Chiunque abbia sperimentato le selezioni, e ne sia uscito vivo, lo ricorda con estrema chiarezza. E’ difficile immaginare che in condizioni simili le persone continuassero a operare scelte. Le circostanze erano tanto costrittive e tanto rigidamente imposte da negare ogni possibile spazio di manovra. E tuttavia ognuno di loro deliberò e scelse. Del tutto privi delle necessarie informazioni per assumere decisioni consapevoli, senza alcuna certezza della sorte cui quelle scelte avrebbero condotto, non si arresero e fecero quanto di meglio fu loro possibile. Ogni giovane con risoluzioni individuali negoziò al meglio la propria vita nel campo: in quale distaccamento di lavoro era più opportuno inserirsi? Doveva farsi avanti o passare inosservato? Mangiare la zuppa o barattarla con una razione di pane? Contro cosa valeva la pena di scambiare la propria razione di cibo, e così via. E ancora, quasi tutti scelsero di rimanere con i propri familiari e amici o, in mancanza di legami preesistenti, di allacciare nuove amicizie. Nella grande maggioranza, i giovani ebrei nei campi di lavoro forzato dell’Europa occupata dai tedeschi attribuirono molta importanza ai rapporti affettivi e di solidarietà. Quei rapporti erano importanti per due essenziali motivi: primo, quelle persone rappresentavano l’ultimo brandello della 185 loro vita come esseri umani liberi, il residuo dell’esistenza precedente allo stato di schiavi numerati. Il secondo motivo che spiega perché i rapporti furono tanto essenziali nella vita dei giovani prigionieri è, sul piano puramente pratico, che essi diedero loro ulteriori risorse per far fronte alle circostanze. Nonostante l’appoggio morale ed i vantaggi materiali di questi rapporti, i giovani internati risentirono profondamente degli effetti del sistema in cui si trovarono intrappolati. Amicizia e protezione, per quanto essenziali, non furono in misura da difenderli dall’opprimente malvagità che era davanti ai loro occhi, né dalle costanti brutali violenze cui vennero sottoposti. Declinarono fisicamente, si indebolirono spiritualmente: il fatto di essere internati, di diventare dei numeri, di non avere più un nome, cancellò carattere, personalità, emozioni e volontà. Non vi era possibilità di recuperi in positivo né di riorganizzazioni decisionali, ma nel tempo solo la progressiva degenerazione. La vita era troppo atroce, e i giovani troppo presi a farvi fronte, perché vi fosse spazio per reazioni emotive; in breve tempo diventarono torbidi, apatici. Sopprimere le emozioni, smettere di pensare fu l’unico modo per superare il giorno; vivere divenne una questione di bisogni e difficoltà quotidiani. L’unica meta fu negoziare il singolo giorno, ogni altra cosa divenne marginale: questo è ciò che «sopravvivere» significò, il problema non era concedersi il lusso di chiedersi se sarebbero sopravvissuti sino alla fine della guerra, quanto, piuttosto, pensare al modo migliore per superare un giorno e una notte. Inoltre molti giovani hanno sottolineato che quel «Regno della Morte» era troppo carico di dolore, sofferenza e malvagità per poter pensare ad altro che non alle necessità quotidiane: non vollero averne conoscenza, tentarono di sfuggire al coinvolgimento. Degenerazione fisica e atrofia emotiva segnarono l’ultima fase della storia dei giovani nell’Europa occupata dai nazisti. Essi continuarono a fare scelte e a mantenere rapporti. Ma non aveva- 186 no potere di controllo sul sistema; l’ingranaggio di morte era troppo efficiente e opprimente. Nonostante i loro sforzi per navigare tra i pericoli della vita nei campi, nonostante il sostegno e l’aiuto che essi offrirono e ricevettero dai compagni più cari, erano condannati. Mai vi fu un miglioramento, gli eventi della vita li condussero inesorabilmente verso il decadimento, mai verso il meglio. La maggioranza dei giovani lottò per l’esistenza quotidiana fino a che quella sofferenza si concluse con la morte per selezione, per stenti o per malattia. La liberazione ne salvò pochi, purtroppo. EPILOGO Come abbiamo visto, anche prima di essere scacciati dalle loro case i giovani non erano sfuggiti all’oppressione nazista che impose loro segregazione (dagli amici non ebrei come dalle comunità più ampie in cui vivevano), isolamento (espulsione dall’abituale ambiente scolastico, parchi, campi da gioco, negozi e così via) e differenziazione (il marchio della stella). Ed essi si conformarono alle circostanze: fecero amicizia con coetanei ebrei, giocarono nel proprio cortile, in giardino o dentro casa. Impararono a portare la stella come una conseguenza logica. Erano ancora a casa, con genitori, fratelli, sorelle, parenti. Erano ancora tutti insieme; l’universo familiare era ancora intatto. Strappati da casa, la situazione cambiò radicalmente; costretti a un’esistenza clandestina, nascosti, la gran parte di loro perse ogni rapporto familiare. Alcuni si affezionarono alle persone che li accolsero, moltissimi altri non vi riuscirono. E tuttavia, qualche basilare principio giovanile venne mantenuto: il tentativo di continuare a studiare, di dedicarsi ad attività e passatempi propri della loro età, composizione letteraria, lavoro a maglia, cucito, disegno. Quanti tra loro, nonostante la clandestinità, non furono costretti a sparire, ebbero maggiori possibilità di continuare (al- 187 meno in apparenza) una vita normale: giocare con altri bambini, allacciare relazioni con le famiglie ospiti e, se ne avevano l’età, talvolta persino frequentare la scuola. Per coloro che furono meno fortunati, quando giunse il momento, entrarono nell’universo dei campi di concentramento, e la loro vita da giovani si concluse. Sappiamo che solo a quelli grandi abbastanza da passare per adulti, o comunque capaci di lavorare come tali, fu concesso di continuare a vivere, gli altri vennero sterminati nelle prime ore. Chi superò la selezione si addossò la responsabilità dei familiari, spesso con la consapevolezza di essere loro gli adulti mentre parenti più anziani si erano trasformati in giovani di cui aver cura. Al passaggio entro quel sistema distruttivo le generazioni si annullarono, la struttura familiare ne risultò sconvolta, scomparvero le ultime tracce d’autorità e di potere dei genitori, ma amore e affetto rimasero inalterati. Per i giovani ebrei, grandi abbastanza per ricordare, anche solo la memoria della vita familiare bastò a dar loro forza e conforto. Figli separati dai genitori perché costretti a vivere in nascondigli o a causa di una diversa sorte di deportazione, figlie che persero ogni contatto con padre e fratelli per la divisione sessuale dei campi o perché questi erano stati prelevati all’improvviso per strada e inviati ai lavori forzati, figli che non videro mai più madri e sorelle, fratelli che non riuscirono a restare uniti… Tutti conservarono l’uno dell’altro l’immagine di come erano al momento della separazione. Per tutta la durata della guerra mantennero la speranza, o il sogno, che un giorno la famiglia si sarebbe riunita. Ma dopo la guerra, i giovani scoprirono che i loro sogni non erano stati che fantasie, e le loro speranze, illusioni. Solo poche famiglie si ritrovarono al completo. I sopravvissuti tornarono a casa per scoprire che i loro cari non li avrebbero mai più raggiunti e che la stessa comunità ebraica era stata distrutta. La società d’anteguerra era cambiata, la vita che avevano conosciuto: abitudini, usanze, principi e credenze erano svaniti. Nulla di quanto aveva- 188 no lasciato nelle case fu ritrovato e ben poco di quanto era stato affidato ai vicini poté essere recuperato. Il saccheggio dei loro beni fu definitivo: i tedeschi avevano compiuto il loro lavoro molto accuratamente e, con lo stesso zelo, i vicini delle vittime rubarono quanto era rimasto. Il fenomeno del ladrocinio da parte dei vicini e il modo in cui persone del tutto ordinarie giustificarono a sé stessi quel sistema di arricchirsi costituisce una serie di comportamenti che va dallo sbalorditivo all’assurdo. Molti giovani sopravvissuti e tornati nelle loro città hanno raccontato che quando si recarono in visita dai vicini, amici dei loro genitori, vennero accolti con gentilezza e cordialità. Li invitarono a entrare in casa, a sedersi e mangiare con loro, ma quelle stesse persone negavano di aver ricevuto in custodia dalle famiglie deportate gioielli, porcellane, lenzuola o argenteria. I giovani ritornati trovarono ben poca solidarietà dai vicini, e i governi nazionali si mostrarono del tutto indifferenti alla loro sorte. Nel periodo dell’immediato dopoguerra (tra il 1945 e il 1950) i politici si preoccuparono di ricostruire i rispettivi paesi, e la situazione dei giovani ebrei non era certo sulla prima pagina della loro agenda. Le città erano state bombardate, le infrastrutture distrutte, l’economia era in rovina. La popolazione, prima della guerra riunita sotto una stessa bandiera nazionale, appariva lacerata dal nazismo, dal fascismo e dall’occupazione. In definitiva, gli ebrei sopravvissuti vennero percepiti come marginali alla società; erano poco numerosi e, data la situazione locale tutt’altro che accogliente, buona parte di loro emigrò poco dopo essere tornata. 189 TESTIMONIANZA DI ARIANNA SZORENY Questa testimonianza è stata tratta dal libro «Il futuro spezzato. I nazisti contro i bambini» di Lidia Beccaria Rolfi e Bruno Maida, Giuntina, Firenze, 1997. L’intervista è stata fatta da Lidia Beccaria Rolfi. Ho ritenuto opportuno allegarla alla relazione data l’importanza che riveste per comprendere al meglio la condizione dei bambini negli anni della persecuzione nazista. Arianna Szorény è nata a Fiume il 18 aprile 1933. Ultima di otto figli, il 16 aprile 1944 venne arrestata con tutta la famiglia, residente a San Daniele del Friuli, salvo una sorella, già sposata. Tutta la famiglia venne trasferita alla Risiera di San Sabba e poi il 21 giugno 1944 ad Auschwitz. Oltre ad Arianna, liberata a Bergen Belsen, solo un fratello sopravvisse al lager. Il resto della famiglia morì ad Auschwitz in data ignota. Che cosa ricordi dell’arresto? Tutto, certi avvenimenti non si possono dimenticare, anche se fino al momento dell’arresto non avevo mai saputo la differenza che passa fra un ebreo e un non ebreo. Papà e mamma erano ebrei, ma mia mamma si era fatta cattolica e noi eravamo stati tutti battezzati. Io mi preparavo per ricevere la prima comunione. Come facevo a sapere - a undici anni che cosa voleva dire essere ebrea? Nessuno me ne aveva mai parlato, forse per non turbarmi. Solo una volta sentii che c’era qualcosa nell’aria che non andava perché mia sorella rincasò piangendo dall’ufficio: parlava di fascisti, di ebrei, di spie, di denunce. A me non dissero niente, non mi diedero spiegazioni. L’arresto allora ti colse impreparata? Certo, ricordo, ero ancora a letto. Due tedeschi aprirono la porta di camera mia con un calcio, urlando. Mia madre mi disse di alzarmi e di 190 vestirmi, così, davanti a loro; avevo vergogna. La casa era tutta piantonata da militari, fuori ci aspettavano due camion coperti da un telone. Mio padre, con i certificati di battesimo in mano, cercava ancora di spiegare al comandante che i documenti erano in regola, che eravamo cattolici, ma non servì a niente: ci caricarono sui camion, ci portarono a Udine, dove ci interrogarono uno per volta. Eravamo nove: papà, mamma, cinque sorelle e due fratelli. A papà presero tutti i soldi e l’orologio, con i miei fratelli fecero altrettanto, poi ci trasferirono nello stesso giorno alla Risiera di San Sabba, a Trieste. San Sabba è stata la mia prigione: ricordo la porta della cella che si chiudeva alle mie spalle e il catenaccio che scorreva. Mi misi a piangere, ma lì avevo ancora la fortuna di piangere nelle braccia della mamma. A San Sabba sapevate che cosa stava succedendo, avrai sentito delle voci, avrai visto qualcosa? Sono rimasta soltanto sei giorni a San Sabba, vedevo quel grande camino fumare ma a me avevano detto che lì bruciavano le immondizie e anche i nostri bagagli. Di notte si sentivano grida e latrati ma erano coperti dalla musica che suonava in continuazione e ci impediva di dormire. Una mattina, dopo sei giorni di cella, entrarono i tedeschi, ci fecero uscire dalle celle, ci portarono alla stazione e ci rinchiusero in un carro bestiame, già pieno di tanta gente, tutti in silenzio perché i soldati ci terrorizzavano con grida, urla, comandi, che io non capivo e che la mamma non mi traduceva per non spaventarmi. Solo quando il treno partì - e passarono tante ore - finalmente cominciammo a respirare. Noi eravamo rimasti tutti insieme, sullo stesso vagone, ma altre famiglie no, erano state divise. Il viaggio fu terribile. Ogni tanto il treno si fermava in qualche stazione, ma non sapevamo mai dove eravamo: non ci fecero mai scendere. Il vagone era sporco, faceva caldo, tutti avevamo fame e sete, era terribile. 191 Quando vi fecero scendere dal treno, ad Auschwitz, qualcuno fra di voi sapeva dove si trovava, a che cosa andavate incontro? Gli altri non so, io non sapevo niente e nessuno mi ha detto niente. A me è parsa una liberazione scendere da quel vagone. Mi sembrava che non mi potesse succedere niente di peggio di quel viaggio. E poi, cosa si può pensare a undici anni? A undici anni si vive ancora attaccati alla mamma e quando sei con la mamma credi che non ti possa succedere niente, perché lei ti protegge. Ti dirò che in un primo momento, più che spaventata, ero curiosa e guardavo quella scena come se fossi stata a teatro. I grandi mi sembravano burattini, perché si muovevano come burattini, prendevano gli schiaffi, le bastonate e stavano zitti, non reagivano, ubbidivano a comando. Sembravano proprio dei burattini. Un teatro di burattini. Mi faceva paura il filo spinato che circondava il campo. Anche il forno crematorio mi impaurì: usciva un fumo nero, mi ricordò San Sabba. A suon di frustate ci misero tutti in fila per cinque e ci spinsero in una baracca, ancora con i nostri bagagli. Dal soffitto pendevano dei bocchettoni per docce. Speravamo di poter bere, ma non credo che da quei bocchettoni sia mai uscita dell’acqua. Nessuna, nemmeno allora, ebbe qualche dubbio vedendo le docce? Qualcuno, sì, doveva sapere qualcosa, perché mia sorella che capiva il tedesco e che parlava con altre persone, non della nostra famiglia, ad un certo punto sbiancò e svenne, ma la mamma non disse nulla, cercò fin che poté di non farmi sapere nulla. Solo adesso che sono mamma anch’io posso capire il dramma di quella santa donna che si rendeva conto del destino delle sue creature. Al mattino - era notte quando ci chiusero nella baracca delle docce - arrivarono le SS con i frustini, separarono subito gli uomini dalle donne e dai bambini: mio padre mi baciò in fronte e mi diede la sua benedizione. Fu l’ultima volta che lo vidi. Sparì con i miei due fratelli. Le donne e i bambini rimasti furono avviati al Waschraum (lavatoio), uno stanzone rettangolare, e qui fecero una prima selezione: 192 qualcuna da una parte, qualcuna dall’altra. La fila dove eravamo noi era molto più lunga. Dalla fila più corta un tedesco, dopo aver contato e ricontato, incominciò ad urlare che gli mancava una famiglia ariana. Mamma capiva il tedesco e con una grande presenza di spirito (ormai aveva capito il pericolo) alzò la mano e disse: «Io sono ariana ». E lui le rispose: «Svelta esci e vieni qui». «Svelte andiamo» mormorò mia madre. Piano piano, la fila da cui eravamo appena uscite, si incamminò verso le docce… Di loro ricordo gli sguardi spenti, rassegnati; ormai, penso, avevano capito. La nostra fila fu fatta sedere su una panchina. Due donne, vestite con un abito a righe e con un numero sul braccio, ci portarono del pane: dissero che venivano da un convoglio di ebrei appena eliminato. Io non capivo più nulla, tempestavo mia madre di domande, ma non mi rispondeva o inventava qualcosa. Sentivo che non mi diceva la verità. Quando ci fecero spogliare fu una tragedia. La mamma tremava, nessuno di noi l’aveva vista nuda. Si vergognava. Si mise ultima, dietro di noi per non essere vista. I tedeschi si accorsero di quel piccolo stratagemma e ghignando ci ordinarono di metterci tutte in fila con le gambe aperte e le braccia alzate. Mia madre reprimeva le lacrime. Tutte le donne, braccia alzate e gambe aperte, furono rasate e depilate. Quando fu il mio turno, come una marionetta mi misi anch’io a gambe aperte, ma non avevo peli e il tedesco credendo che volessi prenderlo in giro mi diede un gran ceffone, il primo di una lunga serie. Dopo la solita doccia ci vestirono con degli stracci e cinque per cinque arrivammo a una baracca, la 16 o 13 del Lager D. Ci assegnarono una Koia (cuccetta) al terzo piano: in sei dovevamo stare, tre ai piedi e tre alla testa. Almeno avevamo la fortuna di stare insieme, tutte e sei senza mescolarci con le altre. Si moriva di caldo, schiacciate sotto il tetto di paglia e cemento pressato. La baracca era strapiena, ma c’erano pochissimi bambini e questo mi preoccupava. Lo dissi alla mamma e lei cercò di prepararmi: forse ci avrebbero divise, mi avrebbero mandata in un posto per bambini dove sarei stata meglio. Io non volevo separarmi da lei e al solo pensiero piangevo, ma lei ancora cercava di consolarmi e farmi ridere. 193 Poi la notte la sentivo piangere. Anche le altre deportate erano preoccupate per me, ero troppo piccola per rimanere nel blocco delle donne. Le più anziane del campo consigliarono a mia madre di camuffarmi per farmi sembrare più grande. Per andare all’appello mia sorella mi prestava le sue scarpe con il tacco, e la mamma mi copriva la testa con uno straccio, così il viso si vedeva poco e sembravo più alta: in mezzo a tutte quelle donne era facile confondersi. In quella baracca rimasi tre mesi e imparai a vivere con le grandi. Imparai anche i trucchi e questo mi servì moltissimo quando rimasi sola. Rammenti qualche episodio di questo periodo, qualcosa che ti ha colpita durante la tua permanenza con le donne? C’è qualcosa che mi ha sconvolta, che mi ha messo all’improvviso davanti all’origine della vita. Una notte - io non dormivo - si sentì un vociferare in fondo alla baracca, una donna venne a chiamare mia madre. Stava per nascere un bambino. Di bambini lei se ne intendeva, ne aveva avuti otto. Le compagne della partoriente, delle jugoslave, fecero di tutto perché non si sentissero i vagiti del neonato, non ricordo se maschio o femmina. Canticchiavano, facevano rumore. La mattina dopo eravamo sul piazzale dell’appello, vidi le SS che si esercitavano a colpire al volo un sacco che una di loro gettava per aria. Nel sacco c’era il neonato che, nonostante tutte le precauzioni, era stato scoperto, forse dalla Kapò. Non ricordo che fine ha fatto la madre del bambino. Un’altra cosa ricordo: un mattino, stavamo andando alle docce, in fila, ed io ero la prima della fila a sinistra. Incrociammo un gruppo di donne SS in divisa, una mi fissò, poi si staccò dalle compagne e venne verso di me. Terrorizzata, continuai a camminare con la testa voltata dall’altra parte - avevo sempre paura che un giorno o l’altro scoprissero la mia età e mi portassero nel blocco dei bambini - ma quella invece si avvicinò e mi mise in mano un cioccolatino con la stagnola rossa. Eravamo verso la metà di settembre; mia mamma avrebbe compiuto cinquantasei anni il 22. Il cioccolatino, insieme a cinque fettine di pane risparmiate con fatica, servì a festeggiare con tanta tristezza questa data. 194 Tu hai il numero tatuato sul braccio: ti ricordi quando te lo hanno fatto? Che cosa pensavi in quel momento? Non ricordo bene quando fu. So che un giorno ci portarono alla sauna, sempre la solita storia tutte in fila. Mamma si mise davanti a me, per farmi coraggio. Con una specie di pennino intriso di inchiostro mi tatuarono il numero sul braccio. Subito il braccio gonfiò e si formò una crosta, poi la crosta cadde e rimase in blu questo numero: 89219. Ho impiegato tempo a imparare il numero in tedesco: la mamma me lo faceva ripetere, perché bisognava rispondere quando chiamavano il numero. E’ successa una cosa curiosa: a noi hanno inciso solo il numero perché la mamma aveva detto che eravamo ariane, però quando arrivai a Ravensbrück un giorno mi chiamarono per incidermi anche il triangolo. Io dicevo: «Sono ariana» - a Ravensbrück parlavo già tedesco e sapevo farmi capire - ma loro mi zittivano: «Che cosa vuoi saperne tu? Se tuo padre è ebreo anche tu sei ebrea». «Guarda - e mi fa vedere il braccio - il triangolo ha il colore diverso dal numero». Ancora negli ultimi mesi di guerra, si preoccupavano dell’ebreo e del non ebreo. Quando ti hanno separato da tua madre? Era la fine di settembre, qualche giorno dopo il compleanno della mamma. Prima però avevo già subito una selezione e quella volta mi era andata bene. Un giorno arrivarono nella baracca le SS, prelevarono i bambini, fra cui mia sorella di quattordici anni e me, e dopo la solita sauna ci fecero uscire nude e ci visitarono così. C’era il dottor Mengele a visitarci e selezionarci. Io ero magra ma vedi, ho gli zigomi alti, e quasi sempre sono colorita in viso. Anche allora ero così, davo l’impressione di essere in salute. Fui messa in una fila e a questa fila distribuirono una coperta per ciascuno. Mia sorella Lea, invece, che aveva delle pustole in viso ed era gonfia perché le avevano fermato le mestruazioni, fu spinta nell’altra fila. Le due file erano parallele: io capii cosa volevano significare le due file diverse, una con la coperta l’altra senza. Anche se mia 195 madre aveva tentato di nascondermi la verità, avevo sentito parlare le altre deportate e avevo intuito da sola il significato delle selezioni. Vedevo nella mia fila bambine più in salute, ancora ben messe, e nell’altra bambine magre come scheletri, affette da foruncolosi, con delle piaghe. Approfittai della confusione che si creava di solito in quelle situazioni, afferrai Lea per un braccio e la tirai sotto la mia coperta, mentre la Kapò aveva già dato ordine di uscire alla mia fila. Una volta tanto ci andò bene, lo capimmo subito. La nostra fila ritornava verso la baracca, le altre non le vedemmo più. Riuscii a salvarmi durante questa selezione, ma alla fine di settembre - me lo ricordo perché era pochi giorni dopo il compleanno della mamma - un tedesco entrò in baracca e fece, urlando, un lungo discorso. Mia mamma impallidì, anche le mie sorelle impallidirono perché capivano il tedesco, poi la mamma con tutta la sua tenerezza mi disse che quel mattino avrebbero fatto una selezione perché occorrevano braccia robuste per lavorare. «Forse tu andrai con i bambini», mi disse, «dove ti faranno fare dei lavoretti adatti a te». Quella mattina mi pizzicarono le guance per farle colorire, mi misero le scarpe con il tacco alto, il fazzoletto in testa, ma fu inutile: il Tedesco mi adocchiò, mi disse di uscire dalla fila, mi chiese quanti anni avessi. «Tredici», dissi io, convinta che a tredici anni fossi già adulta. Allora urlando mi spinse in un gruppo dove c’erano altri bambini. Non piansi, capii che non sarebbe servito a niente: da quel momento non ho quasi più pianto. Riuscii ad abbracciare la mamma, ricevetti le sue ultime carezze, poi ci caricarono sopra un camion e ci portarono al crematorio. Ricordo il pianto dei più piccoli, i tedeschi si irritavano a sentirli piangere e li frustavano. Ci portarono alle docce, tutto si svolgeva come al solito, tutti nudi in fila, ma quel mattino la selezione avvenne prima di entrare nella camera delle docce. Alcuni vennero spinti in una fila e io con loro, tutti gli altri in un’altra, soprattutto i più piccoli. Quella fila entrò nei locali delle docce. Noi ci fecero rivestire e ci portarono in un campo per bambini. Quelli che erano entrati nel locale delle docce - ma ora sapevo di che cosa si trattava - non li vedemmo mai più. 196 Così ti ritrovasti sola, senza la tua famiglia, in un blocco di bambini. Cosa facevate tutto il giorno, chi si occupava di voi? Alcuni erano molto piccoli, chi si occupava di loro? I primi giorni fu terribile, pensavo sempre alla mamma, ma bisognava pur vivere, arrangiarsi. La Kapò parlava solo con il frustino, e nessuno si prendeva cura di noi. Facevano gli appelli come nella baracca degli adulti. Ormai avevo perso le illusioni e la voglia di ridere. Quando ero nel blocco delle donne riuscivo ancora a ridere con le mie sorelle. Specie la sera ci divertivamo a fare il teatrino, a recitare scene di Pinocchio che avevamo recitato al paese durante l’inverno, ma trasformavamo i personaggi della favola con personaggi della nostra vita: la Kapò e le SS erano le marionette, il comandante con la frusta era Mangiafuoco, e così via. Poi c’erano le compagne con le quali andavamo d’accordo, mi sentivo protetta. Qui invece, al Kinderblock ero sola e avevo paura. Sapevo ormai cosa poteva capitarmi. Mentre ci portavano al blocco dei bambini era successo qualcosa che mi aveva spaventata a morte. Stavamo per entrare nel blocco e noi bambini spingevamo, come fanno i bambini, quando due Kapò uscirono e si piazzarono davanti alla porta per non farci entrare. Alla nostra Kapò che ci accompagnava dissero di aspettare: io capivo già il tedesco, ho capito quando ha detto di farci aspettare. Da quel blocco uscirono poco dopo circa duecento bambini piccoli, avevano nelle mani giocattoli e cantavano. Salirono sullo stesso camion che ci aveva portati lì. Non li abbiamo mai più rivisti. Ma tu avevi capito a quale destino andavano incontro quei bambini? Certo, ormai sapevo che cosa voleva dire andare verso il forno crematorio, lo sapevano tutti, non era più un segreto. Anche noi bambini sapevamo cosa voleva dire camera a gas e forno crematorio. 197 Come ti sei organizzata la vita da sola? Io ero già un’anziana del campo, i tre mesi trascorsi nel blocco delle donne mi avevano insegnato molte cose. Mi tenevo pulita, conservavo pezzi di pane o piccoli pezzi di burro per darli alla mamma, se mai fosse riuscita a venirmi a trovare. A quell’epoca ci davano qualcosa in più da mangiare e io non avevo fame, sapevo però che poteva anche servirmi per comprarmi altre cose che mi occorrevano, per fare degli scambi. Incominciavo anche a ribellarmi alla disciplina. Durante il giorno ci obbligavano a fare il girotondo cantando, ma io non avevo voglia di cantare e non cantavo. La Kapò mi picchiava ma io dalla rabbia non cantavo. Ho preso tante frustate per questo. Per alcuni giorni la mamma e le sorelle riuscirono ad avvicinarsi al blocco, oltre il reticolato. Io andavo a salutarle attraverso il filo spinato, passavo il burro che avevo conservato per loro. Poi un giorno ci trasferirono in un’altra baracca e non le vidi più. La nuova Kapò era più buona, ci lasciava andare da sole alla latrina e fu così che un giorno, curiosando in giro - sono sempre stata molto curiosa - mi sono trovata fuori dalle docce davanti a un mucchio di cadaveri. A molti i topi e i corvi avevano rosicchiato il naso, erano tutti nudi. Sono tornata piangendo di spavento nella baracca. E’ questo l’episodio peggiore che ricordi? Questo mi ha spaventata. Era la prima volta che vedevo tanti morti, tutti insieme. E’ terribile vedere tanti morti, corpi tutti nudi, tutti insieme. E’ terribile, ma ci sono altre cose che ho visto e che a ripensarci oggi che ho figli sono più terribili ancora. Un giorno, per esempio, ci portarono nel cortile di una baracca degli uomini e, tutti nudi, sia noi bambine che gli uomini, fummo costretti al freddo a fare il girotondo. Queste sono crudeltà che allora non potevo capire e che oggi mi fanno riflettere su tutta una scala di violenze inutili che abbiamo dovuto patire. E c’è di peggio. La sera nel nostro blocco venivano dei soldati, si 198 sedevano sullo scalino che correva lungo tutto la baracca e la Kapò chiamava qualche bambina. Le poverine erano costrette a sedersi sulle loro ginocchia, i soldati le allettavano con dolci e regalini, poi uscivano con loro e non tornavano più. Allora non capivo, so soltanto che avevo una gran paura perché avevo visto che nessuna di loro tornava, allora mi nascondevo nella Koia (cuccetta). Oggi capisco e inorridisco. Una volta le SS portarono sul nostro piazzale tre «musulmani» chiamavano così i poveri deportati ormai pelle e ossa e senza voglia di vivere. I soldati si divertivano a mettergli in bocca una sigaretta, poi prendevano la mira e sparavano. Fortunatamente erano dei bravi tiratori. Dopo un po’, stanchi del gioco, li lasciavano andare via. Noi dovevamo assistere a quel tiro al bersaglio. Un’altra volta vennero le solite SS mentre eravamo all’appello. Uno di loro aveva un bambino piccolo in braccio, forse di sette, otto mesi. Misero il piccolo in un sacco, il bambino urlò forte, lanciarono il sacco in aria, presero la mira e spararono. Non udimmo più nulla. Questa scena l’avevo già vista nel campo delle donne. Come hai potuto resistere? Forse perché avevo undici anni e a undici anni non si pensa, si registrano i fatti nella memoria. In più i miei erano undici anni non giusti: da una parte ero abbastanza bambina per non rendermi conto di tutto quello che vedevo, era come se vivessi in prima persona una brutta fiaba con orchi e streghe; dall’altra parte ero istintivamente matura per sviluppare l’istinto di conservazione. Per questo mi era servita l’esperienza fatta durante i tre mesi trascorsi nel campo con la mamma, dove c’erano delle donne che erano da tempo ad Auschwitz e che ci davano consigli per resistere. Ora capivo i loro comportamenti, mi modellavano come loro. Sapevo ad esempio abbastanza sui commerci che si facevano nel Lager. Siccome la mamma non veniva più, ma io vivevo con questa speranza, avevo continuato a mettere da parte il burro e qualche patata per loro. Quando però mi convinsi che la mamma non poteva più venire - eravamo già 199 verso la fine dell’anno - riuscii a comperare da un uomo un paio di pantaloni e un maglioncino. Fu lui a chiamarmi dal reticolato, mi chiese se li volevo in cambio di pane. Accettai subito: faceva freddo e capivo che avevo in quel momento più bisogno di abiti che di cibo. Era l’istinto che me lo diceva. In questo periodo la Kapò mi aveva adocchiata, perché avevo ancora un bell’aspetto. Ogni tanto veniva un’infermiera e mi prelevava una siringa di sangue. «Tuo sangue buono per nostri soldati, per nostri Tedeschi malati», mi diceva. Per questo mi davano più da mangiare e io stavo bene, non avevo fame. C’era una romana piccolina, magra, che era invidiosa perché a me davano da mangiare di più. Non avevi paura? No. Non mi facevano male e mi davano da mangiare. Con quel cibo in più facevo i miei commerci. Ero contenta. Mettevo da parte alcune cose per istinto come se sapessi che avrei potuto averne bisogno. Era sempre l’istinto che mi diceva di tenermi lontana dall’infermeria. Verso la fine dell’anno avevo preso una brutta congiuntivite e al mattino non riuscivo ad aprire gli occhi. Quando mi svegliavo, con la saliva mi toglievo le croste dagli occhi perché la Kapò non si accorgesse del male. Mi sono curata da sola con la saliva. Proprio in quei giorni, un mattino sentii gridare il mio nome, fuori dalla baracca. «Ari…Ari…» Siccome nessuno rispondeva la voce continuò a gridare: « Se c’è una bambina fiumana, esca fuori per vedere sua madre». Con un balzo fui fuori sulla porta e riconobbi Luigino, un bambino fiumano che era anche lui nel mio vagone durante il trasporto da San Sabba. Siccome il bambino parlava tedesco, era stato scelto per fare il portaordini del campo. Quando mi vide mi disse di far presto e di guardare in fondo alla fila di baracche, perché c’era mia madre e le mie quattro sorelle. Mi portai dove aveva detto Luigino, che continuava a farmi dei segni dall’altra parte del filo spinato, ma purtroppo non vidi altro che cinque figure lontanissime. Distinsi solo due cappuccetti rosa, i cappucci che mia mamma ci aveva cucito con un pezzo di coperta e del 200 fil di ferro. I cappucci si distinguevano fra cinque pupazzetti neri tanta era la lontananza. Agitai le braccia perché anche loro mi vedessero ma la sentinella della garitta cominciò ad urlare: «Vai dentro, vai via», e sparò un colpo in aria. Luigino appena mi vide tornare mi gettò un pezzo di carta ed io su quel pezzo, con un carboncino, scrissi che ero contenta di averle viste e che appena saremmo tornate a casa volevo che la mamma mi cucinasse le «palacinche», un dolce nostro, di Fiume. Sono sicura che Luigino ha portato - Dio lo benedica - il biglietto alla mamma. Dopo quella volta non le ho più riviste, ma soltanto il pensiero di saperle ancora vive mi diede coraggio, un coraggio nuovo. Cercai di guarire dalla congiuntivite, di tenermi pulita e ci riuscii. Incominciò a nevicare, era dicembre. Auschwitz si coprì di neve. Dovevamo giocare, sempre fuori (solo qualche volta ci portavano a intrecciare delle trecce di fibra sintetica o a spaccare pietre in un campo) e la neve entrava nelle scarpe. Il gioco era peggio del lavoro. Una sera, dopo l’ultimo appello, rientrammo nella baracca come d’abitudine. La Kapò, più gentile del solito, distribuì a tutti una coperta e mezza pagnotta di pane nero, poi ci disse di dormire subito perché il giorno dopo avremmo fatto un bel viaggio. Dopo poche ore di sonno ci svegliarono bruscamente: ordini e contrordini, urla, non si capiva più niente. Ad ogni momento arrivava una Kapò con un ordine nuovo. Ci dissero di prendere la coperta, ci diedero ancora mezza pagnotta di pane e così infagottati e carichi ci misero in fila per cinque. Io stringevo la coperta, il pane, la «minska» (gamella), il cucchiaino, tutti i miei averi. Incominciò la marcia della morte, una fila interminabile con noi bambini per primi, poi le donne ammalate, poi quelle sane, poi gli uomini e in fondo alla fila la scorta tedesca. Ogni venti metri una SS e un cane ci sorvegliavano. Camminammo nella neve per tre giorni e tre notti: non ci si poteva nemmeno sedere, perché non ci eravamo ancora fermati che già davano l’ordine di ripartire. Io avevo imparato. Quando dicevano «Alle sitzen» (Tutti seduti), mi accoccolavo solo sui calcagni per essere pronta a scattare in piedi all’ordine di ripartire. Chi non ubbidiva subito, il cane lo azzannava. Ho visto molte compagne morsicate dai cani non rialzarsi più per il dolore. Allora 201 i soldati le colpivano con il calcio del fucile. Altri le finivano a calci. Durante il viaggio persi il pane, anche se lo avevo legato bene nella coperta. Io andavo avanti con la speranza di incontrare qualcuno dei miei. All’inizio vedevo ancora tanti bambini dietro di me, poi non ne vidi più; morti per la strada ne ho visti tantissimi. Mi si congelarono i piedi, prima il destro, poi il sinistro. Ad un certo punto non sentii più rumore di zoccoli alle mie spalle, ma il passo degli stivaloni SS: ero rimasta ultima. Mi sentii afferrare per una spalla, voltai gli occhi e vidi un soldato con il fucile alzato che stava per colpirmi, ma in quel momento quello che mi aveva afferrata per la spalla fermò il compagno: «Lasciala stare, non vedi è solo una bambina». Oramai capivo il tedesco e lo parlavo anche benino. Mi feci furba e quando mi chiesero perché ero sola dissi che la mamma lavorava ad Auschwitz e che mi facevano tanto male le gambe. Uno di loro tirò fuori dallo zaino un pezzo di pane dolce e del lardo e me lo diede, poi mi fece salire su una slitta carica di bagagli delle SS che quattro donne russe tiravano faticosamente sulla neve. E’ stata la mia salvezza. Come spieghi oggi questo barlume di umanità? Già una volta una donna SS ti aveva dato un cioccolatino, sono casi eccezionali. Non so, loro erano così. Un momento potevi pensare che sotto quella divisa ci fosse un uomo, un padre, ma solo per un momento. Subito dopo ti facevano pagare caro quello che ti avevano dato. Lo stesso che mi aveva dato il pane mi prese a schiaffi poche ore dopo, quando, arrivate alla stazione mi stavo arrampicando a fatica sul vagone, con le poche forze che mi rimanevano, i piedi congelati, le mani piene di geloni, e lui mi schiaffeggiò perché non facevo salire prima una donna incinta. Anche questo atto, diciamo di cavalleria, è inspiegabile in quella situazione. Quella donna partorì il giorno dopo - era gennaio - sul vagone scoperto. Era mattina, non so da quanto tempo si viaggiava. Ricordo le grida della donna e i vagiti del bambino. Era un maschietto. Una donna slava mi tirò vicino a sé e m’impedì di guardare. Il bambino visse forse un giorno, poi una SS prese quel fagottino e lo gettò fuori dal vagone. La madre impazzì. 202 Arrivammo a Ravensbrück e dopo la solita trafila fui assegnata a un blocco, non so quale, so solo che dormivo in un castello con cinque russe, una più cattiva dell’altra. In questo campo ho subito due o tre selezioni, mi sentivo molto vicina alla morte. Un giorno, con un altro «Transport» mi portarono a Bergen Belsen. In che periodo sei arrivata a Belsen? Non ricordo con esattezza, forse metà febbraio, faceva molto freddo. A Belsen non c’erano né le Koie, come ad Auschwitz, né i letti a castello, come a Ravensbrück. La baracca non era pavimentata, si dormiva per terra, sopra un po’ di paglia. Morivano dieci-quindici persone per notte. Sei sempre rimasta in quella baracca? Sì, fino alla fine. Ed è stato lì che ho imparato le ultime cose che poteva insegnarmi il campo: ho imparato a spostare i morti per avere un po’ di zuppa. A Belsen non si mangiava quasi mai: ho imparato ad aspettare che morisse qualcuno per prendergli il pane. E’ successo così. Un giorno vidi una vecchietta che nascondeva un pezzo di pane sotto la sua testa. La vecchietta (ma chissà se era poi tanto vecchia) stava male e un giorno morì. Io la stavo osservando e mi accorsi che non si muoveva più. Allora nella notte mi avvicinai e mi presi la fetta di pane e le sue scarpe. Il giorno dopo aiutai a trasportarla nel mucchio di cadaveri ed ebbi anche un po’ di zuppa. Spero che tu non abbia rimorsi per questo. A Belsen mi ero inaridita, non pensavo più ai miei, cercavo solo di mantenermi in vita, escogitavo di tutto per trovare qualcosa da mangiare, cercavo di non lasciarmi morire come facevano le altre che avevano la diarrea e sporcavano in baracca perché non avevano più la forza di uscire. La baracca puzzava in modo orrendo. Io ero sempre fuori per non 203 vivere in quel sudiciume, mi lavavo ancora, mi spidocchiavo con Luisa e mentre, tutte attente, toglievamo i pidocchi dalle cuciture, parlavamo di casa e di quello che avremmo mangiato. Lei parlava di tortellini al ragù e io di pasta e fagioli e «palacinche». Stavo con Luisa, avevo paura di perdere anche lei, ma Luisa stava male, si consumava e un mattino non volle venire all’appello, non si lasciò convincere, era invasa dalla diarrea. Dopo l’appello la portarono via, non la vidi più. Mi mancò molto, con lei potevo ancora giocare. Giocavamo a spidocchiarci e a contare le qualità di pidocchi. Eravamo arrivate a contarne più di dieci qualità diverse: quelli tutti bianchi, quelli bianchi con la crocetta nera sulla schiena, altri piccolissimi, tutti rossi, e tanti, tanti, tanti altri ancora. In quei giorni pensavi che fuori potesse esserci una vita diversa? Non so, credo che in quei giorni potessi ancora pensare. Non pensavo quasi più ai miei cari, cercavo solo di tenermi in vita e per far questo sapevo che dovevo star fuori da quella baracca puzzolente e piena di malati, star fuori il più possibile, cercare le bucce di patate fuori dalla finestra della Kapò, o qualche filo d’erba. Cercavo l’acqua che non c’era più e un giorno bevvi l’acqua di una vasca dove c’era un morto. Non sapevo che poteva essere inquinata. Passavo i giorni a curarmi i piedi congelati che avevano uno strato di pelle dura e di sangue raggrumato. Provavo sollievo a togliermi quelle croste. L’operazione non mi riuscì all’alluce del piede sinistro che era congelato fino all’osso. Alla liberazione dovettero segarmi un pezzo d’osso. Un giorno - era ormai Marzo - ci portarono, quelle che stavano in piedi, alle docce, poi ci lasciarono nude a lungo all’aperto: pensavo che ci avrebbero portate al crematorio. Ormai ero rassegnata. Invece, era il mio destino, ci fecero rivestire e ci ricondussero in baracca. Forse per il freddo, forse per l’acqua infetta mi venne la dissenteria. Eravamo già in aprile. Io ero sicura che ci avrebbero liberate il 18, giorno del mio compleanno, era la mia speranza. Le morte al mattino erano sempre più numerose. Una notte, costretta ad uscire dalla baracca per andare alla la- 204 trina, vidi all’orizzonte tanto fuoco e dei bagliori rossi e gialli. Non capivo che cosa fosse ed ebbi paura, ma forse anche speranza. Ripensai a tutta la mia famiglia e piansi a lungo, forte. Le donne della baracca mi urlavano di stare zitta, di lasciarle dormire. La diarrea continuava, anzi peggiorava ogni giorno. Avevo paura ad uscire dalla baracca perché un giorno avevo incontrato la Irma Grese che mi aveva puntato la pistola alla schiena e non aveva sparato solo perché in quel momento erano sopraggiunti in gruppo altre SS che l’avevano distratta dal divertimento facendole dei complimenti. Sei sicura che fosse Irma Grese? Io non la conoscevo ma me lo dissero delle donne, anziane del campo, che avevano visto la scena. Sono sicura che era lei. Mi dissero che l’avevo scampata per un pelo. Ti ricordi la liberazione? Sì, ero molto malata, ma la ricordo. Ero uscita al solito per andare alla latrina, quando mi accorsi che non c’erano più Kapò in giro e che mancavano i soldati alle garitte, poi vidi una gran confusione, dei camion verdi e carri armati con soldati festosi che urlavano. Corsi in baracca gridando: «Ci sono gli americani», ma nessuno mi credette. La signora Braun, con il figlio morente fra le braccia, mi disse: «Buttati giù, figlia mia, che sei più pazza di tutte». Invece poco dopo entrarono i liberatori. Io, a guardare le loro facce inorridite, mi spaventai. Erano sempre soldati e non riuscivo a vedere la differenza fra soldati amici e soldati nemici. A dodici anni non ancora compiuti non è facile capire la logica della guerra, la logica ufficiale delle divise. Erano divise e basta. Le divise mi terrorizzavano. Ricordo solo che mentre ero rannicchiata, tutta impaurita, per terra, mi scattarono tante foto ricordo e mi gettarono del cioccolato, scatolette di carne, latte in polvere. Ogni ben di Dio. Per questo ben di Dio mori- 205 rono tante, tante donne. Io non so perché mangiai pochissimo di quel ben di Dio. Lo misi quasi tutto da parte per portarlo a casa, a mia mamma e alle mie sorelle. INTERVISTA A BRUNO VENEZIA La mia famiglia abitava in Grecia da moltissimi anni, ma abbiamo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, tanto è vero che mio padre era di leva nella Prima Guerra Mondiale e andò a combattere come volontario in Italia. Dopo che l’Italia aveva dichiarato guerra alla Grecia, rendendosi conto delle enormi difficoltà che aveva l’esercito, andò in suo aiuto la Germania. I Tedeschi occuparono la città in cui vivevo, Salonicco, e dopo circa un anno iniziarono a dare la caccia agli ebrei, che contavano una comunità di circa 60.000 persone. Nel marzo del ’43 iniziarono le deportazioni, che proseguirono circa fino al mese di agosto; in questo periodo, sebbene brevissimo, furono deportati quasi 60.000 ebrei. Fino a quel momento a noi, che di fatto eravamo Italiani, non venne fatto niente, anzi avevamo anche i permessi per girare liberamente; non abbiamo risentito molto delle leggi razziali perché il console di Salonicco non badava tanto a queste cose. E’ vero che non si poteva più andare a scuola ma, essendoci la guerra, questo era un problema minore. Era molto più importante il cibo e noi che eravamo orfani di guerra (mio padre era morto circa due anni prima e la famiglia in quel momento era composta da me, mia madre e altri quattro fratelli) ricevevamo dal Consolato ogni settimana viveri sufficienti per i successivi sette giorni. Comunque arrivò anche al console la richiesta di trasferire gli ebrei italiani ad Atene; lui non accettò, ma gli venne imposto un ultimatum dai Tedeschi: «Se non li trasferite voi, li porteremo via noi». Allora il console fu costretto a deportare parecchie famiglie ebree da Salonicco ad Atene, noi compresi; lì eravamo abbastanza tranquilli, anche se eravamo profughi e cercavamo di arrangiarci come potevamo. Dopo il famoso 8 206 settembre gli ufficiali delle SS avevano costretto tutti i maschi adulti ad andare alla Comunità ebraica a firmare un registro una volta la settimana; questo durò per parecchio tempo, ormai ci eravamo abituati e non pensavamo minimamente che avrebbero avuto il tempo di portarci via tutti, perché i Tedeschi stavano iniziando a ritirarsi su tutti i fronti, quindi non pensammo neanche a trovare un posto dove nasconderci. Un venerdì ci recammo come al solito a firmare il registro, ma una volta entrati nella Comunità non ci fecero più uscire, e rimanemmo intrappolati. Cercavamo di far capire agli altri di andare a nascondersi perché la cosa era molto grave, ma nessuno ci credeva: erano convinti che i Tedeschi non avrebbero avuto abbastanza tempo per portare via tutti. In poche parole verso le due, le tre del pomeriggio ci hanno caricato su dei camion militari, sotto il controllo delle SS, e ci hanno portato in una grande prigione che c’era lì ad Atene. La mattina seguente ci hanno fatti andare tutti in un cortile e hanno detto di cercare i propri familiari e di unirsi a loro; io e mio fratello non pensavamo di incontrare nostra madre e le nostre sorelle, invece entrando nel cortile le abbiamo viste. I Tedeschi ci avevano detto, ingannandoci, di riunirci alle famiglie perché, quando saremmo arrivati nel posto (non ci dicevano dove, quando, in che città, in che paese), in base al numero dei componenti della famiglia, ci avrebbero dato una casa in cui abitare. Allora, credendo a ciò che dicevano, ci siamo tranquillizzati, pensando che poi gli uomini sarebbero andati a lavorare e le donne sarebbero rimaste a casa. Invece, una volta riunite le famiglie, ci hanno portato allo scalo della ferrovia di Atene e ci hanno messo dentro dei vagoni bestiame: nel mio vagone eravamo circa una settantina, in altri vagoni c’erano anche cento persone, poi hanno sigillato i vagoni con il piombo, come fossimo della merce da spedire. Questi vagoni avevano quattro finestrini molto piccoli, da cui entrava appena un po’ d’aria; in un angolo c’erano una ventina di chili di carote e tre cassettine di uva passa: questo era il nostro sostentamento per il viaggio. Inoltre al centro del vagone c’erano un barile di quelli che si usano per la benzina, che serviva per i bisogni, e un altro barile, più piccolo, che conteneva circa cento litri d’acqua. Ad un certo punto ho guardato fuori e ho visto l’ufficiale che doveva guidare la spedizione 207 attorniato da delle persone in borghese con una fascia al braccio con sopra una croce rossa: erano ufficiali della Croce Rossa che stavano cercando di convincere l’SS a permettere che ci venissero dati dei viveri in più per il viaggio. Venne pattuito che dopo una quindicina di chilometri il treno si sarebbe fermato per distribuire questi viveri; la decisione di fermarsi dopo la partenza era finalizzata a non far vedere alle persone che a quell’ora iniziavano ad andare a lavorare (erano circa le cinque del mattino) il treno che ci trasportava. La distribuzione dei pacchi di viveri è stata la nostra salvezza perché diversamente da ciò che pensavamo (tre, quattro giorni al massimo) il viaggio, secondo il mio parere, è durato 16-17 giorni, questo perché il treno si fermava spesso per dare la precedenza agli altri treni che andavano o tornavano dal fronte, altrimenti ci avremmo messo non più di tre giorni. Inoltre, essendo le locomotive a vapore, il treno si fermava per fare rifornimento di carbone. Abbiamo attraversato la Grecia da Atene a Salonicco, poi a nord in Jugoslavia, da lì verso l’Austria, e poi dall’Austria siamo entrati, penso, in un pezzo dell’Ungheria, poi in Cecoslovacchia e finalmente in Polonia; non sapevamo di essere in Polonia perché non vedevamo scritte, ecc., sapevamo solo che il viaggio era stato molto molto lungo ed eravamo sfiniti tutti quanti, fortunatamente nel nostro vagone ce l’hanno fatta tutti, al contrario di altri vagoni. Eravamo comunque molto spaventati perché quando ci siamo fermati alla stazione di Salonicco (fuori dalla stazione, ci fermavamo sempre fuori, non dove c’erano i passeggeri), ho visto un mio amico che lavorava alla ferrovia, stava controllando i freni del nostro treno e, alzando la testa, mi ha visto dal finestrino, mi ha riconosciuto e sottovoce mi ha detto «Cercate di scappare perché dove vi portano vi ammazzano tutti». Noi avevamo già una mezza idea di scappare e dopo aver sentito le sue parole ci siamo decisi a tentare in ogni modo la fuga: avevamo deciso (io, mio fratello e i miei due cugini) che prima di uscire dalla Grecia, di notte, ci saremmo buttati dal finestrino; io all’epoca ero snello e quindi riuscivo a passarci. Verso mezzanotte, quando tutti dormivano, ci siamo avvicinati al finestrino; mio fratello aveva già una gamba fuori quando il padre dei miei cugini si è accorto della nostra manovra e si è messo a gridare svegliando tutti. Logicamen- 208 te mia madre, come tutti gli altri, si è messa a piangere, perché alla partenza ci avevano contati e se all’arrivo mancava qualcuno avrebbero ucciso tutti, quindi abbiamo desistito. Quando siamo arrivati ad Auschwitz-Birkenau alcuni prigionieri ci hanno spalancato i portelloni, mentre i Tedeschi con i cani al guinzaglio si trovavano a circa dieci metri dal treno. Urlando ci hanno ordinato di scendere dai vagoni, io volevo aiutare mia madre ma non mi è stato possibile, perché le SS avevano creato una tale situazione di confusione e terrore che eravamo tutti impietriti, avevamo paura anche di respirare. Hanno diviso gli uomini dalle donne e delle 1500 persone che eravamo 1050 sono state mandate subito ai forni crematori. Io, mio fratello e i miei cugini siamo stati mandati a Birkenau dove, per prima cosa, ci hanno mandati nella “sauna”, un luogo in cui dovevamo svestirci, fare la doccia, la disinfestazione e cose di questo genere. Per prima cosa, ci fecero spogliare e dei prigionieri ci depilarono completamente, lasciandoci solo una striscia di capelli al centro di modo che se fossimo scappati ci avrebbero riconosciuto subito; con gli attrezzi che avevano a disposizione ci scorticarono a sangue. Comunque dopo questa operazione ci fecero entrare nelle docce dove l’acqua cominciò a scendere bollentissima, perché c’era uno delle SS che stava accanto alle manopole dell’acqua e si divertiva a farla uscire molto calda: istintivamente tutti cercavano di scansarsi, lui allora correva a tirare calci e si metteva a ridere. Dopo ci hanno mandati a fare il tatuaggio, io ho sentito molto dolore al braccio e, strofinando con la mano sul sangue e sull’inchiostro, non riuscivo più a vedere il mio numero; mi sono spaventato perché ero sicuro che mi avrebbero picchiato, fortunatamente sono riuscito a pulirmi il braccio con la saliva e ho visto che l’inchiostro era iniettato. In seguito ci hanno dato vestiti e scarpe, ovviamente usati. Dopo questa operazione ho cercato di informarmi su mia madre e mia sorella e, visto che parlavo già un po’ di tedesco, ho chiesto ad un ebreo polacco, lui mi ha portato vicino ad una finestra e mi ha detto: «Vedi quella fiamma? (c’era una ciminiera molto alta) Tutti quelli che non sono venuti con voi sono stati mandati subito ai forni crematori». La mattina seguente ci hanno portato nelle baracche della quarantena, dove c’erano dei letti a castello a tre piani, ciascun letto doveva 209 contenere cinque persone ma normalmente ci dormivano almeno sette o otto persone. Finalmente ci hanno dato del pane da mangiare, che era un ottavo di una forma, questo perché ancora non andavamo a lavorare, infatti coloro che lavoravano avevano diritto ad un sesto della forma. Inoltre dovevamo ricevere la minestra ma non avevamo niente in cui metterla, pensavamo che avremmo ricevuto anche una scodella, ma non fu così e per questo motivo molti non ricevettero la loro razione di minestra (questo avvenne perché il capo baracca quella mattina non ci aveva portato nel luogo in cui si prendevano le gamelle). Sono stato in quelle baracche per una ventina di giorni circa poi, finalmente, è arrivato un ufficiale delle SS che aveva bisogno di ottanta persone da mandare a lavorare; io ho detto di essere un barbiere (visto e considerato come ero stato depilato, ero capace anch’io di fare il barbiere) e mi hanno portato insieme agli altri scelti al campo centrale. Ci hanno sistemati in una baracca isolata rispetto alle altre, perché era circondata dal filo spinato: era la baracca del “SonderKommando”, ovvero comando speciale. Entrando dentro ho incontrato un prigioniero che era lì da qualche mese, e che mi ha chiesto se sapevo quale lavoro avrei dovuto fare ed io gli ho risposto che ero all’oscuro di tutto, ciò che mi bastava era sapere che ci avrebbero dato da mangiare, era l’unica cosa di cui mi importava. Egli allora mi ha rivelato che dopo tre mesi ci avrebbero uccisi tutti, ma ormai eravamo lì e quindi c’era poco da fare. Il giorno dopo ci hanno portato a lavorare ai forni crematori, ma non ci hanno fatti entrare subito dentro. Il nostro compito consisteva nel fare pulizia generale della zona esterna: estirpare le erbacce, ecc. Ad un certo punto io mi sono avvicinato ad una finestra ad altezza d’uomo e, guardando dentro, ho visto un mucchio di cadaveri ammassati l’uno sull’altro, sono rimasto terrorizzato perché in tutta la mia vita avevo visto un solo morto: mio padre. Quando sono tornato dai miei compagni e ho detto loro ciò che avevo visto, mi hanno preso per matto ma, dopo essersi accertati del fatto, sono rimasti anch’essi sconvolti. Verso le due il capo ci ha detto di andare dentro al crematorio che era formato da una camera lunghissima dove la gente si svestiva ed un’altra, contigua, che costituiva la camera a gas. Dentro alla camera di svestizione c’erano un 210 sacco di vestiti buttati in terra che noi dovevamo riunire in fagotti e portare fuori, poi arrivava un camion, su cui venivano caricati, che li portava in un luogo in cui delle prigioniere li dividevano e sceglievano le cose migliori per spedirle in Germania. Verso le 6 pensavamo di tornare nella nostra baracca al campo, invece, nell’uscire dal crematorio, ci hanno portati in una piccola foresta; dopo circa un chilometro abbiamo scorto una casetta, che probabilmente un tempo apparteneva a dei contadini del luogo, e, una volta arrivati, ci hanno detto di rimanere fermi lì fuori. Dopo un po’ di tempo abbiamo visto arrivare un gruppo di prigionieri (erano la rimanenza di un grande gruppo che evidentemente non entrava tutto all’interno di un crematorio) che vennero fatti svestire all’aperto per poi entrare nella casetta con la scusa di fare la doccia. Quando ormai erano tutti dentro è arrivato un ufficiale delle SS, il quale con uno sgabelletto (sono particolari che non si possono dimenticare) è salito sopra la casetta e, attraverso una finestrella, ha buttato il gas (Cyclon B) dentro alla casetta. Dopo circa dieci minuti ci hanno fatto aprire la porta e il Kapò ci ha detto di trasportare i cadaveri una quindicina di metri più in là, dove era stato scavato un fossato grande come una piscina in cui ardeva il fuoco. Dopo due ore che stavamo lavorando, ho notato un mio compagno che era rimasto impietrito, con il cadavere tra le mani, e non andava né avanti né indietro; io gli stavo passando vicino e gli ho detto di muoversi altrimenti l’SS l’avrebbe ammazzato, ma lui non sbatteva neanche più le ciglia, rimaneva immobile. L’ufficiale se ne è accorto e si è avvicinato gridandogli di sbrigarsi, ma lui niente; allora ha tirato fuori la frusta e ha iniziato a picchiarlo ma il mio compagno continuava a restare fermo; poi ha preso la pistola e gli ha sparato due colpi a salve ma lui non si è mosso di un passo; a quel punto l’SS indignato ha tirato fuori dalla fondina la pistola di ordinanza e l’ha ucciso. La mattina dopo è venuto un altro gruppo a darci il cambio e noi siamo tornati alle baracche a riposarci e, fortunatamente, verso sera sono venuti a dirci che non c’era più bisogno di noi in quel posto. Il giorno dopo ci hanno assegnato il nostro lavoro definitivo: io e un cugino eravamo stati assegnati al crematorio n. 2, mentre mio fratello e l’altro cugino 211 erano stati mandati al n. 3. Appena arrivati il Kapò mi ha dato le forbici: io dovevo tagliare i capelli dei cadaveri delle donne che venivano portati fuori dalle «docce», un mio amico, che aveva detto di essere un dentista (in realtà lavorava in banca), aveva ricevuto le pinze, per estrarre i denti d’oro dalla bocca dei morti. Questo è stato il mio lavoro per diversi mesi. Ero riuscito anche a far trasferire mio fratello al mio crematorio, grazie all’aiuto del mio Kapò, un ebreo polacco molto in gamba, che era riuscito a scambiarlo con un’altra persona che lavorava con me. Non abbiamo mai lasciato il nostro posto ad un altro gruppo (cosa che avveniva normalmente ogni tre mesi), perché c’era un’alta affluenza di prigionieri dall’Ungheria e avevano bisogno di gente che fosse pratica in quel lavoro; non potevano perdere tempo. Inoltre i Tedeschi stavano perdendo su tutti i fronti, e cercavano di uccidere più ebrei che potevano nel minor tempo possibile. Nel frattempo i Kapò dei forni 1 e 2 erano riusciti a mettersi in contatto con i partigiani polacchi che stavano fuori, e stavano organizzando una rivolta. Avevano fissato un giorno, mi sembra un venerdì alle 6 di sera, in cui i prigionieri del crematorio 1, dal quale eravamo separati da un vialone da cui ogni sera passavano delle guardie per andare ai loro posti di guardia, dovevano assalire queste guardie all’improvviso con pugnali o bastoni e ucciderle tutte. Il caso volle che quel giorno, verso le 2, fosse arrivato un grandissimo treno pieno di prigionieri dai vari ghetti della Polonia, e tutte le guardie si erano messe intorno a questo treno: logicamente fino a che non se ne andavano noi non potevamo fare niente. Stranamente rimanevano tutti fermi senza far scendere i prigionieri. Inoltre quelli dei crematori 3 e 4, che dovevano dare fuoco a tutti i pagliericci, non vedevano cosa stava succedendo e iniziarono la rivolta, pensando di riuscire a scappare, ma vennero uccisi tutti. La stessa cosa avvenne al crematorio n. 1, perché erano riusciti ad aprirsi un varco nel filo spinato (sul quale di giorno non passava la corrente), ma non andarono lontano. Anche il nostro forno era stato circondato, ma il Kapò, che aveva intuito che scappare significava morire, ci ordinò di non fare niente. Le SS ci avevano chiusi in una stanzetta, eravamo convinti che ci avrebbero uccisi dopo quello che era successo. Ordinarono di far uscire trenta perso- 212 ne, nessuno voleva farlo; io allora ho pensato «Meglio farla finita subito» e sono andato. In realtà ci hanno mandati ad uno degli altri forni per finire il lavoro di quelli che avevano tentato di scappare. Dopo tre giorni sono tornati degli ufficiali e ci hanno fatto mettere in fila per cinque davanti ai forni, chiamavano una fila per volta e li facevano entrare in un’altra stanza; ogni volta che una fila entrava si sentiva solo silenzio. Eravamo rimasti in venti e ci hanno ordinato di spogliarci; a quel punto eravamo sicuri di essere uccisi perché davanti avevamo il fuoco che ardeva e tutt’intorno SS con i mitra puntati. In realtà i Tedeschi stavano cercando le eventuali armi che dovevano essere usate per la rivolta, fortunatamente nessuno aveva niente con sé e ci hanno ordinato di rivestirci. Anche quella volta ci è andata bene. Verso novembre sono venuti a dirci che dovevamo smantellare i forni, noi che lavoravamo dentro dovevamo smantellare l’interno. Una sera, quando ormai avevamo finito il nostro lavoro, abbiamo visto arrivare altri prigionieri che si sono occupati dell’esterno: toglievano le tegole una per una, perché tutto il materiale doveva rimanere intatto (perfino i mattoni) per essere trasportato altrove. Da quel momento siamo tornati a stare nelle baracca all’interno del campo. Un giorno, mentre rientravamo nel lager, un ufficiale ci ha fermati, e ci ha detto di entrare nella baracca e di non uscire più; entrando nel campo però abbiamo visto che tutti i prigionieri erano pronti all’evacuazione, e abbiamo pensato che se fossimo rimasti nel campo ci avrebbero ammazzati, quindi ci siamo mescolati alla folla sparpagliandoci per non dare nell’occhio, visto che, essendo un gruppo a parte, eravamo più sani e meglio nutriti. Ci hanno spostati da Birkenau ad Auschwitz, dove erano tutti pronti a partire, perché si sentivano già gli spari di cannone dei Russi, che erano accampati oltre il fiume. La mattina seguente, molto presto, verso le cinque e mezzo, abbiamo iniziato la “marcia della morte” verso l’Austria. In quel viaggio abbiamo dormito in terra o in vecchi casolari di contadini; una volta ci hanno caricati su dei treni merce aperti ed eravamo talmente stretti che non riuscivo neanche a piegarmi, però era comunque meglio che camminare al freddo. Quando siamo arrivati in Austria ci hanno portati a Mauthausen; lì ci hanno fatto spogliare, depilare e fare la doccia. Dopo la doccia ci 213 hanno fatti uscire all’aperto, nudi senza neanche le scarpe, nella neve, ad aspettare che ci dessero il nuovo numero, che era inciso su un pezzo di metallo legato al polso con un fil di ferro. Poi ci hanno accompagnati in una baracca, completamente vuota, per passare la notte: siamo stati fortunati perché in terra c’era il linoleum e le finestre erano tutte intatte, comunque eravamo completamente nudi e stretti come le sardine. Il giorno dopo io ho deciso di cercare di farmi mandare in un altro posto per lavorare, almeno avrei ricevuto il vestiario, mentre mio fratello decise di rimanere a Mauthausen perché se uno dei due ce l’avesse fatta avrebbe potuto raccontare ciò che era accaduto. Lui venne mandato in un luogo peggiore rispetto a dove sono andato io, infatti è stato molto male, dopo la liberazione è stato due mesi in coma e tuttora non si ricorda di molte cose di quel periodo. Io invece sono andato a Melk, dove dovevamo scavare dei tunnel, che servivano a nascondere dei missili, i V2. In quel posto mi sono trovato discretamente perché avevamo un ingegnere, un civile che non aveva niente a che fare con le SS, che ci diceva di andare piano, e se fosse arrivato qualcuno ci avrebbe avvisato fischiando di far finta di lavorare. Inoltre stando sotto terra, in profondità, non soffrivamo il freddo. Verso mezzogiorno suonava il gong del pranzo, e tutti cercavano di non stare in cima alla fila per non prendere le prime porzioni, che erano le più acquose. Un giorno sono capitato tra i primi e ho ricevuto una porzione praticamente di acqua calda, ho iniziato a pensare che avrei dovuto aspettare 24 ore prima di ricevere nuovamente la zuppa, così ho tentato di rimettermi in fila, ma gli altri che mi hanno visto hanno iniziato a gridare, allora il Kapò si è avvicinato e, nonostante io abbia tentato di scappare, mi ha tirato una pala nella schiena. Mi è mancato il respiro, è stata la prima volta che ho pianto da quando ero stato deportato. Ho visto che stava alzando la pala di nuovo e sono riuscito a scappare e così mi sono salvato, perché quel Kapò era uno a cui piaceva poter dire ai Tedeschi, la sera, quanti uomini era riuscito ad ammazzare durante il giorno. Dopo un po’ di tempo mi hanno nuovamente spostato in un altro campo, l’ultimo, sempre in Austria. Anche lì dovevamo lavorare a delle gallerie, con la differenza però che quel posto era una montagna roccio- 214 sa, quindi dentro le gallerie filtrava l’acqua. Lavorando dentro a quei tunnel ci si bagnava fino all’osso, senza possibilità di asciugarsi e quando si tornava alla baracca non potevamo neanche toglierci i vestiti bagnati, perché ce li avrebbero rubati sicuramente. Io infatti ero disperato, ero convinto che non ci sarebbe stata via d’uscita. Fortunatamente, però, dopo dieci giorni gli Alleati bombardarono una stazione del treno lì vicino, e mandarono noi prigionieri a togliere i detriti: ogni mattina prendevamo il treno fino a dove la linea era interrotta, poi facevamo un chilometro e mezzo a piedi circa per arrivare alla stazione. Eravamo felici, non ci importava del freddo perché innanzi tutto non eravamo bagnati e poi perché, lavorando tra quelle macerie, c’era la possibilità di trovare merce di scambio come le cicche delle sigarette. Gli ultimi giorni si sentiva che stavano arrivando gli Americani, allora il comandante del campo fece riunire tutti nel piazzale e disse che per la nostra incolumità saremmo dovuti entrare nelle gallerie, ma i Kapò, che avevano capito che in realtà volevano ucciderci, ci dissero di non accettare, e così facemmo. Il comandante allora rimpiazzò le SS con dei soldati semplici, proprio per non lasciarci senza controllo, mentre lui e gli altri scomparvero. Siamo rimasti da soli per cinque giorni, aspettando gli Americani, senza sapere cosa mangiare; io, non so neanche come, sono riuscito a trovare nelle cucine un sacchetto di patate, e con quelle sono riuscito a resistere. Uno di quei giorni ho visto il Kapò che mi aveva tirato la palata sulla schiena, che era già pronto per scappare. Mi è venuto un tale odio dentro che ho preso il bastone di un vecchio che era lì in terra, e gli ho tirato due bastonate con le poche forze che mi restavano, lui si è accasciato come mi ero accasciato io, nel frattempo sono arrivati dei Russi, e mi è bastato dire «Kapò, Kapò!», che gli si sono gettati addosso e l’hanno praticamente ucciso. Come lui una trentina di altri Kapò sono stati ammazzati in questo modo. Finalmente dopo cinque giorni abbiamo visto entrare due carri armati nel campo. Dopo due giorni sono tornato con i viveri, ma non riuscivano neanche a scaricarli che i prigionieri gli si buttavano addosso affamati. Poi sono riusciti ad organizzarsi e, all’interno di una baracca, distribuivano le razioni, di modo che anche il più debole poteva mangia- 215 re. In seguito, hanno montato molti tendoni, ci hanno fatto fare una «vera» doccia, ci hanno disinfettati e (ed è stata la cosa che mi è piaciuta di più) hanno dato fuoco a tutte le baracche perché si era diffuso il tifo. Nei giorni seguenti hanno chiesto ad ognuno dove voleva essere rimpatriato e ci hanno riportati a casa. Così, alla fine, sono riuscito a salvarmi. 216 INTERNATI MILITARI ITALIANI Francesco Martelli La tragica vicenda degli internati militari italiani (I.M.I.)1, come furono denominati dai tedeschi i soldati italiani non riconosciuti quali prigionieri di guerra, ha inizio l’8 settembre 1943, giorno in cui il maresciallo Badoglio rese noto l’armistizio firmato qualche giorno prima con gli anglo-amencani. Dopo l’annuncio dell’armistizio, Badoglio e il re fuggirono in Puglia e, cosa ancor più grave, insieme a loro fuggì anche lo Stato maggiore dell’esercito, lasciando completamente allo sbando e senza alcun ordine l’esercito italiano che in quel momento era impegnato in quella che Mussolini chiamava “guerra parallela”. Parallela perché questa guerra si svolgeva parallelamente a quella dell’alleato tedesco, ma con una notevole differenza in quanto a risultati: infatti l’esercito italiano fino ad allora non era quasi mai riuscito a conquistare territori importanti se non con l’aiuto dei tedeschi come, per esempio, nei Balcani e in Grecia. All’annuncio dell’armistizio l’esercito italiano era di stanza in Italia settentrionale, in Francia e, soprattutto, nei Balcani, in Grecia e nelle isole dell’Egeo. Le truppe tedesche, inviate da Hitler per aiutare gli italiani a conquistare i Balcani e la Grecia, ricevettero dopo l’8 settembre l’ordine di 1 Nell’ambito del presente progetto si è ritenuto interessante approfondire un aspetto della persecuzione nazista a tutt’oggi poco conosciuta. Per le vicende degli I.M.I. sono stati tenuti presenti i seguenti testi: AA. VV., I militari italiani internati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, Atti Del Congresso di studi di Firenze, 14-15 novembre 1985, Giunti, Firenze, 1986; AA. VV., Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945), Le Lettere, Firenze, 1992; A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex-Internati), Resistenza senz’armi. Un capitolo di storia italiana (1943-1945) dalle testimonianze di militari toscani internati nei lager nazisti, Le Monnier, Firenze, 1998; V. Vialli, Ho scelto la prigionia. La Resistenza dei soldati italiani nei lager nazisti 1943-45, A.N.E.I., Roma, 1983. 217 catturare i soldati italiani considerati come traditori del Reich e di condurli in campi di lavoro e di concentramento in Germania. Iniziò così per più di 650.000 militari italiani, catturati da quei soldati che fino al giorno prima avevano combattuto insieme a loro, fianco a fianco, una lunga agonia. Si verificarono casi di strenua resistenza da parte di truppe italiane, che, a causa dell’isolamento e dell’inferiorità numerica, si risolsero tutti con tremende carneficine come a Corfù e a Cefalonia. Facendo salire i soldati italiani sui treni, i tedeschi promettevano di riportarli in Italia alle loro case, mentre in realtà le loro intenzioni erano ben diverse. Per quanto riguarda i treni provenienti dalla Grecia, il viaggio prevedeva un tortuoso itinerario che da Corinto avrebbe dovuto portare i soldati italiani prima in Polonia e poi in Germania, senza però passare dall’Albania e dalla Jugoslavia, perché i tedeschi avevano paura dei partigiani jugoslavi, che più di una volta si erano messi in evidenza con successo nei confronti dei germanici. I prigionieri attraversarono tutta la Grecia, la Bulgaria, la Romania, l’Ungheria, parte della Germania e quasi tutta la Polonia per un totale di ventitré giorni di viaggio senza mangiare ed effettuando molte interminabili soste. Le porte del treno restarono aperte fino a Bratislava e la scorta tedesca era composta da non molte unità, ma furono ben pochi gli italiani che scapparono, malgrado questa scarsa sorveglianza, proprio perché i tedeschi avevano promesso sul loro onore che li avrebbero portati a casa. Ben presto però i prigionieri si accorsero che concezione avessero i tedeschi dell’onore: a Bratislava, durante la notte, le porte, con grande stupore ed incredulità di tutti, furono chiuse per essere riaperte soltanto all’arrivo in Polonia. La cattura dei soldati italiani ed il loro trasporto nei campi di lavoro erano state organizzate meticolosamente già da tempo, secondo un piano denominato “piano Alarico”, attuato alla perfezione. 218 Nei Carpazi era già avvenuto il primo colpo di scena: con il pretesto di atteggiamenti ostili degli italiani verso i tedeschi, i prigionieri vennero disarmati e a fianco della scorta tedesca ne arrivò anche una ungherese. I campi di concentramento in cui vennero portati gli italiani erano campi dove veniva demolita la personalità di ogni prigioniero. I prigionieri infatti erano costretti a subire maltrattamenti morali e fisici che aumentavano con il passare del tempo. L’unico aiuto umanitario che i prigionieri italiani ebbero fu quello inviato dal Vaticano, due gallette militari e un chilo di riso a testa in tutti i diciannove mesi di prigionia: era poco, ma fu tutto quello che gli italiani ebbero. I tedeschi infatti non riconoscevano gli italiani come prigionieri di guerra, impedendo così qualsiasi tipo di aiuto umanitario da parte della Croce Rossa internazionale, al contrario di tutti i prigionieri delle altre nazioni. Gli italiani erano costretti a subire la fame, il freddo (soprattutto nelle interminabili adunate che duravano ore e ore, i prigionieri erano costretti a stare all’aperto mal vestiti ed immobili), la sporcizia, le umiliazioni, la mancanza di notizie da casa, le malattie come tubercolosi o l’avitaminosi ed infine le minacce e i ricatti nei campi di punizione gestiti dalle temibili SS e dalla Gestapo. II primo campo in cui vennero portati i prigionieri italiani fu il campo di Lukenwalde vicino a Berlino. Per i primi tempi furono alloggiati in una baracca con una stufa all’interno, a loro disposizione c’era uno spaccio dove si potevano trovare scarpe, sigarette, lacci da scarpe e birre, anche se già da allora i viveri scarseggiavano. Dopo Lukenwalde i prigionieri furono trasferiti a Beniamiowo in Polonia e lì la vita per gli italiani cambiò drasticamente: la razione giornaliera di cibo diminuì fino a diventare una ciotola al giorno di acqua bollita con delle rape. Per più di tremila ufficiali c’era solo una pompa di acqua che, tra l’altro, si bloccava frequentemente per il freddo intenso. 219 Gli alloggi dove vennero scaraventati erano privi di pavimento; con poche finestre e senza stufe, per letto erano stati messi dei tavoli di legno. Per andare al bagno era necessario uscire dalla baracca, gridare la parola “Abort”, che appunto significa bagno, per non rischiare di essere feriti o addirittura uccisi, come raccontano alcune testimonianze, dalle sentinelle tedesche. La squilibrata e scorretta alimentazione costringeva i prigionieri ad uscire dalla baracca per andare in bagno almeno quattro o cinque volte a notte; il rischio che si correva per arrivare ai bagni obbligava i prigionieri a fermarsi nei pressi delle baracche e questo contribuiva ad accrescere l’odore nauseante vicino ai loro alloggi. Gli unici che davano una mano o almeno cercavano di farlo erano le guardie turche del campo ed i polacchi con i quali avvenivano scambi commerciali che risultarono poi fondamentali per i prigionieri italiani. I baratti con gli altri prigionieri polacchi, che in cambio di oggetti di valore o di vestiario, davano cibo e sigarette sono tra gli unici episodi di collaborazione e di amicizia tra gli internati italiani e quelli di altre nazioni. Infatti gli italiani in quei diciannove mesi di prigionia convivevano con quelli che prima dell’armistizio erano stati dichiarati nemici dello stato fascista, come per esempio i francesi, i belgi, gli olandesi e tanti altri. Purtroppo, nonostante la dura vita nei lager rendesse ogni prigioniero uguale a quell’altro, sia che fosse di un altro Stato o di un’altra estrazione sociale, non mancavano episodi spiacevoli nei confronti degli italiani, considerati traditori da molti prigionieri. Anche il trattamento dei tedeschi verso gli italiani fu tra i più duri e insostenibili, secondo soltanto a quello riservato ai prigionieri russi, particolarmente odiati dai tedeschi che non esitavano ad ucciderli senza ragione. Dalle varie testimonianze raccolte sono emersi episodi spaventosi sul trattamento dei soldati russi; nel campo di lavoro di Wietzerolrf, vicino ad Amburgo, alcuni testimoni raccontavano di un ufficiale delle SS 220 che si divertiva a sparare dalle finestre del suo alloggio ai soldati russi che rientravano nelle loro baracche. Le ingiustizie e le umiliazioni subite sia dai prigionieri russi che da quelli italiani fecero sì che fra di loro nascesse un rapporto di amicizia e comprensione che altrimenti nessuno avrebbe instaurato facilmente con gli altri prigionieri. Spesso, alcuni prigionieri italiani erano abbandonati nei campi anche dai parenti che non scrivevano o non si informavano delle loro condizioni perché in Italia si erano schierati dalla parte della Repubblica di Salò. Una delle domande che alcuni continuano a porsi è come mai i soldati italiani preferirono restare nei campi di concentramento a subire tutto ciò, invece di aderire alle continue richieste, dei tedeschi prima e dei fascisti di Salò poi, di arruolarsi nelle file dell’esercito tedesco. Spesso, durante gli appelli, i tedeschi chiedevano di arruolarsi nel loro esercito, ma la risposta che ottennero dalla stragrande maggioranza degli italiani fu negativa. Il comportamento dei nostri soldati è per molti, e anche per me, da ammirare. C’è chi fa notare che se gli italiani avessero deciso di arruolarsi nelle file dell’esercito tedesco o in quello della Repubblica di Salò, ricostituendo parecchie unità di combattimento (ricordiamo che erano seicentomila gli italiani internati nei campi di concentramento) e collaborando fino in fondo con i tedeschi, i nazi-fascisti ne avrebbero tratto un aiuto importante, dato che il problema più grave dell’esercito tedesco era quello di non avere più reparti sufficienti a fronteggiare una guerra su due fronti, tanto da essere costretti a mandare dei ragazzini a combattere. Le motivazioni che spinsero al rifiuto della collaborazione con i tedeschi sono molte: la stanchezza e la scarsa voglia di tornare a combattere, visto che prima di essere catturati ognuno dei seicentomila prigionieri aveva vissuto situazioni di guerra veramente difficili, anche a causa dell’arretratezza tecnologica e militare dell’esercito italiano, che costò la vita a migliaia di persone. 221 Oltre a questa motivazione ne vengono molte altre, come ad esempio la solidarietà con gli altri prigionieri o l’odio per i tedeschi che cresceva giorno dopo giorno. Gran peso nella decisione di non accettare la proposta tedesca ebbero il giuramento fatto alla patria ed al re che, soprattutto nell’esercito, era molto più importante di Mussolini; il timore di doversi scontrare in guerra con altri italiani ed anche l’orgoglio di essere un soldato italiano. Spesso la motivazione di questa scelta stava nel non sapere, da parte di molti soldati semplici, prendere una decisione così importante da soli e quindi nel limitarsi a seguire l’esempio degli ufficiali. La risposta negativa che questi giovani italiani diedero alle proposte dei tedeschi è considerata da alcuni storici come un esempio di resistenza passiva, effettuata senz’armi ma soltanto con la forza di volontà. Fu una resistenza molto dura perché vissuta in un’ambiente terribile dove non era concessa alcuna pausa ed alcun momento di gloria. Questa resistenza è il simbolo della grande perdita di consensi che il fascismo subì con il passare della guerra, visto che coloro che nei campi di concentramento rinnegarono il fascismo erano quei giovani cresciuti proprio con la mentalità e nella cultura imposta dal regime. Il compito degli internati militari italiani, con l’eccezione degli ufficiali che rimasero nei campi, era quello di fornire manodopera ai tedeschi sia in agricoltura che soprattutto nel settore siderurgico militare. La convenzione di Ginevra, in verità, vietava assolutamente l’utilizzo dei prigionieri nell’industria militare, ma gli italiani, poichè non erano riconosciuti dai tedeschi come prigionieri di guerra, erano costretti a lavorare nelle fabbriche. Per questo motivo molte fabbriche tedesche si videro arrivare alle loro dipendenze questi soldati italiani stremati e mal nutriti, e perciò impossibilitati a lavorare. Molte di queste fabbriche chiesero al governo tedesco generi alimentari per rimettere in forza i soldati italiani, ma il governo non accolse queste richieste, ritenendo che gli italiani fossero in condizione di lavorare e che il 222 loro scarso rendimento fosse dovuto alla pigrizia e alla svogliatezza, aggiungendo inoltre che i proprietari delle fabbriche avrebbero dovuto provvedere da soli, cosa che accadde solo in una o due fabbriche. Molte altre fabbriche adottarono invece un altro metodo, consigliato direttamente dal governo, chiamato “Leistungsernahrung”, che consisteva nella distribuzione alimentare proporzionata al rendimento del singolo operaio. Un operaio che lavorava con buon rendimento veniva premiato con razioni di cibo più abbondanti, sottratte però agli operai che invece non avevano lo stesso rendimento. Questo metodo poteva ottenere risultati positivi in tempi brevi, ma alla lunga, visto che l’alimentazione era sempre scarsa e scorretta, aveva effetti tragici sulle condizioni dei prigionieri. Diversa era la situazione degli italiani impegnati nel settore agricolo, dato che in questo settore furono impiegati un numero minore di prigionieri, i quali venivano nel complesso nutriti e curati. Una volta che gli americani arrivarono nei pressi dei vari campi di lavoro, i tedeschi lasciarono poche unità di veterani a guardia dei prigionieri. Anche per questi soldati la guerra era diventata un incubo, dal quale volevano liberarsi al più presto; forse erano stanchi di uccidere senza pietà, spesso senza motivo e solo per un ideale che ormai non sentivano più loro, come lo era stato in precedenza quando il nazismo era al vertice del suo splendore. Questi veterani lasciarono i campi di lavoro dopo uno o due giorni, abbandonando i prigionieri in attesa che gli americani li venissero a liberare e a riportare a casa. Arrivati nei campi di concentramento, gli americani mostrarono stupore e ammirazione nei confronti dei soldati italiani per come avevano potuto sopravvivere alla prigionia, dato che erano stati praticamente abbandonati da tutti, anche dal proprio governo, e per il trattamento ricevuto in quei lunghi mesi di prigionia. I prigionieri vennero fatti salire in treni speciali che li avrebbero riportati in Italia. 223 Appena tornati in patria, i treni si fermarono all’ospedale militare di Merano dove molti soldati, ormai stremati per aver resistito fino a quel momento, persero la vita per l’aggravarsi delle malattie contratte nei campi di concentramento. Tornati alle proprie case e alle loro famiglie, molti di questi soldati dissero di non aver voglia di raccontare ciò che avevano passato, volendo solamente dimenticare il più in fretta possibile. Gli I.M.I. non vogliono essere ricordati come eroi ma come semplici soldati che hanno fatto il loro dovere con dignità e forza di volontà. Delle vicende degli internati militari italiani si è tornati a parlare solo pochi anni fa, alla metà degli anni Ottanta. Questo silenzio è dovuto principalmente al fatto che i prigionieri italiani erano stati internati anche dagli alleati in campi di concentramento in molte zone del mondo e questo rallentò molto il loro rimpatrio. Un’altra motivazione importante di questo silenzio si può ritrovare nelle responsabilità che l’esercito italiano ha avuto riguardo alla tragedia degli I.M.I.: visto che era stato proprio l’esercito ad abbandonarli, si è preferito non pubblicizzare troppo le vicende dei prigionieri italiani, esaltando invece molto di più l’opera della resistenza armata. INTERVISTA A NICOLA DELLA SANTA La mia esperienza personale cominciò il 25 luglio 1943. Io mi trovavo a Firenze e facevo parte di un reparto automobilistico dell’esercito italiano che allora non era integrato nel resto della truppa ma serviva esclusivamente per il trasporto di viveri e di munizioni. II 25 luglio fummo tutti mobilitati per il servizio di ordine pubblico perché il governo Badoglio, caduto Mussolini, aveva paura che ci fossero delle sollevazioni da parte dei fascisti, tanto che impose il coprifuoco alle otto di sera ed il nostro compito era quello dl far rispettare questo ordine in tutta la città. Fu una vigilanza molto rigorosa, mi ricordo che 224 un ufficiale morì perché circolando in motocicletta dopo il coprifuoco non si fermò al segnale della sentinella che gli sparò. L’otto settembre fui svegliato dal mio capitano nella notte e mi disse di andare subito in caserma perché le autorità militari non sapevano cosa stesse succedendo visto che l’Italia era piena di tedeschi, armati venti volte più di noi che avevamo delle armi che facevano ridere e quel poco che ci era rimasto era stato esaurito al tempo della guerra di Spagna. Avevamo un munizionamento di solo tre o quattro giorni. Le autorità, vista la situazione, aspettarono ordini dal comando superiore. Ognuno di noi aspettava ordini dal proprio superiore. Venimmo concentrati tutti nella Fortezza da Basso, quando i tedeschi si presentarono alle porte delle caserme con i carri armati, non ci fu altra soluzione che arrendersi. Gli ufficiali tedeschi dissero agli ufficiali italiani di depositare le pistole presso l’ufficio del comandante e tutti i soldati depositarono i propri fucili nei magazzini della caserma. I tedeschi ci dissero di stare tranquilli che, una volta disarmati, ci avrebbero rimandati a casa; questo lo dissero solo per tenerci tutti tranquilli, ma naturalmente nessuno ci credeva. Successe che dopo qualche giorno i soldati che riuscirono a fuggire si misero in salvo, ma solo per il momento. Alla Fortezza mi ricordo che su più di cento ufficiali che c’erano quando ci catturarono rimanemmo soltanto in otto. Alcuni soldati scoprirono un passaggio segreto che dalla Fortezza portava direttamente alla stazione. Io ero fra gli otto ufficiali che erano rimasti e provavamo un senso di vergogna per gli altri ufficiali che dopo aver consegnato i propri soldati ai tedeschi fuggirono; per questo decisi di rimanere, perché avevo un obbligo nei confronti di questi soldati. L’undici settembre venimmo portati a Campo di Marte per poi andare in Germania. Noi ufficiali venimmo messi in carrozze di terza classe, considerate come un trattamento speciale. C’era un soldato tedesco in cima al vagone ed uno in fondo per impedire la fuga dei prigionieri. Dopo qualche giorno arrivammo a oriente di Berlino in un campo di smistamento dove fummo trattenuti pochi giorni. Dopo venimmo portati in Polonia ed immatrico- 225 lati. Il campo dove ci portarono non era un brutto campo perché era fatto per le truppe ausiliarie tedesche; c’erano baracche in muratura e castelli di legno ben più grandi di quelli che avevamo noi in Italia. Rimanemmo in questo campo fino alla fine del 1943; poi a poco a poco, fummo portati a Leopoli che allora era ancora una città polacca, dopo venimmo portati nella Germania occidentale, nel campo di Wietzendorf. Mi ricordo che era inverno, il freddo era insostenibile, le baracche erano sfondate e le condizioni di vita molto peggiori di quelle dei campi precedenti. Qui ci furono delle grosse pressioni nei nostri confronti per arruolarsi nell’esercito della Repubblica di Salò, le alternative che ci ponevano i tedeschi erano queste: potevamo conservare il grado, tornare a mangiare regolarmente e percepire uno stipendio, se accettavamo le loro richieste, oppure restare nei campi di concentramento. Questa proposta ci fu fatta molte volte ma noi, nonostante la fame, rispondemmo di no. Rispondemmo di no anche alla proposta di andare a lavorare nelle fabbriche tedesche. La proposta di arruolarsi fu fatta ai soldati solo per i primi due mesi, poi li mandarono ugualmente a lavorare, a noi ufficiali invece venne fatta continuamente. Io fui mandato a lavorare in una fabbrica vicina ad Amburgo. Del nostro gruppo soltanto uno di noi si rifiutò di lavorare, allora i tedeschi lo portarono via e, come facevano in questi casi, probabilmente lo fucilarono. Lavoravo in questa fabbrica ad Amburgo ma a causa dei continui bombardamenti americani si stava più nei bunker che a lavoro. Nell’aprile del 1945 mi ammalai per qualche giorno; quando guarii venne l’ordine di trasferimento e ci portarono in un campo vicino ad Amburgo in delle baracche dove dormivano dei lavoratori volontari italiani. Poco dopo arrivarono gli inglesi a liberarci. Arrivai a Firenze nell’agosto del 1945 dopo essermi fermato a Merano nell’ospedale militare per rimettermi in forza; poi presi il treno per Bologna e da lì salii su un treno merci fino a Firenze. 226 UNA SCELTA MORALE Pier-Filippo Masi Spesso l’odio più profondo nasce da qualcosa che prima si è amato, in cui si è creduto, che è riuscito ad entrarci dentro e che poi ci ha voltato le spalle senza spiegazione, che ci ha tradito. E quanto più i sentimenti e gli ideali sono stati forti, quanto più la ferocia ci pervade l’anima: così tutto l’amore diventa odio, tutta la sicurezza diventa profondo smarrimento, tutte le speranze ridicole velleità.1 I due mondi divisi del fascismo e della resistenza che hanno caratterizzato l’Italia dal ’43 al ’45 hanno dato vita, oltre che ad una cruda guerra civile, ad un profondo scontro ideologico e morale. Sono molte le motivazioni che comunque spinsero gli italiani a seguire due strade diverse e contrarie: spesso bastava infatti un incontro casuale con la persona giusta o sbagliata, bastava un ricordo, un’esperienza vissuta, un piccolo sopruso fatto da una o dall’altra parte; a volte invece giocavano un ruolo l’orgoglio, la vendetta, il rischio, l’onore, altre volte ancora la morale. Ancora oggi infatti alcuni di coloro che si sono schierati da una delle due parti giustificano la propria scelta come atto voluto essenzialmente per moralità: com’è possibile allora arrivare a due scelte così differenti essendo entrambe conseguenza dello stesso sentimento? Escludendo le scelte fatte solo per questioni politiche, per fascismo o antifascismo di vecchia data, per vendetta di un familiare caduto o, come già detto, per casuali circostanze, rimane da capire la componente morale dell’una e dell’altra scelta. Le testimonianze di due persone che si sono trovate a combattere una per la Resistenza e l’altra per la Repubblica di Salò e 1 Per il presente lavoro si è tenuto conto di: C. Pavone, Una guerra civile 1943-1945, Bollati-Boringhieri, Torino, 1991; N. Tranfaglia, Fascismo e postfascismo, Laterza, Bari, 1999. 227 le loro motivazioni possono in parte spiegare almeno due fra le scelte che sono ricordate come morali. Il regime fascista si considerava proiettato verso il futuro, verso la creazione dell’«uomo nuovo» secondo un progetto totalitario, per cui l’intera nazione avrebbe dovuto credere ciecamente al duce e allo Stato. Questo progetto, alquanto utopistico per l’intera popolazione, trovò riscontri efficaci almeno per quella generazione che era cresciuta sotto il segno del fascismo. Questo fu possibile grazie ad un attento inquadramento dei giovani nelle strutture fasciste e alla cultura di cui venivano imbevuti: si ricordi che nelle scuole elementari bisognava imparare a memoria queste parole dell’unico libro di Stato: «Quale dev’essere la prima virtù di un balilla? L’obbedienza! E la seconda? L’obbedienza! (in caratteri più grandi) E la terza? L’obbedienza!» (in caratteri enormi). Tutto era reso possibile dal mondo chiuso che si era creato, grazie al quale il regime riusciva a far sembrare un suo peculiare merito lo sviluppo scientifico e le grandi opere civili, che invece erano realizzate in gran parte d’Europa. Sebbene gli italiani non fossero tutti fascisti convinti, la stragrande maggioranza aveva accettato il regime che si era guadagnato gradualmente la stima dell’opinione pubblica che lo sostenne pienamente, almeno fino a quando non si legò troppo strettamente alla Germania nazista. Quando nel ’38 vennero introdotte le leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei, preannunciate da un manifesto di sedicenti scienziati, sostenitori di una pura razza italiana, esse destarono uno sdegno generalizzato perché l’Italia non aveva mai conosciuto l’antisemitismo. Conseguenza più chiara fu l’immediato inasprimento del rapporto della Comunità ebraica col fascismo, rapporto che fino ad allora era stato improntato a rispetto e collaborazione. Significativa è la testimonianza del signor Gino Servi, di origine ebraica, che dopo un’educazione fascista, si è schierato con la Resistenza. 228 La comunità di Pitigliano venne colpita da un giorno all’altro da queste leggi e quello che più mi procurò dolore fu il fatto che una legislazione che ci condannava così duramente proveniva da un organo ufficiale. Sembrava uno scherzo. Il decreto venne subito applicato in maniera radicale e venimmo buttati fuori dalle scuole sia noi alunni che i docenti. Anche mia zia, infatti, che era insegnante come me, si dovette rassegnare a non andare più a scuola. Il primo impatto fu tremendo, non accettavamo che noi italiani, figli di italiani, fossimo trattati come estranei: mio padre e mio zio avevano fatto la Grande Guerra ed erano stati patrioti ed io, come tutti gli italiani, credevo in questa Italia, nella nostra patria. Eravamo stati educati dal regime, abituati a parlare di patria con la P maiuscola, eravamo stati imbevuti di propaganda nazionalistica: tutti gli italiani erano fascisti, tranne una irrilevante minoranza, e credevamo ciecamente più al Duce che alla mamma. Tra i più ferventi ammiratori c’erano gli intellettuali, gli scienziati, che scrivevano e osannavano il regime. L’impatto fu assurdo perché da una parte ci sembrava che il fascismo dicesse delle cose mostruose, dall’altra era la voce alla quale avevamo creduto fino ad allora. Nel ’38 cadde così questo mito, diventai antifascista per convinzione e non perché ne fui vittima. Accadde un miracolo in me, queste leggi mi illuminarono e vidi tutto il brutto, il ridicolo, il tragico del fascismo. Mi accorsi di quanto fossero stupidi il regime e i suoi apparati, di come stupidamente c’eravamo fatti conquistare dalle parole di un fantoccio che gesticolava di fronte alle piazze. Tutto il mio passato di balilla moschettiere mi apparve ridicolo e con questo tutte le manifestazioni fasciste come le parate. Fu uno sbandamento indescrivibile; cominciò una vita da inferno più sul piano morale che su quello pratico ed economico: infatti il dolore più forte era rendersi conto che eravamo stati buttati fuori dalla nostra società. Ci organizzammo per creare delle scuole private ebree grazie anche ai docenti espulsi e non era raro trovare professori universitari insegnare alle elementari. Vivemmo cinque anni in questa situazione fino a quando, il 25 luglio del ’43, sembrò che qualcosa potesse cambiare con la sfiducia a Mussolini e la caduta del fascismo. Fu il primo giorno di liberazione, di 229 giubilo, di feste per le strade, dove la gente, presa dall’euforia, andava a picconare i simboli del fascismo. Mi accorsi che il fascismo non era solo il male contro gli ebrei ma anche per gli italiani, per l’umanità, e tutto quello che mi era sembrato ridicolo ora si stava tramutando in tragedia. Avevo la paura e il terrore che quel ridicolo si potesse affermare nella società se avesse vinto la guerra, era la società che adesso odiavo, giorno e notte. Il vuoto istituzionale che si creò dopo l’8 settembre caratterizzò il contesto in cui gli italiani dovettero prendere una decisione sulla condotta da tenere. Per molti fu la prima vera scelta perché, finché fu presente un governo che dava sicurezza e funzionava più o meno correttamente, nessuno aveva mai dovuto fare scelte troppo compromettenti o in ogni caso si era dovuto esporre direttamente. Inizialmente la mancanza di una sovrastruttura statale divenne motivo di smarrimento ma poi si tramutò velocemente in un senso di libertà unito ad una singolare solidarietà grazie alla quale ognuno viveva i rapporti interpersonali con serenità. La testimonianza di questa particolare fase in cui si trovarono gli italiani prima della discesa dei tedeschi e della creazione della Repubblica sociale, ci viene ricordata come un’aurora da un colonnello inglese: “Quando un villaggio sta per settimane in terra di nessuno, fra le nostre linee e quelle nemiche, la gente non ruba e non si ammazza, ma s’aiuta l’un altro in modo incredibile. Tutto ciò è assurdo e meraviglioso. Arriviamo noi e mettiamo su gli indispensabili uffici e servizi del governo militare alleato, e gli italiani subito si dividono, si bisticciano, si azzuffano per sciocchezze, si denunciano fra loro. La concordia di prima si disfa in faide e vendette di ogni tipo. Davvero incredibile”. Quando le truppe tedesche cominciarono a dare esempio della loro condotta e i fascisti crearono la Repubblica sociale, ossia quando il vuoto istituzionale venne colmato da nuove autorità, gli italiani si trovarono costretti ad una scelta ancora più difficile: fra una sempre più rischiosa disobbedienza e una pur “normale” adesione all’esercito nazifascista. La libertà di questa scelta nascondeva molte 230 sfaccettature: per molte persone questo bivio fu il primo a cui si trovarono veramente soli e liberi e al tempo stesso era una scelta obbligata da cui nessuno poteva sottrarsi, anche perché nel momento in cui l’avesse fatto avrebbe comunque imboccato una strada senza possibilità di ritorno. L’8 settembre fu l’inizio della tragedia ebraica che ha conciso con la festa nelle strade poiché non potevamo immaginare cosa ci avrebbe aspettato l’indomani: si stavano aprendo le porte per Auschwitz. L’immensa felicità resa dall’armistizio fu seguita presto dalla tragedia dell’avanzata tedesca. Il 9 di settembre iniziai a capire che qualcosa non andava ma non avevo ancora mai avuto la percezione che il governo di Salò potesse fare della discriminazione della violenza pura perché ancora credevo all’Italia, perché ancora credevo al razzismo non violento. Dopo cinque anni di razzismo ideologico mi ero convinto che la mia integrità fisica non era in pericolo. Anche il 16 ottobre, quando oltre mille romani erano stati catturati e deportati crudelmente, io giravo libero per Pitigliano e solo grazie a degli amici provenienti da Roma venni a conoscenza delle violenze che erano state fatte. Mi ricordo che quando mi videro girare libero per le strade del paese mi guardarono attoniti e mi dissero: “Ma come fai a essere così tranquillo, quando a Roma gli ebrei sono stati catturati con violenza anche nelle loro case?” Quando venni a conoscenza di quello che stava accadendo cominciai a nascondermi, ma inizialmente solo in casa. Tutto divenne più chiaro con il decreto di Buffarini Guidi di fine novembre secondo il quale tutti gli ebrei dovevano presentarsi ai campi di raccolta per essere deportati. Non era raro che alcune persone, non pensando per un attimo alle paure comuni, si consegnassero alle organizzazioni tedesche, forse perchè non avevano voglia di reagire, forse solo per stanchezza di fuggire e di nascondersi, forse perché non volevano più adempiere ai doveri che la patria gli imponeva. Mio padre credeva che il campo di raccolta di Fossoli fosse solo per raccogliere gli ebrei, credeva che non gli sarebbe stato fatto del male, così decise di seguire l’ordinanza e di presentarsi con le valigie al pullman adibito al trasporto. La famiglia da quel giorno si spaccò in due: infatti 231 mio padre, mia madre e il più piccolo dei miei fratelli partirono, mentre io, mio fratello e altre due sorelle scegliemmo la strada della macchia. Combattemmo a fianco dei partigiani senza avere più notizie dei nostri genitori. Avevamo la consapevolezza che, se ci avessero presi, sarebbe stata la fine, anche se non avessero saputo che eravamo ebrei, perché di fatto non facevamo parte della legittima Repubblica di Salò. Non accettavo di essere catturato così passivamente e così mi incontrai con altri partigiani, che per vari motivi, avevano scelto di non presentarsi. Ci fu subito una grande solidarietà anche da parte dei contadini toscani che furono sempre disponibili; c’era la constatazione che le persone umili avessero capito più degli intellettuali. Mai più nella mia vita ho provato l’odio che sentivo in quelle giornate. Anche il mondo diviso in due è difficile da capire oggi: non c’erano compromessi, le parti erano chiare e distinte, buoni da una parte, cattivi dall’altra. Il nostro mondo ci sembrava sereno, c’era l’odio ma non la crudeltà , di là vedevamo solo violenza, un mondo sanguinario. Per capire cosa avesse spinto invece molti giovani ad aderire alla Repubblica sociale possono esserci d’aiuto il ricordo di Fabrizio Guerri e le motivazioni della sua scelta: Ho sempre ricevuto un’educazione tesa alla disciplina. Fin da piccoli fummo inquadrati dall’Opera nazionale Balilla che, oltre all’educazione fisica, si proponeva di fornirci un indottrinamento ideologico. Il regime fascista era riuscito a organizzare l’Italia dandole, almeno apparentemente, un ordine. Anche mio padre, che non era fascista convinto, ma, essendo stato un militare ed amando l’ordine, accettava il regime come un po’ tutti gli italiani che per la prima volta avevano visto l’ordine, la disciplina, la creazione di molte opere civili tese a migliorare la vita, la creazione delle strade. Essendo però ancora un mondo chiuso in cui la comunicazione con l’estero era minima e non potendo vedere cosa stava accadendo negli altri paesi occidentali, si credeva che tutte le opere civili, le innovazioni fossero solo merito del fascismo, ignari ad esempio che le strade venivano fatte anche nel resto d’Europa su larga scala. L’8 settembre fu il momento più tragico sul piano morale per le persone della mia generazione perché, essendo nati sotto il fascismo ed 232 essendo cresciuti per diciotto anni in quel mondo, ci trovammo spiazzati di fronte ad una scelta, libera forse per la prima volta. Ad ottobre il governo di Salò decise di chiamare alle armi anche la classe del ’25 di cui io facevo parte e noi non eravamo altro che appena diciottenni imbevuti della sola cultura fascista che ci aveva fatto vedere il mondo solo come meglio gli era congeniale. Non avevamo una cultura personale critica, eravamo i figli del fascismo, i figli dell’onore, del dovere, figli di tutte queste belle frasi. Da lì cominciò il dilemma: presentarsi o non presentarsi? La scelta non era tra aderire alla Repubblica di Salò o fare la Resistenza, ma bensì tra presentarsi alle autorità costituite o nascondersi: era una scelta coraggiosa in ogni caso. Era essenzialmente un problema di morale, in cui era forte però anche la componente della paura. Ognuno di noi aveva i suoi problemi e le sue motivazioni, così decisi di presentarmi perché non accettavo di fare il disertore. Tutti quelli come me che avevano ritenuto giusto seguire l’alleato tedesco si accorsero solo dopo e gradualmente con chi avevamo a che fare. Infatti anche la deportazione degli ebrei era nascosta da un alone di mistero. Inizialmente infatti sapevamo solo dell’esistenza delle leggi razziali perché vedevamo ad esempio che alcuni compagni di scuola ebrei non venivano più l’anno successivo; poi, dopo che i Tedeschi iniziarono le deportazioni in Germania, si credeva che le persone venissero portate a lavorare e già da lì avevamo preso le distanze, ma di quello che stava accadendo in Germania nessuno aveva la minima idea. Solo dopo l’arrivo degli alleati che ci mostrarono i filmati dei campi di concentramento e le condizioni in cui erano stati trovati gli ebrei, capimmo tutte le atrocità di quel popolo che un tempo era stato nostro alleato ed esempio da imitare. L’Italia si era divisa in due, dando vita ad una dura guerra civile in cui l’odio tra fascisti e antifascisti toccò livelli che in altre guerre, diciamo “volute dall’alto” non si raggiungono, quando i soldati mandati al fronte non sono altro che disgraziati come quelli al di là della trincea e dove l’odio è per la guerra in sè, non per il singolo soldato nemico. L’odio di allora ha un riscontro ancora oggi quando si cerca di individuare i responsabili dell’inasprimento della guerra civile. Le reciproche denunce di aver dato 233 vita alla guerra fratricida sono all’ordine del giorno tra alcuni reduci delle due parti. Durante la guerra civile non si sapeva più chi fossero gli italiani e chi portasse avanti i colori della bandiera: Ma chi erano i veri patrioti dell’Italia? Chi ritenne di adempiere ai propri doveri combattendo per la Repubblica di Salò, ultima e vana forma dello Stato italiano fascista, o chi, nella speranza di una nuova società più democratica scelse di combattere contro di essa tradendo gli alleati di un tempo? Nell’attuale repubblica democratica, che trae le origini proprio dalla Resistenza, sembra ovvia la conclusione. Fatto sta che durante la guerra non era possibile avere l’occhio critico dei posteri e tutte le parti in causa si scambiavano accuse di tradimento e questo perché c’era del vero in entrambe le posizioni. Il concetto di traditore nella guerra civile non può essere limitato al solo significato militare di disertore, ma acquista molte altre sfumature che si intrecciano con i problemi di etica e di giustizia. È per questo che molti soldati affermano che in un modo o in un altro quella guerra fu combattuta solo da traditori. 234 LA SINDROME TEUTONICA VERTIGINI DI COSCIENZA Noël Nicolaus “La coscienza di una nazione, che non deve sentirsi superiore, ma neanche inferiore alle altre.” Gerhard Schröder al Bundestag dopo essere stato eletto cancelliere I TEDESCHI E IL PASSATO In ogni società vengono elaborati dalla coscienza collettiva modelli ideali, antitetici, che rappresentano il Bene e il Male nei loro vari aspetti: viene quindi a formarsi l’idea della società “buona” opposta alla società “cattiva”, dell’arte “buona” opposta a quella “cattiva”, e così via, considerando tutti i vari aspetti dell’esistenza umana. Ciò vale anche per noi. Proviamo a pensare a cosa è “Male” e, chiudendo gli occhi, cerchiamo di visualizzarlo in immagini concrete; potremmo scorgere una sfuocata svastica nera su sfondo rosso. Se ci concentrassimo sull’incommensurabile forza evocativa di questo simbolo, potremmo rischiare di precipitare in un abisso di visioni infernali tali da volerne distogliere lo sguardo. Vedremmo orge di carne e sangue, orgasmi di cannoni e deliri di mitragliatrici; vedremmo scendere gli Stuka al suono agghiacciante delle loro sirene sparando sulle colonne dei profughi; lunghe colonne di scintillante acciaio Krupp farsi strada fra le case di un villaggio ucraino che non esiste più; le campagne francesi in fiamme; madri i cui figli sono stati uccisi con un colpo alla nuca da un’aristocratico ufficiale delle SS e bambini orfani i cui genitori sono stati portati via in vagoni piombati... in un delirio wagneriano soffocato dalla sinfonia funebre delle bombe ameri- 235 cane sulle città tedesche... e su tutto, una voce tuonante, la voce degli Dei scacciati dal Walhalla, la voce di un uomo infuocato, furioso, fremente di un’ira e di un risentimento malati... Adolf Hitler, “l’uomo che ha salvato la Germania”. Adolf Hitler, secondo i sondaggi, è la figura più popolare al mondo dopo Topolino. Il nostro Satana personale, un’incrocio tra Attila, Dracula e Jack “lo squartatore” insomma, chewing al sapore di male puro per le menti delle anodine masse del pianeta. Ovunque appaia un regime, ovunque un dittatorucolo si affacci sulla scena mondiale, il paragone è inevitabile: “E’ come Hitler! “. Se ci viene chiesto un qualsiasi elenco di figure negative nella storia, il suo nome compare puntualmente. Adolf Hitler era austriaco. L’Austria non ha certo voluto rivendicare la paternità di questo suo illustre “enfant terrible“. I tedeschi hanno pensato bene che non era il caso di sottolinearlo, visto che Hitler aveva proceduto in maniera piuttosto pragmatica alla risoluzione del problema con una cura che ha preso lo sterile nome di “Anschluss”. I tedeschi, più di chiunque altro, sanno qual’è l’eredità di Hitler. Se lo sentono ripetere giorno dopo giorno da più di mezzo secolo. Lo possono vedere sulla nuca rasata di un neo-nazi, sulle finte facciate del falso centro storico di Francoforte, nelle pietre ancora annerite del duomo di Colonia, in una sinagoga ricostruita, nel volto di un bambino ebreo. Anche se lo volessero (e c’è chi veramente lo vuole), i tedeschi non potrebbero dimenticare. Sanno bene che la rottura provocata dalla seconda guerra mondiale e dall’Olocausto con la stessa storia civile dell’umanità ha anche spazzato via per sempre la Germania illuminista di Beethoven, Goethe e Kant a favore della Germania militarista di Federico il Grande, Bismarck e Guglielmo II. “...Con il ferro e il sangue” aveva giurato Otto von Bismarck. La Germania non l’ha deluso. Cinquanta anni di Repubblica Federale, simboleggiati dalla modesta facciata renana di Bonn, dal marco forte, dal “Maggiolino” Wolksvagen, sono serviti a imparare a convivere con la memoria e sono stati un buon palliativo per colmare il vuo- 236 to lasciato dalla fine della coscienza nazionale tedesca che era nata dai “Discorsi alla nazione” di Fichte. Quello stesso spirito nazionale, improntato sul militarismo e sull’efficienza prussiana, è stato alla base della “questione tedesca” e affonda a sua volta le radici in traumi molto più antichi, a partire da quella che è stato definita “l’inizio della tragedia tedesca”, ossia la guerra dei Trent’anni. Nell’abominio delle persecuzioni religiose perse la vita quasi la metà dei tedeschi, le città furono in larghissima parte distrutte, la nascente, ricca cultura liberale dei comuni tedeschi condannata alla fine. Che la Prussia in seguito sia diventata la paladina del nazionalismo tedesco è risultato fatale poichè, come disse Mirabeau, la Prussia non era uno Stato con un esercito, ma un esercito con uno Stato. Era quindi inevitabile che, dopo i focolai liberali del ’48 uno Stato tedesco unitario dovesse nascere da una guerra e non dalla diplomazia o dal volere popolare. Con un’altra guerra da lei fortemente voluta (ma la questione è aperta a dibattiti) la Germania guglielmina nel 1914 ha cercato di strappare all’Inghilterra il trono mondiale o perlomeno di trovare un “posto al sole”. La sconfitta ha avuto conseguenze psicologiche e materiali incalcolabili ancora oggi; perlomeno è sicuro che Hitler non avrebbe potuto agire con gli schemi propagandistici propri del Nazismo se non ci fosse stata Versailles. Probabilmente sarebbe rimasto un cittadino qualunque, se non fosse stato per quello che lui stesso ha definito come il momento più brutto della sua vita: l’apprendere, in un anonimo ospedale militare della Prussia Orientale, della resa del Reich. Ma la profonda delusione provata da Hitler in quel momento, anche se condivisa da molti, non era comune a tutti i tedeschi: molti anzi si erano impegnati in furiose proteste per porre fine alla guerra. Dal loro impegno nacque la Repubblica di Weimar, simbolo di debolezza politica contrapposta a una vivacità intellettuale senza precedenti. Gli anni Venti sono gli anni del cabaret, del Bauhaus, di Fritz Lang. Nessuno potrà mai spiegare come da un tale humus culturale sia potuto nascere un abbrutimento mentale come il Terzo Reich. 237 Cosa sarebbe la seconda guerra mondiale senza l’Olocausto? Sicuramente non una guerra come le altre, poiché, anche senza considerare i crimini tedeschi, è stata il conflitto più disastroso e totale della storia. Ma indubbiamente le persecuzioni naziste stravolgono la dimensione etica e morale a tal punto da trasportare il nazismo in quel campo mistico dell’immaginario collettivo in cui risiedono il concetto di “Bene” e “Male”. Come si convive dunque con la consapevolezza di essere indissolubilmente legati al secondo concetto attraverso la propria cittadinanza? Milioni di tedeschi si trovarono ad affrontare questa nuova guerra morale al termine del conflitto e il loro comportamento fu ovviamente condizionato da età, posizione sociale e ambiente circostante: non va dimenticato inoltre che le due Germanie uscite dal conflitto, ossia quella occidentale capitalista e quella orientale socialista, manterranno atteggiamenti molto diversi nei confronti del passato. Mentre Bonn, riacquistata l’autonomia sotto l’ala protettrice dell’aquila americana, verrà vista come legittima erede del Reich sia dalla comunità internazionale che dalla maggioranza dei tedeschi, Berlino Est opererà una netta cesura con il passato attraverso l’epurazione di tutti gli organi statali degli elementi nazisti. La “denazificazione” dell’Europa e in particolare della Germania era tra gli obiettivi principali degli alleati al termine della guerra e premessa fondamentale per il rientro della Germania nella comunità internazionale. Su come si dovesse procedere, le opinioni erano discordi: come convertire un popolo da una condizione di schiavitù volontaria, fanatica e violenta ad una mentalità democratica, stabile e dinamica? Gli inglesi, ignorando l’avanzato stato di decomposizione del loro stesso impero, parteggiavano apertamente per uno smembramento definivo della Germania come stato. Churchill, più preoccupato dei bolscevichi che dei tedeschi, sembrava agognare una seconda pace di Westfalia. Il pragmatico Truman, succeduto al coraggioso Roosevelt, consapevole dell’impossibilità di recuperare la zona sovietica, preferiva che ogni stato alleato prendesse la zona che gli era stata asse- 238 gnata e facesse del suo meglio per iniziare un risanamento sociale e strutturale, senza forzare i tempi di pagamento dei risarcimenti di guerra. Risarcimenti che i francesi, vincitori dell’ultimo minuto, non esitavano a richiedere: questa linea “punitiva” andrà poi a scemare a favore di un’alleanza di opportunismo reciproco, con la quale De Gaulle sognerà addirittura di far rinascere un’Europa “carolingia”, libera da bipolarismi. I sovietici infine crederanno nella possibilità di riformare la Germania come stato neutrale: ma sia gli alleati che i tedeschi dubiteranno della genuinità di questa risposta, fatta dal “mostro mangiatore di bambini” del Cremlino, e la massiccia stalinizzazione della Germania Est sembrerà dar loro ragione. La storia ci racconta come prevalse la linea della divisione; questa divisione non fu solo geografica, ma anche spirituale e coinvolse profondamente l’atteggiamento dei tedeschi nei confronti del loro passato. Ad Est, il problema fu rapidamente risolto e il passaggio da una dittatura a un’ altra fu rapido. Dalle ceneri della zona di occupazione sovietica nacque la DDR (Deutsche Demokratische Republik - Repubblica Democratica Tedesca), stato satellite di rosso stolido fulgore, imbrigliata nei tentacoli del partito statale, il SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands Partito tedesco di unità socialista) e difesa dalla STASI (STAatsSIcherheit-Sicurezza di stato), “scudo e spada dello stato”. In un tale leviatano non era spiegabile, immaginabile o tollerabile che tutti i cittadini fossero ex-nazisti, e si concluse che probabilmente i nazisti dovevano essere andati tutti ad ovest. Qui, quasi contemporaneamente, nascerà la Repubblica Federale Tedesca, dalla fusione delle tre zone di occupazione occidentali. Molto più dei fratelli ad est, i tedeschi dell’ovest, in virtù della loro maggiore libertà di pensiero, si troveranno a confrontarsi col proprio passato in relazione al presente. Il ’45 non a caso è divenuto l’”anno zero”: ha segnato l’entrata in una nuova era, l’inizio della ricostruzione dell’identità nazionale. I primi anni dopo il conflitto saranno di fatto i più precari della moderna storia tede- 239 sca; da fieri superuomini ariani i tedeschi erano diventati gli abitanti della “trizonesia”, quasi degli aborigeni nell’Europa da loro stravolta. Al suo primo volo in America come rappresentante tedesco, Adenauer, non ancora cancelliere, in assenza di inno nazionale e confidando nell’ignoranza americana si presentò accompagnato da una canzonetta da birreria. Oltre che con l’annullamento politico e geografico in pieno svolgimento, il popolo tedesco si trovava confrontato con la desolazione delle proprie città, ridotte a cumuli di cenere da quel tipo di strategia militare che essi stessi avevano contribuito a inventare. Nemmeno le più ricche di storia e monumenti, come Dresda o Norimberga, erano state risparmiate. Inoltre, nel periodo immediatamente precedente alla fine della guerra, si era messo in moto il più imponente spostamento di profughi della storia europea: la Germania Ovest (ufficialmente ancora inesistente) si trovò ad accoglierne venti milioni, in larghissima parte tedeschi fuggiti dall’avanzata dell’”orda mongola” (così la propaganda nazista aveva ribattezzato l’Armata Rossa). Intanto, milioni di soldati tedeschi catturati nel corso della guerra erano ancora chiusi in campi di prigionia sparsi per l’Europa e vi rimasero ancora a lungo. In una tale situazione, i cori di accuse che si levavano da tutta Europa non ottenevano grande riscontro: i tedeschi, troppo occupati a sentirsi vittime della propria follia, desideravano solo un po’ della propria normalità perduta e sentirsi accusati della morte di sei milioni di ebrei non li aiutava. La reazione istintiva fu quella di non ascoltare, di ignorare le agghiaccianti urla di orrore provenienti dai lager. Nessuno, fra la popolazione, riuscì a sentirsi in colpa per quello che era successo; a favore di ciò giocherà il fatto che nessuno, fra i civili, aveva effettivamente ucciso un solo ebreo. Molti si ricorderanno solo ora della famiglia Goldschmidt, in Rubelinger Strasse, scomparsa qualche mese prima della guerra. Se ne era parlato appena fra i vicini, per giungere alla conclusione che era meglio non parlarne più... Nessuno, fra coloro che erano stati esposti alla massiccia 240 nazificazione della Germania precedente alla guerra e che non fosse dotato di un sufficiente ammortizzatore culturale-economico, riuscirà a confrontarsi obiettivamente con l’ Olocausto, nonchè col resto del mondo. Qualcosa di malato, perverso, era filtrato dai comunicati radio del Führer nel cuore di milioni di tedeschi, e vi rimase a lungo custodito. Il processo al nazismo, ossia Norimberga, giunse troppo velocemente e servì solo ad avvilire maggiormente la nazione in un momento in cui il passato sovrastava il presente. Quasi con lo scopo dichiarato di dimenticare tale passato, i tedeschi si dedicarono con zelo fanatico alla ricostruzione. Ufficialmente, ogni cosa che rimandasse all’oscuro periodo fra il ’33 e il ’45 veniva deprecata e condannata, senza esclusioni. Così, persino i caratteri più intimi e sacri della nazione, festeggiati e glorificati dal nazional-socialismo, furono sottoposti ad un’esecrante opera di denazificazione. I monumenti, la musica, il cibo, il linguaggio furono epurati degli aspetti più spiccatamente germanici e sostituiti con elementi filo-americani. Lo stesso inno nazionale fu tagliato di un’intera strofa, nella quale ricorreva la famosa frase “Deutschland über alles”. Architettonicamente ci si riallacciò alla tradizione weimariana e funzionalista del Bauhaus e di Walter Gropius, derisa e schernita dagli architetti megalomani di Hitler e perciò “sicura”. Tutto ciò rispondeva ad un esigenza di tipo spiccatamente pragmatico, ossia il rapido inserimento della Germania Ovest nella politica internazionale. A livello quotidiano invece, le generazioni che avevano assorbito la propaganda di Goebbels in tutta la sua potenza non operarono mai un genuino cambio di mentalità e si adeguarono piuttosto ad una “doppia mentalità”, fatta di sottili sfumature e macabre allusioni. Il governo stesso, passato il tempo necessario, cominciò lentamente a reintegrare gli elementi della gerarchia nazista considerati “riabilitati”, chiudendo un occhio sul loro passato. Al contrario, reintegrare pienamente l’élite culturale e politica di stampo liberale, così vivace prima del ’33, spesso non era possibile, poichè il nazismo aveva costretto alla fuga e all’esilio il fior fiore di tale élite. Po- 241 chissimi tornarono in una patria che ormai non consideravano più tale e buona parte degli intellettuali e degli artisti aveva trovato asilo oltreoceano, negli Stati Uniti. Non a caso gli U.S.A. nel corso degli anni ‘40-’50 vivranno un progresso eccezionale nelle scienze e nelle arti figurative, grazie all’apporto di personaggi di origine tedesca ed ebraica. Galvanizzati dai successi economici, i tedeschi potranno permettersi nel corso degli anni ’50 una politica estera di basso profilo e una politica interna mirante alla stabilità. Un’eccezione saranno i delicati vertici miranti alla riconciliazione tra la Germania Ovest, ormai erede a pieno titolo del Reich con i conseguenti obblighi nei confronti della comunità ebraica mondiale, e il neonato stato d’Israele, in quanto nazione ebraica nata in parte dall’Olocausto e dalle persecuzioni. Tutt’altro che scontata, tale riconciliazione non venne accolta con molto entusiasmo in Germania, dove la gente, in un misto di incredulità e indolenza, faceva ancora fatica ad accettare la realtà rappresentata dall’Olocausto, per la quale non si sentiva colpevole. Pochissimi ammisero infatti di essere stati a conoscenza del progetto della “soluzione finale”; eppure non si spiega come un’azione di tale portata sia stata condotta senza la collaborazione perlomeno di una parte della popolazione. Le forti recriminazioni delle comunità ebraiche venivano sopportate a malincuore e con sospetto, e permase a lungo fra le persone semplici il sospetto di matrice nazista di un “complotto giudaico”. Lo stesso Adenauer affermò che “la comunità giudaica mondiale è una grande potenza”, rafforzando tale impressione. Al più tardi nel ’63, durante il “processo di Auschwitz” tenutosi a Francoforte sul Meno, la nazione sentì l’inevitabilità del confronto col passato e la gravità di ciò che era successo. Anche la rivolta giovanile del ’68 non sarebbe stata pensabile senza il grave e amaro atto di accusa contro la generazione dei padri soldati e sostenitori del regime. Nessuno saprà mai quante famiglie si sono disgregate nelle sere di domenica, durante le cene davanti a carne di maiale e Knodel di patate. Frasi buttate lì da figlio e/o 242 figlia, risposte amareggiate dei genitori, sguardi come espressioni di epoche e culture diverse. “Dove eravate? Cosa avete fatto? Cosa sapevate, cosa avete visto? Perchè avete taciuto?”, queste le domande.” Voi non avete idea di cosa state parlando! Per voi è facile parlare!” queste le risposte. In mezzo un muro di incomunicabilità e un arrosto di maiale ormai freddo. Per quanto queste discussioni finissero spesso nel caos, esse hanno contribuito ad alimentare il processo di autoanalisi e a combattere la tendenza a rimuovere dalla memoria quanto era successo. Così è stato in Germania per qualunque cosa trattasse del passato prossimo: nei media, a partire dalla proiezione, nel ’79, della serie americana “Holocaust” sulla rete nazionale, si sono succeduti documentari, film, incontri, per arrivare ai nostri giorni con produzioni come “Schindler’s List”, che non hanno mai mancato di suscitare polemiche e reazioni, positive e negative. Le tesi dello storico Goldhagen sulla complicità del popolo tedesco nell’Olocausto sono state accolte da un’ondata di indignazione, così come una mostra itinerante dal titolo “I crimini della Wermacht”, presentata in questi anni con grande successo di pubblico, ha richiamato in piazza, fianco a fianco, pensionati, veterani e neonazisti che hanno marciato brandendo cartelloni come “mio nonno non era un assassino” o “difendiamo la memoria dei nostri bravi ragazzi”. Oggi il dibattito è ancora in pieno svolgimento, ed è stato ravvivato alcuni mesi fa dallo scontro di vari esponenti della cultura tedesca e della comunità ebraica. La miccia è stata innescata dal poeta tedesco Martin Walser, figura di spicco nel panorama intellettuale nazionale, premiato col “Premio per la pace” dai librai tedeschi l’11 ottobre scorso. In tale occasione, Walser ha tenuto un lungo discorso, che ha ben presto assunto la connotazione di uno sfogo, nel quale criticava l’uso improprio della “clava morale” costituita dall’Olocausto a fini politici e dichiarava la propria insofferenza per la “rappresentazione permantente della nostra vergogna”. Con Walser si è prontamente schierato il politico socialista di Amburgo Klaus von Dohnanyi, figlio di un marti- 243 re dell’opposizione al nazismo, che ha rincarato la dose chiedendosi “se i cittadini ebrei si sarebbero comportati più coraggiosamente” al posto dei tedeschi. Dura la risposta del presidente del Consiglio Nazionale degli ebrei in Germania, Ignatz Bubis, che ha definito tali affermazioni “una cattiveria”. Certo, si può anche ammettere che la continua e martellante riproposizione della questione nazista può risultare snervante. Si può ammettere che ciò rischia di sfociare in una strumentalizzazione di dubbia eticità dell’Olocausto. Ma finchè ciò servirà ad alimentare la memoria sarà bene che ciò accada. Ad un osservatore esterno, diatribe di questo tipo possono apparire incomprensibili o perlomeno esasperate. Non si sbaglia del tutto. L’atteggiamento dei tedeschi nei confronti del passato continua ad essere ambiguo ed isterico. Ciononostante, la recente salita al potere di Schröder, della SPD e dei Verdi rappresenta un cambio generazionale di enorme importanza politica e simbolica. Al potere ora ci sono i ragazzi del ’68, con tutto il loro bagaglio progressista e pacifista, cresciuti nella memoria del nazismo, ma privi di esperienze dirette, e perciò più disincantati ma anche più sobri nel giudicare il passato. Sicuramente la Repubblica di Berlino non sarà priva di memoria, come dimostra il cocente dibattito sul monumento all’Olocausto che dovrà sorgere proprio nella futura capitale. Ma sarà una repubblica padrona del proprio passato? L’atteggiamento pragmatico di Schröder nei confronti della “questione-Olocausto” sembra operare in tale senso. In una serie di vertici top-secret con i più grandi gruppi industriali tedeschi coinvolti nello sfruttamento del lavoro forzato durante la guerra, il governo Schröder ha delineato un programma di rimborsi senza precedenti, attraverso l’istituzione di un vero e proprio fondo comune volto a risarcire le vittime della furia nazista e le loro famiglie. L’Europa nazista è stata luogo del più grande saccheggio mai perpetrato nella lunga storia del continente: i tedeschi estorcevano a banche e assicurazioni tutti i soldi di clienti ebraici, se- 244 questravano oggetti di valore e antiquariato, depredavano case e sinagoghe. Gli oggetti d’arte rubati venivano ripartiti in tre categorie: quelli da portare direttamente al Führer, quelli per la collezione del feldmaresciallo Göring, e infine le opere che nei musei tedeschi avrebbero testimoniato la grandezza del Reich millenario. Quanto al furto di vite umane, oltre ai sei milioni morti nell’orrore dei forni, si stima che altri venti milioni siano stati deportati in Germania da tutti i paesi d’Europa: dall’Olanda, dalla Grecia, dalla Danimarca, ma soprattutto dai paesi dell’Est. Vi furono portati per fungere da schiavi nelle officine del fior fiore dell’industria tedesca: Daimler-Benz (ora Daimler-Christler), Volkswagen, Krupp, Siemens, AEG: tutte si macchiarono del sangue ebraico. Il governo federale fino ad oggi ha pagato circa 100 miliardi di marchi in risarcimenti; le industrie, assieme, appena 100 milioni. Decisamente troppo poco, secondo il neo-cancelliere, come secondo numerosi avvocati e studi legali americani operanti per conto di clienti ebrei. Al fine di evitare l’imbarazzo di una causa pubblica “all’americana”, con la pesante pubblicità negativa implicata, molte compagnie tedesche hanno acconsentito alla creazione di un fondo comune. Ma si continua a parlare di cifre “piccole”: appena 20 milioni di marchi per la Wolksvagen, che, come ricorda un avvocato americano, ha finanziato con 25 milioni il tour di un noto gruppo musicale. Se l’industria tedesca vuole rimanere credibile, deve sborsare almeno uno, forse più miliardi di marchi. Non diversamente hanno dovuto fare le banche svizzere, costrette a sborsare 2,2 miliardi di marchi per avere nascosto “l’oro ebreo” rubato dai nazisti. Sul fatto se sia giusto o no ridurre la morte e la sofferenza di milioni di persone a una questione economica, il dibattito potrebbe essere lungo e le critiche non si sono fatte attendere. In tempi recenti la questione è tornata all’attenzione delle autorità in seguito alla caduta del muro: migliaia di richieste di rimborsi e restituzioni, riguardanti soprattutto beni immobili, sono state inoltrate da famiglie e parenti di ebrei che non avevano ottenuto risposta dalle autorità della repubblica democratica, che come 245 già detto aveva operato una netta cesura con il passato. Ciò ha spinto le autorità federali a cercare accordi con i vicini dell’Est, visto lo stretto collegamento fra gli ex-membri del patto di Varsavia e l’Olocausto. Un trattato in tal senso è già stato firmato con la repubblica ceca. Come si vede, l’aspetto economico della Shoah è tutt’altro che secondario rispetto a quello umano. E’ questa la “strumentalizzazione della vergogna tedesca” così temuta dagli intellettuali? Usando un criterio puramente numerico, con un pragmatismo ed un cinismo che andrebbero evitati su certi temi, alcuni hanno voluto confrontare i sei milioni di morti dell’Olocausto con i venti milioni di morti di Stalin o di Mao, chiedendosi perché i primi godano di più attenzione dei secondi; sul buon gusto di tali paragoni i dubbi sono leciti. La Germania spera, alle soglie del duemila, di poter comprare una nuova coscienza con qualche miliardo di marchi. Il bisogno di “normalità” si è fatto sempre più pressante, rafforzato dalla sensazione, a prima vista non del tutto ingiustificata, che oggi siano i figli a pagare (nel vero senso della parola) per le colpe dei padri. Alle soglie del duemila, definire con precisione cosa significhi essere tedesco e cosa implichi a detta di molti (tedeschi) è ancora impossibile. Una tale affermazione è squisitamente stolida e molto ricercata nella sua assurdità. La Germania, nonostante tutto, oggi è un paese come qualunque altro, con un passato turbolento alle spalle e grandi potenzialità per il futuro, e, come ha notato Ignatz Bubis, sarà ancora più normale quando un giorno, “all’incirca nel 2030”, anche l’ultimo carnefice e l’ultima vittima saranno morti. Ma altri la pensano diversamente: uno psicologo ebreo pensa che “i tedeschi non perdoneranno mai Auschwitz agli ebrei”. Ciò va ancora una volta a riprova dell’uguaglianza delle razze: le assurdità si dicono da una come dall’altra parte. 246 IL RAZZISMO. TEORIA E IDEOLOGIA Tommaso Signorini “Sia l’antropologo che l’uomo della strada sanno perfettamente che le razze esistono: il primo perché può classificare le varietà della specie umana, il secondo perché non può dubitare della testimonianza dei suoi sensi”1 Anche se può sembrare strano, dal momento che oggi è d’uso corrente, la parola “razzismo” è un neologismo. In Italia compare per la prima volta nel dizionario Palazzi del 1939 (ad un anno di distanza dalla promulgazione delle leggi razziali) nel senso di “tendenza politica a curare ed esaltare la purità della razza di un popolo”; in Francia “razzismo” fa il suo ingresso nel vocabolario Larousse solamente nel 1946 ed è definito come “la teoria che tende a preservare la purezza della razza di una nazione”.2 Siamo portati a pensare al razzismo come ad un fenomeno che si è pienamente manifestato nelle atrocità commesse dai nazisti durante l’ultima guerra. Tuttavia, anche ad hitlerismo scomparso, il razzismo si è ripresentato ovunque nel mondo: nel “problema nero” negli Stati Uniti, nell’apartheid in Sudafrica, nei rapporti tra ebrei ed arabi in Medio Oriente, nell’ostilità contro gli immigrati, nella “pulizia etnica” nella ex-Jugoslavia, ma anche altrove. Ma dove inizia il razzismo? Il razzista dà per scontata l’idea di una gerarchia delle razze: una razza è superiore, un’altra è inferiore. Ma la razza cos’è? Forse è importante sottolineare che l’effettiva esistenza delle razze umane è difficile da negare, anche se non è da questa constatazione che il razzismo trae i suoi argomenti. Certamente è arduo definire le razze, ma anche negarne l’esistenza è un metodo che spesso si ritorce contro coloro che, da antirazzisti, lo usano per confutare le tesi antirazziste. Chi sostiene che le razze in quanto 247 tali non esistono, finisce col trovarsi nella posizione più scomoda, perché nega qualcosa che appare evidente, favorendo così i razzisti. Il miglior punto di partenza per definire la razza sta nelle scienze naturali: sono essenzialmente i caratteri somatici che differenziano i gruppi umani dal punto di vista della razza. Le razze sono state definite come “gruppi naturali di uomini che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni, qualunque siano le loro linee, i loro costumi e la loro nazionalità”.3 Il termine “caratteri fisici” comprende elementi morfologici (colore della pelle, forma della capigliatura, statura, forma della testa) e genetici (gruppo sanguigno, fattore Rhesus, sensibilità gustativa) per cui una razza umana può essere definita, come scrive W. Boyd, “una popolazione che differisce in modo significativo dalle altre popolazioni umane per la costante ricorrenza di uno o più geni del suo patrimonio”.4 Questa impostazione, recentemente messa in discussione, non può essere considerata assolutamente valida: per fare solo un esempio, una SS nazista poteva essere ucciso durante una trasfusione del sangue del proprio fratello incompatibile, ma salvato dal sangue di un ebreo! L’insieme delle conoscenze prodotte dalle ricerche morfologiche e genetiche non autorizza i biologi a confermare le tesi razziste. Nell’intento di puntualizzare il risultato delle conoscenze scientifiche di ordine biologico, sono state pubblicate molte dichiarazioni dall’UNESCO: è opportuno ricordare la “Dichiarazione sulla razza e le diversità razziali” del giugno 1951 e le “Proposte sugli aspetti biologici delle questioni razziali”, pubblicata a Mosca nel 1964. La dichiarazione del 1951 attesta l’unità della specie umana e l’origine di tutti gli uomini da uno stesso ceppo e insiste sulla non coincidenza dei gruppi politici, culturali e religiosi con i gruppi razziali. Le proposte di Mosca del 1964 insistono invece sulle differenze fra razze che però sono da ricollegarsi alle acquisizioni dei diversi popoli di differenze dovute alla loro storia culturale: 248 “le differenze nelle acquisizioni dei diversi popoli pare si debbano spiegare interamente con la loro storia culturale”.5 Il 27 novembre 1978 è acclamata ed approvata all’unanimità la “Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi morali”, che ha il merito di affermare il diritto alla differenza tra i gruppi umani e contemporaneamente, di proclamare l’unità del genere umano. Particolarismo e universalismo, diversità e solidarietà, apparentemente contraddittori, sono in realtà complementari. Questa premessa vorrebbe evidenziare l’importanza dell’ideologia, oltre a quella della storia. La storia è particolarmente importante perché i rapporti tra uomini e nazionalità diverse non sono fenomeni nuovi. Le ideologie costituiscono un elemento decisivo per varie ragioni: la relazione con la storia del genere umano ha fatto sì che lo sviluppo delle scienze naturali sembrasse il terreno su cui indirizzare un cammino intellettuale che intende sottomettere il genere umano a classificazioni analoghe a quelle zoologiche e botaniche. Per lo studio dell’uomo era grande la tentazione di attribuire a ciascun gruppo parametri definitivi di superiorità o di inferiorità. Così questa falsa scienza è stata elaborata in tre autori come Gobineau, Chamberlain, Lapouge, il cui pensiero costituisce un importante fattore per la comprensione delle aberrazioni a cui il razzismo è potuto arrivare. TEORIE DELLA RAZZA ARTHUR DE GOBINEAU Nato in Francia il 14 luglio 1816, Arthur de Gobineau appartiene alla piccola nobiltà di provincia. Fra le sue opere ricorderemo il “Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane”, pubblicato tra il 1853 e 1855 in quattro volumi. Gobineau, interrogandosi sulla fine della civiltà, formulò una teoria che si basa sulla razza. Per lui la mescolanza delle razze è allo stesso momento la migliore e la peggiore delle cose: la specie 249 umana è sottomessa ad una “duplice legge di attrazione e di repulsione… che è sia il segno della tendenza alla civilizzazione, sia il segno per la sua decadenza”.6 La legge di repulsione è una teoria razzista perché, secondo Gobineau, “…una parte dell’umanità è afflitta dall’impotenza a raggruppare anche solo il primo gradino della civiltà, perché le è impossibile vincere la ripugnanza naturale che l’uomo, come gli animali, nutre per gli incroci”. La legge di repulsione è però superata quando si scontra con la legge di attrazione che è appannaggio dei popoli forti. Con il legame tra una razza forte, propensa a mischiarsi con altro sangue, ed una debole, nascerà una classe d’élite. Sfortunatamente non c’è possibilità di fermarsi, così, tra incroci e mescolanze si arriva alla degenerazione. Gobineau divide la razza umana in tre grandi “famiglie”: quella nera, gialla e bianca. I neri sono la classe più umile che non uscirà mai dal cerchio intellettuale più limitato. I gialli tendono alla mediocrità, il senso pratico è il loro maggior merito, anche se “Dio nel crearli ha voluto fare solo un abbozzo”. La razza bianca non si può ricondurre a niente, perché è “impossibile riassumere il bello”. Nella razza bianca Gobineau distingue altre tre grandi famiglie: Camiti, Semiti e Giapeti. I Camiti bianchi, quando apparvero la prima volta davanti ai neri, furono considerati come divinità. Per questo il primo sistema di governo fu una teocrazia, perché l’uomo bianco fu Dio; i semiti invece non furono considerati dei. I Giapeti sono gli ariani e Gobineau osserva che “per conformazione fisica era la razza più bella”. Il potere politico era organizzato in una società di uomini liberi ed uguali. Ma è giusto considerare Gobineau il primo razzista? È vero che è stato il primo a formulare ipotesi razziali e per questo è considerato uno dei padri di questa “dottrina”. Tuttavia non possiamo addossargli la responsabilità di quello che sarà poi 250 l’antisemitismo nazista. Gobineau considerava gli ebrei come un “popolo libero, un popolo forte, un popolo intelligente che aveva dato al mondo quasi tanti scienziati quanti negozianti”. VACHER DE LAPOUGE Francese come Gobineau, Vacher de Lapouge sviluppa i suoi studi nel campo dell’antroposociologia, della quale può essere definito come il fondatore. Tale “scienza”, fondata su dati scientifici e antropometrici, faceva riferimento essenzialmente al criterio dell’indice cefalico, che sta alla base della divisione in brachicefali (valori alti, crani larghi) e dolicocefali (valori bassi, crani allungati). Attraverso la presenza di questi, l’antroposociologia, cerca di stabilire le attitudini ed il valore di una razza. La classificazione delle razze europee si svolge in 3 gruppi: a) Homo europaeus. Alto, biondo, dolicocefalo dal volto allungato, vive nelle isole britanniche e nell’Europa del nord-est. Dal punto di vista psicologico è un dominatore. In religione è protestante perché la sua indipendenza mal si adatterebbe all’autorità della Chiesa. b) Homo alpinus. Piccolo, bruno, la testa e il viso rotondo, è il brachicefalo i cui esemplari più tipici sono gli abitanti dell’Auvergne e… i turchi. Predomina in Francia, in Italia e nei paesi balcanici. È un gran lavoratore ma è ben lungi dal voler primeggiare. Politicamente è “lo schiavo perfetto, il servo ideale… e nelle repubbliche moderne, il cittadino più gradito, perché sopporta ogni abuso”. È cattolico e su di lui poggiano la civiltà greca e romana. c) Homo mediterraneus. È bruno e dolicocefalo. Perfetti esponenti, i napoletani e gli andalusi. 251 Uno dei fondatori dell’antroposociologia, è considerato anche lo scienziato tedesco Ammon, a cui si deve la legge omonima. Elaborata nel 1886, dopo lo studio sulle reclute militari di Baden, esprime la “differenza” tra popolazioni rurali e cittadine, soprattutto per la forma cranica. Le reclute di città avevano la testa più lunga e più stretta di quelle di campagna e l’osservazione si armonizzava con rilievi analoghi eseguiti in Francia e in Italia. Quindi, la popolazione delle città diventava sempre più dolicocefala (e al suo interno, le classi dirigenti sono dolicocefale ad un livello più alto delle altre), mentre nelle campagne la tendenza era di accrescimento del tasso di brachicefalizzazione. Ammon suddivideva il gruppo urbano in tre categorie: urbani propriamente detti (cittadini nati da cittadini), i semi-urbani (cittadini nati da campagnoli), i semi-rurali (campagnoli emigrati in città). Un’altra legge di carattere razziale è quella di “stratificazione sociale”: il biondo d’alta statura, teutone o nordico, s’incontra di frequente tra le classi superiori; inoltre, l’indice cefalico diminuisce gradualmente dalle classi più “povere” a quelle di professione liberale. Questa è la tesi della scuola d’antroposociologia, che però dimostrava non poco imbarazzo per la cosiddetta “legge degli intellettuali”, secondo la quale questi mostrano una certa tendenza ad avere una testa larga e rotonda. Era l’ariano però il rappresentante dell’avanguardia del progresso (anche se fu fatto notare che i più dolicocefali erano i neri), del quale Lapouge scriveva: “Primeggia nelle arti, nell’industria, nel commercio, nelle scienze e nelle lettere: è il grande fautore del progresso.” 252 HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN Houston Stewart Chamberlain nasce nel 1855 a Portsmouth. La sua opera fondamentale è “Le origini del XIX secolo” del 1899 ed il suo pensiero centrale è la preservazione del sangue germanico. Nella teoria della razza, Chamberlain scarta i caratteri patenti (il colore biondo dei capelli, il disegno generale del viso) perché, secondo lui, sono i caratteri intellettuali e morali che determinano la razza. Essere consapevoli del senso della propria razza solleva un uomo al di sopra di se stesso. Anche se la razza pura non esiste più, la decadenza non è senza rimedio. Rifacendosi anche a Darwin ed al free crossing obliteratis characters (“l’incrocio cancella i caratteri”), secondo Chamberlain, le razze umane possono ricostituirsi; è sufficiente che seguano le “cinque leggi di natura”: a) materia di prima qualità b) prolungata pratica endogamica (procreazione tra consanguinei) c) selezione dei soggetti d) necessità della mescolanza (per selezione la razza raggiunge il livello più alto di nobilitazione) e) le mescolanze devono essere definite e limitate (non tutti gli incroci nobilitano la razza) Oltre ai criteri intellettuali e ideologici, la cosa importante per determinare la razza è la Weltanschaung, cioè “la visione del mondo” professata da ogni gruppo etnico. Alla metà del XIX secolo era ben radicata la convinzione che il popolo ebraico fosse dotato di una sensibilità religiosa fuori dal comune, ma Chamberlain sostiene nettamente il contrario e scrive che in confronto alle razze ariane, quel popolo sotto il profilo religioso è di una estrema sterilità. Importante per Chamberlain era anche la genesi delle razze e cosa aveva portato alla degenerazione del mondo moderno. 253 Chamberlain rileva questa “non purezza” da quando nel 212 l’editto di Caracalla aveva dato il diritto di cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero. Questo fece cadere la civiltà: non ci sarebbero più stati cittadini, ma soltanto sudditi. Altro periodo di confusione etnica fu il Rinascimento, dopo che nel medioevo c’era stata una padronanza delle tribù germaniche. Chamberlain ha infatti un vero e proprio amore per i germani, i quali secondo lui sono “un unico raggio di sole” che brilla sul mondo degenerato. Chamberlain ammirava gli ebrei per la padronanza con cui usano la legge del sangue: “Il ceppo principale resta immacolato, senza una sola goccia di sangue straniero”. La prima cosa da considerare è che gli ebrei sono ora considerati razza e non più solo dal punto di vista religioso. La seconda è che non bisogna immaginarci un Chamberlain ammiratore degli ebrei; anzi, egli ha un atteggiamento di ostilità e di disprezzo verso questo popolo. Chamberlain afferma che Cristo non era ebreo: “… lo dimostra il mio parlare contro questo popolo, che se Cristo fosse ebreo, starei peccando!”. Queste tesi non sarebbero state pericolose se fossero rimaste confinate nelle opere di Gobineau, Chamberlain o Lapouge. Ma la diffusione del loro pensiero, che non era affatto scientifico, è stata fatta da volgarizzatori che, in libri di second’ordine, romanzi a buon mercato, opuscoli e libelli, hanno ripreso e amplificato gli argomenti razzisti. Anche grazie a ciò, molti individui si sono abituati a disprezzare ciò che era diverso da loro. Gli aberranti stereotipi, diffusi dalle ideologie razziste, hanno avuto grande peso e provocato molte reazioni razziste come quello che passo a descrivere. 254 L’ESTINZIONE DELLA CULTURA NAZIONALE IN GERMANIA, POLONIA, ED ITALIA GERMANIA La Lega per la cultura tedesca Il 23 febbraio 1929 il professore Othmar Spann, tenne nell’auditorium maximum dell’Università di Monaco una conferenza sul tema “La crisi culturale del nostro tempo” per affermare “l’esistenza di crisi profonde che toccavano i gangli vitali” e una “crisi generale del concetto di scienza”. Spann aveva parlato all’Università per conto della Lega per la cultura tedesca (Kampfund für deutsche Kultur), il cui capo era Alfred Rosenberg. Questa Lega aveva una sua preistoria - beninteso non di pubblico dominio. Infatti, già nel 1928 fu fatto circolare nell’ambito della NSDAP un elenco di nomi disposti ad appoggiare un’organizzazione chiamata “Società nazionalsocialista per la cultura tedesca – Società scientifica nazionalsocialista”. Questa organizzazione era stata creata nell’agosto del 1927, a Monaco, sotto la direzione di Alfred Rosenberg, con il seguente statuto: “La società si prefigge lo scopo di chiarire al popolo tedesco quali rapporti esistano tra la razza, l’arte, la scienza, i valori etici e quelli militari. Essa si prefigge lo scopo di accostare al grande pubblico, con la parola e con gli scritti, significative figure di tedeschi oggi condannati al silenzio e di promuovere con ogni energia il Gesamtdeutschtum nel campo della cultura senza riguardo a confini politici. Essa si prefigge lo scopo di creare, mediante l’unione delle forze queste aspirazioni e le premesse per una educazione, nella scuola e nell’Università, che riconosca la nazione come valore primo …”.7 Il programma della Lega per la cultura tedesca di difendere ciò che era ancora vivo del passato e di destare i valori culturali e 255 il carattere della nazione: e proprio in questo programma coloro che nutrivano un risentimento di nazionalità offesa e che cercavano sicurezze nel passato trovarono la convalida delle loro pretese di essere una nazione. Iniziative della Lega La Lega cercò immediatamente di chiarire gli “schieramenti” e lo fece con una rubrica del suo bollettino informativo intitolato “Segni dell’epoca”. In queste colonne erano citati i “nemici” fra i quali Thomas Mann e Bertolt Brecht. Altra iniziativa fu quella di organizzare a Weimar la prima grande assise in occasione della Pentecoste del 1930, nella quale Hans Severus Ziegler, capo della Lega in Turingia, raccomandò ai giovani studenti di ricordare queste parole: “Ogni creatura deve annientarsi in un grande uomo, per pervenire alla consapevolezza e al giusto impiego delle proprie forze”. Partendo dalla Germania meridionale e centrale questi “nuclei della nuova volontà culturale” si irradiarono in tutto il paese, unendosi ad una serie di associazioni culturali, oltre a quasi tutto il movimento giovanile di ispirazione nazionalista. Nell’autunno del 1932, quando il consolidamento politico del nazismo non imponeva più alcuna cautela, fu posto il problema dei rapporti tra la Lega e la NSDAP. L’orientamento antimarxista e anticomunista era diventato parte integrante della fisionomia della Lega, tanto da insidiare la fama della NSDAP. Hans Hinckel, capo di un nuovo gruppo di funzionari, affermò che la Lega era la “fusione al di sopra dei partiti”. Una fra le maggiori autorità della Lega fu Adolf Bartels, che fu celebrato come il vero “Praeceptor Germaniae”. Bartels, come ebbe a dire, aveva capito che le radici di tutti i mali dell’epoca risiedevano nel giudaismo e, cosa anche peggiore, negli ebrei spirituali. Armato del titolo di professore, si applicò in una serie di scritti, conferenze e libelli, a spartire la letteratura e l’arte in “ebraica” e “non ebraica”, secondo uno schema che procurò in pochi 256 anni dieci edizioni alla sua storia letteraria, poi studiata nelle maggiori Università tedesche. Le prime epurazioni culturali Dietro istruzioni di Hitler, per la prima volta nel dicembre del 1930, fu prescritto alle biblioteche delle scuole superiori ed universitarie, nonché a quelle pubbliche, nel bollettino ufficiale del ministero dell’educazione popolare un fondo di base di opere della letteratura “nazionale” e nazionalsocialista. Il ministro dell’educazione popolare affermò che le opere ebraiche non avevano “nulla in comune con la natura tedesconordica, ma si limitavano a rappresentare l’umanità inferiore dell’oriente o altre razze inferiori”. Altra parola d’ordine lanciata da Hitler fu quella di eliminare dalla vita pubblica i “peggiori rappresentanti della decadenza”. Furono per questo insediati nei vari istituti di istruzione i cosiddetti commissari artistici, uomini di fiducia della Lega nazionalsocialista, con il compito di fare ordine grazie anche ad un livellamento dei ruoli. Riuniti nel consiglio dei capi, dopo le elezioni di marzo, i commissari artistici chiedevano l’allontanamento, da tutti gli istituti scolastici, di “tutti i prodotti rilevanti sintomi di cosmopolitismo e di bolscevismo”. I lavori degli artisti e dei funzionari indesiderabili furono messi alla berlina. Statistiche falsificate, campagne di stampa, gruppi di agitazione e il linciaggio morale facevano il resto, se la vittima non cedeva spontaneamente alle pressioni. Finalmente ci si era liberati di costoro, “che da un decennio avvelenavano la nostra nazione con la cloaca della loro letteratura, con il loro disprezzo per tutto ciò che deve essere sacro a un popolo, con la distruzione di ogni vincolo e di ogni legge, con la loro insolenza pervertitrice di ogni valore della vita, con l’atmosfera di stupri e di bordelli tipica delle loro opere, con la loro stucchevole omosessualità, con il loro snobismo bolscevico e nichilista”. 257 Il numero dei “congedi”, dei licenziamenti, delle espulsioni, assunse dimensioni preoccupanti. In molti casi la “legge per il ristabilimento della carriera burocratica” del 7 aprile 1933 dovette fornire a posteriori la giustificazione del licenziamento non soltanto di funzionari “non ariani”, ma in generale di tutti i funzionari che “in base alla attività politica da essi svolta in passato non offrano la garanzia che assumerebbero in ogni circostanza e senza riserve un atteggiamento favorevole allo stato nazionale”. In tal modo veniva coperta in pratica qualsiasi iniziativa arbitraria in materia di licenziamenti di personale. Con il cosiddetto “rovesciamento” delle posizioni, chiamato anche prima fase, venne attuato anche un totale cambiamento negli argomenti da studiare. Il soldato bruno e il contadino erano gli eroi letterari della nuova Germania. Libri come Ballata rusticana, Miseria contadina, Passione rurale uscirono in alte tirature a dimostrare la legge del mercato che imponeva di “preferire l’impegno allo smercio”. Uno studente nazionalsocialista riassunse così il senso di questa bruna inondazione: “Fumigano i solchi grassi, rimbalza lo sterco di cavallo giallo, brillano i frutti succosi; le ragazze si cullano gravi sulle anche galleggianti, gli uomini calpestano con passi incredibilmente pesanti il suolo ereditato dagli avi, il sangue caldo è a buon mercato. Tutti coloro che vanno in città stanno male, o tornano pieni di nostalgia, per trovare gioia in campagna e ricominciare naturalmente dal punto di partenza, da dissodare, dal prosciugare, con la vacca acquistata con i primi centesimi, eppur così buona, parca e feconda, o si rovinano e muoiono in mezzo all’asfalto delle città”. L’operazione “liste nere” Dopo la presa del potere dal punto di vista istituzionale, si procedette al radicale “riordinamento dei valori in conformità alla sollevazione nazionale” del settore artistico della letteratura. Vero e proprio strumento di dominazione furono le liste nere, sulla base delle quali il 10 maggio 1933 furono dati alle fiamme i 258 libri proibiti. I criteri per predisporre liste nere erano di natura politico-letteraria, e si prefiggevano le domande fondamentali per ogni decisione politica: Chi è il vero nemico? Contro chi è diretta la lotta? Gli studenti si trovavano così davanti a queste domande, e sulla base degli slogans “letteratura da bruciare sull’asfalto” e “bolscevismo culturale”, prese campo l’azione contro lo spirito non tedesco. L’iniziativa di bruciare i libri indesiderati sembra sia partita dall’Unione degli studenti tedeschi (Deutsche Studentenschaft) e l’organizzazione dei gruppi universitari nazionalisti. L’idea fu di lasciare l’esecuzione di questa azione ai custodi stessi di questo spirito, agli studenti e ai professori delle università tedesche, a mo’ di “azione simbolica”. Un appello dell’Unione degli studenti tedeschi preannunciò l’azione, indicando i luoghi di raccolta dove sarebbero state simbolicamente distrutte le opere con “un autodafè notturno”. La mattina del 6 maggio il Berliner Lokalanzeiger recò l’annuncio che nella stessa mattinata avrebbe avuto inizio “l’epurazione” di tutte le biblioteche berlinesi. Per quattro giorni apposite vetture decorate con cartelli con la scritta “Contro lo spirito non tedesco” trasportarono gruppi di studenti che, con l’appoggio delle SA e della polizia, eliminarono di proprio pugno i nomi ordinati dalle liste e quanto appariva loro sospetto. L’azione si protasse sino alla fine di giugno. L’autodafè Nella notte del 10 maggio ardevano i roghi nelle pubbliche piazze delle città principali e delle sedi universitarie del Reich. Studenti e formazioni della Hitlerjugend e delle SA facevano ala a largo raggio intorno alla pila dei libri in fiamme. Gli altoparlanti trasmettevano istruzioni e parole d’ordine. Mentre gli studenti, accompagnati da grida di giubilo ed applausi, gettavano nel fuoco i libri dei proscritti, veniva fatto l’appello degli autori più “perniciosi”, il cui nome era contrassegnato sulla lista nera da 259 una croce. Ogni due minuti arrivava una nuova orda che gettava libri sul rogo. Quando il tutto ebbe raggiunto le massime proporzioni, arrivò il ministro della propaganda in persona il quale disse: “Il vecchio rimarrà nelle fiamme. Il nuovo risorgerà dalla fiamma dei nostri cuori... Rischiarato da queste fiamme si levi un giuramento. Per il Reich e la nazione, per il nostro Führer Adolf Hitler: viva! viva! viva!”. Una banda intonò... Popolo, all’armi! A Breslavia la manifestazione studentesca si svolse sulla piazza del castello, nella quale furono bruciati venti quintali di libri pornografici; a Dresda, prese la parola il poeta Wilhelm Vesper; a Francoforte sul Meno, il professore Fricke dell’Università diede via al rito facendo trainare un rogo di libri a due buoi e il tutto finiva sempre con il canto Horst-Wessellied. Analoghi autodafè, in cui furono distrutti anche molti dipinti di “arte degenerata”, ebbero luogo in tutte le sedi universitarie tedesche, con gli studenti delle università eccitati a recitare la parte che il Führer aveva loro assegnato. POLONIA Sotto la presidenza del dr. Hans Keller, nel settembre del 1941 la berlinese “Accademia per i diritti dei popoli” redasse una rivista in cui si diceva che: “L’ordine tedesco in Europa farà sua la parola d’ordine del «diritto di autodecisione dei popoli» ma – e in ciò consiste la novità – realizzerà tale diritto secondo un principio non statuale, bensì nazionale. Al posto del vecchio principio dell’uguaglianza tra stati subentrerà semplicemente il nuovo principio della guida tra popoli. L’attuazione di questa teoria deve assicurare alla Germania la posizione di guida ... anche in campo culturale...”. In particolare le direttive emanate per la politica culturale stabilivano: “Per la popolazione non tedesca dell’oriente non ci dovranno essere scuole superiori all’infuori delle quattro classi 260 della scuola elementare. Obiettivo di questa scuola elementare dovrà essere soltanto: Calcolo semplice al massimo fino a 500, scrittura del proprio nome, insegnamento che è un comandamento divino insegnare ad ubbidire ai tedeschi e ad essere onesti, diligenti e dabbene. Quanto al leggere non è ritenuto necessario. All’infuori di questa scuola non dovranno essercene altre. I genitori che volessero dare ai loro figli una migliore istruzione così nella scuola elementare come più tardi nelle scuole superiori, dovranno presentare domanda ai capi superiori delle SS e della polizia. Sulla domanda sarà deciso anzitutto in conformità al fatto che il figlio abbia qualità razziali ineccepibili e rispondenti alle nostre condizioni. Se riconosciamo che un tale fanciullo appartiene al nostro sangue, si comunicherà ai genitori che il figlio andrà a frequentare una scuola in Germania (cambierà il suo nome) e rimarrà per sempre in Germania...” Questa politica del nazionalsocialismo si definiva cinicamente “colonizzazione orientale”. Trasformare il popolo polacco, fin da bambini, in un esercito di lavoratori schiavizzati senza cultura e quindi privi di volontà propria. Si procedette sistematicamente ad abbassare e a mantenere depresso il livello della vita pubblica artistica e culturale polacca. L’Università di Varsavia, che in passato ebbe una funzione importante nella vita intellettuale della repubblica polacca, fu chiusa immediatamente sin dai primi giorni della dominazione tedesca. Del pari non esistevano più scuole superiori. Dal piano dell’insegnamento furono soppresse la storia, le lingue, la geografia e lo sport; l’istruzione fu orientata verso mestieri agrari, forestali e l’artigianato industriale; furono chiusi tutti gli istituti per la formazione di insegnanti. In futuro gli insegnanti sarebbero stati rimpiazzati da poliziotti in pensione. I professori dell’Università di Cracovia furono inviati in blocco nel campo di concentramento di Oranienburg. Oltre a questo, agli studenti fu anche sottratta la possibilità di informarsi tramite 261 giornali, i quali in questo periodo riproducevano solamente, in polacco maccheronico, selezioni di articoli del Volkischer Beobachter. Tuttavia, “a favore” del nazionalsocialismo, la politica di disgregazione culturale fu realizzata coerentemente: privata dei propri quadri dirigenti, la popolazione, declassata politicamente e socialmente, aveva visto insediarsi elementi tedeschi. Mentre intorno a loro i bimbi tedeschi frequentavano scuole di ogni ordine, i centri di istruzione superiore polacchi rimanevano chiusi. Che cosa restava a questo popolo? Niente, ma “forse” era proprio questa la volontà dei “dominatori”. ITALIA Il fascismo nella politica scolastica italiana La politica del fascismo riguardo alla vita sociale entrò ben presto a comprendere anche il fondamento di questa, cioè la scuola. La teoria fascista sosteneva la necessità di sopprimere ogni distinzione fra la vita pubblica e privata, di conseguire un’impronta puramente autoritaristica, con una forte disciplina e la concezione rigidamente gerarchica della società, necessarie alla creazione di uno stato forte. Slogan come “credere, obbedire, combattere” fecero il loro ingresso nella scuola italiana, già nei primi anni Venti, quando per poter frequentare ogni singolo istituto e per arrivare a concluderlo, era obbligatorio “militare” in una qualche organizzazione fascista. Erano preferite alle materie “classiche”, che avevano fatto sempre parte della politica scolastica, materie, grazie anche a professori più estremisti e quindi più graditi al sistema, che potevano formare grazie al loro impegno fisico, persone “forti” nel corpo, ma deboli nella cultura. Esempi di studenti che per qualche motivo non potevano fare sforzo fisico e che per questo erano quasi emarginati dalle autorità scolastiche fanno capire come era sviluppata la scuola. 262 Innanzitutto, molte scuole, se non tutte, erano divise fra femminili e maschili, con l’obbligo di indossare una divisa prettamente nera. Erano organizzate molte attività extra-scolastiche, in gran parte rurali o, negli anni di guerra, per aiutare, con la produzione di indumenti, i soldati in battaglia e far così vedere che la società era comunque vicina a quegli “eroi di guerra”. La libertà di parola e di conseguenza anche quella di pensiero, erano molto limitate; basti pensare che in alcune aule erano posti un altoparlante e dei microfoni nascosti, affinché il preside, direttamente insediato dal Gran Consiglio fascista, potesse sia educare i ragazzi con mirati insegnamenti che intervenire nei casi in cui qualche individuo avesse mosso critiche nei confronti del regime. Ogni mattina il professore di ruolo doveva chiedere ai ragazzi cosa pensavano del regime, e questi dovevano rispondere con la consapevolezza che il preside fosse in ascolto. In tutte le scuole italiane era predisposto un orario adibito all’ascolto del Bollettino Ufficiale. Durante questa mezz’ora era obbligatorio ascoltare in piedi, poi la bandiera, che era stata issata con grande “onore” la mattina stessa, veniva tirata giù, seguita dal suono di tromba. La diarchia della scuola: il professore e l’ufficiale dell’Opera Balilla Come precedentemente detto, lo scopo della fascistizzazione scolastica era quello di non fare intercorrere nessuna differenza tra la vita privata e la vita pubblica. In alcuni casi non fu così; per questo riporto la testimonianza di una persona che ha frequentato tra il 1926 e il 1933 le otto classi del ginnasio-liceo in una scuola pubblica; figlio di un educatore antifascista che nell’ambito familiare aveva una “dottrina” molto più aperta. La mia insegnante di Lettere di prima ginnasio, così come i miei insegnanti di Lettere e matematica, seppi poi che erano critici del regime. Erano trasparentemente antifascisti, come non pochi altri. Erano 263 menti fortemente critiche ed anche nella scelta dei libri di testo non ne ricordo uno da definire fascista in senso stretto. L’istituto universitario preposto alla formazione dei direttori didattici, peccato non esistesse quello per i presidi, e alla formazione di maestri laureati, era, come allora si diceva, un covo di antifascisti. Devo comunque ricordare che c’era una specie di diarchia nella scuola, ed era molto evidente. Da una parte la scuola con le sue materie, molto cambiate per importanza nella società, e le sue lezioni, dall’altra l’ONB, con le sue gerarchie e le sue adunate. I ragazzi avevano una doppia vita: erano da un lato alunni, dall’altro, balilla, giovani italiane, avanguardisti. Due personalità, diverse anche nel vestire. Due culture. L’una umanistica, in questo o quel senso, ma comunque umanistica, l’altra antiumanistica, sciovinistica, carica di boria della nazione, di impero e sopraffazione. Due collettività separate e rette da leggi e idealità diverse. La classe, nella quale la disciplina era impegno di studio intelligente, ed il plotone, dove disciplina significava credere, obbedire, combattere. Il regime sperava che questo fosse anche nella scuola, ed il tentativo di farlo trovò la sua massima espressione, e il suo simbolo in Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, il ministro dell’Educazione Nazionale con la testa, la cultura e la mentalità del capo-manipolo. Quel tentativo fu fortunatamente un fallimento; poteva riuscire soltanto con epurazioni di massa, roghi di libri di testo, regime del terrore culturale; misure hitleriane in contrasto con una strategia mussoliniana di costruzione di una linea arretrata ed elastica di difesa del regime, basata sul (relativo) consenso, comunque sul non-dissenso nel campo della disciplina nazionale.8 264 COLLOQUIO CON CESARINA DOLFI Professoressa, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale lei era una studentessa. Per questo, volevo chiederle come si svolgeva la vita di un ragazzo ancora “legato” alla scuola? Ero una studentessa negli anni più cruciali del periodo. La prima cosa da dire è comunque che le persone stavano zitte. Mio padre era un popolare zittito dal fascismo e di conseguenza non era iscritto al Fascio. Era impiegato di banca e ad un certo momento nel ’29-’30, volevano mandarlo in Romania perché lui si occupava del Portafoglio Estero, conosceva bene il Francese, anche se non aveva nessun titolo di studio, ma in quel periodo non servivano titoli di studio: l’unico problema era il fatto che non era iscritto al Fascio. Un giorno vide uno dei suoi impiegati, che faceva la domanda per iscriversi al partito; incuriosito, chiese cosa stesse scrivendo e l’altro gli rispose che se non ci s’iscriveva al Fascio era come se fossero già licenziati. Da quel momento capì che era “meglio” compilare la richiesta di iscrizione. Così mandò una lettera e dopo pochissimo arrivò la risposta con il sì. In fin dei conti, più persone s’iscrivevano, meglio era. Tipica mentalità della dittatura. L’iscrizione comportò la tessera, l’obbligo dell’abbonamento al “Popolo d’Italia”, e l’acquisto degli “Scritti e discorsi” di Benito Mussolini, che poi nel ’39, all’inizio della Guerra, non fu più pubblicato. Io ero studentessa, iscritta alle Giovani Italiane, ma non potevo fare Educazione Fisica, che oggigiorno sembra una sciocchezza, ma a quei tempi era una cosa molto seria. Il dottore della scuola, quando si accertò attraverso documenti che nel ‘34 avevo avuto una polmonite doppia infetta, mi disse che non avrei potuto più fare concorsi. Inizialmente, durante i primi anni c’era anche il problema del sabato mattina, cioè ogni studente e professore quel giorno doveva indossare la divisa, per far vedere che il fascismo creava persone sempre in ordine con una moralità “precisa” che si rispecchiava anche nel vestire. Il sabato mattina, quindi, da giovane italiana, all’Università diventai giovane fascista: dovevo indossare sottana nera, calze grigio scure, scar- 265 pe nere, la camicia bianca, la cravatta con i colori di Roma o nera, ed infine il mantello. D’inverno però faceva freddo e fu solo grazie a quello che io chiamavo il “lasciapassare”, il certificato medico che attestava la mia passata malattia, che potevo indossare anche una giacca. Coloro che non lo avevano, non potevano vestirsi di più. Una mattina, infatti, arrivò il preside e vide che molte ragazze avevano il cappotto (c’è anche da precisare che oltre la distinzione fra classi femminili e maschili, anche l’entrata a scuola era diversa). Il lunedì mattina furono tutte chiamate in presidenza per chiedere “scusa” al regime. La mattina e alle tredici era obbligatorio seguire il giornale radio e stare tutti in piedi. Il preside aveva poi la radio con la quale, attraverso i microfoni disposti in ogni classe, poteva ascoltare i vari commenti ed interloquire con tutti gli studenti. Allo scoppio della guerra, arrivò l’ordine dal Ministero della Pubblica Istruzione di parlare per la prima mezz’ora (in particolare il lunedì mattina) della guerra. In questi anni incominciarono anche le prime manifestazioni che avevano come loro punto di arrivo la casa del Fascio. L’insegnamento risentiva molto di questa dittatura; infatti era tutto improntato a dir bene del regime e le materie che presero campo furono quelle più “fisiche”, a scapito della cultura. Era quasi obbligatorio partecipare ad attività extrascolastiche; mi ricordo che insieme ad alcune compagne mi ritrovai a cucire calzini per i soldati in guerra. I libri di testo erano quasi tutti censurati, in particolare quelli di filosofia e storia, perché erano le materie che dovevano aprire il senso critico dei ragazzi. Agli esami gli argomenti riguardavano tutti l’era fascista e conveniva rispondere come “loro” volevano e non come tu la potevi pensare. Con il passare del tempo però cresceva la rivolta all’interno del paese ed io incominciai a capirlo durante l’Università, quando conobbi ragazzi che si sentivano meno oppressi nell’esporre le proprie idee. Comunque per fare gli esami era obbligatorio indossare la divisa da Giovani Fasciste, che si differenziava dall’altra per il colore della cravatta, che in questo caso era azzurra. Degli ebrei non se ne sapeva niente, non solo noi studenti, ma l’intera società. Mi ricordo un episodio in particolare: era un sabato, 266 l’egemonia tedesca stava piano piano scomparendo, anche grazie all’azione di liberazione da parte degli alleati e suonarono le sirene per il pericolo di bombardamenti. Dopo essermi rifugiata con la mia famiglia in un bunker sotterraneo, sentivamo solo un grande silenzio. Il giorno dopo, girava la notizia che erano suonate le sirene “solamente” perché i tedeschi entrarono in sinagoga e fecero strage di tutti i presenti. Finita l’università in tempo “record”, riuscii a trovare lavoro come professoressa, e fu una fortuna. NOTE 1 Cfr. F. de Fontette, Il razzismo, Mondadori, Milano, 1995, p. 14. 2 Ivi, p. 11. 3 Ivi, p. 15. 4 Ivi, p. 18. 5 Ivi, p. 20. 6 Le citazioni da Gobineau, Lapouge e Chamberlain sono tutte riprese da F. de Fontette, op. cit., pp. 62-99, passim. 7 Cfr. AA.VV., Politica culturale del nazionalsocialismo, Einaudi, Torino, 1964, p. 4. Da questo testo sono state riprese le citazioni successive. 8 Cfr. Imberciadori - Biondi, ...Voi siete la primavera d’Italia..., Mondadori, Milano, 1983, pp. 57-59. 267 L’IDEOLOGIA NAZISTA E L’EMIGRAZIONE EBRAICA Martino Manetti L’IDEOLOGIA II partito nazionalsocialista giunse al potere al termine dei quattordici anni di stentata vita della Repubblica di Weimar1. Dal punto di vista storico le origini del nazionalsocialismo vanno ricercate nel contesto socio-politico da cui esso trasse alimento. Il movimento nazionalsocialista fu, quindi, il principale fattore di dissoluzione interna e di collasso dell’esperimento democratico tentato dopo la rivoluzione del novembre 1918. Tra il 1917 e il 1918, gli scioperi scoppiati in Germania furono l’espressione della protesta popolare contro gli insopportabili sacrifici imposti dalla guerra a danno delle classi più umili. Il crollo dell’impero fu dovuto tuttavia ad una disgregazione interna e non fu il risultato di una rivoluzione, ma la premessa di un’involuzione. La spinta rinnovatrice fu rapidamente sopraffatta dagli esponenti conservatori del vecchio equilibrio di potere. Il salto rivoluzionario non fu compiuto e la nuova repubblica nacque dal compromesso tra il vecchio Stato maggiore e la socialdemocrazia. Gli alleati occidentali non si impegnarono, inoltre, a finanziare la rinascita dell’economia tedesca ed a controllare il disarmo dell’esercito, ma solo nelle richieste delle riparazioni economiche di guerra. In questo clima di crisi sociale rinacque il mito della congiura ordita dall’ebreo per abbattere lo stato tedesco. 1 Per la presente relazione si sono tenuti presenti: E. Collotti, La Germania nazista, Einaudi, Torino, 1962 e G. Prezzolini, America in pantofole, Firenze, 1950. 268 Il nazionalsocialismo può essere considerato non solo come l’espressione tedesca della crisi della società moderna occidentale che tende alla negazione della democrazia e allo sviluppo dello Stato totalitario, ma anche come la continuazione del pangermanesimo guglielmino e del militarismo prussiano. Va inoltre respinto il tentativo di spostare il giudizio dal movimento e dal regime alla figura di Hitler, per assolvere altri responsabili. Il movimento politico si sviluppò parallelamente a movimenti intellettuali che negli anni successivi alla pace di Versailles e specialmente dopo il 1930 si fecero promotori in Germania di una completa rigenerazione politica e morale sulla scia di un corredo filosofico tipicamente irrazionalistico, antilluministico e antidemocratico, nel quale confluirono elementi di rivolta reazionaria, nazionalistica, conservatrice, contro le forme democratiche assunte dalla vita politica tedesca nel primo dopoguerra. La critica delle istituzioni repubblicane si trasformò nella pretesa di affermare contro la democrazia, vista come un fatto importato dall’esterno in Germania, la validità di qualcosa esclusivamente “tedesco”, di completamente nuovo e giusto in assoluto per il popolo tedesco e per esso solo. La polemica contro Versailles si trasformò nella rivolta contro l’Occidente, mentre la crisi sociale portò alla condanna totale di ogni preesistente ordinamento ed esperienza; la negazione del classismo generò l’ideale corporativo. Soprattutto la rinascita nazionalista, nella quale si confondeva anche il sempre vivo movimento pangermanista, trovò la più esasperata espressione nel razzismo feroce ed intransigente di tutti i profeti della “rivoluzione tedesca”, che, in realtà, lungi dall’essere portatrice di idee e forze nuove faceva appello alle idee più screditate della tradizione tedesca. La sintesi di queste componenti sarà il Terzo Reich come stato totalitario, militaristico e imperialistico, fondato sul principio carismatico del Führer e sul mito della razza, come travestimento ideologico dell’imperialismo. Alle origini, però, tra questi movimenti dottrinari e il movimento nazionalsocialista non c’era necessariamente una correla269 zione: il primo cioè non era il riflesso e la versione politica del secondo. Spesso però gli intellettuali della “rivoluzione conservatrice” precorsero i tempi o precedettero addirittura la formazione e gli sviluppi ideologici del movimento nazionalsocialista. Quest’ultimo, con l’attitudine a forgiare formule propagandistiche tipiche di ogni movimento politico, operò poi la sintesi di disparati presupposti ideologici eleggendoli a principi programmatici della sua politica. Anche se molti ideologi non aderirono al nazismo possono essere considerati i suoi precursori e dottrinari per la loro critica antidemocratica e antisocialista e per la loro spinta nazionalista e razzista. Walter Darré, ministro dell’Agricoltura e amministratore di un ufficio delle SS per le questioni razziali, sostenne l’esistenza di una diretta influenza del fattore geologico sull’elemento umano, affermando tra l’altro che determinati terreni generano una naturale aristocrazia contadina, con evidente riferimento alla razza nordica. La nobiltà era concepita come una casta chiusa e riserva della razza a cui bisognava dare il mezzo di conservare, mediante l’eredità, il sangue puro, eliminare quello di qualità “inferiore”, permettendo di incorporare nuovi elementi di valore che vengono dal popolo. Ancora più in là di questa versione biologico-agraria del razzismo nordico-germanico, si spinse il fanatico razzista Alfred Rosenberg, uno dei primi collaboratori di Hitler e dei principali esponenti del Terzo Reich, che si proponeva di documentare la congiura ebraica per la conquista del mondo e per lo strangolamento della Germania. Il suo razzismo coincideva largamente con le idee esposte nel Mein Kampf soprattutto sotto il profilo dell’antisemitismo. Anche per Rosenberg, il fondamento del suo razzismo era l’esaltazione dell’uomo ariano, creatore di ogni civiltà, ideale di bellezza e base di una nuova estetica razziale, incarnazione dell’eterna anima germanica cui doveva i suoi valori eterni anche il cristianesimo. Ciò che caratterizzava l’ideologia di Rosenberg era il tentativo di costruire una nuova mitologia, che codificasse l’eti- 270 ca della “rivoluzione nazista” creando al tempo stesso gli strumenti per impedire la restaurazione del passato. Ma questa nuova mitologia pagana, che al posto delle chiese sognava di erigere, quali templi del nuovo culto i monumenti di soldati tedeschi caduti nella prima guerra mondiale, si accompagnava alla creazione di una nuova religione, i cui profeti andavano ricercati nell’antica mistica tedesca. Su questa base il razzismo di Rosenberg non preludeva soltanto alla persecuzione contro gli ebrei, in quanto momento dell’eterna lotta tra la razza nordica e la razza semitica, bensì anche la dichiarazione di guerra contro le confessioni religiose cristiane: nella pretesa infatti di fondare una nuova religione era implicito il confronto, non soltanto teologico, con le Chiese esistenti. In realtà sarebbe anche troppo facile rilevare gli errori logici, le assurdità scientifiche, le debolezze teoriche e i falsi o gli arbitrii storici contenuti nelle opere di Rosenberg; tuttavia il fatto che le idee espresse dai nazionalsocialisti mancassero di serie basi culturali o scientifiche nulla tolse alla loro importanza politica e nulla toglie pertanto che esse debbano essere considerate seriamente nella loro sostanza per quello che effettivamente vollero essere e furono, ossia un programma politico tanto preciso negli obiettivi quanto indeterminato nel suo rigore ideologico. LO STATO DELLE SS Dinanzi ai giudici del processo di Norimberga, la maggior parte degli esponenti nazisti imputati di crimini di guerra e contro l’umanità protestò di non aver mai saputo nulla degli efferati delitti di cui era stato teatro l’impero del Terzo Reich. Himmler, addirittura, fino al momento della sua cattura, si era illuso di potersi consegnare impunemente alle potenze occidentali, nei cui confronti, verso la fine della guerra, aveva pensato di presentarsi come valida alternativa al posto di Hitler, fiducioso soprattutto 271 di trovare salvezza nelle straordinarie benemerenze da lui acquisite nella lotta contro il bolscevismo. Egli era convinto che nel giro di qualche mese sarebbe stato inevitabile l’urto tra le democrazie occidentali e l’Unione Sovietica. Più ambigua può apparire la posizione di von Ribbentrop: anche lui sosteneva di avere saputo troppo poco di quello che stava accadendo per potersi rendere conto dei crimini commessi; del resto, Ribbentrop era stato favorevole ad una soluzione più moderata della questione ebraica. La sua costante preoccupazione era quella di spingere l’antisemitismo soltanto fino al punto in cui non fornisse argomenti troppo forti nelle mani della propaganda avversaria. Per quanto rigurda von Papen per il suo tentativo di salvare il salvabile, evitando di negare l’evidenza, tradiva la sua incorreggibile ipocrisia: egli sapeva sì che esistevano i campi di concentramento, ma credeva che si trattassero di istituzioni rispettabili. L’elenco delle citazioni potrebbe continuare all’infinito; questo tuttavia non dimostrerebbe altro se non il grottesco tentativo di dissociare i crimini compiuti dal Terzo Reich dalla natura intima, dall’essenza stessa del nazionalsocialismo, scaricandone le responsabilità unicamente su una ristretta cerchia di aguzzini. Ma è facile comprendere che una così immane tragedia non poteva essere materialmente opera soltanto di centinaia o anche poche migliaia di uomini, non poteva realizzarsi senza un’organizzazione capillare che attingesse aiuti e collaborazione nei settori più disparati della vita nazionale, praticamente tutti i rami dell’amministrazione, senza cioè la connivenza di milioni di persone, che sapevano, che vedevano, che acconsentivano o che comunque anche se non erano d’accordo, tacevano il più delle volte, lavoravano senza reagire dando il contributo all’ingranaggio dello sterminio. Poteva dunque il popolo tedesco o anche soltanto buona parte di esso, per non parlare dei maggiori gerarchi nazisti, non sapere tutto ciò? 272 L’unico punto di partenza valido per una valutazione storica del nazionalsocialismo nella sua concreta realtà, è il legame intrinseco, strutturale, obiettivo esistente tra le SS e la Weltanschaung nazionalsocialista, tra le SS e la costruzione dello Stato nazista. Le SS non furono un’appendice esterna al regime; esse al contrario ne furono quasi il simbolo, furono un elemento fondamentale, caratterizzante, del “Reich millenario” voluto da Hitler e basato sul Führerprinzip, sul regime del partito unico, sull’idea della supremazia razziale del popolo tedesco, sulle premesse dell’igiene razziale e nella lotta antibolscevica, antiliberale, antireligiosa. Himmler, in definitiva, non fece altro che interpretare l’ideologia hitleriana nei fatti e nelle azioni, fornendo lo strumento materiale per la sua attuazione. Confermando cioè che non era possibile accettare l’idea del nazionalsocialismo senza volerne anche i metodi. Göring, subito dopo la presa del potere, si affrettò nella sua qualità di capo della nuova polizia segreta di Stato (Gestapo) a predisporre la caccia ai nemici interni, soprattutto i dirigenti e i militanti dei partiti operai e agli ebrei. La messa in scena dell’incendio del Reichstag gli era servita per scatenare la prima ondata terroristica: già nell’autunno del 1933 l’immigrazione antinazista poteva denunciare l’esistenza di 45 campi di concentramento e la deportazione di almeno 40.000 persone. Dare una cifra esatta di quante persone furono imprigionate e deportate in un campo di concentramento nei dodici anni dell’era nazista è pressoché impossibile: una valutazione recente fa ammontare a 18 milioni gli esseri umani di tutte le nazionalità che passarono per i campi di concentramento nazisti nella Germania e nell’Europa occupata dalle armate hitleriane; di questi 18 milioni, undici rappresenterebbero il bilancio dei morti della persecuzione e della deportazione. Per quanto riguarda in senso stretto la Germania, si calcola che solo i tedeschi imprigionati e deportati sotto il regime nazista non siano stati meno di un milione. Himmler, influenzato tra l’altro dagli scritti razzisti di Walter 273 Darré, concepì le SS come un centro di irradiazione della razza pura, onde avrebbe voluto moltiplicarne il ceppo originario introducendo tra i loro addetti la poligamia per la diffusione della razza pura nordica. Per questa ragione, gli uomini delle SS dovevano essere reclutati attraverso una severa selezione, anche fisica. Se in un primo momento egli pensò soltanto a una selezione per così dire “positiva” per le razze “inferiori”, in un secondo tempo presero sempre più consistenza in Himmler l’idea e la prassi della selezione negativa, mediante la sterilizzazione e l’annientamento di massa delle razze inferiori dei cosiddetti Untermenschen per estinguerli mediante esaurimento da lavoro o tramite fredde e sistematiche uccisioni. Dove lo Stato nazista non era in grado di risolvere problemi e contraddizioni della società tedesca, allora scorgeva l’ebreo pronto a insidiare e a minare l’esistenza nazionale del popolo tedesco, a sfruttare l’opera dei lavoratori tedeschi; in tal modo si cercava di nascondere ai lavoratori il volto dei loro veri sfruttatori. L’intolleranza razziale e la denuncia della congiura dell’internazionale ebraica e del bolscevismo contro la pacifica e operosa Germania erano una delle componenti essenziali nella preparazione bellica dello spirito popolare. La messa al bando degli ebrei procedette attraverso fasi graduali. La loro indiscriminata eliminazione fisica fu lo stato finale del processo di segregazione e di condanna alla morte civile, attuato in un primo momento mediante l’isolamento all’interno del popolo tedesco e il boicottaggio delle loro attività economiche; seguì successivamente la tendenza a favorirne l’allontanamento dal Reich, nella migliore delle ipotesi mediante l’emigrazione, ma eventualmente anche con la deportazione all’infuori dei confini della Germania. Da ultimo, infine, allorché l’espansione hitleriana al di là dei confini di Versailles portò sotto la dominazione tedesca milioni di ebrei, soprattutto dell’Europa orientale, l’impossibilità di uscire dal dilemma nel quale li aveva costretti il contatto 274 con la realtà, ben più complessa delle loro semplicistiche farneticazioni, spinse gli uomini del Terzo Reich a bruciare ogni soluzione gradualistica e a concepire freddamente la più mostruosa strage che la storia ricordi. L’introduzione sistematica nella vita del Reich dell’antisemitismo, sino allora rimasto sul piano della propaganda e degli ostacoli frapposti di fatto alle attività professionali di mezzo milione di ebrei che costituivano la comunità ebraica in Germania, risale al 1935: in quell’anno ebbe luogo infatti l’attuazione legislativa della distinzione tra compatriota (Volksgenosse) ed ebreo, ossia cittadino di primo grado e cittadino subalterno, o addirittura straniero ospite in Germania, contenuta già nel programma del partito nazionalsociatista del 1920. Il congresso di Norimberga del 1935 segnò il preludio della svolta del problema ebraico. Rosenberg proclamò che il bolscevismo non era altro che l’ultima conseguenza derivante dalla penetrazione del giudaisino nella cultura e nella politica degli stati europei. Il 15 settembre il Reichstag, riunito a Norimberga sotto la presidenza del maresciallo Göring, approvava all’unanimità le cosiddette “leggi di Norimberga”, destinate secondo Göring a fissare i principi della libertà della Germania: con queste leggi gli ebrei ricevevano lo status giuridico di appartenenti alla razza inferiore. Con successive ordinanze del 14 novembre 1935 fu affrontato anche il problema dei cosiddetti misti (Mischlinge), stabilendo in sostanza che chi provenisse da ascendenti per tre quarti ebrei dovesse essere equiparato senz’altro agli ebrei. In margine al sistema concentrazionario, le SS organizzarono lo sfruttamento più integrale dei beni rapinati ai deportati e delle loro stesse persone fisiche, sfruttamento che si prolungava, al di là della vita, fin sui loro cadaveri. Così come non era sfuggita l’occasione di impadronirsi dell’oro dentario strappato ai cadaveri, non sfuggì alle SS neppure la possibilità di sfruttare i capelli e la pelle dei detenuti. Ma gli affari delle SS non si arrestavano a questo punto; i 275 loro rapporti con la grande industria non si fermarono ai contratti per la fornitura del Cyclon B. Dai primi mesi del 1942, nel tentativo di spingere all’estremo limite lo sforzo bellico della Germania, sottoposta ormai ad un’usura sempre più logorante, fu ordinata la mobilitazione dei deportati per l’economia di guerra che segnò per loro il preludio di una nuova strage. Era questo lo stato delle SS: il risultato di una ferrea tirannia esercitata col sistema poliziesco piu raffinato, con l’appoggio delle più influenti forze economiche, con il consenso o la connivenza tacita di larga parte del popolo tedesco, sottoposto alla pressione di una fanatica e frenetica propaganda, che si può bene a ragione considerare tra gli strumenti terroristici del regime nazista. Fu questa organizzazione della propaganda che fornì le premesse psicologiche perché il nazionalismo e il razzismo esasperato dal nazionalsocialismo e spinti sino al limite del parossismo, in vista prima dello scatenamento del conflitto e poi della condotta spietata della guerra totale, potessero tradursi nell’accettazione dell’annientamento programmatico e sistematico di milioni di esseri umani sull’altare del mito della superiorità razziale. INTERVISTA A GIOVANNA VOLTERRA Come era la situazione delle comunità ebraiche prima e durante il fascismo? In Italia vivevano molti ebrei provenienti da altri paesi europei costretti ad emigrare in questo paese che è sempre stato più tollerante nei loro confronti anche se continuavano ad essere segregati nei ghetti. Molti ebrei toscani infatti sono di origine spagnola. Nel 1848 vengono emanate in Piemonte leggi di apertura e tolleranza nei confronti degli ebrei e vengono aboliti i ghetti. Prima del 1938 gli ebrei italiani erano pienamente assimilati nella società. 276 Quale era la situazione sociale degli ebrei italiani? Durante il fascismo, gli ebrei, che erano circa 50.000, non disponevano di ingenti patrimoni, perché svolgevano principalmente lavori “intellettuali” (scienziati, professori universitari, scrittori). La religione ebraica, infatti, attribuisce grande importanza alla cultura. Le comunità ebraiche erano più numerose in città come Roma, Milano, Firenze, ma soprattutto nella città di Trieste. Cosa avvenne nel 1938? Il Governo italiano emanò delle leggi, seguendo la politica nazista, che attaccavano duramente le Comunità. Gli impiegati statali, come i docenti universitari, persero il loro lavoro; gli industriali si videro invece sequestrato il loro patrimonio. Fu proibito inoltre agli ebrei portare denaro all’estero. L’Italia però, a differenza della Germania, non effettuò deportazioni nei loro confronti e le condizioni delle Comunità rimasero ancora abbastanza dignitose. Come reagì la popolazione dopo le leggi razziali? I ceti più bassi, che erano più aperti nei confronti degli ebrei, non approvarono questi provvedimenti, mentre nel mondo intellettuale ed alto borghese furono in pochi a schierarsi dalla loro parte durante il conflitto: l’industriale Lasca aiutò circa 5.000 ebrei ad evitare le deportazioni naziste. Dove emigrarono principalmente gli ebrei? Il maggiore flusso migratorio si riversò principalmente negli Stati Uniti dove trovarono sistemazione circa 5.000 persone; era qui in vigore “l’affidavit per se” secondo cui poteva rimanere negli USA chi avesse trovato un lavoro, chi aveva denaro per mantenersi o chi comunque poteva contare sull’appoggio economico di parenti o conoscenti. Il Gover- 277 no svizzero fu però più intransigente nei loro confronti chiudendo le sue frontiere al flusso migratorio per paura che in tempo di guerra non bastassero le riserve alimentari e per paura di peggiorare i propri rapporti diplomatici con la Germania; d’altra parte alcuni ebrei riuscirono a fuggire in questo paese grazie a guardie doganali e ad amministratori pubblici. L’EMIGRAZIONE Prima del 1938 gli ebrei italiani si erano completamente dimenticati di discendere da una razza di “erranti”. Fin dall’unificazione d’Italia avevano avuto piena libertà di possedere case, terre e partecipare alla vita pubblica e all’esercito. Anche nei secoli precedenti il Risorgimento, l’oppressione non era stata mai grave. Pochi ebrei italiani, prima delle leggi razziali, intuirono il pericolo ed ebbero l’avvedutezza di lasciare l’Italia e l’Europa. Qualcuno era emigrato prima perché antifascista. Molti, che avevano partecipato alle vicende della vita politica italiana, avevano abbracciato il fascismo, parte per convinzione e parte per tornaconto. L’emigrazione ebraica perciò cominciò dopo le leggi razziali e terminò nel 1940; con l’entrata in guerra dell’Italia non era più possibile ottenere visti e passaporti. Più tardi col predominio tedesco in Italia le condizioni di vita degli ebrei peggiorarono e soltanto con la fuga poterono aver salva la vita. L’emigrazione ebraica italiana nel 1938-40 fu assai esigua rispetto all’emigrazione italiana degli anni precedenti. Il movimento di ritorno in Italia sarà sicuramente maggiore rispetto agli altri paesi coinvolti nel conflitto. L’atteggiamento degli ebrei italiani sarà più favorevole al ritorno in Italia che non quello degli ebrei tedeschi, austriaci ed ungheresi. Come per altri casi, dipenderà dal periodo e dalle condizioni della madrepatria. Fattisi più stabili le condizioni economiche nel dopoguerra, alcuni uomini d’affari italiani torneranno. I medici saranno più 278 favorevoli a tornare perché in Italia guadagnavano di più. Un certo numero di professori, impiegati, diplomatici avranno la notifica per la richiesta del loro ritorno. Molti ebrei italiani, emigrati in America, preferirono comunque non tornare in Italia: banchieri, assicuratori, avvocati e rappresentanti di industrie sono diventati agenti del commercio italo-americano e delle relazioni intellettuali dei due paesi. Coloro che sono tornati sono soprattutto gli anziani o persone legate da vincoli familiari; i giovani hanno trovato lavoro e hanno preferito rimanere in America. Sono rimasti soprattutto coloro che avevano figli giovani, che sono entrati nelle scuole americane e hanno imparato l’inglese meglio dell’italiano. Gli intellettuali, e specialmente i professori di fisica (che formano una specie di congregazione internazionale, dato il loro ristretto numero) hanno trovato facilmente lavoro. Molti utilizzarono le loro relazioni precedenti con studiosi americani dello stesso ramo; in maggior parte trovò lavoro, più o meno facilmente, a seconda delle loro capacità e delle loro conoscenze il governo americano e le istituzioni di cultura fecero il possibile per aiutarli e favorirli. Ma oltre agli ebrei che riuscirono a continuare la stessa attività ce ne furono anche che dovettero cambiarla. Coloro che hanno trovato maggiore difficoltà sono stati i medici che hanno dovuto nuovamente sostenere gli esami in una lingua a loro straniera. Alcuni di loro hanno acquisito importanti posizioni negli ospedali americani; altri hanno dato alla luce pubblicazioni tecniche di grande interesse. La maggior parte degli ebrei si è riversata su New York o sulle città della costa dell’Atlantico, che hanno attirato gran parte del flusso migratorio. 279 GLI EBREI IN SVIZZERA Jacopo Venerosi Pesciolini 1995-1998: La Svizzera è in discussione come non era mai avvenuto.1 Il nodo è quello dell’accoglienza ai perseguitati negli anni cruciali fra il 1933 e il 1945. Si critica, certo, il ruolo di piazza bancaria e finanziaria per lo più a favore del Terzo Reich, di centrale d’informazione e spionaggio, di retroterra industriale delle potenze dell’Asse, di crocevia del traffico internazionale d’oro dei paesi belligeranti. Ma ad essere particolare oggetto di discussione è la politica adottata dalla Confederazione negli anni della Seconda Guerra Mondiale, con il rifiuto di concedere asilo a migliaia di profughi razziali e il trattamento loro riservato nei campi d’internamento. Vi è un gran numero di studi sulle vicende che riguardano le “displaced persons” della Seconda Guerra Mondiale: prigionieri di guerra, internati militari, rifugiati civili, deportati politici e razziali, popoli trasferiti con la forza. Tutti i Paesi d’Europa coinvolti nel più grande conflitto che il continente abbia mai conosciuto hanno una “letteratura delle migrazioni” che va infittendosi. La Svizzera risulta sempre più un crocevia di sofferte vicende umane. Gli storici in particolare si interrogano sui motivi che hanno indotto la Confederazione e i Cantoni a concedere o a rifiutare l’asilo agli ebrei, spinti verso le frontiere dall’arrivo al potere di Hitler nel 1933 e più ancora negli anni successivi, in seguito all’occupazione tedesca dell’Europa. Oltre mezzo secolo di indagini e interpretazioni non hanno portato alla luce tutte le responsabilità, né attenuato le polemiche, le accuse, le amarezze. Il paese, scosso, chiede oggi delle risposte più convincenti. Le statistiche ufficiali dicono che la Svizzera nel corso del conflitto ha accolto 300.000 profughi, in media l’8% della popolazione, anche 280 se non tutti sono rimasti nel paese per l’intera durata della guerra. Accoglienza c’è dunque stata. La polemica nasce piuttosto a proposito del rifiuto di concedere asilo a perseguitati razziali nelle fasi più acute dell’emergenza: su un totale di 28.000 ebrei accolti, altrettanti vengono respinti alle frontiere. Una mancata accoglienza, a partire dall’estate del 1942, significava per la maggior parte delle persone una probabile condanna allo sterminio. É un “capitolo oscuro”, che è stato già affrontato nell’immediato dopoguerra, ma che fino ad oggi non ha ancora soddisfatto pienamente. Via via però sono cominciati a venir fuori i particolari, grazie ad una storiografia più coraggiosa ed esplicita, ma soprattutto per l’apertura degli archivi. Nel dicembre del 1996 il Consiglio Federale ha istituito una “Commissione indipendente di esperti: Svizzera-Seconda Guerra Mondiale”, con il compito di dare delle risposte il più possibile documentate agli interrogativi ancora aperti riguardo al periodo 1933-1945. I risultati di questa impresa a largo raggio sono attesi per il 2001. Intanto il 7 maggio 1995 il presidente della Confederazione Kaspar Villiger riconosce a nome del governo svizzero il carico “di colpe nei confronti degli ebrei perseguitati”, conseguenza della situazione di “minaccia” da parte del Terzo Reich, nello sforzo di “resistenza” per salvare la “neutralità armata” insieme con “la democrazia e lo stato di diritto”. Ultimamente poi le associazioni di ebrei americani hanno accusato le banche svizzere di aver trattenuto somme di denaro dopo la morte di molti ebrei. Questo fatto riguarda le banche più grandi; pochi anni fa la Svizzera per sdrammatizzare la situazione ha pagato una somma che dovrebbe risarcire i danni: 2 miliardi di franchi svizzeri. Comunque l’atteggiamento della Svizzera è giudicato assai diversamente: sicuramente tantissime persone ringraziano il paese per l’ospitalità, mentre i respinti ne criticano la posizione non sempre “pulita”, cioè il fatto che le frontiere alcune volte venivano aperte ed altre no e sottolineano che l’accettazione degli immi- 281 grati non seguiva un particolare procedimento, anche perché le guardie di confine avevano un discreto potere decisionale. In Italia la situazione degli ebrei diventa critica l’8 settembre del 1943, quando Badoglio dà la notizia che l’Italia ha ottenuto un armistizio con le forze anglo-americane. La nazione è abbandonata a se stessa. I tedeschi, di colpo nemici, in pochi giorni occupano l’Italia fino a Napoli. Cominciano così i venti mesi della dominazione nazista. Con i tedeschi in casa da nemici, la scelta di non collaborare o di non eseguire gli ordini significa rischiare il carcere, la deportazione, la vita. Per alcuni non c’è possibilità di scelta: sono gli ebrei. Discriminati dalle leggi razziali del 1938, privati di quasi tutti i diritti, senza protezione giuridica, si ritrovano in un’Italia ormai nell’area del genocidio nazista. All’inizio molti non credono nella soluzione finale, ma chi capisce cosa accadrà sono gli ebrei stranieri, che hanno già sperimentato la ferocia nazista. Dopo l’8 settembre, con l’arrivo dei nazisti, gli ebrei hanno poche alternative: o nascondersi in famiglie italiane, o cercare di andare al sud dove c’era il dominio anglo-americano, o rifugiarsi in Svizzera. Quest’ultima soluzione è pensata da moltissimi, anche se non tutti riescono ad attuare questo sogno per motivi economici. Dal 9 al 16 settembre l’intero confine rimane sguarnito e migliaia di militari italiani riescono a sfuggire alla cattura e alla deportazione rifugiandosi nel territorio elvetico. Infatti lì trovano riparo non solo ebrei, ma anche soldati italiani che sbandano dopo la diffusione della notizia dell’armistizio. La situazione però cambia al confine quando il 18 settembre i tedeschi assumono il controllo del dispositivo di sorveglianza con l’invio della V sezione della Grenzwache. Nonostante questo, ci si avventura lo stesso e chi lo fa sa che può finire nelle mani delle SS. Per militari e “politici”, se catturati, c’è il tribunale speciale e il carcere; per gli ebrei la deportazione e il campo di sterminio, o, addirittura, l’uccisione sul posto. Quando i primi profughi dall’Italia premono alla frontiera, in Svizzera è in vigore una legislazione restrittiva sull’asilo; ma 282 da poche richieste di accoglienza per motivi politici si era passati, negli anni, alle migliaia di domande per motivi razziali. La costituzione del 1848 garantiva infatti ospitalità ai perseguitati politici, a condizione di non tramare contro altri stati. Nel 1874 la revisione costituzionale dava potere di “espellere dal territorio svizzero quei forestieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna”. Nel 1929 per la crisi economica, saliti di colpo i disoccupati da 24.000 a 54.000 su una popolazione di circa quattro milioni, gli stranieri vengono considerati come concorrenti e dal 1931 una legge federale ne regola dimora e soggiorno. Nel 1933 una legge tratta dell’impossibilità di accoglierli in numero illimitato per tre motivi: situazione alimentare, sicurezza interna, mercato del lavoro. Con l’arrivo al potere di Hitler il problema dei profughi dalla Germania porta a nuove misure restrittive: il capodivisione della polizia intende frenare “l’infiltrazione straniera” in linea con il timore di un inforestieramento, la Überfremdung. Per tutto l’arco della guerra disposizioni delle autorità svizzere portano ad una continua apertura e chiusura delle frontiere; in questo modo spesso solo gli ebrei più fortunati riescono ad entrare, anche se da molti documenti si denota che spesso se uno si presentava da solo alla dogana lo respingevano, se veniva presentato da qualcuno lo accoglievano. Il 1942 è l’anno cruciale della politica d’asilo. Tra restrizioni e concessioni molti ebrei vengono respinti. Le ragioni di questi decreti sono ancora dibattute. Soprattutto ci si interroga su quanto le autorità svizzere sapessero della soluzione finale, quindi sul grado di responsabilità della Confederazione. In discussione sono l’antisemitismo nella popolazione e nelle autorità, l’influenza di circoli di “fronti nazionali” filonazisti, le complicità individuali e collettive, le decisioni di civili o militari sulla linea di confine, le alternative possibili. Rigorose anche le disposizioni del 1943: chiusura parziale della frontiera, internamento obbligatorio per i profughi, salvo i civili in grado di mantenersi o sostenuti da un garante. Con lo sbarco in Normandia, il 6 giugno 1944, il control- 283 lo al confine è di nuovo intensificato, ma ora l’obiettivo è tenere fuori fascisti e nazisti. Solo nel luglio 1944 ai perseguitati per motivi razziali viene riconosciuta la condizione di persone minacciate nella vita, e quindi questi beneficiano di un’accoglienza più ampia. Al confine italiano, subito dopo l’armistizio, in pochi giorni si è creato un intensissimo traffico clandestino. I contrabbandieri in quel periodo hanno molto successo. Sono soprattutto italiani che conoscono bene le montagne di confine, gli orari e le abitudini delle guardie di confine. Si fanno pagare cifre immense per raggiungere la salvezza. Spesso sono persone “oneste”, ma molte volte sono criminali senza scrupoli, che si approfittano di uomini in difficoltà: alcune volte si fanno dare i soldi e lasciano le persone sulle montagne, altre volte oltre ai soldi rubano anche le poche cose di valore che gli ebrei si portano con loro, oppure violentano le donne o ancora consegnano gli ebrei ai nazisti, così oltre alla cifra stratosferica del pedaggio, ottengono anche la taglia di cinquemila lire istituita dai nazisti per gli ebrei. Il problema scaturisce quando la spedizione non ha successo; i clandestini vengono così catturati e i soldi ce l’ha il contrabbandiere. Per evitare questo fatto nascono così dei garanti che consegnano il resto della somma solo quando i profughi hanno superato il confine. Ma ci sono anche testimonianze più vergognose: alcuni contrabbandieri avevano costruito una rete falsa sul territorio italiano in modo che sembrasse il confine, così il denaro finiva in mani ignobili, mentre gli ebrei, credendo di essere in Svizzera, venivano facilmente catturati dai nazisti o dai fascisti che per lo più consegnavano la taglia ai trafficanti. Quando i profughi riescono a raggiungere il territorio svizzero, vengono accolti dalle guardie di frontiera. È questo il momento più delicato del viaggio: sapere se si è accolti o no. Inizia quindi un giro di telefonate per dimostrare che si ha parenti in Svizzera o per ricercare la protezione di qualche garante. L’ultima parola spetta sempre al Centro nazionale della Confederazione a Berna, ma spesso gli ufficiali di frontiera hanno molto potere. Tutte le testimonianze dicono che anche se qualche 284 volta le leggi svizzere erano strane e ingiuste, la popolazione e soprattutto i soldati di frontiera sono molto gentili e comprensivi. Quelli accolti vengono mandati nei centri di accoglienza, mentre gli altri vengono respinti, cioè vengono accompagnati, in teoria consegnati alle guardie nazi-fasciste, ma in verità rilasciati in modo che non incontrino sulla via del ritorno alcuna guardia. Donne e bambini comunque sono quasi sempre accolti. Le persone “fortunate” vengono mandate nei centri di accoglienza sotto controllo militare, dove restano pochi giorni, solo per poter avviare le pratiche. I comandi territoriali aprono per ciascuno un dossier personale, dove vengono raccolti i documenti dell’asilo, tra cui il famoso libretto o “passaportino svizzero”. Il verbale d’interrogatorio è forse il documento più importante: un modulo di venticinque domande in cui si registrano i dati anagrafici , i motivi, le circostanze e il percorso della fuga, lo stato della salute, le conoscenze in Svizzera, il patrimonio. Quanto ciascuno ha con sé viene inventariato, ritirato, depositato presso la Banca Popolare Svizzera (BPS) a Berna dietro rilascio di ricevuta, bloccato su un conto che non dà interesse, a garanzia del rimborso delle spese d’internamento. Oro, diamanti, preziosi, oggetti d’arte restano di proprietà dei depositanti, che non possono disporne fino al rimpatrio senza il consenso della Divisione di polizia. A ognuno è consentito di trattenere cinquanta franchi svizzeri e pochi oggetti personali. Se al rifugiato occorre un anticipo sui valori depositati per spese straordinarie, la banca può accordarlo dopo aver provveduto a verificare la fondatezza del motivo. Con la presa in carico dei beni privati, le autorità intendono uniformare il tenore di vita dei profughi più ricchi con quello medio degli svizzeri, per non suscitare risentimenti in un paese con una tradizione di rigorosa disciplina. Arriva il momento delle precauzioni sanitarie: doccia, disinfestazione di vestiti e di oggetti con una soluzione di Lysol, lo “spidocchiamento” che le autorità impongono all’arrivo per salvaguardare la salute nei campi. Il rilevamento delle impronte 285 digitali alla polizia completa la registrazione. In questa fase i nuclei familiari vengono subito divisi per il periodo di quarantena: gli uomini nei loro campi e le donne con i bambini in altri. La quarantena consiste in ventun giorni di isolamento che completano la fase delle precauzioni sanitarie. Sistemati in edifici pubblici o in alberghi requisiti, sorvegliati da sentinelle, con il divieto di qualsiasi forma di comunicazione, rifugiati e guardie devono rispettare come “ordini militari” le disposizioni emanate dal comandante. Intanto la Divisione federale di polizia esamina gli atti per decidere caso per caso dove destinarli. Superata la prima fase di sistemazione provvisoria, le condizioni di vita “non brillantissime” migliorano e prendono ritmi quasi da collegio, con restrizioni e divieti, ma anche con molta solidarietà. I rifugiati vengono ora assegnati a campi di “smistamento”, e da qui a homes (piccoli alberghi) adatte o all’internamento privato, dove passano sotto il controllo delle autorità civili. Riuniti con i familiari, aspettano qualche settimana per dare tempo alla Divisione di polizia di trovare la sistemazione più adatta. La Confederazione ha norme precise per i più piccoli. Fino a sei anni possono rimanere con la madre, su richiesta, o venir collocati in famiglie scelte dalla Croce Rossa, poi al compiere del sesto anno arriva l’affidamento. Quando visitano i genitori nelle varie homes, i ragazzi viaggiano da soli, con la “fiche” della Croce Rossa in vista, completa di indirizzo, orari e coincidenze, per orientarli nel tragitto e ricevere aiuto. Il lavoro è una costante dell’internamento. Terminata la fase “militare”, i civili idonei passano alle dipendenze della Zentralleitung, con sede a Zurigo, responsabile degli Arbeitslager aperti per contribuire all’economia del paese, e affidati a militari o civili. La ZL li rifornisce di abbigliamento adatto, si occupa della sistemazione e del mantenimento. Questi lavori vengono retribuiti con una somma settimanale, che il rifugiato dispone, oltre alle varie “mance” che riceve per vari lavoretti minori. Un lato positivo di questo fatto è che molti mandano una parte di questo 286 guadagno sicuro ai familiari in Italia. I lavori variano secondo le zone in cui sono i campi: coltivazioni di patate, prosciugamento di paludi, canalizzazioni, cave, taglio di alberi e, lungo la frontiera col Reich, lavori difensivi. Rendimento e qualità del lavoro restano però deludenti per diverse cause, così individuate dall’amministrazione: scarsità di internati capaci di affrontare lavori pesanti; complicità di medici svizzeri e rifugiati nel firmare esoneri; convinzione che lo stato di provenienza rimborserà i costi del soggiorno, per cui il lavoro non sarebbe obbligatorio. Per chi rimane nell’internamento il “campo di lavoro” può durare fino al rimpatrio; si limita invece a un breve periodo per i “liberati”. Come l’asilo, anche la “liberazione” non é un diritto, ma una concessione della polizia federale. Per lasciare i campi bisogna avere mezzi finanziari per almeno un anno - 5000 franchi, con diritto a un prelievo massimo mensile stabilito - o un garante che assicuri vitto e alloggio. Non pochi rifugiati vi rinunciano perché la vita fuori é costosa e richiede sacrifici. Il “liberato” deve sottostare a certe condizioni: astenersi da attività politiche, lucrative e pubbliche; non cambiare residenza; presentarsi all’ufficio di polizia il 1°, il 10 e il 20 di ogni mese. Altre circolari impongono di non uscire dal raggio di dieci chilometri dal luogo di soggiorno e concedono autorizzazioni di viaggio solo su richiesta motivata. Quando però il bilancio domestico si assottiglia al punto che la vita in privato risulta impossibile, sono le stesse autorità a riconvocare i rifugiati “a malincuore” in campi o homes, dove è più intensa l’attività delle associazioni di assistenza. Queste associazioni sono molto importanti. Infatti oltre quelle svizzere, ce ne sono molte straniere che con aiuti pratici e denaro portarono un significativo aiuto ai rifugiati. Ci sono anche associazioni ebraiche che aiutano gli ebrei a rifugiarsi in Svizzera, o aiutano gli internati nei campi italiani o i deportati nel Reich. Naturalmente le vie di comunicazione sono molto difficili e bisogna agire con cautela, perché fuori dalla Svizzera, ma spesso anche dentro il paese, tutto è sorvegliato da nazisti e fascisti e un’azione sbagliata può compromettere l’intero sistema. 287 Quando, nell’autunno 1944, alla notizia della riorganizzazione delle bande partigiane, molti rifugiati tornano clandestinamente in Italia a combattere nella Resistenza e mentre si avvicina la liberazione dell’Italia, molti si interrogano sul loro futuro. La liberazione avviene improvvisamente: la notizia della radio “Qui radio Milano: libertà” si spande a macchia d’olio. Berna dispone, come d’accordo con gli anglo-americani, la chiusura totale delle frontiere: nessuno può più né entrare, né uscire. Il rientro inizia il 28 giugno con un movimento giornaliero di circa 1000 persone, ma prima sono restituiti i valori prelevati all’ingresso e regolate le pendenze, che danno luogo a conteggi minuziosi. Ma tutta la felicità del rientro spesso si trasforma in una tragedia annunciata. I più fortunati ritrovano una casa, una famiglia; gli altri, sradicati, nemmeno una patria. Gli ebrei devono affrontare il rientro più doloroso: famiglie decimate, catturate, annientate, scomparse nel nulla; e chi si è salvato torna segnato nel fisico e nello spirito dal campo di sterminio. I rimpatriati dalla Svizzera sono poi dei privilegiati perché durante l’asilo hanno svolto una vita quasi normale. Ma la Svizzera avrebbe potuto fare di più? L’entrata di profughi ebrei in così gran numero è, in realtà, già un eccezione, se si tiene conto delle norme sull’asilo in vigore da anni nella Confederazione. Infatti, mentre a Berna si discuteva di quote di accoglienza, grazie a ordini non chiari di chiusura e di apertura della frontiera, molti ebrei riescono ad entrare in Svizzera. Va sottolineato anche che fra dovere e coscienza, autorità e guardie svizzere abbiano dato più valore all’uomo che alle leggi. Nonostante queste disposizioni, sono stati tanti i respinti. Va evidenziato comunque che negli stessi anni altri stati – non solo europei – hanno abbandonato gli ebrei al loro destino, chiudendo le porte all’immigrazione e spesso anche al transito. Nella Svizzera d’allora non mancano le correnti antisemite, i movimenti di destra di idee filonaziste, contrari agli ebrei; ma nel paese, nonostante le pressioni del Reich, l’ordinamento democratico non viene intaccato. Inoltre i paragoni oggi diffusi con facili- 288 tà tra campi svizzeri e lager tedeschi sono improponibili. In Germania il campo è il luogo di sterminio; in Svizzera è la prima accoglienza che precede una certa libertà, un minimo di guadagno con il lavoro, una vita dignitosa in attesa del rientro in patria. Per la Svizzera che in un certo periodo era isolata al centro dei paesi dell’Asse questo è stato un periodo molto difficile. Poiché non dispone di materie prime, deve sempre commerciare con i paesi confinanti o con paesi non europei, come gli Stati Uniti, e poiché la popolazione sta soffrendo la fame, il fatto dei rifugiati provoca anche qualche tensione, poiché i cittadini si vedono privare di ciò di cui essi stessi mancano. Inoltre c’è sempre la paura dell’invasione da parte di Hitler. Anche se tutto l’esercito svizzero è schierato ai confini, per i nazisti sarebbe una passeggiata violare la neutralità della Svizzera e conquistarla. Il caso italiano rientra però solo in parte nella complessa immigrazione in Svizzera: infatti gli ebrei entrano dalla Germania, dall’Austria, dall’Italia, dalla Francia, dalla Polonia e da tutti i paesi sotto il dominio nazista. Proprio dalla Germania è entrato Werner Meyer che gentilmente si é mostrato disponibile a raccontarmi la sua storia. Devo precisare che Werner vive attualmente nel nord della Francia ed essendo io impossibilitato ad avere un colloquio diretto, ho pregato il mio interlocutore di lasciare libero corso per iscritto ai suoi pensieri, emozioni e sentimenti riguardo alla tragica odissea vissuta durante il nazismo da lui e dalla sua famiglia, dopo avergli indicato alcuni temi da sviluppare. Non volendo, questa scelta obbligata ha fatto sì che le pagine che seguono, non interrotte da maldestre domande, si rilevino un documento di eccezionale interesse. Il protagonista chiude, simbolicamente, gli occhi e lascia fluire liberamente il fiume dei ricordi. Ma la cosa sorprendente è la sconcertante mancanza di “pathos”, per cui i fatti narrati sono esposti con cadenza monotona e vengono amplificati particolari di secondaria importanza come l’aspetto del denaro e non viene privilegiato il sentimento di angoscia e apprensione verso i genitori lontani, tuffati nell’inferno 289 della Germania nazista. Werner dà lo stesso risalto a una tessera di lavoro e all’internamento del padre e della madre nel “girone di Auschwitz”, pareggia con cuore apparentemente pietrificato l’inutile tentativo di fuga dei genitori verso la libertà in Nuova Zelanda e le sue peripezie burocratiche nel paese straniero che lo ospita. Dell’infanzia perduta, della famiglia dilaniata, del fratello vicino e lontano solo accenni messi sullo stesso piano della vita quotidiana e delle spese giornaliere. Tutto è posto su un disperante piano orizzontale: fatto questo tanto tragico forse quanto la desolazione di Auschwitz. Cosa pensare di un simile racconto? Ogni lettore può trarre le sue considerazioni che saranno certamente diverse per ciascuno... Pudore? Rimozione? Aridità patologica di carattere? Tutto e tutto il suo contrario è possibile, tranne quello che avrebbe detto un “ariano” del tempo: “I semiti sono una razza inferiore priva tra le altre cose anche di Gefühl (“sentimento”) …” Penso che forse un sentimento troppo forte ha pietrificato il cuore di Werner perché la ragione potesse continuare ad abitare il suo cervello. L’ESPERIENZA DI WERNER MEYER Maggiore di due fratelli, sono nato il 22 giugno 1924 a Königsberg che era in quel periodo la città principale dell’Ostpreussien, una provincia tedesca. Anche mio fratello Ludwig nacque in un ospedale a Königsberg il 15 aprile 1927. Mio padre era comproprietario del secondo mulino più grande della Prussia Orientale. Noi abitavamo a Bartenstein, una cittadina posta sessanta km a sud di Königsberg in una casa unifamiliare, molto vicino al mulino. Fino al 1933 ebbi un’infanzia senza preoccupazioni. Il mulino apparteneva dal 1881 alla famiglia. Anche mia madre crebbe da un famiglia tedesco-ebrea di mugnai di Nakel, nella provincia di Thorn, che dalla divisione della Polonia fino alla fine della Prima Guerra Mondiale apparteneva alla Germania. 290 I miei antenati vissero come minimo dalla fine dell’800 nella Germania dell’Est. La famiglia era completamente integrata nella vita civile tedesca, ma comunque era rimasta ebrea. Mio nonno a Bartenstein era presidente della piccola Comunità ebraica. Andavamo durante le feste principali nella sinagoga e noi bambini non andavamo a scuola. Comunque né il Sabbat né le regole alimentari venivano da noi seguite. Quindi non vivevamo “kosher”. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale mio padre fece una maturità veloce e andò in guerra. Era sottotenente di artiglieria e venne anche decorato con delle medaglie. Alla fine della guerra studiò economia a Königsberg, fino alla laurea. I miei genitori si sposarono nel 1923. Dopo la presa del potere da parte dei nazisti la situazione degli ebrei peggiorò e si fece insidiosa. Furono affissi dei cartelli “Non comprate da ebrei” che mio padre però grazie alla buona amicizia con il sindaco, poté far abolire dal suo negozio. A Bartenstein a dieci anni andavo al ginnasio locale. Dal 1936 i ragazzi ebrei non potevano più andare a scuola. I miei genitori volevano mandarmi con mio fratello in Inghilterra. Ma per caso seppero dell’istituto di Rosenberg a St. Gallen in Svizzera, che aveva una buona fama. Così con mio fratello venni portato nel settembre 1936 da mia madre a St. Gallen. Avevo dodici anni, mio fratello nove. All’inizio stavamo nella stessa camera. Vorrei precisare che il trasferimento in Svizzera non rappresentò una fuga, ma un espatrio assolutamente legale. Fino all’estate del 1938 abbiamo trascorso le vacanze a Bartenstein e nel 1937 con i nostri genitori abbiamo fatto un grande viaggio in macchina in Ungheria e Jugoslavia. Fino all’inizio della guerra mio padre poté trasferire legalmente tutti i soldi per il collegio in Svizzera. Di continuo ricevevamo dei pacchetti e potevamo partecipare a tutte le gite del collegio (che erano molto costose). L’Istituto lo posso solo elogiare. Le classi con poche persone furono una cosa eccellente. C’erano professori giovanissimi che diventarono quasi dei compagni. Lì giocavo sempre a calcio e tennis. Nel secondo semestre fui eletto presidente del club dai coabitanti della casa in cui vivevamo. I miei genitori avevano però progettato un esame per passare in un collegio inglese: ma l’inizio della guerra scombussolò questi piani. Avevo 291 superato l’esame, ma restai lo stesso in Svizzera. Anche se mio padre non poteva più pagare la scuola, l’Istituto mi tenne gratis ancora per qualche mese. All’inizio del 1940 il direttore mi disse che era opportuno che mi trovassi un lavoro. Volevo diventare un agricoltore. Non trovandomi un lavoro del genere, andai a fare il manovale da un giardiniere a Teufen/ Appenzell. Non parlavo ancora il dialetto svizzero. Senza nessun pregiudizio, nonostante fossi un rifugiato ebreo, la famiglia del giardiniere e tutto il paese mi accolsero benissimo: spesso mi riempivano di cioccolata e piccoli regali utili. Appena avevo lasciato l’Istituto venni schedato dalle autorità come immigrato. Dalla Germania fui espulso come ebreo e persi il mio permesso di soggiorno in Svizzera, che venne sostituito da un permesso di tolleranza, revocabile in ogni momento. Questo permesso andava rinnovato ogni tre mesi dietro pagamento. In cambio veniva scritto nel passaporto “in preparazione di espatrio”. La copertina del passaporto venne bucata: i buchi significavano “immigrato”. Il permesso di lavoro nel cantone Appenzell lo ricevetti solo dopo che St. Gallen ebbe dichiarato che finito il lavoro, mi avrebbe ripreso. St. Gallen e Teufen distano soli 5 km, ma sono in diversi cantoni. Il lavoro di giardiniere era inusuale e duro e durava dall’alba al tramonto. Ogni seconda domenica avevo un giorno libero. Veniva mio fratello, che, dopo aver lasciato l’Istituto, aveva trovato rifugio presso una famiglia svizzera. Mio fratello veniva anche assistito da un’associazione per l’aiuto dei bambini svizzeri. Quando lasciò l’istituto aveva tredici anni e cominciò a frequentare la scuola pubblica. Nel febbraio 1941 abbandonai l’attività di giardiniere e tornai a St. Gallen. Tramite un amico trovai una pensione per immigrati non troppo costosa. Un amico di mio padre, anche lui emigrato dalla Germania a St. Gallen, mi diede l’incredibile somma di 5000 franchi, che più tardi parenti americani gli restituirono. Attraverso lezioni private, con un guadagno minimo, riuscii ad “allungare” i soldi iniziali. Quando però questi finirono, fui sostenuto dall’aiuto studentesco. Nella classe sono stato ben accolto. Professori e compagni furono amichevoli e trovai amici, che mi invitavano anche a casa. Mi ricordo di 292 una sola minaccia antisemita di un mio compagno, che però fu messo a tacere dai miei compagni. Durante il periodo da studente ricevetti dalla polizia una lettera che mi suggeriva di cercare un lavoro per potermi inserire meglio quando fossi stato mandato via; tramite il preside inviai una lettera a Berna e poi non sentii più nulla. Nel 1943 feci la maturità e mi iscrissi all’università. Non dovetti pagare niente per gli studi. Abitavo ancora nella pensione. Fui coccolato dalla proprietaria e mi innamorai della figlia. Sarebbe stato un bel periodo se non ci fossero state la guerra e le persecuzioni ebraiche in Germania. Rimasi in contatto con i miei genitori per posta e ancora oggi conservo le lettere dei miei genitori, lunghe e piene di insegnamenti. Dal 1938 a Bartenstein la situazione divenne difficile. Il mulino venne tolto ai miei genitori e venne dato ad “ariani”. Furono costretti ad trasferirsi a Berlino. Riuscirono a stare lì fino al 1943; in giugno furono però mandati a Theresienstadt e poi nell’ottobre 1944 deportati ad Auschwitz, dove poco dopo furono uccisi nelle camere a gas. Le date sono documentate. I genitori di mia madre, allo scoppio della guerra dalla Polonia si trasferirono a Berlino e presero una stanza vicino ai miei genitori. Nel 1942 furono deportati a Theresienstadt e uccisi poco dopo. Devo considerare che mio padre, dopo aver eroicamente partecipato alla Prima Guerra Mondiale come ufficiale, non avrebbe mai pensato ad una fine così. Solo quando era troppo tardi i miei genitori, insieme ai miei nonni, cercarono di emigrare in Nuova Zelanda. Però mia nonna non riuscì ad avere il permesso, così tutto il progetto andò in fumo. Mio padre non volle lasciare sua madre sola in Germania. Lei morì nel 1941 in seguito ad una frattura di una gamba a Berlino. Io vidi i miei genitori l’ultima volta nell’estate del 1939 a Lindau, dove si intrattennero per un giorno, per parlare con un mio professore allo scopo di preparare la fuga verso la Nuova Zelanda. Conservo ancora oggi il mio passaporto tedesco (non valido). Mi definisce come Werner Israel Meyer. L’aggiunta Israel é stata fatta dai nazisti per poter riconoscere subito gli ebrei. Inoltre il passaporto comprende anche una “J” di “Jude” che é stata aggiunta dalle autorità svizzere. 293 Cosa sapevo della situazione degli ebrei in Germania prima di lasciare il mio paese per la Svizzera? Sapevo molto e niente. La ricerca sempre più accanita dei giudei e i rastrellamenti li avevo già vissuti a Bartenstein. Un mio buon amico, che mi ha aiutato fino alla fine, fu pestato crudelmente dalle SS. Così mio padre mi raccomandava di non incontrarlo più nelle nostre proprietà, ma noi non lo ascoltavamo. Per mio desiderio mio padre gli trovò un posto nell’impresa “arianizzata”. Fui buttato fuori da tutte le associazioni, anche quella sportiva. Comunque aggressioni violente non le ho mai subite. Nella mia classe fino all’ultimo giorno regnava un’aria amichevole. Il professore spesso mi invitava a casa sua a prendere un tè e mi mandava le cartoline dalle vacanze. Posso solo pensare che deve essere stato difficile e molto strano per molti abitanti di Bartenstein dover escludere improvvisamente dalla vita quotidiana gli ebrei concittadini che conoscevano o appartenevano alla stessa circoscrizione. Erano in genere passivi e non dimostravano un particolare odio di razza. Con l’avvento del nazismo però questo atteggiamento di non ostilità diventò anche molto pericoloso, regnava il terrore. Torniamo alla Svizzera. Poiché sono entrato nel 1936 non ho avuto molti problemi, e sono potuto rimanere. Nelle autorità svizzere regnava soprattutto la paura di ebraizzare il paese, poiché è un paese molto piccolo con pochi abitanti. Per fermare il fiume di profughi, gli ebrei non furono accolti come rifugiati politici. Questo fatto permetteva di respingerli alla frontiera, se necessario. Naturalmente non tutti gli ebrei sono potuti entrare e questo non fa tanto onore alla Svizzera, poiché probabilmente sapevano cosa succedeva a quelli che non riuscivano a passare. Alfred A. Häsler scrive nel suo libro “La barca è piena” a proposito degli ebrei: “La Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale ha accolto più di 300.000 profughi, ma negli stessi anni ha anche respinto non precisate migliaia di ebrei alla frontiera o che erano già in Svizzera. In tutti gli strati della popolazione c’erano persone che più o meno sostenevano l’antisemitismo e c’erano però anche altri che lottavano contro l’odio per la razza”. Vorrei aggiungere che c’era anche un numero rilevante di persone che non erano né dall’una, né dall’altra parte, ma spesso aiutavano gli immigrati. 294 Infatti tra il governo, il parlamento e la popolazione si aprì una spaccatura. Le autorità erano preoccupate di subire un attacco dalla Germania nazista: dopo la caduta della Francia e l’entrata in guerra dell’Italia, la Svizzera era circondata dai paesi dell’Asse. Il problema maggiore erano le materie prime, di cui la Svizzera è priva, che dovevano continuamente essere importate. Comunque, il governo è riuscito nel suo intento di mantenere la neutralità della Svizzera fino alla fine della guerra. Però il prezzo per questo fu molto alto e se ne vedono le conseguenze ancora oggi. Molti cittadini considerarono il prezzo da pagare troppo alto, perché vennero a mancare molte basi della democrazia. Alla fine della guerra la Svizzera ha pagato un paio di centinaia di milioni di franchi svizzeri agli Stati Uniti, in cambio del protettorato ottenuto indirettamente. Ultimamente poi organizzazioni di ebrei americani hanno rivendicato i soldi trattenuti dalle banche svizzere dopo la morte di molti ebrei. Questo fatto comprende le banche più grandi e si è risolto con il pagamento di due miliardi di franchi ai creditori. Poi ci sono state delle accuse di scambi illeciti tra la Banca Nazionale Svizzera e Tedesca, in particolare riguardo all’oro degli ebrei. Su questo fatto però non ci sono certezze, ma l’immagine della Svizzera è stata sicuramente danneggiata. Invece positive sono state le scuse del Consiglio Centrale per gli errori dei suoi predecessori e l’istituzione di una commissione per la verità. Non so di preciso se gli svizzeri sapessero tutto quello che accadeva agli ebrei in Germania. Di sicuro i fatti in generale erano conosciuti a tutti. Sicuramente sapevano l’esistenza dei Konzentrationslager dove le persone venivano trattate male e spesso anche uccise. Ma anche che gli ebrei erano stati eliminati dalla vita economica e pubblica della Germania. Infatti chi viaggiava in Germania doveva pur vedere che gli ebrei non si potevano sedere sulle panchine e nemmeno entrare in molti negozi. Ai cartelli delle città c’erano affissi grandi cartelli “gli ebrei non sono desiderati qui”: questo l’ho visto con i miei occhi. Nessuno può dire che non sapesse che gli ebrei dovevano portare la stella al braccio e che questi venivano considerati una razza inferiore. Chi non ha sentito un discorso di Hitler o Göbbels alla radio? Chi non conosceva le leggi di Norimberga uscite nel 1934 che distinguevano la razza ariana da quella ebrea? Que- 295 sto credo che basti. Un governo che non accoglie gli immigrati come rifugiati politici e persino qualche volta chiude le frontiere, si comporta in modo non democratico e forse persino in modo criminale. Alcuni episodi particolari sono specialmente cruenti, come una giovane coppia fuggita dal Belgio e rifugiatasi nel cimitero ebraico a Berna, fu espatriata in Francia anche se sotto protettorato di persone ricche. Lì caddero nelle mani della polizia e non si sentì più nulla di loro. Quelli che non rispettavano le leggi svizzere perdevano il loro lavoro. Il più famoso è il caso del capo della polizia di St. Gallen che dopo l’Anschluss fece entrare in Svizzera migliaia di immigrati. Gli fu fatto un processo e fu licenziato senza pensione. Analogo fu il caso del console svizzero a Budapest, che salvò migliaia di vite ebree, trasferendole in Svizzera tramite carte di protezione. Esponenti di questo antisemitismo nel Consiglio Federale furono soprattutto il ministro della polizia Eduard Von Steiger e il ministro degli esteri Marcel Pilez-Golaz. Una posizione dubbia la prese anche il ministro degli interni Pilipp Etter. In primo piano invece troviamo il capo della polizia per stranieri Heinrich Rothmund, che fu anche l’inventore della “J” sui passaporti. Anche l’ambasciatore a Berlino era antisemita: Hans Frölicher non concedeva permessi per entrare in Svizzera. Ad una sorella di mio padre insieme al marito non fu concessa l’entrata in Svizzera dopo il veto di Frölicher, anche se il sindaco della città aveva dato il via libera. Meno male che riuscirono a fuggire all’ultimo momento in Svezia. A proposito di questi fatti ogni rifugiato ha le proprie storie. Non a tutti è andata male. A proposito del mio caso e di come mi hanno trattato non ho nulla da lamentarmi. Questo anche perché sono entrato molto presto e ho sempre incontrato gente simpatica e amichevole, che nelle situazioni difficili mi ha sempre aiutato. Durante la guerra fui per diverse volte accolto nei campi di lavoro e lo trovo una cosa normalissima. I miei compagni di scuola stavano per mesi e mesi alla frontiera per proteggere la Svizzera, mentre io potei concludere il mio studio indisturbato: presi la laurea in economia nel 1949. Sempre in questo anno presi con mio fratello la cittadinanza svizzera, grazie anche all’aiuto dell’associazione degli immi- 296 grati. Per questa cosa devo ringraziare molte persone, anche perché era stata necessaria una votazione favorevole dei cittadini. Ora sono già cinquant’anni che sono cittadino svizzero. Nel 1950 sposai una ebrea berlinese adottata che durante il periodo della guerra aveva “visitato” vari campi di concentramento ed è scampata alla morte per miracolo. I suoi genitori morirono in uno di questi campi. Con lei ho vissuto per venticinque anni. Dopo la laurea ho lavorato all’università e ho scritto vari libri sul mercato svizzero. Poi ho fatto il servizio militare non come soldato semplice, ma, anche se ero ebreo, sono riuscito come molti a “conquistare” un posto più alto. Nel 1952 sono diventato il direttore della redazione di economia di uno dei giornali più importanti della Svizzera: “Basler National Zeitung”. Nel 1954 e 1958 vennero al mondo Brigitte e Billy come cittadini di St. Gallen. Tralasciando poche interruzioni in cui sono stato direttore di una banca americana, fino al 1989 ho gestito la parte economica del giornale svizzero. Come ebreo in Svizzera non ho mai trovato degli ostacoli. Tuttavia non pratico una vita tipica da ebreo e non porto un nome ebraico e non rispetto nemmeno le regole religiose. Sono però un frequentatore della Comunità ebraica a Basilea, anche se non sono religioso. 297 Werner Meyer 9 rue de Bäle F 68960 Oberdorf 27. März 1999 Lieber Jacopo und Familie, Ich habe den Fax Deiner lieben Mutter erhalten, mit dem sie mir einige “intime” Fragen stellt. Für mich handelt es sich also um ein gewisses “coming out”, dem ich mich aber gerne stelle. Denn ich finde die Idee Deines Lehrers (oder Lehrerin?), etwas über die Situation der aus Deutschland nach der Schweiz geflüchteten Juden zu erfahren, wirklich gut. Meistens hört der Geschichtsunterricht in der Schule ja bei der Einigung Italiens oder zumindest noch vor dem Ersten Weltkrieg auf; dabei ist es sehr wichtig für das eigene Bewusstsein, zu wissen, was in unserer Zeit passiert, damit wir daraus lernen und uns menschlicher verhalten. Wenngleich - wie Kosovo und andere Scheusslichkeiten zeigen - es mit der Lernfähigkeit nicht allzu weit her ist. Sei’s drum. Deshalb erzähle ich Dir mit der besten Absicht und ohne Rücksicht auf mich und andere Personen mein Leben, in aller gebotenen Kürze: Geboren wurde ich als ältestes von zwei Kindern am 22. Juni 1924 in Königsberg/Preussen. Königsberg war damals die Hauptstadt von Ostpreussen, eine deutsche Provinz. Mein Bruder Ludwig kam ebenfalls in einem Königsberger Spital am 15. April 1927 zur Welt. Mein Vater war Miteigentümer der zweitgrössten Mühle in Ostpreussen. Wir wohnten in Bartenstein, einem Städtchen 60 km südlich von Königsberg in einem eigenen Haus, ganz dicht bei der Mühle. Ich hatte bis 1933 eine unbeschwerte Jugend. Die Mühle war seit 1881 im Familienbesitz. Auch meine Mutter stammt aus einer deutsch-jüdischen Müllerfamilie, aus Nakel/ Provinz Thorn, die seit der Teilungen Polens bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zu Deutschland gehörte. Meine Vorfahren lebten zumindest seit Ende des 18. Jahrhunderts in Ostdeutschland. Die Familien waren völlig in das deutsche bürgerliche Leben integriert, waren aber Juden geblieben. Mein Grossvater in Bartenstein war Präsident der dortigen kleinen israelitischen Gemeinde. Wir gingen an den hohen Feiertagen in die Synagoge und wir Kinder mussten dann nicht zur Schule gehen. Doch wurden weder der Sabbat noch die Speisegesetze 298 beachtet. Wir lebten also nicht “koscher”. Bei Ausbruch des ersten Weltkriegs machte mein Vater eine Notmatura und meldete sich zu den Waffen. Er machte den Krieg als Artillerie-Leutnant mit und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Nach Beendigung des Krieges studierte er in Königsberg Nationalökonomie bis zum Doktorat. Meine Eltern heirateten 1923. Nach der Machtergreifung durch die Nazis verschlechterte sich die Lage für die Juden “schleichend”. Es wurden Schilder aufgestellt “Kauft nicht bei Juden”, die mein Vater aber dank seiner guten Beziehungen zum Bürgermeister sofort entfernen lassen konnte. In Bartenstein besuchte ich ab meinem 10. Altersjahr das dortige Gymnasium. Ab 1936 erhielten jüdische Kinder Gymnasiumverbot. Meine Eltern wollten meinen Bruder und mich eigentlich nach England schicken. Zufälligerweise hatten aber meine Eltern vom Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen gehört, das einen guten Ruf hatte. Deshalb wurden mein Bruder Ludwig und ich dann im September 1936 in Begleitung meiner Mutter nach St. Gallen geschickt. Damals war mein Bruder neun und ich 12 Jahre alt. Wir bewohnten anfangs dasselbe Zimmer. Ich möchte betonen, dass es sich nicht um eine Flucht, sondern um eine durchaus legale Ausreise handelte. Wir haben bis zum Sommer 1938 die meisten Ferien in Bartenstein verlebt und mit den Eltern 1937 eine grosse Autoreise nach Ungarn und Jugoslawien unternommen. Mein Vater konnte das monatliche Schulgeld von zweimal 220 Mark, was 750 Franken entsprach, bis zum Ausbruch des Krieges 1939 legal überweisen. Auch erhielten wir laufend “Fresspakete” und durften an allen Ausflügen (die oftmals recht teuer waren) teilnehmen. Das Institut kann ich nur loben. Die Schule in Kleinklassen war hervorragend. Wir hatten ganz junge Lehrer, die zu Kameraden wurden. In der schönen Jarheszeit spielte ich jede freie Minute Fussball und oft auch Tennis. Bereits im zweiten Semester wurde ich von den Mitbewohnern des Hauses, in dem wir logierten, zum Clubspräsidenten gewält. Meine Eltern hatten geplant, dass ich nach Absolvierung einer Aufnahmeprüfung in einem englishes College übersiedeln sollte. Doch 299 durchkreuzte der Ausbruch des Krieges diese Pläne. Ich hatte zwar die Prüfung bestanden, blieb aber in der Schweiz. Obwohl mein Vater nicht mehr zahlen konnte, behielt mich das Institut noch einige Monate gratis. Anfang 1940 wurde mir von der Direktion nahe gelegt, eine Lehrstelle zu suchen. Ich wollte Bauer werden. Man fand aber keine entsprechende Stelle, sodass ich in Teufen/Appenzell bei einem Gärtner als Handbub unterkam. Ich sprach damals noch kein Schweizerdeutsch. Im Dorf - so hörte ich von der freundlichen und mir zugetanen Gärtnersfrau - sei man sehr gegen den “Schwaben” eingestellt, bis herauskam, dass ich ein jüdischer “Flüchtling” sei. Die Stimmung kehrte, und ich wurde oft mit Schokolade oder kleinen Münzen beschenkt. Beim Gärtner verdiente ich nebst Kost und Logis fünf Franken in der Woche. Tatsächlich war ich von den Behörden nach meinem Abgang vom Institut zum Emigranten gestempelt worden. Von Deutschland wurde ich als Jude ausgebürgert und verlor meine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, die gegen eine jederzeit widerrufbare “Tolerenzbewilligung” eingetauscht wurde. Die Bewilligung musste alle drei Monate gegen Entgelt erneuert werden. Als Zweck wurde “Vorbereitung der Auswanderung” in den Ausweis geschrieben. Dessen roter Deckel war gelocht: Die Löcher lasen sich als “Emigrant”. Die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung im Kanton Appenzell Ausserrhoden hatte zur Voraussetzung, dass der Kanton St. Gallen eine “Rücknahme-Genehmigung” abgegeben hatte. St. Gallen und Teufen liegen bloss 5 km auseinander, aber eben in verschiedenen Kantonen. Die Arbeit in der Gärtnerei war ungewohnt und schwer und dauerte vom Sonnenaufgang bis zum-Untergang. Jeden zweiten Sonntag hatte ich frei. Dann kam mein Bruder, der nach dem Abgang aus dem Institut bei einer Schweizer Familie Unterschlupf gefunden hatte, meist auf Besuch. Mein Bruder wurde von der Schweiz Kinderhilfe betreut. Er war beim Abgang vom Institut 13 Jahre alt und besuchte in St. Gallen die öffentliche Sekundarschule. Im Februar 1941 verliess ich den Gärtner und siedelte wieder nach St. Gallen über. Durch einen Bekannten fand 300 ich eine billige Emigrantenpension, wo ich 60 Franken für Kost und Logis zu bezahlen hatte. Ein St. Galler - ebenfalls aus Deutschland emigrierter - Bekannter meines Vaters stattete mich mit der fürstlichen Summe von 5000 Franken aus, die er sich von amerikanischen Verwandten unserer Familie vergüten liess. Ich bestand die Aufnahmeprüfung in die dritte Handelsklasse an der St. Galler Kantonsschule. Die Startsumme konnte ich durch Privatstunden, die zwischen 50 Rappen und zwei Franken einbrachten, strecken. Als mir das Geld dann später ausging, wurde ich vorübergehend von der Judischen Studentenhilfe unterstützt. In der Klasse wurde ich gut aufgenommen. Lehrer und Mitschüler waren freundlich und ich fand Freunde, die mich auch nachhause einluden. Ich erinnere mich an eine einzige antisemitischen Anrempolung durch einen Mitschüler, der aber von anderen Kameraden “manu militari” zum Schweigen gebracht wurde. Während meiner Schulzeit erhielt ich ein Schreiben der Eidg. Fremdenpolizei, die mir nahelegte, die Schule zu verlassen und zur besseren Vorbereitung der Auswanderung eine Lehre zu beginnen. Diesen Brief zeigte ich dem Klassenvorstand, der in Bern intervenierte. Seither hörte ich von dort nichts mehr in dieser Angelegenheit. 1943 machte ich Matura und schrieb mich an der Hochschule St. Gallen ein. Das Schulgeld wurde mir erlassen. Immer noch wohnte ich in der günstigen Pension. Von der Pensionsmutter wurde ich verwöhnt, in ihre Tochter verliebte ich mich. Es wäre eine glückliche Zeit gewesen, wenn nicht Krieg und Vorgehen gegen die Juden in Deutschland meine Jugend verdüstert hätten. Ich blieb zwar in brieflichem Kontakt mit den Eltern und habe die teilweise langen und liebevoll belehrenden Briefe aufbewahrt. Ab 1938 wurde es in Bartennstein eng. Die Mühle wurde der Familie weggenommen; sie wurde in “arische” Hände übergeführt. Die Eltern übersiedelten nach Berlin. Sie konnte sich dort bis 1943 halten, wurden dann aber im Juni nach Theresienstadt und im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert, wo sie kurz nach Ankunft im Gas starben; 301 die Daten sind dokumentiert. Die Eltern meiner Mutter waren nach Ausbruch des Krieges von Polen nach Berlin gezügelt, wo sie sich in der Nähe meiner Eltern ein Zimmer nehmen konnten. Sie wurden 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, wo sie bald umkamen. Ich muss beifügen, dass mein Vater als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs und Offizier nie an ein solches Ende geglaubt hatte. Erst als es spät, zu spät wurde, suchten meine Eltern zusammen mit Vaters Mutter und uns beiden Buben nach Neuseeland auszuwandern. Doch erhielt die Grossmutter keine Einreisebewilligung, weshalb die Sache ins Wasser fiel. Mein Vater wollte seine Mutter nicht allein in Deutschland zurücklassen. Sie starb dann 1941 an den Folgen eines Beinbruchs in Berlin. Ich sah die Eltern zuletzt im Sommer 1939 in Lindau, wo sie sich einen Tag aufhielten, um mit einem meiner Lehrer die neuseeländische Emigration zu besprechen. Meinen deutschen (ungültigen) Pass habe ich aufbewahrt. Er lautet auf Werner Israel Meyer. Der Zusatz Israel wurde von Nazi-Amtes wegen in alle Pässe von Juden zur Kennzeichnung der Abstammung beigefügt. Ausserdem enthält der Pass ein grosses J, das bekanntlich auf Wunsch der Schweizer Behörden eingestempelt wurde. Was wusste ich über die Situation der Juden in Deutschland? Eigentlich alles Böse. Das allmähliche Zuziehen der Schlinge habe ich in Bartenstein erlebt. Ein guter Freund, der bis zuletzt zu mir hielt, wurde von Nazibuben verprügelt. Mein Vater forderte mich auf, ihn nicht mehr bei uns auf dem Grundstück zu empfangen, aber wir hielten uns nicht daran. Auf meinen Wunsch hat mein Vater ihm dann bei der arisierten Firma eine Lehrstelle verschafft. Aus dem Deutschen Turnverein wurde ich natürlich herausgeworten. Tätliche Angriffe habe ich aber nicht erlebt. In meiner Klasse herrschte bis zum letzten Tage mir gegenüber eine freundliche Stimmung. Der Klassenlehrer liess sich von mir oft die Mappe nachhause tragen, lud mich zum Tee ein und schrieb mir Karten aus den Ferien. Ich kann daraus nur schliessen, dass es vielen Bartensteinern merkwürdig vorgekommen sein muss, jüdische 302 Mitbürger, die sie achteten und die zu ihnen gehörten, plötzlich aus der Gesellschaft ausschliessen zu sollen. Allerdings begnügten sie sich mit kleinen Gesten bzw. einem “courant normal”, ohne aktiven Widerstand gegen die Rassenhetze zu leisten. Nach der Machtergreitung durch die Nazis war das auch zu gefährlich geworden. Es herrschte Terror. Zurück in die Schweiz: Da ich bereits 1936 in die Schweiz gekommen war, konnte ich hier bleiben. Doch herrschte bei den Behörden eine von einigen Vertretern des Bundesrates ausgesprochene Angst vor einer “Verjudung” der Schweiz. Um den Flüchtlingsstrom zu bremsen, wurden die jüdischen Flüchtlinge nicht als politische Flüchtlinge anerkannt. Das erlaubte den Behörden, sie an der Grenze zurückweisen zu lassen. Selbst als man wusste, dass man die Flüchtlinge damit in den Tod schickte. Diese amtliche Finesse war eine ausgesprochen grausame Massnahme, die der humanitären Schweiz keine Ehre macht. Alfred A. Häsler, ein bekannter schweizerischer Publizist schreibt in seinem Buch über die Schweiz und die Flüchtlinge 1933 bis 45 “Das Boot ist Voll”: “Die Schweiz hat während des Zweiten Weltkriegs fast dreihunderttausend Flüchtlingen für kürzere oder längere Zeit Zuflucht gewährt. Sie hat in den gleichen Jahren ungezählte Tausende an ihren Grenzen zurückgewiesen oder solche, die schon der Schweiz waren, ausgeschaft oder direkt den deutschen Häschern übergeben. Es gab in allen Schichten des Volkes Leute - auch sehr einflussreiche - , die, mehr oder weniger offen, dem Antisemitismus huldigten, und es gab die grosse Zahl der andern, die den Rassenhass bekämpften. Tatsächlich tat sich zwischen der Regierung, dem Bundesrat, und grossen Teilen des Volkes eine Kluft auf. Die Regierung war bedacht, bei Hitlerdeutschland keinen Anstoss zu erregen und Vorwand für einen militärischen Angriff zu schaffen. Die Schweiz war nach der Niederlage Frankreichs und dem Eintritt Italiens in den Krieg an der Seite Nazi-Deutschlands von der “Achse” umringt. Die Landesversorgung konnte nur durch Importe aufrecht erhalten werden. Die Regierung hat ihre Ziele erreicht. Die Schweiz kam unbehelligt bis zum Krezigsende 303 durch. Doch der Preis dafür war hoch und muss zum Teil noch heute bezahlt worden. Viele Bürger hielten diesen Preis - Einschränkung der Volksrechte durch Vollmachtenregime, Pressezensur, Verletzung humanitärer Pflichten - für zu hoch. Nach dem Krieg hat die Schweiz sich durch Abschluss des Washingtoner Abkommens, das zu einer Zahlung von einigen hundert Millionen Franken an die Siegermächte führte, scheinbar frei gekauft. Doch die Vergangenheit hat die Schweiz in den letzten Jahren erneut eingeholt. Eine bürokratischverachtungsvolle Behandlung von jüdischen und nicht-jüdischen Ausländern, die während der Nazizeit Geld auf Schweizer Bankkonten in Sicherheit brachten, führte zu Angriffen von amerikanisch-jüdischen Organisationen auf die Schweiz, die schliesslich in einem Abkommen über die Zahlung von nahezu 2 Milliarden Franken an die Kläger endeten. Es sind vor allem die Grossbanken, die zur Kasse gebeten wurden. Auch die Enthüllungen über zweifelhafte Goldgeschäfte zwischen der Schweizerischen Nationalbank und der Deutschen Reichsbank haben ungute Erinnerungen heraufbeschworen und dem internationalen Image der Schweiz geschadet. Positiv fällt ins Gewicht, dass der Bundesrat sich für die Fehler seiner Vorgänge entschuldigt und eine “Wahrheits-Kommission unter Vorsitz eines Historikers eingesetzt hat (Bergier-Kommission)” Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die Schweizer Bevölkerung die ganze Wahrheit über die Juden unter der Herrschaft der Nazis wusste. Sie hätte die Wahrheit wissen können. Das Bestehen von Konzentrationslagern, wo die Leute sehr schlecht behandelt wurden und oft zu Tode kamen, war wohl jedem bekannt. Dass die Juden aus dem deutschen Gesellschafts und Wirtschaftsleben ausgeschaltet wurden, wohl ebenfalls. Wer in Deutschland reiste, musste zur Kenntnis nehmen, dass Juden nicht auf Parkbänken sitzen und in vielen Läden nichts kaufen durften. An den Ortstafeln waren grosse Schilder angebracht mit der Aufschrift: “Juden sind hier nicht erwünscht”. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und wer wusste nicht, dass die Juden einen Stern tragen mussten. Niemand kann behaupten, er habe nicht gewusst, dass die Juden 304 von der deutschen Regierung verfemt und als Untermenschen abqualifiziert wurden. Wer hat nicht wenigstens eine der vielen Hetzreden von Hitler, Göbbels und Konsorten am Radio gehört? Und wem waren die Nürnberger Gesetze nicht bekannt, die schon 1934 geschlechtliche Beziehungen zwischen Juden und Ariern bei Todesstrafe verboten? Ich meine, das genügt. Eine Regierung, wie die schweizerische, die Flüchtlinge aus einem solchen Land nicht als politische Flüchtlinge anerkennt und den Grenzübertritt untersagt, diese Flüchtlinge sogar wieder über die Grenze zurückschafft, handelt unchristlich, um nicht zu sagen verbrecherisch. Einzelne Fälle sind besonders schockierend, so das Schicksal eines blutjungen Paares, das - aus Belgien geflüchtet - sich auf dem jüdischen Friedhof in Bern versteckte, aufgegriffen und trotz zahlreicher Proteste einflussreicher Leute nach Frankreich abgeschoben wurde. Sie fielen dort der Polizei in die Hände. Man hat nie mehr etwas von ihnen gehört. Beamte, welche die menschenfeindlichen Vorschriften nicht einhielten, wurden gemassregelt und verloren ihre Stelle. Am bekanntesten ist der Fall des St. Galler Polizeichefs Grüninger, der nach dem Anschluss Oesterreichs ans Deutsche Reich 1938 tausende von jüdischen Flüchtlingen in die Schweiz liess. Ihm wurde der Prozess gemacht; er wurde ohne Zahlung einer Pension entlassen. Aehnliches widerfuhr dem Schweizer Konsul in Budapest, der tausende von Juden vor dem sicheren Tod rettete, indem er sie mit Schweizer Schutzpapieren ausstattete. Exponenten dieser ängstlichen judenfeindlichen Haltung waren im Bundesrat vor allem der Polizeiminister Eduard von Steiger und der Aussenminister Mareel Pilez-Golaz. Eine dubiose Haltung nahm auch Innenminister Bundesrat Pilipp Etter ein. Hervorgetan in der Abwimmelung von Flüchtlingen hat sich in erster Linie der Chef der Eidg. Fremdenpolizei Heinrich Rothmund, der auch der Erfinder der berüchtigten J-Stempel in deutsch-jüdischen Pässen war. Der Posten des Botschafters in Berlin war ebenfalls von einem Antisemiten besetzt: Dr. Hans Frölicher verweigerte konsequent Einreisevisa. So scheiterte die Einreise einer Schwester meines Vaters und ihres Mannes 1944 am 305 Veto Fröhlichers, nachdem der Gemeindepräsident von Rorschach bereits seine Zustimmung gegeben hatte. Sie konnten dann in letzter Stunde nach Schweden flüchten. De facto wird jeder Flüchtling seine eigene Geschichte erzählen können. Nicht allen ist es schlecht gegangen. Was meine Behandlung betrifft, so habe ich mich über die Schweiz nicht zu beklagen. Das könnte mit meiner relativ frühen Einreise zu tun haben; eher noch damit, dass ich immer wieder nette Menschen getroffen habe, die mir in kritischen Situationen weitergeholfen haben. Während der Kriegszeit wurde ich jährlich für mehrere Monate in schweizerische Arbeitslager aufgeboten und fand das auch ganz normal. Meine schweizerischen Studienkollegen standen für Monate an der Grenze, während ich mein Studium ungehindert fortsetzen konnte. Ich schloss das Studium der Nationalökonomie an der Hochschule St. Gallen 1946 mit dem Diplom ab und beendete die Studien an der Universität mit dem Dr. rer. pol 1949. Während der Basler Studienzeit arbeitete ich als Werkstudent halbtags als Direktionssekretär. Ende 1949 wurde ich zusammen mit meinem Bruder auf Initiative und mit Hilfe der Hilfe für Emigrantenkinder in der Stadt St. Gallen eingebürgert. Nationalrat Ludwig Rittmeyer (FDP) hat sich sehr für uns eingesetzt. Seine Frau leitete die Kinderhilfe. Dazu brauchte es eine Abstimmung in der Ortsbürgergemeinde. Jetzt bin ich schon 50 Jahre Schweizer Bürger. 1950 heiratete ich eine in Basel zur Kur weilende Berlinerin, die zwischen 1941 bis zum Kriegsende in verschiedenen KZ festgehalten war und wie durch eine Wunder überlebte. Ihre Eltern kamen im Krieg in deutschen KZ um. Mit ihr lebte ich während 25 Jahren zusammen. Wie Du weisst, ist seither Gertrude Palenstijn meine Lebenspartnerin. Nach meiner Heirat arbeitete ich während zwei Jahren als Assistent an der Hochschule St. Gallen und schrieb mit Prof. Gasser ein zweibändiges Buch über den Schweizerischen Kapitalmarkt. Nach meiner Einbürgerung wurde ich dem militärischen HD zugeteilt, wo ich es bei der Abteilung Presse und Funkspruch zum USC (Untersektionschef; Offiziersrang etwa mit Hauptmannn vergleichbar) brachte. 1952 berief mich die Basler National-Zeitung - ich war damals 28 Jahre alt - zum Leiter der Wirtschaftsredaktion. Bereits während meiner St. Galler Zeit hatte ich für die NZ und das St. Galler Tagblatt nebenamtlich gearbeitet. 306 1954 und 1958 kamen Brigitte und Billy bereits als St. Galler Stadtbürger auf die Welt. Mit kurzen Unterbrüchen als Direktor einer amerikanischen Bank war ich immer journalistisch tätig, leitete vorübergehend die Schweiz. Finanz-Zeitung und wurde 1989 als Wirtschaftschef der Basler Zeitung pensioniert. Als Jude in der Schweiz habe ich weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich je Nachteile empfunden. Allerdings führe ich keinen typisch jüdischen Namen und zeichne mich auch nicht durch äussere Anzeichen der Religionszugehörigkeit aus. Ich gehöre der Israelitischen Gemeinde Basel und der Bne Brith-Loge als Mitglied an, bin aber nicht religiös. Das, lieber Jacopo, ist ein langer Bericht geworden. Aber ich wollte Dir nicht nur dürre Fakten liefern, sondern auch ein wenig “Fleisch an den Knochen”. Ich hoffe, Du kannst diese Bemerkungen für Deine Arbeit gebrauchen. Ich freue mich, ein klein wenig zu Deinem Geschichtsbild beitragen zu können. Vielleicht interessiert Dich auch der beiliegende Sonderdruck aus dem Heimatblatt “Unser Bartenstein”, wo Du u.a. weitere Angaben und Bilder über meine Familiengeschichte findest. Sicher wird Dir auch das berühmte Buch von Alfred A. Häsler gute Dienste leisten können. Bitte gib es später Deiner Mutter mit, wenn sie wieder einmal nach Basel kommt. Mit herzlichen Wünschen an Dich und die lieben Eltern. 307 “LEI, CHE COSA AVREBBE FATTO AL MIO POSTO?” Lorenzo Bertocci Il 15 settembre 1935 le leggi di Norimberga, “per la protezione del sangue e dell’onore tedeschi, proibiscono i matrimoni e ogni rapporto sessuale tra ebrei e non ebrei, in quanto generano impurità”. Un uomo austriaco si trova a guidare la Germania, in condizioni disastrose, ha bisogno di un capro espiatorio per spiegare al popolo tedesco il declino: questo è l’ebreo. “Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?” Un uomo italiano si trova in Ungheria, avrebbe potuto mettersi in salvo ma decise di rischiare la vita per aiutare, nel possibile ma anche oltre, gli ebrei ungheresi. Per parlare di quest’uomo occorre preliminarmente riassumere le vicende di tre paesi coinvolti nella sua storia: l’Ungheria, la Spagna, l’Italia1. Ungheria Caduto l’impero austro-ungarico nel 1918, l’Ungheria conquistò l’indipendenza. Si formò una repubblica di tipo sovietico 1 Questa relazione è stata svolta sulla base della testimonianza raccolta da mia madre, Francesca Bertocci, che, in qualità di interprete per M. Ryan, corrispondente del Washington Post, ha intervistato Giorgio Perlasca nel 1990. Da questa intervista, pubblicata nello stesso anno sul quotidiano statunitense con il titolo di In the midst of the Olocaust... This quiet man saved thousands. A compelling story of courage sono citate, in traduzione, le parole di Perlasca. Si sono inoltre consultati i seguenti testi: E. Deaglio, La banalità del bene. Storia di Giorgio Perlasca, Feltrinelli, Milano, 1993; G. Perlasca, L’impostore, Il Mulino, Bologna, 1997. Sulla storia di Perlasca, lo “Schindler italiano” come è stato chiamato, vi è il progetto di girare un film, analogamente a quanto già avvenuto per la vicenda di Schindler, portato sul grande schermo dalla regia di Steven Spielberg nel 1995. 308 sostenuta da Bela Kun (21-3-1919), stroncata dall’intervento militare romeno e dall’esercito controrivoluzionario dell’ammiraglio M. Horty. Ripristinata la monarchia sotto quest’ultimo (1920), si stabilì un regime reazionario legato agli interessi dei grandi proprietari terrieri che sottoscrisse un trattato di amicizia con l’Italia (1927). Nel paese si affermò il movimento filonazista e antisemita delle “Croci frecciate”di F. Szàlasi e, dopo il compromesso di Monaco (1938), l’Ungheria ottenne concessioni territoriali (Transilvania e Voivodina) che la riportarono alla situazione precedente il 1918. Dopo l’entrata in guerra accanto alle potenze dell’Asse (1914), il regime fu travolto dalla sconfitta e il paese, occupato dalle truppe sovietiche (ottobre 1944), si arrese il 20 gennaio 1945. Ridotta alle frontiere precedenti al 1938, si costituì in repubblica (1-2-1946) legata all’URSS sotto la guida di M. Rakòsi, che impose un regime di stretta osservanza stalinista. Proprio nel periodo di alleanza con l’Asse gli ebrei ungheresi andarono incontro al massacro. In Ungheria, a partire dal 1938, vigeva una rigida legislazione antisemita. Il governo ungherese tuttavia si oppose allo sterminio nazista. Il primo ministro Miklos Kallay sfruttò l’importanza economica degli ebrei nel paese, che inviava l’80% dei prodotti proprio in Germania. La questione si riaprì nell’aprile del 1943, ma Horty respinse l’ingerenza diretta della Germania in una faccenda interna. Gli ebrei ungheresi poterono essere considerati salvi fino al 15 maggio del ’44, giorno in cui Eichmann arrivò a Budapest. Da questo giorno al 9 luglio del ’44, circa 450.000 ebrei furono deportati ad Auschwitz-Birkenau. Assenti da questo massacro furono gli ebrei della capitale, il cui trasferimento era previsto per una data poco successiva. In tanto, però, i gerarchi nazisti persero fiducia nei confronti della vittoria finale del Reich, visto che gli Alleati erano sbarcati in Normandia. Himmler, capo della Gestapo, ideatore dei campi di sterminio, si mostrò disponibile a valutare la proposta della Svezia e della Svizzera di concedere passaporti agli ebrei di Budapest. R. Wallenberg, ambasciatore svedese, fu incaricato della missione. Il 309 Comitato per i profughi di Guerra propose lo scambio tra ebrei contro forniture americane. Il Reichsführer, all’insaputa di Hitler, decise di sospendere le deportazioni (ebrei visti come moneta di scambio), ma ciò non portò a niente poichè i governi alleati non portarono avanti le trattative. Fu così allora che circa 70.000 ebrei restarono nelle mani delle Croci frecciate ungheresi, che inflissero loro le peggiori sevizie. Spagna Allo scoppio della prima guerra mondiale si mantenne neutrale. Al termine del conflitto tuttavia un colpo di Stato operato dal generale M. Primo de Rivera portò a un lungo periodo di dittatura (1923-30). Ripristinata la democrazia, nel 1931 l’affermazione elettorale di repubblicani e socialisti, che indusse Alfonso XIII ad abbandonare la Spagna, portò alla formazione della seconda repubblica e alla promulgazione di una nuova costituzione. Le destre vinsero le elezioni politiche nel 1933 e fu formato un governo che incontrò una forte opposizione popolare. Nel 1936 prevalse il fronte popolare. Il generale Francisco Franco non accettò il risultato elettorale e insorse con numerosi reparti dell’esercito contro il governo repubblicano. Il caudillo godeva dell’appoggio politico degli ambienti aristocratici e clericali, oltre che dell’aiuto fornito dai paesi nazi-fascisti Germania, Italia. Dal canto loro i repubblicani poterono contare solo sui volontari delle brigate internazionali. Dopo oltre tre anni la guerra civile si risolse nel1939 con la vittoria dei franchisti. Iniziò per la Spagna un lungo periodo di dittatura, conclusosi solo nel 1975, dopo la morte di Franco. Nel frattempo il paese si mantenne neutrale allo scoppio della seconda guerra mondiale e praticò una politica tendenzialmente autarchica. Italia Il primo dopoguerra in Italia fu caratterizzato da gravi e violente tensioni sociali (occupazione delle fabbriche nel 1920) e da 310 una conseguente profonda crisi politica, di cui approfittò il partito fascista che, rafforzatosi rapidamente grazie al sostegno dei gruppi economici dominanti, raggiunse il potere, forzando la situazione col ripetuto ricorso ad atti illegali e violenti. Il suo capo, Benito Mussolini, insediatosi al governo per incarico del re dopo la marcia su Roma, eliminò in breve tempo le opposizioni e costituì uno Stato autoritario e oppressivo. Il regime fascista, consolidato il suo potere, preparò le imprese militari in Etiopia (seconda guerra italoetiopica,1935-36), Spagna (1936-39) e Albania (1939). La politica estera aggresiva ed espansionistica mise però l’Italia progressivamente in conflitto con le democrazie occidentali e la avvicinò alla Germania nazista (Asse Roma-Berlino, 1936). Nel 1939, allo scoppio della seconda guerra mondiale, l’Italia si mantenne neutrale, ma l’anno successivo, giudicando la situazione favorevole, entrò nel conflitto a fianco della Germania. La guerra, mal preparata e condotta, si risolse in una serie di sconfitte per l’Italia. Dopo lo sbarco in Sicilia, nell’estate del 1943, si determinò la caduta del governo Mussolini (25-26 luglio) e iniziò il progresso di riorganizzazione dei partiti democratici, fino ad allora operanti in clandestinità. Il nuovo governo guidato da Pietro Badoglio, stipulò segretamente un armistizio con gli alleati. L’accordo venne reso noto l ‘8 settembre e portò all’occupazione del centro-nord da parte degli ex alleati tedeschi. Privo di direttive unitarie e convincenti, l’esercito italiano si dissolse. Una parte dei combattenti entrò nella clandestinità e partecipò al nascente movimento partigiano; altri vennero deportati in Germania; altri ancora vennero riorganizzati dal governo della Repubblica sociale italiana, costituito da fascisti in territori non ancora liberati, col sostegno delle truppe di occupazione tedesca. Nel frattempo il re Vittorio Emanuele III fuggì col suo governo nell’Italia meridionale, ormai liberata. I partiti democratici, riuniti nel CLN, accantonarono la pregiudiziale repubblicana e accettarono il principe Umberto nel ruolo di luogotenente del regno, con l’impegno di porre la questione istituzionale alla fine del conflitto. Il governo dell’Italia liberata stipulò un’accordo con gli alleati che riconobbe al paese 311 la condizione di cobelligerante e partecipò con alcuni reparti regolari alla fase finale della guerra, in accordo con le forze della Resistenza che operavano nel nord occupato, sotto la guida del CLNAI. Dopo la liberazione (25 aprile 1945) si ebbero due governi di unità nazionale, presieduti rispettivamente da Parri e De Gasperi. Il 2 giugno del 1946 si tennero le elezioni per l’assemblea costituente e un referendum costituzionale, che portò alla proclamazione della Repubblica. GIORGIO PERLASCA Nel mezzo dell’Olocausto ci fu un uomo che salvò migliaia di persone: la sua è una storia di sfida e di coraggio.Quest’uomo si chiamava Giorgio Perlasca. Non ha mai chiesto nulla ed ha vissuto dimenticato da tutti per qurantacinque anni. Poi, all’improvviso è arrivata la massima onoreficenza dello Stato d’Israele: è diventato un “giusto tra gli uomini”. La sua storia inizia dall’ottobre del 1944 e finisce nel gennaio del 1945 quando l’Armata Rossa arrivò a Budapest. Era un uomo che ha concluso la sua vita terrena a Padova, in un modesto appartamento dove viveva con la moglie, fino a quando gli altri lo hanno cercato, e lui ha raccontato la sua storia: “lei, cosa avrebbe fatto al mio posto?”. Giorgio Perlasca era un cattolico italiano e scelse di mettere a repentaglio la propria vita per salvare degli ebrei ungheresi che non aveva mai conosciuto. Era cresciuto con amici ebrei, era cresciuto nel rispetto degli altri e non riusciva a capire perchè un uomo poteva essere perseguitato solo perchè ha una religione diversa. Perlasca, agendo in veste di diplomatico spagnolo, aiutò a proteggere migliaia di ebrei di Budapest, ponendoli sotto la protezione del governo spagnolo. Gli storici dicono che personalmente ne abbia salvati più di 5000 ed indirettamente altri 5000. In quanto diplomatico - autoincaricato - della Spagna in Ungheria, si incontrava con i ministri di gabinetto del paese, con 312 i generali dell’esercito d’occupazione tedesco e con i nazisti e nel frattempo percorreva tutte le strade della città per salvare vite umane; ma Perlasca non era diplomatico, non era spagnolo: era il rappresentante a Budapest di una ditta italiana di carni che per puro caso si è trovato ad essere testimone oculare di una delle più grandi atrocità della storia del genere umano: “c’è un detto italiano che dice: l’occasione fa l’uomo ladro; io avevo l’occasione e l’ho afferrata”. Quando Mussolini cadde e l’Italia andò contro i suoi alleati tedeschi, gli italiani che si trovavano al’estero furono internati. Ma Perlasca era stato un soldato italiano che aveva combattuto per Franco nella guerra spagnola e aveva tenuto con sè un documento che gli era stato rilasciato dai franchisti quando lasciò la Spagna. Questo documento gli dava diritto di cercare protezione in qualsiasi ambasciata spagnola nel mondo e quindi anche in Ungheria. “Andai alla legazione spagnola e dissi al ministro, Angel Sanz Briz, che mi avrebbe dovuto dare un passaporto”, così ricorda Perlasca, “e lui mi dette un passaporto regolamentare diplomatico quello stesso giorno”. Mentre si espletavano le procedure burocratiche, Perlasca notò che centinaia di persone stavano formando lunghissime code fuori della legazione spagnola; erano ebrei che chiedevano protezione. Sanz Briz, con un atto umanitario che violava ogni principio di diplomazia, aveva cominciato ad emettere documenti falsi, chiamate “lettere di protezione”. Questi documenti dichiaravano che il latore aveva diritto alla cittadinanza spagnola ed era sotto la protezione del governo spagnolo. Sanz Briz sperava che il governo nazista in Ungheria, che dava valore alle sue relazioni con Madrid, avrebbe riconosciuto i documenti e avrebbe lasciato stare i latori. Così il ministro spagnolo dava una lettera di protezione a chiunque potesse entrare nel suo ufficio a richiederne una; Perlasca ebbe la sua lettera ed incominciò ad aiutare chi era meno fortunato di lui. Verso la fine di novembre, il disastro scoppiò. Sanz Briz, l’ultimo rapresentante legale spagnolo ancora a Budapest, dovette 313 lasciare il paese. “Non sapevo cosa fare, così decisi di controllare tutte le case che avevano”; si creò un incarico diplomatico e difese le sue postazioni. Ebbe scontri verbali diretti con gli ufficiali del governo ungherese che ora non riconoscevano più la legittimità della legazione spagnola, dato che Sanz Briz aveva lasciato il paese. “Io dissi che la legazione è ancora in funzione. Sanz Briz è andato in Svizzera per una conferenza diplomatica, la bandiera sventola. Io sono in carica. Io sono il rappresentante legale della Spagna”. Alcuni ebrei erano stati fatti evacuare da una casa protetta, quella di Via Pannonia 44, ed erano là che cercavano di entrare. Perlasca li reclamò e li ottenne. Perlasca era il nuovo incaricato della Spagna a Budapest, nominato e confermato da lui stesso, ed era riconosciuto come tale dal governo ungherese. Una delle ragioni per cui il suo piano funzionò era dovuto all’uomo. Era un uomo giovane, 34 anni, alto, determinato energico e potente. Edith Weiss, che ancora vive a Budapest, era una giovane fanciulla della casa di Via Pannonia 44, non si dimenticherà mai di lui. Le ha salvato la vita. Edith Weiss racconta la sua vicenda: spesso in quei giorni i nazisti ungheresi venivano e portavano, marciando, gli ebrei in riva al Danubio. Li uccidevano e buttavano i loro corpi nel fiume. Ma un giorno venne Perlasca e con un fare deciso e fermo disse loro d’andarsene, aveva autorità, era forte, non c’era modo di contraddirlo, i nazisti se ne andarono. Eva Lang, una poetessa ungherese che gli deve la vita, lo ricorda come il più grande eroe dei nostri tempi. Ricorda il 14 gennaio 1945 quando Perlasca si presentò per l’ultima volta alla casa dove lei si era rifugiata per dire che i Russi erano arrivati in città e che non dovevano aver paura, che non avevano più bisogno di lui. E se ne andò. Gli episodi raccontati da Perlasca sono tanti, uno dei tanti riguarda due fratelli. Gli ebrei venivano convogliati alla stazione, venivano caricati sui vagoni merci, venivano deportati in Germania. I vagoni erano quelli che Perlasca usava per il trasporto degli 314 animali da macelllo che lui commerciava; ma i tedeschi e le SS riuscivano a farci salire più persone di quanti animali Perlasca riusciva. “Ad un certo punto, in questa lunga fila di persone, vidi due bambini di circa 12 anni. Erano identici, come gemelli. Mi ci volle una frazione di secondo perchè mi accorgessi che mi piacevano. Pensai che non potevo lasciarli andare, così dissi loro: vedete quella macchina nera laggiù? andate alla macchina, aprite lo sportello ed entrate. L’autista sa cosa fare”. Una volta dentro, arrivò un ufficiale delle SS che voleva riprendere i ragazzi, Perlasca sostenne l’extra-territorialità della macchina, l’immunità dell’auto, portò come prova la targa diplomatica. Perlasca e l’ufficiale furono raggiunti da Raul Wallenberg, poi arrivarono il diplomatico svizzero Karl Lutz, Monsignor Angelo Rotta, nunzio del papa. Per ultimo arrivò un colonello delle SS, Adolf Eichmann, e Perlasca sostenne ancora la sua tesi. Eichmann gli cedette i ragazzi. Un’altra volta vide alcuni nazisti rincorrere un bambino di circa 10 anni, raggiungerlo, prendere il fucile e sparargli. L’unica sua colpa era d’essere un bimbo ebreo. Era il 24 dicembre 1944 quando Perlasca udì colpi di pistola e urla provenire dal ghetto ebreo; la mattina seguente riuscì a sapere cosa era successo grazie ad un superstite, una ragazza coperta solo da un cappotto militare. Lei gli raccontò che le vittime erano state legate insieme, due a due, con fil di ferro. Furono costrette a camminare nude attraverso la neve dal ghetto al Danubio, lì venivano fatte inginocchiare, dove si sparava ad una delle vittime, questa cadeva e si portava dietro anche l’altra. Lei era riuscita a salvarsi perchè il fil di ferro si era allentato, così quando lo sparo colpì, entrambe caddero nell’acqua e lei riuscì a fuggire. All’inizio del novembre del 1944 l’intera legazione spagnola tornò in patria perchè il governo di Madrid non aveva riconosciuto il regime nazista ungherese. Quindi Perlasca si trovò solo, si installò nella legazione. Incominciò dal parco merci della ferrovia: un gruppo di nazisti ungheresi aveva rastrellato ebrei che avevano lettere di protezione. Questa volta il governo ungherese 315 riconobbe il proprio errore, ma Perlasca dovette personalmente ritrovare gli ebrei e salvarli dalle SS. Poi dovette cercare dei luoghi dove mettere i portatori delle lettere, per la fine di quell’anno aveva già riempito undici case. Ogni casa aveva una bandiera spagnola e Perlasca notificava l’esistenza del governo nazista che dichiarava che gli occupanti erano sotto la protezione spagnola. Per la fine di quell’anno aveva già stivato 5.200 persone in quelle case. Dormivano ovunque, anche per le scale, scioglievano la neve per avere acqua. Perlasca usò i suoi magri risparmi per comprare loro cibi (quel poco che riusciva a reperire). C’era poco di tutto, ma “loro” erano vivi. Lavorando con Otto Komoly, un capo della resistenza ebrea clandestina, e con altri capi sempre della resistenza, il nostro riuscì inoltre a fornire lasciapassare per i bambini ebrei, i cui genitori erano già stati presi. Dopo la guerra, il nuovo governo comunista ungherese non aveva voglia di parlare dell’Olocausto. Anche in Italia il discorso veniva evitato. Perlasca fu lasciato al suo destino, per lungo non riconosciuto come eroe. È giusto che il mondo sappia di Giorgio Perlasca, c’è bisogno di conoscere la sua storia, la storia di un uomo che ha salvato altri uomini. È diventato un eroe perché riteneva la persecuzione nazista inconcepibile. Perlasca fu catturato dai sovietici, messo a pulire le strade dalle macerie e dai cadaveri, poi fu deportato ad Instanbul su un carro bestiame. Riuscì a rientrare in Italia, il suo vecchio datore di lavoro si rifiutò di pagarlo, anzi dovette ripagargli una macchina che era stata distrutta quando la legazione spagnola fu bombardata. Fu duro ricominciare in Italia, ma poi quelli da lui salvati lo hanno rintracciato, grazie a loro e per via di loro è stato nominato cittadino onorario d’Israele, gli è stata conferita anche la più alta onoreficenza al valore ungherese. Nel settembre 1990 ha ricevuto gli onori del Comitato in memoria dell’Olocausto negli Stati Uniti. 316 TRIESTE E LA RISIERA: FINIS EUROPAE? Pietro Poli TRIESTE. CITTA’ DI FRONTIERA Nel dibattito storiografico sul ruolo della città di Trieste sono presenti due correnti: la prima vede la città come l’ultimo baluardo del mondo civile e cristiano dinanzi a un immenso spazio euroasiatico, mentre la seconda la considera un punto d’incontro e insieme di scontro tra popoli diversi1. Per quanto diametralmente opposte, queste due interpretazioni storiografiche concordano almeno su un punto: sulla considerazione che Trieste è da sempre una città di frontiera. Questo implica un’altra caratteristica di Trieste: gli slavi. Per la popolazione italiana questa parola rappresenta due popoli, gli Sloveni e i Croati. I primi presenti nel contado ed entro le mura del borgo fin dall’Alto Medioevo; i secondi, presenti nella vicina penisola istriana e continuamente attivi nel porto triestino per ragioni di traffico e di commercio. Anche se, ai fini della ricerca, può sembrare incongruente dilungarsi sul problema della minoranza slava a Trieste, come vedremo, così non è; infatti bisogna tenere presente che la Risiera triestina fu utilizzata come campo di raccolta e smistamento per la popolazione ebraica e fu vero e proprio campo di sterminio per oppositori politici e partigiani. Questi ultimi comprendevano nelle loro file soprattutto slavi, tanto è vero che questa parola era sinonimo di comunismo. Nel corso dei secoli la popolazione slava è vissuta in soggezione rispetto a quella italiana almeno fino all’Ottocento, secolo in cui si è visto in Europa l’affacciarsi, dal punto di vista culturale 1 Vorrei qui esprimere il mio più sentito ringraziamento ai signori De Polo per la loro squisita ospitalità e per la disponibilità a raccontarmi la loro esperienza, che purtroppo, per motivi personali, non mi è stato possibile riportare. 317 e politico, di tante nazioni. In questo periodo anche gli sloveni, attraverso i loro intellettuali, acquistarono piena e matura coscienza di sé, riuscendo così, in un secolo, a debellare quasi completamente l’analfabetismo e a creare una robusta classe borghese, una valida classe di intellettuali, un ceto contadino saldamente organizzato e, soprattutto, un proletariato battagliero e politicamente attivo. Certamente gli sloveni triestini non rimangono estranei a questa metamorfosi; infatti ecco nascere in città il Circolo slavo, ecco aprire il primo giornale sloveno “Il patriota slavo” ed ecco delinearsi il primo programma politico teso alla conquista dell’uguaglianza con i cittadini di lingua italiana. Il regnante di allora, l’Austria, però, non concesse tutto questo agli sloveni poichè voleva che la città rimanesse nelle mani della borghesia italiana, dato che la borghesia slovena era considerata anti-austriaca. Dopo la fine della guerra e la firma del trattato di Rapallo (1920) la situazione di convivenza tra italiani e slavi divenne quasi impossibile, anche per la nascita dello stato jugoslavo che non aveva nessuna intenzione di sottomettersi all’egemonia italiana. Ancor prima del Fascismo, gli italiani usavano le armi contro questa minoranza. Il fascio di Trieste, uno dei primi a nascere in Italia, fu posto ben presto sotto la guida di Francesco Giunta, inviato in città per coordinare la violenza squadrista. Tale violenza raggiunse il suo culmine nel luglio del 1920 quando venne bruciata, nel cuore della città stessa, la Casa di Cultura slovena. L’incendio fu un colpo durissimo per gli sloveni di Trieste. Comunque fu solo l’inizio: man mano che il fascismo trionfava, le violenze e i soprusi aumentavano. Parlare in sloveno in pubblico fu proibito: le scuole, le organizzazioni ed i giornali furono chiusi; i nomi delle località e delle persone vennero italianizzati. Ciò che rendeva gli sloveni più pericolosi era il fatto che fossero considerati automaticamente comunisti, perché questo era stato l’unico partito ad accoglierli alla pari nelle sue fila. Durante la guerra gli attriti e le persecuzioni si accentuarono fino al 1° maggio del 1945, quando le truppe di Tito entrarono 318 a Trieste con l’intenzione di annetterla alla Federazione Jugoslava. Ciò non fu ben visto dalle truppe alleate; così, il 12 giugno del 1945, gli Jugoslavi si ritirarono su ordine di Stalin che, al tavolo delle trattative di pace, non voleva scontrarsi con gli occidentali per Trieste. Il territorio fu suddiviso nelle zone A e B, amministrate da alleati e jugoslavi, in attesa del trattato di pace con l’Italia. I quaranta giorni di governo comunista portarono all’arresto, giustificato e non, di 4000 persone di cui 1000 non tornarono più a casa. Nel 1954, con la firma del Memorandum che consegnava Trieste all’Italia, l’influenza slovena si fece sentire maggiormente anche perché, con la crisi del settore agricolo, molti si occuparono nel terziario, dedicandosi soprattutto al commercio con la vicina Jugoslavia. Questo permise un più ampio sviluppo culturale ed economico e la ricomparsa di un nuovo ceto medio sloveno che era stato annientato dalla guerra. In questo clima anche gli intellettuali italiani e slavi poterono riavvicinarsi. Questo miglioramento sociale fu anche garantito dall’accordo di Osimo del 1975 fra Italia e Jugoslavia che risolse le controversie fra i due paesi. Più o meno stessa sorte toccò agli italiani rimasti nei territori annessi alla Jugoslavia. In Istria, dove avevano sempre detenuto il potere, dopo il 1954 gli italiani si trovarono a formare una minoranza etnica ridimensionata notevolmente, nell’influenza politica e culturale. A occuparsi dei problemi e a preoccuparsi della salvaguardia dei diritti del GNI (Gruppo nazionale italiano) fu istituito l’UIIF ( Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume), su iniziativa del partito comunista croato che intendeva favorire il processo di assimilazione. A differenza degli slavi di Trieste lo stato democratico italiano garantiva i diritti individuali di ogni cittadino, il regime di Tito garantiva agli italiani la tutela del gruppo etnico, ma non dei suoi componenti. Così l’inasprimento delle tensioni fra Italia e Jugoslavia a cavallo fra il 1950 e il 1960 favorì alcune ritorsioni nei confronti del GNI che portarono alla chiusura di scuole e circoli italiani. 319 Con la riapertura della Jugoslavia all’Occidente, anche l’UIIF riuscì a recuperare la sua importanza grazie anche all’Università popolare di Trieste che, con l’aiuto del governo italiano provò a rilanciare culturalmente il GNI. Alla fine degli anni sessanta si ebbe un nuovo periodo di crisi con la nascita del movimento nazionalista croato che cominciò ad attaccare la minoranza italiana per avere il controllo dell’autonomia della regione. Con il ritorno del potere nelle mani di Belgrado, il GNI si trovò indebolito e le sue strutture, anche se ancora esistenti, passarono sotto il completo controllo del partito comunista. Dopo la guerra che ha portato la repubblica slovena e croata all’indipendenza da Belgrado nel 1992 è stato firmato a Roma un patto fra Italia e Croazia per garantire il rispetto dei diritti della comunità italiana. Anche se questo ha sicuramente portato un miglioramento nella vita dei nostri connazionali in Istria molti problemi del GNI sono tuttora aperti e di difficile soluzione. PERSECUZIONI EBRAICHE NEL LITORALE ADRIATICO Con l’ordinanza del 10 settembre 1943 sulla sistemazione dei territori italiani occupati, Hitler stabiliva la creazione della Operazions Zone Adriatisches Kustenland - OZAK (Zona di operazioni del Litorale Adriatico) comprendente le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e quella di Lubiana, costituita dal governo fascista dopo l’invasione della Jugoslavia dell’aprile 1941. Con le disposizioni di questa ordinanza il Friuli e la Venezia Giulia venivano separati dal resto dell’Italia; si trattava di una soluzione politica destinata a preparare l’annessione della regione al Reich. In queste province il potere nazista venne così ad insediarsi sulle macerie dello Stato fascista italiano, uno stato dissoltosi l’8 320 settembre ’43, ma che da tempo oramai era in via di disgregazione ai confini nord-orientali a seguito della diffusione in Slovenia e Croazia di un movimento partigiano a larga base popolare sotto la direzione di Tito e del Partito Comunista Jugoslavo. Subito dopo essersi insediati, i vertici delle SS decisero di creare a Trieste un campo di concentramento “per i nemici politici del Reich e gli ebrei”, dotato di un forno crematorio. La scelta della località ricadde sulla Risiera di S. Sabba. Questa era un vecchio stabilimento industriale alla periferia della città, vicino al mare, fra via Rio Primario e il Ratto della Pileria, che gli austriaci avevano costruito, attorno al 1913, per raffinare, ogni anno, un milione di quintali di risone proveniente dall’India e dalla Cina e destinato ai mercati dell’impero austro-ungarico. I suoi stanzoni, dislocati sui quattro piani dell’edificio, erano in grado di contenere fino a 20.000 persone e il suo forno riusciva ad incenerire dai 50 ai 70 cadaveri al giorno. La popolazione ebraica di Trieste era seconda in Italia solo a Roma e al momento dell’occupazione tedesca, comprendeva circa 2.300 unità. Nella sola Trieste le cifre parlano di 837 ebrei rastrellati dai tedeschi; di essi solo 77 si salvarono. Sarebbe errato pensare però che questi sfortunati abbiano trovato la morte nella Risiera; infatti dall’istruttoria del 1975 risulta che gli ebrei eliminati a S. Sabba furono solo quaranta perchè i tedeschi preferivano usare il campo per reprimere la lotta partigiana, presente nel litorale, deportando gli ebrei nei campi in Germania e Polonia. Da una statistica risulta che la maggior parte dei convogli fosse diretta a Dachau (32.5%), seguito da Auschwitz (27.5%), Buchenwald (11.5%) e Mauthausen (10.5%). I convogli che partirono dall’Italia furono 43, di cui 23 dal Litorale Adriatico. Il primo convoglio partì da Trieste il 9 ottobre del 1943, giorno di Yom Kippur, con non più di cento ebrei. L’ultimo partì, sempre da Trieste, il 25 febbraio del 1945 diretto a Bergen-Belsen. Il 19 gennaio del 1943 le SS compirono una vera e propria retata arrestando, fra gli altri, anche il segretario della Comunità, 321 dottor Carlo Morpurgo, che venne rinchiuso nelle prigioni del Coroneo per essere trasferito ad Auschwitz, con gran parte del personale della Comunità, il 2 settembre dello stesso anno. Il 20 gennaio sempre del ‘43 le SS irruppero nella Pia Casa Gentiluomo di via Cologna n° 29, un ricovero per vecchi ebrei inabili al lavoro. I tedeschi sapevano quanti erano gli ospiti (80 più o meno), di che nazionalità e a che ora cenavano. Queste notizie vennero fornite loro dalla custode del pensionato, Marianna Waltzl, un’austriaca non ebrea. Le SS arrivarono nella Pia Casa all’ora di cena con tre camion e nel giro di pochi minuti fecero sparire 54 vecchi di cui non si seppe più nulla. Alla fine di gennaio Trieste si poté considerare Juden-rein, ”purificata dagli ebrei”. A Fiume, nell’ottobre del ‘43, i tedeschi compirono una prima razzia di ebrei. La comunità israelitica, che contava circa 1500 persone, fu colta di sorpresa e l’azione provocò un centinaio di vittime. Si trattava per lo più di ebrei croati, russi, bulgari e polacchi che avevano cercato salvezza dalla persecuzione nei loro paesi con la fuga a Fiume. A questa retata non ne seguirono altre, se non qualche arresto dovuto ai posti di blocco nei dintorni della città o a delazioni. Se gli ebrei di Fiume scamparono in gran parte alla morte lo debbono all’opera generosa ed eroica di un funzionario dell’Ufficio stranieri della Questura, il commissario capo dottor Giovanni Palatucci, 40 anni, nativo di Monte Marano (Avellino) che, d’accordo con il CNL, fece immediatamente distruggere i registri degli ebrei custoditi in questura e ordinò all’anagrafe di non rilasciare nessun documento riguardante i cittadini di razza ebraica senza previa informazione all’Ufficio stranieri: mediante questa disposizione, Palatucci ottenne il controllo sui preparativi delle SS contro gli ebrei. Purtroppo, nel settembre del 1944 venne arrestato come “probabile confidente” degli ebrei. Fu internato a Dachau dove morì il 10 febbraio del 1945. Alla sua memoria, il 23 aprile 1961, la città israeliana di Ramath Gan gli ha dedicato una via. A novembre del ‘43 la deportazione si abbattè anche su Gorizia dove, la piccola comunità (239 ebrei), non subiva perse322 cuzioni fisiche da quando, nel 1697, la popolazione, esasperata da una tremenda pestilenza, aveva preteso che gli ebrei della città, i quali vivevano in una zona molto salubre, fossero trasferiti vicino al lazzaretto. Nella seconda metà di novembre dello stesso anno, i tedeschi entrarono anche ad Udine dove, nell’Ufficio anagrafe, s’impadronirono dell’elenco degli ebrei. Nella sera del 23 iniziarono le razzie catturando 45 ebrei che furono trasferiti da Trieste ad Auschwitz. Pochi mesi dopo la deportazione di Udine, questa tragica sorte toccò anche ad una nota figura della storia politica ed economica friulana, il barone e senatore Elio Morpurgo, già sindaco di Udine, deputato di Cividale, sottosegretario dal 1906 al 1919 nei gabinetti Sonnino, Boselli ed Orlando e che, nel ‘43-‘44 si trovava, ormai ottantenne e malato, ricoverato all’ospedale di Udine: preso dalle SS, fu rinchiuso a S. Sabba e poi inviato ad Auschwitz con un trasporto, sul quale morì durante il viaggio. Il suo cadavere venne gettato sui binari. METODI DI ELIMINAZIONE E CONDIZIONI DI VITA NELLA RISIERA Il lager era posto in una zona semiperiferica, in un rione della città abitato da italiani e sloveni accanto a fabbriche, cantieri, impianti sportivi e al sobborgo sloveno di Servola. Il traffico dei prigionieri che provenivano da tutte le carceri italiane era costante ma si cercava di far arrivare gli automezzi di notte per evitare allarmi e curiosità. La Risiera aveva aspetti, nelle strutture, negli impianti, nel trattamento dei prigionieri molto simili a quelli dei lager in Germania e in Polonia. Essa non era un lager di esclusivo e rapido sterminio; perciò assomigliava più a Dachau, Mauthausen e Auschwitz, che a Treblinka o Saibor, anche se alcune “abitudini” 323 erano affini a quelle di questi ultimi: i carnefici ucraini, il sistema di gassazione con gas di scarico dei motori, ecc… Date le modeste proporzioni della Risiera, l’umanità che vi viveva rinchiusa si trovava accanto agli impianti di sofferenza e di morte. Tutto, le bastonate, le torture, gli interrogatori, le esecuzioni si svolgeva nello stretto raggio di pochi metri quadrati del cortile interno del lager, dove nel garage era stato costruito il locale per le eliminazioni e il forno crematorio con il condotto del fumo collegato alla vecchia ciminiera. Intorno vi erano i cameroni e le 17 microcelle destinate ai politici e i partigiani condannati a morte. Queste misuravano 1,20 m x 2,20 m e erano alte meno di 2 m; sul soffitto avevano una apertura di 20x20 cm. La luce rimaneva accesa 24 ore su 24. I sepolti nelle microcelle vivevano in condizioni allucinanti; l’avvocato Bruno Piazza, rinchiuso per una notte, racconta che l’ambiente era simile ad una bara. Il carabiniere Giuseppe Gionechetti, passato ai partigiani nel giugno del 1944 e catturato con altri due commilitoni, racconta che fu condotto in Risiera e qui tutti e tre furono frustati e rinchiusi insieme in una delle 17 celle. La mancanza d’aria, di cibo, di movimento, la luce intensa sopra di loro, rendevano la sofferenza sempre più acuta. Restarono in questo lugubre luogo per due giorni per essere poi trasferiti in una stanza più ampia vicina dove restavano fino alla deportazione in Germania quaranta giorni dopo.2 Anche Maria Del Monte in Grado raccontò di essere stata rinchiusa nelle suddette celle con altre cinque persone e di essere stata frustata tutti i giorni per farle confessare il nascondiglio del suo convivente ebreo3. Le celle non bastavano per il grande numero dei condannati a morte, per cui vi era un’altra stanza, chiamata “cella della morte” per antonomasia. Qui venivano ammassate, appena giunte di sera o di notte, vittime che dovevano essere subito eliminate. Ai lati del cortile vi erano due grandi edifici di tre, quattro o sei piani, destinati in parte ai prigionieri che dovevano essere trasferiti nei lager in Germania e utilizzati in parte come depositi dei beni 324 razziati alle vittime, in parte come caserma, armeria, laboratorio artigiano, ecc (il lager era autosufficiente con i suoi cuochi, facchini, calzolai, sarti, ecc. tratti dalla massa dei prigionieri). Nel primo cortile vi era a sinistra il corpo di guardia con l’abitazione del comandante (Hering e poi Oberhauser) e a destra gli uffici e gli alloggi per i sottoufficiali SS tedeschi e ucraini e per le donne ucraine. I prigionieri sentivano tutto: i colpi di frusta, le urla dei torturati e delle vittime condotte al forno, i colpi di arma da fuoco, i latrati dei cani, i motori accesi, assieme agli altoparlanti della radio accesi per coprire i lamenti delle vittime. Questa intimità, questo contatto fisico e visivo con gli orrori quotidiani del lager è tipico della Risiera e la distinguono dagli altri lager, anche se le strutture, benché di dimensioni più piccole erano ugualmente efficienti e mortali. Le esecuzioni avvenivano raramente per fucilazione, più spesso i metodi usati per le eliminazioni di massa erano il gas dei motori e il colpo di mazza alla nuca. Il medico dentista Stanislao Aczel, di origine ungherese, assoldato per curare le SS, dichiarò di aver sentito un sottoufficiale SS dire a proposito di alcuni partigiani appena arrivati nel lager “che erano pronti per il martello di legno”4. In Risiera le uccisioni di massa venivano praticate molto spesso, comunque più di una volta alla settimana; inoltre ogni notte si udivano spari, urla, latrati dei cani, che testimoniavano le uccisioni singole. Quelle di massa avvenivano il martedì e il venerdì, ma talvolta, se necessario, anche più spesso. Ad ogni esecuzione la ciminiera eruttava fumo di un odore nauseabondo. Delle esecuzioni singole Mayda Schmidt Rupena ricordò l’uccisione di un ragazzo di 14 anni accusato di essere una staffetta partigiana e di una ragazza di 15 anni che aveva avuto la sola colpa di essere tornata nel suo paese appena raso al suolo dai tedeschi5. Dall’insieme delle deposizioni risulta che solo due detenuti furono portati nel locale delle esecuzioni e ne uscirono vivi: Albinia Skabar e Franc Sircelj. La prima racconta che durante gli interro- 325 gatori veniva denudata, appesa ad una trave e bastonata fino a svenire e che un giorno fu portata nel locale per le esecuzioni dove le fecero vedere il forno per intimorirla. Il secondo invece racconta che venne portato con altri quattro compagni nella stanza delle esecuzioni dove vennero fatti spogliare e lasciare i vestiti su un mucchio. I suoi compagni vennero spinti uno ad uno in una porticina di fianco al forno crematorio. Per un improvviso allarme aereo venne respinto nella sua cella e riuscì a salvarsi. Da tutti gli episodi narrati dai superstiti risulta chiaro che non ci si trova di fronte ad una accolita di boia che agiva fuori dalla legge ma che si trattava di una organizzazione che operava all’interno della “guerra totale“ e della “soluzione finale” promossa da Hitler. Perciò ogni gesto, anche disumano, non era per i nazisti né immorale, né illegale. I nemici del Reich andavano trattati in questo modo, anche se questo significava torturare e bruciare vecchi, malati, bambini o donne incinte e giustificava anche il furto dei beni delle vittime o l’estorsione di somme ingenti ai prigionieri più ricchi. Anche sotto questo profilo, la Risiera rappresenta un microcosmo esemplare dell’universo hitleriano. Il popolo della Risiera era in continuo movimento. Nuovi arrivi, nuove partenze, nuove morti, un percorso lastricato di angosce, crudeltà, vessazioni. Ma chi è questo popolo della Risiera? Vecchi, bambini, uomini e donne giovani e anziani, italiani, sloveni, croati, cattolici ed ebrei, proletari, borghesi, civili e militari. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile del ’45, le SS fecero saltare l’autorimessa con il forno crematorio e fuggirono. Prima però liberarono l’eterogeneo gruppo dei superstiti degli artigiani della Risiera, ebrei e non ebrei, italiani e jugoslavi, addetti da molti mesi ai vari servizi per le SS. Anche se il garage era stato fatto saltare, i segni dei misfatti non furono cancellati del tutto. Fra le macerie furono ritrovate ceneri, ossa umane, indumenti che consentirono qualche riconoscimento. 326 QUANTE VITTIME INCENERITE NELLA RISIERA? Il forno crematorio della Risiera iniziò a funzionare all’inizio del ’43 e dapprima inceneriva da 30 a 40 vittime per volta; successivamente si arrivò a 50 persone per giorno. Sono state elaborate diverse stime, le più attendibili delle quali parlano di cifre totali che variano tra i 4000 e i 5000 morti. I “PROTAGONISTI” IL GAULEINER RAINER Il 12 settembre Hitler nominò a capo dell’amministrazione civile dell’OZAK e Oberstekommissar (Supremo Commissario) il potente Gauleiter della Carinzia, Friedrich Rainer, che tra il 1941 e il 1943 era stato anche governatore dei territori sloveni occupati dalla Germania. Era uno dei più influenti e fanatici esponenti di quell’aggressivo nazismo austriaco che operava una politica “da grande Reich Germanico” ed era anche membro delle SS austriache. Già il giorno successivo a quello dell’armistizio, Rainer confermò le sue ambizioni di conquista, il suo acceso rancore antitaliano e i progetti che aveva in mente da tempo. In una sua lettera del 9 settembre ’43 al ministro degli esteri Ribbentrop, dopo essersi espresso a favore del ripristino della frontiera austro-italiana del 1914, egli proponeva la formazione di un’amministrazione civile e non militare sulle provincie di Udine, Gorizia, Trieste (con l’Istria) assieme alla “provincia” di Lubiana, da affidarsi a lui con “adeguati pieni poteri”. Sosteneva che la presenza etnica e linguistica italiana nella regione giulia era nettamente minoritaria, che la gran parte del popolazione del Friuli, di Trieste e dell’Istria rifiutava la sovranità italiana e che, nonostante l’articolazione etnica della regione, essa era un insieme omogeneo da amministrarsi unitariamente. 327 Il vertice del potere politico nell’Ozak, cioè Rainer, era la massima autorità alla quale era politicamente soggetta la popolazione. Per compiere la sua opera egli mise in atto tutta un’opera di rivalutazione del passato “austro-ungarico” con slogan e iniziative tendenti ad esaltare la capacità del “buon governo” austriaco nell’amministrazione di questa regione rispetto alle malefatte dei governi italiani, rievocando il ruolo “culturale“ ed economico che Trieste aveva avuto ai tempi dell’Austria e che avrebbe, a maggior ragione, riacquisito e rafforzato nel più vasto spazio “geopolitico” del Grande Reich. L’occupante prospettò alle popolazioni italiane e slave una sorta di fosca “Mitteleuropa” nazista, depurata da ogni forma di dissenso, liberata dalle scorie dell’ebraismo e del “banditismo”. A tal fine furono messi in atto i metodi hitleriani della “guerra totale”. Furono adottati sistemi di persecuzione, rappresaglia e sterminio analoghi a quelli impiegati nei territori dell’Est europeo. Il capo delle SS del Litorale: Globocnik Il 13 settembre 1943 il Reichsführer e ministro degli Interni Himmler nominava capo supremo delle SS e della Polizia per il Litorale il suo “protetto” Gruppenführer SS Odilo Lotario Globocnik (nato a Trieste nel 1904 da genitori di origine slovena), vecchio amico di Rainer, con il quale aveva militato, ordendo intrighi e complotti, nel partito nazista austriaco e nelle sue formazioni SS prima e durante l’Anschluss, fino a diventare Gauleiter di Vienna. Allontanato dalla carica perché coinvolto in un affare di speculazioni illegali di valute estere, aveva preso parte alla campagna di Polonia nel 1939 con un reparto SS. In suo favore era intervenuto Rainer, perorando presso il generale delle SS Karl Wolff la concessione della croce di ferro di seconda classe “al nostro comune amico Globus”. Riabilitato in pieno da Himmler, che ne stimava l’energia e le capacità organizzative, e nominato SS Brigadeführer, quindi 328 capo delle SS e Polizia del distretto di Lublino, Globocnik aveva progettato e realizzato, con l’approvazione di Himmler, la liquidazione della comunità ebraica in Polonia (circa 2 milioni e mezzo di ebrei e oppositori polacchi uccisi), ricavando ingentissimi profitti, confiscando beni degli ebrei e sfruttando la manodopera ebraica prima di eliminarla. Per questo venne aperta un’inchiesta e, a seguito di “un’insoddisfacente revisione dei conti”6, Himmler sollevò Globocnik dal suo incarico spedendolo a Trieste. La contemporanea presenza ai vertici politici e polizieschi dell’OZAK dei due amici Rainer e Globocnik, il loro diretto legame con Himmler e Hitler a Berlino per eseguire le “istruzioni fondamentali per lo svolgimento della loro attività”7 nella zona, impressero al potere dell’occupante tedesco della regione una discrezionalità ed autonomia tali da sottrarlo anche ad interventi e controlli delle principali autorità politiche e di polizia naziste dell’Italia; essi furono quindi gli artefici della strategia politica tedesca nell’OZAK. Il 31 maggio 1945 una pattuglia britannica arrestò Rainer e Globocnik in una malga della Alpi carinziane dove si erano nascosti. L’ Einsatzkommando Reinhart e altre SS operanti a Trieste La storia della Risiera ebbe inizio con l’arrivo a Trieste di Globocnik e dell’Einsatzkommando Reinhard (EKR) che aveva gestito i quattro lager di sterminio in Polonia. Molti ufficiali di fiducia furono posti a capo dell’EKR o formarono i quadri della locale articolazione dello RSHA e cioè del servizio di sicurezza. Lo RSHA era suddivisa in vari uffici classificati con numeri dal I al VII. Quello che interessa le nostre vicende e i processi della Risiera è l’Ufficio IV (Gestapo) e precisamente le sue sezioni A e B, impegnate nelle persecuzioni degli avversari politici. La IV A1 si occupava del comunismo, la IV A2 della lotta contro i sabotaggi, la IV A3 del liberalismo, opposizione, emigranti, la IV A4 della protezione e notifica degli attentati, la IV B1 del cattolicesi- 329 mo politico, la IV B2 del protestantesimo, la IV B3 delle altre chiese, la IV B4 della questione ebraica. L’EKR (92 uomini) era arrivato a Trieste a scaglioni fra il settembre e novembre 1943. Questi reparti operanti nell’Est dell’Europa, erano reparti di élite, politicamente scelti, che avevano il compito, non solo di garantire la sicurezza delle retrovie del fronte, ma soprattutto quello di eliminare fisicamente gli avversari politici del Reich e i gruppi etnici e “razziali “ pericolosi o indegni di sopravvivere nell’Europa nazista. “Einsatzkommando” significa infatti “comando speciale” e Reinhardt è il nome di battesimo del generale SS Heydrich, primo capo della Gestapo e Protettore di Boemia e Moravia, ideatore della “soluzione finale” ucciso in un attentato a Praga nel 1942. L’EKR aveva una discezionalità di comportamento pressoché totale nelle rappresaglie, nei massacri, nelle operazioni contro gli avversari del Reich. Globocnik era perciò il capo di tutto l’apparato repressivo locale dello RSHA di cui il reparto faceva parte. Himmler dava direttamente istruzioni a lui. Certi crimini non furono tanto “eccessi” ma erano il modo “normale” con cui l’EKR esercitava le sue funzioni di repressione e di sterminio secondo i piani di Hitler. Al comando dell’EKR era giunto a Trieste l’SS Sturmbannführer Christian Wirth, soprannominato “il Selvaggio Christian”, già direttore degli “Istituti dell’Aktion T4” preposti in Germania allo sterminio di invalidi e ammalati mentali tedeschi. Questo gruppo si rese complice dell’uccisione di 70.000 tedeschi fra il ‘39 e il ‘41, quando l’Aktion T4 venne sospesa per la profonda emozione suscitata fra l’opinione pubblica tedesca. Ma Wirth non fu solo reduce dalla T4 ma fu anche lui ad allestire, fra il marzo e il luglio del 1942 i campi di Belzec, Sobibor e Treblinka. Morì a Trieste nel 44 per una imboscata partigiana. Con lui a Trieste fecero parte dell’EKR diversi esperti dell’Aktion Reinhard (operazione di repressione in Polonia). 330 Ne ricordiamo solo alcuni: L’SS Hauptsturmführer Franz Stangl, un ex poliziotto austriaco. Dopo l’annessione, era passato alla Gestapo nella sezione che si occupava in particolare degli ebrei. Nel ‘42-’43 fu comandante dei lager di Sobibor e Treblinka agli ordini di Globocnik meritandosi due decorazioni. La moglie raccontò che egli diresse il suo lavoro senza batter ciglio e se i pensieri erano troppi li affogava nell’acquavite. Stangl, poco prima di morire nel 1971, confidò alla scrittrice Gitta Sereny che nel ’43 lo avevano mandato a Trieste con l’EKR, raccomandandogli di “non lasciarsi scappare gli ebrei neanche là”8. Otto Stadie, Polizeimaster, che nella T4 portava gli ammalati a Burnburg, dove venivano uccisi col gas. Venne condannato nel “processo Treblinka” a 7 anni per favoreggiamento nell’uccisione di 300.000 ebrei. A Trieste Stadie fu il “boia” principale della “Risiera”, ma dichiarò di non ricordare nulla delle uccisioni ivi avvenute. Gustave Munzberger, dal castello di Sonnestein, dove operava con la T4, andò a Treblinka dove uno dei suoi compiti era quello di spingere le vittime nella camera a gas con la frusta in pugno. Mentre era a Treblinka Munzberger era solito bere. Gustave Munzberger, che operò a Udine con la R3 dell’EKR, fu condannato nel 1965 a 12 anni nel processo per i crimini di Treblinka. L’Unterscharführer Franz Rum, dopo aver esercitato la professione di cameriere a Berlino fino al 1939, accettò di fare il “fotocopista” nella T4. Uscito così da una vita grigia e modesta e raggiunto un certo potere in qualità di SS, Rum si adoperò per ottenere un altro impiego in quanto il servizio nella T4 “non mi confaceva per motivi di salute”8. Così “arrivai a Treblinka nel novembre del 1942”. Delle uccisioni della Risiera dichiarò di non aver mai saputo nulla. Il sergente Karl Werner Dubois fece il suo “collaudo” sia negli istituti della T4 che nell’Aktion Reinhard a Belzec e Sobibor. In questi istituti Dubois era “addetto alla cremazione dei cadaveri”. 331 Dubois confermò l’esistenza del forno crematorio costruito dallo specialista Erwin Lambert, un esperto in edilizia di camere a gas, come quelle da lui costruite a Treblinka (infatti in tempo di pace conduceva un’impresa edile a Stoccarda). Dichiarò che “nessun ebreo era morto in Risera” e che “dalla Risiera gli ebrei, uomini e donne e probabilmente anche i bambini, (venti, trenta, quaranta, precisò) venivano deportati in Germania”10. Ammise di avere partecipato ad una retata di ebrei. L’SS Hauptsturmführer Hering fu trasferito a Trieste con Wirth e dopo la sua morte comandò temporaneamente l’EKR fino all’arrivo di Allers che lo rimosse dall’incarico. Franz Wolf giunse a Trieste nel novembre del ‘43. Confermò che l’EKR nell’OAZ era suddiviso nelle 3 sezioni R1 (Trieste), R2 (Fiume), R3 (Udine). Trasferito a Fiume si occupò delle registrazioni della polizia e della gente comune. Disse che gli ebrei da Fiume venivano portati in Risiera e da qui deportati in Germania. Confermò inoltre la notizia che in Risiera vi erano dei prigionieri partigiani e un forno crematorio. Wilhelm Hausler, membro delle SS Polizeimeister, nel ‘39 fece servizio come guardia nel lager di Buchenwald (Weimar). Trasferito in Polonia diventò “capo della contabilità” per i tre lager di Sobibor, Belzek e Treblinka. Dichiarò che l’EKR in Italia aveva tra i suoi compiti quello di concentrare gli ebrei, impiegati in lavori e anche “a un determinato momento, di sterminarli”11. Sostenne ancora che nell’OZAK l’EKR aveva completa autonomia. Disse di non sapere niente circa il numero, la frequenza e le proporzioni dei crimini della Risiera. Paul Arthur Walther entrò nella polizia criminale nel ‘34. Come altri SS fece parte della T4 e dal 1941 al 1944 fu capo dell’amministrazione del castello di Hartheim (Linz), dove venivano addestrate le SS destinate poi ai campi di sterminio polacchi. Nel marzo-aprile ’44 Walther fu mandato a Trieste all’EKR di Wirth. Ma sulla Risiera fece lo smemorato. Egli aveva compiti militari antipartigiani. Non sentì mai parlare di uccisioni in Risiera. 332 Precisò che nel lager triestino venivano condotte le persone sospette; aggiunse, “abbiamo portato a San Sabba anche giovani uomini che chiedevano un lavoro in Germania”12. Konrad Geng, dal 1939 era addetto al servizio di sicurezza della Cancelleria del Führer, dove rimase fino all’aprile del 43. Da Berlino fu trasferito a Lublino dove fece l’autista di Wirth fino al 18 settembre del ‘43 e poi fu mandato a Trieste al comando di Wirth. Geng sostenne che gli ordini operativi al reparto venivano direttamente da Globocnik. In seguito riconobbe che nell’OZAK l’EKR aveva i compiti di gestire la Risiera con il suo forno crematorio e le numerose esecuzioni di ebrei e non ebrei decise dal Kommando stesso. Ricordò la presenza nel lager degli interpreti italiani Antonio Costrè ed Enrico De Reja. Costrè fu poi arrestato e rinchiuso in Risiera perché rilasciava a pagamento esoneri dal servizio del lavoro. Quest’ultimo sarà poi liberato con un gruppo di prigionieri nell’aprile ’45. Nel maggio del ‘45 Geng si consegnò agli inglesi in Austria, ebbe un lasciapassare e tornò a Trieste, ma fu riconosciuto e arrestato. Fu rilasciato senza che alcuna domanda, neppure a titolo di semplice informazione, gli fosse fatta dagli inquirenti sull’organizzazione repressiva delle SS. La sua pratica fu archiviata. Arrestato e poi rilasciato, di nuovo dal giudice Serbo, con l’invito a tenersi a disposizione, fu trasferito al consolato tedesco di Nancy; così un importante testimone non comparve più a deporre. Kurt Franz operò a Treblinka dove fu “uno dei tre peggiori assassini tra le SS.” Egli commise orrori di ogni sorta e nel ‘43 venne anche lui a Trieste. Interrogato, ebbe il coraggio di dire che non sapeva niente di deportazioni e uccisioni nella Risiera. Per questi crimini fu condannato all’ergastolo, ma nel maggio del ‘93 fu scarcerato. Joseph Oberhauser fu uno dei principali personaggi dell’EKR e della Risiera. Venne a Trieste con lo stesso Globocnik e vi rimase fino al ’45. Egli depose al processo che “fece deportare diversi gruppi di soldati italiani che minacciavano di disertare”14. Lui, 333 che in Risiera aveva anche l’abitazione, era il comandate dell’R1 e del Lager. August Edward Dietrich Allers comandò l’EKR di Trieste dalla morte di Wirth alla fine del ‘45. Allers fu uno degli artefici principali della violenza nazista nell’OZAK. Collaudato dal servizio con la T4 di cui era stato uno dei dirigenti, aveva continuato il suo “lavoro” dopo il 1941 sempre negli istituti dell’eutanasia. A Trieste era venuto più volte durante il comando di Wirth. Membro delle SA, del partito, dottore in legge, funzionario di polizia, Allers era nella condizione di trarre opportuni vantaggi da conoscenze politiche altolocate. Dopo aver partecipato alla rapida campagna di Francia, alla fine del ‘40 si trasferì a Trieste dove si installò in un appartamento di via Giustinelli requisito ad una famiglia ebraica con segretarie, l’autista ucraino, sottoufficiali di servizio, interpreti, cuoco, inservienti. A Trieste, Allers sostituì Wirth svolgendo, a suo dire, funzioni di polizia per le strade di Treiste-Fiume. Prescindendo dalle menzogne di Allers che nell’OZAK avrebbe fatto solo il poliziotto combattente e non l’organizzatore di massacri e deportazioni, va ricordato che la “sicurezza” della strada Trieste-Fiume, rimasta assai precaria, comportò la distruzione selvaggia di decine di paesi sloveni e croati con stragi efferate come quella di Lipa del 30 aprile ‘44 dove furono trucidati 287 civili inermi, vecchi, donne, bambini. Allers negò l’esistenza dell’EKR di cui fu il comandante e finse di non ricordare o ricordare male persino i nomi dei principali comandanti dello SD-SIPO dipendenti da Globocnik. Quanto alla Risiera, disse che ci andava per le sue “cavalcate”. Poi ammise che occasionalmente era andato due volte in Risiera per “interrogatori”, ma “gli si concedeva di entrare soltanto previa chiamata telefonica perché la sua persona non era conosciuta”15. Dichiarò di essere venuto a conoscenza del forno crematorio solo nel marzoaprile ‘45. Sappiamo però che spesso si recava in Risiera per compiervi le “selezioni”, esercitando il suo diritto di vita e di morte sui prigionieri. Per difendersi, Allers negò troppo. Nuovamente interroga334 to, anche su rogatoria del giudice Serbo, essendosi finalmente aperta da parte italiana una istruttoria per i crimini della Risiera, fece qualche ulteriore ammissione. Ammise alcune uccisioni in Risiera e disse che nel periodo maggio ‘44-marzo ‘45, regolarmente più volte alla settimana, di notte sarebbero stati uccisi due, tre o più persone in maggioranza ebrei, ma anche cosiddetti “bastardi” e cosiddetti “partigiani”. Ammise anche la partenza da Trieste di nove “trasporti” di deportati dalla Risiera diretti nei lager in Germania. Nel 1945, alla vigilia dell’insurrezione generale, il Gauleiter Rainer partì alla volta di Udine per raggiungere l’Austria e una parte dell’EKR con Allers, Oberhauser, Geng ed altri si aggregò alla sua colonna. Globocnik partì con una autocolonna protetta da mezzi corazzati verso Tolmezzo e a lui si unirono la restante parte dell’EKR e le SS. In Austria le due colonne si incontrarono e anche dopo la morte di Hitler dichiararono che “a noi rimane il dovere di continuare la sua opera”15. Globlocnik si suicidò in Carinzia il 6 giugno del 1945. Rainer fu processato per i misfatti compiuti con l’eutanasia e fu condannato a 8 anni. Gli andò bene perché per l’affare T4 non fece che due anni o poco più di carcere, riprendendo la sua professione di avvocato ad Amburgo fino al 1975, anno in cui morì in seguito ad un incidente. Dello “staff” di Globocnik ricorderemo ancora qui brevemente alcuni nomi a cominciare da quello dello Sturmbannführer austriaco Ernst Lerch che divenne il suo braccio destro, una specie di suo Capo di Stato maggiore. Lerch venne arrestato nel settembre del 1971 a Klagenfurt dove era un personaggio brillante della media borghesia locale ed un esponente della locale Associazione Albergatori; venne subito rilasciato e non fu mai più chiamato a testimoniare a Trieste per la Risiera. Nel 1986 il caso Lerch fu archiviato, ritenendo che egli avesse svolto incarichi solo militari. L’Hauptsturmführer Michelsen giunse a Trieste dalla Polonia con Globocnik, dove si era guadagnato molte decorazioni in seguito a meriti acquisiti nella ripulitura del ghetto di Varsavia e 335 di Bialystok. Comandante delle SS e della Polizia in Istria, lo divenne anche per la provincia di Trieste. Malgrado gli incarichi ricoperti, egli disse nell’interrogatorio di Amburgo nel 1967 di non saper nulla dell’esistenza del Lager Risiera e dell’EKR. L’Obersturmbannführer Gunther, reduce della T4, fu comandante a Trieste della SD-SIPO. Fu un comandante efficiente che fu addirittura elogiato dal capo delle SS e polizia in Italia Karl Wolff per aver annientato nell’44 la sezione triestina del PCI. Questa operazione fu dovuta in realtà all’Ispettorato Speciale (Organo di repressione della RSI) su delazione di ex partigiani passati al nemico. Con Gunther, sempre nel 1944, s’incontrò l’esponente del fascio repubblicano Italo Sauro che propose tutta la deportazione della popolazione compresa fra i 15 e i 45 anni e suggerì di dare maggiore libertà di uccidere ai rappresentanti della Repubblica di Salò. L’ufficiale tedesco bocciò la prima proposta perché di difficile attuazione, ma rimase entusiasta della seconda perché secondo lui “bisognava uccidere più che si poteva”16. All’unità speciale di Globocnik per la propaganda appartiene il capitano austriaco Franz Hradeztky. Questa organizzazione era in stretto contatto con la direzione della propaganda di Rainer diretta da un altro austriaco, Karl Lapper. Altri uomini di fiducia di Globocnik nel Litorale furono il maggiore Ludolf von Alvensleben, comandante delle SS e Polizia; il capitano Labitzke, che dirigeva una “filiale”dello SD e SIPO nel rione triestino di Barcola; il tenente colonnello Traub, comandante SS e Polizia per la provincia di Fiume; il maggiore austriaco Karl Tauss; il capitano Herbert Pakibusch, che dirigeva il Centro di repressione di Palmanova (Udine) dove il tenente Odorico Borsatti e il tenente colonnello Attilio De Lorenzi, trasformarono la caserma Piave in un orrido centro di torture ed esecuzioni. La loro compagnia infierì su oltre 500 fra partigiani italiani e ostaggi. Per questo il Borsatti fu condannato a morte dal tribunale del popolo di Udine. A Trieste l’EKR potè contare su un personale femminile già 336 collaudato nella T4 e che si rese partecipe dei crimini della Risiera. Tra queste la segretaria di Wirth e di Allers; Edeltraud Then confermò che la Risiera era un punto di raccolta degli arrestati e che i partigiani venivano interrogati (civilmente) nell’ufficio-comando di Allers in via Giustinelli. Sulle uccisioni e sul forno crematorio in Risiera non seppe dir nulla. Anche Helene Riegraf faceva parte della T4 dove, nel ‘42, conobbe Hering e lo sposò. Il marito la portò con sé a Trieste. Pur abitando in Risiera, si dichiarò ignara del forno, delle deportazioni e delle uccisioni. I collaborazionisti L’apparato repressivo si avvalse anche di personale civile reclutato sul posto, senza il quale non sarebbe stato possibile svolgere efficacemente le attività sia amministrative che poliziesche. Così a Trieste una schiera di centinaia di civili entrò a far parte dell’organico del Supremo comando di Rainer ma anche dell’EKR di Allers, con mansioni che andavano dall’interprete di fiducia negli interrogatori alla compilazione di rapporti informativi, all’amministrazione dei beni dei deportati. Non è possibile analizzare la struttura di questo settore del collaborazionismo giuliano e triestino in quanto una ricerca non è mai stata fatta e a tanta distanza di tempo presenta difficoltà oggettive. Comunque sono stati trovati vari elenchi di personale per il quale venivano pagati regolarmente i contributi INPS. Una cinquantina di persone fu anche interrogata al processo. Tra questi: Enrico de Reja, interprete di Hering, Oberhauser e Allers, che procedeva agli interrogatori dei prigionieri nella Risiera. Antonio Nicolini, anch’egli interprete e uomo di fiducia, che partecipava agli interrogatori condotti dai nazisti con ogni sorta di sevizie. Erminia Schellander, avvocato, già consulente legale del Consolato di Germania, incaricata di procedere alla liquidazione delle ditte ebraiche. Il successo di questa operazione dipendeva 337 dall’efficienza delle persecuzioni razziali dell’R1 della Risiera. Nel dopoguerra venne condannata a 10 anni, pena poi ridotta a 3 anni. Sua sorella, ex ballerina, collaborava con la SIPO. Erminia dichiarò al processo di non sapere niente di quanto accadeva nel lager, tranne alcune voci di torture a danni di partigiani ed ebrei. Augusta Reiss, interprete, fu “eccezionalmente attiva e capace”17 nel lavoro di persecuzione razziale e in quello di inquisizione politica. Processata e condannata a 13 anni fu subito amnistiata e liberata. Luciano Hesse, partecipò all’operazione dei paracadutisti del Gran Sasso il 12 settembre del ‘43. Collaborò con la Gestapo di Trieste ma al processo negò tutto. Condannato a 4 mesi per reticenza, anni dopo, in appello, fu assolto con formula piena. Raimondo Pisleri, interprete, fu uno dei funzionari più attivi dell’Ufficio IV. Abile e preveggente, si precostituì un alibi per il dopoguerra fornendo informazioni a membri della resistenza slovena e facendo evadere dalla stazione alcuni prigionieri che dovevano essere deportati. Condannato a 20 anni, fu poi assolto per tali meriti. In ultima analisi, il personale civile in servizio prestò la sua opera in centri nevralgici dell’amministrazione, dell’apparato poliziesco nazista e nella Risiera. La maggioranza fece una scelta di carattere strettamente politico ed ottenne incarichi di assoluta fiducia. Non poteva essere diversamente se si considera che si doveva preparare l’inserimento della regione nel Reich e che quindi si doveva procedere alla soluzione del “problema ebraico”, al dimensionamento etnico-nazionale delle popolazioni qui conviventi e al loro sfruttamento politico, economico e militare. Questa “burocrazia” collaborazionista incise sulla vita quotidiana della società triestina e giuliana, creò intorno a sé una rete di rapporti, amicizie, complicità, corruzione, che rese ancora più ambiguo e soffocante il clima dell’epoca e più rischiosa l’attività clandestina politica e militare. 338 Altre componenti del collaborazionismo triestino Oltre ai collaborazionisti, vi furono organi che si occuparono della repressione dell’antifascismo nella regione. Tra questi spicca l’Ispettorato Speciale di PS al comando dell’ispettore generale Giuseppe Gueli. L’Ispettorato si macchiò di crimini nefandi nei confronti di centinaia di uomini e donne (anche incinte), italiani, sloveni, croati e nei confronti dei loro parenti e delle loro famiglie. Le notizie delle torture praticate negli uffici di PS vennero a conoscenza della Curia; infatti il vescovo scrisse una lettera di protesta al ministro Buffarini Guidi, lettera che non ricevette mai risposta. Oltre all’Ispettorato operò l’associazione italo-germanica presieduta da Francesco Giunta che manovrava la quinta colonna nazista in città ed influiva sugli elementi più estremisti e razzisti del fascismo locale. Era questa la vera classe dirigente fascista di Trieste che confermò con il suo comportamento l’antica vocazione antidemocratica che l’aveva portata a sostenere lo squadrismo e l’avvento della dittatura fascista. Dal ‘41 al ‘43 il suo impegno fu soprattutto rivolto a difendere la continuità di uno stato totalitario di classe. Questi uomini sostennero anche la violenta campagna antisemita che a Trieste si manifestò con la devastazione dei luoghi di culto e la persecuzione degli ebrei. Insomma non vi fu nessun “divorzio“ tra i membri dell’alta borghesia economica locale e le strutture fasciste, come invece avvenne nel resto d’Italia tra l’inverno del ‘42 e la primavera del ‘43. Caduto Mussolini, i gruppi dirigenti confindustriali e nazionalfascisti diedero immediata adesione al governo Badoglio e alle misure repressive antioperaie messe in atto dalle autorità militari. Il passaggio indolore dal regime fascista a quello militare assicurava la continuità dei rapporti di forza e di classe e il severo controllo delle masse operaie. Durante la guerra, fino al ’43, l’Ispettorato di PS e l’Esercito italiano intensificarono l’opera di repressione sul proletariato industriale che, per il suo antifascismo e la presenza di cellule comuniste, era ritenuto la 339 principale minaccia dell’ordine. Questa ossessione antioperaia e antidemocratica offuscò a tal punto i comandi militari che questi non si opposero alla crescente penetrazione tedesca nella regione. Nella logica di questa mentalità trova la sua spiegazione la decisione dei militari di respingere le richieste dei comitati antifascisti di reagire all’invasione tedesca e di difendere quei territori e quella città per cui l’Italia aveva combattuto la sanguinosa guerra del ‘15-’18. Dopo il ’43 nessun cambiamento avvenne all’Ispettorato di PS, malgrado le proteste del vescovo Santin e del medico Bruno Pincherle, fondatore con altri del Partito d’Azione a Trieste. L’Ispettorato continuò nelle sue violenze anche sotto il nuovo governo. Il prefetto Coceani (nomina avuta da Rainer) dichiarò che alla fine del’ 44 aveva fatto preparare un decreto di scioglimento dell’Ispettorato, decreto che i tedeschi non avrebbero firmato. Nessuno confermò tale richiesta di scioglimento, tanto più questo appare improbabile in quanto lo stesso Coceani continuò a collaborare con il Gueli per la richiesta alla Repubblica di Salò di rinforzi nella lotta antipartigiana. Il Gueli mandava regolari rapporti anche su azioni di rastrellamento e sugli incendi dei paesi compiuti dalle squadre insieme ai reparti tedeschi, proponendo in tale ambito la promozione del feroce vicecommissario Collotti, dirigente della “Squadra speciale”, al grado superiore per meriti eccezionali. In effetti il Collotti ebbe gran parte nelle atrocità di cui si macchiò l’Ispettorato di PS, teneva i contatti con la Gestapo e con i noti torturatori Zimmer e Hiber di cui presenziava spesso agli interrogatori. Il Collotti fuggì da Trieste con la sua squadra il 25 aprile ‘45 su di una macchina e un camion. Fermati dai partigiani, furono trovati in possesso di timbri falsi della Brigata Garibaldi e di preziosi, pellicce e oggetti di valore sequestrati alle loro vittime, ebrei e non ebrei. Riconosciuto da un partigiano di CLN, venne fucilato sul posto con la sua amante e i suoi uomini. 340 Va ricordato che al Collotti venne conferita una medaglia di bronzo alla memoria per un’azione che aveva portato all’arresto di alcuni partigiani prima del ‘43. La medaglia venne consegnata solennemente nel 1954. A nulla valsero le proteste del Comune di Trieste, delle associazioni e dei partiti antifascisti al presidente della Repubblica Einaudi e ai ministri della difesa e degli interni. Una delle ultime vittime di Collotti fu il partigiano Igor Dekleva che si salvò per miracolo, fingendosi morto, in uno scontro a fuoco con gli agenti di PS in cui un agente venne ucciso. Per tale fatto nel 1955 venne arrestato e imputato di omicidio, venne amnistiato successivamente, ma mai prosciolto. Anche il partigiano Luciano Rapotez, per quanto fosse perfettamente innocente, venne arrestato e torturato a Trieste nel 1955, per fargli confessare un omicidio dello stesso periodo. Il processo lo assolse ma i suoi torturatori non vennero perseguiti. Questi due casi, come molti altri simili, dimostrano che ancora dopo gli anni ’50 c’erano funzionari e autorità che rappresentavano la continuità con il vecchio stato poliziesco. Al comando delle forze armate di Salò c’era il generale Esposito, già comandante della divisione alpina Pusteria dell’esercito regolare italiano, dislocato in Jugoslavia fino dall’otto settembre. Nel 1° bando di Rainer per il servizio obbligatorio di guerra i giovani che scelsero di combattere per Salò furono molto pochi e la maggioranza scelse il lavoro alla Tod. Nella chiamata successiva del ’44, rispose un numero ancora minore di giovani che preferirono unirsi alle brigate partigiane o nascondersi. Il rifiuto alla leva è un fenomeno che si spiega anche dal timore delle violente vendette dei contadini sloveni e croati contro gli italiani nel settembre-ottobre del ‘43, quando vennero uccisi da 400 a 500 persone che, in maggioranza, non avevano partecipato alle violenze perpetrate dal fascismo nella regione. La milizia avrebbe sicuramente offerto una protezione. Fu comunque l’Esposito, che aveva dichiarato i renitenti alla leva “anti-italiani”, a consegnare alle SS gli elenchi degli ufficiali che non avevano giurato fedeltà alla 341 RSI, provocando così la deportazione in Germania di 17 suoi colleghi. La milizia di Salò poté comunque contare su varie compagnie, dislocate sul territorio, che compivano torture e massacri e partecipavano ai rastrellamenti di ebrei. Le SS poterono giovarsi del lavoro di rastrellamento svolto dal “Centro per lo studio del problema ebraico”. Le angherie e i soprusi dei miliziani contribuirono ad inasprire gli animi degli slavi che sfociarono nel fenomeno delle “foibe” dove trovarono la morte molti esponenti del CNL e del CIL. Infine un ruolo notevole nell’amministrazione del territorio lo svolsero i gruppi triestini della Confindustria; infatti i tedeschi fecero balenare agli imprenditori triestini la possibilità di nuovi guadagni offerti dall’imperialismo nazista. Alla difesa dell’ordine pubblico era disposta la Guardia Civica che richiamò molti giovani allettati dall’occasione di sottrarsi ai bandi tedeschi. I suoi compiti furono soprattutto di lotta antipartigiana. GLI OPPOSITORI A Trieste non ci furono solo collaborazionisti, ma anche coloro che avevano scelto la lotta al nazifascismo, soprattutto persone che avevano fatto parte del movimento irredentista sotto l’Austria. Ricordiamo qui alcuni nomi: Gabriele Foschiatti, volontario nella guerra contro la Turchia e decorato nella prima guerra mondiale, fu uno dei fondatori a Trieste del Pd’A e di GL. Nel ‘44 morì a Dachau. Fu medaglia d’oro per la Resistenza. Ercole Miani, anch’egli del Pd’A, volontario nella prima guerra mondiale con decorazioni, fu comandante del GL. Fu arrestato e torturato dal Collotti. Edmondo Paucher fu uno dei capi del socialismo triestino sotto l’Austria; passò al PSU per poi diventare membro del CNL. Venne deportato a Dachau. 342 Giovanni Tanasco era segretario del PPI di Sturzo e poi organizzatore dei primi nuclei della DC. Fu deportato a Dachau. Don Edoardo Marzari, organizzatore e dirigente della DC triestina e del CLN, fu arrestato e torturato dagli uomini dell’Ispettorato speciale. Paolo Reti, democristiano segretario di CLN, fu arrestato e bruciato nella Risiera. Zefferino Pisoni, comunista, animatore del CNL di Trieste, morì a Dachau . Luigi Frausin, comunista, fu ucciso dai nazisti, dopo atroci torture nel settembre del ’44. Lo scrittore Gianni Stuparich, medaglia d’oro della prima guerra mondiale, collaborò con Ercole Miani e fu arrestato dai Tedeschi, ufficialmente per motivi “razziali”, ma in realtà perchè rappresentava un simbolo di quella tradizione culturale e politica triestina che rifiutava di asservirsi all’occupante. Vi fu poi tutta una schiera di giovani che operarono a Trieste nel movimento partigiano e che finirono nei campi di concentramento nazisti o morirono combattendo. La particolare situazione politica nazionale e militare in cui venne a trovarsi il CLN triestino, con il grave limite della questione nazionale e territoriale e le rivendicazioni del movimento jugoslavo, influirono notevolmente sull’azione del Comitato. La tradizione patriottico-irredentista era ancora viva in molti dei suoi componenti che consideravano come acquisita dal 1918 l’appartenenza di queste terre all’Italia e pur riconoscendo alle popolazioni slovene e croate ampi spazi di autonomia culturale e amministrativa, le inserivano nello stato democratico italiano. Questo stato di cose portò ad una crisi nel CLN, in quanto l’egemonia conquistata sul campo, a prezzo di sacrifici durissimi da parte del movimento jugoslavo, l’uscita del PCI a seguito della linea filojugoslava assunta dal partito, l’adesione a questa scelta di gran parte delle masse operaie, resero la posizione del Comitato molto debole e vanificarono i suoi sforzi affinché l’insurre- 343 zione antitedesca di Trieste assumesse il significato di una concreta manifestazione di democrazia e di fedeltà ad un’Italia libera. CHI SAPEVA DELLA RISIERA? Gli accorgimenti usati dai Tedeschi non bastarono a tenere segreta l’esistenza della Risiera durante l’occupazione. Gli abitanti della zona si resero conto che qualcosa lì avveniva di orribile e le notizie poco a poco cominciarono a diffondersi. Per esempio la signora Giuseppina Tomat raccontò che, quando la ciminiera fumava, si sentiva un acre odore di carne bruciata e che di notte si udivano urla e imprecazioni ogni volta che arrivavano autocarri carichi di prigionieri. Inoltre un giorno la signora vide due soldati tedeschi arrivare con un carretto e scaricare in acqua sacchi di cenere. Fermatisi per vedere meglio fu allontanata brutalmente. Il giorno successivo, tornata sul posto, vide sulla battigia “frammenti ossei misti a polvere che ributtati dalla risacca, si spandevano per 500 metri”18. Dalla sua finestra vide più volte ripassare i soldati tedeschi con il carretto. Anche Aldo Fulan testimoniò che, durante il suo turno di lavoro dalle 18 alle 20, vedeva i soldati tedeschi con il carretto scendere al mare e scaricare sacchi di cenere in una barchetta sulla riva, con la quale si allontanavano un centinaio di metri e scaricavano le ceneri in mare. Tali voci si diffusero tanto che il movimento di liberazione jugoslavo diffuse una pubblicazione in cui si denunciavano le raffinate crudeltà dei nazisti nella Risiera. Il vescovo Santin, di cui già si è parlato, dichiarò di non sospettare che in Risiera avvenissero tutte le nefandezze in seguito documentate, ma di ritenere che fosse solo una prigione di transito per i campi di concentramento tedeschi o polacchi. 344 PROCESSI PER COLLABORAZIONISMO NEL DOPOGUERRA I processi per collaborazionismo non portarono mai a nulla; le condanne furono irrisorie. In alcuni casi come per il prefetto Coceani e il podestà Pagnini, gli imputati uscirono dall’aula come “martiri della patria”. Ci si chiede come si potesse giustificare che il Coceani conoscesse la Risiera ma non fosse mai intervenuto dall’alto della sua carica per fermare le torture e gli omicidi, mentre invece aveva fatto la voce grossa con Rainer perché i beni sequestrati agli ebrei tornassero allo stato italiano. Egli dichiarerà in seguito su questo suo gesto: ”Trieste (lui) ha la coscienza di aver fatto tutto il possibile per tutelare intransigentemente i diritti dello stato italiano”19. Nell’insieme, questi processi, con i loro esiti e i loro giudizi, contribuirono paradossalmente a reinserire nella vita pubblica notabili della vecchia classe dirigente fascista e di Salò. Questo, insieme al perdurare dell’amministrazione angloamericana, e al lungo stallo del problema territoriale di Trieste, favorirono la crescita di un neofascismo arrogante e aggressivo. Nel 1973 inziò il processo per i crimini della Risiera in cui erano imputati, fra gli altri, i nazisti Allers e Oberhauser. Il banco degli imputati però rimase vuoto perché molti dei protagonisti erano morti o scomparsi. Nel 1976 il processo venne chiuso. Allers non fu condannato visto che era morto un anno prima, mentre Oberhauser ricevette l’ergastolo che non scontò, dato che il governo italiano non richiese mai l’estradizione. Al processo per i crimini della Risiera emersero manifestazioni di insofferenza ogni qualvolta il discorso si portava sul perché della Risiera ed esulava dalle responsabilità dei nazisti. Non si voleva ammettere che la Risiera aveva le sue origini, oltre che nella violenza nazista, anche nella politica del fascismo e in tutte quelle forze che lo avevano sostenuto e che ne avevano appoggiato le mire espansionistiche, la persecuzione delle minoranze, le campagne antisemitiche, le torture dell’Ispettorato Speciale di PS e le guerre mussoliniane, fino alla catastrofe finale. 345 INTERVISTA A LEA CAMPOS BORALEVI E ALLA MADRE Dai miei studi risulta che il collaborazionismo abbia svolto a Trieste un ruolo molto importante durante l’occupazione tedesca. Lei cosa mi sa dire a proposito? C. B. “Erano molti i triestini che collaboravano con le SS, non solo nella Risiera di S. Sabba ma anche come informatori che riferivano ai militari tedeschi come si potevano raggiungere gli ebrei nascosti sotto falso nome o smascherando persone attive nella resistenza. Dopo la guerra qualcuno ha provveduto a far ridipingere le microcelle dei detenuti, nella Risiera, dove questi ultimi avevano scritto sulle pareti messaggi per i propri cari ma anche denunce del tipo “mi ha denunciato il signor x”. Queste scritte furono fatte perciò sparire. Fortunatamente ci fu un certo signor Diego Enriquez, che era un personaggio molto eccentrico, appartenente alla nobiltà spagnola, ma residente a Trieste, che riuscì a salvare parte di queste epigrafi. Egli era un collezionista d’armi e in questa passione aveva dilapidato tutto il suo patrimonio, costituendo nel ‘75 un “ Museo della Guerra” sul Carso. Era talmente eccentrico che si racconta che durante la prima guerra mondiale raccogliesse i suoi cimeli direttamente dentro le trincee. Alla fine della seconda guerra mondiale, era entrato in Risiera prima che i muri delle celle fossero imbiancati e aveva così potuto trascrivere le epigrafi su dei quaderni. Questi quaderni li conservò fino alla sua morte, avvenuta poco prima del processo in circostanze sospette; infatti i quaderni sparirono, ma il nobile spagnolo ne aveva depositato una copia da un amico che li aveva conservati. Questa storia un po’ romanzesca serve per sottolineare il problema, verificatosi a Trieste, ma non solo, del collaborazionismo. In tutta la Repubblica di Salò a chi consegnava un ebreo o un partigiano venivano date 10.000 lire, che allora erano una grande cifra.” M. “Una famiglia poteva vivere comodamente un anno con questi soldi”. C. B. “Dal giugno del ’45 molti di questi collaborazionisti furono assunti dal governo alleato come sicuri anticomunisti. In questo senso a 346 Trieste non c’è mai stata una vera e propria epurazione. Alcuni fascisti tornarono a Trieste anche dopo dieci o venti anni, quando ormai ci si era dimenticati di loro. Un esempio è Rino Alessi, ex compagno di scuola del Duce e direttore del “Piccolo”, giornale di Trieste fondato dall’ebreo Mayer, al quale venne requisito insieme ai suoi beni dopo le leggi razziali del ‘38”. Come mai l’occupazione delle truppe di Tito non portarono ad una completa epurazione dei fascisti di Trieste? C. B. ”Il governo jugoslavo durò solo 40 giorni e in questo brevissimo periodo non era riuscito a creare un sistema informativo come quello che avevano i tedeschi. La violenza delle foibe è stata determinata da un elemento di vendetta creata dal fatto che in Risiera morirono molti partigiani e civili sloveni e inoltre non si potevano dimenticare vent’anni di angherie del governo fascista contro gli sloveni che vivevano nel territorio italiano; infatti durante il ventennio era stato chiuso il giornale sloveno, era stato bruciato il teatro sloveno ed era anche proibito parlare sloveno in pubblico. Le pene per i trasgressori erano corporali.” M. “Sono stata testimone della partenza di camion pieni di fascisti che andavano, senza motivo, a bruciare le case degli sloveni, uccidendo e picchiando chi capitava. E’ per questi precedenti che si può dire che il “fenomeno delle foibe” sia stato causato da un desiderio di vendetta sloveno. Comunque ci furono molti errori anche perché i veri collaborazionisti si erano nascosti o erano scappati.” Cosa mi può dire della persecuzione ebraica? C. B. “Bisogna dividere la persecuzione ebraica in Italia in tre periodi: prima del ‘38, quando gli ebrei erano ben inseriti nella società, dal ’38 al ‘43 quando gli ebrei a causa delle leggi razziali perdono i diritti civili, politici ed economici. I bambini furono cacciati dalle scuole pubbliche e mandati in scuole ebraiche con insegnanti ebrei che avevano perso le loro cattedre. Anche dall’esercito furono radiati gli ebrei, benché 347 taluni di essi ricoprissero alte cariche. Questo portò grossi problemi psicologici ed economici anche perché era vietato partecipare alla vita sociale, come andare a teatro o possedere la radio e molti bar e negozi già dal 1939 esponevano la scritta ”Vietato entrare agli ebrei e ai cani”. Dalle leggi antisemite in poi ci furono atti vandalici contro i possedimenti degli ebrei: prima i fascisti entravano e rubavano e poi rompevano tutto. Inoltre gli ebrei dovevano andare all’anagrafe per farsi mettere un timbro sui documenti. Questo periodo fu molto difficile e comportò una forte migrazione di chi poteva e soprattutto di chi aveva capito che c’era un pericolo di vita. Nel ‘43 la situazione divenne tragica perché Trieste non faceva parte della Repubblica di Salò, ma venne direttamente annessa al Reich. Questo determinava che la giurisdizione veniva direttamente controllata dal governo di Berlino e ci può spiegare come l’unico campo di sterminio in suolo italiano sia stato costruito a Trieste.” M. “Di quegli anni ricordo di aver visto dalla mia casa arrivare i soldati tedeschi e perciò di essere scappata con mia madre e una sua sorella. Arrivammo in fuga sul lago Maggiore per espatriare in Svizzera dove viveva un mio fratello, ma le guardie ci respinsero. Questo fatto era determinato dall’origine delle guardie di frontiera: quelle di origine tedesca respingevano tutti, mentre quelle di origine italiana o francese lasciavano passare. Intanto a Trieste la domestica ci aveva prima derubato tutta la casa e poi ci aveva denunciate ai Tedeschi. Dalla frontiera scappammo a Padova dove mio cognato aveva degli amici che ci fecero ospitare dalla famiglia di uno scultore, molto famoso al tempo, Luigi Strazzabosco. Qui rimanemmo nascoste tra Padova e Bastia di Rho, vicino a Padova, dove i padovani si rifugiavano dai bombardamenti. In questo paesino siamo state molto aiutate dal parroco. Questi fatti dimostrano che non c’erano solo collaborazionisti ma anche persone che aiutavano a rischio anche della propria vita.” C. B. “A Trieste comunque non tutti gli ebrei riuscirono a scappare, perciò non furono rari gli arresti, mille persone vennero deportate e di queste solo 12 tornarono vive. Trieste ha pagato questo alto tributo perché era territorio del Terzo Reich e questo spiega anche perché il “pro- 348 cesso alla Risiera” sia giunto solo dopo quasi trent’anni, in quanto i militari tedeschi si giustificavano asserendo che quello era territorio tedesco e che avevano ricevuto degli ordini. Pertanto gli avvocati di parte civile dovettero sostenere che in Risiera non si erano svolti solo crimini militari, ma anche crimini comuni punibili dal codice penale italiano.” La popolazione sapeva cosa avveniva in Risiera? C. B. “Il vescovo di Trieste Santin si era molto adoperato per gli ebrei e aveva tentato di salvarne diversi, ma dichiarò di non conoscere l’esistenza del forno crematorio per quanto non potesse ignorarne l’esistenza, visto che il fumo si vedeva da tutta la città. D’altronde il comportamento del clero cattolico riguardo all’Olocausto è un problema molto controverso in quanto ancora si discute sul silenzio di Pio XII. Certamente, anche se il Vaticano non si è mai apertamente schierato, il clero italiano si è sempre adoperato per aiutare gli ebrei, in particolare nelle zone in cui c’era un vescovo che dava delle indicazioni in quel senso. Il vescovo di Padova ne è un esempio, in quanto il parroco che ha aiutato mia madre aveva avuto ordine di operare in tal modo dal suo superiore. I cattolici però aiutavano gli ebrei anche perché volevano convertirli; questo era successo anche tra i ricchi ebrei di Trieste ma non era servito in quanto per i tedeschi per essere ariani bisognava esserlo già da tre generazioni. Comunque è certo che la maggioranza della popolazione di Trieste conosceva quello che succedeva in Risiera, anche se i Tedeschi cercavano di tenere tutto nascosto.” In quali paesi potevano scappare gli ebrei tra il ‘38 e il ’43? C. B.”Oltre alla Svizzera, molti sono andati in Palestina che era un protettorato inglese. Questo comportava il fatto che non vi era una immigrazione libera e si poteva entrare solo clandestinamente. Infatti gli inglesi avevano costruito a Cipro dei campi di raccolta e le navi per il futuro stato di Israele partirono soprattutto da Genova. 349 Chi poteva cercava anche di andare negli USA, ma bisognava avere qualcuno che garantiva economicamente per te. Nel 1939 un fratello di mia nonna, di origine polacca ma che viveva in America, scrisse alla sorella invitandola a raggiungerlo garantendo economicamente per lei e la sua famiglia. Poiché non era possibile avere i documenti per tutti i miei nonni, decisero di rimanere per non dividere la famiglia.” Come potevate mantenervi economicamente se avevate perso tutto? M. “Dopo aver venduto i gioielli di famiglia, io e mia sorella davamo ripetizioni in cambio di generi alimentari, dato che a Padova nessuno sapeva che eravamo ebree.” NOTE 2 Il presente lavoro è stato realizzato sulla base della consultazione dei seguenti testi: A. Scalpelli (a cura di), San Sabba. Istruttoria e processo per il lager della Risiera, 2 voll., Aned Lint, Trieste, dicembre 1995; Comune di Trieste, Civici Musei di storia ed arte, Civico Museo della Risiera di S. Sabba, Capire la Risiera. A Trieste un lager del sistema nazista, Quaderno didattico sette, Trieste, 1996; O. Moscarda e M. Verginella (a cura di), I viaggi di Erodoto, n° 34, Bruno Mondadori, Milano, 1998; R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1993. 3 Cfr. A. Scalpelli, op. cit., p. 69. 4 Ivi, p. 70. 5 Ibidem. 6 Ivi, p. 8. 7 Ibidem. 8 G. Mayda, Gli ebrei sotto Salò, Feltrinelli, Milano, 1978, p.138. 9 Cfr. A. Scalpelli, op. cit., p. 15. 10 Ibidem. 350 11 Ivi, pp. 18-19. 12 Ibidem. 13 Ivi, pp. 22. 14 Ivi, pp. 23-27. 15 Ibidem. 16 Ivi, p. 29. 17 Ivi, p. 35. 18 Ivi, p. 86. 19 Ivi, p. 59. 351
Scarica