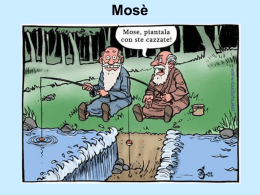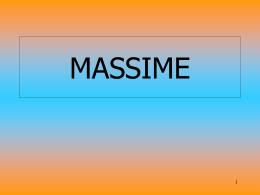Credere
di Stanislao Smiraglia
Come possiamo pensare se non nel modo in cui possiamo pensare?
In questo capitolo cercheremo di fornire risposte a due quesiti fondamentali: in che
modo conosciamo ciò che crediamo di conoscere? E ancora: perché crediamo in ciò
che crediamo di conoscere?
Possiamo iniziare a rispondere a queste
domande
con una
risposta
apparentemente criptica o elusiva: semplicemente perché siamo fatti come siamo
fatti e perché, se crediamo, non possiamo che credere.
Sicché diventa importante nella prospettiva dell’evoluzione naturale comprendere
come siamo fatti, ovvero quali sono le basi naturali del nostro modo di conoscere e
pensare,
e per quale ragione noi crediamo a ciò che crediamo. Solo
comprendendolo possiamo renderci consapevoli (entro limiti contestuali) di quali
sono i limiti impliciti di tutte le conoscenze che noi possiamo elaborare, proprio
perché così fatti e dunque soggetti a limiti naturali e socio-culturali.
Le basi della conoscenza del mondo
I processi del pensiero umano, i processi cognitivi, sono possibili perché il nostro
cervello li rende possibili. È lo sviluppo del grande cervello che ci consente di
affermare il nostro primato culturale e la nostra superiorità tecnologica. Questa
stessa superiorità ha portato a costruire storie, gi{ dall’antichità, che raccontano di
un piano divino teso a consegnarci un destino speciale nel creato. Come dice
l’Antico Testamento, Dio ci avrebbe creato addirittura a sua immagine e
somiglianza. Pressoché in tutte le culture è presente un segno divino che
conferisce significato elettivo alla creazione del mondo e alla centralità del gruppo
sociale che si riconosce in quel dio. Come dobbiamo interpretare la consistenza e
diffusione di questa idea? Perché il nostro cervello (i cervelli della maggioranza
degli uomini che sono vissuti nel mondo) è sistematicamente colonizzato da questa
idea? Quali sono le basi del nostro cogliere e affermare l’esistenza di un’entit{
superiore che ci ha collocato su un gradino così importante delle gerarchie
dell’ordine naturale?
Il progetto divino è l’unica interpretazione possibile delle ragioni di un tale potere,
qual è quello di cui ci sentiamo portatori, perfino simile a quello dello stesso dio?
Come si vede, i quesiti con cui abbiamo aperto il capitolo si sono rapidamente
moltiplicati. Effettivamente la riflessione sistematica produce più domande di
quante siano le risposte; le conoscenze accumulate nel corso di questi ultimi secoli
dalla ricerca scientifica sul mondo naturale sono straordinarie ma ogni nuova
conoscenza evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti per rispondere a
domande sempre più specifiche e sottili. Se Darwin ha elaborato una spiegazione
rivoluzionaria della proliferazione delle forme di vita e dell’evoluzione della specie,
la ricerca che ne è derivata ha consolidato quella prima lettura del mondo naturale
anche attraverso nuove risposte alle nuove domande che quella teoria aveva fatto
sorgere. La ricerca genetica ha individuato il ruolo cruciale del Dna nella
trasmissione ereditaria, fornendo spiegazioni di cui prima non si disponeva (e che
a Darwin mancavano) sulla replicazione dei geni (i veri padroni del nostro pianeta)
e del perché i geni hanno determinato una così grande varietà di forme di vita. Ma
questo non vuol dire che non vi siano domande che meritano ulteriori risposte. La
conoscenza scientifica è essa stessa espressione di un processo evoluzionistico che
non appare destinato a concludersi per lo meno fino a quando la nostra specie
esisterà e ci sarà un cervello in grado di riflettere su ulteriori quesiti. Anche la
paleo-antropologia ha fornito risposte congruenti sulla nostra evoluzione e il
quadro complessivo delle nostre conoscenze si è arricchito di nuove evidenze
empiriche ma anche nuovi interrogativi. Sappiamo che la nostra specie si è
affermata sul nostro pianeta in un certo tempo (milioni di anni) e che il nostro
cervello si è gradualmente evoluto in accordo ai vantaggi che ne sono derivati in
termini di fitness.1
Adottiamo in questa sede la definizione sintetica fornita da D. Dennett (2007, p.76) come
capacità di riprodursi meglio dei competitori. Questa definizione soddisfa il principio di
compatibilità con diverse accezioni del termine, a partire da quella proposta da H. Spencer
e ripresa da Darwin (sopravvivenza del più idoneo) a quella elaborata da Hamilton (1964)
1
Gli individui che appartengono alla specie homo non possono che conoscere il
mondo se non per come essi sono in grado di conoscerlo, ossia per la dotazione che
l’evoluzione naturale consente. Vero è che, nel corso dell’evoluzione, alcune delle
opportunità derivanti dal grande cervello hanno dato origine a una seconda
traiettoria evolutiva: quella culturale dominata dai nuovi replicanti: i memi. In
particolare, l’evoluzione culturale ha prodotto una nuova opportunit{: quella dello
sviluppo della conoscenza condivisa e della produzione di protesi del corpo e della
mente: il fenotipo esteso. In tal senso, le nuove straordinarie conoscenze non
hanno richiesto, come sempre era accaduto in passato per milioni di anni, la
coevoluzione del grande cervello che non si è sostanzialmente accresciuto rispetto
a quello dei primi sapiens. Possiamo dire che il nostro cervello ha raggiunto una
massa critica e che non è passibile di ulteriori accrescimenti? Secondo alcuni è
proprio così. Un’ulteriore crescita del cranio – ad esempio - richiederebbe la
coevoluzione delle caratteristiche del bacino femminile ma simili mutazioni
richiedono milioni di anni di coevoluzione. Il fenotipo esteso non rende necessarie
attese così lunghe: favorisce nuove soluzioni per incrementare la nostra capacità
cognitiva, di governo del pianeta e di proiezione verso nuovi territori cosmici.
Come abbiamo altrove evidenziato il fenotipo esteso produce effetti di
accelerazione della conoscenza perché opera in base ad un diverso principio
cognitivo rispetto al cervello fenotipico individuale: il fenotipo esteso implica una
rete di cervelli, interconnessi e cooperativi, sicché la conoscenza è integrata e
distribuita. Questa supermutazione, la cui trattazione esula dagli scopi di questo
libro, è ampiamente discussa da più punti di vista disciplinari e in base a diversi
riferimenti teorici; e dunque rimando qui al dibattito apertosi in tema di
intelligenza collettiva e connettiva tra Pierre Lévy e Derrick de Kerckhove.
In effetti l’interconnessione dei cervelli è una straordinaria trovata evoluzionistica
che ha avuto origine con il linguaggio, si è perfezionata con la scrittura e poi la
stampa e sta prendendo forma con l’avvento della rete e delle tecnologie digitali.
Tutte soluzioni che sono state possibili per lo sviluppo della parte recente del
nostro cervello: la neocorteccia. Ma, come meglio chiariremo, la neocorteccia non
nel contesto dell’evoluzione del comportamento sociale. Si veda anche Dawkins, nella
specifica accezione di gene e meme buoni.
ha affatto sostituito la parte arcaica, la parte più antica del cervello che costituisce
l’eredit{ evoluzionistica che ci congiunge non solo ai primi sapiens ma anche ai
paleominidi e all’antenato ancestrale dei primati e, prima ancora, dei mammiferi e,
ancor prima dei rettili.
Ecco perché sopravviverebbero in noi, al fianco delle sofisticate formulazioni
tecniche e scientifiche, anche tracce profonde di modalità di elaborazione
dell’esperienza che ci sembrano al di fuori del tempo e incomprensibili, come il
credere ai fantasmi, a diavoli ed altre corbellerie, e – come qui si sostiene – perfino
agli dei (Dio compreso). Nel seguito di questa trattazione, si cercherà di
evidenziare l’utilit{ funzionale (per la fitness) di queste rappresentazioni alla luce
della coevoluzione non necessariamente antagonistica tra pensiero religioso e
pensiero scientifico. Per certi aspetti, che saranno meglio chiariti, le idee religiose
hanno creato premesse comunitarie che – a distanza di qualche centinaio di
migliaia di anni – sono oggi alla base della straordinaria avventura evoluzionistica
delle conoscenze umane. Possiamo dire che l’affermazione delle verit{ fattuali
della scienza (falsificabili) deve molto alle false verità assolute che costituiscono il
corpo delle credenze religiose.
Se il cervello si è andato evolvendo nel tempo – a partire da una minore
complessità del sistema nervoso – dobbiamo dunque ancora una volta guardare
lontano per capire quali sono le funzioni basilari che si sono manifestate in modo
sempre più sofisticato tanto da rendere possibili sia le credenze religiose sia lo
sviluppo della comprensione scientifica del mondo.
Gli antenati: vicini e lontani
A differenza delle altre specie che pure manifestano una qualche forma di
consapevolezza del mondo, homo dispone del pensiero razionale e noi ci sentiamo
orgogliosi di attribuirci una profonda comprensione della realtà personale ed
impersonale in cui siamo immersi. Se la più parte delle persone accetta ormai
l’idea di essere parente di altri primati come gli scimpanzé e i bonobo, tuttavia
contrappone a questa verità anche quella di essere diversa dagli altri animali.
L’idea dell’evoluzione della specie, per quanto semplice ed elegante, non è sempre
facilmente digerita; facciamo altresì fatica a riconoscerci nei nostri antenati
paleolitici e ipervalutiamo il gap prodotto dall’innovazione tecnologica e dalla
scienza, sentendoci per questo assolutamente diversi da quei cavernicoli. Qualcosa
di molto simile accade quando osservando le immagini di una popolazione tribale
trasmesse in televisione classifichiamo come incivili quegli individui e, ci
percepiamo diversi in virtù del nostro modo di vivere e dei nostri riferimenti.
La psicologia sociale, così come l’antropologia e la sociologia hanno accumulato
una mole consistente di studi e di ricerche che spiegano questa nostra disposizione
valutativa. In estrema sintesi siamo antropocentrici ed etnocentrici e, ancora più,
gruppo-centrici e autoreferenziali. Noi percepiamo il mondo dal nostro
osservatorio personale e la nostra disponibilità a condividere natura e identità,
idee e opinioni procede per cerchi concentrici. In prima istanza la pensiamo come
noi la pensiamo; poi, allargando il cerchio, condividiamo posizioni ed identità con
gli individui che compongono il nostro gruppo di riferimento. Allargando sempre
più il cerchio ci riconosciamo (e proviamo empatia) per i gruppi che condividono
un’identit{ sovraordinata e così via; ma a ogni livello individuiamo qualcosa o
qualcuno che per differenza (antagonsticamente) ci consente di conferire senso
all’identit{ che ci qualifica. Naturalmente, ai livelli superiori, non notiamo più le
differenze che pur sussistono con altri individui e che erano invece salienti ai livelli
più ristretti. Così bianca o nera che sia la nostra pelle, ci riconosciamo simili se ci
confrontiamo con il gorilla dietro le sbarre dello zoo, anche se non sono mancate e
non mancano le condizioni storiche e culturali che portano a ritenere un individuo
di colore come più vicino al gorilla che a noi. Inevitabilmente l’organizzazione della
nostra conoscenza sociale (social cognition) è impregnata di pregiudizi o, per
meglio dire, si fonda su una capacità di giudizio non esattamente sistematica. Non
conta la verità di ciò che io penso e credo (anche se fondamentalmente riteniamo
che ciò che pensiamo e crediamo sia vero) ma la sua utilità a fini
fondamentalmente egocentrici, gruppo-centrici, etnocentrici e antropocentrici a
secondo delle opportunità locali.
In questa prospettiva possiamo richiamarci al principio fondamentale che regola i
sistemi cognitivi e il comportamento sociale: il principio di economia psichica.
Come recita il titolo di un delizioso film di Woody Allen (Whatever Works): basta
che funzioni!
Gli antichi greci ritenevano che la terra fosse piatta e che il mondo terminasse al
punto segnato dalle cosiddette colonne di Ercole (l’attuale stretto di Gibilterra).
Oggi sappiamo che questo non è vero. Gibilterra spalanca la porta dell’Oceano
Atlantico; al di là dell’oceano abbiamo scoperto con Colombo un nuovo continente
e con lui abbiamo verificato che la terra non è piatta come si credeva. Tutte verità
dimostrate e condivise di cui tuttavia gli antichi greci, come Ulisse, non
necessitavano. Le tecniche di navigazione limitavano le possibilità di spingersi
oltre certi confini e dunque le loro verità e credenze erano sufficienti per fare
quello che era nelle loro possibilità. Dunque, ritenere che la terra fosse piatta e che
terminasse con un baratro insuperabile era una verità che funzionava quanto
bastava. Analogamente quando comunichiamo con le altre persone nell’ambito
della vita quotidiana, noi affermiamo che il sole sorge e tramonta, trascinandoci
dietro un’idea non vera – quella che il Sole è in movimento attorno alla Terra – ma
che, comunque, funziona ai nostri scopi. Non siamo astronomi professionali e
dunque nella realtà quotidiana possono funzionare più che bene tanto le verità
approssimate quanto le idee non veritiere.
La fede aiuta?
Jesse Bering ha rilevato che il grado di paura o ansia rispetto alla morte non
correla un granché con l'intensità della fede religiosa. Essere credenti non influisce
deterministicamente sulla serenità o sul timore con cui gli individui affrontano la
malattia grave e la loro stessa fine. Non è ignoto ai psicoterapeuti come gli
angosciati interrogativi dei credenti sul proprio destino siano spesso aggravati
dalla considerazione che una simile sorte possa toccare loro nonostante la fede e
pur essendo buoni cristiani.2
I credenti devono fare continuamente i conti con il fatto che drammi e malattie
colpiscono le persone senza particolare riguardo per l’intensit{ della fede di chi ne
è toccato.
Come abbiamo altrove evidenziato, aver fede e seguire la legge di Dio dovrebbe
rappresentare uno scudo proprio alla luce dell’esplicita minaccia divina di colpire gli empi
con gravi sciagure.
2
Dio non interviene sulla distribuzione degli incidenti stradali discriminando tra chi
crede e non crede. Lo stesso vale per le malattie oncologiche o gli incidenti
domestici. In un modo o nell’altro qualche guaio tocca alla quasi totalit{ degli
uomini, atei, cristiani, musulmani o politeisti. Pochi se la cavano benissimo e non
sono necessariamente né credenti né non credenti. Questo per quanto attiene
all’esito biologico che, in conclusione, è sempre e comunque la morte.
Perché si crede, allora? Quale vantaggio si rende disponibile a chi crede?
I vantaggi non sono sempre evidenti. I miracoli – anche per chi ci crede - non sono
affatto frequenti.
Si può sperare, ma il costo della speranza è dispendioso, richiedendo rituali
dall’esito incerto.3 Pensate a quante risorse alimentari sono state sacrificate nei
millenni in onore degli dei per impetrare la vittoria o in epoca di carestia proprio
per supplicarne la fine.
Perfino il vantaggio derivante da un miracolo è ben oltrepassato dai costi che ci
accolliamo nel corso della vita. Se il miracolo favorisce un certo fedele che va a
Lourdes, non salva certo tutti gli altri che si sono lì recati in pellegrinaggio né
esenta il presunto miracolato da altri mali ed acciacchi successivi e, infine, dalla
morte.
Il costo per chi vuole credere nella vita dopo la morte è dato da un investimento di
energie e risorse notevoli (in termini di economia psichica e materiale) per
confermare la credenza. Pensare che si è religiosi perché se ne ricava un vantaggio
è, a mio avviso, una chiave interpretativa molto debole. Oltretutto la storia
religiosa è piena di episodi di martirio che non forniscono la migliore
dimostrazione del vantaggio biologico derivante dalla fede. Anzi.
Si potrebbe forse affermare che disporre di tali credenze è un vantaggio perché
limita il lavoro cognitivo necessario per interpretare il mondo e il senso della
nostra vita. Questo perché, come sostengono in maniera esauriente gli studi
cognitivisti e quelli etologici, nessun comportamento sopravvive se non risponde a
un vantaggio.
3
Mi sembra essenziale il detto popolare senza denari non si cantano messe.
E’ altrettanto vero che di fronte al proprio dolore o alla sofferenza dei propri cari
soprattutto i credenti sono indotti a riflettere e perfino tormentarsi,
interrogandosi su quello che certamente non appare come un segno della
benevolenza di dio. La motivazione richiede risultati e questi non sono sempre e
comunque evidenti.
Forse che le persone non sanno apprezzare le statistiche relative agli effetti delle
loro disponibilità religiose?
La teoria della probabilità si può applicare a qualunque credenza: da quella di
poter vincere al superenalotto a quella nell’efficacia della preghiera per ottenere
una grazia. Sappiamo che la mente umana non applica quasi mai correttamente il
ragionamento statistico nel computo delle probabilità di un evento. Il calcolo
statistico impegna risorse mentali superiori a quella che l’uomo della strada
normalmente spende per agire nel quotidiano: sia quando crede di giocare per
vincere o prega per ottenere miracoli.
Ma non c’è solo la visione della persona come economizzatore di risorse (cognitive
miser) a suggerire di considerare debole l’ipotesi del bisogno/desiderio
corrisposto.
Una vincita strepitosa o una guarigione miracolosa sono pur sempre possibili:
varieranno le probabilità relative degli eventi ma se una cosa accade può accadere
anche a me e - come comunemente si dice - tentar non nuoce.
Oppure, le credenze religiose sono il mero prodotto dell’indottrinamento
culturale? Non vi è dubbio che in molti ambienti familiari e comunitari si è immersi
in un clima di intensa devozione capace di imporsi al pari dell’inflessione dialettale
o delle preferenze alimentari. Bering non è dell’avviso che questo sia
determinante. L’ambiente culturale e le pratiche quotidiane possono dare forma ai
rituali e alle credenze ma non spiegano il sentimento religioso.
Bering si è molto dedicato al tema della nascita espressiva del sentimento
religioso, e con i suoi studi ha rilevato che bambini molto piccoli esibiscono segnali
di credenze soprannaturali anche prima di un’effettiva esposizione culturale di
stampo religioso. Abbiamo forse una parte del cervello che è deputata alla fede?
L’ipotesi è stata anche formulata (quella di un gene della religione) ma non
sussistono riscontri per comprovarla. Piuttosto, al pari di Bering, molti studiosi
impegnati nella ricerca cognitiva hanno elaborato e documentato una diversa
interpretazione. L’ipotesi è che sia la religione a trarre vantaggio da una capacità
umana che precede evoluzionisticamente l’affermazione dell’idea di dio e che a sua
volta assicurava un vantaggio per la sopravvivenza. Bruce Hood, riferendosi a una
tale capacità, sostiene specificamente l’ipotesi di un supersenso.4
Non dunque il mero appagamento di un bisogno (la salute, la vita, il superamento
di un esame) ma una credenza basilare nei confronti del sovraumano che,
indipendentemente dalla sua consistenza fattuale, ha svolto soprattutto in passato
un ruolo cruciale a sostegno di molteplici credenze e non solo di quelle a carattere
religioso e che riguarda tutti – in modo variabile, come ogni tratto organismico,
anche coloro che non credono in Dio. Noi saremmo sostanzialmente predisposti
nei confronti di credenze verso entità al di fuori del nostro controllo.
Su cosa si fonda questa predisposizione? Secondo Bering essa è basata sui
meccanismi di inferenza mentale “disegnati” per ragionare sulle menti degli altri.
Se questo è corretto, la tendenza a “credere al sovraumano” dovrebbe emergere e
incrementarsi parallelamente alla capacità del bambino di concepire una teoria
della mente altrui.5
La chiave interpretativa adottata da Bering nel quadro della dinamica psicoevolutiva del bambino è condivisa da altri autori che svolgono ricerche sulle
capacità cognitive che hanno consentito migliori armi di sopravvivenza ai nostri
antenati da cui abbiamo ereditato il supersenso. Non un gene della religione,
dunque, ma geni che ci rendono capaci di percepire quello che noi definiamo il
soprannaturale.
Percepire il mondo
Hood B., Supersenso. Perché crediamo nell’incredibile,Il Saggiatore, 2009
Cf. Bering J., The Cognitive Psychology of Belief in the Supernatural, in “American
Scientist”,
March-April
2006
Volume
94,
Number
2,
http://www.americanscientist.org/issues/feature/the-cognitive-psychology-of-belief-inthe-supernatural
4
5
Per cogliere correttamente il senso di questa affermazione è necessario esaminare
più in dettaglio quanto la ricerca cognitivista e costruttivista ci ha consegnato a
proposito di come funziona la nostra mente.
Noi, al pari di tutti gli organismi (non solo umani) che si affacciano e si sono
affacciati sullo scenario del mondo siamo reciprocamente connotati da piccole e
grandi differenze (variabilità) e siamo immersi in un mondo di estrema
complessità. Ma in che consistono queste differenze e questa varietà. Le differenze
sono nel mondo o si rivelano tali solo ai nostri occhi? Sono io a cogliere queste
differenze e questa variabilità presente nel mondo o siamo noi? E quanto queste
differenze sono attribuibili agli elementi che noi osserviamo? Le formiche sono
uguali o sono diverse? Mi serve distinguere una formica dall’altra? Cogliere una
differenza tra due serpenti simili ma l’uno velenoso e l’altro no, richiede
conoscenze specifiche e queste conoscenze richiedono talvolta una dolorosa
esperienza quale è l’essere morsi e poter verificare se l’esito dei due morsi produce
effetti differenziali. Superare questa esperienza non è sempre possibile (si può
anche morire) e comunque devo aver un interesse assai particolare nel decidere di
comportarmi diversamente con i due serpenti tanto da correre un rischio così
elevato. Può essere più semplice prendere a bastonate i due serpenti senza
interrogarmi granché su eventuali diversità tra i due animali. Ecco che il mio
comportamento tratta allo stesso modo due organismi diversi. Avrò eliminato un
animale innocuo ma sicuramente avrò evitato il rischio di morire. Il vantaggio è
mio e lo svantaggio è tutto dei serpenti. Ecco perché rifuggiamo dai serpenti: è per
noi economico scappare o prenderli a bastonate, indipendentemente dalla letalità
del loro morso. Il comportamento che ho adottato è un comportamento categoriale
che riflette ruolo e funzioni delle categorie: distinguere (differenziazione
intercategoriale) e assimilazione intracategoriale (rendere tutta l’erba un fascio)
Come afferma Gregory Bateson (Mind and nature,1979),“Difference is the root of
information”: la differenza è la radice dell’informazione.
La percezione opera solamente sulla base della differenza: “La mente può ricevere
solo notizie di differenze, è difficile distinguere tra una variazione lenta e uno stato.
Vi è necessariamente una soglia di gradiente sotto la quale il gradiente non può
essere percepito.” (p. 134)… e conclude: “l’informazione consiste in differenze che
producono una differenza (p.135)”6.
La variabilità presente nel mondo determina effetti diversi nella situazione, e
talvolta suggerisce comportamenti diversi: l’esigenza di sapere se il tempo è bello
o brutto è incrementata dall’idea di prenderci un fine settimana fuori citt{. Non
diversamente, per uno squalo sempre a caccia di cibo, le caratteristiche percepite
delle diverse onde prodotte dal movimento in acqua di potenziali prede elicitano
comportamenti specifici e diversi. La sua sopravvivenza da tempi profondissimi
(400 milioni di anni) è dovuta alla sua elevatissima capacità di cogliere sottili
variazioni che fanno la differenza (c’è una preda potenziale che si dibatte in acqua).
Non possiamo rinunciare a cogliere le diversità tra i funghi se siamo nella necessità
di mangiare funghi. Se la nostra sopravvivenza dipende dalla disponibilità di
funghi, impareremo ad apprezzarne le differenze, se non si vuole morire.
La variabilità è il dato empirico, la differenziabilità è un’opportunit{ che può
qualificare il sistema sensoriale-percettivo dell’organismo: alla base di tutto c’è
l’istanza del controllo da parte dell’organismo individuale e dell’organizzazione
sociale per i fini dell’adattamento e della continuit{ dell’esperienza.
Se la variabilità si riconosce nelle modificazioni teoricamente illimitate delle
situazioni e del comportamento, le modificazioni che contano sono quelle per cui
l’organismo è sensibile e che inducono alternative di comportamento valide per
l’organismo; questo è alla base della definizione della categorizzazione come
interazione differenziale e sistematica tra un sistema sensomotorio autonomo e
adattativo ed il suo mondo.7
Questa lettura porta a escludere le interazioni ordinarie tra gli elementi fisici
dell’ambiente ma non i processi d’interazione tra organismi non-umani e ambiente
per cui la categorizzazione è un processo di base, che rivela continuità con il
comportamento animale e con il comportamento pre-linguistico umano.8
Gregory Bateson, Mente e natura, 1984.
Harnad S., Cognition is Categorization, UQaM Summer Institute in Cognitive Sciences on
Categorization, 2003. http://www.ecs.soton.ac.uk/
8 Tuttavia è bene osservare che le categorie (i concetti) sono un prodotto cognitivo
peculiarmente umano e sociale diversamente dal comportarsi categorialmente che è un
6
7
Qui basta indicare che i comportamenti categoriali basilari sono quelli di
attacco/fuga ed evitamento/controllo. È, dunque, a partire dalle esigenze di
discriminazione congruenti con tali comportamenti categoriali che possiamo
comprendere la genesi dei sistemi categoriali più complessi, inclusa l’idea del sacro
e di dio.
Il cardigan dell’assassino
Questa metafora è stata proposta da Bruce Hood (2010) per introdurre il
supersenso.
Si basa sull’osservazione - che tutti noi possiamo condividere - relativa al diverso
comportamento delle persone a contatto di un oggetto inanimato in conseguenza
della persona cui attribuiamo l’oggetto. Hood ha osservato come una penna che è
mostrata dicendo che è appartenuta a Einstein è manipolata dalle persone
(soggetti ingenui) in maniera notevolmente diversa da come viene trattato un
cardigan che si afferma essere stato indossato da un serial killer. Perché? Forse che
quegli oggetti hanno assorbito le caratteristiche dei due ipotetici proprietari? Il
male procurato dal serial killer ha intriso le fibre di lana del cardigan? La scienza di
Einstein è contenuta nel caricatore della penna? Molti fans di artisti e sportivi si
guardano bene dal lavare il capo di abbigliamento intriso di sudore appartenuto al
loro beniamino. Probabilmente lo annusano compiaciuti e lo ripongono
gelosamente sotto il cuscino. Sarebbero disposti a fare lo stesso per una maglietta
appartenuta a un qualsiasi altro artista? Le lettere di una persona amata sono
trattate e manipolate allo stesso modo delle missive pubblicitarie che ci sono
recapitate? Quante persone conservano montagne di opuscoli ecclesiastici e
santini non tanto perché desiderano conservarli ma perché pensano che buttarli,
anche adottando pratiche di smaltimento differenziato, possa produrre effetti
negativi sulla loro vita? Avrete sicuramente molte esperienze di comportamenti
che consideriamo normali ma che evidenziano tratti singolari, come il parlare con
le piante o fare discorsi complicati rivolgendoci al cane e al gatto di casa o
processo discriminativo determinato biologicamente attraverso la selezione naturale.
Questo rende cognitivamente diverso il comportamento della polizia scientifica e quello
dello squalo.
infuriarsi con un elettrodomestico mal funzionante come se fosse capace di reagire
alle nostre imprecazioni e violenze. Noi interagiamo con le cose del mondo come se
avessero la possibilità di percepire le nostre attenzioni e irritazioni. Recentemente
Fogg (2003) ha coniato il termine captologia per spiegare alcuni aspetti cruciali
dell’interazione uomo-computer e la capacità che esso possiede di farci interagire
con lui come se fosse una fonte umana di persuasione.9
Ma perché siamo persuadibili da una macchina? Perché un opuscolo inviatoci da
qualche congrega che ci chiede offerte è capace di non farsi buttare come accade
con altre missive di propaganda politica e ordinaria promozione commerciale? La
risposta è che il cervello interagisce con il campo del reale percepito come se non
solo le persone e gli animali avessero intenzioni ma anche gli oggetti fossero
interpreti o portatori di qualità, energie ed intenzioni a noi favorevoli o avverse.
Il concetto si ricollega a una specifica caratterizzazione che si coglie in alcuni
sistemi di credenza: l’animismo.
Si
richiama
a
tal
L’antropomorfismo
riguardo
consiste
anche
la
tendenza
nell’impregnare
il
ad
antropomorfizzare.
comportamento
reale
o
immaginario di agenti non umani di caratteristiche, motivazioni, intenzioni o
emozioni simili a quelle umane.10
Questa propensione è ampiamente documentata dallo studio delle diverse culture
e religioni.11
Ulteriori testimonianze della tendenza a cogliere un potere nelle cose come agenti
intenzionali o come mediatori di intenzioni umane o soprannaturali sono presenti
nel pensiero magico, nelle superstizioni e nel malocchio.
Tutte queste credenze, propensioni e tendenze sono espressione di un supersenso
che ha svolto un ruolo fondamentale nell’aumentare la fitness a prescindere dalla
loro fondatezza. Come abbiamo precedentemente evidenziato, non importa che un
comportamento sia valido in sé, purché funzioni.
Fogg J.B., Tecnologia della persuasione, Apogeo, 2003
Epley Nicholas, Adam Waytz, John T. Cacioppo, On Seeing Human: A Three-Factor
Theory of Anthropomorphism, Psychol Rev. 2007 Oct;114(4):864-86.
11 Barrett L. Justin, Keil Frank (1996). Conceptualizing a non-natural entity:
Anthropomorphism in God concepts. Cognitive Psychology, 31, 219–247.
9
10
Il cervello del rettile
La nostra specie è il prodotto evoluzionistico che oggi è in virtù del grande
cervello; ma naturalmente il grande cervello è esso stesso un prodotto
dell’evoluzione: in passato si caratterizzava per minori dimensioni e per una
diversa organizzazione funzionale.
Scendendo nel tempo profondo possiamo delineare tale evoluzione a partire dal
cosiddetto cervello olfattivo, denominato anche nucleo rettiliano perché accomuna
mammiferi e rettili. Si tratta di una parte antichissima ma che, ancor oggi, svolge
un ruolo fondamentale nella produzione dell’esperienza emozionale all’interno del
sistema rappresentato dal lobo limbico. Altre sensazioni hanno gradualmente
assunto per noi importanza prevalente ma in origine era soprattutto l’olfatto a
suggerire i comportamenti più idonei ai fini sia alimentari sia della riproduzione
sessuale. Il sistema limbico si è formato nei mammiferi intorno a quel nucleo
primitivo, assumendo gradualmente nuove funzioni. Le emozioni più primitive che
ancor oggi sperimentiamo, come rabbia, paura, passione, hanno lì la loro sede:
nella parte complessivamente definita archicorteccia. Ancora più recentemente –
ma parliamo di centinaia di milioni di anni - intorno all’archicorteccia si sono
sviluppate le aree neocorticali, quelle che consentono alla specie homo di
comunicare attraverso il linguaggio e di poter astrarre e deliberare razionalmente.
Ciò grazie a due specifiche funzioni limbiche: la memoria e l’apprendimento. Ma
proprio in ragione della storia evolutiva del nostro cervello è agevole comprendere
che la neocorteccia non ha fatto altro che aggiungere capacità a un nucleo
primitivo che tuttora è fondamentale per la nostra esistenza, tanto da esserne
frequentemente padrone. Le emozioni più antiche sono generalmente assorbite dai
sentimenti ma non sono certamente scomparse; la neocorteccia ci rende capaci di
progettare la nostra vita nel lungo periodo ma, nella difficoltà improvvisa, il timone
della nave torna in mano all’archicorteccia, al sistema limbico e al cervello
rettiliano, al cui centro si colloca l’amigdala.12 Come sostiene Antonio Damasio la
L’amigdala scatta come un sorta di grilletto neurale e reagisce inviando segnali di
emergenza e tutte le parti principali del cervello; stimola il rilascio degli ormoni che
12
natura avrebbe edificato l’apparato neocorticale non semplicemente alla sommità
dell’apparato subcorticale deputato alla regolazione biologica, “ma anche con
questo e a partire da questo”13. Possiamo dunque riconoscere che tutta
l’architettura neurale ingloba il sistema limbico e comprendere il ruolo
fondamentale – talvolta anche intrusivo - delle emozioni sul pensiero razionale.
Tra gli studiosi più competenti in tema di influenza dei processi emozionali sui
processi cognitivi, Antonio Damasio ha in particolare introdotto l’espressione
marcatore somatico al fine di meglio interpretare il ruolo delle esperienze
emozionali nel comportamento e nelle decisioni volontarie e razionali.
Il marcatore somatico è l'elemento centrale dell'apprendimento emozionale che
abbiamo acquisito nella nostra esperienza precedente: registra e mantiene traccia
delle
nostre
reazioni
emozionali
pregresse
a
determinate
situazioni
e
corrisponderebbe, in un certo senso, ai concetti psicologici di credenza e di desiderio.
Questo meccanismo di scelta – una sorta di decisione di pancia, immediata e
automatica - riesce a collegare la memoria emotiva alle aspettative future,
consentendo di selezionare immediatamente quella che, per la storia dell’individuo, è
l’opzione migliore, anticipando il ben più lungo e macchinoso ragionamento
razionale costi/benefici.14
Molte persone soffrono di attacchi di panico e fobie incontenibili. Altre sono
indotte da se stesse ad agire compulsivamente sviluppando rituali interminabili
per fronteggiare minacce inesistenti e controllare gli eventi. Che cosa le accomuna?
Tutte queste persone sono ben consapevoli che non hanno di fronte nessuna
minaccia reale e che non esiste alcuna buona ragione per comportarsi come si
comportano. Eppure non possono fare a meno di evitare alcuni luoghi e situazioni,
di controllare ossessivamente, ad esempio, un rubinetto del gas sicuramente
chiuso in precedenza o di prodursi in sfibranti rituali di igiene personale e della
casa. Tutte queste persone ben sanno che non sussiste nessun fondamento
innescano la reazione di combattimento o fuga,(Adrenalina, Dopamina, Noradrenalina),
mobilita i centri del movimento, attiva il sistema cardiovascolare, i muscoli e l’intestino.
13 Damasio Antonio, L’errore di Cartesio, Adelphi Edizioni, 1995, p. 189
14 Damasio Antonio, ibidem
razionale nel fare ciò che fanno ma non possono sottrarsi dal farlo. Se non lo
facessero si sentirebbero male, preda di emozioni assolutamente sgradevoli e
coartanti. Ebbene, di fronte alla decisione di procedere o meno nel controllo del
rubinetto del gas, essi rispondono non alla logica della neocorteccia ma ad uno
specifico marcatore somatico elicitato dal loro stesso nucleo rettiliano e limbico e
sottomettono alla paura e all’angoscia che si scatena incontrollata tutte le
consapevolezze e padronanze culturali che pure le qualificano.
Non dobbiamo tuttavia dimenticare, con riferimento a queste consapevolezze e
padronanze culturali, che l’evoluzione ha impegnato milioni di anni per dotarci di
questo nostro cervello e che lo sviluppo culturale e quello tecnologico ci
accompagnano solo da qualche decina di migliaia di anni. Se nelle società attuali le
paure sono sicuramente un ostacolo per il tipo di vita che facciamo, è facile
rendersi conto che nel passato l’essere particolarmente ansiosi poteva costituire
un vantaggio non indifferente ai fini della sopravvivenza. Molti dei comportamenti
che giudichiamo inappropriati nella contemporaneità e che dipendono da una
disposizione emozionale incontrollata, hanno verosimilmente elevato la fitness
degli individui il cui cervello produceva quegli specifici marcatori somatici,
consentendone dunque l’approdo ai nostri giorni.
Come sostiene Damasio, “le emozioni fanno dunque parte del kit biologico di
sopravvivenza di cui l’evoluzione ci ha dotato e che portiamo impresso nel nostro
genoma: sono meccanismi presenti fin dalla nascita o quasi e poco o nulla
dipendenti dall’apprendimento, anche se poi, con il passare del tempo, l’esperienza
ci insegnerà quando e come applicarle”.15
Quali sono le condizioni che attivano il marcatore somatico? La risposta che vale
per l’uomo accomuna, nella prospettiva evoluzionistica, tutti gli organismi con un
sistema nervoso atto a generare informazioni nell’ambito della relazione con
l’ambiente, in particolare tutti gli organismi superiori. Dennett riconduce
quest’attitudine alla capacit{ di discernere il movimento prodotto da altri agenti
nel campo d’interazione vitale. Abbiamo gi{ evidenziato come ogni organismo sia
15
Damasio, ibidem
sottoposto a una costante necessit{ di controllo dell’ambiente-territorio ai fini
dell’istanza alimentare e riproduttiva e che avvicinamento-allontanamento
(ovvero fuga-difesa-attacco) sono i comportamenti categoriali basilari. Questi
comportamenti sono efficaci ai fini della sopravvivenza solo se l’organismo è in
grado di interpretare efficacemente natura e scopi delle variazioni prossemiche. Se
l’organismo agisce in un territorio boscoso, le probabilit{ di sopravvivere sono
tanto maggiori quanto più il suo sistema sensorio percettivo è in grado di
discriminare tra i rumori neutrali (vento, agitarsi delle foglie, ecc.) e quelli che
segnalano un evento potenzialmente pericoloso – perché il cacciatore potrebbe
diventare oggetto di predazione - o vantaggioso, perché potrebbe invece
segnalargli una preda attraverso lo spezzarsi di un ramo, il calpestio del fogliame,
un odore o un verso. Quanto più l’organismo è in grado di discriminare in modo
fine e in tempo utile (cosa dipendente dal sistema percettivo-reattivo, ovvero dal
cervello di cui dispone), tanto maggiori – rispetto
ai consimili - saranno le
probabilità di sopravvivere e riprodursi, trasmettendo attraverso i geni le
caratteristiche vantaggiose alla discendenza. Così funziona la selezione naturale.
Ma questa maggiore capacità di sensibile discriminazione non è priva di costi. In
natura ogni tratto o caratteristica vantaggiosa può essere fonte di un problema. Se
il pavone con la coda più lunga e sgargiante ottiene un vantaggio riproduttivo
perché una coda appariscente lo rende più attraente per le femmine della sua
specie, allo stesso tempo è esposto a maggiori rischi di predazione perché la
grande coda ne rallenta i movimenti e ne riduce la capacità di fuga. Analogamente
la maggiore sensibilità ai segnali ambientali può incidere sulla capacità di
avventurarsi spregiudicatamente nel territorio o di competere audacemente con i
rivali in amore. Anche per gli uomini (e le donne) è così; le persone molto sensibili
sanno bene quanto la loro qualità di cogliere le sfumature emotive e
comportamentali si possa convertire in un handicap in confronto ad individui dalla
sensibilit{ grossolana ma più portati a intraprendere, con l’altro sesso e nella vita. I
dubbi e le esitazioni ti possono portare a non commettere errori ma anche
all’errore di non correre rischi. Come dice il proverbio: chi non risica non rosica.
Per utilizzare l’espressione di Dennett, una Buona Trovata evoluzionistica può
rivelarsi fin troppo buona.16
Justin Barrett (2000) ha denominato HADD (hyperactive agent detection device) un
sistema di riconoscimento di agenti funzionante per eccesso di allerta.17
Damasio e Barrett identificano dunque lo stesso principio evoluzionistico alla base
della sensibilità nei riguardi dei propri stati interni (emozioni) in risposta a
potenziali condizioni di attivazione della risposta idonea (minaccia).
Sebbene, dunque, non c’è in natura una soluzione tanto buona da essere in
assoluto vincente, nella specie umana si è sarebbe ampiamente diffuso un sistema
di allerta molto spiccato, che potremmo definire ridondante rispetto all’ambiente
con una spiccata attitudine a rintracciare agenti potenzialmente pericolosi.
I vantaggi di questa ipersensibilità verso gli agenti sono forse più chiari se
pensiamo a una madre apprensiva. Ella è continuamente in allerta per i possibili
pericoli che potrebbe correre il figlioletto. Appena il piccolo ha qualche decimo di
febbre consulta il pediatra; se non avverte suoni banali provenire dalla sua
stanzetta, corre a verificare e il suo orecchio è sintonizzato a percepirne la
modulazione della voce per capire se è tutto a posto. Le tecnologie favoriscono
questa propensione; la stessa madre può ritenere opportuno montare in casa un
sistema di controllo audio-visivo tra le stanze per non perdere mai di vista il
bambino. Non meraviglierà se ipotizziamo che il bambino potrà a sua volta
manifestare un atteggiamento particolarmente insicuro e tremebondo nel corso
del suo sviluppo psicosociale. È tuttavia probabile che questo eccesso di cautele
potrà favorirne la sopravvivenza più di quanto potrà conseguire un atteggiamento
di ampia confidenza per le sue sorti da parte della madre. Ogni madre sa, infatti,
che è meglio controllare i propri figli piuttosto che lasciar loro fare di testa propria.
Questo principio ha assunto valore soprattutto in un mondo ostile e pericoloso
come quello popolato dai nostri antenati, tenendo conto della debolezza fenotipica
della specie umana, della sua limitata capacità riproduttiva e del prolungato
periodo d’inettitudine che contraddistingue i cuccioli d’uomo. La formazione di
Dennett, p. 117
per approfondimenti si veda: Barrett Justin, Why would anyone believe in God?,
Rowman Altamira, 2004, p. 39 e sgg.
16
17
gruppi familiari e tribali molto coesi deve altresì essere intesa come espressione
della condivisione di un sistema HADD distribuito tra i diversi membri, così come si
riscontra per i suricati.18
Come già prima si accennava, molte fobie e crisi di panico possono intendersi come
risposte marcate somaticamente per effetto HADD. In questo caso la percezione
del pericolo è tanto forte da indurre la persona che così percepisce il mondo e le
relazioni, a sottrarsi alle relazioni stesse e a quelle situazioni che gli fanno
avvertire la minaccia potenziale. Queste persone, più che provare paura, provano
la paura della paura.19
L’animismo è la prima forma culturale che può essere associata all’evoluzione biosocio-culturale della specie così caratterizzata.
Ma per comprendere questa prima tappa culturale dobbiamo comprendere che
l’HADD funziona non solo perché coglie molto sensibilmente la presenza
nell’ambiente di agenti nell’ambiente naturale ma ne interpreta le intenzioni. In
altri termini non è solo importante cogliere una variazione sul fondo sonoro della
foresta in grado di segnalarci la presenza di un agente ma anche coglierne
opportunamente e rapidamente le intenzioni. Milioni di anni di lotte per la
sopravvivenza e di selezione naturale hanno dunque plasmato questa
fondamentale capacità umana: iperattività nel percepire la presenza di agenti e
capacit{ predittiva delle intenzioni dell’agente. Il linguaggio ha ulteriormente
perfezionato il sistema, rendendo possibile un alto livello di dettaglio nel
comunicare la presenza e le caratteristiche degli agenti e la socializzazione
culturale degli indicatori che favoriscono la predittività delle intenzioni. I
pregiudizi sono esattamente l’evoluzione culturale di sistemi HADD ovvero la
diffusione di schemi ad alta sensibilità responsiva in base ad un fattore di
elicitazione verbale (categorie). Avere un pregiudizio marcato significa interagire
con gli altri utilizzando un sistema di allerta spinto che ci induce a evitare qualsiasi
rapporto con chi è identificato come appartenente a una certa categoria sociale: il
pregiudizio implica risposte generalizzate che riducono i costi della valutazione
I suricati sono mammiferi simili alle manguste che vivono in gruppi numerosi
costantemente impegnati a sorvegliare a 360 gradi il loro territorio, generalmente
ergendosi sulle zampe posteriori come vedette ansiose.
19 Nardone Giorgio, Paura, panico, fobie, Ponte alle Grazie, 1993
18
differenziale tra i diversi appartenenti alla categoria. Così, esemplifichiamo, la
madre ansiosa impedirà al bambino di scendere a giocare in cortile perché ha visto
aggirarsi nei paraggi uno zingaro: il suo allerta è scattato in relazione alla categoria
e non alle caratteristiche differenziali dello specifico individuo intravisto nei
paraggi. Potrebbe anche non averlo visto ma, semplicemente, aver saputo che una
vicina infastidita aveva allontanato da casa uno zingaro questuante il giorno prima.
Nel percepire la presenza dell’agente-zingaro, la madre attiva credenze relative
alle intenzioni dell’agente e il suo comportamento si trasmette nell’evitare
qualsiasi opportunità. Ecco il vantaggio dei pregiudizi, per chi li condivide. Magari
gli zingari non sono più nei paraggi e probabilmente non avrebbero rapito il
bambino ma l’HADD suggerisce il contrario: è meglio non rischiare e conservare la
credenza.
La genesi del pensiero religioso
Quando pensiamo alle origini dobbiamo evitare di pensare alla religiosità nella
nostra accezione. Stiamo parlando di un mondo in cui non ci sono istituzioni
religiose e sacerdoti officianti, non ci sono sacre scritture e luoghi di culto edificati,
non ci sono nemmeno divinità quali noi le rappresentiamo e non è stata elaborata
la parola dio. Ci stiamo occupando, piuttosto, di ciò che può costituire un
antecedente della religiosità e del sentimento del sacro. Stiamo parlando di un
mondo in cui avremmo difficoltà, in presenza, a riconoscerci in quei progenitori.
Non è semplice ma, se mi si vuole seguire, questo sforzo è necessario. Stiamo
parlando di un periodo che precede tutte le pur antichissime testimonianze della
cultura preistorica descritte in precedenti capitoli; di un periodo che ci proietta
indietro tra i due e i quattro milioni di anni, ben prima di Neanderthal e di Erectus.
Se, come riteniamo, le risposte emotive di allerta nei confronti di agenti
potenzialmente presenti nell’ambiente naturale precede la stessa affermazione
della capacità linguistica, la comunicazione degli stati di allerta non può che essere
stata affidata ai gesti, ai segni e al paralinguaggio e, in particolare, alla
comunicazione delle emozioni. Questo tipo di comunicazione non consente di
indicare con sufficiente accuratezza la natura della minaccia e le specifiche
intenzioni dell’agente. Una scimmia che inizia a strepitare fornisce un segnale che
elicita nei consimili il marcatore somatico ma che non identifica necessariamente
chi sia l’agente fonte di minaccia né le specifiche intenzioni dell’agente. Il segnale è
dunque di allarme generalizzato. Questa è la base dell’ansia: non la paura ma la
paura della paura.
In un precedente lavoro abbiamo approfondito quest’aspetto indicando le rilevanti
implicazioni differenziali tra l’impatto sulle credenze e sul comportamento di
segnali di pericolo in comunità paleo-umane prive di linguaggio e di comunità
dotate di linguaggio; abbiamo altresì evidenziato le difficoltà connesse alla
possibilità di trasferire con segni rudimentali ad altri individui appercezioni di una
paleo-mente in ordine a minacce riconducibili ad agenti biologicamente
identificabili e non identificabili. Abbiamo delineato questo scenario introducendo
due costrutti originali: meme-serpente e meme-licantropo.
Per chiarire la distinzione devo proporre al lettore di partecipare idealmente a un
noto gioco da ragazzi, quello del mimo. Il gioco consiste nel descrivere un oggetto o
un concetto senza ricorrere a forme linguistiche ma a dei gesti. Se, ipotizziamo,
siete impegnati a descrivere un serpente o il licantropo non vi è alcun dubbio che
trovereste facile il primo compito e più difficile il secondo. Perché? Beh, è piuttosto
semplice simulare il serpente con un braccio fatto strisciare e ondeggiare
all’altezza del suolo e simularne con una mano il morso che si conficca nel
polpaccio di uno dei presenti. Nonostante tutti noi abbiano in mente l’immagine di
un licantropo per via di storie dell’orrore lette e per i numerosi film visti,
rappresentare quest’essere è un po’ più complesso. Non è per niente facile
trasferire all’esterno un’immagine mentale non disponendo del codice linguistico.
Questa seconda tornata del gioco richiede un impegno maggiore e qualche
tentativo andato a vuoto. In tal caso il linguaggio ci manca davvero. Ovviamente
ancor più difficile è rappresentare concetti di elevata astrazione come moralità o
peccato. Il linguaggio, talvolta, è indispensabile. Io credo che il diverso grado di
difficoltà che noi sperimentiamo nel gioco del mimo rifletta le stesse difficoltà che i
nostri antichi predecessori
hanno vissuto per giungere a sviluppare formule
linguistiche (parole) atte a rappresentare agenti naturali, agenti sovrannaturali e
concetti astratti che fossero condivise non tanto foneticamente ma in quanto
rappresentazioni corrispondenti a particolari immagini insediate nella nostra
mente. Come ricorda Damasio, la mente opera per immagini e comunicare richiede
il trasferimento dell’immagine che è presente nella nostra mente nella mente di un
altro individuo.
Anche se non si possiede già un linguaggio comune, arrivare a condividere un
suono per denominare un serpente è piuttosto semplice: basta un suono sibilante,
un onomatopeico, come shhhss.
Ma per descrivere un licantropo? Una parola non può che nascere per ragioni
economiche, ovvero per comunicare un’esperienza o un comportamento
significativo ai fini della soddisfazione dei due principi basilari della vita: risparmio
energetico e probabilità di sopravvivere/fitness. Facile è allora inventare una
parola ma poi bisogna condividerne l’uso e il corrispettivo mentale: l’immagine
reale di ciò che pensiamo. Se l’agente non è identificabile da tutti (visibile,
riconoscibile), le cose sono più complicate. Ancora più complessa è l’edificazione
linguistico-culturale che porta a condividere idee e concetti non facilmente
riconducibili all’ordine naturale come nel caso del licantropo o di “colpa” o
qualsiasi altro concetto riconducibile ad agenti sovrannaturali.
Ricordiamo ancora una volta che la prospettiva evoluzionistica di fronte a qualsiasi
quesito è obbligata a fornire risposte convincenti in termini di vantaggio
riproduttivo: che cosa ne guadagna la fitness?
Possiamo intanto ritenere che linguaggio e produzione concettuale siano
espressione di un processo coevolutivo che si è avviato con lo sviluppo del grande
cervello. Linguaggio e produzioni cognitive fornivano risposte comportamentali
che elevavano la fitness dal momento che incrementavano i vincoli di reciprocità e
le opportunità di cooperazione tra gli individui della comunità. Assicuravano la
cura di gruppo per i cuccioli d’uomo, la distribuzione della sorveglianza distribuita
(quello che ci piace chiamare “effetto suricati”) del territorio e delle sue risorse, la
caccia organizzata, una certa divisione informale dei ruoli, con riferimento alle
diversit{ di genere e all’anzianit{, che vuol dire esperienza-conoscenza.
Meme-serpente
Nel nostro precedente lavoro, abbiamo inteso con l’espressione Meme-serpente
quella classe di memi, parole, moduli di comportamento, (dunque riferimenti
ideografici e relativi all’azione, comunicabili, condivisibili ovvero replicabili
attraverso imitazione) che afferiscono al campo dell’evidenza percettiva speciespecifica. Non ci riferiamo ovviamente al serpente in sé ma a qualsiasi minaccia
naturale in grado di compromettere la nostra integrità e la nostra vita, fonte di
potenziali pericoli e generatore di paura.20
A questa “classe memetica” appartengono tutte le minacce che rientrano nel set di
responsività biologica della specie ovvero che ricadono nello stesso ambito
dell’esperienza fenomenica: l’ordine naturale e le relazioni con l’ambiente possibili
per compatibilità della scala percettiva.21
Partiamo dunque da ciò che è evidente ovvero dall’apparenza che si impone ai
sensi. I memi-serpente, ovvero quelle soluzioni espressive atte ad indicare
efficacemente i possibili pericoli presenti nell’ambiente sono i primi ad affermarsi.
Avere un qualcosa capace di attivare rapidamente la risposta comportamentale a
una minaccia di questa classe è molto vantaggioso sia essa un suono gutturale
specifico, un gesto o una parola. Di fronte alle minacce ricorrenti le esperienze di
contatto cui si sopravviveva avevano un valore enorme. Prevedere le situazioni,
sapere quale comportamento adottare in quei casi era ed è un vantaggio ancora
più grande, soprattutto se è possibile comunicarlo preventivamente o almeno nel
vivo della situazione. Se l’Hadd comporta un costo elevato per l’organismo,
comunicarsi la presenza di minacce attraverso memi-serpente ne innalza la soglia
di attivazione ad hoc e dunque il linguaggio diventa un regolatore dell’ansia molto
vantaggioso. È comune esperienza sentirsi più tranquilli in una situazione intricata
se siamo in compagnia e se possiamo condividere parole di incoraggiamento e
conforto. Se siamo naufraghi in balia delle onde dell’oceano è meglio essere soli o
in due, in tre o più persone? Non ho dubbi, tutti pensano che più si è meglio è,
anche se non esistono reali possibilità di salvezza.
Smiraglia Stanislao, cit.
La percezione fenomenica deriva dalla possibilità di affondare i nostri sensori all’interno
di quella porzione di spazio-tempo che noi percepiamo come il tutto ma che è invece
delimitata dalla portata-capacità dei nostro organi di senso: ci sfugge quello che (per noi)
è estremamente piccolo o estremamente grande, allo stesso modo di ciò che sentiamo
attraverso l’udito, “tagliando” le frequenze più alte (ultrasuoni) e quelle più basse che non
percepiamo come suoni ma come vibrazioni.
20
21
Il meme-serpente è dunque un prototipo di evidenze biologiche che giustificano
l’assunzione di comportamenti imitativi atti a elevare la probabilità della
sopravvivenza biologica stessa. Effettivamente esistono dei pericoli concreti ed
evidenti in presenza dei quali è necessario attivare quei comportamenti speciespecifici (fuga-controllo/attacco-difesa) che hanno permesso nel corso di milioni
di anni la salvezza da tali minacce. Il legame tra geni e memi, qui è chiaro: i geni
“vogliono” sopravvivere, i memi permettono la replicazione di comportamenti
finalizzati a tale sopravvivenza. La realtà (o quello che a noi di essa appare)
fornisce delle informazioni; l’imitazione di comportamenti tramandati ci permette
di reagire nel modo probabilisticamente più efficace: vedo un serpente? So che
devo restare immobile per non essere aggredito oppure che devo fuggire se non
dispongo di strumenti e tecniche di offesa e cattura. E il calcolo della probabilità
agisce (inappropriatamente) anche nella mente dei naufraghi nell’oceano: se si è in
tanti aumenta la probabilità di salvarsi.
E’ stato di grande vantaggio per i gruppi umani impadronirsi imitativamente di
tecniche strumentali (pietre, bastoni, cappi) e disporre del linguaggio atto a
favorire il controllo della situazione (attento! fermo! scappa! colpisci!).
In ultimo possiamo ipotizzare che il meme-serpente abbia rapidamente assunto
un’altra funzione: quella di conferire il potere a chi lo usava. Comunicare allarme è
un modo per trasmettere empaticamente la paura, così influenzando i soggetti
intimoriti anche a proprio personale vantaggio. L’evoluzione ha in questo senso
favorito coloro che “hanno saputo e sanno impaurire bene”, a primario vantaggio
del meme della paura oltre che di se stessi. La cosa interessante, se si condivide
questo assunto, è che il meme della paura non ha bisogno di corrispondere a un
principio di evidenza per funzionare: basta che sia un “buon meme”… esso
funziona anche se non c’è evidenza ovvero se il serpente non si vede perché
semplicemente non c’è.22 Ma come dicevamo – sul piano teorico - è meglio evitare
un serpente che non c’è che incontrare un serpente che c’è.
La credibilità ed affidabilità del soggetto che influenza adottando la strategia della paura
può essere naturalmente verificata. In questa prospettiva, la tecnica del genere “al lupo al
lupo” a lungo andare smette di essere efficace (se il lupo non c’è). Ma questo è vero se
22
In tal senso il meme vincente (il suono, la parola, il gesto, ecc.) che si afferma nel
gruppo è quello che più strettamente è associato all’espressione di emozioni forti
(in questo caso il costo Hadd è giustificato) laddove la disponibilità comunicativa
del meme consente di controllare preventivamente e tempestivamente analoghe
situazioni future.
Meme-licantropo
Per la stessa logica che abbiamo adottato nell’introdurre il meme-serpente, il
meme-licantropo non si riferisce al licantropo in quanto tale, ma a qualunque fonte
di minaccia dello stesso genere riconducibile all’ambiente naturale e antropico ma
non altrettanto evidente.
Del lupo mannaro non vi è alcuna evidenza biologica e, in effetti, esso non compare
in nessuna classificazione di vita biologica dimostrabile. Eppure i memi-licantropo
sono emersi e sopravvivono nell’iconografia e nelle menti. Gli esempi di memi di
questa classe sono pressoché infiniti e sono riconducibili a tutte quelle entità alle
quali si attribuiscono poteri sovrumani: draghi, sirene, fantasmi, streghe, orchi,
sono tra i più noti. I bestiari medievali raccolgono una grande quantità di questi
mostri e figure mitologiche, così come di organismi mutanti. Le rappresentazioni di
quelli che noi potremmo definire i prodotti di mutazioni genetiche possibili nel
quadro del’evoluzione biologica si affiancano a figure semplicemente prodotte
dall’evoluzione memetica: esse sono l’espressione della selezione cumulativa
memetica di attivatori HADD. Se noi ci troviamo nottetempo in una radura o
brughiera illuminata dalla luna piena, non è improbabile che si possa avvertire un
sentimento di smarrimento e sgomento e che, per tale esperienza emozionale, il
meme del lupo mannaro (o di qualcosa che gli somiglia) possa affacciarsi nella
nostra mente “razionale”. Perché? Come mai il meme del licantropo è
sopravvissuto nell’evoluzione culturale (nonostante si sappia che i licantropi non
esistano) e come mai si affaccia nella mia mente, magari perfino più di quanto non
possa avvenire per una minaccia del genere meme-serpente? In una tale situazione
parliamo di lupi (ovvero di una minaccia appartenente alla classe meme-serpente) e non
vale per paure che si collocano al di fuori del principio di verificabilità (ad esempio i
malefici o le pene infernali dopo la nostra morte).
nessuno si sorprenderebbe di essere angosciato più dall’idea di una minaccia
inesistente che di una minaccia reale! Si potrebbe pensare che ciò sia strano,
perché contraddice il principio di evidenza ma gli psicologi ben sanno (e lo sanno
anche le persone che agli psicologi si rivolgono per risolvere i loro problemi) che le
cose che non si conoscono e non si controllano producono timori e angosce anche
superiori alle minacce reali che si possono controllare. Molti ipocondriaci (i malati
immaginari) sono turbati da malesseri che non trovano conferme negli esami
specialistici eppure essi continuano a ricercare la vera causa dei loro mali. Perché?
La risposta è paradossale: proprio perché non c’è un male oggettivo. Scoprire di
avere un male accertato ci consente di curarci e lottare, cosa impossibile se il
medico di fronte a richieste di ulteriori indagini strumentali risponde: a che le
facciamo a fare? Lei non ha niente!
Il meme-licantropo non ha bisogno di essere reale per replicarsi e infatti la storia
delle culture umane è impregnata di testimonianze di presenze arcane
indimostrabili. Non si dimentichi che i memi sono aspetti ideografici e
comportamentali che non hanno niente a che fare con ciò che è necessariamente
vero (nel senso dell’evidenza empirica). Un meme della paura appartenente alla
classe meme-licantropo si può ben riprodurre indipendentemente dalla
consistenza effettiva della minaccia. Ma esso è del tutto indipendente (in senso
evolutivo) dal substrato biologico? Certamente no! In origine, come tutto ciò che
appartiene alla notte dei tempi, anch’esso non può essere emerso se non per
effetto delle determinanti biologiche-organismiche genetiche, ovvero interpretabili
dalla teoria darwiniana della selezione naturale cumulativa. Anche il memelicantropo, al pari del meme-serpente, ha inizialmente contribuito a elevare la
probabilità di sopravvivenza dei gruppi umani, attraverso credenze e
comportamenti in grado di orientare efficacemente le strategie di azione di coloro
che erano sopravvissuti agli eventi critici. O più semplicemente di attivare risposte
di allarme generalizzato in assenza di minacce identificabili. O ancora più
semplicemente come immagini mentali atte a rispecchiare marcatori somatici ad
ampio spettro. Un po’ come succede nel campo degli antibiotici. Se siamo in
condizione di identificare l’agente patogeno che minaccia il nostro organismo, il
medico curante ci suggerisce un antibiotico specifico che agisce selettivamente
sulla flora che abita il nostro organismo. Ma se non abbiamo identificato l’agente
patogeno è possibile che venga adottato un antibiotico che colpirà la massa dei
microrganismi (muoia Sansone con tutti i filistei).
Possiamo immaginare molti scenari e situazioni capaci di fare emergere il memelicantropo e molti di questi scenari sono ben tratteggiati dalla ricerca demoantropologica.23
Per alcuni autori, l’uomo-lupo poteva essere un guerriero la cui minacciosità era
potenziata da vesti e copricapi ricavati da quell’animale, guerrieri feroci dediti a
pratiche cannibaliche, le cui gesta sono state oralmente tramandate fino a
configurarne il mito cinematografico e letterario come noi lo conosciamo, talvolta a
confluire nell’idea di bestia demoniaca. Ma non necessariamente sono queste
creature reali (per quanto spaventevoli) ad aver originato i memi-licantropo: più
probabilmente esse hanno solo dato forma a marcatori somatici privi di
identificatori specifici.
Senza volere approfondire il tema, possiamo sinteticamente riconoscere che il
meme-licantropo rappresenta quella classe di memi capaci di attivare una risposta
adattativa generalizzata (ad ampio spettro) per lo meno all’origine coerente con la
strategia genetica: la sua funzione è comunque quella di indicare alcune
precauzioni da seguirsi per non incappare in concreti pericoli anche se questi
pericoli non sono deterministici. Al meme licantropo, infatti, non corrisponde
quell’evidenza che invece è peculiare per il meme serpente.
È necessario, per altro, operare una digressione in tema di paura e di pericolo,
soffermandoci sul concetto della “sicurezza” come condizione in cui l’individuo
realizza l’esperienza personale di elevato controllo sull’ambiente.
Il pericolo è una costante della vita biologica nella relazione tra organismo e
ambiente. La generalità degli organismi più complessi ha sviluppato sensori di
pericoli incombenti in forma di dolore e poi di paura. La paura è il corrispettivo
emozionale (segnale interno o propriocettivo) del pericolo suggerito dal dolore, che
ha la funzione di attivare la risposta motoria tendente a controllare la minaccia e a
evitarla ai fini della sopravvivenza. Per essere più precisi: la morte è una forma di
Durand G., Strutture antropologiche dell'immaginario. Introduzione all'archetipologia
generale, Dedalo, Bari 1995.
23
shock organismico estremo e il dolore ne è il primo precursore. Provare dolore è
un vantaggio biologico perché il dolore suggerisce una risposta immediata al fine
di sottrarsi alla morte. Ma la selezione naturale ha anche favorito quegli organismi
che hanno sviluppato la capacità di anticipare il dolore oltre che la morte. Ecco il
vantaggio rappresentato dalla paura: evitare il dolore, prima ancor che evitare la
morte.
Possiamo dunque pensare all’ansia - in quanto paura generalizzata - come
prodotto evoluzionistico tendente ad evitare la paura ed infatti l’ansia l’abbiamo
definita come paura della paura. Ma l’ansia ha un costo molto elevato perché in
assenza di un agente identificabile richiede all’individuo un costante stato di
allerta, incompatibile con le istanze di procacciamento del cibo e di ricerca del
partner. Le persone ansiose sanno molto bene di che cosa sto parlando. La vita per
un ansioso è pressoché impossibile: l’ansia limita la capacit{ produttiva e
soddisfacenti relazioni interpersonali, dal momento che assorbe tutte le energie
mentali e anche quelle fisiche, risucchiate il più delle volte da estenuanti rituali.
Diciamo subito quali sono le nostre ipotesi: i memi-serpente rispondono alla
funzione di regolazione della paura (l’antibiotico specifico), i memi-licantropo
sono il prodotto che la coevoluzione biologico-culturale ha reso disponibile in
risposta all’ansia (l’antibiotico ad ampio spettro).
Riepiloghiamo i passaggi essenziali. I memi sono istruzioni di comportamento che
si riproducono attraverso i cervelli e attivano comportamenti umani che
attualizzano quelle istruzioni. Il meme-serpente è un’istruzione del genere: nonmettere-le-mani-dentro-quel-varco-sotto-le-pietre oppure: quando-cammini-nelbosco-utilizza-un-bastone-per-smuovere-gli-arbusti-sul-tuo-cammino.
Il meme-serpente rinforza anche la nostra risposta aggressiva nei confronti
dell’estraneo come è peculiare della propaganda di guerra. Se categorizziamo
l’altro da noi come “viscido serpente”, attiveremo la risposta aggressiva che fa
parte dei moduli comportamentali innescati da questo tipo di istruzione: schiacciala-testa-al-nemico. Estremamente valido, no? Disporre di memi-serpente ci
consente di regolare le risposte di allarme evitando la condizione HADD. In ogni
caso, il processo di elaborazione cognitiva diventa sbrigativo ed economico,
adeguato a regolare la conformità delle grandi masse di individui che dalla
preistoria alla storia attraversano il palcoscenico della vita.
Anche il meme-licantropo, lo abbiamo anticipato, ha una sua utilità: esso ci
suggerisce
di
non
avventurarci
troppo
disinvoltamente
in
un
luogo
apparentemente tranquillo perché ci potrebbero comunque essere dei pericoli
imprevedibili
ovvero:
“non-avventurarti-nella-brughiera-anche-se-c’è-la-luna-
piena-e-ti-sembra-di-vedere-benissimo”.
Tuttavia, ed è qui la differenza cruciale, il meme-licantropo rivela molta parte
dell’indipendenza della traiettoria evolutiva dei memi rispetto a quella dei geni,
un’indipendenza superiore a quella del meme-serpente. Il meme-licantropo,
ribadiamo, indica qualcosa che sfugge al controllo umano altamente finalizzato e
che attiva ansie a cui non corrisponde la possibilità di controllo specifico
sull’ambiente. Il meme-licantropo evoca una risposta la cui specificità è minore di
quella attivata dal meme-serpente: una minaccia c’è ma la risposta non è attivabile
se non in forma propiziatoria, simbolica oppure, al contrario, in termini di
evitamento ma, comunque, non in termini diretti alla risoluzione della causa
evidente. Ma come suggerisce Henry Laborit un organismo è un sistema
programmato per l’azione. La morte è la massima condizione di
inibizione dell’azione ma sono nefaste per un organismo anche le conseguenze
delle azioni inibite.
"Per noi, la causa prima dell'angoscia è l'impossibilità di realizzare l'azione
gratificante, e sottrarsi a una sofferenza con la fuga o la lotta è anch'esso un modo
di gratificarsi, quindi di sfuggire all'angoscia."24
Da qui la propensione a ricercare minacce e mali generalizzati e, meglio ancora, a
identificare una qualsiasi origine del male tra le molte minacce possibili; il memelicantropo si riferisce a una risposta qualsiasi che produce un effetto
probabilisticamente indifferente ma nello stesso tempo significativo perché
prodotto da un’azione regolata. Per attenerci all’idea del meme-licantropo, si
rifletta sulla strategia della collana di aglio appesa alla porta e alle finestre della
povera casa nel bosco. Non serve a nulla? Non condivido affatto questa banale
24
Laborit Henry, Elogio della fuga, Mondadori, 1990
conclusione: chi può contestare sul piano statistico la contro-obiezione che grazie
alla collana d’aglio quella casa non è mai stata oggetto di aggressioni da parte di un
licantropo? La vostra ulteriore replica basata sull’idea che la casa non sarebbe
stata oggetto di minaccia da parte del licantropo anche senza treccia d’aglio vale
quanto quella del nostro primitivo abitante del bosco che afferma che è l’aglio ad
aver impedito l’avvicinarsi del mostro. Nessuna delle due credenze è in grado di
essere falsificata a meno di non voler correre il rischio di essere aggrediti dal
licantropo. E non si vede perché, se l’aglio funziona, bisogna correre un rischio
mortale. Dunque la credenza dell’aglio sopravvive e si diffonde.
Ciò che conta è che una qualsiasi risposta comportamentale sia replicata con un
grado di successo sufficiente a farla apparire come la risposta efficace (ricordiamo
che successo significa semplicemente che gli interpreti delle istruzioni memiche
sopravvivano). In alcuni casi queste risposte aspecifiche possono senz’altro aver
prodotto risultati importanti e reali per la sopravvivenza degli uomini (come nel
caso dei rimedi naturali che hanno aperto poi la strada alla farmacologia moderna)
ma non c’è dubbio che queste pratiche che noi consideriamo efficaci sono state
selezionate attraverso una quantità sterminata di prove ed errori ritenute scelte
valide, finché gli individui che le hanno messe in atto hanno avuto la ventura di
sopravvivere e di tramandare i memi che ritenevano essere la base della loro
stessa sopravvivenza.25
Nella pratica medica, un magnifico esempio è rappresentato dalla metodica del salasso
in base alla quale si toglieva sangue a pazienti affetti da patologie diverse fino anche a
produrne la morte, in base alla convinzione che togliere il sangue stagnante o malato
avrebbe di per sé restituito la salute. Tale credenza, ovviamente infondata, è perdurata
fino alle soglie del XX secolo a dimostrazione che una credenza può perdurare anche se
inefficace e svantaggiosa per l’individuo e i geni.
25
Scarica