© 1959 Rizzoli Editore, Milano
© 1994 RCS Libri S.p.A., Milano sulla collana storia d’italia
© 2001 RCS Collezionabili S.p.A., Milano sulla presente edizione
storia d’italia
Pubblicazione periodica settimanale
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 197 del 9.4.1994
Direttore responsabile: Gianni Vallardi
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa
n. 00262 vol. III Foglio 489 del 20.9.1892
SOMMARIO
Cronologia
CAPITOLO PRIMO
Ab Urbe condita
CAPITOLO SECONDO
Poveri etruschi
CAPITOLO TERZO
I re agrari
CAPITOLO QUARTO
re mercanti
CAPITOLO QUINTO
Porsenna
CAPITOLO SESTO
SPQR
CAPITOLO SETTIMO
Pirro
CAPITOLO OTTAVO
L’educazione
CAPITOLO NONO
La carriera
CAPITOLO DECIMO
Gli dèi
CAPITOLO UNDICESIMO
La città
CAPITOLO DODICESIMO
Cartagine
CAPITOLO TREDICESIMO
Regolo
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
Annibale
CAPITOLO QUINDICESIMO
Scipione
CAPITOLO SEDICESIMO
“Graecia capta”
CRONOLOGIA
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI, CULTURALI
E ARTISTICI
XI sec. a.C. Si diffonde nella penisola italica l'uso
del ferro; calano dal nord migrazioni di latini, di
umbri, di sabini, seguiti dagli etruschi; nel Lazio
prende sviluppo la città di Alba Longa.
Dal X al III sec. a.C. I popoli italici parlano
l'etrusco, il latino, l'osco, l'umbro, dialetti di cui
avanzano scarsi e oscuri monumenti epigrafici,
nonché il greco nelle colonie della Magna Grecia.
Nell'Italia centrale e particolarmente a Roma, il
carattere dell'architettura, fino al secolo IV, è
ancora completamente etrusco (il Foro, la cinta
difensiva dell'Arce Capitolina e dei Palatino, le
mura serviane, il carcere Mamertino o Tulliano, il
tempio di Giove Capitolino ecc.).
IX sec. Vengono fondate dai fenici numerose
colonie sulle coste del Mediterraneo; tra queste è
Cartagine (841 a.C.).
VIII-VI secc. I greci stanziano nell'Italia
meridionale e in Sicilia numerose colonie
(Taranto, Sibari, Reggio, Catania, Siracusa,
Agrigento, Napoli, Cuma ecc.), il complesso
cosiddetto della Magna Grecia.
753, 21 aprile Data tradizionale della fondazione
di Roma sul Palatino.
753-600 ca. Periodo dei re agrari; la leggenda ha
tramandato i nomi di Romolo (con l'episodio del
ratto delle sabine, la guerra tra romani e sabini,
guidati da Tito Tazio, l'episodio di Tarpeia),
Numa Pompilio, Tullo Ostilio (conquista di Alba
Longa ed episodio degli Orazi e Curiazi) e Anco
Marzio.
600-509 Periodo dei re mercanti etruschi:
Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il
Superbo.
VIII-VII secc. In Roma, Romolo istituisce il
senato, Numa Pompilio fissa le norme religiose,
Anco Marzio fonda Ostia e costruisce il primo
ponte di legno sul Tevere, il ponte Sublicio.
VI sec. In Roma, Tarquinio Prisco fonda il circo
massimo ai piedi del Palatino, sul luogo del ratto
delle sabine (sarebbe stato terminato in muratura
soltanto nel II sec.), costruisce la cloaca massima,
dà inizio alla costruzione del tempio di Giove
Capitolino; a Servio Tullio è attribuita una nuova
costituzione fondata sul censo e sulla divisione dei
cittadini in classi e in centurie, nonché la
costruzione di una cinta di mura (le mura serviane,
i cui avanzi sorgono di fronte alla stazione
Termini).
594 Riforma di Solone in Atene.
540 ca. Etruschi e cartaginesi vincono in battaglia
navale i greci e si assicurano il predominio del
Mediterraneo occidentale.
509 Cacciata dei re e istituzione della repubblica
consolare; guerra contro gli etruschi (episodi di
Porsenna e Muzio Scevola, Orazio Coclite,
Clelia).
510 Trattato tra Roma e Cartagine.
509 In Roma, con la cacciata dei Tarquini è
istituita la repubblica e la magistratura annuale dei
consoli.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI, CULTURALI
E ARTISTICI
500-479 Nel Mediterraneo orientale ha luogo la
guerra tra le città greche e i persiani: 490, battaglia
di Maratona; 480, battaglia di Salamina; 479,
vittorie greche di Platea e di Micale. Comincia la
grande ascesa di Atene.
509-507 In Atene è condotta a termine da
Clistene la riforma democratica.
493 Secessione della plebe sull'Aventino (episodio
di Menenio Agrippa); istituzione dei tribuni della
plebe. Trattato tra romani e latini (foedus
cassianum).
484 Aulo Postumio erige nel Foro il tempio di
Castore e Polluce per adempiere a un voto del
padre fatto durante la guerra contro i latini Il
tempio è tra gli avanzi più caratteristici dei Foro
romano.
471 Viene emanata la lex publilia sull'istituzione
dei tribuni della plebe.
451-449 Biennio del decemvirato istituito in
Roma per fissare per iscritto il diritto
consuetudinario; pubblicazione delle XII tavole
(episodio di Appio Claudio e di Virginia).
450 ca. Vengono pubblicate le leggi delle XII
tavole.
447 È istituita la questura per l'amministrazione
dell'erario.
445 Il tribuno Caio Canuleio fa approvare la lex
Canuleia che permette il matrimonio tra patrizi e
plebei.
443 Cominciano a essere nominati i censori,
incaricati di vigilare sul costume e di redigere le
liste dei cittadini secondo il censo.
431-404 Lotta in Grecia per la supremazia tra
Sparta e Atene (guerra peloponnesiaca): tramonto
della grandezza ateniese.
406-396 Roma combatte contro Veio una guerra
decennale che termina con la vittoria romana
(Furio Camillo). Con la caduta di Veio e la
contemporanea calata dal nord di migrazioni
galliche, termina nella valle padana la supremazia
etrusca.
386 Disfatta romana sull'Allia da parte dei galli
guidati da Brenno e sacco di Roma. Ritirata dei
galli.
443-429 In Atene fiorisce l'età di Pericle.
421 I plebei ottengono l'ammissione alla carica di
questori.
IV-II secc. Età dell'ellenismo alessandrino. Centri
di diffusione della cultura greca sono Alessandria
d'Egitto, Rodi, Antiochia, Pergamo ecc.
387 ca. Risale a questi anni un altro dei più antichi
monumenti romani rimasti: il carcere Mamertino o
Tulliano, dove due secoli dopo sarebbero stati
uccisi Giugurta, i complici di Catilina e
Vercingetorige; secondo una tradizione cristiana,
vi sarebbe stato rinchiuso anche San Pietro.
367 Risalirebbe a questo anno la costruzione, per
opera di Furio Camillo, dei tempio della
Concordia, di cui restano avanzi tra il Foro e il
Campidoglio.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI, CULTURALI
E ARTISTICI
367-366 Promulgazione delle leggi Licinie-Sestie
sulla riduzione dei debiti, la questione agraria
(limitazione dei fondi a cinquecento iugeri) e
soprattutto l'ammissione dei plebei al consolato.
348 Secondo trattato di Roma con Cartagine.
343-341 Prima guerra sannitica.
366 Gli edíli curúli sono incaricati della vigilanza
dei mercati, la manutenzione degli edifici pubblici
(aedes) e il mantenimento dell'ordine urbano.
340-338 Guerra contro i latini.
338 In Grecia, Filippo II il Macedone, con la
battaglia di Cheronea, estende l'egemonia
macedone sulle libere città greche.
336-323 Il figlio di Filippo II, Alessandro Magno,
conquista l'oriente e vi diffonde la civiltà greca.
329 I romani assoggettano i volsci.
327-304 Seconda guerra sannitica; episodio delle
forche caudine (321).
298-290 Terza guerra sannitica. Occupazione
romana di Boviano, capitale dei sanniti, e vittoria
di Sentino; episodio di Decio Mure (295).
312 Il censore Appio Claudio apre la via Appia da
Roma a Capua (la strada sarebbe stata prolungata
fino a Benevento nel 190 e successivamente fino a
Taranto e a Brindisi). Per la sua importanza fu
detta regina viarum. Appio Claudio inaugura il
primo acquedotto.
III sec. Da un membro non identificato della
famiglia Aurelia viene aperta la via Aurelia, da
Roma fino a Luni, presso Sarzana. La strada
sarebbe stata successivamente prolungata fino a
Genova e al Varo (109) e quindi fino ad Arles.
Viene aperta la via Salaria, così detta per il
commercio del sale esercitato dai romani coi
sabini.
Si comincia a parlare anche della via Nomentana,
per Nomentum (Mentana).
A ultimata la via Tiburtina, da Roma a Tivoli e
quindi, col nome di via Valeria, fino all'Adriatico.
Comincia l'influenza dell'architettura greca nella
costruzione dei monumenti. Oltre il tufo, ora
vengono usati il peperino (pietra vulcanica dei
colli Albani) e il travertino (calcare ricavato a
Tivoli e nella valle tiberina).
EVENTI POLITICI
E MILITARI
283 Guerra contro i galli senoni e fondazione di
Senigallia. Tutta l'Italia centrale è romana.
281 Sul Mediterraneo orientale si stabiliscono le
monarchie dei generali di Alessandro Magno:
quella di Macedonia, quella dell'Asia anteriore e
quella dell'Egitto, quest'ultima sotto la stirpe dei
Tolomei.
280-273 Guerra tarantina: 280, prima vittoria di
Pirro a Eraclea; 279, seconda vittoria di Pirro ad
Ascoli Satriano. Episodio di Cainea e di Appio
Claudio Cieco; 278-76, guerra di Pirro in Sicilia in
difesa delle colonie greche contro Cartagine; 275,
Pirro viene sconfitto a Benevento; 272, caduta di
Taranto; 270, i romani conquistano Reggio. Il loro
dominio viene ad estendersi così per 130.000
chilometri quadrati, con una popolazione di oltre
tre milioni e mezzo e la possibilità di reclutare in
armi trecentomila uomini.
264-241 Prima guerra punica: 260, vittoria romana
di Caio Duilio nella battaglia navale di Milazzo;
256, i romani sbarcano in Africa; 255, il corpo di
spedizione viene sconfitto dal generale spartano
Santippo, comandante dell'esercito di Cartagine;
249, sconfitta romana in battaglia navale davanti a
Trapani e tentativi falliti di pace (episodio di
Attilio Regolo); 242, vittoria romana di Lutazio
Catulo alle isole Égadi.
238-233 La Corsica e la Sardegna diventano
romane; vengono assoggettati i popoli liguri.
EVENTI CIVILI, CULTURALI
E ARTISTICI
287 Viene promulgata la lex Hortensia sulle
prerogative dei tribuni della plebe e il
riconoscimento delle deliberazioni dei comizi
plebei (che fino allora avevano richiesto la
sanzione del senato). É la più democratica delle
riforme repubblicane.
280 Appío Claudio Cieco, contro le proposte di
pace di Pirro, pronuncia la prima grande orazione
ricordata dagli storici romani, dopo il leggendario
apologo di Menenio Agrippa.
269 Si cominciano a coniare monete d'argento; la
zecca è posta nel tempio di Giunone Moneta (cioè
ammonitrice).
254 Nasce a Sarsina Tito Maccio Plauto, il più
grande commediografo latino. Di lui restano venti
commedie.
240 Livio Andronico presenta il primo dramma
greco tradotto in latino. Da questo momento inizia
tradizionalmente la letteratura romana.
239 ca. Nasce a Rudiae Quinto Ennio, autore
degli, Annales, in cui sono usati per la prima volta
i versi esametri dattilici.
237 Cartagine conquista la Spagna.
235 Gneo Nevio fa rappresentare la sua prima
opera drammatica. Successivamente compone il
Bellum Punicum.
225 I galli vengono definitivamente battuti a
Talamone.
222 Conquista romana di Milano e fondazione
delle colonie di Piacenza e Cremona.
234-149 Si svolge la vita e l'opera di Marco
Porcio Catone il Censore, autore delle perdute
Origines, la prima o pera storica in latino, di
orazioni e del trattato di Agricoltura rimasto.
221 Il censore C. Flaminio costruisce il circo
Flaminio.
Sorgeva sotto l'attuale palazzo Cenci.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI, CULTURALI
E ARTISTICI
219 Il generale cartaginese Annibale Barca
conquista e distrugge Sagunto, città sull'Ebro
alleata di Roma.
220 ca. Caio Flaminio conduce a termine la via
Flaminia che da Roma raggiunge l'Adriatico a
Fano e termina a Rimini, nel punto dove poi
sarebbe sorto il rimasto Arco di Augusto e
avrebbe preso inizio la via Emilia.
218-201 Seconda guerra punica: 218, Annibale
attraversa le Alpi e batte i romani al Ticino e alla
Trebbia; 217, i romani sono nuovamente sconfitti
presso il lago Trasimeno. Nominato dittatore,
Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore
trattiene Annibale lontano da Roma; 216, 2
agosto, Annibale infligge ai romani, presso Canne
di Puglia, la più terribile disfatta della loro storia.
Tuttavia si ritira a Capua; 216-204, Annibale
attende inutilmente rinforzi da Cartagine per
riprendere la guerra; 212, i romani conquistano
Siracusa (morte di Archimede); 211, riconquistano
Capua; 207, un esercito cartaginese, comandato da
Asdrubale, fratello di Annibale, scende in Italia
ma viene fermato e distrutto sul Metauro da Livio
Salinatore e Claudio Nerone; 215-205, guerra e
pace con Filippo V di Macedonia, alleato di
Annibale; 204, Scipione porta l'esercito in Africa e
Annibale è così costretto a lasciare l'Italia; 202,
Annibale viene battuto da Scipione a Zama; 201,
pace con Cartagine. Roma è padrona del
Mediterraneo centro-occidentale.
197 Vittoria romana a Cinocefale contro Filippo V
di Macedonia.
196 Il console Flaminino annuncia la libertà alle
città greche durante i giochi istmici nello stadio di
Corinto Rivolta di schiavi in Etruria
220 Nasce a Brindisi Pacuvio, pittore e autore di
tragedie andate,perdute.
III-II secc. Fiorisce il mimo, che acquisterà dignità
letteraria al tempo di Cesare. L. Cincio Alimento
scrive in greco una storia di Roma andata perduta.
Risale a questi anni anche la storia di Roma di
Quinto Fabio Pittore, pure in greco e pure andata
perduta.
II sec. Fiorisce in Roma il circolo ellenistico degli
Scipioni, intorno a Scipione Emiliano e a Caio
Lelio; lo frequentano il filosofo greco Panezio, lo
storico greco Polibio e lo scrittore di satire
Lucilio. Si comincia a usare nelle costruzioni la
tecnica del getto di cemento (malta di calce e
pozzolana).
Il censore Marco Emilio Scauro costruisce il ponte
Milvio.
195-190 Guerra contro Antioco III di Siria
(battaglia di Magnesia, 190). Roma è padrona
dell'intero Mediterraneo.
186 Nuova rivolta di schiavi in Apulia.
195 (o 185) - ? Vive e opera il poeta comico
Publio Terenzio Afro, di cui avanzano sei
commedie; è considerato il capostipite del teatro
borghese.
187 Emilio Lepido costruisce la via Emilia, da
Rimini fino a Piacenza, poi prolungata a est verso
Aquileia -e a ovest fino ad Aosta.
180 (o 148) Nasce a Suessa Aurunca Gaio Lucilio,
iniziatore della satira latina.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
171-168 Guerra contro Pèrseo di Macedonia
(figlio di Filippo V) e sua disfatta a Pidna.
EVENTI CIVILI, CULTURALI
E ARTISTICI
179 Emilio Lepido comincia la costruzione dei
ponte Emilio, primo ponte in pietra, poi rovinato.
Oggi ponte Rotto.
170 Nasce a Pesaro Lucio Accio, autore di
tragedie andate perdute.
149-146 Terza guerra punica. Cartagine è presa,
distrutta e i cartaginesi dispersi nei mercati di
schiavi.
160 Polibio di Megalopoli (202-120), il grande
storico greco, comincia a scrivere le Storie,
grandioso affresco in quaranta libri (ne avanzano
cinque) sulle vicende di Roma dalla prima alla
terza guerra punica.
148 La Macedonia diventa provincia romana.
146 Corinto è distrutta e la Grecia diventa
provincia romana col nome di Acaia.
146 Viene aperta la via Egnazia, da Durazzo a
Tessalonica.
CAPITOLO PRIMO
AB URBE CONDITA
NON sappiamo con precisione quando aRoma furono istituite le prime scuole
regolari, cioè “statali”. Plutarco dice che. nacquero verso il 250 avanti Cristo, cioè circa
cìnquecent’anni dopo la fondazione della città. Fino a quel momento i ragazzi romani erano
stati educati in casa, i più poveri dai genitori, i più ricchi da magistri, cioè da maestri, o
istitutori, scelti di solito nella categoria dei liberti, gli schiavi liberati, che a loro volta erano
scelti fra i prigionieri di guerra, e preferibilmente fra quelli di origine greca, che erano i più
colti.
Sappiamo però con certezza che dovevano faticare meno di quelli di oggi. Il latino
lo sapevano già. Se avessero dovuto studiarlo, diceva il poeta tedesco Heine, non avrebbero
mai trovato il tempo di conquistare il mondo. E quanto alla storia della loro patria, gliela
raccontavano press’a poco così:
Quando i greci di Menelao, Ulisse e Achille conquistarono Troia, nell’Asia
Minore, e la misero a ferro e a fuoco, uno dei pochi difensori che si salvò fu Enea,
fortemente “raccomandato” (certe cose usavano anche a quei tempi) da sua madre, ch’era
nientepopodimeno che la dea Venere-Afrodite. Con una valigia sulle spalle, piena delle
immagini dei suoi celesti protettori, fra i quali naturalmente il posto d’onore toccava alla
sua buona mamma, ma senza una lira in tasca, il poveretto si diede a girare il mondo, a
casaccio. E dopo non si sa quanti anni di avventure e disavventure, sbarcò, sempre con
quella sua valigia sul groppone, in Italia, prese a risalirla verso nord, giunse nel Lazio, vi
sposò la figlia del re Latino, che si chiamava Lavinia, fondò una città cui diede il nome
della moglie, e insieme a costei visse felice e contento tutto il resto dei suoi giorni.
Suo figlio Ascanio fondò Alba Longa, facendone la nuova capitale. E dopo otto
generazioni, cioè a dire qualche duecento anni dopo l’arrivo di Enea, due suoi discendenti,
Numitore e Amulio, erano ancora sul trono del Lazio. Purtroppo sui troni in due ci si sta
stretti. E così un giorno Amulio scacciò il fratello per regnare da solo, e gli uccise tutti i
figli, meno una: Rea Silvia. Ma, perché non mettesse al mondo qualche figliolo cui potesse,
da grande, saltare il ticchio di vendicare il nonno, la obbligò a diventare sacerdotessa della
dea Vesta, vale a dire monaca.
Un giorno Rea, che probabilmente aveva una gran voglia di marito e si rassegnava
male all’idea di non potersi sposare, prendeva il fresco in riva al fiume perché era un’estate
maledettamente calda, e si addormentò. Per caso in quei paraggi passava il dio Marte che
scendeva sovente sulla terra, un po’ per farvi qualche guerricciola, ch’era il suo mestiere
abituale, un po’ per cercare delle ragazze, ch’era la sua passione favorita. Vide Rea Silvia.
Se ne innamorò. E senza nemmeno svegliarla, la rese incinta.
Amulio, quando lo seppe, si arrabbiò moltissimo. Ma non la uccise. Aspettò
ch’essa partorisse non uno, ma due ragazzini gemelli. Poi li fece caricare su una
microscopica zattera che affidò al fiume perché se li portasse, sul filo della corrente, fino al
mare, e lì li lasciasse affogare. Ma non aveva fatto i conti col vento, che quel giorno spirava
abbastanza forte, e che condusse la fragile imbarcazione a insabbiarsi poco lontano, in
aperta campagna. Qui i due derelitti, che piangevano rumorosamente, richiamarono
l’attenzione di una lupa che corse ad allattarli. Ed è perciò che quella bestia è diventata il
simbolo di Roma, che dai due gemelli poi fu fondata.
I maligni dicono che quella lupa non era affatto una bestia, ma una donna vera,
Acca Larentia, chiamata Lupa per via del suo carattere selvatico e delle molte infedeltà che
faceva a suo marito, un povero pastore, andandosene a far l’amore nel bosco con tutti i
giovanotti dei dintorni. Ma forse non sono che pettegolezzi.
I due gemelli succhiarono il latte, poi passarono alle pappine, poi misero i primi
denti, ricevettero il nome l’uno di Romolo, l’altro di Remo, crebbero, e alla fine seppero la
loro storia. Allora tornarono ad Alba Longa, organizzarono una rivoluzione, uccisero
Amulio, rimisero sul trono Numitore. Eppoi, impazienti di far qualcosa di nuovo come tutti
i giovani, invece di aspettare un regno bell’e fatto ‘ dal nonno, che certamente gliel’avrebbe
lasciato, andarono a costruirsene uno nuovo un po’ più in là. E scelsero il punto in cui la
loro zattera si era arenata, in mezzo alle colline fra cui scorre il Tevere, quando sta per
sfociare in mare. Qui, come spesso succede tra fratelli, litigarono sul nome da dare alla
città. Poi decisero che avrebbe vinto chi avesse visto più uccelli. Remo, sull’Aventino, ne
vide sei. Romolo, sul Palatino, ne vide dodici: la città si sarebbe dunque chiamata Roma.
Aggiogarono due bianchi buoi, scavarono un solco, e costruirono le mura giurando di
uccidere chiunque le oltrepassasse. Remo, di malumore per la sconfitta, disse che erano
fragili e ne ruppe un pezzo con un calcio. E Romolo, fedele al giuramento, lo accoppò.con
un colpo di badile.
Tutto ciò, dicono, avvenne settecentocinquantatre anni prima che Cristo nascesse,
esattamente il 21 aprile, che tuttora si festeggia come il compleanno della città, nata, come
si vede, da un fratricidio. I suoi abitanti ne fecero l’inizio della storia del mondo, fin quando
l’avvento del Redentore non ebbe imposto un’altra contabilità.
Forse anche i popoli vicini facevano altrettanto: ognuno di, essi datava la storia del
mondo dalla fondazione della propria capitale, Alba Longa, Rieti, Tarquinia, o Arezzo che
fosse. Ma non riuscirono a farselo riconoscere dagli altri, perché commisero il piccolo
errore di perdere la guerra, anzi le guerre. Roma invece le vinse. Tutte. Il podere di pochi
ettari che Romolo e Remo si tagliarono con l’aratro fra le colline del Tevere diventò nello
spazio di pochi secoli il centro del Lazio, poi dell’Italia, poi di.tutta la terra allora
conosciuta. E in tutta la terra allora conosciuta si parlò la sua lingua, si rispettarono le sue
leggi, e si contarono gli anni ab urbe condita, cioè da quel famoso 21 aprile del 753 avanti
Cristo, inizio della storia di Roma e della sua civiltà.
Naturalmente le cose non erano andate precisamente così. Ma così i babbi romani
per molti secoli vollero che venissero raccontate ai loro figli: un po’ perché ci credevano
essi stessi, un po’ perché, gran patrioti, li lusingava molto il fatto di poter mescolare gli dèi
influenti come Venere e Marte, e delle personalità altolocate come Enea, alla nascita della
loro Urbe. Essi sentivano oscuramente ch’era molto importante allevare i loro ragazzi nella
convinzione di appartenere a una patria costruita col concorso di esseri soprannaturali, che
certamente non vi si sarebbero prestati se non avessero inteso assegnarle un grande destino.
Ciò diede un fondamento religioso a tutta la vita di Roma, che infatti crollò quando esso
venne meno. L’Urbe fu caput mundi, capitale del mondo, finché i suoi abitanti seppero
poche cose e furono abbastanza ingenui da credere in quelle, leggendarie, che avevano loro
insegnato i babbi e i magistri; finché furono convinti di essere i discendenti di Enea, di
avere nelle loro vene sangue divino e di essere “unti del Signore” anche se a quei tempi si
chiamava Giove. Fu quando cominciarono a dubitarne che il loro Impero andò in frantumi e
il caput mundi diventò una colonia. Ma non precipitiamo.
Nella bella favola di Romolo e Remo, forse non tutto è favola. Forse c’è anche
qualche elemento di verità. Vediamo di sviscerarlo sulla base dei pochi dati abbastanza
sicuri che l’archeologia e l’etnologia ci hanno fornito.
Già trentamila anni prima della fondazione di Roma, pare che l’Italia fosse abitata
dall’uomo. Che uomo fosse, i competenti dicono di averlo ricostruito da certi ossicini del
suo scheletro trovati qua e là, e che rimontano alla cosìddetta “età della pietra”. Ma noi ci
fidiamo poco di queste induzioni, e quindi saltiamo a piè pari a un’èra molto più vicina,
quella “neolitica” di qualcosa come ottomila anni fa, cioè cinquemila prima di Roma. Pare
che la nostra penisola fosse allora popolata da certi liguri a nord e siculi a sud, gente con la
testa a forma di pera, che viveva un po’ in caverna, un po’ in capannucce rotonde, fatte di
sterco e di fango, addomesticava animali e si nutriva di caccia e di pesca.
Facciamo ancora un salto di quattromila anni, cioè arriviamo al 2000 avanti Cristo.
Ed ecco che dal Settentrione, cioè dalle Alpi, giungono altre tribù, chissà da quanto tempo
in marcia dalla loro patria di origine: l’Europa centrale. Costoro non sono molto più
progrediti degli indigeni con la testa a pera; ma hanno l’abitudine di costruire le loro
abitazioni non in caverna sibbene su travi immerse nell’acqua, le cosìddette “palafitte”.
Vengono, si vede, da posti acquitrinosi, e infatti, arrivati da noi, scelgono la regione dei
laghi, quello Maggiore, quello di C omo, quello di Garda, anticipando di qualche millennio
il gusto dei turisti moderni. E introducono nel nostro paese alcune grandi novità: quella di
allevare greggi, quella di coltivare il suolo, quella di tessere stoffe e quella di circondare i
loro villaggi con bastioni di mota e di terra battuta per difenderli tanto dagli attacchi degli
animali quanto da quelli degli uomini.
Piano piano cominciarono a scendere verso il sud, si abituarono a costruire
capanne anche sull’asciutto, ma sempre puntellandole su palafitte; impararono, da certi loro
cugini, pare, installatisi in Germania, l’uso del ferro con cui si fabbricarono un sacco di
aggeggi nuovi, asce, coltelli, rasoi, eccetera, e fondarono una città vera
e
propria,
che si chiamò Villanova, e che doveva trovarsi nei pressi di quella che oggi è Bologna. Fu
questo il centro di una civiltà che si chiamò appunto “villanoviana” e che piano piano
dilagò in tutta la penisola. Da essa si crede che derivino, come razza,, come lingua, come
costumi, gli umbri, i sabini e i latini.
Cosa facessero degl’indigeni liguri e siculi questi villanoviani, quando si
stabilirono nelle terre a cavalcioni - del Tevere, non si sa. Forse li sterminarono, come si
usava a quei tempi cosìddetti “barbari” per distinguerli da» quelli nostri in cui si fa
altrettanto sebbene si chiamino “civili”; forse vi si mescolarono dopo averli sottomessi.
Fatto si è che, verso il 1000 avanti Cristo, tra la foce del Tevere e la baia di Napoli, i nuovi
venuti fondarono molti villaggi che, sebbene abitati da gente del medesimo sangue, si
facevano guerra tra loro e non si rappacificavano che di fronte a qualche comune nemico o
in occasione di qualche festa religiosa.
La più grande e potente di queste cittadine fu Alba Longa, capitale del Lazio, ai
piedi del monte Albano, che corrisponde probabilmente a Castel Gandolfo. E albalongani si
ritiene che fossero quel pugno di avventurosi giovanotti che un bel giorno emigrarono
qualche decina di chilometri più al nord, e fondarono Roma. Forse erano dei braccianti, che
andavano cercando un po’ di terra da appropriarsi e da coltivare. Forse erano dei poco di
buono che avevano qualche conto da regolare con la polizia e i tribunali della loro città.
Forse erano degli emissari mandati dal loro governo a sorvegliare quel punto, al confine
con la Toscana, sulle cui coste era proprio allora sbarcata una nuova popolazione, gli
etruschi, che non si sapeva da che parte del mondo venissero, ma di cui si dicevano peste e
coma. E forse tra questi pionieri ce n’erano davvero due che si chiamavano uno Romolo e
l’altro Remo. Comunque, non dovevano essere più di un centinaio.
Il posto che scelsero aveva molti vantaggi e molti svantaggi. Era a una ventina di
chilometri dal mare, e questo andava benissimo per tenersi al riparo dai pirati che lo
infestavano, senza rinunziare a farne un porto: perché dalle imbarcazioni di quel tempo, il
braccio di fiume che lo separava dalla foce era facilmente navigabile. Ma gli stagni e gli
acquitrini che lo circondavano lo condannavano alla malaria, malanno che ha battuto alle
sue porte sino a pochi anni orsono. Però c’erano le colline, che almeno in parte pro-
teggevano gli abitanti dalle zanzare. E infatti fu su una di esse, il Palatino, che dapprima si
acquartierarono, col proposito di popolare in seguito anche le altre sei che stavano
tutt’attorno.
Ma per popolarle, occorreva fare dei figli. E per fare dei figli, occorrevano delle
mogli. E quei pionieri erano scapoli.
Qui, in mancanza di storia, dobbiamo per forza tornare alla leggenda, che ci
racconta come fece Romolo, o comunque si chiamasse il capoccione di quei tipacci, a
procurar donne a sé e ai suoi compagni. Indisse una grande festa, forse con la scusa di
celebrare la nascita della sua città, e invitò a prendervi parte i vicini di casa sabini (o
quiriti), col loro re, Tito Tazio, e soprattutto le loro figlie. I sabini vennero. Ma, mentre
erano intenti a gareggiare nelle corse a piedi e a cavallo, ch’era il loro sport preferito, molto
poco sportivamente i padroni di casa rubaron loro le ragazze e li buttarono fuori a pedate.
I nostri antichi erano molto sensibili alle questioni di donne. Poco prima, il ratto di
una, Elena, era costato una guerra durata dieci anni e finita con la distruzione di un grande
regno: quello di Troia. I romani ne rapirono a dozzine, ed è quindi naturale che il giorno
dopo dovessero far fronte ai loro babbi e fratelli, tornati in armi per recuperarle. Si
asserragliarono sul Campidoglio, ma commisero l’imperdonabile errore di affidare le chiavi
della fortezza che vi montava la guardia a Tarpeia, una ragazza romana che dicono fosse
innamorata di Tito Tazio. Costei aprì una porta agl’invasori. I quali, gente cavalleresca e
quindi refrattaria a tutti i tradimenti, compresi quelli perpetrati in loro favore, la compensarono schiacciandola sotto i loro scudi. I romani più tardi diedero il suo nome alla rupe
dalla quale solevano precipitare i traditori della patria condannati a morte.
Tutto finì in un pantagruelico banchetto nuziale. Perché le altre donne, in nome
delle quali la battaglia si era accesa, a un certo punto s’interposero fra i due eserciti e
dichiararono che non intendevano restare orfane, come sarebbe successo se i loro mariti
romani avessero vinto, o vedove, come sarebbe successo se avessero vinto i loro babbi
sabini. E ch’era ora di finirla perché con quegli sposi, sebbene spicciativi e maneschi,
s’eran trovate benissimo. Meglio valeva regolarizzare i matrimoni, invece di continuare a
scannarsi. E così fu. Romolo e Tazio decisero di governare insieme, ambedue col titolo di
re, quel nuovo popolo nato dalla fusione delle due tribù, di cui portò congiuntamente il
nome: romani quiriti. E siccome Tazio, subito dopo, ebbe la compiacenza di morire,
l’esperimento di regno a due quella volta andò bene.
Chissà cosa c’è sotto a questa storia. Forse essa non è che la versione, suggerita
dal patriottismo e dall’orgoglio, di una conquista di Roma da parte dei sabini. Ma può
anche darsi che i due popoli si siano davvero volontariamente mescolati e che il famoso
ratto fosse soltanto la normale cerimonia del matrimonio, come lo si celebrava allora, cioè
col furto della sposa da parte dello sposo, ma col consenso del padre di lei, come si fa
ancora presso certi popoli primitivi.
Se così fu veramente, è probabile che questa fusione fosse, più che suggerita,
imposta dal pericolo di un nemico comune: quegli etruschi che frattanto, dalla costa
tirrenica, si erano sparpagliati in Toscana e in Umbria e, armati di una tecnica molto più
progredita, premevano verso il Sud. Roma e la Sabina erano sulla direttrice di questa
marcia e sotto diretta minaccia. Infatti non vi scamparono.
L’Urbe era appena nata, e già doveva vedersela con uno dei più difficili e insidiosi
rivali di tutta la sua storia. Lo abbatte attraverso prodigi di diplomazia prima, di coraggio e
di tenacia poi. Ma le occorsero dei secoli.
CAPITOLO SECONDO
POVERI ETRUSCHI
ALL’OPPOSTO dei romani d’oggi, che fanno tutto per scherzo, quelli dell’antichità
facevano tutto sul serio. E specialmente quando si mettevano in testa di distruggere un
nemico, non solo gli muovevano guerra e non gli davano tregua prima di averlo sconfitto,
anche a costo di rimetterci eserciti su eserciti e quattrini su quattrini; ma poi gli entravano
in casa e non vi lasciavano pietra su pietra.
Un trattamento particolarmente severo riservarono agli etruschi, quando, dopo
aver subito da loro molte umiliazioni, si sentirono abbastanza forti per poterli sfidare. Fu
una lotta lunga e senza esclusione di colpi, ma al vinto non furono lasciati neanche gli occhi
per piangere. Raramente si è visto nella storia un popolo scomparire dalla faccia della terra,
e un altro cancellarne le tracce con si ostinata ferocia. E a questo si deve il fatto che di tutta
la civiltà etrusca non è rimasto quasi più nulla. Non ne sopravvivono che alcune opere
d’arte e qualche migliaio d’iscrizioni, di cui solo poche parole sono state decifrate.
Su questi scarsissimi elementi, ognuno ha ricostruito quel mondo a modo suo.
Intanto, nessuno sa con precisione di dove questo popolo venisse. Dal modo come
si sono rappresentati essi stessi nei bronzi e nei vasi di terracotta, pare che avessero corpi
più tracagnotti e crani più massicci dei vìllanoviani, e lineamenti che ricordano la gente
dell’Asia Minore. Molti infatti sostengono che arrivarono da quelle contrade, per mare; e la
cosa sarebbe confermata dal fatto che furono i primi, tra gli abitatori dell’Italia, ad avere
una flotta. Certo, furono loro a dare il nome di Tirreno, che vuol dire appunto “etrusco”, al
mare che bagna la costa della Toscana. Forse arrivarono in massa e sommersero la
popolazione indigena, forse sbarcarono in pochi e si limitarono a sottometterla con el loro
armi più progredite e la loro tecnica più sviluppata.
Che la loro civiltà fosse superiore a quella villanoviana è dimostrato dai crani che
hanno trovato nelle tombe e che mostrano opere di protesi dentale abbastanza raffinata. I
denti sono un gran segno, nella vita dei popoli. Essi si deteriorano con lo svilupparsi del
progresso che rende più imperioso il bisogno di cure perfezionate. Gli etruschi conoscevano
già il “ponte” per rinforzare i loro molari e i metalli che occorrevano per fabbricarlo. Infatti
sapevano lavorare non solo il ferro che andarono a cercare, e trovarono, all’isola d’Elba e
che trasformarono da greggio in acciaio; ma anche il rame, lo stagno e l’ambra.
Le città che si diedero subito a costruire nell’interno, Tarquinia, Arezzo, Perugia,
Vejo, erano molto più moderne dei villaggi fondati dai latini, dai sabini e dalle altre
popolazioni villanoviane. Tutte avevano dei bastioni per difendersi, delle strade e
soprattutto le fogne. Seguivano, insomma, un “piano urbanistico”, come si direbbe oggi,
rimettendo alla competenza degl’ingegneri, che erano per quei tempi bravissimi, ciò che gli
altri lasciavano al caso e al capriccio degl’individui. Sapevano organizzarsi per lavori
collettivi, di utilità generale, e lo. dimostrano i canali con cui bonificarono quelle contrade
infestate dalla malaria. Ma soprattutto erano formidabili mercanti, attaccati ai soldi e pronti
a qualunque sacrificio pur di moltiplicarli. I romani ignoravano ancora cosa ci fosse dietro
il Soratte, montagnola poco discosta dalla loro città, che gli etruschi già erano arrivati in
Piemonte, Lombardia e Veneto, avevano varcato a piedi le Alpi e, risalendo il Rodano e il
Reno, avevano portato i loro prodotti sui mercati francesi, svizzeri e tedeschi per scambiarli
con quelli locali. Furono loro a portare in Italia come mezzo di scambio la moneta, che i
romani poi copiarono, tanto è vero che vi lasciarono incisa la prua di una nave prima di
averne mai costruita una.
Erano gente allegra, che prendeva la vita dal lato più piacevole; e per questo alla
fine persero la guerra contro i malinconici romani che la prendevano dal lato più austero.
Le scene riprodotte sui loro vasi e sepolcri ci mostrano uomini ben vestiti con quella toga,
che poi i romani copiarono facendone il loro costume nazionale, lunghi capelli e barbe
inanellate, molti gioielli al polso, al collo, ai diti, e sempre intesi a bere, a mangiare e a
conversare, quando non lo erano a praticare qualcuno dei loro esercizi sportivi.
Questi consistevano soprattutto nella boxe, nel lancio del disco e del giavellotto,
nella lotta e in altre due manifestazioni che noi crediamo, a torto, squisitamente moderne e
forestiere: il polo e la corrida. Naturalmente le regole di questi giuochi erano diverse da
quelle che si usano oggi. Ma sin da allora lo spettacolo della lotta fra il toro e l’uomo
nell’arena era considerato di pregio, tanto è vero che chi moriva se ne voleva portare nella
tomba qualche scena-ricordo dipinta sui vasi, per continuare a divertircisi anche nell’aldilà.
Un gran passo avanti rispetto agli arcaici e patriarcali costumi romani e degli altri
indigeni, era la condizione della donna, che presso gli etruschi godeva di gran libertà, e
infatti viene rappresentata in compagnia dei maschi, partecipe dei loro divertimenti. Pare
che fossero donne molto belle e di liberissimi costumi. Nei dipinti appaiono ingioiellate,
asperse di cosmetici e senza troppe preoccupazioni di pudore. Mangiano a crepapelle e
bevono a garganella, distese coi loro uomini su ampi sofà. Oppure suonano il flauto, o
danzano. Una di loro, che poi diventò molto importante a Roma, Tanaquilla, era una
intellettuale”, che la sapeva lunga di matematica e di medicina. Il che vuol dire che, a
differenza delle loro colleghe latine, condannate alla più nera ignoranza, andavano a scuola
e studiavano. I romani, ch’erano gran moralisti, chiamavano “toscane”, cioè etrusche, tutte
le donne di facili costumi. E in una commedia di Plauto c’è una ragazza accusata di seguire
il “costume toscano” perché fa la prostituta.
La religione, che è sempre la proiezione della morale di un popolo, era centrata su
un dio di nome Tinia, che esercitava il suo potere col fulmine e il tuono. Egli non
governava direttamente gli uomini, ma affidava i suoi ordini a una specie di gabinetto
esecutivo, composto di dodici grandi dèi, così grandi ch’era sacrilegio perfino pronunciarne
il nome. Asteniamocene quindi anche noi, per non confondere la testa di chi ci legge. Tutti
insieme costoro formavano il gran tribunale dell’aldilà, dove i “genii”, specie di commessi
o di guardie municipali, conducevano le anime dei defunti, appena avevano abbandonato i
loro rispettivi corpi. E li cominciava un processo in piena regola. Chi non riusciva a
dimostrare di aver vissuto secondo i precetti dei giudici, era condannato all’inferno, a meno
che i parenti e gli amici rimasti in vita non facessero per lui tante preghiere e sacrifici da
ottenerne l’assoluzione.
E in questo caso veniva assunto in paradiso, per continuare a godervi quei terrestri
piaceri a base di bevute, mangiate, cazzotti e canzonette, di cui s’era fatto scolpire le allegre
scene sul sepolcro.
Ma del paradiso gli etruschi pare che parlassero poco e di rado, lasciandolo
piuttosto nel vago. Forse troppo pochi ce ne andavano, per saperne qualcosa di preciso.
Quello su cui erano informatissimi era l’inferno, di cui conoscevano, uno per uno, tutti i
tormenti che vi si soffrivano. Evidentemente i loro preti pensavano che, per tenere in riga la
gente, valevano più le minacce della dannazione che le speranze dell’assoluzione. E questo
modo dì veder le cose si è perpetuato sino in tempi più recenti, sino a quelli di Dante che,
nato in Etruria anche lui, è rimasto dello stesso parere e sull’inferno ha scialato molto più
che sul paradiso.
Con questo non dobbiamo credere che gli etruschi fossero fiorellini di gentilezza.
Ammazzavano con relativa facilità, e sia pure con la buona intenzione di offrire in
sacrificio la vittima per la salvezza di qualche amico o parente. Soprattutto i prigionieri di
guerra erano adibiti a questa bisogna. Trecento romani, catturati in una delle tante battaglie
che si combatterono fra i due eserciti, furono uccisi per lapidazione a Tarquinia. E sul loro
fegato ancora palpitante di vita gl’indovini cercarono di determinare i futuri eventi della
guerra. Evidentemente non ci riuscirono, altrimenti l’avrebbero smessa subito. Ma l’uso era
frequente, anche se in genere ci si serviva delle viscere di qualche animale, pecora o toro
che fosse, e i romani lo copiarono.
Politicamente, le loro sparse città non riuscirono mai a unirsi, e purtroppo non ce
ne fu nessuna abbastanza forte per tenere in pugno le altre, come fece Roma con le rivali
latine e sabine. Ci fu una federazione dominata da Tarquinia, ma non venne a capo delle
tendenze separatiste. I dodici piccoli stati che ne facevano parte, invece di unirsi contro il
comune nemico, si lasciarono battere e fagocitare da esso uno per uno. La loro diplomazia
era come quella di certe moderne nazioni europee che preferiscono morire da sole piuttosto
che vivere insieme.
Tutto questo è stato ricostruito, a furia d’induzioni, dai resti dell’arte etrusca che
sono giunti sino a noi e che costituiscono la sola eredità lasciataci da quel popolo. Si tratta
specialmente di vasi e di bronzi. Fra i vasi ce ne sono di belli, come “l’Apollo di Veio”,
detto anche “Apollo che cammina”, di terracotta policroma, che denunzia nei coroplasti
etruschi una grande perizia tecnica e un gusto raffinato. Sono quasi sempre d’imitazione
greca e, salvo qualche raro esemplare come il “bucchero nero”, non ci sembrano gran che.
Ma per quanto scarsi siano questi resti, bastano a farci capire come i romani, una
volta ch’ebbero sopraffatto gli etruschi, dopo essere andati per un pezzo a scuola da loro e
averne subito la superiorità soprattutto nel campo tecnico e organizzativo, non solo li
distrussero, ma cercarono di cancellare ogni traccia della loro civiltà. La consideravano
malata e corruttrice. Copiarono da essa tutto quello che faceva loro comodo. Mandarono
alle scuole di Vejo e di Tarquinia i loro ragazzi per addottorarli specialmente in medicina e
ingegneria. Imitarono la toga. Adottarono l’uso della moneta. E forse presero a prestito
anche l’organizzazione politica, che però gli etruschi ebbero in comune con tutti gli altri
popoli dell’antichità e che passò, anche in casa loro, da un regime monarchico ad.uno
repubblicano, retto da un lucumone, magistrato elettivo, e infine a una forma di democrazia
dominata dalle classi ricche. Ma i propri costumi, stoici e sani, basati sul sacrificio e sulla
disciplina sociale, Roma volle preservarli dalle mollezze di quelli etruschi. Istintivamente
sentì che vincere in guerra il nemico e occuparne le terre non bastava,, se poi gli si dava il
destro di contaminare le case del padrone, assumendovelo in qualità di schiavo o di
precettore, come si usava a quei tempi coi vinti. E lo distrusse. E ne volle sepolti tutti i documenti e monumenti.
Questo però successe molto tempo dopo che il primo contatto venisse stabilito fra i
due popoli, i quali s’incontrarono appunto a Roma, quando vi giunsero gli albalongani e vi
trovarono, a quanto pare, già installata una piccola colonia etrusca, che aveva dato al sito un
nome di casa sua. Sembra infatti che “Roma” venga da “Rumon” che in etrusco vuol dire
“fiume”. E se questo è vero, bisogna dedurne che la prima popolazione dell’Urbe fu
formata non soltanto di latini e di sabini, popoli dello stesso sangue e dello stesso ceppo,
come lascerebbe credere la storia del famoso “ratto”, ma anche di etruschi, gente di
tutt’altra razza e lingua e religione. Anzi, secondo certi storici, etrusco sarebbe stato lo
stesso Romolo. E comunque fu certamente etrusco il rito con cui fondò la città, scavando il
solco con un aratro trascinato da un toro e da una giovenca bianchi, dopo che dodici uccelli
di buon augurio avevano volteggiato sulla sua testa.
Senza Volerci mettere in concorrenza coi competenti che da secoli vanno
discutendo di queste faccende e non riescono a mettersi d’accordo, diremo quella che ci
sembra la più probabile di tutte le versioni.
Gli etruschi, che avevano la passione del turismo e del commercio, avevano già
fondato un piccolo villaggio sul Tevere, quando latini e sabini vi giunsero. E questo
villaggio doveva servire da stazione di smistamento e di rifornimento per le loro linee di
navigazione verso il Sud. Qui, e specialmente in Campania, avevano già impiantato ricche
colonie: Capua, Nola, Pompei, Ercolano, dove le popolazioni locali che si chiamavano
sannite e ch’erano di origine villanoviana anch’esse, venivano a scambiare i loro prodotti
agricoli con quelli industriali in arrivo dalla Toscana. Era difficile, da Arezzo o da
Tarquinia, giungere fin laggiù via terra. Mancavano le strade e la regione era infestata da
belve e da banditi. Molto più facile, visto ch’eran gli unici a possedere una flotta, era per gli
etruschi venirci via mare. Ma il viaggio era lungo, richiedeva intere settimane. Le navi,
grandi come gusci di noce, non potevano imbarcare molti rifornimenti per gli uomini, e
avevano bisogno di porti, lungo la strada, dove provvedersi di farina e d’acqua per il resto
del tragitto. La foce del Tevere, giusto a metà del percorso, forniva una comoda baia per
riempire le stive vuote, e per di più, navigabile com’era a quei tempi, offriva anche un
comodo mezzo per risalire nell’interno e combinare qualche affaruccio coi latini e sabini
che lo abitavano. La contrada era costellata non si sa se d’una trentina o d’una settantina di
borghi, ognuno dei quali rappresentava un piccolo mercato di scambio. Non che vi si
potessero fare grandi affari perché il Lazio, a quei tempi, non era ricco che di legname per
via (chi lo direbbe, oggi?) dei suoi meravigliosi boschi. Per il resto, non produceva neanche
frumento, ma soltanto farro, e un po’ di vino e di olive. Ma gli etruschi, pur di far quattrini,
si contentavano del poco, e il vizio gli è rimasto.
Per questo fondarono Roma, chiamandola così o con un altro nome, ma senza dare
troppa importanza alla cosa. Chissà quante ce n’erano, di Rome, scaglionate lungo la costa
tirrenica fra Livorno e Napoli. E ci misero, a badarvi, una guarnigione di marinai e di
mercanti che forse consideravano quel trasferimento un castigo. Dovevano tenere in ordine
soprattutto il cantiere per le riparazioni delle navi danneggiate dalle tempeste, e i magazzini
per rifornirle.
Poi, un bel giorno, presero ad arrivare a gruppetti i latini e i sabini, un po’ forse
perché in casa cominciavano a stare stretti, un po’ perché anch’essi avevano voglia di
commerciare con gli etruschi, dei cui prodotti erano bisognosi. Che avessero già allora un
piano strategico di conquista dell’Italia prima, e del mondo poi, e che per questo ritenessero
indispensabile la posizione di Roma, son fantasie degli storici d’oggi. Quei latini e sabini
erano degli zoticoni di stoffa contadina, per i quali la geografia si riassumeva nell’orto di
casa.
É probabile che questi nuovi arrivati siano venuti alle mani tra loro. Ma è
altrettanto probabile che poi, invece di distruggersi a vicenda, si siano alleati, per fare fronte
agli etruschi che dovevano guardarli un po’ come gl’inglesi guardano gl’indigeni, nelle loro
colonie. Davanti a quella gente forestiera che li trattava dall’alto in basso e che parlava un
idioma a loro incomprensibile, dovettero accorgersi di essere fratelli, accomunati dallo
stesso sangue, dalla medesima lingua e dalla identica miseria. E per questo misero in
comune il poco che avevano: le donne. Il famoso ratto non è probabilmente che il simbolo
di questo accordo, dal quale è naturale che gli etruschi siano rimasti esclusi, ma di propria
volontà. Essi si sentivano superiori e non volevano mescolarsi con quella plebaglia.
La divisione razziale continuò almeno cento anni, durante i quali latini e sabini,
ormai fusi nel tipo romano, dovettero ingoiare parecchi rospi. Quando, dopo Tarquinio il
Superbo che fu l’ultimo re, essi presero il sopravvento, la vendetta fu indiscriminata. E
forse l’accanimento che misero a distruggere l’Etruria non solo come stato, ma anche come
civiltà, gli fu ispirato appunto dalle umiliazioni che dagli etruschi avevano subito anche in
patria. E di essi vollero epurare tutto, perfino la storia, dando un certificato di nascita latino
anche a Romolo che forse lo aveva etrusco e facendo risalire all’unione coi sabini l’origine
della città.
CAPITOLO TERZO
I RE AGRARI
QUANDO Romolo morì, molti anni dopo aver seppellito Tito Tazio, i romani
dissero ch’era stato il dio Marte a rapirlo e a condurlo in cielo per trasformarlo in dio, il dio
Quirino. E come tale d’allora in poi lo venerarono, come fanno oggi i napoletani con san
Gennaro.
A lui successe, come secondo re di Roma, Numa Pompilio, che la tradizione ci
dipinge mezzo filosofo e mezzo santo, come lo fu, parecchi secoli dopo, Marco Aurelio.
Quelle che più lo interessavano erano le questioni religiose. E siccome in questa materia ci
doveva essere una grossa anarchia perché ognuno dei tre popoli venerava i propri dèi, fra i
quali non si riusciva a capire chi fosse il più importante, Numa decise di mettervi ordine. E
per imporlo, quest’ordine, ai suoi riottosi sudditi, fece spargere la notizia che ogni notte,
mentre dormiva, la ninfa Egeria veniva a visitarlo in sogno dall’Olimpo per trasmettergliene direttamente le istruzioni. Chi vi avesse disobbedito, non era col re, uomo fra gli uomini,
che avrebbe dovuto vedersela, ma col Padreterno in persona.
Lo stratagemma può sembrare infantile, ma anche oggi seguita ad attaccare, di
quando in quando. In pieno secolo ventesimo, Hitler, per farsi obbedire dai tedeschi, non
seppe escogitarne uno migliore, E ogni tanto scendeva dalla montagna di Berchtesgaden
con qualche nuovo ordine del buon Dio in tasca: quello di sterminare gli ebrei, per esempio,
o di distruggere la Polonia. E il bello è che, a quanto pare, ci credeva anche lui. L’umanità,
in queste faccende, non ha molto progredito, dai tempi di Numa.
Tuttavia anche in questa leggenda forse c’è un fondo di vero, o almeno
un’indicazione che ci permette di ricostruirlo. Quali che siano stati i loro nomi e la loro
origine, quelli dell’antichissima Roma, più che re veri e propri, dovettero essere dei papi,
come del resto lo era l”arconte Basileo” ad Atene.
Tutte le autorità, a quei tempi, erano puntellate soprattutto sulla religione. Il potere
dello stesso pater familias, o capo di casa, sulla moglie, sui fratelli minori, sui figli, sui
nipoti, sui servi, era più che altro quello di un alto sacerdote cui il buon Dio aveva delegato
certe funzioni. E per questo era così forte. E per questo le famiglie romane erano così
disciplinate. E per questo ognuno sentiva tanto i propri doveri e li assolveva in pace e in
guerra.
Numa, stabilendo un ordine.di precedenza fra i vari dèi che ognuno dei vari popoli
che la formavano si era portato a Roma, compi forse un’opera politica fondamentale: quella
che poi consentì ai suoi successori, Tullo Ostilio e Anco Marzio, di condurre il popolo unito
alle guerre vittoriose contro - le città rivali della contrada. Ma, come poteri - politici veri e
propri, non doveva averne molti, perché quelli più grandi e decisivi restavano nelle mani
del popolo che lo eleggeva ed a cui doveva sempre rispondere.
Questo, di per sé, non vorrebbe dir nulla, perché in tutti i tempi e sotto qualsiasi
regime, chi comanda dice di farlo in nome del popolo. Ma a Roma non si trattò di
chiacchiere, almeno fino alla dinastia dei Tarquini, i quali del resto persero il trono appunto
perché vollero starci seduti come padroni invece che come “delegati”. E la divisione del
comando era fatta press’a poco così.
La città era divisa in tre tribù: quella dei latini, quella dei sabini, quella degli
etruschi. Ogni tribù era divisa in dieci curie, o quartieri. Ogni curia in dieci gente, o casate.
Ogni casata era divisa in famiglie. Le curie si riunivano in genere due volte all’anno, e in
queste occasioni facevano il comizio curiato, che fra le altre cose si occupava anche
dell’elezione del re, quando uno moriva. Tutti avevano il medesimo diritto di voto. La
maggioranza decideva. Il re eseguiva.
Era la democrazia assoluta senza classi sociali, e funzionò finché Roma fu un
piccolo pacifico villaggio abitato da poca gente che di rado metteva la testa fuor delle mura.
Poi gli abitanti crebbero, e crebbero anche le esigenze. Il re che dapprima, oltre a dir messa,
cioè a celebrare i sacrifici e gli altri riti della liturgia, doveva anche applicare le leggi, cioè
fare il giudice, non ebbe più il tempo di assolvere tutti questi compiti, e cominciò a
nominare dei “funzionari” a cui affidarli. Così nacque la cosìddetta “burocrazia”. Colui
ch’era stato soprattutto un prete, diventa vescovo, e designa dei parroci e curati che lo
aiutino nelle funzioni religiose. Poi ha bisogno anche di chi provveda alle strade, al censo,
al catasto, all’igiene, e nomina dei competenti che si occupino di queste faccende. Così
nasce il primo “ministero”: il cosìddetto Consiglio degli Anziani o Senato, costituito da un
centinaio di membri ch’erano discendenti, per diritto di primogenitura, dei pionieri venuti
con Romolo a fondare Roma e che dapprima hanno soltanto il compito di consigliare il
sovrano, ma poi diventano sempre più influenti.
E infine nasce, come stabile organizzazione, l’esercito, basato anch’esso sulla
divisione nelle trenta curie, ognuna delle quali doveva fornire una centuria, cioè cento
fanti, e una decuria, cioè dieci cavalieri col cavallo. Le trenta centurie e le trenta decurie,
cioè tremilatrecento uomini, facevano tutte insieme la legione che fu il primo e unico corpo
d’armata dell’antichissima Roma. Sui soldati il re, che ne era il comandante supremo, aveva
diritto di vita o di morte. Ma anche questo potere militare non lo esercita in maniera
assoluta e senza controllo. Egli dirige le operazioni, ma dopo aver chiesto consiglio al
comizio centuriato, cioè alla legione in armi, di cui sollecita anche l’approvazione per la
nomina degli ufficiali che a quei tempi si chiamavano pretori.
Insomma, tutte le precauzioni erano state prese dai romani perché il re non si
tramutasse in un tiranno. Egli doveva restare un “delegato” della volontà popolare. Quando
un branco d’uccelli passava per aria o un fulmine schiantava un albero, era compito suo
riunire i sacerdoti, con loro studiare cosa volessero dire quei segni e, se gli pareva che
significassero qualcosa di poco buono, decidere che sacrifici bisognava fare per placare gli
dèi evidentemente offesi di qualcosa. Quando due privati venivano a litigio fra loro e
magari uno derubava o scannava l’altro, non era affar suo occuparsene. Ma se uno
commetteva qualche delitto contro lo stato o la collettività, allora se lo faceva condurre
davanti da qualche guardia, e magari lo condannava a morte. Per tutto il resto, decisioni non
poteva prenderne. Doveva chiederle in tempo di pace ai comizi curiati e in tempo di guerra
a quelli centuriati. Se era furbo, riusciva, come avviene anche oggi, a presentare come
“volontà del popolo” quella sua personale. Altrimenti doveva subirla. Ma sempre doveva
fare i conti, per eseguirla, col Senato.
Tale era l’ordinamento che il primo re di Roma, sia egli stato Romolo o no, e a
qualunque delle tre razze sia appartenuto, diede all’Urbe. E tale fu quello che il saggio
Numa lasciò al suo successore Tullo Ostilio, ch’era di temperamento molto più vivace.
Egli aveva nel sangue la politica, l’avventura e l’avidità. Ma il fatto che il
“comizio” avesse scelto proprio lui come sovrano, significa che, dopo i quarant’anni di
pace assicuratile da Numa, tutta Roma aveva una gran voglia dì menar le mani. Dei borghi
e città che la circondavano, Alba Longa era la più ricca e importante. Non sappiamo quale
pretesto escogitasse Tullo per muoverle guerra. Forse nessuno. Ma fatto si è che un bel
giorno l’attaccò e la rase al -suolo, sebbene la leggenda abbia trasformato questa prepotenza
in un episodio cavalleresco e quasi gentile. Dicono infatti che i due eserciti rimisero la sorte
delle armi a un duello fra i tre Orazi romani e tre Curiazi albalongani, Costoro uccisero due
Orazi. Ma l’ultimo a sua volta uccise loro e decise la guerra. Fatto sta però che Alba Longa
fu distrutta, e il suo re fu legato con le due gambe a due carri che, lanciati in direzione
opposta, lo squarciarono. Fu così che Roma trattò quella ch’essa considerava la sua
madrepatria, la terra donde diceva che i suoi fondatori erano venuti.
Naturalmente l’avvenimento dovette allarmare un po’ tutti gli altri villaggi della
contrada che, non avendo subito l’influenza etrusca, erano rimasti indietro, nel cosìddetto
progresso, e quindi si sentivano più deboli e peggio armati dei romani. Un po’ con tutti
Tullo Ostilio e il suo successore Anco Marzio, che ne seguì l’esempio, attaccarono briga.
Per concludere, il giorno che al trono fu elevato Tarquinio Prisco come il quinto
re, Roma era già il nemico pubblico numero uno di quella regione di cui non si conoscono
con esattezza i confini, ma che doveva estendersi press’a poco fino a Civitavecchia a nord,
fino verso Rieti a est, e fin verso Frosinone a sud.
Ora, è molto probabile che questa politica di conquiste, destinata a diventare
ancora più aggressiva con gli ultimi tre re di famiglia Tarquinia, fosse d’ispirazione
soprattutto etrusca. E questo per un semplice motivo: che, mentre latini e sabini erano
agricoltori, gli etruschi erano industriali e mercanti. I primi, ogni volta che scoppiava una
nuova guerra, dovevano abbandonare il podere lasciandolo andare in malora per arruolarsi
nella legione, e rischiavano di perderlo, se il nemico vinceva. I secondi invece avevano
tutto da guadagnare: aumentavano i consumi, piovevano le “commesse” del governo; e in
caso di vittoria si conquistavano nuovi mercati. In tutti i tempi e in tutte le nazioni è sempre
stato così: gli abitanti delle città, capitalisti, intellettuali, commercianti, vogliono le guerre
contro la volontà dei contadini che poi devono farle. Più uno stato s’industrializza, più la
città prende il sopravvento sulla campagna, e più la sua politica diventa avventurosa e
aggressiva.
Fino al quarto re, l’elemento contadino prevalse in Roma e la sua economia fu
soprattutto agricola. Quei tremilatrecento uomini che costituivano il suo esercito ci
dimostrano che la popolazione complessiva doveva ammontare a un trentamila anime, di
cui forse la maggior parte erano disseminate nel contado. Nella città vera e propria ce ne
sarà stata, sì e no, la metà, che dal Palatino ora si erano sparpagliati anche sugli altri colli.
La maggior parte di loro vivevano in capanne di fango venute su alla rinfusa e disordinatamente, con una porta per entrarvi, ma senza finestre, e una sola stanza in cui mangiavano, bevevano, dormivano tutti insieme babbo, mamma, figliuoli, nuore, generi, nipoti,
schiavi (chi ne aveva), polli, somari, vacche e porci. Gli uomini, al mattino, scendevano al
piano per arare la terra. E fra loro c’erano anche i senatori che, come tutti gli altri,
aggiogavano i buoi e spargevano il seme o falciavano la spiga. I ragazzi li aiutavano, perché
il lavoro dei campi era la loro unica e vera scuola, il loro unico e vero sport. E i padri
approfittavano dell’occasione per insegnar loro che il seme dava buon frutto solo quando il
cielo mandava acqua e sole in giuste dosi sulla zolla; che il cielo mandava acqua e sole in
giuste dosi sulla zolla solo quando gli dèi lo volevano; che gli dèi lo volevano solo quando
gli uomini avevano compiuto tutti i loro doveri verso di essi; e che il primo di questi doveri
consisteva nell’obbedienza dei giovani ai vecchi.
Così crescevano i cittadini romani, almeno quelli di discendenza latina e sabina,
che dovevano costituire la maggioranza. L’igiene e la cura della propria persona dovevano
essere ridotte al minimo, anche per le donne. Niente cosmetici, niente civetterie, poca o
punta acqua, che le donne dovevano andare ad attingere in basso e riportare in anfore
sospese sulla testa. Non c’erano gabinetti di decenza né fogne. Si facevano i propri bisogni
fuori dell’uscio e si lasciavano lì. Le barbe e i capelli crescevano incolti. Quanto ai vestiti,
non state a credere ai monumenti, che del resto appartengono ad epoche molto più recenti,
quando Roma ebbe una vera e propria industria tessile ed una categoria di sarti evoluti, che
per la maggior parte erano di origine e di scuola greche. In quei tempi lontani la toga, che
poi acquistò tanta imponenza, o non era ancora nata, o era ridotta alla sua foggia più
elementare. Forse somigliava alla futa che attualmente portano gli abissini: un cencio
bianco, tessuto in casa dalle mogli e dalle figlie con lana di pecora, con un buco in mezzo
per infilarci la testa. Pochi ne avevano una di ricambio. In genere portavano sempre la
stessa, d’estate e &inverno, di giorno e di notte, immaginate con quali conseguenze.
Non s’indulgeva a nessun piacere, nemmeno a quelli di gola. Contro le teorie dei
moderni scienziati americani, secondo i quali la forza di un popolo è condizionata dal suo
consumo di calorie e di vitamine, che a sua volta è condizionato dalla varietà del suo
nutrimento, i romani dimostrarono che si può conquistare il mondo anche mangiando
soltanto un impasto mal cotto d’acqua e di farina, due olive e un po’ di cacio, annaffiato
solo nei giorni di festa da un bicchier di vino. L’olio sembra che sia venuto più tardi, e
dapprima pare che lo abbiano usato solo per ungersi la pelle, a difesa dalle bruciature del
freddo e da quelle del sole. Il che doveva aumentare non poco il puzzo generale.
A questo regime non sfuggiva nemmeno il re, che soltanto con la dinastia dei
Tarquini ebbe una divisa, un elmo e delle insegne speciali. Sino ad Anco Marzio egli fu
eguale tra gli eguali, anche lui arò la terra dietro i buoi aggiogati, sparse il seme e falciò la
spiga. Non risulta nemmeno che avesse una reggia o comunque un ufficio. Risulta invece
che andava fra la gente senza una scorta di protezione perché, se ne avesse avuta una, tutti
lo avrebbero accusato dì voler regnare con la forza invece che col consenso del popolo. Le
decisioni le prendeva sotto un albero, o a sedere sull’uscio di casa, dopo aver sentito
l’opinione degli anziani che gli facevano corona torno tomo. Saliva in cattedra e forse
indossava anche un abito speciale, solo quando doveva compiere un sacrificio o qualche
altra cerimonia religiosa.
Anche in guerra i romani andavano senza niente che somigliasse ad una vera e
propria organizzazione militare. Il pretore che comandava la centuria o la decuria non
aveva insegne di grado. Le armi erano soprattutto bastoni, sassi e rozze spade. Ci volle del
tempo prima che si arrivasse all’elmo, allo scudo e alla corazza, invenzioni che allora
dovettero fare l’effetto ‘ che ai giorni nostri fecero la mitragliatrice e il carro armato.
Sicché le grandi campagne che Roma intraprese sotto i primi suoi bellicosì re
dovettero somigliare più che altro a spedizioni punitive e risolversi in gran mazzate di
uomo contro uomo, senz’ombra di tattica e di strategia. I romani le vinsero non tanto perché
erano i più forti, quanto perché erano i più persuasi che la loro patria era stata fondata dagli
dèi per realizzare grandi imprese e che morire per essa costituiva non un merito, ma solo il
pagamento di un debito contratto nel momento in cui si era nati.
Il nemico, una volta battuto, cessava dì essere un “soggetto” per dìventare soltanto
un “oggetto”. Il romano che lo aveva fatto prigioniero lo considerava cosa sua propria: se
era di malumore, lo ammazzava; se era di buonumore, se lo portava a casa come schiavo, e
poteva farne quel che voleva: ucciderlo, venderlo, obbligarlo a lavorare. Le terre venivano
requisite dallo stato e date in affitto ai sudditi. Le città molto spesso erano dìstrutte e le
popolazioni deportate.
Con questi sistemi, Roma crebbe a spese dei latini a sud, dei sabini e degli equi a
est, degli etruschi a nord. Sul mare, da cui distava pochi chilometri, non osava avventurarsi
perché non aveva ancora una flotta, e la sua popolazione contadina ne diffidava per istinto.
Sotto Romolo, Tito Tazio, Tullo Ostilio e Anco, Marzio, i romani furono “terrieri” e la loro
politica “terrestre”.
Fu l’avvento di una dinastia etrusca a mutare radicalmente le cose, sia nella
politica interna che in quella estera.
CAPITOLO QUARTO
1 RE MERCANTI
NON si sa con precisione quando e come Anco Marzio mori. Ma dovette essere a
un centocinquant’anni dal giorno in cui la leggenda vuole che Roma sia stata fondata, cioè
verso il 600 avanti Cristo. Pare comunque che in quel momento si trovasse in città un certo
Lucio Tarquinio, personaggio molto differente da quelli che i romani usavano scegliersi
come re e magistrati.
Non era del posto. Veniva da Tarquinia, ed era figlio di un greco, Demarato,
emigrato da Corinto e sposatosi con una donna etrusca. Da questo incrocio era nato un
ragazzo vivace, brillante, spregiudicato, ambiziosissimo, che forse i
romani, quando venne a stabilirsi fra loro, guardarono con un misto
d’ammirazione, d’invidia e dì diffidenza. Era ricco e scialacquatore fra gente povera e
taccagna. Era elegante in mezzo ai bifolchi. Era l’unico a sapere di filosofia, geografia e
matematica in un mondo di poveri analfabeti. Quanto alla politica, sangue greco più sangue
etrusco dovevano far di lui un diplomatico di mille risorse fra concittadini che ne dovevano
aver noche. Tito Livio dice di lui: Fu il primo che intrigò per farsi eleggere re e pronunciò
un discorso per assicurarsi l’appoggio della plebe.
Che sia stato il primo,. ne dubitiamo. Ma che abbia intrigato, ne siamo sicuri.
Probabilmente le famiglie etrusche, che costituivano una minoranza, ma ricca e potente,
videro in lui il loro uomo; e, stanche di essere governate da re pastori e contadini, di razza
latina e sabina, sordi ai loro bisogni commerciali ed espansionistici, decisero di innalzarlo
al trono.
Come siano andate le cose, s’ignora. Ma l’accenno di Tito Livio alla plebe ci
consente di farcene un’idea. Essa è un elemento nuovo nella storia romana, o per lo meno
un elemento che non si era fatto sentire sotto i primi quattro re, che alla plebe non avevan
nessun bisogno di parlare per venire eletti, per il semplice motivo che la plebe ai loro tempi
non c’era. Nei comizi curiati, che procedevano all’investitura del sovrano, non esistevano
differenze sociali. Tutti erano cittadini, tutti erano piccoli o grandi proprietari di terra; tutti
quindi avevano, formalmente, gli stessi diritti, anche se, per forza di cose, nella pratica, poi,
a prendere le decisioni e ad imporle agli altri erano alcuni professionisti della politica.
Era una perfetta democrazia casalinga, dove tutto veniva fatto alla luce del sole e
si discuteva fra cittadini uguali e quel che contava, per la distribuzione delle cariche, era la
stima e A prestigio di cui si godeva. Ma essa presupponeva -la piccola città che Roma fu in
quel suo primo secolo di vita, chiusa nella sua angusta cerchia di catapecchie, e dove
ognuno conosceva l’altro e sapeva di chi era figlio e cosa aveva fatto e come trattava la
moglie e quanto spendeva per mangiare e quanti sacrifici celebrava in nome degli dèi.
Ma alla morte di Anco Marzio la situazione era del tutto cambiata. 1 bisogni di
guerra avevano stimolato l’industria e quindi favorito l’elemento etrusco, quello che dava i
falegnami, i fabbri, gli armieri, i mercanti. N’erano arrivati da Tarquinia, da Arezzo, da
Vejo, le botteghe s’erano riempite di garzoni e d’apprendisti che, imparato bene il mestiere,
avevano messo su altre botteghe. Il rialzo dei salari aveva richiamato in città la mano
d’opera contadina. I soldati, dopo aver fatto la guerra, tornavano malvolentieri sui campi e
preferivano restare a Roma, dove si trovavano con più facilità donne e vino. Ma soprattutto
le vittorie vi avevano fatto confluire rivoli di schiavi. Ed era questa moltitudine forestiera
che formava il plenum da cui viene la parola plebe.
Lucio Tarquinio e i suoi amici etruschi dovettero veder subito che profitto si
poteva trarre da questa massa di gente, per la maggior parte esclusa dai comizi curiati, se si
fosse potuto convincerla che solo un re forestiero anche lui avrebbe potuto fame valere i
diritti. E per questo l’arringò, promettendole chissà cosa, magari ciò che poi fece davvero.
Egli aveva dietro di sé quella che oggi si chiamerebbe la Confindustria: i Cini, i Marzotto,
gli Agnelli, i Pirelli, i Falck dell’antica Roma: gente che quattrini per la propaganda
elettorale aveva da spenderne quanti ne voleva, ed era decisa a farlo per garantirsi un
governo più disposto di quelli precedenti a tutelare i suoi interessi e a seguire quella politica
espansionistica ch’era la condizione della sua prosperità.
Certamente ci riuscirono perché Lucio Tarquinio fu eletto col nome di Tarquinio
Prisco, rimase sul trono trentotto anni, e per liberarsi di lui i “patrizi”, cioè i “terrieri”,
dovettero farlo assassinare. Ma inutilmente. Prima di tutto perché la corona, dopo di lui,
passò a suo figlio, eppoi a suo nipote. In secondo luogo perché, più che la causa, l’avvento
della dinastia dei Tarquini fu l’effetto di una certa svolta chela storia di Roma aveva subito
e che non le consentiva più di tornare al suo primitivo e arcaico ordinamento sociale e alla
politica che ne derivava.
Il re della Confindustria e della plebe fu un re autoritario, guerriero, pianificatore e
demagogo. Volle una reggia e se la fece costruire secondo lo stile etrusco, molto più
raffinato di quello romano. Poi nella reggia fece innalzare un trono, e lì si mise a sedere, in
pompa magna, con lo scettro in mano, e un elmo ripieno di pennacchi. Dovette farlo un po’
per vanità, un po’ perché conosceva i suoi polli e sapeva benissimo che la plebe, cui doveva
la sua elezione e di cui intendeva conservarsi il favore, amava il fasto e il re lo vuol vedere
in alta uniforme, circondato da corazzieri. A differenza dei suoi predecessori che la maggior
parte del loro tempo la passavano a dir messa e a fare oroscopi, egli la trascorse a esercitare
il potere temporale cioè a far politica e guerre. Prima soggiogò tutto il Lazio, poi attaccò
briga con i sabini e rosicchiò loro un’altra parte di terre. Per fare questo, ebbe bisogno di
molte armi che l’industria pesante gli fornì facendoci sopra grossi affari, e di molti
rifornimenti che i mercanti gli assicurarono guadagnandoci sopra larghe prebende. Gli
storici repubblicani e anti-etruschi scrissero poi che il suo regno fu tutto un intrallazzo, una
generale mangeria, il trionfo delle mance e delle "bustarelle”, e che il bottino ch’egli prese
ai vinti lo usò per abbellire non Roma, ma le città etrusche, particolarmente Tarquinia, che
gli aveva dato i natali.
Ne dubitiamo, perché fu proprio sotto di lui che Roma fece un balzo avanti, specie
in fatto di monumenti e di urbanistica. Anzitutto vi costruì la cloaca massima, cioè le fogne,
che finalmente liberarono i cittadini dai loro rifiuti, con i quali avevano sino ad allora
convissuto. Eppoi finalmente l’Urbe cominciò a diventar tale davvero, con strade ben
tracciate, quartieri definiti, case che non eran più capanne, ma costruzioni vere e proprie,
col tetto spiovente da ambedue i lati, finestre e atrio, e un foro, cioè una piazza centrale,
dove tutti i cittadini si riunivano.
Purtroppo, per compiere questa autentica rivoluzione, che sconvolgeva non
soltanto la faccia esterna di Roma, ma. anche il suo costume di vita, egli dovette subire
l’ostilità del Senato, depositario dell’antica tradizione e poco disposto a rinunziare al suo
diritto di controllo sul re. In altri tempi esso lo avrebbe deposto o costretto alle dimissioni.
Ma ora bisognava fare i conti con la plebe, cioè con una moltitudine che ancora non aveva
una adeguata rappresentanza politica, ma sperava che Tarquinio gliene desse una ed era
pronta a sostenerlo anche don le barricate. Era più facile ucciderlo, e così fecero. Ma
commisero l’imperdonabile errore di lasciare in vita sua moglie e suo figlio, convinti che
quella per il suo sesso e questi per la sua giovane età non potessero mantenere il potere.
Forse avrebbero avuto ragione, se Tanaquilla fosse stata romana,. cioè abituata
soltanto a obbedire. Ma invece era etrusca, aveva studiato, con suo marito aveva diviso non
soltanto il letto ma anche il lavoro interessandosi ai problemi di stato, all’amministrazione,
alla politica estera, alle riforme; e su tutto la sapeva più lunga degli stessi senatori, molti dei
quali erano analfabeti.
Seppellito il re, essa ne occupò il posto sul trono, e lo tenne caldo per Servio che
frattanto cresceva e che fu il primo e l’ultimo re di Roma a ereditare la corona senza venire
eletto. Non si sa bene se costui fosse figlio suo o di una sua serva, come sembra indicare il
nome. Comunque, anche di lui gli storici, romani, tutti repubblicani ferventi, hanno cercato
di dir male. Ma non ci sono riusciti. Pur controvoglia, essi hanno dovuto ammettere che il
suo governo fu illuminato e che sotto di lui furono condotte a termine alcune fra le più
importanti imprese. Anzitutto egli costruì una cerchia di mura intorno alla città, dando così
lavoro a muratori, tecnici e artigiani che videro in lui il loro protettore. Poi pose mano alla
grande riforma politica e sociale, che fu di base a tutti i successivi ordinamenti romani.
La vecchia divisione in trenta curie presupponeva una città dì trenta o
quarantamila abitanti, tutti press’a poco con gli stessi titoli, le stesse benemerenze e lo
stesso patrimonio. Ma ora essa era straordinariamente cresciuta, e c’è chi fa ascendere a
sette o ottocentomila anime la popolazione cittadina del tempo di Servio. Probabilmente
son calcoli sbagliati: a tanto dovevano ammontare non gli abitanti di Roma, ma quelli di
tutto il territorio da essa conquistato. Tuttavia la città doveva superare almeno i centomila, e
i grandi lavori pubblici che Tarquinio e Servio intrapresero dovettero essere imposti anche
da un’acuta crisi di alloggi.
Di questa massa, solo quella già iscritta ai comizi curiati aveva voce in capitolo e
poteva votare. Gli altri seguitavano a restare esclusi, e fra costoro c’erano anche i più grandi
industriali e commercianti e banchieri: quelli che fornivano i quattrini allo stato per fare le
guerre e le grandi opere di bonifica. Essi avevano ora diritto a una ricompensa.
Come prima cosa, Servio diede la cittadinanza ai libertini, cioè ai figli degli
schiavi liberati, o liberti. Dovettero essere parecchie e parecchie migliaia di persone, che da
quel momento furono i suoi più accaniti sostenitori. Poi abolì le trenta curie divise secondo
i quartieri, e al loro posto istituì cinque classi, differenziate in base non al loro domicilio,
ma al loro patrimonio. Alla prima appartenevano coloro che avevano almeno centomila
assi; all’ultima quelli che ne possedevano meno di dodicimilacinquecento. A difficile stabilire a cosa corrisponda, in moneta d’oggi, un asse. Forse a dieci lire, forse più. Comunque,
furono queste differenze economiche a determinare anche quelle politiche. Perché mentre
nelle curie tutti erano pari, almeno formalmente, e il voto di ognuno valeva quello dì ogni
altro, le classi votavano per centurie, ma non ne avevano un numero uguale. La prima ne
aveva novantotto. In tutte erano centoventitrè. Sicché in pratica bastavano i novantotto voti
della prima classe per determinare la maggioranza. Le altre, anche se si coalizzavano, non
riuscivano a batterla.
Era un regime capitalista o plutocratico in piena regola, che dava il monopolio del
potere legislativo alla Confindustria, togliendolo alla Federterra, cioè al Senato che di
denaro ne aveva molto meno. Ma cosa poteva esso fare? Servio non gli doveva neppure
l’elezione perché la corona l’aveva ereditata dal padre; e aveva con sé i quattrini dei ricchi
che a lui erano debitori della loro nuova potenza, e l’appoggio del popolino cui egli aveva
dato impiego, salario e cittadinanza. Sorretto da queste forze, si circondò di una guardia
armata per proteggere la propria vita dai malintenzionati, si recinse la testa di un diadema
d’oro, si fece fabbricare un trono d’avorio e su esso sedette, maestosamente, con uno scettro
in mano, sormontato da un’aquila. Patrizio o non patrizio, senatore o mendicante, chiunque
volesse avvicinarlo doveva farsi annunziare e aspettare pazientemente il suo turno in anticamera.
Era difficile eliminare un uomo simile. E infatti i suoi nemici, per riuscirci,
dovettero affidarne il compito a suo nipote-genero, che, come tale, poteva circolare
liberamente nella reggia.
Questo secondo Tarquinio, prima di rischiare il colpo, tentò di far deporre lo zio
per abuso di potere. Servio si presentò alle centurie che lo riconfermarono re con
plebiscitaria acclamazione (lo racconta Tito Livio, gran repubblicano, e dunque dev’esser
vero).
Non restava quindi che il pugnale, e Tarquinio lo usò senza troppi scrupoli. Ma il
respiro di sollievo che trassero i senatori, coi quali si era alleato, rimase loro in gola,
quando videro l’uccisore sedersi a sua volta sul trono d’avorio senza chieder il loro
permesso, come avveniva a quei buoni vecchi tempi ch’essi speravano di restaurare.
Il nuovo sovrano si mostrò subito più tirannico di quello che aveva spedito
all’altro mondo. E infatti lo battezzarono “il Superbo” per distinguerlo dal fondatore della
dinastia. Se gli diedero quel nomignolo, qualche ragione ci dovette essere, anche se non è
vero quel che poi si è raccontato della sua caduta. Pare che si divertisse a uccidere la gente
nel Foro. E di carattere aggressivo fu certamente perché la maggior parte del suo tempo,
come re, la trascorse a fare guerre. Guerre fortunate, perché sotto il suo comando l’esercito,
che ora disponeva di alcune decine di migliaia di uomini, conquistò non soltanto la Sabina,
ma anche l’Etruria e le sue colonie meridionali almeno fino a Gaeta. Di qui sin quasi alle
foci dell’Arno, Roma faceva in quel momento il buono e il cattivo tempo. La guerra non
sempre era calda. Spesso era soltanto “fredda”, come si dice oggi. Ma insomma Tarquinio
fu, un po’ in forza di armi, un po’ in grazia di diplomazia, il capo di qualcosa che, per quei
tempi, era un piccolo impero. Esso non arrivava all’Adriatico, ma ormai dominava il
Tirreno.
Forse Tarquinio menò tanto le mani anche per far dimenticare il modo in cui era
salito al trono sul cadavere dì un re generoso e popolare. I successi esterni servono molte
volte a mascherare la debolezza interna d’un regime. Comunque , e a questa smania di
conquista che Tarquinio dovette, a quanto pare, la sua caduta.
Un giorno, raccontano, egli era al campo, con i suoi soldati, suo figlio Sesto
Tarquinio e suo nipote Lucio Tarquinio Collatino. Costoro, sotto la tenda, cominciarono a
discutere della virtù delle loro rispettive mogli, ognuno sostenendo, da buon marito, quella
della propria. Probabilmente uno disse all’altro: « La mia è una sposa onesta. La tua ti
mette le corna ». Decisero di tornare quella notte a casa per sorprenderle sul fatto.
Inforcarono i cavalli, e via.
A Roma trovarono la moglie di Sesto che si consolava della momentanea
vedovanza banchettando con amici e lasciandosene corteggiare. Quella di Collatino,
Lucrezia, ingannava l’attesa tessendo un abito per suo marito. Collatino, trionfante, intascò
la scommessa e tornò al campo. Sesto, mortificato e smanioso di rivincita, si mise a fare la
corte a Lucrezia, e alla fine, un po’ con la violenza, un po’ con l’astuzia, ne vinse la resistenza.
Commessa l’infedeltà, la povera donna mandò a chiamare suo marito e suo padre,
ch’era un senatore, confessò loro l’accaduto e si uccise con una pugnalata al cuore. Lucio
Giunio Bruto, anche lui nipote del re, che gli aveva ucciso il babbo, adunò il Senato,
raccontò la storia di quell’infamia e propose la decadenza dal trono del Superbo e
l’espulsione dalla città di tutta la sua famiglia (eccetto lui, si capisce). Tarquinio, informato,
si precipitò a Roma, mentre Bruto contemporaneamente galoppava verso il campo, e
probabilmente s’incontrarono per strada. Mentre il re tentava di rimettere ordine nella città,
Bruto gli seminava il disordine nelle legioni che decisero allora di ribellarsi e di marciare su
Roma. Tarquinio fuggì verso il Nord, rifugiandosi in quell’Etruria da cui i suoi antenati
erano discesi e di cui egli aveva umiliato l’orgoglio riducendone le città alla condizione di
vassalle di Roma. Dovette essere una ben amara mortificazione per lui chiedere ospitalità a
Porsenna, lucumone, cioè primo magistrato dì Chiusi, che a quei tempi si chiamava
Clusium.
Ma Porsenna, gran gentiluomo, gliela concesse.
A Roma proclamarono la repubblica. Come più tardi quella dei Plantageneti in
Inghilterra e quella dei Borboni in Francia, anche la monarchia di Roma era durata sette re.
Correva l’anno 500 avanti Cristo. Ne erano trascorsi duecentoquarantasei ab urbe
condita.
CAPITOLO QUINTO
PORSENNA
COME sempre i popoli quando cambiano regime, romani salutarono quello nuovo
con grande entusiasmo, e in esso riposero tutte le loro speranze, comprese quelle della
libertà e della giustizia sociale. Fu convocato un grande comizio centuriato cui presero
parte tutti i cittadini-soldati che proclamarono definitivamente seppellita la monarchia, le
attribuirono la responsabilità di tutti gli errori e soprusi di cui si era macchiata
l’amministrazione della cosa pubblica in quei primi due secoli e mezzo di vita; e al posto
del re nominarono due consoli, scegliendoli nelle persone dei due protagonisti, della
rivoluzione: il povero vedovo Collatino e il povero orfano Lucio Giunio Bruto. Il primo
avendo declinato, fu sostituito da Publio Valerio.
Publio Valerio passò alla storia col nomignolo di “Publicola”, che vuol dire
“amico del popolo”. Questa amicizia, Publicola la dimostrò sottoponendo e facendo
approvare dal comizio alcune leggi che rimasero basilari per tutto il periodo che durò la
repubblica. Esse comminavano la pena di morte a chiunque tentasse d’impadronirsi di una
carica senza l’approvazione del popolo. Consentivano al cittadino che fosse stato condannato a morte il ricorso in appello all’Assemblea, cioè al comizio centuriato. E concedevano
a tutti il diritto di uccidere, anche senza processo, chi tentasse di farsi proclamare re.
Quest’ultima legge dimenticava però di precisare in base a quali elementi si poteva
attribuire a qualcuno quell’ambizione. E ciò consenti al Senato, negli anni che seguirono, di
liberarsi di parecchi incomodi nemici additandoli, appunto, come aspiranti-re. Il sistema è
ancora in uso presso parecchi popoli: gli aspiranti-re si chiamano a volta a volta “deviazionisti”, “nemici della patria”, “agenti al soldo dell’imperialismo straniero”. I delitti,
col progresso, non cambiano. Ne cambia solo la rubrica.
Nel suo zelo democratico, Publicola introdusse anche l’uso, da parte del console,
quando entrava nel recinto del comizio centuriato, di far abbassare, dai littori che lo
precedevano, le insegne: quei famosi fasci, che poi Mussolini rimise di moda, e che
costituivano il simbolo del potere. Per dimostrare plasticamente che questo potere veniva
dal popolo: il quale, dopo averlo delegato al console, ne restava l’arbitro.
Erano tutte bellissime cose, che li per li fecero un grande effetto. Ma, una volta
sbolliti gli entusiasmi, la gente cominciò a domandarsi in cosa si concretavano,
praticamente, i vantaggi del nuovo sistema. Tutti i cittadini avevano il voto, va bene, ma nei
comizi si seguitava a praticare quel diritto per classi, sempre combinate su quello schema
serviano, per cui i milionari della prima, avendo novantotto centurie, e quindi novantotto
voti, bastavano da soli a imporre la propria volontà a tutti gli altri. Infatti, una delle prime
decisioni che presero fu quella di revocare le distribuzioni di terre fatte ai poveri dai
Tarquini nei paesi conquistati. Sicché ci furono parecchi piccoli proprietari che si videro
confiscare, da un giorno all’altro, la casa e il podere e, non sapendo come tirare avanti,
tornarono a Roma in cerca di lavoro.
Ma a Roma di lavoro non ce n’era perché i consoli, essendo nominati per un anno
soltanto, non potevano intraprendere nessuna di quelle grandi opere pubbliche ch’erano la
specialità dei re, eletti a vita i primi cinque, e addirittura a titolo ereditario gli ultimi due.
Inoltre la repubblica, dominata dal Senato che l’aveva fatta e che era costituito di
proprietari terrieri di origine sabina e latina, era taccagna, a differenza della scialacquona
monarchia, dominata dagl’industriali e dai mercanti di origine etrusca e greca. Essa voleva
“risanare il bilancio”, come si direbbe oggi, cioè praticare una politica finanziaria spa-
ragnina anche perché non aveva nessun interesse a moltiplicare la categoria dei nuovi
ricchi, suoi naturali avversari.
Insomma, la città era in crisi, e i poveri cafoni che venivano a cercarvi scampo
dalla disoccupazione e dalla fame delle campagne vi trovavano altra fame e altra
disoccupazione. I cantieri erano fermi, rimaste a mezzo le case e le strade. Gli audaci
imprenditori, ch’erano stati i grandi sostenitori dei Tarquini e avevano dato impiego a
migliaia di tecnici e a decine di migliaia di operai, erano al bando o temevano di esserci
messi. I pubblici locali chiudevano uno dietro l’altro per mancanza di clienti, diradati dalla
scarsezza di circolante e dal clima puritano che tutte le repubbliche diffondono o cercano di
diffondere. I propagandisti del nuovo regime arringavano continuamente la folla per
ricordarle i delitti che i re avevano commesso. Gli ascoltatori si guardavano intorno e
pensavano che fra quei “delitti” c’era anche il Foro, dove in quel momento si trovavano, e
ch’era stato costruito dagli esecrati re.
Un altro punto su cui i propagandisti insistevano erano i misfatti perpetrati
dall’ultima dinastia, che aveva cercato di far di Roma una colonia etrusca. C’era del vero,
ma appunto in grazia di questo Roma aveva ora il suo Circo Massimo, la sua Cloaca, i suoi
ingegneri, i suoi artigiani, i suoi istrioni (ch’erano gli attori,del tempo), i suoi pugilatori e
gladiatori, protagonisti di quegli spettacoli di cui i romani erano tanto ghiotti, e le sue mura,
e i suoi canali, e i suoi indovini, e la sua liturgia per adorare gli dèi: ch’era tutta roba
importata appunto dall’Etruria.
Non tutti naturalmente lo sapevano, perché non tutti in Etruria erano stati. Ma
n’erano più degli altri coscienti i giovani intellettuali, che avevano studiato e preso la laurea
nelle università etrusche di Tarquinia, di Arezzo, di Chiusi, dove i babbi li avevano mandati
a studiare, e di cui conservavano un gran ricordo. Essi non appartenevano in genere alle
famiglie patrizie, che i loro figli se li educavano in casa, badando a farne non uomini
istruiti, ma uomini di carattere. Venivano da famiglie borghesi, e la loro sorte era legata a
quella dei traffici, delle industrie e delle professioni liberali, ch’erano appunto le più colpite
dal nuovo andazzo delle cose.
Per tutte queste ragioni, lo scontento fece presto a nascere. E purtroppo esso
coincise con la dichiarazione di guerra, lanciata da Porsenna, su istigazione di Tarquinio.
Come sia andata questa faccenda, con certezza non si sa. Ma, data la situazione,
non è difficile immaginare quali dovettero essere gli argomenti che il deposto monarca
svolse per indurre il lucumone a prestargli aiuto. Costui dovette certo fargli osservare che i
Tarquini, per quanto di sangue etrusco, verso l’Etruria non si erano poi dimostrati buoni
figli, se l’avevano continuamente tormentata con guerre e spedizioni punitive fino a ridurla
quasi tutta sotto la loro signoria. Ma il Superbo probabilmente gli rispose che, nel momento
stesso in cui egli e i suoi due predecessori facevano romana l’Etruria, facevano anche etrusca la stessa Roma, conquistandola per così dire dal di dentro a spese dell’elemento latino e
sabino che dapprincipio l’aveva dominata. La lotta non era stata fra potenze straniere, ma
fra città rivali, figlie della stessa civiltà. Roma, sebbene ultima nata, aveva cercato non di
distruggerle, ma di riunirle sotto un comando unico per condurle al predominio in Italia.
Forse aveva sbagliato, forse aveva qua e là calcato la mano, con poco rispetto delle loro
autonomie municipali. Ma a nessuna i Tarquini avevano serbato la sorte cui avevano
sottoposto per esempio Alba Longa e tanti altri borghi e villaggi del Lazio e della Sabina,
distrutti dalle fondamenta. Nessuna città etrusca era stata mai messa a sacco. 1 mercanti, gli
artigiani, gl’ingegneri, gli attori, i pugilatori di Tarquinia, di Chiusi, di Volterra, di Arezzo,
appena emigravano a Roma, non vi trovavano la sorte degli schiavi, ma vi diventavano
preminenti, e tutta l’economia, la cultura, l’industria, il commercio delle città erano
praticamente nelle loro mani.
Cioè lo erano stati finché i Tarquini erano rimasti sul trono, a proteggerli. Ora, con
la repubblica significava il ritorno al potere di quei latini e sabini zoticoni, avari, diffidenti,
reazionari e istintivamente razzisti, che avevano sempre covato un sordo odio per la
borghesia etrusca liberale e progressista. Non c’era da farsi illusioni sul modo in cui
l’avrebbero trattata. E la sua scomparsa significava l’affermazione, alle foci del Tevere, di
una potenza forestiera e nemica, al posto di quella consanguinea e amica (anche se un po’
litigiosa e manesca), che domani poteva unirsi agli altri nemici dell’Etruria e contribuire al
suo tramonto.
Se la sentiva, Porsenna, di disinteressarsi a una simile rottura di equilibrio? O non
trovava conveniente prevenire la catastrofe, saltando addosso a Roma, ora che il marasma
vi regnava all’interno, e all’esterno, specie nel Lazio e nella Sabina, le ossa della gente
dolevano per le botte ricevute dai soldati romani? A un cenno del potente lucumone-di
Chiusi, tutte quelle città sarebbero insorte contro le scarse guarnigioni che le presidiavano,
e Roma si sarebbe trovata, sola e discorde, alla mercé del nemico.
Non sappiamo quasi nulla di Porsenna. Ma dal modo come si condusse, dobbiamo
dedurre che alle doti del bravo generale doveva accoppiare quelle del sagace uomo politico.
Egli si rese conto che negli argomenti di Tarquinio c’era del vero. Ma prima d’impegnarsi,
volle essere sicuro di due cose: che il Lazio e la Sabina erano davvero pronti a schierarsi
dalla sua parte, e che nella stessa Roma c’era una “quinta colonna” monarchica pronta a
facilitargli il compito con una insurrezione.
L’insurrezione avvenne effettivamente, e ad essa parteciparono anche i due figli
del console Lucio Giunio Bruto, immemori, si vede, della fine che il Superbo aveva fatto
fare al loro nonno. Essi vennero arrestati e condannati a morte, dopo che la rivolta era stata
energicamente domata. E il loro babbo, dicono, volle assistere di persona alla loro
decapitazione.
Ma la guerra andò male. Le varie città latine e sabine massacrarono le guarnigioni
romane e unirono le loro forze a quelle di Porsenna che giungeva dal Nord alla testa di un
esercito confederato cui tutta l’Etruria aveva mandato i suoi contingenti. Contro questa
invasione, Roma, a sentire i suoi storici, fece miracoli. Muzio Scevola, penetrato
nell’accampamento di Porsenna per ucciderlo, sbagliò bersaglio e castigò da solo la propria
fallace mano, stendendola su un braciere ardente. Orazio Coclite bloccò da solo tutto
l’esercito nemico all’ingresso del ponte sul Tevere che i suoi compagni distruggevano alle
sue spalle. Ma la guerra fu perduta e queste stesse leggende lo provano. La loro esaltazione
costituisce uno dei primi esempi di “propaganda di guerra”. Quando un paese subisce una
disfatta, inventa o esagera dei “gloriosi episodi” su cui richiamare l’attenzione dei
contemporanei e dei posteri e distrarla dal risultato finale e complessivo. Ecco perché gli
“eroi” allignano soprattutto negli eserciti battuti. Quelli che vincono non ne hanno bisogno.
Cesare, per esempio, nei suoi Commentari, non ne cita nessuno.
La resa dell’Urbe fu, come si dice oggi, incondizionata. Essa dovette restituìre tutti
i suoi territori etruschi a Porsenna. I latini ne approfittarono per attaccare a loro volta Roma
che però riuscì a salvarsi con la battaglia del lago Regillo dove i Dioscuri, Castore e
Polluce, figli di Giove, vennero in suo aiuto. Comunque, alla fine di tante disavventure,
quella che sotto i re era stata la capitale di un piccolo impero si ritrovava con ciò che oggi
sarebbe, si e no, un circondario, che a nord non arrivava a Fregene e a sud si fermava prima
di Anzio. Era una grossa catastrofe, e le occorse un secolo per riaversi.
Ma quella guerra fece una vittima ancora più grossa: Tarquinio. Il quale aveva già
fatto le valigie per tornare a Roma, riprendere il potere ed esercitarvi le sue vendette,
quando Porsenna lo fermò e gli disse che non intendeva ripristinarlo sul trono. Si era egli
accorto che la restaurazione monarchica era impossibile, o diffidava di quell’intrigante che,
una volta tornato alla testa del suo popolo e del suo esercito, avrebbe forse dimenticato il
beneficio ricevuto e ricominciato a tormentar l’Etruria?
Propendiamo per la seconda ipotesi. L’Etruria era un paese anarchico, dove ogni
città voleva restare indipendente e non ammetteva di veder limitata la propria autonomia.
Tarquinio avrebbe fatto di Roma una città definitivamente etrusca, ma dell’Etruria una
provincia definitivamente romana. L’Etruria non volle, e la pagò cara. La Lega che
Porsenna aveva faticosamente messo in piedi in quell’occasione si sciolse prima che il suo
esercito confederato potesse ripristinare le comunicazioni con le colonie etrusche del Mezzogiorno, che frattanto erano rosicchiate dai greci. Il lucumone ritornò a Chiusi, e vi si
chiuse, mentre i greci avanzavano a sud, e da nord si, profilava un’altra terribile minaccia:
quella dei galli che scendevano dalle Alpi e sommergevano le colonie etrusche della Valle
padana. Ma nemmeno di fronte a questo pericolo l’Etruria trovò la sua unità, quell’unità
che Tarquinio voleva darle nel segno e nel nome di. Roma. Il vecchio re seguitò a intrigare,
ma inutilmente. Le vittoriose città del Lazio, con Vejo alla testa, collaborarono a impedirne
il ritorno. Preferivano aver a che fare con una Roma repubblicana, di cui sapevano tutte le
difficoltà interne e quindi l’impossibilità di tentare una rivincita, che infatti tardò un secolo
a profilarsi.
Le "liberazioni” costano sempre care. Roma pagò quella sua, dal re, con l’Impero.
Aveva impiegato due secoli e mezzo per conquistare l’egemonia sull’Italia centrale, e
l’aveva raggiunta sotto la guida di sette sovrani. La repubblica, per restar tale, dovette
rinunziare a tutto questo po’ po’ di patrimonio.
Cosa dunque non aveva funzionato, sotto la monarchia, per indurre i romani, pur
di disfarsene, a questa rinunzia?
Non aveva funzionato il crogiuolo, cioè la fusione fra le razze e le classi che ne
costituivano il popolo. I primi quattro re avevano mortificato l’elemento etrusco che
costituiva la Borghesia, la Ricchezza, il Progresso, la Tecnica, l’Industria, il Commercio.
Gli ultimi tre avevano mortificato l’elemento latino e sabino che costituiva l’Aristocrazia,
l’Agricoltura, la Tradizione e l’Esercito, che trovavano.la loro espressione politica nel
Senato. E ora il Senato si vendicava. Si vendicava con la repubblica, che fu esclusivamente
opera sua.
D’ora in poi, tutto fu repubblicano, a Roma, anche e specialmente la storia, che
cominciò ad essere narrata in modo da screditare sempre più il periodo monarchico e i
grandiosi successi che sotto di esso Roma aveva conseguiti. Non bisogna dimenticarselo,
quando si leggono i libri di storia romana, concordi nel far coincidere l’inizio della
grandezza dell’Urbe dal momento in cui ne fu scacciato l’ultimo Tarquinio.
Ma non, è vero. Roma era già stata una potente capitale al tempo dei re, ed è in
buona parte grazie alla loro opera che Io ridiventerà. Gli austeri magistrati che ne presero il
posto ed esercitarono il potere %n nome del popolo” vi trovarono già costituite le premesse
dei futuri trionfi: una città bene organizzata dal punto di vista urbanistico e amministrativo,
una popolazione cosmopolita e piena di risorse, una élite di tecnici di prima qualità, un
esercito sperimentato, una Chiesa e una lingua ormai codificate, una diplomazia che aveva
fatto il suo tirocinio formando e rompendo alleanze un po’ con tutti i vicini di casa.
Questa diplomazia fu abile anche nel momento della catastrofe. Essa, si affrettò a
stipulare due trattati: uno con Cartagine per assicurarsi la tranquillità dalla parte del mare,
uno con la Lega Latina per assicurarsela dalla parte di terra. Ambedue implicavano le più
radicali rinunzie. Sul mare, Roma abbandonava ogni pretesa in Corsica, Sardegna e Sicilia,
che s’impegnava a non oltrepassare con le sue navi, e dove poteva soltanto rifornirsi senza
mettervi piede. Ma era una rinunzia che le costava poco, visto che non aveva ancora una
flotta degna di questo nome.
Più dolorose erano quelle di terra, sancite dal console Spurio Cassio al termine
delle ostilità con Vejo e i suoi alleati. Roma rimase padrona solo dì cinquecento miglia
quadrate e dovette accettare di essere pari tra pari nella Lega Latina. Il foedus, cioé il patto
del 493 avanti Cristo, comincia con queste enfatiche parole: Sia pace tra i romani e tutte le
città latine finché la posizione del cielo e della terra rimanga la stessa...
La posizione del cielo e della terra non era per nulla cambiata quando, meno di un
secolo dopo, la repubblica romana riprese il sentiero di guerra a mezzo del quale si erano
fermati i suoi antichi re e non lasciò alle città latine neanche gli occhi per piangere.
Da allora le alleanze fra gli stati si son continuate a stipulare col proposito di farle
durare finché la posizione del cielo e della terra rimanga la stessa. E, a distanza di pochi
anni o di molti anni, uno dei contraenti fa immancabilmente la fine di Vejo. Ma,
impassibili, i diplomatici insistono a usare quella formula, o altra equivalente, e i popoli a
crederci.
CAPITOLO SESTO
SPQR
DA quell’anno 508 in cui fu fondata la repubblica, tutti i monumenti che i romani
innalzarono un po’ dappertutto portarono sempre la sigla SPQR che vuol dire: Senatus
Populus-Que Romanus, cioè “il Senato e il popolo romano”.
Cosa fosse il Senato, già lo abbiamo detto. Viceversa non abbiamo ancora detto
cos’era il popolo, che non corrispondeva affatto a ciò che noi intendiamo con questa parola.
In quei lontani giorni di Roma esso non comprendeva “tutta” la cittadinanza, come avviene
oggi, ma soltanto due “ordini”, cioè due classi sociali: quella dei “patrizi” e quella degli
equites o “cavalieri”.
I patrizi erano quelli che discendevano dai patres, cioè dai fondatori della città.
Secondo Tito Livio, Romolo aveva scelto un centinaio di capi-famiglia che lo aiutassero a
costruire Roma.
Essi naturalmente si erano accaparrati i migliori poderi e si consideravano un po’ i
padroni di casa rispetto a quelli ch’eran venuti dopo. I primi re infatti non avevano avuto
nessun problema sociale da risolvere perché tutti i sudditi erano uguali fra ol ro, e lo stesso
sovrano non era che uno di essi incaricato da tutti gli altri di compiere determinate funzioni
soprattutto religiose.
Con Tarquinio Prisco, a Roma, era cominciata a piovere un sacco d’altra gente,
specie dall’Etruria. E da questi nuovi venuti, i discendenti dei patres tenevano con molta
diffidenza le distanze, difendendosi dentro la roccaforte del Senato, accessibile soltanto ai
membri delle loro famiglie. Ognuna di esse portava il nome dell’antenato che l’aveva
fondata: Manlio, Giulio, Valerio, Emilio, Cornelio, Claudio, Orazio, Fabio.
Fu dal momento in cui dentro le mura della città cominciarono a convivere queste
due diverse popolazioni, i discendenti degli antichi pionieri e i nuovi venuti, che le classi
presero a differenziarsi: da una parte i patrizi, dall’altra i plebei.
Presto i patrizi furono, per numero, soverchiati, come sempre succede in tutti i
paesi nuovi, per esempio l’America del Nord. Qui i patrizi si chiamavano pilgrim fathers, ì
padri pellegrini, ed erano rappresentati dai trecentocinquanta colonizzatori che per primi
vennero a stabilircisi a bordo di una nave chiamata Mayflower, poco più di tre secoli
orsono. Anche i loro discendenti seguitano pur oggi a considerarsi un po’ i patrizi
dell’America: ma non hanno potuto mantenere nessun privilegio perché le successive
ondate di immigranti fecero presto a sommergerli. Discendere da un padre pellegrino del
Mayflower è soltanto, laggiù, un titolo d’onore.
I patrizi romani contro questa mescolanza resistettero molto più à lungo. E per
meglio difendere le loro prerogative, fecero quello che fanno tutte le classi sociali, quando
sono furbe e si trovano in minoranza numerica: chiamarono dei plebei a condividere i loro
privilegi, impegnandoli così a difenderli anch’essi.
Sotto il re Servio Tullio, le classi sociali già non erano più due soltanto. Fra i
plebei si era differenziata una grossa borghesia o ceto medio, abbastanza numerosa e
soprattutto fortissima dal punto di vista finanziario. Quando il re organizzò i nuovi comizi
centuriati dividendoli in cinque classi secondo il patrimonio, e dando alla prima, quella dei
milionari, abbastanza voti per battere le altre quattro, i patrizi non furono punto contenti
perché si videro soverchiati, come potenza politica, da gente che “non nasceva”, come si
dice oggi, cioè che non aveva antenati, ma in compenso aveva più quattrini di loro. Però,
quando Tarquinio il Superbo fu cacciato via e al suo posto instaurata la repubblica, essi
compresero che non potevano restare soli contro tutti gli altri, e pensarono di prendersi
come alleati quei ricconi che in fondo, come tutti i borghesi di tutti i tempi, non
domandavano di meglio che di entrare a far parte dell’aristocrazia, cioè del Senato. Se i
nobili francesi del Settecento avessero fatto altrettanto, si sarebbero risparmiati la
ghigliottina. Questi ricconi, come abbiamo detto, si chiamavano equites, cavalieri.
Venivano tutti dal commercio e dall’industria, e il loro grande sogno era di diventare
senatori. Per riuscirvi, non solo votavano sempre, nei comizi centuriati, d’accordo coi
patrizi, che del Senato avevano le chiavi; ma non badavano a rimetterci di tasca propria,
quando veniva loro affidato un ufficio o un incarico. Perché i patrizi si facevano pagare
profumatamente la concessione dell’alto onore. E quando sposavano una figlia di cavaliere,
per esempio, esigevano una dote da regina. E anche il giorno che il cavaliere riusciva
finalmente a diventare senatore, non veniva accolto come pater, cioè come patrizio, ma
come conscriptus, in quell’assemblea che infatti era costituita da “padri e coscritti”, patres
et conscripti.
Il popolo era dunque formato soltanto di questi due ordini: patrizi e cavalieri.
Tutto il resto era plebe, e non contava. In essa era compreso un po’ di tutto: artigiani,
piccoli bottegai, impiegatucci, liberti. E naturalmente non erano contenti della loro
condizione. Infatti il primo secolo della nuova storia di Roma fu interamente occupato dalle
lotte sociali fra chi voleva allargare il concetto di popolo e chi voleva tenerlo ristretto alle
due aristocrazie: quella del sangue e quella del portafogli.
Questa lotta cominciò nel 494 avanti Cristo, cioè a dire quattordici anni dopo la
proclamazione della repubblica, quando Roma, assalita da ogni parte, aveva perso tutto
quello che aveva conquistato sotto i re e, ridotta press’a poco a capoluogo di circondario,
s’era dovuta acconciare alla parte di membro della Lega Latina su piede di uguaglianza con
tutte le altre città. Alla fine di quella rovinosa guerra la plebe, che aveva fornito la mano
d’opera per combatterla, si trovò in condizioni disperate. Molti avevano perso il podere,
rimasto nei territori occupati dal nemico. E tutti, per mantenere la famiglia mentre si trovavano alle armi, si erano coperti di debiti, che a quei tempi non erano una faccenda di tutto
riposo, come lo sono oggi. Chi non li pagava, diventava automaticamente schiavo del
creditore, il quale poteva imprigionarlo nella sua cantina, ucciderlo, o venderlo.
Se i creditori erano parecchi, erano autorizzati anche a dividersi il corpo dello
sciagurato dopo averlo accoppato. E sebbene a questo estremo non sembra che si sia mai
arrivati. la condizione del debitore restava ugualmente scomoda.
Cosa potevano fare, questi plebei, per reclamare un po’ dì giustizia? Nei comizi
centuriati non avevano voce perché appartenevano alle ultime classi: quelle che avevano
troppo poche centurie, e quindi troppo pochi voti, per imporre la loro volontà.
Cominciarono ad agitarsi per strada e nelle piazze, domandando per bocca dei più svelti,
che sapevano parlare, la cancellazione dei debiti, una nuova ripartizione di terre che
consentisse loro di rimpiazzare il perduto potere, e il diritto di eleggere magistrati propri.
Gli “ordini” e il Senato fecero, a queste richieste, orecchio da mercante. E allora la
plebe, o per lo meno larghe masse di plebe, incrociarono le braccia, si ritirarono sul Monte
Sacro, a cinque chilometri dalla città, e dissero che da quel momento in poi non avrebbero
più dato né un bracciante alla terra, né un operaio alle industrie, né un soldato all’esercito.
Quest’ultima minaccia era la più grave e pressante perché proprio in quel
momento, ristabilita alla meglio la pace coi vicini di casa latini e sabini, una nuova
minaccia si profilava dalla parte dell’Appennìno, dai cui monti avevano cominciato a
ruzzolare a valle, in cerca di terre più fertili, le tribù barbare degli equi e dei volsci, che già
stavano sommergendo le città della Lega.
Il Senato, preso alla gola, mandò ambascerie su ambascerie ai plebei per indurli a
rientrare in città e a collaborare alla difesa comune. E Menenio Agrippa, per convincerli,
raccontò loro la famosa storia di quell’uomo, le cui membra, per far dispetto allo stomaco,
si erano rifiutate di procurargli il cibo: così, rimaste senza nutrimento, finirono per morire
anch’esse, come l’organo di cui volevano vendicarsi. Ma i plebei, duri, risposero che non
c’era scelta: o il Senato cancellava i debiti liberando coloro che eran diventati schiavi
perché non li avevano pagati e consentiva alla plebe di eleggere i suoi propri magistrati che
la difendessero; o essa restava sul Monte Sacro, e venissero pure tutti gli equi e i volsci di
questo mondo a distruggere Roma.
Alla fine il Senato si arrese. Cancellò i debiti, restituì alla libertà chi per essi era
caduto in schiavitù, e mise la plebe sotto la protezione di due tribuni e di tre edili da essa
eletti di anno in anno. Quest’ultima fu la prima grande conquista del proletariato romano,
quella che gli diede lo strumento legale per raggiungere anche le altre sulla strada della
giustizia sociale, l’anno 494 è molto importante nella storia dell’Urbe e della democrazia.
Col ritorno dei plebei, fu possibile mettere in campo un esercito per parare la
minaccia dei volsci e degli equi. In questa guerra, che durò circa sessant’anni e che aveva
per posta la sua sopravvivenza, Roma non fu sola. Il comune pericolo le tenne fedeli non
solo gli alleati latini e sabini, ma anche un altro popolo limitrofo, quello degli ernici.
Nei combattimenti che subito si accesero con esito incerto si distinse, raccontano,
un giovane patrizio chiamato Coriolano, dal nome di una città che aveva espugnato. Era un
conservatore intransigente, e non voleva che il governo facesse una distribuzione di grano
al popolo affamato. I tribuni della plebe, che frattanto erano stati eletti, chiesero e ottennero
il suo esilio. Coríolano allora passò al nemico, se ne fece dare il comando e, da quel
brillante stratega che era, lo condusse di vittoria in vittoria fino alle porte di Roma.
Anche a lui i senatori mandarono ambascerie su ambascerie per farlo desistere.
Non ci fu verso. Solo quando egli vide venirsi incontro, supplicanti, la madre e la moglie,
comandò il “dietro front” ai suoi, che per tutta risposta l’uccisero; ma poi, rimasti senza
guida, furono sconfitti e obbligati a ritirarsi.
Sul loro risucchio comparvero gli equi, che già avevano messo a soqquadro
Frascati. Riuscirono a rompere i collegamenti fra i romani e i loro alleati. E il pericolo fu
così grave che il Senato, per pararlo, concesse titolo e poteri di dittatore a T. Quinzio
Cincinnato che, con un nuovo esercito, liberò le legioni circondate e le condusse a una
definitiva vittoria nel 431, poi, deposto il comando dopo averlo esercitato solo per sedici
giorni, tornò ad arare il podere dal quale era venuto.
Ma prima ancora di questa felice conclusione, una nuova guerra si era accesa a
nord dalla parte dell’etrusca Vejo, che non voleva perdere quella favorevole occasione per
mettere Roma definitivamente a terra. Le aveva già fatto parecchi dispetti mentr’era
impegnata a difendersi da equi e volsci. E Roma aveva subito all’inglese, cioè legandosela
al dito. Appena ebbe le mani libere, le adoprò per saldare i conti. Fu una guerra dura, e
anch’essa richiese, a un certo punto, la nomina di un dittatore. Fu costui Marco Furio
Camillo, gran soldato e soprattutto gran galantuomo, che portò nell’esercito una grossa
novità: lo stipendium,, cioè la “cinquina”. Sino a quel momento i soldati avevano dovuto
prestare servizio gratis; e, se avevano moglie, le famiglie rimaste in patria morivano di
fame. Camillo lo trovò ingiusto e vi pose rimedio. La truppa, soddisfatta, raddoppiò il suo
zelo, conquistò di slancio Vejo, la distrusse meticolosamente, e ne deportò come schiavi
tutti gli abitanti.
Questa grande. vittoria e l’esemplare castigo che la sigillava riempirono d’orgoglio
i romani, quadruplicarono i loro territori portandoli a oltre duemila chilometri quadrati, e li
resero pieni di gelosia e di diffidenza per chi glieli aveva procurati. Mentre Camillo
seguitava a conquistare città su città in Etruria, a Roma cominciarono a dire ch’era un
ambizioso e che s’intascava il bottino dei popoli vinti, invece di consegnarlo allo stato.
Camillo ne fu talmente amareggiato che depose il comando e, invece di tornare in patria a
scolparsi, se ne andò in volontario esilio ad Ardea.
Forse vi sarebbe morto lasciando un nome insudiciato dalle calunnie, se gl’ingrati
romani non avessero di nuovo avuto bisogno di lui per salvarsi dai galli, l’ultimo e il più
grave pericolo da cui dovettero difendersi, prima d’iniziare la grande conquista. 1 galli
erano una popolazione barbara, di razza celtica, che, venuta dalla Francia, già aveva
sommerso la pianura del Po. Divisero quel fertile territorio fra le loro tribù, gl’insubri, i boi,
i cenomani, i senoni; ma una di esse, al comando di Brenno, mosse verso il sud, conquistò
Chiusi, travolse le legioni romane sul fiume Allia, e marciò su Roma.
Gli storici che lo hanno raccontato a cose fatte hanno avvolto di molte leggende
questo capitolo che dovett’essere per l’Urbe molto spiacevole. Dicono che quando i galli
fecero per dare la scalata al Campidoglio, le oche sacre a Giunone cominciarono a stridere
risvegliando così Manlio Capitolino che, alla testa dei difensori, respinse l’attacco. Sarà.
Però i galli in Campidoglio entrarono ugualmente come in tutto il resto della città, donde la
popolazione era fuggita in massa per rifugiarsi sui monti circostanti. Dicono anche che i
senatori però erano rimasti, al completo, solennemente assisi sui rozzi scranni di legno della
loro curia, e che uno di essi, Papirio, nel sentirsi tirar la barba per dileggio da un gallo, che
forse la credeva finta, gli sbatacchiò sul viso lo scettro d’avorio. E infine narrano che
Brenno, dopo aver appiccato il fuoco a tutta Roma, chiese. per andarsene, non so quanti
chili d’oro e impose, per pesarli, una bilancia che rubava. 1 senatori protestarono, e Brenno
allora, sul piatto dei pesi, buttò anche la sua spala, pronunciando la famosa frase: « Vae
victis ! », “guai ai vinti!”. Al che Camillo, ricomparso per miracolo, avrebbe risposto: «Non
auro, sed ferro, recuperanda est patria », la patria la si restaura col ferro, non con l’oro”. si
sarebbe rimesso a capo dì un esercito, che sino a quel momento non si capisce dove si fosse
tenuto nascosto, e avrebbe volto in fuga il nemico.
,La verità è che i galli espugnarono Roma, la misero a sacco, e se ne andarono
incalzati dalle legioni, ma carichi di quattrini. Erano predoni gagliardi e zotici, che non
seguivano nessuna linea politica e strategica nelle loro conquiste. Assalivano, depredavano
e si ritiravano senza punto preoccuparsi del domani. Avessero potuto immaginare che
vendetta Roma avrebbe tratto da quella umiliazione, non vi avrebbero lasciato pietra su
pietra. Invece la devastarono sì,. ma senza distruggerla. E tornarono sui loro passi, verso
l’Emilia e la Lombardia, dando modo a Camillo, richiamato d’urgenza da Ardea, di riparare
i guasti. Egli probabilmente non fece coi galli neanche una scaramuccia. ‘ Essi erano già
partiti, quando egli arrivò. Ma, mettendo da parte i rancori, riprese il titolo di dittatore, si
rimboccò le maniche, e si mise a ricostruire la città e l’esercito.
Coloro stessi che lo avevano chiamato ambizioso e ladro lo chiamarono ora “il
secondo fondatore di Roma”.
Ma mentre tutto questo avveniva sul fronte esterno, su quello interno l’Urbe
raggiungeva un grosso traguardo con la Legge delle Dodici Tavole.
Fu un successo dei plebei i quali, dacché erano tornati dal Monte Sacro, non
avevano cessato di chiedere che le leggi non fossero più lasciate in monopolio alla Chiesa,
che a sua volta era monopolio dei patrizi, ma venissero pubblicate in modo che ognuno
sapesse quali erano i suoi doveri e quali le pene che gli sarebbero toccate in caso
d’infrazione. Sino a quel momento le nonne in base a cui,il magistrato giudicava erano state
segrete, raccolte in testi che i sacerdoti conservavano gelosamente, e mescolate con riti
religiosi con cui si pretendeva indagare la volontà degli dèi. Un assassino, se il dio era di
buon umore, poteva scapolarsela; un povero ladruncolo di polli, se il dio era in giornata
nera, poteva finire sulla forca. Siccome coloro che ne interpretavano il volere, magistrati e
sacerdoti, erano patrizi, i plebei si sentivano senza difesa.
Sotto la pressione del pericolo esterno, dei volsci, degli equi, dei veienti, dei galli,
e la minaccia di una seconda secessione sul Monte Sacro, il Senato, dopo molte resistenze,
si arrese, e mandò tre dei suoi membri in Grecia, a studiare quello che aveva fatto Solone in
questo campo. Quando i messi tornarono, fu nominata una commissione di dieci legislatori,
detti dal loro numero decemviri. Sotto la presidenza di Appio Claudio, essi redassero il
codice delle Dodici Tavole, che costituì la base, scritta e pubblica, del diritto romano.
Questa grande conquista porta la data dell’anno 451, che corrispondeva press’a
poco al trecentesimo anniversario della fondazione dell’Urbe.
Essa non andò liscia. Perché i pieni poteri che il Senato aveva conferito ai
decemviri per realizzarla erano tanto piaciuti a costoro, che alla fine del secondo anno,
quando dovevano scadere, si rifiutarono di restituirli a chi glieli aveva dati. Raccontano che
la colpa fu di Appio Claudio che volle continuare a esercitarli per ridurre in schiavitù e
vincere le resistenze dì una bella e appetitosa plebea, Virginia, di cui si era innamorato. Il
padre, Lucio Virginio, andò a protestare. E, visto che Appio non gli dava retta, piuttosto che
lasciar la sua creatura in balìa di quel típaccio, lo pugnalò. Dopodiché, come già aveva fatto
Collatino dopo la faccenda di Lucrezia, corse in caserma, raccontò ai soldati l’accaduto e li
esortò a sollevarsi contro il despota. Indignata, la plebe ancora una volta si ritirò sul Monte
Sacro (orinai aveva imparato), l’esercito minacciò di seguirvela. Il Senato riunito
d’urgenza, disse ai decemviri (con profonda soddisfazione, riteniamo) che non poteva
mantenerli in carica. Essi furono quindi dimissionati d’ufficio, Appio Claudio venne
bandito, e il potere esecutivo restituito ai consoli.
Non era ancora il trionfo della democrazia, che avverrà solo un secolo dopo, con le
rogazioni licinie-sestie. Ma era già un grosso passo avanti. La P di quella sigla SPQR
cominciava ad essere il Populus, quale noi lo intendiamo al giorno d’oggi.
CAPITOLO SETTIMO
PIRRO
DALL’UMILIAZIONE toccatale per mano dei galli e dalle convulsioni della lotta
interna fra patrizi e plebei, Roma usci con due grosse briscole in tasca: la supremazia nella
Lega, rispetto alle rivali latine e sabine che, molto più devastate di lei, non avevano poi
trovato un Camillo per ricostruirsi; e un più equilibrato ordine sociale, che garantiva una
tregua fra le classi. Sicché, appena si furono, diradati i fumi degl’incendi che Brenno si era
lasciati sul solco della sua ritirata verso il Nord, l’Urbe, tutta nuova e più modernamente
attrezzata di prima, cominciò a guardarsi bene intorno in cerca di bottino.
Fra quelle confinanti, la Campania era la terra più fertile e ricca. L’abitavano i
sanniti, una parte dei quali però era rimasta sui monti dell’Abruzzo. E di qui, incalzati dal
freddo e dalla fame, scendevano spesso a saccheggiare gli armenti e le messi dei loro
confratelli del piano. Sotto la minaccia di una di queste incursioni, i sanniti di Capua si
rivolsero per protezione a Roma, che di tutto cuore gliela concesse, perché era il modo
migliore di dividere definitivamente in due quel popolo e di ficcare il naso nei suoi affari
interni. Così cominciò la prima delle tre guerre sannitiche, quella contro gli abruzzesi, che
durarono in tutto una cinquantina d’anni.
Fu breve, dal 343 al 341, e qualcuno dice che non fu mai nemmeno combattuta,
perché gli abruzzesi non si fecero vedere, e i romani non se la sentirono di andarli a scovare
sui loro monti. Però una conseguenza rimase: la “protezione” di Roma su Capua, che a tal
punto si sentì protetta da invitare i latini a un fronte unico contro la comune protettrice. I
latini aderirono e Roma, da alleati, se li trovò improvvisamente nemici. Fu un brutto
momento, che richiese i soliti eroici episodi per superarne le difficoltà. Il console Tito
Manlio Torquato, per dare un esempio di disciplina, condannò a morte il proprio figlio che,
contrariamente all’ordine di non muoversi, era uscito dai ranghi per rispondere all’oltraggio
di un ufficiale latino. E il suo collega Publio Decio Mure, quando gli auguri gli dissero che
solo col sacrificio della sua vita avrebbe salvato la patria, avanzò da solo contro il nemico,
lieto di farsene uccidere.
Veri o inventati che siano questi episodi, Roma vinse, e sciolse la Lega Latina che
l’aveva tradita. Con questo finì la politica “federalistica” usata sino ad allora, e s’inaugurò
quella “unitaria” del blocco unico. Alle diverse città che avevano composto la Lega, Roma
concesse forme diverse di, autonomia, in modo da impedire una comunanza d’interessi tra
loro. Era la tecnica del divide et impera che faceva capolino. Fra le città soggette non ci
dovevano essere rapporti politici. Ognuna di esse li serbava solo con l’Urbe. In Campania
furono mandati coloni, che ebbero in regalo le terre conquistate e vi costituirono gli
avamposti della romanità nel Sud. Nasceva l’impero.
La seconda guerra sannitica cominciò, senza pretesto, una quindicina d’anni dopo,
nel 328. I romani, giunti con quella precedente alle soglie di Napoli, la capitale delle
colonie greche, vi misero gli occhi addosso e rimasero incantati delle sue lunghe mura
elleniche, delle sue palestre, dei suoi teatri, dei suoi commerci, della sua vivacità. E un bel
giorno l’occuparono.
I sanniti, sia quelli del piano, sia quelli della montagna, capirono che, a lasciarla
fare, quella gente avrebbe divorato tutta l’Italia, conclusero pace fra loro e attaccarono alle
spalle le legioni spintesi così lontano nel Sud. Dapprima il loro esercito, più di guerriglieri
che di soldati, fu battuto; ma poi, conoscendo il terreno meglio dei romani, li attrassero
nelle gole di Caudio presso Benevento, e ce li strangolarono. Dopo ripetuti e inutili tentativi
di sottrarsi alla morsa, i due consoli dovettero capitolare e subire l’umiliazione di passare
sotto il giogo delle lance sannite: furon queste le famose “forche caudine”.
Roma, come al solito, incassò lo schiaffo, ma non chiese pace. Facendo tesoro
dell’esperienza, riordinò le legioni in modo da non esporle più a simili disavventure e da
renderle di più facile e svelto maneggio. Poi, nel 316, riprese la lotta. Ancora una volta si
trovò di fronte al pericolo, quando gli etruschi a nord e gli ernici a sud-est cercarono di
coglierla alla sprovvista. Li batte separatamente. Poi rivolse tutte le sue forze contro
gl’isolati sanniti, nel 305 espugnò la loro capitale, Boviano, e per la prima volta le sue
legioni, traversato l’Appennino, raggiunsero la costa adriatica delle Puglie.
Questi successi preoccuparono gravemente gli altri popoli della penisola che, per
paura, trovarono il coraggio di sfidare, coalizzati, Roma. Ai sanniti si unirono stavolta, oltre
agli etruschi, anche i lucani, gli umbri e i sabini, decisi a difendere, con la propria
indipendenza, la propria anarchia. Misero insieme un esercito, che affrontò i romani a
Sentino, sull’Appennino umbro. Erano superiori come numero, ma i vari generali che
comandavano i vari contingenti, invece di collaborare tra loro, tiravano ognuno a far ciccia
per conto proprio. E naturalmente furono battuti. Decio Mure, figlio del console che si era
volontariamente sacrificato per la patria nella campagna precedente, ripete il gesto del
padre e assicurò definitivamente il nome della famiglia alla storia. La coalizione si sfasciò.
Etruschi, lucani e umbri chiesero una pace separata. Sanniti e sabini continuarono a
combattere ancora cinque anni. Poi, nel 290 avanti Cristo, si arresero.
Gli storici moderni sostengono che Roma affrontò questo ciclo di guerre avendo di
mira un preciso obbiettivo strategico: l’Adriatico. Noi crediamo,che sull’Adriatico le sue
legioni si trovarono senza saper né come né perché, solo correndo dietro al nemico in fuga.
I romani del tempo non avevano carte geografiche, ignoravano che l’Italia costituiva ciò
che oggi si chiamerebbe “una naturale unità geopolitica”, che essa aveva la forma di uno
stivale, e che, per tenerla in pugno, occorreva dominarne i mari. Ma, senza conoscerne né
formularne la teoria, essi praticavano, semplicemente, il principio del Lebensraum, o
“spazio vitale" secondo cui, per vivere e respirare, un territorio ha bisogno di annettersi
quelli contigui. Così, per garantire la sicurezza di Capua, conquistarono Napoli; per
garantire la sicurezza di Napoli, conquistarono Benevento; finché arrivarono a Taranto,
dove si fermarono, perché di là non c’era che il mare.
Taranto, a quei tempi, era una metropoli greca, che. aveva fatto enormi progressi
specie nel campo delle industrie, dei commerci e delle arti, sotto la guida di Archita, uno
dei più grandi uomini di stato dell’antichità, mezzo filosofo e mezzo ingegnere. Non era
una città bellicosa. Nel 303 aveva chiesto e ottenuto dall’Urbe la promessa che le navi
romane non avrebbero mai superato il Capo Colonne, cioè che i romani l’avrebbero lasciata
in pace dalla parte del mare sicura com’era che via terra non potevano giungere fin lì. E
invece proprio da quella parte ora se li vedeva ruzzolare addosso.
Il pretesto di guerra fu offerto, come al solito da una richiesta di protezione che
quelli di Turii, insidiati dai lucani, rivolsero a Roma, che, come sempre, prontamente
l’accolse e mandò una guarnigione a difenderli, ma via mare. Lo fece apposta per attaccar
briga, senza dubbio. Le navi, per raggiungere Turii, dovettero oltrepassare il Capo Colonne;
e i tarantini su questa infrazione ai patti chiusero un occhio. Ma quando le dieci triremi di
Roma pretesero di ormeggiarsi nel loro porto, considerarono la cosa come una
provocazione, le assalirono e ne affondarono quattro.
Compiuto il gesto, si resero conto ch’esso comportava la guerra, e che la guerra
non poteva finire che molto male per loro, se di fuori non giungeva qualche potente aiuto.
Ma quale? In Italia non c’era più -un solo stato che potesse opporsi a Roma. E allora
mandarono a cercarne all’estero,- inaugurando un costume che nel nostro paese dura
tuttora. Lo trovarono, di là dal mare, in Pirro, re dell’Epiro.
Pirro era un curioso personaggio che, se si fosse contentato del suo piccolo reame
montanaro, avrebbe potuto vivere a lungo e da signore. Ma aveva letto nell’Iliade le gesta
di Achille; nelle sue vene c’era sangue macedone, ch’era stato il sangue di Alessandro il
Grande; e tutto concorreva a far di lui una figura molto simile ai nostri condottieri del
Quattrocento. Era insomma,.come si direbbe oggi, un tipo che cercava “rogne”. Quella che
gli offrivano i tarantini era proprio sulla sua misura, e la colse a volo. Imbarcò. sulle loro
navi il suo esercito, e ad Eraclea affrontò i romani.
Costoro si trovarono per la prima volta a faccia a faccia con una nuova arma di cui
non avevano mai immaginato l’esistenza e che fece su di loro la stessa impressione che i
primi carri armati inglesi fecero sui tedeschi in Fiandra nel 1916: gli elefanti. Dapprincipio
credettero che fossero buoi, e così li chiamarono infatti: “buoi lucani”. Ma nel vederseli
venire addosso, furono colti dallo sgomento e persero la battaglia, pur infliggendo tali
perdite al nemico da togliergli ogni gioia per il successo. Le “vittorie di Pirro” sono state,
da allora in poi, quelle pagate a troppo caro prezzo.
L’epirota bissò l’anno dopo (279) ad Ascoli Satriano. Ma anche lì le sue perdite
furono tali che, guardando il campo di battaglia cosparso di morti, fu colto dalla stessa crisi
di sgomento che due millenni più tardi doveva cogliere Napoleone III alla vista del campo
di battaglia di Solferino. E mandò a Roma il suo segretario Cinea con proposte di pace,
dandogli per compagni duemila prigionieri romani che, se la pace non fosse stata conclusa,
s’erano impegnati a tornare. Dicono che il Senato stava per accettare quelle offerte, quando
si alzò a parlare il censore Appio Claudio il Cieco, per ricordare all’assemblea che non era
dignitoso trattare con uno straniero) finché il suo esercito invasore continuava a bivaccare
in Italia.
Non crediamo che sia vero perché per Roma l’Italia, in quel momento, era Roma
soltanto. Però è certo che il Senato respinse le proposte, e che Cinea, tornando con i
duemila prigionieri, nessuno dei quali era venuto meno alla parola data, fece a Pirro un tale
resoconto di ciò che aveva visto a Roma, che l’epirota preferì abbandonare l’impresa: e,
accolto un invito dei siracusani perché li aiutasse a liberarsi dai cartaginesi, mosse verso la
Sicilia. Neanche qui le cose gli andarono bene perché le città greche ch’era venuto a
difendere non riuscirono mai a mettersi d’accordo e a fornirgli i contingenti che gli avevano
promesso. Scoraggiato, Pirro riattraversò lo stretto per tornare a dare manforte a Taranto
che le legioni romane in quel momento investivano. Stavolta esse erano abituate agli
elefanti e non se ne lasciarono sgomentare. Pirro fu battuto a Malevento, che per
l’occasione fu ribattezzata dai romani Benevento, nel 275. Decisamente, l’Italia non gli
aveva portato fortuna. Amareggiato, tornò in patria, andò a cercarsi una rivincita in Grecia,
e vi trovò invece la morte.
Erano trascorsi esattamente settant’anni (343-273) da quando Roma, riassestatasi
alla meglio internamente dopo il terremoto seguito alla caduta della monarchia e superata la
lotta per l’esistenza, si era messa sul piede delle vere e proprie guerre di conquista. Ed
eccola alla fine arbitra di tutta la penisola dall’Appennino tosco emiliano allo stretto di
Messina. Uno dopo l’altro, tutti i piccoli potentati che la costellavano le caddero in mano,
compresi quelli della Magna Grecia continentale, rimasti senza difensori dopo la partenza
di Pirro. Taranto si arrese nel 272, Reggio nel 270. Ma, dopo l’esperienza fatta con la Lega
Latina, Roma aveva capito che dei “protetti” e degli “alleati per forza” non bisognava
fidarsi. E un po’ per questo, un po’ perché sospinti dalla pressione demografica dell’Urbe, i
romani iniziarono la vera e propria romanizzazione dell’Italia col metodo delle “colonie”
già adottato dopo la prima guerra sannitica. Le terre nemiche venivano confiscate e
distribuite a cittadini romani nullatenenti, specie in base a meriti che oggi chiameremmo
“combattentistici”. Erano soprattutto dei veterani che se le vedevano assegnate: gente
sicura, pronta a menar le mani per difendersi e difendere Roma. Gl’indigeni naturalmente li
accoglievano senza simpatia, come ladri oppressori. Dal nome di uno di essi, Cafo, caporale
dell’esercito di Cesare, coniarono più tardi la parola “cafone”, termine dispregiativo che
significa rozzo e volgare. E sipirato da questa ostilità fu l’uso, che nacque allora, della “pernacchia”, sberleffo irriverente con cui i popoli vinti salutavano i romani che. entravano
nelle loro città e che sulle prime, a quanto pare, fu preso per un’espressione di benvenuto.
Naturalmente non si può sperare d’ingrandire il proprio territorio da cinquecento a
venticinquemila chilometri quadrati, come fece Roma in questo periodo, senza pestare i
piedi a qualcuno. Ma in compenso tutta l’Italia del Centro e del Sud cominciò a parlare una
sola lingua e a pensare in termini, invece che di villaggio e di tribù, di nazione e di stato.
Contemporaneamente a queste lunghe e sanguinose guerre e sotto la loro
pressione, i plebei raggiungevano l’uno dopo l’altro tutti i loro obbiettivi, fino all’ultimo e
fondamentale, garantito dalla Legge Ortensia, così chiamata dal nome del dittatore che la
impose: quella per cui il plebiscito diventava automaticamente legge, senza bisogno di
ratifica da parte del Senato. Da quando, con la Legge Canuleja del 445, era stato abolito,
almeno sulla carta, il divieto di matrimonio fra patrizi e plebei, costoro non erano più,
legalmente, esclusi da nessun diritto o magistratura. E poiché la pretura, ad essi liberamente
aperta, consentiva a chi l’avesse esercitata libero ingresso al Senato, anche questa cittadella
dell’aristocrazia fu loro, sia pure con mille cautele e limitazioni, accessibile.
Tutto ciò era stato raggiunto dopo infiniti contrasti che ogni tanto avevano messo
in pericolo l’esistenza dell’Urbe. Ma il fatto che bene o male vi si fosse arrivati, stava a
dimostrare che le classi alte di Roma erano si, conservatrici, ma con molto sale in zucca.
Esse non si vergognavano di difendere apertamente i propri interessi di casta e non
fingevano d’amoreggiare con le “sinistre” come fanno tanti principi e industriali d’oggidì.
Ma pagavano le tasse, facevano dieci anni di duro servizio militare, morivano alla testa dei
loro soldati, e quando si trattava di scegliere fra i propri privilegi e il bene della patria, non
esitavano. Perciò, anche dopo aver accettato la completa parificazione di diritti coi plebei,
.rimasero al potere, come ancora riesce a fare, pur in questo mondo socialista, la nobiltà
inglese.
Nel periodo di riposo che si concesse dopo la vittoria su Pirro e che le servi a
digerire quel po’ po’ di banchetto, Roma diede gli ultimi ritocchi a questo interno equilibrio
e ordine al grosso pezzo di penisola di cui era padrona. La via Appia, che già Appio
Claudio aveva fatto costruire per unire Capua a Roma, fu prolungata fino a Brindisi e
Taranto. E su di essa, oltre ai soldati, furono incamminati i coloni che andavano a romanizzare Benevento, Isernia, Brindisi e tante altre città. Roma riconobbe ai vinti poche
autonornie, ne rispettò ancora meno, e fu la prima e più grande responsabile della mancata
nascita, in Italia, delle libertà comunali e cantonali, che invece si svilupparono così
rigogliose nel mondo germanico. In compenso portò alla più alta espressione il concetto di
stato, di cui fu praticamente l’inventrice, e lo poggiò sui cinque pilastri che tuttora lo
reggono: il Prefetto, il Giudice, il Gendarme, il Codice e l’Agente delle tasse.
Fu con questa attrezzatura che mosse alla conquista del mondo. E ora vediamo più
da vicino perché riuscì a realizzarla.
CAPITOLO OTTAVO
L’EDUCAZIONE
NELLA Roma di quei tempi, tutti “vivevano pericolosamente”. E i pericoli
cominciavano il giorno che si veniva al mondo. Perché se uno nasceva femmina o per
qualche ragione minorato, il padre aveva il diritto di scaraventarlo fuor dell’uscio e di
lasciarvelo morire. E spesso lo faceva davvero.
Il figlio maschio e sano, invece, generalmente era bene accolto, non solo perché
più tardi, col suo lavoro, sarebbe stato di aiuto ai genitori, ma anche perché costoro
credevano che, se non lasciavano qualcuno a curare la loro tomba e a celebrarvi sopra i
dovuti sacrifici, la loro anima non sarebbe entrata in paradiso.
Se tutto andava bene, cioè se aveva azzeccato sesso e fisica integrità, il nuovo
venuto veniva, otto giorni dopo la nascita, ufficialmente ricevuto dalla gente, con una
solenne cerimonia. La gente era un gruppo di famiglie che risalivano a un comune antenato
il quale aveva dato loro il proprio nome. Infatti il pargolo di nomi ne riceveva solitamente
tre: quello individuale o “prenome” (come Mario, Antonio, eccetera), quello della gente o
“nome” vero e proprio, e quello della sua propria famiglia o “cognome”. Questo, per ciò
che riguarda gli uomini. Le donne invece portavano il “nome” solo, cioè quello della gente.
E si chiamavano infatti Tullia, Giulia, Cornelia, eccetera, mentre i loro fratelli erano,
poniamo, Marco Tullio Emilio, Publio Giulio Antonio, Caio Cornelio Gracco.
Questo strano costume ha generato un sacco di confusioni, perché siccome gli
antenati fondatori erano stati, come già abbiamo detto, un centinaio in tutto, altrettanti
erano i “nomi” delle genti, e quindi si ripetevano continuamente, rendendo obbligatoria
l’aggiunta di un quarto o di un quinto soprannome. Per esempio, il Publio Cornelio
Scipione che distrusse Cartagine si aggiunse anche, sul biglietto di visita, un “Emiliano
Africano Minore" per distinguersi dal Publio Cornelio Scipione che aveva vinto Annibale e
aveva aggiunto su quello suo un “Africano Maggiore”.
Erano, come vedete, nomi lunghi, pesanti e imponenti, che già di per se stessi
caricavano un certo numero di doveri sulle spalle del neonato. Un Marco Tullio Cornelio
non poteva concedersi ì lussi né abbandonarsi ai capricci di cui oggi si riconosce il diritto a
un “Fofino” o a un “Pupetto”. E infatti non crescevano punto vezzeggiati. Sin dalla più
tenera età s’insegnava loro che la famiglia di cui. erano membri costituiva una vera e
propria unità militare, in cui tutti i poteri erano concentrati sul capo, cioè sul paterfamilias.
Egli solo poteva comprare e vendere perché egli solo era il proprietario di tutto, compresa
la dote della moglie. Se costei lo tradiva o gli rubava il vino nella botte, egli poteva
ucciderla senza processo. Identici diritti aveva sui figli, che Poteva anche vendere come
schiavi.
Tutto ciò ch’essi compravano diventava automaticamente suo. Le femmine si
sottraevano a que,sta patria potestà solo quando egli le conduceva in sposa a qualcuno cum
manu, cioè rinunziando esplicitamente a ogni diritto su d loro. Ma in tal caso questi diritti
passavano al marito. Di modo che la donna finiva col dipendere sempre da un uomo: o dal
padre o dallo sposo, o dal figlio maggiore quando restava vedova, o da un tutore.
Questa dura disciplina, che poi lentamente si addolcì col trascorrere dei secoli,
trovava il suo limite nella pietas, cioè negli affetti tra i coniugi e tra questi e i figli. Ma essi
non giungevano mai, o quasi mai, a intaccare la granitica unità della famiglia romana, che
includeva anche i nipoti, i pronipoti e gli schiavi, considerati questi ultimi semplici oggetti.
La madre si chiamava domina, cioè signora, e non era confinata in un gineceo, come
capitava a quelle greche. Prendeva i pasti col marito, ma seduta sul triclinio (una specie di
rustico divano); invece che distesa come ci stava lui. In genere, non lavorava molto,
manualmente, perché crisi di personale dì servizio non ce n’era, con tanti schiavi che
venivano catturati sul campo di. battaglia, e ogni famiglia ne aveva più d’uno. La domina li
dirigeva e sorvegliava Eppoi, per svagarsi, tesseva la lana per gli abiti del marito e dei figli
libri, carte da giuoco, teatro, circo: niente. Le visite erano rare e di stretta prammatica. Un
cerimoniale scrupoloso le rendeva complicate e difficili. La domus, cioè la casa, era, più
che una caserma, un fortino vero e proprio. E lì, nella più assoluta obbedienza, si
formavano i ragazzi.
Ad essi veniva insegnato che nel focolare la fiamma non doveva mai estinguersi
perché essa rappresentava Vesta, la dea della vita. Bisognava nutrirla aggiungendo sempre
altra legna e gettandovi briciole di pane durante i pasti. Alle pareti, che erano di fango o dì
mattoni, erano appese piccole icone, in ognuna delle quali il ragazzo vedeva un Lare o un
Penate, spiritelli domestici che proteggevano la prosperità della casa e dei campi. Sulla
porta c’era Giano a sorvegliare, con le sue due facce rivolte una dentro e l’altra fuori, chi
entrava e chi usciva. E tutt’intorno, a montar la guardia, c’erano i Mani, le anime degli
antenati, che restavano nei paraggi anche dopo morti. Sicché nessuno poteva fare un
movimento senza dar di capo in qualche soprannaturale guardiano, che faceva parte anche
lui della famiglia: una famiglia composta non soltanto dai vivi,ma anche da coloro che li
avevano preceduti e da coloro che li avrebbero seguiti. Tutti insieme, essi formavano un
microcosmo non soltanto economico e morale, ma anche religioso, di cui il pater era
l’infallibile papa. Egli compiva i sacrifici sull’altare di casa. Ed era in nome degli dèi che
impartiva gli ordini e distribuiva i castighi.
La religiosità in cui cresceva il ragazzo romano, più che a migliorarlo nel senso
che noi ora diamo a questa parola, mirava a disciplinarlo. Infatti essa non lo spingeva verso
i nobili ideali della bontà e della generosità, ma all’accettazione delle regole liturgiche che
di tutta la sua vita facevano un rito. Non gli si chiedeva, per esempio, di essere
disinteressato; gli si chiedeva, anzi gli si imponeva, di rispettare certe formule e di
partecipare alle cerimonie. Le sue preghiere erano tutte volte al conseguimento di fini
pratici e immediati. Egli si rivolgeva ad Abeona perché gl’insegnasse a muovere i primi
passi, a Fabulina perché gli apprendesse a pronunciare le prime parole, a Pomona perché gli
facesse crescere bene le pere nel giardino, a Saturno perché lo aiutasse a seminare, a Cerere
perché gli consentisse di rnietere, a Stérculo perché le vacche nella stalla facessero
abbastanza letame.
Tutti questi dèi e spiriti erano personaggi senza preoccupazioni morali, ma
pignolissimi per ci che riguardava le forme. Evidentemente non si facevano illusioni
sull’animo umano. E, considerandolo non suscettibile di un vero e proprio miglioramento,
lo abbandonavano a se stesso. Ciò che interessava loro non erano le intenzioni, ma i gesti
dei loro fedeli che volevano tenere ordinati dentro gli argini delle grandi istituzioni, la
famiglia e lo stato, di cui costituivano il cemento. Per questo esigevano l’obbedienza al
padre, la fedeltà al marito, la prolificità, l’accettazione della legge, il rispetto dell’autorità, il
coraggio in guerra fino al sacrificio, la fermezza di fronte alla morte. E il tutto ammantato
di sacerdotale solennità.
A questa accurata e puntigliosa formazione del carattere, seguiva, verso i sei o
sette anni, quella della mente, cioè l’istruzione vera e propria. Ma essa non era gestita dallo
stato, come succede oggi, con le scuole pubbliche. Restava affidata alla famiglia, e di rado
il babbo, anche nelle case benestanti, la delegava a qualche schiavo o liberto. Quest’uso
venne molto più tardi, quando Roma fu più grande e più forte, ma non più stoica. Sino a
tutte le guerre puniche, era il padre che faceva da maestro al figlio, cioè gl’impartiva quella
che oggi si chiama la cultura e che allora si chiamava. “disciplina” per meglio metterne in
risalto il carattere di obbedienza assoluta.
Le materie erano poche e semplici: lettura, scrittura, grammatica, aritmetica e
storia. I romani conoscevano. una specie d’inchiostro ricavato dal succo di certe bacche. In
esso intingevano un’asticciòla di metallo con cui componevano le parole sopra tavolette di
legno piallato (solo più tardi riuscirono a fabbricare carta di lino e pergamena). La loro era
una lingua dalla sintassi severa, ma di pochi vocaboli e senza sfumature, che si prestava più
alla compilazione di leggi e di codici che ai romanzi e alla poesia. Di questa roba i romani
d’altronde non sentivano nessun bisogno, e chi voleva leggerne, doveva imparare il greco,
lingua molto più ricca, sfumata e flessibile. In greco infatti è composto il loro primo testo di
storia scritta: quello di Quinto Fabio Pittore. Ma è del 202 avanti Cristo, cioè di un’età
molto più avanzata.
Sino a quel momento la storia veniva tramandata solo oralmente di babbo in figlio
attraverso racconti immaginosi che colpissero la fantasia dei bambini: era quella di Enea, di
Amulio e Numitore, degli Orazi e dei Curiazi, di Lucrezia e di Collatino. Queste arbitrarie,
ma corroboranti leggende storiche, erano rinforzate dalla poesia, tutta d’intonazione sacra e
commemorativa. Essa era condensata in volumi che si chiamavano Fasti consolari, Libri
dei magistrati, Annali massimi eccetera, e celebravano i grandi eventi nazionali: elezioni,
vittorie, feste, miracoli.
Il primo a uscire da questi argomenti di stretta prammatica fu uno schiavo greco,
Livio Andronico che, caduto prigioniero durante il sacco di Taranto, fu condotto a Roma,
dove cominciò a raccontare l’Odissea agli amici del suo padrone. Costoro ci si divertirono.
E, siccome erano gente altolocata, lo incaricarono di ricavarne uno spettacolo per i grandi
ludi, o giuochi del 240.
Livio, per tradurre quei versi greci) ne inventò di consimili in latino, dal ritmo
rozzo e irregolare. E con essi compose una tragedia, di cui egli stesso recitò e cantò tutte le
parti, finché gli rimase un filo dì voce in gola. i romani, che non avevano mai visto né udito
nulla di simile, ci si divertirono a tal punto che il governo riconobbe i poeti come una
categoria della cittadinanza e gli consenti di fondersi in una “corp6razione” con sede nel
tempio della Minerva sull’Aventino.
Ma anche questo, ripeto, avvenne molto più tardi. Per il momento, di letteratura i
ragazzi romani non ebbero da leggerne. Imparato a compitare e a mandare a memoria
quelle tali leggende, essi passavano alla matematica - e alla geometria. La prima consisteva
in semplici operazioni di contabilità eseguite sulle dita, di cui i numeri scritti non erano che.
imitazioni. I è la rappresentazione grafica di un dito alzato, V è una mano aperta, X due
mani aperte e incrociate. Con.questi simboli, prèfissi (IV) e suffissi (VI, XII), i romani
contavano. Poi, da questa aritmetica manuale, si sviluppò un sistema decimale, su parti e
multipli di dieci, cioè delle dieci dita. Quanto alla geometria, essa rimase arcaica finché non
vennero i greci a insegnarla: si riduceva al minimo necessario per le rudimentali costruzioní
del tempo.
Ginnastica, nulla. Le “palestre” e i “ginnasi” sono di un’età molto posteriore, e
d’importazione greca anch’essi. I babbi romani preferivano corroborare i muscoli dei loro
figli mettendoli al lavoro sul podere con la vanga e l’aratro, eppoi consegnandoli
all’esercito che, quando li lasciava vivi, li restituiva dopo molti anni a prova di bomba. Per
questo non s’insegnava neanche la medicina. I romani ritenevano che fossero non i virus a
provocare le malattie, ma gli dèi. E allora, delle due l’una: o gli dèi volevano, con quel
segno, dire al malato: “sgombra”, e in tal. caso non c’era nulla.da fare; o volevano soltanto
impartirgli un momentaneo castigo, e in tal caso non c’era che da aspettare. Infatti per ogni
malanno c’era una preghiera a questa o a quella divinità. La Madonna della febbre, cui
ancora oggi il popolino romano si rivolge, è la versione aggiornata delle dee Febbre e
Mefite cui si rivolgeva allora.
Quanto alle ore di ricreazione dallo studio, nemmeno esse erano lasciate al
capriccio dei ragazzi e dovevano andare sprecate. Dopo molte ore di zappa e qualcuna di
grammatica, i babbi senatori prendevano i figli per mano e li conducevano alla curia,
davanti al Foro, dove la loro assemblea teneva le sue sedute o senato consulti. E li su quei
banchi, in silenzio, i bambini romani, sin dall’età di sette o otto anni, ascoltavano dibattere i
grandi problemi dello stato, l’amministrazione, le alleanze, le guerre, e si modellavano su
quello stile grave e solenne, che costituì la loro precipua caratteristica (e li rendeva tanto
noiosi).
Ma il definitivo ritocco alla loro formazione lo dava l’esercito. Quanto più un
cittadino era ricco, tante più tasse aveva da pagare e tanti più anni da servire sotto le
bandiere. Per chi voleva iniziarsi a una pubblica carriera, il minimo era dieci. E quindi
soltanto i ricchi praticamente potevano intraprenderla perché solo essi potevano trascorrere
tanto tempo lontani dal podere o dalla bottega. Ma anche chi si contentava di esercitare i
propri diritti politici, cioè quello di voto, doveva aver fatto il soldato. E infatti era come
tale, cioè come un membro della centuria, che prendeva parte all’Assemblea Centuriata, il
massimo corpo legislativo dello stato, divisa, come abbiamo già detto, nelle sue cinque
classi.
La prima, di centurie ne aveva novantotto, di cui diciotto di cavalleria e il resto di
fanteria pesante, dove ognuno si arruolava armato a proprie spese di due lance, un pugnale,
una sciabola, un elmetto di bronzo, la corazza e lo scudo, che mancava invece alla seconda
classe, in tutto il resto identica alla prima. La terza e la quarta erano prive di ogni strumento
di difesa (elmetto, corazza e scudo). Quelli della quinta erano armati soltanto dì bastone e di
sassi. L’unità fondamentale di questo esercito era la legione, costituita di
quattromiladuecento fanti, trecento cavalieri e vari gruppi ausiliari. Il console ne
comandava due, cioè circa diecimila uomini. Ogni legione aveva un suo vessillo, ed era
impegno d’onore d’ogni soldato impedire ch’esso cadesse in mano al nemico. Infatti gli
ufficiali, quando se la vedevano brutta, lo impugnavano e si lanciavano avanti. La truppa,
per difenderlo, li seguiva. E molte battaglie che giravano male, furono rimediate così,
all’ultimo momento.
Nei primissimi tempi, la legione era divisa in falangi, sei solide linee di
cinquecento uomini ciascuna. Poi, per renderla più maneggevole, in manipoli di due
centurie. Ma ciò che faceva la forza di questo esercito non era l’organico, era la disciplina.
Il codardo veniva frustato sino alla morte. E il generale poteva decapitare chiunque,
ufficiale o soldato, per la minima disobbedienza. Ai disertori e ai ladri si tagliava la mano
destra. E il rancio consisteva in pane e vegetali. A questa dieta eran così abituati che i
veterani di Cesare, un anno di carestia di grano, si lamentarono d’essere obbligati a mangiar
carne.
Di leva, si era a sedici anni, quando ai nostri tempi si comincia a pensare alle
ragazze. I sedicenni romani invece dovevano pensare al reggimento, e lì venivano accolti e
rifiniti. La disciplina vi era così dura e il lavoro così pesante, che tutti preferivano la
battaglia. La morte, per quel ragazzi, non era un gran sacrificio. E per questo l’affrontavano
con tanta disinvoltura.
CAPITOLO NONO
LA CARRIERA
IL giovane che era sopravvissuto a dieci anni.di vita militare poteva, quando
tornava a casa, intraprendere la carriera politica, che andava per gradi ed era tutta elettiva e
sottoposta a ogni sorta di precauzioni e controlli.
Stava all’Assemblea Centuriata vagliare le candidature ai vari uffici, ch’erari tutti
plurImi, cioè costituiti di più persone. Il primo gradino era quello di “questore”, specie di
assistente dei magistrati più alti per le finanze e la giustizia. Egli aiutava a controllare le
spese dello stato e collaborava all’investigazione dei delitti. Non poteva restare in carica più
di un anno; ma, se aveva assolto bene i suoi compiti, poteva presentarsi nuovamente
all’Assemblea Centuriata per essere promosso di grado.
Se non aveva soddisfatto gli elettori, veniva bocciato, e per dieci anni non poteva
più presentarsi a nessuna carica. Se invece li aveva contentati, veniva eletto “edile” (ce
n’erano quattro); e come tale, sempre per un anno, aveva la sovrintendenza agli edifici, ai
teatri, agli acquedotti, alle strade, e insomma a tutti gli edifici pubblici o di pubblico
interesse, comprese le case di malaffare.
Se anche in queste mansioni, ch’eran praticamente quelle di un assessore, dava
risultati soddisfacenti, poteva concorrere, sempre con lo stesso metodo elettivo e per un
anno, a uno dei quattro posti di “pretore”, carica altissima, civile e militare. Un tempo essi
erano stati i generali in capo dell’esercito. Ora erano piuttosto presidenti di tribunale e
interpreti della legge. Ma, quando scoppiava la guerra, riprendevano il comando delle
grandi unità agli ordini dei “consoli”.
Giunti all’apice di questa carriera, che si chiamava cursus honorum, o “corso di
onori”, si poteva aspirare a uno dei due posti di “censore”, che veniva eletto per cinque
anni. La lunghezza del termine era imposta dal fatto che solo ogni cinque anni veniva
revisionato il censo dei cittadini, cioè compilato quello che oggi si chiamerebbe il “modulo
Vanoni”.
Era questa la principale attribuzione del censore che poi, per il quinquennio;
doveva, in base all’ “accertamento”, stabilire quanto ogni cittadino doveva pagare di tasse e
quanti anni era tenuto a fare sotto le armi.
Ma le sue mansioni non si limitavano soltanto a questa. Egli ne aveva anche di più
delicate, e perciò la carica, specie quando la esercitavano cittadini di gran fusto come Appio
Claudio il Cieco, pronipote del famoso decemviro, e Catone, faceva concorrenza anche al
consolato. Il censore doveva segretamente indagare sui “precedenti” di qualunque
candidato a qualunque pubblico ufficio. Doveva sorvegliare l’onore delle donne,
l’educazione dei figli, il trattamento degli schiavi. Il che lo autorizzava a ficcare il naso
dentro gli affari privati di ciascuno, ad abbassarne o ad alzarne il rango, e perfino a cacciar
via dal Senato i membri che non se ne fossero mostrati degni. Infine, erano i censori che
compilavano il cosiddetto bilancio dello stato e ne autorizzavano le spese. Si trattava
dunque, come vedete, di poteri vastissimi che richiedevano, in chi li esercitava, grande
accorgimento e coscienza. In genere, nell’età repubblicana, chi ne fu investito se ne mostrò
all’altezza.
All’apice della gerarchia venivano i due consoli, cioè i due capi del potere
esecutivo.
In teoria, almeno uno di essi doveva essere un plebeo. In realtà i plebei stessi
preferirono quasi sempre un patrizio, perché solo uomini di alta educazione e di lungo
tirocinio offrivano loro buona garanzia di saper guidare lo stato in mezzo a problemi che
diventavano sempre più complessi e difficili. Eppoi, c’era l’elezione. La quale si svolgeva
secondo procedimenti che consentivano all’aristocrazia qualunque frode. Il giorno del voto
dell’Assemblea Centuriata, il magistrato in carica osservava le stelle per scoprire quali
candidati fossero personae gratae agli dèi. E siccome il linguaggio delle stelle pretendeva
di saperlo lui solo, poteva leggervi tutto quello che voleva. L’assemblea, intimidita,
accettava il verdetto, e si apprestava a limitare la sua scelta solo fra quei concorrenti che
piacevano al Padreterno, cioè al Senato.
I candidati apparivano vestiti di una bianca toga senza ornamenti per dimostrare la
semplicità della loro vita e l’austerità della loro morale. E spesso ne sollevavano un lembo
per esibire agli elettori le ferite che avevano riportato in guerra. Se venivano eletti, lo
restavano per un anno, con pari potere; entravano in carica il 15 marzo; e, quando ne
uscivano, in genere il Senato li accoglieva come suoi membri, naturalmente a vita.
Poiché il titolo di senatore restava malgrado tutto il più ambito da chiunque, era
naturale che il console cercasse di non dispiacere mai a coloro che potevano conferirglielo.
Egli rappresentava in un certo senso il braccio secolare di quell’alta assemblea che, da un
punto di vista strettamente costituzionale, non contava nulla, ma in pratica, con vari
sotterfugi, decideva sempre ogni cosa.
I consoli erano anzitutto, come i primissimi re, capi del potere religioso e ne
dirigevano i riti più importanti. In tempo di pace essi presiedevano le riunioni sia del Senato
sia dell’assemblea e, raccoltene le decisioni, le eseguivano emanando leggi per applicarle.
In tempo di guerra, si trasformavano in generali e, dividendone in parti eguali il
comando, guidavano l’esercito: metà l’uno, metà l’altro. Se uno moriva o cadeva
prigioniero, l’altro riassumeva in sé tutti i poteri; se morivano o cadevano prigionieri
ambedue, il Senato dichiarava un interregno per cinque giorni, nominava un interrex per
mandare avanti le faccende, e provvedeva a nuove elezioni. Anche queste parole stanno a
significare che il console esercitava, per un anno, gli stessi poteri che avevano esercitato gli
antichi re, quelli non assoluti, di prima dei Tarquini.
Le mansioni di console erano naturalmente le più ambite, ma anche le più difficili
da esercitare, e richiedevano, oltre a molta energia, anche molta diplomazia perché
imponevano continui destreggiamenti fra il Senato e le assemblee popolari, che lo
eleggevano e a cui doveva rispondere.
Queste assemblee erano tre: i comizi curiati, i comizi centuriati e i comizi tributi.
I comizi curiati erano i più -antichi perché risalivano a Romolo, quando Roma era
composta di patres. E infatti soltanto i patrizi ne facevano parte. Ebbero, nei primissimi
tempi della repubblica, funzioni importanti, come quella di eleggere i consoli. Ma poi,
piano piano, dovettero abbandonare quasi tutti i loro poteri all’Assemblea Centuriata, che
fu la vera Camera dei deputati della Roma repubblicana. E lentamente si trasformarono in
una specie di Consulta Araldica, che decideva soprattutto di questioni genealogiche, cioè
dell’appartenenza di un cittadino a questa o a quella gens.
L’Assemblea Centuriata era, praticamente il popolo in armi. Di essa facevano
parte tutti i cittadini che avevano compiuto il servizio militare. Ne erano quindi esclusi gli
stranieri, gli schiavi e coloro che la legge esentava dalla leva e dalle tasse perché troppo
poveri. Roma era avara nella concessione della cittadinanza. Essa comportava privilegi
come l’immunità dalla tortura e il diritto di appello all’Assemblea contro le decisioni di
qualunque funzionario.
L’Assemblea non era permanente. Si riuniva al richiamo di un console o di un
tribuno, e non poteva emanare leggi o ordinanze per suo conto. Poteva soltanto votare a
maggioranza “si” o “no” alle proposte che il magistrato le rivolgeva. Il suo carattere
conservatore era garantito, come già sappiamo, dalla sua ripartizione in cinque classi.
Bisogna sempre tenere a mente che la prima, comp osta di novantotto centurie fra patrizi,
equites e milionari, bastava a formare la maggioranza su un totale di centonovantatrè classi.
Poiché essa votava per prima e il voto veniva subito annunciato, alle altre non restava che
chinare la testa.
Un criterio di giustizia, mi questa procedura, c’era. I romani ritenevano che i diritti
dovessero andare di pari passo con i doveri e viceversa. Per cui quanto più ricchi si era,
tante più tasse si dovevano pagare, tanti più anni si doveva servire sotto le armi, ma in
compenso tanto più s’influiva politicamente.
Però non c’è dubbio che il povero diavolo, anche se aveva il vantaggio di pagare
poche tasse e di servire pochi mesi in caserma, politicamente non contava nulla ed era
costretto a seguire sempre la volontà di chi contava molto.
Fu allora che questi diseredati cominciarono a riunirsi per conto proprio nei
cosiddetti concili della plebe, di cui l’autorità non era riconosciuta dalla Costituzione, ma
da cui, col passare degli anni, si svilupparono i comizi tributi, che furono l’organo con cui il
proletariato romano combatté la sua lunga battaglia per conquistare una maggiore giustizia
sociale.
Essi nacquero subito dopo la secessione della plebe sul Monte Sacro, quando le fu
consentito di eleggere i propri magistrati, i famosi tribuni, che avevano diritto di veto
contro qualunque legge o ordinanza ritenute lesive degl’interessi proletari. E furono
appunto i comizi tributi che s’incaricarono di nominare questi magistrati. Poi, piano piano,
chiesero ed ottennero il diritto dì nominarne anche altri: i questori, gli edili della plebe e
alla fine i tribuni militari con potestà consolare.
Anche questa assemblea, come quella Centuriata, non aveva altro potere che
quello di votare “si” o “no” alle proposte del magistrato che la convocava. Però il voto era
dato individualmente, e quello dell’uno valeva quello dell’altro a prescindere dalle
condizioni finanziarie. Era quindi un organo molto più democratico. Il moltiplicarsi delle
sue attribuzioni contrassegna il lento crescere, attraverso infinite lotte, del proletariato
romano nei confronti delle altre classi: fino a quando le sue deliberazioni, chiamate plebisciti, cessarono di valere soltanto per la plebe e diventarono, obbligatorie per tutti i
cittadini, trasformandosi così in leggi vere e proprie.
Con queste due assemblee, la Centuriata e la Curiata, fatalmente portate a
combattersi tra loro, questa in nome della conservazione, quella in nome del progresso
sociale, e con dei magistrati come i tribuni eletti apposta dalla plebe per ostacolarne l’opera,
capirete quanto difficile doveva essere il mestiere dei due consoli.
Ognuno di costoro aveva, nominalmente, l’imperium, il comando, e lo sfoggiava
facendosi precedere, dovunque andasse, da dodici littori, ognuno dei quali portava un fascio
di verghe con la scure in mezzo. Essi davano congiuntamente il nome all’anno in cui
esercitavano la carica, ed esso veniva registrato nell’elenco dei fasti consolari. Erano cose
che lusingavano le ambizioni di chiunque. Ma, quanto al potere effettivo, era un altro paio
di maniche. Anzitutto, per esercitarlo, dovevano andare d’accordo fra loro, perché ognuno
aveva il diritto di veto sulle decisioni dell’altro. Eppoi, bisognava avere l’assenso delle due
assemblee.
Ma era appunto questa paralisi del potere esecutivo che consentiva al Senato di
esercitare quello suo. Esso era composto di trecento membri, e ì censori provvedevano a
riempire i vuoti che la morte vi produceva nominando al posto dello scomparso un ex
console o un ex censore che si fosse particolarmente distinto. Il censore, o il Senato stesso,
potevano anche espellere i membri che non si fossero mostrati degni dell’alto onore.
Anche questa venerabile assemblea si riuniva nella curia, di fronte al Foro, su
richiesta del console che la presiedeva. E le sue decisioni, che venivano prese a
maggioranza, non avevano nominalmente forza di leggi; erano soltanto consigli al
magistrato. Ma costui quasi mai osava portare dinanzi ai comizi, che soli potevano darle
potere esecutivo, una proposta che non avesse ricevuto la preventiva approvazione del
Senato. In pratica, il suo parere era decisivo per tutte le grandi questioni di stato: guerra e
pace, il governo delle colonie e delle province. Quando poi si arrivava ad una crisi, il
Senato ricorreva a uno speciale decreto di emergenza, il senatus consultum ultimum, che
decideva irrevocabilmente.
Tuttavia, più che dalla Costituzione, la quale non gliene riconosceva molti, il suo
potere veniva dal prestigio. Lo stesso tribuno, che, data la sua origine elettorale, non poteva
essere favorevole al Senato, quando vi sedeva, com’era suo diritto, in qualità di silenzioso
osservatore, ne usciva, in genere, con idee più concilianti di quando vi era entrato. Tant’è
vero che, col passare del tempo, molti tribuni diventarono senatori per gli amichevoli
atteggiamenti che avevano tenuto, durante la loro carica, verso quella che avrebbe dovuto
essere la trincea nemica. Infine il Senato aveva, nelle grandi occasioni, l’arma per risolvere
i nodi, quando venivano al pettine e non si riusciva a mettere d’accordo i magistrati tra loro
e con la cittadinanza. Esso poteva nominare un dittatore per sei mesi o per un anno,
investendolo di pieni poteri, eccetto quello di disporre dei fondi dello stato. La proposta
veniva fatta da uno dei due consoli senza che l’altro potesse opporsi. E la persona veniva
scelta fra i considares, cioè fra coloro che avevano già esercitato quella carica, e quindi
erano già senatori. Tutti i dittatori della Roma repubblicana, meno uno, furono patrizi.
Tutti, meno due, rispettarono i limiti di tempo e di potere che furono loro imposti. Uno di
essi, Cincinnato che, dopo soli sedici giorni di esercizio della suprema carica, tornò
spontaneamente ad arare il campo coi buoi, è passato alla storia coi colori della leggenda.
Il Senato raramente ricorse a questo suo diritto, cioè non ne abusò, sebbene non
sempre sia stato all’altezza del suo grande nome. Ogni tanto si faceva tentare dalla
cupidigia, specie nello sfruttamento dei paesi conquistati. Ogni tanto fu sordo e cieco, nella
difesa dei privilegi della sua casta, contro le necessità di una superiore giustizia. Coloro che
lo componevano non erano superuomini, commisero degli errori, qualche volta vacillarono
e si contraddissero. Ma nell’insieme la loro assemblea ha rappresentato, nella storia di tutti i
tempi e di tutti i popoli, un esempio di saggezza politica mai più superato. Venivano tutti da
famiglie di statisti e ognuno di essi aveva una larga esperienza di esercito, di giustizia e di
amministrazione. Essi erano al loro peggio nelle vittorie, quando si sfrenavano l’orgoglio e
la cupidigia; al loro meglio nelle disfatte, quando la situazione faceva appello al coraggio e
alla tenacia. Cinea, l’ambasciatore che Pirro mandò a trattare con loro, quando li ebbe visti
e uditi, disse ammirato al suo sovrano: «Sfido che a Roma non c’è un re. Ognuno di quei
trecento senatori lo è».
CAPITOLO DECIMO
GLI DÉI
QUESTO ordinamento dello stato e delle magistrature fu reso possibile soltanto
dalla legge, cioè dalla pubblicazione delle Dodici Tavole dei Decemviri, che ne costituirono
insieme la causa, la conseguenza e lo strumento.
Fino ad allora Roma era vissuta praticamente in un regime di teocrazia, in cui il re
era anche papa. Egli solo aveva, come tale, il diritto di regolare i rapporti fra gli uomini non
secondo una legge scritta, ma secondo la volontà degli dèi, che a lui solo la comunicavano
nelle cerimonie religiose. Il papa dapprima faceva tutto da solo. Poi, col crescere della
cittadinanza e col moltiplicarsi e complicarsi dei problemi, ebbe tutto un clero ad aiutarlo. E
furono appunto i sacerdoti i primi avvocati di Roma.
Il povero diavolo che aveva ricevuto, o credeva di aver ricevuto un torto, andava
da uno di essi per avere un consiglio. E costui glielo dava consultando testi segretissimi,
dove soltanto loro, i preti, avevano il diritto di ficcare il naso. Nessuno quindi sapeva con
precisione quali fossero i suoi diritti e i suoi doveri. Glielo diceva, caso per caso, il
sacerdote. E i processi venivano celebrati secondo una liturgia di cui egli solo conosceva i
riti. Siccome il clero, in origine, fu tutto aristocratico, o asservito all’aristocrazia, è facile
capire come fossero i verdetti quando erano in ballo cause fra patrizi e plebei.
Il primo effetto delle Dodici Tavole fu quello di separare il diritto civile da quello
divino, cioè di svincolare i rapporti fra cittadini dalla volubile volontà degli dèi, cioè di
coloro che dicevano di rappresentare gli dèi. E da questo momento Roma cessò di essere
una teocrazia. Piano piano il monopolio ecclesiastico della legge cominciò a cadere a pezzi.
Appio Claudio il Cieco pubblicò un calendario di dies fasti, indicando in che giorni le cause
potevano essere discusse e secondo che procedura: cosa che fin qui i preti dicevano di
essere i soli a sapere. Più tardi Coruncanio fondò una vera e propria scuola di avvocati, che
della legge finirono per diventare i tecnici a esclusione dei preti. Le Dodici Tavole, che
fornirono i princìpi basilari a tutta la successiva legislazione di Roma e del mondo,
diventarono materia obbligatoria d’insegnamento per i ragazzi delle scuole che dovevano
impararle a memoria, e contribuirono a formare il carattere romano, ordinato e severo,
legalistico e litigioso.
È da questo momento che i preti, costretti ad occuparsi soltanto di questioni
religiose, cercarono di mettervi un po’ d’ordine, senza peraltro riuscirvi completamente.
Essi erano organizzati in collegi, ognuno dei quali aveva alla testa un supremo pontefice.
eletto dall’Assemblea Centuriata. Non c’era bisogno, per entrarci, di un particolare
tirocinio, non formavano una casta separata, e non avevano nessun potere politico. Erano
funzionari di stato e basta, e con lo stato, che li pagava, dovevano collaborare.
Il più importante di questi collegi era quello dei nove áuguri che avevano per
compito d’indagare le intenzioni degli dèi circa le gravi decisioni che il governo stava per
prendere. Vestito nei suoi sacri paramenti e preceduto da quindici flamines, il pontefice
massimo prendeva gli auspici nei primi tempi osservando il volo degli uccelli, come aveva
fatto Romolo per fondare Roma, più tardi studiando le viscere degli animali che si offrivano
in sacrificio (ed erano ambedue sistemi imparati dagli etruschi). Nelle crisi più gravi si
spediva una delegazione a Cuma per interrogare la sibilla, ch’era la sacerdotessa di Apollo.
E in quelle gravissime, si mandava a consultare l’oracolo di Delfo, la cui fama era giunta
fino in Italia. Ora, siccome i sacerdoti non avevano altri doveri che quelli verso lo stato, è
naturale ch’essi fossero sensibili alle sollecitazioni che dallo stato venivano fatte, con
promesse di uno scatto di grado o di un aumento di stipendio.
Il rito consisteva in un dono o in un sacrificio agli dèi per guadagnarsene la
protezione o eluderne l’ira. La sua procedura era meticolosa, e bastava un piccolo sbaglio
per doverla ripetere, fino a trenta volte. La parola “religione”, in latino, ha un significato
tutto esteriore e procedurale; e “sacrificio” vuol dire letteralmente rendere sacro qualcosa:
quello che si offriva alla divinità. Naturalmente le offerte variavano secondo le possibilità
di chi le faceva e l’importanza dei benefici a cui si aspirava. Il povero padre di famiglia che,
nell’interno della casa, faceva da pontefice massimo per impetrare un buon raccolto,
sacrificava sul focolare un pezzo di pane e di formaggio o un bicchiere di vino. Se la siccità
si prolungava, arrivava a un galletto. Se era minacciato dall’alluvione, era capace di
sgozzare il porco o una pecora. Ma quando a sacrificare era lo stato per propiziarsi il favore
divino per qualche grande impresa nazionale, il Foro, dove in genere avveniva la cerimonia,
si trasformava in un vero e proprio mattatoio. Greggi intere venivano sgozzate mentre i
sacerdoti pronunciavano le formule di stretto rigore. Agli dèi, che avevano il palato
delicato, si riservavano le rigaglie e soprattutto il fegato. Il resto lo mangiava la
popolazione raccolta in cerchio. Sicché quelle cerimonie si trasformavano in pantagruelici
banchetti intercalati di preghiere. Fu una legge del 97 avanti Cristo che proibì il sacrificio di
vittime umane. Segno che in casi di eccezione ad esse si ricorreva, a scapito degli schiavi o
dei prigionieri di guerra. Ma ci furono anche dei cittadini che volontariamente offrirono la
propria vita per la salvezza della nazione: come quel Marco Curzio che, per placare gli dèi
degli Inferi, in occasione d’un terremoto, si precipitò in un crepaccio, che subito si richiuse.
Meno truculente e più gentili erano le cosìddette cerimonie di purificazione, o di
un gregge, o di un esercito che partiva in guerra, o di una intera città. Vi si faceva una
processione torno torno cantando i carmina, inni pieni di magiche formule. Molto simile era
la procedura dei vota, offerte per ottenere qualche favore dagli dèi.
Quali dèi?
Lo stato romano, che di essi era l’impresario, non riuscì mai a mettere ordine in
questa materia, o forse non volle. Giove era considerato il più importante fra gl’inquilini
dell’Olimpo ma non il loro re, come lo fu Zeus nell’antica Grecia. Rimase sempre nel vago
come una forza impersonale che ora si confondeva col cielo, ora col sole, ora con la luna,
ora col fulmine, secondo i gusti. E forse in un primo tempo faceva tutt’uno con Giano, il
dio delle porte. Solo in seguito si differenziarono. Le ricche matrone romane andavano in
processione a piedi nudi al tempio di Giove Tonante sul Campidoglio per impetrare la
pioggia nelle stagioni di siccità, mentre in tempo di guerra si aprivano i portoni del tempio
di Giano per consentirgli di raggiungere l’esercito e guidarlo in battaglia.
Di rango pari a quello loro erano Marte, cui s’intitolava un mese dell’anno (marzo)
e che a Roma era legato da un vincolo di famiglia come padre naturale di Romolo, e
Saturno, il dio della semina, che la leggenda dipingeva come un preistorico re, professore di
agraria e vagamente comunista.
Dopo questo quadrimivirato, venivano le dée. Giunone era quella della fertilità sia
dei campi e degli alberi, sia degli animali e degli uomini, e col suo nome si era battezzato
un mese (giugno) considerato come il più favorevole ai matrimoni. Minerva, importata
dalla Grecia sulle spalle di Enea, proteggeva la saggezza e la sapienza. Venere si occupava
della bellezza e dell’amore. Diana, dea della luna, sovrintendeva alla caccia e ai boschi, in
uno dei quali, presso Nemi, sorgeva un suo maestoso tempio, dove si diceva ch’essa avesse
sposato Virbio, il primo re della foresta.
Poi veniva uno stuolo di dèi minori: i sottufficiali, diciamo così, di quel celeste
esercito. Ercole, dio del vino e dell’allegria, era capace di giocarsi ai dadi una cortigiana col
sagrestano del suo tempio; a Mercurio attribuivano un debole per i mercanti, gli oratori e i
ladri, tre categorie di persone che evidentemente i romani consideravano della stessa risma;
Bellona aveva la specialità della guerra...
Ma è impossibile nominarli tutti. Essi si moltiplicarono smisuratamente col
crescere della città e con l’espandersi del suo dominio. Perché qualunque stato o provincia
conquistassero i soldati romani, come prima cosa, facevano saccheggio degli dèi locali, e li
portavano in patria, convinti com’erano che, rimasti senza dèi, gli sconfitti non potessero
tentare una rivincita.
Ma, oltre a questi che, sebbene sottoposti a un trattamento di privilegio, erano
tuttavia degli dèi prigionieri, c’erano i novensiles, cioè quelli che di propria iniziativa molti
forestieri, quando si trasferivano a Roma e vi mettevano su casa, si portavano al seguito,
per sentirsi meno esuli e spaesati. Li allogavano in templi costruiti con fondi privati. E i
romani non solo non ne contestarono mai il diritto a nessuno, ma anzi si mostrarono
straordinariamente ospitali verso tutti. Lo stato e i suoi sacerdoti li consideravano in un
certo senso come dei poliziotti che avrebbero collaborato a tenere in ordine i loro fedeli
senza neanche reclamare uno stipendio. E a molti assegnarono addirittura un posto
nell’Olimpo ufficiale. Nel 496 avanti Cristo furono così assunti nell’“organico” Demetra e
Diòniso, come colleghi e collaboratori di Cerere e di Libero. Pochi anni dopo Castore e
Polluce, anch’essi di fresco consacrati, si disobbligarono scendendo dal cielo per aiutare i
romani a resistere nella battaglia del lago Regillo.
Verso il 300 Esculapio fu trasferito d’autorità da Epidauro a Roma per insegnarvi
medicina. E piano piano questi nuovi venuti, da ospiti che erano, si trasformarono in
padroni di casa; specialmente quelli greci, più affabili e cordiali, meno freddi, formalisti e
remoti degli dèi romani. Fu per influsso ellenico che piano piano si formò tra loro una
gerarchia, alla cui testa fu riconosciuto Giove con gli stessi attributi che ad Atene aveva
Zeus. E fu il primo passo verso quelle religioni monoteistiche che prima con lo stoicismo,
poi col giudaismo, trionfarono alla fine col Cristianesimo.
Questo processo pero si sviluppò molto più tardi. I romani del periodo
repubblicano convissero con una folla di dèi di cui Petronio diceva che in alcune città erano
più numerosi degli abitanti e che Varrone valutò a circa trentamila. La loro attività e
interferenze rendevano difficile la vita ai fedeli che non sapevano come destreggiarsi nelle
loro lotte e rivalità. Dovunque si poteva inciampare in qualche oggetto sacro all’uno o
all’altro. Offesi, essi apparivano sotto forma di streghe che volavano di notte, mangiavano
serpi, uccidevano i bambini e rubavano i cadaveri. In Orazio e in Tibullo, in Virgilio e in
Lucano se ne incontra ad ogni passo. Essi erano tanto più pericolosi in quanto, a differenza
di quasi tutte le altre religioni, quella romana non li riteneva confinati nel cielo, sebbene
ammettesse che anche lì ce n’era, ma pensava che di preferenza stessero sulla terra, e preda
di terrestri stimoli: fame, lussuria, cupidigia, ambizione, invidia, avarizia.
Per tener gli uomini al riparo dalle loro malefatte, i collegi, o ordini religiosi, si
moltiplicarono. Fra essi ce ne fu anche uno femminile, quello delle vestali, che, ingaggiate
fra i sei e i dieci anni, dovevano servire per trent’anni in assoluta castità. Furono le
precorritrici delle nostre monache. Vestite e velate di bianco, la loro funzione consisteva
soprattutto nell’annacquare la terra con acqua attinta alla fontana sacra alla ninfa Egeria. Se
sorprese a trasgredire il voto di verginità, venivano battute con le verghe e sotterrate vive.
Gli storici romani ci hanno tramandato dodici casi di questa tortura. Finito il trentennale
servizio, venivano riaccolte in società con molti onori e privilegi, e potevano anche
sposarsi. Ma difficilmente a quell’età trovavano un marito.
Era la religione che dava ai romani, i quali non conoscevano la domenica e il
week-end, i giorni di festa e di riposo. Ce n’era un centinaio all’anno, press’a poco quanti ce
ne sono ora. Ma li celebravano con più impegno. Alcune di queste “ferie” erano austere e
commemorative, come i lemuri (i nostri Morti) in maggio, che ogni padre di famiglia
celebrava in casa riempiendosi la bocca di fagioli bianchi e risputandoli intorno al grido:
«Con questi fagioli, io redimo me stesso e i miei. Andate, anime dei nostri antenati! ». In
febbraio c’erano i parentali, o i ferali e i lupercali, durante i quali si buttavano dei
bambolotti di legno nel Tevere per ingannare il dio che reclamava uomini veri. Poi c’erano
i fiorali, i liberali, gli ambarvali, i saturnali...
Anche in questo campo regnava una tale anarchia che la prima ragione che spinse i
romani a redigere un calendario fu la necessità di stendere una lista di queste feste. Nei
primissimi tempi erano i preti a incaricarsene, indicando, mese per mese, quando si
dovevano celebrare, e come. La tradizione attribuisce a Numa Pompilio il merito di aver
messo ordine in questa materia con un calendario fisso, che fu in vigore sino a Cesare. Esso
divideva l’anno in dodici mesi lunari, ma lasciava ai sacerdoti il diritto di allungare o
accorciare a testa loro il mese, purché in fondo al dodicesimo si fosse raggiunta la somma
di trecentosessantasei giorni. Ed essi a tal punto ne abusarono per favorire o danneggiare
questo o quel magistrato che, alla fine della repubblica, il calendario pompiliano era
diventato del tutto opinabile e fonte soltanto di controversie.
Nella giornata le ore erano misurate a occhio, dalla posizione del sole nel cielo. Il
primo orologio, a sole, fu di manifattura greca, lo importarono da Catania, nel 263, e lo
piazzarono nel Foro. Ma siccome Catania è tre gradi a est di Roma, l’ora non
corrispondeva, i romani si arrabbiavano, e per un secolo ci fu gran confusione perché
nessuno seppe aggiustare quella diavoleria.
I giorni del mese erano divisi secondo le kalende (il primo), le none (il cinque o il
sette) e gli idi (il tredici o il quindici). L’anno, che si chiamava annus, che vuol dire anche
“anello”, cominciava con marzo. Poi venivano aprile, maggio, giugno, quintile, sestile,
settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Un surrogato di domenica
c’era nella nundina che cadeva di nove giorni in nove giorni ed era quello che nei nostri
villaggi è ancora il giorno di mercato. I contadini abbandonavano il campo per venire a
vendere in paese le loro uova e frutta, ma non era una festa vera e propria.
Per divertirsi davvero, i romani dovevano aspettare i liberali e i saturnali. quando,
dice un personaggio di Plauto, « ognuno può mangiare quel che vuole, andare dove gli pare,
e far l’amore con chi gli garba, purché lasci in pace le mogli, le vedove, le ragazze e i
ragazzi ».
CAPITOLO UNDICESIMO
LA CITTA ’
NON si sa con precisione quanti abitanti avesse Roma alla vigilia delle guerre
puniche. Le cifre fornite dagli storici sulla base d’incerti censimenti sono contraddittorie, e
forse non tengono conto del fatto che la maggior parte dei censiti dovevano abitare non
dentro le mura della città, il cosìddetto pomerio, ma fuori, in campagna e nei villaggi che la
costellavano. Nella città vera e propria non dovevano esserci più di centomila anime:
popolazione che a noi sembra modesta, ma che a quei tempi era enorme. La sua composizione etnica doveva farne già un centro internazionale, ma meno di quanto lo fosse
stato sotto i re Tarquini che, con la loro passione etrusca del commercio e del mare, vi
avevano richiamato troppi forestieri, molti dei quali di difficile assimilazione. Con la
repubblica l’elemento indigeno, latino e sabino, aveva preso la sua rivincita, si era
rafforzato e forse aveva regolato con più parsimonia l’immigrazione. Essa veniva per la
maggior parte dalle province limitrofe ed era costituita da gente più facile a fondersi con i
padroni di casa.
La città non era progredita molto, dal punto di vista urbanistico, sotto i magistrati
repubblicani, avari, rozzi, e di scarse pretese. Due strade principali vi s’incrociavano
dividendola in quattro quartieri, ciascuno con propri dèi tutelari, i cosìddetti lari compitali
cui, a tutti gli angoli, si elevavano statue. Erano strade strette e di terra battuta, che solo più
tardi vennero selciate con pietre tratte dal greto del fiume. La Cloaca Massima, cioè con le
fognature esisteva già, a quanto pare, dai tempi dei Tarquini. Essa convogliava i rifiuti di
Roma nel Tevere infettandone l’acqua che doveva servire per bere. Nel 312 Appio Claudio
il Cieco affrontò e risolse questo problema costruendo il primo acquedotto che approvvigionò Roma con acqua fresca e pulita pescata direttamente dai pozzi. E per la prima volta i
romani, almeno quelli di una certa categoria, ne ebbero abbastanza per potersi lavare. Però
le prime Terme, o bagni pubblici, furono costruite soltanto dopo la sconfitta di Annibale.
Le case erano rimaste press’a poco quelle che avevano costruito gli architetti
etruschi. Se n’erano abbelliti solo gli esterni stuccandoli e decorandoli di graffiti.
I pericoli in mezzo a cui erano passati avevano spinto i romani a costruire
soprattutto templi per guadagnarsi la simpatia degli dèi. Sul Campidoglio n’erano nati tre di
legno, abbastanza imponenti e rivestiti di mattoni, a Giove, a Giunone e a Minerva.
La città viveva ancora soprattutto di agricoltura, basata sulla piccola proprietà
privata. Buona parte della popolazione, anche del centro, dopo aver dormito ammucchiata
sulla paglia, si alzava all’alba, e caricate la vanga e la zappa sul carro trascinato dai buoi,
andava ad arare il proprio campicello, che in media non superava i due ettari. Erano
contadini tenaci, ma non molto progrediti, che non conoscevano altro concime che il letame
delle bestie, né altra rotazione di coltura che quella dal grano ai legumi e viceversa. Da esse
molte aristocratiche famiglie trassero anche il loro nome: i Lentuli erano specialisti in
lenticchie, i Caepiones in cipolle, i Fabii in fave. Altri prodottì erano il fico, l’uva e l’olio.
Ogni famiglia aveva i suoi polli, i suoi maiali e soprattutto le sue pecore, che davano la lana
per tessere in casa i vestiti.
Alla vigilia della guerra punica questo idilliaco quadro di vita rustica si era
alquanto alterato. Le spedizioni contro le popolazioni limitrofe avevano spopolato la
campagna: i casolari, abbandonati, erano caduti in rovina; boscaglia e gramigna avevano
seppellito i campi dei reduci che, per vivere, erano tornati in città. Il nuovo territorio
conquistato a spese dei vinti era dichiarato “agro pubblico” dallo stato, che lo rivendeva ai
capitalisti ingrassatisi con gli appalti di guerra. Così sorsero i latifondi, che i proprietari
sfruttarono col lavoro degli schiavi, ch’erano numerosi e non costavano quasi nulla, mentre
in città si formava un proletariato di ex contadini nullatenenti in cerca di lavoro.
Ma il lavoro era difficile da trovare perché l’industria, dopo la caduta dei Tarquini,
invece di progredire, aveva regredito. Il sottosuolo, povero di minerali, era proprietà dello
stato che lo affittava a sfruttatori di scarsa coscienza e competenza. La metallurgia aveva
fatto pochi passi avanti, e il bronzo seguitava ad essere più usato dell’acciaio. Per
combustibile non si conosceva che il legno, e per procurarsene furono rase al suolo le belle
foreste del Lazio. Solo l’industria tessile aveva abbastanza prosperato, e ora c’erano vere e
proprie imprese che avevano iniziato una produzione in serie.
Gli ostacoli alla espansione industriale e commerciale erano quattro. Il primo, di
ordine psicologico, era la diffidenza della classe dirigente romana, tutta terriera, per queste
attività che avrebbero rafforzato le classi medie borghesi. Il secondo era la mancanza di
strade, che non consentiva il trasporto delle materie prime e dei prodotti. La prima di esse,
la via latina, fu costruita solo nel 370, quasi un secolo e mezzo dopo l’instaurazione della
repubblica, e sì limitò a congiungere l’Urbe coi Colli Albani. Solo Appio Claudio, l’autore
dell’acquedotto, senti la necessità, cinquant’anni più tardi, di costruirne una, che infatti
portò il suo nome, per raggiungere Capua. I senatori approvarono riluttanti i suoi grandiosi
progetti solo perché un sistema stradale lo chiedevano anche i generali. Il terzo ostacolo era
la mancanza di una flotta, scomparsa dopo la fine della supremazia etrusca in Roma. Piccoli
armatori privati avevano continuato a costruire qualche nave, ma gli equipaggi erano timidi
e inesperti. Da novembre, a marzo non c’era verso di farli uscire dal porto di Ostia, dove
del resto il fango del Tevere bloccava le loro barche. Una volta esso ne inghiottì duecento
in un solo boccone. Eppoi oltre il piccolo cabotaggio non andavano, perché non volevano
perdere di vista la costa, con tutti quei pirati greci a oriente e cartaginesi a occidente che
infestavano i paraggi. Il che rende tanto più ammirevole il miracolo che Roma compì di lì a
pochi anni affrontando con le sue improvvisate flotte quelle di Annone e & Annibale.
Un quarto impaccio al commercio fu, nei primi tempi, anche la mancanza di un
sistema monetario. Nel primo secolo di repubblica il mezzo di scambio fu il bestiame. Si
commerciava in termini di polli, di maiali, di pecore, di somari, di vacche. E infatti le prime
monete recano le immagini di questi animali, e si chiamarono pecunia, da pecus che vuol
dire appunto “bestiame”: La loro prima unità fu coniata con l’asse ch’era un pezzo di rame
di una libbra. Era nata da poco, che lo stato già la svalutava di ben cinque sesti, per fare
fronte alle spese della prima guerra punica. Dal che si vede che la truffa dell’inflazione è
sempre esistita e si ripete dacché mondo è mondo, con gl’identici sistemi. Anche allora lo
stato lanciò un prestito fra i cittadini che, per aiutarlo ad armare l’esercito, gli portarono
tutti i loro assi di una libbra di rame. Lo stato li incassò, divise ognuno di essi per sei, e per
ogni asse ricevuto ne restituì un sesto al creditore.
Per molto tempo questo svalutato asse restò l’unica moneta romana. Il suo potere
di acquisto era, sembra, pari a quello di cinquanta lire del 1957 (è meglio precisar la data,
perché di qui al 1958 c’è il caso che il nostro governo faccia con la lira la stessa operazione
che quello romano fece con l’asse). Poi un sistema più complesso si sviluppò; venne il
sesterzio d’argento, ch’erano due assi e mezzo, cioè centoventicinque lire; poi il denario,
pure d’argento, pari a quattro sesterzi (cinquecento lire); e infine il talento d’oro, che
doveva essere addirittura un lingotto perché valeva qualcosa come due milioni e mezzo
delle nostre lire, e il novanta per cento dei romani probabilmente non vide mai com’era
fatto.
All’opposto di noi che consideriamo chiese le banche, gli antichi romani
considerarono banche le chiese, e in esse depositavano i fondi dello stato perché le
ritenevano le più al riparo dai ladri. Istituti governativi di credito non ce n’erano. I prestiti li
facevano gli argentari, agenti di cambio privati, che avevano le loro bottegucce in una
stradicciola vicino al Foro. Una delle Leggi delle Dodici Tavole proibiva lo strozzinaggio e
fissava il tasso d’interesse all’otto per cento come massimo. Ma l’usura fiorì ugualmente
sulla miseria e i bisogni dei poveri diavoli, ch’erano molti e in disperate condizioni, perché
quella che qui chiamo l’industria era in realtà un pullulio di piccole botteghe artigiane che
cercavano, per vincere la concorrenza, di abbassare i costi dei loro prodotti soprattutto
lesinando sui salari di una mano d’opera servile e senza protezione di sindacati.
Disorganizzata e senza capi, essa non faceva scioperi contro i padroni. Faceva, ogni tanto,
vere e proprie guerre, che si chiamarono appunto servili, e che misero a repentaglio lo stato.
In compenso, aveva le “corporazioni di mestiere”, riconosciute anch’esse col nome di
“collegi” pare fin dai tempi di Numa. C’erano quelle dei vasai, dei fabbri, dei calzolai, dei
carpentieri, dei suonatori di flauto, dei conciaioli, dei cuochi, dei muratori, dei cordai, dei
bronzisti, dei tessitori e degli “ artisti di Dioniso”, come si chiamavano gli attori. E da esse
possiamo dedurre quali fossero i mestieri dei romani di città. Ma erano controllate da
funzionari di stato, i quali non permettevano che vi si dibattessero questioni di salario o di
stipendio e che, quando sentivano pericolosamente gonfiarsi le scontentezze, provvedevano
a qualche distribuzione gratuita di grano. I membri vi si riunivano per discorrere di
mestiere, giocare a dadi, bere un gotto di vino, e aiutarsi fra loro. Perché erano poveri
diavoli, anche quelli ch’erano liberi e con diritti politici. Non pagavano tasse e facevano
poco servizio militare, in tempo di pace, è vero. Ma in tempo di guerra, morivano come gli
altri.
Gli scrittori romani le cui opere son giunte fino a noi e che fiorirono molto tempo
dopo, hanno parecchio abbellito questo periodo della Roma stoica. Lo hanno fatto per
motivi polemici, per contrapporre le virtù antiche ai difetti dell’epoca loro. La repubblica
non fu immune da gravi difetti, e se sotto di essa fu fondato il diritto, non si può dire che la
giustizia vi trionfasse.
Tuttavia è vero che i cittadini ci vissero più scomodi e sacrificati, ma più ordinati e
sani di quelli dell’Impero. La moralità non era rigida nemmeno allora, ma il malcostume
era mantenuto nella sua “sede” e non contaminava la vita della famiglia basata sulla castità
delle ragazze e la fedeltà delle spose. Gli uomini, dopo qualche scapestrataggine con le
prostitute, si sposavano presto, sui vent’anni. E da allora in poi erano troppo impegnati a
mantener moglie e figlioli per abbandonarsi a passatempi pericolosi.
Il matrimonio era preceduto dal fidanzamento, che in genere era deciso dai due
padri, spesso senza nemmeno interpellare gli interessati. Era un vero e proprio contratto che
riguardava specialmente questioni patrimoniali e di dote, e lo si suggellava con un anello
che il giovanotto infilava nell’anulare della ragazza, dove si credeva che passasse un nervo
che faceva capo al cuore.
Il matrimonio era di due specie: con mano o senza mano. Col primo, il più comune
e completo, il padre della ragazza rinunziava a tutti i suoi diritti su di lei in favore del
genero, che ne diventava praticamente padrone. Col secondo, che dispensava dalla
cerimonia religiosa, li conservava. Quello con mano avveniva per uso, cioè dopo un anno di
coabitazione fra gli sposi, per coemptio, cioè per acquisto, o per confarretio, quando si
mangiava insieme un dolce. Quest’ultimo era riservato ai patrizi, e richiedeva una solenne
cerimonia religiosa con canti e cortei. Le due famiglie si riunivano con amici, servi e clienti, nella casa della sposa, e di lì muovevano in processione verso quella dello sposo, con
accompagnamento di flauti, canti d’amore e apostrofi grossolanamente allusive. Quando il
corteo giungeva a destinazione, lo sposo, di dietro la porta, chiedeva: « Chi sei? ». E la
sposa rispondeva: « Se tu sei Tizio, io sono Tizia ». Allora lo sposo la sollevava fra le
braccia, le presentava le chiavi di casa. E tutti e due, a testa bassa, passavano sotto un giogo
per significare che si sottoponevano a un vincolo comune.
Teoricamente, il divorzio esisteva. Ma il primo di cui abbiamo notizia avvenne
due secoli e mezzo dopo la fondazione della repubblica, sebbene una regola d’onore lo
rendesse obbligatorio in caso d’adulterio da parte della moglie (il marito era libero di fare
quel che gli pareva). Le donne, a quei tempi, erano piuttosto bruttocce e rozze, di gambe
corte e di “attacchi” pesanti. Le bionde, rarissime, facevano premio sulle brune. In casa
portavano la stola, una specie di futa abissina lunga fino ai piedi, di lana bianca, chiusa al
petto da uno spillo. Quando uscivano, ci mettevano sopra la palla, o mantello.
I maschi, più solidi che belli, col viso cotto dal sole e il naso diritto, portavano da
ragazzi la toga pretesta, orlata di porpora; e, dopo il servizio militare, quella virile,
interamente bianca, che copriva tutto il corpo, con un lembo che risaliva sulla spalla
sinistra, di lì scendeva sotto il braccio destro (che in tal modo restava libero) e tornava sulla
spalla sinistra. Le pieghe servivano come tasche. Fino al 300 gli uomini portarono barba e
baffi. Poi prevalse il costume di radersi, che a molti parve audace e in contrasto con quella
gravità, cui i romani tenevano come noi oggi si tiene invece alla disinvoltura.
Una sobrietà spartana vigeva anche nelle case dei gran signori. Lo stesso Senato si
raccoglieva su rozzi banchi di legno dentro la curia che non era riscaldata neanche
d’inverno. Gli ambasciatori cartaginesi che vennero a chieder pace dopo la prima guerra
punica divertirono molto i loro compatrioti, scialacquoni e sibariti, raccontando che, nei
pranzi ch’erano stati loro offerti dai senatori romani, avevano visto sempre girare lo stesso
piatto d’argento che evidentemente essi s’imprestavano l’uno all’altro.
I primi segni di lusso apparvero con la seconda guerra punica. E subito fu
promulgata una legge che proibiva gioielli, vestiti di fantasia e pasti troppo costosi. Il
governo voleva preservare soprattutto una sobria e sana dieta imperniata su una prima
colazione di pane, miele, olive e formaggio, un desinare a base di vegetali, pane e frutta, e
una cena in cui solo i ricchi usavano carne o pesce. Il vino lo bevevano, ma quasi sempre
annacquato.
I giovani rispettavano i vecchi, e forse nell’ambito della famiglia e delle amicizie
c’erano anche espressioni d’amore e di tenerezza. Ma in genere i rapporti tra gli uomini
erano rudi. Si moriva facilmente, e non soltanto in guerra. Il trattamento dei prigionieri e
degli schiavi era senza pietà. Lo stato era duro coi cittadini, e feroce col nemico. Tuttavia
certi suoi gesti furono di autentica grandezza morale. Quando per esempio un sicario venne
a proporre loro di avvelenare Pirro, i cui eserciti minacciavano Roma, i senatori non solo
rifiutarono di associarsi, ma informarono il re nemico del complotto che lo minacciava. E
quando, dopo averli messi in rotta a Canne, Annibale mandò dieci prigionieri di guerra a
Roma per trattare il riscatto di altri ottomila, con l’impegno, se non riuscivano, di ritornare,
e uno di essi trasgredì restando in patria, il Senato lo mise ai ferri e lo restituì ammanettato
al generale cartaginese, la cui gioia per la vittoria, dice Polibio, fu offuscata da quel gesto
che gli dimostrò con che po’ po’ di uomini aveva a che fare.
Tutto sommato, il romano di quest’epoca fu abbastanza somigliante al tipo che ne
idealizzarono gli storici alla Tacito e alla Plutarco. Gli mancavano molte cose: il senso delle
libertà individuali, il gusto per l’arte e per la scienza, la conversazione, il piacere della
speculazione filosofica (di cui anzi diffidava), e soprattutto l’umorismo. Ma ebbe la lealtà,
la sobrietà, la tenacia, l’obbedienza, la praticità.
Non era fatto per capire il mondo e goderne. Era fatto solo per conquistarlo, e
governarlo.
Passatempi, a parte le feste religiose, ne aveva pochi. Fino al 221 avanti Cristo,
quando fu costruito il Flaminio, Roma possedette un solo circo: il Circo Massimo, attribuito
a Tarquinio Prisco, dove si andava ad ammirare le lotte fra schiavi, che quasi sempre
terminavano con la morte del vinto. Anche le donne potevano partecipare, e l’ingresso era
gratuito. Alle spese provvidero prima lo stato, poi gli edili, per farsi la propaganda
elettorale. Qualcuno di loro, a forza di finanziare spettacoli di qualità, riusciva ad arrivare al
consolato come ora certi presidenti di società di calcio diventano, quando la squadra vince,
sindaci o deputati.
Oltre a questi divertimenti, diciamo così, normali, a rallegrare la vita austera e
faticata dei romani, c’era il “trionfo” che si prodigava al generale reduce da una vittoria in
cui avesse ucciso almeno cinquemila soldati nemici. Se era arrivato solo a
quattromilanovecentonovantanove, doveva contentarsi soltanto di una “ovazione”,
cosìddetta perché consisteva nel sacrificio di una ovis, una pecora, in suo onore.
Per il “trionfo” si formava invece una imponente processione fuori di città, alle cui
porte generale e truppa dovevano deporre le armi e passare sotto un arco di legno e di
frasche che fece da modello a quelli che si costruirono dopo di travertino. Una colonna di
trombettieri apriva il corteo. Dietro venivano i carri carichi del bottino di guerra, poi intere
greggi e mandrie destinate al macello; poi i capi nemici in catene. E infine, preceduto dai
littori e flautisti il generale in piedi su una quadriga vivacemente colorata, con una toga
color porpora sulle spalle, una corona d’oro sulla testa, uno scettro d’avorio e un ramo
d’alloro. Lo circondavano i figli, e lo seguivano a cavallo parenti, segretari, consiglieri,
amici. Egli saliva ai templi di Giove, Giunone e Minerva sul Campidoglio, ai loro piedi
deponeva il bottino, faceva raccogliere gli animali da sgozzare, e come offerta suppletiva
ordinava la decapitazione dei comandanti nemici prigionieri.
Il popolo gongolava e applaudiva. Ma da parte dei soldati era costume lanciare
motti e frizzi mordaci verso il loro generale, denunziandone debolezze, difetti e
ridicolaggini, perché non avesse a montare in superbia e a credersi un infallibile padreterno.
A Cesare, per esempio, gridavano: « Smetti, zuccapelata, di guardar le matrone. Contentati
delle prostitute!... ».
Se si potesse fare altrettanto coi dittatori dei nostri tempi, forse la democrazia non
avrebbe più nulla da temere.
CAPITOLO DODICESIMO
CARTAGINE
ANCHE Cartagine, come tutte le città di quel tempo, faceva risalire le sue origini a
una specie di miracolo, e ne raccontava la storia come un romanzo. Secondo il quale, a
fondarla era stata Didone, che più tardi fu venerata dai suoi concittadini come dea, figlia del
re di Tiro. Rimasta vedova per colpa di suo fratello che le aveva ucciso il marito, essa si era
messa alla testa d’un gruppo di seguaci in cerca d’avventure e, dall’estremità orientale del
Mediterraneo, era salpata con loro verso ovest a bordo di una nave. Cabotando lungo la
costa settentrionale dell’Africa, aveva superato l’Egitto, la Cirenaica, la Libia. E giunta alla
fine una decina di miglia a occidente del luogo in cui oggi sorge Tunisi, era sbarcata e
aveva detto ai suoi amici: « Ecco, qui costruiremo la Nuova Città». Così la chiamarono
infatti: Nuova Città, come Napoli e New York, che nel loro linguaggio si diceva Kart
Hadasht, e che poi i greci tradussero Karchedon e i romani Carthago.
Naturalmente le cose non stanno precisamente così. Ma come si siano svolte in
realtà è difficile saperlo, perché anche di Cartagine, ch’ebbe la disgrazia di trovarsi sulla
loro strada, i romani fecero quello che avevano fatto dell’Etruria: la ridussero in tale
poltiglia da rendere quasi impossibile oggi, per mancanza di materiale, una ricostruzione
esatta della sua storia e civiltà.
Certamente la fondarono i fenici, un popolo di razza e lingua semita come gli
ebrei, grandi mercanti e navigatori che facevano in su e giù con le loro barche, vendendo e
comprando un po’ di tutto. Non avevano paura neanche del diavolo. Furono i primi marinai
del mondo a superare le cosìddette Colonne d’Ercole, cioè lo stretto di Gibilterra, per
ridiscendere l’Atlantico lungo la costa d’Africa e risalirlo lungo quelle di Spagna e
Portogallo. Su questo itinerario avevano già, quando Roma nacque, fondato parecchi, paesi,
che dapprincipio dovettero essere soltanto un cantiere e un bazar, cioè un mercato. Leptis
Magna, Utica, Biserta, Bona, ebbero certamente questa origine. E Cartagine fu una loro
consorella, forse fra le più umili, fino a quando le circostanze non ne fecero la più cospicua.
Queste circostanze furono soprattutto il declino militare e commerciale di Tiro e di
Sidone, che per loro sfortuna si trovarono sulla strada di Alessandro di Macedonia, il quale,
mentre Roma era ancora un villaggio, voleva diventare imperatore del mondo e per poco
non ci riuscì. Minacciati dai suoi eserciti, i milionari di quelle due città, che, come tutti i
milionari, avevano più paura degli altri, pensarono di mettere in salvo le loro persone e i
loro capitali. E, come oggi c’è la moda di rifugiarsi a Tangeri, allora ci fu quella di
rifugiarsi a Cartagine.
La città s’ingrossò di nuovi abitanti pieni di soldi e d’iniziative. Essi respinsero
sempre più verso l’interno la popolazione indigena formata di poveri negri, molti dei quali
furono assunti come servi e schiavi. E, non più contentandosi del commercio e del mare, si
dedicarono anche alla terra. Il particolare è interessante perché sin qui si era sempre pensato
che gli ebrei alla terra sian refrattari per costituzione. E invece quelli di Cartagine
dimostrarono il contrario. Essi furono i grandi maestri di molte colture, specie di vigne, di
oliveti e di frutteti; e gli stessi romani ebbero molto da imparare da loro. Fu un cartaginese,
Magone, il più grande professore di agraria dell’antichità.
Era una economia perfettamente equilibrata quella di Cartagine. In città fioriva
una eccellente industria metallurgica che forniva i migliori attrezzi per lavorare la terra,
canalizzarla e trasformarla in orti e giardini. Gran parte di questi prodotti venivano caricati
sulle navi, ch’eran le più grandi del mondo, e avviati verso la Spagna o la Grecia. Gli
armatori finanziavano gli esploratori per scoprire nuovi mercati. Uno di costoro, Annone,
con una solitaria galea, discese le coste atlantiche dell’Africa per duemila chilometri.
Altri commessi viaggiatori battevano gl’itinerari di terra a bordo di muli, cammelli
ed elefanti, trovarono oro e avorio, e li portarono in patria. Attraversavano il Sahara con
l’indifferenza con cui noialtri attraversiamo l’Arno. E in seguito ai loro rapporti, come più
tardi avrebbe fatto Venezia, il governo mandava un po’ di flotta o un po’ di esercito a
prendere possesso dei punti strategici.
Il loro sistema economico e finanziario era il più progredito del tempo. Roma
aveva appena cominciato a coniare rozze monete di metallo, che Cartagine aveva già i
biglietti di banca: certe strisce di cuoio, diversamente stampigliate secondo il loro valore.
Esse erano in tutto il bacino del Mediterraneo quello che più tardi sarebbe stata la sterlina e
più tardi ancora il dollaro. Il loro valore nominale era garantito dall’oro che rigurgitava
nelle casse dello stato. Perché via via che faceva una nuova conquista, la prima cosa che
imponeva Cartagine ai vinti era un tributo, e non dei più leggeri. Leptis, per esempio, ripagava il grande onore di essere vassalla di Cartagine con trecentosessantacinque talenti
all’anno, che corrisponderebbero a quasi un miliardo di lire.
Questo sfruttamento del proprio impero coloniale fu probabilmente una delle
ragioni della disfatta di Cartagine, quando venne in conflitto con Roma. Ma, finché non si
profilò questa minaccia, esso garantì alla città fenicia un rigoglio mai visto sino ad allora.
Essa aveva allora due o trecentomila abitanti che non abitavano in capanne come a Roma,
ma in grattacieli che contavano fino a dodici piani, i più poveri; e in palazzi con giardino e
piscina, i più ricchi. I templi e i bagni pubblici si sprecavano. Il porto aveva duecentoventi
moli e quattrocentoquaranta colonne di marmo. In mezzo all’abitato c’era la city, come a
Londra, col ministero del Tesoro. E tutt’intorno un triplice bastione di mura con torri, una
specie di “1inea Maginot” che poteva contenere fino a ventimila soldati con tutto il loro
armamento, quattromila cavalli e trecento elefanti.
Del popolo e dei suoi costumi, l’unica testimonianza che ci resta è quella degli
storici romani, che naturalmente non potevano essere equanimi verso di esso. La loro lingua
doveva essere molto vicina a quella ebraica, e infatti i loro magistrati si chiamavano
sciofetes, che viene certamente dall’ebraico shofetim. Anche i lineamenti denunziavano
l’origine semitica. Erano gente di colorito olivastro, in genere con lunghe barbe ma senza
baffi, e già sin da allora portavano il turbante. I più poveri, che probabilmente venivano da
mescolanze con l’elemento indigeno e quindi avevano anche la pelle più scura, si vestivano
con quella che oggi in Egitto si chiama gallabìa, un camicione sciolto e lungo fino ai piedi
calzati di sandali. I signori seguivano invece la moda greca, come oggi si segue quella inglese, portavano abiti eleganti, orlati di porpora, e un anello al naso. La condizione delle
donne era inferiore a quella delle ateniesi, ma superiore a quella delle romane. In genere
stavano velate e confinate in casa; però la carriera ecclesiastica era loro aperta, e vi
potevano raggiungere alti gradi. Oppure potevano darsi alla prostituzione che fioriva
rigogliosa e che costituiva un mestiere pregiato, o per lo meno non squalificato, come lo è
ancora oggi in Giappone.
Polibio e Plutarco assicurano concordemente che il livello morale era basso, il che
ci stupisce alquanto trattandosi di un popolo di razza semita, dove i costumi in genere son
severi, anzi puritani. Ce li presentano come gagliardi mangiatori e bevitori, impenitenti
festaioli, sempre pronti a far ribotta nei clubs e nelle taverne. La fides punica, cioè la parola
cartaginese, è rimasta sinonimo, in latino, di tradimento. Ma non bisogna dimenticare che la
storia dei tradimenti cartaginesi fu scritta dagli storici romani. Plutarco ci presenta questi
antichi e irriducibili nemici dì Roma come “servili verso gl’inferiori e oscillanti fra la
codardia nella sconfitta e la crudeltà nella vittoria”. Polibio aggiunge che presso di loro tut-
to veniva misurato sul metro del profitto. Ma si sa che Polibio era amico intimo di Scipione,
colui che distrusse Cartagine incendiandola.
Naturalmente anche i cartaginesi avevano i loro dèi. Se li erano portati dietro dalla
madrepatria, la Fenicia, ma gli avevano cambiato nome. Invece di Baal-Moloch e Astarte,
come li chiamavano a Tiro e a Sidone, li chiamarono Baal-Haman e Tanit. Sotto di loro
c’erano Melkart, che vuol dire “chiave della città”, Eshmun, signore della ricchezza e della
buona salute, e infine Didone, la fondatrice, che a Cartagine teneva il posto occupato a
Roma da Quirino.
A tutti questi dèi offrivano sacrifici, specie nei momenti di bisogno. Si trattava di
capre o di vacche per gli dèi minori. Ma quando c’era da placare o da ingraziarsi
Baal-Haman, si ricorreva ai bambini, collocandoli fra le braccia della grande statua di
bronzo che lo rappresentava, e di li lasciandoli rotolare sul fuoco che vi ardeva sotto. Sino a
trecento in una giornata ne bruciarono in mezzo a un baccanale di trombette e di tamburi
per soffocarne le grida. E le mamme erano tenute ad assistere senza una lacrima né un
lamento. Pare che fosse in uso, da parte delle famiglie ricche, quando erano richieste di fornire un bambino per cuocerlo alla griglia, comprarne dai poveri. Ma quando Agatocle di
Siracusa mise l’assedio alla città, rendendo necessario, oltre al soccorso degli dèi, anche il
buon accordo fra le classi sociali, l’uso fu proibito per non alimentare gli odi fra fortunati e
diseredati. Il regime politico non era, tutto sommato molto diverso da quello di Roma.
Aristotele ne scrisse un grande elogio, forse per sentito dire e perché non vi sorsero mai
serie minacce di dittatura, dalla quale egli aborriva. Come a Roma, l’organo supremo era il
Senato, anche qui composto di trecento membri, di cui la maggioranza dapprima fu fornita
dall’aristocrazia terriera, poi piano piano passò a quella del denaro, cioè alla plutocrazia.
Esso prendeva le grandi decisioni e ne affidava l’esecuzione ai due sciofetes, che corrispondevano press’a poco ai consoli romani. Solo quando essi non riuscivano a mettersi
d’accordo, si chiedeva il parere a una specie di Camera dei deputati, che aveva il potere di
dire “sì” o “no”, ma non quello di avanzare proposte per suo conto.
Anche il Senato era, teoricamente, elettivo. Ma ni pratica, avendo in mano tutte le
leve di comando, riusciva con la corruzione o i brogli a imporre i suoi candidati. Sopra di
esso c’era solo una specie di Corte costituzionale formata da centoquattro giudici che
controllavano un po’ tutto: non solo la costituzionalità delle leggi, ma anche i conti
dell’amministrazione. Durante le guerre con Roma, questa Corte diventò a poco a poco il
vero governo.
Dell’esercito, Cartagine non faceva gran conto, anche perché i suoi vicini d’Africa
non la inquietavano. I cartaginesi non amavano le caserme, che infatti erano piene soltanto
di mercenari, prezzolati fra gl’indigeni, e soprattutto fra i libici. Delle grandi imprese
ch’essa compì nel secolo di lotta contro Roma, il merito va quindi attribuito quasi
esclusivamente al genio dei suoi Annibali, Amilcari e Asdrubali, che furono fra i più
brillanti generali dell’antichità.
Sul mare invece era forte, la più forte fra le potenze navali di quel tempo. La sua
home fleet contava in tempo di pace cinquecento quinqueremi, ch’erano un po’ le corazzate
di allora ma rapide e leggere, e gaiamente dipinte di rosso, di verde e di giallo. Gli
ammiragli che le comandavano la sapevano lunga, e anche senza bussola e compasso
conoscevano il Mediterraneo come la vasca del loro giardino. In tutti gli anfratti delle coste
spagnole e francesi, avevano cantieri, magazzini di rifornimento e informatori. Il loro
Istituto cartografico era il più aggiornato e moderno. Fin quando Roma, occupatissima a
con solidare la sua egemonia sulla penisola, non ebbe varato una propria flotta, quella
cartaginese non accettò intrusioni, fra la Sardegna e Gibilterra, da parte di nessuno.
Qualunque nave straniera capitasse a tiro di quelle loro, la requisivano o l’affondavano,
affogandone i marinai, senza nemmeno chieder loro da che parte venivano e che bandiera
battevano.
Questa era, all’ingrosso, Cartagine, quando i romani, sbarazzatisi l’uno dietro
l’altro di tutti i rivali italiani e unificata la penisola sotto il proprio comando, cominciarono
a occuparsi di cose di mare.
Ma, badate, tutto quel che ne abbiamo detto è stato ricostruito su elementi molto
fragili. Scipione, quando mise a ferro e a fuoco la città senza lasciarvi pietra su pietra, vi
trovò, fra le altre cose, parecchie biblioteche. Ma invece di portarle a Roma, le distribuì fra
i suoi alleati africani (e, da parte di un uomo colto come lui, la cosa stupisce) che per i libri
avevano poca passione e li lasciarono andare in malora. Ecco perché non abbiamo
nemmeno un manuale della sua storia, e dobbiamo contentarci del poco che riuscirono a
ricostruirne Sallustio e Giuba. Qualche frammento di Magone e una testimonianza di
sant’Agostino ci assicurano tuttavia che Cartagine ebbe una sua cultura, e di buona qualità.
I greci, che pure avevano Atene sotto gli occhi, dicevano ch’essa era una delle più
belle capitali del mondo. Ma quel che di essa ci resta è troppo poco per confermarcelo. I
suoi più importanti resti son quelli che gli archeologi hanno disseppellito nelle Baleari,
dove i cartaginesi avevano fondato una colonia e dove forse qualcuno di loro si rifugiò, al
momento del massacro, portandovi anche qualche opera d’arte. Tutto il resto è raccolto nel
museo di Tunisi, dove gli archeologi seguitano ad accumulare quello che via via scavano
dieci miglia più a ovest, dove la città sorgeva.
Vi si possono ammirare alcuni scampoli di scultura, tratti dai sarcofaghi. Lo stile è
una mistura greco-fenicia. Poi, il solito vasellame, ma di scarso valore: roba utilitaria e
costruita in serie. Nulla ci resta di quello che, a quanto pare, fu il vanto di Cartagine:
l’artigianato. Dicono che soprattutto gli orafi erano gran maestri. Purtroppo la gioielleria è
stata, in tutti tempi, il bottino di guerra più ricercato.
CAPITOLO TREDICESIMO
REGOLO
IL patto che avevano stipulato con Cartagine nel 508 avanti Cristo, quando si
trovarono presi tra la rivoluzione all’interno e la guerra con etruschi, latini e sabini
all’esterno, impegnava i romani a non spingere mai, per nessuna ragione, le loro navi oltre
il canale di Sicilia, e a non sbarcare in Sardegna e in Corsica che in caso di “forza
maggiore”, cioè per qualche rifornimento e qualche riparazione in un cantiere.
Erano limitazioni gravi, ma Roma non ne aveva molto sofferto perché la sua flotta
era agl’inizi e del tutto in mano agli armatori etruschi che, con la costituzione della
repubblica, avevano perso quattrini e influenza politica. Sul mare, di cui i senatori
latino-sabini, tutti “terrieri”, s’infischiavano e non capivano nulla, Roma a quel tempo
contava ben poco, e quindi aveva rinunziato a ciò che non aveva. Essa forse ignorava
perfino i grandi cambiamenti che proprio in quegli anni erano sopravvenuti nel cosìddetto
“equilibrio delle potenze navali” del Mediterraneo. Vediamoli, all’ingrosso.
Nel bacino orientale, quello a est del canale di Sicilia, si era combattuta per secoli
una guerra tra le flotte fenicie e quelle greche, che ora si stava risolvendo a favore delle
seconde. Prima l’Egeo, poi lo jonio erano caduti in mani elleniche, e l’Italia se ne accorse,
quando sulle sue coste meridionali e su quelle siciliane i vincitori cominciarono a sbarcare
sempre più numerosi e a fondarvi colonie che poi diventarono un vero e proprio impero: la
Magna Grecia, Catania, Siracusa, Eraclea, Crotone, Messina, Sibari, Reggio, Nasso, furono,
per i loro tempi, fior di metropoli. Purtroppo assieme ai loro déi, alla loro filosofia, al loro
teatro e alla loro scultura, quei pionieri si erano portati dietro dalla madrepatria anche il
vizio della litigiosità. E quel vizio doveva perderli nella lotta contro Roma. Ma per il momento erano loro i padroni della zona.
Nel bacino occidentale, invece, i fenici avevano vinto per opera della loro più
giovane colonia: Cartagine, che a sua volta aveva fondato infinite altre colonie non soltanto
sulla costa nord-africana, ma anche su quelle portoghesi, spagnole, francesi, corse, sarde, in
modo da fare di tutto il Mediterraneo occidentale un lago cartaginese.
Quando Roma, sotto i re, era stata padrona dell’Etruria e quindi anche della sua
flotta, era venuta varie volte in contatto con Cartagine, e probabilmente non sempre questi
contatti erano stati fra i più cortesi. A quei tempi la “guerra di corsa” era corrente e non
impegnava che i capitani e gli equipaggi che la facevano. Una nave ne aggrediva un’altra,
anche di compatrioti, la spogliava, gettava in mare i marinai. E tutto finiva li.
Poi Roma, come potenza mediterranea, era scomparsa, e di fronte non erano
rimasti che i greci della Magna Grecia, e i fenici di Cartagine: gli uni a est, gli altri a ovest
della Sicilia, di cui si erano spartiti le coste: quelle orientali erano infatti greche, quelle
occidentali cartaginesi. Si guardavano tra loro in cagnesco, e vivevano in un perpetuo
regime di “guerra fredda” con episodi di guerra calda, seguiti da armistizi e “distensioni”.
Erano convinti, gli uni e gli altri, di dover arrivare prima o poi a una resa di conti; ma non
s’immaginavano ch’essa sarebbe andata a beneficio di un terzo.
Nessuno può dire con certezza se Roma sapeva quel che faceva e misurò le
conseguenze del suo gesto, quando decise di accettare le offerte dei mamertini.
Erano costoro un branco di mercenari, assoldati in tutte le parti d’Italia da
Agatocle di Siracusa per combattere i cartaginesi. Al momento del congedo, nel 289, invece
di tornarsene a casa, dove forse li aspettava un mandato di cattura, formarono una banda,
assaltarono Messina, la saccheggiarono, ne sternimaron o la popolazione, e vi si stabilirono
da padroni, affibbiandosi quel buffo e presuntuoso nome di “mamertini” , che voleva dire
nientepopodimeno che “figli di Marte”.
Da una ventina d’anni, costoro ne stavano combinando di tutti i colori.
Attraversavano lo stretto per incendiare e distruggere i villaggi della dirimpettaia costa
calabra. Avevano dato noia a Pirro, avevano dato noia ai romani. E ora, alla fine del 270, si
trovavano assediati da Gerone di Siracusa, che voleva farla finita con loro una volta per
tutte.
Per sottrarsi al castigo che sarebbe stato certamente esemplare, i mamertini
chiesero l’aiuto dei cartaginesi che mandarono un esercito e occuparono la città. Visto che
la regola “chiodo scaccia chiodo” aveva funzionato, i mamertini pensarono di applicarla
ancora una volta, e subito dopo chiamarono i romani perché venissero a liberarli dai
“liberatori” cartaginesi. Correva l’anno 264. Ed erano trascorsi due secoli e mezzo da
quando Roma e Cartagine avevano concluso quel solenne patto di alleanza che, tutto sommato, aveva sempre ben funzionato, e che era stato solennemente riconfermato vent’anni
prima, quando Cartagine aveva offerto e pòrto aiuto a Roma nella sua lotta contro Pirro.
Ma per i romani la Sicilia, su cui si trattava di metter piede, era l’Eldorado. Chi
c’era stato non faceva che magnificarne le ricchezze e le bellezze. L’invito dei mamertini
era di quelli a cui si resiste male.
Forse tuttavia esso sarebbe stato declinato, se i senatori fossero stati liberi di
decidere da soli: essi sapevano dove avrebbe condotto quell’intervento. Ma ormai certe
scelte dovevano essere riservate all’Assemblea Centuriata, nella quale dominavano quelle
classi borghesi-industriali e mercantili che nelle guerre avevano sempre inzuppato il pane e
appunto per questo erano nazionaliste e patriottarde a oltranza. Chi non aveva nulla,
sperava di ottenere qualcosa, magari una fattoria in qualche nuova colonia; chi lo aveva,
sperava di moltiplicarlo. Ed è difficile muovere obbiezioni contro chi parla, o dice di
parlare, in nome della Patria e degli Immancabilí Destini.
L’Assemblea Centuriata decise di accettare l’offerta e affidò l’esecuzione
dell’impresa al console Appio Claudio. Nella primavera del 264, dopo alcuni infruttuosi
tentativi, una piccola flotta romana agli ordini del tribuno Caio Claudio riuscì a traversare
lo stretto, entrò di sorpresa, con l’aiuto dei mamertini, in Messina e prese prigioniero il
generale cartaginese Annone, mettendolo alla scelta: o la galera, o il ritiro con i suoi uomini
dalla città.
Annone doveva essere un uomo accomodante. Pochi mesi prima aveva rimandato
ad Appio Claudio certe triremi romane che una tempesta aveva fatto naufragare sulle coste
siciliane, come a dirgli: « Suvvia, non fate sciocchezze ». Ora, di fronte a quella minacciosa
alternativa, non esitò, e alla testa del suo piccolo esercito tornò a casa, dove, per
ricompensa, lo crocefissero. Cartagine evidentemente non era affatto disposta a inghiottire
quel rospo. E infatti subito mise in campo un altro Annone alla testa di un altro esercito.
Il nuovo generale sbarcò in Sicilia, e come prima cosa pensò di trovarvi un buon
accordo con i greci. S’intese subito con quelli di Agrigento e subito dopo, a Selinunte,
ricevette un’ambasciata di Gerone di Siracusa che accettava un’alleanza con lui. Era chiaro
che i greci preferivano il vecchio nemico a quello nuovo.
Appio Claudio, che contava sulla secolare discordia ellenico-fenicia, si trovò colto
di sorpresa col grosso del suo esercito ancora in Calabria. E allora ricorse all’astuzia. Fece
spargere la notizia che la nuova situazione l’obbligava a tornare a Roma per prendervi
ordini, e effettivamente mandò qualche nave a veleggiare verso nord. Rassicurati, i
cartaginesi rallentarono la sorveglianza sullo stretto. E Appio ne approfittò per sbarcare le
sue forze, ventimila uomini, un po’ a sud di Messina, in vista dell’accampamento
siracusano, cui diede l’assalto.
Gerone se la cavò abbastanza bene. Ma la comparsa improvvisa di quell’esercito
gli fece sospettare un tradimento da parte di Annone, che piantò in asso per tornarsene di
furia a Siracusa. Isolati così i cartaginesi, Appio gli si gettò subito contro, ma stavolta senza
riuscire nell’impresa.
Allora, lasciato un distaccamento a circondare Messina, pensò di correr dietro
all’altro nemico ritenendolo più debole. Ma Gerone era un buon capitano e inflisse ai
romani una dura sconfitta. Appio salvò la pelle per miracolo, e dovette rendersi conto che
l’impresa era meno facile di quanto pensassero a Roma. Per cui, lasciate parte delle sue
forze a guardia di Annone, tornò all’Urbe per riferire e chiedere rinforzi.
I rinforzi li diede soprattutto la diplomazia che riallacciò le relazioni con Gerone
riportandolo nel campo romano. Era un buon colpo. Ma dopo Siracusa, bisognava avere
anche Agrigento, e qui la diplomazia non poteva nulla perché ad Agrigento c’era una
guarnigione cartaginese. I romani vi posero l’assedio, dopo sette mesi costrinsero gli
occupanti a tentare una disperata sortita per fame, e li batterono.
Subito i cartaginesi misero in campo un secondo esercito e lo affidarono ad
Amilcare (che non ha nulla a che fare col suo omonimo, padre di Annibale). Questi
comprese che coi romani, per terra, non c’era niente da fare, e prese ad attaccare con la
flotta tutte le loro piazzeforti marittime, riportando una vittoria dopo l’altra.
Fu qui che si vide cos’era Roma. Essa non aveva né navi né marinai. In pochi
mesi, per sforzo concorde di tutti i cittadini, approntò centoventi unità. Amilcare, che ne
aveva centotrenta, mosse loro incontro senza nemmeno le solite misure di prudenza. E si
trovò di fronte ai “corvi”, degli strani arnesi che, issati sulla prora delle navi romane,
impedivano a quelle nemiche di manovrare. Perse un terzo delle sue forze, e fuggì.
A Cartagine, quando lo seppero, rimasero sconvolti, convinti com’erano di poter
dare, sul mare, lezioni a tutti. A Roma s’inorgoglirono, e decisero di portare, attraverso il
Mediterraneo, la guerra nel cuore del nemico. Alla prima flotta, un’altra ne fu aggiunta: in
tutto trecentotrenta vascelli con centocinquantamila uomini agli ordini del console Attilio
Regolo. Contro di essa, Cartagine ne mise in campo una di forze uguali, agli ordini di
Amilcare. Lo scontro avvenne al largo di Marsala. I romani pagarono la loro incerta vittoria
con ventiquattro navi; i cartaginesi la loro certa sconfitta con trenta. Ma Attilio Regolo poté
sbarcare in Africa, a Capo Bon.
Ora stava a Cartagine mostrare cos’era. E lo mostrò. Essa ebbe qualche
tentennamento ai primi successi dei romani che, con l’aiuto dei numidi in rivolta, erano
giunti a trenta chilometri dalla loro città. E mandarono un’ambasciata per chiedere pace.
Regolo impose di sua testa condizioni inaccettabili. E i cartaginesi allora si disposero al
duello mortale. Persa fiducia nei loro generali, affidarono il comando a un greco di Sparta,
che sarebbe come dire, oggi, a un tedesco di Prussia: Santippo. Costui riorganizzò con
mezzi spicciativi e “fucilazioni” sommarie l’esercito, apportandovi quei nuovi criteri
nell’impiego della cavalleria e degli elefanti che poi Annibale sfrutterà mirabilmente.
La battaglia decisiva fu combattuta presso Tunisi. Dell’esercito romano, solo
duemila uomini si salvarono rinchiudendosi a Capo Bon. Regolo fu fatto prigioniero. Era
l’anno 255 avanti Cristo.
A Roma ne occorsero cinque per riprendersi, materialmente e moralmente, da quel
disastro, che aveva ricondotto la guerra in Sicilia. In quel lustro, le vicende furono alterne,
ma in genere favorevoli ai cartaginesi. Finché un giorno il nuovo loro generale, Asdrubale,
nel tentativo di riprendere Palermo, fu battuto e lasciò ventimila uomini sul terreno.
Cartagine, stanca, e pensando che anche l’avversario lo fosse, tirò fuor di prigione Regolo e
lo mandò a Roma con i suoi ambasciatori per caldeggiarvi proposte di pace. Se fossero state
respinte, egli s’impegnava sulla sua parola a tornare. Il Senato lo invitò a esprimere il suo
parere davanti ai plenipotenziari nemici. Regolo sostenne che bisognava continuare la
guerra. E quando vide accolto il suo parere, riprese la via di Cartagine nonostante le
suppliche della moglie. Lo torturarono a morte impedendogli di dormire. I suoi figli a
Roma presero due prigionieri cartaginesi di alto rango, e li tennero svegli finché a loro volta
non morirono. Erano i costumi dei tempi.
La guerra fu ripresa, ma ora vi comparve, da parte cartaginese, un nuovo
protagonista: Amilcare Barca, il padre di Annibale, comandante supremo dell’esercito e
della flotta. Fu l’inventore di quelli che oggi si chiamano i commandos, e cominciò a
lanciarne, con effetti devastatori, persino sulle coste della penisola, dando l’impressione ai
romani di volervi sbarcare.
Il Senato, atterrito, non voleva rischiare una nuova flotta contro di lui. Le leve
militari erano stremate; le casse del Tesoro, vuote. Fu allora che i più ricchi cittadini
costruirono di tasca propria un’armata di duecento navi e la misero a disposizione del
console Lutazio Catulo, che bloccava i porti di Drepano e Lilibeo. I cartaginesi per conto
loro ne mandarono un’altra di quattrocento unità, stivate di rinforzi, armi e rifornimenti. Se
riuscivano a sbarcare, per i romani in Sicilia era la fine. Contro gli ordini del Senato, che gli
vietavano iniziative marittime, Catulo per quanto gravemente ferito, comandò alla sua
squadra di attaccare. Le navi cartaginesi, appesantite dal carico che recavano, non
riuscirono a manovrare, e centoventi furono affondate, mentre le altre riprendevano la rotta
di Cartagine. Amilcare era tagliato dalla madrepatria e dopo tanti successi non gli restava
che chiedere la resa.
Lutazio Catulo non volle ripetere l’esperienza di Regolo, e subito accolse la
proposta concedendo ad Amilcare l’onore delle armi e il ritiro con i suoi uomini, e
rimettendo alla competenza del Senato le altre condizioni.
Qualcuno, a Roma, rimproverò a Catulo tanta indulgenza, e propose di riprendere
le ostilità fino a quella che oggi si chiamerebbe la “resa incondizionata” del nemico. Ma le
“rese incondizionate” sono quasi sempre pretese balorde, e il Senato fece benissimo a
respingerne l’idea. Esso chiese ai cartaginesi l’abbandono della Sicilia, la restituzione senza
riscatto dei prigionieri e il pagamento di tremiladuecento talenti in dieci anni. Erano
condizioni ragionevoli, e Cartagine si affrettò ad accettarle.
Così, dopo quasi un quarto di secolo di lotta, finì la prima guerra punica, durata
dal 265 al 241 avanti Cristo.
Ma tutti sapevano, a Roma e a Cartagine, che quella pace era soltanto un
armistizio.
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
ANNIBALE
AMBEDUE i contendenti uscirono malconci da quel quarto di secolo di lotta, ma le
conseguenze per Cartagine furono più gravi che per Roma. Essa non solo dovette cedere
tutta la Sicilia, impegnarsi a una pesante riparazione, e accettare. la concorrenza del
commercio romano in tutto il Mediterraneo; ma cadde nell’anarchia per lo scatenarsi di
conflitti interni.
Il suo governo si rifiutò di pagare gli “arretrati” ai mercenari che avevano servito
sotto le bandiere di Amilcare. Costoro si rivoltarono sotto la guida di Matone, un
caporalaccio che la sapeva lunga, trovarono subito appoggio nei popoli soggetti e
specialmente nei libici che insorsero, formarono un esercito sotto il comando di Spendio,
ch’era uno schiavo napoletano. E tutti insieme posero assedio alla città.
I ricchi mercanti di Cartagine tremarono, e sollecitarono Amilcare a liberarli da
quella minaccia. Amilcare esitò, gli dispiaceva combattere i suoi vecchi soldati. Ma quando
costoro ebbero tagliato le mani e spezzato le gambe al suo collega Cesco e seppellito vivi
settecento cartaginesi, si risolse ad agire. Chiamò alle armi quanti giovani trovò dentro le
mura della città assediata, li sottopose a un duro e sintetico allenamento militare, attaccò
con diecimila uomini il nemico forte di quarantamila, ne ruppe l’accerchiamento, li incalzò
dentro un’angusta valle di cui tappò le due uscite; e si mise ad aspettare la loro morte per
fame.
Essi mangiarono prima ì cavalli, poi i prigionieri, poi gli schiavi. E alla fine,
disperati, mandarono Spendio a chieder pace. Amilcare, per tutta risposta, lo crocefisse. I
mercenari tentarono una sortita, e furono massacrati. Matone, fatto prigioniero, venne
ucciso a lente scudisciate. Fu, dice Polibio, la più sanguinosa ed empia guerra della storia.
Durò oltre tre anni. E quando finì, Cartagine seppe che Roma aveva occupato anche la
Sardegna. Protestò, e Roma, sapendo in che condizioni l’avversaria si trovava, rispose con
una dichiarazione di guerra. Per evitarla, Cartagine accettò la perdita della Sardegna, vi
aggiunse quella della Corsica, e si rassegnò a pagare altri milleduecento talenti. Cioè, per
evitare la guerra, accettò senzaltro la sconfitta. Ma stavolta non protestò.
Anche Roma in quel frattempo si stava leccando le ferite. L’esercito era povero di
uomini e la moneta era stata svalutata dell’ottantatre per cento. La politica unitaria
inaugurata nella penisola aveva dato, in complesso, buoni frutti perché nessuno dei popoli
sottomessi aveva approfittato delle disgrazie dell’Urbe per ribellarsi. Ma la frontiera del
nord non era sicura. I liguri, incapaci di fondare uno stato, erano però capacissimi di
cabotare con le loro barche lungo il Tirreno, impedendovi i traffici e saccheggiandone le
coste, specie quelle toscane. Nel nord Adriatico gl’illiri, acquattati fra le scogliere della
Dalmazia, facevano altrettanto. E da Bologna alle Alpi, in tutta la piana del Po, i galli si stavano rinforzando per il sopraggiungere di loro confratelli dalla Francia che, non
conoscendo ancora i romani, non li temevano. A lasciarli crescere, c’era il rischio di vedersi
ruzzolare un’altra volta addosso, com’era già accaduto con Brenno.
Rastrellata dai resti cartaginesi la Sicilia e occupatala con guarnigioni e “colonie”,
meno il regno di Siracusa che fu lasciato al fedele Gerone, i romani la proclamarono
“provincia”. Essa fu la prima delle molte che più tardi formarono l’impero. La seconda
consiste nella Sardegna e la Corsica riunite. Poi, instaurato così un certo ordine
amministrativo, l’Urbe decise di estenderlo oltre l’Appennino toscano che costituiva il suo
confine settentrionale.
Cominciò coi liguri, ch’erano i più.isolati e i meno pericolosi. E forse non si trattò
nemmeno di una vera e propria guerra, ma di una serie di operazioni “anfibie”,” cioè
condotte contemporaneamente per terra e per mare. Esse durarono cinque anni, dal 238 al
233, e non ebbero bisogno dei soliti eroici episodi. Quando finirono, i liguri eran diventati
vassalli e non avevano più neanche una barca con cui disturbare i traffici con la Sardegna e
la Corsica.
Poi fu la volta dei galli, che in realtà avevano già preso l’iniziativa, organizzando
con l’aiuto francese un esercito di cinquantamila fanti e ventimila cavalieri. Ai romani
erano sempre andati poco a garbo quei soldatacci che Polibio ci descrive: alti e belli,
sempre smaniosi di guerre che combattevano nudi, salvo qualche collana e amuleto. Il
Senato fu così atterrito di questo nuovo attacco che, tornando a un costume ormai in disuso,
decise d’ingraziarsi gli dèi con un sacrificio umano seppellendo vive due vittime. Ma le
scelse fra i galli. Comunque, si vede che gli dèi ne furono ugualmente contenti, perché a
Talamone le legioni riuscirono a circondare il nemico e praticamente lo distrussero una
volta per sempre. Quarantamila galli rimasero sul terreno, e diecimila furono fatti
prigionieri. Tutta l’Italia, fino alle Alpi, era alla mercé di Roma. Essa chiamò Gallia
Cisalpina questa nuova ricchissima provincia, che fu la terza, ne occupò la capitale,
Mediolanum, e vi fondò due forti colonie: Cremona e Piacenza.
Poi si volse verso est, e in pochi anni, con spedizioni simili a quelle che aveva
organizzato contro i liguri, ridusse a popolo tributario l’Illiria della regina Teuta. E con ciò
mise per la prima volta il piede sull’altra sponda dell’Adriatico, facendone il suo
trampolino di lancio per le successive conquiste in Oriente.
Mentre Roma completava così la conquista della penisola e si metteva al sicuro a
est e a nord, a Cartagine Amilcare faceva fuoco e fiamme per preparare la rivincita. Subito
dopo aver domato la rivolta, egli aveva supplicato il suo governo di dargli un esercito per
ristabilire lo scosso prestigio fenicio di Spagna e costituirvi una base di operazioni contro
l’Italia. Ebbe dalla sua le classi medie, che volevano riconquistare sul Mediterraneo un
monopolio commerciale da cui dipendeva la loro sorte, e contraria l’aristocrazia terriera,
che non voleva più rischiare di perdere i suoi privilegi in pericolose avventure.
Alla fine si scese a un compromesso: invece di un corpo d’armata fu data ad
Amilcare solo una divisione. Ma gli bastò. Amilcare era veramente un grande generale, e
non per nulla gli avevano dato quel soprannome di “Barca”, che in lingua fenicia
significava “folgore”. Prima di partire alla testa di quei pochi uomini, condusse in chiesa i
suoi “leoncelli”, com’egli chiamava suo genero Asdrubale e i suoi tre figli: Annibale,
Asdrubale e Magone. E li fece giurare loro, dinanzi all’altare di Baal-Haman, che un giorno
essi avrebbero vendicato Cartagine. Dopodiché li imbarcò con la truppa e se li portò al
seguito.
In pochi mesi egli ridusse all’obbedienza le città spagnole che si erano ribellate, e
si mise a reclutare indigeni per costituire un esercito vero e proprio. La madrepatria non
mosse un dito per aiutarlo, ma Amilcare fece tutto da solo. Scavò miniere, ne estrasse il
ferro, lo lavorò per ricavarne le armi; e monopolizzò il commercio per finanziarsi.
Purtroppo la morte lo sorprese ancora giovane, durante un combattimento contro una tribù
ribelle. Spirando, raccomandò come successore il genero Asdrubale, che tenne il comando
per otto anni senza far rimpiangere il suocero, e costruì di sana pianta una città nuova,
quella che oggi si chiama Cartagena, nel distretto minerario. Quando a sua volta egli morì,
sotto il pugnale di un assassino, i soldati acclamarono generale in campo Annibale, il
maggiore dei tre figli di Amilcare. Egli aveva ventisei anni in quel momento; e già ne aveva
trascorsi diciassette sotto la tenda, coi soldati. Ma ricordava benissimo il giuramento che
suo padre gli aveva fatto fare.
Annibale fu, se non il più grande in senso assoluto, certo il più brillante
condottiero dell’antichità. Molti lo pongono sullo stesso piano di Napoleone. Prima che suo
padre lo conducesse in Spagna, aveva ricevuto una perfetta educazione. Perfetta per quei
tempi, si capisce. Sapeva la storia, le lingue (il greco e il latino), e dai racconti di Amilcare
si era fatta un’idea abbastanza chiara di Roma, della sua forza, e delle sue debolezze. Era
convinto, per esempio, che una sconfitta in Italia avrebbe tolto all’Urbe i suoi alleati, perché
questo era avvenuto ai tempi di suo padre. Egli ignorava del tutto che la politica romana
non era più federalistica. Era robusto, frugale, e di una furberia e di un coraggio senza
limiti. Tito Livio racconta ch’era sempre il primo ad entrare in battaglia e l’ultimo a
uscirne. Ma forse aveva una fiducia eccessiva nelle proprie capacità d’improvvisazione. Gli
storici romani, Livio compreso, hanno molto insistito sulla sua avarizia, crudeltà e assenza
di scrupoli. Ed effettivamente i tranelli che tese ai romani furono infiniti e diabolici. Ma
anche per questo i soldati lo adoravano e credevano ciecamente in lui. Egli non aveva
bisogno di galloni per affermare il suo prestigio. Vestiva infatti come loro e ne divideva
tutti i disagi. Oltre che un maestro di strategia, si dimostrò un eccellente diplomatico e un
campione dello spionaggio.
Ignoto com’era ai suoi compatrioti, fra i quali non era più tornato dall’età di nove
anni, Annibale non poteva certamente sperare in un loro consenso all’apertura delle ostilità.
La guerra, quindi, invece di dichiararla, bisognava farsela dichiarare. E per questo, nel 218,
assalì Sagunto.
Sagunto era una città alleata di Roma, che però già al tempo di Asdrubale si era
impegnata a riconoscere come zona d’influenza cartaginese tutta quella a sud dell’Ebro. E
siccome la città si trovava appunto in quella zona, Annibale poté facilmente respingere la
protesta che in termini ultimativi gli giunse da Roma, convinta che Cartagine fosse ancora
quella, impaurita e a soqquadro, delle rivolte mercenarie. Così cominciò, con molta abilità
da una parte e molta leggerezza dall’altra, quella seconda campagna.
Annibale rimase ancora otto mesi intorno alle mura di Sagunto, prima di
espugnarla. Non si fidava di lasciarsi alle spalle quell’eccellente porto aperto alla flotta
romana. Poi, lasciato sul posto il fratello Asdrubale con l’ordine di vigilare e preparare i
rincalzi, attraversò l’Ebro con trenta elefanti, cinquantamila fanti e novemila cavalieri.
Erano quasi tutti spagnoli e libici, e non c’era fra loro nessun mercenario.
Le difficoltà cominciarono subito al di là dei Pirenei. Le tribù galliche alleate di
Marsiglia, che a sua volta era alleata di Roma, gli opposero resistenza infischiandosi della
sorte che Roma aveva riservato alle loro consorelle padane. E tremila dei suoi uomini si
rifiutarono di seguire Annibale, quando seppero che voleva attraversare le Alpi. Il Barca
non li forzò. Anzi ne liberò, dai loro impegni altri settemila che si mostravano titubanti e li
rimandò a casa. Così alleggerito dalla truppa pavida e irresoluta, puntò a nord su Vienne, e
iniziò la scalata.
Non si sa con precisione dove passò. C’è chi dice per il San Bernardo, c’è chi dice
per il Monginevro. I più propendono per il Monginevro. Comunque, ai primi di settembre
del 218 giunse in vetta, la trovò coperta di neve e concesse ai suoi uomini due giorni di
riposo. Ne aveva già persi qualche migliaio, vinti dal freddo e dalla fatica, dai precipizi e
dai guerriglieri celtici. Poi, dopo quella sosta, iniziò la discesa, che fu ancora più difficile,
specie per gli elefanti. Ci furono, nell’animo di quei temerari, ore di crisi e di disperazione.
Annibale le superò additando loro, laggiù in lontananza, la bella pianura padana, e
promettendogliela come preda. Quelli che arrivarono in fondo agli scapicolli erano in tutto
ventiseimila uomini, meno della metà di quelli ch’erano partiti. In compenso i boi e gli altri
galli li accolsero amichevolmente, li rifornirono di viveri e si allearono a loro, massacrando
e mettendo in fuga i romani di Cremona e di Piacenza.
Sbigottito da tanta audacia, il Senato si rese subito conto che quella seconda guerra
si annunziava molto più pericolosa della prima. Chiamò alle armi trecentomila uomini e
quattordicimila cavalli, e ne affidò una parte al primo dei molti Scipioni che dovevano
rendere celebre il nome della famiglia. Costui affrontò Annibale al Ticino, si lasciò
sfondare lo schieramento dalla cavalleria numida, e perse la battaglia. Ci sarebbe anche
morto se, gravemente ferito com’era, non fosse stato salvato da suo figlio che, sedici anni
dopo doveva vendicare il padre a Zama. Era l’ottobre del 218 avanti Cristo.
Trascorsero due mesi, e un altro esercito fu mandato ad affrontare Annibale sulla
Trebbia. Seconda battaglia, e seconda sconfitta. Ne trascorsero altri otto, e incontro al
Barca, orinai padrone di tutta la Gallia Cisalpina, mosse Caio Flaminio, alla testa di
trentamila uomini. Era così sicuro di vincere che si era portato dietro un carico di catene per
metterle ai piedi dei prigionieri. Annibale parve voler evitare la battaglia campale. In realtà,
con un sapiente di giuoco di pattuglie e di scaramucce, attrasse il nemico in una piana sulle
rive del Trasimeno circondata dì colline e di boschi dove aveva nascosto le sue cavallerie.
E. dentro di esse lo avviluppò inestricabilmente. Dei romani non rimase vivo quasi nessuno,
nemmeno Flaminio.
Tito Livio racconta che la notizia gettò Roma nel panico. Ma il Senato affrontò la
situazione con virile fermezza. Il pretore Marco Pomponio non cercò di sdrammatizzarla
leggendo, dai Rostri, il comunicato che annunziava la disfatta. « Siamo stati vinti in una
grande battaglia », disse. « Il pericolo è grave ».
Ma nemmeno per Annibale erano tutte rose. Via via che si avvicinava a Roma, si
accorgeva che la speranza di dividerla dai suoi alleati era infondata. In Toscana e in Umbria
le città si chiusero dinanzi al suo esercito, che non sapeva come rifornirsi. Invano egli
rimandò liberi a casa i prigionieri non romani. Dall’Appennino al Sannio l’Italia faceva
blocco con l’Urbe. E ad Annibale non restò che deviare verso l’Adriatico in cerca di terre
più ospitali. 1 suoi soldati, dopo tre battaglie consecutive, erano stanchi, ed egli stesso
soffriva di un acuto tracoma. Gli alleati galli, che non vedevano più in là del loro naso, ora
ch’egli si allontanava dalle loro regioni, cominciarono a disertare. Annibale mandò messi a
Cartagine per chiedere rinforzi: glieli rifiutarono. Ne mandò a Asdrubale: ma questi era
inchiodato in Spagna dai romani, che frattanto vi erano sbarcati. Riprese la sua marcia
verso sud, ma si trovò di fronte a un nuovo e imbarazzante stratega.
Quinto Fabio Massimo era stato nominato “dittatore” e aveva inaugurato quella
“magistrale inazione” per cui passò alla storia col nome di “Temporeggiatore”. Ingaggiava
scaramucce, tendeva imboscate, ma in battaglia non si lasciava attirare. Aspettava che le
difficoltà, la fame, la stanchezza compissero la loro opera tra i soldati del nemico, che
infatti era alla disperazione. Purtroppo prima di loro sì stancarono i romani, che volevano
una vittoria e subito, e porsero compiacenti orecchie alle malignità di Minucio Rufo,
luogotenente e detrattore di Fabio. Costui venne spodestato e il suo comando diviso fra due
consoli di fresca nomina: Terenzio Varrone e Emilio Paolo. Questi era un aristocratico di
gran giudizio, perfettamente conscio che contro la strategia annibalica quella romana non
aveva ancora elaborato criteri adeguati. Varrone era un plebeo, migliore come patriota che
come generale, e voleva quel che volevano i suoi elettori: un rapido successo. Parlando in
nome dell’orgoglio e del nazionalismo, ebbe, come al solito, ragione. E condusse i suoi
ottantamila fanti e seimila cavalieri contro Annibale che, pur avendo soltanto ventimila
veterani, quindicimila infidi galli e diecimila cavalieri, trasse un respiro di sollievo. Egli
temeva soltanto Fabio Massimo.
La battaglia, che fu la più gigantesca dell’antichità, ebbe luogo a Canne
sull’Ofanto. Il Barca come al solito attrasse il nemico in un terreno pianeggiante, adatto al
giuoco della cavalleria. Poi si schierò mettendo al centro i galli, sicuro che avrebbero
tagliato la corda. Così fecero infatti. Nel buco, Varrone si buttò dentro, e le ali di Annibale
gli si richiusero sopra. Paolo Emilio, che non aveva voluto lo scontro, combatté
valorosamente e cadde con altri quarantamila romani, fra cui ottanta senatori. Varrone
riuscì a salvarsi in compagnia dello Scipione che già se l’era cavata sul Ticino, scampò a
Chiusi, e di li rientrò a Roma.
Il popolo in lutto lo attendeva alle porte della città. Quando lo videro apparire, gli
andarono tutti incontro, coi magistrati alla testa, e lo ringraziarono per non aver dubitato
della patria. Così rispose l’Urbe alla catastrofe.
CAPITOLO QUINDICESIMO
SCIPIONE
STANDO ai competenti, Canne rimane, nella storia della strategia, un esempio mai
più superato. Annibale, l’unico capitano che sia stato capace di battere i romani per quattro
volte consecutive, vi perse solo seimila uomini, di cui quattromila erano galli. Ma vi perse
anche il segreto del suo successo, che finalmente il nemico capì: la superiorità della sua
cavalleria.
Sul momento, parve che l’invasore avesse partita vinta: i sanniti, gli abruzzesi, i
lucani si sollevarono; a Crotone, a Locri, a Capua, a Metaponto la popolazione massacrò le
guarnigioni romane, Filippo V di Macedonia si alleò col Barca; Cartagine, ringalluzzita,
annunziò l’invio di rinforzi; e alcuni giovani patrizi romani già corrotti dalla cultura
ellenica pensarono di fuggire in Grecia, loro patria ideale.
Ma questi ultimi furono casi isolati. Il giovane Scipione, reduce dalle due disfatte
del Ticino e di Canne, li denunziò con parole di fuoco. Il popolo accettò nuovi tributi e
nuove leve, le nobili matrone portarono i loro gioielli al Tesoro e andarono a spazzare coi
loro capelli il pavimento dei templi, il governo ordinò un nuovo sacrificio umano, non più
di due, ma di quattro vittime e seppellì vivi due greci e due galli. I soldati rifiutarono la
cinquina. E dalle case partirono volontari di tredici e di quattordici anni per ingrossare la
gracile guarnigione, che si preparava a difendere Roma nell’ultima battaglia contro
Annibale.
Ma Annibale non spuntò, e ancora oggi ci si domanda per quali ragioni non volle
osare. Come Hitler dopo Dunkerque, questo gran soldato che pure in battaglia aveva tanto
coraggio non trovò quello di affrontare l’ultimo ostacolo, sebbene lo sapesse quasi
sprovvisto di difesa. S’illuse di ricevere rinforzi, in tempo per la grande impresa? Sperò che
il nemico chiedesse la pace? Oppure Roma, sebbene l’avesse per quattro volte battuta,
gl’incuteva ancora un reverenziale rispetto? Comunque, invece di sfruttare l’enorme
successo di Canne, egli decise di riposarsi. Rimandò a casa i prigionieri non romani, e
quelli romani offri all’Urbe di restituirli dietro un piccolo indennizzo. Il Senato
orgogliosamente rifiutò. Annibale, mandatine a Cartagine un certo numero come schiavi,
adibì gli altri a giuochi gladiatori per il divertimento dei suoi soldati. Poi si avvicinò a pochi
chilometri da Roma facendola tremare, ma sfilò ad est, su Capua.
I romani per il momento non gli corsero dietro. Stavano penosamente
organizzando un nuovo esercito di duecentomila uomini. Quando fu pronto, ne diedero una
parte al console Claudio Marcello perché rimettesse ordine nella Sicilia che si era ribellata;
una parte la tennero a difesa della città; un’altra la spedirono in Spagna sotto la guida dei
due più anziani Scipioni per inchiodarvi Asdrubale.
L’anno seguente Claudio Marcello aveva conquistato Siracusa che, dopo la morte
del fedele Gerone, aveva tradito l’alleanza, e tentato di resistere con gli accorgimenti di
Archimede, il più grande matematico e tecnico dell’antichità. Costui aveva escogitato fra
l’altro le “mani di ferro” che, dalle confuse e stupefatte descrizioni lasciateci dagli storici,
dovevano essere delle gru che sollevavano le navi romane, e gli “specchi ustori” che le
incendiavano concentrando su di esse i raggi solari. Forse furono soltanto delle brillanti
idee che in pratica poi rimasero sulla carta. Tanto è vero che la città cadde ugualmente, e
nel macello che seguì lo stesso Archimede perse la vita.
A questo successo che rialzò il prestigio di Roma nel Sud, si aggiunsero quelli dei
due Scipioní che batterono a più riprese Asdrubale in Spagna, e la riconquista di Capua che
cadde nel 211, in un momento che Annibale se n’era allontanato nella speranza d’ingannare
i romani fingendo di marciare contro l’Urbe. Il castigo della città infedele fu esemplare:
tutti i capi vennero uccisi, e la popolazione deportata in massa. In tutta Italia si sparse il
terrore e la fede nel “liberatore” Annibale vacillò.
Ed ecco proprio in questo momento sorgere il gran condottiero che doveva
vendicare tutte le umiliazioni di Roma. I due Scipioni, che guerreggiavano contro
Asdrubale, sebbene vittoriosi, caddero in combattimento. A sostituirli fu mandato, appena
ventiquattrenne, il loro rispettivo figlio e nipote, Publio Cornelio, il reduce del Ticino e di
Canne. Egli non aveva ancora raggiunto i limiti di età per un si alto comando, ma il Senato
e l’Assemblea furono d’accordo nel derogare alla legge in un frangente così grave. Publio
Cornelio Scipione era stato un valoroso soldato e un eccellente comandante di falange e di
coorte. Rientrato con Varrone a Roma nel momento più tragico, quello che seguì alla
disfatta di Canne, vi era stato l’animatore della resistenza. Era bello. Era eloquente. Portava
un grande nome. Godeva fama di pio, cortese e giusto. Non intraprendeva nulla, né di
pubblico né di privato, senza prima chiedere il parere degli dèi, raccogliendosi a pregare nel
tempio. E per di più era riuscito a farsi considerare dai suoi compatrioti fortunato, cioè
“raccomandatissimo” dal cielo.
Infatti, appena arrivato in Spagna, dove trovò l’esercito impegnato ad assediare
Cartagena, diede subito una prova dei particolari favori che lo assistevano. Si trattava, per
espugnare la città, di attraversare uno stagno che comunicava col mare, e la profondità
dell’acqua era tale che bisognava farlo nuotando; operazione impossibile per uomini
appesantiti dalla corazza, dall’elmo e dalle armi. Una bella mattina Publio Cornelio
convoca i suoi soldati e racconta loro che Nettuno, apparsogli in sogno, gli ha promesso di
dargli aiuto facendo abbassare il livello dello stagno. I soldati ci credono e non ci credono.
Ma quando a un certo punto vedono il loro generale buttarcisi dentro e attraversarlo di
corsa, urlano al miracolo, gli si lanciano dietro e, per mostrarsi degni più del dio che di lui,
conquistano di slancio l’obbiettivo.
In realtà, di miracoloso non c’era nulla. Publio Comelio aveva semplicemente
appreso, parlando con i pescatori di Tarragona, il giuoco dell’alta e della bassa marea che i
suoi veterani, tutti contadini, ignoravano. Ma le energie e gli entusiasmi di una truppa
raddoppiano, quando è convinta di seguire un generale che ha in tasca Nettuno. Già si
mormorava, di Publio Cornelio, che il suo vero padre non era stato affatto Scipione, ma un
mostruoso serpente in cui si era metamorfosato Giove in persona, o meglio, lo aveva
mormorato egli stesso. A quei tempi, pur di vincere, i romani erano pronti a fare una cattiva
reputazione anche alle loro mamme. Comunque, stavolta il giuoco riuscì.
Quasi tutta la Spagna cadde, per quel colpo, nelle mani di Roma. Ma Asdrubale,
che non aveva più nessuna ragione di restarci, riuscì a sfuggire e col suo esercito si gettò
sulle orme del fratello, per raggiungerlo attraverso la Francia e le Alpi. Bene o male, riuscì
anche lui a superarle. Ma un suo messaggio ad Annibale, in cui annunciava che stava
arrivando e da che parte sarebbe passato, cadde in mano dei romani che così vennero a
conoscere tutto il suo piano di operazioni. Due nuovi eserciti furono allestiti in fretta.
L’uno, comandato da Claudio Nerone, provvide a immobilizzare in Apulia Annibale, che
non si mosse perché era all’oscuro di tutto. L’altro, agli ordini di Livio Salinatore, aspettò
Asdrubale nel punto più favorevole, sul Metauro presso Senigallia, e lo sterminò. Si
racconta che la testa del generale, caduto sul campo, fu spiccata dal corpo, portata in
Abruzzo e lanciata oltre le mura del vallo dietro il quale, con i suoi, si riparava Annibale.
Costui aveva già perso un occhio per il tracoma. Ma quello che gli restava gli bastò per
riconoscere i miseri resti del fratello che aveva amato come un figliolo.
Il cartaginese si sentiva ormai un uomo finito. Filippo di Macedonia, dopo una
platonica dichiarazione di guerra, si era lasciato riconquistare dalla diplomazia di Roma e
aveva fatto pace. I ribelli italiani, impauriti dall’esempio di Capua, mostravano simpatie per
il Barca, ma non lo aiutavano. Delle cento navi cariche di rinforzi che Cartagine aveva
mandato, ottanta erano colate a picco sulle coste della Sardegna. E gli “ozi di Capua”, che
da allora in poi diventarono proverbiali, avevano afflosciato il morale e il fisico del
baldanzoso esercito di Canne. «Gli dèi », aveva detto un luogotenente ad Annibale, quando
costui si era rifiutato di marciare contro Roma, « non danno tutti i loro doni a un uomo solo.
Tu sai procurarti le vittorie, ma non sai come usarle ». Forse c’era del vero, in questo
giudizio.
Nel 204 Scipione, reduce dai trionfi spagnoli, fu messo alla testa di un nuovo e più
potente esercito che, imbarcato sulla flotta, veleggiò verso le coste africane. La guerra, da
offensiva, diventava difensiva per Cartagine che, impaurita, richiamò in fretta e furia il suo
Annibale per difenderla. Ma quello che tornò, dopo trentasei anni di assenza, mezzo cieco e
logorato dalle fatiche e dai disinganni, era, sì, ancora un gran capitano, ma non più il
ventottenne demonio che aveva preso l’avvio da Cartagena. La metà delle sue truppe si
rifiutò di seguirlo laggiù. Gli storici romani dicono ch’egli uccise, per disobbedienza,
ventimila uomini. Con gli altri, nel 202 sbarcò, riconobbe a stento la sua città, da cui era
partito novenne appena; e venne a schierarsi, con i suoi rimanenti veterani, nella pianura di
Zama, una cinquantina di miglia a sud di Cartagine.
I due eserciti, come forze, press’a poco si equivalevano. E stettero a guardarsi per
molti mesi, rinforzando ognuno le proprie posizioni. Poi quello romano trovò un aiuto
insperato. Massinissa, re di Numidia, spodestato dal rivale Siface, ch’era amico e protetto
dei cartaginesi, venne con la sua cavalleria ad allinearsi accanto a Scipione.
E proprio nella cavalleria Annibale riponeva, come sempre, le sue speranze.
Forse fu per questo che, prima dello scontro, egli volle tentare la carta di un
amichevole accomodamento. Chiese un colloquio con l’avversario, che glielo concesse. I
due grandi generali finalmente s’incontravano a tu per tu. La conversazione fu breve e, a
quanto pare, estremamente cortese. I due interlocutori constatarono l’impossibilità di un
accordo, ma, dal seguito degli avvenimenti, si direbbe che abbiano provato l’uno per l’altro
una viva simpatia (quanto alla stima, non poteva mancare). Si lasciarono senza rancore, e
subito dopo scesero in combattimento.
Per la prima volta nella sua vita, Annibale, invece d’imporre, dovette subire
l’iniziativa dell’avversario che, per batterlo, usò la stessa tattica a tenaglia. Il
quarantacinquenne Barca ritrovò, nel disastro, l’energia dei suoi vent’anni. Assali Scipione
in duello individuale, e lo feri. Attaccò Massinissa. Formò e riformò cinque, sei, dieci volte
le sue falangi sconvolte, per trascinarle al contrattacco. Ma non ci fu nulla da fare. Ventimila dei suoi uomini giacevano sul terreno. E a lui non rimase che salire su un cavallo e
galoppare verso Cartagine. Vi giunse coperto di sangue, riunì il Senato, annunziò che aveva
perso non una battaglia, ma la guerra, e consigliò di mandare un’ambasceria per chiedere
pace. Così fu fatto.
Scipione si mostrò generoso. Volle la consegna di tutta la flotta cartaginese, meno
dieci trireme, la rinunzia a ogni conquista in Europa, il riconoscimento di Massinissa in una
Numidia indipendente, e un’indennità di diecimila talenti. Ma lasciò a Cartagine i suoi
possedimenti tunisini e algerini, pur vietandole di aggiungervene altri e rinunziò alla
consegna di Annibale, che il popolo di Roma avrebbe voluto veder aggiogato dietro il carro
dei vincitore il giorno del trionfo.
A tanta cavalleria da parte dell’ex nemico, non ne corrispose punta, per Annibale,
da parte dei compatrioti. Il trattato di pace non era ancora ratificato, che alcuni cartaginesi
già informavano segretamente Roma che Annibale pensava alla rivincita e si era dato anima
e corpo ad organizzarla. In realtà egli cercava soltanto di rimettere ordine nella sua patria e,
alla testa del partito popolare, tentava di distruggere i privilegi della corrotta oligarchia
senatoriale e mercantile, ch’era la vera responsabile della disfatta.
Scipione usò tutta la sua influenza per dissuadere i compatrioti dal chiedere la testa
del suo grande nemico. Ma invano. Per sfuggire all’arresto e alla consegna, Annibale fuggì
di notte a cavallo, galoppò per oltre duecento chilometri fino a Tapso, e di lì s’imbarcò per
Antiochia. Il re Antioco esitava in quel momento fra la pace e la guerra con Roma.
Annibale gli consigliò la guerra e diventò uno dei suoi esperti militari. Ma, nonostante la
sua perizia, Antioco fu disfatto a Magnesia, e i romani, fra le altre condizioni, imposero la
consegna del Barca. Questi tornò a fuggire: prima a Creta, poi in Bitinia. I romani non gli
diedero tregua e alla fine circondarono il suo nascondiglio. Il vecchio generale preferì la
morte alla cattura. Livio racconta che, portando alla bocca il veleno, disse ironicamente:
«Ridiamo la tranquillità ai romani, visto che non hanno la pazienza di aspettare la fine di un
vecchio come me ». Aveva sessantasette anni. Pochi mesi dopo, il suo vincitore e
ammiratore Cornelio lo seguì nella tomba.
Fu questa seconda guerra punica a decidere per secoli e secoli le sorti del
Mediterraneo e dell’Europa occidentale, perché la terza non ne fu che un poscritto del tutto
superfluo. Essa diede a Roma la Spagna, il Nord Africa, il dominio sul mare e la ricchezza.
Ma da questi guadagni prese anche l’avvio una trasformazione della vita romana
che non doveva rivelarsi benefica per le sorti dell’Urbe. In tutto erano rimasti sul campo
trecentomila uomini, che costituivano il fior fiore dell’agricoltura e dell’esercito.
Quattrocento città erano andate distrutte. La metà delle fattorie saccheggiate, specie
nell’Italia del Sud, che appunto da allora non si è mai più completamente ripresa.
I romani di duecent’anni prima avrebbero posto riparo in pochi decenni a questi
malanni. Ma i successori non erano più della loro tempra. Quello che li tentava ora non era
più il lavoro in campagna, ma il commercio internazionale. La ricchezza, invece di faticarla
con pazienza e tenacia, con una vita frugale e sparagnina, era più comodo andarsela a
cercare bell’e fatta in Spagna, per esempio, dove bastava grattare la terra per trovare il ferro
e l’oro. Le spogliazioni dei popoli vinti avevano riempito le casse del Tesoro. I tributi che
pagavano gli stati soggetti, a suon di miliardi, anno per anno, praticamente facevano di ogni
romano un rentier e lo svogliavano dal lavoro.
Questo boom economico, come lo avrebbero chiamato gli americani, sconvolse la
società, rendendo inadeguata l’impalcatura su cui si era retta sino ad allora. Si cominciò a
formare una nuova borghesia di trafficanti e di appaltatori. I costumi si addolcirono e
ammollirono. Sorse quella che oggi si chiamerebbe una social life con salotti intellettuali e
progressisti. La fede negli dèi s’indebolì come quella nella democrazia, che nei momenti di
pericolo aveva dovuto, per salvare la patria, ricorrere ai dittatori e ai “pieni poteri”.
La crisi non precipitò subito. Ma è in questi anni, seguiti alla catastrofe di
Cartagine, che se ne creano le premesse.
CAPITOLO SEDICESIMO
“GRAECIA CAPTA ... “
UNO dei primi carichi di bottino che, quando si decise a muoverle guerra, Roma
rìportò dalla Grecia, fu un gruppo di circa mille intellettuali, che si erano distinti nella
resistenza all’Urbe. Fra essi c’era un certo Polibio, che aveva la passione della storia e
insegnò ai romani come la si scrive. “Con quali sistemi polititici”, egli si chiese arrivando,
“questa città è riuscita in meno di cinquantatre anni a soggiogare il mondo: impresa che
sinora non era mai riuscita a nessuno?”
In realtà Roma aveva impiegato molto più di cinquantatre anni. Ma per il greco
Polibio, il “mondo” era soltanto la Grecia, la cui conquista effettivamente non aveva
richiesto più di mezzo secolo. Senonché non erano affatto state le diavolerie politiche del
Senato e dei generali romani a rendere così facile questo successo, ma il fatto che la Grecia,
prima di essere conquistata, aveva già distrutto se stessa. La sua disintegrazione era
avvenuta dal di dentro. Roma si limitò a raccoglierne i frutti.
I primi rapporti che l’Urbe aveva avuto con la Grecia risalivano infatti al tempo di
Pirro, che prese l’iniziativa di annodarli, sbarcando in Italia nel 281 con i suoi soldati e i
suoi elefanti per difendere Taranto e le altre città greche della penisola dall’aggressione
romana. Ma in quel momento la Grecia, come nazione, aveva già cessato di esistere; o
meglio, aveva abbandonato ogni speranza di diventarlo. Le varie città di cui era composta
passavano il tempo a combattersi tra loro, e non ce n’era più una che fosse capace di tenere
unite le altre nella difesa dei comuni interessi.
L’ultimo tentativo di creare una nazione greca era venuto dal di fuori, cioè dalla
Macedonia, una terra che i greci di Atene, di Corinto, di Tebe eccetera, consideravano
barbara e forestiera. In realtà, di greco essa aveva poco. Le impervie catene di monti che la
chiudevano a sud avevano sbarrato il passo alla cultura e ai costumi, cioè alla civiltà delle
metropoli della costa, che del resto era una civiltà troppo cittadina e mercantile per potersi
acclimatare in quella severa e rozza contrada di chiuse valli, di sparse greggi, di villaggi
arcaici e solitari. In compenso, la popolazione sì era serbata sana, rude e forte. Essa non
sapeva di grammatica e filosofia, credeva ai suoi dèi e obbediva ai suoi padroni.
Costoro formavano un’aristocrazia di grossi proprietari fondiari, la cui sola
occupazione era l’amministrazione delle terre e i cui soli svaghi erano i tornei e la caccia. A
Pella, la capitale, ci andavano di rado e malvolentieri: non solo perché il viaggio era
faticoso, ma anche perché in quel borgo campestre e senz’attrazioni c’era il re, dal quale
volevano restare il più possibile indipendenti. Soltanto Filippo e suo figlio Alessandro
riuscirono a disarmare le loro diffidenze e a unirli in una grande avventura di conquista.
Ognuno di essi portò nell’esercito comune il proprio contingente di forze, delle quali fu il
generale; e tutti insieme, sotto il comando unico prima del babbo e poi del figliolo,
occuparono la Grecia, vi misero ordine, e cercarono di coordinarne le forze con quelle
macedoni per la conquista del mondo.
Fu soltanto una meravigliosa avventura, che non sopravvisse ai suoi due
protagonisti. Quando nel 323, a soli trentatré anni, Alessandro morì in Babilonia, dopo aver
condotto il suo esercito di vittoria in vittoria fino in Egitto e in India attraverso Asia
Minore, Mesopotamia e Persia, il suo effimero impero cadde in pezzi. Ai suoi generali che,
riuniti intorno al capezzale, gli chiedevano chi designasse come erede, rispose: «Il più forte», ma si dimenticò di precisare chi fosse costui, o forse non lo sapeva. Per cui essi si
divisero l’eredità in cinque parti: Antipatro ebbe la Macedonia e la Grecia, Lisimaco la
Tracia, Antigono l’Asia Minore, Seleuco Babilonia e Tolomeo l’Egitto. E subito,
naturalmente, presero a farsi guerra tra loro.
Lasciamo questi “diadochi” come vennero chiamati i cinque successori, alle loro
dispute, che poi tornarono tutte a definitivo vantaggio di Roma. E limitiamoci a quelle che
subito scoppiarono nell’interno del reame di Antipatro, che doveva tenere unite la
Macedonia e la Grecia. Se questa unione si fosse fatta, Roma avrebbe trovato da rodere un
osso molto più duro. Ma i greci non la volevano e fecero di tutto per sabotarla. Quando
Alessandro morì, racconta Plutarco, il popolo ateniese, che non ne aveva ricevuto che
benefici, si compose in cortei per le strade cantando inni di vittoria “come se fossero stati
loro ad abbattere il tiranno”. Demostene, ch’era stato il campione della “resistenza” una
resistenza soltanto di parole, ebbe il suo momento di gloria e incitò i concittadini a
organizzare un esercito per resistere ad Antipatro. L’esercito fu organizzato e naturalmente
sconfitto dal nuovo re macedone. Il quale, ignorante com’era, non aveva le debolezze di
Alessandro per la civilissima Atene, e la trattò com’era abituato a trattare i suoi soldati
quando questi disobbedivano.
Quando anche Antipatro morì lasciando il trono a suo figlio Cassandro, Atene si
ribellò di nuovo. E di nuovo fu sconfitta e castigata. Per decenni si andò avanti a furia di
rivolte e di repressioni. Poi Demetrio Poliorcete (che vuol dire “conquistatore di città”)
figlio di Antigono, venne dall’Asia Minore a scacciare i macedoni dalla Grecia. Ad Atene
lo accolsero come un trionfatore e gli arredarono un appartamento nel Partenone, ch’egli
riempì di prostitute e di efèbì. Poi si stancò di quegli ozi, si proclamò re di Macedonia, e
come tale abolì l’indipendenza ateniese ch’egli stesso aveva restaurato, riconsegnando la
città a una guarnigione macedone.
Da questo regime di anarchia che durò un secolo e che fu complicato da una
terrificante invasione di galli, la Grecia emerse politicamente finita. Sul solco della sua
flotta mercantile e sulle spade di Filippo, di Alessandro e dei loro diadochi, la sua civiltà
era penetrata dovunque, dall’Epiro, all’Asia Minore, alla Palestina, all’Egitto, alla Persia, e
fino all’India; e dovunque le classi dirigenti e intellettuali erano greche o grecizzanti. La
sua filosofia, la sua scultura, la sua letteratura, la sua scienza, trapiantate in quei paesi di
conquista, vi creavano una nuova cultura. Ma politicamente la Grecia era morta, e tale
doveva restare per duemila anni.
Quando Roma, liberatasi di Cartagine, volse verso di essa lo sguardo, non vide che
una Via Lattea di staterelli in perpetua baruffa gli uni con gli altri. Polibio non aveva
nessuna ragione di meravigliarsi ch’essa impiegasse così poco a conquistarli. In realtà
poteva impiegare molto meno.
Tutto cominciò per colpa di Filippo V, re di Macedonia. Questo stato, dissanguato
da Alessandro, non era più quello di una volta. Ma era ancora il più solido della Grecia, le
cui città erano divise in quel momento in due Leghe, quella Achea e quella Etolia, che
facevano pace tra loro solo per unirsi contro di lui.
Nel 216 Filippo, sentendo che Annibale aveva schiacciato i romani a Canne, firmò
un patto di alleanza con lui, e chiese ai greci di aiutarlo a distruggere Roma, che poteva
diventare pericolosa per tutti. Una conferenza fu indetta a Naupacto, dove il delegato degli
etoli, Agelao, parlando a nome di tutti i presenti, incitò Filippo a mettersi alla testa di tutti i
greci in quella crociata. Senonché subito dopo, ad Atene e nelle altre città, cominciò a
circolare la voce che Annibale avrebbe dato al macedone mano libera su di esse in cambio
dell’aiuto ricevuto da lui. Di colpo rinacquero le diffidenze momentaneamente sopite, e la
Lega Etolia mandò messi a Roma per chiedere aiuto contro Filippo. Il quale, per far fronte
alla Grecia, dovette rinunziare all’Italia e stipulare anche lui un patto con Roma, mettendo
così fine, prima ancora di averla cominciata, a quella prima guerra macedone.
Dopo Zama, furono Pergamo, l’Egitto e Rodi a chiedere aiuti all’Urbe contro
Filippo che li molestava. L’Urbe, che aveva la memoria lunga e ricordava il tentativo del re
macedone al tempo di Canne, mandò un esercito agli ordini di Tito Quinto Flaminino, che a
Cinocefale, nel 197, lo schiacciò. La via della Grecia era ora aperta.
Ma Flaminino era uno strano tipo. Di famiglia patrizia, aveva studiato a Taranto,
vi aveva imparato il greco, ed era un innamorato della civiltà ellenica. Per di più, nutriva
idee “progressiste”. Egli non uccise Filippo, anzi lo rimise sul trono nonostante le proteste
dei suoi alleati greci, i quali pretendevano di essere stati loro a vincere a Cinocefale, come
certi francesi oggi pretendono di essere stati loro a sconfiggere la Germania. Poi, in
occasione dei grandi Giuochi Istmici, che riunivano a Corinto i delegati di tutta la Grecia,
proclamò che tutti i suoi popoli e città erano liberi, non più soggetti né a guarnigioni né a
tributi, e potevano governarsi con le proprie leggi. Gli ascoltatori, che si aspettavano la
sostituzione del giogo romano a quello macedone, rimasero sbalorditi. E Plutarco racconta
che poi scoppiarono in tale urlo di entusiasmo che un branco di corvi che incrociavano sulle
loro teste piombarono giù, morti. Se anche tutte le altre sue storie Plutarco ce le ha
raccontate Con lo stesso scrupolo di verità, c’è da stare allegri.
Gli scettici di Atene e delle altre città non ebbero il tempo di mettere in dubbio le
oneste intenzioni di Flaminino, poiché costui le attuò subito ritirando il suo esercito dalla
Grecia. Ma dopo averlo salutato come “salvatore e liberatore” trovarono da ridire sul fatto
ch’egli si fosse portato dietro un cospicuo bottino di guerra sotto forma di opere d’arte e
che avesse emancipato alcune città dalla Lega Etolia, dove stavano di malavoglia. E
chiamarono Antioco, l’ultimo erede di Seleuco, re di Babilonia, a riliberarli. A riliberarli da
cosa, non si sa, visto che Flaminino li aveva lasciati liberissimi.
Pergamo e Lampsaco che, essendo più vicine ad Antioco, lo conoscevano meglio,
e quindi sapevano cosa aspettarsi da lui, chiesero aiuto a Roma. E il Senato, che non aveva
mai creduto all’esperimento liberale e progressista di Flaminino, mandò un altro esercito
agli ordini dell’eroe di Zama. Con pochi uomini, questi attaccò Antioco, a Magnesia, lo
sbaragliò, nonostante i saggi consigli strategici che gli aveva dato Annibale, suo ospite, e
assicurò a Roma quasi tutta la costa mediterranea dell’Asia Minore. Poi. si volse a nord,
batté i galli che ancora bivaccavano in quei paraggi, e rientrò in Italia senza toccare le città
greche.
Per alcuni anni Roma insisté nei loro riguardi in questa politica di tolleranza e di
rispetto, molto simile a quella che gli Stati Uniti hanno praticato in Europa dopo la seconda
guerra mondiale. Interveniva nelle loro faccende interne solo se sollecitata, e cercava di
puntellarvi l’ordine costituito. Per questo raccoglieva le antipatie di tutti gli scontenti, i
quali l’accusavano di reazionarismo.
Di questo stato d’animo delle “masse”, credette di poter approfittare Perseo di
Macedonia che, succeduto a Filippo nel 179, le chiamò a raccolta per una guerra santa
contro l’Urbe. Egli aveva sposato la figlia dell’erede di Antioco, Seleuco, che gli si alleò, e
si trascinò dietro anche l’Illiria e l’Epiro. Questi ultimi stati furono i soli a dargli
praticamente man forte, quando un terzo esercito romano, guidato da Emilio Paolo figlio
del console caduto a Canne, sopraggiunse e sbaragliò a Pidna, nel 168, Perseo, che fu tradotto in Catene a Roma per adornare il carro del vincitore.
Fra le altre cose, cadde nelle mani di Emilio anche l’archivio segreto del vinto. E
vi si trovarono i documenti relativi alla congiura con la prova delle varie responsabilità. Per
castigo, settanta città macedoni furono rase al suolo, l’Epiro e l’Illiria devastati; Rodi, che
aveva cospirato senza prender parte attiva alla guerra, venne privata dei suoi possedimenti
in Asia Minore; e mille simpatizzanti greci di Perseo, fra cui Polibio, condotti come ostaggi
a Roma.
Era già il segno che il Senato, abbandonate le illusioni di Flaminino e degli altri
filelleni dell’Urbe, fra cui gli stessi Scipioni, aveva vinto il complesso d’inferiorità verso la
Grecia e stava tornando ai suoi tradizionali sistemi di trattamento del vinto. Ma nemmeno
stavolta i turbolenti greci vollero capire. Di lì a qualche anno nelle varie città vennero al
potere nuove classi proletarie, che facevano tutt’uno del socialismo e del nazionalismo. La
Lega Achea fu ricostituita e, quando seppe che Roma era impegnata nella terza guerra
contro Cartagine, chiamò tutta la Grecia alla liberazione.
Ma ora Roma poteva tranquillamente combattere una guerra su due fronti. Mentre
Scipione Emiliano s’imbarcava per l’Africa, il console Mummio calò su Corinto, ch’era
una delle città più riottose. L’assediò, la conquistò, ne uccise tutti gli uomini, ne ridusse
schiave le donne e, imbarcato tutto ciò che v’era di trasportabile a Roma, la diede alle
fiamme. Grecia e Macedonia furono unite in una sola “provincia” sotto un governatore
romano, ad eccezione di Atene e Sparta, cui si riconobbe una certa autonomia.
La Grecia aveva finalmente trovato la sua pace: la pace del cimitero.
La terza e ultima guerra punica fu voluta da Catone il Censore e provocata da
Massinissa, ch’eran destinati a non vederne la fine.
Massinissa fu uno dei più strani personaggi dell’antichità. Visse fino a
novant’anni, ebbe l’ultimo figlio a ottantasei, e a ottantotto galoppava ancora alla, testa
delle sue truppe. Dopo Zama, aveva riavuto il trono di Numidia e, siccome Cartagine si era
impegnata con Roma a non più fare guerre, non si stancava di tormentarla con incursioni e
ruberie. Cartagine protestava, e Roma la zittiva. Ma, quando ebbe pagato l’ultima delle
cinquanta indennità che doveva annualmente all’Urbe per il risarcimento, si ribellò a queste
prepotenze e attaccò Massinissa.
A Roma in quel momento aveva il sopravvento il partito di Catone, che terminava
sempre i suoi discorsi, su qualunque argomento li tenesse, col solito ritornello: «Quanto al
resto, penso che Cartagine debba essere distrutta ». Nell’incidente il Senato, aiutato da lui,
vide l’occasione buona, e non solo intimò ai cartaginesi di non prendere iniziative, ma
esigette trecento bambini di famiglia nobile per tenerli come ostaggi. I bambini furono
consegnati fra i lamenti delle mamme, alcune delle quali si buttarono a nuoto dietro le navi
che li portavano via, e morirono. Subito dopo, visto che la provocazione non era bastata, i
romani chiesero la consegna di tutte le armi, di tutta la flotta e di gran parte del grano.
Quando anche queste richieste furono accolte, il Senato esigette che tutta la popolazione si
ritirasse a dieci miglia dalla città, che doveva essere rasa al suolo. Gli ambasciatori
cartaginesi obbiettarono invano che la storia non aveva mai visto una simile atrocità, si
gettarono in terra strappandosi i capelli, offrirono in cambio la propria vita.
Nulla da fare. Roma voleva la guerra, e guerra doveva essere ad ogni costo.
Quando lo seppero a Cartagine, la folla inferocita linciò i dirigenti che avevano
consegnato i bambini, gli ambasciatori, i ministri e tutti gl’italiani che si trovò sottomano.
Poi, pazzi di rabbia e di odio, chiamarono alle armi tutti, compresi gli schiavi,
trasformarono ogni casa in un fortilizio, e in due mesi di febbrile lavoro approntarono
ottomila scudi, diciottomila spade, trentamila lance e centoventi navi.
L’assedio, per terra e per mare, durò tre anni. Scipione Emiliano, il figlio adottivo
del figlio del vincitore di Zama, si guadagnò una dubbia gloria, espugnando alla fine la
città, dove per sei giorni ancora, strada per strada, casa per casa, si seguitò a combattere.
Insidiato dai franchi tiratori che combattevano da tetti e finestre, Scipione distrusse tutti gli
edifici.
Quelli che alla fine si arresero, furono solo cinquantacinquemila, dei
cinquecentomila abitanti di Cartagine. Tutti gli altri erano morti. Il loro generale, che tanto
per cambiare si chiamava Asdrubale, implorò per sé la misericordia di Scipione, che gliela
concesse. Sua moglie, per la vergogna, si precipitò coi figli tra le fiamme di un incendio.
Scipione chiese al Senato il permesso di desistere da quel macello. Gli fu risposto
che non soltanto Cartagine, ma tutte le sue dipendenze dovevano essere distrutte. La città
continuò a bruciare per diciassette giorni. I pochi sopravvissuti furono venduti come
schiavi. E il suo territorio fu d’allora in poi una “provincia” designata col nome generico di
Africa.
Non ci fu trattato di pace perché non si sarebbe saputo con chi stipularlo. Gli
ambasciatori cartaginesi avevano avuto ragione: mai si era vista nella storia una simile
atrocità.
Per loro fortuna, Catone e Massinissa non ebbero il tempo di nutrire rimorsi. Erano
già sottoterra.
Finito di stampare nel dicembre 2001
presso «Grafica Veneta S.r1»
Via Padova, 2 - Trebaseleghe (PD)
Printed in Italy
© 1959 Rizzoli Editore, Milano
© 1994 RCS Libri S.p.A., Milano sulla collana storia d’italia
© 2001 RCS Collezionabili S.p.A., Milano sulla presente edizione
storia d’italia
Pubblicazione periodica settimanale
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 197 del 9.4.1994
Direttore responsabile: Gianni Vallardi
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa
n. 00262 vol. III Foglio 489 del 20.9.1892
SOMMARIO
Cronologia
Capitolo primo
Catone
Capitolo secondo
"... ferum victorem cepit"
Capitolo terzo
I Gracchi
Capitolo quarto
Mario
Capitolo quinto
Silla
Capitolo sesto
Una cena a Roma
Capitolo settimo
Cicerone
Capitolo ottavo
Cesare
Capitolo nono
La conquista della Gallia
Capitolo decimo
Il Rubicone
Capitolo undicesimo
Gl’Idi di marzo
Capitolo dodicesimo
Antonio e Cleopatra
Capitolo tredicesimo
Augusto
Capitolo quattordicesimo
Orazio e Livio
Capitolo quindicesimo
Tiberio e Caligola
Capitolo sedicesimo
Claudioe Seneca
Capitolo diciassettesimo
Nerone
EVENTI POLITICI
E MILITARI
133 a.C. Cade la città spagnola di Numanzia.
Attalo III, re di Pergamo, lascia morendo il
suo regno a Roma.
Viene repressa in Sicilia una rivolta di
schiavi comandati da Euno siriaco; ventimila
schiavi vengono crocifissi. Tiberio Gracco
propone la riforma agraria, ma viene ucciso.
123 II fratello di Tiberio, Caio Gracco,
ripropone la riforma agraria. Massacro di
Caio e dei suoi (121).
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
144 a.C. Il pretore Marcio Re convoglia in
Roma, con un acquedotto di 92 chilometri,
l'acqua dell'alta valle dell'Amene (acquedotto
deLL'aqua Marcia).
121 Caio Gracco pronuncia una celebre
orazione (restano frammenti dei suoi discorsi
in Cicerone, Plutarco e Aulo Gellio).
111-105
Guerra giugurtina. La Numidia
diventa provincia romana.
117 Cassio Longino fa pavimentare l'antica
via Cassia, da Roma a Bolsena, Sutri, Chiusi,
Arezzo.
102 Calano verso l'Italia i teutoni che
vengono disfatti da C. Mario (158-86) alle
Aquae Sextiae (Aix en Provence).
104 Riforma militare di Caio Mario.
101 Calano in Italia i cimbri, disfatti
anch'essi da Mario nella battaglia dei campi
Raudii (Vercelli).
91
II tribuno Livio Druso propone una
nuova legge agraria e la concessione della
cittadinanza agli italici. Viene assassinato.
100 Risale a questi anni il tempio della
Fortuna virile, tra i meglio conservati accanto
a quello di Vesta di età augustea. Si
cominciano ad usare nelle costruzioni marmi
d'Italia e di Grecia.
91-89 Guerra sociale (contro i socii alleati).
88-84 Prima guerra mitridatica. Ha inizio col
massacro di ottantamila romani in un sol
giorno dell'88, in Asia Minore.
88 Comincia la guerra civile tra Mario e
Lucio Cornelio Silla (138-78).
86 Muore C. Mario.
85 Silla batte Mitridate.
83-81 Seconda guerra mitridatica vinta da
Licinio Murena.
82 Silla batte i partigiani di Mario e si fa
nominare dittatore a vita. Stragi di Silla e sua
riforma aristocratica.
89 È promulgata la lex Plautia Papiria, che
concede la cittadinanza agli italici.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
79 Silla lascia
successivo.
il
potere.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Muore
l'anno
74-63 Terza guerra mitridatica iniziata da
Licinio Lucullo e terminata vittoriosamente
da Pompeo Magno (106-48).
72 Termina in Spagna una lunga guerra per
soffocare la ribellione del mariano Sertorio.
71. Termina con un massacro la guerra
iniziata per la ribellione degli schiavi guidati
da Spartaco.
67 Pompeo libera il Mediterraneo dai pirati.
64 II Ponto, la Siria e la Cilicia diventano
province romane.
63-62 Congiura di Catilina sventata da Marco
Tullio Cicerone (106-43).
60 Primo triumvirato di Pompeo, Crasso e
Caio Giulio Cesare (100-44).
59 Giulio Cesare console.
58-51 Campagna di Cesare in Gallia: 58,
batte gli elvezi e i germani di Ariovisto; 57,
sottomette i belgi; 56, sottomette gli aquitati;
55, primo passaggio del Reno e guerra contro
i germani; primo sbarco in Britannia; 54,
secondo sbarco in Britannia; repressione di
una rivolta di belgi; 53, secondo passaggio
del Reno; 52, rivolta generale della Gallia al
comando di Vercingetorige. La rivolta è
domata con l'assedio di Alesia e la resa di
Vercingetorige;
51,
la
Gallia
è
definitivamente romana.
59 Cesare console fa approvare le leggi
agrarie.
Trionfa in questi anni l’atel-lana, la
commedia della maschere {Pappus, Maccus,
Buccus, Dossenus).
53 Crasso viene ucciso dai parti.
49-45 Guerra civile tra Cesare e Pompeo: 49,
Pompeo è battuto a Farsàlo e ucciso in
Egitto. 48-47, guerra alessandrina. Cleopatra
(69-30). 47, vittoria su Farnace (veni,vidi,
vici); 46, battaglia di Tapso e suicidio di
Catone Uticense; 45, battaglia di Munda
contro gli ultimi pompeiani. Cesare è
nominato dittatore a vita.
45-44 Cesare fa costruire il Forum Julii, la
basilica Julia, il tempio di Venere genitrice;
riforma il calendario introducendo l'anno
bisestile; riordina i municipi italici (lex Julia
municipalis); bonifica le paludi Pontine.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
44
II 15 marzo. Cesare è ucciso dai
congiurati guidati da Bruto e Cassio. Lascia
erede il pronipote Ottaviano. Rivolta
popolare contro i congiurati che fuggono da
Roma. La situazione è nelle mani del legato
di Cesare, Marco Antonio (83-30).
44-43 Guerra di Modena tra Marco Antonio e
i cesariani da una parte e Decimo Bruto e
Ottaviano dall'altra. Nel 43 cadono in
battaglia i due consoli di quell'anno, Pansa e
Irzio.
43 Antonio, Ottaviano e Lepido formano il
secondo triumvirato; la prima vittima è Cicerone.
42 Battaglia di Filippi tra Antonio e
Ottaviano e Bruto e Cassio, che, sconfitti, si
uccidono.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Attività letteraria dell'età di Cesare
Cesare scrive l’Anticatone, la Analogia, Il
viaggio (opere perdute) e pubblica i commentarii de bello Gallico in sette libri e de bello
civile in tre libri; gli si attribuisce anche il
bellum Alexandrinum sugli avvenimenti del
47 in Egitto.
Opera il mimografo Publilio Siro, di cui
avanzano circa 700 versi.
Marco Terenzio Varrone (116-27), poligrafo,
pubblica circa 600 libri di varia erudizione, in
gran parte perduti.
Marco Tullio Cicerone (106-43), di Arpino,
pronuncia le orazioni (dalla prima pro
Quintio, alle Catilinarie, le Verrine, la pro
Milone, le 14 Filippiche contro Marco Antonio); pubblica trattati politici (de republica,
de legibus, ecc.), trattati di retorica, come il
de oratore, di filosofia e di morale, come il
de finibus bonorum et malorum, le Tusculanae disputationes, il de officiis; lascia un
Epistolario di oltre mille lettere, fondamentale per la conoscenza minuziosa degli
avvenimenti di questi anni.
C. Sallustio Crispo (86-35) scrive la
Congiura di Catilina e la Guerra giugurtina,
modelli di saggistica storica.
Cornelio Nepote (100-27) scrive una Storia
universale andata perduta e le celebri Biografie di uomini illustri.
Operano in Roma i neoteroi (poeti nuovi) :
Licinio Calvo, Elvio Cinna, Furio Bibaculo,
Levio, Varrone Atacino, e il maggiore di essi
e il solo di cui avanzi l'opera, C. Valerio Catullo veronese (87-54 ca.) celeberrimo
cantore di Lesbia.
Tito Lucrezio Caro (98-55 ca., forse
campano) scrive il poema filosofico La
natura, pubblicato postumo da Cicerone.
Vitruvio Pollione, architetto, scrive i dieci
libri de architectura. Opera Dionigi di
Alicarnasso retore e storico greco, autore
delle Antichità romane, di cui restano dieci
libri fondamentali per la conoscenza dei
primi secoli di Roma.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Opera Diodoro Siculo, storico greco di
origine siciliana; rimangono una quindicina
di libri della sua Biblioteca storica, racconto
della storia di Roma dalle origini a Cesare.
46 Vengono costruiti il ponte Cestio e il
ponte Fabricio tra la sponda del Tevere e
l'isola Tiberina.
40 Marco Antonio e Ottaviano si dividono
l'impero: il primo si stabilisce in Oriente, ad
Alessandria; il secondo a Roma.
40 Intorno a questi anni, viene costruito per
Cecilia Metella, nuora di Cecilio Crasso, il
famoso Mausoleo sulla via Appia.
31 Battaglia di Azio; sconfitta di Marco
Antonio e dei suoi. Suicidio di Antonio e di
Cleopatra (30). L'Egitto è incamerato
nell'impero.
30 ca. Viene costruito il Foro di Augusto a
commemorazione della vittoria di Filippi.
27 II senato conferisce a Ottaviano il titolo di
Augusto.
27 Marco Agrippa, genero di Augusto, fa
costruire il Pantheon.
19
Agrippa
fa
costruire
l'acquedotto
dell'Acqua Vergine (una fanciulla ne avrebbe
indicata la sorgente ai soldati assetati); era
lungo una ventina di chilometri e terminava
dove oggi sorge la settecentesca fontana di
Trevi.
18 Augusto emana leggi per il riordinamento
dei costumi (lex de maritandis ordinibus).
17 Augusto ordina la celebrazione dei ludi
saeculares. Orazio scrive per l'occasione il
carmen saeculare.
13 Cornelio Balbo erige il teatro di Balbo (tra
le arcate si annidavano nel Medioevo piccole
botteghe, da cui il nome odierno della strada:
via Botteghe Oscure.
12 Augusto è dichiarato padre della patria.
12-9 Guerra di Druso, figliastro di Augusto,
in Germania. L'esercito romano giunge all'Elba.
Negli stessi anni Tiberio, l'altro figliastro di
Augusto, sottomette la Pannonia
12 ca. Il tribuno della plebe Caio Cestio
Epulone erige per sé una tomba tra le meglio
conservate: la piramide di Caio Cestio a porta
San Paolo.
11 Augusto termina il teatro Marcello,
dedicato al nipote morto non ancora
ventenne. Conteneva 10.000 spettatori.
.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
9 Viene eretta l'Ara pacis Augustae, nel
Campo Marzio, coi primi esempi di sculture
in rilievo di soggetto storico. In questi anni
cominciano a essere coniate monete d'oro. Si
diffonde, per le costruzioni, l'uso di mattoni
cotti. Risale a questi anni il cosiddetto tempio
di Vesta. Augusto fa costruire il proprio
mausoleo. Vi furono sepolti Augusto, sua
sorella Ottavia, sua moglie Livia, Agrippa,
Druso,
Germanico,
Tiberio,
Agrippina,
Claudio, Britannico e Nerva.
Sorgono ad Arles il grandioso anfiteatro e il
teatro romano. Vengono costruiti l'anfiteatro
e l'acquedotto di Nimes, col celebre ponte sul
fiume Gard; in Italia si costruisce l'arena di
Verona, quella di Pola, ecc.
4-6 d.C. Nuova spedizione di Tiberio in
Germania.
9 II germano Arminio distrugge tre legioni
romane guidate da Varo nella Selva di
Teutoburgo.
Attività letteraria dell'età di Augusto
Sono celebri i circoli letterari di Messalla
Corvino e specialmente quello di Mecenate,
amico di Augusto.
Cornelio Gallo inaugura l'elegia romana. La
sua opera è andata perduta.
Aulo Properzio (50-15 ca.), umbro, scrive i
quattro libri, rimasti, delle sue elegie per
Cinzia. Albio Tibullo (60-19 ca.) ci lascia tre
libri di elegie (corpus Tibullianum) per Delia
e Nemesi.
Q. Orazio Flacco (65-8), di Venosa, scrive i
due libri delle Satire, gli Epòdi, i quattro libri
delle Odi e le Epistole, monumenti della
lirica latina.
P. Virgilio Marone (70-19), di Andes,
Mantova, il più grande poeta di Roma e tra i
maggiori dell'antichità, scrive le Bucoliche, i
quattro libri delle Georg-che, i dodici libri
dell'Eneide.
P. Ovidio Nasone (43 a.C.-17 d.C.), di
Sulmona, scrive i tre libri degli Amori (per
Corinna), l'Arte amatoria, le Eroidi, le
Metamorfosi (quindici libri, tra i più letti e
imitati di tutti i tempi), i Fasti e, durante
l'esilio sul mar Nero, le Tristezze e le Epistole
dal Ponto, nonché numerose altre opere
minori.
EVENTI POLITICI
EVENTI CIVILI,
E MILITARI
CULTURALI E ARTISTICI
14 II 19 agosto muore Augusto a Noia.
14-37 Principato di Tiberio: 31, caduta di
Seiano.
37-41 Principato di Caligola. Termina con
l'uccisione dell'imperatore per mano di Cassio Cherea.
41-54 Principato di Claudio: 43, conquista
della Britannia meridionale.
54-68 Principato di Nerone:
64, incendio di Roma. Massacro dei cristiani;
65, congiura dei Pisoni; tra le vittime illustri
il filosofo Anneo Seneca, il poeta Lucano, lo
scrittore Petronio; 68, col suicidio di Nerone
ha termine la dinastia Giulio-Claudia.
Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.), di Padova,
scrive
il
capolavoro
della
storiografia
romana, i 142 libri Ab Urbe condita (ne
avanzano circa 35). Fedro, liberto di
Augusto, scrive cinque libri di favole. Velleio
Patercolo scrive un compendio di Storia
romana in due libri dedicato all'imperatore
Tiberio. Valerio Massimo scrive i 9 libri di
Fatti e detti memorabili, dedicati a Tiberio.
35 d.C. Caligola fa costruire l'acquedotto
dell'Acqua Claudia, terminato da Claudio nel
49. Era lungo 70 chilometri.
37 Caligola fa portare a Roma da Eliopoli
l'obelisco monolitico che Domenico Fontana,
nel 1586, sotto Sisto V, avrebbe sistemato in
piazza San Pietro.
52 Claudio
Maggiore.
fa
costruire
l'attuale
Porta
64 Nerone fa costruire la Domus Aurea.
Attività
Nerone
letteraria
dell'età
di
Claudio
e
Curzio Rufo scrive i dieci libri della Storia di
Alessandro Magno.
Anneo Lucano (39-65) scrive il poema epico
Farsaglia in 10 libri.
Petronio scrive il Satyricon, romanzo di cui
restano frammenti del XV e del XVI libro.
Persio di Volterra (34-62) scrive sei satire.
Anneo Seneca, spagnolo (4 a.C.-65 d.C.), il
maggior filosofo romano, scrive i Dialoghi,
le Epistole a Lucilio, dieci tragedie.
CAPITOLO PRIMO
CATONE
NEL 195, subito dopo la prima guerra punica, le donne di Roma
formarono un corteo, mossero verso il Foro, e chiesero al Parlamento
l'abrogazione della Legge Oppia, promulgata durante il regime di austerità
imposto dalla minaccia incombente di Annibale, che proibiva al bel sesso
gli ornamenti d'oro, le vesti colorate e l'uso delle carrozze.
Per la prima volta nella storia di Roma le donne si facevano protagoniste
di qualcosa, prendevano un'iniziativa politica, insomma affermavano i loro
diritti. Non era mai accaduto, prima di allora. Per cinque secoli e mezzo,
cioè dal giorno in cui era stata fondata, la storia di Roma era stata una storia
di uomini, cui le donne avevano fatto, in massa e anonimamente, da coro.
Le poche di cui si conosca il nome, Tarpeia, Lucrezia, Virginia, forse non
sono mai esistite e non incarnano personaggi credibili, ma monumenti al
Tradimento o alla Virtù. La vita pubblica romana era soltanto maschile. Le
donne non contavano che in quella privata, cioè nell'ambito della casa e
della famiglia, dove la loro influenza era legata esclusivamente alle loro funzioni di mamma, di sposa, di figlia o di sorella degli uomini.
In Senato, Marco Porcio Catone, nella sua qualità di "censore" preposto
alla sorveglianza dei costumi, si oppose alla richiesta. E il suo discorso,
tramandatoci da Livio, la dice lunga sulle trasformazioni avvenute in quegli
ultimi anni nella vita familiare e sociale dell'Urbe:
«Se ciascuno di noi, signori, avesse mantenuto l'autorità e i diritti del
marito nell'interno della propria casa, non saremmo arrivati a questo punto.
Ora eccoci qui: la prepotenza femminile, dopo aver annullato la nostra
libertà d'azione in famiglia, ce la sta distruggendo anche nel Foro.
Ricordatevi quanto abbiamo penato a tenere in pugno le nostre donne e a
frenarne la licenza, quando le leggi ci consentivano di farlo. E immaginatevi
cosa succederà d'ora in poi, se queste leggi saranno revocate e le donne
saranno poste, anche legalmente, su un piede di parità con noi. Voi le
conoscete, le donne: fatevele vostre uguali, e immediatamente ve le
ritroverete sul gobbo come padrone. Vedremo questo, alla fine: gli uomini
di tutto il mondo, che in tutto il mondo governano le donne, governati dagli
unici uomini che dalle donne si facciano governare: i romani».
Le dimostranti sommersero in una risata di scherno l'oratore, che del
resto c'era abituato come tutti coloro che dicono la verità, la Legge Oppia fu
revocata, e Catone inutilmente cercò di rifarsi decuplicando le tasse sugli
articoli di lusso. Certe ventate, quando cominciano a soffiare, non c'è barba
di censore che possa fermarle. E le suffragette, assunta l'iniziativa, non
intendevano più lasciarsela strappar di mano. Piano piano esse ottennero il
diritto di amministrare la propria dote, il che le rendeva economicamente
indipendenti e libere, come si direbbe oggi, di "vivere la loro vita"; poi
quello di divorziare dal marito e ogni tanto, se non riuscivano, di
avvelenarlo. E sempre più si abbandonarono a pratiche malthusiane per
evitare la "scocciatura" dei figli.
Contrariamente a quel che si crede e a come ce lo hanno dipinto, l'uomo
che cercava di contrastare il passo a queste nuove mode, tutte di origine
greca, non era affatto un insopportabile moralista dalla bocca acerba e dal
fegato in disordine. Tutt'altro. Marco Porcio Catone era un contadino plebeo
dei dintorni di Rieti, pieno di salute e di buonumore, che campò fino all'età
di ottantacinque anni (un'età, per quei tempi, quasi leggendaria), e morì
dopo essersi tolto tutte le soddisfazioni: compresa quella, che gli stava particolarmente a cuore, di farsi molti nemici.
Fu il caso a far di lui un uomo politico di rilievo e forse il personaggio
più interessante di quel periodo. Egli viveva in stoica semplicità sul suo
poderetto coltivandolo con le proprie mani; quando poco discosto venne ad
abitare un vecchio senatore in pensione, Valerio Flacco, ritiratosi laggiù per
il disgusto che gli procurava la corruzione di Roma. Era un patrizio
all'antica, cioè di quelli che avevano in orrore le raffinatezze, e prese subito
in simpatia quel ragazzo dalle mani callose, dalle abitudini rozze, dai capelli
rossi e dai denti radi, che leggeva i classici, ma di nascosto, perché se ne
vergognava come di un vizio poco meno che turpe, e su di essi aveva
imparato a scrivere e a parlare in uno stile schietto e asciutto. Diventarono
amici sulla base di comuni abitudini e idee. E Valerio spinse Marco, che si
chiamava Porcio perché la sua famiglia aveva sempre allevato porci, e
Catone perché tutti i suoi antenati erano stati furbi, a far l'avvocato. Era il
mestiere con cui si debuttava nella vita politica. E forse il senatore ve lo
lanciò proprio con questo scopo, nella speranza di lasciare un erede nella
polemica antimodernista, che l'età a lui non consentiva più di sostenere.
Catone si provò, e vinse, una di seguito all'altra, una dozzina di cause
dinanzi al tribunale locale. Poi, con una clientela sicura, aprì uno studio,
come si direbbe oggi, a Roma, si presentò alle elezioni, e battè il cosiddetto
"corso degli onori" con annibalico piglio. Edile a trent'anni nel 199, pretore
nel 198, tre anni dopo era console. Poi ricominciò: tribuno nel 191, censore
nel 184, praticamente continuò a esercitare magistrature su magistrature fino
alla più tarda vecchiaia, distinguendosi soprattutto in tempo di guerra,
quando cambiava in militari i suoi galloni civili. L'accampamento gli si
confaceva meglio del Foro, perché con più pertinenza poteva farvi appello
alla disciplina, ch'egli considerava la condizione dei valori morali. Pare che
fosse un generale pignolo. Ma i soldati glielo perdonavano perché marciava
a piedi come loro, combatteva con tranquillo coraggio e, al momento del
saccheggio, che rientrava nei diritti del vincitore, concedeva ad ognuno una
libbra d'argento sul bottino, che poi consegnava interamente al Senato senza
trattenerne neanche un'oncia per sé.
Era, questa, una regola che i generali romani avevano quasi sempre
osservato, sino alle guerre puniche; ma che da qualche tempo costituiva
un'eccezione. Il governo non guardava più tanto per il sottile la parte che il
vincitore si era intascata della preda, quando questa era ricca. Quinto
Minucio aveva riportato di Spagna trentacinquemila libbre d'argento e
trentacinquemila denari, Manlio Vulsone dall'Asia quattromilacinquecento
libbre d'oro; quattrocentomila sesterzi, qualcosa come due miliardi di lire,
erano stati estorti ad Antioco e a Perseo... Sotto quella pioggia d'oro, l'onestà
dei generali e dei magistrati romani, strettamente legata alla povertà, al
risparmio e all'avarizia, era naturale che affogasse. E la battaglia che
condusse Catone per impedirlo era destinata al fallimento. Pure, egli la
combattè ugualmente.
Nel 187, quando era tribuno, egli chiese a Scipione Emiliano e a suo
fratello Lucio, che tornavano vincitori dall'Asia, di rendere conto al Senato
delle somme versate come indennità di guerra da Antioco. Era una domanda
perfettamente legittima, ma che sorprese Roma perché revocava in dubbio la
correttezza del trionfatore di Zama, che in realtà era superiore a ogni sospetto. Non si capisce bene cosa spingesse a quel passo Catone, che non
poteva certamente ignorare l'integrità dell'Africano e la sua immensa
popolarità. Forse egli volle semplicemente ristabilire il principio, che stava
cadendo in disuso, che i generali, quali che fossero il loro nome e i loro
meriti, questi rendiconti li dovevano; oppure c'era sotto una violenta
antipatia per il clan degli Scipioni, estetizzante, ellenizzante e modernizzante?
Forse, l'uno e l'altra. Comunque, la pretesa coalizzò, contro chi
l'avanzava, quella oligarchia di dominanti famiglie che, nell'ambito dell'aristocrazia senatoriale, deteneva praticamente il monopolio del potere. Fino a
Silla la storia romana si riassume in quella di alcune dinastie, e infatti
presenta continuamente gli stessi nomi. Degli ultimi duecento consoli della
Repubblica, la metà appartenne a dieci sole casate, l'altra metà a sedici. E di
esse, quella degli Scipioni era forse la più insigne, da quello ch'era caduto
sulla Trebbia, a questo che aveva trionfato a Zama e ch'era il padre adottivo
di colui che più tardi distrusse Cartagine.
L'Africano, per quanto ferito nell'orgoglio, si preparava a rispondere. Ma
suo fratello Lucio glielo impedì. E, tratti dalla cartella i documenti che
comprovavano le avvenute riscossioni e i relativi versamenti, li fece a pezzi
dinanzi al Senato. Per questo gesto fu tratto dinanzi all'assemblea e
condannato per frode. Ma il castigo gli fu risparmiato per il veto di un
tribuno, un certo Tiberio Sempronio Gracco, di cui sentiremo presto parlare,
e che era, tanto per confermare la regola della politica per dinastie, di cui
sopra si parlava, parente dell'imputato, avendo sposato la figlia
dell'Africano, Cornelia. L'eroe di Zama fu convocato in assemblea per
essere sottoposto a giudizio. Egli interruppe il dibattimento invitando i
deputati al tempio di Giove per celebrare l'anniversario della sua grande
vittoria, che capitava proprio in quel giorno. I deputati lo seguirono,
assistettero alle funzioni che vi si celebrarono. Ma, tornati in Parlamento, di
nuovo convocarono il generale. Costui rifiutò stavolta di presentarsi e,
amareggiato da quell'insistenza, si ritirò nella sua villa di Literno, dove
rimase sino alla morte. I suoi persecutori lo lasciarono finalmente in pace.
Ma Catone deplorò, giustamente, che per la prima volta nella storia di Roma
i meriti combattentistici di un imputato facessero ostacolo alla giustizia, e in
questo episodio denunziò il primo trapelare di un individualismo che presto
avrebbe corrotto la società col culto dell'eroe e distrutto la democrazia. I
fatti dovevano incaricarsi di dargli pienamente ragione.
Qualcuno si domanderà come, avendo contro di sé avversari possenti
come le donne e la "mafia" delle famiglie aristocratiche, questo implacabile
"piantagrane" sia riuscito tuttavia a restare in sella e a vincere le elezioni
ogni volta che si presentava candidato a qualche magistratura. Pochi infatti
lo amavano. La sua onestà in quel tempo di corruzione, il suo ascetismo in
quell'epoca di mollezze, erano sentiti da tutti come un rimorso. Egli
rappresentava ciò che ognuno avrebbe dovuto e forse voluto essere, ma purtroppo non era. E per questo appunto, pur detestandolo, lo rispettavano e gli
davano il voto. Per di più era un grande oratore. E la cosa era abbastanza
strana, perché aveva debuttato nelle lettere pubblicando un trattato contro i
retori e anticipando la famosa frase di Verlaine: Quando vedi l'oratoria,
tirale il collo. Ma appunto a furia d'insegnare agli altri come "non" si
doveva parlare, aveva imparato egli stesso a parlare benissimo. Il poco che
ci resta dei suoi discorsi basta a farcelo riconoscere più grande di Cicerone,
certamente più rotondo, togato e letterariamente perfetto di lui, ma meno
diretto, efficace e sincero. Il che ci dimostra che non c'è eloquenza, come
non c'è letteratura, come non c'è musica né pittura, come non c'è nulla, senza
una forza morale e una schietta convinzione che le sostengano.
Catone condiva anche le sue più severe requisitorie di umorismo. E
quando, per esempio, come censore, fece espellere dal senato Manilio per
aver baciato sua moglie in pubblico, e qualcuno gli domandò se lui non lo
aveva fatto mai, rispose: «Sì, ma soltanto quando tuona. Per questo il
maltempo mi mette sempre di buonumore». Anche quando gl'intentavano
processi, e ci si provarono, a quanto pare, quarantaquattro volte, sotto le più
svariate accuse, serbava la sua allegria e rideva nella stessa misura in cui
mordeva. Con quel sarcasmo sempre pronto, con quei frizzi popolareschi,
con quella faccia butterata di ferite, e quei capelli rossi e quei denti
divaricati, non era piacevole trovarselo di fronte in contradditorio. E
nessuno sarebbe riuscito a spodestarlo, se egli stesso a un certo punto non si
fosse stancato di quella inutile battaglia e spontaneamente ritirato a scrivere
libri, occupazione che dentro di sé disprezzava.
Lo fece perché voleva opporre qualche testo scritto in latino a quelli che
ormai tutti i letterati si erano messi a comporre in greco, la lingua che
rischiava di assicurarsi il monopolio della cultura romana. Il De agricultura
infatti, ch'è l'unico che ci resta di lui, è il primo libro in prosa vero e proprio
che sia nato a Roma. Ed è un curioso manuale pratico in cui, assieme a idee
vagamente filosofiche, si mescolano consigli sul sistema di curare i
reumatismi e la diarrea. Quanto ai criteri sul modo di sfruttare le terre,
eccoli qui. Il migliore, egli dice, è un profittevole allevamento di bestiame.
Eppoi? Un allevamento di bestiame moderatamente profittevole. Eppoi? Un
allevamento di bestiame neanche moderatamente profittevole. Eppoi?
Eppoi... eppoi, l'aratura e la semina. Catone non voleva tornare neanche
all'agricoltura, ma alla pastorizia.
Nessuno ebbe più vivo di lui il presentimento della decadenza di Roma,
e nessuno meglio di lui diagnosticò il focolare d'infezione: la Grecia. Ne
aveva studiato la lingua; e, colto e avvertito com'era sotto i suoi rozzi abiti,
aveva capito che la cultura ellenica era troppo più alta e raffinata di quella
romana per non corromperla. Chiamava Socrate "una zitella pettegola", e
approvava i giudici che lo avevano condannato a morte come sabotatore
delle leggi e del carattere di Atene. Ma lo odiava appunto in quanto lo
ammirava e si rendeva conto che le sue idee avrebbero conquistato anche
l'Urbe. Credimi sulla parola, scriveva al figlio, se questo popolo riesce a
contaminarci con la sua cultura, siamo perduti. Intanto ha cominciato con i
suoi medici che, con la scusa di curarci, son venuti qui a distruggere i "barbari". Ti proibisco di aver a che fare con loro. Lo preferiva morto piuttosto
che guarito dalle aspirine e dalle vitamine greche.
Molto probabilmente fu questo terrore a suggerirgli l'insistenza, per cui è
rimasto celebre, sul delenda Carthago. Più che a impedire una rinascita
della città fenicia, egli mirava a distrarre Roma dalle tentazioni di una
conquista della Grecia. Voleva che la sua patria guardasse a Occidente, non
a Oriente, donde, secondo lui, non le sarebbero venuti che vizi e malanni. E
forse rimase molto deluso dalla rapidità con cui Scipione venne a capo
dell'impresa. Avrebbe preferito una guerra difensiva contro dieci Annibali a
una offensiva contro l'Ellade. E quando vide i consoli Marcello, Fulvio ed
Emilio Paolo tornare di laggiù con carri carichi di statue, dipinti, coppe di
metallo, specchi, mobili di pregio e stoffe ricamate, e il popolo fare ressa di
fronte a quelle meraviglie e discutere di moda, di stile, di cappellini, di
sandali, d'argenteria e di cosmetici, dovette mettersi le mani nei capelli.
Morì nel 149, quando il Senato aveva già deciso di mandare l'ultimo
Scipione ad delendam Carthaginem. Forse quel gesto gli ridiede un soffio di
speranza; o per lo meno ci piace pensarlo. Avesse vissuto ancora un poco, si
sarebbe accorto che la distruzione di Cartagine non era servita proprio a
nulla. Anzi, una volta scomparsa quella città dalla faccia dell'Africa e del
Mediterraneo, i romani non ebbero più occhi e orecchi e pensiero che per
Fidia, Prassitele, Aristotele, Platone, la cucina, i belletti e le "etère" di
Atene.
CAPITOLO SECONDO
"...FERUM VICTOREM CEPIT"
ORAZIO, molto più tardi, convalidò a posteriori i timori che Catone aveva
espresso a priori, con un famoso verso: "Graecia capta ferum victorem
cepit'", (la Grecia conquistata conquistò il barbaro vincitore). E per farlo,
essa usò varie armi: la religione e il teatro per la plebe, la filosofia e le arti
per le classi superiori, che ancora non erano colte, ma purtroppo lo
diventeranno.
La religione di Roma, a Polibio, quando ve lo trassero prigioniero, parve
ancora salda. Il carattere, egli scrive, per il quale a mio giudizio l'Impero
romano è superiore a tutti gli altri, è la religione che vi si pratica. Ciò che
in altre nazioni sarebbe considerato riprovevole superstizione, qui a Roma
costituisce il cemento dello stato. Tutto ciò che ad essa attiene è rivestito di
tale pompa e a tal punto condiziona la vita pubblica e privata, che niente
potrà mai farle concorrenza. Credo che il governo l'abbia fatto apposta, per
le masse. Non sarebbe necessario, se un popolo fosse composto
esclusivamente di gente illuminata; ma per le moltitudini, che sono sempre
ottuse e facili alle cieche passioni, è bene che ci sia almeno la paura a
tenerle a freno.
A un uomo come lui, che arrivava fresco fresco di Grecia, dove lo
scetticismo e l'incredulità non avevano più limiti, si capisce che i romani, i
quali un barlume di fede lo conservavano, dovevano far l'effetto di
altrettanti monaci. Ma si trattava proprio d'un barlume, anche se certe forme
liturgiche (la "pompa", diceva Polibio) erano tuttora, per forza d'abitudine,
rispettate. Catone, che pure tirava a salvare tutti i vecchi costumi e credenze,
si domandava in un pubblico discorso come facessero gli àuguri, conoscendo ognuno i trucchi dell'altro, a non ridersi in faccia quando
s'incontravano per strada. E sulla scena Plauto poteva impunemente ridicolizzare Giove nella parte di seduttore di Alcmena e presentare Mercurio
come un pagliaccio.
Il popolo che batteva le mani a queste empie commedie era lo stesso che
pochi anni prima, alla notizia del disastro di Canne, si era precipitato in
piazza gridando: « Quale dio dobbiamo pregare per la salvezza di Roma?».
Evidentemente, solo nei momenti di pericolo i romani si ricordavano di
avere un dio, ma non sapevano chi fosse quello buono, fra i tanti che
popolavano il loro paradiso. E curiosa fu la risposta del governo, che decise
di affidare la salvezza dell'Urbe non a un dio romano, com'era sempre
avvenuto sino ad allora, ma a una dea greca, Cibele, e ordinò che la sua
statua fosse trasportata da Pessino, dove si trovava, in Asia Minore, a Roma.
Attalo, il re di Pergamo, consentì al trasloco. E così Magna Mater, come la
dea fu ribattezzata, un bel giorno giunse a Ostia, dov'era ad attenderla
Scipione l'Africano alla testa di un comitato di nobili matrone. A Roma fu
sparsa la voce che la nave, arenatasi alle foci del Tevere, era stata liberata e
condotta lungo il fiume fin nel cuore della città dalla vestale Virginia
Claudia in forza della sua castità. E tutti, ci credessero o no, bruciarono
incenso al passaggio della dea, che le matrone portarono in processione fino
al tempio della Vittoria. Il Senato rimase un po' scandalizzato e perplesso
quando seppe che la Grande Madre doveva essere accudita da preti autoevirati. A Roma, nei collegi sacerdotali, non ce n'era. Alla fine ne trovarono
alcuni, fra i prigionieri di guerra, e li fecero preti per l'occasione.
Da quel momento la liturgia greca si diffuse, ed essa fu applicata non
soltanto agli dèi che venivano di laggiù, ma anche a quelli romani. E il
risultato fu che, da austera e piuttosto lugubre, qual era stata sino ad allora,
diventò allegra e carnascialesca. Nel 186 il Senato apprese con allarmato
stupore che il popolino si era particolarmente affezionato a Diòniso, ne
aveva fatto il suo santo preferito, riempiva il suo tempio, e gli sacrificava
con particolare entusiasmo. Se ne capisce facilmente la ragione: i sacrifici
consistevano in pantagrueliche mangiate, in gagliarde bevute, e in un
disfrenamento dei rapporti fra uomini e donne. Insomma, erano tutto
fuorché "sacrifici". La polizia fece una retata di partecipanti a quelle feste,
arrestandone settemila, ne condannò a morte alcune centinaia, gli altri alla
prigione, e soppresse il culto. Ma quando si devono far intervenire i
gendarmi per salvare i costumi d'un popolo, vuol dire proprio ch'essi sono in
agonia.
Lo si vedeva del resto a teatro, che stava diventando il vero tempio di
Roma.
Il primo tentativo di spettacolo era stato quello di Livio Andronico, il
prigioniero di guerra tarantino, di origine greca, che nel 240 aveva
sceneggiato, recitato e cantato in rozzi versi "saturnini" l'Odissea. Come
abbiamo già detto, pubblico e governo n'erano rimasti sì compiaciuti, che
avevano consentito agli attori di costituirsi in "corporazione" e di
organizzare, per le grandi feste dell'anno, i cosiddetti ludi scenici.
Cinque anni dopo quella storica première, un altro prigioniero di guerra,
napoletano, stavolta, Cneo Nevio, produsse un'altra commedia che, con
piglio aristofanesco, metteva in ridicolo gli abusi e le ipocrisie della società
romana. Il popolo si divertì. Ma le famiglie influenti, che, si sentivano
colpite, protestarono. Esse erano troppo rozze e cafone per accettare la
satira, che trova diritto di cittadinanza solo presso i popoli molto civili. Il
povero Nevio fu arrestato, e dovette ritrattare. Scrisse un'altra commedia,
certo con l'intenzione di non offendere più nessuno, ma siccome era un
uomo pieno di spirito non ci riuscì. Anche stavolta di sotto la penna gli uscì
qualche frizzo, e lo pagò con la deportazione. Così Roma perse nello stesso
tempo un commediografo che poteva dare l'avvio a una produzione
originale e non più ricalcata sui modelli stranieri, e un umorista che poteva
insegnare a quel popolo tetro e pesante l'arte di sorridere, di accorgersi dei
propri difetti e di rimediarvi. In esilio Nevio continuò a comporre. E lasciò
un brutto poema drammatico sulla storia romana, che rivelava in lui un
forsennato patriottismo.
Da quel momento in poi il teatro romano continuò a scopiazzare quello
greco, fino a quando un terzo forestiero venne a dargli un soffio di
originalità. Quinto Ennio era un pugliese di padre italiano e di madre greca.
Aveva studiato a Taranto, dove si rappresentavano i drammi di Euripide, di
cui si era innamorato. Poi era andato a fare il servizio militare, e in Sardegna
aveva attirato per il suo coraggio l'attenzione di Catone, ch'era lì come
questore, e se lo portò dietro a Roma. I suoi Annali, una storia epica di
Roma, da Enea alle guerre puniche, furono, fino a Virgilio, il poema
nazionale dell'Urbe. Ma la sua passione era il teatro, per il quale scrisse una
trentina di tragedie, prendendo di petto soprattutto lo zelo dei bigotti. Ed
ecco, in bocca a un suo protagonista, le sue convinzioni religiose:
« Vi assicuro, amici, che gli dèi ci sono, ma s'infischiano di ciò che
fanno i mortali. Come spieghereste altrimenti che il bene non sia sempre
ripagato col bene e il male col male?». Cicerone, che riporta questa frase in
cui trapelano già le teorie di Epicuro, e dice di averla sentita declamare con
le sue orecchie, assicura ch'essa fu a lungo e sonoramente applaudita dalla
platea.
Ennio consigliò i suoi seguaci a fare, nelle commedie, un po' di filosofia,
ma non troppo. Sfortunatamente fu il primo a non tener conto di questa
saggia massima, volle scrivere drammi "di pensiero", come si dice oggi; e il
pubblico, annoiato, gli volse le spalle per accorrere alle farse di Plauto, che
fu il primo vero commediografo di Roma.
Vi era capitato dall'Umbria dov'era nato nel 254, e già il suo nome
faceva ridere. Tito Maccio Plauto voleva dire: Tito, il pagliaccio dai piedi
piatti. Cominciò come "comparsa", risparmiò un po' di soldi, li investì in un
affare sballato, e li perse. Allora, per mangiare, si mise a scrivere. Dapprima
adattò commedie greche, interpolandovi battute su avvenimenti romani
d'attualità. Ma quando vide che il pubblico soprattutto di questi rideva,
lasciò i modelli forestieri e si diede a comporne di originali, prendendo a
prestito la trama dalla cronaca della città e inaugurando un vero e proprio
teatro "di costume". Fu presto l'idolo del pubblico che amava il suo
buonumore cordiale e la sua grossa risata rabelaisiana. Il suo Miles
gloriosus mandò in delirio la platea. Tutti gli vollero bene, e da lui
accettarono anche l'Amphitrion, che conteneva quell'irriverente satira a
Giove, presentato come un volgare dongiovanni che, per sedurre Alcmena,
si spacciava per suo marito e invocava se stesso offrendosi sacrifici.
L'anno in cui Plauto morì, nel 184, giunse a Roma come schiavo
Terenzio, un cartaginese, ch'ebbe la ventura di capitare nella casa di Terenzio Lucano, un senatore colto e affabile che scoprì il talento del suo servo
e lo liberò. Terenzio, che in origine si chiamava Publio Afro, per gratitudine
ne prese il nome. Quand'ebbe scritta la prima commedia, Andria, andò a
leggerla a Cecilio Stazio, autore già affermato e che in quel momento
furoreggiava, ma di cui non è rimasto nulla. Svetonio racconta che Stazio
rimase così colpito che invitò a colazione il suo visitatore, sebbene questi
fosse vestito come un mendicante. Terenzio frequentò i salotti e diventò di
moda nelle classi alte, ma non raggiunse mai la popolarità di Plauto. La sua
seconda commedia, Hecyra, cadde, perché il pubblico abbandonò in massa
la platea quando seppe che al Circo era cominciato il combattimento di un
gladiatore contro un orso. La fortuna gli sorrise con l'Eunuco che in due
spettacoli dati lo stesso giorno gli procurò ottomila sesterzi, circa quattro
milioni di lire. A Roma si mormorava che il vero autore di questi lavori
fosse Lelio, il fratello di Scipione, grande amico e protettore di Terenzio. Il
quale, con molto tatto, non smentì né confermò mai questo pettegolezzo. E
forse appunto per sottrarvisi, decise di partire per la Grecia. Non tornò più.
Sulla via del ritorno, una malattia lo uccise in Arcadia.
Gli ambienti intellettuali e sofisticati di allora ebbero per Terenzio la
stessa passione che quelli francesi di oggi hanno avuto per Gide. Cicerone lo
definì "il più squisito poeta della repubblica". Cesare, che di letteratura se
n'intendeva ed era più schietto, lo considerava un perfetto stilista, ma un
dimidiatus Menander, un Menandro dimezzato, sulla scena. Effettivamente
le sue commedie non cadono mai nelle grossolanità di Plauto. I loro
personaggi sono più complessi e sfumati, il loro dialogo più raccolto e ricco
di sottintesi. Ma purtroppo è svolto in una lingua che non è più quella del
popolo: il quale sentì l'artificio. E lo fischiò.
Questo popolo ora andava a teatro sempre più numeroso, anche perché
non si pagava biglietto d'ingresso. I locali erano rudimentali, e si
approntavano soltanto in occasione delle feste, dopo le quali venivano
rimossi. Consistevano di un'intravatura di legno che sorreggeva il palcoscenico, davanti al quale c'era una "orchestra" circolare per i balletti che
accompagnavano lo spettacolo. Gli spettatori stavano parte in piedi, parte
sdraiati per terra, parte seduti su trespoli che si portavano da casa. Solo nel
145 fu costruito un teatro stabile, di legno anch'esso e senza tetto, ma con
sedili fissi disposti circolarmente, torno torn-+o il palcoscenico, secondo lo
stile greco. Tutti vi erano ammessi: anche gli schiavi, che però non potevano
sedere, e le donne, confinate tuttavia in fondo.
Nei prologhi che l'attore recitava prima che il sipario si alzasse, si
trovano raccomandazioni alle mamme di soffiare il naso ai loro bambini
prima dell'inizio dello spettacolo, o di ricondurre a casa quelli che
frignavano. Doveva trattarsi di platee rumorose e indisciplinate, che
interrompevano di frequente la recitazione con battute mordaci e frizzi
grossolani e che spesso non si accorgevano nemmeno quando finiva lo
spettacolo, il quale infatti si concludeva con un nunc plaudite omnes, cioè
con un invito all'applauso.
Gli attori erano in genere schiavi greci, meno il protagonista che poteva
essere un cittadino romano. Il quale però, dandosi a quella carriera, perdeva
i suoi diritti politici, come accadeva in Francia fino al Seicento. Erano gli
uomini a interpretare anche le parti femminili. Essi, finché il pubblico fu
limitato, si contentarono di una sommaria truccatura. Ma quando le platee
diventarono, nell'ultimo secolo prima di Cristo, strabocchevoli, fu
introdotto, per distinguere i caratteri, l'uso delle maschere che si chiamavano
personae dall'etrusco phersu. Sicché dramatis personae significa
letteralmente "maschere del dramma". Gli attori che le incarnavano, quando
si trattava di tragedia, portavano i coturni, ch'erano le scarpe a stivaletto;
quando si trattava di commedia, portavano il soccus, cioè la scarpa bassa.
Anche allora, come oggi, ci furono continui conflitti tra il gusto del
pubblico e la censura, che sorvegliava attentamente la produzione. Era stato
in base a una legge delle Dodici Tavole, la quale proibiva la satira politica e
prevedeva persino la pena di morte, che il povero Nevio era stato bandito e,
per non seguirne la sorte, i suoi successori avevano preso tutto a prestito
dalla Grecia: scene, caratteri, situazioni, costumi, e perfino i nomi delle
monete. I criteri cui s'ispirava questa poliziesca censura erano, come sempre, burocratici e ottusi. Essi consentivano qualunque oscenità, purché non
si accennassero critiche al governo e ai cittadini in vista.
Per fortuna gli edili, che approntavano questi spettacoli per piacere alla
massa e guadagnarsene i voti, erano sempre dalla parte degli autori e li
proteggevano. Plauto dovette averne dalla sua uno molto potente per
permettersi tutto quello che si permise. Se non fosse stato per lui, il teatro
romano non sarebbe nemmeno nato. Sarebbe rimasto un'imitazione di quello
greco e noi non vi troveremmo quello specchio di una società che invece,
bene o male, ci ha fornito.
Ma questo allentamento di freni avvenne soprattutto perché spirava in
aria un vento di "libero pensiero". Lo avevano portato i "grèculi", come li
chiamavano per dileggio i romani, un dileggio che non impediva loro di
prenderseli per maestri. Prigionieri di guerra importati di laggiù in
condizione di ostaggi e di schiavi, furono infatti i primi grammatici, retori e
filosofi, che aprirono scuole a Roma. Il Senato, nel 172, scoprì fra essi due
seguaci di Epicuro, e li bandì. Pochi anni dopo Cratete di Mallo, direttore
della Libreria di stato di Pergamo e capo della scuola stoica, venne a Roma
come ambasciatore, si ruppe una gamba, e, in attesa di guarire, si diede a far
conferenze. Nel 155 Atene mandò in missione diplomatica tre filosofi (non
aveva più che quelli, oramai): Cameade il platonico, Critolao l'aristotelico, e
Diogene lo stoico. Anch'essi tennero conferenze, e Catone, quando sentì
affermare da Cameade che gli dèi non esistevano e che giustizia e ingiustizia
non erano che convenzioni, corse in Senato e chiese il rimpatrio dei tre
ateniesi.
L'ottenne, ma serviva poco, visto che il pensiero e la cultura greci erano
patrocinati da molti degli stessi romani, e fra i più influenti, che li avevano
già assorbiti. Flaminino aveva in casa una galleria piena di statue di
Policleto, Fidia, Scopa e Prassitele. Emilio Paolo, dal bottino fatto a spese di
Perseo, aveva prelevato la biblioteca del re, e su quella educava i figli. Il più
giovane di essi, quando egli morì, fu adottato da Cornelio Scipione, figlio
dell'Africano. Ne prese il nome, e come Publio Cornelio Scipione Emiliano
emulò il nonno distruggendo Cartagine e diventò il capo di quella potente
casata convertendola tutta all'ellenismo. Bello e ricco com'era, di maniere
affabili, d'intelligenza pronta e d'incorruttibile onestà (morendo, lasciò
soltanto trentatré libbre d'argento e due d'oro), era particolarmente indicato
per diventare l'idolo dei salotti che in quel momento cominciavano a pullulare. Polibio visse per anni ospite in casa sua, dove capitava
quotidianamente anche Panezio, altro greco di Rodi, di sangue aristocratico
e di scuola stoica. Il suo libro Dei doveri, che Scipione probabilmente
suggerì e ispirò, fu il testo su cui si formò la "gioventù dorata" di Roma. A
differenza di quelli antichi, i nuovi stoici non predicavano la virtù assoluta e
non invocavano una completa indifferenza alla fortuna e alla sfortuna. Essi
volevano soltanto proporre un surrogato, pieno di compromessi ma decente,
a una fede che ormai non sorreggeva più il costume di Roma. Era
l'indulgenza che si sostituiva al severo puritanismo di un tempo.
Il salotto di Scipione ebbe un'influenza enorme. Vi fecero spicco, oltre a
Flaminino, Gaio Lucilio e Gaio Lelio, la cui fraternità col padrone di casa
ispirò a Cicerone il libro De amicitia. Vi si dibattevano idee alate. Ci si
entusiasmava per il Bello. Vi erano d'obbligo modi raffinati, idee originali e
preziose, e soprattutto una lingua pulita, lustra, senz'accento: una lingua che
poi, in mano a Catullo, il quale frequentò quegli ambienti, diventò quella
letteraria e colta di Roma, ma che, in bocca ai personaggi di Terenzio, il
pubblico fischiò perché la sentiva artificiale e lontana dalla sua.
CAPITOLO TERZO
I GRACCHI
Fu in uno di questi salotti che si preparò la rivoluzione. La quale,
contrariamente a quel che si crede, non nasce mai nelle classi proletarie, che
poi le prestano la mano d'opera; ma in quelle alte, aristocratiche e borghesi,
che poi ne fanno le spese. Essa è sempre, più o meno, una forma di suicidio.
Una classe non si elimina che quando si è già eliminata da sé.
Cornelia, figlia di Scipione l'Africano, aveva sposato Tiberio Sempronio
Gracco, il tribuno che aveva posto il veto alla condanna di Lucio, il fratello
dell'eroe di Zama. Era stata una manifestazione di nepotismo a rovescio
perché, ciò facendo, egli aveva salvato in sostanza lo zio di sua moglie. Ma,
nonostante questa comprensibile debolezza, Sempronio aveva seguitato a
godere fama d'integrità, e la meritava. Eletto censore, e poi per due volte
console, aveva amministrato la Spagna con criteri liberali e metodi
illuminati. Da Cornelia aveva avuto dodici figli, di cui nove erano morti in
giovane età. Quando a sua volta egli morì, a Cornelia ne restavano tre soli:
due maschi, Tiberio e Caio, e una femmina, Cornelia, non si sa se nata
deforme, o diventata tale per paralisi infantile.
Mamma Cornelia fu una vedova esemplare e una grande educatrice.
Doveva essere anche belloccia perché, a quel che dice Plutarco, un re
egiziano la chiese in sposa. Essa rispose orgogliosamente che preferiva
restare la figlia di uno Scipione, la suocera di un altro e la madre dei
Gracchi. In quel momento infatti la seconda Cornelia aveva già sposato il
distruttore di Cartagine. Non era stato, a quanto pare, un matrimonio
d'amore, ma solo di convenienza, come si usava farne in quella società di
famiglie e di dinastie per rinsaldarne le alleanze.
Ma Cornelia era anche qualcosa che a Roma non si era visto mai sino ad
allora: una grande "intellettuale" e una squisita maitresse de maison. Il suo
salotto, dove si riunivano le più illustri personalità della politica, delle arti e
della filosofia, somigliava a quelli di certe signore francesi del Settecento e
assolse press'a poco le stesse funzioni. Vi dominava, anche per ragioni di
parentela, il cosiddetto "circolo degli Scipioni" con Lelio, Flaminino,
Polibio, Gaio Lucilio, Muzio Scevola, Metello il Macedonico. Era quanto di
meglio ci fosse in Roma a quel tempo, per sangue, per intelligenza, per
esperienza. Ma come diversi erano questi nuovi leaders dai loro babbi e
nonni! Intanto, accettavano come ispiratrice una donna. Poi, si facevano il
bagno tutti i giorni, tenendo molto ai vestiti, e non erano affatto convinti che
Roma dovesse dare lezioni al mondo. Anzi, erano persuasi del contrario:
cioè che dovesse andare a scuola. Alla scuola della Grecia.
I discorsi che si tenevano in questo salotto non erano rivoluzionari, ma
"progressisti" sì. Dovevano somigliare vagamente a quelli che oggi si
tengono fra "liberali di sinistra", radicali e azionisti. E siccome erano tutte
persone che avevano le mani in pasta, sapevano quel che dicevano, e quel
che dicevano aveva poi un'eco anche al Senato e al governo.
La situazione di Roma effettivamente non era allegra, e autorizzava le
più ampie critiche e le più nere previsioni. L'Urbe digeriva male l'immenso
impero che con tanta rapidità aveva divorato. Il grano della Sicilia, della
Sardegna, della Spagna e dell'Africa, riversato sui suoi mercati a basso
prezzo perché prodotto a basso costo col gratuito lavoro degli schiavi, stava
conducendo alla rovina economica quell'Italia rustica di coltivatori diretti,
piccoli e medi proprietari, che aveva costituito il miglior baluardo contro
Annibale e fornito i migliori soldati per batterlo. Incapaci di reggere alla
concorrenza, essi stavano vendendo le loro modeste fattorie che venivano
assorbite nei latifondi. Una legge del 220, che proibiva il commercio ai
senatori, li obbligava ad investire nell'agricoltura i capitali che avevano
accumulato col bottino di guerra. E molta parte delle terre requisite al
nemico venivano concesse a speculatori in restituzione del denaro ch'essi
avevano prestato allo stato. Ma né questi speculatori né i senatori erano più
gentiluomini di campagna. Abituati a vivere in città, fra i suoi comodi e le
sue mollezze, fra la politica e gli affari, non intendevano abbandonarla per
tornare alla vita semplice e frugale dei loro stoici antenati. Così facevano
quello che ancor oggi fanno certi baroni dell'Italia meridionale: acquistato
un latifondo, lo davano in appalto a un amministratore che, col lavoro
gratuito degli schiavi, cercava di farlo rendere il più possibile, per il padrone
e per sé, sfruttando al massimo la fatica degli uomini e le risorse del suolo,
senza pensare al domani.
Su questa crisi economica se ne innestava un'altra, sociale e morale:
quella di una società che, abituata a basarsi sui suoi piccoli e liberi
coltivatori, sempre più ora veniva affidandosi al saccheggio all'esterno e alla
schiavitù all'interno. Di schiavi, quello che si riversava a Roma era un
torrente senza pause. Quarantamila sardi vi furono importati d'un colpo solo
nel 177, centocinquantamila epiroti dieci anni dopo. I "grossisti" di questa
merce umana andavano a incettarla dietro le legioni che la procuravano e
che ormai erano giunte, sulla catastrofe degl'imperi greci e macedoni, in
Asia, sul Danubio e fino ai confini della Russia. Ce n'era tale abbondanza
che transazioni di diecimila capi alla volta erano normali sul mercato
intercontinentale di Delo; e il prezzo scendeva fino a cinquecento lire l'uno.
In città, erano gli schiavi oramai che fornivano la mano d'opera nelle
botteghe degli artigiani, negli uffici, nelle banche, nelle fabbriche,
condannando alla disoccupazione e all'indigenza i cittadini che prima vi
avevano trovato impiego. I rapporti con gl'imprenditori variavano secondo il
temperamento di questi ultimi. C'era chi, sebbene verso lo schiavo non fosse
tenuto a nulla, cercava di trattarlo umanamente. Ma la legge economica dei
prezzi e della concorrenza poneva un limite a queste umane disposizioni.
Essa voleva che si esigesse sempre di più e si concedesse sempre di meno.
In campagna, la miseria dello schiavo era ancora più marcata dai tempi
in cui esso era una merce rara, e, assunto in casa, finiva col farne parte come
un parente povero. La modestia delle proprietà e la scarsezza di braccia da
lavoro rendevano dirette e umane le relazioni col padrone. Ma nei latifondi,
dove gli schiavi erano ingaggiati a torme, il padrone non si faceva vedere, e
al suo posto c'era un aguzzino scelto fra le peggiori canaglie, che cercava di
risparmiare anche l'impossibile sul cibo e sui cenci, ch'erano l'unico salario
dovuto a quegli sciagurati. I quali, se disobbedivano o si lamentavano,
venivano caricati di catene e gettati in un ergastolo sottoterra.
Nel 196 c'era stata una loro ribellione in Etruria. Furono tutti uccisi dalle
legioni, e molti crocefissi. Dieci anni dopo un'altra rivolta scoppiò in
Apulia: i pochi che sopravvissero alla repressione furono internati in
miniera. Nel 139 scoppiò una vera e propria guerra "servile", capeggiata da
Euno, che massacrò la popolazione di Enna, occupò Agrigento, e in breve,
con un esercito di settantamila uomini, tutti schiavi ribellati, s'impadronì di
quasi tutta la Sicilia, sconfiggendo anche un esercito romano. Si dovette
faticare sei anni per venirne a capo. Ma il castigo fu, come sempre, adeguato
agli sforzi.
Proprio in quell'anno 133 avanti Cristo, Tiberio Gracco, il figlio di
Sempronio e di Cornelia, venne eletto tribuno.
Nel salotto di sua madre, egli era cresciuto con idee radicali, che gli
erano state ribadite in testa dal suo precettore Blossio, un filosofo greco di
Cuma. E all'età in cui si pensa alle ragazze, egli già non pensava che alla
politica. Era quello che si suol dire un "idealista". Ma sino a che punto le
sue idee, ch'erano eccellenti, fossero al servizio della sua ambizione, ch'era
grandissima, o viceversa, lo ignorava egli stesso, come d'altronde capita a
tutti gl'idealisti. La situazione del paese la conosceva un po' perché nel
salotto se n'era sempre parlato, e con grande competenza; un po' perché, a
quel che ci ha detto suo fratello, era andato personalmente a studiarsela in
Etruria e n'era rimasto inorridito. Egli comprese che l'Italia correva alla
rovina se la sua agricoltura cadeva definitivamente in mano agli speculatori
e agli schiavi, e che in Roma stessa nessuna sana democrazia poteva
trionfare con un proletariato che giornalmente si corrompeva nell'ozio e coi
sussidi.
L'unico rimedio da opporre allo schiavismo, all'urbanesimo e alla
decadenza militare, gli parve un'audace riforma agraria che, appena eletto,
propose all'Assemblea. Essa consisteva di tre proposte: 1) Nessun cittadino
doveva possedere più di centoventicinque ettari dell'Agro pubblico, che
potevano diventare duecentocinquanta solo se aveva due figli o più. 2) Tutte
le terre distribuite o affittate dallo stato dovevano essergli restituite allo
stesso prezzo, più un rimborso per gli eventuali miglioramenti apportativi.
3) Esse dovevano essere divise e ridistribuite fra i cittadini poveri in lotti di
cinque o sei ettari ognuno, con impegno a non venderli e a pagarvi sopra
una modesta tassa.
Erano proposte ragionevoli e in piena coerenza con le Leggi Licinie che
già oltre due secoli prima erano state approvate. Ma Tiberio ebbe il torto di
condirle di un'oratoria demagogica e barricadiera che, oltre a tutto, stonava
con la sua condizione sociale. Perché questi "progressisti", di alta
estrazione, nobile o borghese che fosse, non sapevano sfuggire, allora come
ora, a una contraddizione fra abitudini di vita raffinate e sofisticate e
atteggiamenti politici populisti e piazzaioli. « I nostri generali», egli disse
parlando dal Rostro, «v'incitano a combattere per i templi e le tombe dei
vostri antenati. Ozioso e falso appello. Voi non avete paterni altari. Voi non
avete tombe ancestrali. Voi non avete nulla. Voi combattete e morite solo
per procurare lusso e ricchezza agli altri».
Era detto bene perché, per disgrazia, Tiberio era anche un eccellente
oratore. Ma c'erano gli estremi del sabotaggio. Il Senato proclamò illegali le
proposte, ne accusò l'autore di ambizioni dittatoriali e persuase Ottavio,
l'altro tribuno, a opporvi il veto. Tiberio rispose con un progetto di legge per
cui un tribuno, quando agiva contro la volontà del Parlamento, doveva
essere immediatamente deposto. L'Assemblea approvò la proposta, e i littori
di Tiberio scacciarono a forza Ottavio dal suo banco. Poi il progetto di legge
fu votato, e l'Assemblea, temendo per la vita di Gracco, lo scortò fino a
casa.
Abbiamo l'impressione ch'egli non vi sia stato accolto quel giorno
dall'unanime entusiasmo che forse s'aspettava. Forse Cornelia sola seguitò a
riconoscerlo uno dei suoi "gioielli", come un giorno aveva definito lui e
Caio. Gli altri dovevano essere un po' scossi non tanto dalla legge che aveva
imposto e che corrispondeva in pieno alle vedute politiche e sociali del
"salotto", quanto dai mezzi incostituzionali che aveva usato contro Ottavio.
Ma furono certamente scandalizzati e gli tolsero la loro solidarietà quando,
contro una precisa norma che lo vietava, Tiberio si portò nuovamente in
lizza per il tribunato.
Fu obbligato a farlo perché il Senato minacciava, appena scaduto di
carica, di processarlo. Ma era un gesto di ribellione. Abbandonato così dai
suoi stessi amici di casa, Tiberio accentuò ancora di più la sterzata la sinistra
per guadagnarsi i favori della plebe. Promise, se rieletto, di abbreviare il
servizio militare, di abolire il monopolio dei senatori nelle giurie dei
tribunali e, siccome in quel momento Attalo III di Pergamo moriva
lasciando il suo reame a Roma, propose di venderne la proprietà mobiliare
per aiutare col ricavato i contadini ad attrezzare i loro poderi. E qui scantonò
nella demagogia pura, fornendo validi argomenti all'avversario.
Il giorno delle elezioni, Tiberio apparve nel Foro con una guardia armata
e vestito a lutto per dare ad intendere che la bocciatura significava per lui la
condanna a morte. Ma mentre si votava, irruppe un gruppo di senatori coi
manganelli in mano, guidati da Scipione Nasica. Il prestigio di cui ancora il
Senato godeva e che Gracco aveva scioccamente trascurato, è dimostrato dal
fatto che dinanzi a quelle toghe patrizie gli amici di Tiberio cedettero
rispettosamente il passo lasciandolo solo. Fu ucciso con una mazzata sulla
nuca. E il suo corpo, insieme con quello di alcune centinaia di sostenitori,
venne gettato nel Tevere.
Suo fratello Caio chiese il permesso di ripescarlo e di dargli sepoltura.
Glielo negarono.
Questo avvenne nel 132. Nove anni dopo, cioè nel 123, il secondo dei
"gioielli" di Cornelia aveva preso il posto del fratello come tribuno. Lo
conosciamo meglio e lo stimiamo di più, perché ci sembra d'intelligenza più
realistica del fratello, e anche più sincero. Era stato anche lui un magnifico
oratore: Cicerone lo considerava il più grande (dopo di lui, s'intende); aveva
militato coraggiosamente sotto suo cognato Scipione Emiliano a Numanzia,
e aveva un gran controllo di sé. Infatti andò per gradi, senza voler strafare
sin dal primo momento.
In quei nove anni le Leggi Agrarie di Tiberio che, dopo averne ucciso
l'autore, il Senato non osò abrogare, avevano dato i loro buoni frutti,
nonostante l'applicazione avesse urtato contro molte difficoltà pratiche,
L'anagrafe registrava ottantamila nuovi cittadini, che lo erano diventati
appunto perché avevano avuto un lotto di terra. Ma molte proteste si erano
levate dai vecchi proprietari che non volevano né scorporo né confisca e che
affidarono la loro causa a Scipione l'Emiliano. Non si sa perché costui
accettasse la difesa di quegl'interessi che erano contrari alle sue idee. Ma
forse, a fargliene assumere il patronato, furono proprio le ragioni di famiglia
per le quali avrebbe dovuto astenersene. I suoi rapporti con la moglie
Cornelia erano andati sempre peggiorando. E una mattina del 129 fu trovato
assassinato nel suo letto. Chi lo avesse ucciso, non si è mai saputo; ma
naturalmente i pettegolezzi delle case aristocratiche, dov'erano odiate, incri-
minavano la sposa e la suocera.
Cresciuto in mezzo a tante sciagure e in una casa ormai disertata anche
dai più intimi amici, Caio condusse avanti con cautela l'applicazione delle
leggi di Tiberio; creò nuove colonie agricole nell'Italia del Sud e in Africa;
si guadagnò i soldati stabilendo ch'essi fossero d'ora in poi equipaggiati a
spese dello stato; fissò al grano un "prezzo politico", ch'era la metà di quello
di mercato. E con quest'ultima misura, che fu poi l'arma più forte nelle mani
di Mario e di Cesare, ebbe dalla sua tutto il popolino dell'Urbe.
Armato di questi successi, egli potè ripresentarsi al tribunato dell'anno
seguente senza rimetterci la vita, com'era capitato a suo fratello; e vincere.
Allora credette di poter giocare le carte grosse, e qui sbagliò. Egli propose di
aggiungere ai trecento senatori di diritto altri trecento eletti dall'Assemblea e
di estendere la cittadinanza a tutti i non-schiavi del Lazio e a buona parte di
quelli del resto della penisola.
Ma aveva fatto male i conti con gli egoismi del proletariato romano, che
dei confratelli del Lazio e della penisola s'infischiava. Il Senato prontamente
agì, per sfruttare questo errore tattico del suo avversario. Spinse l'altro
tribuno, Livio Druso, a proposte ancora più radicali: che si abolissero le
tasse imposte dalla legge di Tiberio ai nuovi proprietari e che
quarantaduemila nullatenenti di Roma avessero in distribuzione nuove terre
in dodici nuove colonie. Subito l'Assemblea approvò il progetto. E quando
Caio vi fece ritomo, trovò che tutti i favori ormai li aveva monopolizzati
Druso.
Si presentò per una terza elezione, e fu bocciato. I suoi sostenitori
dissero che c'era stata frode, ma egli li consigliò alla moderazione e si
ritrasse a vita privata.
Quando si trattò di far fronte agl'impegni contratti per liquidare Caio, il
Senato si trovò in imbarazzo e tentò di tergiversare. L'Assemblea capì ch'era
un primo passo per il sabotaggio della legislazione dei Gracchi, i cui
simpatizzanti si presentarono alla successiva seduta in armi. Uno di essi fece
a pezzi un conservatore che aveva pronunciato parole di minaccia contro
Caio.
L'indomani i senatori apparvero in tenuta di battaglia, seguito ciascuno
da due schiavi. I gracchisti si trincerarono sull'Aventino, e Caio cercò
d'interporsi per ristabilire la pace. Non riuscendovi, si buttò a nuoto nel
Tevere. Sull'altra riva, quando stava per essere raggiunto dai suoi persecutori, ordinò a un suo servo di ucciderlo. Il servo obbedì. E poi, tratto il
pugnale intriso di sangue dal petto del padrone, lo immerse nel proprio. Un
seguace di Caio mozzò la testa al cadavere, la riempì di piombo e la portò al
Senato, che aveva offerto di compensarne il peso in oro. Intascò la
ricompensa e si rifece una "verginità politica". Il popolino che tanto lo
aveva applaudito, non battè ciglio all'assassinio del suo eroe: era troppo
occupato a saccheggiarne la casa.
Cornelia, la madre di due figli morti ammazzati e di una vedova sospetta
di assassinio, prese il lutto. Il Senato le ordinò di toglierselo.
CAPITOLO QUARTO
MARIO
Caio vennero uccisi duecentocinquanta suoi sostenitori e altri
tremila furono arrestati. Parve, lì per lì , che i conservatori avessero partita
vinta, e ci si aspettò una radicale repressione. Ma essa non venne. Il Senato
accantonò la riforma agraria, ma non toccò il calmiere del grano né tentò di
ripristinare il monopolio dell'aristocrazia nelle giurie dei tribunali. Capiva
che, malgrado quella momentanea vittoria, la situazione non consentiva
radicali restaurazioni.
Per qualche anno si visse alla giornata senza sostituire nessun rimedio a
quello che i Gracchi avevano tentato, sia pure prematuramente e
commettendo molti errori tattici. Con la scusa di favorire ancora di più i
nuovi piccoli proprietari creati dalle leggi agrarie, si consentì loro di vendere
le terre avute in assegnazione. Essi, rimasti senz'aiuto, lo fecero. E i
latifondi si riformarono, sulla solita base del lavoro servile. Appiano, ch'era
un democratico dei più moderati, riconosceva in quegli anni che in tutta
Roma ci saranno stati sì e no duemila proprietari. Tutti gli altri erano
nullatenenti, e la loro condizione peggiorava di giorno in giorno.
A dare il tracollo e a fornire il pretesto della grande rivolta fu il
cosiddetto "scandalo d'Africa" che cominciò nel 112. Micipsa, succeduto a
Massinissa sul trono di Numidia, e morto sei anni prima, aveva lasciato
Giugurta, suo figlio naturale, reggente e tutore dei suoi due legittimi eredi
ancora minorenni. Giugurta ne uccise uno e si mise in guerra con l'altro che
chiese aiuto all'Urbe, protettrice di quel reame. L'Urbe mandò una
commissione d'inchiesta, che Giugurta comprò con una lauta mancia.
Chiamato a Roma, corruppe i senatori che dovevano giudicarlo. E insomma
si dovette aspettare l'elezione a console di Quinto Metello, ch'era un
mediocre galantuomo, per vedere un generale disposto a far la guerra
all'usurpatore e a respingere le "bustarelle".
Sebbene a quei tempi i giornali non ci fossero, la gente era ugualmente
informata e conosceva benissimo i fatti e i loro retroscena. L'odio che
covava contro l'aristocrazia dal giorno dell'uccisione dei Gracchi, scoppiò
violento quando si seppe che Metello, pur essendo fra i migliori, si
opponeva all'elezione al consolato di Caio Mario, un suo luogotenente, solo
perché non era aristocratico. E, senza neanche sapere con esattezza chi
CON
fosse, l'assemblea votò compatta per costui e gli affidò il comando delle
legioni. Perché a Roma si diceva in quel momento quello che dovunque e in
tutt'i tempi si dice, quando la democrazia entra in agonia: «Ci vuole un uomo...».
E per caso, con quella scelta, lo trovò. Mario era un personaggio
all'antica, come ormai se ne incontrava solo in provincia. Era nato infatti ad
Arpino, come Cicerone, figlio di un povero bracciante, e per università
aveva avuto la caserma, dove si era arruolato giovanissimo. Si era
guadagnato i gradi, le medaglie e le cicatrici che tatuavano il suo corpo
all'assedio di Numanzia. Tornando, aveva fatto un buon matrimonio. Aveva
sposato una Giulia, sorella di un Caio Giulio Cesare, che come famiglia non
era nulla di eccezionale perché apparteneva soltanto alla piccola aristocrazia
terriera, ma che aveva già per figlio un altro Caio Giulio Cesare, destinato a
far parlare di sé per millenni. In grazia delle sue gesta militari, Mario era
stato eletto tribuno. Ed egli ne aveva approfittato non per fare politica e
mostrarvi tutta la sua incapacità, ma per tornare con accresciuti poteri alla
testa dei suoi soldati, sotto il comando di Metello. Costui traccheggiava
nella guerra giugurtina. E quando seppe che il suo sottoposto voleva andare
a Roma per concorrere al consolato, se ne scandalizzò come di una pretesa
fuori di luogo per un povero contadino come lui: il consolato, è vero, era
aperto anche ai plebei, ma soltanto in teoria...
Mario, ch'era suscettibile e rancoroso, si offese. E, una volta eletto,
reclamò il posto di Metello, che dovette cederglielo. La guerra prese subito
un altro ritmo. In pochi mesi Giugurta fu costretto ad arrendersi e adornò il
carro del vincitore, che a Roma fu gratificato con un superbo trionfo dal
popolo che vedeva in lui il suo campione. Questo popolo non sapeva che il
colpo decisivo all'usurpatore di Numidia lo aveva dato non Mario, ma un
suo questore di nome Silla, ch'era un po' rispetto a Mario proprio quello che
Mario era stato rispetto a Metello.
Per il momento tuttavia era Mario l'eroe della città che, ignorando una
Costituzione ormai agli sgoccioli e ravvisando in lui "l'uomo che ci voleva",
gli riconfermò per sei anni di seguito il consolato. Infatti il pericolo esterno
non era finito con Giugurta, anzi incombeva più grave di prima per via dei
galli tornati in massa all'offensiva. Cimbri e teutoni si erano rifatti vivi, più
numerosi e aggressivi che mai, rotolando come una valanga dalla Germania
alla Francia. Un esercito romano che li incontrò in Carinzia era stato
distrutto. Poi ne distrussero un secondo sul Reno, e un terzo e un quarto,
finché il Senato ne mandò un quinto agli ordini di due aristocratici, Servilio
Cepione e Manlio Massimo. I quali non seppero far di meglio che litigare
fra loro, per gelosia, e ognuno disfare quel che l'altro faceva. A Orange
ottantamila legionari, il prestigio dell'aristocrazia donde quegli inetti
generali venivano e quarantamila ausiliari rimasero sul terreno. E Roma
trattenne il fiato nel terrore di vedersi venire addosso quelle orde. Grazie a
Dio, invece delle Alpi, esse scavalcarono i Pirenei per mettere a sacco la
Spagna. E quando tornarono sui loro passi per assalire l'Italia, Mario,
console da quattro anni, era pronto a riceverli.
Egli aveva preparato un nuovo esercito, che costituì la sua vera grande
rivoluzione, quella che poi fornì le armi a suo nipote Cesare. Aveva capito
che non c'era più da fare assegnamento sui cittadini che si chiamavano "atti
alle armi" solo perché, iscritti a una delle cinque classi, erano tenuti al
servizio militare, ma non volevano prestarlo. E si rivolse agli altri, ai
nullatenenti, ai disperati, attirandoli con una buona paga e con la promessa
di bottino e di lauta assegnazione di terre dopo la vittoria. Era la sostituzione
di un esercito mercenario a quello nazionale: operazione rischiosa e, alla
lunga, catastrofica, ma resa necessaria dal decadimento della società
romana.
Egli condusse le sue proletarie reclute, inquadrate da sottufficiali
veterani, al di là delle Alpi. Le indurì con le marce. Le allenò alla battaglia
con scaramucce su obbiettivi minori. E alla fine fece loro costruire un
campo trincerato nei pressi di Aix in Provenza, punto di passaggio obbligato
per i teutoni.
Costoro vi sfilarono accanto per sei giorni di seguito, tanto erano
numerosi, e derisoriamente chiesero ai soldati romani di sentinella sugli
spalti se avevano messaggi per le loro mogli in patria. Erano rimasti quelli
di tre secoli prima: alti, biondi, fortissimi, coraggiosissimi, ma senza nessuna nozione di strategia, altrimenti non si sarebbero lasciati alle terga quel
po' po' di nemico. E infatti la pagarono cara. Dopo poche ore, Mario piombò
alle loro spalle, e ne sterminò centomila. Plutarco dice che gli abitanti di
Marsiglia drizzarono palizzate con gli scheletri e che, concimate da tanti
cadaveri, le terre diedero quell'anno un raccolto mai visto.
Dopo quella vittoria, Mario rientrò in Italia e attese i cimbri presso
Vercelli, là dove Annibale aveva guadagnato il suo primo successo. Come i
loro fratelli teutoni, anche costoro mostrarono più coraggio che cervello.
Avanzarono baldanzosamente nudi nella neve, e si servirono dei loro scudi
come slitte per scivolare sui romani lungo i pendii ghiacciati, gaiamente
schiamazzando, come se si fosse trattato d'un'esercitazione sportiva. Anche
lì, come a Aix, più che una battaglia, fu un mostruoso macello.
A Roma, Mario fu accolto come un "secondo Camillo". E, in segno dì
gratitudine, gli regalarono tutto il bottino catturato al nemico. Così egli
diventò ricchissimo, proprietario di terre "grandi come un reame". E per la
sesta volta consecutiva lo elessero console.
Nel giuoco della politica, che per la prima volta ora gli toccava di
affrontare, l'eroe, come spesso capita agli eroi, si mostrò meno illuminato
che nel maneggio delle legioni. Egli aveva fatto ai suoi soldati delle
promesse che ora bisognava mantenere. E per mantenerle, dovette far lega
con i capi del partito popolare: Saturnino, tribuno della plebe, e Glaucia,
pretore. Erano due canaglie, espertissimi in tutti i raggiri parlamentari, che,
all'ombra del popolarissimo Mario, volevano semplicemente fare i loro
affari. Le terre furono effettivamente distribuite in applicazione delle leggi
dei Gracchi; ma nello stesso tempo, per guadagnar voti al loro partito, il
calmiere del grano, già bassissimo, fu ancora ridotto di nove decimi. Era una
misura assurda che metteva in pericolo il bilancio dello stato. I più moderati
fra gli stessi popolari esitarono, il Senato persuase un tribuno a porre il veto,
ma Saturnino, contro la Costituzione, presentò ugualmente la legge. Ci
furono incidenti. Per il consolato dell'anno 99, candidati per fare da collega
a Mario si portarono Glaucia per i popolari e Caio Memmio, uno dei pochi
aristocratici tuttora rispettati, per i conservatori. Questi venne assassinato
dalle bande di Saturnino. E allora il Senato, ricorrendo alla misura di
emergenza del senatoconsulto per la difesa dello stato, ordinò a Mario di
fare giustizia e di ristabilire l'ordine. Mario esitò. Non faceva altro, del resto,
da quando si era cacciato nella politica. Era invecchiato, ingrassato, e
beveva molto. Ora si trattava di scegliere fra un'aperta ribellione e la
liquidazione dei suoi amici. Scelse la seconda strada, e lasciò che Saturnino,
Glaucia e i loro seguaci venissero lapidati a morte dai conservatori che per
l'occasione egli stesso capeggiò. Poi, sapendo ormai di essere inviso a tutti,
all'aristocrazia che vedeva in lui un infido alleato, e alla plebe che vedeva in
lui un traditore sicuro, si ritirò pieno di rancore e partì per un viaggio in
Oriente.
Non erano trascorsi due anni da quando Roma lo aveva trionfalmente
accolto come un "secondo Camillo". E se egli avesse accettato con un po'
più di filosofia questa ingratitudine, sarebbe passato alla storia con un nome
immacolato. Ma era rozzo, passionale, pieno di ambizioni insoddisfatte, e
più che mai convinto di essere "l'uomo che ci voleva". Per cui, quando gli
avvenimenti lo richiamarono sulla scena, egli vi si ripresentò senza
esitazione alcuna, a rappresentarvi una parte piuttosto ambigua.
Nel 91, Marco Livio Druso fu eletto tribuno. Era un aristocratico, figlio
di colui che si era opposto a Tiberio Gracco, e padre di una ragazza che più
tardi sposerà un certo Ottaviano, destinato a diventare Cesare Augusto. Egli
propose all'assemblea tre riforme fondamentali: distribuire nuove terre fra i
poveri; ridare il monopolio nelle giurie al Senato, ma dopo avervi aggiunto
altri trecento membri; e conferire la cittadinanza romana a tutti gl'italiani
liberi. L'assemblea approvò i primi due progetti. Il terzo non venne in
discussione, perché la mano di un ignoto assassino ne soppresse l'autore.
Subito dopo, tutta la penisola era in armi. Essa seguitava ad essere
trattata, dopo secoli di unione a Roma, come una provincia conquistata. La
si spremeva con le tasse e con le leve militari. La si sottoponeva a leggi
approvate da un Parlamento in cui essa non aveva nessuna rappresentanza. E
il grande sforzo dei prefetti romani nei vari capoluoghi era stato quello di
fomentarvi il contrasto fra ricchi e poveri in modo da tenerli perpetuamente
disuniti. Soltanto qualche milionario aveva ottenuto, brigando e
distribuendo mance, la cittadinanza romana. Ma nel 126 l'assemblea aveva
proibito agl'italiani di provincia di emigrare nell'Urbe, e nel 95 ne aveva
scacciati quelli che c'erano già.
La ribellione si estese in un lampo, salvo in Etruria e Umbria che
rimasero fedeli. E reclutò un esercito, armato più di disperazione che di
lance e di scudi, specialmente fra gli schiavi, che subito unirono le loro sorti
a quelle dei ribelli. Costoro proclamarono una repubblica federale con
capitale a Corfinio, che fece tutt'uno della "guerra sociale" con questa
seconda "guerra servile". Nel panico che si diffuse a Roma, dove nessuno si
faceva illusioni sulla vendetta che quei diseredati dovevano covare verso chi
per tanti secoli li aveva oppressi, risorse il mito di Mario, "l'uomo che ci
voleva". Egli improvvisò un esercito col suo solito sistema, e lo condusse di
vittoria in vittoria, ma senza badare a spese, devastando e massacrando
l'intera penisola. Quando già oltre trecentomila uomini erano caduti da ambo
le parti, il Senato si decise a concedere la cittadinanza agli etruschi e agli
umbri in premio della loro fedeltà, e a tutti coloro ch'erano pronti a giurarla,
per fargli deporre le armi.
La pace che seguì fu quella di un cimitero, e torna poco a gloria di colui
che l'aveva imposta. Per di più Roma tenne la sua parola inglobando i nuovi
cittadini in dieci nuove tribù, che dovevano votare dopo le trentacinque
romane che formavano i comizi tributi: cioè senza nessuna possibilità di
contraddirne i verdetti. Per ottenere i pieni diritti democratici, essi dovettero
aspettare Cesare, cui infatti aprirono con tanto entusiasmo le porte, senza
rendersi conto ch'egli era la fine della democrazia.
Ed ecco l'anno dopo la guerra riprendere: non più "servile", non più
"sociale", ma civile. E stavolta Mario non si limitò ad approfittarne; fu colui
che la provocò, convinto di essere ancora "l'uomo che ci voleva".
Un uomo infatti continuava, purtroppo, a volerci. Ma non era più lui. Era
quello che, anch'essi per caso com'era capitato ai popolari, avevano trovato i
conservatori: l'antico subalterno e questore di Mario in Numidia: Silla.
CAPITOLO QUINTO
SILLA
fu eletto console l'anno 88 avanti Cristo, cioè poco dopo la fine
della rivoluzione sociale e servile che Mario aveva così sanguinosamente
represso. E la scelta, voluta dai conservatori, era un po' fuori della
Costituzione e della consuetudine, in quanto era quella di un uomo che non
aveva seguito un regolare cursus honorum.
Lucio Cornelio Silla veniva dalla piccola e povera aristocrazia, e si era
sempre mostrato refrattario alle due grandi passioni dei suoi contemporanei:
quella per l'uniforme militare, e quella per la toga di magistrato. Aveva
avuto una giovinezza scapestrata. Si era fatto mantenere da una prostituta
greca più anziana di lui, l'aveva tradita e maltrattata. Non si era mai
occupato di politica e di cose serie, forse non aveva fatto nemmeno studi
regolari. Però aveva letto molto, conosceva benissimo la lingua e la
letteratura greca, e aveva un gusto raffinato in cose d'arte.
Le sue qualità di fondo, ch'erano enormi, forse non sarebbero mai
emerse, se, eletto non si sa come questore e assegnato col grado press'a poco
di capitano all'esercito di Mario in Numidia, non si fosse trovato
direttamente implicato nella liquidazione di Giugurta. Fu lui infatti a
persuadere Bocco, il re dei mori, a consegnargli l'usurpatore. Era una
brillante operazione che coronava quelle già compiute con la spada in
pugno. Silla si era mostrato un magnifico comandante, freddo, scaltro,
coraggiosissimo, e di grande ascendente sui soldati. Aveva preso interesse
alla guerra, e ci si divertiva perché implicava il giuoco e il rischio: due cose
che gli erano sempre piaciute. Perciò seguì Mario anche nelle campagne
contro i teutoni e i cimbri, contribuendo potentemente alle sue vittorie.
Rientrato a Roma nel 99 con questi meriti al suo attivo, avrebbe potuto
benissimo concorrere a magistrature più alte. Invece, nulla: si era stufato. E
per quattr'anni si rituffò nella vita di prima fra prostitute, gladiatori del
Circo, poeti maledetti e attori squattrinati. Poi, d'improvviso, si presentò
candidato alla pretura, e fu bocciato. Allora, morso dall'orgoglio che in lui
teneva il posto dell'ambizione, concorse come edile, fu eletto, e incantò i
romani offrendo loro, nell'anfiteatro, lo spettacolo del primo combattimento
SILLA
di leoni. L'anno dipoi naturalmente era pretore; e come tale ebbe il comando
d'una divisione in Cappadocia per rimettere sul trono Ariobarzane,
spodestato da Mitridate. Riportò a Roma, con la vittoria, un grosso bottino.
Ma ancora più grosso pare che fosse quello che si era intascato. Era stanco
di debiti, e preferiva finanziarsi da solo le campagne elettorali, piuttosto che
dipendere da un partito. Infatti non era iscritto a nessuno. Essendo nato
aristocratico, ma povero, nutriva la stessa indifferenza e il medesimo
disprezzo per l'aristocrazia che lo aveva "snobbato" e per la plebe che non lo
considerava dei suoi. Aveva sempre vissuto per se stesso, in compagnia di
gente ai margini. E il suo litigio con Mario non avvenne su questioni
politiche, ma solo perché si era fatto regalare da Bocco un bassorilievo d'oro
in cui era rappresentato il re dei mori che consegnava Giugurta a lui, Silla,
invece che a Mario. Miserie, come si vede.
Al consolato dell'88, Silla si presentò non per fare politica, ma per avere
il comando dell'esercito che si stava allestendo contro Mitridate nella solita
turbolenta provincia dell'Asia Minore, dove già egli aveva combattuto
contro Ariobarzane di Cappadocia. E vinse soprattutto per via di donne. Egli
infatti divorziò, coprendola di regali, dalla sua terza moglie, Delia, per
sposarne una quarta: Cecilia Metella, vedova di Scauro, e figlia di Metello il
Dalmatico, pontefice massimo e principe, cioè presidente, del Senato. Fu per
questa parentela con una delle sue più potenti famiglie, che l'aristocrazia
cominciò a vedere in Silla il proprio campione. E ne favorì l'elezione,
assegnandogli subito dopo l'agognato comando.
Il tribuno Sulpicio Rufo cercò d'invalidare queste nomine e propose
all'assemblea di trasferirle a Mario che, sebbene quasi settantenne, ancora
brigava posti, incarichi e onori. Ma Silla non era uomo disposto a rinunzie.
Corse a Nola, dove l'esercito si stava organizzando. E, invece d'imbarcarlo
per l'Asia Minore, lo condusse su Roma, dove Mario ne aveva improvvisato
un altro per resistergli. Silla vinse facilmente e rapidamente, Mario fuggì in
Africa e Sulpicio fu ucciso da un suo schiavo. Silla ne espose sul Rostro la
testa decapitata, e compensò l'assassino prima liberandolo in cambio del
servigio che aveva reso, eppoi uccidendolo in cambio del tradimento che
aveva compiuto.
Altre rappresaglie, dopo questa prima restaurazione, non ce ne furono, o
ce ne furono poche. Con i suoi trentacinquemila uomini accampati nel Foro,
Silla proclamò che d'ora in poi nessun progetto di legge poteva essere
presentato all'Assemblea senza il preventivo consenso del Senato, e che il
voto nei comizi doveva essere dato per centurie, secondo la vecchia
Costituzione serviana. Poi, dopo essersi fatto confermare il comando
militare col titolo di proconsole, consentì all'elezione di due consoli per il
disbrigo delle faccende in patria: l'aristocratico Cneo Ottavio e il plebeo
Cornelio Cinna. E partì per l'impresa che gli stava a cuore.
Non era ancora in vista delle coste greche, che già Ottavio e Cinna si
azzuffavano. E, dietro di loro, scendevano in lizza per le strade i conservatori, o optimates, da una parte, e i democratici o populares dall'altra. La
guerra sociale e servile di due anni prima sboccava nella guerra civile.
Ottavio vinse e Cinna fuggì, ma in un solo giorno si erano accatastati sui
selciati dell'Urbe oltre diecimila cadaveri.
Mario si affrettò a tornare precipitosamente dall'Africa e a raggiungere
Cinna, che girava in provincia per suscitarvi la rivolta. Melodrammaticamente si presentò con una toga a brandelli, i sandali logori, la barba
lunga, le cicatrici delle ferite bene in vista. E in un battibaleno raccolse un
esercito di seimila uomini, quasi tutti schiavi, con cui marciò sulla capitale,
rimasta ormai senza difesa. Fu un massacro. Ottavio aspettò la morte con
calma, seduto sul suo scranno di console. Le teste dei senatori, issate sulle
picche, furono portate a spasso per le strade. Un tribunale rivoluzionario
condannò migliaia di patrizi alla pena capitale. Silla fu proclamato decaduto
dal comando, tutte le sue proprietà vennero confiscate, tutti i suoi amici
uccisi. Si salvò solo Cecilia perché riuscì a fuggire e a raggiungere il marito
in Grecia. Sotto il nuovo consolato di Mario e Cinna, il terrore continuò
implacabile per un anno. Avvoltoi e cani mangiavano per le strade i
cadaveri, cui si era rifiutata la sepoltura. Gli schiavi liberati seguitarono a
saccheggiare, incendiare e rubare finché Cinna, con un distaccamento di
soldati galli, non li ebbe isolati, circondati e massacrati tutti. Per la prima
volta nella storia di Roma, ci si servì di una truppa forestiera per ristabilire
l'ordine nella città.
Furono queste le ultime gesta di Mario, che morì nel bel mezzo della
carneficina, roso dall'alcool, dai rancori, dai complessi d'inferiorità, dalle
ambizioni deluse che gliel'avevano ispirata. Peccato, per un così grande
capitano che, prima d'immergerla nella guerra civile, aveva tante volte
salvato la patria.
Restava Cinna, ormai praticamente dittatore, perché Valerio Flacco,
eletto al posto di Mario, fu spedito con dodicimila uomini in Oriente per
deporvi Silla.
Tagliato dalla madrepatria, costui stava assediando Atene che si era
alleata con Mitridate, in arrivo dall'Asia con un esercito cinque volte
superiore. Era una situazione quasi disperata, che poteva diventare senza
uscite, se egli si fosse fatto sorprendere sotto le mura della città da Mitridate
e da Flacco contemporaneamente. Ma in Silla, diceva chi lo conosceva,
sonnecchiavano insieme una volpe e un leone, e la volpe era molto più
pericolosa del leone. Un certo numero di "miracoli" da lui provocati ad arte
avevano persuaso i suoi soldati ch'egli fosse un dio e, come tale, infallibile.
Era soltanto, si capisce, un formidabile generale che conosceva
perfettamente gli uomini e i mezzi per sfruttarne, con freddo e lucido
calcolo, la forza e le debolezze. Rimasto senza aiuto di denaro, aveva
procurato la "cinquina" alle sue truppe, lasciando loro saccheggiare
Olimpia, Epidauro e Delfi. Ma sempre, subito dopo, aveva ristabilito la
disciplina. L'imprendibile Atene fu presa con un assalto di sorpresa. E Silla
ne ricompensò i soldati lasciando loro in balìa la città. Non si sa quanta
gente uccisero, dice Plutarco. Ma il sangue corse a fiumi per le strade e
inondò i suburbi.
Dopo giorni e giorni di massacro, Silla che, con tutto il suo amore per la
Grecia, per la sua cultura e per la sua arte, vi aveva assistito con totale
distacco, disse che in nome dei morti bisognava perdonare ai sopravvissuti.
Riordinò le falangi e le condusse contro l'esercito di Mitridate che avanzava
su Cheronea e Orcomeno. Lo battè in una magistrale battaglia, ne incalzò i
resti attraverso l'Ellesponto fin nel cuore dell'Asia. E si preparava ad
annientare definitivamente le ultime forze nemiche, quando Flacco
sopraggiunse con l'ordine di sostituirlo al comando.
I due generali s'incontrarono. E, al termine di quella conversazione,
Flacco non solo aveva rinunziato a eseguire gli ordini, ma si era spontaneamente messo sotto quelli di Silla. Il suo luogotenente Fimbria cercò di
ribellarsi. E allora Silla offrì una vantaggiosa pace a Mitridate, garantendogli il rispetto del suo reame entro i vecchi confini, ed esigendo solo,
per risarcimento, ottanta navi e duemila talenti, con cui pagare la truppa e
ricondurla in patria. Poi mosse verso la Lidia incontro a Fimbria, ma non
ebbe bisogno di batterlo, perché la truppa, appena lo vide, si unì a quella
sua, tale oramai era il prestigio del nome di Silla. E Fimbria, rimasto solo, si
uccise.
Silla tornò sui suoi passi senza trascurare di saccheggiar tesori e di
spremere quattrini in tutte le province in cui passava. Attraversò la Grecia,
imbarcò il suo esercito a Patrasso, e nell'anno 83 arrivò a Brindisi. Cinna,
precipitatoglisi incontro per fermarlo, fu ucciso dai suoi soldati. A Roma
scoppiò la rivoluzione.
Silla portava al governo un bel bottino: quindicimila libbre d'oro e
centomila d'argento. Ma il governo, tuttora in mano ai popolari guidati dal
figlio di Mario, Mario il Giovane, lo proclamò nemico pubblico e gli mandò
incontro un esercito per combatterlo. Molti aristocratici fuggirono dall'Urbe
per unirsi a Silla. Uno di essi, Cneo Pompeo, considerato il più brillante
campione della "gioventù dorata", gli portò un piccolo esercito personale,
composto esclusivamente di amici, clienti e servi della sua famiglia.
In battaglia, Mario il Giovane fu sonoramente battuto. Ma, prima di
fuggire a Preneste, mandò l'ordine ai suoi seguaci di Roma di uccidere tutti i
patrizi che ancora erano rimasti nella capitale. Il pretore convocò il Senato,
com'era suo diritto. E i senatori segnati nella "lista nera" vennero scannati
sui loro seggi. Poi gli assassini sgombrarono la città per raggiungere Mario e
le altre forze popolari che si preparavano a giocare l'ultima carta contro
Silla. La battaglia della Porta Collina fu una delle più sanguinose dell'antichità. Dei cento e più mila uomini di Mario, oltre la metà giacquero sul
terreno. Ottomila prigionieri vennero indiscriminatamente massacrati. E le
teste decapitate dei generali, issate sulle picche, furono portate in
processione sotto le mura di Preneste, ultimo bastione della resistenza
popolare, che poco dopo si arrese. Mario si era già ucciso. Anche la testa
sua fu mozzata, spedita a Roma e issata nel Foro.
Il trionfo che la capitale riservò a Silla il 27 e il 28 gennaio dell'81 fu
immenso. Il generale era seguito dal corteo entusiasta dei proscritti di Mario, tutti con corone di fiori intorno alla testa, che lo acclamavano come
padre e salvatore della patria. E i soldati stavolta non motteggiavano il loro
capitano. Osannavano anch'essi. Silla celebrò i sacrifici di rito sul
Campidoglio, poi nel Foro arringò la folla ritracciando con ipocrita modestia
l'incredibile serie di successi che lo avevano condotto sin lì e ascrivendoli
unicamente alla fortuna, in onore della quale chiese, o meglio impose, che
gli venisse riconosciuto il titolo di felix, che letteralmente vorrebbe dire
felice, ma in questo caso significava baciato dal destino, unto del signore, in
una parola "l'uomo della provvidenza". Il popolo s'inchinò, e stabilì di
erigergli, per gratitudine, la prima statua equestre, di bronzo dorato, che si
fosse vista a Roma, dove non si era mai tollerato che qualcuno venisse
rappresentato altrimenti che a piedi.
Non fu questa la sola novità che Silla introdusse per sottolineare
l'assolutezza dei suoi poteri. Egli fu il vero inventore del "culto della personalità". Fece coniare nuove monete col suo profilo e introdusse nel
calendario, come obbligatorie, le "Feste della vittoria di Silla". Dall'alto del
suo totalitarismo di dittatore, trattò Roma come una qualunque città
conquistata, lasciandola sotto la guardia del suo esercito in armi, e
sottoponendola alla repressione più feroce. Quaranta senatori e
duemilaseicento cavalieri che avevano parteggiato per Mario furono condannati a morte e giustiziati. Premi fino a cinque milioni dì lire furono
distribuiti a coloro che consegnavano, vivo o morto, un proscritto fuggitivo.
Il Foro e le strade furono ornati di teste decapitate, allegramente, come oggi
si fa coi palloncini colorati. Mariti, dice Plutarco, furono scannati tra le
braccia delle loro mogli, e figli tra quelle delle loro mamme. Anche molti
fra coloro che avevano cercato di barcamenarsi senza prender partito per
nessuno vennero soppressi o deportati, specie se erano ricchi: Silla aveva bisogno del loro patrimonio per ingrassare i suoi soldati. Uno degl'indiziati era
un giovanotto di nome Caio Giulio Cesare che, nipote di Mario per parte
della moglie di costui, sì rifiutò di rinnegare lo zio. Poi comuni amici si
misero di mezzo, e il giovanotto se la cavò con una condanna al confino.
Nel firmare la sentenza, Silla disse, come fra sé e sé: «Commetto una
sciocchezza, perché in quel ragazzo ci sono molti Marii». Ciò nonostante, al
firmò ugualmente.
Pochi giorni dopo essersi definitivamente insediato al potere, Silla si
trovò di fronte, in una pubblica cerimonia, al gesto d'insubordinazione di
uno dei suoi più fidi luogotenenti, Lucrezio Ofella, il conquistatore di
Preneste, un bravo soldato, ma di carattere spavaldo e indisciplinato.
Dinanzi alla truppa, che pure lo adorava, Silla lo fece pugnalare da una
guardia, come Hitler doveva fare, duemila anni più tardi, con Roehm, e
Stalin con dozzine di suoi amici. Era il segnale della "normalizzazione".
Silla governò da autocrate per due anni. Per colmare i vuoti provocati
dalla guerra civile nella cittadinanza, ne concesse il diritto a stranieri, soprattutto spagnoli e galli. Distribuì terre a oltre centomila veterani, specie in
quel di Cuma, dov'egli stesso aveva una fattoria. Per scoraggiare
l'urbanesimo, abolì le distribuzioni gratuite di grano. Abbassò il prestigio
dei tribuni e ristabilì la regola dei dieci anni d'intervallo per chi concorreva
al consolato per la seconda volta. Rinsanguò il Senato, svuotato dai
massacri, con trecento nuovi membri della grossa borghesia a lui fedeli; e
gli restituì tutti i diritti e privilegi di cui aveva goduto prima dei Gracchi,
Era proprio una "restaurazione aristocratica". Egli la compì sino in fondo,
congedò l'esercito decretando che d'allora in poi nessuna forza armata
potesse più bivaccare in Italia. Poi, ritenendo esaurita la sua missione, in
mezzo al generale sbalordimento, rimise nelle mani del Senato i suoi poteri,
ripristinò il governo consolare. E, come un privato qualsiasi, si ritirò nella
sua villa di Cuma.
Cecilia Metella, in quel momento, era già morta. Si era ammalata poco
dopo il trionfo di suo marito che, siccome si trattava dì un male infettivo,
l'aveva fatta trasportare in un'altra casa, e lì l'aveva lasciata crepare, come
una cagna rognosa.
Poco prima dell'abdicazione, Silla, ormai vicino alla sessantina, aveva
conosciuto Valeria, una bella ragazza di venticinque anni. Il caso gliel'aveva
fatta trovare accanto, al Circo. Essa vide un capello sulla toga del dittatore, e
con due dita glielo tolse. Silla si volse per guardarla, stupito dapprima del
suo sfrontato ardire, poi dalla sua avvenente bellezza. «Non fartene, dittatore», gli disse lei, «voglio anch'io partecipare, sia pure solo per un capello,
alla tua fortuna». Pare che sia stato l'unico vero disinteressato amore di
Silla, troppo egoista per nutrire di questi sentimenti. Egli la sposò di lì a
poco, e nessuno può sapere quanto il desiderio di godersi appieno quella
bella e giovane moglie abbia influito sui suoi propositi di abdicazione.
Il giorno in cui, deposto il potere e le insegne del comando, egli rincasò
come un privato qualsiasi, in mezzo allo sbigottito e impaurito silenzio dei
passanti, uno di costoro si mise a seguirlo ingiuriandolo. Silla non si volse,
nemmeno quando il marrano gli lanciò uno sberleffo. Solo disse ai pochi
amici che lo accompagnavano: «Che imbecille! Dopo questo gesto, non ci
sarà più un dittatore al mondo disposto ad abbandonare il potere».
Trascorse gli ultimi due anni della sua vita a far l'amore con Valerla, a
cacciare, a discorrere di filosofia con gli amici e a scrivere le sue Memorie,
che ci son giunte solo a pezzi e a bocconi. Il "Felice" pare che sia stato
felice davvero, in quel crepuscolo della sua esistenza, ch'era stata piena e
senza delusioni né rimpianti (di rimorsi egli non era capace), quale egli
stesso l'aveva sognata affacciandovisi. Fra i suoi veterani di Cuma, egli restò
vigoroso e alacre fino all'ultimo giorno, dirimendo le loro controversie al
suo solito modo imperioso e spiccio. Quando un certo Granio gli disobbedì
a proposito di non so quale bagattella, lo fece venire nella sua camera e
strangolare dai servi, come ai tempi in cui era dittatore. Il suo orgoglio e la
sua prepotenza non vennero meno neppure quando si trovò a faccia a faccia
con la morte, che bussava alla sua porta sotto forma di un'ulcera maligna
che forse era un cancro. Coi suoi occhi celesti e freddi sotto la chioma
dorata, con quel pallido viso che sembrava "una bacca di gelso spruzzata di
farina", come diceva Plutarco, seguitò a nascondere le sue sofferenze sotto
un gaio sorriso e parole scherzose. Prima di spirare, dettò il proprio
epitaffio:
«Nessun amico mi ha reso servigio, nessun nemico mi ha recato offesa,
che io non abbia ripagati in pieno».
Era vero.
CAPITOLO SESTO
UNA CENA A ROMA
LA restaurazione di Silla aveva un difetto fondamentale: era, appunto,
una "restaurazione", cioè qualcosa che negava le esigenze o, come oggi si
direbbe, le "istanze" che avevano provocato la rivoluzione. Al suo autore era
mancato, per compiere un'opera vitale e duratura, ciò che più le è
necessario: la fiducia negli uomini. I quali non se la meritano, ma la esigono
in coloro che si propongono di guidarli. Silla non credeva a nulla, e tanto
meno alla possibilità di migliorare i suoi simili. L'amore che aveva per se
stesso era così grande che non gliene restava per loro. Li disprezzava ed era
convinto che l'unica cosa da fare era tenerli in ordine. Per questo aveva
creato un formidabile apparato poliziesco e lo aveva lasciato in appalto
all'aristocrazia: non perché la stimasse, ma perché era convinto che gli altri,
popolari, fossero ancora più spregevoli e che ogni loro riforma sarebbe stata
un peggioramento. La conseguenza fu che dieci anni dopo la sua morte la
sua opera politica era in pezzi.
I patrizi che si erano ritrovati con tutto quel potere in mano, invece di
usarlo per rimettere ordine nel governo e nella società, ne approfittarono per
rubare, corrompere e uccidere. Tutto oramai non era più che una questione
di quattrini. Comprare l'elezione a una carica era un'operazione normale, e
c'era un'industria apposta per procurare voti, con tecnici specializzati: gli
interpreti, i divisori e i sequestri. Pompeo, per far eleggere il suo amico
Afranio, invitò nel suo palazzo i capi delle tribù, e contrattò i loro suffragi
come altrettanti sacchi di mele. Nei tribunali avveniva anche peggio.
Lentulo Sura, assolto dai giurati con due voti di maggioranza, disse,
picchiandosi una manata sulla fronte: « Accidenti, ne ho comprato uno di
troppo. E ai prezzi cui sono saliti!...».
Poiché tutto dipendeva dal denaro, il denaro era diventato la sola
preoccupazione di tutti. Nella burocrazia c'erano ancora, si capisce, funzionari capaci e onesti. Ma la maggior parte erano dei predoni incompetenti
che, per avere un posto nell'amministrazione di una provincia, non solo
rinunciavano agli stipendi, ma lo pagavano, sicuri di potere, in un anno,
abbondantemente rifarsi. E infatti si rifacevano: con le tasse, con la rapina,
con la vendita degli abitanti come schiavi. Cesare, quando gli fu assegnata la
Spagna, doveva ai suoi creditori qualcosa come mezzo miliardo di lire. In un
anno ripagò tutto. Cicerone si guadagnò il titolo di "galantuomo" perché, nel
suo anno di governo in Cilicia, mise da parte solo sessanta milioni, e lo
strombazzò a tutti come un esempio nelle sue lettere.
I militari non si comportavano meglio. Lucullo tornò a casa, dalle sue
imprese in Oriente, miliardario. Pompeo portò dalle stesse regioni un
bottino di sei o sette miliardi al tesoro dello stato e di quindici a quello suo
privato. Tale era la facilità di moltiplicare il capitale quando se ne aveva
abbastanza per comprarsi una carica, che i banchieri lo prestavano a chi non
ne aveva a un tasso d'interesse del cinquanta per cento. Il Senato proibì ai
suoi membri di praticare questa ignobile usura. Ma il divieto fu aggirato con
dei prestanome. Anche uomini di grande dignità come Bruto erano associati
con strozzini che amministravano il loro denaro prestandolo a quelle po' po'
di condizioni. In mano a una classe dirigente così corrotta, Roma era ormai
diventata una pompa che succhiava quattrini in tutto il suo impero per
consentire a una categoria di satrapi una vita sempre più fastosa e un lusso
sempre più insolente.
Una sera Cicerone cominciò a prendere in giro Lucullo per la fama che
si era fatto di raffinato ghiottone. Cicerone era un giovane avvocato di
Arpino, figlio di un agricoltore benestante, che gli aveva dato una buona
educazione. Appena ventisettenne e ancora quasi del tutto sconosciuto,
aveva affrontato un processo celebre e per lui molto pericoloso: perché si
trattava di difendervi Roscio contro Crisògono, ch'era un grande favorito di
Silla, in quel momento ancora dittatore. Vinse con un'arringa magistrale.
Poi, forse temendo qualche rappresaglia da parte di Silla, partì per la Grecia
dove rimase tre anni a studiarvi la lingua, l'oratoria di Demostene e la
filosofia di Posidonio, mediocre epigono di Socrate e della scuola stoica.
Tornò tre anni dopo, quando Silla era già morto, sposò Terenzia e la sua
dote, ch'era cospicua e, con la professione di avvocato, coltivò la politica
che del resto vi era strettamente connessa. Subito ebbe per le mani un altro
celebre processo, quello contro Verre, un senatore che, andato a governare
la Sicilia, vi aveva commesso ogni sorta di ladronerie e birbonate, ma era
sostenuto da tutta l'aristocrazia. Si trovò contro Ortensio, il principe del Foro
romano, l'avvocato di fiducia dell'aristocrazia e del Senato. Quella causa fu
un po' l'affare Dreyfus del tempo, con i patrizi da una parte, e il popolo, ma
soprattutto la grande borghesia equestre dall'altra. E ancora una volta
Cicerone vinse, togliendo lo scettro di mano a Ortensio e diventando così
l'idolo di una classe sociale ch'era anche quella in cui egli stesso era nato.
Lucullo era un ex luogotenente di Silla, che per otto anni ne aveva
proseguito l'opera in Oriente combattendo contro Mitridate. Veniva da una
famiglia aristocratica, povera e malfamata. Dicevano che suo padre si era
fatto corrompere dagli schiavi insorti in Sicilia, che suo nonno aveva rubato
statue e che sua madre aveva più amanti che capelli in testa. Forse eran tutte
calunnie. Comunque Lucullo, da giovane, non aveva mostrato nessuno di
questi vizi, aveva soltanto una grande ambizione e tutte le qualità per
soddisfarla: l'intelligenza, l'eloquenza, la cultura e il coraggio. Finché era
stato vivo Silla, che per lui aveva un debole, la carriera gli era stata facile.
Morto il protettore, non aveva esitato, per continuarla, a procurarsi i favori
di una donna, Precia, molto potente per i suoi amorosi intrighi; e attraverso
di lei ebbe il proconsolato della Cilicia, cioè la possibilità di seguitare a
comandare, a guerreggiare, a vincere e ad arricchirsi con le spoglie del
nemico. Per raggiungere, come capitano, la statura dei Mario, dei Silla e dei
Cesare, gli mancò una qualità sola: l'intuito psicologico. Condusse i suoi
soldati di vittoria in vittoria, ma li stancò fino al punto di provocarne
l'ammutinamento. E come, per intrigo, aveva avuto il comando, per intrigo
lo perse. Richiamato a Roma, si era ritirato dalla vita pubblica, e ora badava
soltanto a godersi le sue ricchezze, ch'erano immense, e a farne insolente
sfoggio. La villa di Miseno gli era costata oltre un miliardo di lire, la fattoria
di Tuscolo aveva oltre ventimila ettari, e il palazzo che si era costruito al
Pincio era celebre per la galleria di statue, per i preziosi manoscritti che
aveva saccheggiato in Oriente, per i giardini dov'egli coltivava con diligenza
di appassionato botanico piante sino ad allora ignote a Roma, come il
ciliegio, e soprattutto per la sua cucina, laboratorio delle più raffinate squisitezze.
Cicerone dunque una sera, in un ritrovo di amici, cominciò a prendere in
giro Lucullo sulla sua ghiottoneria dicendo che si trattava di una posa e
scommettendo che se si fosse andati a casa sua senza avvertire i cuochi, si
sarebbe trovata una cena frugale, da contadini o da soldati. Lucullo accettò
la sfida, invitò tutti a fare un sopralluogo e solo chiese il permesso di
mandare ai suoi servitori l'ordine di apparecchiare per tutti nella sala di
Apollo. Bastò, per far capire al suo personale di cosa si trattava; nella sala di
Apollo, un pranzo non poteva costare meno di duecentomila sesterzi. Vi
erano d'obbligo, come antipasti, frutti di mare, uccellini di nido con
asparagi, pasticcio d'ostrica, scampi. Poi veniva il pranzo vero e proprio:
petti di porchetta, pesce, anatra, lepre, tacchino, pavoni di Samo, pernici di
Frigia, morene di Gabes, storione di Rodi. E formaggi, e dolci, e vini.
Plutarco, che ci racconta l'episodio, non dice chi intervenne al banchetto.
Ma doveva esserci il fior fiore della società romana. Non mancava
certamente Marco Licinio Crasso, un aristocratico figlio di un famoso
luogotenente di Silla, che si era ucciso piuttosto che arrendersi a Mario.
Silla aveva ricompensato l'orfano lasciandogli comprare a prezzi di
liquidazione i beni dei marianisti proscritti e permettendogli di organizzare
il primo corpo dei pompieri che si sia visto a Roma. Quando scoppiava un
incendio, Crasso correva sul posto; ma, invece di spegnere le fiamme,
contrattava su due piedi l'edificio che bruciava col proprietario, ch'era
sempre ben felice di liberarsene. E solo quando era suo metteva in azione le
pompe. Altrimenti, lo lasciava bruciare. Un altro che certamente non poteva
mancare era Tito Pomponio Attico che, sebbene di ascendenze borghesi,
rappresentava un tipo di aristocratico più raffinato. Non avendo bisogno
d'insudiciarsi con affari loschi perché era già ricchissimo di famiglia, aveva
badato soltanto a perfezionare la sua cultura a Atene. Lì lo conobbe Silla e
ne rimase così sedotto che voleva farne un suo collaboratore. Ma Attico
aveva rinunziato per seguitare a studiare. Poi investì il suo patrimonio, che
assommava a quasi un miliardo, in una fattoria in Epiro per l'allevamento
del bestiame, nell'acquisto di appartamenti a Roma, in una scuola per
gladiatori, e in una casa editrice per libri di alta cultura. Cicerone, Ortensio,
Catone e molti altri grossi personaggi del tempo si servivano di lui, oltre che
come consigliere finanziario, anche come banca di deposito. E tali erano la
stima e il prestigio di cui godeva che, sebbene vivesse frugalmente, da vero
epicureo, non c'era salotto della società romana dove non fosse in
permanenza invitato, né festa cui non partecipasse.
E ci sarà stato certamente anche Pompeo, il favorito e genero di Silla
che, con un po' d'ironia, lo chiamava "il Grande". Di lignaggio equestre,
cioè borghese, anche lui, era il "principe azzurro" della "gioventù dorata" di
Roma. Si era guadagnato la vittoria sul campo e un trionfo, prima ancora di
raggiungere la maggiore età. Ed era così bello che la cortigiana Flora diceva
di non potersi staccare da lui senza dargli un morso. Passava per un giovane
integro e, per quel tempo, lo era: cercava di fare il bene di tutti con lo stesso
impegno con cui faceva quello suo proprio. Gli si attribuivano molte
ambizioni. In realtà ne aveva una sola: quella di essere al di sopra di tutti, in
tutto. Ma, più che un'ambizione, era una vanità.
Eran tutti personaggi che, nella Roma stoica di tre secoli prima, non si
sarebbero incontrati. E non solo per la foggia raffinata dei loro abiti, per i
piatti che mangiavano, e per i discorsi che tenevano in un bel latino liscio e
pulito, condito di richiami letterari, ma anche perché a queste feste
partecipavano in compagnia delle donne ormai uscite dal loro stato di
soggezione. Clodia, la moglie di Quinto Cecilio Metello, era a quei tempi la
"prima signora" della città, e faceva scuola alle altre. Essa era femminista,
usciva sola la sera e, quando incontrava un conoscente, invece di abbassare
pudicamente gli occhi com'era sempre usato, lo abbracciava e baciava.
Invitava a cena gli amici quando suo marito era assente, affermava il diritto
alla poligamia anche per le donne, e lo praticò senza risparmio, prendendosi
amanti a dozzine e piantandoli con molta grazia, ma senza rimorso. Uno di
essi fu il poeta Catullo, che non riuscì più a dimenticarla, si strusse di
gelosia e la sfogò nei suoi versi, dov'essa appare col nome di Lesbia. Celio,
un altro abbandonato, per vendicarsi, l'accusò in tribunale di averlo voluto
avvelenare e la chiamò pubblicamente quadrantaria, che vuol dire "quarto di
centesimo": la tariffa delle prostitute povere. Clodia fu condannata a una
multa: non perché fosse colpevole, ma perché era la sorella di Publio
Clodio, uno dei capi del partito radicale, inviso agli aristocratici allora
onnipotenti e nemico giurato di Cicerone, che sostenne le parti di Celio
dicendo che gli seccava accusare una donna, e specialmente quella che si era
mostrata così buona amica di tanti uomini.
Con questi esempi davanti agli occhi, era difficile alle ragazze
trasformarsi in buone madri di famiglia. Dettati unicamente dai calcoli
politici e d'interesse, i matrimoni si facevano e si disfacevano con
disinvoltura. Pompeo, per fare carriera, divorziò dalla prima moglie per
sposare Emilia, la figliastra di Silla. Poi, rimasto vedovo, sposò Giulia, la
figlia di Cesare, che di mogli ne cambiò quattro e le tradì regolarmente tutte.
«Questa città», diceva Catone, «non è più che un'agenzia di matrimoni
politici corretti dalle corna». E Metello il Macedonico, in un accorato
discorso ai suoi compatrioti, li invitò a mettere ordine nella loro vita
familiare dicendo: «Capisco anch'io che una moglie è soltanto una noia...».
Il matrimonio con mano, cioè quello che non ammetteva divorzio, era
praticamente scomparso, appunto per consentire ai coniugi di rinnegarlo
quando volevano. E bastava, per farlo, una semplice lettera. Figli non se ne
volevano, perché sarebbero stati un impaccio. Essi erano diventati ormai un
lusso che solo i poveri potevano consentirsi. Non più preoccupate dalle
gestazioni, dagli allattamenti e dalle pappine, le spose cercavano, come oggi
si direbbe, "evasioni". E le trovavano soprattutto nelle tresche amorose e
nella cultura, che ormai cominciava a diventare un fatto mondano e di
salotto.
I gusti letterari di questa società ricca e frivola non si orientarono verso il
più grande poeta e scrittore del tempo, Lucrezio. L'autore di De rerum
natura fu probabilmente un aristocratico, ma visse ritiratissimo anche per
ragioni di salute: pare che fosse afflitto da una forma ciclica di mania
depressiva, e la sua ispirazione era troppo alta, tragica e profonda per
diventare di moda. A furoreggiare era Catullo, poeta facile e sentimentale,
qualcosa di mezzo fra Gozzano e Géraldy. Era un borghese di Verona,
benestante e avaro, che piangeva sempre miseria, ma aveva casa a Roma,
una villa a Tivoli e un'altra sul Garda. Piaceva alle signore perché parlava
solo d'amore e aveva reso morbida e salottiera una lingua che sembrava fatta
solo per codici di legge e proclami di vittoria.
Con lui andavano per la maggiore Marco Celio, un aristocratico
squattrinato, simpatizzante per le idee comuniste; Licinio Calvo, un
dilettante di poesia e di oratoria non privo d'ingegno; e Elvio Cinna, che,
dopo la morte di Cesare, fu scambiato per sbaglio per uno degli assassini e
ucciso dalla folla. Erano tutti degl'intellettuali "di sinistra", che si
opponevano alla dittatura senza far nulla per difendere la democrazia. Ma
ebbero un'influenza superiore forse ai loro meriti, perché ora avevano a
disposizione, oltre ai salotti e alle donne, una vera e propria editoria per
diffondere le proprie opere.
Attico aveva introdotto la pergamena, e ne faceva "volumi" (che vuol
dire "rotoli") con pagine composte di due o tre "colonne" di manoscritto.
Adibiti a riempirle a mano erano schiavi specializzati, cui si pagava solo il
mantenimento. Nemmeno gli autori erano retribuiti se non con qualche dono
occasionale; e quindi solo i ricchi, praticamente, potevano dedicarsi alla
letteratura. Un'edizione si aggirava quasi sempre sulle mille copie che
venivano distribuite ai librai, dai quali venivano a comprare gli amatori. Fu
uno di costoro, Asinio Pollione, a istituire la prima biblioteca pubblica di
Roma.
Questo progresso tecnico stimolò la produzione. Terenzio Varrone
pubblicò i suoi saggi sulla lingua latina e sulla vita rustica. Sallustio, fra una
battaglia politica e l'altra, diede alle stampe le sue Storie, magnificamente
scritte, ma piuttosto partigiane. E Cicerone, diventato ormai "il maestro" per
eccellenza dell'arte oratoria, tradusse in libri le sue orazioni, di cui soltanto
cinquantasette sono giunte sino a noi.
La cultura insomma non era più il monopolio di qualche solitario
specialista, ma aveva cominciato a diffondersi in quella società che oramai
voltava risolutamente le spalle ai rudi costumi e alla sana ignoranza della
prima èra repubblicana. Ci si avvicinava a quella che si suoi chiamare "l'età
dell'oro" di Roma, e che, come tutte le "età dell'oro", preluse all'agonia della
sua civiltà.
CAPITOLO SETTIMO
CICERONE
POMPEO e Crasso, che abbiamo incontrato nel capitolo precedente, non
erano soltanto dei gaudenti affaristi, ma anche degli uomini politici che
pretendevano recitare una parte di primo piano. E ci riuscirono, sebbene poi
l'abbiano pagata ambedue con la vita.
Come favoriti di Silla, ebbero dapprincipio la carriera facile. Fu infatti a
loro che, dopo il ritiro del dittatore, il Senato ricorse mettendoli alla testa di
due eserciti, per domare le rivolte di Spagna e d'Italia.
La Spagna si era già rivoltata varie volte contro le malversazioni dei
governatori romani. Ma ora alle malversazioni si erano aggiunte le inutili
crudeltà. Nel 98 il generale Didio, imitando l'esempio del suo predecessore
Sulpicio Galba, attirò nel suo campo una intera tribù d'indigeni con la
promessa di una distribuzione di terre, e la sterminò. Un suo ufficiale,
Quinto Sertorio, indignato da sì inutili barbarie, disertò, chiamò alle armi le
altre tribù, organizzò fra loro un esercito, per otto anni lo condusse di
vittoria in vittoria contro i romani, e per altrettanti governò saggiamente la
"provincia". Metello, il generale che il Senato aveva mandato a combatterlo,
non riuscendo a venirne a capo, promise qualcosa come duecento milioni di
lire e diecimila ettari di terra a chi riuscisse a ucciderlo. Perpenna, altro
rifugiato romano nel campo di Sertorio, lo pugnalò. Ma, invece di andare a
riscuotere il premio, preferì prendere l'eredità del morto e continuare in
proprio la guerra. Allora il Senato mandò Pompeo, che sconfisse facilmente
il rinnegato, lo catturò e lo soppresse, restituendo la Spagna alle
malversazioni dei governatori.
Più grave era la rivolta che intanto stava insanguinando l'Italia. Lentulo
Baziate teneva a Capua una scuola di gladiatori, frequentata naturalmente da
schiavi, che vi si preparavano, praticamente, alla morte nel Circo per il
divertimento degli spettatori. Un giorno duecento tentarono di fuggire,
settantotto ci riuscirono, saccheggiarono i dintorni e si scelsero come capo
un tracio di nome Spartaco, che dovett'essere un uomo di buon lignaggio e
di notevoli qualità. Egli lanciò un appello a tutti gli schiavi d'Italia, che si
contavano a milioni, ne organizzò settantamila in un esercito assetato di
libertà e di vendetta, insegnò loro a fabbricarsi le armi, e batté i generali che
il Senato gli mandò contro.
Queste vittorie non lo ubriacarono. Era un politico accorto e sapeva
benissimo che la sua era, a lungo andare, una lotta senza speranza. Per cui
avviò la sua orda verso le Alpi, col proposito, una volta, attraversatele, di
scioglierla e di rimandare ognuno a casa propria. Così almeno racconta
Plutarco. Ma i suoi seguaci vollero tornare indietro, si misero a saccheggiare
città e campagne, e Spartaco, che doveva essere un uomo di coscienza e che
cercava d'impedire queste predonerie, non si sentì di abbandonarli. Perse
una battaglia, ne vinse un'altra ancora contro Cassio. E finalmente si trovò a
faccia a faccia con l'Urbe che trattenne il fiato nel terrore di vedere tutti gli
schiavi d'Italia e quelli di Roma stessa, che vi costituivano una pericolosa
quinta colonna, unirsi agl'insorti e formare con loro una valanga.
Allora fu dato il comando a Crasso, e sotto le sue bandiere si arruolò
volontariamente il fiore dell'aristocrazia. Spartaco si rese conto di avere di
fronte a sé l'Impero, e si ritirò verso il Sud pensando di traghettare le sue
forze in Sicilia e di lì in Africa. Crasso lo seguì, agganciò e distrusse la sua
retroguardia, lo incalzò. A marce forzate, dalla Spagna, stava intanto
sopravvenendo Pompeo con le sue legioni. Conscio di essere ormai alla fine,
Spartaco attaccò, si gettò di persona in mezzo alla mischia, uccise di sua
mano due centurioni e fu a sua volta talmente crivellato di colpi che non fu
più possibile, dopo, identificarne il cadavere.
La maggior parte dei suoi uomini perirono con lui. Circa seimila, snidati
nei boschi, vennero crocefissi ai margini della via Appia.
Correva l'anno 71, e i due vittoriosi generali, di ritorno a Roma, non
congedarono i loro eserciti, come voleva la legge e come desiderava il
Senato. Fra loro non si amavano: erano ambedue troppo ricchi, troppo
fortunati e troppo ambiziosi. Ma quando il Senato rifiutò il trionfo a Pompeo
e la distribuzione di terre ch'egli aveva promesso ai suoi veterani, strinsero
alleanza e accamparono minacciosamente i loro uomini nei dintorni della
città stessa.
Subito i popolari, che dalla morte di Silla spiavano il momento di
vendicarsi dei soprusi dell'aristocrazia, si schierarono intorno a loro, ne
fecero i propri campioni, e li elessero consoli per l'anno 70. Pompeo e
Crasso non erano affatto popolari: appartenevano anzi per nascita all'alta
borghesia. Ma il cieco egoismo dell'aristocrazia aveva sortito appunto
questo effetto: di spingere l'alta borghesia dalla parte del proletariato. I due
consoli infatti, come prime misure, adottarono quella di restaurare il potere
dei tribuni, che Silla aveva esautorato, e di togliere ai patrizi il monopolio
delle giurie nei tribunali, riammettendovi anche i cavalieri. Dopodiché
rinnovarono la loro alleanza per la spartizione dei vantaggi personali.
Pompeo avrebbe avuto il comando supremo delle operazioni in Oriente
sostituendovi Lucullo e aggiungendo ai suoi poteri di generale quelli di
ammiraglio per la repressione dei pirati del Mediterraneo che rendevano
insicure le rotte per l'Asia Minore; in compenso s'impegnava a riaprire i
mercati orientali agl'investimenti dei banchieri, alleati di Crasso, che ne
diventava così il supremo patrono.
Nel Senato, che si oppose unanimemente a questa misura, una sola voce
si elevò a difenderla: quella di un giovane, tuttora quasi sconosciuto e poco
amato dai suoi aristocratici confratelli: Giulio Cesare. L'Assemblea
l'approvò altrettanto unanimemente, trascinata da un altro giovane:
Cicerone. La vittoria dell'Assemblea e di Pompeo segnò la fine della
supremazia patrizia e della restaurazione sillana che vi era imperniata sopra,
ed ebbe conseguenze decisive sul seguito degli avvenimenti. Subito dopo la
partenza di Pompeo alla testa di centoventicinquemila uomini, cinquecento
navi e centocinquanta milioni di sesterzi, il commercio con l'Oriente riprese,
e di conseguenza cadde il prezzo del grano, sostegno dell'aristocrazia
terriera.
Solo un avvenimento venne a turbare questo pacifico e progressivo
ritorno alla democrazia, ridando ossigeno alla reazione. Noi non conosciamo
Lucio Sergio Catilina che dalle descrizioni dei suoi nemici, e
particolarmente di Sallustio e di Cicerone. Quest'ultimo ce lo dipinge come:
un torbido individuo in perpetuo litigio con dio e con gli uomini, che non
riusciva a trovar pace né in sonno né da desto: di qui il suo colorito terreo,
i suoi occhi iniettati di sangue, il suo andazzo epilettico: in breve, il suo
aspetto di pazzo. Il guaio è che Cicerone era, per parte di moglie,
cognatastro di una vestale, della cui deflorazione Catilina era stato accusato.
Al processo lo avevano assolto. Ma nei salotti si diceva ch'era vero e che
non faceva meraviglia poiché aveva già assassinato il proprio figlio per
contentare la sua amante.
Forse anche per questa ostilità che incontrava dovunque, Catilina,
sebbene di aristocratiche ascendenze, passò dalla parte dei più scalmanati
popolari e si tinse di giacobinismo. Il suo programma era radicale:
reclamava l'abolizione di tutti i debiti per tutti i cittadini. E si cominciò a
sussurrare ch'egli aveva già organizzato una banda di quattrocento disperati
per uccidere i consoli e impadronirsi del governo.
In realtà nessuno vide mai questa famosa banda, e Catilina si contentò di
presentare molto democraticamente la sua candidatura al consolato,
sperando evidentemente che sul suo nome si facesse l'unanimità
antisenatoriale che aveva così bene funzionato per Crasso e Pompeo. Ma
l'alta borghesia, cui appartenevano i creditori e che aveva in gran sospetto
quella specie di comunista, stavolta non marciò. Essa era con la plebe
quando si trattava di rintuzzare i monopoli dell'aristocrazia; ma era con
l'aristocrazia, e quindi col Senato, quando erano in giuoco lo stato e il
capitalismo.
Lo si vide nell'atteggiamento di Cicerone che oppose la propria
candidatura a quella di Catilina e vinse predicando la "concordia degli ordini", cioè la Santa Alleanza dell'aristocrazia con la grande borghesia, e di
essa fu per quell'anno il grande interprete.
Trombato alle elezioni, come oggi si direbbe, Catilina cominciò a
organizzare la famosa congiura raccogliendo segretamente qualche migliaio
di seguaci a Fiesole e costituendo una quinta colonna anche nell'interno
della città. Di essa faceva parte un po' di tutto: schiavi, senatori e due
pretori, Cetego e Lentulo. Con questa forza alle spalle si ripresentò l'anno
dopo alle elezioni e, per assicurarsene l'esito, architettò l'assassinio del suo
rivale e di Cicerone.
Questa fu almeno la versione che costui diede, quando si presentò nel
Campo di Marte seguito dai suoi armigeri per il conteggio dei voti. Catilina
risultò ancora una volta battuto.
Il 7 novembre del 63, Cicerone disse che durante la notte i cospiratori
erano venuti a casa sua per ucciderlo, ma erano stati ricacciati dalle sue
guardie. E l'indomani, incontrando Catilina in Senato, pronunciò contro di
lui quella celebre orazione («Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra
pazienza?...») che tuttora costituisce la croce e la delizia degli studenti di
ginnasio. Non gli bastò un giorno, per quella requisitoria: gli ce ne vollero
tre. Fu il suo capolavoro, e vi profuse in egual misura tutti i tesori della sua
eloquenza rotonda e cantante, della sua vanità e della sua gigioneria.
II 3 dicembre riuscì a far spiccare mandato di arresto contro Lentulo,
Cetego e altri cinque cospiratori di alto rango. Ma già Catilina, nottetempo e
in silenzio, aveva abbandonato Roma e raggiunto le sue truppe in Toscana.
Il 5 Cicerone chiese che i prigionieri fossero condannati a morte. Silano e
Catone il Giovane lo appoggiarono. E a difendere gl'imputati di nuovo non
si levò che una fresca e giovane voce: quella di Cesare, fedele avvocato dei
popolari, che chiese una semplice pena detentiva. La sua oratoria,
all'opposto di quella di Cicerone, era sobria e scarna. Quand'ebbe finito di
parlare, alcuni giovani aristocratici cercarono di ucciderlo. Cesare riuscì a
sfuggire, mentre Cicerone si recava alla prigione per far eseguire la sentenza
e l'altro console, Marco Antonio, padre di un giovanotto destinato a
diventare più famoso di lui, partiva alla testa dell'esercito per annientare
Catilina.
La battaglia ebbe luogo presso Pistoia, e nessuno degl'insorti si arrese.
Schiacciati dal numero, combatterono sino all'ultimo uomo intorno alla loro
bandiera, le aquile di Mario, e a Catilina, che ne seguì la sorte.
Il primo ad essere sorpreso ed entusiasmato dell'energia che aveva
mostrato, fu Cicerone, che non sospettava di averne tanta. In un discorso al
Senato egli disse modestamente che l'impresa che aveva compiuto era così
grande da superare i limiti di quelle consentite agli uomini. E, posta così la
candidatura alla divinizzazione, aggiunse che avrebbe paragonato se stesso a
Romolo se il salvataggio di Roma non fosse stato un avvenimento molto più
glorioso della sua fondazione.
I senatori sorrisero a quel linguaggio, ma gli decretarono volentieri il
titolo di "Padre della Patria". E quando, alla fine del 63, egli lasciò la carica,
lo scortarono in segno di omaggio fino a casa. Tutto questo contribuì ancora
di più a montare la testa del grande oratore, che ormai si considerava
l'arbitro di Roma. Egli possedeva ville ad Arpino, Pozzuoli e Pompei, una
fattoria di cinquantamila sesterzi a Formia, un'altra di cinquecentomila a
Tuscolo, e un palazzo di tre milioni e mezzo sul Palatino. Era tutta roba
comprata con prestiti dai clienti perché la legge proibiva agli avvocati di
rimettere "parcelle". E i "prestiti", che naturalmente non venivano rimborsati, le sostituivano. Ma Cicerone escogitò anche un altro mezzo per
arricchire: i testamenti, dove si faceva designare erede. In trent'anni ereditò
dalla sua clientela venti milioni di sesterzi, un miliardo di lire.
Era logico che un simile uomo predicasse la "concordia degli ordini"
cercando un punto di equilibrio, che non fosse la bieca reazione di una casta
aristocratica cui non apparteneva, ma nemmeno il progressismo di chi era
interessato al generale livellamento.
Ricco com'era, principe del Foro e "Padre della Patria", sembrava che
non gli mancasse più nulla. Invece gli mancava la cosa più importante: la
pace in famiglia. Terenzia era una sposa virtuosa e insopportabile che gli
avvelenò la vita con i suoi nervi, i suoi acciacchi reumatici e un'eloquenza
non inferiore a quella del marito. Due oratori, in una casa, sono troppi. Il
principe del Foro, in quella sua, cedeva lo scettro alla moglie, che lo usava a
proposito e a sproposito per lamentarsi continuamente di qualcosa. Quando
alla fine si decise a lasciarlo vedovo, Cicerone la rimpiazzò con Publilia, che
gli portò una dote non inferiore a quella della povera defunta. Ma poi la
mandò via perché non era nelle grazie di sua figlia Tullia, l'unico suo vero e
disinteressato affetto.
Dopo l'affare Catilina, la sua stella politica cominciò a tramontare,
sebbene qualche bagliore le fosse ancora riservato sotto Cesare, di cui fu a
volta a volta amico e nemico, come vedremo, ma a cui non perdonò il fatto
di essere un oratore grande per lo meno quanto lui, sebbene in tutt'altro stile.
Sempre più intensi diventarono i suoi ozi letterari, cui dobbiamo alcune fra
le più belle pagine della lingua latina. A noi piacciono soprattutto, per la
loro immediatezza, le lettere, piene di aneddoti autobiografici. Ne scrisse a
profusione e vi si dipinse qual era: un lavoratore assiduo, un tenero padre,
un accorto amministratore delle finanze pubbliche e di quelle private, il
buon amico di amici che potevano essergli utili, e un vanitoso così inconscio
della propria vanità da immortalarla in una prosa impeccabile con una
specie di candore che ne redime il difetto quasi trasformandolo in virtù.
CAPITOLO OTTAVO
CESARE
NEL momento in cui Catilina cadeva, giungeva a Roma Metello Nepote,
luogotenente e avanguardia di Pompeo, sbarcato a Brindisi di ritorno da un
seguito di brillanti vittorie in Asia Minore. Aveva anticipato il viaggio per
concorrere alla carica di pretore e, una volta eletto, favorire una nuova
candidatura di Pompeo al consolato.
Il primo obbiettivo lo raggiunse coi voti dei popolari, ma si trovò
accanto come collega Marco Catone, rappresentante dei più intransigenti
conservatori, i quali, dopo la vittoria su Catilina, credevano di essere
ridiventati i padroni della situazione. Essi non videro perché dovevano appoggiare le ambizioni di Pompeo, il quale non avrebbe chiesto di meglio che
di diventare il loro campione. Se l'avessero scelto come tale, forse si
sarebbero salvati, o per lo meno avrebbero ritardato la propria disfatta, visto
il prestigio di cui Pompeo godeva. Ma la maggior parte erano invidiosi di
lui, della sua ricchezza, dei suoi successi, e pensarono di non averne
bisogno.
Ancora una volta una sola voce in Senato fece "stecca" sul coro,
appoggiando Pompeo: quella di Cesare, anche lui pretore. L'Assemblea quel
giorno fu tumultuosa. Cesare, destituito insieme con Nepote, fu salvato dalla
folla che venne a proteggerlo e che voleva sollevarsi. Egli la calmò e la
rimandò a casa. Per la prima volta il Senato si accorse che quel giovanotto
rappresentava qualcosa e si rimangiò la destituzione.
Caio Giulio Cesare aveva allora ventisette anni e veniva, come Silla, da
una famiglia aristocratica povera che faceva risalire le sue origini ad Anco
Marzio e a Venere, ma che, dopo questi opinabili antenati, non aveva più
dato alla storia di Roma personaggi di grido. C'erano stati dei Giuli pretori,
questori, e anche consoli. Ma di ordinaria amministrazione. La loro casa
sorgeva nella Suburra, il quartiere popolare e malfamato di Roma, e qui egli
nacque chi dice nel 100, chi nel 102 avanti Cristo.
Non sappiamo nulla della sua infanzia, se non ch'ebbe come precettore
un gallo, Antonio Grifone, il quale, oltre al latino e al greco, gl'insegne forse
qualcosa di molto utile sul carattere dei suoi compatrioti. Pare che nella
pubertà fosse afflitto da mali di testa e attacchi di epilessia, e che la sua
ambizione fosse allora quella di diventare uno scrittore. Fu calvo molto
presto e, vergognandosene, cercò di rimediarvi coi "riporti", tirandosi i
capelli dalla nuca alla fronte. Perdeva molto tempo ogni mattina in questa
complicata operazione.
Svetonio dice ch'era alto, piuttosto grassottello, di pelle chiara, d'occhi
neri e vivi. Plutarco dice ch'era magro e di mezza taglia. Forse hanno
ragione ambedue. L'uno lo descrive da giovane, l'altro da uomo maturo,
quando di solito ci si appesantisce un po'. I lunghi periodi di vita militare
dovettero irrobustirlo. Fu sin da ragazzo un eccellente cavaliere, e usava
galoppare con le mani incrociate dietro la schiena. Ma camminava molto
anche a piedi alla testa dei suoi soldati, dormiva nei carri, mangiava
sobriamente, il suo sangue si serbava sempre freddo e il suo cervello lucido.
Di viso non era bello. Sotto quel cranio pelato e un po' troppo massiccio,
c'erano un mento quadrato e una bocca arcuata e amara, incorniciata da due
rughe dritte e profonde, e col labbro di sotto che sporgeva su quello di sopra. Tuttavia fu sempre fortunato con le donne. Ne sposò quattro e ne ebbe
infinite altre come amanti. I suoi soldati lo chiamavano moechus calvus,
l'adultero calvo e, quando sfilavano per le vie di Roma in occasione di un
trionfo, gridavano: « Ehi, uomini, chiudete in casa le vostre mogli: è tornato
il seduttore zuccapelata!». E Cesare era il primo a riderne.
Contrariamente a una certa leggenda che lo riveste di una seriosa sussiegosa solennità, Cesare era un perfetto uomo di mondo, galante,
elegante, spregiudicato, ricco di umorismo, capace di incassare i frizzi altrui
e di rispondervi con mordente sarcasmo. Era indulgente coi vizi degli altri,
perché aveva bisogno che gli altri lo fossero coi suoi. Curione lo chiamava
"il marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti". E una delle ragioni
per cui gli aristocratici l'odiarono tanto era ch'egli seduceva regolarmente le
loro spose, le quali a dire il vero facevano a gara per essere sedotte. Fra esse
c'era anche Servilia, sorellastra di Catone, che anche per questo gli fu
irriducibilmente ostile. Servilia gli era così devota che gli sacrificò anche la
figlia Terzia, cui lasciò il suo posto quando gli anni l'obbligarono a ritirarsi.
Cesare ricompensò la generosa madre facendole attribuire i beni di certi
senatori proscritti ad un prezzo ch'era un terzo del loro valore. E Cicerone ci
ricamò sopra un giuoco di parole, dicendo che quella svendita era stata fatta
Tertia deducta. Lo stesso Pompeo, per quanto più bello, ricco e, in quel
momento, famoso di Cesare, si vide portar via la moglie da lui e la ripudiò.
Cesare se ne fece perdonare, dandogli in sposa la figlia sua.
Questo straordinario personaggio intorno a cui, d'ora in poi, tutta la
storia di Roma e del mondo comincia a ruotare, era dunque, quanto a
moralità, figlio dei suoi tempi. E infatti debuttò in un modo che non lasciava
presagire nulla di buono. Finiti gli studi sui sedici anni, partì al seguito di
Marco Termo che andava in Asia a farvi una delle tante guerre. Ma, invece
che un bravo soldato, diventò un favorito di Nicomede, re di Bitinia, che
aveva un debole per i bei ragazzi. Tornato a Roma diciottenne, sposò Cossuzia, perché così voleva suo padre. Ma quando costui morì, la ripudiò e
rimpiazzò con Cornelia, figlia di quel Cinna che aveva a suo tempo preso la
successione di suo zio Mario. E così venne a rinsaldare i vincoli che già lo
legavano al partito democratico.
Silla, quando instaurò la dittatura, gli ordinò di divorziare. Cesare,
sebbene abituato a cambiar moglie come si cambia vestito, spavaldamente
rifiutò. Venne condannato a morte e la dote di Cornelia fu confiscata. Poi,
come già abbiamo detto, comuni amici si interposero, e Silla lo lasciò
andare in esilio. Cesare ripagò quel gesto di clemenza definendolo "una
fesseria". Però s'ingannava. Silla aveva capito benissimo la "fesseria" che
stava facendo: ma forse aveva per lui una segreta simpatia.
Quando il dittatore si fu ritirato, Cesare tornò a Roma. Ma, trovandola
ancora in balìa dei reazionari, che lo detestavano come nipote di Mario e
genero di Cinna, ripartì per la Cilicia. Una barca di pirati lo catturò in mare
e chiese per il suo riscatto venti talenti, qualcosa come quaranta milioni di
lire. Cesare rispose insolentemente ch'era un prezzo troppo basso per il suo
valore e che preferiva dargliene cinquanta. Mandò i suoi servi a procurarli e
ingannò l'attesa scrivendo versi e leggendoli ai suoi rapitori che non li
gustarono punto. Cesare li chiamò "barbari" e "cretini", e promise loro
d'impiccarli alla prossima occasione. Tenne la parola, perché, appena
liberato, corse a Mileto, noleggiò una flottiglia, inseguì e catturò quei
filibustieri, riprese i suoi quattrini, cioè quelli dei suoi creditori (cui non li
restituì) e, manifestazione di clemenza, prima d'impiccarli, tagliò loro la
gola.
Fu lui stesso a raccontare quest'avventura in alcune lettere agli amici, e
non giureremmo sulla sua autenticità. Cesare non era ancora, in quel
momento, il sobrio e spassionato scrittore del De bello gallico, che, avendo
vinto realmente molte battaglie, non aveva più bisogno di romanzarle. Era
un ragazzaccio chiacchierone, arrogante e dissipato che quando, rientrato a
Roma nel 68, si presentò candidato al posto di questore, era già carico di
debiti. Li aveva contratti con Crasso dopo aver sedotto anche a lui la moglie
Tertulla. Con quei soldi comprò i voti, fu eletto, ebbe un governatorato e un
comando militare in Spagna, combattè contro i ribelli, e tornò a Roma con la
fama di bravo soldato e di accorto amministratore.
Nel 65 si ripresentò alle elezioni, fu eletto edile e ringraziò i suoi
sostenitori finanziando spettacoli mai visti. Ma fece anche un'altra cosa: fece
ritrasferire in Campidoglio i trofei di vittoria di Mario, che Silla aveva
epurato. Tre anni dopo fu nominato propretore in Spagna. I suoi creditori si
riunirono e chiesero al governo che non lo lasciasse partire prima di aver
pagato. Egli stesso riconobbe di dover loro venticinque milioni di sesterzi. E
Crasso, come al solito, glieli prestò. Cesare tornò fra gl'iberici, li sottomise
quasi completamente, e riportò a Roma un tale bottino che il Senato gli
accordò il trionfo. O forse lo fece soltanto per impedirgli di concorrere al
consolato, visto che la candidatura non poteva essere presentata in propria
assenza, e al trionfatore la legge impediva di tornare a Roma prima della
cerimonia. Ma Cesare ci venne ugualmente, lasciando l'esercito fuor delle
porte di città. E proprio durante questa campagna elettorale cominciò la sua
grande azione politica.
I conservatori detestavano Cesare che aveva difeso Catilina, ricollocato i
trofei di Mario in Campidoglio e ora si presentava come capo dei popolari.
E potevano benissimo impedirgli il successo opponendogli un uomo del
prestigio di Pompeo, che invece delusero, come abbiamo detto, perché erano
gelosi delle sue vittorie e delle sue ricchezze. Queste erano tali che gli
consentivano di tenere un esercito suo proprio: quello con cui sbarcò a
Brindisi di ritorno dall'Oriente e che poteva eleggerlo dittatore con la forza.
Generosamente, Pompeo lo congedò, e fu solo con un piccolo seguito di
ufficiali che entrò a Roma e vi celebrò il trionfo. Coraggioso in battaglia,
Pompeo era timidissimo in fatto di responsabilità politiche e non voleva mai
fare nulla contro la legalità e il "regolamento". Il Senato lo sapeva, ne
approfittò per trattarlo con freddezza e si rifiutò di distribuire ai suoi soldati
le terre ch'egli aveva loro promesso. Cesare ci vide una buona occasione per
attirarlo dalla parte sua e di Crasso.
Questo capolavoro di diplomazia si saldò con un accordo tripartito: il
primo triumvirato. Pompeo e Crasso mettevano la loro influenza, ch'era
grande, e le loro ricchezze, ch'erano immense, al servizio di Cesare per farlo
eleggere console. Questi, assunto il potere, avrebbe distribuito le terre ai
soldati di Pompeo e concesso a Crasso gli appalti cui questi aspirava.
Così fu rotta la famosa "concordia degli ordini" auspicata da Cicerone,
cioè l'alleanza fra l'aristocrazia e l'alta borghesia. Quest'ultima, che vedeva
in Crasso e Pompeo i suoi legittimi rappresentanti, fece lega invece coi
popolari di Cesare. E l'aristocrazia, stupidamente e arrogantemente convinta
di non aver bisogno di aiuti e di non dover dividere i suoi privilegi con
nessuno, rimase isolata. Essa presentò come suo candidato un personaggio
insignificante, Bibulo, che fu eletto. Ma non potè impedire che fosse eletto
anche Cesare, figura di ben altro rilievo.
Cesare mantenne gl'impegni che aveva assunto con gli alleati. Propose
subito la distribuzione delle terre e la ratifica delle misure adottate da
Pompeo in Oriente. Il Senato si oppose. E allora Cesare portò i disegni di
legge davanti all'Assemblea. Era quello che avevano fatto anche i Gracchi, i
quali ci avevano rimesso la pelle. Ma i tempi erano cambiati. Bibulo oppose
il veto dicendo che gli dèi, interrogati, si erano dimostrati contrari.
L'Assemblea gli rise in faccia e un popolare gli rovesciò un vaso da notte in
testa. I progetti furono approvati a grande maggioranza. Pompeo diventò il
genero di Cesare, sposandone la figlia Giulia, borghesi e proletari si
strinsero in un grande abbraccio, e per mesi e mesi si divertirono a spese dei
triumviri, che offrirono magnifici spettacoli nel Circo.
In quest'atmosfera di favore popolare fu facile a Cesare attuare le sue
riforme economiche e sociali, ch'erano poi quelle dei Gracchi. Il Senato le
contrastò tutte mandando regolarmente Bibulo in Assemblea a dire che gli
dèi le disapprovavano. L'Assemblea si infischiava degli dèi e rideva di
Bibulo che alla fine si chiuse in casa e non ne uscì più. Poiché l'uso era di
battezzare l'anno col nome dei due consoli, i romani chiamarono il
cinquantanovesimo "quello di Giulio e Cesare".
Questi lo concluse facendo eleggere come suoi successori per il 58
Gabinio e Pisone, del quale sposò la figlia Calpurnia dopo regolare divorzio
dalla sua terza moglie Pompea, che stava per essere processata per oltraggio
al pudore e alla religione: l'accusavano di aver introdotto il suo amante
Clodio, travestito da donna, nel recinto sacro alla dea Bona, di cui Pompea
era sacerdotessa. Il fatto era vero. Clodio, giovane aristocratico bello,
ambizioso e senza scrupoli, frequentava la casa di Cesare, ne ammirava la
politica e ancora di più la moglie. Non si sa tuttavia se costei fosse sua
complice, quando lo colsero in quell'empio tentativo. Cesare, chiamato a
deporre, proclamò l'innocenza di Pompea. Quando il giudice gli chiese
come mai in tal caso aveva divorziato da lei, rispose: «Perché la moglie di
Cesare non può essere macchiata neanche da un sospetto». E testimoniò
anche in favore di Clodio dicendo che non lo riteneva capace di un simile
gesto, sebbene risultasse ch'egli ne aveva compiuti anche di peggiori: quello
per esempio di sedurre la sua propria sorella, la famosa Clodia, moglie di
Quinto Cecilio Metello, colei che Catullo chiamava Lesbia e che Cicerone
perseguitava con la sua linguaccia. Rancoroso e impiccione com'era, il
grande avvocato venne a testimoniare anche contro il fratello. Ma Cesare
mise in moto Crasso, che comprò i giudici. E Clodio fu assolto.
Perché Cesare tenesse tanto a salvare quello scapestrato che, come oggi
si direbbe, gli aveva disonorato la moglie, lo si vide subito dopo, quando
Clodio si portò candidato per il tribunato della plebe e Cesare lo sostenne.
Evidentemente, dopo aver installato il suocero e un amico intimo nella
carica di consoli, voleva un debitore alla testa del proletariato. Cesare
s'infischiava dell'onore coniugale. Clodio, con tutta quella faccenda, gli
aveva dato il pretesto di liberarsi di una sposa che non gli serviva più a nulla
e di rimpiazzarla con un'altra che gli serviva molto con la sua parentela. Al
momento di lasciare la carica, egli si era autonominato proconsole per
cinque anni della Gallia Cisalpina e Narbonese.
Poiché la legge proibiva di far stazionare truppe dall'Appennino in giù,
chi aveva il comando di quelle dall'Appennino in su era praticamente il
padrone della penisola. E Cesare ormai voleva essere questo padrone.
Sapeva benissimo che il Senato avrebbe fatto il possibile per
impedirglielo. Ma Cesare aveva dimostrato che si poteva governare anche
senza di esso, facendo approvare direttamente le leggi dall'Assemblea. Negli
ultimi tempi si era spinto anche più in là: aveva imposto che tutte le discussioni che si svolgevano in quel solenne e aristocratico consesso
venissero registrate e pubblicate giorno per giorno. Così nacque il primo
giornale. Si chiamò Acta diurna, e fu gratuito, perché, invece di venderlo, lo
affiggevano ai muri in modo che tutti i cittadini potessero leggerlo e
controllare ciò che facevano e dicevano i loro governanti. L'invenzione fu
d'immensa portata perché sancì il più democratico di tutti i diritti. Il Senato,
che traeva prestigio anche dalla sua segretezza, fu così sottoposto alla
pubblica opinione, e non si riebbe mai più da questo colpo.
Con Gabinio e Pisone a guardargli le spalle come consoli; con un
avventuriero facilmente ricattabile come Clodio alla testa della plebe; con
l'amicizia di Pompeo e il sostegno finanziario di Crasso; col Senato
imbrigliato e costretto a rendere conto delle sue decisioni; Cesare ora poteva
allontanarsi anche da Roma per procurarsi quello che tuttavia gli mancava:
la gloria militare e un esercito fedele.
CAPITOLO NONO
LA CONQUISTA DELLA GALLIA
QUANDO Cesare vi giunse nel 58, la Francia era per i romani soltanto un
nome: Gallia. Essi non ne conoscevano che le province meridionali, quelle
che avevano sottoposto a vassallaggio per assicurarsi le comunicazioni
terrestri con la Spagna. Cosa ci fosse più a nord, lo ignoravano.
Più a nord non c'era ciò che oggi si chiama una nazione. Sparpagliate
nelle varie regioni, vivevano delle tribù di razza celtica che passavano il
tempo a farsi la guerra tra loro. Cesare, che tra l'altro era anche un gran
giornalista e aveva il dono dell'osservazione, vide che ognuna di queste tribù
era divisa in tre ceti: i nobili o cavalieri che avevano il monopolio
dell'esercito, i preti o druidi che avevano il monopolio della religione e
dell'istruzione, e il popolo che aveva il monopolio della fame e della paura.
Cesare pensò che per dominare queste tribù bastava tenerle divise, e che per
tenerle divise bastava opporre i cavalieri ai cavalieri. Ognuno, per
combattere l'altro, si sarebbe portato dietro un pezzo di popolo. C'era un
solo pericolo: che i druidi s'intendessero fra loro e costituissero il centro spirituale di una unità nazionale. E per questo bisognava averli tutti dalla parte
di Roma.
Cesare aveva in simpatia i galli per due ragioni: anzitutto perché uno di
loro era stato il suo primo precettore, eppoi perché erano i fratelli di sangue
di quei celti del Piemonte e della Lombardia che Roma aveva già
assoggettato e che costituivano le sue migliori fanterie. Se riusciva a
estendere questa soggezione a tutta la Francia, vi avrebbe trovato una
miniera inesauribile per i suoi eserciti.
Cesare non aveva le forze necessarie a una conquista. Gli avevano dato
solo, per tutto quel po' po' di territorio, quattro legioni, neanche trentamila
uomini. E proprio nel momento in cui ne assumeva il comando,
quattrocentomila elvezi straripavano dalla Svizzera sulla Gallia Narbonese,
minacciando di sommergerla, e centocinquantamila germani traversavano il
Reno per rinforzare nelle Fiandre il loro confratello Ariovisto che già vi si
era stabilito tredici anni prima. Tutta la Gallia impaurita chiese protezione a
Cesare che, senza neanche avvertirne il Senato, arruolò a proprie spese altre
quattro legioni e ingiunse ad Ariovisto di venire a discutere un
accomodamento con lui. Ariovisto rifiutò e Cesare, per affermare il suo
prestigio agli occhi dei suoi nuovi sudditi, non ebbe altra scelta che la guerra
contro di lui e contro gli elvezi.
Furono due campagne temerarie e folgoranti. Battuti, nonostante la loro
enorme superiorità numerica, gli elvezi chiesero di poter ritirarsi nella loro
patria, e Cesare glielo consentì purché accettassero il vassallaggio a Roma. I
germani furono addirittura annientati presso Ostheim. Ariovisto fuggì, ma
morì poco dopo. Lo scapestrato e indebitato donnaiolo si rivelava, sul
campo di battaglia, un formidabile generale.
Approfittando di quel successo che aveva lasciato a bocca aperta tutta la
Gallia, Cesare le chiese di unirsi sotto il suo comando per evitare d'ora in
poi altre invasioni. Ma i galli erano pronti a tutto, fuorché ad andare
d'accordo tra loro. Molte tribù si ribellarono e domandarono aiuto ai belgi,
che accorsero. Cesare li sconfisse, poi sconfisse coloro che li avevano
chiamati, e annunziò a Roma, piuttosto prematuramente, che tutta la Gallia
era sottomessa. II popolo tripudiò, l'Assemblea acclamò, il Senato fece la
bocca torta. Cesare subodorò che i conservatori gli stavano preparando
qualche brutto tiro, rientrò in Italia, e convocò a Lucca Pompeo e Crasso per
rinsaldare con loro, a comune difesa, il triumvirato.
Roma infatti era in preda alle convulsioni, dacché Cesare aveva lasciato
il consolato. Il campione degli aristocratici fino a quel momento era stato
Catone, un reazionario piuttosto ottuso, ma galantuomo. Forse avrebbe
avuto anche idee più aperte, se non avesse portato il nome di suo nonno, il
grande Censore, che le aveva avute chiusissime. Quel nome lo rovinò,
obbligandolo a recitare una parte in cui forse non credeva. Per difendere
l'austerità degli antichi costumi, andava in giro scalzo e senza tunica, sempre
brontolando contro quelli nuovi. Lo aveva fatto anche il primo Catone, ma
mescolando ai suoi brontolii risate schiette e gorgoglianti, sarcasmi pungenti, strippate di fagioli e bevute di chianti. Suo nipote aveva un viso
accigliato e scontroso, un colorito itterico da pastore protestante, e una
bocca acerba, da zitella ossessionata dal rimorso dei peccati non commessi.
Forse rompeva tanto le scatole agli altri perché se le rompeva anche lui, a
fare sempre quella professione di moralista guastafeste. Ma poi era un
moralista a modo suo, che non trovò nulla da obbiettare, per esempio, al
fatto che sua moglie Marcia, scocciata anche lei da un marito così
scocciante (e chi potrebbe darle torto, povera donna?), si prendesse per amico l'avvocato Ortensio, il rivale di Cicerone, ch'era bello e facondo come un
Giovanni Porzio giovane. Anzi, quando se ne accorse, disse all'adultero: «La
vuoi? Te la presto» (così almeno racconta Plutarco). Non solo. Ma quando,
di lì a poco, Ortensio morì, Catone si riprese in casa Marcia e continuò a
vivere con lei come se nulla fosse avvenuto.
Questo curioso uomo aveva tuttavia le sue qualità. Era, anzitutto, onesto.
E ciò spiega come mai in un'epoca in cui era in vendita tutto, ma
specialmente i voti degli elettori, non riuscì a far carriera oltre il grado di
pretore. I senatori, di cui egli difendeva il monopolio politico e che
all'onestà non ci tenevano, avrebbero preferito ch'egli lottasse con armi più
adeguate alla generale corruzione e al nemico che ora si trovavano di fronte:
quel Clodio che, dopo la partenza di Cesare, era diventato il padrone di
Roma e, fra le altre cose, aveva ottenuto dall'Assemblea che Catone fosse
mandato come alto commissario a Cipro Catone obbedì, e i conservatori si
trovarono senza un capo (la testa l'avevano già persa da vari anni).
Per loro fortuna Clodio era, più che un grande politico, un grande
demagogo, e quindi non aveva il senso della misura. Nel suo cieco odio
contro Cicerone si mise a perseguitarlo obbligandolo a fuggire in Grecia, ne
confiscò il patrimonio e ne fece radere al suolo il palazzo sul Palatino.
Ora, Cicerone non era a Roma quello che Cicerone credeva di essere.
Ma rappresentava pur sempre una specie d'istituzione nazionale, e Pompeo e
Cesare furono i primi a disapprovare quelle misure. Ma Clodio non se ne
diede per inteso, si rivoltò contro i suoi due potenti padroni, arruolò una
banda di manganellatori e si diede a terrorizzare la città. Quinto, il fratello di
Cicerone, che aveva chiesto all'Assemblea di richiamare il proscritto, subì
un attentato e se la cavò per miracolo. Ma perché la sua richiesta venisse
accolta, Pompeo dovette assoldare a sua volta una squadra di delinquenti al
comando di Annio Milone, un aristocratico con pochi quattrini e punti
scrupoli come Clodio, cui mosse guerra. Roma diventò allora ciò che
quarant'anni fa era Chicago.
Cicerone, accolto al ritorno da grandi feste, diventò ora l'avvocato dei
triumviri che lo avevano salvato, ne sostenne la causa di fronte al Senato,
fece concedere a Cesare nuovi fondi per le sue truppe in Gallia e a Pompeo
un commissariato con pieni poteri per sei anni per risolvere il problema
alimentare della penisola. Ma nel 57 Catone tornò da Cipro dove aveva
brillantemente assolto le sue mansioni e, sotto la sua guida, i conservatori
ripresero la lotta contro i triumviri. Calvo e Catullo riempirono Roma di
epigrammi contro di loro. Presentandosi candidato per il consolato del 56,
l'aristocratico Domizio impostò la sua campagna elettorale sulla revoca delle
leggi agrarie di Cesare. Cicerone fiutò, come al solito, il vento, credette che
spirasse in favore delle destre, si schierò dalla parte di Domizio, e denunzie
per malversazioni Pisone, il suocero di Cesare.
Fu per mettere riparo a tutto questo che i triumviri s'incontrarono a
Lucca, dove fu deciso che Crasso e Pompeo si ripresentassero al consolato
e, dopo la vittoria, riconfermassero Cesare governatore della Gallia per altri
cinque anni. Spirato il loro termine, Crasso avrebbe avuto la Siria e Pompeo
la Spagna. Così, fra tutti e tre, sarebbero stati padroni di tutto quanto
l'esercito.
Il piano funzionò perché le ricchezze di Crasso e di Pompeo, aumentate
dai contributi di Cesare che ora aveva in mano il portafogli di tutta la Gallia,
bastarono a comprare una maggioranza. E così il proconsole potè tornare
nelle sue province, dove frattanto si profilava una nuova invasione
germanica. Cesare massacrò gl'intrusi respingendoli oltre il Reno, poi
attraversò con un piccolo distaccamento la Manica, e per la prima volta con
lui i romani calpestarono il suolo inglese. Non si sa con precisione perché ci
andò: forse solo per vedere cosa c'era. Ci rimase pochi giorni, sconfisse le
poche tribù che trovò sulla sua strada, prese qualche appunto e tornò
indietro. Ma l'anno dopo ritentò l'avventura con forze maggiori, battè un
esercito indigeno guidato da Cassivelauno, si spinse fino al Tamigi, e forse
sarebbe andato anche più in là, se di Gallia non gli fosse giunta la notizia
che la rivolta era scoppiata.
Cesare lo ritenne lì per lì un episodio di ordinaria amministrazione.
Sbarcato sul continente, sbaragliò gli eburoni che avevano preso l'iniziativa
rivoluzionaria, e lasciò nelle loro settentrionali province il forte del suo
esercito a presidiarle, per tornarsene con piccola scorta in Lombardia. Ma vi
era da poco arrivato quando seppe che tutta la Gallia era in subbuglio, per la
prima volta unita agli ordini di un abile capo, Vercingetorige. Cesare lo
conosceva: era un guerriero dell'Alvernia, terra di soldatacci montanari e
robusti, figliolo d'un Celtillo che aveva aspirato a diventare re di tutta la
Gallia, e per questo i suoi lo avevano ammazzato. Forse il giovanotto
nutriva le stesse ambizioni del padre e aveva sperato di ricevere l'investitura
da Cesare, di cui si era mostrato amico. Deluso, si rivoltava. Ma, più
giudizioso degli altri, faceva appello al sentimento nazionale e si era
assicurato l'appoggio dei druidi, che gli avevano dato una sanzione
religiosa.
Ora Vercingetorige stava con grosse forze fra Cesare a sud e il suo
esercito a nord. La situazione non poteva essere peggiore. Cesare l'affrontò
con la consueta audacia. Coi suoi sparuti drappelli, riattraversò le Alpi e
prese a risalire la Francia, paese ormai tutto nemico. Camminò a piedi giorno e notte, alla testa dei suoi soldati, fra le nevi delle Cevenne, puntando
sulla capitale avversaria. Vercingetorige vi accorse per difenderla. Cesare
lasciò il comando a Decimo Bruto e, con una scorta di pochi cavalieri, filtrò
fra le linee nemiche verso il grosso delle sue forze. Le riunì, battè
separatamente gli àvari e i cenabi, saccheggiando le loro città, ma di fronte a
Gergovia dovette ritirarsi, tallonato dagli edui, che aveva considerato i più
fedeli tra i suoi alleati e che ora lo abbandonavano.
Si accorse di essere solo, uno contro dieci, in un paese ostile, e si
considerò perduto. Giocando tutto per tutto, mosse su Alesia, dove
Vercingetorige aveva ammassato l'esercito, e vi mise l'assedio. Subito, da
tutte le parti i galli accorsero per liberare il loro capitano. Erano
duecentocinquantamila quelli che si concentrarono contro le quattro legioni
romane. Cesare ordinò ai suoi d'innalzare due valli: uno verso la città
assediata, uno di fronte alle forze che accorrevano in suo aiuto. E fra questi
due bastioni sistemò i suoi con le poche munizioni e vettovaglie che ancora
avevano. Dopo una settimana di disperata resistenza su due fronti, i romani
erano alla fame, ma i galli erano a loro volta nell'anarchia, e cominciarono a
ritirarsi in disordine. Cesare racconta che, se avessero insistito ancora per un
giorno, avrebbero vinto.
Vercingetorige in persona uscì dalla città stremata a chiedere grazia.
Cesare la concesse alla città, ma i ribelli diventarono proprietà dei legionari
che li rivendettero come schiavi e ci fecero il loro gruzzolo. Lo sfortunato
capitano fu condotto a Roma, dove l'anno dopo seguì in catene il carro del
trionfatore, che lo "sacrificò agli dèi", come si diceva a quei tempi.
Cesare rimase ancora quell'anno in Gallia a liquidare i resti della rivolta.
Lo fece con una severità che non era abituale in lui, mostratosi sempre
generoso con l'avversario vinto. Ma, una volta inflitto il castigo con la
soppressione dei capi, tornò ai suoi metodi di clemenza e di comprensione.
E così, dosando con sapienza il pugno duro e la carezza, fece dei galli un
popolo rispettoso e attaccato a Roma, come si vide durante la guerra civile
contro Pompeo, quando essi non abbozzarono nemmeno un tentativo per
scuotere il tentennante giogo che li teneva soggetti.
Roma non si rese conto della grandezza del dono che il suo proconsole
le aveva fatto. Essa vide nella Gallia soltanto una nuova provincia da
sfruttare, grande due volte l'Italia e popolata di cinque milioni di abitanti.
Certo, non poteva supporre che Cesare vi avesse fondato una nazione
destinata a perpetuare e diffondere la civiltà e la lingua di Roma in tutta
Europa. Eppoi, in quel momento non aveva tempo di occuparsi di queste
faccende, impegnata com'era nelle sue discordie.
Crasso, dopo il consolato, era partito per la Siria, come si era stabilito a
Lucca; nella sua smania di gloria militare aveva mosso guerra ai parti, ne era
stato sconfitto a Carre e, mentre trattava col generale vincitore, questi lo
aveva ucciso e ne aveva mandato la testa mozza a decorare in teatro una
scena di Euripide. Pompeo invece, fattosi dare un esercito per governare la
Spagna, era rimasto con esso in Italia in un atteggiamento che non lasciava
presagire nulla di buono. Il più forte vincolo che lo univa a Cesare era
scomparso con la morte di Giulia. Cesare gli offrì di rimpiazzarla con la
nipotina Ottavia. E, il vedovo avendo rifiutato, offrì se stesso come sposo
della figlia di lui al posto di Calpurnia da cui avrebbe divorziato. A Roma si
passava con disinvoltura dalla condizione di suocero a quella di genero. Ma
Pompeo respinse anche questa proposta: non teneva a una parentela con
Cesare, perché finalmente s'era messo d'accordo coi conservatori e n'era
diventato il campione. Sapendo che il proconsolato di Cesare sarebbe finito
nel 49, si fece protrarre il proprio fino al 46. Così sarebbe rimasto il solo, fra
i due, ad avere un esercito.
La democrazia agonizzava sotto i colpi di Clodio e di Milone che
l'avevano ridotta a una questione di manganelli. Alla fine Milone accoppò
Clodio, che poco prima gli aveva bruciato la casa. La plebe tributò al
defunto onoranze da martire, ne portò il cadavere in Senato e appiccò il
fuoco al palazzo. Pompeo chiamò i suoi soldati a sedare il tumulto, e così
rimase padrone della città. Cicerone salutò in lui il "console senza collega";
e la formula piacque ai conservatori che l'adottarono perché consentiva di
attribuire a Pompeo i poteri del dittatore evitando la sgradita parola. Pompeo
acquartierò in Roma tutto il suo esercito, all'ombra del quale l'Assemblea
tenne le sue sedute e i tribunali i loro processi. Fra questi ultimi, famoso
quello di Milone che venne condannato per l'assassinio di Clodio, nonostante la difesa di Cicerone, il quale poi pubblicò la sua arringa. Quando
Milone, fuggito a Marsiglia, la lesse, esclamò: «O Cicerone, se tu avessi
davvero pronunziato le parole che hai scritto, non sarei qui a mangiar
pesce!». Il che ci fa nascere molti dubbi sulla rispondenza degli scritti del
grande avvocato coi suoi discorsi veri.
Pompeo ripropose la legge che esigeva la presenza in città per
concorrere al consolato. L'Assemblea, presidiata dalle sue truppe, approvò.
Era l'esclusione di Cesare, che non poteva tornare prima del giorno fissato
per il trionfo. Correva l'anno 49, la carica di Cesare spirava il 1° di marzo,
ma Marco Marcello sostenne che bisognava anticipare quel termine. I
tribuni della plebe opposero il veto, ma il veto presupponeva una legalità
democratica che non c'era più. E Catone rincarò la dose proclamando che
Cesare doveva essere processato e bandito dall'Italia.
Come ringraziamento per la conquista della Gallia, non c'era male.
CAPITOLO DECIMO
IL RUBICONE
LE esitazioni di Cesare prima di scatenare la guerra civile hanno fatto la
gioia di molti scrittori e la fortuna di un fiumiciattolo, di cui altrimenti
nessuno conoscerebbe il nome: il Rubicone. Esso marcava, presso Rimini, il
confine fra la Gallia Cisalpina, dove il proconsole aveva diritto di tenere i
suoi soldati, e l'Italia vera e propria, dove la legge gli vietava di condurli; e
fu sulle sue sponde che gli storici descrivono Cesare meditabondo e roso dai
dubbi. Ma il fatto è che quando Cesare giunse lì, la decisione l'aveva già
presa o, per meglio dire, gliel'avevano già imposta.
Pur di evitare una lotta fra romani, egli aveva accettato tutte le proposte
avanzate da Pompeo e dal Senato che ormai erano una cosa sola: di mandare
una delle sue scarsissime legioni in Oriente a vendicarvi Crasso, di
restituirne un'altra a Pompeo che gliel'aveva prestata per le operazioni in
Gallia. Ma quando il Senato definitivamente gli rispose impedendogli di
concorrere al consolato e mettendolo alla scelta: o sbandare l'esercito, o
essere dichiarato nemico pubblico, egli comprese che, scegliendo la prima
alternativa, si consegnava inerme nelle mani di uno stato che voleva la sua
pelle. Avanzò ancora un'ultima proposta, che i suoi luogotenenti Curione e
Antonio vennero a leggere, sotto forma di lettera, in Senato: egli avrebbe
congedato otto delle sue dieci legioni, se gli prolungavano il governatorato
della Gallia fino al 48. Pompeo e Cicerone si pronunziarono in favore; ma il
console Lentulo cacciò i due messi fuori dell'aula, e Catone e Marcello
chiesero al Senato, che consentì controvoglia, di conferire a Pompeo i poteri
per impedire che "pregiudizio fosse recato alla cosa pubblica". Era la
formula di applicazione della legge marziale. Essa metteva definitivamente
Cesare con le spalle al muro.
Cesare adunò la sua legione favorita, la tredicesima, e parlò ai soldati,
chiamandoli non milites, ma commilitones. Poteva farlo. Oltre che il loro
generale, egli era stato davvero anche il loro compagno. Erano dieci anni
che li conduceva di fatica in fatica e di vittoria in vittoria, alternando
sapientemente l'indulgenza al rigore. Quei veterani erano veri e propri
professionisti della guerra, se ne intendevano, e sapevano misurare i loro
ufficiali. Per Cesare, che di rado era dovuto ricorrere alla propria autorità
per affermare il proprio prestigio, avevano un rispettoso affetto. E quando
egli ebbe spiegato loro come stavano le cose e chiese se se la sentivano di
affrontare Roma, la loro patria, in una guerra che, a perderla, li avrebbe
qualificati traditori, risposero di sì all'unanimità. Erano quasi tutti galli del
Piemonte e della Lombardia: gente a cui Cesare aveva dato la cittadinanza
che il Senato si ostinava a disconoscerle. La loro patria era lui, il generale. E
quando questi li avvertì che non aveva neanche i soldi per pagar loro la cinquina, essi risposero versando nelle casse della legione i loro risparmi. Uno
solo disertò per schierarsi con Pompeo: Tito Labieno. Cesare lo considerava
il più abile e fidato dei suoi luogotenenti. Gli spedì dietro il bagaglio e lo
stipendio, che il fuggiasco non si era curato di ritirare.
Il 10 gennaio di quell'anno 49 "trasse il dado" com'ebbe a dire egli
stesso, cioè passò il Rubicone con quella legione, seimila uomini, contro i
sessantamila che Pompeo già aveva raccolto. A Piceno lo raggiunse la
dodicesima, a Corfinio l'ottava. Altre tre ne formò con volontari del posto,
che non avevano dimenticato Mario e ne vedevano in Cesare, suo nipote, il
continuatore. Le città si aprono dinanzi a lui e lo salutano come un dio,
scrisse Cicerone, che cominciava a non essere più sicuro di aver scelto bene
schierandosi coi conservatori. In realtà l'Italia era stanca di costoro e non
opponeva resistenza al ribelle, che la ripagava con lungimirante clemenza:
niente saccheggi, niente prigionieri, niente epurazioni.
Durante questa incruenta avanzata su Roma, Cesare seguitò a cercare un
compromesso, o almeno a darsi le arie di cercarlo. Scrisse a Lentulo
prospettandogli i disastri cui Roma poteva andare incontro con quella lotta
fratricida; scrisse a Cicerone dicendogli di riferire a Pompeo ch'egli era
pronto a ritirarsi a vita privata, se gli garantivano la sicurezza. Ma, senza
aspettare le risposte, seguitò ad avanzare contro Pompeo che avanzava
anche lui, ma verso sud.
Pur respingendo le offerte di Cesare, i conservatori avevano
abbandonato Roma, dopo aver dichiarato che avrebbero considerato nemici i
senatori che vi fossero rimasti. Carichi di soldi, di pretese e d'insolenza,
ognuno con servi, mogli, amiche, efebi, tende di lusso, biancheria di lino,
uniformi e pennacchi, questi aristocratici facevano schiamazzante codazzo a
Pompeo, frastornandogli il cervello con le loro chiacchiere. Pompeo non
aveva avuto gran carattere nemmeno quand'era giovane e magro. Ora,
invecchiato e imbolsito, aveva perso anche quel poco; e per non affrontare
una decisione, seguitò a ritirarsi fino a Brindisi, dove caricò tutto il suo
esercito sulle navi e lo traghettò a Durazzo. Curiosa tattica, per un generale
che aveva un esercito doppio di quello avversario. Ma disse che voleva allenarlo e disciplinarlo, prima di affrontare la battaglia risolutiva.
Cesare entrò in Roma il 16 marzo, lasciando l'esercito fuori della città. Si
era ribellato allo stato, ma ne rispettava i regolamenti. Chiese il titolo di
dittatore, e il Senato rifiutò. Chiese che fossero mandati messi di pace a
Pompeo, e il Senato rifiutò. Chiese di poter disporre del Tesoro, e il tribuno
Lucio Metello oppose il veto. Cesare disse: «Tanto mi è difficile
pronunciare minacce, quanto mi è facile eseguirle». Subito il Tesoro gli
venne messo a disposizione. Cesare, prima di vuotarlo per impinguare le
casse dei suoi reggimenti, vi versò tutto il bottino accumulato nelle ultime
campagne. Il furto, sì; ma, prima, la legalità.
I conservatori preparavano la riscossa ammassando tre eserciti: quello di
Pompeo in Albania, quello di Catone in Sicilia, e un altro in Spagna.
Contavano di far capitolare Cesare e l'Italia per fame, senza bisogno di una
battaglia che paventavano. Cesare mandò in Sicilia due legioni al comando
di Curione, che inseguì Catone imbarcatosi per l'Africa, lo attaccò senz'adeguata preparazione, fu sconfitto e morì in combattimento chiedendo perdono
a Cesare del male che gli aveva fatto. Contro la Spagna andò Cesare in
persona per assicurarsi i rifornimenti di grano. Credeva che i pompeiani vi
fossero meno forti e si trovò di fronte a impreviste difficoltà. Ma Cesare
dava il meglio di sé nei momenti di pericolo. Un giorno, assediato, dirottò
un fiume e divenne assediante. Il nemico capitolò, e la Spagna fu di nuovo
sotto il controllo di Roma. Il popolo, liberato dallo spettro della carestia, lo
acclamò, e il Senato gli diede il titolo di dittatore. Ma ora fu Cesare a
rifiutarlo: gli bastava quello di console, che gli conferirono gli elettori.
Con l'abituale speditezza, rimise ordine nelle faccende interne dello
stato, ma senza processi, né bandi, né confische. Poi radunò l'esercito a
Brindisi, imbarcò ventimila uomini sulle dodici navi che aveva a
disposizione, e li sbarcò in Albania sulle tracce di Pompeo, che rimase di
stucco convinto com'era che d'inverno nessuno avrebbe osato traversare quel
braccio di mare pattugliato dalla sua potente flotta. Perché non abbia
attaccato subito quel temerario nemico, capitatogli a tiro con sì poche forze,
non lo si è mai saputo. Eppure, ebbe dalla sua anche la tempesta che mandò
a picco la squadra di Cesare, impedendole di traghettare il resto dell'esercito.
Sulla barca con cui cercò di raggiungere tuttavia la costa italiana, Cesare
gridava ai vogatori atterriti: « Non abbiate paura: state trasportando Cesare e
la sua stella». Ma l'uragano ributtò sugli scogli l'uno e l'altra, che, se
Pompeo in quel momento avesse preso l'iniziativa, non sarebbero mai più
risorti.
Il tempo finalmente si rimise al bello, e in rinforzo alle demoralizzate
truppe di Cesare giunse Marc'Antonio, il migliore dei suoi luogotenenti, con
altri uomini e la sussistenza. Prima di attaccare, Cesare dice di aver mandato
a Pompeo una nuova proposta di pace, che non ebbe effetto. Ma nemmeno
l'attacco di Cesare ebbe effetto. Pompeo resistè, prese alcuni prigionieri, e li
uccise. Anche Cesare prese dei prigionieri, ma li arruolò. I suoi veterani
riconobbero che la battaglia era andata male perché non ci avevano messo
impegno e chiesero di esserne castigati. Cesare rifiutò ed essi lo
supplicarono di ricondurli all'attacco. Egli invece li condusse in Tessaglia a
riposarsi e a rifocillarsi in quel granaio.
Nel campo di Pompeo, Afranio consigliava di tornare nell'indifesa Roma
abbandonando Cesare al suo destino. Ma la maggioranza fu per dargli il
colpo di grazia perché lo consideravano ormai già vinto. Pompeo che, non
avendo idee, seguiva quelle degli altri, mosse dietro al nemico, e lo
raggiunse nella piana di Farsalo. Aveva cinquantamila fanti e settemila
cavalieri; Cesare, ventiduemila fanti e mille cavalieri. La vigilia della
battaglia, nel campo di Pompeo ci furono gran banchetti, discorsi, bevute e
brindisi alla certa vittoria. Cesare mangiò un rancio di grano e cavoli coi
suoi soldati, nel fango della trincea. Di fronte a lui, che impartiva ordini
indiscutibili ai suoi ufficiali, c'erano mille strateghi chiacchieroni con mille
piani diversi e un generale che aspettava che gliene suggerissero uno.
Farsalo fu il capolavoro di Cesare, che perse duecento uomini soli, ne
uccise quindicimila, ne catturò ventimila, ordinò di risparmiarli, e celebrò la
vittoria consumando, sotto la sontuosa tenda di Pompeo, il pranzo che i
cuochi avevano preparato a costui per celebrarne il trionfo. Lo sventurato
generale in quel momento cavalcava verso Larissa, sempre seguito da quella
turba di aristocratici fannulloni, tra i quali c'era anche un certo Bruto, di cui
Cesare aveva cercato il cadavere sul campo di battaglia col terrore di trovarcelo. Era figlio della sua vecchia amante Servilia, la sorellastra di
Catone, e forse ne era egli stesso il padre. Respirò, quando ricevette da
Larissa una lettera di lui che gli chiedeva perdono e ne impetrava altrettanto
per il cognato Cassio, che aveva sposato sua sorella Terzia (succeduta a sua
madre Servilia nelle grazie di Cesare) e che era caduto prigioniero con gli
altri pompeiani.
Cesare diede subito l'assoluzione ad ambedue perché Roma era allora ciò
che Ennio Flaiano dice che oggi è l'Italia: un paese non soltanto di poeti, di
eroi, di navigatori, ma anche di zii, di nipoti e di cugini.
Ma torniamo a Pompeo che, raggiunta a Mitilene sua moglie, con essa
s'imbarcava alla volta dell'Africa, probabilmente col proposito di mettersi
alla testa dell'ultimo esercito senatoriale: quello che erano venuti
organizzando a Utica Catone e Labieno. La nave gettò l'àncora nelle acque
d'Egitto, stato vassallo di Roma, che lo amministrava attraverso il suo
giovane re, Tolomeo XII. Era un signorotto mezzo degenerato e mezzo
citrullo, in balìa di un vizir, cioè di un primo ministro eunuco e canaglia:
Potino. Costui sapeva già di Farsalo, e credette di assicurarsi la gratitudine
del vincitore assassinando il vinto. Pompeo fu pugnalato alle spalle sotto gli
occhi della moglie, mentre sbarcava da una scialuppa. E la sua testa fu
presentata a Cesare che storse la propria con orrore, quando arrivò e la vide.
Cesare non amava il sangue, nemmeno quello dei suoi nemici. E non c'è
dubbio che avrebbe graziato Pompeo, se lo avesse catturato vivo.
Oramai ch'era lì, Cesare volle, prima di tornare a Roma, mettere a posto
le faccende di quel paese, che da tempo stava andando in malora. Tolomeo
avrebbe dovuto, secondo il testamento di suo padre, dividere il trono con
sua sorella Cleopatra, dopo averla sposata (questi amori tra fratelli in Egitto
son rimasti frequenti fino a Faruk: fanno parte del "color locale"). Ma
Cleopatra, quando Cesare giunse, non c'era: Potino l'aveva confinata e
rinchiusa per poter fare il suo comodo. Cesare la mandò a chiamare di
nascosto. Per raggiungerlo, essa si fece nascondere tra le coltri di un letto
che il servo Apollodoro doveva portare negli appartamenti dell'illustre
ospite a palazzo reale. Questi la trovò al momento di coricarsi: un momento
particolarmente propizio a una donna di quella fatta.
Non bellissima, ma piena di sex-appeal, bionda, serpentina, maestra
sapiente di ciprie e di cosmetici, con una voce melodiosa che non corrispondeva affatto, come spesso capita, al suo carattere avido e calcolatore,
intellettuale quanto bastava per tenere in piedi con brio una conversazione, e
assolutamente ignara di tutto quel che potesse rassomigliare al pudore; era
proprio quel che ci voleva per un donnaiolo spregiudicato come Cesare
dopo tutti quei mesi di trincea e di astinenza. Perché in fatto di femmine
Cesare era rimasto quello di prima e di sempre: per lui, quel ch'era lasciato
era perso.
L'indomani egli rimise d'accordo fratello e sorella, cioè praticamente
ridiede tutto il potere a costei ai danni di Potino che venne discretamente
soppresso, con la scusa, forse vera, che stava tramando un complotto.
Purtroppo, la città insorse contro Cesare, e la guarnigione romana che la
presidiava si unì ai ribelli. Cesare coi suoi pochi uomini trasformò il palazzo
reale in un fortino, spedì un messo in Asia Minore a chiedere rinforzi, fece
bruciare la flotta perché non cadesse in mano al nemico (e purtroppo l'incendio si propagò anche alla grande biblioteca, onore e vanto di Alessandria), e
con un colpo di mano ch'egli stesso guidò gettandosi a nuoto, s'impadronì
dell'isolotto di Faro, dove aspettò i rinforzi che sopraggiungevano per mare.
Tolomeo credette ch'egli fosse perduto, si unì ai ribelli, e non se ne seppe
più nulla. Cleopatra rimase coraggiosamente con Cesare che, al
sopraggiungere dei suoi, sbaragliò gli egiziani e la rimise sul trono.
Rimase nove mesi con lei, quanti le occorsero per mettere al mondo un
bambino che fu chiamato, perché non ci fossero dubbi sulla sua paternità,
Cesarione. Dovett'essere un grande amore, per rendere Cesare sordo agli
appelli di Roma, caduta preda in sua assenza delle "squadre" di Milone,
tornato da Marsiglia. Finalmente, alla notizia ch'egli stava per intraprendere
con lei un lungo viaggio sul Nilo, i suoi stessi soldati si ribellarono: fra loro
era corsa voce che il generale volesse sposarla e restare in Egitto come re
del Mediterraneo.
Allora Cesare si scosse, si rimise alla testa dei suoi, accorse in Asia
Minore dove "venne, vide, e vinse" a Zela, contro Farnace, il ribelle figlio di
Mitridate.
Poi s'imbarcò per Taranto, dove Cicerone e altri ex conservatori gli
vennero incontro con la testa coperta di cenere. Con la consueta magnanimità, Cesare troncò loro in bocca le parole di contrizione e tese la mano.
Tutti ne furono talmente felici, che non ebbero né il tempo né la voglia di
scandalizzarsi per il fatto che il padrone tornasse in una Roma piena di
stragi e di lutti, portandosi al seguito una donna vestita e truccata come una
sciantosa che si spingeva avanti la carrozzella con dentro un marmocchio
piagnucoloso.
Con questa vivente "preda bellica" egli si ripresentò all'Urbe e alla
propria moglie Calpurnia, che non battè ciglio perché c'era abituata. Essa
tuttavia fu l'unica, probabilmente, ad accorgersi che Cleopatra aveva il naso
un po' lungo. E siamo sicuri che la cosa le fece molto piacere.
CAPITOLO UNDICESIMO
GL'IDI DI MARZO
LA situazione a Roma non era allegra. Il grano non arrivava più dalla
Spagna, dove il figlio di Pompeo aveva organizzato un altro esercito, né
dall'Africa, dove Catone e Labieno erano ormai padroni del campo e
avevano ai loro ordini forze uguali a quelle ch'erano state sconfitte a
Farsalo. All'interno il caos dilagava. Il genero di Cicerone, Dolabella, si era
coalizzato con Celio, il successore di Clodio e il capo degli estremisti.
Insieme essi avevano ordinato la cancellazione di tutti i debiti, che voleva
dire il marasma economico, e richiamato da Marsiglia Milone, il gran
maestro della demagogia e del manganello. Marcantonio che, in
rappresentanza di Cesare, doveva mantenere l'ordine e aveva le maniere
spicce del soldataccio, aveva scatenato la truppa, un migliaio di romani
erano stati sgozzati nel Foro, e Celio e Milone erano fuggiti per organizzare
la rivolta in provincia, dove varie legioni si erano ribellate.
Cesare, abituato a battersi a destra, cioè contro i reazionari, detestava
aver nemici a sinistra e non voleva far la fine di Mario, costretto, per
rimettere ordine, a massacrare i suoi. Cominciò a dipanare la sua matassa
politica dai soldati «perché», disse, «essi dipendono dal denaro, che dipende
dalla forza, che dipende da loro». Si presentò solo e disarmato alle legioni
rivoltate, e disse con la sua abituale calma che riconosceva legittime le loro
rivendicazioni e che le avrebbe soddisfatte al ritorno dall'Africa, dove
andava a combattere «con altri soldati». A quelle parole, dice Svetonio, i
veterani trasalirono di vergogna e di pentimento, gridarono che questo non
poteva essere, che i soldati di Cesare erano loro e intendevano restarlo.
Cesare finse qualche difficoltà, poi si arrese per il semplice motivo che di
soldati non ne aveva altri. Quel gran generale era anche, come oggi si
direbbe, un gran filone. Caricò sulle navi quella truppa che ribolliva di
ardori di redenzione, sbarcò in Africa nell'aprile del 46, a Tapso, e trovò ad
aspettarlo ottantamila uomini al comando di Catone, Metello Scipione, il
suo ex luogotenente Labieno, e Giuba, re di Numidia.
Ancora una volta si trovò a lottare uno contro tre. Ancora una volta perse
il primo scontro. Ancora una volta vinse la battaglia decisiva, che fu
terribile. In quest'occasione i suoi soldati non rispettarono gli ordini di
clemenza e massacrarono i prigionieri. Giuba si uccise sul campo. Scipione
fu raggiunto sul mare e accoppato. Catone si rinchiuse a Utica con un
piccolo distaccamento, consigliò a suo figlio di sottomettersi a Cesare,
distribuì il denaro che aveva in cassa a quanti gliene chiesero per fuggire,
offrì un pranzo ai suoi più intimi amici, li intrattenne su Socrate e Platone.
Poi, ritiratosi nella sua stanza, s'immerse il pugnale nella pancia. I servi se
ne accorsero e chiamarono un dottore che alla meglio rimise al loro posto
gl'intestini traboccanti fuor della ferita e la bendò. Catone si finse in coma.
Poi, quando fu lasciato solo, si tolse la fasciatura, e riaprì lo squarcio con le
proprie mani.
Lo trovarono morto, con la testa reclinata sulle pagine del Fedone di
Platone. Cesare, addolorato, disse che non poteva perdonargli di avergli
tolto l'occasione di perdonarlo. Gli fece fare solenni funerali e riversò la sua
clemenza sul figlio. Egli stesso sentiva forse che quell'uomo sgradevole e
per molti rispetti antipatico si portava nella tomba le virtù della Roma
repubblicana. Avrebbe volentieri barattato la vita di quel nemico con quella
di molti amici: Cicerone, per esempio.
Dopo una breve sosta a Roma, andò a dare il colpo di grazia all'ultimo
esercito pompeiano, quello di Spagna. Lo sbaragliò a Munda, e finalmente
potè dedicarsi interamente all'opera di riorganizzazione dello stato. Ne
aveva ormai i poteri perché il Senato gli aveva concesso il titolo di dittatore
dapprima per dieci anni, poi a vita. Ma l'impresa era gigantesca, e avrebbe
richiesto una classe dirigente che Cesare non aveva. Egli invitò i suoi antichi
avversari aristocratici, ch'erano i più competenti, a collaborare con lui. Gli
risposero con sarcasmi e complotti, ritirando fuori la vecchia favola del
progettato matrimonio con Cleopatra e del trasferimento della capitale ad
Alessandria. Cesare non potè contare che su un gruppo di pochi amici fidati,
ma inesperti di amministrazione, con cui formò una specie di ministero:
Balbo, Marc'Antonio, Dolabella, Oppio, eccetera. L'Assemblea era dalla
parte sua. Il Senato lo ridusse a un corpo puramente consultivo, dopo averne
portato i membri da sei a novecento con l'immissione di nuovi elementi
scelti parte tra la borghesia di Roma, parte tra quella di provincia, parte tra i
suoi vecchi ufficiali celti, molti dei quali erano figli di schiavi.
Questa manovra faceva parte di un più vasto progetto che Cesare aveva
abbozzato quando aveva concesso la cittadinanza alla Gallia Cispadana. Il
Senato non aveva mai convalidato quella misura; ma ora dovette accettare
ch'essa venisse estesa a tutta l'Italia. Cesare aveva capito che non c'era più
nulla da sperare dai romani di Roma, ormai ammolliti, imbastarditi e
incapaci di fornire altro che degl'intrallazzatori e dei disertori. Egli sapeva
che il buono era solo in provincia, dove la famiglia era rimasta salda, i
costumi sani, l'educazione severa. E con questi provinciali di origine
contadina o piccoloborghe se intendeva riformare i quadri della burocrazia e
dell'esercito.
La sua vera rivoluzione era questa, ed egli cercò di realizzarla attraverso
la grande riforma agraria progettata dai Gracchi. Per riuscirvi, chiamò a
collaborare l'alta borghesia industriale e mercantile, che finanziò
l'operazione. Grandi capitalisti come Balbo e Attico diventarono i suoi
banchieri e consiglieri. Cesare spiegò in questa bisogna la stessa energia che
aveva spiegato come generale in battaglia. Voleva tutto vedere, tutto sapere,
tutto decidere. Non ammetteva sprechi e incompetenze. E per escludere gli
uni e le altre, il tempo non gli bastava mai. La politica del pieno impiego
della manodopera si conciliava benissimo col mal della pietra che lo
affliggeva. Cesare era un costruttore nato e trascorreva in letizia le sue
indaffaratissime giornate. I pettegolezzi dei suoi nemici contro di lui, invece
d'irritarlo, lo divertivano.
Se li faceva raccontare per poi riraccontarli egli stesso a Calpurnia, con
la quale era tornato a vivere dopo la parentesi di Cleopatra. Era, a modo suo,
un buon marito che ripagava la moglie di tutte le corna che le aveva messo,
con mille attenzioni, una profonda stima e un affettuoso cameratismo.
Aveva sempre qualcosa da raccontarle, quando tornava dall'ufficio, dove
trattava collaboratori e sottoposti col signorile distacco che gli era abituale.
Era accurato nel vestire, e delle facoltà insite nel suo titolo di dittatore approfittava solo di quella che gli consentiva di portare la corona di lauro sulla
testa per nascondere la calvizie. Faceva tutto con eleganza: anche il regalo
del perdono a chi gli aveva recato offesa. Anzi, le offese preferiva, se
poteva, ignorarle. Per questo aveva bruciato, senza leggerla, la
corrispondenza che Pompeo aveva lasciato nella sua tenda a Farsalo, e
quella di Scipione a Tapso. Chissà quante porcherie, tradimenti, doppi
giuochi ci avrebbe scoperto. Quando aveva saputo che Sesto si preparava a
vendicare il padre in Spagna, gli aveva mandato i nipoti rimasti a Roma. E
dei suoi due avversari Bruto e Cassio aveva fatto due governatori di
provincia. Forse in questa magnanimità c'era anche un po' di disprezzo per
gli uomini: un carattere che si accompagna quasi sempre alla grandezza. E
forse in questo disprezzo sta anche la ragione della sua totale indifferenza ai
pericoli che lo minacciavano. Egli non poteva ignorare che intorno a lui si
complottava e che la generosità è uno stimolante, non un sedativo, dell'odio.
Ma non riteneva i suoi nemici abbastanza coraggiosi per osare. E sognava
nuove imprese: di vendicare Crasso contro i parti, di estendere l'Impero
sulla Germania e la Scizia, di rifondere definitivamente tutta la società
italiana sul livello di una classe media provinciale e campagnola più vigorosa e aderente all'antico costume.
Nel febbraio di quell'anno 48 stava già redigendo i piani per quelle
campagne, quando Cassio si mise alla testa della cospirazione e cercò di
attrarvi Bruto, che Cesare seguitava ad amare come un suo figlio, forse
sapendo che lo era. I romanzieri e i drammaturghi hanno poi fatto di questo
giovanotto un eroe delle libertà repubblicane. Noi dubitiamo che lo fosse. Il
complotto era ammantato di nobili ideali: diceva di voler la morte di un
tiranno che aspirava alla corona di re per dividerla con Cleopatra, la
meretrice forestiera, eppoi lasciarla al bastardo Cesarione dopo averne
trasferito la capitale in Egitto. O non si era fatto innalzare una statua accanto
a quella dei vecchi re? O non aveva fatto incidere il proprio volto sulle
nuove monete? Il potere gli aveva dato alla testa, già turbata da un ritorno di
attacchi epilettici. Meglio, anche per lui e per la sua memoria, sopprimerlo,
prima che avesse il destro di distruggere in un colpo solo la libertà e la
supremazia di Roma.
Furono questi probabilmente gli argomenti che il "pallido e magro"
Cassio, come lo descrive Plutarco, usò per convincere suo cognato. Ma
forse quelli che trionfarono furono altri, più personali e segreti. Bruto
detestava Cesare non perché ignorava di esserne il figlio, ma perché sapeva
di esserlo. Forse egli non aveva mai perdonato a sua madre di aver fatto di
lui un bastardo. Ma sono supposizioni perché Bruto era taciturno e segreto.
Una fonte molto dubbia ha riferito ch'egli scrisse in una lettera a un amico: I
nostri antichi ci hanno insegnato che non bisogna subire un tiranno, anche
se è nostro padre. Ma è troppo facile attribuire simili pensieri a un uomo
dopo che li ha messi in pratica.
Era un uomo colto, che sapeva di greco e filosofia. Aveva governato con
onestà e competenza la Gallia Cisalpina datagli in appalto da Cesare. Aveva
sposato sua cugina Porzia, la figlia di suo zio Catone, che certo non doveva
disporlo favorevolmente verso il dittatore. Ma la cosa più preoccupante di
lui era che scriveva saggi sulla Virtù. La Virtù è una di quelle signore
perbene che si amano, quando si amano, senza parlarne.
Ai primi di marzo, dopo averlo ben bene "lavorato", Cassio venne a
dirgli che ai prossimi Idi, cioè il 15, Cesare avrebbe fatto il gran colpo. Il
suo luogotenente Lucio Cotta avrebbe proposto all'Assemblea, già decisa ad
approvare, di proclamare re il dittatore perché la Sibilla aveva predetto che
solo da un re potevano essere battuti i parti, contro cui si stava preparando la
spedizione. Sull'opposizione del Senato non c'era da sperare: la sua recente
riforma aveva dato la maggioranza ai cesariani. Non restava quindi che il
pugnale, prima che fosse troppo tardi. Questa conversazione si svolse alla
presenza di Porzia che caldeggiò la tesi di Cassio e, per mostrare che
avrebbe saputo tenere il segreto anche sotto la tortura, s'immerse il pugnale
in una coscia. Bruto si arrese, anche per non mostrarsi da meno della
moglie.
Cesare, quella sera, pranzava in casa con alcuni amici. Secondo il
costume degli anfitrioni romani, propose un tema di conversazione: "Che
morte preferireste?". Ognuno disse la sua. Cesare si pronunciò per una fine
rapida e violenta. L'indomani mattina Calpurnia gli disse di averlo sognato
coperto di sangue e lo pregò di non andare in Senato. Ma un amico che
apparteneva alla congiura venne invece a sollecitarlo, e Cesare lo seguì
mancandone di poco un altro a lui fedele che veniva a informarlo del
complotto. Per strada un chiromante gli gridò di guardarsi dagl'Idi di marzo.
«Ci siamo già», rispose Cesare. «Ma non sono passati», ribattè l'altro. Nel
momento di entrare in aula, qualcuno gli mise in mano un papiro arrotolato.
Cesare credette che si trattasse di una delle solite suppliche e non lo svolse.
Lo aveva ancora in pugno quando morì: era una circostanziata denuncia.
Era appena entrato nell'aula, che i congiurati gli furono tutti addosso col
pugnale. L'unico che poteva difenderlo, Marc'Antonio, era stato trattenuto in
anticamera da Trebonio. Cesare dapprima cercò di ripararsi col braccio, ma
smise quando vide, fra gli assassini, anche Bruto. È molto probabile che
abbia detto effettivamente:
«Anche tu, figlio mio?», come ha raccontato Svetonio. È una frase che
avrebbe pronunciato qualunque padre, in quelle condizioni.
Cadde trafitto di colpi ai piedi della statua di Pompeo, che aveva fatto
egli stesso installare lì e cui usava inchinarsi quando vi passava davanti.
Il colpo lasciò sgomenti e incerti coloro stessi che lo avevano fatto.
Agitando il pugnale insanguinato, Bruto lanciò un reboante evviva a Cicerone, chiamandolo "Padre della Patria" e invitandolo a tenere un discorso.
Atterrito all'idea di venire mescolato in quella faccenda e avvertendo
l'inopportunità di ogni retorica, il grande avvocato rimase, per la prima volta
in vita sua, senza parola. Marc'Antonio rientrò, vide il cadavere steso per
terra, e tutti si aspettarono da lui uno scoppio d'ira vendicatrice. Invece il
"fedelissimo" tacque e silenziosamente uscì. Fuori, la folla si ammassava
inquieta per la notizia che già aveva cominciato a circolare. Timorosamente,
i congiurati si fecero sul portone, e qualcuno di loro cercò di spiegare
l'accaduto giustificandolo come un trionfo della libertà. Ma la parola non
aveva più alcun fascino per i romani che l'accolsero con minacciosi
brontolii. I congiurati si ritirarono, barricandosi in Campidoglio e
mettendovi a guardia i loro servi armati, e mandarono un messaggio a
Marc'Antonio perché accorresse a trarli d'impaccio.
Il "fedelissimo" venne l'indomani, quando Bruto e Cassio avevano già
inutilmente pronunciato un secondo discorso per calmare la folla, sempre
più minacciosa. Vi riuscì alla meglio lui con un abile discorso, in cui chiese
il mantenimento dell'ordine promettendo in cambio il castigo dei colpevoli.
Poi andò da Calpurnia, annientata dal dolore, e si fece dare, sigillato in
busta, il testamento di Cesare. Lo consegnò alle Vestali, com'era l'uso di
Roma, senz'aprirlo, tanto era sicuro di esservi designato come erede. Mandò
segretamente a chiamare le truppe accampate fuor di città; e, tornato in
Senato, pronunciò un'allocuzione di cesareo equilibrio ch'era già un
programma di governo e mirava alla distensione. Approvò la proposta di
amnistia generale avanzata da Cicerone a patto che il Senato ratificasse tutti
i progetti lasciati in sospeso da Cesare. Promise a Cassio e a Bruto un
governatorato che gli consentisse di allontanarsi da Roma, e li trattenne
quella sera a cena con sé.
Il 18 fu incaricato di pronunciare l'elogio di Cesare in occasione del suo
funerale, che fu quanto di più solenne si fosse mai visto a Roma. La
comunità israelitica, grata a Cesare dell'amichevole trattamento che ne
aveva ricevuto, seguiva il feretro mescolata ai veterani cantando i suoi
antichi e solenni inni. I soldati gettarono le loro armi sulla pira, gli attori e i
gladiatori i loro costumi. Tutta la notte l'intera cittadinanza rimase raccolta
intorno alla bara.
L'indomani Antonio si fece consegnare il testamento dalle Vestali,
solennemente lo aprì dinanzi alle alte cariche dello stato, e ne diede pubblica
lettura. Della sua privata fortuna che ammontava a circa cento milioni di
sesterzi, Cesare ne lasciava a ogni cittadino romano; e al municipio, come
pubblico parco, donava i suoi meravigliosi giardini. Il resto doveva essere
diviso fra i tre suoi pronipoti, uno dei quali, Caio Ottavio, veniva adottato
come figlio e designato erede.
Il "fedelissimo", che quarantott'ore dopo l'assassinio del suo capo aveva
invitato a cena gli assassini, era ripagato della sua strana fedeltà.
CAPITOLO DODICESIMO
ANTONIO E CLEOPATRA
SALVO i più intimi amici di casa, che ve lo avevano visto adolescente,
nessuno a Roma conosceva questo Caio Ottavio, destinato a cambiare due
volte di nome, e con l'ultimo, Augusto, a passare alla storia come il più
grande uomo di stato di Roma. Sua nonna era stata Giulia, la sorella di
Cesare, andata sposa a un provinciale di Velletri, cafone e quattrinaio. Suo
padre aveva fatto una discreta carriera ed era finito governatore in
Macedonia. Quanto a lui, il ragazzo, era cresciuto sotto una disciplina quasi
spartana, aveva studiato con profitto, e lo zio Cesare che, rimasto senza figli
legittimi nonostante tutte quelle mogli che aveva impalmato, se l'era preso
in casa, ci s'era affezionato. Se l'era condotto dietro in Spagna, quando vi
andò nel 45 a debellarvi gli ultimi resti pompeiani. E in quell'occasione
aveva ammirato la forza di volontà di quel giovanottello imberbe e fragile
nell'affrontare fatiche sproporzionate alla sua salute. Infatti soffriva di colite,
di eczema e di bronchitelle: malanni che col tempo diventarono sempre più
acuti e l'obbligarono a vivere come un pulcino nella stoppa, con pancere,
scialli, berretti di lana, un armamentario di pillole, unguenti e sciroppi al
seguito, e un medico a portata di mano, anche in battaglia. Non beveva,
mangiava come un uccellino, aveva un sacrosanto terrore degli spifferi, ma
affrontava il nemico col più freddo coraggio, e non compiva un gesto, anche
il più. ordinario, senz'averne prima soppesato accuratamente i pro e i contro.
Cesare, il brillante improvvisatore scavezzacollo e di manica larga, dalla
generosità irriflessiva, dalla parola pronta e dal gesto vivace, dovette
prenderlo in simpatia per amor di contrasto. Ne seguì gli studi, lo istradò
versò quelli di strategia e di amministrazione, e appena diciassettenne gli
affidò un piccolo comando in Illiria perché facesse pratica di milizia e di governo. Fu qui che un messo lo raggiunse sulla fine di marzo con la notizia
della morte dello zio e del suo testamento. Accorse a Roma e, contro il
parere di sua madre che diffidava di Marc'Antonio, andò a trovare costui che
lo trattò con disprezzo chiamandolo "ragazzetto".
Il ragazzetto non se la prese. Ma chiese quietamente se il denaro che
Cesare aveva lasciato ai cittadini e ai soldati era stato effettivamente
distribuito. Antonio rispose che c'era qualcosa di più urgente a cui pensare.
E Caio Ottavio che ora, per l'adozione, aveva preso il nome di Caio Giulio
Cesare Ottaviano, si fece prestare i fondi dai ricchi amici del defunto e li
distribuì come questi aveva ordinato. I veterani cominciarono a guardare
con simpatia al "ragazzetto" che prometteva di saperci fare.
Irritato, Antonio dichiarò qualche giorno più tardi di essere stato vittima
di un attentato e di aver saputo dall'attentatore ch'era stato Ottaviano a
organizzare il colpo. Ottaviano chiese delle prove. E, siccome esse non
vennero addotte, raggiunse le due legioni che frattanto aveva richiamato
dall'Illiria, le unì a quelle dei due consoli in carica, Irzio e Pansa, e con essi
marciò contro Antonio.
Non aveva che diciotto anni, in quel momento, e per questo il Senato fu
dalla sua parte. Gli aristocratici erano allarmati dalle prepotenze di Antonio
che, una volta vistosi defraudato dell'eredità di Cesare, cercava di
accaparrarsela con la forza. In quei pochi giorni di potere, egli aveva
saccheggiato il Tesoro, appropriandosi quindici miliardi, occupando
arbitrariamente il palazzo di Pompeo e autonominandosi governatore della
Gallia Cisalpina per avere il pretesto di tenere un esercito in Italia e
diventarne così il padrone. Il Senato si accorse che, a lasciarlo fare, al
Cesare morto se ne sarebbe sostituito un altro e peggiore. E per questo
decise di favorire Ottaviano, un "ragazzetto" che avrebbe dato meno ombra.
Cicerone prestò la sua oratoria a questa lotta contro Antonio in una serie di
Filippiche che si appuntavano soprattutto sulla sua vita privata. Materia ce
n'era. Antonio, che aveva allora trentott'anni, li aveva riempiti di prodezze
militari, di soprusi, di generosità e di indecenza. Lo stesso Cesare, pur di
manica larga com'era e volendogli bene, aveva dovuto scandalizzarsi per
l'harem di ambo i sessi che il suo generale si portava dietro, anche in guerra.
Antonio era un aristocratico ignorante e amorale, robusto, sanguigno e
manesco. Cicerone, frugandone la condotta, vi trovò pretesto a tutte le
accuse.
Lo scontro fra i due eserciti avvenne presso Modena. E la fortuna assistè
così sfacciatamente Ottaviano da lasciarlo unico generale superstite: Irzio e
Pansa erano caduti, e Antonio, battuto per la prima volta in vita sua, era
fuggito. Così il "ragazzetto" rientrò a Roma alla testa di tutte le truppe
acquartierate in Italia, andò in Senato, impose la propria nomina a console,
l'annullamento dell'amnistia ai cospiratori degl'Idi di marzo e la loro
condanna a morte. Il Senato, che aveva contato di usarlo come suo
strumento, s'indignò e resistè. Ottaviano convocò un altro luogotenente di
Cesare, Lepido, lo mandò come ambasciatore di pace ad Antonio, e stabilì
con loro due il secondo Triumvirato, mostrando anche così di aver messo a
profitto la lezione dello zio. Il Senato chinò la testa ed ebbe agio di riflettere
che il successore d'un dittatore fa sempre rimpiangere il predecessore.
Pattuglie di soldati furono dislocate a tutte le porte della città, e la gran
vendetta ebbe inizio. Trecento senatori e duemila funzionari furono incolpati
dell'assassinio, processati e uccisi, dopo il sequestro di tutti i loro beni.
Venticinquemila dracme, circa dieci milioni di lire, era la taglia posta sulla
testa di chi fuggiva. Ma i più preferirono uccidersi, e nel gesto ritrovarono lo
stile dei grandi romani antichi. Il tribuno Salvio diede un banchetto, bevve il
veleno, e la sua ultima volontà fu che il pranzo continuasse, presente il
proprio cadavere. Lo accontentarono. Fulvia, la moglie di Antonio, fece
impiccare sulla porta di casa l'innocente Rufo, solo perché costui non aveva
voluto vendergliela. Suo marito non potè impedirglielo perché in quel
momento era a letto con la moglie di Coponio, il quale in tal modo ebbe
salva la vita.
Ma la preda più ghiotta, per Antonio, fu Cicerone, non solo perché aveva
ancora nel gozzo le Filippiche del grande avvocato, ma anche perché
doveva vendicare Clodio, di cui aveva sposato la vedova, e Lentulo, che
Cicerone aveva fatto trucidare in galera al tempo di Catilina, e di cui
Antonio era il figliastro. Il "Padre della Patria" aveva cercato di fuggire
imbarcandosi ad Anzio. Ahimè, soffriva il mal di mare che gli parve
peggiore della morte e lo costrinse a sbarcare a Formia. Le pattuglie di
Antonio gli piombarono addosso. Cicerone vietò ai suoi servitori di tentare
la resistenza, e offrì docilmente il collo. La sua testa decapitata fu portata
insieme con la mano destra ai triumviri. Antonio ne tripudiò di gioia.
Ottaviano s'indignò, o finse d'indignarsi. Non aveva mai avuto simpatia per
Cicerone, che si era mostrato ambiguo verso lo zio, con gli assassini del
quale aveva fatto lega dopo averlo esaltato da vivo. Quanto a lui, Ottaviano,
lo aveva definito laudandum adolescentem, ornandum, tollendum.
Sembravano elogi. Ma tollendum voleva dire non soltanto "da esaltare", ma
anche "da uccidere". E nella bocca di Cicerone questi doppi sensi si sapeva
benissimo come dovevano essere interpretati.
Così finì, vittima della propria oratoria, il più grande oratore di Roma.
Ora restavano da castigare i due principali colpevoli, Bruto e Cassio che,
andati governatori rispettivamente di Macedonia e di Siria, avevano unito le
loro forze e formato con esse l'ultimo esercito della Roma repubblicana, che
non era destinato a lasciare un gran ricordo in quelle province. La Palestina,
la Cilicia, la Tracia furono letteralmente spogliate. Intere popolazioni,
specialmente ebree, che non avevano di che pagare i contributi, furono
ridotte in schiavitù e vendute. La virtù non impedì a Bruto di assediare,
affamare e ridurre al suicidio in massa gli abitanti di Xanto. Le armate di
Antonio e Ottaviano, quando giunsero, furono accolte come "liberatrici".
Lo scontro avvenne a Filippi nel settembre del 42. Bruto ruppe lo
schieramento d'Ottaviano, ma Antonio sfondò quello di Cassio che si fece
uccidere da un attendente. Ottaviano era a letto, dentro la tenda, con una
delle sue solite influenze. Antonio aspettò che guarisse per gettarsi con lui
all'inseguimento di Bruto. Questi, vedendo i suoi uomini sbandarsi, si
avventò sulla spada di un amico restandovi infilzato. Antonio ne ricercò il
cadavere, lo coprì pietosamente con la sua tunica di porpora. Si ricordava
che Bruto aveva posto una sola condizione alla sua partecipazione al
complotto contro Cesare: che Antonio venisse risparmiato.
A Filippi caddero, con la Repubblica, i più bei nomi dell'aristocrazia che
ne costituiva il puntello. Coloro che non vi trovarono la morte sul campo, la
cercarono nel suicidio, come fecero il figlio di Ortensio e quello di Catone.
Erano quanto restava di meglio dell'antico patriziato romano: per lo meno, si
mostrarono sino all'ultimo soldati coraggiosi. A casa erano rimasti
gl'imboscati e gl'intrallazzatori, gente disposta, pur di non faticare e
rischiare, ad accettare tutto, anche la spartizione che i vincitori fecero del
grande Impero. A Ottaviano toccò la fetta europea; a Lepido quella africana;
Antonio scelse l'Egitto, la Grecia e il Medio Oriente. Ognuno di questi tre
uomini sapeva che l'accomodamento era provvisorio; ognuno di essi, meno
Lepido che si contentava, sperava di far fuori, prima o poi, gli altri due. Il
più sicuro di riuscirci era Antonio, che credeva solo nella forza militare e
sapeva di essere, come generale, superiore agli altri.
Egli mandò, come prima cosa, un messaggio a Cleopatra, ingiungendole
di raggiungerlo a Tarso per rispondere alle accuse, che qualcuno le
muoveva, di aver aiutato e finanziato Cassio. Cleopatra obbedì. Il giorno
fissato per la sua comparsa, Antonio si dispose a riceverla dall'alto d'un
maestoso trono in mezzo al Foro, dinanzi alla popolazione eccitata
dall'imminente processo. Cleopatra giunse su una nave con le vele rosse, il
rostro dorato, la chiglia laminata d'argento. La ciurma era composta dalle
sue cameriere vestite da ninfe che facevano corona a una canopia di lamé
sotto la quale essa stessa giaceva in un provocante costume da Venere,
intenta alle arie che intorno le suonavano con pifferi e flauti.
Quando la notizia di questa straordinaria apparizione sulle acque del
fiume Cidno si sparse in città, tutti accorsero al porto, per vederla, come
oggi accorrono per vedere Sofia Loren, lasciando Antonio solo e fuori dei
gangheri. La mandò a chiamare. Essa gli fece rispondere che lo aspettava a
bordo per pranzo. Furioso, Antonio andò, sempre considerando se stesso il
giudice e lei l'accusata. Ma, vedendola, rimase di stucco. L'aveva conosciuta
bimbetta ad Alessandria, poi non l'aveva più rivista, e ora se la ritrovava di
fronte, donna fatta, e fatta in un certo modo che spiegava benissimo come
mai perfino Cesare c'era rimasto impigliato. I suoi generali erano già tutti
rimbambolati ai piedi di lei. All'aperitivo, egli cominciò ad accusarla
burbanzosamente. Alla frutta, le aveva regalato la Fenicia, Cipro e grossi
bocconi dell'Arabia e della Palestina. Essa lo ricompensò quella notte stessa,
e i generali dovettero contentarsi delle ninfe. Poi se lo rimorchiò ad
Alessandria, dov'egli sembrò aver del tutto dimenticato la provvisorietà
della sua condizione. Cleopatra invece se ne rendeva conto benissimo. Essa
sapeva che l'Impero non tollerava tre padroni. Non amava Antonio, forse
non aveva mai amato nessuno. Ma pensò di farne lo strumento del colpo che
non le era riuscito con Cesare.
Mentre questo avveniva ad Alessandria, Ottaviano, a Roma, gettava le
basi della riunificazione. Il compito non era facile. Sesto Pompeo, in
Spagna, aveva ricominciato ad agitarsi e bloccava i rifornimenti, la
disoccupazione dilagava, l'inflazione minacciava, il Senato faceva la fronda
e bisognava comprarlo volta per volta. Per di più la moglie di Antonio,
Fulvia, forse per sottrarre il marito alle stregonerie di Cleopatra
richiamandolo a Roma, organizzò un complotto col fratello di lui, Lucio.
Essi arruolarono un esercito e lanciarono un appello di rivolta agl'italiani.
Dovette intervenire Marco Agrippa, il più fidato luogotenente di Ottaviano,
per soffocare il tentativo. Lucio si arrese a Perugia. Fulvia morì di rabbia, di
delusione e di gelosia.
Cleopatra vide in questo avvenimento il pretesto per spingere Antonio a
giocare la gran carta. Egli adunò l'esercito, lo imbarcò sulla flotta. E,
sbarcato a Brindisi, vi assediò la guarnigione di Ottaviano. Ma i soldati si
rifiutarono di battersi dall'una e dall'altra parte, obbligando i loro generali a
far pace. Essa fu saldata con un matrimonio: quello di Antonio con la sorella
di Ottaviano, Ottavia, una donna perbene, da cui era pazzia sperare che
quello scavezzacollo si lasciasse imbrigliare.
La storia non ha registrato le reazioni di Cleopatra a questo episodio che
mandava in fumo tutti i suoi piani. Antonio, lontano da lei, sembrò aver
ritrovato un po' di ragionevolezza. Condusse la sposa a Atene, dove essa,
donna istruita, lo portò a visitare i musei e ad ascoltare le lezioni dei filosofi,
nella speranza di fargli prendere gusto alla cultura. Antonio fingeva di
guardare e di ascoltare. In realtà pensava a Cleopatra e alla guerra, le uniche
due cose al mondo che gli piacessero veramente. Forse rifletté che, delle
due, la guerra era meno pericolosa. E, stanco di perbenismo e di virtù
casalinghe, rimandò Ottavia a Roma e si avviò col suo esercito contro la
Persia dove Labieno, figlio del generale traditore di Cesare, stava
organizzando un'armata al servizio di quel re ribelle. Cleopatra raggiunse
Antonio ad Antiochia, disapprovò l'impresa, si rifiutò di finanziarla, ma vi
seguì l'amante. Questi corse inutilmente dietro al nemico per cinquecento
chilometri, perse buona parte dei suoi centomila uomini, impose un teorico
vassallaggio sull'Armenia, si proclamò vincitore, offrì a se stesso un solenne
trionfo ad Alessandria scandalizzando Roma che si riteneva unica
depositaria di quelle cerimonie, mandò un'intimazione di divorzio a Ottavia
rompendo così l'unico vincolo che tuttora lo legava a Ottaviano, sposò
Cleopatra, dando in dote tutto il Medio Oriente ai due figli che aveva avuto
da lei, e nominò Cesarione principe ereditario di Egitto e Cipro.
Così egli stesso rese inevitabile il conflitto con Ottaviano che lo andava
preparando con la sua abituale e cauta tenacia. Anche lui aveva avuto le sue
complicazioni sentimentali. Si era innamorato, figuratevi, di una donna
incinta di cinque mesi, Livia, la moglie di Tiberio Claudio Nerone. Si era
già sposato due volte, prima di allora, sebbene fosse sotto i trenta: prima con
Claudia, poi con Scribonia che gli aveva dato una figlia: Giulia. Ora
divorziò anche da questa seconda sposa e persuase amichevolmente Tiberio
Claudio Nerone a fare altrettanto con Livia, per prendersela lui, con due
figli: Tiberio, già grandicello, e Druso che stava per nascere. Li adottò come
fossero stati suoi.
Ma, liquidate queste pendenze coniugali, si era messo di buzzo buono al
lavoro di ricostruzione. Il blocco di Sesto fu eliminato con la distruzione
della sua flotta, l'ordine fu ristabilito, una rinata fiducia disgelò i capitali
imboscati. Marco Agrippa, oltre che un buon generale, si rivelò un ministro
della Guerra incomparabile. Egli fu il vero riorganizzatore del grande
esercito che doveva riportare l'unità di comando nell'Impero romano.
CAPITOLO TREDICESIMO
AUGUSTO
primavera dell'anno 32 avanti Cristo giunse a Roma un messo di
Antonio con una lettera al Senato in cui il triumviro proponeva ai suoi due
colleghi di deporre tutti insieme il potere e le armi e di ritirarsi a vita privata
dopo aver restaurato le istituzioni repubblicane. Ci pare impossibile che uno
scervellato di quella fatta abbia potuto concepire una mossa così accorta. Ci
doveva essere lo zampino di Cleopatra.
Ottaviano si trovò nei pasticci. Per superarli, egli tirò fuori il testamento
di Antonio, dicendo di averlo avuto dalle Vestali che lo tenevano in
custodia. Esso designava suoi soli eredi i figli avuti da Cleopatra e costei
reggente. Abbiamo molti dubbi sull'autenticità di quel documento. Ma esso
servì a confermare i sospetti che tutta Roma nutriva per quell'intrigante e
permise a Ottaviano di bandire una guerra "d'indipendenza", che con molta
perspicacia egli non dichiarò ad Antonio, ma a Cleopatra.
Fu una guerra di mare. Le due flotte si scontrarono ad Azio. E quella di
Ottaviano, comandata da Agrippa, sebbene inferiore come unità, mise in
rotta quella avversaria che ripiegò in disordine su Alessandria. Ottaviano
non la inseguì. Sapeva che il tempo lavorava per lui e che più Antonio
restava in Egitto, e più vi si logorava in orge e mollezze. Sbarcò ad Atene
per rimettere ordine nelle cose di Grecia. Tornò in Italia a sedarvi una
rivolta. Poi la prese larga, dall'Asia, per distruggere le alleanze che vi aveva
lasciato Antonio, isolandolo. Alla fine mosse verso Alessandria, e per strada
ricevette tre lettere: una di Cleopatra unita a uno scettro e a una corona,
pegni di sottomissione; e due di Antonio che impetrava pace. A lui non
rispose. A lei replicò che le avrebbe lasciato il trono se uccideva il suo
amante. Dato il tipo, stupiamo ch'essa non lo abbia fatto.
Col coraggio della disperazione, Antonio lanciò un attacco e ottenne una
parziale vittoria, che non impedì a Ottaviano di chiudere la città in una
morsa. Ma il giorno dopo i mercenari di Cleopatra si arresero e ad Antonio
giunse notizia che la regina era morta. Cercò di uccidersi con un colpo di
pugnale. E quando, agonizzante, seppe ch'essa era invece ancora viva, si
fece trasportare nella torre dove si era barricata con le sue ancelle, e fra le
sue braccia spirò. Cleopatra chiese a Ottaviano il permesso di seppellire il
cadavere e di accordarle un'udienza. Ottaviano glielo concesse. Essa si
NELLA
presentò a lui come si era presentata a Antonio: profumata, bistrata e ammantata solo di regali veli. Ahimè, sotto quei veli c'era ora una donna di
quarant'anni, non più di ventinove, e si vedevano tutti. Il suo naso aveva
smesso di trovar compensi nella freschezza delle carni e nella luminosità del
sorriso. Augusto non ebbe bisogno di ricorrere a una gran forza di carattere
per trattarla con freddezza e annunziarle che l'avrebbe condotta a Roma
come ornamento del suo carro di trionfatore. Forse, più che come regina,
Cleopatra si sentì perduta come donna; e fu questo che la spinse al suicidio.
S'incollò un aspide al seno e se ne lasciò avvelenare, imitata dalle sue
ancelle.
Ottaviano liquidò l'eredità sua e di Antonio con un "tatto" da cui si può
ricostruire tutto il suo carattere. Concesse che i due cadaveri venissero
seppelliti l'uno accanto all'altro. Ammazzò il giovane Cesarione, mandò i
figli dei due defunti a Ottavia, che li allevò come se fossero stati suoi,
dell'Egitto si proclamò re per non umiliarlo proclamandolo provincia
romana, ne intascò l'immenso tesoro, vi lasciò un prefetto, tornò a casa;
quietamente fece sopprimere anche il maggiore dei figli avuti da Antonio
con Fulvia. E con la tranquilla coscienza di chi avesse compiuto con
quegl'infanticidi il proprio dovere, si rimise al lavoro.
Aveva appena trentun anni in quel momento, e si ritrovava padrone
assoluto di tutta l'eredità di Cesare. II Senato non aveva più né la voglia né
la forza di contestargliela, e solo per cautela egli non gli chiese l'investitura
al trono. Gliel'avrebbero data. Ma Ottaviano conosceva il peso delle parole e
sapeva che quella di re era sgradita. Perché risvegliare certi uzzoli che ormai
sonnecchiavano nelle coscienze intorpidite? I romani avevano smesso di
credere alle istituzioni democratiche e repubblicane perché ne conoscevano
la corruzione, ma tenevano alle forme. Essi domandavano ordine, pace,
sicurezza, una buona amministrazione, una moneta sana e i risparmi
garantiti. E Ottaviano si accinse a darglieli.
Con l'oro riportato d'Egitto liquidò l'esercito, che contava mezzo milione
di uomini e costava troppo, trattenendone duecentomila in servizio, dei quali
si proclamò Imperatore titolo puramente militare, e accasando gli altri come
contadini in terre comprate apposta; annullò i debiti dei privati verso lo
stato; e diede l'avvio a grandi opere pubbliche. Ma questi furono soltanto i
primi passi, e i più facili. Come Cesare, Ottaviano non mirava soltanto ad
amministrare, ma voleva compiere una gigantesca riforma che rifondasse
tutta la società sul modello disegnato dallo zio. Per far questo, gli occorreva
una burocrazia, di cui egli fu il vero inventore. Intorno a sé, formò una
specie di gabinetto ministeriale, composto di tecnici, nella cui scelta ebbe la
mano felice. C'era un grande organizzatore come Agrippa, un gran
finanziere come Mecenate, e vari generali, fra i quali fece presto spicco il
figliastro Tiberio.
Poiché costoro appartenevano quasi tutti alla grande borghesia, e gli
aristocratici si lamentavano d'esserne esclusi, Ottaviano scelse una ventina
di loro, tutti senatori, e ne fece una specie di Consiglio della Corona, che
piano piano diventò il portavoce del Senato e ne vincolò le decisioni.
L'Assemblea o Parlamento continuò a riunirsi e a discutere, ma sempre con
meno frequenza e senza mai un tentativo di bocciare qualche proposta di
Ottaviano. Questi concorse regolarmente al consolato per tredici volte, e
naturalmente altrettante volte vinse. Nel 27 d'improvviso rimise tutti i suoi
poteri al Senato, proclamò la restaurazione della Repubblica e annunciò che
voleva ritirarsi a vita privata. Non aveva che trentacinque anni in quel
momento e l'unico titolo che aveva accettato era quello, nuovo, di principe.
Il Senato rispose abdicando a sua volta e rimettendo a lui tutti i suoi poteri,
supplicandolo di assumerli e conferendogli quell'appellativo di Augusto, che
voleva dire letteralmente "l'aumentatore" ed era un aggettivo, ma poi
nell'uso diventò un sostantivo. E Ottaviano vi consentì con aria rassegnata.
Fu una scena perfettamente recitata da ambedue le parti e dimostrò che
ormai la fronda conservatrice e repubblicana era finita: anche gli orgogliosi
senatori preferivano un padrone al caos.
Ma il padrone seguitò a mostrarsi discreto nell'uso dei suoi poteri.
Abitava il palazzo di Ortensio, ch'era molto bello, ma non lo trasformò in
una reggia, e come appartamento personale si riservò una piccola stanza al
pianterreno con uno studio, monacalmente arredati. Anche quando, tanti
anni dopo, l'edificio andò in rovina per un incendio ed egli ne costruì un
altro uguale, tenne a che gli rifacessero identiche quelle due stanze. Perché
era abitudinario, sobrio e ligio agli orari. Lavorava duro, considerandosi il
primo servitore dello stato. E scriveva tutto: non solo i discorsi che doveva
pronunciare in pubblico, ma anche quelli che teneva in casa, con la moglie e
i familiari. Bisognerà aspettare Francesco Giuseppe d'Austria, cui in molte
cose somiglia, per trovare nella storia un sovrano altrettanto ligio al dovere,
rispettabile, prosaico, poco amabile e sfortunato negli affetti domestici.
Questi erano rappresentati da Giulia, la figlia avuta da Scribonia; da
Livia, la sua terza moglie; e dai due figliastri che costei gli aveva portato in
casa: Druso e Tiberio. Livia fu, come moglie inappuntabile, anche se un po'
noiosa col suo ostentato virtuismo. Educò bene i ragazzi, fece molta
beneficenza, e portò con disinvoltura le corna che suo marito via via le
faceva. Tutto lascia credere ch'essa teneva, più che all'amore, al potere di
Augusto e alla carriera dei figli, che infatti la fecero alla svelta. Generali a
vent'anni, furono mandati a soggiogare l'Illiria e la Pannonia. Augusto, che
realizzò la pax romana, rinunziò presto alla guerra e a nuove annessioni. Ma
voleva garantire i confini dell'Impero, continuamente minacciati. Druso, il
suo preferito, li spostò dal Reno all'Elba per renderli più sicuri, battendo
brillantemente i germani. Ma cadde da cavallo e si ferì gravemente. Tiberio,
che lo adorava e si trovava in Gallia, galoppò quattrocento miglia per
raggiungerlo e fece in tempo a chiudergli gli occhi. Augusto fu scosso dalla
morte di quel ragazzo allegro, impetuoso ed espansivo, di cui pensava di
fare il proprio successore. Ora sperò che Giulia gli desse un altro erede.
Era lei, quella ragazza vivace, sensuale e scorbellata, il suo occhio
destro. A quattordici anni l'aveva sposata a Marcello, il figlio di sua sorella
Ottavia, la vedova di Antonio. Ma Marcello era morto poco dopo; e Giulia
era diventata la "vedova allegra" di Roma, Si divertiva non solo a farle, ma
anche a raccontarle. E suo padre, che aveva cominciato a emanare leggi per
il ristabilimento della morale, pensò di rimetterla sulla buona strada con un
altro marito: quel Marco Agrippa, ministro della Guerra, che, dopo avergli
dato la vittoria ad Azio, era diventato il suo più fidato e abile collaboratore.
Gran gentiluomo, gran soldato, grande ingegnere, egli aveva pacificato la
Spagna e la Gallia, riorganizzato i commerci, costruito strade, ed era l'unico
pezzo grosso di cui non si mormorasse nemmeno che ci speculava sopra.
Augusto, che aveva la stoffa del "pianificatore" e si riteneva in diritto di
regolare anche la felicità altrui, non si curò del fatto ch'egli avesse
quarantadue anni, mentre Giulia ne aveva diciotto, e fosse il marito di una
moglie che lo rendeva felice. Gl'impose il divorzio e le nuove nozze.
La coppia non poteva essere peggio assortita, sebbene mettesse al
mondo cinque figli, che stranamente somigliavano ad Agrippa. Quando
sfrontatamente ne chiesero la spiegazione a Giulia, questa rispose altrettanto
sfrontatamente:
«Io non faccio salire nuovi marinai sulla nave che quando è già carica».
Otto anni dopo Agrippa morì, e Giulia ridiventò la vedova allegra di Roma.
Di nuovo Augusto volle porvi rimedio e le impose un terzo matrimonio: con
Tiberio stavolta, in cui vedeva ora, o in cui Livia gli faceva vedere, un
possibile reggente dell'Impero fin quando non fossero stati maggiorenni i
figli di Giulia, Gaio e Lucio. Anche Tiberio era già sposato, e precisamente
con la figlia di Agrippa, Vipsania, che lo rendeva felice. Ma questa felicità
non coincideva con quella pianificata da Augusto, che la distrusse per creare
al suo posto un'infelicità. Divenuto il successore di Agrippa dopo esserne
stato il genero, Tiberio subì da Giulia tutto quello che il più disgraziato dei
mariti può subire dalla moglie. Quando non ne potè più, si ritirò a vita
privata a Rodi, e ci visse sette anni, dedito solo agli studi, mentre Giulia
offuscava coi suoi scandali il ricordo di Clodia. Gaio e Lucio erano morti,
l'uno di tifo, l'altro in guerra. Augusto, ormai sessantenne, affranto da queste
sciagure, roso dall'eczema e dai reumatismi e sempre più sotto la pantofola
di Livia, alla fine bandì sua figlia per immoralità, facendola rinchiudere a
Ventotene, richiamò Tiberio e lo adottò come figlio ed erede, sempre
continuando a disamarlo.
Forse credeva in quel momento di essere sull'orlo della morte. La colite
e le influenze non gli davano tregua, e non faceva un passo senza il suo
medico personale, Antonio Musa. Era diventato puntiglioso, sospettoso e
crudele. Per una indiscrezione, fece rompere le gambe al suo segretario
Tallo. E per proteggersi da inesistenti complotti, inventò la polizia, cioè quei
"pretoriani" o guardie del corpo, che dovevano svolgere una così nefasta
parte sotto i suoi successori. Fatto più scettico e amaro dalle sofferenze, egli
vedeva con chiarezza il fallimento della sua opera di ricostruzione. Sì, c'era
la pax augusta, e i marinai orientali venivano a rendergli grazie per la
sicurezza con cui ora navigavano. Ma sull'Elba Varo era stato massacrato
con tre legioni da Arminio, il confine aveva dovuto esser ritirato sul Reno, e
Augusto intuiva che al di là di esso, nel buio delle loro foreste, le tribù
germaniche erano in ebollizione. Sì, i commerci riorganizzati da Agrippa
rifiorivano, e la moneta, risanata da Mecenate, era sicura. La burocrazia
funzionava. L'esercito era forte. Ma la grande riforma del costume era
fallita. Divorzi e malthusianismo avevano ucciso la famiglia e il ceppo
romano si era quasi estinto. L'ultimo censimento rivelava che i tre quarti
della cittadinanza erano liberti o figli di liberti forestieri. Si erano costruiti
centinaia di nuovi templi, ma dentro non c'erano dèi perché nessuno credeva
che ci fossero. Una morale non si rifà senza una base religiosa. Augusto
aveva cercato di rianimare l'antica fede, senza condividerla, e il popolo gli
rispose facendo finta di adorare lui come dio.
Giulia, che morì in esilio, aveva lasciato ad Augusto una nipotina, che si
chiamava Giulia come lei, e purtroppo dimostrò subito di voler imitare sua
madre non solo nel nome. Anch'essa il nonno dovette confinare per
immoralità. Distrutto da questo nuovo dolore, pensò di lasciarsi morire per
fame. Poi i doveri d'ufficio, cui era restato attaccatissimo, e la certezza di
non averne più per molto, ebbero la meglio. Invece, come tutti coloro che
reggono l'anima coi denti, egli resse la sua molto a lungo, per quei tempi.
Aveva settantasei anni quando, in convalescenza a Nola dopo una bronchite,
lo sorprese la fine. Quella mattina aveva lavorato come al solito, dalle otto a
mezzogiorno, firmando tutti i decreti, rispondendo a tutte le lettere, da quel
perfetto funzionario che era. Fece chiamare Livia, con cui stava per
celebrare le nozze d'oro, e la salutò affettuosamente. Poi, da vero grande
romano, si rivolse agli astanti e disse: «Ho recitato bene la mia parte.
Congedatemi dunque dalla scena, amici, coi vostri applausi».
I senatori portarono la bara sulle loro spalle per tutta Roma, prima di cremare
il cadavere nel Campo Marzio. Forse sarebbero stati contenti della sua morte, se
non avessero saputo che a succedergli era già designato Tiberio.
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
ORAZIO E LIVIO
ANNI prima, quand'era tornato vittorioso dalla campagna contro Antonio,
Augusto aveva trovato, ad aspettarlo a Brindisi, Mecenate con un giovane
poeta mantovano, Virgilio. Era il figlio di un impiegato di stato di sangue
celtico, cui i legionari avevano sequestrato la piccola fattoria in cui aveva
investito i suoi risparmi. Il ragazzo era venuto a Roma, vi aveva pubblicato
un libro di poesie, Le ecloghe, che avevano avuto un bel successo, Mecenate
lo proteggeva e ora voleva farne uno strumento della propaganda di Augusto, cui era venuto a presentarlo.
Augusto si fece leggere dall'autore il manoscritto delle Georgiche,
ancora inedite, e lo prese in simpatia per due ragioni che con l'arte, di cui
s'infischiava, avevano poco a che fare: prima di tutto perché Virgilio era
malaticcio e scassato come lui e quindi poteva discorrerci a suo piacere di
bronchiti, di tonsilliti e di coliti; eppoi perché quelle poesie celebravano i
piaceri della vita rustica e frugale, cui Augusto voleva che tutti i romani
tornassero. In realtà, come disse poi Seneca, Virgilio descriveva la
campagna col tono e il gusto di chi vive in città, cioè su una nota falsa. Ma
Augusto non aveva orecchio per avvertirlo. Quel che gl'importava era che la
poesia di Virgilio avesse delle qualità didattiche. Ne ricompensò l'autore
facendogli restituire la fattoria che avevano requisito a suo padre. Virgilio
non vi tornò perché preferiva scrivere di campi standosene a Roma, ma
rimase grato a Augusto e in suo onore compose l'Eneide, destinata a
celebrarne le vittorie. Scriveva lentamente, con molta diligenza e scrupolo di
stile, dedicando al lavoro la maggior parte della giornata perché con le
rendite della fattoria e le liberalità di Mecenate non aveva bisogno di
lavorare per vivere e altre distrazioni non conosceva. Non si era sposato per
ragioni di salute, e i suoi amici di Napoli, dove ogni tanto andava a svernare,
lo chiamavano "la verginella". Augusto era ansioso di vedere il lavoro
finito. Virgilio gliene leggeva ogni tanto un pezzo, ma non arrivava mai alla
conclusione. Nel 19 interruppe la stesura per raggiungere l'imperatore ad
Atene, si buscò un'insolazione, e sul punto di morire a Brindisi, dove lo
avevano trasportato, raccomandò di bruciare il manoscritto del poema. Forse
si era reso conto che l'epica non era nelle sue corde, e preferiva affidare il
proprio ricordo ad altri scritti, frammentari ed elegiaci. Augusto proibì che
la volontà del morto fosse eseguita. Volendo serbare a propria gloria
quell'incompiuto monumento, salvò alla poesia un autentico capolavoro di
artificio.
Le sollecitudini di Augusto per la letteratura non si fermarono a Virgilio,
ma si estesero anche a molti altri scrittori, fra cui Orazio e Properzio. Glieli
presentava Mecenate, ch'era il loro impresario e dette il nome alla categoria
dei protettori delle arti, facendosi perdonare con ciò i cattivi versi ch'egli
smesso si piccava di comporre. Ma questo atteggiamento era diffuso ormai
fra tutti i romani ricchi, diventati sensibili alla "cultura" anche quando non
ne avevano. Dopo la prima casa editrice di Attico, ne erano nate molte altre,
che avevano dato l'avvio a un fiorente commercio. Edizioni di cinque o
diecimila copie, tutte scritte a mano dagli schiavi, venivano esaurite in pochi
mesi, a mille, a duemila lire l'esemplare. Il libro era diventato guarnitura
d'obbligo in ogni casa che si rispettasse, anche se poi non lo si leggeva, e
dalla provincia piovevano gli ordinativi.
Questa moda ebbe un grande effetto sulla società che, da guerriera e
incolta, si fece sempre più salottiera e letteraria. E appunto per questo,
Augusto ci vide uno strumento di riforma morale. Fin quando la vecchiaia e
i dolori non l'ebbero reso suscettibile e permaloso, egli si mostrò molto
tollerante anche per gli epigrammi e le satire che lo colpivano
personalmente. Fece costruire pubbliche biblioteche, raccomandò sempre a
Tiberio di astenersi dai castighi e di guardarsi dalla censura, e una volta
compose egli stesso qualche verso per mandarlo a un greco che ogni giorno
lo aspettava all'uscita del palazzo per leggergli i suoi. Il greco lo ricompensò
con una mancia di pochi denari e una cortese lettera in cui si scusava, data la
sua povertà, di non poter pagare meglio. Augusto si divertì assai a quella
replica spiritosa e gli fece rimettere centomila sesterzi.
Gli scrittori e i poeti però delusero le speranze dell'imperatore dando alla
propaganda di stato il peggio della loro produzione, e secondando col
meglio le deplorevoli tendenze di una società che si faceva sempre più
libertina e scanzonata e rifiutava i grandi temi della gloria, della religione,
della natura, ad essi preferendo quelli dell'amore e della galanteria. Il bardo
di questi nuovi motivi fu Ovidio, un avvocato abruzzese che aveva amareggiato suo padre rifiutandosi di fare una carriera politica e si proclamò
designato personalmente da Venere a parlare di Eros. Egli sposò tre donne,
ne amò molte altre, e di tutte scrisse con gran spregiudicatezza, dichiarando
che s'infischiava di tutti i catoncelli che lo criticavano. Il successo che
ottenne coi suoi versi dolci e lascivi gli fece credere a tal punto di essere un
grande poeta, che le ultime parole delle sue Metamorfosi furono
modestamente: "Vivrò nei secoli".
Le aveva appena tracciate, che un ordine di Augusto lo raggiunse,
intimandogli il confino a Costanza sul Mar Nero. Non si è mai saputo con
precisione di cosa l'imperatore volesse castigarlo. Dicono di una sua
relazione con la nipotina Giulia, che infatti era stata bandita negli stessi
giorni. Ovidio, come tutti gli uomini dal successo facile, non aveva la stoffa
per sopportare la disgrazia. I suoi lamenti da quel luogo di confino, Ex
Ponto e Tristia, vanno più a lode della sua vena elegiaca che del suo
carattere. Tornò a Roma da morto, dopo aver inutilmente chiesto in mille
lettere pietà all'imperatore e aiuto agli amici,
In genere, sebbene la si sia chiamata Periodo Aureo, l'epoca di Augusto
non vide una fioritura letteraria e artistica da confrontarsi con quella della
Grecia di Pericle o dell'Italia del Rinascimento. Sotto quell'imperatore
borghese, si sviluppò un gusto altrettanto borghese che prediligeva ciò che è
medio, e ciò che è medio spesso è mediocre. La moderazione e la misura,
condite di un certo bonario e casalingo scetticismo, erano le qualità più
apprezzate. E infatti lo scrittore vero di questo tempo è colui che meglio le
rappresentò: Orazio.
Era il figlio di un agente delle tasse pugliese, che voleva fare di quel suo
rampollo un avvocato e un uomo politico e, a prezzo di chissà quali
sacrifici, lo mandò a studiare prima a Roma, poi a Atene. Qui Orazio
conobbe Bruto, il quale si preparava alla battaglia di Filippi, prese in simpatia quel giovanotto e lo nominò su due piedi comandante di una legione, il
che ci aiuta a comprendere come mai il suo esercito fu battuto.
Orazio, nel bel mezzo dello scontro, buttò via elmo, scudo e sciabola, e
tornò a Atene per scrivervi una poesia su come sia dolce e nobile morire per
la patria.
Rimpatriato senza un quattrino, s'impiegò presso un questore e si mise a
scrivere versi sulle cortigiane che frequentava, perché nei salotti non era
invitato, e signore perbene non ne conosceva. Un giorno Virgilio lesse un
suo libro e ne parlò con entusiasmo a Mecenate che lo pregò di condurgli
l'autore. Prese subito in simpatia quel provinciale un po' cafoncello,
tracagnotto, orgoglioso e timido, e lo propose come segretario ad Augusto,
che consentì. Ma Orazio rifiutò quella che a chiunque altro sarebbe parsa la
manna del cielo: un po' perché il temperamento lo portava più alla
contemplazione che all'azione, un po' perché non era né ambizioso né avido,
e molto, crediamo, perché non si fidava di legar la sua sorte a quella di un
uomo politico che domani poteva essere accoppato e trascinare anche lui
alla medesima fine. Mecenate, per dargli modo di dedicarsi con più agio alla
letteratura, gli regalò una villa in Sabina con buone terre. Essa è stata
disseppellita nel 1932, e ci ha dato la misura della generosità di quel
riccone. Aveva ventiquattro stanze, un gran portico, tre bagni, un bel
giardino e cinque poderi.
Ora ch'era un agiato possidente, Orazio potè abbandonarsi in pieno alla
sua vera vena ch'era quella del moralista. Le sue Satire sono un prezioso
campionario dei più comuni personaggi romani di quel tempo. Egli li prese
dalla strada, non dalla storia e dai palazzi, e li rappresentò con scanzonato
distacco, di ognuno facendo un "carattere". Ogni tanto, per mettersi al sicuro
col governo, scriveva qualche verso di lode retorica e insincera a Augusto,
che ne fu molto lusingato e gli ordinò di completare le Odi con un Carme
secolare in cui fossero celebrate le sue imprese e quelle di Druso e di
Tiberio. Orazio vi si accinse sospirando e senza punta ispirazione. Doveva
vedersela con la Gloria, il Fato e gli Immancabili Destini: tutte cose più
grandi di lui e per le quali non aveva simpatia. Finì quel brutto poema
spossato e annoiato, dopo averlo interrotto mille volte per scrivere quelle
Epistole agli amici, soprattutto a Mecenate, che rimangono, con le Satire, il
suo capolavoro.
Si faceva sempre più sedentario anche per via della salute che
l'obbligava a molti riguardi e a una rigida dieta. Invano Mecenate lo invitava
a viaggi turistici. Orazio preferiva restare a Roma, e più ancora nella sua
villa, a mangiarvi due spaghettini fatti in casa, un filino di lesso e una mela
cotta. Salvo poi a vendicarsi decantando nelle sue poesie l'amicizia
conviviale, i banchetti succulenti, le gran bevute e gli amori con Glicera,
Neera, Pirra, Lidia, Lalage, e infinite altre donne mai esistite o appena
conosciute. Aveva per la virtù un rispetto da stoico, per il piacere una
simpatia da epicureo, ma non potè praticare né quella né questo per i
bruciori di stomaco, i reumatismi e l'insufficienza epatica.
Non s'ingannava sulla decadenza della società e l'attribuiva giustamente
a quella della religione. Ma non aveva la forza di puntellarla anche perché
non credeva a nulla egli stesso.
L'angoscia della morte annuvolò i suoi ultimi anni, durante i quali non
volle più venire neanche a Roma. Le sue lettere ne sono gonfie. "Hai fatto,
mangiato, bevuto abbastanza, ora è tempo di andare", ripeteva a se stesso.
Ma non era vero. Avrebbe voluto fare, mangiare, bere ancora un po', e senza
mal di stomaco.
Morì a cinquantasett'anni, lasciando la sua proprietà all'imperatore e
pregandolo di farlo seppellire accanto a Mecenate, ch'era scomparso pochi
mesi prima. E fu contentato.
Quello che l'età augustea non seppe dare alle arti e alla filosofia, lo diede
invece alla storia attraverso Tito Livio, altro celtico come Virgilio, e nato a
Padova. Anche lui, secondo le intenzioni della famiglia, avrebbe dovuto
essere un avvocato, ma preferì darsi allo studio della Roma antica per il
disgusto che gl'ispirava quella contemporanea. Purtroppo, egli non ha
lasciato scritto nulla delle sue personali vicende; era troppo indaffarato a
raccontarci quelle degli Orazi e degli Scipioni, che riempivano, ab Urbe
condita, cioè dalla fondazione della città, centoquarantadue libri, di cui
soltanto una quarantina son giunti fino a noi. Era un lavoro immenso, a farlo
come lo faceva lui, cioè senza risparmio, alla Bacchelli. E si capisce come,
arrivato alle guerre puniche, non avesse più fiato e volesse smettere. Fu
Augusto a spingerlo avanti.
C'è un po' da stupirne visto che l'opera di Livio è tutta a esaltazione della
grande aristocrazia, repubblicana e conservatrice, e come tale avversa a
Cesare e al cesarismo. Ma è anche un inno agli antichi austeri costumi, cioè
al "carattere" romano, ed era questo che piaceva all'imperatore.
Sull'esattezza di quel che Livio riferisce facciamo le nostre riserve, specie là
dov'egli mette in bocca ai suoi personaggi interi discorsi che somigliano più
a Livio che a loro. La sua è una storia di eroi, un immenso affresco a
episodi, e serve più a esaltare il lettore che a informarlo. Roma, a dargli
retta, sarebbe stata popolata soltanto, come l'Italia di Mussolini, da guerrieri
e navigatori assolutamente disinteressati, che conquistarono il mondo per
migliorarlo e moralizzarlo. Gli uomini, secondo lui, sono divisi in buoni e
cattivi. A Roma c'erano solamente i buoni, e fuori di Roma solamente i
cattivi. Anche un grande generale come Annibale diventa, sotto la sua
penna, un comune mariuolo.
Ciò non toglie che la storia di Livio, costata cinquant'anni di fatiche a un
autore che si dedicò soltanto ad essa, resti un gran monumento letterario.
Forse il più grande fra quelli, piuttosto mediocri, eretti sotto il segno di
Augusto.
CAPITOLO QUINDICESIMO
TIBERIO E CALIGOLA
L'UNICA cosa sicura che si può dire di Tiberio è ch'egli era nato sotto una
cattiva stella. Giudicatene voi stessi.
Quando sua madre lo portò, ragazzo, in casa d'Augusto, l'imperatore non
ebbe occhi che per suo fratello Druso, chiassone, simpatico, prepotente,
impulsivo, quanto lui era timido, riservato, riflessivo e sensibile. Tiberio
avrebbe potuto derivarne qualche sentimento di rancore e d'invidia. E invece
ammirò affettuosamente Druso, rischiò la vita per tentare di salvarlo quando
era ferito in Germania, e la sua morte fu per lui un'autentica tragedia. Ne
scortò il feretro a cavallo, dall'Elba a Roma, e gli occorsero anni per guarire
da quel dolore.
Aveva studiato intensamente e con profitto; appena gli diedero un
esercito lo condusse di vittoria in vittoria contro nemici agguerriti e insidiosi
come gl'illiri e i pannoni; quando gli diedero delle province da
amministrare, le rimise in ordine con competenza e integrità. A vent'anni,
già lo chiamavano "il vecchietto" per la sua serietà. Dedicava le poche ore di
ozio che gli avanzavano dal lavoro per rinfrescare il greco, che sapeva
benissimo, e per darsi a studi di astrologia che gli valsero la riputazione di
"eretico". Non frequentava né i salotti né il Circo. E forse la prima donna
che conobbe fu sua moglie Vipsania, la figlia di Agrippa, che era signora di
grandi virtù e di abitudini casalinghe come le sue.
Avesse potuto restare con lei, forse il suo carattere si sarebbe serbato
qual era in gioventù: quello di uno stoico sereno nella sua semplicità,
generoso verso gli amici, più intransigente verso se stesso che verso gli altri.
Il fatto che i soldati lo adorassero mentre a Roma lo detestavano come il
modello di una virtù che costituiva un rimprovero per tutti, lo dimostra. Ma
Augusto lo fece divorziare per dargli in sposa sua figlia Giulia, una
sciaguratella simpaticona, ma la meno adatta a far da compagna a un uomo
come quello. Perché Tiberio accettò? C'era in giuoco l'eredità, è vero. Ma
egli non aveva mai mostrato di aspirarvi troppo. Era stato uno zelante
collaboratore del suo patrigno, ma non gli aveva fatto mai molto la corte, e
aveva preferito esserne stimato che amato. Certamente nella sua
acquiescenza ci fu lo zampino di Livia, esemplare moglie di Augusto, ma
terribile madre per Tiberio, di cui volle la gloria anche a costo della felicità.
Tiberio portò le sue disgrazie coniugali con grandissimo decoro. E non è
vero che si rifiutasse di denunziare Giulia per adulterio, come la legge
gliene dava il diritto, anzi gliene imponeva il dovere, per non perdere i
favori di Augusto. Tant'è vero che piantò baracca e burattini per ritirarsi da
privato cittadino a Rodi, dove visse forse il periodo più tranquillo. Poi
l'imperatore, mandata al confino Giulia e persi i figli di costei Gaio e Lucio,
lo richiamò. E anche in questo riconosciamo lo zampino di Livia. Tiberio
riprese il suo lavoro a fianco del patrigno fattosi ancora più insopportabile e
malinconico, ne subì l'antipatia. E aveva già cinquantacinque anni, quando
gli toccò di succedergli. Lo fece presentandosi al Senato e chiedendogli di
esonerarlo dalla carica per restaurare la Repubblica. Il Senato la ritenne una
commedia come forse era, lo supplicò di restare detestandolo e gli chiese il
permesso di dare il suo nome a un mese dell'anno, come si era fatto con
Augusto. «E che farete», rispose Tiberio, « dal tredicesimo successore in
poi?».
Con questo sarcastico atteggiamento verso ogni forma di adulazione, il
taciturno e casto Tiberio si mise a governare, lo fece con molta equità e
accortezza, lasciando alla sua morte uno stato più florido e ricco di quello
che aveva trovato. Ma cadde sotto la penna di Tacito e di Svetonio, due
storici repubblicani, che fecero di lui il capro espiatorio di tutti i vizi del
tempo.
La colpa più grave che gli si addebita è quella di aver fatto sopprimere
suo nipote Germanico, dopo averlo adottato come figlio e designato come
erede. Germanico era figlio di Druso e nipote di Antonio: un bel ragazzo
intelligente, vivace, coraggioso, che piaceva a tutta Roma. Tiberio lo mandò
a fare il governatore in Oriente per impratichirsi, e la gente mormorò che lo
aveva esiliato per gelosia. Laggiù morì, e la gente disse ch'era stato Pisone
ad assassinarlo su ordine dell'imperatore. Pisone si uccise per sottrarsi al
processo, e la vedova di Germanico, Agrippina, fu tra le più spietate
accusatrici di Tiberio, mentre la madre, Antonia, gli rimase fedelissima. E
noi, fra una moglie e una madre, crediamo più alla madre.
Un'altra accusa che gli si muove è quella di crudeltà verso Livia. A
Livia, certo, egli doveva il trono. Ma non doveva essere facile vivere con
lei, che pretendeva di controfirmare i rescritti imperiali, ad ogni passo gli
ricordava che, senza il suo aiuto, egli sarebbe rimasto un privato cittadino
emigrato a Rodi, e soprattutto in casa si considerava la padrona rifiutandosi
di dargliene le chiavi quando usciva. Alla fine Tiberio andò a vivere per
conto suo, in un appartamento modesto e malinconico, dove nessuno gli
rompesse le scatole. Ma ebbe da vedersela con Agrippina, che vantava
anch'essa un credito verso di lui: la vita di Germanico.
Oltre che nipote per il matrimonio col figlio di suo fratello Druso, questa
Agrippina era anche sua propria figliastra, perché gliel'aveva portata in dote
Giulia dal matrimonio che l'aveva unita a Agrippa: una donna querula e
avida con tutti i vizi della madre e senza nessuna delle sue qualità: la
simpatia, lo spirito, la generosità. Essa aveva avuto da Germanico un figlio:
un certo Nerone che, secondo lei, ora doveva essere designato erede al posto
del defunto padre. Tiberio subiva i suoi assalti con rassegnata pazienza. « Ti
senti proprio defraudata dal fatto di non essere imperatrice?», le diceva.
Anche lui aveva un figlio, Druso, dategli dalla virtuosa e cara Vipsania. Ma
era un buono a nulla, pieno di vizi, e lo aveva rinnegato. Cercava
effettivamente un successore, ma nemmeno di Nerone era persuaso.
Una serie di complotti fu organizzata contro di lui. Gliene portò le prove
Seiano, il comandante dei pretoriani del palazzo. Chissà se erano vere. Ma a
poco a poco Tiberio cominciò a fidarsi solo di lui e gli permise di aumentare
la guardia fino a nove coorti, senza rendersi conto del terribile precedente
che stava per creare. E si ritirò a Capri.
Non si può dire che di laggiù smettesse di governare. Ma gli ordini li
trasmetteva attraverso Seiano, che li modificava a suo piacere e in grazia di
essi diventò il vero padrone della città. Egli scoprì un ennesimo complotto
fomentato da Poppeo Sabino, Agrippina e Nerone, facendosi autorizzare a
punirli. Il primo fu soppresso, la seconda esiliata a Pantelleria, il terzo si
uccise. Anche Druso era morto, e anche Livia, la "Madre della Patria", come
veniva chiamata per dileggio.
Un giorno sua cognata Antonia, la madre di Germanico, gli mandò
segretamente, a rischio della vita, un biglietto per avvertirlo che Seiano
stava a sua volta complottando per assassinare l'imperatore e sostituirlo.
Tiberio impartì per lettera l'ordine di arrestare il traditore e lo consegnò per
il processo al Senato, che da anni viveva nel terrore di quel satrapo. Non
solo lui, ma tutti i suoi amici e parenti vennero uccisi. La figlia giovinetta,
poiché la legge vietava la soppressione delle vergini, fu deflorata prima del
processo. La moglie si uccise, ma non senz'avere scritto una lettera a Tiberio
per denunziare Livilla, figlia di Antonia, come complice di Seiano. Tiberio
la fece arrestare. Essa si uccise in carcere rifiutandosi di mangiare. Anche
Agrippina si uccise. E il Tiberio che emerse da questa ecatombe familiare,
da questo inferno di sangue e di tradimento, è naturale che non fosse più
l'uomo di una volta. Sopravvisse sei anni, e pare che la sua mente fosse in
disordine. Nel 37 si decise a lasciar Capri, e mentre risaliva la Campania
una malattia lo colse, forse un infarto cardiaco. Quando videro che si
riprendeva, i cortigiani lo seppellirono sotto un cuscino e lo soffocarono.
Tiberio aveva mantenuto la pace, migliorato l'amministrazione,
arricchito il Tesoro. L'Impero sembrava intatto, ma la sua capitale marciva
sempre di più. Per mettere una diga al disfacimento, ci sarebbe voluta la
mano dura d'un grande riformatore. E forse Tiberio credette di ravvisarne la
stoffa nel secondo figlio di Agrippina e Germanico, Gaio, che i soldati fra i
quali era cresciuto in Germania chiamavano Caligola, o "Stivalino", dalle
calzature che portava, di tipo militare.
E infatti sul principio parve una buona scelta. Caligola si mostrò
generoso coi poveri, ridiede una parvenza di democrazia restituendo all'Assemblea i suoi poteri, era già conosciuto come un soldato valoroso e
coscienzioso. La sua improvvisa e rapida trasformazione non è spiegabile
che con l'ipotesi di qualche malanno, che gli sconvolse il cervello: un caso
tipico di schizofrenia, o dissociazione della personalità. Cominciò ad avere
crisi notturne di terrore, specie se c'era il temporale, e ad aggirarsi nel
palazzo chiedendo aiuto. Grande e grosso com'era, atletico, sportivo,
passava ore davanti allo specchio a farsi smorfie, che gli riuscivano
benissimo per via degli occhi scoppati e di una macchia di calvizie che gli
faceva una chierica in testa. A un certo punto, s'innamorò della civiltà
egiziana e pensò d'introdurne i costumi a Roma. Pretese dai senatori che gli
baciassero i piedi, che duellassero nel Circo coi gladiatori facendosene
regolarmente accoppare, e che eleggessero console il suo cavallo, Incitato,
cui fece costruire una stalla di marmo e una greppia d'avorio. Sempre per
imitar l'Egitto, si prese come amanti le sue sorelle. Anzi, una, Drusilla, la
sposò addirittura nominandola erede al trono, eppoi ripudiandola per
impalmare Orestilla il giorno in cui essa stava andando a nozze con Gaio
Pisone. Si fermò alla quarta moglie, Cesonia, ch'era incinta quando la
conobbe, e piuttosto bruttina. A lei fu, chissà perché, devoto e fedele.
Può darsi che Dione Cassio e Svetonio, nel loro odio per la monarchia,
abbiano un po' calcato la mano. Ma matto, Caligola doveva esserlo davvero.
Una bella mattina si svegliò con l'allergia per i calvi, e tutti coloro che lo
erano li fece dare in pasto alle belve del Circo, affamate dalla carestia. Poi
prese in uggia i filosofi, e li condannò tutti alla morte o alla deportazione. Si
salvarono solo suo zio Claudio perché era ritenuto idiota, e il giovane
Seneca perché si fece credere malatissimo. Non sapendo più chi
perseguitare, obbligò al suicidio la nonna Antonia solo perché un giorno,
guardandola, trovò che la sua testa era bella, ma le stava male sulle spalle.
Alla fine, se la riprese anche con Giove. Disse ch'era un pallone gonfiato
che usurpava il posto di re degli dèi, fece mozzar la testa a tutte le sue statue
e la rimpiazzò con la propria.
Peccato, perché nei rari momenti di lucidità era simpatico, cordiale,
spiritoso, aveva il sarcasmo facile e la risposta pronta. A un calzolaio gallo
che gli diede del "gigione" in faccia, rispose: « È vero, ma credi che i miei
sudditi valgano più di me?». Infatti, se avessero valso qualcosa di più, in un
modo o nell'altro se ne sarebbero sbarazzati. Invece lo applaudivano e gli
baciavano i piedi, senatori in testa.
Ci volle la risolutezza del comandante dei pretoriani, Cassio Cherea, per
liberare Roma da quel flagello. Caligola si divertiva a dargli, come parole
d'ordine, osceni insulti. Cassio era permaloso e una sera, mentre
accompagnava l'imperatore in un corridoio di teatro, lo pugnalò. La città
stentò a crederci. Temeva che si trattasse di un trucco di Caligola per vedere
chi gioiva della sua morte e punirlo in conseguenza. Per mostrare a tutti
ch'era vero, i pretoriani accopparono anche la moglie Cesonia, e
fracassarono la testa contro la parete alla figlia bambina.
Era una conclusione intonata ai personaggi e al fosco clima di terrore e
di demenza in cui avevano vissuto. Ma ormai questa era Roma: la capitale di
un Impero dove allo sfrenato satrapismo non c'era altra alternativa che il
regicidio, e per il regicidio ci volevano i mercenari. I romani non sapevano
più neanche ammazzare i loro tiranni.
CAPITOLO SEDICESIMO
CLAUDIO E SENECA
I PRETORIANI che, avendo ucciso Caligola, erano padroni della situazione
e volevano restarlo, si guardarono intorno alla ricerca d'un successore di cui
poter disporre a piacimento. E parve loro che il personaggio più indicato
fosse lo zio del defunto, quel povero Claudio già cinquantenne, con le
gambe inceppate dalla paralisi infantile e la lingua dalla balbuzie, e con
l'aria stordita, che la notte dell'assassinio fu trovato nascosto dietro una
colonna, a tremar di paura.
Era il figlio di Antonia e di Druso, figlio a sua volta di Druso Nerone. Ed
era passato in mezzo alle tragedie della casa Claudia, protetto da una ben
accreditata fama di mentecatto. Se era stata una commedia, la sua, bisogna
dire ch'egli l'aveva recitata molto bene, sin da piccino, perché perfino sua
madre lo chiamava "un aborto" e quando voleva dir male di qualcuno, lo
definiva "più cretino del mio povero Claudio".
È difficile dire sino a che punto questo personaggio, rivelatosi poi un
eccellente imperatore, fosse un idiota, o lo facesse per non pagare dazio.
Certo che, in questo modo, fu l'unico della famiglia a salvarsi. Trascinando
le gambette sinistrate, sputacchiando, quando parlava, in faccia a tutti, alto,
appesantito dalla trippa e col naso rosso di vino, aveva vissuto sino a
quell'età senza dar ombra a nessuno, studiando e componendo storie, fra cui
la sua autobiografia. Parlava il greco, la sapeva lunga di geometria e di
medicina. E quando si presentò al Senato per farsi proclamare imperatore,
disse: «Lo so che mi considerate un povero scemo. Ma non lo sono. Ho
finto di esserlo. E per questo oggi son qui». Dopodiché però sciupò tutto,
tenendo una conferenza sul modo di curare i morsi delle vipere.
Claudio debuttò con una buona mancia ai pretoriani che lo avevano
eletto, ma in cambio si fece consegnare da loro gli assassini di Caligola e li
soppresse per instaurare, disse, il principio che gl'imperatori non si
ammazzano. Poi cancellò con un colpo di penna tutte le leggi del suo
predecessore e si diede a riordinare l'amministrazione, spiegandovi un senno
e un equilibrio che nessuno sospettava in lui. Convinto che fra i senatori non
ci fosse più nulla di buono, formò un ministero di tecnici, scegliendoli nella
categoria dei liberti. E si diede a studiare e realizzare con loro opere
pubbliche di grossa portata, divertendosi a fare di persona calcoli e progetti.
Quello che più l'occupò fu il prosciugamento del lago Fucino. Impiegò
trentamila sterratori e undici anni per scavare un canale e far defluire le
acque. Quando tutto fu pronto, offrì ai romani, come ultimo spettacolo,
prima del disseccamento, una battaglia navale fra due flotte di ventimila
condannati a morte, che gli rivolsero il famoso grido: «Ave Cesare! I
morituri ti salutano!», si colarono a picco gli uni contro gli altri, e
affogarono. Il pubblico, che tappezzava le colline intorno, si divertì
moltissimo.
Tutti si misero a ridere quando nel 43 questo imperatore sbevazzone e
dall'aria scimunita e gioconda partì alla testa del suo esercito per conquistare
la Britannia. Non aveva mai fatto il soldato anche perché lo avrebbero
riformato alla leva, e Roma era convinta che sarebbe scappato al primo
scontro. Ma quando si sparse la notizia ch'egli era morto, il cordoglio fu
grande e generale: i romani si erano sinceramente affezionati a quel loro
imperatore che, con tutte le sue stravaganze, si era mostrato il migliore, o
almeno il più umano, fra quelli succeduti ad Augusto.
Invece Claudio non solo non era morto, ma aveva conquistato davvero la
Britannia, e ora tornava portandosene dietro il re, Caractaco, che fu il primo,
dei re vinti da Roma, ad essere graziato. Il merito di questa vittoria, certo,
sarà stato, più che di Claudio, dei suoi generali. Ma i generali era lui che li
nominava, e in queste scelte non prendeva granchi. Fu sotto di lui che si
formò anche Vespasiano.
Purtroppo questo brav'uomo aveva un debole: le donne. Era un
pomicione incorreggibile. Aveva già avuto, e tradito, tre mogli, quando,
quasi cinquantenne, sposò la quarta, Messalina, che aveva sedici anni.
Messalina è passata alla storia come la più infame di tutte le regine, e forse
non è vero. Forse fu soltanto la più scostumata. Siccome non era bella,
quando qualche giovanotto le resisteva, gli faceva impartire da Claudio
l'ordine di cedere, trasformando così l'amore in un gesto di patriottismo.
Claudio si prestava purché Messalina gli lasciasse mano libera con le
cameriere. Erano, in fondo, una coppia bene assortita, ma il guaio era che
Claudio si era messo in testa di riformare il costume romano su basi di
austerità, e una moglie di quella fatta non costituiva il migliore esempio. Un
giorno, mentre egli era assente, essa sposò addirittura il suo amante di turno,
Silio. I ministri ne informarono l'imperatore dicendogli che Silio voleva
sostituirlo sul trono. Claudio tornò, lo fece uccidere, eppoi mandò due
pretoriani a chiamare Messalina che si era nascosta nella casa materna.
Timorosi di una vendetta, i pretoriani la pugnalarono nelle braccia di sua
madre. Claudio ordinò loro di uccidere anche lui, se avesse accennato a
risposarsi.
Si risposò l'anno dopo, e la quinta moglie virtuosa fece rimpiangere la
quarta svergognata. Agrippina, figlia di Agrippina e di Germanico, era sua
nipote, aveva già avuto due mariti, e il primo di essi le aveva lasciato un
figlioletto di nome Nerone, la cui carriera fu la sua unica passione. In lei
riviveva una Livia peggiorata. Coi suoi trent'anni, le fu facile mettere sotto
la pantofola quel marito quasi sessantenne, infiacchito dagli strapazzi con le
cameriere. Essa lo isolò dai suoi collaboratori, mise il suo amico Burro alla
testa dei pretoriani, e instaurò un nuovo regno di terrore, di cui senatori e
cavalieri fecero le spese. Le condanne capitali portavano una firma di
Claudio che, dopo la morte di costui, si rivelò falsificata. Il pover'uomo,
sebbene rimbambito, parve accorgersi a un certo punto di quel che
succedeva e voler porvi rimedio. Agrippina lo prevenne propinandogli un
piatto di funghi avvelenati. Nerone, che aveva a modo suo un certo
spiritaccio, disse più tardi che i funghi dovevano essere una pietanza da dèi,
visto che erano riusciti a trasformare in dio un povero ometto come Claudio.
Nerone, in dialetto sabino, voleva dire forte, e nei primi cinque anni di
regno il figlio di Agrippina tenne fede al suo nome, mostrandosi un
imperatore magnanimo e assennato. Ma il merito non fu suo; fu di Seneca,
che in suo nome governò.
Seneca era uno spagnolo di Cordova, milionario di famiglia e filosofo di
professione, che già aveva fatto parlare di sé, prima che Agrippina lo
arruolasse come precettore di suo figlio. Caligola lo aveva condannato a
morte per "impertinenza"; poi lo aveva graziato perché malatissimo di asma.
Claudio lo aveva mandato al confino in Corsica per una tresca con sua zia
Giulia, la figlia di Germanico. Seneca era rimasto laggiù otto lunghi anni
scrivendo eccellenti saggi e alcune brutte tragedie. Non sappiamo chi fu a
proporlo ad Agrippina come l'uomo più adatto ad allevare Nerone secondo i
dettami dello stoicismo, di cui era considerato l'incontestabile maestro.
Comunque, nello spazio di pochi giorni, egli passò dallo stato di recluso a
quello di padrone del futuro padrone dell'Impero.
Era uno strano uomo. Usò la sua posizione, senza troppi scrupoli, per
moltiplicare il patrimonio, ma non usò il patrimonio per menar vita da
signore. Mangiava pochissimo, beveva solo acqua, dormiva sul tavolaccio,
scialava solo in libri e opere d'arte, dal giorno che sposò fu fedele solo a sua
moglie, e a chi gli rimproverava di amare troppo il potere e i quattrini,
rispondeva:
« Ma io non lodo la vita che faccio. Lodo quella che dovrei fare, e di cui
a distanza imito, arrancando, il modello». Mentre era all'apice della sua
fortuna, un libellista lo accusò pubblicamente di aver rubato allo stato
trecento milioni di sesterzi, di averli moltiplicati con l'usura, e di essersi
liberato dei rivali e dei nemici con la denunzia. Seneca, che in quel
momento poteva far sopprimere chi voleva, rispose astenendosi dal
denunziare il suo denunziatore. Però l'usura continuò ad esercitarla, a quanto
dice Dione Cassio. Quando il suo pupillo salì sul trono, Seneca gli diede da
leggere in Senato un bel discorso, in cui il nuovo imperatore s'impegnava a
esercitare solo il potere di comandante supremo dell'esercito. Nessuno ci
credette, probabilmente, ma la promessa fu mantenuta per cinque anni,
durante i quali tutti gli altri poteri furono esercitati da Agrippina e da
Seneca. E le cose procedettero abbastanza bene finché costoro furono
d'accordo. Nerone, con quei due suggeritori alle spalle, prese alcune
risoluzioni giudiziose: respinse la proposta del Senato di elevargli statue
d'oro, si rifiutò di firmare condanne a morte, e quando per una dovette fare
eccezione esclamò brandendo la penna: «Potessi non aver mai imparato a
scrivere!». Sembrava davvero un bravo ragazzo, interessato quasi
esclusivamente alla poesia e alla musica, e nessuno pensava che queste
buone disposizioni potessero rivelarsi un giorno pericolose.
Poi Agrippina volle strafare, cioè fare tutto da sola. Seneca e Burro se ne
allarmarono e, per neutralizzarla, spinsero Nerone a far valere la sua
autorità. Incollerita, Agrippina minacciò di disfare la sua opera, mettendo
sul trono Britannico, figlio di Claudio. E Nerone rispose facendo sopprimere
costui e confinando la madre in una villa, dove essa rese alla storia,
crediamo, un brutto servizio, scrivendo un libro di Memorie su Tiberio,
Claudio e Nerone, cui Svetonio e Tacito attinsero a piene mani e che,
ispirato com'era dalla vendetta, temiamo che non fosse molto attendibile.
Che parte abbia avuto Seneca nell'uccisione di Britannico, ce lo
domandiamo. Come autore di un saggio intitolato Della clemenza, ci auguriamo che non ne abbia avuta punta. Ma, dati i precedenti, non oseremmo
giurarlo.
Finché Nerone seguitò a razzolare come Seneca predicava, Roma e
l'Impero furono tranquilli, le frontiere sicure, prosperi i commerci e in
ascesa le industrie. Ma a un certo punto il pupillo, che aveva appena
vent'anni, cominciò a volgersi verso un altro maestro, che soddisfaceva di
più le sue tendenze di esteta: Caio Petronio, l'arbitro di tutte le eleganze
romane, il fondatore di una categoria umana abbastanza diffusa: quella dei
dandies.
Noi troviamo una certa difficoltà a identificare questo ricco aristocratico
che Tacito descrive raffinato nei suoi appetiti, delicatamente voluttuoso,
d'ironica ed elegantissima conversazione, nel Caio Petronio autore del
Satyricon, libello di rime volgari fino all'oscenità con personaggi banali e
situazioni trite. Se è vero che si tratta della stessa persona, vuol dire che fra
il modo di vivere e di essere e quello di scrivere e di apparire c'è di mezzo
non il mare, ma l'oceano. Comunque Nerone, incantato dal Petronio che
conobbe in società, raffinalo, colto, seduttore di uomini e di donne,
intenditore infallibile del Bello, trovò più facile imitare il cattivo poeta e
praticarne gl'insegnamenti letterari. Si prese per compagni gli eroi del
Satyricon e con essi si diede all'orgia nei quartieri più malfamati di Roma.
Il casto Seneca, sul momento, non trovò nulla da obbiettare, anzi è
probabile che abbia spinto su questa via il suo allievo per distrarlo sempre
più dai problemi di governo, che preferiva risolvere da solo o con Burro. In
tal modo, per alcuni anni, sotto un imperatore che sempre più si degradava,
l'Impero seguitò a prosperare. Traiano, più tardi, definì il primo lustro di
Nerone: "il miglior periodo di Roma". Ma a un certo punto il giovane
sovrano incappò in Poppea, un'Agrippina nel pieno rigoglio della sua bellezza, che voleva far l'imperatrice, e per riuscirci spinse Nerone a far
l'imperatore. Quando la conobbe, Nerone aveva ventun anni, una moglie
perbene, Ottavia, che portava con molta dignità le sue disgrazie coniugali, e
un'amante, Acte, perbene anch'essa, e innamorata di lui. Ma a Nerone le
donne oneste non piacevano, e le tradì ambedue per la scostumata, sensuale
e calcolatrice Poppea. È a questo punto che incominciano la sua storia e le
tribolazioni di Roma.
CAPITOLO DICIASSETTESIMO
NERONE
era stata certamente una donna nefasta. Ma gli ultimi episodi
della sua vita sono da vera matrona dell'antica Roma. Essa non esitò a
mettersi risolutamente contro suo figlio, quando costui venne a chiederle il
consenso al divorzio da Ottavia. Tacito dice ch'essa giunse perfino a
offrirglisi.
Nerone, sebbene l'avesse confinata in una villa, aveva ancora paura di
lei. Ma altrettanta paura aveva di Poppea, che gli si rifiutava schernendolo
per questo suo timor filiale. Alla fine essa riuscì a fargli credere che
Agrippina congiurava contro di lui, che, non osando ucciderla, tentò di farla
morire, una volta avvelenandola, e un'altra facendola cadere nel fiume.
Agrippina se l'aspettava. Forse da qualche suo servitore di fiducia lasciato a
palazzo era informata di ciò che le preparavano, e cercò di salvarsi la prima
volta con una medicina che risolse l'avvelenamento in una colica, la seconda
nuotando. Le guardie di Nerone dovettero fare altrettanto per inseguirla
sull'altra sponda. E ci domandiamo quali dovettero essere i sentimenti e i
pensieri di questa donna nel vedersi incalzata dai sicari di un figlio, cui
aveva sacrificato tutta la sua vita. Ma non li mostrò, quando fu da essi
raggiunta. Disse semplicemente: «Colpite qui», e indicò il grembo da cui
Nerone era nato. Costui, quando gli portarono il corpo nudo di sua madre
morta, osservò soltanto: « Toh, non mi ero mai accorto di aver avuto una
mamma così bella». E forse l'unica cosa che rimpianse fu di non essersela
presa quando lei gli si era offerta.
Come già per Caligola, non abbiamo altra ipotesi che la follia per
spiegare simili reazioni. Forse nel sangue dei Claudi c'era un male ereditario, che dava al cervello.
La storia assicura che Seneca in questo orrendo delitto non ebbe parte.
Ma essa ci obbliga a costatare anche ch'egli lo accettò, rimanendo al fianco
dell'imperatore. Sperava forse di trattenerlo sulla china della perdizione?
Quella speranza, se la covò, fu presto delusa. Nerone respinse i suoi consigli
quando egli cercò di fargli capire che a un imperatore non si addiceva
giostrare nel Circo come auriga ed esibirsi in teatro come tenore. Anzi, per
mostrare quanto poco ormai teneva in considerazione il suo maestro, ordinò
ai senatori di misurarsi con lui in quelle prove ginnastiche e musicali,
AGRIPPINA
dicendo che questa era la tradizione greca e che la tradizione greca era
migliore di quella romana.
I senatori, nel loro insieme, forse non meritavano miglior trattamento;
ma in qualcuno di essi brillava ancora un barlume di dignità. Trasea Péto e
Elvidio Prisco parlarono apertamente contro l'imperatore, le cui spie li
accusarono di complotto. Nerone, che dopo il matricidio aveva mostrato una
certa clemenza, si abbandonò a un'orgia di sangue e siccome il Tesoro, che
Claudio aveva lasciato florido, sotto le sue sregolatezze si era esaurito,
impose ai condannati di lasciargli le loro sostanze. Seneca criticò queste
misure. Ma la vera ragione per cui perse il posto fu che criticò anche le
poesie del suo padrone. Forse con un respiro di sollievo si ritirò nella sua
villa in Campania, e qui si diede alacremente a cercare, come scrittore, una
rivincita al suo fallimento di precettore. Burro era morto pochi mesi prima, e
lo aveva rimpiazzato lo scellerato Tigellino.
Senza più freni, Nerone precipitava. Il ritratto fisico che ci hanno
lasciato di lui ce lo mostra, a venticinque anni, coi capelli gialli annodati in
treccine, l'occhio smorto e una pancia adiposa su due gambette rachitiche.
Poppea, ormai sua moglie, ne faceva quel che voleva. Non contenta di
avergli imposto il divorzio da Ottavia, lo spinse a mandarla al confino. E
siccome i romani disapprovarono e coprirono di fiori le sue statue, lo
persuase a farla assassinare. Ottavia morì male, impaurita, e chiedendo
pietà: aveva vent'anni appena ed era nata per fare la buona moglie di un
buon marito, non l'eroina di una tragedia.
Neanche stavolta Nerone ebbe rimorsi perché nel frattempo si era fatto
consacrare dio, e gli dèi non sono obbligati a esami di coscienza. Ora voleva
soltanto costruire per sé un nuovo palazzo d'oro, che diventasse il proprio
tempio e, siccome lo progettava di dimensioni gigantesche, non trovava,
nell'affollato centro di Roma, un'area fabbricabile. Da qualche tempo andava
brontolando che la città era costruita male, e che si sarebbe dovuto rifarla
tutta secondo un più razionale piano urbanistico, quando, nel luglio del
sessantaquattro, vi scoppiò il famoso incendio.
Era stato veramente lui a farlo appiccare? Forse no. Egli si trovava ad
Anzio in quel momento, accorse subito, e spiegò un'energia che nessuno gli
sospettava nell'opera di soccorso. Ma il fatto che subito la voce del popolo
lo accusò dimostra che, anche se non lo aveva fatto, la gente lo considerava
capace di farlo. Stranamente assai, egli non reagì stavolta alle accuse, non
perseguitò nemmeno gli autori dei volantini e dei libelli che lo additavano
alla furia popolare. Ma, da vero capo di un regime totalitario, pensò che,
dato il disastro, prima ancora che a ripararlo, bisognava pensare a trovar
qualcuno cui addebitarlo. E fu così, dice Tacito, ch'egli ricorse a una setta
religiosa formatasi in quei tempi a Roma e che aveva derivato il suo nome
da quello di un certo Cristo, un ebreo condannato a morte da Ponzio Pilato
in Palestina al tempo di Tiberio.
Nerone non sapeva altro di loro, quando ne fece arrestare tutti quelli che
gli capitarono a tiro e condannare, dopo un processo sommario, alla tortura.
Alcuni furon dati alle belve, altri crocifissi, altri spalmati di resina e adibiti a
torce. Roma non si era molto accorta di loro. Ma dopo questo martirio in
massa cominciò a guardarli con una certa curiosità. Ora l'imperatore poteva
finalmente costruire una capitale come piaceva a lui. E in questa bisogna,
che lo assorbì completamente, mostrò una certa competenza. Ma mentre la
nuova Roma cresceva più bella di quella distrutta, Poppea morì di un aborto.
Le male lingue dissero subito ch'era stato il marito a darle un calcio nella
pancia durante un litigio. Può darsi. Comunque il colpo fu terribile per lui,
che vi perse insieme una moglie amata e l'erede che aspettava. Errando nel
dolore per le strade, vi trovò un giovanotto, un certo Sporo, il cui volto
stranamente somigliava a quello della defunta. Lo portò a palazzo, lo fece
castrare e lo sposò. I romani commentarono: «Ah, se suo padre avesse fatto
altrettanto!...».
Soprintendeva ai lavori per l'erezione del suo grande palazzo, quando le
sue spie scoprirono un complotto per installare sul trono Calpurnio Pisone.
Ci furono i soliti arresti, le solite torture, le solite confessioni. In una di
queste furon fatti i nomi di vari intellettuali, fra cui Seneca e Lucano.
Lucano era un altro spagnolo di Cordova, lontano cugino di Seneca, che,
venuto a Roma per studiarvi legge, aveva commesso l'imperdonabile errore
di vincere un premio di poesia a un concorso cui si era presentato anche
Nerone, che perse. L'imperatore gli vietò di continuare a scrivere. Lucano
disobbedì componendo un carme sulla battaglia di Farsalo, retorico e
mediocre, ma d'intonazione chiaramente repubblicana. Non potè
pubblicarlo, ma lo lesse nei salotti aristocratici dove ebbe naturalmente
grande successo, fra quei signori che non avevano più la forza di opporsi
alla tirannia, ma rimpiangevano la libertà. Partecipò egli veramente al
complotto, o vi fu iscritto d'ufficio dagli sbirri che conoscevano l'antipatia di
Nerone per quel suo rivale? Negl'interrogatori, egli ammise la propria colpa
e denunziò gli altri complici, fra cui, pare, anche sua madre e il cugino
Seneca. Condannato, invitò gli amici a una gran festa, mangiò e trincò con
loro, si aprì le vene, e morì recitando alcuni suoi versi contro il dispotismo.
Aveva ventisei anni.
Seneca apprese forse di aver partecipato alla congiura di Pisone dai
messi dell'imperatore che vennero in Campania a partecipargli la condanna.
Stava scrivendo una lettera al suo amico Lucilio che terminava così: Per
quel che mi riguarda, ho vissuto abbastanza a lungo e mi par d'avere avuto
tutto quel che mi spettava. Ora attendo la morte. Ma quando la morte si pre-
sentò nei panni di quell'ambasciatore, obbiettò che non c'era ragione
d'infliggergliela, visto che da tempo non faceva più politica e badava a
curarsi soltanto la salute, di cui lasciò prevedere imminente il collasso. Era
la scusa che aveva invocato anche con Caligola e che gli aveva permesso di
campare fin quasi a settant'anni. L'ambasciatore tornò a Roma, ma Nerone
fu irremovibile. Allora Seneca con molta calma abbracciò la moglie Paolina,
dettò una lettera di addio ai romani, bevve la cicuta, si aprì le vene, e morì
secondo i precetti dello stoicismo meglio di quanto non avesse saputo
vivere. Paolina tentò di imitarlo, ma l'imperatore le fece suturare le vene. I
secoli hanno cancellato le contraddizioni dell'uomo Seneca e hanno
conservato solo le opere dello scrittore, che una sua grandezza la raggiunse.
Egli insegnò come si compone un "saggio" e come si concilia la predica
della rinuncia con la pratica dei propri comodi. A un simile maestro, gli
allievi non potevano mancare.
Fatto il vuoto intorno a sé, Nerone partì per una tournée in Grecia, dove
la gente, disse, s'intendeva d'arte più che a Roma. Partecipò come fantino
alle corse di Olimpia, cascò, arrivò ultimo, ma i greci lo proclamarono
ugualmente vincitore, e Nerone li compensò esentandoli dal tributo a Roma.
I greci capirono l'antifona, gli fecero vincere tutti gli altri tornei,
organizzarono una clamorosa claque nei teatri in cui l'imperatore cantava
(era fatto assoluto divieto di uscire durante lo spettacolo, e ci furono delle
donne che vi partorirono), ed ebbero in cambio la piena cittadinanza.
Tornato a Roma, Nerone decretò a se stesso un trionfo in cui, non
potendo esibire le spoglie di nessun nemico, esibì le coppe che aveva guadagnato come tenore e come auriga. Era in buona fede, nel pretendere
l'ammirazione dei suoi concittadini. Credeva che ne nutrissero davvero per
lui, e quindi fu più stupito che preoccupato quando seppe che Giulio
Vindice chiamava la Gallia alle armi contro di lui. La sua prima cura,
nell'organizzare l'esercito da guidare contro il ribelle, fu di ordinare un gran
numero di carri espressamente costruiti per il trasporto delle scene con cui
montare un teatro. Perché, fra una battaglia e l'altra, intendeva continuare a
recitare, a suonare e a cantare per farsi applaudire dai soldati. Ma durante
questi preparativi, giunse la notizia che Galba, governatore della Spagna, si
era unito a Vindice e che con lui marciava su Roma.
Il Senato, che da tempo spiava l'occasione, dopo essersi assicurata la
benevola neutralità dei pretoriani, proclamò imperatore il ribelle proconsole,
e Nerone si accorse improvvisamente d'essere solo. Un ufficiale della
Guardia, cui chiese di accompagnarlo nella fuga, gli rispose con un verso di
Virgilio: «È dunque così difficile morire?».
Sì, era molto difficile, per lui. Si procurò un po' di veleno, ma non ebbe
il coraggio d'ingerirlo. Pensò di buttarsi nel Tevere, ma non ne trovò la
forza. Si nascose nella villa di un amico sulla via Salaria, a dieci chilometri
dalla città. Lì seppe che lo avevano condannato a morte "alla vecchia
maniera" cioè per fustigazione. Atterrito, afferrò un pugnale per
immergerselo nel petto, ma prima ne provò la punta e trovò che "faceva
male". Si decise a tagliarsi la gola, quando udì uno zoccolio di cavalli fuor
della porta. Ma la mano gli tremò, e fu il suo segretario Epafrodito a
guidargliela sulla carotide. «Ah, che artista muore con me!», sussurrò in un
rantolo. Le guardie di Galba rispettarono il cadavere che fu piamente sepolto
dalla vecchia nutrice e dalla prima amante, Acte. Stranamente assai, la sua
tomba rimase per molto tempo coperta di fiori sempre freschi, e molti a
Roma continuarono a credere ch'egli non fosse morto e stesse per tornare. In
genere, sono idee che germogliano solo nei terricci fecondati dai rimpianti e
dalla speranza.
Che Nerone fosse, tutto sommato, migliore di come la storia lo ha
descritto?
© 1959 Rizzoli Editore, Milano
© 1994 RCS Libri S.p.A., Milano sulla collana storia d’italia
© 2001 RCS Collezionabili S.p.A., Milano sulla presente edizione
storia d’italia
Pubblicazione periodica settimanale
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 197 del 9.4.1994
Direttore responsabile: Gianni Vallardi
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa
n. 00262 vol. III Foglio 489 del 20.9.1892
SOMMARIO
Cronologia
Capitolo Primo
Pompei
Capitolo Secondo
Gesù
Capitolo Terzo
Gli Apostoli
Capitolo Quarto
I Flavi
Capitolo Quinto
Roma epicurea
Capitolo Sesto
II suo capitalismo
Capitolo Settimo
I suoi divertimenti
Capitolo Ottavo
Nerva e Traiano
Capitolo Nono
Adriano
Capitolo Decimo
Marc'Aurelio
Capitolo Undicesimo
I Severi
Capitolo Dodicesimo
Diocleziano
Capitolo Tredicesimo
Costantino
Capitolo Quattordicesimo
II trionfo dei cristiani
Capitolo Quindicesimo
L'eredità di Costantino
Capitolo Sedicesimo
Ambrogio e Teodosio
Capitolo Diciassettesimo
La fine
Capitolo Diciottesimo
Conclusione
CRONOLOGIA
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
753 o 754 di Roma Nasce in Palestina Gesù
Cristo. 33 ca. Crocifissione di Gesù Cristo a
Gerusalemme, sotto il procuratore Ponzio
Pilato. 48 Concilio apostolico a Gerusalemme con Pietro, Paolo e Barnaba. 49-52
Paolo a Corinto. 54-58 Paolo a Efeso. 60-61
Viaggio di Paolo a Roma. 64 Decapitazione
di Paolo a Roma e crocifissione di Pietro nei
giardini Vaticani.
68-69 Si succedono
Ottone e Vitellio.
al
Intorno al 50, Matteo scrive il Vangelo di
Cristo, seguito tra il 54 e il 61 da quello di
Marco, intorno al 60 da quello di Luca; più
tardivo di qualche decennio è quello di
Giovanni. 72 Vespasiano da inizio alla
costruzione
dell'anfiteatro
Flavio,
il
Colosseo, inaugurato da Tito nell'80 con feste
che durarono cento giorni e l'uccisione di
5000 belve.
principato Galba,
69-96 Imperatori di casa Flavia.
69-79 Tito Flavio Vespasiano. 70 II figlio
Tito conquista e distrugge Gerusalemme.
79-81 Tito. 79 Eruzione del Vesuvio e
distruzione di Ercolano e Pompei.
81-96 Domiziano.
Britannia
84
Conquista
della
96-192 Età degli imperatori adottivi.
81-96 Persecuzione dei cristiani sotto
Domiziano. Sotto Domiziano è costruito
l'Arco di Tito in ricordo della vittoria del
fratello sui giudei.
96-98 M. Cocceio Nerva.
98-117 Traiano. 101-107 Conquista della
Dacia oltre il Danubio e del regno dei nabatei
nell'Arabia settentrionale. 115-117 Guerra
contro i parti. Vengono istituite le province di
Armenia, Siria e Mesopotamia. L'impero
raggiunge la sua massima estensione.
98-117 Persecuzione dei cristiani sotto
Traiano. Sotto Traiano è costruito in Spagna
l'acquedotto di Segovia.
Traiano innalza il Foro traiano, opera di
Apollodoro di Damasco, con la colonna celebrante la vittoria sui daci.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Attività letteraria dai Flavi a Traiano
Celso scrive gli otto libri Sulla medicina.
Columella compone il più complesso
Trattato di agricoltura dell'antichità, in 12
libri. Frontino (30-104) scrive Le acque di
Roma e Gli stratagemmi.
Silio Italico (26-101), poeta epico, è autore
dei 17 libri delle Puniche sulla seconda guerra punica.
Valerio Flacco (I sec. d.C.) scrive il poema,
in 8 libri, A-gonautica.
Plinio il Vecchio (23-79), di Como, scrive
una monumentale Storia naturale in 37 libri.
Papirio Stazio (45-96), napoletano, è li poeta
della Tebaide, poema epico in 12 libri, dell'Achilleide e delle Silvae (5 libri di poesie).
Cornelio Tacito (55?-117?), tra i maggiori
storici di tutti i tempi, autore dei 14 libri delle
Storie, da Galba a Domiziano (ne restano
circa 4), degli Annali, 16 libri, dalla morte di
Augusto a Nerone (ne restano una decina),
della Germania, della Vita di Agricola e del
Dialogo degli oratori. Plinio il Giovane (61114), di Como, scrive il Panegirico a
Traiano e 9 libri di Lettere, nonché il
Carteggio con Traiano.
Valerio Marziale (40-102), spagnolo, autore
di 14 libri di Epigrammi e di un libro sugli
Spettacoli (le feste per l'inaugurazione dd
Colosseo).
Giunio Giovenale (60-140), di Aquino, scrive
le Satire, in cinque libri.
Plutarco (46-120), di Cheronea, autore delle
Vite parallele, in greco.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
sec- II Si diffondono l'eresia cristiana di
Marcione, che nega l'umanità di Cristo, e
quella di Montano, che predira imminente la
fino del mondo.
Settimio Severo fa costruire terme imponenti.
117-138 Adriano. Costruzione del Vallo in
Britannia.
132-135 Viene schiacciata una nuova rivolta
dei giudei.
125-134 Adriano fa costruire la sua immensa
villa di Tivoli.
135 Viene iniziato il mausoleo di Adriano
(Castel Sant'Angelo), opera di Demetriano.
138-161 Antonino Pio.
161-180 Mano Aurelio, insieme col fratello
Lucio Vero fino al 169. 162-165 Guerra
contro i parti. 167-175 Prima guerra contro i
marcomanni. 176 II figlio Commodo viene
associato all'impero.
178-180
marcomanni.
Seconda
guerra
180-192 Commodo. Alla morte
l'impero cade in mano ai Pretoriani.
centro
di
176 Viene innalzata la colonna per celebrare
il trionfo di Marco Aurelio sui marcomanni
(attualmente in piazza Colonna).
i
lui
793 Elvio Pertinace.
Imperatori
contemporaneamente
Didio
Giuliano, a Roma, Pescennio Nigro in Siria,
Clodio Albino in Britannia e Settimio Severo
in Pannonia.
193-235 I Severi.
193-211 Settimio Severo unico imperatore.
197-199 Guerra contro i parti. 208-211
Guerra in Britannia.
1II-V secc. Dilaga per l'impero l'inflazione,
ristagna la circolazione monetaria, per la crisi
economica i proletari urbani si spostano nelle
campagne; si diffonde l'economia fondata sul
baratto.
203 Viene innalzato l'Arco di Settimio
Severo, nel decimo anniversario della sua
nomina a imperatore.
204 Viene eretto l'Arco degli Argentari
(cambiavalute) in onore di Settimio Severo e
Giulia Donna.
EVENTI POLITICI
EVENTI CIVILI,
E MILITARI
CULTURALI E ARTISTICI
211-217 Caracalla. 2/2 Caracalla concede la
piena cittadinanza a tutti i liberi dell'impero
206 Settimio Severo inizia le Terme
Antoniniane, inaugurate dal figlio Caracalla
nel 217, da cui presero il nome.
218 Breve impero di Macrino.
220 Eliogabalo introduce a Roma il culto di
Baal
218-222 Eliogabalo.
222-235 Alessandro Severo.
235 Rivolta dell'esercito di Germania sotto
Giulio Massimino
235-268 Periodo dell'anarchia militare.
235-238 Massimino.
238 Gordiano I, Balbino; Gordiano II.
238-244 Gordiano III.
247 Celebrazione sotto Filippo del millenario
di Roma.
244-249 Filippo Arabo.
249-251 Decio.
249-251 Prima persecuzione
cristiani sotto De-
251-253 Trebonio Gallo.
generale
dei
253 Emiliano.
253-260 Valeriano. 254
l'impero col figlio Gallieno.
Valeriano
divide
260-268 Gallieno.
257-258 Persecuzione dei cristiani sotto
Valeriano (morte del vescovo di Cartagine,
Cipriano).
268-270 Claudio II.
270-275 Domizio Aureliano, restitutor orbis.
272 Vince la regina Zenobia.
275-276 Claudio Tacito.
276-282 Marco Aurelio Probo.
282-283 Marco Aurelio Caro.
271 Aureliano costruisce la cinta di mura che
porta ancora il suo nome.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
284-305 Diocleziano. 286 Prende collega
Massimiano col titolo di Augusto. Galerio e
Costanzo sono nominati Ce-sari e loro
successori (Tetrarchia). 297 Divisione amministrativa dell'impero in 12 diocesi e 101
province.
305-306 Costanzo Cloro.
305-312 Lotte tra Galerio, Massimiano,
Massenzio, Severo, Massimino e Costantino.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
297 Diocleziano istituisce
obbligatorie per gli artigiani.
le
corporazioni
301 Leggi contro l'aumento dei prezzi e
l'inflazione. L'impero diventa una monarchia
assoluta e il principe è divinizzato; viene
istituita la servitù della gleba.
Diocleziano fa costruire le Terme che portano
ancora il suo nome.
303-311 Massima ed ultima persecuzione
contro i cristiani sotto Diocleziano e i suoi
successori.
311 Editto di tolleranza per i cristiani di
Galerio e Licinio.
312 Massenzio è sconfitto da Costantino
presso il ponte Milvio.
312-337 Costantino il grande (già Augusto
dal 307). 313 Editto di Milano a favore dei
cristiani. 325 Indice a Nicea il concilio
ecumenico contro Ario. 330 Inaugura a
Bisanzio la Nuova Roma, Costantinopoli.
337 Riceve il battesimo.
313 Piena libertà di culto per i cristiani sotto
Costantino (editto di Milano). È abolito il
culto pagano di stato.
Attività letteraria
da Adriano a Diocleziano
Tranquillo Svetonio (69-140), lo storico delle
Vite dei Cesari, da Giulio Cesare a
Domiziano. Lucio Apuleio (125-180) di
Madaura
in
Africa
è
autore
delle
Metamorfosi in 11 libri, ovvero L'asino
d'oro, l'unicó romanzo giunto intero dall'antichità.
Cornelio Frontone (100-166), retore, scrive
opere di erudizione.
Aulo Gelilo, è autore delle Notti Attiche, in
20 libri, di varia erudizione.
Dione Cassio (155-235), scrive in greco una
Storia di Roma dalle origini fino al 229 d.C.
Ne restano una ventina di libri.
Marco Aurelio, l'imperatore, scrive i Ricordi.
Si fa risalire a questi anni un carme di
anonimo, il Pervigilium Veneris.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Aurelio Nemesiano lascia due poemi sulla
caccia. Ulpiano, giurista, lascia opere
fondamentali di giurisprudenza.
Modestino, allievo di Ulpiano, chiude a metà
del III secolo la giurisprudenza classica.
306-313 Viene innalzata la Basilica di
Massenzio o di Costantino. Viene costruito
l'Arco di Giano Quadrifronte.
Costante,
315 II senato innalza l’Arco di Costantino, in
onore dell'imperatore vittorioso su Massenzio.
337-361 Costanzo II. 355 II nipote Giuliano
viene nominato Cesare.
357 Costanzo II fa trasportare a Roma
dall'Egitto l'obelisco oggi in piazza Laterano.
361-363
Giuliano
l'apostata.
combattendo contro i persiani.
Attività letteraria pagana dei
due ultimi secoli dell'impero
337 Costantino II,
Delmazio, Annibaliano.
Costanzo,
Muore
Ausonio
Mosella.
364-375 Valentiniano. 375 Guerra contro gli
ostrogoti.
Claudio Claudiano, poeta alla corte di
Onorio, scrive la Guerra gotica e il Ratto di
Proserpina.
Dal 375 al 568 è l'età delle grandi emigrazioni barbariche che invadono l'impero, dai
primi movimenti degli unni alla calata in
Italia dei longobardi.
375-378
Valente.
Adrianopoli.
378
Battaglia
di
(IV
sec.)
scrive
il
poema
La
363-364 Gioviano.
Eutropio, storico alla corte di Valente, scrive
il Breviario dalla fondazione di Roma.
Ammiano Marcellino (330-400),
siriaco,
compone 31 libri di Storia, da Domiziano a
Valente (rimangono gli ultimi 18). Aurelio
Vittore (IV sec.), storico africano, scrive I
Cesari, da Augusto a Costanzo.
378-383 Graziano, con Teodosio I quale
Augusto dal 379.
Macrobio (IV-V secc.) scrive i 7 libri dei
Saturnali, di varia erudizione.
379 Ostrogoti e visigoti vengono accolti
nell'impero. 380 Editto di Tessalonica contro
gli ariani.
Rutilio Namaziano, poeta di Gallia (V sec.),
scrive Il suo ritorno.
397 II
stato.
cristianesimo
diviene
religione
394-395 Teodosio unico imperatore.
di
EVENTI POLITICI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
E MILITARI
395 Divide l'impero tra i figli Arcadie, in
Oriente (395-408), e Onorio in Occidente a
Ravenna (395-423).
II sec. Minucio Felice : l'Ottavio (dialogo).
Tertulliano : Apologetico,
numerosi altri scritti.
403 Stilicone respinge i visigoti a Verona.
408 Uccisione di Stilicone.
408-450 Teodosio li,
imperatore in Oriente
Scrittori cristiani
Alle
nazioni
e
III sec. Cipriano : scritti di apologià cristiana.
figlio
di
Arcadio,
Arnobio, Contro i pagani, in 7 libri.
Lattanzio, Così morirono i persecutori.
409 I vandali s'insediano in Spagna.
IV sec. Commodiano: Carme apologetico.
410 I goti di Alarico saccheggiano Roma.
Ambrogio (339-397),
Jnn», Esamerone.
419-507 Regno visigotico di Tolosa.
425-455
Valentiniano
d'Occidente.
III
vescovo
di
Milano:
1V-V secc. Aurelio l'rudcn-zio : Le corone
(14 inni ai martiri).
imperatore
429 I vandali di Genserico passano in Africa
e vi fondano il Regno dei vandali (fino al
534). 430 Assedio di Ippona. Morte di
Agostino nella città assediata.
443-534 I burgundi fondano sul Rodano il
Regno dei burgundi.
450 Attila scende in Italia.
457 Attila è battuto da Ezio ai Campi
Catalauni. 452 È fermato sul Mincio da papa
Leone I. 453 Muore.
454 Valentiniano uccide Ezio.
455 Sacco di Roma da parte dei vandali.
455-456 Avito. 457-461 Maioriano.
461-465 Libio Severo è elevato al trono dallo
svevo Ricimero.
467-472 Procopio Autemio. Muore Ricimero.
Gerolamo (340-420) : la Vulgata.
Agostino (354-430) : La città di Dio in 22
libri, Le confessioni in 13 libri
EVENTI POLITICI
EVENTI CIVILI,
E MILITARI
CULTURALI E ARTISTICI
472 Olibrio. Muore Ricimero.
473-474 Glicerio.
474-475 Giulio Nepote.
475 Oreste depone Giulio Nepote e alza al
trono il figlio Romolo Augustolo.
476 Odoacre, re dei barbari, depone Romolo
Augustolo e rimanda all'imperatore d'Oriente,
Zenone, le insegne dell'impero, assumendo il
solo titolo di « patrizio ». Termina così la
serie degli imperatori romani d'Occidente.
CAPITOLO PRIMO
POMPEI
catastrofe tellurica che il 24 agosto del 79 fece la disgrazia di Pompei
ha costituito la sua fortuna postuma. Era una delle più insignificanti città
d'Italia. Contava poco più di quindicimila abitanti, viveva soprattutto di
agricoltura, e al suo nome non era legato nessun grande evento storico. Ma
quel giorno il Vesuvio s'incappucciò d'una nuvolaglia nera da cui piovve un
torrente di lava che in poche ore sommerse Pompei ed Ercolano. Plinio il
Vecchio, che comandava la flotta alla fonda nel porto di Pozzuoli e che aveva, fra l'altro, la passione della geologia, accorse con le sue navi per vedere
di che si trattava, eppoi per salvare gli abitanti che fuggivano a perdifiato
verso il mare. Ma, accecato dal fumo e travolto nella ressa, cadde, e fu
raggiunto e seppellito dalla lava. Circa duemila persone persero la vita in
quella sciagura. Ma sotto il sudario di morte, la città si serbò intatta. E
quando, circa due secoli fa, gli archeologi la disseppellirono con le loro
escavatrici, quello che piano piano tornò alla luce fu il documento più
istruttivo non soltanto dell'architettura, ma anche della vita di un piccolo
centro di provincia italiano nel secolo d'oro dell'Impero. Amedeo Maiuri,
che vi ha dedicato la vita, ha tratto e seguita a trarre da Pompei
insegnamenti preziosi.
Il centro del paese era il Foro, cioè la piazza, che certamente in origine era
stata il mercato dei cavoli per cui quella zona andava famosa, ma poi col
tempo era diventata anche un teatro all'aperto sia per gli spettacoli
drammatici che per i giuochi. Gli edifici che la circondavano erano quelli di
pubblica utilità, a cominciare dai templi di Giove, di Apollo e di Venere, per
finire al municipio e ai negozi.
È chiaro che la vita si svolgeva lì, il dedalo di viuzze che s'intrecciavano
tutt'intorno costituendo una specie di retrobottega gremita di negozietti e di
botteghe artigiane, sonanti dì martelli, di scuri, di seghe, di pialle, di lime e
del confuso assordante vocio di bambini, donne, gatti, cani, venditori
ambulanti, che ancora costituisce una caratteristica del nostro bello, ma non
silenzioso paese, specie nel Sud. E siccome quelli che si conservano meglio,
del costume di un popolo, sono i vizi, a Pompei possiamo misurare quanto
sia vecchio, in Italia, anche quello d'imbrattare i muri e di servirsene come
LA
strumenti di propaganda delle nostre idee, dei nostri amori e dei nostri odi.
Oggi lo facciamo coi manifesti, il gesso e il carbone. Allora lo si faceva coi
"graffiti", cioè incidendo la pietra. Ma la differenza è soltanto tecnica:
quanto al contenuto, è chiaro che gl'italiani hanno sempre pensato e detto e
urlato le stesse cose. Tizio prometteva a Cornelia un amore più lungo della
sua stessa vita, Caio invitava Sempronio ad andare a morire ammazzato,
Giulio garantiva pace e prosperità a tutti se lo eleggevano questore, e i
"Viva Maio!" si sprecavano all'indirizzo di un edile che ha scritturato a
proprie spese il gladiatore Paride, come oggi si scritturano gli "oriundi"
nelle squadre di calcio, per dare spettacolo nell'anfiteatro dov'erano
disponibili ventimila posti, cinquemila più di quelli richiesti dall'intera
cittadinanza, che dovevano essere riservati, evidentemente, alla gente del
contado.
Le case erano comode e piuttosto lussuose. Non avevano quasi punte
finestre e di rado il termosifone. Ma i soffitti sono di cemento, qualche volta
a mosaico e i pavimenti di pietra. Solo i palazzi hanno la stanza da bagno, e
qualcuno addirittura la piscina. Ma c'erano ben tre terme pubbliche con
relativa palestra. Le cucine erano provviste di ogni sorta di utensili: padelle,
pentole, girarrosti; e in una libreria privata furono rintracciati duemila
volumi in greco e in latino. Del mobilio si sa poco perché, essendo quasi
tutto di legno, si è disfatto. Ma sono rimasti calamai, penne, lampade di
bronzo, e statue, tutte di derivazione greca, ma di alto stile e raffinata
fattura.
Tutto questo suggerisce l'idea d'una vita comoda e bene organizzata, quale
dovette essere infatti quella delle città di provincia nei secoli felici
dell'Impero. Certo, nessuna di esse poteva gareggiare con Roma, quanto a
intensità, servizi pubblici, salotti e divertimenti. In compenso, chi vi abitava
era sottratto ai pericoli delle persecuzioni, o per lo meno ne soffriva in
misura molto minore, e il malcostume della decadenza vi giunse più tardi e
attenuato dalla maggiore solidità delle buone tradizioni. Non per nulla
Cesare, e più tardi Vespasiano, tentarono di colmare i vuoti dell'aristocrazia
e del Senato romani elevandovi le famiglie di questa borghesia provinciale.
E una delle ragioni per cui, caduta Roma, la civiltà romana resistè e
corruppe i barbari assorbendoli è che non soltanto nell'Urbe, ma dovunque
essi mettessero il piede nella penisola, vi trovarono città superiormente
organizzate.
Di esse, non faremo l'inventario. Ci limiteremo soltanto a dire che, al
contrario di ciò che accade oggi, quelle meridionali primeggiavano sulle
settentrionali perché, ancora prima di quella romana, avevano risentito della
civiltà greca. Napoli era la più rinomata per i suoi templi, per le sue statue,
per il suo cielo, per il suo mare, per la sottile furberia dei suoi abitanti e,
come oggi, per la loro pigrizia. Da Roma ci venivano a passare l'inverno, e i
suoi dintorni, Sorrento, Pozzuoli, Cuma, brulicavano di ville. Capri era già
stata scoperta da un pezzo e Tiberio la "lanciò" facendone la sua abituale
residenza. E Pozzuoli fu la più rinomata stazione termale dell'antichità per le
sue acque sulfuree.
Un'altra regione che brulicava di città già stagionate era la Toscana, dove
le avevano costruite gli etruschi.
Le più importanti erano Chiusi, Arezzo, Volterra, Tarquinia e Perugia
ch'era considerata parte di quella regione. Firenze che, appena neonata, si
chiamava Florentia, era la meno cospicua e non prevedeva il suo destino.
Più su, al di là degli Appennini, cominciavano le città-fortino, costruite
soprattutto per ragioni militari, come piazzeforti degli eserciti impegnati
nella lotta contro le riottose popolazioni galle. Tali furono Mantova,
Cremona, Ferrara, Piacenza. Ancora più a nord c'era il grosso borgo
mercantile di Como, che considerava Mediolanum, cioè Milano, il suo
quartiere povero. Torino era stata fondata dai galli taurini, ma cominciò a
diventare una città vera e propria solo quando Augusto la trasformò in una
colonia romana. Venezia non era ancora nata, ma i veneti erano già arrivati
dall'Illiria e avevano fondato Verona. Erodoto racconta che i capi delle tribù
requisivano le ragazze, mettevano all'asta le più belle, col ricavato facevano
la dote alle più sgraziate, e così riuscivano ad accasarle tutte. Ecco qualcosa
a cui i socialisti d'oggigiorno non hanno ancora pensato.
Questo non è un catalogo; è soltanto una esemplificazione. All'ingrossò si
può dire che l'Italia già da allora era gremita di città, perché quasi tutte
quelle che oggi vi si contano nacquero a quei tempi. E le libertà
democratiche vi resisterono più a lungo che a Roma, anche se a esercitare il
potere era un autogoverno di tipo piuttosto paternalistico. Esso costituiva il
monopolio di una Curia, ch'era un Senato in miniatura, il quale, come a
Roma, esercitava il controllo sui magistrati liberamente eletti dalla
cittadinanza. La rosa dei candidati però era ristretta ai ricchi perché non solo
essi non ricevevano stipendio, ma anzi dovevano colmare i vuoti del
bilancio municipale.
Intanto, l'elezione veniva celebrata con un gigantesco banchetto cui tutti
erano invitati e che si ripeteva il giorno del compleanno, quello del
matrimonio della figlia eccetera. Eppoi, il successo nella carica e la
possibilità di ripresentarvisi o di concorrere a una più alta erano misurati
dalle opere pubbliche e dagli spettacoli che il gerarca aveva finanziato di
tasca sua. Lapidi con iscrizioni trovate un po' dovunque documentano la
prodigalità (e la vanità) di questi dirigenti che spesso rovinavano addirittura
la propria famiglia per guadagnarsi la stima e i voti dei concittadini. A
Tarquinia, Desumio Tullo per battere il suo rivale promise di costruire delle
terme e ci spese cinque milioni di sesterzi, sordo alle proteste dei suoi
figlioli che gli gridavano: «Babbo, ci rovini!...». A Cassino, una ricca
vedova regalò un tempio e un anfiteatro. A Ostia, Lucilio Gemala
pavimentò le strade. E tutti, quando c'era carestia, compravano grano e lo
distribuivano gratis ai poveri. Non sempre costoro glien'erano grati. Ci sono
dei graffiti, a Pompei, in cui si accusano i candidati di aver regalato alla
popolazione soltanto la metà di ciò ch'essi avevano rubato con le loro
malversazioni quando erano in carica.
Le interferenze del governo centrale romano nella vita municipale delle
città di provincia fino a Marc'Aurelio furono scarse e quasi sempre volte più
a favorirne che ad impedirne lo sviluppo. Gl'imperatori, quasi tutti rapaci
per quanto riguardava l'amministrazione delle province straniere, per l'Italia
avevano un debole, sia pure interessato. Era qui che reclutavano i loro
soldati e sostenitori. La Repubblica aveva trattato duramente la penisola
perché aveva dovuto combatterla e sottometterla, e spesso n'era stata tradita.
Ma per il Principato ormai essa era lo Hinterland di Roma. Gli imperatori
venivano spesso a visitarne le città, e per ogni visita erano doni, sussidi e
franchigie in risposta alle entusiastiche accoglienze che regolarmente vi
ricevevano, ogni sovrano cercando di superare in munificenza il suo
predecessore.
Per la provincia italiana, insomma, l'Impero fu una manna di Dio. Essa ne
risentì soltanto i benefici: l'ordine, le strade ben tenute, i commerci vivaci, la
moneta sana, gli scambi facili e frequenti, la sicurezza dalle invasioni. Le
lotte di palazzo, le persecuzioni poliziesche, i processi e le carneficine non
la toccarono.
CAPITOLO SECONDO
GESÙ
FRA i cristiani che Nerone fece massacrare nell'anno 64, come responsabili
dell'incendio di Roma, c'era anche il loro capo: un certo Pietro, che,
condannato alla crocifissione dopo aver visto sua moglie avviarsi alla
tortura, chiese di essere appeso con la testa in giù perché non si sentiva di
morire nella stessa posizione in cui era morto il suo Signore, Gesù Cristo. Il
supplizio si svolse là dove ora sorge il gran tempio che porta il nome del
suppliziato. E i carnefici non furono nemmeno sfiorati dal dubbio che la
tomba della loro vittima avrebbe fatto da fondamento a un altro Impero,
spirituale, destinato a sotterrare quello, secolare e pagano, che aveva
pronunciato il verdetto.
Pietro era ebreo e veniva dalla Giudea, una delle province più tartassate
dal malgoverno imperiale. Due secoli e mezzo prima era riuscita, con
miracoli di coraggio e diplomazia, a liberarsi dal dominio persiano e aveva
ritrovato, per una settantina d'anni, la sua indipendenza, sotto la guida dei
suoi re-sacerdoti da Simone Maccabeo in giù. La loro reggia era il Tempio
di Gerusalemme. E qui gli ebrei si asserragliarono per resistere all'invasione
di Pompeo, che voleva estendere anche su questa terra il dominio di Roma.
Combatterono con la forza della disperazione, ma non vollero rinunziare
alla pausa del sabato, che la religione imponeva. Pompeo se ne accorse, e
proprio di sabato li attaccò. Dodicimila persone furono massacrate. Il
Tempio non venne saccheggiato. Ma la Giudea diventò una provincia
romana. Si ribellò pochi anni dopo, pagò il tentativo con la libertà di
trentamila cittadini venduti come schiavi, e ritrovò uno sprazzo d'indipendenza sotto un re straniero, Erode, che tentò d'introdurvi la civiltà greca
e la sua pagana architettura. Fu a suo modo un grande re, intelligente,
crudele e pittoresco, che seppe fare il protetto di Roma senza diventarne il
servo e regalò ai suoi sudditi un tempio ancora più bello, ma decorato di
quelle immagini che l'austera fede ebraica respinge severamente come
peccaminose e contrarie alla legge.
Sotto il suo successore Archelao di nuovo gli ebrei si ribellarono, i romani
rimisero a sacco Gerusalemme, ne vendettero come schiavi altri trentamila
cittadini; e Augusto, per tagliar corto, fece della Giudea una provincia di
seconda classe sotto il governatorato della Siria. Ma poco prima che questa
nuova sistemazione fosse decisa, era avvenuto nel paese un piccolo fatto di
cui nessuno, lì per lì, si accorse, ma che col tempo doveva rivelarsi di una
qualche importanza per le sorti dell'intera umanità: a Betlemme, vicino a
Nazareth, era nato Gesù Cristo.
Per un paio di secoli l'autenticità di questo episodio è stata revocata in
dubbio da una "scuola critica" che voleva negare l'esistenza di Gesù. Ora i
dubbi sono caduti. Ne resta, caso mai, uno solo, di secondaria importanza:
quello sulla data esatta di questa nascita. Matteo e Luca, per esempio,
dicono ch'essa avvenne sotto il regno di Erode, che, secondo il nostro modo
di contare, sarebbe morto tre anni prima di Cristo. Altri dice ch'era un
giorno di aprile, altri di maggio. La data del 25 dicembre del 753 ab Urbe
condita fu fissata d'autorità trecentocinquantaquattro anni dopo
l'avvenimento, e diventò definitiva.
La storia ci serve poco, a ritracciare la giovinezza di Gesù. Essa ci
fornisce testimonianze contraddittorie, date incerte, episodi discutibili, e ha
ben poco da opporre alla versione che ce ne danno poeticamente i Vangeli:
l'Annunciazione a Maria, la vergine sposa di Giuseppe il falegname, la
nascita nella stalla, l'adorazione delle pecore e dei re Magi, la strage
degl'Innocenti, la fuga in Egitto. La storia ci aiuta soltanto a farci un'idea
delle condizioni di quel paese, quando Gesù vi nacque, e delle ispirazioni
che vi trovò. Sono gli unici elementi di cui ci si può fidare.
La Giudea o Palestina era tutto un fremito patriottico e religioso. Ci
vivevano circa due milioni e mezzo di persone, di cui centomila erano
addensate in Gerusalemme. Non c'era unità razziale e confessionale. In
alcune città anzi la maggioranza era dei gentili, cioè dei non ebrei, specie
greci e siriani. La campagna invece era interamente ebraica, composta di
contadini e piccoli artigiani poveri, parsimoniosi, industriosi, austeri e pii.
Passavano la vita a lavorare, a pregare, a digiunare e ad aspettare il ritorno
di Jeovah, il loro Dio che, secondo le Sacre Scritture, le quali costituivano
anche la Legge, doveva tornare a salvare il suo popolo e a stabilire sulla
terra il Regno del Cielo. Commerciavano poco. Anzi, sembra che fossero
del tutto sprovvisti di quel genio speculativo, per cui in seguito diventarono
così celebri (e temuti).
Il limitato autogoverno che Roma concedeva era esercitato dal Sinedrio, o
Consiglio degli anziani, composto di settantun membri sotto la presidenza di
un alto sacerdote, e diviso in due frazioni: quella conservatrice e
nazionalista dei sadducèi, che tiravano più alle cose di questa terra che a
quelle del Cielo; e quella bigotta dei farisei, dei teologi che passavano il loro
tempo a interpretare i sacri testi. Poi c'era anche una terza setta, estremista,
quella degli esseni, che vivevano in un regime comunista, mettevano insieme i profitti del loro lavoro, si servivano di oggetti fatti con le loro mani,
mangiavano a una stessa tavola, tacendo, e così poco, che campavano in
genere oltre i cento anni, e il sabato non evacuavano nemmeno perché lo
consideravano contrario alla Legge. Gli scribi invece, cui Gesù tanto spesso
allude, non erano una setta; erano una professione e appartenevano per la
maggior parte ai farisei. Rappresentavano un po' i notai, i cancellieri,
gl'interpreti delle Sacre Scritture, da cui ricavavano i precetti per regolare la
vita della società.
Non solo tutta la politica, ma anche tutta la letteratura e tutta la filosofia
ebraiche erano d'intonazione profondamente religiosa (e lo sono rimaste). Il
loro motivo dominante è l'attesa del Redentore che sarebbe venuto un giorno
a riscattare il popolo dal Male, rappresentato nella fattispecie da Roma. E i
più, seguendo Isaia, erano convinti che il Messia di questa Redenzione sarebbe stato un Figlio di Uomo, discendente dalla famiglia di David, il mitico
re degli ebrei, che avrebbe scacciato il Male e instaurato il Bene: 'lamore, la
pace, la ricchezza.
Questa speranza cominciava ad essere condivisa allora anche dai popoli
pagani soggetti a Roma che, avendo perso ogni fede nel loro destino
nazionale, la stavano trasferendo sul piano spirituale. Ma in nessun paese
l'attesa era così vibrante e spasmodica come in Palestina, dove i presagi e gli
oracoli davano per imminente la grande apparizione. C'era gente che
passava la giornata nello spiazzo di fronte al Tempio, pregando e
digiunando. Tutti sentivano che ormai il Messia non poteva più tardare.
Pure, Gesù trovò qualche difficoltà a farsi riconoscere come l'atteso Figlio
dell'Uomo. E pare ch'Egli stesso acquistasse la coscienza di esserlo solo
dopo aver ascoltato le prediche di Giovanni il Battista, ch'era Suo lontano
parente perché figlio di una cugina di Maria. In genere, noi ci
rappresentiamo Giovanni, per la sua qualità di precursore, come molto più
anziano di Gesù. Invece sembra che fosse quasi Suo coetaneo. Viveva sulle
rive del Giordano, vestito solo dei suoi lunghi capelli, si nutriva di erbe, di
miele e di locuste, chiamava la gente a purificarsi col rito del Battesimo, da
cui gli derivò il soprannome, e prometteva l'avvento del Messia come
corrispettivo di un sincero pentimento.
Gesù venne a trovarlo "nel quindicesimo anno di Tiberio", cioè quando
Egli stesso doveva averne ventotto o ventinove. E sostanzialmente ne
accettò la dottrina e la riprese per conto Suo, ma astenendosi dal battezzare
gli altri di persona, e portando la predicazione in mezzo alla società. Poco
dopo Giovanni venne arrestato dalle guardie del tetrarca di Gerusalemme,
Erode Antipa. Luca e Matteo raccontano che l'arresto fu dovuto alle critiche
di Giovanni al matrimonio di Erode con Erodiade, moglie di suo fratello
Filippo. La figlia Salomè danzò talmente bene di fronte al tetrarca che questi
si offrì di contentare qualunque suo desiderio. Su suggerimento della madre,
Salomè chiese la testa decapitata di Giovanni, e fu contentata.
Fu dopo questo avvenimento che la missione di Gesù entrò nel suo pieno.
Egli cominciò a predicare nelle sinagoghe, e dalle concordi testimonianze
che ci restano si direbbe che qualcosa di soprannaturale attirasse subito le
folle verso di Lui. Egli accompagnava le prediche, di quando in quando, coi
miracoli; ma li faceva con riluttanza, proibiva ai Suoi seguaci di sfruttarli a
scopi pubblicitari e si rifiutava di considerarli "prove" della Sua
onnipotenza.
Intorno a Lui si era formata una cerchia di stretti collaboratori, i dodici
Apostoli. Il primo fu Andrea, un pescatore ch'era stato seguace di Giovanni.
Egli condusse con sé Pietro, pescatore anche lui, impulsivo, generoso,
talvolta timido fino alla viltà. Anche Giacomo e Giovanni, i figli di
Zebedeo, erano pescatori. Matteo invece era "pubblicano" (oggi si direbbe
"statale") cioè un collaboratore dell'odiato governo romano. Giuda Iscariota
era l'amministratore dei fondi che gli Apostoli mettevano in comune.
Sotto di loro c'erano settantadue Discepoli, che precedevano scalzi Gesù
nelle città ch'Egli intendeva visitare per prepararvi la gente alle Sue
prediche. Eppoi tutto un codazzo di fedeli, uomini e donne, che Lo
seguivano, vivendo fraternamente tra loro secondo la regola degli esseni.
Dapprima il Sinedrio non si preoccupò molto di Gesù. Per due ragioni:
prima di tutto, perché i Suoi seguaci erano ancora scarsi; eppoi perché le
idee che predicava non erano, nel loro complesso, incompatibili con la
Legge e coi suoi dogmi. L'avvento del Redentore e del Regno del Cielo
faceva parte della dottrina ebraica e del suo messianismo, come i precetti
morali che Gesù propagandava. "Ama il prossimo tuo come te stesso",
"Offri l'altra guancia a chi ti ha schiaffeggiato", eccetera erano già nel
galateo di quel popolo. Gesù diceva: «Io non sono venuto a distruggere la
legge di Mosè, ma ad applicarla».
La rottura con le autorità avvenne quando Gesù annunzio di esser Lui il
Figlio dell'Uomo, il Messia che tutti aspettavano, e la folla di Gerusalemme,
dov'era tornato dopo la predicazione in provincia e nel contado. Lo salutò
come tale. Il Sinedrio ne fu preoccupato soprattutto per ragioni politiche:
temeva che Gesù approfittasse del Suo credito di Messia per provocare una
sollevazione contro Roma, sollevazione che sarebbe finita in un nuovo
massacro.
La sera del 3 aprile dell'anno 30, Egli fu informato che il Sinedrio aveva
deciso il Suo arresto su denunzia di uno degli Apostoli. Pranzò ugualmente
con essi in casa di un amico e in quell'ultima cena annunzio che uno fra loro
lo stava tradendo, e li avvertì che ormai Gli restava poco tempo da
trascorrere con loro. I gendarmi Lo catturarono quella notte stessa nel
giardino di Getsemani. E quando al Sinedrio che Gli chiedeva se era Lui il
Messia, rispose: « Sì, sono io», fu deferito al procuratore romano, Ponzio
Pilato, per empietà.
Ponzio Pilato era un funzionario, che più tardi finì la sua carriera piuttosto
ingloriosamente: lo silurarono per malversazioni e crudeltà. Tuttavia nel
caso di Gesù non si comportò molto male, dal punto di vista burocratico. Gli
chiese se manteneva la Sua pretesa di essere il re degli ebrei, ma in tono di
scherzo e forse sperando che l'accusato gli rispondesse di no. Gesù gli
rispose invece di sì, e gli spiegò che regno intendeva instaurare. Pietro dice
ch'Egli aveva deciso di morire per espiare le colpe di tutti gli uomini.
Pilato impartì con riluttanza la condanna a morte che quella confessione
imponeva: cioè a mezzo di crocifissione. Fu inchiodato alle nove del
mattino, fra due ladroni, sotto la tortura per un attimo vacillò e mormorò:
«Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?». Alle tre del pomeriggio
spirò.
Due influenti membri del Sinedrio chiesero e ottennero da Pilato il
permesso di seppellire il cadavere. Due giorni dopo, Maria Maddalena, una
delle più ardenti seguaci di Gesù, andata a visitarne la tomba, la trovò vuota.
La notizia volò di bocca in bocca e fu confermata dalle apparizioni che
Cristo fece ancora sulla terra, presentandosi in carne ed ossa ai Discepoli.
Quaranta giorni dopo il Suo decesso ufficiale, Egli ascese al Cielo,
com'era del resto nella tradizione ebraica, da Mosè a Elia a Isaia. E i Suoi
seguaci si sparpagliarono nel mondo ad annunziare la grande novella della
Sua resurrezione e del prossimo ritorno.
CAPITOLO TERZO
GLI APOSTOLI
QUEST'OPERA missionaria dapprima si sviluppò soltanto in Palestina e
nelle contrade vicine, dove vivevano colonie ebree. Perché, in un primo momento, tra gli Apostoli fu tacitamente convenuto che Gesù era il Redentore
non di tutti gli uomini, ma soltanto del popolo ebraico. Fu dopo la missione
di Paolo ad Antiochia e il successo che egli raccolse fra i gentili di questa
città, che si pose e fu risolto il problema dell'universalità del Cristianesimo.
Paolo fu per la "ideologia", come oggi si direbbe, della nuova fede quel
che Pietro fu per al sua organizzazione. Era un ebreo di Tarso, figlio di un
fariseo benestante, e quindi d'origine borghese, che gli trasmise il più
prezioso di tutt'i beni, a quei tempi: la cittadinanza romana. Aveva studiato
il greco e seguito le lezioni di Gamaliel, il presidente del Sinedrio. Aveva
un'intelligenza acuta, tipicamente ebraica nello spaccare il capello, e un
carattere difficile: imperioso, impaziente, e spesso ingiusto. La sua prima
reazione verso Cristo, che non conobbe di persona, e i cristiani, fu di
violenta antipatia. Li considerava eretici, e quando gliene capitò sotto mano
uno, Stefano, condannato per infrazione alla legge, collaborò con
entusiasmo alla sua lapidazione. Un giorno sentì che i cristiani
guadagnavano proseliti a Damasco. Chiese al Sinedrio di lasciarvelo andare
per arrestarli, e durante il viaggio fu folgorato da uno squarcio di luce e udì
una voce che diceva: «Paolo, Paolo, perché mi perseguiti?». «Chi sei?»,
chiese sbigottito. «Sono Gesù». Rimase cieco per tre giorni, poi andò a farsi
battezzare, e diventò il più abile propagandista della nuova Fede.
Per tre anni predicò in Arabia, poi tornò a Gerusalemme, si fece perdonare
da Pietro il suo passato di persecutore, e con Barnaba andò a dirigere l'opera
di proselitismo fra i greci di Antiochia. Quando seppero che i due missionari
non richiedevano la circoncisione per accettare conversi, come Mosè
prescriveva, cioè li reclutavano anche fra i gentili, gli Apostoli li mandarono
a chiamare per avere spiegazioni. Con l'appoggio di Pietro, la battaglia fu
vinta da Paolo, ma riprese subito dopo la sua seconda tournée in Grecia. La
maggioranza degli Apostoli era ancora fedele alla Legge, frequentava il
Tempio, non voleva rompere col suo popolo e con la sua tradizione. Paolo
sentì che, a lasciarli fare, costoro avrebbero fatto del Cristianesimo soltanto
una eresia ebraica, sostenne le sue tesi in pubbliche prediche e andò a
rischio di essere linciato dalla folla. Volevano processarlo per empietà. Ma
lo salvò la cittadinanza romana che gli dava il diritto di appello
all'imperatore. Così lo imbarcarono per Roma, dove giunse dopo un viaggio
avventurosissimo.
Nell'Urbe lo ascoltarono con pazienza, non capirono un'acca della
questione ch'egli esponeva, compresero soltanto che la politica non c'entrava
e, in attesa che arrivassero gli accusatori, lo trattarono bene, limitandosi a
mettergli un soldato di guardia alla porta della casa che gli avevano lasciato
scegliere. Paolo vi invitò gli esponenti della colonia ebraica, ma non riuscì a
persuaderli. Anche i pochi fra loro ch'erano già cristiani respinsero con
orrore l'idea che il battesimo fosse più importante della circoncisione, e a lui
preferirono Pietro, che giunse poco dopo e trovò un'accoglienza molto più
calda.
Paolo riuscì a convertire qualche gentile; ma in sostanza rimase solo e,
animato com'era da implacabile zelo missionario, lo sfogò nelle famose
Lettere che scrisse un po' a tutti i vecchi amici, di Corinto, di Salonicco, di
Efeso, e che costituiscono ancor oggi la base della teologia cristiana.
Secondo qualche storico, egli fu assolto, tornò a predicare in Asia e in
Spagna, fu di nuovo arrestato e condotto a Roma. Ma pare che non sia vero.
Paolo non fu mai liberato, nell'amarezza di quel solitario esilio perse a poco
a poco la fede nell'imminente ritorno di Cristo sulla terra, o per meglio dire
la tradusse in quella dell'aldilà, sigillando così la vera essenza della nuova
religione.
Non sappiamo come, quando e perché lo processarono di nuovo.
Sappiamo soltanto che l'accusa fu: "Disobbedienza agli ordini dell'imperatore e pretesa che il vero re sia un tale chiamato Gesù". Può darsi infatti che
non ci fosse nient'altro a suo carico. I poliziotti vanno per le spicce e,
sentendo Paolo dare del re a Gesù, quando sul trono c'era Nerone, lo
arrestarono e condannarono. Una leggenda vuole ch'egli sia stato soppresso
lo stesso giorno dell'anno 64 in cui Pietro fu crocifisso e che i due grandi
rivali, incontrandosi sulla via del supplizio, si abbracciassero in segno di
pace. La cosa è poco credibile. Pietro si trovò mescolato con gli altri
cristiani, uccisi in massa come responsabili dell'incendio di Roma. Paolo era
un "cittadino", e come tale aveva diritto a qualche riguardo. Infatti si
limitarono a decapitarlo. E là dove si ritiene ch'egli sia seppellito, la Chiesa,
due secoli dopo, fondò la basilica che ne porta il nome: San Paolo fuori le
Mura.
Quante reclute aveva fatto il Cristianesimo a Roma, nel momento in cui
scomparvero i due grandi Apostoli?
Le cifre sono impossibili da precisare, ma non crediamo che superassero
qualche centinaio, al massimo qualche migliaio. Il fatto stesso che le
autorità vi prestassero poca attenzione, lo dimostra. L'accusa dell'incendio
non faceva parte di una politica persecutoria; fu uno stratagemma
estemporaneo per fuorviare i sospetti contro Nerone. Il massacro, sul
momento, parve aver distrutto per sempre la setta. Poi, come tutti i massacri,
si rivelò un fertilizzante. Ma questo fu dovuto all'organizzazione che Pietro
le aveva dato.
I cristiani si riunivano in ecclesiae, cioè in chiese o congregazioni, che in
quei primi tempi non ebbero nulla di segreto e di cospiratorio. I paragoni
che oggi si fanno con l'organizzazione cellulare comunista sono
assolutamente ridicoli e privi di fondamento. Non solo perché nelle ecclesiae si predicava l'amore invece dell'odio; non solo perché non vi si
svolgeva nessun proselitismo politico. Ma soprattutto perché non c'era
ombra di segretezza, e chiunque si presentasse veniva accolto senza sospetti
né diffidenze. Un'altra falsa credenza di oggi è che gli adepti fossero soltanto proletari, "la feccia", come l'avrebbe chiamata più tardi Gelso. Niente
di più inesatto. C'era di tutto. E in genere si trattava di gente industriosa e
pacifica, di piccoli e medi risparmiatori, che finanziavano le comunità
cristiane più povere. Luciano il miscredente li definiva: "Degl'imbecilli che
mettono insieme tutto quello che possiedono". Tertulliano il convertito
precisava: "Che mettono insieme ciò che gli altri tengono separato e tengono
separata la sola cosa che gli altri mettono insieme: la moglie".
Una discriminazione, imposta dalle circostanze, ci fu soltanto fra la
popolazione di città e quella di campagna. I primi proseliti li diede la prima,
per ovvie ragioni: perché solo in città c'è modo di riunirsi assiduamente,
perché le scontentezze vi sono più acute e le menti più aperte alla critica,
perché in campagna le tradizioni e i costumi si conservano di più e una
maggiore forza morale li sorregge. Ed ecco perché i cristiani cominciarono a
chiamare i miscredenti pagani, cioè contadini, da pagus che vuol dire villaggio.
La prima cosa cui mirarono questi precursori fu l'instaurazione di un
modello di vita sano e decente, di cui comprendiamo il prestigio e il fascino
ch'era destinato ad esercitare in una capitale che si faceva sempre più
malsana e svergognata. L'origine ebraica della nuova fede e di coloro che vi
si convertirono per primi era comprovata dall'austerità che imponeva. Le
donne partecipavano alle funzioni del culto, che ancora si esaurivano nella
preghiera, ma velate, perché i capelli potevano distrarre gli angeli, come
dice san Gerolamo che voleva farli tagliare a tutte. E un regime di vita
ordinato e casalingo era la regola fondamentale. La festa del sabato,
anch'essa di origine ebraica, era osservata, e la si celebrava con una cena
collettiva, che cominciava e finiva con le preghiere e con la lettura delle
Sacre Scritture. Il prete benediceva il pane e il vino, che simboleggiavano
rispettivamente il corpo e il sangue di Gesù, e la cerimonia finiva col bacio
d'amore che tutti si scambiavano, ma che dovette dare origine a qualche
diversivo in contrasto con la teologia perché di lì a poco si prese a praticarlo
solo da uomo a uomo e da donna a donna, e con la raccomandazione di tener
chiusa la bocca e di non ripeterlo se dava piacere.
L'aborto e l'infanticidio furono aboliti ed esecrati dai cristiani in mezzo a
una società che sempre più li praticava e ne stava morendo. Anzi, ai fedeli
fu fatto obbligo di raccogliere i trovatelli, adottarli e educarli nella nuova
religione. L'omosessualità era bandita; il divorzio era ammesso solo su
richiesta della moglie, se costei era pagana. Meno successo ebbe la proibizione di frequentare il teatro. Ma, tutto sommato, la regola rimase severa
specie finché fu praticata quasi esclusivamente dagli ebrei. Poi, a poco a
poco, col crescere di numero e d'importanza dei gentili, essa si fece più
accomodante. E la festa austera del sabato diventò piano piano quella più
allegra della domenica.
In questo "giorno del Signore" ci si riuniva intorno al prete che leggeva un
brano delle Scritture, dava l'avvio alle preghiere, eppoi teneva un sermone.
Questa fu la prima rudimentale Messa, che poi si sviluppò secondo un più
preciso e complicato rituale. In quei primi anni gli ascoltatori ne erano
anche i protagonisti, perché ad essi veniva concesso di "profetizzare", cioè
di esprimere in stato di estasi dei concetti, che poi il sacerdote doveva
interpretare. Quest'uso finì perché minacciava di provocare il caos proprio là
dove la Chiesa si stava sforzando di mettere ordine: nelle questioni
teologiche.
Soltanto due dei sette Sacramenti erano allora praticati: il Battesimo non
si distingueva dalla Cresima perché veniva imposto a persone già adulte,
quali furono i primi conversi. Poi, piano piano, si cominciò anche a nascere
cristiani, e allora i due Sacramenti furono separati, il secondo costituendo la
"conferma" del primo. Il matrimonio era soltanto civile; il prete si limitava a
benedirlo. Invece grandi cure si aveva del funerale, perché, dal momento
che un uomo era morto, esso diventava esclusiva pertinenza della Chiesa e
tutto doveva essere predisposto per la sua resurrezione. Il cadavere doveva
avere la sua propria tomba, e il prete officiava durante il seppellimento. Le
tombe erano costruite secondo il costume siriano ed etrusco: in cripte
scavate nelle pareti di lunghe gallerie sottoterra: le catacombe.
Questo uso durò fino al nono secolo, poi decadde. Le catacombe
diventarono mèta di pellegrinaggio, la terra le ricoperse e furono dimen-
ticate. Vennero riscoperte nel 1578 per un semplice caso. Il fatto che le loro
ramificazioni fossero complicate e ritorte ha fatto pensare che le si fosse
costruite come nascondigli per la "cospirazione". E su questa ipotesi si sono
imperniati molti romanzi.
Così equipaggiata, nacque la vera religione; quella non più limitata a un
popolo e a una razza, come il giudaismo, o a una classe sociale, come il
paganesimo di Grecia e di Roma, che la considerava monopolio dei suoi
"cittadini". Il suo livello morale, la grande Speranza che apriva nel cuore
degli uomini e l'impeto missionario di cui li accendeva facevano dire
orgogliosamente a Tertulliano: « Siamo soltanto di ieri. E già riempiamo il
mondo»
CAPITOLO QUARTO
I FLAVI
A DARE involontariamente una mano ai cristiani fu un imperatore che
aveva in uggia gli ebrei e commise l'imperdonabile errore di perseguitarli
aiutando, con la loro dispersione nel mondo, la diffusione della nuova fede.
Vespasiano salì al trono l'anno 70, dopo lo spaventoso interregno seguito
alla morte di Nerone, con cui terminò la dinastia dei Giulio-Claudi. A
succedergli era stato il generale ribelle Galba, un aristocratico non peggiore
di tanti altri, calvo, grasso, con le giunture inceppate dall'artrite e la mania
del risparmio. Il suo primo gesto, appena proclamato imperatore, fu di
ordinare a quanti avevano ricevuto doni da Nerone di restituirli allo stato. E
gli costò il trono e la vita perché fra i beneficiati c'erano anche i pretoriani
che, incontrandolo, tre mesi dopo la sua proclamazione, nel Foro, dove egli
si faceva portare con una lettiga, gli tagliarono la testa, le braccia e le labbra,
e proclamarono suo successore Ottone, un banchiere che aveva fatto
bancarotta fraudolenta e prometteva di amministrare le finanze pubbliche
con la stessa spensieratezza con cui aveva amministrato quelle sue private.
A quella notizia, l'esercito dislocato in Germania sotto il comando di Aulo
Vitellio e quello dislocato in Egitto sotto Vespasiano si ribellarono e
marciarono su Roma. Prima vi giunse Vitellio che seppellì Ottone già
uccisosi, si proclamò imperatore, si abbandonò alla sua passione preferita,
quella dei pranzi luculliani, e per seguitare ad abboffarsi di abbacchio
trascurò di farsi incontro alle forze di Vespasiano che frattanto erano
sbarcate. La sanguinosa battaglia di Cremona decise le sorti di quella guerra
di successione. Vitellio fu battuto, e i romani si divertirono un mondo al
massacro che seguì nella loro stessa città. Tacito racconta che la gente
gremiva le finestre e i tetti per assistere a quel macello, tifando per i
contendenti come se si fosse trattato di una partita di calcio. Fra un
accoppamento e l'altro, i combattenti entravano nei negozi, li saccheggiavano e vi appiccavano il fuoco; oppure sparivano nei portoni,
adescati da qualche prostituta, e mentre giacevano con lei venivano pu-
gnalati da un nuovo cliente della parte avversa. Vitellio, quando fu catturato
nel suo nascondiglio, dove, tanto per cambiare, banchettava, fu trascinato
nudo per la città con un laccio al collo, bersagliato di escrementi, torturato
con ponderata lentezza, e alla fine gettato nel Tevere.
Questa città che si divertiva al fratricidio, questi eserciti che si
ribellavano, questi imperatori che venivano subissati di sterco pochi giorni
dopo essere stati coperti di osanna: ecco cos'era diventata la capitale
dell'Impero.
Tito Flavio Vespasiano ci aveva vissuto poco. Era nato in provincia, a
Rieti, eppoi aveva abbracciato la carriera militare che lo aveva condotto un
po' dovunque. Non era nobile. Veniva dalla media borghesia campagnola, i
gradi e lo stipendio se li era guadagnati con mille sacrifici, e onorava
soprattutto due virtù: la disciplina e il risparmio. Aveva sessantanni quando
salì al trono, ma li portava bene. Il suo cranio era completamente calvo, il
volto aperto, rozzo e franco, incorniciato da due orecchi immensi e pelosi
come quelli di Ante Pavelic. Detestava gli aristocratici, li considerava dei
bighelloni, non subì mai la tentazione snobistica di farsi passare per uno di
loro, e quando un araldista, appunto per nobilitarlo, venne ad annunziargli
che aveva rintracciato la sua origine e scoperto ch'essa risaliva a Ercole,
scoppiò in una risata da buttar giù i muri e da farci sospettare che in quella
piaggeria ci fosse un po' di verità. Quando riceveva qualche dignitario gli
palpava la tonaca per vedere s'era di stoffa troppo fine e lo annusava per
sentire se odorava d'acqua di colonia. Non sopportava queste sofisticherie.
La sua prima cura fu quella di riordinare l'esercito e le finanze. Il primo lo
diede in appalto a ufficiali di carriera, quasi tutti provinciali come lui. Per le
seconde, scelse la via più spicciola: quella di vendere, a prezzi salatissimi, le
alte cariche pubbliche. «Tanto», diceva, «son tutti ladri, in qualunque modo
li promuoviamo. Meglio che vadano avanti restituendo allo stato un po' di
refurtiva». Lo stesso metodo seguì per riorganizzare il fisco. Lo affidò a
funzionari scelti fra i più rapaci e dissanguatori, e li sguinzagliò con pieni
poteri in tutte le province dell'Impero. Figuratevi che pacchia per le povere
popolazioni. Mai la tributaria di Roma aveva funzionato con sì spietata
puntualità. Ma quando la rapina fu consumata, Vespasiano ne richiamò a
Roma gli esecutori, li elogiò, e confiscò tutti i loro personali guadagni, con
cui, pareggiato il bilancio, risarcì le vittime. Il figlio Tito, ch'era un puritano
pieno di scrupoli, venne a protestare contro questi sistemi repugnanti al suo
bigotto e candido virtuismo. «Io faccio il sacerdote nel tempio», rispose il
padre. «Coi briganti, faccio il brigante». E per aumentare gl'introiti, inventò
quei piccoli monumenti che oramai portano il nome appunto di vespasiani,
stabilendo una tassa per chi li usava e una contravvenzione per chi non li
usava. Non c'era scelta. Chi la faceva fuori pagava più di chi la faceva
dentro. Anche per questa misura, Tito venne a protestare. Suo padre gli mise
sotto il naso un sesterzio e gli chiese: « Puzza di qualcosa?»
Questo figliolo delicato e perbene, che amava teneramente, era la più
grossa preoccupazione di quel sovrano scettico, che non pretendeva riformare l'umanità e abolirne i vizi, ma soltanto mantenerli nella loro sede. Per
fargli fare pratica di uomini, lo mandò a rimettere ordine in Palestina,
dov'era scoppiata l'ultima e più terribile rivoluzione. Gli ebrei difesero
Gerusalemme con un eroismo senza precedenti. Secondo un loro storico, ne
morirono due milioni; secondo Tacito, seicentomila. Per venire a capo della
resistenza, Tito diede la città alle fiamme che distrussero anche il Tempio.
Dei sopravvissuti, alcuni si uccisero, altri furono venduti come schiavi, altri
fuggirono. La loro dispersione, cominciata sei secoli prima, diventò la vera e
propria "diaspora". E come nello zaino dei soldati di Napoleone c'erano i
Diritti dell'uomo, nel sacco di molti fra questi poveri emigranti c'era il
Verbo di Cristo.
Vespasiano, inorgoglito, tributò a Tito un trionfo un po' sproporzionato al
valore militare di quell'impresa, e in suo onore fece costruire il famoso arco
che ne porta il nome. Ma con suo grande sgomento vide suo figlio passarci
sotto portandosi appresso come preda bellica una graziosa principessa ebrea,
Berenice. Non aveva nulla in contrario che se la tenesse come amante; ma il
guaio è che Tito voleva sposarla, sostenendo di averla "compromessa".
Vespasiano non capiva perché mai quel ragazzo volesse confondere l'amore,
passeggero e volubile capriccio, con la famiglia, istituzione seria e
permanente. Dacché era rimasto vedovo, anche lui si era preso una
concubina, ma non l'aveva sposata. Perché Tito non faceva altrettanto,
tenendosi come concubina Berenice? Sembra di sentir parlare il babbo nostro, quando gli s'andava a chiedere il permesso di sposare la sciantosa. E,
come noi, alla fine anche Tito alla sciantosa rinunziò.
Di lì a poco, toccò a lui far l'imperatore. Dopo dieci anni di saggio regno,
il più saggio di cui Roma abbia goduto dopo Augusto, Vespasiano un giorno
tornò a Rieti in vacanza. Ci andava spesso per ritrovare i suoi amici di
gioventù, fare con loro una battuta alla lepre, quattro chiacchiere, una
mangiata di fagioli con le cotiche e una partitella a scopone, ch'erano i suoi
passatempi favoriti. Gli venne la cattiva idea di sciacquarsi i reni con l'acqua
di Fonte Cottorella. O che la cura non fosse adatta, o che ne sbagliasse le
dosi, fatto sta che fu colto da una colica, e subito s'avvide che non c'era
rimedio. « Vae!», disse strizzando l'occhio, senza rinunziare nemmeno in
quel momento al suo abituale e grezzo buonumore, «puto deus fio». (Ahi
ahi, mi sa che sto diventando un dio). Perché in quella Roma di piaggiatori
ormai c'era l'uso di divinizzare tutti gl'imperatori, quando morivano. Dopo
tre giorni e tre notti di dissenteria, trovò ancora la forza di alzarsi, giallo
come un limone e con la fronte imperlata di sudore, guardò gli astanti che a
loro volta lo guardavano sbigottiti e, ridacchiando per far vedere che si
rendeva conto della gigioneria, barbugliò: «Eh lo so, lo so... Ma che volete
farci? Un imperatore ha da morire in piedi!».
E in piedi morì, nell'anno 79, questo borghese nato per morire, come tutti i
borghesi, in fondo a un letto: da attore coscienzioso, costretto a recitare una
parte non sua.
Tito, che gli successe, fu il più fortunato dei sovrani perché non ebbe il
tempo di commettere errori, come certo gli sarebbe capitato in grazia non
dei suoi difetti, ma delle sue virtù: il galantomismo, il candore e la
generosità. Non firmò una condanna a morte. Quando seppe di un complotto, mandò un messaggio di ammonimento ai congiurati e un altro di
rassicurazione alle loro madri. Nei suoi due anni di regno, Roma subì un
terribile incendio, Pompei fu sotterrata dal Vesuvio e l'Italia devastata da
una tremenda epidemia. Per riparare i danni, Tito esaurì il Tesoro. Per
assistere di persona i malati, si contagiò e perse egli stesso la vita, a
quarantadue anni, rimpianto da tutti, meno che da suo fratello, Domiziano,
che gli successe al trono.
Non sappiamo che giudizio complessivo dare di quest'ultimo
rappresentante della dinastia dei Flavi. Fra gli scrittori che vissero sotto di
lui, Tacito e Plinio ne hanno lasciato il ritratto più nero; Stazio e Marziale il
più roseo. Non sono d'accordo neanche sul suo aspetto fisico: i primi lo
descrivono calvo e panzone su gambe di rachitico, i secondi bello come un
arcangelo, timido e dolce. Doveva aver molto sofferto della preferenza che
Vespasiano aveva sempre avuto per Tito, questo sì. E quando il padre
scomparve, avanzò la pretesa a una metà del potere. Tito gliela offrì.
Domiziano rifiutò e si mise a complottare. Dione Cassio sostiene che
quando suo fratello cadde malato, ne affrettò la morte coprendolo di neve.
Il suo regno è un po' come quello di Tiberio, cui abbiamo l'impressione
ch'egli stesso, come uomo, somigliasse. Identico ne fu l'inizio: saggio e
oculato, con qualche venatura di austerità puritana. Domiziano era
soprattutto un moralista e un ingegnere. La carica cui più tenne fu quella di
censore, che gli dava il titolo di controllare i costumi, e i ministri di cui si
circondò erano dei tecnici particolarmente qualificati a ricostruire la città
devastata dall'incendio. Non volle guerre. E quando Agricola, governatore
in Britannia, tentò di portare i confini dell'Impero fino alla Scozia, lo silurò.
Forse fu questo il suo più grave errore, perché Agricola era suocero di
Tacito che lo adorava e che si assunse l'incarico di giudicare gli uomini del
suo tempo. È naturale che abbia conciato così male questo povero sovrano.
Purtroppo la pace, per ottenerla, bisogna essere in due a volerla. E
Domiziano ebbe a che fare coi daci che non la volevano. Essi attraversarono
il Danubio, batterono i generali romani, e obbligarono l'imperatore a
prendere in mano le redini dell'esercito. Lo stava conducendo molto bene,
quando Antonino Saturnino, governatore della Germania, si ribellò con
alcune legioni, obbligandolo a una pace prematura e sfavorevole coi daci e
mettendogli in corpo l'ossessione delle congiure. Colui che sino a quel
momento aveva governato piuttosto come un Cromwell, diventò uno Stalin,
e per salvare la propria "personalità" ne instaurò il "culto" più smodato.
S'installò su un trono vero, volle essere chiamato "Signore e dio nostro", e
pretese che i visitatori gli baciassero i piedi. Anche lui espulse dall'Italia i
filosofi perché contestavano il suo assolutismo, tagliò la testa ai cristiani
perché rifiutavano la sua divinità, e diede la precedenza ai delatori perché
credeva che lo proteggessero dai nemici. I senatori lo odiavano, lo
incensavano, e ne avallavano le sentenze di morte. E fra questi senatori c'era
anche Tacito, il suo futuro spietato giudice.
In un accesso di mania di persecuzione si ricordò che il proprio segretario
Epafrodito era quegli stesso che un quarto di secolo prima aveva aiutato
Nerone a tagliarsi la carotide. E, temendo che ne avesse preso il vizio, lo
condannò a morte. Allora tutti gli altri funzionari di palazzo si sentirono
minacciati, organizzarono una congiura e chiamarono a parteciparvi anche
l'imperatrice Domizia. Lo pugnalarono di notte. Domiziano si difese fino
all'ultimo, selvaggiamente. Aveva cinquantacinque anni, e per quindici
aveva regnato prima come il più saggio, poi come il più nefasto dei sovrani.
Così finì, nel buio da cui era sorta, anche la seconda dinastia dei
successori di Augusto. Di dieci imperatori avvicendatisi nello spazio di
centoventisei anni (dal 30 avanti Cristo al 96 dopo Cristo) sette erano morti
ammazzati. C'era qualcosa nel sistema che non andava, che tramutava in
sanguinari tiranni anche uomini disposti al bene; qualcosa di più decisivo
dello stesso ereditario malanno che forse imputridiva il sangue dei GiulioClaudi.
E questo qualcosa va ricercato nella società romana, com'era venuta
trasformandosi negli ultimi tre secoli.
CAPITOLO QUINTO
ROMA EPICUREA
LA ROMA di questo periodo, che si suol chiamare epicureo, aveva una
popolazione che qualcuno valutava a un milione, altri a un milione e mezzo.
Essa era divisa nei soliti ordini e classi, l'aristocrazia era ancora numerosa;
ma, a parte quello dei Corneli, i memorialisti del tempo non citano più i
grandi nomi di una volta: i Fabi, gli Emili, i Valeri eccetera. Decimate prima
dalle guerre cui davano un alto contributo di cadaveri, poi dalle persecuzioni
e infine dalle pratiche malthusiane, queste illustri famiglie si erano estinte ed
erano state rimpiazzate da altre, con meno antenati e più quattrini, che
venivano dalla borghesia industriale e mercantile di provincia.
«Oggi, nell'alta società», diceva Giovenale, «l'unico buon affare è una
moglie sterile. Tutti ti saranno amici sperando nel testamento. Quella che ti
fa un figlio, chi ti dice che non metta alla luce un negro?».
Giovenale calcava un po' la mano, ma il malanno che denunziava era
autentico. Il matrimonio, che nell'età stoica era stato un sacramento e lo
ridiventerà in quella cristiana, era ora una passeggera avventura; e
l'allevamento dei figli, considerato un tempo un dovere verso lo stato e
verso gli dèi che promettevano una vita ultraterrena solo a chi lasciava
qualcuno a prendersi cura della sua tomba, ora era considerato una noia, un
imbarazzo da evitare. L'infanticidio non era più consentito, ma l'aborto era
una pratica comune, e se non riusciva si ricorreva all'abbandono del neonato
ai piedi di una colonna lattaria, così chiamata perché ci stavano di fazione
delle nutrici stipendiate apposta dallo stato per allattare i trovatelli.
Sotto l'influsso di questi costumi, la stessa struttura biologica e razziale di
Roma era cambiata. Quale cittadino non aveva nelle sue vene qualche
goccia di sangue straniero? Le minoranze greche, siriano, israelite facevano,
messe insieme, maggioranza. Gli ebrei erano già così forti, soprattutto in
grazia della loro unione, al tempo di Cesare, che costituirono uno dei
principali puntelli del suo regime. C'erano pochi ricchi, tra di loro. Ma
nell'insieme costituivano una comunità disciplinata, laboriosissima, di sani
costumi. Non altrettanto poteva dirsi degli egiziani, dei siriani e di altri
orientali, gran maestri soprattutto di borsa nera.
La mamma romana che si decideva a mettere al mondo un figlio, se non
era proprio povera in canna, se ne sbarazzava subito affidandolo prima a una
balia per l'allattamento, poi a una istitutrice greca, che teneva il posto oggi
occupato da quelle tedesche o inglesi, e infine a un pedagogo, in genere
greco anch'esso, per la sua istruzione. Altrimenti lo mandava a qualcuna
delle scuole che oramai erano nate un po' dovunque, ma erano private, non
statali, promiscue e dirette da magistri. Gli allievi frequentavano le
elementari fin verso i dodici o i tredici anni. Poi i sessi venivano separati.
Le femmine completavano la loro istruzione in appositi collegi dove
s'insegnava soprattutto musica e danza. I maschi intraprendevano le
secondarie, tenute da grammatici che, essendo anch'essi per la maggior
parte greci, insistevano soprattutto sulla lingua, letteratura e filosofia greche,
che finirono infatti per sommergere la cultura romana. L'università era
rappresentata dai corsi dei rètori, che non avevano nulla di organico. Non
c'erano esami, non c'era tesi di laurea, non c'era dottorato. C'erano soltanto
delle conferenze, seguite da discussioni. I corsi costavano fino a duemila
sesterzi, fra duecento e duecentocinquantamila lire, l'anno. E Petronio lamentava che non vi s'insegnassero che astrazioni di nessuna utilità per la
vita pratica. Ma essi solleticavano il gusto tipicamente romano, per la
controversia, la sottigliezza e il cavillo: un vizio ch'è poi trasmigrato nel
corpo degl'italiani. Le famiglie più facoltose mandavano i loro ragazzi a
perfezionarsi all'estero: a Atene per la filosofia, a Alessandria per la
medicina, a Rodi per l'eloquenza. E spendevano tanti quattrini per
mantenerveli, che Vespasiano il parsimonioso, per impedire questa
emorragia di valuta, preferì reclutare i più illustri docenti di quelle città e
trapiantarli a Roma in istituti statali che pagavan loro stipendi di centomila
sesterzi l'anno, cioè cinque milioni di lire.
La moralità di questi giovani, per i maschi, non era stata mai granché,
neanche ai tempi stoici. Dai sedici anni in su, era sottinteso che il ragazzo
frequentasse i lupanari e non si badava molto nemmeno al fatto che corresse
qualche avventura non solo con le donne, ma anche con gli uomini. Ma
allora tutto questo era allo stato grezzo, i bordelli erano ignobili, e la
stagione delle scostumatezze finiva col richiamo alle armi eppoi col
matrimonio che inauguravano quella dell'austerità. Ora, dal servizio militare
i ragazzi si facevano esentare, i bordelli erano diventati di lusso, le meretrici
si sentivano in dovere d'intrattenere i clienti non soltanto con le loro grazie,
ma anche con la conversazione, con la musica, con la danza, un po' come
facevano le geishe in Giappone, e i clienti seguitavano a frequentarle anche
dopo il matrimonio.
Più severi si era con le ragazze, finché restavano ragazze. Ma esse si
sposavano in genere prima dei vent'anni perché dopo questo traguardo erano
considerate zitelle, e il matrimonio procurava loro le stesse libertà dei
maschi, o poco meno. Seneca considerava fortunato il marito la cui moglie
si contentava di due amanti soli. E un epitaffio iscritto su una tomba suona
così: "Rimase per quarantun anni fedele alla stessa moglie". Giovenale,
Marziale, Stazio ci parlano di donne della borghesia che giostrano nel Circo,
girano per le strade di Roma guidando di persona i loro calessini, si fermano
a far conversazione sotto i portici e "offrono al passante", dice Ovidio, "il
delizioso spettacolo delle loro spalle nude".
Le "intellettuali" fiorivano. Teofila, l'amica di Marziale, avrebbe vinto di
sicuro i cinque milioni a "Lascia o raddoppia?" in fatto di filosofia stoica;
Sulpicia scriveva versi, naturalmente d'amore. E c'erano anche le
soroptimists che avevano organizzato dei clubs femminili, i cosiddetti
collegi delle donne, dove si tenevano conferenze sui doveri verso la società,
come avviene in tutte le società dove i doveri non sono più osservati.
S'ingrassava. La statuaria di questo periodo, a confrontarla con quella
della Roma stoica, tutta di figure secche e angolose, ci mostra un'umanità
allentata e arrotondita dall'ozio e dalle indulgenze dietetiche. La barba è
scomparsa, i tonsores si sono moltipllcati, la prima rasatura è una festa
inaugurale nella vita dell'uomo. I capelli, la maggioranza li taglia ancora a
zero; ma ci sono degli elegantoni che invece li lasciano crescere e poi li
annodano in treccine. La toga porporina è diventata monopolio esclusivo
dell'imperatore. Tutti gli altri ora portano una tunica o blusa bianca, e i
sandali di cuoio "alla caprese", cioè col laccio infilato fra i diti.
La moda femminile invece si è complicata. La signora di qualche riguardo
non impiega la mattina meno di tre ore e di una mezza dozzina di schiave
per acconciarsi. Buona parte della letteratura è dedicata a illustrare
quest'arte, e le stanze da bagno sono ingombre di rasoi, forbici, spazzole,
spazzolini, creme, ciprie, cosmetici, oli, saponi. Poppea aveva inventato una
maschera notturna intrisa di latte per rinfrescare la pelle del viso, ch'era
diventata d'uso comune. E il bagno nel latte era normale, sicché le riccone
viaggiavano seguite da mandrie di mucche per averne sempre di fresco a
disposizione. Specialisti alla Hauser predicavano diete, ginnastica, bagni di
sole, massaggi contro la cellulite. E ci furono dei tonsores che fecero la loro
fortuna inventando qualche originale pettinatura diversa da quella usuale:
capelli all'indietro, annodati sulla nuca o graziosamente sostenuti da una rete
o da un nastro.
La biancheria era di seta o di lino. E cominciava a far la sua comparsa il
reggipetto. Le calze non si usavano. Ma le scarpe erano complicate, di cuoio
morbido e leggero, col tacco alto per rimediare al difetto delle donne
romane, che è anche quello delle italiane: il sedere basso; e con ricami di
filigrana d'oro.
D'inverno usavano le pellicce, ch'erano il regalo dei mariti o degli amanti
dislocati nelle province settentrionali, specie la Gallia e la Germania. E in
tutte le stagioni si faceva gran scialo di gioielli, ch'erano la gran passione di
queste signore. Lollia Paolina andava in giro con quaranta milioni di
sesterzi, cioè due miliardi di lire, sparpagliati addosso sotto forma di pietre
preziose, di cui Plinio annovera più di cento specie. C'erano anche delle
"imitazioni" che pare fossero capolavori. Un senatore fu proscritto da
Vespasiano perché portava al dito un anello con un opale di centocinquanta
milioni di lire. Il severo Tiberio tentò di mettere un freno a questi esibizionismi, ma dovette arrendersi: ad abolire le industrie del lusso, si rischiava
di precipitare Roma in una crisi economica.
L'arredamento della casa era in tono con questi sfarzi e forse li superava.
Un palazzo degno di questo nome doveva avere un giardino, un porticato di
marmo, non meno di quaranta stanze, fra cui qualche salone con colonne di
onice o di alabastro, piancito e soffitto a mosaico, pareti intarsiate di pietre
costose, tavoli di cedro su gambe d'avorio, broccati orientali (Nerone ne
aveva comprati per trecento milioni di lire), vasi di Corinto, letti di ferro
battuto con zanzariera, e qualche centinaio di servi: due dietro la sedia di
ogni ospite per servirgli il pranzo, due per togliergli simultaneamente le
scarpe quando si coricava, eccetera.
Il gran signore romano di questi tempi si alzava al mattino verso le sette e
come prima cosa riceveva per un paio d'ore i suoi clienti, offrendo la
guancia al bacio di ognuno di essi. Poi faceva la prima colazione, molto
sobria. E infine riceveva le visite degli amici e le restituiva. Questo era uno
degli obblighi più rigidamente osservati dalla social life romana. Rifiutarsi
di assistere un amico mentre stendeva il testamento, o di partecipare alle
nozze di suo figlio, o di leggere le sue poesie, o di sostenerne la candidatura,
o di avallarne le cambiali, era un'offesa e procurava discredito. Solo dopo il
pagamento di questi debiti, si poteva pensare ai propri affari personali.
Questa regola valeva anche per la gente di condizione più modesta, della
media borghesia. Costoro lavoravano sino a mezzogiorno, prendevano un
pasto leggero, all'americana, tornavano al lavoro. Ma tutti, chi prima, chi
dopo, secondo il mestiere e l'orario, finivano poi per trovarsi alle terme per
il bagno. Nessun popolo è mai stato tanto pulito come quello romano. Ogni
palazzo aveva la sua piscina privata. Ma ce n'erano oltre mille di pubbliche,
a disposizione della gente comune, con una capienza media di mille utenti
alla volta. Esse erano aperte dall'alba all'una per le donne, dalle due al
crepuscolo per gli uomini finché diventarono promiscue, e l'ingresso costava
dieci lire, servizio compreso. Ci si spogliava in cabine, si andava a fare in
palestra esercizio di pugilato, giavellotto, pallacanestro, salto, lancio del
disco; poi si entrava nella sala di massaggio. E alla fine si cominciava il
bagno vero e proprio, che seguiva una stretta regola liturgica. Prima ci
s'immergeva nel tepidarium ad aria tepida, poi nel calidarium ad aria calda,
poi nel laconicum a vapore bollente, dove si faceva uso di una novità
importata da poco dalla Gallia, il sapone. E infine, per provocare una sana
reazione del sangue, ci si buttava a nuoto nell'acqua ghiaccia della piscina.
Dopo tutto questo, ci si asciugava, ci si spalmava d'olio, ci si rivestiva e si
passava nella sala da giuoco per una partita a scacchi o a dadi, o in quella di
conversazione per una buona chiacchierata con gli amici che si sapeva con
certezza di trovarvi, o nel restaurant, per una buona cenetta che, anche
quando era sobria, consisteva di almeno sei portate, di cui due di carne di
porco. La si consumava giacendo sui triclini, specie di divani a tre posti, col
corpo disteso per riposarlo dagli esercizi fatti poco prima, il braccio sinistro
appoggiato sul cuscino per sostenere la testa, il destro allungato a prendere
le vivande dal tavolo. La cucina era greve, con molte salse di grasso
animale. Ma i romani avevano uno stomaco solido, e lo dimostravano in
occasione dei veri e propri banchetti che con molta frequenza celebravano.
Questi avevano inizio alle quattro del pomeriggio, e duravano sino a notte
avanzata, se non fino all'indomani. Le tavole erano cosparse di fiori e l'aria
di profumi. I servitori, in ricche divise, dovevano essere almeno, come
numero, il doppio degli invitati. Non si ammettevano che pietanze rare ed
esotiche. «Per i pesci», diceva Giovenale, «ci vogliono quelli che costano
più dei pescatori». L'aragosta rossa faceva premio, le pagavano anche
sessantamila lire l'una, e Vedio Pollione fu il primo a tentarne l'allevamento.
Le ostriche e i petti di tordo erano d'obbligo. E Apicio si fece una posizione
in società inventando un piatto nuovo: il paté de foie gras, ingrassando le
oche a furia di fichi. Era un curioso uomo, questo Apicio: si mangiò in
pranzi un patrimonio colossale, e quando lo vide ridotto a un miliardo solo
si uccise ritenendosi caduto in miseria.
In queste occasioni il banchetto si trasformava in orgia, l'anfitrione offriva
in dono agli ospiti oggetti preziosi, e i servi passavano fra i tavoli
distribuendo degli emetici che provocavano il vomito e consentivano di
ricominciare a mangiare.
Il rutto era consentito. Anzi, era un segno di apprezzamento della bontà
dei cibi.
CAPITOLO SESTO
IL SUO CAPITALISMO
ROMA non era una città industriale. Di grossi stabilimenti c'erano soltanto
una cartiera e una fabbrica di coloranti. Sin da quegli antichi tempi, la sua
industria vera era la politica che offre, ai guadagni, scorciatoie molto più
rapide che non il lavoro vero. E questa vocazione non è cambiata nemmeno
ai giorni nostri.
La fonte principale di ricchezza dei signori romani erano l'intrallazzo nei
corridoi dei Ministeri e il saccheggio delle province. Essi spendevano molti
soldi per far carriera. Ma, una volta arrivati a qualche alto grado
amministrativo, si rifacevano con larghi interessi, e i guadagni li investivano
nell'agricoltura. Giunio Columella e Plinio ci hanno lasciato il ritratto di
questa società latifondista e dei criteri che seguiva per lo sfruttamento delle
fattorie.
La piccola proprietà che i Gracchi, Cesare e Augusto avevano voluto
ripristinare con le loro leggi agrarie non aveva retto alla concorrenza del
latifondo: una guerra o un anno di siccità bastavano a distruggerla a profitto
dei grandi feudi che avevano possibilità di resistere. Ce n'erano di vasti
come reami, dice Seneca, accuditi da schiavi che non costavano nulla ma
trattavano la terra senza nessun criterio, e specializzati nell'allevamento del
bestiame, che rendeva più dell'aratura dei campi. Pascoli di dieci o venti
mila ettari con dieci o ventimila capi non erano una rarità.
Ma fra Claudio e Domiziano cominciò una lenta trasformazione. Il lungo
periodo di pace e l'estensione della piena cittadinanza ai provinciali
interruppero il rifornimento di schiavi che cominciarono a farsi rari e quindi
più costosi: e il miglioramento degl'incroci condusse a una crisi di
sovrapproduzione del bestiame che si procurava con difficoltà i mangimi e
scadde di prezzo. Molti allevatori trovarono più conveniente tornare alla
agricoltura, divisero le fattorie in poderi e li diedero in sfruttamento a degli
affittuari, o coloni, che furono gli antenati dei contadini d'oggidì e molto, se
è vero quel che Plinio racconta di essi, gli somigliano: tenaci, solidi, avari,
diffidenti e conservatori.
Costoro di terra se n'intendevano e avevano interesse a farla rendere. Di
colpo cominciò l'uso dei concimi, la rotazione delle colture e la selezione
delle sementi. I frutticoltori importarono e trapiantarono dopo razionali
esperimenti l'uva, la pesca, l'albicocca, la ciliegia. Plinio enumera ventinove
qualità di fichi. E il vino fu prodotto in tale quantità che Domiziano, per
impedire una crisi, proibì l'impianto di nuovi vigneti.
Le industrie nacquero, su base artigianale e familiare, intorno a questi
microcosmi agricoli per completarne l'autarchia. Una fattoria tanto più era
considerata ricca quanto più bastava ai propri bisogni. Lì c'era il macello,
dove venivano uccise le bestie e insaccate le loro carni. Lì c'era la fornace
per cuocere i mattoni. Lì si conciavano le pelli e si confezionavano le
scarpe. Lì si tesseva la lana e si tagliavano i vestiti. Non c'era ombra di
quella "specializzazione" che oggigiorno rende il lavoro insopportabile e
trasforma in un automa chi lo fa. L'industrioso contadino di quei tempi,
staccate le bestie dall'aratro, diventava falegname o si metteva a battere il
ferro per ricavare ganci o pentole. La vita di questi agricoltori artigiani era
piena e varia molto più che ai tempi nostri.
Le uniche industrie condotte con criteri moderni erano quelle estrattive.
Proprietario del sottosuolo, teoricamente, era lo stato, che però ne affidava
lo sfruttamento, dietro modesti canoni di affitto, ai privati. L'interesse guidò
costoro a scoprire lo zolfo in Sicilia, il carbone in Lombardia, il ferro
all'Elba, il marmo in Lunigiana, e il loro impiego. I costi di produzione
erano minimi perché il lavoro nei pozzi era affidato esclusivamente a
schiavi e a forzati ai quali non si doveva pagare nessun corrispettivo e che
non era necessario assicurare contro nessun infortunio. Date le condizioni
delle miniere, di Marcinelle ce ne dovevano essere ogni settimana, con
migliaia di morti. Gli storici romani hanno trascurato di dircelo perché per
loro questi episodi non "facevano notizia" come si dice in gergo
giornalistico. Un'altra grande industria era quella edile, coi suoi specialisti,
dai boscaioli ai trombai ai vetrai. Ma un vero e proprio capitalismo
industriale non potè svilupparsi soprattutto per la concorrenza che il lavoro
servile faceva al macchinario. Cento schiavi costavano meno di quanto
sarebbe costata una turbina, e la meccanizzazione avrebbe creato un insolubile problema di disoccupazione.
Eppure, molti servizi pubblici furono meglio organizzati allora che
nell'Europa, poniamo, del Settecento. L'Impero aveva centomila chilometri
di autostrade, l'Italia sola possedeva circa quattrocento grandi arterie, sulle
quali si svolgeva un traffico intenso e ordinato. La loro pavimentazione
aveva consentito a Cesare di percorrere millecinquecento chilometri in otto
giorni, il messaggero che il Senato mandò a Galba per annunziargli la morte
di Nerone impiegò trentasei ore a battere cinquecento chilometri. La posta
non era pubblica, sebbene si chiamasse cursus publicus. Modellata da
Augusto secondo il sistema persiano, essa doveva servire soltanto come
valigia diplomatica, cioè per la corrispondenza di stato, e i privati potevano
approfittarne solo su speciale permesso. Il telegrafo era sostituito da
segnalazioni luminose attraverso fari postati sulle alture, ed è rimasto
sostanzialmente identico fino ai tempi di Napoleone. La posta privata era
gestita da compagnie private, oppure affidata ad amici e a gente di
passaggio. Ma i gran signori come Lepido, Apicio, Pollione avevano un
servizio per conto loro e ne erano fierissimi.
Raccordi e posteggi erano magnificamente congegnati. Ogni chilometro
c'era un capitello che indicava la distanza dalla città più vicina. Ogni dieci
chilometri c'era una stazione con trattoria, camere da letto, stalla, cavalli
freschi da affittare. Ogni trenta, c'era una mansione cui a quanto sopra, più
spazioso e meglio organizzato, si aggiungeva anche un bordello. Gli itinerari
erano sorvegliati da pattuglie di polizia, che però non riuscirono mai a
renderli del tutto sicuri. I gran signori li percorrevano seguiti da interi treni
di carri, dentro i quali essi dormivano sotto la guardia dei loro servi armati.
Il turismo fioriva, quasi quanto ai nostri tempi. Plutarco ironizza sui
globe-trotters che infestavano la città. Come quella dei giovani inglesi del
secolo scorso, l'educazione del giovane romano non era completa prima del
grand tour. Lo facevano soprattutto in Grecia, via mare, imbarcandosi a
Ostia o a Pozzuoli, ch'erano i due grandi porti del tempo. I più poveri
prendevano uno dei tanti carghi che andavano a incettare in Oriente; per i
più ricchi c'erano veri e propri transatlantici, che navigavano a vela, ma
stazzavano fino a mille tonnellate, erano lunghi centocinquanta metri e
possedevano cabine di lusso.
La pirateria era scomparsa quasi completamente sotto Augusto che, per
debellarla, aveva istituito due grosse home fleets permanenti in Mediterraneo. Sicché ora le navi viaggiavano anche di notte ma quasi sempre
costeggiando per paura delle tempeste. Orari non ce n'era perché tutto
dipendeva dai venti. Normalmente si andava sui cinque o sei nodi all'ora, e
da Ostia ad Alessandria ci volevano circa dieci giorni. Ma anche il biglietto
costava poco; su un cargo, il tragitto sino a Atene non superava le cinquanta
lire. Le ciurme erano allenate e somigliavano a quelle d'oggi: gente
spregiudicata e manesca, con spiccate tendenze alla bettola e al bordello. I
comandanti erano degli specialisti, che piano piano trasformarono il
mestiere della navigazione in una scienza vera e propria. Ippalo scoprì la
periodicità dei monsoni; e i viaggi dall'Egitto all'India, che prima
richiedevano sei mesi, ora si cominciarono a fare in uno. Nacquero le prime
carte, furono installati i primi fari.
Tutto questo avvenne rapidamente perché i romani covavano in corpo,
oltre alla passione delle armi e delle leggi, quella dell'ingegneria. Essi non
portarono mai gli studi matematici alle altezze speculative dei greci, ma li
applicarono con molta più praticità. Il prosciugamento del Fucino fu un
autentico capolavoro, e le strade che essi costruirono rimangono ancor oggi
dei modelli. Furono gli egiziani a scoprire i princìpi dell'idraulica, ma
furono i romani a concretarli in acquedotti e fognature di colossali
proporzioni. A loro si deve lo zampillio di fontane della Roma di oggi. E
Frontino, che ne organizzò il sistema, lo ha anche descritto in un manuale di
alto valore scientifico. Egli giustamente raffronta queste opere di pubblica
utilità alla totale inutilità delle Piramidi e di tante costruzioni greche. E nelle
sue parole risplende il genio romano, pratico, positivo, al servizio della
società e non a rimorchio dei capricci estetici individuali.
È difficile dire fino a che punto lo sviluppo economico di Roma e del suo
Impero fu dovuto all'iniziativa privata e fino a che punto allo stato.
Quest'ultimo era proprietario del sottosuolo, di un largo demanio e
probabilmente anche di alcune industrie di guerra. Garantiva il prezzo del
grano col sistema degli ammassi e intraprendeva direttamente i grandi lavori
pubblici per rimediare alla disoccupazione. Esso usava anche il Tesoro
come banca prestando ai privati, su solide garanzie, ad alto interesse. Ma
non era molto ricco. I suoi introiti, sotto Vespasiano che li aumentò e li
amministrò con rigore, non superavano i cento miliardi di lire, ricavati
soprattutto dalle tasse.
All'ingrosso si può dire che era uno stato più liberale che socialista, il
quale lasciava persino all'iniziativa dei suoi generali il diritto di batter
moneta nelle "province" da essi governate. Il complesso sistema monetario
che ne derivò fu la pacchia dei banchieri che vi basarono sopra tutte le loro
diavolerie: i libretti di risparmio, le cambiali, gli assegni, gli ordini di
pagamento. Essi fondarono istituti appositi con succursali e corrispondenti
in tutto il mondo, e questo complesso sistema rese inevitabili i booms e le
crisi come succede anche oggi.
La depressione di Wall Street nel 1929 ebbe il suo precedente a Roma
quando Augusto, tornato dall'Egitto con l'immenso tesoro di quel paese in
tasca, lo mise in circolazione per rianimare i traffici che languivano. Questa
politica inflazionistica li stimolò, ma stimolò anche i prezzi che salirono alle
stelle fin quando Tiberio non interruppe bruscamente questa spirale
risucchiando il circolante. Chi si era indebitato contando sul proseguimento
dell'inflazione, si trovò a corto di liquido e corse a ritirarlo dalle casse di
risparmio. Quella di Balbo e di Ollio si trovò in un solo giorno a far fronte a
trecento milioni di obbligazioni, e dovette chiudere gli sportelli. Le industrie
e le botteghe che vi attingevano non poterono pagare i fornitori e dovettero
chiudere anch'esse. Il panico dilagò. Tutti corsero a ritirare i loro depositi
dalle banche. Anche quella di Massimo e di Vibone, ch'era la più forte, non
potè soddisfare tutte le domande, e chiese aiuto a quella di Pettio. La notizia
si sparse come un baleno, e allora furono i clienti di Pettio che si
precipitarono da lui coi loro libretti impedendogli il salvataggio dei suoi due
colleghi. L'interdipendenza delle varie economie provinciali e nazionali nel
seno del vasto Impero fu provata dal contemporaneo assalto alle banche di
Lione, di Alessandria, di Cartagine, di Bisanzio. Era chiaro che un'ondata di
sfiducia a Roma si riverberava immediatamente in periferia. Anche allora ci
furono fallimenti a catena e suicidi. Molte piccole proprietà, sotterrate dai
debiti, non poterono aspettare il nuovo raccolto per pagarli, e dovettero
essere vendute, o meglio svendute a profitto dei latifondi ch'erano in
condizione di resistere. Rifiorirono gli usurai che il diffondersi delle banche
aveva diradato. I prezzi crollarono paurosamente. E Tiberio dovette alla fine
arrendersi all'idea che la deflazione non è più sana dell'inflazione. Con molti
sospiri distribuì cento miliardi alle banche perché li rimettessero in
circolazione con l'ordine di imprestarli per tre anni senza interesse.
Il fatto che questa misura bastò a rianimare l'economia, a scongelare il
credito e a ridare la fiducia, ci dimostra quanto le banche contassero, cioè
quanto fosse sostanzialmente capitalista il regime imperiale romano.
CAPITOLO SETTIMO
I SUOI DIVERTIMENTI
QUANDO Augusto assunse il potere, il calendario romano conosceva
settantasei giorni di festa, press'a poco come oggi; quando il suo ultimo successore ne decadde, ce n'erano centosettantacinque, cioè era festa un giorno
sì e uno no. Esse venivano celebrate coi ludi scenici e coi giuochi atletici.
I ludi scenici non erano più il classico dramma, pomposo e solenne,
estintosi, dopo una breve stagione, molto più rapidamente di quanto non
fosse nato. C'è qualcosa nell'aria non solo di Roma, ma di tutta Italia, che le
rende piuttosto allergiche al teatro. Drammi si continuò a scriverne anche in
questo primo secolo d'Impero ma come esercitazioni poetiche che trovavano
qualche ascoltatore nei salotti in cui l'autore le leggeva, non spettatori nei
teatri e attori per interpretarle. Un pubblico rozzo, composto in buona parte
di stranieri che conoscevano soltanto un latino elementare, preferiva la
pantomima in cui la trama è resa evidente non dalla parola, ma dal gesto e
dalla danza. Si formò allora quella tradizione del "gigione", grossolano,
volgare, che arrota gli occhi, che smorfieggia, gesticoloso, cui ancora oggi i
nostri attori si ispirano. Roma ebbe i suoi Totò e Macario in Esopo e Roscio,
le vedettes di quel tempo, che commettevano stravaganze per farsi
pubblicità, mandavano in delirio le platee coi loro sketches scollacciati e
pieni di doppi sensi, diventarono i "cocchi nostri" dei salotti aristocratici, si
prendevano per amanti le gentildonne più in vista, guadagnavano fior di
milioni e lasciavano in eredità dei miliardi. Essi avevano ora nelle loro
compagnie anche delle donne, le girls del tempo, che venendo a causa di
questa professione ufficialmente equiparate alle prostitute, non avevano più
nulla da perdere in fatto di pudore e contribuivano senza ritegno alla
oscenità degli spettacoli.
La libidine dell'applauso spesso portava questi interpreti a rappresentare
scene colme di allusioni politiche in barba alla censura, come sempre capita
nei regimi di tirannia, quando nessuno osa dir qualcosa, ma tutti vanno in
visibilio per chi lo fa. La sera dei funerali di Vespasiano, un attore ne
parodiò il cadavere drizzandosi nella bara e chiedendo ai beccamorti:
«Quanto costa questo trasporto?». «Dieci milioni di sesterzi». «Be',
datemene centomila», rispose il cadavere, «e buttatemi nel Tevere». Che
era, bisogna riconoscerlo, un'uscita in tono col carattere del defunto.
All'empio andò bene, perché il successore era Tito. Ma pochi anni prima
Caligola aveva fatto bruciar vivo l'autore d'un'allusione molto più timorata.
Mentre il teatro scadeva così nella rivista di varietà, sempre più cresceva
la fortuna del Circo. Cartelli murali come quelli che oggi annunziano i film,
annunziavano gli spettacoli atletici. Essi costituivano l'argomento del
giorno, se ne discuteva appassionatamente in famiglia, a scuola, nel Foro,
alle Terme, in Senato, e perfino il giornale, Acta diurna, ne faceva la
presentazione e la recensione. Il giorno delle gare, folle di centocinquanta o
duecentomila persone si avviavano al Circo Massimo, come oggi allo
stadio, recando fazzoletti coi colori della squadra del cuore, e i maschi
facendo sosta, prima di entrare, nei bordelli che si allineavano ai lati
degl'ingressi. I dignitari avevano palchi a parte con sedili di marmo ornato
di bronzo. Gli altri si sistemavano su panche di legno, dopo essere andati a
frugare negli escrementi dei cavalli per assicurarsi ch'erano stati nutriti a
dovere, aver impegnato fin la camicia nelle scommesse ed essersi procurati
un panino e un cuscino perché lo spettacolo durava tutta la giornata.
L'imperatore aveva addirittura, per sé e la famiglia, un appartamento con
camere da letto per schiacciarvi un pisolino fra una gara e l'altra, e
l'immancabile bagno per le abluzioni e altre comodità.
Come oggi, cavalli e fantini appartenevano a scuderie private, ciascuna
con la propria casacca di cui le più famose erano le rosse e le verdi. Le corse
al galoppo si alternavano con quelle al trotto con due, o tre, o quattro
cavalli. Quasi tutti schiavi, i conducenti portavano elmetti di metallo,
tenendo in una mano le briglie, nell'altra la frusta, e a tracolla un coltello
con cui tagliare i finimenti in caso di caduta. Era un caso frequente perché la
corsa era spericolata, come lo è oggi quella del Palio a Siena. Si dovevano
percorrere sette circuiti, cioè altrettanti chilometri, attorno alla ellittica
arena, evitando le metae e prendendo le curve quanto più stretto si poteva. I
calessini entravano facilmente in collisione, e bipedi e quadrupedi
ruzzolavano giù con stanghe e ruote per essere schiacciati dagli equipaggi
che sopraggiungevano. Tutto questo in mezzo ai boati degli spettatori che
atterrivano i cavalli.
Ma i numeri più attesi erano le lotte gladiatorie: fra animale e animale, fra
animale e uomo, fra uomo e uomo. Il giorno in cui Tito inaugurò il
Colosseo, Roma spalancò gli occhi per la meraviglia.
L'arena poteva essere abbassata e inondata come un bacino lacustre,
oppure riemergere diversamente addobbata, come un pezzo di deserto o un
ciuffo di giungla. Una galleria di marmo era riservata agli alti dignitari, e in
mezzo si elevava il suggestum, o loggia imperiale, con tutti i suoi accessori,
dove imperatore e imperatrice sedevano su troni d'avorio. Chiunque poteva
avvicinarsi al sovrano a impetrare una pensione, un trasferimento, la grazia
per un condannato. Ad ogni angolo fontane lanciavano in aria zampilli di
acqua profumata; e nei ridotti si preparavano i tavoli per gli spuntini fra un
numero e l'altro. Tutto era gratuito: ingresso, sedile, cuscino, arrosto, vino.
Il primo numero fu la presentazione di animali esotici, molti dei quali i
romani non avevano ancora mai visto. Fra elefanti, tigri, leoni, leopardi,
pantere, orsi, lupi, coccodrilli, ippopotami, giraffe, linci eccetera ne
sfilarono diecimila, e molti erano caricaturalmente addobbati per parodiare
personaggi della storia o della leggenda. Poi l'arena fu tirata giù e riemerse
adattata al combattimento: leoni contro tigri, tigri contro orsi, leopardi
contro lupi. Insomma, alla fine dello spettacolo, solo la metà di quelle
diecimila povere bestie era viva. L'altra metà era scomparsa nella loro
pancia. Poi di nuovo l'arena fu tirata giù e riemerse addobbata a plaza de
toros. La corrida, già praticata dagli etruschi, era stata poi importata a Roma
da Cesare che l'aveva vista a Creta. Egli aveva un debole per queste feste, ed
era stato il primo a offrire ai suoi concittadini un combattimento di leoni.
Quello col toro piacque enormemente ai romani che vi si appassionarono
subito e da allora in poi lo reclamarono sempre. I toreri non conoscevano il
mestiere ed erano quindi destinati alla morte. Infatti venivano scelti fra gli
schiavi e i condannati, come tutti gli altri gladiatori del resto. Molti di essi
non combattevano nemmeno. Dovevano rappresentare qualche personaggio
della mitologia e subirne per davvero la tragica fine. Per ravvivare la
propaganda patriottica, uno veniva presentato come Muzio Scevola e
obbligato a bruciarsi la mano sui carboni, un altro come Ercole cremato vivo
sulla pira, un altro come Orfeo sbranato mentre suonava la lira. Volevano
essere insomma degli spettacoli "edificanti" per la gioventù e come tali essi
non erano affatto vietati ai minori dì sedici anni, anzi.
Seguivano i combattimenti fra gladiatori, tutti condannati a pene capitali
per omicidio, rapina, sacrilegio o ammutinamento, ch'erano i delitti per i
quali la morte veniva inflitta. Ma quando ce n'era carestia, compiacenti
tribunali condannavano a morte anche per altri motivi molto meno gravi:
Roma e i suoi imperatori non potevano fare a meno di questa carne umana
da macello. Tuttavia c'erano anche i volontari, e non tutti di bassa
estrazione, che s'iscrivevano alle apposite scuole per poi combattere nel Circo. Erano forse le più serie e rigorose scuole di Roma. Vi sì entrava quasi
come in seminario, dopo aver giurato dì essere pronti a farsi "frustare,
bruciare e pugnalare". I gladiatori avevano, ad ogni combattimento, una
probabilità su due di diventare eroi popolari, cui i poeti dedicavano i loro
carmi, gli scultori le loro statue, gli edili le loro strade e le signore le loro
grazie. Prima della gara si offriva loro un pantagruelico banchetto. E, se non
vincevano, avevano l'obbligo di morire con irridente indifferenza. Si chiamavano con vari nomi secondo le armi che usavano, e ogni spettacolo
contava centinaia di questi duelli che potevano anche finire senza il morto se
il soccombente, essendosi condotto con coraggio e bravura, veniva graziato
dalla folla col gesto del pollice alzato. A uno spettacolo offerto da Augusto e
durato otto giorni, diecimila gladiatori presero parte. Guardiani vestiti da
Caronte e da Mercurio pungevano i caduti con forconi acuminati per vedere
se erano morti, i simulatori venivano decapitati, schiavi negri appilavano i
cadaveri e portavano nuova sabbia per i combattimenti successivi.
Questo modo di divertirsi al sangue e alle torture non sollevava obiezioni
nemmeno fra i moralisti più severi. Giovenale, che criticava tutto, era un
tifoso del Circo e lo trovava del tutto legittimo. Tacito ebbe qualche dubbio;
ma poi riflette che quello che si versava nell'arena era "sangue vile" e con
questo aggettivo lo giustificò. Perfino Plinio, il più civile e moderno
gentiluomo di allora, trovò che quei massacri avevano un valore educativo
perché abituavano gli spettatori allo stoico disprezzo della vita (altrui). Non
parliamo di Stazio e Marziale, i due poeti lodatori di Domiziano, che nel
Circo passavano la vita e vi attinsero le loro ispirazioni poetiche. Stazio era
un napoletano che si era fatto un bel nome con un brutto poema, La
Tebaide, aveva recitato nei teatri, fu invitato a pranzo dall'imperatore e, per
farlo sapere a tutta Napoli, ci scrisse sopra un libro rappresentando
Domiziano come un dio e dedicandogli le sue Silvae, che sono le sole poesie
leggibili di questo autore. Morì sui cinquant'anni, quando già la sua stella
era offuscata da Marziale che cercava le sue ispirazioni soprattutto nel Circo
e nel bordello.
Marziale era uno spagnolo di Bilbao che venne a Roma a ventiquattr'anni
e vi godè la protezione dei suoi compatrioti Seneca e Lucano. Perché gli
spagnoli allora si aiutavano, come fanno oggi i siciliani. Non fu un gran
poeta. Ma anticipò Longanesi nella "battuta", che lasciava il segno come un
morso. «Le mie pagine sanno di uomini», diceva; ed è vero. I suoi
personaggi sono di basso rango perché li sceglieva in quegli ambienti
malfamati delle prostitute e dei gladiatori; ma appunto per questo sono vivi
nella loro) volgarità e abiezione. Era lui stesso un tipo piuttosto ignobile.
Piaggiò Domiziano, calunniò i suoi benefattori, visse nei bassifondi
mangiandosi i soldi in vino, dadi e scommesse alle corse. Ma non seppe
cosa volesse dire retorica, i suoi Epigrammi rimangono il più perfetto
monumento del genere, e la testimonianza ch'egli ci ha lasciato di Roma è
forse la più autentica. Finì per tornarsene a Bilbao, ch'era allora un paesello,
dove visse, tanto per cambiare, alle spalle di un amico che gli regalò una
villa, e dove, di Roma, rimpianse una cosa sola: il Circo, non avendo più
l'età per rimpiangere anche l'altra: i bordelli.
Soltanto Seneca ci ha lasciato una condanna dei giuochi gladiatori che
dice di non aver mai frequentato. Egli andò a visitare il Colosseo una volta
sola, e rimase sbigottito. "L'uomo, la cosa all'uomo più sacra, qui viene
ucciso per sport e divertimento", scrisse tornando a casa.
Ma il fatto è che questo sport e divertimento era ormai in tono col livello
morale di una Roma non ancora cristiana, ma non più neanche pagana.
L'imperatore che vi presiedeva era anche l'Alto Sacerdote, cioè il papa, di
una religione di stato che non trovava nulla da obiettare a simili ignominie
per il semplice motivo che non credeva più a niente essa stessa. Celebrava le
feste con una liturgia sempre più complicata, innalzava templi sempre più
fastosi, creava nuovi idoli come Annona e Fortuna. Ma a sorreggerli c'erano
soltanto dei capitelli di marmo. La fede, no. Essa era monopolio di quelle
poche centinaia o migliaia di cristiani, soprattutto ebrei, che, invece di
andare al Circo a tripudiare per la morte degli uomini, si riunivano nelle loro
piccole ecclesiae a pregare per la loro anima.
CAPITOLO OTTAVO
NERVA E TRAIANO
Gli uccisori di Domiziano non avevano dato alla loro vittima il tempo di
nominare un erede. E il Senato, che non aveva mai ufficialmente riconosciuto il diritto degl'imperatori a designarne, ma aveva sempre accettato
in pratica le loro scelte, ne approfittò per farne una di suo gusto nella
persona di un suo membro.
Marco Cocceio Nerva era un giurista che si dilettava a tempo perso dì
poesia, ma non aveva né la litigiosità degli avvocati né la vanità dei poeti.
Era un omaccione alto e grosso, che non aveva mai fatto del male a una
mosca, non aveva mostrato ambizioni e, alla fine del suo regno, potè dire
con piena ragione di non aver fatto nulla che gli vietasse di tornare alla vita
privata senza correre rischi.
Forse la sua scelta fu dovuta non tanto alle sue virtù, quanto al fatto che
aveva già settant'anni ed era debole di stomaco, il che lasciava prevedere un
regno di breve durata. Infatti durò due anni soli, ma a Nerva bastarono per
riparare i torti del suo predecessore. Richiamò i proscritti, distribuì molte
terre ai poveri, liberò gli ebrei dai tributi che Vespasiano aveva loro imposto
e rimise ordine nelle finanze. Ciò non impedì ai pretoriani, scontenti di quel
nuovo padrone che si opponeva alle loro prepotenze, di assediarlo nel
palazzo, scannare alcuni suoi consiglieri ed imporre la consegna degli
assassini di Domiziano. Nerva, pur di salvare i suoi collaboratori, offrì in
cambio la propria testa. E, siccome gliela risparmiarono, diede le proprie
dimissioni al Senato che le respinse. Nerva non aveva mai preso nessuna
decisione senza consultare il Senato e in opposizione ad esso. Anche
stavolta si arrese. Sentiva di essere alla fine, e il poco tempo che gli restava
da vivere lo impiegò a cercarsi un successore che il Senato gradisse e ad
adottarlo come figlio (di suoi non ne aveva), in modo da togliere ai
pretoriani la tentazione d'incoronare qualcuno di testa loro. La scelta di
Traiano fu forse il miglior servizio che Nerva abbia reso allo stato.
Traiano era un generale che in quel momento comandava un esercito in
Germania, e quando seppe che lo avevano proclamato imperatore, non si
scompose molto. Mandò a dire al Senato che ringraziava della fiducia e che
sarebbe venuto ad assumere il potere appena avesse avuto un minuto di
tempo. Ma per due anni non lo trovò, perché doveva regolare certe pendenze
coi teutoni. Era nato appena quarant'anni prima in Spagna, ma da una
famiglia romana di funzionari, e funzionario era sempre rimasto egli stesso,
cioè mezzo soldato e mezzo amministratore. Era alto e robusto, di costumi
spartani e d'un coraggio a tutta prova, ma senza esibizionismi. Sua moglie
Plotina si proclamava la più felice delle spose perché egli non l'ingannava,
ogni tanto, che con qualche giovanotto; con altre donne mai. Passava per un
uomo colto perché usava portarsi appresso, sul suo carro di generale, Dione
Crisostomo, un celebre rètore del tempo, che gli parlava continuamente di
filosofia. Ma un giorno confessò che non aveva mai capito una sola delle
molte parole che Dione aveva pronunciato, anzi non le ascoltava nemmeno:
si lasciava cullare dal loro suono d'argento pensando ad altro: ai conti della
spesa, al piano di una battaglia, al progetto di un ponte.
Quando alla fine trovò il famoso minuto per cingere la corona, Plinio il
Giovane fu incaricato di rivolgergli un panegirico in cui cortesemente gli si
ricordava ch'egli doveva la sua elezione ai senatori e quindi doveva
interpellarli per ogni decisione. Traiano sottolineò il passaggio con un segno
approvativo del capo, cui nessuno prestò gran fede. Ma ebbero torto, perché
quella regola egli l'osservò strettamente. Il potere non gli diede mai alla
testa, e nemmeno la minaccia dei complotti valse a trasformarlo in un
despota sospettoso e sanguinario. Quando scoprì quello di Licinio Sura,
andò a pranzo da lui, e non solo mangiò tutto quello che gli venne servito
nel piatto, ma poi offrì la gola al barbiere del congiurato per farsela radere.
Era un formidabile lavoratore e pretendeva che lo diventassero anche tutti
coloro che gli stavano intorno. Mandò molti sfaticati senatori a fare
ispezioni e a rimettere ordine nelle province, e dalle lettere che scambiò con
loro e di cui qualcuna c'è rimasta, si possono indurre la sua competenza e
diligenza. Le sue idee politiche erano quelle di un conservatore illuminato
che credeva più alla buona amministrazione che alle grandi riforme,
escludeva la violenza, ma sapeva ricorrere alla forza. Per questo non esitò a
muover guerra alla Dacia (che corrisponde oggi alla Romania), quando il
suo re, Decebalo, venne a insidiargli le conquiste fatte in Germania. Fu una
campagna condotta da brillante generale. Battuto, Decebalo si arrese, ma
Traiano gli risparmiò la vita e il trono, limitandosi a imporgli un
vassallaggio. Tanta clemenza, nuova negli annali della storia romana, fu mal
ricompensata, perché di lì a due anni Decebalo nuovamente si ribellò.
Traiano riprese il sentiero di guerra, batté di nuovo il fedifrago, ne dilapidò
le miniere d'oro transilvane, e con questo bottino finanziò quattro mesi di
giuochi ininterrotti nel Circo con diecimila gladiatori per celebrare la sua
vittoria e un programma di lavori pubblici destinato a fare del suo regno uno
dei più memorabili nella storia dell'urbanistica, dell'ingegneria e dell'architettura.
Un gigantesco acquedotto, un nuovo porto ad Ostia, quattro grandi strade,
l'anfiteatro di Verona, furono tra le sue opere più insigni. Ma quella più
conosciuta fu il Foro Traiano, dovuto al genio di Apollodoro, un greco di
Damasco, che già aveva costruito per lui, in pochi giorni, quel meraviglioso
ponte sul Danubio, che gli aveva consentito di prendere a rovescio
Decebalo. Per innalzare la colonna che ancora si erge di fronte alla basilica
Ulpia, furono trasportati da Paro diciotto cubi di un marmo speciale, di
cinquanta tonnellate ciascuno: un miracolo, per quei tempi. Su di essa
furono incise, in bassorilievo, duemila figure, secondo uno stile vagamente
neorealista, cioè con molta propensione alla crudezza delle scene
rappresentate. È un'incisione troppo gremita per essere bella, ma dal punto
di vista documentario è interessante, e fu questo che piacque di certo a
Traiano.
Dopo sei anni di pace, occupati in quest'opera di ricostruzione, Traiano fu
ripreso dalla nostalgia dell'accampamento e, sebbene toccasse ormai la
sessantina, si mise in testa di completare l'opera di Cesare e di Antonio in
Oriente, portando i confini dell'Impero fino all'Oceano Indiano. Ci riuscì
dopo una marcia trionfale attraverso la Mesopotamia, la Persia, la Siria,
l'Armenia, tutte ridotte a "province" romane. Costruì una flotta per il Mar
Rosso. E rimpianse di esser troppo vecchio per imbarcarsi e muovere alla
conquista dell'India e dell'Estremo Oriente. Ma erano paesi in cui non
bastava lasciar guarnigioni per stabilirvi un ordine duraturo. Traiano era
ancora sulla via del ritorno, quando le ribellioni gli scoppiarono alle spalle
un po' dovunque. Il guerriero stanco voleva tornare indietro per sedarle.
L'idropisia lo trattenne. Mandò in sua vece Lucio Quieto e Marcio Turba, e
riprese il viaggio verso Roma sperando di arrivarvi in tempo per morire.
Una paralisi lo folgorò a Selino nell'anno 117 dopo Cristo,
sessantaquattresimo della sua vita. E a Roma non tornarono che le sue
ceneri, e furono seppellite sotto la sua colonna.
Nerva e Traiano furono certamente due grandi imperatori. Ma fra i molti
effettivi meriti che li raccomandano al nostro ricordo, ebbero anche una
fortuna: quella di guadagnarsi la gratitudine di uno storico come Tacito, e di
un memorialista come Plinio, le cui testimonianze dovevano essere decisive
per il tribunale della posterità.
Tacito, che ha raccontato la vita di tanta gente, si è dimenticato di dirci
qualcosa di quella sua. Non sappiamo con precisione dove sia nato, e non
siamo nemmeno certi che fosse figlio di quel Cornelio Tacito che
amministrava le finanze del Belgio. La sua famiglia doveva appartenere a
quella borghesia quattrinaia che poi era entrata a far parte dell'aristocrazia.
Ma, più che della propria, egli andava fiero della casata di sua moglie, figlia
di quell'Agricola, proconsole e governatore della Britannia, che Domiziano
aveva avuto il torto di silurare. Questo Agricola lo conosciamo attraverso la
biografia che ce ne ha lasciato suo genero, il quale di biografie doveva
restare un insuperato maestro. Ma siccome in Tacito si compendiano tutte le
qualità del grande scrittore meno l'obiettività, non sappiamo se quel ritratto
sia del tutto veridico. Sappiamo soltanto che doveva essere sincera
l'ammirazione che lo ispirava.
Tacito era un grande avvocato. Plinio lo considera più grande dello stesso
Cicerone. Ma noi temiamo ch'egli abbia composto le sue storie un po' con
gli stessi criteri con cui difendeva i suoi clienti: e cioè più per far trionfare
una tesi che per stabilire la verità. Debuttò con un libro dedicato al periodo
fra Galba e Domiziano, di cui era stato egli stesso spettatore. E la sua
potente requisitoria contro la tirannia ebbe un tale successo nei circoli
aristocratici che n'erano stati le maggiori vittime, da indurlo a risalire nel
tempo ai regni di Nerone, Claudio, Caligola e Tiberio. Onestamente egli
riconosce di aver dovuto egli stesso, al tempo di Domiziano, piegarsi ai
capricci satrapeschi di quel sovrano e avallare, come senatore, i suoi soprusi.
Non è difficile indurne che l'amore per la libertà dovette nascergli in corpo
proprio allora. Scrisse quattordici libri di Storie, di cui solo quattro sono
giunti sino a noi, e sedici di Annali di cui ne sopravvivono dodici, oltre a
vari lavori come l'Agricola e un pamphlet sui germani in cui con
straordinaria abilità polemica si esaltano le virtù di quel popolo per
denunciare, sotto sotto, i vizi di quello romano.
Tacito va letto con criterio. Non bisogna chiedergli analisi né sociologiche
né economiche. Bisogna contentarsi di grandi reportages, perfetti come
meccanica di narrazione, col thrill e la suspense come si dice in linguaggio
cinematografico, e animati da personaggi probabilmente falsi, ma
straordinariamente caratterizzati, che si scolpiscono nella memoria con un
vigore di stile che nessuno scrittore ha mai più avuto dopo di lui. Le sue
fonti sono dubbie, e forse non si scomodò mai a ricercarne. Va per sentito
dire, attingendovi quel che gli fa comodo, anche se falso, e respingendo quel
che non gli torna, anche se è vero, al solo scopo di propagandare le sue tesi
favorite: che il massimo bene è la libertà e che la libertà è garantita soltanto
dalle oligarchie aristocratiche; che il carattere vale più dell'intelligenza; e
che le riforme non sono che passi verso il peggio. Tutto sommato, fu un
grosso peccato che Tacito si piccasse di storia. Avesse avuto le ambizioni
del romanziere, sarebbe stato meglio per lui e per noi.
Meno geniale e colorito, ma più circostanziato e attendibile, è il ritratto
che della società di quel tempo ci ha lasciato Plinio il Giovane, un gran
signore che ebbe tutte le fortune, comprese quelle di uno zio ricco che gli
lasciò il nome e il patrimonio, di una eccellente educazione, di una moglie
virtuosa (che per quei tempi doveva essere una rarità) e di un buon carattere
che gli faceva vedere il lato bello di tutto e di tutti. Era insomma nella
tradizione di Attico: quella dei gentlemen. Era nato a Como, e naturalmente
debuttò come avvocato. Tacito gli propose di dividere con lui l'onere e
l'onore dell'accusa contro Mario Prisco, funzionario incriminato di
malversazioni e crudeltà. Plinio accettò. Ma invece di pronunciare
un'arringa contro l'imputato, pronunciò un elogio esclamativo, lungo due
ore, del suo collega, che, quando fu il suo turno, lo ricambiò (e Prisco, nella
gabbia, doveva frattanto fregarsi le mani nel sentirsi completamente
dimenticato).
Gli diedero alcuni incarichi. Li assolse tutti con diligenza e onestà. Ma
particolarmente brillò in quelli diplomatici, per i quali lo prescelse Traiano,
gran conoscitore di uomini. La sua qualità fondamentale infatti era il "tatto".
Basta leggere la lettera che scrisse al suo vecchio precettore Quintiliano, il
gran giurista, per scusarsi di non potergli dare più di cinquantamila sesterzi
(qualcosa come tre milioni di lire) per la dote di sua figlia: sembra che
chieda un favore, invece di offrire un'elemosina. Quando lo mandavano per
qualche ambasceria o ispezione, rifiutava stipendio, trasferte e diaria, si
riempiva le valigie di regali per le mogli dei governatori, dei generali e dei
prefetti che avrebbe incontrato per strada, e si portava al seguito, pagandolo
di tasca propria, qualcuno con cui parlare di letteratura: Svetonio, in
generale, perché aveva un debole per lui. Siccome, con quella mania che
aveva di scrivere lettere a tutti, manteneva i "contatti" (ch'è sempre stata una
gran furberia in tutti i tempi), gl'inviti, dovunque arrivasse, gli grandinavano
sulla testa. Rispondeva sempre per iscritto: Accetto il tuo invito a pranzo,
amico, ma a patto che mi congedi presto e mi tratti frugalmente. Che
intorno alla tavola s'intreccino filosofici conversari, ma anche di quelli
godiamo con moderazione.
Con moderazione: ecco la sua etica, la sua estetica e la sua dietetica.
Plinio fece tutto con moderazione: anche l'amore. E di tutto con moderazione parlò nelle sue lettere descrittive all'imperatore, ai colleghi, ai
parenti, ai clienti, che sono quanto di meglio ci resta di lui e costituiscono la
testimonianza forse più preziosa di quella società e dei suoi costumi.
CAPITOLO NONO
ADRIANO
Si prova, lo confessiamo, qualche riluttanza ad ammettere che un episodio
così fausto come l'avvento al trono del più grande imperatore dell'antichità
fosse dovuto a una coincidenza banale e piuttosto sudicia come l'adulterio.
Eppure, Dione Cassio ci da per certo che Adriano fu qualificato a prendere il
posto di Traiano, morto senza designare eredi, da un titolo solo: quello di
amante della moglie di costui, Plotina.
Ai "si dice" bisogna far credito fino a un certo punto, specie in fatto di
corna. Ma, certo, Plotina almeno una mano per incoronarlo, a Adriano la
diede. Erano zia e nipote, ma non di sangue, eppoi le parentele a Roma non
avevano mai impedito nessun amore. Traiano e Adriano erano compaesani,
perché nati nella stessa città di Spagna, Italica. E il secondo, che portava
quel nome perché la sua famiglia veniva da Adria ed era di ventiquattr'anni
più giovane, venne a Roma chiamatovi dal primo, ch'era amico di casa e suo
tutore. Era un ragazzo pieno di vita, di curiosità e d'interessi, che studiava
tutto con fervore: matematica, musica, medicina, filosofia, letteratura,
scultura, geometria, e imparava presto. Traiano gli diede in moglie sua
nipote Vivia Sabina. Fu un matrimonio rispettabile e ghiaccio, dal quale non
nacquero né amore né figli. Sabina, statuariamente bella ma priva di sex
appeal, si lamentava a mezza voce del fatto che suo marito avesse più tempo
per i cani e i cavalli che per lei. Adriano la conduceva con sé nei suoi viaggi,
la colmava di cortesie, licenziò il proprio segretario Svetonio perché un
giorno parlò di lei poco rispettosamente, ma di notte dormiva solo.
Aveva quarant'anni appena quando salì sul trono, e il suo primo gesto fu
quello di chiudere rapidamente le pendenze militari lasciate da Traiano. Era
sempre stato contrario alle imprese guerresche del suo tutore. E, presone il
posto, si affrettò a ritirare gli eserciti dalla Persia e dall'Armenia, con gran
malumore dei loro comandanti, i quali pensavano che una strategia puramente difensiva fosse l'inizio della morte per l'Impero o la fine della
carriera, delle medaglie e delle "diarie" per loro. Non si è mai saputo con
esattezza come avvenne che quattro di questi comandanti, i più valorosi e
autorevoli, venissero di lì a poco soppressi senza processo. Adriano era sul
Danubio in quel momento a cercarvi una soluzione definitiva coi daci, che
escludesse ulteriori conflitti. Si precipitò a Roma, e il Senato si assunse tutte
le responsabilità dell'eliminazione, dicendo che i generali si erano macchiati
di complotto contro lo stato. Ma nessuno credette all'innocenza di Adriano,
che se la comprò distribuendo ai cittadini un miliardo di sesterzi, liberandoli
dai debiti col fisco e divertendoli per intere settimane con magnifici
spettacoli nel Circo.
Questi debutti fecero temere a molti romani un ritorno neroniano. E i
sospetti furono avvalorati dal fatto che Adriano cantava, dipingeva,
componeva appunto come Nerone. Ma poi si vide che in queste sue
ambizioni artistiche non c'era nulla di patologico. Adriano vi si
abbandonava solo nei ritagli di tempo, per riposarsi delle sue fatiche di
scrupoloso e abilissimo amministratore. Era un bell'uomo, alto, elegante, coi
capelli ricciuti e una barba bionda che tutti i romani vollero imitare forse
ignorando ch'egli se l'era lasciata crescere solo per nascondere certe
sgradevoli chiazze bluastre che aveva sulle gote. Ma non era facile capirne il
carattere complesso e contraddittorio. Di solito era gentile e di buon umore,
ma talvolta fu duro sino alla crudeltà. In privato si mostrava scettico,
irridente agli dèi e agli oracoli. Ma quando adempieva le sue funzioni di
Pontefice Massimo, guai a chi dava segno d'irriverenza. Personalmente, non
si sa a cosa credesse.
Forse agli astri, perché ogni tanto strologava ed era pieno di superstizioni
sulle eclissi e le maree. Ma considerando la religione un puntello della
società, non ammetteva pubbliche offese ad essa, e di persona redasse il
progetto del tempio di Venere e di Roma, dopo aver messo a morte
Apollodoro che aveva risposto al suo invito con uno sprezzante rifiuto.
Intellettualmente, propendeva per lo stoicismo, ed era un ammiratore di
Epitteto che aveva studiato con attenzione. Ma in pratica non si sforzò mai
di applicarne i precetti. Prese il piacere dovunque lo trovò secondo un gusto
raffinato, ma senza vergogna né rimorso. S'innamorava indifferentemente di
bei ragazzi e di belle ragazze, ma nessuno di costoro gli fece perdere la
testa. Gli piaceva mangiar bene, ma detestava i banchetti; e alle orge
preferiva cenette di poche scelte persone che, più che bere, sapessero conversare. Anche per procurarsene, istituì una università, dove chiamò a
insegnare i più grandi maestri del tempo, specialmente greci. Eran costoro e
i loro allievi i suoi ospiti abituali. Nelle discussioni, era buon giocatore:
accettava contestazioni e critiche. Anzi, un giorno rimproverò a Favorino,
un intellettuale gallo, di dargli troppo spesso ragione. «Ma un uomo che
basa i suoi argomenti su trenta divisioni in armi ha sempre ragione», rispose
spiritosamente il giovane filosofo. E l'imperatore riraccontò la storiella in
Senato, divertendolo e divertendocisi.
Il suo tratto più straordinario fu di non sentirsi "necessario", anzi di fare
tutto il possibile per non diventarlo e per non essere scambiato per il solito
"uomo della provvidenza" quali si credono e aspirano ad essere considerati
tutti i monarchi assoluti. Il suo costante sforzo fu quello di mettere in piedi
una organizzazione burocratica cui bastasse la supervisione del Senato per
andare avanti. Aveva la vocazione dell'ordine e cercò d'instaurarlo
semplificando le leggi che si erano accumulate in un caos inestricabile. In
quest'opera, che affidò a Giuliano, precorse Giustiniano.
A questa razionale divisione del lavoro, che consentiva all'apparato statale
una certa meccanicità di funzionamento, egli tendeva anche per ragioni
egoistiche: perché aveva la passione dei viaggi e voleva intraprenderli senza
la preoccupazione che tutto, in sua assenza, andasse in malora. Infatti ne
fece di lunghissimi, che durarono fino a cinque anni, per conoscere da
vicino l'Impero in tutti i suoi angoli. Scrupolo del dovere? Curiosità? Un po'
l'uno e un po' l'altra. Quattr'anni dopo l'incoronazione partì per un'accurata
ispezione della Gallia. Viaggiava come un privato qualsiasi, con un seguito
composto quasi esclusivamente di tecnici. Governatori e generali se lo
vedevano piovere addosso all'improvviso, e dovevano mostrargli le bucce
della loro amministrazione, fino all'ultima. Adriano ordinava un nuovo
ponte o una nuova strada, concedeva una promozione o impartiva un siluro;
e, se capitava, prendeva in mano una legione, lui, l'uomo della pace, per
definire con una battaglia un confine incerto. Batteva da fantaccino, alla
testa dei fantaccini, sino a quaranta chilometri al giorno, e non perse una
scaramuccia.
Dalla Gallia passò in Germania, vi riorganizzò le guarnigioni, studiò a
fondo i costumi degl'indigeni, dei quali ammirò con preoccupazione la
vergine forza, discese il Reno su una nave, salpò per la Britannia e vi ordinò
la costruzione di quella specie di "Linea Maginot" che fu il famoso Vallo.
Poi tornò in Gallia e passò in Spagna. A Tarragona fu aggredito da uno
schiavo. Forte com'era, lo disarmò e lo consegnò ai dottori che lo
dichiararono pazzo. Adriano, accettando questo alibi, lo graziò. Scese in
Africa, alla testa di un paio di legioni soffocò una rivolta di mori, e continuò
per l'Asia Minore.
A Roma si era un po' inquieti per le manie peripatetiche di
quell'imperatore che non tornava più. E le chiacchiere cominciarono a farsi
maligne quando si seppe ch'egli si era imbarcato su una nave che risaliva il
Nilo con un nuovo ospite di nome Antinòo, dagli occhi vellutati e dai capelli
ricciuti.
Sembrava un destino, da Cesare in poi: appena toccavano l'Egitto, i
gerarchi romani inciampavano in qualche disgrazia sentimentale. Di che
natura fosse, per Adriano, quella incarnata da Antinòo, non si sa. Sabina,
che accompagnava l'imperatore, non risulta che abbia protestato contro la
presenza di quel ragazzo. Comunque, non si è mai chiarito come questi
morisse, annegando nel fiume, a quanto pare. Per Adriano, fu un colpo
terribile. Pianse, dice Sparziano, come una donnicciola, fece innalzare un
tempio in onore del povero defunto, e intorno al tempio fece costruire una
città, Antinòpoli, che diventò importante al tempo di Bisanzio. Secondo una
leggenda, forse posteriore agli avvenimenti, Antinòo si era ucciso perché
aveva saputo dagli oracoli che i piani del suo protettore si sarebbero
realizzati solo se egli fosse morto. Certo, scomparendo, un servigio quel
ragazzo lo rese: quello di lasciare la successione al trono aperta a un
monarca della stoffa di Antonino. Se fosse vissuto, forse Roma se lo sarebbe
trovato sul gobbo come imperatore.
L'uomo che tornò a Roma dopo quella sciagura non era più il brillante,
allegro, gioviale sovrano che ne era partito. Adriano si era fatto un po'
misantropo e, mentre un tempo abbandonava il tavolo di lavoro con
sollievo, felice di potersi prendere un po' di riposo e sapendo benissimo
come utilizzarlo, ora sembrava aver paura di quelle ore vuote, e le riempiva
scrivendo. Una grammatica, alcune poesie e un'autobiografia furono il frutto
di questa sua solitudine. Ma quel che più lo teneva occupato erano i piani di
ricostruzione. Adriano aveva il mal della pietra, accompagnato dall'estro e
dal gusto. Rifece il Pantheon, che Agrippa aveva innalzato e il fuoco
distrutto, secondo quello stile greco ch'egli preferiva al romano. E non c'è
dubbio che si tratta del monumento meglio preservato dell'antichità. Quando
il papa Urbano VIII smantellò il soffitto del portico, ne ricavò bronzo per
costruire oltre cento cannoni e il baldacchino che tuttora si trova sull'altare
maggiore di San Pietro.
Un altro capolavoro della sua architettura fu la villa intorno a cui poi
nacque Tivoli. C'era di tutto: templi, ippodromo, librerie e musei, dove per
duemila anni gli eserciti di tutto il mondo son venuti a saccheggiare,
trovandoci sempre qualcosa. Ma vi si era appena stabilito, che una malattia
cominciò a roderlo. Il suo corpo si gonfiava e abbondanti emorragie gli
sgorgavano dal naso. Sentendosi vicino alla fine, Adriano chiamò e adottò
come figlio, per prepararlo alla successione, il suo amico. Lucio Vero, che la
morte stroncò di lì a poco.
La scelta di Adriano cadde allora su Antonino, cui, mantenendo per sé il
titolo di Augusto, conferì quello di Cesare, che d'allora in poi fu adottato per
tutti gli eredi presuntivi al trono.
Le sue sofferenze erano così grandi, ch'egli non aspirava più che alla
tomba. Se la fece costruire di là dal Tevere con un ponte apposta, il ponte
Elio, per raggiungerla: ed è quel grande mausoleo, che oggi si chiama Castel
Sant'Angelo. Un giorno, quando l'edificio era già terminato, il filosofo
stoico Eufrate venne a chiedergli il permesso di uccidersi. L'imperatore
glielo diede, discusse con lui sull'inutilità della vita; e quando Eufrate ebbe
bevuto la cicuta, la chiese anche lui per seguirne l'esempio, ma nessuno
volle dargliela. La ordinò al suo medico; e questi, per non disobbedirgli, si
uccise. Pregò un servo di procurargli una spada o un pugnale; ma il servo
fuggì.
«Ecco qui un uomo», esclamò disperato, «che ha il potere di mettere a
morte chi vuole, salvo se stesso».
Finalmente, a sessantadue anni, dopo ventuno di regno, chiuse gli occhi.
Pochi giorni prima aveva composto un piccolo poema sulle memorie del
tempo che fu, che costituisce forse il più squisito capolavoro della lirica
latina: Animula vagula, blandula, hospes comesque corporis...
Con lui non morì soltanto un grande imperatore, ma anche uno dei più
complessi, inquietanti e cattivanti personaggi della storia di tutti i tempi e
forse il più moderno fra quelli del mondo antico. Come Nerva, si congedò
da Roma rendendole il più insigne dei servigi: quello di designare il
successore meglio qualificato a non farlo rimpiangere.
CAPITOLO DECIMO
MARC'AURELIO
IL titolo di Pio fu dato ad Antonino a posteriori dal Senato, che lo chiamò
anche Optimus princpeps, il migliore dei principi. Il suo successore Marco
Aurelio lo definì "un mostro di virtù" e, quando non sapeva che pesci
pigliare, raccomandava a se stesso: "Fa' come in questo caso avrebbe fatto
Antonino". Precetto, a dire il vero, più facile da enunciare che da seguire
perché il problema era appunto di sapere come avrebbe fatto Antonino.
Non era più giovanissimo quando nel 138 dopo Cristo salì sul trono,
perché aveva già passato la cinquantina. Eppure, se si fosse chiesto a uno
dei tanti romani che salutavano con gioia il suo avvento per quali ragioni
tutti n'erano così felici, lo si sarebbe messo in imbarazzo. Antonino, sino a
quel momento, non aveva fatto nulla d'insigne.
Era un bravo avvocato, ma, avendo piuttosto in uggia la retorica,
esercitava poco, e quel poco gratuitamente perché era ricchissimo. La sua
era una famiglia di banchieri venuta di Francia un paio di generazioni prima,
ed egli aveva ricevuto una educazione da grande borghese. Aveva studiato
filosofia, ma senza troppo addentrarcisi e sempre preferendo, come puntello,
la religione. Non era bigotto, ma rispettoso: forse fu uno degli ultimi romani
a credere sinceramente negli dèi, o per lo meno a comportarsi come se ci
credesse. Sapeva di letteratura e protesse molti scrittori, ma trattandoli un
po' dall'alto, con indulgente e aristocratico distacco, come elementi
decorativi della società da non prendersi troppo sul serio. Ma tutti gli
volevano bene e lo avevano in simpatia per la sua faccia paciosa e serena,
issata su due larghe spalle, per la sua gentilezza, per la sua sincera
partecipazione ai casi altrui, per la discrezione con cui seppe nascondere i
suoi senz'annoiare nessuno. Quest'uomo senza nemici ne ebbe uno in casa:
sua moglie. Faustina era bella, ma, a dir poco, vivace. Anche a far la tara su
quello che si diceva di lei, ne restava sempre di che mandare fuor dei
gangheri qualsiasi marito. Antonino volle ignorare tutto. Aveva avuto da lei
due figlie: una gli morì, l'altra aveva ripreso da sua madre e non
diversamente da lei trattò suo marito Marc'Aurelio. Antonino portò le sue
delusioni in silenzio. Quando morì Faustina, istituì in suo onore un tempio e
un fondo per l'educazione delle ragazze povere, dopo averla rimproverata
una sola volta in vita: quando lei, sapendosi imperatrice, aveva avanzato
alcune pretese di lusso. «Non ti rendi conto», le disse, «che ora abbiamo
perso quello che avevamo?».
Non era retorica, perché il primo gesto di Antonino imperatore fu quello
di versare la sua immensa fortuna privata nelle casse dello stato. Alla sua
morte il suo patrimonio personale era ridotto a zero, quello dell'Impero si
elevava a due miliardi e settecento milioni di sesterzi, cifra mai più
raggiunta. A questo risultato giunse con un'amministrazione giudiziosa, ma
senza taccagnerie. Rivide e ridusse il programma ricostruttivo di Adriano,
ma non lo revocò. E per ogni spesa, anche per la più trascurabile, chiedeva
l'autorizzazione del Senato, cui rendeva i conti sino al centesimo. Sempre
col suo consenso, condusse avanti il riordinamento e la liberalizzazione
delle leggi iniziati dal suo predecessore. Per la prima volta, i diritti e i doveri
dei coniugi furono parificati, la tortura quasi del tutto bandita e l'uccisione di
uno schiavo proclamata delitto.
Al contrario dell'inquieto e curioso Adriano, il gran bighellone, aveva un
temperamento sedentario, da burocrate ligio all'orario. E infatti non risulta
che si sia allontanato neanche per un giorno al di là di Lanuvio dove aveva
una villa e andava a passare il week-end pescando o cacciando in compagnia
di amici. Da quando era vedovo, si era preso una concubina, che gli fu più
fedele di quanto gli fosse stata la moglie. Ma la teneva in disparte, senza
mescolarla alle faccende di stato. Volle la pace. Forse la volle anche un po'
troppo: cioè a costo perfino del prestigio dell'Impero, per esempio in
Germania dove si mostrò eccessivamente arrendevole incoraggiando la
baldanza dei ribelli. Ma non c'è scrittore forestiero di quel tempo che non
abbia esaltato la tranquillità e l'ordine che il mondo godé sotto di lui. A
sentire Appiano, Antonino era addirittura assediato dagli ambasciatori di
tutti i paesi che chiedevano l'annessione all'Impero. Come tutti i regni felici,
quello suo, sebbene durato ventitre anni, fu senza storia, cioè senza eventi.
L'ideale, dice Renan, sembrava raggiunto: il mondo era governato da un
padre.
A settantaquattr'anni, forse per la prima volta in vita sua, Antonino cadde
ammalato. E, siccome non c'era avvezzo, sebbene si trattasse solo d'un mal
di pancia, capì ch'era finita. Egli aveva già il Cesare di ricambio: glielo
aveva indicato, morendo, lo stesso Adriano, nella persona di un
diciassettenne, Marco Aurelio, che di Antonino era anche nipote. Lo mandò
a chiamare e gli disse semplicemente: «Ora, figliolo, tocca a te». Poi ordinò
ai servi di portare nelle stanze di Marco la statua d'oro della dea Fortuna,
diede all'ufficiale di guardia la parola d'ordine per quel giorno:
«Equanimità», disse che lo lasciassero solo perché voleva dormire, si girò
dall'altra parte nel letto. E si addormentò davvero. Per sempre.
Marco aveva in quel momento, 161 dopo Cristo, quarant'anni esatti. Ed
era uno di quei rari uomini che, essendo nati con la camicia, lo riconoscono
lealmente. Ho un grosso debito, ha lasciato scritto, con gli dèi. Essi mi
hanno dato buoni nonni, buoni genitori, una buona sorella, buoni maestri e
buoni amici. Fra questi ultimi c'era stato anche Adriano che frequentava la
sua casa e lo aveva preso sin da piccolo in gran simpatia. La ragione di
questa amicizia era la comune origine spagnola. Anche gli Aureli venivano
di laggiù, dove si erano guadagnati il soprannome di "Veri" per la loro
onestà. Era stato il nonno, allora console, a occuparsi del ragazzo rimasto
orfano a pochi mesi; e che fiducia riponesse in quel nipotino lo dimostra il
numero di precettori che gli diede: quattro per la grammatica, sei per la
filosofia, uno per la matematica. Insomma, diciassette in tutto. Come abbia
fatto quel ragazzo a imparar qualcosa senza diventar matto, lo sa Iddio. Egli
predilesse, fra questi pedagoghi, Cornelio Frontone, il rètore, ma disprezzò
la sua disciplina. Il curialismo e l'oratoria erano quanto egli amava di meno
nei suoi concittadini. Viceversa si appassionò alla filosofia, preferì quella
stoica, e non solo volle studiarla a fondo, ma anche praticarla. A dodici anni
fece portar via dalla sua camera il letto, dormì sul nudo pavimento e si
attenne a tale dieta e astinenza che la sua salute alla fine ne risentì. Ma non
se ne dolse. Anzi ringraziò gli dèi anche di questo: di averlo mantenuto
casto fino ai diciotto anni e capace di reprimere gl'impulsi sessuali.
Forse sarebbe diventato addirittura un sacerdote dello stoicismo, e fra i più
puritani, come ne usava allora, se Antonino non lo avesse fatto Cesare
quand'era ancora adolescente e non se lo fosse associato al governo, dopo
averlo adottato insieme con Lucio Vero, il figlio di colui che Adriano aveva
nominato suo successore e che invece gli era premorto. Ma Lucio era di
tutt'altra stoffa: un uomo di mondo, donnaiolo e gaudente, che non se n'ebbe
punto a male quando Antonino più tardi lo escluse per designare come
Cesare il solo Marco. Costui ricordando i desideri di Adriano, chiamò
tuttavia Lucio a condividere il potere e gli diede in sposa sua figlia Lucilia.
Purtroppo, la lealtà in politica non è sempre buona consigliera.
Tutti i filosofi dell'Impero, quando Marco fu coronato, esultarono,
vedendo nel suo il loro trionfo e in lui il realizzatore dell'Utopia. Ma
sbagliarono. Marco, non fu un grande uomo di stato: non capiva nulla di
economia, per esempio, sbagliava i bilanci, e ogni tanto bisognava
riguardargli i conti. Ma dal tirocinio fatto sotto Antonino, l'illuminato
conservatore realista e un po' scettico, aveva tratto la sua lezione sugli uomini. Sapeva che le leggi non bastano a migliorarli, per cui tirò avanti la
riforma dei codici intrapresa dai suoi due predecessori, ma fiaccamente e
senza troppo credere ai suoi benefici. Da buon moralista, credeva di più
all'esempio, e cercò di darlo con la sua vita ascetica, che i sudditi
ammirarono, ma senza essere tentati d'imitarla.
Gli eventi non gli furono favorevoli. Era appena asceso al trono che i
britanni, i germani e i persiani, incoraggiati dall'arrendevolezza di Antonino,
cominciarono a minacciare i confini dell'Impero. Marco mandò in Oriente
con un esercito Lucio, che ad Antiochia trovò Pantea e ci si fermò. Era la
Cleopatra del luogo, e Lucio era un Marc'Antonio senza il coraggio e il
genio militare di costui. Quando vide quel po' po' di donna, perse
completamente la testa. Dicono che lei ne aiutò la smemoratezza con dei
filtri. Ma se era veramente bella come ce l'hanno descritta, dei filtri non
dovette averne nessun bisogno.
Marco non protestò contro il contegno di Lucio che seguitava a fare il
ganimede con Pantea, mentre i persiani scorrazzavano a loro piacere in
Siria. Si limitò a mandare discretamente un piano di operazioni al capo di
stato maggiore del suo socio, Avidio Cassio, con l'ordine di eseguirlo a
puntino. Era, dicono, un piano che rivelava un gran talento militare. Lucio
rimase a gavazzare ad Antiochia mentre il suo esercito batteva brillantemente i persiani, e non ne riprese il comando che per farsi incoronare
d'alloro il giorno del trionfo che Marco gli fece decretare. Purtroppo, con le
spoglie del nemico vinto, egli portava ai suoi concittadini un brutto regalo: i
microbi della peste. Fu un terribile flagello che uccise nella sola Roma oltre
duecentomila persone. Galeno, il più celebre medico del tempo, racconta
che i corpi dei malati erano squassati da una tosse rabbiosa, si riempivano di
pustole e il loro fiato puzzava. Tutta l'Italia ne fu contaminata, città e
villaggi rimasero disabitati, la gente affollava i santuari per invocare la
protezione degli dèi, nessuno più lavorava, e dietro l'epidemia si profilava la
carestia.
Marco non era più un imperatore, era un infermiere che non abbandonava
nemmeno per un'ora le corsie degli ospedali, ma la scienza a quei tempi non
offriva rimedi. A queste pubbliche calamità se ne aggiunsero per lui di
private. Faustina, la figlia che Antonino gli aveva dato in moglie,
somigliava in tutto e per tutto alla sua omonima mamma: nella bellezza,
nella gaiezza e nell'infedeltà. I suoi adulteri non sono provati, ma tutta
Roma ne parlava. Forse essa aveva delle attenuanti: quel marito ascetico e
malinconico, assorto nel suo sacerdozio di "primo servitore dello stato", non
era fatto per una donnina col pepe in corpo e piena di vita come lei. Gran
gentiluomo come il suo predecessore e suocero, Marco la colmò solo di
attenzioni e di tenerezza, non pronunciò una parola di deplorazione o di lamento, e anche nelle sue Meditazioni ringraziò gli dèi per avergli dato una
moglie così devota e affettuosa. Dei quattro figli nati da quel matrimonio,
una era morta, un'altra era diventata l'infelice moglie di Lucio, che si
comportò bene solo il giorno in cui si decise a lasciarla vedova, e quanto ai
due gemelli, di cui tutta Roma diceva che il vero padre era un gladiatore,
uno morì nascendo, e l'altro, che si chiamava Commodo, aveva ora sette
anni, era una meraviglia di bellezza atletica, già faceva disperare i suoi
istitutori per la sua renitenza allo studio e una sfrenata passione per il Circo
e la lotta con le belve. Quando si dice: il sangue... Ma Marco lo amava disperatamente.
Le decimazioni della pestilenza e la carestia avevano fatto di Roma una
città cupa e sfiduciata. Già vecchio prima della cinquantina in mezzo a tanti
triboli, il galantuomo Marco, roso dall'insonnia e dall'ulcera di stomaco, non
faceva in tempo a riparare un guaio che un altro ne cominciava. Ora erano le
tribù germaniche che dilagavano verso l'Ungheria e la Romania. Quando
Marco si mise personalmente alla testa delle legioni, molti sorrisero:
quell'omino fragile e macilento, costretto a una dieta vegetariana, non dava
affidamento come trascinatore d'uomini. E invece poche volte i legionari
avevano combattuto con tanto impeto come fecero sotto il suo diretto
comando. Quest'uomo di pace fece la guerra, per sei anni, battendo uno
dopo l'altro i più aggressivi nemici: i quadi, i longobardi, i marcomanni, i
sarmati. Ma quando, dopo una giornata di battaglia, si ritrovava solo con se
stesso, sotto una tenda di semplice soldato, apriva il quaderno delle
Meditazioni e scriveva: Un ragno, quando ha catturato una mosca, crede di
aver fatto chissacché. E così crede chi ha catturato un sarmato. Né l'uno né
l'altro si rendono conto di essere soltanto due piccoli ladri. Però il giorno
dopo ricominciava a combattere contro i sarmati.
Stava coronando in Boemia un brillante seguito di vittorie, quando Avidio
Cassio, generale in Egitto, si ribellò proclamandosi imperatore. Era l'ex capo
di stato maggiore di Lucio, che col piano di Marco aveva battuto i persiani.
Marco concluse una rapida e generosa pace coi suoi avversari, riunì i
soldati, disse loro che, se Roma lo voleva, volentieri si sarebbe ritirato per
lasciare il suo posto al concorrente, e tornò indietro. Ma il Senato rifiutò
all'unanimità e, mentre Marco muoveva incontro a Cassio, "questi fu ucciso
da un suo ufficiale. Marco rimpianse di non aver potuto perdonarlo, si fermò
ad Atene per uno scambio di vedute coi maestri delle varie scuole
filosofiche locali e, tornato a Roma, subì a malincuore il trionfo che gli
tributarono e vi associò Commodo, che ormai era celebre per le sue gesta di
gladiatore, per la sua crudeltà, e per il suo vocabolario da bassofondo.
Forse anche per distrarre quel ragazzo dalle sue malsane passioni, riprese
subito dopo la guerra contro i germani, conducendoselo dietro. E di nuovo
fu alle soglie della vittoria definitiva, quando a Vienna cadde malato, cioè
più malato del solito. Per cinque giorni, rifiutò di mangiare e di bere. Al
sesto, si alzò, presentò Commodo, come nuovo imperatore, alla truppa
schierata, gli raccomandò di portare i confini di Roma fino all'Elba, tornò a
letto, si coprì il volto col lenzuolo e attese la morte.
Le Meditazioni ch'egli compose in greco sotto la tenda sono giunte fino a
noi. Esse non rappresentano un gran documento letterario, ma contengono il
più alto codice morale che ci abbia lasciato il mondo classico. Proprio nel
momento in cui la coscienza di Roma si spegneva, essa trovava in questo
imperatore il suo più luminoso barbaglio.
CAPITOLO UNDICESIMO
I SEVERI
NEL presentarlo ai soldati come suo successore, Marco aveva chiamato
Commodo "il sole nascente". E forse i suoi occhi di babbo (se lo era) lo
vedevano così. Ma anche ai legionari quel ragazzo manesco, di pochi
scrupoli, di appetito gagliardo e di turpiloquio pronto, piacque. Lo credevano più militaresco di suo padre.
Grandi furono quindi il loro stupore e malumore quando il giovanotto,
invece di liquidare il nemico già intrappolato in una "sacca", gli offrì la più
sconsiderata e frettolosa delle paci. Per due volte un miracolo interveniva a
salvare quei turbolenti germani: un miracolo di cui Roma doveva fare più
tardi le spese.
Commodo non era un codardo, ma la sola guerra che amava era quella
contro i gladiatori e le belve nel Circo. Alzandosi, rifiutava la colazione
prima di aver scannato la sua tigre quotidiana. E siccome di tigri in
Germania non ce n'era, aveva furia di tornare a Roma, dove dall'Oriente i
governatori erano incaricati di mandarne a branchi. Per questo,
infischiandosi dell'Impero e dei suoi destini, stipulò quella rovinosa pace
che lasciava insoluti tutti i problemi. Il Senato rinunziò al suo diritto elettivo
attraverso l'adozione che da Nerva in poi aveva dato sì buoni frutti, e accettò
il ripristino, che quell'imperatore incarnava, del principio ereditario.
Come per Nerone e Caligola, anche a voler fare un po' di ribasso su quello
che i contemporanei hanno scritto di lui, ce n'è d'avanzo per catalogare
Commodo fra le pubbliche iatture. Giocatore e bevitore, con un serraglio,
dicono, di centinaia di ragazze e giovanotti per i suoi piaceri, pare che abbia
avuto un affetto solo: quello per una certa Marzia, che, essendo cristiana,
non si capisce come conciliasse la sua fede austera con quell'amante
debosciato, ma che tuttavia fu utile ai suoi correligionari salvandoli da una
probabile persecuzione.
Il peggio cominciò quando alcuni delatori denunziarono a Commodo una
congiura capeggiata da sua zia Lucilia, la sorella di suo padre. Senza curarsi
di prove, la uccise, e fu l'inizio di un nuovo terrore che venne dato in appalto
a Cleandro, il capo dei pretoriani. Per la prima volta dopo Domiziano, Roma
cominciò a tremare sotto i soprusi di queste guardie. Un giorno la
popolazione, più per paura che per coraggio, le assediò nel Palazzo e chiese
la testa di Cleandro. Commodo gliela diede senza esitare, sostituendo la
vittima con Leto, un uomo accorto, il quale si rese subito conto che, una
volta salito a quel posto, o si faceva uccidere dal popolo per compiacere
all'imperatore, o si faceva uccidere dall'imperatore per compiacere al
popolo. Per sfuggire a questo dilemma, c'era un'altra via sola: uccidere lui,
l'imperatore. E la scelse con la complicità di Marzia, di cui anche in questa
occasione discerniamo male la cristianità, e che propinò a Commodo una
bevanda avvelenata. Lo finirono strangolandolo nel bagno perché il
giovanotto, appena trentenne, era duro a morire.
Era il 31 dicembre del 192 dopo Cristo. Cominciava la grande anarchia.
I senatori, felici per la morte di Commodo, agirono come se ne fossero
stati essi gli autori, eleggendo a successore un loro collega, Pertinace, che
non voleva saperne e aveva ragione. Per rimettere in sesto le finanze,
dovette fare economia; e per fare economia, dovette licenziare molti
profittatori, fra cui i pretoriani. Dopo due mesi di governo in questo senso,
lo trovarono morto, ucciso dalle sue guardie, le quali annunziarono che il
trono era all'asta: vi sarebbe salito chi offriva loro la mancia più alta.
Un banchiere miliardario di nome Didio Giuliano stava tranquillamente
mangiando nel suo palazzo, quando la moglie e la figlia, ch'erano piene di
ambizioni, gli buttarono addosso la toga ordinandogli di precipitarsi a
concorrere. Riluttante, ma temendo più le sue donne che le incognite del
potere, Didio offrì ai pretoriani tre milioni a testa (doveva averne, oh!), e
vinse.
Il Senato era caduto in basso, ma non sino al punto d'inghiottire un simile
mercato. Spedì segretamente disperate richieste di aiuto ai generali dislocati
in provincia, e uno di costoro, Settimio Severo, venne, vide, promise il
doppio di quel che aveva dato Giuliano, e vinse. Il banchiere piangeva,
rinchiuso in una stanza da bagno, dove lo decapitarono. Sua moglie rimase
vedova, ma si consolò col titolo di ex imperatrice.
Per la prima volta, con Settimio, saliva al trono un africano di origine
ebrea. Roma non se l'era scelto; anzi, il Senato si dichiarò per un altro
generale, Albino. Ma non se ne trovò male, quando Settimio ebbe vinto la
partita, messo a morte i suoi oppositori e trasformato definitivamente il
Principato in una monarchia ereditaria di stampo militare. Era triste che si
fosse arrivati a questo punto. Ma, una volta arrivatici, e non certo per colpa
di Settimio, costui non poteva agire diversamente. Ci voleva una mano di
ferro per indigare la catastrofe, e Settimio la ebbe. Era un bell'uomo sulla
cinquantina, robusto, eccellente stratega, conversatore spiritoso, ma co-
mandante di pochi spiccioli. Veniva da una famiglia benestante, aveva
studiato filosofia ad Atene e diritto a Roma, ma parlava il latino con un forte
accento fenicio. Non aveva certo la stoffa morale di un Antonino o di un
Marc'Aurelio, né la complessità intellettuale di un Adriano. Era anzi un
cinico, ma diritto e onesto, col senso chiaro della realtà. L'unica sua
bizzarria era l'astrologia, cui doveva un matrimonio che a Roma non portò
fortuna. Si trovava in Siria, quando gli morì la prima moglie, ch'era una
brava e semplice donna. Il vedovo, che subito interrogò gli astri, seppe che
uno di essi, un meteorite probabilmente, era caduto nei pressi di Emesa. Vi
andò, e su quel frammento di cielo trovò eretto un tempio, dove se ne
venerava la reliquia, accudita da un prete e da sua figlia, Giulia Donna, che,
oltre tutto, era anche un fior di ragazza. Vedendola, fu facile a Settimio
convincersi ch'era quella la sposa che gli astri gli ordinavano. E fin qui,
nulla di male. Diventata imperatrice, Giulia fece parecchi torti a suo marito,
che aveva troppo daffare per avvedersene. E anche questa fu una sciagura,
sì, ma di carattere soltanto privato. Era una donna intelligente e colta, che
riunì un salotto letterario e vi portò i modi e le mode dell'Oriente. Purtroppo
però mise al mondo Caracalla e Geta.
Settimio governò diciassette anni, rivolgendosi al Senato solo per
impartirgli ordini, e quasi sempre guerreggiando. Egli introdusse una grande
e pericolosa novità: il servizio militare obbligatorio per tutti, ad eccezione
degli italiani, ai quali era invece proibito. Era il riconoscimento della
decadenza guerriera del nostro paese e della sua irrimediabilità. D'ora in poi
esso era in balìa di legioni straniere. Con esse, Settimio combattè un seguito
di guerre fortunate, non solo per rinforzare i confini, ma anche per tenere in
allenamento le guarnigioni. E ne stava portando a compimento una
ennesima, quando la morte lo sorprese in Britannia nel 211 dopo Cristo.
Colui che aveva criticato Marc'Aurelio per aver designato a successore
Commodo, designò Caracalla e Geta. Perché era un babbo anche lui, o
perché non conosceva i suoi figli, dai quali era sempre stato lontano? Forse
perché non gliene importava nulla. A un suo luogotenente disse: «Sono diventato tutto quel che ho voluto. E mi accorgo che non ne valeva la pena». E
ai suoi due eredi raccomandò: «Non lesinate quattrini ai soldati e
infischiatevi sempre di tutto il resto».
Raccomandazione superflua: Caracalla e Geta talmente s'infischiavano di
tutto il resto, da includervi anche il loro padre, e ordinarono ai medici di
affrettarne il trapasso.
Dei due, il primo fu il Commodo di turno, e non tardò a dimostrarlo.
Seccato di dover dividere il potere con suo fratello, lo fece assassinare,
condannò a morte ventimila cittadini sospetti di parteggiare per lui e,
memore delle istruzioni impartitegli da suo padre, placò i malumori dei
soldati riempiendogli le tasche di sesterzi. Non era un ragazzo sprovveduto;
era, semplicemente, un amorale. Ogni mattina, alzandosi, voleva un orso
vivo con cui misurarsi per tenere i muscoli in esercizio, a tavola sedeva con
una tigre per commensale, e si coricava con un leone dormendo fra le sue
zampe. Non riceveva i senatori che affollavano la sua anticamera, ma era
cordiale coi soldati e li colmava di favori. Estese la cittadinanza a tutti i
maschi dell'Impero, ma solo per aumentare il gettito delle tasse di
successione, cui solo i cittadini erano astretti.
Di politica si occupava poco. Preferiva lasciarla a sua madre che se
n'intendeva, ma naturalmente la faceva da donna, cioè basandosi sulle
simpatie e antipatie. Era lei che sbrigava la corrispondenza e riceveva in
udienza ministri e ambasciatori. A Roma dicevano che si era procacciata
questa posizione di favore cedendo alle incestuose voglie di suo figlio.
Probabilmente non era vero. Caracalla da questo lato era abbastanza serio, e
la sua unica vera passione erano le guerre e i duelli. Un giorno qualcuno gli
parlò di Alessandro il Grande. Egli se n'entusiasmò e volle imitarlo. Reclutò
una "falange" armata come quelle dell'eroe, mosse verso la Persia, ma nelle
battaglie si dimenticava di essere il generale perché si divertiva di più a fare
il soldato e a provocare il nemico in singoli corpo a corpo. Finché un giorno
i legionari, stanchi di quel marciare e di quel guerreggiare senza capo né
coda, senza programmi e soprattutto senza bottino, lo pugnalarono.
Giulia Donna, deportata ad Antiochia dopo aver perso tutto, marito, trono
e figli, rifiutò di mangiare finché morì. Ma si lasciò dietro una sorella,
Giulia Mesa, che la valeva come cervello e ambizione. Essa aveva due
nipoti, figli di due sue figlie: uno si chiamava Vario Avito e faceva, con lo
pseudonimo di Elio-gabalo, che vuol dire dio-sole, il prete a Emesa, donde
la famiglia dell'imperatrice era originaria; l'altro si chiamava Alessiano, ed
era ancora bambino.
Mesa sparse la voce che Eliogabalo era figlio naturale di Caracalla, e i
legionari, che laggiù in Siria si erano convertiti alla religione locale e
rispettavano in quel chierichetto quattordicenne il rappresentante del
Signore, lo proclamarono imperatore e lo condussero trionfalmente a Roma,
con la nonna e la madre.
Un giorno di primavera del 219 dopo Cristo, l'Urbe vide arrivare il più
strano degli Augusti: un ragazzo tutto vestito di seta rossa, le labbra tinte di
rossetto, le ciglia ripassate con l'henné, una fila di perle al collo, braccialetti
di smeraldi ai polsi e alle caviglie, e una corona di diamanti in testa. Ma lo
acclamò ugualmente. Oramai nessuna mascheratura la scandalizzava più.
Ancora una volta il vero imperatore fu una donna: nonna Mesa, la sorella
di quella precedente. Per Eliogabalo il trono era un balocco, e lo usò come
tale. Nella sua infantile innocenza, quel ragazzetto era anche simpatico
come un cucciolone. Il suo piacere preferito era quello di fare scherzi a tutti,
ma innocenti: tombole e lotterie con la sorpresa, burle, giuochi di carte. Ma
era anche un sibarita, voleva il meglio di tutto, e ci spendeva cappellate di
quattrini. Non viaggiava con meno di cinquecento carri al seguito, e per una
boccetta di profumo era pronto a pagare milioni. Quando un indovino gli
disse che sarebbe morto dì morte violenta, vuotò le casse dello stato per
provvedersi di tutti i più raffinati strumenti di suicidio: una spada d'oro, un
armamentario di corde di seta, scatole tempestate di brillanti per la cicuta.
Ogni tanto, ricordando i suoi trascorsi sacerdotali, aveva crisi mistiche. Un
giorno si circoncise, un altro tentò di evirarsi, un altro ancora si fece spedire
da Emesa il famoso meteorite del suo bisnonno materno, vi fece costruire
sopra un tempio e propose agli ebrei e ai cristiani di riconoscere la loro
religione come quella di stato, se gli uni accettavano di sostituire Jeovah e
gli altri Gesù con quella sua pietruzza.
Nonna Mesa capì che quel nipotino metteva in pericolo la dinastia. Lo
persuase a adottare il cuginetto Alessiano e a nominarlo Cesare con
l'imponente nome di Marco Aurelio Severo Alessandro. E con la
disinvoltura ch'era una caratteristica della famiglia, lo fece uccidere con sua
madre, ch'era poi sua figlia.
È curioso veder nascere, da un così orrendo massacro, il regno di un santo,
Alessandro Severo, che aveva quattordici anni, faceva onore al suo nome:
aveva studiato con diligenza, dormiva su un duro giaciglio, mangiava
sobriamente, prendeva la doccia fredda anche d'inverno, si vestiva come uno
qualunque, e del suo predecessore aveva ereditato una cosa sola:
l'imparzialità verso tutte le religioni, con pronunciate simpatie per la regola
morale degli ebrei e dei cristiani. Il loro precetto: "Non fare agli altri ciò che
non vuoi che sia fatto a te", fu da lui scolpito su molti pubblici edifici.
Discuteva imparzialmente coi teologi, ed anche su pressione della madre
Mammea, che aveva preso il posto di Mesa ormai morta, e propendeva
verso il cristianesimo, ebbe un debole per Origene, un asceta che portava
nella nuova fede una vocazione di stoico.
Mentre Alessandro si occupava soprattutto del Cielo, Mammea governava
bene la terra, assistita dai consigli di Ulpiano, che di Alessandro era stato il
tutore. Essa condusse un'abile politica economica, ridusse le influenze dei
militari e ridiede al Senato parte dei suoi poteri. Ingiustizie ne commise solo
verso la nuora perché, dopo averla data in sposa a suo figlio, se ne ingelosì e
la fece bandire. Anche le imperatrici son donne e mamme. Ma quando i
persiani ricominciarono a minacciare, essa partì con suo figlio alla testa
dell'esercito per respingerli. Alessandro, prima di ingaggiare battaglia,
mandò al re nemico una lettera in cui cercava di convincerlo a non farla.
L'altro la prese come un segno di debolezza, attaccò e fu battuto.
L'imperatore, che non amava la guerra, cercò di evitare almeno quella coi
germani. E, incontratine in Gallia gli emissari, offrì loro un tributo annuo se
accettavano di ritirarsi.
Fu forse il suo unico sbaglio, e lo pagò caro. I legionari non erano più
ansiosi di battaglie, ma non erano ancora pronti a comprarsi le paci. Indignati, si ribellarono, uccisero Alessandro sotto la tenda con la madre e
tutto il seguito, e acclamarono imperatore il generale dell'esercito di
Pannonia, Giulio Massimino.
Correva l'anno 235 dopo Cristo.
CAPITOLO DODICESIMO
DIOCLEZIANO
L'ANARCHIA che seguì la morte di Alessandro Severo durò cinquant'anni,
cioè fino all'avvento di Diocleziano, e già non fa più parte della storia di
Roma, ma della decomposizione del suo cadavere. Diventa perfino difficile
seguire la successione al trono, e non c'è speranza che il lettore, per quanto
volenteroso, possa ricordare i nomi di tutti coloro che vi si diedero il
cambio, ognuno sgozzando regolarmente il suo predecessore. Limitiamoci a
un "promemoria".
Massimino si sarebbe dovuto chiamare Massimone perché era alto più di
due metri, con un torace in proporzione e delle dita così grosse che usava
come anelli i braccialetti di sua moglie. Era figlio di un contadino della
Tracia, aveva il complesso d'inferiorità della propria ignoranza, e nei suoi
tre anni di regno non volle mettere piede a Roma che infatti non lo vide mai.
Preferì restare tra i soldati in mezzo ai quali era cresciuto, e per finanziare le
guerre, che costituivano il suo solo divertimento e nelle quali riusciva
benissimo, impose tali tasse ai ricchi che costoro gli aizzarono contro la
rivalità di Gordiano, proconsole in Africa, signore colto e raffinato, ma già
ottantenne. Massimino gli uccise il figlio in battaglia, e Gordiano si suicidò.
I capitalisti si rivolsero allora a Massimo e a Balbino, proclamandoli
congiuntamente imperatori. Massimino stava per batterli ambedue, quando
fu assassinato dai suoi soldati. I suoi avversari non poterono godere di quel
gratuito trionfo perché ne seguirono immediatamente la sorte ad opera dei
pretoriani, che sul trono installarono il loro uomo, un altro Gordiano. I legionari lo uccisero mentre li guidava contro i persiani, e acclamarono
Filippo l'Arabo, che a sua volta fu accoppato da Decio a Verona.
Decio riuscì a restare imperatore due anni, che per quei tempi era quasi un
primato, e mise in cantiere alcune serie riforme, tra cui il ripristino
dell'antica religione a danno del Cristianesimo che egli voleva distruggere.
Ma fu sconfitto e ucciso dai goti, sostituito da Gallo che venne assassinato
dai suoi soldati, i quali acclamarono Emiliano e pochi mesi dopo
accopparono anche questo.
Sul trono salì Valeriano, già sessantenne, che si trovò con cinque guerre
contemporanee sul gobbo, contro i goti, gli alemanni, i franchi, gli sciti e i
persiani. Andò a combattere i nemici d'Oriente, lasciando quelli d'Occidente
alle cure di suo figlio Gallieno; ma cadde prigioniero, e Gallieno diventò
unico imperatore. Aveva meno di quarant'anni, coraggio, decisione e
intelligenza. In altri tempi sarebbe stato un magnifico sovrano. Ma non c'era
ormai più forza umana che potesse arginare la catastrofe. I persiani erano in
Siria, gli sciti in Asia Minore, i goti in Dalmazia. La Roma di Cesare, per
non dire quella di Scipione, avrebbe potuto far fronte a queste simultanee
catastrofi. Quella di Gallieno era un rottame alla deriva, in attesa solo di
qualche miracolo per salvarsi.
Uno ne avvenne in Oriente, quando Odenato, che governava Palmira per
conto di Roma, battè i persiani, si proclamò re di Cilicia, Armenia e
Cappadocia, morì, e lasciò il potere a Zenobia, la più grande regina dell'Est.
Era una creatura che, nascendo, aveva sbagliato sesso. In realtà aveva il
cervello, il coraggio, la fermezza di un uomo. Della donna, aveva solo la
sottigliezza diplomatica. Ufficialmente, essa agì in nome di Roma, e come
sua rappresentante si annetté anche l'Egitto. In realtà il suo fu un regno
indipendente che si formò nel cuore dell'Impero, ma che nello stesso tempo
fece diga contro gli invasori sarmati e sciti che calavano in massa dal Nord e
avevano già sommerso la Grecia. Gallieno riuscì faticosamente a batterli, e i
suoi soldati, per ringraziamento, lo uccisero. Il suo successore, Claudio II,
se li ritrovò di fronte più forti di prima.
Anche lui riuscì faticosamente a batterli in uno scontro che, se lo avesse
perso, avrebbe significato la fine della stessa Roma. Ma da quella carneficina si sviluppò la peste, ed egli stesso morì. Era il 270 dopo Cristo.
Ed ecco finalmente salire al trono un grande generale, Domizio Aureliano,
figlio di un povero contadino dell'Illiria, e chiamato dai suoi soldati "mano
sulla spada". Non aveva fatto che il militare, ma aveva la stoffa anche
dell'uomo di stato. Capì subito che contro tutti quei nemici insieme non
poteva combattere, per cui pensò di guadagnarsene qualcuno con la
diplomazia e cedette la Dacia ai goti, che erano i più pericolosi, per tenerli
tranquilli. Poi attaccò separatamente vandali e alemanni, che già invadevano
l'Italia, e li disperse in tre battaglie consecutive.
Ma si rendeva conto che la catastrofe, con queste vittorie, era ritardata,
non evitata, e per questo ricorse a una misura ch'era già il sigillo della morte
di Roma e l'inizio del Medio Evo: ordinò a tutte le città dell'Impero di
circondarsi di mura e di fare assegnamento, d'ora in poi, ciascuna sulle
proprie forze. Il potere centrale abdicava.
Eppure, questa visione pessimistica della realtà non impedì a Aureliano di
continuare a fare il suo dovere sino in fondo. Egli non accettò il separatismo
di Zenobia, mosse contro di lei, ne batté l'esercito, la catturò nella sua stessa
capitale, ne mise a morte il primo ministro e consigliere, Longino, la
condusse a Roma in catene e la confinò a invecchiare tranquillamente a
Tivoli in una splendida villa e in una relativa libertà. Per un momento Roma
credette di essere ridiventata caput mundi e attribuì il titolo di Restitutor,
restauratore, a Aureliano, che tentò di impiantare stabilmente questa sua
opera su basi anche politiche e morali. Questo curioso uomo, che vedeva
tutto con sì disincantata chiarezza, pensò di risolvere il conflitto religioso
che rodeva l'Impero creando; una nuova fede che conciliasse i vecchi dèi
pagani col nuovo Dio cristiano, e inventò quella del Sole, cui fece costruire
uno splendido tempio. Per la prima volta con lui la religione ufficiale fu
monoteista, cioè riconobbe un solo dio, sebbene non fosse quello giusto. E
fu un gran passo avanti verso il definitivo trionfo del Cristianesimo. Da
questo unico dio, e non più dal Senato, cioè dagli uomini, Aureliano
dichiarò di essere stato investito del supremo potere. E con ciò sancì il
principio della monarchia assoluta, quella che si proclama tale appunto "per
grazia di Dio" e che, di origine orientale, si è poi perpetuata nel mondo fino
a un secolo fa.
A provare tuttavia con quanto scetticismo i suoi sudditi accogliessero
questa invenzione, sta il fatto che, per quanto "unto del Signore", essi
accopparono Aureliano come avevano fatto con quasi tutti i suoi
predecessori. E al suo posto, senza aspettare nessuna indicazione del Cielo,
il Senato nominò Tacito, un discendente dell'illustre storico, il quale accettò
solo perché aveva ormai settantacinque anni, e quindi non aveva più nulla
da perdere. Infatti sopravvisse sei mesi soli, e sol per questo poté morire nel
suo letto.
Gli successe (276 dopo Cristo), Probo, che era tale di nome e di fatto.
Purtroppo, era anche un sognatore. E quando, dopo aver vinto le sue brave
guerre contro i tedeschi che seguitavano a straripare un po' dovunque, mise i
soldati a bonificare le terre pensando di fissarveli come contadini, costoro,
ormai abituati a fare i lanzichenecchi di mestiere e a vivere di rapina, lo
uccisero sia pure per pentirsene subito dopo ed elevare un monumento alla
sua memoria.
Ed eccoci a Diocleziano, l'ultimo vero imperatore romano. In realtà si
chiamava Dioclete, era il figlio di un liberto dalmata, e che le sue mire
fossero ambiziose lo si vide quando brigò per ottenere il comando dei
pretoriani: aveva compreso finalmente che al trono si arrivava non attraverso la carriera politica o militare, ma attraverso i corridoi di Palazzo.
Ma aveva compreso anche che, una volta coronati, nel Palazzo non
bisognava restare, per non farvi la fine di tutti gli altri; anzi non bisognava
restare addirittura a Roma. E infatti la sua prima decisione, come
imperatore, fu quella, sensazionale, di trasferire la capitale in Asia Minore, a
Nicomedia. I romani furono offesi, ma Diocleziano giustificò questo passo
con le esigenze militari. L'Urbe era fuori mano, il comando supremo doveva
avvicinarsi alle frontiere per controllarle meglio, e per questo venne diviso:
Diocleziano, col suo titolo di Augusto e la parte maggiore dell'esercito, badò
a quelle orientali, come già aveva fatto Valeriano; per badare a quelle
occidentali egli designò, col titolo di Augusto anche lui, Massimiano, un
bravo generale, che si installò a Milano. Ognuno di questi Augusti si scelse
il proprio Cesare: Diocleziano nella persona di Galerio, che pose la sua
capitale a Mitrovizza, nell'attuale Jugoslavia; Massimiano in quella di
Costanzo Cloro, detto così dal pallore del suo volto, che si scelse come sede
Treviri in Germania. Così si formò la cosiddetta Tetrarchia in cui Roma non
ebbe nessuna parte, nemmeno di secondo piano. Essa era diventata soltanto
la più grande città di un Impero che si faceva sempre meno romano. Vi
rimasero i teatri e i circhi, i palazzi dei signori, i pettegolezzi, i salotti intellettuali, e le pretese. Ma il cervello e il cuore erano emigrati altrove.
I due Augusti s'impegnarono solennemente ad abdicare dopo vent'anni di
potere in favore ciascuno del proprio Cesare, cui cominciarono col dare in
sposa ognuno la propria figlia. Ma nello stesso tempo Diocleziano condusse
a termine la riforma assolutista dello stato già iniziata da Aureliano, che
contraddiceva in pieno a quella divisione di poteri. Il suo fu un esperimento
socialista con relativa pianificazione dell'economia, nazionalizzazione delle
industrie e moltiplicazione della burocrazia. La moneta fu vincolata a un
tasso d'oro che rimase invariato per oltre mille anni. I contadini furono
fissati al suolo e costituirono la "servitù della gleba". Operai e artigiani
vennero "congelati" in corporazioni ereditarie, che nessuno aveva il diritto
di abbandonare. Furono istituiti gli "ammassi". Questo sistema non poteva
funzionare senza un severo controllo sui prezzi. Esso fu istituito con un
famoso editto del 301 dopo Cristo, che tuttora rappresenta uno dei
capolavori della economia controllata. Tutto vi è previsto e regolato, salvo
la naturale tendenza degli uomini alle evasioni e la loro ingegnosità per
riuscirvi. Per combatterle, Diocleziano dovette moltiplicare all'infinito la sua
Tributaria. «In questo nostro Impero», brontolava il liberista Lattanzio, « di
due cittadini, uno è regolarmente funzionario». Confidenti, sovrintendenti e
controllori pullulavano. Eppure le merci venivano ugualmente sottratte agli
ammassi e vendute alla borsa nera, e le diserzioni nelle corporazioni di arti e
mestieri erano all'ordine del giorno. Piovvero gli arresti e le condanne per
questi abusi, patrimoni di miliardi furono distrutti dalle multe del fisco. E
allora, per la prima volta nella storia dell'Urbe, si videro dei cittadini romani
attraversare di nascosto i limites dell'Impero, cioè la "cortina di ferro" di
quei tempi, per cercar rifugio tra i "barbari". Sino a quel momento erano
stati i "barbari" a cercar rifugio nelle terre dell'Impero agognandone la
cittadinanza come il più prezioso dei beni. Ora avveniva il contrario. Era
proprio questo il sintomo della fine.
Eppure, questo esperimento era l'unico che Diocleziano poteva tentare.
Esso mirava all'ingabbiamento del mondo romano dentro un busto d'acciaio
per frenarne la decomposizione. Per quanto inefficace, il rimedio era
imposto dalle circostanze e, nonostante i suoi molti inconvenienti, a
qualcosa servì. Costanzo e Galerio, addetti alla guerra, riportarono le
bandiere romane in Britannia e in Persia. E all'interno l'ordine regnò. Era un
ordine da cimitero, dove tutto si isteriliva e disseccava. Ogni categoria era
diventata una casta ereditaria, intesa ad elaborare soprattutto una propria
complicata etichetta di modello orientale. Per la prima volta l'imperatore
ebbe una vera e propria corte con un minuzioso cerimoniale. Diocleziano si
proclamò una reincarnazione di Giove (mentre Massimiano si contentò più
modestamente di esserlo di Ercole), inaugurò una uniforme di seta e d'oro,
un po' come Eliogabalo, si fece chiamare Domino e, insomma, si comportò
in tutto come un imperatore bizantino, prima ancora che la capitale si fosse
trasferita definitivamente da quelle parti. Ma non abusò di questo suo potere
assoluto, del quale forse fra sé e sé rideva perché era un uomo di spirito,
pieno di equilibrio e di buon senso. Fu un amministratore oculato, un
giudice imparziale. E, allo scadere dei vent'anni di regno, mantenne
l'impegno che aveva assunto salendo al trono.
Nel 305 dopo Cristo, con solenne cerimonia che si tenne
contemporaneamente a Nicomedia e a Milano, i due Augusti abdicarono in
favore ciascuno del proprio Cesare e genero. Diocleziano, appena
cinquantacinquenne, si ritirò nel bellissimo palazzo che si era fatto costruire
a Spalato e non ne uscì più. Quando, alcuni anni dopo, Massimiano sollecitò
il suo intervento per porre fine alla guerra di successione in cui era sboccata
la nuova Tetrarchia, rispose che un simile invito poteva venirgli solo da chi
non aveva mai visto con che rigoglio crescevano i cavoli nel suo orto. E non
si mosse.
Campò fino a sessantatre anni, e nessuno ha mai saputo cosa pensasse
dell'anarchia ricominciata dopo di lui. Egli aveva fatto tutto quello che un
uomo poteva fare: l'aveva ritardata di vent'anni.
CAPITOLO TREDICESIMO
COSTANTINO
FLAVIO VALERIO COSTANTINO era figlio bastardo di Costanzo Cloro, il
Cesare di Massimiano, e ora nuovo Augusto di Milano, che l'aveva avuto da
Elena, una cameriera orientale diventata sua concubina. Diocleziano, nel
nominare Cesare, a Treviri, Costanzo, gli aveva imposto di liberarsi di
quella compagna poco qualificata e di sposare Teodora, la figlia di
Massimiano. Il ragazzo non aveva avuto una buona educazione dalla matrigna, ma se l'era fatta da solo al reggimento, dove si era arruolato
giovanissimo. L'altro Augusto, Galerio, quello di Nicomedia, chiamò a sé il
brillante ufficiale: gli premeva tenerlo come ostaggio in caso di dissapori col
padre, il suo collega di Milano, che in realtà doveva restare suo subordinato,
e cui aveva imposto, come Cesare, Severo. Per sé si era preso Massimino
Daza.
Ma Costantino, al quartier generale di Galerio, non si sentiva tranquillo, e
forse ne aveva fondati motivi. Per cui un bel giorno fuggì, attraversò tutta
l'Europa, raggiunse suo padre in Bretagna, lo aiutò validamente a vincere alcune battaglie e gli chiuse gli occhi pochi mesi dopo a York. I soldati, che
gli erano affezionati per le sue alte qualità di comando, lo acclamarono
Augusto. Ma Costantino preferì il più modesto titolo di Cesare, « perché»,
disse, « questo mi lascia il comando delle legioni senza le quali la mia vita
sarebbe in pericolo». E Galerio, Augusto in carica, sia pure controvoglia, lo
ratificò.
Ma intanto il titolo di Augusto, a Milano, era in palio fra due concorrenti.
In linea di principio, sarebbe dovuto toccare a Severo, il Cesare in carica.
Ma il figlio di Massimiano, Massenzio, avanzò la sua candidatura, sostenuto
dai pretoriani. Temendo di non farcela da solo, egli chiamò in aiuto suo
padre che riprese la carica cui aveva abdicato insieme con Diocleziano; e
con lui marciò contro Severo, che fu ucciso dai soldati. Da Nicomedia,
Galerio tentò di risolvere il conflitto nominando un Augusto a capocchia
sua, Licinio. Allora anche Costantino scese in campo come Augusto. Per
portare al colmo il caos, Massimino Daza, il Cesare di Galerio, fece
altrettanto. E così Diocleziano, annaffiando i suoi cavoli a Spalato, seppe
che la sua Tetrarchia era diventata una Esarchia, tutta di Augusti in guerra
l'uno con l'altro.
Onestamente, non ci sentiamo di confondere ancora di più la testa del
povero lettore, già messa a dura prova, come quella nostra, da un simile
intreccio, seguendone gli sviluppi. E veniamo alla conclusione, che fu anche
la fine dell'età pagana e l'inizio di quella cristiana. Il 27 ottobre 312 dopo
Cristo i due maggiori aspiranti al trono, Costantino e Massenzio, si
trovarono di fronte coi loro eserciti, una ventina di chilometri a nord di
Roma. II primo, con abile manovra, addossò il secondo al Tevere. Poi
Costantino guardò il cielo e più tardi raccontò allo storico Eusebio di averci
visto apparire una croce fiammeggiante che recava iscritte queste parole: In
hoc signo vinces, "In questo segno vincerai".
Quella notte, mentre dormiva, una voce gli rimbombò negli orecchi, che
lo esortava a segnare la Croce di Cristo sugli scudi dei legionari. All'alba ne
diede l'ordine, e al posto del vessillo fece innalzare un labaro che portava
una croce intrecciata con le iniziali di Gesù. Sull'esercito nemico svettava la
bandiera col simbolo del Sole imposto da Aureliano come nuovo dio
pagano. Era la prima volta, nella storia di Roma, che una guerra si
combatteva in nome della religione. Ma fu la Croce che vinse. E il Tevere,
trascinando verso la foce i cadaveri di Massenzio e dei suoi soldati che lo
ingombravano, sembrò che spazzasse via i residui del mondo antico.
Non era finita, perché restavano ancora Licinio e Massimino. Col primo
Costantino s'incontrò a Milano nel 313 dopo Cristo, e il risultato di
quell'intervista fu la spartizione dell'Impero fra i due Augusti e la
compilazione del famoso editto che proclamava la tolleranza dello stato per
tutte le religioni e restituiva ai cristiani i beni sequestrati nelle ultime
persecuzioni. Massimino morì, Licinio sposò la sorella di Costantino, e per
un momento sembrò che i due imperatori potessero dar vita a una pacifica
Diarchia.
Ma l'anno dopo erano già di nuovo ai ferri corti. Costantino batté in
Pannonia un esercito di Licinio, che si vendicò sui cristiani d'Oriente
ricominciando le persecuzioni ai loro danni. Costantino non si era ancora
ufficialmente convertito. Ma i cristiani vedevano ormai in lui il loro
campione, e costituivano certamente la schiacciante maggioranza, se non la
totalità, di quell'esercito di centotrentamila uomini che sotto il suo personale
comando mosse contro i centosessantamila difensori del paganesimo agli
ordini di Licinio. Prima ad Adrianopoli, poi a Scutari, i primi riportarono la
vittoria. Licinio si arrese, ed ebbe salva la vita, che però gli fu tolta l'anno
dopo. Nel segno di Cristo si riformò un Impero che ormai di romano aveva
soltanto il nome.
Cos'era dunque avvenuto?
Avevamo lasciato i cristiani, a Roma, agl'inizi della loro organizzazione:
dapprima poche centinaia, poi poche migliaia di persone, quasi tutti ebrei,
raccolte nelle loro piccole ecclesia, con pochi nessi tra loro, con una dottrina
ancora allo stato fluido, e in mezzo più all'indifferenza che all'ostilità dei
gentili. Queste sparse e scarse cellule erano unite dalla credenza che Gesù
fosse il Figlio di Dio, che il Suo ritorno fosse imminente per stabilire sulla
terra il Regno del Cielo, e che la fede in Lui sarebbe stata compensata col
paradiso. Ma già grossi dissensi erano cominciati a sorgere sulla data del
Ritorno. Qualcuno lo vide annunziato dalle calamità che si abbattevano
sull'Impero; Tertulliano disse che c'era da aspettarselo dopo la caduta di
Roma, la quale sembrava così imminente che un vescovo di Siria partì
addirittura coi suoi fedeli verso il deserto, sicuro d'incontrarvi il Signore;
Barnaba proclamò che ci volevano ancora mille anni. Solo molto più tardi
trionfò la tesi di Paolo che trasferiva definitivamente nel mondo ultraterreno
il Regno del Signore. Ma, per allora, l'attesa della sua imminente
instaurazione contribuì potentemente, con le immediate promesse che
implicava, alla diffusione della fede.
Ma c'erano altri punti della dottrina che minacciavano di provocare vere e
proprie eresie. Celso, il più violento dei polemisti anticristiani, aveva scritto
che la nuova religione era divisa in fazioni, e che ogni cristiano vi costituiva
un partito adattandola a talento suo. Ireneo di queste fazioni ne contava una
ventina. Occorreva dunque un'autorità centrale che distinguesse irrevocabilmente quello ch'era giusto da quello ch'era falso.
La prima decisione da prendere, che fu dibattuta per due secoli, fu quella
sulla sede. La nuova religione era nata a Gerusalemme; ma Roma aveva
dalla sua le parole di Gesù: « Tu sei Pietro, e su questa pietra io costruirò la
mia Chiesa». E Pietro era venuto a Roma. A decidere, più che gli argomenti,
fu la circostanza che il mondo si dominava da Roma, non da Gerusalemme.
Tertulliano assicurò che Pietro, morendo, aveva affidato le sorti della Chiesa
a Lino. Ma il primo sicuro successore è il terzo, Clemente, di cui ci resta una
lettera vergata con piglio autorevole agli altri vescovi.
Costoro cominciarono a riunirsi sempre più frequentemente nei Sinodi, e
furono questi Sinodi i supremi arbitri di quella religione cristiana che si
chiamò cattolica in quanto universale. Il termine di papa divenne esclusivo
del Supremo Pontefice solo dopo quattro secoli, durante i quali esso veniva
dato a tutti i vescovi per contrassegnare la loro parità.
Con questa prima e rudimentale organizzazione, la Chiesa combatté la sua
guerra su due fronti: quello esterno dello stato, e quello interno delle eresie.
E non sappiamo quale dei due fosse più pericoloso. Sappiamo soltanto che
sulla fine del secondo secolo la Chiesa aveva cominciato a inquietare a tal
punto i romani, che uno di essi, fra i più colti, Celso, dedicò la vita a studiarne il funzionamento e ci scrisse sopra un libro accurato e
informatissimo, anche se parziale e rancoroso nelle sue conclusioni. Queste
erano che un cristiano non poteva essere un buon cittadino. E in un certo
senso aveva ragione, finché lo stato restava pagano. Ma il fatto è che il
paganesimo non aveva più difensori; e anche coloro che si rifiutavano di
abbracciare la nuova fede non trovavano più argomenti per difendere quella
vecchia. Sulla scia di Marc'Aurelio e di Epitteto, Piotino fu classificato
filosofo pagano solo perché non si battezzò. Ma tutta la sua morale è già cristiana, come del resto lo è in Epitteto e in Marc'Aurelio.
Anche quando la negavano, tutte le grandi menti del tempo cominciarono
ad arrovellarsi intorno alla dottrina di Gesù e degli Apostoli. Tertulliano
che, sebbene di Cartagine, aveva il rigoroso senso giuridico dei romani ed
era oltretutto un grande avvocato, quando si fu convertito, trasse dal
Vangelo un codice di vita pratica e gli diede l'organicità di un vero e proprio
decreto-legge. Questo vigoroso oratore, che parlava come Cicerone e
scriveva come Tacito, caratteraccio rissoso e sarcastico, fu di grande aiuto
alla Chiesa che aveva bisogno, dopo tanta teologia e metafisica greche, di
organizzatori e di codificatori. Tertulliano, a furia di zelo, finì quasi eretico,
perché in vecchiaia, inasprendosi il suo temperamento, criticò i cristiani
ortodossi come troppo tiepidi e indulgenti e mollaccioni, e abbracciò la più
rigorosa regola di Montano, una specie di Lutero avanti lettera che
predicava il ritorno a una fede più austera.
Un altro formidabile propagandista fu Origene, autore di oltre seimila fra
libri e opuscoli. Aveva diciassette anni quando suo padre fu condannato a
morte come cristiano. Il ragazzo chiese di seguirlo nel martirio e sua madre,
per impedirglielo, gli nascose i vestiti. Mi raccomando: non rinnegare la
tua fede per amor nostro, scrisse il ragazzo al morituro. Quello che impose a
se stesso fu un tirocinio da asceta. Digiunava, dormiva nudo sul pavimento,
e alla fine si evirò. In realtà Origene era un perfetto tipo di stoico, e del
Cristianesimo diede infatti una versione sua, che lì per lì fu accettata, ma
non da tutti. Il vescovo di Alessandria, Demetrio, la ritenne incompatibile
con l'abito talare che frattanto Origene aveva indossato e ne revocò
l'ordinazione. Lo spretato continuò a predicare con ammirevole zelo,
confutò le tesi di Celso in un'opera rimasta famosa; fu imprigionato e
torturato, ma non rinnegò la sua fede, e morì povero e senza macchia
com'era vissuto. Ma duecent'anni dopo le sue teorie vennero condannate da
una Chiesa che ormai aveva abbastanza autorità per farlo.
Il papa che più contribuì a rassodare l'organizzazione in quei primi
difficili anni fu Callisto, che molti consideravano un avventuriero. Dicevano
che, prima di convertirsi, era stato schiavo, aveva fatto i quattrini con
sistemi piuttosto equivoci, era diventato banchiere, aveva derubato i suoi
clienti, era stato condannato ai lavori forzati ed era fuggito con un inganno.
Il fatto che, appena diventato papa, proclamasse valido il pentimento per
cancellare qualunque peccato, anche mortale, ci fa sospettare che in queste
voci un po' di verità ci fosse. Comunque, fu un gran papa, che stroncò il
pericoloso scisma d'Ippolito e affermò definitivamente l'autorità del potere
centrale. Decio, che dei cristiani fu un irriducibile nemico, diceva che
avrebbe preferito avere a Roma un imperatore rivale piuttosto che un papa
come Callisto. Sotto di lui il Papato diventò davvero romano in molti sensi.
Dai sacerdoti pagani dell'Urbe prese in prestito la stola, l'uso dell'incenso e
delle candele accese davanti all'altare, e l'architettura delle basiliche. Ma le
derivazioni non si limitarono a queste di carattere formale. I costruttori della
Chiesa
si
appropriarono specialmente l'intelaiatura amministrativa
dell'Impero e la ricalcarono istituendo accanto e contro ogni governatore di
provincia un arcivescovo, e un vescovo accanto e contro ogni prefetto. Via
via che il potere politico s'indeboliva e lo stato andava alla deriva, i
rappresentanti della Chiesa ne ereditavano le mansioni. Quando Costantino
andò al potere, già molte funzioni dei prefetti, grandemente scaduti di
qualità, venivano assolte dai vescovi. Chiaramente, la Chiesa era l'erede
designata e naturale dell'Impero in collasso. Gli ebrei le avevano dato
un'etica; la Grecia le aveva dato una filosofia; Roma le stava dando la sua
lingua, il suo spirito pratico e organizzativo, la sua liturgia e la sua
gerarchia.
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
IL TRIONFO DEI CRISTIANI
NELLA fantasia della gente, surriscaldata da cattivi romanzi e da brutti
film, la persecuzione dei cristiani porta soprattutto il nome di Nerone. Ma è
un errore. Nerone fece condannare e suppliziare un certo numero di cristiani
per l'incendio di Roma al solo scopo di stornare i sospetti della gente contro
la propria persona. La sua fu una manovra di diversione che non si
appoggiava su nessun serio risentimento del popolo e dello stato contro
quella comunità religiosa che del resto era fra le più pacifiche e che, come
tutte le altre, godeva a Roma di una larga tolleranza. L'Urbe ospitava
liberalmente tutti gli dèi di tutti i forestieri che venivano ad abitarci, e in
questo era realmente caput mundi. Ce n'erano oltre trentamila, di questi dèi,
in coabitazione. E anche quando uno straniero chiedeva la cittadinanza, la
sua concessione non era sottoposta a nessuna condizione religiosa.
I primi screzi nacquero quando s'impose di riconoscere l'imperatore come
dio e di adorarlo. Per i pagani, era facile: nel loro Olimpo di dèi ce n'eran
già tanti che uno di più, si chiamasse Caracalla o Commodo, non guastava.
Ma gli ebrei e i cristiani, che la polizia non riusciva a distinguere gli uni
dagli altri, ne adoravano uno solo, Quello, e non erano punto disposti a
barattarlo. Alla fine, prima di Nerone, fu promulgata una legge che li
esentava da quel gesto che per loro era di abiura. Ma Nerone e i suoi
successori alle leggi facevano poco caso, e così sorse il primo malinteso che
mise a nudo. altre e più profonde incompatibilità. Non a caso Celso, che fu
il primo ad analizzarle seriamente, disse che il rifiuto di adorare l'imperatore
era in sostanza il rifiuto di sottomettersi allo stato, di cui la religione non
costituiva, a Roma, che uno strumento. Egli scoprì che i cristiani ponevano
Cristo al di sopra di Cesare e che la loro moralità non coincideva affatto con
quella romana che faceva degli stessi dèi i primi servitori dello stato.
Tertulliano, rispondendogli che proprio in questo consisteva la loro
superiorità, riconobbe la fondatezza di queste accuse e andò anche più in là,
proclamando che il dovere del cristiano era proprio quello di disobbedire
alla legge, quando la trovava ingiusta.
Finché questa diatriba rimase monopolio dei filosofi, essa non diede luogo
che a dispute. Ma quando i cristiani crebbero di numero e la loro condotta
cominciò a farsi notare in mezzo alla popolazione, quest'ultima prese a
covare delle diffidenze che abili propagandisti sfruttavano a dovere, come
più tardi si è fatto contro gli ebrei. Di loro, si cominciò a dire che facevano
esorcismi e magie, che bevevano il sangue romano, che veneravano un
somaro, che portavano il malocchio. Era il "dalli all'untore" che maturava e
creava l'atmosfera del pogrom e del "processo alle streghe".
Dopo Nerone, l'ostilità nei loro riguardi diventò un'ondata di fondo, e la
legge che proclamava delitto capitale la professione della nuova fede non fu
il ghiribizzo di un imperatore a suggerirla, ma un fremito di odio collettivo a
suscitarla. Anzi, la maggior parte degl'imperatori cercarono di evaderla o di
applicarla con indulgenza. Traiano scriveva a Plinio, elogiandone la
tolleranza: Approvo i tuoi metodi. L'accusato che nega di essere un cristiano
e ne fornisce prova con atto di ossequio ai nostri dèi dev'essere assolto
senz'altro. Adriano, da bravo scettico, andava più in là: concedeva
l'assoluzione anche su un semplice gesto di pentimento formale. Ma era
difficile opporsi alle ondate d'odio popolare quando si scatenavano specie in
occasione di qualche calamità che veniva regolarmente attribuita
all'indignazione degli dèi per la tolleranza che si mostrava verso gli empi
cristiani. La religione pagana a Roma era morta, ma la superstizione era
sempre viva; e non c'era terremoto, o pestilenza, o carestia, che non venisse
messa sul conto di quei poveri diavoli. Neanche quel sant'uomo di
Marc'Aurelio, sotto il cui regno le calamità si moltiplicarono, poté resistere
a questi soprassalti, e dovette piegarvisi. Attalo, Potino, Policarpo furono fra
i più illustri di questi martiri.
La persecuzione cominciò a diventare sistematica con Settimio Severo che
proclamò delitto il battesimo. Ma ora i cristiani erano abbastanza forti per
reagire, e lo fecero attraverso un'opera propagandistica che qualificava
Roma di "nuova Babilonia", ne propugnava la distruzione e affermava
l'incompatibilità del servizio militare con la nuova fede. Era la predicazione
aperta del disfattismo, e suscitò l'ira di quei "patrioti" che per la patria
minacciata dal nemico esterno non si battevano più, ma con quello interno e
inerme erano intransigenti. Decio vide in questo soprassalto d'indignazione
un cemento di unità nazionale e lo sfruttò dandogli soddisfazione. Indisse
una grande cerimonia di ossequio agli dèi avvertendo che si sarebbero presi
i nomi di chi non vi avesse partecipato. Ci furono, per paura, molte
apostasie, ma anche molti eroismi ripagati con la tortura. Tertulliano aveva
detto: «Non piangete i martiri. Essi sono il nostro seme». Terribile e spietata
verità. Sei anni dopo, sotto Valeriano, il papa stesso, Sisto II, fu messo a
morte.
La battaglia più grossa fu quella scatenata da Diocleziano. È curioso che
un così grande imperatore non ne abbia visto l'inutilità, anzi la
controproducenza. Ma pare che sia stato un moto d'ira a suggerirgliene
l'attuazione. Un giorno ch'egli stava officiando come Pontefice Massimo, i
cristiani che gli stavano intorno si fecero il segno della Croce. Irritato,
Diocleziano ordino che tutti i sudditi, civili e militari, ripetessero il sacrificio e che coloro che vi si rifiutavano venissero frustati. I rifiuti furono
molti, e allora l'imperatore ordinò che tutte le chiese cristiane fossero rase al
suolo, tutti i loro beni confiscati, i loro libri bruciati, i loro adepti uccisi.
Questi ordini erano ancora in via di esecuzione quando egli si ritirò a
Spalato, dove ebbe tutto il tempo e l'agio di meditare sui risultati di quella
persecuzione, che costituì la prova più brillante del Cristianesimo e lo
"laureò", per cosi dire, trionfatore. Gli Atti dei martiri, in cui si narrano,
forse con qualche esagerazione, i supplizi e le morti dei cristiani che non si
rinnegarono, costituirono un formidabile motivo di propaganda. Essi
diffusero la persuasione che il Signore rendeva insensibili ai patimenti
coloro che li affrontavano in nome Suo e spalancava loro il Regno dei Cieli.
Non sappiamo se anche Costantino ne fosse convinto, quando fece
stampare la Croce di Cristo sul suo labaro. Sua madre era cristiana. Ma essa
aveva potuto poco sull'educazione di quel ragazzo che se l'era fatta sotto la
tenda in mezzo ai soldati, dove si era circondato di filosofi e rètori pagani.
Anche dopo la conversione, seguitò a benedire gli eserciti e le messi
secondo il rituale pagano, in chiesa ci andò di rado, e a un amico che gli
chiedeva il segreto del suo successo, rispose: « È la Fortuna che fa di un
uomo un imperatore». La Fortuna, non Dio. Nel trattare coi sacerdoti, aveva
un po' il piglio del padrone, e solo nelle questioni teologiche li lasciava fare
non perché ne riconoscesse l'autorità, ma perché si trattava di faccende di
cui s'infischiava. Nella testimonianza dei cristiani contemporanei, come
Eusebio, che avevano i più fondati motivi di gratitudine per lui, egli passa
per qualcosa di poco meno che un santo. Ma noi crediamo ch'egli sia stato
soprattutto un uomo politico equilibrato, freddo, di larga visione e di gran
buon senso che, avendo constatato di persona il fallimento della
persecuzione, preferì mettervi sopra un sigillo.
È molto probabile tuttavia che a questo calcolo di contingente opportunità,
in lui se ne siano aggiunti anche altri, più complessi. Egli doveva essere
rimasto molto colpito dalla superiore moralità dei cristiani, dalla decenza
della loro vita, insomma dalla rivoluzione puritana ch'essi avevano operato
nel costume di un Impero che non ne aveva più nessuno. Essi avevano
formidabili qualità di pazienza e di disciplina. E oramai, se si voleva trovare
un buono scrittore, un bravo avvocato, un funzionario onesto e competente,
era fra loro che bisognava cercarlo. Non c'era, si può dire, città in cui il
vescovo non fosse migliore del prefetto. Non si poteva forse sostituire, ai
vecchi e corrotti burocrati, quei prelati irreprensibili, e far di costoro gli
strumenti di un nuovo Impero?
Le rivoluzioni vincono non in forza delle loro idee, ma quando riescono a
confezionare una classe dirigente migliore di quella precedente. E il
Cristianesimo era riuscito proprio in questa impresa.
Costantino cominciò col riconoscere ai vescovi competenza di giudici
nelle loro circoscrizioni o diocesi. Poi esentò i beni della Chiesa dalle tasse,
riconobbe come "persone giuridiche" le associazioni dei fedeli, diede un
prete per tutore a suo figlio dopo averlo battezzato, e alla fine cancellò
l'editto di Milano che garantiva la tolleranza di tutte le religioni su piede di
parità, per riconoscere il primato di quella cattolica, che da quel momento fu
la religione di stato, rendendo obbligatori per tutti i cittadini i precetti del
Sinodo.
Agendo più da papa che da re, indisse il primo Concilio Ecumenico, cioè
universale, della Chiesa, per risolvere i dissensi interni che la rodevano. Egli
stesso fornì, coi fondi dello stato, i mezzi a trecentodiciotto vescovi e a
infiniti altri prelati minori per raggiungere Nicea, presso Nicomedia. C'erano
gravi questioni da mettere a posto. Alcuni estremisti dell'ascetismo avevano
fatto secessione da un sacerdozio che ai loro occhi si mostrava troppo
disposto ai compromessi e attaccato ai beni di questa terra, e avevano dato
inizio a un movimento monastico.
Quasi nello stesso tempo il vescovo di Cartagine, Donato, lanciò il
progetto, che fece subito proseliti, di un "epurazione" ai danni di quei
sacerdoti che avevano abiurato per paura durante le persecuzioni e di coloro
che da essi. avevano ricevuto il battesimo. La proposta era stata respinta, ma
aveva dato luogo a uno scisma che doveva continuare per secoli. Però il
pericolo più grosso era quello rappresentato da Ario, un predicatore di
Alessandria che attaccava la dottrina alla base, confutando la
consustanzialità di Cristo con Dio. Il vescovo lo aveva scomunicato, ma
Ario aveva seguitato a predicare e a fare seguaci. Costantino aveva mandato
a chiamare i due litiganti e aveva cercato di far da mediatore fra loro
invitandoli a trovare un compromesso. Il tentativo era fallito e il conflitto si
era allargato e approfondito. Ed era soprattutto questo che aveva reso
necessario il Concilio.
Il papa Silvestro I, vecchio e malato, non poté intervenire. Attanasio
sostenne le accuse contro Ario che rispose con coraggio e onestà. Era un
uomo sincero, povero, malinconico, che sbagliava in buona fede. Dei
trecentodiciotto vescovi, due soli lo sostennero sino alla fine, e furono
scomunicati con lui. Costantino assisté a tutti i dibattiti, ma non intervenne
che di rado, per richiamare i contendenti alla calma e alla ponderatezza,
quando la discussione si accendeva. Quando il verdetto che riaffermava la
divinità di Cristo e condannava Ario fu formulato, egli lo tradusse in un
editto che bandiva l'eretico coi suoi due sostenitori, ne condannava al rogo i
libri e comminava la pena di morte a chi li avesse nascosti.
Costantino chiuse il Concilio con un grande banchetto agli intervenuti, poi
si diede a organizzare la sua nuova capitale che, con solenne cerimonia,
dedicò alla Vergine. La chiamò Nova Roma, ma i posteri le diedero il suo
nome: quello di Costantinopoli.
Non sappiamo s'egli si rendesse conto che, con questo trasferimento di
capitale, egli decretava praticamente la fine dell'Impero romano e l'inizio di
un altro, che avrebbe continuato, sì, a chiamarsi "romano", ma di cui l'Italia
sarebbe stata solo una provincia con Roma per capoluogo.
Costantino fu uno strano e complesso personaggio. Faceva gran scialo di
fervore cristiano, ma nei suoi rapporti di famiglia non si mostrò molto
ossequente ai precetti di Gesù. Mandò sua madre Elena a Gerusalemme per
distruggere il tempio di Afrodite che gli empi governatori romani avevano
elevato sulla tomba del Redentore, dove, secondo Eusebio, fu ritrovata la
croce su cui era stato suppliziato. Ma subito dopo mise a morte sua moglie,
suo figlio e suo nipote.
Si era sposato due volte: dapprima con Minervina, che gli aveva dato
Crispo, un bravo ufficiale che si era coperto di medaglie nelle campagne
contro Licinio; poi con Fausta, la figlia di Massimiano, che gli aveva dato
tre ragazzi e tre bambine. Pare che Fausta, per escludere dalla successione
Crispo, lo accusasse presso l'imperatore di aver cercato di sedurla; e che poi
Elena, che per Crispo aveva un debole, raccontasse a Costantino ch'era stata
Fausta a sedurre il figliastro. Per non sbagliare, l'imperatore accoppo
ambedue. Quanto al nipote Liciniano, figlio di sua sorella Costanza che lo
aveva avuto da Licinio, dicono che lo mise a morte perché complottava.
Niente di tutto questo si trova nella Vita di Costantino scritta da Eusebio a
mo' di panegirico e intesa, logicamente, all'esaltazione di chi aveva fatto, di
una setta perseguitata, la Chiesa dell'Impero. Costantino non era un santo,
come dice il suo biografo. Fu un grande generale, un accorto
amministratore, un lungimirante uomo di stato, che commise tuttavia
qualche errore anche lui.
Il giorno di Pasqua del 337 dopo Cristo, trentesimo compleanno della sua
ascesa al trono, si rese conto di essere alla fine. Chiamò un prete, chiese i
sacramenti, lasciò la stola di porpora per indossare quella bianca dei
battezzandi, e aspettò tranquillamente la morte.
Dinanzi al tribunale degli uomini, i servigi ch'egli aveva reso alla causa
della civiltà cristiana sono largamente sufficienti a farlo assolvere dei delitti
di cui si macchiò. Dinanzi a quello di Dio, non sappiamo.
CAPITOLO QUINDICESIMO
L'EREDITÀ DI COSTANTINO
COSTANTINO fu l'unico fra i successori di Augusto che sia rimasto sul
trono oltre trent'anni. Ma sciupò la sua grandiosa opera di ricostruzione col
più assurdo dei testamenti, dividendo l'Impero in cinque fette e
assegnandole rispettivamente ai suoi tre figli Costantino, Costanzo e
Costante, e ai due nipoti Delmazio e Annibaliano.
La cosa ci stupisce perché egli non poteva non aver visto cos'era avvenuto
con la spartizione di Diocleziano e che baruffe si erano scatenate fra tutti
quegli Augusti e Cesari. Ma, una volta che aveva deciso così, poteva almeno
prendere la precauzione di dare ai suoi tre ragazzi dei nomi che li
differenziassero un po' meglio. È un bel pasticcio, anche per chi vuol
riassumerne la storia, dipanare l'aggrovigliata matassa di quei quasi
omonimi. Cercheremo di fare del nostro meglio.
A facilitarci il lavoro semplificando le rivalità provvidero i reggimenti di
guarnigione nella capitale che, appena calato nella fossa il grande defunto,
insorsero e fecero un bel massacro in cui perirono due dei cinque eredi:
Annibaliano e Delmazio. A loro tennero compagnia anche i fratellastri del
morto e i loro figli, meno due, Gallo e Giuliano, che vennero mandati al
confino e di cui sentiremo riparlare, oltre a un numero imprecisato di alti
gerarchi. Costantinopoli era appena nata, e già inaugurava quel repertorio di
carneficine che doveva nei secoli punteggiarne la storia.
Era stato davvero Costanzo, come si disse più tardi, a ordinare quella
strage? Con precisione non si sa. Si sa soltanto ch'egli si trovava in città
quando si svolse, che non fece nulla per impedirla, e che ne rimase il
maggior beneficiario. Egli riunì gli altri due fratelli a Smirne e con essi
addivenne a una seconda spartizione. Per sé tenne tutto l'Oriente con
Costantinopoli e la Tracia; a Costante, ch'era il minore, diede l'Italia, l'Illiria,
l'Africa, la Macedonia e l'Acaia, ma obbligandolo a una specie di
vassallaggio verso Costantino II, cui erano toccate le Gallie.
Se Costanzo escogitò questa clausola per provocare una rivalità fra i due e
restare poi l'arbitro, bisogna dire che il colpo gli riuscì in pieno. Non erano
trascorsi tre anni ch'essi già venivano alle mani. Ma alla prima battaglia Costantino, ch'era di carattere focoso, si buttò troppo avanti, cadde in
un'imboscata e fu ucciso.
Costante non perse tempo ad annettersi tutti i suoi possedimenti. E
Costanzo, il quale forse sperava in una guerra lunga, che avrebbe logorato le
forze di ambedue i contendenti, rimase a bocca asciutta, e con un rivale solo,
sì, ma più potente di lui.
La fortuna anche stavolta lo aiutò sotto forma di un complotto contro
Costante che, in Gallia, vinceva battaglie su battaglie contro i ribelli perché
era un buon generale, ma come uomo di stato non valeva nulla, spremeva i
sudditi con le tasse, li irritava con le sue testardaggini e li scandalizzava coi
suoi costumi. Un comandante di milizie barbare, Magnenzio, lo uccise, e si
proclamò imperatore. Ma altrettanto fecero subito Vetranione, che
comandava le truppe in Illiria, e Nepoziano, nipote del morto.
Costanzo aveva ora le carte in regola per intervenire in Occidente col
pretesto di ristabilirvi la giustizia. Proprio in quel momento egli aveva
concluso una tregua col re persiano Sapore che gli aveva procurato fino ad
allora un sacco di grane e tenuto impegnati i suoi eserciti. Alla testa dei
quali egli mosse ora contro gli usurpatori, ma accompagnando quella
militare con un'abile azione diplomatica, ch'era poi l'arte in cui meglio
riusciva. Vetranione abboccò, unì le sue truppe a quelle di Costanzo nella
pianura di Serdica dove gli era venuto incontro, e s'inginocchiò dinanzi a lui
chiedendogli perdono. Il perdono fu accordato, e anzi vi si aggiunsero
galloni e medaglie. Poi i due eserciti marciarono insieme contro Magnenzio,
lo sconfissero in Ungheria, lo inseguirono fino in Spagna e qui lo
obbligarono a uccidersi con suo fratello Decenzio. Così l'Impero fu di nuovo
riunito sotto un solo sovrano.
A differenza del suo predecessore e padre, costui non era un grande
generale, non amava le guerre, e cercava di evitarle. Ma quando vi era
obbligato, le faceva fino in fondo, sia pure con gran cautela, e vi rischiava
coraggiosamente la pelle. Perché aveva una gran coscienza dei suoi doveri e
li assolveva senza badare a spese e sacrifici. Era un uomo solitario e
sospettoso, malinconico e taciturno, senza slanci, senza calore umano, senza
vizi né abbandoni. In molte cose somiglia a Filippo II di Spagna e a
Francesco Giuseppe d'Austria. Come loro era pio, ma alla fede non univa le
altre due virtù teologali: la speranza e la carità. Anzi era pessimista,
incapace d'indulgenza, e credeva che per salvare un'anima fosse molto
spesso necessario bruciare un corpo. Aveva sposato tre volte, non per
amore, ma per desiderio di un erede. Nessuna delle tre mogli glielo aveva
dato. Ora si trovava senza successori. Nemmeno i suoi fratelli avevano
avuto il tempo di lasciarne. Di vivo, nel gran cimitero in cui aveva trovato
sepoltura la vasta progenie di Costantino, non erano rimasti che i due
ragazzi scampati al massacro del 337: Gallo e Giuliano.
Costoro da anni vegetavano in una cittaduzza di Cappadocia, sotto la
tutela di un vescovo ariano, Eusebio, che anche lui di carità ne aveva poca,
in una vita da collegio, solitaria e desolata.
La loro mamma Basilina era già morta, quando sotto i loro occhi si era
svolta la carneficina in cui erano periti il padre, gli zii, i cugini, e perfino i
servi. Gallo aveva dieci anni, allora; Giuliano, sei. E ambedue seppero più
tardi che il responsabile diretto o indiretto del massacro era stato lui,
Costanzo, che ora all'improvviso si ricordava di loro.
L'eletto fu Gallo, il maggiore, che dal giorno all'indomani, da prigioniero
qual era, si trovò marito di Costantina, la sorella dell'imperatore, nominato
Cesare e insediato ad Antiochia con poteri quasi assoluti. A tenergli la testa
a posto, in quel brusco salto che avrebbe dato le vertigini a chiunque, non
aveva nemmeno l'intelligenza, di cui era cospicuamente sprovveduto. Quel
che gli era capitato di vedere da ragazzo gli aveva fatto credere che
l'assassinio e l'inganno fossero la regola, fra gli uomini, e per mettere se
stesso al riparo seguì quella di dar corpo a ogni sospetto e di uccidere
qualunque indiziato. Prima ancora che Costanzo si accorgesse dell'errore
commesso con quella scelta, aveva già scannato non solo singoli uomini, ma
intere popolazioni. L'imperatore, temendo che una scomunica lo spingesse
all'aperta ribellione, fece finta di nulla e, mostrandoglisi sempre amico, lo
chiamò a Milano dove si trovava in quel momento. Inquieto, Gallo mandò
prima Costantina a scrutare le intenzioni di Costanzo. Ma Costantina morì
durante il viaggio. Gallo dovette decidersi a venire di persona. Ma, arrivato
in Pannonia, un distaccamento di soldati lo arrestò e lo condusse a Pola,
dove lo relegarono nel palazzo in cui Costantino aveva fatto uccidere il suo
primogenito Crispo. Costanzo teneva molto alle tradizioni di famiglia, anche
negli accoppamenti. Un processo sommario, facilitato dalla testimonianza
ben remunerata di un eunuco di corte, condusse alla pena di morte
immediatamente eseguita.
Costanzo era di nuovo senza successori, e invecchiava. Il giorno che
aveva deciso di liberarsi di Gallo, aveva rimandato al confino anche Giuliano, sospettandolo complice di suo fratello. Ma quel ragazzo era l'unico
nelle cui vene scorresse ancora il sangue di Costantino. Dopo molte esitazioni, lo richiamò e lo nominò Cesare. Il successore non poteva essere che
lui.
Quella scelta fatta controvoglia si rivelò subito eccellente. Giuliano, che
passava per un perdigiorno dedito soltanto alla letteratura e alla filosofia,
appena si trovò con qualche responsabilità addosso, ci fece subito la mano.
Non aveva mai visto una caserma quando l'imperatore gli diede in appalto le
province occidentali allora in piena rivolta. Giuliano dapprima lasciò fare ai
generali, ma studiando attentamente le loro mosse. Poi prese il comando
effettivo delle truppe, affrontò le orde franche e alemanne che s'erano
infiltrate oltre il Reno, le annientò, soffocò la ribellione degl'indigeni, e
ristabilì l'autorità imperiale sulla Britannia. Mai titolo di Cesare era stato
dato a un uomo con tanta pertinenza.
Purtroppo proprio in quel momento il re persiano Sapore riprese il
sentiero di guerra, e per pararne la minaccia Costanzo chiese a Giuliano di
mandargli una parte del suo esercito. Giuliano, che aveva preso gusto al
mestiere di soldato, obbedì, ma a malincuore, e non si sa fino a che punto
nascondesse ai suoi uomini il rammarico di doversi separare da loro.
Comunque, essi furono sicuri di interpretare i suoi desideri rifiutando di
obbedire, e anzi acclamandolo Augusto, cioè imperatore. Subito Giuliano si
affrettò a scrivere a Costanzo che tutto questo era avvenuto al di fuori, anzi
contro la sua volontà. Ma quando Costanzo gli rispose che lo perdonava se
rinunziava al titolo e faceva atto di sottomissione. Giuliano, invece di
aderire, gli mosse contro alla testa del suo esercito. Egli non aveva
scassinato la banca, ma si rifiutava di restituire la refurtiva che, non si sa
come, gli era piovuta in casa.
La guerra non ci fu perché Costanzo, partito anche lui per farla, morì in
viaggio. Quando aprirono il testamento, tutti videro con sommo stupore
ch'egli aveva designato unico erede colui che era venuto a combattere e, in
caso di vittoria, probabilmente a uccidere. Come sempre, egli aveva
obbedito non ai sentimenti, ma alla ragion di stato. E, riconoscendo nel
fellone le qualità di un grande politico, ne aveva fatto il suo successore.
Giuliano lo ricambiò tributandogli solenni esequie, vestendosi a lutto e
piangendo a calde lacrime sulla bara. Fu una bellissima commedia, recitata
magnificamente da ambedue le parti.
Su Giuliano son corsi fiumi d'inchiostro, come se non bastassero quelli
che ha profuso egli stesso. Perché era grafomane e aveva la passione dei
proclami, dei panegirici e dei saggi fra il filosofico e il politico. Ma forse
l'importanza di questo imperatore, che regnò venti mesi soltanto, è stata un
poco esagerata.
La ragione per cui si è fatto tanto baccano intorno al suo nome è che gli si
attribuisce il proposito di restaurare il paganesimo contro il Cristianesimo.
Già Costanzo aveva dovuto dedicare la maggior parte del suo tempo alle
questioni religiose. Egli anzi aveva agito, oltre che come imperatore, come
papa, intervenendo nelle beghe interne della Chiesa fra donatisti, ariani e
meleziani. Perché era cristiano, sì, e di quelli ferventi. Ma molto
paganamente considerava la Chiesa uno strumento dello stato e, con la scusa
di proteggerla, intendeva controllarla.
Giuliano ebbe gli stessi interessi religiosi, ma orientati in senso opposto, e
perciò si guadagnò il titolo di Apostata. A riempirlo di rancore verso la
nuova fede, non c'è dubbio che deve aver contribuito quel vescovo Eusebio
che, come suo tutore, aveva condito con la frusta le lezioni di catechismo.
L'unico affetto, nel confino di Nicomedia, Giuliano lo aveva trovato in un
vecchio servo scita, Mardonio, che gli leggeva Omero e i filosofi greci. Non
si è mai saputo se Mardonio fosse pagano o cristiano. Si sa soltanto ch'era
imbevuto di classicismo, e fu lui a ispirarne l'amore al suo padroncino e
pupillo. Questi si guardava intorno, e non gli pareva che i cristiani da cui era
circondato dessero un grande esempio. Non era, checché si sia detto, un
uomo di profondo pensiero, e basta leggere i suoi scritti per convincersene.
A volte i suoi ragionamenti si perdono nel vaneggiamento. Aveva una gran
memoria, ma non capiva nulla d'arte, si accaniva puntigliosamente su
problemi filosofici secondari perdendo di vista quelli principali, si
compiaceva di citazioni e di virtuosismi estetizzanti. Era fatale ch'egli
confondesse la Chiesa con i suoi cattivi pastori e che accomunasse questi a
quella nella medesima antipatia. Comunque, non fa onore alla sua
intelligenza politica l'idea, che gli viene attribuita e che forse coltivò
davvero, di un ritorno al paganesimo come religione di stato. Già, ogni
ritorno, in politica, è uno sbaglio.
La famosa apostasia di Giuliano fu soprattutto un marcato agnosticismo.
Egli si disinteressò delle eresie che seguitavano a dilaniare la Chiesa, ed è
probabile che le vedesse con simpatia. Ma agli ebrei riconobbe libertà di
culto e concesse di ricostruire il tempio di Salomone, le cui impalcature però
andarono distrutte da un terremoto, nel quale gli scrittori cristiani salutarono
un castigo del Cielo. Che sottomano egli abbia incoraggiato il ripristino
degli antichi culti pagani, lo si è detto, ma non è stato provato. Comunque,
non ne dovette ricavare molte soddisfazioni, perché la gente non vi aderì che
svogliatamente e senza entusiasmo. Ad Alessandria fu ucciso dai pagani il
vescovo Giorgio, ad Antiochia fu incendiato dai cristiani il tempio di
Apollo: né in un caso né nell'altro Giuliano ordinò rappresaglie. Voleva
mostrarsi imparziale.
Dio sa come e dove sarebbe finita questa sua anacronistica politica
religiosa, se Sapore non lo avesse costretto a riprendere le armi. Egli preparò
quella difficile e pericolosa spedizione con la consueta cura, allestendo uno
sterminato esercito e una flotta di mille navi con cui discendere il Tigri. I
primi scontri gli furono favorevoli, ma la città di Ctesifonte gli resisté con le
sue formidabili fortificazioni e alla fine lo obbligò alla ritirata. Ma chi
avrebbe fatto risalire la corrente alle navi? Giuliano diede ordine di
bruciarle. Non poteva fare altrimenti, ma la decisione demoralizzò i soldati e
li riempì di furore. La contrada era povera, sassosa, bruciata dal sole, ostile.
Le cavallerie persiane disturbavano la marcia infliggendo gravi perdite coi
loro dardi. Uno di essi raggiunse Giuliano conficcandoglisi nel fegato.
L'imperatore tentò di estrarlo con le sue mani, allargò lo sbrano e provocò
una emorragia mortale. Capì di essere alla fine, si chiamò intorno al letto
dove lo avevano adagiato due filosofi amici suoi, Massimo e Prisco, e con
loro si mise a discutere serenamente sull'immortalità dell'anima.
Dicono che a un certo punto si ficcò la mano nella ferita, la ritrasse lorda
di sangue e, spruzzandone in aria alcune stille, esclamò con rabbia:
«Galileo, hai vinto!».
Ma probabilmente non è vero.
CAPITOLO SEDICESIMO
AMBROGIO E TEODOSIO
A NOMINARE il successore, soprattutto per provvedere alla propria
salvezza in quell'ora di pericolo, fu l'esercito, che lo scelse, seguitando a
ritirarsi, fra i suoi ufficiali. E fu un certo Gioviano, cui la sorte concesse di
compiere, come imperatore, un gesto solo, ma stupido e vile: una pace
frettolosa, che concedeva ai persiani l'Armenia e la Mesopotamia, come a
pagamento di una vittoria ch'essi non avevano riportato.
Ciò fatto, Gioviano si ammalò e morì, prima di raggiungere la capitale.
Di nuovo l'esercito si fermò per designare un altro imperatore e stavolta il
prescelto fu Valentiniano, un bravo generale, figlio d'un cordaio della
Pannonia, che Giuliano, dicono, aveva in precedenza silurato perché non
aveva voluto rinnegare la sua fede cristiana. Sgomento delle responsabilità
che, col trono, gli piovevano sul capo, Valentiniano si associò a parti uguali
il fratello Valente, cui lasciò Costantinopoli con le province orientali, per sé
tenendo quelle occidentali, di cui Milano era ormai la capitale. Correva
l'anno 364 dopo Cristo.
Ambedue i fratelli ebbero subito due grossi problemi da affrontare.
Valente si trovò di fronte all'insurrezione di Procopio che, unico parente di
Giuliano, si mise alla testa di alcuni distaccamenti in Cappadocia
facendosene proclamare imperatore. Fu sconfitto, catturato e decapitato.
Valentiniano dovette vedersela con gli alemanni che, alla notizia della morte
di Giuliano di cui avevano una paura birbona perché li aveva sonoramente
battuti, ripresero i loro sconfinamenti in Gallia. L'imperatore li accerchiò e
annientò sul Reno. Poi mandò in Britannia il suo miglior generale,
Teodosio, che vi rimise ordine sbaragliandovi sassoni e scoti. Ma questo
bravo soldato fu mal ricompensato dei servizi che aveva reso. Perché,
spedito subito dopo in Africa a ristabilirvi la pace, cadde vittima
degl'intrighi di alcuni funzionari malversatori che, con le loro calunnie, lo
fecero processare per tradimento, condannare e decapitare.
Valentiniano, ingannato anche lui, commise certamente questo errore in
buona fede. Non era un uomo di eccelsa mente, ma aveva buon senso e un
carattere saldo e diritto. Purtroppo, era soggetto a scoppi di collera, e fu in
questi iracondi soprassalti che compì i due più grossi sbagli della sua vita: la
firma al verdetto di condanna di Teodosio, e la propria morte. Infatti si
lasciò fulminare dalla sincope il giorno che prese una solenne arrabbiatura
con i quadi che gli si erano ribellati.
Siamo nel novembre del 375 dopo Cristo. Ma la successione al trono
stavolta era già regolata, perché Valentiniano otto anni prima si era associato come collega il figlio Graziano; cui, a quindici anni, aveva dato in
moglie la tredicenne Costanza, figlia postuma di Costanzo, la cui vedova
aveva sposato poi Procopio ed era rimasta vedova anche di lui, ma con un
figlio in più: Valentiniano II. Sì, è un po' difficile, me ne rendo conto, e per
questo cercherò di spiegarmi meglio.
Valentiniano aveva, oltre al fratello Valente cui restava la metà orientale
dell'Impero, un figlio di nome Graziano. Costui aveva sposato Costanza,
figlia dell'imperatore Costanzo. Sua madre Giustina, rimasta vedova, aveva
poi sposato l'usurpatore Procopio, il quale le aveva dato un figlio di nome
Valentiniano, che era quindi fratellastro di Costanza. Ci siamo?
Ora Giustina, ch'era una donna ambiziosissima, tanto aveva armeggiato e
intrigato da spingere il consuocero Valentiniano ad assumere come collega
non solo Graziano, ma anche Valentiniano, che aveva allora quattro anni.
Sicché, alla morte dell'imperatore, mentre a Costantinopoli restava Valente,
a Milano saliva sul trono il giovinetto Graziano, tutore di Valentiniano II,
con cui poi avrebbe diviso il potere.
Era un brutto momento perché proprio allora stavano calando dalla Russia
valanghe di barbari più terribili di tutti gli altri: gli unni. Essi erano già
arrivati a contatto dei goti, che il re Ermanrico aveva raccolto in una
federazione ai confini orientali dell'Impero. Atterriti, costoro chiesero a
Valente di esservi annessi promettendo in cambio di farvi da sentinelle.
Valente, dopo molte esitazioni, accettò, ma per pentirsene subito, quando
vide quei nuovi sudditi, che oscillavano fra i due e i trecentomila, darsi al
brigantaggio e al saccheggio com'era loro costume. Egli era in procinto di
riprendere le armi contro la Persia. Dovette accantonare il progetto per
accorrere a Adrianopoli, dove i riottosi goti si erano spinti. Invece di
aspettare il nipote Graziano che, come si era convenuto, giungeva dal Nord
per stritolare il nemico in una morsa, Valente attaccò subito, da solo, e ci
rimise tutto l'esercito. Egli stesso, ferito, fu arso vivo nella capanna in cui i
suoi attendenti lo avevano ricoverato.
Graziano, rimasto solo, non osò attaccare. Sebbene avesse solo vent'anni,
si era già mostrato un buon generale. Ma ora diede prova anche di grande
assennatezza. Si ritirò cautamente, dispose le sue forze a protezione
dell'Illiria e dell'Italia. E, rendendosi conto di non poter dividere le
responsabilità dell'Impero con un bambino qual era il suo cognatastro
Valentiniano II, pensò di associarsi un collega per l'Oriente. Con molta
sagacia, lo scelse nel generale Teodosio, l'omonimo figlio di quello che
Valentiniano aveva fatto ingiustamente accoppare in Africa. E gli affidò
l'Impero d'Oriente. Ma intanto sulla scena era comparso un altro e decisivo
personaggio: quell'Ambrogio, vescovo di Milano, che ora tutti gl'italiani, e
specialmente i lombardi, venerano come santo.
Non era un prete e non veniva dal seminario. Era un bravissimo
funzionario laico, che sino al 374 aveva fatto il governatore della Liguria e
dell'Emilia. Come tale, si era trovato a dirimere le controversie tra cattolici e
ariani, che anche in quelle diocesi infuriavano. Lo aveva fatto così bene che
alla morte del vescovo Ausenzio, ariano anche lui, fu acclamato suo
successore. Non era nemmeno battezzato, in quel momento, e l'elezione
aveva tutti i crismi dell'irregolarità. Ma Valentiniano I, che aveva una
grande stima di lui, l'aveva confermata. E Ambrogio in pochi giorni
ricevette i sacramenti, gli ordini e il cappello episcopale.
Era un uomo che, se fosse nato oggi in America, sarebbe diventato un
Ford o un Rockefeller. E Graziano che, morto suo padre, gli si affidò in
pieno, trovò in lui il suo più valido collaboratore. Vescovo e sovrano
condussero insieme la lotta contro il paganesimo e l'eresia ariana. Quest'ultima, morto Valente che n'era stato prigioniero, non ebbe più difensori.
Teodosio, che forse doveva in buona parte la sua nomina ad Ambrogio, fu,
in materia religiosa, un suo zelante esecutore di ordini. Il paganesimo era
definitivamente sepolto. E in seno al Cristianesimo era il Cattolicesimo che
trionfava.
Purtroppo, le cose non andarono altrettanto bene sul piano strettamente
politico. Accusando Graziano di essere, come oggi si direbbe, un democristiano piedipiatti e baciapile, il governatore della Britannia, Magno
Massimo, gli si ribellò. Il complotto aveva degli affiliati anche alla corte del
giovane imperatore, che si trovava in quel momento a Parigi e che fu
pugnalato mentre cercava di scappare. Ipocritamente, Massimo deplorò
l'incidente in una lettera a Teodosio in cui gli proponeva di ripartire in tre
l'Impero lasciando a Valentiniano, sotto la tutela di sua madre e di
Ambrogio, l'Italia, e di affidare a lui, Massimo, le province occidentali.
Teodosio era un galantuomo dai riflessi lenti. I suoi nemici lo chiamavano
"un cacadubbi", e forse effettivamente, nel ponderare le decisioni, esagerava
un po'. La fine dell'amico e collega Graziano, cui tanto doveva, lo aveva
indignato. Ma una guerra, nelle condizioni in cui si trovava allora l'Impero
coi goti in subbuglio e gli unni e i persiani alle porte, gli parve una scelta da
scartare. Mandò una risposta dilatoria e tergiversante. Massimo la interpretò
in senso positivo. E, dimenticando l'accusa di baciapilismo lanciata contro
Graziano, spiegò un grande zelo nella lotta contro gli eretici per guadagnarsi
il favore di Ambrogio. Nonostante gl'impegni assunti verso Valentiniano,
pensava con ghiottoneria all'Italia, riuscì a farvi accettare alcuni fra i suoi
reparti più fedeli col pretesto di rafforzarvi le guarnigioni di frontiera, e tutto
sarebbe finito con un altro regicidio, se Giustina, impaurita, non fosse scappata da Teodosio portandosi dietro il figlio imperatore e la figlia Galla che,
fra parentesi, era un fior di figliuola.
Tanto bella che Teodosio, nel vederla, se ne invaghì di colpo, e l'amore
fece quello che il calcolo politico non aveva potuto, per spingerlo a castigare
l'usurpatore. Lo scontro fra i due eserciti avvenne in Pannonia. E Massimo,
sconfitto, venne decapitato. Teodosio sposò Galla, riaccompagnò la suocera
e il cognatino a Milano, tenne loro compagnia per un pezzo, e anche con
questo gesto stabilì una specie di tutela dell'Impero d'Oriente su quello
d'Occidente.
Ambrogio nel frattempo aveva continuato la sua battaglia contro l'eresia.
Gli ariani, debellati da Teodosio a Costantinopoli, in Italia erano stati
protetti da Giustina, che sulle loro teorie aveva educato Valentiniano. Essa
domandò ora che almeno una chiesa venisse loro concessa. Ambrogio
rispose di no. Valentiniano gli comminò l'esilio. E Ambrogio non si mosse.
Era un santo, sì, ma aveva un gran caratteraccio. Subito dopo avvennero
altri clamorosi episodi. I cristiani di Callinico bruciarono la sinagoga.
Teodosio, tuttora a Milano, ordinò che venisse ricostruita a spese dei
colpevoli. Ambrogio andò a chiedere la revoca di quell'ordine. E, siccome
non venne ricevuto, prese penna e calamaio: Io ti scrivo perché tu mi ascolti
nel tuo palazzo. Altrimenti mi farò ascoltare nella mia chiesa...
Cos'era successo nel mondo, che consentiva a un prete di elevarsi a
giudice del capo supremo dello stato, di cui sino a quel momento non era
che un semplice funzionario? Teodosio, se fosse stato Valentiniano I,
sarebbe stato colto anche lui da una sincope, tale fu la sua collera. Invece
tacque e si piegò. Poco dopo dovette intervenire contro quelli di
Tessalonica, che avevano massacrato le guardie, ree di aver arrestato un
auriga, idolo dei "tifosi". Ci andò con la mano un po' pesante, è vero, ma
stavolta non si trattava di questioni religiose. Eppure anche in tale occasione
Ambrogio insorse, parlò dal pulpito, rifiutò d'incontrarsi con l'imperatore e
gli proibì l'accesso alla chiesa finché quegli non ebbe domandato
solennemente e umilmente perdono. Era il trionfo del potere spirituale su
quello temporale, e per celebrarlo fu composto un inno apposta: il Te Deum
laudamus.
Il paganesimo ebbe ancora un sussulto con Arbogaste, un condottiero
franco che gli era rimasto fedele e che aveva reso segnalati servigi
all'Impero sotto Graziano. Ora era capo delle guardie di Valentiniano, ma
disprezzava quel ragazzetto che si metteva in ginocchio davanti ad
Ambrogio e gli baciava l'anello. Un giorno il giovane imperatore fu trovato
morto nel suo letto. Arbogaste disse che si era ucciso, ma non ne usurpò il
posto. Si rendeva conto che l'Impero romano, per quanto decaduto, non era
ancora arrivato al punto di accettare sul trono un barbaro come lui. E
v'innalzò Flavio Eugenio, capo degli uffici civili, qualcosa come cancelliere
di Sua Maestà, per sé serbando il comando dell'esercito.
Neanche stavolta Teodosio reagì subito. Anzi, lasciò passare due anni
prima di decidersi al castigo. In questo periodo Arbogaste impose ad
Eugenio una politica che voleva essere di tolleranza e di equidistanza dalle
due religioni. Ma dovette rendersi conto anche lui che il paganesimo non
resuscitava nemmeno con le iniezioni di adrenalina.
Nel 394 l'imperatore e l'usurpatore scesero in guerra. Flavio e Arbogaste,
che aspettavano il nemico in Italia, costellarono i valichi delle Alpi Orientali
con statue di Giove, il quale fece così la sua ultima comparsa tra gli umani,
armato di fulmini d'oro. Teodosio, prima di partire, era andato nel deserto
della Tebaide a visitare un anacoreta che gli aveva predetto la vittoria.
Ognuno dei due eserciti aveva insomma mobilitato il proprio dio, e infatti lo
scontro fu risolto da una specie di miracolo meteorologico: una
violentissima bora che, soffiando negli occhi dei flaviani, quasi li accecò.
Giove, Arbogaste ed Eugenio vennero travolti nella stessa catastrofe. Ma a
sconfiggerli in nome di Gesù, sia pure sotto il comando dell'imperatore
romano Teodosio, erano stati soprattutto i goti pagani agli ordini di Alarico.
Teodosio, giunto trionfatore a Milano, vi morì d'idropisia. L'imperatore
romano non aveva ancora cinquant'anni, e non era mai andato a Roma,
ormai tagliata fuori dalla grande politica. Era stato non un grande, ma un
buon sovrano: leale e onesto, anche se un po' timorato e timoroso.
Lasciava due figli: Arcadio di diciotto anni, e Onorio di undici.
CAPITOLO DICIASSETTESIMO
LA FINE
QUELLO di Occidente che toccava al bambino Onorio era un Impero che
già Teodosio aveva considerato satellite di quello d'Oriente, che un vescovo
aveva sottoposto alla tutela spirituale della Chiesa, e che, per difendersi,
aveva dovuto accettare entro i propri confini popolazioni barbare, ancora
pagane e assolutamente digiune di stato e di diritto. Ma anche all'interno si
disgregava. Non più tutelate da un esercito che le guerre esterne
risucchiavano ai confini, le piccole comunità di villaggio e di provincia
sempre più si rimettono per la loro difesa ai signorotti, che possono disporre
di milizie proprie. Si chiamano Potentes, costoro, e si fanno sempre più
indipendenti dall'autorità centrale via via che questa sempre più
s'indebolisce. A favorirli è anche una legislazione che da Diocleziano in poi
ha sempre più pietrificato la società, legando irrevocabilmente il contadino
alla terra e al suo padrone, cioè facendone un servo della gleba, e l'artigiano
al suo mestiere. Ormai si nasce col proprio destino e non si può più
cambiarlo. Chi abbandona il podere o la bottega, anche se riesce a sfuggire
ai carabinieri che subito lo ricercano, è destinato a morir di fame perché non
trova altro impiego. E chi è ricco deve seguitare a pagar tasse, anche se
aliena o perde la ricchezza. Altrimenti va in prigione.
Queste leggi, per assurde che possano sembrare, erano imposte dalle
circostanze. Gli scheletri che vanno in pezzi, bisogna ingessarli. Il gesso non
impedisce la decomposizione, ma la rallenta. Tutto questo però è la fine di
Roma, della sua civiltà, del suo ordinamento giuridico, che faceva di ogni
uomo l'arbitro della propria sorte, lo parificava agli altri dinanzi alla legge, e
con la cittadinanza ne faceva non soltanto un suddito, ma anche un
protagonista. È cominciato il Medio Evo. Il potente prende il posto dello
stato, cui si contrappone con sempre maggior successo, fino a romperlo in
una miriade di feudi, ciascuno col proprio signore alla testa, armato sino ai
denti, sul groppone di una massa amorfa, minuta e inerme, abbandonata ai
suoi capricci e senza più nessun diritto: nemmeno quello di cambiar
professione e residenza.
Accanto all'undicenne Onorio, cui toccava in eredità quel crollante
edificio, fu messo il generale Stilicone. Era un vandalo, cioè un barbaro di
razza tedesca, e la sua scelta ci dice fino a che punto ormai i romani si erano
liquefatti. Soltanto lui, fra tutti gli ufficiali dell'esercito, offriva garanzie di
lealtà, di coraggio e di perspicacia. E infatti ebbe modo di fornirne subito le
prove nella situazione che, calato Teodosio nella fossa, subito si arruffò fra
Milano e Costantinopoli. Il defunto imperatore aveva diviso l'Impero, ma
non aveva detto quali province appartenessero all'uno e all'altro moncone.
Arcadio, salito sul trono di quello d'Oriente, e consigliato dal proprio
Stilicone, che si chiamava Ruffino, considerò roba sua anche la Dacia e la
Macedonia. Sorse una baruffa tra le due capitali. Alarico, che malgrado le
promesse nessuno aveva compensato del contributo fornito a Teodosio nella
guerra contro Arbogaste, marciò su Costantinopoli. E certamente l'avrebbe
messa a sacco se Ruffino non fosse riuscito a persuaderlo che la Grecia era
un boccone più prelibato. L'Impero, incapace di difendersi, salvava la
capitale a spese delle province.
A indignarsene fu solo Stilicone, il barbaro, che mandò a Costantinopoli
un distaccamento di truppe richiestegli da Arcadio, con l'ordine al loro
comandante, Gaina, anche lui barbaro, di accoppare Ruffino. L'ordine fu
scrupolosamente eseguito, e al posto del defunto fu nominato un suo
avversario, il ciambellano di corte Eutropio, con cui fu possibile ristabilire
un'intesa fra i due fratelli. Subito Stilicone ne approfittò per mettere a posto
i goti, che saccheggiavano il Peloponneso. Li aveva già insaccati nell'istmo
di Corinto, quando Costantinopoli, gelosa di un successo occidentale,
stipulò un'alleanza con loro e ordinò al generale di lasciarli in pace.
Stilicone si mangiò le mani, ma obbedì anche perché proprio in quel
momento si era ribellata l'Africa, aiutata sottomano da Arcadio e da
Eutropio, mentre ondate di barbari si rovesciavano in Balcania, e Alarico,
l'alleato di Costantinopoli, dopo aver risalito l'Albania e la Dalmazia,
entrava addirittura nella pianura padana. Il povero generale vandalo, unico
rimasto a credere nell'Impero e a servirlo con fedeltà, e costretto a
trascorrere la sua vita sulla sella d'un cavallo lanciato al galoppo per tappare
i buchi che si aprivano da ogni parte, tornò in Italia, batté Alarico ma senza
distruggerne le forze perché pensava di allearselo contro quelle nemiche
sempre più soverchianti. E, non fidandosi più di Milano che, senza difese
naturali, poteva essere conquistata da chiunque, trasportò la capitale a
Ravenna, un villaggio di poco conto, ma circondato di paludi malariche che
avrebbero reso impossibile un assedio. Correva l'anno 403 dopo Cristo.
Il trasferimento fu fatto appena in tempo per sfuggire a un'invasione di
altri goti, che si chiamarono ostrogoti per distinguerli dai visigoti di Alarico,
e che, sotto il comando di Radagaiso, passarono le Alpi e si abbatterono
sulla penisola sommergendola fino alla Toscana. Era la prima volta, dal
tempo di Annibale, che l'Italia subiva un simile affronto. A Stilicone occorse
un anno per raccogliere truppe. Solo nel 406 ne ebbe abbastanza per
sorprendere quelle di Radagaiso a Fiesole e sterminarle. Ma nello stesso
momento vandali, alani e svevi sfondavano le difese romane di Magonza ed
entravano in Gallia, dove sbarcava anche dalla Britannia un usurpatore chiamato Costantino, che mise in fuga i barbari i quali però, invece di ritirarsi,
sommersero la Spagna. Le più belle province d'Occidente erano
praticamente perdute, e l'Italia in balìa di se stessa.
In questo marasma, in cui chiunque avrebbe perso la testa, Stilicone era
l'unico che l'aveva serbata chiara. Mentre trattava con Alarico per
garantirsene l'aiuto bandì una leva fra gl'italiani. Costoro rifiutarono di
arruolarsi, ma lo accusarono di capitolazione di fronte al barbaro. Con che
soldati da costui il generale potesse difenderli, visto che loro ricusavano di
dargliene, Dio solo lo sa. Onorio, impaurito, dimenticò di colpo i servigi che
per dieci anni gli aveva reso quel fedele capitano, e ne ordinò l'arresto.
Stilicone avrebbe potuto benissimo insorgere perché le poche truppe di cui
disponeva l'Impero erano fedeli soltanto a lui. Ma aveva troppo rispetto
dell'autorità per ribellarvisi. Lo trucidarono in una chiesa, a Ravenna. E fu
forse il più stupido, ignobile e catastrofico dei delitti che siano stati
commessi in nome di Roma. Esso non soltanto privò del suo miglior
servitore l'Impero, ma fece capire a tutti i barbari, che ancora gli erano fedeli, che cosa esso fosse diventato. Erano costoro i migliori funzionari e
soldati che ancora reggevano la baracca. Essi credevano al prestigio di
Roma. E Roma, uccidendo Stilicone, lo distrusse con le sue mani.
Da allora tutto precipitò. Alarico, invece di venire in Italia come alleato,
vi giunse da conquistatore. Propose un accordo a Onorio il quale lo respinse
con una fierezza che sarebbe stata nobile se accompagnata da qualche gesto
di coraggio, ma che diventava insolente e ridicola nella bocca di un uomo
che si rinchiudeva a Ravenna facendosi difendere solo dalle zanzare e
abbandonando il resto d'Italia all'avversario. Questi marciò addirittura su
Roma e l'assediò. Il mondo trattenne il respiro. Come? Si osava addirittura
porre assedio a Roma?
Lo stesso Alarico parve colto dal timor panico, quando la città si arrese
senza combattere, e vietò ai suoi soldati di entrarvi. Ci venne solo e
disarmato per chiedere al Senato di deporre Onorio. E il Senato, che ormai
esisteva solo per figura, subito accondiscese. Ma l'anno dopo, siccome
Onorio dal trono non scendeva, vi tornò e stavolta vi mise a bivacco tutto
l'esercito, ma impedendogli, o cercando d'impedirgli, il saccheggio. I barbari
si aggirarono per la città sbalorditi e spaventati dalla loro stessa audacia.
Nelle selve germaniche da cui i loro antenati erano discesi, si era sempre
favoleggiato di Roma come di un irraggiungibile miraggio. Più che
spogliare, furono spogliati da una popolazione che aveva disimparato a
combattere, ma aveva imparato a rubare. E lo stesso Alarico si trasformò da
conquistatore in prigioniero, quando si trovò di fronte a Galla Placidia, la
bellissima figlia di Teodosio, sorellastra di Onorio e di Arcadio. Da quel
momento il re cui obbedivano i goti ebbe una regina cui obbedire. Se la
portò dietro circondandola di tutti gli onori nella sua ultima avventura: la
spedizione in Africa. Ma mentre la preparava sulle coste calabresi, la morte
lo colse a Cosenza. I suoi soldati gli fecero costruire una immensa e fastosa
tomba sotterranea. Eppoi, perché nessuno ne venisse a conoscere il segreto e
la violasse, uccisero tutti gli schiavi che avevano lavorato a scavarla. A
succedergli fu acclamato il fratello di sua moglie, Ataulfo, un bellissimo
ragazzo, di cui Galla Placidia era già da un pezzo l'amante.
La violazione di Roma del 410 e la volontaria scelta di una principessa di
sangue reale, che alla sofisticata reggia imperiale aveva preferito la disadorna tenda di un condottiero barbaro, precipitarono nello sbigottimento il
mondo intero. I pagani dissero ch'era una vendetta degli dèi per il
tradimento degli uomini. E i cristiani, i quali avevano lottato per quattro
secoli contro Roma, ora alla sua caduta si sentirono improvvisamente orfani
e ci videro il segno dell'avvento dell'Anticristo. «La fonte delle nostre
lacrime si è disseccata», singhiozzò san Girolamo.
Solo Onorio sembrava infischiarsene. Chiuso tra gli stagni della sua
Ravenna, rifiutò l'assenso al matrimonio di Galla con Ataulfo e, insensibile
allo sfacelo in cui precipitava la stessa Italia, vegetò fino al 423, quando
morì. Troppo presto per i suoi giovani anni. Troppo tardi, per il modo come
li aveva riempiti. Anche Ataulfo era morto parecchio tempo prima sotto il
pugnale di un barbaro, e Galla era tornata, vedova, a casa. Onorio l'aveva
sposata di forza a un generale rimbambito, Costanzo; e siccome non aveva
eredi, designò a succedergli il figlio nato da questo matrimonio:
Valentiniano III.
Anche Arcadio, a Costantinopoli, era morto da un pezzo, lasciando sul
trono un ragazzetto: Teodosio II. E tragicomico fu vedere in quel momento i
due tronconi dell'Impero, incalzati dalla medesima catastrofe, rimettersi in
contatto solo per litigare sulla delimitazione dei confini. L'Impero era già
tutto in mano ai barbari, e i due romani imperatori, fra l'altro cugini germani, si contendevano una teorica sovranità su province praticamente già
perdute. Un ultimo sprazzo di orgoglio e di coraggio la romanità lo dava
soltanto in Africa, dove il generale Bonifacio, già condannato per alto
tradimento, e il vescovo Agostino, assediati a Ippona, resistevano ai vandali
di Genserico. Fu nell'infuriare della battaglia, dove cadde, che il presule
scrisse la sua opera capitale: La Città di Dio.
L'incalzante prevalere dell'elemento germanico su quello romano trovava
il suo simbolo e riassunto nelle vicende della famiglia imperiale. A Ravenna
sul trono c'era Valentiniano III, ma la vera regina era Placidia, che come
strumento del suo potere s'era scelto un altro barbaro, Ezio, degno
successore di Stilicone. Essa aveva dimostrato di non credere ai romani
neanche come mariti. Figuriamoci se se ne fidava come generali e uomini di
stato. Quando all'orizzonte spuntò Attila, alla testa dei suoi terribili unni,
essa fece fare a sua figlia, Onoria, ciò che aveva fatto lei stessa con Ataulfo:
gliela propose in sposa. Capiva che ormai Roma, coi barbari, poteva vincere
su un campo di battaglia solo: il letto.
Ma Attila non era Alarico. Invece di entusiasmarsi per Onoria, reclamò
anche una dote spropositata: la Gallia. Era la più bella provincia dell'Impero
e, sebbene la sovranità imperiale vi fosse soltanto teorica, la corte di
Ravenna non vi poteva rinunciare. Attila vi straripò ugualmente, ed Ezio
dovette scendere con lui in guerra. Ma, per procurarsi un esercito adeguato,
fu costretto, con un miracolo di diplomazia, ad associarsi nell'impresa il re
dei visigoti, Teodorico. La gigantesca battaglia si svolse nei Campi
Catalauni presso Troyes. E i romani vinsero, ma di romano non avevano che
l'etichetta. Barbari erano coloro che sconfiggevano altri barbari, e un
barbaro romanizzato era il loro stesso comandante supremo. Esso rimase
padrone del campo, ma non inseguì il nemico che si ritirava in buon ordine.
Non aveva sufficienti forze o sperava di farsene un alleato, come Stilicone
era riuscito a fare coi goti?
Nel 452, Attila ricomparve. Ma stavolta non attaccava la Gallia, sibbene
l'Italia stessa. Valentiniano, che, morta sua madre, aveva assunto il potere
effettivo, non volle ripetere l'indecoroso errore di Onorio abbandonando
Roma al suo destino. E, contro il parere di Ezio che gli consigliava di
fuggire in Oriente anche per sbarazzarsene, si trasferì nell'Urbe per
condividerne la sorte. E qui si mise d'accordo col papa, Leone I, per
mandare un'ambasceria di senatori ad Attila, già accampato sul Mincio.
La leggenda vuole che Attila s'impaurisse alla minaccia di essere
scomunicato se osava attaccare Roma. Ma, essendo pagano, non vediamo
proprio cosa potesse la scomunica significare per lui. Comunque, invece di
passar l'Appennino, ripassò le Alpi, e l'anno dopo morì. Del vasto effimero
Impero che si era costruito dalla Russia fino al Po, non rimase nulla,
neanche il popolo, che si sbriciolò e venne rapidamente fagocitato dalle
popolazioni slave e germaniche in mezzo a cui si era accampato da padrone.
La fine di questo pericoloso nemico fu un sollievo per l'Italia e l'Europa,
ma una mazzata in testa per Ezio che, chiuso a Ravenna, non vi aveva punto
collaborato. Valentiniano, che sempre aveva mal sopportato quel servitore
con piglio di padrone, ci vide la buona occasione per disfarsi di lui, come
Onorio aveva fatto con Stilicone. E lo fece di sua mano, infilandolo con la
spada, un giorno che litigarono. Altro fatale errore perché di colpo tutti i
barbari che, accampati nelle province dell'Impero, avevano accettato un
teorico vassallaggio, si misero in subbuglio, e uno di loro accoppò lo stesso
Valentiniano nel Campo di Marte. Genserico, il re dei vandali che ormai
eran padroni dell'Africa, giunse col suo esercito annunziandosi vendicatore
dell'imperatore. In realtà voleva farne occupare il posto dal proprio figlio
Unnerico sposandolo alla figlia del defunto: Eudocia. Il matrimonio si fece.
Ma mentre i soldati lo festeggiavano saccheggiando scrupolosamente la città
e dando così alla parola "vandali" il significato che tutti sappiamo, il nuovo
re dei visigoti, Teodorico II, faceva eleggere in Gallia un altro imperatore di
sua fiducia, Avito.
Genserico tornò in Africa di corsa, ma con un bel bottino: la nuora, la
consuocera vedova di Valentiniano con l'altra figlia Placidia, e alcune
migliaia di romani altolocati, tra cui qualche dozzina di senatori, come per
dire che Roma oramai era roba sua. Giunto a casa, allestì una flotta con cui
occupò la Sicilia, la Corsica e l'Italia meridionale. Ma Avito aveva un
grande generale, barbaro si capisce, ma della stoffa di Stilicone e di Ezio:
Ricimero. Egli sconfisse il nemico in una grande battaglia navale, poi
depose Avito che si consolò nella fede e si fece consacrare vescovo di
Piacenza, e non gli nominò un successore che quattro anni dopo, nel 457,
scegliendolo nella persona di Maioriano.
Lo fece solo per veder di richiamare all'ordine i vandali, i visigoti, e tutti
quegli altri barbari che avevano approfittato della mancanza d'un imperatore
per proclamarsi anche formalmente indipendenti. Ma servì a poco. Essi
seguitarono a fare il comodo loro. Maioriano tentò una spedizione contro
Genserico che gli distrusse a tradimento la flotta, e Ricimero, indignato che
volesse governare sul serio, lo fece trucidare, per sostituirlo con Libio
Severo, uomo più arrendevole. Ma Genserico la pensava diversamente.
Avendo rinunziato a far salire sul trono il figlio Unnerico, marito di
Eudocia, riponeva ora le sue speranze nel senatore Anicio Olibrio cui aveva
dato in moglie la sorella di sua nuora, Placidia. E aveva cominciato una
nuova guerra, cioè aveva continuato con più vigore quella che già da anni
combatteva contro Roma.
Per difendersene, Ricimero ebbe una buona idea: quella di offrire, alla
morte di Severo, il trono a un uomo di fiducia di Costantinopoli, e di
garantirsene così l'aiuto. Si chiamava Procopio Antemio. Venne in Italia nel
467, s'incoronò, armò una flotta di mille navi con centomila uomini agli
ordini del generale Basilisco e la spedì verso le coste tunisine. Basilisco,
appena sbarcato, non seppe far di meglio che accordare una tregua di cinque
giorni a Genserico, che attaccò di sorpresa i vascelli e li incendiò. Si parlò di
tradimento del generale. In realtà il tradimento lo aveva compiuto la corte di
Costantinopoli che sotto sotto aveva concluso un patto d'alleanza col re dei
vandali. Il quale riprese l'offensiva, sbarcò in Italia e mise per la terza volta
Roma a sacco. Ricimero accettò Olibrio come nuovo imperatore, ma
ambedue morirono in quello stesso anno 472.
I vandali cercarono d'imporre sul trono Glicerio. Ma Costantinopoli non lo
riconobbe, nominò al suo posto Giulio Nepote e, per metterlo al sicuro da
Genserico, comprò da costui una pace disastrosa riconoscendogli la signoria
non solo su tutta l'Africa, ma anche su Sicilia, Sardegna, Corsica e Baleari.
L'anno dipoi il re dei visigoti, Eurico, in cambio della neutralità, ottenne la
Spagna. Burgundi, alemanni e rugi si spartirono il resto delle Gallie. E
l'Impero d'Occidente si ridusse alla sola Italia. Nepote diede al generale
Oreste l'ordine di licenziare l'esercito che non poteva più mantenere. I
barbari che lo componevano si ammutinarono, Oreste ne prese il comando, e
Nepote fuggì per raggiungere in Dalmazia quel Glicerio ch'egli stesso vi
aveva confinato dopo averne usurpato il trono.
Oreste proclamò sovrano suo figlio, Romolo Augusto. Una sorte ironica
volle dare a questo ragazzo, destinato a essere l'ultimo imperatore di Roma,
il nome del primo. Ma i soldati barbari, inebriati della vittoria, ora
reclamarono terre nel cuore stesso della penisola, e chi voleva la pianura del
Po, e chi l'Emilia, e chi la Toscana. Uno dei loro ufficiali, Odoacre, prese la
testa della rivolta, attaccò Oreste a Pavia, lo sconfisse e lo uccise. Romolo
Augusto, che poi la storia ha chiamato "Augustolo", cioè "Augusto il
piccolo" per distinguerlo dal grande, venne deposto e confinato nel Castel
dell'Uovo a Napoli con una ricca pensione. Odoacre rimandò all'imperatore
d'Oriente, Zenone, le insegne dell'Impero, e dichiarò che d'ora in poi
avrebbe governato l'Italia come suo luogotenente.
Stavolta era proprio finita: non soltanto di fatto, ma anche di nome. Le
aquile erano volate via. Cominciava il Medio Evo.
CAPITOLO DICIOTTESIMO
CONCLUSIONE
Qui finisce la nostra storia. Come tutti i grandi Imperi, quello romano non
fu abbattuto dal nemico esterno, ma roso dai suoi mali interni. E il suo atto
di decesso fu segnato non dalla deposizione di Romolo Augustolo, ma dalla
adozione del Cristianesimo come religione ufficiale dello stato e dal
trasferimento della capitale a Costantinopoli. Con questo duplice
avvenimento comincia, per Roma, un altro capitolo.
La maggioranza degli studiosi sostiene che questa catastrofe fu provocata
soprattutto da due fatti: il Cristianesimo e la pressione dei barbari che
calavano dal Nord e dall'Oriente. Noi non lo crediamo. Il Cristianesimo non
distrusse nulla. Si limitò a seppellire un cadavere: quello di una religione in
cui ormai non credeva più nessuno, e a riempire il vuoto ch'essa lasciava.
Una religione conta non in quanto costruisce dei templi e svolge certi riti;
ma in quanto fornisce una regola morale di condotta. Il paganesimo questa
regola l'aveva fornita. Ma quando Cristo nacque, essa era già in disuso, e gli
uomini, consciamente o inconsciamente, ne aspettavano un'altra. Non fu il
sorgere della nuova fede a provocare il declino di quella vecchia; anzi, il
contrario. Tertulliano, che ci vedeva chiaro, lo scrisse apertamente. Per lui,
tutto il mondo pagano era in liquidazione. E quanto prima lo si sotterrava,
tanto meglio sarebbe stato per tutti.
Quanto ai nemici esterni, Roma era abituata da mille anni ad averne, a
combatterli e a vincerli. I visigoti, i vandali e gli unni che si affacciavano
alle Alpi non erano più feroci ed esperti guerrieri dei cimbri, dei teutoni e
dei galli che Cesare e Mario avevano affrontato e distrutto. E nulla ci
permette di credere che Attila fosse un generale più grande di Annibale, che
vinse dieci battaglie contro i romani, eppoi perse la guerra. Solo, trovò a
contendergli il passo un esercito romano composto esclusivamente di
tedeschi, compresi gli ufficiali, perché Gallieno aveva proibito il servizio
militare anche ai senatori. Roma era già occupata e presidiata da una milizia
straniera. La cosiddetta "invasione" non fu che un cambio della guardia fra
barbari.
Ma anche la crisi militare non era che il risultato di una più complessa
decadenza, innanzi tutto biologica. Essa era cominciata dalle classi alte di
Roma (perché, come dicono a Napoli, "il pesce comincia a puzzare dalla
testa") con l'allentamento dei vincoli familiari e il diffondersi delle pratiche
malthusiane e abortive. La vecchia orgogliosa aristocrazia, ch'è stata forse la
più grande classe dirigente che il mondo abbia visto, e che per secoli aveva
dato l'esempio dell'integrità, del coraggio, del patriottismo, insomma del
"carattere", dopo le guerre puniche, e più ancora dopo Cesare, cominciò a
dar quello degli egoismi e del vizio. Le famiglie che la componevano furono, sì, anche decimate dalle guerre, dove i loro rampolli cadevano
generosamente, e dalle persecuzioni politiche, ma soprattutto si estinsero per
penuria di figli. Grandi riformatori come Cesare e Vespasiano tentarono di
rimpiazzarla con dinastie più solide di borghesi provinciali e campagnoli.
Ma essi si corrompevano a loro volta, e la seconda generazione era già di
"gagà" rammolliti che non finivano a Cinecittà, solo perché Cinecittà ancora
non c'era.
Questo cattivo esempio fece presto a dilagare, e già al tempo di Tiberio
furono previste sovvenzioni ai contadini per incoraggiarli a fare figli.
Evidentemente, a parte la falcidia delle pestilenze e delle guerre, anche la
campagna faceva del malthusianesimo e si spopolava. Pertinace offriva
gratuitamente le fattorie abbandonate a chi s'impegnava a coltivarle. E in
questo vuoto materiale, conseguenza di quello morale, s'infiltravano gli
stranieri, specie d'Oriente, in dosi così massicce che Roma non fece in
tempo ad assorbirli e a rifonderli in una nuova e vitale società. Questo
processo di assimilazione funzionò fino a Cesare, che chiamò i galli a
partecipare alla vita dell'Urbe, facendone dei cittadini, dei funzionari, degli
ufficiali e perfino dei senatori. Ma esso diventò impossibile coi germani,
molto più refrattari alla civiltà classica, e si risolse in una catastrofe con gli
orientali che vi s'insinuarono, sì, ma per corromperla.
Di tutto questo, la conseguenza fu, sul piano politico, il dispotismo cui
Tiberio diede l'avvio, e che solo in alcuni casi fu "illuminato". Ma è sciocco
prenderlo a bersaglio della critica e addossargli le colpe della catastrofe. Il
dispotismo è sempre un malanno. Ma ci sono delle situazioni che lo rendono
necessario. Roma era in una di queste situazioni, quando Cesare lo instaurò.
Bruto, che lo uccise, se non era un volgare ambizioso, era certamente un
povero diavolo che credeva di guarire il gran malato eliminando non il bacillo, ma la febbre. Anche l'esperimento socialista e pianificatore di
Diocleziano fu un malanno e non risolse nessun problema. Ma le circostanze
lo imponevano come ultimo disperato rimedio.
A guardare le cose dall'alto e a voler dare loro una ragione, si può dire che
Roma nacque con una missione, l'assolse, e con essa finì. Questa missione
fu di raccogliere le civiltà che l'avevano preceduta, la greca, l'orientale,
l'egiziana, la cartaginese, di fonderle e di diffonderle in tutta l'Europa e il
bacino del Mediterraneo. Essa non inventò granché né nella filosofia, né
nell'arte, né nella scienza. Ma fornì le strade alla loro circolazione, gli
eserciti per difenderle, un formidabile complesso di leggi per garantirne lo
sviluppo nell'ordine, e una lingua per renderle universali. Non inventò
nemmeno delle forme politiche: monarchia e repubblica, aristocrazia e
democrazia, liberalismo e dispotismo erano già stati sperimentati. Ma Roma
ne fece dei modelli, e in ognuno di essi brillò per il suo genio pratico e
organizzativo.
Abdicando con Costantino, essa consegnò la sua struttura amministrativa
a Costantinopoli che ne visse per altri mille anni. E lo stesso Cristianesimo,
per trionfare nel mondo, dovette farsi romano. Pietro aveva capito
benissimo che solo infilando l'Appia, la Cassia, l'Aurelia, e tutte le altre vie
costruite dagl'ingegneri romani, non le labili piste che menavano nel
deserto, i missionari di Gesù avrebbero conquistato la terra. I suoi successori
si chiamarono Sommi Pontefici come quelli che avevano presieduto alle
faccende religiose dell'Urbe pagana. E contro l'austera regola ebraica,
introdussero nella nuova liturgia molti elementi di quella pagana: lo sfarzo e
la spettacolarità di certe cerimonie, la lingua latina, e perfino una venatura di
politeismo nella venerazione dei santi.
Così, non più come centro politico di un Impero, ma come cervello
direttivo della Cristianità, essa si apparecchiò a ridiventare caput mundi, e lo
è rimasta fino alla Riforma protestante.
Mai città al mondo ebbe più meravigliosa avventura. La sua storia è
talmente grande da far sembrare piccolissimi anche i giganteschi delitti di
cui è disseminata. Forse uno dei guai dell'Italia è proprio questo: di avere
per capitale una città sproporzionata, come nome e passato, alla modestia di
un popolo che, quando grida:
« Forza Roma!», allude soltanto a una squadra di calcio.
© 1959 Rizzoli Editore, Milano
© 1994 RCS Libri S.p.A., Milano sulla collana storia d’italia
© 2001 RCS Collezionabili S.p.A., Milano sulla presente edizione
storia d’italia
Pubblicazione periodica settimanale
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 197 del 9.4.1994
Direttore responsabile: Gianni Vallardi
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa
n. 00262 vol. III Foglio 489 del 20.9.1892
CRONOLOGIA
EVENTI POLITICI
E MILITARI
V sec. a.C. I Goti dalla Svezia passano in
Germania e poi nella Scizia, sul Mar Nero.
/// sec. d.C.
I Mongoli (Jong-Nu), respinti
dalla Cina, si rivolgono ad Occidente.
Settimio Severo ricaccia i Pitti, calati dalla
Scozia contro il limes romano sotto Commodo.
250 Sotto l'imperatore Decio i Goti
attraversano il Danubio e penetrano nella
Serbia. Decio è ucciso da loro nella battaglia
di Filippopoli.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
I o II sec. d.C. Sant'Apollinare, primo
vescovo di Ravenna, fonda in quella città la
chiesa cristiana. A lui sono dedicate le due
celebri basiliche.
III-V
secc.
L'
esercito
romano
è
sostanzialmente costituito anche negli alti
gradi da elementi barbarici; il gladius cede il
posto alla lunga spa-tha; appaiono le picche e
le corazze di ferro (catafratti); i municipi
romani
cominciano
a
fortificarsi
indipendentemente con sistemi propri di
difesa; si ricordano, sotto l'imperatore
Gallieno (intorno al 250), due architetti,
Cleodamo e Ateneo, incaricati di costruire
mura intorno alle città danubiane. L'Italia
conta non più di cinque milioni di abitanti.
267 I Goti sacceggiano Atene.
268 Claudio II batte e distrugge l’esercito
goto a Nisch, in Serbia.
313 Editto di Milano (Costantino) e libertà di
culto ai cristiani.
IV sec. Il monaco Ulfila, ariano, diffonde il
cristianesimo tra i Goti e traduce in goto il
Nuovo Testamento e parte dell'antico. Si
debbono a lui i caratteri gotici.
Quinto Aurelio Simmaco (morto nel 402),
autore di una Orazione per la collocazione
della statua della Vittoria in Senato.
315 I Sinodi di Roma e di Arles condannano
l'eresia di Donato (donatismo) che sostiene
che la chiesa è formata solo da santi e fa
dipendere la validità dei sacramenti dalla
santità del prete che li somministra.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
330 Costantino fonda Costantinopoli.
325 Concilio di Nicea.
375-378 Valente imperatore: 378, battaglia di
Adrianopoli e morte di Valente.
378-383 Graziano imperatore: 379, Teodosio
viene nominato Augusto. Ostrogoti e Visigoti
sono accolti entro i confini dell'impero. 380,
editto di Tessalonica contro gli Ariani. Morte
di Atanarico, re degli Ostrogoti. 383, rivolta
di
Massimo
e
morte
dell'imperatore
Graziano.
383-392 Valentiniano II imperatore, sotto la
tutela della madre Giustina. 388, Giustina
fugge a Costantinopoli presso Teodosio, cui
da in moglie la figlia Galla. Massimo è
battuto e ucciso ad Aquileia da Teodosio.
390, Ambrogio, vescovo di Milano, interdice
a Teodosio l'ingresso in chiesa dopo la strage
di Tessalonica (Salonicco).
392 Valentiniano è ucciso da Arbogaste, un
franco, che mette al suo posto il romano
Eugenio (392-394). Restaurazione momentanea del paganesimo.
394 Battaglia sul Frigido (l'Isonzo) e vittoria
di Teodosio contro Arbogaste ed Eugenio.
394-395
Teodosio
unico
imperatore.
Morendo,
divide l'impero tra i due figli:
lascia l'Oriente ad Arcadio, sotto la tutela di
Ruffino, e l'Occidente a Onorio, sotto la
tutela di Stilicene.
Eunapio
(347-420), storico greco, scrisse
una perduta Storia dei Cesari e Vite di sofisti.
395 I Visigoti eleggono re Alarico che invade
la Grecia. Arcadio lo nomina governatore
dell'Illiria. In quello stesso anno, sulle rive
del Danubio, appaiono i primi Mongoli.
Aurelio Prudenzio (tra il IV e il V sec.),
poeta, lasciò quattordici inni sotto il titolo Le
corone, dove canta martiri cristiani delle
ultime persecuzioni.
400 I Visigoti di Alarico
all'Italia. Stilicene console.
si
affacciano
Paolino di Fella (370-460), poeta in latino,
autore del poemetto Eucharisticos.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
405 Cala in Italia Radagaiso (ostrogoto?),
disfatto da Stilicone a Fiesole.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
404 Onorio pone fine a Roma ai giochi del
circo.
408 Muore Arcadio e gli succede in Oriente
Teodosio II, sotto la tutela della madre
Eudossia. In Italia muore Silicone.
Alarico devasta l'Italia settentrionale e
assedia Roma, mentre Onorio è chiuso in
Ravenna. Papa Innocenze I permette i riti
pagani.
409 I Romani assediati si ribellano a Onorio
e nominano imperatore Attalo.
410 Alarico saccheggia Roma; Attalo è
deposto. Alarico si dirige verso il sud, ma
muore a Cosenza; nomina successore il
fratello Ataulfo. Dal sacco di Roma, i
Visigoti hanno portato con loro prigioniera
Galla Placidia, figlia di Teodosio e quindi
sorellastra di Onorio.
414 Ataulfo sposa a Narbona Galla Placidia;
l'anno dopo viene assassinato.
415 Galla Placidia è restituita a Onorio e i
Visigoti lasciano l'Italia per stabilirsi a
cavallo dei Pirenei (regno di Tolosa, 419507).
418 Galla Placidia sposa Costanzo, generale
di Onorio : hanno una figlia, Onoria, e un
figlio, Valentiniano.
421 Morte di Costanzo.
425 Morte di Onorio. Sale al trono il figlio di
Galla Placidia, Valentiniano III, sotto la tutela della madre.
427 Bonifacio, già nominato da Galla Placidia conte d'Africa due anni prima, per rivalità
con Ezio, chiama i Vandali dalla Spagna in
Africa.
Paolo Orosio (tra il IV e il V sec.), lasciò
sette libri di Storie contro i pagani, dalla
creazione del mondo fino al 417.
Salviano di Marsiglia (V sec.), lasciò lettere e
trattati, tra cui Il governo di Dio, in otto libri.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
432 Bonifacio ed Ezio si battono. Morte di
Bonifacio.
435 Genserico fa la pace con Valentiniano e
organizza in Africa un rigoroso sistema
feudale.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
431 Concilio di Efeso, dove viene
condannata la dottrina di Nestorio, patriarca
di Costantinopoli (428-431), che sosteneva la
separazione in Cristo della natura divina da
quella umana.
443 Fondazione sul Rodano del Regno dei
Burgundi (443-534).
444 Attila unico re degli Unni alla morte di
Bleda.
447 Attila giunge fin sotto Costantinopoli.
450 Muore a Costantinopoli l'imperatore
Teodosio II; gli succede la sorella Pulcheria,
moglie di Marciano. Il 27 novembre muore a
Roma Galla Placidia.
451 Attila invade il Belgio e la Germania; è
battuto da "Ezio ai Campi Catalaunici.
452 Attila cala in Italia nel Veneto, distrugge
Aquileia. Incontra sul Mincio papa Leone I.
Poco dopo muore. I profughi di Aquileia
fondano Venezia.
454 Valentiniano uccide Ezio.
455 Uccisione di Valentiniano III (lascia la
vedova Eudossia).
Petronio
Massimo
imperatore.
Eudossia
chiama in Italia Genserico e i suoi Vandali
d'Africa. Petronio Massimo muore. Roma è
saccheggiata. Avito imperatore.
456 Nuovo tentativo dei Vandali contro
Roma; vengono dispersi in mare da Ricimero, che assume il titolo di patrizio.
451 Concilio ecumenico IV di Calcedonia,
con la condanna degli Eutichiani e la
conferma in Cristo delle due nature.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
457-460
Maggioriano imperatore. È posto
sul trono e deposto da Ricimero.
461-465 Libio Severo, anche esso creatura di
Ricimero, imperatore.
465-466 L'impero resta per due anni vacante.
467-472 Antemio imperatore.
472 Ricimero incorona Olibrio. Morte di
Ricimero.
473-474 Glicerio imperatore.
474-475 Giulio Nepote imperatore.
475 Oreste depone Giulio Nepote e nomina
imperatore il figlio Romolo Augustolo.
476 Odoacre cala con gli Eruli in Italia,
uccide Oreste e depone Romolo Augustolo.
Quindi invia a Costantinopoli le insegne
dell'Impero e regna in Italia (fino al 493) col
titolo di patrizio. Termina così la serie degli
imperatori romani d'Occidente.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Sidonio Apollinare (430-487), scrittore
latino di Lione. Lasciò nove libri di Lettere.
in
Prisco (V sec.), storico greco, restano
importanti
frammenti della sua Storia
bizantina, in otto libri, sulle vicende degli
Unni.
Zosimo (tra il V e il VI sec.), storico greco
bizantino, lasciò una Storia contemporanea
in sei libri giunta completa.
Procopio di Cesarea (fine del V sec. - 565),
storico greco bizantino, scrisse una Storia
delle guerre (quelle contro i Parti, i Vandali e
i Goti) e una Storia segreta (su Giustiniano).
Giordane (VI sec.), storico latino, tra il 550 e
il 560 scrisse una Storia dei Goti, riassunto
della perduta Storia dei Goti di Cassiodoro.
SOMMARIO
Cronologia
Capitolo Primo
Gli Unni alle viste
Capitolo Secondo
II "limes" e il suo esercito
Capitolo Terzo
I barbari
Capitolo Quarto
Teodosio
Capitolo Quinto
Stilicone
Capitolo Sesto
Roma,A.D.4lO
Capitolo Settimo
Galla Placidia
Capitolo Ottavo
Gli intrighi di Ravenna
Capitolo Nono
Attila
Capitolo Decimo
La fine del "flagello"
Capitolo Undicesimo
Genserico
Capitolo Dodicesimo
Ricimero e Odoacre
Capitolo Tredicesimo
L'ultima Roma imperiale
CAPITOLO PRIMO
GLI UNNI ALLE VISTE
LA STORIA d'Europa comincia in Cina.
In questo remoto e sconosciuto Paese si era costituito un Impero che,
come quello Romano in Occidente e pressappoco negli stessi secoli, aveva
unificato l'Oriente; eppoi, decadendo, si era trovato esposto alla medesima
insidia: quella dei barbari in agguato alle sue frontiere. La sola differenza
era questa: che su Roma la minaccia incombeva da Est; sulla Cina, da
Ovest.
Contro queste nomadi e selvatiche popolazioni scorrazzanti dal Don alla
Mongolia nelle steppe dell'Asia Centrale, gl'Imperatori cinesi avevano
elevato la "grande muraglia", come quelli romani avevano elevato il limes.
Ma le muraglie reggono finché a presidiarle c'è un esercito valido. Da sole,
servono a poco. Verso la fine del III secolo, l'esercito cinese somigliava a
quello francese del 1940, e la grande muraglia diventò un ostacolo da
concorso ippico per gli spericolati cavalieri mongoli che la presero d'assalto.
Gli storici cinesi chiamarono Jong-Nu questi indisciplinati e temerari
saccheggiatori che entrarono nel loro Paese e lo misero a soqquadro,
distruggendovi tutto senza costruire nulla, finché ne furono cacciati da altri
barbari. Costoro si chiamavano Juan-Juan, che piano piano riunificarono la
Cina e ne respinsero oltre la muraglia tutti gl'invasori.
Per gli Jong-Nu, condannati al nomadismo dal fatto di non aver nessuna
nozione di agricoltura, non c'era quindi altra scelta che ritentare a Ovest
l'impresa fallita ad Est. Grandi muraglie da sormontare in questa direzione
non ce n'era, eserciti da battere nemmeno. Dalla Mongolia, loro culla, fino
all'Elba e al Danubio, non si stendevano che steppe e pianure, abitate da
sparse tribù germaniche di pastori. Verso la metà del quarto secolo la grande
alluvione cominciò.
In Occidente, gli Jong-Nu si erano già visti circa due secoli e mezzo
prima ed erano stati chiamati Unni. Ma ne erano giunti solo pochi e slegati
gruppi, che sul Don incontrarono gli Alani, e non riuscirono a venirne a
capo. Forse a Roma non lo si seppe nemmeno. A quei tempi gl'Imperatori e
il Senato si preoccupavano poco di ciò che avveniva oltre il limes, che
isolava il mondo incivilito dal mare di barbarie che lo circondava.
Ma nel 395 cominciarono a spargersi voci allarmanti. Un ufficiale
dell'armata imperiale di guarnigione in Tracia, Ammiano Marcellino, raccontò la terrificante apparizione, sulle rive del Danubio, di certi uomini
"piccoli e tozzi, imberbi come eunuchi, con orribili volti in cui i tratti umani
sono appena riconoscibili. Piuttosto che uomini, si direbbero bestie a due
zampe. Portano una casacca di tela con guarnizione di gatto selvatico e pelli
di capra intorno alle gambe. E sembrano incollati ai loro cavalli. Vi mangiano, vi bevono, vi dormono reclinati sulle criniere, vi trattano i loro affari,
vi prendono le loro deliberazioni. Vi fanno perfino cucina, perché invece di
cuocere la carne di cui si nutrono, si limitano a intiepidirla tenendola fra la
coscia e la groppa del quadrupede. Non coltivano i campi e non conoscono
la casa. Scendono da cavallo solo per andare a trovare le loro donne e i
bambini, che seguono sui carri la loro errabonda vita di razziatori".
Essi non minacciarono subito e direttamente l'Impero. Si fermarono sul
limes, occupando soltanto un angolo di Pannonia, l'attuale Ungheria. Il loro
Re, Rua, si dichiarò pronto a fermarsi lì, se l'Imperatore di Costantinopoli
s'impegnava a versargli, anno per anno, trecentocinquanta libbre d'oro, e
quello d'Occidente, cui la Pannonia apparteneva, gli riconosceva la sovranità
su quel cantuccio di terra. Forse Rua fu sorpreso di vedere prontamente
accolte quelle richieste. Via via che si appressava al limes nella sua
travolgente cavalcata, doveva aver sentito magnificare dalle popolazioni
germaniche con cui era venuto in contatto e che aveva sottomesso, la
potenza dell'Impero romano e delle sue legioni.
Prima di affrontarlo, volle vedere un po' più da vicino, da quel comodo
posto di osservazione, di cosa si trattava.
A prima vista, questo Impero sembrava solido e compatto come ai tempi
di Augusto. Una rete di magnifiche strade collegava le raggelate frontiere
della Scozia ai deserti dell'Arabia, e su di esse si svolgeva un serrato
traffico, quale il mondo non aveva mai prima di allora conosciuto. Le
province occidentali fornivano derrate agricole e materie prime a quelle
orientali che le lavoravano nelle loro fiorenti industrie. Erano vino e olio di
Provenza, minerali di Spagna, cuoio, lana e legno di Gallia, che salpavano
verso Damasco, Antiochia e Alessandria per tornare sotto forma di tessuti,
tappeti, profumi, cosmetici, vetrerie, armi e utensili domestici. Lo
smistamento di questi prodotti, cioè il commercio, era quasi tutto ni mano ai
Siriani, che furono un po' i "magliari" del tempo, e a piccoli gruppi, molto
ben collegati fra loro, avevano invaso l'Occidente. I Greci e gli Egiziani
fornivano invece il nerbo della intellighenzia e delle professioni liberali.
Col tempo, questa divisione di compiti fra Est e Ovest si era un po'
alterata, nel senso che anche l'Occidente aveva cominciato a sviluppare una
propria industria. Erano i grandi latifondisti, specie nel Mezzogiorno della
Francia e nella valle del Reno, che, avendo accumulato grosse ricchezze,
pensarono d'investirle in manifatture.
L'intensità dei traffici e l'unità della moneta basata sul denario d'oro che
godeva lo stesso credito dappertutto dal Portogallo alla Crimea, avevano
potentemente contribuito al livellamento delle varie province. Come vi era
uniforme la legge romana, così vi stavano diventando pressappoco uguali gli
usi e i costumi. In molti paesi, la lingua indigena, o meglio il dialetto, era
scomparso anche nell'uso quotidiano per lasciare il posto al latino in
Occidente e al greco in Oriente. Il centralismo romano aveva trionfato delle
resistenze locali. E Caracalla, concedendo nel 212 la piena cittadinanza a
quasi tutti gli abitanti dell'Impero, non aveva regalato nulla; aveva soltanto
riconosciuto una situazione di fatto.
Quanti erano questi abitanti? Un censimento preciso non lo si ha. Ma da
varie testimonianze sembra di poter dedurre una cifra sorprendentemente
bassa: non più di centoventi milioni, disugualmente distribuiti, perché
l'Oriente era sovrappopolato rispetto all'Occidente. In Italia non ce n'era più
di sei milioni, il che la riduceva quasi a un deserto anche perché la maggior
parte erano addensati nelle città: le campagne erano vuote. E questi sei
milioni d'italiani non godevano più di nessun privilegio, da quando era stato
abolito lo statuto di "provinciale" e il cittadino di Aquisgrana era stato
parificato nei diritti e nei doveri a quello di Cremona che era già parificato a
quello di Roma.
Ma se questo era il panorama visto di lontano, a osservarlo più da vicino
come ora poteva fare Attila, venuto ad acquartierarsi in un angolo del suo
confine, le prospettive cambiavano parecchio.
Ai primi del quarto secolo, Costantino, Imperatore di sangue illirico,
aveva introdotto due innovazioni sensazionali: il riconoscimento del
Cristianesimo come religione di Stato e il trasferimento della capitale a
Bisanzio.
Niente lascia credere che la prima di queste due decisioni gli sia stata
suggerita dalla Fede. Se ne avesse avuta, egli non si sarebbe comportato
nella sua vita privata come si comportò, uccidendo senza nessuna pietà
cristiana non soltanto i nemici, ma anche i familiari, ogni volta che gli
tornava comodo farlo. Egli stesso rimase pagano per tutta la vita, e il
battesimo si decise a prenderlo soltanto alla vigilia della morte. La sua
nuova politica religiosa fu quindi dettata unicamente dalla "ragion di Stato",
ma questa ragione non va ricercata nel fatto che la maggioranza dei suoi
sudditi fosse ormai cristiana. Al contrario. La maggioranza era ancora
schiacciantemente pagana, specialmente nelle province occidentali, dove il
rapporto fra pagani e cristiani era, al minimo, di cinque a uno. Senonché
quell'uno nel suo Dio ci credeva, e per Lui aveva dimostrato di essere pronto
ad affrontare anche il martirio; i cinque nei loro dèi avevano smesso di
credere da un pezzo, e quindi erano del tutto indifferenti ai problemi del
culto.
La scelta di Costantino fu unicamente dettata da questa costatazione. Ma
essa non riuscì a restaurare nell'Impero una unità religiosa. Per quanto
scettici, i pagani non potevano non risentire con una certa amarezza la loro
progressiva estromissione dallo Stato. E questo spiega i tentativi di
restaurazione dell'antica Fede, che culminarono con Giuliano l'Apostata.
Essi non potevano trionfare perché sullo scetticismo non si costruisce nulla.
Ma la vecchia unità spirituale era rotta, come si stava sempre più rompendo
quella politica.
Dacché infatti Costantino vi aveva inaugurato nel 330 la nuova capitale,
Costantinopoli si era sviluppata a spese di Roma e di tutto l'Occidente.
Commercialmente, era meglio situata. Verso di essa veniva convogliato il
grano dell'Egitto, che una volta prendeva la via dell'Italia. E la presenza
dell'Imperatore favoriva l'accentramento di un vasto sistema militare e amministrativo, che si chiamava "romano", ma in realtà non lo era più.
È vero che ancora prima di trasportare la loro sede in Oriente,
gl'Imperatori avevano cessato da un pezzo di farsi eleggere dal Senato e
acclamare dal popolo, come aveva voluto Augusto. Piano piano, il potere si
era tramutato, come dice Mommsen, in una “autocrazia temperata dal diritto
al regicidio". La volontà popolare non c'entrava più. Era di solito qualche
generale che, alla testa della sua armata, si ribellava. E se il colpo falliva,
egli era un ribelle e veniva trattato come tale. Se riusciva, diventava il
legittimo sovrano, e come tale veniva osannato. Ma è certo che il
trasferimento a Costantinopoli, mettendo la Corte a più vicino contatto delle
satrapie orientali, favorì e affrettò questa corsa al dispotismo.
La centralizzazione tocca, ora il suo apogeo. Tutte le redini del Governo
sono in mano al Sovrano, che riceve direttamente da Dio il suo potere e lo
amministra senza consultare nessuno. Un diadema di perle gli orna la fronte.
Chiunque lo avvicini è tenuto a baciargli le pantofole di porpora. Il palazzo
in cui abita è chiamato "sacro" in tutti i documenti ufficiali. I personaggi più
importanti della sua reggia, di cui un'etichetta sempre più severa e
minuziosa rende sempre più difficile l'accesso, sono diventati le donne e gli
eunuchi. Eunuco è anche il Gran Ciambellano o "Preposto del sacro
cubiculo".
La posizione di protettore della Chiesa che Costantino ormai gli ha dato,
attribuisce all'Imperatore anche i poteri del Papa. Il Patriarca non è che il
suo Ministro per gli affari del culto e riceve gli ordini da lui, che presiede
anche i Concili imponendo la propria volontà perfino nelle questioni di
dogma. Le finanze dell'Impero si confondono con quelle personali dell'Imperatore. La sua parola è legge, e non c'è altra legge che la sua parola.
Assorbito da questi immensi compiti burocratici, egli diventa sempre più,
come dicono gli spagnoli, hombre de cabinete, perde contatto con la realtà,
soprattutto con quella dell'esercito dislocato sugli immensi e lontanissimi
confini, e affidato ai magistri militum, cioè a Generalissimi, di cui si paventa
il ritorno nella capitale, dove potrebbero defenestrare il Sovrano in carica,
per istallarsi al suo posto.
No, la "nuova Roma", come si è chiamata dapprincipio Costantinopoli,
non somiglia molto a quella vecchia, anche se ne porta il nome. Perfino la
lingua non è più la medesima: il greco ha sostituito il latino. E gl'Imperatori,
sempre più sedentari e casalinghi, non si scomodano nemmeno a rendere
una visita, sia pure di omaggio formale, all'Urbe gloriosa e decaduta. In
cento anni, si lamenta il poeta del quinto secolo Claudiano, tre soli ci hanno
fatto capolino. Oramai, anche se vengono in Occidente, si fermano a Milano
oppure a Ravenna, che son diventate una dopo l'altra le capitali militari di
un'Europa che sempre più se ne va per conto suo.
Sulla carta e nella convenzione giuridica, l'Impero è considerato ancora
uno e indivisibile. Ma di fatto i suoi due tronconi vivono d'ora in poi due
vite indipendenti. Essi hanno in comune soltanto l'immenso limes che li
isola, o che dovrebbe isolarli, dal mondo barbarico che li circonda, e
l'esercito che vi monta la guardia.
CAPITOLO SECONDO
IL "LIMES" E IL SUO ESERCITO
AUGUSTO, per dare una unità difensiva al suo Impero, era andato alla
ricerca delle cosiddette "frontiere naturali", e le aveva trovate soprattutto in
tre grandi fiumi: l'Eufrate, il Danubio e il Reno. Ma nei punti in cui si era
dovuto varcarli per annettere e presidiare qualche zona al di là, si era
costruito un limes, cioè un confine fortificato.
Basta considerare l'estensione di questo Impero euro-asiatico-africano, per
rendersi conto che doveva trattarsi di un'opera gigantesca. E infatti non fu
decisa né realizzata da un uomo solo, e nemmeno da due o da tre. Fu il
risultato del lavoro di molte generazioni, e non fu mai portata a compimento
perché ogni poco, per esigenze di guerra o ragioni di sicurezza, il limes
doveva essere spostato, e bisognava ricominciare tutto daccapo.
Nato non da un "piano" dello Stato Maggiore, ma dalle necessità tattiche e
strategiche delle singoli guarnigioni, esso non era dappertutto il medesimo.
Ma certi criteri fondamentali li seguiva dovunque. C'erano anzitutto degli
avamposti, muniti di fossati, di bastioni di terra battuta, di palizzate e di
torrette di osservazione. Poi venivano gli accampamenti, che non erano più
di tende, come quando le legioni erano state all'offensiva e animate da uno
spirito di conquista, ma di pietra e di calcina: cioè si stavano lentamente
trasformando in veri e propri villaggi, sia pure soltanto militari. Molto più
indietro c'erano i grandi accantonamenti, dove bivaccava il grosso delle
varie armate, pronte ad accorrere sul punto minacciato del limes.
Al momento in cui Adriano perfezionò questo sistema col famoso "vallo"
che doveva proteggere l'Inghilterra romanizzata dalle bellicose tribù
scozzesi, il limes era ancora organizzato più per la sorveglianza che per la
difesa. C'erano dei posti di guardia, c'erano delle caverne; ma non c'erano
dei fortilizi veri e propri predisposti per lunghi assedi. Tutto era calcolato
per garantire un certo margine di sicurezza a un esercito in sosta, ma di cui
si supponeva che avrebbe ripreso la marcia in avanti. Fu quando alla marcia
definitivamente si rinunciò, che i fortilizi si trasformarono pian piano in
cittadelle e le cittadelle in burgi, in borghi. E questa trasformazione, lenta e
sincopata da momentanee riprese di programmi offensivi, ma continua, era
il sintomo dell'arteriosclerosi di un Impero che si faceva sempre più
conservatore e sedentario.
Infatti il limes, proprio come la sua quasi coetanea Grande Muraglia e
tutte le altre Maginot di tutti i tempi, dimostrò subito la propria inadeguatezza al compito. Al tempo di Commodo, i Pitti, calati dalla Scozia, lo
scardinarono. Erano dei barbari che la civiltà non aveva ancora nemmeno
scalfito. Cacciatori nomadi senza il più piccolo rudimento di agricoltura,
mangiavano ancora la carne cruda, tenevano in comune le donne, e
combattevano nudi, cioè coperti soltanto di mostruosi tatuaggi che
riproducevano belve feroci. Ci volle la spietata energia di Settimio Severo
per infliggergli un castigo. Ma il vallo era in rovina. E si era appena ai primi
del terzo secolo.
Pochi anni dopo erano i Franchi e gli Alemanni che aprivano una falla sul
Reno e devastavano settanta città della Gallia. Le orde gotiche lo
sfondavano sul Danubio. Ma è inutile cercar di seguire cronologicamente le
violazioni che si susseguivano. Quello che importa è segnalare le
conseguenze che tutto questo comportò.
La "fortificazione", prima che un'opera d'ingegneria militare, è uno stato
d'animo che nemmeno la prova provata della sua inadeguatezza riesce a
distruggere. Un popolo reso conservatore dal benessere, e cittadino e
sedentario dalla civiltà, comincia ad accarezzare il sogno della sicurezza, e
per realizzarlo, non potendosi più affidare alle proprie virtù militari, si affida
alla Tecnica. Più frequenti si facevano i raids dei barbari, più larghe le
brecce nel limes, e più nei romani si sviluppava il mal della pietra per
tappare i buchi. Senonché, siccome era ormai chiaro che nemmeno il limes
meglio fortificato poteva reggere, a quello di frontiera cominciarono ad
aggiungersi quelli dell'interno, ogni città mirando a costruirsi il proprio e a
provvedere a se stessa.
Gli architetti diventarono i professionisti più ricercati e i personaggi più
importanti di quel periodo. L'imperatore Gallieno colmò di favori e di
quattrini Cleodamo e Ateneo cui aveva commissionato le mura di cinta delle
città danubiane particolarmente minacciate. Nei consigli municipali dei vari
centri urbani, grandi e piccoli, l'assessorato all'edilizia era la carica più
importante e ambita anche perché era quella che aveva più fondi a
disposizione. Verona, porta settentrionale della Penisola, proprio in questo
momento sviluppò i suoi splendidi bastioni. E le mura esterne di Strasburgo
nacquero prima della città che si sviluppò dentro di esse, come dentro una
culla, in un'isola fortificata del fiume Ill. Roma stessa cominciò a
fortificarsi. E furono le corporazioni urbane che fornirono la manodopera.
Questo genere di edilizia provocò un fenomeno nuovo: l'autonomismo
delle varie città. Nel nome e nella legge di Roma, quando Roma era forte,
cioè fino a dopo tutto il secondo secolo dopo Cristo, i particolarismi
cittadini o non erano insorti, o erano stati debellati. L'Impero aveva impedito
la formazione di quelle città-Stato che, chiuse in se stesse e incapaci di
formare una nazione, erano state la disgrazia della Grecia. Non si era
cittadini di Napoli o di Firenze, o di Marsiglia o di Magonza. Si era cittadini
romani, e basta. Come non avevano mura perché le legioni bastavano a
difenderle e davano a tutti la sicurezza, così queste città non avevano
autonomia né politica, né amministrativa, né spirituale. Vi si osservava la
stessa legge, vi si parlava la stessa lingua, vi si andava fieri dello stesso
Stato. Le fortificazioni che cominciarono a circondarle per ragioni di
autodifesa furono insieme la plastica prova della rottura di questa unità e
una delle cause fondamentali che la determinarono. Il limes cominciava a
spezzettarsi in limites. E dentro di essi si sviluppavano dei mondi sempre
più indipendenti l'uno dall'altro.
A questa evoluzione si aggiunse, favorendola, quella dell'esercito, che vi
diede un apporto decisivo. Come struttura, esso conservava ancora quella
che, con le loro riforme, gli avevano dato Diocleziano e Costantino. Essi
avevano separato una volta per sempre la carriera civile da quella militare
che un tempo erano confuse in una sola. Nella Roma repubblicana e anche
in quella augustea coloro che ricoprivano cariche politiche e amministrative
in tempo di pace erano anche coloro che in tempo di guerra ricoprivano i
gradi militari. L'edile, il pretore, il questore, il console diventavano, in caso
di mobilitazione, capitani, maggiori, colonnelli, generali. Ed era naturale
perché l'esercito era composto unicamente di cittadini, e ogni cittadino era
un soldato che, fin quando non lo richiamavano alle armi, si considerava in
congedo provvisorio.
Ma ai tempi di Diocleziano e Costantino le cose erano cambiate, anzi si
erano capovolte. Il cittadino non era più soldato, e non voleva farlo.
Categorie sempre più numerose e più larghe erano state esentate dal servizio
militare, e l'esercito ormai si riforniva quasi esclusivamente di barbari.
"Sono partiti coi barbari" dicevano le mamme dei loro figli richiamati in
servizio militare. E la cinquina si chiamava "fisco barbarico".
Era naturale che, se il cittadino non coincideva più col soldato, nemmeno
l'ufficiale potesse coincidere più col funzionario. E quindi la separazione
delle due carriere l'avevano già imposta i fatti. Ma i due Imperatori, di
sangue barbaro anch'essi, non si fermarono a questa riforma, già di per sé
molto grave perché praticamente metteva gl'imbelli e disarmati cittadini
dell'Impero sotto la protezione di una milizia straniera. Essi anche divisero
l'esercito in una "armata di campagna" (comitatenses) e in un "corpo
territoriale" o di guarnigioni di frontiera (limitanei).
Queste ultime, godendo di una quasi assoluta inamovibilità, avevano
messo radici sul posto, vi avevano ricevuto terre, i soldati si erano sposati
con ragazze indigene, erano diventati a loro volta piccoli coltivatori diretti, e
oramai costituivano una specie di milizia contadina, che dal punto di vista
militare non valeva granché. Ma così si era venuta a formare proprio a
ridosso del limes una specie dì "terra di nessuno", abitata da una strana
popolazione che, a furia di matrimoni misti, non si sapeva più cosa fosse.
Quella che avrebbe dovuto essere la "cortina di ferro" dell'Impero, la sua
"Grande Muraglia" era in realtà una zona d'incontro fra barbari e romani. E
perfino la lingua che vi si parlava era qualcosa di mezzo fra il barbaro e il
romano, un dialetto mescolato di latino e di tedesco.
Dietro, l'armata di campagna non era in condizioni diverse. Essa aveva
attinto alla grande esperienza romana i criteri strategici e tattici, il culto
della disciplina e la ripartizione in legioni. Ma tutto il resto era cambiato,
perché erano cambiati gli uomini che la componevano, tutti di razza
germanica. Essi non somigliavano più in nulla all'antico legionario di Roma,
tozzo e bruno, con la corazza e lo scudo rettangolare. Il corto gladius aveva
ceduto il posto alla lunga spatha, e già apparivano le picche che di lì a poco
si sarebbero tramutate in lance. La cavalleria era enormemente cresciuta a
spese della fanteria, e aveva adottato come arma d'offesa l'arco ricopiato sul
modello dei Parti, e come mezzo di difesa il catafratto, cioè la corazza di
maglie di ferro.
Essa ricopre ora uomini di ben diverso aspetto, alti e biondi, con occhi
azzurri in cui si alternano espressioni di innocenza e di ferocia. Il loro grido
di guerra si chiama "barrito" come quello dell'elefante, e gli somiglia per la
sua violenza. Invece del gagliardetto, hanno per vessillo un dragone gonfio
d'aria e fissato in cima a una picca. Sono bei soldati, che uccidono e
muoiono con la stessa facilità. Ma è difficile maneggiarli perché si rifiutano
alla manovra. Se un avversario li provoca, escono dai ranghi per andare ad
affrontarlo di propria iniziativa, e non rispettano altro legame di fedeltà che
quello verso il loro capo. L'idea di patria, di Impero, di Stato, di disciplina e
di regolamento è loro del tutto estranea. Hanno insomma i caratteri tipici del
mercenario. E infatti si considerano una milizia personale del loro
comandante, il quale a sua volta li considera un suo personale comitatus,
come lo sono stati fino all'ultima guerra i comitagi jugoslavi che ne
derivano. Molti fra gli stessi Generali non sapevano il latino. Andavano
vestiti secondo la loro foggia barbarica, le gambe fasciate di pelli, la testa
incappucciata di corna.
Erano cittadini romani, da quando Caracalla aveva reso tali tutti gli
abitanti dell'Impero. Ma venivano da province di fresca conquista,
balcaniche e tedesche, che non avevano ancora assorbito la civiltà romana.
La mancanza di cultura impediva loro qualunque "carriera" civile. Era solo
attraverso quella militare che potevano farsi largo, e già nel terzo secolo
l'avevano completamente monopolizzata.
Le cosiddette "invasioni barbariche" furono dunque, prima che un
fenomeno esterno, un fenomeno interno, che si compì attraverso l'esercito.
Ora quest'esercito, cui era affidata la difesa del limes, si trovava a proteggerne
l'integrità contro popolazioni di cui si sentiva consanguineo e di cui conosceva la
lingua, le idee e i sentimenti meglio di quanto non conoscesse la lingua, le idee e i
sentimenti romani. Non si può dire che patteggiasse regolarmente col nemico.
Ma molto spesso s'intendeva con esso in modo da renderlo amico. La "cortina di
ferro" non era sempre tale per quelli che ne stavano al di là. Molti l'attraversavano
più o meno clandestinamente, si presentavano agli accampamenti romani e,
trovandoli pieni di parenti, chiedevano di essere arruolati. I Generali dell'Impero
li accoglievano volentieri perché non avevano molta disponibilità di uomini e,
indipendenti com'erano dal Governo centrale, potevano praticamente fare quel
che volevano. Così l'esercito di Roma sempre più diventava di sangue tedesco.
Sulla fine del terzo secolo, questa pacifica osmosi, da individuale, si
trasformò in collettiva. Alcune tribù germaniche al di là del limes, ormai
convertite all'agricoltura, chiesero in blocco di essere ammesse in Gallia,
cioè in Francia. E le autorità imperiali diedero loro da bonificare alcune
terre abbandonate. Essi conservavano i loro usi, la loro lingua, e una certa
autonomia amministrativa. Ma politicamente dipendevano da un Prefetto
romano, cui pagavano le tasse e fornivano un contingente di reclute.
L'esperimento riuscì.
A distanza di secoli, molti storici hanno creduto di vedere in questo
processo un vasto e abile piano, da parte di Roma, per assorbire e incivilire i
barbari. Ma son ragionamenti suggeriti dal senno di poi. La verità è che
gl'Imperatori lo accettavano perché nella maggioranza dei casi non potevano
far altro. Tuttavia questa politica di appeasement e di assorbimento aveva il
vantaggio di legittimare in maniera decente l'inevitabile, lasciando intatta,
almeno formalmente, la sovranità imperiale che i barbari, varcando il limes,
riconoscevano, anche se poi ogni tanto con le loro ribellioni la violavano.
Ed è probabile che col tempo questa integrazione si sarebbe realizzata e che
il mondo barbarico si sarebbe pacificamente inquadrato nelle complesse e
civili strutture di Roma, se gli Unni non si fossero mossi dalla loro
Mongolia o, una volta penetrati in Cina, vi fossero rimasti. Il loro avvento in
Europa sconvolse ogni cosa rendendo febbrile, tumultuosa e distruttrice
l'alluvione barbarica al di qua del limes.
Ma chi erano, e cos'erano, questi "barbari"?
CAPITOLO TERZO
I BARBARI
I PRIMI scrittori romani che ebbero qualche dimestichezza coi barbari, li
descrissero, con un misto di stupore, di ammirazione e d'ironia, come dei
ragazzoni troppo cresciuti, d'occhi chiari e di capelli biondi, che
mangiavano insieme, bevevano insieme, dormivano insieme davanti ai
fuochi del bivacco, s'intenerivano per un nonnulla, e per un innocente
scherzo impegnavano duelli dai quali era manna se uno dei due contendenti
usciva vivo, perché di solito ci morivano entrambi.
Il loro punto di partenza, ricostruito attraverso incerte leggende
tramandate oralmente, sembra che siano stati la Scandinavia e i territori fra
l'Elba e l'Oder. Lì, sulle vette delle colline e nelle radure delle foreste,
avevano impiantato dei villaggi di capanne effimeri come accampamenti.
Non ci restavano mai a lungo perché, siccome vivevano quasi
esclusivamente di caccia, una volta esaurita la selvaggina in una zona,
emigravano. La loro organizzazione era primitiva, e basata su esigenze
soprattutto militari. Il nucleo fondamentale era il gau, che Hitler ritirò fuori
duemil'anni dopo, gruppo di famiglie che forniva da 1000 a 1500 guerrieri,
soprattutto a cavallo. I gau erano molto indipendenti l'uno dall'altro. Solo in
circostanze eccezionali si riunivano nel thing o mallus, specie di assemblea
plenaria, per decidere per esempio l'elezione di un nuovo Re, la pace o la
guerra.
A differenza del Romano, ch'era sempre un "cittadino", e in qualunque
occasione si sentiva parte di qualcosa, la società o lo Stato, il barbaro era
soltanto un "individuo" gelosissimo della propria assoluta indipendenza.
Egli non riconosceva altro vincolo che quello della parola liberamente data.
Il suo patriottismo era la fedeltà giurata al Signore liberamente eletto e a cui
si sentiva legato da un vincolo puramente personale. Di qui
l'incomprensione fra loro e i latini, che avevano della lealtà un concetto tutto
diverso. A parte Cesare e Tacito, dotati di un fiuto troppo fino per
fraintendere e sottovalutare il senso dell'onore germanico, tutti gli storici e i
memorialisti romani non fanno che denunziare la perfidia e la propensione
al tradimento dei barbari. È vero, nei rapporti da Stato a Stato. Ma è
falsissimo, nei rapporti da persona a persona.
Non si muovevano a masse numerose e compatte. Le cosiddette "alluvioni
barbariche" di cui si è tanto farneticato erano carovane composte fino ai
centoventimila individui, ma più spesso di trenta o quarantamila, di cui i
guerrieri costituivano appena un quinto. Era un mondo fluido ed equestre. A
cavallo, gli uomini precedevano e seguivano i carri, dentro cui si
ammassavano le donne, i vecchi e i bambini. Questi carri, la notte e durante
le battaglie, venivano disposti in un cerchio, al riparo del quale si dormiva e
ci si difendeva.
Il trattamento dei popoli che, in questi continui spostamenti, venivano
sottomessi, variava secondo la resistenza ch'essi opponevano. C'erano dei
casi di totale sterminio. Ce n'erano altri di pacifica fusione. Teodorico, Re
degli Ostrogoti, quando giunse in Italia di Ostrogoti ne avrà avuti sì e no
cinque o seimila. Il resto erano Gepidi, Alani, Rugi, Sciri, resti di tribù vinte
e poi integratesi col vincitore. E nell'esercito di Attila, alla battaglia dei
Campi Catalaunici, gli Unni quanti saranno stati? Non si sa con esattezza.
Ma tutto lascia credere che si trattasse di una minoranza rispetto agli alleati
e federati germanici che ne avevano accettato o dovuto subire la supremazia.
I vinti non venivano ridotti in schiavitù perché la schiavitù non era
compatibile col nomadismo, e infatti si sviluppò solo dopo la conversione
alla sedentarietà e all'agricoltura. Venivano arruolati.
In questo quadro d'insieme, c'erano poi le differenze fra popolo e popolo.
I Longobardi non derivavano il loro nome dal fatto di portare la barba ma la
barda, una lunga ascia, ch'era la loro arma di combattimento. I Franchi,
ch'erano corbellati da tutti gli altri perché si radevano accuratamente il
volto, avevano invece come arma la "francesca". E Sidonio Apollinare riconosceva i Burgundi dalla loro smisurata statura, dalla forza tonitruante
della voce e dal puzzo del burro rancido con cui s'ingrassavano i capelli.
Ostrogoti e Visigoti, che furono i primi a dar la spallata all'Italia, all'inizio
formavano un popolo solo, il popolo Goto, originario della Svezia, una delle
cui province, il Götheland, ne porta ancora il nome. Non avevano una lingua
scritta. E soltanto nel sesto secolo dopo Cristo, uno di loro, Giordane,
incivilito dalla cultura latina, raccolse il racconto che i suoi connazionali si
erano tramandati oralmente del loro passato.
Mescolando storia e leggenda, essi dicevano che, circa quattro secoli
prima di Cristo, mentre Roma era occupata a unificare l'Italia, il loro Re
Berig li aveva condotti attraverso il Baltico dalla Scandinavia in Germania.
Per fare questo traghetto, non avevano che tre barche, le quali dovettero
compiere la traversata chissà quante volte. Una di esse restava regolarmente
indietro. I rematori delle altre due la chiamarono per dileggio gepanta, che
nel loro linguaggio voleva dire "la sfaticata", e gepidi, cioè "bighelloni",
soprannominarono i passeggeri.
Rimasero nelle regioni della Prussia Orientale per alcune generazioni, a
ridosso dei Vandali, coi quali occasionalmente guerreggiavano. Poi
ripresero la marcia verso Sud-Est. Una metà dei loro effettivi fu inghiottita
dalle paludi della Lituania. Fu un disastro. Giordane assicura che ancora ai
suoi tempi, cioè una diecina di secoli dopo, chi passava da quelle parti
incontrava gli spettri dei morti e udiva il lamento del bestiame agonizzante.
Viaggiarono anni, forse decenni, perché erano spostamenti pesanti e lenti,
intramezzati da soste, combattimenti, deviazioni. Dalle espressioni che i
cantastorie si son tramandati, si capisce che la loro gioia, nel vedere
finalmente il mare, non fu minore di quella dei Greci di Senofonte al
termine dell'Anabasi. Non gridarono Thalatta! Thalatta! perché non
sapevano il greco; ma per generazioni preservarono nei loro poemi il ricordo
di quel gran giorno.
Quel mare era il Mar Nero. Ed essi si acquartierarono sulle sue coste
settentrionali in quella parte meridionale della Russia che allora si chiamava
Scizia. Dalle zone che le varie tribù occupavano, presero tre nomi diversi:
gli Ostrogoti guardavano a Est, i Visigoti a Ovest, e i Gepidi, che
seguitavano a essere considerati i fannulloni della famiglia, a Nord. Ma non
ci stavano mai fermi. E siccome dalla parte d'Oriente c'era il deserto, il loro
uzzolo di saccheggio si sfogava verso Occidente, dove si stendeva il limes
romano.
I rapporti con le dirimpettaie autorità imperiali variavano come in tutte le
altre zone di confine dall'amicizia, all'ostilità, alla guerra fredda, alla guerra
calda. Ma molti Goti andavano, come al solito, ad arruolarsi nelle milizie
romane, salvo a crearvi ribellioni e ammutinamenti se la cinquina non
veniva pagata. Verso la metà del terzo secolo dopo Cristo queste disfunzioni
amministrative si verificarono di frequente per via del disordine che regnò
dopo la morte di Settimio Severo.
La prima vera e propria azione di guerra dei Goti contro i Romani
avvenne nel 250 quando sul trono di Roma c'era Decio, un Imperatore di
pochi scrupoli specialmente verso i Cristiani, ma in cui rivivevano le virtù
guerriere dell'antica Urbe. I Goti erano condotti da Cniva che alla testa di
settantamila uomini attraversò il Danubio, penetrò in Serbia, e mise assedio
a Filippopoli. Decio accorse con un forte esercito, e la battaglia fu terribile.
Gli storici romani dicono che i Goti lasciarono sul terreno trentamila
cadaveri. Ma hanno dimenticato di aggiungere quanti ne lasciarono i
Romani, che dovettero perderne parecchi di più, visto che si riconobbero
battuti. La città cadde nelle mani dei barbari, che trucidarono centomila
persone, ma trascurarono nella voluttà del saccheggio di prendere
precauzioni contro i ritorni offensivi di Decio, il quale non era uomo da
darsi per vinto. A un certo punto si trovarono irretiti da lui, e cercarono di
comprare un armistizio che consentisse loro di ritirarsi senza combattere.
Decio, che aveva già appostato il suo miglior generale, Gallo, alle loro
spalle, rifiutò. Ma, dice lo storico Zosimo, Gallo tradì, e in seguito alla sua
defezione fu Decio a trovarsi imbottigliato dentro gli acquitrini. Nella
battaglia, suo figlio cadde. "Uno di meno" disse l'Imperatore seguitando a
combattere. Poi cadde anche lui con quasi tutto il suo Stato Maggiore. Il
traditore Gallo che gli succedette comprò dai Goti quella pace che Decio
non aveva voluto vender loro, impegnandosi a pagare una somma che i
Romani poi chiamarono sussidio e i Goti tributo.
Cniva tornò nelle sue terre con molto bottino, ma soprattutto con la prova
in tasca delle debolezze di un Impero, che sino a quel momento si era retto
sul mito della sua invincibilità. Da allora in poi i Goti non gli dettero più pace e sfogarono il loro istinto di saccheggio soprattutto sull'Asia Minore e la
Grecia. Troia, Bisanzio, Efeso subirono le loro saltuarie incursioni. Poi fu la
volta di Corinto, Sparta, Argo, e alla fine, nel 267, di Atene.
Le incursioni gotiche durarono fino al 268, quando sul trono dell'Impero
salì finalmente Claudio II, che volle porvi riparo in maniera definitiva. Era
un buon soldato che aveva imparato la lezione di Filippopoli, cioè aveva
capito l'importanza decisiva della cavalleria, e in questo senso aveva
riformato l'esercito. A Nisch, in Serbia, egli non riportò una completa vittoria, ma cinquantamila Goti rimasero sul terreno e gli altri furono sospinti
dalla sua superiorità di manovra in un intrico di montagne e di paludi senza
sbocco, dove cominciarono a morire lentamente di fame nei loro pesanti
carri sprofondati nella melma. Dei pochi superstiti, alcuni tornarono
sbandati alle loro case, altri rimasero come federati al servizio del vincitore.
Ma i morti si vendicarono del loro carnefice sviluppando coi loro cadaveri
insepolti una pestilenza che lo contagiò e lo uccise.
Il successore Aureliano trascinò dietro il suo carro di trionfatore a Roma i
condottieri goti prigionieri. Ma non rifiutò la pace al loro Re, concedendogli
la Dacia che, tradotta in termini di geografia moderna, significa Ungheria e
Romania. Qui, dentro i confini dell'Impero, per un secolo rimasero
abbastanza tranquilli, qui diventarono qualcosa di simile a una Nazione, trasformandosi almeno parzialmente in agricoltori e mescolandosi con la
popolazione locale già mezzo romanizzata. E qui, in questi cento anni di
relativa tranquillità, si arricchirono dei due fondamentali strumenti di civiltà:
la lingua scritta e la religione cristiana.
A fargliene dono fu un uomo solo. Ulfila non era un goto di razza pura.
Era figlio di un orientale della Cappadocia preso prigioniero dai Goti dopo
una delle loro tante incursioni laggiù, e sposatosi probabilmente in Dacia
con una donna del posto. Così il figlio Ulfila crebbe fra i Goti, e goto si
sentiva fino alla midolla.
In Dacia la popolazione indigena era, come ho detto, romanizzata, parlava
un dialetto latino (i romeni lo parlano ancora), e coltivava il grano e la vite.
La maggioranza era pagana. Ma c'erano già anche dei cristiani, che
svolgevano opera di proselitismo. Certamente Ulfila, ch'era nato nel 311,
venne in contatto con qualcuno di loro, perché quando, ancora giovinetto, fu
mandato a Costantinopoli, fu subito ordinato prete, e a trent'anni fu
consacrato Vescovo da Eusebio di Nicomedia.
In quel momento la Chiesa non era unita. Era anzi gravemente divisa
dall'eresia di Ario, che negava la divinità di Gesù Cristo. Era il più
pericoloso di tutti i conflitti che fossero mai scoppiati in seno alla nuova
religione. E l'imperatore Costantino, che di questa nuova religione si
atteggiava a protettore, ma con la pretesa di farne uno strumento di governo
e quindi riservandosi il diritto d'intervenirvi, aveva convocato il Concilio di
Nicea, per ristabilire l'unità. Ario si difese con molto coraggio ma fu battuto
specialmente per opera dei Vescovi dell'Occidente, e dichiarato eretico.
Aveva però molti seguaci, e fra costoro c'era appunto Eusebio, alla scuola
del quale Ulfila diventò ariano anche lui.
Gli affidarono una delle imprese più ardue: quella di tornare in patria e di
conveire i suoi compatrioti, tuttora fedeli ai loro dèi pagani, Odino e Thor. Il
re Ermanrico era fra i più tradizionalisti e bigotti, e le persecuzioni cominciarono subito contro chi si lasciava conquistare dalla predicazione del
missionario. Goti minori si chiamarono con disprezzo questi conversi che si
raccolsero in piccole comunità nelle zone di frontiera per essere pronti ad
attraversarla in caso di pericolo e a cercare rifugio nei territori dell'Impero.
Essi si attenevano alla resistenza passiva e a una dieta sobria, in cui la carne
era quasi abolita e il vino sostituito dal latte.
Ulfila, che aveva su di loro un ascendente profondo (e meritato, a quanto
pare, per la santità della sua vita), per facilitare la propria opera missionaria,
si diede a tradurre in gotico la Bibbia. E, siccome una lingua gotica scritta
non c'era, la inventò lui, disegnando quei famosi caratteri dell'alfabeto, che
d'allora in poi furono chiamati appunto "gotici", e mettendo accanto ad
ognuno di essi l'equivalente greco. Naturalmente grammatica e sintassi
erano sommarie. E lo sforzo per abituare quella rozza gente a dare una
forma grafica al loro gutturale balbettamento e una consecutio più o meno
razionale al loro pensiero, dovette essere immenso. Ma Ulfila ci riuscì. Egli
tradusse nella lingua da lui inventata tutto il Nuovo Testamento e la maggior
parte di quello Vecchio, e in tal modo diede alle popolazioni germaniche i
due strumenti per diventare le protagoniste della storia europea.
Tutti i popoli tedeschi, meno i Franchi e i Sassoni, che si convertirono
molto dopo a Gesù e all'alfabeto, impararono a scrivere e a credere secondo
l'alfabeto e la fede di Ulfila. Purtroppo, questa fede non era quella cattolica,
ma quella ariana: e la cosa doveva avere conseguenze assai gravi specie per
l'Occidente, e soprattutto per l'Italia, dove alla fine i Goti vennero ad
acquartierarsi (e a seppellirsi). Ma questo lo vedremo in seguito.
Giordane ci ha lasciato testimonianza di come i Goti videro gli Unni
quando questi apparvero nei loro territori: "Quando il Re Filimer" egli
scrive "ebbe condotto il nostro popolo dalla Svezia in Scizia, trovò in mezzo
alla popolazione del luogo certe streghe, ch'egli scacciò per via dei loro
malefizi. Esse si persero nel deserto dove incontrarono gli Spiriti del Male
che errano in quei paraggi e che se le presero come concubine. Dalla loro
unione nacquero gli Unni, creature giallognole di odio, piccole, ferocissime,
e incapaci perfino di articolare i loro pensieri".
Giordane, da buon goto, aveva ragione di fornire un ritratto così malevolo
degli Unni: i suoi antenati erano stati, dopo gli Alani, le loro prime vittime
in Europa. Ermanrico, in quel momento, regnava ancora su di essi, ma aveva
superato i cento anni, e purtroppo era reduce da un grave incidente.
Tradizionalista e austero com'era, aveva condannato a morte e fatto
squartare una giovane principessa, Sanici, rea di adulterio. E i fratelli di
costei se n'erano vendicati tentando di ucciderlo. L'avevano soltanto ferito,
ma in modo tale da indebolire gravemente la fibra di quell'irriducibile
vegliardo. Giordane ce lo lascia soltanto capire; ma Ammiano Marcellino
dice esplicitamente che un po' per questo attentato, un po' per la disperazione che gli procurava il flagello unno, cui non si sentiva in grado di
resistere, Ermanrico si suicidò. Comunque, una cosa è certa: che, con o
senza resistenza, gli Ostrogoti furono sottomessi dagli Unni e lo rimasero
per ottant'anni. Solo una frazione seguitò a combattere sotto la guida di
Withimir che fu sconfitto e ucciso. I superstiti cercarono scampo in
Valacchia.
Quanto ai Visigoti, essi si ammassarono sulla riva sinistra del Danubio,
pressappoco dove oggi corre il confine fra la Bulgaria e la Romania. Era il
limes. "Agitando le braccia e piangendo" racconta lo storico Eunapio,
"supplicavano che un ponte di barche fosse gettato per lasciarli passare". Le
autorità imperiali del posto risposero che non potevano prendersi quella
responsabilità senza chiederne all'imperatore Valente che impose le seguenti
condizioni: consegna delle armi, il che era logico; rinunzia ai bambini, che
sarebbero stati trasferiti in altre regioni dell'Impero, il che era mostruoso.
I Goti dovettero accettare: non avevano altro scampo. E in realtà le due
imposizioni rimasero sulla carta, perché sia le armi che i bambini furono
nella maggior parte lasciati ai legittimi proprietari. In compenso, gerarchi e
gerarchetti imperiali fecero a gara nello spogliare di tutti i loro averi quei
poveri fuggiaschi tallonati dal terrore unno e nell'accaparrarsi i più solidi
giovanotti come schiavi e le più belle ragazze come concubine. Gli altri
furono abbandonati alla fame e al freddo dell'inverno. E lo spettacolo che
l'Impero diede in quell'occasione di ladrocinio, indisciplina e
disorganizzazione fu tale che, fra quei poveri internati, invece della gratitudine, incubò l'odio e la rivolta.
Testardo e male informato, l'imperatore Valente decise di accorrere
personalmente a infliggere un esemplare castigo ai ribelli, e per prima cosa,
sapendo che costoro si erano incamminati su Adrianopoli, ordinò ai suoi
luogotenenti in quella città di allontanare le milizie gotiche che militavano
sotto le sue bandiere. Erano Goti minori, cristianizzati da Ulfila, fedelissimi
all'Impero. I loro capi si dichiararono tuttavia pronti a obbedire purché si
desse loro la cinquina e i rifornimenti per la lunga marcia che dovevano
affrontare. Gli si rispose con minacce. E il risultato fu che quei reparti andarono ad accrescere le falangi degl'insorti, che si disponevano in assedio
intorno alla città.
L'assedio non riuscì: i barbari non furono mai capaci di espugnare una
fortezza romana. Il loro capo Fridigern, nel togliere il campo, disse: "Noi
siamo abituati a combattere contro gli uomini, non contro mura di pietra".
Ma il suo esercito era enormemente cresciuto per l'afflusso degli schiavi goti
che accorrevano da tutti i distretti della Tracia. Fu un'annata terribile, quella
fra il 377 e il 378, per le province bulgare e romene. I ribelli le misero a
sacco scannando e rubando a più non posso. Valente tardava, trattenuto
dalle difficoltà di una pace con la Persia. Alla fine venne, dando
appuntamento a Adrianopoli a suo nipote Graziano, che governava
l'Occidente. I loro due eserciti avrebbero stretto in una morsa e stritolato i
ribelli.
Il piano poteva benissimo riuscire, date le alte capacità di comando di
Graziano, giovane e brillante generale. Ma appunto perciò Valente, geloso
di lui, invece di aspettarlo, commise la follia di attaccare da solo. Sembra
che fosse stato male informato dai suoi esploratori che, mandati in
avanscoperta, gli avevano riferito che il nemico non aveva più di diecimila
uomini. Prima d'impartire l'ordine di attacco, egli ricevette una lettera di
Fridigern che, in un supremo sforzo per evitare il conflitto, gli chiedeva per i
suoi uomini la Tracia impegnandosi solennemente alla fedeltà all'Impero.
Ma Ammiano dice che, insieme a questa lettera ufficiale, Fridigern ne aveva
mandata un'altra confidenziale in cui suggeriva a Valente di rifiutare la
proposta e di stringere più dappresso i ribelli in modo da impaurire gli
estremisti e far trionfare il partito suo, quello dei moderati.
Ciò convinse ancora di più Valente della propria superiorità. Ammiano
dice che sbagliò lo schieramento e non azzeccò una manovra. Comunque,
quella di Adrianopoli (378) fu la più catastrofica disfatta che l'Impero avesse
subìto da Canne in poi. L'Imperatore, ferito, si rifugiò in una capanna dove
una pattuglia nemica lo bruciò vivo, pare senza sapere chi fosse. I due terzi
dell'esercito imperiale, i più esperti veterani, trentasette Generali, rimasero
sul campo.
Gli storici cristiani dissero che Valente era caduto in espiazione del
peccato commesso consentendo ai Goti, quando li ammise al di qua del
Danubio, di restare ariani. Fra non molto avrebbero rimpianto anch'essi quel
divino castigo, che lì per lì ebbero l'aria di salutare con soddisfazione.
CAPITOLO QUARTO
TEODOSIO
SUL momento sembrò che tutto dovesse crollare. L'Impero aveva perso il
suo titolare e il suo esercito. In Occidente restava, alla testa di truppe
ausiliario franche e alemanne, cioè barbare, un abile e risoluto Generale,
Graziano, che sapeva sconfiggere i nemici sul campo, ma in casa non sapeva
sottrarsi alla cattiva suggestione di una madre autoritaria, appassionata e in
buona fede dissennata: Giustina. In Oriente, il trono era vacante, le
guarnigioni vuote e l'orda gotica in marcia su Adrianopoli. Graziano si
guardò intorno alla ricerca di qualcuno che potesse venirgli in aiuto, e lo
scoprì nella persona di un Generale spagnolo in pensione.
Teodosio era figlio di un altro Teodosio, ch'era stato il migliore e il più
fedele luogotenente dell'Impero. Non sappiamo come avesse fatto carriera.
Ma fu colui che difese con successo la Britannia e poi fu mandato in Africa
a domarvi la rivolta scoppiata fra i Mori. Vi riuscì, coprendosi di
benemerenze. Ma la ricompensa fu una condanna a morte. La Storia non è
riuscita mai a far luce su questo incomprensibile episodio. Sappiamo
soltanto che Teodosio, quando gli comunicarono la sentenza, non pensò né a
fuggire né a ribellarsi. Chiese soltanto, racconta Orosio, di essere battezzato
perché fino a quel momento era rimasto pagano, eppoi, "sicuro della vita
eterna, serenamente abbandonò quella terrena al boia".
Il suo omonimo figlio, che aveva già fatto anche lui una bella carriera
militare fino a guadagnarsi i galloni di "Duca di Mesia", diede le dimissioni
dall'esercito e si ritirò da privato qualsiasi nella sua Spagna. E qui tre anni
dopo lo raggiunse l'invito di Graziano ad occupare, come suo collega, il
trono di Costantinopoli. Teodosio aveva allora trentatre anni, una moglie
somigliante al suo nome, Flaccilla, perché anemica e malaticcia, e un
bambino, Arcadio. È curioso che Graziano avesse scelto proprio lui,
Il figlio di un innocente giustiziato, il quale poteva anche covare qualche
proposito di vendetta, per occupare una sì alta carica. Ma si vede che lo
conoscevano.
Teodosio e Graziano svolsero insieme una politica accorta nei confronti
dei Goti che, non riuscendo a espugnare Adrianopoli, scorrazzavano ora nei
Balcani. Per affrontarli in una battaglia campale, non c'era più un esercito.
Cominciarono a logorarli con azioni episodiche, ma sempre tendendo la
mano per una riconciliazione. Il loro capo Atanarico aveva giurato a suo
padre di non mettere mai piede sul suolo dell'Impero, e infatti se n'era
astenuto anche quando la valanga unna aveva spinto i Visigoti a chiedere
asilo a Valente al di qua del Danubio. Ma nel 380 gli Unni tornarono e a
Atanarico non rimase che attraversare anche lui il Danubio e chiedere
ospitalità a Teodosio.
Questi, all'opposto di ciò che aveva fatto Valente, lo accolse con cortesia,
lo riempì di doni e lo scortò a Costantinopoli. Giordane descrive benissimo
la trasecolata ammirazione del rozzo barbaro alla vista della città. "Ecco,
ecco" balbettò "quello di cui tanto mi avevano parlato e a cui tanto poco
avevo creduto... Un Dio certamente dev'essere questo Imperatore, e chiunque alzi una mano su di lui commette sacrilegio". Di lì a poco Atanarico
morì, come del resto si era impegnato a fare se avesse contravvenuto al
giuramento, e Teodosio gli rese imponenti onoranze cavalcando di persona
davanti alla bara. Quella cerimonia impressionò fortemente gli Ostrogoti
presenti, che accettarono di farsi assorbire nell'Impero nella solita qualità di
federati. Sembravano tornati i tempi di Aureliano e di Costantino. Ma quegli
Ostrogoti erano soltanto una minoranza.
Alla
pacificazione
dell'Oriente
corrispondeva
l'inquietudine
dell'Occidente. Un altro Generale spagnolo, Massimo, si ribellava in
Inghilterra, scendeva in Francia e uccideva a tradimento Graziano, il colto,
brillante e pio Imperatore, che aveva commesso due soli errori, ma gravi:
quello di pensare più allo sport che ai problemi di Stato, e quello di aver
dimostrato troppo apertamente le sue preferenze per gli ufficiali barbari,
specialmente franchi e alemanni, che militavano sotto le sue bandiere. Egli
lasciava come successore il fratellastro Valentiniano II, poco più che
bambino, cui suo padre gli aveva raccomandato di fare da tutore e
protettore, e al quale ora non restava che la improvvida madre Giustina.
Massimo per il momento non minacciò il ragazzo che risiedeva a Milano,
e si contentò di esercitare il potere effettivo su Inghilterra, Francia e Spagna,
senza pretendere al titolo di Imperatore, che lo avrebbe messo fatalmente in
conflitto con Teodosio. Questi non solo subì l'assassinio del suo amico e
collega, cui doveva il trono, con una flemma che lì per lì parve da traditore
ingrato, ma non reagì nemmeno alle voci che lo accusavano di aver istigato
Massimo all'assassinio di Graziano. Era un uomo di carattere difficilmente
penetrabile. Ma i suoi gesti ce lo dipingono come uno spagnolo puro, buon
generale, pessimo amministratore, bigotto e spretato, incapace di perdono,
ma convinto che la vendetta sia, come dicono appunto gli spagnoli, "un
piatto da mangiarsi freddo".
Per quattro anni, lungi dal protestare per il regicidio e l'usurpazione del
comando, egli si tenne in amichevole corrispondenza con Massimo. E questi
forse ne fu indotto a credere che Teodosio non avesse in fondo nessuna
voglia di vendicare il figlio di colui che gli aveva ucciso il padre. Con
cautela cominciò ad avvicinarsi all'Italia, dove Giustina governava (senza
dubbio accatastando spropositi su spropositi) in nome del piccolo
Valentiniano. Essa non si stancava di denunziare a Costantinopoli la
doppiezza dell'usurpatore, l'insaziabilità delle sue ambizioni e il suo
proposito d'incoronarsi Imperatore. E quando lo vide attraversare le Alpi alla testa del suo esercito, impacchettò Valentiniano, che aveva ormai diciotto
anni, e le altre tre figlie; e con essi fuggì oltre Adriatico.
Teodosio le venne incontro a Salonicco, sua residenza favorita. E qui, più
che gli argomenti di Giustina, per la quale non doveva avere gran tenerezza,
furono le grazie di sua figlia Galla a commuoverlo. Teodosio era rimasto vedovo, dopo la morte di Flaccilla, che gli aveva dato un altro figlio, Onorio; e
ormai aveva superato la quarantina, mentre Galla era appena adolescente.
Ma il matrimonio si fece ugualmente, e subito. E il dono di nozze che lo
sposo fece alla sposa, o meglio alla suocera, fu di restituire il trono
dell'Occidente al piccolo Valentiniano, ora suo cognato.
Il fatto che, senza por tempo in mezzo, egli s'incamminasse verso l'Italia,
dimostra che non era stata la mancanza di forze e di truppe a impedirgli fino
a quel momento di vendicare Graziano, come molti storici sostengono. Ma
ciò che più conta sottolineare è che la stragrande maggioranza di queste
truppe era gota. Contro di esse stavano quelle di Massimo, per la maggior
parte franche, cioè anch'esse tedesche. Nei due Stati Maggiori, i nomi dei
Generali più in vista erano Stilicone, Sarò, Arbogaste, Gaina, Ricimero,
Bauto eccetera. Invano vi si sarebbe cercato un Bruto, un Manlio, cioè un
nome romano.
Massimo fu battuto prima a Laybach, poi a Aquileia, dove venne
catturato. Quando fu condotto in catene dinanzi a Teodosio, questi gli
chiese: "È vero che uccidesti Graziano col mio consenso?" "Non è vero"
rispose il prigioniero. "Lo dissi per assicurarmi l'obbedienza dei soldati."
Resa questa confessione, Massimo venne decapitato dai soldati
senz'aspettare l'ordine di Teodosio (che, crediamo, lo avrebbe dato ugualmente). E Valentiniano fu istallato nuovamente sul trono.
Seguirono quattro anni di relativa pace. Teodosio era tornato a
Costantinopoli a godersi la sua bella, ma sterile moglie, e a esercitare il
potere assoluto su un Impero di fatto nuovamente unificato, perché la
potestà sull'Occidente del ventenne Valentiniano era soltanto fittizia. Ma nel
392 Valentiniano fece la stessa fine di Graziano.
Stavolta il ribelle si chiamava Arbogaste, un generale franco, rozzo e
insolente, che aveva servito con fedeltà Graziano e Teodosio, ma era
montato in superbia dacché lo avevano nominato capo di Stato Maggiore
dell'esercito e non sopportava di ricevere ordini da un "ragazzetto". Anzi, lo
trattava con sì ostentato disprezzo che il ragazzetto alla fine gli consegnò
una lettera di dimissioni ingiungendogli di firmarla. Invece della penna, che
forse non sapeva maneggiare, Arbogaste impugnò la spada.
Ucciso il giovane Imperatore, Arbogaste ebbe tuttavia abbastanza buon
senso per non occuparne il posto. V'istallò invece un cittadino romano,
Eugenio, professore di retorica passato al servizio di Corte. Non apparteneva
alla categoria degli "illustri", come allora si chiamavano i personaggi di
altissimo rilievo; ma era fra i "rispettabili". Da tempo aveva legato le sue
fortune a quelle del Generale franco; ma forse questi lo prediligeva
soprattutto per le sue aperte simpatie verso il paganesimo, di cui Arbogaste
era ancora seguace.
Di nuovo, come nel caso di Graziano, Teodosio prese con molta calma la
notizia dell'assassinio di suo cognato, nonostante le insistenze di Galla che
voleva un immediato castigo. La luna di miele ormai era passata. Ed egli si
decise ad esaudire i desideri di sua moglie solo il giorno in cui essa morì nel
mettere finalmente al mondo una figlia che fu battezzata Galla Placidia, di
cui sentiremo ancora parlare.
Questa seconda spedizione in Italia fu molto più ardua della prima. Lo
scontro fra i due eserciti ebbe luogo sull'Isonzo, che allora si chiamava
"Frigido", e fu proprio l'ultima battaglia combattuta in nome del
paganesimo. Arbogaste aveva costellato il suo campo di statue di Giove,
effigiato col fulmine in mano. Ma anche Teodosio aveva mobilitato il suo
Dio. Dopo una prima scaramuccia finita male per lui, egli raccontò di essersi
addormentato e di aver visto in sogno San Giovanni e San Filippo, che lo
ammonivano di non dubitare del suo destino. Mentre narrava questo
episodio, un soldato irruppe nella sua tenda a riferirgli la visione che anche
lui aveva avuto: era la medesima. Gli astanti rimasero impressionati. Fra
essi c'erano Gaina, Bacurio, Saul: tutti bei nomi romani, come vedete. E
c'era anche un certo Alarico, giovane capitano alla testa di un manipolo di
Visigoti.
Lo storico pagano Zosimo ha naturalmente molto insistito sugli aspetti
miracolosi di questa decisiva vittoria, che nella sua narrazione fu dovuta
soprattutto a un vento violentissimo che, soffiando negli occhi dei pagani, li
avrebbe accecati. Probabilmente si trattava di bora, e non crediamo che il
suo effetto possa essere stato determinante. Comunque, il successo di
Teodosio fu schiacciante. Arbogaste si suicidò. Eugenio, preso prigioniero,
ne seguì l'esempio.
Quale mescolanza fosse Teodosio di pietà e di crudeltà, lo dimostra il
conflitto ch'ebbe con Ambrogio, Vescovo di Milano.
Ambrogio appartiene alla Storia della Chiesa. A noi basti sapere che non
era un prete, in origine. Era un funzionario laico che, in qualità di Prefetto,
aveva rappresentato con molta energia e competenza il potere imperiale in
Liguria e in Emilia. Come tale, si era trovato a dover dirimere, non in nome
della Legge divina, ma di quella dello Stato, le controversie fra cattolici e
ariani, che anche lì infuriavano con morti e feriti. Lo fece solo come
difensore dell'ordine pubblico, ma con tale senso di giustizia e di misura,
che gli stessi litiganti alla morte del vescovo ariano Ausenzio, lo
acclamarono suo successore.
Non si sa con certezza se Ambrogio in quel momento fosse già cristiano,
o ancora pagano. Si sa solo che Valentiniano I (si era nel 374) fu soddisfatto
della scelta e l'approvò., Così, nello spazio di una settimana, il funzionario
laico ricevette i sacramenti, gli ordini e il cappello episcopale. I favori della
Corte gli consentirono di esercitare con piena libertà le sue altissime capacità organizzative. Morto Valentiniano, egli dovette vedersela con
Giustina ch'era ariana; ma ebbe dalla sua Graziano cui aveva fatto un po' da
tutore e che, stando ad alcune voci, aveva ricevuto da lui il consiglio di
prendersi come collega Teodosio.
Dopo che Graziano fu ucciso da Massimo e Giustina fuggita coi figli a
Salonicco, Ambrogio, rimasto a Milano, seguitò a riorganizzare la Chiesa.
Certamente egli accolse bene Teodosio, quando questi, sconfitto e ucciso
Massimo, riportò sul trono Valentiniano II, e un po' meno bene, anzi
categoricamente male, Giustina, la quale chiedeva che almeno una chiesa
della Diocesi venisse dedicata al culto ariano. Ambrogio rispose di no.
Valentiniano, certamente sobillato da sua madre, gli comminò l'esilio.
Ambrogio non si mosse. Di lì a poco un'insurrezione scoppiò a Salonicco
per un motivo che testimonia la miseria morale di quei tempi. Buterico, il
Generale goto che comandava la guarnigione, aveva fatto imprigionare un
fantino del Circo, idolo delle folle, che per la sua liberazione insorsero
uccidendo alcuni ufficiali e soldati. Teodosio non aveva perso la flemma
quando gli avevano ucciso Graziano e non la perderà quando gli
uccideranno Valentiniano. Ma guai a chi gli toccava i suoi soldati barbari.
Sebbene Salonicco fosse la sua città preferita, ordinò un indiscriminato
massacro, le cui vittime qualcuno fa ascendere a 15.000.
Alcuni giorni dopo si presentò in chiesa per ascoltare la messa. Ma sul
portale si stagliò Ambrogio, che additandolo alla folla esclamò: "La
grandezza del suo Impero e il corruttore esercizio di un potere assoluto
possono avergli impedito di discernere l'enormità del suo delitto. Ma sotto la
sua porpora c'è soltanto un uomo il cui corpo è destinato a disfarsi in
polvere e la cui anima deve pur tornare a Dio che gliel'ha data... Faccia egli
penitenza in espiazione del suo peccato prima di tornare a mescolarsi al
gregge dei fedeli..."
Nessuno mai aveva osato parlare in tal modo a quell'uomo orgoglioso.
Dinanzi a un prete inerme egli curvò la testa, e per mesi e mesi ne attese
invano il perdono. Lo mandò a sollecitare attraverso Ruffino, un ignobile
cortigiano poco qualificato a quella bisogna. Ma Ambrogio scacciò di casa il
messaggero dicendogli ch'era "più svergognato d'un cane". Sebbene poi la
Chiesa lo abbia riconosciuto Santo, doveva trattarsi d'un Santo di carattere
un po' difficile.
Alla fine l'Imperatore venne di persona a chiedere umilmente che
penitenza doveva fare. "Poiché il motivo del tuo peccato" rispose il Vescovo
" è stata la passione, prepara una legge che renda obbligatorio l'intervallo di
trenta giorni fra la firma di una condanna a morte e la sua esecuzione. C'è da
sperare che in trenta giorni la passione cada e la ragione ne prenda il posto".
Teodosio obbedì. E fu il primo dei numerosi "precedenti" che dovevano
consacrare, nella lunga lotta fra Stato e Chiesa, la sottomissione di quello a
questa. Ambrogio comprese la importanza dell'avvenimento e, per
celebrarlo, fece comporre un inno apposta: il Te Deum laudamus.
Nel 395, dopo la vittoria su Eugenio e Arbogaste, Teodosio tornò a
Milano. Le condizioni di salute non gli consentivano di riprendere la strada
di Costantinopoli. Zosimo, a lui sempre ostile, dice che lo avevano stroncato
i vizi. Ma niente ci fa sospettare che quell'uomo timorato e malinconico ne
avesse. Sentendosi vicino alla morte, mandò a chiamare il secondo dei suoi
figli, il bambinetto Onorio, che giunse da Costantinopoli accompagnato da
Serena, cugina di Teodosio e moglie del suo più fedele Generale, Stilicone.
E gli affidò l'Impero d'Occidente, lasciando quello d'Oriente al maggiore,
Arcadio, il primo sotto la tutela di Stilicone, il secondo sotto quella di
Ruffino.
Con questo gesto chiuse la sua vita Teodosio detto il Grande. Se lo sia
stato veramente, è difficile dirlo. Forse lo sarebbe diventato se Dio gli
avesse dato ancora un po' di tempo per condurre a termine la sua politica
d'integrazione coi barbari e per accorgersi che la scelta dei successori non
era stata indovinata. Fu certamente un bravo soldato, che aveva un alto concetto del titolo che portava e non venne mai meno agl'impegni che gliene
derivavano. Ma l'imparzialità non era il suo forte, e dal punto di vista
amministrativo combinò un mare di guai.
Tuttavia fu certamente l'ultimo Imperatore degno di questo nome.
CAPITOLO QUINTO
STILICONE
IL POETA Claudiano, specialista in panegirici, salutò il nuovo Imperatore
d'Occidente, Onorio, col titolo di Porfirogenito, che voleva dire "nato nella
camera di porpora", cioè quando suo padre era già Imperatore a
Costantinopoli, mentre il suo maggior fratello Arcadio era nato in Spagna,
quando suo padre era tuttora un pensionato qualunque. E a questo titolo,
dovuto a una pura coincidenza, Onorio non seppe, in tutta la vita,
aggiungerne altri, meno quello di pollicultore. Se avesse saputo
amministrare lo Stato come sapeva allevare galline, sarebbe stato un grande
sovrano.
Invece che da suo padre, egli aveva ripreso dalla madre, l'anemica e
malaticcia Flaccilla. Non aveva ambizioni. Non aveva passioni. Non aveva
nemmeno vizi. Una cosa sola sembra che abbia visto con chiarezza e voluto
con tenacia: sopravvivere. Onorio fu un maestro nell'arte di sottrarsi ai
pericoli e di stare al riparo dalle correnti d'aria. Un po' poco, per un
Imperatore, in un momento come quello.
Ma alle spalle di questo ragazzo, su lui stendendo una protezione forse un
po' sopraffattrice, c'era un grande soldato e un fedele servitore. Il barbaro
Stilicone era allora sulla quarantina. Figlio di un capo vandalo che aveva
militato sotto le bandiere di Valente, aveva fatto carriera con Teodosio che
gli aveva affidato anche delle missioni diplomatiche. Alto e solenne
com'era, già il suo aspetto bastava a incutere soggezione. E si vede che fin
da allora l'Imperatore riponeva in lui grosse speranze, perché gli diede in
moglie sua nipote Serena. Da allora Stilicone era stato il luogotenente di
fiducia di Teodosio, lo aveva accompagnato in tutte le spedizioni e
probabilmente ne aveva redatto i piani operativi. Per quanto la sua figura sia
alquanto controversa, la sua fedeltà non solo alla dinastia ma anche alle idee
politiche del suo benefattore è fuori discussione.
Proprio in quello stesso anno 395 in cui egli diventava praticamente
padrone dell'Impero di Occidente, i Visigoti eleggevano a loro Re
quell'Alarico che abbiamo già fugacemente conosciuto nello Stato Maggiore
di Teodosio alla battaglia del Frigido. Aveva la stessa età, la stessa
esperienza di Stilicone, e avrebbe potuto benissimo essere lui al posto di
tutore di Onorio. Ma la sorte lo volle invece alla testa del suo guerriero e
turbolento popolo che lo acclamò sollevandolo sugli scudi e ch'egli provvide
subito a accasare in una regione decisiva dal punto di vista strategico: la
Serbia, passaggio obbligato di tutte le comunicazioni terrestri fra i due
Imperi.
Alarico, da buon barbaro, si sentiva impegnato dal suo giuramento alla
fedeltà a Teodosio, non a ciò che questi rappresentava. Sicché, Teodosio
morto, si considerò libero di fare la politica che voleva, o per meglio dire di
fare una politica, perché sino a quel momento i Visigoti non ne avevano
avuta nessuna.
Che strano impasto fosse quest'uomo di nazionalismo tedesco e di
ammirazione per la civiltà mediterranea, lo dimostrarono l'impeto aggressivo con cui condusse un'operazione di conquista della Grecia e la
brusca rinunzia a proseguirla quando si trovò di fronte alle statue e alle
colonne del Partenone, la cui bellezza lo folgorò. Di colpo, da conquistatore,
si trasformò in turista e firmò con gli ateniesi un patto di amicizia.
L'anno dopo (396) Stilicone accorse, per sloggiare i Visigoti dalla Grecia.
Riuscì a circondarli in Arcadia e il loro annientamento sembrava sicuro
quando invece si seppe ch'erano sfuggiti attraverso un passo non presidiato.
Zosimo dice che fu un errore tecnico di Stilicone, Orosio parla di
tradimento, Claudiano insinua che era giunto un alt! da Costantinopoli.
Forse non fu nulla di tutto questo, ma soltanto il timore da parte di Stilicone
di non essere più necessario il giorno in cui i Visigoti e il loro bellicoso Re
fossero stati distrutti.
Ma nella gara all'accaparramento della gratitudine di Alarico, subito
Arcadio andò ancora più in là, conferendogli, se non il titolo, almeno le
funzioni di Governatore dell'Illiria.
Stilicone non reagì a questo gesto provocatorio. La sua posizione
sembrava incrollabile, ora ch'era diventato suocero di Onorio, cui aveva
dato in moglie sua figlia Maria. Nel 400 fu eletto Console. Era una carica
ormai negletta, cui non corrispondevano più poteri paragonabili a quelli che
Stilicone di fatto esercitava. Ma i romani di antica famiglia ne facevano un
loro monopolio, perché erano sempre i Consoli che davano il nome all'anno
in corso, come ai vecchi bei tempi della Repubblica, e con riluttanza
ammettevano che questo privilegio, sia pure solo formale, toccasse a un
barbaro. Tuttavia a Stilicone si piegarono. Sembrava dunque che per costui
il nuovo secolo cominciasse bene.
E invece proprio in quel momento ecco d'improvviso Alarico presentarsi
alla testa delle sue orde sui valichi delle Alpi Giulie. Si possono fare infinite
congetture sui suoi piani e disegni. La sola che trovi conferma negli avvenimenti successivi è che il focoso visigoto intendesse impadronirsi, più che di
Roma, del "posto" di Stilicone.
L'Italia era abituata a vedersi scorrazzare addosso eserciti in rivolta. Ma
romani, almeno di nome. Da secoli il suo suolo non era calcato da truppe
che sventolavano vessilli stranieri. E lo sbigottimento fu grande. Claudiano
racconta che, a renderlo ancora più disperato, ci si mise di mezzo anche il
soprannaturale. In cielo apparve una cometa, segno sinistro. E l'Imperatore,
passando una rivista ai soldati, vide fuggire dai loro ranghi una coppia di
lupi, che vennero uccisi e squartati. Nel loro ventre furono trovate due mani.
A Roma i Senatori, che seguitavano a esistere e a riunirsi sebbene le loro
decisioni avessero smesso da un bel pezzo di contare, avanzarono l'idea che a Onorio piaceva assai - di attraversare il Tirreno e di fondare una nuova
Urbe in Sardegna o in Corsica. In mezzo a quei balbettamenti di gente
impaurita e irresoluta, l'unico che tenne un linguaggio da Senatore vero fu
Stilicone. "Cessate" egli disse "questi lamenti che non sono da uomini. I
Goti, è vero, ci hanno attaccato a tradimento. Ma l'Italia ha trionfato di
pericoli ben più gravi: quello dei Galli, dei Cimbri, dei Teutoni. Se Roma
cadesse, non ci sarebbe più al mondo, per i suoi figli, una patria sicura...
Andrò al Nord a raccogliere un esercito per vendicare l'insultata maestà di
Roma, ma nel frattempo continuerò a partecipare alle vostre ansietà perché
tra voi lascio mia moglie, i miei figli e questo mio genero (Onorio) che mi è
più caro che la vita stessa."
Così racconta Claudiano, forse abbellendo parecchio l'orazione del suo
eroe. Ma che un poeta romano trovasse plausibile e credibile, in bocca a un
generale barbaro, un simile discorso, basta a farci capire a che punto ormai
s'era arrivati, lì a Roma, e come Stilicone considerasse, con condiscendenza,
un suo semplice "protetto" il giovincello che sedeva sul trono.
Nell'inverno 401-402 il Generale marciò contro Alarico che si era spinto
fin sotto Torino e ora assediava la cittadina fortificata di Pollenzo. Secondo
Claudiano, un veterano goto ammonì il suo Re di non accettare battaglia.
Infuriato, Alarico gli rispose di aver udito una voce che gli diceva:
"Penetrerai nell'Urbe!"
A questa premonizione i fatti, lì per lì, non diedero ragione. Forse quella
di Pollenzo non fu per Stilicone (di cui è incerta, quel giorno, perfino la
presenza sul posto) una schiacciante vittoria, ma certo fu una sconfitta per
Alarico, che a quanto pare lasciò prigionieri in mano all'avversario la moglie
e i figli. Dovette trattarsi di uno dei soliti successi alla Stilicone che, quando
aveva a che fare coi Visigoti, li metteva regolarmente in ginocchio; ma al
momento di assestare il colpo finale, rinfoderava la spada e lasciava loro
libera la ritirata. Anche stavolta infatti Alarico poté riordinare le sue scompaginate falangi e riprendere la strada del Veneto, dove si fermò a bivaccare.
Cortesemente, Stilicone gli rimandò la sposa e la prole.
A Roma, dove la notizia della vittoria non era giunta, si lavorava a
innalzare una nuova cinta di mura di rinforzo a quelle di Aureliano. La
paura aveva restituito di colpo a quella cittadinanza bighellona una gran
voglia di lavorare. Ogni tanto si fermavano a spiare l'orizzonte nel terrore di
veder apparire le colonne gote. Invece apparvero quelle di Stilicone, che fu
accolto stavolta con un entusiasmo indescrivibile e passò in mezzo alla
popolazione acclamante su un cocchio, in cui sedeva accanto all'imperatore
Onorio suo genero e all'imperatrice Maria sua figlia.
Naturalmente i Romani vollero festeggiare il fausto evento alla loro
maniera preferita: e cioè con un grande spettacolo gladiatorio al Circo.
Questi spettacoli erano già stati proibiti da Costantino, quasi un secolo
prima. I Romani non se ne davano per intesi, dimostrando con ciò di aver
avuto anche allora, delle leggi e dei regolamenti, lo stesso rispetto che ne
hanno ora. Ma quella volta per loro girò male. Sul più bello di una massiccia
carneficina fra prigionieri goti, un frate di nome Telemaco saltò nell'arena
per metter fine al massacro. Fu lapidato e ucciso dalla folla imbestialita. Ma
Onorio ne rimase talmente sconvolto, che d'allora in poi i giuochi del Circo
vennero proibiti davvero, e non più soltanto sulla carta.
Nell'anno successivo, 405, Stilicone fu rieletto Console e per la seconda
volta si guadagnò il titolo di "salvatore dell'Urbe". Non era Alarico che la
minacciava, ora, ma un certo Radagaiso, di cui non sappiamo con precisione
che cosa fosse: forse un ostrogoto, riuscito a sottrarre in tempo una parte del
suo popolo al servaggio degli Unni. Era comunque un barbaro nel senso più
completo della parola, "il più selvaggio di tutti i nemici che Roma avesse
mai avuto", dice Orosio. Discese la Penisola alla testa di un'orda di 200.000
uomini (qualcuno dice 400.000). Ma Stilicone, con un capolavoro di
strategia, riuscì a chiuderlo nelle valli ai piedi di Fiesole, proprio là dove,
quattro secoli e mezzo prima, era stato disfatto Catilina.
Non ci fu bisogno di dar battaglia: bastò chiudere i passi. Dentro quel
budello senza uscita, i Goti cominciarono a morir di fame, e Stilicone li
lasciò fare finché di vivo non rimasero che pochi estenuati brandelli,
inservibili anche come schiavi. Stilicone sapeva far le cose fino in fondo,
quando non si trattava di Alarico.
E così l'Italia sembrò finalmente liberata dalla minaccia delle invasioni,
che nessun barbaro infatti per due anni ritentò. Solo che, per raggiungere
questo risultato, sì era dovuto sguarnire tutte le altre province dell'Ovest Britannia, Spagna e Francia -, dove ora si stavano precipitando alla rinfusa,
sospingendosi e guerreggiando l'uno contro l'altro, Vandali, Svevi, Alani, in
conflitto con Alemanni, Franchi e Burgundi che già vi si erano accasati.
L'Impero d'Occidente se ne andava.
Nel 408 l'Imperatore d'Oriente, Arcadio, morì, lasciando erede al trono un
bambino di sette anni, Teodosio II, sotto la tutela di sua madre, l'imperatrice
Eudossia, principessa di sangue franco, cioè tedesco. E qui ci troviamo di
fronte a una serie di avvenimenti che ci lasciano piuttosto perplessi sul
conto di Stilicone.
Alarico aveva ricominciato ad agitarsi, e col suo esercito era penetrato in
Epiro, provincia di Costantinopoli. Poi d'improvviso era tornato indietro, per
il solito passo di Laybach si era di nuovo affacciato in Italia, e aveva
mandato un'ambasciata a Roma per chiedere in termini piuttosto bruschi un
compenso delle spese incontrate in Epiro, "visto che non gli avevano lasciato finire l'impresa". Chi non gliel'aveva lasciata finire dopo avergliela,
evidentemente, ordinata?
In Senato Stilicone spiegò che effettivamente Alarico, andando in Epiro,
aveva inteso servire gl'interessi dell'Imperatore, il quale poi gli aveva
imposto l'alt e quindi bisognava risarcirlo.
Fra i Senatori, uno solo si alzò a fare opposizione, ritrovando nella
requisitoria gli accenti dell'antica Roma: Lampridio. "Questa non è pace"
disse, "ma accettazione della servitù." Però, appena pronunziate quelle
parole orgogliose, corse a rifugiarsi in una chiesa lì vicino.
La proposta di Stilicone fu accolta. Il Generale ormai sembrava
onnipotente. Sua figlia l'imperatrice Maria era morta, ma Onorio l'aveva
rimpiazzata con la sorella minore Termanzia, restando così genero dello
stesso suocero. E da confidente del Sovrano fungeva ora Olimpio, un
gréculo del Mar Nero, che a Stilicone doveva tutta la sua carriera. Ma a
quanto pare invece fu proprio questo cortigiano intrigante a suscitare i
sospetti di Onorio contro il suo Generale.
L'Imperatore progettava una gita a Costantinopoli per affermare il suo
diritto alla tutela del piccolo Teodosio. Stilicone gli prospettò i pericoli e il
costo di quel viaggio in termini tali da persuaderlo a mandarci, in sua vece,
lui. Ma, si affrettò subito a insinuare Olimpio, Stilicone lo aveva fatto
perché in realtà voleva istallare suo figlio Eucherio sul trono d'Oriente.
Elementi di fatto che confermassero questo sospetto non ce n'era, perché
Eucherio era sempre stato tenuto da suo padre piuttosto in disparte. Ma,
morto Arcadio, a Onorio sembrava di non aver più tanto bisogno del suo
Generale che, con la scusa di proteggerlo, lo soffocava. C'erano anche altri
motivi di scontentezza verso l'onnipotente vandalo. I pagani dicevano che
sua moglie Serena, quando per la prima volta venne a Roma al seguito del
suo padre adottivo Teodosio, rubò un gioiello nel tempio di Rea e che lui
stesso si era appropriato di certe lastre d'oro del tempio di Giove Capitolino.
I cristiani, da parte loro, mormoravano che Eucherio era in cuor suo un
pagano idolatra. Ma soprattutto, ad alimentare le dicerie, c'era lo strano
atteggiamento del Generale nei confronti di Alarico, che irritava l'elemento
romano.
Ci fu, nelle legioni, qualche ammutinamento. Onorio ne ordinò la
repressione al Generale, che la eseguì con sommarie decimazioni, proprio
nel momento in cui un usurpatore, Costantino, calava dalla Britannia, di cui
era stato il comandante militare, in Francia, e si attestava ad Arles,
minacciando l'Italia. Con l'esercito mezzo in rivolta, Stilicone capiva di non
poterlo fermare. E altre truppe non ne aveva da richiamare da oltre confine.
Le ultime le aveva macinate nella campagna contro Radagaiso: le province
occidentali, ormai sommerse dai barbari, non ne fornivano più. Egli disse
dunque a Onorio che stava trattando con Alarico per lanciarlo contro
Costantino. E se questo fosse avvenuto in tempo, tutti i sospetti che le sue
passate condiscendenze al capo visigoto avevano suscitato, sarebbero svaniti
di colpo.
Purtroppo, il tempo non ci fu. Onorio, dopo aver dato il suo consenso a
questo piano diplomatico e firmato la lettera a Alarico, partì per Pavia
insieme a Olimpio, mentre il Generale che di costui ancora non sospettava,
restò a Ravenna per preparare il suo viaggio a Costantinopoli. Come siano
andate le cose con precisione non si sa, ma il fatto è che, subito dopo l'arrivo
dell'Imperatore e del suo consigliere, le guarnigioni del Ticino si ribellarono
accoppando sommariamente tutti coloro ch'erano considerati amici di
Stilicone. Queste guarnigioni erano composte degli ultimi soldati di sangue
romano, più o meno puro, che ancora popolassero l'esercito; e quindi la loro
rivolta acquistava un chiaro carattere di pogrom contro i barbari.
I capi di costoro si riunirono a Bologna in consiglio di guerra intorno a
Stilicone. Questi, udendo che anche l'Imperatore era stato assassinato,
approvò subito la loro proposta di marciare su Pavia e passare per le armi gli
ammutinati. Ma subito dopo arrivò la smentita: Onorio era salvo. Il
Generale disse che in tal caso bisognava aspettare i suoi ordini.
Ma non tutti approvarono questo gesto di disciplina; anzi, i più lo
disapprovarono. Il goto Sarò disertò addirittura il campo e di notte attaccò e
massacrò la guardia personale di Stilicone, che riuscì a fuggire a cavallo
verso Ravenna. Pare che Olimpio avesse promesso a Sarò un cospicuo
premio, se uccideva il Generale. Questi sembrava tuttora preoccupato più
della salvezza dello Stato che di quella sua perché, lungi dall'organizzare
una difesa personale, si mise a diramare circolari a tutti i magistrati
ordinando loro di respingere qualunque tentativo delle truppe barbare
dislocate fuori dalle città di entrare dentro le mura. Non voleva, Stilicone,
che corresse sangue fra italiani e tedeschi. Egli restava fedele al gran sogno
dell'integrazione, ch'era sempre stato quello degl'Imperatori più illuminati
da Aureliano a Costantino a Teodosio.
Mentre cercava così di arginare la catastrofe, giunse da parte di Onorio
l'ordine di arrestarlo. Forse solo allora al salvatore dell'Urbe la benda cadde
dagli occhi. Si rifugiò in una chiesa dove i soldati non potevano entrare.
All'alba alcuni di essi, disarmati, furono condotti dal Vescovo in sua
presenza. Nelle mani del prelato essi giurarono, probabilmente in buona
fede, che la pena comminatagli era un momentaneo confino in un luogo
sorvegliato. Stilicone li seguì. Appena fuori del sacro recinto, gli fu data in
lettura una seconda lettera di Onorio che, "per delitti contro lo Stato",
gl'impartiva la condanna a morte, da eseguirsi immediatamente.
C'era intorno al gruppo una piccola folla di amici del Generale e di soldati
barbari
che,
udendo
quell'incredibile
verdetto,
sguainarono
minacciosamente le spade. Stilicone li fermò con un gesto imperioso. Egli
conservava ancora un tale prestigio sui suoi che nessuno osò disobbedirgli.
Poi mise un ginocchio a terra e stoicamente, senza una parola di rammarico,
curvò la bella testa grigia offrendo il collo all'ascia del boia.
Troppi elementi mancano per poter pronunciare un giudizio sicuro su
quest'uomo. Ch'egli avesse approfittato del potere per arricchire se stesso e i
suoi, è possibile. Che fosse ambizioso e che qualche volta avesse scambiato
l'interesse proprio per quello dello Stato, sbarazzandosi sottomano di
avversari e di possibili rivali, è probabile. Che il suo modo di proteggere
Onorio fosse alquanto autoritario e talvolta prepotente, lo dimostra il fatto
che per due volte gli diede in moglie una sua figliola. Ma quella di cui non
si può dubitare è la fedeltà ch'egli serbò alla parola data a Teodosio di
difendere fino all'ultimo i suoi eredi e la sua politica. In lui rifulsero le
qualità migliori del barbaro che si dedicava al servizio di Roma: la sagacia
militare, il coraggio, e soprattutto il senso solenne, quasi maestoso, della
dignità imperiale. Certo, giuocò doppio con Alarico, battendolo tre volte e
altrettante risparmiandolo. Se questa politica, come oggi si direbbe, di
"distensione", fosse giusta o sbagliata, potremmo dirlo solo s'egli fosse stato
in grado di svolgerla sino in fondo. Comunque, questo barbaro fu uno degli
ultimi condottieri dell'Impero che seppero morire da romani.
La sua testa rotolò nella polvere il 23 agosto 408. Il boia che l'aveva
decapitata, Eracliano, in premio di questo nobile servigio, fu nominato
Generale. Eucherio fuggito da Roma e rifugiatosi anche lui in una chiesa, fu
ucciso alcuni mesi dopo. L'imperatrice Termanzia fu rimandata da Onorio
alla madre Serena. Un comitato di epurazione (come tutto si ripete nella
Storia!) presieduto da Olimpio fece piazza pulita di tutti quei funzionari e
ufficiali che, per il fatto di essere stati selezionati da Stilicone, passavano
per "collaborazionisti". Nelle guarnigioni, i Romani imbaldanziti compirono
alcuni massacri sugli "ausiliari" barbari, mescolandovi anche donne e
bambini.
Fu insomma una bella purga, che il contemporaneo Orosio, bigotto e
declamatorio, salutò come una "purificazione" di Roma. Peccato che il suo
risultato più cospicuo, a parte il cambio della guardia nelle cariche (e nelle
prebende) fosse il passaggio di trentamila soldati barbari nel campo di
Alarico proprio nel momento in cui la "distensione" svaniva nell'aria.
CAPITOLO SESTO
ROMA, A.D. 410
AFFACCIATO alla finestra di Laybach nel suo solito ambiguo
atteggiamento, Alarico sembrò lì per lì accogliere con assoluta indifferenza
la notizia della fine del suo amico Stilicone. Anzi mandò un messaggio a
Onorio dicendosi pronto, in cambio di una moderata largizione, a firmare un
trattato di pace con lui e a ritirarsi in Serbia. Onorio, col coraggio che lo
distingueva più quando maneggiava la penna che non la spada, rifiutò. Ma,
invece di prepararsi all'altra eventualità che Alarico implicitamente minacciava, la guerra, si rimise alle sue occupazioni favorite: allevar polli e
redigere decreti di persecuzione contro gli eretici, "affidandosi per tutto il
resto" dice Zosimo "alle preghiere di Olimpio". Oramai egli aveva
definitivamente trasportato la sua Corte da Milano a Ravenna, una città che
gli acquitrini e la malaria bastavano a difendere. La sicurezza, per lui, era
soltanto quella della sua persona.
Alarico valicò le Alpi Giulie, discese il Veneto, non fece tentativi contro
Aquileia, traversò il Po, giunse a Bologna, seminando dovunque miseria e
fame. E a farglisi incontro ci fu soltanto un monaco, che venne a supplicarlo
di desistere dai suoi disegni. "Non sono io" rispose Alarico "che me li
propongo; è qualcosa dentro di me che mi ci spinge irresistibilmente
gridandomi: “Marcia su Roma e fanne un mucchio di rovine." Fu, se non
sbagliamo, il primo tedesco che arruolò il buon Dio sotto le proprie
bandiere. Ma gl'imitatori non gli sarebbero mancati.
A Roma, dove dai tempi di Brenno non si era più visto un esercito nemico
accamparsi sotto le mura della città, lo sbigottimento fu grande. E la prima
misura che venne presa fu quella di uccidere Serena, la vedova di Stilicone,
cioè dell'uomo che coi Goti aveva sempre patteggiato. I pagani,
incolpandola d'intelligenza col nemico, vollero vendicarsi di colei che aveva
commesso il sacrilegio nel tempio di Rea. Ma gli antichi dèi, che il cristiano
Stilicone aveva contribuito a mortificare, non ricompensarono di tanto zelo
l'Urbe, che sulla fine di quell'anno 408 cominciò a morire di fame. Alarico
non l'attaccava, ma la teneva chiusa nella sua morsa. E da Ravenna
arrivavano incitamenti a resistere, ma non battaglioni. Alla fame si aggiunse
un'epidemia. Insorsero qua e là casi dì cannibalismo. A tutte queste jatture
l'orgoglio romano, riluttante ad ammettere che Roma potesse essere tenuta
prigioniera da un nemico, reagì diffondendo la voce che non era Alarico coi
suoi Visigoti quello che bivaccava sotto le sue mura, ma un ribelle
luogotenente di Stilicone.
Anche per appurare la fondatezza di questa diceria, fu mandato come
ambasciatore il capo dei notai imperiali Giovanni che conosceva personalmente Alarico e che dovette convenire che purtroppo era proprio lui.
Nel linguaggio che tenne al guerriero barbaro risuonavano gli accenti
dell'Urbe imperiale, abituata più a imporre la pace che a chiederla. Ma il
guerriero barbaro, lungi dal lasciarsene impressionare, ne rise, e a
quell'aulica concione ribatté con un proverbio popolare tedesco: "L'erba
folta si falcia più facilmente di quella rada". Chissà cosa intendeva. In
compenso, non ci furono dubbi su cosa esigeva: tutto l'oro, tutto l'argento
della città, e la consegna di tutti gli schiavi di sangue barbaro. "Cosa ci lasci
dunque?" chiese sgomento il messo. "L'anima" rispose Alarico. Era in
sostanza la resa senza condizioni.
Il Senato respinse la proposta, e sì rivolse al Papa. Lo Stato,
nell'incombenza del pericolo, abdicava in favore della Chiesa, che così
rimpiazzava il vacillante potere politico in Italia. Innocenzo I era un
Pontefice di alte qualità morali e intellettuali, ma sapeva benissimo che
Roma, cristiana in superficie, era rimasta pagana nella sostanza. Il popolino
andava dicendo che Alarico rappresentava soltanto la vendetta degli dèi
contro l'Urbe che li aveva traditi, mentre altre città come Narni si erano
salvate dalla catastrofe riadottando in tempo l'antica fede e i suoi riti.
Innocenzo I, piegandosi all'emergenza, consentì che questi riti fossero
riesumati. Ma i sacerdoti pagani risposero che ciò doveva essere fatto in
forma pubblica e solenne, in Campidoglio e nel Foro Traiano, con la
partecipazione di tutto il Senato. E anche a questo il Papa diede, sia pure
controvoglia, il suo assenso. Ma le cerimonie e i sacrifici, che per un
momento ritrasformarono l'Urbe nella capitale del paganesimo, non diedero
frutto. Alarico non si mosse, e fame e peste seguitarono a imperversare nella
città assediata.
Le trattative ripresero, e finalmente un accordo fu raggiunto: Alarico si
contentò di 5000 libbre d'oro, 30.000 d'argento, 3000 di pepe, 4000 tuniche
di seta. E questa cupidigia di seta e di pepe la dice abbastanza lunga sui
cambiamenti ch'erano sopravvenuti nel costume e nelle abitudini dei
barbari. Quanto a quelli dei romani, sono documentati dal modo con cui si
procurarono i mezzi per pagare quella pesante tassa. La città che pochi
giorni prima voleva tornare al culto degli antichi dèi, ora ne spogliò le statue
di tutti i loro monili.
Alarico volle mostrarsi arrendevole perché perseguiva un più vasto
disegno politico: quello di farsi accettare come alleato permanente di Roma
e suo difensore. Il momento gli sembrava buono, perché Onorio era allora
più minacciato che mai dall'usurpatore Costantino, acquartierato a Valenza e
momentaneamente vittorioso in Inghilterra, Francia e Spagna, sulle orde
barbariche che le avevano messe a soqquadro. Ai primi del 409 egli mandò
a Onorio un messo per dirgli che, se gli riconosceva il comando su quelle
province, egli le avrebbe d'ora in poi governate in suo nome. Onorio era
dunque alla scelta fra un avversario e un generale fellone. Preferì affidarsi al
fellone, che in quel momento stava sommariamente accoppando tutti i
funzionari fedeli all'Imperatore, e gli mandò la porpora imperiale
associandoselo al trono.
Lo fece forse per coerenza perché l'alleanza con Alarico avrebbe
significato un ritorno alla politica di Stilicone. Ma ad andarne di mezzo fu
Roma, che aveva mandato un'ambasciata a Ravenna per ottenere la ratifica
del trattato di pace col visigoto. Onorio ascoltò i messi, non si commosse al
racconto delle sofferenze della città, rifiutò la ratifica, e Alarico rimise
assedio a Roma.
Stavolta non si poteva dire tuttavia che la colpa fosse dei cattivi consigli
di Olimpio, piombato in disgrazia e in fuga da Ravenna. Il suo posto lo
aveva preso un certo Giovio, un personaggio che veniva dal nulla e di cui si
sapeva soltanto che aveva avuto buoni rapporti con Alarico, di cui era stato
ospite in Epiro. .Egli chiese all'Imperatore il permesso di abboccarsi col Re
goto, e con questi s'incontrò infatti a Rimini per un tentativo di risolvere
amichevolmente la controversia. Nel rapporto che subito dopo mandò a
Ravenna era detto che Alarico chiedeva un tributo annuo oltre l'Istria, la
Venezia e la Dalmazia come settlement per il suo popolo, intatta restando su
queste province la sovranità dell'Impero. Ma Giovio suggeriva che se Alarico fosse stato nominato magister militum, ch'era stata la carica di Stilicone,
si sarebbe accontentato e non avrebbe chiesto altro. Era l'ennesima riprova
che l'ambizione del barbaro non era distruggere l'Impero, ma inserirsi nelle
sue strutture.
La risposta di Onorio fu fulminante: "Non soltanto Alarico, ma nessuno
della sua razza" terminava la lettera "potrà mai aspirare a simili incarichi". E
Giovio commise la dabbenaggine (o il volontario delitto) di leggere questa
frase ad alta voce.
La reazione di Alarico fu quella dell'uomo ferito nei suoi più dolenti
complessi d'inferiorità: quell'accenno alla razza lo aveva scottato. Tuttavia
seppe controllarsi e, prima di riprendere l'assedio di Roma, volle
cattivarsene la popolazione con un gesto di generosità. Adunò i Vescovi
delle città italiane che aveva occupato e li mandò a Ravenna come suoi
ambasciatori per dire all'Imperatore che, pur di evitare all'Urbe nuove
sofferenze, si contentava di un diritto di asilo in Austria promettendo in
cambio la sua assistenza militare contro qualunque nemico di Roma e
dell'Impero.
Di nuovo Onorio rifiutò, allegando il giuramento ch'egli aveva fatto di
non scendere mai a patti col barbaro. E questi, da nemico, si tramutò, agli
occhi dei Romani, nell'amico che cercava di salvarli. Essi tumultuarono
nelle strade manifestando la loro indignazione contro un Imperatore che,
lungi dal difenderli, sfogava sulla loro pelle la propria ostinatezza. E
decisero di ribellarsi tagliando i ponti con Ravenna ed elevando al trono un
altro Imperatore, Attalo.
Era costui un intellettuale greco, che aveva fatto una bella carriera a Corte
sino a farsi nominare Prefetto del Pretorio dell'Urbe, la più alta carica della
città. I pagani lo consideravano dei loro per via della cultura classica di cui
era intriso. In realtà era cristiano. Ma aveva ricevuto il battesimo da un
Vescovo goto e ariano, il che faceva di lui una persona grata agli occhi di
Alarico e dei suoi.
Attalo prese molto sul serio la sua nomina ad Augusto, convocò il Senato
e tenne, in perfetto latino ciceroniano, un magnifico discorso, in cui
annunzio la ricostituzione del vecchio Impero col ritorno di tutto l'Occidente
sotto lo scettro di Roma. Naturalmente una simile operazione egli intendeva
compierla non coi Romani, ma coi Visigoti di Alarico. Ma questo non lo
disse. Il primo passo lo mosse in direzione di Ravenna per eliminare intanto
il decaduto Onorio.
Questi gli mandò incontro non un esercito, perché non ne aveva, ma il
solito Giovio con una proposta allettante: rimanesse Attalo imperatore a
Roma, purché lui, Onorio, potesse restarlo a Ravenna. Ma fu Giovio stesso,
doppiogiochista inesauribile, a consigliare ad Attalo il rifiuto, anzi a
dettargli, pare, l'insolente risposta: "Non un vestigio della dignità imperiale
ti sarà lasciato, Onorio. Solo come un favore ti concederemo salva la vita".
E Onorio, che alla vita ci teneva molto e non si fidava del "favore" già
cominciava a preparare la fuga a Costantinopoli, quando ricevette l'inattesa
notizia che proprio da Costantinopoli erano in arrivo lì a Ravenna 40.000
uomini, mandatigli da suo nipote Teodosio II.
Niente potrebbe meglio darci la misura della disorganizzazione e del
disordine in cui versavano ambedue gl'Imperi, quello d'Occidente e quello
d'Oriente, come il fatto che quei quarantamila uomini erano i rinforzi
sollecitati due anni prima da Stilicone per parare i continui attacchi dei
barbari. Essi avevano impiegato due anni ad accorrere, e non per cattiva
volontà, ma per totale inefficienza. E così Onorio fu ancora una volta
salvato dal Generale ch'egli aveva fatto uccidere e che anche dopo morto
seguitava a rendergli servizio.
Giovio, ch'era rimasto a Roma fingendosi alleato di Attalo, ma
segretamente corrispondendo con Onorio, approfittava della sua personale
amicizia con Alarico per insinuargli all'orecchio che non doveva fidarsi di
Attalo, il quale si preparava a tradire il suo protettore assassinandolo.
Alarico ascoltava, ma sapeva che in fatto di lealtà le lezioni di Giovio non
erano fra le più qualificate. Egli non abbandonò Attalo, anzi mosse prima su
Bologna e poi su Genova per imporre a queste città di riconoscerlo
Imperatore. E solo quando gli giunse notizia che il popolo romano,
nuovamente ridotto alla fame dal blocco dei porti africani, stava per
insorgere contro quell'Augusto unicamente inteso a pronunciare discorsi
solenni e inutili, lo convocò a Rimini. E qui, di fronte a tutta la popolazione,
gli strappò di dosso la porpora e il diadema, e lì mandò in omaggio a
Onorio, per un ultimo tentativo di giungere a un accordo con lui.
Stavolta fu un guerriero goto, un certo Saro, da molti anni alle dipendenze
dell'Imperatore, a consigliare a quest'ultimo il rifiuto di ogni trattativa.
Sembra che questo Saro avesse con Alarico una vecchia ruggine di famiglia.
Comunque, non gli ci volle molto a incoraggiare l'ostinazione di quel
Sovrano che, come poi si dirà di certi Re Borboni, non dimenticava nulla e
non imparava nulla.
Alarico allora tornò per la terza volta sotto le mura di Roma, portandosi
dietro Attalo che, riprecipitato nella polvere da cui era emerso, gli aveva
umilmente chiesto di restare al suo seguito. E dopo breve assedio, v'irruppe,
probabilmente senza incontrare resistenza o incontrandone molto poca.
Correva l'anno 410. E l'avvenimento era così sensazionale che riecheggiò
in tutto il mondo eccitando la fantasia della gente, la quale vi ricamò sopra
le più sinistre dicerie. Si disse, per giustificare quella rapida resa, che
Alarico era ricorso al proditorio stratagemma di mandare in dono ai nobili
romani trecento schiavi, i quali poi avevano agito da quinta colonna aprendo
le porte della città. Secondo altri, fu invece una gentildonna dell'aristocrazia,
Proba, che le fece aprire dalle sue ancelle per risparmiare alla popolazione le
sofferenze di un nuovo assedio.
Purtroppo, della caduta di Roma, non abbiamo che i pochi aneddoti
raccolti da alcuni memorialisti ecclesiastici tutt'altro che attendibili. Non
stentiamo a credere che, dopo esserci ronzati intorno e averla bramata tanti
anni, i guerrieri goti abbiano commesso nella città saccheggi e devastazioni.
Ma furono molto minori di quelli di cui si favoleggiò. Alarico aveva ordinato che gli edifici cristiani fossero rispettati. E i soldati obbedirono. Uno di
essi, entrato senza saperlo in una chiesa, volle depredarla. Una vecchia
monaca gli disse: "Fa' pure. Io non sono abbastanza forte per difendere
questa roba. Sappi però ch'è dell'Apostolo Pietro". Il goto s'impaurì,
sollecitò l'intervento personale di Alarico, e questi ordinò che tutti i preziosi
della Basilica fossero portati in processione nel sotterraneo.
Il sacco di Roma durò da tre a sei giorni. Poi, carico di bottino, l'esercito
di Alarico riprese la marcia verso il Sud, penetrò in Campania, di qui passò
in Calabria, e si diresse verso Reggio. Ma presso Cosenza fu colpito da una
violenta febbre. Forse era malaria. Comunque, di lì a pochi giorni il malato
spirò.
I suoi soldati, non potendo riportarne in patria il cadavere, decisero di
scavargli una tomba che nessuno potesse trovare e profanare. Misero al
lavoro migliaia di schiavi per dirottare il corso del Busento, un torrente che
dalla Sila scende sul Tirreno, scavarono una fossa nel vecchio letto, e vi
ricondussero sopra il fiume. Poi, per maggior precauzione, accopparono tutti
coloro che avevano preso parte a quel faraonico lavoro, in modo che
nessuno potesse rivelare il segreto della esatta ubicazione.
Era un poscritto in carattere con la figura romantica ed errabonda di
questo guerriero tedesco, che apriva la serie di quegli eroi germanici
destinati a calare in Italia assetati di un amore omicida per Roma, e a
perdervisi. Egli aveva riassunto in sé, meglio di chiunque altro, i torbidi
istinti e le confuse aspirazioni del mondo barbarico di fronte alla civiltà
latina. Sebbene la sua politica fosse stata contraddittoria e incoerente,
Alarico fu il primo, dei condottieri teutonici, a concepirne una. Generoso e
avido, nobile e crudele, molto spesso in balìa delle proprie passioni, ma
capace anche di freddo calcolo aveva esercitato sui suoi uomini un fascino
profondo e ne era stato idolatrato. E di tutti i contemporanei, latini e
tedeschi, era stato, con Stilicone, l'unico che avesse visto con chiarezza la
necessità dell'integrazione fra i due mondi. Fu lui stesso a chiedere, in punto
di morte, di essere sepolto lì, nel letto di un fiume che gli ricordava il
Danubio in riva al quale era nato. Come successore, aveva designato suo
fratello Ataulfo.
CAPITOLO SETTIMO
GALLA PLACIDIA
LA NOTIZIA della caduta di Roma aveva precipitato nello sbigottimento il
mondo intero. I pagani ci videro la vendetta degli dèi dimenticati e traditi. E
i cristiani, che per quattro secoli avevano lottato contro l'Urbe auspicandole
la stessa fine di Babilonia, d'improvviso se ne sentirono orfani e si resero
conto quanto ad essa e alla sua intelaiatura politica, amministrativa e
organizzativa, anche la loro Chiesa era indebitata. Sant'Agostino, allora
Vescovo a Ippona, trovò nell'avvenimento lo spunto per la sua opera
capitale La città di Dio. E dalla sua cella di Betlemme in Palestina, San
Girolamo, che di Roma e dei suoi vizi era stato uno spietate accusatore,
scriveva: "La fonte delle nostre lacrime si è disseccata... Di colpo, persi la
memoria di tutto, perfino del mio nome..."
L'unico che non mostrò nessun turbamento fu Onorio. Procopio racconta
che quando un ciambellano venne ad annunziargli la fine di Roma,
l'Imperatore rispose arrabbiato: "Che fine e fine!... Cinque minuti fa,
beccava il granturco nel palmo della mia mano!... " Credeva che il
ciambellano alludesse a un bellissimo esemplare di gallina faraona, cui
appunto aveva dato il nome di Roma. E quando comprese che non era la
gallina, ma la città ch'era andata in rovine, trasse un respiro di sollievo.
L'unico particolare che dolorosamente lo colpì di quella catastrofe, fu la
notizia, che subito dopo gli giunse, della sorte toccata a sua sorella Galla
Placidia, catturata dai barbari e da essi condotta al loro seguito.
Placidia era stata il solitario frutto del secondo matrimonio di Teodosio,
quello con Galla, la sorella di Valentiniano II. Era cresciuta praticamente
orfana perché sua madre era morta quattr'anni dopo averla data alla luce,
alla vigilia dell'ultima spedizione di Teodosio in Occidente, donde
l'Imperatore non doveva più tornare. Non sappiamo come mai si trovasse a
Roma nel momento in cui i Goti la misero a sacco. Forse perché lì era
venuta ad abitare Leta, la vedova di Graziano, che a quanto pare le aveva
fatto da tutrice. Ma forse era anche perché Placidia non voleva coabitare con
nessuno dei suoi due fratellastri, coi quali doveva andar poco d'accordo, e
quindi evitava sia Costantinopoli che Ravenna. Essa non aveva nelle vene il
sangue anemico di Flaccilla, la prima moglie di Teodosio, come Onorio e
Arcadio. Se da sua madre aveva preso la bellezza, da suo padre aveva
ereditato un carattere.
Nelle cronache dei memorialisti, il suo nome compare per la prima volta a
proposito della condanna a morte di Serena, la vedova di Stilicone, che
Zosimo attribuisce proprio a Placidia. Quale odio c'era fra le due donne, e
perché? Claudiano suggerisce che Serena aveva tentato di darle
proditoriamente per marito suo figlio Eucherio. Ma probabilmente sono
chiacchiere. Serena, a quanto ci risulta, fu la vittima dei pagani, non
degl'intrighi di famiglia.
Comunque, Placidia fu catturata dalla soldataglia di Alarico, che la tenne
come ostaggio, pur trattandola con tutti i riguardi dovuti al suo rango di
Principessa reale, e se la condusse al seguito nell'ultima sua cavalcata verso
Brindisi. La si trova menzionata nelle trattative che il condottiero ebbe con
Onorio, il quale ne reclamava con perentoria insistenza la restituzione. I fatti
poi dimostrarono che non si trattava, o per lo meno non si trattava soltanto,
di amore fraterno. Onorio non aveva affetti. Aveva soltanto puntigli e
suscettibilità. Che una sua sorella fosse tenuta prigioniera da un lanzichenecco barbaro gli sembrava un intollerabile oltraggio al suo imperiale
prestigio.
Alarico però, che nella sua smania di trovare un accordo con lui, sui primi
tempi si era offerto di rimandargliela subito, cominciò ora a tergiversare. Il
suo più giovane fratello Ataulfo, destinato a succedergli nel comando, si era
innamorato della bella prigioniera, che lo ricambiava pienamente. E Alarico
approvava quell'idillio, nel quale si riassumeva in fondo tutta la sua politica.
Fra i suoi alti e biondi guerrieri, Ataulfo, a quanto riferisce Giordane, era
fisicamente fra i meno imponenti. Ma aveva un temperamento appassionato
e cavalleresco, che certamente dovette piacere alla Principessa cresciuta fra
cortigiani eunuchi, imbelli e calcolatori. Orosio dice di aver saputo da un
certo Gerolamo, personale amico del giovane condottiero, che costui in
gioventù aveva accarezzato il sogno di rovesciare l'Impero di Roma per
sostituirlo con quello gotico, proclamandosene egli stesso Augusto. Poi,
familiarizzatosi con la lingua e le leggi latine, si era reso conto che i Goti
non erano maturi per sostituirvi quelle loro e si era proposto di restaurare,
invece che di distruggere, la gloria di Roma, rinvigorendola col sangue
tedesco. Innamorandosi di Placidia, egli non aveva dunque fatto che tradurre
in termini coniugali questa concezione politica. Quanto a Placidia, c'è da
pensare che la politica non c'entrasse e che essa ricambiasse i sentimenti di
Ataulfo solo perché era un bel ragazzo e un intrepido soldato. Però alla
stessa politica ci arrivò anche lei, più tardi, seguendo il cammino opposto e
molto più femminile dal letto all'idea, invece che dall'idea al letto.
Il matrimonio non si poté subito celebrare perché Onorio non dava il
consenso, avendo promesso la mano di Galla a Costanzo ch'era il suo
miglior Generale e che ora aveva preso il posto occupato successivamente
da Olimpio e da Giovio. Di sangue illirico, Costanzo era un uomo non più
giovane e fisicamente piuttosto ripugnante per via del testone rinsaccato su
un collo corto e largo, e dello sguardo truculento e minaccioso. Stava in
sella come un sacco di patate pericolando sul collo del quadrupede. Ma, a
dispetto di questo fisico sgraziato e disgraziato, era un buon diavolaccio,
pieno di calore umano, specialmente a tavola dove dava il meglio di sé,
mangiando con gagliardo appetito, bevendo in proporzione, non
disdegnando di recitare pantomime con gli attori ch'egli reclutava per questi
simposi, e scambiando con loro battute scurrili e scherzi grossolani. Doveva
somigliare un po' a Krusciov. Ma, come Krusciov, sapeva fare molto bene e
lealmente il suo mestiere. Era stato lui a catturare ad Arles l'usurpatore Costantino e suo figlio Giuliano che, dopo aver ricevuto da Onorio solenne
promessa di aver salva la vita, furono regolarmente scannati. E ora, in nome
di questi meriti, insisteva per ottener la mano di Placidia.
Ataulfo, dopo la morte di Alarico, cominciò a risalire la Penisola,
attraversò le Alpi occidentali e penetrò in Francia, forse per dare a Onorio la
prova che non intendeva minacciarlo e ottenere da lui il sospirato consenso
al matrimonio. Ma siccome il consenso si ostinava a non venire, allacciò
trattative con Giovino, il nuovo usurpatore che aveva rimpiazzato, lì in
Francia, Costantino. Quando però seppe che sotto le bandiere di costui stava
accorrendo anche Saro, ribellatosi all'Imperatore perché gli aveva ucciso un
servo, gli mosse incontro, lo catturò in un'imboscata, lo uccise, e troncò i
rapporti con Giovino. Anzi lo attaccò di sorpresa, lo prese prigioniero, e ne
mandò la testa decapitata dal tronco, insieme a quella di suo figlio Sebastiano, a Onorio.
Era un bel dono. Così bello, che l'Imperatore stavolta si lasciò
commuovere, nonostante le proteste di Costanzo, e diede il sospirato assenso. Le nozze furono celebrate a Narbona, e si svolsero secondo la liturgia
romana nel palazzo di un ricco proprietario locale. Qui attendeva Placidia,
avvolta nella porpora imperiale. Ataulfo venne a prenderla, ammantato in
una tunica di lana bianca, armato della sua barbarica ascia di guerra, ma
senza il cappuccio e i ghettoni di pelliccia. Dei doni di nozze ch'egli fece
alla sposa si parlò per un pezzo in tutto il mondo: cinquanta bellissimi
adolescenti a lei destinati come schiavi recavano altrettanti vassoi ricolmi di
tutti gli ori e pietre preziose ch'erano stati saccheggiati nell'Urbe. Il
guerriero tedesco restituiva alla Principessa romana la preda bellica per
ricambiarle l'alto onore ch'essa gli faceva acconsentendo a diventare sua
moglie. Attalo, ch'era rimasto al seguito dei suoi protettori, riebbe un'ora di
gloria compilando e declamando un discorso inneggiante all'imeneo fra i
due popoli. I discorsi erano l'unica cosa che sapeva fare. La folla in cui si
mescolavano barbari e romani sentì il valore simbolico dell'avvenimento e
lo salutò con giorni e notti di baldoria. Era la distensione fra tedeschi e
latini.
Nove mesi dopo nacque un figlio, cui fu dato il nome del nonno materno
Teodosio, il quale certamente avrebbe approvato quelle nozze. Poteva essere
l'erede al trono di Onorio, che figli non ne aveva, e il suggello dell'avvenuta
integrazione fra i due popoli. Purtroppo il bambino era ancora in fasce,
quando morì a Barcellona dove Ataulfo si era spostato per mettere ordine
nella Spagna contesa fra Svevi, Alani e Vandali, forse sperando che Onorio,
ora ch'era suo cognato, gliene affidasse il governo. I genitori parvero
annientati dal dolore mentre la piccola bara di massello d'argento calava
nella fossa.
Subito dopo anche Ataulfo morì, vittima di un attentato, ordito
probabilmente da Segerico, il fratello di Saro, che gli successe nel comando.
Spirando, sussurrò ai suoi: "Vivete in amicizia con Roma e restituite
Placidia all'Imperatore". Segerico non ne tenne conto. Anzi, scacciò la
vedova Principessa dai suoi appartamenti, la precipitò al rango di una
schiava qualunque, e la obbligò a seguire a piedi il suo cavallo, mentre egli
sfilava per le vie della città. Placidia, sebbene distrutta dalla perdita del
figlio e del marito, subì quegli oltraggi senza batter ciglio e col sorriso sulla
bocca, da vera Regina. E forse fu anche questo suo contegno che contribuì
ad abbreviare la rapida carriera di Segerico che, dopo soli sette giorni di
comando, venne deposto e massacrato dai soldati furibondi. A succedergli
per acclamazione fu Wallia, un prode e leale guerriero che subito eseguì la
volontà di Ataulfo, facendo accompagnare Placidia ai Pirenei, dove
Costanzo venne a riceverla in pompa magna.
L'addio della Principessa ai "suoi" Visigoti fu malinconico e affettuoso,
ma valse a costoro uno stabile trattato di pace con Onorio. Essi mai più
fecero ritorno in Italia. Sotto la guida di Wallia combatterono
peripateticamente in nome dell'Imperatore, contro Alani, Vandali e Svevi,
finché stabilirono un Reame a cavallo dei Pirenei, ch'ebbe per capitale
Tolosa. La parte francese fu inghiottita un secolo e mezzo dopo da
Clodoveo, quella spagnola dai Saraceni ai primi del secolo ottavo.
Placidia, giunta a Ravenna, resisté ancora per tre anni alla corte di
Costanzo e alle insistenze di Onorio che voleva a tutti i costi quel matrimonio. Finalmente si arrese non al pretendente, ma alla "ragion di Stato" :
Onorio le aveva commissionato un erede, visto che lui non era riuscito a
procurarsene. Il maturo Generale volle festeggiamenti nuziali che
superassero il ricordo di quelli di Narbona, e li ebbe. Ma non ebbe pensiamo - la Placidia che Ataulfo aveva avuto. L'anno dopo nacque una
bambina, cui fu dato il nome di Onoria. E quello successivo, finalmente, un
bambino, cui fu dato il nome di Valentiniano e il titolo di Nobilissimo, che
nella terminologia di quella Corte voleva dire Principe Ereditario.
Per rendere definitiva questa scelta, quattro anni dopo Costanzo fu da
Onorio associato al trono, e Placidia ricevette il titolo di Augusta. Ma sette
mesi più tardi Costanzo morì, e Placidia dovette vedersela con un terzo
corteggiatore, il più inaspettato e il meno gradito di tutti: suo fratello. Non
sapendo come difendersi da quell'incestuoso capriccio (era una donna sana,
Placidia, e di moderati appetiti sessuali), scappò coi due bambini a
Costantinopoli da suo nipote Teodosio II. Per sua fortuna, anche Onorio di lì
a poco morì, di un male che gli somigliava: l'idropisia. Il Porfirogenito,
come lo aveva battezzato Claudiano quando nacque, salutandolo "più
augusto di Giove", non aveva che trentanove anni. Ma li aveva spesi
talmente male, che a rimpiangerlo forse furono soltanto i suoi polli.
Com'era da prevedere, l'assenza da Ravenna dell'erede legittimo favorì
l'usurpazione di un certo Giovanni, capo dei Notai e personaggio assolutamente di secondo piano. Ma la cerimonia dell'incoronazione fu turbata
da un brutto presagio: si udì una voce, non si sa da chi articolata, che diceva:
"Casca, casca, non si regge!..." Infatti non si resse.
Teodosio si affrettò a comunicare a Ravenna che non accettava quel
collega. Restava da sapere se intendeva deporlo per restituire il trono alla zia
Placidia e al piccolo cugino Valentiniano, oppure per tenerselo ricostituendo
così la unità dell'Impero. Scelse la prima alternativa, riaccompagnando di
persona fino a Salonicco l'Augusta e il Principino, conferendo a questo
ultimo la porpora e il titolo di Cesare e affidando entrambi a un Generale di
sangue barbaro, Ardaburio, e a suo figlio Aspar alla testa di un corpo di
spedizione.
Giovanni fu deposto dopo un regno di diciotto mesi e condotto
prigioniero a Aquileia, dove Placidia e suo figlio avevano fatto sosta. Gli fu
mozzata la mano destra, venne spinto per le strade a cavallo di un somaro in
una parodia di trionfo, eppoi abbandonato alla soldataglia che lo linciò.
Alla fine di quello stesso anno 425, un imponente corteo mosse da
Ravenna verso Roma. Lo guidava, per mano a sua madre, il piccolo Valentiniano, che aveva ora sette anni. Sul Campidoglio egli rivestì la porpora,
si coronò del diadema, e il popolo lo acclamò Augusto.
CAPITOLO OTTAVO
GLI INTRIGHI DI RAVENNA
QUANDO ONORIO vi aveva stabilito la sua corte, Ravenna era, come lo è
oggi Venezia, una città di lagune e di canali, che ne facevano il principale
porto dell'Adriatico. Era del resto unicamente a questa cintura d'acqua, che
la proteggeva meglio di qualunque bastione di pietra, ch'essa doveva la sua
elezione a capitale. Altre attrattive essa non aveva, né di clima, né di
paesaggio, né di architettura.
Sidonio Apollinare, che ci capitò alcuni anni dopo, così la descriveva: "È
un pantano, dove tutto va all'incontrario: i muri precipitano, le acque
ristagnano; le torri affiorano e le barche si arenano; i bagni gelano e le case
s'infuocano; i vivi muoiono di sete e i morti galleggiano; i ladri vegliano e le
guardie dormono; i preti esercitano l'usura e gli usurai cantano i salmi; i
mercanti imbracciano armi e i soldati fanno commercio; gli eunuchi
studiano l'arte della guerra e i guerrieri barbari studiano la letteratura. È una
città di terra che non possiede che acqua e la cui popolazione originaria è
composta solo di zanzare e di ranocchi".
Prima di questo Apollinare, n'era giunto a Ravenna un altro nel primo
secolo dell'Era Cristiana, che poi era diventato Santo, Santo Apollinare, e
che vi aveva fondato la prima chiesa, quella che porta il suo nome. Era stato
lui a dare a Ravenna quel carattere di città assorta e monastica, di nebbiosa
necropoli stillante accidia e malinconia, che ha serbato anche nell'età delle
automobili e della televisione. Clima, templi e leggende contribuivano a fare
di essa una delle poche- città romantiche della Penisola. E fu per questo,
probabilmente, che Placidia ben volentieri vi si ritirò coi suoi due figli Onoria e Valentiniano. Romantica di temperamento anche lei, vieppiù lo era
diventata dopo i lunghi anni trascorsi a fianco di Ataulfo in mezzo ai Goti. E
quella quiete, quel silenzio rotto solo dai rintocchi delle campane e dallo
sciacquio della laguna, le si addicevano.
Non aveva ancora trentacinque anni, e ne visse altri venticinque di fatto
esercitando il potere imperiale, anche se di nome esso spettava a suo figlio.
Procopio, che scrisse le sue Storie circa un secolo dopo, l'accusa di aver di
proposito fatto di Valentiniano uno slombato per seguitare a comandare lei.
Ma i fatti non ce ne danno conferma. È possibile ch'essa si sia rifiutata di
vedere in suo figlio un uomo, anche quando questi ebbe raggiunto la
maggiore età, e abbia seguitato a trattarlo da ragazzo. Questo lo fanno quasi
tutte le mamme: sta ai figli dimostrare ad esse che hanno torto, anche a
costo di dar loro qualche dispiacere. Ma ancora più probabile è che Placidia
abbia seguitato a trattare suo figlio da ragazzo perché si accorse che non
riusciva a diventare un uomo.
Gli avvenimenti del suo lungo regno dimostrano, al contrario, ch'essa il
comando lo esercitò poco, specie in materia politica; e fu questa, caso mai,
la sua vera colpa. Quelli che più la interessavano erano i grandi problemi
spirituali e religiosi, e in ciò si mostrò buona figlia di suo padre, specie
quanto a zelo persecutorio contro gl'infedeli e gli eretici. Mentre l'Impero
cadeva a pezzi, provincia su provincia, essa continuava a patroneggiare
Concili e a compilare editti contro chi trasgrediva alle loro decisioni:
Nestorio condannato a Efeso, Dioscoro colpito dall'anatema a Calcedonia,
erano da lei considerati più pericolosi ed esiziali dei Longobardi, dei
Franchi, dei Vandali che stavano sommergendo tutto l'Occidente.
La difesa contro questa minaccia armata essa l'aveva data in appalto a due
uomini, "ognuno dei quali" dice Procopio (e in questo forse ha ragione)
"poteva rappresentare la salvezza se non si fosse trovato a vivere
contemporaneamente all'altro" : Bonifacio e Ezio.
Bonifacio era, come si direbbe oggi, un Generale di carriera, fra i pochi
rimasti con le mani pulite e senza ambizioni politiche. Non si sa se fosse
romano di sangue. Ma lo era diventato, e nel senso migliore, di scelta, di
cultura e di costumi. Per la prima volta, lo si trova citato nel 413 quale
comandante della piazzaforte di Marsiglia, quando respinse l'improvviso attacco di Ataulfo. Sempre fedele a Onorio, lo rimase anche ai suoi legittimi
successori, Placidia e Valentiniano, contro l'usurpatore Giovanni. Passava
per un uomo severo e giusto. Un giorno un contadino era venuto a
lamentarsi nella sua tenda che un soldato della guarnigione gli aveva sedotto
la moglie. Bonifacio fece di notte nove miglia a cavallo per andare a sincerarsi sul posto, e l'indomani presentò al marito ingannato la testa
dell'adultero spiccata dal busto. Si guadagnò anche un certo odor di santità
con la lunga corrispondenza che più tardi ebbe con Sant'Agostino e col voto
che fece, quando gli morì la prima moglie, di non sposarne altre. Poi vi
contravvenne doppiamente impalmando Pelagia, ch'era anche ariana e quindi, agli occhi della Chiesa, eretica. Eretica, ma piena di milioni. Placidia
teneva Bonifacio in gran conto e dopo aver fatto di lui, uomo comunque di
famiglia modesta, un vir spectabilis, cioè un nobile dell'Impero, lo nominò
Conte di Africa e gli affidò il comando di quella provincia, da cui
dipendevano gli approvvigionamenti di grano per l'Italia.
Furono questi onori e riconoscimenti che aizzarono forse le gelosie di
Ezio, l'altro "grande" della Corte di Ravenna. Ezio era un barbaro,
probabilmente un goto; ma già suo padre aveva fatto carriera nell'esercito
romano dov'era diventato Generale di cavalleria. Come usava a quei tempi,
quando si stipulavano dei trattati, Ezio era stato dato in ostaggio prima a
Alarico, eppoi a Rua, Re degli Unni. Così egli aveva trascorso la giovinezza
in mezzo a selvatici guerrieri. E se questo gli servì per capirne i punti deboli
quando più tardi si trovò a combatterli, non lo aiutò di certo a formarsi una
mentalità romana e a sviluppare un vero e proprio senso dello Stato. Rimase
sempre in questo prode soldato un atteggiamento da pretoriano e una
spiccata propensione a mercanteggiare i propri servigi. Li prestò anche
all'usurpatore Giovanni che, per fronteggiare Placidia e le forze di Aspar, lo
spedì a reclutare un esercito unno. Ezio tornò alla testa, pare, di sessantamila
uomini, ma tre giorni troppo tardi per dare man forte al suo padrone già
sgominato sul campo. Sembra che attaccasse ugualmente battaglia. Ma,
anche se lo fece, fu solo per tenere alto il proprio prezzo di mercenario.
Placidia non gli mosse rimproveri: a quei tempi la slealtà era, come la legittimità, un criterio molto opinabile. Anzi, lo ricompensò della pronta
conversione nominando anche lui vir spectabilis e affidandogli, col titolo di
Conte d'Italia, il comando militare della Penisola.
Era fatale che fra i due favoriti scoppiasse la rivalità, e che in questa
rivalità avesse la meglio quegli ch'era più vicino all'Imperatrice. Procopio
racconta che Ezio, pur professandosi grande amico di Bonifacio e
scambiando con lui lettere affettuose, cominciò a far diffondere la voce che
il Conte d'Africa lavorava sotto sotto per staccare quella provincia dall'Impero e incoronarsene Re, com'era già successo con altri luogotenenti. E
quando vide Placidia inquietarsi di quelle dicerie, le suggerì, con l'aria di
difendere l'onore del collega, di chiamarlo a Ravenna per una franca
spiegazione. "Se obbedisce" disse, "è chiaro che non è colpevole." Ma nello
stesso tempo spedì di nascosto una lettera a Bonifacio per avvertirlo che a
Corte lo aspettavano per incriminarlo di tradimento.
Bonifacio, che non doveva fidarsi molto della giustizia imperiale, credette
ad Ezio, e rifiutò di presentarsi. Ciò confermò i sospetti sulla sua pretesa
slealtà e fece sì che nel 427 egli venisse dichiarato "nemico di Roma".
Le conseguenze di questo imbroglio furono drammatiche e irreparabili.
Bonifacio, sentendosi abbandonato, contrattò un'alleanza coi Vandali, che in
quel momento guerreggiavano in Spagna coi Visigoti e gli Svevi,
invitandoli a stabilirsi in Africa, ch'era allora infinitamente più fertile e
ricca. E così colui che non era un traditore, lo diventò. I Vandali, sotto la
guida del loro re Genserico, vennero, e non se ne andarono mai più.
Pochi mesi dopo, alcuni vecchi amici di Ravenna, che non avevano mai
voluto credere alla perfidia di Bonifacio, andarono di nascosto a trovarlo.
Egli mostrò loro la lettera di Ezio, e l'inganno fu chiarito. Placidia mandò al
Generale calunniato, insieme col perdono, l'ordine di scacciare i Vandali.
Bonifacio cercò di farlo, prima con le buone, poi con le cattive, e ottenne
anche qualche vittoria. Ma non aveva forze sufficienti per condurre a
termine l'impresa, né c'era da sperare che gliene mandasse Ezio.
Costui in quel momento guerreggiava con successo, ma senza
conclusione, in Francia contro i barbari che l'avevano messa a soqquadro. E
nessuno pensò, dopo la scoperta del suo raggiro, a togliergli il comando.
Anche questo faceva parte della moralità di quei tempi. Anzi, quando seppe
che Bonifacio, ormai battuto dai Vandali, si era reimbarcato per Ravenna
dove lo attendeva la promozione a Magister utriusque militiae, cioè
praticamente a Generalissimo, Ezio scese apertamente in guerra contro di
lui. Diviso in due, l'ultimo esercito romano si diede battaglia per i fatti
personali dei rispettivi comandanti. Bonifacio vinse. Ma, secondo un
costume che già anticipava il Medio Evo e la Cavalleria, dovette scendere in
singolar tenzone contro il battuto rivale. E qui invece perse. Ferito
gravemente, morì tre mesi dopo. Spirando, raccomandò a sua moglie di non
accettare in sposo nessun altri che Ezio, se costui un giorno fosse rimasto
vedovo a sua volta. E anche questo era un gesto del più puro rituale
cavalleresco.
Ma Ezio vedovo non rimase.
La situazione dell'Italia si era fatta disperata, ora che i Vandali gliene
avevano requisito il granaio. E la città che più ne risentiva era Roma, dove
molta popolazione si era riversata dalle campagne per sfuggire ai saccheggi
delle soldataglie di Alarico. Apollodoro ha lasciato scritto che in tutto quel
periodo erano immigrate nell'Urbe sino a quattordicimila persone al giorno.
Onorio aveva proibito i circenses, cioè i giuochi del Circo, ma la fame di
panem era enormemente cresciuta. Purtroppo quella società rurale di piccoli
e medi coltivatori diretti, che aveva costituito un tempo la forza dell'Italia,
era scomparsa. C'erano soltanto dei latifondi sprovvisti di manodopera e
sfruttati quasi esclusivamente a pastorizia. I dislivelli economici si erano
paurosamente approfonditi. Esisteva ancora una grande aristocrazia che
viveva principescamente su rendite di miliardi. Il grande storico e umanista
Simmaco ne spese otto in un anno per festeggiare la propria elezione a
Pretore, una carica puramente onorifica cui non corrispondeva più nessun
potere effettivo. C'erano palazzi sontuosi, con legioni di camerieri e di
cuochi. C'erano splendidi tiri a quattro e a otto. E c'erano anche vaste
distribuzioni caritative. Il popolino affamato si abituava sempre più a vivere
di elemosina, fidando unicamente sulla generosità dei signori: un carattere
che Roma da allora non ha più perso.
Placidia non ignorava tutto questo, ma non aveva i mezzi per rimediarvi.
Chiusa nel suo palazzo di Ravenna, seguitava a combattere coi suoi editti la
battaglia contro gli eretici, conscia forse che solo la Chiesa poteva sopravvivere alla gran catastrofe del mondo romano e assicurare la resurrezione dei
suoi valori spirituali e culturali. Non fu certo per mancanza di energia
ch'essa rinunziò a impossibili riforme. Questa Imperatrice era l'unico uomo
della famiglia; la sola, della progenie di Teodosio, che ne avesse ereditato il
carattere. Nella sua inazione c'era soltanto la disperata certezza che ogni
giorno perduto fosse un giorno guadagnato. In quell'Impero anchilosato,
ridotto praticamente soltanto all'Italia, cioè a quattro o cinque milioni di
abitanti affamati e resi imbelli da una ormai secolare esenzione dalla leva,
qualunque innovazione poteva affrettare il crollo invece di ritardarlo.
Quando sentì avvicinarsi la morte, trasportò la Corte a Roma. Forse volle,
prima di chiudere gli occhi, rivedere la città di San Pietro e consultarsi col
Papa, ch'era allora Leone I, più grande come uomo di Stato che come
teologo. Essa sapeva che il suo vero successore era lui, il capo della Chiesa ;
non certo i suoi figli Valentiniano, piccolo effeminato, e Onoria, piccola
scostumata.
Spirò non ancora sessantenne, il 27 novembre del 450. E forse fu per suo
espresso desiderio che il corpo, imbalsamato, venne riportato a Ravenna e
collocato in un sarcofago nella chiesa dei Santi Nazario e Celso. Vi rimase
intatto più di un millennio, e lo si poteva vedere attraverso un pertugio,
ammantato nelle sue vesti regali e irrigidito su uno scranno di legno di
cipresso. Un giorno del 1577 un incauto visitatore, per vederlo meglio,
avvicinò troppo una candela al buco. Le vésti presero fuoco e in pochi
secondi tutto si trasformò in un pugno di cenere.
CAPITOLO NONO
ATTILA
DICIASSETTE anni prima che Placidia morisse, e precisamente nel 433, era
scomparso Rua, il Re che aveva guidato le orde unne fin nel cuore
dell'Ungheria. E sul trono sedevano ora i suoi nipoti, Attila e Bleda.
Questa divisione del potere non era un'eccezione, ma il ritorno al vecchio
costume di quel popolo equestre e errabondo, nella cui tradizione i primi Re,
Basi e Kursik, s'incontrano appunto in coppia. Lo stesso Rua dapprincipio
aveva regnato insieme a suo fratello Oktar, e soltanto dopo la morte di
costui aveva potuto accentrare nelle proprie mani il comando. Forse fu
proprio questa la ragione per cui riuscì a imporre alle sue orde un alt così
lungo e così contrario alla loro vocazione, lì sulle rive del Danubio. Il trono
bipartito era sempre stato causa di gran debolezza e di anarchia.
Gli Unni erano ancora un popolo nomade. Ma da quando avevano varcato
il Volga una settantina di anni prima, la loro marcia si era alquanto
rallentata, per due motivi: prima di tutto perché per la prima volta erano
venuti in contatto col limes dell'Impero, con le sue fortificazioni e i suoi
sbarramenti, per quanto deteriorati; eppoi perché la massa unna aveva
convogliato nella sua avanzata i detriti e i brandelli dei popoli germanici
ch'essa aveva sottomessi e che ora forse costituivano il grosso del suo
esercito. Alemanni, Sciri, Rugi, Gepidi, Goti erano ormai più numerosi degli
stessi Unni, e non ne condividevano che parzialmente il nomade istinto. Essi
avevano qualche nozione di agricoltura, e preferivano la casa, o almeno la
capanna, alla tenda e alla groppa del cavallo.
Uno scrittore greco, Prisco, che fece parte di un'ambasceria di
Costantinopoli, ci fornisce infatti degli Unni un ritratto assai diverso da
quello lasciatoci da Ammiano Marcellino. Essi avevano una capitale, ora,
sia pure di effimere catapecchie, ma che denunziava una certa vocazione
alla stabilità. Si chiamava Aetzelburg, sorgeva vicino alla moderna
Budapest, e doveva essere un ben curioso villaggio, policromo e poliglotta,
dove si mescolavano i capitribù mongoli dalla pelle gialla, dagli occhi a
mandorla, dagli zigomi in rilievo e dal corpo basso e tozzo, con i Re e i
Generali tedeschi dal fusto alto, dagli occhi azzurri e dalla pelle rosea. Non
c'era nulla, s'intende, che somigliasse a un'organizzazione statale, e
nemmeno cittadina. Non c'era una lingua scritta, non c'erano leggi, non c'era
una burocrazia. Le ambascerie straniere che vi giungevano da ogni parte del
mondo si acquartieravano sotto tende ch'esse stesse portavano al seguito, e lì
restavano talvolta per mesi in attesa che il Re le ricevesse.
Attila e Bleda, quando salirono al trono, non avevano in comune che la
giovane età e l'origine dinastica. Per tutto il resto differivano profondamente. L'unico ricordo che Bleda ha lasciato di sé è il suo affetto per
un nano negro, Zercone, chissà da chi regalatogli, che lo divertiva come un
giocattolo può divertire un ragazzo grossolano, ignorante e capriccioso.
Trascorreva le sue giornate con lui, a ridere delle sue smorfie e pagliacciate.
E un giorno che Zercone fuggì insieme ad alcuni prigionieri, Bleda mobilitò
mezzo esercito per catturarlo. Quando glielo riportarono ammanettato e in
catene, invece di punirlo, gli chiese premurosamente perché era scappato.
Zercone rispose che lo aveva fatto per andare a cercarsi una moglie, visto
che fra gli Unni non ne trovava. La cosa divertì enormemente Bleda che,
dopo averne riso fino alle lacrime, mandò a chiamare una damigella di
Corte, di nobile lignaggio, e le impose d'impalmare il mostriciattolo. Questi,
dopo la morte del suo padrone, venne mandato da Attila in regalo a Ezio.
Ma un bel giorno tornò ad Aetzelburg a chiedere che gli fosse restituita la
moglie, la quale non lo aveva seguito. Attila non volle saperne, e il nano
rimase lì anche lui di propria volontà, a fare il buffone durante le feste e i
banchetti.
Erano stati i Goti, che ormai costituivano il nerbo del suo esercito, a
coniare quel nome di Attila, che nella loro lingua voleva dire "piccolo
padre". Ma si trattava di un padre un po' a modo suo. Di statura piuttosto
corta, largo di spalle, con una grossa testa sul collo taurino, naso piatto, una
rada barbetta, zigomi sporgenti e occhi a spillo, solo a vederlo questo mongolo metteva i brividi addosso. La sua voce e i suoi gesti erano imperiosi.
Camminava, come tutti i piccoli, a petto in fuori, conscio della propria
potenza e importanza. Il suo orgoglio era pari soltanto alla sua avarizia,
ch'era immensa. Il suo potere era basato unicamente sulla paura ch'egli
ispirava. Non c'erano intorno a lui né entusiasmi né affetti, ma soltanto il
terrore. Se fosse un genio come qualcuno ha detto, non sappiamo, e invano
ne chiediamo conferma agli avvenimenti. Anche in campo militare, dove lo
si vuol paragonare a Annibale e a Napoleone, a conti fatti bisogna
riconoscere che l'unica grande battaglia in cui si trovò impegnato la perse, o
per lo meno non la vinse. In compenso, era scaltrissimo, rotto a tutti i
raggiri, paziente e crudele. Francamente poligamo, era però molto sobrio
nella dieta. Quando i suoi luogotenenti e dignitari, a contatto della civiltà
romana, cominciarono a corrompersi, a ricercare il vasellame d'argento e le
vesti di seta, egli seguitò ad andare vestito di pelli, a scaldare la carne cruda
fra la propria coscia e la groppa del cavallo, e a mangiarla in rozze scodelle
di legno.
Non abbiamo nessun elemento per affermare che Attila soppresse Bleda,
come dice Prisco. Ma ne possediamo quanti bastano a ritenerlo capace di
averlo fatto. Comunque, dopo una decina di anni di regno a due, e cioè nel
444, si trovò solo sul trono e con tutto il potere nelle mani.
Sino a quel momento, egli aveva svolto verso l'Impero una politica in cui
la guerra fredda e la distensione si erano alternate. Abbiamo visto Ezio venir
da Rua a chiedergli un corpo di spedizione per sostenere l'usurpatore Giovanni contro Placidia e Valentiniano. Altri distaccamenti di mercenari unni
combattevano sotto le bandiere di Costantinopoli. Ogni tanto c'erano rivolte,
incursioni e saccheggi; ma questo avveniva anche con le truppe tedesche.
L'Impero pagava uno stipendio a Rua, che lo considerava un tributo: ma
anche questo avveniva pure con gli altri barbari, e non si trattava di una
forte somma.
Il fatto è che, sebbene confinanti, Rua e l'Impero avevano ancora un
nemico comune che faceva da ammortizzatore fra loro: tutte quelle
popolazioni barbare che si aggrovigliavano specie nei grandi spazi
settentrionali fra l'Austria e il Baltico. Ma ora, con l'avvento di Attila al
trono, i barbari del Nord o si erano sottomessi, com'era capitato ai loro
confratelli più a Sud; o, rotto il limes, avevano fatto irruzione in Francia e
Spagna, com'era stato il caso dei Franchi, dei Vandali, dei Burgundi (ed era
stato appunto questo a far naufragare il sogno della pacifica e graduale
integrazione accarezzato da Teodosio e da Placidia). Con la fine di questo
"isolante", Unni e Romani si trovavano direttamente di fronte.
Morendo, Rua aveva lasciato in sospeso una " grana " diplomatica con
Costantinopoli, cui aveva ingiunto di raddoppiare il tributo e di restituire
non solo i disertori unni rifugiatisi dentro le terre dell'Impero, ma anche quei
prigionieri romani che, catturati dagli Unni, erano riusciti a evadere, o di
riscattarli con otto pezzi d'oro a testa.
A trattare coi successori, cioè praticamente con Attila, perché Bleda si
occupava solo di Zercone, vennero da Costantinopoli due diplomatici, Plinta
e Epigene, che non conclusero nulla anche per mancanza d'interlocutori.
Attila abitava in cima a una collinetta in una baracca di legno che si
distingueva dalle altre per le proporzioni e per l'elegante palizzata che la
circondava, con torri di guardia. Accanto, c'erano delle rudimentali terme.
L'idea di costruirle era stata suggerita da un architetto romano, catturato in
una scaramuccia. Con infinita difficoltà si era fatto venire del materiale
dall'Italia, e il costruttore aveva sperato di ottenere in ricompensa la libertà.
Attila invece, per premio, lo aveva nominato bagnino.
Plinta e Epigene invano cercarono ciò che oggi si chiamerebbe una
"Cancelleria" o "Segreteria di Stato" con cui mettersi in rapporto e trattare.
A Aetzelburg non c'era nulla di tutto questo. Bisognava vedersela
direttamente col Re, il quale non era abituato ad avanzar proposte, ma solo a
impartire degli ordini. Ai due messi non restò che subirli pur con la ferma
intenzione di evaderli.
Alcuni anni trascorsero tranquilli. Poi d'improvviso, nel 447, Attila si
mise alla testa delle sue orde e, di saccheggio in saccheggio, le condusse fin
sotto Costantinopoli. La città si salvò grazie alle sue mura. Ma l'imperatore
Teodosio ebbe una tale paura, che si affrettò a triplicare il tributo che già
pagava e coprì d'oro gli ambasciatori unni ch'erano venuti a esigerlo.
L'anno dipoi un'altra ambasciata giunse da Aetzelburg, capeggiata da
Edecone e da Oreste. Li citiamo perché sono due personaggi, di cui udremo
riparlare. Edecone era un barbaro, probabilmente uno sciro, che aveva fatto
carriera sotto Attila fino a diventarne uno dei più importanti consiglieri. Ora
era già padre di un marmocchio che si chiamava Odoacre. Oreste era di
sangue barbaro anche lui, ma apparteneva a una famiglia della Pannonia che
già da almeno un paio di generazioni aveva la cittadinanza romana. Parlava
il latino, aveva una certa cultura, conosceva i classici, sapeva cosa fossero le
Leggi e lo Stato, e dalla figlia di un certo Conte Romolo di Passau aveva
avuto a sua volta un figlio che si chiamava, come il nonno materno,
Romolo.
Il più potente ministro di Costantinopoli era a quei tempi l'eunuco
Crisafio, ambiguo personaggio, che credette di poter giuocare d'astuzia
inducendo Edecone a tradire Attila e ad ucciderlo al suo ritorno. Edecone
intascò il denaro, ma raccontò tutto al suo padrone che non se ne meravigliò
affatto, e solo ne prese pretesto per mortificare gli ambasciatori romani e
avanzare nuove richieste di denaro. Da quanto racconta lo storico Prisco che
faceva parte di quelle ambascerie, non era mai su grandi problemi politici e
di Stato che Attila s'intestardiva, ma sempre su miserabili questioni di
"precedenze" e di quattrini. Una volta minacciò la rottura delle relazioni
diplomatiche se non gli mandavano come ambasciatori delle personalità di
grado almeno consolare, e pretendeva di designarne egli stesso i nomi.
Quando poi essi giungevano, ostentava di non riceverli per settimane,
talvolta per mesi, per invitarli alla fine a un banchetto in cui li confinava agli
ultimi posti della tavola, facendoli servire dopo i più insignificanti dei suoi
dignitari. Si addolciva soltanto quando dalle due capitali dell'Impero gli
giungevano doni di gran valore. Allora andava di persona fino ai confini del
suo Reame incontro ai messi che glieli portavano, e a tavola li faceva sedere
al proprio fianco. Ezio, che lo conosceva bene, non lesinava.
L'avarizia e l'orgoglio erano insomma le due principali componenti del
carattere di Attila. Una volta egli mandò alla Corte di Costantinopoli un
ambasciatore, Esla, incaricato di leggere a Teodosio il seguente discorsino
di saluto, dettato personalmente dal suo padrone : "II mio signore, Attila, ha
ereditato da suo padre Mundzuk il rango di Re, ma lo ha conservato. Non
altrettanto hai fatto tu, Teodosio, che sei decaduto al livello di schiavo di
Attila, rassegnandoti a pagargli un tributo..." Ma poi si scoprì che questa
bella apostrofe era stata compilata solo per indurre Teodosio a largire a Esla
una lauta mancia per addolcirlo. Il taccagno Attila, per arricchire i suoi
funzionari senza rimetterci di tasca propria, li mandava come ambasciatori a
Costantinopoli per procurarsi, con le minacce, qualche sostanziosa
"bustarella". E il giuoco gli riuscì finché sul trono ci fu il gentile ma
remissivo Teodosio II, l'Imperatore antimilitarista che preferiva alle guerre
la miniatura delle pergamene.
Ma nel 450, l'anno in cui moriva Placidia, morì anche Teodosio, senza
lasciare eredi maschi, e a prenderne il posto fu sua sorella Pulcheria, che per
ragioni di stato si associò come marito un onesto e coraggioso soldato di
nome Marciano. Uno dei primi gesti del nuovo sovrano fu l'invio ad Attila
di un ambasciatore, Apollonio. Quando Attila seppe che costui era arrivato a
Aetzelburg senza il solito tributo e con modesti doni, gli mandò a dire che,
se voleva aver salva la pelle, i doni li lasciasse a un segretario e se ne
tornasse pure a casa. Apollonio rispose che gli Unni potevano anche
ammazzarlo, ma che i doni lui li avrebbe consegnati personalmente a Attila,
o altrimenti li avrebbe riportati con sé a Costantinopoli. E così fece senza
che Attila osasse mandare ad effetto le sue minacce.
Il capo unno aveva capito che le cose a Costantinopoli erano cambiate,
che con Marciano i ricatti avevano poche probabilità di successo. E forse fu
per questo che, dopo essersi per tanti anni occupato quasi esclusivamente
dei rapporti con l'Impero d'Oriente, volse d'improvviso la sua attenzione
verso quello d'Occidente.
La scusa per attaccar briga con Roma già da un pezzo ad Attila era stata
fornita da Onoria, la figlia di Galla Placidia e la sorella di Valentiniano.
Questa ragazza scervellata, che doveva aver ereditato da suo padre Costanzo
una buona dose di sensualità, aveva dato scandalo nella puritana Corte di
Ravenna facendone con tutti di tutti i colori. Finché sua madre l'aveva
esiliata a Costantinopoli, mettendola sotto la guardia di sua nipote Pulcheria,
donna di carattere duro e severo. Onoria fu messa a una stretta dieta di
studio e di preghiere. Finché un giorno, non potendone più, trovò il mezzo
di mandare ad Attila un anello come pegno di fidanzamento, dicendosi
pronta a sposarlo se lui la liberava da quella vita di collegio.
Attila di mogli ne aveva già in abbondanza, e poteva rinnovare l'harem
quando e quanto voleva. Ma l'anello se lo mise in tasca, e ogni tanto lo
tirava fuori con la pretesa d'impalmare la principessa e soprattutto
d'incamerarne la dote ch'egli stesso di volta in volta fissava in una o in più
province dell'Impero. Ma si trattava soltanto di uno dei soliti ricatti per
estorcere un aumento del tributo e qualche dono in aggiunta alle mance
abituali.
Nel '50 Onoria, ormai più che trentenne, era stata restituita a suo fratello
Valentiniano, quando a costui fu recato un nuovo messaggio di Attila che
gl'ingiungeva di trattarla con tutti i riguardi: egli la considerava la sua fidanzata e la proprietaria di una metà dell'Occidente. Valentiniano rispose che
Onoria era già sposata (ma forse era una bugia) e che le successioni
nell'Impero erano regolate per via maschile, non femminile.
Ma Attila ormai aveva deciso la guerra, e guerra doveva essere. Per mesi
e mesi egli preparò il suo esercito, che in realtà non era un esercito, ma tutta
la nazione in armi, secondo il costume barbarico dell'orda. Sicché quando si
dice ch'egli si mosse con settecentomila uomini, non s'intende
settecentomila soldati, ma forse settanta o ottantamila. Di questa massa, gli
Unni erano una minoranza e ne formavano la cavalleria. Il grosso delle
fanterie era costituito dalle tribù germaniche soggiogate: i Rugi, gli Sciri,
quei brandelli di Franchi, di Turingi e di Burgundi che non avevano fatto in
tempo a varcare insieme ai loro confratelli il Reno, e soprattutto le due
grandi famiglie gotiche, gli Ostrogoti e i Gepidi, che Attila aveva
interamente asservito. Gli Ostrogoti si erano particolarmente distinti
nell'esercito unno, e il loro re Arderico godeva di una posizione di favore
nello stato maggiore di Aetzelburg.
La ragione per cui questa policroma e poliglotta armata, appesantita dai
carri che trasportavano le famiglie dei guerrieri e da una inverosimile
sussistenza, cominciò dalla Francia l'assalto all'Occidente, non la si conosce
con esattezza, ma forse va ricercata nella guerriglia che v'infieriva tra i
barbari che vi avevano preso stanza. Il predominio dei Franchi non si era
ancora affermato. Glielo contendevano i Visigoti che dopo la morte di
Wallia avevano fondato un reame abbastanza solido di cui Tolosa era la
capitale. I Sassoni si erano acquartierati sulle coste della Manica, gli erculei
Burgundi erano in Savoia, e i pochi Alani scampati ad Attila e trascinati
verso Ovest dai Vandali formavano un'isola a sé in Provenza.
Cosa restasse di autorità romana in questo Paese alluvionato dai barbari,
non è dato sapere con certezza. Però ce n'era ancora un briciolo,
rappresentato da qualche Prefetto, da qualche Questore e da alcuni presidi
sparpagliati qua e là, a Lione, ad Arles, a Narbona, che cercavano di
destreggiarsi approfittando delle rivalità altrui. Ogni tanto i rappresentanti
imperiali si alleavano coi Visigoti contro i Sassoni o coi Sassoni contro i
Burgundi, e vittorie effimere si alternavano con provvisori insuccessi. In
realtà l'unica missione che i Romani ancora assolvevano in queste province
occidentali era la conversione dei barbari a un certo rispetto della cultura
latina, della lingua e dell'ordinamento legislativo e amministrativo. Ma
come influenza politica ne esercitavano ben poca.
Attila evidentemente pensò di volgere a proprio favore tutti questi
contrasti. E infatti mandò due ambascerie: una a Valentiniano, invitandolo a
unirsi a lui per ridurre definitivamente alla ragione il vecchio nemico
visigoto contro cui, al servizio di Roma, anche dei contingenti unni avevano
combattuto; l'altra a Teodorico, il Re dei Visigoti, invitandolo a unirsi a lui
per estromettere definitivamente Roma dalla Francia.
Ma Ezio, che conosceva bene il suo uomo per essere stato a lungo
ostaggio a Aetzelburg, ne sventò abilmente i piani. E Teodorico, sebbene
fosse stato con lui ai ferri corti sino a poco tempo prima, ebbe abbastanza
cervello per capire che, fra i due pericoli, quello unno era infinitamente più
grosso di quello romano. Così, fra Ravenna e Tolosa, fu saldata un'alleanza
che salvò la Francia da quello che fin d'allora si chiamava "il pericolo
giallo".
Attila iniziò l'invasione dal Belgio, e fu la solita mareggiata devastatrice.
Purtroppo i memorialisti della Chiesa, invece di darci la cronaca degli
avvenimenti, la ridussero come al solito a una filastrocca di miracoli come
quello di Servazio, Vescovo di Tongres, che in una visione fu avvertito da
San Pietro della imminente catastrofe, o quello di Aniano, Vescovo di
Orléans, che poi fu fatto Santo per essere riuscito a convincere Ezio della
necessità di difendere la sua città. Tutto questo non impedì ad Attila di
distruggere una dopo l'altra Reims, Cambrai, Treviri, Metz, Arras, Colonia,
Amiens, Parigi (tuttora piccolo villaggio) e di discendere la valle della Loira
lasciandosi dietro solo cumuli di fumanti macerie, fino a Troyes, la cui
salvezza sembra che sia da attribuire a un altro mezzo miracolo.
Anche qui fu il Vescovo, Lupo, che si presentò ad Attila supplicandolo di
risparmiare la sua città. E Attila accettò, ma a condizione che il sant'uomo
pregasse per lui e per la vittoria del suo esercito. Il che Lupo fece,
guadagnandosi certamente la gratitudine dei suoi concittadini, ma lasciando
noi posteri un po' perplessi non solo sul patriottismo, ma anche sulla fede
religiosa di questo prelato che durante la battaglia si trovava nel campo
dell'Unno pagano e idolatra a scongiurare il Cielo che lo facesse trionfare
dei cristiani impegnati con lui in una lotta mortale. Ma forse, siccome pregava in latino, ne approfittò per impetrare il contrario di ciò che aveva
promesso.
La battaglia, comunemente chiamata "dei Campi Catalaunici", ebbe luogo
nella piana di Mauriac, e fu sanguinosissima. 162.000 cadaveri, stando a
Giordane, rimasero sul terreno; ma il risultato rimane tutt'oggi un mistero.
Teodorico cadde, alla testa dei suoi. E Attila dovette ripiegare. Ma lo fece
ordinatamente senza che l'esercito romano-visigoto lo incalzasse. Qualcosa,
in questo successo di Ezio, ricorda quelli di Stilicone contro Alarico. Ebbe
egli il sospetto che, se annientava l'orda unna, Valentiniano e l'Impero non
avrebbero avuto più bisogno di lui? Torismondo, ch'era stato acclamato sul
campo Re dai Visigoti dopo la morte di suo padre, aveva anche lui qualche
ragione a non insistere. La sua successione poteva essere contrastata dai suoi
fratelli rimasti a Tolosa, dove non voleva tornare con un esercito a brandelli.
Sono supposizioni, intendiamoci; ma purtroppo non abbiamo di meglio per
spiegare lo strano episodio.
Comunque, nella piana di Mauriac si decisero le sorti dell'Europa. Essa
doveva restare nelle mani dei tedeschi e dei latini.
CAPITOLO DECIMO
LA FINE DEL "FLAGELLO'
NON C'ERA da aspettarsi che un uomo orgoglioso come Attila si
rassegnasse alla sconfitta. E infatti, appena rientrato a Aetzelburg sul finire
dell'estate del 451, si diede alacremente a preparare la rivincita.
Nella primavera successiva si mosse, ma non per la strada dell'anno
prima. Attraversò le Alpi Giulie e discese sulla pianura veneta. Aveva capito
che in Francia i Romani sarebbero di nuovo accorsi a dare man forte ai
Visigoti, ma che in Italia i Visigoti non sarebbero accorsi a dare man forte ai
Romani. E gli avvenimenti gli diedero ragione. Incontro a lui non si fece
nessun esercito. La gente fuggiva. Le città atterrite gli aprivano le porte.
Una sola le sprangò preparandosi a resistere: Aquileia.
Era, per quei tempi, una città grande in gara, quanto a importanza e a
ricchezza, con Ravenna e Milano; e sorgeva alla foce dell'Isonzo
nell'Adriatico. Nata nel 181 come colonia romana, si era poi enormemente
sviluppata come centro commerciale per gli scambi con la Germania, con
l'Austria (che allora si chiamava Nerico) e con la Jugoslavia (che allora si
chiamava Illiria). Aveva una popolazione mista di italiani, di tedeschi, di
galli celti e di transfughi di tutte le tribù che si davano il cambio,
sospingendosi l'una con l'altra, in Ungheria e Romania : gente attiva, che fra
l'altro si era costruita tutt'intorno una cerchia di mura e di solidi bastioni. La
Chiesa vi teneva addirittura un Metropolita, la cui diocesi si estendeva da
Verona alla Croazia.
Come Metz, Aquileia si chiamava "la fortezza vergine" perché nessun
assalitore era mai riuscito a espugnarla: vi si erano invano provati anche
l'usurpatore Massimino e più tardi Giuliano. Ezio, che pur considerava
impossibile la difesa dell'Italia del Nord, aveva lasciato ad Aquileia un
robusto presidio di truppe scelte. Esse resisterono gagliardamente agli
attacchi di Attila, che alla fine stava per togliere l'assedio, si racconta,
quando vide levarsi in volo dai tetti della città un branco di cicogne.
Superstizioso com'era vi scorse il segno della imminente capitolazione, ne
persuase le sue truppe e le lanciò a un ennesimo assalto. Le difese vennero
travolte, e Aquileia subì un castigo proporzionato alla resistenza che aveva
opposto. Solo pochi brandelli umani riuscirono a scampare dalla città in cui
non era rimasta pietra su pietra.
Giulia Concordia, Altino, Padova subirono pressappoco la stessa sorte.
Però, via via che risaliva il Po, la rabbia di Attila si addolciva. Vicenza,
Verona, Brescia, Bergamo si arresero e furono saccheggiate, ma non
distrutte. Forse l'ordine e la bellezza delle città italiane, molto superiori in
tutto a quelle tedesche e francesi, intimidivano l'Unno. A Milano, Attila si
acquartierò nel palazzo imperiale, quello in cui Costantino aveva firmato il
famoso editto che segnava il trionfo del Cristianesimo, e in cui Teodosio era
spirato. Fra gli affreschi che ne decoravano le sale, ce n'era uno che
rappresentava il trionfo di Roma sui barbari: i due Imperatori, di Oriente e di
Occidente, seduti sul trono dorato di fronte a un gruppo di Sciti morti o in
catene. Attila lo prese come un insulto alla sua persona, mandò a cercare un
pittore e gli ordinò di comporre subito un altro affresco che rappresentasse
lui, il Re unno, seduto sul trono, nell'atto di ricevere il tributo di
Valentiniano e di Teodosio II.
Le orde tartariche giunsero fino a Pavia, e tutta l'Italia cispadana stava col
fiato sospeso in attesa di vederle ruzzolare verso Roma, quando invece si
fermarono. Non se n'è mai saputo il motivo. Si è detto che, una volta entrato
in Italia, Attila era stato colto da una specie di sbigottimento e aveva provato
d'improvviso un senso di reverenziale rispetto per questo Paese tanto più
civile del suo. Ma è un'ipotesi che s'intona male al suo carattere. Si è detto
anche che gli tornò alla memoria il precedente di Alarico che, subito dopo
aver conquistato Roma, morì. E questo è più probabile, data la sua superstizione. Comunque, mentre deliberava coi suoi consiglieri, giunse
notizia dell'arrivo di una ambasceria dell'Urbe, guidata da un uomo il cui
rango non poteva essere discusso, visto che si trattava del Papa.
Cosa fosse frattanto successo nell'Urbe, dove ora risiedeva anche
Valentiniano, non si sa. Come non si sa per quali ragioni Ezio, mostratosi
fino a quel momento un Generale così capace e risoluto, non avesse
nemmeno accennato a scendere in campo contro il nemico. È probabile che
non avesse forze sufficienti per farlo, perché anche nella piana di Mauriac
era stato l'esercito visigoto a decidere le sorti della battaglia e della guerra.
Comunque, non risulta che fosse disposto nemmeno a un tentativo, e anzi
pare che consigliasse all'Imperatore la fuga.
Fu allora che il Papa prese su di sé la suprema responsabilità, e il gesto
segnò una svolta definitiva nella storia dell'Urbe e dell'Italia. Leone I era
della stessa stoffa di Ambrogio, e già da anni conduceva una strenua lotta
nell'interno della Chiesa per affermare la supremazia del Vescovo di Roma
su tutta la cristianità. Era un toscano di Volterra, autoritario e massiccio, con
scarse propensioni per le dispute teologiche. Era stato lui, al Concilio di
Calcedonia, a tagliar corto coi Nestoriani e coi Monofisiti che volevano
introdurre sottili discriminazioni fra Cristo-Dio e Cristo-uomo e a dare
avvio a quel sistema di precetti che doveva precludere la strada a ulteriori
deviazionismi. Era un uomo solido, coraggioso e di buon senso, di gran
carattere più che di gran testa, animato da una fede senza dubbi né
tentennamenti, e convinto che la disciplina e l'obbedienza valessero più
della carità.
Attila si trovò faccia a faccia con lui nell'estate del 452 sulle rive del
Mincio dov'era venuto a incontrarlo. Come si svolse l'intervista, nessuno lo
sa, perché nessuno ne prese nota. La leggenda corse che l'insolenza
abbandonò di colpo l'Unno di fronte al Supremo Pontefice che gl'ingiungeva
col crocefisso in mano di abbandonare l'Italia, e Raffaello ne rappresentò la
scena in un affresco. L'affresco è mirabile, ma la scena ci pare poco
credibile. Attila non era tipo da lasciarsi impressionare e per di più era
pagano e quindi non molto ricettivo a chi gli parlava in nome di Cristo. Si
disse che Leone era stato preceduto sul Mincio dalle voci di una
mobilitazione da parte dell'Imperatore d'Oriente, Marciano, che si preparava
a correre in aiuto del suo collega d'Occidente. Ma di questa iniziativa i
memorialisti di Costantinopoli non hanno mai detto nulla. L'ipotesi più
probabile ci sembra, dato il seguito degli avvenimenti, che Attila avesse già
avvertito in quel momento i primi sintomi del male che di lì a poco doveva
ucciderlo. Aveva forti emorragie dal naso, accompagnate da vertigini, e
forse, superstizioso com'era, pensò che l'Italia gli portasse sfortuna. Non è
da escludersi tuttavia che Papa Leone, inserendosi in questo suo stato
d'animo, gli facesse un grande effetto e desse il colpo decisivo alla sua
tentazione di rinuncia. Egli non chiese ironicamente, come millecinquecento
anni dopo doveva fare il suo quasi consanguineo Stalin: "II Papa!?... Quante
divisioni corazzate possiede?" Trattò con riguardo l'inerme porporato e, pur
ripetendo la sua pretesa alla mano di Onoria e la minaccia, se non gliela
concedevano, di tornare l'anno dopo a prendersela con la forza, ripartì per le
sue pianure magiare.
Accompagnamolo in quest'ultimo viaggio. Giordane racconta che, appena
rientrato a Aetzelburg, Attila si pentì della propria irresolutezza, si rimise in
marcia sulla Francia per vendicarsi dei Visigoti e ne fu per la seconda volta
battuto. Ma l'episodio è rifiutato dalla Storia. Egli mandò un insolente
messaggio a Marciano ingiungendogli di pagare il tributo, eppoi cercò di
consolarsi delle delusioni patite in Occidente prendendosi in moglie la
bellissima giovinetta Ildico. La sera del banchetto, per la prima volta in vita
sua, fece uno strappo alle regole, e mangiò e bevve in abbondanza. Poi salì
nella camera nuziale e l'indomani lo trovarono morto, soffocato dal proprio
sangue, accanto alla sposina che piangeva.
Si parlò di avvelenamento e di regicidio. Si avanzarono anche altre ipotesi
che la decenza ci vieta di riferire. Ma quella più verisimile, che è anche la
più semplice, è che si sia trattato proprio di un'emorragia, più forte delle
altre che aveva già avuto. Il compianto dei sudditi fu grande quasi quanto il
sollievo dei nemici. Secondo il loro barbaro costume, essi si tagliuzzarono il
viso in modo che fosse inondato di sangue virile e non di lacrime da
femminuccia. Il cadavere fu dapprima esposto in una sontuosa tenda intorno
a cui i cavalieri unni pazzamente galopparono a lungo, cantando inni
funebri. Poi fu composto in una bara d'oro, la bara d'oro in una d'argento, la
bara d'argento in una di ferro, che fu portata via segretamente e inumata
insieme ad alcuni scrigni pieni di gioielli in modo che Attila non diventasse
povero nemmeno da morto. Infine, com'era successo per Alarico, gli schiavi
che avevano scavato la fossa furono subito uccisi in modo che non
rivelassero dov'era sepolto. Il mestiere di becchino, a quei tempi, non era di
tutto riposo.
La fine di Attila fu automaticamente la fine degli Unni, ed è proprio
questo a dimostrarci quanto poco grande, in fondo, fosse stato il grandissimo Attila, il "flagello di Dio" come lo chiamavano i Romani. Egli non
aveva saputo creare nulla che potesse sopravvivergli. I numerosi figli che
aveva avuto dalle varie mogli non seppero mettersi d'accordo sulla
successione e si divisero. Ma le varie nazionalità che componevano il suo
popolo, e particolarmente quelle tedesche, fecero secessione o se la
guadagnarono con l'aperta rivolta. Cominciarono i Gepidi sotto la guida del
loro re Ardarico. Continuarono gli Ostrogoti, condotti dai tre fratelli Amai.
Seguirono gli Svevi, gli Eruli, gli Alani. Ernak, il figlio prediletto di Attila,
accettò di acquartierarsi coi suoi pochi seguaci in Dobrugia riconoscendo la
sovranità dell'Impero d'Oriente e accettandone la protezione. Ellak, il
primogenito, fu ucciso in battaglia dai Gepidi, che si costituirono in Stato
indipendente lì in Ungheria. Gli Ostrogoti si accamparono fra Austria e
Croazia, gli Eruli in Carinzia. In piccoli gruppi, la maggior parte degli Unni
ripercorsero a briglia sciolta le piste dell'est per perdersi ancora una volta
nelle steppe russe. Dopo pochi anni in Europa non se ne trovò più traccia.
Nemmeno dopo la morte di Alessandro il Macedone si era assistito a una
così fulminea dissoluzione. Tanto che, come ha scritto qualcuno, vien fatto
di chiederci quale compito la Provvidenza aveva assegnato a Attila, salvo
quello di dimostrare, appunto, che la Provvidenza non c'è.
Ma questo non è del tutto vero perché, pur non riuscendo a costruire nulla
di durevole, Attila di qualcosa fu causa, sia pure involontaria. Egli fondò
Venezia.
Furono infatti i fuggiaschi di Aquileia, di Padova e di tutte le altre città
venete da lui rase al suolo, che per mettersi al riparo da altre sventure del
genere si rifugiarono nelle isolette della laguna. Quelli di Altino ne
popolarono sette, a ognuna delle quali diedero il nome di una delle sette
porte della loro città. Quelli di Aquileia emigrarono a Grado, quelli di
Concordia a Caorle, quelli di Padova a Rialto e Malamocco. Venezia si
formò lentamente dal coagulo di questi detriti sviluppando quella vita
anfibia che doveva dettare il suo destino. Fu una crescita lenta. Duecent'anni
dopo questi avvenimenti un geografo di Ravenna scriveva: "Nel Veneto ci
sono delle isole dove pare che vivano degli uomini". Erano i progenitori di
coloro che dopo qualche secolo dovevano dominare il Mediterraneo e
rendere la pariglia ad Attila bloccandovi l'impeto di un altro conquistatore
della stessa razza asiatica e turanica degli Unni alla cui famiglia
apparteneva: i Turchi.
Ma, oltre a questo, Attila provocò anche la definitiva affermazione del
potere spirituale su quello temporale, simbolizzata e riassunta dall'ambasceria di Papa Leone sul Mincio. Quali che fossero stati i veri motivi
che indussero Attila ad abbandonare l'Italia, a Roma tutti ne diedero il
merito, al Papa, che si era fatto incontro al "flagello di Dio", mentre
l'Imperatore discuteva la fuga con Ezio. Anche questi usciva piuttosto
malconcio dall'episodio. Ma la sua posizione sembrava sicura anche per
l'imminente matrimonio di suo figlio Gaudenzio con una figlia di
Valentiniano che, non avendo eredi maschi, si supponeva che avrebbe
lasciato a lui il trono.
Ma alla notizia della morte di Attila, le cose bruscamente cambiarono. Un
giorno del '54 Ezio fu invitato a palazzo reale per discutere gli ultimi
dettagli delle nozze. Fu un tranello? Oppure fu un'improvvisa collera che
travolse il giovane Imperatore contro quel Generale che lo serviva
fedelmente, ma che anche lo trattava con una certa burbanza? Lo s'ignora.
Ma fatto sta che Valentiniano trafisse di suo pugno Ezio con la spada e due
inservienti lo finirono a pugnalate.
Per quanto ambizioso e arrivista, non alieno da perfidie come quella che
aveva messo in opera per sbarazzarsi di Bonifacio, era pur sempre il più
grande Generale che l'Impero avesse avuto dopo Stilicone, e colui che lo
aveva salvato dalla prima possente spallata di Attila. Eppure, nessuno fece
caso alla sua scomparsa né al modo in cui era avvenuta: in fondo, non si
trattava che di un mercenario barbaro!... Solo un epigrammista ebbe il
coraggio di dire a Valentiniano: "Se tu abbia fatto bene o male, non so. Ma
so che ti sei amputato la mano destra con la sinistra".
Si era alla fine del 454. Pochi mesi dopo, nel marzo del '55, Valentiniano
cavalcava in Campo Marzio, quando due veterani di Ezio gli si avvicinarono
e lo pugnalarono. Nemmeno di questo i Romani si turbarono, e infatti i due
regicidi rimasero indisturbati. Con Valentiniano scendeva nella tomba
l'ultimo discendente di Teodosio sul trono d'Occidente, dove la dinastia era
rimasta sul trono per sessantanni. Il defunto lasciava una vedova,
l'imperatrice Eudossia, che lo aveva riempito di corna, e due figlie, Eudocia
e Placidia. Roma non aveva più né un Imperatore né un Generale.
Esercito e popolo per una volta si trovarono d'accordo nella scelta di colui
che doveva salire sul trono vacante. Era un Senatore sessantenne di nome
Petronio Massimo, che sembrava fornire le migliori garanzie. Veniva dalla
vecchia famiglia dei Probi, che aveva sempre fornito eccellenti Consoli e
Pretori.
Ma l'uomo era irresoluto e si mostrò subito impari al grave compito. Si
rifiutò di castigare i due regicidi, forse per evitare la rivolta dei loro
consanguinei barbari che militavano nell'esercito, e questo fece nascere il
sospetto che egli avesse preso parte alla congiura. Per di più proibì
all'imperatrice Eudossia di portare il lutto di Valentiniano e le chiese, anzi le
ingiunse, di diventare sua moglie. Eudossia era ancora giovane e fra le più
belle donne di Roma. Aveva abbondantemente tradito suo marito, ma gli
aveva voluto bene e non intendeva essere forzata a sposare un vecchio. Sua
zia Pulcheria a Costantinopoli era morta, e quindi non poteva sperare che da
quella parte le venissero aiuti. Non sapendo come uscire da quell'imbroglio,
seguì lo sciagurato esempio di sua cognata Onoria e, non potendolo più a
Attila ormai defunto, si rivolse a Genserico il Re dei Vandali in Africa,
perché venisse a liberarla.
Genserico non se lo fece dir due volte; e di lì a poco Roma fu folgorata
dalla notizia che la flotta barbarica, vele al vento, si stava avvicinando a
Ostia. Chi poté, fuggì. E anche Petronio Massimo si stava preparando a fare
altrettanto. Ma il popolino, che fuggire non poteva perché non ne aveva i
mezzi, circondò il palazzo. I soldati, invece di difendere il loro padrone, si
ammutinarono. E i servi, anche per prevenire una possibile epurazione per
collaborazionismo col codardo traditore, lo linciarono.
Che Roma non avesse un Imperatore sotto quella nuova tempesta che si
addensava all'orizzonte, non importava più nulla a nessuno. Tanto, c'era il
Papa.
CAPITOLO UNDICESIMO
GENSERICO
PER ARRIVARE a Roma, non si può dire che i Vandali avessero seguito una
scorciatoia.
Venivano nientemeno che dalla Prussia Orientale, e probabilmente in
origine erano stati, come i Gepidi, un ramo della grande famiglia gotica. Il
primo storico romano che ne fece menzione fu Plinio, che li chiamava
Vindili. E il primo Imperatore ch'ebbe a che fare direttamente con loro fu
Aureliano, che nel 271 li sconfisse in Boemia dov'erano penetrati, ma poi li
ammise dentro il limes in qualità di federati e ne assoldò duemila per
rimpolpare i suoi reggimenti di cavalleria. Fra di essi si trovava
probabilmente il nonno o il bisnonno di Stilicone.
Al tempo di Costantino il loro re Geberico ebbe un diverbio con quello
dei Goti, Visumar, venuto ad acquartierarsi accanto ad essi. Ne seguì una
sanguinosa battaglia in cui Geberico venne ucciso e il suo esercito quasi
interamente distrutto. I pochi scampati chiesero all'Imperatore il permesso di
rifugiarsi in Ungheria, e lì rimasero tranquilli per un mezzo secolo a leccarsi
le ferite, a fare dei figli per colmare i vuoti e ad assorbire un po' di civiltà
col Cristianesimo cui si convertirono anch'essi secondo il credo ariano di
Ulfila.
Nel 406 ripresero la loro marcia verso Ovest. I nemici di Stilicone
insinuarono ch'era stato costui ad invitare i Vandali, per solidarietà di
sangue, nelle province occidentali del vacillante Impero. Ma non c'è bisogno
di ricorrere a questa ipotesi perché l'anno 406 fu quello in cui anche Alarico
e Radagaiso attraversavano le Alpi e dilagavano in Italia. Stilicone non c'entrava per nulla. Era l'arrivo delle orde unne di Rua che rimescolava tutto il
mondo barbarico provocandone l'alluvione dentro il limes.
Mescolati ai pochi brandelli alani ch'erano riusciti a scampare a Rua, i
Vandali, invece delle Alpi, attraversarono il Reno, penetrarono in Francia, si
scontrarono coi Franchi che ne stavano diventando i padroni, persero in una
battaglia ventimila uomini, attraverso i Pirenei si ritirarono in Spagna, e qui
vennero raggiunti poco dopo dai Visigoti di Ataulfo e di Galla Placidia, i
quali li combatterono in nome dell'autorità imperiale, da cui speravano di i
ottenere l'investitura su tutta la Penisola.
Quanto fosse rimasto di sangue vandalo in questa composita massa di
fuggiaschi cui, oltre agli Alani, si erano ora mescolati anche dei rimasugli
svevi, non si sa. Comunque, non erano più di ottantamila, comprese le
donne, i vecchi e i bambini, quando si rifugiarono nella regione che da loro
prese il nome di Andalusia. Era una terra devastata, arida e povera che, a
quanto pare, obbligò i nuovi occupanti anche a pratiche di cannibalismo. E
questo spiega la ragione per cui quando, nel 429, giunse dal Conte
Bonifacio il famoso e fatale invito a varcare lo stretto di Gibilterra e a
istallarsi in Africa, esso fu accolto senza esitazione.
In quel momento i Vandali erano guidati da due Re, che si dividevano, e
forse si contendevano, il trono: uno, Gunterico, era il figlio legittimo del
defunto sovrano; l'altro, Genserico, era un bastardo. Subito dopo aver preso
di comune accordo la decisione del trasferimento, Gunterico morì.
Naturalmente si disse subito ch'era stato Genserico a farlo uccidere e, dato il
carattere del personaggio, non ci sarebbe da meravigliarsene. Ma non ci
sono prove per affermarlo con certezza. Comunque, se si trattò di fratricidio,
a rimpiangerlo non furono certo i Vandali; ma, caso mai, i loro nemici, e
anche i loro amici, a cominciare da Bonifacio.
Genserico aveva una trentina d'anni, quando diventò Re. Era di media
statura, un po' zoppo per via d'una caduta da cavallo, parco di parole, avido
di denaro, ambizioso e sobrio. Non fu un uomo di larghe vedute perché gli
mancava un minimo di cultura su cui appoggiarle. Era analfabeta, e quando
decise di trasbordare tutto il suo popolo in Africa non sapeva neanche
approssimativamente che cosa l'Africa fosse e dove fosse. Non aveva
nemmeno il complesso carattere romantico di Alarico né l'altezzoso senso
della regalità che caratterizzava Attila. Nel suo cervello non c'erano sogni né
nel suo cuore passioni. Più che dall'intelligenza si faceva guidare dall'istinto,
ma questo non lo ingannava mai.
Fu il primo capo barbaro a fare un censimento. Ne aveva bisogno per
stabilire quante navi gli occorrevano al traghetto. Mise tutti, compresi i
vecchi e le donne, al lavori forzati per costruire la flotta. Poi, una volta
sbarcato al di là dello stretto, non cercò di salvare nemmeno le apparenze
dell'"alleanza" a cui Bonifacio lo aveva invitato. Le città del Marocco, che
allora si chiamava Mauretania, furono letteralmente spianate dalle sue orde.
Poi fu la volta dell'Algeria e della Tunisia, che allora si chiamavano rispettivamente Numidia e Africa Proconsolare. In breve, immuni da quella colata
di ferro e di fuoco, perché protette da solide fortificazioni, non rimasero che
due città: Cartagine e Ippona.
In Ippona assediata, concludeva malinconicamente la sua vita
Sant'Agostino Vescovo, ormai quasi ottantenne, immerso nella stesura della
sua ultima opera: una "confutazione di Giuliano l'Apostata". Ma ancora più
malinconicamente ci vegetava Bonifacio che, messa in chiaro la sua
posizione rispetto a Ravenna e accortosi dell'equivoco in cui lo aveva
indotto Ezio, poteva misurare meglio e rimpiangere ancora di più la
catastrofe ch'egli stesso aveva provocato. Dopo qualche inutile tentativo di
persuadere quel suo strano "alleato" a tornarsene in Spagna o per lo meno a
trattare l'Africa con qualche riguardo, ottenne da Roma e da Bisanzio alcuni
rinforzi, che giunsero sotto il comando di Aspar, e con essi tentò una
soluzione militare. Fu di nuovo sconfitto. E allora si decise a ripartirsene per
l'Italia dove Ezio lo attendeva per ucciderlo in duello. Agostino lo aveva
preceduto nella tomba. Dieci giorni prima della morte, presentendola, proibì
l'ingresso nella propria stanza a tutti, eccetto il dottore e il servo che gli
portava i pasti. Aveva sempre predicato che cristianamente si muore solo in
stato di penitenza, e ne diede una dimostrazione restando sino alla fine
assorto nei Salmi di David copiati e affissi alle quattro pareti. Così finì,
quasi in condizione di prigioniero e nella tristezza di quella catastrofe, il
Padre della Chiesa che alla grandezza della Chiesa aveva più contribuito,
dopo gli Apostoli.
Nel 435, alla fine, Genserico si decise a concludere qualcosa che
somigliava a una pace con Valentiniano, o meglio con sua madre Placidia. Il
Vandalo s'impegnava a rispettare la sovranità imperiale su Cartagine e la
Tunisia, mandando in pegno, come ostaggio, suo figlio Unerico a Roma. Il
resto del Nord-Africa era dato, per così dire, in usufrutto a lui e al suo
popolo.
Questo impegno fu rispettato da Genserico fino al 439, quando le residue
forze imperiali al comando di Ezio dovettero essere concentrate in Francia
per parare la terribile minaccia di Attila. Allora egli richiamò da Roma
Unerico, spazzò via Cartagine e il poco che restava intorno ad essa sotto
bandiera romana, e di questa città fece la sua capitale.
Immediatamente vi riattò il porto e si diede a costruirvi una potente flotta.
Egli non sapeva nulla di mare. Era sempre stato un uomo di terra, come tutti
i tedeschi, non aveva mai visto una carta di navigazione, non aveva idea dei
venti e delle rotte. Ma nel suo animalesco istinto capiva che solo sul mare
l'Africa poteva essere difesa. E per questo il Re brigante si trasformò in Re
pirata. Via via che una nuova triremi veniva varata dai suoi improvvisati
cantieri cui gli ex-cittadini romani lavoravano da forzati, egli vi saliva col
suo passo zoppo, e al timoniere impartiva quest'ordine: "Andate ad attaccare
le dimore di coloro che Dio non ama". E siccome, secondo i Vandali, Dio
non amava che i Vandali, tutti gli altri erano da considerare preda bellica.
Così Cartagine ridiventò per il Mediterraneo, per l'Italia e per l'Europa, ciò
ch'era stata ai tempi degli Amilcari e degli Annibali.
Genserico fu forse il capo barbaro che per primo realizzò nel suo reame
un'organizzazione interamente feudale. La società fu nettamente divisa in
due classi: quella dei signori Vandali, guerrieri e dispensati dal lavoro e
dalle tasse; e quella dei servi indigeni, ch'erano dei romani colti e raffinati,
senza diritto alle armi né a una rappresentanza politica, e legati alla gleba.
Egli fu anche il primo a non sentire affatto il complesso d'inferiorità del
tedesco nei confronti del latino, che tanto aveva angustiato Alarico, e da cui
forse lo stesso Attila era afflitto. L'uomo era così lontano non solo dalla
cultura, ma perfino dal sospetto della cultura che per lui un Romano colto
non si differenziava da un Romano ignorante e ambedue facevano parte
della stessa categoria : quella dei nemici vinti, da tenere in schiavitù. A che
si sappia - se non si tratta di una leggenda -, ne discriminò uno solo, ma per
pura superstizione. Un giorno, guardando dalla finestra del suo palazzo un
gruppo di prigionieri che dovevano essere smistati nei vari campi di lavoro,
ne vide uno che dormiva placidamente senza badare, come gli altri facevano, a ripararsi dal solleone che in Africa picchia con particolare violenza.
Osservando meglio gli parve che ad assicurargli una macchia d'ombra sul
capo fosse un avvoltoio che incrociava lì sopra. Pensò che Dio, per
concedergli una simile protezione, dovesse avere un debole per quell'uomo,
e lo mandò a chiamare. Così seppe da lui che si chiamava Marciano e ch'era
venuto da Bisanzio come attendente di Aspar. Lo lasciò libero, convinto che
sarebbe diventato qualcuno, e che pertanto fosse conveniente accaparrarsene
la gratitudine. E infatti Marciano qualcuno diventò quando, sposata
Pulcheria, fu acclamato Imperatore d'Oriente. Forse, ripeto, si tratta di
leggenda. Ma dalla Storia è accertato comunque che, una volta presa la
porpora, Marciano si rifiutò costantemente di prendere iniziative contro i
Vandali.
Anche quella volta, se l'episodio è vero, Genserico non aveva agito per
generosità. Non ne era capace. Nemmeno il suo profondo sentimento
religioso riusciva a ispirargliene e in lui si trasformava in crudeltà
persecutoria. Infatti, lungi dal provare un senso di solidarietà cristiana per i
cristiani d'Africa, non aveva visto in essi che dei cattolici da tormentare in
nome dell'arianesimo. Anche a fare qualche ribasso sui crimini e i soprusi
che gl'imprestano gli storici della Chiesa, rimane un largo margine per
poterlo considerare un Loyola a rovescio, inteso più a combattere la causa
del diavolo che a difendere quella di Dio.
L'Africa era cattolica in un modo tutto particolare, cioè nel modo fanatico
e zelante in cui lo sono i Paesi dove la disputa teologica è stata viva e floride
le eresie. La Chiesa aveva dovuto combattere una dura battaglia contro i Do-
natisti, i Circoncellioni e altri innumerevoli deviazionisti dalla regola
ortodossa. Nella lotta si era maturata una più stretta disciplina, che qua e là
sconfinava in manifestazioni di puritanismo. I Vescovi con cui Genserico,
dopo la vittoria, si trovò alle prese, si chiamavano Graziaddio,
Quelchediovuole, Sialodaddio eccetera. Erano cresciuti alla scuola rigorosa
di Agostino, avevano aspramente lottato contro gli scismatici, non erano
inclini alle ritrattazioni e ai compromessi. Due di loro furono bruciati vivi,
altri arrestati e torturati. Quello di Cartagine venne caricato con tutti i preti
della diocesi su una nave affidata ai venti, senza timone né remi. Ma i venti
la condussero in Italia.
Tipico fu il caso di Sebastiano, il genero di Bonifacio, ch'era rimasto a
Ippona e s'era messo al servizio del Vandalo. Questi aveva per lui un certo
debole, ma avendo in precedenza stabilito che solo gli ariani potevano
frequentare la Corte, gli chiese di abiurare alla fede cattolica. Sebastiano gli
mostrò una mollica di pane. "Io sono come questa" gli disse. "C'è voluto un
certo quantitativo di grano, un mulino per macinarlo, dell'acqua per
impastare la farina, del fuoco per cuocerla, per fare di essa ciò che è, come
ci son voluti il battesimo, lo studio della Dottrina e l'ispirazione di Dio per
fare di me quello che sono. Credi tu che, convertendomi all'arianismo,
diventerei più bianco di questo pane? Se mi rispondi di sì, lo faccio,
altrimenti rimango ciò che sono." Genserico si diede per vinto. Ma pochi
giorni dopo fece uccidere Sebastiano.
Tuttavia, furbo com'era, si accorse che con quelle persecuzioni, forniva
soltanto ai suoi avversari dei nuovi martiri da venerare. Allora cambiò
metro. Affidò i renitenti al boia, ma dando segretamente l'ordine a costui di
ucciderli solo se all'ultimo momento accettavano la conversione. Morendo
da codardi in abiura, non potevano più passare da eroi. Ma la maggior parte
resisté. E fu il caso, fra gli altri, di un attore comico, Mascula, che rimase
fermo nella sua fede anche quando sentì la lama della spada sul collo, e
diventò un "Confessore", come si chiamavano coloro ch'erano reduci dalla
morte dopo averla impavidamente sfidata. Probabilmente vandalismo
diventò sinonimo di crudeltà non tanto per il trattamento cui i Vandali
sottoponevano le città conquistate e i popoli vinti, che non era poi in fondo
diverso e peggiore di quello che usavano tutti gli altri barbari, quanto per la
fanatica e cocciuta persecuzione religiosa di quella specie di Scarpia
sanguinario e bigotto, che fu Genserico.
Questo era l'uomo che nel 455, raccogliendo l'appello di Eudossia, sciolse
al vento le vele della sua flotta. I piloti stavolta sapevano benissimo qual era
la dimora degli uomini che Dio non ama. I legni barbarici giunsero nelle
acque di Ostia sulla fine di giugno. Nella città indifesa la folla inferocita
aveva linciato Massimo che si preparava a fuggirne. Roma ormai non ri-
conosceva che nel Papa il suo naturale interprete e protettore.
Leone I si fece incontro al Vandalo con la stessa compostezza e maestà
con cui pochi anni prima si era fatto incontro a Attila. La sua mediazione
non ebbe altrettanto successo, ma anche stavolta riuscì a evitare il peggio.
Fra i due fu stipulato uno strano Concordato, in base al quale il Sommo
Pontefice riconosceva in certo qual modo il diritto di saccheggio e di rapina
al barbaro, se questi s'impegnava a non uccidere i derubandi, a non
bruciarne le case e a non sottometterli a tortura per sapere dove avevano
nascosto i loro beni.
Come poi in pratica si siano svolte le cose, è difficile saperlo, e ci
sorprenderebbe che qualche morto non ci sia scappato. Dicono che entrando
nell'Urbe alla testa delle sue soldataglie, Genserico esclamasse non con
ammirazione, ma con cupidigia : "Dio, quanta roba da rubare!" Forse non è
vero. Ma anche se non lo disse, avrebbe potuto dirlo. Quattordici giorni durò
la sarabanda dei lanzichenecchi vandali nelle strade e nelle case di Roma.
Tutto quello che si poteva portarne via fu spiantato e caricato sulle navi alla
fonda. Una di esse era stivata di statue, ma purtroppo l'eccesso di peso la
fece naufragare in mezzo al Mediterraneo nel viaggio di ritorno. Il palazzo
imperiale e il tempio di Giove furono letteralmente spogliati. Molto del
vasellame e argenteria predati in quei giorni venne recuperato dai bizantini a
Cartagine nel palazzo di Gelimero, pronipote di Genserico, un'ottantina di
anni dopo, e trasferito a Costantinopoli.
Come preda bellica fu portata via anche l'imperatrice Eudossia, causa di
tutta quella sciagura, le sue due figlie Eudocia e Placidia, e Gaudenzio, il
figlio di Ezio, che aveva aspirato alla mano di una di esse. Per Eudossia fu
forse un gesto di cortesia: è facile immaginare che fine avrebbe fatto se si
fosse ritrovata faccia a faccia coi suoi sudditi dopo aver loro tirato addosso
quel disastro. Quanto alle ragazze, Genserico le considerava due "buoni
partiti" da sfruttare convenientemente. Diede infatti Eudocia in moglie a
Unerico, di cui si disse ch'era già innamorato di lei sin dai tempi in cui era
ostaggio a Roma. I romanzi sentimentali commuovevano la gente anche a
quei tempi, ma nel caso specifico si trattava certamente d'invenzione perché
quando Unerico si trovava a Roma, Eudocia era in fasce. Placidia rimase a
Cartagine con la madre, trattate ambedue con grande generosità e
correttezza, finché per le insistenze della Corte d'Oriente, con cui Genserico
non voleva storie, furono rimandate a Bisanzio, dove la giovane principessa
sposò il senatore Olibrio. E con queste due ragazze finisce la dinastia di
Teodosio.
Ma, oltre a questi personaggi di primo piano, Genserico si era portato
dietro uno stuolo di tecnici e di artigiani qualificati, come millecinquecento
anni più tardi avrebbe fatto il suo compatriota Hitler nei Paesi occupati. Fu
una operazione alla Todt senza riguardo a casi personali e a vincoli di
famiglia. Migliaia di Romani furono disseminati fra il Marocco e la Libia e
messi ai lavori forzati per contribuire alla ricchezza e alla potenza del loro
carceriere.
CAPITOLO DODICESIMO
RICIMERO E ODOACRE
PER DUE MESI i Romani rimasero senza Imperatore, ma non risulta che se
ne sentissero orfani. Gli ultimi Augusti di imperiale non avevano avuto che
il titolo: il potere lo avevano esercitato con regale indegnità. La popolazione
aveva visto i Vandali abbandonare la città e dirigere le vele verso l'Africa, di
dove erano venuti. I cronisti dell'epoca riferiscono che sull'Urbe violentata e
saccheggiata si era stesa una coltre di apatia. Fu in questa atmosfera stracca
e neghittosa che, sulla fine dell'estate del 455, varcò le mura della città un
vecchio nobile dell'Alvernia, che era una delle province della Gallia. Si
chiamava Avito ma nessuno nella capitale aveva prima d'allora udito il suo
nome. Qualcuno disse che era il nuovo Imperatore. I Romani lo accolsero
con indifferenza e non gli andarono neppure incontro.
Avito era stato incoronato non dai Romani ma dai Visigoti, il dieci luglio
ad Arles. Discendeva da una delle famiglie più cospicue della regione. I suoi
antenati avevano ricoperto per generazioni cariche importanti nell'esercito e
nella pubblica amministrazione. I biografi raccontano che quando divenne
Imperatore doveva essere sulla sessantina, essendo nato nell'anno in cui
Teodosio morì. Possedeva una buona cultura classica e aveva letto Cicerone
e Giulio Cesare che nel De bello gallico, cinque secoli prima, aveva
descritto il suo popolo. Agli studi alternava la caccia al cinghiale. Il suo
cursus honorum fu molto rapido e in pochi anni riuscì a ottenere una delle
cariche più importanti della provincia, la prefettura del pretorio, che tenne
per un lustro quando si ritirò a vita privata con la figlia Papianilla. Di
quest'uomo non avremmo forse mai sentito parlare se un giorno Roma non
lo avesse incaricato di un'ambasceria presso il Re dei Visigoti, Teodorico.
Avito e Teodorico si erano conosciuti da ragazzi ed erano diventati grandi
amici. Sul traballante Impero d'Occidente incombeva la minaccia di Attila il
quale non aveva rinunciato a trasformare l'Italia in un Deserto dei Tartari.
Avito e Teodorico strinsero un patto di alleanza e di mutuo soccorso. Due
mesi dopo la ritirata dei Vandali da Roma, col favore del Re goto. Avito fu
coronato Imperatore. Fu un breve regno. Il poeta Sidonio Apollinare, che
aveva sposato Papianilla, lo immortalò in un brutto panegirico. Come
ricompensa il suocero gli fece erigere una statua nel Foro Traiano.
Quando a Roma giunse la notizia che la flotta di Genserico era per la
seconda volta salpata verso l'Italia, i Romani furono percorsi da un brivido
di terrore. Avito fece subito allestire una flotta e vi pose a capo il conte
Ricimero il quale investì le triremi nemiche che veleggiavano verso la
Corsica, le accerchiò e le colò a picco. Migliaia di Vandali persero la vita. I
superstiti, in catene, furono condotti prigionieri a Roma e Avito li fece
decapitare. La popolazione che aveva ancora vivo il ricordo del sacco del
455 esultò. Ricimero fu portato in trionfo per le strade imbandierate della
Capitale. La folla, in delirio, gli tributò onori degni dei tempi di Augusto. La
gloria del nuovo eroe offuscò quella dell'Imperatore il quale, poche settimane dopo, fu deposto, anche perché aveva fatto fondere alcune statue di
bronzo per pagare la cinquina ai soldati. Riuscì a fuggire ma a Piacenza fu
fatto prigioniero e consegnato a Ricimero. Questi non solo gli risparmiò la
vita, ma lo fece consacrare Vescovo. Un episodio che testimonia in modo
eloquente delle condizioni della Chiesa nel quinto secolo.
Ricimero era un barbaro che aveva fatto una brillante carriera
riorganizzando l'esercito e combattendo contro i barbari che minacciavano
l'Impero. Grande generale, freddo calcolatore, fu sempre fedele a Roma ma
non agli Imperatori che di volta in volta collocò sul trono e da esso sbalzò.
Si ricordava di Stilicone, che Onorio aveva fatto assassinare, e di Ezio, giustiziato da Valentiniano. Capì che l'Impero era marcio e che la sua fine
poteva essere ritardata ma non evitata. Scomparso Avito non volle
succedergli perché le leve del comando era meglio controllarle come primo
ministro di un sovrano esautorato. Si limitò ad assumere il titolo di Patrizio
con cui gli veniva riconosciuto il diritto di proclamarsi padre
dell'Imperatore. Giubilato Avito collocò sul trono Maggioriano, ex-aiutante
di campo di Ezio al cui fianco avrebbe fatto una rapida carriera se la moglie
del generale non lo avesse fatto silurare. Come Cincinnato e Teodosio,
Maggioriano si era ritirato in campagna ad allevare polli, in attesa di tempi
migliori. Quando Ezio fu assassinato, Valentiniano III lo richiamò. Fu in
questa occasione che conobbe Ricimero. Per i Romani l'elezione di
Maggioriano fu un avvenimento di ordinaria amministrazione. Dopo
l'incoronazione, il nuovo Augusto lesse al Senato un messaggio pieno di deferenza in cui dichiarava di assumere la porpora per volontà dei suoi
rappresentanti e nel supremo interesse della Patria. I Senatori quando lo
udirono trasecolarono. Da tempo immemorabile non erano più abituati a
sentirsi trattare con tanto riguardo.
L'incoronazione di Maggioriano riportò alla ribalta Sidonio Apollinare. Il
poeta, dopo la scomparsa di Avito, era caduto in disgrazia. Fu perdonato
perché era l'unico poeta dell'Impero. Il panegirico dedicato a Maggioriano
riscosse gli stessi consensi di quello indirizzato ad Avito. In entrambi i
componimenti - della stessa lunghezza e nello stesso metro - Sidonio aveva
detto suppergiù le stesse cose. Come ricompensa, fu esonerato dalle tasse.
Maggioriano fu un buon Imperatore. Poiché gli Italiani non facevano più
figli, proibì alle donne. di prendere i voti prima dei quarant'anni, obbligò le
vedove a rimaritarsi, impedì ai giovani di farsi monaci e punì gli speculatori
che per costruire nuovi edifici abbattevano quelli antichi dimostrando che a
Roma i Vandali erano del tutto superflui. Ma questa saggezza gli costò cara.
Ricimero non tardò ad accorgersi che Maggioriano voleva fare
l'Imperatore sul serio e nel maggio del 460 lo depose. Maggioriano si ritirò a
vita privata in una villa vicino Roma dove, pochi anni dopo - riferisce
Procopio - morì di dissenteria.
Tolto dalla scena un sovrano che avrebbe meritato di restarci, Ricimero,
nel novembre del 461, incoronò a Ravenna Augusto un certo Libio Severo,
lucano di nascita. Di costui sappiamo solo che regnò quattro anni, visse
religiosamente e morì avvelenato. Dopo di lui il trono restò vacante per due
anni.
Il suo successore Antemio era genero del defunto Imperatore d'Oriente
Marciano. Fu deposto per inettitudine nell'aprile del 472. Ricimero incoronò
allora un certo Olibrio, che non fece in tempo a deporre perché dopo un
mese un'emorragia uccise lui.
Con la sua morte si chiude la serie di quei generali barbari che negli
ultimi tempi avevano retto le sorti dell'Occidente, colmando il vuoto di un
potere che gli Imperatori non erano più in grado di esercitare. Per sedici anni
Ricimero era riuscito a tenere a galla una barca che faceva acqua da tutte le
parti e le cui falle nessuno più era in grado di tamponare. Olibrio non ebbe
neppure il tempo di accorgersi di quello che gli stava succedendo intorno:
un attacco di idropisia lo eliminò. Prima di morire, aveva nominato Patrizio
il nipote di Ricimero, il principe burgundo Gundobado, che nel marzo del
473, dopo un interregno di cinque mesi, proclamò Imperatore a Ravenna
Glicerio. Di costui sappiamo solo che quando l'Italia fu minacciata dagli
Ostrogoti, egli andò incontro al loro re Teodemiro, lo colmò di doni e lo
indusse ad abbandonare la Penisola e a marciare sulla Gallia che, se non di
fatto, almeno sulla carta apparteneva ancora all'Impero. Ma questo
tradimento gli costò il trono sul quale balzò un generale di nome Giulio
Nepote. Gundobado preferì fuggire in Burgundia, dove lo attendeva la
corona di un regno meno glorioso di quello romano, ma certamente più
comodo.
Giulio Nepote governò quattordici mesi e consegnò l'Alvernia ai Visigoti.
I Romani non glielo perdonarono e il suo luogotenente Oreste, nell'estate del
475, lo depose e proclamò Imperatore a Ravenna il figlio Romolo
Augustolo. Oreste era nato in Pannonia, era entrato al servizio di Attila, e lo
abbiamo già incontrato, col suo collega Edecone, alla testa dell'ambasceria
che il "flagello" aveva mandato a Costantinopoli nel 448. Il matrimonio con
una nobildonna greca gli aveva spalancato le porte della società bizantina.
Anche lui, come Stilicone e Ricimero, non indossò la porpora e si
accontentò del titolo di Patrizio. Era un uomo ambizioso, ma ottuso. Quando gli Eruli calarono in Italia e reclamarono un terzo del suo territorio per
acquartierarvisi, Oreste glielo rifiutò. Il loro capo, Odoacre, gli dichiarò
guerra e marciò su Pavia dove egli era riparato. Dopo due giorni d'assedio la
città capitolò e fu spianata al suolo. Gli Eruli sgozzarono i suoi abitanti e
non risparmiarono neppure i vecchi e i bambini. Fu un massacro in piena regola, nello stile di Attila e di Genserico. Ma ci si dimenticò di Oreste il
quale, per la seconda volta, riuscì a mettersi in salvo a Piacenza. Fu scovato
dopo una settimana e passato sommariamente per le armi. Sorte migliore
ebbe il figlio Romolo Augustolo. Odoacre gli risparmiò la vita, un po' per la
sua giovane età, un po' per la sua straordinaria bellezza, e gli concesse di
trascorrere il resto dei suoi giorni in una villa vicino Napoli, con una
pensione annua di seimila soldi.
Odoacre era il figlio di quell'Edecone che con Oreste aveva fatto parte del
servizio diplomatico di Attila. Il modo in cui trattò il vecchio amico e
collega di suo padre, sulle cui ginocchia forse aveva saltato da bambino, ci
dice abbastanza del suo carattere. Egli governò l'Italia per diciassette anni,
dal 476 al 493. C'era venuto dopo la dissoluzione dell'orda, e nell'esercito
imperiale aveva fatto una rapida carriera, proporzionata ai suoi meriti,
ch'erano grandi, e all'inettitudine degli Imperatori, ch'era grandissima. Lo
storico Eugippio ce lo descrive di notevole statura, rosso di pelo e con un
gran paio di baffi biondi. L'imperatore Zenone lo nominò Patrizio, che era
un riconoscimento puramente formale. Gli Eruli lo acclamarono Re e gli
conferirono, col titolo, i pieni poteri. Sotto di lui vincitori e vinti coabitarono
senza fondersi. Le antiche magistrature dei tempi di Silla e di Cicerone e le
gloriose
cariche
repubblicane
nominalmente
sopravvivevano
allo
sconquasso dell'Impero; ma ormai non contavano più nulla, come non
contava più nulla il Senato, esautorato da questo capitano di ventura
ricoperto di pelli di montone. L'Italia era piombata nel Medioevo.
Cominciavano i secoli bui.
CAPITOLO TREDICESIMO
L'ULTIMA ROMA IMPERIALE
NON RISULTA che i Romani, o per meglio dire gli abitanti di Roma, si
rendessero esatto conto di ciò che significava la decisione di Odoacre di
spedire a Costantinopoli le insegne imperiali e di abolire la carica di
Augusto. Il Senato, che pro forma si riuniva per avallare le decisioni del
tirannello di turno, lo considerò un fatto di ordinaria amministrazione, anzi
lo salutò come una provvida riunificazione dell'Impero dopo la divisione
fattane da Costantino. Che tutto l'Occidente se ne fosse separato; che Roma,
una volta caput mundi, non lo fosse più neanche dell'Italia, la quale oramai
gravitava di più su Milano e Ravenna; e che la Penisola non fosse più che la
remota propaggine di un Impero che si proclamava ancora Romano, ma che
in realtà era soltanto grecorientale; parvero loro tutte cose di scarso rilievo e
di secondaria importanza.
Questa indifferenza è significativa. Non che - intendiamoci - all'atto
pratico il Senato avesse la possibilità e i mezzi di opporsi. Se avesse osato,
per dirla con Mussolini, i lanzichenecchi di Odoacre avrebbero fatto di
quell'aula sorda e grigia un loro bivacco. Ma almeno un addio alle aquile e
ai fasci littori, cioè a ottocento anni di Storia e di Gloria, avrebbe potuto
risuonarvi. Invece, niente. Fra gli epigoni di quella ch'era stata la più
orgogliosa aristocrazia del mondo, non se ne trovò uno disposto a
pronunziare un epitaffio.
L'ultimo Senatore degno di questo nome era stato Simmaco, alle cui
"Lettere" dobbiamo il più gradevole ritratto dell'agonizzante Roma
imperiale. Veniva da una grande famiglia di Consoli e di Prefetti, che
avevano servito con la medesima accortezza gl'interessi dello Stato e quelli
propri, come dimostrava l'immenso patrimonio che avevano accumulato.
Fra l'altro essi avevano disseminato, dal Lago di Garda alla Baia di Napoli,
una catena di sontuose ville, in modo da poter scorrazzare la Penisola senza
lo scomodo di uscir di casa.
Simmaco era l'ultimo rappresentante della cultura pagana, sebbene in fatto
di religione si proclamasse agnostico. "Che importanza ha" disse
all'imperatore Valentiniano "quale strada si sceglie per giungere al Vero?
Quel che conta sapere è che non si arriverà mai a scoprirlo." Gran signore e
intimo amico di Vezio Pretestato, capo della minoranza pagana in Senato,
egli fu designato a patrocinarla nella sua ultima battaglia contro il
Cristianesimo. L'imperatore Graziano, completamente dominato da
Ambrogio, sulla fine del quarto secolo ordinò la chiusura e la confisca di
tutti i templi dedicati agli dèi e la rimozione dal Senato della statua della
Vittoria che Augusto vi aveva istallato. Simmaco si oppose con un discorso
degno del miglior Cicerone, e fu bandito da Graziano. Morto costui e
succedutogli Valentiniano II, Simmaco riprese la sua battaglia oratoria e
l'avrebbe vinta sull'animo del nuovo giovane Imperatore, se Ambrogio non
fosse intervenuto con la sua foga abituale. Il Vescovo di Milano trionfò
perché aveva dalla sua la Fede. Simmaco non aveva che la ragione.
Le sue "lettere" sono una limpida, ma parziale descrizione della Roma dei
suoi tempi, dal punto di vista dei ricchi privilegiati, che ancora vi
mantengono posizioni di rilievo, sia pure soltanto decorative. Quella che
non lo è più sul piano politico, è ancora però la capitale intellettuale
dell'Occidente, dove chiunque voglia parlare al mondo civile è costretto a
venire per impararne la lingua e i costumi e per trovare gli strumenti di
diffusione. Nei palazzi si sono accumulati libri e oggetti d'arte. Vi sono
tappeti che costano fino a duecento milioni di lire. Battaglioni di cuochi
preparano pranzi sontuosi. E dalle conversazioni è bandita ogni parola che
non sia del più classico latino. Questa società non è chiusa. Accoglie tutti
coloro, indigeni o forestieri, che in qualche modo fanno spicco, ma
gl'impone la sua etichetta. Le ambizioni sono più intellettuali che politiche.
Tuttavia la dedizione al bene pubblico è ancora grande. Questa classe dirigente, lungi dal trarre profitti dalle sue cariche amministrative e
diplomatiche (di quelle militari ha perso perfino il ricordo), se le mantiene
finanziando di tasca propria circhi e teatri. È un ceto signorile, di altissima
civiltà, che non ruba più perché i suoi avi hanno già rubato abbastanza, e
alla cui porta tutti i forestieri, barbari o meno, fanno ressa per esservi
accolti.
C'è senza dubbio del vero, in questo attraente ritratto, ma visto da una
parte sola. L'altra ce la fornisce un cristiano, anzi un prete di Marsiglia,
Salviano, nel suo libro II governo di Dio, di cui Agostino ebbe probabilmente conoscenza. Salviano non vede che oppressione, corruzione e
immoralità, a differenza di quanto avviene nelle società barbariche, rozze
ma cementate dallo spirito di sacrificio, da un sentimento di solidarietà e di
fratellanza e dalla legge dell'onore. "Roma muore e ride" dice questo
puritano che non l'ama e che forse ha letto un po' troppo Tacito. Ma anche
nella sua descrizione del vero c'è.
La città aveva in quel momento meno di duecentomila abitanti, fra i quali
i Romani di razza dovevano contarsi, al massimo, a centinaia. Dai tempi di
Cesare essa era una metropoli in prevalenza orientale, che si era abituata a
vivere parassitariamente alle spalle delle province romanizzate. A parte una
cartiera e una fabbrica di coloranti, le sue uniche industrie erano la politica e
il saccheggio. Quest'ultimo aveva riempito il suo tesoro pubblico e quelli
privati, come nel secolo decimonono il saccheggio coloniale avrebbe
fruttato la ricchezza dell'Inghilterra. Ma esso era finito da un pezzo, ormai:
da quando Costantinopoli bloccava i mercati orientali e le invasioni barbare
avevano paralizzato quelli occidentali.
Da allora sempre più Roma aveva dovuto contare solo sulla Penisola. Ma
neanche qui le cose procedevano bene. La popolazione complessiva non
superava i cinque milioni. Ma ai guai della decadenza demografica
dovevano aggiungersi quelli del declino della classe media. Dai Gracchi in
poi Roma aveva sempre lottato per ricostruire o puntellare quella società
contadina di coltivatori diretti che davano i migliori soldati all'esercito e i
migliori funzionari all'amministrazione. Ma il sistema fiscale del basso Impero l'aveva definitivamente rovinata. La Tributaria era talmente corrotta e
prevaricatrice che, stando a Salviano, per la prima volta, nel terzo secolo, si
videro dei cittadini romani fuggire, per sottrarvisi, oltre la "cortina di ferro"
del limes, e rifugiarsi presso i barbari. L'imperatore Valentiniano I ne fu così
colpito che istituì una nuova professione: quella dei "Difensori della Città"
cui erano affidati i reclami contro il fisco. Ma nessun rimedio di legge è
valido quando il costume si corrompe. I memorialisti del tempo hanno
lasciato scritto che coloro che vivevano sulle tasse erano più numerosi di coloro che dovevano pagarle. Ed era la conseguenza di due fenomeni
ugualmente deleteri e che si sviluppano sempre di pari passo: da una parte il
proliferare della burocrazia, dall'altra l'assottigliamento dei contribuenti. I
quali, incapaci di far fronte al fisco, sempre più vendevano il podere o la
piccola fattoria al latifondista, facendosene assumere in qualità di coloni,
cioè pressappoco di servi della gleba.
Fu questo il vero inizio del Medioevo, almeno dal punto di vista sociale, e
cominciò a verificarsi prima dell'arrivo dei barbari. Da quando le guerre di
conquista erano finite, era cessato anche l'afflusso di schiavi. E quindi i
grandi proprietari erano ben contenti di assoldare come contadini quelli
piccoli, dopo averne ricomprato le terre. Costoro, dal canto proprio,
cercavano un padrone: non solo per sottrarsi alla Tributaria, ma anche per
avere in lui un protettore nello scompiglio che si andava accentuando.
Il grande feudatario, che sin qui aveva vissuto un po' nel suo palazzo a
Roma, un po' nella sua villa in campagna, comincia a cambiare fisionomia, e
si trasforma nel potente, che è già l'inizio del Feudalesimo. La villa, che
finora tirava soltanto al comodo e al bello perché alla sua protezione
accudivano i Prefetti e i Generali con le loro forze di polizia, adesso cerca
anche la sicurezza, e si trasforma piano piano in castello, cioè in fortilizio,
perché lo Stato non è più sempre in grado di difenderla dai briganti che
infestano le contrade e dai "federati" che cominciano a calarvi e che con essi
spesso si confondono. Quello che invece non cambia è il rapporto umano fra
il padrone e il colono, che si è a poco a poco sostituito allo schiavo ma che il
padrone seguita a trattare come tale.
Questa è una delle ragioni per cui il Feudalesimo, fenomeno tipicamente
germanico, in Italia attecchì prima che altrove, ma vi ebbe anche la vita più
corta. I barbari, che non si erano allenati al comando sugli schiavi, avevano
del vassallaggio un'idea molto più umana dei Romani, perché lo
esercitavano sui loro fratelli, e quindi con molte limitazioni e garanzie. I
Romani invece si erano sempre riconosciuti il diritto di disporre della vita
dei loro dipendenti, e vi avevano contratto una specie di vizio mentale.
Paolino di Pella si congratulava della propria moralità scrivendo, in questi
tempi, di essersi sempre contentato, quanto a concubine, delle serve: il che
costituiva, secondo lui, solo l'esercizio d'un diritto.
In questo contado scarsamente popolato da una plebe di mezzadri e di
braccianti senz'altra protezione che quella graziosamente concessa dai
potenti, solo costoro vivevano agiatamente, perché quasi tutto il reddito
veniva rastrellato a Roma. Ma anche qui ci si guardava dal distribuirlo
equamente. Mentre Simmaco iscriveva nel suo registro dei conti la spesa di
oltre cinquecento milioni di lire per uno spettacolo nel Circo, dove trenta
gladiatori sassoni preferivano strangolarsi ciascuno con le proprie mani
piuttosto che sbudellarsi l'uno con l'altro, un vasto proletariato viveva solo
di sussidi, di elemosine e di piccoli intrallazzi, approfittando di ogni
disordine per dedicarsi al saccheggio di banche e negozi.
Ad Ammiano Marcellino, che vi giunse sulla fine del quarto secolo da
Antiochia, Roma fece l'impressione di una città piacevole e corrotta, dove la
raffinatezza e la crudeltà, l'intelligenza e il cinismo, il lusso e la miseria, la
tradizione e l'anarchia si mescolavano in dosi ugualmente robuste.
Ammiano scriveva in un latino un po' imparaticcio. Ma era un imparziale
galantuomo, a cui il paganesimo non impedì per esempio di condannare
Giuliano l'Apostata per i suoi tentativi contro le libertà cristiane. E al suo
giudizio ci crediamo, anche perché conferma sia il ritratto in rosa di Simmaco che quello in nero di Salviano. Le due Rome, quella splendida dei
pochi e quella miserabile dei molti, convivevano. E si capisce com'essa
potesse apparire diversa secondo gli occhi che la guardavano. Altri due
cronisti forestieri, Macrobio e Claudiano, non videro che la prima, forse
perché ebbero la ventura di essere accolti nella buona società. Ma le loro descrizioni puzzano di omaggio.
Anch'essi tuttavia ci aiutano a capire come mai Roma accettasse con tanta
facilità la sua spoliazione del titolo di Capitale d'Impero. Tutte le decadenze
in tutti i luoghi e in tutti i tempi sono contrassegnate dai medesimi fenomeni: le accresciute distanze sociali fra un numero sempre più piccolo di
privilegiati e una massa sempre più grande di derelitti, l'affievolimento di
ogni vincolo di solidarietà, e la totale indifferenza di tutti agl'interessi della
comunità.
Nei salotti della ricca Roma quasi tutta pagana, si parlava di Cicerone e di
Catullo, si citava Aristotele, si corbellavano i Generali barbari, le loro rozze
maniere, i loro errori di pronunzia e di ortografia. Nei "bassi" della povera
Roma cristiana ci si arrangiava come si poteva e si era troppo impegnati a
metter d'accordo il desinare con la cena per potersi preoccupare dell'Impero,
dello Stato, del Passato e del Futuro. Che un lanzichenecco tedesco
cresciuto alla corte di Attila, come Odoacre, avesse rispedito le aquile e i
fasci a Costantinopoli e stesse governando l'Italia come un Re indipendente,
non interessava più a nessuno.
A intendere e ad esprimere in tutta la sua grandezza e tragicità questa
catastrofe ci fu solo un poeta. Ma non era romano, e nemmeno italiano. Era
un gallo nativo forse di Tolosa, forse di Narbona, si chiamava Rutilio
Namaziano, veniva dalla carriera amministrativa, ed era stato prefetto in
Toscana e in Umbria. Prima di tornarsene in patria sotto l'incalzare delle
invasioni visigote e vandale, volle pagare il suo debito di gratitudine a
Roma, che aveva fatto di lui un uomo civile e colto, dedicandole
un'apostrofe che dimostra quanto quella civiltà e cultura egli le avesse
assimilate. Forse il suo libro De reditu è l'ultimo capolavoro della latinità
classica. Comunque, lo è certamente l'addio all'Urbe che vi è incluso:
Ascolta, regina bellissima di un mondo che hai fatto tuo,
o Roma, accolta negli stellati cieli, ascolta, madre di uomini e di dei.
Non lontani dal cielo siamo noi quando ci troviamo nei tuoi templi...
Tu spargi i tuoi doni eguali ai raggi del sole
per ovunque in cerchio fluttua l'Oceano...
Non ti fermarono le sabbie infocate di Libia,
non l'estrema terra armata di ghiaccio ti respinse...
Facesti una patria sola di genti diverse,
giovò a chi era senza leggi diventar tuo tributario
poiché tu trasformavi gli uomini in cittadini
e una città facesti di ciò che prima non era che un globo.
Non si poteva dire di più, né meglio. Questo barbaro dal cuore
traboccante di affetto, di riconoscenza e di ammirazione, aveva composto
per Roma il più bell'epitaffio in un latino degno di Virgilio. Ma i Romani
non lo lessero. E ancor oggi il nome di Namaziano è noto solo a pochi
studiosi.
© 1959 Rizzoli Editore, Milano
© 1994 RCS Libri S.p.A., Milano sulla collana STORIA d’ ITALIA
© 2001 RCS Collezionabili S.p.A., Milano sulla presente edizione
STORIA D’ITALIA
Pubblicazione periodica settimanale
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 197 del 9.4.1994
Direttore responsabile; Gianni Vallardi
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa
n. 00262 vol. III Foglio 489 del 20.9.1982
SOMMARIO
Cronologia
Capitolo Primo
Teodorico
Capitolo Secondo
L’Italia gotica
Capitolo Terzo
Lo sfacelo
Capitolo Quarto
Bisanzio
Capitolo Quinto
Giustiniano
Capitolo Sesto
La riconquista dell’Italia
Capitolo Settimo
I Longobardi
Capitolo Ottavo
Gregorio Magno
Capitolo Nono
Rotari
Capitolo Decimo
La Chiesa e le eresie
Capitolo Undicesimo
I Padri della Chiesa
Capitolo Dodicesimo
San Benedetto
Capitolo Tredicesimo
Fra Roma e Bisanzio
Capitolo Quattordicesimo
I Franchi
Capitolo Quindicesimo
Pipino in Italia
Capitolo Sedices1mo
L’imbroglio delle donazioni
Capitolo Diciassettesimo
La fine dei Longobardi
CRONOLOGIA
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
V sec. Si diffonde il monachesimo, già attivo
nel secolo precedente (Sant'Antonio, 250356 ca., primo anacoreta; San Pacomio,
IV sec., iniziatore del cenobitismo).
480 Nasce a Norcia San Benedetto.
I Goti e Teodorico
529
Fondazione
Montecassino.
453 Alla morte di Attila, gli Ostrogoti si
stanziano in Pannonia.
L'Italia dei Goti
458 Teodemiro, re degli 0strogoti, devasta
l'Illiria. Il figlio Teodorico è dato in
ostaggio all'imperatore Leone, a Bisanzio.
470 Teodorico ritorna in Pannonia e diviene
capo degli Ostrogoti.
474 Invade la Macedonia.
478 Conduce gli Ostrogoti in Scizia, sulle
rive del Mar Nero.
del
Monastero
di
V-VI secc. L'Italia gotica è divisa in 17
province governate da Presidi, dipendenti
dal Prefetto del Pretorio, responsabile
davanti al re. Le province di frontiera
sono affidate ai Conti. A Roma continua
ad operare il Senato e tutti gli anni sono
ancora nominati i Consoli, che danno
all'anno il loro nome; ma il potere è nelle
mani del Prefetto dell'Urbe, alle dipendenze dirette del re.
484 È nominato console.
486 Invade la Tracia e assedia Bisanzio. Ma
dall'imperatore Zenone è sollecitato a
invadere l'Italia.
488 Da inizio alla campagna d'Italia contro
Odoacre.
489 Sbaraglia i Gepidi: 28 agosto, vince
l'esercito di Odoacre sull'Isonzo. 30
settembre, batte nuovamente, vicino a
Verona, Odoacre, che si chiude in
Ravenna.
489-493 Assedia Ravenna. Nel frattempo
scende a Roma e conquista il mezzogiorno d'Italia.
VI sec. Opera a Pavia Magno Felice Ennodio,
vescovo
e
santo,
autore
dell'Eucharisticum (un'autobiografia) e di
297 Epistole, fonte storica importante per
il periodo di Teodorico.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
493 5 marzo, cade Ravenna, Odoacre è
ucciso. Teodorico è re d'Italia.
493-524 Teodorico svolge una politica di
equilibrio e di accordo tra Ostrogoti e
Romani: 522, nomina primo ministro il
romano Severino Boezio.
524
L'imperatore
di
Costantinopoli
(Giustiniano) emana un editto contro gli
eretici che el de gravemente gli interessi
dei Goti (ariani). Teodorico impone al
papa Giovanni di recarsi a Costantinopoli.
Processo, condanna e morte a Pavia di
Severino Boezio.
526 Morte di papa Giovanni: 30 agosto,
morte di Teodorico. La figlia Amalasunta
reggente in nome del figlio-letto
Atalarico.
534 Muore Atalarico e Amalasunta associa al
trono il cugino Teodato.
500 Teodorico emana un Editto in 144
articoli, che regola la vita militare e civile
del regno.
Per suo ordine, il Prefetto del Pretorio
Liberio realizza una vasta riforma agraria
che assegna ai Romani i due terzi del
suolo e ai Goti un terzo. In questi anni i
Goti da soldati si trasformano in coloni.
Teodorico restaura a Roma il Teatro di
Marcello ed emana leggi contro il vezzo
dei Romani di utilizzare come materiale
da costruzione gli antichi monumenti in
rovina. A Ravenna, Teodorico fa innalzare la basilica di S. Apollinare Nuovo
e il suo Mausoleo.
Amalasunta fa costruire la Basilica di San
Vitale.
524 Simmaco, Prefetto dell'Urbe e Presidente
del Senato, viene ucciso per ordine di
Teodorico. Lascia una Storia di Roma in 7
libri.
Il 23 ottobre viene giustiziato a Pavia
Severino Boezio, già Primo Ministro di
Teodorico dal 522 al 523. Lascia una
traduzione
latina
dell'Organon
di
Aristotele e la Consolatio philosophiae,
scritta in carcere.
535 Morte di Amalasunta.
549 A Ravenna viene consacrata la basilica
di Sant'Apollinaire in Classe.
573 Muore lo storico Cassiodoro, calabrese,
autore di una Storia dei Goti perduta, del
Chronicon e delle Variae.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
Giustiniano
Bisanzio
482 Nasce in Macedonia.
VI sec. Bisanzio, con oltre un milione di
abitanti, è la più grande metropoli del Mediterraneo, centro politico, culturale ed
economico (lavorazione della lana e della
seta, monopolio di Stato). La seguono, per
importanza, Cartagine, Alessandria e
Antiochia.
Grande importanza, a Bisanzio, dell'attività
ludica dell'ippodromo (corse con le bighe,
fazioni dei Verdi e degli Azzurri).
In questi anni Giustiniano fa innalzare
dall'architetto Antemio di Traile la chiesa
di Santa Sofia.
La lingua ufficiale, fino a Giustiniano, è il
latino, poi sarà il greco.
520 Suo zio Giustino, divenuto imperatore di
Costantinopoli,
nomina
Giustiniano
console.
527 Giustiniano succede a Giustino e sposa
Teodora.
532 Ribellione di Bisanzio, sedata da
Belisario.
534 Giustiniano invia Belisario contro i
Vandali del Nord-Africa. Conquista bizantina dell'Africa settentrionale, della
Sardegna, della Corsica e delle Baleari.
535 Belisario da inizio in Italia alla guerra
contro i Goti. Teodato è deposto e
sostituito con Vitige. Belis ario a Roma.
536 Arrivo di Narsete e suo breve soggiorno
in Italia. Belisario a Ravenna. Suo richiamo a Bisanzio. Totila nuovo re dei
Goti.
552 La guerra contro i Goti è portata a
termine da Narsete.
553 I Goti, sotto il re Teia, vengono
definitivamente dispersi da Narsete in
Campania.
553-568 Narsete esarca d'Italia.
554 Giustiniano accorda ai vescovi italiani
larghe autonomie.
528 Giustiniano da inizio alla riforma dei
codici.
529 È pubblicato il Codex constitutionum.
533 Corpus iuris civilis (Pan-dectae e
Institutiones). In questi anni si rendono famosi i monaci:
San Niceforo, eremita; San Daniele, stilita;
San Teodoro Siceota; San Basilio Minore.
Opera lo storico Procopio di Cesarea,
segretario del generale Belisario e autore
di una Storia delle guerre e della Storia
segreta,
dura
requisitoria
contro
Giustiniano e Teodora. Nelle sue Storie
sono descritte le spaventose condizioni
dell'Italia durante la guerra gotica: la
popolazione ridotta a non più di quattro
milioni di abitanti, Roma, intorno al 556,
con non più di quarantamila anime.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
565 Morte di Giustiniano. Gli succede il
nipote Giustino II.
568 Giustino II richiama dall'Italia Narsete
e lo sostituisce col prefetto Longino.
726 Editto di Leone III Isaurico, imperatore
di Costantinopoli, contro il culto delle
immagini.
I Longobardi
III
sec. a.C. ca. Dalla Scandinavia i
Longobardi passano nel continente,
risalgono il corso dell'Elba e si fermano
lungo le coste ungheresi del Danubio.
568 Calano in Italia i Longobardi guidati da
Alboino. Prendono Vìcenza e Verona,
mentre Longino è chiuso in Ravenna.
VI sec. d.C. I Longobardi sono stanziati in
Pannonia, e raggiungono una certa unità
politica sotto Alboino.
569 Conquistano la Liguria. Capitola Milano
e Alboino diventa Signore d'Italia. La
penisola è devastata da una terribile
pestilenza.
572 I Longobardi occupano la Toscana,
Spoleto e Benevento.
572 Occupano Pavia che diviene la capitale
del regno. Muore Alboino nella congiura
ordita dalla moglie Rosmunda, che fugge
coll'amante Elmechi da Longino, a
Ravenna. Loro morte. Cleti, re dei
Longobardi.
574 Clefi muore assassinato. I Duchi
governano indipendenti.
577 A Ravenna Longino
dall'esarca Smarogdo.
è
sostituito
584 I Duchi eleggono a Pavia re Autari.
Grandi alluvioni devastano l'Italia.
590 Autari sposa Teodolinda.
È eletto papa Gregorio Magno (540-604).
597 Muore Autari. Teodolinda si associa al
trono Agilulfo.
593 Agilulfo devasta l'Italia e marcia su
Roma. Scende a patti con Gregorio.
599 L'Italia è stabilmente divisa nelle tre
sfere di influenza longobarda, bizantina e
romana.
590-604 Anni del pontificato di Gregorio
Magno. Riforma della liturgia. Inizio effettivo del potere temporale del papato in
Roma. Gregorio compone i Canti gregoriani, lascia un Epistolario di 14 libri e
una raccolta di Miracoli.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
603 Conversione
Cattolicesimo.
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
dei
Longobardi
al
604 Morte di Gregorio Magno.
616 Morte di Agilulfo. Teodolinda regina e
tutrice del figlioletto Adoloaldo.
625
Morte di Adoloaldo. Diviene re
Arioaldo.
628 Morte di Teodolinda.
A Monza, la regina Teodolinda fa
costruire la basilica di San Giovanni Battista,
che custodisce la corona ferrea dei re
longobardi.
636-652 Regno di re Rotari.
652-712 Si succedono al trono di Pavia
diversi re, tra cui Rodoaldo, Ariperto,
Grimoal-do,
Pertanto
(persecuzione
contro gli Ebrei, 67/) e finalmente
Liutprando.
643 Re Rotari emana l'Editto che regola i
rapporti politici e civili dei Longobardi e tra
Longobardi e Latini.
662 Tentativo fallito di Costante II,
imperatore di Bisanzio, di ricostituire
l'impero di Occidente.
712-744 Regno di Liutprando.
728 Donazione di Sutri.
730 c..a. Re Liutprando perfeziona e
arricchisce l’Editto di Rotari e restaura la
zecca di Pavia che conia il soldo e la fremisse
d'oro.
720-799 Opera lo storico longobardo
Paolo Diacono, autore della Historia Longobardorum.
757 Sotto papa Stefano è confezionata la
falsa Donazione di Costantino, che sarà
confutata da Lorenzo Valla nel 1440.
I Franchi
481 Clodoveo, re dei Franchi.
496 Battesimo di Clodoveo.
511 Sua morte. Il regno dei Franchi si
estende dall'Atlantico al Reno.
539 Prima incursione dei Franchi in Italia.
576 e 590 Due altre incursioni di Franchi in
Italia respinte dai Longobardi.
613 Dopo un periodo di discordie interne,
Clotario riunifica il regno dei Franchi.
EVENTI POLITICI
E MILITARI
EVENTI CIVILI,
CULTURALI E ARTISTICI
VII sec. I re franchi sono esautorati dai
Maestri di Palazzo (periodo dei re fannulloni).
622 II Maestro di Palazzo Pipino da
origine alla dinastia dei Pipinidi. Il più importante è Carlo Martello che nel 732, nella
famosa battaglia di Poitiers, sconfigge i Mori
e li ricaccia in Spagna.
741 Morte di Carlo Martello. Gli
succedono i figli Car-lomanno e Pipino il
Breve,
751 Pipino il Breve unico re dei Franchi.
768 Muore Pipino. Gli succedono i figli
Carlomagno e Carlomanno.
771 Muore Carlomanno. Carlomagno
unico re dei Franchi.
Ultime vicende dei Longobardi
744 A Pavia è eletto re Rachis.
749 Gli succede Astolfo.
751 Astolfo conquista Ravenna e pone fine
all'ingerenza bizantina nella penisola.
753 Papa Stefano invoca aiuto da Pipino
contro i Longobardi.
Pipino scende in Italia, batte Astolfo a Pavia.
756 Morte di Astolfo. Viene eletto re
Desiderio.
770 Matrimonio tra Carlo Magno
Ermengarda, figlia di Desiderio.
e
777 Carlo Magno ripudia Ermengarda.
772 Viene eletto papa Adriano I.
La vedova di Carlomanno, Gerberga, chiede
asilo a Pavia.
I Franchi invadono l’Italia, Adelchi figlio di
Desiderio è battuto sulle Alpi.
773 Assedio di Pavia. Carlo Magno sposa
Ildegarda. Conquista Verona. Adelchi
fugge in Oriente.
774 Cade Pavia. Desiderio è fatto
prigioniero. Termina il regno longobardo.
770-840
Opera lo storico franco
Eginardo, autore di una Vita Karoli, biografia
di Carlomagno
CAPITOLO PRIMO
TEODORICO
QUANDO, alla morte di Attila, l’orda unna si era disgregata e i popoli vinti
che in essa erano confluiti tornarono liberi, gli Ostrogoti chiesero e
ottennero da Bisanzio il permesso di stanziarsi in Pannonia, che
corrispondeva alla parte occidentale della moderna Ungheria. Il loro Re,
Teodemiro, era un uomo inquieto e ambizioso. Nel 458 invase l’Illiria e la
devastò. L’imperatore Leone lo fermò in tempo con una grossa somma di
denaro prima che traboccasse in Tracia. Greci e Goti fecero la pace, e si
scambiarono - come d’uso - gli ostaggi.
Fra costoro c’era anche il figlio del Re. Si chiamava Teodorico - che
significava “capo-popolo” -, aveva sette anni, era un bel bambino biondo
con due grandi occhi celesti. La madre Erelieva era stata una concubina di
Teodemiro che l’aveva conosciuta nell’accampamento di Attila. Il piccolo
Teodorico era cresciuto in mezzo ai guerrieri goti. Sapeva cavalcare, aveva
imparato a manovrare l’arco ed era un buon cacciatore. La spada era il suo
balocco preferito. Dormiva, come il padre, sotto la tenda, accanto al suo
cavallo, al centro del Ring. Qui, nelle tiepide notti d’estate, i cantastorie gli
narravano le antiche saghe nordiche e gli leggevano la Bibbia, quella
tradotta dal saggio Ulfila. Il giorno della partenza per Costantinopoli,
Teodemiro gli donò il suo pugnale, e una scorta di Goti l’accompagnò fin
sul Bosforo.
Teodorico era sempre vissuto nella prateria tra i carri, le greggi e i cavalli
e non aveva mai visto una città. Bisanzio era la più grande metropoli del
mondo. Aveva quasi un milione d’abitanti e ospitava una corte favolosa.
Teodorico restò abbagliato dalla profusione di ori e di marmi e
dall’abbondanza di tappeti e di arazzi. L’imperatore Leone lo ricevette nella
sala della corona, appollaiato su un trono spropositato, sotto un baldacchino
di damasco dal quale pendevano due uccelli meccanici. Era un uomo
piccolo, calvo, privo d’ingegno, balbuziente, un po’ zoppo e pieno di
piccole manie. Viveva nel terrore di essere detronizzato e di notte si
chiudeva a chiave in camera da letto per paura che qualcuno lo uccidesse nel
sonno. Il principino goto, giunto al suo cospetto, s’inchinò, ma lo fece così
maldestramente che scivolò. Per sostenersi s’aggrappò al piede del sovrano
che spenzolava nel vuoto e per poco non tirò Leone giù dal trono.
L’Imperatore ne fu divertito e prese a benvolere il ragazzo. Lo alloggiò a
corte e gli assegnò un bell’appartamento al primo piano del palazzo sacro, le
cui finestre s’affacciavano sul Bosforo. Poi chiamò due servi e ordinò di
preparare un bagno caldo per il piccolo ospite. Teodorico fu calato in una
vasca di marmo, schiumante di sapone, e accuratamente lavato. Un
parrucchiere gli tagliò i capelli biondi e riccioluti che gli scendevano sulle
spalle, e lo cosparse di profumi. Poi, con una tunica azzurra stretta alla vita
da una cinturina di marocchino con una fibbia d’oro e un paio di pantofole
di porpora, fu condotto a scuola.
A Bisanzio c’erano molti collegi, ma uno eccelleva sugli altri: era
qualcosa come Eton o Harrow oggi in Inghilterra. Lo frequentavano i figli
dei ricchi e dei nobili, e i rampolli dei satrapi stranieri. Teodorico vi compì
tutti i suoi studi, al termine dei quali rimase un analfabeta con qualche
nozione di algebra, di astronomia e di galateo. Quando compì quindici anni
fece il suo debutto in società. Era un gran bel ragazzo forte, fiero e sicuro di
sé. Parlava correntemente il greco, masticava un po’ di latino e non aveva
dimenticato il gotico. Era educato e galante, nei salotti le signore se lo
contendevano, l’Imperatore lo invitava a pranzo e lo faceva servire per
primo. Teodorico era ghiotto di lenticchie, aglio e cinghiale. Gli piaceva il
vino ma non si alzava mai da tavola ubriaco. Dopo cena, di solito, andava in
qualche locale notturno a fare un po’ di baldoria con gli amici. La domenica
assisteva all’ippodromo alle corse dei cocchi. Aveva uno scanno riservato
nella tribuna d’onore accanto a quello di Leone, ma preferiva mescolarsi col
popolino sugli spalti ed era amico dei fantini. Qualche volta, durante gli
allenamenti, scendeva anche lui in lizza. Passava l’estate in allegra
compagnia in una villa che aveva preso in affitto sul Bosforo. Era un
nuotatore formidabile e di una resistenza a tutta prova.
Nel 470 - ma la data è incerta - tornò in Pannonia. Aveva diciotto anni ed
era ormai un uomo fatto. Di statura superiore alla media, aveva una testa
grossa e rotonda, una fronte spaziosa, un bel naso aquilino e due sopraccigli
folti e cespugliosi che gli coprivano le palpebre, le orecchie spanse e
vibratili come radar. La bocca, ai cui angoli spiovevano un paio di poderosi
baffi biondi, mostrava una superba dentatura che faceva risaltare le labbra
esangui e sottili. Le narici erano così irte di peli che ogni mattina un
barbiere, munito di uno speciale rasoio, doveva sfoltirle per facilitargli la
respirazione. Un petto villoso e gladiatorio sosteneva il collo taurino. Le
gambe, diritte e muscolose, poggiavano su due piedi corti e affusolati.
Teodemiro quando lo rivide non lo riconobbe. Teodorico trovò il padre
molto invecchiato e un po’ rimbambito. Erano stati lontani dieci anni e non
si erano scambiati che pochi messaggi.
La Pannonia era allora minacciata dai Sarmati che avevano invaso la
Mesia e premevano sui suoi confini. All’insaputa del padre, Teodorico arruolò seimila uomini, passò il Danubio, si avventò sul nemico e lo sterminò.
Tagliò la testa al re Badai, la conficcò in cima a una picca e con questo
trofeo tornò in Pannonia. Poco tempo dopo fu incoronato Re.
La Pannonia era diventata troppo stretta per i Goti, i quali avevano
continuamente bisogno di spazio. Nomadi e pastori, vivevano di pascoli e di
saccheggio e la vita sedentaria li affamava. Bisanzio in quel momento aveva
ammassato gli eserciti sui confini orientali lasciando aperte, anzi spalancate,
le porte della Macedonia. Attraverso queste porte, con tutto il suo popolo,
Teodorico si accinse a passare. Colse di sorpresa le resistenze greche e le
travolse. Il nuovo imperatore Zenone, succeduto nel 474 a Leone, chiese la
pace; e i Goti, in cambio della Macedonia, dove si stanziarono, deposero le
armi. Nel 478 però le ripresero e si trasferirono in Scizia, sulle rive del Mar
Nero.
Per Bisanzio, il Re goto era diventato un inquilino scomodo e
imprevedibile. Nel 484 l’Imperatore lo nominò Console. S’illudeva con gli
onori d’amicarselo. Teodorico indossò la toga, e due anni dopo, per tutto
ringraziamento, invase la Tracia e cinse d’assedio - ma senza fortuna - la
stessa Bisanzio. La Scizia evidentemente non era stata la terra promessa che
egli aveva sperato. Zenone allora l’invitò ad occupare l’Italia.
La Penisola era di fatto diventata un Regno indipendente anche se
Odoacre la governava in nome di Costantinopoli. Lo storico greco Procopio
riferisce che Teodorico accettò con entusiasmo la proposta che in realtà
mirava più a liberare i Balcani dai Goti che a riconquistare un Paese sul
quale l’Imperatore non esercitava più alcun controllo.
La lunga marcia di Teodorico ebbe inizio nel tardo autunno del 488. Era
un intero popolo che migrava: donne, vecchi, bambini, carri, capre,
masserizie. Duecentocinquantamila Goti, di cui solo cinquantamila in
assetto di guerra e alcune centinaia di mercenari greci in cerca di avventure
muovevano verso Occidente lungo l’antica rotta danubiana, attraverso le
strade che Roma aveva costruito e gli Unni non avevano fatto in tempo a
distruggere. Per i primi cinquecento chilometri non fu che una lunga
passeggiata. Poi cominciò l’anabasi, quando i Goti giunsero ai confini della
Dacia dove erano acquartierati i loro cugini Gepidi. Teodorico chiese il
diritto di passaggio sul loro territorio ma ebbe un rifiuto. I Gepidi furono
attaccati nei loro accampamenti e sbaragliati. I Goti arruolarono nell’orda i
pochi superstiti dopo aver trucidato i vecchi e gli invalidi, e ripresero il
cammino verso Nord-Ovest. Nell’agosto dell’anno successivo valicarono le
Alpi Giulie e calarono in Italia.
Odoacre non era rimasto con le mani in mano. Aveva mobilitato l’esercito
e l’aveva concentrato sulle rive dell’Isonzo dove aveva scavato trincee e
eretto fortificazioni. Il 28 agosto, i Goti si scontrarono con le bande di
Odoacre e le sconfissero. Il 30 settembre i due eserciti si affrontarono di
nuovo a Verona. Prima della battaglia Teodorico, ch’era assai superstizioso,
volle indossare un mantello di seta che la madre e la sorella gli avevano
confezionato durante la lunga marcia. Ancora una volta Odoacre fu battuto
e volto in fuga. Cercò scampo a Roma ma i Quiriti, che lo detestavano, gli
chiusero la porta in faccia. Allora ripiegò su Ravenna, dopo aver devastato il
Lazio e decimato i suoi abitanti.
Il Re goto non l’inseguì, ma puntò su Milano dove le retrovie nemiche
avevano cercato riparo, e la occupò. I seguaci di Odoacre furono fatti
prigionieri. Il generale che li comandava, un erulo di nome Tufa, chiese di
essere arruolato fra i Goti. Teodorico l’accontentò, lo mise alla testa di un
esercito e lo spedì ad assediare Ravenna. Appena vi giunse, divorato dal
rimorso - o dalla paura - Tufa si rimise agli ordini di Odoacre. Migliaia di
Goti furono catturati e uccisi, e le sorti della guerra minacciarono di
rovesciarsi. Teodorico allora abbandonò Milano, e marciò su Ravenna.
Poiché la città era praticamente inespugnabile fece scavare un ampio fossato
intorno alle mura e vi ammassò le truppe. Quindi partì per Roma, dove fu
accolto come un liberatore. Di qui mosse alla conquista del Mezzogiorno
che pacificamente gli si sottomise.
Ai primi del 493, stremata da un assedio che durava da oltre due anni e da
una carestia che aveva ridotto i suoi abitanti a cibarsi di erba e di carne di
cane, Ravenna capitolò. Due giorni dopo fu firmata la pace che il Vescovo
Giovanni benedisse. Odoacre invocò la clemenza di Teodorico e gli
consegnò il proprio figlio Telano in ostaggio. Il 5 marzo il Re goto
attraversò a cavallo la città tra le ovazioni del popolo e del clero. Giovanni
ordinò un Te Deum di ringraziamento e gli andò incontro con la croce e un
codazzo di preti salmodianti. I festeggiamenti si conclusero con un gran
banchetto in onore di Odoacre al termine del quale Teodorico sgozzò il
rivale dopo aver fatto sterminare tutti i suoi familiari. Procopio racconta che
Odoacre fu ucciso perché aveva osato chiedere al Re goto di poter governare
con lui.
La conquista della Penisola era durata in tutto cinque anni: gli eserciti
avevano desolato le campagne, spianato le città, trucidato gli abitanti. Ma
oltre che dalla guerra la popolazione era stata falciata dalle carestie, dalle
pestilenze e dagli immancabili cataclismi naturali. Lo storico Ennodio
racconta che la fame uccideva chi sopravviveva alla spada. Odoacre non
aveva governato né meglio né peggio dei suoi predecessori Non aveva
costruito nulla e nulla aveva distrutto. Aveva conservato l’Italia come
l’aveva trovata: un terra di rapina e di conquista alla mercé di tutti. Con
Teodorico molte cose cambiarono e la situazione migliorò.
CAPITOLO SECONDO
L’ITALIA GOTICA
del 494 la conquista gotica era consolidata. Teodorico
s’istallò a Ravenna. Dei duecentocinquantamila Goti che con lui avevano
intrapreso la lunga marcia non più di duecentomila avevano raggiunto la
terra promessa. Di costoro una parte si era acquartierata nella pianura
padana, un’altra aveva seguito il Re nella città adriatica, una terza era calata
nel Mezzogiorno.
L’insediamento fu lento e difficile. Quello di Teodorico non era un
popolo, ma un’orda di guerrieri, di pecorai e di predoni, refrattari a ogni
forma di vita organizzata. Erano troppo barbari per fondersi coi vinti e
questi troppo marci per assimilarli. Non sarebbe stata una convivenza facile.
Il nuovo Regno comprendeva Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio,
Campania, Lucania, Calabria e Sicilia. Teodorico lasciò inalterata l’antica
fisionomia e la tradizionale nomenclatura amministrativa romana : la
Penisola restò divisa in diciassette province, governate da diciassette
Presidi, ch’erano al tempo stesso giudici, amministratori e intendenti di
finanza. Dipendevano tutti dal Prefetto del Pretorio, o ministro dell’Interno,
che risiedeva a Ravenna e rendeva conto del loro operato al Re. Le province
di frontiera furono affidate ai cosiddetti Conti, generali goti in attività di
servizio segnalatisi durante la guerra contro Odoacre. Costoro disponevano
di un piccolo esercito, facevano vita di guarnigione e vigilavano sui confini.
I loro compiti non erano naturalmente solo militari, ma anche civili e
giudiziari.
A Roma il Senato, ridotto a una larva, seguitò a essere, almeno sulla carta,
il più alto organo rappresentativo. Il Re gli confermò tutti i privilegi di cui in
passato aveva goduto, limitandosi a designarne il Presidente. I Senatori conservarono il diritto di trasmettere la propria carica ai figli, e anche i Consoli
AL PRINCIPIO
salvarono le loro prerogative. Quando venivano eletti potevano affrancare
un certo numero di schiavi e avevano ancora l’obbligo di distribuire grano
alla plebe e farla divertire. Si vestivano come sotto Silla, Cesare e Traiano, e
davano il loro nome all’anno. Ma il vero capo a Roma era il Prefetto
dell’Urbe. Lo nominava Teodorico, di cui era il luogotenente. Dirigeva
l’amministrazione, presiedeva alla giustizia ed esercitava la sua giurisdizione persino sui Senatori. Da lui dipendevano tutti i funzionari
pubblici della città, il cui numero - riferisce lo storico Cassiodoro - sotto
Teodorico subì una drastica riduzione.
Quando nell’anno 500 il Re visitò Roma, fu appunto il Prefetto dell’Urbe
il primo a rendergli omaggio, a capo di una delegazione in cui tutte le alte
cariche dello Stato erano rappresentate. C’erano il Questore, che faceva da
collegamento fra Teodorico e il Senato, il Maestro degli Uffici che
sovrintendeva all’annona e alle poste, il Conte delle Largizioni o Ministro
delle Finanze, che vigilava anche sul commercio, il Conte degli Affari
Privati o Ministro della Corona, che aveva il compito di impedire i matrimoni tra parenti e di dare sepoltura ai morti. Tutti costoro avevano il titolo di
illustri e percepivano uno stipendio mensile di mille soldi, corrispondente a
circa dieci milioni di lire attuali.
Nei suoi non troppo frequenti spostamenti Teodorico si faceva
accompagnare da uno stuolo di scudieri e di ufficiali, i quali erano naturalmente tutti goti. Nelle Variae di Cassiodoro non c’è traccia di un solo
funzionario militare romano. Il capo dell’esercito era il Re che dichiarava la
guerra e ordinava la leva. I Goti mobilitavano in massa e provvedevano
personalmente al proprio equipaggiamento che consisteva in una specie di
corazza leggera, un elmo e uno scudo. L’armatura comprendeva la lancia, la
spada, il giavellotto, il pugnale e le frecce. Si davano di solito convegno in
una provincia di frontiera. Lo Stato passava ai soldati stipendio e
vettovaglie, ma vietava loro il saccheggio, lo stupro e il ratto. I Romani
erano tenuti a procurare alle truppe di passaggio vitto e alloggio. Finita la
guerra, i soldati tornavano alle loro case a coltivare i campi. Così lentamente
i Goti si emanciparono dalla vita nomade, e come gli antichi legionari
romani diventarono agricoltori.
Teodorico trovò la Penisola finanziariamente stremata e le casse dello
Stato vuote. Moltiplicò i balzelli e il numero dei pubblicani, che erano gli
agenti incaricati di riscuoterli. Le imposte erano pesanti e generalmente si
pagavano in natura: olio, vino, grano eccetera. All’erario andava anche il
ricavato della vendita dei minerali e del marmo e la cosiddetta tassa sui
monopoli che colpiva il diritto di commercio in esclusiva. Teodorico aveva
il culto dei monumenti. Restaurò il teatro di Marcello, nominò un sovrintendente alle cloache e istituì una commissione di vigilanza sui
vespasiani. Punì i ladri di statue e gli speculatori di terreni. Emanò una legge
contro la demolizione indiscriminata e arbitraria degli antichi edifìci
pubblici, che era diventato un lucroso passatempo per gli abitanti dell’Urbe.
“Le rovine dell’antica Roma - è stato scritto - ci sono state state lasciate
dagli stessi Romani. “
Nel 500 Teodorico pubblicò un Editto in centoquarantaquattro articoli. La
materia che conteneva e lo spirito che l’uniformava erano romani. Romana
era la giurisprudenza che assegnava a tribunali di guerra la competenza a
giudicare reati militari e a corti civili quella di pronunciare sentenze comuni.
Nominò presidenti dei primi i Conti goti e delle seconde i magistrati romani.
Capitava assai di rado che un cittadino romano comparisse dinanzi a un
giudice goto. Poteva accadere, anzi regolarmente accadeva, quando
scoppiava una controversia fra Goti e Romani. In questo caso i secondi erano giudicati da un Conte assistito da un magistrato romano.
I suoi biografi ci descrivono Teodorico come un uomo giusto. Un giorno
una donna gli presentò un ricorso contro certi giudici che non si decidevano
a dirimere una lite in cui essa era coinvolta. Il Re li convocò e ordinò di
celebrare seduta stante il processo. Pronunciato il verdetto, fece tagliare la
testa ai giudici.
Non avendone di suoi, si servì per governare l’Italia di amministratori
romani. Nominò Prefetto del Pretorio un certo Liberio che aveva ricoperto la
stessa carica sotto Odoacre, al quale sino alla fine era stato fedele. Liberio
coronò la sua carriera come Ministro delle Finanze e legò il suo nome alla
riforma agraria che assegnò due terzi del suolo italiano ai Romani e un terzo
ai Goti, che a giusto titolo lo avevano reclamato essendone ormai gli unici
difensori. Successore di Liberio fu Cassiodoro. Anche lui aveva militato
sotto Odoacre di cui era stato Tesoriere. Aveva poi offerto i suoi servigi a
Teodorico che l’aveva nominato governatore della Lucania. La sua carriera
fu continuata dall’omonimo figlio, il grande storico di questo periodo, che
per quasi quarant’anni fu a capo dell’amministrazione gotica in Italia.
Cassiodoro junior era nato a Squillace in Calabria nel 480. Giovinetto si
era trasferito a Roma dove aveva compiuto studi di grammatica e
ornitologia. Quando il padre fu promosso Prefetto del Pretorio, egli divenne
governatore della Lucania, poi assessore a Roma. In tale veste un giorno gli
capitò di rivolgere un brindisi al Re. Lo fece con tanta grazia che Teodorico
lo nominò prima suo segretario, poi Questore, Patrizio, e nel 514 Console.
Cassiodoro non fu solo un uomo di Stato ma anche un grande storico,.
nonostante l’ampollosità e il tono agiografico dei suoi scritti. In una brutta
“Storia dei Goti”, andata perduta, attribuì a loro un’origine divina e una
lontana parentela con Ercole e Teseo. Compilò anche un sommario di
antichità - il Chronicon - che prendeva lo spunto dalla cacciata di Adamo ed
Eva dal Paradiso Terrestre. La sua opera più famosa però sono le Variae,
una raccolta di lettere e documenti, attraverso i quali possiamo ricostruire il
Regno gotico in Italia. Morì vecchissimo, a novantatre anni, nella sua tenuta
di Squillace, dove si era ritirato ad allevare canarini e a trascrivere le opere
di Virgilio e di Seneca.
Gli altri collaboratori civili di Teodorico, Simmaco e Boezio, erano
entrambi romani. Simmaco discendeva dal console omonimo che sotto Teodosio si era opposto alla rimozione della statua della Vittoria, simbolo
pagano, dall’aula del Senato. Il pronipote si era convertito al cattolicesimo e
ne era diventato un campione. Odoacre l’aveva nominato Console, e
Teodorico l’aveva designato Prefetto dell’Urbe col titolo di Patrizio. Nel
524 era stato eletto Presidente del Senato. Era un uomo colto, probo e
raffinato. Scrisse una Storia di Roma, dotta e retorica, in sette volumi.
Attraverso la figlia, s’imparentò con Boezio, di cui così divenne suocero.
Boezio era nato nel 475 a Roma dove aveva compiuto gli studi che poi
aveva continuato ad Atene sui testi di Euclide, Archimede e Tolomeo.
Tradusse l’Organon di Aristotele che servì da modello a tutta la filosofia
medievale. Scrisse anche un trattato di teologia in cui dimostrò - o cercò di
dimostrare - che la Fede trionfa sulla Ragione. A trent’anni Teodorico lo
nominò Console, poi Maestro degli Uffici e, nel 522, Primo Ministro.
Simmaco e Boezio collaborarono con Teodorico come avevano
collaborato con Odoacre; ma improvvisamente, e in modo clamoroso, nel
523, i loro rapporti col Re si ruppero, quando il referendario Cipriano
accusò il Patrizio Albino di aver spedito all’Imperatore d’Oriente alcune lettere piene di calunnie sul conto del Sovrano. Boezio scagionò Albino e
incolpò Cipriano, il quale a sua volta estese l’accusa a Boezio. Teodorico
deferì quest’ultimo al Senato che si costituì in tribunale speciale. Fu il
processo del secolo, e si concluse con la condanna a morte dell’imputato
riconosciuto reo di tradimento, magia e spiritismo. Boezio fu rinchiuso in
carcere a Pavia e il 23 ottobre del 524 giustiziato. I carnefici gli cinsero la
fronte con una cordicella e la strinsero finché gli occhi non schizzarono
fuori dalle orbite. La stessa sorte toccò a Simmaco, colpevole solo di aver
preso le difese del genero.
Nella cella di Boezio fu rinvenuto un manoscritto che egli aveva composto
durante i lunghi mesi di reclusione, e al quale aveva dato il titolo significativo
di Consolatio philosophiae. L’opera è scritta in un bel latino classico che
riecheggia quello di Seneca, e alcune pagine sono intrise di un accorato
lirismo. La Consolatio fu il best seller del Medioevo. La lesse anche Dante.
Fu tradotta in tutte le lingue. L’elenco completo delle sue edizioni riempie
ben cinquanta pagine del catalogo del British Museum a Londra.
CAPITOLO TERZO
LO SFACELO
LE ACCUSE di Cipriano non erano infondate. A Roma da tempo tirava aria
di fronda. Ma di questa fronda, più che Boezio e Simmaco, l’anima erano il
Pontefice e i Senatori, che trescavano con Bisanzio.
Fino a Odoacre, nel marasma del basso Impero, le province erano state
governate dai Vescovi. Con quello di Pavia, Epifanio, i Goti avevano
trattato la resa della città. Consolidata la conquista e istallatosi a Ravenna,
Teodorico aveva reclutato un corpo di funzionari e li aveva spediti, in
qualità di Presidi, nelle province. La giurisdizione civile aveva sostituito
quella ecclesiastica e il Re, coi suoi Conti, non più il Papa coi suoi Vescovi,
era ora l’arbitro della situazione.
Dapprincipio i rapporti fra lo scettico e tollerante Teodorico e la Chiesa
erano stati cordiali. Quando nel 500 per la seconda volta egli si era recato a
Roma, il Papa Simmaco gli era andato incontro a Monte Mario e l’aveva
accompagnato in trionfo a San Pietro. Il Re ariano aveva pregato sulla
tomba dell’Apostolo, e ai piedi dell’altare aveva deposto due candelabri
d’argento del peso di settanta libbre. Simmaco era stato eletto contro un certo Lorenzo che era il candidato dell’Imperatore d’Oriente. Nel 500 la lite
non si era ancora sopita, e il Pontefice era stato addirittura accusato di
adulterio e peculato. L’anno seguente Teodorico aveva convocato un
concilio in Laterano. Simmaco era stato processato e assolto. Era stata
questa l’unica volta che il Re era intervenuto negli affari della Chiesa, e lo
aveva fatto perché i Vescovi glielo avevano chiesto. Aveva concesso al
clero cattolico la più ampia libertà di culto. Però aveva anche esonerato i
preti da quegli impieghi che erano incompatibili con la dignità del loro ministero, e li aveva tassati e privati di molte immunità di cui in passato
avevano goduto. Aveva sottoposto anche i monaci al pagamento delle
imposte. Ciò fatalmente gli aveva alienato la Chiesa che tramò con Bisanzio
la sua rovina.
Nel 524 l’imperatore Giustino bandì un editto contro gli eretici e i
manichei che li escludeva dalle funzioni civili e militari e riconsacrava le
chiese ariane al rito cattolico. L’ariano Teodorico convocò il Papa Giovanni
a Ravenna e gli ordinò di recarsi a Costantinopoli a chiedere la revoca
dell’editto. Il Pontefice, vecchio e malato, lo scongiurò di mandare qualcun
altro, ma Teodorico fu irremovibile. Allora il Papa, accompagnato da tre exconsoli e da alcuni preti, partì. Durante il viaggio - riferisce il Libro
Pontificale - avvennero numerosi miracoli. Quando Giovanni varcò le mura
di Costantinopoli, un sordomuto lo toccò con un dito e riacquistò l’udito e la
favella. Bisanzio gli tributò grandi accoglienze. Giustiniano andò incontro al
Vescovo di Roma e si inginocchiò ai suoi piedi, imitato dai prelati e dai
dignitari del seguito. Il giorno di Pasqua, sorretto dal Patriarca di
Costantinopoli che gli dava la destra, Giovanni celebrò la messa nella chiesa
di Santa Sofia. Al termine incoronò Giustino Imperatore, quindi lo scongiurò di revocare il bando, ma senza osare di far cenno all’altra pretesa di
Teodorico: che Giustino permettesse a coloro che avevano abiurato
all’arianesimo per abbracciare l’ortodossia, di riconvertirsi all’antica fede.
Al principio del 526, stremato dal lungo viaggio e dalla gotta, Giovanni
tornò in Italia. Dopo lo sbarco fu condotto al cospetto di Teodorico, che
pubblicamente l’accusò di tradimento e lo fece imprigionare. Morì in
carcere il 25 maggio del 526, e la Chiesa lo considerò uno dei suoi martiri.
II Re fece appena in tempo a dargli un successore, che il 30 agosto dello
stesso anno morì. Le fonti ecclesiastiche attribuiscono la sua fine a un
attacco di dissenteria. Anche Ario era stato stroncato dalla diarrea.
Evidentemente, secondo la Chiesa, è questo il destino degli eretici. Narra
Procopio che, dopo la morte di Simmaco, Teodorico fu tormentato dal
rimorso. Un giorno, mentre mangiava, vide il merluzzo che gli era stato
servito su un vassoio d’argento assumere il sembiante, pallido e smunto,
della sua vittima: gli occhi erano sbarrati e iniettati di sangue, in un torvo
rigurgito di vendetta. Il Re fu colto da delirio e trasportato a letto dove, due
giorni dopo, spirò. Più probabilmente Teodorico, che soffriva di disturbi
circolatori, fu vittima di una trombosi. Gregorio Magno, nei suoi Dialoghi,
racconta che fu precipitato nell’Inferno attraverso la bocca di un cratere
situato al centro dell’isola di Lipari.
Quando calò nella tomba, Teodorico aveva settantadue anni. Negli ultimi
tempi era diventato scorbutico, sospettoso e misantropo, ma aveva
conservato le sue vecchie abitudini. Si alzava la mattina all’alba, consumava
un’abbondante colazione a base di frutta fresca e carne arrostita, e faceva
una lunga cavalcata nei boschi. Alle dieci andava a messa. In pubblico era
molto devoto. Poi, accompagnato dal Conte degli armigeri, s’avviava alla
sala del trono. Cominciavano le udienze, che duravano un paio d’ore. A
mezzogiorno compiva un sopralluogo al tesoro, che custodiva in un grande
forziere di cui portava sempre con sé, attaccate alla cintura, le chiavi. Se gli
avanzava un po’ di tempo, visitava le stalle. All’una si metteva a tavola. Gli
piaceva la mensa bene imbandita, i piatti d’argento, le brocche d’oro, le
tovaglie di pizzo. Dopo mangiato, di rado si concedeva una siesta. Preferiva
fare una partita ai dadi con gli amici. Se perdeva si arrabbiava, ma naturalmente i suoi avversari facevano in modo che questa disgrazia gli
capitasse di rado. Alle quattro, fino alle sette, ricominciavano le udienze.
Poi andava in giardino ad annaffiare i fiori che coltivava con molta cura.
Alle otto cenava, in compagnia della moglie, della figlia e di pochi intimi,
circondato da nani e buffoni. Si coricava tardi, dopo essersi fatto leggere dal
segretario un capitolo di Tacito o di Svetonio. Si recava spesso in visita al
mausoleo che si stava costruendo a Ravenna e che era un massiccio edificio
di marmo bianco a due piani circolari concentrici, sormontati da una cupola
monolitica. Esempio di architettura romano-barbarica, esso si è mantenuto
intatto nei secoli e, dopo aver subito alcuni restauri, è stato trasformato in
chiesa. È stato paragonato al Pantheon, ma gli mancano l’imponenza e la
levità del monumento di Agrippa.
Teodorico non fu forse quel grande Re che alcuni storici hanno descritto,
ma certamente fu il primo barbaro che seppe innalzarsi sopra il livello del
capotribù. I suoi Goti portarono in Italia, con le vecchie superstizioni
germaniche e il selvaticume dell’orda, la virtù guerriera, il senso dell’onore,
il culto della donna e un certo spirito avventuroso e cavalleresco. Siccome il
suo popolo era una minoranza, temendo che i Romani lo fagocitassero,
Teodorico cercò di impedire, finché fu in vita, che si mescolasse coi vinti.
Negli ultimi tempi aveva trasferito la sua residenza a Pavia, e fu qui che
in punto di morte convocò al suo capezzale i Conti goti e la figlia
Amalasunta. Il genero Eutarico era calato nella tomba da quattro anni e il
nipote Atalarico era ancora un bambino. Amalasunta fu nominata reggente
in nome del figlio. Era una donna colta, bella e prepotente. Parlava correntemente il latino e il greco, conosceva i classici, ed era imbevuta di filosofia.
I Goti la detestavano perché si sentivano disprezzati da lei che si circondava
di Romani e frequentava i loro salotti. Riabilitò la memoria di Simmaco e di
Boezio, e restituì ai figli i beni confiscati. Aumentò lo stipendio ai maestri di
retorica e fondò nuove scuole. Si riconciliò col Senato e col popolo romano,
e s’impegnò a non violare le leggi dei Quiriti. Affidò il figlio a un precettore
romano perché lo iniziasse al culto di quella civiltà latina, di cui essa era
intrisa. I Goti protestarono. Il Re, per loro, doveva essere un guerriero,
possibilmente analfabeta, come lo era stato Teodorico.
Un giorno Amalasunta rimproverò Atalarico e gli appioppò un ceffone. Il
bambino scoppiò a piangere al cospetto di alcuni Conti goti che obbligarono
la Regina a licenziare il precettore e a consegnare a loro il figlioletto.
Atalarico, sottoposto a strapazzi d’ogni genere, morì a diciotto anni,
consunto dalla tisi. La madre allora si associò al trono il cugino Teodato.
Era figlio di Amalafrida, sorella di Teodorico, aveva vissuto a lungo in
Toscana dove possedeva un castello e vaste tenute. Amalasunta lo
prediligeva perché aveva studiato filosofia a Roma e aveva scritto un saggio
su Platone. Ma sotto la vernice dell’intellettuale, egli covava una smodata
sete di potere. Si era arricchito coi soprusi e la violenza. Amalasunta ebbe a
lamentarsi presto del collega che la detestava e voleva liberarsi di lei. Un bel
giorno decise di fuggire a Bisanzio. Caricò tutti i suoi tesori su un dromone
e si accinse a salpare dal porto di Classe. Troppo tardi. Teodato, informato,
fece occupare la nave dai suoi sbirri. La Regina fu arrestata, condotta sul
lago di Bolsena e rinchiusa in una torre. Sotto minaccia di morte, il cugino
l’obbligò a scrivere una lettera all’imperatore Giustiniano in cui diceva di
aver cambiato idea e di voler restare in Italia. Poi diede ordine di ucciderla.
Amalasunta fu strangolata nel sonno. Correva l’anno 535.
Era l’inizio di una crisi che il Papa e i Senatori romani attendevano con
impazienza. Ne avvertirono subito Costantinopoli, ricordandole che l’Italia,
in linea di diritto, era sempre una provincia dell’Impero anche se di fatto
Teodorico l’aveva governata da padrone assoluto. L’assassinio di
Amalasunta forniva ora un buon pretesto per intervenire nella Penisola
nuovamente disponibile.
Vediamo dunque cos’era questo Impero e chi era colui che in quel
momento l’incarnava.
CAPITOLO QUARTO
BISANZIO
COME ROMA,
la nuova Capitale era stata costruita su sette colli. Costantino
l’aveva scelta per la sua posizione naturale e strategica, estremo bastione
europeo e porta d’ingresso al continente asiatico. Nel VI secolo, col suo
milione d’abitanti, Bisanzio era la più popolosa città del mondo, seguita, ma
a molte lunghezze, da Cartagine in Occidente, e da Alessandria e Antiochia
in Oriente. La vita della Capitale ruotava intorno a tre poli: la Corte,
l’Ippodromo e la chiesa di Santa Sofia.
La Corte era una specie di città nella città, come a Mosca, fin dal tempo
degli Zar, lo è sempre stato il Cremlino. Al centro, circondato da diecine
d’edifici, adibiti a ministeri, e da sontuose ville private, sorgeva il Palazzo
Sacro, residenza ufficiale dell’Imperatore. A un tiro di schioppo, la reggia
dell’Imperatrice era il luogo più misterioso e di più difficile accesso della
metropoli. Nessuno, senza uno speciale permesso, poteva varcarne la soglia,
vigilata giorno e notte da eunuchi armati fino ai denti. Lo stesso Imperatore,
quando si recava a visitare la moglie, doveva farsi annunciare.
Coi suoi sfarzosi vestiboli, coi suoi saloni sfavillanti di ori, marmi e
mosaici, il Palazzo Sacro era il cuore di un Impero che la Provvidenza
sembrava aver destinato a durare in eterno. A sacralizzarlo gli Imperatori vi
avevano ammassato i più preziosi cimeli della Cristianità: il legno della
Croce, la corona di spine e gli scheletri dei Santi e dei Martiri più in voga.
Sant’Elena vi aveva fatto trasportare quello di San Daniele, Leone VI quelli
di Maria Maddalena e di Lazzaro. Niceforo Foca e Giovanni Tzimisces
avevano arricchito la collezione coi capelli di Giovanni Battista e i sandali
di Cristo. Sotto la colonna di Costantino, alla venerazione dei fedeli che
ogni giorno vi affluivano in gran numero, erano esposti i pani del miracolo.
Se tutte queste reliquie fossero autentiche; non si sa. Ma il metterlo in
dubbio era considerato sacrilegio.
La Corte non era soltanto la residenza dell’Imperatore, ma anche il
quartier generale della burocrazia e il centro commerciale più importante
dell’Impero. Entro le sue mura erano chiusi i ministeri e gli uffici pubblici. I
suoi ginecei ospitavano migliaia di donne intese non soltanto a prestazioni
di alcova, ma anche a vere e proprie industrie tessili dove filavano la lana e
la seta che lo Stato importava e lavorava in regime di monopolio.
Commercianti e uomini d’affari erano gli stessi Imperatori. Giovanni
Vatatzes per esempio, vendendo polli, riuscì a guadagnare abbastanza
denaro per comperare all’Imperatrice una corona nuova.
L’Ippodromo, come il Foro nell’antica Roma, era il luogo dove si
svolgevano le corse delle bighe e si ordivano i complotti. Dalle gradinate e
dai popolari, capaci di ospitare fino a quarantamila spettatori, partiva la
scintilla che poteva scatenare la rivoluzione. Gli omicidi, i ratti, le
bastonature erano all’ordine del giorno tra le due fazioni rivali dei “Verdi” e
degli “Azzurri”. Contro il “tifo”, la stessa forza pubblica era impotente. E
impotente era l’Imperatore che, per conservare il trono, doveva assicurare il
regolare svolgimento dei giuochi.
Santa Sofia era il terzo grande centro d’attrazione di Bisanzio, sebbene
nella Capitale vi fossero altre quattrocento chiese. Ideata da Giustiniano e
realizzata dal celebre architetto Antemio di Tralle, era la residenza ufficiale
del Patriarca e il più importante luogo di riunione e di preghiera della
Cristianità orientale.
Chiacchieroni, bigotti e superstiziosi, i Greci amavano pazzamente le
dispute religiose che il clero secolare apertamente fomentava. È difficile
misurare l’influenza che i monaci esercitarono sulla società e sul costume
bizantini. Contesi da Principi e da Imperatori, goderne la fiducia era
considerato un autentico privilegio. Alessio I, durante le campagne militari,
era solito ospitarne uno sotto la sua tenda. Particolarmente riveriti e ascoltati
erano gli eremiti. San Niceforo riuscì a indurre l’Imperatore ad abolire la
tassa sull’olio santo. San Daniele, che abitava su una colonna alla periferia
di Bisanzio, quando scoppiava un temporale, veniva, per ordine di Teodosio
II, regolarmente rifornito di ombrello. Solo verso la fine della sua vita decise
di farsi costruire una piccola tettoia. Grande fama godettero anche San
Teodoro Siceota e San Basilio Minore: il primo per aver passato in una
gabbia tutta una Quaresima; il secondo per aver istruito l’imperatrice Elena
sul modo di avere un figlio.
Costantinopoli era sotto il patronato della Vergine, al cui culto erano
dedicate alcune delle sue più belle chiese. Esse non erano solo luoghi di
preghiera, ma anche veri e propri centri diagnostici e terapeutici. Come nella
Roma pagana molti malati preferivano affidarsi alle cure di Asclepio e di
Lucina piuttosto che a quelle del medico, così a Bisanzio si ricorreva alle ricette di Cosma e Damiano che, sembra, ne dispensavano a josa e
gratuitamente. Fra i Santi che facevano i medici c’erano, naturalmente,
anche gli specialisti. Per le malattie sessuali, ad esempio, gli uomini si
rivolgevano a sant’Artemio e le donne a santa Febronia. Quando una
diagnosi si presentava particolarmente difficile, si faceva ricorso agli astri, e
talvolta si chiamava a consulto i maghi e gli stregoni, sebbene la loro
principale attività fosse la lettura del futuro. Non sempre costoro
azzeccavano i pronostici. Catanance, per esempio, profetizzò la morte di
Alessio I, e invece a morire fu il leone di Corte. Ciò non gli impedì, dopo
alcuni anni, di rinnovare la profezia. Ma anche questa volta i fatti lo
smentirono perché a tirare le cuoia fu l’Imperatrice-Madre.
Era una città cosmopolita, una specie di melting-pot, un crogiuolo di
lingue, di razze, di costumi, un miscuglio di Greci, di Illiri, di Sciti, di
Asiatici, di Africani, amalgamati e tenuti insieme dall’ortodossia e dalla
lingua comune. Lacerato dalle eresie, l’Impero Romano d’Oriente, per la
sua eterogeneità etnica, non fu mai agitato dallo spettro del razzismo.
Frequenti erano anzi i matrimoni misti che gli stessi Imperatori
incoraggiavano. Giustiniano II, per esempio, fece sposare al proprio cuoco
negro la figlia di un ricco e influente senatore.
A dispetto di un clima umido e afoso, Costantinopoli era incorniciata da
un panorama incantevole e da un paesaggio nobile e lussureggiante. La
sapienza urbanistica dei suoi architetti aveva fatto di questa città un gioiello
di armonia e di equil
Scaricare
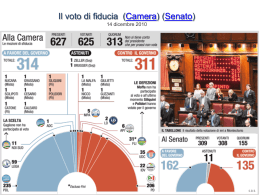

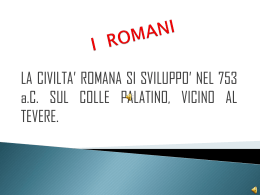


![L`impero romano nei secoli del massimo splendore [b].](http://s2.diazilla.com/store/data/000099212_1-8913594b6420dbae9d7f348b64db2063-260x520.png)



