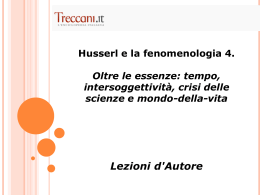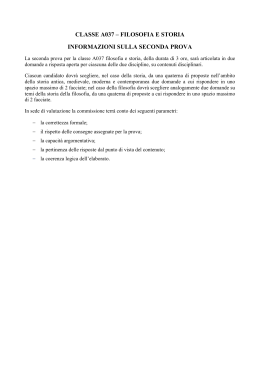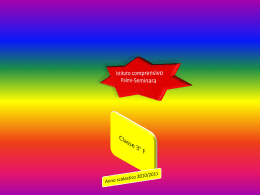RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XXIII NUOVA SERIE - N. 67 - GENNAIO-APRILE 2009 Pubblicazione promossa dal Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento, con la collaborazione del “Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma. Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento e dello stesso Dipartimento. Direttore responsabile: Giovanni Invitto Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce), Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce). Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo, Lucia De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo. Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali, Università degli Studi – Via M. Stampacchia – 73100 Lecce – tel. (0832) 294627/8; fax (0832) 294626. E-mail: [email protected] Questa rivista è anche sul sito: siba2.unile.it/ese Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto I, 51 73016 San Cesario di Lecce – Tel. 0832/205577 – 0832/200373. Iscritto al n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo: Italia t 15,00, Estero t 30,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento dà diritto al numero “cartaceo” pubblicato ogni anno. Un fascicolo t 15,00, degli anni precedenti il doppio. Stampato presso Piero Manni s.r.l. – San Cesario di Lecce nel marzo 2009 INDICE Saggi 7 Mita Arici CHŌRA-CARNE: UN CONFRONTO TRA DERRIDA E MERLEAU-PONTY 34 Santi Lo Giudice IL COLLASSO DELLA PAROLA IN ANTONIN ARTAUD 66 Luca M. Possati «SFIDA SEMIOLOGICA» E TEORIA DELLA FRASE NELLA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO DI P. RICOEUR Note 90 Salvatore Costantino IL DANNO DEL VERBALISMO NELL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA 111 Gianni Donati SANTINO CAVACIUTI E MAINE DE BIRAN 120 Marisa Forcina PIERRE LEROUX TRA INDIVIDUALISMO E SOCIALISMO 126 Recensioni F. Donadio, E. Vitali NOTE PER GLI AUTORI I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. Si può utilizzare l’e-mail: [email protected]. Il materiale ricevuto non verrà restituito. Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche. Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione dell’Autore. “Segni e comprensione” è disponibile in edizione telematica sul sito http://siba2.unile.it/ese, alla pagina Publications. Ogni numero sarà scaricabile due mesi dopo la pubblicazione cartacea della rivista. Anche “Segni e comprensione” si adegua alla rivoluzione informatica e mass-mediatica. Già da alcuni anni la rivista appare tanto nella versione cartacea quanto in quella telematica. Anche le ultime vicende, non ancora concluse, che travagliano l’università pubblica italiana, hanno suggerito al Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali e della Comunicazione dell’Università del Salento (che, insieme al Centro di Ricerche fenomenologiche di Roma, promosse questa rivista nel 1987) di ridurre l’attività editoriale realizzata con le antiche metodologie. Così le tre riviste del Dipartimento, di cui due ultraventennali, dal 2009 avranno una doppia veste: un numero sarà a stampa e avrà carattere monotematico, e gli altri due numeri appariranno on line sul sito http://dipfil.unile.it, dove comunque sarà inserito anche il primo numero. I testi che vi appariranno saranno in formato “pdf”, in modo che autori e lettori possano stamparsi i loro saggi o tutta la rivista come se uscisse dalla consueta tipografia. Ciò avviene da tempo, come è noto, per tanti periodici scientifici nazionali e internazionali. Per quest’anno a chi si abbona a “Segni e comprensione” sarà inviato, senza ulteriori spese, oltre al primo numero 2009 della rivista, il testo collettaneo, da me curato, Il sorriso di Medusa. Il consumo della paura tra cinema e filosofia (Manni, San Cesario di Lecce 2008). Abbiamo già pensato al tema del numero monotematico del 2010. Esso riprende e aggiorna un consuntivo, fatto vent’anni fa, su Fenomenologia ed esistenzialismo in Italia. Fu il tema di un Convegno organizzato a Tarquinia dalla Società Filosofica Italiana nel 1981, i cui atti furono curati dallo scrivente. Quello che “Segni e comprensione” chiede ai suoi Autori antichi ed a quelli più recenti è di cominciare a elaborare testi su quell’argomento e ad inviarli alla rivista entro settembre 2009 ([email protected]). La sapienza millenaria della Chiesa cattolica, parlando di eventi, ahinoi, molto più importanti, ha sempre ricordato che “vita mutatur, non tollitur”. Se “licet parva componere magnis”, ancora usando formule classiche come quella delle Georgiche virgiliane, dobbiamo dire che anche la nostra rivista filosofica continua a vivere grazie all’impegno ed al lavoro di tutti, dall’editore Manni, all’apporto qualificante, quasi sempre nascosto, di Angela Ales Bello, sino al più giovane dei nostri autori e lettori. “Segni e comprensione”, dal suo ventitreesimo anno, continua a vivere in modalità in parte mutate, ma con la qualità, l’impegno, la specifica caratterizzazione culturale e filosofica dimostrati nei primi ventidue anni di vita e che sempre le sono stati riconosciuti nelle sedi più accreditate. Giovanni Invitto 5 6 di Mita Arici S AGGI CHŌRA-CARNE: UN CONFRONTO TRA DERRIDA E MERLEAU-PONTY L’innominabile e l’impresentabile “Per tutto questo ci mancano i nomi”1, afferma Husserl nel descrivere la costituzione dell’intimo flusso temporale della coscienza in un paragrafo che Derrida definisce “mirabile”2. Husserl aveva infatti scoperto che il tempo vissuto internamente, diverso da quello “oggettivo” e misurabile degli orologi, non è concepibile come una successione di istanti puntuali, perché, a rigore, l’istante non c’è mai, non è mai “presente”, sfugge continuamente. Il flusso temporale si costituisce piuttosto come un continuo rimando, una continua reciprocità tra il prima e il dopo, tra ritenzione passata e protensione futura; esso ha quindi in sé qualcosa di circolare. Per questo movimento costituente “ci mancano i nomi” ed è solo una volta che il flusso temporale si è costituito che possiamo parlare di flusso, anche se Husserl ci mette in guardia contro queste metafore: “Noi non possiamo dire altro che: questo flusso è qualcosa che noi chiamiamo così in base al costituito, ma che non è nulla di temporalmente obiettivo”3. Commentando questo paragrafo Derrida osserva che ciò che Husserl chiama “innominabile” è ciò che sfugge alla presenza, mentre “tutto ciò che è presente noi possiamo nominarlo” (VF, p. 122, n. 8)4. In effetti, come già Platone insegnava nel Cratilo, il nome fissa l’essenza immobile ed eternamente presente, la sostanza (ousia) delle cose5. Ci mancano invece i nomi per ciò che, come il flusso temporale descritto da Husserl, è instabile, per ciò che non è completamente visibile e presente, ma che si costituisce grazie ad uno scambio tra visibile e invisibile, presente e assente; ci mancano quindi i nomi per ciò che non è “un oggetto”, ma sta al di là della distinzione stessa tra oggettivo e soggettivo. Molti anni dopo i suoi esordi husserliani6, Derrida dedica un testo al tema della chōra, quella materia amorfa o “ricettacolo” (di cui Platone parla nel Timeo) della quale si serve il Demiurgo per plasmare il cosmo e tutte le cose sensibili sul modello di quelle ideali. Il testo del filosofo francese esordisce in questo modo: “Chōra ci giunge, come il nome. Quando un nome viene, esso dice subito più del nome, l’altro del nome e l’altro come tale, di cui annuncia per l’appunto l’irruzione”7. Oltre a richiamare il tema dell’evento, queste righe ci informano che per Derrida la questione di chōra 7 (così la chiama il filosofo in questo testo, sopprimendo volutamente l’articolo determinativo) ha a che fare con il nome o meglio, con l’innominabile. In particolare chōra sembra qui assumere il valore esemplare di qualcosa che riguarda ogni atto di denominazione: se Platone, nel Cratilo, tentava di isolare una regola per fondare la correttezza dei nomi, Derrida avverte non solo che non c’è un significato o una parola “giusta” per chōra, ma anche che forse nessun nome, per nessun “oggetto”, è un nome “giusto”. Abbiamo inoltre osservato come, già nei suoi primi testi in cui sviluppava una particolare lettura di Husserl, il filosofo francese collegasse una certa debolezza del linguaggio che pone nell’impossibilità di dare un nome ad una certa discronia o anacronia che impedisce di cogliere un essente sotto la forma della presenza. Derrida caratterizza la chōra platonica appunto come qualcosa che non possiede un’essenza determinabile e la cui presenza è sempre differita; chōra, dice Derrida, “è l’anacronia nell’essere o, meglio, l’anacronia dell’essere. Essa anacronizza l’essere” (C, p. 51). Forse, lascia intendere il filosofo, questo non è solo il caso di chōra, perché non c’è nessuna essenza stabile ed è necessario incominciare a pensare la presenza a partire da questa instabilità, da questa différance, e non il contrario. La nozione di chōra assume quindi un valore strategico nell’operazione complessiva in cui è coinvolta la riflessione di Derrida. Com’è noto il filosofo francese intraprende una paziente decostruzione dei testi della metafisica classica la quale, come aveva insegnato Heidegger, concepisce l’essere come “presenza” stabile e originaria da cui procederebbero, a titolo derivato, tutte le differenze e tutto il divenire. Platone, o ciò che viene chiamato il “platonismo”, costituisce una tappa fondamentale nella storia che ha condotto la filosofia a concepire l’essere nei termini di presenza, ossia nella storia di ciò che tradizionalmente chiamiamo “la” filosofia. Il termine “platonismo” è però un’astrazione che cela dell’altro, qualcosa che, dall’interno della stessa scrittura platonica, confuta ciò che chiamiamo platonismo. Siamo di fronte ad un movimento circolare, o, come dice Derrida, ad una “violenta inversione” (C, p. 78): lo scritto di Platone genera il “platonismo”, ma questa inevitabile astrazione (il platonismo) farà sempre un po’ di violenza allo scritto di Platone, perché ci porterà necessariamente a trascurare alcuni dei sentieri che si aprono nelle sue pieghe. Approfondire il tema della chōra significa appunto per Derrida riscoprire uno di questi sentieri in modo da far affiorare le falle o le crepe che contestano l’edificio platonico (che si trova al cuore dell’edificio della filosofia tradizionale) dal suo interno. In questo testo tenteremo di approfondire l’analogia tra la concezione derridiana di chōra e la nozione merleau-pontiana di “carne”. È noto che, come per Derrida, anche per Merleau-Ponty il pensiero di 8 Husserl costituisce un punto di riferimento fondamentale, ma entrambi i pensatori francesi intrattengono con esso un rapporto non semplice; sia l’uno che l’altro, infatti, elaborano questa eredità situandosi non tanto all’interno, quanto piuttosto “ai margini” (Derrida), o “ai limiti” (Merleau-Ponty) della fenomenologia. È utile ricordare che Derrida prende esplicitamente le distanze dall’interpretazione merleau-pontiana di Husserl e afferma che la sua lettura del testo fenomenologico diverge profondamente dalle versioni che ne proponevano negli anni ’50 Sartre e Merleau-Ponty e si situa piuttosto in opposizione a esse o fuori di esse8. Nonostante queste riserve espresse da Derrida e nonostante le effettive differenze che vi sono tra i due pensatori francesi, è possibile affermare che entrambi hanno voluto seguire l’eredità husserliana con un rigore che li porta, paradossalmente, a sviluppare quegli aspetti del pensiero fenomenologico che oltrepassano gli intenti programmatici di Husserl, ancora per molti versi legato ad una visione classica della filosofia in quanto ancorato al sogno di un’evidenza piena, di un’origine pura e di una coincidenza e un’adeguazione assolute. Ecco allora che, mentre Derrida marca lo scarto tra ciò che Husserl affermava dogmaticamente “di diritto” per non contraddire il suo stesso programma e ciò che invece Husserl manifestava dirigendosi “di fatto” verso un nuovo tipo di pensiero irriducibile agli schemi classici, Merleau-Ponty individua nella riflessione husserliana un’ombra di questioni laterali, irrisolte, un “impensato” che scaturisce dai bordi di ciò che il filosofo padroneggiava e che si tratta di pensare di nuovo. Entrambi i filosofi si rendono conto dell’impraticabilità della riduzione radicale prospettata dal pensiero fenomenologico come ritorno a una coscienza trascendentale costituente di fronte alla quale il mondo si dispiegherebbe in una trasparenza assoluta. L’impossibilità di una riduzione completa, l’inattingibilità del momento di origine del senso, l’incapacità di coincidere con i propri movimenti costitutivi, implicano l’abbandono di uno schema filosofico tradizionale, caratterizzato, al contrario, dalla certezza e dalla pienezza dei fondamenti e da un approccio diretto al vero garantito dall’immediatezza dell’evidenza. Con Husserl e nonostante Husserl (e ovviamente con l’apporto di altri influssi importanti come quello del pensiero di Heidegger o dello strutturalismo, per citare altre due fonti comuni a entrambi i filosofi francesi) si fa allora strada l’idea che ciò che ci fa mancare la coincidenza con l’origine del senso e della verità differendo continuamente il nostro accesso diretto all’essere, a se stessi e all’altro, lungi dal costituire ciò che ce ne impedisce l’esperienza, sia proprio l’unica via che abbiamo per accedervi. Conseguentemente, l’essere non è più concepito come opposto al divenire (come avveniva nella metafisica tradizionale), ma come originariamente complicato con esso; questo significa anche rifiutare il principio che 9 vi sia un significato preesistente alla sua espressione linguistica per sostenere invece l’idea di una contemporaneità tra il senso e la sua articolazione; per esempio dall’Origine della geometria di Husserl9 entrambi i pensatori colgono l’idea che non si possa più parlare di un “divenir parola del significato”, ma è l’articolazione linguistica e, per Derrida in modo particolare, grafica, che inaugura (in ritardo) il senso. In Derrida, come si è accennato, questa contestazione della filosofia classica prende la forma di una critica alla “metafisica della presenza”, critica che ha uno dei suoi punti fondamentali nell’elaborazione del concetto-non concetto di différance. Merleau-Ponty, invece, viene man mano sviluppando la convinzione che sia necessario evadere dai canoni tradizionali costruendo una “nuova ontologia” che ci faccia ritornare a vedere e a pensare in un modo diverso, un modo che “ci siamo precluso diventando occidentali”10. La “carne” è appunto il nome che Merleau-Ponty sceglie per esprimere un tipo di essere diverso, inedito, che introduce ad un nuovo modo di concepire la natura, la storia, il linguaggio e le relazioni con sé e con gli altri. Come chōra, il termine “carne” ha in sé qualcosa di sfuggente e di intraducibile, perché la carne non possiede un’essenza definita di cui un nome potrebbe riprodurre l’equivalente esatto: “ciò che chiamiamo carne […] non ha nome in nessuna filosofia”11, afferma Merleau-Ponty. Quando si nomina ci si trova già al livello del logos, si è già operata una certa distorsione nei confronti di quell’essere irriflesso e fluido che si intendeva esprimere, ci si è già posti, come direbbe Husserl, al livello del costituito. La carne però non coincide nemmeno con uno strato assolutamente inattingibile, condannato per sempre al mutismo; Merleau-Ponty osserva con grande interesse il tentativo di Husserl di esercitare la ragione filosofica fino alle sue estreme conseguenze, tentativo che, paradossalmente, porta il filosofo tedesco a scoprire dietro alla riflessione l’irriflesso come sua intima condizione di possibilità; con la nozione di carne il filosofo francese non vuole quindi esprimere un’estraneità assoluta tra riflesso e irriflesso, ma la loro reciprocità, quella stessa reciprocità che ritroveremo nella struttura della chōra. Dovrebbe già apparire chiaro che non si tratterà qui di “tradurre” o di “far coincidere” il termine carne con chōra o viceversa, perché qui sono in questione proprio una certa idea della traduzione come possibilità di incarnare un’essenza o un significato adeguati in un termine equivalente e una certa necessità che la coincidenza non si realizzi mai; è però possibile cogliere tra queste due nozioni dei punti di contatto e delle analogie di struttura. Vedremo che, come la chōra, l’essere carnale descritto da MerleauPonty si sottrae ad una classificazione nei termini di presenza: la carne non si può afferrare con uno sguardo che pretende di possederla completamente, perché essa non è completamente “visibile”, ma è piuttosto un amalgama di visibile e invisibile e si può cogliere solo indirettamente, al10 l’orizzonte delle nostre percezioni e delle nostre riflessioni. Come la chōra, inoltre, la carne è contemporaneamente ciò che non ha una forma propria e ciò in cui e da cui ogni cosa si forma. Osserviamo comunque che il nostro confronto è sin dall’inizio complicato da una particolare mise en abyme: per operarlo è infatti necessario interpretare una certa interpretazione che Derrida ci dà del Timeo platonico. Il Timeo però, come la lettura di Derrida intende precisare, non costituisce “l’origine” dei nostri discorsi, perché questo testo dipende a sua volta dalle nostre interpretazioni. Questo circolo ermeneutico, oltre a riflettere il movimento circolare della chōra, si rispecchia nella struttura a scatole cinesi con cui Derrida gioca continuamente in questo testo presentandoci il Timeo come un labirinto di racconti incassati l’uno nell’altro, di cui però si perde sempre il primo referente, tanto che l’originale e il derivato, il contenente e il contenuto, si scambiano incessantemente di posto obbligando Platone ad un andamento “a zig zag” che lo costringe a riprendere “sempre di nuovo” il filo del discorso. Per non smarrirsi in questa costruzione vertiginosa sembra quindi utile presentare dapprima i punti che ci interessano della lettura che Derrida dà della chōra. Successivamente illustreremo la nozione merleau-pontiana di carne cercando di mettere in luce le analogie e differenze con la chōra derridiana. Infine, a partire da questa angolatura, tenteremo di suggerire alcuni tra i possibili esiti di questo confronto. Derrida e la chōra Derrida pone ad esergo del testo sulla chōra una citazione tratta da J.-P. Vernant in cui lo studioso francese chiede ai linguisti, ai logici e ai matematici di soccorrere il mitologo, poiché questi si trova sprovvisto di una logica adeguata all’investigazione del mito. Il mito, dice infatti Vernant, per la sua comprensione necessiterebbe di una logica differente da quella di non contraddizione dei filosofi, “una logica dell’ambiguo, dell’equivoco, della polarità. […] una logica che non sia quella binaria del sì o no, […] una logica diversa dalla logica del logos”12. È noto, spiega quindi Derrida, che ciò che Platone nel Timeo chiama chōra, sfugge alle categorie binarie della logica tradizionale. Platone presenta infatti la chōra come “un terzo genere” che non è assimilabile né ai paradigmi ideali, né alle cose sensibili: “ora bisogna spiegare un terzo e differente genere. I due generi, infatti, erano sufficienti per le cose dette in precedenza: l’uno posto come forma di esemplare, come intelligibile e come essere che sempre è allo stesso modo; il secondo come imitazione dell’esemplare, che ha generazione ed è visibile. Il terzo genere allora non 11 l’abbiamo distinto, ritenendo che i due bastassero. Ora, invece, il ragionamento ci costringe a cercare di chiarire con le parole anche questo terzo genere difficile e oscuro” (Timeo, 48E-49A)13. La chōra si caratterizza quindi innanzitutto come un termine mediano: né sensibile, né intelligibile, né forma, né materia, essa non appartiene propriamente né al logos, né al mito, come preciserà Derrida più avanti, tanto che si può tentare di coglierla solo attraverso un ragionamento spurio, o “ragionamento bastardo” che è a mala pena oggetto di persuasione (cfr. Timeo, 52B, tr. it. p. 1378). Da una parte, quindi, la chōra non appartiene al regno delle forme, ma rimane sempre indeterminata, “amorfa”, e la sua comprensione resta difficile e oscura appunto perché la comprensibilità implica necessariamente la determinazione della forma. In questo senso la chōra ci sfugge proprio nel momento in cui pensiamo di averla colta: non appena la nominiamo, essa scompare, perciò non ne possiamo parlare direttamente. La sua sintassi appare qui prossima a quella della teologia negativa anche se, a differenza della teologia negativa, per Derrida essa non rimanda ad “alcuna istanza teologica, ontologica o antropologica”14, quindi ad alcuna verità “al di là dell’essere” (FS, p. 22). D’altra parte la chōra non è nemmeno materia. Derrida osserva che Platone si serve di molte parole per qualificarla (ricettacolo, madre, nutrice, causa errante, spazialità, luogo, ecc.), ma non utilizza mai il termine hylē, perciò l’interpretazione aristotelica della chōra come materia appare ai suoi occhi problematica (cfr. C, pp. 85-86). Inoltre, la trattazione di Derrida mira ad evidenziare come essa si situi ad uno strato più originario rispetto alla materia, che si trova già al livello del costituito. Platone in effetti afferma che i quattro elementi materiali con cui i filosofi naturalisti (e in particolare Empedocle) avevano fatto coincidere il Principio di tutto non sono in realtà dei Principi, ma dei principiati, ossia sono derivati e secondi rispetto alla chōra 15. Non è nemmeno possibile identificare quest’ultima come una res extensa, anzi, come vedremo essa annuncia un concetto della spazialità in netto contrasto con quello cartesiano. Più in profondità, Derrida vede nella chōra il manifestarsi di una struttura anteriore al dualismo medesimo tra forma e materia: “il pensiero della chōra renderebbe problematico l’ordine stesso della polarità, della polarità in generale, che sia o meno dialettica” (C, p. 50). Più che come un “terzo genere”, la chōra sembra quasi caratterizzarsi come un unico principio che si trova al di qua e/o al di là del discorso sicuro di una filosofia che procede per opposizioni binarie, allo stesso tempo “madre” e causa di ogni cosa e “ricettacolo” di tutte le forme senza possederne alcuna in proprio. Se la chōra sembra essere più originaria delle opposizioni che si generano in essa, non è però identificabile con un cominciamento inteso come 12 fondamento stabile e sicuro. La questione della chōra, in effetti, è in relazione con il tema dell’origine, ma Derrida mostra come il tentativo di individuare un’origine obblighi il discorso a spostarsi sempre oltre, in un rinvio e un rimando infiniti. Questo scacco nello sforzo di isolare un inizio viene rintracciato dal filosofo francese anche nella costruzione stessa del Timeo, dialogo scandito continuamente da ritorni indietro, in cui Platone annuncia più volte l’intenzione di ricominciare daccapo, ma dove non si risalirà mai ad una presenza originaria. In particolare Derrida fa vedere come questo scritto platonico abbia una struttura che noi potremmo chiamare “a matrioska”, fatta di racconti contenuti l’uno nell’altro: il giovane Crizia riporta un racconto che aveva fatto il giorno innanzi, che a sua volta riporta un resoconto che il vecchio Crizia suo avo gli aveva narrato circa una conversazione avuta con Solone, che espone il colloquio avuto con un sacerdote egiziano, il quale riferisce dell’origine di Atene in base a scritture egiziane, ecc. Derrida mostra però come ciò che sembra di volta in volta l’inizio o la fonte del racconto (Socrate, gli ateniesi, ecc.) diventa fatalmente il fine o il ricevente (il “ricettacolo”) della storia. Sembra quasi, seguendo l’esposizione derridiana, che si potrebbe al limite scegliere come origine un luogo qualsiasi del testo platonico, se non fosse che un’origine scelta a posteriori, un’origine che può “esplodere”16 in un punto qualsiasi del percorso, non è propriamente un’origine. In effetti è proprio la concezione classica della genesi come inizio puntuale, come presenza da cui scaturisce un divenire, che la costruzione di mise en abyme di questo testo e la nozione di chōra problematizzano e mettono in questione. In contrasto con la metafisica tradizionale che prevede un’origine come punto fisso da cui segue uno sviluppo lineare, Derrida, a partire dalla sua tesi di laurea redatta negli anni 1953-54 in cui analizza il problema della genesi nella filosofia di Husserl, scopre infatti una sorta di “legge della contaminazione differenziale”17 che impedisce di ridurre l’inizio ad una puntualità istantanea introducendo nel movimento costituente uno scarto ineliminabile. La genesi è paradossale, spiega Derrida in questo testo, perché essa è sia continua che discontinua rispetto a ciò che produce, sia contenuta che contenente rispetto al suo svolgimento (cfr. PG, pp. 5859)18. La struttura paradossale della genesi riflette lo stesso paradosso della mise en abyme, una tecnica compositiva sulla quale Derrida sofferma l’attenzione più volte, tanto che in un’intervista contenuta in Positions egli confessa che diversi suoi scritti importanti19 possono essere visti come un lungo commentario ad un passaggio di Husserl tratto da Idee I (che egli pone ad esergo de La voce e il fenomeno) in cui uno spettatore all’interno della galleria di Dresda guarda un quadro che rappresenta dei quadri, che contengono delle iscrizioni, ecc. In questo gioco di scatole cinesi si tratta in effetti di mettere in discussione il fatto che ci sia una presenza originaria, per13 ché lo spettatore è sia interno che esterno al quadro, sia contenuto che contenente. La chōra, a suo parere, riflette appunto questa struttura en abyme, perché essa “raffigura il luogo d’inscrizione di tutto ciò che al mondo si marca” (C, p. 64), ciò che in essa si produce è quindi simultaneamente continuo e discontinuo, interno ed esterno rispetto ad essa. La chōra rispecchia la struttura paradossale dell’origine anche perché essa deve essere dimenticata come tale per poter essere colta. In questo senso essa è pre-originaria, “anteriore ed esterna ad ogni generazione” (C, p. 83). In una conferenza tenuta a Capri nel 1994 sulla religione Derrida paragona la chōra alla figura di un deserto “prima” del deserto (FS, p. 21), o di un fondamento che “fonda sprofondando” e che “si sottrae sotto il suolo di ciò che fonda” (FS, p. 23). La questione della chōra sfiora quindi il tema heideggeriano della traccia e quello husserliano della crisi del senso originario in quanto questi esprimono tanto l’impossibilità di attingere direttamente all’origine, quanto la necessità di raggiungere il costituente solo passando attraverso la mediazione del costituito. Per avvicinarsi alla chōra è necessario un cammino a ritroso, è necessario operare quella Rückfrage (o, come traduce Derrida, question en retour) di cui parlava Husserl ne L’origine della geometria quando affermava la necessità di attingere all’originario solo attraverso la mediazione del derivato20. La chōra è quel supporto informe che genera e riceve tutte le determinazioni, a patto però che esse siano date a posteriori; c’è quindi una struttura di ritardo, una specie di “futuro anteriore” senza ritorno (cfr. FS, p. 23), per cui essa non si definisce mai in se stessa, ma solo grazie al suo contrassegno futuro, o alle interpretazioni future che ne saranno date. In un certo senso essa fonda ciò che la fonderà, oltrepassando così l’opposizione classica tra attivo e passivo: “la chōra […] non si lascia facilmente situare [?]: essa è più situante che situata, opposizione che a sua volta bisognerà sottrarre a qualsiasi alternativa grammaticale o ontologica dell’attivo e del passivo” (C, p. 49). La chōra quindi c’è, il y a, es gibt, traduce Derrida nella lingua di Heidegger (evocando in questo modo anche il tema del dono), ma il modo del suo darsi e del suo dare luogo alle cose è quello di una “causa” molto particolare, una “causa errante” (come la definisce Platone; cfr. Timeo, 48 A 7) che vive di un movimento circolare irriducibile al pensiero causale. Nel testo Forcener le subjectile, Derrida paragona più volte esplicitamente la concezione che egli propone in questo testo del soggettile alla chōra platonica21. L’analogia secondo il filosofo risiederebbe appunto nel fatto paradossale che, come la chōra, il soggettile, pur essendo un supporto, uno sfondo, un “ricettacolo” che assume in sé ogni forma, è in realtà senza fondo, perché sfugge a qualsiasi determinazione: il soggettile è infondato proprio perché è un “fondante-fondato” (SOG, p. 29). Questa sorta di “generazione all’inverso” (SOG, p. 82) avviene per14 ché Artaud nei suoi disegni non ci mostra un ordine già articolato, normato, organizzato, quanto “il momento dell’articolazione” (SOG, p. 82). Il soggettile, come la nostra lingua materna (alla quale Derrida lo paragona più volte), si costituisce nel momento in cui i segni, come i di-segni, cominciano ad articolarsi, a differenziarsi tra loro, ossia nel momento in cui tra loro si istituisce uno scarto, uno spaziamento (espacement). Si tratta appunto di concepire la formazione di un campo di senso come un processo di spaziamento in cui i vari elementi acquistano un significato e un’identità solo relazionandosi tra loro. Com’è noto lo spaziamento (espacement) è un termine chiave nel lessico derridiano che gioca un ruolo fondamentale nella sua concezione della scrittura e attraverso il quale viene reinterpretata la concezione strutturalistica per cui il valore di un termine non è isolato, ma acquista la propria identità solo separandosi e scartandosi dagli altri elementi, quindi instaurando fra sé ed essi uno spazio e una differenza22. L’espacement annuncia un tipo di spazialità più primordiale rispetto a quella classica, ossia allo spazio oggettivo ed esteso di tipo cartesiano. Ricordiamo che il termine chōra rimanda anche alla spazialità, al luogo, e che Platone se ne serve anche con questa connotazione23. Derrida mette in rapporto la chōra all’espacement suggerendo che essa abbia a che fare con questa diversa e più originaria concezione dello spazio. Egli riferisce a proposito un passaggio tratto dall’Introduzione alla metafisica in cui Heidegger indica come, a cominciare da Platone, “in base cioè all’interpretazione dell’essere come idea, si prepari la trasformazione dell’essenza [?] del luogo [topoj] e della cwra, nello ‘spazio’ definito attraverso l’estensione. Cwra non potrebbe forse voler significare ciò che si separa da ogni cosa particolare, ciò che si sottrae, ciò che ammette, precisamente, in tal modo, qualcos’altro e ‘gli fa posto’?”24. Questa diversa “tropica” è collegata a quell’“anacronia” di cui abbiamo parlato qui sopra che caratterizza la temporalità della chōra. Scrive Derrida: “la tropica e l’anacronismo sono inevitabili. E tutto ciò che vorremmo mostrare è la struttura che, rendendoli così inevitabili, ne fa altra cosa che accidenti, debolezze o momenti provvisori” (C, p. 51). Similmente alla différance, chōra esprime una struttura (e non un’essenza)25 in cui lo spazio si fa tempo e il tempo si fa spazio, proprio in quanto essi non esprimono due entità costituite, ma si auto-costituiscono attivamente attraverso uno scarto e un differenziarsi di elementi. Questi scarti e queste differenze, inoltre, non costituiscono degli accidenti che un pensiero dell’adeguazione avrebbe il compito di eliminare per riportasi alla pienezza della presenza, ma sono necessari affinché qualcosa possa darsi e “avere luogo”. 15 La carne come chōra È noto che Derrida non si è mai applicato agli scritti della tradizione con l’intento di un esegeta. Proprio per questo motivo non si ritiene essenziale, al fine del nostro paragone con la carne merleau-pontiana, stabilire in che misura l’interpretazione che Derrida dà della chōra platonica sia esatta. Piuttosto, il tentativo è quello di comparare tra loro la caratterizzazione derridiana della chōra e quella merleau-pontiana di carne suggerendo alcuni spunti per un confronto di carattere più generale tra i due filosofi. Ci concentreremo in particolare (anche se non esclusivamente) nell’ambito dell’ultima riflessione di Merleau-Ponty, che raggiunge il suo punto massimo di elaborazione in un’opera che però egli non riuscì a portare a termine a causa della morte: Il visibile e l’invisibile. Merleau-Ponty intende per visibile “il mondo sensibile, […] relativamente continuo” e per invisibile “l’universo di pensiero, […] discontinuo e lacunoso” (VI, p. 39). Queste categorie subiscono però delle trasformazioni di significato che segnano subito un distacco del filosofo francese dall’ontologia classica: mentre quest’ultima, infatti, ripartisce l’essere nei diversi livelli del sensibile e dell’intelleggibile, Merleau-Ponty intende mettere in evidenza che non si tratta di due mondi differenti, ma di un unico livello che contiene la visibilità e l’in-visibilità come due facce di una stessa medaglia. Il filosofo francese conduce una lotta su due fronti contro il realismo del “pensiero oggettivo” e l’idealismo del “pensiero riflessivo” che, dando l’uno la prevalenza al lato oggettivo e l’altro al lato soggettivo, si mantengono comunque nei limiti tradizionali di una visione oppositiva tra soggetto e oggetto, concepiti come due essenze positive. L’essere carnale, “grezzo”, “poroso”, con cui Merleau-Ponty intende proporre anche una concezione innovativa della natura, indica invece un nuova dimensione in cui presenza e assenza, materia e forma, si trovano implicati l’uno nell’altro e allacciati in uno stretto legame e dove passività e attività, oggetto e soggetto, sono in un rapporto di reversibilità. L’elaborazione della nozione di carne si inserisce quindi nell’attacco sferrato da Merleau-Ponty contro il dualismo che caratterizza l’impianto del pensiero tradizionale, dualismo che egli non smette di criticare lungo tutto il corso della propria meditazione. In effetti, come il filosofo francese apprende dallo Husserl degli ultimi scritti (in particolare lo Husserl di Idee II, della Crisi e dei manoscritti inediti), i due poli in cui un pensiero dualista si irrigidisce non sono fondamentali, ma sono già costituiti, astratti, veri “a titolo derivato”: “A partire da Idee II, sembra chiaro che la riflessione non ci insedia in un ambito chiuso e trasparente, che non ci fa passare, per lo meno non immediatamente, dall’“oggettivo” al “soggettivo”, che ha piuttosto la funzione di svelare una terza dimensione in cui questa distinzione diviene 16 problematica […] la riflessione husserliana elude questo star di fronte del soggetto puro e delle pure cose, cerca al di sotto il fondamentale” (S, p. 215). La carne, in questo senso, si configura come quella zona di profondità che dà spessore alla superficialità di un pensiero dualistico. È proprio la contemplazione di questa “terza via” che oltrepassa gli schemi binari di una filosofia tradizionale che porta alla teorizzazione di una contrapposizione non assoluta, ma solo relativa, tra essere e nulla e che segna la distanza tra il pensiero di Merleau-Ponty e quello di Sartre: “Anziché dell’essere e del nulla, sarebbe meglio parlare del visibile e dell’invisibile, ripetendo che non sono contradditori” (S, p. 45)26. Osserviamo che questa definizione della carne come terza dimensione, si può avvicinare alla caratterizzazione della chōra come “terzo genere” che non si può riassorbire né dal lato della forma, né da quello della materia. L’accostamento tra la carne merleau-pontiana e la chōra platonica viene suggerito anche da Mauro Carbone in un breve testo dedicato agli influssi del pensiero neoplatonico nella concezione merleau-pontiana della luce27, dove l’autore osserva opportunamente che tuttavia in Merleau-Ponty, a differenza che in Platone, la carne si configura come un genere unico e non terzo, che è allo stesso tempo amorfo e formatore. In effetti, se la dimensione dell’essere carnale si può definire come una terza via rispetto ai due poli classici del sensibile e dell’intelleggibile, va precisato che però essa non si trova fuori di essi, in un altrove irraggiungibile o in un “altro dall’essere”. Vi è quindi, in questo senso, un unico livello, quello della carne, che vive della differenziazione stessa tra sensibile e intelleggibile, visibile e invisibile, che la costituiscono e ne sono costituiti e che sono l’uno la contropartita dell’altro28. Questa precisazione può consentire di mettere meglio a fuoco il confronto con Derrida. In effetti, se da una parte il filosofo francese sottolinea, come abbiamo visto, il carattere “mediano” della chōra, d’altra parte egli insiste sull’“estraneità” della chōra, sul suo essere sempre oltre e fuori da ogni luogo: “Dall’interiorità aperta di un corpus, di un sistema, di una lingua o di una cultura, chōra situerebbe […] la spaziatura astratta, il luogo stesso, il luogo dell’esteriorità assoluta” (FS, p. 21)29. A questo proposito è utile osservare che anche là dove la chōra derridiana sembra approssimarsi maggiormente alla carne merleau-pontiana, ossia (per esempio) quando Derrida la definisce come un “chiasmo” in cui “tutto verrebbe nello stesso tempo a prendere posizione e a riflettersi ” (C, p. 62), appaiono delle differenze significative. Si ricordi che la figura del chiasmo è fondamentale nel pensiero di Merleau-Ponty, perché indica quel rapporto di scambio, di reciprocità e di rispecchiamento che si stabilisce tra soggetto e oggetto e in generale un tipo di rapporto all’essere che si instaura dall’interno dell’essere. In questo testo di Derrida il chiasmo appare invece come una voragine, un 17 “abisso” che, pur aprendosi all’interno del testo, rimane assolutamente estraneo ad esso. È a partire da questa estraneità, da questa assenza, che si mette allora in moto, come si è visto, il meccanismo della mise en abyme, che rende la chōra sempre più inafferrabile situandola, come un terzo genere o un “terzo uomo”30, sempre al di là di ogni alternativa. La chōra, afferma Derrida, “portando al di là della polarità del senso (metaforico o proprio), [?] non apparterrebbe più all’orizzonte del senso” (C, p. 50); l’essere carnale merleau-pontiano, invece, pur non identificandosi con il logos e il senso tradizionali, non si pone al di fuori dell’“orizzonte del senso”, ma vuole farsi portatore di un senso diverso, grezzo o “selvaggio”, di un “logos del mondo estetico” che aderisce maggiormente al mondo dell’arte e della sensibilità piuttosto che all’universo logico-scientifico o alle “idee dell’intelligenza”. Questa diversità si riflette in una differenza di impronta più globale tra il pensiero di Merleau-Ponty e quello di Derrida, che mantiene in fondo un impianto dualista, poiché pone appunto una separazione radicale tra il logos (con le sue opposizioni) e il suo oltre (in questo caso la chōra), nonostante l’uno non possa darsi senza l’altro31. Merleau-Ponty invece, come si è visto, tenta di superare uno schema binario pensando ai due poli antitetici come reversibili, come i due lati di un unico essere “verticale”, dotato di una profondità che li connette senza mai sovrapporli in una coincidenza perfetta: mentre per Merleau-Ponty non è possibile concepire una discontinuità se non sullo sfondo di una continuità (per quanto “porosa” e “incerta”), Derrida parte da una scissione originaria. Per Merleau-Ponty non c’è, come per Derrida, una “falla”, un’“assenza originaria”, o, come per Sarte, un “buco” che pone un’eterogeneità insuperabile nel tessuto della presenza, ma una “cavità” o una “piega” che lavora interiormente la carne e vi istituisce l’articolazione del senso e della storia. L’invisibile, quindi, non è completamente “altro” dal visibile, ma ne è la controparte e contribuisce così a creare una visibilità più amplia. Un altro angolo visuale fecondo per il nostro confronto riguarda la rielaborazione del termine “struttura”. Sia nel caso della chōra che in quello della carne, infatti, viene applicata la teoria strutturalistica del linguaggio, per cui non siamo di fronte ad una sostanza o ad un insieme di sostanze, ma ad un fascio di relazioni in cui le singole cose si distinguono per contrasto. Come abbiamo visto, la chōra derridiana si alimenta del reciproco differenziarsi tra di loro degli elementi che la compongono. Similmente, con il concetto di carne Merleau-Ponty abbandona qualsiasi posizione sostanzialistica rilevando come “la cosa stessa” sia sempre trascendente e non possa apparire che in filigrana: ciò che è “visibile”, come ad esempio gli individui, gli eventi o le essenze ideali, sembra cristallizzarsi in una “cosa” solo grazie ad un processo di astrazione. In realtà, al 18 livello pre-logico dell’essere carnale per Merleau-Ponty non ci sono che grovigli di relazioni, “ciuffi di essere”, “matrici simboliche”, centri di irradiamento o “raggi di mondo” che non hanno consistenza al di fuori del tessuto connettivo che li lega, ma che si formano nel momento in cui, attraverso la stoffa carnale di cui fanno parte, si rispecchiano gli uni negli altri32. Questa concezione relazionale del reale affiora anche nella peculiare idea merleau-pontiana dello spazio, a cui il filosofo dedica notevoli riflessioni penetrando a fondo il meccanismo della visione e il modo in cui essa si esercita nella pittura. Come abbiamo accennato qui sopra la chōra derridiana, pur coinvolgendo la nozione di spazio, non è assimilabile ad una concezione della spazialità come estensione, ma piuttosto a quel movimento di contrasti e distinzioni che crea lo spazio descritto proprio attraverso il processo di espacement. Similmente, Merleau-Ponty si distanzia dalla concezione cartesiana dello spazio, ossia da uno spazio oggettivo, chiuso in un sistema di coordinate geometriche, ed esplora invece la spazialità primordiale che viviamo spontaneamente relazionandoci con le cose prima ancora di sapere “dove” esattamente siamo, ponendoci in un rapporto chiasmatico, di scambio e di circolarità, con ciò che ci circonda: lo spazio infatti ci avvolge nella misura in cui è la nostra posizione a determinarne l’orizzonte. È chiaro che in questo tipo di spazialità la posizione dei corpi, prima di costituirsi come un dato oggettivo e misurabile, si stabilisce grazie al gioco di distanze e prossimità che le cose istituiscono relazionandosi e riflettendosi le une nelle altre. Come nel caso della chōra, inoltre, questa spazialità comunica intimamente con la temporalità, perché è intrisa di dinamismo e di movimento. Lo spazio e il tempo infatti, secondo Merleau-Ponty, sono delle “strutture di orizzonte” che vivono di una continua differenziazione interna e di un continuo scambio tra visibile e invisibile: come nell’esperienza dello spazio vi sono delle zone di indeterminatezza (gli orizzonti spaziali) che facendo da sfondo alla nostra visione ne sono la condizione, così nella temporalizzazione gli orizzonti della nostra esperienza sono il passato e il futuro che, pur non essendo presenti, contribuiscono alla costituzione del presente33. Come si può osservare, l’identità, sia essa di un soggetto, di una figura su sfondo, di un istante del tempo, non è mai primaria, ma emerge da una struttura più vasta a cui appartiene scartandosi da essa; reciprocamente, è proprio grazie a questa emersione e a questo scarto che anche la struttura appare iniziando ad articolarsi. Nonostante sia la carne che la chōra si definiscano come due “strutture” originarie che accennano ad una filosofia irriducibile a quella degli schemi classici, possiamo osservare che, diversamente da Derrida, Merleau-Ponty arriva a teorizzare questo nuovo tipo di pensiero e di senso a partire dalla percezione, dalla visione nel suo concreto esercitarsi. Nell’ultimo 19 Merleau-Ponty, in particolare, la teoria di Saussure della diacriticità dei segni e alcune idee provenienti dalla psicologia della Gestalt per cui la percezione si dà grazie alla reciproca differenziazione tra figure e sfondi si connettono all’affermazione del nostro inestricabile legame con l’essere grezzo, del nostro appartenere ad una medesima natura, del nostro essere tutti fatti della stessa carne: “L’analisi saussuriana dei rapporti fra significanti e dei rapporti fra significante e significato e delle significazioni (come differenze di significazioni) conferma e ritrova l’idea della percezione come scarto in rapporto a un livello, cioè l’idea dell’Essere primordiale, della Convenzione delle convenzioni, della parola prima della parola” (VI, p. 217). Derrida invece si colloca ad un livello più astratto e nel suo pensiero il continuo rinvio dei segni tra loro non implica, come in Merleau-Ponty, una ricerca sul nostro legame con l’essere primitivo e una rielaborazione del tema della natura, ma si concentra sul mondo del significato e dei segni e rimanda al vuoto originario da cui paradossalmente prende avvio questo gioco di differenze. Queste analogie e divergenze si rispecchiano nel modo di concepire l’originario e il movimento che lo anima. Sia Merleau-Ponty che Derrida, elaborando e sviluppando alcune concezioni di Husserl, arrivano a constatare che non esiste un’origine puntuale, immanente e assoluta, ma che sin dall’inizio si instaura un rapporto dinamico di reciprocità tra il fondante e il fondato. Abbiamo visto come Derrida utilizzi il termine husserliano Rückfrage per descrivere questo continuo rimando tra costituente e costituito. Merleau-Ponty utilizza invece il termine (sempre husserliano) Fundierung, che esprime appunto lo spessore del processo genetico e che ha una sintassi molto simile a quella esposta da Derrida per spiegare l’andamento circolare dell’origine: “il termine fondante – il tempo, l’irriflesso, il fatto, il linguaggio, la percezione – è primo nel senso che il fondato si da’ come una determinazione o una esplicitazione del fondamento senza per ciò poterlo mai riassorbire; tuttavia, il fondante non è primo nel senso empiristico e il fondato non è semplicemente derivato, poiché il fondante si manifesta proprio attraverso il fondato” (FP, pp. 505-506)34. In effetti il tema del senso come scarto, come articolazione di un campo, è filosoficamente connesso a quello della reciprocità fra costituente e costituito, ossia a quel rimando tra archeologia e teleologia che abbiamo visto caratterizzare la temporalità della chōra e che contrassegna anche la struttura della carne; il movimento di articolazione grazie al quale si costituiscono i significati all’interno di una struttura, infatti, non viene a poggiare su un fondo solido e già costituito, ma è esso stesso a costituire, a posteriori, il proprio sfondo, il proprio passato, la propria origine. Nel caso di Merleau-Ponty si può osservare che il livello originario e pre-logico dell’essere carnale si presenta come un mondo più inarticolato e magmatico ri20 spetto a quello dell’attività e della riflessione. Esso costituisce una massa amorfa anche se non omogenea ma, come dice Merleau-Ponty, travagliata al suo interno. Tuttavia, per cogliere questo strato ancora confuso, per pensarlo, è necessario articolarlo, determinarlo altrimenti esso ci sfuggirebbe, perché i nostri significati, come abbiamo visto, sono essenzialmente articolazione, distinzione, differenziazione. Ora, per articolare questo sfondo è però necessario deformarlo, ricrearlo ogni volta. Merleau-Ponty esprime bene questo movimento biunivoco in una nota de Il visibile e l’invisibile in cui, oltre all’aggettivo “amorfo”, che rimanda direttamente alla chōra, compare anche il nome di Proust: “Il mondo percettivo ‘amorfo’ di cui parlavo a proposito della pittura […] che non contiene nessun modo d’espressione e che tuttavia li sollecita e li esige tutti, che ri-suscita con ogni pittore un nuovo sforzo di espressione […] appare come contenente tutto ciò che sarà mai detto, lasciando però che siamo noi a crearlo (Proust): è il logojendi aqetoj che sollecita il logojproforic oj” (VI, p. 187)35. Come nel caso della chōra, anche la carne vive di un movimento circolare per cui il fondante genera ciò che lo fonderà, anche se lo fonderà solo deformandolo, ricreandolo, e quindi escludendo qualsiasi rapporto di derivazione di tipo deterministico. Nonostante queste analogie, possiamo notare che, anche riguardo al tema delle origini, emergono delle differenze significative tra le concezioni di Merleau-Ponty e di Derrida. In Derrida la constatazione della solidarietà del concetto di origine assoluta con la “metafisica della presenza”, congiunta alla lezione di Heidegger e alla critica alla storia di Nietzsche, conduce al rifiuto del concetto di origine tout court. Il riscontro di un circolo vizioso originario che ingloba la genesi nel proprio movimento si ripercuote su tutto il pensiero di Derrida; la storia diviene così reciprocità circolare, senza inizio né fine, tra senso e non-senso. Al posto della carne, ossia di quel campo pressoché inarticolato e brulicante di “ciuffi di essere”, che per Merleau-Ponty costituisce il suolo sfuggente da cui nascono le parole e le cose, non resta che l’avventura seminale della traccia nel gioco di infinito rinvio dei segni. Abbiamo visto qui sopra come nel testo sulla chōra Derrida si avvicini alle posizioni di Merleau-Ponty, concependo appunto quest’ultima come una sorta di struttura originaria in cui tutto viene a disporsi e ad avere luogo. Tuttavia anche in questo testo, come abbiamo osservato, la figura della mise en abyme rimanda all’assenza di un referente originario, in un labirinto senza vie d’uscita e senza vie di entrata. Merleau-Ponty invece non mette in discussione il concetto di origine in quanto tale. Il suo problema è piuttosto quello di cercare un’origine che non sia un arché, tentando di cogliere ciò che fonda il senso, pur senza essere un fondamento positivo assoluto. La Crisi delle scienze europee e altri 21 scritti dell’ultimo Husserl permetteranno al filosofo di porre la questione di una rifondazione della filosofia nella descrizione non più di una coscienza costituente a fondamento di ogni senso, ma della Lebenswelt come luogo di radicamento e di scaturigine del senso. L’origine non è più concepita, cartesianamente, come l’inizio puro del pensiero, ma come ciò da cui deriviamo, trascinando la ricerca verso temi come l’infanzia, il passato, l’inconscio, la natura o la naturalità, il nostro modo naturale di stare al mondo, in generale, l’esplorazione dei tipi di rapporti che si instaurano tra l’attività e la passività. L’attenzione che Merleau-Ponty pone al tema del “suolo” arriverà quindi a coinvolgere la questione di una nuova filosofia della storia e di una nuova ontologia. La tematica del suolo, in effetti, si connette in Merleau-Ponty ad una approfondita riflessone sulla passività, riflessione che il filosofo intraprende in polemica con le posizioni di Sartre, in particolare con il pensiero dualista di quest’ultimo. Allontanandosi da Sartre e dal suo pensiero della costituzione, che oppone radicalmente l’attivo e il passivo, Merleau-Ponty preferisce pensare alla genesi del senso in termini di istituzione (vocabolo con cui traduce quello husserliano Stiftung), che si riferisce ad una reciprocità tra attività e passività. Come è necessario riuscire a concepire la simultaneità (sempre smarcata, “sempre imminente e mai realizzata di fatto”) tra visibile e invisibile, spazio e tempo, passato e avvenire, così, secondo MerleauPonty, occorre cogliere “la passività della nostra attività” e viceversa per penetrare il senso più profondo del “narcisismo” della nostra visione e della carne, che è un “fenomeno di specchio” in cui si realizza continuamente la riflessività propria del sensibile, che è sempre un senziente-sentito, vedente-visibile, toccante-toccato, ecc. In Merleau-Ponty l’attivo e il passivo rappresentano quindi il recto e il verso di una medesima realtà, la carne, che si sviluppa attorno al senziente alla maniera di una guaina di cui esso occupa l’interno, perché esso la sente allo stesso modo in cui è sentito da essa. In questo modo i rapporti tra attivo e passivo si scambiano e fanno del senziente, originariamente incluso nel sentito, la pellicola che lo riveste, come se il mondo potesse riuscire ad “apparirsi” solo attraverso la piega di una corporeità: “ogni rapporto all’essere è simultaneamente prendere ed essere preso, la presa è presa, è inscritta e inscritta nello stesso essere che essa prende” (VI, p. 277). Ora, l’accenno alla polemica tra Merleau-Ponty e Sartre è interessante, in quanto, alcune obiezioni che Merleau-Ponty rivolge a Sarte si potrebbero rivolgere anche a Derrida, mi riferisco in particolare alla caratterizzazione di queste filosofie come dualismi, dualismo tra l’in sé e il per sé in Sartre, dualismo tra il logos e il suo altro in Derrida, che esclude ogni altra possibile dimensione. Questo ragionamento tuttavia si complica riguardo al tema della passi22 vità. Ricordiamo che Merleau-Ponty affermò esplicitamente di essere stato deluso dal fatto che Sartre non avesse mai elaborato una propria teoria della passività. Questo discorso non vale però per Derrida. Né si può dire che il filosofo abbia introdotto la questione della passività a partire dai suoi lavori sulla chōra o sul soggettile, dato che, sin dalla tesi di laurea sul problema della genesi in Husserl, egli affronta direttamente questo argomento. Il tema della passività concerne direttamente quello della chōra intesa come supporto, “ricettacolo” o destinatario ricettivo di tutto ciò che si inscrive in essa. Nella già citata conferenza tenuta a Capri nel 1994 Derrida paragona la chōra ad un deserto o ad una “desertificazione” che si sottrae a ogni determinazione, ma che, nel contempo, è proprio la condizione di possibilità di tutto ciò a cui si sottrae (cfr. FS, pp. 18-19). Qui sopra abbiamo visto come per il filosofo la chōra si situi oltre l’alternativa stessa del passivo e dell’attivo. Tuttavia, proprio perché essa si situa oltre ogni alternativa, oltre il senso (con le sue polarità), al di là del sistema del debito e del dono (cfr. C, p. 68), prima di ogni intersoggettività (cfr. FS, p. 18), essa sembra allontanarsi dalla caratterizzazione merleau-pontiana della carne che, come abbiamo visto, non è assolutamente eteronoma rispetto alle strutture del senso e la cui dialettica si appoggia proprio sul carattere non assoluto, ma relativo dell’opposizione tra attivo e passivo, visibile e invisibile. Alcuni esiti In Memorie di un cieco, dove si propone un “Programma per una rilettura completa dell’ultimo Merleau-Ponty”36, Derrida avverte che la visibilità di Merleau-Ponty, in quanto comporta in se stessa una non-visibilità, è prossima al suo pensiero di un’identità che si può dare solo tramite la differenza. Tuttavia dichiara che, diversamente da Merleau-Ponty, egli avrebbe più volentieri seguito “le tracce dell’invisibilità assoluta” (ibid). Come abbiamo osservato qui sopra è invece impossibile, nel caso di Merleau-Ponty, parlare di un’invisibilità o una differenza assolute. A questo proposito sembra opportuno aggiungere che la perplessità che Derrida ha più volte dimostrato verso il testo merleau-pontiano (la cui lettura, egli ha ammesso, gli provocava un certo disagio), deriva forse dal fatto che nella sua filosofia non è contemplata una “terza dimensione” che, come la carne merleau-pontiana, funge da “cerniera” tra i due poli di ogni dualismo e quindi egli tende a considerare la continuità sfumata tra visibile e invisibile come indice di un pensiero che in fondo tende alla coincidenza e all’adeguazione37. Al contrario, come abbiamo accennato anche all’inizio di questo testo a proposito della ricezione merleau-pontiana di Husserl, per Merleau-Ponty un pensiero della coincidenza e dell’adeguazione asso23 luta tra visibile e invisibile, tra costituito e costituente, tra sé e gli altri o tra sé e sé non si verifica mai e non può mai verificarsi. Questo avviene perché le lacune della nostra visione, lo scarto che ci separa dagli altri e dalle cose impedendoci di possederle con una visione “di sorvolo” non è un accidente o un ostacolo “di fatto” che si tratta di superare, ma è una condizione “di diritto”, è una sorta di “errore buono” che ci permette di vedere, di percepire e di comprendere qualcosa. Per Merleau-Ponty cogliere la “buona dialettica” che segna la struttura chiasmatica della carne significa “cogliere ciò che fa sì che l’uscire da sé sia rientrare in sé e viceversa” (VI, p. 215)38. È quindi ovvio che non si raggiungerà mai una sintesi; la coincidenza assoluta (con l’altro, con sé, o con l’origine) è impossibile perché lo stesso movimento che operiamo per avvicinarci (all’altro, a noi stessi, all’origine, ecc.) è quello che ce ne allontana: poiché siamo parte della carne e intratteniamo un rapporto di inerenza con il mondo, per conoscere qualcosa dobbiamo distinguercene. Com’è noto, a differenza di MerleauPonty, Derrida aveva presto abbandonato l’impiego del termine dialettica; piuttosto che di dialettica, egli preferiva parlare di différance: con il concetto-non concetto di différance il filosofo intendeva inaugurare un nuovo tipo di pensiero che si delinea solo attraverso l’altro da sé, senza però approdare ad alcuna sintesi alla maniera hegeliana. Si può forse suggerire che in questo caso la diversità tra Derrida e Merleau-Ponty si situi più a livello terminologico che concettuale, e che anche Merleau-Ponty, per certi versi e per altre vie, sia arrivato ad un suo pensiero della différance intesa come impossibilità di un approccio diretto, necessità di uno scarto, necessità di un’invisibilità perché si dia visibilità. La carne, come la chōra, indica allora l’impossibilità di un’apprensione diretta e immediata dell’origine, dell’essere e del senso, che possono essere attinti solo attraverso dei processi di mediazione. Tuttavia per Merleau-Ponty questa mediazione è operata primariamente dalla sensibilità e dalle strutture carnali, mentre per Derrida essa avviene soprattutto al livello del logos. Queste differenze si riflettono nel diverso approccio al tema dell’alterità. Ad esempio, nel testo Le toucher (cit.), Derrida rimprovera a MerleauPonty di valorizzare maggiormente la nozione husserliana di Einfühlung piuttosto che quella di “appercezione analogica”, che egli giudica più adatta ad esprimere un maggiore rispetto per l’alterità dell’altro, poiché apre tra me e lui la distanza delle strutture del logos. In realtà per Merleau-Ponty l’Einfühlung non indica affatto un accesso diretto all’altro, ma una via per comunicare con l’altro attraverso la mediazione della sensibilità piuttosto che attraverso la mediazione del logos39. Questa prospettiva permette a Merleau-Ponty di individuare il luogo del nostro incontro più autentico con l’altro nel regno del pre-logico e di rivalutare così un tipo di comunicazione indiretta, laterale, fatta più di segnali corporei e istintivi che di parole. Que24 sto è testimoniato, ad esempio, dall’interesse che il pensiero di questo filosofo ha sempre suscitato in settori come la musicoterapia, che ricerca un tipo di espressione che non si consuma nello scambio frontale e verbale, studiando strategie di comunicazione alternative per persone che trovano la comunicazione tradizionale molto difficoltosa o impossibile. La diversa posizione di Derrida si ricava anche da un testo di notevole importanza e densità, come Violenza e metafisica, in cui il filosofo, allo scopo di rispettare fino in fondo l’altro e la sua irriducibile alterità, difende una certa lettura di Husserl contro Lévinas, ma finisce per impostare la questione in termini dualistici: da una parte l’altro è un fenomeno, ossia si può dare solo attraverso la mediazione delle categorie del logos che salvaguardano e garantiscono la sua alterità; d’altra parte l’altro è un noumeno, un oltre assoluto che sfuggirà irrimediabilmente e alla cui inviolabilità si dovrà sempre vegliare se voglio che l’altro sia veramente tale40. Ma, direbbe Merleau-Ponty, se l’altro è assolutamente altro non posso farne esperienza, perché non c’è “passaggio” tra noi; se l’altro è un’assenza, non è un’assenza qualsiasi, “bensì una certa assenza, una certa differenza secondo delle dimensioni che ci sono immediatamente comuni, che predestinano l’altro a essere specchio di me così come io lo sono di lui, che fanno sì che noi stessi non abbiamo di qualcuno e di noi, due immagini fianco a fianco, ma un’unica immagine in cui siamo implicati entrambi, che la mia autocoscienza e il mio mito dell’altro siano non due termini contraddittori, ma il rovescio l’uno dell’altro” (VI, p. 104)41. La preoccupazione che Merleau-Ponty avverte nel rapporto con l’altro è duplice: non si tratta solamente di affermare la separazione tra me e l’altro per cautelarsi da un pensiero rassicurante che ambirebbe ad una comunione totale tra gli esseri; si tratta, parallelamente, di affermare anche la prossimità dell’altro, poiché anche la dichiarazione della sua assoluta estraneità sarebbe consolante42: è proprio quando sappiamo che l’altro è un nostro simile, che egli ci appare ancora più estraneo; è proprio quando non possiamo dire di non aver nulla a che fare con lui, che siamo chiamati ad essere responsabili nei suoi confronti; l’alterità, per essere avvertita, deve prendere le mosse da un fondo di “confusione” (che non è coincidenza). Come abbiamo osservato, è appunto la presenza di questo sfondo a segnare uno dei massimi punti di distanza tra le filosofie di Derrida e quella di Merleau-Ponty. Nonostante, attraverso la sua lettura della chōra, Derrida si avvicini alla teorizzazione di una “struttura” originaria che ha molte caratteristiche affini a quelle della carne merleau-pontiana, il suo pensiero mantiene comunque un impianto fondamentalmente dualistico, anche se i termini vengono fatti slittare; non si tratta più, infatti, del dualismo classico tra forma e materia, interno ed esterno, poiché la posizione della chōra al25 l’interno di queste alternative rimane indecidibile. Si tratta, piuttosto, del dualismo tra il logos (con le sue opposizioni binarie) e l’indecidibile stesso (in questo caso tra il logos e la chōra), del dualismo tra il senso e il non senso. Queste considerazioni, tutt’altro che esaustive e che richiederebbero una ricerca ulteriore, possono forse illuminare in parte il significato della diversa posizione di Merleau-Ponty che, nel tentativo di evadere dai canoni del pensiero dualista, ha invece teorizzato la possibilità di un senso diverso da quello del logos approfondendo i temi della natura, della sensibilità, della corporeità e in genere ha maggiormente esplorato il mondo della nostra comunicazione intima e indiretta, profonda e in parte inconsapevole e illogica, con ciò che ci circonda. 1 E. HUSSERL, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewustsseins (1893-1917), a cura di R. Bohem, M. Nijhof, Den Haag 1966; tr. it. di A. Marini, Per una fenomenologia della coscienza interna del tempo (1893-1917), Franco Angeli Editore, Milano 1981, § 36, p. 102. 2 J. DERRIDA, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl, PUF, Paris 1967; tr. it. a cura di G. Dalmasso, La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 1968, 3° ed. 1997, p. 122, nota 8 (d’ora in poi VF). Non è la prima volta che Derrida cita queste parole (cfr. J. DERRIDA, Introduction à “L’origine de la géométrie” de Husserl, PUF, Paris 1962; tr. it. a cura di C. Di Martino, Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, Jaca Book, Milano 1987, p. 135 (d’ora in poi IOG). 3 E. HUSSERL, Per una fenomenologia della coscienza interna del tempo, cit., § 36, p. 102. Ritorneremo più volte su questa necessità di partire dal costituito, che interessa sia il tema della chōra che quello della carne. 4 Si ricorda che in questo notevole testo di Derrida l’elaborazione di questa concezione della temporalità in Husserl costituisce il cuore della decostruzione della “voce” fenomenologica intesa come presenza e coincidenza a sé del soggetto. 5 Cfr. PLATONE, Cratilo, 423D, 423E; tr. it. a cura di G. Reale, in Id., Tutti gli scritti, Rusconi 1991. 6 Ricordiamo che le prime opere di Derrida, a partire dalla tesi di laurea (composta negli anni 1953-54, ma pubblicata alla fine degli anni ’90) sono dedicate all’analisi del pensiero di Husserl, che esercitò un’influenza decisiva nel corso del suo pensiero, anche quando egli cesserà di esaminare direttamente i testi husserliani. 7 J. DERRIDA, Khôra, Galilée, Paris 1993; tr. it. a cura di G. Dalmasso e F. Garritano, Chōra, in Id., Il segreto del nome, Jaka Book, Milano 1997, p. 45 (d’ora in poi C). 8 Cfr. J. DERRIDA, The Time of a Thesis: Puntuactions, in Philosophy in France Today, Cambridge University Press, Cambridge 1983, p. 38. 9 Com’è noto questo testo è inserito come appendice terza in E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die traszendentale Phänomenologie, M. Nijhof, Den Haag 1956; tr. it. di E. Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961, ed. EST, Milano 1997, pp. 380-405. Sia Mer- 26 leau-Ponty che Derrida si interessarono moltissimo a questo scritto. Derrida ne compilò un commentario nel 1962 e Merleau-Ponty vi dedicò un corso al Collège de France nel 1959-60; si vedano rispettivamente il già citato J. DERRIDA, Introduction à “L’origine de la géométrie” de Husserl e M. Merleau-Ponty, Notes de cours sur ‘L’origine de la gèometrie’ de Husserl, PUF, Paris 1998. 10 M. MERLEAU-PONTY, Signes, Gallimard, Paris 1960; tr. it. di G. Alfieri, Segni, Il Saggiatore, Milano 1967, p. 186 (d’ora in poi S). 11 M. MERLEAU-PONTY, Le visibile et l’invisible, texte établi par Claude Lefort, Gallimard, Paris 1964; tr. it di A. Bonomi, Il visibile e l’invisibile, Idee Nuove, Milano 1969, ed. riveduta da M. Carbone, Bompiani 1993, p. 163 (d’ora in poi VI). 12 J.-P. VERNANT, Ragioni del mito, in Mito e società nell’antica Grecia, tr. it. di P. Pasquino e L. Berrini Paletta, Einaudi, Torino 1981, p. 250; cit. da J. Derrida, C, p. 43. 13 Derrida si soffermerà anche sulla connotazione della chōra come madre e nutrice, quindi sulla sua appartenenza al genere femminile, per notare come però la sua collocazione rimanga sospesa e irriducibile ad un genere specifico. La chōra, infatti, “non appartiene ad una coppia oppositiva […] indica un posto a parte, la spaziatura che conserva un rapporto asimmetrico con tutto ciò che […] sembra far coppia con essa” (C, pp. 8283). Per questa caratterizzazione della chōra come madre cfr. G. BENNINGTON, Derridabase, in G. BENNINGTON, Jacques Derrida, Seuil, Paris 1991, pp. 193-198, in cui l’autore osserva che non è un caso che la chōra platonica sia stata fatta oggetto di studi da parte di pensatrici come Kristeva e Irigaray. 14 J. DERRIDA, Fede e sapere, in La religione, annuario filosofico europeo, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 22 (d’ora in poi FS). 15 “Perciò la madre e il ricettacolo di ciò che si genera ed è visibile e interamente sensibile, non diciamola né terra né acqua né fuoco né aria, né altre delle cose che nascono da queste o da cui queste nascono. Ma, dicendola una specie invisibile [anoraton] e amorfa [amorfon] capace di accogliere tutto, e che partecipa in un modo assai complesso dell’intelligibile e che è difficile da concepirsi, non ci inganneremmo. E per quanto, stando a ciò che si è detto, risulti possibile raggiungere la sua natura, nel modo più corretto si potrebbe dire così: ogni volta pare fuoco la parte infuocata di essa, acqua la parte liquida, e così terra ed aria nella misura in cui riceve imitazioni [mimhata] di queste cose?” (PLATONE, Timeo, 51 A-B, tr. it. cit., p. 1377). 16 L’immagine di una deflagrazione dell’origine non è utilizzata da Derrida, ma è di Merleau-Ponty: “l’originario esplode, e la filosofia deve accompagnare questa esplosione, questa non-coincidenza, questa differenziazione” (VI, p. 142). 17 Cfr. J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, PUF, Paris 1990; tr. it. di V. Costa, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, Jaka Book, Milano 1992, p. 51, d’ora in poi PG. 18 È utile osservare che, nella prefazione alla pubblicazione di questo testo, datata 1990, Derrida afferma che questa legge di una contaminazione originaria “fin nella sua formulazione letterale, non ha cessato, da allora, di guidare tutto quanto ho tentato di dimostrare” (PG, p. 51). In effetti possono essere formulati ricorrendo alla coppia continuo/discontinuo anche temi della produzione derridiana successiva: ad esempio, l’aporia della responsabilità è costituita dal fatto che essa prevede, da un lato una continuità con un certo schema di valori, dall’altro la capacità di farsi carico di una scelta di discontinuità radicale, ecc. Si osservi inoltre come questa struttura genetica sia affine a quella della temporalità originaria descritta da Husserl cui abbiamo fatto cenno qui sopra, per cui nel flusso temporale vengono individuati contemporaneamente una continuità e una discontinuità, un’identità e un mutamento. 27 19 Derrida si riferisce a La voce e il fenomeno, Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, La grammatologia e La scrittura e la differenza; cfr. J. DERRIDA, Positions: entretiens avec Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta, Editions de Minuit, Paris 1972, pp. 44-45. 20 Per una definizione di question en retour cfr. J. DERRIDA, IOG, in particolare pp. 99100. Com’è noto per Derrida questo ritardo costitutivo presiede in generale alla formazione del senso. Riguardo alla reciprocità tra costituito e costituente si veda anche J. Derrida, La carte postale: de Socrate a Freud et au-dela, Flammarion, Paris 1980. 21 Cfr. J. DERRIDA, Forcener le subjectile, Schirmer/Mosel Publishers, Munich 1986, tr. it. a cura di A. Cariolato, Anonin Artaud. Forsennare il soggettile, Abscondita, Milano 2005 (d’ora in poi SOG). Tecnicamente il termine soggettile (subjectile) appartiene al lessico artistico e designa il supporto o sostrato di un’opera, “ciò che sta al di sotto” (il foglio, la tela, il muro, la materia di una scultura, ecc.). Derrida paragona il soggettile alla chōra alle pp. 77, 86, 89, 90. In altre pagine (49, 53) egli parla invece del soggettile come di “ricettacolo”. Si osservi che, in apparente contrasto, Derrida, nel testo sulla chōra, afferma che “Chōra non è un soggetto. Non è il soggetto. Né il supporto (subjectile)” (C, pp. 52-53). In effetti i due concetti non si possono sovrapporre e si limitano ad incrociarsi laddove entrambi indicano la struttura di un suolo che si auto-costituisce nella maniera circolare che abbiamo tentato di illustrare. L’analogia però si arresta se per “soggettile” si intende un supporto stabile, o un soggetto, che sia possibile raggiungere, che si lasci concepire come tale (cfr. C, p. 53). 22 A proposito del rapporto tra Derrida e lo strutturalismo e sulla concezione di espacement in connessione con la différance si veda M. IOFRIDA, Forma e materia. Saggio sullo storicismo antimetafisico di Jacques Derrida, ETS, Pisa 1988 in particolare capitoli I e II. 23 Cfr. PLATONE, Timeo, 52 A 8 sgg. E52 B 4 (qui come topoj). 24 M. HEIDEGGER, Einführung die Metaphysik, M. Niemeyer, Tübingen 1966, tr. it. di G. Masi, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1968, pp. 76-77; cit. leggermente modificato in Chōra, p. 51, nota 8. 25 “Si tratterebbe [?] di una struttura e non di qualche essenza della chōra, non avendo la questione dell’essenza più senso a tale riguardo”(C., p. 51). 26 In particolare ricordiamo che Merleau-Ponty critica Sartre per non avere sviluppato una propria teoria della passività e per avere identificato soggettività e attività, diversamente da come invece aveva fatto Husserl, che aveva lasciato sempre più spazio, nei suoi ultimi scritti, ad una intenzionalità operante, senza atti (fungierende Intentionalität). 27 Cfr. M. CARBONE, La luce della carne. Istanze antiplatonistiche e tracce neoplatoniche nel pensiero dell’ultimo Merleau-Ponty, “Annuario Filosofico”, n. 20, 2004 (ed. 2005), pp. 133-144. 28 Come nel caso della chōra (cfr. qui sopra, nota 13), pur non appartenendo ad un genere specifico la carne sembra aderire più al genere femminile che a quello maschile. Ne Il visibile e l’invisibile Merleau-Ponty, parlando della natura, annota: “è la carne, la madre” (VI, p. 278). 29 Cfr. anche ivi, p. 23: chora “sarà sempre stata […] il luogo stesso di una resistenza infinita, di una prestanza infinitamente impassibile: un tutt’altro senza volto”. 30 Derrida non menziona l’argomento del terzo uomo nel testo sulla chōra. Com’è noto l’argomento, in cui possiamo rintracciare una struttura simile a quella della mise en abyme, fu formulato da Platone stesso nel Parmenide. 31 Per capire in che senso la filosofia di Derrida si possa considerare un dualismo si veda M. IOFRIDA, L’esaurimento del programma post-strutturalista: un bilancio e qualche prospettiva, in Id., Per una storia della filosofia francese contemporanea. Da Derrida a 28 Merleau-Ponty, Mucchi Editore, Modena 2007, pp. 59-83. Per un confronto tra MerleauPonty e Derrida che sviluppa questo tema in relazione alla diversa concezione dell’alterità espressa dai due filosofi mi permetto di rimandare a M. ARICI, Derrida e Merleau-Ponty: due letture di Husserl a confronto, in AV.VV., Après coup – L’inevitabile ritardo. L’eredità di Derrida e la filosofia a venire, Bulzoni, Roma 2006, pp. 65-86. 32 Come testimonia l’insistenza sui temi del corpo, della natura, della percezione, la filosofia di Merleau-Ponty si caratterizza per una forte ricerca di concretezza. Potremmo anche accostare l’aspetto qui illustrato della carne al senso etimologico di con-cretum, che significa ciò che è cresciuto insieme, ciò che definisce il suo significato in relazione con le altre cose, in cui gli elementi sono connessi gli uni agli altri e che si differenza quindi dall’astratto, ossia ciò che è separato, singolo, ciò che è estrapolato da questa struttura. Si osservi che questa particolare lettura della contrapposizione tra concreto e astratto è offerta da Adorno in alcune Lezioni sulla terminologia filosofica, in relazione alla filosofia hegeliana: “ciò che noi chiamiamo abitualmente concreto, ciò che ci troviamo di fronte qui e ora come isolato, singolo, sparso, e anche noi stessi in quanto ci contrapponiamo isolatamente a queste cose sparse, queste, che per il linguaggio abituale sono realtà concrete, per Hegel sono l’astratto”. In questo senso il pensiero di Derrida, pur incontrando questo peculiare significato della “concretezza” (soprattutto con la nozione di espacement), ha degli aspetti di maggiore astrazione rispetto a quello di Merleau-Ponty, ad esempio quando Derrida parla di una singolarità “assoluta”. 33 Merleau-Ponty elabora questa concezione di un tempo che si fa spazio e viceversa in parte seguendo, in parte criticando Husserl. Per un’analisi più dettagliata su questa comunicazione tra spazio e tempo, che si basa su di una certa concezione della profondità, mi permetto di rimandare a M. ARICI, Avventure dell’espressione, Bulzoni, Roma 2007, pp. 84-105 e pp. 126-136. È possibile accostare la spazialità della chōra a quella della carne anche a partire da un tardo testo husserliano sulla dottrina copernicana (citato più volte sia da Merleau-Ponty che da Derrida) in cui il filosofo tedesco non concepisce la Terra come il pianeta fisico delle “mere cose”, ma come il suolo originario in rapporto al quale movimento e riposo oggettivi perdono senso, il “qui” assoluto che ci porteremmo sempre con noi anche se ci allontanassimo dalla terra fisica. Cfr. E. HUSSERL, Umsturz der Kopernikanischen Lehre in der gewöhnlichen weltanschaulichen Interpretation. Die Ur-Arche Erde bewegt sich nicht [1934], inedito contrassegnato D17, pubblicato in M. Farber (a cura di), Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1940, pp. 307-325; tr. it., a cura di G.D. Neri, Rovesciamento della dottrina copernicana nella corrente interpretazione del mondo, in “Aut-aut”, n. 245, 1991, pp. 3-18. 34 Osserviamo che, come per Derrida, anche secondo Merleau-Ponty la genesi è simultaneamente interna ed esterna rispetto al suo divenire, perché essa descrive il movimento paradossale di “un atto inaugurale che abbraccia un divenire senza essere all’esterno di un tale divenire” (M. MERLEAU-PONTY, La nature, Notes de cours 1956-1960, Seuil, Paris 1995; tr. it. di M. Mazzocut-Mis e F. Sossi, La natura, Cortina, Milano 1996, p. 87). 35 Questo passaggio è citato anche da M. Carbone in La luce della carne (cit). Merleau-Ponty si è interessato moltissimo alla scrittura di Proust, da lui considerato come colui che ha saputo esplorare più di ogni altro i tipi di rapporti che intercorrono tra il visibile e l’invisibile. Il filosofo francese osserva che Proust compose la Ricerca del tempo perduto narrandone l’origine, narrando cioè di come il suo vissuto si convertisse pian piano in lui in una scrittura nuova. Proust cerca di dare forma ai segni sconosciuti del suo vissuto, ma la decifrazione di questo vissuto coincide con la sua ri-creazione, quindi con 29 una sua certa deformazione che però non è totalmente arbitraria, perché deriva proprio da esso. Un altro bell’esempio di questa paradossale inversione tra figure e sfondi si ritrova in una testo in cui Merleau-Ponty descrive le “avventure” della linea di Klee, un pittore a lui molto caro: “Una linea suscita il campo che le dà senso deformando il campo dato”; M. MERLEAU-PONTY, Notes de cours. 1959-1961, Gallimard, Paris 1996; tr. it. di F. Baracchini e A. Pinotti, È possibile oggi la filosofia?, Cortina, Milano 2003, p. 21. 36 J. DERRIDA, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Ed. Réunion Musées Nationaux, Paris 1999; tr. it. di A. Cariolato e F. Ferri, Memorie di un cieco. L’autoritratto e altre rovine, Abscondita SRL, Milano 2003, p. 71. 37 Cfr. ad esempio J. DERRIDA, Le Toucher, Jean Luc Nancy, Galilée, Paris 2000, pp. 238-239: “Qu’est-ce qui (me) rend la lecture de Merleau-Ponty si malaisée? […] Peutêtre ceci, en un mot: le mouvement que nous avions évoqué, cette expérience de la coïncidence avec la non-coïncidence, […] nous le retrouvons transféré dans l’ordre de la conséquence (inconséquente) ou de la continuité (interrompue) des énoncés philosophiques, et de façon non pas toujours diachronique, selon l’évolution ou la mutation d’une pensée, mais parfois synchronique. Faut-il en créditer le philosophe, comme je suis le plus souvent tenté de faire, ou au contraire regretter qu’il n’ait pas pu procéder à une reformalisation plus puissante de son discours pour thématiser et penser la loi sous laquelle il se plaçait ainsi, préférant toujours, au bout de compte, en fait, la ‘coïncidence’ […] à la ‘non-coïncidence’?” 38 Si osservi come in fondo questa impossibilità di una sintesi, di una coincidenza, non sia che una delle conseguenze dell’affermazione dell’impossibilità della riduzione fenomenologica, impossibilità che appare evidente anche a Derrida nel momento in cui, ne La voce e il fenomeno, egli afferma che “La riduzione fenomenologica è una scena” (cfr. VF, p. 124), ossia che è necessario uscire da sé, mettersi in scena, per riconoscersi come sé, per rientrare in sé. Nel porre il sé come equivalente a se stesso, si è già insediata un’alterità in seno alla coscienza. In più luoghi Merleau-Ponty cita inoltre Heidegger, il quale, in Identità e differenza afferma che l’identità è da comprendere come Dasselbe e non das Gleiche, perché “nell’uguale scompare la differenza, mentre nello stesso appare la diversità” (cfr. M. HEIDEGGER, Identität und Differenz, Neske, Pfullingen 1957; tr. it. di U. M. Ugazio, Identità e differenza, in “aut aut”, n. 187, 1982, p. 19). L’impossibilità della riduzione e la messa in discussione di un soggetto trascendentale, oltre che dall’elaborazione del pensiero heideggeriano, è ricavata anche dalle Lezioni di Husserl sulla costituzione della temporalità originaria che abbiamo citato all’inizio di questo testo: se la temporalità è questa non-identità e se la soggettività è temporale, è chiaro che una coincidenza a sé della coscienza è impossibile. È interessante osservare la prossimità di alcune considerazioni di Merleau-Ponty e del primo Derrida su questo tema; cfr. ad esempio J. Derrida, PG, p. 158: “La soggettività è il tempo che si auto-temporalizza. Il tempo è la soggettività che si auto-realizza come soggettività. […] Nell’identità assoluta del soggetto con se stesso la dialettica temporale costituisce a priori l’alterità. soggetto appare originariamente come tensione del Medesimo e dell’Altro”, e M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945; tr. it. di A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 544: “Non comprenderemmo mai come un soggetto pensante o costituente possa porre o cogliere se stesso nel tempo. […] Ma se il soggetto è temporalità, allora l’autoposizione cessa di essere una contraddizione, poiché esprime esattamente l’essenza del tempo vivente. […] l’esplosione o la deiscenza del presente verso un avvenire è l’archetipo del rapporto di sé con sé”. 39 Ho trattato in maniera più estesa questo argomento in M. ARICI, Derrida e Merleau-Ponty: due letture di Husserl a confronto, in AA.VV., Après coup – L’inevitabile ritardo. 30 L’eredità di Derrida e la filosofia a venire, Bulzoni, Roma 2006, pp. 65-86, cui mi permetto di rimandare. 40 Sotto questa prospettiva, che afferma un’alterità assoluta dell’altro, si possono rileggere anche alcune concezioni che Derrida espone soprattutto nei suoi ultimi testi in cui si avverte una certa distanza dalle posizioni di Merleau-Ponty; mi riferisco in particolare alle tematiche del “dono”, della “responsabilità” e del “segreto” (che si appella ad una “singolarità assoluta”), con cui Derrida si pone in relazione con il pensiero di Emmanuel Lévinas. 41 Queste argomentazioni sono indirizzate da Merleau-Ponty contro l’impostazione dualistica data da Sartre al tema dell’alterità. A questo proposito cfr. anche M. ARICI, Derrida e Merleau-Ponty: due letture di Husserl a confronto, cit., pp. 78-80. 42 Confrontando fra loro alcuni aspetti dei pensieri di Merleau-Ponty, Franck, Nancy, Derrida e Henry, Mauro Carbone scrive: “Affermare l’assoluta distinzione fra la carne e la pietra, il familiare e l’estraneo, il fratello e l’intruso, come la ragazza di Novi Ligure non fosse stata lei stessa parte della famiglia che ha distrutto, questo sì, sarebbe evidentemente consolatorio” (M. CARBONE, D. M. LEVIN, La carne e la voce. In dialogo tra estetica ed etica, Mimesis, Milano 2003, p. 32). Bibliografia e abbreviazioni M. ARICI, Avventure dell’espressione. La pittura, la musica e la nuova ontologia di M. Merleau-Ponty, Bulzoni, Roma 2007. M. ARICI, Derrida e Merleau-Ponty: due letture di Husserl a confronto, in AA.VV., Après coup – L’inevitabile ritardo. L’eredità di Derrida e la filosofia a venire, Bulzoni, Roma 2006, pp. 65-86. G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Jacques Derrida, Seuil, Paris 1991. M. CARBONE, D. M. LEVIN, La carne e la voce. In dialogo tra estetica ed etica, Mimesis, Milano 2003. M. CARBONE, La luce della carne. Istanze antiplatonistiche e tracce neoplatoniche nel pensiero dell’ultimo Merleau-Ponty, «Annuario Filosofico», n. 20, 2004 (ed. 2005), pp. 133-144. J. DERRIDA, La carte postale: de Socrate a Freud et au-dela, Flammarion, Paris 1980. J. DERRIDA, Fede e sapere, in AA.VV. La religione, annuario filosofico europeo, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari 1995 = FS. J. DERRIDA, Forcener le subjectile, Schirmer/Mosel Publishers, Munich 1986, tr. it. a cura di A. Cariolato, Anonin Artaud. Forsennare il soggettile, Abscondita, Milano = SOG. J. DERRIDA, Introduction à “L’origine de la géométrie” de Husserl, PUF, Paris 1962; tr. it. a cura di C. Di Martino, Introduzione a “L’origine della geometria” di Husserl, Jaca Book, Milano 1987 = IOG. 31 J. DERRIDA, Khôra, Galilée, Paris 1993; tr. it. a cura di G. Dalmasso e F. Garritano, Chōra, in Id., Il segreto del nome, Jaka Book, Milano 1997 = C. J. DERRIDA, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Ed. Réunion Musées Nationaux, Paris 1999; tr. it. di A. Cariolato e F. Ferri, Memorie di un cieco. L’autoritratto e altre rovine, Abscondita SRL, Milano 2003. J. DERRIDA, Positions: entretiens avec Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta, Editions de Minuit, Paris 1972. J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, PUF, Paris 1990; tr. it. di V. Costa, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl, Jaka Book, Milano 1992 = PG. J. DERRIDA, The Time of a Thesis: Puntuactions, in Philosophy in France Today, Cambridge University Press, Cambridge 1983. J. DERRIDA, Le Toucher, Jean Luc Nancy, Galilée, Paris 2000. J. DERRIDA, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl, PUF, Paris 1967; tr. it. a cura di G. Dalmasso, La voce e il fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 1968, 3° ed. 1997 = VF. M. HEIDEGGER, Einführung die Metaphysik, M. Niemeyer, Tübingen 1966, tr. it. di G. Masi, Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1968. M. HEIDEGGER, Identität und Differenz, Neske, Pfullingen 1957, tr. it. di U.M. Ugazio, Identità e differenza, in “aut aut”, n. 187, 1982. E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die traszendentale Phänomenologie, M. Nijhof, Den Haag 1956; tr. it. di E. Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 1961, ed. EST, Milano 1997. E. HUSSERL, Umsturz der Kopernikanischen Lehre in der gewöhnlichen weltanschaulichen Interpretation. Die Ur-Arche Erde bewegt sich nicht [1934], inedito contrassegnato D17, pubblicato in M. Farber (a cura di), Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 1940, pp. 307-325; tr. it., a cura di G.D. Neri, Rovesciamento della dottrina copernicana nella corrente interpretazione del mondo, in “aut-aut”, n. 245, 1991. E. HUSSERL, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewustsseins (1893-1917), a cura di R. Bohem, M. Nijhof, Den Haag 1966; tr. it. di A. Marini, Per una fenomenologia della coscienza interna del tempo (1893-1917), Franco Angeli Editore, Milano 1981. M. IOFRIDA, Forma e materia. Saggio sullo storicismo antimetafisico di Jacques Derrida, ETS, Pisa 1988. M. IOFRIDA, L’esaurimento del programma post-strutturalista: un bilancio e qualche prospettiva, in Id., Per una storia della filosofia francese contemporanea. Da Derrida a Merleau-Ponty, Mucchi Editore, Modena 2007, pp. 59-83. M. MERLEAU-PONTY, La nature, lezioni al Collège de France 1956-1960, Edi32 tions du Seuil, Paris 1995, tr. it. di M. Mazzocut-Mis e F. Sossi, La natura, Cortina, Milano 1996. M. MERLEAU-PONTY, Notes de cours. 1959-1961, Gallimard, Paris 1996; tr. it. di F. Baracchini e A. Pinotti, È possibile oggi la filosofia?, Cortina, Milano 2003. M. MERLEAU-PONTY, Notes de cours sur ‘L’origine de la gèometrie’ de Husserl, PUF, Paris 1998. M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945; tr. it. di A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1965 = FP. M. MERLEAU-PONTY, Signes, Gallimard, Paris 1960; tr. it. di G. Alfieri, Segni, Il Saggiatore, Milano 1967 = S. M. MERLEAU-PONTY, Le visibile et l’invisible, texte établi par Claude Lefort, Gallimard, Paris 1964; tr. it di A. Bonomi, Il visibile e l’invisibile, Idee Nuove, Milano 1969, ed. riveduta da M. Carbone, Bompiani 1993 = VI. PLATONE, Tutti gli scritti, tr. it. a cura di G. Reale, Rusconi 1991. 33 S AGGI IL COLLASSO DELLA PAROLA IN ANTONIN ARTAUD* di Santi Lo Giudice La ragione mi ha insegnato che il condannare così risolutamente una cosa come falsa e impossibile significa presumere di avere nella testa i confini e i limiti della volontà di Dio e della potenza della nostra Natura, e tuttavia non esiste al mondo follia più grande del riportarle della nostra sicumera. Montaigne, Saggi La follia è un momento duro ma necessario nel lavorio della ragione; attraverso di essa, e persino nelle sue vittorie apparenti, la ragione si manifesta e trionfa. La follia non era per essa se non la sua forza viva e segreta. Foucault, Storia della follia nell’età classica Vittorino Andreoli, in una intervista rilasciata al “Corriere della Sera” di domenica 29 ottobre 1995 in occasione della pubblicazione del suo bellissimo romanzo Camice matto 1, ha espresso questa idea sconvolgente: «La pazzia è oramai un’ombra affascinante e minacciosa che accompagna ciascuno di noi. Tanto che se voglio offendere un amico basta dirgli: tu non sei neanche un po’ matto». E aggiunge che con questa considerazione «vent’anni addietro non avrei fatto arrabbiare nessuno. Oggi la follia è nel contempo temuta e desiderata». Pertanto c’è da chiedersi: se la follia è diventata il comune denominatore della nostra vita relazionale, allora è possibile che l’esclusione di una persona o di un’intera collettività dal vissuto di «sinistre» contaminazioni sia ritenuta un’azione offensiva? Andreoli sembra che abbia ben visto; anche se riteniamo che la parola «offesa» debba essere congiunta alla parola «colpa»: ci si offende perché, nel sentirsi privati dalla follia, si avverte tutto il peso del sapere. E siccome il sapere genera affanno, come recita l’Ecclesiaste, si preferisce l’offesa alla colpa. Per evitare di sentirci colpevoli da giuste o ingiuste mancanze, dettate in parte da limiti naturali, in parte da limiti sociali, in parte da limiti individuali, in parte da una moralmente insana volontà, all’esser considerati saggi preferiamo l’esser considerati matti. La follia libera dagli obblighi morali e intellettuali, la saggezza ci lega a essi, soprattutto attraverso i volti votati da sempre alla sofferenza, alla privazione, alla povertà, all’indigenza, ma anche alla sopraffazione e alla vessazione. La follia della modernità, spesso, è figlia della superbia (ciò che i Gre34 ci chiamavano hybris, a testimoniare della separazione dell’uomo dal divino), mentre la saggezza è figlia della consapevolezza della condizione umana (ciò che i Greci chiamavano omilía a testimonianza dello «stare insieme» dell’uomo col dio). Eppure, un tempo, la follia aveva una sua dignità, acquisita attraverso percorsi sapienziali. Penso, tra i tanti, a quelli che mi giungono da pensatori canonici come Platone e Kant; ma penso anche ai percorsi che mi giungono da un pensatore controverso come Antonin Artaud, che ha consumato la sua vita alla ricerca iperbolica di costruttività linguistiche all’insegna di «misure senza misura». 1. Platone: i doni della follia Follia e Ragione sono per Platone un’esperienza dell’anima. E lo sono entrambe e alla stessa stregua a condizione, come riferisce Umberto Galimberti, che si legga Platone in modo non «platonico», cioè in modo non «ascetico», non «cristiano»2. «I problemi che gli stanno a cuore sono quelli della dicibilità e dell’indicibilità, quindi le regole della ragione e gli abissi della follia», dice Galimberti. Crediamo che sia vicino al vero Galimberti quando afferma: «Platone nell’edificare il cosmo della ragione, il solo che gli uomini possono abitare, non chiude l’abisso del caos, ma lo riconosce come minaccia e dono, come sede di parole incontrollabili, come dimora degli dèi»3. Galimberti supporta questa lettura facendo ricorso a due indicativi passi del Fedro, laddove Platone non esita ad affermare: «I beni più grandi ci provengono mediante una follia (mania) che ci viene data per concessione divina» (244 a), e poco più oltre: «La follia (mania) che proviene da un dio è migliore dell’assennatezza che proviene dagli uomini» (244 d). Espressioni che non vanno collocate ai margini della scrittura platonica, ma fanno parte dell’essenza del pensiero platonico e sono in assoluta armonia con la dottrina dell’anima e delle idee presente nel Fedone e nella Repubblica. Platone non solo inaugura l’«anima razionale» ma si predispone all’altrui comprensione affinché si comprenda la grande fatica che c’è voluto per liberarla dagli abissi da dove per lunghissimo tempo era costretta ad operare. Per consentire che l’«anima» emergesse come «razionale», che facesse suoi i significati che gli erano propri di «divina follia» (theía manía), Platone nel Fedro evidenzia la positività di chi opera in stato di follia e mette l’accento su quanti nulla hanno fatto per scioglierla dal fondo psichico in cui giaceva da così lungo tempo. «La profetessa di Delfi e le sacerdotesse di Dodoma, quando si trovavano in stato di follia (mania), procurarono all’Ellade molti e bei benefici e in privato e in pubblico, 35 mentre, quando si trovarono in stato di senno (sophroneín), ne procurarono pochi o nessuno» (244 a-b). Alle profetesse appena menzionate, Platone accomuna la «Sibilla» e «altri che, avvalendosi della mantica dell’ispirazione divina, predicendo molte cose a molti, li indirizzavano sulla giusta via per il futuro» (244 b). L’ispirazione divina, man mano che la trattazione tende a concludersi, viene attribuita agli dèi mediante altre espressioni di follia: «Della divina follia abbiamo distinto quattro parti con riferimento a quattro dèi: abbiamo attribuito ad Apollo l’ispirazione profetica, a Dioniso l’ispirazione iniziatica, alle Muse la poetica, e la quarta ad Afrodite e a Eros, e abbiamo detto che la follia amorosa è la migliore» (265 b). Nel discernere queste quattro forme di follia, Platone, fa presente Galimberti, sembra dare l’impressione di trascurare «quell’identità che tutte le sottende e le contrappone […] all’umana ragione»4. Le cose non stanno in questi termini. Perdere di vista l’identità e la conseguente contrapposizione tra «umana ragione» e «divina follia» significa non cogliere l’intenzionalità platonica che distingue la differenza tra la conoscenza delle cose del mondo affidata alla «ragione umana» e la conoscenza di sé dal «dio proveniente». Platone non può permettersi di smarrire i termini di questa differenza; e non può perché non saprebbe dove andare una volta che si è proclamato la «voce» di Socrate, di chi aveva sacrificato la sua vita per affermare l’identità ragione=virtù=felicità, di chi aveva rintracciato nella ragione umana la conduzione di uno stile improntato a una vita di saggezza (sophrosine). Con Socrate e, soprattutto, dopo Socrate l’anima non può procedere fuori dal corpo: l’anima non può avere più vita autonoma ma deve scendere a compromesso col corpo, ascoltare le sue scansioni e apprezzandone i suoi ritmi. Anima e Corpo danno vita al «soggetto», e per quanto violenti siano i contrasti mentre si vive ci si rende ben presto conto di quanto sia indispensabile la presenza di entrambi. E, si badi, non si tratta di due polarità che dicono dell’una e dell’altro ma di un insieme dove l’una vive dell’altra, si alimenta cresce e muore grazie all’altra (e anche se un giorno dovessero prendere strade diverse non è detto che non conservino memoria dell’altra in attesa di un definitivo ricongiungimento). Una volta che ha preso coscienza dell’esistenza di un linguaggio senza regole (Filebo, Fedro), Socrate «sa di non sapere» e ne reitera il convincimento. Il suo dialogare con tutti, indipendentemente dal ceto e dalle credenze, si sostanzializza nell’interrogativo: che cos’è il bene, il giusto, il santo? E ciò al fine di raggiungere una definizione sulla cosa oggetto d’argomentazione, che ponga fine all’oscillazione di senso e alla proliferazione selvaggia dei suoi significati. Socrate ha insegnato che se non si addiviene a un punto fermo al di sopra delle correnti della vita si rischia di farsi trascinare fino all’incontrovertibile naufragio. Necessita, nella dialettica dell’esistenza, raggiungere un punto fermo, un punto di riferimento da cui 36 tutto si genera e a cui tutto tende. Un punto che sia capace di sorreggersi da sé, che non si faccia scalfire dalle infinite metamorfosi cui la dialettica fa ricorso. Non è un caso che nei dialoghi Socrate ha sempre ragione; a conferirgliela è il metodo da lui inventato per annullare l’oscillazione del linguaggio e raggiungere l’univocità di senso. Univocità che rende Socrate, a vista di Platone, il padrone di tutte le ragioni e di tutti i significati che emergono oltre la sfera degli enigmi e degli oracoli. La caverna delfica cede alla luce della piazza (agorá), i messaggi soffusi dall’oracolo si dileguano e al loro posto s’insediano le parole disciplinate dalla ragione. Siamo al primo cambiamento di rotta per l’umanità. L’anima, oramai soggetto storico, prende le distanze dall’inquietudine dell’enigma e cerca quiete sotto le ali del sapere. Lasciate le vaghe narrazioni dei miti o degli indizi oracolari, l’anima viaggia verso il possesso delle idee in cui è sita l’essenza delle cose del mondo che le definizioni producono e riproducono. La dialettica partorisce il logos e nel logos i significati si fissano una volta per tutte. Siamo al cospetto di ciò che Platone chiama epistéme: cioè, a seguire Emanuele Severino, «significa lo stare (stème) che si impone su (epí) tutto, e principalmente sull’irrequietezza minacciosa del divenire»5. Questo cambiamento di rotta, che conduce l’uomo dalle seduzioni eleusine alla certezza delle idee, dall’instabilità della conoscenza mitologica alla stabilità della conoscenza razionale, è un’acquisizione definitiva nel percorso platonico. Si direbbe di sì, ma a una condizione: che ci si intenda sul termine epistéme. Platone non contempla l’anima razionale soltanto per la sua capacità di imbastire disciplina e ordine, ma anche di prendere coscienza dell’indisciplina e del disordine. Che tradotto in termini diversi significa che per Platone l’anima razionale deve restare sempre memore degli abissi dell’irrazionalità dai cui è emersa. Platone nel Simposio mette Socrate – proprio quel Socrate che ha fatto del «saper di non sapere» il suo fondamentale strumento di ricerca – nella condizione di affermare che l’unica conoscenza di cui è in possesso certo ha per oggetto la scienza delle cose d’amore: «Vi assicuro, di nulla ho sapere (oudén epístashtai) se non delle cose d’amore» (177 d). Il termine usato da Socrate è epistéme; ma, si badi, non più il sapere abituale ma quello dettato dall’anima che spinge “oltre”. E, puntualizza Socrate: «Amore è un gran demone intermedio fra dio e mortale» (202 e 203 a); dunque, amore non agisce tra gli umani, ma tra gli umani e gli déi. Socrate ha sapere dell’amore; anzi ne ha epistéme, cioè conoscenza stabile. Socrate sa delle profondità da cui l’anima è emersa, si è affacciata alla luce, e discerne tra l’uomo volgare che ha dimenticato la sua origine e l’uomo demoniaco che ne mantiene intatta la memoria: «Chi è sapiente in queste cose è un uomo demoniaco (daimónios); chi, invece, è sapiente in altre cose, in arti o in mestieri, è un uomo volgare (bánausos)» (203 37 a). Socrate non è un uomo volgare: avendo conoscenza (epistéme) delle cose d’amore non le riconduce alle vicende umane ma a quel rapporto lacerante che da sempre è esistito tra gli umani e gli dèi. Gli dèi sono, però, dentro di noi e, pertanto, la loro follia ci abita. Sapere le cose d’amore significa sapere che con il sapere delle cose d’amore siamo in sintonia con l’altra parte di noi stessi, con quella follia da cui un tempo remoto ci siamo emancipati, senza dimenticare la memoria di questa emancipazione. Ogni qual volta (cioè sempre) siamo presi dalle cose d’amore sappiamo, se non siamo uomini volgari, che la follia ci sta accanto e, con amabile discrezione, ci tira un lembo della nostra veste quando facciamo finta d’esserci dimenticati della sua presenza. Socrate assicura di avere epistéme e, Platone, che da Socrate ha appreso del valore del logos (nella sua più ampia accezione) vuol testimoniare della sua demoniacità dando conferma che al di qua e al di là dell’epistéme l’esistenza restituisce i suoi spazi all’uomo comune. Inaugurare l’anima significa, per Platone, stabilizzare il logos in modo da bandire da noi e dalla città ogni possibile ambiguità o disordine. 2. Kant: note al saggio sulle malattie della mente A dare ascolto ai biografi, verso la fine dell’inverno 1803, penultimo suo anno di vita, Kant fu accompagnato da sogni terribili. Per lo più si trattava di sogni legati a figure di assassini che attentavano alla sua vita. Immagini che lo stravolgevano al punto da indurlo, a risveglio avvenuto, a individuare nel domestico che lo accudiva il sicario disposto a eliminarlo. Eppure, al ricordo delle notturne terribili visioni, nel diario ebbe ancora la forza di annotare: «Non arrendersi ora al panico del buio»6. Era l’ultimo tentativo di un uomo stremato che percepiva quanto la sua mente vacillasse e fosse vicina alla catastrofe. Kant finirà i suoi giorni in un catatonico rammollimento cerebrale. Forza del paradosso: i toni beffardi presero il sopravvento proprio sul pensatore che ha trascorso il suo tempo a combattere contro tutto quanto attentasse la ragione. Primariamente la follia, che non disdegnò di indagare ma dalla quale non si lasciò minimamente contaminare. Nel 1764, al tempo del compimento del suo quarantesimo anno, Kant su invito di Johann Georg Hamann scrisse il Saggio sulle malattie della mente7. E se si volge attenzione a tutto il resto della sua produzione si comprenderà meglio il perché tornerà sull’argomento con considerazioni identiche a quelle sviluppale nel saggio pubblicato nella rivista diretta da Hamann. Del resto l’intera produzione kantiana è interpretata alla luce del rafforzamento del corretto uso della ragione contro le illusorie pretese di ciò che non è razionalizzabile. In netto contrasto con il movimento roman38 tico, oramai alle porte, che rintraccia nella follia un motivo di seduzione per la ragione, Kant non nutre alcuna simpatia per la malattia mentale. La osteggia a tal punto da ritenerla un nemico insidioso e imprevedibile. Meglio rafforzare le difese dell’intelletto, come dimostra la strategia che egli si è dato con la Critica della ragion pura. Noi abbiamo fin qui non solo percorso il territorio dell’intelletto puro esaminandone con cura ogni parte, ma l’abbiamo anche misurato e abbiamo in esso assegnato a ciascuna cosa il suo posto. Ma questa terra è un’isola chiusa dalla stessa natura entro confini immutabili. È la terra della verità (non allettante!) circondata da un vasto oceano tempestoso, impero proprio dell’apparenza, dove nebbie fitte e ghiacci prossimi a liquefarsi, danno a ogni istante l’illusione di nuove terre e incessantemente ingannando con vane speranze il navigante errabondo in cerca di nuove scoperte, lo traggono in avventure alle quali egli non sa mai sottrarsi e delle quali non può venire a capo8. «L’oceano tempestoso», «le fitte nebbie», «i ghiacci che si sciolgono». Ecco le nordiche e terrificanti metafore che Kant utilizza per difendere il naufragio della mente dall’insidia più prossima: i perigli dell’imprevedibile, di quel seducente ma ingannevole universo che è l’onirico mondo del mistero. Certo la strategia kantiana non si sofferma sulla ricerca delle cause che generano la malattia mentale. Ma la sua impostazione è di raffinata violenza intellettuale, tanto che un poeta come Heine non esita a definire il pensiero di Kant «micidiale e annientatore»9, portatore, in ambito del pensiero, dello stesso «terrorismo» di cui, in ambito politico, il destino riservò a Robespierre. La terapia che egli propone contro le oscure pretese che freneticamente si muovono dentro la testa del folle si definisce a cominciare da un’analisi filosofica che riferisce, apertis verbis, intorno alle funzioni e ai limiti dell’intelletto. Sul piano della chiarezza e dell’evidenza, per Kant, l’uomo non può addivenire a nessuna forma di conoscenza che non cada all’interno dell’esperienza: Le alte torri e i grandi uomini metafisici (che a queste assomigliano), intorno a cui di solito c’è molto vento, non sono per me. Il mio posto è la fertile bassura dell’esperienza10. Da questa scrittura si evince: tutta la complessa storia, che nel Settecento spingerà la figura del folle dentro la cornice delle spiegazioni deterministiche, genera il più assoluto disinteresse di Kant. Stranezza del destino. Singolare coincidenza vuole che nel 1764, anno della pubblicazione del Saggio 39 sulle malattie della mente, appaia a Londra in forma anonima il Dizionario filosofico di Voltaire, che dedica alla follia una voce. Voltaire, di fronte alle spiegazioni che della follia offre il suo tempo, si rifugia nella celia. Di fronte a quanti dicono che «l’anima è pura» e, pertanto, «non può andare soggetta in sé a nessun’infermità», Voltaire dubita fortemente che ciò sia vero; anzi è convinto che «la facoltà di ragionare, data da Dio all’uomo, sia soggetta ad alterarsi come gli altri organi». «Un pazzo – scrive non senza una punta di ironia – è un ammalato il cui cervello soffre, come il gottoso è un malato che ha male ai piedi e alle mani: egli pensava col cervello, come camminava con i piedi, senza d’altronde aver chiara idea né della sua incomprensibile facoltà di camminare, né della sua non meno incomprensibile facoltà di pensare. Dunque si può avere la gotta al cervello, come si ha la gotta ai piedi? Insomma dopo mille ragionamenti, c’è forse soltanto la fede che possa persuaderci che una sostanza semplice e immateriale vada soggetta alle malattie»11. La chiosa finale della voce voltairiana la dice tutta sul rapporto dei dotti con la follia: «Mi dispiace per Ippocrate che egli abbia prescritto il sangue d’asino per la follia, e ancor più mi dispiace che il Manuale delle dame dica che si guarisce dalla follia quando si prende la rogna». Commenta Voltaire: «Sono ricette assai curiose: sembrano inventate dai malati stessi»12. Kant e Voltaire rinunciano a misurarsi con un tema che li costringerebbe a varcare la soglia di quella casa instabile dove la ragione rischierebbe il naufragio e si ritraggono l’uno nella fortezza dell’intelletto, l’altro in quello della satira. Entrambi rifiutano la discesa nei recessi oscuri della malattia mentale. I malati mentali guardati da Kant e da Voltaire sono, dunque, privi di spessore psicologico. Kant, nello specifico, si limita a offrirci una nomenclatura delle storture della mente: «dalla sua paralisi nell’imbecillità, su su fino ai suoi eccessi nella follia». Egli non offre alcuna minuziosa classificazione nosologica; la sua attenzione è tutta rivolta a ricondurre la diversità delle patologie mentali alla struttura delle facoltà che vi è sottesa. Facendo suo il convincimento che le varie espressioni di equilibrio «si possono suddividere in tante specie principali quante sono le facoltà dell’animo (Gemüt) che esse colpiscono»13. I suoi recuperi newtoniani, tuttavia, non gli impediscono di guardare alla follia più come un prodotto della società che come un guasto fisiologico del cervello. Si percepisce, nel tempo in cui Kant scrive il Saggio e la successiva prima Critica, la eco ancora sensibile delle letture che egli ha fatto delle opere di Rousseau e ne esplicita gli effetti: come la società corrompe moralmente l’uomo così essa può stravolgere i delicati meccanismi del suo cervello. Il modello di spiegazione sociologica, presente nella società settecentesca, non deve condurci in errore. Kant non è Rousseau, anzi si pone agli antipodi dell’autore dell’Emilio (opera che, tuttavia, tanto apprezza). Allorquando si accinge a esaminare le forze «irrazionali» che serpeggiano nel40 la società civile, Kant non contemplerà la malattia mentale. Ne La metafisica dei costumi, opera della tarda età nella quale Kant mette ordine al complesso di regole che disciplinano i comportamenti umani, non esiste alcun riferimento ai guazzabugli mentali. Neppure un rigo viene a essi dedicato. Proprio perché ci si trova al cospetto di una sede formalistica sarebbe stato opportuno, assieme ai problemi del Diritto e dello Stato, affrontare problemi della vita sociale che dal Diritto e dallo Stato vengono regolati. E tra questi un posto di primissimo piano avrebbe toccato la sanità e la malattia mentale. Tuttavia, la volontaria esclusione della problematica relativa alla follia – a fronte, ad esempio, delle riflessioni che egli indirizza ad altre figure devianti, come il bastardo e il criminale14 – suggerisce una strategia particolare rispetto a quella escogitata nella prima Critica: al tempo, cioè, di rimozione e di revocabile fiducia verso l’irrazionale. Da grande realista Kant ha coscienza dei recessi oscuri e negativi della natura umana, ha coscienza del pericolo devastante delle passioni. In sintonia col suo secolo egli scorge nella degenerazione delle passioni il percorso privilegiato alla follia. La passione, mal governata, si trasforma in delirio, che è precisamente un allontanarsi dalla dritta via della ragione: «Dissociazione, demenza, paranoia non sono che le deviazioni dalla regola». Collocate nel chiuso steccato della società civile, quelle passioni diventano per Kant il motore che fa progredire l’umanità. «Siano allora rese grazie alla natura per l’intrattabilità che genera, per la invidiosa emulazione della vanità, per la cupidigia mai soddisfatta di averi o anche di dominio!» – si legge ne Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784) –. «Senza di esse tutte le eccellenti disposizioni naturali insite nell’umanità rimarrebbero eternamente assopite senza svilupparsi. L’uomo vuole la concordia; ma la natura sa meglio di lui ciò che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia»15. E allora: dissociazione, discordia – o «insocievole socievolezza» – non sono varianti della follia umana? Drasticamente esclusa come strumento della conoscenza, la follia è vista da Kant come fattuale strumento dello sviluppo sociale ed economico. Certo è grandemente significativo che la riabilitazione della «follia» avvenga tacendone il nome. Kant considera le passioni come invidia, avidità, emulazione, egoismo, come un male necessario; ma, affinché la loro irrazionalità sia tollerabile, occorre chiuderle in quegli steccati mercantili della libera concorrenza alla quale Kant guardò con occhi spregiudicati. Spregiudicati al punto che ne I sogni di un visionario attribuisce, anche se minima, dignità alla pazzia: «Pazzia ed intelletto hanno dei limiti così mal tracciati che difficilmente si procede a lungo nell’uno dei due domini senza percorrere un piccolo tratto dell’altro»16. 41 3. Artaud È di grande rilievo, filosofico e non solo, che Platone e Kant mettano a tema la tensione tra ragione e follia. Questa tensione diviene estrema, sino allo sbigottimento, se si accosta un pensatore atipico come Antonin Artaud. Artaud si colloca sullo scenario della follia che si disegna dal Rinascimento fino a Nietzsche. Già Erasmo e Heine colsero la vita nei suoi aspetti drammatici e deliranti ma ne furono capaci di ridere e di prenderne le distanze. Essi più che sulla tragicità preferiscono soffermarsi sulla tragicomicità; e anche quando la realtà non si fa carico di questa doppia valenza la loro fantasia ben si presta a rintracciare gli aspetti comici da coniugare con quelli drammatici. Siamo molto lontani dalla follia di un Bosch, Brueghel, Dürer, che mescolano folle dei pazzi e processioni di scheletri. Qui c’è ossessione; e la vita insegue l’«orrido». La stessa cosa che Heine coglieva, nella prima metà dell’Ottocento, nelle espressioni di vita del popolo tedesco17; la stessa cosa si ritrova, nella prima metà del Novecento – a seguire Rudolff Kurtz18 – nelle rappresentazioni cinematografiche tedesche di matrice espressionista. Brandt, Erasmo e Heine sono di segno diverso: ridono anche quando non c’è nulla per cui ridere. E il riso, allora, si muta in sorriso. Si pensi alla descrizione della «nave dei folli» di Brandt, che dice dei luoghi di pellegrinaggio dove i folli erano più numerosi che altrove, ma che recupera anche un aspetto simbolico di grande rilevanza filosofica che rintraccia, nel lento vagare della nave lungo i fiumi, la presenza di una ragione di cui s’è persa da tempo immemorabile la presenza nel mondo. Si pensi a Erasmo e al suo Elogio della follia: opera di grande raffinatezza lessicale, che racconta quanta follia accompagni la vita di ogni uomo, della sua importanza sociale e, pertanto, della necessaria considerazione che bisogna riservarle. Nell’Elogio parla la follia; e parla con accenti caustici e col sorriso sardonico agli uomini che hanno goduto di grande popolarità e che hanno pensato che il mondo non potesse fare a meno della loro presenza: la follia sorride degli uomini grandi ma ride, e tanto, degli uomini piccoli, di memoria reichiana, che si credono grandi sol perché la natura li ha destinati a vendere mercanzie nelle fiere paesane e il destino invece ha voluto che ricoprissero transitori incarichi in qualità di pubblici amministratori. Così Reich in un bel passo di Ascolta, piccolo uomo: Il grand’uomo sa quando e come egli stesso è un piccolo uomo. Il piccolo uomo al contrario non sa di essere piccolo ed è timoroso di saperlo; dissimula la sua piccolezza e ristrettezza mediante grandezza e forza illusorie, ma non di sé. Si entusiasma della teoria che non ha ideato e non di quella che ha ideato. Tan42 to più è fermamente convinto delle cose, quanto meno le comprende19. Si pensi a Heine, il più grande poeta tedesco, pari, forse, al solo Goethe. Nel capitolo finale della Città di Lucca, là dove parla della follia dei protagonisti dei libri fantastici che si sono occupati delle imprese dei cavalieri di re Artù oppure dei paladini di Francia, soprattutto là dove si sofferma, attraverso il seguente dire, sulla differenza tra la sua follia e quella del tanto stimato cavaliere della Mancia: È vero però che la follia, le idee fisse che ho tratto da quei libri, sono di tutt’altro genere che la follia e le idee fisse del cavaliere della Mancia; questi voleva riportare in vita la cavalleria ormai al tramonto, io, al contrario, voglio annientare completamente tutto ciò che è sopravvissuto di quel tempo; e così noi agiamo con fini del tutto diversi. Il mio collega scambiava mulini a vento per giganti, io, invece, nei giganti dei giorni nostri vedo soltanto mulini gonfi di vento; lui prendeva otri di vino per maghi potenti, io vedo nei maghi odierni solo otri pieni di vino; lui prendeva taverne per castelli, asinai per cavalieri, ragazze di stalla per nobildonne, io invece prendo i nostri castelli per bettole, i nostri cavalieri per asinai, le nostre gentildonne per sguattere volgarissime; e come lui prendeva una commedia di burattini per un affare di Stato, così io, nei nostri affari di Stato altro non vedo se non una miserabile commedia di burattini… e con lo stesso valore del cavaliere della Mancia io tiro colpi al nostro governo di legno20. Siamo di fronte alla poesia della follia: Heine ne interpreta il messaggio in un linguaggio che non ha eguale, e dal quale mi piace riferire un’altra considerazione presente nel capitolo XI di Idee. Libro Le Grand: “Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas, Madame!”. Ma in fondo la vita è così mortalmente seria che non sarebbe sopportabile senza una siffatta unione di patetico e comico. Aristofane ci mostra le più atroci immagini dell’umana follia solo nello specchio sorridente dell’ironia; Goethe ha osato esprimere il dolore del gran pensatore che ha coscienza della sua nullità solo nei versi saltellanti di una commedia di burattini, e Shakespeare pone il più desolato lamento sui mali del mondo in bocca ad un pazzo, mentre gli fa scuotere angosciosamente il berretto a sonagli»21. In questa tradizione si colloca Antonin Artaud? Certamente no. Anche se la sua opera è tuttavia da ritenersi innovativa per l’approccio metodologico e fondamentale per una nuova interpretazione della follia. Non a caso Mi43 chel Foucault, in un’impareggiabile pagina della monumentale Storia della follia nell’età classica, legge l’opera di Artaud come l’esito finale di una mentalità che ha le sue radici in un processo che passa attraverso Kant fino a giungere a Nietzsche, Van Gogh e Freud: «Sotto la coscienza critica della follia e le sue norme filosofiche e scientifiche, morali e mediche, una sorda coscienza tragica non ha cessato di vegliare»22. Coscienza che le ultime parole di Nietzsche, le ultime visioni di Van Gogh, hanno ridestato. È lei che indubbiamente Freud ha cominciato a presentire all’estremità del suo cammino: sono le grandi lacerazioni che egli ha voluto simbolizzare con la lotta mitologica della libido e dell’istinto di morte. È lei, infine, è quella coscienza, che è giunta a esprimersi nell’opera di Artaud, in quest’opera che dovrebbe suggerire al pensiero del nostro secolo, se vi prestasse attenzione, la domanda più urgente, quella che dà le vertigini a colui che la pone; in quest’opera che non ha cessato di proclamare che la nostra cultura aveva perduto il suo focolare tragico il giorno in cui aveva respinto da se stessa la grande follia solare del mondo, le lacerazioni in cui si compie senza sosta “la vita e la morte di Satana il Fuoco”23. E i pilastri del ponte del «focolare tragico» che Artaud getta sono visibili nel XVII secolo. Il Medioevo aveva accolto la follia nella gerarchia dei vizi, essa regnava su tutto ciò che di malvagio e di perverso si annidava nell’uomo. Tuttavia il folle, che conobbe insieme la persecuzione e l’ammirazione, non ha conosciuto fino al Medioevo la condizione di recluso24. Dall’alto Medioevo in poi, a seguire quanto si legge in Vie e mort de Satan le Feu, Artaud coglie i segni di un tempo che si è rivelato per la salute mentale dell’intera umanità catastrofico. È il tempo dell’età classica: l’Umanesimo e il Rinascimento. Età che ha aperto ai folli le porte dell’internamento e soprattutto ha dato al sociale le ragioni per rendere credibile e accettabile la loro apertura. Foucault si chiede come sia potuto accadere tutto ciò attraverso i seguenti interrogativi: «Ma come si sono costituiti, nel XVI secolo, i privilegi della riflessione critica? In che modo l’esperienza della follia si è trovata confiscata da essi, tanto che sulla soglia dell’età classica tutte le immagini tragiche evocate nell’epoca precedente si saranno dissolute nell’ombra?»25. La risposta primariamente appartiene ad Artaud: «La Renaissance del XVI secolo ha rotto con una realtà che aveva le sue leggi, forse sovrumane, ma naturali; e l’Umanesimo della Renaissance non fu un ingrandimento ma una diminuzione dell’uomo?»26. Foucault, sulla strada intrapresa da Artaud, comprende, e pone la pietra miliare del suo percorso speculativo: «Il classicismo ha inventato l’internamento, un po’ come il Medioevo la segregazione dei lebbrosi». Con Artaud, fa presente Foucault, si consolida un legame con il XVII secolo 44 la follia diventa una forma relativa alla ragione, o piuttosto follia e ragione entrano in una reazione eternamente reversibile che fa sì che ogni follia ha la sua ragione che la giudica e la domina, e ogni ragione la sua follia nella quale essa trova la sua verità derisoria. Ciascuna è la misura dell’altra, e in questo movimento di riferimento reciproco esse si respingono l’un l’altra, ma si fondano l’una per mezzo dell’altra27. Artaud ha coscienza della sua condizione mentale, come l’hanno avuta, tra i tanti, Tasso, Swift, William Blake, Hölderlin, Gérard de Nerval, Dino Campana. Tuttavia, come ha fatto presente Antonino Pennisi, «nessuno di questi monumenti letterari, nelle cui opere è certo trasparente il gene dell’alterazione psicotica, ha saputo riflettere con la lucidità impressionante di Artaud sul senso della propria esperienza»; «non si tratta», continua Pennisi, «di osservare dall’esterno le modificazioni introdotte dalla psicosi in una poetica rivoluzionaria, quindi il suo valore artistico […], ma di sapere estrarre dall’interno della mente di un grande lavoratore della parola l’evento filmico della crisi dei suoi processi cognitivi, proprio nel punto in cui linguaggio ed esistenza mostrano il loro punto di sutura»28. D’altra parte se ci si accosta, prima della catastrofe, alla sua scrittura si apprende della tensione che caratterizza la sua nefe? (termine che ci giunge dalla tradizione antropologica ebraica e che sta a indicare l’unione della carne e dello spirito, della vita organica e culturale). Tensione già presente in una lettera indirizzata, il 5 giugno 1923, all’amico Jacques Rivière: Soffro di una spaventevole malattia dello spirito. Il mio pensiero mi abbandona a tutti i gradi. Dal fatto semplice del pensiero al fatto esterno della sua materializzazione in parole. Parole, forme di frasi, direzioni interne del pensiero, reazioni semplici dello spirito, io sono alla ricerca del mio essere intellettuale29. Artaud al tempo della presente scrittura aveva ventisette anni, ed era ben considerato nella Parigi del tempo. Artaud, però, ha un organismo malato e un’emotività in disordine. Di questa condizione ne risente il suo linguaggio e la sua logica. L’una e l’altra vengono anatomizzati. Attraverso una metodologia d’indagine mutuata dalla genealogia nietzscheana, Artaud offre un’analisi clinica di se medesimo. È come se vivesse in possesso di due anime: un’anima – molto vicina a quella platonico-cristiana-cartesiana – che astrae e (per quel che può) simbolizza quel sentire, fatto di tensione e di sofferenze, ciò che l’altra anima le fa pervenire attraverso segni non del tutto codificati razionalmente. Fare di Artaud necessariamente un «folle» è una forzatura di coloro che nulla sanno del percorso ontologico e legano alla saggezza filosofica la 45 «pregnanza filosofica dei discorsi» e poi, mischiando capre e cavoli come è nella loro natura, si appoggiano a nomi come Minkowski, Blankenburg, Heidegger e Binswanger per mettere sotto le ali protettive dell’armonia linguistica (mente-linguaggio-realtà) la «pregnanza ontologica». Si dimentica che per Nietzsche il linguaggio è importante ma non al punto da porsi a fondamento dell’«essere», perché quando ciò accade siamo sempre al cospetto di una «vecchia baldracca» che ha la pretesa di spacciarsi come una pulzella casta e pura: un infingimento ben ordito per dare a intendere ciò che non si possiede. Bisogna diffidare delle vecchie favole legate alla concettualizzazione del reale. Nel frammento 9 (98) dei Frammenti postumi 18871888, Nietzsche espressamente dice che «il concetto non contiene niente» e fa presente nel Crepuscolo degli idoli (“La ragione nella filosofia”) che i «concetti sommi» sono i più «vuoti, l’ultimo fumo della svaporante realtà». In prospettiva ontologica ridimensionata, riteniamo che il problema di Artaud sia legato alla sua incapacità di dare a queste due anime, di cui si faceva cenno, le stesse regole grammaticali, sintattiche, lessicali. L’incapacità di gestire unitariamente la diversa “materia” di cui sono formate le sue anime è la causa della sua irriducibile schizofrenia. Artaud, sin dai primordi della sua teoresi linguistica, vuol trovare risposte in quell’ambito della parola (comunicazione interna e comunicazione esterna) dove pensatori più robusti, come Platone e lo stesso Nietzsche, avevano fallito e costretti a ritornare saggiamente sui loro passi: Platone alla «caverna» da dove un giorno si era affrancato dalle false rappresentazioni (cfr. la lezione heideggeriana sull’origine dell’opera d’arte), lo Zarathustra di Nietzsche alla caverna degli animali, da cui un giorno aveva preso congedo per scendere in mezzo agli uomini. In Artaud nessun ripensamento: fermo, ascolta la sua anima sensitiva, e ciò che percepisce intende trasferirlo alla sua anima razionale: ma ben presto si accorge dell’incapacità di quest’ultima di tradurre in linguaggio ciò che le perviene sensorialmente. Incapacità che presto si traduce in paranoia. Platone (si pensi al Cratilo) si salva facendo ricorso al «Sommo Bene», che di preciso non si riesce a capire cosa sia, ma non è da escludere che si tratti di qualcosa di molto vicino all’osservanza etica stabilita dalle leggi dello Stato, ossia di chi gestisce il potere politico ed economico; lo Zarathustra di Nietzsche, una volta esperita l’incapacità di farsi comprendere dagli uomini, ritorna, sconfitto ma gaio, in mezzo agli animali, col proponimento, anche se non mantenuto, di non far più ritorno tra gli uomini: e tra un cocchiere che frusta un cavallo e un cavallo frustato si predispone benevolmente verso quest’ultimo e lo abbraccia come tra i viventi il più vicino alla sua umanità. Anche per Nietzsche il regno delle tenebre è oramai prossimo, perché sa dell’incompiutezza di qualsiasi forma di umanesimo. Quando Artaud percepisce l’assoluta inadeguatezza della pregnanza 46 ontologica della parola (discorsi e proposizioni, narrazioni logiche e finanche metanarrazioni), quando percepisce l’incapacità o distacco del suo pensiero dal contatto vitale della realtà, non gli restano che le «misure senza misura». In un altro passaggio di una lettera del 29 gennaio 1924, inviata a Rivière, direttore della “Revue de la Littérature Français” e personaggio singolare nel panorama filosofico letterario della Parigi d’inizio secolo, offre la cifra della «spaventevole malattia» in cui versa il suo spirito: Questo sparpagliamento delle mie poesie, questi vizi di forma, questo cedimento costante del mio pensiero, sono da attribuirsi non a una mancanza d’esercizio, di possesso dello strumento che maneggiavo, di sviluppo intellettuale, ma a uno sprofondarsi centrale dell’anima, a una specie d’erosione, essenziale ed insieme fugace, del pensiero, […] alla separazione anormale degli elementi di pensiero (l’impulso a pensare, a ciascuno delle stratificazioni terminali del pensiero, passando attraverso tutti gli stati, tutte le biforcazioni del pensiero e della forma. Dunque c’è un qualcosa che distrugge il mio pensiero; un qualcosa che non mi impedisce di essere ciò che potrei essere, ma che mi lascia, se posso dire, in sospeso. Un qualcosa di furtivo che mi toglie le parole che ho trovato, che fa diminuire la mia tensione mentale, che distrugge man mano nella sua sostanza la massa del pensiero, che toglie perfino il ricordo dei giri di frase con cui si esprime e che traducono con esattezza le modulazioni più inseparabili, più localizzate, più esistenti del pensiero30. Cos’è questo «qualcosa» che, in altri termini, lo limita e, nel ridimensionare il senso delle parole in dotazione, non lo rende consapevole del suo “umano, troppo umano”?. Per quanto singolare, il destinatario della scrittura squarcia l’autoanalisi di Artaud e ne tira fuori la ragione del disagio. Artaud, a seguire le acute riflessioni offerte da Rivière nella risposta, non può comprendere la causa di quel «qualcosa» che disfa il suo pensiero perché è portatore di una visione dello «spirito» come una fondamentalità monolitica. Invece lo spirito non si regge su una fondamentalità monolitica, dice Rivière; ma attraverso il seguente considerare attesta la plasticità e poliformicità dello spirito, che si realizza nel tempo non tramite un «eccesso di forza», uno «straboccare di potenza» ma, di contro, tramite la sua intrinseca «fragilità», la sua «debolezza», la sua incapacità di reggersi da «sé». Questo è il punto di vista di Riviére: Lo spirito è fragile in quanto ha bisogno d’ostacoli, d’ostacoli avventizi. Solo, si perde, si distrugge. Mi sembra che questa “erosione” mentale, questi latrocinii interiori, questa “distruzione” del pen47 siero “nella sua sostanza”, che affliggono il suo spirito, non abbiano altra causa che la troppo grande libertà lasciatagli. È l’assoluto a guastarlo. Per tendersi, lo spirito ha bisogno di un limite […] Se per pensiero s’intende creazione, come Lei sembra fare quasi sempre, bisogna che a ogni costo esso sia relativo […] La giustezza d’una espressione comporta sempre un resto d’ipotesi; bisogna che la parola abbia colpito un oggetto sordo e molto prima che sia stata raggiunta dalla ragione. Ma dove l’oggetto, dove l’ostacolo mancano assolutamente, lo spirito continua, inflessibile e debole; e tutto si disgrega in un’immensa contingenza31. Rivière, come si desume dal prosieguo della lettera, suggerisce ad Artaud un cambiamento di prospettiva. Cambiamento che potrebbe essere ricondotto ai «giochi linguistici» di Wittgenstein. Artaud si può ben comprendere alla luce del percorso wittgensteiniano: la «parola», in quanto immagine, è un «modello della realtà» che vive interamente all’interno dello spazio logico entro cui s’è generata. E il linguaggio logico è il linguaggio del potere, a cui Artaud non intende sottostare né tantomeno esserne complice dei misfatti che inevitabilmente è portato a consumare. «Il linguaggio – fa presente Pennisi – rappresenta un’immagine del mondo non attraverso la parola ma attraverso l’insieme dell’articolazione discorsiva»32; pertanto, continua il Pennisi, la misura del giudizio non può riferirsi a referenze naturali ma al confronto tra spazi logici diversi […]: forme di vita quando gli spazi logici si riferiscono a varietà etologiche (per esempio specie animali), modalità di esistenza quando si riferiscono a varietà ontologiche (per esempio diversità antropologiche, religiose, ideologiche, forse anche linguaggi privati e stati mentali». Pennisi dà così senso al suggerimento offerto da Rivière ad Artaud: «Tutta intera la fisiologia dell’attività discorsiva non è “servile imitazione” né semplice “riproduzione”, ma comporta “sempre un resto d’ipotesi”, cioè tende naturalmente a spostare opinioni e conoscenze che, nella nostra raffigurazione, appaiono come ristrutturazioni continue degli spazi logici posti a confronto33. Artaud non raccoglie il suggerimento di Rivière. Anzi dieci anni dopo ritorna sull’argomento e ribadisce, all’inizio del mese di giugno 1934 all’amico Jean Paulhan, quanto importante sia, per la stabilità del suo pensiero, la ricerca della verità suprema: La verità suprema, io non cerco che quella, ma quando si parla di ciò che è vero e mi domando sempre di quale vero mi si par48 li, e sino a qual punto la nozione che possiamo avere di un vero limitato e obbiettivo non scacci l’altra che ostinatamente sfugge a ogni scelta, ad ogni limitazione, ad ogni localizzazione, fuggendo per finire in ciò che chiamiamo Realtà34. «Verità suprema»: fissità (come fissazione) che lo allontana sempre più da quella «accorta prudenza» di cui è portatrice mitologicamente la dea Metis. Artaud non è interessato, sebbene vacillasse tanto nel corpo quanto nella vita di pensiero, alla metis: a quella forma di intelligenza fondata, nella pratica quotidiana, sull’efficacia, sulla stima ad occhio (o a sguardo misuratore) senza un’unità di misura, di cui, ad esempio, il contadino accorto fa ricorso per stimare con reale approssimità, dunque con efficacia, ciò che per natura è instabile, in perpetuo movimento. Artaud non conosce le strategie mentali del contadino accorto e, pertanto, vuole, al pari dei mistici e degli anacoreti, ciò che nessuno su questa terra gli può dare, ciò che nessuno su questa terra ha mai raggiunto: la verità suprema. Artaud si sente Cristo, meglio di Cristo: mentre la fede del Cristo in croce, nel chiedere ragioni al Padre perché lo ha abbandonato, sembra vacillare, Artaud in mezzo a un vissuto di croci, piantati per quanti sono stati gli attimi della sua esistenza, non mostra alcun cedimento di fronte alla ricerca della «verità suprema». È l’incapacità di appropriarsi di questa Verità la causa della sua malattia fisica e mentale? Oppure è il disagio fisico e mentale a dettare la ricerca di un punto fermo, di una verità suprema, nelle tumultuose correnti della vita? Ritengo che si tratti di concause. Anteporre una causa significa limitare la prospettiva d’insieme, ammenoché, come credo, la mancata appropriazione della verità non si ponga come termine medio (come, per dirla come i latini, id quo cognoscitur) del disagio fisico e mentale. Tutte le crisi psicotiche di Artaud sono da collegarsi all’accertata fluttuazione delle sue credenze; a seguire le lettere a Rivière si evince chiaramente che la causa delle sue sofferenze è presente in «una certa flocculazione delle cose»35, al punto, confessa Artaud, «di muovermi molto nel mio pensiero»36. Siamo al cospetto, puntualizza Artaud, «di una malattia che tocca l’essenza dell’essere e le sue possibilità centrali d’espressione e che si applica a tutta una vita»37, di una turba emotiva e caratteriale «da cui l’anima è affetta nella sua più profonda realtà e che ne infetta le manifestazioni. Il veleno dell’essere. Una vera paralisi. Una malattia che toglie la parola, il ricordo, che estirpa il pensiero»38. Con l’avanzare del cataclisma coscienziale, la separazione dell’esistenza dal linguaggio, l’abbandono della vita dal linguaggio, si accentua sempre più. Il delirio lo spinge a sproloquiare. Artaud si sente attanagliato da strane forme di «congiure spontanee»39. Il solco ormai è tracciato; e, una 49 volta tracciato, la rottura della vita della conoscenza da quella del linguaggio spazza via gli argini e il fiume straripa: Sento sgretolarsi il terreno sotto il mio pensiero e sono portato a considerare i termini che adopero senza l’appoggio del loro senso intrinseco, del loro substratum personale. Meglio ancora, il punto che sembra collegare questo sustratum alla mia vita mi diventa di colpo stranamente sensibile e virtuale40. Il tempo, per qualsiasi forma di ritrattazione, è oramai consumato; Artaud prende atto che l’anima venga meno alla lingua o la lingua allo spirito, e che questa rottura tracci nelle pianure dei sensi come un vasto solco di disperazione e di sangue, ecco la grande pena che mina non la scorza o l’impalcatura, ma la STOFFA dei corpi41. Questa impossibilità di rapportarsi alla misura della rappresentazione linguistica è stata vissuta da Artaud come la localizzazione della sua anima. Esplicita questo convincimento in un passo di una lettera indirizzata a Rivière intorno agli anni Venti: Sono imbecille, per soppressione del pensiero, per malformazione del pensiero, sono vacante per stupefazione della mia lingua […] Tutti i termini che scelgo per pensare sono per me TERMINI nel senso proprio della parola, vere terminazioni, risultati dei miei stati mentali, di tutti gli stati che ho fatto subire al mio pensiero. Sono davvero LOCALIZZATO dai miei termini, e se dico che sono LOCALIZZATO dai miei termini è perché non li ritengo validi nel mio pensiero. Sono davvero paralizzato dai miei termini, da un susseguirsi di terminazioni. E per quanto in quei momenti il mio pensiero sia ALTROVE, posso solo farlo passare per quei termini, per quanto contraddittori, paralleli, equivoci possano essere, pena in quei momenti il cessare di pensare42. Nel 1936 Artaud parte per il Messico dove tiene una serie di conferenze e soggiorna presso la tribù dei Tarahumara, dopo aver ricevuto a l’Avana da uno sciamano un pugnale a cui attribuisce poteri magici. Nel 1937 fa ritorno in Francia e si trasferisce quasi subito in Irlanda, nel tentativo di riportavi il presunto bastone di San Patrizio43. Arrestato per vagabondaggio, dopo peripezie di vario tipo, viene rimpatriato e condotto, con sbarco in camicia di forza, a Le Havre. Comincia il calvario dei vari internamenti, tra cui quelli lunghi negli istituti psichiatrici di Ville Èvrard e di Rodez, dove subisce 51 sca50 riche di elettroschock. Il tempo della «resistenza» alla sua salute mentale finisce e comincia quello del delirio. È il tempo della resa. La guerra, iniziata da Platone nel Cratilo, ma anche nel Gorgia e nel Sofista, contro l’imprecisione linguistica, è persa. Oramai è tempo di delirio. Ne fanno testo i sette volumi di Cahiers de Rodez (febbraio-aprile 1945 – febbraio-marzo 1946) e i quattro volumi di Cahiers du retour à Paris (maggio-giugno 1946 – dicembre 1946, gennaio 1947); ma fa anche testo Misure senza misura, un titolo di un libro smarrito o, più probabilmente mai scritto, ma, come rileva opportunamente Pennisi, nell’incipit del suo saggio «sempre vivo nella mente» di Antonin Artaud, che attesta del cedimento del linguaggio o meglio del senso del segno linguistico o dei vocalizzi linguistici. È il tempo dell’afasia, degli schizzi e dei bozzetti, di grida attraverso vocalizzi senza senso. Il deserto avanza fino a impossessarsi di tutta la coscienza. Caduti gli steccati non resta che la lunga notte del delirio. Delirio invasivo ormai al punto da appropriarsi anche delle pur minime movenze del suo spirito che s’innalza, paradossalmente, a sistema: la colpa della catastrofe trova la sua ragione in infinite congiure paranoidi. Ragione che ha nome «affatturamento generale», a cui partecipa l’intera società allo scopo di impedire ad Artaud di giustificare linguisticamente il mondo, restituendogli, attraverso un linguaggio scevro di condizionamenti, tutto il suo orrore e tutta la sua crudeltà. Affatturatori, indipendentemente dal ceto e dalle diversità, presenti a piè sospinto in tutti gli angoli di Parigi (e dire Parigi significava dire il mondo) allo scopo di governare la sua coscienza. È indicativo al riguardo un passaggio presente in una lettera dal manicomio di Rodez: Arrotini, lavandai, droghieri, salumieri, vinai, magazzinieri, impiegati di banca, contabili commercianti, flics, medici, professori universitari, impiegati statali, preti infine, soprattutto preti, religiosi, monaci, frati conversi, cioè incapaci inetti, tutti funzionari dello spirito, uno spirito chiamato dai cattolici Spirito Santo e che è solo lo sfogo anale e vaginale di tutte le messe, i crismi, i viatici, le benedizioni, le elevazioni, le estreme unzioni senza contare le abluzioni e il nardo bruciato ritualmente dai bramini, il vorticare dei dervisci, i rosoni incristati perché incrostati delle cattedrali, l’incrociarsi delle rotule con i talloni sotto le natiche dei budda, e le invocazioni intranaturali dei lama44. Tutte le componenti della città, dunque del mondo, cospirano contro il suo progetto messianico di trasmettere la «verità assoluta». Artaud ora si sente come Dio e forse più di Dio. Ma non c’è da meravigliarsi. Gli stadi paranoidi portano a pensare tutto e il suo contrario; ma si tratta di un tutto che mantiene, rileva Pennisi, come corsia privilegiata il linguaggio: 51 (…) Verbigerazione, logorrea, circostanzialità, effetto valanga della fuga di idee, giochi di parole fondati su eufonìe, deriva metalinguistica pura come nel linguaggio di tutti gli schizofrenici di tutti i tempi e di tutte le nazioni45. Sul terreno delle «verbigerazioni» tutto, o prima o dopo, può venire alla luce, compresa quella «poetica della crudeltà»46 di cui, a un semplice esame, l’umanità farebbe volentieri a meno. Così come farebbe a meno dei tanti «passi di fecalità» che accomunano la scrittura di tutti gli ospiti dei manicomi del mondo. Dal fondo di queste «verbigerazioni», non esenti di colorite espressioni coprolaliche, viene concepito Misure senza misure. Il progetto sa di luciferino: «Si può inventare la propria lingua e far parlare la lingua pura con senso extragrammaticale, ma bisogna che questo senso sia valido in sé, cioè provenga da orrore»47. In vero, a seguire Pennisi, «si tratta di poesie in una neolingua regolare e insensata, fondata sui residui dei processi cognitivi fonetico-prosodici»48 che – aggiungiamo a ragion veduta – neppure in superficie sono portatrici di immagini o sensazioni di orrore. L’orrore resta nella mente, forse, di chi le ha partorite. Si pensi a quanto è riportato a conclusione di “Io sputo sul Cristo innato”, che apre il volume Io sono Gesù Cristo, scritto pochi mesi prima della morte: hoek tibi shakh bí yaz bif che tif49. Oppure: non aumong amay mais arhmong amay tamau50. Oppure si pensi a quanto si registra a conclusione di “Essere Cristo non significa essere Gesù cristo”: koïmonk redi talik onok koïmonk eretiki enoch tapo 52 kalen elen meinarok eretiki ya mon lerbo derfel te dan e nelezo51 Di Artuad, una volta morto, si sono appropriate menti eccelse. Basti pensare a Deleuze e Guattari52, Derrida53 che hanno colto nella glossolalia di Artaud uno «sfondamento» del muro del significante. Basti pensare a Galzigna che non esita a vedere nella glossolalia una spinta a «rompere l’involucro minaccioso della parola per attingere alla vita»54, un «vitalismo radicale capace di infrangere le regole dei generi artistico-letterari»55. Uno psicopatologo dello spessore di Eugenio Borgna ha, con grande compostezza speculativa non disgiunta da un’attenta e meticolosa indagine psicologica, coniugato l’esito glossolalico del travagliato percorso intellettuale di Artaud con la mancanza di attenzioni, di cure e di umanità in cui s’è imbattuto nella tristezza e nello squallore di Rodhez56. A un filosofo del linguaggio come Antonino Pennisi sembra chiaro […] che il finale glossolalico di Artaud non può essere affatto confuso con un rigurgito di creatività, seppur circoscritta all’elemento fonetico-prosodico del linguaggio poetico, ma, semplicemente, considerato la capitolazione definitiva della forza agonistica del processo cognitivo primario che chiamiamo “linguaggio”57. Letture tutte ben argomentate e, dunque, ben supportate da pertinenti riscontri estrapolati dalla carne-scrittura di Artaud. Tuttavia ritengo che l’esito glossolalico di Artuad abbia altra radice, rintracciabile, prima, molto prima, della scrittura o delle analisi fenomenologiche compiute dallo stesso Artaud: in quella primaria condizione dell’essere, che la vecchia tradizione filosofia definisce come pre-ontologica. Artaud visse di un’ontologia scomposta, perché la ritenne di stretta dipendenza dal suo «io». Rimase, finché le forze glielo consentirono, un “Narciso”. Quando le forze vennero meno l’orrore della sua immagine fu così raccapricciante alla sua vista che non si orientò più, e l’io si dileguò. Il Narciso ha perso per sempre il suo oggetto d’amore: l’acqua cristallina si tramutò per incanto in una putrida pozzanghera e l’io di Artuard naufragò in essa per sempre. Freud comprese che l’uomo non ha nessuna intenzione di rinunciare alla perfezione narcisistica della sua infanzia. E comprese anche che la 53 mancata rinuncia di questa condizione coincide con la mancata formazione della persona e con l’apertura a ogni forma di perversione. Egli offrì al riguardo argomentazioni che, se fossero state tenute nell’opportuna considerazione da parte della famiglia, della scuola e della società sarebbero, state di grande sollievo per l’uomo e non avrebbero consentito agli specialisti, ad esempio a quelli del settore linguistico, di scambiare l’effetto (fenomenologia) con la causa (fondamento). Una tale svista non è cosa di poco conto, si muove in un registro di tipo strettamente – o se si vuole – limitatamente linguistico. «La capitolazione definitiva della forza organica del processo cognitivo che chiamiamo “linguaggio”», a differenza di quanto sostiene Pennisi, non è un «fondamento», una causa, ma tutt’al più un effetto della non risolta ipertrofia narcisistica. Artaud non volle mai prendere le distanze della condizione narcisistica; forse non lo volle perché non lo comprese oppure perché non possedette sufficiente ossigeno per disfarsi della bella e perfetta e immagine che della prima infanzia portava con sé. Chiarisce questa condizione, in cui da sempre versa l’uomo e nello specifico l’uomo creativo, Freud in una significativa pagina di Introduzione al narcisismo che non ha bisogno di alcun commento, anche perché è sufficientemente esplicitato il convincimento che il narcisismo non può essere ricondotto soltanto all’incompiutezza della sfera dell’evoluzione sessuale ma primariamente all’ampio spettro della sfera della cognitività: Non ci sarebbe niente di strano se riuscissimo a identificare una speciale istanza psichica che assolve il compito di vigilare affinché a mezzo dell’ideale dell’Io sia assicurato il soddisfacimento narcisistico, e a tal fine osserva costantemente l’Io attuale commisurandolo a questo ideale. Se tale istanza esiste, non è possibile che ci accada di scoprirla; possiamo solo riconoscerla come tale e ci è lecito dichiarare che ciò che chiamiamo la nostra “coscienza morale” ha questa prerogativa. Riconoscere l’esistenza di tale istanza ci rende intelligibile il cosiddetto “delirio di esser notati” o, più precisamente, di essere “osservati”; delirio che si manifesta con tanta evidenza nella sintomatologia delle affezioni paranoidi, sia come fenomeno morboso a sé stante sia inframezzato alle manifestazioni di una nevrosi di traslazione. I malati di questo tipo si lamentano del fatto che tutti i loro pensieri sono conosciuti, che le loro azioni sono osservate e inquisite; sono informati dell’opera di questa istanza da voci che hanno la peculiarità di rivolgersi ad essi usando la terza persona […]. Una forza di questo genere che osserva, scopre e critica tutte le nostre intenzioni esiste davvero, e precisamente nella vita normale di ciascuno di noi. Nel delirio di essere osservati essa compa54 re in forma regressiva, rivelando in tal modo la sua genesi e la ragione per cui la persona ammalata vi si ribella. Infatti, l’esigenza di formare un ideale dell’Io, su cui la coscienza morale è incaricata di vigilare, è scaturita nell’individuo per opere delle critiche che i suoi genitori gli hanno rivolto a voce, alle quali, nel corso del tempo, si sono associati gli educatori, i maestri e l’incalcolabile e infinita schiera di tutte le altre persone del suo ambiente (il suo prossimo e la pubblica opinione)58. Artaud era un Narciso: una smisurata appropriazione della sua immagine filtrata attraverso il suo linguaggio. Egli, come Dio, si riteneva un creazionista: riteneva di poter fare del linguaggio ciò che Dio ha fatto della Natura. Anzi nel suo delirio narcisistico, che cominciò molto tempo prima della sua sosta nel manicomio di Rodhez, pensava di fare con il linguaggio opera maggiormente compiuta di quella fatta da Dio con la natura. Il narcisismo è malattia capitale; capitale proprio nel senso che da essa si generano tutte le altre malattie del corpo-mente. Il narcisismo di Artaud ha, però, radici antiche e moderne: dal libro della Genesi, il cui incipit è legato al Logos (ragione-discoso-linguaggio-parola), alla filologia dell’Ottocento, legata a un principio di verità assoluto. Artaud è figlio di questa mentalità: quando cerca il “linguaggio assoluto” altro non cerca che quella «Verità» che ha sempre costituito la suprema aspirazione degli uomini. Perché meravigliarsi, dunque? La “glossolalia” di Artaud non «sfonda», come vogliono Deleuze e Guattari, il muro del significate, né, come vuole Antonino Pennisi, può essere considerata «la capitolazione definitiva della forza agonistica del processo cognitivo primario che chiamiamo “linguaggio”». La glossolalia di Artaud non è frutto di alcuna «capitolazione» di forze agoniche intrinseche alla sua fisiologia; è, invece, l’affermazione esasperata di un “io” che ha deciso di non condividere il cammino con alcunché né tantomeno di cedere il passo laddove il terreno è periglioso e l’organico instabile: Artaud ha intrapreso la stessa strada di Fichte, Schelling e Hegel, dell’Idealismo e del Positivismo, dell’Imperialismo e dello Scientismo: ha intrapreso la strada del Super-Ego pangermanistico, megalomanico. Artaud è figlio del suo tempo; e del suo tempo non ha tradito, come attraverso altri impianti teorici hanno denunciato Nietzsche e Freud, l’economia dello spirito. Osservazioni conclusive Sul linguaggio si sono dette e scritte tante cose, quasi quante ne sono state dette sulla mente. Eppure – e questo è bene che si sappia – soltan55 to da poco tempo il suo studio è stato messo su solide basi, tanto dal punto di vista linguistico quanto da quello neurobiologico. Pochi sono coloro che riescono a occuparsi seriamente e a parlare con competenza di entrambi questi aspetti. A partire del dato accertato che esistono nel mondo tra 6 e 7 mila lingue diverse, senza contare i vari dialetti. È incredibile che esistano tanti idiomi. Il problema è di sapere se la varietà di questi idiomi è illimitata oppure ha dei vincoli? Domanda che la tradizione di pensiero non si era posta; o meglio una volta posta era stata assorbita inizialmente dalla Metafisica poi dall’Ontologia e, per ultimo, dalla Sociologia. La risposta che ci offre la linguistica attuale è chiara: pur al cospetto della loro grande varietà, i linguaggi delle diverse popolazioni del globo sono solo un sottoinsieme di tutti i linguaggi concepibili. Un linguaggio per essere umano deve possedere certe caratteristiche. Il tempo delle lingue di Babele è finito (se mai c’è stata una Babele). La lingua deve abitare entro certi confini. La precisa definizione di un linguaggio umano è molto simile a quella della natura umana, un concetto rilevante e controverso che dopo anni ed eclissi sta ritornando d’attualità. L’approfondimento delle basi biologiche dell’uomo e dell’altro che gli appartiene per cultura ci sta illuminando sempre più sui fondamenti della nostra medesima essenza: noi percepiamo in un modo, ragioniamo in un modo, ci comportiamo in un modo. E parliamo in un certo modo. Prima di scandagliare le basi biologiche del linguaggio è quanto mai opportuno definirne al meglio le caratteristiche fondamentali. Anche se le lingue vengono analizzate e insegnate da millenni, è solo da qualche decennio che gli studiosi del settore si sono applicati seriamente a questo studio nel corso di questo ultimo mezzo secolo rivelatosi sorprendentemente produttivo: quello della cosiddetta linguistica strutturale, nello specifico quello che si rapporta a Noam Chomsky. All’insegna di questa stagione di ricerca che cosa hanno di particolare le lingue parlate dall’uomo? Queste lingue hanno tratti distintivi, e se ce l’hanno quali sono? A seguire, ad esempio, le risposte che ci giungono dall’interessante volume I confini di babele di Andrea Moro, apprendiamo dell’esistenza di una carta d’identità di una lingua umana generalizzata. Veniamo introdotti ai segreti delle lingue nel quadro di un autentico viaggio di esplorazione, apparentemente esterno ma in realtà profondamente intimo: si tratta di cose familiari, da sempre sotto i nostri occhi ma che soltanto ora veniamo sollecitati a visitare con sguardo curioso e meravigliato. E che apprendiamo? Apprendiamo un patrimonio di conoscenze e, in definitiva di cultura, che è tradizionalmente di patrimonio dei «professionisti del linguaggio». Con l’ausilio di frasi reali o inventate, Moro ci introduce ai segreti della sintassi delle diverse lingue, che possono essere radicalmente diverse tra loro, ma che soddisfano in ogni caso determinati criteri che le fan56 no invariabilmente riconoscere come lingue parlate dall’uomo. Nel tratteggiare con grande perizia «la storia di un incontro fra due culture, la linguistica e le neuroscienze (o, in senso più specifico, le neuroscienze cognitive» è palese il proponimento di Moro di «mettere in luce una rivoluzione “nascosta” nella scienza contemporanea: la scoperta che le grammatiche possibili non sono infinite e che il loro numero è limitato biologicamente»59. La “lingua delle lingue”, cui faceva riferimento Artaud, non appartiene alle lingue parlate dall’uomo e, pertanto, ricondurla alla «capitolazione» definitiva della forza agonistica del processo cognitivo primario che chiamiamo “linguaggio”, è cosa del tutto incomprensibile, per la semplice ragione che una forza per «capitolare» deve prima esistere. E Artaud, quando si mise in testa di dar vita a una lingua universale, non esisteva più né come lingua e né come forza. A seguire gli esempi portati da Moro si può dire: «Maria ha detto che Gianni ha visto quella foto» (in italiano) oppure «Maria Gianni quella foto visto ha che ha detto» (in giapponese), ma non si può dire «Maria quella Gianni foto visto che ha detto ha», come non si può dire «Gianni Maria ha che detto ha visto foto quella». La terza e la quarta frase non si possono dire perché non sono contemplate da nessuna lingua esistente, tuttavia rileva Moro che «la differenza tra le quattro sequenze», relative alle quattro frasi sopra riportate, si riduce infatti al solo fatto che la prima e la seconda sono ricavabili dallo stesso schema sintagmatico, mentre le altre sono veramente caotiche. L’unica differenza tra le prime due sequenze sta nell’ordine lineare della testa e del complemento di ogni sintagma: la testa precede il complemento nella prima sequenza mentre segue il complemento nella seconda; lo specificatore precede sempre il complesso testa-complemento60. A cosa è dovuto, dunque, il fatto che le lingue possiedono certi tratti comuni? E poi, più significativo, dove sta scritto che le cose debbano andare così? Cosa succede a chi si sforza di parlare un linguaggio «incomprensibile»? Una risposta ci giunge da quella parte del libro di Moro, che riporta alcuni preliminari ma fondamentali esperimenti di neurobiologia della funzione linguistica. Riunendo dati altrui e risultati propri, Moro ci offre un quadro organico del lecito e dell’illecito nell’universo delle funzioni cerebrali che ci consentono di parlare. Se io leggo, per esempio, le frasi impossibili riportate sopra a proposito di Maria e Gianni o le migliaia di frasi glossolale di Artaud, il mio cervello soffre perché si trova di fronte un muro invalicabile. La gran parte dell’impossibile linguistico affonda le sue radici in un impossibile neurobiologico. È vero che «non c’è nessuna necessità logica per la quale la linguistica debba aver sviluppato un modello isomorfo 57 al funzionamento reale del cervello»61, pur tuttavia Moro afferma, sorprendentemente, che «esiste una convergenza significativa: non solo la sintassi attiva reti neuronali specifiche distinte dagli altri componenti la grammatica, ma anche il limite di variazione tra grammatiche possibili risulta essere condizionata dall’architettura neurofunzionale del cervello umano»62. Ora, anche all’insegna degli apporti, a volte apparentemente semplicistici di Moro, ma improntati a grande serietà scientifica e chiarezza espositiva, siamo al cospetto di una definizione «in negativo» dell’essenza del linguaggio. Ma è proprio il fatto che sia possibile una tale definizione in negativo dimostra che nella nostra mente esiste una sorta di modello al quale tutte le lingue si devono uniformare. Questo modello di carattere neurolinguistico è parte della nostra natura umana63. Questa e quello, come accaduto ad Artaud, ci possono andare stretti e possiamo desiderare di superarli, ma ciò sarà possibile soltanto conoscendole, e sempre più a fondo. E voglio concludere queste considerazioni rapportandomi al bellissimo, per scrittura e umanità, libro di Pino Roveredo, Ballando con Cecilia64: viaggio attraverso le ombre di un’esistenza spenta ed estraneata dal mondo. Cecilia è una donna che ha trascorso 60 dei suoi 90 anni in un ospedale psichiatrico, dentro il quale, per deliberata volontà, ha deciso di rimanere anche quando i suoi recinti si sono aperti ed è divenuto ex ospedale psichiatrico – grazie alla riforma Basaglia che ha consentito ai rinchiusi di riappropriarsi della perduta dignità e umanità e che ha liberato quei tanti, come accaduto a Cecilia, che non erano finiti in quell’orribile luogo a causa di malattie mentali, bensì per motivi legati a debolezza, cedimento fisico o per comportamenti sociali difformi alle norme che regolano il consuetudinario, anche se non pericolosi: dal disadattamento a innocue bizzarrie, all’alcolismo, alla stessa vecchiaia, ingombrante ai familiari prossimi e, se accompagnata dalla povertà, in balia di nessuno che se ne prenda cura. Una lunga reclusione – come si ricava, in altra prospettiva, ne L’insostenibile leggerezza dell’essere (1984) di Milan Kundera – può rendere inadatti alla libertà, può rappresentare quest’ultima, quando sopraggiunge, un peso insopportabile. Vivere, per chi non ha vissuto per una lunga stagione dell’esistenza, non viene visto come un dono aperto alle meraviglie del mondo, bensì può essere visto come qualcosa di terribile e di insostenibile. Chi ha i polmoni intasati di nicotina è facile che venga colto da vertigini qualora si trovasse improvvisamente a vivere in un luogo non contaminato dal fumo. Non è da escludere che Cecilia abbia preferito rimanere in ospedale, nel suo consolidato torpore pervaso a sprazzi da fioche lucerne, invece che vivere delle possibili vertigini dettate dalla sua nuova condizione di persona libera. Ma passo dietro passo, nel dialogo con lo scrittore che si appropria della sua affezione, Cecilia recupera il tempo andato e si scioglie per il tempo avvenire. 58 Cecilia non è per nulla invasa dalla follia. Quanto di maldestro accompagna i suoi comportamenti iniziali, che rendono se non impossibile certamente difficile i contatti con lei, vanno visti come un usbergo costruito dalle tante afflizioni ricevute (Borgna). Ma la sua grande umanità risiede non nella sua manifesta diversità, bensì nella sua ragione, per lungo tempo disviata dalla sua pena e infine liberata, capace di capire e di appropriarsi della bellezza delle piccole cose che arricchiscono la quotidianità. Senza rinunciare ai grandi temi d’introspezione che Roveredo fa filtrare, per bocca di Cecilia, attraverso una discorsività di rara bellezza e di impareggiabile lucidità: E smettila di cantare, stupido! Non vedi che non abbiamo più niente da dare? Cosa vuoi, che ti dedichiamo un applauso? Certo, sei stato bravo, bravo a tirarci fuori tutto quello che c’era da tirare fuori, però adesso basta! Adesso il gioco è finito, e che ognuno torni alle proprie canzoni, chi a cantarle per far piacere a un amore, e chi, come noi, che l’amore ce lo siamo visti sequestrare, a trattenerle e soffocarle in gola… Ma cosa credi, che noi non abbiamo mai avuto una voglia di cantare? Sapessi quanto, tanto. È che abbiamo imparato a cantare in silenzio, soprattutto i primi giorni, quando la speranza riusciva a calmare la rabbia. Io, bello mio, con l’obbligo del silenzio mi sono cantata dentro: tutte le mattine di sole, il volo delle prime rondini, il mandorlo in fiore lì fuori della finestra. Mi sono cantata anche i temporali, le piogge, e l’inverno che metteva il cappotto grigio al sole. Mi sono cantata persino le notti, sperando che qualcuno venisse ad accendere la luce per portarmi fuori dal delirio. Poi, quando mi sono accorta che il tempo, il mio tempo, era irrimediabilmente chiuso fuori a chiave, non ho cantato più. No, non ho cantato, e ho odiato il sole, le rondini, il mandorlo, la pioggia, il temporale, e mi sono abituata a cancellare le notti per non cadere nella tortura di sognare…Noi, caro il mio musicista, per non vivere di urla abbiamo lasciato che la memoria se ne vada per conto suo, e nel ricordo le camminiamo sempre un passo indietro. La mente e la memoria, per noi, sono come due scintille, e guai al contatto! E adesso, tu pretendi di tagliare la distanza facendoci cantare, ricordare… Ma lascia perdere, lascia perdere… Dami ascolto, porta via la musica da qui, e va a farla girare dove ti pare…con le bertucce, con tua madre, con i cantanti sani, le rondini, le mone calde, i membri pieni…se vuoi anche con le pietre, che sicuramente hanno rumori più vivi delle nostre canzoni…ma a noi, lasciaci perdere, che tanto non saremo mai un bel 59 risultato…Perciò togliti dalle nostre fermate, che qui non c’è niente da guadagnare! Dammi retta, cambia aria, e lasciaci alla compagnia del nostro silenzio, o alla pace della nostra cattiva salute, che noi…si sta bene così! Vai, vai, musicista, torna alla tua musica, ai tuoi concerti… Vai, vai…65 Non è più tempo di stereotipi. La follia non è né uno stato di mostruosità né tantomeno uno stato di grazia. Bisogna finirla con questi pregiudizi. Iniquo è quello che vede nel reale (o presunto) malato mentale una minaccia, talvolta un mostro da esclude dal “genere” umano. Altrettanto iniquo è il pregiudizio di segno opposto, di cui le responsabilità della letteratura in genere non sono poche, che individua nella follia una condizione privilegiata, aperta, seppur dagli infiniti risvolti tragici, alla creatività. Questo vale per tanti comportamenti che, pur anomali rispetto ai paradigmi dominanti fissati da una norma sociale per lo più autoritaria e vessatoria, non sono in realtà affatto folli, ma tali vengono ritenuti in base a ottusi pregiudizi. La fede in Cristo è, ad esempio, per Paolo, «scandalo per i Giudei e follia per i Gentili» (I Cor.1,22); intendendo con questo non tanto che la fede sia reale follia, ma che sia paradosso per chi non è capace di aderirvi. L’autentica malattia mentale, come tutte le malattie, è un male da curare, nel migliore dei casi, da attenuare, nel peggiore. Essa non è l’illuminazione di un dio minore né l’epifania di una realtà trascendente; per lo più è ossessione coatta, ripetizione a tentoni di gesti e pensieri. Chi ha avuto modo di frequentare persone disturbate mentalmente sa che le loro fissazioni, le loro lagnanze, le loro indolenze, le loro pretese, come la loro incapacità di ascoltare, non hanno nulla di creativo, anzi esprimono chiaramente il segno che qualcosa si è mentalmente inceppato. Tuttavia è bene ricordare che, come tutti i malati, anche il malato mentale non si riduce alla sua malattia; non è soltanto un semplice caso clinico bensì una persona umana, in possesso di passioni, affetti, fantasie, intelligenza, fascino. Un persona non affatto disfatta dalla sua malattia. In un disturbato mentale ci possono essere, come ci sono in tutti, intelligenza, ricchezze di ideazione, originalità, complessità di sentimenti, non in virtù della sua malattia ma nonostante la sua malattia. Considerare la sua malattia affascinante equivale a considerare affascinante il tumore. Affascinante è certamente la persona che convive con il tumore, così come affascinante è la persona che convive con la follia. Il «viaggio» autentico nella follia è il viaggio alla ricerca di quell’umanità che la follia tende a soffocare, in alcuni casi, a sopprimere, ma che è presente in tutti e va individuata e, poi, rispettata e amata. Si pensi a Cervantes a Dostoevskij a Pirandello che si sono avventurati nei sottosuoli e nelle radure della follia forse meglio di tutti. 60 Chi è avvinto dal male può essere più ricco di umanità a causa della tragica prova cui è sottoposto, come Primo Levi e Aleksandr Solgenitsyn, divenuti umanamente immensi in virtù del modo in cui hanno vissuto i lager nazisti e i gulag sovietici. Ovviamente non è un buon motivo per essere attratti piacevolmente dai lager e dai gulag, che sono l’espressione del «male assoluto» della prima metà del XX secolo66. Eppure questa follia è stata voluta e preparata dai più grandi filosofi tedeschi dell’Ottocento, e andando indietro tracce visibili si colgono nel pensiero politico di Platone67 e nei proclami etico-politico-religiosi di Lutero68. La follia non è sempre così divertente come quella di quel tale di cui racconta Orazio, che ogni sera la condizione di delirio lo spingeva a immaginare splenditi spettacoli teatrali e se ne rallegrava e, una volta sanato il delirio, era colto da depressione per non più poter godere di quelle meraviglie. Carità, e poi ancora tanta carità, ci impone di convivere con quanti non vivono di una delirante gradevole messinscena, bensì di depressione e di tenebre, coscienti che queste persone non sono portatrici di una minore dignità e di un minore diritto di noi, e che quella condizione di malessere che li aggredisce, potrebbe in qualsiasi momento, come accade per qualsiasi malattia, aggredire anche noi. * La genesi di questo breve scritto è da rintracciarsi in un occasionale incontro con un simpatico amico che ha ritenuto l’essere privato di una «ragione sragionevole» a tutto vantaggio di una «ragionevole sragione», offesa grave. 1 Cfr., V. ANDREOLI, Camice matto, Rizzoli, Milano 1995. Stimo Andreoli per le sue opere d’impostazione scientifica e, soprattutto, per l’umanesimo che accompagna la sua scrittura e la sua pratica medica. Ho, inizialmente, ritenuto la sua affermazione soltanto provocatoria, detta per far riflettere il lettore sullo stato d’essere di una condizione umana che dava segni di irrequietezza e andava alla ricerca di una giustificazione finalizzata ad avvalorare l’insorgenza di possibili stranezze. E invece mi sbagliavo. Debbo riconoscere che la prospettiva di lettura di Andreoli ha colto non una possibile tendenza ma una «verità» de facto: una verità da ritenersi oramai la cifra della variegata stratificazione sociale della contemporaneità. 2 U. GALIMBERTI, Gli equivoci dell’anima, Feltrinelli, Milano 1987, p. 171. 3 Ivi, pp. 171-172. 4 Ivi, p. 173. 5 E. SEVERINO, La strada, Rizzoli, Milano 1983, p. 73. 6 Per una organica trattazione sul vissuto pubblico e privato di Immanuel Kant si rinvia al sempre interessante volume di L. E. BOROWSKI, R. B. JACHMANN, E. A. WASIANSCKI, La vita di Kant narrata da tre contemporanei, trad. it., Laterza, Bari 1969. 7 Cfr., I. KANT, Saggio sulle malattie della mente, trad. it. Massari Editore, Bolsena 2001. Il saggio apparve sulla rivista locale “Königsbergsche gelehrte Zeitung” (edita proprio da Hamann) e pubblicato anonimo in quattro puntate: dal 13-28 gennaio 1764. 61 I. KANT, Critica della ragion pura, trad. it. Laterza, Bari 1971, p. 243. H. HEINE, Per la storia della religione e della filosofia in Germania, in H. HEINE, La Germania, trad. it., Bulzoni, Milano 1979, p. 268. 10 I. KANT, Critica della ragion pura, cit., p. 257. 11 VOLTAIRE, Dizionario filosofico, trad. it. Mondadori, Milano 1970, pp. 323-324. 12 Ivi, p. 325. 13 I. KANT, Saggio sulle malattie della mente, cit. p. 66. Kant ordina i disturbi di una mente squilibrata nei seguenti tre gruppi: «In primo luogo lo stravolgimento dei concetti dell’esperienza nell’allucinazione (Verrückung); in secondo luogo il disordine della capacità di giudizio innanzitutto per ciò che riguarda tale esperienza, nella demenza (Wahnsinn); in terzo luogo lo stravolgimento della ragione rispetto ai giudizi più generali nella pazzia delirante (Wahnwitz)» (ibidem). 14 Cfr. La metafisica dei costumi, trad. it., Laterza, Bari 1970, pp. 316-341. 15 I. KANT, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in I. KANT, Scritti di filosofia politica, a cura di G. Solari e di G. Vidari, La Nuova Italia, Firenze 1975, p. 8. A nessuno è vietato negare che dietro questa «insocievole socievolezza» si nascondano varianti di sinistra condizione umana? Kant chiarisce così i termini di questa condizione: «Io intendo qui col nome di antagonismo la insocievole socievolezza degli uomini, cioè la loro tendenza a unirsi in società, congiunta con una generale avversione, che minaccia continuamente di disunire questa società. È questa evidentemente una tendenza insita nella natura umana. L’uomo ha un’inclinazione ad associarsi, poiché egli nello stato di società si sente maggiormente uomo, cioè sente di potere meglio sviluppare le sue naturali disposizioni. Ma egli ha anche una forte tendenza a dissociarsi, poiché egli ha del pari in sé la qualità antisociale di voler tutto rivolgere solo al proprio interesse, per cui si aspetta resistenza da ogni parte e sa ch’egli deve da parte sua tendere a resistere contro altri. Questa resistenza eccita tutte le energie dell’uomo, lo induce a vincere la sua tendenza alla pigrizia e, spinto dal desiderio di onori, di potenza, di ricchezza, a conquistarsi un posto tra i suoi consoci, che egli certo non può sopportare, ma di cui non può neppure fare a meno» (Ivi, p. 7). 16 I. KANT, I sogni di un visionario spiegati coi sogni della metafisica, trad. it. Rizzoli, Milano 1982, p. 144. 17 H. HEINE, Per la storia della religione e della filosofia in Germania, cit., p. 194. «I Tedeschi», scrive Heine, «trovano spesso nell’orrido il loro migliore divertimento, e le saghe popolari dedicate ai coboldi sono talvolta piene di tratti piacevoli» (ibidem). 18 Cfr., R. KURTZ, Expressionismus und Film, Verlag der Lichtbilbühne, Berlin 1926. 19 W. REICH, Ascolta, piccolo uomo, trad it., Sugar Editore, Milano 1973. 20 H. HEINE, La città di Lucca, in H. Heine, Reisembilder, trad. it. EPIDEM, Novara 1974, p. 218. 21 H. HEINE, Idee. Libro Le Grand, in H. Heine, Reisembilder, cit., p. 99. 22 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, trad. it. Rizzoli, Milano 1978, p. 46. 23 Ivi, pp. 46-47. 24 Cfr. Ivi, p. 47. 25 Ibidem. 26 A. Artaud, citato in M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, cit., p. 47. 27 Ivi, pp. 47-48. Esplicita questo convincimento Vittorio Cotesta in un’interessante pagina del suo pregevole volume sul pensiero foucaultiano: «La parentela tra vagabondi, criminali, prostitute, libertini e folli viene rotta in una duplice direzione: nella riduzione di alcune forme della sragione a ragione (trasformazione produttiva degli esclusi che diventano ‘operai’), nella selezione/separazione tra una sragione-criminale e una sragio8 9 62 ne-folle. Questa nuova coscienza della follia, però, non muta il rapporto della ragione e del suo altro. Al di sotto delle trasformazioni della coscienza della follia, delle forme di riconoscimento e trattamento permane la struttura del rapporto fondato sull’esclusione. L’atto originario che costituisce, a un tempo, la ragione e la follia, è ancora un atto di esclusione, un mettere a margine. La struttura della ragione è ancora l’opera e quella della follia l’assenza d’opera. L’inconcialiabile opposizione tra “l’operante conforme a un fine” e l’agire aprogettuale del folle o del criminale determina nell’età moderna la forma delle “immobili strutture del tragico”» (V. COTESTA, Linguaggio potere individuo. Saggio su Michel Foucault, Dedalo Libri, Bari 1979, p. 100). Per una attenta e acuta analisi dei motivi foucaultiani dell’immaginario e della sragione si rinvia al pregevole saggio di C. SINI, Semiotica e filosofia, Il Mulino, Bologna 1978. Inoltre, per una genealogia foucaultiana della “Ragione” a partire da Cartesio fino Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, fondamentale resta il contributo di S. NATOLI, Foucault e la genealogia della “Ragione moderna”, apparso in Ermeneutica e genealogia, Feltrinelli, Milano 1981 e ora riproposto in S. NATOLI, La verità in gioco. Scritti su Foucault, Feltrinelli, Milano 2005. 28 A. PENNISI, “Misure senza misura. I processi cognitivi nella psicopatologia del linguaggio”, in Patologie del linguaggio e scienze cognitive, a cura di A. Pennisi e R. Cavalieri, Il Mulino, Bologna 2001, p. 397. 29 A. ARTAUD, Corrispondance avec Jacques Rivière, in Œuvres complètes, Gallimard, Paris 1956-1994, vol. I, t. 1°, p. 6. 30 Ivi, pp. 10-11. 31 Ivi, pp. 17-19. 32 A. PENNISI, op. cit., p. 405. 33 Ibidem. 34 A. ARTAUD, Œuvres complètes, cit., vol VIII, p. 184. 35 A. ARTAUD, Corrispondance avec Jacques Rivière, cit., p. 39. 36 Ivi, p. 55. 37 Ivi, p. 23. 38 Ibidem. 39 Ivi, p. 55. 40 Ibidem. 41 Ivi, p. 60. 42 Ivi, p. 41. 43 Nel 1937 René Tohomas donò ad Artaud un bastone contrassegnato da tredici nodi e irto di punte acuminate che, a sua volta, aveva avuto in regalo dalla figlia di uno stregone savoiardo. Artaud considerava questo bastone lo stesso che era appartenuto a San Patrizio, patrono d’Irlanda (389-461 d.C.). Il santo, a seguire la leggenda, avrebbe ricevuto in sogno direttamente dalle mani di Cristo questo bastone pieno di simboli magici. Artaud pensava, dunque, di aver tra le mani il cosiddetto baculus Jesu, un bastone dai poteri sovrannaturali e taumaturgici che avrebbe dovuto necessariamente portare in Irlanda al fine di salvare i suoi abitanti da certa catastrofe. Artaud non si separa mai da questo bastone che aveva fatto ferrare alla base, in modo tale che venendo a contatto con le pietre delle strade producesse scintille, come si legge in Les Nouvelles Révélation de l’être (Denoël, Paris, 1937). Durante la notte Artaud lo interponeva nel letto tra il suo corpo e quello della fidanzata Cécile Schrammer affinché le loro membra non venissero in contatto. 44 A. ARTAUD, Cahiers de Rodez, in Œvres complètes, cit., vol. XV, pp. 163-164. 45 A. PENNISI, op. cit., p. 417. 46 Cfr. A. ARTAUD, Poesie della crudeltà, trad. it., Ed. Stampa Alternativa, Viterbo 63 2002. La «crudeltà» a cui fa riferimento Artaud è brillantemente esplicitata nella breve Premessa (che qui di seguito riportiamo) al saggio di ARTAUD, L’arve et L’aume. Tentativo a-grammaticale a proposito di Lewis Carrol e contro di lui, apparsa nel volume A. ARTAUD, Il sistema della crudeltà. Gli effetti, le intensità, il linguaggio dei corpi, Millepiani, n. 11, Mimesis, Milano 1997: «Il sistema della crudeltà enunciato da Artaud indica il campo degli affetti, delle forze trasformative che mettono in relazione i corpi tra loro. Il problema della relazione tra i corpi-affetti è un argomento che getta una luce inquietante sul nostro tempo dominato dalla parcellizzazione e dalla frammentazione. La fine delle dimensioni utopiche ha scagliato i corpi e le relazioni in un orizzonte di microconflitti permanenti la cui posta in gioco non è il progetto o il desiderio di trasformazione, bensì il narcisistico meccanismo di autoaffermazione di identità deboli. Per questo motivo l’orizzonte ci appare opaco perché privo di capacità progettuale e dominato da quell’istanza del giudizio differito così ben individuata da Gilles Deleuze. Attraversare il piano della crudeltà significa riattivare la capacità creativa dei linguaggi, che indicano le nuove linee di fuga attraverso le quali si rende nuovamente possibile pensare il moderno» (p. 7). 47 A. ARTAUD, Cahiers de Rodez, in Œvres complètes, cit., vol. XV, p. 167. 48 A. PENNISI, op. cit., p. 416. 49 A. ARTAUD, Io sono Gesù Cristo. Scritti eretici e blasfemi, trad. it. Ed. Stampa Alternativa, Viterbo 2003, p. 21. 50 Ivi, p. 37. 51 Ivi, p. 57. 52 Cfr. G. DELEUZE-F. GUATTARI, L’anti-Edipo, trad. it. Einaudi, Torino 1975. 53 Cfr. J. DERRIDA, La disseminazione, trad.it. Jaca Book, Milano, 1989; Mémoires d’aveugle. L’autoportrait, et autres ruines, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1990 e Memorie di cieco, trad.it. Abscondita, Milano 2003. 54 M. GALZIGNA, Artaud l’irriducibile, in AA.VV., Linguaggio, ragione e follia, ESI, Napoli 1990, p. 221. 55 Ivi, p. 227. 56 E. BORGNA, Le intermittenze del cuore, Feltrinelli, Milano 2003. Così scrive Borgna (avvalendosi delle considerazioni presenti nel romanzo di Sylvia Plath La campana di vetro, 1961, in S. Plath, Opere, Mondadori, Milano 2002): «Come in Antonin Artaud, nelle testimonianze fiammeggianti che egli ne ha dato, anche in Syvia Plath, benché con immagini ed espressioni diverse, l’elettroshock è vissuto (per i modi con cui è stato realizzato e, cioè, senza anestesia), come segno indelebile di una desertica esperienza umana e psicologica: nel momento della sua applicazione e nelle conseguenze che ne sarebbero scaturite» (p. 95). 57 A. PENNISI, op. cit., p. 471. 58 S. FREUD, Introduzione al narcisismo, trad. it., Boringhieri, Torino 1976, pp. 50-51. Intorno al percorso freudiano sul narcisismo si rinvia al sempre attuale saggio di G. SASSANELLI, Le basi narcisistiche della personalità, Boringhieri, Torino 1982. 59 Cfr., A. MORO, I confini di Babele. Il cervello e i misteri delle lingue impossibili, Longanesi, Milano, 2006, p. 12. 60 Ivi, pp. 122-132. 61 Ivi, p. 142. 62 Ibidem. 63 Cfr. ivi, pp. 191- 220. 64 P. ROVEREDO, Ballando con Cecilia, Lint Editoriale, Trieste 2000. 65 Ivi, pp. 88-89. 66 Nell’accennare al «male assoluto» della prima metà del Novecento non intendia- 64 mo escludere il fatto che nella seconda metà il male non sia stato meno «assoluto» della prima metà, come ben argomenta al riguardo Salvatore Natoli: «La spartizione postbellica tra USA e URSS in zone di rispettiva influenza ha garantito una politica di equilibrio sufficiente per tenere lontani i pericoli di un nuovo conflitto mondiale. La potenza distruttiva degli arsenali bellici ha favorito paradossalmente la pace, ma, in senso stretto, la guerra non è mai finita. Infatti, mentre il centro del mondo sperimentava con successo una pace armata, la guerra perseguiva altrove e senza interruzione nelle periferie. Nella seconda metà di questo secolo le guerre locali sono divenute endemiche. Dalla Corea in avanti la carneficina non è mai cessata. E tutt’oggi imperversa: da un lato il terrorismo fondamentalista e dall’altro le politiche imperiali, giustificate in nome dell’esportazione della democrazia, promettono guerra infinita» (S. NATOLI, Sul male assoluto. Nichilismo e idoli nel Novecento, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 20-21). 67 «La formula “l’uomo di Stato deve essere saggio” significa per Platone – argomenta Karl Popper – una pretesa di potere del filosofo dotto; da qui deriva la pretesa di potere della gente colta, degli intellettuali dell’“èlite” […] Di solito il platonico non è un re, ma sempre il capo onnisciente di un partito; e per quanto il partito che comanda sia composto solo da lui, all’opposto quasi tutti i capi di partito, specialmente i capi dei partiti aggressivi e di quelli che hanno successo, sono platonici. Perché sono quegli individui migliori, più informati e più saggi di tutti, che Platone insegna debbano essere i nostri padroni» (K. POPPER, La lezione di questo secolo, Marsilio, Venezia 1992, p. 82). 68 «Dar fuoco alle scuole e alle sinagoghe; distruggere le case; sequestrare i libri di preghiere e i testi talmudici; proibire ai rabbini di continuare a insegnare; abolire i salvacondotti che permettono di circolare per le strade; confiscare denari contante e oggetti preziosi. Non basta tutto questo a distruggere il castello di menzogne architettato dagli ebrei? E allora, che si diano loro in mano zappa, vanga e conocchia, in modo da rieducarli al sano lavoro, invece che all’ozio da parassiti alle spalle dei cristiani!» Queste e altre crudeltà pedagogiche, che potrebbero far pensare al diario di un SS operativo ad Auschwitz, si leggono in Degli ebrei e delle loro menzogne (Einaudi) a firma di Martin Lutero, Padre della Patria della “cultura” tedesca. Il libro scritto nel lontano 1543, e successivamente, tra l’altro, strumentalizzato dai seguaci di Hitler e addirittura invocato come opportuna e giusta attenuante dal nazista Julius Streicher davanti al tribunale internazionale di Norimberga, è da ritenersi una sorta di pulizia religiosa ideata da Lutero per mettere a tacere, una volta per tutte, la stirpe ebraica attraverso la soppressione della loro espressione religiosa e del modello di vita conseguente. Lutero non fu il primo antisemita della storia, ma di certo il legame teoricamente più robusto di una catena di infamie destinata ad attraversare tutto il Novecento. Dal tempo delle conversioni forzate degli Ebrei nella Spagna di fine ’400 (i “Libri verdi” che ricostruivano le genealogie dei marrani), alle accuse di “delitto rituale” lanciate contro i giudei nell’800 dall’italiano monsignor Benigni; dal razzismo “scientifico” del francese Gobineau alla Russia dei “Protocolli dei Savi di Sion”, fino alle leggi razziali di Mussolini, ai Lager di Hitler, alla liquidazione bolscevica dell’“ebreo Trotckij”, la catena ideologica, religiosa e politica, inaugurata da Lutero, ha perpetuato la sua infame opera di strangolamento degli Ebrei (e, di conseguenza, della libertà e della civiltà). 65 S AGGI «SFIDA SEMIOLOGICA» E TEORIA DELLA FRASE NELLA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO DI P. RICOEUR di Luca Maria Possati 1. Premessa. Linguaggio e «riflessione concreta»1 Nelle pagine che aprono Della interpretazione. Saggio su Freud, Paul Ricoeur chiarisce le motivazioni del proprio interesse per la psicoanalisi richiamandosi al problema generale del linguaggio, considerandolo un dominio comune sul quale s’incontrano e si scontrano numerose ricerche in filosofia e nelle scienze umane. Un simile primato del «linguistico» nel mondo contemporaneo è inteso da Ricoeur in termini «epocali»: il sorgere di esso non è affatto casuale poiché «noi siamo quegli uomini – scrive il nostro autore – che dispongono di una logica simbolica, di una scienza esegetica, di un’antropologia e di una psicoanalisi e che, per la prima volta forse, sono capaci di abbracciare come un’unica questione quella della ricomposizione del discorso umano […] l’unità del parlare umano fa oggi problema»2. Sulla base di tali considerazioni, Ricoeur inscrive il proprio impegno ermeneutico – ancora volto negli anni Sessanta, nel Saggio così come nel Conflitto delle interpretazioni, allo studio dei simboli e al progetto di una loro «deduzione trascendentale» – entro l’orizzonte più vasto, ma non meramente ideale, di una «filosofia del linguaggio integrale» capace di raggiungere «l’unità del parlare umano» preservando la diversità e l’irriducibilità dei suoi usi. Insomma, «una grande filosofia del linguaggio che renda conto delle molteplici funzioni del significare umano e delle loro reciproche relazioni»3. A questa preoccupazione fondamentale, a quest’intento non riduzionista ma unitario, si rifanno anche le molteplici pieghe del percorso ricoeuriano successivo al Conflitto delle interpretazioni, segnato dalle due opere «gemelle» La metafora viva e Tempo e racconto. In esse, l’«unità del parlare umano» è cercata nei concetti di frase e discorso applicati in prevalenza al linguaggio scritto, al testo: «l’oggetto dell’ermeneutica – scrive, infatti, Ricoeur – non è il “testo”, ma il testo come discorso o il discorso come testo»4. Ciò nonostante, ricercare l’unità del linguaggio nella frase e nel discorso, e ancor più mostrare il sorgere del testo dal «discorso», risultano essere entrambe imprese estremamente complesse, compiti che chiamano in causa discipline e teorie differenti e che generano a loro volta una versione rinnovata e amplificata del «conflitto delle interpretazioni». 66 Essendo per natura evento, atto, concreta realizzazione della competenza linguistica, comunicazione vivente, il discorso si presenta fin dall’inizio come l’esatto contrario di quel che i linguisti d’ispirazione strutturalista chiamano generalmente langue, codice o sistema, e dunque sembra immediatamente ricadere sotto l’etichetta di parole, o événement de parole, e cioè – nei classici termini saussuriani – dell’inessenziale del linguaggio, escluso per principio da ogni serio studio linguistico5. Per giustificare adeguatamente la validità del proprio approccio, allora, Ricoeur si vede costretto ad affrontare un lungo e complesso confronto non solo con i temi e i problemi imposti dalla scienza linguistica e dalle sue più recenti trasformazioni, ma anche – e forse in modo più sottile e problematico – con altre letture «dall’esterno» della fenomenologia husserliana fra cui, in primis, quella derridiana. Come vedremo, tanto in Derrida quanto in Ricoeur la riflessione sul linguaggio va ricondotta ad una problematica di fondo: la questione della possibilità della epoché fenomenologica e quindi della stessa distinzione tra l’empirico e il trascendentale. In entrambe le soluzioni addotte, linguaggio (senso) e tempo (evento) formano un binomio decisivo. Come conferma il lungo saggio che occupa, non a caso, una posizione centrale nella serie dei testi del Conflitto delle interpretazioni 6, le diverse forme dello strutturalismo, insieme alla psicoanalisi, rappresentano per Ricoeur la «sfida semiologica» che la modernità avanza nei confronti della «tradizione riflessiva», nella quale il filosofo di Valence si autoinscrive esplicitamente e che rappresenta quel modo di pensare «derivato dal cogito cartesiano, attraverso Kant e la filosofia post-kantiana francese, poco nota fuori della Francia, e di cui – ammette Ricoeur – Jean Nabert è stato per me il pensatore più rilevante»7. Tradizione, questa, abituata a vivere di periodiche provocazioni e trasformazioni, «respingendo gli attacchi dell’avversario»8, e di cui la fenomenologia husserliana – agli occhi del Nostro – costituisce il più recente ed estremo compimento. Linguistica strutturale e psicoanalisi: «astrazione oggettivante» e «kantismo senza soggetto trascendentale», la prima; «semantica del desiderio» ed «ermeneutica del sospetto», la seconda. Quel che le accomuna è l’affermazione di una «verità senza soggetto», la decisione di «attribuire al segno un peso tale che rimetta in causa ogni intenzione o pretesa di considerare la riflessione del soggetto su se stesso e la posizione del soggetto da parte di se stesso, come un atto originale, fondamentale e fondatore»9. In entrambi i casi, la destituzione del cogito muove dal terreno del linguaggio, o meglio dal venir meno per il linguaggio della necessità del riferimento ad un soggetto parlante e cosciente di sé. L’origine del senso del dire è irrimediabilmente spostata: dal soggetto che si esprime e dalle sue intenzioni significanti verso un inconscio autonomo, «categoriale» o «pulsionale», in base ai postulati della critica assunti in precedenza. A «sopravvive67 re», secondo Ricoeur, è un cogito blessé, cogito che si pone ma non si possiede e che, privato della sua fondazione intuitiva, si rivela un’evidenza falsa, nella quale – secondo il lessico della prima Meditazione cartesiana – l’apoditticità e l’adeguazione cessano di corrispondersi. In breve, dall’incontro con la psicoanalisi e lo strutturalismo, l’originario scopo della Filosofia della volontà – «accedere ad un’esperienza integrale del cogito, fino ai confini della più confusa affettività»10 – si complica enormemente: la sfera dell’involontario non solo si rivela «inconscia» in senso lato, ma pretende a sua volta di mettere in questione il primato della coscienza e della volontà rendendoli così meri epifenomeni. Malgrado ciò, se la crisi della filosofia riflessiva si consuma nel linguaggio, è pur sempre nel linguaggio che Ricoeur cerca di reperire la possibilità della sua pacificazione perché «la decifrazione dei segni è la contropartita dei limiti della conoscenza di sé»11. Al cogito brisé, al cogito frantumato e dequalificato, vengono in soccorso gli strumenti di un’ermeneutica, o meglio di una «fenomenologia ermeneutica». Se, infatti, con la «sfida semiologica» il sogno di una autotrasparenza assoluta del soggetto a se stesso è del tutto svanito, ciò nonostante un tale scacco può offrire lo spazio giusto per riconoscere il senso autentico della «rivoluzione» heideggeriana: la precedenza del comprendere come essere-nel-mondo, come dimensione ontologica preliminare all’instaurarsi di qualsiasi tipo di relazione conoscitiva, alla pensabilità stessa dell’ente intramondano12. Ricoeur trae le conseguenze della svolta, inserendosi pienamente in essa e affermando che «non si dà comprensione di sé che non sia mediata attraverso segni, simboli e testi»13. Ciò significa – in termini più radicali – che la comprensione, l’«apertura all’essere» costitutiva del Dasein, è il risultato dell’interpretazione del linguaggio. La comprensione di sé e del mondo si presenta dapprima celata, dissimulata, oscurata dalla presenza di un «falso cogito» nella polisemia disordinata del linguaggio. Al contrario, «il soggetto che si interpreta interpretando i segni non è più il cogito: è un esistente che scopre, mediante l’esegesi della sua vita, che è posto nell’essere prima ancora di porsi e di possedersi»14. Il soggetto ricoeuriano non è un «io» ma un «sé», un compito, un’«identità narrativa», sempre in tensione tra medesimezza e ipseità, tra atto e potenza, identità e alterità, attività e passività, tensione il cui senso spetta ad un’etica e ad un’ontologia indagare e chiarire. Agli occhi di Ricoeur, quindi, lo strutturalismo, insieme alla psicoanalisi, provoca la necessità di una «ristrutturazione» complessiva della filosofia riflessiva nei termini di una nuova analitica esistenziale che acquista il titolo di «riflessione concreta»: «la filosofia del soggetto che avrà un avvenire sarà quella che non soltanto avrà subito in ordine sparso la critica psicoanalitica e linguistica, ma quella che anche saprà progettare una nuova 68 struttura d’accoglienza per pensare assieme gli insegnamenti della psicanalisi e della semiologia»15. È quanto sintetizza la formula herméneutique du «je suis»: «è la mia ipotesi di lavoro filosofico – scrive Ricoeur – la chiamo la riflessione concreta [la réflexion concrète], cioè il cogito mediato da tutto l’universo dei segni»16. Ma è anche una «seconda rivoluzione copernicana»: il cogito che si fa interprete del linguaggio, che si mette all’ascolto dei simboli e dei testi, rompe il «cerchio incantato» della soggettività trascendentale chiusa in se stessa, e si scopre già e sempre situato in un essere che lo trascende. Entro un tale programma generale si colloca l’analisi ricoeuriana delle tesi della linguistica strutturale. È nel «modello semiologico», infatti, che Ricoeur vede il comune «luogo d’origine»17 di tutti gli strutturalismi e della «sfida» da essi avanzata alla possibilità stessa della riflessione. Ciò nonostante, la trattazione e la discussione delle tesi di Saussure e dei suoi emuli ricevono una necessità ancora più precisa, se considerate a partire dalla logica interna alla riflessione ricoeuriana sul linguaggio. Il presupposto decisivo da cui il nostro autore prende le mosse nello studio del fenomeno linguistico è la convinzione per cui esso si organizza e funziona secondo una molteplicità e una gerarchia di livelli18. Si va così dal segno alla frase, fino alle unità più vaste come il discorso o il testo. Il linguaggio è l’unità e la successione di gradi ed entità diverse. Più che una semplice constatazione teorica, il riconoscimento di questa «nozione del tutto fondamentale»19 s’impone agli occhi del Nostro come un criterio metodologico indispensabile. In effetti, se non riuscissimo a cogliere l’articolazione, la gerarchia e l’unità dei vari livelli, saremmo condannati «a delle controversie inutili, sterili e fanatiche»20. Tale, d’altronde, è la regola che organizza da cima a fondo l’architettura «graduale» di un’opera come La metafora viva: ciascuno degli otto studi che la compongono risulta essere «il segmento di un unico itinerario – scrive Ricoeur – che comincia con la retorica classica, attraversa la semiotica e la semantica, per arrivare infine all’ermeneutica. La progressione da una disciplina all’altra segue quella delle corrispondenti unità linguistiche: la parola [mot], la frase, poi il discorso»21. Se, in una tale insistenza sul carattere architettonico del linguaggio, appare nitidamente l’ispirazione strutturalista di Ricoeur, malgrado ciò – come rivela ancora l’andamento de La metafora viva – la vera posta in gioco per il Nostro non sta tanto nella progressione da un livello linguistico ad un altro, quanto nello stabilire l’esistenza di una continuità o discontinuità tra i diversi livelli. Sebbene, infatti, il darsi di una pluralità di livelli nel linguaggio sia un dato generalmente riconosciuto dai linguisti, tuttavia «molti attenuano questa affermazione», scrive Ricoeur, «sottomettendo tutti i livelli allo stesso metodo, per esempio a quello che ha avuto un buon esito sul pia69 no fonologico, dove si ha effettivamente a che fare con degli inventari limitati e chiusi, con delle entità definite dalla sola prova della commutazione, dai rapporti di opposizione binaria, infine dalle combinazioni rigorose tra unità discrete»22. In queste parole la critica è rivolta chiaramente all’impostazione della linguistica saussuriana stricto sensu (secondo Ricoeur condotta al suo più alto grado di formalizzazione da Greimas, dalla nouvelle rhétorique del gruppo Ì di Liège e da Michel Le Guern23). In essa il principio della gerarchia dei livelli è stato inteso in maniera troppo unilaterale: «le unità caratteristiche dei diversi livelli di organizzazione del linguaggio sono omogenee e di competenza di un’unica scienza, la scienza dei segni o semiotica»24. Ricoeur definisce un tale atteggiamento metodologico monisme sémiotique 25: i molteplici piani in base ai quali il linguaggio si organizza e funziona sono considerati fra loro omogenei, nel senso per cui tutti si fondano in ultimo luogo su un unico livello, su un’entità fondamentale che è il segno o, in breve, la parola, l’unità lessicale. Ne deriva, coerentemente, che ogni possibile formazione linguistica sarà sempre un’estensione o una riduzione di segni a partire da determinate operazioni di combinazione e selezione. Nel passaggio dal segno alla frase o al discorso, non avviene alcuna soluzione di continuità. Ogni elemento sarà insieme costituente del livello superiore e costituito da elementi sempre più piccoli. È quanto sintetizza anche Roman Jakobson – voce molto presente ne La metafora viva – scrivendo che «in un modello normale di linguaggio la parola è nello stesso tempo parte costituente di un contesto superiore, la frase, ed essa stessa un contesto di costituenti sempre più piccoli, i morfemi (unità minime fornite di significato) e i fonemi»26. Dal canto suo, Ricoeur propone di sostituire al monisme sémiotique e al primato della parola-segno un dualisme du sémiotique et du sémantique, secondo il quale «il linguaggio riposa su due tipi di unità, le unità del discorso o frasi, e le unità della langue o segni»27, e dunque propende a favore di una radicale discontinuità tra i livelli: «Il passaggio alla nuova unità del discorso, costituita dalla frase o enunciato, rappresenta una rottura, un mutamento nella gerarchia dei piani»28. In altri termini, nella prospettiva del dualismo semiotico/semantico promosso da Ricoeur, la frase non è affatto riducibile ad una doppia operazione di combinazione e selezione di segni, non è semplicemente costituita da una serie di parole scomponibile e ricomponibile a piacere, come nel monismo semiotico. È invece una nuova entità, una dimensione di linguaggio autonoma, originale, i cui tratti saranno oggetto di una determinata linguistica. Va precisato, inoltre, che, come dimostra altresì la dinamica complessiva dei primi cinque studi de La metafora viva, Ricoeur non si propone affatto di porre in duro contrasto i due approcci appena descritti. Indubbiamente egli li contrappone dando luogo ad un’antinomia calcolata, sviluppata punto per punto, ma solo per 70 mostrare in un secondo momento la possibilità della loro coesistenza e relazione dialettica, o meglio: la pensabilità della conversione di uno nell’altro. Il primato del segno resta, il valore scientifico dell’analisi strutturale è preservato, ma non presenta più caratteri di assolutezza ed egemonia. È invece coordinato all’azione della frase e ricompreso, criticamente, a partire da una linguistica del discorso. 2. La lettura ricoeuriana del Cours de linguistique générale Nel Cours de linguistique générale di Saussure il problema «a monte» è quello di trovare un «principio di classificazione» tale che consenta di studiare tutti i diversi fenomeni posti sotto il titolo di langage in una maniera unitaria, rigorosa e omogenea, in una parola: scientifica. Un simile criterio è ricercato nel langage stesso ed individuato nella langue, cioè soltanto in una parte del langage, anche se essenziale perché «al contempo un prodotto sociale della facoltà di linguaggio e un insieme di convenzioni necessarie, adottate dal corpo sociale per permettere l’esercizio di questa facoltà tra gli individui»29. Con il termine langue il linguista ginevrino intende un insieme di regole, una sorta di «contratto collettivo» stipulato tra individui tutti dotati della medesima facoltà linguistica, e dunque inscritto in una temporalità lunga. La langue è un codice comune che assicura la possibilità di comunicare in una certa comunità di parlanti. Essa quindi non appartiene a nessun membro della comunità in particolare; nessun individuo può crearla o modificarla a suo piacimento. In virtù della sua natura sociale, è insieme virtuale (è una capacità, un sapere, una competenza, e non un agire effettivo) e inconscia (i parlanti la assimilano poco per volta e vi ubbidiscono senza rendersi conto di sottostare ad un sistema di relazioni obbligate). Essendo una «forma», un dato estrinseco che esiste inconsciamente, alla langue si arriva per astrazione, epurando il langage da ogni traccia di presunta «materia», e cioè dal gesto linguistico concreto, individuale, irripetibile, dalla semplice esecuzione psico-fisiologica, in sintesi: dalla parole. Il soggetto parlante «dice» la parole non la langue. Oltre questa distinzione, l’altro tratto che contraddistingue la langue, per Saussure, è il suo essere un sistema di segni: «è un sistema di segni [un système de signes] dove non c’è di essenziale altro che l’unione del senso e dell’immagine acustica»30. L’idea centrale è che gli elementi linguistici non preesistono mai ai rapporti che intrattegono fra loro all’interno dell’organizzazione complessiva della langue. Questa non si sovrappone ad essi, ma li costituisce: la relazione costituisce i suoi termini, che dunque non potranno mai avere alcuna forma di autonomia. Il segno è pensato da 71 Saussure nei termini di una relazione. È un oggetto complesso composto di due facce, il significante e il significato, o meglio l’immagine acustica e il concetto, una faccia sensibile l’altra intelligibile31. Pur trattandosi di un’associazione del tutto arbitraria32, essa è resa necessaria soltanto dalla langue, dal «contratto». Quest’ultimo assicura la possibilità della comunicazione entro un certo gruppo di soggetto parlanti – cioè dotati della medesima faculté linguistique – poiché garantisce che tutti i soggetti parlanti utilizzeranno gli stessi significanti in rapporto agli stessi significati. In sintesi, la langue è un sistema, cioè un insieme organizzato di relazioni tra fattori eterogenei. Scendendo nei particolari, gli elementi che compongono le relazioni raccolte nella langue possono classificarsi in due categorie. (a) Unità di «prima articolazione» sono i cosiddetti lessemi (le unità lessicali, i singoli termini ordinati nel dizionario)33, dotati di un significante e di un significato. Ma la segmentazione si spinge anche oltre, fino ad individuare i monemi o morfi, le unità minime dotate di significante e significato, e componenti i lessemi. Per Saussure, i rapporti che intercorrono tra questi termini della langue possono svilupparsi su due piani: quello dei sintagmi, cioè delle combinazioni lineari e irreversibili (come la frase, il discorso, ecc.), e quello delle associazioni o dei «campi associativi», nei quali i segni si raccolgono e si dispongono per somiglianza o affinità. (b) A loro volta, monemi e lessemi risultano composti da unità di «seconda articolazione», che sono i fonemi, le unità elementari dotate di caratteristiche sonore distintive, o meglio «i segmenti minimi asemantici del significante». I fonemi sono quindi le particelle che compongono il significante del lessema o monema in questione (che vanno distinti dai foni, le loro realizzazioni concrete). Propriamente, essi non sono dotati di significato. Ogni lingua data comporta un numero limitato di fonemi (poche decine) grazie ai quali si può formare una quantità indefinita di monemi. Va tenuto ben presente che è sui fonemi – cioè sul significante, ma diremo anche sull’espressione – che si svolge il grosso del lavoro del linguista: «la classificazione dei significanti non è altro che la strutturazione propriamente detta del sistema»34. La cosa essenziale da capire è che il linguista non parte dal dizionario, dall’insieme dei segni, o dal singolo lessema. Questo, anzi, è il suo scopo, il suo punto d’arrivo: la costruzione del lessico e della sua necessità, procedendo dalle unità di «seconda articolazione» verso quelle di prima. Ciò significa dissociare langue e parole. Queste annotazioni ci conducono al senso esatto del monismo semiotico e al punto critico individuato da Ricoeur. Nella linguistica saussuriana la frase è pensata a partire dalle unità di livello inferiore, è una sommatoria di parole allineate una dietro all’altra. È un sintagma. Sottostà al dominio del segno e del suo inserimento nel sistema. Tuttavia, il sintagma è 72 anche molto vicino alla parole. «Non che [nel Cours] la frase sia ignorata – precisa Ricoeur –: la dicotomia fondamentale, quella tra langue e parole, attraversa il messaggio, che non può che essere una frase; ma non si parlerà più di parole e la linguistica sarà una linguistica della langue, vale a dire del suo sistema lessicale. Per questa ragione il Cours tende ad identificare semantica generale e semantica lessicale»35. Ricoeur si pone una questione cruciale anche per lo stesso Saussure: è possibile una linguistica della parole? O, meglio, è possibile una linguistica del sintagma, l’elemento della langue dove il confine con la parole si fa più labile e indeciso?36 Ne La metafora viva Ricoeur insiste particolarmente su questo punto perché crede di cogliervi una falla determinante del Cours di Saussure, quasi un’inespressa teoria della frase eccedente i limiti del monismo semiotico e che spinge verso un altro genere di linguistica: «il rapporto sintagmatico – scrive Ricoeur – ancor più che il rapporto associativo, sembra appellarsi ad una teoria del discorso/frase: non si dice forse che la frase è “il tipo privilegiato del sintagma”?»37. Tuttavia, il concetto di sintagma continua a restare prigioniero della dicotomia langue-parole, e infatti, «i sintagmi non scaturiscono dalla parole ma dalla langue – osserva giustamente Ricoeur – in quanto sono delle locuzioni complete alle quali l’uso proibisce qualsiasi cambiamento»38. In altre parole, Saussure accenna ad una teoria della frase libera dalla dicotomia langue-parole, che però non sviluppa mai, restando prigioniero dei suoi stessi postulati iniziali. Arriviamo così all’essenza della lettura ricoeuriana del Cours. Saussure pensa il discorso e la frase in termini di parole, come derivazioni di quella sfera psicologica e individuale del langage che non potrà mai costituire l’oggetto di una vera scienza, perché troppo eterogenea e mutevole. Agli occhi di Ricoeur, Saussure non coglie due punti: (a) la distinzione tra parole e discours, ossia l’esistenza di dimensioni, nell’uso concreto della langue, distinte rispetto al mero risvolto psicologico ed individuale; (b) la diversità logica sussistente tra il rapporto di opposizione che regola la langue e il rapporto di predicazione che regola la frase, l’unità del discorso. Quest’ultimo è il punto decisivo. «Il Cours – scrive infatti Ricoeur – ignora interamente la differenza propriamente logica tra il discorso e la langue, in altri termini, la differenza tra il rapporto predicativo nel discorso ed il rapporto di opposizione tra segni. In tal senso, si potrebbe dire che in Saussure si trova una teoria della parole, in senso psicologico ed individuale, ma non una teoria del discorso, in senso propriamente semantico […]. Ed anche la frase non riceve mai uno statuto comparabile a quello delle entità intorno alle quali ruota il contenuto essenziale del Cours»39. Ma perché questa insistenza di Ricoeur sulla frase, sul suo primato e 73 originalità? Perché, e da dove, quest’attenzione costante all’atto della predicazione e alla sua irriducibilità ad una combinazione di segni? Nel corpus ricoeuriano la critica al Cours ha origini lontane e ragioni molto profonde. In essa, Ricoeur non riprende soltanto delle discussioni abituali nel dibattito specializzato fra linguisti, ma cerca anche di consolidare una sua antica convinzione, espressa fin dai tempi de L’uomo fallibile (1960) – dunque una decina d’anni prima dei saggi che stiamo esaminando – e cioè il privilegio della prospettiva apofantica, l’idea per cui il vero essere del linguaggio, la forma nella quale esso meglio esprime la sua autentica funzione, è la frase, l’atto della predicazione, il dire «qualcosa su qualcosa a qualcuno». Scrive infatti Ricoeur: «Abbiamo finto di ignorare sin qui che la vera “parola significante” – per parlare come Aristotele nel trattato Della interpretazione – è il discorso composto che egli [Aristotele] chiama precisamente logosj, è la frase, il giudizio. Aristotele raccoglie qui la scoperta di Platone nel Cratilo, nel Teeteto, e nel Sofista, dove per la prima volta la distinzione del nome e del verbo è riconosciuta nel suo significato profondo e posta come la pietra angolare del discorso umano»40. In queste pagine Ricoeur assume quale filo conduttore delle proprie riflessioni i primi capitoli del De Interpretatione e in particolare i §§ 3 e 6. Egli è portato ad individuare il «cuore» della frase nella predicazione e dunque nel verbo, segno caratterizzato da una «sovra-significazione doppia»41. Infatti, come insegna lo Stagirita, il verbo da una parte designa il tempo, pone cioè l’esistenza di qualcosa in un dato momento: «dire che “Socrate cammina” significa porre l’esistenza presente della camminata; e tutti gli altri tempi non saranno che flessioni del presente»42. Dall’altra, il verbo aggiunge all’asserzione di esistenza l’attribuzione ad un soggetto, «quel che dice lo dice “relativamente a qualcos’altro”»43. E dunque, «“Socrate cammina” vuol dire: la camminata “esiste adesso” e la camminata è “detta di” Socrate»44. «Per mezzo di questa doppia intenzione del verbo – scrive Ricoeur – la frase umana trova al contempo la sua unità di significato e la sua capacità di errore e di verità. È il verbo che fa “tenere-insieme” la frase perché è lui che applica il significato attribuito al soggetto dell’attribuzione attraverso il suo significato supplementare; dichiarando l’essere introduce la frase umana nel regno ambiguo del vero e del falso»45. La «sovra-significazione doppia» del verbo è ricondotta a quel che Ricoeur chiama «il potere terribile e ammirevole dell’affermazione umana»46. È attraverso il verbo, infatti, che affermiamo o neghiamo qualcosa rispetto a qualcos’altro. Ricoeur lo definisce un «potere» poiché in esso intravede una certa capacità di trascendenza della volontà rispetto ai singoli contenuti del pensiero: con il verbo abbiamo la possibilità di negare o affermare qualsiasi cosa, la libertà di negare quel che abbiamo appena affermato così come di affermare quel che abbiamo appena negato, indipendentemente da quanto detto, 74 cioè dal soggetto o dall’attributo in questione. Nell’eventualità dell’assurdo sta la manifestazione estrema di un tale «potere»47. Un logoj autentico è quindi la frase, l’atto di discorso. In senso stretto, è l’affermazione, cioè la proposizione suscettibile di verità o falsità, il cui perno essenziale sta nel verbo. Alla sua base – spingendosi ben al di là di Aristotele – Ricoeur vi pone una fondamentale volontà di affermare, «l’electio, il liberum arbitrium, che è anche liberum judicium»48. Intenzione di verità e intenzione di libertà si fanno concorrenza, intrecciandosi in un medesimo atto intenzionale. Questa concezione della frase ne L’uomo fallibile è radicalmente messa in crisi dal monismo semiotico della linguistica strutturale, il cui fondamentale valore scientifico Ricoeur è ben lungi dal misconoscere: «la conquista del punto di vista strutturale è senza dubbio una conquista della scientificità»49. Com’è possibile, allora, recuperare il senso autentico del logoj?, cioè la «frase» de L’uomo fallibile, con tutto il peso, in essa, della predicazione e della volontà, senza dover rinunciare al guadagno portato dalla linguistica, senza entrare in collisione con il sistema? Per rispondere a questa «sfida», nei saggi raccolti nel Conflitto delle interpretazioni, Ricoeur si muove attraverso una contrapposizione di metodi. Ciò significa che al monismo semiotico della linguistica strutturale è opposto «in blocco» l’approccio della fenomenologia del linguaggio. Per il fenomenologo, infatti, «il linguaggio vuole scomparire, vuole morire come oggetto»50. L’antinomia ha però un valore «costruttivo»: la fenomenologia funge da impianto critico mediante cui valutare e ridimensionare le pretese «assolutistiche» della linguistica, la sua ambizione d’essere l’unica intelligenza possibile del linguaggio, così come la linguistica serve per criticare la fenomenologia, troppo portata a ricadere nello psicologismo, a fare del linguaggio un habitus acquisito per sedimentazione degli usi. 3. La frase come «istanza di discorso»: una replica alla «sfida semiologica» L’impostazione fenomenologica rivaluta l’atto del parlare in quanto intenzione significante di un soggetto che si rivolge al mondo e agli altri. Per il fenomenologo, ridurre il linguaggio alla langue significa mancare la sua intenzione prima che è quella di «dire qualcosa su qualcosa a qualcuno», un’apertura, una veemenza ontologica che rompe con qualsiasi chiusura dell’universo segnico su se stesso. Più che avanzare una semplice serie di critiche sparse, per Ricoeur la fenomenologia si contrappone «in blocco» alla linguistica della langue. Non bisogna dimenticare, infatti, che, agli occhi del Nostro, la prospettiva fenomenologica deve essere pensata come «una teoria del linguaggio generalizzato»51 i cui principî saranno sintetiz75 zabili in tre tesi: (a) il «significato» o «senso» è la categoria più inglobante della descrizione fenomenologica; (b) il soggetto è il portatore del senso; (c) la riduzione è l’atto filosofico che rende possibile accedere al senso, a quel senso che è «trascendenza nell’immanenza», mediazione tra soggetto e mondo. Queste tre tesi «sono inseparabili e possono essere percorse nei due sensi»52, l’ordine della scoperta e quello della fondazione. In pagine fortemente ispirate a Maurice Merleau-Ponty, «il più grande fenomenologo francese»53, Ricoeur dimostra che, assumendo una prospettiva linguistica, è possibile ritrovare in una perfetta unità tutte le tre tesi di partenza della fenomenologia purificandole da ogni inutile astrattezza idealistica. Il linguaggio non si presenta come un’attività, una funzione, un’operazione tra le altre, ma «si identifica con il mezzo significante totale [milieu signifiant total], con il reticolo gruppo dei segni gettati come una rete sul nostro campo di percezione, di azione, di vita»54. È il linguaggio il veicolo primo d’ogni possibile senso, ciò grazie al quale gli uomini hanno un «mondo» e non solo un ambiente circostante. Trovano conferma allora le parole di Don Ihde, secondo il quale «Ricoeur dà inizio al cambiamento da un modello fenomenologico fondato sulla percezione alla fenomenologia linguistica»55. Ciò nonostante, se la fenomenologia è destinata a costituirsi come una «teoria del linguaggio generalizzato», essa non riuscirà a diventarlo nella misura in cui resta legata alla prospettiva di Merleau-Ponty, troppo in attrito con la scienza linguistica. Ricoeur è convinto che la fenomenologia non debba porsi quale alternativa alla linguistica, ma che sia necessario mantenere intatta l’antinomia fra le due discipline, pensandola fino in fondo. Scrive infatti: Il nostro compito mi sembra piuttosto quello di andare fino in fondo all’antinomia di cui la chiara concezione è precisamente il frutto avanzato dell’intelligenza strutturale. La formulazione di questa antinomia è oggi la condizione del ritorno ad un’intelligenza integrale del linguaggio; pensare il linguaggio sarebbe pensare proprio l’unità di quel che Saussure ha disgiunto, l’unità della langue e della parole. Ma come? Il pericolo a questo punto è quello di costruire una fenomenologia della parole in opposizione alla scienza della langue, col rischio di ricadere nello psicologismo e nel mentalismo, da cui la linguistica strutturale ci ha liberato. Per pensare veramente l’antinomia della langue e della parole, bisognerebbe poter produrre l’atto della parole nello stesso ambiente della langue, alla maniera di una produzione di senso, di una produzione dialettica, che faccia accadere il sistema come atto e la struttura come evento [qui fasse advenir le système comme acte et la structure comme événement]. Ebbene! questa promozione, 76 questa produzione, questa avanzata possono essere pensati, se noi acquistiamo una esatta intelligenza dei livelli gerarchici del linguaggio56. Come sottolinea anche il Madison57, Ricoeur – a differenza di MerleauPonty – insiste anzitutto su quel che separa la filosofia dalla linguistica strutturale. Se vuole costituirsi come scienza, la seconda non può non escludere e catalogare come accessorio quel che invece la prima ritiene essenziale. Si tratta allora di spiegare come la langue possa trovare realizzazione nel vissuto linguistico del singolo locutore, come avvenga la traduzione del sistema in atto e, viceversa, il ritorno dell’atto al sistema. Così il «potere terribile e ammirevole dell’affermazione umana»58, evocato ne L’uomo fallibile, viene ripensato e ritrovato nel «potere» di una production dialectique, qui fasse advenir le système comme acte et la structure comme événement. Arrivare a pensare questo passaggio dialettico è lo scopo di Ricoeur e, come rivela l’ultima parte del passo sopra citato, la soluzione è cercata in una intelligence exacte des niveaux hiérarchiques du langage. Solo grazie ad una riformulazione dell’antinomia a partire da questa gerarchia è pensabile la production dialectique, perché con essa diventa chiaro che la filosofia e la linguistica non sono né semplicemente convertibili, né semplicemente antinomiche. Seguendo il ragionamento ricoeuriano, con l’idea di gerarchia dei livelli si fa largo anche quella della dualità semioticosemantico. Leggiamo, infatti, nel seguito del passo sopra citato: Non si è ancora detto nulla su questa gerarchia, fintantoché si è pensato soltanto a sovrapporre due piani di articolazione: l’articolazione fonologica e quella lessicale (anzi, sono tre piani, se si aggiunge l’articolazione sintattica). Non abbiamo ancora superato il punto di vista secondo il quale la lingua è una tassonomia, un corpus di testi già emessi, un repertorio di segni, un inventario di unità ed una combinatoria di elementi. La gerarchia dei livelli del linguaggio esige anche ben altro che non una successione di sistemi articolati: fonologico, lessicale, sintattico. Si cambia veramente di livello quando si passa dalle unità di langue all’unità nuova costituita dalla frase o enunciato. Questa unità non è più di langue, ma di parole o di discorso. Cambiando unità si cambia anche funzione, o piuttosto si passa dalla struttura alla funzione. In questo caso si ha la possibilità di incontrare il linguaggio come dire59. Il denso passo appena citato richiama uno «sfondo» di concetti, termini e idee riprese e rielaborate a partire dai testi di un linguista più volte frequentato da Ricoeur, Emile Benveniste, le cui tesi si tratta ora di esamina77 re più compiutamente, prima di tornare all’antinomia fenomenologia-linguistica60. In effetti, se leggiamo il saggio I livelli dell’analisi linguistica (1962), vi troviamo un’assoluta affinità con le affermazioni ricoueriane di cui sopra. Benveniste sostiene che per costruire una coerente descrizione del linguaggio sia necessario procedere tenendo ben fermo il concetto di «livello linguistico», essendo questo il più «adatto a fare giustizia della natura articolata del linguaggio e del carattere discreto dei suoi elementi»61. E non si tratta affatto di un’affermazione superficiale: il concetto di livello non è solo uno strumento esterno, una convenzione metodologica. È «dentro l’analisi; il livello è un operatore»62. «Forma» e «senso» (le principali dimensioni del linguaggio) si definiscono l’una in relazione con l’altro: «i loro rapporti – scrive Benveniste – sembrano implicati nella struttura stessa dei livelli e in quella delle funzioni che vi corrispondono, che qui noi designiamo come costituente e integrante»63. Ricondurre un’unità linguistica ai suoi elementi costitutivi, attraverso la scomposizione, significa determinarne la «forma». Mostrare, invece, come quella stessa unità possa integrare e completare un’unità più vasta, significa esplicitarne il «senso». Così, se il fonema trova il suo senso nel costituire l’unità chiamata segno, il segno a sua volta trova il suo senso nel costituire, insieme ad altri segni, l’unità chiamata frase. Scomporre il segno nei fonemi che lo compongono vorrà dire intraprendere il cammino inverso, ridurlo alla sua struttura formale. È allora chiaro, secondo quanto afferma lo stesso Benveniste, che «la forma di un’unità linguistica si definisce come la sua capacità di dissociarsi in costituenti di livello inferiore. Il senso di un’unità linguistica si definisce come la sua capacità di integrare un’unità di livello superiore»64. Questo «senso» del segno non andrà mai confuso con la referenza o designazione, con la sua «proiezione esterna». I veri problemi arrivano quando si passa dal livello del segno a quello della frase. I rapporti tra il senso e la forma, da uno all’altro, non sono nemmeno comparabili, tanto che s’impone una descrizione del tutto inversa e cioè il passaggio da una prospettiva semiotica ad una semantica. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il punto di vista semiotico è radicalmente intra-linguistico. Il suo criterio fondamentale è che ogni unità del linguaggio dev’essere pensata e identificata in riferimento soltanto alla langue, alla sua collocazione nel codice. L’unità semiotica per eccellenza è il segno, la cui forma e il cui senso saranno entrambi definiti in base al rapporto con altri segni o elementi della langue. «Tutto quel che è di competenza del semiotico – suggerisce Benveniste – ha per criterio necessario e sufficiente che lo si possa identificare in seno e nell’uso della langue. Ciascun segno entra in una rete di relazioni e di opposizioni con altri segni che lo definiscono, che lo delimitano all’interno della langue»65. 78 Il punto di vista semiotico risulta inadeguato nello studio della frase. «È questo – scrive Benveniste – un punto cruciale. Contrariamente all’idea per cui la frase possa costituire un segno in senso saussuriano, o per cui si possa per semplice addizione o estensione del segno, passare alla proposizione, quindi ai diversi tipi di costruzioni sintattiche, noi riteniamo che il segno e la frase sono due mondi distinti e che essi richiedono delle descrizioni distinte. Instauriamo nella lingua una divisione fondamentale, del tutto differente da quella che Saussure ha tentato tra langue e parole. Ci sembra che si debba tracciare attraverso l’intera lingua una linea che distingua le due specie e i due domini del senso e della forma, sebbene, ecco ancora uno dei paradossi del linguaggio, siano gli stessi elementi che si trovano da una parte e dall’altra, dotati tuttavia di uno statuto differente»66. La prospettiva semantica ribalta quella semiotica, ma non l’elimina affatto. Il suo criterio fondamentale è che ogni unità linguistica, tanto nel suo senso quanto nella sua forma, dev’essere pensata e descritta in riferimento alla frase, cioè all’atto della predicazione, e non alla langue. In un contesto semantico, quel che prima era il segno ora diventa il mot, cioè la parte componente la frase e che riceve dalla frase il proprio senso. «Da una parte, c’è la langue – precisa Benveniste – insieme di segni formali, distinti attraverso procedure rigorose, disposti in classi, combinati in strutture e sistemi, dall’altro la manifestazione della langue nella comunicazione vivente»67. Il piano della «comunicazione vivente» è il piano del linguaggio in quanto discorso. La frase ne rappresenta la «cellula» fondamentale. La nozione di semantica ci introduce nel dominio della lingua in uso e in azione; questa volta vediamo nella lingua la sua funzione mediatrice tra l’uomo e l’uomo, tra l’uomo e il mondo, tra lo spirito e le cosa, [la lingua] che trasmette l’informazione, che comunica l’esperienza, che impone l’adesione, che suscita la risposta, che implora, che costringe; in breve che organizza tutta la vita degli uomini. È la lingua come strumento della descrizione e del ragionamento. Solo il funzionamento semantico della lingua permette l’integrazione della società e l’adeguazione al mondo, e per conseguenza la regolazione del pensiero e lo sviluppo della coscienza. Ora l’espressione semantica per eccellenza è la frase68. Si tratta adesso di determinare il «senso» e la «forma» della frase. Ci si accorgerà immediatamente – come nota Benveniste – che una simile distinzione non ha più valore, o quantomeno subirà una trasformazione radicale rispetto al piano semiotico. Posto il principio che «il senso di una fra79 se è altra cosa dal senso delle parole che la compongono»69, conseguenza diretta è che la frase non trova il suo senso nel costituire, insieme ad altre frasi, un’unità di linguaggio superiore. Secondo Benveniste, la frase non è un segno ma un atto, l’agire concreto di un soggetto che vuole dire qualcosa a qualcun altro su qualcosa, cioè sul mondo, sulla realtà. È, quindi, «ogni volta un evento diverso; esiste solo nell’istante in cui è proferita e subito si cancella; è un evento evanescente»70. Per segnare meglio questo «carattere di atto» della frase, Benveniste forgia anche l’espressione instance de discours, con cui designa «gli atti discreti e ogni volta unici attraverso i quali la langue è attualizzata in parole da un locutore»71. Le frasi sono inclassificabili. Sempre diverse, esse non costituiscono un sistema in cui collocarsi e da cui essere definite. Questo atto in cui consiste la frase è un atto predicativo. Il suo tratto distintivo è quello di essere un predicato. Si delinea, così, il secondo cambiamento essenziale nel passaggio dal semiotico al semantico: all’opposizione che regola la langue si sostituisce il legame sintetico della predicazione. Grazie al riconoscimento e alla valorizzazione di una tale differenza, al contempo Benveniste riesce a separare la frase dalla parole, impedendosi così di scivolare in una psicologia o pragmatica della langue, e apre nuove possibilità alla prospettiva fenomenologica. Il «senso» della frase è il correlato dell’atto predicativo. Benveniste lo definisce intenté: l’idea che il locutore vuole esprimere, e comunicare ad un altro72. Quest’idea è realizzata mediante l’atto predicativo che, regolato dall’idea stessa, preleva i segni dal lessico e compone la frase. La predicazione realizza l’idea, «attraverso la scelta, la gestione delle parole, attraverso la loro organizzazione sintattica, attraverso l’azione che esse [le parole] esercitano le une sulle altre. Tutto è dominato dalla condizione del sintagma, dal legame tra gli elementi dell’enunciato, destinato a trasmettere un dato senso, in una data circostanza»73. Va fatta, però, una distinzione essenziale: «il senso della frase è la sua idea – scrive Benveniste – il senso di una parola è il suo impiego (sempre nell’accezione semantica). A partire dall’idea, ogni volta singolare, il locutore assembla delle parole che in questo impiego hanno un “senso” particolare»74. Benveniste si spinge fino ad introdurre una nozione che rompe completamente ogni legame possibile con il semiotico: l’intenté rinvia a qualcosa di «reale». Esiste una referenza delle singole parole nella frase, «che è l’oggetto particolare a cui la parola corrisponde nel concreto della circostanza e dell’uso»75, ed una referenza della frase presa nella sua totalità, che sarà «lo stato di cose che la provoca, la situazione di discorso o di fatto alla quale essa si riferisce e che non possiamo mai né prevedere, né indovinare»76. Inoltre, una delle principali novità introdotte dalle analisi benvenistiane – che avrà non poca incidenza nella riflessione di Ricoeur – sta nell’attenzione portata alla doppia funzione dell’unità lessicale: 80 Il mot ha una posizione funzionale intermedia, dovuta alla sua natura doppia. Da una parte si scompone in unità fonematiche che sono di livello inferiore; dall’altra esso entra a titolo di unità significante e con altre unità significanti, in un’unità di livello superiore77. L’unità lessicale «abita» sia nel sistema che nella frase. Si presenta allora quale «nodo» di scambio nel passaggio dal semiotico e semantico. È al contempo signe e mot – secondo la terminologia di Benveniste. Allievo di Antoine Meillet, nonché collaboratore di Lévi Strauss sulle pagine de L’Homme e di Lacan su quelle de La Psychanalyse, Benveniste non si propone di cancellare la dicotomia iniziale di Saussure, tra langue e parole, ma di ripensarla fuoriuscendo dal rigido monismo semiotico del maestro in base alla nuova dicotomia segno/frase: «ci spetta di cercare di andare al di là del punto in cui Saussure si è fermato nell’analisi della langue come sistema significante»78. Proprio seguendo questa linea, Ricoeur non pensa alcuna secca opposizione tra semiotica e semantica, tra linguistica della langue e linguistica del discorso. Anzi, nella loro dialettica il nostro autore vede le linee direttrici di una teoria generale del linguaggio che può inglobare linguistica della langue e linguistica del discorso, cogliendo l’unità del linguaggio stesso. Inoltre, applicando la distinzione semioticosemantico all’antinomia fenomenologia-linguistica, egli ritiene che sia possibile recuperare e rileggere in chiave nuova due concetti-cardine della fenomenologia husserliana: il soggetto e la riduzione trascendentale. Se l’istanza di discorso è – ricordiamolo – un concetto prettamente linguistico, come si dà in essa un riferimento linguistico al soggetto loquente, in modo tale che la domanda «chi parla?» abbia un qualche senso determinato? Un concreto appoggio per rispondere alla questione Ricoeur lo trova ancora negli studi di Benveniste, particolarmente in quelli dedicati ai pronomi personali e alle relazioni di persona nel verbo. Per Benveniste, infatti, tutte le lingue possiedono pronomi e questo semplice fatto, «induce a pensare che il problema dei pronomi è insieme un problema di linguaggio e un problema delle lingue, o meglio, che non è un problema di lingue se non perché è prima un problema di linguaggio»79. Tra il pronome personale io e un qualsiasi termine del lessico esistono differenze che non sono solo formali, ma anche di natura più generale e profonda. L’io non è una certa unità sostanziale, compresa in una classe di elementi con cui intrattiene un rapporto oppositivo. Non designa un oggetto particolare, perché «ogni io ha la sua referenza e corrisponde ogni volta ad un essere unico, posto come tale»80. In linguaggio tecnico, l’io è un indicatore. Designa soltanto l’istanza di discorso in cui è inserito, e di essa, precisamente, la persona che l’enuncia. Benveniste – linguista piuttosto avvezzo alla riflessio81 ne filosofica – sviluppa queste tesi fino all’estremo, avanzando l’idea di un’origine linguistica della soggettività. Cosa ciò significhi, lo si evince chiaramente dalle sue stesse parole: «è nel e attraverso il linguaggio che l’uomo si costituisce come soggetto; perché soltanto il linguaggio fonda in realtà, nella sua realtà che è quella dell’essere, il concetto di ego»81. Solo il linguaggio, cioè, dà la possibilità ad un ego di emergere, o, meglio, in una formula ancora più estrema ed incisiva: «È ego colui che dice ego»82, e che immediatamente si contrappone ad un tu. Da parte sua, Ricoeur cerca di moderare queste affermazioni e, mantenendo un atteggiamento più improntato alla fenomenologia, è portato a concepire il pronome personale soltanto come l’espressione secondaria di una più fondamentale, e non-linguistica, capacità del locutore di porsi quale soggetto e di fare riferimento a se stesso. Per quanto riguarda la seconda questione fenomenologica, la riduzione trascendentale, secondo Ricoeur il passaggio attraverso la linguistica benvenistiana pone le basi di una sua re-interpretazione in senso non idealista. È questo, tuttavia, un punto piuttosto delicato, perché si tratta di capire con esattezza quanto della epoché trascendentale husserliana rimanga nell’operazione interpretativa di Ricoeur. La riduzione, infatti, è dal Nostro incorporata nella stessa funzione simbolica, è intesa come il trascendentale della frase, «la possibilità per l’uomo di essere altro che non una natura tra le nature, la possibilità per lui di rapportarsi al reale designandolo per mezzo di segni»83. In breve, la riduzione non è più concepita come una «messa tra parentesi» della tesi generale dell’atteggiamento naturale, ma come una dialettica fra distanziazione e appartenenza. «L’inizio di una vita significante»84 per l’uomo è negativo, è dato con una radicale e improvvisa presa di distanza dalla realtà fattuale. Il segno è in primis diverso dalle cose. La sua condizione di possibilità è dunque la pura e semplice differenza, che però non richiede necessariamente un soggetto. «Se le cose stanno così, l’errore di fondo di Husserl sarebbe quello di aver postulato un soggetto trascendentale per questa differenza, che non è altro, per parlare esattamente, che la condizione trascendentale di possibilità di tutte le differenze empiriche tra i segni e nei segni»85. La differenza è una condizione negativa e non soggettiva del linguaggio. Ma è soltanto la prima dimensione della riduzione, quel che Husserl chiama la «messa fuori circuito» e che egli applica alla tesi generale dell’atteggiamento naturale per derivarne l’autentico atteggiamento fenomenologico e la coscienza trascendentale. Quest’ultima, pertanto, non si presenta affatto – almeno in prima battuta – come un soggetto, ma solo come un «campo» di cogitationes senza caratteri egologici. Ricoeur lo identifica con il sistema, con l’istituzione della langue, di cui la differenza è l’articolazione decisiva. Contropartita della «messa fuori circuito», del piano semiotico, è il ritor82 no «sensato» alla realtà, la «costituzione» fenomenologica. Non è possibile fermarsi alla dimensione negativa della riduzione come scarto, presa di distanza, differenza, «bisogna accedere alla sua dimensione positiva, che è la possibilità, per un essere che si è strappato per differenza ai rapporti intranaturali, di volgersi verso il mondo, di tendersi, di apprenderlo, di cogliere, di comprenderlo»86. È il passaggio dal semiotico al semantico. È il momento della frase, che apre l’ordine della langue sull’universo, che instaura con la realtà un rapporto mediato dal senso. «Il principio della differenza è soltanto l’altra faccia del principio del riferimento»87. Aprendosi alla predicazione la «coscienza senza soggetto» diventa un ego grazie al potere autoreferenziale della frase: «la messa in mostra di un mondo e la posizione di un ego sono simmetriche e reciproche»88. È dunque possibile, in base alla distinzione semiotico/semantico, rifondare la fenomenologia come una «teoria del linguaggio generalizzato» in grado di pensare l’unità del linguaggio, cioè l’unità di langue e parole. La riduzione trascendentale resta il perno di questa fenomenologia, reinterpretata come passaggio dal semiotico al semantico, come una dialettica tra una presa di distanza rispetto al reale e un ritorno sensato ad esso. Ogni atto linguistico come tale è, per Ricoeur, una dialettica tra distanza e appartenenza, dalla semplice frase fino al testo. 4. Polisemia e metafora Se le condizioni della suddetta production dialectique sono state fissate, è tuttavia il suo carattere dialectique che ancora fa problema. Occorre quindi ampliare l’analisi in tale direzione. Come avviene la conversione del semiotico (distanza) nel semantico (appartenenza) e il ritorno del semantico al semiotico? Per dirimere la difficoltà, nei saggi che vanno dal Conflitto delle interpretazioni a Dal testo all’azione, Ricoeur non si stanca di arricchire l’alleanza teorica con Benveniste con tesi e considerazioni riprese dalla teoria degli atti di discorso di John Serale e John Austin, ma soprattutto dalla grammatica generativa di Noam Chomsky e dalla teoria dei sistemi morfologici di Gustave Guillaume. È quindi lecito concordare con Mariano Cristaldi, quando sottolinea che «Ricoeur ha incrociato il complesso travaglio con cui lo strutturalismo francese e americano cercavano di superare le angustie del vecchio strutturalismo»89. Sempre sulla scorta di alcune indicazioni di Benveniste, Ricoeur individua nell’unità lessicale l’autentico operatore della dialettica che va dal semiotico al semantico, per tornare in seguito dal semantico al semiotico. Il termine, infatti, ha una doppia natura, una posizione intermedia. «Abita» sia nel sistema che nella frase. Compare ora come segno nella langue, ora come mot nel discorso. Ri83 coeur traduce questa situazione nell’affermazione: «la parola è molto più e molto meno della frase»90. Definiamo la questione nei suoi termini essenziali: (a) La parola è molto meno della frase perché dipende dalla frase per ricevere un senso qualsiasi. Dicevamo, infatti, che il senso della frase è la sua idea, il senso di una parola è il suo impiego. In effetti, il segno nella langue è un puro valore differenziale, una virtualità semantica. La cosa appare ovvia non appena si sfoglia un vocabolario: per ogni termine vi è acclusa una serie di sensi possibili, corrispondenti ai possibili usi di quel termine in eventuali contesti. Il termine acquista un senso determinato, dice propriamente qualcosa, solo quando è usato concretamente in una frase, «calato» in un contesto. (b) Ma la parola è anche qualcosa in più rispetto alla frase. In effetti, quest’ultima è soltanto un avvenimento, un evento transitorio, evanescente. La parola invece sopravvive alla frase. È un’entità «spostabile». Una volta usata nella predicazione non scompare affatto, ma ritorna alla langue, al vocabolario da cui è stata inizialmente prelevata. (c) Ciò nonostante, la parola non torna alla langue sempre allo stesso modo, sempre col medesimo senso. Dalla frase essa può ricevere anche nuovi valori d’uso, inediti significati che manterrà «in essa» cristallizzandosi nel sistema. Per spiegare questo complesso movimento circolare dal segno alla frase, e dalla frase al segno, Ricoeur fa riferimento al problema della polisemia. Un fenomeno, questo, che in effetti è incomprensibile se non si introduce una dialettica tra segno e impiego, tra struttura e avvenimento. In generale, la polisemia designa la possibilità per un qualsiasi termine di un vocabolario di possedere molti significati e di poterne anche acquisire di nuovi senza per questo perdere quelli già assunti. Ne La metafora viva, seguendo in particolare le indicazioni di Stephen Ullmann91, Ricoeur insiste molto su questo tema e sottolinea come la polisemia debba considerarsi solo la conseguenza di un carattere ancora più originario del nostro linguaggio: la vagueness, cioè la fluidità del lessico, il carattere indefinito, impreciso, delle nostre parole, la loro identità aperta, flessibile, malleabile a seconda degli usi. Naturale che, rispetto ad essa, la polisemia possa dirsi già un abbozzo di ordine, «solamente un carattere più determinato e già più ordinato del fenomeno più generale dell’imprecisione lessicale»92. Per Ricoeur, la polisemia rivela che l’identità dei nostri segni nel lessico ammette una certa eterogeneità, una pluralità di senso abbastanza ordinata, che non minaccia affatto l’identità stessa del segno. Aprendo un qualsiasi vocabolario, subito salterà agli occhi che i tanti diversi significati elencati per un singolo segno non hanno tutti lo stesso valore. Ci sarà una gerarchia, un senso principale attorno al quale si raccoglieranno sfumature, sensi diversi o derivati, corrispondenti ai vari contesti in cui il segno potrà essere usato – Ricoeur nomina tale caratteristica «sensibilità al conte84 sto»93. Si delinea così un’ulteriore caratteristica del fenomeno polisemico: la cumulatività. Non solo un segno è in grado di avere tanti sensi. Esso può anche acquisirne di nuovi senza perdere i precedenti. È proprio questa capacità di una stratificazione di sensi diversi, vecchi e nuovi, che rende il nostro linguaggio permeabile al cambiamento e all’innovazione. E che ciò non sia soltanto una fastidiosa patologia, ma un segno di buona salute, lo dimostra l’ipotesi contraria: un lessico assolutamente univoco sarebbe infinito (tante parole quante cose e stati di cose o pensieri da designare) e perciò stesso incontrollabile, ingestibile. La polisemia garantisce invece l’economia e la comunicabilità del linguaggio: «Abbiamo bisogno di un sistema lessicale economico, flessibile, sensibile al contesto, per esprimere e comunicare la varietà umana»94. Ma all’economicità corrisponde anche il pericolo dell’ambiguità, e cioè la possibilità di tante diverse interpretazioni possibili per un solo discorso95. Sempre ne La metafora viva, Ricoeur dimostra che è proprio il fenomeno della polisemia ad innescare la dialettica tra atto e sistema che avrebbe il suo perno, il suo snodo, nella parola. Il passaggio dal semiotico al semantico, e viceversa, non si dà propriamente né nella frase, né nella langue, ma nel segno. La polisemia è, infatti, allo stesso tempo un fatto sincronico, sistematico (in un dato stato di sistema quel segno possiede più di un significato) e diacronico, cioè ricollegabile all’uso, al piano semantico. È dunque lecito dire che «la parola sembra proprio essere al crocevia di due ordini di considerazione, in forza della sua attitudine ad acquisire nuovi significati e a mantenerli senza perdere i vecchi; questo processo cumulativo, in forza del suo doppio carattere, sembra richiedere un punto di vista pancronico»96. Prim’ancora di essere inserito in una frase e usato in un concreto processo di comunicazione, il segno sta nel lessico e offre al locutore un corredo di sensi più o meno diversi, e cioè valori d’impiego, potenialità d’uso, diciamo un «campo semantico» di cui poi sta al locutore scegliere quale parte usare in relazione al contesto. Al momento dell’uso, passando dal semiotico al semantico, il segno diventa mot, è inserito in una frase e riferito ad un mondo, ma porta anche «scritta» in sé la storia degli usi precedenti. 1 Ecco l’elenco delle sigle che verranno usate, nel corso dell’esposizione, per indicare le principali opere di Paul Ricoeur: PV1 = Philosophie de la volonté I. Le Volontaire et l’Involontaire, Aubier, Paris 1988 (I éd. 1950); HF = Philosophie de la volonté 2. Finitude et culpabilité. Tome 1 : L’homme faillible, Aubier, Paris 1988 (I éd. 1960); EF = De l’interprétation. Essai sur Freud, “Points Essais”, Seuil, Paris 1995 (I éd. 1965); CI = Le conflit des interprétations, “L’ordre philosophique”, Seuil, Paris 1969; SS = La sfida semiolo- 85 gica, raccolta di testi a cura di M. Cristaldi, Armando Editore, Roma 1974; MV = La métaphore vive, “Points Essais”, Seuil, Paris 1997 (I éd. 1975); DTA = Du texte à l’action, Essai d’herméneutique II, “Points Essais”, Seuil, Paris 1998 (I éd. 1986); FL = Filosofia e linguaggio, raccolta di testi a cura di D. Jervolino, Guerini e Associati, Milano 1994; HB = L’herméneutique biblique, Présentation et traduction par F.X. Amherdt, Cerf, Paris 2005; MHO = La mémoire, l’histoire, l’oubli, “Points Essais”, Seuil, Paris 2002. Pur tenendo presenti le traduzioni in lingua italiana, tutti i passi citati dalle opere ricoeuriane sono stati tradotti in italiano direttamente da chi scrive. Per tutti gli altri autori, l’origine delle traduzioni è stata specificata volta per volta. 2 EF, p. 14. 3 EF, p. 13. 4 HB, p. 183. 5 Cfr. F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, publié par Ch. Bally et A. Sechehaye, avec la collaboration de A. Riedlinger, Payot, Paris 1967, p. 30. «Separando la langue dalla parole, separiamo allo stesso tempo: 1° quel che è sociale da quel che è individuale; 2° quel che è essenziale da quel che è accessorio e più o meno accidentale» (la traduzione è di chi scrive). 6 P. RICOEUR, La questione del soggetto: la sfida della semiologia, in CI, pp. 233-262. 7 DTA, p. 29. 8 CI, p. 234. 9 Ibidem. 10 PV1, p. 12. 11 P. RICOEUR, Foreword, in D. IHDE, Hermeneutic Phenomenology. The philosophy of Paul Ricoeur, Northwestern University Press, Evanston 1971, p. XVI. 12 Cfr. CI, pp. 11-12. 13 DTA, p. 33. 14 CI, p. 15. 15 CI, p. 258. 16 CI, p. 260. 17 CI, p. 80. 18 Sul valore metodico generale del concetto di «niveau» in Ricoeur, spesso taciuto dai critici, si leggano le affermazioni di G. VINCENT nel bell’articolo: Le concept de tradition selon Ricoeur, in “Revue d’histoire et de philosophie religieuses”, 86 (2006), p. 124, nota 22. «Nel momento in cui formula un giudizio su un’opera, un enunciato, una teoria, un modello… Ricoeur fa attenzione molto al “livello”, alla scala in rapporto alla quale un’affermazione è valida, potendo il cambiamento di livello o l’indeterminazione del livello trascinare gravi conseguenze in termini di rigore epistemologico». 19 CI, p. 80. 20 P. RICOEUR, Contribution d’une réflexion sur le langage à une théologie de la parole, in “Revue de théologie et de philosophie”, n. 5, XVIII (1968), p. 335. 21 MV, p. 7. 22 CI, p. 81. 23 Ne è compiuta un’analisi approfondita nello studio V de La métaphore vive: «La métaphore et la nouvelle rhétorique», dedicato – non a caso – a Greimas. Cfr. MV, pp. 173-219. 24 MV, p. 130. 25 MV, pp. 130-131. 26 R. JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, trad. it. a cura di L. Heilmann e L. Grassi, Feltrinelli, Milano 2002, p. 37. 86 MV, p. 130. CI, p. 81. 29 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, cit., p. 25. Nelle citazioni del Cours che seguiranno faccio riferimento sia all’edizione francese edita da Plon nel 1967 sia alla traduzione italiana: F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, trad. it., introd. e note di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari 1968. Ricoeur torna più volte sui presupposti della linguistica saussuriana, dandone un elenco che si ripete in tanti saggi, solo con piccole variazioni. Cfr. ad esempio CI, pp. 81-84; CI, pp. 246-247; FL, pp. 2-6. 30 F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, cit., p. 32. 31 F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, cit., pp. 98-99. «Il segno linguistico unisce non una cosa e un nome, ma un concetto e un’immagine acustica. Quest’ultima non è il suono materiale, cosa puramente fisica, ma l’impronta psichica [l’empreinte psychique] di questo suono, la rappresentazione che ce ne dà la testimonianza dei nostri sensi; essa è sensoriale, e se ci capita di chiamarla “materiale” è solamente in questo senso e in opposizione all’altro termine dell’associazione, il concetto, generalmente più astratto. […] Il segno linguistico è dunque un entità psichica a due facce [une entité psychique à deux faces][…]. Questi due elementi sono intimamente uniti e si richiamano l’un l’altro» (la traduzione è di chi scrive). 32 Ivi, pp. 100-101. 33 Cfr. T. DE MAURO, Linguistica elementare, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 50-51. 34 R. BARTHES, Elementi di semiologia. Con un’appendice di testi inediti in italiano, a cura di G. Marrone, Einaudi, Torino 20023, p. 37. 35 MV, pp. 132-133. 36 Si tratta di un problema molto complesso e legato alla discussione interna al Cours. Cfr. R. BARTHES, Elementi di semiologia. Con un’appendice di testi inediti in italiano, cit., p. 50. «Si è visto che la parole (nel senso saussuriano) è di natura sintagmatica, giacché, a prescindere dalle ampiezze di fonazione, essa può essere definita come una combinazione (varia) di segni (ricorrenti): la frase parlata è il tipo stesso del sintagma. Il sintagma è dunque molto vicino alla parole: orbene, dal momento che per Saussure non può esserci una linguistica della parole, bisogna concluderne che la linguistica del sintagma è impossibile? Saussure ha avvertito la difficoltà, e si è prematurato di precisare in che cosa il sintagma non può essere considerato come un fatto di parole: in primo luogo perché esistono sintagmi cristallizzati, nei quali qualsiasi variazione è vietata all’uso […] e che sono sottratti alla libertà comminatoria della parole (questi sintagmi stereotipati diventano quindi delle specie di unità paradigmatiche); in secondo luogo perché i sintagmi della parole si costruiscono secondo forme regolari che, perciò stesso, appartengono alla lingua […] c’è quindi una forma del sintagma […] di cui si occupa la sintassi, che è per così dire la vera “glottica” del sintagma. Ciò non toglie che la “prossimità” strutturale del sintagma e della parole sia un fatto importante, in quanto essa pone continuamente dei problemi all’analisi, ma anche – reciprocamente – in quanto permette di spiegare strutturalmente taluni fenomeni di “naturalizzazione” dei discorsi connotati. È dunque necessario non perdere mai di vista l’intima connessione che intercorre fra il sintagma e la parole». 37 MV, pp. 132-133, nota 3. 38 Ibidem (corsivo mio). 39 Ibidem. Solide conferme a tali considerazioni Ricoeur le trova nell’opera di un altro autore a lui ben noto, su cui La metafora viva torna in continuazione: il linguista Roman Jakobson. Cfr. MV, p. 224. 40 HF, p. 49. Non bisogna dimenticare che l’esame della frase e del verbo si colloca27 28 87 no entro un più ampio disegno di antropologia filosofica che L’uomo fallibile si propone di sviluppare e dove predominanti sono le categorie filosofiche della sproporzione e del paradosso. 41 HF, p. 50. 42 Ibidem. 43 Ibidem. 44 Ibidem. 45 Ibidem. 46 HF, p. 51. 47 Ibidem. 48 Ibidem. 49 CI, p. 84. 50 CI, p. 85. 51 CI, p. 243. 52 CI, p. 242. 53 CI, p. 243. 54 Ibidem. 55 D. IHDE, Hermeneutic Phenomenology. The philosophy of Paul Ricoeur, Northwestern University Press, Evanston 1971, p. 7. 56 CI, p. 86. Ma cfr. anche, CI, pp. 247-248, che riprende gli stessi argomenti in modo più approfondito. 57 G.B. MADISON, Ricoeur et la non-philosophie, in “Laval théologique et philosophique”, 29 (1973), pp. 227-241. 58 HF, p. 51. 59 CI, pp. 86-87. 60 Solo un accenno agli studi di C. NORMAND, Le sujet dans la langue e Linguistique et philosophie: un instantané dans l’histoire de leurs relations, entrambi comparsi su “Langages”, Le sujet entre langue et parole(s), n. 77, 19e année (1985), pp. 7-19, 33-42. Essi compongono l’insieme di un’indagine volta a determinare la ricezione e l’incidenza dei concetti della linguistica benvenistiana sulla linguistica francese fino ai primi anni 70. La tesi della studiosa è che «Benveniste è stato mal conosciuto (più che sconosciuto) prima del 1970 […]. Diciamo che l’enunciazione come insieme teorico da riferire a Benveniste è conosciuto poco o sconosciuto dai linguisti francesi prima del 1970 e che i riferimenti, quando se ne trovano, sono fatti soltanto a Jakobson» (p. 9). Per sostenere queste affermazioni, la Normand si muove in due direzioni: a) svolgendo un monitoraggio delle riviste linguistiche più diffuse nel tempo; b) attraverso l’esame di alcuni testi generali, manuali, di linguistica in uso. Per lo studioso di Ricoeur, l’interesse di queste ricerche sta nel fatto che la Normand effettua numerose incursioni sul terreno della filosofia, mostrando che, negli anni Sessanta, se Benveniste non circola, o circola poco, tra i linguisti di professione, è invece tra i filosofi che trova un pubblico attento e capace di usare creativamente le sue tesi. E, infatti, solo attraverso la spinta dei filosofi e degli psicoanalisti i linguisti arriveranno ad occuparsi seriamente della teoria del discorso di Benveniste. La cosa davvero interessante è che la Normand per approfondire la sua indagine compie, nel secondo degli studi sopra citati, un confronto tra un gruppo di note dattiloscritte prese durante un corso di Ricoeur all’Università di Nanterre nel 1966/67 (note anonime, ritrovate avventurosamente dalla studiosa nel fondo di un baule, cfr. p. 34) e altre note prese da lei stessa, quando era studentessa, durante un corso del linguista J. Dubois, tenutosi nello stesso semestre e nella stessa Università. Il filosofo e il linguista non solo hanno due immagini completamente diverse dell’opera di Benveniste, ma c’è anche una profonda differenza di impostazione teo- 88 rica tra i loro corsi. Lo studio della Normand, inoltre, può essere utile perché riassume, seppure schematicamente, la scansione degli argomenti seguiti da Ricoeur nel suo corso, facendone anche alcune citazioni – che possono così confrontarsi con i testi pubblicati. 61 E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale 1, Gallimard, Paris 1966, p. 119. Per l’esposizione delle tesi benvenistiane sul linguaggio e le loro implicazioni filosofiche (non solo in Ricoeur) faccio riferimento soprattutto allo studio di G. CHARRON, Implications de la distinction de Benveniste entre linguistique de la langue et linguistique de la parole, in “Revue de l’Université d’Ottawa”, n. 2, 41 (1971), pp. 207-223. Per un’esposizione più generale dei problemi trattati, ma che include sia Ricoeur che Benveniste, cfr. anche C. JOJA, L’acte intégral du discours, “Revue Roumaine des Sciences Sociales”, n. 2-3, 27 (1983), pp. 234-241. 62 E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale 1, cit., p. 122. La traduzione, per questo come per i passi successivi tratti dalle opere di Benveniste, è di chi scrive. 63 Ivi, p. 126. 64 Ivi, pp. 126-127. 65 E. BENVENISTE, La forme et le sens dans le langage, in ID., Problèmes de linguistique générale II, Gallimard, Paris 1974, pp. 222-223. 66 Ivi, p. 224. 67 E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale 1, cit., pp. 129-130. 68 E. BENVENISTE, La forme et le sens dans le langage, cit., p. 224. 69 Ivi, p. 226. 70 Ivi, p. 227. 71 E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale 1, cit., p. 251. 72 Cfr. il commento che ne fa Ricoeur, in P. RICOEUR, «Signe et sens», cit., p. 1013. 73 E. BENVENISTE, La forme et le sens dans le langage, cit., p. 225. 74 Ivi, p. 226. 75 Ibidem. 76 Ivi, pp. 226-227. 77 E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale 1, cit., p. 123. 78 E. BENVENISTE, La forme et le sens dans le langage, cit., p. 219. 79 E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale 1, cit., p. 251. 80 Ivi, p. 252. 81 Ivi, p. 259. 82 Ivi, p. 260. 83 CI, p. 254. 84 Ibidem. 85 CI, p. 255. 86 CI, p. 256. 87 Ibidem. 88 Ibidem. 89 M. CRISTALDI, Tempo e linguaggio in Paul Ricoeur, in SS, p. 14. 90 CI, p. 92. 91 Sulla polisemia, cfr. in particolare P. RICOEUR, Polisemia e metafora e La metafora e il problema centrale dell’ermeneutica, entrambi in SS, rispettivamente alle pp. 274-287 e 288-312. 92 MV, p. 146. 93 Cfr. P. RICOEUR, Polisemia e metafora, cit., p. 275. 94 MV, p. 148. Cfr. anche P. RICOEUR, Polisemia e metafora, cit., pp. 275-276. 95 Cfr. ivi, p. 277. 96 MV, p. 157. 89 N OTE IL DANNO DEL VERBALISMO NELL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA di Salvatore Costantino In una tradizione di cultura letteraria, come quella italiana, sarà necessario conquistare la chiarezza sulla spontaneità parolaia, nella minaccia costante di questa degenerazione del linguaggio che è il verbalismo. Il professore di filosofia starà più attento in quanto il suo insegnamento è esso stesso designato come uno dei principali colpevoli. Ma chi accusa chi, e con quali prove? Il filosofo, dal canto suo, denuncia le associazioni dei luoghi comuni che occupano il posto del pensiero, la sostituzione degli argomenti dagli effetti retorici tipici dei nuovi media, infine la pseudodialettica di dibattiti ridotti ad affrontare delle semplici opinioni. Come il giornalista eviterebbe il verbalismo, anche quando si pretende critico, allorché egli si abbandona interamente alla precipitazione del commento quotidiano, e deve captare, per farsi intendere, la prevenzione del suo pubblico? Il fatto è che il giornalista è persuaso di tenere il suo discorso possibile della vita e della realtà umana, da cui si allontana manifestamente il professore di filosofia, fermo nel suo linguaggio astratto anche se scarta ogni tecnicità. Il malinteso sembra insormontabile. Quali che siano i termini nella quale viene espressa una teoria psico-chimica, le cui applicazioni sono conosciute, non sarà mai tacciata di verbalismo. Ma, per quanto concreto sia il suo vocabolario, una disciplina non si difenderà mai abbastanza quando non può opporre né fatti né effetti tecnici. Eric Weil ha mostrato che il filosofo non può opporre che delle parole, nient’altro che parole, per quanto siano sensate, alla brutalità dei fatti e a quella degli uomini. La violenza è muta, anche accompagnata da urla. L’esempio prescelto da coloro che dicono di preferire gli atti alle parole è il seguente: il comando breve (ma potrebbe essere uno slogan commerciale) che può vantarsi nell’automatismo della sua efficacia di non essere semplice parola. Esso non appartiene più al linguaggio, fatto tra i fatti, denudato di senso tanto che non è ripreso in un discorso coerente. Il professore di filosofia, il cui insegnamento è interamente linguaggio, deve subito ammettere che l’accusa di verbalismo, quando non è ingiuria e condiscende a spiegarsi, non sarà mai che la critica delle parole con altre parole, e che non sono mai gli atti che sono opposti alle parole, ma solo ciò che ne è detto. Del verbalismo del filosofo nessuno giudicherà dall’esterno, in nome di un’efficacia che non è mai che forza nuda o artifizio tecnico. Ecco la controprova: sono i filosofi stessi che sono stati i più severi a 90 causa del linguaggio dei filosofi. All’origine stessa della nostra tradizione, la filosofia socratica oppone la ricerca di verità alla seduzione degli effetti retorici dimentichi delle esigenze dell’idea. Ma per un notevole capovolgimento, sarà giustamente questa realtà dell’idea che diverrà l’esempio dell’illusione nata da un uso sconsiderato del linguaggio: verbalismo della sofistica, ma anche verbalismo del platonismo. Potremmo cercare, secondo la moda anglosassone, appoggio nel formalismo logico, senza ricordarci della verità cartesiana per quest’arte che permette di parlare senza giudizio di ciò che s’ignora? Verbalismo di Hegel per un bergsoniano, ma verbalismo dei filosofi dell’intuizione per un dialettico, e verbalismo dell’uno come dell’altro per un positivista. Leggiamo Carnap ridurre il Che cos’è la metafisica di Heidegger a delle false proposizioni incostruttibili logicamente: parole senza grammatica e grammatica senza logica. Questo sì che è verbalismo. Occorre proseguire? Occorre andare a dire, seguendo Jean Paulhan, che il verbalismo è spesso il pensiero dell’altro? Niente qui è suggerito da uno scetticismo comodo, ma occorre ripetere che le regole del linguaggio filosofico non possono essere definite che nell’atto di filosofare, e non preliminarmente. Se il verbalismo è ogni volta denunciato come linguaggio vuoto di contenuto, noi non possiamo liberarci dalla considerazione di questo contenuto. Là ancora la discussione è nel suo fondo filosofica. Tutto ciò, si obietterà, allontana dalla pratica dell’insegnamento chi deve, subito, combattere un verbalismo ordinario, quello che noi ritroviamo senza pena nelle copie d’esame e che è facile da caratterizzare dall’uso eccessivo d’un vocabolario tecnico manifestamente inutile. Il nostro dovere è allora di lottare contro questo impulso dei nostri allievi senza domandarci se la chiarezza, ridotta facilità d’accesso, è ben quella dell’idea cartesiana. Quanto ai grandi testi oscuri, non sapremo affrontarli con sufficiente precauzione, perché il loro ermetismo non divenga contagioso. Ma sotto la modestia pedagogica di questo proposito ritorna l’illusione d’una kotnÁ (tipica dell’insegnamento filosofico e mantenuta assai vicina all’insegnamento corrente. Tuttavia, come potremmo accontentarci delle sue risorse, allorché noi ne deploriamo mille volte la povertà constata nei nostri allievi? È giustamente questa insufficienza, in filosofia come in ogni altra disciplina, che conduce se non al neologismo, almeno, ciò che è lo stesso, all’accezione tecnica di termini usuali. Per il fatto che essi entrano in un’analisi filosofica un po’ rigorosa le parole di tutti i giorni appartengono già ad un lessico specialistico. Letto in un’opera filosofica, il termine di verità non è più che l’omonimo della parola verità nella lingua corrente. D’altronde le distinzioni sono lungi dall’essere facili. Il termine “complesso” appartiene ora al linguaggio più corrente in un significato che non ha più che un rapporto lontano con l’uso dei testi freudiani. Tale è ben la parola che useranno i nostri 91 allievi quando annunceranno i problemi che non dovremmo prendere in considerazione nei termini stessi che sono i loro. Ma qui dove sarà il verbalismo? Nell’accettazione d’una evoluzione semantica espansa fin nella lingua scritta? In un ritorno a un significato originale che è solo accessibile agli specialisti? La maggior parte dei professori non vorrà leggere Freud in controsenso. In questo caso, come in altri, parlare come tutto il mondo sarà comprendere come tutti, cioè erroneamente. “La comprensione del linguaggio filosofico è sempre contestuale. Riporre il termine filosofico nel suo contesto reale ha come risultato l’insegnare agli allievi che l’uso comune da parte dei non filosofi, nella stampa, nella radio, nella televisione, o anche nell’insegnamento filosofico in generale, di termini improntati a certi autori filosofici non è, meno spesso, lontanissimo dal senso filosofico reale al quale occorre sempre riferirsi.” La signora Dreyfus aggiungeva anche che conveniva vietare “salvo rare eccezioni, che sarà necessario giustificare, il transfert del vocabolario, tipico d’una filosofia in un’altra filosofia che possiede, anch’essa, un proprio vocabolario”. Ma è mai possibile che le parole d’un autore non servano mai a spiegare il pensiero di quest’autore? Sarà necessario escludere come parlante in gergo la parola alienazione, strettamente, al di fuori del contesto hegeliano? Il professore di filosofia non può fare altrimenti che utilizzare spesso un vocabolario d’impronta più o meno deviato dal suo senso originario, e su questo d’altronde seguirà l’esempio di quasi tutti i filosofi. Che cosa dunque fa Aristotele dell’eidos platonico, Kant della “categoria” aristotelica, Marx dell’alienazione hegeliana? In quale momento della pratica costante nella storia della filosofia diventa essa, nelle nostre classi, verbalismo? La ripresa d’un termine suppone spesso uno scivolamento di senso, ma essa è anche l’indice d’una filiazione autentica: è alla cultura del professore di esserne sufficientemente cosciente per prevenire ogni confusione. Se l’esattezza storica o filologica deve essere insegnata agli allievi, essa non è un fine a se stessa e deve essere subordinata al solo rigore filosofico. In definitiva, il pericolo sembra meno nell’impronta intenzionale al vocabolario d’un autore che in un vago sincretismo terminologico che riflette l’inconsistenza del pensiero. Si dimentica forse troppo spesso quell’altra forma di verbalismo ordinario che allinea interminabilmente le parafrasi tanto più chiare quanto più insignificanti possono essere. Per quanto le oscurità siano pretenziose, l’esaminatore è oppresso da luoghi comuni e da generalizzazioni piatte e sprovviste di qualunque mistero. Contrariamente a ciò che è a volte suggerito, non è buona regola pedagogica rendere sospetta ogni espressione difficile: l’oscurità non è solo dovuta a goffaggine o a inutile pedanteria. Essa può denotare il coraggio d’un pensiero nella sua lotta con le parole, e questo deve anche essere insegnato al liceo. “Malgrado la grande ricchezza delle nostre lingue – si legge nella Critica della Ragion pura – il pensatore 92 si vede spesso imbarazzato per trovare un’espressione che convenga esattamente al suo concetto, e per colpa di questa espressione, egli non può renderla intellegibile agli altri né, maggiormente, a se stesso”. Kant prende così contro corrente una tradizione francese che postula sempre che una buona lingua classica può bastare a tutto. Ma oseremmo ancora, come i primi traduttori di Kant, rendere a priori con “propedeutico”? Poniamo anche che egli abbia il vantaggio di usare una lingua scientifica che richiede l’attenzione e che ispira qualche rispetto: la fine della prefazione dei Prolegomeni ad ogni metafisica futura evoca questa “oscurità così descritta (scusa ordinaria della pigrizia o dell’impotenza) che ha anche la sua utilità, poiché tutti quelli che nelle altre scienze osservano un prudente silenzio, parlano da padroni quando si tratta delle questioni metafisiche, e lerisolvono con arditezza perché la loro ignoranza, è bene dirlo, non tronca nemmeno in maniera netta con la scienza degli altri”. Noi non siamo così sicuri che tutto ciò che si concepisce s’annunci chiaramente. Al contrario, sappiamo bene che l’oscurità dell’espressione non è per forza sintomo d’un turbamento del pensiero. Il rischio pedagogico, se esiste, non è separabile qui dall’esigenza filosofica. Perché rifiuteremmo di esaminare, come professori, le ragioni dell’ermetismo? Si può affermare del resto che siano diverse, e che una ripugnanza per l’oscurità non assicura che un’unità finta a dei linguaggi molto differenti soprattutto di certi autori tedeschi che, dall’inizio del secolo XIX, affascinano stranamente gli eredi di Boileau. Non sempre nella stessa notte tutte le vacche sono nere”! La storia letteraria dell’Italia e della Francia, può qui guidarci fornendoci l’esempio d’un ermetismo che nessuno oserebbe prendere per vana affettazione, come facevano ancora i manuali di letteratura una trentina d’anni fa. Infine, riconosciuto nel suo proprio significato, l’ermetismo concertato d’un Mallarmé (“dare un senso più puro alle parole della tribù”) ci ha condotto a rileggere di nuovo i poeti difficili del pre-classicismo chiamati a volte “metafisici”, come se giustamente la metafisica fosse legata alla difficoltà dell’espressione. Per restare nel campo francese, non è necessario attendere il XIX secolo perché sia dimenticata la bella chiarezza francese nella più alta poesia. Come non trovare qualcosa di Mallarmé in più di un verso di Maurice Scève, con la stessa densità e la stessa purezza: “E più non vuole il giorno, ma la notte seguire / perché la sua luce è sempre nelle tenebre”. Suggestivi e senza dubbio necessari all’evoluzione del gusto, gli accostamenti di questo genere sono quasi sempre falsi. Infatti questi esempi sono quelli di due ermetismi profondamente differenti. Un critico ha potuto parlare di “geometria appassionata” per caratterizzare i poemi di Scève; un altro mostra che non si serve d’immagini che molto raramente e quando non può esprimere il suo pensiero altrimenti. L’oscurità viene dalla sottigliezza del ragionamento che incide sull’emozione poetica sempre più esaltante, tutto al contrario di un’arte mallarmiana 93 che è evocazione, allusione, suggestione, che si rifiuta di chiudere la realtà e “che non ha da fare nient’altro della musicalità del tutto”. L’onda era chiara così come il più bel giorno: l’esempio di La Fontaine basta a mostrare che la poesia più pura può essere chiara. Ma, ancora una volta, sappiamo apprezzare lo stile facile e musicale di Ronsard senza opporlo forzatamente a Scève che doveva “scrivere male”. Non cerchiamo l’analogia della filosofia e della poesia, poiché si potrebbe giustamente affermare, leggendo Kant, che tutta la filosofia è prosaica. Ma forse sospetteremmo che in quella prosa non conviene opporre ai filosofi che “scrivono bene”, quelli che non hanno l’amabile talento di mettersi alla portata di tutti. Ritorniamo ai modelli dell’oscurità germanica. Un recente commentatore di Kant riprende molto naturalmente i rimproveri dei primi lettori francesi: il suo stile spesso imbarazzato in cui l’affermazione principale è continuamente corretta da interminabili precisioni o restrizioni che danno alla frase una pesantezza irritante, l’estrema astrazione dei suoi propositi che raramente, nelle opere magistrali, sono spesso serviti al suo pensiero e costituito per alcuni un ostacolo quasi insormontabile. Niente che possa trattenere il lettore pressato o amico del bel linguaggio; che sono motivi di scoraggiamento per colui che vuole semplicemente comprendere! La storia stessa che Kant è sembrato difficile anche ai suoi contemporanei in Germania (ad Herder, per esempio) e che la lingua nazionale non è dunque la causa principale. Che Kant utilizzi fino all’abuso, trascinato dalle false simmetrie, tutta una terminologia che in parte ha creato, non si spiega solo con la sua formazione di professore d’università tedesca ma con una marcia propriamente filosofica. Nella Metodologia della Ragion pura gli sembra che la conoscenza filosofica non può avere il rigore della conoscenza matematica. La solidità dei matematici poggia su delle definizioni, su degli assiomi e sulle dimostrazioni. Io mi accontenterò di mostrare che nessuno di questi elementi può essere fornito dalla filosofia nel senso in cui lo assume il matematico; che il geometra seguendo il suo metodo non costruisce nella filosofia che castelli di carta; che i filosofi seguendo il suo metodo nel campo matematico non potrebbero far nascere che dello sproloquio. Si trova così condannata l’impresa spinozista d’una dimostrazione dell’Etica more geometrico. Come negare che sia precisamente quella volontà di “chiarezza” che contribuisce alla difficoltà di leggere Spinoza? D’altronde i commentatori dell’Etica si guardano bene dal seguire il loro auto94 re in questa via e dal cercare di rendere le loro considerazioni più accessibili secondo il modo dei geometri! Secondo Bergson, “si potrebbe scrivere un libro sui vari sensi, a volte appena compatibili tra quelli che Spinoza dà ad essenza ed esistenza”. Bergson prosegue riprendendo la distinzione kantiana ma la sviluppa tutto diversamente: Si dirà che sarebbe stato preferibile sostituire ciascuno di questi termini con un certo numero d’altri? Sarebbe impossibile, perché là dove c’è la parola, si tratta bene in fondo della medesima cosa. Se questa cosa non si può fermare in una formula come una curva costruita dal nostro spirito e definita da un’equazione, se il pensatore ha dovuto girare intorno ad essa e attaccarla ad un gran numero di punti, approfondendola volta a volta nelle varie direzioni e senza arrivare necessariamente ad un centro, è danno per una logica troppo semplice, ma non per un pensiero che vuole diventare più elastico, allargarsi, modellarsi sulla realtà. Beninteso, questa volontà di allargamento del vocabolario che segue il pensiero non sarà affatto kantiana! Kant aveva affermato: “Se dunque non si potesse nulla intraprendere con un concetto prima di averlo definito, si sarebbe appena in tempo a filosofare”. Ma, lungi dal cercare di rompere il rigore del concetto, egli vuole al contrario dargli sempre maggiore stabilità. “Si possono anche usare molto utilmente delle definizioni incomplete, cioè delle proposizioni che non sono ancora definizioni, ma che sono vere per il resto e di conseguenza ne sono delle approssimazioni”. Se il filosofo deve rinunciare alla chiarezza e alla distinzione cartesiane, l’inevitabile approssimazione è da ridurre quanto più è possibile. È allora che interviene il vocabolario specialistico, i cui differenti modi sono distinti e apprezzati da Kant secondo una progressione rimarchevole e che nessun principio pedagogico ci permette di trascurare. Se mostra qualche riserva per i neologismi, non si preoccupa affatto del senso originale delle parole: Forgiare delle parole nuove è una pretesa di legiferare nelle lingue che riesce raramente. Prima di arrivare a questo mezzo dubbio, è più saggio cercare in una lingua morta e scientifica se non si trovasse più il concetto in questione con l’espressione che gli conviene e, nel caso in cui l’antico uso di questa espressione sarebbe divenuto dal seguito della negligenza dei suoi autori, vale ancor meglio consolidare in essa un significato che gli era proprio (si deve lasciare dubbia la questione di sapere se la si intendeva allora esattamente nello stesso senso), piuttosto che perdere tutto per il solo fatto che non renda inintelligibile. 95 Difficile intelligibilità che non saprebbe bastare lingua di tutti, nella quale è troppo difficile consolidare le significazioni. Occorre dunque preferire la lingua morta alla lingua viva, la lingua scientifica alla lingua popolare, e infine prendere il rischio dell’arbitrario piuttosto di quello dell’equivoco. A tutto questo Hegel s’opporrà punto per punto. Nessun bisogno di ricorrere alle lingue morte o scientifiche: “Appartiene alla più alta cultura d’un popolo dire tutto nella propria lingua”. Non solo le parole della lingua tedesca in uso bastano a esprimere tutta la filosofia, ma esse sono capaci di rendere un pensiero speculativo, cioè essa stessa concreta e viva. Hegel sembra così abbandonare il lungo sforzo razionalista per superare gli equivoci della terminologia, sforzo che giustificava un’astrazione spinta al fine di “arrestare” le nozioni. Ma, se questo rigore dell’intelletto trae la vita del pensiero e della cosa stessa, è necessario opporgli una precisione più alta che ne rispetti il movimento, e permetta al pensiero, come scriverà Bergson di “diventare più elastico, di allargarsi e di modellarsi sulla realtà”. Alla rigidità mortale d’una lingua impoverita e che non conviene che ad un formalismo becero e vuoto, Hegel oppone la pienezza d’una lingua ricca della sua storia e le cui risorse restituiscono lo sviluppo dello spirito escludendo l’immobilismo del concetto. Ora Hegel crede di trovare nella lingua tedesca dei vantaggi di cui sono sprovviste le altre lingue moderne. Superiorità del tedesco, lingua del divenire e dell’universale concreto, sul francese, lingua dell’essere e dell’universale astratto? In Hegel, nella ripresa d’un tema romantico, è della ragione che si tratta e della dialettica. Ciò che all’epoca dell’illuminismo l’intelletto aveva misconosciuto, la ragione non mancherà di scoprire nella lingua tedesca: Molte di queste parole possiedono in più questa particolarità di avere non solo molteplici significati ma anche dei significati opposti in maniera tale che in questo fatto non si può non riconoscere lo spirito speculativo della lingua stessa; e il pensatore può avere la gioia di cadere su tali parole e di trovarvi realizzata in forma originale dal vocabolario, in tanto che termini aventi significati opposti, l’unità dei contrari, questo risultato della speculazione, che tuttavia appare all’intelletto come un controsenso. Replica, si dirà, a Kant, preoccupato di preservare l’unica accezione ricevibile di ogni scivolamento, da ogni contaminazione, e preoccupato di aggiustare esattamente l’espressione al concetto al fine di evitare che non si perda con essa il pensiero che solo avrebbe potuto conservare. AI contrario, Hegel vuoi restituire una fluidità che permetta di cogliere il reale in maniera sempre più adeguata. Nel famoso esempio della parola aufheben, così miseramente tradotto con “superamento”, egli scopre all’inizio il sen96 so proprio di levare ed il senso figurato di abolire: ma egli incontra anche a partire dalla particella auf il senso di conservare. Beninteso l’uso corrente tiene questi significati separati e li distingue secondo il contesto, a meno che un gioco verbale sia ricercato. È giustamente, perché vuole utilizzare tutte le possibilità speculative della lingua, che Hegel ricorre al gioco di parole e all’etimologia popolare. L’accusa di verbalismo non è mancata, e queste triturazioni del linguaggio corrente, per lo più intraducibili, sembrerebbero scoraggianti ancor più della tecnicità del lessico kantiano. Occorre condannare l’arbitrarietà di queste ciarlatanerie verbali che spesso non hanno giustificazione né storica né filologica? Ma Hegel non intende qui fare un lavoro di linguista né restituire una condizione originaria della lingua. Senza la nostalgia romantica della purezza primitiva, la lingua della filosofia è quella di un popolo la cui cultura ha finalmente reso possibile il sapere assoluto. Se la saggezza s’incarna in una lingua, non è la rivelazione prima, ma il risultato d’una storia in cui si compie il lavoro della ragione. L’accostamento sarebbe dunque ingannevole con lo sforzo del poeta per restituire alle parole un potere magico perduto. “La filosofia deve fare al presente, al reale, i momenti che lo spirito sembra aver dietro di sé, egli le ha ugualmente nella sua profondità presente”. Importa poco che l’etimologia sia senza valore scientifico se permette di rompere le abitudini dell’intelletto astratto e di liberare il pensiero speculativo già incluso nella lingua d’un popolo che è portatore del senso della storia. Il progetto filosofico resta il fare apparire, diversamente che nelle generalizzazioni d’una formalizzazione, l’identità del reale e del razionale; allora la lingua della filosofia “non è più la lingua estranea a sé e di conseguenza contingente e non universale”. Indubbiamente lo spirito s’incarna necessariamente in una certa lingua che ha una opacità dovuta alla sua storia, ma l’oscurità dell’espressione non viene dal fatto che egli abbia rinunciato all’intelligibilità, allorché egli sforza al contrario di trarre da questa lingua di che attingere ad una razionalità più ampia del discorso filosofico, tale che non lasci più nulla sfuggire dal reale. Koyré conclude il suo articolo sulla terminologia hegeliana notando: “Il migliore commento di Hegel resta, fino a nuovo ordine, un dizionario storico del tedesco”. Sarebbe dunque così soltanto che noi giungeremmo a comprendere a far comprendere come il concetto restituito al suo movimento dialettico rende presente il passato, come il sistema si costituisce in una storia e nella particolarità d’una lingua? Ancora, e testimonianza stessa di Koyré, non vi troverebbe spesso che la prova degli errori filologici di Hegel. Se gli allievi debbono sapere qualcosa del pensiero hegeliano, occorre bene usare delle traduzioni sapendo bene che l’intelligibilità del testo è legata alle virtù tipiche d’una lingua nazionale. Non tuttavia che l’allusione poetica o la risonanza effettiva impediscano qui la trasposizione: l’ostacolo non è quello che è invocato 97 spesso in letteratura, ma sono le risorse dialettiche, cioè le positivamente razionali della lingua tedesca che saranno restituite molto difficilmente. In quel modo il traduttore eviterebbe la tentazione della squisitezza indefinita delle equivalenze da una lingua all’altra. Il professore non ha altra scelta che rassegnarsi a un’insufficienza essenziale alla quale non rimedia un surplus d’astrazione, o anche di voltarsi da quel pensiero traendo gloria da un’esigenza salutare di chiarezza che è quella della propria lingua. Infatti, non è dimostrato che il francese sia meno sprovvisto d’ambiguità, felici o infelici, del tedesco né che un dizionario storico del francese offrirebbe meno risorse. Se si trova che i filosofi francesi ne hanno meno usato fino ai nostri giorni, un contemporaneo di Hegel, Auguste Comte, in una nota del tomo IV del Cours de philosophie positive, proponeva “un lavoro interamente nuovo sulla filosofia del linguaggio” che poggerebbe sulla composizione d’una “sorta di dizionario degli equivoci”. L’esempio dato è quello del doppio senso della parola “necessario” (a volte indispensabile a volte inevitabile), ma anche di ciò che Comte chiama “gli equivoci meravigliosi” nelle parole come “giusto, ordine, proprietà. umanità, popolo”. Queste parole testimoniano una educazione progressiva della ragione umana da cui la filosofia deve liberare il senso: “Non occorre credere in effetti che quella confusione apparente possa essere accidentale: si deve vedere sempre il prezioso testimone d’una certa confidenza fondamentale, mirabilmente sentita dalla ragione pubblica tra le due idee così accostate”. Questa coincidenza non risulta da un movimento dialettico, ma non è l’istituzione d’un dizionario che basterà a determinarne il carattere fondamentale, tanto che essa non sarà accostata all’insieme del sistema positivista. Il sistema di politica positiva conferma: “Anche le ambiguità che si attribuiscono sprezzantemente alla penuria popolare sono testimoni di profondi accostamenti, felicemente colti dall’istinto comune, molti secoli prima che la ragione sistematica vi possa attingere”. Perché s’è distaccato da finzioni teologiche, lo scienziato si lascia prendere dalla astrazioni metafisiche e crede di poter disprezzare la saggezza di cui il linguaggio è l’interprete, anche nelle metafore più usuali. Nella stessa opera Comte ritorna più volte sul doppio senso della parola coeur in francese: “ci indica, moralmente, tanto l’affezione che dispone ad agire e tanto la forza che dirige l’azione reale; il motivo metaforico conviene egualmente nei due casi a seconda che si consideri l’intenzione o l’esecuzione”. Se lo spirito positivo non è altro che il buon senso sistematizzato, cioè la “ragione pubblica” presente sin dall’origine, il filosofo non può senza arbitrio sostituire le sue creazioni verbali alla sua “spontaneità popolare” che è contemporaneamente “progressiva e conservatrice”. Ma vi è un uso filosofico della lingua che sviluppa, per esempio, le cinque accezioni della parola positivo (organico, preciso, certo, utile, reale) ne propo98 ne una sesta (relativo) e ne annuncia un settimo (simpatico). Le divagazioni metafisico-teologiche sono anch’esse quelle del linguaggio: esse spiegano l’anarchia attuale nell’espressione dei filosofi e l’abuso dei neologismi in questa fine della rivoluzione occidentale. Ma quando il “moderno regime intellettuale, fin qui parziale ed empirico, passerà comunemente allo stato sistematico”, allora sarà pienamente costituita “l’ultima condensazione del nuovo linguaggio filosofico”. Senza dubbio la filosofia positivistica vuole appoggiarsi su conoscenze propriamente linguistiche e ricostituire scientificamente la storia delle lingue, ma è una lingua popolare, viva, arricchita dalla poesia, che il filosofo incomincia a sistematizzare con delle “modificazioni convenienti”. Comte è forse più attaccato di Hegel alla “vera logica universale così profondamente impressa in ogni lingua comune”. Ma in questa quiete d’intelligibilità del reale dalla saggezza storica della lingua, non ci furono successori in Francia. Era più facile deplorare, senza andare molto lontano, la pesantezza dello stile di Comte. A questo proposito, come in altri casi, non fu ritenuta del positivismo che l’eredità condillachiana. Molto caratteristica è l’accoglienza fatta ai giorni nostri degli scritti di Heidegger: si ritrovano tutte le obiezioni abitualmente poste alla “falsa profondità” germanica. Gli uni vi hanno denunciato il vocabolario politicamente più sospetto della rivoluzione conservatrice, altri vi hanno visto, più innocentemente, le manie filologiche tipiche dei seminari dei professori d’università tedeschi. Ogni riduzione diviene possibile, infatti, a condizione di scartare ciò che è filosoficamente in questione in una parola. Quanto al lavoro di traduzione, esso incontra delle difficoltà analoghe a quelle che avevano posto le posto le opere di Kant o dei post-kantiani; ricordiamo soltanto i diversi tentativi per rendere la nozione centrale di Dasein: dalla “condizione umana”, all’“esser-là”, esse non derivano dalla lessicografia. Nel prologo alla versione francese di Che cos’è metafisica? Heidegger notava: “una traduzione non consiste soltanto a facilitare la comunicazione col mondo d’una altra lingua, ma essa è un deciframento della questione posta in comune”. Tuttavia il commentatore non potrà affatto dispensarsi dal ricorrere ad un dizionario etimologicamente non solo tedesco, ma anche greco, tanto s’afferma, seguendo il romanticismo tedesco, la preminenza delle due lingue filosofiche per eccellenza. Eccoci invitati a risalire dalla ratio latina, al logos greco, ed a comprendere questo logos nella sua prima accezione di raccoglimento. Così la verità si chiarisce di dirsi aletheia con una parola greca in cui l’a privativo annuncia non più un’adeguazione, ma una scoperta. Dal verum all’aletheia, l’attenzione prestata alle parole ci accosta alle ricchezze dimenticate dell’origine. “Di buon’ora e in modo che regge tutto il dominio del non-nascosto, il legein originale, lo stendersi, si dispiega come dire e discorrere”. La quiete del senso va dunque qui tutto all’inverso d’un irresisti99 bile arricchimento dialettico nel progresso d’una storia. Già in Essere e tempo, il compito assegnato al filosofo era di restituire alle parole un’energia prima che la storia del concetto avesse cessato di indebolirla. Non si tratta dunque da lasciarsi sedurre dal pittoresco dei cominciamenti, né di domandar loro qualche nuova suggestione eccitante per lo spirito; l’intenzione non è filologica né archeologica e, nello stesso passaggio, Heidegger mette in guardia contro “una mistica sfrenata delle parole”, quella stessa che gli sarà spesso rimproverata, Egli dovrà difendersene di nuovo nella conferenza su La Cosa: “Si chiarisce il sospetto che il nostro sforzo per arrivare ad un’esperienza dell’essere della cosa potrebbe non essere fondato sull’arbitrarietà d’un gioco etimologico. L’opinione si conferma, essa si espande già dovunque che in luogo di considerare i rapporti essenziali, noi apriamo molto semplicemente il dizionario”. Se fosse così, l’insegnamento filosofico, ridotto a commento, anche sottile, della positività linguistica, perderebbe di vista la “vera questione”, di cui Heidegger parlava ancora alla fine della sua vita ed era “quella del rapporto tra di esse della tecnica, della lingua, della poesia e del pensiero”. Lasciamo i dizionari al loro posto, che non è un luogo filosofico. Non c’è filosofia filologica, neanche negli autori che sono stati spesso accusati da lasciarsi trascinare dalle oscure suggestioni delle parole. L’ascolto della lingua può piacere diversamente, ma la chiarificazione propriamente filosofica è sempre prima e ultima. In Hegel, in Heidegger o anche in Comte, l’alternativa non è più quella d’un linguaggio tecnico e d’un linguaggio comune. A meno di respingere questi autori fuori della cultura filosofica dell’Occidente, non possiamo attenerci ad un ideale della lingua ben fatta, del resto più condillachiana che cartesiana. Tuttavia non siamo più rinviati ad una confusione di linguaggio filosofico, letterario o poetico, in nome di un irrazionalismo a cui nessuno di questi autori si richiama. Ciò che appare è la necessità dell’elaborazione filosofica d’una lingua storica. L’insegnamento potrebbe esserne dispensato quando la lingua corrente diviene sempre più artificiale, meno che mai “popolare”. Non è nelle parole dell’opinione, dall’uso che l’opinione ne fa, che noi sfuggiremo al regno dell’opinione. Nel nostro tempo, non c’è filosofia, come non c’è poesia. per il solo fatto che “giunge a dare un senso più alle parole che alla tribu”; compito che non è quello del linguista o del lessicografo, ma, a seconda dei casi, del poeta o del filosofo. La poesia di Victor Hugo non s’impara se non nel Dizionario di Moreri. La lingua di Mallarmé è inseparabile dai suoi Versi e Prose. Certo, nessuno oggi si propone più di accedere alla poesia con l’apprendimento d’un vocabolario poetico e di regole della versificazione; non che un tale sapere fosse trascurabile nell’apprezzamento d’un poema, ma nessuno si crederà divenuto poeta perché parla di “destrieri” e dell’“onda amara”. Fin dove possiamo spingere l’analogia con 100 la lingua del filosofo la cui esigenza del rigore potrebbe ben essere altrimenti? Il fragore dell’equivoco meraviglioso in un dire poetico non è della stessa luce del paziente chiaramente della discorsività filosofica. Nessuno è tenuto ad essere hegeliano, ma occorre riconoscere che una certa tradizione francese di chiarezza mostra soprattutto la sua inconsistenza filosofica quando non oppone alla fatica del concetto nient’altro che la facilità d’una retorica neo-classica ancora sensibile, nel ben-dire accademico, ahimè, d’un Bergson. E non è né per qualche trascinamento mistico né per qualche predisposizione nazionale o individuale che si spiega il “tono” d’un Hegel o d’un Kant; le loro diverse oscurità non sono della mancanze alle quali sarebbe di rimedio un saper-dire capace di trasporre tutto ciò che merita di esserlo per renderlo accessibile a tutti. Si può insegnare a filosofare senza apprendere a leggere i filosofi e anche, fino a un certo punto, quelli che sono ritenuti oscuri? La sola lettura diretta d’opere o di testi permette di cogliere l’essenziale che si trova lungo il cammino dell’autore, il movimento del suo pensiero, e non in un catalogo di tesi. Tale epistemologo confuta brillantemente il “platonismo” in matematica e si meraviglia della semplice nota che Platone non ha mai scritto di simile. Perché la formazione dello spirito non si confonde con la trasmissione di conoscenze dottrinali, il ricorso al riassunto è già stato giustamente condannato, o almeno ridotto ad un ruolo subordinato nella iniziazione alla lettura delle opere filosofiche originali. Dopo un quarto di secolo almeno, l’insegnamento filosofico nei licei è orientato in questo senso, malgrado il carattere necessariamente frammentario dei testi studiati, malgrado anche i malintesi che vengono da una confusione tra il testo filosofico e il documento storico. Allora il ruolo del professore di filosofia è guidare gli alunni in questa lettura. Egli stesso sceglierà le opere che convengono a ciascuno, insegnerà le diverse forme di lettura: la lettura libera, corsiva, destinata a familiarizzare lo spirito col pensiero ed il linguaggio filosofico; la lettura con consegna, cioè accompagnata da questioni; la comprensione minuziosa, dettagliata, esaustiva d’un testo. Strettamente parlando, l’esigenza di ricorrere al testo originale dovrebbe condurre al rifiuto della traduzione: i nostri alunni possono leggere Platone in greco, Spinoza in latino, Kant in tedesco? Questa obiezione sarebbe un altro modo di confondere filosofia e filologia, e di fare predominare l’informazione storica. Nessuno si sogna di limitare la lettura ai soli filosofi di lingua francese. Ancora il francese di Montaigne o di Descartes rappresenta una lingua straniera per molti liceali. Tuttavia non è negabile che un’incerta traduzione è spesso alla base di un problema filosofico. Al professore spetta giudicarlo e, se lo crede utile, mostrarlo ai suoi alunni. Potrebbe scartare ogni strumento filologico? Occorre supporre che vi perverrà qualche talento espositivo, ed anche la cultura anteriormente acquisita dagli alunni. Nel 1924 le lingue filosofiche doveva101 no essere ridotte, per quanto possibile, alla lingua comune. Tutta l’arte d’insegnare sembrava essere quella di stabilire la continuità da questa a quelle. Ora, oltre ottanta anni dopo, la rottura della lingua filosofica in rapporto alla lingua corrente, lungi dall’essere evitata, è divenuta un risultato pedagogico metodicamente ricercato. “Iniziare le giovani generazioni alla filosofia, è il fare entrare in una sala in cui il linguaggio è già costituito, in cui c’è stato già Platone, e Descartes, e Kant” sostiene Ricoeur, e Dreyfus commenta: “Attraverso questo linguaggio, gli alunni indovinano già che debbono rompere con le proprie abitudini per apprendere la lingua delle idee. Questa rottura comincia dall’epurazione della lingua comune stessa, al fine di condurla al suo rigore più grande, e si prosegue con l’apprendimento d’un vocabolario propriamente tecnico”. Precisiamo che non può trattarsi che di una pluralità di vocabolari filosofici, perché è ricordato con insistenza che i termini hanno ogni volta il loro senso in determinato contesto. Aggiungiamo che, per Dreyfus, imparare un vocabolario non è ancora filosofare. Sarebbe vano “cercare di sostituire la tecnica all’intelligenza, o attribuire al linguaggio le difficoltà della stessa filosofia”. Alcuni nostri colleghi avrebbero e vorrebbero altre arditezze e non vorranno restare a metà cammino. Essi sosterranno in principio che insegnare la filosofia è inizialmente o anche essenzialmente insegnare la lingua filosofica. “L’iniziazione filosofica si darà come compito primordiale di manifestare le esigenze semantiche per se stesse, le logiche, le retoriche del pensiero filosofico”. Così, da un insegnamento che non si preoccupava quasi dei testi che a titolo di illustrazione o di riferimento storico, noi siamo passati a un insegnamento che domanda loro un indispensabile modello della riflessione, e presto forse ne saremo ad un insegnamento che ha per oggetto gli stessi testi. Su questo partito preso delle parole, tutta una nuova istituzione dovrebbe essere fondata. La progressione dell’insegnamento sarebbe quella dell’acquisizione della lingua filosofica, quella della scuola, la lingua scolastica della fine del XX secolo. Ma essa non basta per assegnare all’insegnamento l’acquisizione della lingua delle idee, perché qualcosa di simile esista, e che la sua unità possa essere definita. Ricorda Ricoeur: “Il linguaggio filosofico, a differenza del linguaggio scientifico, ha una storia, è preso in una tradizione”. Occorre domandarsi ancora se anche questo carattere storico permette di mantenere al singolare una tradizione. Lungi dal risolvere la difficoltà, il ricorso ai testi fa apparire la straordinaria diversità delle lingue filosofiche e non è indubbiamente possibile invocare la tradizione filosofica senza chiedere aiuto ad Hegel. “Filosofare è inserirsi in un dato momento del discorso filosofico, d’un discorso i cui significati maggiori sono già stati costituiti”. Ma continuare quale discorso o quali discorsi? Quello di Hume? Quello di Platone o dei traduttori di Platone? Il professore deve decifrare direttamente ai propri allie102 vi alcuni frammenti del grande Discorso unico che occorre ben pensare acquisito perché possa avere un senso? Allorché i nostri colleghi di lettere non s’accordano quasi sulla lingua che insegnano quando insegnano il francese, su quali considerazioni pedagogiche potremmo pretendere di determinare la lingua filosofica necessaria ai liceali? Ogni argomentazione socio-psicologica è qui fuori causa. Ciò che potrebbe mancare agli allievi e rendere loro meno difficile il filosofare non è una lingua filosofica definita in anticipo, ma una cultura in qualche modo poco coerente, cioè l’uso corrente d’una lingua senza qualificazione filosofica, ma sufficientemente ricca, il che non è indubbiamente accessibile alla maggior parte dei liceali. Che la miglior parte dell’insegnamento filosofico sia stata confinata da una ventina d’anni nelle sezioni dette “Lettere e Filosofia” ha finito per sviluppare delle abitudini d’espressione e anche di pensiero che non sono affatto delle esigenze tipiche della nostra disciplina. Indubbiamente il professore di filosofia è in diritto di informarsi delle capacità di lettura e di scrittura degli alunni che entrano nella propria classe. Ma egli si guarderà bene dall’identificarli in una tradizione soltanto “letteraria”, d’altronde ora troppo scossa e che non saprebbe voler mantenere per un suo esclusivo uso. Se questi insegnamenti hanno una qualche solidità, la lingua della storia, o quella della fisica saranno quelle che l’insegnamento filosofico potrà riprendere, poiché non suppone nient’altro che la padronanza di una lingua colta, cioè ammorbidita ed estesa, fuori da ogni purismo come da ogni linguaggio specializzato. A questo riguardo, l’ingiunzione della chiarezza partecipa della stessa pretesa di fissare una lingua filosofica necessaria e sufficiente da cui sarebbe esclusa ogni tecnicità. Come se tutto non fosse buono per il filosofo, le parole del poeta, quelle dello scienziato, quelle del tecnico, o dello scaricatore di porto! Qual è il vocabolario dei dialoghi di Platone? Hegel ricorda che l’origine dei termini non ha importanza. Senza dubbio vi sarà una lingua filosofica hegeliana, ma non sarà stata anteriore alla costituzione del sistema ed essa non è la specie d’un genere che sarebbe “la lingua delle idee”. Qui ancora l’illusione viene dalla pratica scientifica. Si può affermare che esiste una lingua matematica sufficientemente determinata per essere insegnata. Ma non è possibile apprendere la lingua di Malebranche, di Kant o di Heidegger, e non quella della filosofia. Se la non si riduce a una semplice ripetizione epigonale, essa non potrà farsi precedere dalla sua propria lingua specializzata. La ricerca scientifica e tecnica contemporanea fa proliferare i linguaggi specializzati. Diabolicamente, ogni tentativo per porvi rimedio (interdisciplinarietà, ecc.) aumenta la confusione babelica suscitando nuove discipline “trasversali”. Chi non ha constatato che le teorie della comunicazione erano lungi dall’essere le più comunicabili? Non c’è più tempo d’opporre le difficoltà del lessico specializzato alla semplicità ammessa del103 la lingua comune. Assistiamo già, sotto il dominio della tecnica, alla distruzione metodica di questa lingua comune. Scienze e tecniche non hanno a che fare delle sfumature della sintassi o delle suggestioni dell’equivoco. D’altronde l’uso economico di macchine calcolatrici incoraggia, se non impone, un “linguaggio codificatore e sommario” e che “accumula facilità ed efficacia a carico d’una perdita di contenuto più sensibile agli intellettuali che ai gestori”. Queste caratterizzazioni non denotano la nostalgia di un’era preindustriale: ciò che la filosofia mette in causa nella tecnica non è la messa in opera di nuovi mezzi materiali; ed è ancora meno la razionalità che li ha resi possibili senza tuttavia sposare gli effetti. La filosofia deve trovare le parole per spiegare la confisca della ragione e le generalizzazione cieca d’un modello di dominio. Ora la lingua, divenuta subito comune, dei media associa l’impronta disordinata ai linguaggi tecnici e l’impoverimento sistematico della lingua quotidiana. Se il solo obiettivo è di trattenere l’attenzione (e non di farsi comprendere) simultaneamente da milioni di telespettatori, occorre in effetti rompere le resistenze naturali d’una lingua rimasta troppo classica anche nell’uso più corrente; occorre tendere ad un’espressione costantemente abbreviata e che fa posto all’onomatopea o al segnale pavloviano. Già la lingua parlata quotidianamente è divenuta troppo estesa, molto dislocata per non giocar che maldestramente il suo ruolo di lingua comune suscettibile d’essere colta. Presto, se non si sta attenti, essa non sarà più che un linguaggio “basico” limitato alle relazioni elementari secondo il calcolo tecnico. Fin d’ora, è dubbioso che una reale discussione filosofica possa essere tenuta in linguaggio abituale dei media. Il trionfo quasi assoluto della tecnica si nota dal fatto che, ai giorni nostri, vi è più che il filosofo per mettere in dubbio che la ragione non sia mai che calcolatrice. Nel vocabolario giornalistico, razionale non vuol più dire redditizio o efficace (gestione razionale, campagna elettorale razionale). Evidente si usa per utile o anche facile. Ragionevole rinvia a un compromesso più o meno proficuo. Occorre indubbiamente vedervi più che la penetrazione della lingua ad opera dello spirito tecnico un accumulo fortuito di colpe. Così le parole impongono l’idea che sfuggire alle coercizioni tecniche non può essere che fuggire nell’irrazionale e nel fantastico. Si capisce che per un economista la razionalità di un comportamento si definisce dal suo carattere utilitario? Esempio essenziale: il linguaggio delle scienze umane è tale che esso proibisce di comprendere che cosa sia la razionalità dell’imperativo categorico, ancor meno di poterne discutere. In questo caso un compromesso non è più possibile: il filosofo non può accettare tali usi linguistici senza rinunciare non solo all’enunciato delle dottrine, ma alla stessa posizione dei problemi. Egli dovrà dunque mantenere il suo vocabolario, quello di Kant. Il costume di chiamare “tecnici” i termini particolari di un autore introduce una pericolosa ambiguità, come se la lingua che era la sua fosse rilevata nella sua originalità 104 d’una concezione tecnica, e che essa non si fosse sforzata al contrario di sfuggirvi e di pensare non tecnicamente la tecnica, questo che è il compito più urgente del filosofo d’oggi. Per riprendere un esempio frequente della pretesa tecnicità, la nozione di trascendentale contribuisce a chiarire l’oggettività tecnico-scientifica, ma essa non apporta nulla all’efficacia tecnica alla quale si sottomette ai nostri giorni la lingua la più scorrevole. Il problema del linguaggio dell’insegnamento filosofico si pone in termini ora sovvertiti. La produzione filosofica contemporanea, fino alle sue aberrazioni, verifica questo paradosso che il professore parlerà tanto meno “come tutti” che eviterà, giustamente, d’usare una lingua tecnica. In queste condizioni il dibattito tradizionale sulla chiarezza dell’espressione filosofica diviene quasi risibile. Solo la scuola può preservare e sviluppare una lingua colta di cui ha bisogno il professore di filosofia, ammesso che questa scuola non si lasci deviare dalla sua missione per farsi una sorta d’annesso del giornalismo. Se l’insegnamento delle lettere o dell’italiano importa tanto, non è che egli debba preparare l’insegnamento filosofico, ma soltanto non renderlo impossibile. Il professore di filosofia c’è per mantenere aperto l’accesso al pensiero speculativo in tutto il suo rigore ma anche nella sua diversità; egli usa davanti ai suoi alunni, e con essi, tutti i mezzi d’espressione che giudica necessari, senza purismo, senza arroganza. ma senza compiacenza per una volgarità spesso in se stessa affettata. Se troppi candidati alla laurea credono di essere facilmente riconosciuti filosofi dicendo “fenomenologia” in luogo di “descrizione”, non ne risulta che il tono fenomenologico debba essere bandito dall’insegnamento: l’essenziale è di fare apparire la necessità del linguaggio usato. Tutta l’arte del professore è di verificare che l’alunno non confonda la luminosità dell’espressione con l’esigenza del pensiero, e che egli non si creda divenuto filosofo perché si serve delle parole del filosofo. Ma a questa arte nessuna scienza pedagogica darà le regole, a meno che essa non pretende di farsi giudice di ogni pensiero. Il verbalismo non è dovuto all’eccesso di parole, ma all’insufficienza del pensiero. Così tutti i giudizi perentori portati all’esterno dell’insegnamento filosofico sul linguaggio sono irricevibili, anche se cercano di autorizzarsi dall’esterno dell’interdisciplinarità. Né può essere ritenuto proficuo il progetto di un insegnamento pre-filosofico che pretenderebbe di “sensibilizzare” in anticipo i liceali al discorso filosofico. L’idea stessa, esaminandola bene, è indubbiamente contraddittoria: nulla di pre-filosofico può essere insegnato come tale senza costituirsi come ostacolo alla filosofia. Voler familiarizzare il liceale con una terminologia prima che il movimento del pensiero venga ad abitarlo non è scartare il pericolo del verbalismo, ma al contrario è predisporlo. Nessuna anticamera, neanche linguistica! Occorre entrare in filosofia. Il lavoro sulle parole non è primo, ancor meno è sufficiente. Stiamo attenti a non capovolgere la formula bergsoniana: “Essi s’erano creduti davanti a parole stranie105 re perché erano rimasti stranieri di fronte al pensiero”. A questo punto mi preme mettere in chiaro che la didattica della filosofia non può essere sostituita né da un puro esercizio del pensiero logico-formale né da un’iniziazione a quelle che oggi si definiscono scienze umane, per quanto il loro insegnamento sia legittimo. Pertanto la filosofia, malgrado le profonde affinità con le scienze umane, deve restare una disciplina distinta. Le scienze umane sono scienze quanto al metodo non all’oggetto particolare, e non lo sono in quanto credenze storicamente condizionate. Esse presuppongono il rapporto vissuto col mondo, se ne nutrono e vi si fondano. Questo senso vissuto dell’esperienza quotidiana sottintende tutti i processi critici della scienza. “Noi non possiamo riferire – diceva Merleau-Ponty – la nostra esperienza dei rapporti sociali veri se non per analogia o contrasto con quelli che abbiamo vissuto. Se, dunque, le due problematiche delle scienze umane e della filosofia sono implicate l’una nell’altra e sono convergenti, esse sono nello stesso tempo anche differenti, per cui differente dovrà essere il loro insegnamento e l’oggetto del loro insegnamento. Per quanto concerne la logica ed il pensiero formali, il limite filosofico è evidente: in effetti è formale un pensiero che non è modificato in quanto forma cosciente del suo passaggio attraverso lo scambio verbale e per il quale il carattere significante risulta astrattamente da convenzioni originarie della struttura espressiva”. Come un sistema formale non contraddittorio non contiene alcuna proposizione che potrebbe mettere in causa una conseguenza degli assiomi di significazione del sistema, così non si potrà mai ottenere in questo caso una espressione formale significante al secondo grado. L’insegnamento filosofico, e ancor più specificamente la lezione di filosofia, non potrà mai provare ad essere una dimostrazione formale rigorosa perché è impossibile provare la non-contraddittorietà del proprio linguaggio d’esposizione. Il linguaggio della lezione di filosofia è il linguaggio ordinario ripetuto, che si scompone con l’analisi ed espone gli strati di sensi diversi che vi costituiscono la nostra esperienza; il linguaggio della lezione di filosofia comporta, dunque, la coscienza dei propri limiti, della propria inadeguatezza parziale e della sua necessaria e naturale capacità di ricominciare un discorso. La lezione di filosofia è l’atto essenziale d’iniziazione e di comprensione del nostro potere di ritardare e possibilmente impedire l’oblio, l’irriflessione e l’errore. Perché niente dell’esperienza umana si trasmette senza quello sforzo, quella tensione che si chiama filosofia. Il mio dire non vuole essere – e sarebbe veramente riduttivo – una difesa corporativa d’una disciplina come se si trattasse d’un problema di usi e di sbocchi. La mia è una preoccupazione più che una giustificazione, la quale si basa interamente su tutta la storia dell’umanità europea. Se la filosofia è stata, in definitiva, l’educatrice dell’Europa e del mondo, è certo che l’insegnamento filosofico si possa e si debba identificare con lo stesso processo educativo. 106 Per questa ragione, l’insegnamento filosofico non può seguire la sua intenzione formatrice senza trasmettere nello stesso tempo un sapere, anche se non si può stabilire un modello assoluto della lezione di filosofia. E ciò per una ragione molto semplice: la filosofia è la sua propria pedagogia, essa non esiste realmente che nell’atto di insegnare e non è altro, in gran parte, che l’attività di risveglio della coscienza al senso del pensare: tutti i contenuti che una lezione di filosofia può avere da trasmettere – come la presa di coscienza di teorie, la scoperta e l’analisi di testi, l’utilizzazione di documenti – hanno senso solo in quanto obbedienti ad un disegno unitario: la scoperta da parte degli allievi, attraverso l’esempio del loro docente e con il suo aiuto, della necessità imperativa, per tutta l’esistenza umana, di imparare a pensare e a riflettere. Così, anche in seguito a polemiche e dibattiti, mi pare opportuna la domanda: è legittima la lezione di filosofia? Per quale ragione? Da più parti è venuto il suggerimento di sostituire la lezione con diversi esercizi; ora che gli esercizi intesi come spiegazione di testi, esposizioni, documentazione ecc., siano un buona cosa è un fatto scontato, ma ciò non implica che dall’eccellenza di una cosa si possa inferire che un’altra cosa non abbia diritto all’esistenza. È evidente, infatti, che la lezione di filosofia, come studio diretto di un problema da parte di allievi e docenti e non come mera trasmissione unilaterale di un sapere precostituito di una ideologia, va accolta e difesa. In altre parole, con l’espressione “lezione di filosofia” è possibile indicare un contenuto determinato – per ricordare ancora una volta Hegel – che designi un atto d’insegnamento essenziale senza il quale il concetto stesso di filosofia non avrebbe senso. Pertanto, non credo che una forma istituzionale unica né una pedagogia universale né un contenuto assolutamente predeterminato siano legati per l’eternità all’atto d’insegnare la filosofia, ma sappiamo tutti che un minimum di razionalità oggettiva è necessario perché il nostro insegnamento non degeneri in un’inutile chiacchiera culturale. Dicendo ciò so bene di dare un modello alquanto stretto, non tanto della lezione stessa, quanto dell’attività intellettuale che essa presuppone. Detto esplicitamente: noi ci diamo un modello necessariamente analitico della lezione di filosofia e del pensiero filosofico in generale. Con ciò si intende che il nostro compito essenziale è di prendere delle nozioni, che né noi né i nostri colleghi né i nostri allievi hanno inventato – la nozione di inconscio, le nozioni di dovere, di spazio, di tempo ecc. – onde analizzarle, mostrando la loro articolazione interna, i loro requisiti, le loro conseguenze, il loro legame con nozioni subordinate, esplorando, in una parola, il campo di significazione che li avvolge. Ma questo campo esiste in sé in maniera universale ed univoca? Certo che no! Ed è bene, perché noi non siamo soli al mondo per cui il disaccordo, il consenso, la variazione di senso, la contraddizione sono il segno della vita cosciente nella comunità umana. Donde la necessità storica e 107 non artificiale della lezione di filosofia: infatti essa ha luogo, avviene in una comunità reale, la classe, formata dagli allievi e dal professore che non pensano tutti esattamente la stessa cosa, che non hanno tutti la stessa abitudine alla dialettica. A questo punto, forse, potrebbe sorgere una falsa antinomia, quella della ricerca e dell’insegnamento su cui si fonda un certo rinnovamento del pensiero. La lezione di filosofia è scolastica o universitaria; i due aggettivi sono resi in senso strettamente negativo in opposizione alla ricerca o al lavoro “personale”, come oggi si dice. A dire il vero, nessuna lezione è concepibile se non risponde contemporaneamente ad un travaglio intellettuale di colui che insegna, al suo lavoro quotidiano di lettura, di riflessione e, diceva Hyppolite, ad una scoperta comune di problemi. D’altra parte, la lezione non procede all’analisi ragionata e dialettica d”una nozione, qui ed ora, con questi allievi, con questo docente, con i loro contenuti culturali e le loro lacune, se non per aggiungere una posizione problematica. I problemi non sono mai nel programma, che rappresenta, se si vuole, l’inerzia minimale senza la quale nessun fondo comune sarebbe chiaro: essi nascono dalla lezione e nella lezione. Infatti la messa a punto d’un programma è un compito inevitabile, ma delicato, che sarebbe imprudente lasciare e delle sollecitazioni fatalmente fluttuanti e contraddittorie. Come sapere, infatti, quali sono i problemi veramente attuali della filosofia senza avere i mezzi d’analisi che risultano precisamente dalla riflessione e dalla cultura? Si tratta di problemi momentaneamente dibattuti in pubblico, come avviene periodicamente nel caso della pena di morte, della condizione della donna, della scuola? D’altra parte, si può lasciar ignorare che in epoche diverse dalla nostra questi problemi sono stati appassionatamente dibattuti? Un problema non può essere detto del mondo contemporaneo se non a conclusione d’una ricerca destinata a cogliere delle implicazioni e a rendere sensibili certe differenze. Sviluppo e sottosviluppo, ecologia, controllo delle nascite ecc. possono sì portare a problemi filosofici, ma non è d’altronde possibile porli senza la padronanza conferita dall’esame sistematico di concetti o problemi che hanno un posto ben preciso nel programma dell’insegnamento filosofico, la cui utilità e attualità sarebbero certamente minime se ci si contentasse di riprodurre semplicemente dei titoli di giornali. E soprattutto la novità in filosofia non coincide sempre con le preoccupazioni più vive avvertite in un certo contesto dal “pubblico”. La novità non è mai senza relazione con gli interessi teorici e pratici del presente; ma perché una idea o un problema siano accettati come filosoficamente nuovi, il pensiero ha bisogno di punti di orientamento che possano da soli fornire il lavoro intellettuale e la cultura. A questo punto si potrebbe dire che c’è incompatibilità tra la filosofia intellettuale che dunque non sa in anticipo ciò che troverà e neanche ciò cercherà, e la nozione di programma che indica, per la sua etimologia, ciò che 108 si sarebbe scritto, sottoscritto e giudicato in anticipo sull’ordine e la consistenza delle lezioni. Con inoltre il disappunto che ogni programma, esprimendo le intenzioni e il pensiero di coloro che l’hanno stabilito, predeterminerebbe tramite legami ideologici e sottofondi culturali gli orientamenti possibili della ricerca e dell’insegnamento filosofico. Da qui a dedurne che siamo condannati a trasportare e a ridistribuire i fantasmi culturali di questa o quella classe sociale, il passo è molto breve. Ora questa verità è, a dire il vero, molto limitata per il fatto che, anche senza programma, ciascuno di noi è portatore di idee, di pregiudizi o d’affermazioni implicite. Sottolineiamo qui semplicemente due errori che potrebbero avere gravi conseguenze:anzitutto, la lezione viene diretta a degli allievi, non a noi stessi, e per questi allievi la più conformista e la più modesta delle lezioni sarà, malgrado tutto, sempre nuova; e poi occorre soprattutto sapere ciò che noi vogliamo:se in effetti vogliamo che la filosofia sia insegnata al più gran numero possibile di persone, se noi pensiamo che l’iniziazione filosofica sia necessaria e debba comportare degli atti pubblici d’insegnamento; è allora necessario che sia stabilito un programma che permetta almeno la validità giuridica degli esami e che sia una base di giudizio in caso di controversia. Quindi, per andare un po’ più a fondo delle cose, occorre rilevare che un programma di filosofia non può essere composto che da nozioni assai generali, che non impongono né l’esposizione di una determinata dottrina né la posizione di alcuni problemi invece che di altri. Evidentemente, non si può anticipatamente decidere su tutti i problemi né ancora meno prestabilire il loro ordine. Diciamolo: il più grande pericolo che corre un insegnamento e, più d’ogni altro, l’insegnamento filosofico è l’insignificanza. Infatti, se la lezione è un atto filosofico e non la ripetizione esteriore d’un contenuto culturale predeterminato, sarà ogni volta la costruzione della possibilità del vero. Ciò vuoi dire che per provare che il nostro pensiero è fatto di ragioni e non si appella che alla ragione per essere completo, dobbiamo rendere il nostro uditorio capace di dare ragione o torto ovvero elevarlo al rango di arbitro. In questo senso, l’insegnamento filosofico ha per destino di dover lottare, come dice Hegel, per il riconoscimento. evitando, così, l’asfissia della parola e del pensiero (Kierkegaard) in un’epoca come la nostra, che può deludere una razionalità ingenua e, rivelando attraverso tutte le sue spaccature il fondamentale, esigere una lettura filosofica (Merleau-Ponty). 109 Riferimenti bibliografici I. KANT, Critique de la raison pure, trad. par A. J. L. Delamarre, La Pléiade, Gallimard, Paris 1981 I. KANT, Critica della ragion pura, trad. it. a c. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza, Bari 1965 J. FERRARI, Introduction à Kant, Seghers, Paris 1979 G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, trad. it. a c. di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1963 G. W. F. HEGEL, Scienza della Logica, trad. it. a c. di A. Moni, Laterza, Bari 1999 G. W. F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, trad. it. a c. di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze III ristampa 1975 A. COMTE, Cours de Philosophie Positive – Discours sur l’esprit positif, a c. di Ch. Le Verrier, Garnier, Paris 1949 A. COMTE, Système de politique positive ou Traité de sociologie, condensé par Ch. Cherfils, Ed. V. Giard et E Brière, Paris, 1912 S. BERNARD, Mallarmè et la musique, Nizet, Paris 1959 M. HEIDEGGER, Saggi e Discorsi, a c. di G. Vattimo, Mursia, Milano 1976 M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, a c. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano 1959 H. BERGSON, Comment doivent écrire les philosophe. Lettre a Constant Bourquin (1924), Editions de Minuit, Paris 1997 A. KOYRÉ, Note sur la langue et la terminologie hégélienne, in Etudes d’histoire de la pensée philosophique, “Les Temps Modernes”, n. 31, 1948 E. WEIL, Logique de la philosophie, Vrin, Paris 1967 D. DREYFUS, L’utilisation des oeuvres et de textes des philosophes, in O. O. S. I. P. , n. 1, juin 1965, p. 8, pubblicazione dell’I. P. N. G.R.E.F., in Revue de l’enseignement en philosophie, n. 33-36, Bulletin de l’Association des professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public, Delayance, La Carité-sur-Loire, 1983 110 di Gianni Donati N OTE SANTINO CAVACIUTI E MAINE DE BIRAN La settima trattazione di Santino Cavaciuti1 relativa al pensiero morale del filosofo francese Marie-François-Pierre Gonthier Maine de Biran (17661824), si rivolge al problema della Trascendenza tramite la ricognizione, condotta in quattro capitoli, del fattore religioso e teologico nella vita di Biran (cap. I) e di tutti i Suoi scritti (capp. II, III, IV). Nel Capitolo Primo, l’Autore affronta L’istanza religiosa nella vita di Maine de Biran, in nove paragrafi. L’analisi si snoda attraverso i giudizi, talvolta anche contrastanti, dei critici ora negatori, ora affermatori di un temperamento religioso in Biran, per giungere a concordare con la seconda posizione. Nelle “idee” biraniane relative alla religione, il Cavaciuti trova “chiara disponibilità”, nonostante, in un primo periodo, che si può definire “illuministico”, il Filosofo di Bergerac sia allineato allo spirito “libero” di quel secolo. I presupposti materialistici, benché piuttosto superficiali, si rivelano, in fondo, semplici “tracce”: ben presto egli passerà ad una forma di teismo, in un primo tempo, di ascendenza rousseauiana, per approdare, nell’ultimo periodo della sua vita, a un’adesione più o meno integrale al teismo cristiano. Inoltre, se, nel primo tempo – scrive Cavaciuti –, è “sicura” la concezione agnostica di Biran, altrettanto lo è, però, il riconoscimento “pratico” di Dio. Passando al tema della possibilità di una morale senza la religione, possibilità affermata dal Pensatore, questi riconosce, comunque, l’utilità della stessa religione per la morale. Dal 1818, come testimonia il Diario, il sentimento religioso biraniano si evolve, per giungere ad affermare il primato del Cristianesimo sullo Stoicismo, pur perdurando il dialogo con questa forma di morale, che è conforme – dice Cavaciuti – al principio dell’effort, il quale privilegia «appunto la volontà, la sua autonomia, le sue possibilità» (p. 47). Prima dell’esame delle “idee” religiose, il Cavaciuti tratta del “sentimento religioso” di Biran: il Filosofo della libertà ne lamentava per sé l’assenza. Accanto a questa “assenza”, l’Autore indica, però, nel percorso biraniano, anche sentimenti religiosi positivi, come ad esempio quelli relativi alla Provvidenza, alla penitenza, alla rassegnazione ed alla preghiera, fino ad individuare una certa concezione mistica caratterizzante l’ultimo pensiero biraniano. Il capitolo termina con le testimonianze tratte dal Diario del Pen111 satore circa la sua partecipazione, ancorché saltuaria, ai riti cattolici. La finale adesione ai Sacramenti cristiani sul letto di morte chiude il tema riguardante la dimensione “pratica” dell’attenzione posta dal Filosofo al problema della Trascendenza. Il Secondo Capitolo, L’attenzione teoretica di Biran al problema della trascendenza, considera nello specifico la produzione religiosa e “teologica” di Biran (da intendere, quest’ultima, in senso puramente “filosofico”). La puntuale rassegna del Cavaciuti si snoda attraverso l’esame dei passi “teologici” dell’edizione Tisserand, la più completa prima della recente edizione del CNR francese. L’analisi prende le mosse dal primo scritto filosofico relativo all’esistenza di Dio (1792), Discussion sur l’existence de l’tre suprême, dove si manifesta una certa “ambiguità” o, per meglio dire, “duplicità” che accompagnerà, poi, per lungo tempo, la speculazione biraniana. Cavaciuti evidenzia, qui, «due posizioni di fondo», costituite, la prima, dal “desiderio” di Biran che fosse vera l’opinione affermante l’esistenza di Dio; la seconda, invece, è quella del “dubbio” (p. 76). Incerta, ma orientata verso una soluzione “positiva” del problema di Dio, la posizione dell’Autore francese, nel secondo scritto esaminato, Réflexions sur l’athéisme. Un terzo approccio alla “teologia”, Méditation sur la mort près du lit funèbre de ma soeur Victoire”, mostra ancor maggiore sicurezza nei confronti dell’esistenza di Dio, che ridimensiona le affermazioni scettiche pur presenti nel saggio. Compare il concetto di “senso intimo”, che ci fa vedere Dio nell’ordine dell’universo, il riconoscimento dell’esistenza di Dio stesso e dell’immortalità dell’anima. Dei Primi scritti biraniani vengono, quindi, considerati i saggi rimanenti, dove emergono altri spunti “teologici”. Taluni di questi, come ad esempio il motivo dell’interiorità, diverranno, poi, sempre più frequenti con la maturità del Filosofo. Nella seconda “Memoria” sulla Scomposizione del pensiero, così come negli scritti del periodo di Bergerac, è quasi assente il problema religioso, ad eccezione di alcuni accenni presenti nel Saggio sui fondamenti della psicologia. Nel vol. X, intitolato Rapports des sciences naturelles avec la psicologie, l’Autore tratta del principio di causalità e, in quest’ordine di idee, indica un processo causativo che approda al riconoscimento della causa delle esistenze, cioè di Dio quale Creatore: si tratta di un processo centrale nel pensiero biraniano, che ha come punti di partenza e di arrivo, rispettivamente, il “fatto primitivo” e la “causa delle esistenze”. Nei saggi che costituiscono il volume XI, Études d’histoire de la philosophie, le riflessioni concernenti tale problema aumentano: si incontra una critica alle prove di Cartesio, all’occasionalismo di Malebranche, mentre con gli scritti del 1817-18 si passa al periodo “religioso”, in cui, tra l’altro, si nota la stretta connessione della “teologia” biraniana con la sua psicologia e la morale. Nel saggio sulla filosofia di Leibniz, ultimo del volume in esa112 me, proprio la psicologia è “punto di appoggio” – scrive Cavaciuti – delle idee teologiche biraniane. Queste ultime, poi, nel vol. XII, Defénse de la philosophie, assumono “tonalità nuove”, mentre ricorre il tema del rapporto tra fede e ragione. Due saggi, principalmente, accolgono spunti utili all’indagine del Cavaciuti: quello sui Fondamenti della morale e della religione, e l’altro che dà il titolo al volume. Quivi, oltre a quasi tutti i “capisaldi” del pensiero biraniano, si rinvengono: la tesi della necessità della vita “sociale” per la religione, la “duplice via” per salire a Dio (quella della “ragione” e quella del “cuore”), la pratica della morale quale presupposto per la religione. Segue la considerazione di concezioni errate del “divino”, come quella panteistica e quella politeistica. Esposto il concetto di cecità del “fato”, l’Autore rileva la fondamentalità del concetto di causa in Biran per l’ascesa a Dio. La trattazione morale-teologica di Biran tocca un punto culminante – rileva il Cavaciuti – nei Fragments relatifs aux fondements de la morale et de la religion, in cui si ha correlazione fra i due poli, il morale appunto e il religioso, per concludere il saggio con il risvolto “politico” del riconoscimento del Trascendente. Il citato secondo saggio, Difesa della filosofia, completa il volume rifacendosi a Socrate e poi all’innatismo platonico, presente nella storia del pensiero moderno, da Cartesio a Malebranche, a Leibniz. All’idea di Dio “oggetto della ragione” si associa quella del passaggio pressoché immediato tra il “fatto primitivo” e il riconoscimento di Dio, idea che secondo Cavaciuti si ritroverà in Lavelle. Tornano, inoltre, il concetto di interiorità, ove Biran trova l’unione di religione e filosofia, nonché la tesi relativa alla conoscenza di Dio. Il Pensatore francese si pone il problema delle “prove teologiche”, che, in polemica con De Bonald, ritiene essenzialmente valide, con preferenza per quella “interioristica”, o della “rivelazione interiore”. Tra i saggi del secondo decennio dell’800, raccolti nel vol. XII, meritano di essere citate le Note ai Pensieri di Pascal, in cui spiccano il tema della pace con se stesso, proprio della religione cristiana; ma la consonanza tra i due filosofi – rileva il Cavaciuti – non è totale: Pascal nega la dimostrabilità dell’esistenza di Dio, e l’atteggiamento di Biran nei suoi confronti è, su questo punto, essenzialmente critico. L’esame del vol. XIII, Nouvelles considération sur les rapports du physique et du moral chez l’homme, s’incentra nel saggio Notes sur les deux revélations, che ospita numerosi riferimenti teologici e religiosi. Qui è presente pure una versione “mistica” del mondo religioso, da non intendersi, però, come opposta alla tesi della possibilità di una prova “razionale” dell’esistenza di Dio. È centrale, altresì, l’idea della “duplice rivelazione”: l’una definibile “naturale”, o meglio“spirituale”, e l’altra da Biran detta “positiva”, cioè la ebraico-cristiana. Si ridimensiona, inoltre, il carattere “attivo” dell’io, da cui deriva la passività «di fronte alla luce che viene direttamente da Dio» (p. 143). E ancora, svolgendosi la filosofia tra i due poli, dell’io e Dio, 113 l’“analogia” tra l’io e Dio implica anche che l’uomo, “inferiore analogato”, può avere una più completa conoscenza di se stesso guardando il “principale analogato”, conoscendo cioè Dio, di cui egli è una “lontana partecipazione” (p. 145). Gli altri saggi raccolti nel volume che stiamo considerando ripropongono polemiche contro il panteismo spinoziano ed il pensiero di Malebranche, per riaffermare il concetto di libertà creante. Cavaciuti ritiene di dover sottolineare questo principio biraniano, rilevando che il rapporto fra il Creatore e le creature è un rapporto di libertà. Il vol. XIV contiene i Nouveaux essais d’antropologie (1823/24), un’opera incompleta, ma in grado di rappresentare l’espressione riassuntiva dell’intero pensiero di Biran. Tra varie conferme circa le idee esposte, si incontrano numerose prove dell’adesione di Biran alla verità cristiana, ma si nota in maniera precipua la tendenza a “legare” – scrive il Cavaciuti – le ultime posizioni con quelle originarie. In queste meditazioni si coglie anche una certa novità, e tra i punti più avanzati di detta speculazione vi è l’idea di Terza vita, quella dello “spirito”. Il Filosofo, peraltro, insiste sull’idea di anima e ritiene che l’unione con Dio sia la tendenza fondamentale proprio dell’“anima” umana. Pare centrale, poi, il tema dell’amore, l’amore verso Dio. La dottrina relativa alla Terza vita, pur connessa in Biran a letture mistiche o comunque religiose, fa parte di uno sviluppo autonomo del suo pensiero e anche dell’esperienza personale, itinerario che implica necessariamente un “legame” tra la vita “organica” (primo tipo di vita), quella morale (secondo tipo), e quella dello “spirito”; l’ultima ha in sé qualcosa di unico, e l’accedervi (lo Stoicismo non può giungere a questo livello) esige soprattutto la preghiera. Ci troviamo in presenza – argomenta ancora il Cavaciuti – di uno dei passaggi più innovatori nel pensiero biraniano: il passaggio dalla assolutezza dell’io alla sua subordinazione al piano divino. Essendo formata da pensieri sparsi, l’ultima parte dei Nouveaux Essais risente di una certa disorganicità; ciò non toglie che vi siano passi assai significativi per il tema indagato. I Nouveaux Essais si concludono con una precisazione relativa alla tesi dei “quietisti” (tesi annullatrice della volontà umana), per rivendicare la necessità dell’azione dell’io e della libera volontà concomitante all’agire della grazia (p. 175). Tre Notes sur l’Evangile de Saint Jean, scritte tra il 1820 ed il 1823, chiudono l’esame delle opere di Maine de Biran secondo l’edizione Tisserand. Anche il primo di questi commenti è da ritenersi sostanzialmente “biraniano”, nonostante sia stato approntato dall’amico C. Loyson. Infatti, la trattazione, di impronta “psicologica”, contiene la tesi fondamentale dell’antropologia e ontologia del Filosofo, cioè la tesi dell’essere dell’uomo come costituito dalla libertà. Nel secondo di questi tre saggi, viene ripresa l’accennata impostazione “psicologica”, centralizzando il concetto di “libertà”, il cui primato – insiste Cavaciuti – trova espressione suprema nell’amore. 114 Del 1823 è un altro commento di alcuni versetti del Prologo giovanneo, con la riproposizione dell’analogia tra il Verbo incarnato e l’io, l’essenzialità dell’azione, la volontà libera costitutiva della persona umana, il riconoscimento del Cristo quale “mediatore” e “modello” dell’uomo. Si ha, pure, il richiamo allo stoicismo quale interprete della “virtù umana”, cioè puramente umana. Il Capitolo Terzo, dal titolo Ricognizione di altri scritti biraniani della nuova edizione “Vrin” (1984-2001), consta di otto paragrafi. Nel volume X/1 si trovano alcuni “frammenti”, come l’opuscolo Mort de Socrate, dove, oltre all’affermazione della necessità di risalire a Dio, spuntano diverse idee sintetizzatrici del pensiero biraniano, ad es. l’idea di obbedienza (alla volontà divina), presente anche nell’Extrait de Proclus. Tra le virtù, l’obbedienza è «la più connessa, anche se “negativamente”, con l’idea centrale nella riflessione del Pensatore francese, il suo “volontarismo”» (p. 195). In relazione a questo tema, si ripresenta l’idea della doppia passività: verso il “basso”, intesa come schiavitù delle passioni, e verso l’“alto”, quale obbedienza alla Provvidenza; quest’ultima forma è, in fondo, «massima attività e libertà» perché è un elevarsi a Dio, il quale, poi, è per essenza Libertà. Nel frammento Sur Marc Aurèle si ha la ripresa di istanze proprie della speculazione precristiana, che connotano, quindi, la razionalità biraniana come aperta anche «all’apporto di verità provenienti da altre sponde» (p. 197). Seguono due Lettres sur l’amour e le “Notes” sur De Bonald, De Maistre, Saint Augustin. Trasversale ed essenziale a questi scritti rimane il tema della “libertà umana”, mentre affiorano accenni al mondo soprannaturale e si conferma il primato dell’“amore”. Il volume XI/1 Commentaires et marginalia: dix-septième siècle, è caratterizzato da “Commenti”, “Note marginali” e “Appendici” ad opere di diversi filosofi. Nel primo di questi saggi, Biran – spiega Cavaciuti – ritiene possibile la dimostrazione razionale dell’esistenza di Dio, ma critica Cartesio, in cui vede un uso ambiguo del rapporto di causalità, e respinge l’argomento relativo all’idea di “infinito”. Nei commenti a Cartesio si trova, inoltre, la riflessione circa l’“innatismo” dell’idea di Dio, in una versione simile all’agostiniano inquietum cor. Altri argomenti di critica sono nelle Notes relative a Malebranche: l’identificazione di desiderio e volontà, l’idea di Dio quale unica causa efficace, l’azione di Dio in rapporto alle leggi naturali da Lui stesso stabilite; si ha la difesa, in sostanza, della libertà e dell’autonomia delle creature umane. Nel commento a Leibniz ricorre l’idea dei due “poli” della “scienza umana”: l’io e Dio; si conferma l’idea centrale dell’antropologia e dell’ontologia biraniane – l’effort come essenza dell’io – e si distingue «il processo di formazione dell’idea di Dio da quello della prova dell’effettiva esistenza reale di Dio» (p. 210). Non manca la critica di certi aspetti del pensiero di Leibniz, come il “principio di ragion sufficiente”, rite115 nuto insufficiente nel costruire la prova teologica, a differenza di quello di causa. Seguono Note marginali ai “Pensieri” di Pascal: emergono numerose idee sulla religione e sulla fede, concetti in cui, – avverte l’Autore – vengono toccati problemi sempre aperti per tutti. Per il resto, talvolta Biran concorda con Pascal, talaltra dissente; si rileva, comunque, un certo “equilibrio” e la pregnanza di significato della religione cristiana in rapporto alla morale. Il secondo volume dei Commentaires et Marginalia continua l’impostazione del precedente: vi si discutono, tra l’altro, le tesi occasionaliste di Lignac, se ne corregge il pensiero, si precisano certe istanze ontologiche di Bonnet, si critica in maniera determinata Kant. Anche nella critica alle Mémoires di Mérian si ha la ripresa dell’idea fondamentale biraniana: è l’io e non Dio, l’autore immediato delle nostre volizioni (p. 226). Nel volume XI/3 vengono commentati altri diciotto Autori del secolo diciannovesimo; nei passi relativi, il concetto più ricorrente riguarda l’affermazione di Dio quale principio o causa dell’universo. I saggi dei volumi XII/1 e 2 concernono L’homme public: sono scritti di carattere politico ed amministrativo, che abbracciano il periodo rivoluzionario e napoleonico e quello post-napoleonico fino alla morte di Biran. Accanto a notissimi avvenimenti della storia francese ed europea non mancano spunti morali (come quello sul divorzio), osservazioni sulla soppressione delle Repubbliche di Genova e Venezia, del ’97, sul giuramento dei preti. Alcuni “indirizzi” a Napoleone si discostano dalla posizione di biasimo che Biran assumerà anni dopo. Altri interventi scritti riguardano temi sociali ed organizzativi: citiamo una campagna di vaccinazione, l’organizzazione del collegio pestalozziano di Bergerac (fondato da Biran stesso), la restituzione di un ospizio alle Suore della Misericordia, il discorso per una Loggia Massonica. Frequenti sono gli accenni alla Provvidenza divina, specie in relazione alla figura dell’Imperatore, ora visto come strumento di castigo “per i re e per i popoli” (p. 241). Le varie minute e discorsi esaminati assumono il carattere di testimonianze della presenza del tema religioso nell’attività politica del Filosofo, che è ben conscio, però, del doversi distinguere l’ordine religioso da quello civile; la religiosità di Biran mostra, quindi, un «autentico spirito “liberale”», lontano dall’imposizione e dall’intolleranza. Ciò, parimenti, non lo esenta dal nutrire dubbi su certe “scuole” di formazione dei sacerdoti (p. 247). In altre lettere, discorsi e dialoghi con colleghi deputati, o resoconti di dibattiti, spicca il tema del rapporto tra morale e religione. Sovente, però, l’attenzione di Biran diviene di ordine “pratico”, come nell’interessamento per il Seminario di Périgueux. La rimanente corrispondenza filosofica interessa il volume XIII/3, intitolato appunto Correspondance philosophique: 1805-1824. Cavaciuti estra116 pola i contenuti relativi al suo assunto da lettere che oltrepassano i livelli burocratico e diplomatico e mostrano in Biran una discreta sensibilità nel comprendere il mondo religioso; l’Autore torna ancora a riferirsi al tempo presente rilevando come il grado di laicizzazione della Francia postrivoluzionaria fosse ben inferiore a quello constatabile ai nostri giorni! L’esame delle lettere finali a Cousin, Stapfer, Baggesen si sofferma sul necessario passaggio attraverso l’io per arrivare a Dio; sulle minacce costituite per la religione dal “metodo baconiano” e sulla contemporanea rivalutazione della religione tradizionale operata dalla letteratura romantica. Cavaciuti argomenta, infine, circa la minaccia costituita dal panteismo e ripuntualizza la distinzione tra morale stoica e morale cristiana. Il Capitolo Quarto riguarda l’analisi del “Journal” di Biran secondo l’edizione curata da H. Gouhier negli anni ’50 del secolo scorso. Il primo sottoparagrafo rileva la presenza di riferimenti alla pratica religiosa già trattata nel primo capitolo: così per la partecipazione alla Messa e per la frequenza della preghiera. Questa è in stretto rapporto con l’“amore”: in essa pare confluire – secondo Cavaciuti – l’intera meditazione di Biran che, su questo tema, si giova dell’apporto di autori quali Fénelon, Massillon o anche dell’Imitazione di Cristo. Nel Journal, si trovano, inoltre, numerose lamentele da parte di Biran circa la propria religiosità, come l’assenza di un vero “sentimento religioso”, una certa “leggerezza” spirituale, favorita dalle attrattive del “mondo”. Passando alle riflessioni sulla “religione in generale”, si incontrano il tema della “morte” e pensieri intorno al mondo sociale e politico. Cavaciuti commenta la critica rivolta da Biran alla tesi del “primato politico”, un’idea che chiama “panpoliticismo”, la quale può considerarsi pure “contemporanea”, datane la presenza in certi ambienti culturali e politici odierni. Anche la crisi religiosa della società francese del primo quarto dell’Ottocento, crisi connessa a quelle del principio di autorità, della famiglia, del rispetto per gli anziani, offre al Cavaciuti un altro rimando al nostro tempo, epoca in cui si può constatare come la storia ubbidisca a “ricorsi” vichiani molto simili tra loro (p. 280). Tra i principî esaminati da Biran vi è quello dell’interiorità, quello della sofferenza, momento “negativo” ma sublimabile dalla religione. Qui Cavaciuti ripropone l’idea del primato antropologico e ontologico della volontà e libertà: l’essere dell’uomo è illuminato dall’intelletto ma dominato, appunto, dalla libertà. L’Autore esamina poi aspetti concreti dell’attenzione di Biran ai temi della religione, partendo dai livelli più formali per arrivare a temi più direttamente sostanziali. Tra i primi vi sono le “letture” della Bibbia o di opere di carattere sacro. La prevalenza nella scelta per i testi di Giobbe, Giovanni e Paolo – precisa ancora Cavaciuti – accomuna Biran a tutti quegli Autori che hanno meditato le Scritture contestualmente agli «aspetti e problemi 117 teoretici, oltre quelli esistenziali dell’uomo» (p. 290). Nelle letture spirituali di ascetica e mistica cristiana si ha la predominanza, per quantità di citazioni, di Fénelon, Imitazione di Cristo, Pascal e Bossuet. Nella serie di idee riguardanti il cristianesimo si incontrano anche giudizi parzialmente negativi intorno alla dottrina cristiana in relazione alla libertà, che è «pietra di paragone» per l’interpretazione delle dottrine morali, antropologiche, ontologiche e metafisiche da parte di Biran. Altre idee intorno al cristianesimo considerano le “contraddizioni della nostra natura”: è un riconoscimento espresso da molti interpreti, ma Cavaciuti ricorda in primis l’italiano Michele Federico Sciacca, che ha formulato la tesi dello “squilibrio” essenziale, ontologico dell’uomo. Negli altri sotto-paragrafi della sezione dedicata ai passi inerenti la religione cristiana, si enumerano idee su Grazia, Fede, Morale, sull’amore, su Gesù, sullo Spirito Santo, sulla Chiesa, sulla vita e sulla mistica cristiana. Il prosieguo del commento tocca uno dei vertici del versante religioso della filosofia biraniana: la cooperazione all’azione della Grazia attuata dall’amore. Questo promuove la realizzazione della libertà stessa, che, secondo una certa tesi del Cavaciuti, è “chiamata” a passare dallo stato “iniziale”, che è possibilità di “iniziativa”, a realizzarsi, ad essere “creatività” in atto. Si perviene, così, nel terreno che l’Autore ha reso fertile negli anni meditando i testi di Biran e dei suoi continuatori, fino ad esprimere la propria «idea di fondo» intorno alla libertà. Viene evidenziato, inoltre, il principio di causalità, visto nel duplice livello di applicazione: causa del movimento da parte delle creature e “Causa suprema”, creatrice delle “esistenze”, la causalità di Dio. Le idee su Gesù e sullo Spirito Santo sono interpretate in una versione più vicina alla problematica filosofica che dogmatica, mentre in quelle sulla Chiesa emerge il giudizio sulla progressiva perdita dell’influsso culturale in età moderna e contemporanea. Nel paragrafo conclusivo della I sezione, ricorre la tesi secondo cui «non esiste l’uomo se non nella sua libertà, nella sua causalità libera» (p. 325). La seconda sezione del Capitolo raccoglie i “temi teologici” muovendo dall’argomento dell’“idea di Dio”. Lo studio delinea l’“universalità” dell’idea di Dio, le “affinità” con altre idee dette “assoluti della ragione”: cioè le idee di “dovere” e di “coscienza”. In un corposo paragrafo intitolato La ricerca di Dio, l’Autore affronta l’aspetto teoretico del “raggiungimento” di Dio (su quello pratico è intervenuto nel primo capitolo): sono pagine sostanziate ancora da richiami ad Agostino, Fénelon, Bossuet. Anche qui torna il concetto di “amore”, visto come “fine” e “mezzo” del rapporto con l’Assoluto. La parte finale del volume, riporta lo «schema» della prova teologica e afferma l’“accordo” della filosofia di Biran con la religione. Così la speculazione biraniana approda al discorso sulla Trascendenza, attraverso un per118 corso ‘razionale’ «condotto sino alle ultime possibilità» (p. 360). Vengono infine indagati gli aspetti del rapporto esistenziale con Dio, divisi nei due momenti di tensione a – e di stato di – unione con Dio stesso. La «ricognizione» termina con la considerazione del tema della «somiglianza» dell’uomo con Dio: Cavaciuti ripresenta la propria interpretazione «di fondo» del pensiero biraniano, formulando l’ipotesi che detta «somiglianza» non possa limitarsi all’«intelligenza», ma comporti, soprattutto, la «libertà». Complessivamente direi che dall’esame qui condotto sullo studio del Cavaciuti, si può avere, nel medesimo, un’ampia conferma dell’importanza del tema religioso nel Filosofo francese, tema che non era stato ancora sondato a fondo, almeno in una forma così capillare e completa: da qui, si può pensare, il valore della ponderosa opera del Cavaciuti, utilissima per chi voglia conoscere appieno il pensiero religioso, ma non solo, di Maine de Biran, a cui si rifà, in gran parte, la filosofia spiritualistica francese sino ai nostri giorni. 1 S. CAVACIUTI, Coscienza morale e trascendenza. Il problema morale nel pensiero di Maine de Biran: parte VII/1: Ricognizione della vita e degli scritti religiosi biraniani, Franco Cesati Editore, Firenze, 2006, pp. 404. 119 N OTE PIERRE LEROUX TRA INDIVIDUALISMO E SOCIALISMO di Marisa Forcina La ginestra è una piccola, preziosa collana delle edizioni Diabasis, diretta da Ferruccio Andolfi e Italo Testa, che vuole raccogliere testi che permettano di individuare una tradizione nell’elaborazione di una politica non autoritaria e solidaristica della società, una politica in grado di comporre le disuguaglianze e, contemporaneamente, rispettare la libertà dei soggetti. Non sono molti i filosofi che si sono impegnati in direzione della costruzione di questo tipo di individualismo solidale, perciò i volumi già pubblicati sono pochi, relativi a brani scelti da testi di Simmel, Emerson, Bauman e, anche se sappiamo che in preparazione sono altrettanti testi di Adorno, Landauer, Scleiermacher, siamo sempre nell’ambito dei piccoli numeri. Si tratta, infatti, di portare alla luce, ripubblicandoli, testi rari di autori conosciuti o testi di autori assai poco conosciuti, ma indicativi di un impegno teorico singolare, di cui oggi sentiamo molto il bisogno. L’impegno è quello di mostrare come sia possibile realizzare una coesione sociale che non confligga con la cura di sé propria degli individui emancipati. L’ultimo volume, apparso qualche mese fa, ci offre alcuni saggi di un autore poco frequentato dai filosofi, dagli storici del pensiero politoco1 o dai politologi di professione. Si tratta di Pierre Leroux e il titolo del libro, Individualismo e Socialismo, riprende un saggio, scritto nel 1834, in cui l’autore usava quelli che allora erano due neologismi in modo ulteriormente nuovo: nuovo anche per la tradizione politica a noi contemporanea. Ciò che è particolarmente interessante, e che viene messo bene in luce da Bruno Viard, che firma la puntuale introduzione al volume, è la relazione che Leroux ha posto tra queste due idee politiche. Egli, criticando il socialismo che, opponendo il bene della società a quello del singolo, assolutizza l’altruismo, criticava contemporaneamente l’individualismo che, opponendo i valori dell’individuo e del capitale a quelli della società, assolutizza sempre l’egoismo. Nessuno dei due progetti politici può essere accettato, sosteneva Leroux che vedeva, invece, la dignità dell’uomo assicurata proprio dalla proprietà di un certo numero di beni materiali e la socialità garantita dal rispetto dell’uguaglianza non formale. Insomma, Leroux difendeva i beni materiali, ma non in vista di una accumulazione di essi, come nella logica economica capitalistica, ma perché invece in essi vedeva lo strumento che consente di sviluppare la dignità e le capacità spirituali, politiche e sociali. 120 In un certo senso sarà, esattamente un secolo dopo, Simone Weil a riprendere questa impostazione parlando della necessità di avere la proprietà delle cose che ci circondano come “un bisogno dell’anima”. Anche l’invito di Leroux, come successivamente quello di Weil, era teso a non separare il materiale dallo spirituale perché, se manca l’uno dei due, diceva il primo, il legame sociale si corrode. Come dire che l’impegno di Leroux era quello di insegnare a conciliare la libertà con l’uguaglianza, perché già gli era chiaro che, senza questa unione, gli uomini sono condannati a quelli che oggi definiamo come egoismi individualistici o come totalitarismi. Sull’affinità tra Leroux e Simone Weil ha a lungo insistito Jacques Viard, padre di Bruno che firma l’introduzione al volume, nella sua infaticabile opera di ricostruzione storica della tradition interrompue ossia la tradizione democratica repubblicana che da Leroux, passando per Péguy, giunge sino a Weil, e alla critica dei totalitarismi condotta da Arendt. La libertà per Leroux non può prescindere dal riconoscimento dei diritti. Infatti, egli sostiene nella voce Culte della Encyclopédie Nouvelle, tradotta anche nel volume di Diabasis, che il rispetto della libertà non passa attraverso la tolleranza, “parola vaga e insignificante. Giacché ciò che occorre non è la tolleranza, è il diritto! Io non voglio essere tollerato, voglio conoscere il mio diritto e goderne” (p. 107). Ma, ancora una volta, l’attenzione di Leroux si fa più complessa e guarda alle istituzioni che spesso, invece di servire alla comunità umana, si muovono, proprio a causa di una proliferazione di norme, “contro il suo diritto e contro il suo bisogno. La famiglia la patria e la proprietà sono cose finite, che devono essere organizzate in vista dell’infinito: l’uomo è infatti un essere finito che aspira all’infinito. Il finito assoluto è per lui il male. L’infinito è il suo fine, l’indefinito il suo diritto” (p. 116). Ecco perché I diritti dell’esistente, come io stessa titolai il mio volume dedicato all’Encyclopédie Nouvelle, non devono gravare come una nuova sorta di determinismo sull’uomo, ma devono solo supportare la sua libertà. Si tratta qui, parlando di Leroux, di una libertà che non è la dimensione che racchiude le angosce, le invocazioni, le speranze, l’amore e il furore della storia, come dirà in seguito Benedetto Croce, che ne fece un sentimento dello Spirito, e una religione che, sì, si realizza nella storia, ma che, a sua volta, è sempre storia della libertà. La libertà, per Leroux, si gioca su cose concrete e insieme spirituali perché l’uomo, nel suo complesso, è “sensazione-sentimento-conoscenza”, poiché la libertà costituisce solo una parte della storia, della società e anche della verità in cui si incarna. Infatti, per realizzarsi, ogni individuo ha bisogno non solo che la sua libertà sia riconosciuta, ma che gli siano fornite le opportunità per esercitarla e queste opportunità devono essere paritarie. Per questo, già nel 1831, dopo il suo distacco dal sansimonismo che, con la deriva provocata da En121 fantin, gli aveva fatto comprendere quanto un’organizzazione pianificata della società, dei sentimenti e delle libertà individuali fosse pericolosa, si mise ostinatamente a costruire un progetto politico che non opponesse più i due termini della questione: libertà e società. Era consapevole che se una politica mira solo alla realizzazione della libertà individuale manda letteralmente in polvere il corpo sociale, e che, all’opposto, i progetti di costruzione a tavolino dell’uguaglianza sociale diventano programmi massificanti che soffocano ogni libertà e desiderio. Come costruire, allora, una società concretamente libera e solidale? Promuovendo pratiche efficaci di cittadinanza. Leroux era convinto, infatti, che un governo repubblicano avrebbe realizzato la Libertà e l’Uguaglianza. L’istanza repubblicana veniva preferita a quella nominata democratica, perché quest’ultimo termine e la sua strategia politica, a quel tempo, ossia tra il 1830-1840, evocavano ancora i troppo vivi i ricordi sanguinosi della pseudodemocrazia giacobina, e, per questo, il termine democrazia era circondato da un alone negativo. Ma Leroux sarà in grado di sdoganare progressivamente tale sostantivo per proporlo pubblicamente nel 1848 nel suo Proiet d’une constitution démocratique et sociale, cui il volume di Diabasis non fa riferimento perché invece tende ad esplicitare il messaggio forte contenuto in alcuni dei saggi che costituirono i punti fondamentali di due progetti culturali di Leroux: la Revue encyclopédique (1833-1835) e l’Encyclopédie Nouvelle (1833-1846). Non deve meravigliare l’insistenza sull’esigenza di promuovere una nuova conoscenza enciclopedica, perché, per Leroux, la conoscenza attivata da strumenti agili e a poco prezzo, come le riviste e le enciclopedie pubblicate in fascicoli, doveva essere in grado di proporre in modo chiaro le conoscenze “universali” e servire a costruire un nuovo patto di civiltà politica, visto che quello della razionalità illuministica aveva certamente messo in fuga la superstizione, ma aveva anche provocato un inesorabile ritorno alla barbarie, questa volta illuminata dalla ragione, sotto forma di una violenza indiscriminata. Conciliando libertà e uguaglianza, ma anche ragione e sentimento, da sempre apparsi come pratiche contraddittorie, Leroux profila un socialismo umanitario che troverà un eccezionale e costante interlocutore in Mazzini e di cui si faranno portavoce George Sand, Ernest Legouvé, e che raccoglierà intorno a sé figure di intellettuali e politici che vanno da Jean Reynaud a Charles Rénouvier, che, a sua volta, si dichiarerà fortemente influenzato dalle idee di Leroux. Ma questo versante umanitario del socialismo, al confronto con quello economicistica di matrice marxistica, costituirà il Socialismo sconfitto, come recita il titolo di un bel volume di Leonardo La Puma del 1984. Tale socialismo sarà poi ripreso, ma in maniera indiretta e con maggiori espliciti richiami più rivolti a Mazzini che a Leroux, ma con istanze affini, nella migliore tradizione del socialismo liberale della prima metà del Novecento. 122 Leroux opera una efficace sintesi politica che consente di individuare l’esigenza fondamentale degli uomini: la libertà dal bisogno e la giustizia sociale, temi cari a ogni vero progetto di democrazia. Egli ci insegna che la libertà dell’individuo pone i soggetti come indipendenti gli uni dagli altri, mentre una società che intende essere tale ha bisogno di non essere un semplice aggregato di uomini, ma di riunirli in una forma positiva, attraverso un vincolo sociale, che permetta l’incontro reciproco. Questo è possibile, se viene promossa una nuova forma di associazione tra i cittadini e una pratica consapevole di cittadinanza. Un tipo di cittadinanza che non ha niente a che vedere con quella auspicata da Rousseau, consistente in una nuova forma di religione civile, dove il cittadino-sovrano fondava il governo politico e, in nome di tal governo onnipotente, giustificava ogni azione e decisione politica, rendendo tutto possibile, perché ogni cittadino aveva abdicato al proprio diritto in favore del diritto della società. In Rousseau Leroux vedeva il promotore di un Noi assoluto, dimentico di essere composto anche dalla fragilità e incompiutezza del desiderio di un io singolare (cfr. p. 90). Quando la società ha il potere di regolare le azioni di ognuno, potrà anche comandare anche ai suoi pensieri, sosteneva Leroux che metteva in guardia l’individuo dal considerarsi solo come corpo sociale o come semplice membro della volontà sovrana che altro non è che il governo. Inoltre, “in un governo ci sarà sempre una maggioranza e una minoranza e, di conseguenza, la legge non sarà mai altro che espressione della maggioranza e un atto di dominio di questa maggioranza sulla minoranza” (p. 91). Ancor prima, quindi che Tocqueville mettesse in guardia contro la tirannia della maggioranza, da tutt’altra ottica, Leroux insisteva perché fosse riconosciuta sempre una minoranza non consenziente e che fosse riconosciuto il fatto che “l’uomo non può mettere nelle mani dello Stato né il suo pensiero, né il suo amore, né le sue amicizie, neppure l’orientamento del suo lavoro, o il frutto di questo, in una parola la sua personalità” (p. 91). Ma nemmeno la libertà può essere assoluta e indiscriminata, perché, egli sosteneva con forza, di libertà in libertà, dalla sacrosanta libertà di pensare, scrivere, stampare, dalla libertà di coscienza si passa alla libertà di educazione e alla libertà di praticare qualunque opzione che poi nega e annulla ogni sovranità. La libertà, per essere tale, deve essere plurale, civile, politica. Per essere praticata non ha bisogno di un governo che ne definisca linee e situazioni, ma di cittadini istruiti, formati in una “pubblica istruzione” sin dalla più tenera età. Aveva infatti stilato persino un progetto per l’istituzione di scuole-asilo per i bambini da tre a sei anni, testo raro2, recuperato da Angelo Prontera, che in Italia è stato tra gli studiosi più significativi del pensiero di Leroux3. E allora? Il principio a fondamento di ogni democrazia è il consenso. Non il consenso ubbidiente e pecoraio di chi non sa, ma il consenso di cit123 tadini consapevoli e informati, istruiti, resi solidali dall’impegno nel mutuo soccorso, capaci di socializzare anche gli strumenti di produzione. Il principio che ha infatti a cuore la res publica, secondo Leroux, non è quello della razionalità dell’agire o della ragione, poiché la ragione dei filosofi e dei politici porta con sé un uso sapiente e abile della violenza, ma è il consenso inteso come il principio che fonda la democrazia e come il principio che si basa sull’evidenza tra le cose che sono di dominio dell’individuo e quelle che spettano all’ambito della società e della collettività. La nuova società democratica, infatti, doveva essere il frutto dello sforzo di tutti i cittadini e di tutte le associazioni di cittadini, e non nascere, invece, come un parto dello Stato e della funzione di un governo. La grande Rivoluzione aveva posto la sua bandiera su tre fondamenti: libertà, eguaglianza, fraternità: nessuno dei tre principi poteva essere realizzato facendo degli altri i momenti di una dialettica interna, ma tutti e tre venivano affidati ad altrettante pratiche di cittadinanza. In maniera particolare, la fraternità non poteva essere decretata dall’alto, ma dovevano essere i cittadini a decidere il riconoscimento reciproco e la volontà di voler vivere insieme. Nessuna norma avrebbe potuto definire queste scelte appartenenti alla sfera della singolarità, ma palesi nell’universalità di tale pratica politica. Una pratica utile, per quanto ancora una volta, come spiega l’autore nella voce Bentham, scritta per l’Encyclopédie Nouvelle e tradotta nel volume che stiamo analizzando (pp. 49-76), fatta di un’utilità che non è mancanza di generosità, di grandezza, di capacità di dedizione, ma affermazione di amicizia, riconoscimento reciproco, solidarietà. Per Leroux infatti, il governo, le leggi, tutta la politica possono essere anche fatti per l’utilità generale, come aveva sostenuto Bentham, ma l’errore è quello di costruirvi sopra un sistema, di legare la propria gloria alla dimostrazione e al funzionamento del sistema (p. 58). Come non ricordare qui il Péguy dell’Esprit de système?4 È stata proprio questa modalità antisistematica di Leroux a continuare in una tradizione che si è prolungata sino agli ultimi anni del Novecento sedimentandosi in due autori che hanno consacrato il proprio impegno alla costruzione di una ricerca filosofica senza garanzie5, come Prontera, di cui si è già detto, o del Movimento antiutilitarista nelle scienze sociali (Mauss), fondato da Alfredo Salsano, raffinato direttore della casa editrice Bollati Boringhieri, che aveva tradotto e pubblicato proprio L’individualismo e il socialismo nel n. 12 del 2001 di “La società degli Individui”, diretta da Ferruccio Andolfi, inserendo Leroux tra i grandi autori che, con le sue puntuali traduzioni, aveva fatto conoscere e apprezzare in Italia: Latouche, Polany, Caillé. Una curiosa coincidenza: questi due intellettuali, geograficamente distanti e anche distanti rispetto alle case editrici di riferimento si erano entrambi impegnati in analisi che guardavano all’Africa. Salsano pubblicando nel 1997 L’Altra Africa: tra dono e mercato, Prontera traducen124 do nel 1993 Il pensiero africano di A. Ndaw e nel 1998 Tussanghe, di P. Miguel. Entrambi sono prematuramente scomparsi. Come dire che, ancora una volta, l’avvenire non può essere sistematicamente progettato, ma ha bisogno di uno sguardo nuovo, e questo lo aveva insegnato proprio Leroux, che ci ha lasciato una ulteriore consapevolezza: l’avvenire non ha niente a che fare con la categoria del progresso o con quella della realizzazione prometeica, è avvenire vivente e finito, è esistenza e, nell’esistenza, l’ambiguità dell’agire, ossia la morale, non coincide con l’incertezza e la doppiezza, ma è la possibilità di restare aderenti alla singolarità del caso e alla sua soluzione reale, non prevista, indeterminata, che vi apporta ogni singolo uomo perché, come leggiamo in quest’ultima pubblicazione lerouxiana, pubblicata in Italia, “l’indefinito (è) il suo diritto”. 1 A parte Gian Mario Bravo che, nella sua antologia Il pensiero socialista. 1791-1848 (Editori Riuniti, Roma 1971) aveva già tradotto, sotto il titolo La mutua solidarietà, i brani più significativi di De l’Humanité, de son principe et son avenir. La ristampa è nel volume di cui stiamo discutendo, alle pp. 114-144. 2 Cfr. Femminismo, socialismo, educazione, pref. di Angelo Prontera, Ferrari, Lecce 1992, pp. 90. 3 Cfr. A. PRONTERA, Leroux, religione e politica, Milella, Lecce 1991 ed, inoltre, le traduzioni raccolte in Libertà Uguaglianza, Comunione, a c. di A. Prontera e L. La Puma, Milella, Lecce 1984, De l’union européenne 1827, a c. di L. La Puma, P. Mariano e A. Prontera, iusAED, Paris-Lecce 1990, pp. 84; Le ragioni dell’uguaglianza, a c. di A. Prontera, Milella, Lecce 1991, e infine, dello stesso Prontera, Notre Leroux, in “Les Amis de Pierre Leroux”, Trente-cinque années de colloques sur le socialisme républicain de P. Leroux aux dreyfusards, Aix-en Provence, n. 14, juin 1998, pp. 32-39. Nello stesso registro e nello stesso Dipartimento di Prontera, anche Fernando Fiorentino negli anni ‘80 traduceva il Corso di frenologia, con il titolo Religione e libertà, Milella, Lecce 1980, e poi Ai politici, Milella, Lecce 1989, ed infine, nel 1992, pubblicava sempre per la stessa collana un voluminoso saggio: Filosofia religiosa di Leroux ed eclettismo di Cousin. 4 Mi permetto di rinviare alla Introduzione del volume Charles Péguy, Lo spirito di Sistema, a cura di M. Forcina, Milella, Lecce 1988, pp. 330. 5 Cfr. A. PRONTERA, La filosofia, ricerca senza garanzie, iusAED, Paris-Lecce 1996. 125 R ECENSIONI O. TODISCO, La libertà fondamento della verità. Ermeneutica francescana del pensiero occidentale, Edizioni Messaggero, Padova 2008, pp. 603. Questo denso e documentato lavoro di Orlando Todisco può ben considerarsi come una felice sintesi di un lungo itinerario di ricerca costantemente rivolto a indagare e a riattualizzare nella dinamica del nostro presente la corrente vitale dell’anima francescana che, come un fiume carsico, non ha mai cessato di alimentare, persino in condizioni di evidente marginalità, come nell’epoca moderna del dominio pervasivo della ragione scientifica e tecnologica, ma anche nella stessa stagione culturale del medioevo, lo sviluppo della coscienza occidentale. In effetti, il pregio di questo libro è da riconoscersi innanzitutto nel respiro ampio di una ricerca che si misura con le fonti lontane e pur vicinissime della nostra costitutiva condizione spirituale rintracciando, lungo sentieri spesso impervi e obliati, ma ben noti all’autore per la lunga e accurata frequentazione con cui li ha percorsi e se li è resi familiari, momenti e figure dell’epoca medioevale che rappresentano un controbilanciamento alla linea di un «razionalismo» egemone, destinato a diventare spesso una radice isolata e inaridita, in quanto separata dal suo terreno vitale. Qui non è in gioco solo un’operazione di riabilitazione storiografica, all’interno del medioevo, di una fonte alternativa al razionalismo, rappresentata in buona parte dalla corrente del pensiero francescano, ma più in generale si mira a una diagnosi del presente risalendo alle cause spesso inconsce dei nostri erramenti attuali, da riconoscere appunto in una certa ipertrofia razionalistica, ricercandone opportuni rimedi, anzi sollecitando una diversa e più adeguata autocomprensione dell’uomo rispetto al mondo. Dentro un tale quadro problematico assume peso e significato la ridiscussione di due categorie fondamentali della cultura occidentale, quelle di «libertà» e «verità», spesso analizzate nella loro contrapposizione piuttosto che nel loro reciproco scambio e nella loro attuosità dinamica. Riportandole in qualche modo su un medesimo asse e restituendo pari dignità alle ragioni della «libertà» rispetto a quelle della «verità», l’Autore, riprendendo gli elementi di una critica della ragione strumentale, con il suo corollario di un mondo reso «astratto», in quanto ridotto a risultato di un puro calcolo predatorio razionalmente costruito e controllato, mira a tirar fuori lo stesso soggetto «corporeo» da una passività materiale e dal suo asservimento alle cose, sollecitando con ciò, attraverso la riattivazione di antichi percorsi esplorativi, nuove «aperture» teoretiche ed etiche, indicazioni per una diversa e più ricca qualità della vita, opzioni per un esercizio di vita inteso come grazia e dono, 126 dialogo e amore, in breve come un agire comunicativo sorretto dal principio ispirativo di una «libertà creativa», senza la quale la vita stessa perde il suo carattere di evangelica levità e «avventurosa» innocenza, la forza di volare alto e lontano e si rattrappisce a morta, immota, chiusa identità. Dopo un capitolo iniziale incentrato sull’analisi medievale della corporeità nel suo ricco gioco dialettico di «psichizzazione del corpo» e «somatizzazione dell’anima», con le anticipazioni che una tale ricchezza d’indagine rivela per un tema tutto contemporaneo come quello della Lebenswelt, lo scavo dell’Autore vira verso il cuore della domanda «essenziale» che sottende l’intera indagine del libro, quello della reinterpretazione del «fondo» stesso dell’essere a partire dall’orizzonte di una teologia storico-salvifica, avvertendo, quindi, tutta la problematicità di una onto-teo-logia puramente appiattita sull’impianto del necessitarismo greco-pagano, ignaro della categoria di «creazione», e dominato dal monotono, uniforme imporsi del momento noetico nella interpretazione della dottrina dell’«essere». Si potrebbe riconoscere nella ricerca di un orizzonte alternativo a questo schema l’anticipazione di quella esigenza di una «deellenizzazione del cristianesimo» avanzata esplicitamente più tardi prima da Lutero e poi dalla teologia luterana di fine ottocento, ma già implicita nella stessa rivendicazione della teologia scotista e più in generale della scuola francescana di ripensare in maniera autonoma il «principio» della teologia «cristiana». A partire dalla dottrina della creazione, cioè di un libero atto volitivo inteso come «volontà» d’essere, e a partire dalla dottrina della «incarnazione» divina intesa non come necessario atto riparatore di un debito originario, ma come libero espandersi e mediarsi di un Dio-amore nell’impurità della storia, era l’intera dottrina dell’essere come noesi a essere ripensata come libertà-amore. Nel lessico utilizzato dal Todisco si tratta di reinterpretare, attingendo alla nuova luce del discorso «cristiano», lo stesso rapporto tra «verità» e «libertà», restituendo alla verità tutto il dinamismo della sua originaria creatività, ripensandola appunto come il protendersi della libertà, come un intenzionarsi da e a partire dalla libertà. La «radice» della novità francescana andrebbe ricercata appunto in questo rovesciamento di posizioni, che non rinvia certo a una pura separazione/contrapposizione tra verità e libertà, ma a una loro diversa dislocazione all’interno di un unico campo dinamico, secondo la formula paolina: «veritatem autem facientes in charitate» (Ef. 4, 15). I successivi capitoli (II-VII) forniscono un articolato supporto argomentativo e storiografico a questa tesi centrale attingendo alle originali riflessioni di un’ondata di pensatori francescani che vanno da Bonaven127 tura a Olivi, da Scoto a Occam fino ad Alessandro d’Alessandria, ma spingendosi anche oltre fino a coinvolgere Gioacchino da Fiore e Raimondo Lullo, Cusano e Bruno. Naturalmente sarebbe stato possibile arrivare fin nel cuore della modernità, a Schelling ad esempio, nel quale l’idea di assumere il principio della libertà come l’uno e il tutto della filosofia si radicalizza nell’esigenza di un superamento dell’impianto «razionalistico» del suo generale sistema di pensiero spingendolo a reinterpretare l’«essere» stesso non più come «idea», ma come «volere originario» (Ur-sein), una tesi ricca di conseguenze per lo stesso sviluppo del successivo pensiero europeo. La curiosità del lettore è però già sufficientemente stimolata e divertita dall’ampia rassegna di suggestioni tematiche e personaggi autorevolissimi che illuminano e – si potrebbe aggiungere – animano questo variegato universo di un «illuminismo francescano» osservato nelle sue possibilità tuttora vive di riattivare un antico/nuovo pensiero nutrito di pietà e amore, rispetto e dialogo, vita e storia, verità e libertà, oltre ogni clausura monadica fin dentro il suo agire «politico». Francesco Donadio A. RIZZACASA, Sentinella del nulla. Itinerari meditativi di E. M. Cioran, Morlacchi, Perugia 2007, pp. 392. Pensatore poliedrico, testimone della contraddizione del reale attraverso una produzione fedele ad un altrettanto aporetico atteggiamento di ribellione verso i sistemi di pensiero, magistralmente definito dai suoi interpreti come “metafisico dell’impossibile”, “squartatore misericordioso” nei confronti di un’umanità denudata dei suoi alibi di grandezza, ma al contempo sensibile ad una problematizzazione profonda delle sue sofferenze, Emil Michel Cioran si inserisce nella contemporaneità imponendo la sua voce di esule dal mondo in cammino verso il nulla, tematizzando la centralità del negativo in termini filosofico-letterari. Ricontestualizzando suggestioni eterogenee in un eclettismo non logicamente composto, egli dà vita ad un perentorio interrogativo sul senso della filosofia nel tempo della morte della stessa. Lo fa reinterpretando l’individualità nietzscheana, la religiosità kierkegaardiana, la noia e il pessimismo di Leopardi, fino alla concezione politica di De Maistre. Più vicino all’assurdo camusiano e a Schopenhauer, andando però oltre quella volontà di vivere della specie che si afferma a discapito dell’individuo, dà corpo ad una visione del negativo germinante già nell’individualità stessa, baratro dell’insensatezza, rimpianto per una “eternità statica”. La sua riflessione, mai definitiva ed intessuta di perenni contraddizioni, si concentra sull’ineludibile necessità di 128 avere ben presente, prima di poter cercare una qualsiasi via di fuga in soluzioni di ordine etico, religioso o scientifico, ciò da cui tutti tentano di liberarsi: il negativo quale protagonista assoluto. Per farlo, il pensatore rumeno professa la necessità di una consapevolezza antignoseologica quale “vertigine sull’abisso del nulla”, a cui indirizzarsi mediante una progressiva demolizione dell’attività umana verso l’autenticità – mai priva di sofferenza – dello sterile e del passivo. La sua ribellione decostruttiva, sospesa tra “candida ingenuità” e “tagliente aggressività”, si rivolge ad ogni tentativo di offrire risposte – approdi relativi e vani – attraverso una meditazione originata e concentrata unicamente nella sfera del dato autobiografico ed esistenziale del vissuto di sofferenza. A ciò la finitezza umana non può e non deve sottrarsi, pena la sua immersione nella dimensione storico-temporale, illusoria, che fa capo ad un’infondata speranza o credenza nella sensatezza del reale. Cioran si impone esasperando un codice di pensiero disincantato, guidato da una lucidità quale consapevolezza, né programmatica né redentrice, che elude le illusioni propulsive e chiarificatrici della ragione madre della soggettività moderna. La sua è una alternativa alle tradizionali, ed ormai decadenti, soluzioni intellettualistiche o razionalmente pratiche proposte per far fronte alla crisi dell’Occidente e, in generale, dell’intera umanità: «non esiste altro ormai che la carneficina impersonale. Siamo fantocci chiaroveggenti, capaci giusto di fare moine davanti all’irrimediabile. L’Occidente? Un possibile senza domani» (Cioran, p. 151). L’opera presentata da Aurelio Rizzacasa riesce a dar conto dell’ampio spettro espressivo tramite cui Cioran elabora la sua meditazione asistematica ed antifilosofica, recuperando della filosofia il nucleo più autentico di interrogazione intima nella dimensione esistenziale, privata di riferimenti ontologici o finalistici e di argomentazioni apodittiche, considerati veli ottundenti di schopenhaueriana memoria. Ma la tentazione metafisica è in lui sempre presente come occasionale riemersione di interrogativi, seppur disillusi, ereditati dalla mistificatrice familiarità con un sistema ontologico le cui rassicuranti costruzioni sono ormai al collasso. Ed altrettanto problematica risulta la questione religiosa per un uomo che «rivaluta la semantica del divino al di là della fede religiosa o dell’ateismo che caratterizza le scelte etiche dell’uomo stesso» (p. 23). Egli si fa portavoce di una religiosità più vicina allo gnosticismo, al misticismo e al buddismo che al cristianesimo, al quale critica la cristallizzazione nel dottrinario e l’illusione teleologico-soteriologica, ma col quale non cesserà mai di confrontarsi polemicamente ed appassionatamente, in una perenne tensione irrisolta tra slancio verso l’assoluto e ateismo disincantato, in un recupero della disperazione solitaria di Giobbe e del Qoelet. Come il testo qui presentato chiarisce a più riprese, Cioran condivide alcuni tratti del 129 suo percorso con altri grandi pensatori, senza mai ricalcarne le conclusioni, né cedendo ad una definizione della propria attività meditativa, in una scelta insieme stilistica e contenutistica oscillante tra saggezza antica e misticismo. In ciò, egli predilige al ruolo di mediazione pacificatrice del saggio, l’intimismo buddista che invita alla nullificazione dell’individualità egocentrica. «L’obiettivo delle argomentazioni cioraniane è quello di far perdere consistenza tanto all’universalità concettuale quanto alla vitalità prepotente dell’individuo» (p. 37). Quello di Cioran è un “nichilismo problematico”, nutrito da una forma di scetticismo che, privo di ogni corollario speculativo o pratico, risulta essere piuttosto un atteggiamento intrinseco della condizione umana, auspicato come veicolo doloroso verso la deumanizzazione, in una coesistenza di terapeutica sterilità e tormento senza limiti per un’umanità che vive costantemente nella “tentazione di esistere”, di dare senso a ciò che non lo possiede, di voler ardentemente essere per opporsi ad un’esistenza vuota, solitaria ed incerta. La sua attenzione riservata all’umano si coniuga in modo inconsueto con la proclamata noncuranza nei confronti dell’alterità, dei rapporti quali illusorie vie di riscatto. Ciò che costituisce la peculiarità delle riflessioni dell’Autore è il tendere unicamente al raggiungimento della consapevolezza del nulla. Ne parla spesso in termini di “realismo”, laddove con tale espressione non indica connotazioni ontologiche o gnoseologiche, ma professa l’indicibilità di un nulla solo esistenziale quale empiricità vissuta. Ciò che è veramente “reale” è l’unico modo in cui l’uomo esiste: il non senso, il negativo. Se per Leopardi questo possiede la fisicità del vuoto e in Heidegger è ontologico, per Cioran, anticipatore della riduzione della metafisica a questione linguistica, il nulla non è neppure formulabile. È questo il carattere peculiare di un pensatore contemporaneo che si pone alle soglie dell’esasperazione di un’esistenza che non deve chiedere altro che comprendere la necessità di retrocedere all’inerzia del vegetale, del minerale, per poter liberarsi dalla disgrazia dell’essere in vita, dall’illusione di cui è imbevuta la storia, costruita sull’arbitrarietà semantica dei molteplici parametri culturali. La liberazione è un affrancamento dalle maglie della “caduta nel tempo” che non riposa nella speranza di un’eternità salvifica e giusta, bensì è costituita da una ulteriore “caduta”, questa volta “dal tempo”, nel perdurare e amplificarsi della desolazione sofferente, in una dimensione ancora più estranea al tempo rispetto all’eternità comunemente accettata. Per privare il tempo della “negatività esistenziale” è necessario eliminarne i contenuti: i desideri negli individui e i fatti nella oggettività degli avvenimenti. «Il tempo è una tara dell’eternità; la storia, una tara del tempo; la vita è, anch’essa, tara della materia» (Cioran, p. 140). Estremizzando problemi già presenti nelle teorie contemporanee, Cioran testimonia una visione esasperata e volutamente impro130 duttiva, priva di speranza, sia che essa venga collocata nella trascendenza di derivazione cristiana, sia che si tratti di un’utopia immanentistica altrettanto fuorviante ed inautentica. Non si può negare la sua collocazione singolare nel panorama etico in cui vige il primato della prassi, che per Cioran non è altro che vana “tensione della volontà” a cui gli uomini si appellano per assicurare la propria continuità, ponendo in essere la storia e anelando ad un senso d’esistenza. Ecco perché larga parte della trattazione cioraniana è dedicata al tema del suicidio quale parossistica possibilità di liberazione dal tempo e dalla storia attraverso l’annientamento, in una sovversione della nota “volontà di potenza”, in un titanismo invertito nella negazione del vitale, sia fisiologico che psicologico. Se l’esistenza umana è priva di senso, regredire all’inazione è l’unico modo per essere fedele a se stessa. Attraverso la possibilità del suicidio, che non rinvia ad un qualsiasi aldilà ma al nulla nella sua interezza, l’uomo «si appropria dell’esistenza negandosi, in quanto così annulla, in una decisione consapevole, se stesso» (p. 94). Ma tale esperienza esalta la libertà solo se circoscritta alla pura possibilità, perché, se compiuto, il suicidio consuma tale libertà; è la risposta al non senso ma, se realizzato, contribuisce a rafforzare il non senso stesso, riducendosi ad evento concreto altrettanto insignificante quanto la dimensione vitale a cui appartiene. Con una profonda trattazione di quelli da lui definiti “esistenziali rivelativi del negativo”, Cioran rende giustizia ad un capovolgimento assiologico, ad un’etica del fallimento e della rinuncia al miglioramento, lontana dagli esiti creativi ed innovativi. Rizzacasa riconosce che «la negatività cioraniana [...] non coincide con una forma di pessimismo etico, in quanto evoca la lucidità dell’assurdo dando l’idea di un enigma che rifiuta ogni soluzione, tanto valoriale quanto razionale» (p. 99). Invece che affidarsi alla scommessa nella fede, Cioran si proietta verso l’abisso del nulla, dell’assurdo indefinibile. Per farlo passa attraverso la follia, poi superata nella coniugazione di estetica e mistica proprie della musica. In Sentinella del nulla è offerta un’ampia e documentata analisi dei molteplici ed intricati “sentieri interrotti” percorsi da Cioran nel tentativo mai sopito di testimoniare l’esistenzialità nella sua crudezza, a partire da una commistione fra riflessione e linguaggio rivelativo dell’inesprimibilità del negativo. Tutto ciò è reso possibile attraverso l’allusione, l’enigma, l’ironia e la metafora, al punto di ridurre il più possibile la fallacia della definizione, precaria e mai fedele. Tale scelte stilistiche tentano l’impossibile coniugazione di dicibile e non esprimibile, rivalutando un pensare poetico con esiti differenti rispetto all’ontologia heideggeriana, ma ancora inadeguato all’ideale dell’inazione. Viene ad incarnarsi già nella parola scritta la contraddittorietà dell’esistenza, l’indifferenza di fronte ai giudizi di valore, la perdita delle coordinate attraverso cui la modernità ha consegnato all’uo131 mo l’effimero primato di essere razionale. La vertigine del nulla è scorta attraverso la rarefazione estetica che permette di guardare molto più a fondo del discorso argomentativo e che, «enfatizzando il tramonto, valorizza gli aspetti poetici di una presa di coscienza letteraria delle vicende umane» (Cioran, p. 151). Sono questi i parametri per restare fedeli ad una meditazione dirompente e crepuscolare al tempo stesso, che non vuole persuadere né primeggiare, ma solo manifestare un’intima e radicale consapevolezza. Il testo di Rizzacasa permette di addentrarsi all’interno dei meandri di una produzione florida e coerente nella sua inappagabile vorticosità contenutistica e metodologica, proponendo alternativi percorsi di lettura. La trattazione del pensiero del filosofo-poeta rumeno è infatti condotta in Sentinella del nulla mediante una suddivisione che focalizza innanzitutto i vari temi quali cellule indisgiungibili di un panorama che abbraccia le principali esperienze esistenziali dell’umanità, dalla religione alla politica, dal vissuto autobiografico al discorso sul filosofare. Viene offerto inoltre un excursus delle opere dell’Autore, esauriente nel ripercorrere in progressione cronologica l’evoluzione di ciò che nella prima parte è stato delineato in maniera sincronica; ed infine l’appendice critica, rassegna di prospettive interpretative, permette la formulazione di ulteriori confronti intorno alle molteplici problematiche aperte, lasciate in sospeso da Cioran in ottemperanza del suo stesso fare filosofico. La trattazione monografica è in grado così di fornire un ampio e documentato approfondimento del pensiero cioraniano, fruibile sia a chi già ne possieda i fondamenti, attraverso una capillare analisi dei singoli aspetti peculiari, sia a chi si avvicina all’Autore per la prima volta, e può soddisfare la necessità di conoscerne la “speculazione” accanto all’imprescindibile dato autobiografico. Il filo rosso di Sentinella del nulla è così rappresentato dal desiderio di testimoniare una interpretazione della contemporaneità non precipitata nel nonsenso ontologico, attraverso il tentativo di Cioran di salvare una tematizzazione in chiave filosofica ed esclusivamente esistenziale del negativo, di salvaguardare dal rischio estremo della civiltà tecnologica, in cui i mezzi si trasformano in fini, l’etica e la ricerca di senso, seppur riponendo quest’ultima nel titanismo negativo del nulla esistenziale, in un “attivismo trasvalutato” senza speranza di risposta. «Il negativo lo coinvolge, ma non si converte mai in eroismo» (p. 312). Né va dimenticata l’improduttività di cui Cioran fa sfoggio rispetto persino ad un pessimismo di matrice leopardiana e nietzscheana che, nonostante tutto, non negano la possibilità di una rinascita etica. La mancanza di esiti e di soluzioni rappresenta così la firma cioraniana e insieme il suo limite, di fronte ad una umanità che continua a pretendere risposte, ma a cui il pensatore riesce ad offrire un paradigma fondamentale per avviare una 132 riflessione crudemente consapevole della condizione umana, indipendentemente dalle scelte che ognuno possa in seguito abbracciare. È Cioran stesso a presentarsi come colui che si propone il compito di rinnovare un “risveglio dal sonno dogmatico”, attraverso una «forma di nichilismo religioso in cui il momento etico risiede nella rassegnazione passiva e nell’annientamento di ogni energia attiva perseguito con tutto l’impegno di una ascesi esistenziale» (p. 54). Eleonora Vitali 133 PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE” Volumi: P. ADDANTE, Antonio Rosmini. La persona umana. Malessere diagnosi e terapia dell’amore, Laruffa, Reggio Calabria 2008, pp. 204; Aristotle and the Aristotelian Tradition, a c. di E. De Bellis, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, pp. 514; A. ALVA PEREZ, Filmografia di Fusako Yusaki, Papermoon, Fano 2008, pp. 158; O. BIANCO, Vicenda del cosmo e condizione dell’uomo in Lucrezio e Virgilio, Adriatica Editrice Salentina, Lecce 2008, pp. 80; A. BRUNO, L’inquietudine della coscienza. Saggio sul pensiero esistenziale di Jean Nabert, Mimesis, Milano 2008, pp. 230;. M. CARBONE, Sullo schermo dell’estetica. La pittura, il cinema e la filosofia da fare, Mimesis, Milano 2008, pp. 132; M. CASELLA, Chiesa e società in Italia tra fascismo e democrazia. Il conflitto sulla laicità dello Stato (1943-1948), Congedo, Galatina 2008, pp. 420; V. CESARONE, Per una fenomenologia dell’abitare. Il pensiero di M. Heidegger come oikosophia, Marietti 1820, Genova-Milano 2008, pp. 242; F. FIORENTINO, Verità, bellezza e scienza. Temi di filosofia aristotelico-tomistica/1, Edi, Napoli 2008, pp. 380; S. GRECO, Nord Salento. Calibro 45, Smanubbrio, Acerra 2008, pp. 86; P. GUIDA, Scrittrici di Puglia. Percorsi storiografici femminili dal XVI al XX secolo, Congedo, Galatina 2008, pp. 494; Il tempo. Cinema e psicoanalisi, c. di M. Maisetti, F. Mazzei, L. Vitalone, Arti Grafiche Bianca & Volta, Milano 2008, pp. 112; L. IANNUZZI, D’Annunzio e la Comarella, Ianieri, Pescara 2008, pp. 160; W. G. JACOBS, Leggere Schelling, a c. di C. Tatasciore, Guerini e Associati, Milano 2008, pp. 168; La certezza incerta. Scritti su G. Semerari con due inediti dell’autore, a c. di F. Semerari, Guerini e Associati, Milano 2008, pp. 264; A. MAGRIS, Destino, provvidenza, predestinazione. Dal mondo antico al cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 648; P. MANGANARO, Filosofia della mistica. Per una pratica non-egologica della ragione, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, pp. 158; F. MINECCIA, Città e campagne di Romagna nell’Ottocento, Congedo, Galatina 2008, pp. 228; Nietzsche. Edizioni e interpretazioni, a c. di M. C. Fornari, Ets, Pisa 2006, pp. 548; R. E. PALMER, Cosa significa ermeneutica?, trad. it. A c. di G. Gallo, introd. di S. Ciurlia, Besa, Nardò s. d., ma 2008, pp. 508; P. PASTORI, Alla ricerca dell’ordine nuovo. Napoli e Palermo fra antico regime, rivo- 134 luzione e restaurazione (1759-1821), t. I, Poligrafico Fiorentino, Calenzano 2008, pp. XXII, 692; Poesia e Filosofia nel Novecento. Le voci dell’anima, intr. di S. Arcoleo, testi coord. da G. Ladolfi, S. F. I., Novara 2008, pp. 80; G. RIZZO, Esercizi fenomenologici. Esperienza della logica e logica dell’esperienza, Liguori, Napoli 2008, pp. 210; M. T. RUSSO, Oltre il presente liquido. Temi di antropologia ed etica sociale, Armando, Roma 2008, pp. 142; J.-P. SARTRE, Pensare l’arte, progetto di M. Sicard, a c. di F. Marcarino, Marinotti, Milano 2008, pp. 214; A. SEMERARO, Hypomnémata. Lessico di comunicazione sensibile, Besa, Nardò 2008, pp. 220; Periodici: Ar ch, n. s., VII, 2007-2008: Vetus ordo novus XVI; Publigrafic, Trepuzzi; Acta philosophica, f. II, n. 17, 2008; Pontificia Università della Santa Croce, F. Serra, Pisa-Roma; Aesthetica Preprint, n. 83, agosto 2008: Il sonno eloquente, a c. di M. Semi; C.I.S.d.E., Palermo; Aesthetica Preprint. Supplementa, n. 22, settembre 2008: F. MAUTHNER, La maledizione della parola; C.I.S.d.E., Palermo; Alpha Omega, a. XI, n. 1, gennaio-aprile 2008; Rivista di Filosofia e Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma; Bollettino Studi sartriani. Gruppo ricerca Sartre, a. IV, 2008; Sartre e la tradizione metafisica, Biblink, Roma; Carte di Cinema, n. 22, 2008 ; Istituto di Storia contemporanea, Ferrara; Chiasmi International, n. 10, 2008; Vrin-Paris, Mimesis-Milano, University of Memphis; Estudios Franciscanos, v. 109, n. 447, enero-agosto 2008; Provincias Capuchinas Ibéricas, Barcelona ; Foedus, n. 20, 2008; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Mestre; Giornale di Metafisica,n. s. a. XXX, 2008, n. 2; Tilgher, Genova; Hermeneutica, n. s., 2008: Polis e scienza; Morcelliana, Brescia; Idee, n. 67, 2008; Milella, Lecce; Itinerari, 1, 2, 2008; Ed. Itinerari, Lanciano; L’immaginazione, nn. 239, 240, 241, 242, 2008; Manni, San Cesario di Lecce; Màthesis. Revista de Educação, v. 8, n. 1, jan.-jun 2007; Faculdade de Jandaia do Sul, Paraná; Notes et documents, a. XXXIII, n. s., n. 10, janvier-avril; n. 11, mai-septembre 2008; Inst. Int. Jacques Maritain, Roma; Progresso del Mezzogiorno, a. XXXII, n. 2, 64° della serie; Scienza, filosofia e religione: loro rapporti e influssi per la pace e il progresso dei popoli, p. II; Loffredo, Napoli 2008; Proyección, n. 230, julio-septiembre 2008; Facultad de Teología de Granada; Psychofenia. Ricerca ed analisi psicologica, a. XI, n. 18, 2008; Pensa multimedia, Lecce; Quaderno di comunicazione, n. 9, n. s. , 2008: Reincanto/Disincanto; Meltemi, Roma; Rivista di Filosofia, n. 2, 2008; il Mulino, Bologna; Rivista di filosofia, n. 3, 2008; L’utilitarismo; un’etica dell’esperienza, a c. di E. Lecaldano; Il Mulino, Bologna; Rivista di Studi Utopici, n. 5, aprile 2008; Centro Interdipardimentale di Studi Utopici; Carra, Casarano; Studia Patavina, n. 2, a. LV, maggio-agosto 2008; Facoltà Teologica del Triveneto, Padova.
Scarica