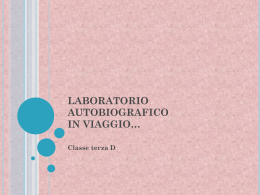J. J. Rousseau La vita di J. J. Rousseau L’autobiografia in Rousseau Le confessioni di J. J. Rousseau Le fantasticherie del passeggiatore solitario La vita di J. J. Rousseau Jean-Jacques Rousseau nacque a Ginevra il 28 giugno 1712 da un modesto artigiano di origine francese, calvinista; la madre morì nel darlo alla luce. La precoce scomparsa della madre segnerà in modo drammatico la vita di Rousseau. II padre non si preoccupa di dargli un'educazione formale e regolare, incoraggiando invece letture disordinate, romanzesche e fantasiose. Nel 1722 il padre viene costretto a lasciare Ginevra per evitare l'arresto perché coinvolto in una rissa e Rousseau viene affidato a uno zio: era l'inizio di una adolescenza e di una giovinezza difficili ed errabonde, dallo stesso Rousseau descritte con grande raffinatezza introspettiva nei primi capitoli delle Confessioni. L'educazione presso il pastore Lambercier, a Bossey, con lo studio del latino, di Plutarco, degli stoici (vedi pag. 5-7); il ritorno a Ginevra nel 1724 e gli impieghi presso un notaio e un incisore. Lavora, dedicando il tempo libero alla lettura e alle proprie solitarie fantasticherie, un'abitudine che lo accompagnerà negli anni. Una sera in cui si spinge, passeggiando, oltre le mura cittadine senza accorgersi del trascorrere del tempo, rimane chiuso fuori; è la spinta ad andarsene, a inaugurare, a sedici anni, una vita di vagabondaggio (vedi pag. 7-9). Dopo varie vicissitudini, trova protezione a Chambery presso Madame de Warens, (vedi pag. 10-11) una dama dedita alla difesa del cattolicesimo a cui lo lega dapprima un affetto filiale e poi una relazione amorosa. Madame de Warens lo invia a educarsi nell'opprimente Ospizio dello Spirito Santo di Torino (dove anche Jean-Jacques abbraccia la religione cattolica). Lacchè di un aristocratico, studente di seminario, maestro di musica, Rousseau trascorre diversi anni ramingo per l'Europa (Lione, Friburgo, Losanna, Neuchatel, Berna) senza riuscire a trovare una collocazione stabile. Raggiunta infine a Chambery Madame de Warens, "Maman", ne diviene l'amante, pur dovendo dividerne i favori con l'intendente di lei. A Chambery Rousseau trascorre alcuni anni tranquilli, rassicurato affettivamente, a contatto con la natura, immerso nelle letture e negli studi (vedi pag. 13-17) .. Ma la comparsa di un nuovo favorito della sua amante-protettrice (vedi pag. 17-18) lo costringe a nuove peregrinazioni: prima a Lione, come precettore e impiegato di catasto, poi a Parigi, dove il giovane provinciale fa il suo primo incontro con i philosophes e con la brillante vita culturale e mondana della capitale. Dopo un soggiorno a Venezia come segretario dell'ambasciatore francese, nel 1745 Rousseau ritorna a Parigi, dove incomincia a farsi conoscere per i suoi studi di teoria musicale e per alcune opere teatrali, sia pure di scarso successo: gli vengono così affidate le voci musicali dell'Encyclopédie. Nel frattempo si unisce a una giovane cucitrice, Marie-Thérèse Le Vasseur, che sarà sua compagna per il resto della vita e dalla quale avrà cinque figli, tutti abbandonati alla pubblica carità (vedi pag. 20). Il grande esordio letterario e filosofico di Rousseau è il Discorso sulle scienze e le arti, scritto per il concorso bandito nel 1749 dall'Accademia di Digione sul tema: "La rinascita delle scienze e delle arti ha contribuito a corrompere o a purificare i costumi?". La conquista del primo premio, ma ancor più le clamorose tesi sostenute da Rousseau, che provocarono un esteso e vivacissimo dibattito, diedero all'autore un'immediata celebrità. Infastidito, Rousseau, con uno dei suoi gesti tipici, rifiutò il ruolo di letterato "alla moda" (compresa la pensione regia) e si appartò, riducendosi a copiare musica per sopravvivere (vedi pag. 21-30). La seconda grande opera del ginevrino, il Discorso sull'origine della disuguaglianza fra gli uomini, del 1754, ancora per l'Accademia di Digione, non ottenne altrettanto successo: ma ormai Rousseau era diventato un "caso" nel mondo culturale e filosofico francese. Nel maggio 1754 Rousseau fece ritorno a Ginevra, ottenendo solennemente il titolo di cittadino dalla repubblica alla quale aveva dedicato il secondo Discorso, e si convertì nuovamente al calvinismo. Gli anni successivi furono quelli di maggiore fecondità del suo pensiero: prima nel castello 1 dell'Ermitage, presso Parigi (vedi pag.30), ospite di Madame d'Epinay, poi a Mont-Louis, sotto la protezione del duca di Montmorency, Rousseau scrisse Giulia o la Nuova Eloisa, nel 1761, e Il Contratto sociale ed Emilio nel 1762. Ma nello stesso tempo maturava la rottura con gli enciclopedisti, causata da una profonda divergenza nel modo di concepire la filosofia e il ruolo dell'intellettuale, nonché da incomprensioni personali, molte delle quali originate dal carattere rigido e instabile di Rousseau, dalla sua volontà di sottolineare in ogni modo la propria diversità ed eccezionalità. Di tali aspetti del suo carattere sono testimoni le Confessioni. Alla rottura con gli enciclopedisti si sommano in questi anni le aspre reazioni suscitate dal Contratto sociale e dall'Emilio, opere peraltro di enorme successo: condannato dall'arcivescovo di Parigi, Christophe de Beaumont, e dal parlamento di quella città per la visione naturalistica della religione esposta nella celebre Professione di fede del vicario savoiardo (contenuta nell'Emilio), Rousseau fu costretto a lasciare nuovamente la Francia per la Svizzera, recandosi a Môtiers, dove rimase sino al 1765. Ma anche i pastori dell'idealizzata repubblica ginevrina lo delusero, condannando le sue opere, tanto che egli rinunciò alla cittadinanza. Coinvolto nei conflitti che opponevano l'oligarchia ginevrina, i borghesi e i "nativi", privi di diritti civili, Rousseau condusse nelle Lettere scritte dalla montagna una lucida analisi delle contraddizioni del sistema politico della repubblica e un violento attacco contro l'intolleranza della locale chiesa calvinista. La condanna dell'opera da parte dei magistrati ginevrini e un feroce libello di Voltaire, dove tra l'altro si rivelava l'abbandono dei figli da parte di Rousseau, resero per quest'ultimo la situazione insostenibile, costringendolo a rifugiarsi sul lago di Bienne (vedi pag. 32-36), in territorio bernese, e quindi in Inghilterra, su invito di Hume (1766). Ma anche il rapporto con il filosofo inglese si deteriorò rapidamente: l'equilibrio psichico di Rousseau si fa sempre più instabile, egli vede ovunque complotti, derisione, persecuzioni ai suoi danni. Rousseau torna quindi in Francia e dopo diversi viaggi nelle regioni francesi meridionali è di nuovo a Parigi. Appartengono a questa fase, tuttavia, altre opere importanti: gli scritti politici Progetto di costituzione per la Corsica (1768) e Considerazioni sul governo della Polonia (1772), in cui Rousseau dà applicazione concreta ad alcune delle tesi esposte nel Contratto sociale, ma soprattutto i grandi scritti autobiografici: le straordinarie Confessioni - un'opera che eserciterà una notevole influenza sull'evoluzione dell'analisi introspettiva che si va affermando nel romanzo all'interno della letteratura europea - i dialoghi Rousseau giudice di Jean- Jacques (1772-76), e le Fantasticherie di un passeggiatore solitario (1776-78). Durante questo periodo parigino si aggrava la mania di persecuzione che da tempo lo tormenta. Ritiratosi nella tenuta di Ermenonville, ospite del marchese de Girardin, muore nel 1778. Nel 1794, sotto il governo della repubblica giacobina, le ceneri di Rousseau sono portate nel Pantheon di Parigi. L’autobiografia in Rousseau L'ultimo quindicennio della vita di Rousseau, profondamente segnato dalla sofferenza e da fasi di perdita della lucidità in forma di vero e proprio delirio persecutorio, è però anche l'epoca della grande riflessione autobiografica. Questa è condotta in primo luogo nelle Confessioni, che narrano dettagliatamente la vita del ginevrino dalla nascita alla fine del 1765, alla vigilia cioè dell'infelice esperienza in Inghilterra presso David Hume, e poi nei dialoghi Rousseau giudice di Jean-Jacques e nelle Fantasticherie di un passeggiatore solitario. Rousseau ripercorre nella forma di una intensa e spesso sofferta meditazione molte delle tematiche che avevano attraversato la sua riflessione filosofica. Senza la pretesa di dare conto della complessità dell'opera autobiografica del ginevrino, vale la pena di indicare qualche filo conduttore di queste pagine, che hanno, tra l'altro, grande dignità letteraria. 2 II valore conoscitivo della meditazione interiore Conviene partire dalla frase celebre che apre il primo libro delle Confessioni: «Mi impegno in una impresa senza esempio, e la cui esecuzione non avrà imitatori. Voglio mostrare ai miei simili un uomo nella nuda verità della sua natura; e quest'uomo sarò io». L'autobiografia è così innanzitutto ricerca di quella trasparenza che, in un mondo dominato dal dissidio fra essere e apparire, si pone non come un dato, ma come un compito esemplare da realizzare. Rousseau afferma il valore di conoscenza che è contenuto nel rientrare in se stessi, nel ritrovare nell'immediatezza del rapporto con il proprio animo la verità della propria natura. Anche se non segue i percorsi della razionalità discorsiva, anche se, addirittura, avviene più profondamente nell'abbandonarsi alla "fantasticheria", il ritorno in se stessi non è un atto irrazionale, un'effusione sentimentale: per Rousseau scrive Jean Starobinski — «rientrare in se stesso vuol dire avvicinarsi a colpo sicuro a una maggiore chiarezza razionale e a una evidenza immediatamente sensibile, in opposizione al nonsenso che regna nella società». L'agostiniano in te ipsum redi trova in Rousseau un nuovo significato: se le Confessioni di Agostino erano uno svelamento della luce divina all'interno dell'anima, quelle di Rousseau sono un atto di ricerca dell'autenticità dell'io, della sua natura, condotto in un contesto di vita dominato dall'inautenticità e dall'opacità delle relazioni fra gli individui e di ogni individuo con se stesso, specificamente al livello culturale cui si è pervenuti nella società contemporanea. È questo un punto che merita di essere sottolineato: nell'autobiografia Rousseau non mostra solo un percorso di conoscenza di sé, ma mostra se stesso al fine di essere conosciuto dagli altri. Per richiamarci ancora ad Agostino, potremmo dire che mentre le confessioni del vescovo di Ippona avevano luogo sotto lo sguardo di Dio, quelle di Rousseau sono sotto lo sguardo degli altri: uno sguardo che si costituisce immediatamente non appena dalla dimensione dell'individuo singolo, irrelato, si passa a quella dell'individuo sociale, che confronta, paragona, giudica. Rousseau ha la certezza di non essere compreso, di venire misconosciuto e quindi fatto oggetto di un'ingiustizia, poiché — come egli dice di se stesso — «giustizia e verità sono, nel suo spirito, sinonimi di cui usa indifferentemente» una certezza che lo accompagna sempre, raggiungendo a volte dimensioni ossessive, patologiche. Per dissolvere questo errore Rousseau vuole che tutti leggano nel suo cuore, perché il giudizio degli altri sia infine equilibrato e giusto. La meditazione autobiografica di Rousseau trascorre così continuamente fra la particolarità di una vicenda individuale e l'universalità di un'esperienza esemplare. Che titoli ha Jean-Jacques per imporre al lettore la propria storia? Non è uomo di rango, non è re né vescovo. Ebbene, questi titoli gli vengono dalla consapevolezza della eccezionalità della propria figura: «Non sono fatto come nessuno di quelli che ho incontrati; oso credere di non essere come nessuno di quanti esistono. Se non valgo di più sono almeno diverso. Se la natura abbia fatto bene o male rompendo lo stampo nel quale mi ha colato, non si potrà giudicare che dopo avermi letto» (Confessioni, I). E un'eccezionalità che viene dall'interno, dalle idee e dal pensiero, e che cancella il dato della condizione sociale: «Non mi si faccia l'obiezione che, essendo solo un uomo del popolo, non posso dir nulla che meriti l'attenzione dei lettori. Per quanto oscuramente abbia potuto vivere, se ho pensato più e meglio dei re, allora la storia del mio animo è più interessante della loro». Rousseau sembra così indicare l'assoluto valore e la piena dignità di quella indagine dell'uomo, di qualunque uomo, su se stesso che sarà uno dei grandi temi della cultura e della letteratura successive. 3 La "marginalità" sociale e la solitudine intellettuale di Rousseau L'importanza della collocazione sociale dell'uomo Rousseau non va sottovalutata: «uomo del popolo», Jean-Jacques ha percorso una "carriera" assolutamente originale rispetto a quelle degli intellettuali del suo tempo. Lo studioso Baczko ha utilizzato per descriverla il concetto di "marginalità sociale", una marginalità che Rousseau vive e presenta a un tempo «come voluta e come imposta, come scelta e come subita». E imposta nel giovane vagabondo, escluso dalla città natale, che fa esperienza di vera e propria povertà; è imposta, ancora, nell'intellettuale debuttante che dalla periferia si affaccia al gran mondo parigino dei letterati. Poi, il successo, le amicizie con i philosophes, la vita smagliante dei salotti, in cui peraltro JeanJacques si mostra incerto, imbarazzato, privo di esprit. Anche nel momento del successo, Rousseau mantiene tratti e comportamenti del "marginale": il legame con una donna semianalfabeta, l'abbandono dei figli. Dopo il 1756, la rottura, la "marginalità voluta": la scelta di copiare musica per campare, il divorzio violento dall'ambiente della philosophie, la solitudine, i nuovi vagabondaggi, la ricerca fallita di nuove radici a Ginevra. Rousseau colloca se stesso ai margini di quel mondo in cui era infine riuscito ad affermarsi. C'è un' ambiguità profonda nella marginalità di Rousseau: come scrive Baczko, «essere senza radici, straniero nel mondo, è per Jean-Jacques nello stesso tempo un destino crudele e il più grande privilegio che egli rivendica». E la solitudine, infatti, intesa come non integrazione sociale che apre a colui che non ha "stato", che non è "nulla", lo spazio per mostrare a tutti com'è l'uomo "naturale", l'uomo nella sua vera essenza. Ed è la solitudine, intesa come dimensione esistenziale, che consente di appartenere esclusivamente a se stessi e alla natura. La tensione fra solitudine e socialità, l'essere per se stessi e l'essere per il mondo, attraversa in profondità tutta l'opera di Rousseau. Quando Diderot, in uno scritto del 1756, afferma perentoriamente «Soltanto il malvagio è solo», Rousseau si sente direttamente chiamato in causa dall'amico; la sua autobiografia si può leggere anche come un lungo, ripetuto tentativo di difendersi da questo giudizio. Scrivendo a Malesherbes, Rousseau giustifica così la propria scelta di isolamento all'Ermitage: «Amo troppo gli uomini per avere bisogno di scegliere fra di loro, li amo tutti, ed è proprio perché li amo che odio l'ingiustizia, è perché li amo che li fuggo». Impossibile amare gli uomini rimanendo prigionieri del mondo delle convenzioni e dell'apparenza. Ma vi è anche un altro aspetto: solo nella solitudine è possibile la vera felicità, che è espansione della propria esistenza, incontro con la natura. Non a caso l'immagine dell'isola ricorre con tanta frequenza nella scrittura di Rousseau; e non a caso è su un'isola, quella di Saint-Pierre nel lago di Bienne, che Rousseau trascorre uno dei momenti più intensamente felici della propria esistenza, fantasticando e contemplando per giorni in una condizione di piena immedesimazione con l'ordine naturale (esperienza descritta nella quinta passeggiata): «Di che cosa si gioisce in uno stato simile? Di niente di esteriore, di niente se non di se stessi e della propria esistenza; finché dura questa condizione, siamo sufficienti a noi stessi, come Dio». 4 LE CONFESSIONI DI J. J. ROUSSEAU Libro Primo Libro Secondo Libro Terzo Libro Quinto Libro Sesto Libro Settimo Libro Ottavo Libro Nono Libro Primo Mi accingo ad un'opera senza esempi e senza imitatori. Voglio mostrare ai miei simili un uomo in tutta la verità della natura, e quest'uomo sarò io, io solo. Sento il mio cuore e conosco gli uomini. Non sono come alcun altro da me conosciuto, e oso credere di non essere fatto come alcun altro che esista. Se non valgo di più sono, almeno, diverso. Se la natura ha operato bene o male nello spezzare la forma nella quale mi ha plasmato, ciò non si può giudicare che dopo avermi ascoltato. Suonino quando vogliono le trombe dell'estremo giudizio, io andrò e, con questo libro in mano, mi presenterò al giudice supremo. Dirò sicuro: « Ecco ciò che ho fatto, ciò che ho pensato, ciò che sono stato. Ho detto il bene ed il male con la stessa franchezza. Non ho taciuto niente di cattivo, non ho aggiunto niente di buono: e se talvolta ho aggiunto qualche indifferente ornamento non è stato che per colmare un vuoto dovuto alla debolezza della mia memoria. Ho potuto pensare come vero ciò che sapevo avrebbe potuto esserlo, non ciò che sapevo essere falso. Mi sono mostrato quale sono stato, spregevole e vile, buono, generoso e sublime. Ho svelato il mio intimo così come Tu stesso l'hai visto, Essere eterno. Raccogli attorno a me l'innumerevole folla dei miei simili: che ascoltino le mie confessioni, che arrossiscano per le mie indegnità, che gemano per le mie miserie; che ciascuno d'essi, a sua volta, apra il suo cuore con la stessa sincerità ai piedi del tuo trono e poi uno solo Ti dica, se osa: «io fui migliore di quell'uomo». . . . Così, risalendo alle prime tracce della mia sensibilità, trovo degli elementi che, pur sembrando qualche volta incompatibili, si sono uniti e fusi in un effetto unico e semplice; e ne trovo degli altri che uguali, in apparenza, hanno formato delle combinazioni così diverse, per il concorso di determinate circostanze, che non si penserebbe mai potessero avere tra loro alcun rapporto. Chi crederebbe per esempio che una delle migliori energie della mia anima scaturì dalla stessa fonte dalla quale attinsi la lussuria e la mollezza? Senza abbandonare l'argomento del quale ho parlato, ne trarrete ora una impressione molto diversa. Un giorno studiavo da solo la mia lezione nella stanza vicina alla cucina. La cameriera aveva messi ad asciugare sulla mensola i pettini della sua padrona. Quando ritornò a prenderli trovò tutto un lato rotto. Chi incolpare di questo danno? Io solo ero entrato nella stanza. Venni interrogato e negai di aver toccato il pettine. Il signore e la signorina Lambercier insieme mi esortarono, mi minacciarono, mi pressarono, io insistei con ostinazione: ma la loro convinzione era troppo forte e non credettero a tutte le mie proteste, sebbene fosse la prima volta che mi trovavano così audace nella menzogna. La cosa fu presa sul serio; lo meritava. La bricconeria, la menzogna, l'ostinazione parvero ugualmente degne di punizione: ma la punizione non ci fu data dalla signorina Lambercier. Scrissero a mio zio Bernard, ed egli venne. Il mio povero 5 cugino doveva scontare un'altra colpa non meno grave: fummo inclusi nella stessa esecuzione che fu terribile. Se, cercando il rimedio nel male stesso, avessero voluto far tacere per sempre i miei sensi depravati, non avrebbero potuto far meglio. Essi mi lasciarono in pace per lungo tempo. Non poterono strapparmi la confessione che volevano. Punito di nuovo e di nuovo ridotto nello stato più spaventoso, fui irremovibile. Avrei sopportata la morte, ero deciso. E la forza dovette cedere al diabolico incaponimento di un fanciullo; non diversamente fu chiamata la mia costanza. Uscii infine da questa prova crudele a brandelli, ma vittorioso. Adesso sono passati quasi cinquanta anni da questa avventura e non ho paura di essere punito da capo per la stessa causa. Ebbene! Posso dire al cospetto del cielo che ero innocente, che non avevo, né toccato, né rotto il pettine, che non mi ero avvicinato alla mensola e che non ci avevo neanche pensato. Non mi si domandi come è successo quel malanno; non lo so e non riesco a capirlo: ciò che so con certezza è che ero innocente. Pensate, un carattere timido e docile nella vita ordinaria, ma ardente, fiero, indomabile nelle passioni, un ragazzo governato sempre dalla voce della ragione, trattato sempre con dolcezza, equità, benevolenza; che non aveva neanche l'idea della ingiustizia, e che, per la prima volta, ne prova una così terribile, proprio da coloro che ama e rispetta di più. Che capovolgimento di pensieri, che tumulto di sentimenti! Che sconvolgimento nel suo cuore, nella sua testa, in tutto il suo piccolo essere morale! Immaginate, se potete, tutto ciò: è impossibile; io, per conto mio, non mi sento capace di distinguere, di seguire la pur minima traccia di ciò che allora si agitava in me. La mia ragione non era ancora in grado di capire come le apparenze mi condannavano e di mettermi al posto degli altri. Quello che sentivo era solo tutta la durezza di una punizione terribile per una colpa che non avevo commessa. Il dolore fisico, sebbene acuto, lo sentivo poco; non sentivo che la indignazione, l'ira, la disperazione. Mio cugino, che era in condizioni quasi simili, punito di una colpa involontaria, come per un atto premeditato, andava in furia, sul mio esempio, e si montava, per dir così, al mio unisono. E tutti e due nello stesso letto ci abbracciavamo con uno slancio convulso, soffocavamo; e quando i nostri giovani cuori, un poco alleviati, potevano sfogare la loro ira, ci mettevamo a sedere e gridavamo insieme cento volte, con tutte le nostre forze: « Carnefice, carnefice, carnefice ». Scrivendo, sento che il mio polso si agita ancora; questi momenti mi saranno sempre presenti, dovessi vivere anche centomila anni. Questa prima impressione della violenza e dell'ingiustizia è rimasta così profondamente incisa nella mia anima che tutte le idee che vi si riferiscono me la fanno rivivere. Ed essa, relativa a me alla sua origine, ha acquistato una tale forza per se stessa, si è talmente liberata da ogni interesse personale che il mio cuore si accende alla vista, o al racconto, di qualsiasi azione ingiusta, qualunque ne sia l'oggetto e in qualunque luogo venga commessa, come se i suoi effetti ricadessero su me. Quando leggo delle crudeltà di un tiranno feroce, delle sottili malvagità della furbizia di un prete, partirei volentieri per prendere a pugni questi miserabili; dovessi per ciò morire cento volte. Spesso mi sono lanciato a inseguire, o con la corsa, o a colpi di pietre, un gallo, una vacca, un cane, un animale che vedevo tormentarne un altro solamente perché si sentiva il più forte. Questo sentimento forse mi è naturale, e credo che lo sia, ma l'impressione della prima ingiustizia che soffersi vi rimase troppo a lungo e troppo fortemente legata per non averlo molto rafforzato. Finì allora la serenità della mia vita di fanciullo. Da quel momento cessai di gioire di una felicità piena, e anche oggi sento che là si arresta il ricordo degli incanti della mia fanciullezza. Restammo a Bossey ancora per qualche mese. Ci restammo come ci viene raffigurato il primo uomo che è ancora nel paradiso terrestre, ma ha cessato di gioirne. In apparenza la situazione era immutata, ma in realtà era tutta un'altra maniera di essere. L'attaccamento, l'intimità, il rispetto, la confidenza, non 6 legavano più gli alunni alle loro guide; non li guardavamo più come dei, capaci di leggere nei nostri cuori; eravamo meno vergognosi di agire male, e più timorosi di essere accusati, cominciavamo a nasconderci, a ribellarci, a mentire. Tutti i difetti della nostra età guastavano la nostra innocenza e rendevano brutti i nostri giuochi. Anche la campagna perdette ai nostri occhi quel fascino di dolcezza e di semplicità che arriva al cuore: ci sembrava deserta e cupa, si era come coperta di un velo che ce ne nascondesse le bellezze. Smettemmo di coltivare i nostri piccoli giardini, i nostri fiori, le nostre erbe. Non andammo più a smuovere leggermente la terra e a gridare di gioia scoprendo il germe del grano che avevamo seminato. Ci disgustammo di questa vita; gli altri si disgustarono di noi; mio zio ci ritirò e ci separammo dal signore e dalla signorina Lambercier stanchi gli uni degli altri e poco dispiaciuti di lasciarci. Sono passati quasi trent'anni da quando ho lasciato Bossey e mai ne ho ricordato piacevolmente il soggiorno per alcuni ricordi che vi si connettono; ma, ora che ho superata l'età adulta e declino verso la vecchiaia, sento che questi ricordi rinascono mentre gli altri si cancellano; essi si incidono nella mia memoria con dei tratti il cui fascino e la cui nitidezza aumentano di giorno in giorno; come se volessi riafferrare dal suo inizio la vita che sfugge. Anche i più piccoli particolari di allora mi piacciono per la sola ragione che sono di allora. E ricordo tutti i particolari dei luoghi, delle persone, delle ore. . . . Così, determinata la mia vocazione, fui mandato come apprendista non da un orologiaio, ma da un incisore. Il mio maestro, signor Ducomun, era un giovane villano e violento che in pochissimo tempo riuscì a spegnere tutto il brio della mia infanzia, ad abbrutire il mio carattere affettuoso e vivace, e a ridurmi, nello spirito, come lo ero stato dalla fortuna, alla mia vera condizione di apprendista. Il mio latino, le mie antichità, la mia storia, tutto fu, per lungo tempo, dimenticato; non ricordavo neanche che al mondo vi erano stati dei Romani. Mio padre, quando andavo a trovarlo, non ritrovava più in me il suo idolo: per le signore non ero più il galante Gian Giacomo; ed io stesso sentivo che il signore e la signorina Lambercier in me non avrebbero più riconosciuto il loro allievo, che avrei avuto vergogna di ripresentarmi a loro, e da allora non li ho più visti.. . . Il lavoro non mi dispiaceva in se stesso; amavo molto il disegno: il giuoco del bulino mi divertiva abbastanza; poiché nell'orologeria l'abilità dell'incisore è molto limitata, speravo di raggiungervi la perfezione. Ci sarei forse arrivato, se la brutalità del mio maestro e la eccessiva soggezione non mi avessero allontanato dal lavoro. Gli rubavo il mio tempo per impiegarlo in occupazioni dello stesso genere, ma che avevano per me il fascino della libertà. Incidevo delle specie di medaglie che dovevano servire a me e ai miei compagni come ordine cavalleresco. Il mio maestro mi sorprese in questo lavoro di contrabbando e mi bastonò di santa ragione, dicendo che mi esercitavo a coniare monete false, giacché le nostre medaglie portavano le armi della repubblica. Posso giurare che non avevo nessuna idea della moneta falsa e molto poca della vera. Sapevo molto meglio come si facevano gli assi romani, che i nostri pezzi da tre soldi. La tirannia del mio maestro finì col rendermi insopportabile il lavoro che avrei amato e col darmi dei vizi che avrei odiato, come la menzogna, la fannullaggine, il furto. Niente, meglio del ricordo dei cambiamenti che produsse in me quest'epoca, mi ha insegnato che differenza esiste tra la sottomissione filiale e la schiavitù servile. Timido e vergognoso per natura, mai per alcun difetto ebbi maggiore repulsione che per la sfrontatezza; ma avevo goduto di una libertà onesta che solamente si era ritratta fin là per gradi e che infine scomparve del tutto. Ero franco con mio padre, libero con il signor Lambercier, prudente con mio zio; divenni timoroso col mio maestro, da allora fui un ragazzo perduto. Abituato ad una uguaglianza perfetta con i miei superiori nella maniera di vivere, a non conoscere un piacere che non fosse alla mia portata, a non vedere un cibo del quale non avessi la mia parte, a non avere un desiderio che non manifestassi, a mettere, 7 infine, tutti i movimenti del mio cuore sulle mie labbra; si giudichi quello che potei diventare, in una casa dove non osavo aprire bocca, dove dovevo alzarmi da tavola a metà del pranzo e uscire dalla stanza non appena non avevo più niente da farvi, dove, continuamente inchiodato al mio lavoro, non vedevo che oggetti di gioia per gli altri e privazioni solo per me, dove la vista della libertà del maestro e dei compagni aumentava il peso del mio assoggettamento, dove nelle discussioni su cose che sapevo meglio di tutti non osavo aprire bocca, dove infine tutto quello che vedevo diventava per me oggetto di desiderio ardente, solo perché ero privo di tutto. Addio disinvoltura, gaiezza, parole spiritose che prima spesso nei miei falli mi avevano fatto sfuggire al castigo. . . . Raggiunsi così i sedici anni, inquieto, scontento di tutto e di me, senza interesse per il mio stato, senza i piaceri della mia età, divorato da desideri di cui ignoravo l'oggetto, piangendo senza ragione di pianto, sospirando senza sapere perché; infine carezzando teneramente le mie chimere, per non vedere attorno a me niente che valesse quanto loro. Le domeniche, dopo la predica, i miei compagni venivano a cercarmi perché andassi a divertirmi con loro. Sarei loro sfuggito volentieri, se avessi potuto: ma una volta impegnato nei loro giuochi ero più ardente e andavo più lontano di un altro; difficile a scuotere e a fermare. Questa in tutti i tempi fu la mia caratteristica costante. Nelle nostre passeggiate fuori della città andavo sempre avanti senza pensare al ritorno, a meno che degli altri non vi pensassero per me. Vi caddi due volte; le porte furono chiuse prima che potessi arrivarvi. Il giorno dopo fui trattato come si immagina; e la seconda volta mi fu promessa una tale accoglienza per la terza che decisi di non espormivi. Ma questa terza volta così temuta arrivò lo stesso. La mia precauzione fu resa vana da un maledetto capitano che si chiamava signor Minutoli e che chiudeva la sua porta una mezz'ora prima delle altre. Tornavo con due compagni. A mezza lega dalla città, sentii suonare la ritirata, raddoppiai il passo; sentii battere il tamburo, corsi a gambe levate; arrivai sfiatato, grondante di sudore; il cuore mi batteva, da lontano vidi i soldati al loro posto; accorsi, gridai con voce spezzata; era troppo tardi. A venti passi dal posto avanzato, vidi levare il primo ponte: fremetti vedendo nell'aria questi corni terribili, sinistro e fatale auspicio del destino inevitabile che in quel momento cominciava per me. Nel primo impeto del mio dolore mi gettai sullo spalto e morsi la terra. I miei compagni ridevano della loro sventura e presero subito la loro decisione. Io presi pure la mia, ma fu diversa. Su quel luogo stesso giurai di non ritornare mai dal mio maestro; e il giorno dopo, quando all'ora dell'apertura essi rientrarono in città, dissi loro addio per sempre pregandoli solo d'avvertire segretamente mio cugino Bernard della risoluzione da me presa e del luogo dove avrebbe potuto vedermi ancora una volta. Da quando avevo cominciato a fare l'apprendista, poiché ero più lontano da lui, lo avevo visto meno. Pur non di meno per qualche tempo ancora ci riunivamo le domeniche; ma, insensibilmente, ognuno prese abitudini diverse e ci vedemmo più raramente. Sono convinto che sua madre contribuì molto a questo cambiamento. Lui era un ragazzo della buona società; io, misero apprendista, non ero più che un ragazzo di Saint-Gervais. Non vi era più uguaglianza, malgrado la nascita; frequentarmi era mancare alla propria dignità. Tuttavia i legami non cessarono del tutto tra di noi; e poiché era un ragazzo buono di natura qualche volta seguiva il suo cuore, malgrado le lezioni di sua madre. Saputa la mia decisione accorse non per dissuadermi o dividerla, ma per darmi con dei piccoli regali qualche piacere nella mia fuga: poiché le mie risorse non potevano condurmi molto lontano. Mi regalò tra l'altro una piccola spada della quale ero molto innamorato e che ho portato fino a Torino dove me ne disfeci o, come si dice, me la sono passata attraverso il corpo. Più ho riflettuto, dopo, sul suo modo di comportarsi con me in questo momento critico, più mi sono convinto che seguì le istruzioni di sua madre e forse di suo padre; perché non è possibile che, spontaneamente, non avesse fatto qualche sforzo 8 per trattenermi, o che non avesse tentato di seguirmi. Ma basta: mi incoraggiò nel mio progetto anziché distogliermi; poi, quando mi vide ben deciso, mi lasciò senza troppe lacrime. Non ci siamo mai scritti, né rivisti. Peccato! era di un carattere essenzialmente buono; eravamo fatti per amarci. Prima di abbandonarmi alla fatalità del mio destino, mi si permetta di volgere un momento gli occhi su quello che mi avrebbe atteso se fossi caduto nelle mani di un maestro migliore. Niente era più confacente alla mia inclinazione, né più adatto a rendermi felice che, lo stato tranquillo e oscuro di un buon artigiano, specialmente in certe classi, come è a Ginevra quella degli incisori. Questo stato, abbastanza lucroso per dare una vita agiata, e non abbastanza per condurre alla fortuna, avrebbe limitata la mia ambizione per il resto dei miei giorni e, lasciandomi un ozio meritato per coltivare dei piaceri moderati, mi avrebbe trattenuto nel mio stato, senza offrirmi alcun mezzo per uscirne. Con un'immaginazione abbastanza ricca per ornare ogni stato con le sue chimere, abbastanza forte per trasportarmi, per così dire, dall'uno all'altro, non mi importava in quale fossi in realtà. Non poteva esservi tanta distanza dal luogo nel quale ero al primo castello di Spagna, che non mi fosse facile fermarmici. Da ciò soltanto seguiva che lo stato più semplice, quello che dava meno imbarazzi e preoccupazioni, quello che lasciava lo spirito più libero, era quello che mi si addiceva di più ed era precisamente il mio. Avrei vissuto nel seno della mia religione, della mia patria, della mia famiglia, e dei miei amici una vita tranquilla e dolce, quale era necessaria al mio carattere, nell'uniformità di un lavoro di mio gusto e di una società secondo il mio cuore. Sarei stato buon cristiano, buon cittadino, buon padre di famiglia, buon amico, buon artigiano, un buon uomo in tutto. Avrei amato il mio stato, lo avrei onorato forse; e dopo aver passato una vita oscura e semplice, ma uniforme e dolce, sarei morto in pace in mezzo ai miei cari. Ben presto dimenticato, senza alcun dubbio; sarei stato tuttavia rimpianto sinché si fossero ricordati di me. Invece... Quale racconto sto per fare! Ah! non facciamo anticipazioni sulle miserie della mia vita, non occuperò che troppo i miei lettori su questo triste argomento. Libro Secondo Tanto mi era sembrato triste il momento in cui il terrore mi aveva suggerito il progetto di fuggire, tanto mi sembrò bello quello in cui lo eseguii. Lasciare il mio paese ancora fanciullo, i miei parenti, i miei appoggi, le mie risorse, lasciare un apprendistato fatto a metà senza conoscere abbastanza il mio mestiere per viverne; slanciarmi verso gli orrori della miseria, senza vedere nessun mezzo per uscirne; espormi nell'età della debolezza e dell'innocenza a tutte le tentazioni del vizio e della disperazione; cercare lontano i mali, gli errori, le insidie, la schiavitù e la morte, sotto un giogo molto più inflessibile di quello che non avevo potuto soffrire; ecco quello che stavo per fare, era questa la prospettiva che avrei dovuto guardare in faccia. Come me la dipingevo diversa! L'indipendenza che credevo di aver conquistata era il solo sentimento che mi commoveva. Libero e padrone di me stesso, credevo di poter fare tutto, giungere a tutto: non dovevo che lanciarmi per innalzarmi e volare nell'aria. Entravo con sicurezza nel vasto mondo; il mio merito lo avrebbe riempito, ad ogni passo mi avviavo a trovare feste, tesori, avventure, amici pronti a servirmi, donne desiderose di piacermi; mostrandomi, stavo per occupare di me l'universo, non tuttavia l'universo intero; lo dispensavo in qualche maniera, non avevo bisogno di tanto. Una società ricercata mi bastava, senza preoccuparmi del resto. La mia moderazione mi inseriva in un ambiente ristretto, ma scelto con molta accuratezza, nel quale ero sicuro di regnare. Un solo castello appagava la mia ambizione. Favorito del padrone e della padrona, amante della 9 figlia, amico del fratello e protettore dei vicini, sarei stato soddisfatto, non avrei avuto bisogno d'altro. In attesa di questo modesto avvenire, vagai per qualche giorno nei dintorni della città, fermandomi presso dei contadini che conoscevo e che mi ricevettero, tutti, con molto maggiore bontà di quel che avrebbero fatto dei cittadini. Mi accoglievano, mi alloggiavano, mi nutrivano troppo bonariamente per farsene un merito. E ciò non si poteva dire un far l'elemosina; non vi mettevano abbastanza l'aria di superiorità. . . . « Dio vi chiama, mi disse il signor di Pontverre. Andate ad Annecy; vi troverete una buona signora molto caritatevole, che i benefici del re mettono in condizioni di liberare altre anime dall'errore dal quale lei stessa è uscita ». Si trattava della, signora di Warens, nuova convertita che i preti obbligavano a dividere con la canaglia che veniva a vendere la sua fede una pensione di duemila franchi che le dava il re di Sardegna. Io mi sentivo molto umiliato di aver bisogno di una buona signora molto caritatevole. Mi piaceva che mi desse il mio necessario, ma non che mi facesse la carità, e una devota non era per me molto attraente. Tuttavia, spinto dal signor di Pontverre, dalla fame che mi incalzava, molto lieto anche di fare un viaggio e di avere uno scopo, prendo la mia decisione sebbene con dolore e parto per Annecy. . . . Quando stavo per entrare in questa porta la signora di Warens si voltò alla mia voce. Che cosa divenni a quella vista! Avevo immaginato una vecchia devota molto arcigna; la buona signora del signor di Pontverre a mio avviso non poteva essere altro. Vidi un viso pieno di grazia, dei begli occhi azzurri pieni di dolcezza, una carnagione splendente, le linee di un seno incantevole. Niente sfuggi al rapido colpo d'occhio del giovane proselita; poiché divenni subito il suo, sicuro che una religione predicata da tali missionari non poteva non condurre in paradiso. Lei prese sorridendo la lettera che le presentai con mano tremante, l'aprì, diede uno sguardo a quella del signor di Pontverre, ritornò alla mia che lesse per intero e che avrebbe riletto ancora se il suo servo non l'avesse avvertita che era tempo di entrare. « Eh! fanciullo mio, mi disse con un tono che mi fece trasalire, eccovi per il mondo molto giovane; in verità, è un peccato ». Poi, senza aspettare la mia risposta aggiunse: « Andate a casa e aspettatemi, dite che vi preparino da mangiare, dopo la Messa parlerò con voi ». Luisa Eleonora di Warens era una signorina di La Tour de Pil, nobile e antica famiglia di Vévai, città del paese di Vaud. Molto giovane aveva sposato il signor di Warens della casa di Loys, figlio maggiore del signor di Villardin di Losanna. Questo matrimonio non diede bambini perché non troppo riuscito e la signora di Warens, spinta da qualche dispiacere familiare, colse il periodo in cui il re Vittorio Amedeo era a Evian, per passare il lago e venire a gettarsi ai piedi di questo principe; abbandonando così la sua famiglia e la sua terra per una balordaggine simile alla mia e che ha avuto tutto il tempo di scontare. Il re, cui piaceva fare il cattolico zelante, la prese sotto la sua protezione, le diede una pensione di 1500 lire piemontesi, molto per un principe così poco generoso; e comprendendo che per questa accoglienza lo avrebbero creduto suo amante, la mandò a Annecy scortata da un distaccamento delle sue guardie, dove, sotto la direzione di Michele Gabriele di Bernex, vescovo titolare di Ginevra, abiurò nel convento della Visitazione. Era là da sei anni quando io arrivai e aveva 28 anni . . . Coloro che negano l'attrazione delle anime spieghino, se possono, come dal primo colloquio, dalla prima parola, dal primo sguardo la signora di Warens mi ispirò non solo il più vivo attaccamento ma una confidenza perfetta che non si è mai smentita. Supponiamo che ciò che ho sentito per lei sia stato veramente amore, cosa che sembrerà almeno dubbia a chi seguirà la storia dei nostri legami; come mai questa passione fu accompagnata sin dal suo nascere dai sentimenti che meno suole ispirare: la pace del cuore, la calma, la serenità, la sicurezza, la fiducia? Come mai, 10 avvicinando per la prima volta una donna cortese, amabile, abbagliante, una dama di una classe superiore alla mia, come non ne avevo mai incontrata una uguale, colei dalla quale in certo modo dipendeva la mia sorte, dall'interesse più o meno grande che vi avrebbe preso; come mai, dico, con tutto ciò mi sentii subito così libero, così a mio agio come se fossi stato perfettamente sicuro di piacerle? Come mai non ho avuto un momento di imbarazzo, di timidezza, di soggezione? Per natura vergognoso, smarrito, senza aver mai visto il mondo, come mai presi con lei sin dal primo giorno, dal primo istante, le maniere semplici, il linguaggio tenero, il tono familiare che avevo dieci anni dopo, quando la più grande intimità lo rese naturale? Vi può essere amore non dico senza desiderio, io ne avevo, ma senza inquietudine, senza gelosia? Non si vuole almeno sapere se chi amiamo ci riama? Mai una volta mi è venuto in mente di farle una simile domanda, come mai mi venuto in mente di chiedere a me stesso se mi amo; e mai lei è stata più curiosa con me. Certamente vi è stato qualche cosa di strano nei miei sentimenti per questa donna affascinante e in seguito troverete delle originalità inaspettate. Libro Terzo In conclusione, mi abbandonavo tanto meglio al dolce sentimento del benessere che provavo vicino a lei, in quanto questo benessere del quale godevo non era turbato da nessuna preoccupazione sui mezzi per sostenerlo. Non ero ancora nella intima confidenza dei suoi affari e credevo che fossero in condizione da procedere sempre nello stesso modo. In seguito, in casa sua, ho trovato gli stessi piaceri; ma, più edotto sulla situazione reale e vedendo che essi anticipavano sulle rendite, non li ho più gustati con tranquillità. La previdenza ha sempre guastato in me la gioia; ho sempre previsto inutilmente l'avvenire, non ho mai potuto evitarlo. Sin dal primo giorno si stabilì tra noi la più dolce familiarità come poi è continuata per tutto il resto della vita. Piccolo fu il mio nome; mammà il suo e restammo sempre piccolo e mammà, anche quando gli anni cancellarono, quasi, la differenza che c'era tra noi. Mi sembra che questi due nomi rendano a meraviglia l'idea dei nostri rapporti, la semplicità delle nostre maniere e soprattutto l'attaccamento dei nostri cuori. Ella fu per me la più affettuosa delle madri, che non cercò mai il suo piacere, ma sempre il mio bene; e se i sensi ebbero una parte nel mio attaccamento a lei, non era per cambiarne la natura, ma solo per renderla più squisita, per inebriarmi alla gioia di avere una mamma giovane e carina che mi era delizioso carezzare dico carezzare in senso letterale; poiché ella non pensò mai di risparmiarmi i baci, né le più tenere carezze materne, e mai pensai di abusarne. Direte che tuttavia alla fine abbiamo avuto relazioni di altro genere, ne convengo; ma bisogna aspettare, non posso dire tutto in una volta. Il primo sguardo del nostro primo incontro fu il solo momento di passione che ella mai mi abbia fatto sentire e questo momento fu effetto della sorpresa. I miei sguardi indiscreti non andavano mai sbirciando sotto il suo fazzoletto; sebbene una floridezza mal nascosta in quel punto avrebbe potuto attirarveli. Non avevo né rapimenti, né desideri presso di lei, ero in uno stato di calma incantevole e gioioso senza sapere di che. In questo stato avrei passato tutta la mia vita e anche l'eternità senza annoiarmi un istante. Essa è la sola persona con la quale non ho mai sentito quella aridità di conversazione che mi rende supplizio il doverla sostenere. I nostri colloqui non erano delle conversazioni, quanto un inesauribile cicaleccio che per finire aveva bisogno di essere interrotto. Anziché pregarmi di parlare, bisognava pregarmi di tacere. A furia di meditare sui suoi progetti, ella cadeva spesso nella fantasticheria. Allora la lasciavo sognare, tacevo, la contemplavo ed ero il più felice degli uomini. 11 Avevo inoltre una stranezza veramente singolare senza aspirare alla gioia di un incontro da sola a solo lo cercavo incessantemente e ne gioivo con uno slancio che degenerava in furore quando degli importuni venivano a turbarlo. Non appena arrivava qualcuno, non importa se uomo o donna, uscivo mormorando poiché non sopportavo di restare vicino a lei come terzo. Andavo nella sua anticamera a contare i minuti e maledivo questi eterni visitatori, senza riuscire a capire cosa avessero da dire così a lungo, poiché io avevo da dire ancora di più. . . . Due cose quasi inconciliabili si uniscono in me senza che io possa capire come: un temperamento molto ardente, delle passioni vive, impetuose e delle idee lente a nascere, impacciate e che si presentano sempre troppo tardi. Si direbbe che il mio cuore e la mia testa non appartengano allo stesso individuo. Il sentimento più veloce del lampo fa traboccare la mia anima, ma invece di illuminarmi mi brucia e mi abbaglia. Sento tutto ma non vedo niente; sono impulsivo, ma stupido. Per pensare è necessario che io sia a sangue freddo. E strano, ma tuttavia ho il senso abbastanza sicuro della penetrazione, dell'acutezza anche, purché mi si aspetti: faccio delle magnifiche improvvisazioni con comodo, ma sul momento non ho mai fatto o detto niente che valga. Farei una bellissima conversazione per posta, come dicono che gli spagnoli giochino a scacchi. . . . Questa lentezza di pensiero insieme a questa vivacità di sentimento non l'ho solamente nella conversazione, la ho anche da solo e quando lavoro. Le idee si combinano nella mia testa con la più incredibile difficoltà. Vi si muovono lentamente, vi fermentano fino a commuovermi, a riscaldarmi, ad agitarmi, e per tanta emozione non vedo niente con chiarezza; non saprei scrivere una sola parola: bisogna che aspetti. Insensibilmente questa grande agitazione si calma, questo caos si schiarisce, ogni cosa si mette al suo posto, ma lentamente e dopo una lunga e confusa agitazione. Non avete visto qualche volta l'opera in Italia? Su quei grandi teatri nei cambiamenti di scena regna un disordine spiacevole che dura molto tempo; tutte le decorazioni sono mescolate. Da ogni parte si vede una confusione che fa pena, si crede che tutto va sossopra, e tuttavia a poco a poco tutto si aggiusta, niente manca e si resta sorpresi nel vedere seguire a questo lungo tumulto uno spettacolo stupendo. Questa manovra è simile a quella che avviene nella mia mente quando voglio scrivere. Se avessi saputo prima attendere, e poi rendere nella loro bellezza le cose che così vi si sono rappresentate, pochi autori mi avrebbero superato. Da ciò deriva la grande difficoltà che trovo nello scrivere. I miei manoscritti, cancellati, scarabocchiati, confusi, indecifrabili testimoniano la fatica che mi sono costati. Non ve ne è uno che non abbia dovuto copiare quattro o cinque volte prima di darlo alle stampe. Non ho potuto mai fare niente con la penna in mano davanti a un tavolo e alla carta. A passeggio, tra le rocce e i boschi, di notte, nel mio letto durante le mie insonnie scrivo nel mio cervello, e si può giudicare con quale lentezza, soprattutto per un uomo assolutamente sprovvisto di memoria verbale, e che durante la sua vita non ha potuto ritenere sei versi a memoria. Alcuni dei miei periodi li ho girati e rigirati cinque o sei notti nella mia testa prima che potessero essere messi sulla carta. Da ciò ancora deriva che io riesca meglio nelle opere che richiedono lavoro, che in quelle che debbono essere fatte con una certa leggerezza, come le lettere; genere di cui non ho mai potuto prendere lo stile e di cui occuparmi è per me un supplizio. Non scrivo una lettera sul più futile argomento che non mi costi delle ore di fatica; e se voglio scrivere di seguito ciò che mi viene non so né cominciare né finire, la mia lettera è una lunga e confusa ciancia; vi si capisce a fatica quando la si legge. Non solo mi è faticoso rendere le idee, ma mi è faticoso anche riceverle. Ho studiato gli uomini, e credo di essere un osservatore abbastanza buono; tuttavia non so vedere niente di quello che vedo, non vedo bene che ciò che ricordo, e non ho acume che nei miei ricordi. Di tutto quello che si dice, di tutto quello che si fa, di tutto quello che avviene davanti a me non comprendo niente non penetro niente, la forma esterna è tutto 12 quello che mi colpisce. Ma dopo tutto ritorna a me, mi ricordo il luogo, il tempo, il tono, lo sguardo, il gesto, la circostanza; niente, allora, mi sfugge su ciò che si è fatto o detto, ritrovo ciò che si è pensato ed raro che mi sbagli. Così poco padrone del mio spirito quando sono solo con me stesso, si pensi quello che debbo essere nella conversazione, quando, per parlare a proposito, bisogna pensare a mille cose nello stesso tempo e con prontezza. Il solo pensiero di tante convenienze delle quali sono sicuro di dimenticarne almeno qualcuna, basta ad intimidirmi; non capisco neanche come si osi parlare in un crocchio poiché a ogni parola bisognerebbe passare in rassegna tutte le persone che sono là, bisognerebbe conoscere tutti i loro caratteri, sapere tutte le loro storie, per essere sicuri di non dire niente che possa offendere qualcuno. Su questo punto quelli che vivono nel mondo hanno un grande vantaggio: sapendo meglio quello che debbono tacere, sono più sicuri di quello che dicono, eppure spesso scappa loro qualche scemenza. Si pensi a chi cade dalle nuvole: gli è quasi impossibile parlare impunemente. Quando si è solamente due vi è un altro inconveniente che io trovo anche peggiore: la necessita di parlare sempre. Quando vi parlano bisogna rispondere, e se non dicono una parola bisogna risollevare la conversazione. Questa insopportabile costrizione da sola mi avrebbe disgustato della società; non trovo che vi sia una tortura maggiore dell'obbligo di parlare con prontezza e sempre. Non so se questo dipenda dalla mia mortale avversione per ogni assoggettamento, ma basta che sia necessario che io parli perché dica infallibilmente una scempiaggine. Quel che è più tragico è che invece di saper tacere quando non ho niente da dire, proprio allora per pagare più in fretta il mio debito ho la smania di voler parlare. Mi affretto a balbettare subito delle parole senza idee, felicissimo quando esse non significano completamente niente. Per voler vincere o nascondere la mia incapacità raramente manco di mostrarla. Libro Quinto Comunque, mammà si accorse che per strapparmi ai pericoli della mia giovinezza, doveva trattarmi da uomo; e fu così che fece, ma nella maniera più singolare che una donna abbia mai pensato in simile occasione. Trovai in lei l'aspetto più grave e il ragionamento più morale che di consueto. Alla gaiezza giocosa, con la quale lei ordinariamente intercalava i suoi insegnamenti, succedette, ad un tratto, un tono sempre sostenuto che non era né familiare, né severo, ma che sembrava preparasse una spiegazione. Dopo aver inutilmente cercato in me stesso la ragione di questo cambiamento gliela chiesi: era quello che aspettava. Mi propose una passeggiata al giardinetto per il giorno dopo: vi andammo al mattino. Aveva fatto in modo che ci lasciassero soli tutto il giorno, e lei ne approfittò per prepararmi alla bontà che voleva usarmi, non come un'altra donna, col raggiro e le lusinghe, ma con dei discorsi pieni di senno e di ragione, fatti più per istruirmi che per sedurmi, e che parlavano più al mio cuore che ai miei sensi. Ma, per quanto magnifici e utili potessero essere i discorsi che lei mi tenne, per quanto non fossero che freddi e tristi, non vi prestai tutta l'attenzione che meritavano e non li impressi nella mia memoria, come avrei fatto in altro tempo. Il suo esordio, questo tono di preparazione mi avevano reso inquieto. Mentre parlava, sognatore e distratto mio malgrado, mi occupavo meno di quello che lei diceva che di cercare a che cosa tendesse. E non appena l'ebbi capito, cosa che non fu facile, la novità dell'idea, che una sola volta mi era venuta in mente da quando vivevo vicino a lei, occupandomi interamente, non mi lasciava la capacità di pensare a ciò che lei mi diceva. Non pensavo che a lei e non l'ascoltavo. Voler rendere attenti i giovani a quello che ad essi si vuol dire, facendo vedere, alla fine, una cosa molto interessante per loro, è un controsenso, frequentissimo negli istitutori e che io stesso non ho evitato nel mio Emilio. Il giovane, colpito 13 dall'oggetto che gli viene presentato, si occupa esclusivamente di questo e salta a pie pari sui vostri discorsi preliminari, per giungere subito dove voi lo conducete troppo lentamente per il suo gusto. Quando si vuole che stia attento non bisogna fare che comprenda oltre: in questo mammà fu malaccorta. Per una stranezza che si doveva al suo spirito sistematico, prese la precauzione perfettamente inutile di fare le sue condizioni; ma, non appena ne vidi il prezzo, non le ascoltai neanche e mi affrettai ad acconsentire a tutto. Dubito anche che, in un caso simile, vi sia, su tutta la terra, un uomo abbastanza franco o abbastanza coraggioso per osar mercanteggiare, e una sola donna che possa perdonare l'averlo fatto. Continuando nella stessa stranezza, aggiunse a questo accordo le più gravi formalità e mi diede otto giorni per pensarvi, dei quali le assicurai falsamente di non aver bisogno. Per colmo di stranezza, infatti, fui molto contento di averli, tanto mi aveva colpito la novità di queste idee e tale era il turbamento delle mie, che mi chiedeva tempo per riordinarle. Penserete che questi otto giorni furono per me come otto secoli. Al contrario, avrei voluto che lo fossero stati in realtà. Non so come descrivere lo stato in cui mi trovavo, pervaso da un certo spavento misto ad impazienza, temevo quello che desideravo, fino talvolta a cercare improvvisamente nella mia testa qualche mezzo onesto per evitare di essere felice. Pensate al mio temperamento ardente e lussurioso, al mio sangue in fiamme, al mio cuore ebbro d'amore, alla mia robustezza, alla mia salute, alla mia età; pensate che in questo stato, assetato di donne, non ne avevo ancora avvicinata nessuna; che l'immaginazione, la vanità, la curiosità si univano per divorarmi nell'ardente desiderio di essere uomo e di sembrarlo: e aggiungete soprattutto, perché questo non dovete dimenticare, che il mio vivo attaccamento per lei, lungi dall'intiepidirsi, non aveva fatto che aumentare di giorno in giorno, che non mi sentivo felice che vicino a lei, che non mi allontanavo da lei che per pensare a lei, che avevo il cuore pieno, non solo della sua bontà, del suo carattere amabile, ma del suo sesso, della sua figura, della sua persona, di lei in una parola, per tutti gli aspetti sotto i quali poteva essermi cara; e non si pensi che per i dieci o dodici anni che io avevo meno di lei, fosse o mi sembrasse vecchia. In realtà, dopo cinque o sei anni, da quando avevo provato dei sentimenti così dolci, alla sua prima vista, era poco cambiata e mi sembrava che non lo fosse affatto. Per me è stata sempre bella e allora lo era per tutti. Solo il suo corpo era un pò più rotondo. Poi erano gli stessi occhi, la stessa carnagione, lo stesso seno, gli stessi lineamenti, gli stessi bei capelli biondi, la stessa gaiezza, tutto fin’anche la stessa voce, quella voce argentea della gioventù che ha fatto sempre tanta impressione su di me, da non lasciarmi, ancor'oggi, sentire senza emozione il suono di una bella voce di ragazza. Era naturale che nell'attesa di possedere una persona tanto cara dovessi temere di anticipare, e di non poter governare abbastanza i miei desideri e la mia immaginazione, per restare padrone di me stesso. Vedrete come, in un'età avanzata, il solo pensiero di qualche piccolo favore, che mi aspettava vicino alla persona amata, accendeva il mio sangue a tal punto che mi era impossibile fare impunemente il breve percorso che mi separava da lei. Come, per quale miracolo, nel fiore della gioventù ebbi così poca fretta di giungere al primo godimento? Come mai potei vederne avvicinarsi l'ora con più dolore che gioia? Come mai, invece delle delizie che dovevano inebriarmi, sentivo quasi ripugnanza e timore? Non vi è dubbio che, se avessi potuto sottrarmi facilmente alla mia felicità, lo avrei fatto di tutto cuore. Ho promesso delle stranezze nella storia del mio attaccamento a lei: eccone una alla quale certamente non eravate preparati. Il lettore, già indignato, pensa che lei, posseduta come era da un altro uomo, dividendosi si degradava ai miei occhi, e che un sentimento di disistima intiepidiva quelli che mi aveva inspirati; si inganna. Questa divisione, è vero, mi dava una pena crudele, sia per una delicatezza molto naturale, sia perché in realtà la trovavo poco degna di lei e di me; ma i miei sentimenti per lei non ne venivano affatto 14 alterati, e posso giurare che mai la amai così teneramente, come quando desideravo tanto poco di possederla. Conoscevo troppo il suo cuore casto e il suo temperamento di ghiaccio, per credere, per un momento, che il piacere dei sensi avesse alcuna parte in quest'abbandono di se stessa: ero perfettamente sicuro che solo la preoccupazione di strapparmi a dei pericoli, diversamente quasi inevitabili, e di conservarmi interamente a me e ai miei doveri, gliene faceva trasgredire uno che lei non considerava con lo stesso occhio delle altre donne, come sarà detto in seguito. La compiangevo e mi compiangevo. Avrei voluto dirle: « No, mammà, non è necessario, vi rispondo di me senza tutto questo »; ma non osavo, innanzi tutto perché non era una cosa da dire e poi perché in fondo sentivo che non era vero, e che in realtà non vi era che una donna, che potesse garantirmi dalle altre, e mettermi al di sopra delle tentazioni. Senza desiderare di possederla, ero ben felice che mi togliesse il desiderio di possederne delle altre, tanto guardavo come male tutto quello che potesse distrarmi da lei. La lunga abitudine di vivere insieme e di vivervi innocentemente, lungi dall'affievolire i miei sentimenti per lei li aveva rafforzati, ma nello stesso tempo aveva dato loro un'altra forma che li rendeva più affettuosi, più teneri forse, ma meno sensuali. A forza di chiamarla mammà, a forza di avere con lei la familiarità di un figlio, mi ero abituato a considerarmi tale. Credo che sia questa la vera causa della poca fretta che ebbi di possederla, sebbene mi fosse tanto cara. Mi ricordo benissimo che i miei primi sentimenti, senza essere più vivi, erano più voluttuosi. Ad Annecy ero in uno stato di ebbrezza, a Chambéry non vi ero più. La amavo sempre appassionatamente, come più potevo; ma l'amavo più per lei e meno per me, o almeno, vicino a lei cercavo più la mia felicità che il mio piacere: era per me più che una sorella, più che una madre, più che un'amica, anche più che una amante. Insomma la amavo troppo per desiderarla: ecco quel che vi è di più chiaro nelle mie idee. Questo giorno, più temuto che atteso, venne alfine. Promisi tutto e non mentii. Il mio cuore confermava i miei impegni, senza desiderarne il prezzo. Non di meno l'ottenni. Per la prima volta mi vidi tra le braccia di una donna e di una donna che adoravo. Fui felice? No, gustai il piacere. Non so quale tristezza invincibile ne avvelenava la bellezza. Mi sentivo come se avessi commesso un incesto. Due o tre volte, stringendola con passione nelle mie braccia, inondai il suo seno delle mie lacrime. Quanto a lei, non'era né triste, né eccitata; era carezzevole e tranquilla. Poiché era poco sensuale, e non aveva cercato affatto la voluttà, non ne ebbe le delizie e non ne ha mai avuto i rimorsi. Libro Sesto . . . Comincia, ora la breve felicità della mia vita; cominciano ora i dolci ma fuggitivi momenti che mi hanno dato il diritto di dire che ho vissuto. Momenti preziosi e tanto rimpianti! Ah! ricominciate per me il vostro dolce corso; se potete, scorrete nel mio ricordo più lentamente di quanto non abbiate fatto nel vostro fuggevole susseguirsi. Come farò a prolungare, come voglio, questo racconto così commovente e semplice, e ripetere sempre le stesse cose, senza annoiare i miei lettori più di quanto non mi annoiassi io ricominciandole senza posa? Se fossero fatti, azioni e parole potrei, ancora in qualche modo, descriverli e renderli, ma come esprimere quello che non era né detto né fatto e neanche pensato, ma solo sentito, senza che io potessi indicare un oggetto della mia felicità che non fosse questo stesso sentimento? Mi alzavo con il sole ed ero felice; passeggiavo ed ero felice; vedevo mammà ed ero felice; scorrazzavo per i boschi, per i pendii, vagavo per i valloni, leggevo, restavo ozioso, lavoravo in giardino, raccoglievo i frutti, aiutavo in casa, e la 15 felicità mi seguiva ovunque; non era in nessuna cosa, era in me, non poteva lasciarmi un solo istante. Niente di quanto mi è accaduto durante questo periodo, a me così caro, niente di quello che ho fatto, detto e pensato è sfuggito alla mia memoria. I periodi che precedono e che seguono mi risovvengono a tratti. Li ricordo in maniera discontinua e confusa; ma ricordo quello per intero come se durasse ancora. La mia immaginazione, che durante la mia giovinezza andava sempre avanti e adesso si volge indietro, compensa con questi dolci ricordi la speranza che ho perduta per sempre. Nell'avvenire non vedo più niente che mi tenti: solo i ricordi del passato possono lenirmi; e questi ritorni così vivi e veri all'epoca di cui parlo spesso mi fanno vivere felice, malgrado le mie sventure. Darò un solo esempio di questi ricordi che potrà fare giudicare della loro forza e della loro verità. Il primo giorno che andammo a coricarci alle Charmettes, mamma era su una portantina e io la seguivo a piedi. La strada saliva; lei era abbastanza pesante; e temendo di stancare troppo i suoi portatori, volle scendere circa a mezza strada, per fare il resto a piedi. Camminando vide qualche cosa di azzurro sulla siepe, e mi disse: « Ecco la pervinca ancora in fiore ». Non avevo mai visto della pervinca; non mi abbassai per guardarla bene, e ho la vista troppo corta per distinguere dalla mia altezza le piante a terra. Passando, diedi solo un'occhiata a quella e sono passati quasi trenta anni senza che abbia rivisto una pervinca, o che vi abbia fatto attenzione. Nel 1764 mentre ero a Cressier con il mio amico signor Du Peyrou salivamo una montagnola, in cima alla quale vi è un grazioso salone che lui chiama a ragione Bellevue. Cominciavo allora ad erborare un poco; salendo e guardando tra i cespugli dò in un grido di gioia: « Ah! ecco della pervinca! » e in realtà lo era. Du Peyrou si accorse della slancio, ma ne ignorava la causa; la conoscerà, spero, quando un giorno leggerà queste pagine. Dall'impressione di una cosa così piccola il lettore può giudicare quella che mi hanno lasciata tutte quelle che si riferiscono alla stessa epoca. . . . Nonostante tutto, l'aria della campagna non mi ridiede la mia primitiva salute. Ero languente e lo divenni di più. . . . Non digerivo più e capii che non dovevo più sperare di guarire. In questo stesso periodo mi accadde un incidente notevole, sia in se stesso, sia per le sue conseguenze che non cesseranno che con me.. . . Le vendemmie, la raccolta delle frutta ci allietarono la fine di questo anno e ci legarono sempre più alla vita rustica, all'ambiente della brava gente dalla quale eravamo circondati. Vedemmo venire l'inverno con grande rimpianto e ritornammo in città come se fossimo andati in esilio; specialmente io che temevo di non rivedere la primavera e credevo di dire addio per sempre alle Charmettes. Non le lasciai senza baciare la terra e gli alberi e senza girarmi parecchie volte nell'allontanarmi. Abbandonati da un pezzo i miei scolari, perduto l'interesse ai divertimenti e ai salotti della città, non uscivo più, non vedevo più nessuno, tranne mamma e il signor Salomon che era diventato da poco medico suo e mio, onest'uomo, uomo di spirito, gran cartesiano, parlava abbastanza bene del sistema del mondo e le sue conversazioni piacevoli ed istruttive mi giovarono più di tutte le sue prescrizioni. Non ho mai potuto soffrire questo stupido ed inutile chiacchierio delle conversazioni ordinarie; ma le conversazioni utili e solide mi hanno sempre fatto gran piacere e ad esse non mi sono mai rifiutato. Presi molto interesse a quelle del signor Salomon; mi sembrava di anticipare con lui qualcuna delle alte conoscenze che la mia anima avrebbe acquistata staccandosi dalle sue pastoie. Questo interesse che avevo per lui si estendeva agli argomenti che trattava, e cominciai a cercare i libri che potevano aiutarmi a comprenderli meglio. Quelli che univano fede e scienza erano i più rispondenti a me; così in particolare quelli dell'oratorio di PortRoyal. Mi misi a leggerli o meglio a divorarli. Me ne capitò tra le mani uno del padre Lami intitolato Conversazioni sulla scienza". Era come un'introduzione alla conoscenza dei libri che ne trattano. Lo lessi e rilessi cento volte; decisi di farne la mia guida. Alla fine, poco a poco, 16 malgrado il mio stato o forse, meglio, dal mio stato, mi sentii trascinato verso lo studio con una forza irresistibile; e pur guardando ogni giorno come l'ultimo dei miei giorni, studiavo con tanto ardore come se avessi dovuto vivere sempre. Dicevano che questo mi faceva male; io credo, per conto mio, che mi fece bene; e non soltanto alla mia anima, ma anche al mio corpo; infatti questa occupazione, alla quale mi appassionavo, mi divenne così deliziosa che, non pensando più ai miei mali, ne ero meno tormentato. E vero, tuttavia, che niente mi apportava un sollievo reale, ma poiché non avevo dei dolori vivi mi abituai a languire, a non dormire, a pensare invece di agire, e infine a considerare il continuo e lento deperimento della mia macchina come un progresso inevitabile che la morte sola poteva arrestare. Quest'idea, non solo mi staccò da tutte le cure vane della vita, ma mi liberò dalla noia dei rimedi ai quali, mio malgrado, mi avevano sottoposto sino ad allora. Salomon, convinto che le sue droghe non potevano salvarmi, me ne risparmiò il disgusto, e si contentò di trastullare il dolore della mia povera mamma con qualcuna di quelle ordinazioni inutili che alimentano la speranza dell'ammalato e salvano la fama del medico. Abbandonai la dieta rigida, ripresi l'uso del vino e tutto l'andamento della vita di un uomo sano, secondo la misura delle mie forze, sobrio in tutto, ma senza privarmi di niente. . . . Mi affezionai alla bottega del libraio Boucahrd frequentata da alcune persone colte; e poiché la primavera, che avevo creduto di non rivedere, era vicina, mi fornii di alcuni libri per le Charmettes, per il caso che avessi avuto la fortuna di ritornarvi. Ebbi questa fortuna e ne approfittai. La gioia con la quale vidi le prime gemme è inesprimibile. Rivedere la primavera era per me risuscitare in paradiso. Le nevi cominciavano, appena a sciogliersi quando lasciammo la nostra prigione, e fummo abbastanza presto alle Charmettes per godervi i primi canti dell'usignolo. Da quel momento non credetti più di dover morire; e veramente è strano che in campagna non abbia avuto mai malattie gravi. Vi ho sofferto, molto, ma mai vi sono stato obbligato al letto. Spesso, sentendomi peggio del solito, ho detto: « Quando mi vedrete vicino a morire portatemi sotto una quercia, vi prometto che resusciterò ». ... Questo ragazzo1, tuttavia; non era affatto di animo cattivo: amava mammà perché era impossibile non amarla: non aveva neanche avversione per me, e quando gli intervalli dei suoi impeti permettevano che gli si parlasse, mi ascoltava talvolta molto docilmente, convenendo con franchezza che non era che uno sciocco, dopo di che faceva, ugualmente, nuove sciocchezze. D'altra parte aveva un'intelligenza così limitata e dei gusti così bassi che era difficile parlargli ragionevolmente, e quasi impossibile stare volentieri con lui. Al possesso di una donna piena di grazie, aggiunse il gusto di una cameriera vecchia, rossa, sdentata, della quale mammà aveva la pazienza di sopportare il disgustoso servizio, sebbene lei le facesse male al cuore. Mi accorsi di questo nuovo maneggio e ne rimasi furente d'indignazione. Ma mi accorsi di un'altra cosa che mi colpì ancora molto più vivamente e che mi gettò in uno scoraggiamento più profondo di tutto quello che, fino allora, mi era successo. Fu il raffreddarsi di mamma verso di me. La privazione che mi ero imposta e che lei aveva fatto finta di approvare è una di quelle cose che le donne non perdonano, qualunque faccia facciano, meno per la privazione che ne deriva per loro stesse, che per l'indifferenza che vi vedono per il loro possesso. Prendete la donna più sensata, la più filosofa, la meno attaccata ai suoi sensi, il delitto più irrimissibile che possa commettere verso di lei l'uomo del quale, per il resto, lei si preoccupa di meno è di poterne godere e di non farlo. 1 Il nuovo favorito della sua amante-protettrice Madame de Warens. 17 Questo deve essere ben senza eccezione, poiché una simpatia così spontanea e forte fu alterata in lei da una astinenza che non aveva che dei motivi di virtù, di stima e di attaccamento. Da allora cessai di trovare con lei quella intimità di cuore che fece sempre la più dolce gioia del mio. Non si apriva più con me che quando aveva da lamentarsi del nuovo venuto. Quando loro stavano bene insieme io entravo poco nelle sue confidenze. In conclusione lei, poco a poco, assumeva una maniera di essere della quale io non facevo più parte. La mia presenza le faceva piacere ancora, ma non ne aveva più bisogno e io avrei potuto trascorrere giorni interi senza vederla, senza che lei se ne accorgesse. Insensibilmente mi sentivo isolato e solo in quella stessa casa di cui prima ero l'anima e dove, per così dire, vivevo il doppio. Mi abituai, poco a poco, a separarmi da tutto quello che vi si faceva, da quelli stessi che l'abitavano, e per risparmiarmi degli schianti continui, mi chiudevo coi miei libri, o andavo a sospirare e a piangere a mio agio in mezzo ai boschi. Questa vita presto mi divenne del tutto insopportabile. Sentii che la presenza personale e la lontananza di cuore di una donna che mi era così cara irritavano il mio dolore e che cessando di vederla me ne sarei sentito meno crudelmente separato. Formai il progetto di abbandonare la sua casa, glielo dissi e lungi dall'opporvisi lo favorì. A Grenoble aveva un'amica, la signora Deybens, il cui marito era amico del signor di Mably gran prevosto di Lione. Il signor Deybens mi propose l'educazione dei figli del signor di Mably. Accettai e partii per Lione senza lasciare, né quasi sentire il minimo rimpianto per una separazione di cui prima il solo pensiero ci avrebbe dato le angosce della morte. Libro Settimo Dopo due anni di silenzio e di pazienza riprendo la penna, malgrado le mie decisioni. Lettori, sospendete il vostro giudizio sulle ragioni che mi forzano a questo. Non potete giudicare che dopo avermi ascoltato. Avete visto scorrere la mia tranquilla giovinezza in una vita abbastanza uguale, abbastanza dolce, senza grandi traversie, né grandi prosperità. Questa mediocrità fu in parte opera della mia natura ardente, ma debole, ancora meno pronta a intraprendere che facile a scoraggiare, che usciva dal riposo a scosse, ma che vi rientrava per stanchezza e per inclinazione, e che, conducendomi sempre, lontano dalle grandi virtù e più lontano dai grandi vizi, alla vita oziosa e tranquilla per la quale mi sentivo nato, non mi ha mai permesso di arrivare a niente di grande, sia nel bene che nel male. Che quadro diverso dovrò tosto tracciare! La sorte che per trent'anni favorì le mie inclinazioni, le avversò negli altri trenta; e, da questa opposizione continua tra la mia situazione e le mie tendenze, vedrete nascere degli errori enormi, delle sventure inaudite, e tutte le virtù che possono onorare l'avversità, tranne la forza. La mia prima parte è stata scritta tutta sulla memoria e ho dovuto farvi molti errori. Costretto a scrivere anche la seconda sulla memoria probabilmente ve ne farò molti di più. I dolci ricordi dei miei begli anni, trascorsi con uguale semplicità ed innocenza, mi hanno lasciato mille impressioni piene di fascino che mi piace ricordare continuamente. Vedrete presto come sono diverse quelle del resto della mia vita. Ricordarle è rinnovarne l'amarezza. Lontano dall'inacerbire quella della mia situazione con questi tristi ritorni, li scarto per quanto è possibile e spesso vi riesco a tal punto che non posso più rintracciarli all'occorrenza. Questa facilità di dimenticare i mali è una consolazione che il cielo mi ha procurato, tra quelli che il destino doveva un giorno accumulare su di me. La mia memoria, che ricorda solo 18 le cose piacevoli, è il felice contrappeso della mia immaginazione spaurita che non mi fa prevedere che crudeli avveniri. Tutte le carte che avevo riunite per supplire alla mia memoria e guidarmi in questa impresa, passate in altre mani, non torneranno più nelle mie. Non ho che una guida fedele sulla quale possa contare: è la catena dei sentimenti che hanno segnato la evoluzione del mio essere, e la cui impressione non si cancella dal mio cuore. Questi sentimenti mi ricorderanno abbastanza gli avvenimenti che li hanno fatti nascere, per potermi illudere di narrarli fedelmente: e se vi è qualche omissione, qualche trasposizione di fatti o di date, cosa che può avvenire solo per avvenimenti di poco conto e che mi hanno colpito poco, per ogni fatto restano abbastanza tracce perché, nell'ordine di ciò che narrerò, possa rimetterlo facilmente al suo posto. Tuttavia, e per buona fortuna, vi è un periodo di sei o sette anni del quale ho notizie certe in una raccolta di lettere trascritte, i cui originali sono nelle mani del signor Du Peyrou. Questa raccolta che finisce nel 1760 comprende tutto il tempo del mio soggiorno all'Eremitaggio e della mia clamorosa rottura con i miei sedicenti amici: epoca memorabile nella mia vita, che fu la sorgente di tutte le mie altre disgrazie. Quanto alle lettere originali più recenti che ancora mi restano, e che sono molto poche, invece di trascriverle, continuando la raccolta, troppo voluminosa perché— possa sperare di sottrarla alla vigilanza dei miei Argo, le trascriverò in questo stesso scritto quando mi sembrerà che possano fornire qualche schiarimento alla verità dei fatti, sia a mio vantaggio sia a mio carico. Non ho infatti paura che il lettore dimentichi che faccio le mie confessioni, per credere che faccia la mia apologia; ma, dopo l'esposizione del mio progetto, egli non deve neanche aspettarsi che io taccia la verità quand'essa parla in mio favore. Del resto, questa seconda parte non ha che questa stessa verità in comune con la prima, né supera l'altra che per l'importanza degli avvenimenti. Tolto questo non può che esserle inferiore in tutto. Ho scritto la prima con piacere e con compiacimento, a mio agio a Wooton o nel castello di Trie. Tutti i ricordi che dovevo risuscitare erano per me altrettante nuove gioie. Vi ritornavo incessantemente con un piacere nuovo e potevo rigirare senza fastidio le mie descrizioni sino a che non ne fossi stato contento. Oggi la mia memoria e la mia testa, indebolitesi, mi rendono quasi incapace di ogni lavoro; non mi occupo di questo che per forza e col cuore stretto dall'angoscia. Esso non mi offre che sventure, tradimenti, perfidie, che ricordi tristi e laceranti. A costo di tutto, vorrei poter seppellire nella notte dei tempi ciò che debbo dire; e, costretto a parlare, mio malgrado, sono ridotto ancora a nascondermi, a usare astuzia, a ingannare, ad avvilirmi alle cose per le quali meno ero nato. I soffitti sotto i quali vivo hanno gli occhi, i muri che mi circondano hanno le orecchie; circondato da spie e da sorveglianti malvolenti e vigilanti, inquieto e distratto getto, sulla carta, in fretta e furtivamente, qualche parola interrotta che appena ho il tempo di rileggere, ancora meno di correggere. So che, malgrado le barriere immense che ammucchiano attorno a me, temono sempre che la verità trapeli da qualche fessura. Come fare per farla trasparire? Lo tento con poca speranza di successo; giudicate se da ciò si possono fare dei quadri piacevoli e dare loro un colorito molto attraente. Avverto dunque quelli che vorranno cominciare questa lettura che niente continuandola può garantirli dalla noia, se non il desiderio di finire di conoscere un uomo, e l'amore puro della giustizia e della verità. Nella prima parte ho lasciato me stesso che partivo per Parigi, lasciando il cuore alle Charmettes, fondandovi il mio ultimo castello di Spagna, progettando di portarvi un giorno ai piedi di mammà, restituita a se stessa, i tesori che avrei guadagnati, e contando sul mio sistema di musica come su una fortuna sicura. Avevamo una nuova albergatrice che era di Orléans. Ella prese dal suo paese, per lavorare la biancheria, una ragazza di circa ventidue o ventitré anni che mangiava con noi come la padrona. Questa ragazza, certa Teresa Le Vasseur, era di buona 19 famiglia. Suo padre era ufficiale della zecca di Orléans, sua madre mercantessa. Avevano molti figli. La zecca di Orléans, falli, il padre si trovò sul lastrico; la madre, avendo subito delle bancarotte, si trovò male nei suoi affari, abbandonò il commercio e venne a Parigi con suo marito e sua figlia, che li sostentava entrambi col suo lavoro. La prima volta che vidi questa ragazza a tavola, fui colpito dal suo comportamento modesto, e più ancora dal suo sguardo vivace e dolce che per me restò sempre unico. La tavola, oltre che dal signor Bonnefond, era composta da parecchi abati irlandesi, guasconi e altra gente simile; la nostra stessa albergatrice conduceva una vita alquanto dissoluta; e là io ero il solo che parlasse e si comportasse decentemente. Cominciarono a stuzzicare la ragazza; presi la sua difesa. Subito i frizzi caddero su di me. Anche se non avessi avuto nessuna inclinazione per questa povera ragazza, la compassione, la contraddizione me l'avrebbe data. Ho sempre amato l'onestà nei modi e nei propositi, soprattutto nei rapporti tra uomini e donne. Divenni apertamente il suo difensore. La vidi sensibile alle mie premure, e i suoi sguardi, animati dalla riconoscenza che non osava esprimere con le parole, diventavano sempre più penetranti. Era molto timida; io lo ero anche. Il legame, che questo comune temperamento sembrava dovesse allontanare, fu tuttavia realizzato molto rapidamente. L'albergatrice che se ne accorse divenne furiosa e le sue cattiverie mi avvicinarono di più alla piccola, la quale, non avendo altro appoggio che me nella casa, mi vedeva uscire con dolore, e aspettava il ritorno del suo protettore. La relazione dei nostri cuori, il convergere delle nostre inclinazioni ebbero presto il loro effetto ordinario. Lei credette di vedere in me un onest'uomo; non si ingannò: io credetti di vedere in lei una ragazza sensibile, semplice e senza civetteria, e non mi ingannai neanche. Le dichiarai anticipatamente che non l'avrei abbandonata, né sposata mai. L'amore, la stima, la sincerità ingenua furono i ministri del mio trionfo, ed è perché il suo cuore era tenero e onesto che fui felice senza essere intraprendente. Il suo timore, che mi seccassi di non trovare in lei quello che lei credeva vi cercassi, fece ritardare la mia felicità più di ogni altra cosa. La vidi interdetta e confusa prima di arréndersi; voleva farsi comprendere e non osava spiegarsi. Lontano dall'immaginare la vera causa del suo imbarazzo, ne immaginai una molto falsa e molto insidiante per i suoi costumi, e, credendo che mi avvertisse che la mia salute correva dei rischi, caddi in perplessità che non mi trattennero, ma che per parecchi giorni avvelenarono la mia felicità. Poiché non ci comprendevamo l'un l'altro, le nostre conversazioni su questo argomento erano altrettanti enigmi e assurdità più che ridicoli. Lei fu quasi per credermi assolutamente pazzo. Alla fine ci spiegammo: piangendo mi confessò un suo sbaglio, unico, all'uscire dall'infanzia, frutto della sua ignoranza e dell'accortezza di un seduttore. Non appena la compresi diedi in un grido: « Verginità! esclamai; è proprio a Parigi, è proprio a vent'anni che si cerca! Ah, mia Teresa, sono troppo felice di possederti, saggia e sana, e di non trovare che ciò che non cercavo ». Da principio non avevo pensato che a procurarmi un divertimento; mi accorsi che avevo fatto di più e che mi ero data una compagna. Un po' di frequenza con quell'ottima ragazza, un po' di riflessione sulla mia situazione mi fecero capire che, non pensando che ai miei piaceri, avevo fatto molto per la mia felicità. Al posto dell'ambizione spenta avevo bisogno di un sentimento vivo che riempisse il mio cuore; per dir tutto, avevo bisogno di un successore a mammà, giacché non dovevo più vivere con lei; avevo bisogno che qualcuna vivesse con il suo allievo e nella quale io trovassi la semplicità, la docilità di cuore che lei aveva trovato in me; era necessario che la dolcezza della vita privata e domestica mi compensasse della carriera brillante alla quale rinunciavo. Quando ero del tutto solo il mio cuore era vuoto, ma non ce ne voleva che uno per riempirlo. Il destino mi aveva tolto, mi aveva alienato, almeno in parte, quello per il quale la natura mi aveva fatto. Ero solo da allora, giacché per me non vi fu mai via di mezzo tra tutto e niente. Trovai 20 in Teresa il supplemento di cui avevo bisogno; per lei vissi felice quanto potevo esserlo, dato il corso degli avvenimenti. Libro Ottavo Ritornando a Parigi appresi la piacevole notizia che Diderot era uscito dalla torre e che gli avevano dato il castello e il parco di Vincennes come prigione sulla sua parola, con il permesso di vedere i suoi amici. Come mi fu duro non potervi accorrere nello stesso istante! Ma trattenuto, per due o tre giorni, dalla signora Dupin per alcuni lavori indispensabili, dopo tre o quattro secoli d'impazienza, volai tra le braccia del mio amico. Momento inenarrabile! Non era solo. D'Alembert e il tesoriere della Sainte Chapelle erano con lui. Entrando, non vidi che lui, non feci che un salto, un grido, incollai il mio viso sul suo, lo strinsi forte senza parlargli in altro modo che con i miei pianti e i miei singhiozzi; mi sentivo soffocare dalla tenerezza e dalla gioia. Il suo primo moto dopo questo slancio di affetto fu di voltarsi verso il prete e dirgli: « Vedete, signore, come mi amano i miei amici ». Tutto preso dalla mia emozione non riflettei allora a questa maniera di trarne vantaggio. Ma dopo, ripensandoci qualche volta, ho sempre pensato che al posto di Diderot non sarebbe stata quella la prima idea che mi sarebbe venuta. Lo trovai molto scosso dalla sua prigione. Il torrione gli aveva fatto una impressione terribile e sebbene al castello stesse molto bene e fosse padrone delle sue passeggiate in un parco, che non era neanche cinto da muri, aveva bisogno della compagnia dei suoi amici per non abbandonarsi al suo umore nero. Poiché io ero certamente quello che compativa di più la sua pena, credetti di essere anche colui la cui visita gli fosse di maggiore consolazione, e ogni due giorni, al più tardi, malgrado le occupazioni mi assorbissero molto, andavo a passare con lui i pomeriggi sia solo, sia con sua moglie. In quest'anno 1749 l'estate fu terribilmente calda. Tra Parigi e Vincennes ci sono due leghe. Non essendo in condizioni da pagare le vetture, quando ero solo andavo a piedi, alle due del pomeriggio, e andavo in fretta per arrivare più presto. Gli alberi della strada sempre potati, secondo la moda del paese, non davano quasi nessuna ombra e spesso, spossato dal caldo e dalla stanchezza, mi sdraiavo per terra che non ne potevo più. Per moderare il mio passo pensai di prendere qualche libro. Un giorno presi il « Mercurio di Francia » e, sempre camminando e scorrendolo, vidi il problema proposto dall'Accademia di Digione per il premio dell'anno successivo: Se il progresso delle scienze delle arti ha contribuito a corrompere o a migliorare i costumi. Non appena lessi questo, vidi un altro universo e divenni un altro uomo. Sebbene abbia un ricordo vivo dell'impressione che ne ricevetti, i dettagli mi sono sfuggiti, da quando li ho affidati alla carta in una delle mie quattro lettere al signor di Malesherbes. È una delle stranezze della mia memoria che merita di esser narrata. Mi serve fino a che mi affido a lei; non appena confido alla carta l'argomento, mi abbandona e, una volta scritta una cosa, non me ne ricordo più del tutto. Questa stranezza mi perseguita finanche nella musica. Prima di averla imparata conoscevo a memoria una quantità di canzoni: non appena ho saputo cantare le arie scritte non ho potuto ritenerne nessuna e temo che, di quelle che ho preferito, oggi non saprei cantarne una intera. Quel che mi ricordo molto distintamente in questa occasione è che, arrivando a Vincennes, ero in una agitazione vicina al delirio. Diderot se ne accorse; gliene dissi la causa e gli lessi la prosopopea di Fabrizio scritta con il lapis sotto un albero. Mi esortò a dare il via alle mie idee e a concorrere al premio. Tutto il resto della mia vita e delle mie sventure fu l'effetto e la conseguenza inevitabile di questo momento di smarrimento. I miei sentimenti ascesero con la 21 più inconcepibile rapidità al tono delle mie idee. Tutte le mie piccole passioni furono soffocate dall'entusiasmo per la verità, la libertà, la virtù, e la cosa più sorprendente è che questa effervescenza si mantenne nel mio cuore, per più di quattro o cinque anni, a un livello così alto, come non è mai stata nel cuore di un altro uomo. . . . Quando terminai questo discorso, lo mostrai a Diderot, il quale ne fu contento e mi indicò qualche correzione. Pur nondimeno, questo lavoro pieno di calore e di forza, manca del tutto di ordine e di logica; tra tutti quelli che sono usciti dalla mia penna è il più debole nel ragionamento e il più povero di stile e di armonia, ma anche se si è nati con qualche capacità, l'arte di scrivere non si apprende d'un colpo. Spedii questo lavoro senza parlarne a nessun altro, se non, mi sembra, a Grimm con il quale, dopo il suo ingresso dal conte di Frièse, cominciavo a vivere nella più grande intimità. Egli aveva un clavicembalo che ci serviva da punto di riunione e attorno al quale passavo, con lui, tutti i miei momenti liberi a cantare arie italiane e barcarole, senza tregua e senza riposo, dalla mattina alla sera, o piuttosto dalla sera alla mattina, e, quando non mi si trovava dalla signora Dupin, si era sicuri di trovarmi da Grimm, o almeno con lui a passeggio, o a teatro. Smisi di andare alla commedia italiana dove avevo ingresso libero, ma che a lui non piaceva, per andare con lui, pagando, alla commedia francese della quale era appassionato. Insomma, una attrazione così forte mi legava a questo giovane e ne divenni talmente inseparabile, che anche la povera zia restava trascurata; cioè la vedevo meno; poiché mai per un momento, nella mia vita, si è affievolito il mio attaccamento per lei. Questa impossibilità di dividere alle mie passioni il poco tempo che avevo libero rinnovò, più forte che mai, il desiderio, che già avevo da lungo tempo, di fare casa unica con Teresa: ma l'ostacolo della sua famiglia numerosa, e soprattutto la mancanza di danaro per comprare i mobili, mi aveva trattenuto sino allora. L'occasione di fare uno sforzo si presentò e io ne approfittai. . . . La signora Le Vasnon mancava di spirito, si piccava e di educazione e di arie del gran mondo; ma aveva una misteriosa ipocrisia che mi era insopportabile, dava pessimi consigli a sua figlia, cercava renderla falsa con me e faceva moine ai miei amici separatamente e a spese gli uni degli altri e alle mie: quanto al resto, madre abbastanza buona perché trovava il suo tornaconto ad esserlo, copriva gli sbagli di sua figlia perché ne approfittava. Questa donna, che colmavo di attenzioni, di cure, di piccoli doni e dalla quale tenevo straordinariamente a farmi voler bene, era, per la mia impossibilità a giungervi, la sola causa di afflizione che avessi in casa mia; per il resto, posso dire di aver gustato durante questi sei o sette anni la più perfetta felicità domestica che la debolezza umana possa comportare. Il cuore della mia Teresa era quello di un angelo, il nostro attaccamento cresceva con la nostra intimità e sentivamo sempre di più, giorno per giorno, come eravamo fatti l'uno per l'altra. Se i nostri piaceri potessero esser descritti farebbero ridere per la loro semplicità: le passeggiate in due fuori città, dove spendevo con magnificenza otto o dieci soldi in qualche bettola; le cenette all'inferriata della mia finestra, seduti di fronte su due piccole sedie poste su un baule che ne occupava la larghezza del vano. In questa situazione la finestra ci serviva da tavola; respiravamo l'aria aperta; potevamo vedere quanto ci circondava, i passanti; e, sebbene fossimo al quarto piano, potevamo sentirci in strada anche mangiando. Chi saprà descrivere, chi comprenderà l'incanto di questi pasti formati da un quarto di pane ordinario, da qualche ciliegia, da un pezzetto di formaggio e da un quartuccio di vino che bevevamo in due? Amicizia, confidenza, intimità, dolcezza d'animo, che delizia quando siete con noi! Qualche volta restavamo là sino a mezzanotte, senza pensarci e senza accorgerci dell'ora, se la vecchia madre non ci avesse avvertiti. Ma lasciamo stare questi dettagli che potranno sembrare insipidi, o ridicoli: l'ho sempre detto e compreso, la vera gioia non si descrive. 22 L'anno successivo 1750, quando non pensavo più al mio discorso, seppi che esso aveva ottenuto il premio a Digione. Questa notizia risvegliò tutte le idee che me lo avevano dettato, le animò di una forza nuova e finì di mettere in fermento, nel mio cuore, quel primo lievito di eroismo e di virtù che mio padre, la mia patria e Plutarco vi avevano messo durante la mia infanzia. Non trovai più niente di grande e di bello se non essere libero, virtuoso, al di sopra della fortuna e di ogni giudizio, e bastare a se stesso. Sebbene la vergogna nociva e il timore dei fischi mi impedissero, da principio, di vivere secondo questi principi e di romperla bruscamente con le massime del mio secolo, sin da allora ne abbi la decisa volontà e non tardai ad attuarla che il tempo necessario perché le contraddizioni la irritassero e la rendessero trionfante. Mentre filosofeggiavo sui doveri dell'uomo, sopraggiunse un avvenimento a farmi riflettere meglio sui miei. Teresa rimase incinta per la terza volta. Troppo sincero con me stesso, troppo fiero nel mio intimo per voler smentire i miei principi con le mie azioni, mi misi ad esaminare il destino dei miei figli, e i miei rapporti con la loro madre, secondo le leggi della natura, della giustizia e della ragione, e secondo quelle di questa religione pura e santa, eterna come il suo autore che gli uomini hanno contaminato fingendo di volerla purificare, e della quale con le loro formule non hanno fatto che una religione di parole, visto che costa poco ordinare l'impossibile quando ci si dispensa di praticarlo. Se mi ingannai nei miei risultati, niente è più meraviglioso della sicurezza d'animo con la quale mi ci abbandonai. Se fossi stato uno di quegli uomini mal nati, sordi alla dolce voce della natura, nell'intimo dei quali nessun vero sentimento di giustizia e di umanità germinò mai, questo indurimento sarebbe naturale, ma quel cuore caldo, quella sensibilità tanto viva, quella facilità ad affezionarsi, la forza con la quale gli affetti mi soggiogano, gli schianti crudeli quando bisogna romperli, la benevolenza innata per tutti i miei simili, l'amore ardente per il grande, il vero, il bello, il giusto, l'orrore del male, qualunque fosse, l'incapacità di odiare, di nuocere e anche di volerlo, la commozione, la viva e dolce emozione che provo di fronte a tutto quanto è virtuoso generoso amabile; tutto questo può accordarsi nella stessa anima con la depravazione che fa calpestare senza alcuno scrupolo il più dolce dei doveri? No, lo sento e lo dico ad alta voce, non è possibile; mai per un solo istante nella sua vita Gian Giacomo ha potuto essere un uomo senza viscere, senza costumi, un padre snaturato. Ho potuto ingannarmi, ma non indurirmi. Se esponessi le mie ragioni, direi troppo. Giacché hanno potuto sedurmi, sedurrebbero molti altri e non voglio esporre i giovani che mi leggeranno a lasciarsi ingannare dallo stesso errore. Mi accontenterò di dire che esso fu tale che, da quel momento, non guardai più i miei legami con Teresa che come una unione onesta e santa, sebbene libera e volontaria; la mia fedeltà verso di lei, come un dovere indispensabile, finché la unione durava; l'infrazione che avevo fatto una sola volta come un vero adulterio. E quanto ai miei figli, abbandonandoli all'educazione pubblica, giacché non potevo allevarli io stesso, destinandoli a diventare operai, o contadini, piuttosto che avventurieri e cercatori di fortuna, credetti di agire da cittadino e da padre; e guardai me stesso come un membro della repubblica di Platone. Dopo, più di una volta, i rimpianti del mio cuore mi hanno detto che mi ero ingannato; ma, anziché sentire lo stesso con la ragione, ho spesso benedetto il cielo di averli così preservati dal destino del loro padre e da quello che li avrebbe minacciati, quando sarei stato costretto ad abbandonarli. Se li avessi affidati alla signora d'Èpinay o alla signora di Luxembourg, le quali, o per amicizia, o per generosità, o per qualche altra ragione, hanno voluto incaricarsene in seguito, sarebbero stati educati ad essere persone oneste? Non lo so; ma sono sicuro che li avrebbero portati ad odiare, forse a tradire i loro genitori: è cento volte meglio che non li abbiano conosciuti. Il mio terzo figlio fu dunque messo ai trovatelli, come gli altri due; e fu lo stesso per i due che seguirono; infatti ne ho avuti cinque in tutto. Questa sistemazione mi sembrò così buona, così sensata che, se non me ne vantai apertamente, fu 23 esclusivamente per riguardo verso la madre, ma lo dissi a tutti quelli ai quali i nostri rapporti non erano ignoti; lo dissi a Diderot, a Grimm; lo dissi poi alla signora d'Épinay e dopo ancora alla signora di Luxembourg, e a testa alta, con franchezza, senza alcuna necessità, quando potevo facilmente nasconderlo a tutti. Al tempo di cui parlo, forse perché mi ero stancato col noioso lavoro di quella maledetta cassa, ricaddi peggio di prima e restai a letto, quasi sei settimane, nel più triste stato che si possa immaginare. La signora Dupin mi mandò il celebre Morand, il quale, malgrado la sua abilità e la delicatezza della sua mano, mi fece soffrire dei dolori incredibili e non riuscì mai a sbloccarmi. Mi consigliò di ricorrere a Daran, i cui cateteri più flessibili, infatti, riuscirono ad insinuarsi e a vincere l'ostacolo; ma, riferendo delle mie condizioni alla signora Dupin, Morand le dichiarò che tra sei mesi non sarei stato più in vita. Questo discorso mi giunse alle orecchie, e mi fece fare delle serie riflessioni sul mio stato e sulla bestialità di sacrificare la tranquillità e il piacere dei pochi giorni che mi restavano da vivere all'assoggettamento di un impiego, per il quale non sentivo che disgusto. Del resto, come accordare i severi principi che avevo adottati con una condizione che vi si adattava così poco? E non avrei dovuto avere un bel coraggio io, cassiere di un ricevitore generale delle finanze, a predicare il disinteresse e la povertà? Queste idee, con la febbre fermentarono così bene nella mia testa, vi si combinarono con tanta forza che niente, da allora, ha potuto sradicarle e, durante la mia convalescenza, a sangue freddo, mi confermai in tutte le risoluzioni che avevo prese nel mio delirio. Rinunciai per sempre ad ogni progetto di fortuna e di avanzamento. Deciso a trascorrere nella indipendenza e nella povertà il poco tempo che mi restava da vivere, rivolsi tutte le forze dell'anima mia a spezzare i ferri dell'opinione pubblica, e a fare con coraggio tutto quello che mi sembrava fosse bene, senza intimidirmi, per nulla, del giudizio degli uomini. Gli ostacoli contro i quali dovetti lottare e gli sforzi che feci per trionfarne sono incredibili. Vi riuscii, per quanto era possibile, e meglio di quanto io stesso non avessi sperato. Se avessi scosso il giogo della amicizia così bene, come quello della opinione pubblica, sarei riuscito nel mio progetto, forse il più grande, o almeno il più utile alla virtù che un mortale abbia mai concepito: ma mentre calpestavo i giudizi insensati della turba volgare dei sedicenti grandi e dei sedicenti saggi, mi lasciavo soggiogare e menare come un bimbo dai sedicenti amici, i quali, gelosi di vedermi andare fiero e solo per una strada nuova, sempre mostrando di occuparsi molto a rendermi felice, in realtà non si occupavano che a rendermi ridicolo, e cominciarono col lavorare ad avvilirmi per arrivare dopo a diffamarmi. Fu meno la mia celebrità letteraria che la mia riforma personale, della quale segno qui l'epoca, che mi attirò la loro gelosia: forse mi avrebbero perdonato di brillare nell'arte dello scrivere, ma non poterono perdonarmi di dare con la mia condotta un esempio che non volevano seguire e che sembrava li infastidisse. Ero nato per l'amicizia, il mio carattere facile e dolce la coltivava senza fatica. Finché vissi ignorato dal pubblico fui amato da tutti quelli che mi conobbero, e non ebbi un solo nemico: ma non appena ebbi un nome, non ebbi più amici. Fu una grande disgrazia; e una più grande ancora fu di essere circondato da persone che prendevano questo nome e che usarono dei diritti che esso dava loro esclusivamente per trascinarmi alla rovina. Il seguito di queste memorie svolgerà questa odiosa trama; qua non ne mostro che l'origine, presto se ne vedrà formare il primo nodo. Nella indipendenza nella quale volevo vivere bisognava pur sostentarsi. Pensai ad un nuovo mezzo molto semplice: copiare musica a tanto per pagina. Se qualche occupazione più solida avesse raggiunto lo stesso scopo l'avrei presa, ma poiché questa era di mio gusto, la sola che potesse darmi pane giorno per giorno, mi attenni ad essa. Credendo di non dovere più essere previdente facendo tacere la 24 vanità, da cassiere di un ricevitore generale delle finanze divenni copista di musica. Credetti di aver guadagnato molto con questa scelta, e me ne sono così poco pentito, che non ho abbandonato questo mestiere che per forza, per riprenderlo non appena fosse stato possibile. Il successo del mio primo discorso mi rese più facile realizzare questa decisione. Diderot si era incaricato di farlo stampare. Mentre ero a letto, mi scrisse un biglietto per darmi notizia della pubblicazione e dell'effetto. Mi scriveva: « Si innalza oltre le nubi, non vi è altro esempio di simile successo ». Questo favore del pubblico, per nulla ricercato e per un autore sconosciuto, mi diede la prima vera sicurezza del mio ingegno, del quale avevo sempre dubitato, sino ad allora. Compresi quanto vantaggio potevo trarne per la decisione che stavo per prendere, e pensai che un copista, in un certo modo celebre nelle lettere, non avrebbe dovuto mancare di lavoro. Non appena presi definitivamente la mia risoluzione, scrissi un biglietto al signor di Francueil per partecipargliela, per ringraziarlo, come la signora Dupin, di tutte le loro bontà e per chiedere la loro clientela. Francueil, non comprendendo niente con questo biglietto e credendomi ancora nel delirio della febbre, accorse a casa mia; ma mi trovò così fermo nella mia decisione che non riuscì a scuoterla. Andò a dire alla signora Dupin e a tutti che ero diventato pazzo; lasciai dire e continuai. Cominciai la mia riforma dal mio vestiario, abbandonai le dorature e le calze bianche, adottai una parrucca rotonda, posai la spada, vendetti il mio orologio, dicendomi con incredibile gioia: « Grazie al cielo non avrò più bisogno di sapere che ora è ». Il signor di Francueil ebbe la correttezza di aspettare ancora a lungo, prima di provvedere alla sua cassa. Alla fine, vedendomi deciso, la affidò al signor d'Alibart, già tutore del giovane Chenonceaux e conosciuto in botanica per la sua Flora parisiensis. Per quanto austera fosse la mia riforma estetica, da principio non la estesi sino alla mia biancheria, che era bella ed abbondante, resto nel mio corredo di Venezia, al quale ero particolarmente attaccato. A furia di farne un oggetto di pulizia ne avevo fatto un oggetto di lusso che mi era dispendioso. Qualcuno mi rese il servizio di liberarmi da questa schiavitù. La vigilia di Natale, mentre le donne erano ai vespri ed io al concerto sacro, forzarono la porta di un granaio dove era sciorinata tutta la nostra biancheria, dopo un bucato fatto poco prima. Rubarono tutto e tra l'altro quarantadue camicie mie di tela bellissima e che costituivano il pezzo forte del mio corredo. . . . Questa avventura mi guarì dalla passione della biancheria bella, e da allora non ne ho avuto che di molto comune, più adattata al resto del mio equipaggiamento. Completata così la mia riforma, non mi preoccupai più di altro che di consolidarla e renderla, duratura, lavorando a sradicare dal mio cuore tutto quello che ancora era ligio al giudizio degli uomini, tutto quello che, per timore di biasimo, poteva sviarmi da quel che era buono e ragionevole in se stesso. Aiutata dallo scalpore che faceva la mia opera, anche la mia decisione fece scalpore e mi procacciò clienti; in maniera che cominciai il mio mestiere con abbastanza successo. Tuttavia, diverse ragioni mi impedirono di riuscirvi come avrei potuto in altre circostanze. Prima di tutto la mia cattiva salute. . . . Le occupazioni letterarie furono un'altra distrazione, non meno dannosa al mio lavoro di tutti i giorni. Non appena apparve il mio discorso, i difensori delle lettere si scagliarono su di me, tutti insieme. Indignato che tanti piccoli signor Josse2, i quali non capivano neanche il problema, volessero giudicare da maestri, presi la penna e ne trattai alcuni in maniera da lasciarli coperti di ridicolo. . . . Tutta questa polemica mi occupava molto, con molta perdita di tempo per il mio copiato, poco vantaggio per la verità e poco vantaggio per la mia borsa, poiché Pissot, che era allora il mio libraio, mi diede sempre molto poco per i miei opuscoli, spesso niente. Per esempio non ebbi un quattrino dal mio primo discorso; 2 Personaggio di una commedia di Molière, divenuto il tipo proverbiale del consigliere interessato. 25 Diderot glielo diede gratuitamente. Bisognava aspettare molto e strappare soldo a soldo il poco che mi dava. Intanto il copiato non procedeva. Facevo due mestieri, era il metodo per fare male l'uno e l'altro. Essi erano in contrasto ancora per le diverse maniere di vivere alle quali mi costringevano. Il successo dei miei primi scritti mi aveva reso di moda. La decisione che avevo presa eccitava la curiosità: volevano conoscere quest'uomo strano che non cercava nessuno e non si preoccupava di niente, tranne che di vivere libero a modo suo; bastava questo perché non lo potesse. La mia camera era sempre piena di gente che con diversi pretesti veniva a rubarmi il mio tempo. Le donne usavano mille astuzie per avermi a pranzo. Più trattavo male le persone più loro si ostinavano. Non potevo respingere tutti. Facendomi mille nemici con i miei rifiuti, ero sempre sopraffatto dalla mia compiacenza, e, in qualunque maniera mi comportassi, non avevo un'ora al giorno per me. Capii allora che non è sempre così facile come si immagina essere povero ed indipendente. Volevo vivere del mio lavoro; il pubblico non voleva. Escogitavo mille modi per ricompensarmi del tempo che mi facevano perdere. I regali di ogni specie venivano a cercarmi. Presto avrei dovuto mostrarmi come Pulcinella, a tanto per persona. Non conosco un asservimento più avvilente e più crudele di quello. Non vi trovai altro rimedio che rifiutare i regali grandi e piccoli, senza fare eccezione per nessuno. Tutto ciò non fece che attrarre i donatori che volevano avere la gloria di vincere la mia resistenza e costringermi ad essere loro obbligato, mio malgrado. Chi non mi avrebbe dato uno scudo, se glielo avessi domandato, non cessava di importunarmi con le sue offerte, e, per vendicarsi di vederle respinte, tacciava i miei rifiuti di arroganza e ostentazione. . . . Questi urti continui e le noie quotidiane delle quali ero vittima finirono col rendermi sgradevole il mio soggiorno a Parigi. Quando i miei malanni mi permettevano di uscire ed io non mi lasciavo trascinare qua o là dai miei conoscenti, andavo a passeggiare solo, pensavo al mio grande sistema, affidavo qualche cosa alla carta grazie ad una matita e ad un libretto che avevo sempre nella mia tasca. Ecco come le noie impreviste di una maniera di vivere che avevo scelto io stesso mi fecero dedicare alla letteratura per cercarvi sollievo, ed ecco perché, in tutte le mie prime opere, trasfusi la collera e lo stato d'animo che me ne facevano occupare. Ancora un'altra cosa vi contribuiva. Lanciato nel mondo, mio malgrado, senza averne il fare e senza essere in grado di acquistarlo, pensai di assumerne uno mio particolare che me ne dispensasse. Poiché la mia stupida e sgradevole timidezza invincibile aveva origine dal timore di venir meno alle buone maniere, decisi di calpestarle tutte. Divenni cinico e caustico per vergogna, e finsi di disprezzare la buona educazione che non sapevo seguire. È vero che questa rudezza, conforme ai miei nuovi principi, si nobilitava nella mia anima, vi assumeva l'intrepidezza della virtù; ed oso dire che è proprio su questa augusta base che si è sorretta meglio e più a lungo di quanto non ci si sarebbe dovuto aspettare da uno sforzo così contrario al mio carattere. Tuttavia, malgrado la fama di misantropia che il mio aspetto e qualche frase felice mi fecero in società, è certo che, in privato, rappresentai sempre male la mia parte, che i miei amici e i miei conoscenti menavano questo orso selvaggio come un agnello, e che limitando i miei sarcasmi ad alcune verità dure, ma generali, non ho saputo mai dire a nessuno una sola parola scortese. Capisco perfettamente che, se un giorno queste memorie arriveranno a veder la luce, io stesso eterno qui il ricordo di un fatto del quale volevo cancellare la traccia, ma ne trasmetto molti altri, mio malgrado. Il nobile scopo del mio lavoro che sempre è presente ai miei occhi, il preciso dovere di adempierlo pienamente non mi lasceranno distogliere da considerazioni più deboli che potrebbero allontanarmene. Nella strana singolare situazione nella quale mi trovo mi sento di dover troppo alla verità per dovere di più ad altri. 26 Per conoscermi bene bisogna conoscermi in tutti i miei rapporti buoni e cattivi. Le mie confessioni sono necessariamente legate con quelle di molte persone: faccio le mie e le altrui con la stessa franchezza in tutto quanto si riferisce a me, non credendo di dovere a chiunque altro maggiore riguardo quanto non ne abbia per me stesso, e volendo tuttavia averne di più. Voglio essere sempre giusto e sincero, dire degli altri bene fino a che mi sarà possibile, non dire mai che il male che mi riguarda e per quel tanto che vi sono costretto. Chi, nelle condizioni nelle quali mi hanno messo, ha il diritto di esigere di più da me? Le mie confessioni non sono fatte per apparire, me vivo, né mentre sono vive le persone di cui vi è trattato. Se fossi padrone del mio destino e di quello di questo scritto, esso non vedrebbe la luce che molto tempo dopo la mia morte e la loro. Ma gli sforzi che il terrore della verità fa fare ai miei potenti oppressori, per cancellarne le tracce, mi costringono a fare, per conservarle, tutti gli sforzi permessi dal più preciso diritto e dalla più severa giustizia. Se la mia memoria si dovesse spegnere con me, piuttosto che compromettere qualcuno soffrirei senza fiatare un obbrobrio ingiusto e passeggero: ma poiché il mio nome deve vivere e passare ai posteri, debbo a me stesso di cercar di trasmettere con esso il ricordo dell'uomo sfortunato che lo portò, quale fu realmente e non quale i suoi iniqui nemici lavorano incessantemente a dipingerlo. Libro Nono L'impazienza di abitare in campagna non mi fece aspettare il ritorno della bella stagione e non appena il mio alloggio fu pronto mi affrettai ad andarvi, seguito dalla baia dell'ambiente di Holbach, dove si prevedeva, pubblicamente, che non avrei sopportato neanche tre mesi di solitudine, e che presto mi avrebbero visto ritornare a vivere a Parigi come loro, vergognoso per poco. Io che, lontano dal mio elemento da più di quindici anni, agognavo solo l'ora di rientrarvi, non facevo neanche attenzione ai loro scherzi. Da quando mi ero lanciato nel mondo, mio malgrado, non avevo cessato di rimpiangere le mie care Charmettes e la dolce vita che vi avevo condotta. Mi sentivo fatto per la campagna e la vita ritirata; non potevo vivere felice in altro luogo: a Venezia nel vortice dei pubblici affari, nella dignità di una certa funzione rappresentativa, nell'orgoglio dei progetti di carriera; a Parigi nel turbinio del gran mondo, nella sensualità dei pranzi, nello splendore degli spettacoli, nel fumo della vanità, i miei boschi, i miei ruscelli, le mie passeggiate solitarie venivano sempre a distrarmi con il loro ricordo, a rattristarmi, a strapparmi sospiri e desideri. Tutti i lavori ai quali avevo potuto sobbarcarmi, tutti i progetti di ambizione che avevano animato il mio zelo, non avevano altro scopo che arrivare: un giorno, a quei felici ozi campestri, ai quali ora speravo di essere giunto. Senza essere giunto all'onesto benessere che solo avevo creduto mi ci potesse condurre, pensavo di essere in condizione da farne a meno, per la mia particolare situazione, e poter arrivare allo stesso scopo attraverso una strada del tutto opposta. Non avevo un soldo di rendita, ma avevo un nome, delle capacità; ero sobrio e mi ero liberato dalle esigenze più dispendiose, tutte quelle dell'opinione pubblica. Oltre a ciò, sebbene pigro, ero laborioso quando volevo esserlo, e la mia pigrizia era non quella di un fannullone, ma quella di un uomo indipendente che non sa lavorare che quando vuole. Il mio mestiere di copista musicale non era né brillante, né lucroso, ma era sicuro. In società mi erano grati di aver avuto il coraggio di sceglierlo. Potevo esser certo che il lavoro non mi sarebbe mancato e che, lavorando bene, avrebbe potuto bastarmi. Duemila franchi che mi restavano dal guadagno sull'Indovino del villaggio e sugli altri miei scritti costituivano un di più per non essere alle strette, e molte opere che avevo in lavorazione mi 27 promettevano, senza vessare gli editori, dei supplementi sufficienti per lavorare con comodo, senza sovraccaricarmi e anche utilizzando gli ozi della passeggiata. La mia piccola famiglia, composta da tre persone che si occupavano tutte utilmente, non richiedeva molte spese. Insomma le mie risorse, proporzionate ai miei bisogni e ai miei desideri, potevano ragionevolmente promettermi una vita felice sulla strada che le mie tendenze mi avevano fatto scegliere. Avrei potuto dedicarmi interamente alla occupazione più rimunerativa, e anziché asservire la mia penna alla copia dedicarla interamente agli scritti, che per lo slancio che avevo preso e che mi sentivo in grado di mantenere, potevano farmi vivere nell'abbondanza ed anche nella ricchezza, se avessi appena voluto unire delle manovre di autore alla cura di pubblicare buoni libri. Ma, senza ripetere ciò che ho detto sullo stesso argomento, aggiungerò soltanto che scrivere libri per guadagnarmi il pane avrebbe presto soffocato il mio genio e ucciso il mio talento. Esso era non tanto nella mia penna quanto nel mio cuore e, nato da una maniera di pensare nobile e fiera, questa sola poteva alimentarlo. Niente di forte, niente di grande può uscire da una penna del tutto venale. La necessita, l'avidità forse, mi avrebbe fatto fare più presto che bene. Se il bisogno del successo non mi avesse cacciato tra le cabale, mi avrebbe fatto meno cercar di dire cose utili e vere, che cose che piacessero alla moltitudine; e da scrittore distinto, quale potevo essere, non sarei stato che un imbrattatore di carta. No, no; ho sempre sentito che il lavoro di autore è, e può essere, rispettabile e illustre, solo finché non è un mestiere. È troppo difficile pensare nobilmente quando non si pensa che per vivere. Per potere, per osar dire delle grandi verità, non bisogna dipendere dal successo. Davo i miei libri al pubblico con la certezza di aver parlato per il bene comune, senza nessuna preoccupazione per il resto. Se l'opera veniva respinta tanto peggio per coloro che non volevano profittarne. Io non avevo bisogno della loro approvazione per vivere. Avevo un mestiere che poteva sfamarmi, se i miei libri non si vendevano; ed è proprio questo che li faceva vendere. Fu il 9 aprile 1756 che abbandonai la città per non abitarvi più; infatti non considero tali i brevi soggiorni che ho avuto dopo, sia a Parigi che in altre città, sempre di passaggio e sempre mio malgrado. . . . Eccomi ora finalmente in un asilo piacevole e solitario, padrone di trascorrervi i miei giorni in quella vita indipendente, uguale e pacifica per la quale mi sentivo nato. Prima di parlare dell'effetto che questa vita così nuova per me fece sul mio cuore, è giusto rivederne i segreti sentimenti, per poter seguire meglio nella sua causa il progresso di queste nuove modificazioni. Ho sempre considerato il giorno che mi unì alla mia Teresa, come quello che determinò il mio essere morale. Avevo bisogno di un affetto giacché quello che doveva bastarmi era stato, alla fine, così crudelmente spezzato. La sete di felicità non si estingue nel cuore dell'uomo. Mammà invecchiava e si avviliva! Mi era chiaro che non potevo più esser felice in questo mondo. Perduta ogni speranza di condividere la sua, dovevo cercare una felicità a me confacente. Per qualche tempo ondeggiai d'idea in idea, di progetto in progetto. Il mio viaggio a Venezia mi avrebbe lanciato negli affari pubblici, se l'uomo con il quale mi ero messo avesse avuto senso comune. Sono facile allo scoraggiamento, soprattutto nelle imprese faticose e a lunga scadenza. L'insuccesso di questa mi disgustò di ogni altra e, guardando, secondo la mia antica massima, gli oggetti lontani come le lusinghe di un inganno, decisi ormai di vivere giorno per giorno, non vedendo più nella vita niente che potesse impegnarmi. Fu proprio allora che ci conoscemmo. Il carattere dolce di questa buona ragazza mi sembrò che si adattasse così bene al mio, che mi unii a lei di un affetto a prova del tempo e dei torti e che si è accresciuto anche attraverso ciò che avrebbe dovuto spezzarlo. In seguito conoscerete la forza di questo affetto, quando scoprirò le piaghe, le trafitture con le quali lei ha torturato il mio cuore nell'imperversare delle mie sciagure, senza che mai, sino al momento in cui scrivo questo, mi sia sfuggita con nessuno una sola parola di sfogo. . . . 28 Io mi ripeto, si sa, ma è necessario. Il primo di tutti i miei bisogni, il più grande, il più forte, il più inestinguibile era tutto nel mio cuore: era il bisogno di una compagnia intima, e intima quanto poteva esserlo; per questo soprattutto avevo bisogno di una donna più che di un uomo, di un'amica più che di un amico. Questo strano bisogno era tale che la più stretta unione dei corpi non poteva bastare: avrei avuto bisogno di due anime nello stesso corpo; senza questo sentivo sempre un vuoto. Credetti di esser arrivato a non sentirlo più. Questa giovane donna, amabile per mille eccellenti qualità, e allora anche per la sua figura senza ombra di arte o di civetteria, avrebbe racchiusa in sé sola la mia esistenza, se io avessi potuto racchiudere la sua in me, come avevo sperato. Non avevo niente da temere da parte degli uomini; sono sicuro di essere il solo che lei abbia veramente amato; e i suoi sensi tranquilli non le hanno mai chiesto altri, anche quando io per lei non fui più uno, sotto questo aspetto. Io non avevo famiglia; lei ne aveva una; e questa famiglia i cui membri erano tutti troppo diversi da lei non fu tale che io potessi farne la mia. Fu questa la prima causa della mia infelicità. Che cosa non avrei dato per diventare il figlio di sua madre! Feci di tutto per riuscirci e non riuscii. Ebbi un bel volere unire tutti i nostri interessi, mi fu impossibile. Se ne creò sempre uno diverso dal mio, contrario al mio e anche a quello di sua figlia che già ne era più separato. . . . Dedita a sua madre e ai suoi, fu più loro che mia o di se stessa. . . . Ecco come in un affetto sincero e reciproco, nel quale misi tutta la tenerezza del mio cuore, il vuoto di questo cuore non fu mai ben colmato. I figli che lo avrebbero colmato, vennero; fu ancora peggio. Fremetti di abbandonarli a questa famiglia male educata, perché venissero educati ancora peggio. I rischi dell'educazione dei trovatelli erano per loro cento volte meno funesti. Questa ragione della decisione che presi, più forte di tutte quelle che comunicai nella mia lettera alla signora di Francueil, fu la sola che non osai dirle. Fin tanto che lo potevo, preferii non discolparmi di un biasimo così grave e risparmiare la famiglia di una persona che amavo. Ma, dai costumi del suo infelice fratello, potete giudicare, checché se ne possa dire, se dovevo esporre i miei figli a ricevere una educazione simile alla sua. Non potendo gustare nella sua pienezza questa intima unione, di cui sentivo il bisogno, vi cercavo dei completamenti che non ne riempivano il vuoto, ma che me lo facevano sentire di meno. Per la mancanza di un amico, che fosse tutto per me, avevo bisogno di amici il cui impulso superasse la mia inerzia. Fu così che coltivai, che rafforzai i miei rapporti con Diderot, con l'abate di Condillac; che ne strinsi nuovi con Grimm, e ancora più stretti, e che, infine, per quell'infelice discorso di cui ho narrato la storia, mi trovai, senza accorgermene, lanciato da capo nella letteratura dalla quale mi credevo fuori per sempre. Il mio esordio mi fece seguire una nuova strada che mi gettò in un altro mondo intellettuale, del quale non potei senza entusiasmo esaminarne la semplice e fiera economia. Presto, a furia di occuparmene, non vidi più che errore e follia nella dottrina dei nostri saggi, che oppressione e miseria nel nostro ordine sociale. Nell'illusione del mio stupido orgoglio mi credetti fatto per dissipare tutte queste forze; e pensando che per farmi ascoltare bisognasse mettere la mia condotta d'accordo con i miei principi, presi l'andamento strano che non mi hanno mai permesso di seguire, di cui i miei pretesi amici non mi hanno mai perdonato di dare l'esempio, che, da principio, mi rese ridicolo e che, alla fine, mi avrebbe reso degno di rispetto, se mi fosse stato possibile perseverare. Sino allora ero stato buono; da allora divenni virtuoso, o almeno ebbro della virtù. Questa ebbrezza era cominciata nella mia testa, ma era passata nel mio cuore. Il più nobile orgoglio vi germogliò sui resti della vanità sradicata. Non recitavo: divenni davvero quale apparivo; e, durante gli almeno quattro anni che durò questa effervescenza, niente di grande e di bello poté entrare in un cuore d'uomo che io non potessi realizzare tra il cielo e me. Ecco da dove nacque la mia sublime 29 eloquenza, ecco da dove si trasfuse nei miei primi libri quel fuoco, veramente celeste, che mi riscaldava internamente e di cui, per quarant'anni, non era sprizzata la più piccola favilla, perché non si era ancora acceso. Ero veramente trasformato; i miei amici, i miei conoscenti non mi riconoscevano più. Non ero più quell'uomo timido, e più vergognoso che modesto, che non osava né presentarsi, né parlare, che una parola scherzosa turbava, che uno sguardo di donna faceva arrossire. Audace, fiero, intrepido, portavo dovunque una sicurezza altrettanto irremovibile e semplice che era più nella mia anima che nel mio comportamento. Il disprezzo che le mie profonde meditazioni mi avevano ispirato per i costumi, per le massime e i pregiudizi del mio secolo, mi rendeva insensibile ai motteggi di coloro che li seguivano e annientavo i loro frizzi con le mie sentenze, come avrei annientato un insetto tra le mie dita. Che cambiamento sorprendente! Tutta Parigi ripeteva gli acri e mordenti sarcasmi di questo stesso uomo, che due anni prima e dieci anni dopo non ha mai saputo trovare quello che doveva dire, né la parola che doveva usare. Si cerchi nel mondo lo stato più contrario alla mia natura; troverete quello. Ricordatevi uno di quei brevi momenti della mia vita in cui diventavo un altro e cessavo di essere io; lo si trova ancora nel tempo in cui parlo: ma, invece di durare sei giorni, sei settimane, durò quasi sei anni e forse durerebbe ancora, se non ci fossero state quelle particolari circostanze che lo fecero cessare, e mi restituirono alla natura, al di sopra della quale avevo voluto elevarmi. Questo cambiamento cominciò non appena lasciai Parigi e lo spettacolo dei vizi di questa grande città cessò di alimentare l'indignazione che mi aveva ispirato. Quando non vidi più gli uomini smisi di disprezzarli, quando non vidi più i cattivi smisi di odiarli. Il mio cuore, fatto poco per l'odio, non fece più che deplorare la loro miseria e non ne rilevava la loro cattiveria. Questo stato più dolce, ma molto meno sublime, smorzò ben presto l'ardente entusiasmo che mi aveva inebriato per tanto tempo; e, senza che ci se ne accorgesse, senza accorgermene neanche io stesso, ridivenni timoroso, compiacente, facile, in una parola, lo stesso Gian Giacomo che ero stato prima. Se il cambiamento non avesse fatto che restituirmi a me stesso e si fosse fermato là, tutto sarebbe andato bene; ma disgraziatamente, andò oltre e mi condusse rapidamente all'altro estremo. Da allora la mia anima ondeggiante non ha più fatto che attraversare lo stato di tranquillità e le sue oscillazioni, sempre rinnovantesi, non le hanno mai permesso di restarvi. Entriamo nei particolari di questo secondo cambiamento: epoca terribile e fatale di un destino che non ha esempi tra i mortali. Avevo una casa isolata, in una meravigliosa solitudine; padrone in casa mia potevo vivere a modo mio, senza che nessuno potesse controllarmi. Questa casa però mi imponeva dei doveri dolci da compiere, ma indispensabili. Tutta la mia libertà non era che precaria; più che da ordini, dovevo essere asservito dalla mia volontà; non c'era un solo giorno in cui, alzandomi, potessi dire: « Lo impiegherò come mi piacerà ». Molto peggio; oltre la mia dipendenza dalle disposizioni della signora di Èpinay, ne avevo un'altra, molto più noiosa, dal pubblico e dai sopravvenienti. La distanza da Parigi non impediva che ogni giorno venissero delle schiere di sfaccendati i quali, non sapendo che fare del loro tempo, sperperavano il mio, senza alcuno scrupolo. Quando meno ci pensavo ero spietatamente assalito; e raramente ho fatto un bel progetto, senza vederlo capovolgere da qualche sopraggiunto. In breve, in mezzo ai beni che avevo maggiormente desiderato, non trovando la pura gioia, riandavo con trasporto ai giorni sereni della mia gioventù e talvolta esclamavo sospirando: « Ah! non sono questi i giorni delle Charmettes! ». Il ricordo dei diversi periodi della mia vita mi portò a riflettere sul punto al quale ero giunto e mi vidi già sul declino della gioventù, preda di mali dolorosi, credendo di essere vicino alla fine della mia vita, senza aver gustato nella sua pienezza quasi nessuno dei piaceri di cui il mio cuore era avido, senza aver dato sfogo ai sentimenti vivi che sentivo di avere in riserva, senza aver assaporato, senza aver 30 almeno sfiorato quella inebriante voluttà che sentivo in potenza nella mia anima e che, per mancanza di un oggetto, vi restava sempre compressa senza potersi sfogare che attraverso i miei sospiri. Come era possibile che con un'anima espansiva per natura, per la quale vivere era amare, non avessi trovato sino ad allora un amico tutto per me, un vero amico, io che mi sentivo così fatto per esserlo? Come poteva essere che con dei sensi così infiammabili, che con un cuore fatto di amore non avessi bruciato della sua fiamma, almeno una sola volta, per un oggetto determinato? Divorato dal bisogno di amare, senza averlo mai potuto ben soddisfare, mi vedevo avvicinarmi alle porte della vecchiaia e morire senza avere vissuto. Queste riflessioni tristi, ma commoventi, mi facevano ripiegare su me stesso con un rimpianto che non era senza dolcezza. Mi sembrava che il destino mi dovesse qualche cosa che non mi aveva dato. A che pro avermi fatto nascere con delle virtù squisite, per lasciarle perdere sino alla fine? La consapevolezza del mio valore intimo dandomi quella di questa ingiustizia me ne ricompensava in qualche modo, e mi faceva versare delle lacrime che mi piaceva lasciare scorrere. J. J. Rousseau LE FANTASTICHERIE DEL PASSEGGIATORE SOLITARIO Quinta passeggiata Fra tutti i luoghi in cui ho abitato – e ce ne sono stati di davvero incantevoli –, nessuno mi ha reso così pienamente felice e mi ha lasciato così dolci rimpianti come l’Isola di Saint-Pierre, in mezzo al lago di Bienne. Quest’isoletta che a Neuchâtel chiamano isola della Motte è piuttosto sconosciuta, perfino in Svizzera. Nessun viaggiatore, a quanto ne so, ne accenna. E tuttavia è piacevolissima e particolarmente ben situata per fare la felicità di un uomo cui piaccia appartarsi; benché io sia forse il solo al mondo il cui destino ne ha fatto una legge, non posso credere di essere il solo che abbia un gusto così naturale, anche se fino ad ora non l’ho riscontrato in nessun altro. Le rive del lago di Bienne sono più selvagge e romantiche di quelle del lago di Ginevra, in quanto rocce e boschi arrivano quasi al livello dell’acqua; non per questo però sono meno ridenti. Se ci sono meno campi e vigne, meno paesi e case, si trova invece più vegetazione naturale, più prati, molti rifugi ombreggiati da boschetti, più frequenti contrasti e cambiamenti improvvisi del terreno. Non esistono su queste felici rive strade grandi e comode per le vetture, per cui il posto è poco frequentato dai viaggiatori; ma quanto è interessante per dei contemplatori solitari cui piaccia inebriarsi a volontà delle bellezze della natura e raccogliersi in un silenzio perfetto, turbato solo dal grido delle aquile, ad intervalli dal gorgheggio di qualche uccello, e dal mormorio dei torrenti che scorrono dalla montagna. Questo bel bacino di forma quasi tonda racchiude nel mezzo due piccole isole, una abitata e coltivata, di circa mezza lega di perimetro, l’altra più piccola, disabitata e incolta, che alla fine verrà distrutta dalle continue rimozioni di terra fatte per riparare i danni che le onde e le tempeste producono a quella grande. È così che l’essenza del debole viene sempre impiegata a vantaggio del potente. Nell’isola c’è solo una casa, ma grande, piacevole e comoda, che come l’isola appartiene all’ospedale di Berna, e dove vi abita un fattore con la famiglia e i 31 domestici. Qui si prende cura di numerosi animali da cortile, di una voliera e di alcuni vivai per i pesci. Benché piccola, l’isola è talmente varia nel terreno e nell’aspetto che offre luoghi di qualsiasi tipo ed accoglie qualsiasi tipo di coltura. Vi si trovano campi, vigne, boschi, frutteti, pascoli grassi ombreggiati da boschetti e delimitati da arbusti d’ogni genere mantenuti sempre freschi dalla vicinanza dell’acqua; un’alta terrazza con due file di alberi costeggia l’isola per tutta la sua lunghezza, e nel mezzo di tale terrazza è stata costruita una bella sala in cui gli abitanti delle rive vicine si riuniscono e ballano la domenica, quando è tempo di vendemmia. È in quest’isola che mi rifugiai dopo il lancio di pietre a Motiers. Qui il soggiorno mi risultò così delizioso, vi conducevo una vita così confacente al mio umore che, risoluto di finirvi i miei giorni, mi preoccupavo solo che non mi lasciassero realizzare questo progetto che mal si accordava con quello di condurmi in Inghilterra, del quale già sentivo i primi effetti. Colto da tali presentimenti che mi rendevano inquieto, avrei voluto che questo rifugio fosse trasformato in una prigione perpetua, che mi si confinasse qui per tutta la vita, e che impedendomi qualsiasi possibilità e speranza di uscirne, mi fosse proibito ogni tipo di comunicazione con la terraferma, in modo tale che, ignaro di tutto quello che succedeva nel mondo, io ne dimenticassi l’esistenza e venisse dimenticata anche la mia. Non mi hanno lasciato trascorrere che due mesi in quest’isola, ma ci avrei trascorso due anni, due secoli, e tutta l’eternità senza mai annoiarmi un istante, benché io e la mia compagna non avessimo altra compagnia che quella del fattore, di sua moglie e dei domestici, che in realtà erano tutti delle gran brave persone e niente di più, ma era precisamente ciò di cui sentivo il bisogno. Considero quei due mesi il periodo più felice della mia vita, talmente felice che mi sarebbe bastato per tutta l’esistenza senza lasciar nascere per un solo istante nell’animo il desiderio di una condizione diversa. In cosa consisteva dunque questa felicità e il suo godimento? Lo do a indovinare a tutti gli uomini di questo secolo in base alla descrizione della vita che vi conducevo. Il prezioso far niente fu la prima e la principale di quelle gioie che ho voluto assaporare in tutta la loro dolcezza, e tutto quel che feci durante il mio soggiorno non fu altro se non l’occupazione deliziosa e necessaria di un uomo votatosi all’ozio. La speranza che non mi si chiedesse di meglio che di lasciarmi in quel soggiorno isolato in cui mi ero imprigionato da me, da cui mi era impossibile uscire senza aiuto e senza essere scoperto, e dove non potevo né comunicare né corrispondere se non tramite coloro che mi circondavano, questa speranza, dicevo, mi dava quella di finirvi i miei giorni con maggior tranquillità di come avevo fino ad allora vissuto, e l’idea che avrei avuto tutto il tempo per sistemarmi come volevo, fece sì che cominciai col non farvi alcuna sistemazione. Trasportato lì, all’improvviso, solo e spoglio, vi feci venire successivamente la governante, i miei libri ed il mio piccolo bagaglio, di cui ebbi il piacere di non tirar fuori nulla, lasciando casse e bauli così com’erano arrivati, vivendo nella casa in cui contavo di finire i miei giorni come in una locanda da cui sarei dovuto partire il giorno seguente. . . . Al posto di queste tristi scartoffie e di tutto questo mucchio di vecchi libri, mi riempivo la camera di fiori e di erbe; era quello il periodo del mio primo fervore per la botanica, per la quale il dottore di Ivernois mi aveva ispirato un gusto divenuto ben presto passione. Non volendo più dedicarmi ad attività legate al lavoro mi occorreva uno svago che mi piacesse e che non mi desse più fastidio di quanto potrebbe sopportare un uomo pigro. Iniziai a redigere la Flora petrinsularis e a descrivere tutte le piante dell’isola senza tralasciarne una sola, con una precisione tale da esserne occupato per il resto dei miei giorni. . . . In conseguenza di questo bel progetto tutte le mattine, dopo la colazione che facevamo tutti insieme, andavo, lente alla mano e Systema naturæ sotto il braccio, a visitare una zona dell’isola che a questo scopo avevo diviso in piccoli riquadri 32 con l’intento di percorrerli uno ad uno in ogni stagione. . . .Di lì a due o tre ore me ne ritornavo carico di un gran raccolto: era la mia scorta di svago nel caso avessi dovuto trascorrere il pomeriggio in casa se fosse piovuto. Impiegavo il resto della mattinata andando a vedere con il fattore, sua moglie e Thérèse i braccianti ed il raccolto. Molto spesso lavoravo con loro e più volte alcuni bernesi venuti a farmi visita mi trovavano appollaiato su grandi alberi, con un sacco attorno alla vita che riempivo di frutti e facevo calare poi a terra con una corda. L’esercizio fatto durante la mattinata ed il buon umore che ne è inseparabile mi rendevano estremamente piacevole la pausa del pranzo; se però questo si prolungava troppo ed il bel tempo mi invitava, non potevo attendere tanto a lungo e mentre eravamo ancora a tavola sgusciavo via e saltavo, solo, su una barca che conducevo in mezzo al lago quando l’acqua era calma. Là, allungatomi tutto, gli occhi volti al cielo, mi lasciavo andare lentamente alla deriva, in balía delle onde, a volte per parecchie ore, immerso in mille fantasticherie confuse ma deliziose che senza avere alcun oggetto determinato o costante mi risultavano mille volte più gradite di tutto quel che di più dolce avevo trovato in quelli che si chiamano i piaceri della vita. Spesso, quando il calare del sole mi avvertiva che era l’ora di ritirarmi, mi trovavo così lontano dall’isola che ero obbligato a remare con tutte le mie forze per arrivare prima che fosse notte fonda. Altre volte, anziché spingermi al largo, mi piaceva costeggiare le verdeggianti rive dell’isola, le cui limpide acque e la frescura dell’ombra spesso mi hanno invitato a fare il bagno. Uno dei miei percorsi più frequenti, comunque, era l’andare dall’isola grande alla piccola; qui sbarcavo e trascorrevo il pomeriggio, ora facendo delle piccole passeggiate in mezzo ai salici, agli ontani, alle persicarie e ad alberelli d’ogni tipo, ora fermandomi in cima ad una collinetta sabbiosa coperta d’erba, di timo, di fiori, perfino di ginestrella e di trifoglio che probabilmente era stato seminato in altri tempi, molto adatta ai conigli che là avrebbero potuto moltiplicarsi in pace senza temere nulla e senza nuocere a nulla. Diedi quest’idea al fattore che fece venire da Neuchâtel conigli maschi e femmine, ed andammo così in pompa magna, sua moglie, una sua sorella, Thérèse ed io, a depositarli nell’isoletta. . . . Quando il lago agitato non mi permetteva di andare in barca, trascorrevo il pomeriggio a percorrere l’isola erborizzando di qua e di là, sedendomi a volte negli angolini più ridenti e solitari per fantasticare a mio agio, a volte sulle terrazze e sui poggi, per seguire con lo sguardo il superbo ed affascinante panorama del lago e delle sue rive, che da un lato sono circondate dai monti vicini, dall’altro lato si slargano in ricche e fertili pianure, dove la vista si stende fino alle montagne bluastre più lontane che la limitano. Quando si avvicinava la sera scendevo dalle alture dell’isola ed andavo volentieri a sedermi in riva al lago, sulla spiaggia, in qualche rifugio nascosto; là il mormorio delle onde ed il movimento dell’acqua arrestavano i miei sensi, scacciavano dal mio animo ogni altra agitazione e lo tuffavano in una deliziosa fantasticheria in cui spesso, senza accorgermene, mi facevo sorprendere dalla notte. Il flusso e il riflusso dell’acqua, il suo sciacquio continuo ma ad intervalli più forte mi colpivano senza posa le orecchie e gli occhi, supplivano ai movimenti interni che il sogno spegneva in me, ed erano sufficienti a farmi percepire piacevolmente l’esistenza, senza la fatica di pensare. Ogni tanto mi nasceva qualche debole e breve riflessione sull’instabilità delle cose di questo mondo, di cui la superficie dell’acqua mi offriva l’immagine: ma ben presto queste impressioni leggere svanivano nell’uniformità del movimento continuo che mi cullava e che senza la partecipazione attiva dell’animo mi incatenava a tal punto che, richiamato dall’ora e dal segnale convenuto, non potevo allontanarmi di là senza sforzo. Dopo cena, quand’era una bella serata, andavamo ancora tutti insieme a passeggiare un po’ sulla terrazza per respirare l’aria del lago e la frescura. Ci si riposava nel padiglione, si rideva, si chiacchierava, si cantava qualche vecchia canzone che certo non era da meno di quelle moderne, ed infine si andava a letto contenti della giornata, con l’unico desiderio di un’altra simile il giorno dopo. 33 Così, tralasciando le visite impreviste ed inopportune, ho trascorso il tempo in quest’isola durante il mio soggiorno. Ditemi ora cosa vi è in quel luogo di tanto attraente da suscitarmi nel cuore rimpianti così vivi, così dolci e così duraturi che, a distanza di quindici anni, mi è impossibile ripensare a quel luogo tanto caro senza sentirmi ogni volta preso dagli slanci del desiderio. Attraverso le vicissitudini di una lunga vita ho notato che i periodi delle gioie più dolci e dei piaceri più vivi non sono tuttavia quelli il cui ricordo mi attiri e mi commuova maggiormente. Quei brevi momenti di delirio e di passione, per quanto possano essere vivi, e proprio per la loro stessa vivacità, sono tuttavia solo dei punti sparsi e radi sulla linea della vita. Sono troppo rari e troppo effimeri per poter costituire uno stato d’animo e la felicità che il mio cuore rimpiange non è certo composta da istanti fuggitivi, è uno stato semplice e permanente che non ha in sé nulla di vivo ma la cui durata ne accresce il fascino al punto da trovarvi, alla fine, la massima felicità. Tutto sulla terra è in un flusso continuo. Nulla mantiene una forma costante e fissa, e i nostri sentimenti per le cose esteriori passano e cambiano necessariamente come loro. Costantemente, prima o dopo di noi, esse ricordano il passato che non è più o anticipano il futuro che spesso non deve affatto essere: non vi è là nulla di solido a cui il cuore si possa attaccare. Così non abbiamo quaggiù nient’altro che piacere che passa; in quanto alla felicità che dura, dubito che la si conosca. A malapena si trova nei nostri più vivi piaceri un istante in cui il cuore possa veramente dire: Vorrei che questo istante durasse per sempre; come possiamo allora chiamare felicità uno stato fuggevole che ci lascia poi il cuore inquieto e vuoto, che ci fa rimpiangere qualcosa che era, o desiderare qualcosa che sarà? Ma se esiste uno stato in cui l’animo trova un equilibrio abbastanza stabile per riposarvisi completamente e raccogliere là tutto il suo essere, senza aver bisogno di ricordare il passato né di sconfinare nel futuro, in cui il tempo non conti e il presente duri sempre, senza però lasciar traccia del suo durare né del succedersi, senza nessun altro sentimento di privazione né di godimento, di piacere né di pena, di desiderio né di timore, se non quello della nostra esistenza che, da solo, possa soddisfare completamente l’animo; fin tanto che questo stato dura, colui che vi si trova può chiamarsi felice, non di una felicità imperfetta, povera e relativa, come quella che si trova nei vari piaceri della vita, ma di una felicità bastevole, perfetta e piena, che non lascia nell’animo alcun vuoto che sia necessario colmare. Questo è lo stato in cui spesso mi sono trovato all’isola di Saint-Pierre durante le mie fantasticherie solitarie, ora sdraiato sulla barca che lasciavo andare alla deriva, in balia delle onde, ora seduto sulle rive del lago agitato, ora altrove, sulla sponda di un bel fiume o di un ruscello mormorante tra i ciottoli. Di cosa si gioisce in una simile situazione? Di nulla di esteriore a sé, di niente se non di sé stessi e della propria esistenza; fin tanto che dura questo stato si è sufficienti a sé stessi come lo è Dio. Il sentimento dell’esistenza spogliato di ogni altro affetto è di per sé un sentimento prezioso di contentezza e di pace cha sarebbe sufficiente da solo a rendere questa esistenza cara e dolce a chi fosse in grado di allontanare da sé tutte le impressioni sensuali e terrestri che vengono continuamente a distrarci e a turbarne, quaggiù, la dolcezza. Ma la maggior parte degli uomini, agitati da continue passioni, poco conosce questo stato d’animo, ed avendolo sperimentato soltanto imperfettamente, per pochi istanti, ne conserva appena un’idea oscura e confusa che non permette di percepirne il fascino. Certo, non sarebbe neanche bene che, nell’ordinamento attuale delle cose, avidi di queste dolci estasi, si disgustassero della vita attiva di cui i bisogni sempre nuovi impongono l’obbligo. Ma un infelice che è stato escluso dalla società degli uomini e non può più fare nulla quaggiù di utile e di buono, né per gli altri né per sé, può trovare in questo stato un compenso a tutte le felicità umane, che né la fortuna né gli uomini saprebbero sottrargli. È peraltro vero che tali compensi non possono essere avvertiti da tutti gli animi e in tutte le situazioni. Occorre che il cuore sia in pace e che nessuna passione ne venga 34 a turbare la quiete. Occorre una certa disposizione in chi li prova e nel ruolo degli oggetti circostanti. Non occorre né un riposo assoluto né troppa agitazione, ma un movimento uniforme e moderato senza scosse né intervalli. Senza movimento la vita sarebbe solo un letargo. Se il movimento è discontinuo o troppo forte sveglia; ricordandoci gli oggetti circostanti distrugge il fascino della fantasticheria, ci strappa dall’intimo di noi stessi per sottoporci subito al giogo della fortuna e degli uomini e per restituirci al sentimento delle nostre infelicità. Un silenzio assoluto porta alla tristezza. Offre un’immagine di morte. Allora è necessario l’aiuto di una ridente immaginazione, che si presenta abbastanza naturalmente a chi ne è stato gratificato dal cielo. Il movimento che non viene dal di fuori si crea allora nel nostro intimo. Il riposo è così minore, è vero, ma risulta anche più piacevole quando lievi, dolci idee, senza agitare il fondo dell’animo, ne sfiorano per così dire solo la superficie. Ne occorre solo quel tanto per ricordarci di noi stessi e dimenticare tutti i nostri mali. Questa sorta di fantasticheria si può godere ovunque sia possibile stare tranquilli, e spesso ho pensato che alla Bastiglia e perfino in una cella di isolamento in cui nessun oggetto mi fosse visibile, avrei ancora potuto sognare piacevolmente. Ma bisogna confessare che era di gran lunga più piacevole farlo in un’isola fertile e solitaria, per natura circoscritta e separata dal resto del mondo, dove mi erano offerte solo immagini ridenti, dove nulla mi richiamava tristi ricordi e i pochi abitanti erano socievoli e gentili senza essere interessanti al punto da tenermi incessantemente occupato; dove insomma potevo dedicarmi tutto il giorno, senza ostacoli e senza preoccupazioni, alle attività che preferivo o ad un molle ozio. Era indubbiamente una bella occasione per un sognatore capace di nutrirsi di piacevoli chimere perfino in mezzo agli oggetti più spiacevoli: poteva saziarsene a piacimento facendo concorrere tutto ciò che realmente gli colpiva i sensi. Uscendo da una lunga e dolce fantasticheria, vedendomi circondato da piante, fiori, uccelli, e lasciando errare lo sguardo lontano, sulle romantiche rive che limitavano una vasta distesa di acqua chiara e cristallina, assimilavo ai miei sogni tutti quei gradevoli oggetti; alla fine, trovandomi a poco a poco ricondotto a me stesso e a quel che mi circondava, non ero più in grado di separare il sogno dalla realtà. Tutto difatti concorreva nella stessa misura a rendermi cara la vita raccolta e solitaria che conducevo in quell’incantevole soggiorno. Non è forse possibile che rinasca ancora? Non potrò mai andare a finire i miei giorni in quell’isola adorata senza mai uscirne, senza mai rivedere alcun abitante del continente pronto a ricordarmi i guai d’ogni tipo che si compiacciono di accumularsi su di me da così tanti anni? Presto sarebbero dimenticati per sempre; senza dubbio essi a loro volta non dimenticherebbero me, ma che mi importerebbe, purché non abbiano accesso per venirmi a turbare il riposo? Liberato da tutte le passioni terrene generate dal tumulto della vita sociale, il mio animo si libererebbe sovente oltre questa atmosfera e intraprenderebbe anzitempo relazioni con le intelligenze celesti di cui spera d’andare ad aumentare il numero entro breve tempo. Gli uomini si guarderanno bene, lo so, dal ridarmi un rifugio così dolce dove non hanno voluto lasciarmi. Ma almeno non mi impediranno di trasportarmici ogni giorno sulle ali dell’immaginazione, e di godervi per qualche ora lo stesso piacere che proverei se ancora ci abitassi. Quello che là farei di più dolce sarebbe sognare a mio agio. Sognando di essere là, non faccio forse la stessa cosa? Anzi, faccio di più; all’attrattiva di un sogno astratto e monotono aggiungo delle immagini incantevoli che lo vivificano. I loro oggetti spesso mi sfuggivano ai sensi durante le mie estasi, ed ora più è profondo il mio sognare e più me li dipingo vivamente. Spesso mi trovo ora più in mezzo ad essi e più piacevolmente ancora di quando vi stavo realmente. Il guaio è che, via via che l’immaginazione si affievolisce, ciò succede con una certa fatica e non dura tanto a lungo. Ahimè, è proprio quando si sta per abbandonare la spoglia mortale che si è maggiormente offuscati! da: Rousseau, Opere, Sansone editore, 1972, pag. 745-1122 35
Scarica