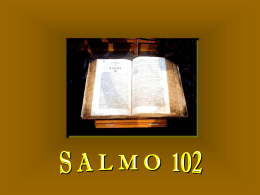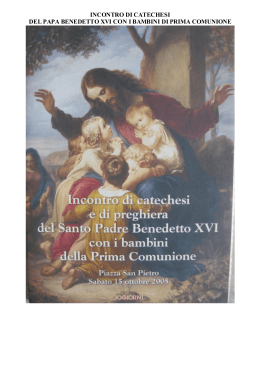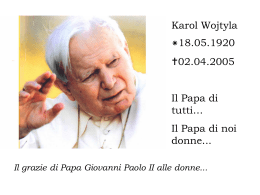TERRE FOGGIANE Questo volume contiene una serigrafia originale, numerata e firmata, di Rolando Greco edizione fuori commercio copia numero TERRE FOGGIANE LANFRANCO TAVASCI MARCO SQUARCINI CITTÀ DIMENTICATE EDIZIONI GEMA Ad eccezione della serigrafia di Rolando Greco e della riproduzione della Tabula Peutingeriana, tutte le illustrazioni nel testo sono opera di Maria Checchia. Le schede biografiche degli artisti sono collocate alla fine del volume. Il progetto grafico è delle Edizioni d’Arte Severgnini © Copyright MIVAL s.r.l. Rolando Greco Città dimenticate INDICE PREMESSA pag. 9 LA DAUNIA PEUTINGERIANA pag. 15 HERDONIA Una capitale dell’archeologia L’anima di Herdonia, forse Obscura Herdonea ‘Mission’ Un Reale Sito pag. 21 ARPI pag. Da Arpi a Foggia: due millenni di Marina Mazzei (2002) Marina Mazzei: un profilo etico-civile di Saverio Russo (2004) 35 MATINUM La Terra madre La testimonianza di Antigone Per passare l’eternità Archita o il ’ Leonardo’ da Taranto Archita per i bambini Naufragio pag. 45 SALINIS Economia e politica del sale Salpi, le donne di bastoni Quelle che rifiutano le nozze Quelle che si bruciano le navi dietro le spalle pag. 55 Salapia, capitale di Annibale Hannibal ad portas! Storie di ordinario collaborazionismo L’inganno infelice Annibale il Foggiano Un generale prestato alla politica? Change Management DEVIA Santa Maria di Devia Tra Greco e Latino L’Abbazia di Diomede Le Porte d’Occidente Il pericolo slavo Gli Ebrei di Torre Mileto La Grotta dell’Angelo pag. 81 MONTECORVINO Un ‘landmark’: la sedia del diavolo Prima di Montecorvino ‘Lega longobarda’ o nazionalismo murgiano? La battaglia di Canne, 1018 Gli anni brevi di Montecorvino Alberto vescovo, ‘santo subito’ pag. 99 TIATI Civitate, 18 giugno 1053 Com’è il fatto I racconti dei testimoni Ma il peggio deve ancora venire pag. 111 FIORENTINO “E l’ora tardi mi pare che sia” “Che nulla medicina me non vale” “Poi tanta caunoscenza” “E son lontano da li miei paesi” “Rimembranza mi serra in suo domìno” pag. 127 “Lo meo coraggio non diparto mai” “Pur aspettando bon tempo e stagione” “Penitenza non aggio fatta niente” “Ca, ss’io fossi oltramare” “In vostra spera vivo, donna mia” “Ed esser la mia morte e non vedere!” I racconti dei testimoni TERTIVERI Tertiveri e il suo mondo La Crociata contro i Saraceni di Puglia Chi è ‘abd el-Aziz, il signore moro di Tertiveri Eudes, l’Arcinemico Châteauroux vs/ Tertiveri pag. 149 SIPONTO La koinè diomedea Un punto di osmosi Il Monte come destino La morte di Siponto Biondo, bello, e di gentile aspetto La Fille ainée de l’Église De pulcritudine civitatis Manfredonie La parola al nemico pag. 169 LA MAGNA CAPITANA pag. 184 GLI ARTISTI pag. 187 GRAZIE pag. 191 PREMESSA di Lanfranco Tavasci Riprendiamo ancora una volta – è l’undecima – le strade della Capitanata alla ricerca di ciò che non si vede. Ciò che nella trama dei secoli ha costituito l’incanto di questa terra. Gli ‘asset non contabilizzabili’, si direbbe nella teoria d’azienda. Incominciammo assieme ad Aldo Chiappe, nel secolo scorso, a studiare le diverse identità delle ‘Terre Foggiane’. La prima ricerca fu sugli stendardi dei Comuni, la seconda sui Santi patroni. L’identità laica e religiosa di ciascuna comunità. Poi abbiamo preso a interrogare lo spirito dei luoghi. Nel 2001 fu il millenario dell’Incoronata, la grande icona della cristianità daunia assieme a Michele Arcangelo e a Pio da Pietrelcina. Per due anni consecutivi abbiamo chiesto ai Dauni stessi di raccontarci la loro terra: sia a quelli rimasti in Capitanata che a quelli che hanno sviluppato altrove la loro vocazione – da Renzo Arbore a Lucio Stanca. Una incursione nel sottoterra di Arpi ci ha portati al volume sulla Medusa: icona, lei, dell’inconscio collettivo, enigmatica vestale della morte e spettacolare figura del Museo Civico. I tre volumi più recenti documentano la nostra passione progressiva per le fonti: storiche, letterarie, documentarie, folcloriche, paesaggistiche, monumentali. Ecco quindi Federico II, il creatore di Foggia; le Tremiti, incredibile microcosmo attraversato spesso dalla ‘grande’ storia; la civiltà della transumanza còlta nelle ultime possibili testimonianze. E adesso queste ‘Città dimenticate’. Il punto di partenza è stato la Tabula Peutingeriana. Una stupefacente carta stradale dell’Impero romano riprodotta nel tredicesimo secolo, conservata a Vienna. Prende il nome dall’umanista che la ebbe in possesso, e si scarica da Internet. Mentre ci si interrogava sui toponimi osci e romani di questo territorio 9 ci si è presentata pian piano l’immagine di un’altra Capitanata: quella che non si è riprodotta attraverso i secoli come la maggior parte delle località che conosciamo. Furfane diventa Cerignola, Aecas dà origine a Troia, l’Aufidus adesso è l’Ofanto. Quella che, semplicemente, si è eclissata lasciando di sé qualche segno in superficie: le traccie affascinanti dell’assenza. Noi abbiamo scelto dieci luoghi e trovato chi assieme a noi provasse ad evocare anche visivamente questa ricchezza dimenticata. Così procede il nostro cammino: leggendo le fonti, ascoltando i luoghi, evitando di fare il verso alle discipline che si occupano seriamente di queste cose. Non archeologia, niente storia né letterature, ma soltanto un invito a frequentare questi luoghi con fantasia, affondando lo sguardo nell’invisibile. 10 Tabula Peutingeriana sectio V 11 12 13 LA DAUNIA PEUTINGERIANA Chi non ha visto lungo i Fori imperiali i grandi tabelloni di marmo che raffigurano l’espansione dell’Impero romano? Astutamente essi si fermano al punto di massimo splendore: lealtà vorrebbe che in altre cinque o sei videate si capisse come siamo arrivati all’estensione di oggi. Questo per ammonire che la rappresentazione cartografica può essere un racconto ma raramente è pura da presupposti ideologici. È sempre una sfida affascinante riprodurre la sfera terrestre su una superficie piatta. Come pelare un’arancia e stendere la buccia per farla aderire alla tavola. Chiunque converrà che la maniera migliore è tagliare la buccia in sezioni triangolari. Più o meno così l’architetto americano Buckminster Fuller concepì il suo Planisfero Dymaxion, in cui la sfera terrestre si riflette su un solido a otto facce, l’ottaedro, oppure a venti facce, l’icosaedro. Ambedue i solidi hanno solo facce triangolari; vengono detti ‘platonici’ perché il Filosofo dice nel Timeo che la realtà è composta da triangoli. Altrimenti ci si arrende a riprodurre la sfera terrestre su una superficie sferica, e abbiamo il mappamondo girevole delle scuole elementari, anche illuminato dall’interno come lampada da notte. O quello di Coronelli per il Re Sole. O quello appoggiato da Hans Holbein su un tappeto anatolico (detto da allora ‘tappeto Holbein’) nella tela ‘gli Ambasciatori’. E’ quel doppio ritratto che contiene in primo piano il teschio anamorfico che pare un sigaro sgretolato, e che è per la National Gallery come la Gioconda per il Louvre o la Nascita di Venere per gli Uffizi. Fra i tabelloni imperiali di Roma, cioè il vertice dell’ideologia, e un 15 mappamondo, cioè la miglior rappresentazione della realtà, si dispone un ventaglio illimitato di modalità e tecnologie per raffigurare la Terra. Le carte che abbiamo più familiari derivano dal Planisfero di Mercatore, che fa sembrare enormi il Canada, la Groenlandia e la Siberia settentrionale, e lunghissimo il Cile, e non può rappresentare i poli perché, rispetto al punto di vista, si trovano all’infinito. Conviene fare due passi su Wikipedia alla voce ‘Proiezioni cartografiche’. Quello che ci colpisce è che mentre tutta l’antichità si è data un gran daffare per raggiungere figurazioni il più possibile realistiche – e infatti il Planisfero di Tolomeo, quello a forma di ventaglio rovesciato, è assai credibile _, inoltrandosi nel Medioevo ci si allontana dalla rappresentazione del vero e si impongono le mappe simboliche. Non hanno nulla a che vedere con l’uso pratico: sono delle icone per illustrare una visione teologica del mondo. La forma più comune è una T inscritta in un cerchio, che dà origine a tre campi: l’Europa, l’Africa e l’Asia (l’Asia è in alto); al centro spesso c’è Gerusalemme; a volte si rappresentano il corso del Nilo o del Don, il Mediterraneo o il Mar Nero. Secondariamente, le mappe sono disegnate per rispondere al bisogno di meraviglie: ed ecco comparire il Paese di Gog e Magog, il Regno di Prete Gianni, i cieli danteschi, il Paradiso terrestre, le Isole di San Brandano, con animali strani e mostri assortiti secondo le varie regioni di pertinenza. Naturalmente la T che dà ordine e significato alla Terra è il segno della croce. A volte con appeso il serpente che salva chi lo guarda dal morso dell’altro serpente, l’antico ingannatore. A volte nella nudità cantata da Venanzio Fortunato con l’inno Vexilla regis prodeunt: “splende il mistero della croce per la quale la Vita patì la morte, e per mezzo della morte restituì la vita”. L’oggetto della raffigurazione, in queste mappe, è un manifesto cosmico e non ha nulla a che vedere con le valigie, gli orari dei treni o i last minute per il Mar Rosso. Eccetto forse l’universo a forma di baule immaginato dal folle bizantino Cosmas Indicopleustes; ma non saran16 no certo più savi, in pieno Novecento, i credenti nella terra concava, nel regno di Agartha, nei deliri dell’esoterismo nazista. La cartografia scientifica dell’antichità riprende con le Repubbliche marinare e con le ‘carte da navigar’. In particolare è la Sicilia normanna all’avanguardia di questa disciplina sotto Ruggero II, il nonno di Federico II, che fa tradurre le opere geografiche e le guide di viaggio dell’antichità e mette il dotto al-Idrisi a capo di una vera e propria impresa di conoscenza. Output famosi di questo ambiente sono il ‘Libro di Re Ruggero’ del 1154, in arabo, adesso alla Bodleian Library di Oxford, e la Carta geografica che venne riprodotta anche su un disco d’argento del diametro di due metri e del peso di 150 chili: troppi per essere immune da furti. I portolani più antichi, in pergamena, conservano la forma della pelle di agnello. Per uno che va a piedi il loro disegno è sconcertante: sono delle mappe del mare, non della terraferma. La costa è un confine e viene descritto minuziosamente; ma di ciò che è oltre la costa, nell’interno, nihil constat. Se ne trovano, a Posta Farano, di ‘carte da navigar’: moderne, naturalmente. La maggior parte è focalizzata su un’area dell’Anatolia meridionale fra Alicarnasso e Attalia. Quest’area comprende sia la città subacquea di Simena, sia il porto di Mira, e cioè le tombe licie e la cattedrale in cui San Nicola, vescovo, presumeva di riposare per sempre. Sulle carte antiche e medievali pende un malinteso secolare: che i loro autori ritenessero la terra piatta, così come la rappresentano. Ovviamente non è vero. D’altra parte la terra rotonda, che contrasta l’esperienza immediata della piattezza, non può che avere un’origine speculativa. La sfericità era acquisita già dai Pitagorici. Platone nel Timeo spiega, parlando dell’intero universo: “Al vivente che comprende in sé tutti i viventi conviene quella forma che comprende in sé tutte le altre forme. Perciò (il demiurgo) lo plasmò arrotondato, in forma di sfera che si stende dal centro alla superficie in maniera uguale da ogni parte: la più perfetta fra tutte le forme, la più uguale a se stessa: il simile infatti è più bello del dissimile”. 17 Raffigurazioni della terra, del mare, e poi anche del cielo: una storia lunghissima di cui ci restano documenti più o meno comprensibili: dalle tavole dei Maya al Globo celeste di Magonza, romano, e a tutte le configurazioni zodiacali legate all’astrologia e alla poesia. Questa, tra l’altro, è una delle strutture implicite della ‘Divina Commedia’: ma è una componente della poetica dantesca da cui rifuggono tutti gli studenti e probabilmente la maggior parte dei professori. Oggi siamo passati alla cartografia computer aided e a Google Earth. Ci siamo arrivati in pochi anni, bruciando monumenti geografici come l’Ortelius, il Blaeu, Isaac Tyrion, lo Zatta e tanti altri geni della cartografia. D’altra parte chi vorrebbe sfogliare le grandi pagine della ‘Corografia’ di Zuccagni-Orlandini quando è sufficiente diteggiare un toponimo su Google Maps? Tutto questo per dare un contesto alla Tabula Peutingeriana di Vienna. Prima di tutto, pur raffigurando un’area che va dalla Spagna (mancante) alle soglie della Cina, la Peutingeriana non è affatto un planisfero. Lo dicono le dimensioni: quasi 7 metri di lunghezza divisi in 11 pergamene, 33 centimetri di altezza. E’ una mappa stradale. Prendiamo gli ‘itinerari’ del Touring Club e affianchiamoli in maniera passabilmente coerente per coprire tutta l’Europa, metà dell’Asia, Ceylon e l’Africa settentrionale. Una follia. Eppure la Tabula Peutingeriana è proprio questo. Si capisce che sia un unicum, e che dalla sua riscoperta, nel Quattrocento, divenga oggetto di sempre nuove ricerche. Si ritiene che il manufatto viennese, passato per le mani dell’umanista Konrad Peutinger, sia la copia prodotta nel XIII secolo di un originale del IV secolo della nostra era. O anche di prima: la fonte potrebbe essere una carta dell’Impero fatta incidere su marmo per cura di Augusto e collocata lungo la Via Flaminia. La fortuna della Tabula Peutingeriana è legata al diffondersi della stampa: infatti essa venne riprodotta nel 1591 ad Anversa dalla tipografia d’arte Plantin Moretus, famosa tra gli ammalati di stampe antiche per la pompa funebre di Carlo V d’Asburgo. Da allora non cessa di risolvere problemi e aprirne di nuovi. 18 Che cosa sarà quell’edificio complesso che si chiama Pretorium Lauerianum, dalle parti di Nucerie Apule, cioè Lucera? E il tempio di Hercul Rani in posizione vicina ad Accadia? E l’Aufidus perché sembra scorrere di qua da Aecas, Troia, invece che passare sotto Canosa, che peraltro non è segnata? Tra Barletta e Trani c’è un fiume, l’Aveldium? Ma soprattutto: dov’è il Gargano? C’è Teano Appulo con il Fortore, c’è Siponto con il Cervaro o il Candelaro, e nel mezzo? Niente. Il mare. Isole della Dalmazia di fronte, Traù che pare una aerofotografia, l’estuario della Narenta, Spalato. Ancora una volta: si tratta di una mappa del Métro, non di una carta geografica. E il Gargano non faceva parte del sistema viario. Ciò che si riporta sono i percorsi schematizzati con un rigo rosso sempre diritto fin quando forma uno scalino: lì è il punto di sosta. Sono designate le città e soprattutto, con precisione quasi assoluta, le distanze espresse in miglia romane (1,477 Km circa) tra una località e la successiva. Le poste sono segnate con delle doppie torri che sembrano cabine da spiaggia; le città hanno dei simboli più figurativi. Non sono nemmeno proporzionati i tratti di strada rispetto alla lunghezza indicata in cifre. Quello che conta sono le distanze e i servizi al viaggiatore. Vogliamo percorrere il tratto Benevento – Siponto? A dieci miglia da Benevento, Foro Novo; a dodici miglia, Aequo Tutico; a diciotto miglia, Aecas: c’è da scollinare il Subappennino; Pretorium Laverianum e Nucerie Apule, sembra cancellata l’indicazione della distanza; nove miglia ad Arpos, e da qui ventuno a Siponto. Sei giorni? Dipende dal mezzo di trasporto. Alcune di queste località le abbiamo prese a cuore, come Siponto, Salinis, Teanum Apulum, Erdonia, Arpi: quelle che non ci sono più, anche se i cittadini ne hanno portato via il nome e lo hanno piantato da un’altra parte. Altre, come Tertiveri o Fiorentino o Montecorvino o Devia o Matinum, non sono raffigurate dalla Tabula Peutingeriana. Ma l’impulso che abbiamo avuto da questo monumento venerando come pochi altri è stato la ricerca, sotto la patina del tempo, dei luoghi che non sono più luoghi. 19 HERDONIA La grand cité sera bien desolée Des habitans un seul ny demeurra: Mur, sexe, temple, & vierge violée Par fer, feu, peste, canon peuple mourra (III, 84) Così com’è, il territorio di Ordona è cosparso di strutture di pietra intente a guadagnarsi la luce, come per una volontà sotterranea di manifestarsi. Di rivendicare un’esistenza che è stata negata: infatti dicono che per sette volte, proprio come Troia – quella vera –, Herdonia sia stata schiacciata al suolo, incendiata, interrata. Dimenticata no. Le tracce delle sue vite successive fioriscono dal prato e affondano radici ancora da liberare. Gli oggetti che le sono stati strappati popolano musei vicini e lontani e collezioni private anche lontanissime. Chissà che un giorno, rotolando da una generazione all’altra, non ritornino qui dove mani esperte li hanno formati, accarezzati, adoperati. Soprattutto il vasellame. Normalmente le persone si annoiano a vedere le teche dei musei affollate da oggetti d’uso. Muoversi da casa per ‘Guernica’ o per la ‘Ronda di notte’ va bene; ma per una piattaia di vasellame? E in effetti la produzione ceramica è fonte di godimento per specialisti. Con una eccezione: la ceramica daunia. A Ordona, come a Canosa, i Dauni sono riusciti a rendere simpatici gli oggetti quotidiani; a trasferirvi uno spirito, a farli sorridere. Il postmoderno tremila anni fa, più o meno: scuola di Ettore Sottsass il Giovine. Già la forma di un askos ricorda un bipede surreale con due teste. C’è anche qualche cratere che al posto dei manici ha delle manine. Ma la stoviglia più rammentata di Ordona è un attingitoio, il kyathos; anzi un modello particolare che viene chiamato ‘coppa cornuta’. E’ raf21 figurato sulla copertina del libro che il professor Mertens ha curato per la divulgazione. Il manico del kyathos riproduce una persona con le braccia alzate, con gli occhi spalancati al posto della testa, a volte un altro paio di occhi sui fianchi perché la sfortuna è sempre in agguato. Il petto è decorato geometricamente, e a guardarlo bene ricorda una microscopica stele daunia, di quelle chi si scolpivano più vicino al mare. Oppure, per i più esagitati, può richiamare anche l’ ‘uomo vitruviano’ di Leonardo o il ‘modulor’ di Le Corbusier. Nell’interno della coppa un disegno triangolare con le zampe sembra un uccello dei fumetti, con un segno solare al posto della testa. Marina Mazzei lo accosta al simbolo nordico della nave solare. Dev’essere fantastico tenere in mano questo kyathos. Forse si entra in contatto con altre mani antiche che lo hanno plasmato, e che dopo la cottura lo hanno ornato: due righe appena sul labbro della coppa. E con quelle che lo hanno usato per attingere, o per mescere il vino ‘alla greca’ ena kai dyo: un askos di vino e due di acqua. Al nuovo Museo di Ascoli Satriano si intuiscono queste emozioni; e se il vasellame ha un’anima – come ha quattro occhi o due manine per farsi tirare sù – probabilmente aspetta con inquietudine il ritorno dei Grifoni policromi dal Getty Museum: assorbiranno su di sé tutta l’attenzione? Una capitale dell’archeologia Si capisce che Herdonia sia un’isola felice dell’archeologia: scavo, teoria, ricerca, pubblicazione. formazione dei giovani studiosi. Da Joseph Mertens di Lovanio a Giuliano Volpe di Foggia, il meglio della scienza dell’antico si è prodigato per Herdonia. Gli undici volumi di ‘Ordona’ che rendono accessibili i risultati di questa spesa enorme di intelligenza sono un monumento al territorio foggiano. Anche se a vederli lì tutti in fila si avverte lo stesso senso di inadeguatezza della ‘Summa Theologica’ o della ‘Recherche’, o perfino dei temibili MGH, i ‘Monumenta Germaniae Historica’. Accanto agli strumenti da scavo, gli spettacoli di Michele Placido hanno aiutato lo spirito del luogo a venire alla luce. 22 Il professor Volpe scrive nel 2007: “Herdonia … costituisce uno straordinario contesto nel quale si è stratificata nel corso di alcuni millenni la storia delle civiltà succedutesi in Daunia dalla Preistoria al Medioevo. Grazie alle ricerche sistematiche avviate nell’ormai lontano 1962, la storia di Herdonia è ormai ben nota, almeno agli archeologi e agli specialisti… Nonostante questa felice situazione degli studi, Herdonia è però ancora ignota ai più, a partire dagli stessi abitanti della Capitanata”. Herdonia non è Efeso, per il momento, né Segesta. E non saremo nemmeno noi, a parole, a farla diventare una piccola Pompei di Capitanata. Però c’è la villa Faragola vicina, e comunque la parte ancora da scavare è sterminata, a giudicare dalla cinta muraria. Lo si vede bene nelle aerofotografie, ma anche da raso terra. Una capitale dell’archeologia che ha ancora molto da dare. L’anima di Herdonia, forse Italo Calvino ci ha insegnato che le città possono anche non esistere, però hanno sempre un nome, una personalità. Forse si doveva chiedere al professor Mertens quale sia l’anima di Herdonia, oppure al rettore Volpe. Essi hanno aspirato l’odore della terra scavata, hanno conteso con le mani e con i ferri i frammenti di pietra e il loro significato. Noi scriventi siamo solo dei visitatori antelucani: grazie alla Pro Loco abbiamo passato una mattinata che neppure il sole a picco riuscirà a rendere meno eccitante. Insomma, due luoghi ci sono rimasti impressi sopra tutti: la via Traiana che entra dal nulla e con un angolo retto esce nel nulla, e il macellum, l’evoluto mercato alimentare a un angolo del Foro. Sommando queste due suggestioni – la strada e il fast food – ci viene in mente un luogo di ristoro per viaggiatori. Insomma, un autogrill. Forse l’anima di Herdonia è il viaggio, il servizio ai viandanti. Un grande centro viario. L’antica via Minucia, poi modernizzata come Traiana, canalizza il flusso della via Appia verso destinazioni locali o 23 anche lungo un percorso alternativo: da Benevento prende per Ariano, Troia, Herdonia, Canosa; ma volendo da Troia indirizza verso Lucera, Arpi, Siponto, il mare. Attorno a Canosa la via Traiana si immette sulla Litoranea che viene giù da Buca in Molise per Teanum Apulum (la nostra Tiati, poi Civitate), Arpi, Siponto, Salapia fin oltre l’Ofanto e il porto di Canosa. Territori familiari, o che lo diverranno a chi avrà la pazienza di leggere questo libro. In più, da Herdonia verso Ascoli e oltre il Subappennino si stacca una bretella, la via Aeclanensis, che collega l’Appia con la Traiana, e una seconda bretella che termina a Venusia. Di queste informazioni, oltre agli archeologhi, possono godere gli appassionati di trekking. A noi rimane, oltre a un po’ di confusione di secoli e di luoghi, la certezza che Herdonia nasce e rinasce attraverso distruzioni e abbandoni proprio perché si trova in quella posizione lì. Ha la missione di raccogliere e di smistare, e naturalmente di vendere servizi, sia a livello di grande viabilità internazionale che di raccordo con gli spostamenti di raggio locale, e sicuramente di interscambio con il sistema di strade commestibili: i tratturi. Questa vocazione al viaggiatore ci richiama altre ‘città dimenticate’ per le vie della seta, del sale, delle spezie. Non vediamo il Tetrapylon di Palmira, o il ponte di accesso alla Commagene, o le colonne ritorte di Apamea. Però l’essenza è la stessa. C’è la strata. L’orgoglio delle pietre allineate con cura dove i carri, con i secoli, scavano un binario che porta dovunque, fin dove è grande l’Impero. Abbiamo visto la prosecuzione di questa via: alle porte di Kars, al passo del Giogo, a Cordoba, a Birmingham. La strata che entra da una porta di Herdonia e subito trova un ninfeo, cioè un monumento all’acqua, perché l’acqua è la prima cosa necessaria a chi arriva, è una metonimia della città. Ma anche una metafora: Herdonia è quello. E’ il viaggio. Si lascia la via Traiana, ci si inoltra per la città verso il Foro dove il viaggiatore poteva soddisfare i bisogni di socialità: templi, porticati, botteghe, le terme, il teatro. Nella valle scavata emergono i basamenti e i capitelli in pietra della Basilica, il palazzo di giustizia: non ci sono più le colonne, che erano di mattoni stuccati. Si vedono bene invece le 24 botteghe, che sono tante per tanti clienti. Le terme sono un po’ più a nord, lungo il tracciato della via Traiana che non si vede. L’anfiteatro invece è incassato nel perimetro delle difese della città daunia, da una parte. La forma leggibile sotto il manto d’erba che in questo momento è secca ci ricorda altri edifici che hanno finto di scomparire e occhieggiano sotto forma vegetale, come il Circo Massimo quando era un bosco di oleandri. Forse una anticipazione del ‘bosco verticale’, moderno ripensamento del grattacielo. Di fronte alla Basilica l’edificio che ci impressiona di più: il macellum. Fantasmi di decorazione sull’intonaco, come uno spiritello ormai monocromo sulla destra, e si capisce che sta per smaterializzarsi. Angela, abituata a fare la spesa in ogni genere di esercizio commerciale, è colpita dal concept della costruzione. Ricorda, come spaccio alimentare, un mercato coperto tipo la Boquería di Barcellona. Di certo il macellum è un progetto architettonico raffinato nella divisione dello spazio quadrato in quattordici corner rispettando la zona di accesso circolare. Forse era un mercato di lusso, se viene da lì il Nettuno marmoreo conservato al Museo Civico di Foggia. Raffigura il dio del mare con un musetto di delfino sul braccio, la parte inferiore di una gamba, il ginocchio dell’altra; manca tutto il corpo, e sembra un’opera di Mitoraj. D’un colpo, come le pietre della via Traiana ci suggeriscono mete favolose, il macellum ci immette nell’animazione di una comunità che offre ai viaggiatori il viaticum per il cammino. Da quando il suo nome era forse Serdonia. La Tabula Peutingeriana la chiama semplicemente Erdonia, su una strada che non si capisce bene da dove parta e dove arrivi. L’Itinerarium antonino la chiama Erdonias; il pellegrino di Bordeaux, Serdonis; Livio anche Ardunas e Nicolò Iamsilla, Dordona. Insomma, il gioco è sull’aspirazione iniziale, la H di Herdonia, che nasconde la caduta del ‘sigma bergamasco’, cioè la sibilante aspirata (come in hura, hota: sopra, sotto). Alla fine cade anche la traccia di aspirazione. Testimone il nome attuale, Ordona; testimone più antico il ‘Libro di Re Ruggero’, che nel ’bilad ankabarda, il Paese dei Longobardi, segnala Atrunam: ecco un altro modo di nominare Ordona. Atrunam come Lujarah. 25 Obscura Herdonea Sette volte distrutta. Di uno di questi eventi traumatici abbiamo la testimonianza di Tito Livio. Accampamento presso Herdonea, 212 a.C. Si tiene d’occhio la città che notoriamente, tenendo famiglia, sta dalla parte del più forte Cartaginese. “Le legioni romane e il pretore Fulvio erano presso Herdonea. Come giunse la notizia che Annibale si avvicinava, poco mancò che non si levassero le insegne e non si uscisse spontaneamente fuori dal campo, senza attendere l’ordine del pretore. Si trattennero solo perché erano certi di poter sferrare l’attacco in qualunque altro momento. Annibale era stato informato dell’insurrezione spontanea nel campo romano. Sapeva che la maggior parte dei soldati era pronta all’armi ed aveva fatto violenta pressione sul comandante perché desse il segnale d’attacco. Si convinse quindi che c’erano condizioni da sfruttare per una vittoria. Nella notte dispose circa tremila soldati leggeri tutt’intorno ad Herdonia, per i casolari, le macchie e le selve. L’ordine era di balzare allo scoperto a un determinato segnale. Poi a Magone ordina di occupare con circa duemila cavalieri tutti i passi che potessero convenire alla la fuga. Fatti durante la notte questi movimenti, all’alba schierò le truppe per la battaglia. E Fulvio non indugiò, trascinato dall’impeto irresistibile dei soldati più che dalla speranza di vittoria. Così, con la stessa avventatezza con la quale si erano precipitati fuori dal campo, le schiere si disposero secondo il capriccio dei soldati: tutti cercavano di arrivare in prima fila, e poi magari si fermavano o si mettevano dietro”. Bisogna dire, a giustificazione dei soldati, che a questo punto della guerriglia annibalica le truppe romane sono composte di ragazzi giovani e motivati ma non adusi ai comportamenti organizzativi. I veterani non avrebbero tentato di forzare la mano ai capi, e soprattutto non avrebbero mai fatto l’errore adolescenziale che adesso Livio racconta. “Con questa confusione la prima legione e l’ala sinistra si disposero tutte in prima linea, formando uno schieramento esteso solo in senso orizzontale. I tribuni invano gridavano che così nelle linee posteriori 26 mancavano le forze, e che i nemici potevano attaccare e sfondare concentrandosi in qualunque punto. Le truppe, nonché con l’animo, neppure con le orecchie ascoltavano questi consigli di salvezza”. E di fronte chi c’era? Annibale stesso, ben altro generale che Fulvio e con un esercito ben altrimenti ordinato. Perciò i Romani non ne sostennero nemmeno il primo grido di guerra e il primo urto. Il comandante Fulvio, quando vide che le cose volgevano al peggio e che i suoi cedevano, prese il cavallo e con circa duecento cavalieri si diede alla fuga. Del resto dell’esercito, respinto sul fronte e poi accerchiato di spalle e sui fianchi, fu fatta strage: di diciottomila uomini che erano, non più di duemila tornarono a casa. Annibale occupò il campo”. Per adesso si accontenta dell’accampamento romano, perché Herdonia gli è alleata. Stesso luogo, due anni dopo. C’è un altro Fulvio a comandare le truppe all’assedio di Herdonia ribelle ai Romani. Ma la professionalità non è migliorata. Annibale piomba improvviso precedendo gli informatori; Fulvio chiama a battaglia ma è tardi. Non fa nemmeno in tempo a fuggire come il suo omonimo del 212. “Lo stesso Cneo Fulvio cadde con undici tribuni militari. Quante migliaia di soldati sono stati trucidati in quella battaglia? Non si può dire con certezza: alcuni storici parlano di tredicimila, altri di settemila. Il vincitore si impadronì degli accampamenti e del bottino. Poi Annibale diede alle fiamme la città (e Silio Italico la chiamerà obscura Herdonea) e trasferì la massa dei suoi abitanti a Metaponto e a Turii. Infatti era venuto a conoscenza che Herdonea sarebbe passata ai Romani appena egli si fosse allontanato. Ne uccise i capi; si sapeva con certezza che avevano avuto incontri segreti con Fulvio”. Insomma, Herdonia oscurata per diffidenza nel 210. Rinascerà come città romana. Faticosamente. Sarà lei quel villaggio dove l’acqua, figuràtevi, bisogna pagarla, ed ha un nome che nell’esametro non c’entra proprio anche se lo si può esprimere a gesti – chissà quali? Ci passa Orazio nel 37 a.C. viaggiando da Roma a Brindisi, di pessimo umore per il bidone appena ricevuto dalla ‘ragazza bugiarda’ alla locanda di 27 Trevico. Di buono almeno c’è il pane, e il viaggiatore accorto se ne carica la schiena perché a Canosa lo fanno lapidosus, sembra un sasso, e anche quanto ad acqua non stanno meglio. Comunque l’archeologia ci racconta di una città influente e ben dotata, centro di un territorio ricco, all’inizio del IV secolo d.C., quando vi sosta il pellegrino di Bordeaux di ritorno dalla Terrasanta. Ma nel 346 il rovinoso terremoto abbatte o danneggia edifici pubblici come il tempio, la basilica, le terme, il macellum. A quanto pare manca a Herdonia l’energia, o le condizioni esterne, per ricostruirsi e recuperare il primato territoriale. In coincidenza con questa debolezza sale invece la stella di Canosa, che concentra servizi pubblici come l’amministrazione della giustizia, opifici tessili, e soprattutto diviene la sede episcopale più gâtée. Ricorda il professor Volpe, in una relazione da leggere assolutamente on line, che il vescovo di Herdonia, Saturnino, partecipa sì al Concilio di papa Simmaco del 499, ma la sua firma appare all’ultimo posto, mentre quella di Rufino, vescovo di Canosa, è al quinto. Dalla fine del V secolo il declino di Herdonia è inarrestabile. L’uso dei grandi edifici rimasti in piedi viene scordato: nelle terme si alloggiano stalle e povere capanne. Passa la guerra greco-gotica nel VI secolo; Costante II aggredisce i Longobardi nel 663. Herdonia subisce e si raggomitola sempre più. Sappiamo che nel IX secolo è composta da 89 famiglie, e poco dopo la sede vescovile migrerà a Ascoli Satriano, in posizione meglio difendibile. I Saraceni da Bari faranno in tempo a completare la distruzione di Atrunam. Col toponimo Dordona, invece, lo storico Nicolò Jamsilla ne attribuisce la ricostruzione a Federico II; si tratta di un castello, pare, più che altro, alla punta nord della città. ‘Mission’ Ma Ordona ha una voglia di vivere che non si estingue facilmente. Se passiamo per l’attuale paese che eredita il nome, forse non ci accorgiamo di essere coinvolti in una delle affaire più singolari della storia della Chiesa. Ma il fatto – la soppressione dell’ordine dei Gesuiti – potrebbe essere letto meglio nella filiera del confronto tra potere spirituale e tem28 porale. Esso nasce forse con le invasioni barbariche ed è uno dei temi portanti della storia europea fino ad oggi stesso. Ordona e il suo territorio vengono acquistati dalla Compagnia di Gesù per instaurare una rete di imprese agricole. C’è da dire che nel Regno di Napoli i possedimenti della Compagnia, verso la metà del Settecento, coprono una superficie enorme. C’è anche da dire che l’esperienza nell’agricoltura i Gesuiti se la sono fatta in maniera assolutamente innovativa e socialmente qualificata nell’America meridionale. Le reducciones del Paraguay, che abbiamo visto sullo schermo nel film ‘Mission’ con Robert De Niro e Jeremy Irons, sono una sponda geniale e cristiana rispetto all’orrenda colonizzazione iberica del continente. Non abbiamo elementi per capire se la Ordona gesuitica avesse uno spessore storico paragonabile. Quello che sappiamo è che dall’America latina si avvia una pulsazione sociale, politica, religiosa, culturale che avrà, tra le sue conseguenze marginali, l’allontanamento dei Gesuiti da Ordona e un tentativo borbonico, intelligente ma non abbastanza, per assicurare il transito da una produzione ‘collettivista’ a una ‘liberista’. Ma che cosa succede alle spalle di Ordona? All’origine vi sono gli encomenderos, i proprietari terrieri spagnoli e portoghesi che non si sono mai rassegnati all’idea che i Guaranì e gli altri nativi del Cono Sur siano considerati come esseri umani. Tanto che il mitico vescovo degli Indios, Bartolomé de las Casas, viene costretto nel 1547 a rientrare in Spagna e ivi difendersi dalle accuse del padre Ginés de Sepúlveda sostenitore della schiavitù naturale degli indigeni. Ovviamente tutta la disputa teologica altro non era che una lotta sferrata dagli encomenderos per aver mano libera nello sfruttamento bestiale ma, insieme, la coscienza pulita: con la benedizione del potere spirituale e l’approvazione di quello temporale. Cosa che otterranno alla grande quando, in pieno Settecento, le istanze del latifondismo retrogrado si sposeranno con il progressismo illuministico nel combattere la manomorta ecclesiastica. Eterogenesi dei fini in una fase di ‘ricorso’ della storia, professor Vico? I Gesuiti caddero nella stessa rete in cui erano caduti i Templari quat29 tro secoli prima: forse è vero che i ‘poteri forti’ sono delle tigri di carta, presidente Mao. La fama della loro potenza economica; le innovazioni efficacissime nell’educazione e nella propagazione del cristianesimo – i successi altrui non garbano nemmeno ai compagni di fede –; la cosiddetta ‘superbia gesuitica’, cioè una certa consapevolezza di superiorità che forse lasciavano trasparire; il ruolo di influenzatori presso alcune corti, come quella prussiana, polacca e russa (si ascolti nel ‘Boris Godunov’ di Mussorgskij la parte odiosa del gesuita Rangoni); infine l’accusa di lassismo morale lanciata dai Giansenisti e ribattuta con eco immensa da Pascal nelle Lettres Provinciales. Questa volta non ci furono processi, torture e roghi: siamo nell’epoca dei lumi! Ma per la pressione delle corti cattolicissime dei Borboni, dal Portogallo alla Spagna alla Francia fino a Parma, il papa Clemente XIV, firmerà la bolla ‘Dominus ac Redemptor’ che sopprime la Compagnia di Ignazio di Loyola. E’ il 21 luglio 1773. Data storica per Ordona. Napoli infatti era in prima fila tra le corti avverse alla Compagnia di Gesù. Intanto il re Ferdinando IV era praticamente sotto tutela del suo Ministro, Bernardo Tanucci, che a sua volta rispondeva di lui al padre diventato Carlo III di Spagna. Per la verità re Ferdinando non è del parere di cacciare i Gesuiti; in fondo la Santa Sede non si era ancora espressa, in quel 1767. Ma questo è l’ordine che da Madrid filtra attraverso il marchese Tanucci. Il Ministro toscano riesce a far breccia nella coscienza del giovane re attraverso il suo confessore, fino a che i Gesuiti non vengono espulsi anche dal Regno di Napoli. Per la cronaca Bernardo Tanucci, nato contadino in Pratomagno, finì i suoi giorni in disparte quando la moglie di Ferdinando IV, Carolina d’Asburgo, riuscì ad emarginarlo dal Consiglio di Stato. Un Reale Sito Liberati dalla ‘manomorta’ ecclesiastica, quale sarà la sorte dei contadini di Ordona? Leggiamo qualche passo di un documento dell’Archivio di Foggia pubblicato da Lucia Lopriore in Internet. “Le terre del Tavoliere di Puglia che vengono denominate i cinque 30 Reali Siti, e che sono assegnate in censuazione a’ naturali de’ comuni di Orta, Ordona, Carapelle, Stornara, e Stornarella, appartenevano altra volta in feudo a’ PP. Gesuiti. Coloro che le coltivavano, vi avevano costituito de’ meschini villaggi. Allorché nella soppressione dell’ordine gesuitico nel Regno di Napoli esse divennero delle proprietà fiscali, volle il Governo accorresse al bisogno degl’infelici agricoltori che fin allora le aveano utilizzate, aderendo alle loro dimande, e distribuendole ad essi. Quindi fu che nell’anno 1774 si diedero in censuazione agli abitanti de’ Siti indicati, assegnandosene a ciascuno dieci versure ad uso di semina, una casa rurale, ed un pascolo sulla mezzana delle terre stesse pel nutrimento degli animali necessarj alla coltivazione. Ebbero altresì i nuovi coloni un proporzionato assegnamento di istrumenti rurali di animali e di vettovaglie, a patto di pagarne il prezzo per cinque anni”. Il trattamento pare illuminato, ma non tiene conto di quello che per i Gesuiti era l’asset principale: la conoscenza, il management, la supply chain, la rete commerciale e finanziaria. Gli agricoltori da soli non saranno in grado di ‘fare impresa’. Per un motivo o per un altro molti non riescono a pagare le tasse, e il fisco si riappropria dei terreni mettendoli in vendita sul libero mercato, dove i pescecani locali si gettano per riaffittarli poi a chi li vorrà ma a prezzi assai più elevati. Devono uscire di scena i Borboni, portati via dal ciclone napoleonico, perché si trovi per Ordona una soluzione socialmente compatibile. E’ nel giugno 1806, quindi da poco insediato, che Giuseppe Buonaparte elabora una soluzione. “Il grido della desolazione e della miseria concordemente elevato dalle avvilite popolazioni di Orta, di Ordona, Carapelle, Stornarella, e Stornara, produsse che all’epoca della censuazione generale del Tavoliere di Puglia si risolvesse di richiamare al Reg[io] Erario il dominio diretto delle terre altra volta vendute, e ch’erano state di principio assegnate a quegli sventurati coloni. Quindi con Decreto de’ 14 Giugno 1806 fu ordinato alla Giunta del Tavoliere di compensare i particolari che le avevano acquistate coll’assegnamento di altre terre fiscali e di concederle in censuazione agli abitanti de’ Siti Reali. E poiché magraldo le vessazioni e le sciagure sofferte quelle popolazioni eransi aumen31 tate, ed era in conseguenza seguito il bisogno di avere delle terre a coltivare; fu stabilito che se ne assegnassero anche delle altre, prendendole da quelle che nel 1774 furono concedute per pascolo a’ Locati di Orta e di Ordona”. Chissà per quale anamorfosi della memoria, questi fatti tutto sommato recenti sembrano anche più remoti della via Traiana e del macellum. Forse perché non vediamo niente che ce li renda vivi. Non siamo più in grado di interpretare i segni di una superficie di terra se non vengono enfatizzati da una casa, da una strada, da un fosso o almeno da un filare di alberi. La lettura del paesaggio è un’arte ancora di élite. 32 33 ARPI Combien de foys prinse cité solaire Seras, changeant les loys barbares & vaines. Ton mal s’aproche: Plus tu seras tributaire La grand Hadrie reovrira tes veines (I, VIII) Arpi, ‘città dimenticata’? Non vediamo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l’erme torri. È più facile incontrare sottoterra delle costruzioni certe, come i villaggi neolitici tra la Villa Comunale e il Galoppatoio, e poi verso l’esterno, in direzione degli accampamenti lunati di Passo di Corvo. La nostra sosta sulla pianura di Arpi è dedicata per intero a Marina Mazzei. Una vita breve che ha segnato per sempre la conoscenza e il godimento del patrimonio archeologico della Daunia. Marina Mazzei riunisce in sé le figure del civil servant, dello studioso, del ricercatore sul campo e del narratore. La Daunia antica non avrebbe parola, per le persone come noi, senza le sue opere; quelle sui siti scavati da lei come Bovino, Arpi, Siponto, e quelle comprensive come ‘L’Oro della Daunia’ e le postume ‘Passeggiate archeologiche nella Daunia’. Emblema della Arpi sotterranea è il volto di Medusa che adesso è conservato nel Museo Civico. Nel 2002 per il volume che dedicammo a Medusa e ad altri mostri fu Marina Mazzei a raccontare la storia rocambolesca e la scoperta vissuta in prima persona. Come omaggio alla grande studiosa e all’amica gentile riproponiamo qui la sua prosa limpida e appassionata. 35 Da Arpi a Foggia: due millenni di Marina Mazzei (2002) Ricordo bene quando arrivò da noi. Quel giorno, era il 1984, Medusa non veniva dalla terra della vicina Arpi, ma da un viaggio più lungo. Da Taranto il furgone della Soprintendenza era partito alla volta di un paese del Napoletano presso la cui stazione dei Carabinieri Medusa giaceva insieme a una coppia di capitelli. Medusa era stata rubata. Il suo trasferimento dalla campagna di Arpi in una destinazione rimasta ignota (Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone?) si era concluso proprio lì: i malcapitati che la trasportavano erano andati fuori strada con il loro automezzo. Solo così, dunque per un caso, Medusa tornò a casa. Ricordo bene quando Medusa arrivò. Ancora sporca di terra: la sua bellezza diveniva sempre più intensa e struggente man mano che la pulivamo. In quei momenti ci chiedevamo non solo dove e come fosse stata trafugata, ma anche chi e quando nell’antichità l’avesse fatta realizzare per la sua tomba. Sapevamo che nelle campagne di Arpi, a pochi chilometri da Foggia, vi era un grande ipogeo il cui saccheggio si era svolto ripetutamente in quegli anni. Presto venne la conferma della provenienza di Medusa. Ad Arpi individuammo il luogo della grande tomba e, piuttosto che cercare al suo interno, ne esplorammo la facciata per avere la conferma che il frontone su cui Medusa era raffigurata venisse da lì. Presto verificammo che la sua fronte era stata smontata ricorrendo addirittura all’uso di una ruspa: il frontone con la Medusa e i capitelli così erano partiti forse per diventare la quinta scenografica di qualche ricco giardino in un paese europeo. Ma Medusa era con noi e dovevamo, anche per un obbligo morale, non lasciarla sola in magazzino, ma capire il più possibile del monumento per il quale era stata scolpita e del signore che l’aveva voluta sulla tomba di famiglia. Presto trovammo i blocchi rimossi e fra questi alcuni con le tracce dei denti di una ruspa, segni di una devastazione senza pari, e un acroterio a palmetta in pietra del quale, proprio al vertice del 36 nostro frontone con la Medusa, si conservava la traccia dell’imposta. Fu grande il cantiere organizzato per la sua costruzione: la pietra, forse già lavorata, fu estratta dalle cave di Santa Lucia e trasportata ad Arpi risalendo il corso del Candelaro; si reimpiegarono i blocchi di una grande tomba a camera, da noi chiamata ‘il Ganimede’, già crollata in antico; le tante vaschette all’interno della tomba testimoniavano la grande attività per realizzare gli intonaci e i dipinti della tomba. Un corridoio lungo 9,30 metri conduceva all’ipogeo; in antico era percorribile solo durante i giorni dei funerali dopo i quali veniva buttata la terra a sigillare l’accesso della grande tomba. Solo in quella occasione, dunque, era visibile a pieno il suo grandioso prospetto con quattro colonne ciascuna sormontata da un capitello figurato con teste di divinità, il frontone con la Medusa e sul suo vertice l’acroterio a palmetta. La porta in pietra di chiusura della tomba faceva da quinta scenografica, arricchendo con le sue cromie le vivaci tonalità del complesso. Infatti, il corridoio d’accesso, la fronte e il vestibolo erano accuratamente dipinti con una sinfonia di colori rosso, azzurro e nero stagliati sul bianco della pietra. Il vestibolo, stretto spazio rettangolare compreso fra il colonnato e l’ingresso alla tomba, racchiudeva una sorta di pinacoteca. Un fregio complesso doveva svolgersi sull’architrave, ma purtroppo anche questi blocchi erano stati asportati da clandestini e solo alcuni, sulle pareti laterali, conservavano resti delle raffigurazioni, con un Hermes accompagnatore delle anime ed un grande Cerbero di colore nero. Su un lato, quello sinistro, su un fondo rosso della parete era dipinto un quadretto (pinax) con un personaggio togato seguito da un cavallo condotto a un palafreniere con un grande scudo tondo: in alto un’iscrizione a caratteri greci, forse la firma del pittore, Artos. Se, dunque, l’esterno della tomba era stato concepito per essere visto al momento della cerimonia funebre, e, pertanto, arricchito anche di soggetti dipinti evocanti l’aldilà come il mostruoso Cerbero, quello interno era uno spazio decisamente privato, tanto da essere costruito riproducendo la stanza da banchetto delle case aristocratiche. Tre le stanze, 37 tutte con la volta a botte, quella d’accesso, finemente pavimentata con il quadretto al centro (emblema), con pistrici e delfini, aveva le pareti dipinte e decorate con un fregio a dentelli di stucco sul quale correva uno splendido fregio dipinto con girali. Il mosaico, con la sua lieve pendenza verso l’ingresso, al momento del funerale era ben visibile dall’esterno prima che la grande, bella porta di pietra dipinta venisse collocata a sigillare l’ingresso. Questi effetti iniziali si persero con l’uso eccessivo del monumento. La sua riapertura, per effettuare altre deposizioni, richiedeva operazioni di manutenzione che si ottenevano dando mani di calce bianca sulla facciata: quegli stessi strati di bianco che, più d’uno, avevano ricoperto il volto di Medusa e che il nostro restauratore aveva pazientemente asportato restituendole la sua originaria bellezza. L’ambiente centrale della tomba, forse quello destinato ad ospitare i materiali usati nel corso del funerale, era una sorta di miniatura del salone nel quale, nelle case, i signori ricevevano gli ospiti per il banchetto, disponendo i letti intorno ad un mosaico centrale. Su ciascun lato si aprivano due stanze, decisamente molto sobrie, ciascuna con un grande letto su cui venivano adagiati i corpi dei defunti con un cuscino di pietra e un basso sgabello alla base. La famiglia proprietaria, dunque, non solo voleva lasciare memoria della propria ricchezza, ma che affermare il proprio modo di pensare ‘alla greca’. Con le volte a botte, i pavimenti composti da piccoli ciottoli di fiume, la struttura architettonica dell’ipogeo della Medusa duplicava, anche se con forti varianti, le tombe a camera che nello stesso periodo erano in voga fra i principi della Macedonia e nei paesi culturalmente influenzati da questa regione. Il monumento era stato costruito durante il III secolo a.C. Arpi, già importante nei secoli precedenti, dal IV aveva consolidato la propria ricchezza divenendo una città-stato con un territorio ricchissimo. Il grano, da sempre risorsa di queste terre, segnò la svolta. Ne fu incrementata la produzione su vaste estensioni anche per soddisfare le necessità di approvvigionamento degli eserciti impegnati nelle guerre 38 che Sanniti e Romani combattevano in quei decenni. Il controllo della produzione e del commercio dei cereali era detenuto da poche famiglie che governarono la città almeno fino alla fine del III secolo. Dunque, i prìncipi di Arpi erano dotati di ricchezze enormi. Non solo è l’archeologia a provarlo, ma ne parlano autori antichi, anzi, proprio per Arpi, trasmettono il nome di uno di loro, forse il più ricco e potente, Dasius Altinius. Dopo la disfatta dei Romani a Canne nel 216 a.C. , Dasius fece la scelta di passare, e con lui la città di Arpi, dalla parte dei Cartaginesi. Ma, quando la guerra volse a favore di Roma, Dasius, prigioniero a Calvi ma ancora in possesso di ricchezze e schiavi, tentò di tornare nuovamente dalla parte romana. Non è nota la sua sorte, ma sappiamo che la famiglia, rimasta ad Arpi dopo la sua fuga, fu sterminata su ordine di Annibale prima della riconquista della città da parte romana. E’ questo il livello sociale e di ricchezza al quale dobbiamo riferire l’ipogeo della Medusa e i pochi materiali sopravvissuti al saccheggio dei tombaroli ne danno un’idea sufficiente: bicchieri, coperchi, spilloni, specchi in argento, vasellame in marmo greco, un bracciale in oro, una tazza ed uno splendido anello in vetro, forse provenienti da Alessandria d’Egitto. Non a caso il periodo durante il quale l’ipogeo fu costruito è l’ellenismo, che alla celebrazione della morte assegnava uno dei momenti più importanti della vita con una grande visibilità sociale. In una società poco aperta alla grecità come quella della Daunia antica venne edificato un monumento che sigillava un rapporto stretto fra le aristocrazie locali e la Grecia del tempo. Certamente, il rapporto fu fatto di migrazioni di maestranze e di circolazione di modelli, di trasmissioni di abilità e sapienze tecniche. Ma ricordiamo che, intorno al 333 a.C., le fonti narrano il passaggio nei territori della Daunia di Alessandro il Molosso, re d’Epiro, e pochi decenni dopo quello di un altro condottiero epirota, Pirro, che presso Ascoli Satriano si scontrò con i romani e con un contingente arpano composto da 4000 fanti e 400 cavalieri che depredò l’accampamento epirota. 39 L’ipogeo continuò ad essere usato ancora per un lungo periodo. Membri della famiglia proprietaria vi furono seppelliti per un centinaio di anni sotto lo sguardo e la protezione di Medusa, il cui viso bello, dolce, non aveva niente di spaventoso, salvo i riccioli serpentiformi che si annodavano con un effetto puramente decorativo per concludersi con un ‘nodo di Ercole’ alla base del collo. Nessuno mai avrebbe immaginato che Medusa fosse proprio lì, ad Arpi, lasciata dopo un importante funerale da circa 2100 anni, coperta da strati di terra secolari, solleticata da aratri e trattori. Sino a quando sottili sonde di ferro, manovrate da saccheggiatori ignoti, iniziarono a perforare le volte della tomba alla ricerca di tesori nascosti, forando le sue prestigiose volte, calandosi nel buio della morte, aggredendone la facciata con le ruspe. Per cercare tesori nascosti, poi trovati, rubati, portati via verso una destinazione che non ancora conosciamo. Salvo Medusa che è tornata a casa e alla quale, in fondo, ora vogliamo bene come ad uno di famiglia. Argos Hippion è il nome esteso di Arpi che la riconnette con le sue fonti micenee. Il mito di fondazione attribuisce a Diomede, il conquistatore di Troia che al rientro in patria trova ad Argo una situazione familiare da cui è meglio fuggire. Egli trova così una posizione alle soglie della storia come ‘padre nobile’ dell’espansione greca lungo le coste dell’Adriatico. Alla futura Foggia riserva il nome della sua stessa patria, Argo, e della sua passione predominante, i cavalli. Marina Mazzei: un profilo etico-civile di Saverio Russo (2004) Per la cortesia del professor Saverio Russo riproduciamo alcuni momenti del suo intervento in presentazione dell’opera postuma di Marina Mazzei, ‘Passeggiate archeologiche nella Daunia’. Marina aveva un’alta considerazione del suo essere funzionaria di un organo prestigioso dello Stato, che non è soltanto un ufficio burocratico, ma strumento di tutela e struttura di ricerca, istituzione culturale per 40 eccellenza che richiede buoni studi preliminari e continuo aggiornamento. Faceva in modo che qualsiasi cosa scrivesse o facesse, nel più piccolo comune o nella sede più prestigiosa, si avesse della Soprintendenza un’alta considerazione. Non amava il sensazionalismo nella ricerca archeologica, i cercatori dell’eccezionale, i cacciatori di reliquie: sapeva bene quanti danni ha fatto all’indagine archeologica la ricerca di qualcosa in particolare, che ha portato a distruggere quanto non serviva. Non amava la pubblicità a tutti i costi, l’annuncio intempestivo, prima che lo scavo fosse chiuso e messo in sicurezza e se ne fosse garantita la custodia. Si meravigliava però anche dello spazio che le agenzie di stampa e i giornali, senza alcun vaglio critico, davano ad ogni annuncio – fanfaluche o ipotesi bizzarre, purtroppo spesso avanzate da chi aveva il dovere della prudenza. Era un po’ preoccupata per l’eccessiva attenzione mediatica per l’archeologia e preoccupata come me che nel nostro Mezzogiorno il passato non sia solo archeologia. E spesso, come sappiamo, l’archeologia del vaso, del reperto non contestualizzato, in una spirale perversa che rende gli oggetti feticci e favorisce il mercato clandestino. Riteneva indispensabile il lavoro oscuro, quello di cui non si parla, ma che costituisce la condizione della tutela: i vincoli, gli espropri, oltre che le buone leggi (di recente aveva più volte inviato al Ministero sue considerazioni sui vari provvedimenti legislativi che tanto hanno allarmato il mondo della cultura). Aveva un grande senso della misura che non la spingeva a sgomitare per stare dappertutto, attenta a che nella sua vita il lavoro non prevaricasse sul mondo degli affetti e che la routine dell’ufficio non le impedisse di studiare. L’unica trasgressione “familista” consentita riguardava il lavoro di ricerca: ci si scambiava schede e documenti e ci ripromettevamo di scrivere un lavoro a quattro mani sul collezionismo tra Sette e Ottocento. Ma non c’è stato tempo e le brevi mie note che compaiono in questo volume, sull’onda dei ricordi dei paesaggi che avevamo visto 41 insieme – il Gargano che a volte sembra un’isola da Margherita, le colline allineate l’una dietro l’altra che si scorgono dal bosco di San Cristoforo – sono quanto resta di questa collaborazione. Ha cercato di far crescere e valorizzare il lavoro dei giovani, non come talvolta si fa in relazioni asimmetriche, tra chi ha potere e chi no, pubblicando a nome del “più importante” la ricerca del più giovane, costretto ad “abbozzare” con la speranza di ottenere un giorno qualcosa. Potrei fare un lungo elenco di laureandi abbandonati a se stessi dai loro professori o di giovani che aveva incoraggiato e aiutato a pubblicare le ricerche a lei sottoposte in lettura. Nel rapporto necessario con Enti e istituzioni stava attenta tuttavia a non farsi spogliare delle sue prerogative, a non cedere sul piano della distinzione dei ruoli. Dava fiducia non sulla base del colore politico, ma della credibilità personale e della coerenza, oltre che dello stile, sempre comunque attenta alla tutela dell’interesse pubblico. Ma, come nel suo stile, su questo e su altri temi, non faceva proclami o dichiarazioni ideologiche. Sarebbe difficile cercare tra i suoi scritti, editi o inediti, qualcosa che riassuma la sua filosofia di vita, un diario più o meno privato, pieno di massime. Faceva, operava e basta. Sperava - forse si illudeva - nell’efficacia dell’esempio. Potremmo dire, come sostengono gli economisti, che purtroppo la moneta cattiva scaccia quella buona. Speriamo - e non abbiamo altra risorsa che la speranza - che il suo seme possa ancora continuare a dare frutti, che la sua testimonianza, così poco ostentata, non sia stata vana. 42 43 MATINUM Entre deux mers dressera promontoire Que puis mourra par le mords du cheval: Le sien Neptune pliera voyle noire, Par Calpre & classe auprès de Rocheual (I, 77) Inoltriamoci sul Monte Saraceno non per la strada comoda e panoramica ma attraverso il bosco fitto e a volte scosceso. Sappiamo di calpestare le orme di infiniti altri uomini, che si sono mossi su questo terreno per epoche indefinite. Un milione e mezzo di anni – tanto sembra vecchio l’Homo di Apricena? E’ vero che non se ne conosce il volto ma solo le selci scheggiate. Però è affascinante pensare che il primo Homo europeo è venuto qui sul Gargano dall’Africa, madre dell’umanità. Oppure che è passato dal Caucaso prima di arrivare qua sopra, magari nel trasferimento verso Apricena, verso Paglicci, e poi verso l’alta Castiglia spagnola. L’abbiamo vista la sua abitazione precedente in Georgia, a sud-ovest di Tbilisi. Il fiume Mashavera si attraversava su un ponte Bailey, e poi si camminava in salita verso un sito non molto diverso da questo. La differenza principale è che l’Homo georgicus di Dmanisi è presidiato da una chiesa paleocristiana che porta il nome di Sioni, come per controllare eventuali spiriti smarriti nei recessi del tempo, delle abitazioni e delle tombe. La Terra madre Carl Gustav Jung diceva qualcosa sull’energia che si trasmette mediante il suolo tra generazioni distanti di secoli. Andando per Monte Saraceno incontriamo orme cancellate e assorbiamo, certamente, dei messaggi. 45 Saltiamo i resti di mura daunie e scendiamo fino al bunker del promontorio. Da soli è meglio, perché lungo il cammino ci aspetta una sfinge che sussurra a ciascuno enigmi distinti. Non ha la forma del mostro alato che si manifestà a Edipo. Ha l’aspetto di una quantità indefinibile di buche scavate nella roccia morbida del terreno. Ognuna di esse è la tomba di una persona. E quindi è una domanda. Piccoli pozzi bianchi, con la forma di bozzoli da seta. Si sa che il defunto veniva composto in posizione fetale e con lo sguardo verso l’Oriente, come è naturale per chi aspetta di essere richiamato in vita da un raggio di sole: ex Oriente lux. Perché questo è il destino di ciò che si pianta nella terra. Lo sfregio imperdonabile infatti è lasciare insepolta la salma. I Greci, maestri definitivi di tutto, hanno sancito questa verità: è contro il volere degli dèi, perché una vita ulteriore può sorgere solo dalla terra. Ettore, racconta Omero, scivola nella morte con il terrore di essere abbandonato ai morsi delle cagne (‘da un figlio di dea come te non mi aspettavo niente di meglio’, mormora ad Achille). Solo dopo i giochi che stilizzano il lutto per la morte di Patroclo, davanti ai doni e alle preghiere di Priamo (‘pensa che cosa direbbe il tuo babbo’), il funesto Achille acconsente a restituire il corpo perché sia onorato sulla pira e le ossa finalmente sepolte. La testimonianza di Antigone Ma sarà poi Antigone a spiegare. La sepoltura è un imperativo assoluto perché “le leggi non scritte e incrollabili degli dei / non sono di oggi o di ieri, ma sempre vivono, / e nessuno sa da quando sono apparse”. E quindi lei accetta la morte pur di seppellire Polinice, il fratello perdente che il re-zio Creonte aveva ordinato di abbandonare ai cani. E per rendere pedagogicamente ancora più impressive questo insegnamento, il mito fa sì che Antigone, murata viva, si impicchi, dando l’avvio a un domino perverso che si porta via il fidanzato-cugino Emone, quindi la zia-regina Euridice per finire con il colpevole di tutto: il re Creonte. Il tema che ai Greci stava a cuore stabilire con tanto pathos è la supe46 riorità della legge divina, o del dovere, sulle leggi umane. E un argomento senza tempo. Per questo Antigone transita attraverso le scritture e i palcoscenici e gli schermi fino ad oggi: da Eschilo (‘I sette contro Tebe’) a Sofocle e Euripide, a Vittorio Alfieri, Bertold Brecht, a Jean Anouilh e infiniti altri, fino ai ‘Cannibali’ di Liliana Cavani, dove Britt Ekland e Pierre Clementi facevano una bella coppia di seppellitori. Carl Orff, dopo i ‘Carmina Burana’, scrive anche la severa ‘Antigonae’ mettendo in musica il testo di Sofocle nella traduzione di Hölderlin. Senza scendere a esperienze così impegnative, questa socializzazione della morte si percepisce in maniera viva, fresca, qui a Monte Saraceno. Forse è una vocazione del luogo. L’hanno sentita i Dauni, i Greci e, fino ai Turchi, tutte le comunità che hanno vissuto il Gargano. Sarà lo sfolgorio del mare, la dolcezza della baia di Mattinata: da queste uova svuotate nel terreno la vita fiorisce ancora. Con che animo negheremmo a un defunto di diecimila anni fa la gioia di essere questo cappero dai fiori sontuosi, o l’albero di fico che cresce spontaneo dalla sepoltura? Per passare l’eternità Non era usanza, nella maggior parte delle comunità antiche, lasciare il defunto senza indicazioni o auspici per il cammino. Ogni tanto magari mettevano in scena contesti di ricchezza esagerata, come i Faraoni, o rappresentazioni della vita quotidiana come gli Etruschi. La natura del décor si allineava alle credenze su ‘che cosa’ il defunto avesse da fare nel tempo futuro. L’abbondanza di vasellame nelle sepolture daunie – a meno che i cocci non fossero così costosi da configurare un lusso – impressiona per i simbolismi che ci pare di leggervi segnati o graffiti: triangoli, reti, meandri (l’acqua, l’umidità?), l’antichissimo chevron, losanghe con uno o più punti al centro – proiezione bidimensionale di una dea gravida forse? –; spire, uncini, svastiche, vortici, che a noi parlano di energia, di divenire; e quindi di vita, fertilità, rigenerazione. Ma per loro, magari, si trattava appena di una provvista di oggetti di vita quotidiana 47 per attenuare lo stress del viaggio nell’oltretomba. Non dobbiamo lasciarci influenzare dal fiorire di tombe vuote. E’ la ‘Sindrome etrusca’. Ma Monte Saraceno è terra di viventi. Persone e comunità che si sono sentite bene qui, fin dal Neolitico di certo, ma forse da prima. Hanno costruito abitazioni e difese. Hanno tenuto accanto a sé i loro morti per non dissipare la coerenza del gruppo e rafforzare l’energia dello stare accanto. Questo ci sembra di sentire mentre la luce, piegando al tramonto, non illumina più il fondo delle tombe. Non ci riconosciamo invece nella folle cavalcata che Massimo D’Azeglio attribuisce (dubitativamente, è vero) a Ettore Fieramosca, il capuano eroe della Disfida di Barletta. Distrutto per la perdita dell’amata Ginevra, avrebbe incitato l’altrettanto amato cavallo fino al precipizio sul mare. E oltre. Archita o il ’ Leonardo’ da Taranto E’ certa invece l’accoglienza che la spiaggia di Matinum, tra le due braccia montuose, offre a uno dei sommi personaggi dell’antichità: Archita di Taranto, il matematico, ingegnere, scienziato, astronomo, condottiero, filosofo, poeta, uomo poltico. Hanno dato il suo nome al cratere lunare nel Mare Frigoris. Da sé invece ha dato il nome a una sua scoperta, la ‘Curva di Archita’, che a una persona normale fa impressione solo a vederne la formula; serve a raddoppiare il volume di un cubo. Di questa salma che i marosi accompagnano da Salona ci parla Orazio. Egli era di Venosa, tre secoli più giovane di Archita, e poteva conoscere sia le cose di Taranto che i segreti dell’Adriatico vicino. Te maris et terrae numeroque carentis harenae Mensorem cohibent, Archytas, Pulueris exigui prope latum parua Matinum Munera nec quicquam tibi prodest Aerias temptasse domos animoque rotundum Percurrisse polum morituro. 48 Tu misuravi il mare, la terra / contavi gli infiniti grani di sabbia, Archita. / Ora sei appena ricoperto dalla cortesia di una manciata di polvere, / presso il fianco di Matinum. Non ti serve a niente / aver ricercato le dimore celesti e percorso le ricurve strade del cielo: / l’animo infatti è destinato alla morte. Archita (Taranto 428. – Matinum 347 a.C.) è sicuramente l’ospite illustre di uno dei sepolcri che costellano il monte Saraceno. Chissà che cosa ha in mente Orazio: temptare le dimore dell’etere (bussare? scuotere? o soltanto immaginare?) e percorrere le vie celesti in cerca di immortalità? Archita sarà una specie di Ulisse che ha tentato l’esperienza “diretro al sol, del mondo sanza gente”? Indubbiamente era un personaggio più avanti del suo tempo, e un paragone con Leonardo da Vinci non sembra affatto mal placé. O anche con Gerberto di Aurillac, il papa dell’anno Mille, divulgatore del numero zero. In ogni modo Archita è la piena fioritura della Magna Grecia. Taranto e Siracusa sono le città leader, unite dalla stessa governance la ‘tirannia democratica’. Aristotele, nei ‘Politikà’., ne esalta l’efficacia: “E’ degno di imitazione anche il governo di Taranto. Qui, facendo partecipi i non abbienti del reddito delle proprietà, si è acquisito il consenso popolare. Inoltre si sono create due carriere di magistratura: una elettiva, l’altra a sorteggio; con questa si governa efficacemente, con quella si garantisce la partecipazione”. Archita capisce che la supremazia sul territorio e la sicurezza passano attraverso la disponibilità di una flotta potente, e per sette volte viene eletto stratego della città mentre la costituzione consentiva al massimo per un anno il conferimento del potere militare supremo. Strabone commenta: proprio alla democrazia e alla costanza del potere si deve la prosperità di Taranto. Si dice che Archita fosse lo ‘statista pitagorico’ per definizione, perseguendo gli ideali di armonia e di proporzione all’interno del corpo sociale. Forse è riuscito a integrare nel sistema metafisico, matematico, astronomico del Maestro di Samo (che peraltro un secolo prima era vissuto a Crotone) anche la politica internazionale e la strategia militare, oltre a diverse scienze come la meccanica razionale, la geometria, l’acustica, e a tecnologie di cui abbiamo informazioni a volte vaghe, e che 49 vanno dall’artiglieria all’agricoltura. Le sue ricerche furono sviluppate dall’amico Platone per la teoria del suono, e più tardi da Euclide per la teoria delle proporzioni, e soprattutto da Archimede, nella Siracusa assediata dai Romani al tempo delle guerre puniche, per gli accorgimenti bellici da usare contro il console Marcello. Archita per i bambini Ma di tutte queste relazioni, compimenti, pensieri, successi, due sono meglio attestati dalle fonti. Il primo è la colomba lignea ad aria compressa: di certo ne dipende la colombina a razzo che ogni mattino di Pasqua attraversa fiammeggiando il duomo di Firenze e si pianta all’esterno sul carro di fuochi artificiali dando l’avvio al più rumoroso spettacolo pirotecnico del mondo (ha infatti come cassa di risonanza la cattedrale intera con la cupola del Brunelleschi, che ogni volta sembra schizzare per l’aria). Noi abbiamo di questa colomba a reazione una testimonianza de relato, come usa dire nei tribunali. Aulo Gellio, nelle ‘Notti Attiche’., cita un testimone. “Un modello di colomba di legno, costruito da Archita secondo certi princìpi di meccanica, riuscì a volare. Essa si sosteneva per mezzo di contrappesi e si muoveva mediante la pressione dell’aria rinchiusa e nascosta nel suo interno. Ma a dire il vero la cosa è così poco credibile che voglio riportare le parole precise di Fervorino”. Questi aggiunge solo che la colomba una volta posata non volava più; poi la citazione è interrotta e non sapremo mai ciò che Fervorino intendeva raccontare. La seconda invenzione memorabile è la raganella. Sì, quel giocattolo che, girando, produce il gracidio della rana facendo scattare una lamina di metallo contro la ruota dentata. Noi ci abbiamo giocato da piccini: ci garbava quel suono secco unito al movimento che, con il polso, si imprimeva al giocattolo. Ma ci saremmo mai immaginati che era stato un genio a crearla per noi? E che un altro genio ancora più grande avesse speso parole di lode per questo strumento? Aristotele, nei ‘Politikà’: ”Consideriamo una invenzione felice la raganella di Archita 50 che si dà ai bambini per tenerli occupati; così si evita che rompano delle cose in casa, visto che non riescono a star fermi”. Nessuna pietà per gli orecchi dei genitori: ‘rumore assicurato!’ promette una pubblicità on line per una raganella a due ruote dentate. Ma questo è solo l’inizio. Intanto la raganella è uno strumento che, debitamente ingrandito, può produrre un volume di suono molto forte: ed è ciò che succedeva fino a pochi anni fa il Venerdì Santo quando le campane tacevano e la scansione religiosa del tempo era affidata, appunto, alla ‘traccola’ che i ragazzi, divertendosi un mare, facevano gracidare sul campanile e attorno alla chiesa. E non basta: i compositori del Novecento non si lasciano scappare questa modalità di produrre suono. Richard Strauss usa la raganella nel poema sinfonico ‘I tiri burloni di Till Eulenspiegel’, e Krzysztof Pendereckij nella Sinfonia per due orchestre discordi (se ne ricorda una esecuzione col giovane Riccardo Muti a Firenze, mille anni fa). E, last but not least, una raganella di nome Simone (Simon Rattle) è direttore stabile della più importante orchestra sinfonica del mondo, i Berliner Philarmoniker. Naufragio Questa salma di un Grande abbandonata sulla sabbia fa venire in mente altri personaggi, diverse circostanze. Non tanto Ulisse naufragato sull’isola dei Feaci, che se la cava benissimo con Nausicaa, quanto piuttosto Percy Bysshe Shelley, il poeta romantico inglese trovato sulla spiaggia di Viareggio nel luglio 1822. Per lui la predica sulle caducità delle terrestri cose la compone, invece di Orazio, Giosuè Carducci: “L’ora presente è in vano, non fa che percuotere e fugge; sol nel passato è il bello, sol ne la morte è il vero” Per quanto non eccelsi, questi versi possono costituire l’epigrafe per 51 una serata a Matinum affollata di millenarie pazienze in attesa di una rinascita, o almeno di una fioritura di capperi e di rosmarino selvatico. 52 53 SALINIS Armée Celtique en Italie vexée De toutes pars conflis & grande perte: Romains fuits, ô Gaule repoulsée, Près du Thesin, Rubicon pugne incerte (II, 71) La Tabula Peutingeriana è precisa. Da Salinis a Anxanum, volgendo le spalle all’Aufidus, dodici miglia romane; nove da Anxanum a Siponto. Sulla riva illirica di fronte, oltre alcune isole tra cui Brazza, è in evidenza una città portuale. Il nome non si legge ma è sulla strada tra Spalato e Inaronia, oggi Makarska, e vi convergono un fiume e un percorso viario dall’interno. Insomma potrebbe essere Almissa – Dalmasium, Oeneum, Alminium – oggi Omiš, famoso nido di pirati nel canyon del fiume Cettina. Gli stessi che scorgeremo, spingendo lo sguardo da Devia, prendere con astuzia e saccheggiare l’abbazia di Tremiti. Salinis non esiste. Non è una città determinabile. E’ un territorio che nei millenni ha dato spazio a diversi luoghi: Salpi, Salapia, Casale della Trinità, Margherita di Savoia; ognuno di essi ha avuto i suoi perché e il suo destino. Mettere dei puntini sulle i della toponomastica è impresa disperante. Salpi sarà il lago e Salapia la sua città di riferimento? I nomi dei luoghi si sono mossi assieme agli abitanti, agli ondeggiamenti del suolo, all’impaludamento e all’infusione delle acque. Uno di questi spostamenti lo conosciamo perché ne parla Vitruvio. I Salapini, ossessionati dalle zanzare e dai miasmi della palude, pregano il governatore romano Marco Ostilio di farli traslocare. “Allora Marco Ostilio, osservato con attenzione tutto il territorio, comperò una possessione in un luogo molto salubre vicino al mare; ottenuto il consenso dal Senato e dal 55 Popolo romano edificò la nuova città, vi trasportò il popolo, rizzò le mura, aprì i fori, e diede a ciascuno dei cittadini un sesterzio. Compiuta questa parte dell’impresa, scavò un canale tra il lago e il mare per aprirgli un varco e alla bocca vi formò un porto”. Laghi, paludi e vie d’acqua dal tratto mutevole. Noi ci troviamo di fronte a un terreno umido che si è mosso e stratificato nei millenni; ci poniamo delle domande guardando appena l’epidermide. Sono gli archeologi che sanno entrare nella carne viva del tempo. Economia e politica del sale Il sale è tra i beni più urgenti per la vita, dopo l’acqua e il fuoco. Preserva qualunque cosa dalla putrefazione, e anche solo per questo diventa un medicamento dell’anima. E siccome i simboli hanno un valore monetario, si pagano i soldati con il salarium. Ma prima ancora si offre sale agli dei e lo si divide in compagnia, come oggi ci si passerebbe uno spinello. Attorno a Salinis una cosa sola è certa: il sale. Ciò che rimane costante fin dalle prime mandrie svernanti è il sale. E l’acquitrino. Quando sopravvengono gli umani, per loro il mare attraverso le bocche degli stagni apre i cammini dell’indefinito. Del sale si parla lungo la costa; nell’interno fino a tutto l’Appennino. Se ne parla a Venezia e in Illiria, che è confinante, e lo apprenderanno gli Slavi che appena arrivati non hanno l’esperienza del mare e delle sue risorse. Di sale si parla a Roma, che con i poli produttivi di Anco Marzio a Ostia è una concorrente commerciale, apre la via Salaria per l’esportazione; una colonia dedotta in Salapinorum plenis pestilentiae finibus, parola di Cicerone, agevolerà il controllo del mercato. La facies attuale di Salinis, se si va per zone umide, per scavi e per musei, forse è acquisita con l’età del bronzo medio, a metà del XVIII secolo a.C. Il ‘popolo degli ipogei’ esercita la pastorizia e la caccia in una cornice agricola consolidata. Vale la pena entrare nell’ipogeo e chiudere gli occhi per ascoltare il suono del silenzio, il lieve pulsare del 56 proprio sangue, come nelle camere sotterranee di Micene. Nel seno della terra, allora, per celebrare riti, per risvegliare la primavera ostaggio dell’abisso; poi in tempi più evoluti gli ipogei custodiranno il riposo senza risveglio delle élite locali. Certamente viene dalla costa albanese, l’Illiria, la prima civiltà strutturata dell’area salapina. La popolazione dei Dauni portatrice – per contatto o per espansione diretta – di tutto quello che di nuovo si crea nella incredibile fucina del Vicino Oriente, tra l’Egitto e la Mesopotamia. Anche qui, la storia ha il suo sense of humor nel configurare oggi in ben altra maniera l’afflusso di Illirici da Valona. Ai Dauni si sovrappongono i Greci, la civiltà cretese-micenea, tra il sedicesimo e l’undicesimo secolo. Qualche traccia ne rimane, ma soprattutto si crea allora il mito collettivo di fondazione di tutte le città argive della Daunia, da Siponto a Troia, da Arpi a Lucera: le imprese dell’eroe omerico Diomede. Il subentro dei nuovi colonizzatori si adombra nelle nozze di Diomede con la figlia del re illirico Dauno, eponimo del territorio foggiano. Una nuova ondata di Illiri, dalle pianure danubiane, giunge nel decimo secolo, ma avrà un respiro sommesso: duecento anni dopo incomincia la Grecia classica ad allargare il suo Lebensraum a tutta l’Italia meridionale. E’ la Magna Grecia. E i Romani? Virgilio racconta di un contatto degli Italici laziali con Diomede per contrastare il passo al nemico comune: Enea il troiano, antenato dei Cesari. Ma l’odio fra Greci e Troiani si è già scaricato con la distruzione della illustre città. L’eroe di Argo, ormai addomesticato, non riprenderà in mano le armi dopo tanti decenni di pacifiche edificazioni. I discendenti di Enea, quindi, si prenderanno le città diomedee e le coltivazioni di sale, qualche secolo più tardi. C’est l’Histoire. La salina, naturalmente, è un bene demaniale (‘Costituzioni Melfitane’, 1231) o comunque legato a soggetti istituzionali. A novembre del 1064 l’arcivescovo Gerardo di Siponto cede all’abate di Tremiti un terzo di salina in cambio di una piccola icona e di uno skaramanghion, il prestigioso abito di corte in seta che, a peso, vale quanto l’oro. Quattro 57 anni dopo, per un altro terzo di salina, l’abate paga al vescovo una icona della Vergine ornata d’oro e un altro skaramanghion di seta e filo d’oro del valore di oltre 20 nomismata. La seta era certamente tessuta nei possedimenti tremitesi di terraferma; la Capitanata fino al 1071 è stata la fonte principale per i lussi di Bisanzio. Capitale dell’immagine ante litteram, la città imperiale annetteva ai vestiti di seta, soprattutto tinti in porpora, un valore ostensivo da fashion victims. Liutprando di Cremona, nel 971, racconta come gli furono sequestrate le vesti liturgiche che si era comprato, trovandosi in missione diplomatica per conto di Ottone I di Sassonia. Ne nasce un battibecco (‘da noi queste vesti le portano le sgualdrine’, e ‘allora perché le compri tu che sei un vescovo?’, eccetera). Ma lo shopping turistico non poteva comprendere la porpora, riservata agli imperatori e ai massimi livelli della Corte. Esiste nella liturgia orientale una formula di benedizione per i bachi da seta in cui si chiede all’Onnipotente di allontanare da essi il freddo, il maltempo, gli incantesimi, il malocchio, le malattie; nulla si dice a proposito dell’acqua bollente, invece, nella quale verranno immersi. Salpi, le donne di bastoni E’ sul tramonto che bisogna vagare presso le acque di Salpi, per assorbire i brividi della notte incipiente. Il porto festoso di Argyrippa non si indovina più; e invece si fanno avanti le ombre inquiete delle devote di Cassandra, dal viso tinto e armate di bastoni, e l’implacata donna di Annibale, l’Alma dannata. Se avvertite l’inquietudine, c’è chi può aiutarci a capire. Licofrone, poeta in lingua greca, che scrive ‘Alessandra’ nello stesso ritmo metrico delle tragedie classiche. Una fiammata scura di poesia. Non si sa bene chi fosse Licofrone. Ne esisteva uno ben conosciuto alla corte dei faraoni greci di Alessandria, nel III secolo avanti Cristo. Ma non è lui. Il nostro Licofrone vive parecchi anni dopo; assiste al trionfo di Roma sull’orbe ellenistico e descrive i luoghi dell’Italia meridio58 nale, l’Ausonia, come se li avesse visti. Alessandra altri non è che Cassandra, l’indovina per antonomasia. Nella sua casa di pietra profetizza la catastrofe di Troia. Come si sa, non viene creduta: è la vendetta di Apollo a cui non ha voluto cedere il proprio corpo. Oltre alla caduta e alle stragi nella sua città, Cassandra vede in anticipo i cupi avvenimenti del ritorno degli eroi greci: le regge achee ormai hanno imparato a fare senza di loro, e la fedeltà di Penelope diventa proverbiale proprio perché è un’eccezione tra le ‘vedove bianche’. Se Menelao riporta la moglie a Sparta, Agamennone, suo fratello, è scannato da Clitennestra mentre gli sta servendo un bagno caldo; e Cassandra, incolpevole bottino di guerra, ha la medesima accoglienza. Diomede, nella sua Argo, rischia la stessa fine con la consorte Egialea e deve rifugiarsi in Ausonia a casa di Dauno, e poi un po’ per tutto l’Adriatico a fondare città. Formalmente ‘Alessandra’ è una specie di monologo tragico e aveva di certo un accompagnamento musicale. In tempi più recenti potrebbe essere ‘Erwartung’, l’attesa, di Arnold Schoenberg: la donna smarrita nella foresta che al buio riconosce il cadavere del suo amante. Licofrone compone un testo affascinante e oscuro, fatto di allusioni ad eventi ignoti, con sintassi da slalom e grande sfoggio di parole rare. Potrebbe sembrare uno scrittore del Siglo de Oro, fra Góngora e San Giovanni della Croce, però con una componente noir molto accentuata. Eppure, per sentire Salpi, bisogna leggere ‘Alessandra’; non si può farlo senza una traduzione a fronte e un apparato cospicuo di note, che per fortuna esistono. Un esempio (i versi 1127-1141): “Ma neppure il mio culto, scolorito dal buio dell’oblio, tra gli uomini sarà privo di fama. I capi dei Dauni costruiranno un tempio per me presso alle rive del Salpe, e quelli che abitano la città dardania vicino alle rive del lago. Le fanciulle quando vorranno fuggire il giogo nuziale rifiutando i pretendenti 59 fieri dei capelli alla foggia di Ettore, ma scarsi di aspetto e di stirpe meschina, stringeranno tra le braccia la mia immagine, vestite da Erinni, con le guance spalmate di erbe magiche, ed avranno una difesa molto potente contro le nozze. Da costoro, dalle donne che portano il bastone (rabdofòrai), sarò chiamata per lungo tempo dea inestinguibile”. Non è una profezia semplice da sciogliere. Rileggiamo qualche passaggio. Quelle che rifiutano le nozze Il tempio: Cassandra parla di un tempio costruito in sua memoria. Poteva esser dedicato ad Atena Acaia, come quello in cui lei fu violata da Aiace Oileo nell’immane saccheggio? Il sedicente Aristotele dei ‘Racconti fantastici’, De mirabilibus, afferma che in una città imprecisata della Daunia vi è un tempio di questa divinità, che conservava anche le scuri di bronzo e le armi di Diomede e dei suoi compagni. Si deve ammettere però che a parere di Strabone questi cimeli si trovano a Lucera. ‘Aristotele’ continua: lì intorno ci sono dei cani che scodinzolano ai Greci ‘come se fossero familiari per loro’. Ci sentiamo di collegare i selettivi quadrupedi con le Diomedee delle Tremiti: i compagni dell’eroe trasformati da Venere in uccelli, che fanno buonissima cera ai Greci e maltrattano i Barbari, e nelle notti di luna piena si lamentano come bambini impauriti. In realtà è un richiamo amoroso. E la ‘città dardania’? Su ben lontane rive, Dardano è il fondatore di Troia. Forse Licofrone, giocando sull’aggettivo, accosta la tragica patria di Cassandra alla città daunia chiamata Dardi di cui sappiamo l’esistenza da Plinio: Diomedes ibi delevit gentes Monadorum Dardorumque et urbes duas, quae in proverbium ludicrum vertere, Arpinam et Tricam. Diomede azzerò le popolazioni dei Monadi e dei 60 Dardi e le due città, Arpina e Trica. Fa sorridere perché ‘abitare in Arpina e Trica’ era come dire ‘stare in un luogo che non esiste’, ‘vivere in Utopia’. Ma ecco il punto delicato. Le donne che si rifiutano alle nozze. Chi saranno questi sgraditi pretendenti? Essi esibiscono tagli di capelli ‘alla Ettore’, cioè corti sulla fronte e lunghi sulle spalle; però sono squallidi di etnia e di carattere, ed è giusto che le ragazze li respingano. Probabilmente sono i Dauni e i Peucezi che portano questo taglio di capelli. Cioè tutta la popolazione locale. Rifiutare questi rozzi indigeni equivale a scartare del tutto l’idea del matrimonio. Posizione irricevibile nell’antica Grecia, come oggi nella gran parte del mondo. E infatti pochi versi più avanti Cassandra dice che ne farà piangere parecchie di madri, al vedere le figlie allontanarsi senza marito. Ma come tener lontani i rozzi pretendenti? La divina Cassandra farà la sua parte soprannaturale. Ma le ragazze hanno da mostrarsi in condizioni ributtanti. Vestite di stracci paurosi, tanto da assomigliare alle Erinni che certamente non erano un sex symbol ad Atene. Le tre cagne arrabbiate, le vespe pungenti, le furie secondo i romani, le mosche secondo Sartre, insomma le dee del rimorso e della vendetta. Le Eumenidi secondo Eschilo. Le Benevole secondo Jonathan Littel. Le Erinni fanno parte degli strati primordiali della mitologia greca: nascono dal sangue di Urano, il dio del cielo, evirato dal figlio Crono con un falcetto. Esteticamente, se si può dir così, hanno le ali, e chiome di serpenti. Sotto il Partenone si vede ancora l’accesso della loro spelonca, ed è un tratto di genio. Alla superficie il logos: la bellezza, la sapienza costruttiva, la purezza delle forme; al fondamento il kaos: l’oscuro richiamo dell’irrazionale morboso e mortifero. Insomma, più le ragazze del tempio di Salpi si acconciano da Erinni, più stanno al riparo dalle proposte di matrimonio. Non bastando l’abbigliamento inquietante, la faccia si deve bruttare con l’aiuto di bacche ed erbacce. Forse Dante può aiutarci a immaginare l’accoglienza che 61 uno spasimante si sarebbe trovato di fronte: “… in un punto furon dritte ratto tre furïe infernal di sangue tinte, che membra feminine avieno e atto, e con idre verdissime eran cinte; serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. L’amico Virgilio tenta le presentazioni: “Guarda’, mi disse, ‘le feroci Erine. Quest’è Megera dal sinistro canto; quella che piange dal destro è Aletto; Tesifón è nel mezzo’; e tacque a tanto”. Ma non sembra che l’accoglienza migliori granché: “Con l’unghie si fendea ciascuna il petto; batteansi a palme e gridavan sì alto, ch’i’ mi strinsi al poeta per sospetto”. Vero è che Dante ci porta alla città infernale di Dite, e non al dolce stagno salato di Salpi. Ma le Erinni sono queste. Sarebbe interessante capire qualcosa di più della comunità di femmine integraliste aggressive e armate di bastoni. Ma teniamo presente che il tutto potrebbe essere anche uno psicodramma collettivo. Un rito nuziale per esempio: quattro passi fra le opere di Margaret Mead o addirittura di Vladimir Propp potrebbero aiutarci a inquadrare questa inquietante consorteria. Lasciamo Licofrone leggendo il finale di ‘Alessandra’. “Ma perché abbaio così a lungo alle pietre che non ascoltano, all’onda muta, grido alle foreste nelle valli spaventose, 62 facendo risuonare un vuoto strepito? Apollo, il dio di Lepsia, mi tolse la fiducia della gente ed immise un sentore di falsità nelle mie parole, nella sapienza profetica dei miei responsi. Lo fece perché rifiutai il suo perverso desiderio per il mio letto. Ma poi le mie profezie saranno avverate. Nella tragedia qualcuno le verrà a conoscere, quando sarà troppo tardi per giovare alla patria, e apprezzerà la rondine ispirata da Febo Apollo”. Quelle che si bruciano le navi dietro le spalle Non bastano le Erinni di Salpi a caratterizzare l’universo femminile delle saline. Ancora il finto Aristotele del ‘De mirabilibus’: “Tutti i Dauni e i loro vicini si vestono di nero, sia uomini che donne”. La causa sarebbe questa. Le Troiane preda dei guerrieri greci non ne volevano sapere di diventare le schiave delle mogli, a casa. Temevano di essere trattate malissimo dalle vedove bianche. Allora, approfittando di una sosta su queste spiagge, dettero fuoco alle loro navi: così in un colpo solo sfuggivano alla schiavitù incombente e costringevano gli uomini a maritarsi con loro. “Con questo espediente, dice ‘Aristotele’, li obbligarono a restare. Ha scritto giusto, su di loro, il Poeta: ‘trascinano il peplo ed hanno seni profondi’. E’ proprio così, pare, che si possono vedere ancora oggi.” Tra le ragazze che si sporcano la faccia per non sposarsi e quelle che bruciano le navi per farsi sposare, bisogna dire che il rapporto tra i generi è assai problematico nella Daunia d’antan. Adesso, passeggiando per Foggia prima di cena, si ha l’impressione che i fantasmi siano definitivamente fugati. 63 Salapia, capitale di Annibale Scagliare una pietra contro la superficie dello stagno per allontanare la malasorte. E se invece rispondesse un grido di dolore? Dicono che si faccia così… Il sito di Salapia è abitato da mille spiriti antichi che ogni tanto, come nella piscina di Bethesda, frusciano sulle acque per segnalare una presenza altrimenti spenta. Annibale e la sua infelice amante, Iride, sfiorano talvolta la superficie dello stagno che si chiama ‘l’Alma dannata’. La vicenda è nota e non è nemmeno eccezionale. Straordinari sono i personaggi nei quali si è incarnato questa volta l’archetipo dell’amore incontenibile, quello che sconvolge le regole. “Come un vento che in cima ai monti si abbatte sulle querce” aveva detto Saffo. Le fonti antiche non soddisfano il bisogno di particolari glamour. Plinio (il Vecchio, quello che muore nell’eruzione del Vesuvio) appena viene a dire della Daunia rammenta l’oppidum Salapia Hannibalis meretricio amore ìnclutum. E di questo ci dobbiamo accontentare, anche se non è poco. Del resto tutti i resoconti dell’epoca sono abbottonatissimi sulla vita privata di Annibale. Non abbiamo trovato informazioni utili né in Tito Livio che è il narratore più analitico, né in Polibio, né in Appiano Alessandrino, né in Cornelio Nepote già noiosissimo alle scuole medie, né in Silio Italico che sulle Guerre Puniche scrive addirittura un poema à la manière de Virgilio. Ma queste sei parole di Plinio sono un piccolo tesoro informativo. Oppidum: Salapia, quanto meno al tempo di Plinio (I sec. d.C.), è un oppidum, una città di rilievo; forse cinta da mura trovandosi in piano. L’amore meretricio di Annibale ne fa un sito ìnclutum: che in latino ha una accezione positiva e tende a significare illustre, nobile (è anche uno degli appellativi di Giove); famoso, non famigerato. Plinio scrive a distanza di due secoli, e si contenta di lanciare una allusione: quindi il ‘fatto’ doveva essere memorabile, e comunque ancora ben presente a chiunque leggesse la ‘Naturalis Historia’. 64 Sappiamo che Annibale era crudele quanto doveva, ma rigoroso in materia di etica guerresca. Ad esempio non permetteva gli stupri collettivi, che sono fino a ieri mattina l’inevitabile corteggio delle conquiste belliche. Sapeva infatti che i nemici possono rassegnarsi a qualunque spoliazione, ma lo sfregio sessuale li accanisce per sempre. Nulla risulta a carico della sua fedeltà alla moglie Imilke sposata a Castulo fra i Celtiberi, sulla strada tra Cartagine e Roma. E poi i Barca erano austeri di famiglia, tanto che le cricche avversarie spargevano la voce che fossero inclini a tenerezze maschili. Questa è la ragione per cui Salapia è resa ‘inclita’ dagli amplessi extramatrimoniali di Annibale. Nessun’altra città può vantare lo stesso pregio. E’ un grande vantaggio competitivo. Con un po’ di cinismo forse a Trinitapoli potrebbe essere ‘venduto’ turisticamente assieme agli Ipogei e ai programmi naturalistici della Casa di Ramsar. Quanto alla natura di questo intercorso di Annibale con la ‘Dama di Salapia’, Plinio parla di amore sì, ma a pagamento: meretricium. Ora, delle due parole la più impegnativa è certamente amor. Che la Dama fosse una fille de petite vertu può davvero essere la malignità del Romano che in un colpo sfigura due nemici: il Cartaginese e la città di Salapia che, traditrice, gli ha aperto le porte delle mura e della camera da letto. Fin qui è il testo che parla. D’ora in avanti è leggenda. Iride è la figlia del principe di Salapia. Convince i concittadini a schierarsi con Annibale. I Romani per vendetta, rientrando da Canne, distruggono la città. Gli abitanti aggrediscono Iride, che viene spinta nel pantano e lapidata, o sepolta viva – come le Vestali che tradivano il voto, o che venivano buone come capri espiatori di errori maschili. Per questo lo specchio d’acqua si chiamerebbe ‘Alma dannata’: è l’anima condannata di Iride che ancora fa sentire il grido della sua disperazione. Sarà forse il richiamo di un uccello? Una sosta attorno a quello specchio d’acqua, per chi sa ascoltare il luogo, lascia aperta ogni possibilità. 65 Hannibal ad portas! Adesso dobbiamo fare un discorso serio su Annibale, in italiano Teodoro (‘grazia del dio Baal’), apolide domiciliato in Daunia a più riprese durante tredici anni di guerriglia; a Salapia nell’inverno 214 a.C. Il punto è questo: sono passati duemiladuecento anni. Eppure troviamo ancora le tracce fresche del suo passaggio. Il grande Cartaginese ha veramente scalfito la coscienza collettiva degli Italici. Non si contano i letti in cui ha dormito Garibaldi né i palazzi abitati da Napoleone; ma assai più numerosi sono i toponimi come ponte di Annibale (solo sulla Sieve ce ne sono due), castello di Annibale, campo di Annibale, sella di Annibale, fonte di Annibale, monte Annibale. E Quinto Fabio Massimo? gli Scipioni? Catone il Censore? Nulla. Una ragione c’è, ed è la grande legge della comunicazione di massa: demonizzare l’avversario vuol dire regalargli la vita eterna. Le urgenze propagandistiche dei Romani hanno trasformato Annibale Barca, ‘il Saetta’, in un barbaro grottesco e crudele. Con questa immagine egli ha continuato a rotolare per la storia, fin sulla spiaggia dei nostri banchi alle elementari. Il babbo che gli fa giurare odio eterno a Roma nel tempio di Baal; il virtuosismo di attraversare le Alpi con quaranta elefanti che diventano sempre meno fino a ridursi a uno, il fido Saurus; il mistero su quale autostrada abbia preso per cadere proprio sopra ai celti torinesi (da cui l’opera Annibale in Torino di Giovanni Paisiello, 1779); la gestione della prima vera guerra mondiale, tra Africa, Europa e Asia; l’invenzione della guerriglia; le sanguinose (e vittoriose) battaglie della Trebbia, del Trasimeno, di Canne, e quella (perduta) di Zama; i santini dei suoi antagonisti, Fabio Massimo che, prudente, ‘temporeggiava’, e Scipio del cui elmo l’Italia si è cinta la testa. Questo è il minimo comun denominatore della vicenda annibalica, e si allaccia nelle menti italiche con Brenno che getta la spada sulla bilancia, con Muzio Scevola che si brucia la mano davanti a Porsenna, con Giulio Cesare, le idi di Marzo, 33 pugnalate e tu quoque Brute fili mi. Annibale sul podio dei massimi condottieri di tutti i tempi: ne convengono tutti gli esperti, dai polemologi ai collezionisti di soldatini di 66 piombo e agli smanettatori di videogiochi. Ma precisano: il più grande condottiero di truppe mercenarie. Con un vago sapore di biasimo. A noi pare invece la massima virtù quella di condurre verso un unico obiettivo comunità umane distanti per etnia, lingua, cultura, motivazione, valore, animosità, modalità di retribuzione, distanza fisica dalla patria. L’osservazione non è nostra ma di Polibio. L’attenzione al fattore umano è una delle risorse strategiche del ‘Saetta’. Un esempio solo. Alla Trebbia aspetta ad attaccare la battaglia il giorno in cui il console Scipione senior è di riposo, mentre il comando è in mano a Sempronio Longo. Annibale lo conosce: omnia ei hostium haud secus quam sua nota erant, conosceva le cose del nemico come le proprie tasche. Sa che Sempronio è uno che si impressiona e che reagisce d’impulso: e allora lo sorprende con una ‘passerella’ mattutina di cavalleria cartaginese che finge di attaccare. E’ una fredda mattina di dicembre, e il console Sempronio ci casca: sveglia l’esercito di fretta e lo lancia all’inseguimento, digiuno e semisvestito, attraverso il corso d’acqua. Ma di là ci sono i Cartaginesi asciutti, vestiti con cura e già rifocillati. La vittoria arride facilmente a loro. Per quanto riguarda lo ‘specifico professionale’ del condottiero, i polemologi riconoscono ad Annibale il genio dell’innovazione. Di colpo, con lui, diventa vecchia la scienza strategica greca e romana. Le quattro specialità – fanteria e cavalleria rispettivamente pesante e leggera – lui non le considera come entità contraddistinte da mission immobili e distintive. Lui concepisce tutto l’esercito come una comunità multitask, flessibile, che in momenti diversi può spartirsi in maniera inusuale una funzione, o subentrare e sopperire. Una ‘protesi’ a disposizione del condottiero. Ma anche questo apprezzamento a noi pare limitativo. Aiuta a capire la battaglia della Trebbia e quella del Trasimeno, ma non quella di Canne. Annibale vince a Canne perché gestisce come un sistema unico non solo il proprio esercito, ma anche quello romano – e, verrebbe da dire, l’intero contesto della battaglia, compresa la componente ambientale. Plutarco racconta. “In quella battaglia Annibale si servì di due accorgi67 menti strategici. Il primo fu di scegliere il luogo dello scontro facendo in modo che i suoi soldati avessero alle spalle il vento, che si era scatenato simile a un turbine infocato. Il vento sollevava dalla pianura piatta e sabbiosa un acre polverone al di sopra dello schieramento cartaginese, lo spingeva contro i Romani e li colpiva in pieno viso costringendoli a voltarsi altrove e a scompaginare le loro file. Il secondo accorgimento riguardò il modo di disporre le truppe: infatti Annibale schierò alle ali estreme quelle più forti e combattive, mentre formò il centro dello schieramento le truppe più fragili, che erano i Celti lombardi. Appena il centro ebbe ceduto e fatto posto ai Romani incalzanti, lo schieramento di Annibale mutò forma e da rettilineo che era si trasformò in una mezzaluna. I comandanti delle punte estreme fanno convergere i loro uomini da destra e da sinistra; le truppe scelte stringono i Romani lungo i fianchi; li chiudono nel cerchio e li massacrano tutti quanti”. Annibale è come un giocatore di scacchi che muova i bianchi e i neri contemporaneamente. E’ solo alla playstation e non può che vincere. Polibio aveva avuto la stessa intuizione prima di noi: “Degli eventi che accadevano agli uni e agli altri, cioè ai Romani e ai Cartaginesi, la causa era un solo uomo e una sola mente: quella di Annibale”. Ancora Polibio, che peraltro vive a Roma nell’entourage degli Scipioni, i nemici mortali di Annibale, formula un giudizio lapidario. “Annibale è una meraviglia della natura. Ci riempie di stupore quando incontriamo una persona il cui intelletto si accorda alla perfezione, per innato schema mentale, con qualunque opera umana decida di intraprendere”. A proposito di Canne vogliamo concederci, con Tito Livio, una sequenza da Quentin Tarantino. Teniamo conto che le vittime furono sessantamila: diecimila meno che a Hiroshima. Colonna sonora: Prokofiev, ‘Alexandr Nevskij’, Il campo dei caduti, con la melopea del contralto. “Il giorno dopo, all’alba, i Cartaginesi attesero a raccogliere le spoglie e a contemplare la strage, terribile anche all’occhio di un nemico. Giacevano tante migliaia di Romani, alla rinfusa fanti e cavalieri, così 68 come il caso o la battaglia o la fuga li avevano l’un l’altro mescolati insieme. Alcuni che, coperti di sangue, tentavano di alzarsi in mezzo alla strage, risvegliati dal freddo che aveva a loro contratto le ferite, vennero finiti dal nemico. Si trovarono poi altri che giacevano vivi con i femori e i garretti tagliati e che, denudando il collo e la gola, scongiuravano che se ne traesse fuori il sangue che ancora li teneva in vita. Altri furono trovati con le teste affondate in una buca: appariva chiaro che essi stessi l’avevano scavata e che sotterrandosi il capo sotto la terra erano morti soffocati. Attirò gli sguardi di tutti un Numida tratto ancor vivo con il naso e le orecchie lacerate, di sotto ad un Romano morto, che non avendo più nelle mani la forza di afferrare un’arma, dall’ira passato alla rabbia era spirato dilaniando coi denti il nemico”. Storie di ordinario collaborazionismo Non c’è dubbio che un esercito estraneo che per quindici anni si muove avanti e indietro per l’Italia meridionale va a creare dei problemi difficilmente immaginabili. Forse l’esempio che ci è più familiare sono le FARC in Colombia o, nel mito, il Vietcong. Razzie di beni alimentari, prima di tutto; pressioni sul territorio per ottenere appoggio, informazioni, supporto logistico di ogni natura, e anche risorse umane quando necessario. Ritorsioni selvagge ed esemplari. Le due distruzioni di Herdonia, gli inutili assedi contro Troia. E’ naturale che l’opinione pubblica si divida secondo linee di faglia che non sono semplicemente opinioni geopolitiche ma risentimenti personali, vendette da compiere, interessi da difendere, limiti invalicabili della ‘capacità contributiva’ del territorio nei confronti della guerriglia. Anche a prescindere dalla ‘Dama di Salapia’ e dall’inverno del 214, Annibale ebbe a che fare con le inquietudini della città daunia che gli era favorevole. Ma naturalmente vi era una corrente filoromana. Bisogna dire che Annibale ha in genere gestito con oculatezza queste sensibilità a lui avverse, consapevole del fatto che i Romani erano per i Salapini tanto estranei quanto i Cartaginesi. E forse altrettanto temuti. Questo contesto va tenuto presente per leggere una storia di collaborazionismo che deve essere stata clamorosa, se ne parla non solo Tito 69 Livio, il cronista ufficiale, ma anche il remoto Appiano di Alessandria nel II secolo, nei suoi ‘Romanikà’. E’ la storia di Dasio e Blazio. A Salapia, mentre era soggetta a Cartagine, vi erano due principes, uguali per nascita, ricchezza e potere ma da lungo tempo nemici l’uno dell’altro. Uno di questi, Dasio, era dalla parte dei Cartaginesi. L’altro, Blazio, teneva per i Romani, ma ovviamente finché i Cartaginesi erano in città doveva tenersi in disparte. A un certo punto però la fortuna incomincia a girare in direzione meno favorevole per Annibale, e si presenta il rischio: che cosa farebbero i Romani se riuscissero ad impadronirsi di Salapia? Necessita una soluzione bipartisan. Blazio, che naturalmente per Tito Livio è il buono, mosso dall’amore per la propria città, cerca di incontrare Dasio e di elaborare con lui un piano per assicurare un atterraggio morbido nel caso che i Romani prendano il sopravvento. Dasio, che evidentemente è il vilain del racconto, finge di aderire al piano di Blazio. Il piano consisteva nel rivolgersi a un comandante amico, acquartierato molto distante su per l’Italia, e farsi assegnare una piccola guarnigione: una forza di interposizione, si direbbe. Ma, come spesso succede, appena siglato l’accordo ognuno dei due contraenti cerca di ingannare l’altro, giocando sul tempo. Il perfido Dasio con tutta calma va ad avvisare Annibale del tradimento che Blazio sta tessendo e chiede i mezzi militari per fare una carneficina dei pochi soldati romani che, chissà quando, arriveranno a Salapia. Quanto a Blazio, egli si guarda bene dall’andare lontano a rastrellare una piccola milizia, ma si presenta nella vicina Roma e ‘vende’ Salapia in cambio di una truppa ben addestrata di mille cavalieri. In men che non si dica li ottiene e rientra a casa come niente fosse. Dasio invece, salutato Annibale, torna con calma a Salapia sapendo che Blazio è a raccogliere soldati chissà dove. Infatti le porte della città sono sguarnite. Felice di essere in largo anticipo sul nemico e di aver tutto il tempo per preparargli una sanguinosa accoglienza, Dasio entra. Ma appena varcata la porta Blazio fa chiudere la saracinesca e lo assale con i suoi mille cavalieri, uccidendo facilmente sia lui e che tutta la guarnigione prestata da Annibale. In pochissimi riusciranno fuggire 70 saltando dalle mura. A proposito di questi due principi contendenti, il Romanelli (‘Antica topografia istorica del Regno di Napoli’) racconta una evidenza numismatica. Le monete di Salapia hanno al diritto un cavallo andante con la leggenda Salpinôn, e al verso un delfino con il nome del magistrato garante della zecca. Ce ne sono rimaste alcune con il nome ‘Daxiou’ e altre con il nome ‘Plotiou’, al genitivo. Quindi Daxio e Plotio sono i veri nomi dei nostri due gentiluomini. L’inganno infelice Ancora dalla lettura di Tito Livio. Col passare del tempo l’astuzia luciferina di Annibale comincia a mostrare le corde. O almeno i nemici imparano a guardarsene. Siamo nel 208 a.C. I Salapini, bon gré mal gré, sono stati transitati da Blazio sotto il potere romano offrendosi al console Marco Claudio Marcello. Forse in questi due anni potrebbe essere avvenuta la vendetta su Iride. Per recuperare la città Annibale tenta un colpo magistrale. Ancora basato sulla padronanza del tempo. Marcello, per marcare stretti i Cartaginesi, aveva posto l’accampamento troppo vicino a loro. Così cade in un’imboscata e perde la vita. La salma viene portata nel campo di Annibale, mentre l’esercito romano resta in mano all’altro console, Crispino. Annibale intuisce subito l’opportunità: il corpo di Marcello ha ancora addosso i sigilli consolari, e lui può adoperarli per architettare qualche inganno: basta che si creda che Marcello è ancora vivo. Ma anche Crispino ha ben presente questo fatto dei sigilli e subodora l’utilizzo che Annibale potrebbe farne. Allora manda, rapido, a tutte le città vicine dei messaggeri ad avvertire che Marcello è stato ucciso e che il nemico ha in mano il suo anello col sigillo consolare. Che non si presti alcuna fede a messaggi che giungessero siglati a nome di Marcello. Il messo di Crispino era appena arrivato a Salapia che, puntuale, viene recapitata una lettera – firmata appunto col sigillo di Marcello – con cui il console annuncia il suo arrivo a Salapia: la notte seguente. L’inganno 71 è manifesto, e i Salapini sanno bene che Annibale ha delle buone ragioni per volersi vendicare di loro. Il messaggero – che era un disertore romano – viene rispedito ’mbressa ’mbressa con ogni assicurazione, e così senza testimoni i Salapini possono organizzare la contromossa. Scavano delle buche, dispongono i cittadini sulle mura e in luoghi opportuni della città formando corpi di guardia; provvedono per quella notte a un sistema di avvistamento di emergenza e concentrano il nerbo delle loro forze intorno alla porta dalla quale il nemico sarebbe probabilmente venuto. Annibale infatti prima dell’alba si avvicina alla città. La sua avanguardia è formata da disertori romani con armature romane. Costoro arrivano alla porta e, parlando ad alta voce in latino, richiamano l’attenzione delle guardie e ordinano di aprire la porta perché il console Marcello sta arrivando. Le sentinelle, come se fossero destate alle loro grida, cominciano a darsi da fare, a correre confusamente, cercano di aprire la porta. Questa era chiusa e con la saracinesca calata; allora i cittadini di Salapia la sollevano fino ad altezza d’uomo, non oltre. Si era aperto uno spazio appena sufficiente al passaggio quando i disertori si precipitano sgomitando attraverso la porta. Ne lasciano entrare circa seicento, poi rilasciano la fune che tiene sù la saracinesca e questa cade con un gran fracasso. Degli abitanti di Salapia alcuni assalgono i disertori che con nonchalance, come tra amici che arrivano da una marcia, portavano le armi sospese sulle spalle; altri, dalla torre di quella porta e da quelle mura, con sassi, pali e giavellotti respingono il nemico. E’ fatta. Annibale, vittima della sua stessa frode, si allontana e si avvia in direzione di Locri per liberarla dall’assedio”. Ma Polibio aggiunge un particolare: “quelli che furono catturati, i Salapini li impalarono, aneskolòpisan, davanti alle mura”. Annibale il Foggiano Questo è Annibale, e non facciamo nessuna fatica ad iscriverlo tra i Grandi delle Terre Foggiane. E’ un immigrato, residente un po’ saltuario per una decina d’anni, tra il 217 e il 207 a.C., i migliori e i più continui della sua vita 72 E’ un primario cliente della produzione agro-alimentare e lattierocasearia locale, anche se ha la tendenza a cuocere il grano quando è ancora nei campi. Mantiene una relazione nota con una Dama di Salapia, nel 214. Consegue il massimo riconoscimento professionale proprio qui a Canne, sulla riva dell’Ofanto. E Foggia lo riconosce: nel 216 Arpi è con Annibale, e per questa scelta Quinto Fabio Massimo non temporeggia nel punirla. Annibale è di valore congruo con gli altri Spiriti magni della Capitanata, Federico II per l’amore della conoscenza e lo spirito laico, Diomede per il genio bifronte dell’edificare e del distruggere. E proprio sotto il profilo manageriale Polibio ne fa l’esaltazione. “Chi non loderebbe in quest’uomo il modo di esercitare il potere di comando? Come un buon pilota preservò masse così grandi di uomini da ogni contrasto sia con lui che fra loro, benché si valesse di soldati che non solo non appartenevano allo stesso popolo, ma nemmeno alla stessa razza? Disponeva infatti di Libici, Iberi, Liguri, Celti, Fenici, Italici, Greci, che per natura non avevano in comune tra loro né leggi né costumi né lingua né altro. Eppure l’intelligenza del capo faceva sì che uomini divisi da tali e tante differenze ascoltassero un solo comando e obbedissero a un solo volere, benché le circostanze fossero tutt’altro che semplici, e anzi complesse, e il vento della fortuna, spesso brillantemente a loro favore, soffiasse a volte contrario”. Testo che può essere tenuto d’occhio nelle redazioni giornalistiche come ‘coccodrillo’ per la morte di qualunque grande capitano d’impresa multinazionale. A questo concittadino dobbiamo riconoscere delle virtù meno note ma assolutamente più costruttive che non quelle belliche. Ce ne parla ancora, per esteso, Polibio, e per transennam Plutarco che però non dedica una delle sue (noiosissime) ‘Vite parallele’ – e così dimostra la mancanza di fantasia – ad Annibale e Scipione: che sono stati lo specchio l’uno dell’altro, tanto che sono morti nello stesso anno, il 183 a.C., e tutti e due in condizioni meschine. 73 Un generale prestato alla politica? Del 216 è la vittoria di Canne, del 202 la sconfitta in casa, a Zama: opera di Scipione il giovane. Zama ci mette sotto gli occhi un aspetto che forse Annibale non aveva considerato: si può essere il più creativo, il più imprevedibile dei combattenti, ma alla fine il repertorio di mosse non è illimitato. Quindi un avversario intelligente può apprendere dalle proprie sconfitte e, un giorno, rovesciare il tavolo. E’ quello che succede a Zama, proprio in casa dei Cartaginesi. A Zama gli elefanti hanno il loro ruolo strategico, con le torri di arcieri e lancieri (howdah) sul dorso. Ma i Romani hanno imparato che i bestioni hanno in gran fastidio il rumore. Perciò gli vanno incontro con grida acute e con clangori di trombe: gli elefanti si imbizzarriscono e si rivoltano a sinistra contro la cavalleria numida. Plinio poi spiega che sarebbero bastato mandargli contro dei maialini terrorizzati che grugnissero acutamente. La sconfitta di Zama non tronca la carriera pubblica di Annibale. Anzi sarà un grand commis, un civil servant. Salazar? Badoglio? De Gaulle? Pinochet, quod Deus avertat? C’è in Senato una corrente favorevole ad utilizzare l’immenso ingegno dell’uomo anche al di fuori del contesto guerresco. Gli affidano il Ministero delle Finanze: infatti le sue campagne avevano sempre pompato risorse nelle casse dello Stato cartaginese. Diventa in qualche modo il garante degli accordi con Roma. Ma fa sul serio le riforme e i controlli; e questo non era previsto né dai Punici traffichini né dall’oligarchia agraria che aveva sempre avversato, fino al sabotaggio, le strategie mediterranee della famiglia Barca. Annibale capisce quindi che non c’è profeta in patria e torna in Oriente, tra Creta, Libano e Siria. Cartagine si avvierà da sola, lentamente, verso la catastrofe del 146 quando sarà distrutta e ‘salata’ dall’orrendo Catone in pieno conflitto di interessi: difendeva dalla concorrenza punica le proprie reti commerciali. Anche allora l’etica d’impresa abitava in Arpina e Trica. 74 Change Management Annibale dunque, come un Kissinger di allora, fa il consulente top level. Lavora come Professional Advisor per Antioco III di Siria, discendente da Seleuco compagno di Alessandro Magno. Anche lì si tratta di una guerra contro Roma, ma la situazione non è più quella della Seconda Punica: deve convincere, mediare, subire comandi da parte di persone saccenti. Il suo animo creativo, brillante, cinico non trova aggancio con la realtà ipocrita e maligna della corte siriana. Per di più deve incassare anche un incarico e un rovescio navale, lui così terragno nel vivere il conflitto. Infine i Romani si fanno sentire e presto ne chiederanno la testa. E’ meglio dimenticare Antiochia. Dove però lascia un ricordo di integrità morale. Luciano, nei ‘Dialoghi dei morti’, gli fa dire di se stesso: “Io ebbi il comando in una patria dove tutti avevano gli stessi diritti. Quando questa mi richiamò perché i nemici avevano fatto vela per l’Africa con una grande flotta, io ubbidii immediatamente; feci di me un privato cittadino e, condannato, accettai la cosa con rassegnazione”. Quasi un discepolo di Socrate. Il meglio della sua maturità intellettuale Annibale lo dà al Caucaso. In Armenia sviluppa l’innovativo ruolo di Consulente globale del re Artaxa, il quale intuisce che il grande distruttore di città poteva essere anche un geniale costruttore. Come affidare agli hacker il sistema informatico di un’azienda. Plutarco racconta come il re Artaxa incarica Annibale del master plan, della edificazione e poi del city management di una nuova capitale: Artaxata. Il sito che viene prescelto manterrà il ruolo direzionale per oltre sei secoli; era stato probabilmente un insediamento urarteo, e ancora si chiama Artašat. La posizione oggi è sul confine, nel punto in cui dalla madrepatria si vede più vicina la montagna sacra degli Armeni: l’Ararat ‘esiliata’ in Turchia. E’ il monte su cui si depositò l’Arca dell’Alleanza, che ci si trova sulla destra – ma bisogna farsi assegnare il posto giusto – volando da Teheran verso Istanbul: dall’oblò i due coni vulcanici, il Grande e il Piccolo Ararat, si godono in tutta la loro solennità. E d’istinto si condividono le credenze religiose legate a certe montagne perfette: dal Fuji al Cervino, dal’Ararat al Damavand e all’Annapurna. E’ come se 75 la natura stessa dicesse: venite, adoremus. A dispetto dei musulmani confinanti Artašat è un mare di vigneti: zona di produzione di un bianco secco, l’Araks,‘giovane, fragrante e di gran carattere’, e patria di un grande brandy, l’Artavazd. Al pari della vicina Georgia, l’Armenia aveva sviluppato in epoche remote la cultura del vino. Quante cattedrali caucasiche, tra il V e il XIII secolo, presentano come decorazione dominante il tralcio di vite: e si capisce che il tema della vitis mystica è accostato alla coppa, alla danza e all’ebbrezza. Sacre, simboliche, per carità. Siamo all’altezza dell’Italia meridionale: vini e frutta fresca erano, ai tempi dell’Unione Sovietica, sentitamente richiesti a Mosca, e gli Armeni e Georgiani accorti potevano imbarcarsi sul primo volo del mattino per Vnùkovo con una valigiata di frutta e di vino, sostare a fianco dei grandi magazzini Gum e rientrare la sera con un adeguato profitto netto. Oggi l’attrattiva del sito di Artašat è il monastero di Kor Virap, costruito nel Medioevo sull’acropoli della città di Annibale. Per la precisione, sulla cella in cui il re pagano Tiridate seppellì per diversi anni l’apostolo degli Armeni, Gregorio l’Illuminatore. Si entra ancora nella cella, scendendo dal soffitto, e se ne esce volentieri. Dell’opera di Annibale si indovina qualcosa di più con Google Earth. Ma anche in mancanza di tecnologie avanzate ci pensa la Fama a echeggiare le lodi della sapienza urbanistica di Annibale fin sul Mar di Marmara. Lì c’è Prusia II, re di Bitinia, in cerca della sua capitale. Annibale identifica il sito sul fianco del monte Olimpo, studia i venti e l’esposizione al sole, esamina la compattezza del suolo, e infine crea la città di Prusa e la mette in grado di funzionare. Tanto bene lavora Annibale che la sua città esiste ancora: è Bursa, deliziosa per la sua collocazione sulle falde del monte, per i bagni termali, per la Moschea Blu decorata di mattonelle inequivocabimente verdi. Fino al 1453 fu la capitale dell’Impero ottomano. Ma prima assai che dagli Ottomani la città di Annibale fu resa illustre dagli amori – forse altrettanto meretricii quanto quelli di Salapia – tra il bisnipote di Prusia, Nicomede IV, e il legato romano Giulio Cesare. Gallias Caesar sub76 egit, Nicomedes Caesarem era la canzoncina che girava affettuosamente fra le truppe. Per onestà intellettuale bisogna dire che non tutti condividono la nostra opinione sulla personalità di Annibale. Tito Livio, che è la fonte principale, sferra un attacco assoluto sul piano morale: “… nessun senso del vero e del sacro, nessun timore degli dèi, nessun rispetto per i giuramenti, nessuno scrupolo di coscienza”. Giovenale, nella X satira, esibisce il suo spirito di Romano meschino. “Qual’è dunque la fine? Oh gloria! Viene sconfitto, naturalmente, e scappa in esilio a gambe levate. Lì siede, cliens nobile e speciale, davanti alla tenda pretoria del re. Aspetta che il tiranno di Bitinia si degni di aprire gli occhi. E a quella vita che mise sottosopra l’universo, non metteranno fine né pietre, né frecce, ma quel famoso anello, vindice di Canne e punitore di tante stragi”. L’anello famoso con veleno. Un giorno lo vince la stanchezza di fuggire, di vivere. E’ l’anno 183 avanti Cristo. “I Romani non hanno tempo di aspettare la morte di un vecchio. Liberiamoli dunque da questa lunga angustia”. E ‘maledicendo la vita’ – dice Livio – beve in una coppa il veleno che aveva sempre celato nel famoso anello. Hic vitae exitus fuit Hannibalis: così esce di scena il grande mattatore. Sulla spiaggia di casa sua, in vista del Mar di Marmara. A Libyssa che adesso si chiama Gebze ed è famosa non tanto per la tomba quanto per la bellezza del luogo e per il ponte costruito nel Cinquecento dal grande architetto Sinan. Forse c’era anche bisogno di compliance con il destino: “Una zolla libyssa, libica, coprirà le tue ossa”, gli era stato predetto. Come a Federico II: morirai sub flore. Come a papa Gerberto: finirai la vita a Gerusalemme. A tutto si può sfuggire ma non alle leggende sulle profezie. E questa è la parte maschile della coppia ‘maledetta’ che trasmette un brivido alle acque dello stagno davanti a Salapia distrutta. 77 79 DEVIA L’embassadeur envoyé par biremes A mi chemin d’incogneuz repoulies: De sel renfort viendront quatre triremes Cordes & chaines en Negrepont troussés. La terra che non c’è. Almeno sulla Tabula Peutingeriana: il Gargano è raso via e tra le foci del Fortore e dell’Ofanto vi sono appena le isole della costa dalmata. Abrasione che rende omaggio all’antichità romana della fonte. Nel IV secolo il Gargano si poteva infatti ignorare: Eteria, la Elsa Maxwell dei pellegrinaggi, non ne fa cenno. All’imbocco del Medioevo, invece, una via di grande comunicazione si inerpica sul Gargano. E’ la Via Francesca. Essa accompagna i pellegrini dal Monte San Michele di Normandia fino a Roma e alla Grotta dell’Angelo in Puglia; in tempi recenti il marketing turistico religioso le ha attribuito il nome suggestivo di Via Sacra Langobardorum. Certamente i dinasti longobardi di Benevento hanno considerato quel tragitto come cosa propria: esso garantiva l’accesso al protettore angelico Michele, così somigliante a Wotan con il martello magico. Di più: in tempi di confini ondivaghi tra l’Impero romano di Costantinopoli, il Patrimonio terriero del papa e lo Stato italiano dei Longobardi, questi ultimi hanno distolto la diocesi di Siponto da Roma e da Bisanzio per legarla alla loro metropolìa di Benevento. Ciò è per costituire un continuum giurisdizionale fino al Gargano e governare il flusso dei turisti. Dall’XI secolo, proprio per uno scivolone longobardo, il pio incarico verrà assunto dai Normanni. E infatti Devia, come la maggiore Lesina, è stata una contea normanna, oltre che una comunità di Slavi con i suoi zupani – si conoscono 81 anche due nomi: Andrea nel 1043, Slubizzo nel 1050. Il Monte d’Elio su cui la città si appoggia scende in mezzo ai due specchi d’acqua garganici. Sulla costa abbiamo davanti la Torre Mileto, difesa aragonese che era in antico il più vicino approdo in terraferma per l’Abbazia di Tremiti. Santa Maria di Devia Le magiche isole si vedono leggermente spostate a ovest. La chiesa di Devia iuxta litus maris, Santa Maria, era stata ceduta all’abate di Tremiti dal vescovo Giovanni di Lucera nel 1032. Quindi adesso siamo sulla principale testa di ponte della potente istituzione monastica che, nel periodo di maggior splendore, rivaleggiava con Montecassino. Il carisma storico e religioso non era paragonabile, ma la nobiltà normanna, interculturale e pan-mediterranea, si identificava volentieri con quegli isolotti diomedei dai quali prima o poi passava tutto il mondo. D’impatto la spianata di Devia sembra essere solo un enorme sagrato per la chiesa di Santa Maria. Ma riusciamo a sentire la città intera sotto i nostri piedi: merito di Matteo che per noi dà senso alle pietre sparse, alle buche, ai resti di fondamenta che appena un occhio esperto può scoprire. Certo, i volumi solidamente tangibili della chiesa hanno tendenza a dilatarsi nella percezione del sito. E’ un edificio grande, e lo sembra ancora di più per il dilagare del bellissimo paramento murario. E’ vero, dice Angela, che ricorda le Pievi toscane: quelle ricche, a pianta basilicale, che si concedevano tre absidi decorate alla lombarda con archetti e lesene. La poesia del calcare aveva ispirato Rodolfo il Glabro intorno al Mille: egli vedeva come un mantello di pietre bianche ricoprire l’Europa nell’uscire da periodi tormentosi. Questa è una, probabilmente. Un muro perimetrale si può guardare per ore, ammirando la connessione perfetta del filaretto; oppure si può leggere come righi di un libro il cui ormai ci sfugge il contenuto ma non l’armonia della composizione. E le ricercatezze concentrate sulle absidi hanno un po’ la funzione di un titolo, di un richiamo, di un frontespizio: poi il resto sarà solo scrittura. Anche 82 se rimane un filo di sospetto: non sarà una nostra costruzione culturale questa estetica della nuda pietra, questo sospetto davanti all’intonaco pur venerando? Ma se l’esterno potrebbe essere in vari altri posti, l’interno di Santa Maria di Devia non si può pensare altrove. Non tanto per il colore di carne delle muraglie, per le colonne a conci di pietra che risentono del tempo e delle integrazioni conservative, per l’evidenza plastica delle tre absidi ognuna delle quali ha una propria vita, per il pavimento che racconta la storia. E nemmeno per i capitelli cubici di austero sapore dorico o per la ricercatezza della ghiera che alleggerisce la vista degli archi. No: la cosa che non potrebbe essere altrove sono gli affreschi, soprattutto in due catini di abside e nel fianco destro. Per qualcuno che non ha ancora fatto l’abitudine alla multiculturalità delle Terre Foggiane, questi affreschi sono fonte di sorpresa. Prima di tutto bisogna dire: grazie di resistere. La città di Devia si spopola assai presto, e lo stato degli edifici segue le alterne fortune della Abbazia madre di Tremiti. Più tardi cercheremo di guardarla con il binocolo e ci racconteremo qualche storia. Ma sappiamo che, senza patire gli oltraggi recenti di Montecassino, la sua lunghissima vita è stata assai contrastata. Lo stesso è successo evidentemente alla filiazione di Devia, che a presidio della chiesa e a supporto gestionale degli affari in terraferma aveva certamente un monastero di cui solo la fantasia può dirci qualcosa. Si sa dalla memoria del luogo che nel tempo degli eremiti hanno custodito le sacre mura e il loro silenzio. Che l’edificio è stato adattato ad utilizzi rurali. Ma dalla documentazione fotografica sappiamo anche che per decenni il tetto è rimasto sfondato, e neppure per gli attrezzi agricoli si poteva ricorrere a questo riparo. I cambiamenti di clima, la pioggia, l’aria marina, i visitatori vandalici potrebbero aver ridotto gli affreschi a fantasmi muti, a mura dilavate. E invece no. Evidentemente i restauri sono stati fatti a regola d’arte. Chiaramente i venti asciutti hanno impedito di marcire o il fiorire di salnitro. Sicuramente gli artisti decoratori hanno usato arriccio e pigmenti di prima qualità e tecniche pittoriche magistrali. Il committente, infine, è stato esigente e non ha lesinato sui pagamenti. Certo non pen83 sava a noi che sette secoli dopo ci incantiamo di questa bellezza. Forse, come poi Giovanni Sebastiano, tutti pensavano al Fine: soli Deo gloria. Tra Greco e Latino Ma qual’è l’evidenza che sorprende i visitatori da fuori? La testimonianza di uno stato culturale in cui la visualità – e quindi la visione del mondo – greco-bizantina e quella romana sono tranquillamente compatibili e coesistenti. Eppure c’era stato lo Scisma: anzi, lo Scisma era passato proprio di qui. La Chiesa una sancta era un ricordo, dal 1054, e ancora peggio dopo il saccheggio crociato del 1204. Ma qui, in questa terrazza sul mare, i monaci di obbedienza tremitese si fanno proteggere da Santi vescovi greci e latini, insieme, vestiti con il pallio tondo o triangolare, benedicenti sia alla greca che alla latina. Vale la pena ricordare che un atteggiamento del genere è stato recuperato nella Chiesa cattolica non prima di quarant’anni fa; nelle comunità ortodosse ancora non se ne parla, e a tutt’oggi nessuno potrebbe farsi comunicare da un prete appartenente all’altra confessione. Entrando, le immagini che colpiscono sono naturalmente i catini absidali, anche perché ti inquadrano subito e stabiliscono il tono del rapporto. Quello centrale è grande e raffigura il Cristo giovane dell’Apocalisse. La sua veste campeggia: una tunica rossa e un manto del colore che noi chiamiamo verde, genericamente, ma si trova tra il blu e il verde, come spesso in Oriente. Insoma è una classica ‘Deesis’ dipinta nel Trecento che avvolge il credente all’interno della scena. Personaggi familiari come la Madonna che vistosamente porge le mammelle (oggi non la farebbero passare) e San Giovanni Battista, angeli, e comunque la colonna sonora: sette trombe che nella grotta di Patmo sente rimbombare il visionario Giovanni, ’o theòlogos come lo chiamano i venditori di Apocalissi tradotte in Greco moderno da Odisseo Elitis, con un filo di retorica, e da Giorgio Seferis, più asciutto e poco più lungo dell’originale. Non credono che tu cerchi di capire Seferis con l’ausilio del testo del Theòlogos: casomai, dicono, il contrario. 84 E’ più antico il ‘Pantocrator’ nel catino dell’abside destra. La faccia incidentata non compromette i grandissimi occhi a mandorla, la barba di pochi giorni e l’acconciatura davvero strepitosa, con un ciuffo che parte di mezzo alla fronte aggrottata e tutti i capelli che ricadono sulle spalle contornando il volto lungo. Seguendo le rughe della fronte, le arcate occipitali sono enormemente allargate, e dentro nuotano questi occhi bellissimi che attraggono i tuoi e devi fare uno sforzo per uscire dal cerchio magico. Ti benedice alla latina appoggiando il pollice sull’anulare. Segue poi sulla parete destra una specie di porticato dipinto i cui archi sono occupati da santi e da sante, anche loro appartenenti alla prima decorazione della chiesa nel XII secolo o poco dopo. Sono questi che benedicono i credenti alla greca o alla latina. Si tratta di due gruppi da tre santi ciascuno: quelli più lontani dall’abside stanno sotto una trabeazione realistica, che si sforza di essere prospettiva. Vi è una Madonna Odighitria che divide con il bambino l’inversione al negativo del colore della faccia – forse il piombo di una biacca, come Cimabue ad Assisi? Le sono accanto due sante martiri, non per questo meno eleganti, con una croce preziosa in mano e qualche ricciolo che sfugge alla severa cuffia; gli abiti sono in seta tinta in filo con disegni molto raffinati e originali. Questa zona degli affreschi è un po’ sacrificata da interventi posteriori, e comunque l’occhio corre subito all’angolo dopo la porta, verso la facciata: lì si staglia glorioso, allegro, vincitore un bellissimo sant’Ippolito a cavallo con lo stendardo segnato con la croce e un gran refolo di vento che gli gonfia il mantello. Suggestioni subliminari per promuovere la Crociata? O forse messa in guardia per gli inconvenienti possibili? Ippolito infatti nasce come custode carcerario di San Lorenzo; assiste probabilente al suo tormento sulla grata; trasferito in Sardegna evidentemente ha un ripensamento che spinge l’imperatore Decio – è il 256 – a legarlo a dei cavalli indomiti fino a lasciare la vita. Certo, nella raffigurazione è lui che doma il cavallo. Anche la parete sinistra ha il suo parato di affreschi che certo sarebbero più apprezzati se non avessero di fronte questi così suggestivi che 85 abbiamo cercato di raccontare. Ma poi alla fine ciò che attrae i visitatori è il mare, Torre Mileto vicinissima e viva ben prima degli Aragonesi, le Tremiti che evaporano nel calore d’estate o si disegnano minuziosamente nella luce invernale. L’Abbazia di Diomede Le isole diomedee fanno parte di Devia anche geograficamente, perché Torre Mileto è l’approdo più vicino. Ma ci suggestiona il pensiero che Devia quanto Peschici, comunità slave dall’VIII secolo, siano lì proprio come interfaccia immediata della comunità benedettina che si sta consolidando e che diverrà nel tempo un player delle diverse partite che si giocano tra Venezia, Roma, le genti illiriche, le orde slave arrivate fresche al mare di Dalmazia, la Terrasanta e naturalmente la sede episcopale e imperiale di Costantinopoli e poi la Sublime Porta. Di questo gioco rischioso ci raccontiamo un paio di episodi. “Vicino alla costa pugliese sono un gruppo di cinque isole. Su una vi è un prospero monastero. I nobili miscredenti dei dintorni vengono qui per divenire monaci. Il monastero è stato fortificato con cannoni e armi tanto che sembra una fortezza. C’è un buon porto. Tre di queste isole si possono paragonare a un treppiede. Le navi non possono entrare nella bocca che dà verso scirocco perché è luogo basso e scoglioso. Ma la bocca di libeccio è profonda e le barche possono entrare e uscire”. Questo dice il ‘Libro del Mare’ di Piri Reis, l’ammiraglio ottomano decapitato a Bassora nel 1554 perché, novantenne, non se la sentiva più di guidare la flotta. Occhio di marinaio. Ma lo sguardo dei poeti si è sempre posato sull’aura mitica di queste isole, cui dà il nome uno degli eroi dell’Iliade, delle Metamorfosi, della ‘Alessandra’ di Licofrone, della Divina Commedia e di molte altre opere poetiche. “Nell’isola di Diomede che giace in Adriatico dicono vi sia un santuario meraviglioso e santo dedicato a Diomede. Tutt’intorno ad esso stanno appollaiati in cerchio uccelli di grandi dimensioni, provvisti di becchi grandi e duri. Di que86 sti uccelli raccontano che stanno tranquilli se sono dei greci che si avvicinano a quel luogo ma, se si avvicinano i barbari dei dintorni, si levano in formazione e svolazzando prendono di mira le loro teste, li feriscono e li uccidono”. Questa è la testimonianza dei ‘Racconti fantastici’ attribuiti a torto ad Aristotele. Questa leggenda dei compagni di Diomede trasformati in uccelli dalla divina stizza di Venere ha veramente bucato le distanze e i tempi e perfino le rivoluzioni culturali. In pieno cristianesimo trionfante, poco dopo il Mille, la Diomedea è raffigurata nel mosaico pavimentale della chiesa di Tremiti, oltre che qua e là per il monastero. E, per la verità, non risulta che al volatile siano stati annessi significati religiosi come al pellicano o alla colomba. E’ lì, anche se non distingue più tra civilizzati e barbari: è il fossile vivente di un mito. Abbiamo facilità di verificare qualche tratto della leggenda: da Rodi Garganico partono i traghetti per le Tremiti. Si superano le fortificazioni di San Nicola (per gli affaticati c’è anche un ascensore) e tutti gli edifici possenti dell’Abbazia, fino alla spianata degli asini dove c’è la tomba di Diomede o, a scelta, della scandalosa Giulia nipote di Augusto. Lì, se gli uccelli sono in cova e ci avviciniamo alla scogliera, saremo l’oggetto di strepitosissime incursioni di volatili che non cesseranno di minacciarci fino a quando non ci ritiriamo. L’accoglienza sarà più deferente quando i visitatori sono greci? Non ne abbiamo avuto evidenza. Le Porte dell’Occidente Via via che Venezia consolida il controllo del ‘suo’ golfo, le Tremiti ne segnano l’accesso almeno fino a quando i porti pugliesi non saranno in mani amichevoli per la Serenissima. Lungo la Dalmazia, infatti, superata Ragusa il percorso è a rischio. Premute dall’interno, si insediano sulla costa e sulle isole ondate di slavi che tra l’impegnarsi nella pesca o nella pirateria non hanno mai avuto esitazione. Tremiti è un avamposto verso gli slavi cristiani e musulmani, verso i pirati uscocchi, e poi lo sarà verso i turchi, quando la flotta di Solimano il Magnifico nel 87 1567 assedierà invano l’abbazia. E infatti filiazioni ‘missionarie’ di Santa Maria di Tremiti si impiantano a Ragusa di Dalmazia, sull’isola di Lacroma. Rimane avvolto nella nebbia il rapporto tra i benedettini di Tremiti e i corsari slavi; all’epoca circolavano voci su favori reciproci e su una certa extraterritorialità concordata sous table. Sarà l’agosto del 1054. Giunge una nave da Costantinopoli. Passeggeri eccellenti: uno dei prelati più in vista della Chiesa romana, il cardinale Federico di Lorena, accompagnato da Umberto di Silvacandida e dal vescovo Pietro d’Amalfi. La sosta viene giustificata come un omaggio a Santa Maria del Mare; ma c’è ben altro. Assieme ai suoi compagni di vela, il cardinal Federico in fuga da Costantinopoli aveva appena consumato il grande Scisma d’Oriente tra la Chiesa romana e quella bizantina: opera millenaria a tutt’oggi pienamente vigente. Ma qual è il fatto? Dal 1042 la cattedra patriarcale di Costantinopoli è affidata a Michele Cerulario, personaggio assai versato nel guerrilla marketing contro la Chiesa di Roma. Casus belli è il trattato di Argyros che formalizza la giurisdizione di Roma sulle diocesi, anche di rito greco, dell’Italia meridionale: fin allora erano dipendenti da Costantinopoli. Michele pretende in cambio il riconoscimento della parità tra le due sedi, e innesca un ordigno esplosivo alla bizantina. Ecco come. Chiede pubblicamente a papa Leone IX di rispondere a quattro quesiti fra cui il più scottante è il ‘Filioque’, l’appassionante dilemma se lo Spirito santo discenda dal Padre e dal Figlio, come afferma Roma, o dal Padre attraverso il Figlio, come giurano a Costantinopoli, con abbondante effusione di ingiurie e sangue da ambo le parti. Il papa, che aveva il suo daffare a districarsi dalle filiali spire dei capi normanni, manda a trattare un brain trust: Silvacandida, Lorena, Amalfi. Succede di tutto. L’imperatore Costantino Monòmaco cerca di trattenere il suo bollente patriarca che agisce attraverso vari manutengoli ma si espone poco; il 19 aprile 1054 muore il papa, il che farebbe decadere il mandato della commissione. Ma ormai infuria una battaglia 88 mediatica in Bisanzio, fatta di lettere rivelate, di dichiarazioni manomesse, di predicazioni interminabili e di insulti che coinvolge tutta la popolazione. Michele Cerulario gioca bene le carte: lascia che il trio di negoziatori travolga i limiti della cortesia oltre che dell’ortodossia, finché il vecchio e stanco Costantino Monòmaco perde la pazienza. A questo punto, siamo al 15 luglio, i tre negoziatori in pompa magna depongono sull’altare di Santa Sofia la bolla di scomunica per il Cerulario. Le motivazioni addette sono, almeno ai nostri occhi di un millennio più vecchi, lievemente confuse o completamente demenziali. In primis viene attaccata la persona e la legittimità patriarcale del Cerulario, accusato di simonia; di conseguenza chiunque gli presti obbedienza si rende complice dello stesso peccato – e sull’argomento avrebbero fatto meglio a passar sopra. Poi viene imputata una sequenza di pratiche che in realtà o non sono in atto a Costantinopoli o sono condivise dalla Chiesa di Roma: l’evirazione – dei cantori, si suppone –; il matrimonio dei preti (falso: si potevano ordinare preti uomini sposati); il battesimo delle donne in partu anche se in stato agonico; il ribattesimo dei fedeli provenienti dal rito romano (falso); l’annullamento della legge mosaica; il rifiuto della comunione agli uomini con la barba rasata; l’inquinamento del Credo con la formula ‘per Filium’. La commissione esce da Santa Sofia scuotendosi la polvere dei calzari, gesto di nobile simbologia biblica; poi opportunamente prende il largo. Il 24 luglio il Cerulario scomunica il papa che peraltro non c’è più. Uno si può domandare: ma ce n’è abbastanza per rompere in due la Chiesa? Forse tutti credevano di agire in uno psicodramma o in un videogioco; le scomuniche del resto si potevano sempre togliere. E infatti la vicendevole scomunica sarà ritirata nel 1965 da Paolo VI e dal patriarca Atenagora. Nient’altro. Per il 2054 si prevede una celebrazione millenaria con programmi di penitenze e proponimenti altrettanto inefficaci. Prendono il largo e approdano a Tremiti. L’isola dei famosi. Silvacandida era un monaco borgognone molto apprezzato da Leone IX, che lo aveva nominato arcivescovo di Sicilia sotto dominazione 89 saracena. Federico, altro francese, era fratello del Duca di Lorena e, in quel momento, bibliotecario di Leone IX. In seguito Federico di Lorena sarebbe diventato abate di Montecassino, poi papa Stefano IX; avrebbe lottato molto per la moralizzazione del clero, per l’alleggerimento della pressione normanna e per il conferimento del titolo imperiale a suo fratello; senza grandi successi, sarebbe morto a Firenze nel 1058. Pietro arcivescovo di Amalfi infine sarà cannibalizzato dall’omonimo successore Pietro Capuano, che porterà via le spoglie di Sant’Andrea approfittando del sacco di Costantinopoli e meritando il monumento funebre che si ammira nella cattedrale della gloriosa repubblica marinara. Guardiamo le Tremiti nella luce sfolgorante del mezzogiorno e commentiamo che la grande storia è passata da qui, e chissà quante volte. Il pericolo slavo Abbiamo già commentato il gossip. Non sarà mica che i benedettini negoziassero con gli Slavi della costa dalmatica, e poi di quella garganica a Devia e Peschici, dei gentlemen agreement sulla base del not in my backyard? Non lo sapremo mai. Qui a Devia ovviamente gli Slavi erano di casa e vivevano in una dipendenza dell’Abbazia isolana. Quello di cui siamo certi, invece, è che i successivi abitatori di Tremiti, i Cistercensi riformati da San Bernardo, non avranno vita facile con gli inquieti vicini: soprattutto con i dirimpettai pirati cristiani del porto di Almissa, città già illirica e romana che sotto il nome di Oeneum potrebbe leggersi sulla Tabula Peutingeriana. La cupa notte dei pirati – data imprecisata del 1334 – è raccontata in un manoscritto di settant’anni posteriore, la ‘Accuratissima Descriptio’ del canonico Benedicto Cochorella. Bisogna premettere che l’abbazia è molto curata dai regnanti angioini di Napoli e serve da base per la loro flotta dell’Adriatico. Quindi le difese dell’isola di San Nicola, dove si trovano gli edifici sacri, sono – e lo si vede anche oggi – impenetrabili. Rimarranno inaccessibili per90 fino alla flotta di Solimano il Magnifico. Ma i pirati ne sanno una più del Sultano e giocano la carta della pietà cattolica per superare lo sbarramento di pietra. Se si guarda il porto di Tremiti ci si figura perfettamente comm’è juto ’o fatto. Una piccola nave, una bireme, e pochi uomini piangenti: uno dei loro è morto in mezzo al mare, durante la pesca, e bisogna dargli sepoltura cristiana. “Lo compongono in una specie di cassa da morto e stendono sul fondo pugnali e spade. Preparata la trappola, due di loro salgono dai frati e, fingendo la massima devozione, insistono per celebrare le esequie e seppellire il defunto nel cimitero dell’isola. I religiosi, convinti facilmente che così stessero le cose, scendono alla riva dove si trova il corpo senza vita e in processione, preceduti dalla croce e in fila per due, sollevano il feretro e lo portano dentro la chiesa. Dietro di loro venivano gli empi macchinatori di sacrilegio, con l’espressione di chi sta per commettere una strage, a capo chino e traendo dal petto i più alti sospiri per il compagno defunto”. Al momento opportuno si danno un cenno con gli occhi, il morto salta fuori, distribuisce pugnali e spade e comincia la mattanza. “Trucidati quasi tutti, tanto i frati quanto i servi, tingono del rosso sangue di monaci il pavimento di tutto il convento. Quindi si volgono alla predazione degli oggetti sacri; fatto a pezzi tutto quanto era destinato al culto di Dio o all’ornamento del tempio, portano via il mobilio rimanente, distruggono, strascicano e dilagano per tutto il complesso monastico. Avidi di preda lo spogliano e niente rimane dietro di loro se non la terra nuda. Gli oggetti pesanti che non si portavano via facilmente li distruggono a ferro e fuoco”. Soltanto l’altar maggiore non si tocca, attesta il Cochorella, e quindi la chiesa non ne viene sconsacrata: pirati e assassini sì, ma pur sempre cattolici! Tornano a casa baldanzosi e consegnano anche qualche ex–voto alla parrocchia in ringraziamento del bottino accumulato. Ma la vendetta divina è immediata. “Dal giorno in cui dall’isola rientrarono alle loro case mai più terreno, mai più vigna, mai più oliveto, mai più campo raggiunse la sua fertilità. Da allora la grandine violenta distrugge i loro poderi, o la canicola estiva li brucia, o per la mancanza d’acqua si sbri91 ciolano come brina sciolta. Nessun frutto giunge a maturazione sugli alberi: cadono tutti ancora acerbi; le spighe non si riempiono di semi, né germina erba sufficiente per le pecore. Le loro donne subiscono aborti, o partoriscono figli storpi e deformi, o gobbi, o muti, o ciechi”. Che fare? Vada a Roma il parroco e supplichi il papa di togliere la scomunica in cambio di una penitenza collettiva. Il prete va, contratta e ritorna con la benedizione apostolica e il conto delle spese. “Ingrati e indegni di tanto beneficio, non solo non lo rimborsano ma lo spintonano, lo percuotono violentemente, lo feriscono e alla fine lo uccidono”. Così rimangono scomunicati almeno per settant’anni, fino a quando Cochorella scrive. Una sola, piccola chiosa: a tutt’oggi nella parrocchiale di Omiš pare si veneri un crocifisso d’argento incastonato di pietre preziose. E’ un exvoto offerto dai corsari, secoli fa. Gli Ebrei di Torre Mileto Si chiamava in verità Torre Maletta: nome del cognato di Federico, Manfredi Maletta di Mineo, fratello di Bianca Lancia. Zio, quindi, di re Manfredi e proprietario dei terreni su cui, a sue spese, si costruirà la città di Manfredonia. Forse (un sussurro) eponimo della stessa città. O forse solo protagonista di una colossale speculazione edilizia. Dobbiamo pensare Torre Mileto come una componente del sistema di comunicazione costiero in funzione antiturca. I fusti di cannone di una marsiliana di Venezia affondata al largo nel 1607 – la Poma Santa Maria – ci ricordano che la zona dal punto di vista geopolitico non ha mai cessato di essere molto calda. Lo stato di allerta era continuo: a volte con successo, a volte no, come sappiamo. Matteo ci apre una dietro l’altra le porte e le finestre di questo edificio sorprendente, restauro da antologia che avrà un riuso importante per la comunità. Guardando dalla terrazza più alta si ha la sensazione precisa di un ingranaggio che si estende sia a filo della costa, sia all’interno del Gargano alle isole Tremiti. 92 Il terreno attorno alla torre è tutto da scavo, e si capisce che le manifatture neolitiche di San Domino dovevano avere qui un approdo per esportare strumenti finiti e importare quella quota di materia prima necessaria per diversificare la produzione, come l’ossidiana dalle Eolie (ne abbiamo visti dei giacimenti importanti in Anatolia, tra la Cappadocia e la Cilicia, ma probabilmente non riuscivano a esportarlo fino a qua). Del resto niente ci impedisce di fantasticare su un tempo in cui il Gargano e le Tremiti emergevano dal mare, mentre il Tavoliere era un fondale marino. E comunque qualcuno di simile a noi si è accomodato molto prima nella Foresta Umbra che a Cala Matano. Uno scavo molto sbrigativo nella memoria ci ricorda una delle magiche storie del Gargano. Se in fondo a San Nicola di Tremiti c’è il cimitero islamico dei cittadini deportati a più riprese dalla Libia, qui a Torre Mileto avvenne la circoncisione e l’immersione rituale (temilah) di tredici persone convertite all’ebraismo. Era il 1946 e i nuovi israeliti accettati dalla Sinagoga di Roma seguivano la predicazione del profeta Donato Manduzio. Successivamente gran parte di essi passò in Terrasanta per una nuova crociata, e sarà nell’esercito israeliano, lo Tsahal. I loro discendenti abitano vicino alla città di Safed, piccolo e famoso centro intellettuale attorno a una sinagoga suggestiva. Donato Manduzio da Sannicandro Garganico è uno di quelli che la prima guerra mondiale ha rimandato a casa senza salute e senza lavoro. Vive per le sue doti di guaritore e le sue declamazioni pubbliche dei romanzi cavallereschi. Finché nel 1930 non riceve l’illuminazione: una visione gli rivela l’unicità di Dio e la necessità di ritornare alla lettera della Bibbia. L’aspetto singolare è che egli non sa che gli ebrei esistono ancora: lo scoprirà per caso, e cercherà di mettersi in contatto con la Sinagoga proprio mentre sta per scoppiare la persecuzione razziale. Per nulla turbato dalla circostanze infauste seguite al 1938, avrà nel 1943 il primo incontro ravvicinato con una comunità israelitica costituita da perplessi soldati alleati. Le prime impressioni non sono favorevoli, perché Manduzio si è fatto ebreo da solo, non conosce il Talmud, nulla sa di ortodossie e di liturgie. In definitiva sarà qui, a Torre Mileto, che le dif93 fidenze reciproche saranno superate e che la circoncisione dei tredici convertiti segnerà l’accoglienza del singolare profeta nel seno di Abramo. Chissà se nel tempo vi saranno stati contatti, o conoscenza, o messaggi, tra il profeta Manduzio e l’altro visionario del Gargano, Pio da Pietrelcina? Forse è blasfemia porre la questione. Ma non possiamo scordare che il Gargano è prodigo di visioni. A partire da quelle concesse ai fedeli avvolti nel vello del caprone appena sacrificato nel tempio di Podalirio, durante il rito notturno dell’incubatio. La Grotta dell’Angelo Matteo ancora, fresca incarnazione dello spirito dei luoghi, guida l’annosa cordata di visitatori sù per il bosco fino alla Grotta dell’Angelo. Franco chiede di fare il punto. Dunque: la Torre Mileto, Devia e la Grotta sono allineati lungo una direttrice nord-sud: invece le tre Grotte garganiche di San Michele – Devia, Cagnano Varano e Monte S. Angelo – sono in linea da nord-ovest a sud-est. Alle suggestive proiezioni cosmiche mancano purtroppo le Tremiti, troppo spostate ad ovest per partecipare a questa configurazione mistica. Pazienza. Da soli non arriveremmo mai all’imboccatura della grotta dell’Angelo. Ma eccola qui. Avvicinandoci tra gli alberi del bosco il primo sguardo viene attratto, in alto rispetto all’ingresso, da una cavità di aspetto inequivocabile: un organo femminile. Guardando meglio ce ne sono altre due intorno, e forse l’imboccatura stessa della grotta, prima di essere addomesticata, aveva questo disegno. Istintivamente tornano in mente situazioni simili. La grande fenditura al centro delle tombe dei re achemenidi, a Naqsh-e Rustam. O anche, più vicina a noi, la spaccatura del monte di Sulmona che fa da asse al tempio di Ercole Curino, sacro alla transumanza. L’ingresso ricorda una gola umana. Avanzando, più che altro sembra di essere Pinocchio nel ventre della balena. Dal Paleolitico al Medioevo l’uomo ha lasciato tracce sicure per gli archeologhi, ma ha pure confi94 gurato questo ambiente in modo rassicurante, per esperienze comunitarie che si immaginano serene. L’opposto, per dire, della Grotta di Cagnano Varano, che sembra plasmata da un turbine violento e in qualche misura malevolo, come se Michele si fosse dovuto conquistare lo spazio in lotta contro gli spiriti d’inferno; e per questo vi lascia qua un’ala, là un’orma. Ed è la sua prima abitazione sul Gargano. Avanziamo nell’umidità con qualche domanda in mente. Che cosa attira noi uomini antichi nelle grotte? A parte il naturale riparo, sembrano risucchiati perso l’interno buio e inabitabile. E che cosa scatta in noi quando vi avvertiamo la presenza di acqua, sotto forma di pozza o di sgocciolio o di fiume o di fonte? E le emozioni che proviamo nel procedere nella caverna: il repentino silenzio, l’ascolto interno delle proprie pulsazioni, l’umidità; la protezione. Più sottile di tutto: la sensazione di procedere verso un punto finale, cioè iniziale. Là dove la generazione avviene di nuovo. E l’acqua? Se la grotta è un utero di Gaia, è naturale che vi sia l’umidità. Ne avrebbe convenuto anche Talete: l’acqua principio di tutte le cose è giusto che sia là dove la vita prende l’avvio. A un certo punto si profila una specie di velopendulo, e poi tre diramazioni. Ma a un muretto di sassi Michele ci blocca: non expedit inoltrarsi. Dal soffitto pendono finissime stalattiti umide, come fanoni di una piccola balena. Ci sono dei graffiti anche, delle tracce rosse, delle pietre verdi di lichene. Quale divinità verrà incontro a noi pellegrini di caverne senza inizio? Ad Apuleio è stata fatta la rivelazione: “Lucio, sono qua, richiamata dalle tue preghiere. Sono la Natura madre di tutte le cose, signora di tutti gli elementi, principio e generazione dei secoli, la più grande dei Numi, la regina dei Mani, la prima fra i Celesti, forma tipica degli Dei e delle Dee, che governano al mio cenno le luminose vette del cielo, le salutari brezze marine, i piangenti silenzi degli inferi. Il mio nome è oggetto di culto in tutto il mondo, seppure sotto diverse forme, con vario rito e con diverse denominazioni. I Frigi primi abitatori della terra mi chiamano la Madre degli Dei di Pessinunte (cioè Cibele); gli abitanti indigeni dell’Attica , Minerva Cecropia. Il mio nome è Afrodite di Pafo presso gli abitanti dell’isola di Cipro; Diana Dittina presso i 95 Cretesi, noti arcieri. Proserpina mi chiamano i Siciliani in tre lingue. Vetusta Cerere fra gli Eleusini; altri mi chiamano Giunone, altri Bellona; alcuni Ecate e altri Ramnusia. Ma solamente coloro che sono illuminati dai primi raggi del sole nascente, gli uni e gli altri Etiopi, e gli Egiziani ammirevoli per la loro dottrina, mi onorano con un culto di adeguate cerimonie e mi invocano con il mio vero nome: Iside Regina”. Iside che nelle statuette ellenistiche tiene in braccio il figlio. Horus. Guardando verso l’esterno non si vede Santa Maria ma, in lontananza, il mare. 96 97 MONTECORVINO La Grand Bretagne comprise l’Angleterre Viendra par eaux si hault à inunder Las ligue neusue d’Ausonie fera guerre, Que contre eux-mêmes il se viendront bander (III, 70) Di tutte le ‘città dimenticate’ delle Terre Foggiane, Montecorvino è una delle meglio ricordate. Anzi ha una vita presente che non è animata soltanto dagli archeologi dell’Università di Foggia con le loro campagne di scavo. Il ‘riuso’ del sito deserto si deve al Santo patrono: Alberto, secondo vescovo della città bizantina. Il fatto? Nel 1889 una siccità persistente devasta il territorio. Invocato ardentemente, Alberto appare in sogno ad alcune persone di Pietra Montecorvino e consiglia di effettuare un pellegrinaggio di penitenza alla sua cattedrale, rudere tra i ruderi della città abbandonata sette chilometri più in basso. E’ il 16 maggio: i cittadini si mettono in cammino portando la statua del santo, il quale sarà stato felicissimo di ritrovarsi in quel luogo di cui aveva amato la bellezza. E quindi la pioggia non si fa attendere: più acqua che grano. Da questa apparizione Montecorvino è tornata ad essere un luogo. Ogni anno da Terravecchia muove la processione in onore di Sant’Alberto e, portando dei palii di legno festosi e multicolori, raggiunge la spianata della città segnata dal maestoso landmark della torre diruta. E qui si celebra ancora il rito propiziatorio nella parte scavata e perfettamente leggibile della cattedrale che Alberto aveva preteso dignitosa, e che in epoca angioina è stata abbellita da due campanili in facciata. Pare anzi che una volta, in anni recentissimi, S. Alberto abbia risposto alla domanda di pioggia in maniera tanto tempestiva e abbondante da avvolgere i pellegrini in un uragano da cui non sapevano riparare né la statua né se stessi. 99 Un ‘landmark’: la sedia del diavolo Per una visita normale forse il momento più suggestivo è il tardo agosto, quando – come dice Lucano nella ‘Pharsalia’ – il contadino apulo brucia le stoppie dei campi esausti e con questo calore prepara la terra per seminare le erbe invernali: renovare parans hibernas Apulus herbas igne fovet terras. Però, dice Saverio sindaco di Pietra Montecorvino mentre guida il fuoristrada, tra non molto tempo sarà proibito dar fuoco alle stoppie. Approfittiamo quindi per interiorizzare qualche piccola sciara di fuoco, questo colore grigio intenso dei campi ondulati, dopo l’oro scintillante del grano mietuto. E’ anche il momento di raccogliere il grano arso, eventualmente, per fare i cavatelli. Da quassù – e meglio ancora dal torrione di Terravecchia – il Subappennino, il Tavoliere, il Gargano e qualche volta l’Adriatico appaiono come un territorio omogeneo dalla morfologia composita. Ma la violenza delle intenzioni umane si sovrappone spesso alla chiarezza della natura, e questo panorama è stato squassato nei secoli da diverse faglie geopolitiche. La fondazione stessa di Montecorvino, all’inizio del Mille, si deve al bisogno di colmare una di queste faglie. Si voleva dare certezza a un confine – tra il mondo bizantino e quello longobardo – che si sarebbe dissolto proprio nel niente, pochi anni dopo. Strano destino. Ricorda la capitale armena di Ani, ad oriente dell’Anatolia. Rovine sontuose esposte a un sole carezzevole che invitava a scattare foto. Ed era mortalmente proibito trent’anni fa, perché la costa del monte accanto era già Unione Sovietica. Lì, in Turchia, vigeva il Patto Atlantico. Una delle frontiere roventi del pianeta, trent’anni fa. Adesso non fanno più storie: il confine si è raffreddato a beneficio di fotocamere analogiche e digitali, reflex, videocamere, telefonini e qualunque sistema di riproduzione dell’immagine. Le opere umane hanno talvolta una loro indispettita volontà di resistenza. Siamo ai piedi della torre di Montecorvino: quella che dopo tre assedi e un terremoto ha perso una facciata intera, e pertanto sembra un seggiolone enorme in mezzo alle ondate di campi di grano. Il nome di ‘sedia del diavolo’ se lo è meritato perché non si capisce chi altro la ter100 rebbe in piedi, ora che un terzo spigolo pare esposto alle lusinghe della forza di gravità. Prima di Montecorvino Questa torre ha una data di nascita, uno scopo e una persona che l’ha voluta. Si chiama Basilio Boioannes e governò il Catapanato d’Italia dal 1017 al 1027. In pochi anni, con un attivismo invincibile, riuscì a tamponare la frana del potere bizantino d’Italia, mentre il suo dante causa, l’imperatore Basilio II, non si sottraeva a una bisogna ancora più drammatica: il blocco dell’espansione bulgara che mirava al cuore dell’Impero sotto la guida di re Samuele. Quindi il Catapano d’Italia poteva contare appena sulle proprie forze per tenere sotto controllo la fronda irredentista filolongobarda tra Bari e Salerno, e insieme l’attrazione fatale verso le bande opportuniste di predoni normanni. Le incursioni dei pirati arabi, intense, e l’affacciarsi degli slavi in Dalmazia coloravano la situazione di una certa drammaticità. Questa è la lettura politica della Capitanata alla nascita di Montecorvino. La lettura culturale è più stimolante. Come terra di confine tra diverse realtà istituzionali, tra storie distinte, etnie allogene, sistemi giuridici di varia origine, tra lingue, credenze, costumi, sensibilità civili e religiose anche contrastanti, il territorio tra l’Ofanto e il Fortore, e fino al Biferno, doveva essere molto vario e complesso. Ciò appare, ad esempio, nelle raccolte di documenti d’archivio: molti riguardano lasciti, donazioni, transazioni attorno all’XI secolo. In ogni documento c’è una data, che a volte è l’anno di regno dell’imperatore tedesco, a volte del basileus di Bisanzio, a volte del principe longobardo di Benevento. Di solito, gli atti stipulati nelle contee di Termoli e Chieuti portano la data tedesca; quelli della contea di Larino hanno la data longobarda; quelle del Gargano, la data dell’imperatore bizantino. Lo stesso vale per i titoli e le funzioni dei personaggi che compaiono nei documenti: una volta si trova anche, a Castellum Pesclizo (Peschici), la citazione del juppanus Glubizo: questo era il titolo dei capi delle comunità slave di Dalmazia. 101 E’ chiaro il disegno di Basilio Boiannes e dell’altro Basilio, l’imperatore ‘romano’ di Bisanzio: riaffermare la potestà sulla Daunia; strutturare una nuova linea di confine; creare una catena di città fortificate per difendere la frontiera da incursioni, razzie e ribellioni. Ovviamente tra la vecchia linea di difesa, poco sopra l’Ofanto, e la nuova all’altezza del Fortore c’era il Tavoliere da ripopolare e da rendere appetibile come luogo di insediamento sicuro per le famiglie. ‘Lega longobarda’ o nazionalismo murgiano? Sede del Catapanato bizantino d’Italia è Bari, dal 976, dopo la liquidazione dell’effimero Emirato arabo. Città di borghesia cosmopolita come la start-up Venezia, a capo di linee commerciali importanti. Le condizioni competitive ci sarebbero, ma vengono soffocate dal governo bizantino e soprattutto dalla fiscalità esosa destinata a finanziare imprese militari estranee oppure il lusso parassita della corte – dove il Catapano d’Italia occupa tra i dignitari il 39° posto. Il malcontento è diffuso in Terra di Bari e trova echi compiacenti nel mondo longobardo che si sviluppa dal Subappennino a Salerno includendo la capitale, Benevento, e il principato di Capua. Perché la fiamma s’accenda servono due condizioni: un motivo di esasperazione e un condottiero che sappia prendere in mano la lotta. Il leader della situazione si chiama Melo, che forse è un nomignolo per Ismaelo; suo braccio destro è Datto, il cognato. Più che i loro nomi ci dice qualcosa il sistema di parentela. Il figlio di Melo si chiama Argyrio, che avrà una vita politica lunga e contraddittoria; dunque siamo in una famiglia di classe benestante bizantina, e non necessariamente di nazionalità greca. La moglie, che si chiama Maralda, è longobarda. Melo, come dimostreranno poi i fatti, ha accesso ai grandi centri di potere in Occidente: la Santa Sede papale e la Sacra Corte imperiale della dinastia Salica. Qual era il suo programma? Forse la creazione di un soggetto politico regionale. La strategia? Una devoluzione di poteri da parte di Bisanzio? Uno ‘strappo’ verso gli Stati longobardi? O addirittura verso il Papato, o verso l’Impero germanico? Come di tutti i perdenti, nessuno ha cantato la sua storia. 102 La ribellione contro Bisanzio si innesca nel 1009 in concomitanza con una carestia disastrosa, e sale da Bari verso nord, fino a Bitetto, Bitonto e Trani. Da segnalare l’appoggio papale. Ma da Bisanzio arriva un nuovo Catapano, Basilio Mesardonite: uomo di pochi complimenti, assedia duramente la città, la espugna l’11 giugno 1011, e riesce a ottenere formale atto di vassallaggio dai principi longobardi e dall’abate di Montecassino. Il sogno di Melo sembra spento. In realtà esso attraversava dei disegni più grandi: il nuovo papa, Benedetto VIII, non vuol disperdere questa energia antibizantina che Melo ha saputo evocare, e lo raccomanda all’imperatore germanico, Enrico II il Santo. Melo ne ottiene un platonico investimento del ducato di Puglia, che però non era nelle disponibilità del Sacro Romano Impero. In questo confuso daffare dei grandi e dei piccoli personaggi, il filo rosso della storia passa silenziosamente da un’altra parte e la diplomazia non se ne accorge. Siamo nella grotta dell’Angelo sul Gargano. Melo è lì a impetrare una protezione di cui ha davvero bisogno, e S. Michele gli risponde a modo suo. Sono lì in preghiera dei devoti inconsueti: un gruppo di giovani normanni di ritorno dal Santo Sepolcro. Prima di ripartire verso casa sono già d’accordo con Melo: torneranno tra un anno con una nutrita schiera di cavalieri. Questo cambierà la storia d’Italia. Benedetti dal papa, nella primavera del 1017 muovono tutti verso la Capitanata e sconfiggono i bizantini a Civitate e a Vaccarizza presso Troia: così arrivano a Trani. La battaglia di Canne, 1018 Ma Bisanzio aveva carte da giocare: il nuovo Catapano, Basilio Boioannes, e un drappello della Guardia variaga. I Variaghi sono guerrieri scandinavi chiamati dagli Slavi dell’area commerciale di Novgorod per sedare i propri dissensi. Fondano il primo Stato russo, il Rus’. Compaiono sulla scena internazionale nel 998: il gran Principe di Kiev, Vladimir I, sposa Anna, la sorella di 103 Basilio II; il dono di nozze, o meglio il ‘prezzo della sposa’, è un drappello di 6000 guerrieri variaghi armati di ascia a due impugnature, spade e archi. Erano personaggi altolocati: il loro capo, Hardrada, diventerà poi il re Harald III di Norvegia. “Il popolo dei Winnili, cioè dei Longobardi, che poi regnò felicemente in Italia, mosse dalla (pen)isola chiamata Scania”. Cioè dalla Scandinavia: lo attesta Paolo Diacono, il loro storico. Hanno tracciato uno ‘Stato’ italiano, a macchia di leopardo; a sud la capitale amministrativa e religiosa è Benevento, ma Capua e Salerno sono centri importanti e inquieti, e anche l’Abbazia di Montecassino non sarà estranea a questa configurazione del potere. I Vikinghi, chiamati ‘normanni’ dai francesi, vengono dalla Scandinavia, predano la Gran Bretagna, arrivano in America. A un certo punto si posano in Normandia dove nel 911 vengono legittimati dai Carolingi. Al loro capo Hrolfr (che i francesi non riescono a pronunciare se non Rollon) viene assegnato il ducato di Rouen. Da lì in Italia meridionale e Sicilia, poi Oltremare; e nel 1066 in Inghilterra: battaglia di Hastings, Guglielmo il Conquistatore, l’arazzo della regina Matilde a Bayeux. Questa è ironia della storia. A Canne, luogo privilegiato di battaglie, il 1° ottobre 1018 vengono allo scontro tre eserciti di scandinavi: Variaghi contro Longobardi alleati coi Normanni. Chissà se si saranno riconosciuti, in qualche modo? Qualche tipo di arma, qualche grido di guerra, qualche insulto nel corpo a corpo? Non lo sapremo mai. Però nella seconda battaglia di Canne prevalgono i Variaghi di Boioannes, probabilmente per la migliore disciplina e per l’abitudine al lavoro di gruppo nell’ordinato esercito bizantino. I vincitori di lungo periodo saranno invece i Normanni. Rainulfo Drengot, a quanto dice Rodolfo il Glabro, chiama i suoi a una migrazione di massa: famiglie intere con donne e bambini dalla Normandia prendono la via del Sud. Per il Gran San Bernardo travolgono i blocchi e i gabellieri istituiti dai signorotti dei valichi alpini, e vanno ad ingros104 sare le avanguardie normanne combattenti a Benevento e in Puglia. Ma questo appartiene ad un’altra ‘città dimenticata’: Tiati, cioè Civitate. Gli anni brevi di Montecorvino Boioannes, il padre di Montecorvino, vince la battaglia e anche la guerra. La Puglia ritorna sotto i Bizantini e finalmente Basilio ha modo di realizzare il suo disegno per bloccare eventuali rigurgiti di fratellanza longobarda tra Bari, Capua e Salerno e piantare dei ‘picchetti’ di confine verso il Fortore: Devia, Fiorentino, Montecorvino, Civitate, Dragonara, Tertiveri, Biccari, Troia. Non è un disegno puramente militare: il Bugiano, come lo chiamano qui, si muove a tutto campo, anche sul piano civile ed ecclesiastico. Anzitutto separa la diocesi di Siponto da quella di Benevento. E questo è un buon colpo per la città portuale daunia, che viene sciolta non solo dal potere longobardo ma anche da quello papale: infatti la capitale sannita aveva il privilegio di dipendere direttamente dalla Santa Sede. Però c’è un problema. Forse Basilio non aveva letto la Vita Barbati, opuscolo in lode del primo vescovo di Benevento. San Barbato era già pago di aver convertito i Longobardi e annientato i culti etnici, da quello banale per il dio-albero a quello molto più intrigante della vipera d’oro (astutamente se la fa portare dalla regina e poi la fonde per farne un calice). Ma il duca Romualdo come tutti i neofiti ha la smania di fare qualcosa di troppo. Allora il santo vescovo parla: “Se ti urge offrire un dono per la tua salvezza, c’è una cosa sola che puoi fare. Sul Gargano c’è la casa del beato Michele arcangelo. Tu la sottrai alla giurisdizione del vescovo di Siponto e la sottometti in tutto e per tutto alla Sede della quale indegnamente io sono il titolare”. Detto fatto, e anche di più: la diocesi di Siponto viene accorpata a quella di Benevento. E il testo soggiunge: “Così risuona attraverso il futuro: sono colpiti da anatema coloro che agissero contro questa concessione rendendola vana”. Questo anatema spiega molte cose che verranno, e soprattutto l’improvvida destituzione di Boioannes che avrà conseguenze fatali. 105 Per intanto il papa frena le impazienze dell’arcivescovo di Benevento e lascia spazio alle nuove diocesi–piazzeforti della Capitanata. Infatti le città di Boioannes sono comunità vere, non pure macchine da guerra. In ciascuna di esse, eccetto Devia, viene insediato un vescovo. Attorno al presule si aggrega un clero, si innalzano edifici, si strutturano servizi in rete con la sede metropolitana di riferimento, e anche con la Santa Sede, e quindi si disegna un tessuto cittadino. Si chiama ‘effetto poleopoietico’ del vescovato. A Montecorvino questo effetto è affidato al vescovo Beatus. Il modulo dell’abitato è costante in tutte le piazzeforti: su siti difensivi, come alture o speroni circondati da strapiombi, il tessuto urbano nasce allungato; le contrade che partono dalla platea magna sono strette; ovviamente le mura difendono la città e culminano con il castrum nei cui paraggi, a seconda delle opportunità offerte dal suolo, sorge la cattedrale. Un famoso libro chiama il XX ‘il secolo breve’. Ma forse fu più breve il Mille, almeno per Montecorvino: appena fondata vide squagliarsi l’Impero bizantino che l’aveva voluta e imporsi una nuova potenza, quella normanna, capace di tenere in scacco entità come il Papato e l’Impero germanico. E breve fu la vita della città: per diverse vicende – due assedii, 1137 e 1332, e un terremoto, 1452 – Montecorvino resta desolata. Dopo il 1452 la popolazione si esilia in tre borghi a portata di mano sulla più stabile falda del Subappennino: Volturino, Motta e Pietra Montecorvino. Tutte e tre sono orientate verso il ‘luogo assente’ della loro origine comune: quella città che Boioannes edificò prima di essere richiamato alla Corte di Bisanzio. Il nuovo imperatore, Costantino VIII, non sapeva che cosa farsene di lui né di Montecorvino. E da lì in avanti il declino dell’Impero fu inarrestabile, in terra di Puglia. I decenni seguenti avrebbero visto rovesciamenti di alleanze, fino ad una effimera trilateral tra i due imperatori terreni e quello spirituale. Ma a prevalere fu sempre il ‘patto scandinavo’ tra Longobardi e Normanni, fino all’esclusione dei Bizantini da Bari nel 1071. Annus horribilis sul Bosforo: in Cilicia i Selgiuchidi sfondano l’armata imperiale e 106 dilagano per l’Anatolia. Nel frattempo, è il 1054, la caratterialità e l’improfessionalità di quattro prelati – tre latini, uno greco – fanno saltare all’aria l’unità della chiesa, e fino ad oggi non se ne vede riparazione. Davvero un secolo breve, questo Mille. Alberto vescovo, ‘santo subito’ Il protoepiscopo Beatus avrà saputo allestire una schola episcopale nella sua città? Si capirebbe perché il piccolo Alberto dell’età di cinque anni, rampollo di famiglia normanna dei dintorni, si trasferisca per ragioni di studio a Montecorvino. E’ il 1037. Il ragazzo cresce in sapienza e santità sotto gli occhi di Beatus e di tutta la gente; non si fa mancare preghiere e digiuni. Alla morte di Beatus si forma su di lui, che non aveva ancora trent’anni, un consenso caloroso da parte del popolo, del clero e del conte di Civitate: Alberto sarà il nuovo vescovo. Molto a malincuore Alberto accetta la responsabilità, ma mette una condizione: prima di essere consacrato vuol vedere la cattedrale più grande e più bella. La cura pastorale non lo farà deflettere dall’austero ascetismo: anzi la fama di santità richiama a Montecorvino anche i vip dell’epoca per consigli e confessioni. Non solo: il territorio diocesano, e poi tutta la Puglia, passa dai bizantini ai normanni, e di conseguenza si accresce il bacino d’utenza per il cammino di Montecorvino. Non sarà stato molto diverso, mutatis mutandis, da San Giovanni Rotondo molti secoli dopo. E infatti anche qui c’è chi cerca di lucrare sulla santità altrui, a quanto riporta la letteratura tradizionale. I digiuni e le privazioni hanno indebolito la fibra di Alberto fino a renderlo cieco, e gli viene assegnato un coadiutore: Costanzo. Questo sacerdote, si dice, fiutando aria di successione, fa di tutto per abbreviare la dolorosa vita del vescovo Alberto. Comunque sia, è vero che erediterà la cattedra episcopale; ma non così in fretta. Infatti nel 1082 Alberto, cinquantenne, partecipa alla sceneggiata con cui l’abate di Montecassino, il grande Desiderio, rinuncia 107 pubblicamente alle pretese della sua abbazia montana su quella marina di Santa Maria di Tremiti. Poi sarà eletto papa: ciò che esce dalla porta rientra per la finestra. Si sa che Alberto muore il 5 aprile di un anno imprecisato attorno alla fine del Mille e viene proclamato ‘santo subito’, come si vorrebbe oggi a ogni morte di papa. Fa un effetto strano entrare nella pianta della sua cattedrale. A terra e nei bassi muri laterali, fino alla traccia di abside, abbiamo tutto quanto ci serve per immaginare la chiesa eretta. L’Università di Foggia anno dopo anno arricchisce la vista e la conoscenza. Le due torri angioine di facciata, che al sindaco Saverio richiamano quelle di Acerenza. Le arcate di cui si vedono i basamenti dei pilastri. Una cappella sulla sinistra, e poi vicino all’abside alcune aperture non ancora comprensibili. Sulla testa però abbiamo il sole della tarda estate. Sant’Alberto fuit hic, è chiaro. 108 109 TIATI La cité obsesse aux murs hommes & femmes Ennemis hors le chef prestz à foy rendres Vent sera encontre les gens-darmes Chassés seront par chaux, poussiere et cendre (IV, 52) L’ETR 450 è uno dei modi più esaltanti di addentrarsi nelle Terre Foggiane attraverso lo spessore del tempo. Forse perché fra tutti i treni addetti alle velocità sostenute, non diciamo alte, è il più antico e il più affidabile: lo vedevamo quarant’anni fa asserpentarsi tra Roma, l’Umbria e le Marche torcendosi sulle curve. Toccava l’Adriatico in meno di tre ore. Adesso un po’ imbellettato, e quindi meno sincero, perfino rallentato dalla sfiducia nel giunto cardanico che gli dette il nome ‘pendolino’, lo troviamo a fare il servizio Eurostar tra Roma e Foggia. Un avvicinamento al capoluogo daunio che è come sfogliare la sua storia. Aversa è una stazione insapore, e in teoria non dovremmo fermarci; ma giustamente lo facciamo quasi sempre. Forse come riconoscimento al primo Stato normanno in Italia? E’ il 1030 e il duca bizantino di Napoli, Sergio IV, investe della Contea di Aversa il ‘padrino’ di una delle famiglie avventuriere calate dalla Normandia: Rainulfo Drengot Quarrel. Aversa, anche vista dai binari, è una collocazione troppo vicina a tutte le ‘centrali’ politiche del Mille: vicina ai Longobardi del principato di Capua, della capitale Benevento, della ‘capitale morale’ Salerno che si estendeva a tutta la Lucania; vicina alla frangia bizantina di Napoli, confinante; e a Roma pontificale, che è sulla strada. Il duca Sergio ha le sue ragioni per avviare la sedentarizzazione delle bande venute dalla Normandia: ragazzi di grande bravura, pochi scrupoli, senso familiare e forte istinto predatorio. Sapranno loro come colonizzare tutta l’Italia meridionale e la Sicilia. E comunque è qui a Aversa che ha inizio que111 sta storia. Il punto d’arrivo sarà Tiati, o Civitate, dove il quinto signore di Aversa, Riccardo, darà nel giugno 1053 il colpo decisivo alla ‘vecchia’ Italia centro-meridionale e insulare. A Caserta ci raggiunge la ferrovia da Roma via Frosinone, che connette gli ozi annibalici di Capua con l’operosità benedettina di Cassino: laboriosità innescata con la preghiera, e capace di fiorire in santità, in sapienza e in potere. Ai nostri tempi – cioè a quelli di cui parliamo adesso: gli anni dell’abate Desiderio – è soprattutto potere. Stazione di Telese Cerreto: a volte i treni si fermano. Alessandro di Telese, abate di San Salvatore, è la fonte principale per la storia di Ruggero II. Solopaca è un piacere pensarla come allegra terra di vino prima di arrivare a Benevento. La capitale longobarda, saldamente legata a Roma chiunque vi incarnasse il potere, dalla stazione non si vede. Ugualmente ci si fanno incontro storie e personaggi di epoca sannitica, romana, longobarda, papalina. Le janare, streghe eponime del famoso liquore. E poi una serie di battaglie che per istinto leggiamo come sconfitte: nelle guerre sannitiche, nel tentativo di espansione di Pirro re dell’Epiro, nelle guerre puniche con Annibale, per finire con l’uccisione di re Manfredi biondo, bello e di gentile aspetto. Chi ha letto qualche libro in più fa memoria della scrittura beneventana, dei codici liturgici miniati, della musica sacra un po’ cruda tra il gregoriano e il canto ortodosso (ma sarebbe più interessante cercarvi una eco germanica o scandinava che i Longobardi vi hanno sicuramente immesso). Da Benevento in avanti siamo in mano a un monumento di archeologia ferroviaria: la prima linea elettrificata a corrente continua. Non si fa in tempo a salire l’Appennino che ecco un altro colpo della storia: Ariano degli Hirpi, popolazione sannitica; nodo stradale dal Neolitico fino ad oggi, e per questo motivo oggetto di concupiscenza da parte di chiunque abbia avuto in potere il Meridione: dai Romani ai Goti ai Longobardi ai Normanni agli Svevi agli Angioini agli Aragonesi, per non parlare dei Saraceni a cui nessun luogo praticamente è sfuggito. Ora scendiamo in Capitanata imbucando gallerie che sembrano restringersi, ogni tanto sarà effetto ottico o terreno argilloso? L’ETR 450 ci ha fornito mille suggestioni e qualche comprensione nuova; ed ecco 112 Orsara con la sua Grotta, sorella minore di Monte sant’Angelo, e subito dopo Bovino, nella cui cattedrale una facciata asimmetrica fa velo all’interno dalle delicate proporzioni greco-normanne. Troia, peraltro del tutto virtuale come stazione, è la dama bella, superba. E fedele: prima a Roma poi ai Bizantini, che le tolgono il nome storico, Aecae, per farle indossare questa denominazione gloriosa. E ormai corriamo nella bassa valle del Cervaro, già illuminata dai fuochi della prima apparizione mariana del millennio passato. Ci raggiunge sulla destra la ferrovia da Ordona e Ascoli Satriano e da Melfi, nel 1042 capitale dei Normanni di Puglia. Poco dopo, dalla stessa parte, ci affianca la linea dorsale adriatica che ha appena scavalcato l’ ‘Ofanto tauriforme’ di Orazio, e ha superato Canne della Battaglia (ma sappiamo che ne ha ospitata più di una: ci sono dei siti nati per battaglie) e la terra delle Saline. Subito arriviamo a Foggia con la voglia di diramarci, sempre in treno, o verso Siponto e Manfredonia, o verso San Severo e il Gargano, o verso Lucera con la ferrovia in costruzione. Oppure a nord, fino al Fortore. Sulle sue sponde ci aspetta una meta fatale per tutto il Meridione: Teanum Apulum sulla Peutingeriana, poi Civitate, o Civitella sul Fortore, ora San Paolo Civitate. Insomma Tiati, se parliamo osco come ogni buon Sannita. La città che porta questi nomi migra leggermente, nei millenni, per il territorio che si affaccia da sud sul Fortore. Il Museo di San Paolo Civitate raccoglie documentazione assai interessante sulle fasi della comunità tiatina. Civitate, per chi perlustra un po’ faticosamente il sito, offre ancora qualche muraglia forse romana, forse medievale, oltre a una fattoria in piena attività. Però scendendo abbasso con un largo giro si incontra in riva al fiume un’area attrezzata – alberi, panche, una chiesetta, un edificio diruto più antico – che è il luogo preciso della battaglia che ha dato luogo a una svolta decisiva nella storia d’Italia. Un cippo ben visibile ci assicura: è proprio quello il posto della battaglia di Civitate, 18 giugno 1053. 113 Civitate, 18 giugno 1053 Qui sulla riva del Fortore vengono ad annodarsi diverse storie che troveranno uno scioglimento inatteso e gravido di futuro. Grandi personaggi si trovano di fronte, sotto il colle da cui gli abitanti di Civitate traggono auspici sulla loro sorte. C’è il grande e rosso alsaziano Leone IX. C’è Roberto il Guiscardo ancora giovane. C’è una massa di gente. Per Dante è addirittura un benchmark di qualunque adunata oceanica (Inf. XXVIII): S’el s’adunasse ancor tutta la gente che già in su la fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente… per contrastare a Ruberto Guiscardo... L’esito della battaglia rappresenta un punto di svolta repentino e perfettamente inteso da tutti nei suoi significati simbolici e politici. Le fonti storiche principali sono tre. Uno è Geoffroi Malaterra, benedettino normanno cresciuto in Sant’Eufemia e morto in Sant’Agata a Catania. Scrive il ‘De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis’. Il secondo è Amato di Montecassino, che non è un normanno ed esprime il punto di vista della grande abbazia rispetto ai fatti in oggetto. Aveva scritto in latino, ma per nostro divertimento la sua opera ci è giunta in una traduzione franco-italiana, ‘L’Ystoire de li Normant’: sembra di sentire una signora parigina che si sforza di chiedere indicazioni a un vigile di Napoli. Il terzo è il più esposto politicamente: Guglielmo di Puglia con le ‘Gesta Roberti Wiscardi’. Di questo Guglielmo non si sa molto, ma fa capire che odia gli ‘effeminati greci’ e quindi potrebbe essere longobardo. Lasciamo per ultima la Signora, la principessa della storia medioevale: Anna Comnena, che a lode del padre scrive il poema ‘Alexiade’. Quando lei era piccola, Alessio I Comneno aveva combattuto e sconfitto Roberto il Guiscardo nei Balcani; quindi ci aiuta a capire la personalità del vincitore morale della battaglia di Civitate (o meglio, di quello che riuscì a spendersi mediaticamente la vittoria). 114 Cercheremo di capire che cosa è veramente successo, seduti sotto i pini che allietano il sito di tanta strage. Com’è il fatto Il massimo player e promotore della battaglia è il papa Leone IX, già Brunone vescovo di Toul. Egli era asceso al soglio di Pietro con estrema riluttanza, giacché i predecessori erano stati metodicamente eliminati da fazioni del Sacro Collegio. Suo sponsor è il cugino, l’imperatore Enrico III di Franconia. La situazione dell’Italia, specie nel Sud, è funestata dal dilagare delle bande normanne: non dal 1016, come cerca di far credere Guglielmo di Puglia per tagliar via la parte peggiore, ma anche da prima. Il Meridione è da decenni più o meno in stallo tra l’autorità legittima dell’imperatore ‘romano’ di Bisanzio e gli Stati longobardi mai veramente diventati grandi: Benevento, Salerno, Capua (si ricorda, anni fa, una mostra a Brescia sui Longobardi del Sud, senza niente che attirasse l’attenzione). L’arrivo e la percolazione delle bande normanne mette in agitazione lo status quo. La ragione politica, e probabilmente la vicinanza etnica (sono tutti Germani di Scandinavia), fanno sì che il nazionalismo longobardo imbelle veda in questi mercenari bravi un possibile strumento di riscatto. Abbiamo così le due rivolte ‘separatiste’ a Bari guidate da Melo, e abbiamo il figlio Argyrio che invece viene educato a Bisanzio prima come ostaggio, poi come consigliere degli imperatori sulle questioni riguardanti il Catapanato d’Italia. Se Bisanzio fibrilla per i Normanni, Roma ancora di più: teme per la sicurezza e l’integrità dello Stato pontificio e dei suoi ormai naturali alleati, i Longobardi. Poi c’è un pianto e una protesta continua che arrivano in alto loco dalle popolazioni pugliesi malversate e dai pellegrini che, per raggiungere il Gargano, devono mettere in palio insieme la borsa e la vita. Papa Brunone compie diversi sopralluoghi e si rende conto che la situazione creata dai Normanni è intollerabile. Ne scrive all’imperatore di Bisanzio, ne parla vis-à-vis a quello di Germania nel 1051. Dalla Germania nulla, ma con Bisanzio arrangia un accordo il 115 giovane Argyrio. La tela incomincia a essere tessuta. Il papa sollecita anche Guaimario, il principe longobardo di Salerno, ma egli era in parola con Roberto il Guiscardo per dargli in moglie la sorella Sichelgaita, famosa virago guerriera, quindi si schiera contro la coalizione; e male gliene incoglierà: quando ci sono di mezzo i Bizantini, si sa, i confini tra il lecito e l’illecito sono sempre discutibili, e soprattutto superabili. Intanto comincia la campagna di preparazione morale. Amato di Montecassino enumera i prodigi che in varie parti del territorio annunciano sciagure. Nasce un bimbo con un occhio solo in mezzo alla fronte, gli zoccoli e la coda. Un altro con due teste. A Montecassino stessa l’olio di una lampada da chiesa si muta in latte. Chiaro segno della prossima morte di Guaimario. Infatti. Saranno i Normanni a riportare sul trono l’orfano Gisulfo. Il rullo dei tamburi s’appressa. Papa Leone ritorna in Germania, ma tutto quello che ottiene è di arruolare a sue spese settecento fanti svevi. Attorno a questo nucleo si aggrega, via via che Leone scende lungo l’Italia, della soldataglia minore. Giunti a Benevento, centro logistico delle operazioni, l’esercito è numeroso davvero. Ma assolutamente scombinato, come si vedrà. Accedono anche diversi prìncipi dell’Italia meridionale: Gaeta, Aquino, Teano, Amalfi; e poi dalla Marca di Ancona, da Spoleto, dalla Puglia stessa. La strategia concordata con i Bizantini di Argyrio è la seguente: attanagliare i Normanni che presumibilmente saranno disposti a difesa dei simboli della nazione: la fresca capitale Melfi e il duca Umfredo. L’appuntamento è a Siponto: Argyrio viene sù dal Salento, Leone scende da Roma. I Normanni possono soltanto impedire che avvenga il congiungimento tra i due temibili eserciti. Così Umfredo impegna e sconfigge Argyrio sotto Siponto; a Crotone, nel salire, il calabro Guiscardo batte il protospatario Sicone. Leone, da Benevento, occupa Civitate. Messi normanni chiedono un ripensamento, hanno fame, sono disposti a riconoscere l’autorità feudale del papa. Ma non se ne fa di nulla. Gli Svevi pensano: siamo venuti fin qua soltanto per fare conversazione? E così decolla la battaglia di Civitate del 18 giugno 1053. 116 Primo assalto: il conte normanno Riccardo d’Aversa contro gli Italiani e Longobardi. Sembravano lì per caso, per passione ma senza alcuna preparazione bellica. Vengono messi in fuga in un momento. Secondo assalto: Umfredo contro la falange sveva. Con loro, che sono dei professionisti, è molto più dura. Presi in una tenaglia pene omnes occubuerunt: muoiono quasi tutti. Pare che scavando nel luogo siano stati trovati molti scheletri di persone alte più di un metro e ottanta. Leone si rinchiude in Civitate, ma gli abitanti trovano più conveniente indicargli l’uscita. A questo punto il gran coup de théâtre: Roberto il Guiscardo si inginocchia davanti al Santo Padre, gli bacia la pantofola, chiede perdono per la sofferenza inflitta e gli promette che d’ora in avanti saranno loro, i Normanni, a occuparsi della sua sicurezza. Questo è puro genio politico. Sottomettendosi al papa, i Normanni sottometteranno senza discussioni tutta l’Italia meridionale. Nel 1059 al Sinodo di Melfi il papa Nicolò II investirà Roberto conte di Puglia, Calabria e Sicilia (quest’ultima però ancora da riscattare dagli Arabi). I racconti dei testimoni Adesso che sappiamo com’è andata, seduti all’ombra dei pini sul sito della battaglia, ascoltiamo i particolari dai testimoni dell’epoca. Le premonizioni (Amato di Montecassino, in franco-napoletano). “Puiz que fu seu par publica fame que li Pape venoit, molt en estoient alegre”. C’era chi godeva dell’avvicinarsi del papa. Ma Giovanni, vescovo di Salerno, era stato tormentato da una visione. Afflitto dalla malattia che aveva (non si sa quale) decide di compiere un rito paganissimo: la incubatio. Si fa stendere accanto alla tomba di San Mattia apostolo, si sfoga con lui, e tra il dolore e il parlare si addormenta. Quindi San Mattia gli appare e gli dice: “Je te promet que tu es guari de ton infermeté. Més je te prophetize que la mort non est trop long”. Per adesso ti guarisco ma la morte ti si avvicina. E aggiunge: “Li Pape vient avec vilz chavaliers pour chacier; més li sien seront destruit, et espars, et en prison, et mort. Et puiz ceste 117 cose, retornera à Rome et sera mort”. Muore anche il Papa, ma prima, con un esercito da poco, si prenderà una bella sconfitta. E adesso viene il meglio. “Quar c’est ordené devant la presence de Dieu, quar quicunques sera contre li Normant, pour les chacier, ou tost morira, ou grant affliction aura. Quar ceste terre de Dieu est donnée à li Normant”. Chiaro? E’ Dio che ha dato questa terra ai Normanni, e chi si mette contro di loro ne avrà morte immediata o afflizione grande. “Et puiz lo evesque se resveilla tot sain et salve. Et ensi comme lui fu dit en avision, ensi fu fait”. I tentativi diplomatici dei Normanni (Guglielmo di Puglia). “I Normanni, sebbene si distinguessero per armi sfolgoranti, temendo di non resistere alla vista di tante schiere, mandarono ambasciatori per chiedere un trattato di pace e per pregare il papa di accogliere con benevolenza il loro omaggio. I Teutonici, che si distinguevano particolarmente per capigliatura, bellezza fisica e statura, deridevano i Normanni, che apparivano fisicamente più bassi, e non prendevano in considerazione i loro messaggi, considerando quel popolo inferiore per numero e per forze. Si rivolsero al papa con parole superbe ed animo ostile: ‘Ordina ai Normanni di gettare le armi, di abbandonare l’Italia e di ritornare nel loro territorio. Se si rifiutano, noi vogliamo che tu respinga le loro proposte di pace e non tenga conto dei loro messaggi. Essi non hanno ancora sperimentato le spade teutoniche. Muoiano colpiti dalle nostre spade o siano costretti ad andarsene e ad abbandonare a malincuore questo suolo che non vogliono abbandonare volontariamente’. Il papa, anche se per diversi motivi non era d’accordo con quei facinorosi, non riuscì a calmare gli animi: gente superba era!” Appartengono a loro gli altissimi scheletri scavati sotto Civitate. I guerrieri normanni (Guglielmo di Puglia, Anna Comnena). “Tra i capi normanni i più prestigiosi erano ritenuti Umfredo, sopravvissuto alla morte del fratello Drogone, e Riccardo, poco prima nominato conte nella città di Aversa. Un po’ più giovane, Roberto superava i fratelli maggiori per il suo straordinario valore: costui prese parte a quella guerra. Era soprannominato Guiscardo, poiché superava in astuzia Cicerone e lo scaltro Ulisse”. 118 “Roberto apparteneva a una famiglia minore tra i Normanni. Di temperamento tirannico, astuto di pensiero e coraggioso nell’azione, estremamente ingegnoso nel pianificare attacchi alle ricchezze di facoltosi possidenti e ancor più ostinato nel metterli in pratica: non tollerava alcun ostacolo alla realizzazione dei propri disegni. Era di statura notevole, tale da superare anche i più alti fra gli individui; aveva una carnagione rubiconda, capelli di un biondo chiaro, spalle larghe, occhi come scintille di fuoco, e nel complesso era di bell’aspetto. Si racconta che il grido di quest’uomo avesse messo in fuga intere moltitudini. Con queste doti di fortuna, di fisico e di carattere, egli era per natura indomabile, mai subordinato ad alcuno”. Questa è Anna Comnena, si capisce il tocco femminile. I guerrieri Teutonici con il papa (Guglielmo di Puglia). “In una battaglia la vittoria non dipende né dal numero dei cavalli né dai soldati né dalle armi, perché è il Signore dei cieli che la concede. Tra i Teutonici e le truppe normanne s’ergeva in mezzo un colle. In aiuto dei Teutonici erano giunte folte schiere di Puglia, Valva, Campania, Marsica, Chieti. Guarniero e Alberto, capi dei Teutonici, avevano con sé non più di 700 Svevi, uomini coraggiosi e di animo feroce ma incapaci di combattere a cavallo. Essi colpiscono più efficacemente con la spada che con la lancia. Le loro spade sono particolarmente lunghe e assai taglienti; spesso colpiscono il corpo dalla testa e lo spaccano in due e se disarcionati restano fermi sui piedi. Preferiscono morire combattendo piuttosto che fuggire”. Gli schieramenti per la battaglia (Guglielmo di Puglia). “Non è il caso di citare nei miei versi la massa dei nemici venuta per cancellare il nome del popolo normanno. Tutti costoro si erano accampati insieme ai Teutonici presso la riva del fiume Fortore, nei pressi della città che prende il nome dai suoi cittadini. I Normanni si armano e sull’ala destra dello schieramento pongono Riccardo conte d’Aversa, col compito di attaccare i Longobardi. Lo accompagna il primo valoroso squadrone di cavalieri, mentre Umfredo viene scelto come comandante della schiera centrale che deve opporsi ai forti Svevi. Riceve l’ordine di difendere l’ala sinistra, insieme ai Calabri, 119 suo fratello Roberto, col compito di intervenire tempestivamente in aiuto degli alleati in caso di necessità e per ristorarne le forze. I Teutonici avevano collocato la loro ala destra contro le due ali, mentre sull’ala opposta stavano gli Italici ammassati tutti insieme, perché in caso di scontro non sapevano disporre in giusto ordine le loro schiere”. I Normanni attaccano gli Italiani e gli Svevi (Guglielmo di Puglia). “Contro di essi incomincia ad attaccar battaglia per primo Riccardo, che li assale con coraggio. Gli Italiani non resistono all’assalto: le loro forze vengono scompigliate, tutti vengono assaliti dal terrore e, volti in fuga, corrono disordinatamente per valli e per monti; molti l’impeto stesso della fuga travolge e getta a terra. Vengono uccisi così da frecce e da spade. Fuggono gli Italiani, ma per quelli catturati da lui e dai suoi compagni non c’è alcuna possibilità di fuga. Lì muoiono in battaglia moltissimi Italiani, la maggior parte fugge. Gli Svevi ingaggiano un combattimento contro le truppe del prode Umfredo; dapprima Umfredo li attacca da lontanto con le frecce e a sua volta si espone alle frecce dei nemici; infine entrambe le schiere ricorrono alle spade, con le quali vengono vibrati da entrambe le parti colpi incredibili; là si sarebbero potuti vedere corpi umani decapitati e cavalli abbattuti insieme ai cavalieri”. Ma non dovevano esserci i Longobardi a spalleggiare le truppe tedesche? (Amato di Montecassino) “Et li Thodeschi se reguardent derriere pour veoir lor compaingnie; més nul Longobart venoit aprés eauz, quar tuit s’en estoient foui. Cestui Todeschi qui iluec se troverent furent tuit mort: nul non eschappa, se non aucun à qui li Normant vouloient pour pitié pardoner. Et secuterent ceus qui fuyoient, et les prenoient et occioient” Esordio di Roberto il Guiscardo (Guglielmo di Puglia) “Roberto, visto il fratello accanitamente incalzato dai nemici per nulla disposti a dargli respiro si scaglia con foga in mezzo ai nemici. Alcuni trafigge con la lancia, altri decapita con la spada, e con le sue mani possenti vibra colpi terribili; combatte con entrambe le mani e dovunque decida di colpire va a segno sia con la lancia che 120 con la spada. Tre volte disarcionato, tre volte riprende vigore e torna a combattere con maggiore efficacia, perché è il furore che lo stimola. Così Roberto non cessa di far strage con diversi tipi di morte degli Svevi che gli si oppongono; ad alcuni tronca un piede, ad altri le mani, ad altri sfracella il capo e il corpo; ad alcuni taglia a pezzi il ventre e il petto, ad altri trafigge le costole dopo aver tagliato il capo, rendendo i grandi corpi mutilati simili ai piccoli e dimostrando che non sempre agli uomini più dotati fisicamente tocca il premio alla bravura, di cui spesso sono dotati i più esili. Come è stato provato al termine dei combattimenti, in questa battaglia nessuno, vincitore o vinto, ha vibrato colpi così pesanti”. Riccardo di Aversa, il colpo decisivo (Guglielmo di Puglia). “Mentre ritorna dopo aver compiuto ingente strage di Italiani, di cui una parte fugge, un’altra viene uccisa da spade e da lance, allorché vede che così i Teutonici resistono ai suoi compagni, esclama: ‘Ahimè, la vittoria che noi credevamo acquisita con la fine del combattimento, non ha ancora posto fine alla battaglia!’; e senza indugio si scaglia nel mezzo dei nemici. Costoro, persa ogni speranza di fuga e di salvezza, resistono con maggior violenza, ma a nulla giova la loro resistenza, perché vengono circondati dalla moltitudine dei nemici. La gloriosa armata del vittorioso Riccardo è causa di grave rovina per i nemici che, miseri, vengono annientati con diversi tipi di uccisione, e di tanta moltitudine non sopravvive nessuno”. Il dramma di Leone IX (Goffredo Malaterra, Guglielmo di Puglia, Amato di Montecassino). “Apostolicus, fuga vitae asylum expetens, intra urbem provinciae Capitanatae, quae Civitata dicitur, sese profugus recepit. Il Padre apostolico cerca rifugio in Civitate. Quem hostes insequentes, armato milite obsident: aggeres portant, machinamenta ad urbem capiendam parant, incolas minis terrent, ut apostolicum reddant. I Normanni lo incalzano, pongono assedio con soldati armati, allestiscono dei terrapieni, preparano macchine per sferrare l’assalto, minacciano gli abitanti perché consegnino il papa. Si tratta, ma solo a tutela della città; quanto al papa, eum per portas eiciunt: lo sbattono fuori dalle porte”. 121 “La popolazione normanna lo venera e gli chiede perdono in ginocchio. Il papa accoglie benevolmente i supplicanti, che tutti insieme gli baciano i piedi. Egli li ammonisce con parole benigne e li benedice, si lamenta molto per avere essi disdegnato le proposte di pace (era vero l’esatto contrario, ma in certi momenti è più elegante tacere) e prega piangendo per i fratelli defunti”. “Et quant ce fu fait, li Normant s’en alerent à lor Terre. Li Pape avoit paour, et li clerc trembloient. Et li Normant vinceor lui donnerent sperance, et proierent que securement venist lo Pape. Liquel menerent, o tout sa gent, jusque à Bonivent; et lui aministroient continuelment pain et vin et toute choze neccessaire”. Umfredo accompagna il papa a Benevento, che è città appartenente alla Santa Sede, e in viaggio gli offre continuamente pane e vino. Aveva bisogno di tirarsi su di morale, povero Brunone! Tant’è che sempre scortato dai Normanni rientra a Roma, dove muore dieci mesi più tardi “et fist molt miracle”. Ma avevamo incominciato con la profezia di San Mattia all’Arcivescovo di Salerno, Giovanni. E infatti “lo Archevesque de Salerne, loquel avoit veue celle avision, à li .v. mois et .VI. yde de septembre, fu mort”. E per finire, “a li Conte de Puille vindrent autre frere de la contrée de Normendie, c’est assavoir Malgere, Gofrede, Guillerme et Rogier”. Siamo al Sud e c’è sempre una famiglia numerosa da sistemare. Conclusione. “Cresce a dismisura il coraggio dei Normanni vincitori, ai quali ormai non si ribella più alcuna città di Puglia. Crescit Normannis animus victoribus ingens, iamque rebellis eis urbs appula nulla remansit. Guglielmo di Puglia dixit. Profezia e morte di Roberto il Guiscardo (Anna Comnena). “Roberto non si fermò nemmeno dopo questa sconfitta (nei Balcani contro suo padre Alessio I) e avendo già inviato una nave con suo figlio a Cefalonia e il resto della flotta e dell’esercito a Boditza, egli 122 stesso, in viaggio per ricongiungersi col figlio, fece ancorare la sua galea a Cefalonia nei pressi del capo Atheras dove fu preso da una febbre molto alta. L’arsura lo spinse a chiedere acqua freschissima, tutti i suoi uomini ne andarono in traccia. Uno del luogo mostrò loro l’isola di Itaca dirimpetto, dicendo che un tempo sull’isola c’era una città chiamata Gerusalemme, ora caduta in rovina, e tra le rovine c’è una fonte di acque gelide. Roberto si spaventò al sentire che era in prossimità di Gerusalemme perché tempo addietro degli indovini gli avevano profetizzato che quando sarebbe stato ad Atheras avrebbe riunito tutti i popoli sotto il suo dominio, ma da lì sarebbe partito per Gerusalemme e là avrebbe pagato il suo debito alla Natura. Infatti se morì di febbre o di pleurite non saprei dire con certezza ma fatto sta che in sei giorni fu spacciato. Sua moglie Sichelgaita arrivò giusto in tempo per vederlo prima che spirasse e vide anche il figlio chino su di lui e in lacrime. Quindi con tutti loro partì per la Puglia. Durante la traversata scoppiò una terribile tempesta nonostante si fosse d’estate. Molte navi fecero naufragio e le più fortunate furono sbattute a riva e andarono in pezzi. Anche la nave con il cadavere del padre fece naufragio ma i marinai riuscirono a costo della vita a salvare la bara che fu traslata a Venosa. Roberto fu sepolto nell’antico monastero dedicato alla SS.ma Trinità dove i suoi fratelli erano stati sepolti prima di lui. Roberto era morto dopo 25 anni di regno, il suo titolo era di Duca e aveva 70 anni. Un matematico di nome Seth (che, detto così, suona un po’ come il Mago di Arcella), molto esperto anche di astrologia, aveva predetto il destino di Roberto dopo il suo passaggio in Illiria; aveva scritto la sua predizione su un foglio, l’aveva sigillato e inviato agli intimi del duca pregandoli di non leggerlo prima di una data stabilita. Dopo la morte di Roberto, questi dissuggellarono la lettera e lessero la predizione che era: ‘Un grande nemico proveniente da ovest cadrà improvvisamente dopo aver generato grande confusione’. Ciò creò enorme meraviglia per la sapienza del profeta – infatti costui aveva approfondito moltissimo questa scienza che, mi si consenta una divagazione, ha fatto grandi progressi in questi ultimi tempi…“. 123 Ma il peggio deve ancora venire Papa Leone continua a sentirsi a disagio per la protezione esibita dai Normanni. Cerca di raccattare i cocci con Bisanzio e manda la famosa ambasceria al fratello patriarca di Costantinopoli (la Chiesa è ancora una, fino a quel momento) e all’imperatore d’Oriente, che solo poteva contrappesare i Normanni del Sud. Ma se cercava da parte bizantina flessibilità e disponibilità, Leone manda giù, inspiegabilmente, le tre persone più rigide e meno aperte all’ascolto che avrebbe potuto trovare nella sua Curia: Umberto di Silvacandida, Federico di Lorena e Pietro arcivescovo di Amalfi. Tra un imperatore malaticcio, un patriarca Cerulario livoroso e isterico, un papa stanco, due cardinali convinti di essere la Verità e un arcivescovo della stessa opinione, il dramma corre veloce verso la catastrofe. Leone IX fa il massimo per evitare l’inevitabile: muore. E’ una soluzione brillante: la morte del papa delegittima gli ambasciatori, che dovrebbero solo rientrare in sede. Ma i tre prelati, in delirio di onnipotenza, compiono il gesto irreparabile che abbiamo sentito raccontare a Devia. E’ il 1054. Rotta l’unità della Chiesa, è perduto per sempre l’appoggio dell’imperatore d’Oriente, mentre con quello d’Occidente si sta aprendo la secolare quérelle sui poteri rispettivi delle due Istituzioni. Ma con grande prontezza la Sede apostolica fa di necessità virtù. E’ vero che non le mancherà, fino al 1870, qualche legione sul cui numero Stalin si interrogava con sarcasmo caucasico. Però di un protettore terreno c’è sempre bisogno. E allora, messi da parte gli imperatori lontani, chi meglio dei Normanni, volenterosi e piano piano anche un po’ evoluti, può reggere la staffa alla pantofola pontificia? E così ha inizio un racconto lungo diversi secoli, che passa per i re normanni di Sicilia e la loro civiltà raffinatissima e interamente ‘mediterranea’; poi per Federico II e Manfredi, assai mal visti; poi per gli Angoini, gli Iberici, i Borboni, i Savoia, la Repubblica. Fino a oggi. E comunque molto di questo passa per le Terre Foggiane. 124 125 FIORENTINO Le Sol & l ’Aigle au victeur paraîtront: responce vaine au vaincu on asseure, par cor me crys harnoys n’arresteront vindicte, paix par mort si acheue à l’heure (I, 38) 13 dicembre 1250 Hosara! Questa smania di falconeria, non riesco a resisterle. Non mi è bastata la caccia sul greto del Taro, due anni fa. Sembra ieri. Seguivo la picchiata del Shahin su un airone quando ho visto alzarsi le colonne di fumo… La mia effimera capitale data alle fiamme – l’avevo chiamata Victoria, figuriamoci! I Parmigiani trionfanti hanno saccheggiato e fatto festa a uno sciancato che inalberava la corona imperiale. Il segno del Sacro Romano Impero. Per non dire della camera imperiale. Le reliquie. Le sete preziose. I manoscritti. I miei soldati arabi, pugliesi, tedeschi trucidati con rabbia. E le mie suonatrici arabe, le danzatrici, i compositori di musiche, i poeti. Se Cremona non mi avesse aperto le porte, adesso non sarei qui nemmeno io. Da allora ho dovuto imparare a proteggere la mia vita. E anche il mio sangue. Tra figli e figlie, legittimi o nati da amori di fuoco, la mia discendenza è come quella di Abramo. Occupa tutta la terra. Prima di partire per questa maledetta caccia oltre il Fortore ho scritto una lettera in greco a mio genero, l’imperatore di Nicea. Per evitare malintesi è meglio scrivere nella lingua degli altri. Costanza ha i suoi problemi, povera figlia mia, con quella marchesa Fricka che le ruba il letto e la confidenza di suo marito. Ma in fondo non è importante. Basta che la marchesa non dia un figlio all’imperatore Giovanni. Ne so qualcosa delle dame di compagnia delle mie mogli. Un giorno mi dovrò pentire, credo. 127 Il punto è che Giovanni sta tessendo rapporti per riprendersi Costantinopoli. Ma si muove male, è ingenuo e prende iniziative avventate. Non ha idea delle persone né dei rapporti di forza. Ho dovuto bloccare la sua ambasceria al pontefice. Gli ho scritto, come un padre al figliolo, anche se ha la mia età. Io nelle questioni d’Oriente non prenderei iniziative senza il suo consiglio. Faccia lo stesso lui in Occidente. Chi conosce meglio di me i Paesi e i regnanti? A partire dai papi. Ho dovuto essere duro con lui: gli ho anche detto che i papi non sono arcivescovi di Cristo ma lupi rapaci, belve inferocite che divorano il gregge di Cristo. “Ouk archiereis allà lykoi àrpaghes, theres agrioi kathestìontes ton laòn tou Christou”. Ma non c’è da farsi illusioni: i Selgiuchidi di Rum ormai controllano l’Anatolia, e piano piano travolgeranno tutto. Il sultano di Konia ha dietro di sé, dai monti dell’Altai fino alla pianura di Nicea, tutta una marea che preme verso la Città, come la chiamano loro: Sten polin, Stan bul. Gli avidi crociati e i papi fanatici hanno distrutto la forza di Bisanzio, e prima o poi Costantinopoli sarà la capitale dei Turchi. E credo proprio che non si fermeranno lì. Avrei proprio soddisfazione se un giorno che non vedrò arrivassero alle mura degli Asburgo. “E l’ora tardi mi pare che sia” Già mi sento poco tranquillo in questo castelletto. Due stanze lunghe al piano terreno. Non mi sembra di esserci mai stato. Volevo ritornare a Lucera dai miei medici arabi. Ma Pietro Ruffo non ha voluto. Nemmeno Giovanni da Procida. Ero prosciugato, e il fuoco stava prendendo il sopravvento sugli altri temperamenti corporali. Adesso mi pare che la febbre stia tornando. Questo dolore di ventre che non mi lascia. Almeno ci fosse ancora Michele Scoto, mago naturale. Mi dava energia con i suoi filtri. Mi chiamava malleus orbis, il martello del mondo! Ma nella sua Salerno dicono contra vim mortis non est remedium in hortis. Non c’è la pianta che vinca la morte. Morirai sub flore, la profezia di Michele. E tutta la mia vita è stata un gioco nell’evitare le città denominate con un fiore, in Italia e in Germania. Firenze, Fiorenzuola, Rosenheim, Blumenthal, Montefiore; anche l’abbazia di 128 San Giovanni in Fiore del buon abate Gioachino… che non mi ama molto, dicono. Peccato, eravamo fatti per intenderci. Dai vetri delle finestre vedo Lucera verso sud. Anzi tutta la Capitanata. Siamo su un monte? Io mi ricordo una strada in salita, ieri; mi sentivo scivolare dalla lettiga. Riccardo di Montenegro mi teneva. Siamo entrati per una grande porta. Tutta la gente nella platea magna, anche se era notte. Bertoldo di Hohenburg faceva largo. Davanti alla chiesa di San Michele un vescovo mi ha benedetto. Aveva una pisside incastonata di venturine azzurre. Forse orientale. Magari è stato un sogno. Adesso sono qui, e non vedo l’ora di andarmene. Appena recupero le forze, a Lucera dai miei. O magari al Pantano di Foggia, per rimettermi in salute con le acque fresche dei giardini e con qualche partita di caccia. Saranno arrivati i leopardi da Malta? “Che nulla medicina me non vale” Mi sento perdere, ogni tanto. Non era mai successo. La testa è come si svuotasse di pensieri. Un medico non c’è? A Salerno ho la scuola migliore del mondo, e nessuno dei professori è qui per curare l’Imperatore. Eppure ho fatto molto per loro. Gli ho creato un mercato captivus: chi esercita la medicina nel Regno senza essere laureato a Salerno perde tutti i suoi averi e un anno di vita. Ma Salerno non è il massimo della medicina moderna, devo ammetterlo. Esisteva prima di me. La mia università è quella di Napoli. Greci, Arabi, Ebrei, Tedeschi, Italiani, le migliori intelligenze riunite per creare il mio Studium. Da un quarto di secolo è il più importante del mondo. Mi piacerebbe che portasse il mio nome nei secoli a venire. Ho creato tutte le condizioni per attrarre i maestri e gli scolari. Ho proibito di andare a studiare all’estero: non amo la fuga dei cervelli. Napoli poi è bella e dolce di suo: me lo diceva anche il figlio di Landolfo d’Aquino, quel giovane frate Tomaso predicatore che ha studiato lì filosofia prima di trasferirsi a Parigi per la teologia. Chissà se è sempre così grasso? A Napoli gli hanno incavato un tavolo perché non arrivava a leggere bene i libri. 129 Mentre Bologna erige mausolei ai suoi professori di diritto, Napoli e Salerno studiano la natura. E la Sorbona, dove passano la vita in dibattiti senza senso? No, un senso ce l’hanno, ma è sempre diverso da quello che appare. E’ politica, soprattutto. Quel cancelliere dell’Università, Eudes di Châteauroux, è riuscito a bruciare il Talmud perché contiene falsità filosofiche. Bruciare un libro sacro è sempre blasfemìa! O quel chierico che hanno evirato perché amava una scolara. Ha scritto una confessione, ‘Historia calamitatum’. Ma Abelardo è un un intellettuale, un arrivista, un uomo freddo. C’è più calore nelle canzonette di mio padre. “Wol hoeher dannez rîche / bin ich al die zît: ero così ricco al tempo / contento come se fossi guidato da Dio / lei era vicina al mio cuore…”. E non parlava certo della mamma. Anche io ho composto qualche poesia. Misura, providenzia e meritanza / fanno esser l’uomo sagio e conoscente. Più che altro per giocare con Giacomo da Lentini. Non passerò alla storia per i miei versi: Giacomo è molto più poeta di me. Che belle le riunioni nella sala ottagonale di Enna. Ognuno declamava le sue poesie più recenti. Guido delle Colonne, Odo, Giacomino Pugliese. Piero della Vigna cantava spesso un presentimento di morte. Si sentiva braccato. Cielo d’Alcamo era divertente con i suoi doppi sensi. Scriveva in siciliano e toscano. “Donna mi so’ di pèrperi/ d’auro massamotino”… Nessuno di loro sapeva leggere l’arabo, nemmeno Manfredi Maletta, il fratello di Bianca, altrimenti si sarebbero cantati i vecchi poeti siciliani come ibn Hamdis. “Poi tanta caunoscenza” Dicono che io abbia l’ossessione dell’ottagono. Tra la perfezione del cerchio e la rigidità del quadrato, è l’unica forma di spazio in cui io mi senta sicuro. L’ho capito a Aquisgrana durante la mia incoronazione nella Cappella Palatina. A Gerusalemme, nella Moschea della Roccia, ho avuto la stessa sensazione. Anche nel palazzo di Lucera, dove ho cercato di circoscrivere il cortile ottagonale con la base quadrata del130 l’edificio. A Castel del Monte ho superato me stesso, e forse mi sono liberato dal fantasma ottagonale. Ora vorrei discutere con Leonardo da Pisa sulle virtù magiche del pentagono, del numero d’oro, della proporzione divina. La grande architettura algebrica del cosmo. La lettera greca pi, la phi. Ma quel Fibonacci è sempre da qualche altra parte, generalmente in Ifriqiya. Fa bene. O forse è andato a contemplare le geometrie celesti. E’ parecchio tempo che non sento parlare di lui. A volte li capisco, gli intellettuali. Sono avari, ma il sapere è la loro ricchezza: più ne distribuisci meno ha valore. Michele Scoto recitava il giuramento di Ippocrate: non rivelare ai profani i segreti della medicina. La Santa Inquisizione gli potrebbe far confessare un’eresia ma non una ricetta. E invece la sapienza si accresce soltanto con lo scambio. Perfino il sommo Aristotele scrive delle sciocchezze sul volo degli uccelli. Bastava che ne parlasse con un cacciatore, le avrebbe evitate. La gente si diverte quando sfila il mio zoo. Applaude gli elefanti, i leoni, le scimmie, e soprattutto la giraffa che mi ha regalato al-Malik al-Khamil. Io preferisco i leopardi per cacciare, e i dromedari per i viaggi e i trasporti. Mi hanno detto che in Asia centrale ci sono dromedari con due gobbe. Sarà una delle solite leggende sui luoghi fantastici. Ma soprattutto io mi occupo degli uccelli predatori; ho scoperto come accoppiarli per migliorare le loro virtù. Shahin è stato il mio capolavoro nel creare falconi. Una pazienza da agostiniano di Brünn mi ci è voluta! Mi viene da sorridere quando leggo Pietro da Eboli, che profetizza alla mia nascita la pace tra i rapaci, i predatori e il resto del mondo animale. Un biografo di papa Gregorio mi ha descritto così: non armis decoratus et legibus, sed canibus et avium garrulitate munitus, in capturam avium sollicitabat aquilas triumphales. I cani e gli uccelli al posto delle armi e delle leggi, cacciatore più che regnante, e le aquile dello stemma imperiale usate per catturare gli uccelli. Non è generoso, ma nemmeno del tutto falso. Studiare è un’esperienza estetica, per me: come aspirare un profumo. Anche adesso, quel poco tempo che riesco a strappare al lavoro non sopporto di sprecarlo nell’ozio. L’ho fatto scrivere nella prefazione al ‘De arte venandi cum avibus’ che regalerò a Manfredi: “L’Autore è vir 131 inquisitor et sapientiae amator, il divo augusto Federico eccetera”. La conoscenza ringiovanisce la mente e ci rende liberi. Un frate di quel nuovo tribunale mi ha detto che gli uomini hanno bisogno di essere tenuti schiavi per essere felici. Lasciarli liberi, sostiene l’Inquisitore, è pura crudeltà. “E son lontano da li miei paesi” Le stelle mi cadono addosso tutte insieme. Una febbre così non l’ho avuta nemmeno quando partii per Oltremare. Sento la memoria come una tela stracciata. Non ho niente da opporre al nulla se non i miei ricordi. Cinquantasei anni ho vissuto finora. Mia madre mi raccontava che sono nato sotto una tenda, nella piazza di Iesi. Tra due settimane è Natale, il mio compleanno. Tutti hanno assistito all’evento, diceva. E non è bastato, povera Costanza, partorirmi all’aperto in pieno inverno. E’ corsa voce che fosse troppo vecchia per concepire, aveva quarantadue anni e mio padre poco più di trenta. Dicono che mi avessero comprato da un macellaio. L’ho scritto a papa Gregorio: io e mia madre fummo come Maria e Gesù a Betlemme, poveri, minacciati e congelati. Adesso a Gerusalemme sono il re perché ho sposato la regina, Jolanda di Brienne, e ho generato il mio successore, Corrado. Gerusalemme, città dalle mille meraviglie! Walther von der Vogelweide, già molto anziano, ci incitava da Würzburg con le sue canzoni: Owe war sint verswunden alliu miniu jar! “Attenti, cavalieri, meditate; questo è il vostro onere: indossare l’elmo scintillante e la cotta di maglia pesante. A voi il resistente scudo lungo, la spada consacrata. Vorrei esser degno di una ricompensa benedetta di tal genere! Che ricchezze allora, io povero, potrei accumulare (non intendo oro o argento o qualche vasto possedimento)! Ma una eterna corona di gloria potrebbe brillare sulla mia fronte. Qualunque soldato semplice potrà vincerla con la sua lancia. 132 E potessi attraversare il mare, se ciò potesse avverarsi, il mio canto sarebbe di gioia, mai più di dolore”. Il Tempio di Salomone, la Cupola della Roccia, i luoghi santi della vita del Nazareno e della sua passione. Non dimentico mai al-Malik alKhamil, il re di Babilonia. Uomo illuminato ma ospite esagerato! Io sognavo di minareti, di muezzin ciechi, e la prima stella del vespero, e la falce di luna… Ma lui, per non disturbarmi, ha spento per una notte il richiamo alla preghiera. Mi ha rubato un’emozione. Gliel’ho dovuto dire, la mattina. “Sentire l’adhan era uno dei miei scopi. Avete fatto male ad alterare il vostro rito e la vostra legge. Se voi foste presso di me, nel mio paese, sospenderei forse il suono delle campane per causa vostra?” Davvero, penso che nel futuro i pellegrini di Gerusalemme saranno emozionati anche dall’appello che viene dai minareti della santa città. E quelli di Costantinopoli? Abbiamo firmato il trattato di pace, e chiuso con queste folli spedizioni oltremare! Così credevo. Ho ottenuto tutto quello per cui ci si stava battendo da quando Bernardo di Chiaravalle e quel folle Pietro l’Eremita avevano montato l’opinione pubblica. Come nascono dal nulla le idee perverse! Un manigoldo comincia a gridare, e la gente si lascia prendere dall’emozione, si arrende al delirio, muore la ragione. Qualche volta ho pensato che l’estremismo sia una malattia infantile: si propaga come la peste, e ancora non hanno trovato rimedio. “Rimembranza mi serra in suo domìno” Il Santo Sepolcro è stato onorato dai saraceni e profanato dai cristiani. Questa è la verità. Abbiamo finto di credere che la liberazione fosse un obbligo per ciascun credente. E a maggior ragione per un regnante. Bernardo di Chiaravalle, Pietro l’Eremita, papa Urbano, e ora questo fanatico Eudes di Châteauroux che è stato creato cardinale di Frascati. Dicono che abbia scritto centinaia di sermoni per incitare a prendere la croce. Anche a Gerusalemme ha fatto i capricci. Li ha costretti a fon133 dere le monete d’oro e d’argento battute con l’iscrizione in alfabeto cufico. Egli credeva che portassero il nome del Profeta o qualche eulogia islamica. Invece, me le ricordo bene, oltre alla croce con il fiordaliso c’era scritto ‘al-Ab, al-Bin wa al-Rukh al-Quds’: il segno della croce. Hanno distrutto il segno della croce solo perché era scritto in arabo! Quello sciocco re Luigi si è preso la peste per seguire nel delta del Nilo i fantasmi di Eudes e dei suoi papi contorti. Io invece ho vinto al gioco della trasparenza. Ero solo e scomunicato. Non avevo una force de frappe per imporre condizioni. Nell’aprire i negoziati ho detto: ‘Non ho alcuna mira effettiva su Gerusalemme né su altra terra. Devo solo tutelare il mio onore presso la Cristianità’. AlMalik al-Khamil fu ragionevole, e concludemmo presto l’accordo. Credo che avesse avuto qualche influenza su di lui l’incontro con il frate di Assisi, anni prima. Ho raccontato ad al-Malik che io e il frate siamo stati battezzati nello stesso fonte ad Assisi, e lui è parso impressionato. Ma Francesco aveva osato sfidare i teologi dell’Islam a una ordalia del fuoco. Una proposta un po’ barbarica, bisogna ammettere. Non so se frate Elia fosse d’accordo, glielo chiederò. Ora è scomunicato come me per l’affetto che ci lega. Il saggio al-Farasi per primo si era eclissato. Non per paura, se lo conosco bene, ma per educazione. Scrissi subito a mio cognato Enrico, in Inghilterra: “E’ un miracolo! Senza ricorrere alle armi ho portato a compimento un’impresa che nel passato tutti i capi e governanti del mondo non erano stati in grado di compiere. Né con la forza, per quanti eserciti venissero coalizzati, né per minaccia”. La città di Gerusalemme con il titolo regale. Betlemme, Nazareth, difesa per i pellegrini e garanzie per i governanti europei: il re, il principe di Antiochia, i conti di Edessa e di Tripoli. Là dove regnava Melisenda, amata dal sire di Blaia, Jaufré Rudel. Il Santo Sepolcro di nuovo in mani cristiane. Come al tempo di Goffredo di Buglione, prima della riconquista di Salah ed-Din il curdo. Ho attraversato la piazza quadrata di fronte alla basilica con le vesti imperiali. Mi sono inginocchiato davanti alla pietra unta. L’ho baciata. 134 Che effetto quel passaggio freddo viscido sulle labbra. Il luogo della Santa Croce, proprio come avevo letto nel diario di quella antica viaggiatrice spagnola, Eteria. E il mausoleo circolare dell’imperatrice Elena madre di Costantino: l’anello di pietra che incastona la gemma più preziosa della cristianità. Il Sepolcro di Cristo, ombelico della terra, esplosione di luce della resurrezione. Ero circondato di soldati con le aquile imperiali nere sugli scudi e da cavalieri teutonici con le vesti bianche e le croci nere. Il Gran Maestro Hermann von Salza era con me. Ho preso la corona con le mie mani e me la sono posta sul capo. Un pensiero mi ha traversato rapido la mente: è Dio che me l’ha data; guai a chi la minaccia. Cristo stesso mi ha incoronato, e verso di Lui ho la responsabilità di guidare il popolo cristiano. Credo che il nonno Ruggero abbia avuto la stessa esperienza interiore. Altri forse l’avranno. A Monreale il nonno si è fatto raffigurare incoronato da Gesù Cristo, che peraltro ha la sua stessa faccia. Il Sepolcro in mani cristiane. Subito il patriarca Geroldo ha levato gli scudi. Razza di vipera, sepolcro imbiancato. Come il suo papa. Hanno fatto una campagna diffamatoria. Una circolare velenosa a tutte le cancellerie cristiane. Hanno detto che il Sepolcro era stato acquisito con un tratto d’inchiostro invece che con un fiume di sangue. Il mio sangue, preferibilmente. La crociata degli scomunicati, l’hanno chiamata; finta pacificazione. Io avevo risolto il problema e loro, il papa e la chiesa, ne erano crucciosi a morte. L’ho scritto: ‘Quando l’Impero romano, destinato a difesa della Cristianità, è assalito da nemici e da infedeli, l’imperatore brandisce la spada, conoscendo i doveri che il suo ufficio e il suo onore gli impongono. Ma che c’è più da fare e da sperare se è proprio il padre di tutti i Cristiani, il successore dell’Apostolo Pietro, il vicario di Cristo, quegli che spinge i nemici contro di noi?”. E adesso quell’altro folle francese, re Luigi, si è impantanano nel delta del Nilo. Con il Legato papale, Eudes di Châteauroux, che passa la vita a proclamare crociate. L’avevo messo in guardia re Luigi, ma la follia 135 religiosa gli porterà via il trono, la vita. Poi lo faranno santo. A loro non interessa il Santo Sepolcro. Io lo avevo liberato, loro non l’hanno voluto. Hanno bisogno che rimanga in mano degli infedeli per ricattare la cristianità. “Lo meo coraggio non diparto mai” Papa Innocenzo, anche lui. Giovane, longobardo, non ho mai capito se, oltre a servirsi di me, mi fosse anche affezionato in qualche modo. Era il mio tutore. Anzi il padre adottivo, secondo la mia mamma. Ben retribuito, del resto, in denaro e in feudi. Il nostro è stato un rapporto tutto epistolare: ci siamo visti una volta sola, nel 1212, mentre da Messina andavo a reclamare la corona di Germania. Una volta mi ha scritto una lettera molto bella: anche se ero un orfano infelice, nutrito di latte e assenzio, avevo come padre spirituale lo stesso papa, e come madre la Chiesa. Innocenzo è stato bravo a difendermi dai baroni e dai grandi dell’Impero. Da Ottone di Brunswick, che pure ha incoronato imperatore prima di me. Da quell’orribile Markwald, che non per niente era amico di mio padre, complice delle sue crudeltà. Io ero felice quando riuscivo a scappare dal Palazzo e a vagabondare per le strade di Palermo. C’era sempre qualche mamma pietosa che mi dava da mangiare. A volte potevo star fuori anche delle settimane. Almeno così dicono: io ho rimosso molti ricordi della mia infanzia. Innocenzo mi ha incoronato re di Sicilia, duca di Apulia, principe di Capua. Mi ha dato una famiglia facendomi sposare Costanza. Solo dieci anni più anziana di me. Il nome Costanza è un’ossessione di famiglia. Madre, moglie, sorella. Anche mia figlia piccola. A Nicea però è stata ribattezzata Anna. Mi hanno mandato il testo della canzone di nozze. L’edera si avvinghia al bel cipresso / l’edera è il mio sovrano / cipresso l’imperatrice. E’ di un certo Nicola. Non mi pare un granché. L’imperatore Giovanni la saprà amare quanto io ho amato la sua mamma, l’imperatrice Bianca Lancia di Agliano? Almeno ha con sé i nonni e gli zii a Nicea. La aiuteranno a sopportare che la sua ancella Fricka indossi addirittura i calzari di porpora. 136 Forse è mia moglie Jolanda che si vendica. Aveva la stessa età, tredici anni, quando la sposai e m’innamorai della sua accompagnatrice. Anais. Spero che Costanza, anzi Anna, sappia evitare lo scontro. Diventerà una buona diplomatica come me? No, non riesco a seguire il filo dei ricordi. Il dolore di ventre mi sale sù a ondate e mi stringe le tempie. Sarà dura uscire da questa affezione. Dovrei anche mangiare qualcosa, ma non ci posso nemmeno pensare. Forse qualche frutto. Delle pere. Sì, Costanza è un nome fausto per me. Anche la città di Costanza, sul lago: è stata la chiave della mia vita. Era il 1212. Arrivammo di notte, come un piccolo gruppo di avventurieri meridionali. In palio c’era la corona di Germania. Ottone di Brunswick era già stato incoronato imperatore da Innocenzo. Non voleva che la corona imperiale si congiungesse con quella di Sicilia. In un certo senso aveva ragione Walther von der Vogelweide: il papa aveva messo due tedeschi sotto la stessa corona. Bisogna aver rispetto per i poeti. Ho offerto a Walther un feudo, non a Bolzano ma a Würzburg. Così i suoi ultimi canti saranno più sereni. Gli Elettori erano riuniti lì, aspettando Ottone per offrirgli il trono di Germania. Ma non avevano fatto i conti con noi meridionali. Io avevo creato re di Sicilia mio figlio Enrico appena nato, quindi Innocenzo non aveva più paura. Poi c’era Berardo Castacca, l’arcivescovo di Palermo. Ah, forse è un sogno, ma mi è sembrato di vederlo qui, ieri notte. Povero vecchio. Aveva una brutta cera, sembrava portare notizie sconvolgenti. Mi ha rammentato anche Piero della Vigna, ma non ho capito. Credevo che fosse a San Miniato in Toscana. Mi viene in mente la canzone che scrisse quando morì l’imperatrice Isabella: Ingressa m’è la morte / per afretosa sorte/ non aspettando fine naturale… “Pur aspettando bon tempo e stagione” Grande arcivescovo Castacca! Si fece aprire le porte di Costanza di notte, presentandosi come legato pontificio. Giurò che re Ottone era stato scomunicato da papa Innocenzo. E la città di Costanza mi accla137 mò re! Ottone arrivò più tardi… troppo tardi! Poi a Worms, dove hanno appena finito di abbellire la loro fantastica cattedrale. E a Francoforte – anche allora era dicembre – fui eletto ‘Re dei Romani’ nel Römer, come in antico. Ottone non cedeva le insegne imperiali, erano in mano sua. Non lo amavano gli Elettori perché era avido e gretto e contendeva loro i privilegi e i territori. Io invece lasciai nelle loro mani anche il demanio imperiale: che m’importava dei feudatari, la mia vita era altrove. Mi bastava che eleggessero mio figlio Enrico Re dei Romani al posto mio. Così l’Impero sarebbe stato di nuovo dal Mare del Nord al Mediterraneo, fino alla Terrasanta. Ci volle la domenica di Bouvines per strappare a Ottone almeno le aquile imperiali dorate. Era il luglio 1214. Ero io con Filippo Augusto di Francia contro Ottone con Ferrante di Fiandra. Chi ci aveva portati a darci battaglia in quel posto delle Fiandre? Papa Innocenzo, naturalmente. Io e Filippo Augusto, con la sua orifiamma al vento e lo stendardo con l’aquila imperiale, avemmo vittoria. Ottone fu deposto dal papa. Onestamente non è che io abbia fatto molto, in quella giornata. però credo che sarà riconosciuta come una data importante, nel futuro. E’ da allora che in Germania mi chiamano l’imperatore dei preti. Rex presbyterorum, un insulto che Ottone ha lasciato dietro di sé, da perdente. Così come ha tenuto in ostaggio le insegne imperiali sper, kriuz und krone – la lancia, la croce, la corona – fin dopo la morte. E poi, sempre con Berardo Castacca, ad Aquisgrana, sulla tomba di Carlo Magno: finalmente l’incoronazione. Chissà se Berardo ha mai saputo di me e di Manna, la sua bella nipote? Mi ricordo bene la cappella imperiale, altissima, circolare, piena di reliquiari d’oro e di smalti mosani e limosini. I battenti di bronzo a forma di leone. Quell’immenso lampadario che scendeva dalla cupola e raffigurava le mura di Gerusalemme celeste. Grande quanto il perimetro della chiesa. Lo guardavo fisso mentre giuravo di spendere la mia vita per riconquistare la Gerusalemme terrena, il Sepolcro. E sognavo davvero le porte immortali e la moschea ottagonale costruita da Omar, il secondo dei Califfi ben guidati. Un ottagono perfetto. Nel punto in cui Abramo stava sacrificando Isacco. Sulla roccia da cui il Profeta spiccò il volo sul buraq. Un ottagono! 138 “Penitenza non aggio fatta niente” Mi gira la testa, è tremendo, anche stando qui fermo. Tutto il mondo mi ruota davanti agli occhi. Ho voglia di vomitare in continuazione. Sento il sudore scorrere. Avvolgetemi asciugamani freddi attorno alla fronte. Un grande vantaggio dell’Islam è che le comunità sono guidate dai discendenti del Profeta. Si avvolgono il turbante verde. Nessuno contesta la loro autorità. I nostri papi si scelgono per rapporti di forza tra le nazioni. Per questo poi rosicchiano i poteri dei regnanti. Scatenano contro di loro l’angoscia dei credenti. Tre volte sono stato scomunicato. Perfino papa Gregorio mi ha ricomunicato appena ha avuto bisogno di me. Il popolo romano gli si era ribellato e lo assediava in Castel Sant’Angelo. Adesso sono scomunicato di nuovo. Quindi, se dovessi morire… Che pensiero! Non mi trovo sub flore. Già, chissà come si chiama questo castello? Non riconosco nessuna delle mie case. Ho solo intravisto una grande tavola di pietra mentre mi portavano qui ieri notte. O era il giorno prima? Sembrava una mensa da altare. Il peggiore dei miei papi è stato Gregorio nono. Era nipote di Papa Innocenzo, quindi un mio cugino spirituale. Innocenzo lo usava per fare i lavori sporchi. La sale besogne, diceva Filippo Augusto. Dirty job, secondo re Giovanni in Inghilterra. Ora si è messo in proprio a cercare il bene attraverso il male, come dice lui. Potrebbe essere il motto del suo Tribunale della Santa Inquisizione. Portare il purgatorio sulla terra, ecco il sogno demente di Gregorio. Era perfino patetico con la sua ossessione della scomunica. Non capiva che l’arma spirituale funziona se non la si adopera. Oppure con la certezza del risultato. Così aveva fatto un secolo fa l’altro Gregorio, Ildebrando di Soana, contro Enrico il Salico. L’aveva obbligato a Canossa, a supplicare perdono, in ginocchio nella neve. Vorrei avere anche io un mucchio di neve per rotolarmi sopra. Per spegnere questo fuoco nel ventre. Mi attacco a ogni pensiero per non lasciarmi andare al dolore, all’assopimento mortale che sento sopra di me. Non rinfaccio a Gregorio la stupidità, la limitatezza di vedute. E’ la sua 139 malafede che non posso perdonare. Neanche fossi sul punto di morte. O forse si deve perdonare ed essere perdonati per accedere alla salvezza? Ne parlerò a Berardo Castacca, quando sarò guarito. Andremo insieme a Palermo. Ho voglia di rivedere i miei giardini, gli aranceti. Le fontane della Zisa. La cattedrale di Monreale. “Ca, ss’io fossi oltramare” Gregorio voleva che andassi Oltremare e che morissi là. Non si accontentava di niente di meno: mano libera per impadronirsi del mio regno con quei suoi finti crociati, i clavigeri. Era il 1228. A Brindisi ci toccò imbarcarci. C’era una pestilenza fra le truppe, e anche io ne fui colpito. Ma Gregorio incitava, ricattava. Sciogliemmo le vele, e la situazione a bordo divenne subito drammatica. Sarà stato l’effetto della scomunica? Decisi di riprendere terra a Otranto, e fu un diluvio di maledizioni feroci dal Padre dei credenti. In estate, come Dio volle, si riuscì a partire. Mi ero curato a Pozzuoli con le acque che sgorgano dal cuore caldo della terra. Oppure dall’inferno, diceva Piero della Vigna, il mio alter ego sarcastico. Avrei bisogno adesso di farmi massaggiare, con l’odore dello zolfo così acuto che ti sembra di non respirare. Mi ha sempre angosciato la sensazione del respiro che manca. La parte ufficiale del mio passaggio oltremare la conoscono tutti. Ma naturalmente non si può andare in una terra di tanta magia soltanto per ragioni politiche. Ero curioso delle architetture dei Selgiuchidi, che hanno vissuto nel centro dell’Asia. Gli atabeg di Mosul, che ci avevano tolto Edessa con la spettacolosa vasca dei pesci biblici. Il cavalleresco Zengi. I loro castelli, i mausolei, i minareti, gli spazi per la preghiera. E soprattutto i castelli di delizia nel deserto oltre il Giordano. Li avevano costruiti i primi governanti islamici di Damasco, gli Omayadi. Adesso i loro discendenti regnano a Cordoba. Che meraviglie di giardini, di hammam, di condotte d’acqua, di padiglioni per la caccia col falcone. Gioia pura per ogni senso, e contemplazione di bellezza per l’intelletto: l’intimo disegno delle cose. Avrei voluto vivere lì per sem140 pre. Al ritorno ho cercato di ricreare quelle atmosfere. Il mio palatium di Foggia: ut sit Fogia regalis civitas inclita imperialis. Castel del Monte, Lucera, Ordona, Deliceto. Anche a Fiorentino ho fatto costruire un castello, ma non ci sono mai voluto andare. Troppo sub flore, ha sempre detto Michele Scoto. Dicono che in Oltremare abbia conosciuto gli Assassini, forse il Grande Vecchio in persona, ad Alamut. O addirittura il Prete Gianni; Gog e Magog i mostri della Bibbia; i Magi persiani; i popoli deformi e misteriosi. Lo dicono con cattiveria, e non sanno quanto mi sarebbe piaciuto davvero inoltrarmi verso il sorgere del sole, e magari perdermi lì. Come il grande Alessandro. Quando penso a quei tempi mi sento come un espatriato che hanno costretto a tornare in patria. Certo che sono rientrato, mentre papa Gregorio stava invadendo il mio regno e seduceva le città perché mi impedissero l’accesso. Perfino Foggia! Ma lo sapevo, e deviando per Gerba ho imbarcato molti guerrieri saraceni. Assieme a quelli di Lucera, adesso l’ordine regna nella Giudicatura di Capitanata. “In vostra spera vivo, donna mia” Ma guarda, Manfredi! E’ lui, vero? E’ venuto il mio ragazzo. Bello come la sua mamma. Forte come me. I suoi capelli… L’andamento fiero… Sì, a Gioia del Colle aveva ragione Berardo Castacca: se non sposi Bianca lei morirà come amante di Federico, madre di figli senza diritti. E così lei è stata per qualche giorno, Bianca Lancia di Agliano, imperatrice del Sacro Romano Impero. La sola donna amata da Federico. La vedo ancora nel castello delle Lanze, quando per averla finsi di essere vedovo di Isabella d’Inghilterra. E in un certo senso lo ero: solo per rispetto a papa Gregorio l’avevo sposata; era il 1235 e re Haakon mi aveva mandato dalla Norvegia un grande orso bianco come la neve. Spero che a Palermo non abbia sofferto il clima. Ho fatto dipingere il ritratto di Isabella in una chiesa vicino a Melfi, sulla roccia, quando è morta. È successo pochi anni fa, a Foggia, nel Palazzo. E prima di lei, per obbedienza a papa Onorio, mi ero fatto genero del 141 re di Gerusalemme. Jolanda, una bambina! Aveva 13 anni, e poi era impacciata, bruttina, buona solo per la corona regale che portava con sé. Sua cugina Anais la accompagnava alla cerimonia. Poteva bastare il nome per accendere la fantasia; e lei assomigliava al suo nome. Anais senza pudore, pronta a lasciar cadere ogni velo. Scrissi una canzone per lei. Il Fiore di Siria, quella c’à in pregione lo mio core! Non fu una cosa onorevole lasciare il letto nuziale di Jolanda e passare la prima notte con Anais. Re Giovanni mi chiamò ‘fis d’un bechè’, figlio di macellaio, e protestò ufficialmente presso il papa. Ne ebbe in cambio dei benefici alla corte romana. Qualche volta riuscii comunque ad avvicinarmi a Jolanda. Nacque Corrado, erede al trono di Gerusalemme. Anche Margherita. Poi mi lasciò vedovo per la seconda volta. Aveva 16 anni. Non resse alle sofferenze di un altro parto. Vieni, Manfredi, avvicinati a tuo padre. Hanno ragione, mi assomiglia ma è più bello di me. Un vedovo recidivo sono. La prima volta era proprio scritto nella natura: io avevo 15 anni e mia moglie forse trenta di più. Il mio padre adottivo, papa Innocenzo, pensò di domare i miei spiriti inquieti mettendomi accanto una donna matura, autorevole, religiosa. Un’altra mamma, ho spesso pensato. Con lo stesso nome: Costanza d’Aragona! Sono trent’anni ormai che non c’è più. La ricordo quando indossava il camaleuco nelle cerimonie pubbliche. La corona intessuta con gemme, perle, bellissime corniole incise, e i pendenti laterali che le conferivano un aspetto davvero imperiale. Assomigliava al faldistorio che porto sempre con me, per ogni esigenza di mostrarmi sul trono imperiale. Stessi ricami di oro e perle; io ho fatto aggiungere gli smalti con le miniature dei miei antenati. Avevo quasi timore, o meglio un certo imbarazzo ad avvicinarmi a Costanza. Mi sentivo Edipo nel letto di Giocasta, come raccontano le favole dei Greci. Il nostro primo figlio lo chiamammo come mio padre, Enrico. Non era un gran buon augurio, e difatti Enrico è stato fra tutti quello che mi ha capito meno. Mi sfidava, tesseva alleanze dementi con i feudatari germanici. Non aveva capito il disegno di mio padre: un potere moderno, ereditario, al posto della consuetudine elettiva che indebolisce l’Impero e rafforza il Papato. Ho dovuto chiuderlo in car142 cere. Non c’è più. Forse si è dato la morte da solo? Mi hanno detto qualcosa di Piero della Vigna, ma non riesco a ricordare. Parlano spesso di lui, lo accusano di tradimenti. Mi torna a mente una canzone sua: Son menato per forza /ed eo medesmo mi meno al morire, / ed esser la mia morte e non vedere! “Ed esser la mia morte e non vedere!” Mi sembra che siano venuti tutti a visitarmi qui, a Fiorentino. Ecco il nome di questo castello! Che cosa avrebbe detto Michele Scoto? Lo stavo nascondendo a me stesso, ma sono ricoverato sub flore. Devo andare a Lucera, subito. Manfredi mi accompagnerà nel viaggio. Vorrei affacciarmi alla finestra. Non so più distinguere, è la febbre. Oppure sto sognando. Ma questo non è un sogno: è mio figlio. Manfredi, principe legittimo di Taranto. La sua presenza mi rende più tranquillo. E’ incredibile come Bianca sia riuscita a riprodurre un altro me stesso. Lo dicono tutti. E’ un uomo del Sud anche lui. L’ho fatto studiare a Parigi, a Bologna, e con tutti gli scienziati della Magna Curia di Palermo. Anche io gli ho insegnato qualcosa. L’ultima volta che ci siamo incontrati mi ha detto che sta traducendo in latino, dall’arabo o forse dall’ebraico, il De pomo di Aristotele. Sarebbe stato uno stupor mundi come me, se fosse nato prima di Corrado, e da una moglie legittima. E invece il mio successore sarà Corrado, e poi suo figlio, il Corradino. Enzo è ancora in prigione a Bologna: non hanno accettato nessun riscatto per lui. Forse si pregiano di avere un re in città, e non lo trattano male. Mi hanno detto che ha avuto dei figli. Vedi come’è premuroso Manfredi. Mi bacia la mano. Mi aggiusta il pimaccio dietro la nuca. No, lo sfila via. Me lo appoggia sul viso. Preme forte con tutto il corpo. Non respiro, non vedo 143 I racconti dei testimoni Mattheo di Giovinazzo Alli 29, si è saputa la novella, che lo imperatore stà malato. Alli 5 de Decembre quilli, che passaro per Iovenazzo, dissero, che l’imperatore steva malissimo. Alli 9, si sparse fama, che era fora de pericolo. Alli 13, lo dì si santa Lucia, si trovao morto. Et la sera innante avea magnato certe pere cotte cò lo zucchero, et disse, che la matina venendo si voleva levare. Et questo anno ei lo 1250. Alli 16 di Decembre ale 21 hore ei venuta la lettera de principe di Taranto (Manfredi), che va avvisando le terre de passo in passo dela morte de lo patre. Alli 29 passao lo corpo dell’imperatore, che lo portaro a Taranto; et io fui a Bitonto per vederlo, et andao in una lettica coperta de velluto carmesino con la sua guardia de Sarraceni à pede et sei compagnie de cavalli armati, che, come entravano per le terre, andavano chiangendo ad nome l’imperatore; et poi venevano alcuni baroni vestuti negri et li sindaci dele terre. (Gli diurnali di messer Mattheo di Giovenazzo, MGH XVIII, 472473) Giovanni Villani Come lo ‘mperadore Federigo morì a Firenzuola in Puglia. Avenne che agravando de la detta malatia, essendo co·llui uno suo figliuolo bastardo ch’avea nome Manfredi, disiderando d’avere il tesoro di Federigo suo padre, e la signoria del Regno e di Cicilia, e temendo che Federigo di quella malatia non iscampasse o facesse testamento, concordandosi col suo segreto ciamberlano, promettendoli molti doni e signoria, con uno pimaccio che a Federigo puose il detto Manfredi in su la bocca, sì·ll’afogò; e per lo detto modo morì il detto Federigo disposto dello ‘mperio e scomunicato da santa Chiesa, sanza penitenzia, o nullo sagramento di santa Chiesa. E per questo potemo notare la parola che Cristo disse nel Vangelio: «Voi morrete nelle peccata vostre»; che così avenne a Federigo, il quale fu così nimico di santa Chiesa, ch’egli fece morire la moglie e Arrigo re suo figliuolo, e videsi sconfitto e preso Enzo suo figliuolo, e egli dal suo 144 figliuolo Manfredi vilmente morto e sanza penitenza; e ciò fu il dì di santa Lucia di dicembre, gli anni detti MCCL. E lui morto, Manfredi detto prese la guardia del reame e tutto il tesoro, e ’l corpo di Federigo fece portare e soppellire nobilemente alla chiesa di Monreale di sopra a la città di Palermo in Cicilia, e a la sua sepultura volendo scrivere molte parole di sua grandezza e podere, e grandi cose fatte per lui, uno cherico Trottano fece questi brievi versi, i quali piacquero molto a Manfredi e agli altri baroni, e fecegli intagliare nella detta sepultura, gli quali diceano: Si probitas, sensus, virtutum gratia, census, Nobilitas orti possint resistere morti, Non foret extintus Federicus qui iacet intus (Giovanni Villani, Nova Cronica, VII, 41) Piero della Vigna secondo Dante Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e diserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi; fede portai al glorïoso offizio, tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e’ polsi. La meretrice che mai da l’ospizio di Cesare non torse li occhi putti, morte comune e de le corti vizio, infiammò contra me li animi tutti; e li ‘nfiammati infiammar sì Augusto, ch’ e’ lieti onor tornaro in tristi lutti. L’animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d’esto legno vi giuro che già mai non ruppi fede al mio segnor, che fu d’onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che ’nvidia le diede (Dante Alighieri, Inferno, XIII) 60 63 66 69 72 75 78 145 147 TERTIVERI Pour les contrées du grand fleuve Bethique Loing d’Ibere, au regne de Granade, Croix repoussées par gens Mahumetiques Un de Cordube trahira la contrade (III, 20) Tertibulum. Bisogna essere proprio affamati di ruderi per affrontare, col sole di luglio, la salita verso i resti del castello. Ma il viaggio incomincia lontano da qui, alla Posta Farano sopra Siponto, mentre siamo a tavola sotto il papaglione. Su una porta è raffigurato un paesaggio campestre con i resti imponenti di un castello. La veduta è a volo d’uccello e, per quanto non appaiano strade per raggiungere il monumento, pare facile arrivarci di mezzo ai campi. Ma è un inganno percettivo: quando siamo vicini, dalla strada per Biccari che corre in piano un’onda immensa si solleva, e proprio sulla cresta, come un surfer, domina la torre di Tertiveri. L’onda è dorata per il grano appena tagliato e le muraglie prendono un aspetto diverso via via che gli si gira attorno. Il primo aspetto, venendo da Lucera, è una mano di pietra con l’anulare mozzato. Forse ricorda le Torri del Vajolet, ma è incredibile che una costruzione umana si regga nonostante queste fenditure. Dalla parte opposta invece, dal centro abitato di Tertiveri, le mura appaiono più in ordine; la facciata del torrione si riconosce con le sue finestre. Il rudere ritorna castello. Però bisogna arrivare fin lassù. Fendere l’onda immobile di stoppie che azzanna le calcagna. Un ricordo lampeggia: Gassman – l’indimenticabile Brancaleone da Norcia – e Gian Maria Volonté – il dissoluto Teofilatto de’ Leonzi – che si affrontano nel campo di grano maturo e lo mietono a colpi di spada. E non è insensato: un cavaliere crociato contro un guerriero bizantino può aver combattuto benissimo su questa proda. Tertiveri infatti è nata come avamposto dell’Impero d’Oriente 149 verso i principi longobardi di Benevento. Sarà magari il Deserto dei Tartari? Sì, forse nell’avvicinarsi alla mano mozzata si può pensare a Giovanni Drogo. Nemici non se ne vedono, ma ce ne sono stati, eccome. Per finire con l’ultimo, accanito, il più disperato: Carlo II d’Angiò, figlio del primo Carlo. Quindi nipote di San Luigi di Francia e padre di San Ludovico di Tolosa, la cui figura ascetica è resa da Simone Martini in una famosa tavola di Capodimonte. Il santo è raffigurato nell’atto di incoronare il fratello minore Roberto, al quale facendosi frate ha aperto la strada al trono e a se stesso la gloria degli altari. En passant l’opera piacque a re Roberto, che nominò Cavaliere l’artista senese con un appannaggio annuo di 50 once d’oro. La guerra di Carlo II non è direttamente contro il signore del castello, ‘abd el-Aziz. Anzi, è proprio lui che gli ha concesso il feudo di Tertiveri. Adelasisius, come è denominato nei documenti ufficiali, è l’esponente più in vista della comunità saracena di Lucera, ricco e potente di famiglia e riconosciuto dalla inquieta comunità come un personaggio politico di riferimento. Non a caso, forse, ‘abd el-Aziz non si trova a Lucera nella notte di San Bartolomeo, quando Giovanni Pipino da Barletta la desertifica con l’inganno. E’ il 24 agosto del 1300. Nota. Il 24 agosto se uno è protestante o musulmano farebbe meglio a stare alla larga dai francesi. Quella notte scatta la loro licantropia, a volte. A Parigi avverrà nel 1572 contro gli Ugonotti, e ancora ci corre un brivido quando, davanti al Louvre, si sente la campana di SaintGermain l’Auxerrois. A Lucera e nel territorio avvenne prima, e non ci fu rintocco di campana. Fu una carneficina strisciante. Ma la storia è lunga. Ci sono diversi protagonisti, eventi epocali, battaglie decisive. Arrancando tra le stoppie abbiamo tutto il tempo di andare avanti e indietro per un paio di secoli. 150 Tertiveri e il suo mondo Partiamo da una nottata d’agosto del 1264. Gli abitanti di Tertiveri, un po’ cristiani un po’ musulmani, stanno all’aperto per respirare un refolo di vento e per contare le stelle cadenti a cui appendere qualche desiderio. Qualcuno, a un tratto, comincia a indicare una stella speciale: non una sfera cadente ma una cometa vera e propria dalla coda fiammeggiante! Come quella dei Re Magi? No. Aveva anzi qualcosa di inquietante. Intanto si piazzò nel cielo fino a novembre. Poi emanava una luce esagerata, transitando da Oriente verso Occidente. Abbiamo un testimone: Giovanni Villani, manager fiorentino esperto in finanza internazionale. Si sa che, in genere, “queste stelle comate significano mutazioni di regni”. Infatti si disse che annunciava la venuta del re Carlo dalla Francia, e il cambiamento che ne sarebbe derivato al regno di Sicilia e di Puglia: e cioè, con la sconfitta e morte del re Manfredi, “il passaggio della signoria de’ Tedeschi a quella de’ Franceschi”. Dunque l’energia maligna della stella chiomata si esercita proprio contro Tertiveri. Ma non è tutto qui; anzi “intra l’altre significazioni fu evidente e aperta, che come la detta stella apparve, papa Urbano amalò d’infermità, e la notte che la detta comata venne meno si passò il detto papa di questa vita nella città di Perugia”. Sorella Morte ritarda la discesa di Carlo d’Angiò. “Manfredi e’ suoi seguaci furono molto allegri, avisando che morto il detto papa Urbano ch’era Francese, s’impedisse la detta impresa di Carlo”. Allegria di naufraghi, direbbe Ungaretti tanto innamorato della terra pugliese. Infatti la Sede di Pietro rimane vacante per cinque mesi; però poi viene eletto un altro papa francese. E’ Clemente IV “della città di San Gilio in Proenza, il quale fu buono uomo e di santa vita per orazioni, e digiuni, e limosine, tutto che prima fosse suto laico, e avesse avuto moglie e figliuoli, cavaliere e grande avogado in ogni consiglio del re di Francia. Regnò presso di IIII anni, e molto fu favorevole alla venuta del detto Carlo, e rimise santa Chiesa in buono stato”. Siamo nel 1265; il Francese siede sul Soglio di Pietro per quattro anni. Ma il successore, eletto in circostanze davvero singolari, sarà ancora una volta un Francese: Urbano IV. 151 Pessima stella per Manfredi, dunque, e anche per Tertiveri, valvola di sicurezza per le tensioni della vicina metropoli saracena di Lucera. Già una quota dei deportati islamici dalla Sicilia era stata collocata lì da Federico II, oltre che a Stornara e Acerenza. Questa ‘miniaturizzazione’ del confronto tra la Mezzaluna e la Croce ha attratto l’interesse dell’Istituto Storico Germanico che nel 2006, nell’ambito di una ricerca sull’insediamento islamico in terra cristiana, ha sviluppato a Tertiveri delle analisi geofisiche. Tertiveri aveva già una sua storia, come gli altri avamposti della ‘linea Maginot’ di Basilio Boioannes, Catapano d’Italia ai primi del Mille. Sede vescovile, nel 1058 risulta suffraganea di Benevento, ed è un po’ strano perché Tertiveri è in territorio bizantino e Benevento è la capitale longobarda. Magari è per sparigliare queste carte che Alessandro II nel 1067 depone per simonia il vescovo di Tertiveri, Landolfo (quindi un longobardo) e lo stesso trattamento riserva al vescovo di Biccari, Benedetto. Ma il fatto è che il Catapanato d’Italia è ormai un territorio di precario confine. In più le apostasie fioccano anche in campo cristiano. Le identità politiche e religiose continuano a trascolorare ben oltre il 1071, data fatale per Bisanzio: perdita di Bari e del Catapanato d’Italia, e sconfitta di Manzicerta che apre l’Anatolia ai turchi ed è premessa necessaria e sufficiente per il fatale 1453 di Mohamed Fatih, il Conquistatore. La Crociata contro i Saraceni di Puglia Lucera saracena è un gesto politico geniale di Federico II. La gloriosa città già colonia romana vivacchia, ed è un peccato perché la Capitanata sta diventando il cuore dell’Impero da Amburgo a Capo Passero. I Saraceni di Sicilia si sentono ovviamente a casa loro e oppongono resistenza sorda, quando va bene, agli organi dello Stato cristiano. Rivolte – come quella famosa di Mirabetto, Emir Abbad, e di sua figlia nella rocca trapanese di Entella – creano imbarazzo e preoccupazione. In più, chi dimentica gli anni dell’incerta giovinezza di Federico a Palermo, quando l’élite saracena trescava con i baroni germanici, con l’orrendo Markwald, contro di lui? Una ‘soluzione finale’ 152 non è ragionevole, o forse è prematura? Assurdo gettare al vento un patrimonio di energia e di bravura che, opportunamente sfruttato, sarà una risorsa per lo Stato. Quindi si tratta semplicemente di travasare da un recipiente siciliano troppo pieno a un recipiente pugliese quasi vuoto. Sub debita servitute, precisa Nicolò Jamsilla. Deportazione? Beh, sì. Comunque sia, nel centro della Capitanata si instaura un motore propulsivo sotto il segno della Mezzaluna: arti e mestieri, uomini d’arme, un Istituto di formazione, tutte le bellezze e dolcezze di cui il Mediterraneo tiene il segreto. Libertà di culto. Almeno due moschee; in basso la più grande, che poggia su undici colonne di breccia verde recuperate da un tempio romano. Il palatium sull’acropoli, a base di piramide tronca come Termoli, e cortile ottagonale come Castel del Monte. L’esile comunità cristiana lucerina, assieme al suo Pastore, viene molto scrollata. Dapprima il vescovo si dà da fare per imparare l’arabo: ed è giusto contrappasso per la predicazione in volgare che i Domenicani avevano inflitto ai miscredenti su mandato papale (e da questo ascolto negato ai Domenicani il teologo della Crociata, Eudes de Châteauroux, trarrà uno dei suoi sermoni più velenosi). Poi, sfiduciato, trasferisce la sede a Tertiveri; sarà piccola e appartata ma è cristiana. Almeno in parte, per il momento. Nessuno tocca Lucera finché vive Federico. E anche mentre regna Manfredi l’enclave saracena con le sue pertinenze continua a prosperare, a dispetto della propaganda scatenata dai Guelfi e dal Papato. Il fatto è che re Manfredi è intoccabile. Meglio: non c’è chi gli si possa opporre. Ci prova nel 1255 il papa Alessandro IV a indire la Crociata contro lo Hohenstaufen colpevole di disobbedienza. La bolla Pia Matris punta il dito proprio su Lucera. Siamo a un confronto escatologico tra la verità e l’errore: Cristianesimo e Islam. la Fallaci contro Bin Laden. Oppure, più semplicemente: perché attraversare il mare per andare a caccia di musulmani, quando ne abbiamo trentamila proprio qui a due passi? La Crux Cismarina vale tante indulgenze quanto la Crux Transmarina. Ed è molto meno spigolosa. La Crociata di Alessandro VI viene proclamata però non decolla. Anzi: la sconfitta dei Guelfi a Montaperti – “che fece l’Arbia colorata in 153 rosso” nel 1260 - inorgoglisce l’Italia ghibellina e fa abbassare le penne a quella fedele alla Sede papale. Per di più il papa muore, e i cardinali non riescono a mettersi d’accordo per un successore. Cinque mesi di sede vacante. Un regalo per Manfredi. Poi, a Viterbo, il caso strano. Riparati in qualche modo dal sole ai piedi del palazzo di Tertiveri, ascoltiamo Giovanni Villani con il suo accento fiorentino. “Poi elessono papa Urbano il IIII, della città di Tresi di Campagna in Francia, il quale fue di vile nazione, siccome figliuolo d’uno ciabattiere, ma valente uomo fu, e savio. Ma la sua elezione fu in questo modo: egli era in corte di Roma povero cherico, e piativa una sua chiesa che gli era tolta, di libbre XX di tornesi l’anno; i cardinali per loro discordia serrarono con chiavi ov’erano rinchiusi, e feciono tra·lloro dicreto segreto che ’l primo cherico che picchiasse la porta fosse papa. Come piacque a·Dio, questo Urbano fu il primo, e dove piativa la povera chiesa di libbre XX di tornesi, ebbe l’universale Chiesa”. Questo avviene nel 1261. Il papa ciabattino ha, ovviamente, cervello fino. Non sopporta “la forza di Manfredi, il quale occupava quasi tutta Italia”; anzi con le truppe saracene invade terre del Patrimonium Petri. “Così predicò croce contro a·lloro, onde molta gente fedeli si crucciaro, e andarono ad oste contra loro; per la qual cosa i detti Saraceni si fuggirono in Puglia”. Ma anche questa non è una crociata di successo: “Non lasciava Manfredi di continuo fare perseguitare il papa e la Chiesa a’ suoi fedeli e masnade; e egli stava quando in Cicilia e quando in Puglia a grande delizia e in grandi diletti, seguendo vita mondana e epicurea, ad ogni suo piacere, tenendo più concubine, vivendo lussuriosamente, e non parea che curasse né Dio né santi. Ma Idio giusto signore tosto mandò la sua maladizione e ruina a Manfredi”. La ‘maladizione’ si chiama Carlo d’Angiò e di Provenza, fratello di re Luigi IX di Francia, finanziato con fideiussioni della Santa Sede presso i banchieri toscani. E’ un personaggio di tutt’altro genere rispetto all’epucureo Manfredi. “Amico e protettore e difenditore di santa Chiesa e della nostra città di Firenze. Questo Carlo fu savio, di sano 154 consiglio, e prode in arme, e aspro, e molto temuto da tutti i re del mondo, magnanimo e d’alti intendimenti, in fare ogni grande impresa sicuro, in ogni aversità fermo, e veritiere d’ogni sua promessa, poco parlante, e molto adoperante (il tormentone della cultura del fare, anche allora!), e quasi non ridea se non poco, onesto com’uno religioso, e cattolico; aspro in giustizia, e di feroce riguardo; grande di persona e nerboruto, di colore ulivigno, e con grande naso, e parea bene maestà reale più ch’altro signore. Molto vegghiava e poco dormiva, e usava di dire che dormendo tanto tempo si perdea”. Inquietante, vero, questo re in pectore? Aggiungiamo che ha 46 anni e due figli: uno si chiama come lui “e fu sciancato alquanto”. Sarà il sinistro successore Carlo II. L’altro, Filippo, sposa la figlia del Despota di Morea “ma morì giovane, e sanza figliuoli, però che si guastò a tendere uno balestro”. Era forse maldestro? Ma non abbiamo tempo per le affabulazioni di Giovanni Villani: la ‘Nuova Cronica’ si può scaricare facilmente da Internet, assieme all’altrettanto saporita ‘Chronica’ di Salimbene de Adam nel suo latino già rotondamente parmigiano. Carlo d’Angiò ha ricevuto dal papa un cadeau avvelenato: deve guadagnarsi il regno di Sicilia e Apulia, e il possesso non è per nulla scontato. Anzi: Manfredi, che a spregio lo chiamava Carlotto, era prevalente per mare per terra e per buone relazioni politiche. Ciò nonostante la maligna stella chiomata dell’agosto 1264 porta i suoi frutti avvelenati a Tertiveri. Carlotto infliggerà a Manfredi la sconfitta e la morte: Benevento, febbraio 1266. Prima di morire Manfredi ha tempo di pentirsi dei suoi peccati, e questo basta a dribblare l’odio del papa Clemente e della Chiesa tutta. Sconfitto nella vita terrena, trionfa nella vita eterna. Chi lo dice? Dante. Che drammatizza raccontando come le ossa del defunto siano state tratte dalla cattedrale di Benevento, o da una sepoltura accanto al fiume, e sparse di notte per la campagna accanto al fiume Liri. “Or le bagna la pioggia e muove il vento”, gli dice Manfredi in salvo davanti al Purgatorio. François Villon avrebbe dato ai cadaveri questa voce: La pluie nous a lessivés et lavés et le soleil nous a séchés et noircis; 155 pies, corbeaux nous ont creusé les yeux, et arraché la barbe et les sourcils. Dante invece idealizza anche fisicamente questa salma sciagurata: “biondo era, e bello, e di gentile aspetto ma l’un dei cigli un colpo avea diviso”. A Lucera la sconfitta di Benevento procurerà un nuovo signore e toglierà il benessere, la libertà, l’autonomia relativa, il ruolo di ‘vetrina dell’Islam’ verso l’Occidente. Ma ancora non tutto è perduto, in questo oscuro 1266. E nemmeno nel 1268, quando a Tagliacozzo il fratello Corradino viene sbaragliato e a Napoli perderà la testa. L’altro fratello, Enzo, passerà la vita a Bologna, in prigione. Il peggio tocca all’ultimo fratellino, Enrico, che vegeta per trent’anni in una segreta di Castel dell’Ovo, e non rivedrà la luce. Sarà nel 1300 che il combinato disposto del Giubileo di Bonifacio VIII e del bisogno di soldi di Carlo II, lo ‘sciancato alquanto’, avvicinerà la distruzione non solo della città ma della comunità islamica nel territorio di Lucera. Le sue mura abbattute segneranno il piccolo transito di un’epoca: la fine di un sogno illuministico, realistico e anche un po’ cinico – e quindi pienamente politico – di Federico. E di Manfredi, il figlio illegittimo in cui egli si rispecchiava. Lo dice a chiare note il presunto Nicolò de Jamsilla. Il nome Manfredi infatti è Manens Fredericus (l’Imperatore è vivo e lotta con noi), Manus Frederici (a me lo scettro!), Mens Frederici (la sua memoria ci accompagna), Minor Fredericus (ma crescerà), Mons Frederici (la fortezza che difende la gloria del babbo). Chi è ‘abd el-Aziz, il signore moro di Tertiveri Tertiveri multiculturale aveva accolto il vescovo di Lucera con il clero e una parte dei cristiani, dal 1246 al 1255: non parlavano arabo, si dice, e quindi non riuscivano a comunicare con la città saracena. Forse è un pretesto. Nel frattempo lontano da Tertiveri e anche da Lucera la comu156 nità saracena solidarizza senza esitazione con la casata sveva nelle sue ultime sventure: Benevento e Tagliacozzo. Questa compattezza e lealtà della truppa moresca deve impressionare gli Angiò: magari in un futuro potrebbero orientarle a proprio favore. Così come non vorrebbero gettare al vento il patrimonio di abilità guerriere, di competenze artigianali e, last but not least, la capacità contributiva di una comunità ricca. Così Carlo II, impoverito dalla Guerra del Vespro in Sicilia, cerca ogni modo per trarre risorse da Lucera, ribattezzata Città di Santa Maria. E solo quando le uova d’oro saranno tutte raccolte, Carlo si deciderà a strozzare la gallina. Con il pretesto di un favore fatto al mai abbastanza schiaffeggiato Bonifacio VIII: la ‘bonifica’ del territorio cristiano nel 1300 in omaggio al Giubileo. Ed ecco ‘abd el-Aziz come signore feudale, investito da Carlo II in persona per i suoi meriti nel servizio al potere e per la sua influenza nella comunità lucerina. ‘abd vuol dire servo, schiavo, e el-Aziz è l’Amato. Nel senso più ampio. Allah stesso può essere el-Aziz, ma ugualmente qualcuno che Allah segna con la sua predilezione. Anche il Re, o l’Imperatore. Il bello di questi nomi ad ampio spettro è che possono, nel corso del tempo, esser vissuti con significati diversi da chi li porta. Una specie di amuleto polivalente. Sotto il sole di mezzogiorno il castello di Tertiveri è una specie di gnomone che non segna a terra nessuna ora con nessuna ombra. Tertiveri possedimento saraceno. Ma dov’è la moschea? Risulta che c’è: forse al posto della cattedrale normanna. Il terreno intorno, però, non parla. Adelasisius dicebamus, signore di Tertiborum, o Tortibulum, ricopre un ruolo di spicco nella comunità saracena di Lucera. Non quanto lo sciancato Giovanni Moro, uomo di fiducia già di Federico. Fiducia mal riposta se a un certo punto il Moro si converte e cerca di vendere Lucera al papa: saranno i ‘suoi’ di Acerenza a sopprimerlo e a inviare la testa in città, dove sarà appesa a Porta Foggia in spectaculum suae nefandae proditionis: lo attesta Jamsilla. ‘abd el-Aziz non è nemmeno un capo carismatico come ‘abu Abdallah, al secolo Riccardo da Lucera, che addirittura appartiene alla tribù dei Quraysh, i discendenti del Profeta che si avvolgono il turbante verde. 157 No, ‘abd el-Aziz è un grande artigiano, maestro argentiere, imprenditore ed influente moral suasor ovviamente in favore del potente di turno. Tanto che Carlo II, nell’ambito della ‘soluzione finale’, affida a lui la selezione dei concittadini da cui si può ancora spremere del valore. Un piccolo Quisling di Tertiveri? Di certo Francesco da Eboli, Giustiziere di Bari, riceve un minuzioso ordine di rastrellamento da Carlo II. Si diano al miles Niccolò de Civitate Sanctae Marie – cioè ad ‘abd el-Aziz battezzato – cinque suoi familiari; con il loro aiuto vogliamo che tutti i Saraceni artistae che egli vi mostrerà, o di cui vi darà l’elenco, siano trasferiti a Napoli e integrati nei nostri piani di sviluppo del Terziario. Gli artistae, per esser chiari, sono i fabbricatori di armi, balestre, archi, tende da campo, oggetti in cuoio rosso e cuscini (pouf); maestri muratori, bardatori, carpentieri. Il novello cristiano ‘abd elAziz deve accertarsi che il viaggio avvenga sub tuta custodia. Infatti le povere colonne di deportati sulla strada della vita grama venivano anche aggredite dai virtuosi credenti; ma questi Saraceni erano portatori di un valore economico, la sapienza artigiana, e quindi non si potevano massacrare: né a Serracapriola e Larino, né a Candela e neppure ad Ascoli Satriano, come era capitato ad altri gruppi di rifugiati. E ancora a dispetto di questa trentennale e violenta repressione rimangono nell’agro lucerino, autorizzate, diverse centinaia di famiglie saracene: purché non costruiscano moschee. E non facciano proseliti come succedeva prima. Tanto che nel 1294 era venuto da Napoli il Grande Inquisitore del Regno in persona, fra’ Giovanni da San Martino, per riconciliare bon gré mal gré i cristiani convertiti all’Islam. ‘abd el-Aziz – Nicola da Lucera, o Nicolò da Santa Maria – era stato toccato dalla Grazia due anni dopo la caduta di Lucera. E il figlio? E’ battezzato Giovanni, ed eredita la concessione di alcune case a San Severo da parte di re Carlo. Il quale scrive, l’11 luglio del 1301: le case erano per il babbo, ma purtroppo Adelasisius non ha saputo aspettare ed ha pagato il debito di natura prius quam predicta nostra gratia potiretur: è morto prima di poter godere della nostra benevolenza. Ma c’è un altro erede per ‘abd el-Aziz. A Tertiveri. 158 Il feudo di Tertiveri alla morte di Adelasisius viene assegnato a Johannes Pipinus de Barolo, il risolutore finale di Lucera nominato Connestabile di Santa Maria. Giovanni Pipino era tutt’altro che un uomo di guerra. Era un notaio, un politico casomai. Questo ci dice come la presa di Lucera sia avvenuta per astuzia diplomatica, tra l’Assunta e San Bartolomeo del 1300, prima che per violenta estinzione degli abitanti. Non c’è da dubitare che il Barlettano avrà omogeneizzato la facies cristiana di questa fantastica ondata di terra d’oro su cui la torre, cavaliere affaticato ma instancabile, continua a raccontare la storia esemplare del Signore moro e cristiano e del materiale genetico che dal suo popolo – disperso, venduto, sterminato – ha fecondato tutte le Puglie. Eudes, l’Arcinemico Della eliminazione di Lucheria Sarracenorum e del suo feudo di Tertiveri abbiamo raccontato le modalità e i motivi. L’odio per la Casa imperiale Sveva: la diffidenza per il diverso; il bisogno di soldi per combattere gli Aragonesi in Sicilia (Pietro III poi era un rampollo degli Hohenstaufen, nipote di Federico); la pretesa di far valere i diritti feudali del Papato sull’Italia meridionale; i santi e implacabili rancori per mille questioni politiche, dalla Crociata inconclusa alla lotta per le investiture dei grandi feudi ecclesiastici; la decisione di puntare sulla cristianissima stirpe reale francese. Ma queste motivazioni di vario ordine e grado trovano il punto di fusione in un crogiolo che non può che essere ideologico. E la dottrina della delenda Lucheria è formulata, incarnata e perseguita da un personaggio religioso tra i più rilevanti del secolo. Eudes di Châteauroux. Ha più nomi di Arsenio Lupin: Ottone di Tuscolo, Ottone di Châteauroux, Odo de Castroradulpho, Odo Gallus. Ma è sempre lui: frate Eudes, cistercense francese, nato attorno al 1190, Cancelliere dell’Università di Parigi, Cardinale di Tivoli e poi di Tuscolo, Legato papale in Terrasanta, morto a Perugia nel 1273 e sepolto con adeguata magnificenza a Orvieto in San Domenico. Il suo monumento funebre non ci è rimasto; certo non raggiungeva i vertici del suo vicino di sepol159 tura, il Cardinale di Braye, premiato da Arnolfo di Cambio con un’opera che diventerà il must to have per l’architettura funeraria fino al pieno Rinascimento. Eudes è un grande intellettuale con due o tre ossessioni. La più angosciosa è l’ortodossia cristiana. L’ortodossia patologica eterna che dal campo della fede straripa nelle altre forme di conoscenza – la filosofia, le scienze, la tecnologia – travolgendo assieme Galileo con i suoi canocchiali e la procreazione assistita con le staminali. Al tempo di Eudes non si vedono ancora gli atei devoti che difendono le istituzioni ecclesiastiche dai credenti critici. Nel suo dispiegamento di energie Eudes è perlomeno equanime: tanto si impegna contro l’Islam quanto contro l’Ebraismo. Riesce a far bruciare per due volte il Talmud come libro eretico, a Parigi, nonostante le appassionate perorazioni dei rabbini che in fondo erano gli unici interessati alla questione. La seconda ossessione di Eudes è l’archivistica, o almeno la catalogazione delle proprie opere. Il corpus autentificato e poligrafato raggiunge l’imponente cifra di 1100 sermoni, e qualcuno gli è pure sfuggito: infatti noi leggeremo i tre ‘Sermones de Rebellione Sarracenorum Lucherie in Apulia’ in un solo manoscritto della Biblioteca Municipale di Arras, in Piccardia (137 (876) ff. 108 2b III vb). Forse bisogna aggiungere che queste opere d’ingegno non venivano soltanto pronunciate dall’Autore in varie circostanze e con differenti accentuazioni secondo che si parlasse a crociati in armi, a possibili leve, a sponsor o a opinion leader. I testi, o le scalette, venivano diffusi quanto più possibile in modo da raggiungere un ‘effetto televisione’: che tutti i fedeli fossero imprinted con le medesime idee e con identiche verbalizzazioni e raffigurazioni mentali delle stesse. La terza e devastante ossessione di Eudes è la Crociata. Al servizio di questa follia egli dispone le sue eccellenti capacità intellettuali. Le campagne di opinione lanciate da lui sono paragonabili a qualunque organizzazione del consenso di oggi. La disciplina dei comunicatori dice che due sono gli obiettivi immancabili di una campagna: membership increasing e fund rising. E da questi obiettivi 160 Eudes non si discosta mai. Con eleganza, certo: non ci aspetteremmo da lui l’infelice frase con cui si raccoglieva l’obolo per la costruzione di San Pietro: ‘quando la moneta tintinna nel barattolo l’anima sale in Paradiso’. La Crociata! Il Pellegrinaggio armato, il Passaggio oltremare. Le spinte intrecciate della fede, della competizione razziale, della crescita demografica, della povertà endemica, della cavalleria, della governance feudale. Il tutto amalgamato e portato a temperatura di fusione dall’asset esclusivo del potere papale: le chiavi della vita eterna, che possono aprire l’indulgenza o chiudere sulla scomunica e la dannazione eterna. La prima Crociata, quella di Pier l’Eremita e di San Bernardo, era stata un successo: nel 1099 uno Stato europeo si insedia in Siria e Palestina, per un secolo. Fino a quando le armate di Saladino il Curdo non cacciano i cavalieri cristiani dal Sepolcro di Cristo. Ma per tre secoli ancora il brand Crociata viene riempito di valore: indizioni, concili, poemi, solenni partenze, predicazioni, teste coronate maschili e femminili, donazioni, lasciti, prestiti, questue, tassazioni e ingegnerie finanziarie, animazione delle potenze marinare, movimentazione globale della cristianità. Insomma un invasamento mondiale che ha avuto pochi paragoni, fino a ieri. Forse è invincibile la tentazione di far passare sotto questo brand name anche delle iniziative, imprese, intenzioni che avrebbero in realtà ben poco a che vedere con gli scopi di San Bernardo, di Pier l’Eremita e di Goffredo di Buglione. Ed ecco la Crociata contro i Mongoli, la Crociata contro i Pagani baltici, la Crociata contro gli Albigesi, la Crociata contro i pauperisti in Germania, in Italia e nei Balcani, la Crociata contro la Casa di Hohenstaufen e i suoi manutengoli, e infine quella che interessa noi: la Crociata contro i Saraceni di Puglia. Questa predicazione di Eudes su Lucera e quindi contro Tertiveri è il canto del cigno di una vita sempre eccellente: nella politica, nella diplomazia, nel pensiero speculativo, nell’arte polemica della parola. Sarà il capolavoro di una vita. Think global, act local, e questa volta la Crociata raggiungerà l’effetto. 161 Châteauroux vs/ Tertiveri Seduti ai piedi di questa torre tormentata ascoltiamo un silenzio che porta in sé mille anni di suoni. Campane e inviti alla preghiera; grida e richiami in lingue germaniche, greche, italiche, semitiche e altre ancora. Ma, affinando la percezione del silenzio, fantastichiamo sulle parole fatali che hanno segnato il crollo di queste mura. Come il rimbombo dello shofar aveva sbriciolato le difese di Gerico: il paragone non dispiace di certo a Eudes di Châteauroux. Sentiamo infatti alcuni passi dei suoi tre ‘Sermo de rebellione Sarracenorum Lucherie in Apulia’ scritti, diffusi, pronunciati per la Crociata indetta da papa Clamente IV. Siamo nel 1268 e Corradino si affaccia in Italia: la strategia papale è di sciogliere il nodo Lucera prima che possa costituire la testa di ponte per il ritorno del Sud nelle mani degli Svevi. Alla lettura ci pare che Eudes faccia della Parola divina un uso brutalmente mistificatorio. Bisogna avere in mente quello che Dante dice nel Convivio sui quattro livelli di interpretazione applicabili alle scritture. Il senso letterale, puramente descrittivo; il senso allegorico, che cela delle affermazioni di carattere generale; il senso morale, che indirizza verso i comportamenti guidati dalla fede; il livello anagogico, che svela i significati attinenti alle ‘superne cose de l’etternal gloria’. Eudes si muove agevolmente tra i quattro registri ma insiste naturalmente sull’ultimo: quello assoluto e indiscutibile della Volontà divina. Lucera 1, ‘Pietà l’è morta’. Il primo sermone potrebbe essere stato pronunciato a Viterbo per la Pasqua 1268, quando Carlo I e il suo esercito prendono la Croce dalle mani del papa e si avviano contro Corradino. Il messaggio infatti è da Terminator. Lucera è la Terra Promessa da conquistare alle condizioni dettate da Dio al popolo di Israele (Num. XXXIV). Quid terribilius quam quod in terra ecclesie lex Mahometa proclametur et observetur! Se vi rifiuterete di sterminare tutti gli abitanti, i sopravvissuti saranno per voi come chiodi negli occhi e lance nei fianchi e vi renderanno la vita difficile nella vostra terra. E quel ch’è più tremendo, Dio minaccia: “io farò a voi tutto quello che avevo deciso contro di loro”. Ma le anime belle si appelleranno al quinto comandamento ‘non 162 ammazzare’? Peggio per loro! Se i Saraceni vincono, distruggono i Cristiani. Se invece soccombono ma li si lasciano in vita, è anche peggio: “con il loro denaro acquisiranno il favore dei principi della terra e si faranno nominare esattori del fisco, in modo da poter meglio gravare i Cristiani e conculcarli”. Dobbiamo registrare su questa profezia un moto di contrarietà da parte di Lanfranco Tavasci. Un grande finale. “O Cristo, ti spinga alla vendetta la voce del sangue dei tuoi figli – voglio dire i Cristiani – sparso dagli empi Saraceni e dai loro padri come ancor oggi son pronti a fare, e anzi introdurranno altri Saraceni d’Oltremare. Sommuovi non solo la terra ma anche il cielo. Espelli e distruggi, Domine Deus noster. Amen”. Lucera 2, ‘Oh Jericho’. Come Gerico (Giosuè VII), le cui mura crollarono al suono delle trombe, e il sole arrestò il suo corso per consentire un lavoro rifinito. Haec ystoria parabola est instantis temporis. La terra promessa è questa, l’Apulia, e Dio l’ha assegnata al nostro Giosuè, cioè il signore Carlo. Anche questa terra promessa ha la sua Gerico che sarebbe Lucheria, habitatio et refugium Sarracenorum. Essi l’hanno fortificata e armata contro tutti i Cristiani: non solo quelli di Puglia ma di tutto il Regno di Sicilia. Ecco però che Dio ha ordinato ai sacerdoti di suonare la tromba contro questa Gerico di Lucera. “Che il popolo cristiano sorga dunque contro di loro con un animo solo e li elimini dal Regno; che ciò sia bastante a placare Iddio e ad evitare tutti i pericoli auxiliante Domino nostri Ihesu Christo qui vivit in saecula saeculorum. Amen.”. Lucera 3, ‘Il sentiero dei nidi di aspide’. Il terzo sermone è il più bello. Qualcosa ci fa pensare che sia rivolto a un pubblico di ecclesiastici. Il linguaggio è quasi espressionista, anche perché si appoggia a un visionario testo di Isaia: “Ova aspidum ruperunt et telas aranee texerunt. Qui comedit de ovis eorum morietur”. Hanno spaccato le uova dell’aspide / e tessuto la tela del ragno. / Chi mangia le loro uova morrà”. Le aspidi ovipare sono – chi ne dubita? – i Saraceni di Lucera. Più precisamente, secondo il Salmista, “aspidi sorde / che occludono i propri orecchi / per non sentire la voce dell’incantatore”. Vennero infatti più volte i predicatori domenicani fino a Lucera; ma gli empi che fanno? “Appoggiano un orecchio a terra e l’altro lo tappano con la coda” (chis163 sà dove sono gli orecchi dell’aspide). Così si sono negati alla verità cristiana; e, se anche parlano di paradiso, pensano a un luogo dove “ciascuno ha cento donne da soddisfare ogni giorno” (programma un po’ stressante, in verità). Ma forse un giorno potrebbero ravvedersi? Eh no: Gesù ha detto che non può essere suo discepolo chi non rinunzia a tutti i beni terreni; ma questi qui, e i loro genitori, semper intenti fuerunt divitia divitiis aggregare per mercimonia, per depredationes et furta: chiaro quindi che non potrebbero mai diventare discepoli di Cristo. Che poi il programma di ‘aggiungere ricchezze alle ricchezze’ potesse essere tranquillamente sottoscritto da qualunque cristiano, è un’idea che non sfiora Eudes neanche da lontano. La prassi dell’autocritica si sarebbe imposta diversi secoli dopo. E’ vero dunque che questi Saraceni sono simili alle aspidi e non si lasciano trarre fuori dalle tane dei loro peccati, o in subordine cacciar via dal Regno. E le uova? “Sono i disegni astuti e velenosi coi quali non solo una volta o all’improvviso, ma dai tempi antichi e in più riprese tramarono per spezzare il giogo dei Cristiani e sottoporli al proprio dominio. Oggi poi (con la ribellione contro Carlo in favore di Corradino) i loro disegni si sono chiaramente manifestati”. Magari è stato un moto spontaneo, improvviso? No: è malizia premeditata. E’ un complotto tessuto. C’è la prova? Eccola qua. “Le uova di aspide non si rompono in un colpo, come quelle dei polli quando nascono i pulcini. Esse devono essere incubate per più giorni, in modo che i serpentelli vedano la luce”. E i ragni? Ecco: questo gran lavorìo dei Saraceni è del tutto inutile. “Essi hanno intrecciato una tela di ragno: la tela si realizza con artificio e non senza impegno e fatica; e benché il ragno si finisca le viscere con la tessitura è facile rompere la tela e farla scomparire. Così i saraceni hanno tessuto tela di ragno con grandi veglie e fatiche e con grande astuzia; e tuttavia la loro opera sarà dissipata facilmente”. E che gli dobbiamo fare? Basta la parola: morietur. “La morte porta a compimento ogni genere di castigo. Infatti le pene sono di per sé ordinate alla morte, anzi sono temute soprattutto a causa della morte: nes164 sun castigo è più atroce del morire. Per questo ai peccatori viene comminata proprio quella cosa da cui si vorrebbe massimamente fuggire. Ai trasgressori della parola del Signore ‘chi fa questo, morrà’ giustamente viene data morte”. Ma Corradino? Ha solo sedici anni. “Tutto ciò che i Saraceni fecero aveva un obiettivo, ed è questo: che venisse alla luce il regulus, il basiliskos (reuccio in italiano, ma anche serpentello), cioè Corradino, il re dei serpenti. Il re degli uomini malevoli. Per le loro trame il clero e i religiosi saranno cacciati e privati delle dignità e dalle libertà; proprio come i nostri progenitori un dì furono cacciati dal paradiso, sedotti dalla malizia - appunto - del serpente”. Alla demonizzazione della gente di Lucera e del re Corradino manca un tassello solo: la beatificazione di Carlo d’Angiò e, magari, della sua santa Mamma, la regina Blanche. Lo sapete che Carlo, da piccino, si astenne spontaneamente dal seno della madre? E sapete che lei si addolorò tanto quando lui partì militare in Terrasanta? Là, però, si batté virilmente contro i Saraceni. E adesso, vi pare che non faccia tutto il possibile per cacciar via i Saraceni da Lucera e da tutto il Regno di Sicilia? Anche per far piacere alla Mamma. Oremus. “Che questo regulus non prevalga, ma la sua contumacia venga schiacciata da Cristo Signore; anzi meglio: dal Sommo Pontefice che, come Carlo, si è staccato dal seno materno, cioè si è allontanato volontariamente da ogni godimento carnale”. Questa preghiera – che sia il merito di Isaia, sia la lungimiranza del Salmista, sia l’impulso di Eudes de Châteauroux, siano le mammelle della regina Blanche, siano quelle simboliche del papa, sia la bravura di Carlo, siano i soldi dei banchieri toscani garantiti dalla Santa Sede – insomma alla fine viene esaudita. Napoli, piazza del Mercato, 29 ottobre 1268. Il regulus perde la corona e la testa. 165 167 SIPONTO Le divin verbe donrra à la sustance Compris ciel terre, or occult au fait mystique Corps, ame, esprit aiant toute puissance, Tant sous ses pieds, comme au siège celique (III, 2 ) Quale potrebbe essere l’incipit di un capitolo su Siponto? Come appoggiare anche una sola parola lì, dove gli archeologi hanno segnato ogni pietra con la traccia della loro sapienza? Forse prendendo un’altra strada: quella dell’immaginazione poetica. “Poi dalla solitudine si sprigiona una colonnetta, e le fanno seguito a pochi passi, su leoni, le colonne che, fra le scure sopracciglia di archi ciechi, reggono in una facciata deserta il ricco portale di Santa Maria Maggiore di Siponto. Non me ne intendo, ma non mi stupirei se questa cattedrale in mezzo al prato fosse davvero il primo esempio del costruire monastico e guerriero nel quale il Medioevo si provò a fondere le esperienze del suo rincorrere la visione del mondo, dall’innocente epica dei Mari del Nord alle erudite voluttà della svelta Persia. La nascita d’una architettura significa il principio d’una chiarezza spirituale e d’una volontà vittoriosa. Perché nell’era cristiana non dovrebbe essere stata per prima questa terra, questo ponte dei Crociati, a immaginare saldamente, nella pietra murata e ornata, un’unità fra Occidente e Oriente?”. Segue, Giuseppe Ungaretti, col segnalare come la cattedrale sipontina sia costruita, cubica, su una iterazione del numero quattro: espediente espressivo dei pitori cubisti del suo tempo. Dalla disposizione delle colonne al disegno delle losanghe che decorano la facciata, forse un tempo abbellite con specchiature di marmi colorati. Piacevolezze pisano-lucchesi? Sì, come dalla campagna toscana la ‘pieve’ di Santa Maria 169 sembra planare sulla città scomparsa di Devia. Chissà per quali mode e con quali strumenti le forme decorative e i disegni degli edifici potevano trasferirsi attraverso lo spazio? E’ classica, e ormai datata, la questione sulla dipendenza delle piramidi maya da quelle egiziane. Jurgis Baltrušaitis aveva affascinato la nostra giovinezza con i suoi collegamenti tra bizzarrie gotiche e disegni dell’Asia centrale e della Cina. Marija Gimbutas, lituana anche lei, nelle grotte della piana di Siponto aveva dato colpi di luce sui motivi decoranti gli oggetti d’uso. Ma c’era anche Carl Gustav Jung che rapportava certe immagini complesse al vocabolario dell’inconscio collettivo, mentre Rudolf Arnheim collega le forme essenziali alla memoria ram del nostro processore cerebrale. Di Santa Maria fanno parte anche i ritratti, per così dire, della Titolare: una icona bellissima e una statua in legno di cedro dipinto della fine del Mille, detta la ‘Sipontina’ o anche la ‘Madonna dagli occhi sbarrati’. L’immagine appunto esercita questa magia di attrarre lo sguardo verso il suo, meravigliato e addolorato. Non era nata così. Però, mentre si trovava nella sua chiesa originaria che adesso funge da cripta, fu sconvolta dallo stupro che subì Catella, figlia del diacono Evangelio, da parte del nipote del vescovo Felice. Non poté far niente per impedirlo: era solo una statua di legno; però le è rimasta questa espressione di dolente stupore. Il fatto è avvenuto davvero, alla fine del VI secolo: lo sappiamo dalle lettere che il papa, San Gregorio Magno, scrisse al vescovo, al suddiacono Pietro e al notaio Pantaleone perché venisse resa giustizia a Catella. Un risarcimento pecuniario? Un matrimonio riparatore? Questo non lo sappiamo. In ogni modo Catella sarà stata trattata meglio che Medusa, alla quale per un fatto simile la titolare del Partenone, Atena, inflisse quella capigliatura di serpenti e quello sguardo assassino. C’è da precisare che sia l’icona che la statua sono conservate nella infelice cattedrale di Manfredonia. Ungaretti legge Santa Maria di Siponto come una sintesi originale, e quindi significativa di una nuova visione del mondo, tra le costruzioni severe della Scandinavia e quelle vivaci dell’Oriente. In effetti, comparando piante di edifici sacri nei secoli stretti attorno al Mille, una somiglianza con Siponto si trova nell’architettura armena; e, più che nelle chiese, nel gavit, lo spazio di servizio che accoglieva i visitatori e 170 consentiva adunanze e predicazioni; manca solo un’apertura centrale sul soffitto. Quello che per Siponto riteniamo come certo dalla prosa ungarettiana è il ruolo di ‘ponte’. Non solo per il tempo e gli scopi dei Crociati che andavano in Outremer, ma soprattutto per ciò che veniva in senso opposto: ex Oriente lux. La koinè diomedea Siponto partecipa alla comunità dei centri urbani che devono a Diomede, eroe omerico e dantesco, la loro esistenza. Egli pour cause si dice abbia sposato la figlia del re illirico Dauno, eponimo del territorio foggiano. Questo mito di fondazione ‘in rete’, che comprende tra il XVI e l’XI secolo a.C.una costellazione di città ‘micenee’ lungo tutta la costa occidentale dell’Adriatico e anche nell’interno, come Aecae/Troia, Herdonia e Lucera, è dettagliatamente riportato da Strabone verso la fine del sesto libro della ‘Gegrafia’. “Si dice che Canosa e Arpi tutte e due siano fondate da Diomede, e si mostrano in questi luoghi come segni della signoria di Diomede la pianura (nel Tavoliere dovevano esserci dei Campi Diomedei o qualcosa di simile) e molte altre cose. Nel tempio di Atena a Lucera ci sono antichi doni votivi – anche questa città fu importante per i Dauni, pur essendosi ora un po’ immiserita –, e nel mare vicino due isole vengono chiamate ‘Diomedee’, delle quali una è abitata, l’altra dicono sia deserta. In quella deserta alcuni tramandano il mito secondo cui Diomede scomparve (il testo greco dice aphanisthénai, che in realtà significa ‘non essere più visto’, non proprio ‘morire’), mentre i compagni furono trasformati in uccelli e ancora rimangono domestici e conducono una vita in qualche modo umana, avvicinandosi agli uomini perbene e fuggendo i malfattori. Si è già parlato delle tradizioni diffuse tra i Veneti a proposito di Diomede e degli onori che vengono tributati a questo eroe. E’ ritenuta fondazione di Diomede anche la città di Sipous, che dista da Salapia circa 140 stadi ed era chiamata, con nome greco, Zepious a causa delle seppie spiaggiate qui dalle onde. Fra Salapia e 171 Sipous c’è un fiume navigabile e una grande laguna: attraverso queste vie d’acqua vengono trasportate le merci provenienti da Sipous, e soprattutto il grano”. Ma, di fatto, che cosa è successo a Diomede? Strabone ci offre quattro opzioni. O è stato richiamato in patria, ad Argo, e lì sorpreso dalla morte. O è rimasto qui dove è morto naturalmente. O è stato assunto in qualche modo al cielo, come avevamo detto sopra, nell’isola disabitata delle Tremiti. O, simile a questa, “la versione narrata dai Veneti: essi favoleggiano che la scomparsa di Diomede sia avvenuta presso di loro, e la chiamano ‘apoteosi’, deificazione”. Ora, che cosa significa rivendicare la fondazione da parte di Diomede, cioè innestare il mito di fondazione in un mito di colonizzazione? Il senso sembra essere un riscatto dell’alterità etnica; la proiezione di una matrice greca sulla dimensione illirica della prima civiltà daunia; l’attribuzione alla volontà divina dell’atto di colonizzazione: la ventilata assunzione in cielo e la ‘deificazione’ dell’eroe ne sono una garanzia. E se cerchiamo le radici comuni dell’Europa non possiamo fermarci che a Troia, madre del Mediterraneo: ogni civiltà locale, sia che si richiami a Micene come Foggia, sia che si scopra discendente da Troia come Roma, nasce da quella conflagrazione di culture che l’ ‘Iliade’ è lì a testimoniare. Un punto di osmosi Nella rete di città daunie fecondate dalla grecità micenea, Siponto riceve dal mare, oltre alle sue seppie, la cultura materiale e il mondo di idee che per diverse vie procede dal crogiolo della civiltà: la terra fra i due fiumi. Siponto, quindi, come Stargate. Non l’unico, non il primo, non il più importante. Ma reale. A un certo punto le seppie portano il sussurro di una visione del mondo nuova, che procede dall’ecumene greco e viene a far guerra a quello romano. Il cristianesimo. A Siponto si attribuisce un primo vescovo, Giustino, consacrato da San Pietro di passaggio verso il martirio, nel 64 d.C. 172 Di certo questo è uno dei porti attraverso i quali filtra il cristianesimo, assieme a Brindisi, Egnazia, Otranto. Gli storici oppongono che la prima figura certa della chiesa sipontina è il vescovo Felice che partecipa al Concilio del 465 a Roma. Morto Felice, nel 491 i Sipontini chiedono un successore al loro patriarca naturale, quello di Costantinopoli. L’imperatore Zenone gli assegna un suo parente: Lorenzo. Il quale viene a Roma, si fa consacrare da papa Gelasio e si insedia a Siponto consegnando come dono ai fedeli le reliquie di Santo Stefano e di Sant’Agata. Ma la fortuna sua e della diocesi sarebbe dipesa da un altro soggetto sacro, sempre collegato a culti di origine orientale: l’arcangelo Michele. Il quale, in quel lasso di tempo, stava dedicandosi a bonificare grotte e montagne di mezza Europa dai culti pagani. Sua mira principale i misteri persiani di Mitra, con il toro sgozzato che piovendo sangue sui fedeli li faceva sentire rigenerati. Per questo il culto furoreggiava tra gli eserciti della tarda romanità. Ma bisogna anche ammettere che vi era una qualche tenerezza reciproca tra il mitraismo e il cristianesimo: assai spesso i mitrei, luoghi di culto sotterranei attrezzati appositamente per i riti e per il pasto sacro, l’agape, davano origine a chiese cristiane, come a Roma nel rione Monti la basilica di San Clemente. Questo dolce subentrare del culto cristiano a quello orientale, mediato dall’angelo Michele, era la restituzione di una cortesia: la visita dei Magi zoroastriani alla culla di Gesù, sempre avendo l’angelo come guida. Il Monte come destino Mons Garganus inminens Sipontinae civitati, dice Servio nel commento alla ’Eneide’. Subdita Sipus montibus, aggiunge Lucano nella ‘Farsaglia’. Dunque il Gargano incombe e condiziona l’immagine di Siponto. Le vicende del vescovo della costa, Lorenzo, e di Michele, angelo del monte, sono note per tradizione, per un paio di Vite tardive e per un testo del X secolo chiamato ’Apparitio’. Il clou del racconto è la difesa da parte di Michele di un toro rifugiatosi nella sua grotta, forse 173 per alludere ai culti di Mitra. La parte più divertente è l’intemerata dell’iroso arcangelo al vescovo Lorenzo che solo dopo ripetute apparizioni e miracoli anche militareschi (come la salvezza dai Goti di Odoacre) si era deciso a salire sul Gargano per consacrare la grotta. ‘La mia casa me la sono consacrata da solo, sibila; voi dovete soltanto celebrarvi i sacri riti’. Iniziative simili, per la cronaca, l’arcangelo assumerà poi a Mont Saint-Michel, nel mare dei Normanni, e alla Sacra di San Michele in val di Susa, come racconta Rodolfo il Glabro, il cronista dell’Anno Mille. Nel 1188 Monte Sant’Angelo era già una meta turistica di massa. Testimonia un bestseller dell’epoca, il ‘Florimont’ di Aimon de Varennes: Un signore ebbe terre sul monte Gargano. Era nativo di Siponto. Egli portava lo stesso nome del monte: Gargano, A causa dei possedimenti che vi teneva. Attraverso un torello che egli aveva Dio gli mostrò una tale forza Che egli fece un monastero sotterraneo: Uno più bello non se ne potrebbe vedere. San Michele vi è adorato. Adesso è un sito di gente affollato. Le folle sul Gargano si erano viste anche prima dell’insediamento di Michele. Sempre per ragioni sacre e lievemente sulfuree. Strabone, sesto libro della ‘Geografia’: “Su un’altura di nome Drion si vedono due templi. Sulla cima quello di Calcante: i fedeli che consultano l’oracolo gli sacrificano un montone nero, si avvolgono nella pelle e dormono. Più in basso, ai piedi, c’è il tempio di Podalirio, che dista dal mare circa 100 stadi (meno di due chilometri). Dal monte Drion scende un ruscello che guarisce le malattie degli animali”. Siamo in piena Iliade: Calcante sarebbe il profeta che auspicò il sacrificio di Ifigenia in Aulide per avere vento favorevole alla flotta greca; ma c’è chi dice che sia un omonimo re-sacerdote daunio, cioè illirico. 174 Quel che è certo, nel tempio in cima al monte si pratica l’antichissimo rito dell’incubatio. Calcante appare ai dormienti nel vello nero del caprone sacrificato e svela gli arcani esistenziali. Anche Fauno, presso Tivoli, offre lo stesso servizio: lo descrive Virgilio nel settimo libro dell’Eneide. Bisogna dire che, all’origine, i riti di incubatio e in genere le interpellanze degli oracoli si facevano volentieri nelle grotte, vicini al grembo della Terra. Forse è lì che Michele… Podalirio è invece il grecissimo figlio di Esculapio e fratello dell’ ‘ufficiale medico’ Macaone; i due guariscono Filottete dalla purulenta ferita causata dal morso di un serpente; si rilegga l’omonima tragedia di Sofocle, mentre si dà per scontato che l’Iliade sia il livre de chevet di ogni buon Occidentale. Il cristianesimo, in qualche secolo, nel passare da religione urbana a credenza rurale, fa tabula rasa di queste pratiche. Ma i bisogni restano. E ci rimane un dubbio: Michele avrà saputo rispondere in qualche modo ai bisogni di divinazione delle popolazioni del Tavoliere? E come avrà fatto? La morte di Siponto La vittoriosa e in parte enigmatica cattedrale di Santa Maria, consacrata da Pasquale II nel 1117 con la traslazione del corpo del vescovo San Lorenzo, domina un territorio vasto che gli scavi ci consentono di immaginare, in parte. C’è anche il pavimento della cattedrale precedente, ortogonale a questa. Ci sono gli ipogei in vista del mare. Se ci facciamo suggerire una lettura del luogo da un poeta ionio, sentiremo che questi muri di calcare dorato siedon custodi dei sepolcri, e quando il Tempo con sue fredde ali vi spazza fin le rovine, le Pimplee fan lieti di lor canti i deserti, e l’armonia vince di mille secoli il silenzio. Il silenzio di Siponto si chiama acqua, sabbia, malaria e terremoto. A 175 Manfredi, il figlio e successore di Federico, toccherà prendere atto che la città non è più viva. Dice Giovanni Villani, il consulente finanziario fiorentino prestato alla storiografia dopo un infortunio con la Giustizia fiscale: ”Questo Manfredi fece disfare la città di Sipanto in Puglia, perché per gli paduli che l’erano intorno non era sana, e non avea porto; e di quelli cittadini ivi presso a due miglia, in su la roccia e in luogo d’avere buono porto, fece fondare una terra, la quale per suo nome la fece chiamare Manfredonia, la quale ha oggi il migliore porto che sia da Vinegia a Brandizio”. Siponto viene aggredita dall’acqua che si allontana, dai pirati, dai terremoti: uno disastroso nel 1223 e quello definitivo nel 1255. Il disfacimento dell’ecosistema trasferirà nella popolazione l’idea che bisogna allontanarsi di lì. Con prontezza e spirito costruttivo sarà il re Manfredi ad affrontare la situazione: fondiamo una nuova città. Otto anni dopo è già tracciata Manfredonia. In parallelo scompare Siponto, le cui pietre sono disponibili a disegnare la nuova forma-città. Fortunatamente Santa Maria resterà come segnacolo di una comunità vivente per secoli e aperta ad accogliere idee, curiosa di forme nuove, appassionata della mediazione culturale. Chissà se avrà avuto sentore di questi valori l’Arcivescovo che governò Siponto tra il 1447 e il 1449? Purtroppo era un prelato commendatario, quindi semplicemente percepiva le rendite, e di sicuro non vi si fece mai vedere. Ma sarebbe stato in grado di portare a compimento la missione storica di Siponto. Il cardinale Bessarione, già patriarca Vissarion di Trebisonda, umanista, attore al Concilio di Firenze della effimera riconciliazione tra le due chiese e poi animatore della vita culturale romana: abitò sulla via Appia in un palazzetto (il ‘casino’) che sarebbe diventato un modello di architettura rinascimentale. All’arcivescovo commendatario di Siponto si deve, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, l’accoglienza dei dotti bizantini in fuga dagli Ottomani, e soprattutto la raccolta dei codici di autori greci che lascerà a Venezia come nucleo della Biblioteca Marciana. 176 Biondo, bello, e di gentile aspetto L’ultimo Hohenstaufen a cingere la corona è Manfredi, che regna in pratica, come reggente, dal 1250, quando muore Federico, fino al 1266, quando a Benevento viene sconfitto e profanato da Carlotto d’Angiò, come lo chiamava lui. Tranne il breve intermezzo in cui scese di Germania il titolare della corona di Puglia e Sicilia, suo fratello Corrado. Dopo qualche tensione Corrado, che non aveva molta salute, venne meno lasciando il figlio Corradino sotto la tutela dello zio. Naturalmente le malelingue, amplificate al solito dagli scrittori guelfi, vollero che la dipartita di re Corrado nel 1254 fosse dovuta ad un clistere avvelenato, così come vollero che Federico fosse stato aiutato a morire, sempre da Manfredi, con un cuscino premuto sulla faccia. Leggiamo, passeggiando con Franco e Angela sugli spalti angioini del castello di Manfredonia, questa descrizione di Manfredi che si deve a Giovanni Villani, espressione dei papa-boys, “Il detto re Manfredi fue nato per madre d’una bella donna de’ marchesi Lancia di Lombardia, con cui lo ’mperadore ebbe affare; e fu bello del corpo, e come il padre, e più, dissoluto in ogni lussuria; sonatore e cantatore era, volentieri si vedea intorno giocolari e uomini di corte, e belle concubine, e sempre si vestìo di drappi verdi; molto fue largo e cortese e di buon’aire, sì ch’egli era molto amato e grazioso; ma tutta sua vita fue epicuria, non curando quasi Idio né santi, se non al diletto del corpo. Nimico fu di santa Chiesa, e di cherici e de’ religiosi, occupando le chiese, come il suo padre e più; ricco signore fu, sì del tesoro che gli rimase dello ’mperadore e del re Currado suo fratello, e per lo suo regno ch’era largo e fruttuoso. E egli, mentre che vivette, con tutte le guerre ch’ebbe colla Chiesa, il tenne in buono stato, sì che ’l montò molto di ricchezze e in podere per mare e per terra. Per moglie ebbe la figliuola del dispoto di Romania, ond’ebbe figliuoli e figliuole. L’arme che prese e portò fue quella dello ’mperio, salvo ove lo ’mperadore suo padre portò il campo ad oro e l’aguglia nera, egli portò il campo d’argento e l’aguglia nera”. In effetti il vessillo nero e argento non è considerato di buon augurio, ai nostri tempi; forse a Benevento non ci si sarebbe presentati con questi colori. 177 La Fille ainée de l’Église. Non sappiamo se la liquidazione degli Hohenstaufen rientri in qualche modo tra gli archetipi della questione franco-tedesca. Sedan e Dunkerque contro Benevento e Tagliacozzo? Certo è che gli Svevi vengono atterrati da una filiera di papi francesi che vogliono insediare il sang royal capetingio nel Sud Italia considerato come proprietà feudale. La tensione tra la Sede di Pietro e le successive case imperiali germaniche, dopo l’idillio tra Gerberto d’Aurillac e Ottone III di Sassonia, è un’asse portante dell’alba del Millennio. Chi non ricorda Enrico IV in ginocchio nella neve davanti al castello di Canossa? E la lotta per le investiture, monumento al conflitto di interessi per due secoli (se un vescovo è anche signore feudale, chi ha il diritto di nominarlo: il capo della piramide feudale o il capo della piramide ecclesiastica)? Però fino alla morte di Federico il dissenso non si era mai intrecciato con le nascenti nazionalità. Apre le ostilità papa Urbano IV; Jacques Pantaléon, il figlio del ciabattino di Troyes innalzato nel 1261 al soglio pontificio per manifesta volontà divina: per sbaglio bussò alla porta del Conclave, gli aprirono e lo incoronarono. Manfredi offre tempestivamente l’omaggio feudale e una somma di denaro per le opere di carità del nuovo papa. Ma Urbano apre il fuoco su tutta la linea: la Crociata; la richiesta a Luigi IX poi santo di prestargli il fratello, l’inquietante ed insonne Carlo d’Angiò; la citazione di Manfredi in giudizio; le pressioni sul re Giacomo d’Aragona per impedire le nozze tra il figlio Pietro e la figlia di Manfredi, Costanza. Ma quello che ci fa intravedere un disegno nazionalistico nella lotta contro gli Hohenstaufen è che Urbano rafforza nel Sacro Collegio la presenza di cardinali francesi: anche dopo la sua morte è assicurata l’entente cordiale tra la Sede apostolica e la nazione definita, al battesimo di Clodoveo, la Fille ainée de l’Église. E infatti nel 1265 il nuovo papa è Guy Foulques da Saint-Gilles du Gard, la cui abbazia è oggi reputata per la facciata mai completata e per la grazia della fecondità che viene concessa alle signore che venerano le reliquie del santo; la grazia opposta a questa non risulta che sia elargita in alcun santuario. Clemente IV è meno assatanato del predeces178 sore, più uomo di mondo, ma al cambio di suonatore la musica è la stessa. La conclusione, si sa, è a Benevento il 26 dicembre 1266. De pulcritudine civitatis Manfredonie Questo titolo è preso nientemeno che dall’arcinemico padano degli Hohenstaufen, Salimbene da Parma. Poi leggeremo i suoi commenti. Ma intanto Manfredi, per fortuna della Capitanata e con l’ottimismo della ragione, va avanti a risolvere il problema di Siponto. Nel 1263 il progetto urbanistico viene approvato, con attenzione alla bio-architettura che abbiamo visto Annibale applicare a Prusa. Viene tempestivamente trasferita la sede episcopale nel nuovo centro abitato, riconoscendo la funzione poleopoietica del vescovo. Manfredi ha una strategia: vuole che Manfredonia diventi il capoluogo amministrativo della Puglia, il massimo centro commerciale; stabilisce lì una zecca che, dal 1263 al ’66, conia i denari di biglione con la grande M gotica o romana al diritto e la croce al rovescio, e i tarì d’oro con l’aquila ad ali spiegate e la croce. Naturalmente Carlotto chiude la zecca e fonde le monete con il marchio dell’odiato predecessore. I collezionisti oggi gli sono grati perché le ha rese una rarità. Ma la nuova città ha bisogno anche di un suono che le sia proprio e riconoscibile in un raggio vastissimo. Manfredi, per la salvezza dell’anima sua e per chiamare a soccorso se Manfredonia fosse attaccata dai nemici mentre è ancora in costruzione, ordina una campana enorme, la più bella che ci sia. Quanto Hohenstaufen c’è in questa volontà! Ma quando la sente, gli pare debole: la fa rifare con nuovo metallo, racconta Matteo Spinelli da Giovinazzo. Avrà vita breve questa campana. Carlotto la fa trasportare a San Nicola di Bari; poi lì viene fusa per farne monete. Ma siccome noi troviamo molta più verità nelle leggende che nelle cronache, diciamo che la campana fu trascinata via dai Turchi durante un saccheggio – forse quello del 1620, assieme a Giacometta Beccarino che divenne moglie del sultano? Di fatto, in mezzo al mare una tempe179 sta affonda la nave sacrilega. Ma per la festa di San Lorenzo Maiorano, il patrono di Siponto, proviene dalle profondità degli abissi il suono cupo e solenne della campana. E anche in seguito la si potrà ascoltare. Chissà se si crea l’effetto emerso-sommerso che Debussy riesce a dare nel magico preludio ‘La Cathédrale engloutie’… In realtà sono due i Manfredi che affrontano felicemente il dramma di Siponto: il figlio di Federico e lo zio ricco e potente, Manfredi Maletta signore di Monte Sant’Angelo, fratello di Bianca Lancia d’Agliano. Giovanni Villani riporta che “di quella terra fue Manfredi Bonetta, conte camerlingo del detto re Manfredi, uomo di gran diletto, sonatore e cantatore, il quale per sua memoria fece fare la grande campana di Manfredonia, la qual è la più grande che si truovi di larghezza, e per la sua grandezza non può sonare”. Del resto il terreno su cui sorge Manfredonia era di sua proprietà, e giustamente egli sarà nominato dal nipote signore della città che porta il proprio nome. O forse il nome di ambedue? La parola al nemico Sulla fine di Siponto e la sua rinascita come Manfredonia lasciamo all’opposizione la parola finale. Salimbene ci testimonia lo stato di Manfredonia proprio mentre sta in corso d’opera. Si vixisset princeps per paucos annos amplius, fuisset Manfredonia una de pulcrioribus civitatibus de mundo. Bastava che Manfredi non fosse morto a Benevento: pochi anni ancora e Manfredonia sarebbe tra le più belle città al mondo. “Il circuito delle mura è lungo quattro miglia, dicono. Ha un porto ottimo, ed è ubicata alle radici del monte Gargano. La strada principale è già tutta costruita, e tutte le fondamenta delle altre abitazioni sono pronte. Ha delle vie molto ampie, il che conferisce molto alla bellezza di una città. Sed rex Karolus habet eam exosam, in tantum quod eam audire nominari non potest, immo vult quod appelletur Sipontus nova. Il re Carlo ce l’ha in uggia, non sopporta nemmeno di sentire il nome: per questo vuole che sia chiamata Siponto Nuova. Però bisogna ammettere che il principe Manfredi ha fatto anche qual180 cosa di buono: ne ho scritto a sufficienza nel mio libro su papa Gergorio X. Lo storico infatti deve essere una persona di buon senso: non deve scrivere solo le cose negative di qualcuno tacendo tutte quelle positive”. Noi non siamo per niente degli storici, ma crediamo di aver seguito il buonsenso di fra’ Salimbene. La cui opera raccomandiamo di leggere: è molto folle, assai divertente, e facilmente comprensibile in un latino parmigiano ormai vicino – senza volere – al maccheronico mantovano che sarà inventato da Merlin Cocai. E si scarica on line. 181 183 LA MAGNA CAPITANA Un vademecum per luoghi pieni di riserbo e non sempre offerti con facilità. Questo era l’obiettivo del testo e delle ricerche che lo hanno accompagnato. Per forza abbiamo attraversato, da viaggiatori curiosi, i terreni dell’archeologia, della storia, delle letterature classiche. L’abbiamo fatto in punta di piedi e sempre con un filo di autoironia: i testi specialistici sono ben altri, e quelli divulgativi richiedono un possesso delle materie che noi non ci sogniamo. Per accentuare il disimpegno dalle scienze, le citazioni non hanno quasi mai referenze bibliografiche e, peggio, alcune sono lasciate senza indizi sull’autore. Una piccola civetteria. Alla fine, ci bastava evocare delle atmosfere e suscitare delle curiosità; ricordare, delle Terre Foggiane, spessori e orizzonti che non sono più evidenti. Per ciò il titolo ‘Città dimenticate’. Il nostro ideale narrativo resta sempre l’Aleph di Borges: “il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli”; ma nemmeno la Biblioteca di Babele sarebbe sufficiente a contenere il nostro testo. Quindi, umilmente, abbiamo distribuito il racconto tra le dieci stazioni del percorso mirando a una certa consequenza storica. Abbiamo insistito sui Dauni tra Herdonia e Matinum; sui Greci a Arpi e a Salinis; sui Romani a Herdonia e a Salinis; sui Bizantini a Montecorvino; sui Longobardi tra Montecorvino e Tiati; sui Normanni a Tiati; sui Saraceni a Tertiveri; sugli Svevi a Fiorentino e a Siponto; sugli Angioini a Tertiveri. E’ inevitabile che una terra parli con più convinzione di chi l’ha amata maggiormente. Questo spiega perché nei successivi volumi di ‘Terre 184 Foggiane’ aleggia volentieri lo spirito della famiglia sveva. Consapevoli di questa preferenza, affidiamo la conclusione di ‘Città dimenticate’ a chi invece ne ha coltivato il ricordo e la nostalgia: Enzo re di Sardegna, figlio giovanile di Federico e di Alayta di Urslingen. Come il padre e il fratello Manfredi egli era seduttivo, valente, amante della poesia e della falconeria. Dalla prigionia in Bologna scrisse una canzone: “e vanne in Puglia piana, la magna Capitana, là dov’è lo mio core nott’e dia”. 185 ROLANDO GRECO La litografia che apre ‘Le Città dimenticate’ è un’opera originale di Rolando Greco. Rolando Greco nasce il 18-12-1966 a Cosenza (Montalto Uffugo). Si trasferisce nel 1986, a 20 anni, a Stradella (PV) dove ha modo di approfondire le sue qualità artistiche grazie alla conoscenza di diversi maestri. Nel 1992 entra a far parte del gruppo artistico “en-plain-air” storico gruppo nato nel 1930, fondato dal Maestro Walter Visioli e seguito da molti critici d’arte, tra cui Umberto Zaccaria, Umberto Tessari, storico d’arte, Luciano Bertacchini, Dino Pasquali, Gianni Ingoglia, Presidente annuario Comet Milano, e di cui fece parte Renato Guttuso nel 1966. La partecipazione a questo gruppo ha dato a Rolando Greco la possibilità di girare l’Italia ed esporre le proprie opere nelle varie rassegne. Nel 1997 gli viene conferito a Nardò in Puglia il diploma di “Maestro del pennello”. Partecipa a numerosi concorsi nazionali, conseguendo lusinghieri consensi di critica e pubblico e ottenendo significativi premi, fra i quali si ricordano: Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica; Medaglia d’Argento del Comune di Milano; Medaglia della Regione Lombardia; Medaglia della Città di Bergamo; Oscar dell’arte 2001 – Targa D’Oro Regione Lombardia. Opere di Rolando Greco si trovano quasi in tutti i Paesi del mondo, sia nei Musei e Collezioni pubbliche, sia nelle collezioni private di persone che apprezzano il suo linguaggio molto personale. 187 MARIA CHECCHIA Le dieci illustrazioni che esprimono il concetto di ciascuna delle ‘città dimenticate’ sono opera originale dell’artista foggiana Maria Checchia. Maria Checchia inizia il suo percorso artistico nella città nativa frequentando tra il ’91 e il ’95 l’Accademia di Belle Arti e proseguendo con una serie di mostre e concorsi nell’ambito della pittura e dell’illustrazione. Il processo creativo delle sue opere si manifesta attraverso un’auto-sensibilizzazione dei soggetti da lei rappresentati in contesti in cui il regno animale ed umano vivono un rapporto simbiotico. Da qui nasce per l’artista l’esigenza di dipingere una serie di opere dedicate ad argomenti come i 7 peccati capitali e numerose illustrazioni su ibridi e il regno fantastico. Gran parte delle suggestioni figurative hanno uno stretto legame con i temi e le contaminazioni musicali, con una predilezione particolare per la musica dei grandi cantautori come Paolo Conte, Vinicio Capossela, Giorgio Gaber o Tom Waits. Il suo metodo di lavoro si lega al foto-realismo, ma senza rinchiudersi nella banalità della cruda rappresentazione iperrealistica di un soggetto, lascia alle immagini che realizza un tratto più illustrativo ma con una ricerca del dettaglio davvero incredibile. A partire dal ’99 approfondisce il suo percorso creativo attraverso l’Aerosol Art ed ispirata da questo movimento realizza innumerevoli lavori in tutta la penisola, partecipando a molte tra le più prestigiose Convention di writing, mantenendo sempre la sua forte impronta figurativa. Partecipa al progetto per la campagna di sensibilizzazione delle problematiche femminili all’interno del “Progetto Dominae” (2001) a 188 cura dell’assessorato alle Politiche Femminili e Pari Opportunità della Regione Lombardia. Realizza una rivisitazione in chiave contemporanea de “L’ultima cena”, 2003 (Opera sita nella chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Rodi Garganico). Elabora alcuni interventi pittorici sulle palizzate del cantiere del canale Molassi (“Balôn”) presso il Comune di Torino (2004). Realizza il dipinto murale della facciata d’ingresso dell’Auditorium del “Villaggio Don Bosco”, a Lucera (2006). E’ ospite per la realizzazione di numerosi dipinti murali durante le diverse rassegne internazionali di writing come i“Meeting of Styles”(Padova ’05-’06; Anversa, Belgio ’06; Eindhoven, Olanda ’06;Wiesbaden, Germania ’07). Vince il Primo Premio della 3° Edizione del Concorso Nazionale “Lanciano nel Fumetto”, Settore Illustrazioni (Lanciano, CH), 2006. Espone alcune opere presso i locali espositivi dei cantieri navali dell’ “Inside”, con una relativa performance tematica in memoria del 30° anniversario degli incidenti presso gli stabilimenti dell’ex-Enichem di Manfredonia (FG). Si esibisce in “live painting” all’evento “Art de Mar”insieme a 60 artisti internazionali presso il perimetro delle pareti dell’Università della scienza e della tecnica di Matarò (Barcellona,2007). Espone alla Provincia di Foggia in una mostra titolata “Tracce dei segni” con un testo critico di Gaetano Cristino e la presentazione di Vito Capone (Foggia,2008). Partecipa alla collettiva presso il Centro Poliedro di Pontedera con interventi in live painting sui muri perimetrali degli stabilimenti Piaggio (Pontedera, 2008). In quest’ultimo anno vince il primo premio al concorso “Le strade del paesaggio” tenutosi ad Arcavacata (CS) e viene scelta per illustrare con dieci tavole i capitoli de ‘Le Città dimenticate’, Edizioni GEMA 189 GRAZIE Ai maestri dell’Archeologia in Daunia: a Marina Mazzei, non dimenticata, e ai suoi collaboratori; a Giuliano Volpe e alla sua scuola. Agli amici che hanno reso facile la ricerca delle città dimenticate; Angela Bruno, Saverio Lamarucciola, Francesco Paolo Marucci, Matteo Vocale, tra i primi. A Franco Iadarola, compagno di sopralluoghi e di scrittura. All’inventore di ‘Terre Foggiane’, Aldo Chiappe bonae memoriae. A tutti gli uomini del passato che ci hanno consentito di giocare con loro: Dante Alighieri, Amato di Montecassino, Eudes de Châteauroux, Benedicto Cochorella, Anna Comnena, Guglielmo de Apulia, Nicolò Jamsilla, Licofrone, Liutprando di Cremona, Tito Livio, Goffredo Malaterra, Mattheo di Giovinazzo, Michel de Notre-Dame, Omero, Orazio Flacco, Plutarco, Piero della Vigna, Salimbene da Parma, Strabone, Giovanni Villani, Giuseppe Ungaretti, Walther von der Vogelweide. 191 Finito di stampare nel giorno di Virgilio dell’anno duemilaotto da Edizioni d’Arte Severgnini in Cernusco sul Naviglio in settecento esemplari di cui i primi duecentosettanta numerati in confezione.
Scaricare