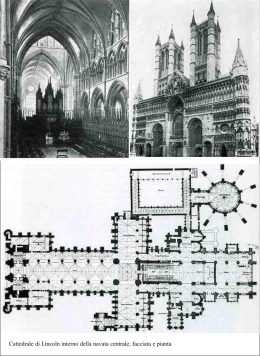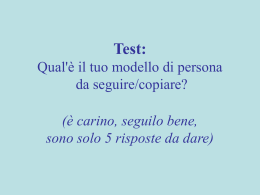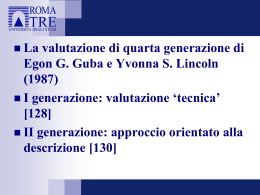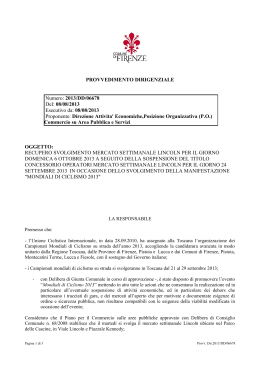Manifesto – 28.11.12 Fragili speranze erette sulle rovine - Giorgio Boatti Un atlante delle rovine, soprattutto se dedicato a un paese come l'Italia, è creatura troppo variegata e stratificata, mutevole e ingannevole, perché possa accasarsi dentro le pagine di un solo libro, pur intenso e attentamente costruito quale Spaesati. Luoghi dell'Italia in abbandono tra memoria e futuro, pp, 250, euro 18, che Antonella Tarpino ha appena pubblicato da Einaudi. Già c'è qualcosa di paradossale e contraddittorio, di speranzoso e scorato al tempo stesso (che sia «il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo etc etc...»?) nel progetto di dar vita a una costruzione, seppur fragile come un libro, attingendo a rovine. Le baite di Paraloup. Rovine, non macerie, come già nelle pagine iniziali precisa l'autrice: poiché «la maceria...è traccia inerte del passato, sequenza muta di un tempo che non parla più», mentre la rovina è il suo contrario: «irriducibile alla storia, o almeno alla cronologia (in quanto...incrocio di passati multipli, tutti inesorabilmente "in rovina") essa dà tuttavia ancora segni di vita». La rovina è qualcosa di «caduto fuori dal tempo, costretto a cedere a nuove pur precarie funzionalità, a progetti a loro volta mai durevoli». La rovina, insomma, «è sospesa in una fine, piuttosto che finita». Dunque se questa è la rovina, e se costruire è dar vita a qualcosa di nuovo per farvi abitare il futuro, costruire attingendo a rovine è accendere un cortocircuito, evidenziare contraddizioni e implicazioni di un non sopito evolvere. Del resto ne sa qualcosa questo nostro Bel Paese nel quale, da sempre, sino a poco tempo fa, il nuovo è stato quasi sempre fabbricato attingendo, in qualche misura, alle rovine circostanti. Dando vita a quella metabolizzazione del passato, a volte riuscita, a volte molto meno, da parte del presente. Da qui prendeva e prende vita il non ancora esistente. Il futuro, dunque. È con questo spirito che, senza enfasi, con applicazione e sabaudo understatement, muove il viaggio di Antonella Tarpino lungo la penisola alla ricerca di luoghi in abbandono. Muove i primi passi dalle baite in rovina dei borghi delle Alpi occidentali da cui presero l'avvio le prime bande partigiane: sono le baite di Paraloup e gli orizzonti delle valli contigue alle quali, dopo la Resistenza, tornò Nuto Revelli per costruire quel monumento alla memoria della vita quotidiana della gente di montagna eretto con Il mondo dei vinti pubblicato da Einaudi. Sono gli stessi luoghi dove Olmi e Stajano gireranno Nascita di una formazione partigiana e Paolo Gobetti Prime bande. Dalle parti di Paraloup ora molti ambienti sono stati recuperati - c'è lo spazio per il museo multimediale, la biblioteca, l'area dell'ospitalità - con interventi dove è esplicita la discontinuità tra il pre-esistente e quanto di nuovo si presenta oggi agli occhi del visitatore che vede all'opera la «supplenza» del moderno - all'insegna della sostenibilità ambientale e della reversibilità - nel sorreggere l'antico in rovina. Confini mobili. Quello che traspare dall'esperienza di Paraloup, luogo che come tante altre località di montagna è stato investito dalla discesa a valle degli abitanti e dal progressivo abbandono, emerge anche dalle altre tappe di questo viaggio condotto attraverso la penisola. Antonella Tarpino pare seguire un crinale non orografico ma storico e culturale, soggettivo e, al tempo stesso, condiviso, lungo quel confine mobile che passa tra rovine e macerie, memoria e abbandono, spaesamento e costruzione di un nuovo accogliere. Dalle Alpi scende alle grandi cascine della pianura attorno al Po, scenari delle lotte contadine del dopoguerra e, ora, luogo di vita e di lavoro degli immigrati indiani che, utilizzando le più sofisticate tecnologie installate nelle stalle, sostituiscono, nell'accudimento delle mucche, i mungitori e i lavoranti agricoli che facevano da sfondo alla narrazione cinematografica di Novecento, il film di Bertolucci girato proprio in questi luoghi. Qui ci sono ambienti come il «Calderon» (la Cascina Falchetto del Vho di Piadena) ripresi negli primi anni '90 da Giuseppe Morandi, uno dei fondatori della Lega della Cultura di Piadena, nel filmato I Paisan. I «carriolanti» dell'Aquila. La vita quotidiana dei contadini, così come si svolgeva nella prima metà del Novecento a «El Calderon», occupava un posto centrale ne Il paese sbagliato, Einaudi, 1970, il libro costruito da Mario Lodi, allora maestro elementare e animatore della biblioteca di Piadena, assieme ai suoi scolari. Del resto in un'altra cascina vicina al Vho c'è la Drizzona dove Mario Lodi ha poi impiantato la sua «Casa delle arti e del gioco» per continuare con mostre, seminari per insegnanti, visite di scolari, il suo impegno di decenni fa. Il percorso di Antonella Tarpino prosegue quindi attraverso quella spina dorsale della penisola rappresentata dall'Appennino, fragile e ballerino compagno della vicenda italiana, presenza con cui talvolta è così doloroso, faticoso e tuttavia imprescindibile imparare a convivere. Vi sono dunque, in Spaesati, le pagine dedicate al centro dell'Aquila distrutto dal recente terremoto e l'incontro con i «carriolanti» che, contro l'inazione dello Stato e dei commissari straordinari nominati dal governo Berlusconi, portano via le macerie, come azione emblematica di rivendicazione di un urgente recupero del centro storico della città e della vita comune che vi deve rifiorirre. Altre tappe, sempre intense, oltre a quella al monumento ai martiri delle Ardeatine posta a conclusione del libro, conducono nell'Irpinia messa in ginocchio dal terremoto del 1980 e rimessa in piedi da una ricostruzione dissennata, priva di saggezza urbanistica e di meditato rispetto delle rovine che costellavano il territorio. Questo, come sanno i lettori dei numerosi libri del paesologo Franco Arminio, ha significato per intere comunità sperimentare uno stare in piedi stralunato, senza baricentro, come se il terremoto si fosse trasferito nell'anima dei sopravvissuti. Il viaggio di Spaesati raggiunge infine la Calabria, quella dei paesi abbandonati, più volte narrata con lucida partecipazione dall'antropologo Vito Teti. Sono le località inerpicate dove di tanto in tanto si sta sperimentando l'accoglienza, quanto mai difficile da radicare davvero, dei profughi sbarcati sulle coste. Cosa emerge da questo complesso cammino delineato dall'autrice di Spaesati lungo un'Italia disaccostata dai grandi percorsi, trascurata dall'attenzione dei media, in bilico tra silenzio avvolgente e omogeneità che tutto travolge? Affiora - quasi per interstizi e imprevedibili presenze - la forza con cui le rovine si insinuano comunque nel presente. Sono mondi irrimediabilmente trascorsi eppure ancora capaci di accendere emozioni, rievocare vite, testimoniare in modo forte sulla verità e la dignità dell'essere uomini. Se questo accade è perché si è messo all'opera un traghettatore, qualcuno che ha saputo e voluto caricarsi di un significativo frammento del passato, e dei suoi nodi ancora attuali, portandolo nell'oggi, facendogli spazio e difendendolo dal frastuono che tutto tritura e dall'omologazione che tutto cancella. Due reti diverse. A questa tribù di indispensabili «traghettatori» appartiene anche Vittorio Emiliani, una delle grandi firme del giornalismo italiano, saggista (suo tra l'altro Il silenzio e il furore, splendida biografia di Rossini), deputato progressista per una legislatura nel 1994 ma, soprattutto, protagonista di grandi campagne a difesa del paesaggio e contro la selvaggia cementificazione del Bel Paese. Di Vittorio Emiliani appare ora Belpaese Malpaese. Dai taccuini di un cronista 1959-2012 (Bonomia University Press, pp. 435, euro 23) ed è un libro denso di spunti che, seppure da altra angolazione, entrano in dialogo fecondo proprio con le tematiche affrontate da Spaesati. Come si sarà capito, un atlante delle rovine accoglierà i frammenti di mondi che ancora parlano, da traghettare appunto dal passato al presente, secondo la personalissima rete di cui ognuno saprà e vorrà dotarsi. Quella di Spaesati è una rete robusta e ideologicamente ben connotata, contiene luoghi-momenti rilevanti e prevedibili: la Resistenza, le grandi lotte del mondo contadino, il terremoto e la ricostruzione delle comunità. La rete che il «cronista» Emiliani trascina lungo mezzo secolo è diversa. A sguardo superficiale sembra dare l'impressione - sbagliata - di essere un po' sbrindellata e di lasciarsi sfuggire eventi rilevanti: poi si scopre che non è affatto così. In realtà chi sale sulla cartacea barca su cui Emiliani accoglie è omaggiato, grazie anche a una scrittura diretta e felice, da una pesca gioiosa, sorprendente. Emiliani recupera «rovine» di un'Italia che è appena dietro le spalle, le accosta al presente più attuale, e ce le mette sotto gli occhi così che sia evidente la filigrana che percorre il tutto. (In Belpaese Malpaese ci sono alcune sue inchieste giovanili esemplari: sui contadini padani, sui pescatori dell'Adriatico, sui pendolari durante il boom, sulle voraci edificazioni nei centri storici). Ci racconta in modo impareggiabile i suoi amici (Fellini, per dirne uno) e i suoi maestri (Arrigo Benedetti, Antonio Cederna, Renzo Zorzi, Camilla Cederna). Pesca nei fondali vicini e meno vicini della nostra storia recente e porta alla superficie, e alla nostra memoria, un continuo susseguirsi di momenti, personaggi, testimonianze, eventi, grandi querelle che s'accendono, scompaiono dalla ribalta nazionale e poi ritornano: il risultato è un affresco vivacissimo, mai affastellato, dove il passato prende vita e significato. Ci parla. Suggerisce strade di impegno non più dilazionabile (si vedano le profonde riflessioni sul paesaggio e sul perché, nel difenderlo, la sinistra marxista italiana non fu, e a lungo, in prima fila, anzi...). La strada giusta. Prodigo della propria esperienza e generoso nel condividerla, Emiliani ci porta lungo il crinale tra il Bel e il Mal Paese, con la lucida sicurezza di chi sa riconoscere la strada giusta. Quella dove il ricordo non è rimpianto, il cammino verso il futuro non è rassegnato, la memoria è una forza alla quale ogni traghettatore, se vorrà, potrà attingere. Le città-fantasma rivivono nella Rete - Non solo in Italia esistono le rovine e il fascino inquietante dei luoghi abbandonati aleggia nello spazio apparentemente più lontano dal passato che si possa immaginare, la rete. Da Web Urbanist a Urban Ghosts, sono numerosi i siti che, in tutto o in parte, dedicano pagine a villaggi e città un tempo brulicanti di vita e oggi deserti: si va così, sia pure virtualmente, dalla città murata di Kowloon, alle porte di Hong Kong (antico baluardo contro i pirati, occupato dai giapponesi durante la guerra, poi densamente abitato e infine evacuato nel '93), al piccolo villaggio di Oradour-sur-Glane, in Francia, i cui 642 abitanti furono massacrati dai soldati tedeschi come punizione per la Resistenza e che oggi rivive come memoriale a testimonianza di un passato che non va rimosso. Palestina e Israele sotto la lente di Michele Giorgio - Gian Paolo Calchi Novati Raccogliere i propri articoli apparsi nel tempo su un quotidiano può essere un atto di albagia o un azzardo. O le due cose insieme. Secondo un luogo comune che non di rado contagia i redattori e direttori di giornale, un quotidiano il giorno dopo è buono solo per incartare la verdura. E anni dopo? Michele Giorgio pubblica un'antologia di suoi scritti apparsi sul manifesto fra il settembre del 2000 e il settembre del 2012 (Nel baratro. I Palestinesi, l'occupazione israeliana, il Muro, il sequestro Arrigoni, Edizioni Alegre, pp. 286, euro 14). Gli articoli non hanno un inquadramento perché i fatti, e i contesti in cui i fatti si collocano, parlano da sé. Nella peggiore delle ipotesi il risultato è una cronologia ragionata (e verificata dall'interno) di come la Palestina ha vissuto questi primi anni del Duemila. Nessuna manipolazione, nessuna lettura ex post. In effetti, un piacere e un arricchimento per dotti e incolti, perché la successione degli avvenimenti è incalzante e la memoria di tutti è sollecitata a ricordare quando e come sono accaduti eventi d'importanza storica come la seconda Intifada, i disastri di Jenin e Hebron, la morte di Arafat dopo il lungo assedio nel Moqata di Ramallah, la crescita di Hamas, la vicenda di Gaza, la costruzione del muro che potrebbe diventare un confine. L'interesse è intrinseco e sarebbe banale aggiungere che per capire l'ultima crisi è bene avere presenti i precedenti. Qua e là la cronaca del giorno è interrotta da un'opinione, non tanto del giornalista quanto di protagonisti come Marghouti, Edward Said o lo stesso Arafat, o di storici israeliani come Benny Morris e Ilan Pappe. Michele Giorgio si impegna di persona soprattutto nel ricordo in mortem di Vittorio Arrigoni che conclude il volume. La prima impressione è un po' estraniante. È come se più il racconto procede, anche con svolte oggettivamente determinanti, più la questione palestinese sembra sempre uguale a se stessa. E non solo per la notizia che suona come una non-notizia dei «tre palestinesi uccisi oggi nei territori occupati» di cui parla Tommaso Di Francesco nella prefazione. Le singole vittime sfumano in un insieme senza contorni precisi. Ci sono tanti «prima» e tanti «poi» eppure i fondamentali non cambiano. Una novità è forse la crescente attualità dello stato democratico per arabi ed ebrei rispetto allo slogan «due stati per due popoli» che per l'evoluzione sul terreno, a cominciare dagli insediamenti ebraici nei territori occupati, è sempre meno realistico anche a prescindere dai principi a favore dello stato unico a parità di diritti e doveri per tutti. E c'è naturalmente il divario fra Cisgiordania e Gaza e quindi fra Al-Fatah e Hamas. Già ai tempi di Sharon (l'articolo è del 20 agosto 2001) Michele Giorgio sospetta che la strategia di Israele sia di eliminare l'autorità palestinese e i resti dell'Olp per avere di fronte solo Hamas con il calcolo di veder aumentare la solidarietà da parte di tutto il fronte occidentale anti-islamico con la repressione della resistenza e la negazione delle rivendicazioni palestinesi. Un motivo di più per rimpiangere Mister Palestina che (sono parole di Arafat riportate in un articolo del 19 dicembre 2001) si sentiva impegnato «a rispettare la parola data a Rabin». Nel libro di Giorgio è puntualmente registrato quello che doveva essere l'accordo per un governo unitario fra i due spezzoni della Palestina, con i buoni propositi e i nomi nelle varie caselle (eravamo nel febbraio del 2007). Hamas si diceva pronta ad accettare gli accordi sottoscritti con Israele mantenendo tuttavia la propria linea di non concedere un riconoscimento «storico e morale» dello stato ebraico. Come si sa, la storia vera è andata in un'altra direzione. Le mediateche francesi allo specchio della società - Antonella Agnoli Uno spettro si aggira tra gli scaffali delle mediateche francesi e, anche se non si tratta del faccione barbuto di Karl Marx, l'apparizione ha attirato l'interesse di «Le Monde», che ha mandato una giornalista a Meudon, un comune a pochi chilometri da Parigi, per vedere cosa succedeva. A Meudon, in realtà, ci sono due mediateche perché la cittadina ne ha una in centro e una, inaugurata nel 2001, nella frazione di Meudon-la-Forêt, un quartiere di edilizia popolare di appena 13.500 abitanti, in collina, lontano dal centro e incastrato fra un'autostrada da una parte e una foresta dall'altra. Il tema dell'articolo di «Le Monde» del 16 novembre non è il ritorno d'attualità dell'autore del Capitale ma, più modestamente, le differenze delle collezioni nelle due mediateche: più borghese l'una e più popolare l'altra. I classici come Tocqueville sono in entrambe le sedi, ma è inutile cercare i premi Nobel della letteratura a Meudon-la-Forêt o i manga in centro: le collezioni sono state pensate per due popolazioni diverse, divise dalla provenienza, dalla condizione sociale, dai consumi culturali. In collina ci sono molti ex pieds-noir algerini, molti pensionati ed ex operai della Renault, in centro avvocati e medici, insieme a molte coppie giovani, di reddito medio-alto, che gravitano su Parigi grazie alla fermata del metrò regionale, la Rer. In Francia, le divisioni di classe, di status sociale, di cultura, sono forse meno visibili di quelle di un secolo fa ma esistono eccome. La giallista Fred Vargas aveva colto abilmente la divisione fra borghesi e proletari in un dialogo del suo romanzo Chi è morto alzi la mano, dove la proprietaria di un piccolo ristorante offriva un posto di cameriere ai suoi nuovi vicini, tre studenti squattrinati: « -Per uno che ha fatto l'università un posto di cameriere non è il massimo, ma nell'attesa... - Come fa a sapere che abbiamo fatto l'università? - domandò Marc. - È facilissimo da capire, per chi non ha studiato, - disse Juliette ridendo nella notte». Nessuno più del singolo cittadino è cosciente della sua condizione nella scala sociale e si comporta di conseguenza anche al momento di entrare in una biblioteca. La scelta di fare due mediateche diverse, che però hanno una gestione unica con una trentina di bibliotecari, è stata quindi coraggiosa, una iniziativa favorita dalla tradizione sociologica francese, molto presente nel mondo bibliotecario, che ha approfondito in modo sistematico il problema dei non lettori, attraverso una serie di studi sul campo. È stato il sociologo Bernard Lahire a spiegare che l'estraneità di gran parte della popolazione al mondo dei libri è soltanto l'ultimo anello della lunga opera di separazione fra cultura «alta» e cultura «popolare», una separazione deliberatamente perseguita nell'Ottocento e nel primo Novecento, e concretizzatasi nella creazione di istituzioni culturali modellate sulle esigenze di distinzione delle classi dominanti, che esigono un certo tipo di comportamento rispettoso e contemplativo verso l'opera d'arte, la pièce teatrale, il concerto. Su scala nazionale, le indagini francesi mostrano che i non iscritti alla biblioteca offrono varie ragioni per giustificare il loro disinteresse. Il 79 per cento risponde che «non gli piace leggere» o che «legge troppo poco perché valga la pena andarci», nonostante la varietà dell'offerta culturale delle mediateche, che mettono a disposizione del pubblico non soltanto libri ma anche giornali, musica, fumetti, film e molto altro. Purtroppo, è un fatto che i grandi investimenti fatti a partire dal 1981 in poi hanno dato risultati mediocri: la percentuale di francesi iscritti alle biblioteche è salita, fino a toccare il 18-20 per cento dei cittadini ma poi si è assestata su questa cifra. Anche tenendo conto del fatto che molti frequentano le mediateche senza essere iscritti - magari soltanto per leggere un giornale o incontrare un amico (forse un altro 30 per cento della popolazione) -, si tratta di un risultato deludente rispetto alle ambizioni del piano dell'allora ministro della Cultura Jack Lang: più di metà dei francesi non ha alcun rapporto con queste strutture. Malgrado gli sforzi, a Meudon, come altrove, per cambiare l'immagine della biblioteca, per cancellare l'idea che essa sia un «museo di libri», una istituzione severa e poco attraente, sembra non si sia riusciti a cambiare la percezione dominante delle caratteristiche del luogo. E questo nonostante il fatto che molte richieste dei cittadini, come la varietà dei documenti, o la creazione di luoghi più conviviali, siano state soddisfatte. Un punto molto dolente riguarda gli orari: il costo di gestione dei nuovi edifici incide pesantemente sul bilancio e le due mediateche di Meudon sono aperte solo trenta ore la settimana, cioè sei pomeriggi, più la mattina del mercoledì e quella del sabato. Troppo poco per facilitare l'afflusso del pubblico marginale. Gli Idea Stores di Londra sono aperti settantadue ore la settimana e gran parte del loro successo sta in questa disponibilità verso utenti cui il lavoro e la famiglia lasciano pochissimo tempo libero. La Francia, sebbene il governo Hollande abbia tagliato i fondi per la cultura, ha continuato fino all'anno scorso a investire fortemente in mediateche: quella costruita da Roland Castro nel ventesimo arrondissement di Parigi - un quartiere storicamente operaio - è grande (oltre quattromila metri quadri aperti al pubblico) e ricca (più di centomila documenti). Ci si chiede quando mai anche l'Italia riuscirà a trovare l'interesse della politica per biblioteche moderne, accoglienti, ben realizzate e ben gestite. Biblioteche al nord come al sud, in centro come in periferia, che accolgano gli adolescenti come i pensionati, le mamme con i bambini come gli immigrati. Un investimento per la qualità della vita non solo dei centri storici ma anche di quartieri periferici come Meudon-la-Forêt. Ambiguità dell'handicap - Giulia D’Agnolo Vallan NEW YORK - La attuale società si pone in maniera positiva nei confronti delle persone disabili, e allo stesso tempo cerca di evitare la disabilità stessa. Sono i due fenomeni interdipendenti? C'è un legame tra l'accettazione delle persone con handicap da una parte, e dall'altra le tecniche di diagnosi prenatale che in molti casi individuano con forte anticipo malattie e deformazioni del feto, indirizzando all'aborto terapeutico? È uscito quest'anno in Germania lo studio di una ex regista, ora consulente familiare, Monika Hey, dal titolo Mein gläserner Bauch («Il mio ventre di vetro», Dva 2012). Nota l'autrice che la maggior parte delle gravidanze nelle quali i medici individuano un handicap del feto si concludono con interruzione artificiale. Nel caso della diagnosi di Trisomia 21, la sindrome Down, il 90 % delle donne incinte decidono di abortire; una delle conseguenze è che i bambini Down sono, nei paesi dove viene praticata una diagnosi prenatale accurata, in via di estinzione. Nel libro Hey parla di sé, del suo lavoro, della sua intenzione iniziale di avere figli ma non subito; racconta di quando scoprì, allorché mai più se lo sarebbe aspettato, di essere incinta e poi di come, dopo la diagnosi di Trisomia 21 del feto, si sottopose a un parto provocato allo scopo di eliminarlo. Dopo anni di elaborazione di questo lutto l'autrice si rende conto di essersi sottoposta con eccessiva leggerezza alla costrizione sociale di mettere al mondo un figlio sano e decide di scrivere la sua storia (è una storia tutta laica ed esaminata dalla prospettiva dell'etica laica, come laiche sono del resto queste mie considerazioni). Troppo debole e confusa e disperata e senza comprendere fino in fondo le conseguenze del gesto (rimanere senza figli, senza un figlio Down) l'autrice, dopo il risultato degli esami, si lascia docilmente condurre dal personale medico verso la scelta quasi obbligata di un parto/aborto che le lascia per sempre una terribile sensazione di vuoto e le apre una serie di interrogativi: non c'è posto per persone che non si adeguano alle norme di una società orientata verso rendimento e prestazioni? Il valore degli uomini è giudicato soltanto in base alle loro capacità? Devono venire al mondo solo esseri umani dai quali ci si può attendere che nel corso della vita si rivolgano all'orientamento al successo che caratterizza le nostre società? Già oggi il vedere un bambino Down in carrozzina suscita perplessità, leggibile chiaramente sui nostri volti: non si poteva evitare? Perché quel bambino è stato fatto nascere? Sono domande che si pone anche, a Zurigo, il pedagogista Ricco Bonfranchi, autore di una ricerca sulle conseguenze etiche della diagnostica prenatale. Aggiungo alle parole di Hey e di Bonfranchi un ulteriore argomento di riflessione: vedo in Svizzera, in questo autunno 2012, i cartelloni stradali della campagna per far conoscere un'associazione che si occupa di assistenza ai tetraplegici. Ogni cartellone mostra, vista di spalla, una persona di cui si legge essere divenuta tale in seguito a un evento traumatico: caduta da un albero, tuffo di testa azzardato, incidente stradale... Ogni cartellone mi fa pensare al fatto che ogni bambino come ogni adulto, nato sano, può diventare disabile in seguito a un incidente, ma che non per questo non merita cure e assistenza. E allora perché eliminare tout court il futuro disabile quando l'handicap sia diagnosticato in fase prenatale? È questa l'ambiguità, è questo il paradosso (dei nostri tempi?) cui accennavo in apertura: evitare il più possibile la nascita di bambini disabili tramite aborto terapeutico da una parte, e dall'altra accogliere e accettare la disabilità, soprattutto fisica. Che l'accettazione dell'handicap sia cresciuta è sotto gli occhi di tutti: in Germania un ministro delle finanze siede su una sedia a rotelle, come pure su una sedia a rotelle sta una rappresentante dell'Spd, ministro del lavoro della Renania-Palatinato, che soffre di sclerosi multipla; il ministro svizzero dell'istruzione del Ticino è non vedente. Milioni di persone hanno visto al cinema Quasi amici, il film in cui il tetraplegico Philippe si fa assistere non da un infermiere professionista ma da un improvvisato badante, il rustico Driss, proprio perché questi non manifesta la compassione che Philippe detesta. Insieme compiono imprese divertenti: correre in Maserati attraverso la città, fare sesso con belle ragazze, buttarsi col parapendio. Milioni di persone in Europa hanno pianto un pochetto ma soprattutto hanno molto riso di Driss e del suo capo paralizzato, in questo leggero e sereno racconto dal mondo della disabilità. Nella scorsa estate le paralimpiadi di Londra hanno rappresentato una grande festa dello sport per disabili ma anche dello sport in generale. E non è detto che a qualche allenatore senza scrupoli delle palestre-lager per piccoli atleti (non solo) cinesi non sia venuto in mente di amputare le gambe dei bambini internati per sostituirle con protesi stile Pistorius... Da molte parti, infine, viene esaltato il valore della resilienza, un concetto mutuato dall'ingegneria, dall'ecologia e dalla biologia, che è passato a indicare la capacità dell'uomo di trasformare positivamente le avversità della vita. Concetto con cui si trasmettono, precipuamente in Italia, falsi messaggi alla melassa, che sostengono che i bambini precocemente orfani di madri suicide o di padri vittime del terrorismo diventano vicedirettori e direttori di giornali; e che i bambini di vetro saranno grandi musicisti. Soprattutto nell'ultimo caso assistiamo a glorificazioni della disabilità che suonano false persino alle orecchie di Peter Radtke, scrittore e attore nonché presidente dell'Associazione Tedesca Disabilità e Media, sofferente della sindrome delle ossa di vetro, che nota come la disabilità sia esaltata da una parte solo per essere eliminata appena possibile dall'altra. Che sia questo l'effetto collaterale di una società mercantile orientata al denaro e al guadagno? Che sia il risultato dell'applicazione del principio del calcolo delle probabilità elaborato da Pascal nel 1600 e subito adottato dalle compagnie assicurative: facciamo il possibile affinché il vostro carico arrivi sano e savo alla meta per essere colà rivenduto, ma se si altera durante il viaggio lo buttiamo a mare, mentre se si rovina dopo ce ne occupiamo a spese della collettività? Abraham, il giocatore - Giulia D’Agnolo Vallan NEW YORK - «Sono passati ormai quasi due anni. Il paese ha avuto il tempo per manifestare un suo eventuale rifiuto. Ma mi hanno rieletto, quindi forse non è una cosa proprio indigesta». Il presidente americano alla vigilia del secondo mandato che pronuncia queste parole, quasi riflettendo ad alta voce, non è Barack Obama, bensì Abraham Lincoln. E non sta facendo riferimento alla riforma sanitaria, ma al Proclama di Emancipazione con cui, servendosi della sua autorità costituzionale di comandante delle forze armate , nel 1863, Lincoln decretò la libertà degli schiavi negli stati della Confederazione. Passato e presente e presidenti diversi si sovrappongono e dialogano tra di loro nell'ultimo film di Steven Spielberg che, dietro al titolo monolitico, da polpettone storico/agiografico/hollywoodiano, nasconde una radiografia astuta e straordinariamente contemporanea della macchina politica americana. Sul presidente più riverito degli States Spielberg voleva fare un film da sempre, come lo fecero tra gli altri, Griffith, Clarence Brown, Ford (più volte) e, solo qualche mese fa, Timur Bekmambetov. Ma, ha detto il regista di ET, la chiave l'ha trovata solo qualche anno fa, nel libro della storica Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. L'altra chiave fondamentale è stata la scelta della sceneggiatore, il drammaturgo illuminato Tony Kushner (Angels in America) che con Spielberg aveva già felicemente collaborato in Munich. Lincoln apre e torna in chiusura su grandi immagini di campi di battaglia, che richiamano la riflessione spielberghiana sulla guerra di Empire of the Sun, Saving Private Ryan e The War Horse. Ma, in realtà, è un film «da camera». Anzi, da interno washingtoniano - fumoso e immerso nei marroni grigiastri, ipersaturi, che sempre caratterizzano la fotografia di Janusz Kaminski. Il set dominante è dentro alla Casa bianca, ma non è l'edificio attraversato a velocità folle dall'adrenalinico orecchio/occhio di Aaron Sorkin in The West Wing. Piuttosto, una successione di scene risolte quasi sempre con inquadrature fisse e quello che sembra il minor numero di stacchi possibile. Forse solo in Amistad la mise en scene di Spielberg era stata così intenzionalmente «sotto tono». Minimalista anche l'oggetto apparente del film: il passaggio di una legge, quel tredicesimo emendamento della costituzione americana con cui il repubblicano Lincoln si assicurò - stato di guerra o meno - che la schiavitù sarebbe stata bandita per sempre dal suo paese. Che Hollywood, e «Spielberg», investano così tanto in un oggetto dalla superficie squisitamente procedurale, testimonia una certa fiducia nella fascinazione (non priva di obbrobrio, come per ogni reality che si rispetti) che il processo politico sta esercitando sul grande pubblico Usa. Non a caso Lincoln è uno dei candidati più probabili per gli Oscar, su molti fronti. Ed effettivamente è difficile non guardare l'intricata rete di trattative, calcoli e compromessi intorno a cui si snoda il film senza pensare alle trattative, ai calcoli e ai compromessi che si stanno giocando dietro alle quinte del gran teatro del fiscal cliff. O a immaginare che un autore intelligente e impegnato come Kushner non abbia lavorato anche sul doppio binario. Come la Camera presieduta da John Boehner è un problema per Obama, nel 1863, era la Camera ad essere un problema per Lincoln, nonostante, a differenza di oggi, fosse controllata dal suo stesso partito. Sono proprio i repubblicani e i membri del gabinetto dei ministri a chiedersi perché il loro presidente, appena rieletto e molto amato, voglia rischiare il tutto e per tutto sull'improbabile passaggio di una legge che non convince tanto nemmeno a loro... Perché invece non concentrarsi sull'obbiettivo molto più popolare di metter fine alla guerra civile? Ma questo Lincoln (Daniel Day Lewis), che concentra genio strategico e legale, spietatezza politica, humor e passione civile in un involucro di gesti, voce e sguardo di luccicanza marziana sa che, se la guerra finisce, e i sudisti rientrano al governo, quell'emendamento non avrà più chance e quindi sceglie l'azzardo. Il margine di tempo è piccolissimo: mentre una delegazione confederata è in viaggio verso il nord per discutere i termini della pace, Lincoln ordina ai suoi di procurargli i voti necessari, convincendo qualche democratico a cambiare fazione e i repubblicani progressisti ad accettare una versione più moderata dell'emendamento. Il tutto, a qualunque costo. La suspense (questa sì, spielberghiana) nel film sta nella corsa e nelle acrobazie per ottenere i voti. James Spader, John Hawkes e Tim Blake Nelson, comici come i Three Stooges, vengono assoldati per un reclutamento tra il losco e il folk. Tommy Lee Jones, nei panni del più agguerrito degli abolizionisti, il leader radical repubblicano Thaddeus Stevens, è il personaggio più straight del film, l'idealista che deve decider cosa significa essere veramente fedeli a se stessi. Le scene ambientate alla Camera, piene di retorica e di colpi di teatro, sembrano «d'epoca» solo se non ci si ricorda che, fino a pochi anni fa, il repubblicano Jesse Helmes arrivava in Senato con i disegni di un maiale per simbolizzare gli eccessi di spesa. Tutti si sporcano le mani in Lincoln, primo tra gli altri il presidente. Eppure non è un film cinico sulla politica (come lo era per esempio The Ides of March di George Clooney). Anzi. «Forse, una volta che tutto sarà concluso, potremo permetterci di aspirare a qualcosa di simile alla democrazia», dice Lincoln alla fine del film, invecchiato di decenni in pochi mesi. È vero si tratta di un punto di fuga situato all'infinito. L'importante è non perderlo mai di vista. Quell’umanità nauseante – Giampero Cane BOLOGNA - a galleria de' Foscherari ha inaugurato sabato scorso una mostra di opere di George Grosz. Egli fu un artista eminente nella Germania del primo dopoguerra, che insieme a Beckmann e a Otto Dix rappresentò il vertice di quella che fu chiamata la «nuova oggettività» (Neue Sachlichkeit), indirizzo d'avanguardia che venne a seguito del «cavaliere azzurro» (Der blaue Reiter) che, a sua vota, era subentrato nella leadership artistica tedesca al Die Brücke. Dei tre, il primo era il più legato al classicismo; Dix era quasi un giornalista che della pittura si serviva per mostrare con lucidità le miserie metropolitane, ma anche la ferocia della guerra; Grosz fu uno spirito satirico devastante capace di mostrare l'anima turpe del potere in corpi che non sono più protetti o mascherati dalle divise indossate, civili o militari. Incorporò più e meglio degli altri, probabilmente, lo spirito di Weimar, uno degli esempi più felici nella storia contemporanea di cosa possa la cultura quando il potere non abbia la forza di contrastarla, ma anche di quanto essa sia fragile di fronte agli attacchi della stupida, ma ingorda avidità. Grosz fu, tra gli artisti dell'epoca, uno dei più impegnati ideologicamente. Il suo comunismo lo portò fin a trattare la propria arte alla stregua di un ornamento. È evidente che per lui la democrazia di Weimar non era che una maschera politica dietro cui si nascondevano capitalismo e militarismo. Anche se per lui l'arte era una cosa secondaria, anche se «le arti e gli artisti non valgono un osso o un capello solo di un operaio che lotta per il proprio pane», come Grosz ebbe a dire nel 1919, egli era ben cosciente del fatto che quello fosse l'unico suo strumento e vi si applicava con cura. Com'è stato osservato «non era la pittura, ma l'umanità che gli dava la nausea». Quasi ogni suo disegno, quasi tutti i suoi quadri sono anche manifesti politici. Dunque Grosz non ottenne il favore degli accademici. La sua produzione parve esclusivamente «illustrativa». Ma in ciò che così veniva criticato negativamente consisteva, invece, l'attualità dell'artista. Era una voce interna al movimento che veniva riconoscendo il primato delle idee e degli strumenti di divulgazione di massa. Dagli inizi, nell'espressionismo, al dadaismo il ruolo dell'efficacia politica dell'opera viene in primo piano. Grosz arriverà a respingere la «profondità» metafisica o misteriosofica come una gran «balla cabalistica», mentre affermava che «verrà un giorno in cui l'artista non sarà più un anarchico gonfiato, ma un uomo sano che lavorerà in una società collettivistica». La prova generale di quest'avvento, forse egli la fece negli anni americani. Come l'arte di Kurt Weill però, anche la sua di quest'ultimo periodo è generalmente negletta dalla critica successiva. L'uno e l'altro li si vorrebbero costretti su eterne barricate. C'è chi, come Umbro Apollonio, scrive di un «fare lezioso e corrente». Quel che si può piuttosto dire è che nell'esotismo americano non riconosce un autoritarismo politico, un'avidità del potere analoghi a quelli vissuti nella sua Germania. Qui la nevrosi della ricchezza pare natura, piuttosto che follia, lo sfoggio charme. Kurt Weill non incontrò i ghetti, nemmeno quelli neri, ma del jazz conobbe gli abiti dei club. Grosz non conobbe gli artisti della Ash Can School, probabilmente nemmeno Benton o Ben Shahn, col quale probabilmente sarebbe andato d'accordo, o la O' Keefe; né fu coinvolto in una grande macchina produttrice, come Weill con Broadway o Hollywood. Quello fu un mondo che gli restò estraneo. La Stampa – 28.11.12 Il colpevole va sempre punito se il giallo è scritto in Cina – Ilaria Maria Sala HONG KONG - Del romanzo poliziesco cinese, è d’uso dire che si tratta di un genere con radici molto antiche, il che è corretto solo in parte. I cosiddetti «Romanzi dei magistrati» erano sì amati e diffusi in molte epoche dinastiche, ma si trattava di narrativa che aveva al centro i tentativi di un giudice di indagare e individuare i responsabili di ogni tipo di crimine, per poi punirli secondo la legge. Il magistrato incarnava sia l’investigatore che per l’appunto il giudice, e la sua figura di mandarino colto rendeva le sue supposizioni e astuzie per smascherare farabutti e bugiardi ancora più avvincenti e raffinate. Le cose cambiano dal 1800 in poi, quando vengono tradotti in Cina gialli per lo più anglosassoni, e come in ogni altro Paese, i lettori cinesi si lasciarono intrattenere da queste storie astute, che sollecitano l’intelligenza con trame ricche di colpi di scena. I giallisti della Repubblica Popolare Cinese, però, si sono ritrovati a fare i conti con la censura di Partito anche in questo campo, e dopo indigesti polpettoni in cui agenti governativi scoprivano complotti capitalisti, solo di recente cominciano a spuntare romanzi più propriamente polizieschi. Con «caratteristiche cinesi». Qiu Xiaolong, autore fra i più noti (tradotto in italiano da Marsilio, fra i suoi titoli Quando il rosso è nero e Il vicolo della polvere rossa) scrive in inglese su delitti ambientati nella sua Shanghai: «ma una volta tradotti in cinese - racconta diventano romanzi nella “citta di X”, altrimenti le autorità di Shanghai si offenderebbero. E in assenza di investigatori privati in Cina (eliminati già da una decina d’anni, dopo un breve periodo in cui erano autorizzati a investigare casi d’adulterio), bisogna cercare altre figure centrali». Qiu ha creato quella dell’ispettore Chen, agente di polizia appassionato di poesia antica e gastronomia, che lo consolano quando le inchieste s’insabbiano. Per He Jiahong, romanziere e giurista di Pechino (insegna Diritto all’Università del Popolo) innamoratosi di Sherlock Holmes durante gli studi negli Usa, l’investigatore è Hong Jun – una sorta di suo alter-ego – un avvocato privato, figura relativamente moderna nel panorama giuridico cinese ma che offre una certa latitudine narrativa. «Le autorità di Pechino sono più rilassate rispetto a quelle di Shanghai, e posso far abitare Hong nella capitale in modo esplicito. Alcuni dei casi che affronta, però, in particolare se includono omicidi o quadri di Partito, devono avvenire in località immaginarie, per non incorrere nella censura», racconta, durante un’intervista nel corso del Festival di letteratura di Hong Kong, che ha conciso con il lancio del suo primo volume in inglese (in italiano si può leggere La donna pazza, presso Mursia, ma è una traduzione doppia, dal francese). «Puoi scrivere di crimini, e puoi scrivere di indagini: ma se fai pensare a qualcuno che ti riferisci a un vero funzionario, o alle autorità di una certa città riconoscibile, il libro non sarà pubblicato», dice. Motivo per il quale Wang Xiaofang, autore di romanzi criminali sulla burocrazia cinese, dopo alcuni volumi di successo si ritrova ora a non essere più pubblicabile nel suo Paese. Il suo è un percorso inusuale: segretario personale di Ma Xiandong, ex vice-sindaco di Shenyang, ha deciso di passare alla letteratura dopo che Ma è stato arrestato e giustiziato per aver perso ai casinò di Macao 6,3 milioni di dollari Usa di fondi pubblici. Scagionato da ogni crimine, Wang ha deciso di scrivere romanzi «in cui metto in luce il livello di corruzione del sistema, che è endemico, perché è parte della cultura cinese stessa», spiega con passione. I suoi sono romanzi postmoderni, come Il taccuino del funzionario (ancora non tradotto) dove il lettore osserva come e se i corrotti saranno smascherati, mentre le malefatte sono raccontate da testimoni oculari un po’ inusuali: a parlare infatti sono sia i protagonisti umani, che le sedie, le stilografiche, il tavolo o perfino le graffette negli uffici della burocrazia corrotta. «Quello che ho cercato di fare spiega - è di mostrare davvero a 360 gradi, da ogni prospettiva possibile, il modo in cui avvengono crimine e corruzione in Cina – la ricca rete di connessioni e connivenze che trovo sia alla base di molti dei problemi della nostra società». Altri, come Lei Mi (un ispettore di polizia e professore di Diritto lui stesso, autore della serie non tradotta «Crimini psicologici») o Zhi Wen (scrittore a tempo pieno, dietro uno pseudonimo che significa «impronte digitali», autore del romanzo non tradotto Salvezza in punta di coltello) perseguono i loro criminali in vari Paesi esteri, sbarazzandosi di nuovo dei problemi della censura. Tutti questi autori, però, fedeli alla tradizione contemporanea del poliziesco in Cina, si soffermano a lungo sulla punizione dei criminali: l’ordine è ristabilito, e sia la società, che la censura, possono dormire sonni tranquilli. La regola può essere sovvertita da Qiu Xiaolong, che scrive all’estero, o dai romanzi criminali tradotti in cinese con grande successo di vendite: che mille efferati crimini avvengano nel pericoloso, decadente Occidente non è un problema, anzi, conferma solo quello che già si sapeva. Naretto, il medico si fa detective – Marco Neirotti C’è un mistero nel silenzio immobile del malato in Rianimazione, corpo forse affondato nel nulla o forse traversato da percezioni impotenti, dall’irrealtà di allucinazioni. Attorno a lui muovono l’affaccendarsi dei camici, l’apprensione dei parenti, scandita da orari di visita brevi. C’è il mistero della vita in generale, c’è quello del singolo. La fissità d’un uomo nel lettino sotto le luci artificiali, nel buio del coma indotto dai farmaci, è il respiro di un romanzo, Notti di guardia (Ponte alle Grazie), il cui protagonista, il medico Massimo Dighera, valica i confini della terapia e passo dopo passo si inoltra in questo mistero, un viaggio ai limiti del lecito o quantomeno dei diritti-doveri, attraverso lo scavo nell’esistenza del paziente e del suo mondo affettivo, cercando nello schianto della sua auto contro un camion verità da polizia e risvolti da confessore. L’autore, Giuseppe Naretto, è anestesista rianimatore all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Dunque, dopo i magistrati-giallisti (Carofiglio, De Cataldo, per citarne due a tutti noti), s’inaugura la stagione dei medici che ambientano nel loro campo l’intrigo? Fino a un certo punto, oppure sì se al «giallo» si lascia l’accezione più ampia e libera, perché la caccia alla verità che compie il protagonista Dighera non percorre tanto gli itinerari penali quanto i meandri emotivi. Di fronte al corpo dell’uomo intubato, il medico non si accontenta delle consuete domande, risposte e cure. Va oltre. Perché l’affermato uomo d’affari Aldo Martinez compie l’improvvisa e assurda manovra che lo incastra moribondo tra le lamiere? Dighera scruta allora più a fondo l’affettuosa moglie del paziente e il recalcitrante figliolo, si lascia avvolgere e muovere dalla voce sconosciuta che invoca informazioni sul ferito, fruga la memoria di chi allo scontro ha assistito e vìola la segretezza di una compagnia aerea, scopre dettagli e via via li collega e interpreta. Si interroga sulla liceità di ciò che sta compiendo e si fornisce un alibi: più informazioni si possiedono più si individua la terapia migliore. Naretto sa raccontare con passione e misura insieme. L’indagine è tutt’uno con la realtà quotidiana dei reparti di Terapia intensiva, dialoghi di lavoro e di consolazione, solitudini, amicizie e antipatie tra colleghi, emergenze e sfide e dubbi. Proprio l’indagare mette alla prova e rischiara l’uomo della scienza di fronte alle vite appese a un elastico: «Ecco quello che facciamo noi: acchiappiamo al volo la gente che sta per cadere nel dirupo. Ed è una cosa bella, ma spaventosa nello stesso tempo, perché un sacco di persone ci sfuggono di mano». Disse LouisFerdinand Céline, che fu anche medico: «La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte». E le «notti di guardia» sono il tentativo di prolungare quella luce che finisce per investire le due vite, quella nel lettino e quella nel camice, e impastarle. Macchiavelli: “Sarti Antonio è nato per colpa di Brecht” - BRUNO VENTAVOLI Nel 2014 Sarti Antonio, l’antieroico sergente della polizia bolognese compirà 40 anni di vita letteraria, come Maigret, e forse più. Un record per il giallo. Perché il suo demiurgo, Loriano Macchiavelli, continua a scodellare storie con la stessa verve della prima avventura, aggiornando il sapore dei crimini, il contesto, lo Zeitgeist. Dagli anni di piombo al disordine del nuovo mondo globale (i suoi primi libri tornano con successo da Einaudi Stile Libero, collana amata dai giovani, magari nati dopo Sarti). “Nell’87 l’ho fatto morire (Stop per Sarti Antonio) poi l’ho resuscitato, preso da nostalgia, per raccontare il Paese che viviamo”. Nell’Ironia della scimmia Sarti Antonio gestisce il caso più pericoloso della sua sfigata carriera (è rimasto tenente, continua il tormento della colite, e non trova la donna giusta per far pace con l’amore), con la Cia, servizi segreti, un seduttivo Samir legato ad Al Qaeda, una scia di odio e misteri occultati che porta alle stragi nazifasciste della seconda guerra mondiale. Macchiavelli narratore spunta qua e là nelle indagini con la consueta voce un po’ disincantata, burbera, indignata verso terrori e miserie della seconda repubblica, portando il lettore fino all’Aquila, resa fantasma dal terremoto e da una ricostruzione ancora da venire. Fa capolino come un compagno d’osteria che sa scandire le pause giuste e cambiar tono, accanto a un bicchiere di vino. Come ama fare con l’amico Guccini per ricordare parole in dialetto, oggetti quotidiani caduti in disuso, o imbastire trame del nuovo romanzo. Perché dopo le 90 Mila copie di Malastagione, stanno scrivendo a quattro mani, e una lingua sola, molto bolognese, il seguito delle avventure di «Poiana», ispettore della Forestale: Giallo o nero? «Non so la differenza… l’unica, forse, è che alla fine del noir sono tutti un po’ tristi e scontenti, il lettore, lo scrittore, i protagonisti. Da giovane ho fatto scorpacciate di Chandler, di “hard boiled”, fino a Mickey Spillane… che bei pugni nello stomaco ci dava Hammer. Erano le nostre letture da ragazzi, costavano poco, e ci davano tanto”. A scrivere delitti ci è arrivato solo per amore degli opuscoli gialli? «I ricordi partono più lontani, dalla voce di mio padre, meraviglioso affabulatore. Nelle sere d’inverno, con la neve, mi portava nelle stalle dove la gente lo aspettava. Il tepore scioglieva il freddo nelle ossa, gli uomini chiacchieravano con un bicchiere di vino, le donne facevano la calza, i ragazzi giocavano. Poi il chiasso si smorzava e mio padre raccontava delitti, passioni, storie gotiche, e la gente pendeva dalle sue labbra. Inventava storie, le pescava chissà dove. Leggendo i Miserabili, ho scoperto, dopo, che aveva citato interi brani. E’ uno dei suoi tanti dolci misteri, perché non sapeva quasi leggere. Rincasando a piedi, nel buio pesto della Porrettana, ero terrorizzato mi vedevo saltar fuori i briganti e gli spettri che aveva raccontato. Gli stringevo la mano, per sentirmi rassicurato dal calore del suo palmo». Attraverso quella mano le ha trasmesso anche una visione del mondo? «Era comunista, il suo grande rimpianto era di non essere riuscito a vedere Gramsci. Da ragazzo, 17enne, era sceso in valle per prendere un treno e andare al congresso di Livorno del ’21. I carabinieri lo fermarono a una stazione, e lo rispedirono indietro perché non aveva i documenti. Ovviamente mi sono sempre sentito di sinistra, mai però organico al partito. Il vecchio pci non mi considerava. Anzi, la classe politica mi osteggiava, perché secondo loro parlavo male della felice Bologna. In realtà io vedevo studenti insoddisfatti che gettavano il cibo in strada perché la mensa faceva schifo e costava cara, delinquenza, strade cupe. Sono sempre stato un anarchico. Anzi, no mi piace l’ordine, quello che viene dalla coscienza, dai valori. Ormai non so più da che parte sto dopo l’assassinio delle ideologie, quel divertente noir metafisico finito malissimo, senza un arresto di presunti colpevoli». Che letture «militanti» ci sono nel suo scaffale? «In realtà i libri in casa mia tracimano dagli scaffali, ho riempito il garage, che doveva servire all’auto… comunque, c’è Marx, il Manifesto, e quel che riuscivo a capire del Capitale. Gli scrittori emarginati della democratica America come Kazan. E Brecht, che oggi quasi non si cita più, ma per me è stato fondamentale. Facevo teatro di strada, siamo stati i primi a rappresentare, La madre, Terrore e miseria nel Terzo Reich, tra l’altro senza permesso, perché i diritti per l’Italia erano di Strehler e del Piccolo di Milano (loro erano d’accordo…). In fondo Sarti Antonio è legato a Brecht. E’ nato per colpa sua. Quando facevamo spettacoli abusivi, occupavamo suolo pubblico, attaccavamo manifesti di straforo, e ci portavano in questura qualche ora prima di lasciarci dicendo di non farlo più. Nelle attese vedevo poliziotti sfigatissimi, ma onesti, volonterosi. Ne ricordo uno disperato e furioso perché aveva scoperto leggendo l’ordine del giorno che gli toccava un’altra notte sul “pattuglione”, dicasi “pattuglione” il pulmino che faceva il giro della città con sei poliziotti a bordo quando non c’erano ancora le auto… e lui, poveretto aveva un catetere nelle mutande. Soffriva come un cane, ma svolgeva il suo lavoro, un operaio in cantiere mica ci sarebbe andato in quelle condizioni… Quando ho scritto la prima avventura di Sarti Antonio, su un quaderno, in Costa Brava, davanti a una birra, per non andare in spiaggia, mi venivano in mente loro, la commedia umana degli agenti in questura che non avevano una vita alla Marlowe, ma magagne burocratiche e malanni personali». Nella sua casa da piccolo c’erano libri… «Nessuno, era una famiglia povera, senza istruzione, anche se affamata di cultura. Mio padre faticava persino a darci da mangiare. Lui e un altro suo amico, il Bergamini, erano gli unici disoccupati del borgo sugli appennini perché non avevano preso la tessera fascista. Tutta la montagna lavorava nella canapiera, loro si arrangiavano come carbonai, andavano a tagliare legna. Aspettavo che tornasse il sabato per sentire il suo profumo, che era un gran puzzo di sudore e fatica della settimana passata nei boschi. Non mi dava la cultura dei libri ma quella, straordinaria, della vita». Trapela dalla sua scrittura, dietro l’italiano, la vivace cantilena del dialetto. «Il bolognese di montagna è stata la mia prima lingua. Ricordo gli sforzi infernali per capire i miei compagni e la maestra che parlavano il bolognese di città, che è un’altra cosa, anche in classe. In dialetto si raccontavano storie fosche e meravigliose, di immigrati tornati ricchi dall’America con tesori nascosti, di fratelli che si accoltellavano per amore della stessa donna e poi svanivano, di contesse adultere relegate tra i monti per espiare la loro colpa». Come sono arrivati i libri? «Con i libri ho imparato l’italiano. Sfamavano l’immaginazione. Verne. Giamburrasca. I ragazzi della via Pál. Erano un mondo. Sono persino andato a vederla in Ungheria, dopo trent’anni, e m’è spiaciuto vederla così piccola, corta. La Malesia di Salgari. Durante una convalescenza, settanta giorni di gesso, divoravo Dostoevskj, Tolstoj, i classici russi. Dopo la guerra un amico più anziano della società sportiva - facevo ciclismo, ero anche bravo in salita, ho vinto un campionato regionale juniores - mi aveva passato una lista di americani, scoprii Hemingway Faulkner, procurandomeli in biblioteca. Leggevo bulimico, a caso, col sogno pronto». Ricorda il suo primo libro? «Era pieno di figure mitologiche bellissime, come la madeleine di Proust si lega al sapore della banana. A scuola eravamo in un’unica aula che conteneva tutte le cinque classi. Io ero in seconda. Le prime due ore la maestra spiegava a noi, dopo, ai più grandi e noi ascoltavamo cose che non sapevamo, tipo la banana. Chiesi spiegazioni a mia madre. Lei disse “mercoledì ti porto alla fiera”. Vidi le banane da lontano, erano un cespo giallissimo, magnifico, che spiccava in mezzo agli altri frutti. Ma l’occhio mi cadde anche sulla copertina di un libro con una ragazza nuda, avvolta di soli capelli, in groppa a un centauro. “Tutti e due no”, disse la mamma. Scelsi il libro, perché le banane ormai le avevo viste». “Ellenico plurale” apre al Vittoriano ROMA - La Grecia non è solo crisi e la sua arte è anche contemporanea. È questo il duplice messaggio dell’esposizione «Ellenico plurale», che si apre oggi al Complesso del Vittoriano a Roma con 88 opere di 25 artisti greci contemporanei della collezione privata di Sotiris Felios. «La crisi economica ha monopolizzato le pagine dei giornali», questa mostra «è un’occasione per riportare in Italia la Grecia di sempre, quella della cultura», ha detto ieri l’ambasciatore greco Michael Cambanis alla conferenza stampa di presentazione. L’Occidente «fatica ad immaginare la Grecia fuori dal suo passato» e la mostra servirà «a sfatare questo pregiudizio», spiega il curatore dell’esposizione Giuliano Serafini. Le opere, aggiunge, hanno come tema principale il corpo e combinano «una visione fisica e metafisca della realtà». I quadri scelti fanno parte della collezione privata del mecenate Sotiris Felios, che ha coperto i costi della mostra e ha scelto di devolvere gli incassi del catalogo al finanziamento della cattedra di studi neo ellenici all’università Tor Vergata. «Ellenico plurale» è la prima tappa di un percorso di promozione dell’arte e della cultura greca, fortemente voluto dall’ambasciata anche per favorire la risorsa economica del turismo. Il prossimo obiettivo, ha spiegato Cambanis, è organizzare a Roma un’esposizione di opere della Pinacoteca nazionale ellenica di Atene, che verrà prossimamente chiusa per restauri. Sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, la mostra «Ellenico plurale» rimarrà aperta fino all’11 gennaio. In mongolfiera con Renzo Piano ROMA - Renzo Piano racconta se stesso e la tecnica del costruire nell’Almanacco dell’Architetto, un viaggio nell’architettura - compiuto in mongolfiera con il figlio giornalista Carlo - che prende spunto da 16 dei suoi progetti più significativi, il Beaubourg, appunto, ma anche il grattacielo del New York Times, l’aeroporto Kansai in Giappone, la chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Realizzata in due grandi volumi per un totale di 1.300 pagine e oltre 5 mila immagini, la pubblicazione (Proctor Edizioni) è un ambizioso compendio che ad una parte più discorsiva ne aggiunge un’altra più tecnica: al viaggio nell’architettura, raccontato in forma di dialogo tra padre e figlio, è dedicato il primo volume (Viaggi nell’architettura), mentre il secondo (Costruire l’architettura) raccoglie i contributi degli esperti indicati da Piano, che approfondiscono tutte le fasi della costruzione. Un’opera, chiariscono gli editori, pensata per addetti ai lavori e non solo: «Leggete questo Almanacco come un racconto di vita e di architettura, di arte del costruire e del raccontare, di testimonianze tecniche e poetiche, di materiali e colori, di città e paesi lontani, come un caleidoscopio che combinandosi con la luce rilascia un itinerario immaginario da seguire, quello della qualità e della bellezza». La Nasa: “Curiosity ha scoperto su Marte precursori della vita” – V.Arcovio ROMA - «Forse Curiosity ha trovato su Marte semplici molecole organiche». E’ con queste parole che Charles Elachi, direttore del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della Nasa, anticipa quella che potrebbe essere una scoperta degna di finire sui libri di storia. L’annuncio è stato lanciato a margine di un convegno all’Università Sapienza di Roma, e risponde in parte alle voci che circolavano da tempo relativi ad un’importante scoperta da parte del robot Curiosity. Per sapere qualcosa di più bisognerà però attendere il 3 dicembre, quando maggiori dati verranno presentati in un convegno a San Francisco. «Purtroppo non ho avuto modo di parlare con i ricercatori in questi ultimi giorni in cui stanno elaborando le informazioni raccolte da Curiosity», dice Elachi. Per il moment, quindi, le informazioni sono pochissime. «I dati preliminari fanno supporre di aver identificato probabilmente semplici molecole organiche, non biologiche», precisa Elachi. Questo significa che Curiosity avrebbe scovato i precursori necessari alla vita, cioè le stesse molecole che in passato sono state rintracciate anche su nubi cosmiche, su comete, su meteoriti, ecc. Non sono quindi una prova incontrovertibile della presenza, anche in passato, di forme di vita sul Pianeta Rosso. Bisognerà quindi capire come queste molecole potrebbero essere finite su Marte. Tuttavia, se la scoperta venisse confermata la caccia agli marziani diventerebbe sicuramente più interessante. “Se credete solo al Dna avete sbagliato tutto” – Gabriele Beccaria Quando vuole spiegare di che cosa si occupa, David Baulcombe usa una formula secca: «It’s not all in my Dna!». Non è tutto nel mio Dna! Spesso la doppia elica e le quattro lettere che la compongono - A, C, G e T - vengono usate a sproposito. E c’è chi pensa di essere ciò che è per colpa o per merito del Genoma. Come se ci fosse un meccanico, e rozzo, rapporto causa-effetto. Baulcombe, capo del dipartimento di scienze botaniche alla University of Cambridge, sta esplorando l’ancora misterioso universo delle piante per smontare gli stereotipi di chi si è fatto imprigionare nella camicia di forza del determinismo genetico. Le cose - ha scoperto - sono decisamente più complicate. E a rivelarlo è la scienza di cui lui è diventato maestro: l’epigenetica. I geni non galleggiano nel vuoto. Sono influenzati dall’ambiente e quindi dall’insieme degli elementi in cui è immerso un organismo. Le loro «espressioni» possono modularsi come uno spartito musicale continuamente variabile e non c’è essere vivente che sfugga a questo destino. Ciò che vale per le piante vale anche per noi umani e il fascino dell’epigenetica - spiega Baulcombe - sta proprio nel fatto che fa a pezzi molte idee e ne propone altre, rivoluzionarie: dall’origine delle nostre malattie ai modi di coltivare il grano o i pomodori, fino a influenzare la concezione stessa dell’evoluzione, rendendone le logiche più sofisticate di quanto pensasse il suo ideatore di due secoli fa. Ospite a Roma, dove ha ricevuto il Premio Balzan della Fondazione omonima, Baulcombe salta volentieri da un tema all’altro, esattamente come suggeriscono i molteplici scenari disegnati dall’epigenetica. «Quando penso a Darwin, mi viene in mente il celebre schizzo dell’albero della vita che tracciò sui suoi taccuini. Una vera icona. In effetti oggi sappiamo che noi e le piante abbiamo un antenato comune, che non è altro che un’ameba. L’epigenetica conferma, se ce ne fosse bisogno, la teoria dell’evoluzione, sebbene Darwin non conoscesse i meccanismi genetici delle variazioni nel corso del tempo». E anche se c’è chi deduce che la nuova disciplina tenda a mettere un po’ da parte Darwin e a ridare spazio al grande avversario - Lamarck - il professore inglese non ne è così convinto. «Nessuna ricerca ci dice che sia vera la famosa deduzione sul collo delle giraffe che si allungherebbe per raggiungere, un po’ alla volta, le foglie più alte». Se l’ereditarietà di alcuni caratteri acquisiti è una delle scoperte dell’epigenetica, contrariamente al pensiero del biologo e botanico francese non ci sono prove di quegli automatismi che hanno fatto sognare tanti studiosi. «Le mutazioni non hanno necessariamente una direzione e un obiettivo - dice -. Tutto succede in modi “random”». Casuali, insomma. E questo è un punto fondamentale sul quale il professore studioso di fiori, alghe e ibridi - ama insistere. I cambiamenti nei geni e quindi delle proteine che esprimono possono seguire esiti diversi. Persistere intatti da un padre a un figlio oppure - sottolinea - «resettarsi» rapidamente o, ancora, perdersi per ripartire in modi nuovi. Non c’è - che si sappia - un modello prestabilito. Si osserva piuttosto una molteplicità di quelle che vengono definite «manifestazioni molecolari», indotte da aspetti specifici dell’ambiente (e che possono essere quasi infiniti): dall’intensità delle piogge che infradiciano una pianta all’alimentazione di un essere umano. Le particelle che curano i tumori più difficili – Marco Pivato È il bisturi più preciso e potente al mondo ed è puntato contro il cancro. Non immaginatevi un coltello qualunque tra le cianfrusaglie affilate sui banchi operatori. In realtà è un invisibile fascio di ioni carbonio, sparati, alla velocità della luce, da un flusso creato niente meno che da un acceleratore di particelle. Già, proprio come il Large Hadron Collider di Ginevra, la più grande macchina acceleratrice mai costruita dall’uomo, che ha sbirciato la cosiddetta «particella di Dio», ovvero il Bosone di Higgs. L’utilizzo di radiazioni prodotte da acceleratori per aggredire i tumori è una pratica consolidata, ma mai l’«arma» era stata caricata a ioni carbonio, che la sperimentazione ha dimostrato essere i «proiettili» più potenti contro le neoplasie, dando risultati importanti contro malattie a tutt’oggi ancora resistenti ad altre cure. Il «bisturi quantistico» - come è stato battezzato dai fisici dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), che ne ha curato la tecnologia - è stato installato al Centro nazionale di adroterapia oncologica, il Cnao di Pavia, costruito tra il 2005 e il 2010. Il suo nuovo acceleratore a ioni carbonio è un record per il nostro Paese: è la prima macchina del genere in Italia, dopo quelle di «Chiba», a Hyogo e a Gunma in Giappone, e a Heidelberg in Germania. Il costo per la costruzione, per il personale e per gli enti che hanno collaborato è pari a 125 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 40 milioni per la sperimentazione clinica richiesta dal ministero della Salute, necessaria per poter ottenere la marcatura «CE» del dispositivo. Il via ai test era stato dato dal Comitato etico e dal ministero della Salute già l’anno scorso, quando furono trattati con successo 42 pazienti con protoni. Da questo mese, invece, è stato finalmente avviato il programma di sperimentazione clinica con fasci di ioni carbonio che ha aumentato notevolmente l’efficacia dei trattamenti e ridotto anche la loro durata. Nel corso del 2013, poi, si completeranno i protocolli sperimentali con protoni e ioni carbonio e la struttura andrà gradualmente a pieno regime a partire dal 2014. L’attività ambulatoriale erogherà prestazioni per cinque giorni alla settimana, per 13 ore al giorno, a circa 2 mila pazienti all’anno, in 20 mila sedute, eseguite nelle tre sale di trattamento, con quattro linee di fascio. A queste si aggiungerà anche una sala sperimentale, dedicata alla ricerca clinica e radiobiologica. Ma che cosa c’entrano gli acceleratori di particelle con i tumori? Questi gioielli della tecnologia - com’è noto - sono impiegati per produrre intensissime collisioni tra i mattoni fondamentali della materia, proprio come i protoni, ricreando in laboratorio le estreme condizioni fisiche a cui si rivelano particelle come quella di Higgs. Tuttavia, gli acceleratori non servono soltanto ad alzare il sipario sui segreti dell’origine e della composizione dell’Universo. «La tecnica – spiegano dal Cnao –, che si serve di finissimi fasci di particelle generati da un modello di acceleratore chiamato sincrotrone, è in grado di bombardare e bruciare l’interno del tumore in maniera estremamente selettiva ed efficiente, salvaguardando tessuti e organi sani molto vicini, anche a quelli vitali, e consentendo allo stesso tempo un tasso di sopravvivenza estremamente alto». Si tratta di un significativo «up-grade» rispetto alle tecniche convenzionali: «Gli ioni carbonio sono 12 volte più pesanti dei protoni – spiega Sandro Rossi, segretario generale e direttore tecnico della Fondazione Cnao - e quindi rilasciano una quantità maggiore di energia nei tessuti, in un regime di campi elettromagnetici molto superiore». Sfruttando gli ioni carbonio, la terapia adronica fa quindi un salto di qualità e punta a diventare un vanto della ricerca biomedica «made in Italy». Un successo che si misura anche in termini economici. L’importo di 165 milioni di euro per tutto l’apparato «chiavi in mano», infatti, è risultato del 50% inferiore rispetto al costo degli analoghi apparecchi impiantati nel resto del mondo. «Questo è stato possibile - spiegano dal Cnao - grazie alla sinergia tra la Fondazione pavese e gli altri enti». Al risultato hanno contribuito, infatti, realtà diverse, sia economiche sia scientifiche del Paese: come l’Irccs della Lombardia, l’Ospedale Maggiore di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia, i milanesi Istituto nazionale dei tumori, Istituto europeo di oncologia e Istituto neurologico Besta, oltre alla Fondazione per la terapia con radiazioni adroniche di Novara, e amministrazioni ed enti privati di altre aree. Giuseppe Battistoni, ricercatore dell’Infn che studia proprio le applicazioni degli acceleratori alla cura dei tumori, sottolinea il ruolo di punta, in questo settore, dell’industria italiana. «Come nel caso di Lhc – spiega – anche questa volta sono stati impiegati magneti prodotti dall’azienda Ansaldo e la lista delle altre ditte nostrane impiegate nel progetto è molto lunga, da quelle che hanno curato l’elettronica dei controlli fino quelle che si sono occupate degli alimentatori». L’opera è quindi figlia di una vasta scommessa scientificoimprenditoriale. «È proprio nella filiera dell’alta tecnologia - continua Battistoni - che l’Italia deve tenere il passo, pur essendo ancora pochi i segnali di interesse da parte delle istituzioni su un concetto così prezioso in termini di ricadute e di prestigio». Ciò che sta succedendo con gli acceleratori - chiosa il presidente dell’Infn Ferdinando Ferroni dovrebbe allora trasformarsi in un segnale molto importante. «Questo risultato per il futuro della cura delle patologie tumorali - spiega - dimostra ancora una volta come le tecnologie sviluppate per la ricerca di base, che hanno un ruolo cruciale nello studio delle particelle e del cosmo, vengono poi sempre trasferite alla società. E i benefici sono estremamente vasti e più che evidenti». Scambio di culla e destino tra israeliano e palestinese – Fulvia Caprara TORINO - Il sangue non mente, contiene la differenza, e niente può cancellarla. Joseph, che sta per essere arruolato nell’esercito israeliano di leva, scopre che non è ebreo, come ha sempre pensato di essere, ma palestinese, come non avrebbe mai voluto essere. Colpa di uno scambio di culla, un incidente fatale per cui, alle soglie dell’adolescenza, due ragazzi si ritrovano dal lato opposto a quello dove credevano di stare. E due madri, quella di Joseph e quella del palestinese Yacine, devono imparare ad amare un figlio che non conoscono. Diretto da Lorraine Levy, che si definisce ebrea ma atea, Il figlio dell’altra, ieri al Tff, è uscito in Francia raccogliendo tanto pubblico e tanti dibattiti perchè il quesito che pone è uno di quelli che vanno alla radice delle cose, scardinando i pregiudizi sulla diversità, dimostrando che tutte le barriere, perfino quelle più insormontabili, in realtà potrebbero essere abbattute: «Sono ebrea e l’ebraismo fa parte di me - dice Levy -, non sono praticante, ma non posso dimenticare che gran parte della mia famiglia è stata sterminata nei campi di concentramento... Non essendo né israeliana né palestinese, avevo dei dubbi sull’opportunità di lanciarmi in questo progetto e non volevo dare l’aria di impartire lezioni». Eppure seguendo le tracce dei due ragazzi «scambiati», osservando come il loro dolore e il loro rifiuto si trasformino, a poco a poco, in un’amicizia che all’inizio sembra inimmaginabile, s’impara eccome: «Joseph - dice Jules Sitruk (22 anni) che lo interpreta - è diviso tra ostilità e curiosità, vuole fare la conoscenza della sua nuova famiglia e quest’esperienza, gradualmente, lo aiuta a capire, a superare lo sgomento». Intorno ai ragazzi si muovono famiglie sbandate, mariti che, sulle prime, non sanno far altro che litigare, sorelline che trovano subito il modo per giocare insieme, e soprattutto mogli, madri, che, dal primo momento, guidate da speciale sensibilità, trovano la strada della convivenza pacifica: «I padri preferiscono fuggire piuttosto che affrontare la loro sofferenza, le madri, invece, riescono presto a chiarirsi tra loro, capiscono che i figli che hanno allevato continuano ad essere i loro figli e che ora , per ognuna di loro, c’è un figlio in più da amare. Il mio film dice che la donna rappresenta il futuro dell’uomo e che, quando le donne si alleano, possono spingere gli uomini a essere migliori». La francese Emmanuelle Devos è Orith, la madre di Joseph, mentre Areen Omari è Leila, madre di Yacine: «Sono ebreo - dice Sitruk - e quindi il problema del conflitto arabo-israeliano mi tocca, anche se, siccome vivo a Parigi, trovo difficile darne un giudizio oggettivo. Le informazioni che abbiamo in Francia parlano solo di bombe, attentati, cose negative...». E invece Il figlio dell’altra si chiude coraggiosamente bene, con un happy end che ha fatto storcere il naso ad alcuni critici ma che, assicurano l’attore e la produttrice Virginie Lacombe, piace moltissimo al pubblico: «La prima sceneggiatura - spiega l’autrice - si concludeva con un attentato, ma io volevo qualcosa di meno prevedibile». E infatti nessuno salta in aria, c’è un momento di tensione, un ferimento, un ospedale, ma alla fine i personaggi si stringono insieme, legati da una catena d’affetti che, in giorni come questi, può sembrare utopica: «Due o tre giornali hanno accusato il film dicendo che la soluzione è naif, ma il pubblico si commuove e lascia le sale soddisfatto». D’altra parte il film è già di per sé un miracolo. Ci ha lavorato una troupe formata da ebrei, palestinesi e francesi, a cui, prima dell’avvio delle riprese, è stato fatto leggere il copione: «Volevamo che chi ci lavorava ne accettasse il significato». Venduto in Belgio, in Svizzera, in Brasile, in Canada e anche negli Stati Uniti dove ha avuto un buon successo, Il figlio dell’altra arriverà in gennaio sui nostri schermi, con il marchio Teodora: «Josef e Yacine incarnano la speranza delle nuove generazioni. I giovani che ho conosciuto da entrambe le parti del muro, non nutrono sentimenti di odio, ma aspirano alla vita normale degli uomini liberi. Volevo fare un film sull’apertura e la speranza». Corsera – 28.11.12 Torna in Italia la Tavola Doria - Paolo Fallai Il genio, il mistero e l'intrigo. Sarebbe stata sufficiente l'evocazione del nome di Leonardo da Vinci a rendere straordinario il ritorno in Italia della Tavola Doria, dipinto cinquecentesco scomparso da 70 anni nel mercato clandestino internazionale. Ma gli elementi che hanno convinto la Presidenza della Repubblica a presentare il quadro al Quirinale e a organizzare nella sala della Rampa una mostra tutta per lui, sono molti di più. Leonardo, si diceva, ma è tutt'altro che sicura la mano del genio di Vinci. Sicurissimo, invece, il soggetto: la rappresentazione di un particolare della Battaglia di Anghiari, celebre e sfortunato affresco del Maestro nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio di Firenze, «coperto» da un'opera successiva del Vasari e di cui periodicamente (e invano) si cercano tracce. Che si tratti di un quadro preparatorio del genio o di un dipinto della sua scuola, da oggi il dibattito sull'attribuzione è aperto: con la possibilità finalmente di uno studio ravvicinato della tavola da parte degli esperti e dei restauratori dell'Opificio delle pietre dure di Firenze. Straordinario è senz'altro il lavoro investigativo che ha portato a ricostruire il percorso che questa tavola ha compiuto. È il 1621 quando compare per la prima volta nell'inventario della famiglia Doria come Una battaglia di soldati a cavallo di Leonardo da Vinci. L'opera riappare nel 1939, dopo essere stata esposta a Milano, e uno straordinario funzionario della Soprintendenza, Bruno Molajoli, si affretta a «notificarla», cioè a vincolarla come bene dello Stato italiano. Nel 1940, nell'asta che mette in vendita le collezioni del principe Marcantonio Doria d'Angri, la tavola non è più attribuita a Leonardo ma un «maestro toscano del XVI secolo» e cambia proprietario, acquistata dal marchese Giovanni Niccolò De Ferrari di Genova. Fu «notificata» una seconda volta, non si sa mai, il 25 gennaio 1941. Ma da qui in poi le tracce si fanno confuse: nel 1961, alla morte del marchese De Ferrari gli eredi la vendono a un faccendiere svizzero di Locarno, Antonio Fasciani. È il primo acquisto illegale e la tavola esce dall'Italia. Nel 1965 Fasciani la rivende alla società di Monaco di Baviera, Interkunst Gmbh di Georg Hoffmann. Nel mondo del mercato parallelo si scatena un'altra asta. Il quadro pare interessare anche la galleria Wildenstein di New York. È in questi anni che la tavola viene restaurata a Monaco, combinando anche qualche guaio alla struttura delle due tavole. Ma Hoffmann muore nel 1970 e la Tavola Doria risulta in una banca di Monaco. Ci saranno altri passaggi non proprio limpidi prima di arrivare al 1992 quando il dipinto viene acquistato per una cifra imprecisata (tra i 30 e i 60 milioni di euro) e «in buona fede» è stato ripetuto in conferenza stampa, dal Tokyo Fuji Art Museum. Quel che sappiamo è che da quel momento la tavola scompare in un caveau svizzero, nel porto franco di Lugano. Quello che non sappiamo è quando e come il museo giapponese si rende conto di aver acquistato un'opera che non potrà mai esporre. È una delle fonti primarie per immaginare l’affresco «La battaglia di Anghiari». Tre fanti sono a terra. I quattro cavalieri che si scontrano per lo stendardo, sono Francesco Piccinino, suo padre Niccolò, comandanti dell’esercito milanese, Ludovico Scarampo e Pier Giampaolo Orsini, capi delle truppe papali e fiorentine vittoriose il 29 giugno 1440. Il mistero si scioglie nel 2009 quando il lavoro del Comando carabinieri tutela patrimonio culturale individua la tavola in Svizzera, indagini che un anno fa portano la Procura di Roma, ad aprire un'inchiesta. È la condizione da cui è partita la trattativa tra il ministero per i Beni culturali e il Tokyo Fuji Art Museum che ha portato all'accordo presentato ieri al Quirinale dal sottosegretario Roberto Cecchi, dal consigliere del presidente Louis Godart e dal direttore del museo privato giapponese Akira Gokita: il museo di Tokyo ha donato all'Italia la Tavola Doria e l'Italia ha concesso all'istituzione giapponese per 26 anni di poterla avere in prestito, con l'alternanza di due anni in Italia, e di quattro in Giappone. Akira Gokita non ha voluto fare alcun accenno a quanto speso per acquistare il quadro. Ma si sa che il museo l'ha assicurato per 20 milioni di euro. Il sottosegretario Cecchi ha dato ampio risalto al clima di cooperazione che forse porterà in Giappone anche altre opere, ma quante e soprattutto quali, non è stato detto. Quindi si è preferito sottolineare il lavoro - davvero fondamentale - dei carabinieri e della magistratura (erano presenti il procuratore Giancarlo Capaldo, il sostituto procuratore Patrizia Ciccarese e il generale Ignazio Mossa). E in particolare l'esempio che la vicenda rappresenta per il mercato clandestino e la grande occasione per gli studiosi della storia dell'arte. Dopo l'esposizione fino al 13 gennaio al Quirinale, inaugurata dal capo dello Stato Giorgio Napolitano insieme con il ministro Lorenzo Ornaghi, la Tavola tornerà a Firenze, nei laboratori dell'Opificio. «Le indagini - ha sottolineato Roberto Cecchi - si concluderanno il prossimo mese di giugno ma hanno già fatto emergere degli aspetti molto interessanti e incoraggianti». Poi l'opera «resterà a Firenze, probabilmente agli Uffizi», ha aggiunto. Quando non sarà in viaggio per il Giappone. La scuola è giusta? Paese al top - Cristina Taglietti I modelli sono Finlandia e Corea del Sud: sono queste le superpotenze dell'istruzione, come emerge da una corposa ricerca sui sistemi educativi di 50 Paesi, realizzata dall'Economist Intelligence Unit per la multinazionale dell'educazione Pearson. Lo studio viene presentato oggi a Londra e ha come obiettivo principale supportare politici, dirigenti scolastici e ricercatori universitari nell'individuare i fattori chiave di miglioramento della scuola. L'idea è che, per quanto sia difficile da quantificare, c'è un collegamento evidente tra le conoscenze e le competenze con cui i giovani entrano nel modo del lavoro e la competitività economica di un Paese a lungo termine. Lo studio ha prodotto un database pubblico e open-source (da oggi consultabile al link http://thelearningcurve.pearson.com) che raccoglie oltre 60 indici comparativi da 50 Paesi: dati come spesa pubblica nell'istruzione, salari dei docenti, tasso di alfabetizzazione, raggiungimento del diploma e della laurea, tasso di disoccupazione, Pil e via dicendo. La classifica, che vede l'Italia al ventiquattresimo posto, propone un nuovo parametro di valutazione, l'«Indice globale sulle capacità conoscitive e il raggiungimento del livello di istruzione», basato su test internazionali (quello dell'Ocs-Pisa, le valutazioni Timms e Pirls), ma anche dati nazionali sulla media di conseguimento di diploma e laurea. Hong Kong, Giappone e Singapore sono nelle posizioni più alte, mentre negli ultimi posti si trovano Messico, Brasile e Indonesia, pur essendo, queste ultime, economie in veloce via di sviluppo. I due Paesi al vertice della classifica, Finlandia e Corea del Sud, propongono due sistemi educativi completamente diversi: mentre quello coreano è rigido, basato su verifiche, test, apprendimento mnemonico e obbliga gli studenti a investire molto tempo nella loro istruzione (oltre il 60 per cento dopo la scuola segue lezioni private), quello finlandese è molto più duttile e soft: le ore di scuola sono inferiori rispetto a molti altri Paesi (in Italia il tempo passato sui banchi è superiore di tre anni), non vengono assegnati compiti a casa, viene privilegiata la creatività sull'apprendimento mnemonico. Ciò che accomuna i due Paesi è l'importanza attribuita all'insegnamento. La ricerca evidenzia che entrambi danno grande importanza all'arruolamento e all'aggiornamento della classe docente (Finlandia e Corea del Sud scelgono gli insegnanti tra i migliori laureati). Entrambi fanno leva sul senso di responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi e sono caratterizzati da un'idea morale diffusa nella società che motiva docenti e studenti (in entrambe le società il rispetto per l'insegnante è considerato fondamentale). D'altro canto l'importanza dell'insegnamento è l'indicazione principale che emerge dalla ricerca e si basa soprattutto sul riconoscimento del ruolo sociale, mentre il salario degli insegnanti sembra avere scarsa rilevanza sui successi scolastici e pochi collegamenti con lo sviluppo della capacità cognitive misurate secondo i test internazionali. Uno studio su due milioni e mezzo di americani ha stabilito che gli studenti che hanno avuto insegnanti migliori hanno più probabilità di frequentare college prestigiosi, guadagnano di più, vivono in quartieri di migliore status economicosociale, risparmiano di più per la pensione e, addirittura, hanno meno probabilità di avere gravidanze adolescenziali. Da un punto di vista generale, dice la ricerca, l'investimento economico sull'istruzione sembra sì importante nel raggiungimento di risultati positivi, ma ancora più importante è una cultura di supporto all'educazione. Non è un caso che, negli Stati Uniti, a seconda della cultura d'origine, ci sono forti differenze, per cui è statisticamente provato che studenti provenienti da famiglie di Hong Kong o Singapore fanno meglio di studenti che vengono dall'America latina o da Haiti. La questione dell'istruzione appropriata in vista di una futura crescita economica, in grado di offrire agli studenti gli strumenti per affrontare un futuro incerto sono il cuore di alcune riforme scolastiche sopratutto in Asia. Il fatto di anticipare, nella formazione, quelli che saranno i lavori di domani, ha fatto sì che il sistema educativo di Singapore, per esempio, fin dal 1997, sia passato da una forma di apprendimento tradizionale, con grande attenzione allo studio mnemonico, a una formazione che si basa su matematica, scienza e cultura generale combinata con l'apprendimento di come applicare le informazioni che si acquisiscono. I sistemi scolastici di alcuni dei Paesi che si collocano più in alto nella classifica si basano su un'enfasi maggiore sullo sviluppo di «creatività, personalità e collaborazione». Dallo studio emerge che insegnare a lavorare in squadra, a interagire ed empatizzare con gli altri è la sfida della scuola di domani, tanto che un gruppo di lavoro che include i ministeri dell'Educazione di alcuni Stati stanno cercando di elaborare un metro di valutazione per queste abilità, che verrà introdotto nel programma di valutazione internazionale Pisa del 2015. Santi, criminali e imperatori: viaggio ai confini della notizia – Gian Antonio Stella «Da due giorni correvamo nel deserto e Aleichem non aveva ancora smesso di cantare. Cantava in russo, la sua lingua, cantava in rumeno, la lingua di sua moglie, cantava in tedesco, cantava canzoni italiane, nenie arabe, inni di guerra israeliani, pezzi d'opera francesi, fischiava marce austroungariche». In quasi settant'anni di (grande) giornalismo, Angelo Del Boca ha incontrato peregrinando per il mondo principesse e imperatori, despoti e statisti, santi e guerriglieri che hanno segnato un secolo. Eppure, il libro che esce in questi giorni riassumendo in qualche modo la sua vita avventurosa e densa, Da Mussolini a Gheddafi. Quaranta incontri, regala qua e là anche piccole ma indimenticabili figure di uomini e donne, come appunto quell'autista che nel 1958 lo scarrozzò di kibbutz in kibbutz in giro per il Negev o Francesca Strada, l'ultima maestra del «villaggio Marconi» in Tripolitania, o madame Baussoley che pettinava le ventidue mogli e concubine di Maometto V del Marocco, esule in un grand hotel di Ile-Rousse in Corsica, o il medico ebreo Rinaldo Laudi che curava i partigiani, fu catturato dai tedeschi senza armi, solo con la valigetta da dottore, e sparì nel nulla accompagnato da una leggenda sinistra: «Sarebbe stato murato vivo, in uno spazio angusto, in modo che morisse in piedi. Particolare terrificante: nel vano, insieme al suo corpo, sarebbero stati murati anche alcuni gatti selvatici». Erano da spavento, alcuni degli uomini che Del Boca ha incrociato in decenni da inviato. Come il fanatico Akao Bin, che scatenava i suoi adepti armati di pugnale contro i leader della sinistra giapponese e accolse il giornalista, tutto solo perché perfino l'interprete si era rifiutata di partecipare all'incontro, dichiarando la sua fede nazifascista sotto i ritratti di Cristo, Confucio, Maometto e Buddha. O Adolf Eichmann, il pianificatore dell'Olocausto, che aveva l'aria di «un pallido signore, con gli occhiali dalla montatura pesante e una calvizie da intellettuale» e seguiva il processo che l'avrebbe condannato a morte torcendosi nervoso le mani. O ancora il dittatore vietnamita Jean Baptiste Ngo Dinh Diem che aveva sistemato in tutti i posti chiave moglie e fratelli e parenti. O vari satrapi africani dai profili inquietanti. Per non dire di Muammar Gheddafi, che una quindicina d'anni fa, nonostante Del Boca fosse stato il primo a denunciare in diversi libri documentatissimi i crimini di guerra compiuti dai nostri soldati in Libia per ordine di Rodolfo Graziani, gli concesse un'intervista infliggendogli un'attesa interminabile: quattordici giorni in albergo ad aspettare, da un momento all'altro, una telefonata con la convocazione sotto la tenda a Bab al-Aziziyyah. Tra le altre, spiccano le interviste ad Hailè Selassiè, il 225° imperatore d'Etiopia discendente in linea diretta da re Salomone, e poi a suo cugino Immirù Haile Sellase. Il primo, «antico, per sangue, come Ninive e Babilonia» e col «petto coperto da dodici file di decorazioni e dalle mostrine rosse con le spighe d'oro», lo accolse con un sorriso che pareva scusarsi del cerimoniale: «L'ospite varcherà la soglia e farà un primo inchino, poi, camminando sulla passatoia rossa, si porterà a metà circa del salone e lì farà un secondo inchino, e infine un terzo nell'atto di ricevere la stretta di mano del Negus Negast». Il secondo gli raccontò di quando era miracolosamente scampato a un bombardamento chimico italiano, vietato dalle convenzioni internazionali, spiegando che gli aerei sganciavano «strani fusti che si rompevano in aria o appena toccavano il suolo o l'acqua del fiume, e proiettavano intorno un liquido incolore» e che gli uomini investiti dagli spruzzi «urlavano per il dolore, mentre i loro piedi nudi, le loro mani, i loro volti si coprivano di vesciche. Altri, che si erano dissetati nel fiume, si contorcevano a terra in un'agonia che durò ore. Fra i colpiti c'erano anche dei contadini che avevano portato le mandrie al fiume, e gente dei villaggi vicini». Su tutti, nel libro, si stagliano gli incontri col grande Jawaharlal Nehru, che si lagnava del popolo americano perché «parla solo di denaro» e spronava l'India a cambiare, attaccando invariabilmente «la religione, che rende schiavi» e «l'astrologia, che è uno stupido non senso», e spingendosi a strattonare quelli che faticavano a seguirlo sulla strada della modernizzazione: «Voi vivete fra le vacche, nel loro sterco, e ragionate con una mentalità da sterco di vacca». E poi ecco il leggendario dottor Albert Schweitzer, che a un certo punto della sua vita di precoci successi aveva mollato tutto per andare a metter su un ospedale a Adolinanongo, nel Gabon, ed era premurosamente assistito da «venerabili e ossute infermiere tedesche» e «continuava a trattare gli africani come eterni fanciulli» e «a raccogliere aneddoti per i suoi libri, che sembravano scritti al tempo di David Livingstone». Forse nessuno, però, ha il fascino di madre Teresa di Calcutta: «Com'è piccola e magra. E com'è liso il suo sari bianco orlato di azzurro. Se non portasse il piccolo crocifisso sopra il cuore, potrebbe essere scambiata per la più povera delle donne...». Spiegava: «Qualcuno mi ha detto, in una certa occasione, che neppure per un milione di dollari si azzarderebbe a toccare un lebbroso. Ho risposto che neppure io lo farei. Se fosse per denaro, non lo farei nemmeno per due milioni di dollari. Invece lo faccio volentieri, gratuitamente, per amore di Dio». Quel giorno, dopo aver passato ore accanto alla Santa immerso in quella umanità sofferente «scattando fotografie di quello spaventoso esercizio di pietà», Angelo Del Boca scrisse un articolo dall'incipit strepitoso: «Sono le prime luci dell'alba e vedo i "cadaveri" alzarsi dai loro giacigli di pietra, sbarazzarsi dello straccio che portano intorno alle reni e andare alla più vicina fontana, dove si lavano versandosi addosso l'acqua con una ciotola di cotto. Il sole li asciuga all'istante, ed eccoli di nuovo pronti a camminare per questa sterminata città, per creare quel fiume ininterrotto che per l'intero giorno la terrà mostruosamente viva...» Una chiave per capire «cosa c'è sotto» la notizia – Ranieri Polese Si scrive Osint, si legge Open sources intelligence, ovvero l'uso che i servizi segreti fanno delle notizie apparse sui media. Nell'epoca delle intercettazioni a tutto campo e della incontrollabile vastità della Rete, questa prospettiva nello studio dei servizi di intelligence va al di là dell'immagine tradizionale che mostra i servizi interessati a fornire ai media notizie manipolate, false. Qui invece l'intelligence ottiene informazioni dalle «fonti aperte» grazie a uno speciale filtro di lettura. Il nuovo saggio di Aldo Giannuli, Come i servizi segreti usano i media (Ponte alle Grazie), vuole insegnare ai lettori quel metodo, per aiutarli ad analizzare le notizie, smontarle, confrontarle, leggerle fra le righe. Docente alla Statale di Milano, consulente delle commissioni parlamentari d'inchiesta sulle stragi e sull'affare Mitrokhin nonché consulente giudiziario in vari processi (fra gli altri, piazza Fontana e piazza della Loggia a Brescia), Giannuli offre alcuni esempi di questa lettura. Come il caso di Dominique Strauss-Kahn, la morte di Osama bin Laden, la caduta dell'astro nascente del comunismo cinese Bo Xilai. Gli chiediamo di leggere notizie uscite quando il libro era già stampato, come l'affaire Petraeus e il sequestro del ragionier Spinelli. «Per come le abbiamo ricevute dai mezzi di informazione, ci appaiono costruite in modo che nemmeno un bambino di 5 anni ci potrebbe credere. Prendiamo Petraeus: l'Fbi, su sollecitazione di una donna che dice di essere molestata dall'amante del capo della Cia, entra nella sua mail; lui non si accorge che la sua cassetta postale è stata «bucata»; anzi usa la mail della Cia per messaggi privati anche con la sua amante. Non regge niente in questo racconto. Ovviamente c'è molto di non detto. Per esempio, la signora Broadwell, l'amante di Petraeus, forse era una spia, ma allora la Cia che ci sta a fare se non sa neppure che la donna con cui il suo capo ha una relazione è al servizio del nemico? È l'Fbi a scoprirlo. Ma allora perché non va dal presidente degli Usa? Di certo c'è che è in atto una lotta fra i servizi segreti americani; che il disastro di Bengasi (nell'attacco al consolato americano restano uccisi l'ambasciatore Christopher Stevens e due marine) è l'episodio che scatena la resa dei conti; che la nuova amministrazione Obama sta procedendo a una riorganizzazione degli assetti». E Spinelli? «Stesso grado di incredibilità per questa storia. Tutti i dettagli raccontati sono pazzeschi, l'offerta della chiavetta, la recita del rosario eccetera. Si può pensare che era in atto un ricatto al Cavaliere. Ma per cosa? Dopo le storie del bunga bunga, difficile trovare qualcosa di più clamoroso di quello già uscito. Anche il sospetto giro di coca, insomma, non scandalizzerebbe più di tanto. Forse, azzardo, ci potrebbe essere un tangentone di qualche miliardo di euro. Però non sottovaluterei il fatto che fra le ragazze sul libro paga di Spinelli due sono legate al clan barese di Savinuccio Parisi, un manager del crimine del calibro di Messina Denaro o Riina. Insomma, l'idea precisa è che sotto questa storia ci sia qualcosa di veramente grosso ma che per ora è difficile cogliere». Fra Petraeus e il caso Spinelli-Berlusconi c'è anche un'altra affinità: le donne, il sesso. «Sì, assistiamo da qualche tempo a un'epidemia di sesso compulsivo che colpisce uomini di potere in tutto il mondo. Da Berlusconi a Strauss-Kahn, dal capo della Cia all'ex presidente israeliano Katzav. Fino a non molto tempo fa, i servizi segreti conoscevano le storie private dei politici ma erano molto discreti. In America tutti sapevano che il capo del Fbi Hoover era gay, ma nessuno ne parlava; Hoover a sua volta conosceva i nomi di tutte le amanti di J.F. Kennedy, ma i media non ne scrivevano. In Italia, dopo il caso Montesi (il Pci cavalcò la storia della ragazza trovata morta sulla spiaggia di Torvajanica l'11 aprile 1953 ), si stipulò una sorta di tregua durata molti anni. Era successo che l'avvocato Giuseppe Sotgiu, comunista, difensore dei giornalisti che accusavano il figlio del ministro dc Piccioni, risultò da un'indagine della questura un frequentatore con la moglie di una casa d'appuntamenti». E oggi? «Da un lato assistiamo a una moltiplicazione di servizi segreti; si nota un abbassamento del livello di professionalità dell'intelligence; gli uomini di potere sono in preda a una sindrome di sesso compulsivo e le storie di sesso, che prima erano tenute come carte di riserva dai servizi, circolano apertamente. Dall'altro lato, però, è avvenuto un cambiamento nei rapporti fra politica ed economia, «prima erano distinte, oggi l'economia, o meglio la finanza, ha preso il posto della politica, decide i governi e la loro durata, regola i rapporti internazionali. Ai politici non resta che usare i propri privilegi per far soldi e cercare avventure sessuali sempre più spinte». Repubblica – 28.11.12 Il museo dell’innocenza di Orhan Pamuk - Tiziana Zita Dico subito che l’ho interrotto a pagina 336 perché non ne potevo più. Mi rendo conto che non è simpatico dire una cosa del genere di un Premio Nobel, ma questo romanzo morboso e lunghissimo è immobile proprio come il museo di cui parla. Immaginate un libro che racconti di oggetti quotidiani insignificanti, che li descriva e ci spieghi le circostanze, anche quelle ordinarie, in cui il protagonista feticista li ha presi per collezionarli. Il romanzo narra la storia di un uomo di trent’anni che ha tutto quello che si possa desiderare: è ricco, bello e colto e sta per sposarsi con una donna bellissima, ricca e colta anche lei. Si inizia con il loro sfarzoso fidanzamento, sullo sfondo di una Istanbul affascinante, nell’anno 1975. Il trentenne va a comprare una borsa in regalo alla sua fidanzata e nella boutique incontra una lontana parente diciottenne e bellissima: ha pure partecipato a un concorso di bellezza. La ragazza fa la commessa e intanto studia. Con una scusa lui l’attira in una sua casa che viene usata come una specie di deposito e lì i due fanno l’amore e diventano amanti. Si vedono quasi quotidianamente e fanno un ottimo sesso. Lui però non ha il coraggio di cambiare la sua vita e mandare a monte il fidanzamento per l’amore di una commessa, perciò porta avanti le due relazioni parallelamente. Ma dopo il fidanzamento ufficiale, la ragazza sparisce e lui, che contava di tenersela come amante, dà i numeri. Cade in uno stato depressivo in cui gli pare che niente più nella sua vita abbia senso. Comincia a bere e non combina niente di buono. «L’unica cosa che rende questo dolore sopportabile è possedere un oggetto, retaggio di quell’attimo prezioso. Gli oggetti che sopravvivono a quei momenti felici conservano i ricordi, i colori, l’odore e l’impressione di quegli attimi con maggiore fedeltà di quanto facciano le persone che ci procurarono quella felicità». Dunque colleziona oggetti e li accumula nella casa in cui s’incontrava con l’amante. La sua fidanzata, che è molto innamorata di lui, fa di tutto per aiutarlo, regge al fatto che lui non riesce più a fare l’amore con lei e per stargli dietro diventa mezza alcolizzata. Regge persino all’urto della confessione, quando lui le dice della relazione con la commessa aspirante miss. Ma non c’è niente da fare, lui si crogiola nel suo stato e nel suo immobilismo, senza mai decidere niente, finché lei non ne può più e lo lascia. In tutto questo tempo, lui continua a cercare la sua amata in fuga e quando lei finalmente riappare e lo invita a casa, oltre ai suoi genitori c’è anche suo marito: ha sposato un tipo grassottello che aspira a diventare regista. Allora lui comincia a frequentare la loro casa, illudendoli che vuole produrre un film di cui il marito sia il regista e lei l’attrice, mentre il suo piano segreto è riconquistarla, fare in modo che lasci il marito e si metta con lui. Perciò va a cena a casa loro tutte le sere. Per otto anni. Ma non succede niente: lui si limita a descrivere il suo stato d’animo, il più delle volte irritato e umiliato, ma anche felice se per caso lei gli ha detto una frase gentile. Il protagonista descrive il suo delirio e ci preannuncia che durerà otto anni. Che succederà dopo questi otto anni? Non lo so perché dopo un po’ di queste seratine in cui cenano a casa mentre guardano la tv, oppure al ristorante, e l’unica cosa che succede sono gli stati d’animo del protagonista che spreca la sua vita in questo modo insulso, l’ho abbandonato anch’io come la sua fidanzata. Questo sarebbe l’amore? Questa sarebbe la sofferenza amorosa, come vorrebbe farci credere il protagonista? No, non ci credo. Questo stato morboso in cui lui è spettatore della vita degli altri non c’entra con l’amore. Dov’è il confine tra un amore romantico e malinconico e un atteggiamento ossessivo che si avvita sempre più su se stesso? Non si riesce a provare simpatia per questo protagonista viziato e mezzo alcolizzato che ha tutto e vuole solo quello che non può avere, probabilmente proprio perché non può averlo. Visto che leggere è il modo migliore per viaggiare, dovendo passare un week-end a Istanbul avevo cominciato Il museo dell’innocenza per prepararmi alla città. Mi sono imbarcata nel libro prima ancora di partire e forse Istanbul è la cosa che vi è meglio rappresentata. Devo ammettere che il romanzo parte bene, ma nella parte centrale diventa di una noia mortale. Pamuk ha avuto il premio Nobel per la letteratura nel 2006 e questo romanzo, che è del 2008, non lo aveva ancora scritto. Immagino che non sia il suo migliore. Tempo fa in una libreria, parlavo con una coppia di appassionati lettori tedeschi. Ci raccontavamo i nostri romanzi preferiti. Lei mi ha indicato due libri di Marquez (altro Nobel per la letteratura), dicendomi che erano i suoi due migliori. Parlava con cognizione di causa perché ha letto tutti i suoi libri. Si tratta di Cent’anni di solitudine e di L’amore ai tempi del colera: altra storia d’amore che dura tutta la vita, ma che ha tutt’altra ricchezza. Non voglio dire che se Pamuk avesse scritto prima Il museo dell’innocenza non gli avrebbero dato il Nobel, ma che anche i grandi scrittori non scrivono solo capolavori (a parte rare eccezioni). Perciò mi chiedo: non sarà che i geni della letteratura hanno a disposizione solo un paio di romanzi straordinari, mentre sul resto si può soprassedere?
Scaricare