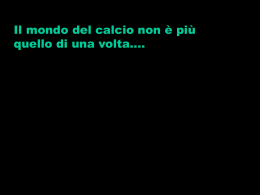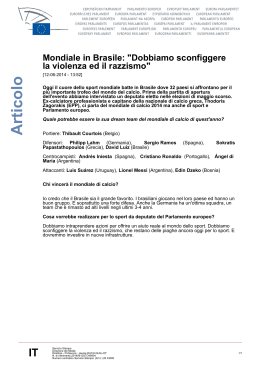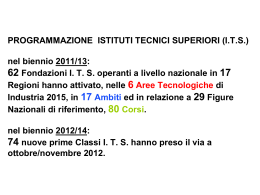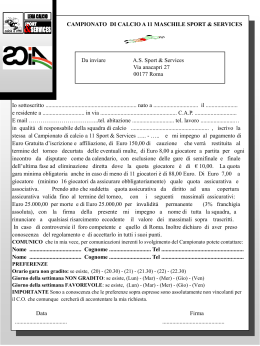PagInaUNO - bimestrale di analisi politica, cultura e letteratura - aNNO IV - N. 20 - DIcEmbRE 2010 / gENNaIO 2011 paginauno bimestrale di analisi politica, cultura e letteratura Restituzione pRospettica Il romanzo mai scritto sugli anni Novanta (5ª parte) Fallimento delle Leghe del sud e appoggio a Forza Italia di Walter G. pozzi polemos Profitti da debito pubblico Manovre speculative e mancata redistribuzione di Giovanna cracco Piccole bombe nucleari crescono La fusione fredda e le nuove mini-armi atomiche di emilio Del Giudice inchiesta Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane di Fabio Damen DuRa lex Le fondazioni bancarie: il furto pubblico del no profit privato di Giovanna Baer inteRvista Elvira Dones. Una libertà senza sogni di sabrina campolongo a pRoposito Di... Ridere, obbedire, combattere! di Giuseppe ciarallo Filo-loGico Storia e geografia della colpa di Felice accame veRità al tempo Della moviola Premi Nobel à la carte di Davide pinardi 8,00 euro anno iv - numero 20 - dicembre 2010/gennaio 2011 - www.rivistapaginauno.it DIRETTORE EDITORIALE Walter G. Pozzi VICE DIRETTORE Giovanna Cracco GLI AuTORI DI quEsTO numERO Felice Accame Giovanna Baer Augusto q. Bruni Fabiana Bussola sabrina Campolongo Giulia Caputi Giuseppe Ciarallo Fabio Damen Emilio Del Giudice Paul Dietschy Luca Gallo Davide Pinardi Claudio Vainieri Le opere pubblicate sono di Romeo Traversa ART DIRECTOR Federica serra sEGRETARIA DI REDAZIOnE Giusy mancinelli sTAmPA maingraf s.r.l. vicolo Ticino, 9 - Bresso (mI) DIsTRIBuZIOnE ndA via Pascoli, 32 - Cerasolo Ausa di Coriano (Rn) tel. 0541 682186 - [email protected] Anno IV – numero 20 Dicembre 2010 / gennaio 2011 Pubblicazione bimestrale (5 numeri annuali) Prezzo di copertina 8 euro Autorizzazione del tribunale di monza n. 1429, registro periodici, del 13/12/1999 sOCIETà EDITRICE mc nelly s.r.l. via A. Villa, 44 - Vedano al Lambro (mB) DIRETTORE REsPOnsABILE Giancarlo Pozzi ABBOnAmEnTO AnnuALE Ordinario 35 euro sostenitore 50 euro c/c postale n. 78810553 intestato a Valter Pozzi b/b IBAn: IT 41 V07601 01600 000078810553 [email protected] numERI ARRETRATI Per ricevere i numeri arretrati scrivere a: [email protected] Le collaborazioni a questa rivista sono a titolo gratuito. Tutti i testi, salvo diversamente indicato, sono soggetti a licenza Creative Commons - Attribuzione, non commerciale, non opere derivate, 2.5 Italia. I testi proposti per un’eventuale collaborazione non vengono restituiti e vanno inviati a: [email protected] Chiuso in redazione il 30 ottobre 2010 www.rivistapaginauno.it questo numero è andato in stampa anche grazie al contributo di Sifra Impianti di Gianni Torre, video citofoni, antenne satellitari, impianti di climatizzazione, video sorveglianza e allarme. Via Rimembranze, 92 - sesto san Giovanni (mI) - tel. 333 4804774 sOmmARIO In questo numero Le stragi del ’92/93: nel 1990 il centro-sud assiste al diffondersi di movimenti leghisti. Pochi mesi dopo, i partitini federalisti del nord confluiscono nella Lega Nord di Bossi e Miglio. E mentre prende vita il progetto federalista, tornano alla ribalta due vecchie conoscenze: Licio Gelli e Stefano Delle Chiaie. La fusione fredda e le nuove mini-armi atomiche: il potere militare parla di ‘uranio impoverito’, la comunità scientifica tace, e intanto dalla prima guerra del Golfo vengono usate armi nucleari grandi come proiettili d’artiglieria. L’asta del petrolio in Iraq: il fallimento della guerra, le ragioni della sconfitta delle compagnie petrolifere americane e la conseguente ricomposizione geopolitica mondiale. Profitti da debito pubblico: operazioni speculative e mancata redistribuzione mentre le manovre varate dai governi europei tradiscono la volontà di non voler cambiare rotta rispetto alla rivoluzione neoliberista inaugurata negli anni ’90. Le fondazioni bancarie: struttura e percorso legislativo di un potere finanziario che la politica ha assoggettato, per mettere nelle mani degli enti locali i lauti profitti delle banche che la norma originaria destinava al no profit privato. I morti del profitto nell’era dell’azienda totale: più di cinquanta suicidi in tre anni tra i dipendenti di France Télécom. E ancora: Calcio e fascismo: l’uso dello ‘sport nazionale’ come strumento di consenso e propaganda fascista. Satira e fascismo: storia e percorso della satira nel Ventennio. Da Atlantide a Thule: quando il mito della ‘terra perduta’ e di una umana ineluttabile colpa da pagare sostituisce qualsiasi analisi sul sistema sociale e sulle responsabilità del potere. Nobel per la pace: un premio da sempre asservito agli interessi della politica occidentale. Non ultimi: intervista a Elvira Dones, racconti inediti di narrativa sociale, critica musicale, recensioni di romanzi e saggi, arte con le opere di Romeo Traversa. _ pag. 6 _ pag. 11 _ pag. 13 _ pag. 20 _ pag. 28 _ pag. 38 _ pag. 50 _ pag. 52 _ pag. 54 _ pag. 64 4 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV _ RESTITUZIONE PROSPETTICA Il romanzo mai scritto sugli anni Novanta (5ª parte) Fallimento delle Leghe del sud e appoggio a Forza Italia di Walter G. Pozzi _ IL RACCONTO Botta e risposta di Regina di Luanto _ POLEMOS Profitti da debito pubblico Manovre speculative e mancata redistribuzione di Giovanna Cracco La memoria del calcio e il fascismo di Paul Dietschy Piccole bombe nucleari crescono La fusione fredda e le nuove mini-armi atomiche di Emilio Del Giudice _ INCHIESTA Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane di Fabio Damen _ RACCONTI Il cassonetto di Fabiana Bussola La telefonata di Luca Gallo _ DURA LEX Le fondazioni bancarie: il furto pubblico del no profit privato di Giovanna Baer _ PER LA CRONACA I morti del profitto nell’era dell’azienda totale di Claudio Vainieri _ pag. 68 _ pag. 72 _ pag. 76 _ pag. 82 _ pag. 88 _ pag. 92 _ pag. 93 _ pag. 94 _ FILO-LOGICO Storia e geografia della colpa di Felice Accame _ VERITÀ AL TEMPO DELLA MOVIOLA Premi Nobel à la carte di Davide Pinardi _ INTERVISTA Elvira Dones. Una libertà senza sogni di sabrina Campolongo _ A PROPOSITO DI… Ridere, obbedire, combattere! di Giuseppe Ciarallo _ SOTTO I RIFLETTORI Facendo finta di annegare recensione de La cascata, margaret Drable di sabrina Campolongo _ IN LIBRERIA – narrativa Gabbiani sul Carso, Giulio Angioni (G. Caputi) Mia figlia follia, savina Dolores massa (s. Campolongo) Racconti disperati, Peppe Lanzetta (G. Ciarallo) _ IN LIBRERIA – saggistica Veleni di Stato, Gianluca Di Feo (G. Cracco) Distruzione del padre. Ricostruzione del padre, Louise Bourgeois (s. Campolongo) Teruel-Malaga 1936-1939, massimo De Lorenzi (G. Ciarallo) _ LE INSOLITE NOTE Sempre tra noi di Augusto q. Bruni 5 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV REsTITuZIOnE PROsPETTICA _ di Walter G. Pozzi Il romanzo mai scritto sugli anni novanta (5ª parte) Il romanzo mai scritto sugli anni Novanta (5ª e ultima parte) * Fallimento delle Leghe del sud e appoggio a Forza Italia quanto accaduto in Italia nella prima metà degli anni novanta denota un’inquietante sovrapposizione di fatti: 1) nascita di partitini federalisti al centrosud e nascita della Lega nord; 2) inizio di una nuova strategia della tensione perpetua che dalla fine di Gladio, passa per la conseguente nascita della Falange Armata fino alla rivendicazione della strage di via dei Georgofili del 1993. Terminano qui le telefonate dei ‘falangisti’. Dopodiché, entra in gioco il misterioso unabomber nei territori del nord-est. Le stragi hanno Nei primi anni ’90 risalito l’Italia, dalle eclatanti esplosionascono partiti ni siciliane, a quelle continentali, fino ad federalisti al centro- approdare al terrorismo a bassa intensisud mentre inizia tà dell’inafferrabile e abilissimo bombauna nuova strategia rolo ‘solitario’ nel profondo nord. Eledella tensione mento di unione dello spostamento perpetua che dalla spazio temporale, un personaggio indafine di Gladio passa gato nell’inchiesta su unabomber che, per la nascita della grazie a una perizia fonica, viene indiviFalange Armata duato come uno dei telefonisti che hanno rivendicato gli attentati a nome della Falange Armata. questo, mentre l’inchiesta mani Pulite colpisce i vertici della politica e del sistema economico; 3) elezioni del 1994 che celebrano la vittoria dell’alleanza di centro-destra capeggiata da una nuova figura politica: l’uomo d’affari silvio Berlusconi. nella sostanza, quanto avvenuto – se accettato anche come consequenziale – si palesa come un processo dialettico in cui un vecchio equilibrio viene alterato per dar vita a un nuovo ordine. una forzatura? no, risponde lo scrittore: solo una semplice scansione cronologica, funzionale alla vicenda narrata. La posta in palio di questa nuova partita a Risiko, giocata sullo sfondo del ‘dopo muro’, è il federalismo – ovvero, il decentramento e la delocalizzazione dei poteri. Come per incanto, la parolina comincia a saettare su giornali e televisioni a uso e consumo dell’onnivora opinione pubblica, che si ritrova all’improvviso, dopo decenni di indottrinamento scolastico all’insegna dei valori unitari e di retorica patriottarda, a dover ingoiare come buona la nuova panacea. ma se è vero che l’impostazione propagandistica che cala dai partiti e dai media è politica, criminale è la spinta che erompe dal cuore di tenebra di un potere in difficoltà. Dal 1990 al 1992, la mappa politica del centro-sud si popola di piccole realtà leghiste/secessioniste/autonomiste, un po’ come accaduto in settentrione a partire dal decennio precedente sulla spinta pionieristica di Liga Veneta e Lega Lombarda. quest’ultima, nel contempo, dopo un’incubazione durata un paio d’anni, si stacca dal bozzolo per diventare, rinnovato nel nome e nei propri quadri, un partito di caratura nazionale. Ed è proprio in questo passaggio cruciale per il futuro dell’Italia, che si celebra l’alleanza tra i fondatori del vecchio movimento spontaneista e uomini appar- * le prime quattro parti sono pubblicate su Paginauno n. 16/2010, n. 17/2010, n. 18/2010 e n. 19/2010; questo articolo, come i precedenti, trae spunto anche dalla Richiesta di archiviazione del Procedimento penale n. 2566/98 denominato ‘sistemi criminali’, tribunale di Palermo; il virgolettato contenuto nel testo – salvo diversa indicazione nelle note a margine – è tratto dal suddetto decreto di archiviazione 6 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV tenenti ai poteri forti – le cosiddette forze occulte. un vincolo di sangue con il potere, grazie al quale il Carroccio spicca il volo verso le poltrone di governo. secondo lo scrittore, osservare al microscopio questa mutazione genetica, avvenuta in sincronia con la fioritura di partitini leghisti al sud, equivale a cogliere la filigrana della verità; equivale ad auscultare attraGianmario verso la superficie della versione ufficiaFerramonti si fa le dei fatti, consegnata alla popolazione strada nella Lega ignara di quanto stia accadendo dietro Nord: oltre a essere il fumo delle bombe, la sotterranea infilun collaboratore di trazione delle forze massoniche, mafioGianfranco Miglio se e neofasciste all’interno del sistema è anche al centro di linfatico della politica italiana. Forse prouna rete di relazioni prio quel sistema (il Potere, ovvero) che con la massoneria sta emergendo nel 2010, a macchia di internazionale e leopardo nel Paese, dalle inchieste deluomini dei servizi la magistratura. È il leghista mario Borghezio, ripreso a segreti sua insaputa durante l’incontro all’estero con alcuni neofascisti francesi, a spiegare come funzioni l’inganno: «Bisogna rientrare nelle amministrazioni di piccoli comuni» dice. «Dovete insistere sull’aspetto regionalista del movimento. Ci sono delle buone maniere per non essere etichettati come fascisti nostalgici, ma come un movimento regionale, cattolico… ma sotto sotto rimanere gli stessi» (1). Lo scrittore, compie un salto temporale in avanti (1994) e costruisce una scena ambientata a Roma per mostrare che, sin da subito, la Lega nord è pronta a sedersi al tavolo da gioco del potere, pur continuan- (1) videoinchiesta di Canal+ dal titolo Europe: ascenseur pour les fachos (Europa: ascensore per i fascisti), 2009 do a mostrarsi al proprio elettorato come alternativa alla partitocrazia romana. La scena è ambientata proprio nel cuore della Roma ladrona. Bossi e maroni, seduti intorno a un tavolo, confabulano con il capo della polizia Vincenzo Parisi, Enzo De Chiara e Gianmario Ferramonti. L’incontro si svolge in prossimità della formazione del primo governo Berlusconi. si discute di poltrone. De Chiara e Parisi chiedono al leader del Carroccio di rinunciare al ministero degli Interni in cambio della Difesa. spiegano al senatur i consistenti vantaggi che il suo partito potrebbe trarre dal cambio. De Chiara, amico da lunga data di Parisi, è un importante lobbista che si muove tra gli stati uniti e l’Italia. Ha contatti tra i vertici della politica repubblicana più reazionaria, è segnalato dalla magistratura come emissario della Cia, in passato ha lavorato vicino a sindona e a Licio Gelli, e riceve incarichi di consulenza per grandi aziende quali la stet, l’Efim e l’Aermacchi di Varese. È interessato alla Lega sin dalla fine degli anni Ottanta, proprio nel periodo in cui il ‘romanzo mai scritto’ prende piede. È tuttavia il suo sodale, Gianmario Ferramonti, ad avvicinare i capi leghisti e a guadagnare spazio all’interno del partito sin dal 1991, fino a diventare l’amministratore della Pontidafin, la società con la quale vengono gestite le attività economiche della Lega. Dall’indagine della procura di Aosta viene accertato che Ferramonti, oltre a essere un collaboratore di Gianfranco miglio, è anche al centro di una rete di relazioni con esponenti di spicco della massoneria internazionale e con uomini dei servizi segreti. nello stesso periodo, Ferramonti entra a far parte del neonato partito Forza Italia. A questo punto manca solo una piccola tessera per comple7 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV REsTITuZIOnE PROsPETTICA tare il puzzle che mostra l’alleanza vincitrice alle elezioni del ’94: Alleanza nazionale. Ci pensa Enzo De Chiara, diventando un riferimento importante per Tatarella e Fiori. È sempre De Chiara l’uomo che organizza l’avvicinamento di Fini alla comunità ebraica, a completare, rendendola definitiva, la svolta democratica di Fiuggi. In cambio del baratto Interni-Difesa, alla Lega vengono offerte le commesse da parte della fabbrica di armi Oto melara e dell’Aermacchi (fatto, questo, contestato ai giudici da Ferramonti nel corso di un interrogatorio). una proposta che la Lega rifiuta, essendo determinata a non rinunciare alla poltrona del Viminale. secondo un’informativa della Direzione investigativa antimafia (Dia), i registi del progetto federalista/separatista/autonomista da realizzarsi attraverso la nascita nel centro-sud di uno sciame di formazioni leghiste, sono Licio Gelli e stefano delle Chiaie, spalleggiati dall’avvocato e socio di quest’ultimo, stefano menicacci. un sommovimento durato due anni, dal ’90 al ’92 che, nell’approfondito quadro tracciato dalle indagini della Dia e dal pentito Leonardo messina, trova in Gianfranco miglio il contraltare nordista, da lui definito il vero artefice del passaggio della Lega Lombarda a Lega nord. Il giurista comasco, “dietro al quale,” secondo messina, “c’erano Gelli e Andreotti”, si assume l’incarico di consegnare ai Lumbard un pensiero politico più articolato che non il semplicistico Va’ a ca’, terun e che consegni la Lega nord a una dimensione nazionale. A ogni modo, ciò che colpisce è il legame tra miglio, che corre ad agganciare la forza politica emergente per piegarla alle esigenze del vecchio sistema, e la coppia di caronti, Andreotti-Gelli, due scatole nere della prima Repubblica. E, se anche è vero che di fronte alle parole dei pentiti è doverosa la cautela, è altresì vero che la concomitanza di alcuni fatti, e di molte testimonianze, autorizza lo scrittore, attraverso l’uso della finzione narrativa, a formulare congetture. 8 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Durante la fase di documentazione lo scrittore trova due interviste – una di miglio e l’altra di Gelli – che, incrociate tra loro, rafforzano la tesi proposta dal ‘roSecondo la Dia manzo mai scritto’. i registi del progetto miglio (2): “Io sono per il mantenimento anche della mafia e della ‘ndrangheta. federalista/ Il sud deve darsi uno statuto poggiante separatista/ sulla personalità del comando. Che cos’è autonomista la mafia? Potere personale spinto fino al da realizzarsi delitto. […] Insomma, bisogna partire attraverso la nascita dal concetto che alcune manifestazioni nel centro-sud tipiche del sud hanno bisogno di essere di uno sciame di costituzionalizzate”. formazioni leghiste Gelli (3): “È da un pezzo che ci sarebbero sono Licio Gelli, tutte le condizioni per un colpo di Stefano delle Chiaie stato onde eliminare la teppaglia che e Stefano Menicacci ci sta rapinando. […] In realtà, sa chi rappresenta l’unica speranza, in questo Paese alla deriva? Bossi. Bossi che se davvero darà il via allo sciopero fiscale… Eh, be’: sarò il primo ad aggregarmi. D’altronde, perché dovrei pagare le tasse?” Il romanzo a questo punto amplia il respiro dando vita a uno stuolo di personaggi. non è semplice rintracciare il momento aurorale di un’architettura complessa che può essere considerata la nuova avventura politica di Licio Gelli. Per questa ragione, lo scrittore decide in maniera arbiPer Leonardo traria di partire dalla nascita della Lega Messina, meridionale. È il 1989. Fondatori: l’avvocato Egi- Gianfranco Miglio dio Lanari, difensore del boss mafioso è il vero artefice michele Greco, di cui propone la candi- del passaggio della datura alle successive elezioni politiche Lega Lombarda a – insieme ai nomi di Vito Ciancimino Lega Nord: dietro e Licio Gelli; e il Gran maestro sicilia- di lui ci sono Licio no Giorgio Paternò, che accoglie Licio Gelli e Andreotti Gelli “fraternamente e a braccia aperte nella fratellanza universale, insieme a tutti i fratelli iscritti alla Venerabile Loggia P2” e afferma la legittimità della P2, battezzando i piduisti “massoni in eterno”. semplice e conciso il programma: abbasso la partito- (2) Il Giornale, 20 marzo 1999 (3) L’Europeo, 10 settembre 1992 Il romanzo mai scritto sugli anni novanta (5ª parte) crazia, dagli alla magistratura, abrogazione della legge Rognoni-La Torre e amnistia per i reati politici. non mancano stretti contatti con uomini legati agli ambienti eversivi della destra come Adriano Tilgher (Avanguardia nazionale), Giuseppe Pisauro, avvocato di stefano delle Chiaie, Tomaso staiti di Cuddia e i fratelli stefano e Germano Andrini (movimento di estrema destra movimento Politico Occidentale), nonché appartenenti agli skinhead romani come mario mambro, esponente anch’egli del mPO. nel giro di un anno (maggio del 1990), a pochi giorni di distanza, sorgono nell’ordine: la Lega Pugliese, la Lega marchigiana, la Lega molisana, la Lega degli Italiani e la Lega sarda. Buona parte di questi neonati partiti politici ha sede presso lo studio dell’avvocato menicacci, già sede della Intercontinental Export Company I.E.C, società di import-export di cui menicacci è socio con il suo ‘cliente’ stefano Delle Chiaie. sono loro, insieme a un pregiudicato per reati comuni, Domenico Romeo, i fondatori di questa particolarissima galassia politica. In stretta alleanza con Licio Gelli. Costruendo un dialogo tra i tre, lo scrittore ricorda che stefano menicacci è “l’elemento di collegamento principale” tra le iniziative leghiste centro-meridionali e la Liga Veneta (uno dei partiti leghisti più coinvolti con gli ambienti di estrema destra), per la quale è stato più volte candidato. La caratterizzazione del personaggio Delle Chiaie merita un po’ di spazio perché è attraverso di lui che vengono rivelati i legami storici, tutt’oggi molto vivi, tra terrorismo, politica, massoneria e servizi segreti. una biografia che certo non si può rilegare in una nota a fondo pagina. Fondatore dei movimenti di estrema destra Ordine nuovo e, in seguito, di Avanguardia nazionale, il suo nome è stato spesso inserito tra quelli dei protagonisti della stagione stragista italiana all’inizio degli anni settanta. nello stesso periodo raccoglieva lodi e applausi in sudamerica tra figure di rilievo (uno era Pinochet) appartenenti a sanguinarie giunte militari e fasci- ste, che lo consideravano un genio del terrorismo. I nomi a cui si accompagna la sua carriera sono di tutto rispetto. Implicato nel fallito Golpe Borghese (1970) e riparato nella spagna di Franco, lavora spalla a spalla con El Brujo (lo stregone), un criminale riconosciuto come il Rudolph Hess argentino, al secolo José Lopez Rega, un rosacroce, peronista, consulente mistico di Isabelita Peron, nonché fondatore degli squadroni della morte AAA e iscritto alla P2. Lopez Rega è amico di Gelli. un altro ‘amico’ di Delle Chiaie è Klaus Barbie, meglio noto come il macellaio di Lione (4). Licio Gelli, dal canto suo, non rimane con le mani in mano e vive una seconda giovinezza politica. nel 1991 fonda la Lega Italiana in compagnia dell’ex piduista Bruno Rozzera, prefetto in pensione, Domenico Pittella, condannato a sette anni e tre mesi per partecipazione a banda armata, Alfredo Esposito, vicino agli ambienti missini, e il pubblicista, funzionario della regione Lazio, Enrico Viciconte. Gli stessi Pittella e Viciconte (1992) fondano la Lega Italiana-Lega delle Leghe, in stretta alleanza con altri esponenti del msi, con rappresentanti del movimento Lucano, della Lega nazional Popolare, formazione riconducibile a Delle Chiaie e Adriano Tilgher, e della Lega sud di Calabria. un progetto che prevede la costituzione di un cartello elettorale dal nome Lega delle Leghe, a cui avrebbero dovuto partecipare il Partito di Dio Partito del Dovere, il movimento Lombardo e Popolare di milano e Busto Arsizio, la Lega Toscana e la Lega Laziale. Dalle indagini della Dia emerge la sincronia con cui, nello stesso tempo, in alcune regioni meridionali e del centro, sorgono movimenti collegati alla Lega nord, fondati per la maggior parte da Cesare Crosta, proveniente dagli ambienti monarchici, in seguito fusi con quelli creati da menicacci. Lo scrittore, in un breve capitolo, mostra una tournée in meridione di umberto Bossi per presenziare e battezzare a modo suo la nascita dei partitini leghisti del sud, partecipando ad alcune manifestazioni organizzate dall’infaticabile menicacci. È proprio durante uno di questi incontri che un giovane Alemanno gli dà senza mezzi termini del razzista. L’intero progetto, per quanto ragionato e messo in moto in maniera capillare, si arena nelle secche di un sonoro insuccesso alle elezioni del 1992. Restano tuttavia gli effetti delle infiltrazioni e il trionfo nazionale della Lega nord. Le ragioni del tonfo sono molteplici. sicuramente la fretta non aiuta. La mafia siciliana, schiacciata sotto il tallone dello stato, ha bisogno di soluzioni rapide per non morire, e un progetto federalista non è cosa che si possa realizzare con uno schiocco di dita. È comunque possibile, per lo scrittore, formulare alcune considerazioni che devono trovare spazio nel romanzo. Frasi rubate ai pentiti, collegamenti temporali. Alcuni collaboratori di giustizia parlano apertamente di tradimenti. (4) satana e la svastica, Peter Levenda, mondadori 9 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV REsTITuZIOnE PROsPETTICA Durante un interrogatorio, massimo Pizza rivela di avere appreso da Carmine Cortese (massone piduista e uomo di vertice della ‘ndrangheta) che la Lega meridionale era la longa manus della mafia siciliana. Il progetto politico, mostrato al Pizza dall’avvocato Lanari, prevedeva la fondazione delle leghe, un patto con la Lega nord tramite Gianmario Ferramonti (l’uomo seduto al tavolo con Bossi, maroni, Parisi e De Chiara). E afferma che il fallimento del progetto è dovuto al tradimento di Gelli e Andreotti. questa frase, inserita nell’ultima parte del romanzo, permette allo scrittore di portare all’incasso due ‘anticipazioni’ apparse all’inizio. Il lettore di buona memoria le ricorda di sicuro. La prima: l’omicidio Lima, mirato a fare cadere la candidatura di Andreotti alla presidenza della Repubblica, potrebbe nascondere nelle ragioni anche una sanzione punitiva per il nuovo tradimento – considerando il primo, il voltafaccia che sarebbe alla base delle condanne definitive comminate dal maxi processo (5). La seconda: il messaggio annotato da Elio Ciolini e consegnato al giudice di Bologna prima dell’inizio della stagione stragista: “si giustifica Lima, per pressione a Andreotti” (6). È un altro pentito, Tullio Cannella, a suggerire agli inquirenti i risvolti che rendono molto prossimo, questo passato, al quadro politico siciliano delineatosi all’inizio dell’ottobre 2010, che vede due partiti autonomisti/federalisti impegnati a preparare le prossime elezioni, su un tavolo più ampio dei confini imposti dal mare. Le parole di Cannella rivelano ai magistrati che, nel 1994, i rappresentanti di un altro movimento leghista, sicilia Libera, incontrano uomini della mafia ed esponenti di altri movimenti leghisti per capire il da farsi in vista delle elezioni politiche di marzo. La decisione passa per i voleri dei boss (5) Il romanzo mai scritto sugli anni novanta (1ª parte), Walter G. Pozzi, Paginauno n. 16/2010 (6) Il romanzo mai scritto sugli anni novanta (3ª parte), Walter G. Pozzi, Paginauno n. 18/2010 10 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Bagarella, dei fratelli Graviano e di Giovanni Brusca: accantonare momentaneamente il progetto e convogliare il voto sul neonato partito di silvio Berlusconi. È questa, a loro avviso, la soluzione più rapida ai problemi, malgrado non vedano di buon occhio i tanti imbarcati appartenenti alla vecchia nomenclatura socialista e democristiana. Il romanzo sembra così costituirsi di tutti i fatti e lo scrittore può sedersi di fronte al computer per iniziare la prima stesura. I tre momenti dialettici potrebbero essere raccontati in un’unica stesura fiume, secondo un complicato modello di romanzo americano (qualcosa di simile a un underworld stile Don DeLillo) o trovare una divisione logica all’interno di un trittico. Eh sì, perché lo scrittore ritiene che la componente avventurosa (ovvero la fase centrale) meriti comunque, pur con tutte le lacune dovute a un vuoto di notizie, di essere raccontata. In quest’ultimo caso sarebbe opportuno disseminare fatti di violenza, bombe, omicidi misteriosi, tenendoli sullo sfondo del primo e del terzo libro; il che gli consentirebbe di mostrare la politica italiana come una malata cronica, patologicamente affetta dalla necessità di perpetuare nella propria storia, senza soluzione di continuità, la strategia della tensione. Violenza che invece diviene il focus del romanzo centrale, incentrato sulla componente criminale dell’intero progetto eversivo. Già immagina una scena iniziale, cruenta e concitata. Il giorno 4 gennaio 1991, nel momento in cui comincia a nascere il piano federalista al centro-sud – mentre le indagini sui fondi neri del sisde scoperchiano tombini e pozzi neri, nel bel mezzo dello scandalo Gladio e del suo conseguente ‘scioglimento’ tra mezze rivelazioni e tentativi di depistaggio – e un anno e mezzo prima dell’omicidio Lima, i poliziotti della uno Bianca uccidono tre carabinieri con mitra in dotazione alle forze speciali di pronto intervento. L’attentato viene rivendicano con la sigla Falange armata. una forzatura? no, una congettura, semmai, che potrebbe trovare un parallelismo nell’ultima pagina del romanzo. Con due date che ne suggellano la fine. schio, 24 marzo 2003: un ordigno esplode nel Palazzo di giustizia, nel bagno posto accanto all’aula Falcone e Borsellino. schio, 15 gennaio 2009: un altro ordigno esplode in un parcheggio sotterraneo, proprio sotto piazza Falcone e Borsellino. Lo scoppio avviene in singolare coincidenza con momenti culminanti delle indagini su unabomber, dalle quali comincia a emergere il dubbio che gli attentati del famigerato bombarolo non siano opera di un uomo solo. un’altra forzatura? Di fronte a quest’ultima domanda, lo scrittore non può che allargare le braccia e limitarsi a una flemmatica risposta: può darsi. IL RACCOnTO Botta e risposta di Regina di Luanto (1862 – 1914) N ella stanza risuonò improvviso, irrefrenabile il riso squillante ed ironico di Donna Valentina. «Non ve ne abbiate a male, Laurenzi… Che volete, ogni volta che mi sento rivolgere una dichiarazione d’amore, come quella che ora avete fatto, non posso fare a meno di ridere!» E continuava, mentre Laurenzi, seduto dall’altra parte del tavolinetto da thè, la guardava interdetto e sorpreso. Rimase zitto, col busto stretto nella redingote bene attillata, molto aperta davanti. Chiusa dalla piccola striscia bianca della sottoveste si mostrava sgargiante la cravatta di raso grigio a pallini rossi, col piccolo spillo di perle. L’occhiello della rivolta di seta era guarnito da un mazzolino di mughetti ed il colletto della camicia altissimo, diritto, costringeva il capo ad una posa forse incomoda, ma di sopraffina eleganza. La faccia di lui giallastra, colle palpebre un po’ gonfie, era atteggiata a studiata immobilità, per evitare che la lente rotonda incastrata nell’orbita cadesse troppo spesso. Donna Valentina riprese sorridendo: «Tant’è; questo avanzo di romanticismo, che stride tanto col positivismo ideale e reale del tempo nostro e che dura agonizzante nella rettorica della quale un uomo crede necessario far uso nella corte ad una signora, mi pare davvero grottesco». «Ma è possibile parlar d’amore in altri termini?» «A me invece pare impossibile che ancora non ci si sia decisi a confessare che oramai d’amore non si deve più parlare». «Come?… Perché?» «Perché non esiste più». «Che dite, Donna Valentina?» «Una cosa verissima. Nelle esigenze della vita moderna, nella quale l’uomo non ha altro pensiero che quello di trovare il modo di soddisfare i suoi bisogni sempre crescenti, nella quale egli è tutto all’incertezza dell’indomani, vi pare che ci possa essere posto per l’amore? Parlo dell’amore, che è oggi una leggenda, del tempo cioè in cui per amore si era o eroi o ribaldi, in cui l’amore 11 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV IL RACCOnTO era il più alto ideale dell’uomo… Ora tutto questo fa ridere, è vero?» «Naturalmente i tempi sono mutati». «Precisamente. Ed oggi si ama un poco per abitudine, un poco per necessità». «Oh!!» «È proprio così, ed anzi a questa necessità le classi ricche cercano di sottrarsi più che possono… capite? Le conseguenze ne sono incomode!…» «Mi sembra invece che nelle classi ricche l’amore abbia sempre una gran parte…» «Non v’illudete. Il più delle volte codesti amori non hanno altra causa che la noia o la vanità… Nelle classi inferiori poi è ancora peggio, poiché sono determinati, nelle donne per avere un vestito o un gioiello, nell’uomo per ottenere una protezione o un avanzamento». «Ma voi esagerate». «No, no: ai nostri giorni è così; si pecca senza piacere, senza rimorso… Neppure con curiosità; tanto la storia si conosce, è sempre quella; sempre la stessa noiosa tiritera». «Donna Valentina, che eresia!! Ma ditemi, se nella forma l’amore ha cambiato, nella sostanza non è, non sarà sempre lo stesso? L’uomo di una volta non è nella sua natura uguale a quello di oggi?… Io non sento forse di amarvi colla stessa unica devozione di un cavaliero del medioevo?» «Sarà; ma cavaliero del medioevo risuscitato nell’anno di grazia 1890. Ve lo figurate voi?… Un cavaliero medioevale costretto a manifestare i prepotenti ardori della sua passione nei furtivi incontri entro una lurida carrozza in piazza, a contentarsi di poche ore passate nella mediocre volgarità di una stanza d’albergo?… Ed il feroce cavaliero, geloso custode della sua dama, obbligato a stringere la mano del marito; anzi ad esserne il migliore amico per timore di uno scandalo, di cui non vorrebbe sopportare le conse12 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs guenze… Perché è così che voi intendete dire, quando affermate di sentirvi l’animo di un antico amatore?» «Ecco… veramente…» «Non mi negherete che la descrizione che vi ho fatta è la perfetta immagine dell’amore, come si pratica adesso. L’uomo è sempre il medesimo, voi dite? E sarà; ma diminuito, rimpiccolito, esausto per il lungo corso dei secoli che hanno consumato a poco a poco tutto quello che era in lui di grande e nobile… Non vedete tutti gli artifizii, tutte le macchine, che egli ha dovuto inventare per averne aiuto, soccorso alla sua debolezza, alla sua impotenza?» «Ah!!» «Credetemi, credetemi; a che voler continuare una commedia che oramai si cangia in farsa e non illude più nessuno? Perché parlar d’amore? Quando il corpo è già fiacco a vent’anni; quando nello spirito indebolito appena reggono ancora le meschine ambizioncelle… Tutto è ridotto così piccino, così gretto, così degenerato e vorreste che l’amore solo non fosse mutato?… Ed ora che vi ho detto il mio modo di pensare, non ho io ragione di ridere, di ridere, quando mi si parla arcadicamente d’amore?» «No; mille volte no» rispose Laurenzi, cercando di esprimere colla voce tutta l’enfasi che non ardiva manifestare coi gesti, per timore di perdere altrimenti la sua elegante insaldatura. «No, perché di tutta quella rovina che voi vorreste fare dell’uomo resterà sempre una cosa… Una cosa che voi non potrete negare, distruggere; che domina e dominerà sempre… L’attrazione dei sessi… La potenza del maschio sulla femmina, potenza che sarà sempre vittoriosa contro ogni ragionamento e contro ogni sofisma…» «Ma per codesto,» interruppe Donna Valentina, squadrandolo da capo a piedi, «preferirei il mio cocchiere!!» PROFITTI DA DEBITO PuBBLICO mAnOVRE sPECuLATIVE E mAnCATA REDIsTRIBuZIOnE di Giovanna Cracco “Dopo la rivoluzione di luglio il banchiere liberale Laffitte, accompagnando il suo compare, il duca di Orléans, in trionfo all’Hotel de Ville, lasciava cadere queste parole: «D’ora innanzi regneranno i banchieri». Laffitte aveva tradito il segreto della rivoluzione”. Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Karl marx “moody’s ha tagliato il rating sul debito della spagna ad Aa1 da AAA, con outlook stabile…”. “standard & Poor’s ha abbassato il rating dell’Irlanda ad AA- con outlook negativo…”. “Il rating di Fitch sul debito dell’Italia è oggi AA-…”. Per addetti ai lavori e profani, frasi simili a quelle sopra citate sono diventate la norma. una volta accettato il gioco, infatti, se ne assimilano le regole – anche quando non le si comprende affatto – e si spera che il rating del proprio Paese resista vittorioso sul primo gradino del podio della tripla A – anche quando si è ben consapevoli che la credibilità delle tre sorelle americane moody’s, s&P e Fitch è perlomeno dubbia, come confermano i clamorosi errori di valutazione commessi in passato. È come giocare a monopoli o a Risiko, salvo che le manovre del mercato finanziario comportano conseguenze sugli esseri umani e che i carri armati sono veri. Tre sono le questioni su cui occorre soffermarsi a ragionare: il rapporto tra debito pubblico e mercato finanziario, quello tra politica e finanza nato con il neoliberismo, e il carattere anti-redistributivo che sta dietro un debito pubblico elevato. Partiamo dalla prima. uno stato non è un’azienda privata il cui scopo è fare utili, bensì un’istituzione politica che deve rendere conto di un contratto sociale sottoscritto con i cittadini; non dovrebbe dunque essere considerato così ‘normale’ che la sua gestione sia valutata sulla base di parametri puramente contabili, ossia il bilancio, al pari di un’impresa privata. Dall’altra parte, dato che così stanno le cose, allora le regole imprenditoriali dovrebbero essere rispettate fino in fondo: se la gestione di uno stato può essere oggetto di valutazione contabile, se i titoli pubblici possono essere oggetto di speculazione, se, dunque, uno stato è trattato sul mercato finanziario come un’impresa privata, allora deve poter anche fallire. E nulla lo impedisce, tecnicamente, come dimostra il caso argentino del 2001. In realtà, che un altro stato possa oggi seguire la via del Paese sudamericano è un’ipotesi molto remota, per ragioni che con la politica hanno ben poco a che fare. Uno Stato è un’istituzione politica che deve dar conto di un contratto sociale sottoscritto con i cittadini: la sua gestione non può essere valutata sulla base di parametri contabili al pari di un’impresa privata subito dopo aver dichiarato l’insolvibilità sui titoli pubblici, il 2 gennaio 2002, il neoeletto presidente Duhalde sganciò la moneta argentina dall’anco13 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs raggio con il dollaro americano, una parità forzata vecchia di undici anni che aveva contribuito a distruggere economicamente il Paese. Da un lato, aveva bloccato le esportazioni, impoverendo l’industria nazionale e creando gravi problemi occupazionali; dall’altro, aveva favorito l’enorme bolla speculativa sul debito pubblico e rimpinguato le casse del sistema bancario Profitti da debito pubblico già qualche mese prima, dimostrando che determinati ambienti ben sapevano in anticipo della dichiarazione di fallimento (una Commissione parlamentare sta cercano di far luce sull’entità delle somme espatriate, pare siano state circa 160 miliardi di dollari, una cifra superiore sia al debito pubblico che al Pil del Paese); per mesi l’economia fu bloccata, aumentò ulteriormente la Il potere finanziario/ politico ha compreso che è più conveniente finanziare uno Stato anziché farlo fallire: 110 miliardi alla Grecia in tre anni al tasso del 5%, raccogliendo il denaro al 3% e speculando un bel 2% _ AnGELOⓇ Romeo Traversa, 2003, elaborazione digitale/testo originale, colore, 21x21 cm internazionale e del Fondo monetario, che finanziavano lo stato sudamericano imponendo riforme neoliberiste. sganciato dal dollaro, il peso argentino subì un grosso deprezzamento ed esplose l’inflazione. I risparmi degli argentini si volatilizzarono – non di tutti, naturalmente: ministri, funzionari, banchieri, industriali, direttori di giornali ecc. avevano opportunamente spostato all’estero le proprie ricchezze 14 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV disoccupazione, esplose una crisi sociale. Il governo promosse politiche di reindustrializzazione, le importazioni diminuirono e le esportazioni aumentarono grazie al ridotto – e più reale – valore della valuta argentina, e verso la fine del 2002, quindi dopo meno di un anno dalla dichiarazione di default, l’economia iniziò a stabilizzarsi. La disoccupazione, arrivata al 20,8% nel 2002, diminuì progressivamente negli anni successivi fino al 7,9% del secondo trimestre 2010; il debito pubblico, pari al 140% del Pil nel 2003, passò al 73% nel 2005 e al 48,8% nel 2009. nel 2005 il Paese propose una ristrutturazione del debito al 30% con scadenze tra il 2033 e il 2045, accettata da circa la metà dei creditori; i rimanenti hanno optato per un ricorso all’arbitrato internazionale che durerà anni. se si confronta la situazione dell’Argentina del 2001 con quella della Grecia del 2009, ne risulta un curioso parallelo: debito 62% del Pil per la prima, 114% per la seconda; disavanzo pubblico 6,4% del Pil per la prima, 12,7% per la seconda. La repubblica ellenica versa dunque in una ben più grave situazione. Eppure, gli stati dell’unione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale hanno fatto di tutto pur di non farla fallire. non serve particolare acume né cinismo per affermare che la ragione del sostegno ad Atene non sta nella volontà di non far patire ai cittadini greci ciò che hanno patito i cittadini argentini in termini di impoverimento e disoccupazione – basta dare un occhio all’entità e alle caratteristiche della manovra finanziaria imposta alla Grecia; non far patire alle istituzioni bancarie che detengono i titoli ellenici la grossa perdita che una ristrutturazione del debito avrebbe comportato, non far innescare l’effetto domino su altri Paesi europei, non far crollare ulteriormente il valore dell’euro nel mercato monetario, con il conseguente deprezzamento dei titoli detenuti in portafoglio – tutti i titoli in euro, non solo quelli greci – sono le sole ragioni del sostegno. A ben guardare, infatti, nel fallimento dell’Argentina i creditori ci hanno rimesso parecchio. Grandi – istituzioni finanziarie – e piccoli – singoli risparmiatori, numerosi gli italiani, che davanti agli alti interessi dei titoli di stato del Paese sudamericano credevano di aver fiutato l’affare di un buon investimento parassitario. Fatto tesoro dell’esperienza, il potere finanziario/politico oggi si guarda bene dal far fallire uno stato, soprattutto se inserito in un contesto monetario più ampio come l’unione europea. Ha compreso che è molto più conveniente finanziare la Grecia con 110 miliardi in tre anni, al tasso del 5%, raccogliendo il denaro da dare in prestito al tasso del 3%: speculando dunque un bel 2%. Ossia speculando per la seconda volta, dato che alla situazione greca – già grave a causa dell’alta evasione fiscale, della corruzione diffusa e del governo che aveva falsificato i conti pubblici (con l’aiuto di Goldman sachs) – si è arrivati grazie a un’altra manovra speculativa. sulla pelle dei cittadini greci – ed europei – si è consumata una guerra monetaria dollaro vs euro. quello delle monete è un delicato equilibrio, come dimostra anche l’acceso conflitto valutario tra stati uniti e Cina: una valuta debole favorisce l’esportazione ma non è certo un bene rifugio, e nel caso del dollaro, moneta di riferimento mondiale per tutte le quotazioni di materie prime, dal petrolio al grano, si aggiunge la paura di perdere il dominio monetario – più volte sul mercato ha fatto capolino la proposta di quotare il petrolio in euro. A dicembre 2009 la valuta europea tocca la soglia massima di 1,51 euro contro 1 dollaro. una situazione che non favorisce nemmeno l’euro: significa veder diminuire le esportazioni e, soprattutto per la Germania, che dopo la crisi ha impostato il rilancio della propria economia sul mercato estero, non è un problema da poco (quella Germania, guarda caso, che ha tirato per le lunghe la sua adesione al salvataggio della Grecia dando alla speculazione qualche ul- Sulla pelle dei cittadini greci si è consumata una guerra monetaria dollaro vs euro scatenata dai sei maggiori fondi speculativi mondiali allo scopo di affossare la valuta europea I governi europei non sono vittime del potere finanziario: potevano decidere di bloccare la manovra speculativa, come fece Hong Kong nel 1998, e varare manovre economiche che colpissero la finanza 15 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs teriore giorno di profitti e all’euro qualche punticino in meno…). La leggenda metropolitana narra… non è nemmeno troppo leggenda, in realtà, visto che il dipartimento della Giustizia americano ha messo avanti le condizioni per l’apertura di un’indagine, chiedendo ai principali fondi speculativi, per ora solo in via ufficiosa, la conservazione rigorosa di tutti i documenti delle operazioni sull’euro. L’8 febbraio scorso, in un ristorante di new York, si incontrano a cena i gestori dei sei maggiori fondi speculativi mondiali, i famigerati hedge funds, tutti e sei targati stati uniti. scopo della riunione, affossare l’euro. La strategia messa a punto prevede come prima mossa di agire sul mercato dei futures, i prodotti finanziari derivati che scommettono sul futuro valore di un titolo. L’obiettivo è far aumentare sul mercato la quantità di futures che puntano sulla parità dollaro/euro, e dunque sulla svalutazione dell’euro. A fine febbraio, i futures contro l’euro toccano quota 70.000 contratti, il numero più alto dalla nascita della valuta europea nel 1999. Le tre sorelle non stanno a guardare: tra aprile e maggio moody’s, s&P e Fitch declassano a più riprese il rating della Grecia e paventano diminuzioni di rating anche per Portogallo, Irlanda, Italia e spagna: nasce l’acronimo Piigs. non stanno a guardare nemmeno i Cds (Credit default swap), ossia quei derivati finanziari che assicurano l’investitore dal rischio di insolvenza del suo investimento, un mercato al 75% nelle mani delle cinque grandi banche di Wall street: Jp morgan, Bank of America, Goldman sachs, morgan stanley, Citigroup. A fine maggio, il Cds Grecia è a quota 687, Portogallo 323, spagna 233, Irlanda 246, Islanda 319, Italia 215. significa che per assicurare, per esempio, 10 milioni di dollari in titoli di stato 16 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Profitti da debito pubblico italiani contro il rischio default, l’investitore è disposto a pagare un ‘premio assicurativo’ pari a 215.000 dollari l’anno. Per fare una proporzione, nello stesso periodo il Cds Francia è 71, Inghilterra 82, Germania 42, Finlandia 28, norvegia 22, stati uniti 38. Il mercato finanziario conta sulla natura gregaria degli uomini, fa leva sulla psicologia degli investitori. L’effetto valanga, quando si mettono in piedi simili manovre corazzate su più versanti, è assicurato: e infatti il 18 maggio scorso l’euro quota 1,21 dollari, ai minimi storici rispetto agli ultimi quattro anni. nel frattempo la Grecia, anello debole di Eurolandia, e via via tutti gli altri Paesi europei corrono ai ripari varando manovre finanziarie di miliardi centrate su draconiani tagli alla spesa, sperando di convincere i mercati della solidità finanziaria dei propri bilanci. Potrebbe venir voglia di affermare che i poveri governi europei, vittime di un potere finanziario più forte di quello politico, siano stati costretti a compiere determinate scelte. non è così. Il legame tra politica e finanza è infatti molto stretto dall’avvento del neoliberismo. A confermarlo, in primo luogo, il fatto che i governi potevano decidere di bloccare la manovra speculativa. nell’agosto 1998, in conseguenza alla crisi finanziaria del sud-Est asiatico, a essere presi di mira dalla speculazione furono la valuta e il mercato azionario di Hong Kong, che iniziarono a scendere a picco. Davanti al crollo, la Banca di Hong Kong rispose all’attacco finanziario elevandosi al di sopra delle norme, che vogliono che una banca centrale non possa intervenire direttamente nei mercati finanziari con operazioni di acquisto. La ragione è semplice: se posso emettere moneta, ho una capacità illimitata di acquisto che falsa ogni equilibrio. In pochissimi giorni la Le manovre varate tradiscono la volontà politica di non voler cambiare rotta rispetto alla rivoluzione neoliberista inaugurata negli anni ’90 e la leva finanziaria è un cavallo di Troia per entrare nelle politiche di un Paese L’Unione europea ha raggiunto l’obiettivo: esautorare i governi nazionali dalle decisioni relative alla spesa pubblica, vincolandola all’applicazione di rigide regole non derogabili e affidandola a organismi non elettivi Banca di Hong Kong comprò azioni – addirittura azioni, non titoli di stato – per 15 miliardi di dollari. L’operazione inflisse grosse perdite agli speculatori al ribasso, che lasciarono il mercato con la coda tra le gambe. In aggiunta, essa rivendette poi gradualmente le azioni acquistate, traendone un guadagno per le casse pubbliche di 4 miliardi di dollari. Il solo timido accenno da parte di alcuni economisti a una simile manovra a opera della Bce, per proteggere l’evidente speculazione al ribasso sull’euro, ha prodotto lanci di strali e denunce contro la tentata violazione delle sacre regole del libero mercato. Piuttosto vanno accelerate le manovre per rientrare dai deficit di bilancio, ha tuonato il presidente Jean-Claude Trichet: mai la Bce acquisterà in prima battuta titoli di stato europei. D’accordo con lui tutti i governi di Eurolandia. Poco importa se anche la Fed, la banca centrale americana, nel momento più cupo della crisi, ha acquistato sul mercato titoli pubblici statunitensi e addirittura derivati legati ai subprime: la Bce “non prende ordini” dalla politica, dice Trichet, la sua indipendenza vale più di ogni altra cosa. ma si tratta di indipendenza o di una precisa scelta tutt’altro che finanziaria? Perché, in secondo luogo, i governi europei potevano decidere di varare manovre economiche dalle differenti caratteristiche: che contenessero, per esempio, un aumento delle imposte alle banche, alle rendite, alle transazioni finanziarie, ai prodotti derivati ecc., insomma a quella realtà finanziaria nel suo complesso che stava per di più guadagnando dalla stessa speculazione sui titoli pubblici. non sarebbe stato poi così illogico, considerando il paradosso del circolo vizioso che si è innescato: il potere finanziario è tornato ad alzare la testa, dopo la crisi del 2008, anche grazie ai finanziamen- ti statali elargiti dai governi alle banche per evitarne il fallimento; prestiti che hanno contribuito ad aumentare i debiti pubblici, insieme alle maggiori spese che gli stati hanno dovuto sostenere per far fronte alla crisi economica innescata dalla precedente crisi finanziaria; debiti che ora il potere finanziario giudica eccessivi. ma, appunto, i governi europei non sono affatto vittime. Le manovre varate tradiscono la precisa volontà politica di non voler cambiare rotta rispetto alla rivoluzione neoliberista inaugurata negli anni novanta. siamo anzi di fronte a una nuova fase: la crisi economica esige un ulteriore ridimensionamento degli spazi rimasti al welfare, un travaso dal pubblico al privato che vada ad alimentare i profitti del capitale impoveriti dalla crisi: trasporti, energia, fondi pensione; e poi sanità, scuola ecc. E la leva finanziaria è un perfetto cavallo di Troia per entrare nelle politiche di un Paese: permette ai governi di fingersi ostaggio di un nemico – la finanza – che detta le regole, quando in realtà ne sono alleati. _ ARTE VERsO AmOR Romeo Traversa, 1980-2009, fotocopia/disegno/ elaborazione digitale, colore, 21x21 cm 17 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs Ad Atene è stata imposta una manovra finanziaria ‘lacrime e sangue’. stipendi pubblici bloccati fino al 2014 e tredicesime e quattordicesime cancellate (e difficilmente il settore privato si comporterà diversamente); età minima pensionabile equiparata tra uomini e donne e portata a 65 anni, con un ammontare dell’assegno mensile calcolato sulla base del salario medio di tutti gli anni lavorati e non più sugli ultimi dieci anni come in precedenza; quasi azzerati gli investimenti pubblici; al via una privatizzazione dei settori dei trasporti e dell’energia; aumento del 10% delle tasse su alcolici, tabacchi e benzina; aliquota iva al 23%, ossia aumentata di ulteriori due punti dopo che già a febbraio 2010 era passata dal 19 al 21. nessuna maggiorazione di imposta per i redditi più alti, per gli utili delle banche, per le imprese – che anzi vedono facilitata la possibilità di licenziare, con l’aumento del tetto fino a oggi fissato del 2% al mese rispetto al numero dei dipendenti; nessuna nuova tassa sulle operazioni finanziarie, nessun aumento d’imposta per la rendita. Ben lontana dall’aver fallito, l’unione europea ha centrato l’obiettivo che si era riproposta alla nascita, suscitando addirittura l’invidia di Bernanke. Il 4 ottobre scorso, nel corso di un convegno annuale a Rhode Island, il presidente della Fed americana dichiara imminente il disastro finanziario pubblico globale a causa dell’insostenibilità delle spese pensionistiche e sanitarie per una popolazione mondiale che ha visto costantemente crescere le proprie aspettative di vita. L’unica via percorribile per evitarlo, a opinione di Bernanke, è l’attuazione fin da ora di rigide misure di austerità e tagli alla spesa pubblica. Tuttavia, afferma, un simile programma è difficile da attuare in sistemi democratici elettivi, governati da Parlamenti nazionali che devono cicli18 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Profitti da debito pubblico camente fare i conti con il consenso popolare e gli appuntamenti elettorali. Occorre dunque agire in due modi: da un lato, esautorare i governi nazionali dalle decisioni relative alla politica di spesa pubblica, affidandola a organismi non elettivi; dall’altro, vincolarla all’applicazione di rigide ‘regole fiscali’ impersonali, asettiche, non derogabili. L’unione europea è riuscita in entrambe le cose, di qui l’ammirazione del presidente della Fed per il sistema del vecchio continente: il Patto di stabilità, rinnovato e reso ancora più stringente dopo la crisi greca, sottrae di fatto ai governi nazionali ogni decisione relativa alla spesa pubblica, demandandola al Consiglio europeo, nella fattispecie all’Ecofin, ossia il Consiglio Economia e Finanza composto dai ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi membri della ue; l’Ecofin, dunque, è un organismo non elettivo. ne consegue che nessun Paese facente parte dell’unione europea possiede più quella sovranità nazionale – ancor meno, evidentemente, quella monetaria – che ha permesso all’Argentina di mandare i creditori a quel paese e ridisegnare, in autonomia, una propria politica fiscale ed economica. E pensare che Trichet non è affatto soddisfatto: il controllo dei conti pubblici non si può lasciare in mano ai politici, dichiara criticando il nuovo Patto di stabilità. E il 25 ottobre, in un articolo sul Financial Times Deutschland, Juergen stark, membro del consiglio esecutivo della Bce, incalza: “quello che ci serve è una vigilanza fiscale e macroeconomica depoliticizzata […]. una sorveglianza depoliticizzata può essere meglio realizzata da un organismo indipendente, che sia ufficiale o non ufficiale”. ma come si è arrivati all’esplosione dei debiti pubblici? La crisi finanziaria e poi quella economica, certo; questo Un elevato debito pubblico è indice anche di una cosciente volontà antiredistributiva: il denaro non prelevato tramite la fiscalità diviene per i cittadini ricchi risparmio da investire in titoli pubblici negli ultimi tre anni. ma in una realtà come quella italiana, per esempio, in cui fin dagli anni Ottanta si combatte con un indebitamento superiore al Pil? un elevato debito pubblico può essere indice di un’alta evasione fiscale e di una mala gestione della cosa pubblica; nel Belpaese lo è certamente, quando per mala gestione si intende una corruzione spaventosa e sistematica che pilota gli appalti e porta le opere pubbliche a costare fino a quattro volte di più rispetto agli altri Paesi, a sostenere per decenni quella collusione criminale che ha prodotto un capitalismo feudale e straccione perennemente attaccato alla mammella dello stato (1). ma un elevato debito pubblico è indice anche di altro: di una cosciente volontà anti-redistributiva o, se vogliamo usare termini oggi considerati obsoleti, di una società classista. Anziché creare un equo sistema fiscale, che preveda imposte maggiori per i redditi elevati e le rendite, incamerando così più entrate di cassa per coprire le spese pubbliche, la politica sceglie di fare debiti. Il denaro non prelevato tramite la fiscalità, diviene infatti per i cittadini ricchi risparmio da investire, risparmio con cui acquistare anche titoli pubblici. In tal modo lo stato si assicura la liquidità necessaria per affrontare le spese e i cittadini facoltosi, anziché pagare imposte adeguate al loro alto reddito, si assicurano un investimento fruttifero. I cittadini che affollano le aste di titoli pubblici pronti ad acquistarli, sono gli stessi che poi pretendono un bilancio contabilmente equilibrato, da tripla A, lontano dal rischio fallimento; e quando il debito supera il Pil del Paese, e il disavanzo tra entrate e uscite cresce pericolosamen- te, e il costo degli interessi sul debito aumenta sempre più fino a mangiarsi miliardi di euro – 70 miliardi all’anno per l’Italia, secondo i dati del ministero dell’Economia del 2007 – sono quelli che ne pretendono la riduzione a suon di tagli alle spese, l’unica via possibile se non si vuole l’aumento delle tasse. Così, coloro che allo stato possono dare solo le imposte, magari trattenute direttamente in busta paga, e non hanno alcun risparmio da investire in titoli pubblici o altrove, si ritrovano a pagare due volte: in termini di tagli a pensioni e di esorbitanti tariffe private per quelli che un tempo erano gratuiti o economici servizi pubblici – sanità, trasporti, energia, scuole – e in termini di interessi sul debito pubblico. I cittadini che possiedono solo il salario, in sostanza, pagano ai cittadini che possiedono un patrimonio parte degli interessi sui loro risparmi investiti in titoli pubblici. Forse è per questo che a maggio scorso, nei giorni di maggiore tensione sociale in Grecia, quando le piazze erano gremite di persone che urlavano di non voler essere loro a pagare il prezzo della speculazione, di una manovra finanziaria che avrebbe aumentato ancora di più la sperequazione tra ricchi e poveri, un enorme striscione è comparso sull’Acropoli. In greco e in inglese, vi era scritto: “Popoli d’Europa, alzatevi”. (1) Debito pubblico: italianità al 104 per cento, Giovanna Cracco, Paginauno n. 10/2008 19 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs LA mEmORIA DEL CALCIO E IL FAsCIsmO di Paul Dietschy L’Italia fascista è stata senz’altro il primo stato, insieme all’unione sovietica, ad aver organizzato una politica sportiva e genuina con lo scopo di trasformare gli italiani in “una nazione sportiva” (1). Il primo passo fu la progettazione e la realizzazione di un’ampia opera di lavori pubblici: mirando a costruire tanto i campi littori – un modello standardizzato di stadio per la pratica di massa nelle piccole e medie città – quanto gli stadi Littoriale (Bologna), Berta (Firenze) e mussolini (Torino), autentiche vetrine architettoniche, il regime volle rompere con l’apatia atletica dell’Italietta liberale e forgiare l’uomo nuovo, che sarebbe stato, anche, un homo sportivus. Le pose del ‘primo sportivo d’Italia’, mussolini in persona, del ‘gigante buono’ Primo Carnera che saluta romanamente, le vittorie olimpiche di Luigi Beccali (1932) o di Ondina Valla (1936) sono, tra le altre, le figure più emblematiche dello sport in camicia nera, all’interno del quale il calcio ha occupato uno spazio particolare. Per semplificare le cose, si potrebbero, in effetti, considerare immagini simbolo del calcio del Ventennio, le squadre di serie A schierate in linea per salutare le gerarchie sedute nelle tribune d’onore degli stadi italiani. O gli Azzurri del ’34 – il portiere della Juventus Giampiero Combi in testa – che sollevano la Coppa del Duce, l’altro trofeo assegnato al termine della finale della seconda Coppa del mondo della Fifa, disputata nello stadio del Partito nazionale fascista. sarebbe tuttavia una visione parziale considerare il calcio sotto il regime alla stregua di un calcio meramente ‘fascista’. Primo, perché non era lo sport di regime. secondo, perché la cultura del calcio deve essere reinserita in un contesto più ampio in cui vanno inclusi anche il calcio e lo sport europei. Terzo, perché solo in mancanza di meglio i calciatori e la passione calcistica furono strumentalizzati dal regime e dalle autorità sportive legate al partito. sono quindi questo sistema sportivo complesso e la sua memoria che qui si intende analizzare. Il regime voleva rompere con l’apatia atletica dell’Italietta liberale e forgiare l’uomo nuovo, che sarebbe stato anche un homo sportivus: il primo passo fu la realizzazione dei campi littori e degli stadi Trasformismo e apolitismo: la memoria del calcio sotto il fascismo dopo il ’45 Lo sport e il calcio furono forse l’eredità meno problematica che l’Italia del dopoguerra poteva raccogliere dal Ventennio. Allorché le ambizioni di raggiungere e mantenere il rango di grande potenza svanirono, con l’avventurosa politica estera di mussolini, lo sport fu “il solo terreno sul quale La politicizzazione dello sport non era una peculiarità solo dell’Italia fascista: le federazioni sportive si mostravano avide di riconoscenza da parte delle autorità statali (1) sport e fascismo. La politica sportiva del regime 1924-1936, Felice Fabrizio, Guaraldi, 1976 20 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV l’orgoglio nazionale poteva esprimersi senza riserva” (2). E benché le pagine sportive dei quotidiani italiani non erano state avare di metafore guerriere, il calcio apparve come un segno della pace e della libertà ritrovate. Fascismo e calcio dalla guerra all’occupazione tedesca Eppure… Al contrario del maggio del 1915, nel quale tutte le competizioni sportive nazionali erano state annullate fino alla fine del conflitto, il regime scelse di lasciarle svolgere, malgrado l’entrata in guerra del 10 giugno 1940. Era, secondo la stampa asservita, la dimostrazione della normalità della situazione, una sfida agli inglesi che cominciavano a bombardare le grandi città italiane. un uomo d’ordine come Vittorio Pozzo, nello stesse tempo Commissario unico della nazionale e giornalista – condizione che gli permetteva di commentare e giudicare le prestazioni azzurre sul quotidiano La stampa – collegava questa scelta a quella dell’alleato tedesco. Il 23 ottobre 1941, sul giornale torinese scriveva: “sotto quest’aspetto ha visto la questione il Partito nel dare la sua adesione alla ripresa del campionato, proprio nelle attuali contingenze. sotto questo aspetto ha considerato la cosa la nostra grande al- leata, la Germania. Il capo dello sport tedesco, richiesto al momento dell’inizio della offensiva contro la Russia, se era il caso di riprendere il campionato di calcio, rispose con una parola sola, una parola che tagliò corto agli indugi: ‘Weitermachen’. Proseguire”. se il calcio era stato messo al servizio della propaganda di guerra, i calciatori furono messi anche alla sbarra degli accusati. Al contrario di alcuni loro colleghi, atleti o ciclisti, vennero infatti molto spesso considerati degli imboscati, poiché lasciati a disposizione delle loro sociétà. Tuttavia, l’accusa di essere prima di tutto dei mercenari non era nuova. Per molti versi derivava dalla diffidenza nutrita nei confronti del calcio, alla fine degli anni Venti, dai gerarchi dello sport fascista come Lando Ferretti, presidente del Coni, o come Augusto Turati, segretario del Partito nazionale fascista. ma in un contesto di guerra, tali accuse tornavano nuovamente ad assumere rilievo. A tal punto che La Gazzetta dello sport, alludendo a un articolo del Popolo d’Italia, il 4 aprile 1943, riferendosi al fronte, chiedeva: “Dove sono gli sportivi?” Occorre precisare che la prospettiva di uno sbarco degli Alleati si faceva sempre più reale. Dopo la caduta di mussolini e l’invasione tedesca, per il mondo del calcio si trattò soprattutto di aspettare giorni migliori. Furono ben pochi quelli che scelsero di schierarsi da una parte o dall’altra durante la guerra civile. Bastò per rifarsi una verginità? In ogni caso, la squadra del Torino che si era rinforzata a colpi di milioni di lire fino a “diventare un’esagerazione” (3), alla fine del maggio 1945 prese parte a una manifestazione sportiva e patriottica giocando contro una rappresentativa lombarda, davanti a un pubblico selezionato da Palmiro Togliatti, segretario del Pci. secondo Gioventù d’azione, l’organo dei gruppi di giovani partigiani di Giustizia e Libertà, la folla che assisteva alla partita (2) storia della prima Repubblica, Aurelio Lepre, Il mulino, 1993, pag. 146 (3) Il film del Campionato di calcio 1942-1943 21 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs La memoria del calcio e il fascismo sentì “vibrare nel suo cuore generoso un fremito di libertà, un desiderio imperioso che lo sport al più presto riprenda per cancellare un triste ricordo di oppressione” (4). Vittorio Pozzo, che si vantava di azioni partigiane, intonò a sua volta, al momento della ripresa delle attività calcistiche, la retorica della libertà ritrovata: “Comincia il Campionato” scriveva sulla stampa del 14 ottobre 1945, “la cosa più desiderata dagli sportivi italiani. se ne parlava, come di un sogno, al tempo della occupazione tedesca. Poter assistere ancora a un vero campionato italiano”. Certo, il biennio settembre 1943/ ottobre 1945 valeva allora quanto un secolo, in termini di cambiamenti e di rovesciamenti della storia e degli uomini. ma Pozzo dava anche un’esemplare dimostrazione di una nuova forma di trasformismo applicata al campo sportivo, dopo la fine della seconda guerra mondiale. fratellata e commentava l’operato proprio. miracoli della maglia azzurra”. Altre voci, tra quelle che avevano dato il tono del giornalismo sportivo durante il Ventennio, iniziarono a evocare in termini piuttosto positivi l’opera del fascismo nel campo dello sport. uno sport fascista che sarebbe stato più pulito di quello della Repubblica perché sostenuto economicamente dal regime. Fu la spiegazione di Renato Casalbore in Tuttosport del 27 settembre 1948, a proposito della creazione del Totocalcio. secondo lui, “molti mali guarirebbero il giorno in cui lo stato italiano fosse in condizione di sostenere lo sport: difficile appare ora l’investimento di una situazione creata all’avvento delle scommesse sulle partite di calcio. Il regime fascista fu sempre contrario a tal genere di iniziative; ma il regime sovvenzionava ampiamente lo sport”. E concludeva: “La differenza è sostanziale”. Prime nostalgie del passato Il tecnico piemontese non fu neanche tra gli ultimi a ricordare le gloriose ore del passato. Ora che le strutture sportive del fascismo erano state più o meno conservate, a cominciare dal Coni – affidato a un giovane socialista dottore in diritto, Giulio Onesti – Vittorio Pozzo poteva vantare anche lo spirito delle vittorie dell’anteguerra. Il 6 aprile, dopo una vittoria (3-1) ottenuta a Parigi contro la nazionale francese, nel bel mezzo della situazione da guerra civile che circondava le elezioni politiche, sempre sulla stampa scriveva: “Pareva di essere tornato allo stato d’animo dell’anteguerra, quando la squadra, a incontro terminato, affluiva tutta in una camera stretta, unita, af- Da Rimet a Vaccaro se, da un lato, la citazione di Casalbore non deve essere interpretata come l’espressione di una specie di nostalgia del fascismo, bensì come un rimpianto del dinamismo e dei successi dello sport italiano sotto il fascismo grazie al sostegno del regime, dall’altro la dottrina ufficiale dell’apoliticità dello sport, in corso negli ambienti sportivi, giustificava questo tipo di sguardo benigno sul passato. non si trattava solo di una mania italiana. questo sguardo era diffuso in tutta la società internazionale dello sport. A cominciare da Jules Rimet, il presidente francese della Fédération internationale de football association (Fifa) dal 1921 al 1954. Alla fine della sua presidenza e della sua vita, Rimet scrisse un opuscolo su “il calcio e il riavvicinamento dei popoli” nel quale sosteneva che, lungi dal creare ten- (4) Gioventù d’Azione. Giustizia e Libertà, anno 2, n. 4, 27 maggio 1945 22 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Accanto alle imprese di Italo Balbo, lo sport proponeva all’estero un’immagine dinamica, giovane e finalmente virile e moderna dell’Italia I vettori italiani della cultura di massa erigevano a modello una vita moderna e spensierata: in questo senso il privato dei calciatori era l’equivalente sportivo dei film dei ‘telefoni bianchi’ sioni tra le fazioni sportive e i popoli, il calcio contribuiva al loro affratellamento (5). E rievocando, nello stesso anno (1954), la “meravigliosa storia della Coppa del mondo”, Rimet relativizzava il carattere politico dell’edizione italiana (1934). In particolare, rifiutava di identificare Giorgio Vaccaro, il presidente della Figc – peraltro, console della milizia – come lo strumento di controllo del potere fascista sul calcio. “non dobbiamo giudicare nel Generale Vaccaro” scriveva Rimet vent’anni dopo, “il personaggio politico. ma lo sportivo ci appartiene. Abbiamo il diritto di dire che è stato per l’associazione italiana un presidente prestigioso e che tutti quelli che sono stati in relazione con lui debbono dare la testimonianza della loro simpatia” (6). Un aspetto della politicizzazione del calcio negli anni Trenta Da una decina di anni, giornalisti e storici hanno deciso di indagare sul calcio del Ventennio. sia sotto l’aspetto dei grandi protagonisti (7), sia sotto quello della storia culturale e politica (8), le loro opere hanno insistito sulla politicizzazione e sullo sviluppo del calcio sotto il fascismo. Purtroppo, quando si cercano negli archivi segni di questo processo, i risultati spesso deludono. Le fonti dell’archivio centrale di stato rivelano, per esempio, che mussolini si era mostrato molto indifferente all’organizzazione della Coppa del mondo, fino alla vigilia dell’evento. Il mantenimento dell’ordine pubblico durante le partite era certamente la preoccupazione principale dei prefetti e dei questori, ma ciò non significa che lo sport che stava diventando ‘lo sport nazionale’ non scampasse alla politicizzazione in corso nella società italiana. Anche se questo fenomeno deve essere ricondotto in un quadro europeo. Un matrimonio di ragione Lando Ferretti, il fascista colto e perbene, incaricato del controllo del Coni, riassumeva bene la posizione particolare del calcio all’interno del sistema dello sport fascista. scriveva nel 1928 che “le fortune travolgenti del calcio fra noi, per il suo meraviglioso adattarsi al temperamento della stirpe, sono uno dei fatti salienti della ripresa sportiva italiana”. ma aggiungeva egualmente: “Certo il foot-ball (sic) ha potentemente contribuito a questa ripresa, ma oggi col suo incipiente professionismo e con le sue aspre contese campanilistiche cui dà luogo, ne compromette i successivi sviluppi” (9). Corruzione, violenze di tifosi, denaro componevano già il cocktail del calcio, anche se in misura minore rispetto a oggi. E i calciatori erano già accusati di comportarsi come dei mercenari. A tal punto che Augusto Turati in persona cercò di limitare la sua diffusione, creando uno ‘sport di sintesi’ a uso dei dopolavoristi come la ‘volata’, e decretò il rugby “sport fascista per excellenza” per farne il gioco dei Gruppi universitari fascisti (Guf). ma la passione delle popolazioni urbane per il calcio era tale che sembrava impossibile arrestarne la crescita. Piuttosto che combatterlo, sembrò più utile assegnargli l’obiettivo di contribuire al consenso e di tenere alti i colori dell’Italia nelle competizioni internazionali. Il calcio e la politicizzazione dello sport negli anni Trenta La politicizzazione dello sport in generale, e del calcio in particolare, non era una peculiarità solo dell’Italia fascista. Le federazioni sportive si mostravano avide di riconoscenza da parte delle autorità statali. nel 1927, la federazione francese di calcio invitò il presidente della Repubblica Gaston Doumergue alla finale della Coppa di Francia. nasceva in quel momento una tradizione, ispirata alla FA Cup inglese. Ogni anno, da allora, la personalità più importante della République assiste alla Fête nationale du football française, per analogia con il 14 luglio. Il fatto (5) Le football et le rapprochement des peuples, Jules Rimet, Fifa, 1954 (6) Histoire merveilleuse de la Coupe du monde, Jules Rimet, union européenne d’éditions, 1954, pag. 99 (7) Vittorio Pozzo. storia di un italiano, mauro Grimaldi, società stampa sportiva, 2001 (8) in particolare Football and Fascism: the national game under mussolini, simon martin, Berg, 2004 (9) Il Libro dello sport, Lando Ferretti, Libreria del Littorio, 1928, pag. 164 23 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs che, da Gaston Doumergue a nicolas sarkozy, i presidenti abbiano consegnato il trofeo al capitano della squadra vincente non è senza significato. La formula della Coupe, una competizione nella quale le squadre dilettanti incontrano quelle dei professionisti in una partita a eliminazione diretta, incarnava non solo la democrazia dello sport ma anche l’ideale della meritocrazia e dell’egalitarismo repubblicani. nella Coupe de France, dei dilettanti seri e allenati potevano eliminare delle vedette poco motivate, esattamente come un ragazzo, titolare di una borsa di studio statale, poteva salire nella scala sociale tramite i suoi successi scolastici. Gli anni Trenta vedranno anche le prime politiche sportive democratiche, in reazione a quelle degli stati totalitari. Furono i governi di Front populaire (1936-1938) a integrare lo sport e l’educazione fisica in un progetto politico più globale. ma i giochi di Berlino avevano anche provato che lo sport poteva servire come arma politica. Così, la diplomazia britannica suggerì ai giocatori della nazionale inglese di effettuare il saluto nazista prima della partita contro la Germania allo stadio olimpico di Berlino il 14 maggio, meno di due mesi dopo l’Anschluss (10). Era il contributo calcistico alla politica dell’appeasement... L’immagine di una Italia virile e moderna non era questo, tuttavia, il significato attribuito alle vittorie azzurre dalla propaganda fascista. In effetti, lo sport costituiva un altro modo di assumere i desideri di potenza al- La memoria del calcio e il fascismo meno dal punto di vista simbolico. E un gerarca sportivo come Lando Ferretti, sosteneva la necessaria sovversione ideologica dei valori dello sport. Denunciava in particolare l’internazionalismo decoubertiniano. Per lui lo sport internazionale doveva produrre una gerarchia tra le nazioni, dimostrare il valore di una razza, e non contribuire alla pace tra i popoli. Di fatto lo sport, accanto alle imprese aeree come quelle di Italo Balbo, proponeva all’estero un’immagine dinamica, giovane e finalmente virile e moderna dell’Italia. Per la stampa popolare parigina, simpatizzante del regime e sovente ‘corrotta’ dai servizi di propaganda italiani, il campione italiano, che fosse Giuseppe meazza, Tazio nuvolari o Alfredo Binda, incarnava l’Italia nuova, disciplinata dal suo duce. Gli stadi di Firenze o di Torino erano portati a esempio e ispiravano gli architetti che progettarono gli stadi-velodromi di marsiglia e Bordeaux nella seconda metà degli anni Trenta. A tal punto che, alla vigilia della Coppa del mondo di calcio organizzata in Francia (1938), la stampa francese si allarmava per il paragone che gli stranieri avrebbero potuto fare con l’edizione italiana, giudicando gli stadi francesi troppo piccoli per una competizione mondiale. La vittoria finale di Pozzo e dei suoi uomini nello stadio di Colombes, il saluto romano del capitano meazza al presidente della Repubblica francese Albert Lebrun prima di ricevere il trofeo, confermarono il timore dei giornalisti francesi. Due anni dopo Berlino, le imprese e i successi sportivi delle dittature, accompagnavano la loro aggressività diplomatica. Il calcio negli anni Trenta tra cultura di massa transnazionale e consenso italiano La stampa sportiva europea dipingeva volentieri il carattere politico del calcio italiano. Pubblicando una serie di caricature sugli stili nazionali dopo il mondiale del ’34, il settimanale francese Football mostrava un Azzurro trionfante mentre salutava romanamente un mussolini marziale (11). Con un dettaglio ‘umoristico’. sulla tribuna, sulla quale era rappresentato il duce, era disegnato anche il fascio del littorio coperto dal pallone. una maniera per dire, come avrebbe affermato Rimet vent’anni più tardi, che il calcio poteva cancellare una parte della carica politica che gli si voleva attribuire. (10) su questo episodio dell’appeasement sportivo cfr. scoring for Britain: international Football and International Politics 19001939, Peter J. Beck, Franck Cass, 1999 (11) Football, 28 giugno 1934 24 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Il calcio, una cultura oltre le frontiere Benché il calcio fosse organizzato su un piano nazionale e le partite internazionali fossero definite matchs internations, la cultura del calcio prodotta e trasmessa dalla stampa sportiva era in parte transnazionale. I direttori di testate come Walther Bensemann (Der Kicker, prima dell’avvento al potere dei nazisti), Gabriel Hanot (Le miroir des sports) o marcel Rossini (Football) formavano una società di giornalisti che scambiavano informazioni e facevano circolare immagini e rappresentazioni del gioco. Il calcio italiano era esso stesso aperto al cosmopolitismo sportivo fin dall’inizio. Certo, Leandro Arpinati, il ras di Bologna, presidente della Figc, aveva vietato l’importazione di calciatori stranieri nel 1926, chiudendo un periodo nel quale molte vedette erano austriache o ungheresi. ma l’utilizzazione degli ‘oriundi’, questi argentini o brasiliani che, come Raimundo Orsi o Luis monti, vestivano la maglia della nazionale, dava un tocco esotico al neonato campionato di serie A. La mitropa Cup, la Coppa internazionale, le Coppe del mondo del 1934 e del 1938, e gli incontri amichevoli internazionali, offrivano altrettante occasioni di vedere all’opera i grandi giocatori stranieri – in particolare i danubiani – o di leggere la descrizione dei loro successi nelle ampie pagine dedicate allo sport dalla stampa italiana durante il Ventennio. non a caso Carlo Levi, evocando l’atmosfera del dopoguerra e del governo Parri, ricorda a un redattore del giornale di cui è direttore, le stelle degli anni Venti e Trenta. “Zamora, mateo, Hirzer la gazzella, sindelar cartavelina. quei nomi, come una realtà poetica ed eternale, spingevano lontano da lui ogni cosa presente, e la politica e il giornale” (12). L’uomo nuovo del calcio: un piccolo borghese Allorché Primo Carnera simbolizzava nolens volens la brutalità fascista e una Italia immaginaria popolata da giganti e altri maciste, i calciatori simbolizzavano, al contrario, la velocità e la destrezza. Giuseppe meazza fu soprannominato ‘balilla’, sicuramente in virtù della sua giovane età ma anche perché non era un colosso. La tecnica e la vista gli permettevano di ingannare la guardia dei più feroci terzini. Aveva anche un bel sorriso, che la stampa francese faceva ammirare; una forza seduttiva paragonabile a quella degli attori del cinema. Il fascino dei calciatori non era limitato ai campi da gioco. La stampa degli anni Trenta amava far conoscere l’uomo oltre che lo sportivo. Il calciatore era quello che poteva raggiungere uno stile di vita da cui la maggiore parte degli italiani era esclusa. Automobili Fiat per meazza (una Balilla, ovviamente) o per Orsi; vacanze sul litorale tirreno a Forte dei marmi per Rosetta, il terzino della Juventus, e per tutti la gestione di un bar o di un negozio. nella ‘biografia’ di Rosetta, il giornalista Erberto Levi evocava il progetto dell’ex calciatore della Pro Vercelli in questi termini: “Iniziativa commerciale e industriale, in una parola. Virginio Rosetta amministra i frutti dei suoi risparmi con la stessa saviezza con cui amministra i suoi trentatré anni d’atleta” (13). nessuno spirito di sacrificio al regime, ma piut- Tuttavia il calcio nel Ventennio non fu un calcio meramente ‘fascista’: non era lo sport di regime, la sua cultura deve essere inserita in un contesto europeo e fu strumentalizzato solo in mancanza di meglio Dopo la caduta di Mussolini e l’invasione tedesca, per il mondo del calcio si trattò soprattutto di aspettare giorni migliori; furono ben pochi quelli che scelsero di schierarsi da una parte o dall’altra durante la guerra civile (12) L’Orologio, Carlo Levi, Einaudi, 1989 (prima ed. 1950), pag. 192 (13) Viri (Virginio Rosetta): piccola storia di un grande atleta, Erberto Levi, Editrice Popolare milanese, 1935, pag. 200 25 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs La memoria del calcio e il fascismo La dottrina ufficiale e diffusa dell’apoliticità dello sport giustifica uno sguardo benigno sul passato e non si tratta nemmeno di una mania solo italiana _ COmPOsIZIOnE_1 Romeo Traversa, 2008, elaborazione digitale, colore, 200x200 cm tosto spirito di risparmio piccolo borghese. Rosetta non seguiva quindi la definizione dello sport secondo Lando Ferretti nel suo breviario atletico: “Lo sport è per noi anzitutto e soprattutto, scuola di volontà che prepara al fascismo i consapevoli cittadini della pace, gli eroici soldati della guerra” (14), scriveva nel 1928 il capo del Coni. Il consenso calcistico se i raduni di massa organizzati da Achille starace hanno potuto contribuire a costruire il consenso ottenuto da mussolini, secondo Renzo De Feli- ce, per una grande parte degli italiani nella prima metà degli anni Trenta questo non bastava. Certo, nuto Revelli poté ricordare che per lui “il fascismo e lo sport erano la stessa cosa” e che era “orgoglioso dei suoi nastrini e delle sue medaglie” (15). In questo modo, lo sport, associato ai riti del Campo Dux, poteva lusingare il “narcisismo dei piccoli in divisa” (16). Per i più grandi, il richiamo del moschetto e della divisa era senz’altro meno forte. O forse il proposito militaresco del regime non era per loro il volto più efficace dell’immagine del fa- (14) Lando Ferretti, op. cit., pag. 225 (15) Le due guerre. Guerra fascista e guerra partigiana, nuto Revelli, Einaudi, 2003, pagg. 14-15 (16) Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a salò, Antonio Gibelli, Einaudi, 2005, pag. 319 26 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV scismo. ma, come altrove nell’Europa dell’ovest, i vettori italiani della cultura di massa erigevano a modello un modo di vita moderno e spensierato. In questo senso la vita dei calciatori era l’equivalente sportivo dei film dei ‘telefoni bianchi’. E, con il suo primo sistema di protezione sociale, il dopolavoro, grazie al quale i giovani adulti potevano per di più acquistare a buon prezzo i biglietti per vedere le partite di serie A, il regime prometteva anche un presente e un avvenire migliori. Illusione che affondò nelle guerre mussoliniane. ma lo stadio offriva anche la possibilità di esprimere quella rabbia che era esclusa dal campo sociale e politico. In particolare quella relativa al campanilismo, a tal punto che nel 1932, Il Littoriale, il quotidiano organo del Coni, dovette richiamare l’esasperazione espressa dal duce contro tutte le manifestazioni di regionalismo (17). malgrado i decreti legge promulgati da Federzoni dopo la sparatoria della stazione di Porta nuova nel 1925, al termine della finale Bologna-Genoa, una situazione elettrica accompagnò le partite di calcio fino al 1943. Furono in parte tollerate perché non si trattava di tensioni politiche e, in fin dei conti, non rappresentavano un pericolo per il regime. I tifosi al più erano una specie di ‘indifferenti’ degli stadi, come i protagonisti del romanzo di Alberto moravia uscito nel 1929. sori non erano affatto gli idealtipi dello sportivo fascista e che furono anche accusati di essere dei mercenari o peggio degli imboscati. Ciò significa che la storicizzazione di questo aspetto della storia del Ventennio è necessaria per capire la passione degli italiani per il campionato di serie A, il quale è senz’altro l’istituzione più solida del novecento italiano! questo non significa che il calcio non fu politicizzato. Il ‘giornalista’ Vittorio Pozzo ne dà numerosi esempi. una ragione di più per lui e suoi colleghi, come Bruno Roghi, direttore della Gazzetta dello sport, per gettare un velo pudico nell’immediato dopoguerra su queste relazioni pericolose tra calcio e regime e per costruire, con altri ‘gerarchi’ dello sport, la leggenda dell’apolitismo sportivo che innerva la memoria dello sport. È quindi questa ambivalenza, questa complessità della posizione del calcio e dei calciatori sotto il regime, che fa di questo sport un osservatorio singolare e pertinente degli anni del fascismo. Conclusione: storia e memoria del calcio durante il Ventennio Da qualche anno, calciatori come il portiere del milan Christian Abbiati, fanno il loro coming out mussoliano. se avessero la curiosità di sfogliare i periodici pubblicati durante il Ventennio, potrebbero verificare che i loro predeces- (17) Dopo la parola del Duce. Basta coi regionalismi!, Il Littoriale, 28 luglio 1932 27 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs PICCOLE BOmBE nuCLEARI CREsCOnO LA FusIOnE FREDDA E LE nuOVE mInI-ARmI ATOmICHE di Emilio Del Giudice Incontro sul libro inchiesta Il segreto delle tre pallottole di maurizio Torrealta e Emilio Del Giudice (Edizioni Ambiente, collana Verdenero, 2010) alla libreria Odradek di milano, 1 ottobre 2010 una delle caratteristiche della società moderna, che sembra fondata sull’abbondanza e sulla disponibilità dell’informazione, è la capacità di mantenere segreti. E li mantiene proprio grazie all’enorme quantità di informazione che viene rovesciata sulla testa delle persone le quali, non avendo più punti di riferimento, assumono, rispetto all’informazione che ricevono, un’attitudine passiva. Convinti di sapere tutto proprio perché hanno ricevuto un mare di notizie i cittadini, paradossalmente, non sanno niente. E non esiste modo migliore per nascondere la verità che fare riferimento non a bugie plateali ma a verità parziali. Alcuni giornalisti chiesero, durante una conferenza stampa del portavoce del governo israeliano, se era vero che nel 2006, sul fronte del Libano, Israele avesse usato armi nucleari di tipo nuovo. La risposta del portavoce fu: “noi dichiariamo che l’esercito israeliano non ha mai fatto uso di armi vietate dalle convenzioni internazionali”. Il che è verissimo, l’arma di cui parliamo non è vietata dalle convenzioni internaziona28 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV so l’esistenza, gli americani lo abbiano a loro volta appreso dagli inglesi e gli israeliani dagli americani. negli ultimi tempi, è probabile che anche i francesi le abbiano sviluppate. li, per il semplice motivo che è un arma di tipo nuovo, e quindi non è prevista nelle convenzioni internazionali; nessuno ufficialmente sa dell’esistenza di questo tipo di arma e dunque essa non è un’arma vietata. Il cittadino che riceve questa informazione resta convinto che non c’è niente di misterioso, invece di misterioso c’è tutto. Per prima cosa occorre precisare che le potenze coinvolte nell’uso di miniarmi nucleari appartengono a un largo spettro; anche se è difficile dire con esattezza quali siano, è probabile che la Russia le abbia usate in Cecenia e gli stati uniti e la Gran Bretagna nelle varie guerre del medioriente e nei Balcani. La possibile catena è questa: i primi ad averci pensato sono stati i tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È vero che erano molto lontani dal realizzare armi del tipo usato a Hiroshima, ma probabilmente perché non avevano preso quella strada: gli scienziati tedeschi studiavano il modo di creare un differente tipo di bomba, molto simile a quelle usate nei conflitti dalla prima guerra del Golfo in poi, ed erano sul punto di realizzarla. Dato che i laboratori dove questo accadeva erano situati nella parte orientale della Germania, è molto probabile che i russi abbiano messo le mani su questo tipo di armi e le abbiano ulteriormente sviluppate; è probabile che dopo, in seguito a giochi di spie, gli inglesi ne abbiano appre- È difficile dire con esattezza quali siano le potenze coinvolte nell’uso di mini-armi nucleari: è probabile che la Russia le abbia usate in Cecenia e gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e Israele nelle varie guerre del Medioriente e nei Balcani Partiamo da quello che già è noto, ossia che a partire dagli ultimi vent’anni, dai campi di battaglia dei Balcani, del medioriente, probabilmente anche della Cecenia, sono arrivate notizie ‘strane’: strane patologie che colpiscono le persone, sia militari che civili. Tutti abbiamo sentito parlare della ‘sindrome del Golfo’: nel corso del tempo, molte persone che sono state in quei campi di battaglia sviluppano strane patologie. Per esempio, tra i militari italiani che hanno prestato servizio nei Balcani, sia in Bosnia che nel Kosovo, pare si sia sviluppato un numero di leucemie molto superiore a ciò che statisticamente ci si potrebbe aspettare, tant’è che il Parlamento italiano ha nominato una Commissione – che non ha concluso alcunché, però il semplice fatto di averla nominata significa che un problema esiste. Ovviamente gli organismi militari hanno fatto del loro meglio per depistare l’attenzione e hanno dichiarato che, probabilmente, causa di queste patologie sono i proiettili fatti di uranio usati nel conflitto. La ragione della scelta di questo materiale, affermano i militari, è nel fatto che l’uranio è il metallo più pesante esistente in natura, e dato che per perforare una corazza o un muro di cemento occorre un forte impatto, un proiettile fatto di un metallo molto pesante causa un buco molto maggiore rispetto a un normale proiettile di piombo. In più, affermano, visto che grazie all’industria nucleare esiste una grande quantità di scarti di uranio che non si sa dove buttare e che non costano nulla, l’uranio è la materia prima perfetta e a basso costo per fabbricare proiettili. La contropartita, purtroppo, affermano sempre i militari, è che l’uranio presenta proprietà di radioattività, e quindi il fatto che sui campi di battaglia restino dei detriti provocati dalla rottura di questi proiettili provoca patologie nelle persone coinvolte. questa tesi è poco credibile. se così fosse, dato che l’uranio è usato da parecchio tempo, tutti i minatori delle miniere di uranio si dovrebbero ammalare in massa, mentre tra loro questa patologia non risulta. Oppure tutti coloro che hanno a che fare con l’industria nucleare dovrebbero presentare le stesse caratteristiche, eppure gli stessi soggetti dicono da una parte che il nucleare è sicuro e dall’altra che il semplice fatto di maneggiare proiettili di uranio provoca patologie mortali. Oltretutto, che l’uranio possa presentare una qualche forma di radioattività è notissimo, dunque come è venuto in mente ai militari di usare un proiettile di uranio? È vero che l’uranio è più pesante del piombo, ma lo è solo del 20%. Il guadagno vale il rischio? La botta che il proiettile dà al bersaglio è funzione della sua energia cinetica, la cui formula è: metà del prodotto della massa per la velocità al quadrato. Per aumentare la forza dell’impatto i militari hanno deciso di aumentare del 20% la massa, ma potevano ottenere molto più facilmente lo stesso risultato aumentando del 10% la velocità del proiettile, e tutto sommato per farlo bastava usare una carica di esplosivo leggermente maggiore. non è difficile, anzi. negli ultimi tempi l’artiglieria ha realizzato grandi progressi, per cui, per esempio, mentre nella seconda guerra mondiale le granate sparate dai cannoni uscivano dalla bocca a un chilometro al secondo, adesso escono a cinque chilometri al secondo. In proporzione, che cosa può mai essere quel 20% di maggiorazione… 29 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs A dispetto delle varie dichiarazioni ufficiali, le inchieste proseguono. nella guerra del Libano del 2006 si verificò un caso che fece parlare: in un paesino che si chiama Khiam, dove vi era un caposaldo degli Hezbollah, l’aviazione israeliana bombardò, e si dà il caso che erano presenti fotografi che scattarono alcune foto. L’immagine riprese qualcosa che sembrava, in piccole dimensioni – piccole ma non tanto, era una colonna di 5.000 metri, anche se rispetto a un’esplosione nucleare si può definire piccola – un fungo atomico. Il caso vuole che in quel villaggio era nato un fisico nucleare libanese, il quale prelevò dei campioni dal cratere dell’esplosione – che si era successivamente riempito d’acqua – e li mandò in differenti laboratori in giro per il mondo. Due di questi – non uno, due, indipendenti tra loro, di cui uno era il laboratorio di Harwell in Inghilterra, il più rinomato al mondo per fare questo tipo di ricerca – trovarono nel campione una presenza di uranio arricchito. qui occorre fare una piccola digressione scientifica: che cos’è l’uranio arricchito? L’uranio è fatto da vari isotopi; il nucleo dell’elemento consta di un certo numero di protoni e di un certo numero di neutroni, nel caso dell’uranio i protoni sono 92 – fissati, perché danno la carica elettrica che dà le proprietà chimiche – mentre i neutroni possono essere in numero variabile: 146, e in questo caso la somma protoni più neutroni fa 238, e questo nucleo non è fissile, cioè non si può spezzare, oppure 143, e in questo caso la somma fa 235 e questo nucleo è fissile. Per la bomba atomica serve dunque la varietà 235, quella fissile, mentre la varietà 238 è utile solo in quanto può essere utilizzata per produrre plutonio: attraverso un procedimento ormai ben noto si bom30 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Piccole bombe nucleari crescono barda con neutroni il nucleo il quale acquista un neutrone e dopo un rimescolamento interno diventa plutonio 239, a sua volta fissile. quindi l’uranio 238 è utile non in sé e per sé ma come materia prima per fare il plutonio. Dell’uranio che esiste in natura, il 99,3% è fatto dell’isotopo 238 e solo lo 0,7% è fatto dell’isotopo 235. Dato che per fare la bomba atomica occorre l’uranio 235, si deve cercare di ottenerne una maggiore quantità con un procedimento apposito: si prende l’uranio naturale, in forma gassosa, composto appunto per il 99,3% di isotopo 238 e per lo 0,7% di isotopo 235, lo si mette in una centrifuga, per effetto della forza centrifuga la parte più pesante va all’esterno, la parte più leggera resta al centro. In questo modo, la parte che resta al centro si definisce arricchita ed è uranio 235, mentre la parte che resta all’esterno si definisce impoverita ed è uranio 238. naturalmente, per avere la quantità necessaria a fare una bomba atomica bisogna arricchire l’uranio fino a raggiungere il 90% di isotopo 235 e il risultato è che questo processo è molto costoso – è quello che stanno tentando di fare, si dice, gli iraniani con le loro centrifughe: ottenere uranio arricchito. È chiaro a questo punto che, poiché l’arricchimento richiede tutti questi processi complicati e costosi, uno stato non si sognerebbe mai di usare uranio arricchito in una normale bomba semplicemente per dare maggiore forza all’impatto: quindi la presenza di uranio arricchito nel cratere di Khiam testimonia del fatto o che è stata usata un’arma nucleare contenente già uranio arricchito oppure che l’uranio si è arricchito nel momento dello scoppio. In entrambi i casi c’è qualcosa di nucleare in gioco. Di fronte ai risultati dei due laboratori le autorità, ovviamente, sono corse ai ripari, e il laboratorio di proprietà delle nazioni unite, per esempio, ha negato i risultati. D’altra parte questo laboratorio si è reso famoso perché ha negato anche che nel Kosovo ci fosse alcunché… d’altra parte questi non sono laboratori indipendenti perché dipendono da organismi politici. Dopo aver chiarito la questione dell’uranio, per affrontare l’argomento delle nuove armi utilizzate occorre spiegare brevemente come è fatta una bomba atomica del tipo utilizzato a Hiroshima e nagasaki. una volta ottenuta una massa fatta di uranio 235, i nuclei che lo compongono possono essere fissionati, ossia rotti, da neutroni; rompendosi, i nuclei liberano energia, molta energia, tuttavia la probabilità che un neutrone colpisca un nucleo e lo rompa è piccola, perché i neutroni sono molto piccoli, i nuclei anche, e quindi la probabilità che il neutrone riesca a colpire il nucleo è molto bassa: è come fare il tiro a segno. Per aumen- tare questa probabilità, occorre mettere dunque un gran numero di nuclei: in tal modo, se il neutrone attraversa uno spazio dove ci sono molti nuclei, prima o poi ne becca uno. questa tecnica è alla base di quello che si chiama la ‘massa critica’. se io prendo un blocco di uranio 235 tale che la sua dimensione superi quello che in gergo si chiama il ‘libero cammino medio’, cioè il tratto che deve fare il neutrone prima di avere la probabilità di colpire un nucleo, ogni neutrone che passa di lì prima o poi centra un nucleo e quindi avviene l’esplosione. Il valore della massa critica è un segreto militare ma è un segreto di Pulcinella: si sa che esso varia tra 7 e 8 chili. quindi se io prendo una massa di uranio 235 di 3 chili, non scoppia; aumento la massa e a 7 chili ho l’esplosione. stabilito questo, com’è fatta una bomba nucleare? Dato che non posso tenere insieme la massa critica altrimenti esplode, questa massa è divisa in tante sotto-masse, frammenti che separatamente non esplodono, inseriti all’interno di un contenitore foderato all’esterno di esplosivo normale; quando questo esplode, i frammenti implodono, ossia sono proiettati l’uno contro l’altro, creano la massa critica e si ha il botto nucleare. Il fatto che al di sotto di quella massa critica non può esserci esplosione nucleare vuol dire che l’esplosione deve essere per forza gigantesca. La bomba atomica o distrugge un’intera città o niente, non è possibile con questo sistema fare un’arma che distrugga solo un palazzo e basta. In questo senso l’arma atomica è un’arma di estremo ricorso, un’arma poco flessibile che non può essere usata per normali fini militari. Eppure, nei casi in questione – la prima guerra del Golfo, i Balcani, i conflitti degli ultimi anni in medioriente, forse in Cecenia – pare che le armi usate fossero mini-armi atomiche, cosa che le potenze militari negano proprio dicendo che come tutti sanno, un’arma nucleare non funziona al di sotto di una massa critica. Dopo la prima guerra del Golfo del 1991 è uscito un libro scritto da un missionario francese, padre Jean-marie Benjamin, tradotto in italiano con il titolo Iraq: l’Apocalisse, in cui sono contenute molte foto. si vedono carri armati distrutti, e la particolarità è che se si prendono le fotografie della seconda guerra mondiale, della guerra di Corea, o delle prime guerre del medioriente, lì i carri armati bombardati conservano più o meno la silhouette originaria; solo avvicinandosi si vede che c’è un bel buco nella corazza, causato dalla granata che entrata all’interno, in contatto con i vapori di benzina, produce la fiammata che carbonizza i militari. nelle foto dal 1991 in poi si vede un’altra cosa: il carro armato ha perduto la sua silhouette, è diventato una massa di metallo fuso. un carro armato è fatto di acciaio e pesa 40 tonnellate, non esiste alcun esplosivo convenzionale in grado di fonderlo: significa riuscire a sprigionare tantissima energia e per di più localizzata, perché intorno al carro armato c’è distruzione per 20 metri, non oltre. A Hiroshima venne distrutta un’area il cui raggio era 1,5 chilometri, ossia un cerchio di 3 chilometri di diametro. questo significa che sono state inventate mini armi nucleari, superando il problema della massa critica? E se l’hanno superato, come hanno fatto? Di certo se è così, il risultato deve essere ben difeso con il segreto. Negli ultimi vent’anni, dai campi di battaglia sono arrivate notizie di strane patologie che colpiscono sia i soldati che i civili: gli organismi militari parlano di proiettili all’uranio impoverito Dal 1991 in poi, le foto dei carri armati bombardati mostrano una massa di metallo fuso: non esiste alcun esplosivo convenzionale in grado di fondere 40 tonnellate di acciaio quando si fece la bomba atomica nel ’45, i princìpi fisici su cui la bomba era fondata erano già noti ed erano stati chiariti negli anni Trenta: c’era poco da tenere segreto, soltanto la tecnologia adottata per mettere in pratica princìpi 31 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs fisici ben noti. ma se uno stato investe denaro e mette a lavorare abbastanza ingegneri, in capo ad alcuni anni il segreto tecnologico viene scoperto e rivelato. se invece è il principio fisico a essere ignoto, allora è diverso, perché si deve avere l’idea. se qualcuno ha l’idea, allora, il modo migliore per proteggerla è far calare una coltre di silenzio, non parlarne e non permettere che se ne parli, e magari depistare l’attenzione verso qualcos’altro, come l’uranio impoverito. Piccole bombe nucleari crescono americano, Fleischmann e Pons, annunciarono di essere riusciti a realizzarla – da notare che Fleischmann, precedentemente, aveva lavorato per sette anni in laboratori militari della marina inglese. In che consiste la fusione fredda? Facciamo prima un passo indietro: in che consiste la fusione? I nuclei degli elementi sono un insieme di neutroni e protoni tenuti insieme da forze di tipo nucleare a cui si aggiunge, come correzione, la repulsione Libano 2006: esistono foto del bombardamento dell’aviazione israeliana sul paese di Khiam che mostrano l’immagine di una colonna di 5.000 metri simile a un fungo atomico _ COmPOsIZIOnE_2 Romeo Traversa, 2008, elaborazione digitale, colore, 200x200 cm La prima guerra del Golfo inizia nel gennaio 1991, la mobilitazione militare iniziò nel ’90: quindi già nel ’90 queste armi esistevano. Che cosa accadeva sul fronte scientifico negli stessi anni? Ci fu una grande polemica in merito alla cosiddetta ‘fusione fredda’. nel marzo 1989 due scienziati, un inglese e un 32 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV elettrostatica dei protoni che essendo cariche positive si respingono. se i protoni sono pochi, questa repulsione è piccola, se cominciano ad aumentare di numero la correzione elettrica inizia a diventare grande. Ci sono i due estremi: pochissimi nucleoni – così sono definite le particelle subatomi- che che compongono il nucleo, siano esse protoni o neutroni – oppure moltissimi nucleoni. nel caso di moltissimi nucleoni, per esempio l’uranio, dove i protoni sono 92 e i neutroni 143, la repulsione tra questi 92 protoni mette a rischio la stabilità del nucleo che tende dunque a spezzarsi. nei nuclei cosiddetti leggeri invece, per esempio un nucleo fatto con 2 protoni e 2 neutroni, dato che questi nucleoni si attirano tra di loro e la forza repulsiva elettrostatica è minima, se io ne aggiungo un altro l’energia prodotta aumenta. Immaginiamo due persone che si abbracciano: in due si abbracciano con una certa forza, in quattro con una forza maggiore, via via fino al punto di saturazione. Dai nuclei leggeri quindi si ottiene liberazione di energia fondendo, cioè aumentando il numero dei nucleoni, mentre dai nuclei pesanti la si ottiene rompendo; da questi ultimi dunque libero energia con il processo della fissione, spezzando il nucleo, dai primi invece il contrario, ossia fondendo. Facciamo un esempio: prendo un nucleo di idrogeno fatto da un protone e basta. se aggiungo un neutrone ottengo una cosa che è ancora idrogeno ma pesa di più: è idrogeno pesante ossia deuterio. Poi prendo due nuclei di deuterio, li metto insieme e faccio un nucleo con due neutroni e due protoni, che è l’elio. Ho fatto una fusione. Da questa fusione si libera energia. Però nella fusione c’è una difficoltà: le forze nucleari sono un milione di volte più intense delle forze elettriche ma hanno un raggio di azione piccolissimo per cui solo se quei due nuclei entrano in contatto si fondono; se stanno un poco lontani, le forze nucleari non hanno il raggio di azione sufficiente per attirarli. Dall’altra parte, le forze elettriche sono molto più deboli ma hanno il raggio di azione più grande, però sono repulsive: i due nuclei si respingo- no tra di loro, quindi la fusione non si può realizzare a meno che io non trovi un modo per farli entrare in contatto. Come fare? Ci sono due modi: o con la forza o con le buone maniere. Il primo è il metodo della cosiddetta ‘fusione calda’, che si basa sull’idea di dare ai nuclei tanta di quella energia che essi vincono la repulsione; questa energia è fornita tramite la temperatura. Fatti i calcoli, si scopre che occorre una temperatura di 60 milioni di gradi per sormontare la repulsione elettrica. Con questa tecnica è stata realizzata la bomba H, la bomba all’idrogeno: prendo una bomba atomica a fissione, questa esplode, produce una temperatura di milioni di gradi e abbiamo la fusione dei nuclei. La bomba H è dunque un processo a due stadi. Occorre un detonatore, formato da una bomba atomica normale, che esplodendo determina la fusione. Detto per inciso, questo è utile solo per le applicazioni militari, non per quelle energetiche, perché non posso far scoppiare una bomba atomica per produrre energia. nel campo dell’uso energetico quindi il nucleare presenta ancora non pochi problemi, perché temperature così alte vaporizzano qualsiasi cosa, l’idrogeno riscaldato a 60 milioni di gradi si deve guardare bene dal toccare qualsiasi parete perché altrimenti la vaporizza. L’idea astuta è quella di prendere un recipiente con potenti calamite, confinare i nuclei nel centro del recipiente, quindi lontano dalle pareti, e bombardarli con potenti laser in modo da alzare la temperatura. Alzandosi, la potenza delle calamite deve ancora aumentare perché i nuclei tendono a respingersi… insomma, è una contraddizione che non finisce più e quindi non sorprende che il problema non sia ancora stato risolto. I campioni prelevati dal cratere di Khiam contengono tracce di uranio arricchito; nessuno Stato lo userebbe mai in una bomba convenzionale semplicemente per dare maggiore forza all’impatto Reduci americani affermano che il 27 febbraio 1991 l’aviazione statunitense ha sganciato una bomba atomica nella zona compresa tra Bàssora e la frontiera iraniana 33 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs In questa situazione di sfida tecnologica arrivano due professori che dicono: noi abbiamo realizzato la fusione nucleare a temperatura ambiente, spendendo in cinque anni di lavoro, dato che nessuno ci finanziava, i nostri risparmi, in totale l’equivalente di 20 milioni di lire di allora. E come? usando le buone maniere invece della violenza. I nuclei non vengono lasciati soli nel vuoto ma inseriti dentro una matrice metallica, in cui si trovano allo stato libero elettroni che sono carichi negativamente. L’idea è che gli elettroni, frapposti tra i nuclei di deuterio, li schermino. Il metallo che più si presta a fare questo è il palladio. Fleischmann era uno dei maggiori elettrochimici del mondo – dopo l’annuncio è stato dipinto come un cretino che non capiva nulla, ma era presidente dell’Associazione internazionale di elettrochimica – e qualche hanno prima aveva ricevuto la Palladium medal, la medaglia di palladio: lui prese questo pataccone e lo fuse per fare gli elettrodi in cui inserire i nuclei. quando il numero di nuclei di deuterio inseriti nel metallo supera una certa soglia – che corrisponde a un nucleo di palladio per ogni nucleo di deuterio – i nuclei di deuterio cominciano a fondersi spontaneamente e si libera energia in forma di campi elettromagnetici che hanno la frequenza dei raggi gamma, campi che poi degradano e danno luogo al calore. Ora: la frequenza dei raggi gamma è adatta a spezzare un nucleo. se dunque anziché adoperare un ‘proiettile’, come un neutrone, si adopera un campo elettromagnetico, che non è puntiforme ma esteso, il problema della massa critica per avere un’esplosione nucleare non esiste più, perché un campo esteso non ha difficoltà a ‘colpire’ tutti i nuclei che trova, a scuoterli vigorosamente – dato che 34 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Piccole bombe nucleari crescono il campo elettromagnetico è un’oscillazione – e a spezzarli. Abbiamo così trovato un modo alternativo di realizzare la fissione nucleare senza usare ‘proiettili’, e quindi superare il problema balistico di cogliere il bersaglio. In questo modo non rompo il nucleo ma lo schiodo tramite risonanza. Che questa non sia un’ipotesi ma un certezza posso personalmente garantirlo, perché ho partecipato agli esperimenti di fusione fredda fatti a Frascati ed esaminando al microscopio elettronico, dopo l’esperimento, il pezzo di metallo in cui questo è avvenuto, si evidenziava che c’erano zone vergini dove non era accaduto nulla e zone in cui tutto il reticolo cristallino era dissestato; facendo l’esame della natura dei nuclei con un’altra tecnica, chiamata sEm, questi erano, nei tratti vergini, al 99,9% nuclei di palladio, mentre nei tratti dissestati il 10% erano di nichel, e il nucleo di nichel è circa metà del nucleo di palladio. questo vuol dire che era avvenuta una fissione del palladio. Tra parentesi, la fissione del palladio è del tutto innocua, non libera energia perché il palladio non è né pesante né leggero ma in equilibrio e quindi rompendosi non libera energia. questo esperimento è stato fatto nel 2002, ma supponete che qualcuno avesse scoperto questi princìpi fisici molto prima di quanto non l’abbiano fatto Fleischmann e Pons; supponete che negli anni ’70/80, nei laboratori militari, qualcuno abbia scoperto questa cosa, e abbia provato a usare, come metallo ospite, l’uranio invece del palladio. Anche i nuclei di uranio si romperebbero, ma a differenza dei nuclei di palladio libererebbero energia. Dunque si potrebbe ottenere un’esplosione nucleare, e senza massa critica; non ci sarebbe più bisogno di fare esplodere 7/8 chili di uranio, potrebbe bastare anche un grammo. si Nel 1989 a Bàssora le morti per tumori sono 34, nel 2001 superano i 600 casi e si evidenziano tumori rarissimi Al di sotto della massa critica, 7/8 chili di uranio, non può esserci esplosione nucleare: ma questo vale solo per il procedimento della fusione calda potrebbe quindi realizzare un’arma nucleare delle dimensioni di un proiettile di pistola. E che potenza avrebbe questa mini esplosione nucleare? Facciamo una proporzione: a Hiroshima, usando 7 chili di uranio 235, per avere il quale Probabilmente, alla base della cosiddetta sindrome del Golfo vi è il fatto che i militari americani non si aspettavano effetti radioattivi perché, in effetti, questa è una fissione non radioattiva: mentre un neutrone che Nel marzo 1989 Fleischmann e Pons annunciano di essere riusciti a realizzare la fusione fredda; il primo aveva lavorato per sette anni in laboratori militari della marina inglese _ COmPOsIZIOnE_3 Romeo Traversa, 2008, elaborazione digitale, colore, 200x200 cm devo usare 1.000 chili di uranio normale – dato il rapporto dello 0,7% di uranio 235 presente nell’uranio in natura – si è prodotta un’esplosione che corrisponde a 20.000 tonnellate di tritolo, o venti chilotoni. Con un chilo avrei un’esplosione pari a 1.000 volte di meno, 20 tonnellate; con un grammo avrei l’equivalente di 20 chili di tritolo, che corrispondono alla carica di una cannonata. quindi, sparando un proiettile di pistola da un grammo non solo produco l’effetto di una cannonata, ma ho anche tutte le conseguenze di un’esplosione nucleare, ossia la radioattività. colpisce un nucleo lo rompe a caso, come quando si scaraventa un bicchiere contro una parete, se il nucleo è messo in risonanza in realtà non viene rotto ma, appunto, schiodato; i suoi frammenti sono dunque in equilibrio e perciò non radioattivi – la radioattività è causata dal fatto che un frammento non è in equilibrio e comincia a buttare fuori qualche particella per ritrovare l’equilibrio. questo è vero però in prima istanza, perché comunque vengono emessi dei raggi gamma che rendono radioattiva la materia circostante e producono una radioattività di secon35 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV POLEmOs do ordine che produce effetti sulla salute. È vero che questo tipo di radioattività è confinata nei 30/50 metri dal punto in cui è avvenuta l’esplosione, che è una zona molto ridotta rispetto a quella interessata a Hiroshima, ma è anche vero che la bomba di Hiroshima era una: se uso cento di queste bombe, o migliaia di questi proiettili, posso comunque ricoprire l’intero territorio di radioattività. sulla base di questa scoperta le grandi potenze, chi prima e chi dopo, realizzano dunque armi di questo genere, fatte in questo modo: si prende un pezzo di uranio, si carica di deuterio appena al di sotto della soglia, in modo che non esploda in mano, si spara il proiettile, il proiettile colpisce il bersaglio, subisce una compressione che fa andare la densità di deuterio al di sopra della soglia, scatta la fusione fredda, produce quel campo elettromagnetico che scuote i nuclei di uranio i quali cominciano a spezzarsi e abbiamo il botto nucleare. Il processo è dunque invertito rispetto alla bomba H: mentre in questa usiamo una bomba a fissione per innescare la fusione, qui all’opposto usiamo la fusione per innescare la fissione. Torniamo alla prima guerra in Iraq del 1991. un corrispondente di guerra segnalò il seguente fatto: vide un carro iracheno inseguito da un carro americano. Il primo si nascose dietro una duna di sabbia, il secondo, senza neanche cercare di andare a stanarlo, sparò una cannonata contro la duna. Il proiettile passò la duna da parte a parte, colpì il carro iracheno e lo distrusse. Per prima cosa, una simile potenza Piccole bombe nucleari crescono di cannonata non si è mai vista nelle armi usuali; in secondo luogo, i cadaveri dei soldati iracheni avevano la pelle nera. non erano carbonizzati, i peli, come le sopracciglia, erano integri: quei militari non si erano bruciati, erano come abbronzati. ma dato che i raggi gamma sono molto più potenti dei raggi ultravioletti, era come se i poveretti si fossero fatti una super lampada. questo evento è l’evidenza che lì è accaduto un fenomeno nucleare. un altro caso, a Baghdad: un ricovero antiaereo venne colpito da un missile il quale perforò un blocco di cemento di un paio di metri di diametro ed entrò all’interno, esplodendo e provocando la morte di tutte le persone presenti. La particolarità è che sul muro rimasero stampate le silhouette di tre persone, di cui una era una donna incinta. Come mai? La persona che sta lì e che quindi proietta la propria ombra sul muro viene istantaneamente vaporizzata, il che avviene in un tempo brevissimo: l’ombra non fa in tempo a sparire, perché l’ondata di calore scalda tutta la parete non in ombra e salva la parte in ombra. Fatti come questi sono stati fotografati a Hiroshima. questo vuol dire che quelle persone sono state vaporizzate, e non c’è nessuna esplosione chimica in grado di vaporizzare una persona. Altro esempio: a Bàssora, dove ci sono stati pesanti bombardamenti, la percentuale di tumori si è moltiplicata in modo esponenziale. mentre nel 1989 le morti per tumori erano state 34, nel 2001 superano i 600 casi e si evidenziano tumori rarissimi. Il primario di oncologia di Bàssora, che aveva riportato questi dati, ha successivamente ricevuto il formale avvertimento dal governo iracheno di non divulgarli ulteriormente, pena il taglio totale dei finanziamenti; ovviamente, non ha più parlato. È stata realizzata anche un’arma intermedia, usata proprio vicino a Bàssora; è oggetto dell’inchiesta video realizzata da maurizio Torrealta e mandata in onda da Rainews24 nel 2008, ancora visibile e scaricabile sul sito (1). Reduci americani affermano che l’ultimo giorno della guerra, il 27 febbraio 1991, l’aviazione statunitense ha sganciato una bomba atomica nella zona compresa tra Bàssora e la frontiera iraniana. Per avere conferma di ciò, Torrealta ha un’idea brillante: controllare se in zona e in quel momento, i sismografi abbiano rilevato una scossa sismica. un’esplosione nucleare, infatti, produce un’onda simile a un terremoto ma con caratteristiche diverse: mentre questo parte piano e poi cre- (1) http://www.rainews24.it/ran24/rainews24_2007/inchieste/08102008_bomba/ 36 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV sce, un’esplosione nucleare parte forte e poi decresce, quindi se si guarda la forma dell’onda si può distinguere un evento dall’altro. Esiste poi una tabella, creata negli anni Cinquanta, che misura la potenza dell’esplosione in base ai gradi della scala Richter dei terremoti. Torrealta si rivolge all’Osservatorio sismologico di stoccolma, specializzato nel testare e controllare se i vari Paesi facciano o meno esperimenti nucleari. L’osservatorio risponde che il 27 febbraio 1991 sono state registrate scosse sismiche a 30 miglia a est di Bàssora, alle 13.39 ora locale, un evento di 4,2 gradi della scala Richter. Dichiara inoltre che le caratteristiche del profilo dell’evento non possono, per ragioni connesse allo statuto dell’Osservatorio di stoccolma, essere rese pubbliche, e l’unica cosa che può affermare è che l’evento registrato non è incompatibile con un evento nucleare e che è avvenuto in superficie, tra zero e 33 chilometri di profondità. La tabella dice che 4,2 gradi della scala Richter corrispondono a 5 chilotoni, cioè a un quarto della potenza usata a Hiroshima; minore dunque a quella che corrisponde alla massa critica. Comunque notevole, perché pari a 5.000 tonnellate di tritolo. Perché mai l’ultimo giorno della guerra gli americani avrebbero usato un’arma di questo tipo, oltretutto in una zona desertica dove apparentemente non vi erano bersagli? si possono fare solo supposizioni: tenendo conto che la zona è contigua al confine iraniano, l’esplosione potrebbe essere stata un avvertimento all’Iran. nella prima guerra del Golfo, in cui i militari, probabilmente, non previdero le conseguenze radioattive di queste nuove armi, solo le truppe angloamericane svilupparono la sindrome del Golfo: i militari degli altri Paesi al- leati non vennero infatti ammessi nelle zone di combattimento anglo-americane, probabilmente allo scopo di proteggere il segreto sulle nuove armi. nella guerra successiva, quella nei Balcani, queste armi furono nuovamente usate ma stavolta gli anglo-americani si guardarono bene dall’andare a occupare i campi di battaglia e ci mandarono gli italiani; e la moria è avvenuta tra i militari italiani. una volta mi trovai a parlare con un soldato che prestava servizio in Kosovo e gli chiesi, fingendo ingenuità, se lui avesse mai preso contatto con carri armati serbi distrutti; rispose che i militari italiani avevano il divieto assoluto di avvicinarsi e che per impedire che anche la popolazione lo facesse, intorno ai carri armati esplosi veniva tirato un filo spinato lungo uno spazio di alcune decine di metri di diametro. questo significa che i comandi italiani erano stati informati sulla natura delle armi usate. naturalmente le stesse precauzioni non furono mantenute dagli ignari civili, per cui ci sono state perdite enormi soprattutto tra i bambini. I raggi gamma producono una radioattività di secondo ordine confinata nei 30/50 metri dal punto di esplosione: ma se uso cento bombe, o migliaia di proiettili, posso ricoprire l’intero territorio di radioattività non dimentichiamo, infine, che uno dei vantaggi della fusione fredda è che non richiede grosse somme di denaro per essere realizzata, tanto che Fleischmann e Pons lo fecero con i loro risparmi. A differenza di altre branche della scienza, non necessita dunque di massicci finanziamenti. La comunità scientifica come tale ignora tutto ciò. non vi è nemmeno ostilità, c’è il vuoto pneumatico. Fleischmann e Pons sono stati considerati dei pazzi buffoni e la questione della fusione fredda è convenientemente finita nell’oblio. 37 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InCHIEsTA _ Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company AMERICANE _ di Fabio Damen L ’11 e 12 dicembre 2009 si è tenuta a Baghdad la seconda asta petrolifera dopo che la prima, nel giugno dello stesso anno, era andata praticamente deserta per le esose richieste del governo iracheno e del suo ministero del Petrolio. All’asta sono state accreditate quarantacinque company di tutti i Paesi, fatta eccezione per quelle che in passato avevano avuto concessioni petrolifere dal governo curdo. Questo a testimonianza dello scontro in atto tra il governo centrale di Al Maliki e quello ‘autonomo’ del Kurdistan iracheno, nato da una soluzione tattica americana che aveva come obiettivo quello di tenere sotto controllo la principale area di produzione petrolifera irachena e che alla fine ha creato più confusione che altro, sia in termini di gestione pseudo nazionalistica, sia in termini di amministrazione delle stesse riserve petrolifere del Paese. Le concessioni rilasciate dal ministero del Petrolio di Baghdad hanno visto prevalere le aziende europee e asiatiche, in alcuni casi riunite in joint venture. Dei dieci giacimenti aggiudicati nel 2009, appena due vedono le compagnie americane impegnate nelle operazioni di sfruttamento e una sola delle due in un giacimento di qualche rilievo. A ot38 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV tenere i migliori risultati è stata la compagnia statale malese Petronas, la quale ha conquistato i diritti per tre giacimenti, poi l’angolana Sonangol con due. Hanno ottenuto concessioni anche la China National Petroleum Corporation (CNPC), le russe Lukoil e Gazprom, e le europee Shell (Olanda), Total (Francia), Statoil (Norvegia), BP British Petroleum e buon ultima l’italiana Eni. Secondo i contratti ventennali firmati a Baghdad, le aziende appaltatrici hanno accettato di ricevere somme che variano tra un minimo di 1,35 e 2 dollari per ogni barile di petrolio estratto in più rispetto all’attuale livello, in modo che qualsiasi (auspicato) aumento del prezzo del greggio andrà a ingrassare le esangui casse del governo iracheno. La posta in gioco, quella più appetitosa, era la concessione dei diritti di sfruttamento dei giacimenti presenti nel sud del Paese, attorno alla città di Bàssora, dove si trova il sito di Al-Zubayr, che dispone di riserve stimate tra i quattro e i sei miliardi di barili e che vede la presenza di una joint venture formata da Eni, Occidental Petroleum e Korea Gas. Sempre nel sud del Paese, quasi ai confini con l’Iran, è situato il più consistente giacimento iracheno, quello di Majnoon. A ottenere i diritti sui 12,58 miliardi di barili stimati sono state Shell e Petronas. Il secondo poz- zo potenzialmente più produttivo del Paese, West Qurna 2 (12 miliardi di barili), è stato appaltato a un consorzio guidato dalla russa Lukoil. A scendere, i giacimenti meno importanti e le compagnie meno competitive. In pratica, per le Big oil americane il bottino è stato, sorprendentemente, quasi nullo. Questo è stato sufficiente perche i corvi della passata amministrazione Bush si alzassero in volo per riprendere il vecchio ritornello secondo il quale gli Usa non avrebbero scatenato due guerre, in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 2003, spinti dalla volontà di mettere le mani sul petrolio iracheno e allo scopo di creare una serie di pipeline che dal Caspio arrivassero in Pakistan, nell’Oceano Indiano. Il loro rinato sinistro canto suonerebbe così: chi ha pensato che la più grande democrazia del mondo avesse scatenato due conflitti per le risorse energetiche è servito. Il governo iracheno ha indetto l’asta per lo sfruttamento dei suoi giacimenti di petrolio in perfetta autonomia, senza pressioni di sorta da parte degli Usa, tant’è che lo svolgimento dell’asta stessa ha finito per favorire tutte le compagnie meno quelle americane. Con tutti i soldi che hanno speso, continua il nero ritornello corvino, gli Usa avrebbero comprato tutto il petrolio di questo mondo, senza impegnarsi personalmente in nessun conflitto. Non avrebbero avuto morti tra i loro soldati, e avrebbero più tranquillamente ottenuto i loro scopi senza spese e senza traumi sociali di sorta. E invece, le cose non stanno in questi termini: ripercorriamo le perverse traiettorie dell’imperialismo americano sulla via di Baghdad. I preparativi alla guerra Ancora nel 2002, l’Oil and Gas International, un’informata rivista del settore, riportava che il dipartimento di Stato e il Pentagono, in previsione della guerra contro l’Iraq, altro non avevano in testa che allestire gruppi di pianifica- zione che proteggessero dai bombardamenti le più importanti infrastrutture petrolifere irachene. Nello stesso anno, nel mese di novembre, il dipartimento della Difesa ha fatto pressione presso l’Army Corps of Engineers per l’aggiudicazione di un appalto all’impresa americana Brown & Root addetta allo spegnimento degli incendi nei pozzi petroliferi, alla loro messa in opera dopo aver subito eventuali danni, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l’apparato estrattivo e commerciale messo in difficoltà dalle prevedibili conseguenze dell’imminente evento bellico. Secondo il Wall Street Journal del 16 gennaio 2003, poco tempo dopo che il presidente Bush aveva dichiarato l’inevitabilità dell’invasione dell’Iraq, il vice presidente Cheney aveva contattato i dirigenti delle maggiori compagnie petrolifere americane per predisporre un piano di ‘rinascita’ dell’industria petrolifera irachena, rinascita che sarebbe stata finanziata, organizzata e controllata dalle major made in Usa. Lo stesso WSJ precisa che l’amministrazione Bush, sempre nell’imminenza della guerra, e sempre per il diretto interessamento di Cheney, aveva organizzato una riunione informativa con Exxon Mobil, Chevron Texaco, Conoco Philip e Halliburton per 39 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InCHIEsTA predisporre il piano del futuro sfruttamento del petrolio iracheno. Il tutto sotto il patrocinio della Casa Bianca, del Pentagono e del dipartimento di Stato. Peraltro tutta l’amministrazione Bush, dallo stesso presidente a Cheney a Condoleeza Rice, era rappresentativa delle lobby petrolifere di cui facevano parte ancora come azionisti e/o consulenti (Cheney all’Halliburton e la Rice alla Chevron). Si è data più cura e attenzione ai particolari della pianificazione dello sfruttamento futuro dei giacimenti petroliferi, nonché alla confezione delle menzogne che dovevano tacitare l’opinione pubblica interna e internazionale sull’imminente atto predatorio, che sull’esecuzione militare dello stesso, nonostante la profusione di mezzi, uomini e finanziamenti. Sempre nel 2003, subito dopo la caduta del governo baatista di Saddam Hussein, il New York Times metteva in evidenza come sotto il comando del ‘proconsole’ Bremer e del governo Allawi, già si stessero avviando le prime operazioni legislative per la futura privatizzazione dei giacimenti petroliferi iracheni. Privatizzazione che avrebbe visto la prevalenza delle compagnie americane e inglesi, senza nessuna forma di messa all’asta dei pozzi già esistenti e di quelli da trivellare. Perché il piano potesse prendere corpo, senza troppi problemi da parte dell’opposizione interna e di quella internazionale, l’amministrazione Bush non ha lesinato risorse finanziarie, sotto forma di corruzione, da somministrare ai ministri di turno, ai dirigenti del ministero del Petrolio, a tutti coloro che direttamente o indirettamente potevano essere inseriti nel piano di spoliazione energetica. L’operazione è stata così evidente e arrogante che alcuni investigatori federali sono stati costretti ad aprire un’inchiesta contro un congruo numero di alti ufficiali ed emissari politici del governo coinvolti nel ‘Programma di ricostruzione in Iraq’. Che poi all’inchiesta sia stato prescritto un periodo molto lungo di (in)sabbiature terapeutiche, rientra nella logica delle cose. Ma le rivelazioni del N.Y. Times e di altri organi di stampa rimangono, così come i resoconti dattiloscritti dei colloqui tra alti funzionari dell’amministrazione e rappresentanti governativi di Allawi. In aggiunta va segnalata la dichiarazione di Chalabi, ai tempi consulente dell’amministrazione Bush prima dell’invasione, poi sottosegretario iracheno al petrolio, rilasciata all’emittente radiofonica To the point, nella quale non fa mistero che la guerra a Saddam altro non era che “una mossa strategica da parte degli Stati Uniti d’America e del Regno Uni40 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane to in vista di una presenza militare nel Golfo, al fine di assicurarsi in futuro le forniture petrolifere”. Per poi concludere che ancor prima dell’invasione aveva incontrato gli esponenti delle major americane perché quello del petrolio era “un obiettivo primario”. I maneggi prima dell’asta Mettendo per il momento da parte l’andamento disastroso della guerra e le implicazioni imperialistiche internazionali (il ruolo dell’Iran, della Siria e della Russia) sul fronte dell’opposizione sunnita e, in parte, sciita – che peraltro hanno complicato non poco la vita ai vari governi fantoccio iracheni – l’amministrazione Bush, un paio d’anni prima della sua scadenza, ha tentato ripetutamente di passare dalla cassa per il ‘rimborso spese’. I termini della questione inizialmente (sino al 2007) erano due: il primo riguardava l’accesso alla trivellazione di nuovi campi, mentre quelli già in attività sarebbero rimasti sotto l’amministrazione irachena in deroga alla vecchia legge sulla nazionalizzazione (1972); il secondo si avvitava sulla necessità di una legge petrolifera che sancisse, una volta per tutte, i diritti di estrazione e le quote di gestione tra la vecchia Iraq National Oil Company e le imprese anglo-americane. Per gli strateghi Usa la nuova legge avrebbe dovuto mettere in atto un rapporto secondo il quale il 75% dei campi petroliferi già esistenti sarebbe andato alle compagnie straniere e solo il 25% a quella irachena, mentre per i campi che dovevano essere messi in opera, data la necessità di investimenti e di impiego di alta tecnologia, la prelazione sarebbe toccata sempre alle compagnie internazionali. In aggiunta, gli strateghi prevedevano che l’assegnazione dei campi avesse una lunga durata, venti/venticinque anni, e non avvenisse attraverso un’asta internazionale (no bid), ma su chiamata da parte del governo iracheno attraverso il ministero del Petrolio. Nel febbraio del 2007 il presidente Bush premeva insistentemente perché la legge passasse a favore delle solite Exxon Mobil, Chevron, BP & C. In effetti, anche se la legge tanto auspicata non era stata ancora votata per la forte opposizione interna, il nuovo governo iracheno di Al Maliki e del suo ministro del Petrolio Shahristani, nell’estate 2008 prometteva la firma dei contratti su una serie di importanti giacimenti a Exxon, Chevron, Shell, BP e alla francese Total, che rivendicava l’esecuzione di vecchi accordi firmati all’epoca di Saddam Hussein. Dalle intese erano completamente escluse le compagnie russe e cinesi, come da programma. Per gli Usa il gioco sembrava fatto. Le prime aree petrolifere erano state assegnate secondo i desideri di Washington, e si sperava che al più presto la legge petrolifera avrebbe conquistato il voto positivo del Parlamento; la guerra in Iraq sembrava dare i suoi frutti. L’imperialismo sa fare molto bene le pentole, ma non sempre gli riescono i coperchi. Infatti, la legge così confezionata non passa, nonostante l’iniziale accondiscendenza del governo Al Maliki, la presenza di 140mila uomini americani e di un mini-esercito di tecnici petroliferi inviati da Bush. Le ragioni della bocciatura sono tante e tutte attinenti alla voracità con la quale le varie componenti nazionali e internazionali si sono gettate sui meccanismi di gestione della rendita petrolifera. Innanzitutto, il progetto di concedere il petrolio iracheno a quelle compagnie, le solite (Exxon, Chevron, Shell, BP e Total), quelle che prima della nazionalizzazione rappresentavano la presenza imperialistica in Iraq, aveva sollevato furibonde proteste non soltanto nei partiti dell’opposizione sunnita e dello sciita Moqtada al Sadr, ma persino da parte di un partito sciita di governo. Shatha al Musawi, rappresentante della United Iraqi Alliance, con l’appoggio di una parte consistente del Parlamento ha brandito la bandiera del nazionalismo energetico, denunciando la svendita del petrolio iracheno alle multinazionali estere, dopo che i vari governi che si erano succeduti dalla caduta di Saddam avevano investito nel settore oltre 8 miliardi di dollari; l’obiettivo nazionale, secondo al Musawi, doveva essere quello di portare l’Iraq fuori dalla spaventosa crisi economica e politica in cui la guerra lo aveva gettato, a quindi a produrre nel giro di sei/otto anni quei 10 milioni di barili al giorno che lo avrebbero collocato al terzo posto nella graduatoria internazionale relativa alla produzione e all’esportazione di petrolio. Obiettivi ambiziosi, che sarebbero morti sul nascere se si fossero dati in concessione alle compagnie straniere i maggiori pozzi petroliferi nazionali. Un altro ostacolo era rappresentato dall’altro nazionalismo energetico, quello curdo. Contravvenendo alla norma generale, quanto generica, che il petrolio iracheno competeva al ‘popolo iracheno’, e che la sua estrazione/commercializzazione sarebbe dovuta essere concordata centralmente, il Kurdistan iracheno aveva già ini41 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InCHIEsTA ziato in proprio una politica di concessioni, oltretutto anche su pozzi contestati dalle due amministrazioni nazionali, come quelli della zona di Arbil, Dahouk, Sulaimaniya e della parte meridionale di Kirkuk ai confini del Kurdistan. La frizione è stata cosi forte, che il governo di Al Maliki Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane Petrolio Shahristani di politiche capitolarde e fallimentari. Lo scontro tra Baghdad e Kirkuk ha sfiorato la secessione da parte del governo curdo, lasciando gli Stati Uniti attoniti e impotenti, nonostante fossero stati proprio loro a inventare una simile situazione nella speranza di avere più opzio- tro la svendita del petrolio iracheno. Nella zona di Bàssora gli scioperi, accompagnati da alcuni attentati agli oleodotti che dal nord arrivano al terminale dell’isola di Faro, alla foce dello Shatt el Arab nel Golfo Persico, hanno letteralmente creato il panico nei palazzi di Baghdad e, ancora una volta, Al Maliki ha usato il pugno di ferro, minacciando feroci repressioni che in parte si sono pesantemente espresse e mettendo i sindacati fuori legge – benché agissero sul terreno nazionalistico ma, in quel momento, dalla parte sbagliata, ossia in opposizione al governo. Ad affossare ulteriormente il progetto di legge petrolifera ad usum delle Usa company, ci si è messa anche l’opposizione democratica nel Parlamento americano. I deputati e senatori, più per una mal calcolata questione elettorale di contrapposizione al governo repubblicano che per una impostazione critica nei confronti della guerra, hanno impugnato la ‘questione morale’ (daremmo ragione ai detrattori della politica estera americana se così palesemente allungassimo le mani sui giacimenti iracheni, meglio sarebbe agire per il medesimo obiettivo ma in maniera meno rude ed evidente), votando No al progetto della legge petrolifera nei termini voluti dal governo Bush. _ COMPOSIZIONE_4 Romeo Traversa, 2008, elaborazione digitale, colore, 200x200 cm ha ritenuto necessario mettere al bando tutte quelle compagnie che avevano fatto contratti con l’amministrazione autonoma curda. Come risposta, il curdo Ali Hussain Balu, presidente della Commissione parlamentare sul petrolio e gas, ha pesantemente criticato il governo e il ministro del 42 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV ni allo sfruttamento dei giacimenti del nord, oltre a quelli del sud nella zona di Bàssora. A coronamento dell’affossamento della legge ci si sono messi anche i sindacati, che hanno mobilitato i lavoratori delle imprese petrolifere a sostegno degli interessi nazionalistici con- Nel computo complessivo dell’operazione bellica in terra di Mesopotamia rientrava anche il ruolo del dollaro come coefficiente di scambio tra le merci, in modo particolare quello relativo agli scambi petroliferi. Se il piano Bush fosse andato a compimento, l’economia americana non solo si sarebbe giovata di un’importante fonte di reperimento della materia prima da un punto di vista energetico, non solo avrebbe diversificato le sue fonti d’approvvigionamento per i prossimi vent’anni, ma avrebbe contemporaneamente ridato fiato all’asfittico ruolo del dollaro in caduta libera dopo l’ingresso dell’euro sul mercato monetario internazionale. Sino alla fine degli anni Novanta, infatti, il 92% degli scambi commerciali, petrolio compreso, erano effettuati in dollari; a metà degli anni duemila si era scesi al 40%. La speculazione internazionale comincia ad abbandonare il dollaro quale bene rifugio per orientarsi sempre di più verso l’euro. Tra il 2006 e il 2008 alcuni fra i maggiori produttori di petrolio e di gas, primi tra tutti la Russia, l’Iran e il Venezuela, hanno iniziato a vendere anche in euro, yen e rubli. Nello stesso periodo i Paesi del Golfo hanno messo in cantiere il progetto Gulf, un paniere di divise legate alla produzione del greggio che in prospettiva, non tanto lontana nel tempo, potrebbe sostituire in parte o in toto il dollaro. La nuova legge e la debacle delle compagnie americane La nuova legge, peraltro parziale e controversa, frutto di una frettolosa necessità, ispirata al reperimento dei finanziamenti e delle tecnologie funzionali al progetto di fare dell’Iraq, in pochi anni, il secondo o terzo produttore di petrolio al mondo, ribalta i termini della precedente impostazione voluta dal governo americano – praticata in parte nella fase iniziale e poi resa inagibile dagli ostacoli che abbiamo visto. Il suo contenuto prevede l’indizione di aste, la cancellazione dei production sharing agreement e contratti di solo servizio con le compagnie estere. Le licenze sottoscritte sia a giugno, poche, che nei giorni di dicembre, sono infatti particolarmente vantaggiose per Baghdad: pur avendo durata ventennale, non prevedono una condivisione del profitto con le società petrolifere, bensì solo la corresponsione di una tariffa fissa da parte del governo iracheno alla compagnia estrattrice, da elargire per ogni barile portato in superficie oltre il livello attualmente in corso; tariffe che sono risultate inaspettatamente basse, variando da un minino di un 1,30 dollari sino a un massimo di 2 dollari a barile/giorno estratto. Nonostante la ristrettezza dei margini del futuro guadagno, che comporta peraltro consistenti investimenti finalizzati all’aumento delle capacità estrattive degli impianti già in produzione (current field) e di quelli da attivare, la partecipazione delle company 43 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InCHIEsTA internazionali è stata, come abbiamo visto, elevata, ben quarantacinque, a rappresentanza dei maggiori Paesi a vocazione energetica. Nella prima giornata l’asta ha visto la vittoria della Royal Dutch Shell e della Petronas, che si sono aggiudicate il giacimento di Majnoon nella parte del sud-est dell’Iraq. Il giacimento, ancora vergine, prevede una riserva di 12,6 miliardi di barili ed è considerato uno dei più importanti tra quelli messi all’incanto. Il consorzio anglo-olandesemalese ha firmato un contratto in base al quale riceverà una commissione di gestione dal governo iracheno di 1,39 dollari a barile estratto, impegnandosi a portare, in breve tempo, la produzione a 1,8 milioni di barili al giorno, duplicando le più ottimistiche aspettative degli stessi tecnici iracheni. Sempre nella zona sud del Paese, che viene ritenuta quella a minor rischio di attentati e di sabotaggi, il secondo giacimento assegnato è quello di Halfaya, stimato per 4,1 milioni di barili al giorno. A vincere la gara d’appalto è stato un consorzio formato dalla cinese CNPC, che vi partecipa al 50%, e da Total e Petronas, entrambe al 25%. Il contratto si è concluso con una commissione di 1,40 dollari a barile per una produzione futura di 535mila barili/ giorno da ottenere entro sei anni. Nella seconda giornata, quella del 12 dicembre 2009, il grande giacimento di West Qurna 2 è stato assegnato alla russa Lukoil e alla norvegese Statoil, con quote dell’85% per la prima e del 15% per la seconda. Il giacimento può contare su riserve pari a 12,9 milioni di barili. Il consorzio delle due compagnie si è impegnato ad aumentare la produzione di 1,8 milioni di barili al giorno, facen44 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane do di West Qurna 2 uno dei più importanti currente field di tutto l’Iraq. A scalare, i giacimenti meno importanti sono andati alla malese Petronas, che si è aggiudicata il campo di Gharaf, mentre all’angolana Sonangol sono andati i siti di Najmah e Qaiyarah e quello di Badra alla russa Gazprom. Le imprese americane sono praticamente rimaste a bocca asciutta. Benché iscritte al pari delle altre quaranta compagnie internazionali, se si fa eccezione per la Occidental, che, all’interno di un consorzio con la Sonangol, la cinese CNPC e la sud coreana Kogas, ha subìto una sconfitta per i giacimenti di Halfaya vinti dalla cinese CNPC con Total e Petronas, per le restanti Exxon, Chevron e &, il risultato è stato quasi nullo. Quasi nullo nonostante il governo iracheno avesse promesso alle company americane che in caso di parità d’offerta, l’asta sarebbe stata loro. Una specie di contentino dopo il cambiamento di rotta di Shahristani e Al Maliki. Le prime giustificazioni addotte a una simile debacle patita dalle compagnie Usa, secondo i soliti frettolosi analisti, risiederebbero nel fatto che per le Big oil, fallito il tentativo di avere in gestione i migliori pozzi attraverso assegnazioni che non passassero dalla competizione dell’asta, il rischio di trovarsi spiazzate sul terreno della sicurezza e dell’ulteriore esborso finanziario per mantenere e gestire i pozzi, le avrebbe messe in una situazione di minore competitività. Le ragioni del disastro Certamente la disaffezione, se non l’odio, nei confronti della presenza delle truppe americane nel Paese non ha giovato alle attese delle company Usa, per il concreto rischio di sabotaggi che avrebbe alzato i prezzi di gestione dei pozzi; ma altre sono le ragioni che hanno determinato la loro sonora sconfitta. Principalmente, come abbiamo visto, vi è stata la questione di politica interna irachena: la scadenza elettorale del 7 marzo 2010 si è giocata prevalentemente, se non esclusivamente, sul terreno del nazionalismo politico, sia in termini di generica propaganda, sia in termini di nazionalismo energetico. La rendita petrolifera è stata presentata come la questione nazionale fondamentale. Il che non ha potuto che enfatizzare gli accenti nazionalistici anti-americani, in termini velati (Al Maliki), moderati (Allawi) o di aperto scontro (sunniti e al Sadr), ben sapendo tutti che il dichiarato ritiro delle truppe americane sarebbe avvenuto solo nelle grandi città; gli Usa tenteranno infatti di rimanere a tempo indeterminato nel Paese, con basi militari, per tenere sotto controllo Damasco e Tehran, per difendere l’alleato di sempre Israele, per essere vicini al sempre più ingovernabile Afghanistan e, non ultimo, per rilanciare quella politica petrolifera in centro Asia che sino a oggi ha fatto acqua da tutte le parti, come le campagne militari che ne dovevano rappresentare la base d’appoggio. Un altro aspetto va messo in evidenza nella debacle delle oil company statunitensi: la devastante crisi che, ancora una volta, è partita dalle declinante economia americana, ha messo in seria difficoltà le imprese petrolifere. La vecchia Unocal, una delle five oil company, non è arrivata nemmeno all’asta. L’impresa di John Maresca, che tanto si era data da fare presso le Commissioni governative per ave- re l’appoggio di Bush al fine di gestire monopolisticamente la costruzione della pipeline che dal Caspio, via Afghanistan, avrebbe dovuto trasportare il petrolio kazaco sin sulle sponde dell’Oceano Indiano, in Pakistan, è affogata nei debiti fino al fallimento; e questo dopo aver investito non poco (400 milioni di dollari) in favore dell’ascesa dei talebani a Kabul, nella vana speranza di controllare il territorio. Complici, oltre alla fallita e dispendiosa avventura afghana, le nefaste vicende nel Myanmar: citata in giudizio per connivenza con il regime al potere, che avrebbe garantito la costruzione e la protezione militare di un gasdotto nella regione di Yadana, al confine con la Thailandia, a colpi di lavori forzati, torture e omicidi, la Unocal ci ha rimesso, oltre alla faccia, una montagna di milioni di dollari in spese per gli avvocati. E così nell’aprile del 2005, dopo una lunga agonia e un debito di 11 miliardi di dollari, la Unocal è stata comprata per 18 miliardi di dollari dalla Chevron Texaco, sfuggendo di poco al tentativo d’acquisizione da parte di una compagnia petrolifera cinese. La stessa Chevron Texaco che nel 2005, all’epoca dell’acquisizione della Unocal, aveva un utile netto di 13,3 miliardi di dollari, nell’ottobre del 2009, alle soglie dell’apertura dell’asta a Baghdad, perde un colossale 51% del suo profitto, arrivato a soli 3,33 miliardi di dollari. Il 29 settembre dello stesso anno, il tribunale ecuadoriano cita la Chevron per danni ambientali chiedendo un rimborso di 27 miliardi di dollari, mettendo la compagnia petrolifera alle corde come nel caso precedente della Unocal. La Conoco Phillips nel 2008 regi45 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InCHIEsTA stra un debito di 30 miliardi di dollari per incaute acquisizioni, con una capitalizzazione di soli 74 miliardi. In borsa le sue azioni precipitano da un valore di 100 dollari a 77,439 nello spazio di poche settimane. Nemmeno la più potente delle compagnie americane ha saputo resistere negli anni terribili della crisi. La Exxon Mobil, che, non a caso, solo fuori dal gioco delle aste è riuscita ad accaparrarsi il giacimento di West Qurna 1, ha visto i suoi conti in rosso. Al 30 ottobre 2009 il suo utile netto ha subito una flessione del 68%, arrivando a un misero 4,37 miliardi di dollari; mentre il fatturato è passato da 137,74 miliardi a 82,26. Il dato rilevante di questa debacle sta nel fatto che le compagnie petrolifere americane hanno prevalentemente operato sul terreno della speculazione, hanno riacquistato le loro azioni nel tentativo di mantenerne alto il prezzo, hanno elargito, finché è stato possibile, lauti compensi ai manager e distribuito dividendi agli azionisti. Mediamente, il 55% degli utili sono andati in acquisizioni e non in investimenti, all’acquisto di azioni delle varie finanziarie e fondi. In molti casi, le stesse compagnie hanno speculativamente operato attraverso le proprie finanziarie, con il risultato di ritrovarsi al centro dello scoppio della bolla coperte di debiti, con i pacchetti azionari dimezzati, con le proprie finanziarie sul lastrico, senza liquidità e con una diminuzione della redditività dei capitali investiti che, sempre mediamente, si è aggirata attorno al 26%. Le compagnie americane sono rimaste vittime di quella crisi finanziaria che loro stesse hanno contribuito a creare sino all’atto della deflagrazione finale. 46 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane Crisi e ricomposizione imperialistica mondiale La crisi mondiale del capitalismo sta ridisegnando lo scacchiere imperialistico, in cui la questione energetica continua ad avere un ruolo preminente. Per gli Usa, fallita anche in Iraq l’operazione ‘bonifica’, la battaglia del petrolio in centro Asia sembra essere quasi definitivamente perduta. Da qui la riconferma della decisione del ritiro dall’Iraq, salvo il mantenimento di un contingente di 40.000 uomini a controllo del territorio. Sempre originata dalla sonante sconfitta si fa strada l’idea, già espressa da Bush, di trivellare i ghiacciai dell’Alaska e le coste atlantiche in cerca di petrolio, accanto al ripescaggio del nucleare, alla faccia della tanto evocata green economy sbandierata in campagna elettorale da Obama. L’unica ‘vittoria’ nella guerra dei tubi gli Usa l’anno parzialmente ottenuta con la costruzione della pipeline che da Baku (Azerbaijan) arriva a Ceyhan (Turchia) passando per Tbilisi in Georgia. Il BTC, costruito con 4 miliardi di dollari, lungo 1.770 chilometri, e il cui percorso è stato studiato in modo da non attraversare né il territorio russo né quello iraniano, ha visto in fase di progettazione e di realizzazione la presenza di un consorzio nel quale l’azionariato di maggioranza è nelle mani della BP (30%), della Socar, impresa statale azera (25%), della Unocal (9%) prima del suo fallimento, e dell’Eni (5%), più compagnie francesi e olandesi con quote minoritarie. Nelle intenzioni, il progetto, finanziato in parte dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale e fortemente voluto dagli Usa, doveva convogliare verso il porto turco non soltanto il petrolio azero ma anche quello del Kazakistan e del Turkmenistan, facendo di questa pipeline l’oleodotto più importante tra i giacimenti dell’Asia centrale e il Mediterraneo, per poi proseguire, via sottomarina, sino al porto israeliano di Ashdod. Ma i governi azero e kazako, che in una fase iniziale avevano aderito al progetto, si sono parzialmente tira- na non è stata ancora costruita. Per l’imperialismo americano il successo è stato molto, molto parziale, anche perché chi gestisce il BTC è la British Petroleum, mentre la Unocal è stata costretta, suo malgrado, a togliere il disturbo. La parte più consistente delle esportazioni kazake va verso nord, in direzione della Russia, usufruendo dei vecchi oleodotti di epoca sovietica ti indietro, concedendo all’oleodotto, inaugurato nel luglio del 2006, solo poche centinaia di migliaia di barili al giorno e preferendo accordi di esportazione di petrolio e gas con gli altri due imperialismi, quello russo e quello cinese. In più, la ‘bretella’ israelia- per arrivare al porto di Novorossijsk sul Mar Nero. Tre mesi prima (maggio 2006), è stato inaugurato un oleodotto tra il Kazakistan e la Cina. Parte dalla località di Atirav per arrivare ad Alashankou, dando un nuovo assetto alle linee di _ COMPOSIZIONE_5 Romeo Traversa, 2008, elaborazione digitale, colore, 200x200 cm 47 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InCHIEsTA percorrenza verso l’est della più importante materia prima energetica. Il 14 dicembre 2009, pochi giorni dopo l’indizione dell’asta di Baghdad, è stato inaugurato il gasdotto Turkmenistan-Cina, struttura cruciale nella geopolitica del gas del Mar Caspio e degli assetti energetici sul continente asiatico. Il presidente cinese Hu Jintao e il collega turkmeno Berdymukhamedov, assieme al capo di Stato kazako Nazarbaev e al presidente uzbeko Karimov, hanno aperto i rubinetti del nuovo gasdotto, lungo 1.883 chilometri, che parte dal nord turkmeno e attraversa Uzbekistan e Kazakistan per arrivare nel Xinjiang. Dovrebbe trasportare in Cina, ogni anno, 30 miliardi di metri cubi di gas, mentre altri 10 miliardi saranno ‘trattenuti’ dal Kazakistan. Insomma, un importantissimo tassello nella distribuzione energetica in Asia, sia perché è la prima tratta che aggira il territorio russo sia, soprattutto, perché elimina le pretese americane nell’area. Il 13 dicembre ad Ashgabad, capitale del Turkmenistan, il capo di Stato cinese ha incontrato il presidente del Turkmenistan; le due parti hanno raggiunto importanti consensi per promuovere ulteriormente lo sviluppo delle relazioni di cooperazione e d’amicizia tra Cina e Turkmenistan. In quella occasione, come riporta una nota d’agenzia, “Hu Jintao ha espresso il suo apprezzamento per le relazioni CinaTurkmenistan e proposto quattro suggerimenti per il rafforzamento di una concreta cooperazione. Primo, attivare al più presto il meccanismo per la cooperazione Cina-Turkmenistan; secondo, approfondire la cooperazione sulle risorse energetiche; terzo, rafforzare la cooperazione per quanto riguarda le 48 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane risorse non energetiche; quarto, effettuare al meglio i programmi di credito raggiunti dalle due parti, promuovendone al più presto l’esecutivo”. Allo stesso tempo, Hu Jintao ha affermato che la parte cinese intende rafforzare gli scambi con il Turkmenistan, cooperando anche alla lotta ai criminali che oltrepassano i confini, mantenendo efficacemente la sicurezza e la stabilità delle regioni. Berdimuhamedov si è dichiarato totalmente d’accordo con le proposte fatte da Hu Jintao sullo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, e ha ricordato che i rapporti CinaTurkmenistan si basano su una grande fiducia, rispetto reciproco e amicizia: costituiscono una partnership di cooperazione a lungo termine, ha affermato. Ne consegue che lo scontro imperialistico nell’area vede una netta supremazia di Cina e Russia a scapito degli Usa i quali, non a caso, sono messi a mal partito anche in Kirghizistan, dove i recenti avvenimenti interni, quantomeno appoggiati da Mosca, stanno mettendo in forse la permanenza della base militare americana di Manas, ultimo avamposto in Asia centrale. A completamento dell’opera di smantellamento della presenza americana, c’è l’ennesima sconfitta sul terreno dello sfruttamento dei giacimenti della zona caspica. I due progetti concorrenti, il South Stream progettato dalla Russia e il Nabucco fortemente voluto dagli Usa, in consorzio con alcuni Paesi europei, hanno come base la necessità di assicurarsi sia le fonti di approvvigionamento del gas, sia il controllo delle vie di percorrenza verso il bacino del Mediterraneo. La sfida, dunque, consiste nel garantirsi i rifornimenti da parte di Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan. I tre Paesi in questione, a maggio del 2009 a Praga, si sono rifiutati di firmare l’accordo sul progetto Ue-Usa per il Nabucco e altri due gasdotti, tra cui il White Stream, che dovrebbe andare dalla Georgia alla Romania con un percorso sotto marino nel Mar Nero e una ‘bretella’ che attraverserebbe Turchia, Grecia e Italia (ITGI) tra la parte ionica della Grecia e quella italiana. Dietro il rifiuto ci sono le pressioni russe e gli accordi bilaterali tra il governo di Mosca e quelli dei Paesi centro asiatici interessati. Prova ne è che Mosca, subito dopo il summit energetico di Praga, ha organizzato una riunione a Soci per rafforzare il progetto South Stream con Grecia, Serbia, Bulgaria e Italia, dopo essersi assicurata del rifiuto dei tre Paesi centro asiatici. La Gazprom ha inoltre dichiarato di essere disposta ad acquistare l’intera produzione di gas dell’Azerbaijan e del Turkmenistan per complessivi 18 miliardi di metri cubi l’anno, con l’evidente obiettivo di assicurasi una posizione monopolistica in campo gassifero contro le ambizioni, uguali e contrarie, degli Usa; anche se, come tutti i progetti, deve fare i conti con la disponibilità di adeguati investimenti, le appropriate tecnologie e, non da ultimo, la duratura affidabilità dei partner. A mo’ di ciliegina sulle frananti ambizioni americane, il 6 gennaio di quest’anno, l’Iran e il Turkmenistan hanno inaugurato un ennesimo gasdotto nella zona, via Dovletabat-SaralihsKhangiran, contravvenendo a tutte le pressioni di Washington sul governo di Tehran. Nelle tre settimane successive il governo turkmeno ha deciso di vendere la totalità delle sue esportazioni di gas all’Iran, alla Cina e alla Russia. Quest’ultima ha inoltre l’intenzione di raddoppiare le importazioni di gas dall’Azerbaijan per contenere i rifornimenti di Baku al progetto Nabucco. Inoltre, l’Azerbaijan ha stabilito un altro accordo con l’Iran per un gasdotto (Kazi-Magomed-Astara) lungo ben 1.400 chilometri. Gli Stati Uniti hanno subìto prima e perso poi l’asta di Baghdad perché il loro peso imperialistico, in termini di impegno militare e di disponibilità finanziarie, è diventato più leggero rispetto a quello della concorrenza. L’amministrazione Bush ci ha provato con tutti i mezzi, ha però perso su molti fronti nonostante l’impegno economico e militare; l’amministrazione Obama, complice anche la crisi, sta cercando di limitare i danni nell’epicentro asiatico, concentrandosi su obiettivi geopoliticamente ‘periferici’ – ancora Afghanistan, Pakistan e India – per non uscire completamente dal gioco. Come si può notare, la guerra dell’energia è in pieno sviluppo. Gli attori non si risparmiano colpi, con le buone o con le cattive (come l’intervento armato russo in Ossezia del sud contro la Georgia filo americana e le tensioni in Kirghizistan anti-americane), oltre alle pluriennali guerre in Iraq e Afghanistan. Gli Usa potranno anche ritirarsi dall’Iraq e dall’Afghanistan, ma solo perché sconfitti dagli altri imperialismi che, pur non fisicamente presenti, hanno fatto sentire il loro peso all’interno della questione irachena. 49 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Racconti – Il cassonetto Fabiana Bussola – La tessera per la raccolta punti era quasi ultimata. Un paio di pacchetti di biscotti e avrebbe potuto spedire la busta. L’attesa per il nuovo tegame stava per trovare soddisfazione e un futuro di omelette perfette si stagliava nella sua fantasia. La signora Fernanda finì di bere il secondo caffé del mattino mentre fuori un cielo incolore si distendeva sulla città risvegliata, raccolse la zuccheriera e la latta dei frollini per riporle nella credenza, cambiò l’acqua nella ciotola del gatto e si diresse alla porta d’ingresso. Imbozzolata in un grigio accappatoio che pareva un sarcofago, aprì di poco l’uscio e lanciò uno sguardo verso lo zerbino. Quello che vide le suscitò un fastidio imprevisto: il sacchetto della spazzatura se ne stava ancora lì, sotto gli occhi di chiunque del vicinato fosse passato davanti al suo appartamento. “Eh no, non si fa così. Devo dire due paroline a quel Goran, che se continuiamo così mica siamo d’accordo!” Raccolse tutta la sua stizza, accostò l’uscio per non far uscire Nerone e si diresse alla porta di fronte. Bussò ritmicamente tre volte, un modo distintivo per farsi riconoscere dall’inquilino, dato che il campanello era fuori uso da un decennio. Non provenne però nessun rumore dall’interno del monolocale, così Fernanda rientrò ancora più irritata di prima, scavalcando la sporta con i rifiuti. “Se pensa di farmi fessa quello lì, non sa con chi ha a che fare”. Il pensiero fisso dell’anziana divenne il sottofondo di tutte le sue poche mansioni: cuci- 50 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV nare, telefonare all’ambulatorio per prenotare la visita oculistica, rassettare le tre stanze, pulire la lettiera del micio, cambiare canale, ogni cosa quel giorno ruotava nella mente intorno a un chiodo fisso. Dopo l’ultimo telegiornale della notte andò a coricarsi, ma fu inamovibile con il suo senso del decoro e decise che la spazzatura sarebbe rimasta sullo zerbino, che quello slavo doveva imparare come si rispettano gli accordi e non si sognasse di prenderla in giro. Quella notte non riuscì a dormire a lungo: se ne restò in allerta per decifrare i rumori che provenivano dall’androne, tre piani sotto. Sapeva riconoscere i condomini dal tintinnare delle chiavi o dallo sbattere della porta, di ciascuno conosceva abitudini e tacchi delle scarpe. Anche di Goran aveva imparato a distinguere i segnali, tanto da capire persino da quale lavoro stesse rientrando. Quando lo sentiva trascinare gli scarponi sapeva che stava tornando dal cantiere, mentre all’impiego di imbianchino associava lo stridio delle scarpe da ginnastica logore sul pavimento. Dall’alloggio di fronte non giunse però nessun suono per tutta la nottata. La vecchia si sollevò all’alba dal letto con una specie di oppressione al petto, si infilò il molle scafandro e quasi corse alla porta per vedere se il pattume fosse stato portato nel cassonetto. Girò le quattro mandate, aprì uno spiraglio e gettò uno sguardo avido ai suoi piedi. L’immondizia troneggiava come il giorno prima, anzi, a Fernanda sembrò che una mano precisa l’avesse ricollocata al centro del tappeto con la chiara intenzione di indispettirla. In pochi istanti la donna si proiettò alla porta di fronte e cominciò a tamburellare le nocche ossute con la chiara intenzione di far scendere dal letto quell’affittuario indisponente. “Prima ti fanno mille storie perché non possono pagare, non hanno i documenti, ti raccontano le loro storie pietose. Tu gli fai un favore e gli fai pagare un prezzo basso in cambio di qualche lavoretto, ed ecco che dopo poco se ne approfittano. Pensano che sia una vecchia scema, ma si sbagliano”. Nonostante questi pensieri e la foga con cui percuoteva la porta, Fernanda si trovò da sola per dieci minuti in quel corridoio buio, senza ricevere alcun segnale dal tugurio. Tornò in casa, ma quella giornata trascorse in perenne tensione. Solo il mattino seguente alla radio sentì del ritrovamento in una discarica del corpo di un giovane, Goran Krstic, clandestino di nazionalità kosovara, la cui morte sarebbe stata causata da un litigio in un cantiere. La donna intinse l’ultimo biscotto nel caffè, sparecchiò la tavola e andò a vestirsi. Raccolse i capelli con le forcine, spazzolò la gonna beige e l’impermeabile, si sistemò il cappello di feltro e uscì. Scese lentamente le scale per non lasciare che l’odore acre dell’immondizia impregnasse l’interno del piccolo ascensore e finalmente fu fuori. La città di sempre, con il suo respiro umido e metallico le permeò narici e rughe mentre in pochi gestì gettava il sacchetto di rifiuti nel cassonetto. Stava per dirigersi verso il discount dell’isolato vicino, quando si accorse di una giovane africana, che stazionava davanti all’ingresso del palazzo con un biglietto in mano. «Scusa, qui fita partamento?» le chiese in un italiano stentato. Il suo sguardo mite e le spalle forti offuscarono la diffidenza della vecchia, che aggiustandosi il soprabito si avvicinò alla ragazza. «Aiutami a fare la spesa. Poi vieni su da me, vedrai che ci mettiamo d’accordo». 51 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Racconti – La telefonata d Luca Gallo – Q uel giorno Luciano tornò presto dall’università. Stranamente erano pochi gli studenti rimasti per la lezione pomeridiana e così aveva deciso, in accordo con loro, di rinviarla ad altra data. Aprì il frigo e prese del latte. Ne versò un po’ in un bicchiere; a lui piaceva berlo così: freddo e in un recipiente trasparente. Sedette sul divano in soggiorno, di fronte alla grande biblioteca piena di libri delle più svariate discipline. Alcuni erano accatastati senza un criterio preciso, uno sopra l’altro. Contemplò il latte tra le pareti tondeggianti del bicchiere: era bianco, puro, senza macchia. Stava pensando a cosa fare quando sentì un vociare concitato provenire dall’esterno e andò alla finestra a fianco della libreria. Spostò la pianta di dracena posizionata davanti: ancora non le aveva trovato una collocazione definitiva dopo averla presa dal giardino della villa dei genitori la domenica precedente. Guardò fuori. Vide un gruppo di persone dirigersi freneticamente verso la piazza della stazione in fondo alla via. Squillò il telefono. «Ehi, hai sentito cos’è successo?!» Lo aggredì Valentina, con la consueta vitalità e freschezza. «No, non so, sono tornato ora… che c’è?» rispose lui sedendosi nuovamente sul divano. «Accendi la tivù!» Appoggiò il bicchiere sul tavolino e accese la televisione. Ebbe un sobbalzo quando si rese conto di ciò che intendeva Valentina. 52 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV «Allora, ci sei?! Dobbiamo andare anche noi… si stanno radunando tutti nelle piazze!» «Sì ma… tu sei ancora in fabbrica?» «No, siamo usciti quasi tutti… non si poteva certo rimanere lì con quello che sta accadendo; ci siamo fermati subito… nessuno ha avuto il coraggio di dirci nulla… vorrei anche vedere!» Luciano cominciò a grattarsi la nuca insistentemente. «Ma…» riprese con tono incerto «sei da tua madre o da tuo padre?» «Ma che cazzo di domande mi fai! Sono da mio padre, come al solito! Sono più vicina! Passa di qua, dai muoviti!» Le gambe di Luciano oscillavano nervosamente, le ginocchia si toccavano quasi e poi si staccavano a un ritmo costante ma veloce. «Senti… domani ho più ore di lezione, sia al mattino che al pomeriggio… devo prepararmi, lo sai. E poi questi ritrovi spontanei… potrebbero esserci disordini…» «Ma come! Proprio tu mi dici questo… dopo tutti i discorsi che mi hai fatto!? Ti rendi conto di quello che sta succedendo?!» «No… ascolta… ma anche tu… cosa…» «Ho capito… Ciao». «Cia…» il saluto uscì monco dalle corde vocali; lei aveva già chiuso la telefonata. Più tardi Luciano accese la radio: seppe che nelle principali città del Paese si erano popolate strade e piazze. Grande spazio veniva dedicato al resoconto di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con aggiornamenti continui delle cifre riguardanti feriti e arrestati. Pigiò il tasto di spegnimento con un gesto secco, violento. Guardò fuori dalla finestra del soggiorno, senza attenzione, come per cercare una via d’uscita. Iniziò a camminare: cominciò col percorrere una linea immaginaria delimitata dalle pareti della sala; poi continuò tracciando un percorso simile a un inestricabile groviglio di forme geometriche ora curve ora rettilinee e spigolose. Poi si fermò di colpo: prese il telefono e compose il numero di Valentina: non era raggiungibile. Ore dopo tentò di richiamarla. Senza successo. Sentì solo la fredda voce registrata della signorina della compagnia telefonica che esasperava l’impossibilità della comunicazione. Si diresse in camera da letto per andare a dormire; si coricò supino. Notò che il soffitto della stanza aveva delle sfumature scure nei dintorni del lampadario. Era trascorso tanto tempo dall’ultima passata di bianco ma solo ora ci faceva caso. Spense la luce e si voltò a pancia sotto. Poi prese il guanciale tra le mani e se lo mise sopra la testa. La notte era solo all’inizio. 53 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV DuRA LEX DI GIOVANNA BAER Le fondazioni bancarie: iL furto pubbLico deL no profit privato 22 settembre 2010. Alessandro Profumo, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Unicredit, la prima banca italiana per capitalizzazione e la quattordicesima al mondo per attivo patrimoniale (decima in Europa), rassegna le dimissioni. Il più carismatico e abile manager nostrano, soprannominato Mr. Arrogance per aver avuto l’ardire di sbattere la porta in faccia a più riprese a soggetti del calibro di Telecom e RCS, autore della “più bella operazione del sistema bancario italiano degli ultimi anni” (1), la fusione fra Unicredit e Capitalia, alla fine non ce l’ha fatta e ha dovuto cedere lo scettro a Dieter Rampl, presidente tedesco del colosso bancario. Le motivazioni della sua uscita di scena (costate alla banca – cioè agli azionisti – la cifra record di 40 milioni di euro) non sono chiare: nonostante l’appoggio del ministro Tremonti, che si è dichiarato contrario ai ribaltoni in un clima di già elevata instabilità del si- stema finanziario, il Cda è stato irremovibile nel togliergli la fiducia. Per colpa del suo penchant per la Bank of Lybia, si dice, ma pare che quel che bolle in pentola sia ben altro, se uno come Cesare Geronzi, il punto di contatto fra la grande finanza e il Palazzo, sostiene che la causa sia da ricercare nella volontà dei politici di allungare le mani sulle banche. La Lega usa le fondazioni per costruire le sue roccaforti locali, Unicredit è il primo esempio, ma ce ne potrebbero essere altri, afferma Geronzi senza mezzi termini. E uno come Profumo – deciso e capace, ma poco propenso a prendere ordini – senza dubbio disturba. La legge Amato-Carli In realtà, l’obiettivo iniziale delle fondazioni era esattamente l’opposto, cioè sottrarre le banche al controllo dello Stato. All’inizio degli anni Novanta, quando l’Italia dovette affronta- (1) Geronzi: la Spectre non sono io, intervista a Cesare Geronzi di Massimo Giannini, La Repubblica, 23 settembre 2010 54 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV re l’apertura dei propri mercati ai partner europei, più della metà degli enti creditizi italiani era di diritto pubblico. La necessità di adeguare il sistema bancario alla cosiddetta ‘unità economica europea’ spinse l’allora governatore della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi, a separare la funzione di diritto pubblico dalla funzione imprenditoriale: la legge delega Amato-Carli n. 218/1990 dispose che gli enti bancari diventassero società per azioni sotto il controllo delle fondazioni, le quali successivamente avrebbero dovuto collocare le proprie azioni sul mercato. Le fondazioni bancarie costituivano una sorta di holding pubblica che, pur gestendo il pacchetto di controllo della banca partecipata, non poteva esercitare attività bancaria: i dividendi percepiti venivano intesi come reddito strumentale a un’attività istituzionale (indicata nello statuto), che doveva perseguire “fini di interesse pubblico e di utilità sociale”. Un compromesso tipicamente all’italiana per cedere formalmente il controllo operativo senza in sostanza cedere alcunché, simile a quello escogitato per risolvere il conflitto di interessi berlusconiano: il legislatore sosteneva che, se chi è proprietario di un’azienda si disinteressa della sua gestione, limitandosi a percepirne gli utili, il rischio di sue interferenze indebite nell’amministrazione risulta annullato. Va sottolineato che questa ambiguità di fondo nella definizione dei nuovi soggetti era probabilmente necessaria per far digerire ai politici quello che doveva sembrare un eccesso di emancipazione dei banchieri italiani: le banche facevano un primo passo verso un sistema di mercato autentico, come volevano sia la Comunità europea che Bankitalia, e nello stesso tempo il Palazzo poteva consolarsi nella consapevolezza che si cambiava tutto per non cambiare nulla, secondo il celebre adagio. Questo conflitto irrisolto fra i desiderata delle banche e quelli della politica era evidentemente destinato a far sentire la sua influenza nelle riforme successive, ed è testimoniato dai numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale sollevati dalle fondazioni nel tentativo di escludere il più possibile l’influenza della politica dalla loro attività. 55 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV DuRA LEX La direttiva Dini e la legge Ciampi Fino al 1994 le fondazioni, dette ‘enti conferenti’, avevano l’obbligo di mantenere il controllo della maggioranza del capitale sociale delle Casse di Risparmio (dette ‘banche conferitarie’). Con l’entrata in vigore della legge n. 474/94 (cosiddetta direttiva Dini) tale obbligo fu eliminato e furono introdotti incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle fondazioni. Nel 1998, con l’approvazione della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (cosiddetta legge Ciampi), e con il successivo decreto applicativo n. 153/99, il Parlamento ha provveduto, da un lato, a creare i presupposti per un completamento del processo di ristrutturazione bancaria avviato con la legge Amato e, dall’altro, a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni: per effetto della riforma attuata dalla legge Ciampi, la cui prima fase si concluse con l’approvazione degli statuti da parte dell’Autorità di vigilanza, “le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” (art. 2 d.lgs 17 maggio 1999, n. 153). Il decreto, nel testo vigente, individua i settori ammessi (famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali), nell’ambito dei quali le fondazioni scelgono, 56 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV ogni tre anni, non più di cinque settori rilevanti. Le fondazioni bancarie possono così assumere la struttura di ‘fondazioni grant-making’ (erogare denaro a organizzazioni no profit che operano nei settori individuati) oppure possono scegliere quella di ‘fondazioni operative’, svolgendo direttamente attività d’impresa nei suddetti settori, intendendola come attività strumentale al raggiungimento dello scopo di utilità sociale. Con la legge Ciampi, inoltre, l’iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche, già eliminato dalla direttiva Dini, è stato sostituito da un obbligo opposto: la perdita da parte delle fondazioni del controllo delle società stesse. Per incentivare la perdita del controllo fu previsto un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. Questa disciplina fiscale, la cui durata temporale era stata dapprima limitata ai quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto applicativo, è scaduta il 31 dicembre 2005. In base all’ultimo bilancio di sistema (relativo al 2008), su 88 fondazioni, 18 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie; 55 ne detengono una quota minoritaria; le altre 15 – che nel loro complesso rappresentano il 4,4% del totale dei patrimoni delle fondazioni – posseggono più del 50% del capitale sociale (peraltro nel pieno rispetto della normativa vigente, in quanto l’originario obbligo di perdere il controllo delle conferitarie è stato eliminato, tramite il dl n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, per le fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro, oppure operanti prevalentemente in regioni a statuto speciale). La legge Tremonti A fine 2001 il governo, con la legge finanziaria per il 2002, (art. 11, legge n. 448/01, cosiddetta legge Tremonti), apportò profonde modifiche alla riforma Ciampi, intaccando l’essenza rappresentata, da un lato, dalla natura privatistica delle fondazioni, dall’altro, dalla loro autonomia gestionale; e stabilendo che quasi il 90% delle risorse economiche delle fondazioni dovesse essere destinato a iniziative di carattere locale, cioè nell’ambito della regione di appartenenza. Le fondazioni in più occasioni espressero contrarietà in merito all’intervento del legislatore, godendo dell’appoggio di buona parte del mondo della cultura, del volontariato, delle organizzazioni internazionali e dello stesso mondo politico. Il mondo del volontariato redasse un manifesto chiedendo di confermare per le fondazioni il ruolo sussidiario e non sostitutivo _ IL TEMPO SI FERMA, Romeo Traversa, 1980-2009, xerocopia/disegno/elaborazione digitale/testo originale, colore, 21x21 cm 57 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV DuRA LEX di quello pubblico e di continuare a valorizzare l’apporto della società civile all’operato di queste organizzazioni. L’articolo 11 subì un radicale ridimensionamento da parte della magistratura cui si erano rivolte le fondazioni. A seguito del ricorso, il Tar del Lazio ravvisò la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale e, con l’ordinanza n. 803/2003, dispose la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per verificarne la coerenza con il dettato costituzionale. Il ruolo delle fondazioni secondo la Consulta La Corte Costituzionale si è pronunciata con le sentenze 300 e 301 del 29 settembre 2003, con le quali ha fatto chiarezza sul ruolo e sull’identità delle fondazioni di origine bancaria, che sono state definitivamente consacrate come “persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” e collocate a pieno titolo “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”. In sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che l’evoluzione legislativa intervenuta dal 1990 ha spezzato quel “vincolo genetico e funzionale”, “vincolo che in origine legava l’ente pubblico conferente e la società bancaria”, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro, “della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante”; ha sancito definitivamente la natura privata delle fondazioni di origine bancaria, ribadendo che sono collocate nell’ordinamento civile e che, quindi, la competenza legislativa sulle stesse compete allo Stato; ha dichiarato incostituzionale la prevalenza negli organi di indirizzo delle fondazioni dei rappresentanti di regioni, province, comuni, città metropolitane; ha stabilito al contrario che la prevalenza deve essere assegnata a una qualificata rappresentanza di enti, pubblici e privati, espressivi della realtà locale; ha valutato incostituzionale l’utilizzo di 58 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV atti amministrativi da parte dell’Autorità di vigilanza (ad interim il ministero del Tesoro e delle Finanze, in attesa della creazione di un nuovo soggetto), che comprimano indebitamente l’autonomia delle fondazioni, cioè gli atti di indirizzo di carattere generale o i regolamenti intesi a modificare l’elenco dei settori di utilità sociale; ha definito il concetto di controllo congiunto da parte di più fondazioni presenti contemporaneamente nell’azionariato di una banca, evidenziando che esso sussiste solo se fra di esse c’è un patto di sindacato accertabile; e ha ridimensionato gli spazi delle incompatibilità delle cariche per i membri degli organi delle fondazioni, stabilendo che vale solo per la presenza in società che siano in rapporto di partecipazione o di controllo con la banca conferitaria. I pronunciamenti della Corte Costituzionale, intesi a configurare in maniera risolutiva l’identità delle fondazioni di origine bancaria appartenenti ai “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, privati e autonomi, sono stati ripresi dal regolamento attuativo (d.m. 18 maggio 2004, n. 150) della legge Tremonti, concludendo così il lungo periodo di incertezza che ha condizionato l’operatività delle fondazioni. Parrebbe proprio che le esigenze del sistema bancario italiano (il mercato), abbiano alla fine prevalso sulle ingerenze della classe politica. “In salvo il bottino delle fondazioni”, titola il 30 settembre 2003 La Repubblica, riferendosi ai 36 miliardi di euro sottratti al controllo del ministro del Tesoro di turno. Del resto gli autori dell’impianto legislativo principale sulle fondazioni sono stati tutti alti esponenti di Bankitalia (Carli e Ciampi ne sono stati governatori e Dini direttore), e il tentativo di Tremonti di ricondurre i nuovi soggetti a più morbide posizioni nei confronti del controllo politico è naufragato sugli scogli della Consulta. Ma se quella del 2003 fosse stata solo una piccola vittoria all’interno di una guerra i cui esiti erano tutt’altro che scontati? Il cavallo di Troia Ai politici in generale e, ahimè, a quelli italiani in particolare – come si può facilmente immaginare – non piace affatto rinunciare ai propri poteri, soprattutto quando riguardano il controllo di un tesoro di ben 36 miliardi. Figuriamoci se un personaggio determinato e creativo come il ministro Tremonti poteva ritirarsi in buon ordine, accettando passivamente le sentenze della Corte Costituzionale. Se non posso controllare direttamente le fondazioni – deve aver pensato il nostro – nulla mi impedisce però di usarle indirettamente per i miei obiettivi. E quali fossero questi obiettivi era già all’epoca, almeno per chi volesse vedere, abbastanza chiaro. Le esigenze di contrazione della spesa pubblica imposte dalla Comunità europea obbligavano tagli sostanziali in settori vitali per il Paese (infrastrutture, sanità, scuola e cultura, politiche sociali). Le fondazioni, grazie ai loro statuti, si prestavano egregiamente allo scopo di sostituire il ruolo dello Stato centrale e degli enti locali in queste aree di investimento. La pronuncia della Consulta, che non a caso ribadisce la piena autonomia delle fondazioni circa i settori di investimento e la ridotta rappresentanza nei loro Cda degli enti locali, non poteva tuttavia condizionare il processo legislativo dello Stato. Tremonti aveva previsto, o almeno considerato, la possibilità che la sentenza di settembre della Consulta non fosse in suo favore, tanto che, giocando d’anticipo, il primo agosto venne approvata una legge (la 166/2002) intitolata “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” (ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Roberto Maroni, ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Pietro Lunardi), in cui all’art. 7 si inserisce “la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità” fra i settori di intervento delle fondazioni. Ma non basta. Dal momento che le fondazioni sono vincolate nelle loro aree di investimento alla regione di appartenenza, serve un soggetto con ampia au- tonomia d’azione in cui le fondazioni potessero confluire per finanziare quella parte di spesa per investimenti non riconducibile agli enti locali: Tremonti aveva ben chiaro quale potesse essere questo soggetto, e da tempo sognava di metterci mano: la Cassa depositi e prestiti. La Cdp nasce a Torino nel 1850 con una funzione strettamente bancaria – raccogliere depositi da privati cittadini quale luogo di fede pubblica – a cui sette anni dopo si aggiunge quella di finanziare l’attività degli enti pubblici. In effetti, poco o nulla è cambiato da allora. La Cdp mantiene ancora oggi due rami di attività: la ‘gestione separata’, che opera nel finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, altri enti locali e comunque strutture afferenti allo Stato, utilizzando come fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale; e la ‘gestione ordinaria’, che si occupa del finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinate alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. A questo ramo di attività la Cdp provvede attraverso l’assunzione di finanziamenti e l’emissione di titoli (in particolare obbligazioni) che, contrariamente al risparmio postale, non sono garantiti da parte dello Stato. Il progetto del ministro è semplice e geniale: favorire il restyling dei conti dello Stato attraverso la privatizzazione della Cdp, trasformandola in s.p.a.; e nel contempo partecipare al tesoro delle fondazioni bancarie, vendendo loro il 30% del capitale della nuova società sotto forma di azioni privilegiate, convertibili nel 2010 in azioni ordinarie. Benché gli alleati di governo (il solito Fini e Follini), non vedano ragione per cui si debba privatizzare un ente pubblico che ha sempre funzionato bene, il progetto è vitale e Tremonti, sostenuto dall’asse Berlusconi-Bossi, non si arrende: il super decreto passerà col ricorso alla fiducia, e il 30 dicembre 2003 le azioni della Cdp vengono girate alle 65 fondazioni banca59 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV DuRA LEX rie che ne hanno fatto richiesta. Come si legge nel comunicato stampa del ministero dell’Economia e delle Finanze, l’operazione ha fruttato 1.050 milioni di euro, a cui si deve aggiungere il corrispettivo “per la cessione alla Cdp s.p.a. del 10,35% di Enel, del 10% di Eni e del 35% di Poste italiane, pari complessivamente a poco meno di 11 miliardi di euro”. A dicembre 2003, la Cassa vantava 57 miliardi di euro di crediti verso i clienti (Stato, enti locali), e una raccolta di oltre 200 miliardi di euro (in continua crescita) nel risparmio postale: nel 2008 sarebbero stati 99 i miliardi di euro disponibili per investimenti strutturali, un patrimonio che fa gola a tutti. Da grande voglio fare l’Iri L’enorme liquidità della Cassa e la sua elasticità statutaria rappresentavano (e rappresentano) una formidabile risorsa per qualunque policy maker di destra o di sinistra: poter far leva sul proprio ruolo di azionista della Cdp per fare politica industriale, intervenire nel mercato e acquisire le partecipazioni nelle società che più interessano, per le finalità che più si desiderano e in base alla visione politica che più aggrada – il tutto al riparo dai vincoli europei sul deficit, dai quali la Cdp, in quanto azienda privata, è esclusa – è una tentazione assolutamente bipartisan. Tant’è che alla presidenza della neonata società viene nominato Franco Bassanini, già ministro nei governi Prodi, D’Alema e Amato: uomo da sempre vicino alle fondazioni (che salutano con entusiasmo la sua nomina), ci si aspetta che giochi un ruolo determinante nella partita della conversione delle azioni. “Con l’elezione di Bassanini alla presidenza si rafforza il ruolo delle fondazioni nella Cdp” commenta il presidente della Fondazione Monte (2) Ansa, 13 novembre 2008 (3) Ibidem 60 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV dei Paschi, Gabriello Mancini, “un ente che ora può davvero incidere nel campo della realizzazione di infrastrutture di cui il Paese ha bisogno” (2). Gli fa eco Fabrizio Palenzona, vicepresidente Unicredit e uomo di riferimento delle fondazioni: “La Cdp, avendo risorse fuori dal bilancio dello Stato, è lo strumento giusto per migliorare il sistema economico in un momento di difficoltà come questo” (3). Come super amministratore delegato viene nominato Massimo Varazzani (il delfino di Giulio Tremonti), ex funzionario Bankitalia, una lunga permanenza nel gruppo Sanpaolo Imi e incarichi di vertice in Ferrovie dello Stato e Enav: toccherà a lui muovere gli oltre 90 miliardi di euro di raccolta postale parcheggiati nel conto corrente di tesoreria (il gigante addormentato, lo chiama il ministro), per investimenti diretti in progetti infrastrutturali. Ovvio, qualcuno si rende conto che possono nascere dei problemi: “Una società che ha così importanti partecipazioni e che capitalizza le piccole e medie imprese (dal 2009 la Cdp ha messo a disposizione delle piccole/medie imprese un fondo pari a 3 miliardi di euro, aumentato a 8 nel 2010, n.d.a.), ha in astratto una componente di rischio”, avverte il senatore Giovanni Legnini, membro della Commissione parlamentare di vigilanza; mentre la Corte dei Conti, nella relazione del 2008 sull’attività di gestione della Cassa, ricorda che “ci si deve guardare da ogni rischio di devianza verso forme di surrettizio ritorno a modelli superati di presenza dello Stato nell’economia”. Ma Tremonti da quell’orecchio ci sente poco: lui da grande vuole fare l’Iri. La Lega in cantiere Come è stato ricordato, dal 2003 le fondazioni bancarie possono avere fra le proprie finalità istituzionali la realizzazione di lavori pubblici nelle regioni di appartenenza. Gli obiettivi dei legislatori (leghisti ed ex democristiani) sono chiari: restituire agli enti locali con la mano sinistra quel che gli si è tolto con la destra (i vincoli del Patto di stabilità). Come si legge su Il Sole 24Ore del 3 ottobre 2010: “Nel nord, segnato dai vincoli della spesa pubblica, i nuovi equilibri di potere sull’asse carroccio e post Dc spingono le fondazioni ad aumentare il pressing sulle banche perché sostengano con maggiore intensità la costruzione di strade, poli logistici e snodi intermodali. Con una tendenza che, al di là dell’attuale friabilità del quadro politico nazionale, segnerà i prossimi anni. E in più l’incognita sul futuro di Unicredit, che rispetto al passato potrebbe avere un ruolo più da protagonista, accanto a Intesa Sanpaolo, pivot incontrastato – come azionista e finanziatrice – delle grandi opere settentrionali” (4). Ed ecco che l’estromissione dello scomodo Mr. Arrogance da Unicredit assume un senso: i progetti di Profumo per la sua ‘grande banca’ avevano probabilmente un respiro un po’ più vasto di quelli che gli volevano imporre gli enti locali. E le pressioni sulle fondazioni devono aver raggiunto livelli davvero preoccupanti, se Giancarlo Galan, ministro delle Politiche agricole ed ex governatore del Veneto, si sente di affermare: “Assisto con angoscia alla prepotenza di una certa politica che si vuole impossessare di tutto. I banchieri hanno il dovere di amministrare gli istituti nell’esclusivo interesse dell’economia, mentre i politici debbono dettare le regole senza intromissioni nella gestione dei Cda” (5). Perché, sebbene la Consulta abbia dichiarato in- costituzionale la prevalenza negli organi di indirizzo delle fondazioni dei rappresentanti di regioni, province, comuni e città metropolitane, aggirare il divieto non è difficile: è sufficiente che nel Cda di qualche associazione locale (che sieda in Consiglio di una data fondazione) si inseriscano gli uomini giusti e il gioco è fatto, con buona pace di no profit e volontariato. Come nota Massimo Giannini su La Repubblica, siamo passati da “le banche sono nostre” di Andreotti e Craxi, all’“abbiamo una banca” di Fassino e D’Alema, al “ci prendiamo le banche” di Bossi e Zaia. Afferma candidamente Luca Galli, rappresentante del Carroccio in Cariplo: “Lo so bene io che faccio l’assessore al bilancio del comune di Castellanza. Il ruolo delle fondazioni è diventato essenziale: non solo diretto, come in Cdp, ma anche attraverso una pressione virtuosa sulle banche” (6). Se la pressione sia davvero virtuosa è dubbio, ma è un fatto che gli investimenti in infrastrutture al nord siano in una fase di stallo: secondo un’analisi di Finlombarda, da giugno 2009 a giugno 2010 sono partite grandi opere per 96 milioni contro quelle per 2,1 miliardi dell’anno precedente. Mario Ciaccia, numero uno di Intesa infrastrutture e sviluppo, dice che “servono garanzie, e diversi miliardi di euro, non bruscolini” (7). Lo strumento del project financing – presentato a suo tempo come l’Eldorado delle grandi opere a costo zero – non decolla, e gli enti locali pensano a dismettere più che a investire, mentre ci sono scadenze sempre più ravvicinate: la Pedemontana va completata entro il 2013; la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) l’anno successivo; e, nel 2015, la seconda tangenziale esterna di Milano. (4) Lega e fondazioni bancarie in pressing per le infrastrutture al Nord, Paolo Bricco e Cheo Condina (5) Galan: la Lega è senza lealtà e metta giù le mani dalle banche, La Repubblica, 11 settembre 2010 (6) Paolo Bricco e Cheo Condina, art. cit. (7) Paolo Bricco e Cheo Condina, art. cit. 61 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV DuRA LEX Per chi vuole l’intervento della mano pubblica, perché le priorità non vengono concertate nelle sedi deputate (il Parlamento) e i mezzi per perseguirle escono dal controllo dello Stato; per i fautori del laissez faire, perché la Cassa viene utilizzata dalla politica per bypassare dettati comunitari e dinamiche di mercato, nazionalizzando in sostanza – come ha sottolineato qualcuno – quel che si era detto di voler privatizzare. Per quanto riguarda invece il ruolo delle fondazioni voluto dagli enti locali, cioè quello di super investitori in infrastrutture, la questione è doppiamente grave: in primo luogo perché storna una gran parte delle risorse da settori – come la cultura, la scuola, le politiche sociali – in cui si sente davvero bisogno di finanziamenti alternativi a quelli dello Stato (benché il conflitto fra responsabilità pubblica e privata rimanga irrisolto, trasferendosi a livello locale). In secondo luogo perché l’obbligo per le fondazioni di investire il 90% dei proventi nella regione di appartenenza privilegia il nord rispetto al sud del Paese (l’interesse della Lega non è casuale), Per la Brebemi servono capitali per 1,6 miliardi, che verranno erogati per metà da Cdp e per l’altra metà da un consorzio formato da Intesa Sanpaolo, Unicredit e Centrobanca (gruppo Ubi). Per la Pedemontana invece i soldi necessari sono molti di più e la situazione è meno definita: il costo è di 5 miliardi, di cui 3,2 circa da finanziare. Il dominus del progetto è la provincia di Milano, che attraverso Asam controlla il 68% della società, ma nel capitale ricompaiono i soliti noti: Ubi con il 6% e Intesa Sanpaolo con il 26%. Nelle prossime settimane Intesa, Unicredit, Ubi, Mps e Popolare di Milano dovrebbero aprire i cordoni della borsa ed erogare i finanziamenti mancanti. contribuendo a enfatizzare una differenza di disponibilità che ha ormai ampiamente superato il livello di guardia. Ma se le sedi delle grandi fondazioni e delle relative grandi banche sono concentrate al nord, lo stesso non si può dire dei loro correntisti, o in generale della loro attività operativa: queste banche hanno interessi nazionali e, nel caso esemplare di Unicredit, addirittura internazionali. Perché mai dovrebbero beneficiarne solo i residenti di Piemonte, Lombardia e Veneto? Conclusioni Investire i lauti profitti delle banche in opere a sostegno della società civile può sembrare a prima vista un progetto meritorio in cui le fondazioni assumono un ruolo di Robin Hood moderno. Ma, tolto il velo dell’apparenza, la situazione si rivela di un’ambiguità spaventosa. Per quanto riguarda la Cdp, al di là del giudizio (positivo o negativo) che si possa avere circa l’intervento dello Stato nell’economia, lasciare decidere la strategia industriale di un Paese a una società privata, libera di perseguire i propri interessi di profitto, qualunque essi siano, nei settori che appaiono più interessanti, e senza vincoli di alcun tipo, è tutt’altro che rassicurante. _ ELLISSE, Romeo Traversa, 2009, elaborazione digitale, colore, 200x200 cm 62 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV 63 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV PER La cRonaca i morti del profitto nell’era dell’azienda totale di Claudio Vainieri La nuova sede della Orange business service, azienda del gruppo France Télécom, è situata nella città di Saint-Denis, alle porte di Parigi, presso la direzione dell’aeroporto internazionale Charles de Gaulle. Tra le particolarità del nuovo palazzo, c’è l’impossibilità di raggiungere le terrazze, tranne che in occasioni molto particolari. Per vedere il panorama, bisogna sempre starsene dietro a una finestra inesorabilmente bloccata. L’immobile è esteso su 31.000 metri quadrati. Le finestre sono concepite per evitare la tentazione di lanciarsi nel vuoto, mentre le scale interne sono studiate al fine che un’eventuale caduta non abbia conseguenze di particolare gravità. Gli ambienti sono illuminati con luce artificiale non troppo forte. La nuova sede è operativa dalla primavera del 2010, ed è una discutibile soluzione per porre rimedio al sempre crescente numero di suicidi all’interno dell’azienda. In totale ben 35 dipendenti del gruppo si sono tolti la vita tra il 2008 e il 2009. Per quest’anno, i sindacati contano altri 23 casi. La società riconosce un proprio coinvolgimento in appena tre casi, dichiarati ‘incidenti sul lavoro’: gli altri affondano le cause in ‘drammi personali’, afferma. Con oltre 193 milioni di clienti in trentadue Paesi, France Télécom è il maggior operatore telefonico francese. Amministrata dallo Stato fino al 1997, è diventata un gruppo privato dal 2004. Con la parziale privatizzazione – lo Stato è ancora l’azionista di riferimento – la ex società pubblica deve affrontare la concorrenza agguerrita dei nuovi operatori (1). Parallelamente, è in corso una veloce rivoluzione tecnologica. Vecchi mestieri vengono spazzati via, la telefonia mobile prende il sopravvento su quella fissa. Ai vecchi dipendenti, che hanno lo statuto di funzionario pubblico, viene chiesto di abbandonare la filosofia del ‘servizio pubblico’ e imposta una forte pressione per raggiungere tassi di produttività da settore privato. Arrivano i giovani, assunti con contratti di diritto privato, aumenta la concorrenza interna. France Télécom conta sul territorio francese circa 100.000 dipendenti. Nel 2006, per ripianare i 110 miliardi di euro di debiti, la società avvia un piano di ristrutturazione. In due anni vengono tagliati 22.000 salariati, 10.000 sono i trasferimenti. Per i sindacati il piano, basato sugli incentivi all’abbandono volontario, si è tradotto in pressioni su alcuni dipendenti 64 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV (1) Ammazzarsi per Tèlècom, Jessica D’Ercole e Roberta Mercuri, Altrimondi, 17 marzo 2010 (2) Suicidi a France Télécom: l’ispezione del lavoro accusa i dirigenti, Anna Maria Merlo, Il Manifesto, 13 marzo 2010 affinché se ne andassero senza far problemi. Per quanti rimanevano, invece, progressivo aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità. I medici all’interno della compagnia raccontano che dopo la privatizzazione, molti dipendenti si sono dovuti adeguare ai nuovi ruoli o accettare il trasferimento in un’altra città. Ingegneri che per vent’anni avevano lavorato alle riparazioni delle linee telefoniche, venivano riassegnati nei call center, soffrendone il cambiamento. I casi di depressione e di attacchi di panico si moltiplicavano. Nel marzo 2010, è cambiato l’amministratore delegato: Stéphane Richard è subentrato al criticato Didier Lombard, celebre per alcune dichiarazioni scioccanti. Nel settembre 2009 si lasciò scappare alla televisione francese: «Bisogna fermare questa moda dei suicidi che evidentemente ci angoscia tutti». La direzione, per cercare di far fronte a questi drammi, aprì un’inchiesta interna all’azienda, affidandola nell’autunno 2009 alla società Technologia (2). Il rapporto rilevava che, malgrado i cambiamenti al vertice e le promesse di intervento, la profondità della crisi a France Télécom rimaneva allarmante. Technologia aveva distribuito ai centomila dipendenti un questionario, a cui ben l’80% aveva risposto. Le conclusioni, emerse nella primavera 2010, riassumevano le ragioni del malessere in: mobilità forzata, perdita di riferimenti a causa dei vari piani di ristrutturazione, precarizzazione, maggiori carichi di lavoro, mancanza di personale cronica, pressioni per raggiungere gli obiettivi, mancanza di riconoscimento da parte della gerarchia. Nel settembre del 2009, a seguito della prima ondata di suicidi, l’azienda dichiarò il blocco della mobilità. L’ispettorato del lavoro aprì un’inchiesta, giudicando ‘molestie morali’ i metodi di management adoperati dalla direzione sui propri dipendenti. La procura di Parigi aprì di conseguenza un’istruttoria contro France Télécom. Questi, sono spunti di cronaca utili a capire la vicenda, ma solo dal racconto dei protagonisti – alcuni dei protagonisti, appena quattro, sui più di cinquanta in tre anni che si sono tolti la vita – si può realmente avere un’idea del dramma. 65 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV PER La cRonaca Yonnel ha 49 anni, di cui trenta passati in azienda. Scoprì in una giornata del settembre 2009 che sarebbe stato declassato da ingegnere per i sistemi aziendali ad addetto guasti per i clienti privati: altri ci erano già passati, ora toccava a lui. Alla sua età, aveva raggiunto la massima competenza lavorativa nel suo campo. Il giorno seguente si presentò puntuale in ufficio, per partecipare alla riunione che avrebiMMobiLe romeo traversa, 2009, elaborazione digitale/testo originale, colore, 200x200 cm be reso ufficiale la riorganizzazione della sede. Quando prese la parola, tirò fuori dalla tasca un coltello che si piantò dentro lo stomaco. Si era preparato, voleva uccidersi in azienda davanti a tutti e in modo plateale: “Nessuno doveva potersi discolpare” racconta nel suo libro. Yonnel non riuscì ad ammazzarsi, la ferita fu curata subito, i medici lo dimisero dopo una settimana (3). Il primo suicido risale al 19 febbraio 2008, un uomo di 51 anni. Tecnico di unità d’intervento, riassegnato a centralinista di call center, si impiccò in azienda. A lui come a molti altri, toccava subire le Orange Journey, giornate di formazione in cui i dipendenti, “per esprimere la propria ag66 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV gressività”, erano costretti ad avvolgersi il capo con bandane arancioni, come i colori sociali dell’azienda. Fanny cercava l’abito giusto per morire, e si cambiò tre volte prima di buttarsi giù dalla finestra del suo ufficio, schiantandosi sul marciapiede. Trentaduenne, single, abitava in quaranta metri quadri, vicino a Parigi. Laureata in legge, voleva fare il giudice e sposarsi in Sicilia. Entrata a France Télécom a 23 anni, ricollocata già due volte durante la ristrutturazione, da qualche mese aspettava il terzo trasferimento, non sapevano più dove metterla. Scrisse al padre: “Preferisco morire che ricominciare ancora con un altro capo”. Morì in ospedale, lasciò il gatto Frimousse e il coniglio Zebulon. Jean Paul, 51 anni, sposato e padre di due figli, anche lui degradato da tecnico a centralinista. Continuava a dire agli amici: «Quando uno rimbambisce mica se ne accorge». Una sera comprò un biglietto del cinema, ma cambiò idea e guidò fino a un viadotto sull’autostrada, scavalcò il parapetto e si buttò di sotto. Sulla vettura, lasciò alla moglie una lettera: “Mi hanno ucciso loro, rendendomi la vita impossibile”. Al funerale, la famiglia non ha voluto i dirigenti della società né i giornalisti. (3) Io, distrutto da France Télécom, salvo dal suicido ma morto dentro, Anais Ginori, La Repubblica, 22 novembre 2009 67 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV FiLo-LoGico sTORIA E GEOGRAFIA DELLA COLPA DI FELICE ACCAME Riferendosi alla tragedia greca e alle tecniche del suo svolgimento, l’Aristotele della Poetica parla dell’hybris. Chi ne tenta una traduzione, oggi, si trova di fronte a una gamma di soluzioni che vanno dall’‘offesa’ alla ‘sopraffazione’, dalla ‘tracotanza’ alla ‘superbia’ – secondo quanto ci si trova bell’e servito dai processi di metaforizzazione cui la parola è stata sottoposta. Inalienabile, però, sembrerebbe quel senso di peccato di ‘eccesso’ e di ‘orgoglio’, che, narrativamente, può esser posto nel passato e determinare negativamente il futuro. Una specie di peccato dei padri che ricade sui figli – categorizzato come tale, ovviamente, con il senno di poi, perché non sempre quando il peccato lo si commette fa così schifo come si vorrebbe dopo. Atto fin troppo – in eccesso, appunto – a seguir virtute e conoscenza, fin a farsi abbindolare dalle sirene di turno, Ulisse esercita esemplarmente l’hybris – come chi si ritrova all’improvviso fuori dal suo Paradiso per aver osato troppo, senza preoccuparsi un granché di quanto, poi, toccherà ai propri discendenti. Nel 1984, Gavino Ledda ha titolato Hybris un suo film e, ancora nel 1993, Franco Battiato, ha inciso una sua Atlantide, nella quale, tra l’altro, dice: “Per generazioni la legge dimorò / nei principi divini / i re mai ebbri delle immense ricchezze / e il carattere umano s’insinuò / non sopportarono la felicità / neppure la felicità / neppure la felicità”. 68 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Perlopiù chi ha dedicato lunghi studi ad Atlantide e ai numerosi altri Paradisi perduti non si è accontentato di dirci com’era e come non era, dov’era e quand’era – luogo fisicamente meraviglioso, luogo mentalmente meraviglioso – dei due l’uno per qualcuno, per altri addirittura tutti e due – ma si è ingegnato a spiegarci il perché – a un punto più o meno certificato – non c’è più. Atlantide non ci sarebbe più a causa di una catastrofe naturale, ma questa catastrofe naturale se la sarebbe andata a cercare. La grande saggezza raggiunta dai suoi abitanti si sarebbe trasformata in superbia, in tali dosi di orgoglio e di tracotanza, da indurre il Dio del momento a comminar loro il meritato castigo. Insomma, sia che ci si dia da fare nel grande regno di Atlantide – quella che Platone immagina alle prese con una altrettanto mitologica Atene, l’Atene dei suoi sogni – sia che si ciondoli da perdigiorno, felici, nei giardini dell’Eden e ci si chiami Adamo e Eva, saremmo tutti, sempre e comunque destinati a sprofondare da qualche parte, perché ci sarebbe sempre e comunque una colpa capitalizzata da pagare. Tutti i mutui vengono al pettine. Val già la pena di riflettere profondamente su questa idea dell’incapacità dei popoli di sopportare la prosperità raggiunta, se non fosse che, correlativamente, questa idea è spesso associata a un’altra – ugualmente pestifera, altrettanto meritevole di riflessione. Le varie Atlantidi, con le loro popolazioni perfette, con le loro società tutte ben ordinatine – sinarchiche e mai anarchiche – perfette e pur caduche – hanno alimentato ogni teoria razzista e tutti quegli orientamenti politici autoritari – nazionalsocialismo incluso – che, nella giustificazione di una superiorità, hanno pianificato più e meno scientificamente la soggezione e l’eliminazione fisica di chi, teoria alla mano, riuscivano a dichiarare come inferiori. La storia di tutto ciò – con la pazienza di Giobbe, perché leggersi le teorie formulate in più di duemila anni dai migliori disturbati mentali di mezzo mondo non è una passeggiata – è molto ben raccontata da Davide Bigalli ne Il mito della terra perduta – Da Atlantide a Thule (Bevivino, Milano 2010). Con imperturbabile sagacia, sottile ironia e geometricità di argomentazioni, Bigalli svela molto di più di quanto siamo abituati a chiedere a una storia pencolante tra geografia e fantasia, perché, di quel che oggi come ieri tiene solidi e consolidi gli assetti di potere di questo mondo – siano essi espressi in termini di fede religiosa o di scienza più e meno cialtronesca – nulla si salva: sono narrazioni pelosamente interessate, palesemente modellanti, istruttive ed educanti, capo- saldo della nostra cultura, non robetta, e pur tuttavia cucite e ricucite alla bell’e meglio per masse di bocca buona – o in attesa di schisciarsi sotto il tallone di ferro di turno o di ricevere la generosa dose di droga sufficiente per tirare avanti. Non si tratta, allora, soltanto di mera letteratura consolatoria – di matrice, peraltro, rigorosamente maschile. La colpa ineluttabile da pagare prima o poi sostituisce qualsiasi analisi nonché qualsiasi assegnazione eventuale di responsabilità specifiche – non è il potere, non è l’asimmetria sociale, non è il sistema produttivo, non è lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, non è l’accumulazione del plusvalore capitalistico, ma è l’intrinseca incapacità degli esseri umani a impedire ogni amorevole e durevole convivenza. L’idea di degenerazione implica un paradigma valorizzato – un’età dell’oro, per dirla in linguaggio appropriato all’occasione – e una sua ferita in costante progresso, una ferita sanabile soltanto dai pochi eletti consapevoli di quanto sta avvenendo e pronti anche al sacrificio di sé per riportare alla luce ciò che, invece, è andato languendo nel buio. Quando lo psichiatra francese Bénédict-Augustin Morel, nel 1857, pubblicò Traité de Dégénérescences physique, intellectuelles et morales de l’espèce humaine et 69 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV FiLo-LoGico des causes qui produisent ces variétées maladives non sapeva di dare il là a un movimento di idee che, dal suo ambito – all’interno del quale fu fatto proprio da Lombroso, per esempio – debordò piuttosto velocemente nell’estetico. Max Nordau (in Degenerazione, ristampato da Piano B, Prato 2009), infatti, ravvisa nell’evoluzione delle forme artistiche di fine Ottocento – nel simbolismo, per esempio – i sintomi della degenerazione e, praticamente, senza saperlo – per uno di quei paradossi della storia ancora da venire, era un sionista – prepara il modello ideologico della repressione nazista di anni dopo. Se Morel fa risalire la sua degenerazione in senso psichiatri- co all’uso di narcotici, di oppio, di alcol, di bibite fermentate e di eccitanti vari, Nordau rinviene la causa fondamentale della sua degenerazione estetica nella “vita nelle grandi città” – come se, per l’appunto, al di là di un certo numero di abitanti, metaforicamente o meno, non ci potesse attendere che la catastrofe. Non vorrei essere equivocato. Può esser utile – perché no – analizzare come vadano male gli esperimenti di società animale (la letteratura ce ne ha fornito esempi illuminanti – due titoli rilevanti in tal senso potrebbero essere Il signore delle mosche di William Golding e La torre di MENTE, Romeo Traversa, 1980-2009, elaborazione digitale/testo originale, colore, 21x21 cm 70 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Babele di Antonia Susan Byatt) ma non per dire che non possono andar bene in linea di principio, non per invocare Autorità ancora più autoritarie – il che è mistificante ed evidentemente strumentale – quanto, piuttosto, per individuare gli errori commessi e correggerli. ti per distinguere metafore innocue da metafore esiziali, va da sé che qualsiasi narrazione può andare bene e che il governo delle relazioni umane possa avvenire soltanto in termini di un potere che qualcuno ha e qualcun altro no. Ne Il mito della terra perduta, Davide Bigalli cita, tra il tanto d’altro, un brano di Sant’Agostino tratto dal suo commento al Genesi, che, a mio avviso, rappresenta perfettamente il punto cruciale da cui prendere le mosse per liberarsi di tutta la zavorra ideologica costituita dal paradigma della colpa originaria e del suo effetto degenerativo vita natural durante. Laddove sta parlando a proposito delle opinioni che circolano sul Paradiso e sul suo statuto ontologico, Agostino dice che le più comuni sono tre. La prima opinione è quella di coloro che vogliono intendere il Paradiso in senso letterale – dunque come luogo fisico, dico io – la seconda è quella di coloro che lo intendono in senso allegorico – dunque come una metafora e nulla più, dico io – e la terza è quella di coloro che lo intendono ora in un senso ora nell’altro. “Confesso”, conclude sciaguratamente Agostino, “che a me piace la terza opinione”. Con il che – costituendo il nucleo di quel relativismo linguistico cui il cattolicesimo non potrà mai rinunciare – viene a sostenere che una parola può designare qualcosa di fisico o di mentale a seconda dell’umore di chi la usa. Può piacergli quanto gli pare, ma sappia – l’opportunista Agostino – che così dicendo giustifica il venir meno del rapporto semantico e degli impegni che tutti quanti prendiamo allorché impariamo e condividiamo una lingua. Non è al comodo di qualcuno che una parola possa mutare di significato. Il linguaggio ha un fondamento sociale ineludibile. Se non si fornisce un criterio alla suddivisione tra metaforico e letterale, se non si hanno strumen71 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV VERITà AL TEmPO DELLA mOVIOLA di Davide Pinardi PREMI NOBEL à LA CARTE* Quesito tormentoso: qual è la migliore guida ai ristoranti d’Italia? È meglio quella dell’Espresso o invece quella di Slow Food? È preferibile l’annuario del Gambero Rosso o la Rossa Michelin? Ognuno ha la sua risposta. Dipende dai gusti, dalle preferenze, dalle visioni del mondo… Secondo quesito: ma quanto sono affidabili, in genere, queste guide? Bisogna prenderle come oro colato, come il Vangelo, come dei sacri breviari? O è meglio considerarle come cataloghi di volta in volta più o meno utili e attendibili da prendere sempre con un filo di scetticismo? Domanda retorica, ovviamente. Tutti o quasi propendiamo – tranne qualche eccezione di fanatico per professione – verso il secondo atteggiamento. Perché sappiamo come vanno queste cose, noi che siamo uomini di mondo: al di là dei sacri proclami di etica e di rigore, chi mai crede davvero alla mitologia, che vorrebbero spacciare per vera, dei segreti assaggiatori, dei rigorosi buongustai, degli incorruttibili savant che vagano in incognito per locali, bettole e osterie di tutto il Regno – su su, nella notte buia e tempestosa, fino ai villaggi e ai borghi più sperduti – al fine di stabilire ‘oggettive graduatorie’ di qualità e merito? Queste sono innocue panzane adatte a divertenti pellicole come Ratatouille, nella quale il topolino buongustaio viene scoperto essere un cuoco capace di creare sublimi zuppe proprio dalla direttrice della Bibbia del Gourmand. Ma la normalità è differente, lo sappiamo bene. Nelle pragmatiche redazioni delle case editrici di questi volumetti si guardano le graduatorie dell’anno prima già comodamente inserite nel computer, si riceve qualche segnalazione interessata, si contano le pagine vuote e che bisogna riempire, si controlla che un ristoratore non sia magari morto da qualche anno senza che nessuno ce l’abbia fatto sapere (capita, capita…) si telefona all’amico di un amico e ci si fa offrire la cena e un paio di bottiglie per una gita con la fidanzata… Questa è la vita vera, diciamolo con onestà: un mix di serietà e opportunismo. * l’argomento Alibi Norimberga sarà ripreso sul prossimo numero 72 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV E allora come facciamo a scegliere una guida per i ristoranti? Semplice, usiamo le esperienze, nostre e altrui. Usiamo una guida e per tre volte riceviamo delle fregature? Mai più andremo in quei ristoranti e, soprattutto, mai più con quella guida. Un amico che se ne intende ci racconta che con un certo calepino non sbaglia mai? Allora lo compriamo anche noi, l’anno dopo. Insomma, quando abbiamo bisogno dei consigli o dei suggerimenti di qualcun altro usiamo il buon senso e facciamo tesoro dell’esperienza. Princìpi da utilizzare in ogni situazione della vita, quando possibile. Che ci fanno da scudo – purtroppo non sempre efficace – dalle fregature, dagli imbrogli, dalle furbizie interessate. In altre parole, quello che conta in chi ci indica una stra_ MIO FRATELLO CATTIVO, Romeo Traversa, 2009, elaborazione digitale/ testo originale, colore, 200x200 cm da, un ristorante o un venditore di auto è il suo tasso percentuale di credibilità: di nessuno ci dobbiamo fidare al cento per cento, ma sappiamo che tra fidarsi all’1% e al 95% esiste una bella differenza. E il mix tra serietà e opportunismo è molto variabile in relazione alle circostanze e alla caratura delle persone. Passando di palo in frasca (apparentemente): ma voi avete mai visto l’elenco dei vincitori dei Nobel per la Pace in questi ormai centodieci anni del premio? Qua e là alcune grandi figure passate alla Storia e oggettivamente meritevoli. Poi varie persone ormai dimenticate e quindi difficilmente giudicabili (e questo testimonia quanto la Storia sia una questione di memoria mediatica); infine una sequela di personaggi del tutto improponibili. Personaggi incoerenti con quanto il premio vorrebbe affermare (ma cosa esattamente vorrebbe affermare? Mah…). Qualche esempio? Theodore Roosevelt, il bellicoso presidente imperialista americano, coinvolto direttamente nella guerra ispano-americana su cui costruisce la sua personale carriera politica, premiato perché dopo aver sollecitato l’espansionismo giapponese in funzione antirussa, nella guerra del 1905 interviene a fare da mediatore tra le parti in conflitto. Insomma, dopo varie decine di migliaia di morti… E poi Woodrow Wilson il quale, dopo aver patrocinato per fini trasver73 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV VERITà AL TEmPO DELLA mOVIOLA sali il criminale trattato di Versailles che frantuma l’Europa ponendo le basi della guerra successiva, riceve il premio perché sostiene la Lega delle Nazioni. E che dire di Henry Kissinger, premiato nello stesso identico anno in cui la sua amministrazione orchestrava il colpo di Stato in Cile (l’altro premiato, Le Duc Tho, rifiutava dignitosamente il riconoscimento dato per le trattative di Parigi che miravano alla conclusione della guerra del Vietnam – peraltro al momento fallite – affermando che “in Vietnam non c’è ancora pace”). La bella coppia Sadat e Begin (il primo un dittatore, il secondo che, qualche anno dopo, sempre in carica, promuoveva l’invasione del Libano del 1982 con gli spaventosi massacri di Sabra e Chatila, e non risulta che il premio gli sia stato ritirato). Ma al di là di questi casi sconcertanti, l’analisi tecnica, statistica dell’elenco dei premiati nel suo complesso mostra alcune costanti, a prescindere dal merito del premiato. 1) La presenza di leader politici solo e soltanto occidentali (e in particolare anglo-americani) è continua (per esempio, cinque presidenti o vicepresidenti USA di cui tre mentre sono in carica: ma questi leader americani sono proprio dei pacifisti!). I capi di Stato di altre aree del mondo possono essere premiati soltanto quando, si può ragionevolmente affermare, sono venuti incontro ai desiderata occidentali (per esempio il pio Gorbaciov). Vengono premiate anche figure non immediatamente politiche ma che esercitano un’azione politica travestita di umanitarismo che si trasforma in oggettivo fiancheggiamento di posizioni occidentali (per esempio Elia Wiesel, un commovente caso di pacifista al passato…). 2) I premi a emeriti sconosciuti (dunque a persone per la cui opera tali onorificenze sarebbero estremamente utili al fine di difendere e far sopravvivere la loro lotta) sono rarissimi. E se questi erano poco conosciuti prima, tali rimangono anche in seguito, perché il circo mediatico internazionale offre alla loro opera un’attenzione scarsissima. Insomma, la loro personale figura in qualche modo si sacralizza rendendoli intoccabili ma le realtà in cui operano rimangono completamente abbandonate a loro stesse. Questo dimostra che, 74 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Premi nobel à la carte di per sé, un Nobel per la Pace serve a poco o nulla se altri interessi molto consistenti non vi si accompagnano. 3) Molti premi (soprattutto negli ultimi trent’anni) sono stati assegnati a oppositori – guarda caso – soltanto all’interno di Stati con i quali l’Occiden- te appare in contrasto o frizione: Walesa e Sacharov durante la guerra fredda, Aung San Suu Kyi in Birmania, Shirin Ebadi in Iran, il Dalai Lama e infine quest’anno Liu Xiaobo in Cina. In questi casi vi è una continua sovrapposizione tra la tematica della pace e quella dei diritti civili: vien dunque da pensare che il riconoscimento di Stoccolma non sia un premio per la Pace bensì per i diritti civili. Ne consegue il punto successivo. 4) Alcune aree geografiche sono straordinariamente sottorappresenta_ VEDOCHIAROⓇ, Romeo Traversa, 2009, fotografia digitale/elaborazione digitale, colore, 21x21 cm te: America latina e Africa, nello specifico (mediaticamente valgono poco…). Eppure sono aree nelle quali sono avvenuti alcuni tra i peggiori crimini contro l’umanità e molti – moltissimi – sono stati coloro che vi si sono opposti pacificamente. 5) Appare smaccatamente evidente una prevalenza numerica di premi al mondo anglo-americano anche nella società civile e non soltanto in quella politica. Ma, si osservi con cura che – a parte Martin Luther King – tutti i premiati sono creatori di organizzazioni di intervento in altre aree del mondo, di opere pie e assistenziali in campo internazionale, di gruppi filantropici per il terzo mondo. In altre parole, sono membri dell’establishment che proclama (giustamente o opportunisticamente) la necessità di intervenire altrove e non all’interno del proprio Paese. Sono persone che raccolgono un po’ di quattrini da miliardari e tycoon e li portano tra i disperati. Meglio di niente, ma stiamo parlando di carità. Ritornando alla metafora delle guide dei ristoranti, vien da pensare che nel ristretto comitato che decide i Nobel per la Pace, anno dopo anno, ci siano molti furbetti che hanno capito come gira il mondo. Forse tra di loro qualche persona seria c’è, qualche idealista, qualche nobile spirito umanitario. Ma pochi. D’altra parte il Nobel per la Pace è l’unico premio norvegese e non svedese e il suo direttivo è eletto dal Parlamento in funzione della maggioranza vincitrice alle elezioni (la Norvegia è storicamente un bastione della Nato: che strano. La Svezia no…). Il loro problema principale è come fare gli interessi dei loro sponsor maggiori, diretti o indiretti, interni e internazionali, senza fare una brutta figura. E così lavorano, limano, si impegnano per trovare qualcuno che vada bene, in una parola, all’Occidente, senza che sia davvero impresentabile (e se è persona apprezzabile, tanto meglio). Negli anni in cui non ci sono interessi forti da accontentare si può dare una sterzatina verso l’autenticamente umanitario. Ma quando i padroni premono, allora non ci sono dubbi. Attualmente, per esempio, si profila una ripresa in grande stile della guerra valutaria con la Cina, dunque è il momento di darle fastidio. Agiscono politicamente, ed è perfettamente logico che molti rispondano politicamente. Non sono dei pii idealisti un po’ allocchi, che compiono errori in buona fede. Sono gente molto scafata con parecchio pelo sullo stomaco. Il sistema dei media segue con entusiasmo ebete o, più spesso, complice. Ma non è una sorpresa. Proprio come quando scoppia una bomba: se esplode in una nostra piazza è importante, se esplode altrove è banale. E proprio come nel caso delle condanne capitali in giro per il mondo: se è di una donna in Iran (giustamente) ci si indigna e si appendono i suoi ritratti sulle facciate dei municipi; se è negli Stati Uniti si borbotta e in fretta si scorda; se è nelle aree dimenticate del mondo si trascura. A chi importa, in fin dei conti? 75 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InTERVIsTA _ a Elvira Dones Una libertà sEnza sogni di sabrina Campolongo Nel suo romanzo Vergine giurata, si fa riferimento a un codice ancestrale, il Kanun, che consente a una donna di diventare socialmente un uomo, con tutti i privilegi e i doveri di un uomo, a prezzo della rinuncia totale alla sua femminilità. I giornalisti e blogger italiani che hanno scoperto dell’esistenza del fenomeno sociale delle ‘vergini giurate’ (fenomeno circoscritto ad alcune comunità isolate tra i monti dell’Albania del nord e del Kosovo) grazie al suo romanzo e al documentario in cui ha intervistato alcune di queste donne, hanno usato parole come “antico orrore” per descriverlo. Confesso che la mia prima reazione, invece, è stata di sorpresa. L’idea che un codice così arcaico, peraltro feroce, sotto molti aspetti, consentisse alle donne non solo di rinunciare a essere femmine (come accade alle suore, in fondo, alle ‘spose di Cristo’) ma di diventare uomini, permettendo loro di ottenere, seppur a un prezzo altissimo (lo stesso pagato dalle monache, in ogni caso) un ruolo paritario a quello dell’uomo, mi è sembrato quasi rivoluzionario. Non credo che questa ‘opportunità’ sia mai stata concessa a nessuna donna di nessuna civiltà, almeno nel mondo occidentale, se escludiamo il popolo delle Amazzoni. Mettendoci più di un pizzico di cinismo, mi verrebbe da dire che oggi – in Italia, almeno – si vedono donne pagare un prezzo simile per ottenere molto meno, forse per la promessa di un trattamento paritario, promessa che spesso diventa miraggio. Lei ha pensato di denunciare un abominio, scrivendo la storia di Hana, oppure è rimasta, almeno in parte, affascinata dalla potenza, non solo simbolica, di una scelta come la sua? Vergine giurata è una storia, un libro di narrativa, non ho voluto denunciare nulla, se così fosse mi sarei messa a scrivere un libro giornalistico con qualche venatura storico-antropologica. Dalle vergini giurate ero affascinata da quando avevo quindici anni o giù di lì. Ho solo atteso il momento per fare serie ricerche; ho anche atteso che il libro 76 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV maturasse dentro di me. Quindi Vergine giurata ha attraversato, in un certo senso, una lunghissima gravidanza. Trovo la definizione “antico orrore” una scorciatoia, una semplificazione. Con questo non voglio dire che sia bellissimo che una donna venga privata dalla sua sessualità, e soprattutto della possibilità di dare amore a un uomo. Però va detto che il Kanun è una raccolta di leggi ancestrali complessa. Le vergini giurate sono sì il prodotto di una forma mentis prevaricatrice che nei secoli ha posto la donna sull’ultimo gradino della società, ma al contempo le ha lasciato uno spiraglio. È uno spiraglio feroce? Sì. Ma è, al contempo, un compromesso. Gli uomini concedono ‘la libertà’ e il diritto della ribellione a una donna. Se la donna imbocca quella strada gli uomini la rispettano; la accolgono come loro pari. È come una elaboratissima pièce de teatre, basta vedere le cose nella loro complessità, invece di usare soltanto un pennello imbevuto di nero... Sarebbe lungo fare luce qui su tutto il meccanismo che porta alla ‘creazione’ di una vergi- ne giurata. Tutto è nato secoli fa, si è protratto nel tempo per diverse ragioni e sta morendo ora con l’era moderna. Ma guardiamolo da un diverso punto di vista: fare voto di castità, rifiutando il marito scelto dal padre, per esempio, è una forma di ribellione. La fai franca, sei libera di andare ovunque senza sentire in ogni momento il fiato sul collo, senza dovere pendere dal giudizio del fratello, del padre che ha in mano il tuo ‘onore’. Diventi socialmente un uomo, quindi smetti di essere un oggetto a vita. E poi non dimentichiamo che il matrimonio d’amore è un’invenzione relativamente recente della società. In molte regioni del mondo ancora vige la regola del matrimonio combinato. L’opzione amore resta, appunto, un’opzione, non un diritto assoluto. Basta guardare l’India: in molte regioni la ragazza viene data in sposa senza il diritto di scelta; in altre regioni del lontano Oriente succede la stessa cosa. Il matrimonio è un contratto economico, l’unione dei beni tra due famiglie... Io scrissi il libro affascinata dai monti del nord dell’Albania e per amore delle genti che lo abitano. Ero affascinata dalla solitudine delle donne-uomo; la solitudine interna, quella mai espressa ad anima viva. Le parole pesano, da quelle parti; il silenzio è quasi d’obbligo; se attraversi le vallate ti trovi avvolto da un manto di sublime bellezza. A volte la bellezza uccide. Ma la bellezza uccide ovunque, no? Un giorno una vergine mi disse: «Visto che ti stai scervellando per capire perché ho giurato castità...» (infatti la osservavo, doveva essere stata bellissima da giovane, era ancora un uomo piacevole). «L’ho fatto» mi confidò, «perché ero molto più avanti del mio tempo. Non volevo essere menata per il naso da un uomo. Non io. Ed eccomi qua». Dopo l’uscita del libro, e soprattutto dopo la messa in onda del documentario girato per la televisione pubblica svizzera, le vergini giurate diventarono una specie di meta ambita per giornalisti e fotografi. Gente da mezzo mondo mi contattava per ottenere le loro coordinate. Spesso percepivo dalle mail, dalle telefonate di richie- sta, non un interesse a capire a fondo la complessità della storia, bensì la fretta di catturare in immagine i fenomeni da baraccone: donne strambe, esotiche, forse lesbiche e primitive, di un Paese povero e disgraziato. A una donna-uomo due giornaliste occidentali promisero di regalare un orologio d’oro se avesse concesso l’intervista. La vergine era disoccupata da mesi. Le due occidentali ottennero la storia, le scattarono le foto. Ritornarono a casa propria, pubblicarono il pezzo. Non le inviarono mai l’orologio, nemmeno uno da venti dollari. La sua vita è divisa tra l’Albania, la Svizzera, gli Stati Uniti e l’Italia. Qual è la differenza più significativa che ha vissuto sulla sua pelle di donna e scrittrice, tra questi Paesi? Amo molto l’Italia perché parlo e scrivo la lingua. E l’amo ancora di più perché ci sono venuta da scrittrice e da documentarista, con il privilegio di avere conosciuto l’Italia migliore: quella degli studenti che fanno volontariato con passione e tra mille sacrifici; degli 77 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InTERVIsTA _ a Elvira Dones - Una libertà senza sogni operatori sociali; dei magistrati e degli attivisti dell’Antimafia; degli psicologi e degli psichiatri che si occupano delle ragazze di strada e dei bambini abbandonati... Senza tutto questo, non so se avrei conservato e nutrito l’amore e il profondo interesse. Moltissimi albanesi, da emigranti, hanno avuto un’altra esperienza: quella dell’umiliazione; della gente che non dava loro casa in affitto perché erano albanesi. Storie che conosciamo molto bene... Va anche detto che gli elementi della malavita albanese in Italia non hanno subito molto; qualche pesce piccolo è finito dentro, sì, ma gli altri, i pezzi grossi, stanno bene. La malavita, come ovunque nel mondo, il rispetto se lo compra. Se l’è comprato anche in Italia. Gradualmente, per la diaspora albanese in Italia le cose sono migliorate grazie all’olio di gomito e alla perseveranza di ogni emigrante, e anche grazie alla memoria storica degli italiani che una volta da emigranti avevano dovuto percorrere la medesima strada: l’emigrazione. L’ha incorniciato molto bene Gian Antonio Stella nel suo libro L’orda: quando gli albanesi eravamo noi. Per quanto mi riguarda, il muro io lo trovai in Svizzera, dove approdai quando lasciai l’Albania. Era un muro educato, ma comunque di cemento. Ho la cittadinanza elvetica; mia figlia è nata lì; mio figlio maggiore vive molto bene in Svizzera; mio marito è svizzero. È uno dei miei Paesi, dunque. Ma nei primi anni avrei preferito un pugno aperto sul muso invece della condiscendenza, dei guanti bianchi. Dovevo dimostrare che non ero una furba, non ero una lavativa. Ho camminato sulle uova, ho sbattuto contro i muri, contro le porte, dentro di me non sempre ho gestito bene la rabbia e la frustrazione. Poi un giorno venne pubblicato, in Italia, il mio primo libro, l’unico libro autobiografico, Senza bagagli. Arrivò ovviamente in Ticino. E la storia cambiò. Ero stata finalmente sdoganata. Oggi ho con la Svizzera un rapporto di reciproco rispetto, credo. L’America è altamente imperfetta ma è abbastanza calda per dirti, ogni volta che arrivi all’aeroporto: Welcome home. L’accento, che sia pesante o leggero, non spaventa nessuno. L’America fa casa. È casa. Quando in centro Milano o in centro Parigi metteranno una donna islamica col velo ad accogliere i clienti nella profumeria del centro commerciale superchic, per gli ultra ricchi, me lo facciano sapere; e quando la 78 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV donna in questione parla pure male la lingua eppure è stata assunta, ancora: me lo facciano sapere. Amo profondamente l’Europa ma certe barriere sono ancora dure da far cadere, sempre che cadano. L’Albania è le radici, gli amici, la lingua, la tomba di mio padre. L’Albania è un amore quasi atroce, ti risucchia, perciò ci devi stare attento. È un Paese straordinario, intenso, nel bene e nel male. Che Paese è l’Albania di oggi? Cosa ha guadagnato e cosa ha perduto (se qualcosa ha perduto) rispetto a quello da cui è fuggita? L’Albania ha guadagnato la libertà, e ha perso i sogni. E qui non vorrei essere fraintesa. Non sono una nostalgica della dittatura, non sto dicendo che sotto il regime di Hoxha si stava meglio. Al contrario, l’Albania di allora era un’orribile, lugubre prigione a cielo aperto. Ma il popolo era capace di sognare. Immaginavamo cosa c’era dall’altra parte del muro. Ci tenevamo in piedi con l’idea di un mondo che forse mai avremmo visto. Ma c’era ‘l’illusione della bellezza’, pensavamo che qui, in Occidente, ogni cosa era bella, impeccabile. Se fossimo stati abbastanza colti, preparati, istruiti, l’Occidente un gior- no ci avrebbe accolto a braccia aperte. Il sogno quindi ci teneva umili, e pieni di dignità. Era la dignità del prigioniero che, tra la tentazione del suicidio dietro le sbarre e la pazienza della tortura quotidiana, sceglie la pazienza, coltiva la pazienza. E nonostante tutto osa sognare... Poi ‘scese’, venne, arrivò la democrazia, e l’Albania si trovò spiazzata. Non aveva esperienza. Non aveva più pazienza di costruire con calma, ave- va fame di tutto. Negli ultimi vent’anni il mio Paese ha attraversato tutte le malattie infantili e inevitabili di ogni democrazia giovane. Ha assorbito dall’Occidente le caratteristiche peggiori a scapito di quelle migliori. L’Albania di oggi è un Paese fragile, il livello di corruzione è altissimo. Il popolo è svogliato, il distacco dalla vita politica e sociale è andato approfondendosi. Gli albanesi onesti sono delusi e stanchi di sperare per- ché presi regolarmente in giro da chi li governa. Perciò hanno chiuso gli occhi. Non c’è più un sogno di un mondo migliore. Il mondo è questo, la realtà è questa... Oggigiorno il piccolo paese si trova davanti a un bivio: o decide di rafforzare le ossa e crescere, facendo buon uso delle indubbie risorse che possiede, oppure si troverà a essere definitivamente il pariah dell’Europa. A febbraio di quest’anno, lei ha scritto una lettera aperta, pubblicata da La Repubblica, al nostro premier, Silvio Berlusconi, comunicandogli la sua rabbia e sdegno per l’ennesima battuta di cattivo gusto, questa volta riferita alle “belle ragazze albanesi”. Le ha mai risposto? Quali altri ritorni ha prodotto il suo atto di accusa? Sarei stata un’ingenua se mi fossi aspettata una risposta dal premier Berlusconi – con tutte le battute che ha seminato negli anni, il Cavaliere prima di me avrebbe dovuto dare un bel po’ di risposte ad altra gente. E se lo avesse fatto sarebbe stato un gran signore. Ma ha sempre perso l’occasione. In tutta franchezza, non ho scritto la lette- _ nOn CI ImPORTA, Romeo Traversa, 1980-2009, elaborazione digitale/testo originale, colore, 200x200 cm 79 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV InTERVIsTA _ a Elvira Dones - Una libertà senza sogni ra aperta nemmeno con rabbia. L’ho fatto per una pura e semplice ragione: qualcuno doveva farlo. Il primo ministro albanese Salì Berisha, amico di Silvio Berlusconi nonché responsabile dello sfascio dell’Albania odierna, non lo ha fatto. Davanti a una battuta di pessimo gusto, Berisha, accanto a Berlusconi, ha sorriso e taciuto. Ho scritto perché le botte sulla pelle delle “belle ragazze” albanesi le ho visto con i miei occhi; perché il loro dolore l’ho raccolto, per anni. Mi sarei sentita a disagio con la mia coscienza se non l’avessi fatto. E gli effetti di quella lettera sono stati ambivalenti. Moltissimi lettori hanno espresso stima, indignazione, solidarietà. Hanno espresso partecipazione e si sono scusate, a nome del Cavaliere, anche molte persone che Berlusconi lo hanno votato, e che sanno distinguere, analizzare, di volta in volta, il modus operandi del premier. Poi, com’è normale, ci sono i soliti detrattori: «Lei signora si fa pubblicità a poco prezzo. Come si permette lei? Come ti permetti tu e il tuo Paese di pezzenti! Hai fatto i soldi sulla pelle di quelle ragazze...» È un gioco vecchio, banale, si ripeterà sempre: quando mancano gli argomenti si va all’offesa, all’attacco personale, alla calunnia. L’Italia degli ultimi mesi ne sa qualcosa, no? Nel suo documentario Cercando Brunilda, un momento che mi ha molto toccata è quello in cui legge la bellissima poesia scritta da Vassi, una ragazza albanese costretta dal fidanzato a prostituirsi sulle strade italiane. Nell’intervista che segue, Vassi dice: «Scrissi la poesia per non impazzire, per dare un senso a quella notte tanto irragionevole». La sua prima notte sulla strada. Ho pensato subito a Hana e alle sue poesie. Molti direbbero che per lei le poesie e la scrittura sono l’unico conforto, nei quattordici anni di solitudine sui monti, eppure io credo che il significato della letteratura, per Vassi come per Hana, sia più vicino all’insubordinazione. Mi _ nYARLATHOTEP_1, Romeo Traversa, 1980-2009, disegno/elaborazione digitale, colore, 200x200 cm 80 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV piacerebbe conoscere il suo punto di vista. Poco tempo fa incontrai in Texas una ragazza quindicenne. Suo padre era stato condannato a morte per un crimine che non aveva commesso. Ora l’uomo è libero, la prova del DNA l’ha scagionato. Ma sua figlia, cresciuta con il padre condannato a morte, in tutti gli ultimi anni ha scritto, ogni giorno. Aveva un dolore intenso nello sguardo, uno di quelli che ti spaccano in due. Mi disse: «Quando uno è contento e felice ride, fa le battute. La felicità sta nel bel mezzo della faccia, non c’è bisogna di nasconderla. Il dolore sì. Se uno prova dolore, lo vuole mettere da qualche parte, toglierlo dalla faccia. Allora scrive. Mette le cose giù, le mette al riparo. Io scrivo. Ho scritto. È meglio così». Il legame tra la sua attività letteraria e quella di documentarista mi appare molto stretto. Qual è il rapporto tra i due piani, quello dell’inchiesta sulla realtà oggettiva, spesso drammatica, e quello del romanzo? Sono una che racconta storie, prima di ogni cosa sono una scrittrice di narrativa. Però darei fuori di matto se non andassi là fuori a raccontare anche per immagini. Non tutte le storie di cui mi innamoro possono diventare un romanzo o un racconto breve. E poi cambiare strumento di espressione è utile anche alla narrativa pura. La ravviva, le dà forza, la nutre, le regala materiale vivo. L’inchiesta, o meglio la ricerca, mi sta molto a cuore. Prima di iniziare un documentario macino molto materiale, accumulo più che posso. Parto per le riprese solo quando sono convinta di avere fatto molto bene ‘i compiti’. Per l’inizio del 2011 è annunciata l’uscita del suo nuovo romanzo, scritto in italiano come già Vergine giurata, dal titolo: Una piccola guerra perfetta. Di che cosa parlerà? Di una guerra. Di un amore. No. Di molti amori. E dell’orrore di una guerra ‘piccola’ – in fondo i bombardamenti sul Kosovo e la Serbia durarono solo settantotto giorni. Nessun soldato occidentale perse la vita in combattimento, nella guerra del Kosovo; fu una guerra combattuta dal cielo. Ma ciò che accadde in terra fu atroce. Andai nel Kosovo pochissimo tempo dopo. Feci ritorno più volte. Fu una meticolosa raccolta di testimonianze: a casa avevo tonnellate di materiale ‘ufficiale’ dai media di mezzo mondo. Percorsi tutto il Kosovo. Donne e uomini si fi- darono, mi misero il loro cuore sul palmo della mano. Quando mi sentii pronta scrissi il libro. Sotto forma di romanzo. Elvira Dones è nata a Durazzo e cresciuta a Tirana (Albania). Nel 1988 ha lasciato il suo Paese e si è stabilita in Svizzera, dove ha scritto sette romanzi, due raccolte di racconti, alcune sceneggiature e realizzato documentari per la televisione. Dei suoi scritti, sono stati pubblicati in Italia: Senza bagagli, BESA, Lecce 1998, Sole bruciato, Feltrinelli, Milano 2001, Bianco giorno offeso, Interlinea, Novara 2004 (da cui è stato tratto il film tv Roulette di Mohammed Soudani), I mari ovunque, Interlinea, Novara 2007, e Vergine giurata (scritto in italiano) pubblicato da Feltrinelli, Milano 2007. Sposata e madre di due figli, vive ora nei sobborghi di Washington. Di prossima uscita il romanzo Una piccola guerra perfetta, per Einaudi, Torino. 81 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV a PRoPosito di... RIdeRe, obbedIRe, CombatteRe! _ di Giuseppe Ciarallo Ci sono pareri contrastanti tra coloro che sostengono la superiorità dell’uomo sulle altre specie del regno animale. Alcuni credono che questa supremazia sia data dal fatto che l’essere umano sia l’unica bestia ad avere coscienza di sé. Io sono in totale accordo con il compianto Gualtiero Schiaffino, fumettista, illustratore e fine pensatore, il quale, invece, aveva una teoria tutta sua che si può sintetizzare nell’assunto: la principale caratteristica che distingue l’uomo dagli animali non è l’intelligenza, bensì la coglioneria. Comunque la si pensi, una cosa è certa: l’uomo è l’unico animale sulla faccia della terra che abbia la capacità di ridere, di sé (poco) e degli altri (moltissimo). Nei secoli è stato dimostrato che nulla e nessuno è mai riuscito a impedire all’uomo di ridere. In tale intento, hanno fallito tanto le dittature più feroci e sanguinarie quanto i regimi religiosi più miopi e integralisti, anzi, possiamo dire che chiunque abbia provato a soffocare la sana, liberatoria risata, ha visto ritorcere contro di sé il maldestro tentativo, diventando ben presto uno zimbello, oggetto di ironia e sberleffo. Anche nei momenti più duri e bui nella vita di un uomo, la risata (che può esplodere in qualsiasi contesto e con qualsiasi stato d’animo, non ultima la disperazione) ha la funzione di valvola di sfogo, onde evitare che quella pentola a pressione che è il nostro cervello, possa giungere a tali livelli di tensione da deflagrare poi improvvisamente. Quando diciamo “c’è poco da ridere”, per sottolineare la gravità di una situazione, ci riserviamo inconsciamente la possibilità di ridere, magari poco, ma di ridere. E anche nei casi estremi, quando esclamiamo gravemente “non c’è niente da ridere”, evidentemente ci stiamo rivolgendo a qualcuno che nonostante tutto, una grassa ghignata se la sta facendo. A proposito di ciò che verrà trattato in seguito, neanche a farlo apposta esiste un’antologia di Umoristi Italiani Contemporanei, dall’eloquente titolo: Ridi poco. Anno di stampa 1943, XXI anno dell’Era Fascista (a cura di Mario Buzzichini e Enzo Ferrieri, Hoepli Editore). Da sempre l’ironia, e la sua parente più nobile, la satira, non sono altro che elementi che il popolo assume per com- 82 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV battere il veleno del potere. Oggi, invece, nel ‘mondo roverso’ nel quale ci tocca vivere, c’è chi ha voluto, non si comprende se consapevolmente o meno, rovesciare il concetto: un potente racconta a ritmo continuo barzellette, per combattere gli effetti devastanti di quella che egli ritiene una terribile malattia infettiva, e cioè la democrazia. Il nostro presidente del Consiglio, tanto per non fare nomi, per giustificare le sue quasi quotidiane gaffe in ogni contesto possibile e immaginabile, ha sempre raccomandato ai propri seguaci di diffidare delle persone che non sanno ridere, spingendosi ultimamente ancora oltre, ad affermare, rivolgendosi ai giovani del suo partito: diffidate di quelli che non sanno farvi ridere. Una persona con un minimo di cervello, merce che sembra essere sempre più rara in un Paese dimentico di essere stato la patria di sommi pensatori, risponderebbe che sono molto più pericolose le persone che non sanno essere serie, nemmeno quando le circostanze lo richiedono. Al momento siamo ancora troppo impegolati in questo pastrocchio storico-politico-istituzionale, ma probabilmente tra qualche anno il berlusconismo potrà essere sezionato e analizzato sotto ogni punto di vista, diventerà oggetto di studio e si troveranno disamine anche sull’ironia e la satira ai tempi del ‘duce formato tascabile’, come è già avvenuto per il fascismo, quello originario, con l’interessante libro Vent’anni di beffe. Le ‘barzellette’ sul fascismo durante il fascismo di Carlo Veneziani (Monte Università Parma Editore, 2006). L’autore, già nella prefazione, citando Tacito sottolinea quanto sia terribile l’arma del ridicolo. E il fascismo non seppe sottrarsi a questa esposizione al ridicolo, del tutto facilitato nel compito dalla presenza di gerarchi spesso rozzi e ignoranti il cui unico compito nella vita sembrava consistere nel compiacere in tutto e per tutto le follie egocentriche del loro capo. Come definire se non grottesca e caricaturale quella ossessione esterofoba che faceva tradurre ogni termine straniero in un italiano per forza di cose approssimativo, che faceva cambiare (sui giornali, a futura memoria) il nome del musicista di ‘musica negroide’ Louis Armstrong in Luigi Fortebraccio, quello del diretto- re d’orchestra Benny Goodman in Beniamino Bonomo e il titolo del brano jazz Saint Louis Blues in una strappalacrime versione dal titolo, però, scoppiettante, Le tristezze di San Luigi! E che dire del sabato fascista voluto da Starace, il ‘cretino ubbidiente’ come lo stesso Mussolini lo aveva definito, con frotte di panciuti gerarchi impegnati nell’irrealizzabile, per molti, tentativo di saltare attraverso un cerchio di fuoco? E poi le smorfie del duce durante i comizi, le demenziali veline del Minculpop che indirizzavano i giornali dove il regime voleva, spesso surreali come quella del 23 giugno 1943: “Il Messaggero del 20 ha pubblicato un’inserzione tra i ‘matrimoniali’ che suona così: ‘Professore ventinovenne, distintissimo, occhi bellissimi, sentimentale, sposerebbe dotata carina, anche provinciale, aiutargli a consolidare posizione’. Le espressioni occhi bellissimi ecc. sono eccessive e bisogna evitarle” (1). Da notare la data. Il fascismo si occupava di tali infinitesimali sciocchezze alla vigilia di un evento nodale della Storia, come fu lo sbarco degli americani in Sicilia che avvenne di lì a qualche giorno. Ma ridicoli erano anche i pomposi slogan, spesso riportati a caratteri cubitali sulle facciate delle case, a detur- (1) Le veline del duce. Come il Fascismo controllava la stampa, Riccardo Cassero, Sperling & Kupfer, 2004 83 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV a PRoPosito di... _ Ridere, obbedire, combattere! pare i paesaggi dei borghi contadini: NOI TIREREMO DIRITTO; MOLTI NEMICI MOLTO ONORE; BOIA CHI MOLLA!; ME NE FREGO! A proposito di queste pillole di fascistica propaganda, ho scoperto con non poco fastidio che la frase “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”, non è farina del sacco di Jake/John Belushi del film The Blues Brothers di John Landis, ma un motto coniato proprio da Benito Mussolini, o, quantomeno, a lui attribuito. Nel libro di Carlo Veneziani, che non è azzardato definire saggio antropologico, viene ripercorsa la parabola ventennale del fascismo accompagnata dalla sagace ironia popolare che ne puntualizza anno per anno, episodio per episodio, il carattere di grandezza fondato sulla menzogna, sul tenere nascoste le beghe al popolo attraverso la manipolazione della stampa (vizietto, questo, che oggi più che mai pare essere estremamente in voga): erano severamente vietati articoli che riguardassero suicidi, tragedie passionali, violenze e atti di libidine su minorenni, pornografia, incidenti ferroviari ecc. Questa totale assenza di informazione relativa a dette tematiche, è servita in seguito a far passare la convinzione che “quando c’era lui certe cose non succedevano”. Numerose le battute, i versi, le considerazioni degne di nota, riportate nella raccolta di Veneziani. Quando uno diceva che il dittatore aveva nelle sue mani tutti i ministeri, altri aggiungevano subito: è vero, ma gli manca la Giustizia, e non ha la Cultura né l’Educazione. Ma se la Storia è destinata a ripetersi e non si incontra alcuna difficoltà a trasferire le trame delle barzellette del passato alle acrobatiche evoluzioni dei politici di oggi, se basta cambiare i nomi dei protagonisti di ieri con quelli del presente per riconoscere la stessa galleria di loschi figuri, di raccomandati, di banderuole, di farabutti, viene il fondato dubbio che il potere sia sempre uguale a se stesso, che si perpetui senza variare di una virgola pur cambiando i partiti e i colori che lo rappresentano, e che alla fin fine, forse, Sul tavolino di un caffè di via Veneto, un rimatore scrisse: passa il Gran Segretario / ed il pubblico vario / guarda il cavallo al trotto / chiedendo: “Val di più / la bestia che sta sotto / o quella che sta su?” Quando a segretario del partito venne nominato Ettore Muti, costui spedì subito il dispaccio d’obbligo: Duce, ai vostri ordini assolverò la mia carica in modo che gli italiani siano tutti come voi li volete. Muti. Ce n’è una, poi, che mi è piaciuta particolarmente in quanto ha un triste rimando all’oggi, con il vizietto di un certo governante di voler accentrare su di sé ministeri, poteri e decisioni varie, con gli stessi risultati del suo predecessore. 84 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV non aveva tutti i torti quell’anima candida di Fabrizio De André nel sostenere che “non esistono poteri buoni”. In un regime dispotico, la satira deve giocare a nascondino, deve assottigliarsi e farsi fine, per passare attraverso le _ NYARLATHOTEP_1.1, Romeo Traversa,1980-2009 disegno/elaborazione digitale, colore, 200x200 cm maglie sempre più fitte della censura. E deve combattere anche contro il nemico più subdolo, e cioè l’ambigua tesi secondo la quale se la satira può essere espressa liberamente vuol dire che il potere non è dispotico (e di conseguenza non dovrebbe essere bersaglio della satira stessa). Ed è tra le maglie strettissime della censura fascista che si insinua la scrittura di un autentico fuoriclasse della satira quale era il purtroppo dimenticato Anton Germano Rossi. Rossi è uno scrittore all’avanguardia, nel senso che è avanti di un secolo rispetto ai codici espressivi e alle tematiche della sua epoca, ha una scrittura ipersurreale, crea mondi spiazzanti e personaggi che disorientano il lettore, elegge il cinismo e la cattiveria a pura normalità. Nei suoi racconti trovano spazio tutte le azioni scorrette che ognuno di noi vorrebbe commettere almeno una volta nella vita, ma che ci vengono impedite dalle convenzioni morali e sociali che ci rendono parte del consorzio civile. Rossi è il precursore del politically incorrect quando questo termine non era ancora stato coniato né pensato da mente umana. Nella sua raccolta di ‘contronovelle’ dall’assurdo titolo Porco qui! Porco là! (Edizioni Corbaccio, 1934), l’autore prende in giro i fanti ma anche i santi (nel racconto Crisi di mendicanti, il sant’uomo lamenta lo scarso numero di ammalati disposti a farsi confortare e le eccessive pretese di denaro che questi hanno, forti “dell’offerta superiore alla domanda”), non ha remore nemmeno di fronte agli handicap fisici, argomento che in seguito, secondo la moderna in85 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV a PRoPosito di... _ Ridere, obbedire, combattere! terpretazione della satira, sarebbe diventata una delle cinque tematiche tabù insieme a religione, capo dello Stato, razzismo e omosessualità. Ignorando bellamente ogni tipo di freno etico, e immergendo la narrazione nel paradosso più estremo, troviamo vecchi paralitici malmenati, anziani signori scaraventati dai finestrini di un autobus o dalle finestre di un palazzo tra il grande divertimento degli altri passeggeri o dei vicini di casa, formose signore che si sentono fare proposte oscene per aver chiesto l’ora a un passante. Sono le situazioni assurde create dall’autore, però, che rendono lieve e piacevole la narrazione di azioni che altrimenti riterremmo inaccettabili. Ma a rendere unico e prezioso il libro Porco qui! Porco là! è il capitolo finale, dal titolo Il prode capitano o L’arte della guerra, diviso in tredici giornate. Qui Rossi si supera, la guerra diventa un gioco stupido giocato da bambini stupidi, che fanno dispetti, che replicano permalosi agli scherzi altrui, che perdono le armi per poi ritrovarle nei posti più impensati, e il linguaggio roboante che abbiamo imparato a conoscere dai cinegiornali Luce dell’epoca, viene ridicolizzato da queste situazioni stralunate e grottesche all’estrema potenza. Mi piace pensare che Bonvi, il grande fumettista autore delle Sturmtruppen, si sia abbondantemente ispirato alle novelle di Rossi per le avventure dei suoi piccoli soldati dell’esercito tedesco, il cui mito è stato annullato e ridicolizzato dalle loro azioni e dai loro dialoghi strampalati. Un piccolo saggio della follia visionaria di Rossi, in alcuni frammenti della prima giornata de Il prode capitano o L’arte della guerra. «Chi è lei? Cosa vuole?» gridò ad un tratto il prode capitano ad un vecchio fuciliere che passava. «Buon giorno» disse il vecchio fuciliere «io sono il nemico: devo andare avanti con alcuni amici a conquistare quella collina». «Non si può!» ribatté il prode capitano. «Per conquistare quella collina bisogna passare sul corpo dei miei vecchi granatieri». «Li lasci andare» suggerì il vecchio granatiere «e la finisca con questa storia di farci sempre passare il nemico sul nostro corpo. In un 86 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV conti di Rossi suonavano come una sonora pernacchia nei confronti delle tronfie parole della propaganda. Fu solo grazie alle atmosfere surreali in cui i militari di Rossi si muovevano con finto (artefatto) candore, che probabilmente venne risparmiata all’autore l’infamante accusa di disfattismo e la conseguente pena che tale tipologia di reato prevedeva. Un consiglio per chi volesse accostarsi alla lettura di Porco qui! Porco là!: un’ottima colonna sonora, perfettamente intonata alla prosa di Anton Germano Rossi, è il disco Mezzacoda nel quale un Paolo Poli particolarmente ispirato, accompagnato al pianoforte da Jacqueline Perrotin, ripercorre in una corposa carrellata di successi, la canzone italiana dall’inizio del Novecento agli anni ’50. Naturalmente i brani in cui l’attore sfoggia con maggior enfasi la sua affilata ironia, sono quelli patriottardi, bellicisti, colonialisti del periodo fascista. Eia, eia… ma va là! mese, per gusto suo son ridotto che non mi posso chinare tanto son pieno di dolori». «Attenzione!» gridò il prode capitano «viene il nemico». «Senta» disse il vecchio granatiere «non è per me, ma queste cose vanno dette gradatamente: ci sono dei malati di cuore». «Sparate il cannone!» gridò il prode capitano. «È una parola!» disse il vecchio artigliere. «L’hanno mandato senza istruzioni». «Oggi» gridò il prode capitano «ci copriremo di alloro». «Tutti i gusti sono gusti» commentò seccato il vecchio granatiere «ma con questa storia di coprirci di alloro, uno la sera si ritrova tante foglioline nel colletto». «Senta» disse un vecchio caporale «sono andato a vedere se si potevano passare le linee del nemico». «Bravo!» disse il prode capitano. «Non si può sa…» continuò il vecchio caporale «c’è un cartello su cui è scritto ch’è vietato il passaggio». «Maledizione!» urlò il prode capitano. «C’è scritto:» disse il vecchio caporale «Vietato l’ingresso al nemico. Multa di dieci lire ai contravventori. Se andiamo, spendiamo un capitale!» «Che roba!» concluse il prode capitano con amarezza «domando e dico se si può fare la guerra a questo modo!» La particolarità di questo libro di Anton Germano Rossi è data dal fatto che la prima edizione è datata 15 settembre 1934, XII, e cioè in piena preparazione dell’azione bellica che fissava l’obiettivo della ‘conquista totale dell’Etiopia’ che avrebbe avuto inizio di lì a qualche mese. In un momento storico in cui il regime cercava di instillare nella popolazione italiana, soprattutto nei giovani, lo spirito indomito e battagliero necessario alla pugna, i rac- 87 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV sotto i Ri(F)LEttoRi di Sabrina Campolongo Facendo Finta di annegare recensione de la cascata, Margaret Drable Non è facile immaginare in quali territori possa avventurarsi oggi la narrativa femminile, per poter essere considerata sovversiva. Specialmente per noi, lettori italiani sommersi da uno stuolo di lolite letterarie, sempre più giovani e sempre più ciniche, spogliate anche di quell’aura di grazia dolente che Nabokov regala alla sua bambina perversa, volgare e superficiale, ma anche fragile e sola. Tra presunte confessioni di cubiste dodicenni e prose ‘realiste’ che narrano di adolescenti che usano il proprio corpo per sfuggire al grigio della periferia industriale, che cosa avrebbe l’energia ancora, oggigiorno, di épater la bourgeoisie? Forse, a ben pensarci, le scrittrici contemporanee non sono andate molto avanti, se pensiamo che Erica Jong scriveva già di sesso ‘come un uomo’ all’inizio degli anni Settanta, che, anzi, faceva molto di più: scriveva di sesso come una donna, ma con la spregiudicatezza di un uomo. Osava dipingere la sua eroina, la memorabile Isadora Wing, con un vorace appetito sessuale, un sagace intelletto, un preciso ri88 Paginauno no 17 · aprile /maggio 2010 · anno IV fiuto verso gli eccessi igienici e nessun imbarazzo a fare l’amore anche in pieno ciclo mestruale. Eppure, nemmeno la scandalosa Jong osò infrangere apertamente il più granitico dei tabù riguardo il corpo femminile: la sacrosanta dicotomia madre/puttana. Da qui la sorpresa scoprendo che, già nel 1969, Margaret Drabble, scrittrice inglese figlia di un giudice e di un’insegnante, aveva osato aprire il suo romanzo La cascata con l’immagine di una puerpera che, nel letto in cui ha appena partorito, ancora caldo e umido dei liquidi del parto, suscita una feroce attrazione erotica in un uomo quasi estraneo, più precisamente, il marito di sua cugina. Basterebbe questo a consigliarne la lettura. Come se non bastasse, la passione è tutt’altro che univoca. Jane, questo il nome dell’eroina, dopo essere stata abbandonata dal marito (o dopo averlo spinto ad abdicare, più correttamente, dopo un matrimonio disastroso e quasi asessuato, nonostante la nascita di due figli) non teme di corrispondere con trasporto la passione di James, il marito di colei che potrebbe definirsi la sua sola amica: la risposta è un definitivo sì allorché, in una delle scene d’amore più originali che io abbia mai letto, James le chiede, con l’urgenza di chi non potrebbe sopportare un rifiuto, di potersi accoccolare nel tepore del suo letto, vicino al suo corpo ancora scosso dagli spasmi uterini del dopo-parto, alla ricerca di un contatto che più erotico non si può, nonostante, per ovvie ragioni, non osi fare di più che guardarla dormire respirando il suo umanissimo odore (la voce narrante non trascura di informarci, en passant, che Jane non ha ancora avuto modo di lavarsi i capelli, dopo il parto). Ma ecco che un secondo colpo di scena ci attende subito dietro l’angolo, quando la solitaria eroina, fino a quel momento inquadrata dall’occhio benevolo di un narratore esterno, decide di prendere la parola, esordendo con un: “Naturalmente non andrà. Come resoconto, cioè, dei fatti”. Per poi informarci che la narrazione, per forza di cose, non potrà restituire un quadro veritiero della situazione e che lei stessa, narratrice/personag- gio, pur alternando il punto di vista dall’interno all’esterno della storia, finirà per scodellarci un sacco di bugie. La più importante di queste menzogne, scopriremo con il procedere del racconto, è indubbiamente quella di rappresentarsi come una donna patologicamente fragile, ammalata di passività, travolta e sommersa (la narrazione procede per una serie di metafore acquatiche) da questo amore e in generale dal suo destino, incapace di salvarsi, trasportata dalla corrente verso lo spaventoso abisso che l’attende alla fine del viaggio. Ma ci sarà davvero, laggiù, il precipizio? Molti sono, in effetti, gli elementi che sembrano custodire cupi presagi, primo fra tutti la luce, quasi ultraterrena, che trafila dal rapporto tra i protagonisti: raramente storia d’amo- _ La cascata, Margaret Drable, Luciana Tufani Editrice, 2000 89 Paginauno no 17 · aprile /maggio 2010 · anno IV sotto i Ri(F)LEttoRi re in un romanzo fu meno affollata di ombre, soprattutto riflettendo sul fatto che entrambi i protagonisti sono sposati, che Jane è madre di due figli piccoli, che James viene descritto come un padre e un marito attento (ma questo non sembra vietargli di passare svariate notti fuori casa), che Jane descrive se stessa come estremamente problematica, inadatta alla vita… Eppure non c’è la minima tensione tra loro, tutto scorre placido, la delicatezza tra i due è commovente, il rapporto con i piccoli perfetto, troppo bello per durare, direbbe anche il lettore meno cinico. Ci si aspetterebbe la tragedia alla fine della corsa anche se la narratrice/ protagonista non ci informasse delle abitudini estremamente pericolose di James, della sua guida spericolata, del fatto che non si presenti al lavoro e dei suoi debiti, anche se non facesse continui riferimenti a eroine tragiche come Maggie Tulliver di The mill on the floss di George Eliot, che finisce con il morire annegata, dopo essere stata accusata di avere rubato l’uomo all’adorata cugina (Lucy, non a caso lo stesso nome della cugina di Jane). Il presentimento funesto si fa più concreto quando James propone all’agorafobica Jane un viaggio in macchina fino in Norvegia, viaggio che, pur con prevedibili riserve, la sventurata accetta. Ed eccoli, i due amanti, correre, felici e inconsapevoli, verso l’incidente che il lettore si attende con pragmatica certezza. La prosa si fa elegiaca, quasi che Jane stesse preparando il suo commiato, quando un nuovo ribaltamen90 Paginauno no 17 · aprile /maggio 2010 · anno IV to dei canoni – quelli del romanzo sentimentale romantico, preso a modello e deformato abilmente lungo tutta la narrazione – porterà la storia fuori dai binari del prevedibile. Proprio la non-spettacolarità del finale, la sua apparente piattezza, le parole di ridimensionamento che la narratrice/protagonista dedica alla sua esperienza, ne fanno una storia “quietamente sovversiva” come la definisce Eleanor Honig Skoller. Ed è con un sorriso compiaciuto che dobbiamo accettare che l’autrice ci abbia ingannato, che il tono della narrazione si sia rivelato tanto più fuorviante quanto più appariva realistico, che raramente o mai sia stato conforme a quello che stava esprimendo. Rimuginando sulla propria educazione, per esempio, Jane si attribuisce la colpa di non aver mai imparato a distinguere “tra la falsità resa vera dalla passione e la verità resa falsa dalla doppiezza”. A titolo di esempio, continua: “Non è quello che indossi che conta, è quello che sei, diceva virtuosa mia madre, valutando con gli occhi il tessuto e il taglio dell’abito delle sue amicizie, e soavemente basando le sue pretese sociali e la voglia di inviti su queste conclusioni”. Soavemente, proprio come la narratrice smaschera, con chiarezza e senza indulgenza alcuna, l’ipocrisia materna e la meschinità del milieu borghese nel quale è stata cresciuta. Per contro, quel destino in agguato a cui Jane dichiara di non potersi ribellare “se sola, anche da sola, andando sotto, sprofondando, in silenzio, lei avrebbe rifiutato il ramo provvidenziale e non avrebbe cercato di raggiungere la salvezza della riva”, si manterrà a distanza di sicurezza sia dal tragico che dal meraviglioso. Nessun dramma e l’ennesimo inganno, invece. Perché Jane si salva eccome, e, a ben pensarci, in ogni momento della storia compie esattamente le scelte che la porteranno o la tratterranno in salvo; il suo essere “inadatta alla vita” si concretizza, in pratica, con una scarsa propensione verso le faccende domestiche, una sorta di passività – che in verità più che intralciarla le viene spesso comoda – e una moderata agorafobia. Se Jane dipinge se stessa come un essere così fragile è forse, allora, semplicemente perché vuole farci intendere che una donna con una sensibilità artistica, una donna sola con due bambini piccoli, una donna abbandonata dal marito con cui non ha mai avuto una vera intesa emotiva e sessuale, una donna cresciuta nell’algido tempio dell’ipocrisia borghese, abbeverandosi per tutta al vita alla fonte di Shelley, Wordsworth e Keats, di Jane Austen, delle sorelle Bronte e di George Eliot, non possa che essere un’eroina fragile, tragica, sballottata dalla corrente. I fatti invece raccontano una storia ben diversa. L’incontro con James ‘salverà’ Jane, non per via delle particolari doti del suo amante, quanto grazie alla determinazione con cui deciderà di averlo, alla forza con cui vorrà prenderselo, passando soavemente sopra ogni genere di scrupolo morale. Mentre ci dice di non poter fare a meno di lui, di essere dipendente in modo ossessivo da questo amore, Jane sta tessendo, imperturbabile, con ogni mezzo a sua disposizione, un bozzolo d’acciaio attorno a James. Il quale, non dimentichiamolo, non sembra avere alcuna intenzione di lasciarla. In fin dei conti, Jane potrebbe tranquillamente dirsi perfettamente felice: è amata, accudita, coccolata, rassicurata, non deve pensare a quasi nulla, ha trovato un nuovo padre part-time per i suoi figli, e, quel che è interessante, non esprime mai il desiderio che diventi full-time. Come si dimostrerà nel finale, la condizione di amante, con la libertà relativa, calza a Jane a pennello. Il sogno romantico non è il suo. Non si immagini però La cascata come una parodia del manicheismo romantico. Se lo è, almeno in parte, l’ironia è così sottile, il confine tra quello che è e quello che si vorrebbe far credere, tra realismo e mistificazione, è così mobile, che si potrebbe leggerlo tutto senza porsi il problema, accettando l’incongruenza come l’essenza stessa della storia, prendendo Jane sul serio. Non sorprende, infatti, che l’ultima frase del romanzo – “Preferisco soffrire, credo” – abbia fatto infuriare alcune femministe, quando quell’ultima parola dopo la virgola, credo, (detto da una che si è appena salvata la vita) avrebbe dovuto farle sorridere. 91 Paginauno no 17 · aprile /maggio 2010 · anno IV In LIBRERIA narrativa A quattro anni dalla caduta del Muro, le installazioni militari nel Triveneto sono ancora un necessario baluardo contro i nemici dell’ex Patto di Varsavia e il fronte di guerra balcanico che minaccia di travolgere il nuovo assetto geopolitico occidentale. Quando l’esplosione di una polveriera sul confine italo-sloveno riduce l’ufficiale Anselmo Manca in fin di vita, il professore Lampis, ordinario di antropo- logia all’università di Trieste e suo tutore accademico, inizia a pensare che i quaderni dell’allievo, sequestrati dalla procura, celino qualcosa di più di una semplice “parata militare di buoni sentimenti”. Aiutato dall’assistente, l’antropologo scava nella vita di Manca, e finisce in un inghiottitoio carsico di armamenti militari, imprenditori di scorie e interstizi, zingari che s’intendono d’artiglieria e ufficiali che se la intendono con la retrovia. Giulio Angioni traccia i vertici di un ideale triangolo che dalla Soglia di Gorizia alla regione serba della Vojvodina, passando per la discarica-imbuto di Repen, racchiude una monade di micro conflitti narrati con uno stile aforistico che dà al lettore un’unica, socratica certezza: “La verità non è soltanto il credito che una notizia si guadagna. Spesso è meno, è solo ciò che i tempi possono accettare”. (G. Caputi) GaBBiani sUl Carso, Giulio Angioni, Sellerio, 437 pagg., 14,00 euro In LIBRERIA saggistica La vecchia sulla porta si è perduta, schiantata, un giorno affatto speciale, dall’insostenibile leggerezza dell’esistenza. Il ragazzo condannato a vivere per cent’anni per fortuna ereditaria, decide di spezzare la linea già tracciata, sfidando Dio o il destino, di certo la famiglia. L’anziano professore omosessuale sceglie di morire doppiamente trafitto da un giovane sfrontato, piuttosto che continuare a chiedere perdono ai preti di tutte le sue voglie. E poi c’è Maddalenina che nessuno vuole, che si è intromessa ancora in embrione tra la madre e il suo lutto per il marito morto troppo presto. Nata per forza, nonostante tutti i tentativi di sbarazzarsi di lei e caparbiamente venuta su, sorda al primo “vattene” dalla bocca materna, come a tutti quelli che verranno. Scacciata come un cane eppure non più infelice degli altri, spettacolo tanto più osceno per quelli che hanno scelto di non vederla quando qualcosa si sarebbe potuto salvare, Maddalenina vive, soprattutto da quando deciderà, a cin- quant’anni suonati, di scriversi da sola l’amore che vuole, fino al (in)naturale epilogo della maternità. Una favola perversa e poetica sul potere salvifico del narrare, contro l’indifferenza assassina. (S. Campolongo) mia fiGlia follia, Savina Dolores Massa, Il Maestrale, 192 pagg., 16,00 euro 92 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV Se il proletariato non esiste quasi più, schiacciato e umiliato da un capitalismo liberista sempre più selvaggio e miope, il sottoproletariato, inteso come classe emarginata delle opulente società occidentali, è invece più vivo e vegeto che mai. Quel sottoproletariato urbano fatto di schiere di disperati convinti di vivere una vita vera facendo propri i modelli imposti da media spietati, vero braccio armato di quel capitalismo cialtrone poc’anzi citato. I protagonisti dei racconti disperati sono loro, i tossicomani, gli usurai, i travestiti sovrappeso, i rapinatori, i sognatori, le ragazze senza speranza condannate alle vite fallite delle loro madri. L’inchiostro sulle pagine pulsa e ribolle come il sangue di questa umanità caparbiamente impegnata a farsi del male, a dare e a darsi dolore. Una cosa è certa, Peppe Lanzetta ogni volta che impugna (o è più consono dire brandisce?) la penna per scrivere della sua Napoli, scaraventa in malo modo il lettore in un ‘basso’, a stretto contatto con quella monnezza, materiale e morale, che ricopre e cela da sempre l’anima di una città infinitamente capace e al contempo bisognosa di amore. (G. Ciarallo) raCConti disperati, Peppe Lanzetta, Tullio Pironti Editore, 134 pagg., 12,00 euro Nel 1995 il presidente Scalfaro dà il via all’operazione Coscienza pulita e gli italiani scoprono che dal ’93 un impianto militare a Civitavecchia sta neutralizzando tonnellate di armi chimiche risalenti al Ventennio e rimaste nascoste in depositi segreti disseminati lungo lo Stivale. L’operazione durerà fino al 2015: si tratta infatti di smantellare quello che nel ’41 era uno dei maggiori arsenali chimici del mondo: i gas letali utilizzati in Libia nel ’27 e in Etiopia nel ’36. Ma ciò che Scalfaro non dice è che la produzione di iprite, fosgene, di miscele di arsenico, non ha prodotto solo armi: gli scarti tossici della lavorazione hanno inquinato terreni, falde acquifere e fiumi, seminando, dal dopoguerra a oggi, tumori e morti. I dati inquietano. Dalla Lombardia alla Puglia, le aree delle industrie chimiche smantellate e mai bonificate sono ormai zone residenziali; in Abruzzo c’è la più grande discarica clandestina d’Europa, che nasconde 240mila metri cubi di rifiuti tossici; nel mare di Napoli e del Gargano giacciono migliaia di testate inesplose, armate con gas letali. Sessant’anni di interessi politici, militari e industriali sepolti dai silenzi di Stato, e che Di Feo porta alla luce scavando negli archivi britannici, americani e tedeschi. (G. Cracco) Veleni di stato, Gianluca Di Feo, Bur Rizzoli, 254 pagg., 10,50 euro Dall’accurata raccolta di scritti e interviste messa insieme da M.L. Bernadac e H.U. Obrist, emerge il ritratto spietatamente coerente (non ci si lasci depistare dal piacere dell’intervistata nel mescolare le carte) di una grande artista e del suo lavoro, vita e arte così intimamente legate da farle affermare: “Il mio corpo è la mia scultura”. Pur nell’insofferenza verso la teorizzazione, Louise Bourgeois non si risparmia, regalandoci la sua visione adamantina di un’arte incorruttibile, centrata sulla ricerca, legata all’inconscio e sganciata dal potere, dai salotti e dalle scuole. Libera anche dall’appartenenza di genere. “Non esiste un’estetica femminista. Assolutamente no! Esiste un contenuto psicologico. Ma non lavoro come lavoro perché sono una donna. È per le esperienze che ho attraversato. Le donne non si sono unite perché avevano qualcosa in comune, ma perché a tutte mancava qualcosa – erano trattate tutte nello stesso modo”. Prima che si affermi un aspetto stilistico comune alle donne artiste “le donne dovranno dimenticare il loro desiderio di compiacere la struttura del potere maschile”. E, rispetto a questa necessaria indifferenza, Bourgeois, che mai accettò la definizione di femminista, si dimostra, di gran lunga, più avanti del suo tempo. (S. Campolongo) In questo libro l’autore mette a confronto, in forma d’intervista, le esperienze nella guerra civile spagnola di due giovani schierati sui fronti opposti: l’antifascista svizzero Eolo Morenzoni, volontario a sedici anni, fuggito di casa per combattere per la causa repubblicana, e il fascista italiano Dario Ferri (pseudonimo utilizzato per l’indisponibilità dell’interessato a rivelare la propria identità), legionario di Cristo inquadrato nella Divisione ‘Dio lo vuole’, partito per la Spagna a difesa della cristianità. Nelle parole dei due, oramai anziani, ci sono le attese, le speranze e le delusioni dei ragazzi che furono e l’entusiasmo che li spinse all’esperienza devastante della guerra, uno mosso dalla ricerca di uguaglianza e giustizia sociale, l’altro dal desiderio di affermare armi in pugno il concetto di Dio, Patria e Famiglia. Il volume è corredato da interessanti documenti d’epoca (ritagli di giornale di avverso schieramento, volantini, atti giudiziari, schede segnaletiche) che il lettore, munito di una buona lente d’ingrandimento, può leggere e confrontare con i passi del racconto autobiografico dei protagonisti. (G. Ciarallo) terUel-malaGa 1936-1939, Massimo De Lorenzi, Edizioni Arterigere, 184 pagg., 14,00 euro distrUzione del padre. riCostrUzione del padre, Louise Bourgeois, Scritti e interviste, Quodlibet, 444 pagg., 32,00 euro 93 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV LE InsOLITE nOTE DI AUGUSTO Q. BRUNI SEMPRE TRA NOI John Winston Lennon Liverpool, 9 ottobre 1940 – New York, 8 dicembre 1980 James Marshall “Jimi” Hendrix Seattle, 27 novembre 1942 – Londra, 18 settembre 1970 Miles Dewey Davis III Alton, 26 maggio 1926 – Santa Monica, 28 settembre 1991 In somma, tra il 18 settembre e l’8 dicembre appena trascorso ci sono state ben tre – dico tre – consecutive ricorrenze funebri che mi hanno pressoché steso. Voglio dire, è pur vero che l’arte rimane e le persone prima o poi se ne vanno, ma non capita tutti i giorni di percepire nettamente che tre pilastri della musica pop, rock e jazz se ne sono andati e che – soprattutto – all’apparenza, non c’è quasi nessuno che abbia compiutamente raccolto il loro messaggio. Più ancora mi colpisce che tutti e tre questi giganti della musica abbiano qualcosa in comune che va al di là del semplice intersecarsi di frequentazioni e apparizioni più e meno pubbliche. Visto che poi in Italia un bel dossier non si nega a nessuno, ecco qua una serie di considerazioni e ipotesi che qualcuno potrebbe usare per un bel libro di fiction prossimo venturo. Tutti e tre i grandi uomini hanno avuto alle spalle – come afferma il proverbio – una grande donna. Yoko Ono, checché ne pensino i fan più sciocchi del defunto Beatle, ha avuto il grosso merito di aver fatto diventare adulto il suo compagno. La musica di Lennon fuo94 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV ri dai Beatles è finalmente sua e, semmai, anche di Yoko per le parole. Soprattutto, finalmente Lennon parla da adulto di cose da adulti come la guerra e la pace. Tutta la sua presa di coscienza non sarebbe probabilmente mai andata tanto a fondo senza Yoko: “Imagine there’s no countries / it isn’t hard to do. / Nothing to kill or die for / and no religion too”. Immagina che non esistano le nazioni / non è difficile. / Niente per cui uccidere o morire / e anche nessuna religione. Al di là dell’essere, grazie ai Beatles, un’icona pubblica, ma proprio grazie a tale circostanza, tutto ciò che Lennon intraprende finisce sulla bocca di tutti, ma con contenuti diversi (se dio vuole). Nascono collaborazioni ad altissimo livello. Una di queste è l’esibizione dal vivo nel marzo 1972 a New York della Plastic Ono Band con Frank Zappa e le Mothers of Invention. Il concerto trova posto sul successivo album solista di Lennon, Some Time in New York City del 1972, che ha un’impostazione chiaramente politica. Il disco, che ebbe ottimi riscontri di vendite in Gran Bretagna e pessimi negli Stati Uniti, si avvaleva di prestigiose collaborazioni; alle incisioni del lato 95 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV LE InsOLITE nOTE 3, per esempio, registrato dal vivo al Lyceum londinese, parteciparono Eric Clapton e George Harrison alla chitarra, Billy Preston e Nicky Hopkins alle tastiere, Klaus Voormann al basso, Keith Moon e Jim Gordon alla batteria. Altre collaborazioni prestigiose e stretti rapporti amichevoli Lennon li ebbe col giovane David Bowie e con Elton John (padrino di suo figlio Sean). Una leggenda metropolitana che mi piace alimentare è quella della partecipazione di Lennon come corista al doppio album inciso da Jimi Hendrix dal vivo alla BBC inglese (edito dalla MCA Records il 2 giugno 1998: contiene tracce recuperate da svariate incisioni in programmi come Saturday Club e Top Gear, tracce registrate nel 1967). La leggenda viene alimentata dalle note di copertina che sul classico Day Tripper commentano: “Who is that singing with him? One can only IMAGINE”… Gli evemeristi di turno si sono scervellati a dimostrare che no, non era possibile, tutt’al più era vero che Hendrix e i Beatles, così come altra gente del calibro di Roy Wood, Trevor Burton, Grahm Nash, s’erano incontrati a Londra per una birra al Bag O’Nails – a tali incontri partecipò anche Noel Redding, bassista di Hendrix, che in più di un’intervista (come in quella rilasciata prima di morire [1]) afferma di essere stato lui a imitare alla meno peggio Lennon nella registrazione di Day Tripper. Hendrix ha anch’egli avuto la sua musa ispiratrice al pari di Lennon, ma l’ispirazione (per quanto ne sappiamo) non s’è trasmutata anche in una grande storia d’amore. Tra il 1966 e il 1968, a New York, avviene l’incontro tra Hendrix e la giovane e bellissima modella Betty Mabry. Betty, nelle parole di Carlos Santana, suo amico anche sulla scena, “è stata la prima Madonna, ma Madonna al paragone con lei era come Donny Osmond” (zuccheroso e soprattutto casto cantante pop per adolescenti). Libera, nel lavoro come verso il sesso e il denaro, Betty era una forza della natura. Quando nel 1967 conosce Miles Davis ha solo 23 anni e lui ben 41: Davis è già (1) http://www.me.umn.edu/~kgeisler/noelint.html 96 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV prigioniero dell’incredibile successo dell’album Kind of Blue (1959) nel senso che pur rivoluzionario per i tempi, quello stesso album l’ha incasellato in una capsula piena di ragnatele agli occhi delle giovani generazioni cresciute col rock’n roll. Betty non solo lo fa innamorare perdutamente e lo spreme sessualmente, ma lo riveste da capo a piedi con pantaloni di cuoio sciarpe e camicie psichedeliche, buttando a mare i seriosi completi da rispettabile uomo bianco. Soprattutto, lo introduce al nuovo mondo afro-americano in cui si parla di Black Panthers, Vietnam e rivoluzione sessuale. Grazie a Betty – che sposerà nel settembre 1968 – Davis conosce il re del funk d’avanguardia Sly Stone, il suo padrino James Brown e soprattutto Jimi Hendrix. Il grande feeling tra i due si traduce in numerose session in cui Davis, per nulla preoccupato del fatto che Hendrix non sapesse leggere la musica, si affida soprattutto allo straordinario orecchio musicale del chitarrista, a cui piaceva molto Kind of Blue; gli spiega materialmente come fa a suonare un certo brano, gli fa ascoltare un disco suo o di Coltrane e lo commenta. Così, afferma Davis nella sua autobiografia del 1989: “Lui cominciava a incorporare le cose che gli avevo detto nei suoi album. Era grande. Lui ha influenzato me e io lui ed è così che è sempre fatta la grande musica. Ognuno mostra qualcosa a qualcun altro e poi ci si muove da quel punto in avanti”. La stretta collaborazione tra i due non venne incrinata nemmeno dalla gelosia di Davis, che accusò la compagna di avere avuto una relazione proprio con Hendrix (cosa che Betty sino a oggi ha sempre recisamente negato), chiedendo per tale ragione il divorzio nel 1969. L’impronta di Betty resterà per sempre nella copertina di Filles de Kilimanjaro e nel brano Mademoiselle Mabry, così come nel titolo dello straordinario Bitches Brew (suggerito proprio da Betty al posto del più serioso Witches Brew), l’album che più di ogni altro ha segnato il confine tra un certo jazz e quello successivo che non aveva paura di sporcarsi, dialogando e magari misurandosi con il rock. Quello che sappiamo è che il dialogo tra Hendrix e Davis divenne sempre più fitto. Da una clandestina jam 97 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV LE InsOLITE nOTE session del 1969 con John McLaughlin, Dave Holland e Buddy Miles, a una seduta di registrazione vera e propria in cui Hendrix e Davis avrebbero suonato materiale composto da Gil Evans, saltata, a quanto pare, perché sia Davis che il suo batterista Tony Williams si erano lamentati dello scarso compenso loro offerto. Nonostante questo, Hendrix andò avanti: avrebbero dovuto incontrarsi a Londra, dopo le reciproche esibizioni al festival dell’Isola di Wight (rispettivamente il 29 e il 30 agosto 1970), per parlare del disco da incidere assieme. Ma l’incontro saltò. Fu programmato un altro incontro a New York, per la seconda metà di settembre, ma il 18 settembre Jimi fu trovato morto a Londra in una stanza d’albergo. Davis, per la prima volta in vita sua, partecipò a un funerale, dicono, col cuore spezzato, commentando: “I wish I’d had a chance to play with Jimi. But that’s okay – he’s playing with Coltrane now…” (avrei voluto avere la possibilità di suonare con Jimi. Ma va bene così – adesso sta suonando con Coltrane…). Ora, al di là della bella e puntuale ricostruzione che fa della storia Gianfranco Salvatore nel suo Lo Sciamano Elettrico (Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2007), e al di là delle voci insistenti che vogliono credere a tutti i costi che esista davvero da qualche parte una registrazione con Miles e Jimi – sarebbe ancora oggi il disco del secolo, se esistesse – io sono più pragmatico e provo sempre a chiudere gli occhi e a mescolarmi in testa grappoli di note della tromba di Miles con scale vertiginose di Jimi. Ultimamente ho provato a metterci sopra anche dei coretti isterici di John Lennon e Betty Mabry, anche se il risultato non mi convince… L’altra notte sono stato premiato. Qualcuno, più abile (e meno pigro) di me ha realizzato a beneficio nostro un mash-up con Miles e Jimi (2). Ascoltatelo e ditemi se non avrebbe potuto veramente andare così… prometto d’impegnarmi e metterci su le voci degli altri due. (2) http://mmedia.kataweb.it/video-utente/262165/miles-davis-jimihendrix-live 98 Paginauno no 20 · dicembre 2010 / gennaio 2011 · anno IV PagInaUNO - bimestrale di analisi politica, cultura e letteratura - aNNO IV - N. 20 - DIcEmbRE 2010 / gENNaIO 2011 paginauno bimestrale di analisi politica, cultura e letteratura Restituzione pRospettica Il romanzo mai scritto sugli anni Novanta (5ª parte) Fallimento delle Leghe del sud e appoggio a Forza Italia di Walter G. pozzi polemos Profitti da debito pubblico Manovre speculative e mancata redistribuzione di Giovanna cracco Piccole bombe nucleari crescono La fusione fredda e le nuove mini-armi atomiche di emilio Del Giudice inchiesta Iraq: l’asta petrolifera e la sconfitta delle Oil company americane di Fabio Damen DuRa lex Le fondazioni bancarie: il furto pubblico del no profit privato di Giovanna Baer inteRvista Elvira Dones. Una libertà senza sogni di sabrina campolongo a pRoposito Di... Ridere, obbedire, combattere! di Giuseppe ciarallo Filo-loGico Storia e geografia della colpa di Felice accame veRità al tempo Della moviola Premi Nobel à la carte di Davide pinardi 8,00 euro anno iv - numero 20 - dicembre 2010/gennaio 2011 - www.rivistapaginauno.it
Scarica