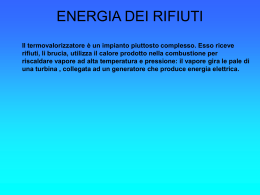A.B.A.P. Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi Ecosistema città: biotopi e biocenosi urbane Gestione ecologica dei sistemi urbani e delle trasformazioni connesse Gestione integrata dei rifiuti Gestione integrata del ciclo dell'acqua Dott.ssa Elvira Tarsitano 1 Indice 3. Ecosistema città: biotopi e biocenosi urbane 3.1 Introduzione 3.2 Ecosistema città: ecosistema artificiale 3.3 Bibliografia 4. Gestione ecologica dei sistemi urbani e delle trasformazioni connesse 4.1 Introduzione 4.2 La pianificazione integrata/partecipata 4.3 Significato dello sviluppo ecosistemico del territorio. Proposta di un modello innovativo di gestione integrata/partecipata di economia, ambiente e cultura della città 4.4 Ciclo dell’acqua, dell’aria e dei rifiuti 4.4a Ciclo dell’acqua 4.4b Ciclo dei rifiuti 4.4c Ciclo dell’aria 4.5 Bibliografia 5.7 Gestione integrata dei rifiuti 5.7a Introduzione 5.7b Rifiuti urbani 5.7c Conclusioni 5.7d Bibliografia 5.8 Gestione integrata del ciclo dell'acqua 5.8a Bibliografia 2 3. Ecosistema città: biotopi e biocenosi urbane 3.1 Introduzione Le innovazioni tecnologiche, i progressi nei vari campi delle scienze e della medicina non sempre sono andati di pari passo con il miglioramento della qualità della vita soprattutto in ambiente urbano. Le mutate abitudini della civiltà odierna, lo sviluppo smisurato e disordinato dell’edilizia, l’addensamento dei nuclei abitativi e la crescente industrializzazione, hanno sconvolto gli equilibri dei sistemi ecologici determinando l’aumento dei già noti problemi d’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque e favorendo lo sviluppo e la trasmissione di agenti patogeni per l’uomo, le piante e gli animali, animali d’affezione, animali sinantropici desiderati e non, hanno contribuito ad accelerare i rischi sanitari nelle città. La città rappresenta un ecosistema artificiale creato dall’uomo molto complesso e limitato, in continua trasformazione per le innumerevoli variabili presenti. Una volta insediatesi nelle città, alcune specie animali si diffondono rapidamente e, indisturbate, colonizzano altre nicchie e creano una serie di pericolose interconnessioni e di problemi che coinvolgono interessi e competenze diverse. La difesa dell’ambiente urbano si ottiene attraverso la conoscenza degli equilibri che regolano i rapporti tra le diverse specie, delle condizioni ambientali che ne permettono la crescita e riproduzione e dei meccanismi che la ostacolano. In una corretta programmazione territoriale, che si inserisca in un quadro di gestione integrata dell’ambiente urbano, è necessario dare il giusto risalto a tali problematiche di estrema attualità, quali l’inquinamento urbano inteso, in questo caso, come ecologia urbana, etologia urbana, patologia urbana. Tali problematiche devono essere affrontate in maniera interdisciplinare, perciò sono necessarie diverse conoscenze: l’ecologia, l’etologia, la biologia, l’entomologia, la parassitologia, l’urbanistica, l’ingegneria, la veterinaria, la medicina, l’agraria, le scienze naturali. Il contributo coordinato e combinato di queste competenze, derivante dalle discipline scientifiche diverse, può permettere l’individuazione di strategie adeguate per la programmazione degli interventi di carattere preventivo e di controllo per una migliore fruibilità dell’ambiente urbano. 3.2 Ecosistema città: ecosistema artificiale L’area urbana costituisce un ecosistema artificiale complesso e limitato che degrada senza soluzioni di continuità verso l’area periferica, sfumando in agroecosistemi e ecosistemi naturali. Quello urbano può essere considerato un ecosistema giovane e in transizione, dove l’attività antropica non gli consente di raggiungere una situazione di stabilità o comunque di maturità, il corrispondente del climax degli ecosistemi naturali, mantenendolo quindi in una continua attività produttiva e di crescita, sino, in alcuni casi, ad arrivare a soffocare completamente la componente naturale. Ricordando le definizioni classiche di : ECOSISTEMA: l’insieme delle condizioni geologiche, climatiche e biologiche che definiscono un dato ambiente. Un ecosistema è dato da una biocenosi e dal biotopo che essa occupa. BIOCENOSI: letteralmente significa comunità di organismi viventi. E’ l’insieme dei rapporti sociali che legano gli organismi tra loro. BIOTOPO: letteralmente significa ambiente di vita. E’ lo spazio naturale in cui si realizza una biocenosi. Diverse sono le definizioni di ecosistema che comprendono anche quello urbano. Nel 1984, Noveh divide il territorio in relazione alla dominanza degli artefatti umani (rurali ed urbani) e di trasformazione d’uso degli ecosistemi naturali, secondo una serie di sette insiemi caratteristici denominati: 3 1. naturale, ad esempio formato da ecotopi di foreste climax e paludi; 2. semi-naturale, ad esempio foreste con aree di rimboschimento; 3. semi-agricolo, ad esempio boschi da legna con parchi semiartificiali; 4. agricolo, campi arabili e laghi artificiali; 5. rurale, ad esempio fattorie con orti e stalle, o villaggio agricolo; 6. urbano-industriale, città e aree metropolitane. Più semplicemente, secondo Tricart (1992) esistono tre tipologie fondamentali di ecosistemi: 1. la natura spontanea; 2. le aree agro-silvo-pastorali 3. gli insediamenti antropici. Al di là degli sforzi tassonomici, qui interessa sottolineare l’importanza della lettura in chiave ecosistemica dell’ambiente urbano, in modo da evidenziare gli aspetti connessi ai flussi di materia ed energia, ai cicli naturali delle risorse e alle componenti biotiche e abiotiche che costituiscono il substrato per gli esseri viventi. Perciò, partendo dall’assunzione dell’ecologia urbana come strumento di conoscenza degli spazi fisici e dei cicli funzionali della città, l’ecosistema urbano può essere considerato come costituito da: 1. biotopi artificiali: edifici, industrie, infrastrutture; 2. biotopi semi-artificiali: giardini, viali, orti urbani; 3. biotopi semi-naturali: grandi parchi, foreste urbane, parchi, ville comunali. In tal senso la città può essere studiata attraverso le sue componenti intese come fattori ecologici, cioè valutando una componente abiotica (biotopo) e una componente biotica (biocenosi), considerando integrate le parti abiotiche della città con i suoi processi vitali. Questo approccio consente di capire le interazioni dell'uomo con queste componenti, le interferenze delle attività antropiche con i processi naturali, gli effetti degli interventi e delle strutture umane sul contesto ambientale, sia a livello locale che livello globale, evidenziando il grado di conflittualità e il grado di integrazione. Perciò è fondamentale il concetto di "metabolismo urbano", che permette di evidenziare come l'organismo urbano assume una serie di risorse, per la sua sopravvivenza e per lo svolgimento di una serie di attività, e ne restituisce altre. Il contesto ambientale in cui la città si inserisce interessa soprattutto come fonte di risorsa, in termini di capacità produttiva e di serbatoio, e come depuratore, in termini di riciclo e assorbimento dei rifiuti. In termini biologici, la città è un sistema a bassa produttività che dipende pressoché totalmente dall'esterno per i suoi fabbisogni energetici e sempre all'esterno si rivolge per scaricare i rifiuti prodotti dagli impieghi energetici. Poiché ogni azione richiede energia, un modo efficace per studiare gli ecosistemi, compresi quelli urbani, è analizzare come l'energia fluisce attraverso essi. Studiando i sistemi urbani si evidenzia una forte richiesta di energia, che aumenta vorticosamente man mano che la città aumenta di dimensioni. Analizzando i flussi energetici urbani risulta che più dei 2/3 dell'energia introdotta è utilizzata per le attività domestiche e industriali. Da ciò si evince che l'aumento del fabbisogno procapite non è in rapporto diretto con la crescita numerica della popolazione, ma con lo sviluppo di nuovi stili di vita e utilizzo di nuovi processi produttivi. Nel caso degli ecosistemi naturali il bilancio, tra i flussi energetici di un sistema è dato dai rapporti che esistono nei vari livelli trofici della catena alimentare, tra produttori e consumatori. Quando entrate ed uscite si bilanciano, le dimensioni non possono aumentare ulteriormente, la quantità di biomassa prodotta che può essere sostenuta in quelle condizioni viene chiamata capacità portante massima del sistema (carrying capacity), oltre la quale si creano una serie di dismetabolismi, tipici del tessuto urbano. La sorgente e la qualità dell'energia stabilisce a tutti i livelli il tipo e il numero degli organismi, i modelli dei processi di sviluppo, lo stile di vita delle popolazioni umane. Poiché l'energia è un 4 elemento importantissimo su cui si basano i vari ecosistemi, essi possono essere classificati anche in termini di flussi energetici. Si possono così distinguere almeno quattro tipi fondamentali di ecosistemi in base ai flussi di energia su cui si reggono: 1. naturali, alimentati dall'energia solare; 2. naturali, alimentati anche da altri fonti energetiche; 3. antropizzati, ad energia solare; 4. antropizzati, urbani-industrializzati, alimentati da combustibili (fossili, organici, nucleari). Questo tipo di sistema aperto e dissipativo non è perciò in sintonia con i ritmi della natura e con le dinamiche globali dei cicli biogeochimici degli elementi. Le città attuali sono caratterizzate da condizioni di sovraffollamento, prevalenza di alcune specie su altre, mancanza di biodiversità, alterazione dei meccanismi naturali di competizione e predazione con crescita abnorme e incontrollata di alcune specie, basse fluttuazioni delle popolazioni animali con alterazione delle leggi classiche di dinamica delle popolazioni. Queste caratteristiche proprie delle città, rende l'ambiente urbano particolarmente ricercato da diverse specie animali che sfruttano condizioni favorevoli alla loro moltiplicazione. Il clima e la temperatura superiore di alcuni gradi rispetto alle campagne circostanti, le abitazioni riscaldate consentono a molti insetti di svilupparsi molto velocemente e anche in periodi diversi da quelli in cui si sviluppano normalmente; l'acqua e una grande varietà di cibo sono sempre disponibili e abbondanti; i numerosi biotopi e le molte nicchie ecologiche consentono lo sviluppo di faune altamente specializzate. Basti pensare che una sola abitazione può ospitare contemporaneamente specie animali diverse. Le città sono caratterizzate da una serie di sottoinsiemi particolari, con condizioni microclimatiche molto diverse, per esempio la cantina e la soffitta di una abitazione o i viali alberati e la metropolitana. Questi diversi ambienti risultano però spazialmente vicini e quindi consentono continue possibilità di interscambio con complesse interrelazioni tra le diverse specie colonizzatrici. Le considerazioni sinora trattate dovrebbero essere attentamente considerate e valutate nell'approccio ecosistemico alla pianificazione delle aree urbane. Criteri ecologici di tutela e progettazione dovrebbero consentire la fusione della città con il paesaggio tramite anche l'individuazione di validi indicatori di sostenibilità urbana. Aree di biodiversità e naturalità, considerando che la città è strutturata come un mosaico di habitat; indici di emergenza e rapporto tra l'uso di energie rinnovabili sul territorio urbano; indici del rapporto popolazione/riciclo/ripristino: indici del ciclo dei materiali; introduzione del parametro dell'ecological footprint (impronta ecologica) come vincolo alla pianificazione urbana. Nella moderna pianificazione urbanistica si dovrebbe includere anche la stesura dell'Atlante Ambientale proprio di ogni città, inserendo come punti fondamentali il decalogo seguente: preservare le strutture naturali storiche della città; predisporre una pianificazione ecologica urbana, prevedendo la cartografia dei biotopi urbani e la stesura del piano faunistico urbano; mantenere la varietà locale; preservare la diversità degli elementi caratterizzanti il paesaggio urbano; preservare nella città ampi spazi aperti unitari; utilizzazione nelle nuove realizzazioni delle specie autoctone, partendo da ecotipi locali; valutare l'ambiente in funzione dello sviluppo; integrazione funzionale degli edifici negli ecosistemi urbani; pianificare l'uso degli spazi aperti; 5 educazione della popolazione. E' facile intuire che in questo modo si può fare opera di prevenzione. Tutto questo non è irrealizzabile si tratta di passare da una visione meccanicistica, utilitaristica e consumistica del tessuto urbano ad una visione di tipo ecosistemica e sostenibile. 6 3.3 Bibliografia - Bettini V. (1996). Elementi di ecologia urbana, Einaudi, Torino. Clark B.D. (1988). L'energia e l'ambiente (dalla rivoluzione industriale agli anni '80). In: Uomo Ambiente Energia. Vol. 2 (a cura di F.Quilici e M.Pizzigallo). Pp. 199-213 Scandurra E. (1995). L'ambiente dell'uomo. Verso il progetto della città sostenibile. ETAS Libri, Milano. 7 4. Gestione ecologica dei sistemi urbani e delle trasformazioni connesse 4.1 Introduzione La gestione corretta di un territorio deve partire da una profonda conoscenza dell’ambiente, dei suoi meccanismi dinamici per permetterci di individuare le sue peculiari caratteristiche, le sue potenzialità e i suoi punti deboli, in modo da non rischiare, con qualunque tipo di attività, di modificarlo al punto di turbarne gli equilibri in maniera irreversibile. Obiettivo di ciò è l’individuazione di una strategia di utilizzo razionale ed equilibrato del valore dell’habitat naturale in cui viviamo. Quindi la parola “sfruttamento” tanto usata, oggi, quando si parla si sviluppo economico deve essere sostituita da un’altra: “utilizzo” o meglio “gestione”. Si sottolinea che le risorse dei territori non sono illimitate e non possiamo turbare gli equilibri degli ecosistemi senza aspettarci delle loro modificazioni con conseguenze più o meno negative per la qualità della nostra vita. L’azione antropica legata all’urbanizzazione o alla produzione, non può essere indiscriminata, ma deve tenere in seria considerazione le peculiarità dell’ambiente in cui viene effettuata. Occorre avere una visione integrata ed armonica della città inserita nel suo ambiente e strettamente legata ad esso, e non frammentaria, come è purtroppo ancora adesso. Si deve promuovere un processo di recupero, valorizzazione e sviluppo del territorio con una corretta pianificazione ambientale a livello comunale, considerando l’ambiente urbano come strettamente legato all’ambiente naturale in cui si sviluppa. I criteri per guidare un’azione di gestione territoriale devono essere ispirati a principi che consentano di usufruire del valore dell’habitat naturale senza distruggerlo, ma al contrario, cercando di mantenerlo il più possibile integro e in equilibrio, e nello stesso tempo, di garantire per gli abitanti di quel territorio, il massimo livello possibile di qualità della vita. Prima di avviare qualunque attività antropica si dovrebbe fare: 1. un’analisi approfondita del territorio e delle sue dinamiche sia in termini ambientali che in termini culturali; 2. un’analisi dell’azione antropica che si intende attuare; 3. una ricerca ed una analisi delle interazioni fra azione antropica e territorio; 4. un rilevamento dei miglioramenti o dei peggioramenti (impatti) conseguenti all’azione; bilancio degli stessi; 5. eventuali riarrangiamenti o modifiche al progetto iniziale e scelte operative. Quindi, di un territorio dobbiamo conoscere le caratteristiche ambientali, quelle socio-economiche, le peculiarità culturali e tradizionali; dobbiamo cercare di intuire le potenzialità specifiche e di conseguenza la sua “vocazione”; solo in questo modo potremo utilizzarlo verso un tipo di sviluppo compatibile e sostenibile, quindi equilibrato e in grado di rimanere a buoni livelli anche a lungo termine. Tutto ciò ha senso, però, se “gli abitanti del luogo si riappropriano del proprio habitat”, ovvero occorre avere un atteggiamento di consapevolezza del valore intrinseco dell’ambiente in cui si vive e della stretta dipendenza che ad esso ci lega, ed in una attenzione continua a contestualizzare qualunque tipo di azione antropica (V. Bevilacqua, 1998). 8 4.2 La pianificazione integrata/partecipata La pianificazione integrata/partecipata è il più moderno strumento di programmazione ed organizzazione di tutti gli interventi umani su un’area territoriale mista: urbana ed extra-urbana. Suo elemento di base è l’analisi dettagliata del territorio e dei flussi di materia e di energia che lo attraversano, in modo tale da definire la ristrutturazione e la riconversione generale del territorio stesso, sotto tutti gli aspetti: sociale, produttivo, infrastrutturale, abitativo ed ambientale, in forma, appunto, integrata e partecipata. “Integrata” sta ad indicare che il sistema territoriale viene affrontato nella sua complessità, in maniera da prevedere una riarmonizzazione di tutte le componenti, nel massimo rispetto degli equilibri ambientali e socio-culturali. Gli aspetti analizzati, come raffigurato nella Tabella 4/1 (Schema delle relazioni del piano Integrato), sono essenzialmente: il ciclo dell’acqua, potabile e reflua, la qualità dell’aria outdooor/indoor e l’acustica ambientale; il ciclo delle materie prime e seconde (rifiuti); i reflui industriali e i relativi rischi tossicologici; la trasformazione ecologica del sistema produttivo, agricolo e della piccola e media impresa; l’assetto urbano e i piani urbanistici; la qualità dell’abitare; la formazione e l’informazione dei cittadini sul nuovo “modello di sviluppo ecocompatibile” del territorio. In questo quadro, vanno inseriti la raccolta differenziata, il riciclo e la riduzione dei rifiuti (i rifiuti vanno considerati come risorsa da non sprecare), il riciclo delle acque reflue, l’uso pieno del verde urbano inteso come verde da vivere; le produzioni agricole biologiche derivanti dall’agricoltura ecocompatibile che tende a difendere la fertilità dei suoli, ad non usare mezzi chimici di sintesi e produrre così alimenti di qualità; le fabbriche in regola con le norme europee di Audit (cioè l’impresa ecologica che segue il percorso di Audit per ‘produrre senza inquinare’); il tutto con un notevole incentivo all’occupazione in tutti quei settori definibili “di lavoro socialmente utile”. “Partecipata” sta ad indicare una pianificazione che prevede una intensa e attiva collaborazione delle forze sociali, produttive e di tutti i cittadini. Il Piano, cioè, non è solo frutto del lavoro degli “esperti”, non viene calato dall’alto sulla testa di imprenditori e cittadini, ma si sviluppa con la loro piena partecipazione e consenso ed implica verifiche, modifiche e correzioni durante il suo percorso (Tabella 4/2 -Percorso Storico di una Pianificazione Integrata – Partecipata). 4.3 Significato dello sviluppo ecosistemico del territorio. Proposta di un modello innovativo di gestione integrata/partecipata di economia, ambiente e cultura della città La città, come già detto, è un ecosistema artificiale attraversata da flussi di materiali ed energia in entrata ed in uscita. I flussi in entrata provengono sia dall’ambiente naturale che dalle attività produttive che si svolgono al di fuori della città, essi vanno ad alimentare le attività produttive (negozi, uffici, officine, ecc.) e quelle di consumo sia delle famiglie che dei servizi (trasporti, riscaldamento e illuminazione degli edifici, ecc.). Tali attività trasformano la materia in residui e rifiuti che finiscono più o meno rapidamente nell’ambiente esterno. L’analisi dei flussi di materia ed energia che purtroppo, è stata condotta solo in pochissimi casi, consentirebbe l’identificazione degli effetti delle attività che si svolgono all’interno della città sulla salute umana, sulla vegetazione, sulla corrosione di strutture all’aperto e di monumenti. Inoltre, permetterebbe la realizzazione di una migliore pianificazione urbana finalizzata alla razionalizzazione dell’uso dei materiali e dell’energia. Per analizzare i flussi di energia che attraversano un ecosistema urbano è necessario definire i confini geografici dell’ecosistema stesso; in alcuni casi più Comuni attigui costituiscono un unico grande ecosistema (conurbazioni). Dopo avere definito il confine geografico dell’ecosistema urbano, si effettua uno studio sulla popolazione ed infine si procede alla determinazione delle quantità di merci e di scorie che rispettivamente 9 entrano ed escono da ciascuno dei settori vitali della città (abitazioni, negozi, uffici, ospedali, fabbriche, trasporti, attività artigianali). Le città rappresentano dei sistemi altamente dissipativi, in cui si realizza un uso crescente ed irrazionale di materiali ed energia. A differenza degli ecosistemi naturali, l’ecosistema urbano è privo di meccanismi di autocontrollo in grado di apportare automaticamente correzioni per limitare inutili sprechi; solo l’azione dell’uomo, ossia, una corretta pianificazione della città, può contrastare la tendenza altamente dissipativa della città. Quali sono le merci che entrano in una città? Sono tantissime: acqua, alimenti, carta, materie plastiche, imballaggi, mobili, materiali da costruzione, libri, ecc.; la maggior parte dei materiali entranti viene rapidamente trasformata in varie sostanze di rifiuto; i rifiuti solidi urbani rappresentano la forma più vistosa ed ingombrante in cui si presentano le “scorie” della trasformazione e dell’uso delle merci nella vita urbana. “L’ambiente urbanizzato o edificato è ‘parassita’ dell’ambiente che produce i generi di sostentamento della vita (naturale, addomesticato), almeno per quanto riguarda le sue richieste biologiche fondamentali, l’ambiente urbano crea ed esporta altre risorse, per lo più abiotiche, quali fertilizzanti, denaro, energia elaborata e beni che portano sia benefici che stress all’ambiente produttivo delle materie prime.......Ma nessuna tecnologia possibile, oggi conosciuta, può sostituire su larga scala, i beni abiotici fondamentali di mantenimento della vita forniti dagli ecosistemi naturali” (E. P: Odum, 1988). I principi dello sviluppo ecosistemico vengono applicati alla pianificazione, cioè ad una politica razionale di gestione del territorio. Le città sono sistemi ad alto consumo di energia che incidono sulla natura per il mantenimento del proprio equilibrio. Da qui nasce l’importanza di preservare “il capitale naturale” in maniera tale da garantire il necessario input di risorse naturali e non incorrere nel grave rischio di una diminuzione della qualità della vita (città a misura d’uomo). E’ necessario conservare un rapporto equilibrato ed armonico tra campagna e città. La storia dell’ultimo ventennio mostra come la città abbia invaso la campagna in modo del tutto irrazionale. L’ambiente naturale deve essere preservato all’interno di un circoscritto ambito amministrativo (città, regione, nazione) per sostenere un adeguato livello di sviluppo della società umana. Infatti, esso è un sistema che ha in sé la potenzialità di proteggere il mantenimento della vita, stabilizzare i substrati, controllare i cicli atmosferici e i cicli idrici, moderare i valori estremi della temperatura e di altri fattori fisici e così via (ci si riferisce agli ecosistemi maturi come le antiche foreste, gli oceani che sono più protettivi che produttivi). Ciò premesso, si deduce che il fondamento della pianificazione deve essere la capacità di automantenimento della vita. Gli obiettivi della pianificazione integrata/partecipata sono i seguenti: * conoscere e proteggere l’ambiente naturale necessario al mantenimento della vita; * difendere la qualità della vita nelle città; * regolare, per quanto possibile, il tipo e l’intensità dello sviluppo in modo da non superare la capacità portante e ridurre le pressioni sull’ambiente naturale di pertinenza; * sfruttare di meno con maggiore efficienza e riciclare di più. La visione “ecologica” del territorio consiste nel ritrovare e nel garantire l’armonia tra l’insediamento urbano ed il territorio extra-urbano. Occorre affrontare con le giuste strategie il degrado ambientale, progettando e individuando regole insediative della città e del territorio che risultano di per sé generatrici di nuovi durevoli equilibri ambientali. Si individuano, così, nuove strade per risolvere i problemi urbanistici il cui obiettivo è: * migliorare l’assetto urbanistico dei quartieri periferici ad urbanizzazione selvaggia; * valorizzare le potenzialità culturali, geografiche, storiche ecc.; 10 * promuovere la rigenerazione delle zone urbane in difficoltà mediante l’introduzione di nuove attività connesse allo loro riabilitazione ad alla protezione del loro ambiente; * migliorare l’ambiente con la creazione di strutture e/o attività ricreative con relative infrastrutture durevoli, nei quartieri densamente popolati; * ridurre il consumo energetico mediante l’uso di fonti di energia rinnovabili o alternative “pulite”; * ridurre la produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi alla fonte; * separare i flussi di rifiuto; * riutilizzare i sottoprodotti; * migliorare la qualità della vita e tutelare l’aria indoor all’interno delle residenze mediante l’adozione di criteri di manutenzione, recupero e risanamento tipiche dell’architettura ecologica; * individuare soluzioni efficaci alla creazione di spazi verdi pubblici e privati; * tutelare la qualità dell’aria, predisponendo nell’arredo del verde urbano, specie vegetali autoctone da ecotipi locali a crescita veloce e che si trapiantano e si adattano all’inquinamento atmosferico; * incoraggiare la scelta del mezzo pubblico, l’uso collettivo dell’autovettura e l’uso della bicicletta; * progettare la penetrazione degli ambienti naturali nella città ; * trasformare e/o ammodernare il parco dei mezzi di trasporto pubblico urbano e dei mezzi di raccolta dei R.S.U. da gasolio a metano e/o alimentazione con celle combustibile e/o trazione elettrica; iutilizzare combustibili a ridotto impatto ambientale quali il biodisel, con basse emissioni di particolato solido e di composti aromatici; iagevolazioni giuridico-istituzionali per la realizzazione dei progetti innovativi e tendenti a favorire nuova occupazione; ieducare e rieducare su stili e abitudini di vita. 11 4.4 Ciclo dell’acqua, dell’aria e dei rifiuti 4.4a Ciclo dell'acqua * analisi del ciclo completo dell’acqua nel territorio della città considerata, come confronto fra ciclo storico, di fatto in equilibrio naturale, e attuale ciclo alterato; * piano di ripristino del ciclo idrico completo tramite: a) incentivi alla riduzione degli sprechi in rete; b) recupero e riciclo acque per usi produttivi industriali e artigianali in maniera separata dal ciclo domestico (captazione acqua piovana e riuso reflui); c) incentivi al riutilizzo di acque bianche per circuiti civili non potabili: a livello di singoli condomini o abitazioni (da terrazzi, pozzi individuali), per il carico di vaschette water, per lavanderia, per irrigazione giardini e terrazzi. Per le acque bianche stradali, invece, si possono adottare combinazioni di permeabilizzazioni stradali per consentire l’assorbimento naturale da parte del suolo, con riutilizzo di quelle più pulite per l’irrigazione giardini pubblici e usi produttivi; d) riutilizzo delle acque nere tramite massima diffusione sul territorio di stazioni di accumulo e gestione finalizzata al riutilizzo agricolo e non, secondo il ciclo naturale. I livelli di trattamento devono essere i minimi necessari, garantendo al tempo stesso riutilizzo dei fanghi di risulta e funzionamento ottimale dei processi. A loro volta gli impianti di trattamento saranno di piccole dimensioni, a bassa tecnologia e a processo conforme ai fenomeni naturali dell’area considerata. 4.4b Ciclo dell'aria * reti di monitoraggio: al fine di avere una conoscenza adeguata e puntuale sulla qualità dell’aria è indispensabile munirsi di reti di monitoraggio per le emissioni in atmosfera, configurando la rete in modo appropriato all’ambiente oggetto di controllo e in base agli obiettivi che si intendono perseguire durante la sorveglianza degli inquinanti. La rappresentatività dei punti di campionamento deve essere tale che ogni zona da monitorare deve risultare omogenea, secondo l’equazione complessa che costituisce l’atmosfera e cioè: clima - territorio - attività umane; * valutazione del rischio ambientale: le emissioni di molecole di sintesi che per elevata reattività danno luogo a reazioni chimiche, portano alla formazione di composti fortemente tossici, mutageni e cancerogeni, per cui si rende necessario valutare il danno sulla biosfera e sulla salute pubblica. La gestione è il controllo di tutte le fasi del processo industriale che può sicuramente contribuire a dare un valore aggiunto sulla qualità dell’aria, in quanto soltanto dalle sinergie dei fattori in gioco si può valutare lo stato di recupero o degrado ambientale. Lo sviluppo di studi di ecotossicologia è uno strumento di informazione verso la valutazione del rischio ambientale, in quanto si relaziona la risposta biologica a problemi tossicologici; * l’acustica ambientale: la prevenzione, soprattutto nei centri ad elevata densità urbana, va programmata attraverso piani di risanamento acustico, in grado di migliorare la viabilità stradale, la pianificazione territoriale degli insediamenti produttivi, creare delle zone con ampi spazi verdi. Dunque, definire gli standard di inquinamento acustico e localizzare le zone critiche, attuare insomma quella politica atta a ridurre l’impatto acustico; * coordinamento e interdisciplinarietà delle attività: una corretta gestione della qualità dell’aria implica un coordinamento di tutta l’attività interessata, altrimenti si corre il rischio di intervenire in modo disordinato apportando danni e non benefici. Va ricordato che gli inquinanti nelle diverse componenti dell’ecosistema, atmosfera, litosfera, idrosfera e biosfera, passano attraverso processi quali: volatilizzazione, assorbimento, adsorbimento, evaporazione, dissoluzione, desorbimento. Per cui si rende indispensabile coniugare la interdisciplinarietà delle competenze di chimica analitica chimica fisica, tossicologia, ecologia, per meglio comprendere e affrontare con efficacia la tutela ambientale; 12 * corretta informazione: la complessità dei fenomeni di polluzione ambientale, fanno scaturire spesso dai mass media informazioni che sovente creano soltanto allarmismi legati soprattutto alla situazione d’emergenza, anche se va riconosciuto che attraverso i mezzi d’informazione esiste oggi una maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali. Per un corretto approccio è importante dare l’informazione sul dato ambientale in modo inequivocabile, senza lasciare dubbi o sospetti; poiché solo creando un rapporto di fiducia con la gente è possibile auspicare un modello di vita sostenibile. 4.4c Ciclo dei rifiuti * caratterizzazione socio-economica del territorio, analisi del ciclo completo dei rifiuti della città; * piano di riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata delle varie tipologie separabili dei R.S.U., utilizzo dei materiali riciclati, mercato dell’usato; * recupero, a monte, della frazione organica dei R.S.U., dai ristoranti, mense, mercati ortofrutticoli, verde pubblico e così via, mediante compostaggio, compreso quello domestico per giardini e terrazzi. L’obiettivo è ottenere un prodotto di qualità, il compost, utile in agricoltura per ripristinare la fertilità del terreno agrario, riequilibrando l’alterato ciclo della sostanza organica; * modalità e soluzioni per la creazione del mercato delle materie prime seconde e loro riutilizzo, sovvenzioni o sgravi fiscali ad imprese che riutilizzano le materie seconde; creazione d’impresa; * campagna di informazione e sensibilizzazione di tutti gli attori sociali: cittadini, scuole, apparato produttivo; * creazione dell’Osservatorio comunale sui rifiuti. Diversi sono gli obiettivi: studi per acquisire tutte le informazioni utili per una migliore gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti; dati ed informazioni di carattere territoriale legati alla composizione ed all’entità dei diversi flussi di rifiuti; censire e monitorare la qualità dei rifiuti tramite analisi chimico-fisicomerceologiche, e così via. Per tutto questo necessita una Commissione Tecnico-Scientifica, costituita da esperti del settore, una équipe multidisciplinare: esperti appartenenti alla azienda di gestione dei rifiuti, esperti dell’ufficio tecnico comunale ed esperti esterni. 13 4.5 Bibliografia - AA.VV. (1996). Risorse ambientali. Serie Quaderni - Le Scienze n° 90, giugno 1996. - AA.VV. (1996). Ecologia Applicata. A cura di Roberto Marchetti, Società Italiana di Ecologia, Città Studi - Bevilacqua V. (1998). “Riappropriarsi dell’habitat. In Biologando”, Periodico d’Informazione dell’Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, Anno 2 – n.1 Gennaio/Giugno 1998, pp.4-5. - Blonda M., Campanile M., Rubino L. (1997). “La Pianificazione Integrata/Partecipata; dai biologi una proposta multidisciplinare altre categorie professionali ed alle amministrazioni”. In Atti del 1° Congresso Regionale I Biologi per lo sviluppo sostenibile della Puglia”. Coordinamento tecnico-scientifico ABAP-Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, Bari, 1999, pp.163-174. - Odum E. P. (1988). Basi di ecologia. Loreto Rossi (a cura di), Edizioni Piccin. 14 5. Principi di analisi delle valenze territoriali per interventi ecologicamente sostenibili 5.1 Controllo integrato dell’inquinamento urbano: monitoraggio e lotta 5.1a Introduzione L’inquinamento urbano è una vasta disciplina che si occupa dei complessi meccanismi che regolano l’ambiente e delle profonde modificazioni arrecate ad esso dall’uomo. In questo capitolo saranno trattate le strategie di controllo integrato che riguardano alcune problematiche emergenti: ecologia urbana, etologia urbana e patologia urbana, spesso trascurate dagli studi classici d’inquinamento urbano. Le modificazioni dell’ambiente urbano sono spesso imprevedibili, ciò rende necessaria una profonda conoscenza delle diverse problematiche e un monitoraggio costante nel tempo per prevenire e se necessario intervenire con la strategia più adeguata. In una città, oltre alle pianificazioni “convenzionali”, come quelle territoriali e urbanistiche per una corretta gestione dei rifiuti, acqua, aria, programmazione del traffico e di tutte le attività commerciali, artigianali e terziarie, è altrettanto importante una pianificazione che tenga in considerazione la presenza di animali domestici (cani, gatti e altri) e sinantropici (insetti, uccelli, topi e altri). Da studi condotti negli ultimi anni in alcuni paesi europei risulta che il 46% delle famiglie possiede un animale e che accanto a una popolazione umana di 275 milioni di abitanti, in questi paesi vive un numero di animali domestici e sinantropici pari rispettivamente al 72% e 10% della popolazione umana. Le stime, soprattutto per questi ultimi, sono approssimate per difetto, non essendo possibile per diverse ragioni conoscere il numero esatto. Nelle città attuali, la tendenza è quella di costruire ambienti di vita che tengano conto solo delle esigenze dell’uomo e non considerino in alcun modo che, accanto alla popolazione umana, si trova una vasta popolazione animale portata dall’uomo (animali domestici) e una che invade nicchie da lui create artificialmente (animali sinantropici). Si creano così situazioni di sovraffollamento che vanno di pari passo con l’urbanizzazione e conducono queste popolazioni, compresa quella umana, ad adattarsi a questi nuovi spazi, mutando in maniera drastica il loro comportamento e le esigenze ecotrofiche e riproduttive. Questa condizione di sovraffollamento genera non pochi problemi di diverso ordine e grado. Per quanto riguarda gli animali domestici, per esempio i cani, se si considera che un cane produce in media 100 grammi di feci al giorno e che i luoghi dove queste si rinvengono sono prevalentemente le aree verdi, in prossimità degli alberi, nelle cunette, sui marciapiedi, vicino ai porticati, nelle aree pedonali, nelle sedi stradali, ci si rende conto di quanti e quali possono essere i problemi legati a queste realtà e come sia possibile considerare tale problematica nelle strategie d’intervento nella programmazione urbana. Se si pensa, invece, agli animali sinantropici, una specie che si è adattata all’ambiente urbano, mutando il proprio comportamento e le proprie esigenze ecologiche, è il colombo (Columba livia) Questi uccelli nidificano sugli edifici e utilizzano per il loro sostentamento quanto la città può loro offrire, sviluppando un esteso commensalismo con l’uomo. Negli ultimi anni, la loro presenza è aumentata notevolmente nelle città italiane e ciò ha determinato l’accumulo di notevoli quantità di materiale organico da loro prodotto nei luoghi di nidificazione: piazze, palazzi, monumenti. E’ noto che le sostanze organiche prodotte dai colombi in presenza di acqua diventano altamente corrosive oltre a essere un buon terreno nutritivo per molti microrganismi (salmonelle, streptococchi, chlamidie, listerie, Campylobacter, Yersinia) e artropodi (argasidi). I colombi si comportano come portatori sani, gli animali eliminano con secreti ed escreti gli agenti patogeni senza presentare manifestazioni cliniche. Per non parlare di tutti i problemi connessi alla presenza di roditori, scarafaggi e insetti come le zanzare, i flebotomi e le zecche. 15 Questi sono soltanto alcuni esempi, ma sono sufficienti a chiarire quanto sia indispensabile in una corretta gestione di una città la programmazione degli interventi, tenendo conto di tutte le variabili che possono essere presenti. Di seguito saranno tracciate le linee guida per gli interventi di programmazione connessi alla presenza di specie animali in ambito urbano. La strategia proposta per affrontare le problematiche descritte è quella del controllo del tipo “Integrato-Partecipato”. 5.1d Conclusioni Nel complesso occorre quindi privilegiare un programma di lotta integrato impostato essenzialmente sui seguenti punti: • Applicazione contemporanea ed armonica delle tecniche di difesa disponibili scegliendo quelle meno pericolose per l’uomo e per l’ambiente. • Definizione delle soglie economiche. Questo capitolo vuole fornire una serie di imput che conducano all’approfondimento e all’attivazione di nuovi programmi di ricerca in questo settore, in modo da poter superare le innumerevoli difficoltà che si riscontrano nell’attivare le strategie di controllo integrato, per la carenza di informazioni e di cultura specifica. L’esperienza che si potrà acquisire è da considerare un patrimonio inestimabile da non dissipare e i risultati che si potranno ottenere non possono che ripercuotersi in maniera positiva sulla propositività dei progetti per il futuro della civiltà urbana e della sostenibilità della vita. Se c’è uno scoglio da superare, anche se ciò sembra arduo e difficoltoso, deve essere affrontato con serietà e professionalità e questo sarà possibile soltanto se si riuscirà a rendere maggiormente partecipi i diretti interessati: i cittadini. 16 5.1e Bibliografia − Ballarini G. (1983). Patologia animale da urbanizzazione e salute urbana. In Atti della giornata di studio su “Zoonosi e Animali da compagnia”. Quaderno 9, edito a cura della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 27 Maggio, pp. 11-27. − Bellini R. (1995). Aedes albopictus in Italia: che fare? “Il Divulgatore Agricoltura & Ambiente”, XVIII(2):14-20. − Bellini R. (1997). La valutazione dei risultati. “Interventi di lotta ai Culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell’area del Delta del Po”, Corbo Editore, Ferrara, Dicembre 1997, pp.89-157. − Bottalico A., Decataldo A., Simone O., Tarsitano E. (1998). “Piano di intervento sull’emergenza zanzare nella città di Bari”. Documento A.B.A.P. (Asssociazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Bari, Marzo 1998. − Bottalico A. (1998). Lotta Biologica. “Piano di intervento sull’emergenza zanzare nella città di Bari”. Documento A.B.A.P. (Asssociazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Bari, Marzo 1998, pp. 16-19. − Cancrini G., Raineri V., Della Torre A. (1992). Aedes albopictus. Quale possibile vettore di dirofilariosi canina ed umana in Italia. Parassitologia, 34 (suppl.1), 13. − Cassani A. (1983). Convivenza uomo-animali in città. In Atti della giornata di studio su “Zoonosi e Animali da compagnia”. Quaderno 9, edito a cura della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 27 Maggio, pp. 173-183. − Celli G. (1997). Le zanzare e l’uomo: una convivenza difficile. “Interventi di lotta ai Culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell’area del Delta del Po”, Corbo Editore, Ferrara, Dicembre 1997, pp. 9-28. − Celli G., Bellini R., Carrieri M. (1994). Survey on Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) infestation in Desenzano del Garda (Brescia province-Italy). Boll. Ist. Ent. “G. Grandi” Univ. Bologna, 48: 211-217. − Cox F.E.G., (1996). “Parassitologia”, Zanichelli, 1996. − Domenichini G. Crovetti A. (1989). “Entomologia Urbana”, UTET, Torino 1989. − Mantovani A. (1983). Igiene urbana veterinaria. In Atti della giornata di studio su “Zoonosi e Animali da compagnia”. Quaderno 9, edito a cura della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 27 Maggio, pp. 115-160. − Pagano A. (1983). Rapporto uomo-animale nell’area urbana. In Atti della giornata di studio su “Zoonosi e Animali da compagnia”. Quaderno 9, edito a cura della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Brescia, 27 Maggio, pp. 161-172. − Puccini V. (1992). “Guida alle Malattie Parassitarie degli animali domestici”, Edagricole, Bologna 1992. − Romi R. (1995). Programma per il controllo e la sorveglianza di Aedes albopictus in Italia. Documento I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità), 30 pp. − Simone O. (1998). Gestione dell’ambiente. “Piano di intervento sull’emergenza zanzare nella città di Bari”. Documento A.B.A.P. (Asssociazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Bari, Marzo 1998, pp.13-16. − Suss L. (1990). Gli Intrusi: Guida di Entomologia Urbana, Edagricole, Bologna 1990. − Tarsitano E. (1998). Gestione dell’ambiente. “Piano di intervento sull’emergenza zanzare nella città di Bari”. Documento A.B.A.P. (Asssociazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Bari, Marzo 1998, pp.13-16. − Tarsitano E. (1998). Campagne di educazione-informazione. “Piano di intervento sull’emergenza zanzare nella città di Bari”. Documento A.B.A.P. (Asssociazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Bari, Marzo 1998, pp.19-20. 17 − Tarsitano E. (1999). “Controllo integrato dell’inquinamento urbano: monitoraggio e lotta”. Atti del seminario “Inquinamento urbano”, ONB, Università degli Studi di Bari, A.B.A.P., Bari 29 Aprile, 1999, pp.21-35. − Veronesi R. (1997). Organizzazione della strategia di lotta. “Interventi di lotta ai Culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell’area del Delta del Po”, Corbo Editore, Ferrara, Dicembre 1997, pp.63-74. 18 5.7 Gestione integrata dei rifiuti 5.7a Introduzione Per quasi 4 miliardi di anni la natura ha gestito i suoi rifiuti in un ciclo quasi perfetto accumulandone solo una frazione piuttosto piccola, frazione che ora forma le nostre risorse non rinnovabili, carbone, petrolio e gas naturale. Negli ultimi 2 secoli, l’uomo con il sistema industriale, ha rotto questi equilibri estraendo con ritmi sempre maggiori le materie prime non rinnovabili, producendo più di quanto l’ambiente possa assimilare e inventando sostanze che in natura non esistono e che i cicli biologici trovano estranee e perciò rifiutano. La logica conseguenza di ciò è che bisogna fare in modo che i nostri cicli produttivi assomiglino il più possibile a quelli naturali e vi rientrino gradatamente, cercando di non produrre ciò che non serve e riutilizzando ciò che ci è servito. Per questo occorre: PREVENIRE E RIDURRE GLI SPRECHI RIUTILIZZARE I PRODOTTI RECUPERARE E RICICLARE I MATERIALI La natura è giunta fino ad oggi perché conosce le soluzioni migliori ai problemi. A noi il compito di imparare a capirla per poterne godere a pieno. 5.7b Rifiuti urbani I rifiuti urbani vengono ancora considerati da un lato come un prodotto obbligato della nostra civiltà, dall’altro come un ingombro di cui disfarsi in ogni modo. Le strategie di gestione che derivano da questa logica producono molti danni, sia all’ambiente che all’economia, e creano i presupposti per cicliche fasi di crisi, le così dette “emergenze rifiuti” che compromettono le condizioni igieniche e di qualità della vita nelle nostre città. Questo modello detto “distruttivo” è ormai insostenibile e deve essere sostituito con un modello “conservativo”, che sappia imitare i processi naturali, di per sé sostenibili. In natura, infatti non esistono rifiuti, e i prodotti di scarto di un processo vitale altro non sono che preziosa materia prima per un’altra processo, in un continuo ciclo chiuso. Le attività umane, per essere sostenibili, devono quindi rispettare il principio del riuso ciclico dei materiali, in parte fidando nei processi naturali per quelle materie così dette biologiche che la natura stessa sa riciclare, in parte fidando su tecniche di recupero per le materie ad alto contenuto tecnologico. Su tutto deve predominare, comunque, una netta riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti. In altri termini si tratta di orientare il nostro sistema futuro di sviluppo verso un modello dove i rifiuti non recuperabili vengano ridotti al minimo e smaltiti in modo da non interferire nei cicli biologici. Questo modello, detto di “economia ecologica”, prevede tre punti fondamentali per ciò che riguarda i rifiuti: 1. priorità ad un piano di riduzione graduale dei rifiuti prodotti, coinvolgente imprese e società civile; 2. organizzazione dettagliata della raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuto separabile; 3. promozione di attività per il riutilizzo di tutte le materie seconde recuperate. Il tutto va applicato secondo criteri di integrazione differenziata dei vari prodotti in armonia con le attività del territorio, limitando al minimo gestioni di tipo consortile e grossi spostamenti di materia fra diversi territori, rispettandone la capacità portante. Per la frazione organica vanno privilegiati gli usi agricoli, dopo opportuno compostaggio, in piccoli impianti, ma non devono essere ignorati possibili usi produttivi, quali ad esempio la produzione di materiali biologici per l’edilizia. Gli interventi necessari per attuare questi principi si articolano come segue: 1. organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, istruendola 19 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 6. 7. 8. riguardo le iniziative intraprese sul riciclaggio e sui comportamenti individuali, tali comportamenti sono così riassumibili: * non mescolare la spazzatura, ma separarla per materiali, * preferire i vuoti a rendere, * ridurre al minimo l’uso di plastica a perdere (sacchetti, polistirolo, bottiglie), * rifiutare i prodotti usa e getta, * scegliere indumenti con tessuti naturali (lana, cotone e lino), * riutilizzare al massimo i prodotti usati. coinvolgimento degli esercizi commerciali nella raccolta differenziata e nella riduzione degli imballaggi; raccolta di carta e cartoni presso le utenze commerciali; incentivazione all’adozione da parte delle aziende di adeguamenti per il riciclaggio; sovvenzioni o sgravi fiscali ad imprese che utilizzano materie seconde; premi ai privati che consegnano i loro rifiuti separati per tipologie riciclabili; organizzazione di banche dati per fornire informazioni sulle disponibilità di materie seconde e potenziali acquirenti (borsa delle materie seconde); organizzazione della raccolta differenziata (porta a porta, multimateriale) di vetro, carta, plastica, metalli, pile, farmaci, legno, solventi, vernici, parti elettroniche, materiali ingombranti e inerti, frazione umida e verde; realizzare ecocentri per la multiraccolta (plastica, vetro, alluminio ecc.) e per rifiuti urbani pericolosi; istituire mercatini dell’usato; costituzione di un "Osservatorio dei rifiuti"; compostaggio, utilizzando matrici derivanti da raccolta differenziata a monte di scarto verde dal mercato ortofrutticolo, dai fioristi, dai vivaisti e dai lavori di manutenzione del verde pubblico e privato e di frazione umida da mense, ristoranti e supermercati, da utenza domestica; incentivazione del compostaggio domestico; predisporre la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti (vecchi mobili, elettrodomestici ecc.); passaggio da tassa a tariffa. Gli effetti positivi di questa strategia, del resto già ampliamente adottata in gran parte dell’Europa e del Nord Italia, sono notevoli: 1. il beneficio ambientale derivante dalla riduzione dei rifiuti da smaltire (in discarica); 2. il beneficio ambientale derivante dal ridotto prelievo di materie prime; 3. il risparmio energetico ed economico ottenuto sia come costo energetico di smaltimento non speso, sia come risparmio nei processi che utilizzano queste materie seconde, rispetto all’utilizzo di materie prime; 4. l’incremento di una quota di occupazione stabile indotta dalla necessità di reggere un sistema complesso quale quello del riutilizzo; 5. il riequilibrio di alcuni cicli alterati, quale ad esempio quello della sostanza organica del suolo grazie al compostaggio della frazione organica; 6. lo sviluppo di una cultura e di un modello di vita basato su consapevolezza, responsabilità e rispetto. Il sistema da adottare, quindi, è quello della raccolta differenziata integrata con separazione dei flussi all’origine, cioè sin dal momento del loro conferimento i rifiuti vengono separati in distinte tipologie di rifiuto. Con le raccolte differenziate integrate si considera il rifiuto, non più come materiale prevalentemente da buttare in un unico contenitore, ma come “risorsa” costituita da diverse componenti che devono subire destini diversi sin dalla fonte, cioè sin dal momento del conferimento da parte del singolo utente. La raccolta differenziata più innovativa è quindi la raccolta differenziata della frazione umida, criterio fondante di tutta una strategia che si basa sulla differenziazione alla fonte, recupero e trattamento separato della frazione organica con una valorizzazione agronomica del prodotto, cioè il compost di qualità; esiste poi una strategia complementare, quella della stabilizzazione di frazioni organiche da selezione meccanica del rifiuto tal quale, ma questa rappresenta un’opzione tattica a breve periodo, per fronteggiare l’emergenza. 20 Appare evidente che una razionale pianificazione della gestione dei rifiuti, con modelli applicativi, porterebbe inevitabilmente ad ottenere risultati di: * drastica riduzione quantitativa di rifiuti da smaltire con abbassamento degli oneri finanziari; * recupero di materiali con reinserimento nei cicli produttivi; * produzione di ammendante organico di qualità da utilizzare per attività produttive del territorio. E’ nostra convinzione che per ottenere risultati significativi è opportuna un’azione capillare sul territorio con particolare attenzione ai giovani (scuole di ogni ordine e grado) e ceti produttivi, che diffondi una cultura, oramai già acquisita nei paesi del nord Europa, di salvaguardia del territorio e recupero di risorse esauribili. Un progetto di fattibilità per la raccolta differenziata deve avere i seguenti obiettivi: * Drastica riduzione quantitativa dei rifiuti da destinare in discarica * Informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile * Miglioramento della qualità della vita urbana * Costituzione di un osservatorio “Rifiuti” La redazione di un progetto di fattibilità necessita di un’analisi del territorio per l’individuazione di interventi specifici. Fase 1. Analisi dell’esistente * costi attuali; * personale coinvolto; * mezzi ed attrezzature per l’espletamento dei servizi in atto; * strumenti a disposizione del servizio (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, ecc.); * ubicazione strategica degli strumenti attuali. Fase 2. Analisi urbanistica e sociologica del Comune Questa fase consiste nell’analisi dell’insediamento urbano di riferimento: * consistenza della popolazione (numero di abitanti, famiglie, popolamento); * stato occupazionale della popolazione; * tipologie abitative dominanti; * numero di famiglie per complesso abitativo; * infrastrutture viarie e sistemi di trasporto; * dotazione di verde e standard urbanistici; * consistenza della copertura vegetale (specie arboree ed erbacee); * attività produttive e loro tipologia; * abitudini alimentari; * comportamenti sui consumi e sul conferimento * conoscenza dettagliata del flusso di materiali, nell’ambito comunale (attraverso compilazione di schede conoscitive). Fase 3. Piano di gestione Questa fase comprende l’elaborazione dei dati analitici raccolti nelle fasi precedenti e la stesura di un piano di massima consistente in proposte alternative circa: 21 * modalità di intervento sulla produzione, recupero e riuso di imballaggi; * modalità di raccolta differenziata attuabile per le abitazioni (tipo porta a porta, a conferimento individuale stradale, condominiale, etc.), per i mercati e le imprese; * individuazione dei siti di conferimento accentrato per tipologie accorpabili o da separare (vetro, alluminio, pile, farmaci, etc); * procedura per i rifiuti ingombranti (area di conferimento o prelievo a prenotazione); * individuazione delle aree e tecnologie di compostaggio della frazione organica; * gestione dei materiali separati e del compost (gestioni locali, convenzioni con aziende di recupero, promozioni, etc); * individuazione dei destini di smaltimento per i materiali non recuperabili; * individuazione delle linee di commercializzazione delle materie seconde verso utenti esterni al bacino; * piano economico complessivo (costi, ricavi, ripartizione degli oneri), e piano funzionale (definizione dei compiti, servizi e funzioni dettagliate degli interessati); * analisi dei costi. Fase 4. Attività di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Inoltre, è prevista una fase di attività di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in maniera continua che si attua attraverso i seguenti interventi: * elaborazione di base grafica di opuscoli (chiari e leggibili) riguardanti la tipologia merceologica delle frazioni circolanti nelle case, e la schematizzazione dei compiti dell’utente (uno per famiglia); * elaborazione di base grafica per opuscoli riguardanti la tipologia merceologica delle frazioni di imballaggio e rifiuti circolanti nelle aziende e imprese e la schematizzazione dei compiti dell’utente; * elaborazione di contenuti per spot informativi sull’iniziativa; * organizzazione ed attuazione di manifestazioni pubbliche per il coinvolgimento dei cittadini presso la sede circoscrizionale, le parrocchie, le associazioni; * organizzazione ed attuazione di incontri con le imprese (artigiani, terziario, ristorazioni, commercianti) previa consultazione di associazioni di categoria; * organizzazione ed attuazione di giornate di studio presso le scuole per la promozione e per l’educazione ai comportamenti nei luoghi domestici e pubblici; * formazione del personale addetto alla raccolta e gestione dei materiali (in numero di un operatore ogni 600 abitanti), preventivamente selezionato dalle liste di disoccupati o di lavoratori inseriti in progetti socialmente utili, oppure forniti da cooperative sociali; * osservatorio “Rifiuti”. La fase 4) prevede, anche, la realizzazione di un osservatorio “Rifiuti” finalizzato alla: * previsione dell’andamento quali-quantitativo dei rifiuti, rilevandone e conservandone i dati tramite la costituzione di una banca dati (mediante indagini merceologiche); * avvio di studi al fine di acquisire tutte le informazioni utili per una migliore gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti; 22 * produzione di materiale allo scopo di diffondere dati e pubblicazioni relativi al territorio della circoscrizione; * incentivazione del mercato delle materie prime-seconde. Fase 5. Fase conclusiva: Creazione di impresa * Analisi conoscitive delle tipologie dei senza lavoro attraverso indagini presso tribunali, servizi sociali del Comune, Associazioni di volontariato, ecc. * Individuazione di forme di impresa in grado di attuare gli obiettivi del progetto; * analisi economica costi/benefici delle varie filiere oggetto del piano e dell’intero ciclo di produzione. 5.7c Conclusioni. La riduzione della produzione dei rifiuti nella nostra società dei consumi appare utopistica, ma un serio lavoro di informazione ed educazione in questo campo porta sicuramente all'affinamento della sensibilità di imprenditori, educatori, amministratori, cittadini ed all'assunzione di stili di vita alternativi al “usa e getta", più rispettosi dell'individuo, dell'ambiente e delle sue risorse, e ad una riduzione delle quantità di rifiuti, con notevoli risparmi per la comunità civile. E’ bene ricordare che non esistono ricette univoche per le politiche di recupero. L’esperienza insegna che ogni realtà deve trovare un proprio modello. 23 5.7d Bibliografia - AA.VV. (1998). Proposta di progetto di fattibilità per la gestione integrata dei R.S.U. In un Comune pugliese. ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) – Gruppo di lavoro “Gestione Integrata dei Rifiuti”, Bari, 1998. - AA.VV. (1997). Progetto pilota: piano circoscrizionale di riduzione della produzione nei rifiuti, raccolta differenziata dei RSU e recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità. ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) – Gruppo di lavoro “Gestione Integrata dei Rifiuti”, Bari, 1997 - AA.VV. (1996). La raccolta differenziata porta a porta. L’esperienza del Consorzio di Bacino Padova Uno 1996. Ecoistituto del Veneto -A. Langer. Achab Editoria - Bevilacqua V. (1997). Analisi del territorio. Riappropriarsi del proprio territorio. Seminario sui rifiuti, Bari - 1997. - Blonda M. (1995). L’approccio biologico al problema dei Rifiuti. Materiale programmatico ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), 1995. - Boato M. (1996) Prevenire i rifiuti e liberarsi dall’’usa e getta’. Achab Editoria, Venezia, 1996 - Campanile M. (1996). “Compostaggio dei rifiuti organici. Microbiologia del processo di compostaggio”. ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), 1996. - Centemero M., Favoino E. (1994). Corso sul compostaggio dei residui verdi. Scuola Agraria del Parco di Monza. Milano, 1994 - Favoino E (1997). Strategie e tecnologie per il sistema compostaggio. Scuola Agraria del Parco di Monza, Febbraio 1997 24 5.8 Gestione integrata del ciclo dell'acqua L’attuale schema di gestione delle acque in genere, e dei reflui in particolare, rappresenta un tipico paradosso ambientale: mentre da un lato i terreni agricoli, ed il territorio più in generale, soffrono per la scarsa disponibilità di acqua e si impoveriscono nel contempo di fertilizzanti e di sostanze organiche, dall’altro un fertilizzante liquido, quale è appunto l’acqua di fogna, viene continuamente riversato in mare, nei corsi d’acqua o in falda, causando gravi problemi di impatto complessivo su questi recettori. Si determina in questo modo sia un flusso aperto anomalo di acqua sia uno spostamento di massa di sostanze dal suolo ai corpi idrici recettori. In sostanza si genera una modificazione dei cicli naturali dell’acqua e degli elementi, cioè un dissesto generale dei delicati equilibri del territorio. L’attuale modello di gestione del ciclo dell'acqua si basa, su principi ispiratori di vecchia generazione, che sembrano essere ispirati ad alcune direttrici fondamentali: collettamento di grossi volumi di acqua, provenienti da stazioni molto distanti tra loro e con reflui quantitativamente molto diversi e con innumerevoli variabili. La principale causa del cattivo funzionamento dei depuratori esistenti è imputabile a questo modello di gestione. Così come per i rifiuti, anche per le acque si deve puntare su una depurazione differenziata e decentrata per ottenere reflui che rispecchino determinati standard di qualità. Per una migliore pianificazione e gestione del patrimonio idrico, è necessario conoscere i fattori che regolano il ciclo dell’acqua, il funzionamento di un bacino idrografico e le connessioni esistenti tra questi in un determinato territorio. La soluzione proposta è una pianificazione del tipo integrato-partecipato. Questo tipo di approccio predilige soluzioni il più possibile vicine a quelle naturali e che conducano alla chiusura dei cicli biogeochimici degli elementi. L'adozione di una soluzione per la gestione integrata del ciclo dell'acqua dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi: 1) Analisi dei siti Determinazione delle regioni fitoclimatiche: a. caratteristiche climatiche b. mappaggio della vegetazione c. analisi del terreno d. analisi geologica, geomorfologica strutturale e. analisi geografica, paesaggistica, storica f. cartografia tematica 2) Salvaguardia e rivalorizzazione della risorsa acqua Analisi della risorsa: a. acque superficiali e sotterranee b. censimento sorgenti naturali c. mappaggio risorse e inquinamento d. carte della vulnerabilità della risorsa idrica e. studi di fattibilità per la rinaturalizzazione 3) Analisi e rilevazioni dei sistemi di approvvigionamento idrico a. analisi dei sistemi fognari e di depurazione b. norme tecniche c. utenti allacciati alla rete d. mappaggio di reti fognarie e scarichi 25 e. tipologia impianti esistenti f. analisi qualitative delle acque di scarico g. riutilizzo di acque depurate 4) Inquadramento territoriale a. Inserimento dell’intervento a scala nel territorio di riferimento. I criteri di definizione della pianificazione finale devono essere: • Massima dispersione sul territorio delle stazioni di accumulo e trattamento delle acque in funzione di una microintegrazione con il territorio e delle possibili utenze di riutilizzo. Non si devono collettare grossi volumi di acqua e provenienti da zone molto distanti tra loro. • Separazione gestionale dei reflui di diversa origine e di diversa composizione al fine di una loro migliore gestibilità. Non si devono costruire megaimpianti che mal si collocano in una corretta e razionale gestione dei reflui, rappresentando un elemento di rottura e non di chiusura dei cicli biogeochimici degli elementi. • Livello di trattamento minimo possibile commisurato al tipo di riutilizzo previsto, preferendo là dove sia possibile, trattamenti di tipo naturale e più ecologicamente corretti, con soluzioni alternative rispetto a quelle attualmente utilizzate. Dove per trattamento minimo s’intende quello che è strettamente necessario a fornire un’effluente assorbibile dal massimo volume di corpo recettore disponibile. Diventa prioritario (inversione prioritaria) quanto suolo, sottosuolo o ambito naturale sono disponibili per l’inserimento del refluo. A questo dato è subordinata la qualità e l’intensità del livello di trattamento, tenendo presente che la stessa volumetria di corpo recettore complessivo dovrà recepirne i sottoprodotti (fanghi e altro). • Riutilizzo dei reflui e fanghi ai fini produttivi (agricoltura e industria), civili (verde pubblico e privato, circuiti idrici non potabili). Possibilmente, riutilizzo dei reflui e dei fanghi nell’ambito della stessa realtà in cui sono stati prodotti, sempre per la chiusura dei cicli, maggiore economicità e quindi scelta di una soluzione integrata. • Istituzioni di reti duali per i recuperi di acque reflue e pluviali, con enorme risparmio di acqua potabile, che risolve, in parte, i problemi connessi alle fonti di approvvigionamento idrico. • Campagne di educazione-informazione dei cittadini sui comportamenti corretti da adottare per una migliore qualità biologica dei reflui, con creazione anche di una carta dei servizi. Si tratta di soluzioni di tipo integrato-partecipato, perché è necessario che ci sia, accanto ai programmi d’intervento e d’attuazione, una maggiore attenzione alla partecipazione dei cittadini, che devono essere educati e abituati a un corretto uso del patrimonio acqua. Ciò non va sottovalutato perché si potrebbero ricavare innumerevoli vantaggi, che vanno dalla riduzione degli sprechi all’eliminazione di una serie di problemi connessi alla qualità dei reflui che affluisce agli impianti. Esistono, perciò, limiti ben precisi per la qualità dei reflui che impongono alcuni accorgimenti da adottare alla comunità interessata. Comportamenti corretti da adottare sono: 1) Abolire o limitare al minimo la presenza di detersivi a formulazione sintetica che inibiscono in parte l’attività fermentativa dei batteri e contribuiscono alla formazione di incrostazioni, scegliere detergenti ecologici completamente biodegradabili. 2) Evitare l’afflusso di sabbia, ghiaia, cellophan, legno, carta plastificata e cerata, stagnola, stoffe sintetiche, assorbenti, profilattici, cerotti, bastoncini cotonati e altro materiale solido. 26 3) Ridurre al minimo l’utilizzo di detergenti o igienizzanti, eliminando quelli contenenti cloro, ammonio o formaldeide, scegliere detergenti ecologici completamente biodegradabili. 4) Ridurre o eliminare l’uso di solventi come acetone e acqua ragia, di acidi e alcali (soda, acido muriatico e solforico). 5) Evitare assolutamente l’uso di sgorganti per liberare le tubazioni. 6) Evitare assolutamente lo scarico di antibiotici, farmaci vari, fitofarmaci e composti chimici in genere. 1) Evitare lo scarico di qualsiasi sostanza non di natura biologica o comunque in forma o quantità molto concentrata nel tempo e nello spazio (grossi volumi di olio di frittura, di latte o altri alimenti deteriorati, ecc. ). Ad ogni tipo di insediamento può essere applicato un sistema diverso di trattamento, collegato al riutilizzo di tutte le componenti del ciclo dell’acqua. Infatti, è necessario prevedere una serie di interventi che conducano ad una minore produzione di reflui e con qualità tali da non rappresentare un pericolo per le falde acquifere. In tal senso, si dovrebbero prevedere, per esempio, dei sistemi di raccolta per le acque piovane, che opportunamente filtrate, potrebbero essere utilizzate: per il lavaggio dei nuclei abitativi, irrigazione dei prati, dove possibile, lavaggio auto e alimentazione degli sciacquoni dei bagni nelle abitazioni; per lavaggi vari negli insediamenti produttivi; irrigazione dei prati, lavaggio delle stalle ed altro nelle aziende zootecniche e agroalimentari; lavaggi vari e alimentazione delle piscine negli insediamenti turistici. • Gestione delle opere definitive, garantendo una continuità di funzionamento che rispecchi i criteri di rispetto ambientale applicati. In questo quadro anche il problema del mal funzionamento degli impianti viene affrontato prima di tutto a monte, tendendo a rimuovere a questo livello eventuali disfunzioni, e solo successivamente nello specifico. Per quanto riguarda l’acqua potabile i principi ispiratori della pianificazione dovrebbero essere: 1) Salvaguardia a monte, oltre che a valle, dell’acqua destinata al potabile. Privilegiare l’aspetto preventivo che tuteli la qualità dei corpi idrici destinati all’emungimento e di conseguenza la qualità dell’acqua destinata a tale scopo. Parte dei problemi connessi alla potabilità sono correlabili a contaminazioni di tipo microbiologico, dovuti non solo a inquinamento alla fonte, ma anche a compromissioni lungo la rete di distribuzione. Queste sarebbero causate per lo più non da fenomeni di tipo intrusivo, ma dalla proliferazione di biomassa internamente alla rete. Pertanto, oltre all’interesse primario di salvaguardia a monte devono essere assicurate operazioni di manutenzione e controllo della rete stessa. 2) Studio di una soluzione integrata: • Valutazione dei cicli storici sui sistemi utilizzati in passato per rendere potabile l’acqua. • Sistemi alternativi di potabilizzazione rispetto a quelli chimici in uso. Diversi studi hanno esso in evidenza come i trattamenti di disinfezione chimica, ma anche l’adozione di nuove tecniche come i raggi UV o combinazioni di diverse tecniche da un lato non sono immuni da rischi, producendo composti di dubbia o accertata dannosità, dall’altro rischiano di indurre selezione di microrganismi sempre più resistenti. I reattivi chimici, inoltre presentano impurità varie che contaminano l’acqua in maniera imprevedibile e spesso con composti molto pericolosi. Per contro è stato evidenziato come la qualità dell’acqua ai fini potabili è tanto maggiore quanto più naturali sono i processi di affinamento: filtrazione lenta su sabbia, flocculazioni, ricarica artificiale della falda, filtrazione golenale, trattamenti biologici, trattamenti naturali. Per ciò che riguarda, invece, la decontaminazione delle acque destinate 27 • • al potabile, relativamente a inquinanti di origine chimica - ambientale, ovvero di composti xenobiotici, bisogna privilegiare ancora una volta l'aspetto preventivo, teso a una progressiva dismissione dell'uso di composti o comportamenti con ricaduta negativa sulla qualità delle acque alla fonte più che all'adozione di soluzioni di emergenza a valle. Separazione delle rete con creazione di reti duali e gestione razionale dei volumi d'acqua. Buona parte dell'acqua "buona da bere" si perde a causa di buchi nella rete; ma il vero problema è rappresentato dall'impiego di acqua potabile per gli usi più disparati, dove non serve affatto tale qualità: cicli industriali, scambi termici, irrigazione, lavaggi vari, allontanamento di deiezioni. Una separazione delle reti consentirebbe di limitare i trattamenti di potabilizzazione alla sola quota di acqua destinata a tale uso, rendendo economicamente sostenibile la spesa per i processi che garantiscono una migliore qualità e tutela dell'ambiente. Campagne di educazione-informazione dei cittadini con creazione di una carta dei servizi sulla corretta gestione del ciclo dell'acqua. In conclusione, questo approccio di gestione integrata del ciclo dell’acqua proposto rappresenta una grossa sfida che coinvolge l’impegno e le competenze di tecnici e ricercatori, ma anche un grande spirito innovativo e una costante partecipazione delle comunità interessate. Sono queste che ne trarrebbero il maggior vantaggio, in termini di recupero e salvaguardia ambientale e quindi in qualità della vita. 28 5.8a Bibliografia - - - AA.VV. (1996). I criteri biologici per la corretta gestione delle acque di scarico. Documento Programmatico ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi). Blonda M. (1996). I criteri biologici per la corretta gestione delle acque di scarico. I° corso di aggiornamento A.B.A.P. (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Ordine dei Biologi/Bari, 1996. Tarsitano E. (1996). Processi di Trattamento per piccole comunità e processi naturali. I° corso di aggiornamento A.B.A.P. (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi), Ordine dei Biologi/Bari, 1996. Tarsitano E., Blonda M. (1997). Linee guida per il nuovo PRRA (Piano Regionale Risanamento Acque). I° Congresso Regionale “I Biologi per lo sviluppo sostenibile della Puglia”, Bari, 8-10 maggio 1997, pp.56-61. 29
Scarica