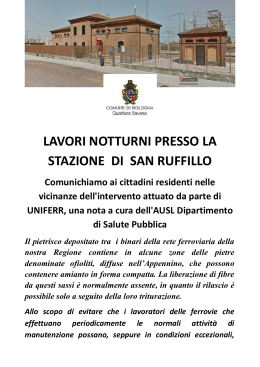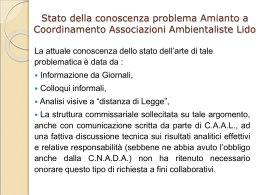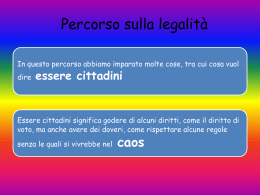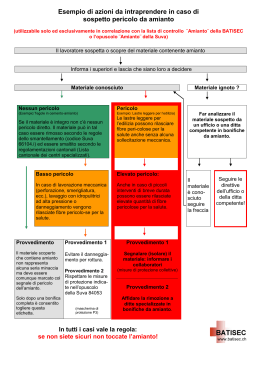magazine HS+E the occupational health & safety + environmental quarterly magazine Italian/English Edition Vol. 2 - N. 1 Poste Italiane - Spedizione in a.p. 45% - art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - D.R.T. - D.C.B. - TO n. 1/2003 Editoriale HS+E inizia il 2004 all’insegna dell’italianità. Infatti, nonostante la scelta editoriale di essere una “finestra” sul mondo anglosassone (stampa periodica, letteratura tecnica, nuove attrezzature ecc.) con l’intento di trasmetterne la buona “cultura HSE” di questi paesi, questo numero tocca le diverse tematiche sulla sicurezza, trattando soprattutto casi italiani. Si parte con l’intervista a Federica Guidi, Presidente dei Giovani industriali dell’Emilia-Romagna, per proseguire con i sistemi di gestione ambientale applicati ai porti turistici e finendo con il tema sempre attuale delle demolizioni. Questo perché riteniamo importante sapere, e far sapere, come è vissuta la questione HSE nel nostro paese. La sicurezza sul lavoro va vista anche come un diritto fondamentale della persona. Non è solo un problema di leggi, di coordinamento, di azioni, è anche, e soprattutto, un problema di cultura. E questa è una delle cose che HS+E vuole trasmettere ai suoi lettori. La società italiana sta affrontando la sfida della globalizzazione e della competitività rendendo efficiente un sistema pubblico che assicuri la protezione di quei diritti sociali, che spesso i processi di cambiamento rischiano di schiacciare o di degradare in modo irreparabile. È una sfida che istituzioni, parti sociali, società italiana devono affrontare insieme. La sicurezza nei luoghi di lavoro è una componente essenziale, perché l’Italia possa (continua a pagina 20) Gen - Mar 2004 Focus Group Emilia-Romagna 2010 Premessa di G. Cavassi, M. Casmiro Intervista di M. Galletti Il Focus Group, costituito come gruppo di lavoro nei primi mesi del 2003, è stato istituito dal Comitato Regionale Giovani dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna. Obiettivo del Focus è elaborare una visione di medio termine per lo sviluppo economico e sociale della Regione Emilia-Romagna, da oggi al 2010. La riflessione sugli scenari futuri viene sviluppata con il coinvolgimento diretto dei Giovani Imprenditori e dunque partendo da un punto di osservazione per così dire “interno” all’Associazione stessa. Tema centrale del Focus Group è l’analisi della modernizzazione del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna, attraverso tre aree tematiche principali rappresentate da Ricerca ed Innovazione, Ruolo della Politica, e Risorse umane. Gli aspetti discussi sono stati molteplici e fra questi, a titolo di esempio, vi sono le problematiche relative alle Infrastrutture, i rapporti Scuola-Mondo del lavoro, l’Immigrazione, i Rapporti con la Comunità Europea e la Qualità della Vita. Dopo un anno di lavoro l’attività del Focus Group, coordinato dal Prof. Nicola Bellini della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è alle sue battute finali; il documento conclusivo del Progetto sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane dalla Dott.ssa Federica Guidi, Presidente del Comitato Regionale Giovani dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna. Federica Guidi – Presidente Giovani Industriali dell’Emilia-Romagna ([email protected]) sommario / contents 1 Focus Group Emilia-Romagna 2010 4 Sistemi di Gestione Applicati ai Porti Turistici Environmental Management Systems Applied to Tourist Harbours 8 L’esplosivo: un’arma economica e sicura per trasformare le nostre città 10 The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) 12 L’amianto, un tema d’attualità anche nel futuro Amiantus. 16The Standard Lighthouse 17 Event calendar 18Press Review 19 Bookshop 2 HS+E magazine INTERVISTA a Federica Guidi HS+E MAGAZINE Trimestrale di Sicurezza, Igiene Industriale e Ambiente The Occupational Health & Safety and Environmental Quarterly Magazine Gen-Mar 2004 / Vol.2, N.3 Editore / Publisher: Tipografia Alzani sas Via Grandi, 5 - Pinerolo (TO) Proprietà / Owner: Techno srl Redazione / Editorial Office: c/o Techno srl Via Pirano, 7 – 48100 Ravenna (I) ph. +39 0544 591393 [email protected] Fotocomposizione e Stampa / Photocomposition and Printing: Alzani Arti Grafiche ph. +39 0121 322657 Registrazione Tribunale di Ravenna n. 1200 del 25/02/2003 Direttore Responsabile / Editor in Chief: Manila Galletti Direttore Tecnico / Technical Editor: Roberto Nicolucci Responsabile Commerciale / Marketing Manager Roberta Nonni Coordinatore di Produzione / Production Co-ordinator Davide Mazzotti Traduzioni / Translations: Chiara De Angelis HS+E MAGAZINE è pubblicato trimestralmente. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma e con alcun mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia, senza il preventivo consenso scritto dell’Editore. I punti di vista e le opinioni espresse dagli Autori all’interno della rivista non necessariamente coincidono con quelli del Proprietario, dell’Editore e del Direttore Responsabile. The HS+E MAGAZINE is published quarterly. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without prior written consent of the Publisher. The views and opinions expressed elsewhere in the magazine are not necessarily those of the Owner, Publisher or Editor in Chief. 1. Come e perché è nato il Focus Group? Il Focus Group è nato perché ritenuto un ottimo esercizio per immaginare il futuro del nostro territorio, per capire come il modello di sviluppo dell’Emilia-Romagna, tutt’ora esistente, subisce i contraccolpi di una congiuntura non favorevole. Di conseguenza capire se si tratta ancora di un valido modello o debba essere modificato per far sì che le imprese siano competitive. Il Focus Group ci permetterà di avere una visione di come questo modello dovrà essere per raggiungere questo obiettivo. In primo luogo si tratta di un’analisi all’interno delle aziende, un’autoanalisi, perchè i giovani imprenditori hanno responsabilità dirette nel gestire questo cambiamento. Secondo, la vision deve essere ascoltata dalle istituzioni; si tratta di proposte concrete in cui gli imprenditori spendono risorse. 2. In qualità di Presidente del Gruppo Giovani Industriali dell’Emilia-Romagna come colloca la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del contesto economico europeo attuale? Parlare oggi di distretti, mercati, regioni, nazioni è un concetto superato, il mercato della domanda è europeo. Quella attuale non è una fase positiva, alcuni settori sono più interessati dalla stagnazione di altri, ma vi sono concre- ti segnali di ripresa. In Emilia-Romagna le piccole-medie imprese sono sempre in sviluppo, il nostro è un modello di competitività vincente. Ma basta paragonarsi a realtà non locali come il Galles, la Spagna e alcune aree della Germania per capire che non ci si deve “sedere”. 3. Qual è lo stato attuale, in Emilia-Romagna, nel recepimento della normativa CE in Materia di Sicurezza? Gli imprenditori italiani che operano con il mercato europeo da tempo hanno già prodotti a norma Europea, non debbono fare nessun adeguamento rispetto alle normative. E, nello specifico, l’Emilia-Romagna è da sempre molto attenta al mercato estero figuriamoci ora che si tratta del mercato “di casa”… Gli imprenditori sono abituati a queste normative, se non lo fossero sarebbero stati tagliati fuori dai rapporti commerciali ed economici, fanno parte della loro cultura ed oltre ad essere attenti sono spesso in anticipo. 4. In quale misura ritiene che la competitività dei prodotti dell’Emilia-Romagna all’interno del mercato europeo sia legata all’applicazione della normativa europea sulla sicurezza? Non si tratta di competitività ma di scegliere se vendere o non vendere. La certificazione dei prodotti è un requisito fondamentale per la vendita. Certo è 3 HS+E magazine che l’Europa deve cercare di armonizzare le regole relative alle proprie normative per rendere più semplice agli imprenditori l’applicazione. Per questi ultimi non è uno sforzo è un MUST. Se si vuole competere non si può scegliere se attenervisi o meno. 5. La marcatura CE ed il processo produttivo ad essa collegato sono visti dai Giovani Industriali come un elemento di qualità per la produzione o piuttosto come una “ingessatura burocratica”? Generalmente non sono considerati un’ingessatura, sono cose “buone e giuste”, possono migliorare la situazione aziendale, si tratta di un circolo virtuoso. Non vi sono, da parte degli imprenditori, ritrosie a questo adeguamento. Si può parlare però di ingessatura quando nascono difficoltà nel recepire le norme, quando si lascia spazio all’incertezza o sono lunghi i tempi di applicazione. È l’incertezza che crea difficoltà. Il “punto oscuro” è il margine di perplessità che si vive da quando lo Stato riceve la normativa a quando la recepisce e questo provoca disomogeneità e scompenso. Vi sono anche processi produttivi su cui le modifiche possono impattare pesantemente. Inoltre, non sempre gli adeguamenti sono a costo zero ma, nonostante ciò, sono visti come un circolo virtuoso, come un miglioramento della qualità del prodotto e di conseguenza delle vendite e del mercato, sono una salvaguardia per il cliente e l’ambiente. Come tutte le cose hanno dei pro e dei contro ma mediamente l’approccio degli imprenditori è positivo. 6. Innovazione, Nuove Tecnologie e Sicurezza: quale peso relativo possono avere, secondo Lei, nei prossimi anni? Innovazione e tecnologie hanno un peso altissimo. Certe aree dell’Europa, Emilia-Romagna inclusa, sono in competizione con il Far East, la Cina e devono investire proprio su questi elementi per posizionarsi nella fascia alta del mercato. La fascia bassa deve invece deverticalizzarsi ed investire nelle aree dove la manodopera ha un costo minore, ma facciamo attenzione, non parlo assolutamente di trasferimento dell’azienda: il Know-how è da finanziare a parte. Tutto questo permetterà di ottenere il Gap del prodotto, questi sono gli asset portanti su cui puntare per rimanere competitivi. Per quanto riguarda la sicurezza ritengo che essa faccia parte della nostra cultura. La 626, per esempio, è opportuna salvaguardia, tutela, è un’assicurazione da rispettare per i lavoratori. Le norme di sicurezza fanno parte della nostra civiltà, sono essenziali. E’ necessario però che non travalichino il limite del buonsenso e condizionino le persone che operano in azienda, non debbono diventare un vincolo, un laccio da cui è difficile slegarsi. Ma la validità di queste leggi e i loro requisiti non possono essere messi in discussione. Mi ripeto: non ci devono però essere difficoltà nella realizzazione e nella lettura di queste norme. 7. L’Emilia-Romagna può contare sull’appoggio della Comunità Europea, da oggi al 2010, per lo sviluppo dei propri prodotti? Generalmente gli imprenditori del nostro territorio non si aspettano aiuti concreti da nessuno, semplicemente non vogliono ostacoli nello sviluppo. Domandano piuttosto di potere incidere sulle decisioni del Governo europeo che li riguardano. Chiedono però che l’Europa venga tutelata dal Far East creando una sorta di corporativismo. Se l’Europa sarà unita aiuterà tutti a rimanere competitivi. 4 HS+E magazine SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE APPLICATI AI PORTI TURISTICI Carlotta Queirazza*, Michela Gallo**, Mauro Fabiano**, Adriana Del Borghi*** 1. Introduzione La salvaguardia dell’ambiente ha visto in questi ultimi anni una crescita di sensibilità da parte di tutti i soggetti interessati. Gestire le proprie attività preservando il più possibile l’ambiente è divenuta una questione di primaria importanza. Nel settore turistico, la nautica ed i porti turistici ricoprono un ruolo economico importante. Con l’aumento progressivo della presenza di porti turistici lungo le coste, della stazza delle imbarcazioni e del tempo di permanenza di queste ultime nei porti, grazie anche al miglioramento dei servizi offerti, si è determinata la necessità di considerare le fonti d’inquinamento relative ai porti turistici al fine di valutarne e contenerne gli impatti ambientali. La gestione ambientale prevede che le aziende implementino un sistema basato non solo sulla prevenzione di eventuali superamenti di limiti di legge, ma anche su un programma di miglioramento continuo del comportamento aziendale nei confronti dell’ambiente circostante. La gestione dei problemi ambientali rappresenta un aspetto fondamentale legato alla percezione della qualità aziendale. Un’azienda non può, infatti, pensare di operare in condizioni di garanzia della qualità se non è in grado di dare risposte adeguate ai propri clienti, alle istituzioni (per leggi e regolamenti), ai propri collaboratori (per gli aspetti legati alla sicurezza), al pubblico (per problemi di ambiente e d’immagine). In quest’ambito la certificazione ambientale rappresenta un efficace strumento di comunicazione per trasmettere chiaramente all’esterno un forte messaggio d’impegno per il rispetto dell’ambiente. Tale prerogativa non è circoscritta al solo mondo industriale: una gestione nel rispetto dell’ambiente applicata ad un porto turistico, offre numerose opportunità di crescita sia economica che sociale e fornisce le garanzie necessarie per una migliore qualità della vita e per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato. Nel caso dei porti turistici è necessario considerare le varie ragioni che legano il turismo e l’ambiente in un’ottica di gestione: la perdita d’identità dei luoghi, le alterazioni dell’ecosistema, l’aumento di consumo delle risorse, la produzione di ri- fiuti legati ad uno sviluppo incontrollato del turismo, la crescente attenzione della Comunità Internazionale verso forme di turismo sostenibile, la scelta dei turisti che prendono sempre più in considerazione il fattore di qualità ambientale, la nascita di tour operator specializzati in turismo ecocompatibile. Il panorama attuale evidenzia, a fronte di una richiesta sostenuta di posti barca per il diporto, una diminuzione dell’offerta: i siti naturali idonei all’installazione di nuovi porticcioli turistici, accettabili dal punto di vista ambientale ed economico, sono infatti sempre più rari. Da ciò deriva l’urgenza di nuovi progetti che migliorino la qualità dei porti già esistenti ed in servizio attraverso la loro ripianificazione o l’ampliamento, la riqualificazione di zone portuali abbandonate, lo sviluppo dei porti a secco (per alleggerire i porti dai piccoli battelli) o ancora l’utilizzo di attrezzature leggere come gli ormeggi organizzati. 2.Implementazione di un sistema di gestione ambientale I criteri definiti di seguito si applicano a realtà nella pratica molto diverse tra loro, poiché le caratteristiche di ogni porticciolo sono connesse a parametri molto diversificati e dipendenti, in primo luogo, dall’ubicazione del porticciolo sul territorio stesso. La procedura di applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale ad un porticciolo turistico evidenzia comunque 5 fasi fondamentali, tra loro concatenate: I. Classificazione dell’area portuale Per prima cosa è necessario individuare le caratteristiche del porto attraverso la definizione della natura del sito e del suo ambiente (natura degli ecosistemi, caratteristiche del litorale, analisi geomorfologica, idrologica, urbanistica, ecc.). II. Analisi ambientale preliminare Si procede poi ad una valutazione della situazione di partenza attraverso l’attuazione di un’analisi ambientale iniziale, i cui contributi principali sono: a) descrizione delle attività che avvengono nell’area del porto o nelle immediate vicinanze che potrebbero avere un 5 HS+E magazine impatto sull’ambiente sia direttamente che indirettamente; b)valutazione di tale impatto; c) la conformità alle normative vigenti per tali attività; d)individuazione delle azioni di possibile miglioramento ambientale. III. Definizione della politica e degli obiettivi ambientali Basandosi proprio sui documenti di analisi ambientale iniziale e sui risultati che ne derivano, si stabilisce la propria politica ambientale, attraverso una dichiarazione che fornisca uno schema di riferimento per l’attività e la definizione degli obiettivi e traguardi in campo ambientale. IV. Pianificazione e strutturazione del sistema di gestione ambientale Fissati gli obiettivi, deve essere definita la “pianificazione”, che può essere considerato il momento centrale di tutto il processo, poiché rappresenta la fase in cui viene definito e strutturato il sistema di gestione ambientale che deve garantire sia il rispetto delle leggi ambientali, applicabili al porto turistico, sia il conti- nuo miglioramento delle prestazioni ambientali. V.Attuazione e controllo del sistema di gestione ambientale implementato In seguito all’attuazione vera e propria del Sistema di Gestione Ambientale, è necessario prevedere con cadenza periodica dei momenti di controllo e verifica sul sistema stesso. Qualora l’esito di tali esami risulti positivo, e cioè si possa affermare che i traguardi prefissi sono stati raggiunti, s’innesca un circolo virtuoso, con la definizione di nuovi obiettivi ambientali, definito come: “processo di miglioramento continuo”. Per verificare l’adeguatezza e l’efficacia di un Sistema di Gestione Ambientale si ricorre alle visite (o verifiche) ispettive. Tali verifiche sono sempre finalizzate a dare un quadro generale dell’affidabilità del sistema e sono regolate dalla normativa di riferimento. 3.Obiettivi della certificazione di porti turistici L’obiettivo della certificazione ambientale è la promozione di uno sviluppo so- stenibile, uno sviluppo, cioè, che non comprometta la capacità di riproduzione delle risorse utilizzate e che soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere analoghe possibilità di utilizzo da parte delle generazioni future. Nel caso dei porti turistici l’adozione di un sistema di gestione ambientale si propone quindi di favorire una gestione razionalizzata del sistema portuale che, partendo dall’analisi preventiva dei carichi ambientali, preveda una serie di interventi mirati. Questi possono essere, ad esempio, la messa in opera delle vasche per la raccolta degli oli esausti e delle batterie, l’avvio di un servizio di presidio tecnico, la messa in opera di piani d’emergenza e procedure operative specifiche per la gestione di potenziali incidenti e situazioni d’emergenza, al fine di raggiungere obiettivi quali: ✓ contribuire al miglioramento qualitativo delle acque di mare; ✓ mirare alla conservazione dell’ecosistema; ✓ offrire servizi portuali volti a minimizzare gli impatti ambientali. 6 HS+E magazine Infine, l’inquinamento cronico o accisfuggire né ai gestori dei porti del litorale Un sistema di gestione si configura coconsiderazione dell'aspetto ambiental dovuto a sversamenti di idrocarmediterraneo, né ai diportisti che citano lo ladentale, me una struttura dinamica, capace di evolburi non sembra invece rappresentare scarico delle acque reflue delle imbarcaversi e di fornire risposte adeguate al muattività dei diportisti nei portiuna del golfo fonte significativa d’inquinamento dei zioni fonti comediuna delle principali fonti di intare delle esigenze, grazie ad un monito- principali inquinamento da attività di diporto scarico delle acque provenienti turistici. quinamento (figura 4.1). raggio continuo dei risultati conseguiti da porti attività di carenaggio che permette di ritarare i propri programscarico delle acque reflue dalle mo mi ambientali, definendo eventualmente 5% 5% 16% imbarcazioni 5% 26% 16% nuovi obiettivi ambientali e innescando un 15% motori delle imbarcazioni med processo di miglioramento continuo delle prestazioni verso traguardi più elevati, descarico di oli dalle pompe dello sen stinato a coinvolgere tutte le strutture che scafo delle imbarcazioni la considerazione dell'aspetto ambientale durante le 24% interagiscono con l’area portuale. rifiuti solidi scaricati dalle 30% imbarcazioni attività dei diportisti nei porti del Quest’ultimo punto è l’obiettivo princi58%golfo di Genova inquinamento da attività di diporto scarico delle acque provenienti pale dei principali Sistemifonti di diGestione Ambientale: altro da attività di carenaggio ottenere continui miglioramenti delle prescarico delle acque reflue dalle non risponde stazioni ambientali, 5% in accordo con la po5% 5% imbarcazioni molto 16% 16% 26% litica ambientale dell’organizzazione. 15% motori delle imbarcazioni 4.Applicazione della certificazione ambientale alla costa ligure 24% Lo studio d’ingegneria francese BCEOM ha condotto uno studio, per conto dell’Accordo Internazionale RAMOGE, relativamente all’impatto dei porti turistici sulla qualità delle acque del litorale mediterraneo, in particolare delle costa monegasca e ligure. Oggetto di questo studio sono nove porti della costa ligure (il porto comunale di Bordighera, il porto comunale di San Remo, il porto privato di San Remo “Porto Sole”, il porto comunale d’Alassio, il porto privato “Marina Porto Antico” di Genova, il porto privato dello Yacht Club Italiano (YCI) nel bacino Duca degli Abruzzi a Genova, il porto pubblico di Portofino, il porto privato di Chiavari, il porto privato di Lavagna) e due della costa monegasca (le port de Fontvieille e le port de la Condamine). Quest’indagine ha consentito di effettuare alcune importanti considerazioni riguardo l’inquinamento organico-batteriologico e l’inquinamento chimico del litorale franco-italo-monegasco. Per quanto riguarda l’inquinamento organico-batteriologico, si ricerca nello specifico una correlazione tra intensità di frequentazione del porto da parte delle imbarcazioni e degrado della qualità dell’acqua. Tuttavia, dalle numerose osservazioni su porti francesi ed esteri (USA), si ravvisa che la predominanza di altre fonti d’inquinamento, specialmente le acque di ruscellamento pluviali, causano spesso il mascheramento degli apporti diffusi di inquinanti batteriologici da parte delle imbarcazioni. L’attività portuale, nonostante questo mascheramento, risulta comunque causa di inquinamento di questo tipo, ed aumenta all’aumentare della sedentarietà delle imbarcazioni. Quest’aspetto sembra non 30% mediamente scarico di oli dalle pompe dello scafo delle imbarcazioni rifiuti solidi scaricati dalle imbarcazioni altro non risponde Figura 4.1 Principali fonti di 58%inquinamento da attività di diporto I porti turistici possono infatti acuire in modo significativo, specialmente nei periodi di alta stagione (mesi estivi), la presenza di rifiuti flottanti, principalmente per quanto riguarda le imbarcazioni con peso superiore alle due tonnellate, che rappresentano la gran parte delle imbarcazioni dei diportisti europei, le quali non sono generalmente dotate di equipaggiamento per il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi a bordo. Per quanto riguarda, invece, l’inquinamento di tipo chimico si ha una correlazione più marcata con l’attività da diporto, rispetto all’inquinamento di tipo organicobatteriologico. La presenza di metalli pesanti, come stagno e rame, tipici residui delle vernici antivegetative, rappresenta, ad esempio, un indicatore specifico delle attività da diporto. Questo tipo di inquinanti sono persistenti in quanto entrano nella catene trofica. Le sorgenti di inquinamento chimico più diffuse sono, quindi, le vernici antivegetative. Anche se la nuova generazione di questi prodotti tende a minimizzare la presenza di metalli pesanti, rimane comunque una forte componente tossicobiocida. In particolare le aree di carenaggio delle acque portuali e delle loro immediate vicinanze, contribuiscono all’arricchimento di inquinanti tossici quando il numero di operazioni risulta significativo. Anche le batterie esauste, che possono venire gettate nelle acque, rappresentano una fonte importante d’inquinamento. senza risposta Figura 4.2 - La considerazione dell’aspetto ambientale durante le attività dei diportisti nei porti del Golfo di Genova Durante questo studio sono state compiute, inoltre, alcune indagini sulle opinioni dei gestori e dei diportisti dei porti considerati (figura 4.2). Ad esempio, le principali cause di inquinamento nel Golfo di Genova causato dalle attività da diporto, sono state identificate come riassunto nella figura 5.1. Come principale fonte d’inquinamento sono stati identificati “gli scarichi d’olio dalle pompe degli scafi” (30%), seguiti da “i motori delle imbarcazioni” (24%). I gestori dei porti sembrano ritenere di essere sufficientemente equipaggiati per far fronte ad aspetti ambientali come la raccolta differenziata, vasche per la raccolta di oli esausti, trattamento delle acque provenienti dalle aree di carenaggio. 5.Primo porto turistico italiano certificato: Marina Porto Antico Il Porto di Genova (figura 5.1) si estende ininterrottamente per 20 km lungo una fascia costiera che si sviluppa dal bacino del Porto Antico, in corrispondenza del centro storico della città, fino al suo estremo di ponente. In Porto possono essere accolte navi di diverso tipo e stazza e movimentate merci solide e liquide di qualsiasi natura e dimensione, attraverso l'operatività di 13 terminal raccordati. All'interno del bacino del porto antico della città sono presenti dei terminal traghetti e dei terminal crociere. La superficie occupata dall'insieme delle infrastrutture portuali è pari a circa 7 milioni di metri quadrati. 7 HS+E magazine Figura 5.1 - Cartina del porto di Genova Figura 5.2 - Mappa del tratto della costa ligure che comprende il bacino del Porto di Genova Figura 5.3 - Planimetria del sito di Marina Porto Antico Marina Porto Antico (figura 5.3), che si trova all’interno del bacino del Porto di Genova, ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001, con la consulenza tecnica di Servizi Industriali Genova SIGE, rilasciata dal RINA nell’ottobre del 2000. Questo riconoscimento rientra in un progetto più ampio del Consorzio Ligure dei Porti Turistici, a cui fa capo Marina Porto Antico, che prevede la futura certificazione di altri porti turistici liguri che fanno parte dello stesso consorzio. Questo investimento della Marina Porto Antico S.p.A. ha ricevuto l’appoggio della Regione Liguria che ha finanziato in parte il progetto, riconoscendo in esso un primo passo verso uno sviluppo sostenibile della costa ligure. Marina Porto Antico comprende un molo principale che dall'estremità di Ponte Morosini si protende verso il centro del Porto Antico di Genova. Da questo molo, destinato ad ospitare le imbarcazioni più grandi, ne dipartono quattro minori. I pontili affiancati ai moli storici esistenti e lungo il perimetro a mare dei nuovi edifici di ponte Calvi e Ponte Morosini completano la struttura. La struttura è stata costruita su un’area precedentemente occupata da edifici adibiti a magazzini o uffici (silos vinari della Società Denaro, uffici della Corsica Ferry e sede nautica della Capitaneria di porto). Sui materiali usati per la costruzione dei pontili esposti agli agenti marini risulta eseguito uno speciale ciclo protettivo che offre garanzie di sicurezza e durata nel tempo. I pontili poggiano su pali incamiciati in acciaio, per garantire il passaggio della corrente ed eliminare il fenomeno ”risacca”. Il complesso di Marina Porto Antico può contare su 270 ormeggi per imbarcazioni da 10 a 40 metri di lunghezza. All'interno della Marina si trova una piccola Darsena dove sono stati realizzati alcuni posti barca per imbarcazioni dai 5 ai 7 metri. ✓ I servizi tecnici di banchina presenti sono: colonnine acqua/energia elettrica, cabine telefoniche, smaltimento batterie, pulizia pontili e ritiro rifiuti in banchina, servizio antincendio. ✓ Il servizio di assistenza prevede: servizio di assistenza all’ormeggio, ascolta VHF canale 74, assistenza subacquea, guardianaggio, servizio meteorologico, cantiere Marina Service. ✓ Sono presenti inoltre: sistema di illuminazione, servizi igienici e docce, trasporto bagagli con auto elettrica, deposito attrezzature, parcheggio autovetture all’interno dell’autosilo, stazione di rifornimento carburante. Prima di procedere all’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale , Marina Porto Antico ha effettuato un’Analisi Ambientale Preliminare con la funzione di fotografare la situazione di partenza e di individuare gli aspetti su cui è neces- Figura 5.4 - Veduta dall’alto dei sito di Marina Porto Antico sario intervenire per ridurre gli impatti ed iniziare il processo di miglioramento continuo. Nel caso di Marina Porto Antico la “fotografia iniziale” ha avuto difficoltà a considerare alcuni aspetti a causa della breve storia del complesso. Questo è stato il caso, ad esempio, dei consumi di materie prime, idrici, energetici e di combustibile. In particolare la mancanza di prelievi ed analisi per una valutazione dello stato dello specchio d’acqua in concessione e dei sedimenti relativi a tale area è causata dal fatto che il porto turistico si trova all’interno di un bacino già notevolmente urbanizzato, e incide quindi in modo poco significativo sullo stato delle acque. 6.CONCLUSIONI Malgrado si parli già da tempo di turismo sostenibile o ecoturismo, l’attuale relazione tra turismo ed ambiente è ancora troppo basata su uno sfruttamento delle risorse distante dai principi definiti nella Conferenza di Rio. Le norme volontarie possono effettivamente rappresentare un’occasione per dare origine ad un nuovo corso della vita 8 economica, sociale, ed in generale gestionale del territorio. A distanza di due anni dalla certificazione del sito di Marina Porto Antico, si è notato un miglioramento evidente per quanto riguarda la consapevolezza della direzione e dei dipendenti sulla tutela e rispetto dell’ambiente e sul possibile impatto derivante dalle proprie attività. Ciononostante risulta ancora difficile ottenere una misurazione vera e propria di miglioramento degli impatti delle diverse attività del porto, soprattutto a causa della localizzazione del sito che si trova immerso in un centro cittadino già estremamente antropizzato, in cui si hanno impatti molto elevati derivanti da altre attività che avvengono in prossimità e che si sovrappongono agli impatti del porto turistico. Quindi si ritiene che nel complesso la certificazione del sito abbia portato risultati positivi come già sottolineato, principalmente per quanto riguarda la sensibilizzazione del personale e della direzione. PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI [1] Commission RAMOGE, 2001 – Le Management environnemental des ports de plaisance, guide à l’attention des gestionnaires et exploitants – HS+E magazine [2] ANPA, 1998 – Linee guida per l’applicazione del Regolamento CEE 1836/93 (EMAS) e della norma ISO 14001 da parte della Piccola e Media Impresa – [3] UNI-Milano, 1997 - Gestione ambientale: adesione al reg. CEE 1836/93 “EMAS” e norme ISO 14000 [4] ENEA, 1998 – L’impresa e lo sviluppo sostenibile, i sistemi volontari di gestione ambientale EMAS – [5] Commission RAMOGE, 2000 – Expertise environnementale des Ports de Plaisance de la zone RAMOGE – [6] UNEP, 1995 – Guidelines for Integrated Management of Coastal and Marine Areas. *Laureata in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Genova, attualmente frequenta il Master GESAL all’Università di Milano Bicocca **Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse - Università di Genova ***Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo “G.B. Bonino” – Università di Genova. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS APPLIED TO TOURIST HARBOURS In the last few year, environmental safeguard has become a top priority for most of the parties involved. With the progressive increase in tourist harbours along the coasts, in boats tonnage and due to their longer permanence in harbours, also thanks to the improvement of services offered, the need to take into due account pollution sources related to tourist harbours has arisen, thus imposing to assess and control relevant environmental impacts. Environmental management provides for companies to implement a system based not only on trying to avoid passing law limits but also on a programme for the continual improvement of company behaviour towards the surrounding environment. The management of environmental issues is an essential aspect strongly related to the company consideration of quality. It is inconceivable for a company to operate under quality assurance conditions while not being able to provide adequate answers to its Clients, to relevant Authorities (as to laws and regulations), to its collaborators (as to safetyrelated aspects), to the public (as to environmental and image-related issues). For this reason, the environmental certification is an important means of communication aimed at clearly conveying a strong commitment of the company to the respect for the environment. The implementation procedure of an Environmental Management System to a tourist harbour highlights 5 essential connected steps: 1. Classification of the harbour area 2. Preliminary environmental analysis 3. Definition of environmental policy and objectives 4. Structure and organisation of the Environmental Management System 5. Implementation and control of the Environmental Management System Following the Environmental Management System control and should targets set be achieved, a virtuous circle defined as continual improvement process is triggered off, leading to increasingly more important and demanding objectives as to environmental safeguard. 9 HS+E magazine L’esplosivo: un’arma economica e sicura per trasformare le nostre città Massimo Viarenghi*, Claudio Mattalia** In un paese sempre più saturo di ferro e cemento si sta facendo avanti la convinzione che siano necessarie mosse strategiche per il rinnovamento, l’ampliamento dei centri urbani e il riutilizzo di nuovi spazi occupati da vecchi insediamenti industriali; ne deriva la consapevolezza che un buon contributo alla qualità dell’ambiente cittadino può essere rappresentato anche da azioni di demolizione nei punti nevralgici delle aree urbane ed industriali. Nel contesto italiano, infatti, quello che manca è la cultura della demolizione, un movimento di pensiero che spinga ad un’applicazione più incisiva di questa tecnologia. Il culto della conservazione, d’altronde, sembra escludere a priori la demolizione anche delle strutture più obsolete e prive di qualsiasi pregio architettonico. Gran parte degli edifici di cui si discute la demolizione è stata costruita tra gli anni ‘50-’60 per rispondere alla crescente domanda di abitazioni privilegiando la quantità costruttiva piuttosto che la qualità. In questo senso l’Italia è il fanalino di coda dell’Europa; in Francia, Inghilterra e Germania, l’utilizzo della demolizione, finalizzata al rinnovamento cittadino, è radicata da diversi anni. Negli Stati Uniti la situazione è ancora diversa, oltre oceano le tecniche di demolizione sono così perfezionate e sono entrate a fare parte della filiera del rinnovamento delle città e delle periferie. Tuttavia qualcosa sta cambiando: la sempre crescente necessità di nuovi spazi per costruire, la necessità di rinnovamento e recupero urbano fanno sì che la demolizione divenga sempre più un’esigenza ineludibile, in aggiunta a questo fattore è necessario sottolineare che la demolizione dell’esistente per ricostruire non solo costa circa un terzo rispetto alle operazioni di restauro, ma permette di ricostruire edifici con tipologie e dotazioni di standard più adeguati. In questo panorama la demolizione deve rispondere a diverse esigenze: ridurre il più possibile i costi e tempi dell’intervento, garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori durante le operazioni di demolizioni e non generare disturbi o impatti ambientali. Attualmente, le tecniche in uso per la demolizione di strutture complesse come fabbricati industriali o di edifici, possono essere suddivise in due grandi categorie: le tecniche di demolizioni convenzionali con escavatori muniti di pinze e frantumatori e le tecniche di demolizione non convenzionali con esplosivo. Quando le demolizioni rientrano nel campo degli interventi che mirano ad eli- minare un pericolo o un ingombro costituito da strutture instabili o non più utilizzate, oppure a recuperare superfici occupate da strutture dismesse, da costruzioni abusive o ecologicamente inquinanti, l’esplosivo offre i vantaggi di rapidità di esecuzione, di minor disagio per la popolazione e maggior sicurezza per gli addetti ai lavori, soprattutto per strutture di elevata altezza (oltre i 12-15 m). Le tecniche di demolizione con esplosivo sono applicabili in qualsiasi luogo ed a qualsiasi tipo di costruzione dove, con il termine costruzione si intende non solo l’edificio in se stesso ma anche strutture industriali, silos, ponti e ciminiere. Con queste tecniche, utilizzando le sinergie tra ingegneri e artificieri, si è in grado di ridurre in pochi secondi strutture poderose in un “mucchio di macerie composte” senza il minimo danno per gli edifici limitrofi anche se distanti pochi metri. Nella demolizione con esplosivo si produce l’indebolimento della struttura, modificandone lo schema statico, mediante la detonazione di cariche di esplosivo piazzate in punti strategici; il cedimento o l’abolizione di alcuni degli elementi portanti crea un cinematismo che evolve in crollo per azione della forza peso. Le strutture possono essere demolite secondo diverse modalità, tra cui le più utilizzate sono l’implosione e il ribaltamento. 10 HS+E magazine Foto 1: Torre piezometrica demolita con la tecnica di ribaltamento (foto by Esplodem Service). Quando una struttura viene demolita utilizzando la tecnica dell’implosione si eliminano i vincoli interni del manufatto utilizzando cariche microritardate partendo dal centro fino alla periferia; in questo modo si induce la struttura a collassare su se stessa rimanendo mediamente all’intermo del suo volume iniziale. Il ribaltamento consiste nella caduta laterale del manufatto: eliminando con le cariche di esplosivo una porzione di appoggio della struttura si crea artificialmente un asse di cerniera tra terreno e costruzione, la struttura inizia così a ruotare quasi rigidamente attorno a questo asse creando le condizioni cinematiche per il crollo, sotto l’azione della forza peso. Questa tecnica viene solitamente utilizzata per demolizioni di strutture snelle come edifici di elevata altezza ciminiere e torri piezometriche, si veda la foto n.1. Condizione per l’applicabilità di questa tecnica è la presenza, lungo almeno una facciata della struttura, di un area libera per accogliere il crollo, viceversa, ove non sussistano gli spazi di caduta, si utilizza la tecnica dell’implosione, si veda la foto n.2. In entrambe le tecniche il direzionamento viene ottenuto temporizzando le cariche di esplosivo, il cui compito è eliminare taluni vincoli strutturali (appoggi e incastri), secondo una ben prestabilita sequenza trasformandoli in cerniere che producono una variazione dello schema statico strutturale, (da iperstatico a labile) direzionando le altre parti della struttura risparmiate dalla detonazione delle cariche. Per quanto riguarda il dosaggio dell’esplosivo, esso deve essere in quantità “sufficiente e necessaria” alla disgregazione degli elementi strutturali per produrre il crollo; qualsiasi dose eccessiva, infatti, non aiuta maggiormente l’effetto ma favorisce solo il rischio di proiezioni di detriti dagli elementi minati. La previsione e il monitoraggio di tutti i disturbi (vibrazioni, sovrapressioni, rumori, proiezioni di detriti) legati all’utilizzo di esplosivo in ambienti antropizzati fanno sì che in un progetto di demolizione con esplosivo nulla venga lasciato al caso elevando gli standard di sicurezza fino a superare, in diversi casi, quelli delle tradizionali demolizioni con mezzi meccanici. Nelle demolizioni con mezzi meccanici, infatti, gli operatori infatti sono continuamente a contatto con il manufatto in demolizione e sovente i costi per garantire un ambiente di lavoro sicuro sono elevati. Utilizzando l’esplosivo, invece, oltre alla possibilità di eseguire la demolizione utilizzando unicamente una meccanizzazione leggera, si ha il vantaggio di operare sulla struttura integra, o eventualmente indebolita a ragion veduta senza comprometterne la stabilità, nel corso dell’intera fase preparatoria, mentre ovviamente nella fase conclusiva il personale è in sicurezza, lontano dalla struttura da demolire. Foto 2: Complesso industriale in pieno centro cittadino demolito con la tecnica dell’implosione - (foto by Esplodem Service). In definitiva, l’utilizzo dell’esplosivo per le operazioni di demolizione è un’arma vincente, economica e sicura da utilizzare per il rinnovamento ed il miglioramento dell’assetto edilizio nazionale. *Ingegnere, Responsabile settore demolizioni e sicurezza ENVIARS, Chieri TO **Ingegnere, Responsabile tecnico ENVIARS, Chieri (TO) 11 HS+E magazine The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) Inizia con questo numero di HS+E Magazine, la pubblicazione di una serie di articoli che illustrano la storia e la “mission” delle principali Istituzioni ed Agenzie internazionali private o governative che, in diverso modo, hanno contribuito a sviluppare e diffondere la cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché la cultura del soccorso e del salvataggio sia in ambito civile che industriale. In seguito ad una conferenza pubblica sulla sicurezza del traffico tenutasi nel 1916 a Londra presso la Caxton Hall fu deciso di creare un comitato, denominato “London Safety First Council”, con lo scopo di promuovere iniziative contro l’allarmante aumento di incidenti stradali causati dal sempre più caotico traffico della capitale britannica. Nel 1941 fu poi adottata l’attuale denominazione di Royal Society for the Prevention of Accident (RoSPA). L’Associazione che già nei primi anni dopo la sua creazione all’obiettivo originario di occuparsi di sicurezza stradale e dei trasporti aveva affiancato l’attività di prevenzione in altri settori, si è sempre distinta per iniziative originali e campagne pubbliche che spesso hanno portato all’emanazione o alla modifica di leggi riguardanti la sicurezza dei cittadini. Già nel 1918 fu istituita la “British Industrial Safety First Association” allo scopo di promuovere la sicurezza nel mondo del lavoro. Negli anni ‘20 l’Associazione risultò fortemente impegnata nella produzione di filmati educativi e nella promozione di concorsi in ambito scolastico in cui evidenziava l’importanza della prevenzione quale misura primaria per la drastica riduzione degli infortuni in ambito scolastico, casalingo e durante le attività ricreative. In materia di regolamentazione del traffico occorre ricordare che a livello mondiale l’Associazione si è per prima battuta per la realizzazione degli attraversamenti pedonali segnalati, per l’adozione dei semafori temporizzati e per il divieto d’uso dei fari abbaglianti all’incrocio con altri veicoli. È curioso notare come nel 1925 alcune imprese assicuratrici si rifiutarono pubblicamente di appoggiare una associazione le cui attività, volte a ridurre gli incidenti, avrebbero verosimilmente portato ad una diminuzione dei premi!. Nel 1933 fu prodotto in 10.000 copie (subito andate a ruba) il primo opuscolo inerente la sicurezza domestica. GRUPPO NUOVA OLP per mettere la vostra sicurezza in mani sicure!! Via M. Monti, 38 – 48100 RAVENNA Tel. 0544 450902 Fax 0544 451731 - www.nuovaolp.com Nuova Olp Nuova Olp Impianti Securproject Commercializzazione di un’ampia gamma di dispositivi per la protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, attrezzature e dispositivi antincendio. Realizza, installa, cura l’assistenza e la manutenzione di una vasta tipologia di impianti nei settori industriale, civile, navale e dell’offshore petrolifero e precisamente: ANTINCENDIO SICUREZZA TERMOTECNICA Progetta impianti elettrici, elettronici, antincendio e termoidraulica; e svolge servizio di consulenza e formazione in materia di sicurezza Aziendale. Sempre in quell’anno il Duca di York e Sir Malcom Campbell (famoso recordman di velocità e futuro presidente dell’Associazione) presero parte ad un filmato promozionale in tema di sicurezza stradale mostrato a più di 250.000 studenti. Nel 1942 furono creati 62 poster sul tema della sicurezza nei diversi ambienti di lavoro; furono distribuiti in oltre mezzo milione di copie ed esposti per un certo periodo anche al Museum of Modern Art di New York. Alla fine degli anni ’40 si incrementò ulteriormente l’impegno nelle campagne di promozione per la sicurezza domestica. Dall’inizio degli anni ’50 in poi l’Associazione divenne meglio strutturata potendo contare su centinaia di comitati di zona che localmente potevano promuovere la sicurezza nei tre settori principali – traffico e trasporti, domestico/ ricreativo e ambienti di lavoro. Tra questo periodo e la fine degli anni ‘60 RoSPA si fece promotrice di diverse leggi governative riguardanti tra l’altro: - l’obbligo dell’uso del casco per i motociclisti; - la revisione della segnaletica stradale; - le sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza; - l’obbligo di adozione di un sistema di chiusura di sicurezza per i contenitori dei medicinali; - la sicurezza nelle attività ricreative in ambiente acquatico - la sicurezza dei giocattoli Nel 1971 fu pubblicato il primo numero di “Occupational Safety & Health Journal”, ancora oggi tra i più rinomati periodici internazionali in materia di sicurezza ed igiene industriale. Nel 1976 l’Associazione trasferì la propria sede da Londra a Birmingham diventando da lì a breve uno dei promotori dell’importante “Safety and Health Expo” che si svolge ancora oggi all’interno dei padiglioni del NEC –National Exhibition Centre. Gli anni ’90 hanno visto L’Associazione impegnata su diversi fronti tra cui la sicurezza delle attrezzature elettriche, la sicurezza nei trasporti pubblici, negli sport acquatici e nell’utilizzo dei velocipedi da parte dei minorenni. Tra le più recenti campagne condotte da RoSPA si segnala quella contro l’utilizzo in auto dei telefoni cellulari. 12 HS+E magazine l’amianto, Un tema d’attualità anche nel futuro Davide Mazzotti*, William Vandini** L’amianto, dal greco Amiantos (immacolato, incorruttibile) o Asbesto (perpetuo, incombustibile) indica una serie di minerali fibrosi appartenenti alle famiglie dei silicati e nello specifico ai serpentini (fillosilicati) ed agli anfiboli (inosilicati). L’amianto è conosciuto ed utilizzato fin dall’antichità: dall’uso durante i riti funerari di Romani e Persiani, all’uso come fibra tessile in Cina, descritto da Marco Polo, fino all’utilizzo nel 1600 in alcune medicine. Nel 1893 in Austria inizia la produzione di cemento amianto; negli anni seguenti questo minerale acquista sempre più importanza, arrivando all’apice della produzione e dell’utilizzo negli anni ‘50-’70. Sono stati stimati oltre 3000 prodotti contenenti amianto tra i quali lastre in cemento-amianto, tubazioni, serbatoi per acqua, canne fumarie, intonaci, vernici, isolanti termici (pannelli, tessuti, guarnizioni, ecc.), pavimentazioni (vinil-asbesto), indumenti (guanti, tute) e componenti per freni e frizioni. A seconda della famiglia di silicati a cui appartengono e della specifica composizione chimica, sono diversi i tipi di amianto utilizzati. Per quanto riguarda l’amianto di serpentino l’unica forma utilizzata è il Crisotilo o asbesto bianco [Mg3Si2O5(OH)4], un silicato di magnesio, ritenuto meno pericoloso delle altre ti- Tipo di materiale/utilizzo pologie di amianto per la caratteristica delle fibre di essere difficilmente inalabili. Il D.Lgs 277/91 fissa il limite di esposizione per il Crisotilo a 0,6 fibre/cc). Tra gli amianti di anfibolo utilizzati troviamo la Crocidolite o amianto blu [Na2(Mg,Fe)5Si8O22], l’Amosite o asbesto bruno [(Mg,Fe)7 Si8O22(OH)2] e, in maniera meno diffusa, l’Actinolite, la Tremolite e l’Antofillite. Gli amianti di anfibolo, per le caratteristiche aghiformi delle fibre, sono ritenuti assai pericolosi; per questi il D.Lgs 277/91 fissa il limite di esposizione a 0,2 fibre/cc. Il limite fissato dall’ ACGIH (TWA) è invece più restrittivo e pari a 0,1 fibre/cc per tutti i tipi di amianto. In Italia il 75% dell’amianto utilizzato è Crisotilo. Nella tabella seguente si riportano i principali utilizzi dell’amianto (o suoi composti), con l’indicazione della tipologia di amianto generalmente presente e con la caratteristica, propria del materiale, di rilasciare fibre, caratteristica correlata principalmente alla friabilità o compattezza del materiale stesso. Si ricorda che, secondo la definizione presente nel DM 06/09/94, si definiscono friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale, mentre si definiscono compatti i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici. Amianti utilizzati Caratteristiche Prodotti in cemento-amianto In genere tali prodotti contengono il 10-15% di asbesto bianco (Crisotilo); si possono però trovare prodotti contenenti anche Crocidolite ed Amosite (tubi, lastre) Materiali compatti, possono rilasciare fibre se lavorati o deteriorati Cartoni, carte ed affini Generalmente costituiti da Crisotilo al 100% Sono soggetti a facile usura o deterioramento; rilasciano facilmente fibre se maneggiati. Rivestimenti isolanti (tubazioni, caldaie) Tutti i tipi di amianto Materiali friabili se non ricoperti bene ed uniformemente, o se la ricopertura è deteriorata, la possibilità di rilascio di fibre è alta. Rivestimenti a spruzzo In genere fino all’85% di amianto prevalentemente amosite Funi, corde, tessuti Tutti i tipi di amianto con prevalenza di crisotilo Elevata friabilità e possibilità di rilascio fibre. Possibilità di rilascio fibre se maneggiati. Prodotti bituminosi, pavimenti vinilici, stucchi, mastici, vernici Tutti i tipi di amianto Materiali compatti, la possibilità di rilascio fibre è limitata alla lavorazione di detti materiali (taglio, abrasione, perforazione) 13 HS+E magazine Aspetti normativi Diverse sono le leggi che disciplinano la materia amianto; lo storico è riassumibile con tre norme principali: il DPR 1124 del 30.06.65 (disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi), la Circolare Ministero della Sanità n. 45 del 10.07.86 (interventi da effettuarsi negli edifici scolastici ed ospedalieri all’interno dei quali vi sia amianto o materiali che lo contengono) ed il DPR 215 del 24.05.88 (limitazioni e divieti riguardanti l’uso della crocidolite e l’etichettatura dei tipi di amianto diversi dalla crocidolite). Solo nel 1991, con l’emanazione del D.Lgs. 277 del 15.08.91 (protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro), si pone l’attenzione specifica sull’esposizione ad amianto in ambito lavorativo. Il D.Lgs. 277/91 anticipa, per quanto riguarda l’amianto (il piombo ed il rumore), il D.Lgs. 626/94. Fa seguito al D.Lgs. 277/91 la Legge 257 del 27.03.92 (concernente norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) con la quale si decreta la fine dell’estrazione di amianto e della produzione di qualsiasi materiale che lo contenga e l’obbligo di denuncia dei materiali friabili da parte dei detentori. Questa legge introduce inoltre (art. 13) la possibilità a chi è stato esposto all’amianto (secondo le diverse ipotesi specificate nella Circolare INAIL n. 252 del 23.11.95) di usufruire di benefici pensionistici: in maniera di 0,5 anni in più di contribuzione figurativa per ogni anno di esposizione per un periodo superiore a 10 anni. Successivamente il D.M. 06.09.94 (norme e metodologie di applicazione della legge 257/92) fornisce i principi per la valutazione del rischio da esposizione ad amianto, definisce il concetto di compatto e friabile ed introduce il monitoraggio del degrado dei manufatti in cemento amianto. In seguito sono state emanate altre leggi sempre più focalizzate alla dismissione dei materiali contenenti amianto, come ad esempio il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), o alla prevenzione e monitoraggio dell’inquinamento ambientale da fibre di amianto (D.Lgs 114/95). Aspetti medico-sanitari È ormai certa la cancerogenità delle fibre di amianto. Le fibre di amianto maggiormente pericolose risultano essere quelle con rapporto lunghezza/diametro > 3 ed in particolare con lunghezza maggiore di 5µm e diametro inferiore a 3 µm. La via di penetrazione principale nell’organismo umano è sicuramente quella respiratoria, ma può essere rilevante anche quella digestiva. Le principali malattie correlate ad una esposizione a fibre di amianto sono l’asbestosi (fibrosi interstiziale progressiva del polmone con diminuzione irreversibile della capacità respiratoria), il mesotelioma pleurico-peritoneale (tumore maligno della membrana di rivestimento del torace o dell’addome; sembra provocato esclusivamente da amianti di tipo anfibolico), il cancro polmonare e il cancro laringeo. L’origine del mesotelioma è ad oggi correlabile esclusivamente all’inalazione di fibre (con esposizioni anche non intense) di amianto o all’irradiazione di alte dosi di radiazioni ionizzanti. Il rischio di mesotelioma dipende dal tipo di fibra e dall’intensità dell’esposizione, nonostante non esista una dose-soglia di inalazione di fibre al di sotto della quale può essere esclusa la possibile azione carcinogenetica. Già da tempo l’ISPESL, in collaborazione con i COR (Centri Operativi Regionali), ha prodotto numerose ricerche, il registro nazionale dei mesoteliomi e le linee guida per i lavori in presenza di amianto. Tralasciando le problematiche connesse all’amianto friabile (utilizzato soprattutto come isolante per tubazioni, rivestimenti o riempimento di pannelli isolanti o per intonacature) che per legge deve essere denunciato alle Autorità Competenti e reso “innocuo” vista l’estrema pericolosità, vogliamo in questa sede prendere in considerazione il cemento amianto, più conosciuto come “eternit”, oramai ubiquitario in ambito industriale, artigianale ma anche civile (in fig 1 una caratteristica copertura in lastre ondulate di eternit). Figura 1. Una copertura in lastre ondulate di eternit. 14 L’eternit fa parte della categoria dei materiali compatti; negli anni è stato utilizzato soprattutto a copertura di capannoni industriali e artigianali, di edifici civili, di tettoie o per la costruzione di tubazioni, serbatoi o pareti interne. L’eternit, se in buone condizioni di conservazione, non è pericoloso in quanto le fibre di amianto sono “immerse” in una matrice di cemento che non ne permette il rilascio; i problemi nascono quando la matrice comincia a sgretolarsi. In linea generale possiamo affermare che l’eternit, all’interno di edifici, capannoni, eccetera, può rappresentare un pericolo solo se lavorato (forato, molato, levigato o tagliato) mentre per quanto riguarda l’eternit presente all’esterno, il discorso cambia e non è possibile generalizzare. All’esterno infatti sono diversi i fattori che possono intaccare il cemento amianto tra i quali i fattori meteo climatici (pioggia, alternanza di caldo e gelo) e la formazione di organismi quali muschi, licheni, ecc.; le azioni prodotte da questi fattori possono provocare la disgregazione della matrice con il conseguente rilascio di fibre nell’ambiente. Attualmente, essendo messa al bando la produzione e la lavorazione di manufatti contenenti amianto, gli unici lavoratori che, in base alla definizione della 277/91, risultano “esposti” sono gli addetti alle operazioni di bonifica (rimozione, inertizzazione, incapsulamento). Tali operazioni sono quindi soggette ad una accurata valutazione dei rischi e alle prescrizioni per la tutela della salute dei lavoratori contenute nel D.Lgs 277/91. L’amianto ed i sui derivati sono però presenti in maniera massiccia intorno a noi e la potenzialità di rilascio di fibre nell’ambiente può rap- HS+E magazine presentare un pericolo anche per quei lavoratori classificati come “non esposti” o che magari operano in aziende che non hanno manufatti in amianto. Ma non solo, anche chi vive nei pressi di strutture con coperture in eternit può essere a rischio. Considerato per tanto che il rischio è connesso allo stato di conservazione, risulta assai chiaro come un controllo periodico delle coperture in eternit sia necessario. Le Autorità già da tempo auspicano un controllo periodico delle condizioni delle lastre; in particolare la Regione Emilia Romagna ha emesso la Delibera del Consiglio Regionale 497 del 11/12/1996. Tale controllo rientra comunque tra gli obblighi imposti anche dal D.Lgs 626/94 in quanto, in presenza di una sostanza pericolosa, è necessario effettuare la valutazione del rischio. Quindi, anche per tutelare chi non è esposto professionalmente, il Datore di lavoro, il detentore o il proprietario di strutture con coperture o pareti in cemento amianto deve valutare il pericolo di rilascio di fibre nell’ambiente. La valutazione dello stato di conservazione e del possibile rilascio di fibre in ambiente ha una metodologia normata dal DM 6/9/94 di cui si riporta una sintesi. Esame visivo: consiste nell’esame visivo delle condizioni delle strutture e nell‘esecuzione di prove sullo stato di integrità del materiale in relazione alla compattezza, alla presenza di zone con affioramento di fibre e/o sfaldamenti, crepe e/o rotture, alla presenza di materiale friabile o polverulento in grondaia o stalattiti. Dai risultati dell’ispezione visiva viene quindi elaborata una scheda con 15 HS+E magazine assegnazione di un punteggio ai vari parametri dalla cui somma viene infine estrapolato il giudizio sullo stato di conservazione della copertura e le conseguenti azioni da adottare. Campionamento con metodo a strappo: viene utilizzato, ad integrazione dell’esame visivo, come indagine analitica finalizzata alla valutazione della compattezza del materiale mediante la determinazione delle fibre libere, e/o facilmente liberabili, presenti sulla superficie. L’applicazione del metodo “a strappo” è disciplinata dalla Norma UNICHIM 10608 e consiste nell’applicazione di uno speciale nastro adesivo sulla lastra indagata (fig. 2) e successiva determinazione ponderale della massa di materiale distaccato: dal risultato ottenuto in termini di peso viene estrapolato il giudizio sullo stato della superficie delle lastre. Figura 2. Le quattro fasi del metodo di campionamento a “strappo”. Microscopia ottica in luce polarizzata (MOLP): si utilizza per definire la presenza/assenza di amianto nel materiale. Le verifiche devono essere condotte da personale adeguatamente formato che abbia frequentato il corso riconosciuto dalla Regione per “addetto alle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate e dirigente gestione del rischio“. La relazione tecnica che segue agli esami in campo, oltre a fornire indicazioni sul rischio amianto e sulle possibili soluzioni tecniche per diminuire tale rischio (se necessario), potrà essere presentata agli organi di controllo quando richiesto. Se infatti le coperture risultano essere in cattivo stato di conservazione, con un possibile rilascio di fibre, il Datore di Lavoro dovrà attuarne la messa in sicurezza. Tra le varie possibilità che si presentano, oltre chiaramente alla rimozione dei manufatti in amianto, vi sono l’incapsulamento e la ricopertura. Tali tecniche, che non sempre sono la soluzione più economica, rappresentano un buon compromesso tra la salvaguardia della salute dei lavoratori, la produzione di rifiuti e la durata degli interventi nel tempo. ** Dottore in Scienze Ambientali Project Manager - Techno srl (RA) E-Mail: [email protected] Fase 1 ***Chimico Libero Professionista - già Direttore ARPA (RA) Fase 2 Fase 3 Fase 4 Amianthus, from the Greek “Amiantos” (spotless, imperishable), or Asbestos (everlasting, non-flammable) indicates a variety of fibrous minerals belonging to the families of silicates and, in particular, to serpentines (phyllosilicates) and to amphiboles (inosilicates). Asbestos fibres carcinogenity is by this time certain. The most dangerous asbestos fibres are those with a length/ diameter ratio > 3 and in particular those longer than 5µm and with a diameter smaller than 3 µm. The main route for penetration into the human body is certainly through the respiratory tract; however penetration through the digestive apparatus may be remarkable as well. The asbestos-related discipline is regulated by Legislative Decree 277/91 and by law 257/92, which suspend both asbestos extraction and the production of any material containing it while providing for the obligation to declare the possession of friable materials. However asbestos and its derivatives are massively present all around us and the potential of fibres release into the environment may be a serious danger also for those workers classified as “non exposed” or who operate within companies which do not deal with asbestos manufactured products. For this reason Authorities involved hope for a periodical check of the conditions of asbestos cement manufactured products, mainly of those located outdoors, exposed to the different atmospheric conditions. 16 HS+E magazine Ergonomia Il termine ergonomia che deriva dal greco “ergon” - lavoro, azione e “nomos” - legge, governo, indica una “ disciplina che persegue la progettazione di prodotti, ambienti e servizi rispondenti alle necessità dell’utente, migliorando la sicurezza, la salute, il comfort, il benessere e la prestazione umana”. Si tratta quindi di una scienza interdisciplinare che riguarda l’ingegneria, l’anatomia, la biologia, la fisiologia, la psicologia, la biomeccanica e la sociologia ”. Il termine fu coniato dallo psicologo gallese K.F.H. Murrell il quale riteneva che i progettisti delle varie discipline dovessero interagire fra loro sulle problematiche progettuali ponendo al centro della ricerca l’uomo e le sue esigenze operative. Nel 1949 fu fondata in Inghilterra la prima società nazionale di ergonomia che si sviluppò rapidamente anche negli Stati Uniti con il nome di I.E.A (Associazione Internazionale di Ergonomia) e in Italia con il nome di S.I.E (Società Italiana di Ergonomia). Il termine “ergonomia” comprende varie discipline e diversi aspetti tra i quali: la postura, la movimentazione dei carichi, l’organizzazione del lavoro, l’interazione uomo-macchina, le condizioni degli ambienti di lavoro (illuminazione, microclima, rumore, lavoro al videoterminale...). L’ergonomia risulta pertanto l’anello di congiunzione fra uomo-macchina-ambiente, tra i quali dovrebbe esserci un equilibrio tale da garantire la tutela della salute e il benessere per l’operatore. Il punto di riferimento in materia di ergonomia in Italia è rappresentato dal Decreto Legislativo 626/94, l’articolo 3 comma 1 lettera f) infatti riporta: “ le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono “....” il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo”. Risulta chiaro come per la legislazione l’obiettivo di questa nuova disciplina sia adattare il lavoro all’uomo, non considerando solo i rischi ergonomici legati alla ripetitività, ma anche altri fattori legati all’ambiente, ai rapporti interpersonali, ai fattori tecnici di costruzione e a quelli psico-sociologici. Per quanto riguarda i principi tecnici dell’Ergonomia, sia per la progettazione/realizzazione di ambienti/attrezzature di lavoro, sia per la loro valutazione, vi sono diverse norme UNI e ISO; se ne riportano di seguito le principali. Tra le norme UNI troviamo: UNI 8459 del febbraio ‘83 – Ergonomia dei sistemi di lavoro. Terminologia di base e principi generali; UNI ENV 26385 del maggio ‘91 – Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro; UNI 10380:1994/A1 dell’ottobre ‘99 – Illuminotecnica – Illuminazione di interni con luce artificiale; UNI EN ISO 9241-5 del settembre ‘01 – Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) – Requisiti posturali e per la configurazione del posto di lavoro. UNI EN ISO 9241-13 del maggio ‘02 – Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) – Guida per l’utente. UNI EN ISO 9241-6 dell’ottobre ‘01 – Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) – Guida sull’ambiente di lavoro. UNI 7367 – Posto di lavoro: scrivania e sedia, tavolo per video terminale UNI EN 527-1 – Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie – Dimensioni UNI 10916 - Mobili per ufficio - Appoggiapiedi - Dimensioni e caratteristiche Tra le norme ISO troviamo: ISO 2631 – Esposizione dell’intero corpo a vibrazioni; ISO 6385 – Principi ergonomici; ISO 7730 – Comfort termico; ISO 8995 – Illuminazione interna; ISO/CD – Ergonomia – Movimentazione manuale dei carichi – Sollevamento e trasporto. Numerosi sono inoltre gli studi effettuati da diversi enti tra i quali l’ISPESL, il NIOSH, l’ACGIH e le linee guida emanate in seguito. HS+E magazine 2004 ✔ SICUR “14° Salone internazionale della sicurezza” 24 - 27 Febbraio • Madrid (E) ✔ S.I.E. Salone delle imprese edili e degli studi di progettazione 04 - 06 Marzo • Padova (I) ✔ SEP 2004 “ECO-TECHNOLOGIES EXHIBITION” 17 - 20 Marzo • Padova (I) ✔ Bica Biennale Internazionale Comunicazione Ambientale 24-27 Marzo • Venezia (I) ✔ Ergonomics Society Annual Conference 2004 14 - 16 Aprile • Swansea (UK) ✔ 4th European Conference on Promoting Workplace Health 14-15 Giugno • Dublin (Ireland) 17 18 HS+E magazine Molte attività del commercio, dell’artigianato e del terziario in genere spesso presentano un livello di rischio per la salute e la sicurezza degli operatori non sempre trascurabile. La gestione di alcune tipologie di locali di intrattenimento quali le discoteche ed i pub sono caratterizzati da problematiche specifiche alle quali occorre prestare la dovuta attenzione. Ad esempio le normative anglosassoni pongono in capo al gestore di un pub l’obbligo di salvaguardare l’incolumità dei propri dipendenti come quella degli avventori. Anche in virtù della elevata diffusione di tali strutture nel Regno Unito sono stati svolti numerosi ed approfonditi studi in materia. Sono state individuate quattro aree principali di rischio: l’incendio, il fumo di tabacco, le attrezzature di cucina (con particolare riferimento al rischio elettrico e meccanico), la movimentazione manuale dei carichi. In generale viene individuato come fattore aggravante dei primi due punti l’alto affollamento che spesso caratterizza questa tipologia di locali nella fasce orarie preserali e serali. Le Autorità e le Agenzie britanniche hanno messo a punto alcune interessanti check-list ad uso di chi deve occuparsi di valutazione dei rischi in questo settore. Una raccomandazione particolare è rivolta alla predisposizione di una adeguata procedura di emergenza ed evacuazione. La discussione maggiore in UK ruota comunque attorno all’opportunità di vietare il fumo nei pub che se da una parte limiterebbe notevolmente il rischio di incendio e di contaminazione da fumo di tabacco dall’altra allontanerebbe forse la stragrande maggioranza degli avventori che per tradizione vedono il pub come luogo per eccellenza per bere e fumare. Una alternativa percorribile pare essere quella dell’adozione di innovativi impianti LEV (Local Exhaust Ventilation) ad alta efficienza in grado di mantenere un adeguato confort microclimatico estraendo, filtrando e riciclando l’aria climatizzata. The RoSPA Occupational Safety and Health Journal “Public Houses” Peter Ellis 19 HS+E magazine Le attività lavorative svolte in prossimità di corsi d’acqua e bacini o all’interno di insediamenti portuali presentano per gli operatori un rischio aggiuntivo dovuto al pericolo di caduta in acqua. Da tale premessa è nato questo Manuale sviluppato attraverso competenze interdisciplinari con l’intento di offrire a tutti coloro che si occupano di protezione dei lavoratori uno strumento per definire tutte le necessarie misure di salvaguardia. Il libro partendo dai fondamenti di idrologia e meteorologia descrive le principali tecniche di organizzazione e gestione dei soccorsi, di ricerca e recupero in acque delimitate nonché le principali nozioni di primo soccorso sanitario. Una parte rilevante è anche dedicata ai criteri di scelta ed al corretto utilizzo di numerosi dispositivi utilizzabili nelle attività di ricerca e soccorso ed alla descrizione delle misure di sicurezza preventive. Non mancano inoltre i riferimenti normativi nazionali ed internazionali. Allegato al manuale vi è il pratico ed utile “libretto di addestramento” studiato appositamente per l’addestramento delle squadre di primo soccorso, che illustra gli esercizi da effettuarsi in acqua e gli obiettivi da raggiungere a seguito degli stessi. abbonamenti HS+E Pubblicità “Manuale di salvataggio e recupero in acque portuali ed interne” di Roberto Nicolucci Ed. Alzani € 38,00 pp. 200 La pubblicità su HS+E magazine ha durata annuale (4 numeri), viene accettata a discrezione dell’Editore e fino ad esaurimento degli spazi disponibili. – – – – 1/8 1/6 1/4 1/3 DI DI DI DI PAGINA .................................................................... PAGINA .................................................................... PAGINA .................................................................... PAGINA. .................................................................... 300,00€ 450,00€ 600,00€ 800,00€ – 1/2 DI PAGINA. .....................................................................1.100,00€ – PAGINA INTERA....................................................................1.600,00 € – ULTIMA PAGINA....................................................................2.500,00 € Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Techno srl via Pirano, 7 - 48100 Ravenna • Tel. 0544 591393 Fax 0544 591402 Gli abbonamenti hanno durata annuale (4 numeri). Uno-tre abbonamenti annui: € 16,00 cadauno; Quattro-dieci abbonamenti annui: € 14,00 cadauno; Oltre dieci abbonamenti annui: €12,00 cadauno. Abbonamento estero: € 32 cadauno. Per informazioni: [email protected] Per sottoscrivere l’abbonamento spedire il seguente coupon, tramite servizio postale o fax, a: Gruppo Alzani Editore via Grandi, 5 – 10064 Pinerolo (TO), fax 0121 71880. Desidero sottoscrivere N°……… abbonamento/i annuali (4 numeri) ad HS+E magazine per un totale di €……………………........... VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N° 17814104 intestato a: Tipografia Alzani sas - Pinerolo (To) ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a: Tipografia Alzani sas - Pinerolo (To) Nome .......................................... Cognome .......................................... Titolo ................ Azienda ....................................................... Indirizzo ............................................................................................. CAP ....................... Località ....................................................... PROV ( .........) E-mail ....................................................................................... Tel ............................................... firma ...................................................... Ai sensi dell’art.10 Legge n.675/1996, La informiamo che i dati degli Abbonati e degli Inserzionisti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini della consegna dei fascicoli e per le necessità amministrative e contabili della Società. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 della Legge 675/96 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano, l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi mediante richiesta/comunicazione scritta a Techno srl - via Pirano, 7 48100 Ravenna (rif. magazine). Via Nobel, 9/A - 43100 Parma Tel. +39.05.21.60.00.37 - www.riccoboni.it compiere anche sul piano della qualità civile e sociale il passo in avanti che ha saputo compiere su altri fronti: stabilità monetaria, credibilità internazionale ecc. Una grande nazione è tale se riesce ad affermare tutti i valori fondanti della sua democrazia”. HS+E starts the year 2004 with a typical Italian spirit. Despite the publishing strategy to be a “showcase” on the British and North European HSE world (periodical press, technical literature, new equipment and technologies, etc.) with the aim of circulating the “HSE culture” widespread in these countries, this issue deals with several safety issues, mostly concentrating on Italian case studies. The interview to Federica Guidi, Chairwoman of the “Giovani industriali dell’Emilia-Romagna” (Emilia Romagna Young Manufacturers Association) for a start, followed by environmental management systems applied to tourist harbours and by the topical subject of demolitions as a conclusion. This because we deem it important to know and let other workers know how HSE issues are experienced in our country. Safety at work shall be considered as an essential right for people; it is not only a matter of laws, co-ordination, actions but above all a matter of culture. This is one of the messages that HS+E is willing to convey to its readers. The Italian society is facing the globalisation and competitiveness challenges by making efficient a public system aimed at assuring the protection of those social rights often trampled on or irreparably deteriorated by the process of change. It is a challenge that institutions, social parties and the Italian society shall face all together. Safety at the workplace is an essential step for Italy to make, in the civil and social sphere, the same progress already achieved in several other fields: monetary stability, trustworthiness at an international level, etc. A nation can be actually considered a “great” nation if all the values underlying its democracy are asserted and safeguarded.
Scarica