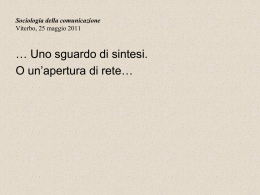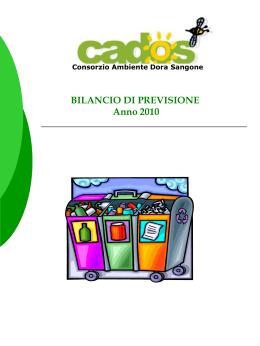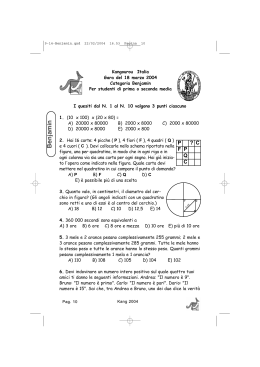Walter Benjamin, uno dei «profeti» culturali del Novecento, morì in una piccola località sulla frontiera spagnola; fuggiva dalla Francia occupata e si suicidò per timore di essere riconsegnat alla Gestapo. Era ebreo oltre che antinazista. La sua fine è abbastanza nota. È invece per lo più ignota la vicenda delle personalità con cui più vivamente e drammatica si intrecciò la sua storia e, in parte, la sua attività: Georg, il fratello minore, medico, dirigente comunista, soppresso a Mauthausen nel 1942, la sorellina Dora, sociologa e attivista, esule a Parigi con Walter dal 1933 e morta in Svizzera dov’era in esilio, la cognata Hilde, militante clandestina antinazista e madre di un bambino «meticcio» da sottrarre allo sterminio, poi giudice supremo nella DDR e ministro della Giustizia, distintasi nella prosecuzion giudiziaria dei criminali nazisti. L’autore di questa inchiesta storica, basata su documenti sconosciuti e su conversazio con i protagonist li definisce «una famiglia tedesca». E infatti la loro vicenda collettiva di disperazion di morte e di coraggio, è aggrovigliat in modo indistinguib con la stessa storia della Germania. E il racconto di essa si staglia sullo sfondo della vita in Germania, prima e dopo il 1933. A partire dal primo miracolo tedesco, la grande crescita dopo la nascita dell’impero del 1871, in cui fiorì la famiglia di agiati e colti ebrei Benjamin; fino agli anni Sessanta del Novecento quando, mentre i caporioni ex nazisti completava le loro carriere indisturbati ad Ovest, l’ultima dei Benjamin si guadagnava l’epiteto di «Ghigliottin rossa» per il suo lavoro di giudice ad Est, contro i criminali di guerra. Una ricostruzion dal respiro del Ventesimo secolo europeo, quella condotta dallo storico e giornalista Heye che riesce a coniugare con passione l’empatia esistenziale di una storia privata degli affetti, con l’interesse documentar della grande storia. UweKarsten Heye (1940), giornalista, è stato autore di discorsi per Willy Brandt, portavoce del governo di Gerhard Schroeder e autore di testi per le reti televisive ARD e ZDF. La nuova diagonale 111 Uwe-Karsten Heye I Benjamin Una famiglia tedesca Traduzione di Margherita Carbonaro Sellerio editore Palermo 2014©AufbauVerlag GmbH&Co.,Berlin 2015©Sellerioeditore viaSiracusa50Palermo e-mail: [email protected] www.sellerio.it Titolo originale: Die Benjamin.Einedeutsche Familie Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. EAN 978-88-389-3416-2 I Benjamin Una famiglia tedesca Prefazione I fratelli Walter e Georg con la sorella Dora: eccoli, sono loro i Benjamin, figli di una famiglia ebrea altoborghese. I genitori, Emil e Pauline Benjamin, non assistettero alla fine del loro mondo dopo il 1933. Morirono negli anni Venti. I fratelli e la sorella si opposero coraggiosamente al terrore nazista e pagarono con le loro vite. Nei documenti e nelle numerose lettere conservate e ordinate dalla moglie di Georg, Hilde Benjamin, e, dopo la sua morte, dal figlio Michael si può leggere e ripercorrere la loro resistenza contro il nazionalsocialismo, di cui riconobbero presto il carattere omicida. Hilde Benjamin e il figlio Michael erano gli unici sopravvissuti della famiglia in Germania quando l’Armata rossa entrò a Berlino e i bombardamenti terminarono. La vittoria degli alleati sullo stato nazista rappresentò per Michael la salvezza. Dai nazisti era considerato un «meticcio di primo grado». Suo padre Georg era ebreo, medico e comunista. Il fratello di Georg, Walter, era scrittore, critico letterario e filosofo. Dora si era segnalata con i suoi saggi di critica sociale. L’anno in cui nacque Walter Benjamin era il 1892, quello in cui morì sua cognata Hilde il 1989. Un secolo tedesco attraversato da una scia di sangue che ebbe inizio con le conquiste coloniali in Africa del casato Hohenzollern, prima del 1914, e terminò con le morti di massa nelle due guerre mondiali. In entrambe le guerre c’è una responsabilità innegabile dei tedeschi, la quale si riflette nei destini dei fratelli Benjamin e li segna. Dopo il 1945, la fragile pace fredda. La divisione del mondo in Est e Ovest e la scissione dell’Europa. Comincia una guerra delle parole anziché delle armi, ma ugualmente in grado di distruggere le persone. Hilde Benjamin ne fu colpita. In Germania Occidentale gli alti esponenti del potere amministrativo e politico, rimasti nelle loro cariche, mantennero il medesimo atteggiamento antibolscevico che in precedenza era stato coltivato per dodici anni. La guerra fredda e l’assorbimento dell’Europa orientale nella sfera di potere sovietica crearono un clima che agevolò la rimozione dello stato hitleriano, fondato sul terrore, e della propria corresponsabilità. Nel tumulto della propaganda fra Est e Ovest la Repubblica Democratica Tedesca divenne il baluardo di ogni male che doveva far dimenticare le azioni criminose dei nazisti, e che in ogni caso le faceva arretrare in seconda posizione. Ogni criminale nazista condannato diventava automaticamente vittima dello «stato d’ingiustizia» della DDR e di Hilde Benjamin, che quale vicepresidente della Corte suprema e, dopo il 1953, ministro della Giustizia della Germania Est era responsabile della persecuzione penale dei criminali nazisti. Dopo la proibizione del Partito comunista tedesco in Occidente, nessuno scalpore suscitarono invece le diverse migliaia di processi contro i suoi membri e funzionari. Nuovamente si perseguivano i reati d’opinione. Negli anni del dopoguerra, in Occidente, ciò che si collocava a sinistra del centro era investito rapidamente dal sospetto politico generale. Le classi dirigenti vecchie/nuove provvedevano alla continuità. Il fatto che in Germania Occidentale i responsabili del nazismo potessero continuare a operare indisturbati nelle istituzioni e nelle amministrazioni, nella giustizia e nell’economia non restò senza conseguenze. Quanto alla composizione del personale, la Polizia federale tedesca (Bundeskriminalamt, BKA) per esempio, creata all’inizio degli anni Cinquanta, non si distingueva quasi dall’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich (Reichssicherheitshauptam la centrale del terrore attiva nello stato nazista. Uno studio in tre volumi pubblicato di recente, commissionato dallo stesso Bundeskriminalamt, dimostra che ancora nel 1959 la metà dei funzionari con mansioni direttive era costituita da ex membri delle SS o di unità speciali della polizia, i quali erano stati coinvolti in uccisioni di massa oltre le linee del fronte in Russia. Conseguentemente «infruttuose» risultavano le indagini della polizia ogni volta che bisognava chiarire episodi neonazisti o legati all’estremismo di destra. Somiglianze sorprendenti con gli «intralci» verificatisi nel corso delle indagini su una serie di omicidi compiuti da gruppi clandestini nazionalsocialisti ai nostri giorni, e segno a loro volta di una cecità della giustizia che perdura ancora oggi. Fino agli anni Sessanta del secolo scorso la Repubblica Federale Tedesca sembrava talvolta il teatro, immerso nell’atmosfera da idillio agreste di uno Heimatfilm,1 di un ritorno del nazismo, solamente privo di Hitler e Goebbels. La revisione in sede giuridica del nazionalsocialismo cominciò a Norimberga. In tredici processi davanti al tribunale degli accusatori alleati furono giudicati elementi del partito, dell’economia e dell’esercito, responsabili delle montagne di cadaveri nei campi di sterminio e delle guerre di rapina da loro scatenate. La denazificazione dei colpevoli e dei fiancheggiatori, avviata dalle potenze vincitrici occidentali ed estremamente impopolare, fu affidata ben presto ad appositi tribunali tedeschi. In definitiva era ormai solo una farsa e nel giro di poco tempo fu sospesa del tutto. Il parlamento approvò una serie di leggi che equivalevano a un’amnistia concessa alle sfere direttive naziste, leggi che in ogni caso permisero loro di continuare a ricoprire le cariche occupate. Ciò spiega fra l’altro perché nelle redazioni della BRD, infiltrate di ex nazisti, a differenza che nella DDR vi fosse poco o nessun interesse a confrontarsi con il passato nazista. Questo virus non doveva comunque essere trasmesso. Hilde Benjamin, che offriva senz’altro spunto alla critica, fu un obiettivo prediletto di campagne legate a loro volta all’intenzione di dipingere a tinte talmente fosche il regime del Partito socialista unitario tedesco (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) che l’orrore nello stato delle SS sembrava impallidire. Una visione così tendenziosa e incurante della storia che ancora oggi è possibile cogliere. Solo nel 1972, nel primo discorso pronunciato dal cancelliere Willy Brandt sullo stato della nazione, fu ammessa la differenza fra i due stati tedeschi nel loro confrontarsi col nazionalsocialismo. Nei materiali che successivamente furono pubblicati dal Ministero federale delle relazioni intratedesche si può leggere come la Repubblica Democratica Tedesca avesse proceduto con serietà alla rimozione dei quadri direttivi nazisti nella giustizia e nell’economia, nelle università e nei mezzi di informazione. E di conseguenza crescente era il numero degli ex nazisti fra i profughi dalla DDR, che nella Repubblica Federale non dovevano temere alcuna persecuzione. Dopo quello strappo senza precedenti dalla civiltà, attuato dal governo di Hitler, Adenauer non giudicava prioritario procedere a un’autoepurazione, cosa che ancora oggi pregiudica l’igiene politica nel paese. Gli incartamenti riguardanti criminali nazisti come Klaus Barbie o Adolf Eichmann, i quali riuscirono a scappare all’estero, continuano a essere segreti. Ciò evidentemente vuol dire che non possono essere divulgati nell’interesse pubblico della Repubblica Federale Tedesca, e ciò a sua volta impedisce che l’opinione pubblica apprenda qualcosa di più preciso sul ruolo qui giocato dal Servizio federale di informazione (Bundesnachrichtendiens nella sua sede di Pullach, in Baviera. Dopo la morte di Hilde Benjamin nella primavera del 1989, suo figlio Michael con la moglie Ursula e i figli adulti si ritrovarono nel 1990 nella Germania riunificata, dove i nipoti appena nati crebbero. Per questi ultimi la DDR era già materia di storia. Tuttavia è ancora difficile voltarsi indietro a osservare senza pregiudizi e in maniera storicamente adeguata la divisione della Germania, la BRD e la DDR, e il ruolo e la funzione che la guerra fredda assegnò ai due stati. La psicoterapeuta berlinese Anette Simon li descrisse come due «gemelli tedeschi, figli di madre Germania e di padre Fascismo». Ormai riunificati, il materiale genetico di padre Fascismo torna ad affiorare. Di nuovo toni nazionalistici e inclinazioni all’estremismo di destra. Tutto questo ha una tradizione e non è mai stato salutare per i tedeschi. La tendenza a dividere ancora in Est e Ovest il paese riunificato e a puntare il dito nell’altra direzione, sentendo solo là puzza di bruciato, ha contribuito a sostituire la divisione esterna con quella interna nella Germania unita. Anche perciò è stato scritto questo libro. I Benjamin con la loro vita e le loro sofferenze ci ricordano che nei libri di storia tedesca dopo il 1871, l’anno di fondazione del Secondo Reich, non sono stati molti i momenti in cui la Germania ha risvegliato buoni sentimenti. Uno di questi fu la rivoluzione pacifica del 1989. Fu la gente che allora prese in mano il proprio destino, conquistando la strada. Il fatto che ciò sia stato possibile senza spargimento di sangue e abbia avuto tuttavia una forza rivoluzionaria è stato un dono di cui dobbiamo ringraziare soprattutto, se non in maniera esclusiva, i cittadini della DDR. Ciò che i molti gruppi di opposizione si auguravano allora e che volevano portare nella Germania comune restò in gran parte inascoltato. E in parte reca anzi il timbro: «Domanda da ripresentare». Potsdam,primavera2014 1 Genere cinematografico estremamente popolare in Germania soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta. Le trame molto spesso sentimentali si dipanano su sfondi bucolici. È il mondo intatto e puro della Heimat: terra natia e delle origini, casa, luogo sorgivo della propria identità [N.d.T.]. Capitolo primo Infanzia intorno al millenovecento. Un prologo Ed eccoli, Georg e il fratello maggiore Walter, e la sorellina Dora seduta su una soffice pelliccia. Quattro cuginette guardano nella macchina fotografica insieme a loro. Devono aver aspettato a lungo, tutti concentrati, che l’artista Lili Strauss avesse finalmente catturato nella cassetta la foto scattata col flash al magnesio. Georg Benjamin sta a sinistra, la mano destra posata sul bracciolo curvo di una sedia Chippendale, molto più vecchia dell’età che si otterrebbe contando insieme gli anni di vita dei bambini. Questi hanno da uno a undici anni. Sulla sedia, come due bamboline, ci sono le cugine più piccole, a destra accanto a Walter le due più grandi, e davanti a tutti Dora. Una foto del 1906. Una rappresentazione di contentezza borghese. Gli abitini bianchi, le gonnelline drappeggiate con amore e leggermente sollevate imprimono uno slancio all’immagine: moda per bambini nell’anno 1906, in chintz e con guarnizioni finemente lavorate al tombolo. Le bambine più piccole portano fiocchetti e scarpe di vernice, le più grandi indossano vestiti di tessuto a pied-de-poule con i colletti ampi e chiusi, che spiccano bianchi. Gertrud ha un anno più di Georg, che è nato il 10 settembre 1895, tre anni dopo Walter. I bambini portano vestiti alla marinara. Due famiglie ebree: una è quella dei Chodziesner, in cui la sorella di Pauline Benjamin, nata Schönflies, era entrata al momento di sposarsi. Negli anni Venti la cugina Gertrud Chodziesner scrive poesie con lo pseudonimo Gertrud Kolmar. I suoi volumi di liriche bruciano nel 1933 sui roghi nazisti. I piccoli Benjamin sono Walter, Georg e Dora. Una schiera di bambini nell’album ingiallito di un’epoca che già otto anni dopo sarebbe sfociata nella prima grande guerra mondiale. Guerra e dopoguerra segneranno in maniera decisiva la vita dei bambini. In questo momento regna ancora l’ottimismo dei «Gründerjahre», l’epoca del grande sviluppo economico tedesco dopo il 1871. I progressi dell’industrializzazione e i primi tentativi di navigazione aerea stanno sulle prime pagine dei giornali. Non sappiamo se nel maggio 1906 anche i piccoli Benjamin, come migliaia di altre famiglie berlinesi, fossero andati a Tegel. Là avrebbero visto salire in aria il primo dirigibile «semirigido» e provato l’intensa sensazione di assistere al sorgere di una nuova era. Quello stesso anno ebbe luogo per la prima volta una gara ciclistica tutt’intorno a Berlino. E soltanto una supposizione è l’eventualità che il padre, Emil Benjamin, avesse letto nella «Vossische Zeitung» qualche notizia sul congresso del Partito socialdemocratico a Mannheim, sempre che i giornali borghesi ne avessero parlato. Nel 1906 era in gioco niente meno che la separazione di partito e sindacati, contro cui si era fortemente opposta l’ala sinistra del partito con Rosa Luxemburg e Karl Kautsky. Fu approvata tuttavia a grande maggioranza. Così si legge nella risoluzione: «I sindacati sono indispensabili e costituiscono un’organizzazione necessaria al miglioramento della condizione della classe operaia nella società borghese; non sono meno necessari del partito socialdemocratico». Quali che fossero le opinioni politiche di Emil Benjamin, il suo interesse per la cultura in ogni caso è certo. Lui e Pauline avranno visitato sia la Nationalgalerie sia il Neues Museum per ammirare l’esposizione «Un secolo di arte tedesca dal 1775 al 1875», che venne realizzata nel 1906 con più di duemila quadri e trecento disegni, attirando la borghesia colta berlinese. Nel 1906 inizia inoltre la sua carriera la cantante di cabaret Claire Waldoff, originaria della Ruhr ma adottata dai berlinesi, le cui canzoni hanno ancora oggi un loro pubblico. Proprio quell’anno fu scattata la fotografia con i bambini delle due famiglie ebree, altoborghesi e assimilate, che dovrebbe mostrare un armonico coesistere e non irradia invece nulla più che una prossimità. Nella sua Infanziaberlineseintorno al millenovecento, il cui manoscritto l’autore continuò a rielaborare fino all’epoca in cui era emigrato a Parigi, tanto che ne esistono edizioni diverse e non sempre coincidenti, Walter Benjamin descrive proprio l’opposto di ciò che questa fotografia e la sua composizione studiata volevano mostrare. In brevi capitoli, nell’edizione che ho sottomano, Benjamin ordina la sua infanzia in una lingua sempre più densa e libera da ogni leggenda, senza quei racconti di scherzi fatti in comune o di avventure con gli amici o in compagnia del fratello e della sorella che facilmente accompagnano invece i ricordi d’infanzia. Il fratello e la sorella, le cugine, i genitori e i nonni «fanno tutti il loro ingresso in scena nel libro, ma solo come servitori ombra delle cose, mai come esseri umani», osservò un critico inglese a proposito dell’Infanzia berlinese intorno al millenovecento di Benjamin. Lontanissima aleggiava, simile a una fata, la figura della madre durante i primi anni del bambino. Il quale vede in lei una bellezza che persino retrospettivamente gli mozza il respiro. Anche quando si limita a descrivere i genitori che, invitati a una serata, devono uscire di casa lascia capire quanto li ammirasse. «Ed erano sempre queste ore a confortarmi» scrive «anche nelle sere in cui stava per uscire, sfiorandomi sotto forma dei neri ricami del foulard che già aveva indossato. [...] Quando poi da fuori la chiamava mio padre, nel momento del distacco sentivo solo l’orgoglio di lasciarla andare così splendente in società. E pur senza conoscerlo, poco prima di prendere sonno, nel mio letto avvertivo la verità di un piccolo enigma: “Ospite in ritardo, ospite di riguardo”». Nei ricordi d’infanzia di Walter, Emil Benjamin è il padre lontano e spesso assente. La sua ricchezza viene da un fiorente commercio di oggetti antichi. Più volte Emil Benjamin va a Parigi per acquistare là, con la sua competenza di esperto, tappeti e mobili e offrirli sul mercato berlinese dell’antiquariato. Forse è questo ad avere risvegliato in Walter la curiosità per la lontana metropoli, che in seguito divenne la sua città preferita. Nei ricordi di questi anni, condensati in brevissimi capitoli che vanno dal 1892, l’anno della sua nascita, al 1912-13 circa, appare chiaro anche quanto fosse stato circondato dagli attributi del benessere. Per il piccolo Walter agio e lusso sono qualcosa di ovvio, tanto da non farci neppure caso. Al lettore tuttavia balzano subito all’occhio quando egli descrive i preparativi per una serata in casa Benjamin con invito a cena: «Era avvenuto con la manovra grazie alla quale il tavolo da pranzo si apriva, facendo comparire un’asse che, dispiegata, colmava il vuoto tra le due metà sì da far posto a tutti gli ospiti». Walter aiutava ad apparecchiare con «pinze da aragosta o coltelli da ostrica». Racconta di verdi calici per il vino bianco, di altri bicchieri per il Porto, dallo stelo basso e finemente molati, di filigranate coppe da champagne e saliere in forma di piccole botti d’argento, e dei tappi sulle bottiglie in forma «di pesanti gnomi o animali di metallo. E infine, ecco che potevo collocare sopra uno dei tanti bicchieri di ogni coperto il cartoncino che indicava all’ospite il posto che gli spettava». Ma più la sera si avvicinava e la tavola doveva tenere fede al proprio splendore, che soltanto agli ospiti era dato di godere, «più si velava quel tanto di luminoso, di radioso che essa mi aveva promesso verso mezzogiorno. E quando poi mia madre, malgrado rimanesse in casa, entrava solo di sfuggita per darmi la buona notte, avvertivo con doppia intensità quale regalo le altre volte mi deponesse sulla coperta a quell’ora: la consapevolezza delle ore che la giornata ancora le riservava e che io, consolato, portavo con me nel sonno come un tempo il bambolotto». E tuttavia, nei ricordi d’infanzia di Walter Benjamin, nemmeno la madre prende forma. Aveva la sensazione di essere quasi un figlio unico? Spesso malaticcio com’era? Una volta dovette restare lontano da scuola per più di un trimestre. Già da bambino era molto miope. In seguito il collegio lo separò dal fratello e dalla sorella. E c’era poi la differenza di età: tre anni rispetto al fratello e nove rispetto alla sorella. Con la pubertà, che all’epoca cominciava più tardi di oggi, essi dovevano apparire a lui, ragazzino solitario, troppo infantili per essere menzionati quali confidenti o compagni di conversazione. Succedeva evidentemente di rado che i tre bambini fossero insieme ai genitori. Li sostituiva la bambinaia, in seguito la governante. Non stupisce che Walter avvertisse come un raro dono la vicinanza della madre a letto, alla sera, una rapida carezza sui capelli o un bacio veloce sulla guancia. Ne godeva come di un riconoscimento, cui si legava un desiderio inappagato di tenerezza e attenzione. Il ragazzino che viene descritto come molto introverso rinveniva una vita fantastica soprattutto nel mondo delle cose intorno a sé, dove la madre appare talvolta con contorni indistinti. Un amico lo descrive «strano, solitario, un bambino estremamente egocentrico». La sua profondità era spesso quella di un «pozzo angusto e oscuro, che non comunicava con il mondo circostante». La sua fantasia continua a rivolgersi alle cose che gli riservano la sua stanza o l’appartamento dei genitori e che lui risveglia a vita propria. In Infanzia berlinese intornoalmillenovecento, nel capitolo «Mattini d’inverno», Benjamin racconta un piccolo avvenimento: una bambinaia accende la stufa nella sua stanza e vi infila una mela al forno attraverso lo sportello in alto. A partire da qui Benjamin crea un mondo incantato, rischiarato dalla fiamma della stufa che «non poteva quasi muoversi» a causa del carbone. Eppure era «qualcosa di impetuoso ciò che lì vicino iniziava a trovare una propria sistemazione, qualcosa che era più piccolo di me e per raggiungere il quale la domestica doveva chinarsi più che per avvicinarsi a me». Descrive un «viaggio attraverso il paese oscuro del calore nella stufa» e «lo spumoso profumo della mela al forno, che emanava da una cellula della giornata invernale più profonda e discreta persino di quella da cui proveniva il profumo dell’albero nella notte di Natale». Può essere il fatto di aver terminato il manoscritto solo quando era emigrato a Parigi, nella fase della sua breve vita in cui si sentiva immensamente perduto e in ristrettezze materiali, a far sì che nel libro i genitori, come il fratello e la sorella, non gli vengano in mente. In maniera subliminale ciò può aver contribuito al suo aggrapparsi a immagini dell’infanzia in cui latte e miele scorrevano a fiumi, dove regnava una sicurezza materiale priva di pensieri. È la vita nel ricco Westen di Berlino, la parte occidentale della città: «In questo quartiere di persone abbienti restai rinchiuso, senza sospettare la presenza di altri. I poveri – per i bambini ricchi della mia età esistevano solo come mendicanti». Questi, osservava il suo biografo Werner Fuld, esistevano per lui tutt’al più nel periodo prima di Natale, quando agli artigiani e ai lavoranti a domicilio era permesso di esporre ai mercatini nei quartieri delle ville i giocattoli da loro costruiti, gli angioletti dorati e le noci bronzate. Il bambino avrebbe potuto «intuire oscuramente che c’era un altro mondo oltre a quello della sua classe». Qui la realtà e le esperienze dei fratelli e della sorella cominciano a diversificarsi. Walter conobbe ancora il mondo intatto della grande borghesia ebrea berlinese, che con i salotti del diciottesimo secolo e la rapida industrializzazione nel diciannovesimo secolo aveva condotto a una società con possibilità di avanzamento, il cui liberalismo e la cui impronta intellettuale recavano anche un influsso ebreo. Georg e Dora non ebbero più modo di avvertire tutto questo. Una società berlinese «mossa da una creatività nel campo culturale, oltre che da una dinamica e brutale sete di guadagno», come si legge in Die Berliner Gesellschaft (La società berlinese) di Klaus Siebenhaar, «che nell’insieme produssero un’arte di vivere che a poco a poco abbandonò ogni angustia e provincialismo, tanto che Theodor Fontane poté constatare rassicurato: “[...] lo sguardo si è ampliato e sovrasta il mondo”». L’ingannevole sicurezza degli ebrei berlinesi, le loro speranze, i loro sentimenti e pensieri ancora «nel segno della fine e della distruzione fisica», sono evocati da Lion Feuchtwanger nel suo romanzo Die GeschwisterOppermann (I fratelli Oppermann). I fratelli Martin, Edgar e Gustav rappresentano il cosmopolitismo, la cultura, una vivacità intellettuale e, così li vede Siebenhaar, sono figure guida di questo centro della modernizzazione economica e culturale che è Berlino. Il romanzo di Feuchtwanger, scritto nell’esilio americano di Villa Aurora, ricorda lo «splendore e lo spirito» della grande borghesia ebraica che influenzò tanto profondamente la società berlinese. La tragedia di questa élite fu l’incapacità, proprio nella coscienza del profondo radicamento culturale nella sua Germania, di riconoscere per tempo il pericolo di ciò che avvenne dopo il 1933. A differenza di Georg Benjamin e soprattutto di Dora, che durante e dopo la Prima guerra mondiale si sarebbero volti alla politica, Walter impiegò più tempo a manifestare la sua posizione. Da soldato Georg aveva abbandonato l’idea che ci fosse una classe superiore alla quale apparteneva quasi per diritto di nascita. Walter invece, che non ebbe grandi difficoltà a farsi riformare alla visita di leva, anche dopo la guerra trascorre i suoi anni di studio in diverse università, da Berlino a Monaco e poi a Friburgo e a Berna. Un precoce leader studentesco, che si mantiene fedele a una Jugendbewegung (Movimento giovanile) idealistica e apolitica. Un atteggiamento che voleva trasmettere alla gioventù universitaria. L’origine di queste idee è legata al passaggio dal Kaiser-FriedrichGymnasium di Berlino al collegio di Haubinda in Turingia. Là Walter conosce il pensiero pedagogico di Gustav Wyneken, che lo guiderà per più di un decennio. E, come ha constatato il suo biografo Werner Fuld, «si avvicinò all’ideale di una gioventù volitiva, diventando un protagonista del movimento della “Gioventù risoluta” (Entschiedene Jugend)». Fino alla rottura con Wyneken, Walter condivise un pensiero il cui vocabolario stesso era carico di pathos e che in seguito sarebbe stato terribilmente abusato. Wyneken veniva chiamato «Führer» e Martin Gumpert, cofondatore della rivista «Der Anfang» (L’inizio), organo della Jugendbewegung, riferendosi ai primi articoli ivi apparsi sul «Führer» e i «seguaci» parlò di una «corresponsabilità mistica rispetto al nazionalsocialismo». In seguito anche Wyneken esternerà il proprio sgomento di fronte agli esiti del suo stesso pathos, espresso in formule che invocavano l’«impegno per la causa, la cessazione del singolo, una nuova fede». «Con questo grido» lo cita Fuld «i miei amici sono andati volontari in guerra e con questo grido sulle labbra sono morti. La sua eco è rimasta nell’aria e, predata e travisata dal falso Messia, risuona oggi nelle orecchie di una gioventù nuova che barcolla incontro a una nuova miseria». Walter Benjamin aveva anticipato il successivo giudizio di Wyneken, che nel 1914 voleva ancora infiammare la gioventù alla guerra, e proprio per questo motivo ruppe con lui. A differenza di Georg, Walter faceva parte «di quei giovani tra cui Hitler avrebbe reclutato in seguito i suoi seguaci, e aveva già contribuito a creare il loro vocabolario» conclude il suo biografo. Solo aver preso le distanze da Wyneken al momento giusto l’avrebbe salvato dalle formule retoriche, apologetiche e insieme distruttive, che parlavano di «gioventù abusata nel suo idealismo». Un riconoscimento non da poco da parte del meno che diciottenne Walter Benjamin, il cui interesse per la politica si stava allora formando e che in ogni caso si era già sottratto autonomamente all’incredibile infatuazione bellica di quegli anni. Nel 1914, all’inizio della Prima guerra mondiale, Dora aveva tredici anni e visse gli anni del conflitto e il crollo dell’impero tedesco senza il bagaglio di esperienze dei fratelli. Non era legata a un mondo di corte ormai scomparso, per Walter ancora una realtà ma che già per Georg non significava quasi più nulla. Da soldato Georg visse la follia della guerra di posizione e dell’impiego dei gas. Nel 1918 tornò dal fronte nella Berlino rivoluzionaria e in tumulto, e simpatizzò con i consigli dei soldati e la rivoluzione di novembre (1918-19), cominciata con la rivolta dei marinai di Kiel e la proclamazione della repubblica. Egon Erwin Kisch, il cosmopolita praghese, racconta nei suoi diari di guerra quel che Georg e la sua generazione dovettero sopportare nelle «tempeste d’acciaio». Un’esperienza che condusse entrambi nel Partito comunista. Giudicavano che il mondo borghese capitalista fosse arrivato alla sua fine e la Rivoluzione di Ottobre rappresentasse l’avvisaglia di una società di liberi e uguali. Per Pauline e Emil Benjamin era naturale offrire ai figli la migliore educazione e istruzione possibile. Tutti e tre terminarono l’università. Il commercio di antiquariato e tappeti del padre prosperava. Emil era socio di una casa d’aste, membro del consiglio di sorveglianza e azionista di alcune società berlinesi, e aveva inoltre una partecipazione nell’«Eispalast», il «Palazzo del ghiaccio» che in seguito fu ribattezzato Berliner Scala. Walter vi accompagnò una volta il padre, e qui poté osservare molti dei bizzarri personaggi che si incontrano solo in una grande città. Fra questi c’era la prostituta con l’abito aderente alla marinara che, come lui stesso dichiarò, avrebbe guidato le sue fantasie erotiche per molti anni. La sua immagine della donna è stata descritta molte volte come conservatrice. Tuttavia è più complessa, spesso tinta di un’arroganza maschile e poi nuovamente caratterizzata dalla consapevolezza della superiorità femminile. Nelle sua vita le donne hanno spesso un ruolo importante. Durante la giovinezza Benjamin vive la propria sessualità sul mercato dell’amore, cosa che non nasconde, e solo a poco a poco comprende quale sfruttamento vi abbia luogo. Nel capitolo «Tiergarten» dei suoi racconti di infanzia Benjamin descrive un momento irritante che potrebbe significare più di quanto fa apparire fra le righe. Anche qui al centro c’è la sua immagine della donna. Uno sfaccendato che si perde nella città: questa è l’immagine che fa da metafora. «I nomi delle strade devono parlare all’errabondo come lo scricchiolio dei rami secchi e le viuzze del centro gli devono scandire senza incertezze, come in montagna un avvallamento, le ore del giorno». È un’arte che ha appreso tardi. Essa ha «esaudito il sogno, le cui prime tracce furono i labirinti sulle carte assorbenti dei miei quaderni». Poi gli viene in mente un’altra immagine, un’esperienza in un labirinto, cui non è mancata Arianna. La via verso questo labirinto passava per il ponte Bendler, «il cui dolce arco fu per me il primo pendio collinare. Non lontano da lì era la meta: Federico Guglielmo e la regina Luisa. Emergevano dalle aiuole su tondi piedestalli e parevano ammaliati dalle magiche curve che un corso d’acqua disegnava davanti a loro nella sabbia». Accompagnato dalla sua «Fräulein», Walter va nel suo posto preferito al Tiergarten. Un posto che non rivelava affatto come là, a pochi passi appena dal corteo delle vetture pubbliche e delle carrozze, «dormisse la parte più misteriosa del parco. [...] In quel punto, infatti, o non lontano, deve aver avuto la sua dimora quell’Arianna alla cui presenza per la prima volta avvertii ciò di cui solo più tardi appresi il nome: l’amore. Purtroppo alla sua sorgente compare la “Fräulein” che si posò su di essa come algida ombra». Questa esperienza irritante è come un’allusione al fatto che il suo ideale femminile assomiglia a Arianna che, avvincendolo al filo, lo riconduce indietro quando si è perso, così come l’aveva guidato lungo il tragitto verso la Luisa di pietra, in cima al suo piedistallo. Come sua moglie Dora Sophie Pollak o il suo grande amore, Asja Lacis? E anche sua madre, non stava per lui in cima a un basamento? Né la madre né tantomeno il figlio erano in alcun modo al corrente degli affari paterni. Nel mondo patriarcale intorno al 1900 questo era il segreto del capofamiglia, il quale non vedeva perché mai avrebbe dovuto parlare del modo in cui guadagnava i mezzi per sostentare la famiglia. In casa, d’altro canto, era soltanto la madre a detenere il potere su tutto ciò che era nascosto nei diversi armadi e comò. In svariate occasioni Walter trovò accesso a quel che chiamava il «tesoro d’argento» della famiglia. Ne facevano parte, in servizio da trenta, coltelli e forchette, posate da astice, cucchiai da minestra e dessert e diversi posacoltelli. E poi tovaglie e tovaglioli di lino. In casa, alle pareti, opere d’arte contemporanee in pesanti cornici e nel corridoio e in giardino copie di divinità greche, e sicuramente anche pezzi originali che Emil aveva acquistato sul fiorente mercato dell’arte greca o egizia non solo a Parigi, ma anche a Berlino. Non c’era infatti soltanto Nefertiti, che James Simon poté introdurre in Germania del tutto legalmente dopo che fu portata alla luce, con l’inarrivabile splendore delle sue proporzioni, durante una campagna di scavi da lui finanziata nella Valle dei Re in Egitto. In seguito la donò generosamente alla città di Berlino. Simon rappresentava un genere di mecenatismo tipico per la società ebrea nella capitale prussiana. Eccettuata l’interruzione dei quattro anni di guerra, anche Georg Benjamin risiedette a Berlino, dove terminò gli studi di medicina diventando pediatra. Dora e Georg ebbero perciò un rapporto molto stretto. Quando i suoi studi glielo permettevano, Dora dava una mano nell’ambulatorio del fratello. Le esperienze con i bambini in cura presso Georg, spesso malnutriti e costretti a vivere sulla strada, furono fondamentali per la sua tesi di dottorato che esaminava la condizione delle lavoratrici a domicilio nei suoi riflessi sulla famiglia e l’educazione dei figli. Solo negli anni Venti, terminati gli studi e già professionalmente attivi, i giovani Benjamin si sarebbero dimostrati più volte pronti ad aiutarsi a vicenda, per esempio in occasione di una mostra curata sostanzialmente da Dora. Ciò svela come percepissero il mondo circostante con un’affinità di opinioni sempre maggiore e uno scetticismo crescente ma, in quanto intellettuali di sinistra, con simili speranze politiche. Interessi comuni si svilupparono a partire da questo atteggiamento politico, anche se Walter poté essere con loro solo saltuariamente. Tutto cambiò durante il periodo dell’emigrazione che Dora e Walter trascorsero insieme a Parigi, fino all’invasione della Francia da parte della Wehrmacht. In quest’epoca si avvicinarono più di quanto avessero avuto modo di fare in tutti gli anni precedenti. Nella sala di lettura del Walter Benjamin Archiv a Berlino, nella Luisenstraße, all’ombra dell’alto palazzo della Charité, appaiono sullo schermo del computer le lettere che Dora o Georg scrissero a Walter. La ricercatrice dell’archivio le ha già preparate per il visitatore. Un clic e compaiono. Conducono all’epoca dell’emigrazione a Parigi e testimoniano un intenso affetto tra i fratelli e la sorella. Questa mattina la sala di lettura con le sei scrivanie è tutta prenotata. Fotografie in grandi cornici nel guardaroba e sulle pareti suscitano l’impressione che Walter Benjamin osservi alle loro spalle i visitatori. E io mi sento sempre a disagio quando leggo posta inviata e ricevuta quasi otto decenni fa. Malgrado tutti gli anni trascorsi occorre sempre vincere una certa riluttanza per introdursi, quale terzo lettore, nell’intimità di una corrispondenza. Nel febbraio 1935 Dora scrive per esempio da Parigi al fratello Walter, il quale si trova in Danimarca ospite dell’amico Bertolt Brecht, raccontandogli che la sua salute va un po’ meglio e lo mette al corrente sulle sue difficoltà di trovare un lavoro pagato. «Da Berlino» dice «ricevo regolarmente buone notizie», e poi domanda se gli abbia già raccontato in un’altra lettera di come dietro sua richiesta un’amica abbia «fatto a Natale bellissime fotografie di Georg». Non appena avesse avuto in mano le copie già ordinate, gliene avrebbe spedita una. Prima dei saluti dice poi che a Parigi è «inverno profondo, con venti gelidi e uno spesso strato di ghiaccio sulle strade». A Natale del 1933 Georg era stato rilasciato inaspettatamente dalla «detenzione protettiva».2 Migliaia di comunisti e socialdemocratici erano stati arrestati dopo l’incendio del Reichstag e portati in campo di concentramento. Georg rimase tre anni in libertà, prima di essere arrestato nuovamente nel 1936. Ora che mantenere i contatti è più difficile i fratelli e la sorella si cercano, sia pur solo per lettera o nei loro buoni pensieri. E a Parigi Walter può aver raccontato a Dora del suo intimo amico Gerhard Scholem, del suo matrimonio con Dora Sophie Pollak e poi del fallimento di questo, e del suo grande amore per Asja Lacis. Nel 1915, durante una discussione a proposito di una conferenza di Kurt Hiller sul «Senso della storia», Walter conobbe Gerhard Scholem. Fu un incontro fatale. Poco tempo dopo Walter lo invitò per una conversazione nella villa paterna a Grunewald. Fu l’inizio di un’amicizia e di un dialogo che sarebbero durati per tutta la vita, ma anche l’inizio di un epistolario fondamentale per comprendere il pensiero di Benjamin. Nel 1917 Walter aveva sposato Dora Sophie Pollak, nata Kellner, da cui aveva avuto un figlio, Stefan, nato nel 1918. Gli amici descrivono il matrimonio come difficile. Fu sciolto dopo tredici anni. Il divorzio assunse toni di un’asprezza tale da allontanare Walter e Dora per anni. Quando poi Walter fuggì dalla Germania ed emigrò a Parigi, i due si avvicinarono nuovamente. Più di una volta, quando lui si trovò in gravi difficoltà finanziarie, Dora Sophie gli offrì un alloggio gratuito nella sua pensione sulla Riviera. Come coppia dovettero superare insieme lo scontro con il padre Emil, il quale comunicò al figlio che non avrebbe più potuto sostenere finanziariamente lui e la sua famiglia. Per ridurre i costi, come si può leggere nelle lettere di Walter, la coppia dovette trasferirsi nella villa al Grunewald e rinunciare così al proprio appartamento. Nello stesso tempo il padre insistette perché Walter si decidesse a provvedere da sé al suo sostentamento. Gli suggerì di dedicarsi al commercio librario o al lavoro editoriale. Il motivo di ciò erano le sue pretese difficoltà negli affari, e il tutto sfociò in una grande lite. A Walter pareva inimmaginabile tornare in casa dei genitori e mettere sé e la propria famiglia sotto la tutela del padre. L’atteggiamento di Emil Benjamin ottenne che Walter si trasferisse temporaneamente, con la moglie e il figlio, presso una coppia di amici, i Gutkind. L’atmosfera in casa Gutkind, che erano ebrei, stimolò Walter a studiare l’ebraico. Mentre né Georg né la sorella Dora si rifecero mai alla loro identità ebraica, Walter si sentì spinto dai Gutkind e dall’amico Gerhard Scholem a confrontarsi intensamente con quel patrimonio di pensiero. Nello stesso tempo gli venne suggerito di trasferirsi in Palestina, cosa che Scholem, il quale sarebbe emigrato là e in seguito avrebbe insegnato all’università di Gerusalemme, continuò a consigliargli di fare anche dopo il 1933. Per Benjamin, come lui stesso dichiarò, emigrare in Palestina sarebbe equivalso quasi a una fuga da parte di chi aveva fallito in Europa, tanto che esitò sempre a considerarla un’alternativa. Scholem, d’altro canto, non vedeva nella Palestina una fuga ma un ritorno a casa, non un gesto di rassegnazione ma una speranza. Walter sperava di poter compiere in Svizzera l’abilitazione alla libera docenza. Era tornato ancora una volta a Berlino per parlare con i genitori, ma la situazione là si era inasprita al punto da fargli scrivere: «Qui la prima settimana è stata un disastro». Dopo un mese con la famiglia nella villa dei genitori si arrivò alla rottura totale. In seguito Walter disse a proposito di quell’epoca che «ero stato male come quasi mai nella mia vita». Anche Georg Benjamin lascia la villa dei genitori e si trasferisce in un pensionato per scapoli, dove ha la sensazione di essere più vicino a quelli la cui miseria conosce in quanto medico e per i cui interessi si impegnerà anche in politica, come rappresentante di quartiere per il Partito comunista. La famiglia si spaccò. Troppo diversi erano gli atteggiamenti e i valori che per Emil e Pauline si radicavano in un mondo scomparso, mentre per Walter, Georg e Dora si orientavano verso una realtà auspicata, che stava forse sorgendo. A Emil e Pauline fu risparmiato di assistere al crollo del loro mondo e alla catastrofe culturale e di un’intera civiltà durante l’epoca nazista. Emil morì nel 1926 e Pauline lo seguì quattro anni più tardi. Dora si affaccia nei ricordi d’infanzia di Walter una volta sola, raccontata nel penultimo capitolo intitolato «La luna», che racconta un sogno. La luna compare nella sua stanza come una visitatrice notturna, ed egli descrive un momento in cui il satellite della terra diventa mito della sventura che si sta approssimando. Una sventura che raggiungerà anche Walter, emigrante e profugo, e che nel suo presentimento così delinea: «La luna, fin allora già piena in mezzo al cielo, aveva d’improvviso cominciato a dilatarsi sempre più vertiginosamente. Facendosi vicina, sempre più vicina, essa spaccò in due il pianeta. La ringhiera del balcone, su cui tutti ci eravamo affacciati verso la strada, volò in mille pezzi, e i corpi che lo avevano occupato si disintegrarono ai quattro venti». E: «Dov’è Dora?» sente sua madre esclamare. Era stata Dora che un giorno, probabilmente nel 1920, aveva portato con sé l’amica Hilde Lange e l’aveva presentata alla famiglia a Grunewald. Devono aver raccontato anche, e ci piace pensare che l’abbiano fatto con molte risate, le loro esperienze all’università, dove le ragazze erano ancora un’eccezione. Dora studiava economia politica e Hilde giurisprudenza, un dominio maschile in cui erano necessarie forza e tenacia per riuscire a resistere. Dora e Hilde si sostenevano e si incoraggiavano a vicenda per opporsi all’atmosfera maschilista che regnava nelle università e tra i professori. La loro amicizia sarebbe durata letteralmente una vita intera. Solo durante il periodo nazista furono separate, quando Dora emigrò a Parigi e successivamente in Svizzera. Hilde Lange diventò Hilde Benjamin; lei e Georg si erano conosciuti e sposati. Un amore al secondo sguardo. 2 Schutzhaft: misura di privazione della libertà («per la protezione del popolo e dello Stato») applicata contro gli oppositori del regime, senza procedimento giudiziario né possibilità di ricorso. La «detenzione protettiva» era scontata in carceri e campi di concentramento [N.d.T.]. Capitolo secondo I Benjamin Lo spumante Rotkäppchen, «Cappuccetto rosso», frizza nel bicchiere. È finalmente il momento di brindare. La piccola donna dalla figura un po’ tonda ha ringraziato con un breve discorso. Tutt’intorno a lei bisbigli e risate e un nervosismo amichevole. Si porgono fiori e biglietti di auguri. È il 5 febbraio 1967 e Hilde Benjamin, ministro della Giustizia della DDR, festeggia il suo sessantacinquesimo compleanno. Il dono che i collaboratori del suo ministero le hanno appena solennemente consegnato è una bella scatola di cartone; cinque chili e mezzo pesano i documenti e i manoscritti qui raccolti, cento pagine esatte in dimensioni A4, irrobustite con cartoncini, piene di date e fatti che vanno dalla nascita a Bernburg fino al compleanno che si festeggia oggi a Berlino Est, capitale della DDR. Le si legge in viso la gioia. Curiosa sfoglia quello che hanno messo insieme i suoi collaboratori. Sulla prima pagina, scritta a mano, spicca in bella grafia la dedica: «Alla nostra compagna, dott.ssa Hilde Benjamin...». I compagni hanno confezionato signorilmente il regalo: la scatola verde rilucente sembra ricoperta in pelle. Tre eleganti quadrati, intrecciati l’uno all’altro, formano una cornice dorata sulla copertina; impressa in oro è anche la firma dal tratto vivace della festeggiata («Dott.ssa Hilde Benjamin»). Sulle cento pagine numerate, di cui solo le ultime sei sono vuote, si trovano documenti ufficiali, fotografie, lettere, ritagli di giornale offerti «quale modesta fatica [...] nel suo senso e intento», come specifica la formula di accompagnamento vergata per mano del suo vice. Quarantasette anni dopo Ursula Benjamin, la nuora di Hilde, solleva con una certa fatica la scatola ben conservata e la depone sul tavolino rotondo nella biblioteca del suo appartamento. Vive in un quartiere orientale di Berlino. Dopo la morte del marito Michael conserva anche il lascito della suocera, che il figlio aveva messo in ordine. Qui sediamo insieme e parliamo di Hilde e di Michael, della madre e del figlio, della DDR e della BRD. Anche del motivo per cui da più di vent’anni la DDR è ormai parte della storia. Dei suoi sei nipoti sono Laura e talvolta Jakob quelli che per lo più vanno a trovarla. Entrambi hanno un rapporto affettuoso con la nonna, come tutti i nipoti. Suo figlio Georg, padre di Laura e Jakob, vive e lavora a Kiev. Per evitare di far confusione fra lui e il nonno, che portava lo stesso nome, durante un soggiorno a Berlino lui stesso suggerisce di chiamarlo nel libro non Georg ma Grischa, cioè col suo soprannome: «Tutti mi chiamano comunque così». Beviamo tè o caffè. A volte si ha l’impressione che insieme a noi al tavolo siedano le persone di cui fondamentalmente parliamo e delle quali vorrei scrivere; il nonno di Grischa, Georg, e il suo famoso fratello Walter Benjamin. Le loro lettere sono custodite da Ursula, e mi è concesso di leggerle. In ogni riga sulla loro vita quotidiana a quei tempi, nel periodo precedente la Prima guerra mondiale, durante la Repubblica di Weimar e dopo la presa del potere da parte dei nazisti, trovo speranze e orrore. Walter Benjamin e Georg Benjamin, il fratello di due anni più giovane, «medico e comunista». Questo è anche il titolo di un libriccino su di lui, che fino al suo arresto nel 1933 era stato medico scolastico a Wedding. E c’è poi la moglie di Georg, Hilde Benjamin nata Lange, e il loro figlio Mischa, considerato «meticcio» in epoca nazista: il padre Georg Benjamin era ebreo, Hilde aveva il «certificato di arianità». Si parla quindi di vite tedesche, di biografie con successi ed errori. Volevano un mondo più giusto e umano di quello che trovarono. In politica si collocano a sinistra e provano ripugnanza per il disprezzo nei confronti degli uomini dimostrato dai nazisti. Nati a cavallo del ventesimo secolo, vogliono prendere in mano il proprio destino, segnato dalla loro origine e dalle successive convinzioni. Una storia di famiglia. La vita di Hilde, raccolta in cento pagine, è una fonte importante nel lascito dei Benjamin. La mia ricerca parte proprio da qui. Tutti parteciparono alla resistenza contro il nazionalsocialismo. Hilde e Georg nel Partito comunista e Walter Benjamin con la forza delle parole, come critico e autore ma anche collaboratore dell’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte, dove insegnavano e si dedicavano alla ricerca i famosi professori Horkheimer e Adorno. Anche la minore dei Benjamin, la sorella Dora, ne faceva parte. Ursula custodisce anche il lascito di suo marito, cioè il figlio di Hilde, Michael Benjamin, nato nel 1932 e morto nel 2000, il quale fu giurista e professore, esperto di giurisprudenza e di filosofia del diritto. Anche lui era comunista, uno che dopo la fine del socialismo reale e di quel mondo dominato da Mosca rifletté ampiamente sulle cause della sua scomparsa. Michael Benjamin, sua moglie Ursula e i suoi figli adulti, Grischa e Simone, vissero la riunificazione da cittadini della DDR. Per i nipoti Laura e Jakob Benjamin, nati all’epoca della svolta, la storia della Repubblica Democratica Tedesca è la storia dei loro genitori e nonni, e fa parte del programma scolastico. La loro vita comincia dopo. Scrivere sui Benjamin significa immergersi nel sanguinoso ventesimo secolo. Significa anche trovare la propria collocazione rispetto a due guerre e all’esperienza della dittatura nazista. Per me i Benjamin, in maniera differente, sono emozionanti testimoni della storia tedesca contemporanea. Georg e Walter Benjamin pagarono con la vita la loro resistenza. Solo di rado riesce a crearsi un sentimento di vicinanza tra i fratelli e la sorella. Troppo spesso si ritrovarono divisi. Walter, Georg e Dora vissero già la Prima guerra mondiale in luoghi diversi. I difficili anni che la seguirono furono decisivi nel dar forma al loro impegno sociale e politico. Dora ammira l’impegno sociale di Georg, e terminati gli studi collabora strettamente con lui per qualche tempo. L’iniziale entusiasmo bellico di Georg svanì in fretta, dopo l’esperienza della terribile guerra di posizione e alla luce dei milioni di soldati morti. Ogni giorno imparava a odiare quello che viveva in quanto soldato. Suo fratello era riuscito a sottrarsi al servizio di leva. Era molto miope e grazie a utili attestati poté evitare la via del fronte e proseguire invece gli studi a Monaco e Berna. Nel 1918, tornato dal fronte, Georg cominciò a studiare medicina e divenne medico scolastico e pediatra a Wedding. La Berlino rivoltosa e rivoluzionaria dell’immediato dopoguerra e la triste condizione sociale della città proletaria lo fecero aderire prima al Partito socialdemocratico indipendente tedesco (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USDP), un gruppo fuoriuscito dal Partito socialdemocratico tedesco (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), e poi al Partito comunista (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD). Georg Benjamin si candidò e fu eletto rappresentante del KPD nel consiglio di quartiere a Wedding. Si trasferì in un pensionato per scapoli, dove poteva essere più vicino a coloro la cui condizione sociale lo angustiava, e che cercò di alleviare. Dora, nata nel 1901, ricevette ugualmente un’istruzione universitaria, com’era naturale che fosse nelle famiglie illuminate dell’alta borghesia ebraica. Frequentò i corsi liceali per ragazze e là conobbe Hilde Lange, che aveva un anno meno di lei e di cui in seguito sarebbe diventata amica. Dora studiò economia politica e conseguì il dottorato all’Università di Greifswald. In seguito lavorò in diversi ambiti dell’assistenza sociale e per il Gesundheitshaus3 socialista a Kreuzberg. Introdusse a casa l’amica e così accadde che Georg e Hilde si conobbero e si innamorarono. Si sposarono nel 1926. Hilde fu una delle prime donne a studiare giurisprudenza; soltanto da poco era concesso alle donne di sostenere il secondo esame di stato. Nel 1928 si stabilisce a Wedding come avvocato, dove Georg aveva già il suo ambulatorio di medico. Apre uno studio legale, lascia l’SPD e come Georg entra nel Partito comunista. Fino alla presa del potere dei nazisti nel 1933 i due hanno davanti a sé ancora cinque anni insieme – e inizialmente in grandi ristrettezze: solo negli ultimi due anni riuscirono a tirare un sospiro di sollievo anche da un punto di vista materiale. E finalmente le entrate bastarono per un appartamento più grande. La sorella di Hilde, Ruth, nata nel 1908, nel 1927 è campionessa tedesca di lancio del peso e segna più volte record mondiali. Il fratello Heinz Lange diventa ingegnere. I genitori, Adele e Walter Lange, avevano offerto loro un ambiente familiare liberale. Dopo aver lavorato presso le industrie Solvay a Bernburg, il padre passò a dirigere un’azienda del medesimo complesso industriale nella capitale del Reich. Berlino divenne allora il nuovo centro della famiglia. Quando i nazisti arrivano al potere nel marzo 1933 e il Reichstag in fiamme scatena una prima ondata di arresti che colpisce comunisti e socialdemocratici, anche Georg viene arrestato e rinchiuso nel campo di concentramento di Sonnenburg. A Hilde viene proibito l’esercizio della sua professione. La comunicazione reca la firma di Roland Freisler, che in qualità di presidente del Volksgerichtshof4 condannerà in seguito a morte anche i fratelli Hans e Sophia Scholl (La rosa bianca) e gli autori dell’attentato a Hitler del 20 luglio 1944. Freisler fu responsabile di migliaia di condanne a morte. Nel 1933 Walter e Dora Benjamin fuggono dalla Germania ed emigrano in Francia. In quest’epoca Georg viene messo in «detenzione protettiva» dai nazisti e, esclusa la possibilità di emigrare, comincia quindi per Hilde l’epoca terribile della politica razziale nazionalsocialista. Hilde teme per la vita del marito ebreo e del figlio Michael, che ha appena compiuto un anno e in quanto «meticcio» è soggetto alle leggi razziali. Sarà un martirio che durerà dodici anni, prima che Berlino sia liberata dall’Armata Rossa e per Hilde divenga possibile un nuovo inizio. Su un lato del curriculum, compilato dai suoi collaboratori, è incollata la fotografia ufficiale che la ritrae nelle vesti di ministro. Hilde Benjamin siede alla scrivania. Sopra, sfocati, si vedono alcuni documenti che la mano sinistra prende e raduna, mentre la mano destra è girata verso l’interno, morbida e leggermente sollevata. È manifestamente la donna abituata a esporre le sue ragioni, che osserva con attenzione quel che le sta di fronte. La foto è anche una messinscena, e vuole trasmettere la certezza di un obiettivo: avanti insieme per il socialismo. Nel suo viso si leggono le esperienze di una vita. Nel momento in cui le presentano il regalo preparato con tanta cura, i suoi collaboratori non possono ancora sapere che due anni dopo Hilde Benjamin sarà sollevata dal suo incarico al ministero. Non più nelle grazie di Ulbricht, continuerà tuttavia a presiedere la Commissione per la riforma del codice penale. La terza pagina della raccolta biografica porta la firma del suo sostituto, Hans Ranke, e il titolo «Introduzione». C’è scritto che si tratta di un contributo in una «occasione solenne», che mostra un «segmento della vita, dell’opera e della lotta di Hilde Benjamin per il diritto e con il diritto, in un duplice senso». Viene onorata la sua battaglia per il «diritto degli oppressi» in un’epoca in cui «l’avvocato e membro del Partito comunista, compagna Hilde Benjamin, si schierò davanti ai tribunali e ai tribunali del lavoro per i diritti dei lavoratori». Lo attestano le lettere di ringraziamento dei compagni che allora furono difesi con successo da lei in tribunale. Si parla anche di un processo dell’ottobre 1930, presso il tribunale del lavoro. Walter Kranewitz, veterano del partito di Fürstenwalde, ricorda che Hilde Benjamin aveva assunto la sua difesa. Membro del consiglio di fabbrica, Kranewitz era stato licenziato senza preavviso: «Le sue conoscenze legali erano maggiori di quelle del direttore dell’azienda che aveva ordinato il licenziamento; potemmo vincere sull’azienda mondiale Pintsch. Firmato Walter Kranewitz». L’indice ha trenta capitoli. Parlano di lotta e giustizia di classe, dell’ingresso nel partito e di come questo fosse il punto intorno a cui ruotava tutta la vita, parlano di sconfitte politiche e del suo sopravvivere da comunista durante il nazionalsocialismo. E parlano anche della grande speranza riposta nello stato socialista tedesco, che avrebbe vinto il fascismo e smentito il capitalismo. E tuttavia la vita raccolta nell’elegante scatola suscita più distanza che simpatia. Parla del ministro, dottoressa Hilde Benjamin. Qui l’altra Hilde non appare, la madre che fece da insegnante al proprio figlio, perché dopo il 1942 gli era stato proibito di frequentare qualsiasi scuola superiore. La donna che ama e, senza curarsi della propria sicurezza, cerca ostinatamente il prigioniero Georg Benjamin dietro le mura delle prigioni naziste, e diverse volte lo trova, fin quando non riesce più a raggiungerlo. È strano quanto poco i trenta capitoli della sua vita sappiano in fondo trasmettere. Sono come un paravento che lascia intravedere soltanto l’ombra della persona al di là. Ma anche questo lato ufficiale fa parte di Hilde Benjamin, vestita dei panni di combattente per il socialismo, il cui cuore batte solo per il partito e per la causa del proletariato. Ci sono indicazioni che proprio così volesse essere vista durante i primi anni della DDR. Il paravento che fa emergere solo l’immagine della brava soldatessa del partito offre anche la protezione di cui forse aveva bisogno. Diversamente da Georg Benjamin, Hilde non viene infatti da una famiglia altoborghese, ma è troppo intellettuale per poter essere definita una combattente proletaria. Quindi mostra poco di ciò che fa affettuosamente trapelare nelle sue lettere a Georg: il coraggio con cui stette al suo fianco e che dimostrò anche verso gli amici ebrei, i quali poterono sempre contare sul suo aiuto. Tutto questo lo mantenne nascosto, ben custodito per il figlio e in seguito per i nipoti e i pronipoti, e si può leggere nelle lettere e nei documenti privati. Nel 1945, quando sulle rovine del Reichstag sventola già la bandiera rossa con la falce e il martello, Hilde Benjamin viene a sapere del suicidio di suo cognato Walter Benjamin, la cui fuga al di là dei Pirenei era terminata alla frontiera spagnola, a Portbou sulla Costa Brava. Con cinque anni di ritardo la notizia la raggiunge in una lettera dell’amica Dora. Costei aveva trascorso il periodo della guerra in Svizzera. Deve aver raccontato a Hilde anche del comune lavoro con suo fratello Walter e della loro difficile esistenza durante l’esilio a Parigi, dove Dora rinunciò alle proprie ambizioni accademiche e aiutò il fratello nella stesura dei suoi manoscritti. A Parigi si impegnò inoltre a favore dei bambini profughi attraverso l’organizzazione «Assistance Médicale aux Enfants des Réfugiés». Un anno dopo, un’altra lettera; questa volta è posta ufficiale delle autorità svizzere che cercano parenti di Dora, morta in esilio. La lettera aveva fatto una lunga deviazione fino a New York e all’Istituto di Francoforte che era stato là trasferito, prima di raggiungere Hilde a Berlino. L’eredità in questione consiste in un paio di libri e in pochi documenti personali. Dora non possedeva più nulla e nel 1942 non venne rimandata dalla Svizzera in Francia, incontro a una morte certa in un campo di sterminio tedesco, perché essendo già moribonda non sarebbe sopravvissuta al trasporto. Malata di cancro all’ultimo stadio, nel giugno 1945 Dora partecipò tuttavia a una conferenza di profughi a Montreux. Come già a Parigi, anche qui lottò per migliorare le condizioni dei bambini profughi. La piccola donna con i capelli grigi, che ai partecipanti alla conferenza doveva apparire prossima a terminare l’arco della sua vita, pregò con grande passione di non dimenticare che i bambini traumatizzati dalla fuga e dalla deportazione dei loro genitori appartenevano a quella gioventù nelle cui mani sarebbe stata la ricostruzione dell’Europa. Un anno dopo Dora è morta: aveva appena quarantacinque anni. Sei anni prima Walter Benjamin si era suicidato per evitare l’arresto da parte della polizia francese e la consegna alla Gestapo. Walter aveva quarantotto anni. Due anni dopo di lui, nel 1942, sul filo spinato percorso dalla corrente ad alta tensione del campo di sterminio di Mauthausen suo fratello Georg terminò la propria vita. Una famiglia in Germania. Quando Hilde Benjamin riceve la lettera che per mano di Dora le dà la notizia della morte di Walter, non immagina che la sua amica avrebbe seguito tanto presto i fratelli. Quali pensieri la inseguono mentre tiene in mano la lettera? Cosa può sopportare un essere umano? Le resta il figlio Mischa, che ha saputo strappare alla ridda mortale dei nazisti. Ogni giorno le ricorda Georg, la cui fede politica era stata per lei, durante tutto il tempo nella Germania di Hitler, un sostegno a cui reggersi. E adesso, un anno dopo, la notizia della morte di Dora in Svizzera. Tutti quelli che sentiva vicini erano morti senza che avesse potuto dar loro un ultimo saluto. Avvertiva un obbligo nei loro confronti e anche verso le loro speranze, a cui si augurava di rendere giustizia con il suo lavoro per l’idea comune di una Germania socialista. Nel 1950-51 Hilde Benjamin ricevette ancora alcune lettere che avrebbero influenzato profondamente la sua vita. Le conservò fino alla morte. Quando Michael Benjamin esaminò il suo lascito, trovò una busta con la scritta «Ultimo saluto di Utti – ultime lettere di mia madre». Sono due lettere e una cartolina di auguri da parte di Utti (la sorella di Hilde) per il suo compleanno. Entrambe le missive mostrano l’affetto che Adele Lange provava per sua figlia. Così scrive nella prima: «Mia cara piccola Hilde, penso a te e a Mischa con amore e nostalgia, e il mio cuore è felice se so che state bene». Adele Lange racconta di una dolorosa contusione alla gamba e accenna a un piccolo regalo per il compleanno di Hilde. La lettera non è datata, ma si può supporre che sia stata scritta per il suo quarantanovesimo compleanno, il 2 febbraio 1951. Il calore di quelle parole deve aver reso felice Hilde Benjamin, e sarebbe strano se non fosse così. La casa dei genitori fu sempre aperta per lei. Durante l’epoca nazista Hilde era dipesa più volte dall’aiuto che la famiglia naturalmente le dava. Anche la seconda lettera è segnata dal calore con cui la madre Adele parla alla figlia. È tuttavia molto breve, sette righe, piuttosto un messaggio diretto da Ovest a Est, sul cui contenuto Hilde Benjamin a quanto pare non volle mai dire nulla. Eccolo: Cara piccola Hilde! Oggi viene qui Sophie e ti scrivo subito stamattina per poterti dire con calma quello che volevo dirti da tempo! Se io dovessi finire presto in ospedale, o se addirittura morissi all’improvviso, ti prego con tutto il cuore: Non venire da me, perché in questa terribile spaccatura fra Est e Ovest non ti sarebbe possibile. Tesoro mio, spero di vivere ancora per un po’, ma se la fine dovesse arrivare in fretta non venire qui! Tesoro mio, il bene che ci vogliamo è così grande che non c’è bisogno di dimostrarlo. Con amore, tua madre La Sophie qui nominata potrebbe essere la domestica di Hilde, che a quanto pare dava ogni tanto una mano in casa dei Lange. La lettera voleva proteggere la figlia, la cui fede politica non fu mai un problema in casa dei genitori. È difficile oggi giudicare se questa decisione, che gravava su madre e figlia, fosse davvero necessaria. La madre abitava a Berlino Ovest e Hilde stava nella parte orientale della città. Ma è chiaro che Hilde era molto legata alla sua famiglia e che la madre sperava di aiutare la figlia ad affrontare la sua vita «dall’altra parte» senza una cattiva coscienza. Adele Lange non aveva che da aprire i giornali o sentire i commenti alla radio per sapere come sua figlia, vicepresidente della Corte suprema della DDR, veniva presentata dai media della Germania Occidentale. Nei titoli dell’altro stato tedesco Hilde Benjamin era definita «Hilde la Sanguinaria» o «Ghigliottina rossa». Prima di essere nominata ministro della Giustizia nel 1953 Hilde giudicò i colpevoli del nazifascismo nell’ambito della sua sfera di potere, ma anche quelli che riconosceva come nemici della DDR. La violenza della contrapposizione fra Est e Ovest in quegli anni, quando la guerra di Corea sembrava minacciare la pace mondiale, si manifestò anche, se non in primo luogo, a Berlino. Qui i cittadini dell’Ovest avvertivano la particolare criticità della loro posizione di isola, essendo ancora vivo il trauma del blocco di Berlino. Per lungo tempo ebbero la sensazione di sedere su una polveriera. Era probabilmente quello che intendeva Adele quando parlava della terribile spaccatura fra Est e Ovest. La lettera della madre deve aver pesato su Hilde Benjamin. Evidentemente non c’era nessuno con cui poteva parlarne, tanto più che nei media occidentali si speculava sulla supposta rottura di Hilde Benjamin con la famiglia. Di certo nulla sarebbe cambiato se avesse respinto quelle speculazioni. Conservò le lettere, come tutto ciò che riguardava la sua famiglia. Anche questo mostra fino a che punto e per quanto tempo quelle sette righe abbiano occupato la sua mente. Adele Lange morì nel 1952. A Hilde rimase il fratello che viveva nella DDR, come lei membro della SED, che in seguito andò a vivere in Occidente. Hilde era certamente in contatto anche con la sorella Utti. Il socialismo scientifico era la fede da lei professata. All’interno della sfera di potere dei sovietici, nella zona da essi occupata che divenne poi la Repubblica Democratica Tedesca, Hilde volle dare il suo contributo per sconfiggere il nazionalsocialismo che le aveva portato via il marito, il genero e la cugina Gertrud Kolmar, da lei tanto ammirata. La vita di Hilde Benjamin non può essere raccontata senza la coscienza che «la morte è un maestro tedesco». Molti anni più tardi è il figlio Mischa a chiedersi perché il progetto della DDR sia fallito. Mischa, che nel 1945 poté riprendere a frequentare la scuola e nel 1948 ottenne la maturità con eccellenti voti – Hilde era stata evidentemente una brava insegnante –, seguì le convinzioni politiche della madre e vi rimase fedele anche dopo la fine della DDR. La paura costante che entrambi ebbero l’uno per l’altra durante il nazismo segnò fino in fondo le loro vite. Ciò spiega la gratitudine del figlio, che aveva bisogno della protezione materna e ne ebbe sempre la certezza. Questa parte della vita di Hilde Benjamin avrebbe potuto facilmente riempire le sei pagine vuote della documentazione raccolta dai suoi collaboratori al Ministero della Giustizia, che fino alla pagina 94 parla di Hilde nelle sue vesti ufficiali. Chissà se simili pensieri privati trovarono spazio nella confusione della piccola festa di compleanno. Hilde Benjamin intendeva sul serio eliminare quelli che avevano quasi annientato la Germania. Per quanto riguarda la sua sfera di potere, gli alti funzionari nazisti potevano augurarsi clemenza solo se non avevano le mani direttamente sporche di sangue. Il contrario accadeva nella nazione di Adenauer. Nessun giudice o procuratore avrebbe dovuto rispondere delle decisioni da lui prese nello stato del terrore e delle leggi razziali, o delle condanne a morte pronunciate contro imputati appartenenti all’opposizione. Per la migliore amica di Hilde, Dora Benjamin, sarebbe stato desolante vivere il dopoguerra nella Germania Federale. A differenza di quanto si potrebbe credere, Dora non fu semplicemente la sorellina messa in disparte, che ammirava il fratello maggiore. Nell’Infanzia berlinese intorno al millenovecento viene menzionata solo in un breve passaggio. Ciò cambia in seguito, soprattutto dopo che entrambi emigrarono a Parigi nel 1933. Per me è importante farla uscire dall’ombra gettata dal celebre fratello. Perciò è di lei che voglio cominciare a raccontare. 3 Il Gesundheitshaus («casa della salute») di Kreuzberg fu il primo centro berlinese di medicina preventiva e educazione sanitaria [N.d.T.].. 4 Volksgerichtshof («Corte di Giustizia del popolo»): tribunale speciale con sede a Berlino, istituito su ordine di Hitler, competente per i crimini di alto tradimento e politici [N.d.T.]. Capitolo terzo Dove resta Dora... Dora Benjamin e i suoi fratelli maggiori, Walter e Georg: chi desidera scoprire qualcosa su di loro non può ignorare il fatto che Dora fu spesso la sorellina sottovalutata o semplicemente non presa in considerazione, quasi la quinta ruota del carro rispetto agli altri due. Ciò non valeva per il rapporto dei fratelli verso di lei, e soprattutto non per Georg. È un luogo comune dovuto soltanto ai biografi, il cui interesse si è focalizzato puramente su Walter. Oltre a lui solo la moglie di Georg, la cognata Hilde, quale ministro della Giustizia della DDR è riuscita a entrare nelle sale di lettura delle biblioteche. Si deve a sua moglie Hilde se Georg non scomparve nell’oscurità della storia tedesca, brutalizzata dai nazionalsocialisti. Fu lei la sua biografa, grazie alla quale egli ottenne una sorta di fama postuma che tuttavia rimase limitata sostanzialmente alla DDR e con questa si estinse. Si deve ugualmente a Hilde e alla sua lunghissima amicizia con Dora se quest’ultima non fu dimenticata. Occorre ringraziare Hilde se la tesi di dottorato di Dora, discussa presso la ErnstMoritz-ArndtUniversität a Greifswald, divenne accessibile. Hilde Benjamin scovò l’originale nel 1963, molto tempo dopo la morte di Dora, nell’archivio dell’Università di Greifswald. Dora vi studia la «Condizione sociale delle operaie berlinesi occupate nel settore della confezione». In altre circostanze e in un’altra epoca sia Georg che Dora avrebbero raggiunto una maggiore notorietà. Entrambi erano colti, attenti alla realtà degli altri, cosa che li esponeva alle drammatiche contraddizioni sociali della Repubblica di Weimar, da cui sarebbero rimasti scottati. Qualsiasi ingiustizia si possa lamentare nella Germania contemporanea, non è comparabile alla drammatica miseria nel periodo successivo alla guerra. Nessuno dei tre Benjamin poté ignorarla. E questo è tanto più notevole in quanto l’infanzia trascorsa nella casa dei genitori al Grunewald non aveva conosciuto alcun tipo di privazione. Fu Walter, nel suo libro Infanzia berlinese intorno al millenovecento, ad aprire squarci sull’agiata vita della famiglia che durante le ferie si trasferiva nella dimora estiva sul Brauhausberg, a Babelsberg. Walter ebbe bisogno di molto tempo per riuscire a staccarsi da questa dipendenza materiale. Dopo l’università e il dottorato Dora si ritrovò più vicina al fratello Georg, che terminati i suoi studi di medicina aveva lasciato la casa di famiglia. Anche l’impegno sociale di Dora era rivolto in primo luogo ai bambini. Il quartiere rosso di Wedding era quel che si definisce oggi un quartiere a rischio. A quel tempo era la zona più povera di Berlino. Nella sua tesi di dottorato Georg esaminava la questione se l’istituzione dei «centri per scapoli» potesse migliorare le condizioni di vita dei giovani che affluivano dalle campagne verso le città nella speranza di trovare un lavoro. Fino a quel momento l’unica possibilità era stata per lo più quella di affittare, come «pigionanti a ore», un letto e un tetto sopra la testa da dividere con altri, in base ai diversi turni di lavoro. Era un piccolo guadagno extra per molte famiglie che abitavano nei cortili interni dei caseggiati e ospitavano spesso due o tre «pigionanti a ore». Che i rapporti con le famiglie si facessero talvolta intimi appariva evidente solo quando una figlia ormai grande si ritrovava incinta. La miseria dei bambini a quel tempo era il tema di Dora. Già la sua tesi per il «conseguimento del dottorato in Scienze politiche» aveva studiato la «Condizione sociale delle operaie berlinesi occupate nel settore della confezione, con particolare riguardo all’allevamento dei figli». E anche nel sottotitolo si chiariva subito quale fosse l’obiettivo della ricerca: il «tentativo di una valutazione del lavoro a domicilio in confronto al lavoro in fabbrica, relativamente alla maniera migliore di allevare i figli». Chiunque vivesse a Berlino dopo la Prima guerra mondiale non poteva ignorare i bambini di strada denutriti e coperti di stracci. Si aggiravano per lo più a gruppi per le strade e le piazze, sopravvivendo per mezzo di piccoli furti. Molte ragazzine, appena un po’ cresciute, si prostituivano sulle strade. Nell’ambulatorio di Georg, a Wedding, Dora poté studiare gli effetti che la vita in strada produceva sulla salute. Il tema della sua tesi di dottorato non era dunque affatto casuale, come non lo era stato lo studio dell’economia politica che aveva concluso con ottimi risultati. Oltre alla tesi di dottorato, alle lettere ai fratelli e agli amici, alle descrizioni del comune lavoro con Walter in esilio, sono pochi i documenti biografici su Dora. Trovo le indicazioni più ampie in un saggio di Eva SchöckQuinteros, Dora Benjamin:«dennichhoffe nach dem Krieg in America arbeiten zu können». Stationen einer vertriebenen Wissenschaftlerin (19011946) (Dora Benjamin: «perché spero di poter lavorare in America dopo la guerra». Tappe di una scienziata profuga, 1901-1946), pubblicato in occasione di un convegno tenutosi all’Università di Brema nel 1997, «Barrieren und Karrieren. 100 Jahre Frauenstudium in der Wissenschaft» (Barriere e carriere. Cento anni di studio femminile nella scienza). La testimonianza principale sull’impegno politico di Dora è la sua tesi di dottorato. A differenza dell’amica Hilde Lange, che studiava giurisprudenza, nel suo studio dell’economia politica Dora si interessò in particolare modo delle questioni legate a maternità e lavoro. Hilde e Dora, quasi coetanee, si erano conosciute quando entrambe si preparavano alla maturità liceale, e furono da allora intime amiche. Fatta eccezione per un semestre estivo che trascorsero insieme a Heidelberg, Hilde compì tutto il suo percorso universitario nella capitale del Reich. Al termine dei suoi studi Dora andò invece per un semestre a Jena, e seguì poi a Greifswald il suo relatore, Karl Muhs, che nel giugno 1924 giudicò il suo lavoro «ottimo» e raccomandò che venisse ammesso all’esame. Le ampie ricerche per la tesi sollecitarono anche la scelta di una materia secondaria presso la facoltà di medicina: «Igiene». L’impressione lasciata in lei dalle necessarie visite nelle famiglie o dall’ambiente domestico delle operaie dovette essere così incisiva da farle comprendere, come afferma SchöckQuinteros, l’importanza dell’igiene per la vita e la salute delle donne e delle madri che lavoravano in casa, e soprattutto per i loro figli. La tesi di dottorato è uno studio accademico sul tema «Lavoro e maternità». Mette in dubbio la convinzione ampiamente diffusa secondo cui «solo l’occupazione a domicilio procura a madri e bambini posti di lavoro irrinunciabili, che devono essere protetti». Secondo l’opinione generale il lavoro in fabbrica significava allora che le madri, separate dai loro bambini, potevano allattarli troppo di rado e non avevano modo di controllarli a sufficienza. A ciò veniva ricondotto l’aumento del tasso di mortalità nei neonati e nei bambini piccoli, ma anche il crescente abbandono che colpiva i ragazzi. La ricerca di Dora partiva proprio da questo punto. Definiva «immagine distorta» il presunto idillio di una vita da madre e lavoratrice a domicilio rispetto a quella di un’operaia in fabbrica, e replicava con la tesi che proprio il lavoro a domicilio, con i suoi orari di lavoro non regolati, in locali scuri e spesso mal arieggiati era dannoso per i bambini. Era perciò più sensato aiutare le operaie delle fabbriche attraverso la creazione di asili e asili nido, e di curare inoltre la formazione attenta delle maestre. Consigliava anche di istituire un’assicurazione sulla maternità per consentire alle madri di stare insieme ai neonati fino al termine dell’allattamento. Ma soprattutto Dora Benjamin esprimeva l’opinione che il lavoro a domicilio comportasse il coinvolgimento dei bambini nel lavoro stesso, ai fini del sostentamento, e che perciò promuovesse il lavoro minorile. Chi sfoglia la tesi di Dora Benjamin vede quanto fossero avanzate le sue idee ottantacinque anni fa. Forse sarebbe utile oggi, nel 2014, mandarne una copia a qualche attivista che si batte in favore di una politica familiare conservatrice. Dopo gli studi e il dottorato Dora si era indirizzata in realtà verso una carriera accademica. Era fra i collaboratori della rivista «Soziale Praxis» (Prassi sociale). «Le sue critiche ai tentativi di abbellire la realtà del lavoro a domicilio divennero sempre più taglienti e politiche» scrive Eva Schöck-Quinteros. La vita privata di Dora non viene purtroppo descritta in nessun luogo. Un paio di fotografie suggeriscono di collocarla nella serie delle donne emancipate e illuminate che determinarono a quell’epoca l’immagine della donna moderna e consapevole di sé. Il contributo di SchöckQuinteros su Dora rimanda all’ultimo suo saggio noto sulla donna e il lavoro, pubblicato nel 1931 nel volume collettaneo DieKulturder Frau. Eine Lebenssymphonie im XX. Jahrhundert (La cultura della donna. Una sinfonia della vita nel ventesimo secolo). La sua posizione è univoca e tuttora attuale. Sono tre i lavori svolti dalle donne: la cura della casa, l’accudimento e l’educazione dei figli e l’occupazione retribuita. Anche qui Dora mette in rilievo il pericolo che, a causa della bassa remunerazione, i bambini vengano fatti lavorare e siano così privati della loro infanzia. La sua critica si rivolge anche alle comunità che mettevano a disposizione pochi asili, doposcuola e asili nido. La crociata pubblicistica di Dora contro la concezione dominante nel mondo classista postguglielmino circa i ruoli maschili e femminili e la subordinazione della donna nella società patriarcale terminò bruscamente. Nel suo lavoro Schöck-Quinteros suppone che l’interesse di Dora Benjamin per la psicologia e la pedagogia, a scapito dell’economia politica, fosse dovuto alla constatazione che «le sue analisi impegnate sul lavoro a domicilio come causa di lavoro minorile non avevano smosso nulla» e «di fatto non avevano aiutato un solo bambino». A colpire Dora era stato in primo luogo Georg e «il suo appassionato impegno sociale e le sue idee per una politica sanitaria socialista», che egli sviluppò insieme a importanti riformatori come Ernst Joel e Fritz Fränkel. Nasce qui la loro collaborazione ai progetti del Gesundheitshaus socialista, in cui dovevano essere ugualmente messe in pratica sia l’assistenza sanitaria che un’opera di educazione. Questo fu l’obiettivo perseguito anche dalla mostra «Nervi sani», esposta al Gesundheitshaus nell’ottobre 1929, il cui motivo conduttore fu così descritto da Walter Benjamin, come riportato nel lavoro di Schöck-Quinteros: «Che cosa non diventerà un corpus delicti per chi inesorabilmente conduce il processo contro lo sfruttamento, la miseria e la stupidità?». Per gli organizzatori della mostra nulla conta più di questa consapevolezza e del piccolo choc «che insieme a essa sorge dalle cose [...] da un interno dell’ufficio di collocamento un modulo in cui su dieci colonne, dall’alto verso il basso, è stampata sempre e solo la parola “attendere”. Assomiglia al bollettino di borsa in un quotidiano. Sopra, di traverso, in grassetto: “Il listino del povero”». Un altro punto focale era l’assistenza nelle dipendenze. Dora sosteneva già un punto di vista che oggi, pur variamente dimostrato, non è ancora condiviso da tutti: cioè che la dipendenza non è un crimine, ma una malattia che deve essere curata fra l’altro con la somministrazione di sostanze sostitutive. Come mi accade spesso quando rifletto sui pochi squarci che le lettere e i documenti, insieme al saggio di Eva SchöckQuinteros, mi aprono sulla vita di Dora Benjamin, anche qui ammiro il suo pensiero progressista che si lascia alle spalle molti di quei pregiudizi che ancora oggi, più di settanta anni dopo la sua morte, determinano le azioni della nostra società. Appena quattro anni più tardi, nel 1933, la visione nazista del mondo ha distrutto l’ottica variegata e umanistica del Gesundheitshaus. Nessuno allora era dotato di sufficiente fantasia per prevedere che la rabbia piccoloborghese del nazionalsocialismo, satura d’odio, avrebbe fatto dimenticare tutto ciò che era stato pensato in precedenza. Il fascismo hitleriano eliminò a modo suo i pesi sociali di una realtà dissestata dalla guerra e dal dopoguerra, e fece sognare alla gente un futuro libero da essi, perché avrebbe separato con un taglio netto la vita degna e quella indegna. Sotto l’insegna dell’arianizzazione veniva depredata nel contempo una parte della popolazione che contribuiva in maniera significativa, sia in ambito culturale che economico, alla ricchezza della società. In due successivi passi, dopo il 1933, ciò portò alla cosiddetta «soluzione finale» – attraverso la Notte dei cristalli nel 1938, con la distruzione dei negozi ebrei e il furto dei loro beni privati, e nel 1941 con l’inizio della deportazioni e lo sterminio in massa degli ebrei europei. Nel 1933 Dora aveva trentadue anni. Si stava facendo un nome in campo accademico e avrebbe avuto tutte le porte aperte per una carriera di successo. Ma la consegna del potere a Hitler distrusse nello stesso tempo «la rete di contatti professionali, politici e interpersonali» necessari per questo, come specifica SchöckQuinteros nel suo lavoro. Cominciò l’epoca degradante e spesso segnata dagli stenti dell’emigrazione, l’epoca delle persecuzioni, del carcere e della fuga dalla Germania. Nel 1933 le fiamme dell’incendio al Reichstag illuminarono un paese che passo dopo passo si stava trasformando in una dittatura, che utilizzava come armi politiche la sua brama di morte e di ricatto predatorio, e che nel giro di dodici anni ridusse l’Europa in macerie. Per Dora l’arresto del fratello Georg e del suo relatore, il professor Fränkel, furono un avvertimento che non si poteva ignorare. Fritz Fränkel fu rilasciato soprattutto grazie al coraggioso intervento di sua moglie Hilde, con l’ordine di lasciare subito il Reich tedesco. Cosa che, a quanto pare, riuscì a fare anche grazie allo scrittore Wolfgang Hellmert, come dimostra Schöck-Quinteros. Hellmert fu uno dei numerosi poeti dimenticati che prima del 1933 si approssimavano alla fama e che oggi solo pochi esperti ricordano. Hellmert faceva parte della cerchia di Klaus Mann, ed emigrò a Parigi dove morì a ventotto anni. Era considerato un poeta della Nuova oggettività. I suoi libri, come quelli di molti altri scrittori, finirono sul rogo acceso nel 1933 dagli studenti che aizzati dall’araldo di Hitler, Joseph Goebbels, sarebbero diventati «Herrenmenschen». I Fränkel in fuga fecero una breve sosta in Svizzera, prima di andare a Parigi dove Fritz aprì uno studio medico. Walter Benjamin, che nel 1933 lasciò la Germania, emigrò anch’egli nella sua seconda patria, a Parigi, e alloggiò per qualche tempo presso i Fränkel. Là arrivò infine anche Dora. La quale trascorse il periodo intorno alla Pasqua del 1933 in Svizzera, tornò una volta a Berlino ma dovette riconoscere che ogni speranza in una fine del terrore nazista era vana e, nell’agosto 1933, scelse definitivamente la via dell’esilio verso la Francia. Fu anche un addio alla carriera e alla vita universitaria. L’imperativo divenne allora letteralmente il sopravvivere. In Francia regnava una strana ambivalenza nei confronti della Germania hitleriana. Il fatto che la squadra olimpica francese nel 1936 facesse il suo ingresso all’Olympiastadion di Berlino con il braccio levato nel saluto hitleriano è stato variamente commentato. Molti emigranti raccontano nelle loro memorie quanto scarsa fosse la comprensione, soprattutto negli Uffici passaporti e delle amministrazioni, per quanti erano fuggiti dalla Germania. Soprattutto gli ebrei incontravano riserve. L’ostacolo maggiore – e ciò vale ancora oggi per la legislazione restrittiva che regola il soggiorno degli stranieri in Germania – era il permesso di soggiorno per gli emigranti o i profughi. Subito dopo il suo arrivo a Parigi, il 17 agosto 1933, Dora fa domanda per il rilascio della Carte d’identité, che deve aspettare con inquietudine fino al marzo 1934. E poi: come guadagnare del denaro? Non era previsto in tutto ciò un permesso di lavoro. Com’era possibile vivere a Parigi in condizioni del genere? Dora si cercò diversi impieghi e lavorò come collaboratrice domestica e donna delle pulizie. Al più tardi nel 1935-36 dovette prendere atto che soffriva di spondilite o morbo di Bechterev, una dolorosa – e incurabile – artrite reumatoide che a poco a poco può condurre al totale irrigidimento della colonna vertebrale, ma anche di altre articolazioni e organi. L’amica Hilde, che fino allo scoppio della guerra fu in contatto epistolare con Dora, lo riferì a Georg in prigione. Dal carcere preventivo di Moabit, a Berlino, Georg scrisse nel 1936 una lettera allarmata chiedendo a Hilde se «Dodo», come chiamava la sorella, fosse consapevole della gravità del disturbo. Georg era preoccupato per Dora poiché, così scrisse a Hilde nel settembre 1936, la cosa peggiore della malattia «è la sua inarrestabilità, pur essendo il progresso generalmente molto lento» – com’era ancora nel suo caso. Georg aveva ragione. Le condizioni di Dora peggiorarono in maniera sensibile, costringendola a lasciare il faticoso impiego di collaboratrice domestica. Nel suo piccolo appartamento in rue Robert Lindet 7 lavorò per una organizzazione di profughi occupandosi di bambini traumatizzati, e quel che guadagnava bastava appena per l’affitto e qualche magro pasto. Quando Walter le chiese se poteva aiutarla finanziariamente lei gli descrisse la precarietà della sua situazione, in parte determinata dalla malattia. Il lavoro con i bambini esauriva già le sue forze. Dora gli mandò una lettera, in cui fra l’altro scriveva: «Ma credo che tu non abbia ben chiaro cosa significhi per me la lotta per l’esistenza, cosa significhi lavorare con forti dolori quasi ogni giorno». È possibile che Fritz Fränkel le abbia parlato di uno specialista a Berlino. I rapporti di Dora con i Fränkel furono sempre stretti anche a Parigi. Nel gennaio 1938 Dora si azzardò in ogni caso a compiere il viaggio a Berlino, dove fu sottoposta a cure fino al marzo 1938. In questo periodo fu certo in contatto con la cognata Hilde, che molto probabilmente aveva organizzato ogni cosa perché Dora si ristabilisse. Quali che fossero le rassicurazioni ricevute dal consolato tedesco a Parigi, dopo tre mesi di cure a Berlino poté tornare indisturbata a Parigi. Nel novembre dello stesso anno le sinagoghe in fiamme illuminarono i terribili pogrom nelle strade di Berlino e del Reich. Il ritorno di Dora a Parigi fu accompagnato da una felicità doppia. Le cure a Berlino le avevano procurato un certo sollievo dai dolori, e aveva conosciuto Gert. Chi fosse Gert e cosa l’avesse portato a Parigi non si sa. In luglio Walter Benjamin, che era andato a trovare il suo amico Bertolt Brecht in Danimarca, riceve un biglietto da Dora per il suo compleanno, citato anche da SchöckQuinteros: «Se non torni troppo tardi farai in tempo a conoscere Gert. Resterà probabilmente fino agli ultimi giorni di settembre. Ancora non sappiamo quali saranno i nostri progetti per il futuro. Naturalmente non sarà facile e nel futuro più prossimo per me non cambierà niente. Gert deve ancora sostenere il suo esame». Non possiamo dire cosa significasse per lei questa relazione, quanto fosse stata importante e intensa, appagamento e amore per qualche mese, quanto meno una breve pausa da tutto quel che l’aveva assillata fino ad allora e che avrebbe continuato ad assillarla in seguito. Un’estate d’amore a Parigi, e un anno dopo Dora scrisse a Walter che ignorava dove fosse finito il compagno. Gert dovette lasciare la Francia e tornare in Germania perché era scoppiata la guerra? Era stato richiamato? Ed era ancora vivo, o aveva partecipato come soldato all’invasione della Polonia ed era caduto? Chi fosse e quali fossero le sue idee, perché si trovasse a Parigi e come avesse conosciuto Dora, sono tutte domande senza risposta. È del tutto possibile che un bel giorno fosse comparso dai Fränkel. Forse un amico l’aveva portato con sé nel salotto, oggi famoso, al numero 10 della rue Dombasle, dove si incontrava spesso un’illustre schiera di emigrati. Nonna Fränkel, la madre di Fritz, abitò per qualche tempo da Dora e si occupò della casa. Vedo Dora in una foto in bianco e nero. Porta un cappello a tesa larga, come andavano al tempo, un po’ obliquo sul capo e i capelli probabilmente corti, forse con il caschetto che era di moda verso la fine degli anni Venti. Il suo viso è leggermente ombreggiato dall’ampia tesa. Uno sguardo scettico, rivolto a sinistra e distolto dall’osservatore. Il naso piccolo e la bocca piena che agli angoli, con un po’ d’autoironia, soffoca un sorriso e non gli concede di schiudersi. Una giovane donna attraente e consapevole di sé, un ritratto a mezzo busto che fa pensare a una corporatura di media altezza. Il 15 maggio 1940 Dora – scrive Eva SchöckQuinteros –, come tutte le donne non sposate e senza figli in un’età compresa fra i diciassette e i cinquantacinque anni, deve presentarsi al Vélodrome d’Hiver. Il bagaglio non può superare i trenta chili e oltre alle provviste per due giorni, a posate e stoviglie, consiste in vestiti e un po’ di biancheria intima. Dora potrebbe avere incontrato là Lisa Fittko, che in seguito avrebbe condotto sui Pirenei, oltre la frontiera con la Spagna, il profugo Walter Benjamin e poi anche Hannah Arendt e Fränze Neumann, l’amica di Fritz Fränkel che nel 1935 si era separato dalla moglie Hilde. Pochi giorni dopo Dora, insieme a più di duemila donne, fu consegnata con il primo trasporto nel famigerato campo d’internamento di Gurs, nei Pirenei. Dopo l’avanzata della Wehrmacht verso il confine olandese e poi il bombardamento e l’occupazione del Benelux in maggio si poteva prevedere quando Hitler avrebbe dominato l’intera Europa occidentale, compresa la Francia. Il 14 giugno 1940 la Wehrmacht occupò Parigi. Con l’armistizio del 22 giugno e l’occupazione parziale della Francia molti internati, nella Francia di Vichy, poterono lasciare Gurs. Dora Benjamin riuscì a raggiungere Lourdes, dove trovò il fratello Walter. Anche Hannah Arendt era nella famosa città dei pellegrinaggi. Là incontrò Walter Benjamin, con cui era in rapporti di amicizia, come raccontò in una lettera inviata a Theodor W. Adorno a New York, senza tuttavia dire se fosse presente anche Dora. Forse non si videro affatto, se si considera la possibilità che dopo il forzato addio a Parigi e le settimane di internamento Dora soffrisse di una forte ricaduta della sua malattia reumatica e fosse costretta a letto. Fratello e sorella abitavano in rue Notre Dame. Si separarono alla fine di luglio, quando Walter partì per Marsiglia. Sperava di espatriare negli Stati Uniti, paese per cui Max Horkheimer gli aveva procurato un visto. Non si videro più. Dal questionario delle autorità svizzere si deduce che Dora rimane un altro anno a Lourdes, prima di recarsi anche lei a Marsiglia nell’agosto 1941. Ha un affidavit necessario per l’ingresso negli Stati Uniti. Se aveva sperato di ottenere come Walter un visto tramite l’Emergency Rescue Committee, era arrivata troppo tardi. A quell’epoca l’ufficio del comitato a Marsiglia doveva essere già chiuso e il suo direttore, l’americano Varian Fry, era stato arrestato. La situazione dei profughi ebrei dalla Germania era drammatica. Le autorità naziste richiedevano ai francesi di riconsegnarli. Cominciarono le deportazioni dalla Francia. Nel 1942 la Wehrmacht occupò anche il sud del paese, e a Dora restavano ormai poche alternative, se voleva salvarsi la vita. O la fuga al di là dei Pirenei, o la clandestinità nel paese, o il passaggio illegale della frontiera con la Svizzera. Eva Schöck-Quinteros dimostra che Dora scelse quest’ultima via. Sui suoi ultimi mesi in Francia esiste un verbale delle autorità svizzere, citato da Eva SchöckQuinteros: «Nell’agosto [1942] avrei dovuto essere arrestata dalla polizia francese e deportata, ma fui rilasciata grazie a un certificato medico. Dopo l’entrata dei tedeschi nella zona libera fui costretta a tenermi costantemente nascosta. Nonostante gli sforzi impiegati nel corso di mesi per ottenere il visto di ingresso in Svizzera, non lo ottenni. Nel timore di essere presa in qualsiasi momento dai tedeschi lasciai Aix-enProvence il 17 (dicembre 1942) e quello stesso giorno varcai la frontiera svizzera a Landecy, dove mi consegnai spontaneamente (ci consegnammo spontaneamente) ai soldati. Questi ci trasferirono poi alle autorità militari». La sua vita in Svizzera può essere ricostruita attraverso le lettere e le fonti ufficiali a cui poté avere accesso Eva Schöck-Quinteros, in cui appaiono evidenti le difficoltà che dovettero superare gli emigranti che volevano raggiungere la Svizzera e soggiornarvi in sicurezza. In una lettera del marzo 1946 a Theodor W. Adorno, indirizzata a New York, Dora descrive il modo in cui da Aix-en-Provence arrivò alla frontiera svizzera. «Nell’agosto 1942 avrei dovuto essere presa e deportata, e fui salvata soltanto da un certificato dell’ufficiale sanitario che confermava la mia inadeguatezza ad affrontare il trasporto; all’epoca avevo trascorso diversi mesi a letto con forti reumatismi articolari. La malattia mi impedì di fuggire in Svizzera prima che il resto della Francia fosse anch’esso occupato. Durante l’invasione dei tedeschi ebbi la fortuna di potermi nascondere in una fattoria vicino a Aixen-Provence, dove avevo vissuto. Alla fine di dicembre del ’42 riuscii a fuggire in Svizzera, un’impresa già allora molto rischiosa, perché la frontiera era sorvegliata dai tedeschi. In Francia viaggiai con documenti falsi. Il passaggio della frontiera fu una marcia notturna a piedi, molto eccitante e avventurosa. Arrivata in terra svizzera ebbi la sfortuna di finire in un posto di dogana dove fui minacciata in un primo momento di essere rimandata al di là della frontiera. E questo quando credi di avere raggiunto la salvezza! Fu un terribile choc. Ero decisa a seguire l’esempio di Walter pur di non tornare indietro, cosa che avrebbe significato la deportazione quasi sicura. Per fortuna riuscii, dopo ore di contrattazioni, a farmi ammettere. Gli eventi di questi anni hanno naturalmente lasciato su di me le loro tracce, e a ciò riconduco in sostanza il peggioramento del mio stato di salute». La durezza con cui la Svizzera respingeva i profughi e rifiutava soprattutto di accogliere gli ebrei veniva da una disposizione del capo della Sezione di polizia del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia: i confini dovevano essere completamente chiusi. Tutti i profughi civili, anche ebrei, venivano mandati indietro. Fu un ignoto ufficiale svizzero a ordinare che Dora non fosse direttamente «espulsa» dalle guardie di frontiera Ernest Strasser e G. A. Schoenbachler, ma venisse invece arrestata e portata nel campo di Charmilles. Il motivo della lettera non ha tuttavia nulla a che fare con la storia delle sue sofferenze. Queste sono descritte in ogni caso con un’intima distanza, affinché Adorno possa prenderle solo come una spiegazione per l’inconsueta forma dello scritto. Le preme soltanto che l’opera del fratello Walter abbia un riconoscimento adeguato, che sia ordinata e il più possibile pubblicata, cosa a cui esorta Adorno. Nello stesso tempo informa l’amico di Walter a New York che il suo secondo fratello Georg, dopo aver scontato una pena carceraria di sei anni, nell’agosto 1942 era stato ucciso nel campo di concentramento di Mauthausen. Poi ritorna a Walter e racconta di aver avuto grandi difficoltà in Francia subito dopo la sua morte a Portbou, e certo in relazione con essa. «Interrogatori, perquisizioni domiciliari ecc. senza che abbia potuto capire cosa volessero davvero da me». Questo generico accenno ci ricorda ancora una volta come non sia mai stato fugato il dubbio se la versione ufficiale sulla morte di Walter Benjamin a Portbou corrisponda davvero ai fatti. Il sospetto che la Gestapo dei nazisti, in collegamento con i fascisti spagnoli di Franco, possa aver avuto la sua parte è suggerito anche dal documentario argentino di Davi Mauas «Chi ha ucciso Walter Benjamin?», uscito nei cinema nel 2005. Nel film si rivela come sia il medico che attestò la causa della morte sia il proprietario della pensione in cui Benjamin si sarebbe suicidato ebbero un importante ruolo tra i falangisti spagnoli della regione. Il mistero del manoscritto scomparso che Walter Benjamin portava con sé e di cui disse a Lisa Fittko, la sua guida fino al confine spagnolo oltre i Pirenei, che era «più importante della sua vita» – dov’è finito? Solo la sua cartella vuota fu inventariata. Chi prese con sé il manoscritto e perché, chi fu esortato a farlo? Mancano anche gli occhiali, la pipa e una radiografia. Forse non verrà mai data una risposta a queste domande, e forse non è nemmeno importante che l’ebreo Walter Benjamin sia stato sepolto in un cimitero cattolico, cosa tuttavia inconsueta. Per Dora l’esilio in Svizzera era come una rete fatta di pregiudizi, oltre che di ordinanze e divieti, appuntati in special modo contro gli emigranti ebrei. Una rete che di fatto non consentiva nessuna libertà di movimento ed era accompagnata dal divieto di lavorare. La cosa più urgente per lei era uscire in fretta dal famigerato campo di Charmilles. Le lettere indirizzate ad amici svizzeri fanno capire molto bene quale fosse la situazione degli emigranti a cui era consentito di rimanere in Svizzera. Persone abbastanza influenti fecero sì che le fosse rilasciato infine un permesso per motivi di salute e che potesse farsi curare a Zurigo. L’internamento nel Lager fu notevolmente mitigato da un internamento «privato». Con l’aiuto del Soccorso operaio svizzero Dora ottenne in effetti un posto non retribuito presso un insegnante a Regensberg, nel Canton Zurigo. Questi dirigeva un centro educativo per bambini deboli di mente, ma in grado di apprendere. «Dal 5 del mese sono qui a Regensberg, nella famiglia dell’insegnante del grande istituto locale per deboli di mente» scrive Dora in una lettera del maggio 1943. Era stata accolta con molto affetto e aveva la possibilità di coniugare il riposo con un’attività interessante. Poiché non viveva all’interno dell’istituto era libera di disporre del proprio tempo. Aveva già avuto i primi positivi contatti e poteva lavorare nell’ambito della sua specializzazione, sperando di poter giovare a qualche bambino anche dal punto di vista psicoterapeutico. Doveva però presentarsi regolarmente all’amministrazione militare, e per qualsiasi spostamento o piccolo viaggio che la allontanava da Regensberg era necessaria un’autorizzazione. Eva Schöck-Quinteros evidenzia come Dora avesse ricominciato a pensare al futuro, sperava che la guerra finisse e di poter riprendere il lavoro e le proprie ricerche negli Stati Uniti. «Vivo qui» scrive nel 1943, «un po’ stregata – in uno strano ambiente fra deboli di mente e sordomuti, e fra i pochi abitanti nominalmente “normali” del nostro villaggio, fatto di dieci case. Ma naturalmente sono felicissima di aver trovato questa ospitalità – che è già diventata amicizia – e attendo con impazienza il momento in cui la salute mi concederà di dedicare molto più tempo alla ricerca. Devo prepararmi a poco a poco, perché spero di poter lavorare in America dopo la guerra». Quattro settimane più tardi scrive di avere grande speranza che la guerra possa presto finire. Voleva tentare già allora qualche passo perché il visto americano fosse davvero pronto al momento buono. Sembrava che sarebbe stato possibile espatriare attraverso l’Italia già prima della fine della guerra. Dora fu costretta tuttavia nuovamente a un’altra lunga degenza nell’Ospedale cantonale di Zurigo, al cui termine la attendeva la devastante diagnosi: cancro al seno. La sua aspettativa massima di vita, secondo la stima dei medici, non superava i tre anni. Non ci sono commenti da parte sua o degli amici che facciano capire come avesse reagito alla notizia. È certo però che tornò a immergersi nel lavoro. Intrattenne anche un fitto scambio sulla futura organizzazione degli istituti pedagogici nella Germania del dopoguerra. Propose inoltre (non senza giudicare la cosa «forse totalmente irrealizzabile») di introdurre in Germania due generi di passaporti: quello comune e una «sorta di passaporto preferenziale per le persone dal provato atteggiamento antifascista». Era convinta che in questo modo si sarebbero facilitati, o comunque resi possibili, i viaggi all’estero per la seconda categoria. E tanto più riteneva assolutamente indispensabile che i futuri insegnanti «ampliassero i loro orizzonti attraverso la conoscenza di altri paesi – questo ora è più importante che mai». Come avrebbe reagito se avesse visto il paese diviso e, in Germania Occidentale, le vecchie élite naziste che continuavano a occupare le loro cariche e uffici? Si impegnò anche attivamente nella formazione di chi allora e poi dopo la guerra si sarebbe occupato dei bambini e dei giovani che i campi di concentramento, la fuga e la guerra avevano sradicato dal loro mondo. Dovette essere gratificante vedere come il suo sapere e le sue competenze fossero richiesti. Quando nel febbraio 1944 si costituì un comitato di organizzazioni umanitarie svizzere e internazionali che avrebbe dovuto istituire corsi di formazione per personale di sostegno nel dopoguerra, fra i docenti vennero inclusi anche alcuni profughi. Dora Benjamin avrebbe collaborato nel campo della psicologia e della pedagogia. Il tema specifico del suo seminario sarebbe stato l’assistenza psicologica ai bambini che avevano subito danni a causa della guerra. La sconfitta dello stato hitleriano restituì evidentemente a Dora forza, speranza e fiducia, tanto da allontanare sullo sfondo la sua infermità. Subito dopo la guerra era certa di riscuotere l’attenzione di una parte dell’opinione pubblica svizzera. Ugualmente certo è che pose le basi per un lavoro psicologico-pedagogico con i bambini e i ragazzi vittime di traumi, che avrebbe permesso loro di ricominciare a vivere. Oggi la ricorda il parco intitolato a lei a Friedrichshain, nella parte orientale di Berlino. Dora Benjamin morì in esilio in Svizzera nel 1946. Capitolo quarto L’esilio Nel 1933 Walter Benjamin non aveva altra scelta se non Parigi, quale luogo in cui voltare le spalle alla Germania. Dora lo seguì, e forse lo stesso avrebbe fatto anche Georg Benjamin con la sua famiglia se, in quanto comunista e oppositore del nazismo, non fosse stato rinchiuso in «detenzione protettiva» già nel 1933, subito dopo l’incendio del Reichstag. I due fratelli e la sorella furono così separati. Ciò seguiva la logica di un’epoca che nella sua brama di rivalsa era pronta a qualsiasi orrore nazionalista. Il fascismo tedesco aveva inoltre l’ambizione patologica di caricare in senso razzista la sua «ideologia dei bassifondi» (Hannah Arendt). Era una miscela assassina, che si sarebbe rivelata insieme autodistruttiva. Nella scelta del paese in cui prendere la via dell’esilio Walter e Dora Benjamin seguivano Heinrich Heine o Ludwig Börne e altri intellettuali rivoluzionari e sgraditi, che nel corso della storia furono scacciati dalla Germania. L’ondata di emigranti che fece seguito alla rivoluzione sconfitta del 1848 doveva ripetersi. Nel 1934 circa sessantamila persone avevano lasciato la Germania, due anni dopo erano già più di centomila. Nell’insieme furono più di mezzo milione quelli che si lasciarono alle spalle il paese, e fra questi un buon novanta per cento era perseguitato per motivi razziali. Molti esercitavano mestieri proibiti agli ebrei nella Germania nazista. La scena culturale si impoverì tutt’a un tratto. Le opere degli «artisti degenerati» nelle arti figurative e in letteratura furono distrutte o bruciate, e l’esistenza dei loro creatori fu così annientata. Fuggirono o furono privati della cittadinanza, e ciò accadde a intellettuali come Benjamin o a socialdemocratici e comunisti. Trovarono dimora in Francia, classica terra di asilo, che nel 1933 rilasciava ancora generosamente i suoi permessi di soggiorno. Questo ebbe termine però nel 1940, quando in due fasi la Francia fu aggredita e occupata dalla Wehrmacht. Il numero dei richiedenti asilo in Francia, in drammatico aumento dopo il 1933, comportò problemi sociali e politici per il paese, già di per sé tutt’altro che stabile al suo interno. A tratti la Francia minacciava di scivolare nel fascismo, come l’Italia e la Germania e in seguito la Spagna. Fu un segno esplicito del clima politico imperante allora in Francia il fatto che la squadra nazionale francese, il giorno di apertura delle Olimpiadi nel 1936, sfilasse davanti al palco del Führer nell’Olympiastadion di Berlino facendo il saluto hitleriano. Fattori scatenanti di rapporti che in certi momenti rasentarono la guerra civile furono un montante e aggressivo estremismo di destra e uno scandalo quasi dimenticato che tra la fine del 1933 e l’inizio del 1934 portò a una grave crisi di politica interna. Al centro di tutto c’era il banchiere russo ebreo Serge A. Stavisky, strettamente legato al mondo della politica, che dopo la scoperta delle sue pesanti truffe era morto mentre si trovava in fuga dalla polizia. Per paura che venisse alla luce il proprio coinvolgimento nell’affare e soprattutto nell’uccisione del banchiere la destra radicale, sostenuta da una molesta stampa di destra, cercò di addossare tutta la colpa sul regime liberale del primo ministro Chautemps. La cosa fu agevolata dal fatto che alcuni membri del suo gabinetto erano anch’essi pesantemente compromessi. Le dimissioni del regime Chautemps traferirono sulla strada il conflitto fra le parti politiche, ci furono morti e feriti, e una guerra civile minacciò di scoppiare. L’attentato mortale dei nazionalisti croati a Marsiglia nel 1943 contro il re jugoslavo, che si trovava in visita di stato in Francia ed era accompagnato dal ministro degli Esteri francese, attizzò nuovamente la dilagante xenofobia e l’antisemitismo nel paese, facendo sì fra l’altro che gli emigranti fossero consegnati ai loro persecutori, soprattutto alla Germania. Solo un’ampia «tregua fra i partiti» salvò la Terza Repubblica e la Francia democratica, prima dell’attacco da parte della Wehrmacht, che ne segnò la fine. Per molti profughi l’incerta situazione politica interna in Francia fu un motivo per rifugiarsi temporaneamente in Spagna. Alcuni scoprirono l’isola di Ibiza, che non conoscevano. Anche Walter Benjamin andò là e insieme allo scrittore francese Jean Selz si cimentò in una traduzione della sua Infanziaberlineseintorno al millenovecento. Il progetto fallì, e così il tentativo di trovare un editore per la sua Strada a senso unico. Furono però fortissimi accessi di febbre che posero termine alla sua collaborazione con Selz e costrinsero Benjamin, malato di malaria, a lasciare Ibiza e a tornare a Parigi, dove si affidò alle cure di un medico amico. Il biografo Fuld ricorda che alla fine del 1933 Walter Benjamin, nuovamente a Parigi, si trovava in una situazione totalmente disperata. Era così indebolito dalla malattia che non riusciva a salire i gradini fino al suo albergo di terza classe in un sobborgo parigino. Per vergogna della propria povertà viveva isolato e cercò tuttavia di intrattenere rapporti con quei letterati francesi che facessero balenare qualche opportunità di pubblicazione. Dopo il ritorno dalle vacanze estive, quando la città sulla Senna si era in gran parte svuotata, i parigini si imbatterono nei tantissimi emigranti che nelle sale d’attesa sovraffollate dei comitati d’aiuto, istituiti in fretta e furia, speravano in un sostegno. Fra questi c’era anche Walter Benjamin. Ciò spiega la sua lettera alla sorella, ugualmente malata e senza mezzi, in cui le chiedeva se avesse potuto mandargli una piccola somma di denaro. Lei però guadagnava così poco che bastava appena per l’affitto e a stento per un pasto quotidiano. In seguito la sua situazione migliora quando Gretel Adorno, che più di una volta l’avrebbe sostenuto, gli invia dei soldi. Nel contempo riceve dall’Istituto per le ricerche sociali un compenso mensile di 500 franchi per la sua regolare collaborazione. L’Istituto si era trasferito da Ginevra, dove si era spostato in seguito all’avvento al potere dei nazisti, a New York, perché Theodor W. Adorno e Max Horkheimer temevano che anche la Svizzera potesse essere travolta dal fascismo. A Parigi Benjamin incontra Bertolt Brecht e fra le due personalità così contrastanti si sviluppa un’amicizia che soprattutto per quest’ultimo è piuttosto inconsueta. Benjamin è ospite almeno tre volte e per diverse settimane nella casa di Brecht sull’isola di Fünen, in Danimarca. Un’amicizia che avrebbe resistito alla tendenza di Brecht a sequestrare per sé le persone a lui vicine e a «consumarle». Quando aveva un po’ di soldi Benjamin li spendeva principalmente per libri e riviste, sempre nella speranza di riuscire a piazzare lui stesso uno scritto in cambio di un compenso. Nasce così a Parigi anche il celebre saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Una lettera a Max Horkheimer, inviata a New York, chiarisce anche la sua condizione personale a Parigi: «La mia situazione è difficile, quanto può esserlo la situazione di uno che non ha debiti. Non voglio attribuirmi alcun merito, ma dire soltanto che ogni aiuto che Lei mi dà significa per me un sollievo immediato». Nella lettera Walter Benjamin racconta di vivere al momento come subinquilino in casa di altri emigranti. Aveva ottenuto inoltre il diritto a usufruire di una mensa calda, istituita per gli intellettuali francesi. Ma la concessione era soltanto provvisoria, e in secondo luogo ne poteva approfittare solo nei giorni che non trascorreva in biblioteca, poiché il locale era distante da lì. Solo di passaggio menziona di dover rinnovare la Carte d’identité, ma di non avere i cento franchi necessari. Nel diciannovesimo volume dei Werke und Nachlass (Opere e lascito) pubblicati dall’editore Suhrkamp, che contiene le tesi Sul concetto di storia, compare regolarmente anche il nome di Dora Benjamin, che approntò il dattiloscritto trascrivendo gli appunti di Walter. Un segno della loro stretta collaborazione a Parigi. Entrambi soffrivano di una costante incertezza materiale. Lui stesso dichiarò di aver bisogno di mille franchi al mese per coprire le spese essenziali, il che corrispondeva a circa centocinquanta marchi. Il mercato degli onorari in campo scientificoletterario, ovvero accademico, era limitato anche a Parigi e gli intellettuali francesi non erano affatto contenti della nuova concorrenza. In altre parole, la possibilità di ottenere compensi per saggi e conferenze era decisamente scarsa. E così anche quella di abbandonare l’Europa assediata dal fascismo e trovare accoglienza in America del Nord o del Sud. In una lettera a Gershom Scholem, Hannah Arendt racconta degli ultimi tempi trascorsi insieme a Walter Benjamin. Scrive che allo scoppio della guerra si trovava insieme ad alcuni amici, fra cui Walter (Benji) Benjamin, «in un paesino francese» vicino a Parigi. La notizia della guerra l’aveva spaventato enormemente. Come tutti i profughi, anche lui fu internato. Nel campo provvisorio di Colombes incontrò poi il marito della Arendt, a cui apparve totalmente privo di speranze. Arrivato nel campo definitivo, nei mesi successivi scrisse le sue tesi di filosofia della storia e ne mandò una copia – «come lui mi disse» – anche a Scholem. Nella sua lettera Hannah Arendt dice che alla visita medica «Benji» era stato giudicato inabile al servizio di lavoro obbligatorio per tutti gli internati di età inferiore ai quarantotto anni. Nel contempo, alla metà di maggio, gli era stato risparmiato «come per miracolo» l’«internamento più duro». Poiché lei stessa allora era internata, erano stati alcuni amici ad averle raccontato che Benjamin non osava più uscire per la strada e viveva in uno stato di panico costante. Era partito per Lourdes con l’ultimo treno che aveva lasciato Parigi. Alla metà di giugno Hannah Arendt era stata rilasciata dal campo di Gurs e casualmente era arrivata anche lei a Lourdes, dove rimase diverse settimane per desiderio di Benjamin. «Benji e io giocavamo a scacchi dalla mattina alla sera e nelle pause leggevamo i giornali, quando ce n’erano». Tutto era andato bene fino al momento in cui venne reso noto l’armistizio con la famigerata clausola di estradizione. Dopodiché le cose si erano fatte molto più sgradevoli. Non poteva dire che Benji fosse caduto nel panico, anche se erano giunte loro notizie sui primi suicidi di internati in fuga dai tedeschi. Ma per la prima volta, e poi ripetutamente, lui aveva parlato di suicidio. Che restava ancora quella via d’uscita. A lei che ribatteva con energia come per questo ci fosse sempre tempo, lui rispondeva che non si può mai sapere e in queste cose non bisogna arrivare in ritardo. Hannah Arendt partì all’inizio di luglio da Lourdes e fino a settembre restò in contatto epistolare con Walter Benjamin. Molto scoraggiato lui aveva scritto che la Gestapo era stata nel suo appartamento parigino e aveva sequestrato tutto. Notizie simili comunicava Dora, che a Parigi era stata interrogata più volte. In settembre Hannah Arendt incontrò ancora una volta Walter Benjamin a Marsiglia, perché erano arrivati i loro visti per gli Stati Uniti. Il visto di Walter Benjamin era stato procurato da Max Horkheimer. Benjamin aveva anche i necessari documenti di transito per la Spagna e il Portogallo, e così partì per i Pirenei dove avrebbe incontrato Lisa Fittko che attraverso il confine franco-spagnolo doveva condurlo in Spagna, oltre le montagne. Capitolo quinto L’ultimo bivacco prima di Portbou Il fresco della notte. Un breve pendio. I suoi passi, su e giù, sono prudenti. Sa che il cuore deve farcela. Respira con affanno, trema e spera che il movimento aiuti a vincere il freddo. Deve superare la notte in montagna, sui Pirenei, vicino alla frontiera spagnola ma ancora in Francia. Anche adesso che è rimasto da solo, i suoi occhi non si staccano un istante dalla cartella. È più importante della sua stessa vita, aveva sussurrato a Lisa Fittko quando, ore prima, si erano congedati dal sindaco di Banyuls-surMer. Sollevando la borsa Lisa ne sente il peso e ha paura che sia troppo per il «vecchio Benjamin», così lo chiama dentro di sé. Lui aveva mormorato qualcosa a proposito di un manoscritto infilato nella cartella, che assolutamente non doveva andare perduto. Lisa aiuta la gente a fuggire e accompagnerà il piccolo gruppo – Walter Benjamin, Henny Gurland e suo figlio Joseph – oltre le montagne, fino alla frontiera spagnola. Hanno un visto per gli Stati Uniti e visti di transito validi per la Spagna e fino al Portogallo, dove sperano di imbarcarsi su una nave che li porti in America. Lisa e suo marito Hans si erano conosciuti a Praga, dove erano arrivati nel 1933 fuggendo da Berlino. Facevano parte dell’opposizione di sinistra e all’inizio della guerra erano dovuti scappare in Francia. Nel 1940 lavorano per l’ufficio delle associazioni sindacali americane a Marsiglia, occupandosi di accompagnare i profughi. L’ufficio aiuta gli oppositori del nazismo a procurarsi il visto di ingresso negli Stati Uniti. I Fittko hanno già portato decine e decine di persone oltre i Pirenei. Lisa non conosce ancora la via di fuga verso la vicina frontiera spagnola che hanno intenzione di prendere il giorno successivo. Si scopre che è un vecchio sentiero di contrabbandieri. Perciò vogliono percorrere il primo terzo della via quel pomeriggio. L’ha consigliato il sindaco. Lo schizzo che egli dà loro mostra ogni diramazione, che devono memorizzare bene per non smarrire il percorso. La via consueta non era più sicura, ma erano stati messi in guardia per tempo dalle pattuglie di frontiera francesi. Lisa e Walter con la cartella e il manoscritto, da cui non si separa mai, e Henny Gurland con il figlio Joseph si mettono in cammino. Dopo tre ore raggiungono un boschetto di pini su un pendio. Da lì non doveva essere che un’ora, al massimo un’ora e mezza, secondo la previsione del sindaco di Banyuls. Attraverso la finestra dell’ufficio in Comune il boschetto era sì lontano, ma ben riconoscibile. «Una passeggiata» aveva aggiunto con sollecitudine il sindaco, «come prova». Ma Walter Benjamin non era abbastanza forte, né il suo cuore gli avrebbe fatto giudicare una «passeggiata» quella marcia. Gli sembrava perciò poco fattibile ripercorrere quello stesso giorno il medesimo tratto fino a Banyuls, per ritornare lì il mattino dopo, probabilmente non meno esausto. E così il «vecchio Benjamin» – aveva in effetti compiuto da poco i quarantotto anni – dice all’accompagnatrice: «Passerò qui la notte». Ed eccoli sotto un pino, lo sguardo puntato sul sentiero scosceso che conduce a Banyuls-surMer. Di lassù salutano le luci della cittadina ai loro piedi, che verso sera si accendono. Walter Benjamin deve economizzare le proprie forze, e non si lascia deviare dal suo proposito. Dopo aver tentato di dissuaderlo Lisa soffoca il proprio impulso di restare e non lasciarlo solo. Deve comunque procurare acqua e viveri per il giorno successivo, quando si dirigeranno verso la città di frontiera spagnola, Portbou. Così il gruppo si divide. Il piano di Lisa è quello di partire prestissimo da Banyuls-sur-Mer e mescolarsi ai viticoltori che verso le quattro del mattino si incamminano verso le vigne. Sarebbe stato il mascheramento migliore, aveva assicurato il sindaco. Solo nel vigneto, Walter deve innanzitutto riprendersi; per sedersi adopera, a mo’ di cuscino, la cartella con il manoscritto che «conta per me più della mia vita», come scrive Lisa Fittko nelle sue memorie. Il terreno è ancora caldo per il sole d’autunno. Walter cerca rami per accendere un fuoco e a mani nude scava una buca, perché il piccolo falò non si scorga da lontano. È sufficiente per scaldarsi. La notte è piena di stelle. La luna irradia una luce lattea; un cielo notturno come solo in montagna è possibile vedere. L’uomo lassù in cima tira un respiro profondo, un momento di quiete che sembra fatto per ripercorrere nel pensiero la sua vita, da Berlino a Monaco, poi a Friburgo, a Berna e a Francoforte, e i diversi soggiorni a Parigi. Una strada che l’ha portato fino a questa solitudine in mezzo ai Pirenei. Vuole fuggire la possente scossa che con la sua forza distruttiva colpirà tutta l’Europa, e ha visto giungere quel che si sta addensando. Ci sono molte testimonianze risalenti agli anni dopo la Prima guerra mondiale che descrivono il cammino politico dell’intellighenzia critica, degli artisti e dei letterati in quest’epoca travagliata. Molti speravano nella rivoluzione desiderata ardentemente dai comunisti e attesa da loro come qualcosa di ineluttabile. Le masse non ne furono infiammate. L’Internazionale comunista, che dopo la sua fondazione nel 1919 si riuniva ogni anno a Mosca, attendeva invano il legittimo avvento della rivoluzione mondiale. La socialdemocrazia riformista non condivideva comunque l’attesa e la fede che l’ex impero fosse maturo per una rivoluzione, sul modello dell’Ottobre rosso. Lo scetticismo di Benjamin in effetti traspare, ma è minore di quello dello scrittore Werner Kraft, la cui indicazione di non «voler accogliere per ora il comunismo “come soluzione per l’umanità”» gli arriva in uno scambio epistolare. E risponde: «Ma, attraverso le soluzioni praticabili che questo offre, occorre mettere fine alla sterile pretesa di offrire soluzioni valide per l’umanità, e in generale all’immodesta prospettiva di “sistemi totali”, facendo almeno il tentativo di organizzare la vita degli uomini in modo tale che possa scorrere con la stessa tranquillità con cui affronta le proprie giornate un uomo ragionevole che abbia ben dormito». Qualche anno più tardi lo ribadisce con un’immagine che suggerisce in maniera complessa e insieme chiara quanto nel comunismo vi sia un «surrogato della religione». Viene naturale supporre che sul monte Benjamin abbia pensato all’«omino con la gobba»: «È noto che sarebbe esistito un automa costruito in modo tale da reagire a ogni mossa di un giocatore di scacchi con una contromossa che gli assicurava la vittoria. Un manichino [...] sedeva davanti alla scacchiera, posta su un ampio tavolo. Con un sistema di specchi veniva data l’illusione che vi si potesse guardare attraverso da ogni lato. In verità c’era seduto dentro un nano gobbo, maestro nel gioco degli scacchi, che guidava per mezzo di fili la mano del manichino. Un corrispettivo di questo congegno si può immaginare nella filosofia. Vincere deve sempre il manichino detto “materialismo storico”. Esso può competere senz’altro con chiunque se prende al suo servizio la teologia, che oggi, com’è a tutti noto, è piccola e brutta, e tra l’altro non deve lasciarsi vedere». Il suo amico Adorno parlava di «nucleo teologico», senza cui il materialismo avrebbe perso la sua fondamentale forza propulsiva. Ma per ciò fu necessaria la morte di Stalin nel marzo 1953 e la sua successiva detronizzazione al XX Congresso del Partito comunista sovietico, quando vennero resi noti i suoi crimini. Molti comunisti fedeli che avevano venerato l’uomo al Cremlino furono profondamente scossi nelle certezze coltivate fino a quel momento: un dio che non era tale. Benjamin critica anche il Partito socialdemocratico tedesco e il suo concetto di progresso che non si attiene alla «realtà», ma mostra pretese dogmatiche. Critica lo «sfruttamento della natura» e l’esaltazione del lavoro in quanto «sacro». E in effetti ci vollero il movimento ecologico e i Verdi negli anni Ottanta del ventesimo secolo perché la socialdemocrazia giungesse alla «riconciliazione» fra lavoro e ambiente. Cosa avrà pensato Walter Benjamin nel leggere gli errori e le false valutazioni sulla consegna del potere a Hitler, formulate dal comitato esecutivo dell’Internazionale comunista il 1° aprile 1933? In un comunicato stampa diffuso allora si dice: «L’instaurazione della dittatura scopertamente fascista, che distrugge tutte le illusioni democratiche nelle masse e le libera dall’influsso dei socialdemocratici, accelera i tempi di avanzamento della Germania verso la rivoluzione proletaria». Quale errore. La lotta contro i socialdemocratici, che i comunisti chiamavano sprezzantemente «socialfascisti», era considerata più importante della resistenza comune contro i nazisti, perché i socialdemocratici intralciavano la rivoluzione mondiale. Mosca si sbagliava e a lungo si mostrò cieca di fronte alle dimensioni e agli esiti di questo errore. Già durante la guerra di Spagna fu possibile cogliere note di questo genere, quando dietro le linee di combattimento venivano liquidati quei compagni che non volevano seguire i dettami di Mosca. In Spagna era il riflesso del terrore stalinista che imperversava già da tempo in Unione Sovietica. L’errato giudizio di Stalin, convinto che Hitler avrebbe rispettato il patto di non aggressione con l’Unione Sovietica, prolungò le sofferenze dei popoli aggrediti e portò alla Russia quattro anni di persecuzioni, campi di sterminio, invasione e genocidio. Nel suo quartier generale chiamato «Wolfsschanze», cioè la «tana del lupo», Hitler si era prefisso niente di meno che la conquista del territorio russo per il «popolo privo di spazio». I sopravvissuti avrebbero servito come schiavi la razza padrona. Questo progetto affondò nel terreno senza fondo delle strade malsicure, battute da costanti piogge, o fu arrestato dalle masse di neve a quaranta gradi sottozero. I suoi pensieri per un’analisi della condizione dell’Europa centrale, che in forma di rotolo Bejamin aveva donato al suo amico Gershom Scholem quando quest’ultimo era emigrato in Palestina, sono un testo veggente, scritto nel 1923: «Un singolare paradosso: la gente, quando agisce, pensa solo al più gretto interesse personale, ma al tempo stesso è più che mai condizionata nel suo comportamento dagli istinti della massa. E ora più che mai gli istinti di massa sono divenuti insensati ed estranei alla vita. [...] Sicché in essa giunge a compimento l’immagine della stupidità: insicurezza, anzi degenerazione degli istinti vitali e impotenza, anzi decadimento dell’intelletto. Questa è la disposizione di spirito della totalità dei borghesi tedeschi». Come va letto questo testo se non come una previsione di ciò che sarebbe venuto, dell’ideologia razzista del popolo che sfocia poi nella concezione deragliante della razza padrona? Lo Stato delle SS, come lo descrive Eugen Kogon dopo il collasso della Germania nazista e la tragedia dei tedeschi, qui già nebulosamente si intravede. Le grandi parate naziste, le fiaccolate e le fantasie apocalittiche, le apparizioni messianiche del suo Führer che guida la «provvidenza», il tutto accompagnato da una borghesia servile il cui collasso morale si annuncia con fanfare e musica possente. Ma torniamo a Walter Benjamin nel 1940, alla frontiera francospagnola. Quali stati d’animo e sentimenti possono averlo dominato? Poteva rievocare con un sorriso la sua infanzia e altre fasi della sua vita, così contraddittorie e diverse? È Benjamin stesso che mi incoraggia a immaginarlo là sognante. «Nel 1932» scrive «mentre ero all’estero, iniziai a rendermi conto che presto avrei dovuto dire addio per molto tempo, forse per sempre, alla città in cui ero nato. Nella mia vita interiore avevo più volte sperimentato come fosse salutare il metodo della vaccinazione; lo seguii anche in questa occasione e intenzionalmente feci emergere in me le immagini – quelle dell’infanzia – che in esilio sono solite risvegliare più intensamente la nostalgia di casa». In esilio a Parigi completa il manoscritto della sua Infanzia berlinese intorno al millenovecento. Chissà se guardando indietro ha ricordato quel Walter che era stato a quindici o sedici anni, e un’infanzia a Berlino che non era pensabile senza lo Zoo. I ricordi d’infanzia e pubertà non sono estranei agli adulti. Si accendono quando bambini o ragazzi ci corrono accanto, quando la loro risata risuona e ci ricorda i nostri momenti di gioia. Walter Benjamin sulla montagna. Me lo immagino seduto sull’erba, appoggiato a un albero, le mani incrociate dietro la testa, e ora questo ora quello che gli attraversa i pensieri. Ancora oggi ci sono persone che vanno a Berlino solo per mettere piede nel famoso Zoo. Walter Benjamin ci andò spesso. Potrebbe aver varcato la Porta del leone, quelle volte che fra il 1908 e il 1910 fu parte anche lui dell’interminabile flusso dei visitatori. Aveva già osservato a sazietà tutte le bestie esotiche, fra gabbie e recinti. Ma continuava a sentirsi attirato, e lo scrive, dagli «spiazzi sabbiosi degli gnu e delle zebre, dagli alberi spogli e dalle scogliere dove nidificavano condor e avvoltoi, dai puzzolenti recinti dei lupi e dai luoghi di cova dei pellicani e degli aironi. [...] Questo era il clima in cui, mentre con accentuato zelo si rivolgeva all’amico, per la prima volta lo sguardo del ragazzo cercò di stringersi a una passante». Ciò fa capire quanto lo Zoo attirasse come un sicuro sfondo per i primi flirt. Là si passeggiava, si scambiavano sguardi. Walter, attorno ai sedici anni, fece le sue prime titubanti esperienze con le elettrizzanti curve delle donne e delle ragazze che gli sfilavano accanto. Deve aver ghermito più di un incoraggiante sguardo d’invito. Le prostitute berlinesi non passano infatti inosservate, e Walter Benjamin non manca di osservarle. Scopre la Berlino «peccaminosa». Il rampollo della Delbrückstraße, nell’elegante Grunewald, è sconvolto e insieme magicamente attratto, perché intuisce «i servigi» che queste donne avrebbero «reso agli istinti risvegliati». E descrive questo conflitto fra l’educazione e il desiderio, prigioniero nel corsetto di un riserbo inculcato e della morale borghese, che scatena l’insorgente e sconvolgente brama sessuale. Ricorda lo sforzo compiuto su di sé per «abbordare per la strada una puttana. Potevano volerci ore prima che accadesse. L’orrore che provavo era lo stesso che mi avrebbe trasmesso un congegno automatico per la cui messa in funzione sarebbe bastata una domanda. E così inserivo la mia voce nella fessura. Allora mi sentivo le orecchie in fiamme e non ero in grado di raccogliere le parole che cadevano da quella bocca carica di trucco. Correvo via, per ripetere nella stessa notte – quante volte ancora – la temeraria impresa. Quando poi, talvolta già verso mattina, mi soffermavo in un passo carraio, mi ero irrimediabilmente impigliato nei nastri d’asfalto della città, e non erano le mani più pulite quelle che mi liberavano». Un ricordo criptico e tuttavia limpido che in seguito continuò a influenzare la sua immagine della donna, già segnata dallo sguardo precocemente eccitato, rivolto alla prostituta con l’abito aderente alla marinara, e che continuerà a riaffiorare anche tra le righe. Ciò che solo in seguito gli apparirà chiaro è la triste condizione del proletariato a Berlino, che già nel 1892, l’anno della sua nascita, è una metropoli con più di un milione di abitanti. Le prostitute ufficialmente registrate erano almeno diecimila. La cifra sommersa era di gran lunga maggiore. L’industrializzazione distruggeva le strutture sociali di stampo rurale; la famiglia estesa scompariva e con essa la relativa sicurezza per gli anziani e i malati, che venivano assistiti in casa. I lavoratori agricoli cercavano lavoro nelle nuove fabbriche, e il proletariato che si andava formando era sfruttato e privo di diritti. Prima riempirsi la pancia, poi la morale, come canta l’amico Brecht nell’Opera da tre soldi. Chiesa e predica della domenica, che in campagna avevano determinato ancora il codice morale, servivano a ben poco in città e nella lotta per la sopravvivenza in cui era ingaggiato il proletariato privo di diritti. Esistono molte testimonianze letterarie sugli anni a cavallo fra i due secoli, che al pari dei successivi anni Venti sono visti come un’«epoca dorata». Le fotografie di quel tempo sono ingiallite quanto il tempo a cui risalgono. Le persone vi appaiono rigidamente addobbate e tutte identiche, gli uomini con robuste scarpe ai piedi, in abito e panciotto, il colletto rigido con la cravatta a farfallino che li costringe a tenere ritta la testa; le donne portano vestiti molto accollati; i bambini sono vestiti alla marinara e le bambine hanno guarnizioni all’uncinetto sulle gonnelline bianche, come nella foto con le cugine del 1906. Le cloache puzzolenti nei cortili interni dei caseggiati berlinesi, la sofferenza di chi non ha più forze, il lavoro minorile e la settimana di settanta ore, tutto ciò che produce rabbia e cerca valvole di sfogo viene descritto solo da pochi. Quel mondo proletario, quel mondo di prostitute e protettori è ritratto realisticamente nelle immagini di Heinrich Zille, il pittore dell’epoca. Nella villa a Grunewald o negli appartamenti estivi della famiglia altoborghese dei Benjamin, a Babelsberg e al Brauhausberg a Potsdam, la disperazione di molti nella Berlino guglielmina non è un argomento di discussione. E il figlio Walter, che i genitori erano certi sarebbe diventato uno scrittore fin dal momento della sua nascita, non vi avrà certo parlato dei suoi desideri da adolescente e delle sue voglie sessuali. Può invece sfogarle nei luoghi in cui la povertà costringe donne e ragazze a prostituirsi per sopravvivere. Nelle descrizioni e nei ricordi sulla Berlino intorno al 1900 e negli anni successivi i «boulevard costellati di puttane» ritorneranno spesso. Tutto solo sulla montagna, nella frescura della notte, Benjamin conosceva il quadro di Ludwig Kirchner intitolato Potsdamer Platz, con le ancelle dell’amore dai grandi cappelli. Per i giovani figli della borghesia abbiente era impossibile non vederle, e ancora più difficile evitarle. Il governo prussiano, preoccupato della morale, aveva proibito i bordelli e alle donne che erano costrette in quel modo a guadagnare da vivere per sé o per la famiglia restava spesso solo il marciapiede. Ma il mercato dell’amore, che in ogni tempo ha le sue congiunture, si allargava sempre di più e poteva trovarsi anche altrove. In una biografia di Benjamin si cita un libretto di Georg Zivier sul «Romanisches Café». Parla dei punti di incontro della bohème intellettuale berlinese a cavallo fra i due secoli e descrive ragazze e giovani donne che «come senza patria sgusciano fra i tavoli, si intrattengono a parlare ora con l’uno ora con l’altro, prendono posto qua e là e subito ricominciano il loro girovagare senza sosta». Molte ragazze in queste memorie di caffè «erano poetesse o pittrici, le cui fonti di guadagno apparivano equivoche». Di tanto in tanto vi si poteva incontrare anche Walter Benjamin. Le cortigiane dei caffè erano anche un segno della disponibilità femminile nel mondo patriarcale, prima e dopo la guerra. La morale borghese faceva però sottili distinzioni. Solo il marciapiede, la forma più povera e sfruttata nel traffico dell’amore, era visto come l’ambiente delle prostitute. Cioè la vita fuori dai caffè. L’immagine femminile di Benjamin fu influenzata anche da questo; non c’era molto che potesse spingerlo a una concezione più avanzata. Nemmeno a Parigi. Il giovane intellettuale sognante e apolitico fu scosso dalla Prima guerra mondiale e dalla brutale guerra di trincea, e poi dalla tragedia sociale seguita alla sconfitta tedesca. Riconosce che la situazione di quanti si trovano al fondo della società può essere migliorata solo attraverso l’azione politica. Benjamin comincia a capire la rabbia del proletariato privo di diritti, che dopo la Prima guerra mondiale imbocca la via della rivoluzione, prima in Russia e poi a Berlino. Presto riconosce il pericolo che questa rabbia possa sfogarsi anche in maniera reazionaria, come variante fascista. Il grande creatore delle idee rivoluzionarie e comuniste fu Karl Marx. Molti, fra cui Walter Benjamin, presero su di lui le proprie misure. Dall’altro lato c’era il mondo della borghesia piccola e grande che si opponeva a ogni movimento di emancipazione, che trovò nella stampa prevalentemente nazional-conservatrice i suoi più strenui difensori e in Adolf Hitler il suo esecutore. Quella notte sul vigneto vicino a Portbou io vedo meno il filosofo e il pensatore acuto che non l’uomo in carne e ossa, i suoi desideri, le sue speranze e la sua disperazione, anche a causa di quella Germania che l’aveva così ignobilmente trattato. Questo vale anche per la Goethe-Universität a Francoforte sul Meno e l’atmosfera antisemita che vi regnava. Benjamin aveva ritirato la sua tesi sul «Dramma barocco tedesco», scritta per il conseguimento della libera docenza universitaria, in modo da prevenire il rifiuto ufficiale. L’ultimo bivacco prima di Portbou. Walter Benjamin aveva rivisto forse i frammentari Passages? Era un nuovo manoscritto dei Passages quello che portava al di là dei Pirenei, in cui «era scritto tutto» e che lui considerava «più importante della sua vita»? Allora come oggi, per molti che lo venerano affascinati dalla sua mente e dalla sua intelligenza piena di emotività, egli possiede quel che Theodor W. Adorno così delinea: «Se mi si chiedesse di descrivere l’aspetto esteriore dovrei dire che Benjamin aveva qualcosa di un mago, ma in un senso molto poco metaforico e molto letterale. Sarebbe stato possibile immaginarlo con un altissimo cappello e una specie di bastone magico». Hannah Arendt, la buona amica, lottò con tutte le sue forze perché i manoscritti di Benjamin fossero pubblicati e lui ottenesse così un posto al fianco dei grandi pensatori – da qualche parte fra Kant e Karl Marx. Un grande tedesco che i tedeschi scacciarono nell’epoca orribile in cui il paese compì il grande «strappo dalla civiltà». C’erano anche altre voci, le quali vedevano in lui l’eterno bambino viziato che non volle mai diventare completamente adulto. Anche a ciò avrà pensato quella notte. A contestazioni di ogni tipo, e forse non si sentiva pronto ad affrontarle tutte. Hannah Arendt, ugualmente fuggita dai nazisti come molti altri tedeschi con radici ebraiche, pochi mesi dopo Walter Benjamin superò l’ostacolo di Portbou, che lui non era riuscito a vincere. Anche per lei Benjamin era avvolto in un mistero. E pensandolo la accompagnava questa sensazione: «Così difficile da capire in Benjamin era il fatto che pur non essendo un poeta pensava poeticamente, e la metafora doveva essere quindi per lui il più grande e misterioso dono della lingua, perché nel trasferimento consente di rendere sensibile l’invisibile». Quel che Hannah Arendt ammirava tanto in Benjamin, nessuno riuscì a descriverlo meglio di lui: «Trovare parole per ciò che si ha dinnanzi agli occhi: quanto può essere difficile. Ma quando esse arrivano, allora è come se battessero con dei piccoli colpi di martello contro la superficie del reale, sino a sbalzarne, come da una lastra di rame, la forma». La descrizione dell’immagine di San Gimignano gli riesce soltanto così: «Alla sera le donne si raccolgono alla fontana davanti alla porta della città, per prendere acqua in grandi brocche – soltanto quando ebbi trovato queste parole, dal turbamento delle impressioni immediate emerse, con i suoi precisi rilievi e le sue ombre pronfonde, l’immagine. Cosa mai avevo saputo prima dei salici fiammeggianti, che al pomeriggio fanno guardia con le loro lingue di luce davanti ai bastioni che cintano la città? Quanto strette prima dovevano stare le tredici torri, e come comodamente ciascuna trovava ora il suo posto, e anzi avanzava ancora molto spazio tra loro!». Più di un amico gli sarà venuto incontro durante la notte sulla montagna. Ricordi di una stretta di mano, un battere di dita incoraggiante sulle spalle. Forse pensa all’amico Bertolt Brecht. E anche all’amico di più lunga data, a (Gerhard) Gershom Scholem; il fondamento della loro amicizia non si spezzò mai, nessuna controversia per quanto accesa poté intaccarlo. Addirittura essenziali a mantenerlo in vita furono le amicizie femminili che si adoperarono per farlo uscire dal campo d’internamento di Vernuche. I loro nomi stanno nella sua rubrica, rimasta a Parigi insieme con altre carte e manoscritti. Vi si trovano settantuno nomi e indirizzi. Fra questi ci sono anche quelli di sei donne che fanno di tutto per ottenere il suo rilascio. Accanto alla sorella Dora, queste sono le libraie Adrienne Monnier e Sylvia Beach, la scrittrice inglese Winifred Ellermann, la fotografa Gisèle Freund e Juliane Favez, la segretaria dell’Istituto per la ricerca sociale a New York. Benjamin sorrise quando si vide davanti Hans Fittko? Un incontro nel campo di Vernuche? Gli raccontò che stava smettendo di fumare e gli descrisse i tormenti della disassuefazione. Per Hans era indiscutibilmente il momento sbagliato. E tentò di trasmettergli una regola fondamentale che a suo dire l’aveva sempre aiutato a superare le crisi e a non perdere la ragione: «Cercare sempre cose che diano gioia e non caricarsi di ulteriori difficoltà». Benjamin aveva respinto la regola, scrive Lisa nelle sue memorie, e rivendicato per sé l’esatto contrario: «Io riesco a sopportare le condizioni nel campo solo se sono costretto a concentrare tutte le mie forze spirituali su una grande fatica. Smettere di fumare mi costa questa fatica, e così diventa per me la salvezza». Pensò forse a quel consiglio mentre si trovava sulla montagna? Lui e Hans Fittko: due uomini che non avrebbero potuto essere più diversi, e tuttavia affini. E quella notte, prima della sua ultima decisione, raggiunse forse quello stato di semiannebbiamento necessario perché nella mente si avviasse un film con le immagini che si erano raccolte negli anni prima e dopo la Grande guerra? Un conflitto che aveva contribuito a capovolgere il mondo. Soldati sacrificati in un’accanita guerra di posizione. Ogni rilievo fu conquistato più volte da ciascuna parte e nuovamente perduto, le baionette conficcate nel corpo dei nemici; si uccise in maniera moderna, con i gas tossici che corrodevano i polmoni e portavano alla morte per soffocamento. Dopo il grande macello: nove milioni di soldati morti. Le città erano piene di mutilati, scampati alla guerra, che chiedevano l’elemosina. Walter Benjamin era stato risparmiato; l’avevano dichiarato inabile al fronte. Eppure vedeva da ogni parte inappagati desideri di vendetta. Voglie di rivalsa pronte ad affacciarsi. Sfociano nella Seconda guerra mondiale e nei bombardamenti che moltiplicheranno i numeri dei morti. Quali immagini può avergli mostrato il suo film interiore? In cima alla montagna è il luogo che come nessun altro riflette la sua solitudine. Questa volta c’è in gioco la sopravvivenza e non la possibilità di ritirarsi. Quante volte ha pensato il contrario, semplicemente smettere e mollare la vita. E adesso io gli attribuisco invece il desiderio di scampare un’altra volta. Negli anni precedenti Arianna gli era rimasta fedele, lei che tante volte e in diverse forme l’aveva guidato quando, stanco della vita, lui minacciava di smarrirsi. Come quella volta al Tiergarten di Berlino, quando incontra la regina Luisa sul piedistallo di pietra e lo visita la parola «amore». Nella biografia di Werner Fuld viene citato il suo Diario dal sette agosto millenovecentotrentuno finoalgiornodellamorte: «Questo diario non promette di diventare molto lungo». Vi ricorda anche le sue tre grandi esperienze amorose: Dora, Julia, Asja. «Ho conosciuto nella vita tre diverse donne, e tre diversi uomini in me». Dora Sophie, la moglie, descrive questa diversità della sua natura nel momento culminante dei contrasti che nel 1930 conducono allo scioglimento del suo matrimonio con Walter. Non trova che sia diventato un altro, non lo vede cambiato, ma è accaduto soltanto che certi lati della sua natura abbiano conosciuto uno sviluppo esorbitante. Si lamenta che Walter non si occupi più del figlio Stefan. Traggo queste parole dal libro Benjaminiana, che Hans Puttnies e Gary Smith hanno pubblicato nel 1990 in occasione della mostra «Bucklicht Männlein und Engel der Geschichte» (L’omino con la gobba e l’angelo della storia). La mostra era allestita al MartinGropius-Bau a Berlino. In una lettera a Gershom Scholem, Dora deplorava il fatto che la «spregiudicata Asja» lo sfruttasse, «cosa che fa pensare a un cattivo romanzo, ma è vera». Tuttavia, nei difficili anni dell’emigrazione a Parigi, lo accoglierà più volte consentendogli di vivere gratuitamente nella sua pensione a Sanremo, prima di emigrare lei stessa a Londra. Il film nella sua mente, dove lui stesso recita la parte del protagonista, non è pensabile senza il figlio Stefan e Dora Sophie, la ex moglie. Walter aveva incontrato il suo grande amore, Asja Lacis, a Capri. Lei è comunista, ed era stata già regista, attrice e direttrice di teatro. E lui si precipita a raggiungerla quando lei, gravemente malata, desidera vederlo a Mosca. Quando Walter finalmente riesce ad arrivare, Asja si sta già rimettendo da un esaurimento nervoso. Lui va a trovarla ogni giorno, e lei scrive: «Giocava pazientemente con me a domino. Ebbe la buona volontà di adattarsi all’inconsueto ambiente e di capirlo». Asja gli fece visita alla fine del 1928 a Berlino, dove si videro per l’ultima volta. Quel che vede nell’«inconsueto ambiente» moscovita alimenta il suo scetticismo. In una lettera a Scholem del dicembre 1928 Benjamin scrive: «Non si può affatto prevedere che cosa si produrrà in Russia. Forse una società davvero socialista, forse tutt’altro. La lotta è ancora in corso, senza sosta. Essere oggettivamente legato a questa situazione è qualcosa di terribile, adattarmi a essa in base a considerazioni di principio non mi sarebbe possibile». Nella radura in montagna anche il fratello Georg gli sarà stato vicino; non lo vede da più di sette anni. L’ossessione della razza si era diffusa, come un cancro che prolifera in fretta. Le chiese cristiane fanno poco per realizzare con la loro azione il messaggio d’amore espresso nel Discorso della montagna. Diverse cose suonano là altrettanto razziste, sebbene ammantate nella religione, e non c’è quasi differenza rispetto agli apologeti di «sangue e terra» dell’epoca. A Sonnenburg o nel carcere di Brandeburgo e – due anni dopo la morte di Walter – nel KZ di Mauthausen, sua ultima stazione: Georg Benjamin soffrì soprattutto perché era ebreo e per di più comunista. Come può aver lavorato la fantasia di Walter Benjamin, quando pensava al fratello? Avevano dovuto fare a meno l’uno dell’altro per sette volte trecentosessantacinque giorni, e cosa rimane a quel punto? Si erano persi? Alla disperata razionalizzazione del patto fra Hitler e Stalin, elaborata dal fratello, Walter Benjamin avrebbe certo reagito diversamente da Hilde, che seguiva gli argomenti di Georg nelle sue lettere dal carcere e il tentativo di rinvenire una strategia razionale dietro questo patto col diavolo. Walter non si sarebbe fatto convincere. Il suo scetticismo è espresso nel disegno di Paul Klee, Angelus novus, che Benjamin interpreta nello scritto Sul concetto di storia. Alla nona tesi del testo premette una citazione da una poesia di Scholem: La mia ala è pronta al volo tornerei volentieri indietro perché, rimanessi anche tempovivo, avreipocafelicità. E scrive: «[...] un angelo sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti anoi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa bufera». La «bufera dal paradiso» che inesorabilmente lo sospinge «può essere decifrata in molti modi», così leggo in Sven Kramer, un eccellente conoscitore di Benjamin. In combinazione con un’altra sentenza mi viene nuovamente incontro un Benjamin scettico, quando cita Karl Marx: «Le rivoluzioni sono la locomotiva della storia universale». Ed egli, scetticamente, obietta: «Ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le rivoluzioni sono il ricorso al freno d’emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno». Avrebbe potuto opporre questo a Georg, il comunista fedele che nel proprio credo vedeva il pilastro a cui reggersi nella frustrante realtà della sua cella; nulla di quel che arrivava da Mosca poteva essere falso. La sua convinzione divenne a sua volta per Hilde un lascito che lei continuò a onorare: «Il partito, il partito ha sempre ragione». Nessuno può sapere davvero come Walter Benjamin abbia trascorso quella notte sulla montagna. Si può suppore che l’abbiano occupato i ricordi. Forse, come nella sua Infanzia berlinese intorno al millenovecento, sono anche odori e rumori che egli trova nei cantucci più lontani e adopera per via di associazione. Così avviene con lo squillo del telefono e le sue prime esperienze con questa diavoleria moderna e il suo irritante suono, per cui non è sicuro se fosse la «struttura dell’apparecchio» o quella della sua fragile «memoria» a far sì che le prime conversazioni telefoniche gli «si presentano all’orecchio diverse da quelle di oggi». Per lui erano «rumori notturni, nessuna musa li annuncia. La notte da cui provenivano era la stessa che precede ogni nascita autentica» così leggo. «E neonata era la voce che sonnecchiava negli apparecchi. Fin nel giorno e nell’ora il telefono mi fu fratello gemello. Potei essere testimone di come si lasciò alle spalle le umiliazioni del suo noviziato». E coglie quel che ancora oggi, nell’epoca dei media elettronici, causa contrasti grandi e piccoli in ogni famiglia, quando i figli telefonano per ore e ore. Forse gli risuona ancora nell’orecchio, mentre i suoi pensieri volano indietro al primo decennio del ventesimo secolo: «Non molti fra coloro che usano l’apparecchio sanno quale scompiglio la sua comparsa provocò allora nelle famiglie. Il suono con cui si annunciava fra le due e le quattro, quando l’ennesimo compagno di scuola desiderava parlarmi, era un segnale d’allarme che minacciava non solo il riposo pomeridiano dei miei genitori, ma l’epoca nel cui grembo essi si abbandonavano al sonno». Benjamin era anche un eccellente scrittore. E così, in un altro punto del manoscritto che precede l’Infanzia, ricava la descrizione di un ricordo che non è di ogni bambino: «Si trattava, per quanto inverosimile possa apparire, del rumore che produceva il coltello con cui mia madre spalmava i panini che, la mattina, mio padre portava con sé in ufficio, quando esso veniva passato un’ultima volta sui croccanti bordi per ripulirlo dal burro che poteva esservi rimasto appiccicato. Questo suono, che preannunciava la giornata lavorativa di mio padre, era per me non meno eccitante di quanto, anni più tardi, mi parve lo scampanellio che a teatro annuncia l’inizio della rappresentazione». Chiunque abbia mai tentato di incontrare l’uomo sulla montagna e si sia avvicinato a lui, concorderà che la sua vita assomigliava davvero a una galleria, a un passage dove ogni fase aveva una propria entrata e uscita. Allo stesso modo in cui le cose si trovano nelle mondane gallerie commerciali, abbaglianti e simili a cattedrali: libri, forse anche antichi, e accanto a questi articoli di lusso, eleganti negozi di abbigliamento e sartorie, gioiellieri, cappellai e raffinati ristoranti, il tutto gomito a gomito sotto un solo tetto. Qui si ritrovava il tout Paris, ovvero il tout Madrid o il tout Budapest – i ricchi e i belli del loro tempo. È solo naturale che egli non veda a Milano o a Londra la più bella di queste gallerie, ma nella sua città, a Parigi, nel Palais Royal. Qui matura l’idea dei Passages. Sull’esempio di Parigi vuole raccontare la storia del diciannovesimo secolo. E questa è per me un’occasione di rivolgere lo sguardo ai membri dell’intricata famiglia Benjamin e ai cammini delle loro vite, inseparabili dal ventesimo secolo. Là si trovano le loro battaglie e conquiste, sempre nutrite dalla speranza di contribuire a creare un mondo migliore. E per me questa notte solitaria è quasi un simbolo della sua lotta per la vita. In fuga da quelli che osserva con sguardo freddamente analitico, smascherando tutte le loro terribili semplificazioni. E in quelle ore solitarie lassù, mentre attende il ritorno di Lisa Fittko, potrebbe aver visto questo film della sua vita. Forse con altri dettagli che possono essere stati più importanti per lui di quanto io sappia. Così dice lui stesso: «Chi abbia dispiegato una prima volta il ventaglio della memoria trova sempre nuove componenti, nuove ramificazioni, nessun’immagine fra quelle riconosciute gli pare sufficiente, perché ha capito: è possibile svolgere, solo fra le pieghe si trova l’essenziale: quell’immagine, quel gusto, quella sensazione tattile alla ricerca dei quali abbiamo scisso, dispiegato; ed ora la memoria passa dal piccolo al piccolissimo, e da questo al minuscolo, e ciò che incontra in questi microcosmi diventa sempre più potente». E quindi torno volentieri a citarlo: «Le memorie, anche quando entrano nei dettagli, non sempre costituiscono un’autobiografia». Quando Walter Benjamin batte alla porta della mansarda di Lisa Fittko a Port Vendres, nella tarda mattinata del 24 settembre 1940, erano già iniziate le prime deportazioni. Quello stesso anno era stato proibito agli ebrei il possesso di una connessione telefonica o l’acquisto di sapone. Poco dopo vennero proibiti gli animali domestici. A nessun ebreo e a nessuno dei suoi figli era consentito avere un cane, un gatto, un canarino, un criceto o un coniglio. Fin quando fu tutto proibito, persino sedere sulla panchina di un parco. In origine gli animali domestici avrebbero dovuto essere completamente proibiti nel Reich. Il ministero dell’Economia a Berlino sperava che in questo modo si sarebbero risparmiate tonnellate di cereali, destinate a nutrire gli animali domestici. Pare che sia stato Hitler in persona a voler rinunciare al divieto che, nell’ottica dell’economia di guerra, forse avrebbe giovato alla popolazione. Indietreggiò, e probabilmente non sbagliava nel ritenere che un simile provvedimento non sarebbe stato compreso. E tanto più che in quel caso sarebbe stato inevitabile mettere al corrente gli appartenenti alla «razza padrona» della situazione effettivamente critica dei rifornimenti. È probabile che Walter Benjamin non sapesse niente di tutto questo quando bussò alla porta che una Lisa ancora assonnata aprì dopo un poco. Lisa stessa non sa spiegarsi il motivo per cui dentro di sé chiama il gentile visitatore soltanto il «vecchio Benjamin». «Davvero non so perché» scrive. «Aveva più o meno quarantotto anni». Degli ultimi sette anni di esilio in Francia, che l’avevano segnato, Lisa non può sapere nulla, ma certo dovevano pesargli addosso. A Parigi aveva dovuto soppesare ogni centesimo, e il miglior cuoco là era stato la fame. Aveva incontrato scarsa disponibilità a concedere all’intellettuale tedesco onorari e spazi di pubblicazione in gazzette e istituti. Gli restavano solo i sussidi dell’Istituto per la ricerca sociale di New York. Né Max Horkheimer né Theodor W. Adorno, a cui era legato da un rapporto di amicizia, avevano evidentemente un’idea delle sue condizioni. Il che induceva Hannah Arendt a esternazioni piene di rabbia nelle sue lettere all’amico Gershom Scholem. Quando l’Istituto da Francoforte si trasferì prima in Svizzera e poi a New York, verso la salvezza, Benjamin temette addirittura di perdere la sua unica fonte di guadagno. In una lettera che lo raggiunse nel 1934 a Parigi, Horkheimer gli assicurava in realtà che, nonostante il trasferimento in America, Benjamin avrebbe continuato a collaborare con l’Istituto, e tuttavia la paura di perdere l’unica fonte di guadagno rimasta non lo lasciò mai del tutto. Sosteneva finanziariamente l’Istituto per la ricerca sociale una fondazione del commerciante di granaglie Weil e, in seguito, una donazione del figlio Felix. Ma torniamo a Port Vendres: Benjamin chiede scusa all’assonnata Lisa Fittko per il disturbo, e lo fa con grande gentilezza, come lei ricorda: «Spero di non arrivare in un momento inopportuno» dice, e poi aggiunge: «Suo marito mi ha spiegato come trovarla. Ha detto che lei mi avrebbe portato oltre la frontiera, in Spagna». Lisa Fittko descrive l’inquietudine che la colse il mattino dopo, quando si avvicinò al posto dove lei e gli altri due fuggiaschi avevano lasciato Walter Benjamin. «Finalmente la radura! E il vecchio Benjamin? Vivo!». E poi la paura nel vedere le chiazze marroni intorno ai suoi occhi – sintomi di un infarto? Lui la tranquillizza. Erano solo i bordi della montatura degli occhiali che nell’umidità notturna si erano ossidati, lasciando tracce di colore intorno agli occhi. Il cammino continua a essere faticoso, e le previsioni del sindaco di Banyuls-sur-Mer sui tempi di marcia non possono essere rispettate. Persino un escursionista sano e allenato farebbe fatica ad avanzare all’andatura necessaria su questo sentiero che procede ripido tra i vigneti. Ogni dieci minuti una pausa per far riposare il cuore. Poi di nuovo avanti, a ritmo uniforme. Quando raggiungono il passo – uno sguardo gettato all’indietro, laggiù in fondo c’è il Mediterraneo di un blu intenso e sull’altro lato, così descrive Lisa, «rocce scoscese cadono su una lastra di vetro color turchese trasparente – un secondo mare?». È la costa della Spagna, di una straordinaria bellezza. Eccoli in territorio spagnolo. Sebbene dovesse stare attentissima a non farsi scoprire dalla polizia spagnola di frontiera, Lisa rimase con il gruppo e tornò indietro solo quando apparvero le prime case di Portbou. A questo punto giudicava che i tre avrebbero attraversato senza pericoli la frontiera e preso il treno per Lisbona. Arrivato a Portbou, nella piccola stanza all’interno della pensione, Benjamin scrisse un ultimo biglietto: era incappato in una situazione senza via di uscita, e non aveva altra scelta se non mettere fine alla sua vita. Non aveva più tempo per scrivere tutte le lettere che avrebbe voluto scrivere. «Al momento del pericolo estremo, cui non è possibile strappare nessuna dilazione – e dunque nessuna speranza –, a questo momento io vado incontro con una risoluzione esistenziale». La cartella fu trovata e inventariata per bene nel pubblico registro funebre, ma non il manoscritto. Henny Gurland pagò in anticipo la tomba per cinque anni. Ci si può chiedere se la morte di Benjamin abbia indotto le guardie di frontiera spagnole a far passare i Gurland anche senza il timbro di uscita dalla Francia, cosa che avevano rifiutato invece a Benjamin. Ma l’assenza del manoscritto suggerisce anche altre ipotesi. Anche l’ultimo biglietto di Benjamin consente ogni genere di interpretazione. Compresa quella affacciata nel documentario dell’argentino Mauas, che mette in dubbio il suicidio. Bertolt Brecht scrive nell’epitaffio Per il suicidiodelprofugoW.B.: Ho saputo che hai alzato lamanocontrotestesso prevenendoilmacellaio. Esule da otto anni, osservando l’ascesa del nemico, spinto alla fine a un’invalicabilefrontiera hai valicato, dicono, una frontierainvalicabile. Imperi crollano. I capibanda incedono in veste di uominidistato.Ipopoli non si vedono più sotto le armature. Così il futuro è nelle tenebre,eleforzedelbene sono deboli. Tutto questo haiveduto quando hai distrutto il torturabilecorpo. Capitolo sesto Hilde Benjamin «Eccone uno!». Una mano infantile prende il coleottero che sta aggrappato al lato inferiore di una foglia di patata, piccolissimo e giallognolo con le sue strisce nere sulle ali. Un’allegria chiassosa ha invaso il campo di patate, molti bambini corrono tutt’intorno scatenati e cercano i coleotteri sulle piante. Di continuo risuona il grido: «Ne ho preso uno!». Il coleottero cade in un grande vasetto per conserve che ciascuno dei bambini ha portato con sé nel campo. Un divertimento immenso sotto il cielo azzurro. L’avevamo atteso, contando su un’eccitante avventura. Quando la maestra aveva annunciato che il mattino successivo saremmo partiti subito dopo l’inizio della scuola con un pullman che ci avrebbe portati fuori città, con l’obiettivo di raccogliere i coleotteri delle patate e salvare il raccolto, la risposta era stata un felice baccano. Un cattivo raccolto avrebbe significato una catastrofe, considerate le difficoltà negli approvvigionamenti alimentari dopo la fine della Seconda guerra mondiale. E così la salvezza del raccolto divenne un dovere nazionale a cui tutte le scuole e il personale di fabbriche e amministrazioni dovevano partecipare. In un giorno di scuola nel 1950 apprendemmo chi dovevamo ringraziare per quel momento che nel ricordo io conservo come un insperato giorno di vacanza, proprio come il pentolone con la zuppa grassa di piselli che veniva mandato agli scolari nei campi. Noi ragazzini e le ragazzine più grandi, che portavamo le camicie azzurre della FDJ (Freie Deutsche Jugend, Libera gioventù tedesca), prendevamo ciascuno due mestolate di zuppa dal pentolone. Facendo gran rumore con la bocca mangiavamo poi dalle scodelle che avevamo portato da casa. Ci riempivamo la pancia. L’attrezzatura con il pentolone apparteneva all’Armata Rossa, lo si riconosceva dalla stella e dai caratteri cirillici. Una splendida pausa di mezzogiorno. Il nostro ringraziamento per la giornata libera dalla scuola doveva andare al nemico imperialista. Ci fu spiegato che solo lui aveva potuto far piovere sui campi i coleotteri delle patate dagli aeroplani. Il giorno dopo apprendemmo inoltre che con la guerra ai coleotteri avevamo combattuto e vinto una battaglia. Gli imperialisti in Germania Occidentale e negli Stati Uniti avevano subito un’amara sconfitta. Noi eravamo gli eroi. Avevamo preso d’assalto il fronte dei coleotteri. Così ricordo un particolare giorno di scuola nella DDR, quando portavo anch’io il fazzoletto azzurro dei pionieri. Dopo la fuga da Danzica e prima della successiva, avventurosa, partenza dalla DDR abitavamo a Rostock, nella Kröpeliner Straße, che era stata ribattezzata Stalin-Straße. Solo la nonna e il nonno rimasero là. Vennero in Occidente quando ebbero raggiunto l’età della pensione. Nel martellamento della propaganda la guerra delle parole conobbe un ulteriore capitolo. Era condotta con violenza e con tutti i possibili mezzi illeciti. L’alleanza bellica era ormai spezzata, e l’aveva seguita la guerra fredda. Io sentii per la prima volta il nome Hilde Benjamin. Fino al 1953 era stata vicepresidente della Corte suprema della DDR e in seguito fu ministro della Giustizia. Nella DDR si mormorava su di lei. Veniva chiamata la «russa». La parola pronunciata in tono sprezzante e quasi con la pelle d’oca. Doveva quel soprannome alla sua acconciatura: i capelli pettinati severamente all’indietro e raccolti in una treccia, arrotolata poi attorno al capo. Un’acconciatura prediletta dalle donne russe. E poi c’era il cliché particolarmente amato dai mezzi di informazione occidentali, i quali vedevano in lei il giudice senza pietà che terminava i suoi processi con clamorosi verdetti punitivi e metteva gli accusati dietro le sbarre per molti anni. Le vengono attribuite due sentenze di morte. In Occidente l’opinione pubblica era unanime: tutti gli accusati erano vittime della giustizia inumana vigente nel secondo stato tedesco, la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca che per quarantacinque anni volle considerarsi la Germania antifascista. Solo la lettura di una biografia mi consentì di collegare Hilde e Walter Benjamin, ponendoli sotto un comune e familiare tetto. Hilde era la cognata di Walter Benjamin, sposata con suo fratello Georg. Allora non sapevo nulla su di lei, la sua famiglia o il suo destino. Tante volte nel corso degli anni, dopo la nascita dei due stati tedeschi quale esito della guerra hitleriana, avevo incontrato il suo nome. In Occidente era avvolto spesso in una sfumatura di disprezzo, quando si parlava della «zona sovietica» e del suo supremo giurista. Era chiamata «Hilde la Sanguinaria», o nel migliore dei casi «Hilde la Rossa», o addirittura veniva paragonata a Roland Freiser, giudice penale del Terzo Reich. Molto di quello che lessi su di lei mi parve poco credibile. Avevo passato sette anni della mia vita nella Zona di Occupazione Sovietica (Sowjetische Besatzungszone, SBZ), ossia nella DDR, e nel 1951 fuggii con mia madre e mia sorella da uno stato tedesco verso l’altro. Già da bambino imparai che la morale più alta pareva trovarsi sempre nella Germania dove stavo in quel momento. Ma diversamente dalla Repubblica Federale, la Repubblica Democratica Tedesca allontanò con coerenza gli ex membri del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) dalle sfere della giustizia, dell’amministrazione e dell’insegnamento. Fu Hilde Benjamin a far sì che con l’istituzione di «giudici del popolo» (Volksrichter) fosse possibile continuare ad amministrare la giustizia, sia pure con lentezza e in maniera spesso contestabile. Le autorità sovietiche e tedesche, la direzione politica e i quadri del partito riconobbero quale loro compito più urgente quello di formare in fretta nuovi insegnanti, giudici del popolo e funzionari amministrativi che potessero occupare i posti vacanti. Puntarono sulla voglia di apprendere della giovane generazione e incontrarono una grande fame di sapere. Non fu una ristrutturazione priva di sussulti e i colpevoli di ieri, espulsi, si consideravano vittime innocenti del «regime d’ingiustizia» della DDR. Ci furono vittime, per esempio al momento dell’unione forzata fra Partito comunista e Partito socialdemocratico, da cui nacque il Partito socialista unitario tedesco (SED), e poi anche nelle file di quest’ultimo. Un partito che aveva «sempre» ragione e sospettava di scissionismo ogni divergenza ottenne facilmente di moltiplicare quotidianamente il numero delle sue vittime. Durante la Guerra fredda tra Oriente e Occidente ci furono sempre più frequentemente guerre calde sostitutive – in Corea o in Africa. La realtà era l’antagonismo fra le due superpotenze. E scemò dunque in fretta l’interesse delle potenze vincitrici per la rieducazione dei tedeschi e la loro denazificazione. Ai processi di Norimberga non seguì nulla che potesse arrestare la perdita di memoria. Ma non soltanto fra gli intellettuali fu posta la domanda se dopo Auschwitz fosse ancora possibile la poesia. Erano così tanti i concetti svalorizzati, come l’onore, la fedeltà, il popolo, la razza, la giustizia, la morale, persino la patria e la cultura. Inutilizzabili. Come descrivere allora quel che divenne storia e accadde in nome della Germania? Devastazione totale. Tabula rasa. Com’è possibile avvicinarsi a Hilde Benjamin in quell’epoca? Capire cosa l’ha spinta, cosa l’ha segnata, cosa ha fatto di lei il sanguinario ventesimo secolo? Sarebbe potuto diventare un secolo tedesco se la Repubblica di Weimar fosse diventata una forte democrazia e avesse saputo affermarsi contro Hitler. Hilde Benjamin fu anche una testimone dell’epoca successiva al 1945. «Cominciò allora ciò per cui avevamo combattuto durante i dodici anni trascorsi» scrisse al termine dell’orrore e dopo che a Potsdam era stata suggellata la fine, «e a cui ci eravamo preparati negli ultimi mesi». Dal comandante russo ricevette l’incarico di riorganizzare il tribunale di Steglitz-Lichterfelde. Era il 12 maggio 1945. Dopo la divisione di Berlino in quattro settori Hilde si trasferì nella parte della città occupata dai sovietici. Era membro del Partito comunista, e poi della SED. Ma come poteva fiorire quel che nella sfera di potere sovietica si andava sviluppando come stato autonomo per grazia di Mosca? Anche i comunisti a Berlino Est si ritrovarono di fronte una popolazione postfascista che aveva vissuto la quotidianità dello stato nazista senza evidenti emozioni. Poteva svilupparsi ciò che molti si attendevano dalla DDR? Alle spalle c’erano ben dodici anni di martellamento antibolscevico, che con il patto fra Hitler e Stalin del 23 agosto 1939 aveva conosciuto solo una breve pausa, prima dell’attacco lanciato dalla Wehrmacht contro l’Unione Sovietica per ordine di Hitler, il 12 giugno 1941. La campagna militare combattuta come una guerra di annientamento contro la Russia e la sua popolazione divenne la più sanguinosa carneficina della Seconda guerra mondiale. La gente sapeva o immaginava in quali atrocità fosse coinvolta la Wehrmacht. La paura della vendetta che l’Armata Rossa avrebbe inflitto nella sua avanzata indusse molti a Est ad abbandonare tra il panico le proprie case e i campi. Ciò determinò in molti tedeschi, dopo il 1945, un atteggiamento psicologico difensivo verso tutto quel che era legato a Mosca. Vi contribuirono anche la vita quotidiana durante l’occupazione e non da ultimo i tabù imposti a seguito dell’amicizia forzata tedescosovietica, il silenzio sui soprusi dei soldati dell’Armata rossa e le frequenti violenze sessuali – che si verificavano ogni giorno. Erano la risposta ai crimini commessi nel nome della Germania e al corridoio della morte spianato dai tedeschi attraverso la Russia. I quadri dirigenti della SED, come ricorda Rudolf Herrnstadt, primo caporedattore del quotidiano «Neues Deutschland» (Nuova Germania), ignorarono la paura delle donne e le violenze di massa. La sfiducia della gente si appuntò in due direzioni: contro gli occupanti che diffondevano paura e orrore, e contro i comunisti tedeschi della prima ora che non osavano opporsi alla forza di occupazione e dare un nome alle violenze e ai crimini. Hilde Benjamin, insediata come procuratrice a Steglitz nel 1945 dal comandante dell’Armata Rossa, ricordava che nei corridoi della pretura si potevano cogliere forti espressioni di indignazione per quei fatti, e non di rado vi risuonava anche la nostalgia della quiete e dell’ordine che avevano regnato in epoca nazista. La diffidenza dei funzionari verso gli umori di tipo fascista del proprio popolo è così già formata, e trova nella Sicurezza di Stato (Staatssicherheit), la Stasi, la sua corrispondente forma di espressione, che con gli anni diventa sempre più abietta. Durante i primi tempi della DDR molti speravano in una terza via fra capitalismo e fascismo. Anche Walter Benjamin avrebbe condiviso questa speranza? Alla domanda Hilde Benjamin risponde convinta che sarebbe entrato nella SED. Occorre mantenersi scettici. E a questo punto mi viene in mente la cartolina che ho trovato sulla sua tomba a Portbou. Quasi un saluto tardivo dalla DDR ormai scomparsa, svolazzato fin sulla lapide commemorativa; posava sui fiori freschi della corona ufficiale della città di Portbou per il settantunesimo anniversario della sua morte. Una cartolina non scritta, in bianco la parte destinata al messaggio, senza un mittente. Sul lato superiore l’immagine dell’Alexanderplatz nella Berlino divisa degli anni Ottanta. Come se qualcuno volesse far presente che il legame fra Walter Benjamin e la DDR deve rimanere uno spazio vuoto. Walter Benjamin si sarebbe probabilmente mantenuto distante da entrambi gli stati tedeschi. Rudolf Herrnstadt, caporedattore di «Neues Deutschland» caduto in disgrazia a seguito della rivolta del 17 giugno 1953, che Hilde sicuramente conosceva, poco prima della sua morte nominò quello che per lui era «il cancro nelle proprie file»: «Questa piccola borghesia difficilmente concepibile e caratteristicamente tedesca che erige intorno a sé barricate comuniste. Riconosciuta al primo sguardo da tutti i russi. Ma tollerata da molti, per misteriosi motivi. E che oggi non sono più misteriosi: avevano bisogno gli uni degli altri; il culto della personalità stalinista non era meno piccolo borghese – e il suo terrore aveva bisogno di lacchè». Molto fa credere che Walter Benjamin avrebbe pensato in maniera analoga e non avrebbe tollerato la DDR. Ma certo non avrebbe accettato nemmeno la Repubblica Federale Tedesca con la sua atmosfera di restaurazione, che solo nella seconda parte degli anni Sessanta sarebbe riuscita a riesumare dalle zone profonde della memoria collettiva rimossa il periodo nazista. Il fatto che ci vollero più di quindici anni dipende da molti motivi. Uno di questi è l’assunzione delle classi dirigenti nazionalsocialiste nell’economia, nell’amministrazione e nella giustizia della Repubblica Federale Tedesca, oltre che nelle redazioni di giornali e riviste, da «Zeit» a «Spiegel». Deve nascere da questo anche la reazione piena d’odio dei mezzi di informazione occidentali verso il tentativo compiuto da Hilde Benjamin per far piazza pulita dei criminali nazisti nella DDR. Questo virus non sarebbe dovuto penetrare in Germania Occidentale. Fu Fritz Bauer, procuratore generale a Francoforte, che in Occidente cominciò a mettere ordine nella giustizia. Una storia con grandi contraccolpi. Ed essenziale affinché questa storia possa essere raccontata è il contributo di entrambi, Fritz Bauer a Ovest e Hilde Benjamin a Est. Helene Marie Hildegard Benjamin veniva da Bernburg (Saale), dove era nata nel 1902. La sua famiglia si era trasferita in seguito a Berlino. Quarantotto anni dopo Hilde Benjamin sarebbe tornata nella sua città natale come presidente della prima corte penale del tribunale supremo della DDR, per pronunciarvi il suo verdetto. Una visita che avrebbe potuto essere il modello per il dramma di Friedrich Dürrenmatt: La visita della vecchia signora. Alta appena un metro e sessanta ed esile: così viene descritta la giovane Hilde. Il suo colorito scuro e i capelli neri le procurarono il soprannome l’«indiana». Nella biografia Die Machtfrau (La donna di potere) di Marianne Brentzel l’epoca della scuola è descritta con una certa superficialità: «Latino e matematica erano considerati poco femminili» scrive l’autrice. «Al liceo le ragazze imparavano solo quello che veniva ritenuto adatto e utile alle future mogli di militari, funzionari, imprenditori e professori: lavoro manuale, disegno, religione, balli di società, conversazione in tedesco, inglese e francese. Le scienze naturali e la matematica avevano invece un ruolo subordinato». Michael Benjamin, figlio di Hilde, il quale trasse vantaggio dalla vasta cultura della madre poiché a lui, il «meticcio», era vietato frequentare le scuole superiori, giudicò errata questa affermazione per ciò che si riferiva a lei. Ricorda con affetto di doverle una buona parte delle sue nozioni di botanica. Il loro comune «lavoro di ricerca» produsse addirittura una piccola «monografia» sui «fiori di Löcknitzwiese». Michael racconta che Hilde iniziò la scuola elementare in una «fase interessante» per lo sviluppo dell’istruzione femminile in Germania. Era iniziata la lotta per una più elevata istruzione femminile. Un risultato di ciò erano gli istituti e i corsi liceali a Berlino, fondati da Helene Lange con l’intento di raggiungere un pareggiamento di principio dell’istruzione femminile e maschile. Alle donne venne concesso di compiere studi universitari, sia pure con una minore possibilità di scelta tra le facoltà. La motivazione ufficiale di questo passo sarebbe piaciuta all’Unione cristianosociale (ChristlichSoziale Union, CSU) fino agli anni Sessanta, e non solo in Baviera: «Il rapido sviluppo della nostra cultura e le conseguenti trasformazioni degli attuali rapporti sociali, nelle professioni e nell’istruzione, hanno fatto sì che specialmente nelle classi medie e alte molte ragazze non abbiano accesso allo studio e una gran parte della forza lavoro femminile, preziosa per la collettività, resti inutilizzata. L’eccedenza della popolazione femminile rispetto a quella maschile e il crescente numero di uomini che non contraggono matrimonio nelle classi alte costringono una percentuale sempre maggiore di donne a rinunciare al proprio ruolo naturale di spose e madri. Occorre aprire loro le strade verso i mestieri adeguati alla loro educazione, che nella maggioranza dei casi devono offrire inoltre i mezzi per il proprio sostentamento, non solo come insegnanti di scuola superiore, ma anche in quelle altre posizioni accessibili alle donne che richiedono uno studio universitario». Hilde Benjamin lasciò nel 1918 l’Auguste-ViktoriaLyzeum per passare al liceo scientifico, dove ottenne il diploma di maturità nel 1921. Studiò giurisprudenza e nel 1928 superò il secondo esame di stato con la valutazione «ottimo». Ovunque io legga qualcosa su di lei scopro una donna intelligente, aperta e colta. Era già così alla scuola elementare, dove si annoiava perché sapeva tutto. Suonava il pianoforte e amava la musica classica. Le sue convinzioni politiche si formarono a Berlino dopo la Prima guerra mondiale, terminata con un armistizio che equivaleva a una capitolazione. Il trattato di Versailles fu un durissimo colpo per il paese, mentre il Kaiser spaccava la legna nel suo esilio in Olanda. Il paese era nel caos. Allora, all’inizio degli anni Venti, lo spirito dei tre Benjamin e della loro amica Hilde era colmo della certezza che i miseri resti del mondo borghese e del dispotismo imperiale fossero stati definitivamente liquidati dalla storia. Molti segnali facevano pensare all’imminente inizio di una nuova epoca, in cui la frattura tra alto e basso, tra poveri e ricchi sarebbe stata finalmente superata e la prospettiva di sinistra, socialista, avrebbe potuto essere realizzata. Forse Hilde si ricordava di escursioni fatte insieme ai fratelli Walter e Georg e all’amica Dora. Il figlio Michael, che sistemò il lascito della madre scomparsa nel 1989, si imbatté per la prima volta nel nome di Dora Benjamin in un appunto di diario risalente all’ottobre 1920. I fratelli di Dora, Walter e Georg Benjamin, avevano letto e discussero con le due ragazze le ultime opere di Heinrich Mann, il diario moscovita di Lion Feuchtwanger, Cyankali di Friedrich Wolf, e poi Kurt Tucholsky, Walter Mehring e naturalmente Thomas Mann. Grazie alla sua Montagna incantata, che Hilde non conosceva ancora, lei e Georg si avvicinarono. Lui le prestò la sua edizione. Un buon pretesto, non solamente per lui, per rivedere la ragazza che aveva allora ventidue anni ed era nel pieno dei suoi studi di giurisprudenza. Andavano nei teatri di Berlino a vedere allestimenti di Max Reinhardt al Deutsches Theater, oppure di Otto Falckenberg e naturalmente di Erwin Piscator. C’era poi il mondo del cabaret e i concerti della Berlino del swing e del jazz nell’Opera da tre soldi di Brecht, che ebbe la sua prima nel 1928 e per quasi un anno attirò il pubblico nel Theater am Schiffbauer Damm. La musica che Kurt Weill vi faceva risuonare sembrava dovesse diventare il suono del nuovo secolo. E loro sentivano di essere la nuova avanguardia di sinistra. Giovani com’erano, non sorprende che la socialdemocrazia apparisse loro poco attraente, troppo incline a compromessi e, dopo l’approvazione data ai crediti di guerra nel 1914, profondamente discreditata. Puntavano sulla sinistra rivoluzionaria, e sia Georg che Hilde entrarono nel Partito comunista. Gerhart Hauptmann, che in qualche modo era il «poeta di stato» e il portavoce della repubblica, come lo descrisse euforico un contemporaneo, sperava in una vittoria definitiva della democrazia e credeva nella rinascita della Germania. Si sarebbe rivelato un parto mostruoso. Lo slogan che inneggiava alla rinascita della Germania divenne parte della propaganda nazista che si concluse infine con il passo di marcia della Wehrmacht nelle vaste pianure europee. Nella biografia La donna di potere di Marianne Brentzel viene quasi rimproverata la particolare serietà con cui Hilde Benjamin affrontò il lavoro politico all’interno del partito. Era così. Hilde condivideva le idee del marito Georg e le sue opinioni politiche, ed era certa che solo il comunismo avrebbe portato la liberazione delle masse. Più di una frase del libro, apparso nel 1997, fa capire come l’autrice non approvi le convinzioni di Hilde. E vi emerge il dubbio sulla facoltà del lettore di formare da sé un giudizio sulla protagonista, il suo carattere e le sue idee. Misurata sull’obiettivo di occupare la metà del cielo, l’emancipazione femminile al tempo in cui Hilde frequentava la scuola e poi l’università non era affatto qualcosa di reale. Le compagne presenti insieme a lei alle lezioni di giurisprudenza si contavano sulle dita di una mano. La necessità di lavorare, parallelamente agli studi, per mantenersi la rendeva un’outsider; i suoi compagni non ne avevano in genere bisogno. Ma questo rafforzò il suo impegno sociale. Dopo il primo esame di stato Hilde fece il suo tirocinio a Berlino, presso il tribunale per i minori, all’ufficio di assistenza ai minorenni e nel carcere femminile. Mentre sto lavorando a questo testo un messaggio appare sullo schermo del mio computer. Una e-mail di Ursula Benjamin mi annuncia brani di diario e lettere di Hilde che suo marito Michael, figlio di Hilde, aveva raccolto, selezionato e ordinato all’epoca in cui esaminava il lascito della madre. Il giorno dopo ricevo per posta un saluto e una spessa busta. Carta scritta dal mondo analogico. Su una cinquantina di pagine trovo esternazioni della giovane Hilde Lange, datate successivamente al 1933, quando Georg Benjamin venne arrestato subito dopo l’avvento al potere dei nazisti e i due si scambiavano brevi lettere o messaggi segreti. Avevo mandato a Ursula Benjamin uno schema del libro con i titoli provvisori dei capitoli per agevolarle la ricerca, all’interno del voluminoso lascito, di ulteriori tracce della vita di Hilde. Cosa deve aver provato il figlio leggendo le annotazioni della madre? In un ambiente tanto ostile deve sorgere una particolare vicinanza. Lui condivideva le opinioni politiche di lei, e come stupirsi di questo? Le lettere parlano anche dei sentimenti nutriti dalla gioventù dopo la Prima guerra mondiale. All’inizio del 1922 Hilde cominciò i suoi studi di giurisprudenza. Quella che allora si riflette nel diario è l’immagine di una donna rivolta decisamente all’indietro; con scarsa consapevolezza di sé si chiede se debba sottomettersi per ottenere un amore. Questo tono carico di dubbio cambia soltanto al fianco di Georg Benjamin. In un appunto del 1922, dopo una delusione amorosa, scrive: «Hilde Lange, adesso sei diventata piccolissima. Non hai nemmeno più un’ombra di forza. Piccolissima e debole – e ti lasci guidare come un bambino piccolo. E tu, Rudi, d’un tratto hai la bontà di prendermi per mano. Mi hai reso tanto piccola, e io avrò bisogno di tempo per risollevarmi. Vorrei riposarmi queste settimane nella tua bontà – ma è ancora possibile?». Il giorno dopo aggiunge: «Così gli ho scritto – e la risposta?». «Trovo indegno di te che tu mi cerchi di nuovo dopo che ti sei riposata qualche giorno e sei “abbastanza forte”. Se non vengo è anche per il rispetto che devo a me stesso». E la reazione dubbiosa di Hilde a questa lettera, quasi un punto finale pronunciato con fastidio: «Era necessario?». Ma le lettere non parlano solo di esperienze personali, di innamoramenti o del grande amore; vi rientrano anche in larga misura lo studio, poi le esperienze professionali e un crescente interesse per la politica, che finisce per occupare un posto sempre più centrale nella sua vita. Hilde cerca ancora in qualche modo di ritrarsene: «Non voglio che tutto sia ingoiato dal lavoro e dalla pesantezza delle cose e da Berlino. Spero che il lavoro possa coinvolgere in futuro anche il sentimento», e poi, in tono pensoso: «C’è in me forse un che di artistico, che si fa avanti». E riferendosi alla realtà sempre più brutale e alla battaglia che si annuncia, domanda: «Il mio socialismo? La mia religione? La mia idea, un’idea? Niente!». È qualcosa che conosce dal suo lavoro: «Come essere in prigione». L’assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht nel 1919 è per molti intellettuali la risposta al proprio interrogarsi sulla posizione politica da assumere. La giovane repubblica si mostrò incapace di impedire l’esecuzione dei due portavoce della Lega spartachista da parte di membri dei Freikorps, le organizzazioni paramilitari di estrema destra. Hilde Benjamin ricorda molto bene quanto gli assassinii avessero spaventato lei e la sua famiglia: «Mia madre e io esprimemmo in casa nostra, e io lo feci anche nella mia reazionaria scuola, la nostra indignazione e ripugnanza». Agli omicidi seguirono lotte e scioperi a Berlino. La rivolta spartachista e la rivoluzione di novembre divennero un mito, e a ogni mito è intrecciata anche la menzogna. Avviene anche qui quando – coprendo i propri errori – c’è chi grida accusando i socialdemocratici di tradimento. La frattura fra i partiti di sinistra nati all’interno del movimento operaio, cioè il Partito socialdemocratico e quello comunista, era profonda e incolmabile. La brutale repressione della rivolta spartachista rimane legata al nome del socialdemocratico Gustav Noske, commissario del popolo e poi ministro per l’Esercito e la Marina nel primo gabinetto Scheidemann. Furono soprattutto l’estrema destra borghese e le forze reazionarie a uscirne rafforzate. Fra i partiti di sinistra vigeva un’ostilità che contribuì anch’essa a seppellire il sogno rivoluzionario e nello stesso tempo a indebolire mortalmente la repubblica. «La repubblica» scandivano i comunisti «è vuota, il socialismo è la meta». Era una repubblica senza repubblicani. La Baviera rifiutò la costituzione di Weimar dell’agosto 1919, come avrebbe rifiutato in seguito quella della Repubblica Federale Tedesca dopo la Seconda guerra mondiale. La democrazia di Weimar fu ritenuta debole e incapace di superare il «trattato ingiusto» di Versailles e di rinnovare la Germania. Né cambiò in questo senso nulla il fatto che nel 1924 l’inflazione, con l’emissione della nuova valuta temporanea, la Rentenmark, grazie ai crediti americani e alla modernizzazione dell’industria sembrasse per qualche tempo superata, e avesse inizio la bella leggenda dei «dorati anni Venti». E dopo il 1929, quando i crediti americani vennero improvvisamente a mancare con l’inizio della crisi economica mondiale e le grandi banche chiusero gli sportelli, il 1930 segnò la fine di tutte le illusioni con i suoi cinque o sei milioni di disoccupati. La giustizia era di regola un baluardo della restaurazione. Era una giustizia di classe, dalla Corte imperiale di Giustizia5 di Lipsia in giù. Chi conosce la storia della giustizia nella Repubblica di Weimar non si stupisce che dopo il 1933 essa sia diventata, senza soluzione di continuità, la compiacente ancella del nazionalsocialismo. Il Girotondo di Schnitzler fu giudicato osceno dai giudici berlinesi, Carl von Ossietzky fu condannato come traditore del paese perché la sua «Weltbühne» (La scena mondiale) aveva riportato notizie sul riarmo illegale dell’esercito. Con il suo scritto contro la guerra dei gas che le industrie tedesche avevano preparato e che avrebbe reso possibile Auschwitz, Johannes R. Becher sfuggì per poco alla condanna. Attraverso una sequela infinita di controlli e censure i nemici della repubblica fecero delle aule dei tribunali il loro prediletto campo di battaglia. I quattro anni di omicidi politici (Vier Jahre politischer Mord), descritti già nel 1924 nel libro di Emil Julius Gumbel, smascherarono la sollecitudine della giustizia a risparmiare i nemici dichiarati della repubblica. Le indagini su omicidi compiuti da estremisti di destra venivano trascinate o archiviate. Solo in casi molto rari si arrivò a un processo. Hilde Benjamin dapprima si rivolse alla SPD. «Per il momento esito» scrisse «a fare il passo decisivo e a impegnarmi attivamente nel partito. Per il momento – ma anche questo dev’essere fatto presto, o non esserlo del tutto. Sono ancora in uno stato di transizione, di un piacevole lasciarsi sospingere – è così quando le forze ritornano dopo una malattia». Hilde deve aver conosciuto in prima persona quella giustizia, quando al termine degli studi si stabilì a Berlino come avvocato. Stimolata da Georg, cominciò a interessarsi al comunismo. Così si legge nel diario: «Nelle mie discussioni politiche con i comunisti mi imbatto sempre in Georg Benjamin, di cui tuttavia riconosco in ogni caso il valore umano». Fu un cauto avvicinarsi. Nessuna accensione agli inizi del suo amore per Georg. La loro vita insieme e i pochi anni di comune lavoro politico li segneranno. Ma in quel momento, prima delle mezze vittorie e delle sconfitte piene che avrebbe vissuto successivamente in tribunale, Hilde soffriva ancora della sua insicurezza nei discorsi politici. Faceva fatica a motivare i suoi autentici pensieri, e non si accontentava di ripetere «frasi di giornale». Così scrive nel diario: «Mi sento come un atomo bivalente, che cerca tutt’intorno con la sua libera forza di coesione». Attraverso il Partito socialdemocratico indipendente Georg aveva trovato la strada verso il Partito comunista. Di lui è stato detto molte volte che non era una mente dogmatica: aperto agli argomenti e comprensivo nei dibattiti. Nella sua quotidianità era onnipresente la miseria che la facciata dorata degli anni Venti voleva nascondere. Fra i suoi pazienti a Wedding c’erano anche bambini di strada, come quelli che a migliaia vagavano mendicando per i quartieri proletari di periferia. Bambini che cercavano solo di sopravvivere, i padri dispersi o morti in guerra. Milioni di famiglie senza un sostegno. E in più le terribili condizioni abitative e la fame. Georg Benjamin compilava rapporti per le autorità sanitarie. Durante un congresso sull’assistenza all’infanzia, che si tenne nel 1922 a Ginevra, la città della Società delle Nazioni precorritrice delle Nazioni Unite, si giunse alla conclusione che in Germania due milioni di bambini erano «votati alla morte» e altri sei milioni si trovavano in serio pericolo. Il diario di Hilde e le lettere di Georg mostrano la cautela con cui entrambi vivono la propria attrazione reciproca, e la crescente fiducia nei loro sentimenti. Entrambi avevano alle spalle qualche delusione. Quell’amicizia che andava maturando in un amore sarebbe durata. «Giovedì notte» scrisse Georg, senza una data ma probabilmente nel 1926, «amore, sono certo di non provare nessun timore. Anche tu devi stare tranquilla. Non c’è bisogno di aver paura: puoi fare a meno di guardarmi a volte così seria e triste. Tuo Georg». Una lettera di Hilde: «Mio caro, ho dimenticato di raccontarti questo: di recente, mentre ero in giro a raccogliere infiorescenze di amento, mi sono costruita un oracolo: quando si schiuderanno e spargeranno il polline... e adesso si sono schiuse tutte, e anche i noccioli, sul tavolo c’è il polline verde, io lo sfioro appena e una nuvola intera si solleva. Voglio leggere ancora un po’, ma la tua immagine continua a guardarmi, e credo che questo mi disturbi più di quanto ti abbia disturbata io ieri. E mio padre conta e fa la faccia lunga, e per molte cose dovremo forse trovare altri mezzi o una sostituzione. E io ti sento sempre ridere e dire: Che cosa buffa. Forse mi risuona così nelle orecchie perché prima non l’avevo mai sentito. Oh mio caro. È come vedere l’amore crescerti dentro un pezzetto di più ogni giorno. [...] Buona notte, e quanto vorrei gridarlo: Ti voglio bene. Tua». Poco tempo prima del loro matrimonio Walter Benjamin scrisse a un amico: «Mio fratello sposerà fra pochi giorni una giovane e simpatica ragazza, un’amica di mia sorella di cui ha fatto una comunista. I suoi suoceri cristiani devono inghiottire un doppio boccone amaro». La breve lettera, citata volentieri, tolto l’annuncio del matrimonio è piena di malintesi. Nei suoi ricordi Hilde si stupisce della valutazione che Walter dà di suo fratello. «Che Georg avesse fatto di me una comunista» scrive «– sono entrata nel Partito solo nel 1927 – questo sarebbe stato totalmente estraneo alla sua natura e contraddiceva il suo rispetto per la libertà di ogni essere umano». Allo stesso modo respingeva l’illazione per cui i suoi «genitori cristiani» avrebbero potuto opporsi alla tradizione ebrea dei Benjamin: «Non furono mai antisemiti e da molto tempo avevano rapporti anche con famiglie ebree». Il 27 febbraio 1926 Hilde e Georg si sposarono, e Hilde Lange divenne Hilde Benjamin. Nel 1928 superò il secondo esame di stato e nell’aprile 1929 cominciò la sua carriera di avvocato. In due stanze ammobiliate vicino al municipio di Wedding aprì il suo primo studio. A quell’epoca erano sempre più frequenti gli scontri fra comunisti e socialdemocratici da un lato e le squadre di picchiatori nazisti dall’altro. È il 1° maggio 1929. Il capo della polizia di Berlino ha proibito la manifestazione del Partito comunista. Sull’organo del partito, «Rote Fahne» (Bandiera rossa), i compagni leggono: «No al veto, il 1° maggio è rosso!». Fu una battaglia con molti feriti e numerosi arresti. Hilde Benjamin si assunse la difesa di quanti erano stati accusati di aver turbato l’ordine pubblico o resistito alle forze dell’ordine. Comincia a farsi un nome, le sue arringhe attirano l’attenzione e «Rote Hilfe», l’organizzazione del «soccorso rosso» vicina al Partito comunista, incarica più volte la compagna Benjamin di difendere i compagni accusati. Fu il processo per l’attentato al nazista Horst Wessel a portarla definitivamente sotto i riflettori e sul palcoscenico della legge. Wessel era stato «visitato» nella sua pensione da un gruppo di attivisti vicini al Partito comunista. La «ripassata proletaria» terminò con uno sparo che lo colpì. All’inizio il KPD volle presentare l’incidente come un «dramma della gelosia» fra protettori di prostitute. Non ci riuscì e una squadra di avvocati esperti, fra cui Hilde Benjamin, fu incaricata di difendere gli accusati. Wessel morì quattro settimane dopo l’aggressione. Sarebbe probabilmente sopravvissuto se non avesse rifiutato di farsi curare da un medico ebreo del vicinato. Hilde difese con efficacia la padrona di casa di Wessel, riscuotendo le lodi dei colleghi e della stampa. Chiese e ottenne l’assoluzione della sua assistita. Dopo quel processo fu nel mirino dei nazisti. E in privato? Così scrive, nell’estate 1928: «Nota bene: in novembre avrò un bambino». E, il 10 dicembre 1931, la seguente annotazione: «Il 16 novembre è nato Peter. Il 2 dicembre è morto. L’abbiamo trovato – Georg l’ha trovato – al mattino, quando volevamo prenderlo dalla stanza grande, senza sensi nella sua carrozzina. Il faccino così dolce e grazioso, il corpicino molle e inerte; il cuoricino batteva ancora e ha continuato a battere per due ore – ma tutti i tentativi di riportarlo in vita non sono serviti a nulla. Si suppone che siano state le conseguenze di un’emorragia subita alla nascita, che hanno bloccato i centri del respiro. In seguito ci sono venute in mente diverse cose che avrebbero segnalato un disturbo: il tremore nelle braccine, la frequente rigidezza del corpo, la grande eccitabilità. Non si deve pensare che potesse essere evitato, bisogna ritenerla – come l’ha definita Georg – una disgrazia. «Gli abbiamo detto addio sulle note dell’Andante dell’Incompiuta. Il suo faccino era coperto da una corona di mughetti. Teneva la manina posata sul visetto, come faceva spesso. Sulla sua bara c’erano bianchi narcisi, e Utti ha portato una coroncina di nontiscordardimé e margheritine. Abbiamo voluto tanto bene al nostro Peter – gli abbiamo voluto tanto bene». E il 17 luglio 1933 un appunto riferito a un fatto di molto anteriore, probabilmente annotato a posteriori perché la gioia per la nascita di Michael, il 27 dicembre 1932, aveva sovrastato tutto. Un fatto che è anche l’inizio di un’epoca di sofferenza, che segnerà la vita di Hilde: «Dall’8 aprile Georg è in detenzione protettiva. Dal 4 luglio è nel campo di concentramento di Sonnenburg». Appena due righe – ma sono per me come un grido affilato. Un grido che in chiunque lo ascolti lascia vibrare anche una profonda paura, dove a sua volta è racchiuso il presentimento di quel che inevitabilmente arriverà. Un’ombra scura che ancora non lascia capire quale figura la stia proiettando. Quel genere di grido che spinge d’istinto a portarsi la mano alla bocca, come se fosse possibile riprenderselo. È l’intuizione del momento, simile a una porta dietro la quale si nasconde tutto ciò che intimorisce e spaventa. Il Lager di Sonnenburg fu il primo «campo di rieducazione» nazista, cioè il primo campo di concentramento, istituito contemporaneamente alla presa del potere dei nazisti nel 1933. Vi sono innumerevoli testimonianze su Sonnenburg. Non era ermeticamente isolato, e si sa inoltre che le SS erano responsabili del Lager ma ricettive ai cambiamenti. Dal 1934 tornò a essere un carcere. Nel racconto di un ex prigioniero, riguardante il breve periodo in cui Sonnenburg funzionò come campo di concentramento, si legge che l’amministrazione, il lazzaretto, la cucina, la squadra degli artigiani e altre funzioni all’interno erano state assunte da compagni affidabili, socialdemocratici o comunisti. Il che fu agevolato dall’«infinita stupidità, dalla pigrizia o corruttibilità di quasi tutti i funzionari di polizia, delle SA e in seguito del corpo di guardia delle SS, oltre che dalla rivalità fra polizia, SA e SS». Fra i primi prigionieri, accanto a Carl von Ossietzky, direttore della «Weltbühne», allo scrittore Erich Mühsam, all’avvocato Hans Litten e a molti altri c’era anche Georg Benjamin. Insieme ad altri duecento noti socialdemocratici e comunisti, arrestati subito dopo l’incendio del Reichstag e portati a Sonnenburg. In tutto il Reich furono messe in detenzione protettiva più di diecimila persone. Rinchiuse, torturate, e molte di loro uccise. Alcune riuscirono a fuggire da Sonnenburg. Dai loro racconti il mondo apprese dei brutali maltrattamenti a Ossietzky e agli altri. Nel 1936 Ossietzky ricevette, retroattivamente per il 1935, il premio Nobel per la pace. Il suo calvario passò per il KZ di Esterwegen. Morì di tubercolosi. Ci sono tracce che gli agenti patogeni della tubercolosi gli fossero stati iniettati. Hilde era sollevata per il fatto che Georg non fosse stato prelevato da uomini delle SA ma da poliziotti in uniforme, accompagnati da alcuni individui in borghese, che si erano comportati in maniera apparentemente corretta. Non fu portato in una delle cantine delle SA, ma «soltanto» al presidio di polizia. Su quel che Georg passò a Sonnenburg abbiamo una sua affermazione del 1942, quando dopo il carcere di Brandeburgo e il Lager esterno di Wuhlheide, dove Hilde e Georg si videro per l’ultima volta, sperava ancora di essere trasferito a Sachsenhausen: «Dopo il 1933 e negli ultimi anni non mi scompongo tanto facilmente». Dietro questa frase c’è anche la sua esperienza in detenzione protettiva. La permanenza a Sonnenburg iniziava per ogni prigioniero con un «barbaro maltrattamento». Così, dopo la guerra, un sopravvissuto ricorda in una lettera a Hilde Benjamin. Il carcere di Sonnenburg era stato chiuso per motivi di igiene. L’acqua potabile era contaminata, nei sotterranei umidi scorrazzavano topi e parassiti. Anche la vita di Georg era in pericolo. Si sapeva abbastanza sulle condizioni a Sonnenburg – da ex prigionieri o da donne alle quali era stata concessa una visita. Dopo il 1934 vi furono imprigionati soprattutto stranieri provenienti da tutta Europa. Non esisteva un registro con i nomi, i prigionieri avevano soltanto numeri. Nella notte fra il 30 e il 31 gennaio 1945 le SS non andarono per il sottile: tutti i prigionieri furono uccisi a colpi di arma da fuoco. Il numero esatto dei morti è sconosciuto. Le stime oscillano fra settecento e mille. Solo tre sopravvissero. Il destino di Georg Benjamin mostra chiaramente anche la rapidità con cui la categoria dei medici aderì alla dittatura nazista. Hilde chiama tutto ciò «il meccanismo dell’esclusione»: con una lettera del 29 giugno 1933 Georg Benjamin fu espulso dall’Associazione dei medici di Berlino in quanto rappresentante di quartiere del Partito comunista, e con un’altra lettera del 28 luglio 1933 fu escluso dall’Ordine provinciale berlinese dei medici per «appartenenza al Partito comunista e attività in tal senso quale rappresentante di quartiere». La comunicazione ufficiale, in cui l’Ordine comunicava la sua decisione, mostrava evidenti segni di una frettolosa compiacenza verso il potere. Conteneva soltanto, come nota Hilde Benjamin, le parole: «Motivazione: appartenenza al Partito comunista», senza specificare quel che doveva essere motivato, cioè appunto l’esclusione dall’Ordine. Ancora più urgente appariva ai rappresentanti dei medici il rilascio del verdetto della corte d’onore. Georg Benjamin fu accusato insieme a una collega, la dottoressa Käte Held, anche lei membro del Partito comunista. Nel verdetto pervenuto a Hilde Benjamin la data della deliberazione decisiva non è segnata (fu probabilmente nell’agosto 1933), e al posto del nome proprio è scritto «Erich» anziché Georg. La motivazione era articolata già in formule tipicamente naziste: «Nella determinazione della pena si considera che il comportamento dei due accusati è indegno di un medico tedesco. Avrebbero dovuto riconoscere lo scopo dei certificati che si sono prestati a compilare, e secondo il parere della corte d’onore l’hanno anche riconosciuto. Sono stati dunque disposti a mettere la loro arte medica al servizio di uno scopo in contrasto con gli interessi della patria». Così la maggior parte dei medici ebrei e comunisti aveva perso la propria base di sussistenza. Il vuoto che si creava fu colmato dai medici «ariani», e i nazisti mantenevano in questo modo la promessa di migliorare la situazione economica di quei medici che erano stati pronti a dichiarare la loro fede al regime. L’iscrizione all’albo era dunque negata «quando l’aspirante non potrebbe ottenere la qualifica di funzionario a causa delle proprie origini o di quelle del consorte, e se al momento della sua domanda di iscrizione la quota dei medici di sangue non tedesco rispetto al numero totale dei medici nel Reich tedesco supera la quota degli individui di sangue non tedesco rispetto alla popolazione del Reich tedesco. Il ministro degli Interni del Reich può, in circostanze particolari e in accordo con l’Ordine dei medici del Reich, consentire eccezioni». La società ariana, maggioritaria nel senso dell’«igiene razziale» nazista, approfittò in maniera analoga in molti altri campi. Le imprese ebree furono «arianizzate», espropriate e trasferite a prezzi vantaggiosi a offerenti ariani. Opere d’arte, denunciate in quanto «degenerate», quando erano in possesso di ebrei furono offerte sul mercato internazionale con alti profitti. Tutto questo portò miliardi nelle casse del Reich, assicurando in parte la copertura degli sgravi fiscali per la maggioranza ariana. E quando nel Reich non ci furono più «non ariani» che avrebbero potuto essere espropriati o derubati con la sanzione dello stato, Hitler cominciò la Seconda guerra mondiale. Il riarmo della Wehrmacht aveva minato la situazione finanziaria del Reich. Agli occhi dei nazisti le razzie nel resto dell’Europa apparivano dunque necessarie per motivi materiali. Da Sonnenburg si sono conservate due lettere a Hilde, in cui Georg chiede anche notizie del figlio Michael. Probabilmente ne scrisse altre, ma furono fatte sparire. Così scrive il 10 dicembre 1933: «Continuo a stare bene. Il mio lavoro è tutti i giorni lo stesso; ogni tanto – come oggi – ho naturalmente una mezza giornata o anche una giornata intera. All’aperto esco in genere al mattino, prima di iniziare il lavoro, e quando c’è tempo a volte anche al pomeriggio. [...] Naturalmente si parla molto del rilascio dei cinquemila. Ti ho già scritto che non mi attendo nulla; spero che anche tu non ti faccia illusioni. Se invece dovesse succedere, tanto meglio. Quali saranno le possibilità di scrivere fra due settimane, a Natale, ancora non lo so. E non è neanche sicuro se potrò scrivere al momento giusto per il compleanno del bambino. Accludo come regalo due sue diverse silhouette. Come ricorderai, sono ritagliate seguendo le fotografie di profilo fatte in luglio. Spero che siano venute bene. A parte questo non posso mandare per il compleanno niente se non tanti auguri. «All’occasione potresti spedirmi i fascicoli dal 4 al 6 della Commissione del Reich per la salute del popolo. Di cibo mi rifornisci in abbondanza; la carne e la torta sono naturalmente per l’intera camerata, come fanno anche gli altri quando ricevono qualcosa. Da non fumatore il più grande desiderio sarebbe quello di una bella tazza di caffè. Il freddo è diminuito. Le temperature nelle giornate più fredde vanno dai dodici ai quindici gradi. Il maglione va benissimo, sia in stanza che al lavoro. La vostra richiesta alla Gestapo non ha avuto ancora risposta? È inutile insistere e chiedere di nuovo. Ogni tanto leggo il settimanale “Blick in die Zeit” (Sguardo nel tempo), che riporta solo le voci dei giornali. Lo consiglio anche a voi, qualche volta. Se nella “Frankfurter Zeitung” dovesse uscire qualcosa di particolare, ti prego di mandarmelo». Hilde avrà preso questa lettera, che evita chiaramente ogni accenno diretto alla terribile realtà del Lager, com’era previsto che fosse: bisognava leggere attraverso le righe. Nel 1945, al processo contro il comandante del Lager e membro delle SS Adrian, l’ex deputato del Reichstag per il KPD Fritz Emmerich rese la sua testimonianza. Raccontò come si tentasse di tutto per far sistemare in una qualche speciale funzione, «fuori dalla linea di tiro», quei prigionieri che avevano bisogno di una «protezione particolare». Altri testimoni raccontarono come alcuni compagni lavorassero all’«accoglienza» e informassero la direzione del partito quando arrivavano nuovi prigionieri. Tuttavia non potevano impedire che le «brutalità avvenissero regolarmente [...] quando Adrian era di guardia». Un altro prigioniero ricorda il dottor Müller di Spandau, che in particolare «aiutava i prigionieri che avevano subito maltrattamenti, e il suo infermiere di nome Georg». Forse un indizio che Georg Benjamin potesse avere offerto anch’egli soccorso medico, secondo le sue possibilità. Hilde Benjamin aveva letto la lettera di Georg insieme a Egon Thurau, un ex compagno di prigionia di Sonnenburg, per poter decifrare insieme a lui le notizie fra le righe. Georg si trovava in una camerata collettiva. Così Thurau interpretò in ogni caso il numero di protocollo N.III.8, indicato sulla lettera. Può significare ala nord, reparto III, camerata 8. I compagni erano riconoscibili nelle silhouette che Georg aveva portato con sé al momento del rilascio. Sul retro della silhouette incorniciata Georg aveva annotato i nomi, documento storico sulla composizione di una camerata nel Lager di Sonnenburg nel dicembre 1933. Segue una seconda lettera, datata 13 dicembre 1933, questa volta senza numero di protocollo. Se ne deduce che era stata fatta uscire clandestinamente: «Cara moglie, ho ricevuto ieri la tua lettera con la notizia della malattia di Mischa [...]. Spero che nel frattempo stia di nuovo bene. Febbre probabilmente non ne ha avuta. Così immagino, visto che non lo scrivi. [...] Qui non c’è niente di nuovo. Ti piacciono le silhouette del bambino? Prima di Natale non riceverai da me altre lettere!». Il messaggio termina con un saluto a tutti e l’avvertimento: «Gli auguri allegati per Mischa sono stati disegnati da un compagno!». Con quale timore Hilde deve aver aperto talvolta una lettera di Georg, sempre attendendosi qualcosa di terribile? Oppure la speranza di riavere il marito, sano e salvo, sovrastava tutto? Sicuramente c’era anche la gratitudine per aver ricevuto comunque un segno di vita. Cosa si poteva desumere davvero da queste lettere – oltre alla certezza che era ancora vivo? Hilde deve aver esaminato e studiato ogni riga alla ricerca di un doppio senso. Quanto meno sembrava che Georg affrontasse il suo destino con una sorprendente intima tranquillità. Pochi segnali soltanto alludono alla sua profonda nostalgia delle due creature là fuori, che come una riserva di forza lo rifornivano tuttavia di fiducia. Hilde Benjamin non si sentiva direttamente in pericolo. Lei e il piccolo Mischa erano registrati alla polizia presso i genitori di lei nel quartiere berlinese di Steglitz. Dopo una perquisizione domiciliare seguita ben presto all’arresto, la polizia e la Gestapo a quanto pare non si interessarono più a lei. L’abilitazione di avvocato le era stata già disconosciuta nel maggio 1933. Un giurista davvero «temibile» aveva firmato il divieto di esercitare la professione forense. Era il dottor Roland Freisler, che in seguito divenne presidente del Volksgerichtshof di Hitler. Subito dopo Hilde si era data alla clandestinità per diverse settimane, e aveva lasciato Mischa dai nonni. Quando poté ricomparire si trasferì dai genitori nella Dünther Straße a Steglitz e si occupò del bambino. Era disoccupata. Natale 1933. I preparativi per la festa sono in pieno corso. Hilde Benjamin non fa eccezione, anche se si è staccata dalla chiesa. Per i genitori è tradizione festeggiare il Natale con le figlie adulte, Ruth e Hilde, e con il nipotino Mischa. Si sta organizzando la cena. A un certo punto del pomeriggio squilla il telefono. Una voce: «Sono alla stazione dello Zoo e vengo da voi con il tram». La voce di Georg. Non sappiamo se Hilde abbia mantenuto il controllo, se abbia singhiozzato, pianto o riso o tutto insieme: «Georg è stato rilasciato!». Piena di gioia abbraccia la sorella Ruth. Mischa grida solo «papà! papà!» e ride, prima che in fretta e furia, al posto delle ciabattine da casa e del maglione, gli vengano fatti indossare cappottino e scarpe chiuse. Anche Hilde si getta sulle spalle il cappotto per correre insieme a Mischa fino alla fermata del tram, che dista venti minuti. Che momento la spinge attraverso la Berlino natalizia, immersa nel buio. Un bagliore insperato che si irradia su ogni cosa. Ancora poco prima stava adornando l’albero, l’ultima lettera di Georg nella mente, e cercava di non cadere nella voragine profonda che le si apriva davanti, trattenuta solo dal piccolo Mischa che la guardava raggiante, porgendole i fili argentati e le palle e ammirando l’albero colorato. E adesso: Mischa corre incontro a Georg, che scende dal tram. In seguito, nel 1977, quando nella DDR mette per iscritto i suoi ricordi su Georg e racconta una parte della sua stessa vita, a proposito di quella meravigliosa sera di Natale che ebbe un esito così insperato con il bellissimo regalo, le sorge nella mente questa frase: «Il rilascio di Georg Benjamin fu un regalo per noi e soprattutto un obbligo verso il partito, che bisognava utilizzare e adempiere...». Vengono i brividi a leggere quel che suona come la realizzazione più che zelante, da parte della compagna Benjamin, dei doveri imposti dal piano. Non voglio credere che quella sera il partito fosse più importante della gioia e della sorpresa per una fortuna che non si sarebbe più ripetuta. Restavano loro meno di due anni, in un ambiente ostile che avrebbe trasformato drammaticamente le loro vite. Per Georg la professione di medico apparteneva al passato. Per un poco la fortuna restò tuttavia fedele alla famigliola. Hilde ottenne un lavoro nell’ufficio legale della rappresentanza commerciale sovietica. Quello che guadagnava era abbastanza per vivere e poterono rinunciare al sostegno dei suoi genitori. 5 Il Reichsgericht (Corte imperiale di Giustizia) con sede a Lipsia fu il tribunale supremo del Reich tedesco dal 1879 al 1945. Profondamente compromesso con il nazismo, venne sciolto subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale [N.d.T.]. Capitolo settimo «Benvenuti» a Mauthausen È il «muro del pianto». Il mio occhio inquadra lo stesso taglio dell’immagine riportata nella piccola guida del memoriale che tengo in mano. È il muro accanto all’imponente entrata. Divenne un muro del pianto perché i prigionieri che dovevano disporsi là cominciavano a intuire cosa li aspettava. Alla mia destra, allineate sul lato più lungo, le baracche di legno delimitano la strada che attraversa il Lager, mentre a sinistra ci sono edifici in muratura: l’infermeria, la prigione e il bunker, una cantina sotto l’infermeria. Alle pareti della cantina sono appese fotografie di prigionieri originari di mezza Europa. Qui si praticava la tortura, i prigionieri erano «interrogati» e uccisi, oppure puniti, picchiati fino a essere ridotti in fin di vita. Accanto c’erano la baracca della cucina e la lavanderia. A destra, accanto al portone di ingresso, la fureria e la mensa, e dietro a questa le baracche numero sei e sette. In origine c’erano cinque baracche in ogni fila, e venticinque in tutto il Lager, in ciascuna delle quali erano sistemate trecento persone. Di fatto ve ne erano ammassate fino a mille. La numero nove era quella degli ebrei. Oggi si vedono solo le fondamenta. La baracca non esiste più. Nei crematori posti nelle cantine dell’infermeria e della prigione venivano bruciati i cadaveri dei prigionieri uccisi dalla fame o condotti altrimenti alla morte. Ai familiari veniva comunicato brevemente per lettera il «decesso inopinato» del padre, dello zio o del fratello, senza chiarimenti sulle circostanze precise della morte, e anche senza il consueto «rammarico» nel porgere la notizia. Mi trovo sulla strada all’interno del campo di sterminio di Mauthausen. L’ex KZ è circondato da alti muri. La pioggia mi ha accompagnato per tutta la giornata. Anche adesso sta piovigginando. I desolati edifici si specchiano nelle pozzanghere. Una giornata estiva del 2011. Mentre salivo la ripida strada d’asfalto a due corsie – «strada della memoria», così è scritto sul cartello – e la macchina entrava nel parcheggio ho visto il massiccio edificio costruito con le pietre squadrate provenienti dalle vicine cave di granito, quell’edificio che ha reso famosa in tutto il mondo la cittadina sul Danubio: il campo di concentramento di Mauthausen. Oggi luogo della memoria e di pellegrinaggio per visitatori di tutta Europa, che qui piangono parenti o amici. Molte scolaresche vengono per farsi un’idea dell’aspetto che può avere uno dei molti inferni che l’umanità si crea. Tutto nel mostruoso edificio esibisce una possanza: l’entrata, le mura con le torri. Si è riluttanti ad avvicinarsi. Il breve tragitto dal parcheggio al colosso murato è lungo. È consigliabile andare innanzitutto al centro visitatori, posto in un edificio moderno con alte finestre a destra del campo di concentramento, dove si trovano luminose stanze per seminari e schermi tattili che rispondono a ogni possibile domanda. Una libreria con un’abbondante offerta di testi sulla storia del Lager e sull’inferno di Mauthausen. Nell’annesso caffè il visitatore esitante può fare ancora una breve pausa prima di iniziare il percorso attraverso il Lager. Ma poi, insieme a un centinaio di visitatori in questa giornata, ci si ritrova improvvisamente accodati e si diventa una delle miserabili figure che più di settant’anni fa scesero o si trascinarono giù dai vagoni ferroviari alla stazione di Mauthausen, creature semimorte di fame, che fra le grida dei comandi venivano spinte nelle colonne di marcia e dovevano poi incamminarsi sulla collina. Risuonava forse alle loro orecchie, come un’eco, il frenetico consenso alla costruzione di questo inferno? Il «Völkischer Beobachter», nella sua edizione viennese, riportava da Linz l’entusiasmo con cui era stata accolta la notizia che il Gauleiter della circoscrizione dell’Alto Danubio, August Eigruber, aveva annunciato nel 1938 sull’Adolf-Hitler-Platz a Gmunden, nello Heimatgau, la «circoscrizione natia» del Führer: sarà costruito un «campo di concentramento per i traditori del popolo»! «Un fragoroso giubilo accompagna questo annuncio, tanto che il Gauleiter fatica a proseguire il suo discorso». Questo il titolo del «Völkischer Beobachter»: «Baluardo Salzkammergut. In futuro l’Alta Austria terrà sotto sorveglianza tutti i nemici del popolo nel paese». Sono già prefigurati i circa duecentomila prigionieri che nei successivi sette anni presero la via del campo di sterminio di Mauthausen. Poiché molti non sopravvivevano nemmeno al trasporto vennero create due fosse comuni. Dodicimila morti furono sotterrati là. Una delle fosse si trova vicino alla stazione, dove un ex cimitero militare risalente all’epoca della Prima guerra mondiale fu perciò spianato. Tuttavia si fece attenzione a «seppellire» là solo i prigionieri morti di una morte «naturale». Gli altri, picchiati, uccisi a colpi d’arma da fuoco o con il gas, venivano bruciati nei crematori del Lager. Ciò accadde sempre più spesso nell’ultimo anno di guerra. Probabilmente un tentativo, da parte della direzione del Lager, di cancellare le tracce nel caso in cui la vittoria finale non si fosse realizzata. Chi arrivava vivo al Lager veniva rasato a zero. Molti ricordano forbici spuntate e rasoi. I capelli non venivano tagliati quanto piuttosto strappati. Gli uomini uscivano dalla stanza con il cuoio capelluto sanguinante e venivano assegnati alle loro baracche. Già a quel punto avevano perso ogni rispetto di sé ed erano invasi dal disgusto della propria persona. Il loro annientamento cominciava con la sottrazione del rispetto. Erano stati trasformati in oggetti. Per la costruzione del Lager vennero portati a Mauthausen prigionieri da Dachau e altri campi di concentramento. Così raccontò un testimone che trascorse là tre anni, come si può leggere nel piccolo opuscolo del memoriale: «Arrivammo in mille. Sul posto c’erano pochi attrezzi, tanto che una gran parte di noi dovette compiere i lavori di sterro a mani nude. Costruimmo quattro baracche, era il centro di raccolta. [...] Per pranzo ci davano tre quarti di litro di zuppa, principalmente cavolo e acqua. Dopo mangiato si tornava subito al lavoro, fino a quando faceva buio. Soffrivamo parecchio la fame, ma il peggio era la sete. Siccome il Lager era stato costruito in cima alla montagna bisognava portare su l’acqua dalla città di Mauthausen, che stava in fondo alla valle, per mezzo di una vecchia autoinnaffiatrice. Questa saliva solo tre volte al giorno, e la maggior parte dell’acqua veniva usata per la cucina delle SS e il loro corpo di guardia!». Poi ci fu la cava di pietra. «Venne formata una squadra di portatori. Quattro uomini trascinavano sopra una barella fino a trecento chili di pietre su per la ripida montagna, e poi scendevano di nuovo a passo di corsa [...]. Le [...] sentinelle erano pronte a picchiare con i manganelli, se lungo la strada qualcuno non era più in grado di correre. Chi veniva richiamato perché si era rifiutato di lavorare riceveva nel Lager più di [...] venticinque colpi con il temutissimo scudiscio». Dopodiché «il sedere era nero come il carbone». La storia del KZ di Mauthausen fa rabbrividire ancora oggi il visitatore. Tutto vi parla di annichilimento e di una viltà disumana. Fu questa la sua ultima stazione nel 1942: Georg Benjamin resistette a Mauthausen solo poche settimane. Fu trovato sopra il filo spinato, attraversato dalla corrente ad alta tensione, sotto il bordo del muro. Le sentinelle delle SS si divertivano a inseguire i prigionieri verso il filo spinato. Un prigioniero descrisse gli ebrei del suo trasporto che «vestiti solo di mutande e camicia venivano braccati verso la rete. [...] Là restarono fino al mattino. Dopo che le squadre di lavoro ebbero lasciato il Lager, la corrente venne staccata e i becchini andarono a prendere i cadaveri dal filo spinato». Nel campo di sterminio di Mauthausen e nei campi esterni di Melk e Ebensee morirono centotrentamila uomini, fra cui venticinquemila ebrei. Nella parte del campo destinata agli ebrei ciascuno sapeva che quella sarebbe stata la sua ultima stazione. Di notte si dormiva sul nudo pavimento, non solamente vicini ma addirittura ammucchiati gli uni sugli altri. Per i propri bisogni si utilizzavano bottiglie, essendo impossibile arrivare ai bagni senza calpestare altra gente. Si inciampava su braccia e gambe dei compagni di prigionia. Durante il giorno, lavoro forzato nelle cave di pietra. Chi non ce la faceva veniva picchiato a morte o atterrato da una pallottola. Le condizioni igieniche erano inimmaginabili. Non era prevista assistenza medica, e i prigionieri soffrivano la fame e la sete. L’angoscia che mi ha assalito là impiega parecchio tempo a svanire. L’impressione della visita perdura a lungo. Torno al parcheggio e rifletto su specificazioni come «le SS», «il corpo di guardia delle SS», o anche «i nazisti», che trovo nelle testimonianze scritte sul Lager. Non erano però privi di un volto, ogni singola guardia delle SS aveva un nome. In Austria si chiamavano forse Sepp, Xaver o Bertl, ed erano figli e padri, mariti e fratelli. Avevano amici, famiglie, avevano un’infanzia. Come diventarono boia, SS e guardie senza un volto? Cosa portavano in sé per diventarlo? Cosa li rendeva tanto spietati? Cosa li educò a tanto, deformandoli e facendo di loro simili creature? Percorro all’indietro la «strada della memoria» e leggo sui cartelli che a sinistra si va alla «Corte delle trote» e a destra si arriva alle «Osterie del sidro». Ospitalità nel paradiso delle vacanze chiamato Austria. E io penso ai dibattiti politici nel mio paese e al panorama dei partiti di quella estrema destra, ancora molto vivace, che torna a raccogliere seguaci. All’ingresso in città leggo: «Un caloroso benvenuto a Mauthausen», ed è come un pugno nello stomaco. Si vorrebbe annullare la memoria? O c’è nuova vita in questa città, senza che questo significhi abbandonare la propria storia? Da allora sono passati settant’anni. «Benvenuti a Mauthausen»: sulla collina che sovrasta la città c’è un inferno da ricordare. Un «Benvenuti» sul cartello d’ingresso di Mauthausen sarebbe stato probabilmente del tutto normale per Georg Benjamin, nell’inverno del 1934. Nel paese dei crocifissi, che si incontrano a ogni curva della strada, non sarebbe stata una sorpresa. Lui stesso non avrebbe compreso il mio sgomento nel vederli. Il campo di concentramento non c’era ancora. Fu osannato solo quattro anni dopo. Dopo il rilascio da Sonnenburg Georg era andato in montagna tutte le volte che aveva potuto. Nel ricordo di Hilde Benjamin quelli erano stati «gli ultimi momenti di libertà, di una primavera in montagna». Visitò anche la Svizzera e i laghi dell’Italia settentrionale. «Anche quando incontrava conoscenti e compagni» precisò Hilde «a cui forniva informazioni e dai quali a sua volta ne riceveva, non aveva [...] nessun particolare incarico da sbrigare». Era disoccupato – e cercò di trarre il meglio dalla situazione. Così racconta ancora Hilde: «Non si poteva sapere quanto sarebbe durato il dono di quel tempo in cui poter vivere e lottare e lavorare, e Georg Benjamin lo usa quindi fin dall’inizio [...] nelle maniere più diverse per imparare, per lavorare, e quando era possibile per trascorrerlo insieme al suo bambino, in mezzo alla natura, con i libri, e sempre a disposizione degli altri». Prese appena in tempo la patente, prima che agli ebrei fosse proibito nel 1935, e studiò il russo. Il nome del suo insegnante fu utilizzato spesso in seguito, nella corrispondenza dal carcere, come parola cifrata. Dall’estate del 1934 frequentò anche le lezioni dei corsi di aggiornamento per medici ebrei, organizzati dall’amministrazione sanitaria della comunità ebraica. Hilde guadagnava da vivere per la famiglia. Il bambino riceveva «amorevole assistenza e un’educazione nella colonia che la compagna Edith Fürst aveva appena aperto nel quartiere berlinese di Niederschönhausen, dove alcuni figli di compagni che in parte si trovavano in carcere e in parte vivevano in clandestinità, e insieme a loro alcuni bambini ebrei, trovavano sicurezza e protezione». Il 14 maggio 1936 Hilde Benjamin annota: «Quando [...] sono tornata a casa dopo il lavoro nella rappresentanza commerciale ho avvertito che qualcosa era “diverso”. Non ricordo più se fosse lo straccio per la polvere che faceva da segnale, appeso fuori dalla finestra della nostra stanza al pianterreno, come avevamo concordato con zia Grünwald (la padrona di casa e amica). Ma c’era la sensazione che qualcosa non quadrasse. Dalla nostra coinquilina venni a sapere che al mattino diversi individui della Gestapo erano venuti con Georg Benjamin e avevano perquisito la casa. Esternamente era avvenuto tutto in maniera corretta e ordinata, la macchina da scrivere non era stata sequestrata, né in apparenza era stato preso o sequestrato nulla». Il 16 maggio arriva il primo segno di vita da parte di Georg. Scrive dal campo di concentramento di Columbia, un’ex prigione nel campo militare di Tempelhof, a Berlino: «Mia carissima moglie! Dev’essere stata una brutta sorpresa per te! Sì, mia cara, la tua vita è difficile insieme a me, ma cerca ora di conquistare un po’ dell’imperturbabilità di cui abbiamo parlato tanto spesso. Pensi ancora al bel libro di (Martin) Gumpert con le biografie, che abbiamo letto insieme?». Hilde lo ricorda. Insieme hanno letto anche il destino di Miguel Serveto, che Gumpert descrive, e Hilde lo cita: «Al mattino del 27 ottobre 1553 le chiavi tintinnarono per l’ultima volta nella pesante porta, e lui fu tirato fuori dall’oscuro buco dove aveva trascorso gli ultimi mesi, fra i pidocchi e la muffa, per essere consegnato al rogo». Serveto era stato bruciato come eretico a Ginevra. Fra le altre cose aveva messo in dubbio il dogma della trinità, cioè la consustanzialità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Calvino fece arrestare Serveto e si premurò di ottenere la sua condanna. Fu un antesignano processo farsa, in cui la condanna a morte era già scritta. Lo zelo religioso fu causa di pogrom che provocarono innumerevoli morti. Ciò colpì soprattutto la comunità ebraica e si ripeté quasi quattro secoli dopo con la distruzione degli shtetl ebraici e dei loro abitanti, dopo l’invasione dell’Unione Sovietica da parte della Wehrmacht. Il ricordo di quella comune lettura è come un presagio della sventura che attende. La lettera di Georg tuttavia continua: «Cara Hilde, ora devi trovare una maniera di vivere totalmente autonoma con il nostro bambino e con gli amici e i parenti che ti aiuteranno. Dobbiamo aspettarci che sarà una cosa molto lunga e difficile. In futuro dovrai prendere tutte le decisioni sostanzialmente senza considerarmi. Il mio bambino, il nostro Mischa, dovrà dimenticarmi un po’ per volta. Spero che riesca a farlo abbastanza in fretta. O vuoi mandargli ogni tanto qualcosa da Georg che è partito? Fai come ritieni giusto. Cara moglie, quello che più mi darà pace sarà sapere che nemmeno tu ti lasci abbattere dal destino! «Non ho molti desideri. Gli sforzi per ottenere una qualche rogatoria sono, allo stato attuale, del tutto inutili. Per il resto i miei desideri coincidono con le cose concesse e indicate in cima alla lettera: cambio di biancheria una o due volte alla settimana (camicia, mutande lunghe, calze e qualche fazzoletto); abbonamento al “Völkischer Beobachter”, come disposto sopra, e intanto un invio di 5 marchi. Più di tutto sarò felice di ricevere le tue lettere! [...] «Hilde – cerca di godere il più possibile l’estate, come tre anni fa. Sembra che le giornate calde non siano ancora davvero cominciate. Già adesso una preghiera per la tua prima visita: porta sempre con te una fotografia di Mischa. Nella macchina c’è ancora una pellicola nuova... «Per oggi è tutto! Un saluto pieno di affetto a te e Mischa. E saluti ai genitori, a Utti, a zia Grünwald e a tutti gli altri. Tuo Georg». Il 14 ottobre 1936 giunse il verdetto della Corte d’appello contro Benjamin e altri, accusati di «preparativi di alto tradimento». L’imputazione: «L’accusato ha continuativamente tradotto articoli da giornali stranieri – inglesi, francesi e russi – riguardanti la Germania e le condizioni del paese, ma anche articoli sugli sviluppi politici in Spagna e in Francia, al fine di permetterne la diffusione in ambienti comunisti, ovvero a scopo di propaganda. [...] Accanto alla sua attività di traduttore, l’accusato ha intrattenuto contatti con individui i quali gli hanno fornito notizie sui loro rapporti di lavoro, su questioni salariali, sugli umori presso i disoccupati ecc. Si trattava di due lavoratori occupati presso la AEG e di un disoccupato, cioè il coimputato Perleberg. Questa informazione è stata fornita dall’accusato alla funzionaria menzionata». Georg Benjamin fu condannato a sei anni di carcere, da cui venivano scalati i cinque mesi di carcerazione preventiva, con privazione dei diritti civili per cinque anni. Il calcolo della pena è così motivato: «L’accusato, di razza ebrea, appartiene da molti anni al movimento comunista. È stato rappresentante di quartiere per il KPD nel quartiere berlinese di Wedding, e fino al 1933 medico scolastico statale della città di Berlino. È stato in detenzione protettiva dall’aprile al settembre [di fatto dicembre] 1933. Al momento del rilascio ha firmato una lettera di garanzia in cui si impegnava a non svolgere più alcuna attività sovversiva. Ciò nonostante l’accusato, disoccupato dal 1933, ha lavorato dalla primavera 1935 per il Partito comunista». Il documento prosegue, ricapitolando: «Occorre inoltre concludere che, considerata la sua personalità e l’ampiezza del suo impegno, debba toccare all’accusato Benjamin la condanna più dura. Quale aggravante pesa nel suo caso il mancato rispetto della promessa, resa al termine della detenzione protettiva, di non svolgere più alcuna attività sovversiva. L’aver tuttavia ripreso con tale ampiezza la sua attività sovversiva testimonia l’ostinazione della sua prepotente volontà. Tale attività deve essere considerata particolarmente pericolosa. Benjamin appartiene al numero degli intellettuali ebrei intenzionati con ogni mezzo ad aizzare i lavoratori tedeschi, al fine di ottenere la vittoria del comunismo. A suo favore si è potuta considerare soltanto la circostanza che, quanto a sé, egli ha confessato di aver combattuto in guerra come soldato. Una pena di sei anni di carcere è apparsa in queste circostanze necessaria, ma anche sufficiente». Più di cinque anni in quello che era considerato il carcere «più moderno» del Brandeburgo. La sua finalità in ogni caso apparve chiara a Hilde Benjamin, durante la sua prima visita nell’inverno 1937. Benché all’epoca l’edificio fosse riscaldato, Hilde parla di una «luminosità fredda e limpida, che ancora oggi si accompagna in me al ricordo le luogo, una luminosità che sembrava voler nascondere l’oscurità del terrore e della morte incombente, la quale si trovava in un incolmabile contrasto con i versi ipocriti e penosi sopra l’ingresso: Disciplina, lavoro e bontà / dell’animo sciolgon l’asperità, / del passato fan tabula rasa / e un giorno poi riporteranno a casa». I tempi delle visite, come li ricorda Hilde, sono quattro volte quindici minuti durante il primo anno, cioè un’ora in totale, e ogni anno si allungano di un’ora, arrivando in cinque anni a cinque ore e trenta minuti. Nel parlatorio Hilde e Georg siedono l’uno di fronte all’altra, in presenza di un funzionario. Questo sta a un capo del tavolo, mentre loro siedono ciascuno a uno dei lati lunghi. Nel diario di Hilde trovo questa annotazione: «Era naturale che l’abbondanza delle cose da dire, per cui il tempo non bastava mai» significasse una tensione mentale e psicologica. La quale, soprattutto per Georg Benjamin, si risolveva in un’ansietà che nonostante la buona preparazione, il fatto di conoscere bene le parole chiave, di leggersi reciprocamente nello sguardo e nel viso, non poteva sempre essere vinta. La presenza del funzionario non li disturbava, e a volte «al momento del saluto potevamo andare in fretta all’altro lato del tavolo e abbracciarci». Per comprendere bene la loro corrispondenza il lettore deve conoscere le parole cifrate con cui si dissimulavano certi fatti nelle lettere e in parlatorio. Nel rievocarli Hilde si rese conto che non ricordava più tutti i codici. «L’Unione Sovietica era in genere “Sophie” (il nome del nostro medico, la sorella del deputato al Reichstag Eduard Alexander) oppure “Utti”, il vezzeggiativo di mia sorella, o era indicata anche con il nome del mio ex capo. “Konrad” significava il Partito comunista tedesco, la Spagna era la signora Götz (dal nome del mio collega, l’avvocato Götz Berger che aveva combattuto in Spagna), la Mariendorfer Straße (con l’accento sulla prima sillaba) era Madrid. Dietro il nome Dora o Walter c’era naturalmente la Francia, e così via». Georg Benjamin era il «baby papà» – come l’avevano chiamato i bambini nell’istituto di Edith Fürst perché era il padre del più piccolo fra loro, nome che era stato «accolto» da tutti. Con quanta forza quegli anni, le visite in carcere, le lettere di Georg e la sua nostalgia della moglie e del figlio devono essersi impressi a fuoco nell’anima di Hilde. Quante volte lui deve avere avvertito la propria impotenza, l’impossibilità di aiutare. Com’è ridotta da una simile esperienza una persona che non può mettere fine alla rovina che, senza il proprio concorso, segna la sua vita? Come dev’essersi sentito lui, costretto a chiedersi continuamente se la sua fede politica valesse il pericolo a cui esponeva se stesso e la sua famiglia? Quante volte fu assalito dai dubbi? Anche le sue convinzioni, la sua incrollabile fede nei compagni a Mosca, come Hilde Benjamin la descrive, non poterono essere mai del tutto libere dal tormento del dubbio. Alla fine fu però soltanto la fede nella salvezza promessa dall’idea comunista a dargli la forza di resistere – quello che Theodor W. Adorno chiamò il «nucleo teologico incandescente», senza il quale il materialismo avrebbe perso la sua principale forza propulsiva. La fede infatti sposta le montagne. Le lettere di sua moglie furono per lui il ponte verso un’altra vita, da cui lo isolavano le mura del carcere. Minuziosamente lei gli descrive ogni momento della crescita di Mischa, ogni sua frase, ogni suo cambiamento. Hilde ammirava il fatto che persino in prigione Georg continuasse a preoccuparsi per il benessere dei suoi familiari, e che volesse sempre conoscere ogni dettaglio delle loro vite là fuori. Dopo l’invasione della Francia crebbe l’ansia per il fratello Walter e la sorella Dora, entrambi fuggiti a Parigi. Ancora nel 1938 Walter Benjamin aveva scritto una lettera a Hilde, ringraziandola per gli auguri di compleanno. Pregava «alla prossima occasione di ringraziare Georg per i suoi auguri e di mandargli un saluto affettuoso da parte mia». La lettera veniva dalla Danimarca, dove Walter Benjamin fu più volte ospite dell’amico Bertolt Brecht. Non era facile per Georg, Walter e Dora scambiarsi informazioni; le notizie li raggiungevano solo dopo aver compiuto intricate deviazioni e con grande ritardo. Georg chiese perciò pressantemente a Hilde di non nascondergli nemmeno le notizie più brutte. Quanto la stessa Hilde, nella Germania di Hitler, fosse tagliata fuori dal resto del mondo e quanto poco arrivasse fino a lei lo dimostrano fra l’altro gli anni di ritardo con cui apprese la notizia del suicidio di Walter a Portbou. Non passa inosservato – e anzi stupisce – che Georg Benjamin non vedesse alcuna necessità di riflettere sulla politica estera del PCUS. È chiaro che gli mancavano informazioni affidabili; e ci si chiede come avrebbero potuto raggiungerlo. Ma come avrebbe reagito alle parole dell’Internazionale comunista (Comintern), al giudizio secondo cui la rivoluzione in Germania, dopo l’avvento al potere del Partito nazionalsocialista nel 1933, fosse solo una questione di tempo? Ovvero: le masse proletarie scacceranno sicuramente il fascismo. Forse non volle credere alle forniture di armi dall’Unione Sovietica, con cui già all’epoca di Weimar e poi in seguito fu accelerato il riarmo della Germania. A meno che non trovasse giustificato ogni mezzo di alleggerire la difficile situazione economica e la miseria in Russia. Era evidente che lo stato fascista non si sarebbe accontentato del bottino costituito dai Sudeti e dall’Austria, conquistato in maniera incruenta. E il patto fra Hitler e Stalin, cos’altro era se non un segno del fatto che Hitler voleva avere mano libera per aggredire la Polonia, cosa che scatenò la Seconda guerra mondiale? Hilde si mostrò irritata e scrisse in questo senso a Georg. «Per molti compagni in Germania non fu facile comprendere subito il patto di non aggressione, e devo averlo anche accennato in una lettera». Georg rispose limitandosi al consiglio di non giudicare affrettatamente la questione. Il 17 settembre 1939, appena due settimane dopo l’attacco alla Polonia, scrisse: «Non te la prenderai se sulla dialettica non sono d’accordo con te. Questa, che in realtà è un metodo esplicativo e di pensiero, non è superiore qui alla nostra concezione ingenua. Credo che la migliore formazione hegeliana sia destinata a fallire quando manca una conoscenza sufficiente dei rapporti e dei fatti a cui si dovrebbe applicare il pensiero dialettico. Del resto, per quanto molte cose mi siano parse dapprincipio inattese, ora mi sembrano molto comprensibili e non più in contraddizione con il mio sapere ingenuo». Ci fu poi l’occasione di rivedere Georg e di parlare con lui, e anche Mischa poté essere presente. La pena carceraria di suo padre ebbe termine il 14 maggio 1942, non però il suo calvario. Prima di essere consegnato da Brandeburgo alla Gestapo poterono vedersi. Hilde andò a Brandeburgo, e finalmente Mischa fu in braccio a papà. Alla famigliola venne concessa un’ora buona insieme. Poi Georg fu portato a Berlino, alla prigione della Gestapo nella Prinz-AlbrechtStraße. Una telefonata anonima raggiunse Hilde due settimane dopo. Le fu detto che Georg era stato portato alla questura in Alexanderplatz. Apprese che si poteva consegnare là biancheria pulita in cambio di quella sporca, e così i familiari dei prigionieri stavano in lunga fila nel corridoio dell’edificio. In mezzo alla biancheria pulita era possibile infilare anche qualcosa da mangiare, e qualche piccolo messaggio. Sull’elenco della biancheria c’era sempre l’avvertimento: «Rischio di pidocchi, sterilizzare tutto». Nel biglietto del 30 maggio Hilde decifrò: «Procurati permesso visita. Manda posta». Sul secondo biglietto, una settimana dopo: «Manda per favore anche asciugamano, scacchi, pastiglie tosse o simili, finora impossibile scrivere lettere, riprova visita settimana prossima». E sul biglietto successivo: «Cibo e igiene qui assolutamente carenti, niente ore libere, affollamento terribile, tutti i popoli europei sono qui». Hilde riuscì a ottenere due volte il permesso di una visita. Il 28 giugno ricevette l’ultima lettera dalla questura: «Cara H. mentre ti scrivo non so se questa lettera riuscirà ad arrivarti. Sono destinato infatti a un trasporto verso il “Campo di educazione al lavoro di Wuhlheide” presso “Karlshorst”. [...] Anche se qui non sento parlare bene di Wuhlheide, sarà certo meglio del campo di concentramento; in genere a termine, pochi ebrei, e per questi nessun trattamento speciale, polizia e non SS. Sembra sia possibile mandare lettere e ricevere pacchi solo dopo sei settimane. Adesso devi cercare soprattutto di stabilire un contatto, forse in casi urgenti sono consentite addirittura visite? All’occasione potresti andare a parlare al dipartimento per la detenzione protettiva. Scoprire un po’ per volta che intenzioni hanno con me. Pur con tutte le cautele nel giudizio, voglio però vedere come positivo il fatto di non essere mandato in KZ, anche se ogni settimana parte un trasporto per Sachsenhausen. Comunque più probabile essere rilasciati da lì che dal KZ – per ora il cambiamento mi rende in ogni caso ottimista – e penso che ce la farò. Facendo un giro nella zona forse potresti trovarmi mentre sono al lavoro!? «Purtroppo non ho avuto finora tue notizie. Spero che il bambino stia bene, forse si è già rimesso in piedi? [...] Cordiali saluti a tutti gli amici, Opi, Omi, Utti. E un bacio a te e al bambino. Tuo marito. «In ogni caso assicurati al più tardi fra otto giorni, oppure – per sapere dov’è finito il pacco – anche prima, se sono già partito o no; nel caso non lo sia, forse è ancora possibile una visita urgente qui alla questura? «Nell’ultimo trasporto di evacuazione è stato portato via anche zio Ludw.? «Si dice che a Wuhlheide la maggioranza siano stranieri fuggiti dal lavoro che vengono “educati” là per qualche settimana, e poi rispediti ai loro posti di lavoro. Le condizioni igieniche dovrebbero essere buone, peggio di qui non è possibile». E adesso un salto nel presente. È il 30 dicembre 2011, l’anno sta per finire. Non c’è neve ma gelo, fino a venti gradi sotto zero. Come Hilde Benjamin quasi settant’anni fa, voglio compiere il tragitto con il treno urbano che lei fece per rivedere Georg. La sua meta era Wuhlheide. Con la sua descrizione esatta del luogo nel bagaglio, aspetto il treno. Più volte Hilde incontrò successivamente Georg di nascosto alla stazione di Wuhlheide, quando lui era assegnato al lavoro sui binari. Ho con me persino l’originale di uno schizzo a matita, tracciato decenni fa da Hilde Benjamin su un foglio di carta a righe strappato da un quaderno, quando studiava i paraggi della stazione. Proviene dall’armadio di Uschi Benjamin, dov’è conservato il lascito. Da Potsdam via Ostkreuz, con cambio sulla linea S3 in direzione di Wuhlheide passando per Rummelsburg e Karlshorst, mi attende una buona ora di viaggio. Sto accanto al binario della S-Bahn alla stazione di Potsdam, insieme ad altri passeggeri infreddoliti. A destra c’è un treno in attesa e a sinistra, annunciato sul tabellone elettronico, arrivo e partenza di un treno fra due minuti. Entrambi viaggiano nella mia direzione. Sui tabelloni che pendono dal soffitto della banchina coperta, la partenza del treno a destra è prevista invece fra dodici minuti. Davanti a me c’è un gruppetto di persone irrequiete. Russe. Non sanno quale treno devono prendere. Tre donne, cariche di bagagli. Una posa a terra il suo. Esita a rivolgersi a qualcuno, e alla fine si mette proprio davanti a me. Capisco subito una parola, per la quale lei impiega sicuramente tre «r»: «Berrrlin?». Poiché nel pronunciarla la voce si innalza, la prendo per una domanda e annuisco indicando la scritta che fino a poco fa segnalava due minuti e adesso invece scompare, annunciando il passaggio di un treno. I vagoni attraversano la stazione sferragliando, senza fermarsi. I tabelloni elettronici entrano di nuovo in movimento. Poi l’annuncio della S7 diretta a Ahrensfelde attraverso Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Ostbahnhof. Nel frattempo gli orari di partenza sono cambiati: su questo binario, dove poco fa c’era scritto due minuti, all’improvviso bisogna attenderne dodici. Dall’altra parte del binario la partenza del treno nella stessa direzione è annunciata invece fra due minuti. Il traffico dei treni urbani fra Potsdam e Berlino è sempre pieno di sorprese. Qualche conoscenza di russo ora sarebbe utile per avvisare le signore cariche di bagagli. Hilde Benjamin lo parlava perfettamente. Agitando le mani dirigo le tre donne al treno che fino a poco tempo fa era sbagliato e adesso è quello giusto. Ce la faccio: «Il treno è in partenza, attenzione alla chiusura delle porte!». Durante il mio viaggio con la S-Bahn verso il passato berlinese di Hilde Benjamin, è come se lei fosse qui con me. Si sarebbe stupita di sentire, accanto e dietro il mio posto al finestrino, una vivace conversazione in russo? A Potsdam c’è una grande colonia russa, come a Berlino. Raggiungo Wuhlheide e lascio il treno, come fece Hilde che molto tempo fa stette accanto a questo binario. Cercava di rintracciare Georg e di mettersi in contatto con lui. Sperava di trovarlo sul cantiere delle ferrovie, proprio di fronte alla banchina. Una telefonata anonima glielo aveva sussurrato. Mi siedo su una panchina e guardo nella direzione che nel suo schizzo viene indicata come la zona in cui lavorava Georg. A differenza di allora, vedo oggi solo binari ordinati, davanti a una fitta macchia di alberi e cespugli. Hilde Benjamin annotò la data esatta in cui ritrovò suo marito: era il 13 giugno 1942. Stava su un vagone merci carico di sabbia e portava «una specie di abito militare azzurro». Così scrive ancora Hilde: «Ero rimasta seduta a lungo accanto al binario, osservando la situazione: [...] ci vedemmo quasi nello stesso istante». Lui fece un segno con il braccio, gridò «là [...] e andai in quella direzione». Con grande precisione descrisse quel che avvenne dopo: «Parallelo alla banchina e ai binari dei treni passeggeri, separato solo da quelli dove passavano i treni a lunga percorrenza c’era un binario di manovra per treni merci. Dietro si stendevano cumuli di sabbia, con diverse rotaie per treni a vagonetti. Questi venivano riempiti di sabbia e poi rovesciati in vagoni merci, fermi sul binario di manovra. Venendo dalla stazione si doveva passare su un ponte che si stendeva sopra il corpo della stazione e a ciascuno dei cui lati, in un piccolo casotto, c’era un guardiano. Il ponte proseguiva, dapprima ancora rialzato, in una strada che si inoltrava nel bosco. Al di là della strada, su un terreno incolto, c’era la baracca del cantiere. Dietro la striscia incolta, piuttosto ampia, cominciava un boschetto». Hilde Benjamin scese lungo l’argine, evitò di avvicinarsi alla baracca dove pensava si trovasse personale di vigilanza, e attraversò il boschetto in modo da uscire all’altezza della banchina e del cantiere. Contemporaneamente si era mosso anche Georg, ed entrambi si diressero «verso un mucchio di traversine che ci nascondevano alla vista dal cantiere. Lui mi diede per prima cosa un biglietto: prendi intanto questo». E poi: «Scrivi sempre quello che ti dico. Hai con te da mangiare?». Nascose poi tutto sul suo corpo, e disse: «Torna la settimana prossima, e corse via». A quel punto Hilde poté leggere il biglietto che le aveva dato Georg: «Qualche breve informazione, casomai il tentativo riesca. Situazione qui brutta. Psicologicamente non mi lascio influenzare, anche se la mancanza di compagni non è facile. Condizioni in molti sensi simili a quello che si sente dire del KZ. Fisicamente è necessario l’impiego di tutte le mie energie. Non tanto per il lavoro, ma perché sonno e cibo non bastano. Per quel che sta a me, naturalmente resisto». Segnalava che sembrava possibile far avere «pacchi con cibo attraverso la questura sull’Alex». Non era del tutto certo però se li avrebbe ricevuti poi a Wuhlheide: «Quando voi potete farne a meno, alimenti concentrati: cose dolci, zucchero, grasso, uova o simili. Anche tabacco, però non attraverso Alex, perché non è consentito. Come oggi, se possibile magari una volta alla settimana, naturalmente facendo grande attenzione. E poi circa dieci marchi in banconote piccole. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 7-4 1/2, forse potresti seguirmi sulla strada del ritorno, senza farti notare! «Sali nel primo vagone, poi cercami. Mano destra alzata: momento buono. Mano sinistra alzata: possibile tentare. Mano in tasca: momento inopportuno. Pausa di mezzogiorno circa 12-12 1/2, ma anche prima o dopo. Nel caso non ci fosse tempo per parlare o troppo poco, porta con te lettera. Difficile poi da conservare, quindi non scrivere troppo! Ma anche per es. pane imburrato. Per favore anche un coltellino con lama non troppo piccola per il pane. «Ebrei solo 2 int., più 3/2, perciò poche misure dirette specialmente contro gli ebrei». Hilde Benjamin riuscì a incontrare là Georg una volta alla settimana, in seguito anche più spesso, quando si accordavano. Anche sua sorella e una compagna riuscirono, una volta ciascuna, a portargli da mangiare. Le informazioni sul campo di concentramento di Wuhlheide, che Georg aveva ricevuto durante i giorni di reclusione in questura all’Alex, erano esatte. Il Lager era un «campo di rieducazione» per lavoratori stranieri «insubordinati», che venivano portati là per qualche settimana. Ci si può all’incirca immaginare che cosa aspettasse i lavoratori forzati. Il Lager dipendeva dalle SS, ma era sorvegliato da poliziotti. I prigionieri erano impiegati in lavori sui binari delle ferrovie, assegnati per contratto a imprese edili di Berlino. Erano alloggiati in baracche nel quartiere di Lichtenberg. Queste sono state demolite da tempo, e là dove si trovavano c’è oggi una parte del parco zoologico. Biglietto del 20.07.1942: «Ricevuto il 18.07 ordine di detenzione protettiva, quindi andrò via di qui forse fra otto o dieci giorni. Probabilmente Sachsenhausen, via Alex. Se non mi vedi più cerca quindi di ottenere visite a Alex. Non mi dispiace il cambiamento. Il guardiano del ponte, fra punto ristoro e ponte, cioè dopo averlo attraversato, prende cose per baby papà. Quindi fai pacchetti piccoli e legati con lo spago, e anche lettera con indirizzo per baby papà. Come ricompensa va bene marmellata o qualcosa di grasso, ma devi contrattare. Fanno i turni in due, e sono brave persone. Ho nuotato nell’abbondanza per due giorni. È stato un grande aiuto. L’olandese, che potrebbe forse arrivare, ha incarico solo di consegnare e raccontare. Altri desideri: sapone e giornali nuovi, ma solo i principali. «Se come previsto Franz – un piccolo tedesco – verrà non è sicuro. Lavoro non troppo pesante, ma fisicamente molto faticoso per me». Biglietto del 26.7.1942: «Carissima moglie! «Spero che tutto continui a funzionare bene così direttamente. L’altra possibilità al momento è un po’ incerta. Non puoi immaginare quanto le cose mi aiutino. Non so se potrei resistere fisicamente senza. È stato tutto un’altra volta magnifico. Per ora niente più soldi, ma sigarette sì. Anche carte per adesso basta. Probabile che vada questa settimana all’Alex e poi in KZ. Spero che riesca ancora una visita all’Alex. Un motivo urgente si troverà pure. In ogni caso mi aspetto intanto qualcosa giovedì. «Se non arrivo subito, tieni d’occhio il sentiero. Io arrivo dalla parte dei binari. Potrebbe servirmi un po’ di tempo prima di potermi allontanare. Mi farebbe comodo una bottiglietta di Schnaps per uno a cui devo rendere un favore». Hilde osservò come il carattere degli incontri cambiasse sempre di più: «Georg era più disinvolto e tranquillo, direi quasi più sereno». Aveva inoltre l’impressione che stesse diventando un po’ più imprudente, e lo esortò quindi a fare attenzione. Soprattutto a non dare nell’occhio – il che non era facile sulla banchina poco utilizzata, con i treni della S-Bahn che viaggiavano sempre meno frequentemente. Il percorso passava poi regolarmente accanto al guardiano del ponte. Perciò Hilde indossava ogni volta qualcosa di diverso, «un cappello azzurro, senza cappello, un cappello bianco, un fazzoletto sulla testa». Si incontravano a cadenza quasi regolare, due volte alla settimana, e a quanto pare il mascheramento funzionava. Lei osò addirittura rivolgersi direttamente al guardiano, il quale disse di non averla mai vista in precedenza. Una volta prese con sé Mischa e fu perciò molto cauta. Avevano passato tutto il pomeriggio nelle vicinanze del cantiere. Da un chiosco osservavano la squadra degli operai che andava via e Georg, in fondo alla fila, marciava proprio davanti a loro. Il bambino vide il padre e pensò: «È molto diverso dagli altri, molto più sano». Gli altri si trascinavano, pelle e ossa, a piedi nudi e spingendo avanti un compagno che era crollato. Ci fu un incontro diretto? Hilde era convinta di no, a differenza di Mischa che ricordava esattamente di aver parlato con il padre. Biglietto del 30.7.1942: «Voglio proprio vedere se domani riesce, ora che la faccenda lassù in alto – naturalmente non a causa mia – si è fatta un po’ scottante. Intanto è forse l’ultima occasione, perché ritengo molto probabile finire venerdì mattina all’Alex e forse già sabato mattina a Sachsenhausen. Potresti cercarmi magari venerdì mattina, e se non ci fossi più tentare di ottenere una visita là a mezzogiorno? «Martedì cambio di personale, e non so se sarà ancora possibile un contatto diretto. Il guardiano del ponte potrebbe mandare un paio di pacchetti per il misuratore attraverso il caposquadra. Malgrado il trasferimento in KZ, sono contento di andarmene da qui! Puoi immaginare quindi che aspetto ha questo posto!». Hilde e Georg si videro in ogni caso, come deduco dal diario, i giorni 6, 8 e 10 agosto. «Tutte e tre le volte Georg ha oltrepassato l’argine, mi ha fatto segno di rimanere nel bosco ed è venuto». A quanto pare c’era un nuovo addetto. Lei tirò fuori l’insalata di patate, le polpette e il budino con le ciliegie, ed erano entrambi allegri nonostante lui le raccontasse che il giorno prima si erano verificate scene terribili. Gli ebrei erano stati accusati di far traffico di sigarette. Parlarono di nuovo della guerra. Georg calcolava che la fine del fascismo sarebbe arrivata nel giro di uno o due anni e le chiese preoccupato se sarebbe stata in grado di fargli avere ancora tanta roba da mangiare; grazie a quei supplementi di cibo si sentiva di nuovo bene e in forze. E accordarono di vedersi il mercoledì successivo. Ma il mercoledì successivo lei attese invano. Andò alla questura per sapere dove si trovava Georg. Questo fu il colloquio, che appena tornata Hilde annotò: «Suo marito è stato mandato in un campo di rieducazione. “E dov’è adesso? Durante l’ultima visita mi ha detto che sarebbe stato trasferito a Wuhlheide”. “Sì, è vero. È stato assegnato a una squadra di lavoro ma... a partire da...”. L’impiegato si è interrotto. Io: “è ancora là? Posso raggiungerlo da qualche parte?”. Dissi poi che dovevo almeno potergli scrivere, per via della scuola del bambino. “Non è possibile”. “Dov’è adesso?”. “Non posso dirlo”. “Nel trasporto?”. “Sì”. “Posso ritornare?”. “Sì, fra due settimane circa”». Bisognò attendere fino all’inizio di settembre, poi la certezza: Georg Benjamin era morto. Una comunicazione per posta militare delle SS raggiunse Hilde da Mauthausen. Il quartier generale del campo di concentramento di Mauthausen comunicava: «L’ebreo Georg Benjamin è morto il 26 agosto. Causa del decesso: suicidio per contatto con linea di alta tensione». Nel registro delle morti a Mauthausen è indicata la causa: «Suicidio per corrente ad alta tensione». Giorno e ora della morte: «26.8.1942, ore 1.30», in piena notte. Per posta Hilde ricevette inoltre il certificato di morte, il berretto, sei fazzoletti e un asciugamano. Estate 1942 – vita quotidiana in un paese e in un ambiente pieno di trappole, che in qualsiasi momento poteva finire in un vicolo cieco e mortale. Hilde Benjamin viveva seguendo una bussola interiore che il marito Georg aveva regolato. Continuò a frequentare i suoi amici ebrei. Non voleva farsi intimidire. Rimase dalla parte di quelli il cui unico «reato» era il fatto di essere ebrei. La «soluzione finale della questione ebraica» era stata decisa alla conferenza del Wannsee nel 1941 dai grigi funzionari lacchè della «razza padrona», sotto la direzione dell’Obersturmbannführe delle SS, Reinhard Heydrich. Da allora gli ebrei dovettero portare la stella gialla. Edith Fürst, che era ancora direttrice della colonia per bambini ebrei nell’Auguststraße, aveva sposato in carcere il detenuto ebreo Emanuel Bruck. Anche lei ricevette la notizia che suo marito era «deceduto» in campo di concentramento. Alla fine del 1942 gli impiegati della comunità ebraica di Berlino furono convocati nella Oranienburger Straße. La Gestapo selezionò chi doveva prepararsi al trasporto nei giorni successivi. Fra questi c’era anche Edith Fürst. Gli amici le consigliarono di nascondersi. Fu Hilde a procurarle da mangiare. La mise in contatto con Harald Poelchau, cappellano carcerario attivo nella resistenza antinazista, che la prese come domestica. Edith si chiamava ora Gertrud Heß. Hilde, sorvegliata dalla Gestapo in quanto comunista, era segretamente in contatto con lei e altri amici ebrei. Nascose le lettere di Edith, i suoi appunti e le sue fotografie nella cantina dell’appartamento dei genitori a Steglitz. Solo alla fine del 1944 anche Edith Heß/Bruck/Fürst fu scoperta dalla Gestapo. Sua sorella Rosa aveva lasciato la Germania al momento giusto. Edith finì nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück e sopravvisse. Nel 1943 Hilde riuscì a procurare una nuova identità a Gertrud Kolmar, la cugina di Walter, Georg e Dora Benjamin. Non poté tuttavia impedire che fosse costretta a prestare lavoro forzato in una fabbrica. Hilde ricordava con ammirazione e affetto la poetessa Gertrud Kolmar: «Una grande tranquillità e nello stesso tempo un’inquietudine interiore. Oscura, ma non cupa. Protetta dietro un muro di modestia e singolarità. Colori scuri e caldi la circondavano. Aspra, ma di un’amarezza mite. Distaccata, mai però fredda». Gertrud Kolmar consegnò a Hilde il manoscritto di una raccolta di poesie. A un certo punto la Gestapo scovò le sue tracce. La sua fine si chiama Auschwitz. Nel lascito fu trovata anche questa poesia: L’abbandonata Tu ti sbagli. Tu credi d’esserelontano e che io, assetata, non ti possapiùritrovare? Io ti catturo con i miei occhi, con questi occhi scuri, stellati. Ti attiro sotto queste mie palpebre, le chiudo salde e tu resti dentro,prigioniero. Comepuoiusciredaimiei pensieri, reti da caccia a cui nessuna selvaggina può sfuggire? Tu non mi lascerai più caderedallatuamano come un mazzo di fiori appassiti chevolagiùnellastrada, calpestato davanti alla casa, impolverato da tutti. Iotihoavutocaro.Tanto caro. Ho pianto tanto... con cocentipreghiere... e ti amo anche di più perchéhosoffertoperte, mentre la tua penna non mi ha scritto nessuna lettera,nessunamai. Ti chiamavo amico, signore e guardiano del faro sopra una sottile striscia insulare, tu, giardiniere del mio frutteto, e mille erano più saggi di te,manessunopiùgiusto. Ho sentito appena che il mioportos’èinfranto, il porto che custodiva – piccolo solo – la mia giovinezza e che essa gocciava giù, assorbitadallasabbia. Iostavoetiseguivoconlo sguardo. Il tuo passaggio è rimasto neimieigiorni come perdura in un vestito un dolce, sconosciutoprofumo che non si nota, si coglie appena purportandolosempre. La realtà quotidiana di Hilde, prima e dopo Georg, era il pensiero per le persone a lei vicine. Molte portavano la stella gialla che lei, l’«indiana», non dovette portare. Così nel 1939, poco prima che la guerra iniziasse, scrisse nel diario: «Ieri a Rahnsdorf ci siamo imbattuti nel cartello: Non sono graditi gli ebrei. Mischa ha chiesto cosa voleva dire. Poiché non eravamo soli ho risposto che glielo avrei spiegato a casa. Mentre faceva il bagno è ritornato sulla questione. Allora ne abbiamo parlato a lungo – alcune cose le conosceva, per esempio ebrei-ariani. “Hitler non può sopportare nemmeno te...?” e poi: “Perché non andiamo subito da Georg?”. Ha intuito da tempo cosa c’è dietro la storia del viaggio di suo padre in Sudamerica. Racconta poi una conversazione fra bambini. Lui aveva detto che Georg era “sul campo”». Hilde: «Ma puoi dire quello che sai, che è in Sudamerica». Lui: «O devo dire che è ebreo?». Alla fine del 1940 andavano a trovare spesso e volentieri i Rosenberg, parenti della famiglia Benjamin. «Le visite a queste persone intelligenti e buone erano molto piacevoli per noi due». Mischa si infilava subito nell’accogliente biblioteca e leggeva tutto quello che gli capitava fra le mani. E i Rosenberg furono preziosi anche per Hilde. La aiutarono a superare i primi terribili anni dopo l’arresto di Georg. Si tolsero la vita nel 1943, prima del trasporto nel Lager. Mischa Benjamin avvertiva sempre più nettamente di non avere il diritto di appartenere al mondo degli altri, e di essere escluso dai compagni di classe. Alle sue domande la madre trovava spesso risposte che lei stessa giudicava insufficienti. Un nuovo insegnante aveva chiesto quali padri servissero in guerra come soldati, o avessero servito in quella precedente. Mischa alzò la mano e raccontò che suo padre era stato ferito due volte e aveva la Croce di ferro. Fallì il tentativo di trasferire il figlio al Ginnasio francese, che aveva fama di essere tollerante verso i «meticci». Nel 1942 non fu più consentita l’iscrizione alle scuole superiori. Hilde divenne l’insegnante privata di Mischa. E l’amico Werner Wüste ricorda con profonda ammirazione che Mischa già nel 1948, a sedici anni, «superò brillantemente l’esame di maturità. Tanto valide erano state le lezioni di Hilde». Insieme al divieto della scuola arrivarono le notti dei bombardamenti. Il 20 luglio 1944 il fallito attentato a Hitler, la sconfitta dell’esercito tedesco a Stalingrado – cominciò la fase finale. Durante gli ultimi mesi di guerra morirono più persone e i bombardamenti distrussero più città che negli anni precedenti. Nel 1942 il padre di Hilde aveva acquistato un terreno per la figlia a Brieselang, un villaggio dietro Finkenkrug nello Havelland. Là non si sentivano gli allarmi antiaereo che a Berlino erano all’ordine del giorno. Hilde Benjamin, che per proteggere Mischa aveva ripreso a chiamarsi Hilde Lange, vi montò una tenda per i mesi estivi. Coltivavano l’orto e insieme alla sorella Ruth e al suo compagno costruirono un capanno. Là Hilde conservava le lettere di Georg, le poesie di Gertrud, le fotografie e gli appunti di Edith Fürst. Hilde era per Mischa come un faro che gli permetteva di orientarsi. Molte delle sue testimonianze rivelano una profonda gratitudine verso la madre, che non pensò mai di arrendersi. Quando Hilde Benjamin negli anni Cinquanta andò a Mauthausen con una delegazione ufficiale della DDR, il luogo era ancora in condizioni simili a quelle che gli americani avevano trovato nel 1945, al momento della liberazione. Avevano seppellito i cadaveri trovati all’interno del Lager. Le camere a gas erano state in attività fino agli ultimi giorni prima della liberazione. Hilde ebbe quasi l’impressione che tutto fosse successo appena il giorno prima. Anche se ho potuto incontrare Georg solo nelle sue lettere e nei ricordi di Hilde Benjamin, provo una sensazione di vicinanza. Come dev’essersi sentita lei durante la visita compiuta con la delegazione, mentre camminava lungo la strada all’interno del Lager? Ricordava il suo sguardo amichevole, la fronte alta, il naso fine, la sua umanità piena di gioia di vivere, il suo calore – la sua immagine, vicinissima? Forse pensava alla lettera del suo carissimo amico e compagno di prigionia nel carcere di Brandeburgo, che Hilde ricevette verso la fine del 1944. Mandata da Ernst Wüste, il quale fu liberato nel 1945: «Di recente, mentre passeggiavo di nuovo nel grande cortile dopo anni e vedevo comparire qua e là un viso noto, fui colto da un ricordo doloroso di Georg. Cosa vede il mio occhio esteriore? Muri di mattoni rossi, finestre munite di inferriate, un pezzetto d’orto in un quadrato racchiuso da una striscia di prato larga un metro, e il luminoso sentiero bianco con le lastre di pietra calcarea, tagliate irregolarmente. Come se nelle cose fosse rimasto racchiuso un pezzo della natura viva del mio buon compagno: ho provato una sensazione così strana. Ah, Hilde, quasi mi vergognavo di camminare ancora qui attorno. No, Georg, no, la traccia dei tuoi giorni sulla terra non scomparirà mai e io prometto di fare la mia parte perché nessuno la disperda. Quanto profondamente deve essersi impressa nel cuore della tua stirpe». L’amicizia dei padri diventerà l’amicizia dei figli, Werner Wüste e Mischa Benjamin. Quando Michael Benjamin improvvisamente muore dopo un’operazione all’ospedale della Charité, il 7 agosto 2000, è il figlio di Ernst Wüste che durante il rito funebre lascia percepire in ogni sua parola la perdita dell’amico. E considera anche «le madri, che si sono caricate di tutti i fardelli. Che furono le mediatrici fra i padri e noi». In questo ultimo cammino il cimitero è pieno di persone che vogliono porgere il loro addio. La guerra terminò e si poterono lasciare i rifugi antiaerei, dove Walter e Adele Lange con il nipote Michael e le due figlie Ruth e Hilde erano sopravvissuti alle settimane dei bombardamenti sopra Berlino e alla battaglia casa per casa. Era il 22 aprile 1945, e un pensiero accompagnava Hilde: dare infine un senso alla morte di Georg e con tutte le proprie forze contribuire alla costruzione dello stato antifascista degli operai e dei contadini. Capitolo ottavo Padre e figlio Hilde Benjamin riceve una trentina di lettere dalla prigione di Brandeburgo. Contengono anche poesiole bizzarre e divertenti per il figlio Mischa, scritte in occasione di compleanni o feste. In ogni riga delle lettere traspare il tentativo di trasformare la distanza dal figlio in una prossimità. Ogni parola è come un’amorosa carezza. E sempre appare lo sforzo fatto in prigione da Georg, che ha compiuto da poco i quarant’anni, per affrontare l’incubo e non mostrare debolezze. Dev’essere stato molto difficile per lui non poter offrire una protezione ai suoi cari. Tutta la responsabilità ricade su Hilde Benjamin. Già la formula «Cara moglie» in alcune delle lettere è un segnale della sua intima disperazione, mascherata attraverso uno stile particolarmente sobrio. Anche considerando che nelle file della sinistra era presente un grande numero di donne politicamente coscienti del proprio valore, da Rosa Luxemburg a Clara Zetkin, il maschilismo non è meno evidente che all’interno della destra borghese. Nei quaranta anni di esistenza della DDR ci furono due donne ministro: Hilde Benjamin e Margot Honecker. E nonostante tutte le leggi progressiste che garantivano la parità dei diritti colpisce vedere quante poche donne abbiano raggiunto in sostanza posizioni di comando. Il dibattito procede ancora oggi, nella Germania riunificata da tempo, e terminerà soltanto quando gli ostacoli psicologici, culturali ed economici saranno infine superati. Nelle sue lettere ed esternazioni Georg mostra di non rispondere quasi per nulla al ruolo maschile della sua epoca. Hilde Benjamin ha sempre evidenziato la sua disponibilità ad ascoltare, a far valere gli argomenti e a guadagnare nuovi punti di vista. È grazie a lei che le sue lettere si sono conservate. Per far sì che Mischa, non appena ebbe imparato a leggere, avesse un’immagine di suo padre Hilde trascrisse interamente in stampatello le lettere di Georg, che adoperava ancora il vecchio corsivo tedesco, in modo che il figlio riuscisse a leggerle. Rivolgendo indietro lo sguardo, mentre lavorava alla biografia del marito che pubblicò in forma di libro, Hilde trovava parole di ammirazione per «il suo equilibrio e la sua calma interiore, a cui si legava il coraggio della persona», come rivelano le sue lettere. Era «riservato e parco nell’espressione dei suoi sentimenti», e pieno di «un profondo amore e di una tenerezza schiva nei confronti di quelli che gli erano vicini». Affermazioni simili sono note anche da parte di amici: Georg viene descritto come un uomo onesto, aperto, equilibrato. Malgrado il suo talento e la sua grande cultura era il contrario di un intellettuale puro, ed era invece desideroso di trasformare i rapporti sociali. Sensibile, attento e modesto, offriva il suo aiuto dove poteva, cosa che gli procurò a Wedding il nomignolo di «San Giorgio». Hilde ricordava che un recluso poteva scrivere una lettera ogni due mesi: quattro pagine di normale carta da lettere a righe, con un terzo della prima pagina occupato dal «Regolamento» che disciplinava la corrispondenza, a cui i prigionieri si dovevano attenere. Dal 1942 fu consentito soltanto un foglio. La risposta doveva osservare la stessa misura. Poiché non aveva le copie delle proprie lettere, nella sua biografia Hilde non poté presentare una corrispondenza completa. Affidandosi alla memoria, al diario e ad altri appunti sul figlio Mischa riuscì però a trovare punti di contatto con quelle di Georg, tanto che è possibile ricostruire il contenuto delle sue lettere e, in seguito, di quelle scritte da Mischa. Tutto ciò mostra quanto Hilde e Georg Benjamin si sostenessero a vicenda in una situazione che entrambi giudicavano totalmente disperata, e accompagnata tuttavia dalla speranza che cambiasse. Le lettere di Hilde sono per Georg l’unico legame con la vita fuori dalle mura del carcere. Perciò descrivono minuziosamente ogni fase, ogni parola, ogni sviluppo di Mischa. «Le visite e le lettere avevano una grande importanza per Georg Benjamin» scrive Hilde. E osserva che il suo rapporto con il figlio era «indescrivibile in tutto il suo amore e la sua tenerezza». Quando Georg fu arrestato Mischa aveva tre anni. Era molto legato a lui «perché il padre, all’epoca disoccupato, assisteva i bambini nell’istituto della compagna Edith Fürst, e lui lo vedeva più spesso di me». Perciò sentiva molto consapevolmente la mancanza del padre. Quando gli spiegavo che era partito, lui rispondeva: «Ma potrebbe anche telefonare, vorrei sentirlo ridere». La stessa nostalgia provava il padre. A ogni visita Hilde doveva portare con sé una fotografia. Parlavano costantemente di Mischa, anche della sua educazione. In una delle sue prime lettere dal carcere Georg parla della «prepotenza» di Mischa all’asilo, e di come affrontarla. Il pensiero corre sempre al piccolo Mischa, che non ha ancora quattro anni, e gli fa formulare diagnosi a distanza. Nulla era altrettanto importante. E si vede anche quanto Georg sapesse immedesimarsi nella mentalità infantile. Mentre leggo la lettera mi viene da pensare subito a mio figlio e a un bambino un po’ irruente che l’aveva spaventato. Nel campo giochi, fra le buche di sabbia, era scoppiato più di un litigio. E, quanto a Mischa, sua madre aveva fatto capire più o meno chiaramente che era uno dei più irruenti. Georg riprese un accenno che Hilde deve aver fatto in una lettera e consigliò di parlare sempre con i bambini, quando si arrivava alle botte e alle zuffe. Anche se non escludeva che le «botte», e lo prova il modo in cui le bambine trattano le loro bambole, possano essere un istinto primario. E in un’epoca in cui sia a casa che a scuola la bacchetta e gli sculaccioni erano del tutto normali, Georg era convinto che bisognasse combattere la stupidità di usare la violenza fisica come una misura pedagogica o anche spinti dall’ira, soprattutto verso bambini tanto piccoli. Quando inizia a scontare la sua pena nel carcere di Brandeburgo, Georg Benjamin esprime a Hilde due desideri, il cui esaudimento spera possa alleviare la sua situazione: portare sempre una foto di Mischa durante le visite, e tenere un diario. Modello per questo erano le lettere di Hilde all’amica Dora, sorella di Georg, emigrata come Walter dalla Germania nel 1933 e che lei aggiorna regolarmente sulla loro vita a Berlino e sul destino del fratello. Hilde annota coscienziosamente tutto, come desiderava Georg, e glielo trasmette. In questo modo lui può seguirlo crescere in tutto e per tutto. In occasione del suo quarto compleanno, nel dicembre 1936, Georg compone versi vivaci per un libro illustrato: «Andiamo allo zoo». Descrive quasi solo animali che il bambino possiede come statuine di legno. Qui guarda, oh meraviglia: saltellanolescimmiette, unatifaunasmorfia, un’altra allunga il braccio: vuolelozuccherino. Edeccolelaggiù edeccolelassù, volteggianoscatenate esempreallegreeliete sonlescimmietteallozoo. Già all’epoca della detenzione protettiva Georg scrisse versi per un libro illustrato sugli animali e la vita nella foresta. Hilde aveva il compito di ritagliare le figurine che si trovavano nei pacchetti di sigarette o disegnare lei stessa le immagini, ricopiare in bella il testo e rilegarlo. I libri, così fatti, purtroppo non si sono conservati. Per Pentecoste Mischa vuole mandare al padre una cartolina fatta da lui, sulla quale si vedono dei fiori che Hilde ha disegnato secondo le sue istruzioni e che lui poi ha colorato. E dice: «Forse anche Georg mi manda i fiori del suo giardino! Cioè dell’ospedale dove lavora». Solo a poco a poco Hilde si ricorda che alla domanda di Mischa, tre settimane prima, aveva risposto che Georg lavorava in un grande ospedale, dove c’erano molti malati. Poiché in seguito non vi accennò più, Hilde chiese notizie a Edith Fürst, la quale ricorda di avergli sentito raccontare la stessa cosa. Continuamente si chiede quando potrà dire a Mischa la verità. Per il momento non riesce a prendere una decisione chiara. Quindi non resta che raccontare nella sua cella a Georg, nella maniera più colorita possibile, quel che Mischa dice, pensa, come cresce, e mantenere viva la speranza che un giorno ci sarà una via d’uscita. Georg siede dunque dietro le spesse mura del carcere di Brandeburgo e maschera il proprio isolamento con le sue fantasiose favole, che condivide con Mischa. Le sue lettere sono inoltre l’unico mezzo di cui dispone per aiutare la moglie e il figlio a resistere là fuori. Devono far vedere che anche lui è forte abbastanza da superare questa prova inumana. Ciò conduce all’intero strumentario di storie eccitanti, poesiole per libri illustrati, rime sugli animali e presto anche indovinelli, e quando Hilde gli insegna a giocare a scacchi si aggiungono i relativi quesiti. Questi sono i regali per il figlio, di cui dispone in abbondanza. Mischa – e Hilde lo racconta non senza orgoglio – è un ometto intelligente che molto presto, a cinque anni, sa già leggere. Cosa a cui allude questa lettera del febbraio 1939: Mio caro Maestro Mischa! Presto potrò scrivere «caro scolaro» e presto tu potrai scrivermi con l’inchiostro. Il tuo disegno per Natale mi ha fatto molto felice. Quello che non mi piace è però che a volte continui a buttarti a terra; i bambini così grandi in genere non lo fanno. Allora neanche a te succederà più? – Ci vai mai su e giù per il mondo? Prova ad andare una volta da Amburgo a Shanghai, in Cina; prima per nave: attraverso quali mari? e poi con il treno: attraverso quali paesi? E come si potrebbe viaggiare più in fretta? E per finire un indovinello: L’uccello ce l’ha e pure il cappello in mano per scrivere la prendi... Fraituoigiocattolicerca lacodadiunafreccia. Salutoniebacioni TUO GEORG Stimolato evidentemente da questa lettera nasce un gioco di viaggio, chiamato «Visita a Georg». Mischa vi recita una doppia parte: la propria e quella di Georg. Il figlio va in nave a trovare suo padre. Per Natale e per il compleanno, il 27 dicembre 1938, aveva ricevuto un mappamondo e un libro intitolato «Thomas scrive dal Messico». Tutto questo è scritto nel diario per non dimenticare nemmeno un minuto insieme a Mischa, perché Georg possa essere vicino al figlio e viceversa. Hilde, che nel gioco degli indiani è l’«amico bianco», in questo viaggio avrà rischiato più volte di perdere la calma. Chi può resistere a una cosa del genere, senza commuoversi per la nostalgia del proprio figlio? Come riesce Hilde, nel gioco, a tenere sotto controllo la sua stessa nostalgia? Come si vive quando svanisce la speranza di uscire dal tunnel? Resistere, quindi, andare avanti. Leggere le lettere di Georg e sentirvi l’eco dell’ultima visita, come in questa: «E poi le foto che adesso ho guardato con calma. Sono davvero bellissime». Segue un complimento alla fotografa: «Trovo che quella in cui è seduto sulla sabbia non sia da meno delle altre: così nitida – decisamente più nitida delle altre, probabilmente la distanza e la luce erano regolate molto bene – e soprattutto espressiva. [...] Avrei ancora un desiderio: che naturalmente tu non parlassi solo del bambino, ma anche di te». Alla fine della lettera, scritta nell’autunno 1936, Georg ritorna sull’osservazione di Hilde, cioè sulla grande timidezza di Mischa, e ricorda di essere stato anche lui «molto timido, fino in età scolastica». Poi affronta nuovamente la questione se sia giusto ricordare a Mischa il padre attraverso i suoi regali e le lettere. «Ho già scritto la volta scorsa che con il tempo, inevitabilmente, il suo ricordo di me in parte sbiadirà, in parte prenderà un carattere “leggendario”, non meno irreale, il che intanto sarebbe una buona cosa». Fino a quando Mischa inizia la scuola Georg scambia una dozzina abbondante di lettere con il bambino, che con stupore del padre sapeva scrivere e descrivere in maniera sempre più efficace. Georg è «sbalordito» dalla rapidità con cui Mischa impara, e continua a manifestare la sua meraviglia per l’esattezza e l’ottimo livello di espressione. Il 24 aprile 1939 Hilde Benjamin scrive nel suo diario: «Si è svegliato raggiante: oggi ho sognato che Georg ritornava. Non era per niente cambiato». Poi annota: «Quando sento la parola “arresto”, non posso fare a meno di pensare a Georg». E nel diario dell’agosto 1939 si trova questa annotazione: «Una volta ho detto che nei nostri cuori noi due sapevamo di essere uniti, e lui ha corretto: “Noi tre!”». Di lettera in lettera e di anno in anno il dialogo scritto diventa più ricco. Questo vale non solo per la coppia. Quanto più Mischa diventa capace di capire, tanto più Georg gli è grato per ogni cosa che dice. Ma si avvicina anche il momento in cui sarà possibile svelare al figlio l’autentica situazione del padre. Lo si deduce da una lettera del marzo 1940, in cui Georg si mostra felice per l’«autonomia» del bambino: «E lo lasci già viaggiare da solo sul tram». Critiche sulla sua educazione e sulla vita di Hilde non gli vengono in mente, «perché finora hai superato benissimo tutte le grandi e piccole difficoltà». Orgoglio anche per Mischa: «Scrive quasi senza errori e in uno stile perfetto e, per quanto riguarda il contenuto [...], sempre più ricco». E poi il consiglio medico: «Cambio dei denti: aspettare la terapia. I primi molari permanenti ci sono già; arrivano prima del cambio dei denti, come sesti in ogni emimandibola». E infine il cenno pensoso: «Su come far comprendere al bambino la mia situazione vorrei farti una proposta alla tua prossima visita». E il papà orgoglioso, nell’eventualità che la scuola non offra abbastanza stimoli: «Altrimenti in materie in cui non saresti d’intralcio – per esempio scienze naturali, geografia o scacchi – potresti dargli tu un’ora di lezione. È nell’età in cui si impara più in fretta». La lettera termina con alcune righe per Mischa: Mio caro appassionato delle racchette da neve! A Berlino non si sono visti quasi mai tanto ghiaccio e neve come quest’anno. E tu hai potuto imparare bene ad andare con le racchette e i pattini! Presto arriverà la pagella; scrivimi i tuoi voti. Andate a scuola adesso o è ancora chiusa per il freddo? E presto potrai andare di nuovo a nuotare e farti promuovere anche dal maestro di nuoto? Io ce l’ho fatta solo a dieci o a undici anni! – Penso di avere trovato la risposta giusta al tuo indovinello: le onde. Eccone uno nuovo per te: Quale giocattolo gira e si avvolge, viene dall’albero ma non ha foglie eanchelamammalousa? E poi una «frase magica»: leggila prima dall’inizio: Itopinonavevanonipoti. E poi leggila all’incontrario e scrivi cosa viene fuori. TUO GEORG «Nel frattempo è scoppiata la guerra» scrive Hilde nel suo diario: «Nei primi giorni lui era molto impressionato, agitato e nervoso. Specialmente perché al primo allarme io non ero a casa. Si è calmato dopo qualche giorno. Questa è stata la sua spontanea affermazione: sono così contento che Georg non è qui. Segue l’avanzata delle truppe e punta bandierine. Durante l’allarme notturno è stato molto ragionevole, si è vestito da solo e continuava a dire che non aveva paura. A scuola hanno modellato aeroplanini con l’argilla. Il suo a quanto pare era il migliore e gli è stato permesso di mostrarlo a tutti gli altri bambini. A casa ne ha fatto poi un altro e io sono rimasta sorpresa dalle sue doti di osservazione. Nell’autunno 1941, quando gli allarmi si sono intensificati, è comparsa una serie di disturbi nervosi – nessuna paura – che abbiamo superato andando a letto presto, con un sonnellino al pomeriggio e giornate il più regolate possibile». Il consiglio che Georg diede a sua moglie durante la successiva visita si può dedurre dall’ultima lettera inviata a Hilde e Mischa da Brandeburgo. Entrambi avevano discusso a voce la questione e si erano poi intesi sui tempi e il modo: nel dicembre 1941 Hilde racconta al bambino «la verità sul destino di suo padre». E Georg scrive a Mischa: «Sono molto contento che Hilde abbia potuto raccontarti tutto su di me, perché ormai sei abbastanza grande e giudizioso per capire molte cose che prima non ti si potevano dire. Naturalmente sono sempre felice di ricevere le tue lettere». Riflessioni su Georg. La sua sensibilità pedagogica e liberale, le sue affettuose lettere al figlio. Le sue rime, i suoi indovinelli e i problemi scacchistici – tutto ciò dice molto sulla sua generosità, la sua attitudine a riflettere e il suo atteggiamento antidogmatico. Gli amici sottolineano sempre la sua pazienza e tolleranza. L’essersi dedicato anima e corpo al suo lavoro di medico scolastico, il dolore provato di fronte all’ingiustizia e alla discriminazione sociale; tutto ciò fondava le sue posizioni di sinistra. Ogni riga mostra la sua intelligenza, che Hilde apprezzava tanto quanto la sua mente aperta all’emotività e il suo amore per il prossimo. E nonostante abbia sofferto nelle prigioni della Germania nazista ogni bassezza di cui sono capaci, o a cui vengono condotti, gli esseri umani fuorviati. Hilde Benjamin riceve posta da Mauthausen e il certificato di morte di Georg. Contiene la notizia, registrata presso l’anagrafe II numero 5348 / 1942: «Il medico Israel Georg Benjamin – senza fede (in precedenza mosaica) – residente a Berlino – Pankow – Binzstraße 50 – è morto il 26 agosto 1942 alle ore 1:30 a Mauthausen. Il defunto era nato il 30 settembre 1895 a Berlino. Padre: Emil Benjamin, defunto. Madre: Pauline, nata Schönflies, defunta. Il defunto era sposato con Hilde, nata Lange, residente a Berlino – Steglitz, Dünterstraße 7 – Mauthauen, 23 novembre 1942». Hilde annota la reazione di Mischa a questa notizia. Pianissimo, quasi in un soffio, percepisce le sue parole: «Me lo sono sempre aspettato». Hilde avrà ripensato anche a quel momento, durante il suo viaggio a Mauthausen dopo la guerra e mentre camminava lungo la strada all’interno del Lager. Avrà avuto davanti agli occhi il marito che aveva abbracciato alla stazione della S-Bahn di Wuhlheide, il 10 agosto 1942, due settimane prima che venisse ucciso. Senza immaginare che sarebbe stato il sempre temuto ultimo abbraccio. Senza sapere che nel gennaio di quell’anno, il 1942, in una villa al Wannsee alcuni alti funzionari del Ministero degli Interni, della Giustizia e dell’Ufficio centrale per la Sicurezza del Reich stabilivano il piano di sterminio autorizzato dallo stato, la «soluzione finale della questione ebraica». Nel suo ultimo biglietto Georg Benjamin aveva parlato di un pogrom nel Lager esterno di Wuhlheide, contro i compagni di prigionia ebrei: «Sono state scene terribili». A lui era successo relativamente poco. E aveva la speranza di poter rimanere ancora un po’ perché venerdì, il giorno del trasporto, non era stato trasferito. Faceva conto di rimanere ancora. C’era un ennesimo nuovo addetto. Aveva già parlato a lungo con lui. Nel suo diario Hilde Benjamin annotò il contenuto del biglietto che lui le aveva dato di nascosto nei rapidi istanti del loro incontro lungo il binario, e che sarebbe stato anche l’ultimo, descritto come un pezzo di carta strappato da un taccuino, mentre altri erano scarabocchiati su moduli con la scritta «Storia clinica». Mesi dopo la raggiunse la notizia della fine. Era sopravvissuto a Mauthausen appena pochi giorni, prima di finire braccato nella morte, riducendosi a un puro nome nello schedario della direzione del Lager. Quanto dev’essere stata difficile per lei la visita a Mauthausen, pochi anni dopo la liberazione del KZ da parte dell’esercito americano. Eccola nel campo di sterminio, mentre ricorda forse l’ultimo incontro con lui. Si erano già salutati e Hilde ritornò alla stazione della S-Bahn; da lì era ben visibile la sua postazione di lavoro, proprio di fronte: «Poi mi sedetti lungo il binario e lui mi mostrò le sue arti. Saltò dal vagone in movimento e azionò lo scambio. (In seguito pensai: se solo fosse caduto, forse questo gli avrebbe salvato la vita). Manovrava avanti e indietro una piccola locomotiva elettrica. Ora faceva un cenno con la mano dall’alto della locomotiva, ora passava da un vagone all’altro, sempre più lontano da me. Sul terrapieno della ferrovia, in mezzo ai boschi, era sospesa la foschia del mezzogiorno che annunciava un temporale. Lo distinsi a stento mentre si toglieva il berretto, si passava la mano sui capelli, stringeva le mani in segno di ringraziamento. Il treno scomparve nella foschia, e non si vide più. Io mi consolavo: mercoledì. Ma il mercoledì aspettai invano». Capitolo nono Dietro le mura Bautzen, città dell’Oberlausitz, mille anni di storia nonché centro della minoranza slava dei Sorbi. Ma Bautzen vuol dire anche Gestapo, KGB, Stasi, vuol dire muri e celle. Il nome Bautzen ha due significati: l’uno è la città, l’altro è la prigione, costruita in origine come riformatorio. Bautzen e la prigione, ovvero vittime e carnefici. Dentro e fuori, il carcere viene chiamato lo «squallore giallo». Così detto per via del clinker di questo colore che lo ricopre esternamente. Ma è soprattutto Bautzen II, un’ala di alta sicurezza situata ai margini della città, a far rabbrividire quando si parla di questo luogo. Oggi Bautzen II è un memoriale, ed era un luogo tristemente noto già in epoca nazista. Qui fu detenuto il segretario del KPD, Ernst Thälmann, prima di essere ammazzato nel campo di concentramento di Buchenwald. La sua cella si è conservata e all’epoca della DDR doveva ricordare le persecuzioni attuate dai nazisti. Fra il 1945 e il 1956 furono registrati a Bautzen circa 27.000 prigionieri, soprattutto ex criminali nazisti. La forza occupante sovietica seguiva le risoluzioni prese a Potsdam dalle potenze vincitrici. Nel difficile inverno 1946-47 la fame all’interno corrispose alla miseria del dopoguerra all’esterno. Fino alla consegna del carcere alla DDR, nel 1956, vi morirono circa 3.000 prigionieri. Nel 1950, per ordine della Commissione di controllo sovietica i campi di internamento di Buchenwald, Sachsenhausen e Bautzen furono chiusi e i 3.432 prigionieri, insieme ai fascicoli di inchiesta contro di loro, furono consegnati alle autorità giudiziarie della DDR. Le corti si riunirono nella cittadina di Waldheim, entrando nella storia giudiziaria della DDR come «processi di Waldheim». Furono «procedimenti lampo», quasi del tutto privi dei formali requisiti giuridici. Le accuse furono trattate in tre mesi e i verdetti emessi a intervalli di un’ora l’uno dall’altro. Ciò suscitò violente critiche nei media occidentali, soprattutto nella Repubblica Federale Tedesca. Ci furono trentadue condanne a morte, ventiquattro delle quali furono eseguite. Vennero inflitti inoltre 146 ergastoli e 2.745 pene detentive superiori ai dieci anni. I processi di Waldheim sono visti ancora oggi come la prova dell’arbitrarietà della giustizia nella DDR. Tuttavia non ci si domanda mai quali persone sedessero là sul banco degli imputati e se si trattasse davvero delle vittime innocenti di una giustizia arbitraria. Si tace per esempio che la DDR, dopo la revisione dei verdetti, nel 1952 aveva già rilasciato dal carcere mille detenuti e che nuovi procedimenti di grazia si susseguivano ogni anno, tanto che nel 1956 vi erano detenuti solo trentacinque alti gerarchi nazisti. Gli ultimi due furono rilasciati nel 1964. Allo stesso modo, quasi nessuno si dà pena di leggere le trecentocinquanta pagine della richiesta di rinvio a giudizio: i condannati a morte erano in maggioranza giuristi nazisti che in passato erano stati attivi presso il Volksgerichtshof, in tribunali di guerra o speciali. Tutti, senza eccezione, avevano emesso dubbie condanne a morte, alcune contro individui singoli, alcune contro dozzine o centinaia di persone. Lo stesso vale per gli esponenti delle SS e della Gestapo, seduti sul banco degli imputati durante i processi di Waldheim. Le modalità di deduzione delle prove, giudicate carenti, seguivano il diritto speciale degli alleati, in vigore anche nelle zone occidentali. La storia di Bautzen al tempo della DDR comincia con i prigionieri speciali che dall’agosto 1956 furono trasferiti nel carcere speciale Bautzen II del Ministero per la Sicurezza di Stato. Il detenuto e scrittore Erich Loest definì la prigione il «kombinat della giustizia» della DDR. La sua descrizione della prigionia a Bautzen II è estremamente sobria. Ma in ogni riga, in ogni parola risuona la ferita che gli era stata inferta con la condanna a sette anni e mezzo di detenzione in quanto «controrivoluzionario». A Bautzen incontrò Walter Janka, direttore della casa editrice Aufbau, e Wolfgang Harich, suo vicedirettore, e inoltre Gustav Just, caporedattore del settimanale «Sonntag», appartenente alla casa editrice: nel 1957, accusati di «cospirazione controrivoluzionaria», erano stati condannati come «gruppo Marich» a cinque anni di reclusione. Erich Loest: «Siamo sempre stati convinti che si trattasse di un pubblico errore». E in un’intervista alla radio aggiunse: «Mio Dio, volevamo qualche miglioramento, volevamo un socialismo migliore e perciò questi idioti ci hanno rinchiusi. Nei primi tempi la cosa bruciava parecchio, io avevo fatto più di un anno di carcerazione preventiva e me ne aspettavo tre». Sulla base delle loro discussioni Harich aveva messo per iscritto la «piattaforma per la speciale via tedesca verso il socialismo», provocando l’accusa di controrivoluzione. Loest e Walter Janka facevano parte di quelli che, in quanto comunisti, erano già stati rinchiusi a Bautzen dai nazisti, prima che Loest finisse nel Lager di Sachsenhausen. Ormai è possibile dar vita anche a un’altra immagine. La città cerca di staccarsi sempre più dall’immagine fatta di mura e prigione, di infamia e perversità umana. Qui non si tratta di allontanarsi dalla storia della città, quanto di elaborarla. Oggi la prigione della Stasi di Bautzen II è un memoriale dell’epoca successiva al 1945, inaugurato alla metà degli anni Novanta. Anche la storia prima del 1945 deve diventare parte del memoriale, ma il tempo per questo non è ancora venuto. Bautzen, che in sorbo si chiama Budyšin, si apre adesso a una nuova vita. Invita a trascorrervi del tempo. Segnano il suo profilo la città vecchia, appena ristrutturata, le testimonianze della sua origine barocca e Biedermeier, così come le torri che sovrastano la città fin dal Medioevo. Bautzen ha molti musei, fra cui uno dedicato alla storia della famosa senape di Bautzen. Anche i Sorbi hanno un loro museo. Durante il nazismo furono vessati e discriminati, in quanto minoranza slava. Tutto questo ormai è passato. Oggi, quanto meno, ogni cartello stradale è in due lingue. E con il Teatro popolare tedesco-sorbo la città sulla Sprea possiede l’unico teatro bilingue della Germania. Ero stato invitato in occasione del ventiduesimo BautzenForum della Fondazione Friedrich Ebert, che nel maggio 2011 era dedicato alla costruzione del muro e alla separazione, marcata dal cemento, dei due stati tedeschi. Vi incontrai anche alcuni ex prigionieri. Fin dall’apertura della conferenza si poté avvertire quanto fossero ancora vive le loro dolorose esperienze. Bautzen potrebbe essere un luogo della memoria nazionale. La sua storia è costituita in misura rilevante dalla catastrofe seguita al 1933, ed è insieme parte di un capitolo oscuro nella storia della DDR. Non c’erano e non ci sono scusanti per Bautzen, né per il periodo precedente né per quello seguente il 1945. Dopo la capitolazione Bautzen divenne il «Lager speciale 4» dell’NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich del, Commissariato del popolo per gli affari interni), cioè la polizia segreta sovietica. La guerra scatenata dai nazisti aveva portato all’Unione Sovietica una violenza inimmaginabile; la Wehrmacht e le truppe speciali naziste misero a ferro e a fuoco il paese, innumerevoli città e villaggi furono rasi al suolo, le vittime delle unità speciali tedesche sotterrate in fosse comuni. L’Armata Rossa lamentava la perdita di milioni di soldati. Solo in Unione Sovietica i morti furono trenta milioni. Il tribunale militare nella zona di occupazione sovietica condannò in massa alla reclusione nei campi di lavoro nelle distese siberiane gli ex funzionari nazisti e quanti venivano giudicati tali. Si trovarono là quasi in funzione di rappresentanza per la valanga di miseria e colpa che gli ideologi della razza avevano lasciato dietro di sé. La Russia aveva bisogno di forza lavoro. Nel 1951 la prigione di Bautzen fu restituita alla DDR, e nel 1956 Bautzen II fu sottoposta alla Stasi. Questa controllava le opinioni nel paese, cosa che contribuì allo stravolgimento della DDR e finì poi per distruggerla. Dal canto suo la Stasi vedeva invece la propria azione come un’autodifesa contro l’attività di spionaggio dell’Occidente, intesa a minare la DDR. Chi in queste zone grigie ai margini della legalità veniva smascherato come agente o spia finiva ugualmente a Bautzen. In effetti il controspionaggio non fu mai l’unico compito della Stasi. Nella realtà la «ditta» del compagno Erich Mielke destabilizzò soprattutto il proprio stato, del quale avrebbe voluto essere «lo scudo e la spada». Al Bautzen-Forum della Fondazione Friedrich Ebert, arrivato nel frattempo alla sua ventiduesima edizione, si susseguono i racconti. Per molti non è facile vedere le proprie sofferenze, causate dalla DDR, come parte di una storia comune e di una comune narrazione tedesca, ed è certo comprensibile che gli ex prigionieri di Bautzen ricordino innanzitutto cosa poteva succedere in uno stato socialista di lavoratori e contadini quando si voleva fare uso della «libertà d’opinione garantita». È nuovamente fallito al Forum 2011 il tentativo di creare un collegamento fra la storia precedente il 1945 e le esperienze individuali all’epoca della divisione delle due Germanie, poiché queste ultime – inclusa la divisione stessa – derivavano da ciò che le aveva precedute. La chiusura suggellata dal muro il 13 agosto 1961 viene discussa al Forum e si cerca una risposta alla domanda perché la DDR abbia in definitiva fallito, sebbene la via di fuga verso Occidente fosse stata in quel modo bloccata. Abbattere il muro da Occidente non sarebbe stato possibile. Su questo tutti concordano: avrebbe condotto a una nuova guerra. E divenne così una guerra fredda. Vi ebbe la sua parte l’esortazione a «votare con i piedi», che fino al 13 agosto 1961 si poteva leggere quotidianamente nella stampa della Repubblica Federale. Ciò a sua volta fu significativamente un esito delle massicce ingerenze nel diritto di autodeterminazione dei cittadini nella DDR. L’inesorabile trasformazione delle imprese familiari contadine in cooperative agricole condusse a esodi massicci – e di conseguenza a grandi problemi negli approvvigionamenti. Il crescente flusso di profughi da Est a Ovest e lo spopolamento della DDR indussero Berlino Est e Mosca a chiudere i cancelli. Una precoce fine della DDR era così temporaneamente sventata. Il muro concluse l’esodo della popolazione nel secondo stato della nazione tedesca. Gettò Bonn e i vertici del Senato di Berlino Ovest in una crisi esistenzialpolitica, spingendo molti a Oriente e a Occidente in un profondo scoramento. Con il muro la situazione di Berlino Ovest era diventata ancora più difficile. Questo e, in seguito, la temporanea e vessatoria chiusura delle vie di transito furono tuttavia negli anni successivi lo spunto per riaffrontare politicamente il problema su come il peso della divisione potesse essere alleggerito per la gente. Era di questo che si occupava il Forum 2011. In Occidente il motto di Egon Bahr, «avvicinarsi per cambiare», segnò un cambiamento nel modo di pensare. Si arriva così più o meno all’anno in cui i bicchieri tintinnavano nell’ufficio di Hilde Benjamin, mentre i suoi collaboratori brindavano. Le stazioni della sua vita, raccolte in trenta capitoli e consegnate nella scatola ornata, riportano all’inizio, quando i primi carrarmati dell’Armata Rossa avanzavano attraverso la capitale tedesca devastata e Hilde e Michael poterono lasciare finalmente il rifugio antiaereo. Quattro giorni dopo la resa incondizionata dello stato hitleriano finiscono per lei dodici anni di paura e isolamento e il divieto di esercitare la propria professione. Non nella raccolta ufficiale, ma nel diario di Hilde Benjamin leggo: «Il 12 maggio 1945 – un sabato – vengo portata in tutta fretta al municipio. Il comandante voleva parlarmi. Mi veniva chiesto di organizzare il tribunale per il quartiere di Steglitz, entro lunedì mattina bisognava aver risolto la questione degli spazi e aver trovato anche i giudici». Dovevano essere giudici con una formazione regolare. Non però ex membri del partito o appartenenti a un’organizzazione nazista. Fin quando americani, britannici e francesi non entrarono nella città che sarebbe stata divisa in quattro settori, l’Armata Rossa ebbe per breve tempo la sovranità amministrativa su tutta Berlino. Hilde non descrive come si incamminò attraverso quel paesaggio di rovine per raggiungere la pretura di Steglitz. Forse fu la parte più faticosa dell’incarico. Conosceva in ogni caso la strada già molto tempo prima che la città fosse bombardata. Vi aveva lavorato all’epoca in cui era praticante procuratrice. Finalmente arrivata, si ritrovò di fronte un edificio intatto. E alla domanda se conoscesse i giudici, il portinaio di servizio diede la sconcertante risposta: «Sì, i signori hanno messo qui la loro firma ogni giorno!». Risultò che nelle pause fra i bombardamenti degli alleati i giudici avevano seguito la disposizione del presidente della corte d’appello, che li invitava a presentarsi in un tribunale nelle vicinanze, nel caso in cui non avessero potuto raggiungere il proprio ufficio. Il collegio dei giudici era apparso quindi «in servizio» ogni giorno, in orari non prevedibili, e aveva scritto il proprio nome in una lista. Fu Hilde Benjamin a separare il grano dal loglio e a scartare quelli con cui non credeva si potesse costruire uno stato socialista. Si fece consegnare le liste contenenti i nomi dei membri del Partito nazionalsocialista, indagò presso il portinaio e i dattilografi per cercare di capire quali fossero i magistrati dal passato pulito, che come giudici tutelari o del registro si erano tenuti il più possibile ai margini della giustizia nazista. E descrisse tutto questo vent’anni più tardi, nelle sue memorie: «Mi vedo ancora oggi mentre, fra l’attenzione generale, mi dirigo al comando con un gruppo di anziani signori!». I candidati da lei selezionati vennero sottoposti a nuovo esame, e il tribunale distrettuale di Steglitz poté riprendere poco tempo dopo il suo lavoro con tre giudici recentemente designati. Lei stessa fu nominata procuratrice. Il capo dell’amministrazione militare sovietica e comandante supremo delle truppe sovietiche in Germania, maresciallo Žukov, emanò il 4 settembre 1945 l’ordine n. 49 sulla riorganizzazione dei tribunali tedeschi nelle province della zona occupata dalle truppe sovietiche. Una copia dell’ordine si trova su una delle cento pagine che i collaboratori di Hilde Benjamin al Ministero della Giustizia hanno raccolto per lei. Vi si dice: «Al fine di eliminare le differenze nell’organizzazione dell’attività delle autorità giudiziarie tedesche nella zona della Germania occupata dalle truppe sovietiche, si dispone quanto segue: «I tribunali tedeschi in tutte le province e le regioni sono riorganizzati in base alla legislazione vigente prima del 1° gennaio 1933. [...] I capi delle Amministrazioni militari sovietiche nelle province e nelle regioni vengono qui incaricati di prestare all’Amministrazione centrale della giustizia tedesca la necessaria assistenza nella sua attività. Nel corso dell’opera di ristrutturazione dei tribunali tedeschi devono essere allontanati da tutti i tribunali e da tutte le procure della repubblica gli ex membri del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (NSDAP) e coloro che durante il regime hitleriano hanno presieduto l’esecuzione delle pene. Il controllo e la sorveglianza sull’esecuzione dell’ordine sono imposti al capo della sezione giudiziaria presso l’amministrazione militare sovietica». E alla pagina 21 della menzionata raccolta dei collaboratori trovo una copia del primo numero della «Deutsche Volkszeitung» (Quotidiano tedesco del popolo), organo ufficiale della KPD. La notizia di apertura è costituita dall’«APPELLO del Partito comunista tedesco», in cui viene indicata la «via verso una nuova Germania». «I compiti più immediati e urgenti lungo questa via» sarebbero a quanto si dice: – Espropriazione di tutti i beni degli alti esponenti nazisti e dei criminali di guerra – Liquidazione totale del regime e del partito hitleriani –Lottacontrolafameela disoccupazione –[purtroppononleggibile] – Ricostruzione degli organi di autogoverno fondati su base democratica – Difesa dei lavoratori dall’arbitrio degli imprenditori e da uno sfruttamentoindebito – Liquidazione dei fondi delle grandi proprietà terriere di Junker, conti e principi – Consegna di tutte quelle imprese che servono bisogni pubblici fondamentali – Convivenza pacifica e cordiale con gli altri popoli – Riconoscimento delle riparazioni per i danni provocati ad altri popoli dalleaggressionidiHitler Al lavoro con tutte le forze! Dal bisogno e dalla morte, dalle rovine e dal disonore sorgerà la via verso una nuova Germania! Queste affermazioni, poco dopo la fine della guerra, erano più che semplice propaganda. Corrispondevano al sentimento e al pensiero di molte persone, vuoi socialdemocratici o conservatori o cristiani, che avevano desiderato intensamente la fine del nazismo. Vi rientrava anche il fatto che la spinta verso l’unificazione dei partiti dei lavoratori era condivisa anche da alcuni rappresentanti della SPD. Una foto del congresso fondativo della SED mostra Wilhelm Pieck (KPD) e Otto Grotewohl (SPD) che suggellano con una stretta di mano l’unione dei due partiti operai, mentre accanto a loro è seduto Walter Ulbricht. Nella didascalia si citano massime e obiettivi della SED nel 1946 che, se fossero stati imposti tutti in maniera durevole, avrebbero significato anche un distacco dalla dittatura del proletariato: «Libertà di espressione attraverso la parola, l’immagine e la scrittura, per salvaguardare la sicurezza dello stato democratico dagli attacchi reazionari. Libertà di opinioni e di religione, uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di razza e di sesso. Parità della donna nella vita pubblica e nel lavoro. Protezione della persona da parte dello stato. Riforma democratica della giustizia e del diritto». La carta è paziente. E chi richiama alla mente il crescente numero dei prigionieri dopo il 17 giugno 1953 capirà che la giustizia fu amministrata secondo criteri di opportunità. Essi furono arrestati, benché il diritto di sciopero fosse garantito. Il ministro della Giustizia, Max Fechner, in un’intervista apparsa su «Neues Deutschland» si era pronunciato contro la persecuzione penale degli operai edili in sciopero. Anche lui fu arrestato e condannato a nove anni di prigione in quanto «nemico dello stato e del partito». Gli succedette Hilde Benjamin. La quale fece propria l’interpretazione della SED, secondo cui la rivolta del 17 giugno era un putsch manovrato da agenti occidentali, che dovette essere soffocato sul nascere. Osservo questa donna dalla distanza dell’anno 2012 e sfoglio lettere e documenti che non sono in grado di leggere o di decifrare interamente. Suppongo che il suo amore per Georg Benjamin sia una chiave per le sue motivazioni e certezze ideologiche. Durante tutto il periodo nazista Hilde ebbe poca speranza di sopravvivere con il figlio a quell’epoca. Era sicura della buona causa di una Germania socialista? Se sì, perché allora fu così intransigente, come nel 1950 al processo contro un gruppo di testimoni di Geova, che avvertivano la contraddizione esistenziale in cui la loro fede settaria li poneva rispetto allo stato socialista fondato sull’adesione al partito? Comminò molti anni di reclusione; motivo bastante dovette essere il fatto che la chiesa madre si trovasse a New York – come prova per l’accusa di «congiura imperialista». Le prime elezioni comunali per l’intera Berlino nel 1946 rientrarono probabilmente fra le esperienze che mostrarono ai comunisti tedeschi quanto fosse improbabile un successo elettorale della SED, sostenuta dal potere dell’Armata Rossa, presso una popolazione postfascista. I nazionalsocialisti avevano fatto tranquillamente uso dell’arsenale ideologico della KPD, cosa che non aveva impedito loro di dichiarare i comunisti nemici mortali del Reich. Hilde Benjamin si candidò a Steglitz anche contro un Partito socialdemocratico che a Berlino Ovest era rimasto indipendente. Nella raccolta dei suoi collaboratori trovo una scelta degli strumenti con cui Hilde Benjamin si presentò agli elettori. Il suo personale manifesto elettorale mostra un’immagine di mezzo profilo. Un disegno al tratto, bianco e nero, i capelli divisi nel mezzo e severamente pettinati all’indietro, raccolti in una crocchia. Guarda con aria pensosa, la testa piegata obliquamente verso il basso. Un ritratto palesemente lontano dai manifesti delle moderne campagne elettorali. Alle elezioni la SED, con il venti per cento abbondante dei voti, arrivò al terzo posto dopo l’Unione cristianodemocratica (CDU). I vincitori furono i socialdemocratici, che ottennero quasi il cinquanta per cento dei consensi. Wolfgang Leonhard, membro del gruppo Ulbricht e in seguito oppositore della sua linea, ricorda quanto poco l’avesse sorpreso il risultato: «La causa della sconfitta mi era perfettamente chiara. Nel linguaggio popolare eravamo il partito dei russi. Il risultato elettorale era la conseguenza logica della nostra dipendenza dalla potenza occupante sovietica». La sconfitta elettorale alimentò anche la sfiducia della SED nei confronti della propria popolazione. In questa sfiducia nella lealtà della gente verso lo stato socialista si cela un problema fondamentale della DDR, dove l’entusiasmo delle masse spesso si manifestava solo a comando e molto era pura messinscena. Non sappiamo quanto Hilde Benjamin l’avesse compreso. Combatteva per una riforma della giustizia che si sarebbe lasciata finalmente alle spalle lo stato fascista e i suoi giudici. Nella sua biografia Marianne Brentzel guarda con stupore il carico di lavoro quasi inconcepibile della procuratrice generale e vicedirettrice dell’amministrazione centrale della Giustizia nella zona di occupazione sovietica, il cui direttore era l’ex socialdemocratico Max Fechner, che in seguito fu ministro della Giustizia nella DDR. All’impegno principale di Hilde Benjamin nell’amministrazione centrale della giustizia «si aggiunge ben presto una serie di altri compiti», scrive Marianne Brentzel: «il lavoro insieme alla commissione per la denazificazione dei giuristi, presso la municipalità di Berlino, la commissione d’esame per l’ammissione all’Università di Berlino», che fu riaperta nel 1945, e il suo «sforzo per un impiego il più possibile ampio delle donne nella Giustizia, in collaborazione con le commissioni femminili e, in seguito, con l’Unione democratica delle donne». Questo elenco dimostra dove Hilde Benjamin vedesse il punto focale del suo incarico di riformatrice, al fine di superare lo stato fascista. Ed è anche una motivazione per il suo irrefrenabile impulso al lavoro. Hilde sapeva naturalmente che i suoi processi e il loro effetto propagandistico avevano anche lo scopo di chiarire alla popolazione che era vantaggioso per tutti sostenere lo stato della SED. Registrazioni televisive conservate presso l’Archivio radiofonico tedesco (Deutsches Rundfunkarchiv) di Babelsberg la mostrano capace di schierarsi per il proprio stato anche in maniera meno veemente. Qui la vedo per la prima volta, così com’era negli anni Sessanta: piccola e, con il passare del tempo, quasi fragile. Non traspare nulla che possa giustificare l’appellativo «Hilde la Rossa» o «Hilde la Sanguinaria», dato a questa donna dalla voce dimessa, e che ancora oggi le viene attribuito. Dal 1945, così la descrive esprimendosi nel tipico tedesco di partito il suo sostituto Hans Ranke, Hilde Benjamin si dedica alla «lotta per l’avvento e l’azione di un nuovo diritto che, dopo la sconfitta del fascismo, con la creazione del potere degli operai e dei contadini cerca di affermarsi». Su tutto questo esistono naturalmente valutazioni divergenti a Est e a Ovest. In realtà la sua costruzione di un diritto socialista non suscitò in Occidente alcun dibattito, ma tutt’al più commenti sprezzanti. Quanto meno il diritto di famiglia della DDR, che fu sostanzialmente opera sua, avrebbe meritato più del necrologio con cui venne seppellito in Occidente dopo la riunificazione. Era così moderno e avanzato che i critici occidentali rimasero senza parole. All’opuscolo con il nuovo diritto di famiglia Hilde Benjamin diede un titolo che fa capire di cosa la sua principale autrice avesse sentito fortemente la mancanza durante l’epoca nazista. Una felice vita familiare si chiama il libriccino sulla «questione del codice di famiglia della DDR». Esso contiene la legge introduttiva, presentata il 20 dicembre 1965 alla diciassettesima seduta del parlamento della DDR. In precedenza era stata discussa ampiamente in numerose riunioni nelle fabbriche e presso i sindacati. La parità fra i due sessi è garantita, in un’epoca in cui le donne in Occidente avevano ancora bisogno del consenso del marito per ottenere un credito o aprire un conto in una banca. Solo a poco a poco i riformatori della giustizia a Ovest riuscirono, attraverso proprie riforme, a eguagliare almeno per frammenti il diritto di famiglia della DDR e a rivedere gradualmente il codice civile guglielmino, disseminato ancora di macchie brune fasciste. Lo stesso vale per il diritto del lavoro e la richiesta di uno «stesso compenso per uno stesso impiego», una rivendicazione che nella DDR fu quasi interamente soddisfatta e che nella Germania riunificata attende ancora il suo compimento. La fama di giudice implacabile nei media occidentali, con il soprannome «Hilde la Rossa», la ottenne soprattutto perché nella sua sfera d’influenza epurò le autorità giudiziarie rimuovendo i giudici e i procuratori nazisti, anche se il cannoneggiamento occidentale contro «Hilde la Rossa» faceva di ogni nazista da lei condannato una vittima del «disumano sistema d’ingiustizia nella DDR». Il suo ruolo di riformatrice della giustizia non contava nulla per i mezzi di informazione occidentali. Senza dubbio fu severa e implacabile, quando intuiva un pericolo per l’intero progetto socialista della DDR. E il suo comportamento offrì sufficienti motivi alle critiche. Ma paragonarla al terribile giudice nazista Roland Freisler era ingiusto quanto il tentativo di descriverla come un’alcolizzata, mentalmente incapace di intendere e di volere. Al di là di tutti gli errori e le deformazioni che avrebbero fatto miseramente crollare il secondo stato tedesco: per Hilde Benjamin soltanto la DDR era una risposta antifascista alla Germania di Hitler. Le reazioni dell’opinione pubblica tedesca occidentale alle riforme giuridiche nella DDR sono strettamente legate alla politica di Konrad Adenauer, che rinunciò a un’analoga epurazione degli ex membri del partito, degli alti gradi delle SS e dei funzionari nazionalsocialisti nella giustizia, nell’amministrazione, nell’economia e nei mezzi di comunicazione. Risulta difficile interpretare questa politica come un alto servizio reso da Adenauer allo stato, ispirato da motivazioni filosofiche. Nella politica, nell’economia e nella burocrazia della repubblica suddivisa in tre zone vi erano legami di solidarietà fra nazisti che cercarono di impedire che, al di là dei processi di Norimberga, funzionari alti e medi del partito venissero chiamati a rendere conto delle loro responsabilità. Il settimanale «Die Zeit» mise allora in dubbio persino la legittimità dei processi di Norimberga e nel numero del 29 settembre 1950 diede la parola a Paul Leverkuehn, uno dei difensori tedeschi dei generali della Wehrmacht là accusati. Per Leverkuehn, presentato come «esperto di lunga data in diritto internazionale», l’amministrazione della giustizia nel tribunale alleato fu un «fondamentale errore». «Scopo dei processi ai criminali di guerra a Norimberga» scrive Leverkuehn «era – accanto alla punizione dei colpevoli – convincere il popolo tedesco della superiore qualità della giustizia nei paesi democratici. Questo scopo non è stato raggiunto». Il primo processo era ruotato intorno all’invasione della Polonia. E poiché vigeva il patto di non aggressione fra la Germania e la Russia, secondo Leverkuehn i russi avrebbero preso parte almeno indirettamente all’attacco. Quindi non potevano essere giudici e accusatori. Questo esempio mostra con «terribile chiarezza in cosa è sfociato il diritto internazionale a Norimberga». La medesima argomentazione era ripetuta nel memoriale degli ex generali nazisti che facevano capo al generale feldmaresciallo von Manstein: la Wehrmacht avrebbe dovuto essere prosciolta da ogni correità nella guerra di annientamento contro l’Unione Sovietica e nei terribili crimini commessi nelle zone del conflitto. Soprattutto i due settimanali, considerati oggi l’espressione di un giornalismo serio e critico, durante i loro primi anni non corrispondevano affatto al nomignolo di cui si era investito lo «Spiegel»: un «cannone della democrazia». Ebbene, non lo erano proprio. Nel bilancio critico di Lutz Hachmeister e Friedemann Siering, intitolato Die Herren Journalisten (I signori giornalisti), che reca l’ironico sottotitolo «Le élites della stampa tedesca dopo il 1945», è descritto come molti propagandisti dello stato nazista avessero potuto rioccupare le loro poltrone direttive grazie alle licenze rilasciate dagli alleati ai giornali. Da costoro non c’era da attendersi alcuna riflessione sullo «strappo dalla civiltà» compiuto dalla Germania. La guerra fredda dava al contrario l’occasione di riallacciarsi direttamente alle tirate anticomuniste che erano uscite dalle loro penne già prima del 1945. Proprio il caporedattore della «Zeit», Richard Tüngel, nel suo articolo natalizio intitolato «Friede auf Erde» (Pace sulla terra) espresse un clamoroso rifiuto di prendere atto dei crimini nazionalsocialisti. Il suo predecessore era stato sollevato dopo breve tempo dal suo incarico per mano delle autorità responsabili della denazificazione. «Ci troviamo oggi in una situazione simile a quella del popolo ebreo» scrive Tüngel «quando l’annuncio raggiunse i pastori. Anche la Germania oggi è occupata, anche noi abbiamo soltanto quei diritti che le potenze occupanti ritengono giusto darci. In molti sensi stiamo peggio. Non abbiamo abbastanza spazio abitativo, siamo costretti a soffrire la fame e il freddo, non possiamo lavorare liberamente e siamo odiati nella comunità dei popoli». Questo pensava l’élite dei giornalisti, i «signori giornalisti» nella Germania Occidentale dopo il 1945. Hachmeister e Siering si stupirono di fronte a un testo che trovarono «veementemente nazionalista, indelicato e totalmente privo di sensibilità verso la catastrofe provocata poco tempo prima dai tedeschi». Per Tüngel il gruppo dirigente della SED nella Germania Orientale occupata dai sovietici era «il regime bastardo di Mosca», e lo «Spiegel» descrisse il «ministro della Giustizia della Zona sovietica, Hilde Benjamin», come una «che aveva assunto le proporzioni fisiche di una matrona». Fra le righe traspare il maggior timore nutrito allora nelle redazioni: che anche in Occidente si facesse piazza pulita del passato nazionalsocialista. Berlino Est non doveva fare quindi in alcun caso da esempio: cannoni puntati per far fuoco continuo contro Hilde Benjamin, schernita e sbeffeggiata. Così accadde anche quando la DDR cercò di insediare giudici popolari nei posti rimasti vacanti. Così scrive lo «Spiegel»: «I giudici e i procuratori popolari» sarebbero un «mezzo di fortuna», e comunque «sangue nuovo per la giustizia ormai anemica» della DDR: per gli «autentici signori della Zona non strumenti di un’astratta giustizia, bensì l’autentica leva per scardinare il diritto borghese e spezzare il dominio della borghesia». E segue poi il timore degli autori dello «Spiegel»: «Mentre la denazificazione negli altri uffici della zona sovietica, e fin nei comandi di polizia, fu perseguita dapprima in maniera elastica, Hilde Benjamin disponeva dei pieni poteri necessari per realizzare un’epurazione di massa nella categoria dei giuristi, e ciò grazie all’ordine n. 49 del comandante supremo dell’amministrazione militare sovietica. La scrupolosità con cui agì è mostrata dall’esempio della Sassonia, dove nel giro di un anno non meno di ottocento giudici e procuratori su mille furono buttati sulla strada». Lo «Spiegel» non chiedeva se e quante condanne a morte questi giudici espulsi avessero pronunciato durante il nazismo, quanti oppositori la giustizia nazista avesse mandato non «sulla strada» ma sul patibolo. Rimuovere e sgravare possibilmente la propria coscienza; anche nel mondo della cultura si ebbe uno sviluppo simile. Coloro che in qualità di registi, autori o attori avevano fatto la loro parte nei Durchhaltefilmen di Babelsberg6 e nell’industria cinematografica diretta da Goebbels, contribuendo al suo influsso sul pubblico durante il Terzo Reich, erano quasi certi di essere classificati come semplici fiancheggiatori dopo il 1945. E così poterono essere nuovamente disponibili in Occidente per i film del dopoguerra, nei centri di produzione a Monaco o ad Amburgo. Da Hans Albers a Marika Rökk, da Heinz Rühmann con il suo atterraggio di fortuna a Zarah Leander, che riprese subito a cantare: «So che accadrà un miracolo e allora mille fiabe diverranno realtà». Prima del 1945 si leggeva in queste parole la speranza in un’arma miracolosa che avrebbe impresso una svolta alla guerra; dopo il 1945, invece, la speranza nell’ultimo verso della canzone era rivolta verso l’eternità: «Quel che avevo non può esser perduto per sempre». Lo Heimatfilm conobbe una nuova fase di successo. Il cineasta tedesco occidentale Edgar Reitz, cofirmatario nel 1965 del memorandum «Papas Kino ist tot» (Il cinema di papà è morto), definì questa continuità una «Babelsberg, soltanto senza Goebbels». La politica di Bonn non riuscì a impedire che la lotta della DDR per ottenere il proprio riconoscimento statale avesse infine successo. L’aspettativa, nutrita nella DDR, che ciò significasse anche una maggiore stabilità politica all’interno tuttavia non si realizzò. Lo splendido romanzo di Eugen Ruge, che descrive il progressivo sfaldarsi dell’idealismo della generazione che aveva fondato la DDR, porta il geniale titolo In tempi di luce declinante. La luce vitale della DDR si era indebolita sempre più, fin quando le grida «Noi siamo il popolo» e le manifestazioni del lunedì finirono per spegnerla del tutto. Hilde Benjamin, questo è il commento pensoso di suo figlio Michael, non sarebbe sopravvissuta alla fine della DDR. Per lei il secondo stato tedesco apparteneva alla logica stessa della sua vita. Chi volesse valutare il suo operato nella DDR non sarebbe tuttavia giusto verso di lei se non considerasse i dodici anni del fascismo tedesco e del delirio razzista. Per «Spiegel», «Zeit» e altre testate del dopoguerra la DDR e la possibilità di trasferire là ogni male consentivano di rimuovere la barbarie nazionalsocialista. Ciò comprendeva anche il rifiuto di vedere la divisione in due stati tedeschi come una conseguenza dei dodici anni hitleriani e di riconoscere questi come la causa della devastazione del paese e della distruzione della sua cultura e morale. Ne è un esempio la storia di copertina che lo «Spiegel» dedica a Hilde Benjamin il 18 marzo 1959. L’«efferatezza» dei nazisti, che sarebbe stata «rivolta contro certi gruppi», e la loro micidiale risoluzione a colpire ebrei, intellettuali, socialdemocratici, comunisti e la Bekennende Kirche (Chiesa Confessante), a disseminare la guerra in Europa e a dividere l’umanità in Herrenmenschen, cioè gli appartenenti alla «razza padrona», e il suo miserabile resto – tutto ciò viene liquidato con disinvoltura. Colpisce la mancanza di rispetto con cui viene trattato il destino dei Benjamin. Il medico generico Georg Benjamin è il «comunista idealista» che vive nella «lussuosa villa» dei genitori. Al suo matrimonio con l’avvocatessa Hilde Benjamin si accenna per far intendere come lei non potesse essere annoverata tra gli avvocati rossi di punta a Moabit. La situazione reale dei due traspare solo in una frase secondaria, quasi un flash: «Lo studio legale e l’ambulatorio medico dei due “comunisti idealisti” nella “rossa Wedding” vengono devastati nel 1933 da una banda di SS». Il «dottore comunista» sembra direttamente colpevole di quel che poi gli accade: finisce in carcere e «ricompare» dopo dieci mesi. Citiamo dall’articolo: «La sua allegria umanitaria si era volatilizzata nel campo di concentramento di Sonnenburg. Al desco familiare sedeva un laconico estraneo». Lo sgomento per la «laconicità» degli autori della storia di copertina, quando si tratta del nazionalsocialismo, è accresciuto ancora dal tono implacabile con cui sono elencate le successive stazioni del candidato ebreo alla morte, Georg Benjamin. La prigione di Brandeburgo, dove trascorre sei anni, viene così illustrata in una frase: «Per qualche mese, in una sovraffollata cella collettiva del carcere di Brandeburgo, Georg Benjamin poté dare una mano al leccapiedi dei secondini che si occupava della distribuzione del cibo, poi le SS lo spedirono con un gruppo di prigionieri politici nel campo di concentramento di Columbia; da lì finì poi nel Lager provvisorio di Wuhlheide, alla periferia orientale di Berlino». E così termina il passaggio: «Dopo un pogrom nel Lager di Wuhlheide i prigionieri ebrei – che là “vivono come pascià” – vengono trasferiti». L’articolo non dice a chi si debba l’affermazione secondo cui i prigionieri ebrei nel Lager esterno di Columbia a Wuhlheide avrebbero vissuto come pascià. Quanto alla posizione di Hilde Benjamin dopo il 1945, l’autore dello «Spiegel» riesce a fare la seguente valutazione: «Politicamente si sentiva sempre più legata alla professione di fede del marito Georg Benjamin, umanamente gli anni della persecuzione l’avevano indurita». E poi: «Convinta delle proprie capacità, da quel momento voleva far parte di quelli che calpestano, anziché di quelli che sono calpestati». Calpestare o essere calpestati: per lo «Spiegel» era impensabile che le motivazioni di Hilde Benjamin potessero essersi nutrite di altre esperienze. Impensabile che potesse auspicare invece un diritto socialista, distinto dalla giustizia di classe che aveva conosciuto nella repubblica di Weimar. O che volesse porre fine alla tradizione della giustizia borghese, che nutriva una simpatia segreta per il terrore di destra. Il libro Vier Jahre politischerMord (Quattro anni di delitti politici), che nel 1922 fece brevemente scalpore, mostra quanto la giustizia fosse vicina ai nemici della repubblica. Il suo autore, Emil Julius Gumbel, è quasi dimenticato. «Die Zeit» ha pubblicato solo di recente la storia della sua vita. Novant’anni dopo l’uscita il libro torna ad avere una spaventosa attualità. Accusa una magistratura che contribuì a distruggere la prima democrazia. La quarta edizione, rivista nel 1922, fu definita da Kurt Tucholsky, nella rivista «Weltbühne», un «libro della vergogna tedesca». Sulla base di documenti studiati con acribia e riguardanti omicidi compiuti per motivi politici emerge che nei pochi anni fra le due guerre furono attribuiti alla destra trecentocinquantaquattro omicidi, mentre ventidue furono quelli imputati alla sinistra. Trecentoventisei omicidi commessi dalla destra restarono impuniti, contro quattro di quelli commessi dalla sinistra. Ma Gumbel non si limitava ai soli numeri. Pubblicò anche tutti i nomi degli assassini di cui disponeva, non solo di quelli presenti sul luogo del delitto, ma anche dei mandanti e degli istigatori sullo sfondo, sulle cui liste della morte, prima di essere uccisi, c’erano stati anche Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, Matthias Erzberger e Walther Rathenau. Dopo l’iniziale scalpore e le minacce di azioni legali il libro non ebbe alcuna ripercussione. La destra nazionalista poté praticamente esercitare, nell’assenza di ogni diritto, il terrore contro la repubblica, contro ebrei, comunisti e socialdemocratici – cioè contro gli altri. Circa novant’anni dopo l’espressione di Tucholsky, cioè la «vergogna tedesca», viene nuovamente utilizzata, senza tuttavia ricordare lui e l’occasione di allora. Fu la cancelliera Angela Merkel a pronunciarla nel 2012, durante una cerimonia funebre per le vittime di una serie di omicidi che scosse la Germania. Dieci vittime di una cellula neonazista che per dieci anni poté manifestare in incognito il proprio odio contro tutto ciò che le era estraneo. Persero la vita nove immigrati, otto dei quali di origine turca, e uno greco, oltre a una poliziotta. Tutti e dieci furono giustiziati con la medesima arma. Nessuno degli inquirenti pensò mai di collegare la serie degli omicidi con gli ambienti di estrema destra. Gli investigatori cercarono i colpevoli nelle famiglie, appuntarono i loro sospetti sui parenti delle vittime fin quando gli assassini, per caso, furono smascherati. Il capo del governo parlò durante la cerimonia funebre di «vergogna tedesca» e si scusò con i parenti perché le autorità giudiziarie li avevano tormentati per dieci anni, sospettandoli di essere responsabili dei crimini. Non le venne in mente nulla che potesse condurre a un sostanziale miglioramento della condizione degli immigrati in Germania. Nel 1922 Gumbel fece un calcolo: un omicidio con movente nazionalista costava quattro mesi di prigione e due Reichsmark di multa. Gli assassini con opinioni di sinistra dovevano aspettarsi in media quindici anni di reclusione o una condanna a morte. Nelle aule dei tribunali la giovane avvocatessa Hilde Benjamin poté osservare dunque giudici indulgenti verso i criminali di destra e «una giustizia nazionalconservatrice che agisce come fedele complice del terrore» (Kurt Tucholsky). Fra la giustizia penale del 1922, cieca dall’occhio destro e attivamente partecipe all’affossamento della Repubblica di Weimar, e il nuovo inizio nella parte orientale della Germania, nel 1945, passano dodici anni abbondanti. I collaboratori di Hilde Benjamin avevano chiamato questo capitolo della sua vita: «Contributo alla democratizzazione della giustizia». Il titolo è dipinto con mano sobria su carta a mano e protetto da una pagina trasparente, simile a una pergamena. Mentre molte delle vecchie strutture, comprese le tasse scolastiche per i licei, sopravvivevano nelle zone occidentali, la DDR aveva altri problemi: dopo l’allontanamento dei collaboratori con un passato nazionalsocialista nell’amministrazione, nella giustizia e nell’istruzione il compito più urgente era quello di formare al più presto, attraverso corsi brevi, giudici popolari e futuri funzionari amministrativi che potessero ricoprire i posti vacanti. Nelle cento pagine raccolte per il sessantacinquesimo compleanno di Hilde Benjamin si trova a questo proposito una citazione di Walter Ulbricht, il quale nominava le priorità che avrebbero guidato il rinnovamento nella DDR: «Io domando: quanti antifascisti sono stati istruiti in modo da poter operare come giudici popolari? I compagni dicono sempre di volere delle leggi. Miei cari amici, non è affatto facile. Dove sarebbero i giuristi appartenenti al nucleo della popolazione attiva e in possesso di un’istruzione che li renda capaci di promulgare leggi democratiche? O volete lasciare tutto ai vecchi avvocati? Così non va. Per ciò che riguarda l’impiego e la formazione di nuove forze democratiche siamo appena all’inizio. Questa è la situazione reale. [...] Ciò che conta sono i quadri, è rieducare la gente, giungere a un più rapido impiego di forze nuove. Nella prima tappa dello sviluppo si poneva per noi la necessità di un’epurazione». In un’intervista trasmessa nel marzo 1946 da «Deutschlandsender», emittente radio della DDR, Hilde Benjamin si appropriò del concetto di «giudice popolare», utilizzato da Ulbricht. Pregò gli ascoltatori di guardarsi da due cose, quando si utilizzava quella denominazione: «Non si deve credere che chi abbia frequentato i corsi per giudici sia diverso, e magari inferiore, rispetto a chi ha ricevuto una formazione universitaria. È un giudice a tutti gli effetti. Quello di “giudice popolare” deve diventare anzi un titolo d’onore, applicabile a tutti, e il nostro sforzo più urgente è che presto tutti coloro che lavorano nella giustizia della nuova Germania siano davvero giudici popolari». Per il futuro ministro della Giustizia della DDR i giudici popolari erano più che un semplice strumento per riempire con mezzi di fortuna i buchi sorti fra le fila dei giudici in seguito alla «eliminazione di tutti i membri del partito». Faceva notare che dei duecento studenti di giurisprudenza presso l’Università di Berlino nel 1946 meno di sessanta erano al secondo e al terzo anno, tanto che un sufficiente apporto da parte della nuova generazione non era pensabile prima di altri cinque o sei anni. I giovani giuristi, questa era la sua speranza, sarebbero «venuti dal popolo» e avrebbero mostrato la stessa «pulizia di carattere e dirittura antifascista e democratica dei giudici che arrivano adesso dalle scuole di formazione». Le scuole per giudici, quale percorso alternativo accanto a quello universitario, avrebbero dovuto formare persone «di età più matura» e caratterizzare la nuova tipologia dell’«autentico giudice popolare», non più «giurista di vecchia scuola, appartenente a una corporazione», ma persona capace di garantire un’amministrazione della giustizia derivante dalla conoscenza di tutte le condizioni di vita e dei bisogni del popolo. Nel verbale di una riunione dell’Amministrazione tedesca della Giustizia (Deutsche Justizverwaltung)7 nell’ottobre 1948 Hilde Benjamin descrisse la situazione del personale e riferì che alla metà di settembre di quell’anno, nella zona 915, erano impiegati 327 procuratori e pubblici ministeri. Seguì attentamente gli allievi dei corsi per giudici popolari e riferì sull’esame finale del secondo corso a Potsdam nel giugno 1947. In quell’occasione Hilde si adoperò per garantire una migliore alimentazione agli allievi. Sulla stessa pagina campeggiava una foto del castello di Babelsberg: «un tempo castello di principi – oggi centro di formazione per giudici socialisti» – e sotto un passaggio in cui si descrive il misero aspetto degli allievi: «La loro condizione, per quanto riguarda l’alimentazione, è manifestamente carente. Nelle ultime due settimane, come si è riferito, l’alimentazione collettiva del governo provinciale di Potsdam, alla quale essi partecipano, è stata molto insufficiente. I loro risultati ne sono stati in parte compromessi». Nei materiali per il Rapporto sullo stato della nazione del 1971, paragonabile allo «State of the Union Message» negli Stati Uniti, una raccolta di fatti che integravano il discorso del cancelliere Willy Brandt davanti al Parlamento della Germania Occidentale, si analizzavano le differenze fra i due stati tedeschi. Così è detto a proposito della riforma socialista del diritto: «La legislazione della DDR» si riallaccia alla «tradizione giuridica nazionale; essa segue fondamentalmente i procedimenti utilizzati da ogni legislatore per aggiornare l’ordinamento giuridico nazionale, anche se occorre concedere qui notevoli differenze quantitative». In questo senso l’«evoluzione del diritto nella DDR è insieme uno sviluppo del diritto tedesco». Tutto questo è detto – cosa piuttosto rara – senza acrimonia. Se nella competizione fra i sistemi la qualità del confronto sociale fosse stata un’altra, essi, il diritto socialista e quello borghese, avrebbero potuto fare a gara per superare l’epoca nazista, e non solo per screditarsi l’un l’altro. Nei materiali relativi al Rapporto sullo stato della nazione si trova una «prima descrizione empirica fondata delle diverse strutture della DDR, messe a confronto con quelle della Repubblica Federale Tedesca». Nella prefazione si legge che la grande risonanza di cui ha goduto la pubblicazione dimostra l’interesse rivolto finalmente a un’informazione spassionata e obiettiva sulla DDR. Nell’analisi, che si sviluppa in più di trecento pagine, si afferma tra l’altro che tutti gli ex membri del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (NSDAP) erano stati – con poche eccezioni – allontanati dalla giustizia, dall’amministrazione e dalla scuola, come richiesto nell’accordo di Potsdam. Nella Repubblica Federale, invece, il comportamento verso la «generazione dei colpevoli» era stato generalmente un altro. Ciò aveva condotto al clima di restaurazione in Germania Occidentale, che si è variamente descritto. Nei materiali del 1971 si dice ancora: «L’allontanamento della generazione dei colpevoli il più rapidamente possibile dai suoi uffici e dalle sue funzioni e la cesura rispetto al passato fascista sono seguiti dalla necessità di sostituire gli esperti eliminati, e quindi non più disponibili, con altri che abbiano ricevuto una rapida formazione». In un primo tempo ciò avviene principalmente fuori dalle università e dagli istituti di istruzione superiore. Ma le università della DDR si aggiornano in fretta, quando appare chiaro che i corsi brevi possono trasmettere solo una ridotta competenza. Per rimediare alla grande scarsità di giovani qualificati nelle scuole e nelle amministrazioni, nel 1946-47 vengono fondate facoltà di pedagogia in alcune università e un anno dopo anche facoltà di scienze sociali – a Lipsia, Rostock e Jena. Nudi fatti che, elaborati per il pubblico tedesco occidentale, confluirono nei materiali del Rapporto sullo stato della nazione, senza far ricorso a formule propagandistiche. Anche il sostegno ai bambini socialmente svantaggiati, così si legge, è un obiettivo esplicito nella DDR. I figli dotati degli operai e dei contadini devono godere di un accesso privilegiato all’università. A questo scopo vengono istituiti già nel 1946 «istituti propedeutici», sottoposti inizialmente alle università popolari, poi incorporati alla fine del 1947. Nel 1949 vengono trasformati in facoltà operaie e contadine. Alla dirigenza della DDR preme innalzare la percentuale degli studenti che provengono dagli strati sociali più bassi e che, all’apertura delle università, costituiscono appena il quattro per cento. Ciò venne generalmente accolto come un nuovo sforzo di giustizia sociale. Nella guerra di propaganda fra Est e Ovest, i media occidentali furono pronti ad annunciare la «bolscevizzazione delle università». Le maggiori difficoltà incontrate dai giovani di famiglie borghesi o lontane dal sistema, che volevano accedere all’università, rappresenta l’altro lato della medaglia. Il Ministero per la Ricerca della BRD e l’Opera universitaria tedesca rendono noti i risultati di uno studio, analizzati sessantatré anni più tardi, nella Germania del 2012, dall’Istituto per la ricerca universitaria: oggi il cinquanta per cento degli studenti viene da famiglie di laureati. Vent’anni abbondanti dopo la riunificazione «Focus» intitolava: «All’università i figli di laureati fanno gruppo a sé». Se l’obiettivo è quello di liberare dalla selezione sociale l’accesso a un’istruzione superiore, la DDR ha avuto certamente più successo della Repubblica Federale. Uno sguardo al nucleo della politica scolastica della DDR – se si tralascia lo strumentario linguistico che ruota intorno alle «facoltà degli operai e dei contadini» – potrebbe risultare molto stimolante. Non è possibile considerare la seconda parte della vita di Hilde Benjamin senza rivolgere lo sguardo ai due stati tedeschi. Equivalente dell’antibolscevismo imposto dai nazionalsocialisti era, nella Repubblica Federale, il contegno politico che le potenze occidentali si aspettavano da una società appartenente al proprio orientamento. Quando la coalizione dei quattro alleati si spezzò nel 1948 – e poi in maniera definitiva con la formazione di due stati tedeschi – gli Stati Uniti vollero evitare che la Germania Federale finisse anch’essa sotto l’egemonia moscovita. Konrad Adenauer vide in ciò l’occasione di sciogliere dalla tutela delle potenze vincitrici occidentali la repubblica renana con la sua capitale provvisoria Bonn, rendendosi indispensabile alle potenze occidentali come «baluardo» ideologico contro Mosca. L’immunizzazione contro le offerte di Mosca per una Germania neutrale ma unita funzionò. Nessuna delle proposte di Stalin in questo senso fu seriamente accolta o presa in esame, e sarebbe stata rifiutata di certo anche da Berlino Est. Ciò d’altro canto rafforzò anche l’autoesaltazione della DDR, che vedeva se stessa come un progetto antifascista alternativo alla Repubblica Federale Tedesca. È vero che già nel 1946 anche la SED eliminò la norma che non consentiva l’adesione nelle proprie fila agli ex membri del Partito nazista. Nel complesso la DDR mostrò di far seriamente i conti con il nazionalsocialismo. Lo confermò la reimmigrazione di molti intellettuali di sinistra nello stato tedesco orientale. La promessa della SED, che annunciava di voler percorrere una propria via tedesca verso il socialismo, era nel contempo un richiamo per quegli intellettuali che ritornavano dall’emigrazione e speravano di trovare una terza strada fra il fascismo e il capitalismo. Questa speranza fu condivisa da filosofi come Ernst Bloch o dal critico letterario Hans Mayer. Entrambi avevano insegnato a Lipsia, prima di volgere delusi le spalle (rispettivamente nel 1961 e nel 1963) alla DDR. Alcuni di quelli che lasciarono la DDR negli anni prima e dopo la costruzione del muro avevano dovuto constatare di persona come le proprie convinzioni socialiste, di stampo individualistico, non fossero gradite alla SED. Il celebre cantautore e poeta Wolf Biermann era uno di questi. Chi dopo il 1961 cercava di superare senza permesso la ben sorvegliata linea di demarcazione fra Est e Ovest rischiava di lasciare la propria vita sulla striscia di frontiera. E nella Germania Federale il clima restaurativo degli anni Cinquanta e Sessanta era soffocante. La messa al bando del KPD nel 1956 da parte della Corte costituzionale federale e le circa duecentomila indagini preliminari fra il 1951 e il 1968 evidenziarono gli intenti di una propaganda diretta contro ogni opposizione di sinistra, la quale veniva costantemente denunciata come avversaria dell’«ordinamento liberale». In entrambi gli stati tedeschi esisteva un «diritto penale dell’atteggiamento interiore» (Gesinnungsstrafrecht). La Germania Federale proibiva ogni alternativa socialista di sinistra o marxista che si andasse profilando. La DDR aveva bisogno di Bautzen, Hohenschönhausen e delle altre prigioni della Stasi, e demolì ogni speranza in un socialismo dal volto umano. I detenuti divennero una merce: la Repubblica Federale riscattò fra il 1963 e il 1990 circa trentaquattromila prigionieri politici, detenuti nella DDR. In cambio Berlino Est incassò valuta e merci per un valore totale di 3,5 miliardi di marchi. 6 Cioè i film che invitavano la popolazione a «resistere» e «tenere duro» (durchhalten); il concetto, e il genere cinematografico stesso, nacquero dopo la disfatta tedesca a Stalingrado. L’«atterraggio di fortuna» nelle righe seguenti rimanda alla commedia Quax der Bruchpilot (Quax il pilota di fortuna), uno dei film prediletti di Hitler, storia di un apprendista pilota per caso [N.d.T.]. 7 La Deutsche Justizverwaltung fu l’organismo preposto all’amministrazione della Giustizia nella Zona di occupazione sovietica fra il 1945 e il 1949 [N.d.T.]. Capitolo decimo ... tutto quel che è diritto La scarsa disponibilità esibita dalla giustizia della Germania Occidentale a far chiarezza sui crimini dello stato hitleriano ha condotto alla disperazione non soltanto i familiari delle vittime. Gli assassini o i loro assistenti, che non avevano mostrato alcun dubbio di coscienza nell’uccidere a colpi di arma da fuoco o con il gas gli oppositori del nazismo o i perseguitati per motivi razziali, poterono far conto invece su giudici straordinariamente comprensivi. La regolare assoluzione si fondava, con altrettanta regolarità, sul riconoscimento della «situazione senza via d’uscita» in cui si erano trovati gli accusati, che potevano richiamarsi all’«obbligo di eseguire gli ordini», a cui la maggior parte dei tribunali dava ascolto. Il genocidio a comando rimase impunito. Così fu per esempio nel processo contro il commissario capo di polizia Heinz Gerhard Riedel, che nel giugno 1974 poté lasciare da uomo libero il tribunale di Kiel: era accertato che in quanto capo della Geheime Feldpolizei 570 aveva dato ordine di uccidere sette partigiani prigionieri in un camion speciale in cui venivano immessi gas di scarico. Il tribunale giudicò che l’azione non costituiva omicidio «poiché non era stata né “efferata” né realizzata “a tradimento”». I partigiani avrebbero potuto sapere che i tedeschi impiegavano i cosiddetti Gaswagen, cioè i «camion del gas». Le vittime quindi non erano state «in buona fede», «e il fatto non presentava perciò alcun carattere di insidia». Oppure il proscioglimento di un neurologo, coinvolto in innumerevoli omicidi per eutanasia. La pretura di Colonia attestò che il medico accusato aveva commesso quei delitti per «idealismo». Ciò si era manifestato non da ultimo nella sollecitudine con cui «si era premurato di ottenere le bare necessarie per seppellire le sue vittime». Negli anni Settanta un tribunale di Monaco rifiutò l’apertura di un procedimento contro ex appartenenti alle SS, adducendo quale motivazione il loro «obbligo di eseguire gli ordini»: di fatto era stato prestato concorso nell’omicidio collettivo di un numero di persone compreso fra novantamila e quattrocentocinquantami e tuttavia costoro non potevano essere imputati perché avrebbero «agito nella consapevolezza» di trovarsi in una situazione totalmente senza via d’uscita e di non poter fare altro che «ubbidire agli ordini loro impartiti». Sono tre esempi fra mille sul funzionamento della giustizia nella Repubblica Federale dopo il 1945. Dopo i tredici processi di Norimberga si giunse nel giro di poco tempo a leggi che concedevano l’amnistia agli ex nazisti. Con la legge sui cosiddetti «131»8 fu abolito il divieto, sanzionato dagli alleati negli accordi di Potsdam, di riassumere quei funzionari che nel 1937 fossero stati membri di un’organizzazione dello Stato nazionalsocialista o del Partito. Nel 1948 i procedimenti contro crimini nazisti erano 1819, nel 1955 si erano ridotti a 21. Definitivamente al riparo da ogni rischio si ritrovarono gli «assistenti omicidi» il 1° ottobre 1968, quando il Parlamento federale approvò la legge introduttiva alla legge sugli illeciti amministrativi. Eduard Dreher, alto funzionario presso il Ministero della Giustizia a Bonn, ex nazista e responsabile a quel tempo per la riforma della Giustizia, aveva introdotto nel testo della legge una modifica del codice penale, con la sconcertante conseguenza di una piena e retroattiva impunità per una considerevole parte dei burocrati della morte nazisti. Sapeva quel che faceva, quando accorciò a quindici anni il termine di prescrizione per il concorso in omicidio. I reati il cui termine era di quindici anni erano quindi prescritti già a partire dall’8 maggio 1960. Con questa amnistia velata, di cui nessuno parve accorgersi, i pianificatori dello sterminio che per esempio avevano servito nell’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich non potevano più essere chiamati a rispondere. In epoca nazista Dreher era procuratore presso il tribunale speciale di Innsbruck, dove era stato un propugnatore intransigente della pena di morte che chiedeva per il più lieve reato, anche se non riusciva sempre a farla accettare. Nella DDR, invece, l’epoca fra il 1945 e il 1949 era considerata il periodo del «cambiamento radicale antifascistademocratico». Da una statistica della DDR si può rilevare che fra il 1945 e il 1965 furono condannati complessivamente 1.208 criminali nazisti. A 118 persone fu comminata la pena di morte, e in 231 casi l’ergastolo. Fra il 1965 e il 1978 ci furono altre 54 condanne. Poiché nella DDR non era prevista alcuna verifica dei verdetti da parte di una corte d’appello di livello superiore, non si può dire se i processi fossero giuridicamente ineccepibili anche da un punto di vista formale e includessero anche una difesa d’ufficio. Durante i primi cinque anni dopo il 1945 il diritto degli Alleati era comunque il fondamento per le indagini contro i criminali nazisti. Ciò valeva a Est come a Ovest. Complessivamente nella DDR per ogni centomila abitanti fu condannato per crimini nazisti un numero doppio di persone rispetto alla Repubblica Federale. Il bilancio della revisione giuridica dei crimini nazisti durante il primo decennio del dopoguerra in Germania Occidentale fu dunque disarmante. Al termine delle 110.000 indagini preliminari avviate dopo la guerra, che tennero impegnati i tribunali, furono condannate secondo la legge circa 6.500 persone, 166 delle quali all’ergastolo. Giudici e procuratori dello stato nazionalsocialista, i quali avevano pronunciato complessivamente 50.000 sentenze a morte, non dovettero temere di essere tenuti a giustificarsi davanti a un tribunale. La generazione dei colpevoli non voleva che si ricordasse, i mezzi di informazione e la politica crearono il clima necessario a questo scopo. Perciò era necessario contrapporre a sé l’immagine della DDR come «regno del male». In questo il nazionalsocialismo era scivolato quasi al secondo posto, diventando un che di quasi trascurabile. I ricordi dell’epoca hitleriana e del suo «strappo dalla civiltà» furono intenzionalmente soffocati per molti anni. In un sondaggio del 1951 lo stato nazionalsocialista, secondo l’opinione del quaranta per cento dei tedeschi occidentali, aveva avuto «anche del buono» e, fino agli anni Sessanta, per una minoranza non trascurabile Hitler era stato un «importante uomo politico». Fu Adenauer stesso che contribuì a tutto questo. Al primo congresso federale dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU) a Goslar, in cui si riunì la CDU di tutte e tre le zone occidentali, Adenauer arrivò a formulare questo paragone: «La pressione che il nazionalsocialismo [...] ha esercitato attraverso i campi di concentramento era contenuta rispetto a quel che succede ora nella zona orientale». Il fascismo hitleriano era ufficialmente descritto come un teatro di guerra secondario, e del tutto giustificabile, della storia tedesca. Parole simili promossero la restaurazione e l’ascesa di noti ex nazisti nell’epoca di Adenauer. Conseguentemente cospicuo era il loro numero nelle più alte cariche dello Stato e della società. Fra questi c’era anche Hans Maria Globke, promosso sottosegretario di Stato nella Cancelleria. Rimase dieci anni in quella posizione. Si dimise solo nel 1963, quando fu condannato all’ergastolo in absentia nella DDR. Si era segnalato fra l’altro come commentatore delle leggi razziali. Lui come Theodor Oberländer e Waldemar Kraft, e accanto a loro noti medici e professori, figuravano nel fitto “libro bruno” delle élite hitleriane che ricoprivano le massime cariche nella Repubblica Federale. La guerra fredda agevolò alla BRD l’obiettivo di dipingere un quadro storico sorretto da una perdita di memoria. Come mostra per esempio il Land della Bassa Sassonia. Già nel 1946 si arrivò là a un’amnistia «fredda» per la giustizia. Furono istituite «commissioni di epurazione» locali, mentre il regime militare si riservava ancora temporaneamente l’ultima decisione. Per la giustizia venne creato un comitato speciale apposito, che inquadrava la maggioranza dei giudici e dei pubblici ministeri nel gruppo dei «fiancheggiatori» (Mitläufer, Livello IV) o degli «scagionati» (Entlasteten, Livello V). La porta ai vecchi impieghi era con ciò aperta. La famigerata «Fabbrica dei fiancheggiatori» si mise in moto, e la Bassa Sassonia divenne un rifugio particolarmente ambito per giuristi dal passato compromesso. La percentuale dei membri del Partito nazionalsocialista fra i giudici della Bassa Sassonia salì dal 65 per cento, prima della fine della guerra, fino al 90 per cento nel 1948. I «terribili» giuristi dell’epoca nazista continuarono a essere giudici o procuratori, mostrando in questo modo come la giustizia non si adeguasse solo a un certo sistema di valori ma anche al potere stesso, e come in genere diventi norma giuridica ciò che serve gli interessi di chi in quel momento lo detiene. In questa logica anche le leggi e l’igiene razziali con cui la vita «priva di valore» veniva annientata erano giustificate, e si poté andare avanti con la coscienza pulita. Il rifiuto di confrontarsi politicamente e storicamente con l’epoca nazionalsocialista non poteva tuttavia reggere a lungo. I motivi erano molti, e il principale era la divisione del paese. Essa contribuì a far sì che le élite brune, che in Occidente avevano riacquistato «potere e influenza», non potessero sfuggire all’ombra lunga del passato. «Malgrado il silenzio collettivo e gli sforzi di occultamento, la speranza nel grande oblio non si realizzò» constatava giustamente Norbert Frei nel suo libro Carriere.LeélitediHitler. Poiché c’erano di fatto due «Germanie»: la DDR non lesinava di pubblicare documenti e altre prove contro criminali nazisti, quando ciò le appariva politicamente opportuno. Per migliorare la reputazione della Germania Federale, e poiché un tale sviluppo suscitava grande apprensione all’estero, a Bonn furono valutate diverse iniziative di pubbliche relazioni. I funzionari responsabili erano anch’essi ex membri del partito. Questo valeva inoltre per due terzi di tutti i funzionari di quello che sarebbe stato in seguito il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Federale, e quindi anche per Herbert Blankenhorn, temporaneamente segretario personale di Adenauer, e per l’allora portavoce del governo Günter Diehl, entrambi incaricati di «rendere più attraente» l’apparato governativo della Federazione con le sue tinte brune. E così i crimini nazisti e la scarsa disponibilità occidentale a rivedere criticamente il passato divennero strumenti della guerra di propaganda fra Est e Ovest. Per gli ex nazisti nei media della Repubblica Federale Hilde Benjamin era un benvenuto schermo di proiezione. Lei non avrebbe mai messo la parola «fine», sempre invocata tra le fila della generazione dei colpevoli. Non la portò nemmeno la riunificazione, al contrario: negli anni a essa successivi un patrimonio ideologico di estrema destra, insieme a uno spontaneo e virulento razzismo quotidiano, proruppe nuovamente dagli strati profondi e grezzi della rimozione collettiva. Nuovamente i crimini d’odio contro gli immigrati e i richiedenti asilo a Est e a Ovest furono perseguiti in maniera insufficiente. Anche nella Germania riunificata si assistette a un chiaro fallimento delle istituzioni, dalla polizia ai Servizi di sicurezza interni. Solo di rado ci si chiese se una delle cause fosse la scarsa disponibilità, nella Repubblica Federale dopo il 1945, a fare i conti con la catastrofe nazista. Una mozione presentata al Parlamento dalla SPD e dai Verdi, che nel 2012 fu accolta a maggioranza dalla sua Commissione culturale, chiese di effettuare uno studio indipendente che accertasse in quale misura all’interno dei tre ministeri degli Interni, della Giustizia e delle Finanze fossero riscontrabili «continuità istituzionali e relativamente alle persone». Sette storici, udita la richiesta di una simile indagine, vi aderirono: i professori Micha Brumlik del FritzBauer-Institut e Michael Stolleis del Max-PlanckInstitut per la Storia giuridica europea si trovarono d’accordo con altri cinque storici di fama sul fatto che dopo il 1945 i tre ministeri avessero fatto poco per favorire un riesame critico. In parte l’avrebbero consapevolmente bloccato. Se la mozione fosse accolta a maggioranza anche nell’assemblea plenaria del Parlamento potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nel confronto con la dittatura nazista. Ciò che stava bene alla politica e alla giustizia non dispiaceva nemmeno ai giornalisti. Chi oggi, quasi settant’anni dopo la fine della guerra, sfoglia i numeri dello «Spiegel» e della «Zeit» fino alla fine degli anni Cinquanta e legge quel che si scriveva sulla zona sovietica divenuta poi la DDR, deve sopportare una lingua che si avvicinava molto al registro della propaganda di regime nazista. Nei giornali non si provava alcuna vergogna a sferrare attacchi misogini, quando si trattava di screditare la nemica prediletta, Hilde Benjamin. Alcuni commentatori proponevano un’immagine femminile ancora influenzata dalla Croce d’onore nazista alle madri tedesche. Il ministro della DDR non poteva che esservi rappresentato come una «calzetta azzurra», cioè come una donna istruita pedante e saccente. Così appare infatti nel testo maschilista di una storia di copertina che le dedicò lo «Spiegel» nel 1951: «Gli anni migliori della sua vita Hilde Benjamin, nata Lange, li trascorse davanti alle porte delle sale da ballo della vita. Né in quanto donna né in quanto avvocato le arrisero mai la fortuna e il successo». Uno sguardo alla sua vita in epoca nazista avrebbe dovuto proibire in realtà un testo del genere: dodici anni trascorsi nel divieto di esercitare la professione, il matrimonio con il medico Georg Benjamin, che fu uno fra milioni di vittime, e la costante paura per il figlio Mischa, esposto fin da bambino alle persecuzioni in base alle leggi razziali. Gli autori della rivista amano creare l’impressione di essere stati molto vicini a Hilde per un certo periodo di tempo e di averla conosciuta come se fossero stati compagni di scuola, quei compagni che nella scuola femminile «GumbelLyzeum», che lo «Spiegel» sosteneva avesse frequentato Hilde, non avrebbero nemmeno potuto esserci. In realtà Hilde era stata allieva dell’AugusteVictoria-Lyzeum di Berlino. Nel dicembre 1952 si leggeva che le sue compagne di classe la consideravano un «freddo mostro di intelligenza». Si era riusciti infatti a scovare delle «studentesse liceali» che parlavano dell’allieva modello Hilde Lange come di «una creatura con le trecce nerazzurre e la pelle giallo bruno». L’«indiana» della Dünterstraße era «un tipo interessante, ma poco simpatico». Nel paragrafo successivo la ragazza intelligentissima e dinoccolata aveva già messo su «del grasso. Le guance sottolineano il mento sfuggente. Sopra gli occhi vivaci e le sopracciglia folte si annidano le trecce, raccolte sul capo». L’effetto sul lettore era calcolato: dopo la guerra, a causa della scarsità di spazio abitativo, l’igiene era spesso carente. In ogni scuola, in ogni colonia infantile si annidava fra i capelli di adulti, ragazzi e bambini ben altro che «trecce raccolte sul capo». Rimandando a una registrazione dal vivo dell’emittente radiofonica del settore americano (RIAS) si rammentava un sondaggio riguardante «quella donna in un processo farsa nella zona sovietica», lei e la sua «voce scura, monotona, impersonale, spaventosamente nota a ciascuno nella zona sovietica, che risuona persino nelle orecchie di milioni di ascoltatori tedeschi occidentali, quando esorta e chiede: “avanti, imputato, avanti!” e “cos’ha fatto poi?”». Chiaro: la donna che interrogava, così «spaventosamente nota», era la cinquantenne Hilde Benjamin, vicepresidente della corte suprema della Repubblica Democratica Tedesca, descritta dallo «Spiegel» come «rappresentante di quella perfida “giustizia progressista” che si è sviluppata nella Germania centrale durante gli ultimi sette anni e che proprio adesso una riforma della giustizia trasforma forzatamente in direttive di legge». La descrizione della sinistra figura che ne era responsabile terminava con la frase: «Nessun altro che non sia russo ha avuto una parte così ampia in questo sviluppo come Hilde Benjamin, la comunista venuta dall’appartamento di Steglitz con le poltrone di velluto». Si può accennare di sfuggita come gli autori credessero che Hilde fosse la vedova di Walter Benjamin, anziché del fratello Georg. Più volte nell’articolo i fratelli vengono scambiati. Ciò che lo «Spiegel» in quegli anni definiva «scellerata» era la figura del «giudice popolare» e del «procuratore popolare» che, come la rivista segnalava ai suoi lettori, non erano «strumenti di un’astratta giustizia, ma sono di fatto la leva per scardinare il diritto borghese e spezzare così il dominio della borghesia». Hilde Benjamin, a cui nel gergo dello «Spiegel» veniva immancabilmente assegnato il nomignolo «Hilde la Sanguinaria», era descritta come l’«esecutrice inesorabile di una [...] volontà di partito non ancora del tutto compresa nella sua portata complessiva». In effetti non esisteva quasi quel «giudice popolare e antifascista, dotato di giudizio ed esperienza della vita» sul quale Hilde Benjamin puntava, «che prima o durante il periodo hitleriano, o anche dopo il tracollo, si era impegnato attivamente per la democrazia», come auspicava in Meclemburgo il quotidiano «Neuer Weg». Si cercava il «combattente consapevole per una nuova Germania». Parlando del quarto corso di formazione per giudici popolari, nell’ottobre 1948, il giornale accennava alla preparazione richiesta per i futuri magistrati: «È sufficiente aver terminato la scuola dell’obbligo; presupposto per frequentare il corso con profitto sono tuttavia una buona capacità di comprensione, facoltà logiche e giudizio logico, nonché la capacità di utilizzare correttamente le parole e di esprimersi fluentemente, sia in forma orale che scritta». Limite minimo di età per i partecipanti ai corsi erano venticinque anni, quarantacinque il limite massimo. Il corso era gratuito, durava un anno, e veniva assegnata inoltre una piccola somma di denaro mensile. Anche alla famiglia era garantito un sussidio, a seconda del numero dei componenti. Lo «scellerato diritto progressista» e i «processi farsa» della DDR, a essa legati e stigmatizzati dallo «Spiegel», furono paragonati alla Giustizia durante il nazionalsocialismo. Si ricordava l’interrogatorio degli accusati dopo l’attentato a Hitler del 20 luglio da parte di Roland Freisler, presidente del tribunale speciale nazista e principale pubblico accusatore dello stato hitleriano. Quel che qui si considerava era solo la persona dell’accusatore nazista, non il sistema giuridico disumano che egli serviva. Esemplare il suo interrogatorio a Peter Yorck von Wartenburg: «Yorck von Wartenburg: “Signor presidente, ho già dichiarato durante il mio interrogatorio che lo sviluppo preso dalla visione del mondo nazionalsocialista...”. «Freisler (interrompendo): “... non la trovava d’accordo! Per dirla concretamente, lei gli avrebbe dichiarato [a Stauffenberg] che in merito alla questione ebraica non le stava bene lo sterminio degli ebrei, e nemmeno la concezione nazionalsocialista del diritto”». Almeno qui gli autori dell’articolo sullo «Spiegel» avrebbero potuto introdurre un elemento di sorpresa, invocando una riforma del Codice civile che superasse il diritto nazista e – al di là della propria agenda di riforme che avrebbe dovuto attendere comunque più di un decennio – si confrontasse con la politica giuridica della DDR. O avrebbero potuto ricordare Globke, sottosegretario di stato di Adenauer, i cui commenti alle leggi razziali nazionalsocialiste erano stati citati da Freisler. Proprio questo non fecero gli autori dell’articolo. Michael, figlio di Hilde Benjamin, giurista anch’egli e professore all’Accademia di Stato e Diritto a Potsdam, dopo la fine della DDR si occupò variamente del nazionalsocialismo in lettere, articoli e innumerevoli osservazioni analitiche, pur essendo il suo sguardo rivolto in primo luogo allo stato appena scomparso. Lo mostra anche la sua reazione a un articolo dello storico Jochen Czerny sull’influsso dell’epoca nazionalsocialista sulla DDR, scritto che Michael giudicò «opportuno considerare e discutere». Czerny introduceva nel suo confronto fra lo stato nazista e la DDR una necessaria discriminante: senza paragoni era «il modo in cui la Germania nazista faceva violenza all’umanità». E tuttavia osservare il «fascismo quotidiano» lo sollecitava a un confronto. Ci sarebbero state «vergognose somiglianze fra il nazionalsocialismo e il socialismo praticato nella DDR per ciò che riguardava le strutture del potere, i metodi e i rituali». Michael Benjamin vedeva le cose in maniera simile, relativizzando tuttavia ciò che Czerny definiva «fascismo quotidiano» e che gli rammentava la DDR, poiché per Benjamin quello era solo «un minuscolo frammento di tutta l’inveterata meschinità di quell’epoca in Germania». E poi descrive la sua esperienza quotidiana nella Germania nazista: «Razzista da cima a fondo, nazionalista, militarista e anticomunista. Tutto dipendeva dalla certificazione di arianità, quel che cioè si era e si poteva fare, come si viveva e come si moriva, quel che si poteva imparare, mangiare e bere. Quotidianità furono all’inizio i negozi ebrei distrutti, e poi le famiglie ebree arrestate. Fra le cose più terribili del potere nazista c’erano la discriminazione razziale, la stella di Davide, gli emblemi altrettanto umilianti che polacchi e Ostarbeiter (lavoratori dell’Est) dovevano portare sugli abiti. Quotidianità erano le condanne per Rassenschande (oltraggio alla razza) o Wehrkraftzersetzung (corruzione del potere difensivo), erano i campi di concentramento, l’esaltazione della razza padrona, gli insegnanti che punivano con il bastone, e poi il popolo privo di spazio vitale, il culto della fecondità per le donne – eccetera eccetera». Benjamin scrive che si risparmia di contrapporre la quotidianità della DDR a queste realtà. «Si può parlare di antifascismo obbligato, ma il fatto che quella quotidianità [...] fosse stata eliminata fu percepito come una liberazione da tutti quelli che ne erano stati colpiti». A ciò aggiunge un secondo pensiero: «Ma non era così. L’idea che fenomeni come l’anticomunismo e l’antisemitismo fossero stati estirpati una volta per tutte, e che nella DDR non fosse più necessario preoccuparsi di una loro comparsa, non si dimostrò solo un’illusione poco scientifica ma fu qualcosa di esiziale. La quotidianità nazista, proprio perché si trattava di una quotidianità, era radicata nelle menti più profondamente di quanto noi volessimo riconoscere e di quanto dovemmo constatare con orrore dopo il 1989. Ma non era la quotidianità della DDR». Dal 1952 il tono allo «Spiegel» lo danno i due responsabili dei settori «Esteri» e «Affari internazionali», Horst Mahnke e Georg Wolff, entrambi ex ufficiali delle SS e, come puntualizza Lutz Hachmeister nella sua raccolta sui «signori giornalisti» in tinta bruna, «ex specialisti del Servizio di Sicurezza (Sicherheitsdienst, SD) di Reinhard Heydrich». Il capo dell’intero Servizio di sicurezza interno, il professor Franz Alfred Six, che guidò anche la carriera di Adolf Eichmann, nel 1948 era stato condannato da un tribunale alleato a venti anni di reclusione come criminale di guerra, ma già nel 1952 era stato graziato e rilasciato dal carcere di Landsberg. Anche lui si era stabilito ad Amburgo. Là divenne direttore di una casa editrice e pubblicò libri di alti gerarchi nazisti con ambizioni accademiche, che a loro volta venivano recensiti dallo «Spiegel». Per esempio l’opera Der Frieden hat eine Chance (La pace ha un’occasione), a cui venne dedicata una breve recensione nel 1954. Gli autori erano i redattori e i compagni dei vecchi nazisti Six, Wolff e Mahnke, che avevano scritto il libro «facendo evidente ricorso a materiali segreti», come specificava Hachmeister. Avevano buoni contatti con le cordate brune, fino ai servizi segreti dell’ex generale di brigata Reinhard Gehlen a Monaco, precursore del Servizio informazioni federale (Bundesnachrichtendiens BND), la cui vicenda postbellica con le sue infiltrazioni da parte di ex appartenenti alle SS e al Servizio di sicurezza (SD) è ugualmente documentata. Le storie sul passato nazista si vendevano benissimo, e questo era uno dei motivi per cui la rivista si era assicurata i loro servizi. Si dava per scontato che i vecchi nazisti nella redazione non sarebbero stati capaci di operare alcuna differenziazione rispetto a quello che chiamavano «bolscevismo». Da qui veniva anche il tono disinvolto da circolo ufficiali. Passarono altri anni prima che nel 1959 la rivista cominciasse a scollare Hilde Benjamin dallo specchio deformante della guerra fredda. Per la prima volta apparve un commento misurato sul suo lavoro di vicepresidente della Corte suprema della DDR. Era «notevole», si legge tutt’a un tratto, «quante poche condanne a morte avesse pronunciato nei quattri anni in cui era stata in servizio e quante fossero state invece le condanne alla reclusione». Segue poi un elenco dei suoi verdetti: «Dei sessantasette accusati che in quattro anni sono apparsi davanti al suo scranno due sono stati condannati a morte, dodici all’ergastolo e gli altri complessivamente a cinquecentotrentasei anni di carcere duro e a tredici anni di reclusione». Anche il bilancio della rivista, espresso in una lingua quasi obiettiva e tollerabile, era sorprendente: «Nelle sue vesti di giudice la Benjamin non era una truculenta riedizione femminile di Freisler, bensì una fredda marxista che puntava all’effetto politico dei suoi verdetti». Con il suo lavoro Hilde Benjamin non si faceva amici né nella DDR né in Occidente. Nella DDR l’espropriazione della grande industria e la riforma agraria erano considerate un importante contributo a ciò che Karl Marx chiamava il superamento della contraddizione fondamentale fra il carattere sociale del lavoro e l’appropriazione economica privata. Dovettero sperimentarlo anche i dirigenti dei gruppi industriali IG- Farben e Solvay, accusati di reati economici. La sede del gruppo Solvay era a Bernburg, vicino a Magdeburgo, dove era nata Hilde Benjamin. Là suo padre aveva compiuto la sua formazione commerciale, prima che la famiglia si trasferisse a Berlino. Gli accusati erano oppositori convinti della statalizzazione degli stabilimenti rimasti nella Zona di Occupazione Sovietica. Era chiaro che la DDR si sarebbe difesa contro il sabotaggio e, come a Bernburg, contro il trasferimento di capitali nella Repubblica Federale. Gli accusati non facevano alcun mistero dell’intenzione di danneggiare l’economia della DDR. I verdetti oscillano fra i due e i quindici anni di reclusione. Hilde Benjamin fece capire subito, senza possibilità di dubbio, che il procedimento e i verdetti avrebbero dovuto essere anche un avvertimento a tutti quelli che intendevano similmente danneggiare la DDR. Parlava perciò del «grande significato educativo di questo processo» e delle «deprecabili convinzioni degli accusati». Su questa linea erano i titoli della stampa orientale: «I criminali di Bernburg» o «I sabotaggi dei lacchè della Solvay». Il processo contro la Solvay a Bernburg e, in precedenza, quello contro nove alti dirigenti della Conti-Gas a Dessau contribuirono a formare la sua immagine di «spietato giudice». In base agli accordi fra gli alleati a Potsdam, anche la Conti-Gas era stata espropriata. I vertici del gruppo industriale avevano tentato di trasferire illegalmente a Occidente, cioè a Hagen in Vestfalia, sede della società affiliata, i capitali che si trovavano a Est. L’ordine di grandezza era quello del milione di Reichsmark. Hilde Benjamin non aveva per tutto ciò la minima comprensione. Lo giudicava un attacco al proprio stato. E sfavorevole era dunque la sua predisposizione verso «gli uomini del monopolio», che definiva «caratterialmente deteriori». L’immagine del giudice senza pietà si confaceva alla Guerra fredda. Essa serviva a sua volta l’immagine che l’Occidente aveva di sé, cioè la sua convinzione di rappresentare la parte migliore dell’umanità. Le responsabilità della generazione dei colpevoli dello stato nazista erano invece misteriosamente sbiadite. L’evidente pacatezza con cui la politica e i mezzi di informazione occidentali guardavano il passato delle élite vecchie/nuove e la richiesta, avanzata molto presto, di un’amnistia per i criminali di guerra condannati possono aver rafforzato Hilde Benjamin nella sua convinzione che soltanto la DDR facesse seriamente i conti con il fascismo; la sua vita doveva contribuire a questo. Possono avervi giocato un ruolo anche i ripetuti attacchi contro il regime della DDR, compiuti dai gruppi della resistenza che agivano in clandestinità. Nei quotidiani tedeschi occidentali si riportavano in ogni caso sempre nuove notizie su atti di sabotaggio nella Zona di Occupazione Sovietica. Anche queste azioni indussero alla creazione, nel maggio 1950, del Ministero per la Sicurezza di stato (Staatssicherheit). Da qui si sviluppò la capillare struttura della sicurezza interna nella Repubblica Democratica Tedesca. Un anno dopo la fondazione della DDR, nell’autunno 1950, sui giornali irreggimentati campeggiava il titolo sensazionalistico: «Gangster, assassini, banditi». Si fornivano dati su gruppi della resistenza guidati da agenti occidentali. Lo «Spiegel» era al corrente di una «lista dei danni», compilata nel corso di dieci giorni. Una detonazione in una fabbrica di esplosivi a Gnaschwitz aveva ridotto del settanta per cento la produzione. A Tschornau presso Aue era saltato in aria un frantoio a sfere per minerale metallico. Il pilastro di una torre di estrazione, in una miniera a Niederschlag presso Annaberg, era crollato a seguito di un attacco con una carica esplosiva. Lo stesso giorno una locomotiva era esplosa nel medesimo luogo. Due speciali vagoni frigorifero delle ferrovie orientali risultavano distrutti. In una fonderia di acciaio a Chemnitz gli operai avevano visto ridursi in mille pezzi un forno a cupola e un forno a tino per fondere i metalli. Fra i rottami in attesa di essere fusi si trovava una granata tagliente da 15 centimetri. C’era poi la leggendaria perdita di armi subita dagli appartenenti alla Volkspolizei, la Polizia di Stato, che lo «Spiegel» aveva classificato ugualmente come «azione di resistenza»: 229 pistole, 23 carabine e 2 mitragliatrici nel corso degli ultimi tre mesi. Quanto al numero, la Turingia stava in cima alla lista delle perdite. Soltanto là erano venute a mancare 91 pistole di calibro 7,65 (portate esclusivamente dagli ufficiali della Volkspolizei). Non fu mai chiarito se quelle azioni fossero state effettivamente promosse da agenti occidentali o se si trattasse di gruppi autonomi della resistenza. In ogni caso ciò deve avere rafforzato ai vertici del partito la sensazione che la popolazione della DDR avrebbe seguito solo brontolando la via verso un’esemplare repubblica socialista. Dure sentenze ne furono l’esito. Ciò valse soprattutto per lo sciopero degli operai edili che il 17 giugno 1953 scesero sulle strade a Berlino e in molte altre città della DDR per protestare contro le quote di produzione, che erano state aumentate arbitrariamente. Lo sciopero divenne una rivolta e la SED poté soffocarla solo con l’aiuto dell’Armata Rossa. Fu anche un’insurrezione dettata dalla fame. Gli approvvigionamenti erano in una situazione critica, anche a causa delle espropriazioni, perseguite con intransigenza ai danni dei contadini, e in seguito all’assegnazione delle fattorie alle cooperative agricole. Interi villaggi si spopolarono. I contadini espropriati e le loro famiglie si accodarono al flusso dei profughi diretti in Occidente. La risposta da parte della giustizia fu totalmente contraddittoria. Dura e inflessibile contro quelli che venivano identificati come i capi. Il ruolo di Hilde Benjamin sullo sfondo viene descritto in maniera tutt’altro che univoca, ma lo caratterizzava soprattutto l’intenzione di esercitare un influsso politico sui procuratori e sulle loro richieste nei processi in corso. Seguì il salto di carriera con cui Hilde divenne ministro della Giustizia della DDR. Non era nell’interesse di Mosca gonfiare ancora di più gli umori antisovietici nella popolazione adoperando troppa durezza dopo la rivolta del 17 giugno. La SED aveva istruzioni di concludere i processi nella maniera più rapida e silenziosa possibile. Ciò valse infine anche per le azioni giudiziarie contro reati commessi da ex membri della NSDAP, in cui si dovette assumere un atteggiamento più conciliante. Il confronto con il passato nazionalsocialista arretrò a favore di considerazioni più storiche. Così l’epoca nazista divenne soprattutto parte dello scontro propagandistico fra Est e Ovest. Quando era politicamente opportuno la SED non lesinava la pubblicazione di fascicoli riguardanti ex nazisti, al fine di smascherare le vecchie e nuove classi dirigenti tedesche occidentali nell’economia, nelle scienze e nell’amministrazione. Le élite brune, tornate a detenere «potere e influsso» in Occidente, non poterono sfuggire tuttavia all’ombra lunga del passato. «Malgrado il silenzio e la cura nell’occultamento, la speranza nel grande oblio non si compì» osservò giustamente Norbert Frei nel suo libro Carriere.LeélitediHitler. Perché in Occidente la renitenza a rispondere della propria storia cominciasse a mutarsi fu necessario attendere la fine degli anni Cinquanta con il loro clima di restaurazione. Chi visse l’epoca ricorda i tavoli di formica marmorizzati a forma di rene, sui quali pioveva la luce diffusa da più lampade sorgenti da un unico stelo. Pile di libri che raccontavano le eroiche avventure della Wehrmacht sulle pianure russe, con cui la generazione di Stalingrado poteva ricrearsi. Chioschi di giornali con romanzi di guerra e, ben visibile sugli espositori, il quotidiano di estrema destra «Deutsche National-und SoldatenZeitung». Oppure la serie televisiva «Fin dove arrivano i piedi» (Soweit die Füße tragen, 1959), che glorificava il soldato semplice e celebrava la Wehrmacht, vista a sua volta come un’ardita soldatesca che in realtà non aveva avuto nulla a che fare con la guerra di sterminio in Russia. Tutto ciò rientrava nella visione e nella psicologia della guerra fredda. Certi accessi di un tramandato, quotidiano razzismo sono rimasti nella memoria, quando i padri o i nonni si precipitavano a volte nella stanza dei figli o dei nipoti gridando «Basta con quella musica da negri!», trasmessa dagli Studios dell’American Forces Network (AFN) e ascoltata a tutto volume. La AFN era la radio della generazione postbellica, che con il swing e le big band, il jazz e il bebop trovò la sua musica, la colonna sonora per un’epoca politicamente di piombo. L’estremismo di destra ereditato dalla generazione dei padri e dei nonni continuava ad agire e si infiltrò nella generazione successiva, cosa che non può stupire in una società postfascista. E questo valeva sia per la Germania Est che per la Germania Ovest. Se si osservano oggi i successi elettorali del Partito Nazionaldemocratico Tedesco (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) e se ne sovrappone la distribuzione su una carta geografica del Reich prima del 1945, si vede che essa corrisponde esattamente a luoghi e regioni dalla Bassa Sassonia al BadenWürttemberg, dalla Baviera alla Turingia o alla Sassonia, dove il partito di Hitler poté registrare fin dall’inizio grandi successi. Nel 1962 l’affare «Spiegel» si abbatté sullo stato di Adenauer. Il governo federale con il capo della CSU Strauß, allora ministro della Difesa, riconobbe in un articolo sulle forze armate tedesche, intitolato «In parte pronti alla difesa», un «abisso di alto tradimento» e fece arrestare il direttore, Rudolf Augstein, il quale rimase centotré giorni in prigione. Anche l’autore dell’articolo e altri quattro redattori finirono in carcerazione preventiva. La reazione dei lettori, degli studenti e degli appartenenti alla borghesia liberale fu di grande sdegno. La loro protesta discese sulle strade della politica tedesca occidentale. I mezzi di informazione della repubblica cominciarono a trasformarsi. I primi quindici anni dello «Spiegel» furono dimenticati. Per Hachmeister questa fu una cesura storica che lo indusse a spostare la «data di fondazione mentale» della rivista dal 4 gennaio 1947 al 26 ottobre 1962, quando iniziò l’affare «Spiegel». Dopo la carcerazione preventiva Augstein definì l’affare un «colpo di fortuna», che utilizzò per rendere la rivista quel che ancora oggi vuole essere: liberale di sinistra e un «cannone d’assalto della democrazia». 8 «131» (dal corrispondente articolo della Costituzione della Repubblica Federale) erano chiamati tutti i dipendenti statali rimasti senza impiego al termine della guerra, nel cui numero erano comprese anche le persone allontanate dal servizio a causa della loro attività nel Terzo Reich. Un’apposita legge del 1951 consentì la riassunzione di quanti non fossero stati classificati «rei principali» (Hauptschuldige) o «compromessi» (Belastete) nei procedimenti di denazificazione [N.d.T.]. Capitolo undicesimo Madre e figlio La penna, intinta nell’inchiostro, grattava sulla carta da lettera. Era il 14 aprile 1960. La data sta in alto a destra sul foglio, a tre dita dall’orlo. Una lettera amorevole su due pagine: «Mia carissima bambina – cara mamma Usch!». Hilde Benjamin scriveva alla nuora Ursula (Usch), che aveva appena partorito. Georg, detto Grischa, era venuto al mondo. Nella sua lettera riecheggiava il ricordo delle proprie gravidanze: i due parti, a poco più di un anno l’uno dall’altro. Le era restato solo il secondogenito, Michael (Mischa). Peter era vissuto appena due settimane. Con il pensiero al nipote e a sua madre, così leggo la lettera più di cinquant’anni più tardi, Hilde Benjamin rivisse ancora una volta le sue sensazioni di puerpera. Dolore per il primo figlio, gioia per il secondo. Nell’armadio che contiene il lascito di Hilde Benjamin, e che Ursula ha conservato e curato per molti anni, si trovano anche queste righe che raccontano molto su chi le ha scritte. Ursula Benjamin mi allunga sul tavolo questa e poi un’altra lettera di sua suocera, entrambe protette da una busta trasparente. È un gesto schivo, del tutto discreto. Avevamo appena parlato di Bautzen e di quest’altra Germania scomparsa e io sento dalle sue parole, fra cui introduce qualche osservazione critica sull’idea che io ho di Bautzen, che le risulta difficile conciliare la mia descrizione con il suo ricordo della DDR e ancor più con la sua immagine di Hilde Benjamin, legata piuttosto a queste lettere. Da una sua frase capisco che ha avuto una lunga e accesa discussione a proposito di questo con suo figlio Grischa, la cui nascita nel 1960 era stata l’occasione per gli auguri di Hilde. Esito a insistere con le domande. Lei torna a guardare gli appunti che ha preso sui passaggi del mio testo che riguardano Bautzen, e non viene aggiunto altro sulla discussione telefonica. Io lo interpreto come un desiderio di approfondire tutto ciò che riguarda Hilde Benjamin. Queste lettere hanno in ogni caso un significato per chi vuole tratteggiare il suo ritratto. Dopo averle lette la vedo davanti ai miei occhi, intenta a riflettere sulle parole. Sono frasi come questa: «Forse però sei un po’ più contenta perché è un maschio». E poi prosegue: «Penso che per noi donne sia così, perché un maschio – come primogenito – ci incarna un’altra volta l’uomo che amiamo». Frasi che rimandano alla sua vita e al rapporto molto stretto fra madre e figlio, rafforzato ancora di più dalle circostanze dell’esistenza. Hilde augurava alla nuora gli stessi sentimenti di gioia che aveva provato lei da puerpera: «Sono nella mia memoria giornate di una grande e tranquilla felicità, giornate in cui il bambino appartiene ancora solo a noi, e in cui siamo colme dell’amore per lui, quell’amore che è cresciuto durante nove mesi». Quanto Mischa costituisse il centro della sua vita si può leggere in moltissime lettere e in centinaia di pagine. Hilde descriveva ogni minimo dettaglio della sua vita, la sua crescita e ogni sua trasformazione, in modo che il padre lontano potesse esserne al corrente. Già alla sua nascita lei aveva avuto quasi il presagio di ciò che sarebbe avvenuto e che avrebbe determinato anche il senso e il valore del loro rapporto. Hilde era la garanzia della sua sopravvivenza. Lei e il suo certificato di arianità erano il rifugio in cui Mischa avrebbe potuto crescere il più possibile libero dalla paura. E Georg, che negli inferni dei Volksgenossen9 e dei loro carnefici perse la vita, è vivo attraverso le testimonianze delle sue lettere, che Hilde ugualmente raccolse e conservò. Là c’è quello che gli amici dicevano di lui e che Hilde amava: la sua tolleranza, la capacità di ascoltare e di pensare in maniera opposta a ogni dogmatismo. L’infanzia di Mischa, il tempo della scuola e degli studi passarono diversamente rispetto a quelli dei bambini appartenenti a famiglie «di pura razza ariana», che gli vivevano accanto. Solo quando mi fu chiaro il rapporto simbiotico fra Hilde e il figlio Mischa e sentii di poter decifrare con relativa sicurezza l’eredità scritta delle loro due vite, vidi i molti segni che confermavano quella sensazione. Mischa era pronto in ogni istante a difendere la madre. Irritazione e una crescente rabbia lo assalivano quando si leggevano su di lei quelle frasi ripetute e divenute ormai rigidi cliché. E respingeva le costruzioni dei media occidentali e le formule provenienti soprattutto dall’arsenale della guerra fredda, che creavano l’immagine della «gelida donna di potere». In quella biografia non aveva approvato nemmeno la descrizione, un po’ superficiale, della cultura e dell’educazione femminile all’inizio del ventesimo secolo, perché la sentiva rivolta contro sua madre. Anzi, come esempio e dimostrazione della vasta cultura di Hilde portava se stesso, poiché tutto ciò che sapeva di botanica lo doveva alle sue lezioni. Vedeva tra l’altro anche il divieto di frequentare la scuola come una conferma del senso di inferiorità che i nazisti avvertivano rispetto agli intellettuali ebrei, tanto da voler impedire loro l’accesso all’istruzione e al sapere. Mischa leggeva tutto quello che veniva scritto o diffuso sulla madre. E prendeva posizione. Esigeva comprensione ed esattezza, ed era sempre pronto a parlare quando gli sembrava che fosse stata l’ignoranza a far pronunciare giudizi falsi su sua madre. Dopo la sua morte nel 1989, Mischa si propose di scrivere un libro su di lei. Come racconta sua moglie Uschi, cominciò a ordinare il lascito e a leggere le sue lettere. La morte inattesa di Mischa pose un’anticipata fine al progetto. Nessuno dei medici della Charité aveva considerato pericolosa la sua operazione al cuore, ritenuta un intervento di routine. Ci sono due biografie di Hilde Benjamin che non potevano piacere a Michael Benjamin. Già per questo motivo egli voleva correggere giudizi e pregiudizi che nei primi anni dopo il 1945 e al principio della guerra fredda si erano fatti strada in articoli o nelle pagine dei libri. Malgrado decine di test atomici, sopra e sotto la terra, almeno in Europa ci si limitò per fortuna alla guerra delle parole. L’equilibrio dell’angoscia produsse i suoi effetti: l’impasse atomica era espressione della paura di entrambe le parti, la forza distruttiva immagazzinata negli arsenali sarebbe bastata a dare il colpo di grazia all’umanità e al pianeta azzurro. Ma anche nella guerra delle parole ci furono i soccombenti. E per quanto riguardava l’immagine di Hilde Benjamin, quale veniva proposta nei mezzi di comunicazione, il figlio adulto non voleva concedere che l’Occidente accampasse diritti sull’immagine della propria madre. Nel marzo 1994 Mischa Benjamin scrisse da lettore alla «Berliner Zeitung», rivolgendosi a Stefan Heym e riferendosi al suo necrologio per Walter Janka. Heym vi ricordava anche il processo contro quest’ultimo, accusato di «istigazione al boicottaggio», un concetto dalle mille sfaccettature nella giustizia penale politica della DDR, e imputato inoltre di aver ordito un «complotto mirante alla caduta di Walter Ulbricht». La lettera di Michael Benjamin criticava solamente alcune parole del necrologio, che si riferivano a sua madre e al suo supposto ruolo nel processo del 1956 contro Walter Janka, ex direttore della casa editrice Aufbau, contro il caporedattore Wolfgang Harich e Gustav Just, caporedattore del settimanale «Sonntag». Il punto era se Hilde Benjamin, in quanto ministro della Giustizia, fosse stata sempre presente come uditrice nell’aula del processo, come Walter Janka credeva di potersi ricordare. E poiché ammirava molto lo scrittore Heym, Michael Benjamin coglie con spavento quella sfumatura che pare alludere a sua madre come a «Hilde la Sanguinaria». Queste sono le parole: «con lui [Janka], così pensavano i Melsheimer e i Benjamin [rispettivamente presidente e vicepresidente della corte suprema della DDR fino al 1953, poi ministro della Giustizia], si poteva montare un processo». Nella sua lettera Michael riprendeva il plurale utilizzato da Heym, cioè «i Benjamin»: «I Benjamin – sono mio padre Georg, che i nazisti hanno ammazzato a Mauthausen; mio zio Walter Benjamin, i cui scritti Lei certamente conosce, che nel 1940 in Spagna, la notte prima di essere consegnato ai nazisti, pose fine alla sua vita; ne fa parte anche la cugina di mio padre, la poetessa Gertrud Chodziesner-Kolmar, divenuta celebre dopo il 1945, che prese la via di Auschwitz. I Benjamin – sono generazioni di commercianti, fabbricanti e librai, rabbini, eruditi e medici, borghesi grandi e piccoli, conservatori e liberali e rivoluzionari che da trecento anni, se non da più, risiedono in Germania». I progenitori dalla parte del nonno erano ebrei venuti da Occidente, che per sfuggire all’Inquisizione avevano lasciato la Spagna e il Portogallo e, attraverso i Paesi Bassi, erano arrivati in Renania e in Vestfalia. Lontani rapporti di parentela sussistevano con le famiglie di Heinrich Heine (in ottavo grado) e di Karl Marx (in tredicesimo grado). Dalla parte della nonna la famiglia Schönflies discendeva da ebrei dell’Est, che per sfuggire ai pogrom del Medioevo si erano spostati in Austria, Ungheria e Polonia. Un antenato della famiglia Schönflies, Simon Markus, potrebbe aver fatto parte di una delle cinquanta famiglie ebree originarie di Vienna a cui il «grande» principe elettore Federico Guglielmo, con l’editto del 21 maggio 1671, consentì di immigrare nella Marca di Brandeburgo. I Schönflies/Benjamin appartenevano all’antica nobiltà prussiano-ebrea, come Mischa Benjamin notava non senza ironia. Loro discendente era anche Gertrud Chodziesner, cugina dei fratelli Benjamin, che con lo pseudonimo di Gertrud Kolmar avrebbe ottenuto una fama postuma come poetessa. Mischa Benjamin era un ammiratore della sua lirica. Capiva bene che Heym non si riferiva a tutti questi e che con quel plurale puntava soltanto a una persona, a Hilde, sua madre. «D’altro canto» commentava, «le sue azioni non possono essere comprese né spiegate senza gli altri Benjamin e il loro destino». Per lui quella donna era in primo luogo sua madre, che «nelle condizioni più ostili – dodici anni di nazismo, guerra, dopoguerra, persecuzioni razziali e anticomuniste, bombe e fame – da sola l’aveva tenuto in vita e cresciuto». In ciò vedeva un motivo sufficiente per contrapporsi a ogni «unilateralità e prevenzione nel giudizio sulla sua vita e la sua opera». Dei ricordi di Janka c’era comunque da dubitare ma, anche se non avesse sbagliato, la semplice presenza di lei non dimostrava affatto che avesse avuto un ruolo determinante nel processo. Stefan Heym, che ho incontrato diverse volte a Berlino negli anni Ottanta, lui stesso ebreo, lui stesso perseguitato, non avrà reagito con imperturbabilità a questa lettera. Ricordo lo sguardo dei suoi occhi intelligenti e cordiali. La voce ruvida, con quella leggerissima cadenza sassone. E il cranio possente e i capelli bianchi, sempre un po’ arruffati. Lui, come altri dopo il 1945, voleva trarre i corretti insegnamenti dalla storia e stare finalmente dalla parte giusta. La sua fama di scrittore gli assicurava il privilegio di viaggiare anche all’estero, nell’Occidente capitalista. Il suo ideale era tuttavia una DDR che realizzasse la visione di un mondo migliore e socialista, vagheggiata nell’emigrazione. Heym fece perciò sempre ritorno nel paese. Con la lettera di Mischa nella mano rifletté forse sulla velocità con cui si è pronti ad accogliere un’immagine particolare di qualcuno, senza conoscerne davvero le circostanze di vita. Il processo Janka risultò fatale per lo sviluppo interno della DDR. Il necrologio per la sua morte nel 1994 ricordava che lui e i coimputati Harich, Just e altri furono condannati a pene carcerarie fra i cinque e i dieci anni perché accusati di «cospirazione controrivoluzionaria». Incontrai Gustav Just nell’estate 2011, poco prima del suo novantesimo compleanno, nella sua vecchia casa contadina ristrutturata, sulla Dorfstraße a Prenden, fuori Berlino. Conobbi anche sua moglie, la quale era un po’ più giovane e, diversamente da lui, non mostrava alcuna debolezza fisica. Lui invece riusciva a muoversi solo appoggiandosi a un deambulatore, ma era lucido di mente. Entrambi avevano ancora ben presenti il processo e le sue circostanze. Anche Just era certo di aver visto almeno una volta fra gli spettatori «la signora Benjamin, come un’ombra minacciosa». I due avevano pubblicato i loro ricordi relativi al processo. Parlammo di questo e poi degli anni di carcere a Bautzen. Sei mesi dopo il nostro incontro Gustav Just morì. Sul settimanale «Sonntag» aveva divulgato i dibattiti teorici in Polonia e Ungheria. Mentre ne parlava si notava ancora la delusione procurata in lui dalla dirigenza della SED e dal gruppo di discussione che l’avrebbe portato in carcere, cosa in cui ebbe parte l’allora ministro della Cultura, Johannes R. Becher, che lo denunciò come controrivoluzionario. Dopo le rivelazioni sul terrore staliniano al XX congresso del PCUS lui e i suoi compagni avevano sperato in un maggior liberalismo interno anche nella DDR, e furono incarcerati come controrivoluzionari. La speranza morì con la repressione del comunismo riformista ungherese e la rivolta del 1956. Portò in Unione Sovietica la fine della breve primavera che aveva seguito la morte del dittatore e rafforzò gli stalinisti nella DDR. Quello, ogni caso, non fu il processo di Hilde Benjamin. Michael ammette nella lettera a Stefan Heym che, in quanto ministro della Giustizia della DDR fino al 1967, la madre aveva «preso parte in maniera significativa e in posizione di responsabilità al saliscendi, agli insuccessi e alle disfunzioni, alle traversie della giustizia nella DDR, così come alle sue conquiste». Quanto la promulgazione e l’applicazione delle leggi siano atti politici fu qualcosa che Hilde Benjamin, come suo figlio Michael, poté osservare direttamente, nella repubblica di Weimar, nello stato nazista e nella Repubblica Federale. Ciò consolidò in lei l’idea che solo la DDR si opponesse alla restaurazione nella Germania Occidentale. È soltanto il figlio di Hilde che nel passaggio seguente si rivolge a Stefan Heym: «Molti hanno odiato mia madre; altri l’hanno non meno rispettata e onorata. Credo che la storia non abbia ancora pronunciato l’ultima parola sul suo operato. So però una cosa, meglio di tutti i documenti che non conosco e che si potranno ancora trovare: non c’era in lei alcun interesse personale né cinico calcolo. Qualsiasi cosa abbia fatto, è avvenuta nella profonda convinzione di servire alla causa a cui aveva dedicato la sua vita: la creazione di una società migliore e socialista». Michael fa capire del resto quanto condivida l’opinione di Heym su Janka e con quanta partecipazione abbia letto perciò il necrologio nella «Berliner Zeitung». Nel 1994 erano passati cinque anni dalla scomparsa della DDR e la Germania nuovamente riunita cominciava a scrivere la storia. Un cambiamento radicale che sua madre, come affermava Michael, «non avrebbe sopportato» se avesse ancora vissuto. Fra le righe credo di poter leggere che dopo la sua morte Michael poté riflettere in maniera sempre più libera e indipendente su ciò che aveva portato alla fine della DDR. Chiedo a Georg, figlio di Michael Benjamin, se condivide questa mia ipotesi sullo speciale rapporto fra madre e figlio. Georg riceve le bozze di questo libro nei diversi stadi di elaborazione e corregge, se necessario, numeri, fatti, date. E così fanno anche la madre Ursula Benjamin e i nipoti Laura e Jakob, figli di Georg, tutti quelli la cui storia si racconta in questo libro tedesco di lettura che supera i confini del ventesimo secolo. Georg, con cui in genere ho solo contatti per email, siede con me, Ursula, Laura e Jakob al tavolino rotondo nella biblioteca, davanti agli scaffali pieni di libri che occupano un’intera parete della stanza. In occasione della sua nascita, nel 1960, la nonna Hilde aveva scritto quella lettera affettuosa a Uschi. Un buon mezzo secolo è passato da allora sul paese. Intorno a noi il chiasso e l’entusiasmo per la partita di calcio. Un’altra volta i campionati europei, i cui penetranti echi ci raggiungono. L’interesse di Georg per il calcio è pari a zero, e non cambia nulla che l’Ucraina sia il paese ospitante insieme alla Polonia. Non avrei mai pensato che alla mia preghiera di esprimere la sua opinione sul capitolo che parla della madre Hilde e del figlio Mischa lui potesse rispondere venendo per il fine settimana da Kiev a Berlino. Da alcuni anni lavora in Ucraina. Ora mi siede di fronte, di media statura, snello, molto disinvolto. Un uomo sportivo sulla cinquantina, gli occhiali con la montatura a giorno, lo sguardo intelligente, i jeans con qualche buco, una maglietta nera. Se deve leggere qualcosa sposta gli occhiali sulla fronte. Dove però sono più che altro d’intralcio. Questa amichevole schiettezza ce l’hanno anche i suoi figli, Laura e Jakob. Già da bambino, dice, aveva imparato a porre domande critiche di contro alle ovvietà: «Così mi hanno educato i miei genitori». Georg Benjamin racconta di suo padre, che dopo l’abilitazione alla libera docenza e la nomina a professore aveva avuto l’incarico di occuparsi dell’«Organizzazione scientifica della dirigenza statale». A questo scopo doveva creare un istituto a Mosca e nel 1981 ne assunse per quattro anni la vicedirezione. Dal 1989 al 1991 seguirono altri due anni all’istituto, prima che fosse liquidato. In quest’epoca Mischa Benjamin viaggiò anche in Occidente, dove poté venire a contatto con le tecniche di management e le idee di good governance. Georg, che lo seguì a Mosca per studiare, ricorda che suo padre aveva riconosciuto presto l’irrigidimento del socialismo «amministrativo». Quando gli fu chiesto di sviluppare altre strutture direttive nella DDR era troppo tardi. L’incarico gli era stato affidato da Egon Krenz, successore di Honecker, segretario del Comitato centrale della SED che poco tempo dopo, nel 1990, fallì nel tentativo di farsi eleggere alle prime nonché ultime libere elezioni per la Camera del Popolo (Volkskammer) della DDR. Tutti nell’istituto, ricorda Georg includendo se stesso e i suoi compagni, erano affascinati quando entrarono in contatto con il «nuovo pensiero» di Gorbačev. Nessuno allora poteva prevedere che la perestrojka avrebbe causato una tale scossa tellurica, la quale avrebbe agitato e dissolto il blocco orientale dominato da Mosca. Nemmeno le persone direttamente coinvolte in questo sviluppo lo prevedevano, nemmeno lo stesso Gorbačev. Non era neppure il suo obiettivo. Era semplicemente accaduto così. Georg Benjamin contraddice con decisione: no, non era stato solo dopo la morte di sua madre che Michael si era sentito libero di osservare criticamente la realtà della DDR. Non nega però che parlando con la madre Michael possa aver espresso in maniera meno tagliente le contraddizioni che lo colpivano. Uschi aggiunge che lei e Mischa si erano ripromessi di evitare possibilmente il tema nelle conversazioni con Hilde. Georg crede tuttavia di ricordare dai suoi discorsi con la nonna un deciso accento di critica sulla situazione del paese. Giudica esagerata la supposizione di suo padre, vale a dire che Hilde non avrebbe «sopportato» la fine della DDR. Georg conferma l’osservazione di Uschi, cioè che proprio i «compagni anziani, dai settant’anni in su» abbiano accolto con una sorprendente tranquillità la fine della DDR. Per loro non era stata che una tappa. Il suo fallimento rappresentava una sconfitta, ma non la fine della battaglia. La loro fede nel socialismo scientifico restava immutata. Uschi ricorda soprattutto le conversazioni con Lotte Ulbricht, che già due anni prima di morire l’aveva pregata di tenere il suo discorso funebre per lei. Uschi e Mischa vissero diversamente la fine della DDR. Mancava loro la tranquillità degli anziani. Suo padre, ricorda Georg, aveva visto nell’assenza di apertura e nella sfiducia dei dirigenti del partito verso l’intelligenza critica una causa fondamentale dell’irrigidimento del paese, che aveva finito per travolgerlo. Per Uschi Benjamin invece la DDR significò soprattutto l’accesso all’istruzione e l’affrancamento dalla minorità. Nella società borghese, ne è convinta, sarebbe stata esclusa dall’istruzione. Continua a ripetere di essere stata la prima della famiglia che poté conseguire il diploma liceale e poi universitario. Torna a risuonare il sentimento di gratitudine e lealtà per lo stato che aveva reso possibile tutto questo. E poi ricorda la prima visita di Hilde, la suocera, il ministro, a Rostock in casa dei suoi genitori. Ricorda il proprio batticuore prima del suo arrivo e poi la cordialità di Hilde Benjamin, che aveva reso tutto più facile. Michael Benjamin aveva conosciuto la sua futura moglie a Leningrado quando lei era ancora studentessa; era la figlia di una pescivendola di Rostock e di un operaio che aveva circumnavigato Capo Horn su una nave da carico. La fame di studio in quella generazione era immensa, e molti conseguivano una seconda laurea attraverso corsi per corrispondenza; si studiava sempre, se necessario anche nelle ore serali e notturne. La divisione in classi era superata almeno per quanto riguardava l’accesso allo studio. Anche negli studi superiori i figli dei proletari erano la regola e non l’eccezione. Nessuno metteva in dubbio la loro capacità di istruzione. È vero d’altro canto che ai figli di famiglie borghesi o dei parroci era impedito di conseguire la maturità liceale e di studiare all’università. Il ricordo della sua personale ascesa non consente a Uschi – anche a distanza di due decenni abbondanti dalla fine del suo stato – di tollerare la sfumatura critica che traspare in diverse mie frasi. Eppure ci prova. Capisco il suo disagio; dopo aver letto nei libri di Christa Wolf le riflessioni sul senso di perdita causato in lei dal fallimento della DDR posso immaginare il suo stato d’animo. Per Christa Wolf il congedo interiore dalla DDR era cominciato dopo l’XI seduta plenaria del Comitato centrale della SED, quando Ulbricht fece i conti con gli esponenti della cultura, e soprattutto con gli scrittori. Ne parlò in un articolo, uno dei cinque contributi di scrittori tedeschi orientali sulla DDR e dei venti autori occidentali sulla storia della Germania Ovest. L’occasione erano i sessant’anni della Repubblica Federale. Il rapporto venti a cinque, questo il sospetto di Christa Wolf, poteva avere da un lato la funzione di un alibi; d’altro canto contribuiva a opporre invece al quadro differenziato della Repubblica Federale una visione esclusivamente cupa della DDR, soddisfacendo lo spirito del tempo. E tuttavia lo scrisse, certo anche perché l’XI seduta plenaria era stata molto importante per l’evoluzione della DDR. Per lei era stata la fine della speranza che dopo la costruzione del muro si potesse sviluppare e affermare finalmente un clima più liberale e che la situazione economica della DDR, in drammatico declino, tornasse a riprendersi. Due speranze che sarebbero state deluse. Christa Wolf aveva preso le parti dei colleghi scrittori, i quali vennero messi globalmente alla berlina, come i registi e altre persone che lavoravano nel cinema. Particolarmente esposti alle critiche erano stati Stefan Heym, Wolf Biermann e Werner Bräunig con il suo progetto di romanzo Rummelplatz, sull’estrazione dell’uranio nelle miniere della Wismut, alcune parti del quale erano state pubblicate sulla rivista «Neue Deutsche Literatur». Soprattutto Bräunig era stato bersaglio di una élite di funzionari aggressiva e timorosa nella sua perplessità, che vedeva negli intellettuali i responsabili del mancato compimento del postulato di Ulbricht: «Superare senza raggiungere» l’Occidente.10 Nella sua premessa al romanzo di Bräunig, che poté essere pubblicato solo dopo la fine della DDR, Christa Wolf ammirava lo straordinario materiale e il suo autore, sopravvissuto nove anni al divieto di pubblicare. Ho letto sul ruolo di Christa Wolf alla seduta plenaria. E anche adesso, mentre scrivo queste frasi, me la rivedo davanti, lei che per i suoi lettori in Occidente era solo geograficamente lontana, dietro le mura. Vedo l’espressione pensosa nel viso dalla bellezza antica di una donna che avrebbe potuto essere nel contempo Cassandra e Medea. Lei stessa diede a entrambe le donne una grande forza di carattere, una forza soprattutto nelle loro sconfitte. Come Christa Wolf allora: giunta in veste di candidata al Comitato centrale della SED, dopo il suo discorso e la sua appassionata arringa a favore della libertà dell’arte chiese di non esserlo più. In un’intervista la Wolf illustrò gli esiti di quella seduta plenaria: dodici film furono proibiti. Ciò valeva anche per il film basato sulla sua sceneggiatura «Fräulein Schmetterling» [La signorina Farfalla], che Konrad Wolf voleva realizzare. Fu proibito dopo il montaggio preliminare. E così il romanzo Rummelplatz di Werner Bräunig. Christa Wolf divenne una sorta di autorità morale che invocava un’immagine della DDR dal volto umano – un’immagine che tuttavia non divenne mai reale. La sua forte personalità e la sua fama di scrittrice la protessero, e tuttavia il Ministero per la Sicurezza di Stato utilizzò ciò come un pretesto per tenerla sotto controllo, cosa che si concretizzò in quarantadue fascicoli su di lei. La sua breve collaborazione informale presso la Stasi con cui, com’è dimostrato, non danneggiò nessuno condusse dopo la svolta a una caccia alle streghe che doveva colpire la sua integrità. Un anno dopo il plenum cominciò a scrivere Riflessioni su Christa T. La protagonista muore a trentacinque anni di leucemia e fallisce nel conflitto fra le sue esigenze personali e quelle della società. Christa Wolf ribadì che la trama era opera di finzione, nella quale tuttavia era confluita anche la storia di un’amica. Poiché gli organi di censura avevano fiutato nel romanzo il «pericolo di uno spaesamento ideologico» per i lettori, al principio la prima edizione del 1969 non poté essere interamente consegnata. Questo – insieme alla frase finale del romanzo: «Quando, se non ora?» – le venne ricordato durante una conversazione con il settimanale «Die Zeit». Gli intervistatori supponevano che fosse una frase per la morte. Christa Wolf contraddisse: «No, in sostanza è una frase per la vita». Era l’espressione condensata dell’aver compreso che ogni giorno è prezioso, e il libro sarebbe nato dal lutto per la morte di un’amica: «La DDR ha sempre rinviato tutto, la realizzazione di una società perfetta, di nuovi uomini felici. Per un futuro luminoso ci si è fatti sfuggire il passato». La frase può riferirsi anche a questo. La città degli angeli: in questo libro Christa Wolf ha descritto la sua lotta tra speranza e delusione, fra desiderio e disgusto. E anche il dolore per la perdita della DDR. «Abbiamo fallito. Il paese in cui vivo e nel quale all’inizio avevo riposto ancora qualche speranza si fossilizza e si pietrifica di anno in anno sempre più, è prevedibile che presto se ne starà immobile come una salma, esposta lì per essere depredata». Citiamo ancora dalla conversazione con «Die Zeit», in cui la scrittrice risponde alla domanda su quale sia stato il momento in cui si è allontanata dalla DDR: «È stato un lungo congedo, iniziato nei primi anni Sessanta. L’ultimo periodo in cui sarebbe stato possibile cambiare davvero la DDR attraverso le riforme fu il 1968. Poi però i russi hanno soffocato la primavera di Praga. A quel punto era finita. Dopo la riunificazione si insinuò per breve tempo una sorta di dolore fantasma, anche perché trovavo troppo vago inquadrare la DDR esclusivamente sotto il segno della dittatura. Ma anche questo dolore è passato». Come chiunque sia interessato può vedere e leggere, la DDR ha lasciato dietro di sé una grande eredità letteraria. Accanto a Christa Wolf c’è una folta schiera di scrittori importanti, e non è meno folto il numero degli artisti e degli straordinari attori, registi e autori teatrali come Heiner Müller, Peter Hacks, Stefan Heym, Thomas Brasch, Jurek Becker, Hans Joachim Schädlich, Kurt Bartsch, Peter Huchel, Heiner Kipphardt, Volker Braun, Günter de Bruyn, Christoph Hein, Maxie Wander, Günter Kunert, Erich Loest, Wolf Biermann, a cui si aggiungono non pochi fra quanti lavorarono negli studi cinematografici della DEFA, registi come Konrad Wolf, Frank Beyer, Heiner Carow, Egon Günther e Kurt Maetzig che – quando i loro film arrivavano al pubblico – hanno fatto grande cinema. Michael Benjamin aveva dunque molto da scoprire nel momento in cui si poneva la domanda retorica se e cosa fosse rimasto della DDR. C’erano cause che spiegavano perché, in quanto modello di una società socialista, non avesse superato la «prassi storica», come lui l’avrebbe probabilmente chiamata. È quasi una beffa della storia che sia soprattutto la sua eredità culturale, non amata dalla SED e osservata sempre con diffidenza, a trovare posto nella quinta Germania. Michael Benjamin non era uno di quelli che dipingevano positivamente la storia del movimento comunista, soprattutto là dove esso mostrava tratti di sgradevolezza. In una lettera espresse il suo sgomento per il fatto che lo storico Gossweiler cercasse di «sottacerne, oppure di giustificarne» proprio le «pagine più scure». Quella fase del primo socialismo legata a Stalin, che lui definiva «profondamente contraddittoria», non era stata accompagnata solo da errori, cosa inevitabile, ma anche da «ingiustizia, terrore, deportazioni di interi popoli, sterminio di comunisti, oppressione e distruzione di chi la pensava diversamente o semplicemente non era più gradito. Proprio noi comunisti dobbiamo riconoscere anche questa parte della nostra storia e trarne le conseguenze». Poi si occupò dei «processi contro i parassiti» degli anni Trenta, che Gossweiler aveva giustificato citando Brecht, il procuratore della corona Pritt, Lion Feuchtwanger e certi diplomatici americani, i quali avevano dato una «valutazione positiva». «Purtroppo» scrisse Benjamin «sappiamo da molti anni che queste donne e questi uomini non avevano ragione». Contro di loro c’erano le testimonianze delle decine di migliaia di persone che erano state liberate dai campi di lavoro, delle altre centinaia di migliaia, molte delle quali riabilitate solo dopo la loro morte, fra cui molti onesti comunisti sovietici e anche tedeschi che dopo tutte queste vicissitudini restarono fedeli alla causa comunista. Michael Benjamin rimanda a «fascicoli e documenti, denunce e processi e condanne a morte». Avrebbe potuto anche rimandare a manoscritti e vicende occorse all’Hotel Lux di Mosca, dove i membri dell’Internazionale comunista (Comintern), i quali erano alloggiati là, reagivano a ogni colpo alle porte delle loro stanze con un timore panico, perché vivevano nell’angoscia di essere condannati come «parassiti», uccisi a colpi di arma da fuoco, impiccati, arrestati comunque dalla Polizia segreta e nel migliore dei casi confinati in Siberia. Una testimonianza recente di tutto questo è data dalle memorie, pubblicate postume, di Wolfgang Ruge, noto storico della DDR e padre dello scrittore Eugen Ruge. Anche lui alloggiava all’Hotel Lux, dove a quanto ricorda vigeva un motivo solo: «epurazione». A lui, comunista convinto, ciò procurò quindici anni di Lager e il confino in Siberia. Non è facile rispondere alla domanda perché i comunisti tedeschi come Ruge, che avevano provato sulla propria pelle il terrore staliniano, tacquero su queste esperienze e in moltissimi casi mai, o solo dopo decenni, riuscirono a rielaborarle. Anche i ricordi di Ruge sarebbero rimasti sconosciuti se il figlio Eugen non avesse messo in ordine e pubblicato il lascito del padre. Persino nel 1953, dopo la morte del mostro al Cremlino e le rivelazioni dei suoi crimini al XX Congresso del Partito nel 1956, essi restarono per lo più in silenzio. Michael Benjamin si è occupato sostanzialmente e in maniera critica degli anni del terrore in Unione Sovietica, attorno al 1930. Ciò che innanzitutto gli premeva era riaprire le vie ostruite e ormai divenute impraticabili, per non fallire già al primo tentativo di sincerarsi della propria identità di comunista. È così quando afferma che «la violenza e il terrore rivoluzionari possono essere imposti e giustificati dalla storia». Sostiene che essi non erano un fine a sé per i rivoluzionari e soprattutto per i comunisti, ma erano per lo più una risposta obbligata alla «violenza e al terrore controrivoluzionari». Ricordava che la Rivoluzione di Ottobre era cominciata come una delle meno sanguinose della storia – fin quando sopraggiunsero la controrivoluzione armata e l’intervento straniero. D’altro canto non sarebbe stato né giustificato né rivoluzionario aver annientato quasi tutti i compagni di lotta di Lenin, la maggioranza dei delegati al XVI Congresso del PCUS (il «congresso dei vincitori»), nonché gli oppositori della propria ideologia nel partito, che da tempo non esercitavano più alcun influsso politico, o le compagne e i compagni semplicemente non più graditi. Respingeva anche l’ultimo argomento di Gossweiler: senza i processi negli anni Trenta non ci sarebbe stata la vittoria in guerra contro il fascismo tedesco. Michael Benjamin lo contraddice: non è possibile alcuna giustificazione del terrore e degli arresti di massa, dell’annientamento dei comunisti e di altri onesti cittadini sovietici. Al contrario: l’eliminazione a decine di migliaia dei quadri dirigenti dell’economia e la quasi totale rimozione dei generali e degli alti ufficiali dell’Armata Rossa avevano provocato gravissimi danni all’economia e alla capacità difensiva dell’Unione Sovietica proprio nei momenti più critici, immediatamente prima e dopo l’aggressione nazista; avevano influenzato la fase iniziale della «Grande guerra patriottica» in maniera sostanzialmente sfavorevole all’Unione Sovietica, il che era costato la vita a milioni di persone. Michael Benjamin voleva il dialogo fra posizioni differenziate e un pluralismo di sinistra che si potesse sostenere nell’uso del rispetto. Solo così il partito giustificava la sua esistenza e diventava l’opposto di una stanca appendice della socialdemocrazia. Era convinto che non si dovesse escludere nessuna corrente interna al partito. Prese più volte le difese di Sahra Wagenknecht, che dieci anni dopo diventò la comunista esemplare, invitata ai talk show dei programmi pubblici e che all’occasione argomentava in maniera piuttosto efficace, quando si parlava della spaccatura tra ricchi e poveri all’interno della società. La sua ascesa nel partito che da Partito del socialismo democratico (Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS) si era mutato nella Sinistra (Die Linke) è comunque notevole. Ancora pochi anni prima, sotto il tiro continuo di influenti media, il partito era stato manifestamente diviso sulla maniera di porsi rispetto alla piattaforma comunista. Ormai un tema secondario? Sahra Wagenknecht fu candidata addirittura alla presidenza del partito, e ne divenne vicepresidente. È chiaro – e perciò torno a rileggerlo – che Michael Benjamin si interessò molto alla vita ebraica nella DDR. Anche qui riesce a evitare i soliti cliché e nello stesso tempo a turbare l’(auto)certezza tanto diffusa in Occidente, cioè che il secondo stato tedesco che si definiva antifascista non avesse affrontato meglio questa parte della storia comune rispetto a quanto aveva fatto l’Occidente. Un discorso tenuto al congresso dell’Associazione internazionale dei giuristi ebrei nel 1994 ci fa conoscere il suo pensiero. Nel contempo appare nuovamente chiaro quanto esso sia stato segnato dalla sua drammatica storia familiare e dal peso che aveva gravato su di lui, «meticcio», outsider e respinto. Quante volte prima del 1945 Hilde Benjamin deve aver legato il suo disprezzo della «Volksgemeinschaft»11 nazista alla speranza di un ordine sociale che non avrebbe conosciuto nulla del genere. Solo nel successivo corso della storia postbellica Michael Benjamin potrebbe d’altro canto aver capito che non sono soltanto l’ideologia o la riflessione filosofica a formare una società. Soltanto dopo la svolta comprese anche lui che nel suo rifiuto del pensiero di estrema destra la DDR non era molto più avanti della Repubblica Federale. Michael Benjamin descrive tuttavia la DDR come una «collettività in cui l’ebraismo era ininfluente, nello stato come nelle istituzioni». Questo era stato per lui un enorme sollievo. L’ebraismo divenne una questione privata e «noi volevamo che – finalmente – fosse questo e nient’altro». Lo era anche rispetto alla possibilità di ascesa a posizioni elevate. «Non si saliva in alto nonostante si fosse ebrei, e tanto meno perché lo si era». In generale c’era di che essere critici rispetto ai meccanismi di formazione delle élite nella DDR, anzi era doveroso esserlo perché in fin dei conti avevano fallito, contribuendo a rovinare il socialismo. «Ma la sua indifferenza nelle cose ebraiche era uno dei suoi pregi». Tuttavia gli è chiaro «che nessun tedesco, membro di una comunità ebraica oppure no», poteva negare anche solo a se stesso la propria origine: «Nella nostra storia recente è successo troppo perché ciò sia concepibile. Chi prima del 1933 non sapeva nulla delle proprie origini ebraiche, magari perché proveniva da una famiglia totalmente assimilata, o pur conoscendole le considerava con indifferenza, dopo dodici anni di nazionalsocialismo e persecuzione non poteva più considerarle così. A quel punto era salda la consapevolezza di essere ebreo». Ricorda «con dolore» che nella DDR era stata sempre avvertibile un’attitudine che non soltanto «considerava ufficialmente irrilevante l’ebraismo (cosa in sé buona), ma lo ignorava (cosa in sé negativa)». Essa era stata un elemento di quella rigidezza e quella distorsione che aveva investito la vita sociale del paese, e anche una componente del suo fallimento. Vi rientrava anche la falsa convinzione che l’antisemitismo nella DDR fosse estirpato «per sempre», e che il problema fosse dunque risolto. Nelle due Germanie ci furono, sia pure in periodi diversi, tentativi di far pulizia rispetto allo stato hitleriano. Nei primi anni dopo il 1945 ciò parve riuscire gradualmente meglio nella DDR. Sotto lo choc dell’estremismo di destra che negli anni dopo la svolta era tornato a mostrarsi, Michael Benjamin avanzava dubbi sulla profondità di tutto questo. Anzi, sarebbe stato sorprendente se le società postfasciste avessero potuto essere superate in meno di una generazione. Nella quotidianità della DDR, come recenti pubblicazioni dimostrano, l’antisemitismo era qualcosa di avvertibile. Michael Benjamin non tradì le sue convinzioni. Dopo la morte di Hilde si mantenne fedele alla sua causa e alla propria, e così anche dopo aver vissuto il crollo della DDR. In quanto ebreo tedesco (o «discendente di ebrei») si sentiva parte peculiare del popolo tedesco stesso. Quanto all’ebraismo in Germania e al suo notevole contributo a ciò che in maniera poco specifica si chiama cultura tedesca, Michael cercava di distinguere l’elemento duraturo dal transitorio, cercando nel contempo una risposta all’interrogativo se anche della DDR sarebbe rimasto qualcosa. Il socialismo democratico è legato per lui alla possibilità, da parte del Partito comunista, di accettare anche di non essere rieletto, cosa che in elezioni libere e segrete può sempre inevitabilmente succedere. Per Michael Benjamin la DDR, misurata sui suoi stessi criteri, è fallita soprattutto dal momento in cui princìpi da essa stessa stabiliti, come per esempio il principio di partecipazione e coorganizzazione, vennero erosi e infranti in misura sempre crescente. In maniera altrettanto critica giudica l’operato della Sicurezza di Stato e la sua «vigilanza estesa oltre misura», soprattutto sui propri cittadini. Il suo credo per una seconda rincorsa verso una società socialista si trova nel terzo paragrafo del programma del Partito del Socialismo Democratico (Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS): «Lottiamo per una via che ci porti al di là del capitalismo e non indietro nel socialismo amministrativo. E per far questo abbiamo bisogno di tutte le tradizioni democratiche». Michael Benjamin conobbe nella sua vita soltanto il PDS, non ne vide l’espansione alle vecchie regioni della repubblica federale e il cambiamento del nome in «La Sinistra», che sembra rimandare piuttosto a un movimento composito. Attualmente il pluralismo che anche qui risuona sembra piuttosto fallire. Per lui, in ogni caso, le radici socialdemocratiche erano importanti quanto quelle marxiste: «L’accento posto per esempio sulla questione della democrazia, la battaglia per ottenere miglioramenti sociali, la partecipazione alle lotte sindacali e alla politica comunale, e in generale la visione del “socialismo come movimento” rimandano in maniera considerevole a tradizioni socialdemocratiche». Dell’eredità anarchica gli piacevano la critica alla statalizzazione della società, il risalto dato all’individuo e alle sue possibilità di autoorganizzarsi. Tuttavia non si può nemmeno ignorare che proprio al comunismo risalivano l’idea di eliminare lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo e il concetto dell’uguaglianza sociale ottenuta attraverso il superamento delle differenze di classe. Così Michael Benjamin descrive in maniera calzante le radici del movimento operaio, e perciò pondera sia le vittorie che le sconfitte. Spesso madre e figlio ne avevano discusso. Quante volte Hilde Benjamin deve aver pensato a Georg e alle sue opinioni non dogmatiche, che un giorno avrebbero potuto metterlo in difficoltà. Il suo sguardo torna al marito assente, che per la sua fede dovette seguire il proprio calvario fino alla fine. Tanto più la famiglia del figlio la circonda invece di un’attenzione affettuosa, che trova espressione in una lettera per il primo compleanno del nipote Georg: «Per il primo compleanno del vostro bambino i miei pensieri vanno a voi, con profondo amore. Noi non parliamo molto dei nostri sentimenti; noi lasciamo che il nostro legame sia percepito anziché avvolto in parole, e nei miei pensieri io mi rivolgo spesso a voi. Questo primo anno in cui siete stati una famiglia non è stato facile per voi. Ma io penso: l’aver sopportato insieme [...] la malattia e altre difficoltà vi ha avvicinato più in fretta e saldamente. Il periodo che ho vissuto con voi è stato una grande gioia inattesa. Dirlo non significa che io mi aspetti che questa convivenza esterna debba continuare sempre così. Ma al presente ne godo, e ne sono grata. Lo sviluppo della vita cosciente in Grischa è per me – evidentemente – un miracolo quasi più grande di quel che ho vissuto con mio figlio». La lettera con l’intestazione «Dott.ssa Hilde Benjamin, Berlin Niederschönhausen, Majakowski-Ring 59» viene da Friedensburg, una casa di riposo in Turingia, ed è datata 10 aprile 1961. Il Majakowski-Ring, una via trasversale che si diparte dal castello di Schönhausen, esiste ancora, così chiamata in ricordo del poeta rivoluzionario russo e rappresentante del futurismo Vladimir Majakovskij. Era nato nel 1893, un anno dopo Walter Benjamin, e morì nel 1930 a Mosca. Anche questa lettera è un segno della vicinanza e dell’amore che Hilde Benjamin provò nella sua vita per il figlio, e che ora trasmette anche al nipote. Ogni riga lascia intuire nel contempo quanto avesse desiderato una famiglia con suo marito Georg. Ora vede una famiglia felice, Michael, Ursula e i nipoti, Grischa e la sorellina Simone, e scorge per sé l’occasione di recuperare un po’ di quello che nella sua vita era rimasto uno spazio vuoto, coperto dal lutto. Georg ricorda una nonna che fino alla fine si interessò alla politica. Dopo aver lasciato la carica di ministro della Giustizia Hilde Benjamin si era ripromessa varie volte di scrivere a Ulbricht, e in seguito a Honecker, per verbalizzare la propria critica alla realtà della DDR. La sua morte giunse inattesa, come lo sarebbe stata undici anni dopo quella di suo figlio Michael, padre di Georg. Quest’ultimo racconta che Hilde aveva subito una complicata frattura dell’anca, che doveva essere operata. Nessuno poteva immaginare che non sarebbe sopravvissuta. In ospedale contrasse un’infezione e morì di polmonite. 9 Attestato fin dalla fine del diciottesimo secolo nell’accezione di «compatriota», durante il nazionalsocialismo il termine Volksgenosse si carica di una valenza fortemente ideologica e razzista. «Cittadino può essere soltanto chi è Volksgenosse» si legge nel programma del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi nel 1920. «Volksgenosse può essere soltanto chi ha sangue tedesco, indipendentemente dalla sua confessione religiosa. Un ebreo perciò non può essere un Volksgenosse» [N.d.T.]. 10 «Überholen, ohne einzuholen» aveva annunciato nel 1959 il Segretario generale e Presidente della SED Walter Ulbricht: superare economicamente la BRD, seguendo però un’altra via [N.d.T.]. 11 La «comunità del popolo», cioè la comunità dei Volksgenosse, legati dal «sangue» e nel «destino» [N.d.T.]. Capitolo dodicesimo Riflessi da una Germania all’altra Era l’anno in cui Nikita Chruščev si tolse una scarpa nella grande sala per le riunioni delle Nazioni Unite e, con mossa rapida e vivace, ne picchiò ritmicamente il tacco sul tavolino pieghevole al proprio posto, battendo la cadenza di marcia a quella quindicesima assemblea plenaria. Il tavolino resse, la sua carriera no. Da New York l’immagine con la scarpa nella mano fece il giro del mondo. Non ci fu quotidiano che il giorno dopo non stampò con ampio spazio in prima pagina la foto. Negli Stati Uniti il giovane John F. Kennedy, candidato del Partito democratico, vinse le elezioni presidenziali. Divenne l’avversario di Chruščev nella competizione fra le superpotenze per la supremazia globale. Il motivo dell’ira di Chruščev, sfogata attraverso la scarpa, era il seguente: nel maggio 1960 il pilota Francis Gary Powers era per così dire caduto dal cielo, planando col paracadute sopra il territorio sovietico, ed era finito in prigione. I sovietici avevano sparato al suo U2, un aereo spia. L’episodio fu giudicato da Mosca un atto di aggressione. I rapporti con gli Stati Uniti avevano raggiunto un punto di congelamento già sotto il presidente Edward D. Eisenhower. Powers fu condannato in quanto spia. Due anni più tardi sedeva in una limousine del KGB, diretto a Potsdam. L’agente della CIA Powers era volato da Mosca a Berlino Est su un Il’jušin e da lì era stato portato in macchina al ponte di Glienicke. A metà del ponte, davanti alla linea di demarcazione che separava i due blocchi di potere, il 10 febbraio 1962 alle ore 8.44 del mattino Powers scese dalla limousine di marca Volga. Gli andò incontro l’agente del KGB Rudolf Ivanovič Abel, sospettato di aver spiato il programma atomico degli Stati Uniti, benché lo avesse sempre negato. Era stato portato in aereo dagli Stati Uniti a Berlino Ovest. Scambio di agenti segreti durante la guerra fredda, una pura routine. E nella lontana Francoforte sul Meno il procuratore generale Fritz Bauer sedeva nel suo ufficio, e in questa giornata primaverile del maggio 1960 dovette apprendere con una certa soddisfazione la notizia che l’ex SSObersturmbannführer Adolf Eichmann era stato rapito in Argentina da un commando israeliano ed era stato portato a Haifa. Pochi giorni dopo, il 23 maggio 1960, lo stato di Israele avviò un procedimento penale contro l’uomo che aveva organizzato i trasporti per le persone marchiate con la stella gialla, avviando la «soluzione finale della questione ebraica». Senza Fritz Bauer invece non ci sarebbe stato questo processo: era stato lui ad aver dato ai servizi segreti israeliani le informazioni decisive sul luogo in cui si trovava Eichmann, in Argentina. L’anno di nascita di Grischa (Georg) Benjamin, cioè il 1960, offrì abbondante materia ai radiogiornali, la guerra fredda era nuovamente sul punto di accendersi. Il 13 agosto, mentre Grischa ancora gattonava sulla moquette, apportò un taglio netto nella vita dei genitori: il muro. Quaranta anni dopo, quando la DDR era ormai scomparsa da tempo, il padre di Grischa avrebbe scatenato una controversia pubblica con la sua opinione sul mostro di cemento e filo spinato. Poteva essere fondatamente visto come una misura «imposta dalle circostanze». L’indignazione fu grande. E tuttavia non fu una misura capace di tenere in vita la DDR. Molti modelli maturati nell’infanzia si spiegano a partire da questo mondo in trasformazione: gli anni Sessanta del secolo scorso. Quando sorge qualcosa che assomiglia a una coscienza politica? In un qualche momento dopo i quattordici o i quindici anni di età? Di sicuro Grischa fu influenzato anche dalle serate dei Pionieri o dai dibattiti politici nei circoli della FDJ, dove si discuteva la situazione mondiale. La guerra fredda è al suo culmine. E rischia sempre di diventare una guerra calda. Tutto questo, e inoltre l’atteggiamento critico di suo padre verso le comunicazioni ufficiali del governo della DDR o dei vertici del partito, fa sì che Grischa viva quest’epoca con una grande consapevolezza. In ogni caso cresce ai due lati del muro una generazione incapace di credere che la divisione del mondo in Est e Ovest possa in qualche modo mutare nel corso della propria vita. O che potrebbe farlo soltanto attraverso una terza, e probabilmente ultima, guerra mondiale in cui si adopererebbero le armi atomiche. Una guerra per la riunificazione – impensabile. Grischa ricorda subito questa visione molto pragmatica quando gli chiedo se le limitazioni ai viaggi in Occidente fossero state per lui un problema. «No» è la sua risposta. «Forse sarebbe stato diverso se avessimo avuto parenti in Germania Ovest» ammette di fronte alla mia reazione stupita. Non ricorda che questo gli sia mai pesato. Era così e non si poteva cambiare. Poiché la visuale verso l’Occidente non era libera, rimaneva l’Oriente. Naturalmente era desideroso di conoscere anche altri paesi e immergersi in altre culture. Per lui ciò significò innanzitutto l’Unione Sovietica. Suo padre aveva studiato a Leningrado, lui invece andò a Mosca a studiare politica internazionale e tre lingue straniere. Sarebbe stata la via per il servizio diplomatico. Anche in Occidente, negli anni Settanta, l’irreversibilità della divisione del paese era una certezza non solo per i giovani socialisti della SPD occidentale. E benché i discorsi ufficiali della politica di Bonn suonassero diversi, questa valutazione era condivisa anche dai partiti conservatori della Repubblica Federale. Dopo il 1969 la coalizione social-liberale seppellì la dottrina Hallstein,12 la quale implicava il non riconoscimento della DDR, ponendo fine con ciò alla ricattabilità della Repubblica Federale in politica estera. Con il Trattato di Mosca (1970) e il Trattato fondamentale (Grundlagenvertrag) del 1972 che regolava i rapporti fra la DDR e la BRD fu riconosciuta la realtà, e con ciò la Repubblica Democratica come secondo Stato tedesco. In questo modo erano stati creati i presupposti per una politica di distensione e pace che avrebbe toccato l’intera Europa, iniziata dalla Repubblica Federale e legata ai nomi di Willy Brandt e Egon Bahr. Ancora nel 1960, e poi per l’ultima volta nel 1964, alle Olimpiadi invernali ed estive si presentò una sola squadra per le due Germanie. Le tensioni però non mancarono e fu tutt’altro che una «gioia, bella scintilla divina», come recita l’inno di Beethoven, suonato allora per le vittorie degli atleti tedeschi al posto di un inno nazionale. La lotta della Repubblica Federale per rivendicare il ruolo di unica rappresentante della Germania e, a questa legata, la questione relativa alla successione del Terzo Reich dominarono la politica estera durante l’era di Adenauer. Non restava spazio per un’altra impronta, al di là del forte vincolo con l’Occidente. Per il cancellierato e il ministero degli Esteri c’era solo quello che, con termine indiretto, veniva chiamato «riparazione». Già l’astrazione della parola rendeva chiaro che la dimensione autentica del genocidio nazista non era ammessa nell’era di Adenauer. La storia doveva essere smaltita in maniera sostanzialmente materiale. Fritz Bauer, giurista ritornato dall’emigrazione, impiegò quattro anni, fino al 1949, per riottenere il suo impiego statale. Le sue esperienze al ritorno nella parte occidentale dello Stato diviso erano sintomatiche del clima e della consapevolezza in cui versava il paese con i suoi sessanta milioni di abitanti. Bauer era uno dei pochi della sua corporazione a essersi prefisso di costruire un autentico stato di diritto. Alla metà del gennaio 1949 Bauer, che in quanto ebreo tedesco e socialdemocratico era riuscito a prendere la via dell’esilio dopo diversi mesi in campo di concentramento, aveva ricevuto la notifica che il suo «procedimento di denazificazione» aveva accertato la non applicabilità a lui delle «relative norme». E nell’aprile di quell’anno ricevette l’atto di nomina a direttore del tribunale di Braunschweig. Alla maggioranza dei giudici e dei procuratori che senza alcuna difficoltà avevano accolto le leggi razziali e condannato a morte migliaia di oppositori del nazismo, Bauer oppose la sua intenzione: «Volevo essere un giurista che serve la legge e il diritto, l’umanità e la pace non soltanto con parole vuote». E la mise in atto come quasi nessun altro. Sarebbe stata una battaglia con molte sconfitte, ma anche successi. E ogni sua vittoria sulle pattuglie di combattimento brune nella Giustizia e nell’apparato statale della Repubblica Federale aumentava la loro aggressività. Fuori dalle sicure stanze del suo ufficio Bauer si sentiva come in un paese nemico. Gli fu contrapposto ogni possibile ostacolo, anche quando mise sotto accusa a Braunschweig il generale nazista Otto Ernst Remer. Quest’ultimo, un irriducibile nazionalsocialista, quale comandante del battaglione di guardia «Großdeutschland» aveva arrestato il 20 luglio 1944 a Berlino il generale di divisione Karl Paul von Hase, Comandante della Piazza a Berlino, dopo il fallito attentato a Hitler. Von Hase aveva partecipato alla congiura del 20 luglio con l’incarico di arrestare la dirigenza nazista dopo l’attentato. Fu impiccato nel carcere di Plötzensee. Nel 1951 Remer fondò il neonazista Partito socialista del Reich (Sozialistische Reichspartei, SRP). La sua esaltazione del nazionalsocialismo, in occasione delle elezioni per il parlamento regionale della Bassa Sassonia, gli procurò l’undici per cento dei consensi e l’ingresso nell’organo di rappresentanza. Durante i comizi elettorali Remer definiva rei di alto tradimento i partecipanti alla congiura del 20 luglio, che avevano pugnalato alle spalle la Wehrmacht, rafforzando così nella popolazione un’immagine negativa della resistenza e soprattutto degli autori del fallito attentato a Hitler. Sondaggi dell’epoca mostrano che solo una minoranza giudicava positivamente questa azione. Il processo contro Remer, iniziato nel 1952, terminò con un verdetto di colpevolezza e tre mesi di carcere per oltraggio e diffamazione. La SRP fu messa al bando dalla Corte costituzionale federale, in quanto organizzazione discendente dal Partito nazionalsocialista. Quanto a Remer, riuscì a non scontare la pena fuggendo in Egitto. Là, come in Argentina, c’era una rete ben organizzata di ex nazisti con le migliori connessioni nella Repubblica Federale. Il verdetto fu per lungo tempo l’ultimo successo riportato nell’ambito di una revisione giuridica dell’epoca nazista nella BRD. Rese tuttavia celebre Fritz Bauer, che nel frattempo era stato nominato procuratore generale a Braunschweig, anche oltre i confini della Germania Federale. Al processo erano presenti molti corrispondenti internazionali, che parlarono con ammirazione delle sue strategie processuali. Nel 1956 Bauer fu nominato procuratore generale a Francoforte. Nel 1968, estenuato da anni di lotte, morì di infarto. Il sospetto che si trattasse di suicidio non fu confermato. Il suo è un altro eroismo rispetto a quello dei canti inneggianti alla Wehrmacht nazista, che si levavano dai romanzi di guerra esposti nei chioschi. Un eroismo che distinse anche Max Horkheimer e Theodor W. Adorno e molti altri che dall’esilio tornarono in Germania per «tenere testa al nuovo inasprimento fascista», come lo definì Horkheimer, e per «contribuire all’educazione alla resistenza». Nel 1960 la Germania Federale si trovò nuovamente di fronte a un’ondata di attacchi neonazisti. La repubblica di Bonn non poté ignorarne il danno in politica estera, tanto che il cancelliere Adenauer si vide costretto a pronunciarsi sugli attacchi e le devastazioni di cimiteri e istituzioni ebraiche. In un discorso radiofonico e televisivo condannò quegli eccessi. La pressoché ininterrotta continuità delle élite vecchie/nuove nella Repubblica Federale aveva generato un clima intollerante di qualsiasi memoria critica del periodo nazista. Erano ancora lì, i nazisti in abito vecchio e nuovo, e il «grembo era ancora fecondo». Che paese era quello che entrava nel libro della storia tedesca come il successore del Terzo Reich? L’attore e scrittore Josef Bierbichler ne ha offerto una descrizione calzante nel suo recente romanzo Mittelreich (Regno di mezzo). «Con tenacia» gli uomini si erano risollevati «dopo il pasticcio della guerra perduta e la cattiva fama nel mondo, che si erano tirati addosso con la guerra e i suoi effetti collaterali». Ricorda la costruzione delle autostrade, voluta a tutti i costi dai nazisti, e la domanda che in genere vi si legava, cioè se «tutto fosse stato poi così malvagio in quei dodici anni, quando il paese aveva perseguito una politica mondiale». E poi, ben presto, «non se n’era potuto più di starsene prostrati a capo chino, come si addice ai cani ma in certe situazioni anche agli esseri umani [...] e si cominciò dunque a raddrizzare la schiena, tornando in posizione eretta». Furono Margarete e Alexander Mitscherlich che, quasi accompagnando psicoanaliticamente lo stato tedesco occidentale, riconobbero l’«incapacità di affrontare il lutto». Ciò vale ancora, immutato, per gli omicidi nazisti ai nostri giorni. Centocinquanta morti dalla riunificazione, vittime della violenza di estrema destra, e alcune centinaia di feriti gravi non indussero a calare a mezz’asta le bandiere per annunciare il lutto. Ci volle tempo perché le generazioni postbelliche, l’intellighenzia critica tornata dall’esilio e la resistenza durante le elezioni potessero trionfare sul resto della generazione dei colpevoli. Senza i Mitscherlich, senza quelli come Eugen Kogon, il Gruppo 47, i molti membri dei sindacati, i successori della Chiesa confessante e la gioventù in rivolta dopo il 1968, non sarebbe stato possibile strappare ai bruni cacciatori di eredità, che si erano già comodamente insediati nei centri democratici del potere, la democrazia ricevuta in dono. Ma per questo era necessario che qualcuno come Fritz Bauer lavorasse per un nuovo inizio, che senza una revisione anche giuridica degli omicidi nazisti non sarebbe stato credibile. Nella società postfascista del dopoguerra molti, e forse anzi la maggioranza, pensavano di essere le vittime di un coinvolgimento fatale. Parecchi in Occidente vedevano Willy Brandt, che era emigrato in Norvegia, come un traditore. E la sua Ostpolitik, la sua politica di distensione che conteneva il germe di una riconciliazione con i popoli dell’Europa orientale e la Russia, era considerata da questi una politica di rinuncia. La destra nazionalista lo perseguitava con odio e scandiva: «Willy Brandt al muro». Nessuno colse l’atmosfera dominante in Germania Occidentale meglio di Hannah Arendt, che nel 1950 tornò a visitare per la prima volta il paese: «La vista offerta dalle città tedesche distrutte e la conoscenza dei campi di concentramento e di sterminio hanno proiettato sull’Europa un’ombra di profonda tristezza». Poi continua: «E tuttavia, da nessun’altra parte questo incubo di distruzione e paura è meno sentito, e in nessun altro luogo se ne parla meno che in Germania». E aggiunge specificando che rientra in tutto questo il rifiuto di provare il lutto, e inoltre l’indifferenza, l’apatia, l’assenza di sentimenti, l’insensibilità che a volte era dissimulata da un sentimentalismo dozzinale. Ciò tuttavia era solo il sintomo più evidente di un rifiuto profondamente radicato, caparbio e talvolta brutale di affrontare ciò che era realmente avvenuto e di riconoscerlo. Una simile fuga dalla realtà era naturalmente anche una fuga dalla responsabilità. Fritz Bauer imparò in fretta che gli emigranti non erano particolarmente benvenuti. Anche Walter Mehring, che con Kurt Tucholsky aveva espresso per iscritto la sua opposizione al sorgente nazionalsocialismo sulla «Weltbühne» di Ossietzky, disse dopo una breve visita nel 1948: «Non ci perdoneranno mai che non ci siamo fatti ammazzare a colpi di bastone o almeno un po’ dai gas». C’era da provare ripugnanza di fronte al modo in cui vecchi e nuovi nazisti cercavano di scagionarsi puntando il dito altrove. Questo valeva allo stesso modo in Germania Est e Ovest. E non occupandosi dei procedimenti o archiviandoli, la giustizia tedesca occidentale contribuì non da ultima a destare l’impressione che lo «strappo dalla civiltà» operato dai nazisti fosse sostanzialmente propaganda dei vincitori, e dunque irrilevante da un punto di vista giuridico. Il dibattito intorno al Zentrum gegen Vertreibungen (Centro contro le espulsioni)13 mostra come questa tendenza sia viva ancora ai nostri giorni. Quando Fritz Bauer arrivò a Braunschweig nel 1949, nel settore di sua competenza erano già state eseguite 985 indagini preliminari contro criminali di epoca nazista, e di queste solo un’ottantina erano riuscite a superare le pastoie giuridiche; per 836 procedimenti era stata disposta l’archiviazione. Il «processo di Helmstedt» contro picchiatori appartenenti alle SA e alle SS, che nel 1933 avevano brutalmente perseguitato e usato violenza contro oppositori politici ed ebrei, si era chiuso con verdetti così miti che nel 1947 ci furono accese proteste e manifestazioni, a cui parteciparono ventimila persone. La guerra fredda e l’opinione generale, incline a scagionare tutti, secondo cui la «zona sovietica», come diceva Adenauer, era peggio dei campi di concentramento nazisti, fecero il resto per sospendere di fatto, alla fondazione della Repubblica Federale Tedesca, una revisione giuridica. Nel Libero Stato di Braunschweig, il Land più piccolo dell’ex Reich, il terrore nazionalsocialista era così agguerrito che fin dal marzo 1933 i membri delle frazioni della SPD e del KPD non poterono più partecipare alle sedute del parlamento regionale. La «brutale edificazione» del potere nazionalsocialista vi costò la vita, nella primavera e nell’estate 1933, ad almeno ventisei persone. Anche la procura della repubblica di Braunschweig arrivò perciò dopo il 1945 alla conclusione che già nel 1933 la giustizia era uno «strumento compiacente del regime nazionalsocialista» e che «partecipò alla persecuzione». Il fatto che Hitler a Braunschweig avesse potuto acquisire la cittadinanza tedesca per vie traverse è solo una dimostrazione di ciò che allora, nella città e nella regione, era all’ordine del giorno e che dopo la liberazione fu messo agli atti attraverso mille indagini preliminari contro millecinquecento persone, accusate di crimini nazisti. L’assoluzione, pronunciata dal tribunale di Monaco, dello SSStandartenführer responsabile dei procedimenti di corte marziale nei campi di concentramento di Sachsenhausen e Flossenbürg, fu esemplare e del tutto all’ordine del giorno. Costui aveva ordinato l’esecuzione delle sentenze di morte contro Hans von Dohnanyi, Dietrich Bonhoeffer e Hans Oster. Fu assolto con la motivazione che i combattenti della resistenza uccisi si erano resi colpevoli del reato di alto tradimento, in base al diritto vigente allora. Questa interpretazione scagionava in linea di principio tutti i responsabili del terrore nazista e si conformava all’opinione dell’Associazione dei soldati tedeschi e di parti del Bundestag, secondo cui i congiurati del 20 luglio erano anch’essi «colpevoli di alto tradimento». Fritz Bauer invece, nella sua arringa al processo contro il vecchio nazista Remer, aveva chiarito che le sentenze a morte della giustizia nazista contro gli attentatori di Hitler dovevano essere annullate, e la loro resistenza contro la tirannia doveva essere riabilitata incondizionatamente «in base alla giustizia eternamente valida, allora come oggi». L’astuzia della storia veniva ogni volta in aiuto all’evidente scarsa sollecitudine ad affrontare il proprio passato. Quando si trattò di far accettare il riarmo della Germania Occidentale, Adenauer si sentì obbligato a pronunciare al Bundestag un’apologia della resistenza antihitleriana. Era necessaria già solo per smontare le diffuse critiche alla riassunzione nella Bundeswehr di ex ufficiali della Wehrmacht, e comunque per mostrare che un’affinità con la Wehrmacht nazionalsocialista non era né auspicata né tanto meno perseguita. La sua dirigenza interna e l’immagine del cittadino in uniforme erano in contrasto con l’obbedienza cieca richiesta all’epoca del nazismo. La lotta di Fritz Bauer conobbe nuovo slancio a Francoforte. La SPD, sotto il primo ministro dell’Assia Georg August Zinn, gli fu al fianco quando Bauer fu preso nuovamente di mira. Raccolse intorno a sé giovani procuratori capaci di respingere il siluramento di quei procedimenti contro nazisti che erano stati trasferiti a Francoforte. La sua sfiducia verso la propria corporazione era chiara. Le costanti minacce di morte facevano parte della sua vita quotidiana. Per alcuni un modello, per molti un oggetto d’odio: Hilde Benjamin e Fritz Bauer hanno questo in comune. Entrambi avevano compiuto una scelta seguendo le proprie convinzioni. L’arresto di Eichmann e il ruolo che Fritz Bauer avrebbe avuto nella vicenda sono come una parabola che mostra la continuità politica delle élite vecchie/nuove in Occidente. Fu la lettera di un ebreo tedesco emigrato in Argentina a fornire a Fritz Bauer il primo indizio sul luogo in cui si trovava Eichmann. Ed era stato probabilmente il processo a Remer ad aver dato all’autore della lettera la certezza che Bauer avrebbe seguito la traccia. Dopo che Bauer si fu accertato attraverso intermediari della sua serietà, occorreva capire come e tramite chi sarebbe stato possibile arrestare Eichmann. In seguito all’esperienza che lui stesso ne aveva fatto, la fiducia di Bauer nella giustizia tedesca e nelle autorità di sicurezza era estremamente scarsa. Doveva presumere che Eichmann, avvertito per tempo, si sarebbe sottratto all’arresto. Uno sguardo al Bundeskriminalamt (BKA, Polizia federale tedesca), creato nel 1951, la cui collaborazione Bauer avrebbe dovuto assicurarsi, mostra che un’estradizione in Germania non sarebbe stata possibile. La storia postbellica della BKA è disponibile ora in tre volumi, rispettivamente intitolati Schatten der Vergangenheit. Das BKA und seine Gründungsgeneration in der frühen Bundesrepublik (Ombre del passato. La BKA e la generazione dei suoi fondatori agli inizi della Germania Federale), Der Nationalsozialismus und die Geschichte des BKA. Spurensuche in eigener Sache (Il nazionalsocialismo e la storia della BKA. Una ricerca di tracce al proprio interno) e Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte (La Polizia federale affronta la propria storia). Fino agli anni Sessanta, la sua struttura era più vicina a quella del Reichssicherheitshauptam (Ufficio centrale per la sicurezza del Reich), la centrale del terrore nello stato nazionalsocialista, che allo stato democratico che pure avrebbe dovuto servire. Alla fine degli anni Cinquanta il personale direttivo del BKA era costituito esclusivamente da uomini, il novanta per cento dei quali avevano già servito nella polizia prima del 1945, e fra questi ugualmente alto (ossia il cinquanta per cento) era il numero dei cosiddetti «131», cioè di ex membri del partito nazista, al quale avevano aderito prima del 1937. Circa due terzi del personale dirigente erano costituiti da ex membri delle SS. Nel terzo volume della storia postbellica del BKA si legge la nuda frase: «Fino alla fine degli anni Sessanta (cioè al 1969) non era avvenuta alcuna frattura radicale nella composizione del personale dirigente». Si riallacciarono così a quello che già prima del 1945 era stato il loro compito vitale: obiettivo principale delle indagini del gruppo di sicurezza dell’ufficio era «fondamentalmente il respingimento del “bolscevismo” dall’esterno e la lotta al comunismo all’interno». Responsabile dei compiti del BKA era il Ministero della Giustizia a Bonn, in quanto sua autorità di sorveglianza. Le indagini contro neonazisti e criminali nazionalsocialisti avevano tutt’al più un’«importanza subordinata». Il ministero partecipò «preventivamente, con tutti i mezzi del diritto penale, alla lotta contro il nemico ideologico», osservando e coordinando le decisioni dei tribunali nel campo della difesa dello stato. La BKA era soprattutto parte della «lotta preventiva» contro la «penetrazione di scritti propagandistici dalla zona sovietica, capaci di mettere a repentaglio lo stato», contro il lavoro di «infiltrazione e sovvertimento da parte di agenti e spie della DDR, ma anche contro l’attività sovversiva del Partito comunista illegale», dopo il suo divieto nel 1956. Ieri e oggi non facevano quasi differenza nel lavoro del BKA. Gli esiti delle indagini tuttavia non erano più presentati alle SS o al Reichssicherheitshauptam bensì alla direzione del BKA o al Ministero della Giustizia. Diversamente succedeva per le azioni penali contro reati commessi negli ambienti nazisti vecchi e nuovi, che per lo più si insabbiavano. Le indagini erano compiute in ogni caso solo quando la reputazione della Germania Federale entrava in pericolo a livello internazionale. Allora, come mostra l’esempio dei fatti di Salzgitter, si suscitava almeno l’impressione che si stesse indagando in ogni direzione. Attorno alla Pasqua del 1957 fu segnalata «in un cimitero a Salzgitter la profanazione di tombe ebraiche e di un monumento» dedicato agli ebrei vittime della dittatura nazionalsocialista. Sul braccio destro di una croce in onore dei prigionieri francesi dei KZ era appesa una bambola di paglia con le braccia legate dietro la schiena. Portava un cartello con la croce uncinata e l’invettiva: «Germania risvegliati, Israele crepa». Era l’anniversario della nascita di Hitler. I colpevoli non furono trovati. In seguito a ciò il segretario generale del Consiglio centrale ebraico, Hendrik George van Dam, intervenne sulla «Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland» (Settimanale nazionale degli ebrei in Germania) con il sarcastico commento: «O è presente nel popolo tedesco una inestirpabile inclinazione alla delinquenza che si esprime nella profanazione dei cimiteri, in una misura ignota ad altre nazioni, oppure una polizia frammista di ex nazionalsocialisti manca dell’energia sufficiente a prevenire e combattere questo genere di crimini». Van Dam sapeva di cosa stava parlando: le indagini di una commissione straordinaria composta di undici membri erano dirette da tre funzionari del BKA. Due dei tre erano appartenuti a squadre di intervento durante la Seconda guerra mondiale, e contro uno di questi indagò in seguito la procura di Dortmund per sospettato concorso in omicidio. Già due giorni dopo il fatto gli inquirenti avevano reso noto che i colpevoli andavano cercati negli ambienti dell’estremismo di destra, e tuttavia simili gruppi non erano presenti a Salzgitter. Poiché il caso aveva avuto una risonanza internazionale si costituì nuovamente una commissione speciale. Ma neppure la «ricompensa più alta offerta dopo la guerra per un caso criminale, cioè 15.000 marchi» ottenne qualcosa e la questione fu archiviata. I profanatori rimasero sconosciuti. Il rapporto finale della Commissione speciale si può leggere nella storia postbellica del BKA. L’analisi degli storici afferma «che i funzionari della Commissione speciale relegarono i colpevoli in uno spazio remoto – sia in senso geografico che nelle loro analisi. Nella visione degli inquirenti i colpevoli non potevano (o non dovevano?) provenire dalle fila dei cittadini tedeschi occidentali». Gli inquirenti trovarono a Salzgitter un ambiente a ciò propizio, che nel contempo li aiutò ad archiviare senza alcun esito le indagini. Soltanto con il conglomerato industriale dei «Reichswerke Hermann Göring»14 nell’area di Salzgitter c’erano sessantasette ex Lager per lavoratori forzati e prigionieri di guerra, a cui si aggiungevano i prigionieri dei «Lager esterni». Il «Cimitero degli stranieri di Jammertal» divenne una fossa comune per molti lavoratori schiavi. Alcuni sopravvissuti rimasero inizialmente nella regione dopo la fine della guerra. Finirono subito nell’obiettivo degli inquirenti. La lista delle persone controllate riportava: 77 «appartenenti al blocco arabo», 144 «appartenenti al blocco baltico» e 536 «visitatori della zona orientale», che furono investigati perché dietro di loro avrebbe potuto esserci la Sicurezza di stato della DDR. In soli 159 casi le persone controllate erano della zona di Salzgitter. Soprattutto gli arabi, in qualità di sospetti, erano benvenuti da parte della Commissione. Prove non ce n’erano. Per il BKA bastava la supposizione che essi e altri gruppi etnici «fossero stati sempre profondamente avversi all’ebraismo». Pur tradendosi nelle intenzioni, il gruppo di sicurezza del BKA era tuttavia ingegnoso quando si trattava di indagare senza successo contro nazisti vecchi o nuovi. Bisogna supporre che Fritz Bauer conoscesse la struttura «bruna» del BKA. Le sue esperienze nella sfera della Giustizia dovevano essere sufficienti a soffocare ogni desiderio di informare l’apparato di sicurezza tedesco circa l’esistenza di Eichmann. Dal 1956 Bauer condusse indagini a Francoforte contro criminali nazisti «di primo piano», che avevano messo in opera il mostruoso crimine contro l’umanità rappresentato dal genocidio degli ebrei europei. In tutto questo Adolf Eichmann stava al primo posto. Accanto a lui Josef Mengele, il medico che sulla rampa di Auschwitz selezionava le vittime ebree e le mandava nelle camere a gas. Il terzo era Martin Bormann, la mano destra di Hitler. Soprattutto grazie a questa cautela nei confronti dei funzionari della sicurezza tedeschi risultò possibile, con l’aiuto dei servizi segreti israeliani, processare Eichmann in Israele. Diverso fu il caso di Bormann, di cui a lungo si credette che fosse scappato in Sudamerica. Dopo un’intensa ricerca i suoi resti mortali furono trovati e identificati vicino alla bombardata Cancelleria del Reich a Berlino. Aveva posto fine alla sua vita con il cianuro. Mengele invece annegò nel 1979 nella località balneare di Bertioga, in Brasile, dopo che – avvertito per tempo – si era sottratto più volte all’arresto. Dal 1960 Bauer si dedicò alla preparazione dei processi per eutanasia e su Auschwitz. I puntuali ritardi delle indagini contro le Squadre di impiego (Einsatzgruppen), che poterono essere processate infine a Ulm nel 1958, ottennero che gli indugi nella persecuzione penale dei criminali nazisti fossero sempre più criticati anche nella Germania Federale. Più di due milioni di ebrei uccisi dalle unità di polizia e dalle Squadre di impiego che seguirono la Wehrmacht e il fronte in Unione Sovietica e nel Baltico furono oggetto del processo. In Germania Occidentale tutto ciò provocava un senso di vergogna. I ministri della Giustizia dei Länder fondarono perciò nel dicembre 1958 la «Sede centrale delle amministrazioni regionali della giustizia per il chiarimento dei crimini nazionalsocialisti», ospitata a Ludwigsburg. Aveva il compito di preparare e coordinare la persecuzione dei crimini nazisti compiuti fuori dai confini della Germania Federale. Uno dei primi grandi processi fu quello di Auschwitz, di cui era responsabile Fritz Bauer. Furono trovati perciò millecinquecento testimoni e avviate indagini contro novecentocinquanta ex appartenenti ai corpi di guardia delle SS. Durante le fasi preparatorie del processo la procura della repubblica fu sommersa da un fiume di lettere minatorie e da minacce di morte in gran parte anonime. Il 20 dicembre 1963, dopo oltre cinque anni di intense indagini in cui furono coinvolte sia la Polonia che le autorità giudiziarie della DDR, il processo si aprì. Lo «strappo dalla civiltà» compiuto nella Germania nazionalsocialista era con ciò messo agli atti. I processi di Auschwitz segnarono una svolta nell’opera di smascheramento, fino ad allora insufficientemente perseguita, dei crimini nazisti nella Germania Federale. La crescente vergogna collettiva per i crimini contro l’umanità perpetrati dai nazisti e gli inizi della protesta mondiale contro la guerra degli Stati Uniti in Vietnam modificarono il clima sociale anche nella Repubblica Federale. La rivolta contro l’oblio comportò anche la graduale fine della Repubblica di Adenauer con il suo clima di restaurazione. La Germania postbellica conobbe una politicizzazione inattesa. Le manifestazioni contro la classe dirigente dal passato bruno divennero parte della quotidianità. I centri della rivolta contro i padri e i nonni, contro il grande silenzio e per una presa di possesso democratica della repubblica furono Berlino e Francoforte. Ma vi ebbero un ruolo anche altre città, come Hannover e Amburgo, dove la protesta, accompagnata dallo slogan: «Sotto le toghe – la muffa dei millenni», fece saltare le cerimonie di immatricolazione all’università. E accanto a Karl Marx c’era Herbert Marcuse, la cui «filosofia concreta» lo rese il filosofo più citato del movimento di protesta del ’68. Gli si affiancava tuttavia un altro nome, che era stato riscoperto e riletto: Walter Benjamin. Era onorato per la sua resistenza durante il nazionalsocialismo, e le sue tesi sul concetto di storia, i suoi saggi e il suo diario moscovita sono una parte del bagaglio intellettuale che fondò la protesta e la condusse sulle strade. Per seguire le sue tracce nei dibattiti del movimento studentesco e soprattutto della Lega tedesca degli studenti socialisti (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, SDS) vado a trovare uno dei compagni di lotta di quel tempo, il mio amico G. Voglio parlare con lui dell’influsso esercitato da Walter Benjamin su moltissimi studenti, più di venticinque anni dopo la sua morte a Portbou. Per G. Benjamin apparteneva senza dubbio, come lo definisce lui, al «contesto percettivo» di quegli anni. Lo scetticismo di Benjamin verso modelli di società autoritari o dogmatici fu un’importante integrazione alla teoria critica della Scuola di Francoforte, che sosteneva fondamentalmente un marxismo moderno e non dogmatico, arricchito da Freud. Ci incontriamo in campagna, dove G. ha una piccola casa di vacanza. Ci avvolge una calda giornata estiva. Sediamo sotto la corona bombata di un sambuco e, senza concederci lunghe pause, torniamo a visitare gli anni Sessanta e Settanta. Come soldatini di stagno si allineano i nomi degli ideologi della rivolta, da Rudi Dutschke a Bernd Rabehl, dai fratelli Wolff e Hans-Jürgen Krahl a Oskar Negt. Si parla dei colpi mortali sparati a Benno Ohnesorg e dello spiacevole sospetto che il tiratore assassino avesse fatto fuoco dietro incarico della Sicurezza di Stato della DDR. Ci troviamo presto d’accordo su ciò che fu vano e ciò che resta di quegli anni. Ci rendiamo conto del ruolo rivestito dalle donne solo quando parliamo della RoteArmee-Fraktion e attraverso Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin e Verena Becker riflettiamo sulle speranze ingannevolmente riposte nell’azione che tuttavia non produssero risultati sulle masse ma si risolsero invece nella lotta armata. Una scissione settaria che sfociò nella morte comune. Continuiamo a parlare della fase antiautoritaria del ’68. Appare nuovamente chiaro che esso fu anche – e anzi forse soprattutto – un movimento che intendeva dare una risposta pratica agli atteggiamenti autoritari e ai modelli educativi della generazione dei padri. All’inizio c’era l’educazione. Questo valeva anche per Walter Benjamin. Il quale si sarebbe probabilmente opposto ad alcuni paralleli avventati con cui abbiamo confrontato grandezze inconfrontabili. G. ricorda con imbarazzo l’azione «Punto rosso», quando a Hannover si manifestò contro l’aumento dei biglietti per i mezzi di trasporto cittadini. In uno scontro con la polizia, inferiore anche numericamente, i giovani fecero ala, il braccio destro levato, scandendo: «Polizia, SA, SS». G. disse di provarne ancora vergogna; non perché la polizia avesse reagito con misura. «No, caricavano anche loro senza troppa pietà. Ma non erano paragonabili ai nazisti. Non ci accorgevamo affatto che stavamo contribuendo a minimizzare l’aberrazione nazista». Ma non accadeva lo stesso con la percezione della DDR da parte della Repubblica Federale e dei suoi mezzi di informazione? Nonostante la DDR risultasse insopportabile per molti dei suoi cittadini, era lontana molte miglia dallo Stato del terrore nazista. L’influsso di Walter Benjamin perdura ancora ai nostri giorni. Parlando ci stupiamo di quante volte ci riferiamo a lui. Ciò dovette valere specialmente per quelli che a Francoforte seguivano la teoria critica. Ma non solo. Chi viene considerato oggi un conoscitore di Benjamin può essere sicuro di trovare davanti a sé, a Tokio e a Londra e in quasi ogni punto del mondo, un pubblico interessato. Un motivo per l’inalterato valore del pensiero di Walter Benjamin è probabilmente anche il fatto che la sua opera e la sua azione, non prive di contraddizioni, non furono mai ripensate da un Benjamin ormai anziano. Come accadde invece nel caso di Adorno, che in vecchiaia mise in dubbio il contenuto e la validità della Dialettica dell’Illuminismo, cosa che produsse il suo effetto sulla Scuola di Francoforte e i suoi allievi, delusi da lui. Adorno stesso, diversamente da Marcuse, era piuttosto scettico verso il movimento del ’68. Un altro motivo che spiega come mai la figura di Walter Benjamin si stagli così luminosa e con la sua influenza postuma abbia contribuito al superamento della società postfascista dell’era di Adenauer è ciò che G. chiama il lato esistenziale della sua resistenza. Già nel 1938 Benjamin avrebbe potuto scegliere la strada dell’emigrazione. Ma sentiva di dover restare: «Qui c’è ancora bisogno di me». Mise in gioco l’intera sua esistenza e già per questo gli è rivolta la nostra «dolorosa ammirazione». Torno a Berlino e penso nuovamente a quanto sarebbe stato importante un autoesame individuale e collettivo da parte dei sopravvissuti che nel maggio 1945 uscirono dalle cantine delle città bombardate e inciamparono nelle rovine delle case che li avevano sovrastati. Un autoesame che chiarisse la propria parte nella tragedia, e non quell’assenza di un sentimento di corresponsabilità riscontrata da Hannah Arendt. E in seguito, quando il Terzo Reich in frantumi entrò nell’ordinamento postbellico nella forma assunta dalle sue risultanti schegge, la BRD e la DDR, si riuscì nuovamente a rimuovere la propria fondamentale colpa per la divisione del paese, che sarebbe durata quarantacinque anni. Questo almeno spiega un po’ l’atteggiamento di molti tedeschi occidentali, un’opinione diffusa comunque nei primi venti anni dopo il 1945 e anche oltre, che imputava «ai fratelli e alle sorelle dietro la cortina di ferro» il fatto di non essere riusciti a ottenere una ripresa materiale altrettanto forte, come se ciò fosse un loro fallimento. Ma alla maggioranza dei tedeschi occidentali era totalmente estranea l’idea che uno stato potesse prosperare in condizioni non capitalistiche. Tanto più grande era lo sconcerto per l’ammirazione tributata a Karl Marx dai figli della guerra che stavano crescendo e vedevano in lui un interessante pensatore. Se la Repubblica Federale, in contrasto con i suoi inizi, si andava mutando in una struttura statale democratica relativamente salda, la DDR non riuscì invece a trasformarsi in un esempio di socialismo democratico riuscito. Una citazione di Hans Mayer, dalle sue memorie pubblicate nel 1991 con il titolo Der Turm von Babel (La torre di Babele), illustra molto bene la parabola vitale della DDR: «Una brutta fine non esclude un possibile buon inizio». Bisognò attendere più o meno il 1960 perché nella DDR le statue di Stalin fossero abbattute dai loro piedestalli. Erano passati sette anni dalla sua morte e quattro da quando il XX Congresso del PCUS aveva puntato lo sguardo nei terribili abissi della sua era. Invece di affrontare il rischio di un intenso dibattito su tutto questo, la SED informò i propri membri sugli esiti del congresso in riunioni che si tennero lontano da ogni spazio pubblico. Non era consentito prendere appunti su ciò che selettivamente veniva reso noto dai verbali tradotti, né ai compagni era consentito esprimersi pubblicamente al proposito. Il silenzio collettivo fu il sudario tessuto nella DDR per il defunto Stalin. E tuttavia parlare dell’errore avrebbe fatto bene a molti. Era ancora fresco in loro il ricordo del lutto, quando avevano scritto sgomenti i propri nomi sui libri di condoglianze dell’Armata Rossa, piangendo la scomparsa del grande «piccolo padre» Stalin. Georg Benjamin respinge la mia impressione che suo padre fosse stato meno critico all’epoca della DDR che non successivamente. Al contrario, egli aveva ricevuto stimoli e influssi critici soprattutto in Unione Sovietica, dalla metà degli anni Cinquanta all’inizio degli anni Sessanta, quando studiava a Leningrado. Allora aveva visto bene ciò che le rivelazioni sul «padreterno» al Cremlino significarono per la credibilità dell’idea e dell’equilibrio interno del paese. E poi fu nuovamente a Mosca nei primi anni Ottanta, quando ebbe inizio il «nuovo pensiero» con Gorbačev e la rigidezza del sistema sembrava eliminata. Finiva in ogni caso l’era dei vecchi combattenti, da Leonid Brežnev a Andropov e Černenko, i cui nomi quasi non si ricordano più. Era stato questo ad averlo segnato, dice Georg Benjamin, non la totale assenza di ogni disponibilità ad accogliere la sfida da parte dei dirigenti della SED. Dopo il suo ritorno nella DDR Michael fu colpito dalle difficoltà con cui la SED accoglieva quegli sviluppi. La sua critica si era fatta sentire. E Georg concorda manifestamente con il padre, ricordando come Michael Benjamin avesse fatto notare sempre ai suoi due figli le incongruenze nella propaganda della SED. Li aveva educati a ragionare criticamente. E, come Laura ricorda quando pensa alla sua infanzia, prima e dopo la svolta ci furono occasioni, come per esempio i pranzi con i nonni, in cui era possibile osservare il risultato di questa educazione, quando padre e figlio discutevano in toni vibrati e veementi. Georg è sicuro che a suo padre avesse giovato il fatto di non aver vissuto il vigliacco silenzio sull’era stalinista nella DDR, ma di averne osservato lo smascheramento in Unione Sovietica, o l’aver conosciuto poi a Mosca il «nuovo pensiero», con il forte cambiamento da esso suscitato nella struttura del blocco orientale. Per Georg e suo padre gli inizi, nei primi anni Ottanta, furono in ogni caso un’esperienza elettrizzante. Nessuno immaginava allora dove avrebbe portato la politica della perestrojka avviata da Gorbačev. Oggi Georg vede l’attuale governo russo più come una ricaduta nella Russia prerivoluzionaria: chiesa e stato nuovamente stretti in un’alleanza lontana dalla democrazia, sorrette dalla ricchezza degli oligarchi che così garantiscono i loro privilegi. Ma forse la sorprendente protesta sulle strade non solo di Mosca riuscirà ad acquistare abbastanza forza da poter bloccare l’attuale sviluppo. Di certo Gorbačev non voleva la fine dell’Unione Sovietica, eppure le aveva inflitto il colpo mortale, dice Georg, nuovamente d’accordo con suo padre. Del quale ricorda bene lo sconforto per il fatto che la dirigenza del partito a Berlino Est vedesse la perestrojka solo come una minaccia e non come un’occasione. Nessuno nel Comitato centrale della SED sarebbe stato davvero in grado di imprimere al movimento rivoluzionario sulle strade della DDR una direzione che corrispondesse al manifesto dei dimostranti sull’Alexanderplatz il 4 novembre 1989. Più di un milione di persone firmarono l’appello «Per il nostro paese», che l’élite culturale della DDR aveva pubblicato nel novembre 1989. Soprattutto gli scrittori avevano sperato in un paese diverso da quello che stava scomparendo. C’era ancora la speranza che fosse possibile preservare l’autonomia della socialista Repubblica Democratica Tedesca. Lo sguardo volto all’indietro verso la storia postbellica indugia sugli anni 1953, 1956 e 1968, che rappresentano le speranze infrante in un socialismo dal volto umano. Nei colloqui con Georg ci sono momenti in cui fra le parole affiorano piano anche in lui la tristezza e il rammarico per il fatto che i sogni dei genitori siano così manifestamente appassiti. Immagini in movimento che gli corrono nella mente e ricordano quanta autocritica inespressa, rispetto al fare o al non fare, vi fosse quando la famiglia si riuniva alla sera e ripercorreva la giornata. Molte cose nella DDR avevano suscitato le critiche dei figli, anche la ribadita semplicità con cui veniva descritto ma non realizzato il futuro. Al tempo stesso erano i genitori, i nonni, i genitori degli amici che vi puntavano e si facevano coraggio, convinti che l’alternativa al capitalismo avrebbe potuto – prima o poi – diventare realtà con un calante indice di errori. Di nascosto i figli compiangevano i genitori con le loro speranze sempre rinnovate, ma vane. Come si potrebbe intendere altrimenti lo sforzo fatto da Georg per restare vicino alle speranze sbiadite del padre Michael e mantenersi fedele almeno un poco alla scomparsa DDR, quando dice: «Sono nato in un paese che non esiste più. Ho un passaporto tedesco, ma non un luogo a cui sento di appartenere». Georg esprime questo sentimento nel discorso funebre sulla tomba del padre. Nelle sue parole ho riconosciuto specialmente il lutto per le speranze perdute dei genitori: E non meritavano che ti sacrificassi per loro, pensavamo. Non che fossimo gelosi. No, ci dispiaceva soltanto che tu spendessi la tua energia per chi non lo sapevaapprezzare,eforse nonlomeritava. E in questo avevamo ragione. Eppure in questo non avevamoragione. 12 In base alla quale (dal 1955 e fino al 1969) l’instaurazione di relazioni diplomatiche con la DDR da parte di un terzo Stato era considerata un atto ostile verso la BRD. Walter Hallstein (CDU) fu sottosegretario del Ministero degli Esteri della BRD dal 1951 al 1958 [N.d.T.]. 13 Risale al 1999 il progetto – elaborato dall’Associazione dei profughi tedeschi (Bund der Vertriebenen) – di un centro di documentazione sulle espulsioni dei popoli e i genocidi del ventesimo secolo, e in particolare sul trasferimento obbligato di milioni di tedeschi, alla fine della Seconda guerra mondiale, dai territori non più appartenenti al Reich. Proprio l’accento posto sulle vicende tedesche suscitò subito critiche non solo in Germania, ma anche nella Repubblica Ceca e in Polonia, principalmente a causa del timore che il proposito del centro potesse essere frainteso e interpretato in senso revisionista [N.d.T.]. 14 Creato nel 1937 per l’estrazione e la lavorazione dei minerali di ferro, fu il più grande complesso industriale di proprietà statale del Terzo Reich, con sede centrale a Salzgitter in Bassa Sassonia. Il complesso inglobò a mano a mano impianti di produzione anche in paesi e territori occupati dalla Germania nazista e fece amplissimo uso di manodopera forzata, prigionieri di guerra e dei campi di concentramento [N.d.T.]. Capitolo tredicesimo Nella quinta Germania Le prime frasi del suo discorso di addio al padre morto lasciano echeggiare anche un’altra perdita. Qui Georg Benjamin non è solo. Molti, nello scomparso paese fratello, incontrano difficoltà crescenti in questa nuova/vecchia Germania indivisa. Così accade a sua madre, che pure vive pragmaticamente la sua vita. Solo vent’anni dopo la riunificazione molti diventano consapevoli di un dolore fantasma, lasciato dall’amputazione della DDR. Solo pochi avevano previsto o immaginato che la sua scomparsa potesse essere anche una perdita. Lo slogan «Noi siamo il popolo», gridato a migliaia di voci, non pensava alla DDR reale come alla dimora del futuro. Ma all’improvviso questa perdita si avverte. Molti sono presi anche dalla sensazione di aver fatto troppo poco per l’utopia DDR, affinché potessero realizzarsi le speranze di giustizia, libertà e uguaglianza, e di una cessazione dello sfruttamento e della servitù. Lo si poteva cogliere già nel novembre 1989, quando milioni di persone si riversarono sull’Alexanderplatz a Berlino per salvare nell’ultimo attimo immaginabile ciò che, quasi avvolto in un bozzolo, era stato pur sempre presente come speranza nelle tre lettere «DDR». La percezione di perdere qualcosa era stata ormai dimenticata con il Trattato di Unificazione, tanto più che in esso non era contemplata, e perciò neppure individuata, alcuna «conquista» di quella DDR che veniva fatta scomparire. Un senso di estraneità è ampiamente diffuso ancora oggi in questa quinta Germania, la quinta se considero prima Germania la Repubblica di Weimar che successe all’impero, seguita poi dal fascismo hitleriano del «Terzo Reich», che rappresenta la seconda, mentre le numero tre e quattro sarebbero la DDR e la BRD, e la quinta Germania è infine quella successiva alla riunificazione. Anette Simon, psicoterapeuta berlinese, descrive la Germania Est e quella Ovest come due stati gemelli, figli di madre Germania e padre Fascismo. Nella sua raccolta di saggi intitolata Versuch, mir und anderen die ostdeutsche Moral zu erklären (Cerca di spiegare a me e agli altri la morale tedesca orientale) vede i gemelli che dopo quarantacinque anni di separazione e il primo entusiasmo per la riconquistata unità si accorgono di quanto siano diventati reciprocamente estranei. Tutte le fasi della storia tedesca nel ventesimo secolo e la loro interpretazione giocano qui un ruolo. I percorsi di vita dei Benjamin, la loro condotta e le loro decisioni riflettono le cinque Germanie. Dopo il compimento dell’unità nel 1990, quando la DDR tramonta annullandosi nella gonfia autoconsapevolezza dello stato fratello di Occidente e si aggancia al suo rimorchio, la fascinazione scema e i suoi ex cittadini vivono all’improvviso in un mondo dove non incontrano pressoché nulla di noto. Tutto ciò che aveva odore di DDR sembrava ormai inadatto al consumo e soltanto adesso, a un secondo o terzo sguardo nel passato, viene reputato in parte adatto anche alla quinta Germania e richiamato in vita: il sistema educativo, per esempio, depurato dalla resistenza ideologica contro tutti quelli che la diffidente Sicurezza di Stato spingeva in disparte nella scuola. Questo sistema educativo potrebbe offrire una speranza a molti nello stato borghese capitalista, una speranza alle tante vittime del nostro attuale dramma dell’istruzione. Ogni esperienza raccolta per dare aiuto e stimolo alla nuova generazione proletaria potrebbe essere utile. In Finlandia i suoi emulatori hanno tanto successo che i giovani finlandesi distaccano per livello di istruzione i loro concorrenti tedeschi. Per non parlare degli asili, dei diritti delle donne e della parità di salario. L’arte e la cultura della DDR si introdussero semplicemente attraverso la porta posteriore, fecondando in Occidente la letteratura e il teatro e le arti figurative in una misura tanto considerevole da far nascere l’impressione che siano sempre state una parte del mondo culturale occidentale. Ma anche questo è vero: quelli che manifestarono nelle strade delle città e dei paesi della DDR volevano l’annessione e solo dopo si accorsero che in questo modo avevano espropriato la loro stessa vita. Nessuno tuttavia si era atteso che, quasi contemporaneamente all’unità, sarebbe risorto come uno spettro ciò che la DDR credeva di essersi lasciata alle spalle. Anche nei nuovi Länder si raccolse una marmaglia che, brandendo razzismo e antisemitismo, si riuniva e continua a riunirsi sotto le croci uncinate. Anette Simon dice acutamente che la storia tedesca, insieme alla colpa con essa ereditata e al suo superamento, è fallita perché è stata divisa in due e interpretata diversamente in due strutture statali. Per Michael Benjamin era comunque chiaro che la quotidianità nazista, anche nella società postfascista della DDR, perdurava con maggiore forza in molte menti, e attraverso quei nonni che erano stati allontanati dalle loro cariche si era infiltrata in molti dei nipoti maschi, e talvolta anche nelle bambine. Ad Anette Simon ciò ricorda la Repubblica di Weimar «per via della polarizzazione fra skinhead di estrema destra e gruppi di sinistra. Le croci uncinate, il razzismo e l’antisemitismo sono di nuovo qui. [...] Dobbiamo confrontarci nuovamente con il nazionalsocialismo, con la colpa vecchia e nuova» dice. L’annullamento della divisione potrebbe essere in questo senso un’opportunità, ma i tedeschi riunificati non si concedono tempo per ciò. Anette Simon: «Essersi riunificati proprio il 9 novembre dovrebbe essere per loro un cattivo presagio». Il 9 novembre, giorno fatale per la Germania, con la caduta del muro conosce un ulteriore capitolo, dopo la caccia ai tedeschi di fede ebraica nella «Notte dei cristalli», il 9 novembre 1938, e la rivoluzione di novembre del 1918, sfociata nella proclamazione della Repubblica tedesca. Tutto questo va ricordato nel 2013, così come occorre ricordare la consegna del potere al regime nazista nel 1933. Forse un’occasione per riflettere finalmente insieme e con maggiore intensità sui motivi che hanno determinato la rinascita dell’estremismo di destra dopo l’unità. Ognuno punta il dito dall’altra parte. Raccoglievo cenni di sdegno quando, durante alcune discussioni nei nuovi Länder, ricordavo che già ai tempi della DDR c’erano neonazisti nel paese, finiti nei registri della polizia per vandalismo. Secondo i miei interlocutori non c’erano invece nazisti ai tempi della DDR. Per loro il fenomeno era emerso solo dopo la caduta del muro, cioè dopo la riunificazione, e non aveva nessun legame con la DDR. Inutile persino richiamare alla mente Lichtenhagen, dove una marmaglia cresciuta nella DDR appiccò con miscele incendiarie il fuoco a un centro per asilanti. In Occidente domina comunque l’impressione che i neonazisti siano un problema esclusivo dei nuovi Länder orientali. Si tende a sottacere il fatto che il Partito nazionaldemocratico (NPD) e la Deutsche Volksunion (DVU) [Unione Popolare Tedesca] siano importazioni dall’Occidente. Dopo l’unificazione tornano a divampare molte cose coperte evidentemente solo da una sottile patina. E tuttavia anche nella quinta Germania ci sono episodi che incoraggiano all’ottimismo. In un solo giorno leggo infatti nel quotidiano «Süddeutsche Zeitung» due notizie che riguardano la memoria della storia. Una è la dichiarazione dell’Assemblea dei medici tedeschi, riunitasi nel 2012 a Norimberga, sul ruolo ricoperto dalla categoria durante il nazionalsocialismo. L’annientamento di «vite prive di valore» accadde con la consapevolezza e l’aiuto dei medici, che per proprio vantaggio accolsero con tranquillità il ritiro dell’abilitazione già rilasciata ai colleghi ebrei. Chissà se il parlamento dei medici, dopo la dichiarazione di Norimberga con le sue frasi tanto generiche, si occuperà anche dei sopravvissuti che da bambini furono forzatamente sterilizzati dai medici? Il lungo silenzio della categoria, i cui appartenenti amano apparire come «semidei in bianco», sembra in ogni caso finalmente terminato. E c’è poi il racconto di una scrittrice che si era trasferita con la famiglia da Berlino a Heidelberg e per caso era venuta a sapere di aver affittato un appartamento in cui, dopo il 1940, avevano vissuto ebrei che – come succedeva in genere nelle cosiddette «Judenhäuser», nelle «case degli ebrei» – attendevano il trasporto. Descrive l’orrore che tutt’a un tratto la colse. Per lungo tempo non poté aggirarsi nell’appartamento di quell’edificio storico, che tutti gli ospiti trovavano bellissimo, senza continuamente chiedersi come dovevano essersi sentite quelle persone che, talvolta anche in numero di nove, accompagnate dalla paura e da un’immensa angoscia avevano vissuto là. Ciò cambiò solo quando la scrittrice riuscì a trovare informazioni negli archivi cittadini e a dare un nome e un volto a quanti avevano alloggiato allora nell’«appartamento degli ebrei». La donna scoprì che nel 1940, quando Walter Benjamin a Portbou si sottraeva con il suicidio all’arresto e alla consegna in un campo di sterminio nazista, i fratelli Bernd e Sigmund Kaufmann, rispettivamente nove e dieci anni, erano deportati nel famigerato campo di internamento francese di Gurs. E nel 1942, quando Georg Benjamin a Mauthausen veniva braccato fin sotto il recinto attraversato dalla corrente ad alta tensione, Emma Bendix era deportata a Izbica. Nessuno dei deportati sopravvisse. Da Heidelberg Betty Snopek, dopo essere stata a Gurs, finì ad Auschwitz. Ludwig e Sara Snopek, gli affittuari veri e propri dell’«appartamento degli ebrei», sopravvissero. Nel febbraio 1940 poterono espatriare negli Stati Uniti. Sara morì (per la disperazione? per il dolore?) un anno dopo, mentre suo marito Ludwig morì nel 1956. Il cammino di Philip Snopek passò per Berlino e terminò a Riga, dove incontrò la morte. Luise Wolfers, ugualmente deportata nel 1940 a Gurs, morì nel Lager di Nexon, mentre Hilde Wunsch fu ammazzata a Theresienstadt. Samuel Zucker, avvocato, sopravvisse di due anni alla devastazione del suo studio e della sua esistenza, e morì nel 1940 a Heidelberg. Se in precedenza Maja Linthe, la scrittrice, aveva l’impressione di sentire da ogni fessura del pavimento di legno i passi di quelle persone, le fu d’aiuto averli strappati all’oblio: avevano ottenuto un volto. Linthe scrive: poterli ricordare aveva reso nuovamente abitabile, pur con difficoltà, l’appartamento. La quiete familiare si era solcata di crepe. Ma era pronta a sopportarlo. Andarsene sarebbe equivalso a una fuga dal passato, che non poteva riuscire. Il puro orrore per i crimini nazisti «rende impotenti – io voglio poter continuare ad agire, io voglio guardare fino in fondo». Aveva capito «che dev’esserci sempre qualcuno che scrive i nomi delle vittime [...] perché si accorge della loro assenza e può chiedersi dove sono finite». Questo è anche il senso assunto per me dalla storia familiare dei Benjamin. Walter, la cui fama postuma è legata anche all’aver avuto intercessori instancabili e importanti come Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, o come l’amico Gershom Scholem, Bertolt Brecht e la non meno famosa amica Hannah Arendt. Anche questo contribuì al rinascimento benjaminiano, alla fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta, quando i giovani cresciuti nel dopoguerra in Germania lo scoprirono e lessero le sue tesi sulla storia. Con i suoi libri e i suoi saggi nella mente essi, e non erano pochi, ripristinarono formalmente la democrazia all’Ovest, spianando la strada perché potesse giungere al cancellierato un antifascista che, inchinandosi davanti al monumento alle vittime del ghetto di Varsavia, segnalò anche la necessità di riconoscere la propria storia. Georg Benjamin senior invece era noto solo nella DDR, come combattente della resistenza contro i nazisti: portavano il suo nome l’ospedale circondariale di Staaken e la colonia di riposo dell’esercito a Sorge, sulle montagne dello Harz, e inoltre una scuola per portatori di handicap fisici nel quartiere di Lichtenberg, a Berlino. Il nome e i cartelli indicatori furono levati al momento dell’unità. Ebreo e comunista non era evidentemente buona cosa. Resta Hilde Benjamin, nella cui vita si riflette la storia tedesca prima e dopo il 1933, prima e dopo il 1945. Dopo dodici anni trascorsi nella costante angoscia per il figlio e il marito Georg, nel 1945 Hilde si trovò di fronte a un nuovo inizio. Come sarebbe andata se il crescente contrasto fra Est e Ovest non avesse segnato la storia postbellica, anche quella della DDR? Le speranze di Georg, di cui sentiva di portare anche lei la responsabilità, si sarebbero forse realizzate, almeno in parte? Sarebbe dunque tempo di prendere sul serio la quinta Germania. Michael Benjamin era su quella strada. Lo choc fu grande quando morì nel 2000 dopo un’operazione al cuore che era considerata un semplice intervento di routine. Disinvolto e certo delle proprie motivazioni, sarebbe rimasto sul terreno politico che la quinta Germania gli offriva. Con le sue esperienze prima e dopo il 1945 avrebbe probabilmente ripreso la lotta e non avrebbe mai disprezzato i minuscoli passi sui quali soltanto si misurano i successi. Avrebbe capito, ma non condiviso, l’atteggiamento di suo figlio verso la quinta Germania. Per questo, nonostante ogni distanza scientifica, il suo pensiero era troppo politico. Non è possibile agire senza interferire. Michael Benjamin era portavoce della Piattaforma comunista all’interno del PDS, nonché la sua mente guida. A differenza di Gesine Lötzsch, ex capo della Sinistra, probabilmente non si sarebbe lasciato sottrarre la libertà di condurre un dibattito sul futuro del comunismo. Lo spaventoso livello degli argomenti con cui la signora Lötzsch fu aggredita non solo dai conservatori rasentò quasi la brutale censura di ogni opinione. Il rifiuto di Michael Benjamin di cessare le proprie riflessioni su questo tema si accompagnò sempre a un atteggiamento autocritico e a una grande levatura intellettuale. L’attuale aspetto del mondo capitalista suscita sempre più l’impressione che sarebbe il caso di tornare a riflettere sulle alternative. Il più grande istituto finanziario tedesco, la Deutsche Bank, sta per esempio di fronte a una serie di processi o di costose transazioni con accusatori statali e privati, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Inghilterra e in Italia, che le rimproverano intrighi fraudolenti. Il massimo investment banker della Deutsche Bank era tenuto fra l’altro a scommettere sul declino e la caduta di valore dei propri pacchetti ipotecari sul mercato immobiliare statunitense. Già nel 2005 questi aveva avvertito del loro crollo a causa dei mancati pagamenti da parte dei proprietari di case che erano rimasti disoccupati. In questo modo assicurò alla banca profitti per 1,5 miliardi di dollari, che ne ridussero le perdite. In cambio ricevette premi per oltre 50 milioni di dollari. Non stupisce che migliaia di persone siano scese in strada per manifestare contro il potere delle banche e il sistema finanziario globale. E tuttavia i tribunali sono pronti, come a Francoforte, a dare una mano ai banchieri che si trovano in posizioni delicate e a proteggerli dalla rabbia dei clienti, proibendo per motivi di sicurezza pubblica le manifestazioni nel quartiere delle banche. Lo stato di diritto invece è molto pignolo quando si tratta di garantire ai neonazisti la libertà di manifestare. La crisi del capitalismo stimola anche a riflettere sul suo superamento. Si torna a leggere Karl Marx. E ciò benché l’opinione dominante non si stanchi mai di rifiutarne il pensiero in quanto erroneo. Resta da chiedersi, come se lo chiedeva Michael Benjamin, cosa possa dialetticamente restare dopo la DDR, quale idea progressista, e il dubbio se davvero solo i compagni siano in grado di dare a ciò una risposta. Se Christa Wolf fosse ancora viva, Michael riceverebbe da lei un eloquente aiuto. Con La città degli angeli la scrittrice aveva dedicato a questa domanda un libro intero. Una sua frase indica una direzione che forse conduce anche a quelli che potrebbero dare la risposta: «Avevano vissuto da ultimo senza illusioni, ma non senza ricordare i propri sogni». A volte Ursula Benjamin porta i lunghi capelli grigi pettinati all’indietro e legati con un nastro in una coda di cavallo. A volte li porta sciolti o raccolti in uno chignon sulla nuca. Spesso mi sembra di cogliere uno sguardo pensoso e assorto. Contiene anche un po’ di scetticismo nel suo domandarsi se la DDR e l’opera di così tante persone possano essere comprese e onorate solo da loro stesse. Un passaggio scritto da suo marito appare qui calzante: «Ancora più essenziale di una radicale critica alla DDR [...]» era per lui domandarsi cosa la DDR avesse prodotto nel senso di una rielaborazione del concetto di socialismo. Come molti altri, dopo l’89 si era chiesto: Com’era potuto succedere? Cosa era sbagliato? Quali ne erano le cause? E la sua certezza, sottolineata con forza: «Solo noi abbiamo un interesse a riconoscere le cause autentiche del fallimento. Solo noi possiamo nominare gli errori; e dobbiamo farlo, perché chi verrà dopo non li ripeta. È il compito della nostra generazione». All’inizio non aveva pensato che una «riflessione sulla DDR» dovesse avere anche quel secondo lato dialettico. Legate a questo pensiero sono anche alcune frasi nel programma della PDS del 1993, il che fa supporre a Werner Wüste, amico di Michael Benjamin, che quest’ultimo vi abbia dato un contributo sostanziale. Wüste ha raccolto lettere e manoscritti di Michael Benjamin e li ha pubblicati nel libro Das Vermächtnis (L’eredità). La speranza era che il suo pensiero e la sua qualità intellettuale potessero raggiungere un pubblico più ampio. Io sono stato raggiunto, e questo ha suscitato anche il mio rincrescimento per non averlo potuto incontrare. Almeno nelle prime tre frasi e nell’ultimo dei passaggi qui citati traspare la sua mano. «Milioni di persone si impegnarono dopo il 1945 per la costruzione di un miglior ordinamento sociale e di una Germania amante della pace, che superasse l’eredità fascista. Qui non c’è bisogno di scuse. Le trasformazioni in senso antifascista e democratico nell’est della Germania e in seguito lo sforzo di dar forma a una società socialista erano in legittimo contrasto con il salvataggio del capitalismo nella Germania dell’Ovest, quel capitalismo indebolito e screditato dal crimine senza precedenti nella storia dell’umanità che fu il nazismo tedesco. Al tentativo della DDR di realizzare il socialismo appartengono preziosi risultati ed esperienze raccolte nella lotta per la giustizia sociale, per la definizione degli obiettivi della produzione nell’interesse della popolazione attiva, per una convivenza solidale e pacifica sul suolo tedesco. Ci furono tuttavia anche errori, traviamenti, omissioni e persino crimini». Questo testo solleva la questione sui motivi per cui i negoziatori della DDR non tentarono di esporre e far accogliere nel Trattato di unificazione i «preziosi risultati» ottenuti nella lotta per la giustizia sociale, per la definizione degli obiettivi produttivi nell’interesse della popolazione attiva. Chi ebbe la possibilità di riscontrare la carente prevenzione sanitaria nelle fabbriche e negli stabilimenti di produzione della DDR, l’inquinamento dell’aria dovuto all’assenza di impianti di filtrazione, e ricorda le acque, i fiumi e i laghi biologicamente morti, può nominare cose che non avvengono più. La sconfitta economica della DDR aveva le sue cause e fu il motivo fondamentale per l’emigrazione di massa che trovò un’espressione visibile a Praga, nel giardino davanti all’ambasciata della BRD. Jürgen Habermas, filosofo famoso in tutto il mondo e studioso di scienze sociali, accoglie con un commento ironico l’assenza di ogni disponibilità da parte della CDU e del Libero partito democratico (Freie Demokratische Partei, FDP) a prendere in considerazione le eventuali conquiste della DDR, e quindi la delusione che ne seguì: «Quel contratto che il signor Schäuble (CDU e mediatore di Bonn) attraverso la figura del signor Krause (CDU dell’Est e mediatore del governo de Maizière, emerso dalle elezioni) concluse con se stesso dovette fare da surrogato per un contratto sociale fra i cittadini dei due stati». Sono sicuro che Michael Benjamin non avrebbe lasciato che la colpa per simili omissioni nel processo di unificazione venisse attribuita esclusivamente alla carente comprensione dell’Occidente. Con sagge riflessioni avrebbe potuto arricchire anche il dibattito su ciò che rimane e sui futuri spazi di azione che in futuro torneranno ad aprirsi per la sinistra in seguito all’evidente crisi del capitalismo. Il suo punto di partenza era il «deficit di democrazia nella DDR», che vedeva come «uno dei motivi del suo fallimento». In una critica al libro di André Brie, Befreiung der Visionen (Liberazione delle visioni), chiarisce che «la democrazia è una componente imprescindibile» anche della sua idea di socialismo. Ciò lo condusse nel contempo a un confronto critico con le concezioni della DDR riguardo alla costituzione, allo stato e al diritto. A ragione contestò la piatta formula che parlava di «stato d’ingiustizia». Nessuno definirebbe «stato d’ingiustizia» la repubblica di Weimar, sebbene l’arbitrio in campo legale fosse all’ordine del giorno. Nessuno criticò la giustizia a Weimar, e con essa la realtà dello stato borghese di diritto, in maniera più calzante di Kurt Tucholsky. Una citazione che ho cercato a lungo, e che ho trovato poi nella raccolta degli scritti di Benjamin compilata da Wüste: «La fanciulla Justitia tocca piano e forte i tasti dello strumento, come capita. È una fanciulla delicata. Morbida è nei confronti della nobiltà, degli studenti, degli ufficiali, dei nazionalisti. Là non si picchia. E contro gli operai, invece? Certamente». E chi osserva con attenzione gli anni Venti arriva al medesimo risultato, o quanto meno a una conclusione simile a quella che Michael Benjamin aggiunse alla citazione di Tucholsky: «Questa amministrazione e questa giustizia compirono, con pochissime eccezioni, il passaggio diretto nello schieramento del nazionalsocialismo e, anni dopo, un altro passaggio non meno diretto nella Repubblica Federale». A questa valutazione della «cieca» giustizia borghese faceva riscontro la sua analisi del sistema giudiziario della DDR, verso il quale non era meno critico quando constatava «... che la concezione della DDR relativa alla costituzione, allo stato e al diritto, con i suoi princìpi come l’unità dei poteri, la norma costituzionale che sanciva il ruolo guida della SED (Partito combattente marxistaleninista), il rifiuto della giurisdizione costituzionale e del controllo giuridico delle decisioni amministrative non ha superato in definitiva la prova della prassi storica. La tesi che sosteneva l’unità degli interessi sociali e individuali condusse alla subordinazione dei secondi ai primi». In questo modo i princìpi della collaborazione diretta dei cittadini e della loro iniziativa sociale erano stati svuotati e subordinati a una politica economica sempre più discutibile. Per Michael Benjamin le «strutture di uno stato di diritto erano anch’esse un’importante conquista democratica, che un partito socialista non può impunemente ignorare» e dietro le quali «nessun principio di socialismo deve indietreggiare». Il suo interesse per la questione è evidenziato dall’atteggiamento autocritico con cui osserva i propri errori, che non si è perdonato, come in relazione al tema «I comunisti e la Legge fondamentale». Ricordava il «dibattito sullo stato di diritto» nella DDR, che era ripreso nel 1988 – «nel tentativo, compiuto in ritardo e fondamentalmente privo di efficacia, di legittimare la DDR». E osservò, testualmente: «Gli articoli che ho scritto allora, come per esempio “La Repubblica Democratica Tedesca – uno stato di diritto” – sono fra le mie cose peggiori. Non per il tema, ma per il loro carattere apologetico e l’attenzione con cui eludono i problemi e le contraddizioni reali». Nel suo discorso alla tomba del padre Grischa fece capire come tutto ciò rientrasse nelle personali riflessioni di Michael Benjamin già all’epoca della DDR. Lo chiamava il «costante conflitto», a cui sentiva di non essere esposto lui solo. «Vivevamo nella DDR, nel nostro paese, nel tuo, nel paese in cui cercammo di realizzare i nostri ideali e in cui tante cose non funzionavano come avevamo sperato o desiderato. E sempre ci chiedevamo come modificare le cose ed esercitare una critica attiva, senza distruggere l’intero edificio e tuttavia ottenendo qualcosa». Voltandosi indietro il figlio riconosce come fin dal 1985 il padre, ormai tornato da Mosca e divenuto prorettore all’Accademia di Stato e Diritto di Balbelsberg, avesse cercato per cinque anni di far conoscere ai capi del partito e dello stato i cambiamenti in Russia. «Cercasti di mettere in pratica le esperienze fatte a Mosca e di influire sui leader facendogliele comprendere – non a voce alta, gridando, ma attraverso colloqui personali, presentazioni e analisi». Era a piccoli passi che molte cose erano pur sempre cominciate – «a piccoli passi, come si mostrò nel 1990». Anche nella quinta Germania Michael Benjamin avrebbe probabilmente agito in questo modo, sebbene in altri contesti sociali. Sono sicuro che non lo avrei trovato in cima a una tribuna, intento a guardare dall’alto il campo da gioco. Non avrebbe mai smesso di immischiarsi. La quinta Germania fronteggia grandi problemi concreti: ha bisogno per esempio di immigrazione per compensare il mutamento demografico e il sensibile invecchiamento della società. Entrambi i nipoti di Ursula, Laura e Jakob, sono nati poco prima della svolta e sono cresciuti nella Germania riunificata. Anche loro si domandano se la sinistra oggi possa contribuire a controllare politicamente il processo di cambiamento che la Germania attraversa in quanto paese di immigrazione, senza suscitare una resistenza aggressiva da parte dei tedeschi che continuano a essere la maggioranza. Nel 2012 l’Ufficio federale di statistica annunciò un saldo positivo nella popolazione, grazie all’immigrazione e malgrado un tasso di natalità che nel 2011 era nuovamente rimasto fermo al livello più basso mai raggiunto, e malgrado inoltre l’emigrazione e la mortalità; per la prima volta dopo anni la popolazione era cresciuta. Ciò viene spiegato con l’immigrazione di giovani provenienti dai paesi europei in crisi, dalla Spagna e dalla Grecia, che sperano di trovare lavoro in Germania. Si vedrà se la capacità di integrazione della società sarà sufficiente e se si renderà disponibile la necessaria base finanziaria affinché gli immigranti ricevano un adeguato sostegno per inserirsi nel nuovo paese. In generale si deciderà inoltre se nel mondo globalizzato la Germania potrà mantenere il suo posto fra le nazioni maggiormente orientate all’esportazione, o se fallirà per le sue contraddizioni interne, soffocando sotto il suo provincialismo. Finora La Sinistra, discesa dalla DDR, non ha saputo mostrare dove intende spingersi politicamente. Entrambi i partiti moderatamente democratici di sinistra, l’SPD e La Sinistra, pensano ancora in gran parte secondo le categorie dei due stati divisi dai quali provengono. Le dimensioni del quinto stato, della Germania più ampia, sono ben altre. Lo stesso appare evidente nella politica europea dei partiti conservatori, che agitano la forza economica del paese come una clava con cui mettere in ginocchio l’Europa, e non la aiutano a sollevarsi. La crisi finanziaria forzata dalle banche potrebbe comportare uno spostamento a sinistra delle maggioranze nel parlamento europeo. A Bruxelles e a Strasburgo potrebbero crescere i presupposti programmatici che renderebbero pensabile un avvicinamento dei due partiti operai tedeschi. In Europa potrebbe svilupparsi ciò che a sua volta in Germania potrebbe fare, a quel punto, della maggioranza strutturale una maggioranza politicamente utilizzabile. Non è chiaro però se ci sia abbastanza coraggio politico dalle due parti. La quinta Germania in Europa ha urgente bisogno di un dibattito accelerato per impedire che la ricaduta negli egoismi nazionali, a cui spingono a grandi lettere i giornali, conduca alla rovina dell’Unione. Laura Benjamin, studentessa di giurisprudenza, deve ascoltare di continuo osservazioni poco divertenti sulla sua bisnonna, l’ex ministro della DDR. In gran parte esse ignorano tutto sulla vita di Hilde Benjamin. Laura dice che non fa nulla. Eppure la toccano. Lei e il fratello non hanno conosciuto la bisnonna. Tanto più hanno amato il nonno. Al funerale Georg menziona l’insofferenza di sua nonna Hilde, insofferenza che anche il figlio Michael manifestava – sempre quando notava semplici espressioni di malumore, brontolii senza motivo o una carente disponibilità a pensare e a imparare. «Tu la chiamavi pigrizia del pensiero, e a noi, i tuoi figli, già venivano le lacrime perché ci sentivamo incompresi». Nella «famiglia profondamente politica» il pensiero era qualcosa di presupposto. «I dubbi dovevano essere possibilmente motivati. Se si era capaci di motivarli – in maniera plausibile – venivano presi sul serio e discussi. Il che non era tipico per l’epoca, ma lo era per noi, per voi, per te». Laura ride con aria smaliziata, mentre io siedo nella piccola cucina del suo accogliente appartamento di studentessa a Pankow, e ricorda il calore del nonno, che sapeva unire intelligenza e un profondo sapere con l’umorismo e la gioia di vivere. Non aveva nulla dell’intellettuale altezzoso e freddo. Laura e Jakob rammentano il biglietto attaccato alla porta del suo studio, le cui parole recitano insieme a memoria: «Se avessi saputo quanto sono divertenti i nipoti li avrei avuti prima». Il suo interesse e il talento per la cucina si mostravano nelle dimensioni crescenti del suo giro vita. Ai figli, per il loro diciottesimo compleanno, regalò un libro di cucina compilato da lui. Georg poté leggervi nella prefazione che l’idea secondo cui la donna appartiene ai fornelli era una favola, continuamente riscaldata ma «del tutto passé». Restava vero però che «l’amore passa per lo stomaco». Anche i nipoti ricevettero per la Jugendweihe15 la loro dote di ricette, insieme all’invito ad arricchire personalmente la raccolta. Michael ammira molto un aforisma di Walter Benjamin: «Sia detto soltanto di passaggio che per il pensiero non esiste punto di partenza migliore della risata. E, in particolare, la vibrazione del diaframma offre al pensiero possibilità generalmente migliori che non l’anima». Laura studia giurisprudenza e Jakob architettura. Sono già stati in diverse occasioni all’estero per soggiorni di studio o qualche tirocinio, come ha fatto Laura a New York, presso il consolato generale della Repubblica Federale. La sua concezione della gente è influenzata anche dal nonno, ed è lontanissima dalla mancanza di rispetto che contraddistingue molti giovani e rende più difficile, se non impossibile, un reciproco contatto costruttivo. Laura e Jakob osservano attentamente il mondo intorno a loro e non sono sicuri se rimarranno in Germania o andranno via. Non conoscono barriere linguistiche. Se rimanessero a disposizione di questa quinta Germania avrebbero degli alleati. L’intero spettro dell’attuale scena giovanile tedesca si ritrova da due anni, più volte alla settimana, nei sette spazi tematici della mostra interattiva «7xjung» (7 volte giovani), sotto le arcate della stazione S-Bahn di Bellevue. L’associazione «Gesicht Zeigen!» («Mostrare la faccia!») ha percorso nuove vie per allacciare l’oggi e la storia recente. Più di quattromila studenti delle scuole superiori, fra i dodici e i diciotto anni, hanno già visitato gli spazi artistici e trascorso insieme molte ore partecipando a workshop. Molti hanno vissuto esperienze di emarginazione. Attraverso l’esempio di fatti molto personali vedono qui gli esiti a cui ha condotto l’emarginazione delle minoranze nella storia tedesca dopo il 1933, e li pongono a confronto con la realtà della loro vita odierna. Il libro degli ospiti è pieno dei commenti lasciati dagli studenti, e anche delle lodi delle delegazioni internazionali, spesso mandate dal Ministero degli Esteri, le quali ammirano il progetto che stimola per alcune ore le classi a confrontarsi vicendevolmente. Nella realtà scolastica di tutti i giorni se ne offre solo raramente l’occasione. Spesso arrivano ragazzi da scuole in cui la percentuale dei figli di immigrati arriva al novanta per cento. Ogni tanto si incontrano anche classi di liceali. E Jan ricorda alcuni che hanno raccontato qui, per la prima volta, le loro esperienze con giovani neonazisti, e si sono sentiti incoraggiati a sviluppare strategie per opporsi a loro senza ricorrere alla violenza. Sono cose che li toccano ogni giorno, e a volte sono anche scontri fisici. «Ma non se ne parla con nessuno, non a scuola o con gli insegnanti, e nemmeno a casa». Anche negli altri progetti sono offerti stimoli al rispetto e alla tolleranza, al fine di riconquistare una terraferma democratica. Senza i molti che compiono il loro anno di servizio sociale volontario presso «Gesicht Zeigen!», l’istituzione non potrebbe mantenersi in attività. Ciò vale anche per altre iniziative che si oppongono alla corrente delle crescenti opinioni di destra. Con questo lavoro contribuiscono al rafforzamento dell’Europa democratica che in certe regioni dell’Italia, della Polonia o della Repubblica Ceca è in ritirata. Particolarmente disastrosa è la situazione in Ungheria, dove si va formando un regime dispotico che riceve solo una debole risposta dall’Europa. La quinta Germania avrebbe un debito con la sua storia, e tanto più in quanto membro più forte dell’Unione. Ma ottempera a questa responsabilità? È davvero falso quel che afferma il primo ministro lussemburghese, JeanClaude Juncker, quando dice che i tedeschi trattano l’Unione Europea come una filiale, con cui perseguono la loro politica interna? Così conferma soltanto l’impressione, condivisa comunque da molti osservatori, che Berlino mantenga un comportamento sconsiderato verso l’Europa comune. A ciò contribuisce anche La Sinistra. Non è ben chiaro su quale immagine dell’Europa intenda fondare il suo futuro politico. In tempo di crisi è più che evidente come le società capitalisticoborghesi vadano nuovamente incontro a una stagnazione. Appena la metà degli studenti tedeschi viene da famiglie in cui i genitori non hanno frequentato l’università, e solo il due per cento da strati con un livello di istruzione decisamente basso. Lo scandalo risiede proprio in questi numeri e in altri simili, poiché mostrano bene quanto siano attivi nella società i meccanismi di selezione fra alto e basso. Basti pensare al numero degli analfabeti funzionali, che in Germania sarebbero circa sette milioni. Alle scuole superiori il dieci per cento degli studenti non ottiene nemmeno il diploma di grado più basso, ciò che significa ogni anno un numero compreso fra i 60.000 e gli 80.000, i quali infoltiscono così la schiera dei disoccupati che beneficiano dei sussidi sociali. Un bambino ogni cinque in Germania appartiene a una famiglia che vive sotto la soglia ufficiale di povertà. Il modo di affrontare il problema è descritto da Walter Benjamin. «“La povertà non è un disonore”. Benissimo. Loro però disonorano il povero. Ciò fatto, lo consolano con la bella frasetta. Che è di quelle che si potevano lasciar passare una volta, ma che sono ormai fuori corso da un pezzo. Non diversamente da quel brutale “Chi non lavora non mangia”». Vale la pena di rimanere con Walter Benjamin e di seguire la sua riflessione: «Quando di lavoro che a uno dava da vivere ce n’era, c’era anche una povertà che non lo disonorava se lo colpiva per un cattivo raccolto o per altri rovesci. Disonora invece questa vita grama che milioni di persone trovano venendo al mondo e in cui centinaia di migliaia d’altri restano invischiati. Sudiciume e miseria» così descrive in Strada a senso unico, «crescono intorno a loro come mura innalzate da mani invisibili». Benjamin è convinto: «Mai però sarà lecito a uno far pace con la povertà se essa, come un’ombra gigantesca, si abbatte sul suo popolo e sulla sua casa». Potrebbe essere un commento ai numeri quotidianamente disponibili dell’economia di oggi, dove sempre più numerosi sono i posti di lavoro che non bastano a sfamare un uomo o una donna. Il lavoro mal pagato distrugge la fiducia in sé degli individui, che lavorano e non riescono tuttavia a vivere e hanno bisogno di un secondo o terzo impiego per farcela da soli o con la famiglia. Walter Benjamin vuole che si assuma una chiara consapevolezza rispetto a questa forma di sfruttamento e autosfruttamento, e dice: «Allora egli dovrà tenere ben vigili i propri sensi di fronte a ogni umiliazione che verrà loro inflitta, e disciplinarli finché la sua sofferenza avrà aperto non più la rapida discesa dello sconforto, ma il sentiero in salita della rivolta». Alle sue parole così attuali segue la non meno attuale critica ai media e alla loro incapacità di elaborare almeno analiticamente il caos economico dell’epoca, che in definitiva condusse alla catastrofe della Seconda guerra mondiale, e di illuminarne le autentiche cause. «Qui non c’è nulla da sperare finché ogni più atroce, ogni più nero destino, discusso ogni giorno, anzi ogni ora dalla stampa, analizzato in tutte le sue fittizie cause e conseguenze, non aiuta nessuno a scoprire le forze oscure alle quali la sua vita ha dovuto assoggettarsi». Anche Georg, alla tomba del proprio padre, non può non menzionare Walter Benjamin. Per il padre egli era importante «al fine di comprendere e preservare», e lo era anche nella sua storia personale, in cui «l’elemento ebraico, e con esso la conoscenza e il riconoscimento di Walter Benjamin, tuo zio, divennero essenziali. [...] In molte cose assomigliavi a Walter, l’umanista costantemente alla ricerca». Georg ricorda un incontro su Walter Benjamin, tenutosi cinque anni prima, in cui Michael parlò di lui e della propria concezione di sé e del suo rapporto con la storia. La stessa cosa potrebbe dire Georg a proposito di suo padre, di cui in conclusione cita alcune parole sulla «maniera in cui Walter Benjamin intendeva il proprio essere tedesco e in cui credo che noi dobbiamo intenderlo. “Dell’onore senza gloria, della grandezza senza splendore, della dignità senza mercede”». 15 «Festa [lett. consacrazione] della gioventù», sorta di versione socialista della cresima cattolica e della confermazione protestante [N.d.T.]. Capitolo quattordicesimo Cosa resta... Sopra la città di Portbou, su un plateau di roccia c’è il monumento a Walter Benjamin, intitolato Passages. Un luogo della memoria che pare incollato sulle rocce, opera dell’artista israeliano Dani Karavan. Il fragore dell’acqua si sente fino in alto, quando le onde coronate di schiuma si infrangono sulla spiaggia. Il monumento è formato da un’esile scalinata, abbracciata da una costruzione di acciaio color ruggine, una specie di corridoio chiuso alla sommità e con pareti più che ad altezza d’uomo. Sessantotto gradini di ferro conducono in basso, dove una massiccia parete di vetro impedisce la caduta nel mare in burrasca. La vista attraverso la lastra di vetro e la sensazione di star sospesi sul mare – un’illusione perfetta. Dietro il vetro – gli ultimi diciassette gradini verso il nulla. Incisa sul vetro c’è una citazione dalle tesi Sul concetto di storia di Walter Benjamin: «È più difficile onorare la memoria dei senza nome che non quella degli uomini famosi. Alla memoria dei senza nome è consacrata la costruzione storica». L’ingresso nello stretto corridoio di ferro è aperto. A mano a mano che si scende, il pozzo delle scale offre in fondo la vista del mare e, quando poi invece si risale, la luce del giorno al termine del tunnel. Gli incompiuti Passages di Benjamin sono riecheggiati in questo salire e scendere. Un luogo del ricordo di lui, che nella notte fra il 25 e il 26 settembre 1940 si prese qui un’ultima libertà: decidere da sé della (propria) vita o morte. La piccola pensione di Portbou, la stanza al primo piano sul retro dove fu trovato moribondo dopo che aveva ingerito pastiglie di morfina, non esiste più. Al suo posto c’è una casa a due piani. Una piccola targa sul marciapiede davanti al nuovo edificio ricorda lui e il giorno della sua morte. Il fascicolo di Benjamin rimase intatto presso le autorità spagnole. Un provvedimento di estradizione impolverato e mai chiuso, sulla smisurata scrivania della storia. L’ingresso in Spagna gli fu negato perché nei suoi documenti mancava il timbro di uscita dalla Francia. I doganieri spagnoli perciò volevano rispedire indietro il gruppo il mattino dopo, cosa che per Benjamin avrebbe significato la consegna alla Germania nazista. Dove si riuscirebbe a ricordarlo meglio che qui, nel luogo in cui trovò la morte? A quel tempo Portbou era una tappa per molti profughi, lungo il percorso che dalla Spagna arrivava al Portogallo. L’amica Hannah Arendt lo superò senza problemi, pochi mesi dopo il fallimento di Benjamin. La disposizione che prescriveva il timbro di uscita era ormai stata abolita. Hannah Arendt non sapeva che Portbou era stata l’ultima stazione di Benjamin. Si erano visti poche settimane prima a Lourdes, dove erano fuggiti lasciando Parigi dopo l’invasione tedesca della Francia. Hannah Arendt racconta per iscritto a Theodor W. Adorno di lunghe conversazioni durante interminabili partite a scacchi. Questo paese di duemila anime arroccato sopra il golfo, lungo la selvaggia costa spagnola, le apparve come «uno dei posti più belli e stupefacenti del mondo». Così può apparire a chi è sfuggito all’inseguimento dei nazisti, giunto senza più fiato oltre l’ultima cresta dei Pirenei – la vista che finalmente spazia libera sul mare e la costa e su Portbou, la città spagnola di frontiera con la grande stazione di smistamento. Nessun racconto su questa via di fuga e sulla città manca di accennare al diverso scartamento ferroviario utilizzato nei due paesi. Fortissimo perciò è il fragore che arriva dalla stazione, quando i vagoni sono spinti da un binario all’altro. Mia moglie e mio figlio Tom, nove anni, viaggiano in macchina con me lungo la strada piena di curve verso il lato francese dei Pirenei, a Banyuls-sur-Mer, il punto di partenza della fuga di Walter Benjamin. Da lì vogliamo seguire il suo percorso in direzione di Portbou. È la prima settimana di ottobre, e sono magnifiche giornate di sole. Alla radio dicono che non si sono mai avute giornate tanto calde in questo momento dell’autunno. Mentre parcheggio la macchina ai margini della città, mi chiedo se ciò sia dovuto ai cambiamenti climatici. Pochi metri dopo c’è il cartello dove, a scelta, è possibile leggere Chemin o Ruta Walter Benjamin. Qui cominciò la fuga del piccolo gruppo con Walter Benjamin e Henny Gurland, che aveva fra l’altro lavorato come fotografa per il «Vorwärts» (Avanti) socialdemocratico a Berlino, e suo figlio Joseph. I tre avevano viaggiato insieme fin da quando si erano incontrati a Marsiglia. Li guidava Lisa Fittko, emigrata nel 1933 da Berlino in Francia e finita poi nei Pirenei. Lei e suo marito Hans conoscevano bene le montagne della zona di confine franco-spagnola, e salvarono decine e decine di persone dai nazisti. Anche il «Chemin Benjamin» è un sentiero gradinato, che potrebbe aver fatto da modello per il monumento Passages. Un passaggio ampio un metro che costeggia un muro di case, limitato a destra e a sinistra da arbusti rigogliosi e folti, su cui getta ombra un tetto di fogliame. Arrivati in fondo, ci si inoltra nei vigneti. La via, pochi metri su un fondo solido di calcare e sabbia, serpeggia con morbide curve su per il Col de Rumpira, alto seicento metri, incontro alle cime azzurre dei Pirenei. Quarant’anni dopo Lisa racconta il suo incontro con Walter Benjamin. L’idea di scrivere su questo un libro era stata dell’amico di Walter, Gershom Scholem, che viveva in Israele. Nella piena delle pubblicazioni apparse nel 1980 non l’avevo visto. E trascorsero così altri trent’anni, fin quando mi cadde fra le mani in un negozio di antiquariato. Leggo il racconto di questo incontro distante, lontanissimo nel tempo, e immagino quali sentimenti di paura e speranza l’abbiano accompagnato. Sulla sovraccoperta c’è una fotografia: Lisa con una sigaretta all’angolo sinistro della bocca. Un leggero sorriso sul bel volto. La testa inclinata a destra, lo sguardo pensoso. Un’eroina della resistenza, il cui libro e la sollecitazione che ne promana mi hanno attratto fin qui a settant’anni di distanza. Affaticati e riscaldati dal sole autunnale, percorriamo in tre la Route F (F sta per Fittko), che Lisa e il suo gruppo avevano preso. Nel 1940 la città portuale di Marsiglia brulicava di profughi dalla Germania e da tutta Europa, fuggiti dal Nord della Francia verso il Sud non ancora occupato. Già prima dell’invasione e dell’armistizio nel giugno 1940, con la conseguente divisione del paese, era stato disposto l’internamento «di tutti i tedeschi e degli altri stranieri in un’età fra i diciassette e i quarant’anni». In seguito la disposizione fu estesa alle persone fino ai sessantacinque anni. Ma c’era comunque sempre il rischio di essere consegnati alla Germania, anche dal Sud della Francia inizialmente «libero», che portava il nome della città di Vichy. Non mancavano gli agenti e i delatori che per denaro tradivano i profughi. Qui Walter Benjamin aveva nuovamente incontrato Hans, il marito di Lisa Fittko, che conosceva dal campo di internamento di Vernuche. Entrambi erano riusciti a uscirne. Erano un centinaio i campi come quello di Vernuche, destinati alle migliaia di tedeschi emigrati in Francia dopo il 1933. Un incontro casuale nell’ufficio dei sindacati americani, che lavoravano insieme a una serie di altre organizzazioni della resistenza, come il gruppo socialdemocratico «Neu Beginnen» (Nuovo inizio), gli «American Friends of German Freedom» e la «HICEM», organizzazione umanitaria che assisteva i profughi ebrei. Dirigeva l’ufficio il giornalista americano Varian Fry che in meno di due anni, fino al suo arresto nel 1941, fece passare clandestinamente dalla Francia in Spagna più di duemila persone, e poi da lì fino agli Stati Uniti. Molte furono accompagnate oltre la frontiera da Hans e Lisa Fittko. L’ufficio esisteva già un anno prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra. Era stato fondato a New York per consentire a eminenti oppositori di Hitler o a ebrei in pericolo di vita l’ingresso negli Stati Uniti. Il sindaco di Banyulssur-Mer aveva suggerito loro un nuovo percorso tracciandone uno schizzo, perché il tratto che da Cerbère attraversava i vigneti, preferito da Lisa, non era più sicuro. «Ora questo» si legge nel libro «era attentamente vigilato dalle “Gardes mobiles”, per ordine della Gestapo». Il nuovo e sicuro tragitto si trova più in alto ed è più faticoso. Molte delle persone scortate da Lisa non erano fisicamente in grado di percorrerlo o erano talmente indebolite dallo scarso nutrimento che spesso si crearono situazioni critiche. Walter Benjamin soffriva di una miocardite e doveva evitare il più possibile gli sforzi eccessivi. Ma voleva andare a tutti i costi. «L’importante è che sia sicuro» aveva risposto quando Lisa gli aveva illustrato il percorso. Per tranquillizzarlo, e certamente con buone intenzioni, il sindaco consigliò di provare il primo terzo della via il giorno stesso del loro arrivo a Banyuls, così da memorizzarla: «Una bella passeggiata, un’ora al massimo» aveva aggiunto. Per questo tragitto di prova Benjamin impiegò, come sappiamo, più di tre ore. Pausa ogni dieci minuti per calmare il cuore. Settantuno anni più tardi copriamo la stessa via nella metà del tempo. Ma ogni pietra che ci fa scivolare, ogni ostacolo che ci si para davanti quando avanziamo a fatica sugli erti pendii, coperti di fitti vitigni, e ogni interruzione che superiamo a volte solo con estrema cautela e sostenendoci con le mani, fanno capire cosa affrontò Walter Benjamin. Mentre saliamo mi chiedo dove sarei stato durante quei quindici anni, dal 1918 al 1933, se fossi stato un contemporaneo. I difficili anni dopo il 1921 e poi l’inflazione nel 1929, la disoccupazione, i governi inadeguati, dappertutto una miseria tangibile in un paese dilaniato, il movimento nazista che cresceva alle porte. Dove sarei stato? Al fianco suo e a quello del fratello Georg e della sorella Dora, che si lasciarono alle spalle la ricca dimora dei genitori? Georg era membro del Partito comunista tedesco, mentre Walter si avvicinò a esso ma non vi entrò mai, scettico sulla possibilità che un intellettuale borghese riuscisse ad abbandonare, o addirittura a cambiare, la sua appartenenza di classe. Gli pareva inevitabile finire tra «i fronti delle classi», il cui scontro si attendeva. Seguo il ripido cammino, accanto a me c’è il piccolo Tom e davanti mia moglie che avanza con passo leggero. Non faccio che passare dalla concentrazione sulle difficoltà del cammino alle riflessioni su Walter Benjamin, che presumibilmente era sospinto dalla pura volontà di resistere. Solo attraverso i ricordi di Lisa Fittko so qualcosa della sua notte solitaria in cima alla montagna. Da allora leggo su di lui tutto quel che mi ritrovo fra le mani. Avevo scelto di seguire il cammino attraverso i Pirenei come primo avvicinamento a quest’uomo e al suo destino. Molte cose si chiarirono a poco a poco, anche la certezza di poter attraversare cinque Germanie insieme ai Benjamin, Walter e Georg, poi a Hilde e suo figlio Michael e la moglie di lui, Ursula. Grazie a quest’ultima ho la fortuna di poter accedere al lascito di Hilde, le cui lettere e i molti documenti sono quasi i segnavia di ciò che a sua volta la segnò. Il fratello e la sorella di Walter ci divengono noti soprattutto attraverso Hilde, la moglie di Georg, e suo figlio Michael, nato alla fine della Repubblica di Weimar. E Walter Benjamin: il suo influsso si estende nel ventesimo e fin nel ventunesimo secolo. Coloro che alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso si rivoltarono contro la silenziosa generazione dei colpevoli, contro i padri e i nonni, gli mostrarono la loro gratitudine per ciò che trovarono nei suoi scritti. Crearono curiosità verso di lui. Oggi Walter Benjamin è famoso in tutto il mondo e Portbou è la città che con il monumento Passages racconta la sua aura. Michael Benjamin, che continuò a occuparsi del celebre zio e del suo pensiero, all’inaugurazione del monumento Passages a Portbou, il 15 maggio 1994, ricordò che Benjamin morì come profugo a cui era stato negato asilo. Anche oggi viene negato asilo ai profughi, non solo in Europa. Chi conta tutti quelli che attraverso il Mediterraneo sperano di raggiungere le coste dell’Italia e quindi l’Europa, e pagano con la vita il viaggio su barconi pieni di falle? Chi nonostante tutto raggiunge la Germania e vuole essere riconosciuto come profugo politico ha davanti a sé un lungo cammino che quasi sempre termina con l’espulsione e riconduce quindi alla miseria a cui si era cercato di sfuggire. Il diritto di asilo e la legislazione sugli stranieri necessitano urgentemente di una riforma. Il monumento a Walter Benjamin di Dani Karavan è stato il motivo che mi ha spinto ad andare là. Altrimenti non avrei forse mai visitato Portbou. L’autunno volge alla fine, solo pochi turisti si aggirano ancora per le strade. Dal mare soffia una leggera brezza. Solleva la sabbia e irrita gli occhi. La quiete del mezzogiorno. I negozi che sperano ancora in qualche cliente a quest’ora chiudono e non riapriranno prima delle cinque. La Rambla di Portbou invita all’ombra dei suoi alberi, con i caffè e i ristoranti. La piazza dev’essere stata in ogni tempo un punto di attrazione. Anche durante la guerra civile spagnola, che nel luglio del 1936 prese il suo avvio nel Marocco spagnolo e infuriò fino all’aprile del 1939. Dalla Francia giungeva un flusso di profughi, già provenienti dalla Germania e dall’Austria, che dopo l’avvento al potere dei nazisti e l’annessione dell’Austria dovettero fuggire. A migliaia passavano ogni giorno la frontiera. Nella vecchia stazione di confine una mostra fotografica ricorda oggi il dramma di un tempo. Vi sono riflesse la paura e la miseria del cammino nell’esilio. Si vedono anche i bambini, gli occhi grandi nelle facce scavate, che spesso attraversavano il confine senza i genitori. Furono creati dei campi per quelli che arrivavano da soli, mandati là nella speranza che potessero sfuggire almeno agli sgherri nazisti e sopravvivessero. Sul lato sinistro della Rambla, vicino al porto, c’è una stazione di polizia, ed è qui che Walter Benjamin potrebbe aver ricevuto l’ordine di ripresentarsi il giorno dopo per essere consegnato alle autorità francesi. La pensione dove lui e i Gurland pernottarono era dietro l’angolo, qualche passo addentro in una stradina laterale che sfocia sulla Rambla. Dopo la marcia di nove ore a piedi attraverso le montagne Walter Benjamin era completamente esausto. Più di una volta non sarebbe riuscito a raggiungere la meta senza il soccorso di Lisa e Joseph, che un po’ spingendolo e un po’ sorreggendolo lo aiutarono a giungere in cima alla montagna. Chissà se si sedette qui, quasi disidratato dal calore e dalla fatica, davanti a un bicchiere d’acqua o a una limonata? E la sua situazione gli apparve tanto disperata che il pensiero poteva guardare solo in una direzione? Nove ore di tormentoso tragitto per poi arenarsi qui? Non aveva la forza per attraversare indietro le montagne, verso Banyuls-sur-Mer, e tentare un’altra volta. Ma un ritorno forzato in Francia avrebbe significato finire direttamente in un campo di sterminio tedesco. Contò le pastiglie di morfina che gli erano rimaste. A Marsiglia, prima di iniziare il viaggio per Banyuls-sur-Mer, aveva incontrato Arthur Koestler e spartito con lui la sua provvista. Conosceva Koestler da Parigi, entrambi avevano vissuto nella stessa casa in rue Dombasle. Anche Koestler era diretto a Lisbona. Venticinque pastiglie era quel che restava. Bisognava prendere un’ultima decisione. Le autorità spagnole produssero un certificato di morte a cui era apposto il nome Dr. Walter Benjamin e seppellirono l’ebreo nel cimitero cattolico di Portbou. Il manoscritto nella cartella, definito più importante della sua stessa vita e che non sarebbe dovuto cadere nelle mani della Gestapo, non fu mai trovato. Nessuno sa dove siano finiti gli oggetti personali registrati dalla polizia spagnola, l’orologio da tasca d’oro, gli occhiali, una radiografia e la pipa. Chi li ha presi e perché? A chi furono consegnati e in base a quale ordine? La sua morte continua a porre enigmi. Chi cerca il monumento di Karavan trova presto il cartello che guida alle rocce sopra la città. Al termine della strada ombreggiata c’è un’ultima curva, prima dello stretto pozzo di ferro color ruggine che nasconde gli scalini verso il mare. Nessuna enfasi, nulla che possa distrarre dall’aura di Walter Benjamin. Il monumento commemorativo dista pochi metri dal piccolo cimitero di urne, dove si trova la tomba allestita da un gentile guardiano. Finalmente poteva rispondere, senza scuotere le spalle in segno di rincrescimento, quando i turisti gliene chiedevano conto. La tomba originaria era stata spianata. Henny Gurland aveva pagato la tassa per cinque anni, prima di continuare insieme al figlio il viaggio verso il Portogallo. Le guardie di confine, sconvolte dal suicidio di Benjamin, avevano concesso loro di proseguire il cammino. E quando negli anni Sessanta e poi successivamente il flusso dei turisti alla ricerca di Benjamin crebbe, l’amministrazione cittadina di Portbou pose una lapide che con grande ufficialità ricorda il celebre defunto. Non si sa dove sia stato originariamente sepolto. Dani Karavan descrive ciò che lo spinse a far sorgere il monumento a pochi metri di distanza dal cimitero: «Là ho capito che solo quello può essere il luogo che ricorda lui e la sua tragedia [...]. Il rumore dei treni provenienti dalla grande stazione di confine, simile al rumore delle deportazioni nei Lager. La morte, la frontiera, la speranza; non avevo altra scelta, non avevo scelta, tutto mi fu dettato. Sapevo che il posto dell’omaggio doveva essere vicino al piccolo cimitero. E poi, all’improvviso, la natura mi offre uno spettacolo straordinario ed emozionante, un vortice che dal mare si infrange tra le rocce. L’acqua si agita impetuosamente, precipita scrosciando, torna a balzare in alto con fragore, e poi silenzio, pace. E di nuovo questo straordinario spettacolo si ripete, come il battito di un cuore ferito. Le onde colpiscono le rocce, proprio come ci si colpisce il petto». E aveva visto poi «l’olivo, che per sopravvivere lotta contro il vento carico di sale e il terreno arido», e l’orizzonte, la libertà chiusa da una barriera, quella del cimitero. E tutti questi elementi, dice Karavan, che stavano là quando Walter Benjamin aveva cercato di raggiungere la libertà, e anche prima, tutti raccontano la storia tragica di quest’uomo. Le sensazioni di Karavan si trasmettono anche al visitatore, quando raggiunge l’ingresso del corridoio di ferro. Proprio come Karavan, sente che solo questo può essere il luogo. Mi dirigo verso il piccolo cimitero di urne. Fiori freschi sono posati davanti alla lapide. Una corona che sul nastro reca le parole: «La città di Portbou ricorda il giorno della morte, 26 settembre 1940». E ugualmente davanti alla lapide, come portata dal vento, la già menzionata cartolina della DDR. Mostra l’Alexanderplatz prima della riunificazione dei due stati tedeschi. Chi può averla messa là? Chissà se quell’uomo o quella donna, che nessuno conosce, era consapevole della forza simbolica di questo piccolo gesto. Un ricordo, senza parole, di un paese scomparso. «Filosof alemany» c’è scritto sulla lapide. Si trova in cima al lato anteriore del cimitero, disposto a gradinate. Chissà se Walter Benjamin avrebbe accettato di farsi inserire nella serie dei filosofi tedeschi. Per i catalani, in ogni caso, ciò sembra ovvio. Anche Mischa, suo nipote, pone la domanda e offre la risposta in un discorso per l’inaugurazione della mostra «Grenzüberschreitungen» (Passaggi di frontiere) all’Istituto di Storia sociale di Amsterdam il 16 settembre 1993: «Avrebbe accettato questa definizione – lui che si occupò della cabala e a lungo si sentì legato al sionismo, e che all’ebraismo lo fu per l’intera vita? Lui che era stato respinto dall’erudizione universitaria e scacciato dalla Germania? Lui che la Gestapo ricercò? Che amò vivere a Parigi e si sentiva affine ai francesi Charles Baudelaire e Marcel Proust? Che pensava in contesti storici mondiali?». Eppure mi azzarderò ad affermare che Walter Benjamin avrebbe accettato questa definizione. Davanti ai suoi occhi c’era un altro genere di identità tedesca rispetto a quella vigente allora, sotto il «fragore saltellante dei pezzi d’ossa battuti», come scrisse sua cugina Gertrud Kolmar, anch’essa una combattente della parola la cui forza poetica, al pari della sua, si manifestò solo dopo la sua morte e la liberazione dal nazifascismo. Certo un’altra identità tedesca rispetto a quella che oggi comincia a ripresentarsi sotto elmi azzurri o di altro colore, e a cui il mondo dovrà abituarsi. La maniera «tedesca» di pensare che fu propria a Benjamin non era affatto quella che oggi torna a mostrarsi «out of area» e fuori dai confini tedeschi. Anch’io sto davanti al luogo della memoria, come fece un tempo Michael Benjamin, e poi in tre ci dirigiamo a Banyuls per seguire la Ruta Walter Benjamin. Per il tragitto di ritorno da Portbou a Banyulssur-Mer Lisa Fittko ebbe bisogno di due ore. E ricordava l’infinito sollievo provato al pensiero di aver portato con sicurezza alla meta il piccolo gruppo. Solo qualche giorno più tardi venne a sapere del suicidio del «vecchio» Benjamin, del quale ammirava il «pensiero cristallino e l’irriducibile forza interiore», e la cui evidente inettitudine alla vita tornava spesso a strapparle un sorriso. Ci abbandoniamo ai nostri pensieri. Sulla via del ritorno Tom va avanti e indietro, fra mia moglie e me, e raddoppia così il cammino. Lei – sia in discesa che in salita – è sempre avanti, senza fatica. Tom mantiene il contatto. La calura è diminuita, una leggera brezza ci porta un po’ d’aria. Il sentiero in salita aveva stancato Tom. Più volte ho dovuto incoraggiarlo a staccarsi dal punto in ombra che gli offriva un po’ di frescura. Sollecitando quindi in lui la domanda scettica su come sapessi che proprio quella era la via presa «dal signor Benjamin». E come conoscevo lui e la sua fuga. E se aveva dei figli. E io gli racconto quello che so, anche della sua celebre raccolta di libri per l’infanzia, e di quanto amasse i bambini. Chi ricorda Walter Benjamin e, senza lasciarsi intimidire dalla frequente difficoltà delle sue opere, ha colto l’occasione di incontrarlo, non seguirà la tentazione di vagare nel passato ma ordinerà testi e aforismi nel corpo stesso del presente. Come il celebre saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, che parla del modo in cui il film sonoro soppiantò il muto, rafforzando ancora di più il potere delle immagini. La sua invenzione avvenne al tempo del grande dibattito ideologico del ventesimo secolo. Il ministro della Propaganda hitleriano, Joseph Goebbels, riconobbe la seduzione resa possibile dal nuovo mezzo, e lo utilizzò per i suoi scopi. Molto di quello che Benjamin con grande acutezza disse, analizzando le bande di assassini che circondavano Hitler, offriva già una risposta a domande che sarebbero sorte da tutto ciò, ma vennero formulate troppo tardi. Il programma di erigere questo luogo del ricordo rischiò fortemente di fallire. Nel 1991 tutto sembrava chiarito. Il Ministero degli Esteri a Bonn era pronto a finanziare con un milione di marchi il progetto e l’esecuzione del monumento Passages di Dani Karavan. Le idee dell’artista avevano incontrato un’approvazione unanime. Molti videro in ciò il distacco da una discussione su monumenti e luoghi commemorativi per le vittime del regime nazista che equiparava ancora ogni morto, carnefice o no. Il contributo dei politici era spesso qualcosa che bisognava temere, come scriveva la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» nel 1991: «Un terribile barcamenarsi tra vittime e carnefici, con zone grigie in cui persino le Waffen-SS erano certe della devota indulgenza che avrebbero ricevuto». Il quotidiano di Francoforte celebrava il progetto di Karavan come «il superamento dell’illustrazione, così come dell’astrazione: un dialogo con le figure del pensiero di Benjamin e le metafore del passaggio di frontiera, un momento senza monumentalità stentorea, un esempio di un rapporto preciso e complesso con il paesaggio e i ricordi del posto». La sollecitazione a creare il luogo della memoria era venuta da Richard Weizsäcker, allora presidente della Repubblica Federale. L’inaugurazione era prevista per l’estate 1992. Weizsäcker aveva invitato il suo omologo israeliano, Chaim Herzog, come quest’ultimo comunicò per lettera a Dani Karavan. La posa della prima pietra ebbe luogo nel settembre 1991. Alla cerimonia a Portbou vennero letti messaggi di saluto da parte del presidente von Weizsäcker, del ministro della Cultura spagnolo, lo scrittore Jorge Semprún, e del suo omologo francese Jack Lang. I resoconti in Spagna e in Germania furono esaurienti e apprezzabili. Nonostante l’impegno del Ministero degli Esteri, il cui finanzamento appariva certo, all’improvviso si moltiplicarono gli ostacoli. La Corte dei Conti federale era – con evidente intenzione – erroneamente informata. E fu perciò inevitabile quel che ne seguì, cioè il titolo del quotidiano scandalistico «Bild»: «Quasi un milione per una targa». Il rotocalco «Neue Revue» mise il ministro degli Esteri Genscher nella fila dei «peggiori dilapidatori di tasse». La rivista pubblicò una foto della semplice pietra che la comunità di Portbou aveva offerto nel 1990 a proprie spese per il cinquantesimo anniversario della morte di Walter Benjamin. Fu suscitata l’impressione che per quella pietra si dovesse spendere un milione di marchi. La Corte dei Conti aveva contestato che la «cura di una tomba» fosse diventata «un progetto milionario». Anziché chiarire la questione l’allora ministro degli Esteri, Hans-Dietrich Genscher, cancellò ufficialmente l’incarico. La Repubblica Federale rischiava di fare una gran brutta figura. Le regioni dell’Assia e del Baden-Württemberg, che inizialmente avevano voluto sostenere una piccola parte dei costi, decisero di assumersi tutto l’onere. Walter Benjamin aveva lasciato le sue tracce in entrambi i Länder. Aveva trascorso alcuni semestri di studio a Heidelberg. A Francoforte aveva vissuto una grande delusione, quando la sua tesi di abilitazione alla libera docenza sull’Origine del dramma barocco tedesco era stata respinta dall’università. Inoltre era stato collaboratore del celebre Istituto per la ricerca sociale di Francoforte. In ogni caso i due Länder risparmiarono alla Repubblica Federale Tedesca un grande imbarazzo. La realizzazione del progetto di Karavan subì un ritardo di due anni. La «Frankfurter Allgemeine Zeitung» congetturò una campagna di disinformazione, guidata dal Ministero degli Esteri. Coloro che l’avevano ordita restarono sullo sfondo. Il monumento fu costruito e ultimato nel maggio 1994. Ci fu una cerimonia alla quale intervennero i presidenti dei due Länder, Hans Eichel per l’Assia e Erwin Teufel per il BadenWürttemberg. Erano stati invitati anche Dani Karavan e Michael Benjamin, sua moglie Ursula e i figli e i nipoti in età adulta. Era arrivata anche Lisa Fittko. Michael Benjamin appariva profondamente commosso dalla presenza ufficiale della comunità catalana degli ex prigionieri del campo di concentramento di Mauthausen, dove suo padre Georg, il fratello di Walter, era stato ucciso. Avevano contribuito a finanziare l’opera. Lisa Fittko era giunta sola da New York a Portbou. Suo marito Hans era morto. La loro fuga allora, attraverso Cuba e fino a New York, sarebbe una storia a sé. Entrambi fanno parte di quegli eroi silenziosi che agirono quando altri si nascosero. Il calcolo di quanti volevano sabotare tutto questo non si è realizzato. Il monumento e la sua forma espressiva hanno trasmesso l’esperienza dell’esilio. Dovevano passare altri venti anni prima che la storia del Ministero degli Esteri e il suo coinvolgimento nello stato nazista fossero studiati ed elaborati. Das Amt und die Vergangenheit (Il Ministero e il passato) è il sobrio titolo di un voluminoso libro. Esso chiarisce l’estrema vicinanza del Ministero e di molti dei suoi membri, dopo il 1933, agli obiettivi dello stato nazionalsocialista. Anche la loro adesione all’ideologia della razza e a un antisemitismo diffuso fra i diplomatici prevalentemente dal sangue blu. L’intrigo del 1991 fu probabilmente uno degli ultimi frutti del coinvolgimento «bruno» all’interno del Ministero. L’analisi approfondita della sua storia, durante i dodici anni della dittatura nazista, trova un commento adeguato in Walter Benjamin: «Non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della barbarie. E come non è esente da barbarie esso stesso, così non lo è neppure il processo della trasmissione per cui è passato dall’uno all’altro». Cosa rappresentano i Benjamin, i due fratelli e la sorella Dora? Furono perseguitati, umiliati, e non cedettero. Come Gertrud Kolmar, la cugina di Walter, Georg e Dora, la poetessa la cui arte Michael Benjamin ammirava: uccisa a Auschwitz. E Hilde, che sopravvisse a tutti, la giovane donna con la pelle scura e i capelli color pece, chiamata a scuola «l’indiana», con la sua patente di «arianità» che offrì una protezione al figlio. Nelle sue lettere e nei biglietti traspare una speranza che non si compie quasi mai. Come suo marito Georg, Hilde è membro del movimento comunista mondiale, manovrato da Mosca. Mostra il suo coraggio civile, si mantiene fedele ai parenti e agli amici ebrei, e tuttavia non può impedire che questi siano consegnati, l’uno dopo l’altro, alla macchina nazista della morte. Più di settant’anni dopo la fine della guerra e il superamento della divisione europea sembrava che il capitalismo avesse trionfato. Questa valutazione, accolta da molti, si è incrinata. Insoddisfazione per la politica e stanchezza della democrazia aumentano. Un segno tipico di questo è lo slittamento a destra che dagli Stati Uniti e il Tea Party arriva fino in Russia, dove un presidente disorientato vuole spezzare la voglia di libertà della giovane generazione. Come un’epidemia, l’estremismo di destra si aggira spettralmente per l’Europa. E, nel contempo, si avverte la ricaduta negli egoismi nazionali. In gioco c’è niente di meno che l’integrazione europea. È tempo di riflettere. Il capitalismo in crisi? Con la fine del mondo bipolare era scomparso anche il capitalismo renano e democratico, che sosteneva l’economia sociale di mercato. La globalizzazione l’ha cancellato, e da allora il numero delle sue vittime cresce, come quello dei giocolieri della finanza e di quelli che nelle banche traggono vantaggio dalla crisi e sarebbero pronti a scommettere persino sulla propria fine, se in questo modo fosse possibile far balzare al venticinque per cento il volume delle rendite. Si cercano alternative che potrebbero escludere una cosa del genere. È stata l’unica rivoluzione senza spargimento di sangue a noi nota, e ha avuto luogo proprio in Germania, dove si pensava in termini di alternative. Non c’era discorso ufficiale nel paese riunificato in cui non fosse ricordata la «rivoluzione pacifica». In realtà si tende a dimenticare che gli iniziatori di questa rivoluzione speravano di trasformare la DDR, e non pensavano né all’annessione né al capitalismo come forma sociale. Vale la pena di rileggere il lascito dei rivoluzionari pacifici. Hanno scritto molte cose a cui oggi si potrebbe apporre il timbro «pratica da ripresentare». Per esempio l’appello con cui si annunciava la fondazione di «Aufbruch 89 – Neues Forum» (Risveglio 89 – Nuovo Forum), il 10 settembre 1989: «Vogliamo un margine di azione per l’iniziativa economica, ma non la degenerazione verso una società di competizione selvaggia. Vogliamo mantenere ciò che è collaudato e creare tuttavia spazio per il rinnovamento, per vivere con più sobrietà e in maniera meno ostile alla natura. Vogliamo rapporti ordinati, ma nessuna tutela. Vogliamo individui liberi e consapevoli di sé, che però agiscano in uno spirito di collettività. Vogliamo essere protetti dalla violenza, ma non dover sopportare uno stato di scagnozzi e spie. Sfaticati e gradassi devono essere allontanati dai posti che ricoprono senza fare nulla, ma non vogliamo procurare con questo svantaggi a persone inermi o in posizione socialmente debole». Tutto ciò parla della speranza di trasformare radicalmente il proprio stato in senso democratico e socialmente equo, come alternativa alla Repubblica Federale capitalista. Non se ne fece nulla. E tuttavia, chi come Michael Benjamin chiede se la DDR abbia lasciato qualcosa, troverebbe molto nel lascito della rivoluzione pacifica. Walter Benjamin l’ha anticipata. «Occorre mettere fine alla sterile pretesa di offrire soluzioni valide per l’umanità, e in generale all’immodesta prospettiva di “sistemi totali”, facendo almeno il tentativo di costruire la vita degli uomini in modo tale che possa scorrere con la stessa tranquillità con cui affronta le proprie giornate un uomo ragionevole che abbia ben dormito». Postfazione Il processo contro Clandestinità nazionalsocialista (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU) e Beate Zschäpe e i suoi complici16 ha sollecitato a prendere in esame, accanto al momento attuale, anche il periodo postbellico della Repubblica Federale. Si tratta anche di vedere come la storia nazionalsocialista sia stata elaborata nei primi decenni dopo il 1945 nei due stati tedeschi. È documentato come in Occidente la classe dirigente nazista abbia potuto diventare di fatto la nuova élite. Non lo è invece la continuità che si estese ai campi della giustizia, dell’amministrazione e dell’economia, e nell’elaborazione della memoria di quei dodici anni di terribile storia tedesca. Oggi disponiamo di studi come quello sul Ministero degli Esteri e il suo passato. Essi mostrano quanto a lungo, anche dopo il 1949, i quadri del Partito nazionalsocialista abbiano continuato a comandarvi. O come la ricerca in tre volumi sul coinvolgimento del Bundeskriminalamt, che per un certo tempo fu una copia dall’Ufficio centrale per la sicurezza del Reich. Ora tocca al Ministero della Giustizia e dunque al tema dell’assunzione diretta della Giustizia nazista e dei suoi giudici e procuratori nello stato democratico. I servizi segreti a Pullach consentono che la loro storia postbellica sia esaminata, e anche questo mostrerà come le vecchie élite si fossero impadronite del nuovo stato. Soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta la Repubblica Federale sembrava la continuazione dello stato nazista immersa nell’atmosfera di uno Heimatfilm, soltanto senza Hitler e Goebbels. Nessuno dei due stati tedeschi, dopo il 1945, poté uscire dall’ombra degli interessi della sua potenza guida, tale era il reciproco invischiamento fra le due grandi potenze durante la guerra fredda. Non era un’epoca che potesse stimolare il lavoro del ricordo, che per frammenti si impone oggi come una necessità. I Benjamin, una famiglia tedesca. Le loro vite stanno contro la rimozione e una retorica che torna a gonfiarsi di nazionalismo. 16 Il processo contro Beate Zschäpe e gli altri quattro membri della cellula terroristica nazista, accusati dei dieci omicidi a sfondo razzista che a lungo scossero la Germania, si è aperto nel maggio 2013 a Monaco [N.d.T.]. Bibliografia e fonti Aly, Götz, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt am Main 2006 Arendt, Hannah, Eichmannin Jerusalem. Ein Bericht von der BanalitätdesBösen, München 2011 (La banalità del male – Eichmann a Gerusalemme, trad. di Piero Bernardini, Feltrinelli, Milano 2003) Arendt, Hannah, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, München 2005 Baumann, Immanuel, Herbert Reinke, Andrej Stephan, Patrick Wagner; Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut (a cura di), Schatten der Vergangenheit. Das BKA und seine Gründungsgeneration in der frühen Bundesrepublik, Köln 2011 Benjamin, Hilde, Georg Benjamin. Eine Biographie, Leipzig 1987 Benjamin, Michael, Das Vermächtnis, a cura di Werner Wüste, Berlin 2006 Benjamin, Walter, Über den Begriff der Geschichte. Werke und Nachlass – Kritische Gesamtausgabe, vol. 19, a cura di Gérard Raulet, Berlin 2010 (Sul concetto di storia, a cura di Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, Einaudi, Torino 1997; Opere complete, 9 voll., a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, ed. it. a cura di Enrico Ganni, Torino, Einaudi 2000-2014, vol. VII) Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in Gesammelte Schriften, vol. I, Werkausgabe vol. 2, a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1980 (L’operad’arte all’epoca della sua riproducibilità tecnica, in Opere complete, ed. cit., vol. VI) Benjamin Walter, Berliner Kindheit um neunzehnhundert, Frankfurt am Main 1980 (Infanzia berlinese, traduzione di Marisa Bertolini Peruzzi, Einaudi 1973; Infanzia berlinese intorno al millenovecento, a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2007) Botsch, Gideon, Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute, Darmstadt 2012 Brentzel, Marianne, Die Machtfrau. Hilde Benjamin 1902-1989, Berlin 1997 Conze, Eckart; Frei, Norbert; Hayes, Peter; Zimmermann, Moshe, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010 Curilla, Wolfgang, Die Deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in Weißrussland 19411944, Paderborn 2006 Deutschkron, Inge, Mein Leben nach dem Überleben, Berlin 2001 Deutschkron, Inge, Emigranto/Vom Überleben in fremden Sprachen, Berlin 2001 Diehl, Ernst (a cura di), Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Abriß, Berlin 1978 Draexler-Just, Heide, Sprecherlaubnis.EinTagebuch ausderDDR, Berlin 2005 Ebermayer, Erich, Eh ich’s vergesse... Erinnerungen an Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Klaus Mann, Gustaf Gründgens, Emil Jannings und StefanZweig, München 2005 Flügge, Manfred, Die vier Leben der Marta Feuchtwanger, Berlin 2008 Frankl, Viktor E., ... trotzdem Ja zum Leben sagen, Wien 2005 Frei, Norbert, Karrieren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945, Berlin 2005 (Carriere:le élite di Hitler dopo il 1945, Bollati Boringhieri, Torino 2003) Fuld, Werner, Walter Benjamin: Zwischen den Stühlen, München/Wien 1979 Fittko, Lisa, MeinWegüberdie Pyrenäen, München/Wien 1985 Hessel, Stéphane, Tanz mit dem Jahrhundert, Zürich/Hamburg 2011 Hachmeister, Lutz; Siering, Friedemann, Die Herren Journalisten. Die Elite der deutschen Presse nach 1945, München 2002 Haffner, Sebastian, Die deutsche Revolution 1918/19, Köln 2008 Hecht, Ben, Revolution im Wasserglas. Geschichten aus Deutschland 1919, Berlin 2006 Klee, Ernst, Was sie taten – was sie wurden. Ärzte und Juristen und andere Beteiligte an den Kranken – und Judenmorden, Berlin 2012 Kogon, Eugen, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, München 1974 Kramer, Sven, Walter Benjamin zur Einführung, Hamburg 2003 Krockow, Christian von, Hitler und seine Deutschen, München 2001 Lanzmann, Claude, Shoah, Düsseldorf 1986 Leonhard, Wolfgang, Meine Geschichte der DDR, Berlin 2007 Liebmann, Irina, Wäre es schön? Es wäre schön!, Berlin 2008 Lillteicher, Jürgen (a cura di), Profiteure des NS-Systems? Deutsche Unternehmen und das «Dritte Reich», Berlin 2006 Meyenburg, Ruth von, Hotel Lux. Die Menschenfalle, München 2011 Meyer, Hans, Wendezeiten. Über Deutsche und Deutschland, Frankfurt am Main 1995 Mitscherlich, Alexander; Mitscherlich, Margarete, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1977 Nachama, Andreas; Hesse, Klaus (a cura di), Vor aller Augen. Die Deportation der Juden und die Versteigerung ihresEigentums, Berlin 2011 Pingel-Schliemann, Sandra, Zersetzen. Strategie einer Diktatur, Berlin 2002 Puttnies, Hans; Smith, Gary, Benjaminiana. Eine biographische Giessen 1991 Recherche, Rosh, Lea; Jäckel, Eberhard, «Der Tod ist ein Meister aus Deutschland». Deportation und Ermordung der Juden; Kollaboration und Verweigerung in Europa, Hamburg 1990 Schreiber, Jürgen, Die Stasi lebt. Berichte aus einem unterwanderten Land, München 2009 Schädlich, Susanne, Immer wieder Dezember. Der Westen, die Stasi, der Onkel und ich, München 2009 Schöck-Quinteros, Eva, Dora Benjamin: «... denn ich hoffe nach dem Krieg in Amerika arbeiten zu können». Stationen einer vertriebenen Wissenschaftlerin (19011946), in Barrieren und Karrieren: Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland, volume pubblicato in occasione del convegno «100 Jahre Frauen in der Wissenschaft» (100 anni di donne nella scienza) tenutosi nel febbraio 1997 all’Università di Brema, a cura di Elisabeth Dickmann e Eva Schöck-Quinteros, con la collaborazione di Sigrid Dauks, Berlin, Trafo-Verlag Weist, 2000, 2a ed. 2002 (Schriftenreihe des HedwigHintze-Instituts Bremen, vol. 5, pp. 71-102. L’articolo è disponibile all’indirizzo http://www.hhi-bremen.de). Sommer, Theo, 1945. Die Biographie eines Jahres, Hamburg 2005 Spira, Leopold, Feindbild «Jud». 100 Jahre politischer Antisemitismus in Österreich, Wien/München 1981 Stern, Carola, In den Netzen der Erinnerung. Lebensgeschichten zweier Menschen, Hamburg 1989 Stulz-Herrnstadt, Nadja; Hernnstadt, Rudolf (a cura di), Das HerrnstadtDokument. Das Politbüro der SEDunddieGeschichtedes17. Juni1953, Hamburg 1990 Treß, Werner, «Wider den undeutschen Geist». Bücherverbrennung 1933, Berlin 2003 Winter, Irena, Georg Benjamin, Arzt und Kommunist, Berlin 1965 Widerstand und Exil der Deutschen Arbeiterbewegung 1933-1945, a cura di Bundeszentrale für politische Bildung Wissenschaft und Gesellschaft in der DDR, eingeleitet von Christian Ludz, München 1971 Wojak, Irmtrud, Fritz Bauer 1903-1968, München 2011 Wolf, Christa, EinTagimJahr, München 2003 (Un giorno all’anno 1960-2000, trad. e cura di Anita Raja, Edizioni e/o, Roma 2006) Wolf, Christa, Rede, daß ich dichsehe, Berlin 2012 Wolf, Christa, Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, Berlin 2010 (La città degli angeli, trad. e cura di Anita Raja, Edizioni e/o, Roma 2012) Le lettere, i diari e i biglietti di Georg e Hilde Benjamin provengono dall’archivio privato di Ursula Benjamin, Berlino. Le lettere citate di Dora a Walter Benjamin sono conservate nell’archivio della Akademie der Künste di Berlino. Il capitolo «Dove resta Dora?» segue ampiamente nella struttura, nel testo e nelle fonti il saggio di Eva SchöckQuintero sopra citato. Per le traduzioni dei brani citati sono state utilizzate, oltre alle opere già indicate in bibliografia, anche le seguenti versioni italiane: Arendt, Hannah, Ritorno in Germania, traduzione di Pierpaolo Ciccarelli, Donzelli, Roma 1996 Benjamin, Walter, Cronaca berlinese, in Opere complete, ed. cit., vol. V, 2003 Benjamin, Walter, Immagini di città, trad. di Marisa Bertolini, Nuova edizione a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2007 Benjamin, Walter, Strada a senso unico, Nuova edizione accresciuta, a cura di Giulio Schiavoni, Einaudi, Torino 2006 Brecht, Bertolt, Poesie politiche, a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2014 Kolmar, Gertrud, Il canto del gallo nero, traduzione di Giuliana Pistoso, Essedue, Verona 1990 Indice dei nomi Abel, Rudolf Adenauer, Konrad Adorno, Gretel Adorno, Theodor W. Albers, Hans Alexander, Eduard Alexander, Sophie Andropov, Jurij Arendt, Hannah Augstein, Rudolf Bahr, Egon Barbie, Klaus Bartsch, Kurt Baudelaire, Charles Bauer, Fritz Beach, Sylvia Becher, Johannes R. Becker, Jurek, Becker, Verena Beethoven, Ludwig van Bendix, Emma Benjamin, Dora Benjamin, Emil Benjamin, Georg Benjamin, Georg (Grischa) Benjamin, Hilde (Helene Marie Hildegard) Benjamin, Jakob Benjamin, Laura Benjamin, Michael Benjamin, Pauline Benjamin, Peter Benjamin, Simone Benjamin, Stefan Rafael Benjamin, Ursula Benjamin, Walter Berger, Götz Beyer, Frank Bierbichler, Josef Biermann, Wolf Blankenhorn, Herbert Bloch, Ernst Bonhoeffer, Dietrich Bormann, Martin Börne, Ludwig Brandt, Willy Brasch, Thomas Braun, Volker Bräunig, Werner Brecht, Bertolt Brentzel, Marianne Brežnev, Leonid Brie, André Bruck, Edith (Fürst) Bruck, Emanuel Brumlik, Micha Bruyn, Günter de Carow, Heiner Černenko, Konstantin Chautemps, Camille Chodziesner-Kolmar, Gertrud Chruščev, Nikita Czerny, Jochen Dam, Hendrik George van Diehl, Günter Dohnanyi, Hans von Dreher, Eduard Dürrenmatt, Friedrich Dutscke, Rudi Eichel, Hans Eichmann, Adolf Eigruber, August Eisenhower, Edward D. Ellermann, Winifred Emmerich, Fritz Ensslin, Gudrun Erzberger, Matthias Falckenberg, Otto Favez, Juliane Fechner, Max Federico Guglielmo, re Federico Guglielmo, principe Feuchtwanger, Lion Fittko, Hans Fitto, Lisa Fontane, Theodor Fränkel, Fritz Fränkel, Hilde Frei, Norbert Freisler, Roland Freud, Sigmund Freund, Gisèle Fry, Varian Fuld, Werner Fürst, Edith, v. Bruck, Edith Fürst, Rosa Gehlen, Reinhard Genscher, Hans-Dietrich Globke, Hans Maria Goebbels, Joseph Gorbačev, Mikhail Göring, Hermann Gossweiler, Kurt Grotewohl, Otto Gumbel, Emil Julius Gumpert, Martin Günther, Egon Gurland, Henny Gurland, Joseph Gutkind, Curt Sigmar Gutkind-Kutzer, Laura-Maria Habermas, Jürgen Hachmeister, Lutz Hacks, Peter Harich, Wolfgang Hase, Karl Paul Immanuel von Hauptmann, Gerhart Hein, Christoph Heine, Heinrich Held, Käte Hellmert, Wolfgang Herrnstadt, Rudolf Herzog, Chaim Heydrich, Reinhard Heym, Stefan Hiller, Kurt Hitler, Adolf Honecker, Erich Honecker, Margot Horkheimer, Max Huchel, Peter Janka, Walter Joel, Ernst Juncker, Jean-Claude Just, Gustav Kant, Immanuel Karavan, Dani Kaufmann, Sigmund Kautsky, Karl Kennedy, John F. Kipphardt, Heiner Kirchner, Ernst Ludwig Kisch, Egon Erwin Klee, Paul Koestler, Arthur Kogon, Eugen Kolmar, Gertrud, v. Chodziesner-Kolmar, Gertrud Kraft, Waldelmar Kraft, Werner Krahl, Hans-Jürgen Kramer, Sven Kranewitz, Walter Krause, Günther Krenz, Egon Kunert, Günther Lacis, Asja Lang, Jack Lange, Adele Lange, Heinz Lange, Helene Lange, Hilde, v. Benjamin, Hilde Lange, Ruth Lange, Walter Leander, Zarah Leonhard, Wolfgang Leverkuehn, Paul Liebknecht, Karl Linthe, Maja Litten, Hans Loest, Erich Lötzsch, Gesine Luisa, regina di Prussia Luxemburg, Rosa Maetzig, Kurt Mahnke, Horst Maizière, Lothar de Majakovskij, Vladimir Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Manstein, Erich von Marcuse, Herbert Marx, Karl Mauas, David Mayer, Hans Mehring, Walter Meinhof, Ulrike Melsheimer, Ernst Mengele, Josef Merkel, Angela Mielke, Erich Mitscherlich, Alexander Mitscherlich, Margarete Monnier, Adrienne Muhs, Karl Mühsam, Heiner Negt, Oskar Neumann, Fränze Noske, Gustav Oberländer, Theodor Ohnesorg, Benno Ossietzky, Carl von Oster, Hans Pieck, Wilhelm Piscator, Erwin Poelchau, Harald Pollak (nata Kellner), Dora Sophie Powers, Francis Gary Pritt, Denis Nowell Proust, Marcel Puttnies, Hans Rabehl, Bernd Ranke, Hans Rathenau, Walther Reinhardt, Max Reitz, Edgar Remer, Otto Ernst Riedel, Heinz Gerhard Rökk, Marika Ruge, Eugen Ruge, Wolfgang Rühmann, Heinz Schädlich, Hans Joachim Schaüble, Wolfgang Scheidemann, Philipp Schnitzler, Arthur Schoenbachler, G. A. Scholem, Gerhard (Gershom) Scholl, Hans Scholl, Sophie Schönflies, Elise Schönflies, Simon Markus Selz, Jean Semprún, Jorge Siebenhaar, Klaus Siering, Friedemann Simon, Anette Simon, James Six, Franz Alfred Smith, Gary Snopek, Betty Snopek, Ludwig Snopek, Philip Snopek, Sara Stalin, Josef Stauffenberg, Claus Schenk von Stavisky, Serge A. Stolleis, Michael Strasser, Ernest Strauss, Lili Strauß, Franz Josef Teufel, Erwin Thälmann, Ernst Thurau, Egon Tucholsky, Kurt Tüngel, Richard Ulbricht, Lotte Ulbricht, Walter Wagenknecht, Sahra Waldoff, Claire Wander, Maxie Weil, Felix Weil, Hermann Weill, Kurt Weizsäcker, Richard von Wessel, Horst Wolf, Christa Wolf, Friedrich Wolf, Konrad Wolfers, Luise Wolff, Frank Wolff, Georg Wolff, Karl Dietrich Wolff, Reinhart Wunsch, Hilde Wüste, Ernst Wüste, Werner Wyneken, Gustav Yorck von Wartenburg, Peter Zetkin, Clara Zille, Heinrich Zinn, Georg August Zivier, Georg Zschäpe, Beate Zucker, Samuel Žukov, Georgij Ringraziamenti Un libro di questo genere ha bisogno dell’aiuto di altre persone. Ringrazio innanzitutto Franziska Günther, la mia intelligente e ostinata redattrice, i cui consigli hanno contribuito all’equilibrio del racconto. E naturalmente Ursula Benjamin, che mi ha donato la fiducia di poter affrontare adeguatamente questo tema, aprendomi il lascito che ha reso possibile il libro. L’amico Gerd Weiberg, che con la sua grande conoscenza di Walter Benjamin mi è stato al fianco leggendo il testo. Robert Jarisch, che mi ha sollevato di un’importante parte del lavoro di archivio, e Jörg Hafkemeyer; e ancora gli altri lettori e le persone che mi hanno incoraggiato, come Jürgen Leinemann, e in ogni momento mia moglie Sabine, i cui giudizi su quel che era riuscito o meno sono stati uno sprone per me. U.-K. H. Indice I Benjamin. Una famigliatedesca Prefazione Capitolo primo Infanzia intorno al millenovecento. Un prologo Capitolo secondo I Benjamin Capitolo terzo Dove resta Dora... Capitolo quarto L’esilio Capitolo quinto L’ultimo bivacco prima di Portbou Capitolo sesto Hilde Benjamin Capitolo settimo «Benvenuti» a Mauthausen Capitolo ottavo Padre e figlio Capitolo nono Dietro le mura Capitolo decimo ... tutto quel che è diritto Capitolo undicesimo Madre e figlio Capitolo dodicesimo Riflessi da una Germania all’altra Capitolo tredicesimo Nella quinta Germania Capitolo quattordicesimo Cosa resta... Postfazione Bibliografia e fonti Indice dei nomi Ringraziamenti
Scaricare