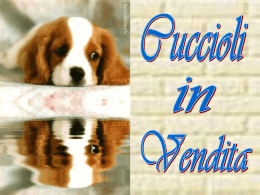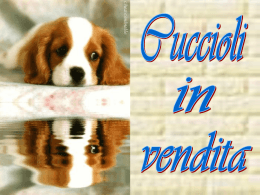Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida isola della sua infanzia affacciata sulle casette bianche e le rocce scoscese di Fjällbacka, nell’idillio dell’arcipelago svedese. Vuole rimettere a posto la colonia che le appartiene e che non ha più rivisto dal giorno in cui, una vigilia di Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo una tavola apparecchiata a festa e una bambina di un anno che vagava smarrita. Nessuno li rivide più; nessuno fu mai in grado di stabilire cosa fosse realmente accaduto. Un mistero che da sempre stuzzica la curiosità di Erica Falck, ora entusiasta all’idea di poter riprendere in mano la sua personale indagine su quell’oscura storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace. Qualcuno vuole allontanarla, disposto a tutto per proteggere il segreto dell’isola. Dopo un incendio scoppiato nella notte, le minacce si fanno sempre più incalzanti: Ebba ha già perso tutto, eppure c’è ancora qualcuno che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta che unire le forze per trovare le ragioni di un rancore che gli anni non hanno placato, cominciando da un debole indizio: vecchie tracce di sangue che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella colonia di Valö. Una sorta di filo rosso che si snoda a ritroso, conducendo a un passato lontano quando, all’inizio del secolo scorso, Fjällbacka conobbe una misteriosa «fabbricante di angeli». (1974) è l’autrice della serie di Erica Falck e Patrik Hedström, pubblicata in 55 paesi con oltre quindici milioni di copie vendute nel mondo. Vive con i tre figli a Stoccolma, dove continua a lavorare ai suoi libri, ora diventati anche serie televisiva di successo, in onda in Italia su laEffe. CAMILLA LÄCKBERG Il segreto degli angeli traduzione di Laura Cangemi Marsilio Della stessa autrice nel catalogo Marsilio La principessa di ghiaccio Il predicatore Lo scalpellino L’uccello del malaugurio Il bambino segreto La sirena Il guardiano del faro Titolo originale: Änglamakerskan © 2011 by Camilla Läckberg First published by Bokförlaget Forum, Sweden Published by arrangement with Nordin Agency, Sweden In copertina: illustrazione di Fabio Visintin. Fotografia dell’autrice © Bingo Rimér © 2015 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia Prima edizione digitale 2015 ISBN 978-88-317-3925-2 www.marsilioeditori.it [email protected] Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. Seguici su Facebook Seguici su Twitter Iscriviti alla Newsletter Scopri la community www.giallosvezia.it Indice Copertina Abstract - Autrice Frontespizio Della stessa autrice - Copyright Esergo Avevano pensato di superare il dolore Fjällbacka 1908 Patrik, puoi andare a Valö? Fjällbacka 1912 Josef passò nervosamente il pollice sul sasso Fjällbacka 1915 La torre dei tuffi di Badholmen si stagliava, maestosa Fjällbacka 1919 Patrik aveva radunato i colleghi Fjällbacka 1919 Patrik si accovacciò davanti al grosso buco Fjällbacka 1919 Erano settimane che si preparava Fjällbacka 1919 Erica si sentiva un po’ in colpa Fjällbacka 1920 Josef aprì speranzoso la porta Fjällbacka 1925 La macchina di Gösta accostò Stoccolma 1925 Strano che bastasse così poco Stoccolma 1925 Grazie, Anna Stoccolma 1925 Patrik entrò a passo veloce Ospedale psichiatrico di Långbro 1925 Era stato suo padre a insegnargli come si faceva un buon affare Fjällbacka 1929 Quando arrivò alla porta d’ingresso, Patrik aveva il fiatone Fjällbacka 1931 Per una volta, Josef era andato da solo alla cava di granito Cimitero di Lovön 1933 A volte la casa a schiera di Falkeliden sembrava decisamente troppo piccola Ospedale psichiatrico Sankt Jörgen, 1936 Si stavano avvicinando a Torp Fjällbacka 1939 Viene anche Anna, se per te va bene Carinhall 1949 La conferenza stampa era finita Fjällbacka 1951 Gösta osservò Patrik che tamburellava con le dita sul volante Fjällbacka 1961 Ebba saltò sul pontile a Valö Fjällbacka 1970 Seduto in macchina, Percy guardava l’imbocco del porto di Fjällbacka Valö 1972 Prima che arrivassero era rimasto seduto a lungo alla finestra Valö 1973 Patrik guardò l’orologio Valö 1974 All’inizio Patrik aveva pensato di ignorare il segnale acustico del cellulare Valö, vigilia di Pasqua 1974 Il paesaggio gli sfilava accanto oltre il finestrino Valö, vigilia di Pasqua 1974 Si sentivano stranamente vuoti Stoccolma 1991 Postfazione e ringraziamenti GIALLOSVEZIA.IT - Il meglio del giallo nordico IL SEGRETO DEGLI ANGELI Se un uomo può esprimere tanto odio, pensa quanto amore possiamo esprimere tutti insieme. Avevano pensato di superare il dolore grazie ai lavori di ristrutturazione. Nessuno dei due era sicuro che fosse un buon piano, ma era l’unico che avessero. L’alternativa era sdraiarsi e lasciarsi deperire lentamente. Ebba passò il raschietto sulla parete. La vernice si staccava con facilità. Aveva già cominciato a scrostarsi di suo e serviva solo un piccolo aiuto. Il sole di luglio picchiava forte facendole incollare la frangia alla fronte lucida di sudore. Il braccio le faceva male a forza di eseguire lo stesso monotono movimento dall’alto verso il basso per il terzo giorno consecutivo, ma il dolore fisico era il benvenuto: per un po’ serviva ad attutire quello che le bruciava nel cuore. Si girò a guardare Mårten che segava le assi nel prato davanti alla casa. Lui sembrò sentirsi addosso i suoi occhi perché alzò il viso e sollevò la mano in un saluto, come se fosse una conoscente che passava per la strada. Ebba sentì il proprio braccio compiere lo stesso gesto impacciato. Sebbene fossero passati più di sei mesi da quando la loro vita era stata rasa al suolo non sapevano ancora come rapportarsi uno all’altra. Ogni sera si stendevano nel letto matrimoniale dandosi le spalle, atterriti all’idea che un contatto involontario scatenasse qualcosa che non erano in grado di governare. Era come se il dolore li colmasse al punto di escludere ogni altra emozione. Niente amore, niente calore, niente empatia. Il senso di colpa era ancora sospeso fra loro, pesante e inespresso. Sarebbe stato più semplice se fossero riusciti a definirlo e attribuirgli una collocazione, e invece veniva palleggiato avanti e indietro mutando forma e intensità e attaccando continuamente da direzioni diverse. Ebba si girò di nuovo e riprese a lavorare di raschietto. Sotto le sue mani la vernice bianca cadeva a grosse scaglie mettendo a nudo il legno. Accarezzò le tavole con la mano libera. Quella casa aveva un’anima, cosa che non aveva mai percepito in nessun’altra abitazione. La villetta a schiera di Göteborg che lei e Mårten avevano comprato insieme era quasi nuova. All’epoca le piaceva moltissimo essere circondata da ambienti lustri e intatti, ma poi, di colpo, il nuovo era diventato un memento di ciò che era stato e per questo la vecchia casa con tutti i suoi difetti si addiceva meglio alla sua anima. Si riconosceva nel tetto che perdeva, nella caldaia che doveva essere presa a calci a intervalli regolari per partire e nelle finestre piene di spifferi che rendevano vano qualsiasi tentativo di tenere una candela accesa sul davanzale. Anche nel suo intimo pioveva dentro e c’erano gli spifferi. E le candele che cercava di accendere venivano spente da un soffio impietoso. Forse lì a Valö l’anima avrebbe avuto modo di cicatrizzare. Non aveva ricordi di quel luogo, eppure era come se lei e l’isola appena al largo di Fjällbacka si riconoscessero a vicenda. Se scendeva al pontile vedeva il piccolo luogo di villeggiatura al di là del braccio di mare, con le casette bianche sotto la scoscesa parete rocciosa e i capanni dei pescatori simili a una collana di perle rosse. Era una vista così bella da provocare una stretta al cuore. Il sudore le colò negli occhi, facendoli bruciare. Se li asciugò con la maglietta e li socchiuse verso il sole. Sopra di lei i gabbiani tracciavano cerchi nel cielo, gridando e schiamazzando, e i loro versi si mescolavano al rumore delle imbarcazioni che attraversavano lo stretto. Chiuse gli occhi e si lasciò trascinare via da quei suoni. Via da se stessa, via da... «Ci fermiamo un attimo e andiamo a fare un tuffo?» La voce di Mårten lacerò la cortina di rumori facendole fare un salto. Prima scosse la testa, confusa, ma poi annuì. «Ma sì, dai» disse scendendo dal ponteggio. I costumi erano stesi sul retro della casa. Si tolse gli abiti da lavoro impregnati di sudore e indossò un bikini. Mårten, più veloce, l’aspettava impaziente. «Andiamo?» disse precedendola verso la spiaggia. L’isola era piuttosto grande e un po’ più verde delle altre dell’arcipelago del Bohuslän. Ai due lati del sentiero c’erano alberi frondosi ed erba alta. Ebba procedeva battendo forte i piedi: la paura dei serpenti, già ben radicata in lei, era stata rafforzata qualche giorno prima dalla vista di un marasso che si crogiolava al sole. Quando il terreno cominciò a digradare verso la riva, non poté fare a meno di pensare a quanti piedini infantili fossero passati di lì nel corso degli anni. Quel posto veniva ancora chiamato “la colonia”, anche se non svolgeva più quella funzione dagli anni Trenta. «Attenta» disse Mårten indicando delle radici che spuntavano. La sua sollecitudine, che avrebbe dovuto commuoverla, le causava invece un senso di soffocamento. Scavalcò ostentatamente le radici e dopo qualche metro sentì la sabbia ruvida sotto i piedi. Le onde si infrangevano sulla lunga spiaggia. Ebba lanciò via l’asciugamano ed entrò direttamente nell’acqua salata. Le alghe le sfiorarono le gambe e il freddo improvviso le fece trattenere il respiro, ma poco dopo cominciò a godere della frescura. Pur sentendo che Mårten la chiamava fece finta di niente e proseguì. Quando non toccò più si mise a nuotare e con un paio di bracciate raggiunse la piccola piattaforma galleggiante ancorata sul fondo. «Ebba!» Di nuovo un richiamo dalla spiaggia, ma lei continuò a ignorarlo e afferrò la scaletta. Aveva bisogno di stare un po’ per conto suo. Se si fosse distesa e avesse chiuso gli occhi avrebbe potuto fingere di essere una naufraga in mezzo al vasto mare. Sola. Senza doversi fare riguardo di nessun altro. Sentì il rumore di bracciate in avvicinamento. La piattaforma galleggiante ondeggiò quando Mårten vi si issò e lei strinse più forte gli occhi per escluderlo ancora un attimo. Voleva essere sola per conto suo, non come succedeva sempre, ormai, quando lei e Mårten erano soli insieme. A malincuore, aprì gli occhi. Erica aveva l’impressione che nel soggiorno in cui era seduta fosse scoppiata una bomba giocattolo. Automobiline, bambole, peluche e travestimenti, tutto mescolato. Tre bambini sotto i quattro anni di età facevano sì che la casa avesse per lo più proprio quell’aspetto, ma avendo per una volta un po’ di tempo libero dai figli aveva come al solito preferito dedicarlo alla scrittura che a riordinare. Quando sentì aprirsi la porta d’ingresso alzò gli occhi dal computer e vide suo marito. «Ciao! Cosa ci fai qui? Non dovevi andare da tua madre?» «Non era in casa. È un classico. Avrei dovuto chiamare prima» rispose Patrik scalciando via gli zoccoli di plastica. «Devi proprio metterteli, e oltretutto usarli mentre guidi?» Stava indicando le orrende calzature che, come se non bastasse, erano verde evidenziatore. Gliele aveva regalate sua sorella Anna per scherzo e lui ormai si rifiutava di indossare altre scarpe. Le si avvicinò e le diede un bacio. «Ma sono comodi» disse andando verso la cucina. «A proposito, ti hanno trovato quelli della casa editrice? Dovevano avere urgenza di parlarti, visto che hanno cercato persino me.» «Vogliono sapere se quest’anno riuscirò ad andare alla fiera del libro come avevo promesso. Non so decidermi.» «Ma certo che devi andarci. Quel fine settimana mi occuperò io dei bambini. Ho già verificato e non sarò di turno.» «Grazie» disse Erica, anche se con una punta di rabbia nei propri confronti per la gratitudine che provava verso il marito. Quante volte capitava che fosse lei a dover mettersi a disposizione quando i suoi impegni di poliziotto lo costringevano a uscire con un minuto scarso di preavviso o quando fine settimana, feste comandate e serate saltavano perché il lavoro non poteva aspettare? Amava Patrik più di ogni altra cosa al mondo, ma a volte lui sembrava dare per scontato che fosse lei ad assumersi quasi tutta la responsabilità per la casa e i figli. In fondo aveva anche lei una carriera, e per giunta di successo. Molti le dicevano che doveva essere fantastico mantenersi grazie alla scrittura, poter decidere autonomamente del proprio tempo e dover rispondere solo a se stessi, ma la cosa la irritava perché, pur amando il suo lavoro e rendendosi conto di avere fortuna, la realtà era ben diversa. La libertà non era certo il primo concetto che le venisse in mente pensando alla propria attività di scrittrice. Al contrario: capitava che il progetto di un libro fagocitasse tutto il suo tempo e la sua attività cerebrale ventiquattro ore su ventiquattro per sette giorni la settimana. A volte provava invidia per chi andava in ufficio, faceva quello che doveva fare per otto ore e poi, una volta a casa, era libero. Lei non riusciva mai a staccarsi del tutto dal lavoro, e il successo comportava doveri e aspettative che andavano coordinati con la sua vita di madre di tre bambini ancora piccoli. Inoltre era difficile sostenere che la sua professione fosse più importante di quella di Patrik. Lui proteggeva le persone, risolveva casi e contribuiva a un migliore funzionamento della società, mentre lei scriveva libri che venivano letti come intrattenimento e quindi capiva e accettava di ritrovarsi con la pagliuzza più corta, anche se a volte le veniva la tentazione di mettersi a urlare. Si alzò con un sospiro e raggiunse il marito in cucina. «Dormono?» chiese lui tirando fuori gli ingredienti del suo spuntino preferito: pane croccante, burro, formaggio e pasta di uova di merluzzo. Erica rabbrividì al pensiero che di lì a poco avrebbe intinto la fetta nella cioccolata calda. «Sì, per una volta sono riuscita a metterli a letto tutti insieme. Stamattina hanno giocato senza pausa e quindi erano sfiniti.» «Ottimo» disse Patrik sedendosi a mangiare. Erica tornò in soggiorno per scrivere ancora un po’ prima che i bambini si svegliassero. Attimi rubati. Per il momento, gli unici su cui potesse far conto. Nel sogno c’era un incendio. Vincent, lo sguardo terrorizzato, premeva il naso contro un vetro e alle sue spalle lei vedeva le fiamme, sempre più alte, avvicinarglisi e sfiorargli i riccioli biondi mentre lui gridava senza emettere suono. Voleva gettarsi contro il vetro, spaccarlo e salvare Vincent dal fuoco che minacciava di fagocitarlo, ma per quanto tentasse il corpo non le ubbidiva. Poi sentì la voce di Mårten, piena di accuse. Lui la odiava perché non era in grado di salvare Vincent, perché restava lì a guardare mentre suo figlio bruciava vivo sotto i loro occhi. «Ebba! Ebba!» La voce la indusse a riprovare. Doveva lanciarsi avanti e spaccare il vetro. Doveva... «Svegliati, Ebba!» Qualcuno la scosse per le spalle e la costrinse ad alzarsi a sedere. Il sogno si dileguò lentamente anche se lei voleva trattenerlo, gettarsi nel fuoco e forse sentire per un attimo il corpicino di Vincent contro il proprio prima di morire con lui. «Devi svegliarti! C’è un incendio!» Di colpo si sentì sveglissima. L’odore di fumo le penetrò nelle narici facendola tossire, la gola in fiamme. Alzando gli occhi vide il fumo che entrava dalla porta. «Dobbiamo uscire!» gridò Mårten. «Striscia sotto il fumo. Io arrivo. Vado solo a vedere se si riesce a spegnere l’incendio.» Ebba si lasciò scivolare giù dal letto e avvertì contro la guancia il calore delle tavole di legno. Sentiva bruciare i polmoni e provava una stanchezza immensa. Come avrebbe trovato la forza di spostarsi? Voleva cedere e addormentarsi. Chiuse gli occhi e una pesante sonnolenza le pervase il corpo. Poteva riposare, dormire solo un attimo. «Avanti! Devi muoverti!» La voce stridula di Mårten la risvegliò dal torpore. Non si spaventava mai, lui, ma in quel momento le stava strattonando il braccio spingendola a sollevarsi carponi. A malincuore, Ebba cominciò a spostare mani e ginocchia. La paura cominciava a mettere radici anche in lei. A ogni inspirazione sentiva il fumo riempirle sempre di più i polmoni, come un veleno a lento rilascio, ma preferiva morire per il fumo che divorata dal fuoco. Il pensiero della pelle accartocciata le bastò per accelerare e uscire dalla stanza. Di colpo la confusione fu totale. Avrebbe dovuto sapere da che parte si trovava la scala, ma era come se il cervello non funzionasse. Davanti a sé vedeva solo una compatta nebbia grigio-nera. In preda al panico, cominciò a muoversi in avanti per non restare imprigionata nel fumo. Proprio quando arrivò al primo gradino Mårten la superò di corsa con un estintore tra le mani. Fece la scala in tre balzi ed Ebba lo seguì con lo sguardo ma, come nel sogno, sembrava che il corpo non le ubbidisse. Impotente, rimase bloccata carponi con le membra che si rifiutavano di muoversi mentre il fumo s’addensava sempre di più. Tossì di nuovo, e a un accesso ne seguì un altro. Le lacrimavano gli occhi mentre il pensiero correva a Mårten senza trovare però la forza di preoccuparsi per lui. Di nuovo provò la tentazione di arrendersi, di lasciarsi sparire liberandosi per sempre del dolore che le lacerava corpo e anima. Davanti agli occhi cominciò a calare il buio e lentamente Ebba si accasciò, appoggiando la testa alle braccia e chiudendo le palpebre. Quel morbido calore l’avvolgeva. La sonnolenza la pervase di nuovo, dandole il benvenuto. Non le voleva male: l’avrebbe accolta, rendendola di nuovo integra. «Ebba!» Mårten la strattonò per un braccio, ma lei oppose resistenza. Voleva lasciarsi trasportare nel luogo piacevole e silenzioso verso cui stava scivolando. Poi sentì un colpo al viso, uno schiaffo che le fece bruciare la guancia e, scossa, si tirò su e si ritrovò a fissare Mårten negli occhi, lo sguardo inquieto e arrabbiato nello stesso tempo. «Ho spento il fuoco» disse lui, «ma non possiamo restare qui dentro.» Fece per sollevarla ma lei si divincolò. Era stata privata dell’unica possibilità di riposare che le fosse stata concessa da un sacco di tempo e, furiosa, prese a tempestargli il petto di pugni, provando sollievo nello sfogare tutta la rabbia e la delusione. Lo colpì più forte che poteva finché lui non riuscì a bloccarle i polsi e l’avvicinò a forza al proprio petto. La tenne stretta a sé. Sentendo il suo battito accelerato, lei si mise a piangere. Poi si lasciò prendere in braccio. Mårten la portò fuori e, quando l’aria fredda della notte le riempì i polmoni, Ebba cedette e si lasciò cadere nel torpore. Fjällbacka 1908 Arrivarono la mattina presto. Sua madre era già in piedi con i piccoli, mentre Dagmar stava ancora crogiolandosi a letto. Era quella la differenza tra una figlia vera e uno dei bastardi di cui si occupava la madre. Dagmar era speciale. «Cosa succede?» chiese il padre a gran voce dalla camera da letto. Come Dagmar, era stato svegliato dagli ostinati colpi alla porta. «Aprite! Polizia!» Evidentemente avevano perso la pazienza, perché la porta si spalancò e un uomo in divisa da poliziotto irruppe in casa. Dagmar si alzò a sedere nel letto cercando di coprirsi con il lenzuolo. «La polizia?» Il padre entrò in cucina armeggiando con la cintura. Aveva il torace incavato, con ciuffi sparsi di peli grigi. «Se mi date il tempo di mettermi la camicia risolviamo tutto. Dev’esserci un malinteso. Qui abitano solo persone oneste.» «Helga Svensson vive qui, no?» rispose il poliziotto. Alle sue spalle aspettavano altri due uomini. Lo spazio era scarso perché la cucina era piccola e piena di letti. Al momento avevano in casa cinque mocciosi. «Io mi chiamo Albert Svensson e Helga è mia moglie» rispose il padre. Si era infilato la camicia e aveva incrociato le braccia sul petto. «E dove si trova?» chiese il poliziotto con voce imperiosa. Dagmar notò la ruga di preoccupazione che si era formata sulla fronte del padre. La madre diceva sempre che era un ansioso. Nervi deboli. «Mia madre è in giardino, sul retro. Con i piccoli» disse, e solo in quel momento i poliziotti sembrarono accorgersi di lei. «Grazie» rispose il primo dei tre girando sui tacchi. Il padre li seguì a ruota. «Non potete irrompere così in casa di gente per bene. Ci fate prendere un colpo. Abbiamo il diritto di sapere di cosa si tratta.» Dagmar lanciò via le coperte, mise i piedi nudi sul freddo pavimento della cucina e li rincorse in camicia da notte, fermandosi dietro l’angolo. Due poliziotti tenevano per le braccia la madre che si divincolava, facendoli ansimare per lo sforzo. I bambini strillavano e il bucato che stava stendendo fu tirato giù dai fili nel tumulto. «Mamma!» gridò Dagmar lanciandosi verso di lei. Poi si gettò su uno dei due poliziotti e gli addentò la coscia con quanta forza aveva in corpo. Lui gridò, lasciò andare la madre, si girò e diede a Dagmar uno schiaffo tale da farla cadere a terra. Scossa, la bambina rimase seduta sull’erba, passandosi una mano sulla guancia in fiamme. Nei suoi otto anni di vita, nessuno l’aveva mai picchiata. Non che non avesse visto la madre darle di santa ragione ai piccoli, ma su di lei non aveva mai alzato un dito e di conseguenza non lo faceva neanche il padre. «Ma cosa le salta in mente? Picchia mia figlia?» La madre, furiosa, si mise a tirare calci all’uomo. «Non è niente rispetto a quello che ha fatto lei.» Il poliziotto le afferrò di nuovo il braccio. «È sospettata di infanticidio e abbiamo il mandato per perquisire casa sua. E mi creda: lo faremo con la massima cura.» Dagmar vide la madre rimpicciolirsi. La guancia le bruciava ancora come il fuoco e il cuore batteva forte nel petto. Intorno a lei i bambini urlavano come se fosse arrivato il giorno del giudizio, e forse era proprio così. Perché, anche se Dagmar non capiva cosa stesse succedendo, l’espressione di sua madre le diceva che il loro mondo era appena crollato. «Patrik, puoi andare a Valö? È arrivata una chiamata. È scoppiato un incendio e si sospetta che sia doloso.» «Cosa? Scusa, cos’hai detto?» Patrik si stava già alzando dal letto e si premette il telefono tra l’orecchio e la spalla mentre s’infilava i jeans. Guardò l’orologio, gli occhi ancora velati dal sonno. Le sette e un quarto. Per un breve attimo si chiese cosa ci facesse Annika alla stazione di polizia a quell’ora del mattino. «A Valö è scoppiato un incendio» ripeté lei paziente. «I vigili del fuoco sono accorsi sul posto stamattina presto, ma sospettano sia doloso.» «In che punto di Valö?» Erica si girò nel letto. «Cosa c’è?» mormorò. «È la stazione. Devo andare a Valö» sussurrò. Visto che per una volta i gemelli dormivano oltre le sei e mezzo non gli sembrava il caso di svegliarli. «Alla colonia» rispose Annika al telefono. «Okay, prendo la barca e ci vado. Sveglio anche Martin. Siamo io e lui di servizio oggi, no?» «Sì, esatto. Allora ci vediamo dopo qui.» Patrik chiuse la chiamata e s’infilò una maglietta. «Cos’è successo?» chiese Erica alzandosi a sedere. «I vigili del fuoco sospettano che qualcuno abbia incendiato la vecchia colonia.» «La colonia? Qualcuno ha cercato di bruciarla?» Erica tirò subito giù le gambe dal letto. «Prometto che poi ti riferirò tutto» sorrise Patrik. «So bene che ci stai lavorando su.» «Be’, è una strana coincidenza che qualcuno cerchi di bruciarla proprio adesso che Ebba è tornata.» Patrik scosse la testa. Sapeva per esperienza che sua moglie s’immischiava spesso e volentieri in faccende che non la riguardavano, partendo per la tangente e giungendo subito a conclusioni esagerate. Doveva riconoscere che spesso, a dire il vero, i fatti le davano ragione, ma altre volte causava anche dei grandi pasticci. «Annika ha detto che sospettano sia doloso, ma al momento sappiamo solo questo e non è detto che sia così.» «Vero, ma è comunque strano che succeda proprio ora» insistette Erica. «Non posso venire con te? Avevo pensato di andarci comunque per fare una chiacchierata con Ebba.» «E i bambini? Temo che Maja sia ancora un po’ piccola per preparare la farina lattea ai gemelli.» La baciò sulla guancia e poi infilò le scale sentendo che, come a comando, i due piccoli facevano partire la sirena. Durante la breve traversata verso l’isola, Patrik e Martin non si scambiarono molte parole. La possibilità che l’incendio fosse doloso era incomprensibile e inquietante e quando si avvicinarono all’isola e spaziarono con lo sguardo su quell’idillio la situazione sembrò ancora più irreale. «Che posto splendido» disse Martin mentre risalivano lungo il sentiero che partiva dal pontile a cui Patrik aveva assicurato il beccaccino. «Ci sei già stato qui, no?» rispose Patrik senza voltarsi. «Sì, certo, ma è un bel po’ che non ci vengo.» Davanti a loro si apriva un grande prato. Si fermarono e si guardarono intorno. «Ho un sacco di bei ricordi di questo posto» disse Patrik. «Ci venivamo una volta all’anno con la scuola e un’estate sono anche stato qui a fare un campo di vela. Ho giocato parecchio a calcio nel campetto laggiù. E pure a brännboll.» «Già, chi non è mai venuto qui in gita? In realtà è strano che si sia sempre chiamata “la colonia”.» Patrik alzò le spalle e insieme si diressero a passo veloce verso la casa. «I nomi rimangono spesso appiccicati ai posti. D’altra parte è stata usata come collegio solo per un breve periodo e di sicuro nessuno voleva battezzarla ispirandosi a quel von Schlesinger che ci ha abitato dopo.» «Già, di quel pazzo se ne sono sentite delle belle» ammise Martin, imprecando quando un ramo gli sferzò il viso. «E adesso chi sono i proprietari?» «La coppia che ci vive, immagino. Dopo l’episodio del 1974, per quanto ne so, era il comune a gestirla. Peccato che l’edificio sia stato lasciato andare in rovina. Però sembra che lo stiano ristrutturando.» Martin alzò lo sguardo. I ponteggi coprivano tutta la facciata. «Già, può venire fuori una meraviglia. Speriamo che l’incendio non abbia causato troppi danni.» Proseguirono fino alla scalinata che conduceva alla porta d’ingresso. L’atmosfera era tranquilla e alcuni uomini del corpo volontario dei vigili del fuoco di Fjällbacka stavano raccogliendo i loro attrezzi. Certo che in quelle tute devono sudare a litri, pensò Patrik. Nonostante fosse mattina presto, la calura era già fastidiosa. «Ehi, ciao!» Il caposquadra, Östen Ronander, si avvicinò per salutarli. Aveva le mani nere di fuliggine. «Ciao, Östen. Cos’è successo? Annika mi ha detto che sospettate che l’incendio sia doloso.» «Sì, tutto lo fa pensare. Noi però non siamo qualificati per fare una perizia tecnica, per cui spero che stia arrivando Torbjörn.» «L’ho chiamato lungo il tragitto e dice che dovrebbe essere qui tra...» Guardò l’orologio. «Una mezz’oretta, direi.» «Bene. Vogliamo dare un’occhiata, intanto? Abbiamo cercato di non compromettere eventuali indizi. Quando siamo arrivati il proprietario aveva già spento le fiamme con l’estintore e quindi ci siamo solo assicurati che non fosse rimasto qualche focolaio. Per il resto, non potevamo fare granché. Venite a vedere.» Östen indicò l’interno dell’ingresso. Appena oltre la soglia le bruciature sul pavimento seguivano uno strano disegno irregolare. «Un qualche genere di liquido infiammabile, vero?» Martin guardò con aria interrogativa il caposquadra, che annuì. «Secondo me qualcuno l’ha versato da sotto la porta e poi ha dato fuoco alla pozza che si era formata. Dall’odore direi che è benzina, ma Torbjörn e i suoi sapranno determinarlo con sicurezza.» «Dove sono le persone che abitano qui?» «Sul retro, ad aspettare i soccorritori che purtroppo sono in ritardo a causa di un incidente stradale. Sembrano piuttosto scossi e mi sembrava che avessero bisogno di stare tranquilli. E poi ho ritenuto opportuno che non girassero per casa prima che voi aveste la possibilità di rilevare eventuali indizi.» «Non ti scappa nulla.» Patrik gli diede una pacca sulla spalla e si rivolse a Martin: «Andiamo a parlare con loro?» Senza attendere risposta si avviò verso il retro della casa. Girando l’angolo videro a poca distanza dei mobili da giardino piuttosto rovinati. Dovevano essere esposti alle intemperie da anni. Una coppia sui trentacinque anni dall’aria spaesata era seduta al tavolo. Quando l’uomo li vide, si alzò e andò loro incontro tendendo la mano, dura e callosa come se adoperasse spesso attrezzi da lavoro. «Mårten Stark.» Patrik e Martin si presentarono. «Non ci capiamo niente. I vigili del fuoco hanno parlato di incendio doloso...» La moglie di Mårten aveva seguito il marito. Era molto minuta e, sebbene Patrik fosse di altezza media, gli arrivava appena alla spalla. Aveva un aspetto fragile e delicato e stava tremando nonostante il caldo. «Non è detto. Per il momento non si sa niente di certo» li tranquillizzò Patrik. «Questa è mia moglie Ebba» disse Mårten. La donna si passò una mano sul viso in un gesto stanco. «Possiamo sederci?» intervenne Martin. «Vorremmo sapere qualcosa di più su cosa è successo.» «Certo, mettiamoci lì» rispose Mårten indicando i mobili da giardino. «Chi di voi si è accorto dell’incendio?» Patrik guardò Mårten, che aveva una macchia scura sulla fronte e, come Östen, le mani nere di fuliggine. L’uomo notò il suo sguardo e abbassò gli occhi come se solo in quel momento si fosse accorto che erano sporche. Se le strofinò lentamente sui jeans prima di rispondere. «Io. Mi sono svegliato e ho sentito uno strano odore. Mi sono reso conto subito che doveva essere scoppiato un incendio al piano di sotto e ho cercato di svegliare Ebba. Ci è voluto un po’ perché dormiva profondamente, ma alla fine sono riuscito a farla scendere dal letto. Sono corso a prendere l’estintore con un solo pensiero in testa: che dovevo spegnere l’incendio.» Aveva parlato tanto in fretta che ansimava e dovette fermarsi per riprendere fiato. «Pensavo che sarei morta. Ne ero sicurissima.» Ebba si stava tormentando le unghie e Patrik provò compassione per lei. «Ho preso l’estintore e mi sono messo a spruzzare come un matto sulle fiamme giù nell’ingresso» continuò Mårten. «All’inizio sembrava che non succedesse niente ma ho continuato e di colpo il fuoco si è spento. Però il fumo c’era ancora, dappertutto.» Stava ansimando di nuovo. «Perché qualcuno avrebbe... non capisco...» Ebba sembrava assente e Patrik immaginò che Östen avesse ragione: era sotto shock. Questo spiegava anche il tremito. I soccorritori dall’ospedale avrebbero dovuto farle una visita accurata e assicurarsi che né lei né Mårten avessero subito lesioni a causa del fumo. Molti non sapevano che era più mortale del fuoco e che inspirarlo nei polmoni poteva avere conseguenze di cui ci si accorgeva solo dopo un certo periodo di tempo. «Perché pensate che sia doloso?» chiese Mårten strofinandosi di nuovo il viso. Non doveva aver dormito granché. «Come dicevo, non abbiamo ancora nessuna certezza» rispose Patrik esitante. «Ci sono elementi che lo indicano, ma non voglio pronunciarmi prima di avere la conferma dei tecnici. Avete sentito dei rumori nella prima parte della notte?» «No. Mi sono svegliato solo quando l’incendio era già scoppiato, come spiegavo prima.» Patrik accennò con la testa a una casa poco distante. «I vicini ci sono? È possibile che abbiano visto qualche sconosciuto aggirarsi qui intorno?» «Sono in vacanza, quindi su questo lato dell’isola restiamo solo noi.» «C’è qualcuno che potrebbe avere motivo di danneggiarvi?» intervenne Martin. Per lo più lasciava che fosse Patrik a fare le domande, ma ascoltava sempre con attenzione osservando le reazioni degli interlocutori, cosa altrettanto importante. «No, nessuno, almeno per quanto ne so io.» Ebba scosse piano la testa. «Non è molto che viviamo qui. Solo qualche mese» disse Mårten. «È la casa dei genitori di Ebba ma nel corso degli anni è sempre stata affittata e lei ci è tornata solo adesso. Abbiamo deciso di rimetterla in sesto e utilizzarla in qualche modo.» Patrik e Martin si scambiarono un’occhiata. La storia della colonia e di conseguenza anche di Ebba era nota nel circondario, ma quella non era l’occasione giusta per affrontare l’argomento. Patrik era contento che non ci fosse Erica. Lei non sarebbe riuscita a trattenersi. «Dove abitavate prima?» chiese Patrik pur immaginando la risposta, visto il marcato accento di Mårten. «A Göteborg, come avrai già capito» rispose lui serio. «Niente conti in sospeso con qualcuno, laggiù?» «Non abbiamo conti in sospeso, né a Göteborg né in qualsiasi altro posto.» Il tono si era fatto duro. «E come mai vi siete trasferiti qui?» chiese Patrik. Ebba abbassò gli occhi sul tavolo e si mise a giocherellare con la catenina in argento che portava al collo, a cui era appeso un ciondolo a forma di angelo. «Nostro figlio è morto» disse tirando così forte l’angioletto che la catenina le lasciò un segno sul collo. «Dovevamo cambiare aria» continuò Mårten. «Questa casa stava cadendo a pezzi senza che nessuno se ne curasse e l’abbiamo vista come una possibilità per ricominciare da capo. Io vengo da una famiglia di ristoratori e quindi la scelta di aprire qualcosa di nostro è venuta naturale. Abbiamo pensato di partire con un bed and breakfast per poi cercare di attirare qualche gruppo attrezzando uno spazio per convegni e conferenze.» «Sembra che ci sia parecchio da lavorare.» Patrik guardò il grande edificio con la vernice bianca scrostata, scegliendo consapevolmente di non fare domande sulla morte del bambino. Avevano tutti e due il dolore stampato in faccia. «Il lavoro non ci spaventa. E continueremo finché potremo. Se non ce la faremo da soli, ingaggeremo qualcuno per aiutarci, ma se possibile vorremmo evitare di spendere soldi per un’impresa. Sarà già abbastanza impegnativo dal punto di vista economico.» «Quindi non vi viene in mente nessuno che possa voler danneggiare voi o la vostra attività?» insistette Martin. «Attività? Quale attività?» chiese Mårten con una risata ironica. «No, comunque: non ci viene in mente proprio nessuno che possa volerci male. Non abbiamo una vita di quel genere. Siamo dei comunissimi signori Nessuno.» Patrik pensò per un attimo al passato della famiglia di Ebba. Non erano tanti i signori Nessuno con un enigma di quel calibro nella storia familiare. Le congetture e le ipotesi su quello che era accaduto tanto tempo prima erano state moltissime e delle più disparate a Fjällbacka e dintorni. «A meno che...» Mårten rivolse uno sguardo interrogativo a Ebba, che non sembrò capire a cosa si riferisse. Lui continuò senza distogliere gli occhi: «L’unica cosa che mi viene in mente sono i biglietti di compleanno.» «I biglietti di compleanno?» ripeté Martin. «Da quando era piccola, Ebba riceve ogni anno un biglietto da qualcuno che si firma solo con una “G”. I suoi genitori adottivi non hanno mai scoperto chi li inviasse, e hanno continuato ad arrivare anche dopo che è andata a stare via di casa.» «E neanche Ebba ha idea di chi li mandi?» chiese Patrik prima di accorgersi che parlava di lei come se non fosse lì. La guardò e ripeté: «Non sai proprio indovinare chi potrebbe spedirteli?» «No.» «E i tuoi genitori adottivi? Sei sicura che non sappiano nulla?» «Non ne hanno idea.» «Questo “G” si è mai messo in contatto con te in qualche altro modo? Ti ha minacciata?» «No, mai. Vero, Ebba?» Mårten spostò la mano verso la moglie come se volesse toccarla, ma poi la lasciò ricadere sul ginocchio. Lei scosse la testa. «Ecco, arriva Torbjörn» disse Martin indicando il sentiero. «Bene, allora direi che per ora ci fermiamo qui, così potrete riposarvi un po’. I soccorritori stanno arrivando e se vi chiedono di andare con loro in ospedale secondo me dovreste farlo. Sono cose che non vanno sottovalutate.» «Grazie» disse Mårten alzandosi. «Fatevi vivi se venite a sapere qualcosa.» «Certo.» Patrik lanciò a Ebba un’ultima occhiata ansiosa. Sembrava ancora chiusa in una specie di bolla. Si chiese quanto la tragedia della sua infanzia l’avesse plasmata ma poi si costrinse a smettere di pensarci. Doveva concentrarsi sul compito che aveva davanti: catturare l’incendiario, se davvero si trattava di un atto doloso. Fjällbacka 1912 Dagmar non capiva ancora come fosse potuto accadere. Le era stato portato via tutto ed era rimasta completamente sola. La gente le sussurrava malignità alle spalle ovunque andasse. La odiavano per quello che aveva fatto sua madre. A volte, la notte, la nostalgia dei genitori era così forte che doveva mordere il cuscino per non piangere forte. Se l’avesse fatto, la megera che la ospitava gliele avrebbe date di santa ragione. Ma quando gli incubi la travolgevano facendola svegliare coperta di sudore non sempre riusciva a trattenere le grida. Nei sogni vedeva le teste mozzate del padre e della madre. Perché alla fine erano stati giustiziati e, nonostante lei non avesse assistito all’esecuzione, quelle immagini le bruciavano lo stesso sulla retina. A volte anche i bambini popolavano i suoi sogni. Scavando sotto il pavimento sterrato della cantina la polizia aveva trovato otto neonati. L’aveva detto la megera. «Otto piccoli indifesi» mormorava scuotendo la testa appena qualcuno andava a trovarla, e le amiche puntavano il loro sguardo tagliente su Dagmar. «Non è possibile che la bambina non ne sapesse niente» dicevano. «Anche se è piccola, doveva aver capito cosa stava succedendo.» Ma Dagmar si rifiutava di farsi mettere sotto. Non aveva importanza che fosse vero o no. I suoi genitori le volevano bene e dopotutto quegli sporchi mocciosi che strillavano e basta non li voleva nessuno. Per questo erano finiti da sua madre. Aveva sgobbato per anni e come ringraziamento per essersi presa cura di quei piccoli esseri indesiderati era stata umiliata, derisa e uccisa. Lo stesso valeva per il padre: aveva aiutato sua moglie a seppellire i bambini e per questo, secondo loro, meritava di morire. Dopo che la polizia li aveva portati via, lei era stata piazzata dalla megera. Nessun altro aveva voluto accoglierla, né parenti né amici. Nessuno voleva avere a che fare con la famiglia. La fabbricante di angeli di Fjällbacka: era così che avevano cominciato a chiamare sua madre dal giorno in cui erano stati trovati gli scheletrini. Da allora qualcuno aveva addirittura preso a cantare delle ballate su di lei, sull’infanticida che annegava i piccoli in un catino e sul marito che li seppelliva. Dagmar le conosceva a memoria perché i mocciosi della megera gliele cantavano ogni volta che se ne presentava l’occasione. Ma tutto questo poteva sopportarlo. Era stata la principessa dei suoi genitori e sapeva di essere stata desiderata e amata. L’unica cosa che la faceva tremare di terrore era il rumore dei passi del marito della megera. In quei momenti avrebbe voluto poter essere morta insieme ai suoi genitori. Josef passò nervosamente il pollice sul sasso che teneva in mano. Era una riunione importante e non poteva permettere a Sebastian di mandare tutto a rotoli. «Ecco qui.» Sebastian indicò le planimetrie che aveva aperto sul tavolo riunioni. «Questa è la nostra “vision”. A project for peace in our time.» Josef sospirò tra sé e sé. Non era affatto sicuro che i rappresentanti del comune si lasciassero incantare dal suo sfoggio di frasi fatte in inglese. «Quello che sta cercando di dire il mio socio è che per il comune di Tanum questa è una splendida occasione per fare qualcosa a favore della pace. Un’iniziativa che vi porterà in dote un’ottima reputazione.» «Già, la pace sulla terra è un ideale non da poco. E anche economicamente non è un cattivo investimento. In prospettiva, servirebbe ad aumentare il turismo e a creare posti di lavoro per gli abitanti, e voi sapete benissimo cosa significhi.» Sebastian alzò una mano e sfregò pollice e indice. «Più soldi nelle casse del comune.» «Certo, ma questo è soprattutto un importante progetto di pace» intervenne Josef resistendo all’impulso di assestargli un calcio nello stinco. Sapeva che sarebbe finita così, accettando i suoi soldi, ma non aveva scelta. Erling W. Larson annuì. Dopo lo scandalo della ristrutturazione del Badhotell a Fjällbacka era rimasto fuori dai giochi per un po’, ma di recente era rientrato nella vita politica locale. Un progetto di quel tipo avrebbe potuto dimostrare che era uno su cui si poteva ancora contare e Josef sperava che lo capisse. «Ci sembra interessante» disse Erling. «Potreste dirci qualcosa di più su come avreste pensato di sviluppare l’idea?» Sebastian prese fiato per rispondere, ma Josef lo precedette. «È un pezzo di storia» disse mostrando il sasso che aveva in mano. «Albert Speer comprava granito dalle cave del Bohuslän per conto del Reich. Aveva elaborato insieme a Hitler un progetto grandioso che mirava a trasformare Berlino, ribattezzandola “Germania”, nella capitale del mondo, e il granito doveva essere trasportato in terra tedesca per essere usato come materiale edile.» Josef si alzò e cominciò a passeggiare avanti e indietro senza smettere di parlare. Nella mente sentiva il calpestio degli stivali dei soldati tedeschi, il rumore di cui tante volte gli avevano parlato i suoi genitori con il terrore nella voce. «Poi però le sorti della guerra cambiarono» continuò. «Germania non fu mai più di un modellino su cui Hitler continuò a fantasticare fino ai suoi ultimi giorni. Un sogno irrealizzato, una visione fatta di monumenti e edifici grandiosi da costruire al prezzo della vita di milioni di ebrei.» «Uff, che brutta cosa» disse Erling in tono superficiale. Josef lo guardò rassegnato. Non capivano. Nessuno capiva. Ma non aveva intenzione di permettere che fosse tutto dimenticato. «Grosse partite di granito di questa zona non furono mai imbarcate...» «Ed è qui che ci inseriamo noi» s’intromise Sebastian. «Abbiamo pensato che se ne potrebbero ricavare dei simboli di pace che poi verrebbero messi in vendita. Gestendola bene, l’operazione frutterebbe un bel po’ di soldi.» «Con quei fondi si potrebbe creare un museo dedicato alla storia degli ebrei e al rapporto tra Svezia ed ebraismo. Per esempio, la nostra presunta neutralità durante la guerra» aggiunse Josef. Si risedette e Sebastian gli circondò le spalle con un braccio e gli diede una stretta. Josef dovette trattenersi dal toglierselo di dosso e cercò invece di sorridere. Si sentiva falso come durante il periodo a Valö. Né allora né dopo aveva mai avuto qualcosa in comune con lui o con gli altri cosiddetti amici. Per quanto si sforzasse, non avrebbe mai avuto accesso al mondo perfetto da cui venivano John, Leon e Percy, e neanche lo voleva. Ma in quel momento Sebastian gli serviva. Era la sua unica occasione di realizzare il sogno che coltivava da tanto tempo: onorare le sue origini e diffondere la consapevolezza dei soprusi compiuti, e che ancora si compivano, contro il popolo ebraico. Se anche fosse stato costretto a stringere un patto con il diavolo, l’avrebbe fatto. Sperava di potersi sbarazzare di lui appena le circostanze l’avessero permesso. «Come dice il mio socio qui» intervenne Sebastian, «sarà un museo coi fiocchi che attirerà turisti da tutto il mondo, e a voi saranno attribuiti i meriti del progetto.» «Non mi sembra una cattiva idea» disse Erling. «Tu che ne pensi?» Si stava rivolgendo a Uno Brorsson, il suo vice, che nonostante il caldo indossava una camicia scozzese di flanella. «Mah, potremmo prendere in considerazione la cosa» borbottò lui. «Ma dipende anche da quanto dovrà contribuire il comune. Sono tempi difficili.» Sebastian gli rivolse un gran sorriso. «Sicuramente troveremo un accordo. L’importante è che ci siano interesse e volontà. Io stesso investirò una grossa somma nel progetto.» Già, ma a loro non dici a quali condizioni, pensò Josef. Strinse i denti. Non poteva far altro che accettare in silenzio quello che gli veniva dato tenendo gli occhi puntati sul traguardo. Si sporse in avanti per stringere la mano tesa di Erling. Ormai non poteva più tornare indietro. Una piccola cicatrice sulla fronte, altre più grandi sul resto del corpo e un’andatura leggermente zoppa erano gli unici segni dell’incidente in cui, un anno e mezzo prima, aveva perso il figlio che aspettava da Dan e rischiato di morire a sua volta. Dentro, però, era diverso: le ferite erano tutt’altro che rimarginate. Anna esitò un attimo davanti alla porta d’ingresso. A volte era faticoso andare a trovare Erica e rendersi conto di come tutto fosse andato per il meglio, per lei, che non aveva perso niente. Su sua sorella l’incidente non aveva lasciato segni. Nello stesso tempo, vederla le faceva bene. Le ferite dentro di lei pulsavano e bruciavano, ma gli attimi passati con Erica contribuivano ugualmente a farle rimarginare un po’. Anna non avrebbe mai potuto immaginare che il processo di guarigione sarebbe durato così tanto, ed era una fortuna. Se avesse saputo quanto tempo ci sarebbe voluto forse non avrebbe mai trovato la forza di risvegliarsi dallo stato di apatia in cui era scivolata dopo che la vita era andata in mille pezzi. Qualche tempo prima aveva detto per scherzo a Erica che si sentiva come uno dei vasi antichi che vedeva spesso quando lavorava alla casa d’aste: un oggetto caduto a terra e andato in frantumi e poi faticosamente rincollato. Anche se visto da lontano sembrava intero, avvicinandosi le crepe risultavano dolorosamente visibili. In realtà non era affatto uno scherzo, si rese conto premendo il campanello. Si sentiva proprio un vaso pieno di crepe. «Avanti!» gridò Erica da un qualche punto della casa. Anna entrò e scalciò via le scarpe. «Arrivo subito! Sto cambiando i gemelli.» Anna andò nella cucina, così familiare. La casa era appartenuta ai loro genitori e lei ne conosceva ogni angolo. Diversi anni prima era stata oggetto di un litigio che aveva rischiato di rovinare per sempre il loro rapporto, ma era successo in un’altra epoca, un altro mondo. Ormai potevano addirittura scherzarci sopra e parlare del “Pcl” e del “Pdl”, cioè del “Periodo con Lucas” e del “Periodo dopo Lucas”. Anna rabbrividì. Si era ripromessa di pensare il meno possibile al suo ex marito e a quello che aveva fatto. Non c’era più. Di lui le erano rimaste le uniche cose buone che le avesse mai dato: Emma e Adrian. «Vuoi un dolcetto?» chiese Erica entrando in cucina con un gemello su ciascun fianco. Vedendo la zia i bambini s’illuminarono e la madre li mise a terra. Subito corsero da Anna attaccandosi alle sue gambe per essere presi in braccio. «Calma, calma, ci state tutti e due!» Se li mise sulle ginocchia, uno alla volta, e poi guardò Erica. «Dipende da cosa mi offri.» Allungò il collo per vedere cosa c’era in casa. «Che ne dici della torta della nonna al rabarbaro e pasta di mandorle?» Erica le mostrò un dolce avvolto nella pellicola trasparente. «Scherzi? A quella non si può dire di no.» Erica ne tagliò due grosse fette e le mise su un piatto che appoggiò sulla tavola. Noel si slanciò subito in avanti ma Anna riuscì a sottrarglielo in tempo. Poi prese una fetta, ne staccò due pezzetti e li diede ai gemelli. Noel se lo infilò allegramente in bocca tutto in una volta mentre Anton ne staccò un bocconcino e fece un grande sorriso. «È incredibile quanto sono diversi» disse Anna scompigliando i capelli ai due piccoli. «Dici?» rispose Erica ironica, scuotendo la testa. Aveva versato il caffè nelle tazze e messo come d’abitudine quella di Anna fuori dalla portata dei bambini. «Ce la fai o vuoi che ne prenda uno?» chiese guardando la sorella che, con qualche difficoltà, cercava di tenere in equilibrio nipotini, caffè e dolce tutto in una volta. «Va bene così. È tanto bello tenerli vicini.» Anna strofinò il naso sulla testolina di Noel. «Dov’è Maja, a proposito?» «Incollata al televisore. Il suo nuovo grande amore è Mojje. Sta guardando la puntata Mimmi e Mojje ai Caraibi e se sento un’altra volta “Su una spiaggia assolata ai Caraibi” giuro che vomito.» «Adrian è fissato con i Pokemon, al momento, e l’effetto è lo stesso.» Anna sorbì cauta un sorso di caffè, attenta a non versarlo sui due nipotini che non stavano fermi un attimo. «E Patrik?» «Fuori per lavoro. Sospetto incendio doloso a Valö.» «Valö? Dove?» Erica fece attendere la risposta. «Alla colonia» rispose poi con malcelata eccitazione. «Ma dai! Che roba! Quel posto mi ha sempre dato i brividi. Che siano spariti così e basta...» «Non dirmelo. Ho cercato di fare delle ricerche e ogni tanto ho anche pensato che se avessi trovato qualcosa ne sarebbe potuto venire fuori un libro, ma non c’è mai stato niente da cui partire. Fino adesso.» «Cosa vuoi dire?» Anna staccò un grosso boccone di torta. Aveva avuto anche lei la ricetta dalla nonna materna, ma faceva i dolci con la stessa frequenza con cui stirava le lenzuola con il mangano, cioè mai. «È tornata.» «Chi?» «Ebba Elvander. Anche se adesso si chiama Stark.» «La bambina?» Anna stava fissando sua sorella. «Esatto. Lei e suo marito si sono trasferiti a Valö e pare che vogliano ristrutturare il posto. E adesso qualcuno ha cercato di bruciarlo. Sono cose che fanno riflettere.» Erica non stava più neanche cercando di nascondere il proprio entusiasmo. «Non potrebbe essere un caso?» «Certo. Però sarebbe abbastanza strano che comincino a succedere delle cose proprio quando torna Ebba.» «Veramente ne è successa una» le fece notare Anna. Sapeva con quale facilità Erica intessesse le sue fantasiose teorie. Il fatto che avesse scritto una serie di libri basati su approfondite ricerche documentarie era un miracolo, un’equazione che non era mai riuscita a risolvere. «E va bene, una» ammise Erica con un gesto impaziente. «Non vedo l’ora che torni Patrik. In realtà avrei voluto accompagnarlo ma non avevo nessuno che mi tenesse i bambini.» «Non pensi che avrebbe fatto una strana impressione se ti fossi presentata lì con lui?» Anton e Noel si erano stancati di stare in braccio. Scesero a terra e corsero in soggiorno. «Mah, tanto ho intenzione di andare a parlare con Ebba nei prossimi giorni.» Erica versò altro caffè nelle tazze. «Già, mi chiedo davvero cosa sia successo a quella famiglia» disse Anna in tono pensoso. «Mammaaaa! Portali via!» gridò Maja dal divano ed Erica si alzò sospirando. «Lo sapevo. Ero stata seduta tranquilla per troppo tempo. È sempre così. Maja non li regge. Non so quante volte al giorno devo intervenire.» «Mm» disse Anna, guardando la sorella che usciva dalla cucina e sentendo una stretta al cuore. Magari avesse potuto evitare anche lei di starsene seduta tranquilla. Fjällbacka sfoggiava il suo lato migliore. Dal pontile davanti al capanno dove era seduto con moglie e suoceri, John godeva della vista completa del porticciolo. Il tempo splendido aveva attirato più turisti e appassionati della vela del solito e dalle imbarcazioni ormeggiate a ranghi serrati lungo i pontili galleggianti provenivano musica e risate allegre. Ammirò quel vivace spettacolo socchiudendo gli occhi nel sole. «È un peccato che oggi in Svezia ci sia così poco spazio per esprimere le proprie idee.» John si portò il bicchiere alle labbra e bevve un sorso di rosé ben refrigerato. «Si parla tanto di democrazia e del diritto di tutti a far sentire la propria voce, ma a noi non viene concesso di esprimerci. Anzi, sarebbe meglio che non ci fossimo proprio. Ci si dimentica che è stato il popolo a eleggerci. Un numero sufficiente di svedesi ha dimostrato di nutrire una profonda sfiducia nei confronti del modo in cui vengono gestite le cose. Vogliono un cambiamento, il cambiamento che abbiamo promesso.» Riappoggiò il bicchiere e passò a un altro gambero. Sul piatto c’era già una bella montagna di gusci. «Proprio così, è un vero schifo» concordò il suocero allungandosi verso la zuppiera e prendendone una manciata generosa. «Se è una democrazia, bisogna ascoltare la voce del popolo.» «E lo sanno anche i bambini che molti immigrati vengono qui per i sussidi» intervenne la suocera. «Se venissero solo gli stranieri disposti a lavorare e a dare il loro contributo alla società, andrebbe anche bene. Ma io non ho nessuna voglia che i soldi che pago in tasse vadano a mantenere quei fannulloni che vivono a scrocco.» Aveva già cominciato a biascicare leggermente. John sospirò. Che idioti. Non avevano idea di quello che dicevano. Come la maggior parte del branco di pecoroni, semplificavano il problema senza riuscire a vederlo nel suo insieme. I suoi suoceri erano la personificazione dell’ignoranza che tanto detestava, e gli toccava pure sorbirseli per una settimana. Liv gli fece una carezza tranquillizzante sulla coscia. Sapeva cosa pensava di loro e in generale era d’accordo con lui. Ma Barbro e Kent erano comunque i suoi genitori e non poteva farci molto. «La cosa peggiore è questa tendenza a mescolarsi» continuò la suocera. «Nel nostro quartiere si è appena trasferita una famiglia in cui la mamma è svedese e il papà arabo. M’immagino che vita grama deve avere la poveretta, considerando come si comportano quelli con le loro mogli. I bambini verranno sicuramente presi in giro, a scuola. Poi finiranno in qualche giro di criminalità e allora sarà troppo tardi per pentirsi di non essersi presa un marito svedese.» «Verissimo» concordò Kent, cercando di addentare il gigantesco tramezzino ai gamberi che si era preparato. «Non potremmo lasciare da parte la politica per un po’?» intervenne Liv in tono di leggero rimprovero. «Penso che a John basti sentir parlare di immigrati tutto il giorno a Stoccolma. Vogliamo concedergli una piccola pausa?» John le rivolse un’occhiata riconoscente e ne approfittò per rimirarla. Era così perfetta... capelli chiari e setosi dolcemente ravviati in modo da non cadere sul viso, lineamenti puliti e limpidi occhi azzurri. «Scusaci, stellina. Non ci abbiamo pensato. È solo che siamo così orgogliosi di quello che fa e della posizione che si è conquistato... Be’, adesso parliamo d’altro. Come va con la tua attività, per esempio?» Liv cominciò a riferire vivacemente delle lotte quotidiane con la dogana che le complicava la vita ritardando continuamente la consegna degli elementi d’arredo che importava dalla Francia per poi rivenderli online. John sapeva però che il suo interesse per l’attività stava in realtà scemando e che dedicava sempre più tempo al partito. In confronto, tutto il resto sembrava rivestire ben scarsa importanza. Vedendo che i gabbiani si avvicinavano sempre di più al pontile, si alzò. «Propongo di sparecchiare. Questi uccelli cominciano a diventare un po’ troppo invadenti.» Prese il suo piatto, andò in fondo alle tavole di legno e gettò in acqua i gusci. I gabbiani scesero in picchiata per cercare di conquistarne il più possibile. Di quello che restava si sarebbero occupati i granchi. Rimase lì qualche istante inspirando profondamente e guardando verso l’orizzonte. Come al solito gli occhi indugiarono su Valö e come al solito la rabbia cominciò a covare nel profondo. Per fortuna i pensieri furono interrotti da una vibrazione nella tasca destra dei pantaloni. John si affrettò a tirare fuori il telefono e prima di rispondere lanciò un’occhiata al display. Era il primo ministro. «Che ne pensi di quei biglietti?» Patrik tenne la porta aperta a Martin. Era così pesante che dovette appoggiarsi con tutta la spalla. La stazione di polizia di Tanum era stata costruita negli anni Sessanta e la prima volta che Patrik era entrato nell’edificio simile a un bunker l’aveva trovato squallidissimo, ma ormai era talmente abituato ai colori gialli e beige degli arredi che non si curava minimamente dell’inospitalità del suo luogo di lavoro. «Molto strani. Chi manda biglietti anonimi d’auguri a ogni compleanno?» «Non erano del tutto anonimi. C’era una “G”.» «Ah, be’, questo cambia tutto» osservò Martin, e Patrik rise. «Cosa c’è da ridere?» chiese Annika che al loro ingresso aveva alzato gli occhi da dietro il vetro del suo ufficio. «Niente, veramente» rispose Martin. Annika girò la poltroncina a ruote e si piazzò sulla soglia del suo piccolo ufficio. «Com’è andata?» «Dovremo aspettare di vedere a che conclusioni giunge Torbjörn, ma sembra proprio che qualcuno abbia voluto bruciare la casa.» «Metto su il caffè, così poi continuiamo la chiacchierata.» La segretaria si avviò nel corridoio sospingendoli davanti a sé. «Hai fatto rapporto a Mellberg?» le chiese Martin quando arrivarono nella saletta del personale. «No, non mi sembrava fosse necessario informarlo, per ora. In fin dei conti questo fine settimana è in ferie. Non si deve disturbare il capo, in casi del genere.» «Hai ragione» concordò Patrik sedendosi vicino alla finestra. «Ah, e così fate gli spuntini senza avvertirmi, eh?» Gösta era comparso sulla porta con aria offesa. «Ehi, e tu cosa ci fai qui? Come mai non sei sul campo da golf, visto che non saresti in servizio?» Patrik scostò la sedia accanto a sé per farlo accomodare. «Troppo caldo. Tanto valeva venire a scrivere un paio di rapporti in modo da potermi prendere qualche ora un giorno in cui non si possono cuocere le uova direttamente sull’asfalto. Dove siete stati? Annika ha detto qualcosa a proposito di un incendio doloso.» «Già, pare che sia proprio così. A quanto abbiamo visto, qualcuno ha versato benzina o un liquido del genere sotto la porta e poi ha acceso.» «Che roba.» Gösta prese un biscotto Ballerina dal pacchetto e separò con cura i due strati. «Dove?» «A Valö. La colonia» rispose Martin. Gösta si bloccò. «La colonia?» «Sì, è un po’ strano. Non so se lo sai ma la figlia più piccola, quella sopravvissuta quando è scomparso tutto il resto della famiglia, è tornata e sta rimettendo a posto l’edificio.» «Sì, la voce si è sparsa» rispose Gösta con lo sguardo fisso sul tavolo. Patrik lo squadrò, curioso. «Giusto... all’epoca avevi lavorato anche tu al caso?» «Esatto, sono abbastanza vecchio per aver partecipato» constatò Gösta. «Viene da chiedersi come mai voglia ritornare a stare lì.» «Ha detto qualcosa a proposito di un figlio morto» disse Martin. «Ebba ha perso un figlio? Quando? E come?» «Non hanno spiegato niente di più.» Martin si alzò e andò a prendere il latte nel frigo. Patrik aggrottò la fronte. Non era da Gösta lasciarsi coinvolgere nei casi, ma era un fenomeno che non gli tornava nuovo: tutti i vecchi poliziotti ne avevano uno con la C maiuscola. Un caso su cui rimuginare un anno dopo l’altro e su cui tornare per cercare, se possibile, una soluzione o una risposta prima che fosse troppo tardi. «Per te è stato un caso speciale, vero?» «Sì. Darei qualsiasi cosa per sapere cosa successe quella vigilia di Pasqua.» «Credo che tu non sia il solo» disse Annika. «E adesso Ebba è tornata.» Gösta si passò una mano sul mento. «E qualcuno ha cercato di bruciare la casa.» «Non solo la casa» precisò Patrik. «Chi ha appiccato il fuoco deve aver capito, e forse ci aveva anche contato, che Ebba e suo marito erano dentro e dormivano. È stata una fortuna che Mårten si sia svegliato e sia riuscito a spegnere l’incendio.» «Sì, indubbiamente è una strana coincidenza» disse Martin, facendo un salto quando Gösta batté un pugno sul tavolo. «È evidente che non si tratta di una coincidenza!» I colleghi lo guardarono straniti. Per un attimo scese il silenzio. «Forse dovremmo dare un’occhiata al materiale d’indagine» disse alla fine Patrik. «Solo per sicurezza.» «Posso tirare fuori quello che abbiamo» si offrì Gösta. Il viso magro e simile al muso di un levriero era di nuovo animato e impaziente. «Ogni tanto mi capita di prenderlo e riesaminarlo, per cui so dove trovare quasi tutto.» «Okay. Poi ce lo dividiamo. Forse leggendolo con uno sguardo fresco possiamo scovare qualcosa di nuovo. Intanto tu, Annika, ci tiri fuori dai database quello che c’è su Ebba, va bene?» «Certo» rispose lei cominciando a raccogliere le tazze. «E dovremmo anche controllare la situazione economica degli Stark e verificare se la casa di Valö è assicurata» disse Martin con tatto lanciando uno sguardo a Gösta. «Cosa vuoi dire, che sarebbero stati loro? È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Quando è scoppiato l’incendio erano dentro ed è stato il marito di Ebba a spegnerlo.» «Comunque vale la pena di approfondire. Chissà, magari ha appiccato lui il fuoco e poi ha cambiato idea? Me ne occupo io.» Gösta aprì la bocca come per dire qualcosa ma la richiuse e uscì a grandi passi dalla saletta. Patrik si alzò. «Credo che anche Erica abbia un po’ di informazioni.» «Erica? Come mai?» Martin si era bloccato a metà di un passo. «È un pezzo che si interessa a quel caso. È una storia che tutti hanno sentito raccontare, a Fjällbacka, e considerando di cosa si occupa non è strano che abbia risvegliato la sua curiosità.» «Allora parlagliene. Tutto quello che riusciamo a tirare fuori può tornare utile.» Patrik annuì, ma non era del tutto convinto. Sapeva come sarebbe potuta andare a finire se avesse coinvolto Erica nelle indagini. «Certo, lo farò» disse sperando di non doversene pentire. Quando Percy riempì due bicchierini del suo cognac più pregiato la mano gli tremava leggermente. Ne passò uno alla moglie. «Proprio non capisco come ragionano.» Pyttan bevve a sorsi veloci. «Il nonno si rivolterebbe nella tomba se lo sapesse.» «Devi risolvere la situazione, in un modo o nell’altro.» Tese il bicchiere e lui non esitò a riempirglielo sebbene fosse solo primo pomeriggio. Dopotutto, da qualche parte nel mondo erano le cinque passate e quella giornata richiedeva bevande forti. «Io? Cosa vuoi che faccia?» La voce si era fatta stridula e la mano gli tremava al punto che metà cognac finì fuori dal bicchierino di Pyttan, che lo tirò indietro e disse: «Ma cosa fai, stupido!» «Scusa, scusa.» Percy si lasciò sprofondare in una delle grandi poltrone logore della biblioteca. Si sentì uno strappo che indicava chiaramente che il rivestimento si era lacerato. «Merda!» Si alzò di scatto e cominciò a prendere a calci la poltrona, fuori di sé. Intorno a lui stava cadendo tutto in pezzi. L’intero castello andava in malora, la sua eredità era svanita da tempo e quegli stronzi dell’agenzia delle entrate sostenevano che doveva tirare fuori una grossa somma che non aveva. «Calmati.» Pyttan si asciugò le mani con un tovagliolino. «In qualche modo una soluzione ci sarà. Però non capisco com’è possibile che siano finiti i soldi.» Percy spostò lo sguardo su di lei. Sapeva quanto quell’idea la spaventasse ma non riusciva a provare altro che disprezzo. «Com’è possibile che siano finiti?» gridò. «Ma non ti rendi conto di quanti ne fai fuori ogni mese? Non capisci quanto costano tutti i viaggi, le cene, i vestiti, le borse, le scarpe e i gioielli e le altre cazzate che ti compri?» Non era da lui urlare a quel modo e Pyttan arretrò, fissandolo allibita. Percy la conosceva a sufficienza per sapere che stava soppesando le due alternative: affrontare la battaglia o blandirlo. Quando vide addolcirsi i lineamenti del viso capì che aveva optato per la seconda. «Amore, non litighiamo per una cosa meschina come i soldi.» Gli raddrizzò la cravatta e infilò la camicia nei pantaloni. «Ecco fatto. Adesso sei di nuovo il mio elegante signore del castello.» Gli si strinse addosso, disarmandolo. Oltretutto quel giorno indossava l’abito di Gucci che gli rendeva sempre difficile resisterle. «Facciamo così: telefoni al commercialista e rivedi i conti. La situazione non può essere poi tanto disastrosa. Sicuramente servirà a tranquillizzarti.» «Devo parlare con Sebastian» mormorò lui. «Sebastian?» ripeté Pyttan con l’espressione di chi abbia assaggiato qualcosa di disgustoso. Alzò gli occhi su Percy. «Sai che non mi piace che lo frequenti, anche perché a me tocca sorbirmi quell’insulsa di sua moglie. Non hanno un briciolo di classe. Avrà pure tutti i soldi che vuoi, ma è un buzzurro. Ho sentito dire che l’ufficio nazionale per i reati finanziari lo tiene d’occhio da parecchio senza trovare prove, ma è solo questione di tempo e quindi sarebbe meglio non avere a che fare con lui.» «Il denaro non puzza» disse Percy. Sapeva cos’avrebbe detto il commercialista: i soldi erano finiti. Non restava più niente e per cavarsi d’impiccio e salvare Fygelsta gli servivano dei capitali. Sebastian era la sua unica speranza. Avevano fatto una visita all’ospedale di Uddevalla, ma sembrava che fosse tutto a posto. Niente fumo nei polmoni. Il primo shock era passato ed Ebba si sentiva come se si fosse svegliata da uno strano sogno. Si accorse che stava socchiudendo gli occhi nella penombra e accese la lampada da tavolo. D’estate il buio arrivava insinuandosi impercettibilmente e le capitava spesso di sforzare gli occhi prima di rendersi conto che le serviva più luce. Stava lavorando a un angioletto che le creava qualche problema e il passante non voleva saperne di inserirsi nel punto giusto. Mårten non capiva perché producesse i gioielli a mano invece di farli fare in Thailandia o in Cina, soprattutto da quando grazie al sito web aveva cominciato a ricevere ordinazioni consistenti, ma il lavoro non avrebbe avuto lo stesso significato. Lei voleva realizzare ogni pezzo a mano, investendo la stessa quantità di amore in ciascuna collanina che spediva e intessendo negli angioletti il proprio dolore e i propri ricordi. Inoltre era rilassante stare seduta lì la sera dopo aver imbiancato, martellato e segato tutto il giorno. Quando si alzava la mattina le dolevano tutti i muscoli, ma durante il lavoro sui gioielli la tensione del corpo si allentava. «Ho chiuso a chiave tutto, adesso» disse Mårten facendole fare un salto sulla sedia. Non l’aveva sentito arrivare. «Maledizione!» esclamò quando il passante si sfilò dopo essere quasi andato a posto. «Non vuoi fare una pausa, per stasera?» chiese Mårten con tatto mettendosi dietro di lei, vicinissimo. Ebba percepì la sua esitazione: non sapeva se metterle le mani sulle spalle. Prima che morisse Vincent le massaggiava spesso la schiena e lei adorava quel contatto deciso e insieme delicato, ma ormai quasi non sopportava che lui la sfiorasse e c’era il rischio che si scuotesse istintivamente di dosso le sue mani, ferendolo e aumentando così la distanza che li separava. Fece un altro tentativo con il passante e alla fine riuscì a infilarlo. «Ha importanza che chiudiamo a chiave?» disse senza voltarsi. «Sembra che le porte non abbiano fermato chi ha cercato di farci morire bruciati vivi la notte scorsa.» «Già, ma cosa dobbiamo fare?» rispose Mårten. «Non potresti almeno guardarmi quando mi parli? È una cosa importante. Qualcuno ha cercato di radere al suolo questo posto, e neanche sappiamo chi o perché. Non la trovi anche tu una cosa orribile? Non hai paura?» Ebba si girò lentamente. «Di cosa dovrei avere paura? Il peggio è già accaduto, con o senza porte chiuse. Per me non cambia niente.» «Non possiamo continuare così.» «Perché no? Ho fatto quello che proponevi tu: mi sono trasferita qui, accettando il tuo megaprogetto di ristrutturare questa specie di castello diroccato per poi vivere felice e contenta nel nostro piccolo paradiso, con gli ospiti che vanno e vengono. Ho accettato. Cos’altro pretendi?» Si accorse da sola di quanto suonasse fredda e intransigente. «Niente, Ebba. Non pretendo niente.» La voce di Mårten era gelida quanto la sua. Fece dietrofront e uscì dalla stanza. Fjällbacka 1915 Finalmente libera. Era stata presa a servizio in un podere di Hamburgsund e non avrebbe più avuto niente a che fare con la megera e con i suoi disgustosi marmocchi. E soprattutto con suo marito. Via via che cresceva e che il suo corpo si sviluppava, le visite notturne si erano intensificate e da quando era comparso il ciclo era vissuta nel terrore che dentro di lei potesse cominciare a crescere un bambino. Un figlio era l’ultima cosa che voleva. Non aveva intenzione di diventare come quelle ragazzine spaventate, con il viso arrossato dal pianto, che venivano a bussare alla porta di sua madre con un fagottino urlante tra le braccia. Le disprezzava fin da quando era bambina così come disprezzava la loro debolezza e rassegnazione. Dagmar mise via i suoi pochi averi. Della casa dei genitori non le era rimasto nulla e da lì non aveva niente da portare via. Tuttavia non aveva intenzione di andarsene a mani vuote. Entrò di nascosto nella camera della coppia a cui era stata data in affidamento. In una scatola sotto il letto, spinta contro la parete, la megera conservava i gioielli ereditati dalla madre. Dagmar si stese sul pavimento e la tirò fuori. La donna era a Fjällbacka e i bambini giocavano in cortile. Non l’avrebbe disturbata nessuno. Aprì il coperchio e sorrise compiaciuta. Il contenuto le sarebbe bastato per un po’. Inoltre le faceva piacere immaginare il dolore della megera per aver perso i gioielli di famiglia. «Cosa stai facendo?» La voce del padre affidatario dalla soglia la fece trasalire. Pensava che fosse nella stalla. Per un attimo il cuore le batté all’impazzata, ma subito dopo la calma tornò a diffondersi nel corpo. Niente avrebbe potuto rovinare i suoi piani. «Tu cosa dici?» disse prendendo il contenuto della scatola e infilandolo nella tasca della gonna. «Sei pazza? Rubi i gioielli?» Avanzò di un passo, ma lei sollevò una mano. «Esatto. E ti consiglio di non provare a fermarmi, perché in caso contrario andrò dritta in gendarmeria a dire quello che mi hai fatto.» «Provaci!» Chiuse le mani a pugno, ma un attimo dopo lo sguardo gli si rasserenò. «Tanto, chi crederebbe alla figlia della fabbricante di angeli?» «Sarò convincente, vedrai. E la voce si spargerà più in fretta di quanto credi.» Lui si rabbuiò di nuovo e sembrò esitare. Dagmar decise di dargli un aiutino. «Ti faccio una proposta. Quando la mia cara madre affidataria scoprirà che i gioielli sono spariti tu farai tutto quello che potrai per farle capire che è meglio che lasci perdere. Se me lo prometti, prima di partire ti concederò un piccolo premio.» Dagmar si avvicinò al padre affidatario, sollevò lentamente la mano, gliela mise sul membro e cominciò a muoverla. Gli occhi dell’uomo divennero lucidi e lei seppe di averlo in suo potere. «Siamo d’accordo?» chiese sbottonandogli i calzoni. «Siamo d’accordo» disse lui appoggiandole la mano sulla nuca e premendole la testa verso il basso. La torre dei tuffi di Badholmen si stagliava, maestosa come sempre, contro il cielo. Erica scacciò con decisione l’immagine di un uomo che penzolava lentamente da una corda dalla piattaforma più alta. Non voleva tornare neanche con la mente a quel tragico evento, e Badholmen faceva del suo meglio per farle pensare ad altro. L’isolotto addossato a Fjällbacka sembrava un gioiello immerso nell’acqua. L’ostello godeva di grande popolarità e in genere d’estate era al completo, cosa più che comprensibile. La posizione e il fascino antiquato dell’edificio erano una combinazione irresistibile. Quel giorno, però, le riusciva difficile godere del panorama. «Ci siamo tutti?» Si guardò intorno ansiosa e contò i bambini. Tre figurine scatenate, avvolte in altrettanti giubbotti di salvataggio arancioni, correvano in direzioni diverse sul pontile. «Non potresti darmi una mano, Patrik?» disse agguantando il grosso colletto del giubbotto di Maja mentre la bambina le sfrecciava accanto, pericolosamente vicino al bordo. «Già, e allora chi fa partire il motore?» Patrik spalancò le braccia, il viso paonazzo. «Se riusciamo a farli salire a bordo senza che qualcuno finisca in acqua, puoi avviarlo dopo.» Maja si divincolava come un verme per liberarsi ma Erica la teneva stretta per l’asola del colletto. Con la mano libera afferrò Noel che rincorreva Anton sulle gambette tornite. Se non altro, le restava da recuperare un solo figlio. «Tieni, prendi.» Trascinò i bambini recalcitranti verso il beccaccino ormeggiato al pontile e li passò a Patrik, salito con aria scocciata sull’alzata in legno. Poi si girò subito per rincorrere Anton che era quasi arrivato in fondo al pontile, in direzione del molo di pietra che univa Badholmen alla terraferma. «Fermati, Anton!» gridò, invano. Nonostante il bambino corresse come un razzo, in poco tempo lo raggiunse e lo prese in braccio, con il risultato che il piccolo si mise a scalciare e a urlare istericamente. «Dio santo, come ho fatto a pensare che fosse una buona idea?» disse quando finalmente riuscì a passare a Patrik il figlio singhiozzante. Poi, con il sudore che le colava sulla fronte, slegò la cima e saltò a bordo. «Andrà meglio quando saremo al largo.» Patrik girò la chiave del motore che, per fortuna, partì al primo tentativo. Poi si sporse in avanti e staccò la cima posteriore mentre con la mano manteneva costante la distanza dalla barca accanto. Uscire non fu troppo facile: i ranghi erano serrati e, se non avessero avuto il parabordo, né la loro né le imbarcazioni vicine se la sarebbero cavate senza danni. «Scusa se sono stata sgarbata, prima.» Erica si lasciò cadere su uno dei banchi dopo aver costretto i bambini a sedersi sul fondo. «Già dimenticato» rispose lui allontanando lentamente da sé il timone in modo che la barca si girasse con la poppa al porto e la prua verso il centro abitato. Era una splendida domenica mattina con il cielo azzurro, l’acqua simile a uno specchio lucido e i gabbiani che roteavano sopra di loro emettendo gridi rauchi. Guardandosi intorno Erica si accorse che a bordo di diverse imbarcazioni nel porto la gente stava facendo colazione. Probabilmente molti erano ancora a letto a smaltire la sbornia. I sabati sera erano spesso ben innaffiati, soprattutto tra i giovani. Meno male che quel periodo è ormai lontano, pensò guardando molto più teneramente di prima i figli seduti nella barca. Andò a sedersi di fianco a Patrik e gli appoggiò la testa sulla spalla. Lui le circondò le spalle con un braccio e le diede un bacio sulla guancia. «Ah, senti» disse d’un tratto. «Dopo che avremo attraccato ricordami di chiederti un po’ d’informazioni su Valö e sulla colonia.» «Cosa vuoi sapere?» chiese lei curiosa. «Ne parliamo dopo con calma» rispose lui baciandola di nuovo. Erica sapeva che si comportava così solo per stuzzicarla: il desiderio di sapere di più le faceva formicolare tutto il corpo, ma si controllò. In silenzio, schermò gli occhi con la mano e scrutò in direzione di Valö. Quando oltrepassarono lentamente l’isola intravide il grande edificio bianco. Chissà se si sarebbe mai riusciti a scoprire cos’era successo tanti anni prima? Detestava i libri e i film in cui alla fine non si ottenevano tutte le risposte e quasi non riusciva a leggere sui giornali le notizie sui casi insoluti. Scavare in quello di Valö non aveva portato a niente, per quanto avesse cercato una spiegazione. La verità era nascosta nella penombra quanto la grande casa dietro gli alberi. Martin rimase per qualche istante con la mano a mezz’aria prima di appoggiare il dito al campanello. Poco dopo sentì dei passi oltre la porta e si trattenne dal fare dietrofront e andarsene. La porta si aprì e Annika lo guardò stupita. «Ehi... che sorpresa! È successo qualcosa?» Cercò di spremere un sorriso, ma la segretaria della stazione di polizia era l’ultima persona che potesse ingannare ed era proprio per questo, in un certo senso, che era andato da lei. Fin dal suo primo giorno di lavoro era stata per lui una specie di mamma di riserva e in quel momento era la persona con cui aveva bisogno di parlare. «Ecco, io...» cominciò. «Entra» lo interruppe lei. «Ci mettiamo in cucina davanti a una bella tazza di caffè e poi mi dici cosa succede.» Martin entrò, si tolse le scarpe e la seguì. «Siediti» disse Annika cominciando a versare la polvere nel filtro, un misurino dopo l’altro. «Pia e Tuva dove sono?» «A casa. Ho detto che andavo a fare una passeggiata, quindi tra poco devo tornare. Dopo pensavamo di scendere in spiaggia.» «Ah, certo. Anche Leia adora fare il bagno. Ci siamo stati l’altro giorno e quando è venuta l’ora di andare a casa quasi non riuscivamo a tirarla fuori dall’acqua. È davvero un pesciolino. Lennart è appena uscito con lei per darmi la possibilità di mettere un po’ in ordine.» Quando parlava della figlioletta le s’illuminava il viso. Era passato quasi un anno da quando lei e il marito Lennart, dopo molti episodi dolorosi, erano potuti andare in Cina a prendere la bambina che avevano deciso di adottare, e ormai tutta la loro esistenza orbitava intorno a Leia. Martin non riusciva a immaginare una madre migliore di Annika. Era una persona che traboccava di calore umano e sollecitudine, e lo faceva sentire al sicuro. In quel momento avrebbe desiderato appoggiarle la testa sulla spalla e dar sfogo alle lacrime che premevano dietro le palpebre, ma si trattenne. Se avesse cominciato a piangere non avrebbe più smesso. «Mi sa che tiro fuori qualche ciambellina.» Prese un sacchetto dal freezer e lo mise nel microonde. «Le ho fatte ieri e pensavo di portarne un po’ anche alla stazione.» «Lo sai, vero, che il rifornimento di dolcetti per il caffè non rientra nelle tue mansioni?» disse Martin. «Mah, non sono convinta che Mellberg sia d’accordo. Se dovessi controllare con cura il mio contratto d’assunzione probabilmente troverei una clausolina a carattere minuscolo tipo “rifornirà inoltre regolarmente la stazione di polizia di Tanum di dolci fatti in casa”.» «Già, santo cielo. Senza di te e la panetteria, Bertil non sopravvivrebbe un solo giorno.» «Sì, soprattutto da quando Rita l’ha messo a dieta. A sentire Paula, a casa loro ultimamente si va a pane integrale e verdura.» «Vorrei proprio vederlo!» Martin scoppiò a ridere e sentì che la tensione diminuiva e il nodo allo stomaco si allentava. Il microonde emise un segnale acustico e Annika dispose su un piatto le ciambelline calde per poi metterlo in tavola insieme a due tazze piene di caffè. «Bene, adesso abbiamo tutto ed è il momento che tu mi dica cosa ti opprime. Già l’altro giorno mi sono accorta che qualcosa non andava, ma mi sembrava giusto che venissi a dirmelo quando ti fossi sentito pronto.» «Forse non è niente, e davvero non voglio rovesciarti addosso i miei problemi, ma...» Si fermò, accorgendosi che il pianto era di nuovo in agguato. «Sciocchezze. Sono qui per questo. Racconta.» Martin inspirò profondamente. «Pia è malata» disse alla fine, sentendo le parole echeggiare tra le pareti. Vide che Annika impallidiva, evidentemente impreparata. Fece girare la tazza tra le mani e poi riprese lo slancio, buttando fuori tutto in una volta: «È un pezzo che si sente stanca, in realtà fin dalla nascita di Tuva, ma non ci sembrava strano e pensavamo che fosse normale, dopo il parto. Solo che ormai sono passati quasi due anni e invece di rimettersi è solo peggiorata. Poi ha cominciato a sentire dei noduli nel collo...» La mano di Annika corse alla bocca, come se avesse già capito la conclusione. «E qualche settimana fa l’ho accompagnata a una visita e ho capito subito cosa sospettava il medico. Le ha fatto una prescrizione urgente e siamo andati a Uddevalla per gli esami, e adesso ha un appuntamento con l’oncologo per domani pomeriggio. Le daranno i risultati, ma sappiamo già cosa ci diranno.» Le lacrime cominciarono a scendere e lui le asciugò con un gesto rabbioso. Annika gli tese un fazzolettino. «Piangi, vedrai che dopo ti sentirai meglio.» «È così ingiusto. Pia ha solo trent’anni e Tuva è tanto piccola... Ho googlato le statistiche e se è quello che pensiamo sono davvero pessime. Pia è coraggiosissima, mentre io me la faccio sotto al pensiero di parlarne con lei. Quasi non riesco a vederla con Tuva e a guardarla negli occhi. Mi sento una merda!» Incapace di trattenere oltre le lacrime, abbassò la testa sulle braccia e si mise a singhiozzare forte. Un braccio gli si posò sulle spalle e subito dopo Martin sentì la guancia di Annika contro la propria. Lei non disse niente ma rimase lì ad accarezzargli la schiena con una mano. Dopo un po’ lui si tirò su, si girò verso di lei e si rifugiò nel suo abbraccio mentre Annika lo cullava sussurrando come quando Leia si faceva male. Avevano avuto fortuna a trovare posto al Café Bryggan. I tavolini all’aperto erano al completo e Leon vedeva i camerieri andare avanti e indietro con i vassoi carichi di tramezzini ai gamberi. La posizione su Ingrid Bergmans torg era perfetta, con i tavolini che arrivavano fino al pontile in legno. «Secondo me dobbiamo comprare la casa» disse Ia. Leon si girò verso la moglie. «Dieci milioni non sono bruscolini.» «Perché, ho detto questo?» Si sporse in avanti e gli sistemò il plaid sulle ginocchia. «Lascia stare quella coperta del cavolo. Sto sudando!» «Lo sai che non devi prendere il raffreddore.» Una cameriera arrivò al loro tavolo e Ia ordinò un bicchiere di vino per sé e uno di acqua minerale per lui. Leon alzò gli occhi sulla ragazza. «Una birra doppio malto» disse. Ia lo guardò con aria di rimprovero, ma lui confermò l’ordinazione con un cenno alla cameriera, che reagì come facevano tutti quelli che incontrava, sforzandosi di non fissare con troppa insistenza le cicatrici lasciate dalle ustioni. Quando se ne fu andata, lui spaziò con lo sguardo sul mare. «L’odore è quello che ricordavo» disse. Le mani attraversate da un reticolo di cicatrici sottili erano appoggiate in grembo. «Io resto della mia idea, ma accetto a patto che compriamo la casa. Non ho intenzione di stare in un bugigattolo e neanche di passare qui tutte le estati. Bastano un paio di settimane all’anno.» «Non ti sembra irragionevole comprare una casa che vale dieci milioni di corone se poi la sfruttiamo solo due settimane l’anno?» «Sono le mie condizioni» ribadì lei. «Altrimenti te ne stai qui per conto tuo. E non credo che funzionerebbe, giusto?» «No. So bene che non me la cavo da solo. E se contro ogni previsione dovessi dimenticarmene, provvedi tu a ricordarmelo ogni volta che puoi.» «Ma ogni tanto pensi a tutti i sacrifici che ho fatto per te? Mi sono sempre dovuta sorbire i tuoi colpi di testa senza che tu ti sia mai chiesto cosa provavo. E adesso vuoi venire qui. Non ti sei scottato abbastanza per voler giocare con il fuoco?» La cameriera arrivò con il vino e la birra e appoggiò i bicchieri sulla tovaglia a scacchi bianchi e blu. Leon ne bevve qualche sorso accarezzando il bicchiere freddo con il pollice. «Okay, facciamo come vuoi tu. Chiama quell’agente immobiliare e digli che compriamo la casa. Ma voglio che andiamo a starci il più presto possibile. Detesto alloggiare in albergo.» «Bene» disse Ia senza alcuna gioia. «In quella casa credo che riuscirò a resistere un paio di settimane all’anno.» «Sei così stoica, amore.» Lei gli rivolse un’occhiata cupa. «Speriamo solo che tu non ti penta di questa decisione.» «Ne è passata di acqua sotto i ponti» rispose lui calmo. In quello stesso istante sentì che qualcuno, alle sue spalle, tratteneva il respiro di scatto. «Leon?» Trasalì. Non aveva bisogno di girarsi per sapere a chi apparteneva la voce. Josef. Dopo tutti quegli anni, Josef era lì. Paula spaziò con lo sguardo sull’insenatura scintillante crogiolandosi al sole. Si appoggiò una mano sulla pancia e, sentendo i calci, sorrise. «Bene, mi sembra proprio che sia ora di un gelato» disse Mellberg alzandosi in piedi. Poi lanciò un’occhiata a Paula e sollevò un dito ammonitore. «Lo sai, vero, che non fa bene esporre la pancia alla luce diretta del sole?» Lei lo seguì sorpresa con lo sguardo mentre si allontanava in direzione del chioschetto. «Mi sta prendendo in giro?» chiese rivolta a sua madre. Rita rise. «È animato dalle migliori intenzioni.» Paula borbottò ma si coprì lo stesso la pancia con un pareo. Leo le sfrecciò davanti nudo come mamma l’aveva fatto e fu agguantato al volo da Johanna. «Ha ragione» disse. «I raggi Uv possono provocare delle alterazioni del pigmento, per cui vedi di proteggere bene anche il viso.» «Ma come, scusa?» obiettò Paula. «Io sono scura di pelle!» Rita le tese un flacone di crema protettiva a fattore trenta. «Quando aspettavo te, a me sono venute un sacco di chiazze, quindi non protestare.» Paula ubbidì e anche Johanna si spalmò con cura la pelle chiara. «E comunque sei fortunata» disse. «Se non altro non devi sforzarti di abbronzarti.» «Sì, però vorrei che Bertil si desse una calmata» rispose Paula versandosi una dose abbondante di crema nel palmo. «Qualche giorno fa l’ho sorpreso a leggere gli esami che ho fatto dall’inizio della gravidanza e l’altro ieri è arrivato a casa con un flacone di omega-3 preso in un negozio di macrobiotica. Aveva letto su una rivista che favorisce lo sviluppo del cervello nel feto.» «È così felice. Lascialo fare» intervenne Rita cominciando a spalmare Leo da capo a piedi per la seconda volta. Leo aveva ereditato la pelle lentigginosa e chiara di Johanna e si scottava facilmente. Paula si chiese distratta se il bambino che aspettava avrebbe avuto i suoi colori o quelli del donatore anonimo. A lei non importava. Leo era figlio suo e di Johanna e ormai non le capitava neanche più di pensare che c’era una terza parte coinvolta. Lo stesso sarebbe accaduto per quel nuovo bebè. Le sue riflessioni furono interrotte dall’annuncio allegro di Mellberg: «Arrivano i gelati!» Rita lo trafisse con lo sguardo. «Non l’avrai preso anche per te, spero.» «Solo un Magnum microscopico. Sono stato bravissimo per tutta la settimana, no?» Sorrise e le fece l’occhiolino nel tentativo di ammansirla. «Be’, scordatelo» disse Rita calma, prendendo il gelato e andando a gettarlo in un cestino. Mellberg bofonchiò qualcosa. «Prego?» Lui deglutì. «Niente. Assolutamente niente.» «Sai bene cos’ha detto il medico. Sei in zona rischio sia per il cuore sia per il diabete.» «Cosa vuoi che faccia un Magnum! Dopotutto bisogna anche vivere» disse lui distribuendo gli altri gelati. «Ancora una settimana di vacanza» mormorò Paula leccando il suo Cornetto con gli occhi chiusi. «Secondo me non dovresti tornare al lavoro» disse Johanna. «Ormai non manca molto. Se ne parlassi con l’ostetrica sicuramente ti consiglierebbe di metterti in malattia. Hai bisogno di riposare.» «Ehi» intervenne Mellberg. «Guarda che ti ho sentito. Non dimenticare che sono il suo capo.» Si grattò pensoso la testa semicalva. «Comunque sono d’accordo. Anche secondo me non dovresti lavorare.» «Ne abbiamo già parlato. Diventerei pazza a stare a casa ad aspettare. E poi al momento regna la calma.» «Ma quale calma?» Johanna la stava fissando. «Se è il periodo più frenetico di tutto l’anno, tra ubriachi e il resto.» «Volevo dire soltanto che non abbiamo indagini particolarmente impegnative. Il trantran estivo a base di furti con scasso e roba del genere riesco a gestirlo a occhi chiusi. E poi non devo per forza uscire con i colleghi: posso fermarmi alla stazione e occuparmi delle scartoffie, per cui smettetela di insistere. Sono incinta, non malata.» «Be’, vedremo» disse Mellberg. «Comunque, su una cosa hai ragione: al momento fila tutto abbastanza liscio.» Era il loro anniversario e come ogni anno Gösta aveva con sé dei fiori freschi da portare a Maj-Britt. Non era troppo costante nella cura della tomba, ma questo non c’entrava con i sentimenti nei suoi confronti. Avevano passato molti begli anni insieme e ogni mattina ne sentiva ancora la mancanza. Certo si era abituato alla vita di vedovo e le sue giornate erano così incasellate che a volte l’idea di aver vissuto nella sua casetta insieme a qualcun altro gli sembrava un sogno lontanissimo. Ma il fatto che ci fosse abituato non significava che quella vita gli piacesse. Si accovacciò e seguì con il dito l’incisione nella pietra che formava il nome del loro figlioletto. Non c’era neanche la foto. Convinti com’erano di avere tutto il tempo del mondo, non l’avevano fotografato appena nato. E non l’avevano fatto neppure alla sua morte. A quell’epoca non usava. A quanto aveva capito, non era più così, ma allora bisognava dimenticare e andare avanti. Fatene un altro appena potete, era stato il consiglio che avevano ricevuto quando, ancora sotto shock, erano usciti dall’ospedale. Ma non era stato così. L’unica figlia che avessero mai avuto era la bambina. La Piccola, come l’avevano chiamata. Forse avrebbero dovuto fare di più per tenerla, ma il dolore era ancora troppo grande e non si erano sentiti in grado di darle ciò di cui aveva bisogno che per un breve periodo. Era stata Maj-Britt, alla fine, a prendere la decisione. Lui aveva cercato di proporre con garbo di continuare a occuparsi della bambina, di permetterle di restare. Ma, con il volto addolorato e la perdita già incisa nel cuore, Maj-Britt aveva risposto: «Ha bisogno di fratelli e sorelle.» E così la bambina se n’era andata. Dopo non ne avevano mai parlato, ma Gösta non era mai riuscito a dimenticarla. Se gli avessero dato una corona per ogni pensiero che le aveva rivolto, a quell’ora sarebbe stato un uomo ricco. Si alzò. Aveva strappato un po’ di erbacce e il mazzo di fiori campeggiava nel suo vaso. Sentì chiaramente nella testa la voce di Maj-Britt: “Ma insomma, Gösta, che sciocchezza. Perché sprecare dei fiori tanto belli per me?”. Era convinta di non meritarsi niente di più delle cose di tutti i giorni e Gösta desiderò di averle dato meno ascolto, di averla viziata. Di averle regalato dei fiori quando ancora poteva goderne. Ormai non gli restava che sperare che, da dove si trovava, guardasse giù e ne gioisse. Fjällbacka 1919 In casa Sjölin ci si preparava di nuovo a una festa. Dagmar era riconoscente di ogni occasione in cui ne veniva organizzata una. La paga per il servizio fuori orario le faceva comodo ed era bellissimo vedere da vicino quelle persone ricche in tutto il loro splendore. Conducevano una vita così meravigliosa e spensierata! Mangiavano, bevevano, ballavano, cantavano e ridevano fino all’alba. Avrebbe voluto che fosse così anche la sua, ma per il momento doveva accontentarsi di servire i fortunati e crogiolarsi per qualche attimo nella loro luce riflessa. Quella festa in particolare si prospettava ancora più speciale. Fin dalla mattina lei e gli altri domestici erano stati portati sull’isola al largo di Fjällbacka e la barca aveva fatto la spola per trasferire cibo, bevande e ospiti. «Dagmar! Vai in cantina a prendere dell’altro vino!» le gridò la signora Sjölin, e lei scese di corsa. Teneva molto a restare nelle grazie della moglie del dottore. L’ultima cosa che voleva era che cominciasse a sorvegliarla, perché in quel caso si sarebbe accorta degli sguardi e dei buffetti affettuosi che suo marito le riservava durante le feste. A volte, quando la moglie si scusava e andava a dormire e gli altri ospiti erano troppo ubriachi o impegnati a divertirsi a loro volta per accorgersi di quello che accadeva intorno a loro, gli concedeva anche qualcosa di più. Dopo quelle occasioni, al momento di consegnare il salario ai domestici il dottore le passava di nascosto una piccola somma aggiuntiva. Prese quattro bottiglie di vino e si affrettò a salire, tenendole strette al petto, ma disgraziatamente andò a sbattere contro qualcuno e le lasciò cadere. Due si ruppero e, disperata, Dagmar si rese conto che le sarebbero state detratte dalla paga. Le lacrime presero a scorrerle sul viso mentre alzava gli occhi sullo sconosciuto. «Scusi!» esclamò lui in danese, ma con uno strano accento. La disperazione si trasformò in rabbia. «Ma cosa fa? Non capisce che non può mettersi proprio davanti alla porta?» «Scusi» ripeté lui. «Ich verstehe nicht.» Dagmar capì di colpo chi era. Era andata a sbattere contro l’ospite d’onore della serata: l’eroe tedesco, l’aviatore che aveva coraggiosamente combattuto in guerra ma che dopo la cocente sconfitta della Germania si manteneva grazie alle esibizioni di volo. Era tutto il giorno che si sussurrava di lui. Si diceva che avesse abitato a Copenaghen e che un qualche scandalo l’avesse costretto a spostarsi in Svezia. Dagmar lo scrutò. Era l’uomo più affascinante che avesse mai visto. Non sembrava affatto ubriaco come la maggior parte degli altri ospiti e quando i suoi occhi incrociarono quelli di Dagmar lo sguardo era saldo. Rimasero a lungo a fissarsi. Dagmar raddrizzò la schiena. Sapeva di essere bella: le era stato confermato molte volte dagli uomini che, passandole le mani sul corpo, le gemevano nell’orecchio. Mai prima di allora, però, si era rallegrata della propria bellezza. Senza toglierle gli occhi di dosso, l’aviatore si abbassò a raccogliere i cocci di vetro. Li portò cauto in un boschetto ai margini del giardino e li gettò via. Poi si portò il dito alle labbra, scese in cantina e portò su altre due bottiglie. Dagmar sorrise riconoscente e gli andò incontro per prenderle. Lo sguardo le cadde sulle sue mani e vide che sanguinava da un taglio all’indice sinistro. Gli fece capire a gesti che voleva controllare il taglio e lui appoggiò le bottiglie a terra. La ferita non era profonda ma sanguinava parecchio. Con gli occhi fissi in quelli di lui, Dagmar si portò il dito alla bocca e lo succhiò delicatamente. Le pupille gli si dilatarono e Dagmar le vide coprirsi del familiare velo lucido. Si scostò e prese le bottiglie. Quando si avviò verso il salone, il suo sguardo le bruciava sulla schiena. Patrik aveva radunato i colleghi per fare il punto della situazione. Non essendo sicuro che Mellberg fosse informato sugli sviluppi, si schiarì la voce e disse: «Lei non era qui, commissario, ma forse ha saputo cos’è successo.» «No. Cosa?» Mellberg lo stava fissando con insistenza. «Sabato c’è stato un incendio alla colonia di Valö. Pare che sia stato appiccato da qualcuno.» «Doloso, quindi?» «Non è ancora confermato. Aspettiamo il rapporto di Torbjörn.» Patrik esitò, ma poi continuò: «In ogni caso gli elementi in questo senso sono sufficienti per cominciare a lavorarci.» Indicò Gösta che si trovava accanto alla lavagna con un pennarello in mano. «Gösta sta tirando fuori il materiale sulla famiglia scomparsa a Valö. Si tratta...» «So di cosa stai parlando» lo interruppe Mellberg. «È una storia nota a tutti. Ma cosa c’entra con l’incendio?» Il commissario si chinò a grattare la testa al suo cane Ernst, accucciato sotto la sedia. «Non lo sappiamo.» Patrik si sentiva già stanco. Possibile che dovesse sempre discutere con quello che in teoria era a capo della stazione ma in pratica lasciava ben volentieri a lui la responsabilità di tutto, ovviamente prendendosi i meriti a lavoro finito? «Cominceremo a indagare senza escludere nessuna possibilità. Mi sembra strano che questa cosa succeda proprio quando la figlia sopravvissuta torna per la prima volta dopo trentacinque anni.» «Saranno stati loro a dar fuoco alla stamberga. Per ricavarne i soldi dell’assicurazione» bofonchiò Mellberg. «Sto esaminando la loro situazione economica.» Seduto di fianco ad Annika, Martin sembrava più pacato del solito. «Domani mattina dovrei avere in mano un po’ di materiale.» «Bene. Vedrete che il mistero sarà presto risolto. Avranno scoperto che ristrutturare quell’edificio fatiscente costava troppo e deciso che era meglio bruciarlo e basta. Ne ho viste di queste situazioni all’epoca in cui ero a Göteborg.» «Come dicevo, non ci stiamo limitando a una sola possibilità» disse Patrik. «Adesso però vorrei sentire quello che ha da riferirci Gösta.» Si sedette e segnalò al collega che poteva cominciare. Quello che gli aveva raccontato Erica il giorno prima durante la gita nell’arcipelago era affascinante e voleva sapere cos’aveva da dire Gösta sulla vecchia indagine. «Conoscete già alcuni aspetti di questa faccenda, ma se non avete niente in contrario parto dal principio.» Gösta si guardò intorno e tutti annuirono. «Il 13 aprile 1974, la vigilia di Pasqua, alla polizia di Tanum arrivò una chiamata con la richiesta di mandare qualcuno al collegio di Valö. La persona al telefono non disse cosa fosse successo e riattaccò subito. Aveva risposto il commissario dell’epoca, secondo il quale non si capiva se a parlare fosse stato un uomo o una donna.» Gösta tacque un istante e parve tornare indietro con la mente nel tempo. «A me e al collega Henry Ljung venne ordinato di andare lì e verificare di cosa si trattasse. Arrivammo nel giro di mezz’ora e trovammo qualcosa di molto strano: la tavola in sala da pranzo era apparecchiata e il pasto era stato lasciato a metà, ma non c’era traccia della famiglia che abitava nella casa a eccezione della piccola Ebba di un anno che girava per la stanza completamente sola. Era come se il resto della famiglia si fosse volatilizzato. Come se si fossero alzati nel bel mezzo del pranzo per sparire dalla faccia della terra.» «Puf!» fece Mellberg, ma fu fulminato da un’occhiataccia di Gösta. «Dov’erano tutti gli allievi?» chiese Martin. «La maggior parte era tornata a casa per le vacanze pasquali. Alcuni però si trovavano ancora a Valö e al nostro arrivo non si vedevano in giro, ma dopo un po’ spuntarono cinque ragazzi in una barca. Dissero di essere stati a pesca per qualche ora. Nelle settimane successive furono messi sotto torchio, ma non sapevano niente di cosa fosse successo alla famiglia. Parlai anche io con loro e dicevano tutti la stessa cosa: che non erano invitati al pranzo e che quindi erano usciti a pesca. Quando erano partiti la situazione era normale.» «La barca della famiglia era ancora ormeggiata al pontile?» chiese Patrik. «Sì, e perlustrammo l’isola palmo a palmo, ma sembrava che si fossero volatilizzati.» Gösta scosse la testa. «Quanti erano?» Mellberg sembrava essersi incuriosito suo malgrado e si sporse in avanti per sentire la risposta. «La famiglia era composta da due adulti e quattro figli. Ma una di loro era la piccola Ebba, quindi a sparire furono i due genitori e tre dei ragazzi.» Gösta si girò per scrivere sulla lavagna. «Il padre, Rune Elvander, era il direttore del collegio. Era un vecchio militare e l’aveva aperto con l’idea di offrire una scuola maschile per ragazzi i cui genitori richiedevano un alto livello di istruzione abbinato a una rigida disciplina. Una formazione di prima categoria, regole in grado di plasmare il carattere e attività all’aria aperta per temprare il corpo, il tutto per ragazzini abbienti. Era così che veniva descritta la scuola in un opuscolo informativo, se ricordo bene.» «Caspita, a sentirti sembra che parli degli anni Venti» osservò Mellberg. «Sono sempre esistiti i genitori nostalgici dei bei vecchi tempi ed era esattamente questo che Rune Elvander offriva» rispose Gösta, continuando il resoconto. «La madre di Ebba si chiamava Inez. Al momento della scomparsa aveva ventitré anni, quindi era molto più giovane del marito, che era sulla cinquantina. Rune aveva anche tre figli da un precedente matrimonio: Claes, di diciannove anni, Annelie di sedici e Johan di nove. La loro mamma, Carla, era morta circa un anno prima che Rune si risposasse. Secondo i cinque ragazzi c’era qualche problemino in famiglia, ma non riuscimmo a cavare loro di bocca niente di più.» «Quante persone stavano in collegio quando non era vacanza?» chiese Martin. «Il numero si aggirava sempre intorno alla ventina. Oltre a Rune c’erano due insegnanti, ma erano in ferie anche loro.» «E avevano un alibi, immagino?» Patrik scrutò attentamente Gösta. «Sì. Uno era andato a festeggiare la Pasqua dai parenti, a Stoccolma. L’altro aveva fatto nascere qualche sospetto, all’inizio, perché se ne stava sulle sue e non voleva dire dove si trovava quel giorno, ma poi saltò fuori che era andato in vacanza con il suo partner ed era questo il motivo della sua reticenza. Non voleva che saltasse fuori che era omosessuale e fino a quel momento l’aveva tenuto ben nascosto, all’interno della scuola.» «E gli altri allievi, quelli tornati a casa per le vacanze? Li controllaste tutti?» chiese Patrik. «Fino all’ultimo. E le famiglie confermarono che avevano festeggiato con loro senza avvicinarsi minimamente all’isola. Tutti i genitori sembravano tra l’altro molto soddisfatti dell’influenza positiva esercitata dalla scuola sui figli ed erano molto indispettiti dal fatto che non ci fosse più un collegio in cui mandarli dopo le vacanze. Ebbi l’impressione che molti di loro trovassero faticoso anche solo averli per casa quei pochi giorni.» «Okay. E non trovaste nessun indizio materiale che potesse spiegare cosa fosse successo alla famiglia?» Gösta scosse la testa. «Ovviamente non avevamo né la strumentazione né le competenze di cui si dispone oggi e quindi il sopralluogo tecnico era a un altro livello, ma tutti fecero del proprio meglio, e non c’era niente. Anzi, forse dovrei dire che non trovammo niente. Mi è sempre rimasta la sensazione che ci fosse sfuggito qualcosa, senza saper dire cosa.» «Cosa ne fu della bambina?» chiese Annika, il cui cuore s’inteneriva sempre quando ci andavano di mezzo dei minori. «Non c’erano parenti in vita e quindi Ebba fu sistemata presso una famiglia affidataria di Göteborg. A quanto ne so, in seguito l’adottarono.» Gösta smise di parlare e abbassò lo sguardo sulle mani. «Penso di poter dire che facemmo un buon lavoro. Seguimmo tutte le piste possibili e cercammo di individuare un movente. Scavammo nel passato di Rune senza trovare scheletri negli armadi. Andammo di casa in casa per tutta Fjällbacka per verificare se qualcuno avesse visto qualcosa di insolito. Insomma, affrontammo il caso da ogni direzione possibile, ma non arrivammo da nessuna parte. Senza prove era impossibile determinare se fossero stati uccisi o rapiti o se semplicemente se ne fossero andati di propria volontà.» «Davvero affascinante, questa storia.» Mellberg si schiarì la voce. «Però ancora non capisco perché dovremmo scavarci dentro. Non c’è motivo di complicare inutilmente le cose. O sono stati quella Ebba e il marito ad appiccare il fuoco, oppure sarà uno scherzo di ragazzini.» «Mi sembra un po’ ambizioso come scherzo di una banda di adolescenti annoiati» obiettò Patrik. «Volendo giocare agli incendiari l’avrebbero fatto prima qui nel centro abitato, invece di prendere una barca e andare fino a Valö. E come abbiamo già detto Martin sta indagando la possibilità che si tratti di una truffa ai danni dell’assicurazione. Ma più parliamo di questo caso, più sento che l’incendio ha a che fare con quello che accadde in corrispondenza della sparizione della famiglia.» «Tu e le tue sensazioni» borbottò Mellberg. «Non c’è niente di concreto che punti in quella direzione. So bene che qualche volta i fatti ti hanno dato ragione, ma questa volta sei fuori strada.» Mellberg si alzò, chiaramente soddisfatto di aver pronunciato quella che riteneva essere la perla di saggezza della giornata. Patrik alzò le spalle e lasciò perdere. Era un pezzo che non si curava più di quello che diceva il suo capo, ammesso che l’avesse mai fatto. Distribuì i compiti e chiuse la riunione. Mentre uscivano, Martin lo fermò. «Posso prendermi mezza giornata, oggi pomeriggio? So che è un po’ scarso, come preavviso...» «Certo che puoi, se è importante. Di che si tratta?» Martin sembrò esitare. «Una questione personale. Preferirei non parlarne adesso, se per te va bene.» Qualcosa nella sua voce consigliò a Patrik di non fare domande, anche se lo feriva che il collega non volesse confidarsi con lui. Gli sembrava che negli anni di lavoro fianco a fianco fossero riusciti a costruire un rapporto di fiducia reciproca e che non avesse motivo di tenere per sé cosa non andava. «Non me la sento, adesso» aggiunse lui come se gli avesse letto nel pensiero. «Quindi va bene se esco subito dopo pranzo?» «Certo, tranquillo.» Martin gli rivolse un sorrisino pallido e si voltò per andarsene. «Ah, senti» disse Patrik. «Se vuoi parlare, io sono qui.» «Lo so.» Martin esitò un secondo e poi si avviò lungo il corridoio. Mentre scendeva le scale, Anna sapeva già cosa avrebbe trovato in cucina: Dan, avvolto nella vestaglia lisa e immerso nella lettura del quotidiano con una tazza di caffè in mano. Quando la vide varcare la soglia, s’illuminò. «Buongiorno, amore.» Allungò il collo per farsi dare un bacino. «Buongiorno.» Anna girò il viso. «Ho un alito tremendo» disse con aria di scusa, ma ormai il danno era fatto. Dan si alzò senza una parola e andò a mettere la tazza nel lavandino. Possibile che fosse così difficile? Anna si rendeva conto di fare e dire ogni volta le cose sbagliate. Eppure voleva che tutto tornasse a posto, come in passato. Voleva riavere la spontaneità che li univa prima dell’incidente. Dan stava lavando le tazze e lei si avvicinò e lo circondò con le braccia da dietro appoggiandogli la guancia alla schiena, ma avvertì nel corpo teso solo la frustrazione, che le si trasmise e spazzò via per l’ennesima volta il desiderio di intimità fisica. Difficile dire se e quando si sarebbe presentata una nuova occasione. Lo lasciò andare con un sospiro e si sedette. «Devo ricominciare a lavorare» disse prendendo una fetta di pane e tendendosi verso il coltello del burro. Dan si girò, si appoggiò al piano di lavoro e incrociò le braccia sul petto. «E cosa vorresti fare?» Anna non rispose subito. «Mi piacerebbe gestire un’attività mia» disse alla fine. «Ma è un’idea fantastica! Cos’avevi in mente? Un negozio? Posso dare un’occhiata in giro per vedere se c’è qualche locale libero.» Dan aveva un largo sorriso stampato sulla faccia e in qualche modo il suo entusiasmo fece scemare quello di Anna. Era un’idea sua e non era disposta a dividerla con nessun altro, pur non sapendo spiegare perché. «Voglio farlo da sola» disse, accorgendosi da sola dell’acidità della propria voce. L’espressione allegra di Dan sparì d’incanto. «Okay» disse riprendendo ad armeggiare nel lavandino. Cazzo, cazzo, cazzo. Anna imprecò tra sé e sé chiudendo forte le mani a pugno. «Ho pensato alla possibilità di un negozio, ma in questo caso accetterei anche degli incarichi come arredatrice d’interni, per cercare mobili antichi e così via.» Continuò a chiacchierare cercando di ricoinvolgere Dan, ma lui andò avanti a lavare tazze e bicchieri senza nemmeno rispondere, la schiena rigida e offesa. Anna appoggiò la fetta di pane sul piatto. Le era passato l’appetito. «Esco un attimo» disse salendo a vestirsi. Dan non rispose. «Che piacere averti qui per un pranzetto» disse Pyttan. «Fa piacere a me venire qui a vedere come se la passa l’altra metà del mondo.» Sebastian fece una risatina e assestò a Percy una pacca sulla schiena, così forte da provocargli un involontario colpo di tosse. «Ah be’, non è che ve la passiate poi così male neanche voi.» Percy sorrise tra sé e sé. Pyttan non aveva mai fatto mistero di quello che pensava della sfarzosa villona di Sebastian con due piscine e un campo da tennis che, pur estendendosi su una superficie più ridotta di quella di Fygelsta, non era certo meno costosa. «Il buon gusto non si compra con i soldi» diceva spesso di ritorno da lì, arricciando il naso al pensiero delle cornici d’oro scintillante e degli enormi lampadari di cristallo, e lui era propenso a darle ragione. «Vieni, accomodati» disse accompagnando Sebastian alla tavola che avevano apparecchiato sulla terrazza. In quella stagione Fygelsta era imbattibile. Lo splendido parco si estendeva a perdita d’occhio. Per molte generazioni era stato curatissimo, ma ormai era solo questione di tempo: presto avrebbe cominciato a decadere come il castello. Finché non avesse sistemato la propria situazione economica, Percy avrebbe dovuto cavarsela senza giardiniere. Sebastian si sedette e si appoggiò allo schienale con gli occhiali da sole sollevati sulla fronte. «Un po’ di vino?» Pyttan gli tese una bottiglia di chardonnay di prima classe. Anche se non le era andata a genio l’idea di dovergli chiedere aiuto, Percy sapeva che avrebbe fatto tutto quello che poteva per spianargli la strada. Ormai la decisione era stata presa, anche perché le alternative non erano molte, per non dire nulle. Pyttan riempì il bicchiere a Sebastian che cominciò a mangiare l’antipasto senza neanche aspettare che la padrona di casa augurasse buon appetito a tutti. Dopo essersi infilato in bocca una grossa forchettata di gamberetti alla maionese si mise a masticare a bocca aperta. Percy si accorse che la moglie aveva distolto lo sguardo. «Quindi avete qualche problemino con gli esattori?» «Già, cosa dire? È un disastro.» Percy scosse la testa. «Ormai sembra che non ci sia più niente di sacro.» «Hai proprio ragione. In questo paese non conviene lavorare sodo.» «No. Ai tempi di mio padre era tutto diverso.» Dopo uno sguardo interrogativo a Pyttan, Percy cominciò a tagliare la tartina ai gamberetti. «Uno si aspetta che venga apprezzato tutto lo sforzo fatto per mantenere questo patrimonio culturale. Quello che la nostra famiglia si è assunta l’onere di preservare è un pezzo di storia svedese, e l’abbiamo fatto al meglio.» «Sì, ma adesso soffiano venti diversi» disse Sebastian agitando la forchetta. «Effettivamente quelli socialdemocratici spirano da tempo, ma anche il governo conservatore non ha cambiato niente. Non hai il diritto di possedere più del tuo vicino, e quindi ti porto via tutto quello che hai. Ho dovuto subire anch’io le stesse angherie. Quest’anno ho avuto un conto alquanto salato, ma per fortuna solo su quello che ho qui in Svezia. Bisogna essere furbi e piazzare i propri beni all’estero in modo che il fisco non possa sottrarre quello che uno ha accumulato con il sudore della fronte.» Percy annuì. «Certo, però nel mio caso la maggior parte del capitale ha dovuto essere investita nel castello.» Non era uno stupido. Sapeva di essere stato sfruttato da Sebastian, negli anni. Per lo più gli aveva prestato il castello per organizzare riunioni d’affari con annessa battuta di caccia o pure occasioni di intrattenimento, o ancora per portarci qualcuna delle tante signore di cui si circondava. Si chiese se la moglie sospettasse qualcosa, ma non erano affari suoi. Quanto a lui, Pyttan gli teneva le briglie corte, e poi gli mancava il coraggio per fare cose del genere. Gli altri potevano gestirsi i loro matrimoni come meglio credevano. «L’eredità che ti ha lasciato tuo padre però non era poi così male, no?» osservò Sebastian tendendo ostentatamente il bicchiere verso Pyttan che, senza mostrare quello che pensava, prese la bottiglia e glielo riempì fino all’orlo. «Sì, ma vedi...» Percy cambiò posizione sulla sedia. Parlare di soldi gli causava un enorme disagio. «La manutenzione di un posto come questo ha costi molto alti, che aumentano continuamente. Ormai è tutto carissimo.» Sebastian sogghignò. «Eh già, le necessità quotidiane sono dispendiose.» Squadrò apertamente Pyttan dagli orecchini di diamanti alle scarpe a tacco alto di Louboutin. Poi si rivolse a Percy. «Cosa ti serve?» «Ecco...» Percy tentennò, ma dopo aver lanciato un’occhiata alla moglie prese lo slancio. Doveva risolvere quella faccenda, altrimenti lei avrebbe cominciato a guardarsi intorno per trovare qualcun altro. «Naturalmente si tratta soltanto di un prestito a breve termine.» Seguì un silenzio impacciato che però non sembrò toccare Sebastian, la cui bocca si era atteggiata a un sorrisino. «Ho una proposta» disse lentamente. «Però penso sia meglio che ne parliamo a quattr’occhi, tra vecchi compagni di scuola.» Pyttan sembrava pronta a protestare ma Percy le lanciò un’occhiata insolitamente dura facendole chiudere la bocca. Poi guardò Sebastian, uno sguardo più eloquente delle parole. «Sì, meglio così» disse abbassando la testa. Sebastian sorrideva da orecchio a orecchio. Di nuovo tese il bicchiere verso Pyttan. Dato che quando il sole era allo zenit faceva troppo caldo per lavorare alla facciata, a metà giornata decisero di passare agli interni. «Cominciamo dal pavimento?» chiese Mårten. Stavano ispezionando la sala da pranzo. Ebba diede una tiratina a un lembo di tappezzeria, con il risultato che ne venne giù una grossa striscia. «Non è meglio partire dalle pareti?» «Non sono sicuro che il pavimento tenga: diverse tavole hanno delle parti marce. Temo che dovremo occuparcene per forza prima di poter passare ad altro.» Premette il piede su una tavola che s’imbarcò sotto il suo peso. «Okay, allora che il pavimento sia» disse Ebba infilandosi gli occhiali protettivi. «Come facciamo?» Non aveva niente in contrario all’idea di lavorare duro e faticare lo stesso numero di ore di Mårten, ma il più competente dei due era lui e quindi le toccava fidarsi della sua esperienza. «Facciamo che io prendo la mazza e tu il piede di porco? Secondo me dovrebbe funzionare.» «Va bene.» Ebba si allungò verso l’attrezzo che le stava porgendo Mårten. Poi si misero all’opera. Mentre infilava l’estremità tra le tavole e faceva leva per sollevare il legno sentì l’adrenalina scorrere piacevolmente nelle braccia. Finché metteva alla prova il corpo evitava di pensare. Quando il sudore scorreva e l’acido lattico riempiva i muscoli si sentiva libera, anche se per poco: non era più la mamma di Vincent, ma Ebba, venuta lì a mettere ordine nella sua eredità, demolire e ricostruire da capo. Non pensava neanche all’incendio. Se chiudeva gli occhi ricordava il panico, il fumo che bruciava nei polmoni, il calore intenso che le faceva intuire come si sarebbe sentita se il fuoco le avesse consumato la pelle. E anche la piacevole sensazione data dalla resa finale. Così, con lo sguardo puntato avanti e più energia di quella necessaria per staccare i chiodi arrugginiti dall’armatura sottostante, si concentrò sul proprio compito. Dopo un po’ i pensieri le si insinuarono lo stesso nella mente. Chi aveva voluto loro male e perché? La domanda continuava a rigirarle nella testa ma le riflessioni non portavano a niente. Non c’era nessuno. Solo loro volevano male a se stessi. Molte volte le era capitato di pensare che sarebbe stato meglio non vivere più e sapeva che lo stesso valeva per Mårten. Ma intorno a loro avevano tutti dimostrato tanta solidarietà. Non c’era malevolenza né odio, solo comprensione per quello che avevano passato. Eppure non si poteva prescindere dal fatto che qualcuno si era aggirato di nascosto lì nel buio e aveva voluto farli morire bruciati. I pensieri continuavano a vorticare senza trovare appigli. Ebba si fermò e si asciugò la fronte. «Fa troppo caldo qui» disse Mårten abbattendo la mazza sul pavimento con una forza tale che le schegge volarono da tutte le parti. Era a torso nudo, con la maglietta infilata nella cintura da falegname. «Attento a non farti saltare una scheggia in un occhio.» Ebba studiò il corpo di Mårten illuminato dalla luce del sole che inondava la stanza dalle finestre sporche. Era identico a quando si erano messi insieme: un fisico sottile e segaligno che, nonostante tutta l’attività manuale, non sembrava mettere su un filo di muscoli. Quanto a lei, negli ultimi sei mesi aveva perso le sue forme femminili. L’appetito le era passato del tutto, con la conseguenza che era dimagrita di almeno dieci chili. Non lo sapeva neanche con esattezza, dato che non si curava di pesarsi. Lavorarono per un po’ in silenzio. Una mosca rimbalzava ostinatamente contro un vetro e Mårten andò a spalancare la finestra. Dato che fuori non tirava un filo di vento, non servì a rinfrescare l’ambiente ma almeno, uscita la mosca, non furono più tormentati dall’insistente ronzio. Mentre lavoravano, Ebba avvertiva costantemente la presenza di ciò che era stato. Le pareti erano impregnate della storia della casa. Con gli occhi della mente vedeva tutti i bambini venuti lì in colonia, d’estate, per respirare aria sana e stare in buona salute, come si leggeva su una vecchia copia di Fjällbacka-Bladet che aveva trovato. La casa aveva avuto anche altri proprietari, non ultimo suo padre, ma era soprattutto ai bambini in colonia che le veniva da pensare. Che avventura doveva essere stata lasciare i genitori e ritrovarsi a dormire con bambini sconosciuti. Giornate piene di sole e bagni nell’acqua salata, ordine e disciplina mescolati a giochi e baccano. Riusciva a sentire le risate, ma anche le grida. Nell’articolo si leggeva di una denuncia per maltrattamenti e forse non era stato tutto così idilliaco. A volte si chiedeva se le grida venivano solo dai bambini della colonia o se le emozioni risvegliate dall’edificio si mescolavano a ricordi. C’era qualcosa di familiare e insieme pauroso in quei rumori, anche se all’epoca in cui abitava lì era piccolissima. Se erano ricordi, dovevano appartenere alla casa stessa e non a lei. «Ce la faremo?» chiese Mårten appoggiandosi alla mazza. Ebba era talmente immersa nei suoi pensieri che sentendo la sua voce sobbalzò. Lui si sfilò la maglietta dalla cintura, si asciugò il viso e la guardò. Non volendo incrociare i suoi occhi, lei si limitò a sbirciare dalla sua parte e riprese a far leva su una tavola che non voleva cedere. La domanda sembrava riferirsi alla ristrutturazione, ma Ebba si rese conto che conteneva qualcosa di più. Solo che lei non aveva una risposta. Vedendo che non diceva niente, Mårten riprese in mano la mazza emettendo un verso per lo sforzo ogni volta che colpiva le tavole. Nel pavimento aveva cominciato a formarsi un grosso buco. Mårten sollevò ancora una volta l’attrezzo, ma poi lo riabbassò lentamente. «Ma che c... Vieni a vedere!» disse facendole cenno di avvicinarsi. Ebba continuò a combattere con la tavola che non si smuoveva ma, suo malgrado, s’incuriosì. «Cosa c’è?» chiese andandogli vicino. Mårten indicò il buco. «Cosa ti sembra quello?» Ebba si accovacciò e guardò giù. Poi aggrottò le sopracciglia. Nel punto in cui era stato tolto il pavimento si vedeva una grossa macchia scura. Pece, fu il suo primo pensiero. Poi si rese conto di cosa poteva essere. «Sembra sangue» disse. «Un lago di sangue.» Fjällbacka 1919 Dagmar capiva benissimo che se veniva scelta per servire alle feste dei ricchi non era solo per la sua bravura come cameriera e per il suo bel visetto. I bisbigli non erano mai particolarmente discreti. I padroni di casa si premuravano sempre di spargere rapidamente intorno al tavolo la voce sulla sua identità e ormai lei sapeva riconoscere al volo gli sguardi avidi di sensazionalismo. «Sua madre... la fabbricante di angeli... decapitata...» Le parole fendevano l’aria come piccole vespe e le punture erano dolorose, ma Dagmar aveva imparato a continuare a sorridere e fingere di non sentire. Quella festa non era diversa. Al suo passaggio le teste si avvicinavano e poi facevano cenni allusivi. Una signora si portò scioccata la mano alla bocca e fissò apertamente Dagmar che stava versando il vino nei bicchieri. L’aviatore tedesco osservava con aria perplessa lo scalpore destato dalla cameriera e con la coda dell’occhio lei lo vide avvicinarsi alla sua vicina di tavolo. La donna gli sussurrò qualcosa all’orecchio e Dagmar aspettò la sua reazione con il cuore che batteva forte. Lo sguardo del tedesco si trasformò, ma di colpo lei gli colse un guizzo negli occhi. La studiò calmo per qualche istante e poi sollevò il bicchiere. Lei gli sorrise e sentì impazzire il cuore. Via via che passavano le ore, intorno alla tavola imbandita il volume delle voci aumentava. Il cielo cominciava a scurirsi e, sebbene la serata estiva fosse ancora tiepida, alcuni ospiti cominciarono a ritirarsi all’interno per continuare a brindare nel salone. I signori Sjölin erano generosi e anche l’aviatore sembrava aver mandato giù una buona dose di alcolici. Dagmar gli aveva riempito più volte il bicchiere con la mano tremante, sorpresa della propria reazione. Aveva conosciuto molti uomini, alcuni dei quali di gran classe. Diversi sapevano cosa dire e come toccare una donna, ma nessuno aveva mai scatenato in lei le vibrazioni che provava nel ventre. Al giro successivo, mentre lo serviva lui le sfiorò la mano. Nessuno sembrò accorgersene e Dagmar si fece forza per mantenere un’espressione neutra, ma raddrizzò le spalle spingendo in fuori il seno. «Wie heissen Sie?» chiese lui fissandola con gli occhi lucidi. Dagmar lo guardò interrogativa. Lo svedese era l’unica lingua che parlasse. «Come si chiama?» biascicò l’uomo seduto di fronte. «Vuole sapere il suo nome, signorina. Lo dica all’aviatore, così magari dopo viene a sedersi un po’ sulle mie ginocchia per sentire com’è un vero uomo...» Rise alla propria battuta e si batté le grasse cosce. Dagmar arricciò il naso e rivolse di nuovo lo sguardo al tedesco. «Dagmar» disse. «Mi chiamo Dagmar.» «Dagmar» ripeté lui. Poi indicò il proprio petto con un gesto enfatico. «Hermann» disse. «Ich heisse Hermann.» Dopo un breve silenzio alzò una mano e le toccò la nuca, facendole sollevare tutti i peli delle braccia. Poi disse di nuovo qualcosa in tedesco e lei guardò il ciccione di fronte. «Ha detto che gli piacerebbe sapere che aspetto hanno i suoi capelli quando li scioglie.» L’uomo scoppiò di nuovo a ridere, come se la cosa fosse esilarante. D’istinto, Dagmar portò la mano alla crocchia sulla nuca. I capelli biondi erano così folti che non riusciva mai a tenerli a bada e qualche ciocca riusciva sempre a sfuggire al pettine. «Che continui pure a chiederselo. Glielo dica» rispose girandosi per andarsene. Ridendo, il ciccione disse diverse lunghe frasi. Il tedesco invece non rise, ma le mise di nuovo una mano sulla nuca. Con un gesto fulmineo le sfilò il pettine dalla crocchia e i capelli le ricaddero sulla schiena. Lei si voltò, lenta e rigida. Per qualche istante il suo sguardo e quello dell’aviatore tedesco rimasero agganciati, accompagnati dalle grasse risate del ciccione. Tra di loro fu suggellato un tacito patto e poi, ancora con i capelli sciolti sulla schiena, Dagmar risalì verso la casa da cui provenivano le voci sguaiate degli invitati che disturbavano la quiete della notte estiva. Patrik si accovacciò davanti al grosso buco. Le assi erano vecchie e imputridite, ma quello che c’era sotto era tanto più sorprendente. Avvertì uno sgradevole nodo allo stomaco. «Avete fatto bene a chiamare subito» disse senza distogliere lo sguardo. «È sangue, vero?» Mårten deglutì. «Non che io sappia che aspetto ha il sangue vecchio... potrebbe anche essere pece o qualcosa del genere. Ma considerato che...» «Sì, ha tutta l’aria di esserlo. Puoi chiamare la scientifica, Gösta? Bisogna che vengano qui i tecnici a verificare.» Patrik si alzò, facendo una smorfia quando le giunture scrocchiarono ricordandogli che non stava ringiovanendo. Gösta annuì e si spostò componendo il numero sul telefono. «Può esserci... altro, là sotto?» chiese Ebba con voce tremante. Patrik capì subito a cosa si riferiva. «Impossibile a dirsi. Ci toccherà rompere il resto del pavimento e controllare.» «In effetti ci serviva un aiutino per la demolizione, anche se non era proprio quello che avevamo pensato» disse Mårten accennando una risata, ma nessuno si unì a lui. Gösta aveva finito di telefonare e raggiunse il gruppetto. «I tecnici non riescono a venire prima di domani. Spero non sia un problema per voi. Dovrete lasciare tutto esattamente com’è, senza sistemare o mettere in ordine.» «Non toccheremo niente. Perché dovremmo?» disse Mårten. «Appunto. Secondo me potrebbe essere l’occasione giusta per sapere cosa successe.» «Che ne dite di sederci e parlarne un po’?» Patrik arretrò dalla parte demolita del pavimento, ma l’immagine gli era rimasta impressa sulla retina. Per quanto lo riguardava, era certo che fosse sangue. Una spessa pellicola di sangue ormai secco, non più rosso ma scurito dal tempo. Se le sue supposizioni erano giuste, risaliva a oltre trent’anni prima. «Possiamo metterci in cucina. Almeno lì c’è un po’ d’ordine» disse Mårten precedendolo. Ebba rimase dov’era. «Vieni?» Mårten si voltò a guardarla. «Andate pure. Noi vi raggiungiamo» disse Gösta. Patrik stava per obiettare che era soprattutto con Ebba che avevano bisogno di parlare ma poi si accorse del suo pallore e capì che il collega aveva ragione: le serviva un po’ di tempo, e dopotutto non avevano fretta. Che la cucina fosse abbastanza in ordine era un eufemismo. Dappertutto si vedevano attrezzi e pennelli e il piano di lavoro era ingombro di piatti sporchi e dei resti della colazione. Mårten si sedette. «In realtà siamo dei tipi pignoli, Ebba e io. Anzi, lo eravamo» si corresse. «Difficile a credersi, eh?» «Ristrutturare una casa è sempre un inferno» rispose Patrik spazzando via qualche briciola da una sedia e accomodandosi a sua volta. «Adesso l’ordine non sembra più così importante.» Mårten guardò fuori dalla finestra della cucina coperta da uno strato di polvere, come se un velo fosse calato sul panorama. «Cosa sai del passato di Ebba?» chiese Patrik. Sentiva gli altri due parlare in sala da pranzo ma, per quanto tendesse le orecchie, non riusciva a distinguere cosa dicevano. Il comportamento di Gösta lo lasciava perplesso. Anche prima, alla stazione, quando era corso a dirgli quello che era successo, la sua reazione non era stata da lui. Poi si era chiuso come una cozza e non aveva detto una parola per tutto il tragitto fino a Valö. «I miei e i genitori adottivi di Ebba sono amici e il suo passato non è mai stato un segreto, per cui so da tempo che la sua famiglia sparì inspiegabilmente. Non credo ci sia molto altro da sapere.» «Infatti. L’indagine non portò a nessuna conclusione, sebbene fossero stati investiti molto tempo e molte energie per scoprire cosa fosse accaduto. È un vero mistero che siano potuti sparire così.» «Forse sono qui da sempre?» La voce di Ebba li fece trasalire. «Non penso che si trovino lì sotto» disse Gösta dalla soglia. «Se qualcuno avesse manomesso il pavimento ce ne saremmo accorti. Invece era intatto e neanche si vedevano tracce di sangue. Deve essere filtrato dalle fessure.» «Io comunque voglio essere sicura che non si trovino lì» insistette Ebba. «Domani i tecnici passeranno in rassegna ogni millimetro, stanne certa» disse Gösta circondandole le spalle con un braccio. Patrik lo fissò incredulo. Era raro che il suo anziano collega si sforzasse più del necessario e non gli sembrava proprio di ricordare di averlo mai visto toccare un’altra persona. «Hai bisogno di bere un po’ di caffè forte» aggiunse Gösta dandole una pacchetta sulla spalla, per poi mettersi ad armeggiare intorno alla macchina. Quando il caffè cominciò a filtrare, andò al lavandino e lavò qualche tazza. «Potresti raccontarci quello che sai di quanto accadde qui?» chiese Patrik a Ebba scostandole una sedia. Quando la donna si sedette si accorse di quanto fosse magra. La maglietta le pendeva addosso e le clavicole si delineavano nette sotto la stoffa. «Penso di non essere in grado di raccontare niente che la gente qui intorno non abbia già sentito. Avevo poco più di un anno quando sparirono e di conseguenza non ho ricordi. Neanche i miei genitori adottivi sanno niente, se non che qualcuno chiamò la polizia dicendo che era successo qualcosa qui. Quando arrivarono gli agenti la mia famiglia era sparita e io mi trovavo qui da sola. Era la vigilia di Pasqua.» Tirò fuori la catenina che era rimasta sotto la maglietta e si mise a giocherellare con il ciondolo come Patrik le aveva già visto fare un paio di giorni prima, un gesto che la faceva apparire ancora più fragile. «Ecco qui.» Gösta le mise davanti una tazza dopo averne versata una anche per sé, e poi si sedette. Patrik non riuscì a trattenere un sorriso. Era decisamente da lui. «Non avresti potuto versarne un po’ anche a noi, visto che c’eri?» «Perché, ti sembro un cameriere?» Mårten si alzò. «Faccio io.» «È vero che quando la tua famiglia sparì non avevi altri parenti in vita?» chiese Patrik. Ebba annuì. «Sì. Mia madre era figlia unica e la nonna era morta prima che io compissi un anno. Mio padre era molto più anziano e i suoi se n’erano andati da tempo. L’unica famiglia che ho è quella adottiva. In un certo senso ho avuto fortuna. Berit e Sture mi hanno sempre fatto sentire come se fossi loro figlia.» «Qui a scuola erano rimasti alcuni ospiti del collegio, durante le vacanze. Hai mai avuto contatti con qualcuno di loro?» «No, perché avrei dovuto?» Nel viso magro gli occhi di Ebba sembravano enormi. «Non abbiamo avuto niente a che vedere con questo posto fino al momento in cui abbiamo deciso di trasferirci qui» intervenne Mårten. «Ebba ha ereditato la proprietà dopo la dichiarazione di morte presunta dei suoi genitori biologici, ma per diversi periodi è stata affittata, mentre in altri è rimasta vuota. Insomma, è per questo che stiamo affrontando la ristrutturazione: finora nessuno si è mai preso cura della casa. Ci si è limitati a rimediare ai guai più grossi.» «C’è un senso nel fatto che siamo venuti qui e abbiamo cominciato a demolirla» disse Ebba. «Tutto ha un senso.» «Davvero?» sbottò Mårten. «Ne siamo sicuri?» Ma Ebba non rispose e quando il marito accompagnò alla porta i poliziotti rimase seduta, in silenzio. Mentre si lasciavano alle spalle Valö, Patrik si fece la stessa domanda. A cosa avrebbe portato l’eventuale conferma della presenza di sangue sotto il pavimento? Il reato era andato in prescrizione. Erano passati molti anni e non era garantito che saltassero fuori delle risposte. E dunque qual era il senso di quella scoperta? Con la mente ingombra di pensieri irrequieti, puntò la prua verso casa. Quando il medico smise di parlare, nella stanza scese il silenzio. Martin sentiva solo il martellare del proprio cuore. Guardò il dottore. Come faceva a mantenere quell’espressione indifferente dopo quanto aveva appena detto? Faceva comunicazioni come quella diverse volte la settimana? E se era così, come resisteva? Si costrinse a respirare. Gli sembrava di avere dimenticato come si faceva. Ogni respiro richiedeva un atto consapevole, un’istruzione precisa inviata dal cervello. «Quanto?» riuscì a chiedere. «Ci sono diverse terapie e la ricerca scientifica progredisce continuamente...» Il medico spalancò le braccia. «Statisticamente la prognosi qual è?» domandò ancora Martin sforzandosi di mantenere la calma anche se avrebbe voluto gettarsi sulla scrivania, afferrarlo per il bavero e fargli sputare la risposta a scossoni. Pia non aveva aperto bocca e Martin non era ancora riuscito a guardarla. Se l’avesse fatto, il mondo sarebbe andato in pezzi. Doveva solo concentrarsi sui dati concreti. Su qualcosa di afferrabile a cui aggrapparsi. «Non si può dire con certezza. Gli elementi in gioco sono molti.» La stessa espressione dispiaciuta, le braccia spalancate. Martin detestava quel gesto. «Ma risponda una buona volta!» gridò sobbalzando al suono stesso della propria voce. «Cominceremo subito con le terapie e vedremo come risponderà Pia. Ma considerando la diffusione e l’aggressività apparente del cancro... insomma, direi che si va dai sei ai dodici mesi.» Martin lo fissò. Aveva sentito bene? Tuva non aveva neanche due anni. Non poteva perdere la sua mamma. Non potevano succedere cose del genere. Cominciò a tremare. Nella stanzina faceva un caldo terribile, eppure stava battendo i denti. Pia gli appoggiò una mano sul braccio. «Calmati, Martin. Dobbiamo restare calmi. C’è sempre una possibilità che non sia così e io farò qualsiasi cosa...» Si rivolse al dottore. «Voglio una terapia d’urto. Ho intenzione di combattere.» «La ricoveriamo subito. Vada a casa e faccia la valigia. Noi intanto le prepariamo un posto.» Martin si vergognò. Pia era forte e lui stava per crollare. Nella mente gli vorticavano immagini di Tuva dall’attimo in cui era nata a quella mattina, quando giocava con loro nel lettone. I capelli scuri le volavano intorno alla testa e gli occhi traboccavano di risate. Possibile che dovessero spegnersi, che la sua bambina dovesse perdere la voglia di vivere, la fiducia nel fatto che andava tutto bene e che il domani sarebbe stato anche meglio? «Ce la faremo.» Pia era grigiastra in viso ma mostrava una determinazione che, lo sapeva, poggiava su una caparbietà senza uguali che le sarebbe servita per la battaglia più importante della sua vita. «Adesso passiamo a prendere Tuva da mia madre e andiamo in pasticceria» disse alzandosi. «Parleremo tranquilli dopo che l’avremo messa a letto. E poi farò la valigia. Quanto tempo devo calcolare di stare via di casa?» Martin si alzò su gambe malferme. Quell’attenzione agli aspetti pratici era proprio da lei. Il medico esitò. «Faccia conto di stare qui per un po’.» Li salutò e poi passò al paziente successivo. Martin e Pia si ritrovarono nel corridoio. In silenzio, si presero per mano. «Ma come, metti il succo di frutta nel biberon? Non pensi ai dentini?» Kristina guardò con aria di disapprovazione Anton e Noel che, seduti sul divano, succhiavano tranquilli. Erica inspirò profondamente. Sua suocera non aveva cattive intenzioni ed era anche molto migliorata, ma a volte la metteva davvero a dura prova. «Ho provato con l’acqua, ma non vogliono saperne. E con questo caldo devono bere. Però l’ho diluito parecchio.» «Bah, fai come vuoi. Io comunque te l’ho detto. A Patrik e Lotta ho sempre dato l’acqua e andava a meraviglia. Non hanno avuto neanche una carie finché non sono andati via di casa e il dentista si complimentava sempre con me per i loro denti perfetti.» Erica si morse una nocca. Per fortuna era in cucina a rassettare e Kristina non la vedeva. A piccole dosi poteva sopportarla e con i bambini era molto brava, ma quando come quel giorno si fermava per diverse ore di seguito era davvero uno strazio. «Mi sa che vado ad avviare la lavatrice, Erica» disse la suocera a voce alta, per poi continuare, come parlando tra sé e sé. «È più facile se si sistema un po’ alla volta tenendo tutto in ordine, perché almeno non si formano tutti questi mucchi. Ogni cosa al suo posto, e poi si rimette sempre lì, e poi ormai Maja è abbastanza grande da cominciare a riordinare dopo aver tirato fuori i giochi, altrimenti poi diventa uno di quegli adolescenti viziati che non si decidono mai ad andare a stare per conto loro e che si aspettano di essere serviti e riveriti. La mia amica Berit, sai... suo figlio ha quasi quarant’anni eppure...» Erica si ficcò le dita nelle orecchie, si appoggiò a un pensile e si mise a battere piano la testa contro la superficie fresca del legno, invocando pazienza. Un tocco deciso sulla spalla le fece fare un salto. «Cosa stai facendo?» Kristina era di fianco a lei con una bacinella piena di panni accanto ai piedi. «Ti ho chiamato e non mi rispondevi.» Ancora con gli indici nelle orecchie, Erica cercò di farsi venire in mente una scusa plausibile. «Io... io sto compensando.» Si chiuse il naso e soffiò forte. «Ultimamente ho avuto un po’ di problemi alle orecchie.» «Ah, caspita» disse la suocera. «Sono cose che vanno prese sul serio. Hai verificato che non sia otite? Andando al nido i bambini portano a casa ogni genere di infezione. L’ho sempre detto, io, che mandarceli non è affatto una buona idea. Io sono stata a casa con Patrik e Lotta fino a quando non sono andati alle medie. Non hanno dovuto passare un solo giorno al nido o con qualche baby sitter e non sono mai stati malati. Infatti il pediatra si complimentava sempre...» Erica la interruppe un po’ troppo bruscamente. «Veramente i bambini non ci vanno da settimane, quindi dubito che il problema sia il nido.» «Va be’, va be’» fece Kristina con espressione ferita. «Comunque, io te l’ho detto. E so anche chi chiamate quando i bambini si ammalano e voi dovete lavorare. Sono io quella che deve mettersi a disposizione.» Con uno scatto del mento, partì con il bucato. Erica contò lentamente fino a dieci. Certo, non poteva negare che la suocera dava una grossa mano, ma spesso il prezzo da pagare era alto. Quando la madre aveva inaspettatamente scoperto di essere incinta, entrambi i genitori di Josef avevano superato la quarantina. Ormai si erano riconciliati da anni con l’idea che non avrebbero potuto avere figli e di conseguenza avevano organizzato la propria vita a partire da quella certezza, dedicando il loro tempo alla piccola sartoria di Fjällbacka. L’arrivo di Josef aveva cambiato tutto e alla gioia di avere un figlio si era accompagnato l’obbligo morale di trasmettere ai posteri la propria storia per suo tramite. Josef guardò affettuosamente la loro foto all’interno della spessa cornice d’argento che teneva sulla scrivania. Dietro c’erano quelle di Rebecka e dei figli. Lui era sempre stato il perno attorno a cui ruotava la vita dei genitori e loro lo sarebbero sempre stati per lui. La sua famiglia doveva accettarlo. «Tra poco è pronto.» Rebecka entrò piano nello studio. «Non ho fame. Voi mangiate pure» disse senza nemmeno alzare gli occhi. Aveva cose ben più importanti da fare. «Non potresti venire, visto che ci sono qui i ragazzi?» Josef la guardò sorpreso. Era raro che insistesse. Provò un moto d’irritazione ma fece un respiro profondo. Aveva ragione. I figli non venivano più tanto spesso. «Arrivo» disse con un sospiro, chiudendo il blocco pieno di idee su come dar forma al progetto. Se lo portava sempre dietro, nel caso gli venisse in mente qualcosa da aggiungere. «Grazie» disse Rebecka. Poi girò sui tacchi e uscì. Josef la seguì. In sala da pranzo era già apparecchiato. Notò che la moglie aveva tirato fuori il servizio buono. Aveva un po’ la tendenza all’ostentazione e in realtà non gli piaceva che ne facesse sfoggio davanti ai figli, ma lasciò perdere. «Ciao, papà» disse Judith dandogli un bacio sulla guancia. Daniel si alzò e andò ad abbracciarlo. Per un attimo Josef sentì il cuore riempirsi di orgoglio e desiderò che suo padre avesse potuto veder crescere i nipoti. «Sediamoci, prima che la cena si raffreddi» disse mettendosi a capotavola. Rebecka aveva cucinato il piatto preferito di Judith: pollo arrosto con il purè. Di colpo Josef si accorse di quanta fame aveva e si rese conto di aver saltato il pranzo. Dopo aver mormorato la benedizione, Rebecka riempì i piatti e cominciarono a mangiare in silenzio. Una volta placata la prima fame, Josef mise giù le posate. «Gli studi vanno bene?» Daniel annuì. «Ho avuto il massimo dei voti in tutti gli esami del corso estivo. Adesso devo solo procurarmi un buon posto per il tirocinio di quest’autunno.» «E io mi trovo benissimo al lavoro» s’inserì Judith. Gli occhi sprizzavano entusiasmo. «Dovresti vedere come sono coraggiosi i bambini, mamma. Devono sottoporsi a operazioni molto dure e a lunghe radioterapie e a tutto l’immaginabile, eppure non si lamentano e non si arrendono. Sono incredibili.» Josef inspirò profondamente. I successi dei figli non diminuivano l’ansia da cui era sempre accompagnato. Sapeva che avevano ancora qualcosa da dare, un gradino in più da salire. Avevano tanto con cui confrontarsi e da cui riscattarsi, ed era compito suo assicurarsi che facessero sempre del loro meglio. «E la ricerca? Riesci a seguire anche quella, spero.» Inchiodò Judith con lo sguardo e vide l’entusiasmo spegnersi lentamente nei suoi occhi. Si vedeva che voleva la sua approvazione e le sue lodi, ma se avesse dato loro l’impressione che quello che facevano fosse abbastanza avrebbero smesso di impegnarsi. E non doveva accadere. Non attese nemmeno la risposta di Judith e si rivolse a Daniel. «La settimana scorsa ho parlato con il tuo referente e mi ha detto che hai perso due giornate dell’ultimo corso. Come mai?» Josef vide con la coda dell’occhio che Rebecka lo guardava deluso, ma non poteva farci niente. Più lei li coccolava, maggiore era la responsabilità che cadeva sulle sue spalle per guidarli nella direzione giusta. «Avevo un virus gastrointestinale» rispose Daniel. «Non sarebbe stato il massimo se mi fossi messo a vomitare in un sacchetto in mezzo all’aula.» «Vuoi fare lo spiritoso?» «No, era solo una risposta sincera.» «Sai bene che vengo sempre a sapere la verità» disse Josef, le posate ancora appoggiate sul piatto. Aveva perso l’appetito. Detestava non avere più il controllo sui figli come quando vivevano con loro. «Avevo un virus» ripeté Daniel abbassando gli occhi. Sembrava fosse passata la fame anche a lui. Josef si alzò di scatto. «Ho del lavoro da sbrigare.» Quando si rifugiò nello studio pensò che probabilmente erano contenti di esserselo tolto di torno. Sentiva oltre la porta le loro voci e l’acciottolio di stoviglie. Poi Judith rise forte, una risata liberatoria che penetrò attraverso il legno e risuonò forte come se lei gli fosse seduta di fianco. Di colpo si rese conto che la gioia dei ragazzi si smorzava non appena lui entrava nella stanza. Judith rise di nuovo e gli sembrò che un coltello gli venisse rigirato nel cuore. Con lui non aveva mai riso così, e gli venne da chiedersi se sarebbe potuto essere diverso. Ma non sapeva come sarebbe potuto succedere. Voleva un bene dell’anima a entrambi, eppure non poteva essere il padre che desideravano ma solo quello che gli aveva insegnato a essere la vita, amandoli a modo suo e trasmettendo loro il proprio retaggio. Gösta fissava lo sfarfallio del televisore. Sullo schermo si muovevano delle persone e dato che stava guardando L’ispettore Barnaby sicuramente qualcuno sarebbe stato ucciso. Ma era un pezzo che si era perso nei meandri della trama. I pensieri erano da tutt’altra parte. Sul tavolino davanti a lui c’era un piattino con due fette di pane Skogaholm imburrato, con il salame. Praticamente a casa non mangiava altro. Era troppo squallido e impegnativo cucinare solo per sé. Il divano cominciava a invecchiare, ma non se la sentiva di buttarlo via. Ricordava l’orgoglio di Maj-Britt quando era stato consegnato. L’aveva sorpresa più volte a passare una mano sulla lucida stoffa fiorata come se stesse accarezzando un micino. Per tutto il primo anno sì e no gli aveva concesso di sedercisi. La bambina, invece, poteva saltarci e scivolarci sopra. Maj-Britt la teneva per le manine sorridendo mentre lei rimbalzava sempre più in alto sull’imbottitura a molle. Ormai la stoffa era opaca e logora, con grossi buchi. In un punto, proprio di fianco al bracciolo destro, spuntava una molla. Tanto, lui si sedeva sempre nell’angolo sinistro. Era il suo lato, mentre il destro era di Maj-Britt. La sera, quell’estate, la bambina stava seduta in mezzo. Non aveva mai guardato la televisione prima d’allora e quindi strillava, esaltatissima, appena succedeva qualcosa. Il suo programma preferito era Il coccodrillo Gena: quando lo guardava non riusciva a stare ferma e per la gioia rimbalzava sul posto. Ormai era un pezzo che nessuno saltava più su quel divano. Quando era partita, sembrava quasi che si fosse portata via ogni slancio nei confronti della vita e le serate si erano fatte silenziose. Nessuno dei due aveva immaginato che il rimorso potesse fare tanto male. Erano convinti di aver agito bene e quando si erano resi conto di aver ragionato nella maniera sbagliata era troppo tardi. Gösta fissò lo sguardo vuoto sull’ispettore Barnaby, che aveva appena trovato l’ennesimo cadavere. Prese una delle due fette di pane e ne staccò un morso. Era una sera uguale a tante. E altre ne sarebbero seguite. Fjällbacka 1919 Non potevano vedersi nel dormitorio dei domestici e quindi Dagmar aspettò da lui il segnale per raggiungerlo in camera sua. Era stata lei a preparargli la stanza e fargli il letto, ignara del fatto che, qualche ora dopo, avrebbe provato un tale bruciante desiderio di scivolare sotto quelle belle lenzuola di cotone. Quando ricevette il segnale atteso la festa era ancora in pieno svolgimento. Lui era un po’ malfermo sulle gambe, con i capelli biondi tutti spettinati e gli occhi resi lucidi dell’alcol, ma non tanto ubriaco da non riuscire a passarle senza farsi notare la chiave della sua camera. Il breve contatto con la mano le fece accelerare i battiti e, senza guardarlo, Dagmar la nascose nella tasca del grembiule. A quell’ora nessuno si sarebbe accorto della sua assenza. Sia i padroni di casa che gli altri ospiti erano troppo ubriachi per curarsi di qualcosa che non fosse il bicchiere sempre pieno, e per occuparsene bastavano i domestici rimasti. Prima di aprire la camera degli ospiti più grande si guardò comunque intorno e, una volta entrata, si appoggiò con la schiena alla porta e fece diversi respiri profondi. La sola vista del letto con le lenzuola bianche accuratamente ripiegate le fece formicolare il corpo. Lui sarebbe arrivato da un momento all’altro e quella consapevolezza la indusse a correre nel bagnetto per lisciarsi i capelli, togliersi la divisa della servitù e lavarsi rapidamente sotto le ascelle. Poi si morse le labbra e si pizzicò le guance per farle diventare rosse come andava di moda tra le ragazze di città. Quando sentì qualcuno afferrare la maniglia si affrettò a tornare in camera e sedersi sul letto, in sottoveste, e si drappeggiò i capelli sulle spalle, consapevole dell’effetto che avrebbero fatto illuminati dalla luce tenue della notte estiva che penetrava dalla finestra. Non rimase delusa. Quando lui la vide, sbarrò gli occhi e si richiuse velocemente la porta alle spalle. Dopo averla guardata per qualche istante si avvicinò al letto, le mise una mano sotto il mento e le sollevò il viso. Poi si chinò e le loro labbra s’incontrarono in un bacio. Delicatamente, quasi prendendosi gioco di lei, le infilò la punta della lingua tra le labbra socchiuse. Dagmar rispose smaniosa ai baci. Non aveva mai provato niente del genere e le sembrava che quell’uomo fosse stato inviato da un qualche potere divino per congiungersi con lei e renderla un’entità completa. Per un breve istante le calò davanti agli occhi un velo nero, uno schermo su cui balenarono immagini del suo passato. I bambini che venivano immersi in un catino con un peso sul corpo finché non smettevano di muoversi. I poliziotti che irrompevano in casa portando via i suoi genitori. I piccoli cadaveri dissotterrati in cantina. La megera e il marito. Gli uomini che gemevano su di lei con l’alito che puzzava di alcol e fumo. Tutti quelli che l’avevano sfruttata e derisa... Era venuto il momento di inchinarsi davanti a lei e chiederle scusa. Quando l’avessero vista camminare a fianco del giovane eroe si sarebbero pentiti di ogni parola che avevano sussurrato alle sue spalle. Lentamente, lui le sollevò la sottoveste sul ventre e Dagmar alzò le braccia per aiutarlo a sfilargliela. Non desiderava altro che sentire la sua pelle contro la propria. Un bottone dopo l’altro gli slacciò la camicia e poi lui se la tolse. Quando tutti i vestiti furono in un mucchietto sul pavimento lui le si stese addosso. Non c’era più niente che si frapponesse tra loro. Quando si congiunsero, Dagmar chiuse gli occhi. In quel momento non era più la figlia della fabbricante di angeli ma una donna finalmente benedetta dalla sorte. Erano settimane che si preparava. Fissare un’intervista con John Holm a Stoccolma si era rivelata un’impresa, ma visto che sarebbe venuto a Fjällbacka in vacanza Kjell era riuscito, a forza di insistere, a strappargli un’ora per tracciare un suo ritratto per il Bohusläningen. Sapeva che John conosceva di nome suo padre, Frans Ringholm, perché era stato uno dei fondatori degli Amici della Svezia, il partito di cui era l’attuale rappresentante. Le simpatie neonaziste erano uno dei tanti motivi per cui Kjell aveva preso le distanze da suo padre. Solo subito prima che morisse si erano avvicinati, arrivando a una specie di riconciliazione, ma con le sue opinioni politiche non si sarebbe mai riconciliato, e lo stesso valeva per gli Amici della Svezia e i recenti successi ottenuti dal partito. Avevano fissato l’appuntamento al capanno da pesca di John e nel traffico estivo il percorso da Uddevalla a Fjällbacka aveva richiesto quasi un’ora. Parcheggiò sullo spiazzo davanti al capanno con dieci minuti di ritardo, sperando che non fossero decurtati dall’ora concordata per l’intervista. «Per evitare che non ce ne sia il tempo alla fine, magari fai qualche scatto mentre noi parliamo» disse al collega quando scesero dall’auto. Sapeva che non ci sarebbero stati problemi: Stefan era il fotografo più esperto del giornale e faceva sempre un ottimo lavoro, a prescindere dalle difficoltà. «Benvenuti!» John venne loro incontro. «Grazie» rispose Kjell. Dovette fare uno sforzo per stringere la mano tesa. Oltre a detestare le sue opinioni, sapeva che era uno degli uomini più pericolosi del Paese. John li precedette nel capanno per poi uscire dalla parte opposta, sul piccolo pontile. «Non ho mai conosciuto suo padre, ma so che era un uomo che incuteva rispetto nelle persone.» «Già. Qualche anno in carcere può avere quell’effetto.» «Non dev’essere stato facile crescere in condizioni del genere» disse John sedendosi sui mobili da giardino sistemati a ridosso della barriera antivento. Per un attimo, Kjell ebbe un moto d’invidia. Gli sembrava una vera ingiustizia che un uomo come John Holm avesse un posticino così bello, con vista sul porto e sull’arcipelago. Per nascondere l’avversione che probabilmente gli si leggeva chiara in viso si sedette di fronte a John e si mise ad armeggiare con il registratore. Sapeva benissimo che la vita era ingiusta e, a quanto aveva capito facendo qualche ricerca su di lui, Holm era semplicemente nato con la camicia. Il registratore partì. Sembrava che funzionasse tutto a dovere e Kjell cominciò con le domande. «Da cosa pensa che dipenda il vostro recente ingresso in parlamento?» Era sempre meglio andarci piano, all’inizio. Sapeva anche di essere fortunato ad averlo davanti da solo. A Stoccolma sarebbero sicuramente stati presenti l’addetto stampa e altri personaggi. Lì invece c’erano solo loro due e probabilmente, essendo in vacanza e per giunta nel suo territorio, il leader del partito era più rilassato. «Credo che il popolo svedese sia maturato. Siamo diventati più consapevoli del mondo che ci circonda e di come ne siamo influenzati. Per molto tempo siamo stati troppo ingenui ma ora ci siamo svegliati e gli Amici della Svezia hanno la prerogativa di essere una voce della ragione al centro di questo risveglio» rispose John sorridendo. Kjell capiva molto bene perché le persone ne venissero attirate. Aveva uno charme e una sicurezza che inducevano a credere a quello che diceva. Lui però era troppo temprato per farsi incantare e il modo in cui il politico usava i verbi alla prima persona plurale per sé e il popolo svedese lo infastidiva moltissimo. John Holm non era certo il rappresentante degli svedesi, che non erano caduti così in basso. Continuò facendo domande innocue: che sensazione si provava a fare ingresso in parlamento, come erano stati accolti, che forme aveva assunto il lavoro politico nella capitale. Stefan girava intorno a loro scattando continuamente e Kjell prevedeva già le foto: John Holm seduto sul suo pontile privato con il mare che scintillava sullo sfondo. Immagini completamente diverse rispetto a quelle severe che si vedevano di solito sui quotidiani in cui compariva in giacca e cravatta. Diede un’occhiata all’orologio. Erano già trascorsi venti minuti dell’ora concordata e l’atmosfera era piacevole, se non proprio cordiale. Era il momento di partire con le domande vere. Durante le settimane passate da quando avevano fissato l’appuntamento, Kjell si era letto innumerevoli articoli su John Holm e visto una quantità di registrazioni di dibattiti televisivi. Molti giornalisti lavoravano a uno standard bassissimo. Grattavano solo la superficie e se, contro ogni previsione, facevano una domanda sensata, evitavano di mettere alle strette John Holm scendendo in profondità e si limitavano a prendere per buone le sue risposte tranchant, spesso basate su statistiche erronee e vere e proprie bugie. A volte si vergognava di essere un giornalista, ma a differenza di molti suoi colleghi lui si era preparato, e molto bene. «La vostra proposta di bilancio si basa sugli ingenti risparmi che secondo voi deriverebbero alla società se si fermasse l’immigrazione, e cioè settantotto miliardi di corone. Come siete arrivati a determinare questa somma?» John si irrigidì. Una ruga tra le sopracciglia lasciò trasparire una leggera irritazione, ma sparì in fretta per essere sostituita dal consueto sorriso affabile. «I calcoli poggiano su basi molto solide.» «Ne è sicuro? In realtà diversi fattori portano a ritenere che siano conteggi errati. Le faccio un esempio: voi sostenete che solo il dieci per cento di coloro che immigrano in Svezia trovi un lavoro.» «Certo, è corretto. Tra le persone che accogliamo nel nostro Paese vige un tasso di disoccupazione altissimo, che per la società comporta costi immensi.» «Ma dalle statistiche che ho consultato risulta che il sessantacinque per cento degli immigrati tra i venti e i sessantaquattro anni ha un lavoro.» John Holm rimase in silenzio e Kjell vide che il cervello andava a mille. «La percentuale che ho io è il dieci» disse alla fine. «Però non sa come è stata calcolata?» «No.» Kjell si accorse di cominciare a godere di quella situazione. «I vostri calcoli partono inoltre dal presupposto che, nel caso di un blocco dell’immigrazione, la società risparmierebbe in maniera incisiva grazie alla diminuzione dei costi dell’assistenza sociale. Tuttavia uno studio che ha preso in esame il decennio dal 1980 al 1990 mostra che le entrate fiscali derivanti dal contributo degli immigrati superano di gran lunga i costi sopportati dallo Stato per l’immigrazione.» «Non mi sembra molto credibile» rispose il leader con un sorriso storto. «Il popolo svedese non si fa più incantare da queste indagini bluff. È noto a tutti che gli immigrati sfruttano il sistema assistenziale.» «Ho qui una copia dello studio. Può tenerla ed esaminarla più a fondo, se vuole.» Kjell tirò fuori un fascio di fogli e glielo mise davanti. L’uomo non lo degnò di uno sguardo. «Ho dei collaboratori che si occupano di queste cose.» «Ah. Però a quanto pare non hanno letto con troppa attenzione» obiettò Kjell. «Poi abbiamo la parte delle uscite. Quanto costerebbe, per esempio, il ripristino della leva obbligatoria che vorreste introdurre? Non potrebbe farmi uno schema dei costi della vostra proposta, per chiarire meglio?» Gli spinse davanti blocco e penna, ma John li guardò come se fossero oggetti di pessimo gusto. «Tutti i dati sono enumerati nella nostra proposta. Basta che guardi lì.» «Non li sa a memoria? Dopotutto le poste di bilancio sono la base da cui intendete partire per portare avanti la vostra politica.» «È evidente che ho presenti tutti i numeri.» John allontanò il blocco. «Ma non ho intenzione di sottopormi ai suoi trucchetti di bassa lega.» «Allora lasciamo per un attimo i dati della proposta di bilancio. Forse avremo motivo di tornarci sopra dopo.» Kjell frugò nella cartella e tirò fuori un altro documento, un elenco che aveva stampato. «Oltre a una politica dell’immigrazione più restrittiva, voi vorreste introdurre pene più severe per i criminali.» John raddrizzò la schiena. «Certo. È scandaloso che in Svezia si sia così indulgenti. Grazie alla nostra politica non accadrà più che qualcuno possa cavarsela con una bacchettata sulle dita. Anche all’interno del partito abbiamo stabilito uno standard molto alto, soprattutto perché siamo consapevoli di essere stati messi in relazione, nel passato, ad alcuni... elementi poco felici, diciamo.» Elementi poco felici? Sì, in effetti così si poteva dire, pensò Kjell, restando però in silenzio. Lo stava portando esattamente nella direzione voluta. «Abbiamo ripulito le nostre liste elettorali da tutti coloro che hanno precedenti penali e applichiamo la tolleranza zero. Per esempio, tutti hanno dovuto sottoscrivere un’attestazione che comprende anche eventuali condanne che risalgono a periodi molto indietro nel tempo. Se si ha un passato non limpido non si possono rappresentare gli Amici della Svezia.» John si appoggiò allo schienale e accavallò le gambe. Kjell lo lasciò tranquillo per alcuni secondi per poi mettergli davanti la lista. «E come mai allora non ponete le stesse condizioni a quelli che lavorano nella segreteria del partito? Non meno di cinque suoi collaboratori hanno riportato condanne. Si parla di maltrattamenti, minacce, rapina e oltraggio a pubblico ufficiale. Il suo addetto stampa, per esempio, nel 2001 è stato condannato per aver preso a calci un etiope nella piazza di Ludvika.» Spinse leggermente il foglio in modo che fosse proprio davanti a lui. Il collo del leader del partito si tinse di rosso. «Non sono io a occuparmi dei colloqui d’assunzione e dell’ordinaria amministrazione della segreteria, quindi non posso esprimermi sulla questione.» «Come responsabile ultimo del personale direi che la cosa dovrebbe essere portata alla sua attenzione, anche se non è lei a occuparsene dal punto di vista pratico.» «Tutti hanno diritto a una seconda occasione. Nella maggior parte dei casi si tratta di peccati di gioventù.» «Una seconda occasione, dice? Perché i vostri dipendenti ne hanno il diritto, mentre gli immigrati che commettono un reato non possono goderne? Per voi devono essere buttati fuori dal Paese subito dopo la condanna.» Quando John Holm strinse le mascelle i lineamenti del viso apparvero ancora più squadrati del solito. «Come le ho già detto, non sono stato coinvolto nella procedura di selezione. Su questo punto mi riservo di esprimermi in seguito.» Kjell soppesò per un attimo la possibilità di metterlo alle strette, ma il tempo scorreva veloce e il leader poteva averne abbastanza da un momento all’altro e chiudere prima dell’ora pattuita. «Ho anche alcune domande personali» disse invece sbirciando nei suoi appunti. In realtà aveva tutto in testa ma per esperienza sapeva che tenere a portata gli appunti serviva a incutere rispetto nella controparte, che si agitava di più. «In una precedente occasione lei ha dichiarato che il suo impegno nelle questioni migratorie cominciò quando, a vent’anni, venne aggredito e picchiato da due studenti africani che frequentavano il suo stesso corso di laurea a Göteborg. Lei fece denuncia alla polizia ma l’indagine fu archiviata e per tutto il restante periodo di studi universitari fu costretto a incontrare quotidianamente i colpevoli, che deridevano lei e, di conseguenza, anche la società svedese. Quest’ultima frase è una citazione esatta di quanto da lei dichiarato in un’intervista allo Svenska Dagbladet nella primavera scorsa.» Kjell guardò John, che annuì serio. «Sì, è un episodio che ha lasciato un segno profondo e ha plasmato la mia visione del mondo, perché era indicativo di come funzionava la società e soprattutto dimostrava che gli svedesi erano retrocessi a cittadini di seconda classe mentre gli individui che eravamo stati tanto ingenui da accogliere dal resto del mondo venivano favoriti in tutti i modi.» «Interessante.» Kjell inclinò la testa di lato. «Ho controllato quest’episodio e ci sono diversi elementi che risultano... piuttosto strani.» «Cosa intende dire?» «Prima di tutto, negli archivi della polizia non risulta alcuna denuncia del genere e in secondo luogo nel suo corso di laurea non c’erano iscritti africani. E non basta: non c’era neanche uno studente africano in tutta l’università.» Kjell osservò il pomo d’adamo di John Holm sollevarsi e poi abbassarsi mentre l’uomo deglutiva. «Lo ricordo molto chiaramente. Lei si sbaglia.» «Non è che piuttosto le opinioni politiche le derivino dal suo ambiente familiare? Secondo le mie informazioni, suo padre nutriva forti simpatie per il nazismo.» «Sulle opinioni politiche di mio padre non ho intenzione di esprimermi.» Una rapida occhiata all’orologio gli confermò che restavano solo cinque minuti e Kjell sentì l’insoddisfazione mescolarsi al compiacimento. L’intervista non aveva dato risultati concreti, ma mettere in difficoltà John Holm era stato un piacere. E non aveva intenzione di arrendersi: era solo l’inizio. Avrebbe scavato e scavato finché non avesse trovato qualcosa che potesse fermarlo. Forse avrebbe dovuto incontrarlo di nuovo e quindi era il caso di chiudere l’intervista con una domanda che esulava dalla politica. Gli sorrise. «A quanto mi risulta lei era uno degli allievi del collegio di Valö quando quella famiglia scomparve nel nulla. Sono in tanti a chiedersi cosa successe.» John gli lanciò un’occhiata e si alzò di scatto. «Il tempo concordato è scaduto e adesso ho parecchio da fare. Penso che sappiate trovare l’uscita da soli.» L’istinto giornalistico di Kjell era sempre stato molto affinato e la reazione di Holm gli mise in moto le rotelle del cervello. C’era qualcosa, in quella vicenda, che l’uomo non voleva rivelargli. Non vedeva l’ora di tornare in redazione per cominciare a scavarci dentro. «Dov’è Martin?» Patrik guardò gli altri nella saletta del personale. «Ha chiamato prima. È in malattia» rispose Annika evasiva. «Però ho qui il suo rapporto sulla parte relativa all’economia familiare e all’assicurazione.» Patrik la guardò ma non fece domande. Se la segretaria non voleva dire quello che sapeva, non sarebbe bastata la tortura per farle sputare il rospo. «E io ho qui il materiale della vecchia indagine» intervenne Gösta indicando diversi grossi fascicoli appoggiati sul tavolo. «Che rapidità!» osservò Mellberg. «In genere ci vogliono secoli per far saltare fuori dall’archivio le vecchie scartoffie.» Gösta rimase in silenzio qualche secondo. Poi disse: «Le avevo a casa.» «Ma sei pazzo? Conservi a domicilio vecchio materiale d’archivio?» Il commissario era balzato in piedi ed Ernst, che era accucciato ai suoi piedi, si alzò a sedere, aguzzò le orecchie e abbaiò un paio di volte, ma dopo aver constatato che era tutto a posto si riaccucciò. «Ogni tanto me lo riguardavo e mi sembrava inutile correre avanti e indietro dall’archivio. Ed è stata una fortuna, altrimenti non l’avremmo qui.» «Ma come si fa a essere così scemi da...» cominciò Mellberg e Patrik capì che doveva intervenire. «Calma. L’importante adesso è avere il materiale a disposizione. Le questioni disciplinari le affronteremo dopo.» Mellberg borbottò acido ma poi si risedette. «La scientifica si è messa al lavoro sull’isola o no?» Patrik annuì. «Stanno sollevando il pavimento e intanto prelevano i campioni. Torbjörn ha promesso di farsi vivo appena saprà qualcosa.» «Qualcuno potrebbe spiegarmi perché investiamo risorse in un supposto reato che è comunque già prescritto?» chiese il commissario. Gösta lo guardò storto. «Dimentica che qualcuno ha cercato di incendiare l’edificio.» «Non l’ho dimenticato, ma mi chiedo ancora cosa faccia pensare che una cosa sia collegata all’altra.» Aveva articolato le parole in modo esagerato per stuzzicare Gösta. Patrik sospirò. Sembravano due bambini. «La decisione spetta a lei. Tuttavia penso che sarebbe un errore non esaminare più accuratamente la scoperta fatta ieri dagli Stark.» «So come la pensi, ma non sei tu a dover rispondere ai vertici quando vengono a chiederci conto dello sperpero delle nostre già scarse risorse su un caso che ormai ha superato da un pezzo la data di scadenza.» «Se è collegato all’incendio doloso, come ritiene Patrik, il caso della scomparsa è attinente» ribatté Gösta con voce decisa. Mellberg rimase in silenzio un istante. «E va bene, qualche ora possiamo dedicargliela. Forza, cominciamo.» Patrik tirò un sospiro di sollievo. «Okay. Allora partiamo da quello che ha trovato Martin.» Annika inforcò gli occhiali e abbassò lo sguardo sul rapporto. «Non ha rilevato niente di insolito. Gli Stark non hanno sovrassicurato la colonia, anzi, piuttosto è vero il contrario e quindi in caso di incendio non otterrebbero un grosso risarcimento. Per quanto riguarda la loro economia privata, hanno una somma abbastanza consistente in banca: sono i soldi ricavati dalla vendita della casa di Göteborg. Si suppone che sia denaro da utilizzare per la ristrutturazione e per coprire le spese correnti fino a quando l’attività non sarà avviata. Ah, poi Ebba ha una società registrata a suo nome. Si chiama “Il mio angelo”. Pare che realizzi gioielli in argento e li venda su internet, ma le entrate non sono granché.» «Bene. Non abbandoniamo del tutto la pista, ma al momento niente sembra indicare che si tratti di una truffa ai danni dell’assicurazione. Poi abbiamo la scoperta di ieri» continuò Patrik rivolgendosi a Gösta. «Perché non ci racconti che aspetto aveva la casa quando faceste il sopralluogo dopo la scomparsa della famiglia?» «Certo. Ho anche delle foto» rispose lui aprendo uno dei raccoglitori e tirando fuori un fascio di istantanee ingiallite per passarle ai colleghi. Patrik rimase sorpreso: nonostante risalissero a tanto tempo prima, documentavano perfettamente la situazione. «Nella sala da pranzo niente indicava che fosse successo qualcosa» continuò Gösta. «Il pasto era stato lasciato a metà ma non c’erano segni di colluttazione. Le stoviglie erano integre e il pavimento pulito. Guardate, se non mi credete.» Patrik esaminò le foto nel dettaglio. Gösta aveva ragione. Sembrava proprio che la famiglia si fosse alzata poco dopo aver cominciato a mangiare e se ne fosse andata. Rabbrividì: la tavola imbandita aveva un che di spettrale, con il cibo ancora nei piatti e le sedie ordinatamente accostate. Al centro campeggiava un grande vaso con un mazzo di giunchiglie. L’unica cosa che mancava erano le persone, e il rinvenimento del sangue sotto le tavole di legno conferiva alle foto una nuova dimensione, che gli fece capire come mai Erica avesse dedicato tante ore a scavare nella misteriosa scomparsa della famiglia Elvander. «Se è davvero sangue, sarà possibile stabilire se appartiene alla famiglia?» chiese Annika. Patrik scosse la testa, esitante. «Non è il mio ambito, ma non penso. Credo che sia troppo vecchio perché si possano fare delle analisi di quel genere. L’unica conferma che possiamo avere è se si tratti o no di sangue umano. E poi non abbiamo niente con cui metterlo a confronto.» «Abbiamo Ebba» gli fece notare Gösta. «Se il sangue è di Rune o Inez forse si può ottenere un profilo dna da mettere a confronto con il suo.» «Sì, è vero. Ma credo che il sangue abbia tempi di disgregazione piuttosto brevi e qui sono passati molti anni. Bisogna scoprire cosa accadde quella vigilia di Pasqua a prescindere dal risultato delle analisi. Dobbiamo tornare indietro nel tempo.» Patrik appoggiò le foto sul tavolo. «Ci toccherà leggere tutti gli interrogatori con le persone che hanno avuto a che fare con il collegio e poi parlare di nuovo con loro. La verità è lì da qualche parte. Una famiglia intera non può sparire e basta. E se ci verrà confermato che si tratta di sangue umano possiamo dare per acquisito che in quella stanza fu commesso un reato.» Guardò Gösta, che annuì debolmente. «Hai ragione. Dobbiamo tornare indietro nel tempo.» Forse era un po’ strano esporre tutte quelle foto in una camera d’albergo, ma nessuno glielo aveva fatto notare. Potersi permettere una suite comportava dei vantaggi. Davano tutti per scontato che chi aveva molti soldi fosse un po’ eccentrico. Inoltre la sua condizione gli dava la possibilità di fare quello che voleva senza curarsi di cosa pensassero gli altri. Le foto erano importanti per lui e per questo le portava con sé. Era una delle poche cose su cui Ia non metteva becco. Per tutto il resto sapeva di essere in sua balia, ma lei non poteva sottrargli quello che era stato un tempo e le imprese che aveva portato a termine. Leon si spostò con la sedia a rotelle fino al cassettone su cui erano appoggiate le foto. Chiuse gli occhi e per un breve istante si concesse di tornare con il pensiero ai luoghi raffigurati in quelle immagini, sentendo il vento del deserto bruciargli le guance e il gelo estremo trafiggergli le dita. Aveva amato quei tormenti. No pain, no gain, era sempre stato il suo motto: senza dolore non si migliora. Ironia della sorte, il dolore era diventato per lui un compagno costante, ogni giorno, ogni secondo, e senza nessun guadagno. Il viso che gli sorrideva dalle foto era bello, o meglio, avvenente. Dire che era bello equivaleva a definirlo effeminato, cosa del tutto fuorviante. Lui esprimeva forza e virilità. Un’audace temerarietà, il desiderio di sentir scorrere in corpo l’adrenalina. Tese la mano sinistra che, a differenza della destra, era integra, e prese la sua foto preferita. Era stata scattata sulla cima dell’Everest. La scalata era stata durissima e diversi dei partecipanti alla spedizione avevano abbandonato l’impresa fermandosi a uno dei campi base. Alcuni si erano addirittura arresi prima della partenza. Quel genere di debolezza gli riusciva incomprensibile. Arrendersi non era una possibilità che contemplava. Molti avevano scosso la testa quando aveva deciso di raggiungere la vetta senza ossigeno. Non ce l’avrebbe fatta, dicevano quelli che se ne intendevano. Anche il capo spedizione l’aveva pregato di tornare sulla decisione, ma Leon sapeva che era possibile. C’era il precedente di Reinhold Messner e Peter Habeler nel 1978. Già allora era ritenuto impraticabile e neanche gli scalatori nepalesi ne avevano avuto la forza. Loro però sì, il che comportava che ci sarebbe riuscito anche lui. E infatti era arrivato in cima all’Everest al primo tentativo, senza ossigeno. Nella foto sorrideva con la bandiera svedese in una mano e i multicolori drappi di preghiera alle sue spalle. In quel momento si trovava nel punto più alto della terra. Aveva l’aria forte. E felice. Rimise a posto la foto e prese quella accanto. Parigi-Dakar. Categoria moto, naturalmente. Gli rodeva ancora non aver vinto. Si era dovuto accontentare di rientrare nei primi dieci. In realtà sapeva che era stata un’ottima prestazione, ma per lui contava solo il primo premio e così era sempre stato. Doveva essere sul gradino più alto del podio, di qualsiasi cosa si trattasse. Accarezzò con il pollice il vetro del portafotografie e represse un sorriso. Quando sorrideva un lato del viso tirava in modo sgradevole ed era una sensazione che detestava. Ricordava la paura di Ia. Dopo che uno dei gareggianti si era ammazzato all’inizio della corsa, l’aveva implorato di ritirarsi, ma quell’incidente aveva rafforzato la sua motivazione. Era la consapevolezza del pericolo a spingerlo, l’intuizione che la morte poteva aspettarlo dietro l’angolo. Il rischio gli faceva amare il bello della vita in maniera ancora più intensa. Lo champagne aveva un sapore migliore, le donne sembravano più belle, le lenzuola di seta scivolavano più morbide sulla pelle. La sua ricchezza era più preziosa se la si metteva costantemente a repentaglio. Ia, invece, temeva di perdere tutto. Detestava che lui ridesse in faccia alla morte e facesse puntate altissime ai casinò di Monaco, Saint-Tropez e Cannes. Non capiva l’ebbrezza che provava quando perdeva grosse somme per poi riprendersi tutto la sera dopo. In quei frangenti non riusciva a dormire la notte e si rigirava nel letto mentre lui si godeva un sigaro sul balcone. In fondo in fondo quella sua inquietudine gli aveva sempre fatto piacere. Sapeva che lei amava la vita che lui aveva da offrirle. E non solo la amava: ne aveva bisogno e la pretendeva. Per questo le perdite avevano un pizzico di sapore in più se poteva osservarle il viso quando la pallina finiva nel settore sbagliato o vederle mordere l’interno della guancia per non strillare quando lui puntava tutto sul rosso e vinceva il nero. Leon sentì una chiave nella serratura. Lentamente, rimise a posto la foto sul cassettone. L’uomo sulla moto gli sorrideva. Fjällbacka 1919 Era una giornata splendida e Dagmar si stirò come un gatto. Da quel momento sarebbe tutto cambiato. Finalmente aveva conosciuto qualcuno che avrebbe messo a tacere le chiacchiere e fatto morire le risate in gola alle vecchie pettegole. La figlia della fabbricante di angeli e l’eroe aviatore, insieme: quello sì che sarebbe stato un argomento di cui parlare! Ma lei non ne sarebbe stata toccata, perché sarebbero andati via insieme. Dove, non lo sapeva, ma non aveva alcuna importanza. Quella notte lui l’aveva accarezzata come nessuno aveva mai fatto prima. Le aveva sussurrato tante parole all’orecchio, parole che non capiva ma che in cuor suo sapeva essere promesse sul loro futuro insieme. Il suo alito caldo le aveva diffuso il desiderio in tutto il corpo e lei gli aveva dato tutta se stessa. Si alzò lentamente a sedere sul bordo e, nuda, andò alla finestra e la spalancò. Fuori cinguettavano gli uccelli e il sole era appena sorto. Si chiese dove fosse Hermann. Che fosse sceso a prendere la colazione per tutti e due? In bagno si dedicò a una minuziosa toilette mattutina. In realtà non voleva togliersi di dosso il suo odore, ma al suo ritorno desiderava profumare come la più bella delle rose. E presto avrebbe avuto modo di sentire di nuovo quell’odore. Ne avrebbe goduto per tutta la vita. Quando ebbe finito si stese di nuovo sul letto ad aspettare, ma Hermann si faceva attendere e Dagmar cominciò a essere impaziente. Il sole era salito nel cielo e il cinguettio degli uccelli si era fatto fastidioso. Dov’era finito? Non capiva che lo stava aspettando? Alla fine si alzò, si vestì e uscì a testa alta dalla porta. Che cosa le importava se qualcuno l’avesse vista? Ben presto le intenzioni di Hermann sarebbero state chiare a tutti. La casa era immersa nel silenzio. Gli ospiti stavano smaltendo la sbornia dormendo e probabilmente così sarebbe stato per almeno altre due ore. In genere si svegliavano solo intorno alle undici. Dalla cucina, però, si sentivano dei rumori. Il personale di servizio stava preparando la colazione. Quando finalmente si svegliavano, gli invitati avevano sempre una fame da lupi e le uova dovevano essere sode e il caffè già pronto. Sbirciò cauta in cucina. No, Hermann non era lì. Una delle aiuto cuoche la vide e aggrottò le sopracciglia, ma Dagmar sollevò il mento di scatto e richiuse la porta. Dopo aver cercato per tutta la casa scese al pontile. Possibile che avesse pensato di fare un tuffo mattutino? Era così atletico... sicuramente aveva deciso di rinfrancarsi con una bella nuotata. Aumentò il passo e si affrettò verso la spiaggia. I piedi sembravano volare sull’erba e quando arrivò al pontile fece spaziare sorridendo lo sguardo sull’acqua. Ben presto tornò seria. Niente nemmeno lì. Si guardò intorno ancora una volta ma Hermann non era in acqua e sul pontile non si vedevano i suoi vestiti. Un ragazzo che lavorava per i padroni di casa le si avvicinò a passo lento. «Posso aiutarla, signorina?» chiese socchiudendo gli occhi per schermarli dal sole. Quando si avvicinò la riconobbe e rise. «Ma sei tu, Dagmar. Cosa fai qui a quest’ora? Ho saputo che stanotte non hai dormito con il resto dei domestici ma te la sei spassata da un’altra parte.» «Taci, Edvin» disse lei. «Sto cercando l’aviatore tedesco. L’hai visto?» Il ragazzo ficcò le mani nelle tasche dei pantaloni. «L’aviatore? Ah, quindi eri con lui?» Sbottò di nuovo nella sua risata di scherno. «Sapeva di essere andato a letto con la figlia di un’assassina? Ma magari quei forestieri trovano che sia eccitante...» «Smettila e rispondi alla mia domanda. L’hai visto stamattina?» Edvin non disse niente per un pezzo, limitandosi a scrutarla. «Dovremmo vederci qualche volta, io e te» disse alla fine facendo un passo verso di lei. «Non abbiamo mai avuto veramente occasione di conoscerci.» Lei lo guardò storto. Oh, quanto detestava quegli uomini rivoltanti, senza finezza né cultura. Non avevano il diritto di toccarla con le loro manacce sporche. Lei meritava di meglio. Una vita di agi: gliel’avevano detto i suoi genitori. «Allora?» disse. «Hai sentito quello che ti ho chiesto?» Lui sputò a terra, la guardò negli occhi e, senza riuscire a nascondere la sua gioia maligna, rispose: «Se n’è andato.» «Cosa vuoi dire? Dove?» «Gli è arrivato un telegramma stamattina presto. Un qualche incarico di volo. È venuta a prenderlo una barca due ore fa.» Dagmar inspirò di scatto. «Stai mentendo!» Avrebbe voluto mollargli un pugno dritto su quella boccaccia sghignazzante. «Padrona di non credermi» replicò lui girandosi. «Comunque non c’è.» Lei rivolse lo sguardo verso il mare nella direzione in cui era scomparso Hermann e giurò di ritrovarlo. Sarebbe diventato suo, costasse quel che costasse. Perché così era scritto. Erica si sentiva un po’ in colpa, anche se in realtà non aveva mentito a Patrik ma solo omesso la verità. Oltretutto la sera prima aveva cercato di parlargli dei suoi piani, ma non si era presentata l’occasione giusta e per di più lui era di umore strano. Gli aveva chiesto se fosse successo qualcosa al lavoro ma lui aveva risposto in maniera evasiva e così avevano passato la serata in silenzio davanti alla televisione. A come spiegare l’uscita di quel giorno avrebbe pensato un’altra volta. Accelerò e virò a sinistra con il beccaccino, ringraziando mentalmente suo padre Tore per aver insistito a insegnare alle figlie a governare la barchetta. Secondo lui era un dovere, se si abitava al mare. E a essere sincera era più brava lei di Patrik nell’attracco, anche se per amor di pace lasciava fare a lui. I maschi avevano un ego tanto fragile... Salutò con la mano una delle lance della guardia costiera che stava rientrando in porto. Sembrava venisse da Valö ed Erica si chiese cosa ci fossero andati a fare. Dopo un attimo, però, smise di pensarci per concentrarsi sulla manovra e scivolò elegantemente accanto al pontile. Si accorse con sorpresa di essere un po’ agitata. Le tante ore dedicate a quella vicenda rendevano un po’ irreale la possibilità di incontrare uno dei protagonisti in carne e ossa. Prese la borsetta e saltò a terra. Era un pezzo che non metteva piede sull’isola che, come per molti altri abitanti di Fjällbacka, suscitava in lei ricordi di gite scolastiche e campi estivi. Mentre camminava tra gli alberi quasi riusciva a sentire il profumo di salsicce alla brace e di pane abbrustolito intorno a un bastoncino. Avvicinandosi alla casa si bloccò stupita. Regnava un’attività frenetica e sui gradini esterni c’era una figura gesticolante che le era molto familiare. Ricominciò a camminare e aumentò l’andatura mettendosi quasi a correre. «Ciao Torbjörn!» lo chiamò agitando il braccio e ottenendo finalmente la sua attenzione. «Cosa fate qui?» Lui la guardò sorpreso. «Erica? Potrei fare la stessa domanda a te. Patrik sa dove sei?» «Ehm... non credo. Ma dimmi cosa state combinando.» Torbjörn sembrò soppesare la risposta. «Ieri i proprietari hanno fatto un ritrovamento in casa mentre lavoravano alla ristrutturazione» disse alla fine. «Un ritrovamento? La famiglia sparita? Dove?» Torbjörn scosse la testa. «Purtroppo non sono autorizzato a dire altro.» «Posso entrare?» Mise un piede sul primo gradino. «No, l’accesso è vietato. Non possiamo avere gente che gira per casa mentre lavoriamo.» Sorrise. «Immagino che tu cerchi i proprietari. Sono sul retro.» Erica arretrò. «Okay» disse senza riuscire a nascondere del tutto la delusione. Seguì il muro esterno e girando l’angolo vide un uomo e una donna più o meno della sua età. Avevano l’aria seria, lo sguardo puntato sulla casa, e non stavano parlando. Erica esitò un attimo. Presa dall’entusiasmo e dalla curiosità, non aveva neanche pensato a come spiegare il motivo della sua visita, ma l’incertezza durò lo spazio di pochi secondi: dopotutto fare la ficcanaso e frugare nei segreti e nelle tragedie delle persone faceva parte del suo mestiere. Ormai aveva da tempo superato i propri scrupoli e sapeva che, a libro pubblicato, molti familiari delle persone di cui si era occupata avevano espresso il loro apprezzamento. Inoltre era più facile quando l’evento, come in quel caso, risaliva a un’epoca lontana nel tempo, perché le ferite erano per lo più rimarginate e le tragedie avevano cominciato ad appartenere alla storia. «Buongiorno!» disse, e i due rivolsero lo sguardo dalla sua parte. Poi la donna le sorrise. «Ciao. Io ti riconosco. Sei Erica Falck. Ho letto tutti i tuoi libri e li adoro» disse, smettendo poi di parlare di colpo, come vergognandosi di essersi lasciata andare a quel modo. «Piacere. Tu devi essere Ebba.» Erica le strinse la mano sentendola fragilissima nella sua, anche se i calli rivelavano che stava lavorando sodo alla ristrutturazione. «Grazie per il complimento.» Ancora un po’ intimidita, Ebba presentò il marito ed Erica strinse la mano anche a lui. «Non male come tempismo.» La padrona di casa si sedette e sembrò aspettarsi che Erica la imitasse. «In che senso?» «Be’, immagino che sia venuta per scrivere della scomparsa, no? Allora sei arrivata proprio il giorno giusto.» «Già» ammise Erica. «Ho sentito che avete trovato qualcosa all’interno dell’edificio.» «Sì, quando abbiamo divelto il pavimento» disse Mårten. «Non sapevamo cosa fosse ma ci è sembrato sangue. Poi è venuta la polizia e ha deciso di esaminare la cosa. Per questo c’è tutta questa gente.» Erica capì come mai Patrik fosse stato così telegrafico il giorno prima, quando gli aveva chiesto se era successo qualcosa. Si chiese cosa ne pensasse, se desse per scontato che la famiglia fosse stata uccisa lì nella sala da pranzo e che poi i corpi fossero stati portati via. Nella foga stava per domandare se oltre al sangue avessero trovato qualcos’altro, ma si dominò. «Dev’essere stato sgradevole. Non posso negare che la vicenda mi ha sempre interessata, ma per te, Ebba, è una questione personale che ti tocca da vicino.» La donna scosse la testa. «Ero così piccola che non ho alcun ricordo della mia famiglia. Non posso piangere delle persone che sono cancellate dalla mia memoria. Non è come...» Si bloccò e distolse lo sguardo. «Credo che mio marito, Patrik Hedström, sia uno dei poliziotti venuti qui ieri. Era passato anche sabato scorso per l’altro episodio. Un incidente piuttosto inquietante, vero?» «Mah, non so se lo si possa chiamare così. Inquietante, comunque, lo è stato di sicuro e io proprio non capisco perché qualcuno possa volerci male.» Mårten spalancò le braccia. «Patrik pensa che abbia a che vedere con quello che accadde nel 1974» disse Erica prima di riuscire a trattenersi. Imprecò tra sé e sé. Sapeva quanto si sarebbe arrabbiato se lei avesse svelato qualcosa che poteva compromettere le indagini. «Ma come? È passato tanto tempo.» Ebba guardò la casa. Da dove erano seduti non vedevano quello che accadeva all’interno, ma si sentiva il rumore del legno che veniva asportato. «Se per te va bene, vorrei farti qualche domanda sulla scomparsa della tua famiglia» disse Erica. Ebba annuì. «Come ho detto a tuo marito, non credo di avere un gran contributo da dare, ma tu chiedi pure.» «Ti spiace se registro la conversazione?» domandò Erica estraendo un registratore dalla borsa. Mårten rivolse un’occhiata interrogativa a Ebba, che alzò le spalle. «No, figurati.» Quando l’apparecchietto prese a ronzare Erica avvertì un formicolio allo stomaco per l’eccitazione. Pur avendo pensato di farlo molte volte, non si era mai azzardata ad andare a cercare Ebba a Göteborg, ma avendola finalmente davanti forse avrebbe potuto ottenere qualche elemento su cui basarsi per proseguire le ricerche. «Ti è rimasto qualcosa della tua famiglia d’origine? Qualche oggetto che ti ha seguito da qui?» «No, niente. I miei genitori adottivi hanno detto che quando sono arrivata da loro avevo solo una valigetta con dei vestiti. E non credo neanche che venissero da Valö. Secondo mia madre un’anima buona aveva confezionato un piccolo corredo ricamandoci sopra le mie iniziali. Li ho ancora. La mamma li aveva tenuti nel caso avessi avuto una figlia.» «Niente lettere, niente foto?» chiese Erica. «No, non ne ho mai viste.» «C’erano altri parenti che potrebbero aver conservato qualcosa del genere?» «No, nessuno. L’ho detto anche a tuo marito. A quanto ne so, né i miei nonni materni né quelli paterni erano vivi e pare che i miei genitori non avessero fratelli o sorelle. Se ci sono dei lontani parenti, non si sono mai fatti vivi con me. E all’epoca non c’era nessuno che mi volesse.» L’ultima frase suonava infinitamente triste ed Erica le rivolse un’occhiata dispiaciuta, ma Ebba sorrise. «Ho avuto fortuna. Ho una madre e un padre che mi vogliono bene e due fratelli che mi sono molto cari. Non mi è mancato nulla.» Erica rispose al sorriso. «Non sono molti a poter dire tanto.» Si accorse che la donna minuta che aveva davanti le piaceva sempre di più. «Sai qualcos’altro sui tuoi genitori biologici?» «No. Non ho mai voluto scoprire di più. Certo, a volte mi sono chiesta cosa potesse essere accaduto, ma in un certo senso non mi sembrava che avesse a che fare con la mia vita. Forse ero anche preoccupata del fatto che i miei potessero restarci male e pensare di non essere all’altezza delle mie aspettative se io avessi cominciato a fare ricerche sui miei genitori biologici.» «Pensi che l’interesse per le tue radici si risveglierebbe se aveste dei figli?» chiese Erica con tatto. Non sapeva granché su Ebba e Mårten e forse era una questione delicata. «Ne avevamo uno» rispose Ebba. Erica si ritrasse come per uno schiaffo. Non era la risposta che si aspettava. Avrebbe voluto fare altre domande, ma il linguaggio non verbale di Ebba parlava chiaro. «Il fatto che ci siamo trasferiti qui può forse essere considerato un modo di cercare le sue origini, per Ebba» intervenne Mårten. Cambiò posizione ed Erica notò che la coppia sembrava allontanarsi impercettibilmente sulla panca, come se un contatto ravvicinato risultasse difficile da sopportare. L’atmosfera si era fatta tesa e di colpo ebbe l’impressione di essere invadente e di aver ficcato il naso in qualcosa di molto personale. «Ho fatto qualche ricerca documentaria nella storia della tua famiglia e ho trovato un bel po’ di materiale. Dimmi se vuoi che ti mostri quello che ho raccolto» disse. «Grazie, molto gentile» rispose Ebba senza entusiasmo. Sembrava aver perso tutte le energie ed Erica si rese conto che non aveva senso continuare la conversazione. Si alzò. «Grazie di avermi concesso un po’ del vostro tempo. Mi farò viva. Oppure, se volete, fatevi sentire voi.» Prese un blocco, scrisse il numero di telefono e la mail, strappò la pagina e gliela diede. Poi spense il registratore e lo infilò nella borsa. «Sai dove trovarci. Non facciamo altro che lavorare alla casa dalla mattina alla sera» rispose Mårten. «Già, l’avevo capito. Riuscirete a completare la ristrutturazione da soli?» «Sì, è la nostra intenzione. Almeno fin dove riusciremo ad arrivare.» «Se conosci qualcuno in zona che ci sa fare con l’arredamento di interni, accettiamo consigli» s’inserì Ebba. «Né io né Mårten siamo particolarmente bravi.» Erica stava per rispondere che purtroppo non era molto esperta in materia quando le venne un’idea. «Conosco una persona che sicuramente sarebbe in grado di aiutarvi. Ve lo saprò dire.» Si congedò e tornò alla facciata. Torbjörn stava dando istruzioni a due dei suoi tecnici. «Come procede il lavoro?» chiese a voce alta per sovrastare il ronzio di una motosega. «Non ti riguarda» le rispose Torbjörn, «ma più tardi chiamo tuo marito per fargli rapporto, quindi stasera potrai fare il terzo grado a lui!» Erica rise e lo salutò con la mano. Mentre scendeva verso il pontile si fece seria. Che fine avevano fatto gli effetti personali della famiglia? Perché Ebba e Mårten si comportavano in modo così strano l’uno nei confronti dell’altra? Cos’era successo al loro bambino? E poi: dicevano la verità sostenendo di non sapere chi avesse tentato di dare fuoco alla casa mentre loro si trovavano dentro? Anche se quella conversazione con Ebba non aveva dato i risultati sperati, quando avviò il motore e puntò la prua verso casa la mente di Erica era affollata di pensieri. Gösta borbottava tra sé e sé. In realtà non se l’era presa troppo per le critiche di Mellberg, ma gli sembrava assurdo lamentarsi tanto solo perché si era portato a casa il materiale dell’indagine. Non era forse il risultato che contava? Tutto ciò che precedeva l’epoca digitale era difficile da trovare e almeno così avrebbero fatto a meno di andare a frugare nei meandri dell’archivio. Mise carta e penna sulla scrivania e aprì il primo raccoglitore. Quante ore della sua vita aveva dedicato a rimuginare su quello che era successo al collegio? Quante volte aveva scrutato le foto, riletto i verbali degli interrogatori e i rapporti dei sopralluoghi? Per fare le cose bene era necessario lavorare in maniera sistematica. Patrik gli aveva assegnato il compito di redigere un elenco delle persone i cui nomi comparivano nella vecchia indagine. Avrebbero dovuto interrogarle in ordine di importanza. Non avevano la possibilità di parlare con tutti in contemporanea ed era importante seguire la successione giusta. Si sedette e cominciò a sciropparsi i verbali degli interrogatori, che a dire il vero dicevano ben poco. Dato che li aveva letti innumerevoli volte sapeva che non contenevano niente di concreto e quindi bisognava interpretare le sfumature e leggere tra le righe, ma si accorse che faticava a concentrarsi. I pensieri correvano da soli alla bambina ormai diventata adulta. Era stato strano rivederla e sovrapporre un’immagine reale a quella che si era costruito nella fantasia. Cambiò posizione sulla sedia, inquieto. Erano passati molti anni dall’ultima volta che aveva preso il lavoro con slancio e, nonostante quell’incarico lo stimolasse, era come se il cervello non volesse recepire le nuove istruzioni. Mise da parte i verbali e passò invece lentamente in rassegna le foto. C’erano anche quelle dei ragazzi rimasti a scuola durante le vacanze. Gösta chiuse gli occhi e ripensò alla vigilia di Pasqua del 1974, assolata ma freschina. Insieme al defunto collega Henry Ljung era risalito a piedi verso il grande edificio bianco. Regnava un silenzio assoluto, quasi inquietante, ma forse era una ricostruzione a posteriori. Eppure ricordava benissimo di essere rabbrividito mentre camminava lungo il sentiero. Henry e lui si erano guardati, incerti su cosa avrebbero trovato dopo la strana telefonata alla stazione di polizia. Il responsabile dell’epoca aveva mandato due uomini a verificare. «Sarà un tiro di quei ragazzini» aveva detto spedendoli sul posto, più che altro per avere le spalle coperte se, contro ogni previsione, fosse saltato fuori che non era uno scherzo di qualche annoiato rampollo di buona famiglia. All’inizio dell’anno scolastico qualche problema c’era stato, ma dopo che il capo aveva chiamato Rune Elvander le acque si erano calmate. Gösta non aveva idea di come il direttore avesse conseguito quel risultato, ma qualsiasi cosa avesse fatto aveva funzionato. Fino a quel momento. Davanti alla porta d’ingresso lui e Henry si erano fermati. Da dentro non si sentiva nessun rumore. Poi uno strillo infantile aveva lacerato il silenzio, riscuotendoli da quella momentanea paralisi. Avevano bussato una volta per poi aprire la porta. «C’è nessuno?» aveva chiamato lui e, seduto alla scrivania a tanti anni di distanza, si chiese come potesse ricordare tutto così nel dettaglio. Non aveva risposto nessuno ma gli strilli infantili si erano intensificati. Seguendone la provenienza si erano affrettati per bloccarsi di colpo entrando nella sala da pranzo. Una bambina molto piccola girava per la stanza, sola, piangendo in modo straziante. Gösta si era precipitato d’istinto a prenderla in braccio. «Dove sarà il resto della famiglia?» aveva chiesto Henry guardandosi intorno. «Ehi, c’è qualcuno?» aveva chiamato tornando verso l’ingresso. Nessuna risposta. «Controllo di sopra» aveva avvertito, e Gösta aveva annuito, tutto preso a cercare di calmare la piccola. Non aveva mai tenuto in braccio un bambino in vita sua e non sapeva come fare per farla smettere di piangere. Si era messo a cullarla maldestramente, accarezzandole la schiena e mugolando una melodia imprecisata. Con sua sorpresa, aveva funzionato. Il pianto si era stemperato in piccoli singhiozzi irregolari e poi la bambina gli aveva appoggiato la testa sulla spalla, con il petto che si alzava e si abbassava a ogni respiro. Gösta aveva continuato a cullarla e a mugolare, sentendosi colmare da emozioni che non avrebbe saputo esprimere a parole. Henry era rientrato nella stanza. «Non c’è nessuno neanche di sopra.» «Dove possono essere finiti? Come si fa a lasciare da sola una creaturina a questo modo? Sarebbe potuta andare a finire malissimo.» «Già, e chi diavolo ha telefonato?» Henry si era tolto il cappellino con la visiera e si era grattato la testa. «Possono essere andati a fare una passeggiata sull’isola?» Gösta aveva guardato dubbioso la tavola con il cibo ancora sui piatti. «A metà del pranzo? Molto strano.» «Ah be’, questo è certo.» Henry si era rimesso il cappellino. «Cosa ci fa qui tutta sola questa bella bambina?» aveva gorgheggiato rivolto alla piccola. Lei si era subito rimessa a piangere aggrappandosi al collo di Gösta con una forza tale da togliergli il respiro. «Lasciala stare» aveva detto facendo un passo indietro. Si era domandato se avrebbe provato la stessa sensazione di calore nel petto se suo figlio fosse sopravvissuto. Poi si era affrettato a scacciare quell’idea. Aveva deciso di non pensare a quello che sarebbe potuto essere ma non era. «La barca era attraccata al pontile?» aveva chiesto dopo un po’, vedendo che la bambina si era di nuovo calmata. Henry aveva aggrottato le sopracciglia. «Ce n’era una, ma ne hanno due, no? Se non sbaglio l’autunno scorso hanno comprato il beccaccino di Sten-Ivar mentre io ho visto ormeggiata solo l’altra. Ma mi sembra impossibile che siano usciti in mare senza portarsi la piccola... Non possono essere così pazzi, anche se sono cittadini!» «Inez è originaria di qui» lo aveva corretto Gösta, assente. «La sua famiglia è di Fjällbacka, e da diverse generazioni.» Henry aveva sospirato. «Bah, comunque è strano. Dovremo portare la bambina sulla terraferma e vedere se salta fuori qualcuno.» Poi si era girato per andarsene. «I coperti sono solo sei» aveva osservato Gösta. «Sì, ma ci sono le vacanze di Pasqua, quindi è rimasta solo la famiglia.» «Possiamo davvero lasciare tutto così?» La situazione era quanto meno strana e l’assenza di un protocollo da seguire lo preoccupava. Aveva riflettuto per un po’. «Facciamo come dici tu e ci portiamo dietro la bambina. Se nessuno si fa vivo, domani ritorniamo, e se non sono tornati dobbiamo partire dal presupposto che sia successo qualcosa. E di conseguenza questo posto sarà messo sotto sigilli.» Senza avere la certezza di agire nel modo giusto erano usciti e avevano chiuso la porta alle proprie spalle. Poi erano scesi verso il pontile e quando erano quasi arrivati avevano visto avvicinarsi una barca. «Guarda, ecco il vecchio beccaccino di Sten-Ivar» aveva detto Henry indicandola. «Ci sono diverse persone a bordo. Forse è il resto della famiglia.» «Be’, in questo caso dirò loro due parole. Lasciare la bambina a quel modo. Mi viene voglia di prenderli a sberle.» Henry era sceso a grandi passi verso il pontile con Gösta che quasi gli correva dietro ma non osava aumentare la velocità per paura di inciampare con la bambina in braccio. La barca aveva attraccato e ne era saltato giù un ragazzo sui quindici anni con i capelli neri corvini e l’espressione truce. «Cosa state facendo a Ebba?» aveva sibilato. «E tu chi sei?» aveva chiesto Henry quando il ragazzo gli si era parato davanti con le mani sui fianchi. Altri quattro ragazzi erano nel frattempo scesi dalla barchetta per avvicinarsi a Henry e a Gösta che l’aveva appena raggiunto. «Dove sono Inez e Rune?» aveva ribattuto il ragazzo con i capelli neri mentre gli altri aspettavano alle sue spalle. Chiaramente era il leader del gruppo. «Ce lo chiediamo anche noi» aveva risposto Gösta. «La polizia ha ricevuto una chiamata da qualcuno che ha detto che era successo qualcosa e quando siamo arrivati abbiamo trovato la piccola sola in casa.» Il ragazzo lo aveva fissato incredulo. «C’era solo Ebba?» Quindi era così che si chiamava la bambina il cui cuoricino stava battendo forte contro il suo. «Siete gli scolari di Rune?» aveva domandato Henry in tono autoritario, ma il ragazzo non si era lasciato intimorire e si era limitato a guardare calmo il poliziotto per poi rispondere educatamente: «Siamo gli allievi della scuola rimasti qui per le vacanze.» «E da dove spuntate?» Gösta aveva aggrottato la fronte. «Siamo fuori in barca da stamattina presto. Non eravamo invitati al pranzo familiare e così abbiamo deciso di andare a pesca, invece, per “forgiare il carattere”.» «Preso qualcosa?» Il tono di Henry lasciava capire che non credeva alle parole del ragazzo. «Un mastello pieno» aveva risposto lui indicando la barca. Gösta aveva seguito la direzione del dito e visto il palangaro agganciato alla poppa della barca. «Dovrete venire con noi alla stazione finché non saremo andati a fondo di questa faccenda» aveva detto Henry precedendoli verso la barca della polizia. «Non possiamo lavarci, prima? Siamo sporchi e puzziamo di pesce» aveva chiesto uno degli altri con espressione spaventata. «Adesso facciamo come dicono gli agenti» l’aveva zittito quello che comandava. «Naturale che veniamo con voi. Vi chiedo scusa se siamo stati sgarbati. È che ci siamo preoccupati vedendo degli estranei con Ebba. Io mi chiamo Leon Kreutz.» Gli aveva teso la mano. Henry era già in barca e li stava aspettando. Gösta era sceso a bordo con la bambina dopo i ragazzi, lanciando un’ultima occhiata verso la casa. Dove diavolo si trovava la famiglia? Cos’era successo? Gösta tornò al presente. I ricordi erano così vividi che gli era quasi sembrato di avvertire il calore della bambina tra le braccia. Raddrizzò la schiena e tirò fuori una foto dal mucchio. Era stata scattata alla stazione quella vigilia di Pasqua e ritraeva tutti e cinque i ragazzi: Leon Kreutz, Sebastian Månsson, John Holm, Percy von Bahrn, Josef Meyer. Avevano tutti i capelli spettinati, i vestiti sporchi e un’espressione corrucciata. Tutti tranne Leon, che sorrideva allegro all’obiettivo e dimostrava più dei suoi sedici anni. Era un bel ragazzo, anzi, molto bello. All’epoca non se n’era accorto. Sfogliò il materiale dell’indagine. Leon Kreutz. Chissà cos’aveva fatto della sua vita. Gösta prese un appunto sul blocco. Dei cinque ragazzi era lui quello che gli era rimasto più impresso. Poteva essere quello giusto da cui cominciare. Fjällbacka 1920 La bambina strillava senza interruzione, notte e giorno, e Dagmar non riusciva a sovrastare il pianto neanche se si tappava le orecchie con le mani e urlava: l’unico risultato era che agli strilli si aggiungevano i colpi del vicino sulla parete. Non era così che doveva essere. Sentiva ancora le sue mani sul corpo, il suo sguardo su di sé, nuda nel letto con lui. Era convinta che i sentimenti che provava fossero corrisposti e dunque doveva essere successo qualcosa. Altrimenti lui non l’avrebbe abbandonata nella povertà e nell’umiliazione. Forse era stato costretto a tornare in Germania? Sicuramente là c’era bisogno di lui. Era un eroe che, ligio al dovere, era tornato quando la patria l’aveva chiamato, anche se essere costretto a lasciarla gli aveva spezzato il cuore. Già prima di scoprire di essere incinta l’aveva cercato in tutti i modi possibili. Aveva scritto diverse lettere alla legazione tedesca a Stoccolma e chiesto a ogni persona che incontrava se conosceva l’eroe di guerra Hermann Göring e sapeva cosa ne fosse stato di lui. Se fosse stato informato di avere una figlia sarebbe tornato. Qualsiasi importante incarico rivestisse in Germania, avrebbe lasciato tutto per salvare lei e Laura. Non le avrebbe mai permesso di vivere in quella miseria, in mezzo a persone detestabili che la guardavano dall’alto in basso e non le credevano quando diceva chi era il padre della bambina. Il giorno in cui Hermann si fosse fermato davanti alla sua porta, elegantissimo nella sua uniforme dell’aviazione, con le braccia aperte e una bella automobile in attesa, sarebbero rimasti di sasso. La bambina strillava sempre più forte nella sua culla e Dagmar sentì montare la rabbia. Non riusciva a stare in pace neanche un attimo. Quella mocciosa lo faceva apposta, glielo si leggeva negli occhi. Piccola com’era, mostrava nei suoi confronti lo stesso disprezzo di tutti gli altri. Dagmar li odiava. Potevano andarsene all’inferno, fino all’ultima pettegola, e anche quei puttanieri che, nonostante le invettive, la sera venivano da lei e pagavano una miseria per ficcarglielo dentro. Quando le stavano sopra grugnendo come maiali se la facevano andar bene, chissà come mai. Gettò via le coperte e andò nel cucinino. Tutte le superfici libere erano coperte di piatti da lavare e dagli avanzi di cibo incrostati saliva un odore stantio. Aprì l’anta della dispensa. Era vuota, a parte una bottiglia di alcol diluito che aveva ricevuto come pagamento dal farmacista. La prese e se la portò nel letto. La bambina continuava a strillare e il vicino si rimise a battere sul muro ma Dagmar non ci fece caso. Aprì il tappo, con la manica della camicia da notte tolse alcune briciole di pane rimaste attaccate intorno all’apertura e si portò la bottiglia alla bocca. Se solo avesse bevuto a sufficienza, i rumori intorno a lei sarebbero spariti. Josef aprì speranzoso la porta dello studio di Sebastian. Sulla scrivania era appoggiata la planimetria del terreno su cui si sperava che in un futuro molto prossimo sarebbe sorto il museo. «Congratulazioni!» disse Sebastian andandogli incontro e assestandogli una poderosa pacca sulla spalla. «Il comune ha deciso di sostenere il progetto.» «Ottimo» rispose Josef. In realtà se lo aspettava. Come avrebbero potuto rifiutare una possibilità così fantastica? «Quando si parte?» «Calma, calma. Non so se ti rendi conto della mole di lavoro che ci aspetta. Dobbiamo elaborare i simboli di pace, pianificare il cantiere, fare tutti i calcoli e soprattutto rastrellare un sacco di grana.» «Ma la vedova Grünevald ci ha concesso il terreno e abbiamo già ricevuto diverse donazioni. E dato che a costruire sarai tu, spetta a te decidere quando si può cominciare, no?» Sebastian rise. «Non è che solo perché a costruire sarà la mia ditta sia tutto gratis. Ho dei salari da pagare e il materiale da acquistare. Costerà un bel po’ di soldi, questa roba.» Batté con il dito sui disegni. «Devo coinvolgere dei subappaltanti, e quelli non fanno niente per niente. Mica come me.» Josef sospirò e si sedette. Dire che le motivazioni di Sebastian lo lasciavano alquanto scettico era poco. «Cominciamo dal granito» continuò l’altro appoggiando i piedi sulla scrivania. «Ho ricevuto alcuni schizzi non male per i simboli di pace. Poi dobbiamo produrre del buon materiale di marketing e un packaging convincente, e si può partire.» Vide la faccia di Josef e il viso gli si aprì in un largo sorriso. «Ridi, ridi pure» disse Josef. «Per te si tratta solo di soldi. Non capisci il valore simbolico di questa cosa? Quel granito destinato al Terzo Reich diventerà la testimonianza della sconfitta dei nazisti e del trionfo del bene. E noi possiamo farne qualcosa e, sulla lunga distanza, creare tutto questo.» Indicò i disegni con una rabbia tale che quasi tremava. Il ghigno di Sebastian si allargò ulteriormente. «Nessuno ti costringe a lavorare con me. Posso strappare il contratto adesso e tu sarai libero di andare da chi vuoi.» Quell’idea lo tentava e per un attimo Josef soppesò la possibilità di farlo davvero. Poi abbassò le spalle. Doveva portare a compimento quello che si era ripromesso di fare. Fino a quel momento la sua era stata una vita sprecata. Non aveva niente da mostrare al mondo, niente che potesse onorare la memoria dei suoi genitori. «Sai benissimo che sei l’unico a cui possa rivolgermi» disse alla fine. «E resteremo uniti.» Sebastian tolse i piedi dalla scrivania e si sporse in avanti. «Ci conosciamo da molto tempo. Siamo come fratelli e tu sai come sono fatto: io sono sempre disposto ad aiutare un fratello.» «Sì, resteremo uniti» disse Josef. Poi lo scrutò. «Hai saputo che Leon è qui?» «Sì, ne ho sentito parlare. Pensa un po’, rivederlo qui. E anche Ia. Non l’avrei mai creduto.» «Pare che abbiano comprato la casa in vendita sopra Brandparken.» «Be’, il capitale ce l’hanno, quindi perché no. A proposito, magari anche Leon ha voglia di investire in questa cosa. Non gliel’hai chiesto?» Josef scosse forte la testa. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per affrettare la realizzazione del museo. Qualsiasi cosa, tranne coinvolgere Leon. «Tra l’altro ieri ho incontrato Percy» disse Sebastian, laconico. «Come gli vanno le cose?» chiese Josef, sollevato all’idea di cambiare argomento. «Ha ancora il castello?» «Gli è andata bene che la proprietà di Fygelsta fosse sottoposta a fedecommesso. Se avesse dovuto dare ai fratelli parte dell’eredità sarebbe stato al verde da un pezzo. Comunque, adesso sembra che le casse si siano esaurite definitivamente e per questo mi ha cercato. Per avere un aiutino estemporaneo, come l’ha messa giù lui.» Sebastian tracciò le virgolette nell’aria con le dita. «Pare che la commissione tributaria gli sia alle calcagna e quelli non riesce a incantarli con il nome e le pose aristocratiche.» «Quindi aiuterai anche lui?» «Non fare quella faccia impaurita. Non lo so ancora. Ma, come ho detto, sono sempre disposto a dare una mano a un fratello, e Percy lo è tanto quanto te, no?» «Sì» ammise Josef spostando lo sguardo sul mare oltre la finestra. Certo, erano fratelli uniti dalle tenebre. Riportò gli occhi sui disegni. Le tenebre dovevano essere scacciate grazie alla luce. L’avrebbe fatto per amore di suo padre, e per se stesso. «Cosa succede a Martin?» Patrik era sulla porta dell’ufficio di Annika. Non era riuscito a trattenersi dal chiederlo. Qualcosa non andava e si sentiva inquieto. Annika si girò a guardarlo e allacciò le mani in grembo. «Non posso dirti niente. Quando si sentirà pronto te ne parlerà lui.» Patrik sospirò e, con la testa piena di pensieri, si sedette sulla sedia di fianco alla porta. «E di questo caso che opinione ti sei fatta?» «Credo che tu abbia ragione.» Annika era palesemente sollevata per il cambio d’argomento. «L’incendio e la scomparsa sono collegati, in un modo o nell’altro. E considerando quello che è stato trovato sotto il pavimento mi sembra probabile che qualcuno temesse ciò che sarebbe saltato fuori se Ebba e il marito avessero proseguito con i lavori di ristrutturazione.» «È un pezzo che quella storia affascina la mia cara mogliettina.» «E adesso hai paura che ficchi il naso nella faccenda» concluse Annika. «Sì, puoi dirlo forte. Ma magari questa volta avrà sufficiente buon senso da non farlo.» Annika sorrise e Patrik si rese conto di non credere neanche per un momento a quello che aveva appena detto. «Sicuramente ha raccolto un bel po’ di materiale, considerando quanto è brava nelle ricerche documentarie. Se riuscisse a mantenere il suo lavoro d’indagine entro un livello accettabile, credo che potrebbe esserti utile» disse Annika. «Già. Peccato che il cosiddetto livello accettabile non sia il suo forte.» «Però sa badare a se stessa. Da che parte pensavi di cominciare, a proposito?» «Non saprei.» Patrik accavallò le gambe e si mise a giocherellare con il laccio di una scarpa, l’aria assente. «Dobbiamo sentire tutti quelli coinvolti all’epoca. Gösta sta cercando i recapiti degli insegnanti e degli allievi. La cosa più importante, naturalmente, è che parliamo con i cinque ragazzi che erano sull’isola quella vigilia di Pasqua. Gli ho chiesto di fare un elenco in ordine di priorità e di decidere da chi partire. Poi pensavo che tu potresti fare qualche verifica sui nomi che tira fuori lui. Non ho troppa fiducia nelle sue abilità, quanto a ricerche di questo genere, e forse avrei dovuto affidare a te anche questa parte, ma dopotutto è lui a sapere di più sul caso in questione.» «Per una volta, sembra davvero coinvolto» disse Annika. «E penso anche di sapere perché. Ho sentito dire che lui e sua moglie tennero con sé la piccola Elvander per un breve periodo.» «Come? Ebba era ospitata a casa di Gösta?» «Così si dice, almeno.» «Questo spiegherebbe il suo strano comportamento sull’isola.» Patrik ripensò a come il collega aveva guardato la donna dimostrandole mille premure, addirittura fisicamente. «Dev’essere per questo che non è riuscito a dimenticare il caso. Si saranno affezionati alla bambina.» Lo sguardo di Annika corse alla grande foto incorniciata di Leia, sulla scrivania. «Be’, certo» disse Patrik. Erano tante le cose che non sapeva e tante quelle che doveva cercare di scoprire su cosa fosse veramente successo a Valö. Di colpo il suo compito gli parve di una difficoltà insormontabile. Era davvero possibile risolvere quel vecchio caso dopo tanti anni? E quanta fretta c’era? «Pensi che chi ha cercato di dar fuoco alla casa ci proverà di nuovo?» chiese Annika come se gli avesse letto nel pensiero. Patrik soppesò la domanda e poi annuì. «Non so, forse. Ma non possiamo correre rischi. Dobbiamo mettercela tutta per scoprire cosa accadde davvero quella vigilia di Pasqua. Chiunque abbia voluto fare del male a Ebba e Mårten deve essere fermato prima che colpisca di nuovo.» Nuda davanti allo specchio, Anna sentiva che le lacrime premevano per uscire. Non si riconosceva. Sollevò lentamente una mano e se la passò sui capelli. Dopo l’incidente le erano ricresciuti più scuri e grossi di prima, ed erano ancora molto più corti rispetto alla lunga chioma che aveva sempre portato. Un salto dalla parrucchiera poteva forse servire a migliorarne l’aspetto, ma non le sembrava che ne valesse la pena. Il corpo non sarebbe cambiato grazie a una nuova pettinatura. Con la mano tremante seguì le cicatrici che lo attraversavano formando una specie di mappa casuale. Erano impallidite parecchio ma non sarebbero mai andate via del tutto. Si pizzicò distrattamente un rotolo all’altezza della vita. Era sempre stata snella senza grandi sforzi e aveva potuto dirsi orgogliosa del proprio corpo, e quella ciccia la disgustava. A causa delle lesioni aveva potuto muoversi poco, mangiando senza curarsi di quello che mandava giù. Alzò gli occhi sul viso ma quasi non trovò la forza di sostenere il proprio sguardo. Grazie ai bambini e a Dan aveva lottato per tornare alla vita, riemergendo dalle tenebre più profonde in cui fosse mai caduta, anche contando gli anni con Lucas. La domanda era se ne fosse davvero valsa la pena. Non conosceva ancora la risposta. Lo squillo del campanello la fece trasalire. Era sola in casa e quindi toccava a lei andare ad aprire. Dopo un ultimo sguardo al proprio corpo nudo s’infilò di corsa la tuta da casa che aveva lasciato a terra in un mucchietto e si precipitò giù. Quando vide che era sua sorella tirò un sospiro di sollievo. «Ciao, che combini?» chiese Erica. «Niente. Entra. Dove sono Maja e i gemelli?» «A casa. C’è Kristina con loro perché avevo un po’ di cose da fare, e così mi è venuta voglia di passare anche da te prima di andare a darle il cambio.» «Ottima pensata» disse Anna andando in cucina per preparare uno spuntino. Rivide davanti agli occhi il rotolo di ciccia bianca ma scacciò quell’immagine e tirò fuori dal frigo un po’ di pasticcini ripieni e ricoperti di cioccolato. «Uffa, io quelli non dovrei proprio mangiarli» disse Erica con una smorfia. «Il fine settimana scorso mi sono vista in bikini e non era un bello spettacolo.» «Ma va’, stai benissimo» ribatté Anna senza riuscire a nascondere l’amarezza. Erica non aveva niente di cui lamentarsi. Preparò una brocca di sciroppo diluito con acqua ed Erica la seguì sul piccolo patio sul retro della casa. «Che bei mobili da giardino... sono nuovi?» Passò la mano sul legno verniciato di bianco. «Sì, li abbiamo trovati dai Paulsson, di fianco all’alimentari della vecchia Eva, sai.» «Sei bravissima a scovare sempre le cose giuste» disse Erica, sentendosi ancora più sicura del fatto che Anna avrebbe apprezzato la sua idea. «Grazie. Ma dove hai detto che sei stata?» «Alla colonia» rispose Erica, e poi le riferì a grandi linee quello che era successo. «Che cosa emozionante. Quindi hanno trovato del sangue ma neanche un corpo? Comunque vuol dire che qualcosa deve essere successo per forza.» «Sì, così sembra.» Erica si allungò verso un pasticcino. Prese un coltello per dividerlo a metà ma poi lo rimise a posto e lo addentò decisa. «Sorridi» disse Anna, avvertendo per un attimo una ventata calda d’infanzia. Erica capì al volo e fece un sorriso da orecchio a orecchio mostrando i denti coperti di crema al cioccolato. «E guarda adesso» disse prendendo due cannucce dal vassoio e infilandosele nel naso. Poi incrociò gli occhi, sempre con i denti marroni in evidenza. Anna non riuscì a trattenersi dal ridere. Ricordava benissimo quanto la divertiva vedere la sorella maggiore fare la buffona, soprattutto considerando che per lo più era seria e matura, una specie di mamma più che una sorella. «Scommetto che non sai più bere con il naso» la sfidò Erica. «Certo che sono capace» rispose Anna offesa, infilandosi una cannuccia in ciascuna narice, immergendole nel bicchiere e inspirando con il naso. Quando l’acqua mescolata a sciroppo le penetrò nelle narici cominciò a tossire e starnutire in maniera incontrollata ed Erica scoppiò a ridere. «Si può sapere cosa combinate voi due?» Dan si era materializzato sulla soglia e quando videro la sua faccia le due sorelle esplosero letteralmente, cercando di dire qualcosa mentre si indicavano a vicenda ma senza riuscire a parlare per il troppo ridere. «Ho capito: è il caso che di qui in avanti non rientri mai senza preavviso.» Dan scosse la testa e tornò dentro. Alla fine riuscirono a darsi una calmata e Anna sentì che il nodo duro nello stomaco si era un pochino allentato. Lei ed Erica avevano avuto qualche screzio nel tempo ma era la persona che arrivava a toccarla più nel profondo in assoluto. Nessuno la mandava in bestia quanto lei e nessuno riusciva a renderla più allegra. Erano unite per sempre da un laccio invisibile e, mentre si asciugava le lacrime per le troppe risate, si rese conto di quanto avesse bisogno della sorella. «Dopo che ti ha vista in queste condizioni temo che stasera non potrai contare su manovre di avvicinamento da parte sua» disse Erica. Anna sbuffò. «Non so se cambi qualcosa. Però preferirei parlare d’altro. Sa un po’ di incestuoso parlare di sesso con una sorella che per puro caso è stata insieme al proprio convivente...» «Ma santo cielo, è stato una vita fa! A essere sincera non mi ricordo neanche com’era da nudo.» Anna si ficcò ostentatamente gli indici nelle orecchie ed Erica scosse la testa ridendo. «Okay, okay, parliamo di qualcos’altro.» Anna abbassò le mani. «Dimmi ancora di Valö. Che tipo è la figlia? Come hai detto che si chiama? Emma?» «Ebba» rispose Erica. «Abita lì con il marito, Mårten. Hanno intenzione di ristrutturare tutto e aprire un bed and breakfast.» «Pensi davvero che riesca a stare in piedi? La stagione non dura particolarmente a lungo.» «Non ne ho idea, ma ho la sensazione che non lo facciano per i soldi. Secondo me il progetto ha uno scopo diverso.» «Può darsi. Quel posto ha un gran potenziale.» «Lo so. Ed è qui che entri in scena tu.» Erica la indicò, lasciando trasparire l’entusiasmo. «Io?» chiese Anna. «Perché, cosa c’entro?» «Niente, per il momento, ma potresti entrarci. Ho avuto un’idea geniale!» «Sempre modesta» commentò Anna, ma doveva riconoscere che la sua curiosità era stata risvegliata. «In realtà sono stati Ebba e Mårten a entrare in argomento. Sono bravi nei lavori di ristrutturazione e falegnameria ma avrebbero bisogno di aiuto nell’individuare lo stile e l’atmosfera giusta. E tu hai proprio quello che serve: sei un’esperta di arredi e di antichità e hai buon gusto. Sei praticamente perfetta!» Erica riprese fiato e bevve un sorso di acqua e sciroppo. Anna non credeva alle proprie orecchie. Poteva essere il modo per verificare se la strada dell’arredatrice freelance era percorribile. La sua prima consulenza. Sentì salire un sorriso alle labbra. «Gliel’hai detto? Pensi che vogliano affidare l’incarico a qualcuno? Possono permetterselo? Che stile pensi che stiano cercando? Non deve essere per forza roba costosa, anzi: sarebbe bellissimo andare in giro alle aste in campagna a cercare mobili e oggetti davvero belli a poco prezzo. Visto il posto, secondo me ci starebbe bene uno stile leggermente all’antica, romantico, e so dove si possono trovare delle belle stoffe e...» Erica alzò una mano. «Ehi, ehi, calma! La risposta è no, non ho fatto il tuo nome. Ho solo detto che forse conoscevo qualcuno che poteva aiutarli. Non ho idea di che cifra abbiano a disposizione, ma chiamali e chiediglielo e se sono interessati possiamo andare da loro.» Anna scrutò Erica. «In realtà vuoi solo avere una scusa per andare là a ficcare il naso.» «Può darsi, ma penso che sarebbe bellissimo anche che vi conosceste. Sono convinta che saresti bravissima.» «Sì, in effetti ho riflettuto sulla possibilità di avviare un’attività mia.» «Ma allora buttati! Adesso ti do il numero, così li chiami subito.» Anna sentì nascere dentro qualcosa di inedito. Entusiasmo. Sì, era quella la parola che meglio descriveva ciò che sentiva. Per la prima volta da moltissimo tempo provava entusiasmo. «Okay, dammi qui, prima che cambi idea» disse prendendo il cellulare. L’intervista continuava a roderlo. Era così frustrante dover stare attenti a ogni parola e non poter parlare a chiare lettere. Il giornalista che aveva incontrato quella mattina era un cretino. Ce n’erano un sacco, in giro. Non vedevano la realtà per quella che era e per questo la sua responsabilità era ancora più grande. «Pensi che il partito ne verrà danneggiato?» John stava facendo ruotare il bicchiere tra le dita. La moglie alzò le spalle. «No, non sarà niente di grave. Non è un giornale a tiratura nazionale.» Si portò i capelli dietro le orecchie e inforcò gli occhiali per cominciare a leggere la pila di documenti che aveva davanti. «Non ci vuole molto perché un’intervista si diffonda. Ci stanno addosso come avvoltoi e sono sempre lì a cercare il minimo appiglio per attaccarci.» Liv lo guardò al di sopra degli occhiali da lettura. «Non venirmi a dire che sei sorpreso! Sai bene chi ha il potere sui mezzi d’informazione in questo Paese, no?» John annuì. «Non c’è bisogno che lo spieghi a me.» «Dopo le prossime elezioni le cose staranno diversamente. La gente aprirà gli occhi e si renderà conto di come va la società.» Sorrise, certa della vittoria, e continuò a sfogliare le carte. «Mi piacerebbe avere la tua stessa fiducia nel genere umano. A volte mi chiedo se arriverà mai un momento in cui la gente capirà. Che gli svedesi siano diventati troppo pigri e stupidi, troppo imbastarditi e degenerati per capire quanto si stanno diffondendo quei parassiti? Forse ormai nelle loro arterie scorre troppo poco sangue puro perché valga davvero la pena di darsi tanto da fare.» Liv smise di leggere e quando gli occhi si posarono sul marito mandavano lampi. «Adesso ascoltami, John. Fin da quando ci siamo conosciuti avevi chiaro in mente il traguardo. Hai sempre saputo cosa dovevi fare, a cosa sei destinato. Se non ascolta nessuno devi parlare più forte. Se qualcuno mette in discussione ciò che dici devi argomentarlo meglio. Finalmente siamo in parlamento ed è il popolo, esattamente quello di cui dubiti, che ha fatto in modo di farci arrivare lì. Chi se ne frega se un giornalista da strapazzo mette in discussione i calcoli della nostra proposta di bilancio. Sappiamo che abbiamo ragione e questa è l’unica cosa che conta.» John la guardò sorridendo. «A sentirti sei identica a quando ti ho conosciuto nella sezione giovanile. Però devo dire che stai meglio con i capelli che con il cranio rasato.» Si avvicinò e le diede un bacio sulla testa. A parte il temperamento focoso e la predisposizione alla propaganda agitatoria, non c’era niente, nella sua algida moglie sempre elegante e in ordine, che ricordasse la skinhead in abiti militari di cui si era innamorato. Eppure l’amava ancora di più. «È solo un articolo su un giornale locale.» Liv diede una stretta affettuosa alla mano di lui, rimasta appoggiata sulla sua spalla. «Ma sì, è vero» ammise John, anche se l’ansia non era scomparsa. Doveva a tutti i costi portare a termine quello che si era prefisso. I parassiti andavano estirpati e quel compito era stato affidato a lui. Avrebbe soltanto voluto avere più tempo. Il rivestimento del bagno era di una freschezza deliziosa sulla fronte. Ebba chiuse gli occhi e si lasciò colmare dal refrigerio. «Vieni a letto?» Sentì la voce di Mårten dalla camera ma non rispose. Non voleva andare a dormire. Ogni volta che si stendeva accanto a lui le sembrava di tradire Vincent. Per tutto il primo mese non era riuscita a stare nella stessa casa in cui si trovava Mårten. Neanche riusciva a posare gli occhi su di lui, e se incrociava il proprio sguardo allo specchio distoglieva il viso. Tutt’intorno a lei c’era solo la colpa. I suoi genitori si erano occupati di lei giorno e notte, accudendola come se fosse una bambina piccola. Le avevano parlato, implorandola e dicendole che lei e Mårten avevano bisogno l’uno dell’altra. Alla fine aveva cominciato a crederci, o forse si era solo arresa perché era più facile. Lentamente e a malincuore gli si era riavvicinata, tornando a stare nella loro casa. Per le prime settimane erano vissuti in silenzio, temendo quello che sarebbe potuto accadere se avessero cominciato a parlare e detto qualcosa che non avrebbero più potuto rimangiarsi. Poi avevano iniziato a scambiarsi brevi frasi quotidiane: «Mi passi il burro?», «Hai fatto il bucato?» Cose innocue e non pericolose da cui non potessero scaturire accuse. Con il tempo le frasi si erano allungate e gli argomenti inoffensivi erano aumentati di numero. Avevano cominciato a parlare di Valö. Era stato Mårten a proporre per primo di trasferircisi, ma anche lei l’aveva vista come una possibilità di lasciarsi alle spalle tutto quello che ricordava un’altra vita, forse non perfetta ma felice. Seduta con gli occhi chiusi e la fronte appoggiata al rivestimento del bagno dubitò per la prima volta di aver fatto la cosa giusta. Avevano venduto la villetta a schiera in cui Vincent aveva vissuto la sua breve vita, in cui gli avevano cambiato il pannolino e in cui avevano vagato la notte tenendoselo appoggiato alla spalla, in cui aveva imparato a gattonare, camminare e parlare. Non era più loro ed Ebba si chiese se avessero davvero preso una decisione o se piuttosto fossero fuggiti, per ritrovarsi in una casa in cui forse non erano neanche al sicuro e l’intero pavimento della sala da pranzo era stato sventrato perché probabilmente la sua famiglia era stata falciata lì dentro. Quel pensiero la turbava più di quanto non volesse riconoscere. Durante l’infanzia e l’adolescenza non aveva rimuginato troppo sulle proprie radici, ma ormai non era più possibile relegare il passato in un angolo della coscienza. Quando aveva visto quella grossa macchia scura sotto le tavole di legno si era resa conto, in uno sconvolgente attimo di lucidità, che non era un rompicapo, ma qualcosa di concreto. I suoi genitori erano probabilmente morti proprio lì e per qualche strana ragione sembrava più reale quello che il fatto che qualcuno avesse cercato di fare la pelle a lei e a Mårten. Non sapeva come rapportarsi a quella realtà e a viverci dentro, ma non c’era un altro posto dove andare. «Ebba?» Capì dal tono che, se non gli avesse risposto, di lì a poco si sarebbe alzato e sarebbe venuto a cercarla. Così alzò la testa e rispose a voce alta, rivolta alla porta: «Arrivo!» Si lavò accuratamente i denti, osservandosi allo specchio. Quella sera non distolse lo sguardo ma lo tenne fermo sulla donna con gli occhi vuoti, la madre senza un figlio. Poi sputò nel lavandino e si tamponò la bocca con l’asciugamano. «Quanto ci hai messo!» Mårten aveva un libro aperto davanti ma Ebba si accorse che era alla stessa pagina della sera prima. Lei non gli rispose. Sollevò le coperte e si infilò sotto. Lui mise il libro sul comodino e spense la luce. Le tende avvolgibili che avevano messo subito dopo il trasloco oscuravano completamente la stanza anche se fuori non era mai veramente buio. Ebba rimase immobile, gli occhi puntati verso il soffitto. Sentì la mano di Mårten che, tentoni, cercava la sua. Finse di non accorgersene ma lui non la ritirò, come faceva di solito, e proseguì verso la coscia, infilandosi lentamente sotto la maglietta e accarezzandole la pancia. Lei sentì la nausea risalire in gola mentre la mano saliva decisa verso l’alto sfiorandole il seno. Lo stesso seno che aveva allattato Vincent, gli stessi capezzoli che le sue piccole labbra avevano succhiato avidamente. Avvertendo in bocca il sapore della bile saltò giù dal letto, si precipitò in bagno e fece appena in tempo ad aprire il coperchio del water prima che lo stomaco si rivoltasse. Quando ebbe finito si accasciò senza forza sul pavimento. Dalla camera da letto sentì i singhiozzi di Mårten. Fjällbacka 1925 Dagmar guardò il giornale a terra. Laura la tirava per la manica ripetendo il suo eterno “mamma, mamma” ma lei non le diede retta. Era stanca di sentire quella vocina lamentosa che avanzava pretese e quella parola ripetuta così spesso da farla impazzire. Si piegò lentamente a raccogliere il giornale. Era tardo pomeriggio e aveva lo sguardo torbido, ma non c’erano dubbi. C’era scritto nero su bianco: “L’eroe tedesco Göring torna in Svezia”. «Mamma, mamma!» Laura la strattonava sempre più forte e lei divincolò il braccio con tanto impeto da far cadere dalla panchina la figlia, che si mise subito a frignare. «Taci!» sibilò Dagmar. Detestava quel pianto falso. Alla bambina non mancava niente. Aveva un tetto sulla testa, vestiti per coprirsi e cibo per sfamarsi, anche se qualche volta non era troppo abbondante. Dagmar rivolse di nuovo lo sguardo all’articolo e lo lesse faticosamente con il cuore che le batteva forte nel petto. Era tornato, si trovava in Svezia e sarebbe venuto a prenderla. Poi lo sguardo le cadde su una riga più sotto: “Göring si trasferisce in Svezia con la moglie svedese Carin”. Dagmar sentì che le si seccava la bocca. Si era sposato con un’altra. L’aveva tradita! La furia che le imperversava dentro fu intensificata dagli strilli di Laura che le riecheggiavano nella testa e inducevano le persone di passaggio a fissarle. «Adesso basta!» Diede a Laura uno schiaffo che le fece bruciare il palmo. La bambina si zittì, si portò la mano alla guancia arrossata e la fissò con gli occhi sbarrati. Poi si rimise a strillare ancora più forte e Dagmar si sentì spaccare in due dalla disperazione. Si lanciò sul giornale e lesse e rilesse la frase. Carin Göring. Il nome le rimbalzava da un lato all’altro della mente. Non c’era scritto a quando risaliva il matrimonio ma dato che era svedese era probabile che si fossero conosciuti in Svezia. Lei l’aveva sicuramente indotto a sposarla con l’inganno. Doveva essere colpa di Carin se Hermann non era tornato a prenderla e se non poteva stare con la sua famiglia. Accartocciò il giornale e si allungò a prendere la bottiglia sulla panchina. Era rimasto solo un goccio, cosa che la stupì perché quella mattina era piena. Ma non ci pensò più e bevve, sentendo il meraviglioso bruciore mentre la bevanda scorreva in gola. La bambina aveva smesso di urlare. Seduta per terra, tirava solo su col naso, le gambe piegate e le braccia intorno alle ginocchia. Come al solito si autocommiserava, già navigata a cinque anni di età. Ma Dagmar sapeva cosa bisognava fare. C’era ancora la possibilità di aggiustare tutto. In futuro Hermann avrebbe avuto modo di stare con loro e sarebbe riuscito a mettere in riga anche Laura. Un padre capace di mantenere la disciplina era esattamente quello che serviva alla bambina, perché per quanto lei tentasse di farla ragionare a forza di botte sembrava del tutto inutile. Seduta sulla panchina in Brandparken, Dagmar sorrise. Aveva scoperto la radice di ogni male ed entro poco tempo per lei e Laura le cose si sarebbero sistemate. La macchina di Gösta accostò davanti al passo carraio ed Erica tirò il fiato. Aveva temuto che Patrik potesse incrociarlo mentre andava al lavoro. Aprì prima che Gösta avesse il tempo di suonare il campanello. Alle sue spalle i bambini facevano un tale chiasso che per lui dovette essere come penetrare in un muro sonoro. «Scusa il rumore. Questo posto verrà classificato come luogo di lavoro non idoneo da un giorno all’altro.» Si girò per richiamare Noel che stava rincorrendo un Anton in lacrime. «Tranquilla. Tanto sono abituato a sentir sbraitare Mellberg» rispose Gösta accovacciandosi. «Ehi, ciao. Sembrate proprio dei bei diavoletti.» Anton e Noel si bloccarono, improvvisamente timidi, mentre Maja si fece avanti spavalda. «Ciao, vecchio signore. Io mi chiamo Maja.» «Ma Maja, non si dice così!» la rimproverò Erica guardandola seria. «Non fa niente.» Gösta rise e si alzò. «I bambini e i matti dicono sempre la verità, e io sono in effetti un vecchio signore. Vero, Maja?» La bambina annuì, lanciò un’occhiata trionfante alla madre e se ne andò. I gemelli non si erano ancora fatti avanti e arretrarono lentamente in direzione del soggiorno senza staccare lo sguardo dall’ospite. «Quei due non li si incanta tanto facilmente» commentò Gösta seguendo Erica in cucina. «Anton è sempre stato timido. Noel invece di solito è molto estroverso, ma adesso sembra essere entrato in una fase in cui gli estranei sono pericolosissimi.» «Non male, come impostazione» commentò Gösta sedendosi e guardandosi intorno inquieto. «Siamo sicuri che Patrik non torni a casa?» «È uscito mezz’ora fa e ormai dovrebbe essere alla stazione.» «Non sono sicuro che sia una buona idea.» Si mise a disegnare con il dito sulla tovaglia. «È perfetta, invece» ribatté Erica. «Non c’è motivo di coinvolgere Patrik, per ora. Non sempre apprezza che io dia una mano.» «Non posso dargli torto. Diciamo che ogni tanto sei riuscita a cacciarti abbastanza nei pasticci.» «Però è sempre andata a finire bene.» Erica si rifiutava di farsi mettere all’angolo. A lei sembrava che la mossa fosse geniale, e infatti la sera prima era subito andata a telefonare a Gösta di nascosto. Ed eccolo lì, anche se ci era voluta tutta la sua abilità persuasiva per convincerlo a venire senza dirlo a Patrik. «Io e te abbiamo una cosa in comune» disse sedendosi di fronte a lui. «Entrambi vogliamo davvero sapere cosa successe a Valö quella Pasqua.» «Sì, però ora ci sta lavorando la polizia.» «Ed è una gran cosa. Ma sai bene quanto siete resi inefficienti dalla costrizione a seguire regole e protocolli. Io posso lavorare in maniera molto più libera.» Gösta sembrava ancora scettico. «Può darsi, ma se Patrik viene a saperlo diventerà una belva. Non so se voglio...» «Per questo non saprà nulla» lo interruppe Erica. «Tu fai in modo che io possa esaminare in segreto il materiale dell’indagine e in cambio io ti metterò a parte di tutto quello che scopro. Appena trovo qualcosa te lo passo. Tu lo presenti a Patrik e diventi l’eroe della situazione e poi io potrò usare tutto il materiale per un libro. Ci guadagneremo tutti, non ultimo Patrik. Lui vuole risolvere il caso e incastrare l’incendiario. Non farà domande, ma sarà ben contento di accogliere tutto quello che gli arriva. Inoltre adesso che Martin è in malattia e Paula in ferie non avete delle gran risorse a disposizione, no? In fondo non fa male se un’altra persona lavora all’indagine, giusto?» «Forse hai ragione.» L’espressione di Gösta si rischiarò un po’ ed Erica intuì che l’idea di poter diventare un eroe lo allettava. «Ma pensi davvero che Patrik non si insospettirà?» «No, vedrai. Sa quanto sei coinvolto in questo caso, quindi non intuirà niente.» In soggiorno sembrava essere scoppiato un parapiglia e quindi Erica si alzò e corse a vedere. Dopo un paio di paroline a Noel, esortato a lasciare in pace suo fratello, e un veloce intervento per mettere su un film di Pippi, nella stanza fu ristabilita la calma e lei poté tornare in cucina. «Quindi adesso dobbiamo decidere da che parte cominciare. Avete già saputo qualcosa del sangue?» Gösta scosse la testa. «No, non ancora, ma Torbjörn sta ancora lavorando con i suoi tecnici per vedere se trova altro e nel corso della giornata spera di poter avere un rapporto che stabilisce con sicurezza se si tratta o meno di sangue umano. L’unica cosa che abbiamo ottenuto finora è un rapporto preliminare sull’incendio, che Patrik ha ricevuto ieri subito prima che io andassi a casa.» «Avete già cominciato con gli interrogatori?» Erica era così presa dalla foga che quasi non riusciva a stare seduta. Non aveva intenzione di arrendersi finché non avesse fatto tutto quello che poteva per contribuire alla soluzione di quell’enigma. L’eventuale libro che ne sarebbe venuto fuori sarebbe stato un di più, una splendida ciliegina sulla torta. «Ieri ho fatto un elenco, in ordine di priorità, delle persone coinvolte che dovremmo interrogare, e ho anche cominciato a cercarne i recapiti, ma considerando il tempo che è passato non è facilissimo. Da un lato, può riuscire difficile rintracciare la gente, dall’altro i ricordi possono essere molto vaghi. Vedremo che risultati darà.» «Pensi che i ragazzi potessero essere coinvolti?» chiese lei. Lui capì al volo a chi si riferiva. «Certo, qualche volta ci ho pensato, però non lo so. Li interrogammo ripetutamente e le versioni coincidevano. E non c’erano prove materiali che...» «Neanche una?» lo interruppe Erica. «No, non c’era molto su cui basarsi. Dopo aver trovato Ebba sola in casa, io e il mio collega Henry scendemmo al pontile e fu allora che incrociammo i ragazzi che stavano arrivando con la barca e in effetti avevano tutta l’aria di essere stati fuori a pesca.» «Controllaste la barca? Non si poteva escludere che i corpi fossero stati scaricati in mare.» «Fu esaminata con la massima cura e non presentava tracce di sangue né niente del genere, il che era quanto meno probabile nel caso fosse stata usata per trasportare cinque cadaveri. Tra l’altro mi chiedo se avrebbero avuto la forza di trascinare i corpi fino al pontile. Erano ragazzi piuttosto esili. Inoltre in genere i cadaveri vengono a galla e prima o poi vengono sospinti a riva. Qualche membro della famiglia avrebbe dovuto essere trovato, a meno che i ragazzi non si fossero impegnati per zavorrare i corpi, cosa che si può fare solo con pesi che magari non si trovano tanto facilmente, quando si ha fretta.» «Parlaste anche con gli altri allievi della scuola?» «Sì, ma alcuni genitori quasi non ci permisero di interrogare i figli. Erano dell’alta società e non volevano rischiare uno scandalo.» «Venne fuori qualcosa di interessante?» Gösta sbuffò. «No, le solite frasi fatte: era una cosa terribile ma il loro figlio non c’entrava e non aveva niente da dire sulla vita nel collegio. Era tutto il massimo. Rune era il massimo, gli insegnanti erano il massimo e non c’erano conflitti né screzi. I ragazzi ripetevano per lo più le parole dei genitori.» «E gli insegnanti?» «Naturalmente li interrogammo entrambi. Uno dei due, Ove Linder, all’inizio ci sembrò sospetto, ma poi saltò fuori che aveva un alibi.» Gösta rimase in silenzio un istante. «Insomma, non avevamo indiziati. Non potevamo neanche dimostrare che fosse stato commesso un reato. Però...» Erica appoggiò i gomiti sul tavolo e si sporse in avanti. «Però...?» Gösta esitò. «Bah, non lo so. Tuo marito ogni tanto parla di sensazioni di pancia e in genere lo prendiamo in giro, ma devo riconoscere che già allora di pancia sentivo che c’era qualcos’altro da scoprire. Ce la mettemmo veramente tutta, senza cavare un ragno dal buco.» «Allora riproviamo. Dal 1974 a oggi sono cambiate molte cose.» «La mia esperienza mi dice che alcune cose rimangono uguali: le persone dell’alta società trovano sempre il modo di proteggersi.» «Riproviamo lo stesso» ripeté Erica paziente. «Tu finisci di preparare l’elenco di allievi e insegnanti e poi me lo passi, così possiamo lavorare su un duplice fronte.» «Basta che...» «No, Patrik non verrà a saperlo. E tu avrai tutto quello che trovo. Non eravamo rimasti d’accordo così?» «Sì.» Il viso magro di Gösta aveva l’aria tormentata. «Tra l’altro ieri sono andata a parlare con Ebba e suo marito.» Gösta la fissò. «E come stava? È preoccupata per quello che è successo? Come...?» Erica rise. «Calma, calma! Una domanda alla volta.» Poi si fece seria. «Era giù, ma non particolarmente preoccupata, direi. Sostengono di non avere idea di chi possa aver appiccato l’incendio, però non riesco a stabilire se mentono o se sono sinceri.» «Secondo me dovrebbero andare via di lì.» Lo sguardo si fece ansioso. «Almeno finché non avremo finito di indagare. Non è un posto sicuro e se non ci sono rimasti secchi è stato per pura fortuna.» «Non mi sembrano tipi da mollare alla prima occasione.» «Sì, Ebba è una testarda» disse Gösta con evidente orgoglio. Erica lo guardò con aria interrogativa ma non fece domande. Sapeva anche lei quanto le capitava di lasciarsi coinvolgere nel destino delle persone di cui scriveva. Probabilmente lo stesso valeva per i poliziotti che nel corso della loro vita professionale dovevano seguire quello di tanta gente. «Una cosa che mi ha fatto pensare, quando ho parlato con Ebba...» «Sì?» disse Gösta, ma uno strillo acutissimo costrinse Erica a correre in soggiorno per vedere chi si fosse fatto male, e solo qualche minuto dopo poté riprendere il filo del discorso. «Dov’eravamo? Ah, sì, mi è sembrato un po’ strano che Ebba non avesse neanche un oggetto appartenuto alla famiglia. Dopotutto quell’edificio non era solo un collegio ma anche la loro casa e devono esserci stati degli effetti personali. Davo per scontato che li avesse Ebba, e invece lei non ha idea di che fine abbiano fatto.» «Hai ragione.» Gösta si accarezzò il mento. «Devo controllare se si accenna alla faccenda in qualche parte della vecchia indagine. Non mi sembra.» «Pensavo che sarebbe utile osservare i loro oggetti con occhi nuovi.» «Non male come idea. Vedrò cosa riesco a trovare.» Guardò l’orologio e saltò su dalla sedia. «Santo cielo, il tempo è volato. Patrik si chiederà dove sono.» Erica gli appoggiò tranquillizzante una mano sul braccio. «Sono certa che ti verrà in mente una buona scusa. Inventati che non hai sentito la sveglia, o qualsiasi cosa. Non sospetterà nulla, garantito.» «È facile dirlo, per te» rispose Gösta andando a mettersi le scarpe. «Non dimenticare quello che abbiamo deciso. Mi servono i recapiti di tutte le persone coinvolte e poi devi guardare se trovi qualcosa sugli effetti personali degli Elvander.» Erica si sporse in avanti e lo abbracciò di slancio. Lui rispose rigido alla stretta. «Va bene, va bene. Adesso lasciami andare. Prometto che me ne occuperò appena ne avrò la possibilità.» «Sei una roccia» sorrise Erica facendogli l’occhiolino. «Ma va’. Torna dai tuoi piccolini, ora. Mi faccio vivo quando ho in mano qualcosa.» Erica chiuse la porta e fece come aveva detto Gösta: si sedette sul divano e mentre tutti e tre le si arrampicavano addosso per conquistare il posto migliore sulle sue ginocchia seguì distratta le avventure di Pippi sullo schermo. Alla stazione di polizia regnava la calma. Per una volta, Mellberg aveva lasciato il suo ufficio per andare a sedersi nella saletta del personale. Ernst, che non era mai a più di un metro di distanza dal padrone, si era steso sotto il tavolo nella speranza che prima o poi fosse ora di uno spuntino. «Che deficiente!» sibilò Mellberg indicando il giornale che aveva davanti. Il Bohusläningen aveva messo in evidenza l’intervista con John Holm. «Già. Proprio non capisco come si possa votare persone del genere facendole entrare in parlamento. Probabilmente è l’altra faccia della medaglia della democrazia.» Patrik si sedette davanti al suo capo. «Tra l’altro dobbiamo parlare con lui. Pare che fosse uno dei ragazzi che quella settimana di Pasqua si trovavano sull’isola.» «Allora sarà meglio che ci muoviamo. Qui c’è scritto che si ferma questa settimana ma poi rientra a Stoccolma.» «Sì, ho visto, e quindi pensavo di prendere con me Gösta e andare a parlargli stamattina.» Si girò e guardò in corridoio. «Solo che non so che fine abbia fatto. Annika? Hai notizie di Gösta?» «Non una parola. Magari non ha sentito la sveglia?» rispose la segretaria dal suo ufficio. «Allora vengo io con te» sentenziò Mellberg chiudendo il giornale. «No, non è necessario. Posso aspettare Gösta. Arriverà da un momento all’altro. Sicuramente lei ha cose più importanti da fare.» Patrik sentì arrivare il panico. Un interrogatorio con il capo al seguito significava un disastro assicurato. «Sciocchezze! Avermi al tuo fianco mentre parli con quel deficiente ti sarà utile.» Si alzò e lo guardò deciso. «Allora? Partiamo?» Mellberg fece schioccare le dita e Patrik cercò febbrilmente un argomento che potesse distoglierlo dal suo piano. «Forse è meglio che prima chiamiamo per fissare un appuntamento?» Mellberg sbuffò. «Uno come quello bisogna coglierlo... coglierlo... come si dice?» chiese facendo di nuovo schioccare le dita. «Ah sì! Alla provvista.» «Alla sprovvista» lo corresse Patrik. «Si dice alla sprovvista.» Qualche minuto più tardi erano in macchina e stavano procedendo verso Fjällbacka. Mellberg fischiettava soddisfatto tra sé e sé. All’inizio aveva insistito per guidare, ma Patrik aveva opposto un netto rifiuto. «Quelle persone hanno vedute così limitate. Sono meschine, senza alcun rispetto per le altre culture e per le differenze tra esseri umani.» Mellberg annuì convinto per sottolineare le proprie parole. Patrik aveva una gran voglia di ricordargli quanto erano limitate le sue fino a poco tempo prima. Alcune delle affermazioni che declamava ai quattro venti sarebbero sicuramente state apprezzate dagli Amici della Svezia. Tuttavia, a sua difesa andava detto che si era sbarazzato dei suoi pregiudizi appena si era innamorato di Rita. «È quello, vero?» Patrik si fermò sullo spiazzo sterrato davanti a uno dei capanni rossi lungo Hamngatan. Avevano deciso di tentare, sperando che fosse lì e non nella sua casa a Mörhult. «Se non altro qualcuno è sul pontile.» Mellberg allungò il collo per guardare oltre la staccionata. Si avvicinarono facendo scricchiolare la ghiaia sotto le scarpe. Patrik non sapeva se bussare, ma sembrava ridicolo e così spinse il cancelletto e basta. Riconobbe subito John Holm. Il fotografo del Bohusläningen aveva catturato in pieno il suo fisico da tipico svedese, riuscendo peraltro a far risultare minacciosa la foto dell’uomo sorridente. Anche in quel momento, venendo loro incontro, aveva sulla bocca un largo sorriso, ma gli occhi azzurri avevano un’espressione perplessa. «Buongiorno, siamo della polizia di Tanum» disse Patrik presentando se stesso e Mellberg. «Ah.» Lo sguardo si fece più vigile. «È successo qualcosa?» «Dipende da come la si vede. In realtà si tratta di un episodio che risale a molto tempo fa ma che purtroppo è tornato di attualità.» «Valö» disse John, senza che si riuscisse a interpretare l’espressione del suo sguardo. «Sì, esatto» rispose Mellberg in tono aggressivo. «Si tratta di Valö.» Patrik fece un paio di respiri profondi per mantenere la calma. «Possiamo sederci?» chiese, e l’uomo annuì. «Certo, accomodatevi. Qui il sole batte piuttosto forte. A me piace, ma se per voi è eccessivo posso aprire l’ombrellone.» «Grazie, non serve.» Patrik agitò una mano per tranquillizzarlo. Voleva sbrigare la faccenda il più in fretta possibile, prima che il capo avesse il tempo di fare danni. «Vedo che sta leggendo il Bohusläningen.» Mellberg fece un gesto in direzione del quotidiano aperto sul tavolo. John alzò le spalle. «Il giornalismo scadente mi irrita sempre. Sono stato mal citato e male interpretato e l’intero articolo è pieno di insinuazioni.» Mellberg si aggiustò il colletto della camicia. Aveva già cominciato a diventare rosso in viso. «A me è sembrato ben scritto.» «È evidente che il giornale ha scelto da che parte stare e se si scende in campo si deve essere preparati ad accettare questo genere di attacchi.» «Tutti gli aspetti che il giornalista mette in discussione sono quelli che avete portato avanti nella vostra politica. Per esempio questa sciocchezza dell’espulsione dal Paese degli immigrati che hanno commesso un reato, anche se hanno il permesso di soggiorno. Come funzionerebbe, secondo voi? Uno che abita in Svezia da un sacco di anni e ha messo radici dovrebbe essere rimandato nel suo Paese d’origine solo perché ha fregato una bicicletta?» Mellberg aveva alzato la voce e parlava con tanta foga che stava sputacchiando. Patrik era paralizzato. Era come assistere a un incidente stradale un attimo prima che accadesse. Anche se era d’accordo su tutto quello che aveva detto Mellberg, non era certo l’occasione giusta per mettersi a discutere di politica. John gli rivolse un’occhiata indifferente. «Quella è una questione che i nostri avversari hanno scelto di interpretare in maniera del tutto sbagliata. Potrei spiegarvela in maniera approfondita, ma immagino che non siate qui per questo.» «No, infatti. Come si diceva siamo qui per parlare di quanto successo a Valö nel 1974. Vero, commissario?» si affrettò a dire Patrik trapanando con lo sguardo Mellberg che, dopo qualche secondo di silenzio, annuì controvoglia. «Sì, corre voce che sia successo qualcosa in questi giorni» annuì John. «Avete trovato la famiglia?» «Non proprio» rispose Patrik evasivo. «Ma qualcuno ha cercato di dar fuoco alla casa. Se ci fosse riuscito, probabilmente la figlia e suo marito sarebbero rimasti bruciati vivi.» John si raddrizzò sulla sedia. «La figlia?» «Sì, Ebba Elvander» confermò Patrik. «O Ebba Stark, come si chiama da sposata. Lei e suo marito hanno preso in mano l’edificio e lo stanno ristrutturando.» «Immagino sia necessario. A quanto ho sentito è piuttosto malmesso.» Lo sguardo gli corse a Valö, oltre il braccio di mare scintillante. «Non ci va da tempo?» «Non ci ho più messo piede da quando fu chiuso il collegio.» «Come mai?» John spalancò le braccia. «Mah, non ne ho più avuto motivo.» «Lei cosa pensa che sia successo alla famiglia?» «Immagino di poter tentare di indovinare come chiunque altro, ma non ne ho davvero idea.» «Be’, rispetto a chiunque altro lei ha sicuramente qualche elemento in più su cui basarsi» obiettò Patrik. «Dopotutto abitava con loro ed era lì quando sparirono.» «Non proprio: io e un gruppo di altri allievi eravamo usciti a pesca. Quando tornammo a terra e ci trovammo davanti due poliziotti rimanemmo di sasso. Leon si arrabbiò addirittura. Pensava che due estranei stessero portando via Ebba.» «Quindi non ha nessuna teoria? Eppure deve averci riflettuto sopra, negli anni.» Mellberg sembrava scettico. John lo ignorò e si rivolse a Patrik. «Per essere precisi, non abitavamo con la famiglia. Frequentavamo la scuola, e tra noi allievi e la famiglia Elvander correva un confine preciso. Per esempio, non eravamo stati invitati al pranzo della vigilia. Rune stava molto attento a tenerci a distanza e gestiva quella scuola come un acquartieramento militare. Per questo i nostri genitori lo adoravano con lo stesso trasporto con cui lo odiavamo noi.» «Gli allievi andavano d’accordo oppure tra voi c’erano dei conflitti?» «Qualche dissidio c’era, ma in una scuola di soli adolescenti maschi sarebbe stato strano il contrario. Comunque non è mai successo niente di grave.» «E gli insegnanti? Che opinione avevano del direttore?» «Quegli smidollati avevano una tale paura di lui che probabilmente non ne avevano proprio, di opinioni. Per lo meno non dicevano mai niente che giungesse alle nostre orecchie.» «I figli di Rune avevano più o meno la vostra età. Li frequentavate?» John scosse la testa. «Rune non l’avrebbe mai permesso. Però con il più grande avevamo a che fare piuttosto spesso, visto che era una specie di aiutante nella scuola. Uno stronzo bello e buono.» «A sentirla parlare sembra che avesse opinioni abbastanza decise su alcuni membri della famiglia.» «Li detestavo, come i miei compagni. Ma non abbastanza da ucciderli, se è questo che pensate. È tipico di quell’età non dare credito alle autorità.» «E gli altri figli?» «Se ne stavano per conto loro. Non avevano il coraggio di fare diversamente, e questo valeva anche per Inez, che si occupava personalmente delle pulizie, del bucato e della cucina. La figlia di Rune, Annelie, le dava una mano. Comunque, come dicevo, non potevamo frequentarli e forse un motivo c’era. Molti dei ragazzi erano dei veri scapestrati, a forza di crescere in mezzo a vizi e privilegi. Per questo finivano in collegio, immagino. I genitori si accorgevano all’ultimo momento di aver tirato su degli individui pigri e incapaci e cercavano di rimediare spedendoli da Rune.» «Probabilmente neanche i suoi erano proprio indigenti, no?» «I soldi li avevano» rispose John sottolineando “avevano”. Poi sigillò le labbra per mostrare che non intendeva discuterne oltre. Patrik lasciò perdere ma decise di fare qualche ricerca sul suo background familiare più tardi. «Lei come sta?» chiese John di colpo. Gli ci volle un secondo per capire a chi si riferisse. «Ebba? Abbastanza bene, sembra. Come dicevo, sta rimettendo in sesto la casa.» John rivolse di nuovo lo sguardo a Valö e Patrik desiderò di poter leggergli nel pensiero. Si chiedeva davvero cosa si muovesse nella testa di John Holm. «La ringraziamo di averci concesso un po’ del suo tempo» disse alzandosi. Per il momento non avevano altre domande, ma quella conversazione l’aveva reso ancora più curioso di come funzionasse la vita del collegio. «Sì, la ringraziamo. Capisco che è molto impegnato» disse Mellberg. «A proposito, le porto i saluti della mia convivente. Viene dal Cile. È arrivata in Svezia negli anni Settanta.» Patrik lo trascinò via per un braccio. John Holm chiuse il cancelletto alle loro spalle con un sorriso rigido sul viso. Gösta cercò di entrare non visto, ma non poteva sperare di riuscirci. «Cos’è successo, non hai sentito la sveglia? Non è da te» disse Annika. «No, non ha proprio suonato» rispose lui senza sostenere il suo sguardo. La segretaria aveva la capacità di scandagliare la gente nel profondo e non gli piaceva mentirle. «Dove sono tutti?» Dal corridoio non si sentiva il minimo rumore e Annika sembrava essere l’unica presente. Solo Ernst arrivò a passo felpato sentendo la sua voce. «Patrik e Mellberg sono andati a parlare con John Holm, ma io ed Ernst teniamo le posizioni. Vero, piccolo?» disse la segretaria grattando il cane dietro le orecchie. «Patrik si chiedeva dove fossi, quindi ti consiglio di esercitarti un po’ su quella storia della sveglia.» Alzò gli occhi e lo scrutò. «Dimmi cosa stai tramando, così magari posso aiutarti a non farti scoprire.» «E che diavolo...» mormorò Gösta, sapendo benissimo di essere stato smascherato. «Parliamone bevendoci un caffè.» Si avviò verso la saletta del personale e Annika lo seguì. «Allora?» disse lei quando si furono seduti. Gösta riferì suo malgrado l’accordo stretto con Erica e Annika si fece una gran risata. «Certo che sei riuscito a cacciarti in un bel guaio. Lo sai, no, com’è fatta? Se le si concede un dito si prende il braccio. Patrik monterà su tutte le furie se viene a saperlo.» «Sì, me ne rendo conto» disse Gösta cambiando posizione sulla sedia. Sapeva che aveva ragione, ma per lui quella faccenda era davvero importante. E non era così stupido da non capire perché: lo stava facendo per lei, per la bambina che lui e MajBritt avevano in un certo senso tradito. Annika aveva smesso di ridere e lo stava guardando seria. «Questa storia significa molto per te.» «Sì, è vero. Ed Erica può darmi una mano. È brava. So che Patrik non approverebbe il suo coinvolgimento, ma lei sa fare il suo lavoro, cioè trovare informazioni scavando nel passato, ed è innegabile che una competenza del genere ci serve, adesso.» Annika rimase in silenzio per qualche istante. Poi inspirò profondamente. «Okay. Non dirò niente a Patrik. A una condizione.» «Quale?» «Che tu mi tenga informata sulle conclusioni a cui arrivate tu ed Erica e che io possa aiutarvi quando serve. Non sono male neanche io, quanto a trovare informazioni.» Gösta la guardò sorpreso. Non era esattamente quello che si aspettava. «Allora è deciso. Però, come hai detto anche tu, quando Patrik ci scoprirà non sarà piacevole.» «Ci penseremo quando verrà il momento. A che punto siete, allora? E come posso contribuire io?» Sollevato, Gösta riferì la conversazione avuta con Erica la mattina. «Dobbiamo trovare i recapiti di tutti gli allievi e gli insegnanti della scuola. Io ho il vecchio elenco, ma la maggior parte dei dati non è aggiornata. Però a partire da quelli credo che si riesca a risalire a quasi tutti quelli attuali. Diversi avevano cognomi piuttosto insoliti e forse agli indirizzi di un tempo si trova qualcuno che può dirci dove sono finite le persone che ci interessano.» Annika lo guardò con le sopracciglia sollevate. «Ma scusa, i numeri di codice fiscale non erano riportati?» Lui la fissò, dandosi dello stupido. Come aveva fatto a non pensarci? Non sapeva cosa dire. «Devo interpretare la tua espressione come una risposta positiva? Quindi i numeri c’erano. Bene, in questo caso entro oggi pomeriggio o domani al massimo dovrei avere l’elenco pronto. Può andare?» Gli stava sorridendo e Gösta glielo concesse volentieri. «Perfetto» disse. «Quanto a me, pensavo di chiedere a Patrik di andare insieme a parlare con Leon Kreutz.» «Perché proprio lui?» «Non c’è un motivo particolare, ma è uno dei ragazzi che ricordo meglio. Ebbi l’impressione che fosse il leader del gruppo. Inoltre ho saputo che lui e sua moglie hanno appena comprato la grande casa in cima alla rupe. Sai, quella di Fjällbacka.» «Quella bianca da cui si gode un panorama spettacolare, messa in vendita a dieci milioni di corone?» chiese Annika. I costi delle case con vista sul mare non cessavano di sorprendere i residenti della zona, che seguivano con interesse basi d’asta e prezzi concordati alla fine delle trattative. Tuttavia, dieci milioni provocavano un moto di stupore anche nei più navigati. «A quanto ho capito possono permetterselo.» Gösta ricordava bene il ragazzo dagli occhi scuri e il bel viso. Già all’epoca era circondato da un’aura di ricchezza e di qualcos’altro che non avrebbe saputo definire. Una sorta di sicurezza innata: era la descrizione più fedele che riuscisse a trovare. «Bene, allora diamoci da fare» disse Annika mettendo la sua tazza nella lavastoviglie e lanciando un’occhiata a Gösta per invitarlo a fare altrettanto. «A proposito, mi ero dimenticata che stamattina avevi un appuntamento dal dentista.» «Dentista? Mica avevo...» Gösta s’interruppe e sorrise. «Ah, giusto. Te l’avevo detto, ieri, che dovevo andare dal dentista. E guarda qui: neanche una carie.» Indicò la bocca e le fece l’occhiolino. «Non rovinare una bugia efficace aggiungendo troppi particolari» gli raccomandò Annika avviandosi verso il suo computer. Stoccolma 1925 Per poco non erano state buttate giù dal treno. Il controllore le aveva portato via la bottiglia sostenendo che era troppo ubriaca per viaggiare. Non era affatto vero. Le serviva solo un cicchetto ogni tanto per sopportare la vita, cosa che chiunque avrebbe dovuto capire. Era costantemente costretta a elemosinare e sbrigare le umilianti incombenze che le venivano concesse solo “per riguardo alla bambina” e quasi sempre andava a finire che doveva piegarsi alle visite in camera di ipocriti e ansimanti puttanieri. Era stato sempre per riguardo alla bambina che il controllore si era impietosito e le aveva lasciate restare a bordo fino a Stoccolma. E meno male, perché se le avesse sbattute giù a metà strada Dagmar non avrebbe saputo come tornare indietro. Aveva impiegato due mesi a mettere insieme i soldi per un biglietto di sola andata e non le restava neanche un centesimo. Ma non faceva niente, perché se solo fossero arrivate a destinazione e lei avesse potuto parlare con Hermann non avrebbero mai più dovuto preoccuparsi dei soldi. Lui si sarebbe preso cura di loro. Una volta capito quello che aveva passato Dagmar, avrebbe subito lasciato quella bugiarda con cui si era sposato. Si fermò davanti a una vetrina e si specchiò. Sì, in effetti era un po’ invecchiata dall’ultima volta che si erano visti. I capelli non erano più così folti e a pensarci era un po’ che non li lavava. E il vestito che aveva rubato da uno stenditoio prima di partire le cadeva sul corpo magro come un sacco. Quando i soldi non bastavano preferiva spenderli per l’alcol che per il cibo, ma anche questo sarebbe cambiato. Presto sarebbe tornata al suo aspetto consueto e, capendo quanto era stata dura la vita per lei da quando lui l’aveva abbandonata, Hermann avrebbe sicuramente provato per lei una tenera compassione. Prese Laura per mano e ricominciò a camminare. La bambina recalcitrava, costringendola a trascinarla. «Muovi quelle gambe» sibilò. Possibile che dovesse essere sempre così lenta? Dovettero chiedere indicazioni più volte, ma alla fine si ritrovarono davanti al portone giusto. Era stato facile scovare l’indirizzo. Era sull’elenco telefonico: Odengatan 23. Il palazzo era grande e imponente come l’aveva immaginato. Fece per aprire il portone, ma era chiuso e Dagmar aggrottò le sopracciglia. In quel momento arrivò un signore che tirò fuori una chiave e aprì. «Da chi dovete andare?» Lei raddrizzò fiera la testa. «Göring.» «Ah. In effetti potrebbero avere bisogno di una mano» rispose l’uomo facendole entrare. Per un attimo Dagmar si chiese cosa intendesse, ma poi alzò le spalle. Non importava. Ormai c’erano quasi. Guardò sul tabellone nell’ingresso, prese nota del piano a cui abitava la famiglia Göring e si trascinò dietro la bambina per le scale. Con la mano tremante suonò il campanello. Presto sarebbero di nuovo stati insieme. Hermann, lei e Laura. Sua figlia. Strano che bastasse così poco, pensò Anna al timone della barca sua e di Dan. Quando aveva telefonato a Mårten lui le aveva proposto di andare a Valö non appena ne avesse avuto il tempo e da allora lei non aveva pensato ad altro. Tutta la famiglia si era accorta che il suo umore era decisamente migliorato e la sera prima in casa si percepiva un’atmosfera speranzosa. In realtà, però, non era così poco. Quello rappresentava il primo passo verso una nuova autonomia. Per tutta la sua vita era dipesa da altri. Quando era piccola, si appoggiava a Erica. Poi la vera e propria dipendenza che aveva sviluppato nei confronti di Lucas aveva portato alla catastrofe che lei e i bambini si portavano ancora dentro. Infine era venuto Dan, l’uomo affettuoso e sereno che aveva preso sotto le proprie ali sia lei sia i suoi bambini segnati nel profondo. Era stato così piacevole concedersi di essere piccola e confidare nel fatto che qualcun altro avrebbe pensato a ogni cosa. Ma l’incidente le aveva insegnato che neppure Dan poteva governare tutto. A essere sincera, era stato quello l’aspetto che aveva compromesso di più il loro rapporto. La perdita del bambino che aspettavano aveva scatenato un dolore inconcepibile ma il peggio era stato la sensazione di solitudine e vulnerabilità. Se voleva continuare a vivere con lui doveva imparare a stare in piedi da sola. Sapeva di averne la forza, per quanto fosse tardi. Il primo passo era ottenere quell’incarico come arredatrice. Restava solo da scoprire se aveva il talento che serviva e se sapeva vendersi. Bussò con il cuore che batteva forte. Sentì avvicinarsi dei passi e la porta si aprì. Un uomo della sua età in tuta da falegname e con gli occhiali protettivi sollevati sulla fronte la guardò con aria interrogativa. Era talmente bello che per un attimo Anna perse il dono della parola. «Ciao» disse poi. «Sono Anna. Ci siamo parlati al telefono ieri.» «Anna! Ma certo. Scusami, non volevo essere scortese. Sai, a volte mi lascio prendere dal lavoro al punto di dimenticare tutto il resto. Avanti, avanti. Benvenuta in questo caos.» Si scostò e la fece passare. Anna si guardò intorno. Caos era in effetti la parola più appropriata per descrivere lo stato della casa, ma il potenziale non le sfuggì. Era una dote che aveva da sempre, quasi possedesse un paio di occhiali magici che poteva inforcare in qualsiasi momento per vedere il risultato finale. Mårten seguì il suo sguardo. «Come vedi ci manca un po’ di lavoro da fare.» Stava per rispondere quando una donna magra e bionda arrivò dalle scale. «Ciao, io sono Ebba» disse pulendosi con uno straccio le mani macchiate di vernice bianca. Qualche chiazzetta si vedeva anche sui vestiti, sul viso e sui capelli chiari. Un forte odore di acquaragia fece venire le lacrime agli occhi ad Anna. «Scusa per come siamo messi» aggiunse Ebba spalancando le braccia. «Mi sa che è meglio se non ci stringiamo la mano.» «Figurati, siete nel bel mezzo dei lavori. Mi preoccupa di più... insomma, tutto il resto che avete intorno, diciamo.» «Erica te ne ha parlato?» disse Ebba, facendo più una constatazione che una domanda. «Ho saputo dell’incendio e del resto» rispose Anna. Trovare del sangue sotto il pavimento di casa propria era così assurdo che non riusciva neanche a formulare la frase. «Stiamo cercando di continuare i lavori, per quanto possibile» intervenne Mårten. «Non possiamo permetterci di fermare tutto.» Dall’interno della casa si sentivano delle voci e il rumore di assi di legno che venivano divelte. «I tecnici sono ancora in sala da pranzo» spiegò Ebba. «Stanno asportando tutto il pavimento.» «Siete certi che sia sicuro per voi restare qui?» Anna si rese conto di essere invadente, ma qualcosa in quella coppia risvegliava il suo istinto di protezione. «Stiamo bene dove siamo» rispose Mårten con voce atona. Sollevò un braccio per circondare le spalle della moglie, ma sembrava che lei avesse previsto quel gesto perché fece un passo di lato. Il braccio ricadde lungo il fianco. «Avete detto che vi serve aiuto, giusto?» disse Anna per alleggerire la tensione che si era improvvisamente creata. Mårten sembrò sollevato all’idea di cambiare argomento. «Come ti dicevo al telefono, non sappiamo come continuare una volta finiti i lavori di base. Non siamo grandi esperti di arredamento d’interni.» «Vi ammiro davvero. Quello che avete avviato non è un progetto da poco. Ma una volta completato potrà venire fuori un vero gioiellino. Vedo bene uno stile rurale un po’ all’antica, con mobili in legno bianco decapato, colori sbiaditi, rose romantiche, belle tele di lino, oggetti in vetro argento, piccoli dettagli fuori posto che attirino lo sguardo.» Mentre parlava, le immagini le si susseguivano nella mente. «Non devono essere costosi pezzi antichi, anzi: piuttosto, un mix di roba scelta nei mercatini delle pulci e di mobili realizzati in stile arte povera che possiamo decapare noi. Servono solo delle pagliette di lana d’acciaio e delle catene e...» Mårten rise e il viso gli s’illuminò. Anna si accorse che le faceva piacere. «Certo che sai davvero cosa vuoi! Comunque continua pure. Credo che quello che dici piaccia a tutti e due.» Ebba annuì. «Sì, è proprio quello che immaginavo io. Solo che non capivo come si potesse mettere in pratica.» Aggrottò la fronte. «Il nostro budget è quasi inesistente e forse tu sei abituata a spendere un bel po’ e ad avere anche un compenso consistente...» Anna la interruppe. «So quali sono le condizioni. Me le ha spiegate Mårten. Ma voi sareste i miei primi clienti e se sarete soddisfatti del mio lavoro potrò usarvi per eventuali referenze. Ci metteremo senz’altro d’accordo su una cifra alla vostra portata. Quanto agli arredi, l’idea è proprio che diano la sensazione di mobili ereditati e in parte trovati nei mercatini dell’usato. Considererò una sfida riuscire a realizzare tutto con la minima spesa possibile.» Anna li guardò speranzosi. Teneva tantissimo a quell’incarico e tutto ciò che aveva detto a Ebba e Mårten era vero. Avere mano libera per trasformare la colonia in un gioiellino dell’arcipelago sarebbe stato un progetto straordinario che oltretutto avrebbe potuto attirare clienti per la sua nuova attività. «Sono anch’io una libera professionista, per cui capisco perfettamente. Il passaparola è la cosa più importante.» Ebba la stava guardando con aria quasi intimidita. «Di cosa ti occupi?» chiese Anna. «Gioielli. Realizzo ciondoli a forma di angioletti da portare con catenine in argento.» «Che bella idea. Da dove hai tratto l’ispirazione?» Ebba s’irrigidì e distolse il viso. Mårten, imbarazzato, si affrettò a rompere il silenzio improvviso. «Non sappiamo esattamente quando finiremo la ristrutturazione. Il lavoro della polizia e i danni dell’incendio nell’ingresso hanno fatto slittare un po’ i tempi e quindi è difficile dire in che periodo potrai cominciare a occuparti degli arredi.» «Non importa. Mi adatterò alle vostre esigenze» rispose Anna senza riuscire a soprassedere sulla reazione di Ebba. «Se volete potrei darvi già adesso qualche consiglio sulla scelta dei colori per le pareti e cose del genere. Poi comincerei a fare qualche schizzo e magari anche ad andare a una o due aste nelle vicinanze per vedere se trovo qualcosa.» «Ottima idea» disse Mårten. «L’intenzione sarebbe di aprire con i primi ospiti intorno alla prossima Pasqua per poi partire come si deve con l’estate.» «Be’, allora il tempo c’è. Va bene se prima di andare faccio un giro e prendo qualche appunto?» «Certo. Fai come se fossi a casa tua in questo caos assurdo» rispose Mårten. Poi si bloccò. «Però temo che dovrai stare alla larga dalla sala da pranzo.» «Non c’è problema. Verrò a vederla un’altra volta.» Ebba e Mårten tornarono alle loro incombenze lasciando che girasse indisturbata. Anna prese un bel po’ di appunti con un effervescente senso di aspettativa alla bocca dello stomaco. Poteva venire fuori una vera bellezza. E segnare l’inizio della sua nuova vita. Al momento di firmare il documento Percy si accorse di avere la mano malferma. Fece un respiro profondo per calmarsi e l’avvocato Buhrman lo guardò impensierito: «Sei davvero sicuro di quello che fai, Percy? Tuo padre non approverebbe.» «Mio padre è morto!» sibilò lui ma quasi subito mormorò una scusa e continuò: «Può sembrare una misura drastica, ma le alternative sono due: o questo, oppure vendo il castello.» «E un mutuo?» chiese Buhrman. Era stato l’avvocato anche di suo padre e Percy si chiese quanti anni avesse in realtà. Dopo tutte le ore passate al campo da golf vicino alla sua casa di Maiorca era per di più talmente mummificato che lo si sarebbe potuto esporre in un museo. «È ovvio che ho parlato con la banca, cosa crede?» Di nuovo aveva alzato la voce e si costrinse a moderare i toni. L’avvocato di famiglia gli si rivolgeva ancora come se fosse un ragazzino. Sembrava aver dimenticato che era lui il conte, e da parecchio. «Mi hanno comunicato con estrema chiarezza che non vogliono più aiutarmi.» Buhrman apparve confuso. «E dire che abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con Svenska Banken. Tuo padre e il vecchio direttore frequentavano Lundsberg insieme. Sicuro di aver parlato con la persona giusta? Vuoi che faccia qualche telefonata? Penso proprio che...» «Il vecchio direttore ha lasciato la banca da un pezzo» lo interruppe Percy. Ormai stava perdendo la pazienza. «Anzi, ha lasciato anche la vita terrena da tanto di quel tempo che probabilmente sono rimaste solo le ossa. Le cose sono cambiate. In banca è tutto in mano a contabili e giovincelli appena usciti da economia e commercio che neanche sanno come ci si comporta. Ormai è governata da piccolo borghesi. Lo capisce o no, avvocato Buhrman?» Firmò irosamente l’ultimo documento e lo spostò vicino al vecchio, che aveva l’aria alquanto perplessa. «Be’, lo trovo strano» disse scuotendo la testa. «Cosa deve succedere, ancora? Che eliminino l’istituto del fedecommesso e lascino che antiche tenute vengano frammentate a piacere? A proposito: non potresti parlare con i tuoi fratelli invece? Mary ha fatto un buon matrimonio e Charles guadagna bene con i suoi ristoranti, no? Forse potrebbero esserti d’aiuto? Dopotutto siete parenti.» Percy lo fissò. Il vecchio non era in pieno possesso delle sue facoltà mentali. Aveva dimenticato tutti gli anni di litigi e contenziosi legali seguiti alla morte del padre, quindici anni prima? I suoi fratelli erano stati tanto incoscienti da tentare di contestare il fedecommesso che, in qualità di figlio maggiore, gli conferiva il diritto di ereditare il patrimonio indiviso. Per fortuna, la legge era molto chiara: Fygelsta era suo e solo suo per diritto di nascita. Poi, certo, il bon ton voleva che, se possibile, si concedesse qualcosa agli eventuali fratelli, ma dopo i loro insistenti tentativi di portargli via quello che gli spettava per legge e tradizione non si era sentito particolarmente in vena di mostrarsi generoso. Così erano rimasti a mani vuote e in più avevano anche dovuto pagare le sue spese legali. Come diceva Buhrman, non erano certo indigenti, e quando sentiva rodere la coscienza Percy si consolava con quella consapevolezza. Ma certo non sarebbe andato da loro con il berretto in mano. «Questa è la mia unica possibilità» disse accennando con la testa ai fogli. «Ho la fortuna di avere degli amici disponibili e restituirò il prestito appena avrò sgarbugliato questa infelice situazione con le autorità fiscali.» «Bah, fai come vuoi, ma sappi che metti a repentaglio parecchio.» «Io mi fido di Sebastian» disse Percy, desiderando di sentirsi davvero sicuro come cercava di mostrarsi. Kjell sbatté il telefono sulla scrivania così forte che l’urto si propagò lungo il braccio. Il dolore aumentò ulteriormente la rabbia facendolo imprecare mentre si massaggiava il gomito. «Cazzo!» esclamò chiudendo le mani a pugno per evitare di scaraventare qualcosa contro il muro. «Cosa succede?» Il suo miglior amico e collega Rolf si affacciò alla porta. «Tu che dici?» Kjell si passò la mano tra i capelli scuri che già da qualche anno avevano cominciato a mostrare qualche spruzzo d’argento. «Beata?» Rolf entrò nella stanza. «Naturale! Hai sentito, no, che di punto in bianco non potevo tenere i bambini nel fine settimana, anche se sarebbe stato il mio turno! E adesso ha chiamato e si è messa a urlare che non li lascerà venire con me a Maiorca. Pare che non possano stare via una settimana intera.» «Ma scusa, se lei se li è portati alle Canarie due settimane, in giugno, tra l’altro prenotando senza neanche consultarti prima? Perché non dovrebbero andare via una settimana con il papà?» «Perché sono i “suoi” figli. Lo dice tutto il tempo. Evidentemente io posso solo prenderli in prestito.» Kjell si costrinse a respirare con più calma. Detestava lasciarsi turbare a quel modo da lei e soprattutto sapere che non pensava al bene dei bambini ma solo a rendergli la vita impossibile. «Mi pare che abbiate l’affido condiviso, no?» osservò Rolf. «Probabilmente riusciresti addirittura a ottenere di averli più spesso di quanto non succeda adesso.» «Sì, lo so. È che vorrei che avessero un minimo di stabilità, ma questo presuppone che non venga boicottato ogni volta che desidero stare con i miei figli. Una misera settimana di vacanza con loro... è chiedere troppo? Sono il loro papà e ho gli stessi diritti di Beata.» «Stanno crescendo, Kjell. Piano piano capiranno. Tu cerca di essere un uomo migliore, un genitore migliore. Hanno bisogno di calma e tranquillità e se gliele darai si risolverà tutto. Ma non smettere di lottare per vederli, per la miseria.» «Non mi arrenderò» disse Kjell in tono amareggiato. «Bene» concluse Rolf, e poi agitò il quotidiano che aveva in mano. «Bellissimo articolo, a proposito. L’hai veramente messo in difficoltà più volte. Credo sia la prima intervista che ho letto in cui qualcuno sia riuscito a evidenziare i punti deboli suoi e del partito.» Si sedette su una delle due poltroncine davanti alla scrivania. «Sì, in effetti non capisco dove stia andando il giornalismo in questo Paese.» Kjell scosse la testa. «Nella retorica degli Amici della Svezia ci sono delle lacune evidentissime. Non dovrebbe essere tanto difficile portarle alla luce.» «Spero proprio che venga diffusa» continuò Rolf indicando la pagina del giornale. «C’è davvero bisogno di dimostrare che razza di persone sono in realtà.» «Il peggio è che la gente casca nella loro propaganda da quattro soldi. Questi si mettono il vestito della festa, buttano fuori qualche iscritto che si è distinto nella maniera sbagliata e cercano di parlare di tagli di bilancio e razionalizzazione, ma dietro la facciata si nascondono ancora i soliti vecchi nazisti. Se fanno il saluto e agitano le bandiere con la croce uncinata si assicurano di essere ben protetti dal buio. Poi compaiono in tv e si lamentano di essere sottoposti a critiche e ad attacchi gratuiti.» «Non c’è bisogno che lo dica a me. Siamo già dalla stessa parte» rise Rolf alzando le mani. «Secondo me c’è sotto qualcosa» disse Kjell massaggiandosi la radice del naso. «Sotto che cosa?» «Parlo di John. È troppo abile, troppo rileccato. È tutto troppo perfetto. Non ha neanche tentato di tenere nascosto il suo passato nel movimento degli skinhead, anzi: ha fatto il mea culpa con la lacrimuccia nei talk show mattutini. Quindi per gli elettori non è una novità. No, devo scavare più a fondo. Non può essersi sbarazzato di tutti gli scheletri.» «Credo che tu abbia ragione. Ma non sarà facile trovare qualcosa. John Holm ha dedicato un sacco di lavoro a ricostruirsi una facciata.» Rolf gettò lontano il giornale. «Comunque...» Kjell fu interrotto dallo squillo del telefono. «Se è di nuovo Beata...» Esitò un secondo prima di tuonare nel ricevitore: «Sì?» Quando capì chi chiamava cambiò subito tono, accorgendosi dello sguardo divertito di Rolf. «Ehi, ciao Erica... No, niente... Tranquilla... Ma cosa dici? Stai scherzando?» Lanciò una rapida occhiata a Rolf, sorridendo. Mentre parlava aveva preso rapidamente qualche appunto e chiudendo la telefonata gettò lontano la penna, si appoggiò allo schienale e allacciò le dita dietro la nuca. «E vai. Qualcosa comincia a muoversi.» «Cosa? Chi era?» «Erica Falck. Pare che io non sia l’unico a essere interessato a John Holm. Mi ha fatto i complimenti per l’articolo e mi ha chiesto se avevo del materiale di supporto da passarle.» «Come mai le interessa?» chiese Rolf. Poi sbarrò gli occhi. «Perché era uno degli allievi di Valö? Ha intenzione di scrivere un libro sulla scomparsa della famiglia?» Kjell annuì. «Sì, a quanto ho capito. Ma c’è di più. Tieniti forte.» «Dai, sputa il rospo.» Kjell sogghignò. Era una notizia fantastica ed era certo che anche Rolf l’avrebbe ritenuta tale. Stoccolma 1925 La donna che aprì la porta non aveva l’aspetto che si era immaginata Dagmar. Non era né bella né seducente ma stanca e sciupata. Inoltre sembrava più vecchia di Hermann e in generale esprimeva una sorta di ordinarietà. Dagmar rimase interdetta. Possibile che avesse sbagliato appartamento? Eppure sulla porta c’era scritto Göring. Decise che doveva essere la domestica e strinse più forte la mano di Laura. «Cerco Hermann.» «Non c’è.» La donna la squadrò dalla testa ai piedi. «Allora aspetto che torni.» La bambina si era nascosta dietro la schiena di Dagmar e la donna le rivolse un sorriso gentile. Poi disse: «Io sono la signora Göring. Posso esserle d’aiuto?» Dunque era quella la donna che odiava e che infestava i suoi pensieri da quando aveva letto il suo nome sul giornale. Dagmar osservò stupita Carin Göring: le scarpe robuste e pratiche, la gonna di sartoria che scendeva fino alle caviglie, la camicetta pudicamente abbottonata fino alla gola e i capelli raccolti in una crocchia. Intorno agli occhi si vedevano delle rughe sottili e la pelle era di un pallore malato. Di colpo le fu tutto chiaro. Naturalmente aveva ingannato il suo Hermann. Una vecchia zitella come quella non avrebbe mai potuto conquistare un uomo come lui senza sporchi trucchi. «Sì, abbiamo alcune cose di cui parlare anche noi.» Diede uno strattone a Laura e varcò la soglia. Carin si scostò senza fare niente per fermarla e si limitò ad annuire, temporeggiando. «Vuole darmi il cappotto?» Dagmar la guardò sospettosa e poi entrò nella stanza più vicina senza aspettare di essere invitata a farlo. Nel grande salone si fermò di botto. L’appartamento era quasi bello come si era aspettata, e cioè spazioso e con grandi finestre, i soffitti alti e il parquet scintillante, ma quasi completamente vuoto. «Perché non ci sono mobili qui, mamma?» chiese Laura guardandosi intorno con gli occhi sgranati. Dagmar si rivolse a Carin. «Sì, perché non avete mobili? Perché Hermann vive in questo modo?» Carin aggrottò la fronte per un attimo a segnalare che trovava la domanda inopportuna, ma rispose lo stesso con gentilezza: «Negli ultimi tempi abbiamo avuto qualche difficoltà. Ma adesso mi dica chi è, per favore.» Dagmar ignorò la domanda e lanciò un’occhiata irritata alla signora Göring. «Difficoltà? Ma Hermann è ricco. Non può vivere in questo modo.» «Ha sentito cos’ho detto? Se non mi dice chi è e cosa ci fa qui tra un attimo mi vedrò costretta a chiamare la polizia. Preferirei evitarlo, per riguardo alla piccola.» Carin accennò con la testa a Laura, tornata a nascondersi dietro la madre. Dagmar l’agguantò e la sospinse davanti a sé, verso Carin. «Questa è mia figlia. Mia e di Hermann. D’ora in poi lui starà con noi. Lei lo ha avuto abbastanza a lungo e lui non la vuole. Non lo capisce?» Carin studiò Dagmar e Laura per un lungo minuto di silenzio, mantenendo la calma sebbene il viso fremesse. «Non so di cosa lei stia parlando. Hermann è mio marito. Io sono la signora Göring.» «Lui ama me. Sono io il suo grande amore» ribatté Dagmar battendo un piede a terra. «Laura è sua figlia ma lei se lo è preso prima che io potessi dirglielo. Se lo avesse saputo non si sarebbe mai sposato con lei, qualsiasi cosa lei abbia fatto per costringerlo.» La collera le faceva ronzare la testa. Laura le si era di nuovo rannicchiata dietro. «Adesso se ne vada, prima che chiami la polizia.» La voce di Carin era ancora controllata, ma Dagmar le lesse la paura negli occhi. «Dov’è Hermann?» insistette. Carin indicò la porta. «Fuori!» Poi, sempre tenendo il dito puntato, si diresse verso il telefono con le mascelle serrate. I tacchi risuonarono nell’appartamento spoglio. Dagmar si calmò un pochino e rifletté. Si rendeva conto che la signora Göring non le avrebbe mai detto dove si trovava il marito, ma finalmente lei le aveva rivelato la verità e questo la riempiva di soddisfazione. Le restava solo da trovare Hermann. Avrebbe aspettato il suo arrivo, anche a costo di dormire davanti al portone. Poi sarebbero rimasti insieme in eterno. Tenendo stretta Laura per il colletto la trascinò con sé fino alla porta. Prima di richiudersela alle spalle, lanciò a Carin Göring un’occhiata trionfante. «Grazie, Anna.» Erica baciò la sorella sulla guancia e si affrettò verso l’auto dopo aver salutato velocemente con la mano i bambini. Provava un vago senso di colpa all’idea di lasciarli di nuovo, ma a giudicare dagli strilli di gioia scatenati dall’arrivo della zia non avrebbero sentito la sua mancanza. Partì verso Hamburgsund con la testa piena di pensieri. La irritava non essere riuscita ad andare avanti con le sue ricerche sulla vicenda della famiglia Elvander. Si era continuamente incagliata senza mai arrivare, come la polizia, a una spiegazione sulla scomparsa. Eppure non si era arresa. La storia della famiglia l’affascinava e più scavava negli archivi più la trovava interessante. Sembrava che le donne della stirpe di Ebba fossero vittime di una maledizione. Erica scacciò il pensiero del passato. Grazie a Gösta aveva finalmente una pista: le ricerche sul nome che le aveva fornito erano il motivo per cui in quel momento si trovava in auto, decisa ad andare a parlare con una delle persone che forse poteva avere informazioni preziose. Spesso fare ricerche su casi molto vecchi era come comporre un gigantesco puzzle di cui fin dall’inizio mancavano tessere importanti. Per esperienza sapeva comunque che, ignorandole e cominciando a costruirlo con quelle che si aveva a disposizione, alla fine di solito si cominciava a intravedere il disegno con sufficiente chiarezza. Nel caso specifico fino a quel momento non era stato così, ma sperava di raccogliere presto altre tessere in modo da capire cosa raffigurava il puzzle. Altrimenti, tutto il lavoro sarebbe stato inutile. All’altezza del distributore degli Hansson si fermò a chiedere indicazioni. A grandi linee sapeva dove andare ma preferiva evitare di perdersi. Dietro il bancone c’era Magnus, che gestiva l’area di servizio insieme alla moglie Anna. A parte suo fratello Frank e la cognata Annette, proprietari del chiosco di hot dog giù in piazza, nessuno era più informato di loro sugli abitanti di Hamburgsund e dintorni. Magnus la guardò un po’ perplesso ma non disse niente e le fece una mappa dettagliata su un foglietto. Erica guidò con un occhio alla strada e uno al biglietto e finalmente arrivò a quella che doveva essere la casa giusta. Solo in quel momento le venne in mente che forse in una giornata così bella non avrebbe trovato nessuno. La maggior parte delle persone in ferie si trovava su qualche isola dell’arcipelago oppure in spiaggia. Visto che c’era, comunque, tanto valeva suonare il campanello. Quando scese dall’auto e sentì della musica la speranza si riaccese. Mentre aspettava che qualcuno venisse ad aprire si mise a mugolare la melodia: Non, je ne regrette rien di Édith Piaf. Conosceva solo il ritornello, e per giunta in francese maccheronico, ma si lasciò coinvolgere dalla musica al punto di non accorgersi quasi che la porta si era aperta. «Ah, un’ammiratrice della Piaf, a quanto vedo!» esclamò un omino avvolto in una vestaglia di seta viola con particolari in oro, il viso truccato con cura. Erica non riuscì a nascondere il proprio stupore. L’uomo sorrise. «Avanti, tesoro. Vuoi vendere qualcosa o sei qui per altri motivi? Se sei una venditrice sappi che ho già tutto ciò che posso desiderare, ma in caso contrario entra pure e vieni a farmi compagnia in veranda. A Walter il sole non va a genio e quindi sono lì tutto solo. E non c’è niente di più triste che bere del buon rosé da soli.» «Io... be’, sì ho qualcosa da dirle» riuscì a balbettare Erica. «Benissimo!» L’omino batté le mani compiaciuto e arretrò per farla entrare. Erica si guardò intorno nell’ingresso. Dappertutto oro, nappe e velluto. Definirlo barocco era poco. «Io ho arredato questo piano mentre di sopra ha deciso tutto Walter. Se si vuole che un matrimonio duri tanto come il nostro bisogna scendere a compromessi. Tra poco saranno quindici anni che siamo sposati e prima abbiamo vissuto nel peccato per dieci.» Si girò verso la scala e chiamò: «Amore, abbiamo visite! Scendi a bere un bicchiere con noi al sole invece di startene di sopra con il muso lungo!» Proseguì facendo un gesto con il braccio verso l’alto. «Dovresti vedere com’è lassù. Sembra un ospedale, tanto è asettico. Walter la chiama pulizia delle linee. È fissato sul cosiddetto stile nordico, che certo non si può definire accogliente. E neanche troppo difficile da realizzare. Basta tinteggiare tutto di bianco, metterci quei detestabili mobili Ikea in piallaccio di betulla ed ecco fatta una casa.» Girò intorno a un’enorme poltrona rivestita di broccato rosso e si diresse verso la porta aperta su una terrazza. Su un tavolino c’erano un secchiello del ghiaccio con una bottiglia di rosé e un bicchiere a metà. «Posso offrirti un po’ di vino?» Stava già andando verso la bottiglia con la vestaglia di seta che gli svolazzava intorno alle gambe bianche. «Sarebbe splendido, ma devo guidare» rispose Erica pensando a quanto sarebbe stato piacevole un bicchiere di vino in quella fantastica veranda con vista sul braccio di mare e Hamburgö. «Oh, che cosa triste. Davvero non posso tentarti neanche con qualche goccia?» Agitò invitante la bottiglia che aveva preso dal secchiello. Erica non poté fare a meno di ridere. «Sa, mio marito fa il poliziotto, per cui non oso proprio, anche se mi piacerebbe davvero.» «Scommetto che è molto attraente! Ho sempre adorato gli uomini in uniforme.» «Anch’io» ammise Erica sedendosi su una sdraio. L’uomo si girò per abbassare leggermente il volume dello stereo. Poi le riempì d’acqua un bicchiere e glielo porse con un sorriso. «Bene, allora a cosa devo la visita di una ragazza tanto graziosa?» «Ecco, mi chiamo Erica Falck e sono una scrittrice. Al momento sto svolgendo delle ricerche per un libro che ho in mente. È lei Ove Linder, vero? Era insegnante al collegio maschile di Rune Elvander all’inizio degli anni Settanta?» Il sorriso si spense. «Ove. È passato tanto tempo...» «Ho sbagliato indirizzo?» Erica si rese conto che poteva essersi confusa nel seguire le accurate indicazioni di Magnus. «No no, ma è passato parecchio da quando ero Ove Linder.» Fece ruotare pensoso il bicchiere tra le dita. «Non ho mai voluto cambiare nome ufficialmente, altrimenti non mi avresti trovato, ma adesso mi faccio chiamare Liza. Nessuno usa più Ove, a parte Walter quando si arrabbia con me. Liza naturalmente in omaggio alla Minnelli, anche se sono solo una sua pallida copia.» Inclinò la testa di lato e sembrò aspettare che Erica lo contraddicesse. «Smettila di andare in cerca di complimenti.» Erica girò la testa, immaginando che la sagoma all’interno del vano della porta appartenesse a Walter, il coniuge. «Eccoti qui! Vieni, ti presento Erica» disse Liza. L’uomo uscì sul terrazzo e appoggiò teneramente le mani sulle spalle di Liza, che mise la sinistra sulla sua e la strinse. Erica si sorprese a desiderare che lei e Patrik potessero essere altrettanto affettuosi l’una nei confronti dell’altro dopo venticinque anni di vita insieme. «Di cosa si tratta?» chiese Walter sedendosi con loro. A differenza di Liza, aveva un aspetto assolutamente anonimo: altezza media, corporatura normale, fronte stempiata e abbigliamento discreto. Uno che sarebbe stato impossibile ricordare in caso di confronto tra testimoni, pensò Erica. Però aveva occhi buoni e intelligenti e per qualche strana ragione quella coppia disassortita dava l’impressione di essere perfetta. Si schiarì la voce. «Come dicevo, sto cercando di scoprire qualcosa di più sul collegio di Valö. Lei insegnava lì, giusto?» «Uff, sì» rispose Liza con un sospiro profondo. «Fu un periodo bruttissimo. Non avevo ancora fatto coming out e allora essere gay non era accettato come adesso. Come se non bastasse, Rune Elvander aveva terribili pregiudizi che esprimeva spesso e volentieri. Prima di poter vivere secondo la mia vera natura ho cercato disperatamente di rientrare nello schema precostituito. Insomma, non sono mai stato il genere taglialegna, ma cercavo di farmi passare per eterosessuale, quello che si dice “normale”. Avevo fatto molta pratica, durante l’adolescenza.» Abbassò gli occhi sul tavolo e Walter le accarezzò il braccio per consolarla. «Probabilmente riuscii a ingannare Rune, ma dagli allievi dovetti subire parecchie frecciatine. Il collegio brulicava di buoni a nulla che si divertivano a cercare i punti deboli del prossimo. Rimasi lì poco più di sei mesi e non sarei riuscito a resistere oltre. A dire il vero avevo intenzione di non tornare, dopo le vacanze di Pasqua, ma non dovetti neanche prendermi la briga di licenziarmi.» «Come reagì a quello che accadde? Ha qualche teoria?» chiese Erica. «Fu un evento sconvolgente, questo è certo, a prescindere da quello che pensavo della famiglia. Comunque, do per scontato che sia successo qualcosa di molto brutto.» «Ma non ha idea di cosa?» Liza scosse la testa. «No, è un mistero per me come per tutti.» «Com’era l’atmosfera a scuola? C’erano persone che non andavano d’accordo?» «Puoi dirlo forte. Quel posto era una specie di pentola a pressione.» «In che senso?» Erica sentì aumentare i battiti. Per la prima volta aveva la possibilità di sapere cosa si era svolto dietro le quinte. Perché non ci aveva pensato prima? «Secondo il mio predecessore, tra i ragazzi c’era maretta fin dall’inizio. Erano abituati a ottenere quello che volevano e nello stesso tempo le famiglie li incalzavano pretendendo prestazioni adeguate, e il risultato non poteva che essere un perenne combattimento di galli. Quando presi servizio io, Rune aveva già fatto schioccare la frusta e i ragazzi erano stati messi in riga, ma sotto la superficie si percepivano le tensioni.» «Com’era il loro rapporto con il direttore?» «Lo odiavano. Era uno psicopatico, un sadico.» Il tono era distaccato, di constatazione. «Quella che dà di Rune Elvander non è una bella immagine.» Erica si pentì di non aver portato il registratore. Avrebbe dovuto semplicemente cercare di ricordare il più possibile della conversazione. Liza ebbe un brivido, come se di colpo le fosse venuto freddo. «Era senza ombra di dubbio la persona più sgradevole che abbia mai conosciuto. E credimi» aggiunse con un’occhiata al marito, «vivendo come viviamo noi si viene a contatto con un bel po’ di gente insopportabile.» «Che rapporto aveva con i membri della sua famiglia?» «Dipende: Inez non sembrava passarsela troppo bene e in realtà ci sarebbe da chiedersi perché l’avesse sposato, considerando che era giovane e carina. Sospettavo che fosse stata sua madre a costringerla. La vecchia era morta poco prima che prendessi servizio nella scuola e penso che per Inez fosse stato un sollievo, perfida com’era quella vecchia strega.» «E i figli di Rune?» continuò Erica. «Come vedevano il padre e la matrigna? Non doveva essere stato semplicissimo, per Inez, entrare a far parte della famiglia. Non era molto più vecchia del maggiore, no?» «Esatto, e quello era un ragazzo orribile, molto somigliante a suo padre.» «Chi? Il più grande dei tre?» «Sì. Claes.» Seguì un lungo silenzio. Erica aspettò paziente. «È quello che ricordo meglio. Mi vengono i brividi al solo pensiero. In realtà non so spiegare perché. Era sempre educato nei miei confronti, ma qualcosa, nella sua espressione, mi induceva a non voltargli le spalle.» «Lui e Rune andavano d’accordo?» «Difficile a dirsi. Si giravano intorno come pianeti, senza mai incrociare le rispettive orbite.» Liza rise, imbarazzata. «Sembra di sentir parlare una vecchia esponente della new-age o un poeta d’infimo livello...» «No, no. Continui» disse Erica. «Capisco cosa intende. Quindi tra loro due non c’erano mai conflitti?» «No, si tenevano a distanza. Claes sembrava ubbidire al minimo cenno di Rune, ma probabilmente nessuno sapeva cosa pensasse in realtà del padre. Una cosa avevano in comune, però: entrambi adoravano Carla, la defunta moglie di Rune, ed entrambi sembravano detestare Inez. Nel caso del ragazzo lo si poteva anche capire, visto che aveva preso il posto della madre, ma lui l’aveva sposata...» «Quindi Rune la trattava male?» «Sì, non era certo un rapporto amorevole. Le urlava continuamente addosso, come se fosse una sottoposta invece che la moglie. Da parte sua, Claes era apertamente cattivo e impertinente e non sembrava avere un grande attaccamento neanche nei confronti di Ebba. La sorella, Annelie, non era molto meglio.» «E Rune cosa pensava del comportamento dei figli? Lo incoraggiava?» Erica bevve un sorso d’acqua. Nella veranda faceva molto caldo anche sotto l’ombrellone. «Ai suoi occhi non avevano un solo difetto. Manteneva il solito tono militaresco anche con loro, ma l’unico che potesse rimproverarli era lui. Se qualcun altro accennava anche solo a lamentarsi, apriti cielo. So che Inez ci aveva provato, ma era bastata una volta. No, l’unico a essere carino con lei nella famiglia era il figlio minore di Rune, Johan, un bambino premuroso e gentile che le si era affezionato.» Il volto di Liza si fece triste. «Chissà cosa ne è stato di Ebba.» «È tornata a Valö. Lei e suo marito stanno ristrutturando la casa. E l’altro ieri...» Erica si morse il labbro. Non sapeva quanto poteva spingersi a dire. Però Liza era stata tanto disponibile con lei... Inspirò profondamente. «L’altro ieri, demolendo il pavimento della sala da pranzo, hanno trovato del sangue.» Liza e Walter la fissarono. A qualche distanza si sentivano i rumori di imbarcazioni e persone, ma nella veranda regnava il silenzio. Alla fine fu Walter a prendere la parola: «In effetti hai sempre detto che dovevano essere morti.» Liza annuì. «Era l’ipotesi più probabile. E poi...» «E poi?» «Bah, è una cosa talmente stupida...» Agitò una mano facendo svolazzare la manica della vestaglia di seta. «Allora non ne parlai nemmeno.» «Non c’è niente di insignificante o troppo stupido. Mi dica.» «In realtà non è niente di che, ma era come se avessi il presentimento che qualcosa stesse per andare storto. Sentivo...» Scosse la testa. «No, è un’idiozia.» «Continui!» Erica trattenne a stento l’impulso di prenderla per le braccia e scuoterla. Liza bevve un sorso di vino e poi la guardò dritto in faccia. «Di notte si sentivano dei rumori.» «Rumori?» «Sì. Passi, porte che si aprivano, una voce distante. Ma quando mi alzavo per andare a vedere non trovavo mai nessuno.» «Come se fossero fantasmi?» chiese Erica. «Io non credo ai fantasmi» disse Liza seria. «Posso solo dire che c’erano dei rumori e che avevo la netta sensazione che stesse per accadere qualcosa di terribile. Per questo non provai alcuno stupore venendo a sapere della scomparsa.» Walter annuì. «Hai sempre avuto un sesto senso.» «Uff, sto parlando a vanvera» si riscosse Liza. «Non mi piace quest’atmosfera cupa che si è creata. Erica penserà che siamo due musoni.» Di colpo gli occhi erano tornati a scintillare e sulle labbra si era disegnato un largo sorriso. «Al contrario! Grazie di questa chiacchierata. Mi ha fornito molti spunti di riflessione, ma adesso temo di dover tornare verso casa.» Erica si alzò. «Salutami la piccola Ebba» disse Liza. «Lo farò senz’altro.» Fecero per accompagnarla alla porta, ma lei li prevenne. «State pure. Trovo la strada da sola.» Mentre attraversava il mare di oro, nappe e cuscini di velluto, alle sue spalle Édith Piaf riprese a cantare del proprio cuore spezzato. «Dove cavolo eri finito stamattina?» chiese Patrik entrando nell’ufficio di Gösta. «Volevo che mi accompagnassi da John Holm.» Gösta alzò gli occhi. «Non te l’ha detto Annika? Ero dal dentista.» «Dal dentista?» Patrik si sedette e lo scrutò in viso. «Niente carie, spero.» «No, neanche una.» «Come va con l’elenco?» Patrik guardò i fogli sulla scrivania. «Bene. Ho trovato la maggior parte degli attuali indirizzi degli alunni.» «Hai fatto in fretta.» «Il codice fiscale» rispose Gösta indicando la vecchia lista di nomi. «Bisogna usare il cervello, sai.» Gli tese un foglio. «E com’è andata con il vecchio nazista?» «Credo che avrebbe qualcosa da obiettare a quella definizione.» Patrik cominciò a scorrere l’elenco con gli occhi. «Be’, è la verità. Hanno smesso di radersi la testa ma sono gli stessi. Mellberg ha fatto il bravo?» «Indovina...» Patrik appoggiò il foglio sulle ginocchia. «Diciamo che la polizia di Tanum non ha mostrato il suo volto migliore.» «È venuto fuori qualcosa di nuovo, almeno?» Patrik scosse la testa. «Non molto. John Holm non sa niente della scomparsa. A scuola non era successo niente che potesse spiegarla: si percepivano solo le tensioni che ci si può immaginare esistano tra una banda di adolescenti e un direttore severo. E così via.» «Torbjörn si è fatto vivo?» chiese Gösta. «No. Ha promesso di accelerare i tempi, ma visto che non abbiamo cadaveri freschi da far valere non possono darci la precedenza. Inoltre il caso è in prescrizione, anche se dovesse saltare fuori che la famiglia fu assassinata.» «Ma le risposte delle analisi del sangue possono fornirci dei fili conduttori importanti per la nostra indagine. Hai dimenticato che poche notti fa qualcuno ha cercato di bruciare vivi Ebba e Mårten? Sei stato tu a insistere sul fatto che l’incendio deve essere legato alla scomparsa della famiglia. E a Ebba hai pensato? Non ha forse il diritto di sapere cosa ne è stato dei suoi cari?» Patrik sollevò le mani per calmarlo. «Lo so, lo so, ma per ora nella vecchia indagine non ho trovato niente di interessante e sono un po’ scoraggiato.» «Nel rapporto di Torbjörn sull’incendio non c’era nessuno spunto?» «No. Era normale benzina a cui è stato dato fuoco con un fiammifero. Niente di più concreto.» «Allora bisogna cominciare a sbrogliare la matassa partendo da un altro filo.» Gösta si girò a guardare una foto appesa alla parete. «Secondo me dobbiamo mettere alle strette i ragazzi. Sanno più di quanto non avessero detto allora.» Patrik si alzò e studiò da vicino la foto dei cinque allievi del collegio. «Sicuramente hai ragione. Ho visto sull’elenco che secondo te dobbiamo partire da Leon Kreutz, e quindi perché non andare a parlargli subito?» «Purtroppo non so dove si trovi. Il cellulare è spento e in albergo dicono che lui e la moglie non sono più lì. Probabilmente si stanno installando nella casa nuova. Aspettiamo domani, così potremo parlargli con più calma?» «Okay, facciamo così. Allora magari possiamo provare con Sebastian Månsson e Josef Meyer, adesso? Loro abitano ancora qui.» «Certo. Aspetta solo un attimo che sistemo un paio di cose.» «E poi non dobbiamo dimenticare di verificare quel “G”.» «“G”?» «Sì, la persona che manda sempre gli auguri di compleanno a Ebba.» «Pensi davvero che possa dare qualcosa?» Gösta cominciò a riordinare le sue carte. «Non si sa mai. Come hai appena detto tu, dobbiamo provare a cominciare a sbrogliare la matassa.» «Se si tirano troppi fili contemporaneamente si finisce per creare dei nodi» borbottò Gösta. «Secondo me è un lavoro inutile.» «No, no» rispose Patrik dandogli una pacchetta sulla spalla. «Facciamo...» Sentì ronzare il cellulare e guardò il display. «Aspetta, prendo questa telefonata» disse lasciando Gösta alla scrivania. Qualche minuto dopo tornò con un’espressione trionfante sul viso. «Forse abbiamo trovato il filo che ci serviva. Era Torbjörn. Sotto il pavimento non c’era altro sangue, ma hanno trovato qualcosa di molto meglio.» «Cioè?» «Incastrata tra i listelli c’era una pallottola. In altre parole, prima che la famiglia scomparisse è stato sparato un colpo proprio nella sala da pranzo in cui si trovava riunita.» Patrik e Gösta si guardarono seri. Il senso di impotenza di un attimo prima era stato spazzato via. Aveva pensato di andare direttamente a casa a dare il cambio ad Anna ma, cedendo alla curiosità, proseguì oltre Fjällbacka in direzione di Mörhult. Dopo aver esitato se svoltare a sinistra all’altezza del minigolf per scendere ai capanni, decise di tentare la fortuna e vedere se li trovava in casa. Ormai era tardo pomeriggio. La porta era tenuta socchiusa da uno zoccolo fiorato ed Erica fece capolino nell’ingresso. «C’è nessuno?» chiese. Dall’interno della casa si sentirono dei rumori e un attimo dopo arrivò John Holm con uno strofinaccio in mano. «Mi scusi, disturbo in piena cena?» chiese. Lui abbassò gli occhi sullo strofinaccio. «No no, per nulla. Mi sono appena lavato le mani, ecco tutto. Posso aiutarla?» «Mi chiamo Erica Falck e sto lavorando a un libro...» «Ah, è lei la famosa scrittrice di Fjällbacka? Venga, le offro un caffè» disse John Holm con un sorriso caloroso. «Cosa la porta da me?» Si sedettero in cucina. «Ho intenzione di scrivere un libro sugli avvenimenti di Valö.» Le parve di cogliere un guizzo di preoccupazione negli occhi azzurri, ma fu un attimo, e poteva anche esserselo immaginato. «È pazzesco quanti siano improvvisamente interessati ai fatti di Valö. Se ho interpretato correttamente le chiacchiere che girano, quello con cui ho parlato qualche ora fa è suo marito.» «Sì, sono sposata con un poliziotto, Patrik Hedström.» «Con lui c’era un tipo piuttosto... interessante.» Non ci voleva molto a capire di chi stesse parlando. «Ah, dunque ha avuto l’onore di conoscere Bertil Mellberg, l’uomo, il mito, la leggenda?» John rise ed Erica si rese conto che il suo fascino non la lasciava indifferente, cosa che la irritò. Detestava tutto ciò che propugnava il suo partito, eppure quell’uomo sembrava simpatico e innocuo. Attraente. «Ne ho incontrati altri come lui. Suo marito invece sembra in gamba.» «Sono di parte, ovviamente, ma è un bravo poliziotto. Scava finché non trova quello che vuole sapere. Proprio come me.» «Insieme dovete essere pericolosissimi.» John Holm sorrise di nuovo mettendo in mostra due fossette perfette. «Può darsi. Ma a volte ci si insabbia. Sono anni che, a intervalli regolari, faccio ricerche su questo caso, e adesso l’ho ripreso in mano.» «E ne verrà fuori un libro?» Di nuovo quell’ombra di preoccupazione negli occhi. «Sì, l’idea è quella. Ha qualcosa in contrario a qualche domanda?» Tirò fuori carta e penna. Per un attimo John Holm sembrò esitare. Poi disse: «Va bene. Ma come ho spiegato a suo marito e al collega che lo accompagnava, temo di non aver molto di utile da dire.» «A quanto ho capito, all’interno della famiglia Elvander c’erano dei conflitti. È vero?» «Conflitti?» «Già. Pare che ai figli di Rune non andasse troppo a genio la loro matrigna, no?» «Noi allievi non eravamo coinvolti nelle questioni personali del direttore.» «Ma la scuola era piccola. Non possono esservi sfuggite le dinamiche interne alla famiglia.» «Non ci interessavano. Non volevamo avere niente a che fare con loro. Bastava dover avere intorno Rune.» L’uomo sembrava pentito di aver accettato di rispondere alle sue domande. Sollevò le spalle cambiando posizione sulla sedia, cosa che motivò ancora di più Erica. Evidentemente c’era qualcosa che lo metteva a disagio. «E Annelie? Una sedicenne e un gruppo di maschi adolescenti... come si conciliavano le due cose?» John sbuffò sprezzante. «Annelie era fissata con i ragazzi, e di brutto, ma la cosa non era corrisposta. Certe ragazze bisogna tenerle a distanza e lei era una di quelle. Inoltre Rune ci avrebbe ammazzati se l’avessimo anche solo sfiorata.» «In che senso, a distanza?» «Ci correva dietro facendo la smorfiosa e credo che mirasse a metterci nei guai. Una volta si piazzò a prendere il sole in topless proprio sotto la nostra finestra, ma l’unico che osò guardarla fu Leon. Già allora era un ragazzo sprezzante della morte.» «E cosa successe? Suo padre non la scoprì?» Erica sentì che veniva trascinata in un altro mondo. «Claes la proteggeva. Quella volta la vide e la cacciò via con modi tanto bruschi che pensavo le staccasse il braccio.» «C’era qualcuno di voi che le piaceva particolarmente?» «Certo, cosa crede?» rispose John, ma poi parve rendersi conto della confusione di Erica. «Leon, ovviamente. Era il ragazzo perfetto: famiglia ricca sfondata, bellezza assurda, una spavalderia a cui nessuno di noi poteva neanche lontanamente avvicinarsi.» «E lui era interessato?» «Come dicevo, Annelie era una ragazza che creava problemi e Leon troppo intelligente per mettersi con lei.» Dal soggiorno si sentì la suoneria di un cellulare e John Holm si alzò di scatto. «Mi scusi, le dispiace se prendo questa telefonata?» Uscì dalla stanza senza aspettare risposta ed Erica lo sentì parlottare a bassa voce. Sembrava che non ci fosse in casa nessun altro e così, per ingannare il tempo, si guardò intorno. Una pila di carte su una delle sedie attirò la sua attenzione. Dopo una rapida occhiata alle proprie spalle, si mise a sfogliarle con cautela. Sembravano soprattutto verbali delle sedute del parlamento e documenti preparatori, ma di colpo le sue dita si bloccarono. Tra le stampe di computer c’era un foglietto su cui erano scarabocchiate delle scritte per lei incomprensibili. Dal soggiorno sentì John chiudere la telefonata e, velocissima, sfilò il foglietto dalla pila e se lo mise nella borsetta. Quando l’uomo tornò in cucina gli sorrise innocente. «Tutto a posto?» Lui annuì e si risedette. «È lo svantaggio del mio lavoro. Non si è mai in ferie, neanche in vacanza.» Erica annuì. Non voleva impelagarsi in discussioni sul ruolo politico di Holm. Le sue opinioni sarebbero trapelate e si correva il rischio che l’uomo si risentisse e non le dicesse più niente. Afferrò di nuovo la penna. «Com’era Inez nei confronti degli allievi?» «Inez?» John evitò il suo sguardo. «Non è che la vedessimo molto. Aveva il suo da fare, tra la casa e la bambina.» «Be’, un qualche genere di rapporto dovevate pur averlo, no? Io la casa la conosco bene e non è poi così grande. Di tanto in tanto vi sarete sicuramente incrociati.» «Certo, la vedevamo, ma era silenziosa e bistrattata. Lei non si curava di noi e noi non ci curavamo di lei.» «Neanche suo marito si curava troppo di lei, vero?» «Esatto. Era inconcepibile che un uomo come lui fosse riuscito a generare quattro figli. Ci chiedevamo se non potesse trattarsi di partenogenesi.» Fece un sorrisino storto. «Che opinione aveva dei due professori della scuola?» «Erano due originali. Sicuramente bravi come insegnanti, ma Per-Arne era un vecchio militare e se possibile ancora più rigido di Rune.» «E l’altro?» «Ove... Mah, aveva un che di losco. La teoria imperante era che fosse un frocio non dichiarato. Chissà se ha mai fatto coming out.» A Erica venne da ridere: si era vista davanti agli occhi Liza con le ciglia finte e la sua bella vestaglia di seta. «Può darsi» disse sorridendo. John la guardò interrogativo ma lei lo lasciò nell’incertezza. Non era compito suo informarlo della vita di Liza e inoltre conosceva la posizione degli Amici della Svezia sugli omosessuali. «Ma di loro non ricorda niente di particolare?» «No, niente. C’erano confini molto ben delineati tra gli allievi, gli insegnanti e la famiglia. Bisognava stare al proprio posto, ciascuno nel suo gruppo.» Un po’ come in politica, pensò Erica mordendosi la lingua per non dire niente. Sentiva che John Holm stava cominciando a essere impaziente e così fece l’ultima domanda: «Secondo una persona con cui ho parlato, di notte si sentivano strani rumori. Ricorda niente del genere?» John sobbalzò. «Chi l’ha detto?» «Non ha importanza.» «Sciocchezze» rispose lui, alzandosi. «Quindi a lei non risulta?» Erica lo scrutò con attenzione. «Assolutamente no. E adesso purtroppo devo fare un paio di telefonate.» Non sarebbe riuscita a cavargli altro di bocca, per lo meno al momento. «La ringrazio di avermi dedicato un po’ del suo tempo» disse raccogliendo le sue cose. «Di nulla!» John Holm era di nuovo in modalità sorriso smagliante, ma quasi la spinse fuori dalla porta. Ia tirò su a Leon slip e pantaloni e lo aiutò a spostarsi dal water alla sedia a rotelle. «Avanti, smetti di fare tante smorfie.» «Non capisco perché non possiamo trovare un’infermiera che si occupi di queste cose» disse lui. «Voglio essere io a prendermi cura di te.» «Il tuo cuore trabocca di bontà» sbuffò Leon. «Ti rovinerai la schiena, se continui così. Abbiamo bisogno di qualcuno che ti aiuti.» «Sei carino a preoccuparti della mia schiena, ma sono forte e non voglio che venga qui qualcuno a... imporre la sua presenza. Siamo io e te, finché morte non ci separi.» Ia gli accarezzò il lato del viso ancora sano, ma lui girò la testa e lei ritirò la mano. Leon si spostò sulla sedia a rotelle e lei andò a sedersi sul divano. Avevano comprato la casa ammobiliata e quel giorno avevano finalmente potuto prenderne possesso, dopo che la banca, da Monaco, aveva dato l’autorizzazione per il prelievo. Avevano consegnato tutta la somma in contanti. Fuori dalla finestra si vedeva l’intero centro abitato di Fjällbacka e doveva confessare che quel panorama le piaceva più di quanto avesse previsto. Sentì Leon imprecare in cucina. Gli interni non erano ancora stati adattati e questo comportava che urtasse angoli e mobili e facesse fatica a prendere quello che gli serviva. «Arrivo» disse, senza però alzarsi subito. A volte era un bene farlo aspettare un po’, in modo che non desse per scontato l’aiuto così come dava per scontato il suo amore. Ia abbassò gli occhi sulle mani, segnate da cicatrici quanto quelle di Leon. Quando era in mezzo alla gente portava sempre i guanti, ma lì in casa lasciava che lui vedesse le lesioni che aveva riportato estraendolo dall’auto in fiamme. Riconoscenza: non pretendeva altro. Quanto all’amore, aveva abbandonato le speranze. Ormai non sapeva neanche più se Leon fosse in grado di amare un altro essere umano. Molto tempo prima l’aveva creduto possibile. Molto tempo prima, il suo amore era l’unica cosa che contava. Quando si era trasformato in odio? Non lo sapeva. Erano tanti anni che cercava di trovare quello che non andava in se stessa, sforzandosi di correggere gli aspetti che lui criticava e facendo di tutto per dargli ciò che sembrava volesse. Eppure lui aveva continuato a tormentarla come se volesse consapevolmente ferirla. Montagne, mari, deserti, donne. Non aveva importanza. Le altre erano tutte amanti. E l’attesa del ritorno era sempre stata insopportabile. Si portò la mano al viso liscio, senza espressione. Di colpo le tornò in mente il dolore dopo gli interventi. Mai era stato al suo capezzale a tenerle la mano quando lei si svegliava. Mai era stato a casa ad aspettarla. La cicatrizzazione era proceduta con una lentezza esasperante. Ormai guardandosi allo specchio non si riconosceva. Vedeva il viso di un’estranea. Ma non doveva più sforzarsi: non c’erano montagne che Leon potesse scalare, né deserti da attraversare, né donne per cui potesse lasciarla. Lui era suo e solo suo. Mårten si raddrizzò con una smorfia. Gli doleva tutto il corpo a causa dello sforzo ininterrotto e aveva quasi dimenticato com’era non avere male da qualche parte. Sapeva che valeva anche per Ebba. Spesso, quando pensava che lui non vedesse, si massaggiava spalle e giunture, facendo le sue stesse smorfie. Ma il dolore al cuore era peggio. Ci convivevano notte e giorno e la nostalgia era talmente immensa che non se ne vedeva né l’inizio né la fine. Il punto era che a lui non mancava solo Vincent, ma anche Ebba. E il tutto era peggiorato dal fatto che la nostalgia si mescolava alla rabbia e al senso di colpa di cui non riusciva a liberarsi. Seduto sui gradini con una tazza di tè in mano, si mise a guardare Fjällbacka al lato opposto del braccio di mare. Nella luce dorata della sera il panorama si mostrava in tutto il suo splendore. In qualche modo aveva sempre saputo che sarebbero approdati lì. Pur credendo a Ebba quando lei diceva di aver avuto un’infanzia felice, a volte aveva intuito che dentro nutriva un desiderio di sapere che non sarebbe stato esaudito almeno fino a quando non avesse tentato di trovare le risposte. Se gliel’avesse detto allora, prima che succedesse tutto, lei avrebbe probabilmente negato. Ma lui non aveva mai avuto dubbi: un giorno si sarebbero ritrovati lì, dove aveva avuto inizio tutto. Quando alla fine le circostanze li avevano costretti a fuggire verso qualcosa che era noto e insieme ignoto, verso una vita in cui Vincent non c’era mai stato, aveva molte speranze. Si augurava che potessero recuperare l’affiatamento di un tempo e lasciarsi alle spalle la rabbia e il senso di colpa. Invece Ebba aveva continuato a tenerlo a distanza, respingendo i suoi tentativi di avvicinamento. Ne aveva davvero il diritto? Il dolore e il lutto appartenevano a entrambi e anche lui si sarebbe meritato qualche sforzo da parte sua. Strinse più forte la tazza, lo sguardo perso all’orizzonte. Vide davanti agli occhi Vincent, così simile a lui. Ne avevano riso già al reparto maternità. Appena nato, avvolto in una coperta nella sua culla, sembrava una caricatura del papà. Con il passare del tempo la somiglianza non aveva fatto che aumentare e Vincent lo adorava. A tre anni lo seguiva come un cagnolino ed era sempre il papà che chiamava per primo. A volte Ebba se ne lamentava, dicendo che era un ingrato visto che era stata lei a tenerlo nella pancia per nove mesi e ad affrontare un parto doloroso, ma in realtà non diceva sul serio. Era ben contenta del rapporto intenso tra Vincent e Mårten e di venire al secondo posto. Si asciugò con il dorso della mano le lacrime che gli bruciavano gli occhi. Non aveva più la forza di piangere e oltretutto non serviva a niente. L’unica cosa che desiderava era che Ebba tornasse a essergli vicino. Non si sarebbe mai arreso. Avrebbe tentato finché lei non avesse capito che avevano bisogno l’uno dell’altra. Si alzò e rientrò. Salì le scale e tese le orecchie per localizzarla, anche se in realtà sapeva dove l’avrebbe trovata. Come sempre quando non erano impegnati nei lavori per la casa era seduta al suo tavolo, concentrata su una nuova collanina richiesta da qualche cliente. Entrò e le si mise dietro. «Ti hanno ordinato qualcosa?» Lei fece un salto sulla sedia. «Sì» rispose continuando a maneggiare l’argento. «Che cliente è?» L’indifferenza della moglie fece scaturire la rabbia e non esprimerla gli costò uno sforzo immenso. «Si chiama Linda. Il suo bambino aveva quattro mesi. Morte in culla. Era il suo primogenito.» «Ah» disse lui distogliendo lo sguardo. Non capiva come lei riuscisse ad assorbire tutti quei racconti, tutto il dolore di tanti genitori sconosciuti. Non le bastava il suo? Senza neanche guardare, sapeva che aveva al collo la catenina con l’angioletto. Era la prima che aveva fatto e la portava sempre. Sul retro era inciso il nome di Vincent e in certi momenti lui avrebbe voluto strappargliela, sentendo di colpo che non era degna di portare al collo il nome del loro bambino, ma ce n’erano altri in cui non desiderava altro che vederla con Vincent appoggiato sul petto. Perché doveva essere così difficile? Cosa sarebbe successo se si fosse arreso, se si fosse riconciliato con quanto era accaduto e avesse riconosciuto che la colpa era di entrambi? Appoggiò la tazza su una mensola e fece un passo verso Ebba. Dopo un attimo di esitazione le appoggiò le mani sulle spalle, sentendola irrigidirsi. Cominciò a massaggiarla piano, sapendo che era tesa quanto lui. Lei non disse niente, lo sguardo dritto davanti a sé. Le dita avevano smesso di lavorare all’angioletto e i palmi erano appoggiati sul tavolo. Si sentiva solo il respiro di entrambi. La speranza si risvegliò in lui. La stava toccando, sentiva il suo corpo sotto le proprie mani e forse esisteva una strada che potevano imboccare insieme. Di colpo Ebba si alzò. Uscì senza dire niente e le mani di Mårten restarono sospese a mezz’aria. Rimase a guardare per qualche istante il tavolo da lavoro, ingombro di oggetti. Poi, come animate di vita propria, le sue braccia spazzarono via tutto dal ripiano, facendo cadere a terra il materiale con un tintinnio assordante. Nel silenzio che seguì capì che c’era una sola via da seguire. Doveva puntare tutto su una carta. Stoccolma 1925 «Ho freddo, mamma.» Laura piagnucolava ma Dagmar non le fece caso. Avrebbero aspettato finché Hermann non fosse rientrato. Prima o poi doveva arrivare e sarebbe stato contento di trovarla lì. Non vedeva l’ora di scorgere la luce nei suoi occhi, il desiderio e l’amore che sarebbero stati ancora più forti dopo tutti gli anni di attesa. «Mamma...» La bambina tremava tanto forte che le battevano i denti. «Taci!» sibilò Dagmar. Quell’impiastro doveva sempre rovinare tutto. Non voleva la felicità di entrambe? Provò una rabbia incontenibile e alzò un braccio per picchiarla. «Se fossi in lei non lo farei.» Una mano forte le afferrò il polso e Dagmar ruotò su se stessa, vedendo un uomo elegante in cappotto e pantaloni scuri e con un cappello in testa. Dagmar alzò il mento di scatto. «Non deve intromettersi nel modo in cui educo mia figlia.» «Se la picchia, io picchierò lei con la stessa forza. Così capirà come ci si sente» disse lui calmo, con una voce che non ammetteva repliche. Dagmar soppesò la possibilità di dirgli cosa pensava della gente che ficcava il naso negli affari altrui, ma si rese conto che non le conveniva. «Chiedo scusa» mormorò. «È tutto il giorno che piagnucola. Non è facile essere madre e a volte...» Alzò le spalle come per giustificarsi e abbassò gli occhi in modo che lui non potesse leggervi la collera. L’uomo le lasciò andare lentamente il polso e fece un passo indietro. «E cosa fate qui davanti al mio portone?» «Aspettiamo il mio papà» disse Laura rivolgendo allo sconosciuto un’occhiata implorante. Non le capitava spesso che qualcuno si mettesse contro sua madre. «Davvero? Tuo padre abita qui?» L’uomo scrutò Dagmar. «Aspettiamo il capitano Göring» disse lei tirandosi accanto la bambina. «Ah, allora vi toccherà aspettare parecchio» rispose lui continuando a studiarle curioso. Dagmar sentì che il cuore cominciava a martellarle nel petto. Era successo qualcosa a Hermann? Per quale motivo quella persona odiosa lassù non le aveva detto niente? «Perché?» chiese. L’uomo incrociò le braccia sul petto. «Sono venuti a prenderlo con l’ambulanza. L’hanno portato via in camicia di forza.» «Non capisco...» «È ricoverato all’ospedale di Långbro.» L’uomo con il cappotto elegante si avviò verso il portone, di colpo desideroso di chiudere quella conversazione. Dagmar lo prese per un braccio, ma lui si divincolò con un gesto brusco, disgustato. «Per favore, signore, da che parte è l’ospedale? Devo trovare Hermann.» Con il ribrezzo stampato sul volto, l’uomo aprì il portone ed entrò senza rispondere. Quando il pesante battente si richiuse alle sue spalle Dagmar si accasciò a terra. Cosa poteva fare? Piangendo in modo straziante, Laura la strattonò cercando di farla rialzare. Dagmar si scosse di dosso le sue manine. Possibile che quella bambina non potesse semplicemente sparire e lasciarla in pace? Cos’avrebbe potuto fare, se non avesse rintracciato Hermann? Laura non era figlia sua, era figlia di entrambi. Patrik entrò a passo veloce nella stazione ma si fermò di colpo davanti alla segreteria. Annika era immersa nella lettura di qualcosa e alzò gli occhi solo dopo un po’. Quando vide chi era sorrise e riabbassò lo sguardo. «Martin è ancora in malattia?» chiese Patrik. «Sì» rispose Annika fissando lo schermo del computer. Patrik le lanciò un’occhiata perplessa e poi girò sui tacchi. C’era una sola cosa da fare. «Esco un attimo» disse infilando la porta. Ebbe appena il tempo di vederla aprire la bocca, ma non sentì nulla. Guardò l’orologio. Mancava poco alle nove e forse era un po’ presto per disturbare qualcuno a casa, ma ormai era talmente preoccupato che non gli importava di svegliarli. Impiegò solo qualche minuto ad arrivare in auto all’appartamento in cui Martin abitava con la famiglia. Davanti alla porta esitò. Forse non era nulla di grave e Martin era semplicemente sotto le coperte per un’influenza, il che significava che l’avrebbe svegliato per niente. Magari si sarebbe persino offeso e convinto che Patrik lo controllasse. Ma la sensazione di pancia gli diceva qualcosa di diverso. Se fosse stato malato, si sarebbe fatto vivo. Mise un dito sul campanello. Attese a lungo e stava per suonare di nuovo, ma sapeva che l’appartamento non era poi così grande e sicuramente se c’erano l’avevano sentito. Alla fine si avvicinarono dei passi. Quando la porta si aprì, Patrik rimase scioccato. Martin sembrava davvero malato. Aveva la barba lunga e i capelli spettinati e puzzava vagamente di sudore, ma fu soprattutto lo sguardo vuoto a renderlo per un attimo irriconoscibile. «Ah, sei tu» disse. «Posso entrare?» Martin alzò le spalle, si girò e lo precedette nell’appartamento strascicando i piedi. «Pia è al lavoro?» chiese Patrik guardandosi intorno. «No.» Martin si era fermato davanti alla porta del balcone, in soggiorno, e stava guardando fuori. Patrik aggrottò le sopracciglia. «Stai male?» «Mi sono messo in malattia. Annika non te l’ha detto?» Si girò, rabbioso. «Cos’è, vuoi il certificato medico? Sei venuto a controllare che non menta e me ne stia in panciolle a prendere il sole su uno scoglio?» Di norma, Martin era la persona più calma e bonaria che Patrik conoscesse. Non era mai successo niente di simile e l’ansia aumentò. Qualcosa non andava, poco ma sicuro. «Vieni, andiamo a sederci» disse accennando con la testa alla cucina. La rabbia di Martin si placò con la stessa velocità con cui era venuta, lasciando di nuovo il posto allo sguardo spento. Acconsentì con un cenno e lo seguì. Quando si sedettero, Patrik lo guardò preoccupato. «Cos’è successo?» Per quasi un minuto regnò il silenzio. «Pia sta per morire» disse poi Martin, abbassando gli occhi sul tavolo. Erano parole incomprensibili e Patrik si rifiutava di credere di aver sentito bene. «Cosa vuoi dire?» «È stata ricoverata per le terapie l’altro ieri. Pare abbia avuto fortuna a trovare posto così in fretta.» «Terapie? Per cosa?» Patrik scosse la testa. Aveva incrociato Martin e Pia il fine settimana precedente e sembrava che andasse tutto bene. «A meno di un miracolo, i medici dicono che forse le restano sei mesi.» «Sei mesi di terapie?» Martin alzò lentamente la testa e lo fissò dritto negli occhi. Il dolore che Patrik gli lesse nello sguardo era così nudo che per poco non si tirò indietro. «Sei mesi di vita. Poi Tuva non avrà più una mamma.» «Cosa... come... Quando avete...?» Patrik si accorse di balbettare, ma dopo quella notizia non riusciva a dare forma a una frase compiuta. Non ottenne risposta: Martin si accasciò con la testa sul tavolo piangendo a dirotto. Patrik si alzò e lo abbracciò. Alla fine, senza che nessuno dei due sapesse quanto tempo era passato, il pianto si attenuò e la tensione del corpo si allentò leggermente. «Tuva dov’è?» chiese Patrik senza lasciar andare il collega. «Dalla mamma di Pia. Io non ho la forza... almeno adesso.» Si rimise a piangere, ma in maniera più composta, con le lacrime che scendevano lentamente sulle guance. Patrik gli passava e ripassava la mano sulla schiena. «Avanti, sfogati.» Era una frase fatta che lo fece vergognare un po’, ma cosa si diceva in una situazione del genere? C’era qualcosa di giusto o sbagliato? Difficile, peraltro, che Martin avesse sentito le sue parole e se, in ogni caso, avrebbero fatto qualche differenza. «Hai mangiato qualcosa?» Martin tirò su col naso, si asciugò la faccia sulla manica della vestaglia e scosse la testa. «Non ho fame.» «Non me ne frega niente. Devi mangiare.» Andò a fare l’inventario del frigo, tutt’altro che vuoto, ma decise che non era il caso di preparare un pasto vero e proprio e si accontentò di tirare fuori burro e formaggio. Poi tostò un paio di fette di pane che trovò nel freezer. Probabilmente Martin non avrebbe mangiato più di così. Dopo averci pensato su un attimo ne preparò una anche per sé. Era sempre più facile mangiare, se lo si faceva in compagnia. «Adesso raccontami tutto» disse quando Martin fu riuscito a mandare giù la prima fetta e cominciò a prendere un po’ di colore. Martin riferì a spizzichi e bocconi tutto quello che sapeva del cancro di Pia e dello shock subito passando da un giorno in cui sembrava che andasse tutto bene a quello successivo in cui avevano saputo che doveva essere ricoverata per una terapia d’urto che probabilmente non l’avrebbe comunque salvata. «Quando tornerà a casa?» «La settimana prossima, penso. Non lo so con precisione, non ho...» La mano gli tremava e lo sguardo era pieno di vergogna. «Non hai parlato con i medici? Non sei stato da Pia da quando è stata ricoverata?» Patrik fece del proprio meglio per non usare un tono di rimprovero: era l’ultima cosa di cui Martin avesse bisogno e stranamente riusciva anche a capire la sua reazione. Aveva visto un numero sufficiente di persone in stato di shock per riconoscere lo sguardo spento e i gesti rigidi. «Preparo un po’ di tè» disse prima che Martin avesse il tempo di rispondere. «O preferisci il caffè?» «Caffè» rispose Martin che masticava e masticava, facendo fatica a deglutire. Patrik prese un bicchiere e lo riempì d’acqua. «Butta giù con questo. Il caffè arriva subito.» «Non ci sono andato» disse Martin smettendo di mangiare. «Non è poi così strano. Sei sotto shock» rispose Patrik mentre contava i misurini. «Non sono stato al suo fianco. Proprio adesso che ha più bisogno di me non sono lì con lei. E lo stesso vale per Tuva. Non vedevo l’ora di spedirla dalla nonna. Come se non fosse un momento difficile anche per lei... dopotutto Pia è sua figlia.» Sembrava sul punto di ricominciare a piangere ma inspirò profondamente e poi buttò fuori piano l’aria. «Non capisco da dove attinga la forza Pia. Mi ha telefonato più volte perché era in pensiero per me. Non è folle? Le stanno facendo la radioterapia e la chemio e il diavolo sa cos’altro. Sicuramente ha una fifa boia e sta da cani, eppure è in ansia per me!» «Non è strano nemmeno questo» disse Patrik. «Facciamo così: adesso tu ti fai una doccia e ti radi e così quando avrai finito il caffè sarà pronto.» «No, io...» fece per obiettare Martin, ma lui alzò una mano. «O vai in bagno e fai da solo oppure ti trascino io nella doccia e ti do una bella strigliata, ma preferirei evitare e credo che lo stesso valga per te.» Martin non poté fare a meno di ridere. «Non provare ad avvicinarti con una saponetta in mano. Faccio da solo, grazie.» «Bene» concluse Patrik girandosi per cercare delle tazze nel pensile. Sentì che Martin si alzava e andava verso il bagno. Quello che entrò dieci minuti dopo in cucina era un altro uomo. «Oh, adesso sì che ti riconosco» disse Patrik versando il caffè fumante in due tazze. «Mi sento un po’ meglio. Grazie» disse Martin sedendosi, il viso ancora pallido e tormentato ma gli occhi verdi leggermente più vivi. I capelli rossi, ancora umidi, erano ritti sulla testa. Sembrava un Kalle Blomkvist un po’ troppo in là con gli anni. «Ho una proposta» disse Patrik, che mentre il collega era in bagno aveva riflettuto. «Devi dedicare a Pia tutto il tuo tempo a darle il massimo sostegno. Inoltre bisognerà che ti assumi la responsabilità di Tuva. Prenditi le ferie a partire da adesso, e poi vedremo quanto si dovrà estenderle.» «Mi restano solo tre settimane.» «Il problema si risolve» rispose Patrik. «Non pensare agli aspetti pratici, adesso.» Martin gli rivolse uno sguardo vuoto e annuì. A Patrik vennero in mente Erica e l’incidente d’auto. Avrebbe potuto essere lui a trovarsi in quella situazione. Era stato a un passo dal perdere tutto. Era rimasta sveglia a pensare tutta la notte. Dopo che Patrik era andato al lavoro si era seduta in veranda per cercare di raccogliere le idee in pace mentre, per una volta, i bambini giocavano da soli. Adorava la vista dell’arcipelago di Fjällbacka ed era davvero grata di essere riuscita a salvare la casa appartenuta ai genitori in modo che i suoi figli potessero crescere lì, anche se la manutenzione non era delle più facili. Il vento e l’acqua salata rovinavano il legno e c’era sempre qualche riparazione da fare. Ultimamente l’aspetto economico non rappresentava più un problema. Le ci erano voluti molti anni di fatica, ma i suoi libri ormai rappresentavano una buona fonte di guadagno. Non aveva cambiato troppo le sue abitudini di vita ma non doversi più preoccupare se la caldaia si fosse rotta o se ci fosse stato bisogno di riverniciare la facciata le dava un senso di sicurezza. Molte persone non ne potevano godere, e lei ne era ben consapevole. Quando i soldi non bastavano e i posti di lavoro sparivano da un giorno all’altro era facile cercare un capro espiatorio. Probabilmente gran parte del successo degli Amici della Svezia era da ricercare proprio in quel fenomeno. Dall’incontro con John Holm non era riuscita a smettere di pensare a lui e a ciò che rappresentava. Aveva sperato di trovarsi di fronte un uomo antipatico che sbandierava apertamente le proprie idee e invece aveva trovato qualcosa di molto più pericoloso: una persona che aveva il dono dell’oratoria, sapeva dare risposte semplici in modo convincente ed era in grado di aiutare gli elettori a identificare il capro espiatorio per poi promettere di toglierlo di mezzo. Erica rabbrividì. Era convinta che John Holm nascondesse qualcosa. Forse i fatti di Valö c’entravano, forse no. Non le restava che scoprirlo, e sapeva con chi parlarne. «Bambini, andiamo a fare un giretto in macchina?» chiamò rivolta al soggiorno, e fu subito ricompensata da un’esplosione di grida di gioia. A tutti e tre era sempre piaciuto andare in auto. «Prima la mamma fa una telefonata. Tu intanto mettiti le scarpe, Maja, e tra poco vengo io ad aiutare Anton e Noel.» «Li aiuto io» rispose la bambina prendendo i fratelli per mano e trascinandoseli dietro verso l’ingresso. Erica sorrise. A ogni giorno che passava Maja diventava sempre più una vicemammina. Un quarto d’ora dopo erano in macchina sulla strada per Uddevalla. Aveva telefonato per assicurarsi che Kjell ci fosse in modo da evitare una trasferta inutile con i bambini a strascico. All’inizio aveva pensato di spiegare tutto al telefono ma poi si era resa conto che era meglio mostrargli il foglietto in modo che lo vedesse con i suoi occhi. Aveva cantato con i bambini per tutta la strada fino a Uddevalla e fu dunque con voce piuttosto rauca che si presentò all’accoglienza. Dopo un attimo arrivò Kjell. «Caspita, sei qui con tutta la banda?» disse abbassando gli occhi sui tre bambini, che risposero timidi al suo sguardo. La salutò con un abbraccio ed Erica sentì la barba lunga grattarle la guancia. Sorrise. Era contenta di rivederlo. Si erano conosciuti qualche anno prima, quando un’indagine per omicidio aveva dimostrato che durante la Seconda guerra mondiale la sua defunta madre, Elsy, e il padre di Kjell si erano frequentati parecchio. Kjell andava a genio sia a lei sia a Patrik ed entrambi apprezzavano le sue doti di giornalista. «Oggi niente baby sitter.» «Non importa. A me fa solo piacere vedervi» rispose Kjell sorridendo. «Penso di avere una cesta di giocattoli con cui potete giocare mentre io e la mamma parliamo.» «Davvero?» La timidezza era sparita di colpo e Maja corse dietro a Kjell a caccia della cesta promessa. «Eccola qui, ma temo che siano soprattutto pastelli e carta» disse il giornalista rovesciando tutto sul pavimento. «Non posso garantire che non si macchi la moquette» avvertì Erica. «Non sono ancora troppo bravi a restare nei margini.» «Perché, ti sembra che farebbe qualche differenza, su questa moquette?» chiese Kjell sedendosi alla scrivania. Erica abbassò gli occhi e si rese conto che aveva ragione. «Ieri ho parlato con John Holm» disse prendendo posto sulla poltroncina per i visitatori. Kjell la scrutò. «E che impressione ne hai tratto?» «Affascinante. Ma pericolosissimo.» «Giusta interpretazione, credo. In gioventù apparteneva a uno dei gruppi peggiori all’interno del movimento degli skinhead. Tra l’altro è stato lì che ha conosciuto la moglie.» «Faccio un po’ fatica a immaginarmelo senza capelli.» Erica si girò a controllare i bambini, che per fortuna si stavano comportando in maniera esemplare. «Già, diciamo che ha migliorato parecchio la sua immagine pubblica, ma l’esperienza mi dice che quelle persone non cambiano idea. Semplicemente, con gli anni diventano più furbe e imparano a comportarsi in un altro modo.» «E la sua fedina penale?» «Non è mai stato arrestato, anche se in gioventù ci è andato vicino più volte. Però non credo assolutamente che la sua posizione sia cambiata dagli anni in cui partecipava alle marce in memoria di Carlo XII a Lund con i suoi amici nazisti. Penso però di poter dire che è tutto merito suo se il partito è in parlamento.» «In che senso?» «La sua prima mossa geniale è stata quella di sfruttare la frattura creatasi tra i diversi gruppi nazionalsocialisti dopo l’incendio nella scuola di Uppsala.» «Quello per cui erano stati condannati tre nazisti?» chiese Erica ricordando i titoloni di diversi anni prima. «Esatto. Oltre alla frattura all’interno e tra i vari gruppi, l’interesse dei media era improvvisamente aumentato e anche la polizia teneva gli occhi bene aperti. È stato allora che John Holm ha fatto ingresso sulla scena, raccogliendo intorno a sé i cervelli migliori dei diversi raggruppamenti e proponendo una collaborazione che in seguito ha portato gli Amici della Svezia a diventare il partito di punta. Poi ha dedicato molti anni a fare pulizia tra i membri, almeno in superficie, e ha diffuso il messaggio che la loro politica è quella della gente comune. Insomma, alla fine si sono collocati come un partito dei lavoratori, la voce dell’uomo qualunque.» «Ma non dovrebbe essere difficile tenere insieme un partito del genere? Ci sono un bel po’ di estremisti lì dentro, no?» Kjell annuì. «Eccome. Infatti alcuni sono scesi dal carro perché ritenevano che John Holm avesse un atteggiamento troppo accomodante e che avesse tradito i vecchi ideali. Pare ci sia una regola inespressa che impedisce di parlare apertamente di politica dell’immigrazione. Le opinioni sono troppo diverse e c’è il rischio che il partito si spacchi. Dentro c’è di tutto: da chi pensa che gli immigrati si debbano mettere sul primo aereo utile per il loro Paese d’origine a quelli secondo cui bisogna imporre condizioni più stringenti a chiunque arrivi nel nostro Paese.» «A quale categoria appartiene John Holm?» chiese Erica girandosi per zittire i gemelli che avevano cominciato a fare chiasso. «Ufficialmente alla seconda, ma ufficiosamente...? Per essere chiari: non mi sorprenderebbe se in qualche armadio tenesse un’uniforme nazista.» «Com’era entrato in quei giri?» «Dopo che mi hai chiamato, ieri, ho fatto un controllo sul suo passato. Sapevo già che veniva da una famiglia molto abbiente. Suo padre aveva fondato una società di export negli anni Quaranta e dopo la guerra aveva continuato a espandersi. Gli affari andavano a gonfie vele. Ma nel 1976...» Kjell fece una pausa a effetto ed Erica si rizzò a sedere sulla sedia. «Sì?» disse. «Nella cerchia più esclusiva di Stoccolma ci fu uno scandalo. La madre di John, Greta, lasciò il padre Otto per un imprenditore libanese con cui il marito stesso era in affari. Poco dopo saltò fuori che Ibrahim Jaber, come si chiamava, aveva sottratto con l’inganno a Otto la maggior parte del suo patrimonio. Così, in miseria e abbandonato, Otto si sparò alla sua scrivania alla fine di luglio del 1976.» «E Greta e John che fine fecero?» «La morte di Otto non fu la conclusione della tragedia. Si venne a sapere che Jaber aveva già moglie e figli. Non aveva mai avuto intenzione di sposare Greta e, dopo aver intascato i soldi, la lasciò. Qualche mese più tardi il nome di John compare per la prima volta in contesti nazionalsocialistici.» «E l’odio è rimasto» commentò Erica. Si allungò verso la borsetta, prese il foglio e lo tese a Kjell. «Questo l’ho trovato ieri a casa sua. Non so come interpretare quello che c’è scritto, ma forse può servire a qualcosa?» Lui fece una risatina. «Spiegami meglio quel “trovato”.» «Mi sembra di sentir parlare Patrik» sorrise Erica. «Era lì in giro. Un foglietto scarabocchiato di cui nessuno sentirà la mancanza.» «Vediamo.» Kjell si abbassò sul naso gli occhiali che aveva sollevato sulla fronte. «Gimle» lesse a voce alta, aggrottando le sopracciglia. «Sì. Cosa significa? Non ho mai sentito questa parola. Sarà un acronimo?» Kjell scosse la testa. «Il Gimle è quello che viene dopo il Ragnarök nella mitologia nordica, una specie di cielo o paradiso. Un concetto noto e utilizzato nelle cerchie neonaziste. È anche il nome di un circolo culturale i cui membri sostengono di essere apartitici, ma non so fino a che punto sia vero. In ogni caso sono apprezzati sia dagli Amici della Svezia sia dal Partito del popolo danese.» «E che attività svolgono?» «Agiscono, come dicono loro, per ricreare il senso di appartenenza nazionale e un’identità comune. Si interessano agli antichi rituali svedesi, alle danze popolari, alla poesia arcaica, alle testimonianze culturali del passato e via di questo passo, cosa che si adatta perfettamente all’idea di conservazione delle tradizioni portata avanti dagli Amici della Svezia.» «Quindi Gimle potrebbe riferirsi a quel circolo?» Erica indicò il foglietto. «Impossibile a dirsi. Magari si tratta di tutt’altro. Difficile capire anche cosa significhino queste cifre. 1920211851612114. E dopo 5 08 1400.» Erica alzò le spalle. «Mah, non ne ho idea. Possono essere anche scarabocchi di quelli che si fanno telefonando e non significano niente. Hanno l’aria di essere stati scritti di fretta.» «Può darsi» disse Kjell. Poi agitò il foglietto. «Posso tenerlo?» «Certo. Aspetta solo un attimo che lo fotografo con il cellulare. Non si sa mai... magari mi viene un colpo di genio e scopro la chiave per decrittarlo.» «Ottima idea.» Le spinse vicino il foglietto e lei scattò una foto. Poi si mise in ginocchio a riordinare gli oggetti sparsi in giro dai bambini. «Hai qualche idea su come utilizzarlo?» «No, non ancora. Però ho in mente diversi archivi in cui posso cercare altre informazioni.» «Ma sei sicuro che non siano semplici scarabocchi?» «No, però vale la pena di provarci.» «Fatti sentire se scopri qualcosa, e io farò lo stesso con te» disse Erica sospingendo i bambini verso il corridoio. «Certo! Ci sentiamo» rispose Kjell allungandosi verso il telefono. Era un’ingiustizia bella e buona. Se arrivava in ritardo lui, apriti cielo, ma quando era Patrik a stare via metà mattinata nessuno batteva ciglio. La sera prima Erica l’aveva chiamato per riferirgli delle sue visite a Ove Linder e John Holm, e Gösta non vedeva l’ora di andare da Leon con Patrik. Sospirò e tornò all’elenco che aveva davanti. Un secondo dopo il telefono squillò e lui si gettò sulla cornetta. «Pronto?» «Gösta» disse la voce di Annika. «C’è Torbjörn in linea. È arrivato il risultato delle prime analisi del sangue. Cercava Patrik, ma forse puoi sentire tu?» «Certo.» Gösta ascoltò con attenzione prendendo nota di tutto, anche se sapeva che sarebbe arrivato un fax. In genere i referti autoptici erano scritti in un linguaggio molto complesso ed era più facile capire le spiegazioni orali. Appena ebbe riattaccato sentì bussare sulla porta aperta. «Annika ha detto che Torbjörn ha appena chiamato. Cosa ti ha detto?» La voce di Patrik era vivace ma gli occhi sembravano tristi. «È successo qualcosa?» domandò Gösta senza rispondere. Patrik si sedette pesantemente. «Sono andato a vedere come stava Martin.» «E come andavano le cose?» «Martin sarà in ferie per un po’. Tre settimane, per cominciare. Poi vedremo.» «Come mai?» Gösta fu colto dall’ansia. Effettivamente a volte lo prendeva un po’ in giro, ma Martin Molin gli andava a genio. Era impossibile non voler bene a quel ragazzo. Quando Patrik gli riferì quello che sapeva sulle condizioni di Pia, Gösta deglutì a fatica. Povero Martin. E la loro bambina, ancora piccolissima, che avrebbe perso la sua mamma. Mandò giù di nuovo la saliva, distolse il viso e batté febbrilmente le palpebre. Non poteva mettersi a frignare al lavoro. «Dovremo continuare a lavorare senza di lui» concluse Patrik. «Allora, cos’ha detto Torbjörn?» Gösta si asciugò discreto gli occhi e si schiarì la voce. Poi si girò e prese in mano gli appunti. «Il laboratorio centrale conferma che si tratta di sangue umano, ma è troppo vecchio per riuscire a tirarne fuori un dna confrontabile con quello di Ebba. Inoltre non è chiaro se appartenesse a una o più persone.» «Okay. Più o meno quello che pensavo. E la pallottola?» «Ieri Torbjörn l’ha mandata a uno che conosce, un esperto balistico che ha fatto una rapida analisi, ma purtroppo non corrisponde a nessuna pallottola di altri casi insoluti.» «Be’, ci abbiamo provato» rispose Patrik. «Sì. Comunque ha un diametro di nove millimetri.» «Nove? Non ci serve granché a circoscrivere la gamma di armi possibili.» Patrik abbassò le spalle. «No, però Torbjörn ha detto che presentava scanalature molto nette, per cui il suo amico farà un’analisi più accurata per stabilire il tipo di arma usato. E se salta fuori l’arma possiamo verificare se è quella da cui è stata sparata la pallottola.» «Resta solo un piccolo dettaglio: dovremmo trovarla.» Guardò pensoso il collega. «Con quanta precisione setacciaste la casa e i dintorni?» «Vuoi dire nel 1974?» Patrik annuì. «Facemmo il possibile» rispose Gösta. «Avevamo poca gente ma perlustrammo tutta l’isola. Se ci fosse stata un’arma gettata da qualche parte non ci sarebbe dovuta sfuggire.» «Probabile che sia in fondo al mare.» «Mi sa che hai ragione. A proposito, ho cominciato a telefonare agli allievi che frequentavano la scuola, ma per il momento non è venuto fuori niente. Molti non rispondono, il che non è strano visto che siamo in periodo di ferie e la maggior parte della gente è in vacanza.» «Hai fatto bene a cominciare, comunque» disse Patrik passandosi una mano nei capelli. «Magari fatti un appunto su quelli con cui ti sembra particolarmente importante parlare e poi vediamo se abbiamo la possibilità di andare a trovarli di persona.» «Sono sparsi per la Svezia» obiettò Gösta. «Se vogliamo cercare di vederli tutti dovremo girare in lungo e in largo.» «Be’, affronteremo la cosa quando sapremo quanti potrebbero essere.» Patrik si alzò e puntò verso la porta. «Allora andiamo da Leon Kreutz dopo pranzo? Per fortuna lui è a portata di mano.» «Va bene. Speriamo che venga fuori qualcosa di più rispetto a ieri. Josef era abbottonato come me lo ricordavo.» «Sì, c’era da cavargli le parole di bocca con le tenaglie. E quel Sebastian è un tipo viscido» rispose Patrik uscendo. Gösta si girò e si concentrò per comporre un altro numero. Per qualche motivo detestava parlare al telefono e se non fosse stato per Ebba avrebbe fatto di tutto per evitarlo. Era ben contento che Erica si occupasse di alcune delle chiamate. «Gösta? Puoi venire un attimo?» lo chiamò Patrik. In corridoio c’era Mårten Stark, l’aria seria e, in una mano, una bustina di plastica contenente qualcosa che sembrava una cartolina. «Mårten ha una cosa da mostrarci» disse Patrik. «L’ho messa in una busta appena ho potuto» spiegò Mårten, «ma naturalmente prima l’ho presa in mano e quindi può darsi che abbia rovinato qualche impronta.» «Hai fatto bene comunque» lo tranquillizzò Patrik. Gösta guardò la cartolina attraverso la plastica. Era una di quelle classiche con un grazioso gattino come immagine. La girò e lesse le poche righe. «Ma che diavolo...?» sbottò. «Sembra che “G” cominci a mostrare il suo vero volto» commentò Patrik. «Questa è sicuramente una minaccia di morte.» Ospedale psichiatrico di Långbro 1925 Doveva esserci stato un malinteso, oppure era colpa di quella donna orribile. Ma Dagmar l’avrebbe aiutato. Qualsiasi cosa fosse successa, tutto si sarebbe sistemato non appena fossero stati di nuovo insieme. Aveva lasciato la bambina in una pasticceria in città. Non le sarebbe successo niente. Se qualcuno le avesse chiesto come mai era lì da sola avrebbe risposto che la mamma era andata un attimo in bagno. Dagmar studiò l’edificio. Non era stato difficile trovarlo. Dopo aver fermato alcune persone per chiedere indicazioni, alla fine aveva incontrato una signora in grado di descrivere esattamente il percorso per arrivarci. Restava da capire come entrare. Davanti all’ingresso principale c’erano diversi addetti e l’avrebbero scoperta subito. Aveva pensato alla possibilità di presentarsi come signora Göring, ma se Carin era già stata lì il suo bluff sarebbe stato smascherato e non le sarebbe rimasta nessuna alternativa. Piano piano, per non essere vista da qualche finestra, si portò sul retro della costruzione dove c’era una porta che sembrava un ingresso riservato al personale. Rimase lì a lungo a sorvegliarla, vedendo entrare e uscire donne di tutte le età in divisa inamidata. Alcune mettevano della biancheria in un carrello sulla destra e di colpo le venne un’idea. Si avvicinò vigile, tenendo d’occhio l’ingresso per assicurarsi che non stesse uscendo nessuno. La porta rimase chiusa, permettendole di controllare rapidamente il contenuto del carrello. Sembravano soprattutto lenzuola e tovaglie, ma ebbe fortuna: in fondo c’era una divisa identica a quella che aveva visto indossare dalle infermiere. La tirò fuori e si nascose dietro l’angolo per cambiarsi. Quando ebbe finito s’infilò con cura i capelli nella cuffietta. La gonna era un po’ sporca sul bordo ma in generale non sembrava troppo usata. Non le restava che sperare che le infermiere non si conoscessero tutte e non si accorgessero subito che c’era una faccia nuova. Aprì la porta e sbirciò dentro quello che sembrava uno spogliatoio per il personale, deserto. Si affrettò verso il corridoio, sempre lanciandosi intorno occhiate furtive. Procedendo vicino al muro superò una lunga fila di porte chiuse. Non si vedevano targhette da nessuna parte e lentamente si rese conto che non avrebbe mai trovato Hermann lì dentro. Sentì montare la disperazione e si portò una mano alla bocca per ricacciare indietro un lamento. Non poteva arrendersi subito. Due giovani infermiere le venivano incontro lungo il corridoio, parlando a voce bassa, ma quando furono più vicine Dagmar distinse qualche parola. Aguzzò le orecchie. Avevano nominato Göring, ne era quasi sicura! Rallentò, cercando di sentire cosa dicevano. Una delle due aveva in mano un vassoio e sembrava che si stesse lamentando con l’altra. «L’ultima volta che sono entrata mi ha scaraventato addosso tutto il cibo» disse scuotendo la testa. «Per questo la caposala ha dato ordine di andare sempre in due da Göring, d’ora in avanti» rispose l’altra, anche lei con la voce leggermente tremante. Si fermarono davanti a una porta e sembrarono esitare. Dagmar capì che era arrivato il momento: doveva agire subito. Si schiarì la voce e disse con voce autoritaria: «Mi è stato comunicato che devo occuparmi io di Göring, così potete farne a meno voi ragazze» disse tendendo le mani verso il vassoio. «Davvero?» disse quella che lo teneva in mano, confusa, ma le si leggeva chiaro in viso il sollievo. «So io come tenere testa a quelli come lui. Avanti, adesso vedete di andare a rendervi utili, che qui ci penso io. Basta che mi aiutiate con la porta.» «Grazie» dissero le due ragazze con una piccola riverenza. Una delle due prese un grosso mazzo di chiavi e ne infilò una nella serratura. Le tenne aperta la porta e appena lei fu entrata si allontanarono in fretta, contente di aver evitato un compito sgradevole. Dagmar sentì battere forte il cuore. Eccolo, il suo Hermann, steso su una semplice branda e girato di spalle. «Andrà tutto bene, Hermann» disse appoggiando il vassoio a terra. «Adesso ci sono qui io.» Lui non si mosse. Dagmar gli fissò la schiena, rabbrividendo di gioia al pensiero di essergli finalmente vicina. «Hermann» disse appoggiandogli una mano sulla spalla. Lui se la tolse di dosso e con un solo gesto si girò e si alzò a sedere sul bordo del letto. «Cosa vuoi?» tuonò. Dagmar si ritrasse. Possibile che quello fosse davvero Hermann, l’elegante aviatore che l’aveva fatta fremere in tutto il corpo, l’uomo dalla schiena diritta e dalle spalle larghe i cui capelli brillavano dorati nel sole? «Dammi la mia medicina, maledetta troia. Lo pretendo! Non lo sai chi sono io? Hermann Göring, ed esigo che mi sia data la mia medicina!» Parlava svedese con un forte accento tedesco e facendo delle pause come per cercare le parole. Dagmar sentì che le si chiudeva la gola. L’uomo che gridava come un ossesso davanti a lei era grasso, con la pelle di un pallore malato. I capelli radi erano come incollati al cranio e sul viso colava il sudore. Dagmar inspirò profondamente. Doveva assicurarsi di non essersi sbagliata. «Hermann. Sono io, Dagmar.» Restò a distanza da lui, aspettandosi un’aggressione da un momento all’altro. Le vene sulla fronte pulsavano e il pallore cominciava a cedere il passo a un rossore intenso che risaliva lentamente dalla gola. «Dagmar? Me ne frego di come ti chiami, tu e tutte le sgualdrine come te! Voglio la mia medicina. Sono gli ebrei che mi hanno rinchiuso qui dentro e io devo guarire! Hitler ha bisogno di me. Dammi la mia medicina!» Continuò a gridare con tanta veemenza da spruzzare Dagmar di saliva. Sconvolta, lei ritentò: «Non ti ricordi di me? Ci siamo conosciuti a una festa del dottor Sjölin. A Fjällbacka.» La sfuriata s’interruppe di colpo e l’uomo aggrottò la fronte e la guardò interdetto. «A Fjällbacka?» «Sì, alla festa del dottor Sjölin» ripeté lei. «Abbiamo passato la notte insieme.» Lo sguardo gli si fece più limpido e Dagmar si rese conto che ricordava. Finalmente. Presto si sarebbe sistemato tutto. Lei avrebbe pensato a rimettere le cose a posto e Hermann sarebbe tornato a essere il suo elegante aviatore. «Sei la cameriera» disse lui asciugandosi la fronte. «Mi chiamo Dagmar» sussurrò lei avvertendo un vago senso di disagio alla bocca dello stomaco. Perché non l’aveva già stretta tra le braccia, come si era sempre immaginata nei suoi sogni? Di punto in bianco lui scoppiò a ridere facendo sobbalzare la grossa pancia. «Dagmar, è vero.» Rise di nuovo e lei chiuse le mani a pugno. «Abbiamo una figlia. Laura.» «Una figlia?» La fissò con gli occhi ridotti a due fessure. «Non è la prima volta che lo sento dire. Queste cose non si possono mai sapere. Soprattutto con una cameriera.» Le ultime parole grondavano disprezzo e Dagmar sentì di nuovo montare la rabbia. In quella stanza bianca e asettica in cui non penetrava un filo di luce del giorno andarono in pezzi tutti i suoi sogni e le sue speranze. Tutto ciò che pensava di sapere della sua vita era una menzogna: gli anni di nostalgia e desiderio in cui aveva sopportato quella bambina urlante, sua figlia, che non faceva altro che pretendere e pretendere, erano stati gettati al vento. Si gettò su di lui con le dita ricurve come grinfie mentre dalla gola le uscivano versi gutturali, animata dal desiderio di fargli male come lui ne aveva fatto a lei. Le unghie gli si conficcarono nel viso e, come a distanza, lo sentì gridare in tedesco. La porta si aprì e delle braccia l’afferrarono e la trascinarono via dall’uomo che aveva amato per tanto tempo. Poi calò il buio. Era stato suo padre a insegnargli come si faceva un buon affare. Lars-Åke “Sopravvento” Månsson era una leggenda e Sebastian l’aveva ammirato per tutta l’infanzia e l’adolescenza. Il soprannome gli derivava dai suoi costanti successi negli affari e dalla capacità di cavarsela sempre, anche quando si trovava nei guai. “LarsÅke riesce a sputare sopravvento senza ritrovarsi una goccia di saliva in faccia” si diceva. Sopravvento sosteneva che in realtà fosse facilissimo indurre le persone a fare come si voleva. Il principio di base era lo stesso della boxe: si identificava il punto debole dell’avversario e poi lo si colpiva una volta dopo l’altra fino a poter alzare le braccia in un gesto vittorioso. Oppure, come nel suo caso, fino a portare a casa il gruzzolo. Il suo modo di fare affari non lo rendeva popolare e nemmeno rispettato ma, come diceva sempre: “Il rispetto non riempie la pancia”. Era diventato anche il motto di Sebastian. Sapeva benissimo di essere detestato da molti e temuto da un numero anche maggiore di persone, ma seduto a bordo piscina con una birra fredda in mano pensò per l’ennesima volta che non gliene fregava un bel niente. Non gli interessava avere amici: comportava scendere a compromessi e rinunciare a una parte di potere. «Papà? Io e i ragazzi pensavamo di andare a fare un giro a Strömstad, ma sono rimasto senza soldi.» Jon, in boxer da bagno, lo stava guardando implorante. Sebastian si schermò gli occhi con la mano e osservò il figlio ventenne. A volte Elisabeth si lamentava dei vizi che dava sia a lui sia alla sorella Jossan, di due anni più giovane, ma erano sciocchezze belle e buone. L’educazione rigida, fatta di regole e via di questo passo, era per i signori Nessuno, non per loro. I ragazzi dovevano imparare quello che la vita aveva da offrire e che se si voleva qualcosa ce lo si prendeva. A tempo debito avrebbe coinvolto Jon nella ditta e gli avrebbe insegnato tutto quello che lui aveva imparato da Sopravvento, ma per il momento riteneva che il ragazzo avesse il diritto di divertirsi. «Prendi la mia carta oro. È nel portafogli, nell’ingresso.» «Sei un grande, papi. Grazie!» Jon si affrettò in casa, come se temesse che Sebastian potesse cambiare idea. Quando aveva preso in prestito la carta oro durante il torneo di tennis a Båstad il conto aveva sfiorato le settantamila corone, ma nel contesto erano spiccioli, soprattutto se poteva servire a far mantenere a Jon il suo status nel giro che si era fatto a Lundsberg, dove la fama delle ricchezze di suo padre gli aveva procurato rapidamente amici destinati a essere in futuro uomini potenti. Naturalmente era stato Sopravvento a insegnare a Sebastian l’importanza di avere le conoscenze giuste, molto più preziose degli amici, e infatti l’aveva iscritto a Valö non appena aveva saputo i nomi di alcuni dei ragazzi che avrebbero frequentato il collegio. L’unica cosa che lo disturbava era la presenza del piccolo ebreo, come lo chiamava lui. Non aveva né soldi né una famiglia di riguardo e il fatto che frequentasse la scuola ne abbassava il livello. Ripensando a quell’epoca strana e lontana, però, Sebastian si rese conto che, tra tutti i compagni, Josef era stato il suo preferito. Era animato da una spinta a migliorare, quasi un’ossessione, che ritrovava anche in se stesso. Grazie alla folle idea di Josef si erano ritrovati e Sebastian doveva riconoscere che lo ammirava per la sua ferrea volontà di raggiungere il suo scopo a ogni costo. Che i loro obiettivi fossero completamente diversi non aveva importanza. Sapeva che il risveglio sarebbe stato brusco ma immaginava che in fondo Josef intuisse che, per quanto lo riguardava, la vicenda non avrebbe avuto un lieto fine. Ma la speranza è l’ultima a morire e Josef era ben consapevole di dover fare quello che diceva Sebastian. Come tutti gli altri. Gli sviluppi degli ultimi tempi erano innegabilmente interessanti. La voce del recente ritrovamento sull’isola si era sparsa in fretta, ma già l’arrivo di Ebba aveva messo in moto i pettegolezzi. Tutto ciò che poteva riportare in auge quella vecchia storia veniva accolto con favore. E negli ultimi giorni la polizia aveva cominciato a scavarci dentro. Sebastian fece ruotare pensoso il boccale di birra e se lo premette sul petto per rinfrescarsi. Si chiese cosa pensassero gli altri di quanto stava succedendo e se anche loro avessero ricevuto visite. Dal vialetto d’ingresso sentì che la Porsche veniva messa in moto. Il ragazzino gli aveva fregato le chiavi che aveva lasciato di fianco al portafogli. Sorrise. Ci sapeva fare, il suo figliolo. Nonno Sopravvento sarebbe stato fiero di lui, se avesse potuto vederlo. Fin da quando era tornata da Valö, il giorno prima, Anna non aveva fatto altro che riflettere su come arredare i vari locali, e quella mattina era scesa dal letto quasi saltellando. Dan aveva riso della sua foga ma gli si leggeva negli occhi la gioia per quella trasformazione. Sarebbe passato ancora parecchio prima che potesse mettersi davvero all’opera ma Anna non stava nella pelle. C’era qualcosa, in quel posto, che l’attirava enormemente. Forse dipendeva dall’atteggiamento aperto ed entusiasta dimostrato da Mårten nei confronti delle sue proposte. L’aveva guardata con qualcosa che somigliava ad ammirazione negli occhi e per la prima volta da molto tempo l’aveva fatta sentire una persona interessante e in gamba. Quando aveva telefonato per chiedere se poteva tornare a fare foto e prendere misure le aveva risposto che era più che benvenuta. Mentre misurava la distanza tra le finestre della camera da letto avvertì chiaramente la sua mancanza. Quando lui non c’era, l’atmosfera in casa era diversa. Lanciò un’occhiata a Ebba, che stava tinteggiando lo stipite della porta. «Non è solitario questo posto?» «Mah, a me piace un po’ di tranquillità.» La risposta era stata riluttante e il silenzio nella stanza si fece oppressivo, al punto che Anna si sentì costretta a dire qualcosa di più. «Sei in contatto con qualcuno della tua famiglia? Di quella biologica, intendo dire.» Avrebbe voluto mordersi la lingua. Quella domanda poteva essere interpretata come invadente, con il risultato che Ebba si chiudesse ancora di più in se stessa. «Non è rimasto nessuno.» «Ma hai fatto qualche ricerca? Immagino che sia curiosa di chi fossero i tuoi genitori.» «Finora non lo sono stata.» Ebba rimase con il pennello a mezz’aria. «Ma da quando sono arrivata ovviamente ho cominciato a pensarci.» «Erica ha del materiale.» «Sì, me l’ha detto. Ho intenzione di andare a Fjällbacka a dare un’occhiata, ma non mi sono ancora decisa. Qui ci si sente al sicuro. Mi sono arenata sull’isola, diciamo.» «Prima ho incrociato Mårten. Stava andando in paese.» Ebba annuì. «Sì, gli tocca fare la spola per la spesa, la posta e tutte le altre commissioni. Cercherò di darmi una regolata anch’io, ma...» Anna stava per chiederle del figlio morto, ma non se la sentì. Il suo dolore era ancora troppo grande per avere la forza di parlare con qualcun altro di una perdita di quella portata. Nello stesso tempo, era perplessa. A quanto poteva osservare, nella casa non si vedeva nulla che indicasse che Ebba e Mårten fossero stati genitori, come foto o altri oggetti. Solo qualcosa, nei loro occhi, in cui Anna si riconosceva. Uno sguardo che incrociava ogni giorno allo specchio. «Erica ha detto che avrebbe cercato di scoprire che fine hanno fatto i loro effetti personali» disse cominciando a misurare il pavimento. «Sì, sono d’accordo con lei: è un po’ strano che sia sparito tutto. Se vivevano qui dovevano avere un bel po’ di roba. Mi piacerebbe ritrovare degli oggetti che mi sono appartenuti da piccola, per esempio vestiti e giocattoli. Come quelli che ho tenuto di...» Si bloccò e ricominciò a tinteggiare. La stanza si riempì del fruscio del pennello sul legno. A intervalli regolari si chinava a intingerlo in un secchiello in cui la vernice cominciava a scarseggiare. Quando dal piano di sotto si sentì la voce di Mårten, s’irrigidì. «Ebba?» «Sono qui sopra!» «Ti serve qualcosa in cantina?» Ebba andò a rispondergli dal pianerottolo. «Un barattolo di vernice bianca, grazie. C’è qui Anna.» «Ho visto la barca» rispose Mårten. «Prendo la vernice. Intanto metti su un po’ di caffè?» «Okay.» Ebba si girò verso Anna. «Fai volentieri uno spuntino anche tu, no?» «Certo» rispose Anna cominciando a ripiegare il metro di legno. «No, continua pure per un po’, se vuoi. Ti chiamo quando è pronto il caffè.» «Grazie, va benissimo.» Anna riprese a misurare, annotando accuratamente i numeri su uno schizzo. Sarebbe servito a facilitare la progettazione. Lavorò concentrata per un po’, sentendo Ebba armeggiare in cucina. Aveva proprio voglia di una bella tazza di caffè, preferibilmente in qualche punto all’ombra. Al piano di sopra il caldo cominciava a diventare insopportabile e la canotta le si era appiccicata alla schiena da un pezzo. D’un tratto si sentì uno schianto seguito da uno strillo acuto. Anna fece un salto e lasciò cadere il metro. Al secondo colpo secco in pochi secondi si precipitò alla scala e scese così velocemente che per poco non scivolò sugli ultimi gradini logori. «Ebba?» chiamò correndo verso la cucina. Sulla soglia si fermò di botto. La finestra che dava sul retro della casa era in pezzi e sotto c’era un mucchio di vetri, con frammenti sparsi per tutta la stanza. Sul pavimento, davanti al forno, Ebba era accucciata con le braccia sulla testa. Aveva smesso di gridare ma respirava a singhiozzo. Anna si precipitò dentro sentendo i vetri che le si rompevano sotto le suole. Circondò Ebba con le braccia e cercò di controllare se era ferita, ma non vide sangue. Si guardò intorno per capire cosa potesse aver spaccato il vetro. Quando gli occhi le caddero sulla parete di fondo trattenne il respiro di scatto: due fori di proiettile si distinguevano nettamente nel muro. «Ebba? Cosa cazzo è successo?» Mårten arrivò di corsa dalla scala della cantina. «Cos’è stato?» Lo sguardo corse dal vetro rotto a Ebba e in un passo fu accanto a lei. «È ferita? Non è ferita, vero?» Strinse a sé la moglie, cullandola tra le braccia. «Non credo, ma sembra che qualcuno abbia cercato di spararle.» Anna sentì il cuore battere all’impazzata e di colpo si rese conto che potevano essere in pericolo, che chi aveva sparato poteva ancora essere lì fuori. «Dobbiamo andarcene» disse. Mårten capì subito cosa intendeva. «Non alzarti, Ebba. Dobbiamo stare alla larga dalla finestra.» Parlava articolando bene le parole, come se si rivolgesse a un bambino. Ebba annuì, ubbidendo. Corsero piegati in due nell’ingresso e Anna fissò terrorizzata la porta. E se chi aveva sparato fosse entrato di lì, semplicemente varcando la soglia e riprovandoci? Mårten seguì il suo sguardo e si lanciò verso la porta, girando la chiave nella serratura. «Ci sono altri ingressi?» chiese lei con il cuore che andava ancora a mille. «La porta della cantina, ma è chiusa.» «La finestra della cucina? Ormai è in pezzi.» «È troppo in alto» rispose lui, ma era meno calmo di quanto volesse suonare. «Chiamo la polizia.» Anna prese la borsetta, che era appoggiata su una mensola nell’ingresso. Quando tirò fuori il cellulare le tremavano le mani. Mentre sentiva gli squilli guardò Mårten ed Ebba, seduti sul primo gradino della scala, lui che le cingeva le spalle e lei con la testa appoggiata al suo petto. «Ehi, finalmente! Dove siete stati?» Sentendo la voce dall’interno della casa Erica fece un salto. «Kristina?» Fissò la suocera che stava uscendo dalla cucina con uno strofinaccio in mano. «Sono entrata con le mie chiavi. Meno male che le avevo da quando sono venuta a innaffiare le piante mentre eravate a Maiorca, altrimenti avrei fatto un viaggio inutile da Tanumshede» disse lei rientrando allegramente in cucina. Già, oppure avresti potuto telefonare per chiedere se potevi venire, pensò Erica. Tolse le scarpe ai bambini, inspirò profondamente e la seguì. «Ho pensato di venire a dare una mano per qualche ora. Ho visto come siete messi e ai miei tempi non si poteva vivere in questo modo. Non si sa mai chi può venire in visita e certo una casa in queste condizioni non è un bel vedere» continuò Kristina sfregando energicamente il piano di lavoro. «Certo, non si sa mai quando può passare il re a prendere un caffè.» La suocera si voltò con un’espressione stupita sul viso. «Il re? Perché dovrebbe venire qui?» Erica strinse i denti con una forza tale che le si bloccarono le mascelle, ma non disse niente. In genere era la soluzione migliore. «Dove siete stati?» chiese di nuovo Kristina passando a strofinare il tavolo. «A Uddevalla.» «Ma come, hai messo in macchina i bambini e sei andata avanti e indietro da Uddevalla? Poveri amori della nonna. Perché non mi hai telefonato? Avrei potuto stare io con loro! Certo avrei dovuto rinunciare alla mia colazione con Görel, ma cosa non si fa per i figli e i nipoti. Quello che tocca, tocca. Lo capirai quando sarai più in là con gli anni e i figli saranno cresciuti.» Fece una pausa per poter sfregare per bene una macchia di marmellata che si era seccata sulla tovaglia di plastica. «Ma può darsi che un giorno non troppo lontano non sarò più in grado di darvi lo stesso aiuto. Sono cose che capitano in fretta. Ho più di settant’anni e non si sa mai per quanto tempo ne avrò ancora la forza.» Erica annuì spremendo un sorrisino riconoscente. «I bambini hanno mangiato qualcosa?» chiese Kristina ed Erica s’irrigidì. Se n’era completamente dimenticata. Dovevano avere una fame da lupi, ma non aveva intenzione di ammetterlo di fronte alla suocera. «Abbiamo mangiato un hot dog per strada ma sicuramente adesso vorranno il pranzo.» Andò decisa al frigo per vedere cosa poteva mettere in tavola. La soluzione più veloce era latte fermentato e cereali e così tirò fuori l’occorrente. Kristina emise un sospiro costernato. «Ai miei tempi non ci si sarebbe neanche sognati di dare ai bambini qualcosa di diverso da un vero e proprio pasto. Patrik e Lotta non hanno mai mangiato cibi precotti e guarda come sono venuti su sani. La base di una buona salute è la dieta, l’ho sempre detto, ma purtroppo non c’è più nessuno che ascolti la saggezza degli anziani. Voi giovani ne sapete sempre di più e ormai si deve fare tutto di fretta.» Fu costretta a riprendere fiato e proprio in quel momento Maja fece capolino dalla porta. «Mamma, ho famissima e anche Noel e Anton. Qui dentro è tutto vuoto.» Si passò una mano sul pancino ancora rotondo da bambina. «Ma come, se prima quando eravate in macchina avete mangiato l’hot dog» disse Kristina facendole una carezza sulla guancia. Maja scosse la testa facendo volare i capelli chiari. «No, non è vero! Abbiamo solo fatto colazione e io ho tanta fame!» Erica fulminò con lo sguardo la piccola delatrice e avvertì lo sguardo di riprovazione della suocera. «Posso fare un po’ di pannkakor» disse Kristina e Maja cominciò subito a saltare dalla gioia. «I pannkakor della nonna! Evviva!» «Grazie.» Erica rimise in frigo il latte fermentato. «Allora io vado su a cambiarmi e controllo una faccenda di lavoro.» Kristina era di spalle e aveva già cominciato a tirare fuori gli ingredienti e messo la padella a scaldare sul fuoco. «Vai pure, così io vedo di far mettere qualcosa sotto i denti a questi poveri bambini.» Erica salì le scale contando lentamente fino a dieci. In realtà non doveva controllare proprio niente, solo riprendere fiato un attimo. La suocera era animata dalle migliori intenzioni, ma sapeva quali pulsanti premere per irritarla alla follia. Patrik stranamente non se la prendeva altrettanto e la cosa la faceva imbestialire ancora di più. Ogni volta che lei provava a parlargliene, riferendogli qualcosa che aveva detto o fatto, lui diceva soltanto: «Non pensarci. Mia madre ogni tanto esagera, ma tu lasciala fare.» Forse era così tra le madri e i figli maschi e magari un giorno sarebbe diventata anche lei insopportabile con le mogli di Noel e Anton, ma non lo credeva. Sarebbe stata la miglior suocera del mondo, una di quelle che le compagne dei figli consideravano un’amica e con cui si confidavano. Avrebbero voluto che lei e Patrik li accompagnassero in tutti i loro viaggi e lei li avrebbe aiutati con i bambini, e se avessero avuto molto da fare al lavoro sarebbe andata a casa loro a dare una mano per le pulizie e i pasti. Probabilmente avrebbe avuto una sua chiave e... Erica si bloccò. Forse non era poi così semplice essere la suocera ideale. In camera si cambiò, infilandosi pantaloni corti di jeans e maglietta. Quella bianca era la sua preferita, convinta com’era che la facesse sembrare più magra. Effettivamente nel corso degli anni il suo peso era variato parecchio, ma una volta portava la taglia quarantadue mentre da quando era nata Maja era passata alla quarantasei. Come aveva fatto a ridursi così? E Patrik non era molto meglio. Non che quando si erano conosciuti fosse tutto muscoli, ma di sicuro aveva il ventre piatto, mentre da un po’ di tempo a quella parte gli sporgeva di brutto e purtroppo negli uomini la pancetta era la cosa meno attraente che si potesse immaginare. Quella riflessione la portò a chiedersi se lui pensasse la stessa cosa di lei, visto che non era certo uguale a quando si erano incontrati. Lanciò un’ultima occhiata allo specchio a figura intera, trasalì e si girò. C’era qualcosa di diverso. Si guardò intorno cercando di ricordare che aspetto avesse la stanza quando si era alzata. Non riusciva a farsi un’immagine chiara di quella mattina, eppure avrebbe potuto giurare che qualcosa era cambiato. Che fosse salita Kristina? No, perché in quel caso avrebbe riordinato e rifatto i letti, e non era così: le coperte e i cuscini erano ammucchiati e il copriletto attorcigliato come al solito. Si guardò intorno ancora una volta, ma poi alzò le spalle. Doveva esserselo immaginato. Andò nello studio, si sedette al computer e aprì la finestra del log-in. Sorpresa, fissò lo schermo. Qualcuno aveva cercato di entrare nel suo pc. Dopo tre tentativi a vuoto, era comparsa la domanda di sicurezza: come si chiamava il tuo primo animale domestico? Con un crescente senso di disagio setacciò la stanza con gli occhi. Sì, qualcuno era decisamente stato lì. Forse non sembrava che tenesse un ordine preciso in quel caos, ma in realtà sapeva esattamente dove metteva gli oggetti ed era evidente che qualcuno aveva frugato tra le sue cose. Perché? Cercavano qualcosa e, in caso affermativo, cosa? Dedicò un bel po’ di tempo a verificare il contenuto della stanza, ma sembrava che non mancasse niente. «Erica?» Kristina la stava chiamando dal piano di sotto e, ancora con il senso di disagio in corpo, Erica si alzò per andare a sentire cosa voleva. «Sì?» chiese sporgendosi dal corrimano. In piedi nell’ingresso, la suocera la guardava con aria di rimprovero. «Devi ricordarti di chiudere per bene la porta della veranda. Poteva andare a finire male. Per fortuna ho visto Noel dalla finestra della cucina. Era già fuori e puntava dritto alla strada. Ho fatto in tempo a riacciuffarlo, ma non si possono lasciare le porte aperte con dei bambini piccoli in casa. Ci mettono un attimo a sparire, sai?» Erica si sentì gelare. Ricordava perfettamente che quando erano andati via la porta della veranda era chiusa. Rifletté qualche secondo, prese il telefono e compose il numero di Patrik. Un istante dopo sentì la suoneria dalla cucina, dove il cellulare giaceva dimenticato sulla panca. Chiuse la chiamata. Paula si alzò sbuffando dal divano. Il pranzo era pronto e anche se il pensiero di mangiare le faceva venire la nausea sapeva di doverlo fare. Di solito adorava la cucina di sua madre, ma la gravidanza le aveva fatto perdere l’appetito e se fosse stato per lei sarebbe vissuta di cracker e gelato. «Ecco che arriva l’ippopotamo!» disse Mellberg scostandole la sedia. Lei non si prese nemmeno la briga di rispondere alla battuta, che aveva già sentito innumerevoli volte. «Che si mangia?» «Spezzatino preparato nella pentola di ghisa. Sai che è importante assorbire il ferro» rispose Rita mettendo in un piatto una porzione enorme e piazzandogliela davanti. «Grazie di avermi invitato a mangiare. In questo periodo non ho nessuna voglia di cucinare, soprattutto quando Johanna è al lavoro.» «Ma è naturale, stellina» le rispose Rita con un sorriso. Paula inspirò a fondo e affrontò la prima forchettata. La sentì lievitare in bocca ma si costrinse a continuare a masticare. Il bambino aveva bisogno di nutrimento. «Come va al lavoro?» chiese poi. «Il caso Valö procede?» Mellberg finì quello che aveva nel piatto prima di rispondere. «Ma sì, si va avanti. Mi tocca farmi in quattro, ma quando mi ci metto i risultati si vedono.» «E a che conclusioni siete giunti?» domandò Paula. Sapeva benissimo che, nonostante fosse il responsabile della stazione di polizia, con tutta probabilità Bertil non sarebbe stato in grado di rispondere a quella domanda. «Bah... Diciamo che ancora non abbiamo avuto modo di assemblare i diversi filoni» disse lui confuso. In quel momento gli squillò il cellulare e lui andò a rispondere, contento dell’interruzione. «Sì, parla Mellberg. Ah, ciao, Annika. E dove diavolo è Hedström, si può sapere? E Gösta?... Come, non li trovi?... Valö? Va bene, me ne occupo io. Ho detto che me ne occupo io!» Chiuse la chiamata e, borbottando tra sé e sé, andò nell’ingresso. «Dove vai? Non hai sparecchiato!» lo richiamò Rita. «È un’emergenza. Sparatoria a Valö. Non ho tempo da perdere in faccende domestiche.» Paula sentì tornare le energie e balzò in piedi alla massima velocità possibile. «Un attimo! Cos’è successo? Qualcuno ha sparato a Valö?» «Non so i particolari, ma come ho chiarito ad Annika andrò sul posto e me ne occuperò personalmente.» «Vengo anch’io» disse Paula sedendosi su uno sgabello per infilarsi le scarpe. «Non se ne parla» rispose Mellberg. «E poi sei in ferie.» Subito fu spalleggiato da Rita che arrivò a precipizio dalla cucina. «Sei matta?» gridò talmente forte che per puro miracolo non svegliò Leo, addormentato nel lettino in camera dei nonni. «Tu non vai da nessuna parte, nelle tue condizioni.» «Brava, falla ragionare.» Mellberg afferrò la maniglia per battersela. «Non ho intenzione di cedere. Piuttosto faccio l’autostop fino a Fjällbacka e arrivo a Valö per conto mio.» Paula aveva deciso. Era stanca di stare ferma, stanca di quell’inattività, e liquidò con la mano i rimproveri della madre. «E che diavolo! Possibile che debba essere circondato da pazze scatenate?» sbottò Mellberg. Sconfitto, la precedette alla macchina e quando Paula uscì lo trovò con il motore avviato e l’aria condizionata accesa. «Promettimi di fare attenzione e di stare alla larga, se succede qualche casino.» «Promesso» rispose Paula prendendo posto sul sedile del passeggero. Per la prima volta da mesi a quella parte si sentiva di nuovo se stessa e non più un’incubatrice ambulante. Mentre Mellberg telefonava a Victor Bogesjö della guardia costiera per avvertirlo del loro arrivo, pensò allo scenario che avrebbero trovato sull’isola. Fjällbacka 1929 La scuola era un tormento. Ogni mattina Laura cercava fino all’ultimo di rimandare l’attimo in cui avrebbe dovuto andarci. Durante la ricreazione veniva bombardata di parolacce e nomignoli e naturalmente era solo colpa della mamma. Tutta Fjällbacka sapeva chi era Dagmar: una pazza ubriacona. Tornando da scuola la vedeva spesso: vagava per la piazza urlando dietro alla gente e delirando di Göring. Laura non si fermava mai e la ignorava, affrettandosi oltre. La mamma non era quasi mai a casa. Stava fuori fino a tardi e quando lei usciva per andare a scuola dormiva. Poi, al suo rientro, era di nuovo in giro, e allora per prima cosa lei riordinava. Solo dopo aver fatto sparire tutte le tracce della presenza di sua madre si sentiva tranquilla. Raccoglieva i vestiti gettati sul pavimento e quando ne aveva un mucchio sufficientemente grosso li lavava. Puliva la cucina, metteva via il burro lasciato in tavola e toccava il pane per vedere se era ancora mangiabile nonostante fosse rimasto fuori. Poi spolverava e sistemava dove era necessario. Quando era tutto a posto e le superfici brillavano aveva finalmente il tempo di giocare con la casa delle bambole, il suo bene più prezioso. Gliel’aveva regalata la vicina, una donna buona che era venuta a bussare un giorno che la mamma non c’era. Ogni tanto capitava che le persone fossero gentili con lei e le portassero qualcosa: cibo, vestiti e giocattoli. La maggior parte della gente, però, si limitava a fissarla e indicarla a dito, e dal giorno in cui sua madre l’aveva lasciata sola a Stoccolma Laura aveva imparato a non chiedere aiuto. Era stata prelevata dalla polizia e si era ritrovata in paradiso. Per due giorni era stata ospitata da una famiglia in cui i genitori avevano gli occhi buoni. Sebbene all’epoca avesse solo cinque anni ricordava benissimo quei due giorni. La mamma aveva preparato la montagna di frittelle più alta che Laura avesse mai visto incoraggiandola a prenderne ancora finché si era ritrovata con la pancia così piena da pensare di non poter mai più avere fame. Da un cassettone avevano tirato fuori per lei dei vestitini a fiori che non erano né rotti né sporchi ma anzi i più belli che si potessero immaginare. Si era sentita una principessa. Per due sere era stata messa a letto con un bacio sulla fronte e si era addormentata in un letto comodo con le lenzuola pulite. La mamma dallo sguardo gentile aveva un buon profumo, non puzzava di alcol e sudore come la sua. Avevano anche una bella casa, con soprammobili di porcellana e quadretti ricamati alle pareti. Fin dal primo giorno Laura aveva pregato e implorato di poter restare, ma la mamma non aveva risposto e l’aveva solo stretta tra le braccia morbide. Poco tempo dopo lei e la madre si erano di nuovo trovate a casa, come se non fosse successo niente, e Dagmar era più furiosa che mai. Gliene aveva date tante che quasi non riusciva a stare seduta, e Laura aveva preso una decisione: non avrebbe sognato quella mamma gentile. Nessuno era in grado di salvarla e non valeva la pena di lottare. Qualsiasi cosa fosse successa, lei sarebbe sempre finita con sua madre in quell’appartamentino scuro e stretto. Ma da grande avrebbe avuto una bella casa, con gatti di porcellana su centrini all’uncinetto e quadretti ricamati in tutte le stanze. S’inginocchiò davanti alla casa delle bambole. L’appartamento era pulito e in ordine, e aveva già piegato e messo via il bucato. Poi aveva mangiato pane e burro e finalmente poteva lasciarsi trasportare per qualche attimo in un mondo diverso e migliore. Soppesò nella mano la bambolina che raffigurava la madre, così bella e leggera. Il vestito bianco, con i pizzi e il colletto alto, i capelli raccolti in una crocchia. Laura l’adorava. Le accarezzò il viso con l’indice. Aveva l’aria gentile, proprio come la mamma dal buon odore. L’appoggiò delicatamente sul bel divano del salone, la stanza che preferiva e in cui era tutto impeccabile: c’era persino un minuscolo lampadario di cristallo fissato al soffitto. Passava ore a studiare i prismi in miniatura, stupendosi di come si potesse produrre qualcosa di così piccolo e perfetto. Socchiuse gli occhi studiando la stanza con aria critica. Non aveva davvero difetti o era possibile migliorarla ancora? Provò a spostare il tavolo da pranzo un po’ a sinistra e poi le sedie, una a una, in modo che fossero allineate al millimetro. Alla fine il risultato non le dispiacque ma dovette muovere anche il divano perché altrimenti sarebbe rimasto uno strano spazio vuoto al centro che proprio non le piaceva. Prese la mamma con una mano e il divano con l’altra. Soddisfatta, cercò i bambini. Se si fossero comportati bene avrebbero potuto stare lì anche loro. Nel salone non si poteva correre e mettere in disordine: si doveva fare i bravi e stare seduti composti. Lo sapeva bene, lei. I bambolini furono sistemati ai due lati della mamma. Se la si guardava inclinando la testa, sembrava quasi che sorridesse. Era così bella e perfetta. Da grande, Laura sarebbe stata come lei. Quando arrivò alla porta d’ingresso, Patrik aveva il fiatone. La casa era in una bella posizione, in cima a un’altura che si affacciava sul mare, e dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio di Brandparken lui e Gösta erano saliti a piedi. Gli scocciava parecchio ansimare come un mantice mentre l’anziano collega non faceva una piega. «C’è nessuno?» chiamò dalla soglia. D’estate non era raro che la gente lasciasse spalancate porte e finestre e di conseguenza, invece di suonare, si dava una voce. Comparve una donna in cappello di paglia, occhiali da sole e una sorta di tunica variopinta. Nonostante il caldo, portava un paio di guanti sottili. «Sì?» Non sembrava propriamente entusiasta della visita. «Siamo della polizia di Tanum e cerchiamo Leon Kreutz.» «È mio marito. Io sono Ia Kreutz.» Tese la mano senza togliersi il guanto. «Stiamo pranzando.» Era chiaro che considerava la loro visita un disturbo e Patrik e Gösta si scambiarono un’occhiata eloquente. Se Leon si fosse rivelato sulle sue come la moglie, non sarebbe stata una passeggiata. La seguirono sulla terrazza, dove un uomo in carrozzella era seduto a tavola. «Abbiamo visite. La polizia.» L’uomo annuì e li guardò senza alcuno stupore nello sguardo. «Accomodatevi. Mangiamo solo un po’ d’insalata. Il cibo preferito di mia moglie.» Leon fece un sorrisino storto. «Mio marito invece avrebbe volentieri saltato il pranzo e acceso una sigaretta» contrattaccò Ia sedendosi al suo posto e aprendo il tovagliolo sulle ginocchia. «Vi disturba se continuo a mangiare?» Patrik fece un gesto a indicare che poteva tranquillamente masticare la sua insalata mentre loro parlavano con Leon. «Immagino siate qui per Valö, giusto?» Leon aveva interrotto il pranzo e abbandonato le mani sulle ginocchia. Una vespa si depose su un boccone di pollo nel piatto e cominciò a pasteggiare indisturbata. «Esatto.» «Ma cosa succede laggiù in realtà? Girano voci di ogni genere.» «Sono stati fatti alcuni ritrovamenti» rispose Patrik senza entrare nei dettagli. «Siete appena tornati a stare a Fjällbacka?» Osservò il viso di Leon: un lato era liscio, senza traccia di lesioni, mentre l’altro era segnato dalle cicatrici e l’angolo della bocca si era irrigidito in una curva ascendente che lasciava scoperta parte dei denti. «Abbiamo comprato la casa qualche giorno fa e ci siamo trasferiti ieri» rispose Leon. «Come mai è tornato dopo tanti anni?» domandò Gösta. «Forse la nostalgia arriva con gli anni.» Leon girò la testa e guardò il mare, mostrando così solo il lato sano del viso. Patrik pensò che doveva essere stato un uomo bellissimo. «Io avrei preferito restare nella nostra casa in Riviera» intervenne Ia, scambiando con il marito uno sguardo difficilmente interpretabile. «Di solito riesce sempre a ottenere quello che vuole.» Leon fece di nuovo il suo strano sorrisetto. «Ma questa volta non mi sono lasciato smuovere. Avevo voglia di tornare qui.» «La sua famiglia aveva una seconda casa da queste parti, vero?» chiese Gösta. «Sì, o casa di villeggiatura, come si diceva all’epoca. A Kalvö. Purtroppo mio padre l’ha venduta. Non chiedetemi perché. Ogni tanto aveva le sue alzate d’ingegno e negli ultimi anni di vita era diventato un tantino eccentrico.» «Si dice che lei abbia avuto un grave incidente d’auto» disse Patrik. «Sì. Se non mi avesse salvato Ia oggi non sarei qui. Vero, tesoro?» Le posate tintinnarono così forte che Patrik fece un salto. Ia fissò il marito senza rispondere. Poi lo sguardo le si addolcì. «È vero, amore. Senza di me oggi non saresti qui.» «Già. E tu stai bene attenta a non farmelo dimenticare.» «Da quanto tempo siete sposati?» chiese Patrik. «Quasi trenta.» Leon si girò di nuovo a guardarli. «Conobbi Ia a un ricevimento a Monaco. Era la ragazza più bella. E non si lasciava accalappiare facilmente. Dovetti mettercela tutta.» «Non è poi così strano che fossi un po’ scettica, vista la tua reputazione.» Il continuo battibeccare dava l’impressione di essere una danza ormai rodata ma sembrava anche che servisse a farli rilassare e a Patrik parve addirittura di scorgere un sorrisino sulle labbra di Ia. Si chiese che aspetto avesse senza quegli enormi occhiali da sole. La pelle era tirata e le labbra innaturalmente piene, il che alimentava il sospetto che gli occhi avrebbero solo completato l’immagine di una persona che aveva pagato un bel gruzzolo per migliorare il proprio aspetto. Patrik si rivolse di nuovo a Leon. «Il motivo per cui abbiamo voluto parlarle era, come si diceva, il ritrovamento che abbiamo fatto a Valö e che suggerisce la possibilità che la famiglia Elvander sia stata assassinata.» «Non mi sorprende» disse Leon dopo qualche istante di silenzio. «Non ho mai capito come un’intera famiglia potesse sparire così.» Ia diede un colpo di tosse. Era pallida in viso. «Vi prego di scusarmi. Non credo di avere un gran contributo da dare e preferirei andare a sedermi dentro, così potete parlare tranquilli.» «Prego. È soprattutto con Leon che dobbiamo fare una chiacchierata.» Patrik ritirò le gambe per farla passare e lei si avviò con il piatto in mano, avvolta da una nuvola di profumo molto dolce. Leon socchiuse gli occhi guardando Gösta. «Ho l’impressione che ci siamo già visti. Non fu lei a venire a Valö e a portarci alla stazione di polizia?» Gösta annuì. «Sì, esatto.» «Ci trattò in modo gentile, mi ricordo. Il suo collega invece aveva modi molti spicci. È ancora in servizio anche lui?» «Henry si trasferì a Göteborg nei primi anni Ottanta. Non abbiamo mantenuto i contatti ma ho sentito che è mancato qualche anno fa» rispose Gösta. Poi disse: «Ebbi l’impressione che lei fosse il classico leader.» «Non saprei dirlo. Comunque è vero: ho sempre avuto la capacità di farmi ascoltare dalle persone.» «Gli altri sembravano guardare a lei con estremo rispetto.» Leon annuì lentamente. «Credo che lei abbia ragione. Che banda, a pensarci.» Sbottò in una risatina. «Costellazioni così strane si trovano solo nei collegi maschili.» «Be’, in realtà avevate parecchio in comune, no? Venivate tutti da famiglie benestanti.» «Tutti tranne Josef, che era lì solo a causa dell’immensa ambizione dei suoi genitori. Gli avevano fatto il lavaggio del cervello. Il retaggio ebraico comportava degli obblighi ed era come se si aspettassero che lui compisse delle imprese grandiose per controbilanciare tutto quello che avevano perso durante la guerra.» «Un compito non da poco per un ragazzino» osservò Patrik. «Infatti, ma lui lo prendeva molto sul serio. E ancora adesso sembra fare tutto quello che può per rispondere alle aspettative che gravano su di lui. Avete sentito parlare del museo ebraico, no?» «Sì, credo di aver letto qualcosa in proposito sul giornale» disse Gösta. «Perché vuole costruire un museo del genere proprio qui?» chiese Patrik. «Be’, ci sono diverse testimonianze del periodo della guerra, in zona, e a parte la storia ebraica il museo dovrebbe mettere in luce il ruolo della Svezia durante il secondo conflitto mondiale.» Patrik ripensò a un’indagine condotta qualche anno prima e si rese conto che Leon aveva ragione. Il Bohuslän era vicino alla Norvegia e le corriere bianche avevano portato molti ex prigionieri dai campi di concentramento a Uddevalla. Inoltre all’interno della popolazione locale le simpatie erano diverse. Quella della neutralità era una costruzione a posteriori. «Come mai è al corrente dei progetti di Josef?» chiese Patrik. «L’abbiamo incontrato al Café Bryggan pochi giorni fa.» Leon si allungò a prendere il bicchiere d’acqua. «Voi cinque che eravate rimasti sull’isola avete mantenuto i contatti?» Leon riappoggiò il bicchiere dopo aver bevuto alcuni lunghi sorsi. Un po’ d’acqua gli colò sul mento e lui lo asciugò con il dorso della mano. «No, perché avremmo dovuto? Dopo la scomparsa degli Elvander ci separammo. Mio padre, che era piuttosto iperprotettivo, mi spedì in una scuola in Francia, e anche gli altri furono iscritti in vari istituti. Come dicevo, non avevamo molto in comune e negli anni trascorsi non ci siamo sentiti. Anche se, veramente, io posso solo parlare per me. Josef dice che Sebastian fa affari sia con lui sia con Percy.» «Ma non con lei?» «No, Dio me ne scampi. Preferirei gettarmi in mezzo ai pescecani. Cosa che peraltro ho fatto.» «Perché non farebbe mai affari con Sebastian?» chiese Patrik, pur immaginando la risposta. Sebastian Månsson godeva di pessima reputazione nella zona e il colloquio del giorno prima non aveva migliorato l’immagine che aveva di lui. «A meno che non sia cambiato, quello venderebbe anche sua madre.» «E gli altri non lo sanno? Perché fanno affari con lui?» «Non ne ho idea. Dovrà chiederlo a loro.» «Lei ha qualche teoria su quello che può essere successo alla famiglia Elvander?» domandò Gösta. Patrik sbirciò nel soggiorno. Ia aveva finito di mangiare e lasciato il piatto sul tavolo. Non si vedeva in giro. «No.» Leon scosse la testa. «Chiaramente ci ho pensato spesso, ma proprio non riesco a capire chi possa averli voluti uccidere. Dev’essere stato qualcuno che è andato lì a rubare, o dei folli. Come Charles Manson e la sua banda.» «Be’, in questo caso ebbero una bella fortuna ad arrivare proprio mentre voi eravate fuori a pescare» rispose Gösta asciutto. Patrik cercò di attirare la sua attenzione. Quello era un colloquio introduttivo, non un interrogatorio. Non ci avrebbero guadagnato niente a inimicarsi il padrone di casa. «Non ho spiegazioni migliori.» Leon fece un gesto con la mano. «Forse qualcuno volle far pagare a Rune qualche torto passato? Magari una o più persone avevano sorvegliato la casa e quando ci muovemmo in barca ne approfittarono? Erano le vacanze di Pasqua e quindi c’eravamo solo noi cinque da evitare. Nelle normali settimane gli allievi erano molti di più, il che significa che se qualcuno voleva fare del male alla famiglia aveva scelto il momento più opportuno.» «Non c’era nessuno a scuola che avesse motivo di odiarli? Lei non notò niente di sospetto nel periodo che precedette la scomparsa? Strani rumori notturni, per esempio?» chiese Gösta, e Patrik lo guardò perplesso. «No, non che io mi ricordi.» Leon aggrottò le sopracciglia. «Era tutto come al solito.» «Può dirci qualcosa di più della famiglia?» Patrik scacciò una vespa che gli ronzava insistente davanti al viso. «Rune la governava con il pugno di ferro, o almeno era quello che credeva. Nello stesso tempo era come cieco alle manchevolezze dei suoi figli, in particolare i due più grandi, Claes e Annelie.» «Davanti a cosa chiudeva gli occhi? Da come parla sembra che si riferisca a qualcosa in particolare.» Lo sguardo di Leon si perse lontano. «No, erano insopportabili come lo sono per lo più gli adolescenti. Claes si divertiva a tormentare gli alunni più deboli quando il padre non vedeva. E Annelie...» Sembrò riflettere su come esprimersi. «Se fosse stata più grande, la si sarebbe probabilmente definita una cacciatrice di uomini.» «E la moglie di Rune, Inez, come se la passava?» «Non troppo bene, temo. Ci si aspettava da lei che governasse tutta la baracca, oltre a occuparsi di Ebba. Come se non bastasse, subiva costantemente le prepotenze di Claes e Annelie. Il bucato su cui Inez aveva sudato sette camicie finiva per puro caso rovesciato a terra, uno spezzatino che aveva impiegato ore a preparare si bruciava perché chissà chi aveva per sbaglio alzato la temperatura della piastra elettrica. Erano cose che succedevano continuamente, ma Inez non protestava mai. Sapeva benissimo che non le sarebbe servito a niente lamentarsi con Rune.» «Non avreste potuto aiutarla voi?» chiese Gösta. «Purtroppo tutte queste cose succedevano senza che nessuno le vedesse. Intuire il colpevole non voleva dire avere delle prove da portare a Rune.» Li guardò perplesso. «A cosa vi serve conoscere i rapporti familiari di allora?» Patrik rifletté su cosa rispondere. La verità era che non lo sapeva con certezza, ma qualcosa gli diceva che la chiave di quanto era accaduto si trovava nei rapporti tra le persone che vivevano al collegio. Non credeva proprio per niente all’idea di una banda di rapinatori assetati di sangue. Cos’avrebbero potuto rubare su quell’isola? «Come mai proprio voi cinque eravate rimasti al collegio durante le vacanze pasquali?» chiese senza rispondere alla domanda di Leon. «Percy, John e io eravamo lì perché i nostri genitori erano in viaggio. Nel caso di Sebastian era invece una punizione: l’avevano di nuovo beccato a combinarne una delle sue. E al povero Josef toccava sorbirsi delle ore di studio aggiuntive. I suoi genitori non vedevano che motivo ci fosse di fare vacanze inutili e così si erano messi d’accordo con Rune, pagandolo perché gli desse lezioni private.» «A sentirla sembra che potessero esserci dei buoni motivi anche per dei conflitti tra di voi.» «Perché?» Leon sostenne lo sguardo di Patrik. Fu Gösta a rispondere: «Quattro di voi erano figli di ricchi, abituati a ottenere tutto ciò che volevano. Posso immaginare che creasse una notevole competizione. Josef, invece, aveva tutt’altro vissuto alle spalle e per giunta era ebreo.» Fece una pausa. «E sappiamo tutti che posizione ha John oggi.» «Non era così, a quell’epoca» disse Leon. «So che suo padre non approvava che frequentasse la stessa scuola di un ebreo eppure, ironia della sorte, i più uniti erano proprio loro due.» Patrik annuì e rifletté qualche istante su cosa avesse fatto cambiare atteggiamento a John. Possibile che le opinioni del padre l’avessero contagiato via via che cresceva? Oppure c’era un’altra spiegazione? «E gli altri? Come li descriverebbe?» Leon sembrò ponderare la domanda. Poi si raddrizzò e chiamò verso l’interno della casa: «Ia? Sei lì? Metteresti su un po’ di caffè?» «Percy è l’aristocrazia svedese personificata. Era viziato e arrogante ma in realtà non cattivo. Pensava di essere meglio degli altri perché gli era stato inculcato e spesso e volentieri parlava delle battaglie condotte dai suoi antenati. In compenso aveva paura della sua ombra. E Sebastian, come si diceva, era sempre a caccia di un buon affare. Lì sull’isola aveva messo in piedi un’attività lucrativa. Nessuno sapeva esattamente come facesse, ma penso che pagasse qualche pescatore facendosi consegnare degli articoli che poi rivendeva a prezzo di usura. Cioccolato, sigarette, bibite, giornalini porno e in qualche rara occasione anche alcol, ma smise dopo che Rune per poco non lo beccò.» Ia arrivò con un vassoio e mise le tazzine in tavola. Non sembrava trovarsi a proprio agio nel ruolo di moglie al servizio del marito. «Spero che venga bevibile. Non ci so fare con queste macchine moderne.» «Andrà bene di sicuro» disse Leon. «Ia non è abituata a questo genere di vita spartana. A Monaco abbiamo i domestici che ci preparano il caffè e quindi per lei è un po’ una novità.» Patrik non ne era sicuro, ma gli era sembrato di percepire una venatura di malevolenza nella sua voce. Un attimo dopo, però, Leon era di nuovo l’amabilità in persona. «Quanto a me, durante le estati passate a Kalvö avevo imparato a vivere semplicemente. In città avevamo tutte le comodità che si potessero desiderare, ma là...» rivolse lo sguardo verso l’arcipelago, «mio padre si toglieva la giacca e la cravatta e andava in giro in pantaloni corti e maglietta. Pescavamo, raccoglievamo le fragoline selvatiche e facevamo il bagno. Un lusso molto semplice.» S’interruppe quando Ia arrivò con il caffè e lo versò. «Da allora non ha proprio vissuto una vita semplice» osservò Gösta bevendone un sorso. «Touché» ammise Leon. «No, in effetti ha ragione. Ero più attirato dall’avventura che dalla vita di agi.» «È l’adrenalina che cerca?» chiese Patrik. «È un modo molto semplificato di descrivere la cosa, ma forse ci va abbastanza vicino. Immagino che sia un po’ come con le droghe, anche se io non ho mai intossicato il mio corpo con quella robaccia, e certo si sviluppa una dipendenza. Se si comincia, non si riesce a smettere. Si rimane svegli la notte a pensare: riuscirei ad arrampicarmi ancora più in alto? Quanto posso scendere in un’immersione? Che velocità sono in grado di raggiungere? Sono domande che esigono risposte.» «Ma adesso è finita» constatò Gösta. Patrik si chiese tra sé e sé perché non avesse mandato da un pezzo sia lui sia Mellberg a un corso in tecnica d’interrogatorio, ma Leon non sembrò prendersela. «Sì, adesso è finita.» «Com’è successa la disgrazia?» «È stato un banalissimo incidente d’auto. Guidava Ia e come sicuramente sapete le strade a Monaco sono strette, tortuose e in certi punti anche ripide. Abbiamo incrociato un altro veicolo, Ia ha sterzato troppo bruscamente e siamo finiti fuori strada. L’auto ha preso fuoco.» Il tono non era più disinvolto come prima e gli occhi erano persi nel vuoto, come se stesse rivedendo la scena. «Lo sapete quanto è raro che le macchine s’incendino? Non è come nei film, dove tutte le auto esplodono appena urtano contro qualcosa. Abbiamo avuto sfortuna. Ia se l’è cavata relativamente bene, ma io sono rimasto incastrato con le gambe e non potevo muovermi. Sentivo bruciare mani, gambe e vestiti. Poi il viso. A quel punto ho perso conoscenza, ma Ia mi ha tirato fuori dall’auto. È stato così che si è rovinata le mani. Per il resto, miracolosamente, si è solo procurata dei tagli e fratturata due costole. Mi ha salvato la vita.» «Quanto tempo fa è successo?» chiese Patrik. «Nove anni.» «Non ci sono possibilità che...» Gösta accennò con la testa alla sedia a rotelle. «No. Sono paralizzato dalla vita in giù e posso dirmi fortunato di essere in grado di respirare da solo.» Fece un sospiro. «Un effetto collaterale è che mi stanco rapidamente. Di solito a quest’ora faccio un riposino. Posso aiutarvi ancora in qualche modo? Altrimenti temo che dovrò essere così scortese da chiedervi di andare, adesso.» Patrik e Gösta si guardarono e si alzarono. «No, non credo che ci sia altro, per il momento, ma può darsi che avremo motivo di tornare» disse Patrik. «Siete i benvenuti.» Leon li seguì dentro la casa. Ia scese dal piano superiore e allungò una mano con un gesto elegante per salutarli. Proprio mentre stavano uscendo, Gösta si bloccò e si girò verso di lei, che sembrava ansiosa di chiudere la porta alle loro spalle. «Ci servirebbero l’indirizzo e il numero di telefono della vostra casa in Riviera.» «Nel caso dovessimo cercare di scappare?» Fece un sorrisino vago. Gösta alzò le spalle e lei si girò verso il tavolino nell’ingresso per annotare su un blocco indirizzo e telefono. Poi staccò il foglietto con un gesto deciso e glielo tese. Lui se lo mise in tasca senza fare commenti. In macchina cercò di discutere dell’incontro appena concluso, ma Patrik era occupato a cercare il suo cellulare e quasi non sentiva cosa diceva. «Devo averlo dimenticato a casa» disse alla fine. «Mi presti il tuo?» «Mi spiace, non l’ho portato con me. Sai, tu ce l’hai sempre...» Patrik si chiese se fosse il caso di dedicare qualche istante a spiegargli l’importanza, per un poliziotto, di avere sempre con sé il telefono, ma decise che non era il momento e girò la chiave d’accensione. «Ci fermiamo da me sulla via del ritorno. Devo passare a prendere il cellulare.» Per i pochi minuti che impiegarono ad arrivare a Sälvik rimasero in silenzio. Patrik non riusciva a scuotersi di dosso la sensazione di essersi lasciato sfuggire qualcosa di fondamentale durante il colloquio con Leon. Non sapeva se avesse a che fare con ciò che era stato detto o, piuttosto, con ciò che non era stato detto, ma qualcosa non tornava. Kjell aspettava con ansia l’ora di pranzo. Carina sarebbe entrata in servizio la sera e aveva chiamato per chiedergli di mangiare insieme a casa. Era difficile riuscire a vedersi, con lei che faceva i turni e lui che aveva orario di ufficio. Le settimane in cui Carina lavorava diverse notti di seguito passavano giornate intere senza che s’incrociassero. Ma Kjell era fiero di lei. Era una combattente nata e ce la metteva tutta, e negli anni in cui erano stati separati aveva mantenuto se stessa e il figlio senza fare una piega. A posteriori, lui si era reso conto che aveva avuto seri problemi di alcolismo, ma era riuscita a uscirne da sola. Paradossalmente era stato suo padre Frans a convincerla. Una delle poche cose buone che avesse fatto, pensò con un misto di amarezza e di riluttante affetto. Beata era tutto il contrario. Fosse stato per lei non avrebbe lavorato affatto. All’epoca in cui stavano insieme era tutto un parlare di soldi. Voleva che lui salisse di grado per avere uno stipendio da caporedattore ma non faceva niente per contribuire a sua volta. «Io mi occupo della casa e dei figli» diceva. Parcheggiò sul vialetto d’ingresso e cercò di inspirare profondamente. Si sentiva ancora colmare dal disprezzo ogni volta che pensava all’ex moglie, ma in gran parte si trattava di disistima nei propri confronti. Come aveva potuto gettare via diversi anni della propria vita per lei? Naturalmente non si pentiva dei figli avuti ma di essersi lasciato circuire. Lei era giovane e carina e lui vecchio e sensibile alle lusinghe. Scese dall’auto e scacciò il pensiero di Beata. Non le avrebbe permesso di rovinare il pranzo con Carina. «Ciao amore» lo salutò lei vedendolo entrare. «Siediti, è già pronto. Ho fatto le frittelle di patate.» Gli mise davanti il piatto e lui inspirò il profumo. Adorava le frittelle di patate. «Come va al lavoro?» chiese Carina sedendoglisi di fronte. Lui le rivolse uno sguardo tenero. Era invecchiata bene. Le sottili rughe intorno agli occhi le donavano e le giornate trascorse a fare giardinaggio, la sua attività preferita, le avevano dato un bel colorito sano. «Un po’ a rilento, in effetti. Sto approfondendo un’informazione che ho avuto su John Holm, ma non so come andare avanti.» Prese un boccone di frittella e non rimase deluso. «Non c’è nessuno a cui puoi chiedere aiuto?» Kjell stava per rispondere di no quando si rese conto che in effetti Carina non aveva tutti i torti. Considerando la posta in gioco, era pronto a mettere da parte l’orgoglio. Tutto ciò che era venuto a sapere di John Holm suggeriva che ci fosse qualcosa di grosso che andava portato alla luce e in fin dei conti non gli importava niente di essere lui a poter fare lo scoop. Per la prima volta nella sua carriera giornalistica si trovava in una situazione che prima conosceva solo per sentito dire: aveva fiutato una storia molto più grossa di lui. Si alzò di scatto da tavola. «Scusami, devo fare una cosa.» «Adesso?» chiese Carina guardando la porzione lasciata a metà. «Sì. Scusami. So che hai preparato e ti sei data da fare e anche io ero contento di avere un attimo da solo con te ma...» Leggendole la delusione negli occhi per poco non si rimise a sedere. L’aveva delusa un numero sufficiente di volte e non voleva rifarlo. Ma poi il viso di lei si rasserenò e si aprì in un sorriso. «Vai a fare quello che devi. So che non lasceresti a metà una frittella di patate se non ne andasse della sicurezza del regno.» Kjell rise. «Sì, più o meno siamo a questo livello.» Si sporse in avanti e la baciò sulla bocca. Di ritorno in redazione, pensò a cosa dire. Probabilmente ci voleva qualcosa in più di vaghe intuizioni e scarabocchi su un foglietto per catturare l’attenzione di uno dei maggiori giornalisti svedesi in ambito politico. Si grattò la barba e di colpo gli venne in mente: il sangue di cui aveva parlato Erica. Nessun giornale era ancora uscito con la notizia del ritrovamento fatto a Valö. Aveva quasi finito l’articolo e naturalmente l’intenzione era che il Bohusläningen fosse il primo a riportarla, ma sicuramente ormai la voce aveva cominciato a girare. Era solo questione di tempo: nel giro di qualche ora sarebbe giunta agli altri giornali e a quel punto il fatto che lui avesse regalato la notizia non avrebbe cambiato niente, cercò di autoconvincersi. Oltretutto, con la sua conoscenza del territorio, anche se avesse perso lo scoop in sé il Bohusläningen avrebbe avuto modo di pubblicare articoli di completamento molto più dettagliati di quelli dei concorrenti più grossi. Rimase seduto per qualche secondo davanti al telefono, riordinò le idee e buttò giù qualche appunto su un blocco. Bisognava essere ben preparati per telefonare a Sven Niklasson, cronista politico dell’Expressen, e chiedergli aiuto per scoprire qualcosa di più su John Holm. E su Gimle. Paula scese dalla motovedetta facendo attenzione a non scivolare. Mellberg le aveva fatto la ramanzina per tutto il percorso fino a Valö, prima in macchina e poi a bordo della MinLouis, una delle imbarcazioni della guardia costiera, ma senza grande convinzione. Ormai la conosceva a sufficienza per sapere che non sarebbe mai riuscito a farle cambiare idea. «Attenta. Se finisci in acqua tua madre mi fa fuori.» Le tese una mano mentre Victor le teneva l’altra. «Chiamate se avete bisogno che venga a prendervi» disse quest’ultimo, e il commissario annuì. «Non capisco perché ti sei intestardita a venire» disse mentre salivano verso la casa. «Magari chi ha sparato è ancora qui. Può essere pericoloso e non stai mettendo a repentaglio solo la tua vita.» «È passata quasi un’ora dalla telefonata di Annika. Chiunque fosse, ha fatto in tempo ad andarsene. Inoltre immagino che ormai siano stati rintracciati anche Patrik e Gösta. Sicuramente stanno arrivando pure loro.» «Sì, però...» fece per dire Mellberg, ma richiuse la bocca. Erano arrivati alla porta d’ingresso. Si affacciò e chiamò: «Ehi, di casa! Siamo della polizia!» Comparve un uomo biondo con l’aria sconvolta e Paula immaginò che fosse Mårten Stark. Durante il tragitto in mare era riuscita a raccogliere qualche informazione sul caso. «Ci siamo messi di sopra, in camera da letto. Abbiamo pensato che fosse il posto più... sicuro.» Lanciò un’occhiata alle proprie spalle, verso le scale, su cui erano comparse altre due persone. Paula trasalì riconoscendone una. «Anna? Cosa ci fai qui?» «Stavo prendendo delle misure... Dovrei occuparmi degli arredi.» Era un po’ pallida, ma sembrava composta. «State tutti bene?» «Sì, per fortuna» rispose Anna, e gli altri due annuirono. «Da quando avete telefonato non è più successo niente?» chiese Paula guardandosi intorno. Pur essendo convinta che chi aveva sparato se ne fosse andato da un pezzo, non poteva darlo per scontato e aveva le orecchie tese e pronte a captare il minimo rumore. «No. Volete vedere dove sono arrivati i colpi?» Anna sembrava avere preso in mano la situazione, mentre Ebba e Mårten si tenevano in secondo piano. Lui cingeva le spalle di lei, che aveva le braccia incrociate sul petto. «Certo» rispose Mellberg. «Da questa parte, in cucina.» Anna fece strada e si fermò sulla soglia, indicando. «Come vedete le pallottole hanno rotto il vetro.» Paula osservò la scena. Frammenti su tutto il pavimento, ma soprattutto sotto la finestra. «C’era qualcuno qui dentro quando sono partiti gli spari? E a proposito, siete sicuri che siano stati più di uno?» «Ebba era qui» disse Anna toccandola con il gomito. Lei alzò gli occhi lentamente e si guardò intorno nella cucina come se la vedesse per la prima volta. «Ho sentito solo un botto» disse. «Fortissimo. Non ho capito cosa fosse. Poi ce n’è stato un altro.» «Due spari, quindi» constatò Mellberg entrando nella stanza. «Meglio che non giriamo lì dentro» lo ammonì Paula. Avrebbe tanto desiderato che Patrik fosse presente. Non era sicura di riuscire ad arginare il capo da sola. «Niente paura. Mi sono trovato su molte più scene del delitto di quante tu riuscirai mai a vederne nella tua carriera e so benissimo cosa devo e non devo fare.» Pestò un grosso frammento di vetro che gli si ruppe sotto la scarpa. Paula inspirò profondamente. «Be’, secondo me è comunque meglio che Torbjörn e i suoi tecnici possano lavorare su una scena il più possibile intatta.» Mellberg la ignorò e si avvicinò ai fori nella parete di fondo della cucina. «Ah! Eccole qui! Dove tenete le buste di plastica?» «Nel terzo cassetto» rispose Ebba con voce assente. Mellberg lo aprì e tirò fuori un rotolo di sacchettini da freezer. Ne strappò uno, si mise un paio di guanti di gomma da cucina trovati appesi al rubinetto e poi tornò davanti al muro. «Vediamo un po’. Non sono conficcate troppo in profondità e quindi non sarà difficile tirarle fuori. A Torbjörn rimarrà ben poco da fare» disse estraendo le pallottole. «Ma bisognava scattare le foto e...» obiettò Paula. Mellberg non le diede retta: sollevò invece il sacchettino davanti a loro e se lo infilò nella tasca dei pantaloni corti. Poi si tolse rapidamente i guanti e li lanciò nel lavandino. «Bisogna preservare le impronte digitali» disse aggrottando la fronte. «È fondamentale per la raccolta degli indizi e dopo tanti anni di servizio è un riflesso condizionato.» Paula si morse il labbro tanto forte da sentire il gusto del sangue in bocca. Spicciati ad arrivare, Hedström, pensò tra sé e sé. Ma la sua preghiera rimase inascoltata e Mellberg continuò imperterrito a camminare in mezzo ai vetri sotto i suoi occhi. Fjällbacka 1931 Avvertiva gli sguardi su di sé. La gente pensava che non capisse niente, ma Dagmar non si lasciava mettere nel sacco, meno che mai da Laura. Sua figlia era una brava attrice e si attirava le simpatie di tutti. La gente faceva tante storie e diceva che era una piccola massaia e che era un vero peccato che avesse una madre come lei. Nessuno la vedeva per quella che era veramente, ma Dagmar non si faceva fregare dalla sua ipocrisia. Sapeva cosa si nascondeva sotto quell’aria da santerellina. Laura era segnata dalla sua stessa maledizione. Era marchiata, anche se il marchio si trovava sotto la pelle e non si vedeva. Dividevano la stessa sorte ed era inutile che si facesse strane idee. Seduta in cucina, Dagmar tremava leggermente. Per accompagnare il cicchetto mattutino aveva mangiato un pezzo di pane croccante senza companatico e ne aveva sminuzzato il più possibile per fare dispetto a Laura, che non sopportava le briciole e non si sarebbe data pace fino a quando non le avesse raccolte tutte. Qualcuna era finita sul tavolo e Dagmar spazzò giù anche quelle, così la ragazzina avrebbe avuto qualcosa da fare una volta tornata da scuola. Dagmar si mise a tamburellare le dita sulla tovaglia a fiori. Era assillata da un’inquietudine a cui doveva continuamente dare sfogo ed era un pezzo, ormai, che non riusciva più a stare seduta ferma. Erano passati dodici anni da quando Hermann l’aveva lasciata, eppure sentiva ancora il tocco delle sue mani sul proprio corpo, un corpo talmente cambiato da non avere più niente della ragazza che era allora. La rabbia che aveva provato nei suoi confronti nell’asettica stanzetta d’ospedale era come spazzata via. Lei lo amava e lui amava lei. Niente era stato come se l’era immaginato, ma era bello sapere a chi attribuirne la colpa. In ogni momento di veglia, e anche nei sogni, si vedeva davanti il viso di Carin Göring, sempre con un’espressione superiore e sprezzante. Era chiaro che aveva goduto nell’umiliare lei e Laura. Tamburellò più forte con le dita. Il pensiero di Carin la colmava tutta ed era grazie a quello e all’alcol che restava in piedi giorno dopo giorno. Si allungò verso il giornale sul tavolo. Non potendosi permettere di comprarli, rubava le vecchie copie dai mucchi di resi lasciati dietro l’edicola in attesa che venissero prelevati. Scrutava sempre con attenzione ogni pagina, perché qualche volta le era capitato di trovare notizie di Hermann. Era tornato in Germania e in qualche articolo si faceva il nome di Hitler, quello che gli aveva sentito gridare in ospedale. Leggendo si era emozionata. Il suo Hermann era quello di cui parlavano i giornali, non il grassone sbraitante in camicione da ospedale. Nelle foto indossava l’uniforme e, pur non essendo tornato snello ed elegante come allora, era di nuovo un uomo di potere. Quando aprì il quotidiano le mani le tremavano ancora. Sembrava che a ogni giorno che passava il cicchetto mattutino impiegasse sempre più tempo per fare effetto. Tanto valeva prenderne subito un altro. Dagmar si alzò e se ne versò una dose generosa. Lo bevve d’un fiato e subito sentì il calore diffondersi nel corpo e attenuare il tremito. Poi si risedette a tavola e ricominciò a sfogliare il giornale. Era quasi all’ultima pagina quando vide l’articolo. Le lettere le si mescolarono davanti agli occhi. Dagmar si costrinse a concentrarsi sul titolo: Sepolta la moglie di Göring. Hitler invia una corona di fiori. Studiò le due foto e un sorriso le si aprì sulle labbra. Carin Göring era morta. Era la verità, e dalla bocca le scaturì una risata. Ormai non c’era più niente che potesse fermare Hermann: sarebbe finalmente tornato da lei. I piedi si misero a battere il pavimento come un tamburo. Per una volta, Josef era andato da solo alla cava di granito. A essere sincero non apprezzava troppo la compagnia di altre persone. Quello che cercava poteva trovarlo solo guardandosi dentro. Nessun altro sarebbe stato in grado di darglielo. A volte desiderava essere diverso, o meglio, più simile agli altri, saper provare un senso di condivisione, essere parte di qualcosa, eppure teneva a distanza anche la sua famiglia. Il nodo nel petto era troppo serrato e lo faceva sentire come un bambino con il naso premuto contro la vetrina di un negozio di giocattoli, che vedeva tutte quelle cose meravigliose là dentro senza avere il coraggio di aprire la porta. Qualcosa gli impediva di entrare, di allungare la mano. Si sedette su un blocco di pietra e i pensieri tornarono a vagare verso i suoi genitori. Erano morti da dieci anni ma senza di loro si sentiva ancora perso. E si vergognava di aver tenuto loro nascosto il suo segreto. Suo padre aveva sempre sottolineato l’importanza della fiducia, della verità e dell’onestà, e gli aveva fatto capire che sapeva che gli nascondeva qualcosa. Ma come avrebbe potuto parlare? Certi segreti erano troppo grandi e i suoi genitori si erano tanto sacrificati per lui. Durante la guerra avevano perso tutto: familiari, amici, beni, sicurezza, patria. Tutto tranne la fede e la speranza di una vita migliore. Mentre loro soffrivano, Albert Speer vagava lì intorno, indicando e urlando e ordinando i blocchi con cui sarebbe stata costruita la principale città del regno conquistato con il sangue. In realtà Josef non sapeva se Speer fosse venuto lì di persona, ma sicuramente qualcuno dei suoi galoppini era stato nella cava alle porte di Fjällbacka. Per lui la guerra non era un evento appartenente a un passato lontano. Ogni giorno della sua infanzia aveva ascoltato i racconti della caccia agli ebrei, dei tradimenti subiti, dell’odore del fumo che usciva dalle ciminiere dei campi di concentramento, delle facce allibite dei soldati arrivati a liberarli in cui si rispecchiava il loro degrado. La Svezia li aveva accolti a braccia aperte ma nello stesso tempo si rifiutava ostinatamente di ammettere il proprio ruolo nella guerra. Suo padre gliene parlava ogni giorno: il suo nuovo Paese doveva alzarsi in piedi e riconoscere le malefatte compiute. Il concetto gli era stato impresso nella mente come i numeri tatuati sul braccio dei suoi genitori. Guardò verso il cielo con le mani giunte in preghiera, chiedendo la forza necessaria per amministrare nel giusto modo la sua eredità, per affrontare Sebastian e il passato che minacciava di distruggere quello che voleva realizzare. Gli anni erano trascorsi in fretta e lui era diventato bravo a dimenticare. Un uomo poteva creare la propria storia. Lui in realtà aveva voluto cancellare quella parte della sua vita e avrebbe desiderato che Sebastian facesse altrettanto. Si alzò e spazzò via la polvere dal fondo dei pantaloni. Sperava che Dio avesse ascoltato le sue preghiere in quel luogo simbolo sia di quello che avrebbe potuto essere sia di quello che sarebbe stato. Dalla roccia intorno a lui avrebbe ricavato la conoscenza, e dalla conoscenza la comprensione e la pace. Avrebbe pagato il debito che aveva nei confronti dei suoi antenati, degli ebrei tormentati e oppressi. Poi, una volta portato a termine quel compito, anche la vergogna sarebbe stata cancellata per sempre. Il cellulare squillò ma Erica chiuse la chiamata. Era la casa editrice e, di qualsiasi cosa si trattasse, avrebbe sicuramente richiesto del tempo che non aveva. Si guardò intorno nello studio per quella che doveva essere la centesima volta. Detestava quella sensazione, la certezza che qualcuno fosse stato lì ficcando il naso tra oggetti che lei riteneva estremamente personali. Chi poteva essere e cosa poteva aver cercato? Immersa com’era nei suoi pensieri, sentendo la porta d’ingresso che si apriva e chiudeva al piano di sotto fece un salto. Scese veloce le scale. Nell’ingresso c’erano Patrik e Gösta. «Ciao! Cosa ci fate qui?» Gösta sembrava a dir poco preoccupato e non sapeva dove guardare. Il loro accordo segreto non era certo una cosa che avesse preso alla leggera ed Erica non poté fare a meno di tormentarlo un pochino. «Ciao Gösta, quanto tempo! Come stai?» Dovette sforzarsi per trattenere un sorriso e nel frattempo lo vide arrossire fino ai lobi delle orecchie. «Mmh... non male, direi» mormorò lui guardandosi i piedi. «Tutto bene qui?» chiese Patrik. Erica si fece seria di colpo. Per un attimo era riuscita a rimuovere l’intrusione di qualcuno in casa loro. Si rese conto che avrebbe dovuto parlargli dei propri sospetti, ma al momento non aveva prove e in un certo senso era una fortuna che prima Patrik non avesse risposto al telefono. Sapeva bene quanto si preoccupava appena succedeva qualcosa che aveva a che fare con la famiglia. Se si fosse convinto che qualcuno si era introdotto in casa non si poteva escludere che spedisse lei e i bambini da qualche parte. Pensandoci, Erica decise di rimandare, anche se non riusciva a scacciare la propria preoccupazione. Lo sguardo le corse alla porta della veranda come se qualcuno potesse aprirla di nuovo da un momento all’altro. Stava per rispondere quando Kristina arrivò dalla lavanderia nel seminterrato con i bambini al seguito. «Sei a casa, Patrik? Sai cos’è successo un attimo fa? Pensavo che mi venisse un infarto. Ero in cucina a fare i pannkakor per i bambini quando ho visto Noel che correva sulle sue gambette verso la strada, e ti dirò che l’ho preso per un pelo. Chissà cosa sarebbe successo, altrimenti. Dovete veramente ricordarvi di chiudere bene le porte, perché quei piccolini sono dei fulmini. Può andare a finire male e poi si rimane con il rimorso per tutta la vita...» Erica guardava affascinata la suocera chiedendosi quando avrebbe ripreso fiato. «Mi ero dimenticata di chiudere la porta della veranda» disse senza guardare Patrik in faccia. «Okay, ottimo placcaggio, mamma. Dovremo semplicemente stare ancora più attenti, adesso che cominciano a muoversi di più.» In quel momento arrivarono a razzo i gemelli e lui li prese al volo tra le braccia. «Ciao Gösta» disse Maja, facendolo tornare rosso fuoco, ma Patrik non sembrò accorgersi della sua occhiata disperata a Erica, preso com’era a fare il solletico ai bambini. Dopo un po’ alzò gli occhi. «In realtà eravamo passati solo a prendere il mio cellulare. L’hai visto?» Erica indicò la cucina. «L’hai lasciato sulla panca stamattina.» Lui andò a prenderlo. «Vedo che mi hai chiamato. Volevi dirmi qualcosa?» «No, solo che ti amo» rispose lei, sperando di non essere smascherata. «Anch’io, tesoro» mormorò lui distratto, lo sguardo fisso sul display. «Ho anche cinque chiamate perse di Annika. Meglio che senta cosa voleva.» Erica cercò di origliare, ma Kristina chiacchierava senza interruzione con Gösta impedendole di sentire più di qualche parola isolata. In compenso, quando Patrik chiuse la telefonata la sua espressione diceva tutto. «Sparatoria a Valö. Qualcuno ha fatto fuoco all’interno della casa. Anche Anna è là. Mi ha detto che è stata lei ad avvertire.» Erica si portò la mano alla bocca. «Anna? Sta bene? È ferita? Chi...?» Si accorse di pronunciare frasi smozzicate ma non riusciva a pensare ad altro che a quello che poteva essere successo alla sorella. «A quanto ho capito, sono tutti incolumi. Questa è la buona notizia.» Si girò verso Gösta. «Quella cattiva è che, non trovandoci, Annika è stata costretta a mandare là Mellberg.» «Mellberg?» sbottò Gösta, la voce incredula. «Già, quindi sarà meglio che ci muoviamo subito.» «Non penserete mica di andare là se qualcuno sta sparando, vero?» disse Kristina con le mani sui fianchi. «Certo che ci andiamo. È il mio lavoro» rispose Patrik seccato. Sua madre gli lanciò un’occhiata offesa, sollevò il mento di scatto e andò in soggiorno. «Vengo anch’io» disse Erica. «Neanche per idea.» «E invece sì. Se Anna è là, vengo con voi.» Patrik la fissò deciso. «C’è un folle che spara alla gente, sull’isola. Tu non vieni e basta!» «Ci saranno altri poliziotti, no? Quindi cosa vuoi che succeda? Non correrò alcun pericolo.» Si allacciò le stringhe delle scarpe da ginnastica bianche. «E chi sta con i bambini?» «Sicuramente Kristina può rimanere.» Si alzò e gli lanciò un’occhiata da cui si capiva che non valeva la pena di protestare. Mentre scendevano verso l’attracco Erica sentì aumentare la preoccupazione per la sorella. Patrik poteva fare il muso quanto voleva. Lei era responsabile di Anna. «Pyttan? Sei lì?» Percy girò perplesso in tutto l’appartamento. Non aveva detto che sarebbe uscita. Erano tornati a Stoccolma per qualche giorno per andare alla festa per un sessantesimo compleanno a cui non potevano mancare. Una buona fetta del libro d’oro della nobiltà sarebbe probabilmente stata presente per brindare al festeggiato e ci sarebbero stati anche diversi pezzi grossi dell’industria svedese. Certo, in contesti del genere non erano considerati pezzi grossi: la gerarchia era molto chiara e il fatto di essere amministratori delegati di una delle principali aziende svedesi non contava niente se non si avevano i giusti presupposti e il nome giusto e se non si erano frequentate le scuole giuste. Quanto a lui, rispondeva a tutti i criteri. Di solito neanche ci pensava. Era stato così per tutta la sua vita e per lui era scontato come respirare. Il problema era che rischiava di diventare un conte senza castello, il che avrebbe influito moltissimo sul suo status. Non sarebbe finito in basso come i parvenu, ma sicuramente sarebbe stato relegato a una posizione subalterna. Nel salone si fermò davanti al carrello degli alcolici e si versò un whisky, un Mackmyra Preludium da cinquemila corone circa la bottiglia. Non gli sarebbe mai passato per l’anticamera del cervello di abbassarsi a un whisky di qualità inferiore. Il giorno in cui fosse stato costretto a bere del Jim Beam avrebbe anche potuto prendere la vecchia Luger di suo padre e spararsi alla tempia. Quello che più gli pesava era la consapevolezza di essere venuto meno all’impegno nei confronti del padre. Essendo il primogenito, aveva sempre ricevuto un trattamento privilegiato e nessuno in famiglia ne aveva fatto mistero. Il padre aveva spiegato in maniera spassionata e distaccata ai suoi due fratelli minori che lui era speciale e che un giorno gli sarebbe subentrato. Percy aveva segretamente goduto delle occasioni in cui il padre li metteva a tacere, mentre chiudeva gli occhi davanti alla delusione che a volte leggeva nel suo sguardo. Sapeva che lo riteneva debole, pauroso e viziato, e forse era vero che sua madre era stata iperprotettiva, ma gli aveva raccontato molte volte quanto era stata vicina a perderlo. Era nato con quasi due mesi d’anticipo, piccolo come un uccellino. I medici avevano detto ai genitori di non aspettarsi che sopravvivesse, ma per la prima e ultima volta in vita sua si era dimostrato forte. Contro ogni previsione ce l’aveva fatta, anche se era rimasto cagionevole. Guardò fuori, verso Karlaplan. L’appartamento aveva un bel bovindo che dava sulla piazza con la fontana e con il bicchiere di whisky in mano Percy osservò il viavai là sotto. D’inverno non si vedeva un’anima ma nei mesi caldi le panchine si riempivano di gente e i bambini giocavano, mangiavano il gelato e si godevano il sole. Sentì dei passi dalla scala e rizzò le orecchie. Era Pyttan? Doveva essere uscita solo per un rapido giro di shopping. Sperò che la banca non avesse ancora bloccato la carta di credito, provando un profondo senso d’umiliazione. Che razza di funzionamento aveva la società? Possibile che potessero pretendere da lui una fortuna in tasse? Maledetti comunisti. Strinse forte il bicchiere. Mary e Charles si sarebbero fregati le mani se fossero stati al corrente dei suoi problemi economici. Andavano ancora in giro a raccontare balle dicendo di essere stati buttati fuori da casa e privati di ciò che spettava loro. Di colpo Valö gli si intrufolò nella mente. Se solo non ci avesse mai messo piede, quello a cui aveva deciso di non pensare mai più ma che ogni tanto riusciva ad aggirare le sue difese non sarebbe mai successo. All’inizio l’idea di cambiare scuola gli era sembrata ottima. A Lundsberg l’atmosfera non era più la stessa da quando era stato indicato come uno di quelli rimasti a guardare mentre uno degli allievi di pessima fama costringeva la vittima predestinata della scuola a scolarsi una dose rinforzata di lassativo subito prima della cerimonia di fine semestre nell’aula magna. Il completo estivo bianco si era macchiato di scuro fino a metà schiena. Dopo quell’episodio il direttore aveva convocato suo padre a Lundsberg per un colloquio. Volendo evitare uno scandalo, gli aveva comunicato di aver deciso di non espellerlo ma l’aveva invitato a trasferirlo in un’altra scuola. Il padre era montato su tutte le furie. Percy si era limitato ad assistere alla scena e stare a guardare non era un crimine! Alla fine però si era dichiarato sconfitto e, dopo aver raccolto informazioni negli ambienti giusti con la dovuta discrezione, aveva deciso che l’alternativa migliore era il collegio di Rune Elvander. In realtà avrebbe preferito spedirlo all’estero, ma per una volta la madre si era impuntata. Così era finito a Valö, guadagnandoci una serie di tormentosi ricordi da rimuovere. Percy bevve un lungo sorso. La vergogna bruciava di meno quando la si diluiva con del whisky di qualità: gliel’aveva insegnato la vita. Si guardò intorno nella stanza. Aveva dato mano libera a Pyttan per quanto riguardava l’arredamento. Tutto quel biancore e quelle linee essenziali non erano forse proprio di suo gusto, ma lì nell’appartamento le lasciava fare di testa sua. Gli bastava che non toccasse le stanze del castello, dove doveva rimanere tutto come ai tempi di suo padre, di suo nonno, del suo bisnonno e del suo trisavolo. Era una questione di onore. Un vago senso di disagio allo stomaco lo spinse ad andare in camera. Ormai Pyttan sarebbe dovuta rientrare. Quella sera erano invitati a un cocktail party da amici e in genere lei cominciava a prepararsi fin dal pomeriggio. Apparentemente era tutto come al solito, ma il disagio non voleva passare. Appoggiò il bicchiere sul comodino di Pyttan e si avvicinò a passi esitanti alla parte dell’armadio della moglie. Quando lo aprì, alcune grucce ondeggiarono per lo spostamento d’aria. Era vuoto. Nessuno avrebbe potuto immaginare che solo un’ora prima lì ci fosse stata una sparatoria, pensò Patrik attraccando al pontile. Regnava una calma quasi irreale. Prima che riuscisse ad assicurare la barca all’ormeggio, Erica saltò giù e si mise a correre verso la casa. Patrik si affrettò a seguirla, con Gösta alle calcagna, ma andava così forte che non riuscì a recuperare il distacco e quando arrivò lei stringeva già Anna tra le braccia. Mårten ed Ebba erano rannicchiati su un divano e vicino a loro trovarono non solo Mellberg ma anche Paula. Patrik non aveva idea del motivo per cui si trovasse lì ma fu ben contento di poter avere un resoconto attendibile di quanto era successo. «Stanno tutti bene?» chiese andandole incontro. «Sì sì. Sembrano solo un po’ scossi, soprattutto Ebba. Qualcuno ha sparato all’interno della cucina, da fuori, mentre lei si trovava lì da sola. Niente indica che chi ha fatto fuoco sia ancora qui intorno.» «Avete chiamato Torbjörn?» «Sì, la scientifica è in arrivo, ma Mellberg ha già cominciato il sopralluogo tecnico, diciamo.» «Sì, ho trovato le pallottole» confermò il commissario mostrando la busta di plastica. «Non erano troppo in profondità e ci ho messo un attimo a tirarle fuori dal muro. Chi ha sparato doveva essere piuttosto lontano, visto che hanno perso parecchia velocità.» Patrik sentì arrivare la rabbia ma strinse i pugni nelle tasche e fece qualche respiro profondo: una scenata non avrebbe cambiato niente. A tempo debito avrebbe fatto due chiacchiere con il suo superiore sulle regole da seguire sulla scena di un tentato omicidio. Si rivolse ad Anna, che stava cercando di divincolarsi dall’abbraccio di Erica. «Tu dove ti trovavi quando è successo?» «Al piano di sopra. Ebba era appena scesa a preparare il caffè.» «E tu?» chiese a Mårten. «In cantina a prendere dell’altra vernice. Ero tornato un attimo prima dalla terraferma e praticamente ho fatto appena in tempo a scendere le scale che ho sentito il primo colpo.» Era pallido sotto l’abbronzatura. «Quando sei arrivato c’erano imbarcazioni estranee?» chiese Gösta. Mårten scosse la testa. «No, solo quella di Anna.» «E non avete visto aggirarsi qui intorno qualche sconosciuto?» «Nessuno.» Ebba teneva lo sguardo vitreo fisso davanti a sé. «Chi sta facendo tutto questo?» Mårten guardò Patrik con aria abbattuta. «Chi ci vuole male? Ha a che fare con la cartolina che vi ho dato?» «Purtroppo non lo sappiamo.» «Quale cartolina?» chiese Erica. Patrik ignorò la domanda ma l’occhiata di sua moglie gli fece capire che più tardi avrebbe dovuto darle una risposta. «Da questo momento nessuno entra in cucina. È da considerarsi zona sottoposta a sequestro giudiziario. Naturalmente dovremo anche perlustrare l’isola e quindi la cosa migliore sarebbe che voi due, Ebba e Mårten, vi trasferiste sulla terraferma e trovaste un posto dove stare finché non avremo finito qui.» «Ma...» protestò Mårten. «Noi non vogliamo.» «Sì, facciamo così.» D’un tratto la voce di Ebba era decisa. «E dove la troviamo una camera? È alta stagione.» «Potete stare da noi. Abbiamo una stanza degli ospiti» rispose Erica. Patrik fece un salto. Era impazzita? Offriva a Ebba e Mårten di stare da loro nel bel mezzo dell’indagine? «Sul serio?» chiese Ebba guardandola. «Ma certo. Così potrai anche dare un’occhiata al materiale che ho raccolto sulla tua famiglia. Ieri l’ho riguardato velocemente e in effetti è molto interessante.» «Be’, secondo me...» cominciò Mårten, ma poi abbassò le spalle. «Facciamo così. Tu vai e io mi fermo.» «Preferirei che non restasse nessuno» disse Patrik. «Io rimango.» Mårten lanciò un’occhiata alla moglie, che non protestò. «Okay, allora propongo che Ebba, Erica e Anna vadano via adesso, così possiamo cominciare a lavorare in attesa di Torbjörn. Gösta, controlla il sentiero che porta alla spiaggia e vedi se qualcuno può essere arrivato da quella parte. Paula, tu occupati della zona intorno alla casa. Sarà più facile quando avremo qui il metal detector, ma nel frattempo ci toccherà fare quello che possiamo. Se abbiamo fortuna, magari chi ha sparato ha gettato l’arma in qualche cespuglio.» «Se invece abbiamo sfortuna è già in fondo al mare pure quella» osservò Gösta dondolandosi sui talloni. «Può darsi, ma intanto facciamo un tentativo e vediamo che risultati dà.» Patrik si rivolse a Mårten. «Tu dovrai stare il più possibile alla larga. Come ho già detto, rimanere non è una buona idea, soprattutto considerando che stanotte, dopo che saremo andati via, sarai qui da solo.» «Posso lavorare al piano di sopra. Non vi darò fastidio» rispose lui con voce piatta. Patrik lo scrutò per qualche istante, ma poi lasciò perdere. Se non voleva allontanarsi dall’isola lui non poteva costringerlo. Si avvicinò a Erica che era sulla soglia, pronta a partire. «Ci vediamo a casa» le disse con un bacio sulla guancia. «Certo. Anna, prendiamo la tua barca, no?» chiese raccogliendosi intorno il gruppetto che avrebbe accompagnato a casa. Patrik non poté fare a meno di sorridere. Le salutò con la mano e poi guardò la schiera male assortita di poliziotti che aveva davanti. Sarebbe stato un miracolo se fossero riusciti a trovare qualcosa in assoluto. La porta si aprì lentamente e John si tolse gli occhiali da lettura e mise giù il libro. «Cosa leggi?» chiese Liv sedendosi sul bordo del letto. Lui sollevò il volume in modo che potesse vederne la copertina. «Race, evolution and behavior di Philippe Rushton.» «È bello. L’ho letto qualche anno fa.» Lui le prese la mano e le sorrise. «È un peccato che le vacanze siano quasi finite.» «Sì, ammesso che questa settimana possa essere definita di vacanza. Quante ore al giorno abbiamo lavorato?» «È vero.» Aggrottò la fronte. «Stai di nuovo pensando all’articolo del Bohusläningen?» «No, credo che tu abbia ragione. Non rappresenta un pericolo. Tra una settimana sarà dimenticato.» «Gimle, allora?» John la guardò serio. Sapeva che non se ne doveva parlare a voce alta. Solo una cerchia estremamente ristretta era informata del piano e John si era amaramente pentito di non aver bruciato il foglietto su cui aveva preso l’appunto. Era stato un errore imperdonabile, anche se non poteva essere sicuro che fosse stata quella scrittrice a prenderlo. Poteva essere stato portato via dal vento o essersi perso da qualche parte in casa, ma in realtà sapeva che la spiegazione non era così semplice. Il foglietto era nella pila di carte prima che Erica Falck arrivasse e quando doveva tirarlo fuori, poco dopo, era sparito. «Andrà in porto.» Liv gli fece una carezza sulla guancia. «Io ci credo. Abbiamo fatto molta strada ma c’è il rischio di non arrivare oltre, se non passiamo a qualcosa di drastico. Dobbiamo creare un maggiore margine di manovra, per il bene di tutti.» «Ti amo.» Poteva dirlo con sincerità. Nessuno lo capiva come Liv. Avevano condiviso pensieri ed esperienze, successi e insuccessi e lei era l’unica con cui si fosse confidato e che sapesse cosa ne fosse stato della sua famiglia. In effetti molti conoscevano la sua storia, dato che se n’era spettegolato per anni, ma lui non aveva mai raccontato ad altri che a Liv i pensieri che si era portato dentro in quel periodo. «Posso dormire qui stanotte?» chiese Liv di colpo. Gli lanciò un’occhiata insicura e John si sentì colmare da emozioni contrastanti. In realtà non voleva altro che sentire vicino il suo corpo caldo, addormentarsi con il braccio su di lei e sentire il profumo dei suoi capelli, ma sapeva che non poteva. L’intimità del letto comportava una serie di aspettative e faceva venire a galla tutte le delusioni e le promesse mancate. «Forse potremmo tentare di nuovo?» disse lei accarezzandogli il dorso della mano. «Ormai è passato un po’ e magari le cose sono... cambiate?» Lui distolse il viso di scatto e ritirò la mano, sentendosi quasi soffocare dal ricordo della propria inadeguatezza. Non voleva ricominciare. Visite mediche, pastiglie azzurre, strane pompette, lo sguardo negli occhi di Liv ogni volta che non ci riusciva. No, non funzionava. «Vai, per favore.» Sollevò il libro, mettendoselo davanti come uno scudo. Fissò senza vederle le pagine del libro sentendo i piedi di lei muoversi sul pavimento e la porta che si chiudeva piano. Gli occhiali da lettura erano rimasti sul comodino. Quando Patrik rientrò era tardi. Erica, seduta da sola sul divano, stava guardando la televisione. Dopo che finalmente i bambini si erano addormentati non aveva avuto la forza di riordinare e lui dovette fare lo slalom tra i giocattoli sul pavimento. «Ebba dorme?» chiese sedendosi accanto a lei. «Sì, già dalle otto. Sembrava esausta.» «Direi che è comprensibile.» Patrik appoggiò i piedi sul tavolino. «Cosa c’è alla tele?» «Letterman.» «E l’ospite chi è?» «Megan Fox.» «Oh...» fece Patrik sprofondando meglio tra i cuscini del divano. «Hai intenzione di stare qui a eccitarti con fantasie varie su Megan Fox che poi intendi mettere in pratica sulla tua povera moglie?» «Hai afferrato al volo» rispose lui infilandole la testa nell’incavo del collo. Erica lo scostò da sé. «Com’è andata a Valö?» Patrik sospirò. «Male. Abbiamo perlustrato l’isola il più possibile prima che facesse buio e mezz’oretta dopo che siete andati via sono arrivati i rinforzi di Torbjörn, ma non abbiamo trovato niente.» «Niente?» Erica prese il telecomando e abbassò il volume. «No, nessuna traccia di chi ha sparato. E l’ipotesi più probabile è che abbia gettato l’arma in acqua. Forse però le pallottole forniranno qualche indizio. Torbjörn ha fatto appena in tempo a spedirle in laboratorio.» «Di che cartolina parlava Mårten?» Patrik non rispose subito. Spesso si sentiva come un equilibrista. Non poteva svelare troppi dettagli di un’indagine in corso, ma in più di un’occasione la capacità analitica di Erica gli era tornata utile. Prese una decisione. «Da quando è nata, Ebba riceve in occasione del compleanno un biglietto da qualcuno che si firma “G”. Non sono mai stati messaggi minacciosi, almeno fino adesso. Oggi Mårten è venuto alla stazione e ci ha mostrato una cartolina arrivata per posta, completamente diversa.» «Quindi sospettate che la persona che invia questi biglietti sia responsabile di quanto successo a Valö negli ultimi giorni?» «Per il momento non sospettiamo niente, ma sicuramente è un dettaglio da esaminare. Pensavo di prendere con me Paula e andare a Göteborg, domani, a parlare con i genitori adottivi di Ebba. Gösta non è il massimo quando si tratta di entrare in contatto con la gente, come sai. E poi Paula mi ha implorato di farla lavorare un po’. Pare che non resista più a stare in casa.» «Stai attento che non si stanchi, però. È facile sopravvalutare le proprie forze.» «Sei proprio una chioccia» sorrise Patrik. «Non sono del tutto digiuno, sulla materia, considerato che ho vissuto due gravidanze.» «Prego? Guarda che non sei tu ad avere vissuto due gravidanze. Non mi sembra di ricordare che tu abbia mai sofferto di lassità legamentosa, caviglie gonfie, formicolio alle gambe o reflusso né che ti sia sciroppato ventotto ore di parto e un cesareo.» «Okay, messaggio recepito.» Patrik sollevò le mani. «Comunque prometto di badare a Paula. Mellberg non mi perdonerebbe mai se le succedesse qualcosa. Si può dire quello che si vuole di lui, ma per la sua famiglia si getterebbe nel fuoco.» Sullo schermo stavano scorrendo i titoli di coda del David Letterman Show ed Erica fece una carrellata. «Cosa fa Mårten tutto solo sull’isola, a proposito? Perché si è intestardito a rimanere?» «Non lo so. Non ero affatto convinto di lasciarlo lì. Ho come l’impressione che stia andando in pezzi. Sembra calmo e prende tutta la faccenda con una sorta di strana obiettività, ma mi fa pensare a quel disegno di un’anatra che scivola tranquilla sull’acqua mentre sotto le zampe si muovono a velocità vertiginosa. Capisci cosa intendo o sto solo parlando a vanvera?» «No no, capisco perfettamente.» Erica continuò a fare zapping. Alla fine scelse Pesca estrema su Discovery Channel e si mise a guardare distrattamente le immagini di uomini in cerata che, in balia di un tempo allucinante, tiravano in barca una gabbia dopo l’altra di grossi granchi simili a ragni. «Domani non portate Ebba con voi, vero?» «No, credo sia meglio che parliamo con i genitori senza di lei. Paula viene qui alle nove e prendiamo la Volvo.» «Bene, così posso mostrare a Ebba il materiale che ho raccolto.» «Non l’ho visto neanche io. C’è qualcosa che potrebbe tornare utile per l’indagine?» Erica rifletté un attimo, ma poi scosse la testa. «No, quello che poteva essere pertinente te l’ho già riferito. Le informazioni che ho sulla famiglia di Ebba risalgono più indietro nel tempo e penso siano più che altro interessanti per lei.» «Be’, mi piacerebbe lo stesso vedere il materiale, ma non stasera. Adesso voglio solo stare qui tranquillo con te.» Le si mise più vicino, la strinse a sé e le appoggiò la testa sulla spalla. «Dio, che lavoro che hanno quei ragazzi. Pericolosissimo. Meno male che non faccio il pescatore di granchi.» «Sì, amore. Me lo dico tutti i giorni: grazie a dio non sei un pescatore di granchi.» Rise e gli diede un bacino sulla testa. Da quando aveva avuto l’incidente, a Leon capitava ogni tanto di sentire una specie di fremito nelle membra. Era un dolore insistente, come un presentimento di qualcosa, e in quel momento lo avvertiva, simile all’afa che precede un temporale coi fiocchi. Ia era abituata a percepire i suoi umori. Di solito lo rimproverava quando lo vedeva sprofondare nell’inquietudine, rimuginando, ma non quella volta. Anzi, si stavano evitando reciprocamente, muovendosi per la casa senza incrociarsi. In un certo senso la cosa lo stimolava. Il suo più grande nemico era sempre stato la noia. Quando era piccolo suo padre rideva della sua incapacità di stare fermo, del fatto che dovesse sempre cercare le sfide e mettere alla prova i propri limiti. La mamma si disperava per tutte le fratture e le escoriazioni che si procurava, ma suo padre era fiero di lui. Dopo quella Pasqua non lo aveva mai più incontrato. Era andato all’estero senza avere il tempo di salutarlo. Poi erano passati gli anni e lui era stato troppo impegnato a servirsi a piene mani della vita, anche se suo padre aveva continuato a rimpinguargli generosamente il conto ogni volta che si svuotava, senza mai rimproverarlo né porgli limitazioni ma lasciandolo anzi volare libero. Alla fine Leon si era avvicinato troppo al sole, esattamente come aveva sempre saputo che sarebbe successo, ma i genitori erano morti prima, ignari del fatto che la tortuosa stradina di montagna l’avrebbe privato del suo corpo e del desiderio d’avventura da un giorno all’altro. Suo padre non era stato costretto a vederlo incatenato. Lui e Ia avevano vissuto insieme un lungo percorso, ma il momento decisivo si stava avvicinando. Bastava una scintilla per dare fuoco a tutto. Mai e poi mai avrebbe lasciato che fosse qualcun altro a farlo: era compito suo. Tese le orecchie verso l’interno della casa. Regnava il silenzio. Probabilmente Ia era già andata a letto. Prese il cellulare dal tavolo e se lo mise sulle ginocchia. Poi spinse la sedia a rotelle sulla terrazza e cominciò senza esitazione a telefonare a tutti, uno a uno. Quando ebbe finito appoggiò le mani sulle cosce e spaziò con lo sguardo su Fjällbacka. Nel buio della sera il centro abitato era illuminato da una quantità di luci, come un’immensa taverna scintillante. Puntò di nuovo gli occhi sul mare e su Valö. Nella vecchia colonia era tutto spento. Cimitero di Lovön 1933 Erano passati due anni dalla morte di Carin, ma Hermann non era ancora venuto a prenderla. Con una fedeltà degna di un cane, Dagmar l’aveva aspettato mentre i giorni diventavano settimane, mesi e anni. Aveva continuato a seguire i giornali con costanza. Hermann era diventato ministro, in Germania. Nelle foto era elegantissimo nella sua uniforme. Un uomo potente in cui quell’Hitler riponeva la sua fiducia. Finché si era trovato in Germania a fare carriera Dagmar aveva potuto accettare che la lasciasse aspettare, ma i giornali scrivevano che era tornato in Svezia e lei aveva deciso di facilitargli le cose. Era molto impegnato e, se non poteva muoversi, lo avrebbe raggiunto lei. Come moglie di un politico di spicco avrebbe dovuto adattarsi e probabilmente trasferirsi in Germania. Ormai si era resa conto che la figlia non avrebbe potuto accompagnarla. Un uomo nella posizione di Hermann non poteva avere una figlia illegittima. Ma Laura aveva compiuto tredici anni e poteva cavarsela da sola. Sui giornali non si diceva dove abitasse e di conseguenza Dagmar non sapeva come rintracciarlo. Andò al vecchio indirizzo di Odengatan, ma la porta le venne aperta da uno sconosciuto che la informò che la famiglia Göring non stava più lì da molti anni. Senza sapere cosa fare, Dagmar rimase davanti al portone a riflettere finché non le venne in mente il cimitero in cui era stata sepolta Carin. Forse lo avrebbe trovato là, a visitare la tomba della moglie morta. Aveva letto che era a Lovön, nei pressi di Stoccolma, e dopo qualche ricerca trovò un autobus che la portò quasi a destinazione. Accovacciata davanti alla lapide, fissò il nome di Carin e la croce uncinata incisa sotto. Le foglie giallo-dorate dell’autunno le turbinavano intorno nel vento freddo di ottobre ma lei non se ne accorgeva nemmeno. Era convinta che, una volta morta la rivale, l’odio nei suoi confronti sarebbe scemato. Invece, stretta nel suo cappotto logoro, ripensò a tutte le privazioni subite e sentì risvegliarsi l’antico rancore. Si alzò di scatto e arretrò di alcuni passi dalla lapide. Poi prese la rincorsa e vi si gettò addosso con tutte le forze. Dalla spalla una fitta di dolore le attraversò il braccio fino ai polpastrelli, ma la lastra di pietra non si smosse. Frustrata, Dagmar se la prese con i fiori che ornavano la tomba, estirpando le piantine con le radici. Poi arretrò di nuovo per cercare di abbattere la croce uncinata di ferro verniciato di verde di fianco alla lapide, che cedette e cadde nell’erba. Dagmar la trascinò il più lontano possibile ma, mentre osservava soddisfatta lo scempio, si sentì afferrare per un braccio. «Si può sapere cosa sta facendo?» Di fianco a lei c’era un uomo alto e robusto. Lei sorrise, felice. «Sono la futura signora Göring. Io so che Hermann trova ingiusto che Carin abbia tutte queste cose belle intorno, ma ho sistemato tutto e adesso devo andare da lui.» Dagmar continuò a sorridere, ma l’uomo la guardò serio, scuotendo la testa e borbottando. Tenendole il braccio in una morsa di ferro, la trascinò con sé verso la chiesa. Quando arrivò la polizia, un’ora più tardi, Dagmar sorrideva ancora. A volte la casa a schiera di Falkeliden sembrava decisamente troppo piccola. Dan sarebbe andato con i bambini a passare il fine settimana da sua sorella, a Göteborg, e quella mattina, nell’isteria delle valigie da preparare, Anna si era sentita in mezzo ai piedi ovunque si mettesse. Inoltre aveva dovuto fare più di una corsa giù al chiosco della stazione di servizio per comprare caramelle, bibite, frutta e giornalini da portare via. «Allora, siete pronti?» Anna osservò la montagna di borse e aggeggi vari nell’ingresso. Dan stava andando avanti e indietro dall’auto per infilarci dentro tutto. Si vedeva benissimo che non ci sarebbe riuscito, ma toccava a lui risolvere il problema, visto che aveva detto ai ragazzi di preparare le valigie da soli aggiungendo, come se non bastasse, che potevano portare quello che volevano. «Sei sicura di non voler venire? Non mi piace l’idea di lasciarti qui sola, dopo la brutta esperienza di ieri.» «Grazie, non preoccuparti. Passare qualche giorno per conto mio mi farà bene.» Guardò Dan, sperando che non ci restasse male. Lui annuì e la cinse con le braccia. «Capisco benissimo, tesoro. Non devi spiegare. Adesso pensa a te stessa e passa due belle giornate. Mangia cose buone, dedicati alle lunghe nuotate che ti piacciono tanto o a un po’ di shopping. Insomma, fai quello che vuoi, basta che la casa sia in piedi quando torno.» Con un’ultima stretta si staccò da lei e ricominciò a portare le borse. Anna sentì che le si stava annodando la gola. Per poco non disse che aveva cambiato idea, ma poi ricacciò indietro le parole. Aveva bisogno di tempo per riflettere e non doveva rielaborare solo il terrore provato il giorno prima. Aveva tutta la vita davanti, eppure non riusciva a fare a meno di gettare continuamente occhiate allo specchietto retrovisore. Era venuto il momento di decidere. Come avrebbe potuto fare per scuotersi di dosso il passato e guardare avanti? «Perché tu non vieni, mamma?» Emma la stava tirando per il braccio. Anna si accovacciò, accorgendosi di quanto era cresciuta la figlia. Tra la primavera e l’estate aveva fatto uno scatto in altezza e ormai era grande. «Te l’ho detto che ho parecchio da fare a casa.» «Sì, ma andiamo a Liseberg!» La guardava come se avesse perso il lume della ragione e nel mondo di una bambina di otto anni probabilmente era così, se si rinunciava spontaneamente a una visita al parco divertimenti. «La prossima volta vengo anch’io. E poi sai che me la faccio sotto. Non avrei il coraggio di salire su nessun’altra giostra. Tu sei molto più coraggiosa di me.» «Sì, è vero!» Emma raddrizzò la schiena, orgogliosa. «Io andrò sulle montagne russe grandi, quelle su cui non ha il coraggio di salire neanche il papà.» Pur non essendo più una novità, ogni volta che sentiva chiamare Dan “papà” da Emma e Adrian, Anna si commuoveva, e questa era una delle tante ragioni per cui aveva bisogno di due giorni di solitudine. Doveva trovare un modo per rimettersi in sesto. Per il bene della sua famiglia. Baciò la figlia sulla guancia. «Ci vediamo domenica sera.» Emma corse alla macchina e Anna si appoggiò allo stipite per godersi lo spettacolo. Dan cominciava a sudare e forse a intuire l’impossibilità dell’impresa. «Dio santo, quanta roba hanno preso su» disse asciugandosi la fronte. Il bagagliaio sembrava già strapieno e nell’ingresso c’era ancora un mucchio di roba. «E tu non dire niente!» l’ammonì sollevando l’indice. Anna spalancò le braccia. «Io non aprirò bocca.» «Adrian! Siamo sicuri che Dino deve proprio venire?» Dan aveva sollevato il peluche preferito del bambino, un dinosauro lungo un metro che gli avevano regalato Patrik ed Erica per Natale. «Se lui non viene sto a casa anch’io» gridò Adrian strappandoglielo dalle mani. «Lisen?» chiamò Dan a quel punto. «È necessario che ti porti tutte le Barbie? Non potresti scegliere solo le due più belle?» Lisen scoppiò immediatamente a piangere e Anna scosse la testa, per poi lanciargli un bacio. «Io non voglio intromettermi. Non possiamo cadere in battaglia entrambi. Divertitevi.» Entrò e salì in camera, stendendosi sul copriletto e accendendo il minitelevisore con il telecomando. Dopo una matura riflessione, optò per Oprah, sul terzo canale. Sebastian fece rimbalzare irritato la penna sul blocco. Sebbene fosse andato tutto come previsto, non riusciva a sentirsi del solito buon umore. Adorava la sensazione di avere in suo potere Percy e Josef, e i loro comuni affari stavano per fruttargli un bel gruzzolo. A volte non la capiva, certa gente. Lui non avrebbe neanche pensato per un momento di mettersi in combutta con uno della sua risma, ma entrambi erano disperati, ciascuno a proprio modo: Percy per la paura di vedersi sottrarre l’eredità paterna e Josef perché animato dal desiderio di riscatto e di apprezzamento dei genitori. Sebastian comprendeva meglio le ragioni del primo che del secondo, perché stava per perdere qualcosa di importante, e cioè soldi e status, mentre Josef era per lui un enigma. Che importanza aveva quello che stava facendo? Tra l’altro l’idea di aprire un museo sull’olocausto rasentava la follia. Era un’iniziativa in perdita e, se non fosse stato uno scemo, Josef avrebbe dovuto capirlo. Si alzò e si piazzò davanti alla finestra. Il porto era affollato di imbarcazioni battenti bandiera norvegese e camminando per strada si sentiva parlare norvegese dappertutto, ma lui non aveva niente in contrario. Aveva fatto diversi affari immobiliari con i cugini d’Occidente che, arricchiti dal petrolio, erano disposti a spendere e avevano pagato prezzi esorbitanti per le loro ville con vista mare sulla costa svedese. Spostò lentamente lo sguardo su Valö. Perché mai Leon doveva tornare e incasinare tutto? Per un breve istante pensò a lui e a John. In realtà li aveva in pugno ma, saggiamente, non aveva mai sfruttato il proprio potere su di loro, concentrandosi invece sugli elementi più deboli del branco e separandoli dagli altri. Leon voleva invece riunirlo, il branco, e Sebastian aveva la netta sensazione che non ci avrebbe guadagnato. Solo che ormai l’ingranaggio si era messo in moto e le cose stavano come stavano. Non era da lui preoccuparsi di qualcosa che non poteva cambiare. Erica guardò fuori dalla finestra finché non si fu assicurata che Patrik era partito. Poi si mise in pista: vestì rapidamente i bambini e li fece salire in macchina, lasciando un biglietto a Ebba che era ancora a letto per avvertirla che in frigo avrebbe trovato tutto quello che serviva per la colazione e che era solo uscita per una commissione. Appena sveglia aveva mandato un sms a Gösta, per cui sapeva che li stava aspettando. «Dove andiamo?» Maja era seduta dietro con una bambola stretta in braccio. «Da Gösta» rispose Erica rendendosi conto in quel momento che la bambina avrebbe inevitabilmente fatto la spia a Patrik. Pazienza: tanto prima o poi sarebbe venuto a sapere dell’accordo. La preoccupava di più non avergli parlato dei sospetti sull’intrusione in casa loro. Svoltò verso Anrås scacciando il pensiero di chi potesse essere andato a frugare nel suo studio. In realtà conosceva già la risposta, o meglio, c’erano solo due possibilità. O si trattava di qualcuno convinto che avesse scovato qualche dettaglio compromettente sugli eventi alla colonia di Valö oppure aveva a che vedere con la visita fatta a John Holm e il foglietto che aveva portato via. Considerando il dato temporale, propendeva per la seconda ipotesi. «Ti sei portata tutta la truppa?» chiese Gösta aprendo la porta, ma il tono poco entusiasta era bilanciato dallo scintillio negli occhi. «Se hai qualche cimelio raro a cui tieni molto è meglio che lo tolga di mezzo subito» rispose Erica sfilando le scarpe ai bambini. I gemelli, intimiditi, le si aggrapparono alle gambe, mentre Maja alzò le braccia felice: «Ciao Gösta!» Per un attimo lui s’irrigidì e sembrò non sapere come comportarsi davanti a quella spontanea dimostrazione d’affetto, ma poi i tratti del viso gli si ammorbidirono e si chinò per prenderla in braccio. «Sei proprio una bambina simpatica.» La portò dentro e, senza voltarsi, disse: «Ho preparato in giardino.» Erica si sistemò un gemello su ciascun fianco e lo seguì, guardando curiosa gli interni della casetta, opportunamente vicina al campo da golf. Non sapeva cosa si era aspettata ma quella che vedeva non era la solita abitazione spoglia da uomo single, al contrario: la trovò ben tenuta e accogliente, con floride piante alle finestre. Anche il giardino sul retro era sorprendentemente in salute per quanto, data la piccolezza, non richiedesse un impegno eccessivo. «Possono bere lo sciroppo allungato con l’acqua e mangiare le ciambelline oppure voi siete di quei genitori salutisti che vogliono solo cibo sano e biologico?» Gösta sistemò Maja su una sedia. Erica non poté fare a meno di sorridere tra sé e sé chiedendosi se nel tempo libero leggesse di nascosto Mama, il mensile che andava per la maggiore tra le madri svedesi. «Ciambelline e sciroppo andranno benone» rispose mettendo giù i gemelli che, piano piano, cominciarono a muoversi allontanandosi sempre di più da lei. Maja vide alcuni cespugli di lamponi e, con un gridolino estasiato, saltò giù dalla sedia. «Può raccoglierli?» Erica conosceva la figlia a sufficienza da sapere che nel giro di un attimo non sarebbe rimasta una sola bacca, per quanto acerba. «Lasciala mangiare» rispose Gösta versando il caffè per loro due. «Tanto gli unici a goderne sono gli uccellini. Maj-Britt li raccoglieva e ne faceva confetture e sciroppo, ma io non sono il tipo. Ebba...» S’interruppe e chiuse la bocca, mescolando il caffè in cui aveva messo una zolletta di zucchero. «Sì? Cosa stavi dicendo di Ebba?» Ripensò all’espressione della donna mentre si allontanavano in barca da Valö, al sollievo che si mescolava all’ansia in quel viso combattuto tra il desiderio di tornare là e quello di andarsene. «Anche Ebba a volte stava lì finché non aveva raccolto fino all’ultimo lampone» rispose Gösta a malincuore. «L’estate in cui la tenemmo qui con noi non facemmo né confetture né sciroppo, ma Maj-Britt era contenta lo stesso. Era così carina da guardare mentre, in pannolino e basta, si ficcava in bocca una manciata dopo l’altra facendosi colare tutto il succo sulla pancia.» «Ebba fu ospitata da voi?» «Sì, ma solo per l’estate, prima di andare a stare con la famiglia di Göteborg.» Erica rimase a lungo in silenzio per cercare di digerire la notizia. Strano. Facendo le sue ricerche sul caso non aveva trovato nessuna indicazione in merito. Solo in quel momento capì come mai si fosse lasciato coinvolgere tanto. «Non pensaste alla possibilità di tenerla?» chiese alla fine. Gösta abbassò lo sguardo sulla tazza continuando a girare il cucchiaino e per un attimo Erica si pentì di averglielo chiesto. Sebbene non potesse vederglieli, intuiva che aveva gli occhi lucidi. Poi lui si schiarì la voce e deglutì. «Eccome. Ci pensammo e ne parlammo molte volte, ma secondo Maj-Britt non eravamo adeguati. E io mi lasciai convincere. Ci sembrava di non avere molto da offrirle.» «E dopo che andò a Göteborg avete mantenuto i contatti?» Gösta sembrò esitare. Poi scosse la testa. «No, pensammo che la cosa più semplice per lei fosse rompere del tutto. Il giorno in cui partì...» La voce gli s’incrinò, impedendogli di completare la frase, ma Erica capì. «E cosa provi rivedendola adesso?» «È un po’ strano. È un’adulta e io non la conosco. Eppure in qualche modo riesco a vedere in lei quella bambina che raccoglieva lamponi e sorrideva appena si guardava dalla sua parte.» «Adesso non sorride più tanto.» «No, è vero.» Aggrottò la fronte. «Tu sai cos’è successo al loro bambino?» «No, non ho voluto chiedere. Ma Patrik e Paula stanno andando a Göteborg a parlare con i genitori adottivi e immagino che verranno a sapere di più.» «Suo marito non mi va a genio.» Gösta si allungò verso una ciambellina. «Mårten? Non credo che abbia qualcosa che non va. Mi sembra solo che ci siano dei problemi tra loro, ma d’altra parte hanno da rielaborare la perdita del figlio e anche io, con mia sorella, vedo fino a che punto una tragedia del genere può influenzare un rapporto. Non è sempre detto che un dolore comune riavvicini le persone.» «Hai ragione.» Gösta annuì e lei si rese conto che sapeva benissimo di cosa stava parlando. Lui e Maj-Britt avevano perso il loro primo e unico figlio a pochi giorni dalla nascita. E poi avevano perso Ebba. «Guarda, Gösta, ci sono tantissimi lamponi!» chiamò Maja dal cespuglio. «Mangia, mangia pure!» rispose lui, con gli occhi che brillavano di nuovo. «Magari potresti fare il baby sitter qualche volta» disse Erica un po’ per scherzo e un po’ sul serio. «Tre non riuscirei a gestirli, ma la bambina penso di potervela tenere se qualche volta avete bisogno di una mano.» «Me ne ricorderò.» Erica decise di fare in modo che Gösta avesse presto occasione di occuparsi di Maja. Non che fosse timida, ma con il burbero collega di Patrik sembrava avesse un feeling particolare e probabilmente sarebbe stata in grado di colmare almeno in parte il buco nel cuore che Gösta dimostrava di avere. «Che opinione ti sei fatto di quello che è successo ieri?» Gösta scosse la testa. «Non mi ci raccapezzo. La famiglia sparì nel 1974, probabilmente assassinata. Poi, per anni, non è più successo niente, ma quando Ebba torna a Valö si scatena un inferno. Perché?» «Non certo perché potrebbe essere una testimone di qualcosa. Era talmente piccola che non sarebbe in grado di ricordare niente.» «No, però magari qualcuno voleva impedire a lei e Mårten di trovare il sangue. Solo che non mi spiego gli spari di ieri, visto che quello che doveva succedere era già successo.» «La cartolina di cui parlava Mårten indica comunque che qualcuno vuole far loro del male. E visto che gliene arrivano regolarmente di simili dal 1974 si può trarre la conclusione che quanto successo a Ebba in quest’ultima settimana abbia a che vedere con la scomparsa, anche se solo ora il messaggio si è fatto minaccioso.» «Ecco, io...» «Maja! Non spingere Noel!» Erica balzò in piedi e corse dai bambini che litigavano davanti al cespuglio. «Ma lui ha preso il mio lampone! Se l’è... se l’è mangiato!» strillò Maja facendo per mollare un calcio al fratello. Erica la prese per un braccio e la guardò severa. «Smettila! Non si danno i calci. E poi ci sono ancora un sacco di lamponi.» Indicò il cespuglio carico di grosse bacche mature. «Ma io volevo quello!» Dalla faccina si capiva quanto ritenesse ingiusto il trattamento subito e quando Erica le lasciò andare il braccio per consolare Noel ne approfittò per scappare via. «Gösta, Gösta! Noel ha preso il mio lampone!» singhiozzò. Lui guardò la bambina appiccicaticcia di succo rosso e poi, sorridendo, se la prese in braccio, dove lei si rannicchiò come una pallina. «Su, su» disse lui accarezzandole i capelli, come se in vita sua non avesse fatto altro che consolare bambini di tre anni in crisi. «Sai, quel lampone non era il più buono.» «No?» Maja smise di piangere di colpo e lo guardò. «No, so io dove si trovano i più buoni. Però deve restare il nostro segreto. Non potrai rivelarlo ai fratellini e neanche alla mamma.» «Promesso.» «Bene, mi fido di te.» Si chinò e le bisbigliò qualcosa all’orecchio. Maja ascoltò con attenzione e poi scivolò a terra e puntò di nuovo verso il cespuglio. Noel si era calmato ed Erica tornò a sedersi. «Cosa le hai detto? Dove sono i più buoni?» «Se insisti te lo svelerò, ma purtroppo dopo dovrò ucciderti» rispose Gösta con un sorriso. Erica girò la testa verso il cespuglio. Maja, in punta di piedi, si allungava verso i lamponi troppo in alto perché i gemellini ci arrivassero. «Mica scemo» disse ridendo. «Dov’eravamo? Ah sì, al tentato omicidio di ieri. Dobbiamo trovare un modo per proseguire. Sei riuscito a scoprire che fine hanno fatto gli effetti personali della famiglia? Sarebbe utilissimo poterli esaminare. Possibile che siano stati buttati via? Nessuno che sia andato lì a sgomberare, dopo? Si occupavano loro di tutto da soli, anche delle pulizie e del giardino?» Gösta si rizzò a sedere di colpo. «Dio santo, che cretino. A volte mi chiedo se non sono arteriosclerotico sul serio.» «Cosa?» «Avrei dovuto pensarci... Ma faceva parte del trantran quotidiano, il che in realtà avrebbe dovuto indurmi a pensarci subito.» Erica gli lanciò un’occhiataccia. «Ma insomma, di chi parli?» «Olle il rigattiere.» «Olle il rigattiere? Vuoi dire quello che ha il deposito di roba usata su a Bräcke? Cosa c’entra lui con Valö?» «Andava e veniva come gli pareva, là, e aiutava con le cose da sistemare.» «E pensi che abbia portato via lui la roba?» Gösta spalancò le braccia. «Potrebbe essere una spiegazione. Quell’uomo tiene tutto, e a meno che qualcuno si sia fatto avanti a reclamarne la proprietà non sarei sorpreso che avesse rastrellato quello che poteva.» «La domanda è se ce l’ha ancora.» «Intendi dire che Olle avrebbe potuto fare le pulizie di primavera finendo per dare via qualcosa?» Erica rise. «No, se è stato lui a prendere tutto penso si possa stare sicuri che ci sia ancora. Forse sarebbe il caso di andarci subito e sentire?» Si stava già alzando dalla sedia, ma Gösta le fece cenno di stare seduta. «Calma, calma. Se ce l’ha lui, ce l’ha da trent’anni e passa e dubito che la dia via oggi. Non è un posto in cui portare i bambini. Lo chiamo dopo e, se la roba è lì, ci andiamo quando hai la baby sitter.» Erica sapeva che aveva ragione ma non riuscì a nascondere l’impazienza. «Come sta?» chiese Gösta, e lei impiegò qualche secondo a capire a chi si riferisse. «Ebba? Be’, sembrava esausta. Ho avuto l’impressione che in fin dei conti fosse un sollievo allontanarsi da Valö per un po’.» «E da quel Mårten.» «Secondo me l’hai giudicato male, ma probabilmente in questo caso hai ragione. Là sull’isola si logorano a vicenda. Lei comincia a essere curiosa della sua famiglia e pensavo di mostrarle quello che ho trovato appena saremo tornati a casa e i gemelli si saranno addormentati.» «Lo apprezzerà di sicuro. La storia della sua famiglia è piena di contrasti.» «Puoi ben dirlo.» Erica bevve l’ultimo sorso di caffè ormai freddo e fece una smorfia. «A proposito, sono andata a parlare con Kjell al Bohusläningen. Mi ha fornito alcune informazioni sul passato di John Holm.» Riferì in breve la vicenda familiare che l’aveva spinto a intraprendere la strada dell’odio. Gli disse anche del foglietto che aveva trovato e di cui fino a quel momento non aveva avuto il coraggio di parlargli. «Gimle? Non ho idea di cosa significhi, ma non è detto che abbia a che fare con Valö.» «No, ma può averlo messo in agitazione a sufficienza da spedire qualcuno a introdursi in casa nostra» disse Erica prima di riuscire a trattenersi. «Qualcuno è entrato da voi? E Patrik cos’ha detto?» Erica rimase in silenzio e Gösta la fissò sbalordito. «Non gliel’hai detto?» La voce era andata in falsetto. «Quanto sei sicura che i colpevoli siano John Holm e i suoi?» «È solo un’ipotesi e in realtà non è successo niente. Qualcuno è entrato dalla porta della veranda, ha frugato tra le mie cose e cercato di entrare nel computer senza riuscirci. Posso dirmi fortunata se la persona in questione non ha rubato il disco fisso.» «Patrik andrà su tutte le furie quando verrà a saperlo. Se poi scopre che io ne ero informato e non gliel’ho detto se la prenderà anche con me.» Erica sospirò. «Glielo dirò. Ma l’aspetto interessante di tutto questo è che evidentemente nel mio studio ho qualcosa ritenuto così importante che qualcuno si assume un rischio del genere per trovarlo. E sono convinta che sia quel foglietto.» «Possibile che John Holm faccia una cosa del genere? Se saltasse fuori che si è introdotto in casa di un poliziotto, per gli Amici della Svezia sarebbero guai grossi.» «Forse sì, se ci tiene a sufficienza. Comunque adesso ho messo la cosa in mano a Kjell. Sarà lui a cercare di scoprire cosa significa.» «Bene. E quando Patrik rientra stasera gli dici tutto, altrimenti finisco nei guai anche io.» «Sì, va bene» rispose Erica stancamente. Non era ansiosa di farlo, ma non aveva scelta. Gösta scosse la testa. «Chissà se lui e Paula riusciranno a scoprire qualcosa di più, a Göteborg. Comincio a perdere le speranze.» «Sì, ma possiamo riporne qualcuna anche in Olle il rigattiere» gli ricordò Erica, lieta che avesse cambiato argomento. «Già, sperare non costa nulla.» Ospedale psichiatrico Sankt Jörgen, 1936 «Riteniamo improbabile che sua madre venga dimessa in tempi brevi» disse il dottor Jansson, un uomo sulla sessantina con i capelli bianchi e una gran barba che lo faceva somigliare a Babbo Natale. Laura trasse un sospiro di sollievo. Era riuscita a sistemarsi: aveva un buon lavoro e un nuovo alloggio. Come pensionante presso la vecchia Bergström in Galärbacken disponeva soltanto di una stanzetta, ma era sua ed era bella come la casa delle bambole che teneva al posto d’onore, sull’alto cassettone di fianco al letto. La vita era molto meglio senza Dagmar. Da tre anni era rinchiusa al Sankt Jörgen di Göteborg e per lei era stata una liberazione non doversi preoccupare dei suoi continui colpi di testa. «Di cosa soffre esattamente mia madre?» chiese cercando di apparire sincera nel suo interessamento. Si era vestita bene, come faceva sempre, ed era seduta con le gambe unite, leggermente di lato, e la borsetta sulle ginocchia. Aveva solo sedici anni, ma si sentiva molto più vecchia. «Non siamo riusciti a stabilire una vera e propria diagnosi, ma probabilmente è debole di nervi. Purtroppo le cure non hanno dato grandi risultati. Continua a delirare di Hermann Göring. Non è raro che le persone con questo tipo di problemi si perdano in fantasie su persone di cui hanno letto sul giornale.» «Sì, ne parla da sempre, per quanto posso ricordare» disse Laura. Il medico la guardò compassionevole. «Immagino che non abbia avuto vita facile, ma sembra che se la sia cavata bene e non ha solo un bel faccino. Mi pare che lei sia una ragazza di buon senso.» «Ho fatto quello che potevo» rispose lei modesta, ma al ricordo della propria infanzia sentì risalire in gola un rigurgito acido. Detestava i momenti in cui non riusciva a tenere in scacco quelle immagini. Di solito le seppelliva in un angolo remoto della mente e solo di rado pensava alla madre e all’appartamentino buio impregnato di quell’odore di alcol che non riusciva mai a cancellare, per quanto strofinasse e sfregasse. Anche gli insulti erano sepolti. Nessuno le nominava più la madre e ormai era rispettata per la sua bravura, precisione e coscienziosità in tutto quello che faceva. Da un pezzo nessuno le rivolgeva parole di scherno. Ma la paura c’era ancora. La paura che sua madre uscisse e rovinasse tutto. «Vuole vederla? Le consiglio di non farlo ma...» Il dottor Jansson spalancò le braccia. «No, credo che non sia il caso. Lei rimane sempre così... turbata.» Laura non poteva dimenticare gli improperi che la madre le aveva riversato addosso in occasione della visita precedente. Le aveva detto parole talmente orribili che Laura non riusciva neppure a pronunciarle. Anche il medico sembrava ricordare l’episodio. «Penso sia la decisione giusta. Cerchiamo di lasciarla tranquilla.» «Spero che non abbia ancora il permesso di leggere i quotidiani.» «No, dopo quanto successo non ha accesso ai giornali.» Scosse la testa, deciso. Laura annuì. Era stato due anni prima: le avevano telefonato dall’ospedale perché, dopo aver letto sul giornale che Göring non solo aveva spostato i resti della moglie Carin nella sua tenuta di Carinhall in Germania ma addirittura costruito un mausoleo in suo onore, la madre aveva distrutto la sua camera e anche ferito uno degli infermieri in modo così grave che avevano dovuto dargli dei punti. «Vi fate vivi voi se succede qualcosa, vero?» chiese alzandosi e spostando i guanti nella mano sinistra per tendere la destra al medico. Quando gli voltò le spalle e uscì dallo studio, sulle sue labbra si disegnò un sorriso. Era libera, ancora per un po’. Si stavano avvicinando a Torp, poco a nord di Uddevalla, quando rimasero bloccati in un ingorgo. Patrik rallentò e Paula cercò di trovare una posizione più comoda sul sedile. Lui le lanciò un’occhiata ansiosa. «Sei sicura di sopportare il viaggio su e giù da Göteborg?» «Ma sì, non preoccuparti. Ne ho già abbastanza di persone che lo fanno, intorno a me.» «Speriamo almeno che ne valga la pena, con il traffico che c’è.» «Insomma, ci metteremo quel che ci metteremo. Come sta Ebba?» «Non lo so. Dormiva quando sono arrivato ieri e dormiva stamattina quando sono uscito. Erica ha detto che era esausta.» «Non è strano. Dev’essere una specie di incubo per lei.» «Insomma, vai avanti adesso!» Patrik fece una strombazzata per dare la sveglia al conducente davanti che non si era accorto che la fila era avanzata di parecchio. Paula scosse la testa ma non fece commenti. Aveva viaggiato con Patrik un numero sufficiente di volte per sapere che cambiava radicalmente d’umore appena si metteva al volante. Nel traffico estivo impiegarono un’ora abbondante più del previsto per arrivare a Göteborg e quando scesero dall’auto nella tranquilla via di villette a Partille, Patrik era sul punto di esplodere. Si staccò la camicia dalla pelle per farsi aria. «Dio santo, che caldo che fa oggi! Non stai morendo?» Paula lo guardò superiore. «Io essere straniera, io non sudare» rispose alzando le braccia per mostrargli che era completamente asciutta. «Bene, allora sudo io per tutti e due. Avrei dovuto portarmi una camicia di scorta. Presentandoci così non faremo una gran impressione: io fradicio e tu come una specie di balena spiaggiata. Si faranno qualche domanda sulla polizia di Tanum» disse Patrik premendo il campanello. «Spiaggiato sarai tu. Io sono incinta. Tu che scusa hai?» contrattaccò Paula infilandogli un dito nel rotolo di ciccia all’altezza della vita. «Quella è solo un po’ di zavorra che conferisce autorevolezza e sparirà appena ricomincerò ad allenarmi.» «Già, ho sentito dire che la palestra ha diramato un avviso di ricerca nei tuoi confronti...» La porta si aprì, impedendo a Patrik di rispondere per le rime. «Buongiorno! Voi dovete essere i poliziotti di Tanumshede» disse un uomo anziano dall’aria cordiale. «Sì» rispose Patrik presentando se stesso e la collega. La moglie venne a salutarli a sua volta. «Prego, entrate. Io sono Berit. Abbiamo pensato di accogliervi nella nostra incubatrice per pensionati.» «Incubatrice per pensionati?» sussurrò Paula in tono interrogativo a Patrik. «La veranda in vetro» rispose lui vedendola sorridere. Nella piccola veranda soleggiata Berit accostò al tavolo una poltrona in vimini e fece un cenno a Paula: «Si sieda qui. È la più comoda.» «Grazie. Poi però dovrete ricorrere a una gru per tirarmi fuori» disse Paula prendendo posto sul cuscino morbido. «E per i piedi c’è lo sgabello. Non dev’essere facile portarsi in giro il pancione con questo caldo.» «Sì, in effetti comincia a pesare» ammise Paula. Dopo il lungo viaggio in macchina aveva i polpacci simili a due palloncini. «Ricordo benissimo l’estate in cui Ebba aspettava Vincent. Faceva altrettanto caldo anche allora e lei...» Berit si interruppe a metà frase e il sorriso si spense. Sture le circondò le spalle con il braccio e le fece una carezza. «Su, adesso mettiamoci comodi e offriamo caffè e dolce ai nostri ospiti. C’è la torta tigre di Berit. La ricetta è talmente segreta che non so neanche io come la fa.» Aveva usato un tono allegro per cercare di alleggerire l’atmosfera, ma lo sguardo era triste come quello della moglie. Patrik si sedette rendendosi conto che prima o poi durante quel colloquio avrebbe dovuto affrontare un argomento che evidentemente per i genitori di Ebba era molto doloroso. «Servitevi.» Berit avvicinò loro il piatto. «Lei e suo marito sapete già se sarà un maschio o una femmina?» Paula si fermò con la fetta di dolce a mezz’aria. Poi guardò dritto negli occhi la donna e rispose in tono gentile: «No, io e la mia convivente, Johanna, abbiamo deciso che preferiamo non saperlo. Ma abbiamo un maschietto e quindi è naturale che ci piacerebbe che fosse una bambina, questa volta. Comunque, come si dice in questi casi, l’importante è che sia sano.» Si accarezzò la pancia e si preparò alla reazione della coppia. Berit s’illuminò. «Che bello per lui essere il fratello maggiore! Dev’essere molto orgoglioso.» «Con una mamma così graziosa, sarà una meraviglia di qualsiasi sesso venga fuori» disse Sture con un sorriso caloroso. Il fatto che il nascituro avrebbe avuto due madri sembrava non turbarli affatto e Paula rispose allegra al sorriso. «Adesso diteci cosa sta succedendo» disse Sture. «Quando chiamiamo Ebba e Mårten ci rispondono a monosillabi e non vogliono neanche che andiamo lì.» «No, in effetti è meglio che non lo facciate» rispose Patrik, pensando che l’ultima cosa che serviva erano altre persone in pericolo a Valö. «Perché?» Lo sguardo di Berit passò irrequieto da Patrik a Paula. «Ebba ci ha detto che demolendo un pavimento hanno trovato del sangue. Si tratta del...?» «Sì, sembra l’ipotesi più probabile» rispose Patrik. «Ma è lì da tanto di quel tempo che non si riesce a stabilire con certezza se viene dalla famiglia di Ebba, e neanche di quante persone diverse sia.» «È davvero orribile» disse Berit. «Non abbiamo mai parlato molto con Ebba della tragedia, e in effetti sapevamo solo quello che ci aveva riferito l’assistente sociale e che leggevamo sui giornali. Per questo siamo rimasti un po’ sorpresi quando lei e Mårten hanno deciso di prendere in mano la casa.» «Secondo me non desideravano andare lì» intervenne Sture, «ma semplicemente andare via.» «Potreste dirci cos’è successo al loro bambino?» chiese Paula con tatto. Dopo un’occhiata alla moglie, Sture prese la parola e, lentamente, raccontò ciò che era accaduto il giorno della morte di Vincent. Ascoltandolo, Patrik sentì formarsi un groppo in gola. Sembrava impossibile che la vita fosse così crudele e senza senso. «Quanto tempo dopo si sono trasferiti Ebba e Mårten?» chiese quando Sture smise di parlare. «Mah, sei mesi, più o meno» rispose Berit. Sture annuì. «Sì, è così. Hanno venduto la casa. Abitavano qui vicino.» Indicò in una direzione non meglio specificata lungo la via. «Mårten ha rinunciato agli ordini che aveva come falegname ed Ebba era in malattia da quando era successo. Prima lavorava all’ufficio delle imposte ma non ha mai ripreso servizio. Siamo un po’ in ansia per come se la caveranno economicamente, ma avendo venduto la villetta a schiera una base di partenza ce l’hanno.» «Vuol dire che li aiuteremo, nel limite del possibile» disse Berit. «Abbiamo altri due figli, per così dire nostri, anche se consideriamo nostra lei quanto loro. È sempre stata la loro cocca e se sarà necessario daranno una mano, nel limite del possibile, per cui in qualche modo si farà.» Patrik annuì. «Una volta finiti i lavori verrà fuori molto bene. Mårten sembra un ottimo falegname.» «È bravissimo» disse Sture. «Quando vivevano qui lavorava quasi senza interruzione. A volte anche un po’ troppo, ma meglio uno così di un fannullone.» «Altro caffè?» chiese Berit alzandosi per prendere la caraffa. Sture la guardò andare in cucina. «Questa cosa la logora, anche se non vuole darlo a vedere. Ebba arrivò come un angioletto nella nostra famiglia. Gli altri due avevano sei e otto anni e avevamo parlato della possibilità di averne un altro. Fu Berit a lanciare l’idea di vedere se c’era qualche bambino che poteva avere bisogno di noi.» «Avevate avuto altri minori in affido in precedenza?» chiese Paula. «No, Ebba fu la nostra prima e unica. Restò da noi e poi decidemmo di adottarla. Berit quasi non riusciva a dormire la notte, prima che la procedura d’adozione fosse completata. Aveva una gran paura che qualcuno potesse venire a portarcela via.» «Com’era da piccola?» chiese Patrik, più che altro per curiosità. Qualcosa gli diceva che la Ebba che aveva visto era solo una pallida copia di se stessa. «Oh, un vero ciclone, le dirò.» «Chi, Ebba?» Berit arrivò nella veranda con la caraffa. «Quella bambina ne combinava di birichinate! Ma era sempre allegra e non si riusciva ad arrabbiarsi davvero con lei.» «Per questo è così difficile» disse Sture. «Non abbiamo perso solo Vincent, ma anche Ebba. È come se una parte di lei fosse morta con lui. E lo stesso vale per Mårten. In effetti lui è sempre stato meno costante di umore e per qualche periodo ha avuto anche delle depressioni, ma prima che morisse Vincent stavano bene insieme. Ora, invece... non lo so più. All’inizio quasi non riuscivano a ritrovarsi nella stessa stanza mentre adesso sono su un’isola dell’arcipelago, da soli. Insomma, per noi è una preoccupazione.» «Avete qualche teoria su chi possa aver dato fuoco alla casa o sparato a Ebba?» chiese Patrik. Berit e Sture lo guardarono allibiti. «Non ve l’ha detto?» domandò con un’occhiata a Paula. Non gli era neanche passato per l’anticamera del cervello che i genitori di Ebba potessero non sapere cos’era successo alla figlia. In quel caso avrebbe fatto la domanda con più tatto. «No, ci ha soltanto detto che hanno trovato il sangue» disse Sture. Patrik stava ancora cercando le parole giuste per descrivere quello che era successo a Valö quando Paula lo prevenne e fece un resoconto calmo e obiettivo dell’incendio e della sparatoria. Berit afferrò il tavolo così forte che le s’imbiancarono le nocche. «Non capisco perché non ci abbia detto niente.» «Probabilmente non voleva preoccuparci» disse il marito, ma si vedeva che anche lui era turbato. «Perché si fermano lì, allora? È una follia! Dovranno andarsene subito. Andiamo a parlare con loro, Sture.» «Sembrano decisi a restare» spiegò Patrik, «ma per il momento Ebba è a casa mia. L’ha accompagnata mia moglie e stanotte ha dormito nella nostra camera degli ospiti. Mårten invece si è rifiutato di spostarsi ed è ancora sull’isola.» «Ma è pazzo?» esclamò Berit. «Adesso ci andiamo. Subito.» Si alzò, ma Sture la fece risedere con un gesto deciso. «Non facciamo passi affrettati. Chiamiamo Ebba e sentiamo cos’ha da dire. Sai quanto sono testardi. Non vale la pena di litigare.» Berit scosse la testa ma non tentò di rialzarsi. «Vi viene in mente qualche motivo per cui qualcuno potrebbe voler fare loro del male?» Paula cambiò posizione sulla poltroncina. Nonostante fosse molto comoda, le giunture le dolevano. «No, nessuno» rispose Berit con enfasi. «Conducevano una vita del tutto normale. E perché qualcuno avrebbe dovuto accanirsi? Hanno già avuto la loro razione di dolore e disperazione.» «Secondo me ha a che fare con quello che è successo alla famiglia di Ebba» disse Sture. «Forse qualcuno teme che venga fuori qualche verità scomoda?» «È anche la nostra teoria, ma al momento non sappiamo molto e per questo vogliamo stare attenti a quello che diciamo» rispose Patrik. «Un elemento che ci lascia perplessi è quello dei biglietti ricevuti da Ebba e firmati con l’iniziale “G”.» «Sì, è un po’ strano» ammise Sture. «Arrivavano tutti i compleanni. Davamo per scontato che fosse qualche lontano parente a spedirli e francamente ci sembrava innocuo, per cui non abbiamo dato importanza alla cosa.» «Ieri ne ha ricevuto uno che non era tanto innocuo.» I genitori di Ebba lo guardarono sorpresi. «Cosa c’era scritto?» Sture si alzò e chiuse un po’ le tende. La luce del sole aveva cominciato a intrufolarsi e si rifletteva sul tavolo. «Diciamo che erano minacce.» «Be’, è la prima volta. Pensate che il mittente sia la stessa persona che ha cercato di fare loro del male?» «Non lo sappiamo. Ma sarebbe utile se aveste ancora qualche biglietto da mostrarci.» Sture scosse la testa, dispiaciuto. «No, purtroppo non li abbiamo conservati. Li facevamo vedere a Ebba e poi li buttavamo via. Non erano molto personali. C’era scritto soltanto “Auguri di buon compleanno” e poi “G”. Nient’altro. Per questo non ci sembrava avesse molto senso tenerli.» «No, è chiaro» disse Patrik. «E non c’era nient’altro che potesse rivelare chi li spediva? Per esempio il timbro postale?» «Era di Göteborg, quindi non forniva nessun filo conduttore.» Sture smise di parlare, ma poi si riscosse e guardò la moglie. «I soldi» disse. Berit sbarrò gli occhi. «Come abbiamo fatto a non pensarci?» Si rivolse a Patrik e Paula: «Da quando è venuta a stare da noi fino al suo diciottesimo compleanno, ogni mese venivano depositati dei soldi per lei in forma anonima. Ci era solo arrivata una lettera che ci informava dell’apertura di un conto a suo nome. Glieli abbiamo dati quando lei e Mårten si sono comprati la casa.» «E non avete idea di chi versasse i soldi? Avete provato a scoprirlo?» Sture annuì. «Sì, abbiamo fatto qualche tentativo. Eravamo curiosi, naturalmente. Ma la banca ci ha comunicato che il donatore voleva restare anonimo e ci siamo dovuti accontentare. Alla fine abbiamo pensato che probabilmente era lo stesso che inviava i biglietti: un lontano parente animato da buone intenzioni.» «Da che banca vi era arrivata la lettera?» «Handelsbanken. La filiale di Norrmalmstorg, a Stoccolma.» «Allora approfondiremo la cosa. Meno male che vi è venuto in mente.» Patrik rivolse a Paula un’occhiata interrogativa e quando lei annuì si alzò e tese la mano ai padroni di casa. «Grazie mille di aver trovato il tempo di incontrarci. Fatevi vivi se per caso vi ricordate di qualcos’altro.» «Certo. Vogliamo aiutarvi in tutti i modi possibili.» Sture fece un pallido sorriso e Patrik capì che si sarebbero lanciati sul telefono per chiamare la figlia appena lui e Paula fossero ripartiti. La trasferta a Göteborg aveva reso più di quanto avessero osato sperare. “Follow the money”, come si diceva nei film americani. Se avessero rintracciato il donatore forse avrebbero trovato uno spunto per andare avanti. Quando salirono in macchina Patrik accese il telefono. Venticinque chiamate non risposte. Sospirò e si girò a guardare Paula. «Qualcosa mi dice che la stampa ha fiutato la pista.» Avviò il motore e partì per Tanumshede. Sarebbe stata una lunga giornata. L’Expressen era uscito con la notizia di Valö e quando il capo di Kjell venne a sapere grazie al tamtam della redazione che sarebbero potuti uscire per primi con lo scoop s’inalberò non poco. Dopo una bella lavata di capo, mandò Kjell fuori dal suo ufficio con l’incarico di surclassare il tabloid della capitale e rendere più affilati gli articoli del Bohusläningen sul vecchio caso irrisolto. «Il fatto che siamo un giornale locale molto più piccolo non significa che dobbiamo essere da meno», come diceva sempre. Kjell sfogliò tra i suoi appunti. Certo andava contro i suoi principi giornalistici cedere a qualcun altro una notizia del genere, ma l’impegno contro le organizzazioni xenofobe era più importante. Se il prezzo per farsi aiutare a tirare fuori la verità sugli Amici della Svezia e John Holm era regalare uno scoop, era pronto a pagarlo. Dovette trattenersi dal telefonare a Sven Niklasson per sentire come andava. Probabilmente non avrebbe saputo granché prima di leggere tutto sui giornali, ma non riusciva a smettere di rimuginare sul possibile significato di Gimle. Era sicuro che il tono della voce del collega era cambiato quando lui gli aveva riferito del biglietto trovato da Erica a casa del politico. Sembrava che avesse già sentito parlare di Gimle e che ne sapesse qualcosa. Aprì l’Expressen e lesse i pezzi sul ritrovamento del sangue a Valö. Avevano dedicato quattro pagine alla notizia e sicuramente nelle giornate successive sarebbe diventato una specie di feuilleton. La polizia di Tanum aveva convocato una conferenza stampa per quel pomeriggio e c’era da sperare che venisse fuori qualcos’altro. In ogni caso, la vera sfida non consisteva nel riportare le stesse informazioni che avevano tutti gli altri ma nell’andare a scovare quelle che non aveva nessuno. Kjell si appoggiò allo schienale e rifletté. Sapeva che in zona la gente era stata sempre affascinata dai ragazzi rimasti a scuola durante le vacanze di Pasqua. Nel corso degli anni erano state fatte mille congetture su cosa sapessero o non sapessero e su quanto potessero avere a che fare con la scomparsa della famiglia. Se avesse trovato la massima quantità possibile di materiale sui cinque ragazzi sarebbe forse riuscito a comporre un articolo che nessuno degli altri giornali avrebbe potuto battere. Raddrizzò la schiena e cominciò a fare la ricerca al computer. Una parte delle informazioni sugli uomini in cui i ragazzi si erano trasformati si poteva trovare nei database pubblici ed era sempre un buon punto di partenza. Inoltre aveva i suoi appunti dell’intervista con John. Gli altri quattro avrebbe cercato di rintracciarli nel corso della giornata. Molto lavoro concentrato in poco tempo, ma se fosse riuscito come voleva lui il risultato poteva essere davvero buono. Gli venne un’altra idea e si affrettò ad annotarla sul blocco. Avrebbe dovuto parlare con Gösta Flygare, che all’epoca era stato sul posto. Con un po’ di fortuna, il poliziotto avrebbe potuto dirgli qualcosa delle impressioni avute durante gli interrogatori con i ragazzi, il che avrebbe dato all’articolo quel pizzico in più che serviva. Il pensiero di Gimle continuava ad assillarlo, ma Kjell lo respinse con decisione. Non era più responsabilità sua e magari non significava proprio niente. Prese il cellulare e cominciò a fare telefonate. Non aveva tempo di rimuginare. Percy preparò lentamente la valigia. Non sarebbe andato alla festa del sessantesimo compleanno. Erano bastate un paio di telefonate per sapere che Pyttan non solo se n’era andata ma si era anche trasferita a casa del festeggiato. La mattina dopo sarebbe salito sulla sua Jaguar e partito per Fjällbacka. Non era sicuro che fosse una buona idea, ma la telefonata di Leon era stata la conferma che la sua vita stava andando in pezzi, e a quel punto cos’aveva da perdere? Come sempre, quando Leon parlava tutti ubbidivano. Era il leader fin da allora ed era strano e anche un po’ inquietante che avesse la stessa autorevolezza a tutti quegli anni di distanza. Forse la vita sarebbe stata diversa se non avesse eseguito i suoi ordini, ma non voleva pensarci. Aveva rimosso gli eventi di Valö per un sacco di tempo e non era mai tornato sull’isola. Quando erano saliti in barca, quella vigilia di Pasqua, non si era neanche voltato. Di lì a poco sarebbe stato costretto a ricordare di nuovo. Sapeva che sarebbe stato meglio fermarsi a Stoccolma, ubriacarsi fino a non capire più niente e restare in Karlavägen a guardare la vita passare mentre aspettava che i creditori bussassero alla porta, ma la voce di Leon l’aveva privato della forza di volontà, proprio come allora. Il suono del campanello lo fece sussultare. Non aspettava visite e Pyttan aveva già portato via tutto ciò che avesse un valore. Non si faceva illusioni sul fatto che cambiasse idea e tornasse. Non era stupida: aveva intuito che lui avrebbe perso tutto e se l’era battuta in tempo. In un certo senso la capiva. Era cresciuto in un mondo in cui ci si sposava con qualcuno che aveva qualcosa da offrire, come una sorta di aristocratico baratto. Aprì la porta. Fuori c’era l’avvocato Buhrman. «Avevamo un appuntamento?» Percy frugò nella memoria. «No.» L’avvocato fece un passo avanti costringendolo ad arretrare e farlo entrare. «Avevo alcuni impegni in città e in realtà sarei dovuto andare a casa nel pomeriggio, ma si tratta di un’emergenza.» Buhrman evitava il suo sguardo e Percy sentì che le ginocchia cominciavano a tremare. Guai in vista. «Prego» disse cercando di mantenere salda la voce. Nella testa risentiva le parole del padre: qualsiasi cosa accada, non mostrarti mai debole. Di colpo i ricordi delle occasioni in cui non era riuscito a seguire quel consiglio, accasciandosi a terra in lacrime, gli si presentarono prepotenti alla mente. Deglutì e chiuse gli occhi. Non era il momento giusto per lasciare spazio al passato. Il giorno dopo sarebbe bastato. Doveva sapere cosa voleva Buhrman. «Un goccio di whisky?» chiese andando al carrello degli alcolici e versandone un bicchiere per sé. L’avvocato si sedette lentamente sul divano. «No, grazie.» «Caffè?» «No, grazie. Siediti.» Buhrman batté il bastone a terra e Percy ubbidì. Rimase in silenzio mentre l’avvocato parlava, annuendo solo di tanto in tanto per indicare che capiva ma senza battere ciglio. La voce del padre echeggiava sempre più forte tra le tempie: non mostrarti mai debole. Quando Buhrman se ne fu andato, continuò a preparare la valigia. C’era una sola cosa da fare. Quella volta, tanto tempo prima, era stato debole e si era lasciato sconfiggere dal male. Chiuse la cerniera della valigia e si sedette sul letto, lo sguardo fisso davanti a sé. La sua vita era in briciole. Niente aveva più alcun significato. Ma non si sarebbe mai più mostrato debole. Fjällbacka 1939 Mentre facevano colazione, Laura osservò il marito. Erano sposati da un anno. Il giorno stesso in cui aveva compiuto diciotto anni aveva accettato l’offerta di matrimonio di Sigvard e solo qualche mese dopo si era tenuta in giardino la cerimonia per pochi intimi. Lui aveva cinquantatré anni e sarebbe potuto essere suo padre, ma era ricco e le avrebbe garantito un futuro senza preoccupazioni. Aveva scritto una lista obiettiva di pro e contro e gli argomenti a favore avevano prevalso. L’amore era per i folli, un lusso che una donna nella sua posizione non poteva permettersi. «I tedeschi hanno invaso la Polonia» disse Sigvard eccitato. «Ed è solo l’inizio, te lo dico io.» «A me la politica non interessa.» Laura si preparò una mezza fetta di pane e burro. Non osava mangiarne di più. La fame costante era il prezzo che doveva pagare per essere perfetta e a volte si rendeva conto di quanto fosse assurdo. Aveva sposato Sigvard per conquistare la sicurezza, per la certezza di avere sempre cibo in tavola, eppure era affamata esattamente come quando, da piccola, non poteva mangiare perché Dagmar spendeva in alcol invece che in cibo. Sigvard rise. «Citano anche tuo padre.» Lei gli rivolse un’occhiata gelida. Era disposta a tollerare molte cose, ma gli aveva detto più volte di non parlare di niente che avesse a che fare con quella pazza di sua madre. Non aveva bisogno che le venisse ricordato il passato. Dagmar era al sicuro, rinchiusa nell’ospedale Sankt Jörgen, e con un po’ di fortuna sarebbe rimasta lì per il resto della sua miserabile vita. «Questa potevi risparmiartela.» «Scusami, tesoro. Comunque non c’è niente da vergognarsi, anzi. Göring è il pupillo di Hitler, al momento è a capo della Luftwaffe. Mica male, no?» Annuì pensoso e s’immerse di nuovo nella lettura del giornale. Laura sospirò. Non era interessata e non voleva più saperne di Göring. Per anni aveva dovuto sopportare le fantasie malate della madre e non le andava a genio di dover sentir parlare e leggere di lui a ogni piè sospinto solo perché era uno dei più stretti collaboratori di Hitler. Dio santo! Cosa importava agli svedesi se la Germania invadeva la Polonia? «Vorrei riammobiliare un po’ il salone. Posso?» chiese con la sua voce più dolce. Non era passato molto tempo da quando aveva rinnovato completamente gli arredi e il risultato era buono, ma non ancora impeccabile. Non quanto il salone della sua casa delle bambole. Il divano che aveva comprato non si adattava alla perfezione e i prismi del lampadario di cristallo non erano lucidi e scintillanti come si aspettava prima di farlo appendere. «Mi metterai sul lastrico» disse Sigvard, rivolgendole però uno sguardo innamorato. «Fai quello che vuoi, amore. Basta che tu sia felice.» «Viene anche Anna, se per te va bene.» Erica guardò Ebba, incerta. Nell’attimo stesso in cui aveva invitato la sorella si era resa conto che forse non era stata una buona idea, ma le era sembrato che avesse bisogno di compagnia. «Va benissimo.» Ebba sorrise, anche se aveva ancora l’aria stanca. «Cos’hanno detto i tuoi? A Patrik è spiaciuto che ricevessero la notizia dell’incendio e degli spari in quel modo. Era convinto che tu gliene avessi parlato.» «Avrei dovuto farlo, ma ho rimandato la cosa. So bene quanto si preoccupano. Avrebbero voluto che rinunciassimo al progetto e tornassimo lì, dove sono loro.» «E non ci avete pensato?» chiese Erica mettendo un dvd del film tratto dai libri di Astrid Lindgren su Lotta di via dei Combinaguai. I gemelli, esausti dopo l’escursione da Gösta, dormivano profondamente e Maja era sul divano che aspettava l’inizio del film. Ebba rifletté un po’ e poi scosse la testa. «No, non possiamo tornare. Se questa cosa non funziona non so proprio come faremo. Mi rendo conto che è stupido restare e in effetti ho paura, ma nello stesso tempo... la cosa peggiore che potesse capitarci è già capitata.» «Potresti...» fece per dire Erica, che finalmente aveva preso il coraggio a due mani per chiedere cosa fosse successo al figlio, ma proprio in quel momento la porta si aprì ed entrò Anna. «C’è nessuno?» chiamò. «Vieni, vieni. Sto solo facendo partire il film su Lotta per la millesima volta.» «Ciao» disse Anna rivolgendo un cenno a Ebba e sorridendole cauta, quasi non sapesse esattamente come rapportarsi a lei dopo lo sconvolgente episodio del giorno prima. «Ciao Anna» rispose Ebba, anche lei un po’ riservata, ma nel suo caso sembrava che quell’atteggiamento fosse una questione di carattere, anche se Erica si chiedeva se prima della morte del figlio non fosse stata più aperta. La sigla del film cominciò ed Erica si alzò. «Andiamo in cucina.» Anna ed Ebba la precedettero e si sedettero. «Sei riuscita a dormire un po’?» chiese Anna. «Sì, ho fatto dodici ore di sonno filato, ma ho la sensazione di poterne dormire altrettante.» «Sicuramente è lo shock.» Erica entrò in cucina con una pila di fogli. «Ovviamente questa roba non copre tutti gli aspetti e immagino che tu ne abbia già vista una parte» disse depositandola sul tavolo. «Non ho visto proprio niente.» Ebba scosse la testa. «Forse vi sembrerà strano, ma non ho mai pensato molto al passato della mia famiglia fino a quando non abbiamo preso in mano la casa e ci siamo entrati. Stavo così bene, e poi mi sembrava tutto così... assurdo, credo.» Fissò la pila di carta come se potesse assorbirne il contenuto in blocco con un solo sguardo. «Bene.» Erica aprì un quaderno e si schiarì la voce. «Tua madre Inez era nata nel 1951 e al momento della scomparsa aveva solo ventitré anni. In realtà non ho scoperto molto sulla sua vita precedente al matrimonio con Rune. Era nata e cresciuta a Fjällbacka, a scuola aveva voti nella media e in pratica negli archivi non ho trovato altro su di lei. Si è sposata con tuo padre, Rune Elvander, nel 1970, e tu sei nata nel gennaio 1973.» «Il tre» annuì Ebba. «Rune era parecchio più vecchio di Inez, come penso tu sappia. Era nato nel 1919 e aveva tre figli da un precedente matrimonio: Johan, che al momento della scomparsa aveva nove anni, Annelie di sedici e Claes di diciannove. La madre Carla, prima moglie di Rune, era morta un anno scarso prima che lui si risposasse con Inez, e secondo le persone con cui ho parlato per tua madre non è stato facile entrare a far parte della famiglia.» «Mi chiedo il perché di un matrimonio con qualcuno tanto più vecchio di lei» disse Ebba. «Quando si sono sposati mio padre doveva avere...» fece un rapido calcolo mentale, «... cinquantun anni.» «Sembra che la tua nonna materna abbia avuto un ruolo importante nella decisione. Pare fosse... mah, non so come esprimere la cosa...» «Non ho nessun tipo di rapporto con mia nonna, quindi non farti problemi. La mia famiglia è a Göteborg. Questa parte della mia vita rappresenta più una curiosità che altro.» «Allora non te la prendi se dico che aveva la fama di essere un’arpia.» «Ma Erica!» esclamò Anna guardando la sorella con aria di rimprovero. Ebba rise forte per la prima volta da quando l’avevano conosciuta. «Niente paura.» Si rivolse ad Anna. «Non ci rimango male. Voglio sapere la verità, o almeno quella che è umanamente possibile scoprire.» «Va bene» borbottò lei, non del tutto convinta. Erica continuò: «Tua nonna si chiamava Laura ed era nata nel 1920.» «Quindi mia nonna aveva la stessa età di mio padre» constatò Ebba. «E questo mi fa venire ancora più dubbi su come possano essere andate le cose.» «Come ti dicevo, pare che Laura ci avesse messo del suo. Fu lei a far sposare tua madre con Rune. Però non ne ho la certezza, quindi devi prendere l’informazione con le pinze.» Erica cominciò a scavare nel mucchio e le mise davanti un foglio con la stampa di una foto. «Questa raffigura tua nonna Laura con tuo nonno Sigvard.» Ebba si abbassò per vedere meglio. «In effetti non ha l’aria molto contenta» disse guardando la donna dall’aspetto severo. Anche l’uomo accanto a lei non sembrava tanto più allegro. «Sigvard morì nel 1954, poco dopo che fu scattata questa foto.» «Sembrano benestanti» disse Anna avvicinandosi a sua volta al foglio. «Infatti» annuì Erica. «Per lo meno fino alla morte di Sigvard, perché in seguito venne fuori che aveva fatto una serie di pessimi affari. Non erano rimasti molti soldi e dato che Laura non lavorava il capitale si erose lentamente. Se Inez non si fosse sposata con Rune, probabilmente la madre sarebbe rimasta senza un soldo.» «Mio padre era ricco?» chiese Ebba. Aveva sollevato il foglio e lo stava studiando per non perdere neanche un dettaglio. «Non direi ricco, ma benestante sì. A sufficienza per garantire a Laura una sistemazione più che dignitosa sulla terraferma.» «Però quando i miei sparirono lei non era più in vita, giusto?» Erica sfogliò il blocco che aveva davanti. «Esatto. Laura morì d’infarto nel 1973. A Valö, tra l’altro. Fu Claes, il figlio maggiore di Rune, a trovarla priva di vita sul retro della casa.» Erica s’inumidì il pollice, prese a sfogliare la pila e poco dopo tirò fuori la fotocopia di un articolo di giornale. «Ecco, c’è scritto qui sul Bohusläningen.» Ebba prese il foglio e lesse. «Pare che mia nonna fosse una celebrità da queste parti.» «Già. Sapevano tutti chi era Laura Blitz. Sigvard aveva accumulato i soldi grazie alla sua compagnia di navigazione e si sussurrava che durante la Seconda guerra mondiale avesse fatto affari con i tedeschi.» «Erano nazisti?» chiese Ebba inorridita, alzando gli occhi su Erica. «Non so quanto fossero coinvolti» rispose lei esitante, «ma era risaputo che i tuoi nonni avevano determinate simpatie.» «Anche mia madre?» domandò Ebba con gli occhi sbarrati e Anna lanciò uno sguardo intimidatorio alla sorella. «Non mi risulta.» Erica scosse la testa. «Una cara ragazza ma un po’ ingenua: è così che Inez viene descritta per lo più. E molto sottomessa a tua nonna.» «Questo potrebbe spiegare il matrimonio con mio padre.» Ebba si morse il labbro. «Non era anche lui molto autoritario? Oppure è una rappresentazione che mi sono fatta io solo perché era direttore di un collegio?» «No, pare sia proprio così. Si dice che fosse una persona dura e severa.» «Mia nonna era originaria di Fjällbacka?» Ebba riprese in mano la foto della donna dall’aria arcigna. «Sì, la sua famiglia viveva qui da generazioni. La madre si chiamava Dagmar ed era nata a Fjällbacka nel 1900.» «Quindi quando ha avuto mia nonna aveva... vent’anni. Be’, a quell’epoca non era insolito avere figli così giovani. E il padre chi era?» «Nei registri c’è scritto “padre ignoto”. E Dagmar era un personaggio.» Erica s’inumidì di nuovo il dito e sfogliò finché non trovò una pagina quasi in fondo al mucchio. «Questo è un estratto del casellario giudiziale.» «Condanna per meretricio? Quindi la nonna materna di mia madre faceva la puttana?» Ebba guardò Erica, sorpresa. «Era una ragazza madre con una figlia illegittima e probabilmente si manteneva come poteva. Non deve aver avuto vita facile. Fu anche condannata per furto a più riprese. Dagmar era considerata un po’ tocca e beveva troppo. Ci sono documenti che attestano lunghi ricoveri in ospedali psichiatrici.» «Che infanzia terribile deve aver avuto mia nonna» disse Ebba. «Non c’è da meravigliarsi che sia diventata perfida.» «Infatti. Crescere con Dagmar non deve essere stato facile. Oggi il fatto che una bambina debba vivere con una madre del genere sarebbe uno scandalo, ma allora si era molto indietro e inoltre vigeva uno sprezzo totale nei confronti delle ragazze madri.» Erica aveva dedicato tante ore a documentarsi sulla storia di quelle donne che per lei erano persone estremamente concrete. In realtà non sapeva perché fosse risalita tanto indietro nel tempo quando aveva cominciato a documentarsi sul mistero della scomparsa della famiglia Elvander. Ma il loro destino l’aveva intrigata e così aveva continuato a scavare nel passato. «Cosa ne è stato di Dagmar?» chiese Ebba. Erica le tese un altro foglio: la copia di una foto in bianco e nero che sembrava essere stata scattata durante un processo. «Dio santo, è lei?» «Fa’ vedere...» disse Anna, ed Ebba le mostrò il foglio. «Quando è stata scattata? Sembra terribilmente vecchia e sciupata.» Erica guardò i suoi appunti. «La foto è del 1945, quindi aveva quarantacinque anni. Gliel’hanno fatta mentre era ricoverata al Sankt Jörgen di Göteborg.» Erica fece una pausa a effetto. «Cioè quattro anni prima che sparisse.» «Sparisse?» chiese Ebba. «Sì, sembra che sia un evento ricorrente nella famiglia. L’ultima annotazione che si trova su Dagmar risale al 1949. Dopo sembra che sia svanita nel nulla.» «Laura non sapeva niente?» «A quanto mi risulta, aveva interrotto i rapporti con la madre da un pezzo. Era già sposata con Sigvard e aveva una vita completamente diversa da quella che era stata costretta a condurre con Dagmar.» «Nessuno aveva delle ipotesi su dove potesse essere finita?» chiese Anna. «Sì, la più accreditata era che, ubriaca fradicia, fosse annegata in mare. Ma il corpo non fu mai ritrovato.» «Aiuto» disse Ebba riprendendo in mano la foto di Dagmar. «Una bisnonna ladra e puttana che poi è svanita nel nulla. Non so come riuscirò a digerire tutta questa roba.» «E non è finita.» Erica si guardò intorno sul tavolo godendo nel sentire che aveva tutta l’attenzione puntata su di sé. «La madre di Dagmar...» «Sì?» la incalzò Anna, impaziente. «No, facciamo così: prima pranziamo e poi andiamo avanti» disse Erica senza avere in realtà nessuna intenzione di farlo davvero. «Smettila!» esclamarono in coro Ebba e Anna. «Vi dice niente il nome Helga Svensson?» Ebba sembrò riflettere qualche secondo ma poi scosse la testa, esitante. Anna rimase in silenzio con la fronte aggrottata. Poi guardò Erica e negli occhi le si accese una luce. «La fabbricante di angeli» disse. «Cosa?» fece Ebba. «Fjällbacka non è famosa solo per Kungsklyftan e Ingrid Bergman» spiegò Anna. «Abbiamo anche il dubbio onore di essere il paese nativo della fabbricante di angeli Helga Svensson, che se non sbaglio venne decapitata nel 1909.» «1908» precisò Erica. «Decapitata per cosa?» Ebba sembrava ancora confusa. «Aveva ucciso dei neonati abbandonati che le erano stati dati in affido, annegandoli in un catino. Fu scoperta solo quando una delle madri cambiò idea e venne a riprendersi il piccolo. Non trovandolo, nonostante fosse più di un anno che Helga scriveva lettere su di lui, s’insospettì e andò alla polizia. Le credettero e una mattina presto fecero irruzione in casa di Helga, dove c’erano anche il marito e alcuni bambini, di cui una era figlia loro e gli altri, in affido, avevano la fortuna di essere ancora vivi.» «E quando scavarono nel pavimento sterrato della cantina ci trovarono otto cadaveri di neonati» concluse Anna. «Dio che orrore!» disse Ebba con aria nauseata. «Però non capisco cosa c’entri con la mia famiglia.» «Helga era la madre di Dagmar» rispose Erica. «La fabbricante di angeli Helga Svensson era la madre di Dagmar, e cioè la nonna della tua nonna materna.» «Mi stai prendendo in giro?» Ebba la guardò incredula. «È tutto vero. Forse adesso capisci perché quando Anna mi ha detto che realizzi gioielli a forma di angeli ho trovato che fosse una strana coincidenza.» «Ho l’impressione che forse avrei dovuto lasciare sepolto tutto questo» disse Ebba, anche se non sembrava convinta. «Io invece lo trovo emozionante...» cominciò Anna, ma sembrò pentirsi delle parole usate. Si girò verso Ebba e le disse in tono di scuse: «Perdonami, non intendevo...» «È emozionante anche per me» la rassicurò Ebba. «E vedo anch’io il paradosso dei miei ciondoli. Strano. Suscita delle domande sul destino.» Negli occhi le passò un’ombra scura ed Erica ebbe il sospetto che pensasse al figlioletto. «Otto bambini» disse poi lentamente. «Otto neonati sepolti sotto il pavimento di una cantina.» «Già. Cos’ha nella testa una persona che commette un delitto del genere?» si chiese Anna. «Cosa ne fu di Dagmar quando giustiziarono Helga?» Le braccia conserte sul petto, Ebba appariva più fragile che mai. «Venne decapitato anche il padre» rispose Erica. «Era stato lui a seppellire i corpi e per questo fu considerato complice degli omicidi, sebbene fosse stata Helga ad annegare i piccoli. Così Dagmar rimase orfana e finì a casa di un contadino alle porte di Fjällbacka per diversi anni. Non so che vita facesse lì, ma immagino che non fosse facile, essendo la figlia di un’infanticida. La gente di qui non doveva aver perdonato tanto facilmente un peccato del genere.» Ebba annuì. Aveva l’aria esausta ed Erica decise che per il momento poteva bastare. Era ora di pranzo e poi voleva controllare il cellulare per vedere se Gösta si era fatto vivo. Sperava intensamente che avesse avuto una risposta da Olle il rigattiere e che finalmente la fortuna girasse. Una mosca ronzava contro la finestra, gettandosi una volta dopo l’altra contro il vetro in una battaglia persa in partenza. Doveva chiedersi come mai, pur non essendoci un ostacolo visibile, rimbalzasse continuamente contro qualcosa. Mårten capiva perfettamente come si sentiva. La guardò per un po’ prima di tendere lentamente la mano verso la finestra, unire pollice e indice in una specie di pinzetta e catturarla. La studiò affascinato mentre premeva i polpastrelli fino ad appiattirla completamente per poi pulirseli sul telaio. Senza il ronzio, nella stanza regnava il silenzio più completo. Era seduto sulla poltroncina da ufficio di Ebba e davanti aveva gli strumenti che lei usava per realizzare i suoi lavori. Un angelo ancora a metà si trovava sul tavolo e Mårten si chiese quale dolore fosse destinato a lenire. Non era detto che fosse così: non tutte le catenine venivano ordinate in memoria di un defunto. C’era chi le comprava solo perché erano belle, ma quella in particolare sembrava richiesta da qualcuno in lutto. Da quando era morto Vincent aveva cominciato a percepire il dolore delle altre persone senza neanche vederle. Prese in mano l’angioletto incompleto e seppe con sicurezza che era destinato a qualcuno che era tormentato dallo stesso senso di vuoto e di mancanza di significato che provavano loro. Strinse più forte. Ebba non capiva che, insieme, avrebbero potuto colmare una parte di quel vuoto. Sarebbe bastato che lei gli permettesse di tornarle vicino. E che ammettesse la propria colpa. Per molto tempo lui era stato accecato dai rimorsi, ma da un po’ di tempo aveva cominciato a capire con sempre maggiore chiarezza che la colpa era di Ebba. Se solo fosse riuscita a riconoscerlo l’avrebbe perdonata e le avrebbe dato un’altra possibilità. Ma lei non diceva niente e si limitava a guardarlo con aria di accusa, cercandogli la colpa negli occhi. Lo teneva a distanza, e lui non riusciva a capirlo. Dopo tutto quello che era successo avrebbe dovuto lasciarsi accudire, appoggiarsi a lui. Prima era lei a governare tutto: dove abitare, dove andare in vacanza, quando fare dei figli... e anche quella mattina aveva deciso lei. La gente si lasciava sempre ingannare dagli occhi azzurri e dal fisico minuto, la vedeva timida e accomodante, ma non era così. Da quel momento in poi sarebbe stato lui a decidere. Si alzò e gettò lontano l’angioletto che, coperto di qualcosa di rosso e appiccicoso, atterrò sul tavolo in mezzo al casino. Sorpreso, abbassò gli occhi sul proprio palmo, coperto di minuscoli tagli. Si pulì la mano sui pantaloni. Ebba doveva tornare. Era il momento di spiegarle alcune cose. Liv stava strofinando con gesti energici i mobili da giardino. Doveva farlo tutti i giorni se voleva tenerli puliti e continuò a sfregarli fino a far luccicare la plastica. Sotto il sole intenso, la schiena le si coprì di sudore. Dopo tutte le ore passate al capanno aveva assunto uno splendido colore dorato ma sotto gli occhi si vedevano dei cerchi scuri. «Secondo me non devi andarci» disse. «Perché dovreste fare una specie di rimpatriata proprio adesso? Lo sai quanto è precaria la situazione nel partito. Dobbiamo volare bassi finché...» S’interruppe di colpo. «Lo so anch’io, ma su certe cose non si può avere il controllo» disse John sollevando gli occhiali sulla fronte. Stava passando in rassegna i giornali. Ogni giorno leggeva i quotidiani nazionali e alcuni di quelli locali. Non era mai riuscito una volta a completare lo spoglio del mucchio di carta senza provare disgusto davanti alle idiozie che riempivano le colonne. Tutti quei liberali, giornalisti, commentatori e sedicenti esperti convinti di capire come andava il mondo, messi insieme, contribuivano a condurre alla rovina il popolo svedese, lentamente ma inesorabilmente. Era suo dovere aprire gli occhi alla gente. Il prezzo era alto, ma le guerre comportavano sempre delle perdite. E quella era una guerra. «Ci sarà anche l’ebreo?» Dopo aver deciso che le sedie erano abbastanza pulite, era passata al tavolo. John annuì. «Immagino che ci sia anche Josef, sì.» «E se qualcuno vi vede e vi fotografa insieme? Secondo te cosa succede se la foto finisce sul giornale? Prova solo a immaginare cosa direbbero i tuoi sostenitori. Ti metterebbero in discussione e forse saresti costretto a dimetterti e non possiamo lasciare che succeda. Non ora che manca così poco.» John rivolse gli occhi al porto evitando lo sguardo di Liv. Lei non sapeva niente. Come avrebbe potuto dirle del buio, del freddo e del terrore che occasionalmente cancellava ogni confine razziale? Lì e allora si era trattato di sopravvivere e lui e Josef erano legati per sempre, nel bene e nel male. Non sarebbe mai riuscito a spiegarlo a Liv. «Devo andarci» disse in un tono che non ammetteva repliche. Liv sapeva che non era il caso di contraddirlo ma continuò a borbottare tra sé e sé. John sorrise e guardò il bel viso che amava e la cui espressione rivelava una volontà di ferro. Insieme ne avevano passate tante, ma il buio poteva dividerlo solo con quelli che c’erano stati. Si sarebbero riuniti per la prima volta dopo tutti quegli anni, e sarebbe stata anche l’ultima. Il compito che aveva davanti era importante e l’avrebbe costretto a dare un taglio netto al passato. Quello che era successo nel 1974 era tornato a galla per un caso ma poteva sprofondare di nuovo nell’oblio, se solo fossero stati tutti d’accordo. Gli antichi segreti dovevano restare nel buio da cui erano scaturiti. L’unico che lo preoccupava era Sebastian, che già allora godeva della propria posizione di superiorità e poteva creare dei problemi. Ma se non si fosse riusciti a farlo ragionare c’erano altre strade da percorrere. Patrik inspirò profondamente. Annika stava finendo di predisporre le ultime cose in vista della conferenza stampa e i vari giornalisti, alcuni venuti fin da Göteborg, erano già arrivati. In qualche caso avrebbero riferito ai giornali a tiratura nazionale e quindi il giorno dopo la vicenda sarebbe comparsa anche sui quotidiani più importanti. Da quel momento in poi l’indagine si sarebbe trasformata in una specie di circo, lo sapeva per esperienza, e nel bel mezzo dell’arena Mellberg avrebbe giocato a fare il direttore. Anche questo lo sapeva per esperienza. Quando aveva saputo che era necessario organizzare in fretta una conferenza stampa, il commissario era fuori di sé dalla gioia. Probabilmente era in bagno a sistemarsi il riporto. Quanto a lui, Patrik era come al solito piuttosto agitato. Sapeva che, oltre a riferire sulle indagini senza rivelare troppo, avrebbe dovuto arginare i danni che la presenza di Mellberg comportava inevitabilmente. Nello stesso tempo, era comunque contento che la cosa non fosse esplosa sulla stampa già qualche giorno prima. Di solito tutto quello che succedeva in zona si veniva a sapere alla velocità della luce e gli eventi di Valö dovevano essere già arrivati all’orecchio di tutti gli abitanti di Fjällbacka. Era un puro caso che nessuno avesse fatto una soffiata fino a quel momento. Alla fine, però, la fortuna era venuta meno e ormai non c’era più modo di fermare le rotative. Un colpetto alla porta lo risvegliò dal suo cupo rimuginare. La porta si aprì ed entrò Gösta che si sedette senza aspettare di essere invitato a farlo. «Gli avvoltoi sono qui» disse. Abbassò gli occhi sulle mani appoggiate sulle ginocchia. Stava roteando i pollici. «Fanno il loro lavoro» rispose Patrik, anche se fino a un attimo prima aveva pensato ai rappresentanti della stampa negli stessi termini del collega. Non aveva senso vedere i giornalisti come degli avversari. A volte tornavano addirittura utili. «Com’è andata a Göteborg?» chiese Gösta, ancora senza guardarlo in faccia. «Benino, direi. Si è capito che Ebba non aveva detto ai genitori né dell’incendio né degli spari.» Gösta alzò gli occhi. «Come mai?» «Credo che non volesse preoccuparli. Sospetto che si siano lanciati sul telefono appena ce ne siamo andati e soprattutto la mamma avrebbe voluto partire seduta stante per Valö.» «Forse non è un’idea malvagia. Anzi, sarebbe ancora meglio che Ebba e Mårten se ne andassero da lì finché non avremo risolto il caso.» Patrik scosse la testa. «Ah be’, io non mi sarei fermato un minuto più del necessario se qualcuno avesse tentato di farmi fuori non una ma due volte.» «La gente è strana.» «Già. Comunque i genitori di Ebba sono in gamba.» «Quindi ti sono sembrate persone per bene?» «Sì, credo che sia stata fortunata a finire da loro. Sembra che abbia anche un buon rapporto con i fratelli. Tra l’altro è una zona carina, case piuttosto vecchie con un sacco di cespugli di rose.» «A sentirti si direbbe un bel posto in cui crescere.» «Purtroppo però non abbiamo trovato nessun filo conduttore per risalire al mittente dei biglietti di compleanno.» «Ah, non ne avevano conservato neanche uno?» «No, li hanno buttati via tutti. Ma erano solo auguri, niente di minaccioso come l’ultima cartolina. E pare che il timbro postale fosse di Göteborg.» «Strano.» Gösta ricominciò a studiarsi i pollici. «Ancora più strano è il fatto che ogni mese qualcuno mettesse dei soldi per Ebba su un conto corrente fino a quando ha compiuto diciotto anni.» «Cosa? In modo anonimo?» «Esatto. Quindi se riusciamo a rintracciarne la provenienza forse qualcosa troviamo. Lo spero, almeno. Dopotutto è probabile che si tratti della stessa persona che inviava i biglietti. Ma adesso devo andare.» Patrik si alzò. «C’è altro?» Scese un attimo di silenzio. Poi Gösta si schiarì la voce e alzò gli occhi su Patrik. «No, niente. No, no.» «Okay.» Patrik aprì la porta ed era appena uscito in corridoio quando il collega lo richiamò. «Patrik?» «Sì? La conferenza stampa comincia tra un minuto.» Un attimo di silenzio. Poi: «No, niente, lascia perdere.» «Va bene.» Patrik si avviò verso la sala in fondo al corridoio con la sensazione che avrebbe dovuto fermarsi e far sputare il rospo a Gösta. Poi entrò nella stanza e si concentrò sul compito che lo aspettava. Gli sguardi conversero su di lui mentre Mellberg era già davanti a tutti con un gran sorriso stampato sulla faccia. Almeno uno, alla stazione, era pronto ad affrontare la stampa. Josef chiuse la telefonata. Le gambe gli si piegarono, costringendolo a sedersi lentamente, con la schiena contro la parete. Fissò la tappezzeria a fiori dell’ingresso, rimasta la stessa da quando avevano comprato la casa. Rebecka avrebbe voluto cambiarla da tempo ma lui non aveva mai capito perché avrebbero dovuto spendere dei soldi per qualcosa che era ancora in ottimo stato. Quello che funzionava non si sostituiva e bisognava essere riconoscenti di avere un tetto sulla testa e cibo in tavola. Inoltre nella vita c’erano cose molto più importanti. Ma proprio nel momento in cui aveva perso la più importante in assoluto, Josef si stupì di non riuscire a smettere di guardare la tappezzeria. Era davvero orribile e gli venne da chiedersi se non avrebbe dovuto dar retta a Rebecka e lasciargliela cambiare. Forse avrebbe fatto bene ad ascoltarla di più su tutto? Era come se di colpo riuscisse a vedersi dall’esterno. Un uomo piccolo e presuntuoso. Un uomo convinto che i sogni potessero realizzarsi, sicuro di essere destinato a grandi imprese. E invece eccolo lì, smascherato come un folle ingenuo, e la colpa era solo sua. Fin da quando era stato circondato dal buio, fin da quando l’umiliazione gli aveva indurito il cuore, era riuscito a ingannare se stesso con la certezza che un giorno avrebbe ottenuto giustizia. Naturalmente non era stato così. Il male era più potente. C’era stato nella vita dei suoi genitori e, sebbene loro non gliel’avessero mai detto, sapeva che li aveva costretti ad azioni empie. Anche lui era stato contagiato dal male ma nella sua hybris si era convinto che Dio gli avesse concesso un’occasione per purificarsi. Batté la testa contro il muro, prima piano e poi via via più forte, sentendo che era giusto così. Di colpo ricordò di aver trovato, allora, un modo per trascendere il dolore fisico. Per i suoi genitori il fatto di dividere la sofferenza con altri non aveva rappresentato un conforto e lo stesso valeva per lui. Anzi, la vergogna era ancora più grande. E lui era stato così ingenuo da pensare di potersi liberare anche di quella, se solo la penitenza fosse stata abbastanza grande. Si chiese cos’avrebbero detto Rebecka e i figli se avessero saputo, se fosse venuto tutto a galla. Leon voleva che si riunissero, voleva risvegliare la sofferenza che avrebbe dovuto essere dimenticata. Quando gli aveva telefonato, la sera prima, il terrore lo aveva quasi paralizzato. La minaccia sarebbe diventata realtà e lui non avrebbe potuto fare niente per impedirlo. Ma ormai non aveva più importanza: era troppo tardi. Era impotente come allora e non aveva più la forza di combattere, anche perché non sarebbe servito a niente. Fin dall’inizio, quel sogno c’era stato solo nella sua testa e Josef si rimproverava soprattutto di non essersene reso conto. Carinhall 1949 Dagmar pianse, e il dolore si mescolò alla felicità. Finalmente era arrivata da Hermann. Per un po’ aveva disperato. I soldi che le aveva dato Laura erano bastati solo per un tratto. Troppi se n’erano andati per placare la sete e di alcuni giorni non aveva quasi nessun ricordo, ma ogni volta si era rialzata ed era andata avanti, perché il suo Hermann l’aspettava. Certo, sapeva benissimo che non era sepolto a Carinhall, come le aveva fatto notare maligno uno dei tanti compagni di viaggio che aveva incontrato in treno, quando aveva detto dove era diretta. Ma per lei non era importante dove si trovava il corpo. Aveva letto gli articoli e visto le foto. Carinhall era stata la sua casa ed era lì che si trovava la sua anima. C’era anche Carin Göring. Persino dopo la morte quella schifosa aveva tenuto Hermann nella sua stretta. Dagmar chiuse le mani a pugno nelle tasche del cappotto e spaziò con lo sguardo sulla proprietà, respirando affannosamente. Era stato il regno di Hermann, ma ormai era tutto distrutto. Sentì risalire le lacrime agli occhi. Come poteva essere accaduto? La tenuta era in rovina e il giardino che in passato doveva essere stupendo era inselvatichito e devastato. Il bosco frondoso che un tempo circondava la proprietà premeva sempre più da vicino. Aveva dovuto camminare per diverse ore per arrivare fino a lì. Da Berlino aveva fatto l’autostop e poi era andata a piedi fino al bosco a nord della città, dove aveva letto che si trovava Carinhall. Non era stato facile trovare un passaggio. La gente la scrutava diffidente e poi lei non sapeva neanche una parola di tedesco, ma aveva ripetuto “Carinhall” e alla fine un signore piuttosto anziano l’aveva fatta salire a malincuore sulla propria auto. A un bivio dove la strada si divideva le aveva fatto capire che doveva proseguire nell’altra direzione e lei era dovuta scendere. Nell’ultimo tratto i piedi le avevano fatto sempre più male ma era andata avanti. Desiderava solo essere vicina a Hermann. Si aggirò tra le rovine, cercando. Le due garitte all’imbocco del viale mostravano quanto dovevano essere imponenti quegli edifici un tempo, e qui e là si vedevano resti di pareti e pietre decorative che le permettevano di immaginare facilmente il fasto della proprietà. E se non fosse stato per Carin, quel posto avrebbe portato il suo nome. Sopraffatta dall’odio e dal dolore, Dagmar cadde singhiozzando in ginocchio. Ricordava ancora quella dolce notte estiva in cui aveva sentito sulla pelle l’alito di Hermann, i suoi baci su tutto il corpo. Era stata la notte in cui aveva trovato e perduto tutto in un colpo solo. La vita di Hermann sarebbe stata tanto più bella se avesse scelto lei. Si sarebbe presa cura di lui e non avrebbe permesso, come invece aveva fatto Carin, che diventasse il rudere d’uomo che aveva visto in ospedale. Sarebbe stata abbastanza forte per tutti e due. Prese una manciata di terra e la lasciò cadere tra le dita. Il sole le bruciava la nuca e in lontananza si sentivano ululare i cani selvatici. Poco più in là c’era una statua in pezzi, rovesciata a terra. Mancavano il naso e un braccio e gli occhi di pietra guardavano il cielo senza vederlo. Di colpo si accorse di essere stanchissima. La pelle surriscaldata aveva bisogno d’ombra. Il viaggio era stato lungo e la nostalgia infinita, ma finalmente Dagmar poteva stendersi e chiudere gli occhi un istante. Si guardò intorno in cerca di un angolo fresco. Di fianco a una scala che non portava più da nessuna parte si era rovesciata una colonna finendo per appoggiarsi al gradino più alto e lì sotto c’era una piccola zona d’ombra. Troppo stanca per alzarsi, Dagmar strisciò sulla terra irregolare fino alla scala, si rannicchiò il più possibile e con un sospiro di sollievo s’infilò nell’apertura e chiuse gli occhi. Il viaggio che l’avrebbe portata da lui, da Hermann, era iniziato quella notte di giugno. Finalmente poteva riposare. La conferenza stampa era finita da un paio d’ore e si trovavano tutti riuniti nella saletta del personale. Ernst, che prima era rimasto chiuso nell’ufficio di Mellberg, era stato liberato e come al solito se ne stava accucciato ai piedi del suo padrone. «Be’, è andata bene, no?» disse il commissario sorridendo soddisfatto. «Non sarebbe meglio che tu andassi a casa a riposare, Paula?» tuonò poi, facendo fare un salto sulla sedia a Patrik. Paula lo fulminò con un’occhiata. «Decido io quando ho bisogno di riposo, grazie.» «Non capisco cosa ci fai qui visto che sei in ferie. E sei persino andata avanti e indietro da Göteborg. Se qualcosa non va per il verso giusto ricordati che...» «Sì, mi sembra che la situazione fosse sotto controllo» intervenne Patrik per fermare il litigio imminente. «Credo che i ragazzi si ritroveranno sotto un fuoco incrociato.» In realtà era assurdo chiamare ragazzi quegli uomini che ormai avevano superato la cinquantina, ma quando pensava a loro erano i cinque allievi della foto che vedeva davanti agli occhi, in abiti anni Settanta e con un che di vigile nello sguardo. «Gli sta bene. Soprattutto a quel John» disse Mellberg grattando Ernst dietro le orecchie. «Patrik?» Annika fece capolino dalla porta e gli fece cenno di seguirla. Lui si alzò e andò in corridoio, dove lei gli porse il telefono portatile. «È Torbjörn. Pare che abbiano trovato qualcosa di interessante.» Patrik sentì aumentare il battito. Prese il telefono, andò nel suo ufficio e chiuse la porta. Ascoltò quello che aveva da dirgli Torbjörn per un buon quarto d’ora e gli fece alcune domande a sua volta. Quando ebbe finito si affrettò a tornare nella saletta del personale dove lo aspettavano Paula, Mellberg, Gösta e anche Annika, che si era unita a loro. Sebbene fosse tardi, nessuno accennò ad andarsene. «Cos’ha detto?» chiese la segretaria. «Calma. Prima mi verso un po’ di caffè.» Con gesti esageratamente lenti, Patrik andò alla macchina del caffè e si allungò verso la caraffa ma, prima che avesse il tempo di afferrare il manico, Annika si alzò, gli riempì una tazza facendo fuoriuscire parte del caffè e l’appoggiò davanti alla sua sedia. «Fatto. Adesso siediti e spiegaci cosa ti ha detto Torbjörn.» Patrik sogghignò ma ubbidì. Si schiarì la voce. «Torbjörn è riuscito a trovare una chiara impronta digitale sul retro del francobollo attaccato al biglietto spedito da “G”. Questo ci dà la possibilità di confrontarla con eventuali indiziati.» «Ottimo» disse Paula appoggiando le gambe gonfie su una sedia. «Ma hai la faccia di un gatto che ha appena ingoiato un canarino, quindi ci dev’essere dell’altro.» «Esatto.» Patrik bevve un sorso di caffè caldissimo. «Si tratta della pallottola.» «Quale?» chiese Gösta. «È proprio lì il bello. La pallottola trovata incastrata sotto il listello del pavimento e quelle estratte in barba al regolamento dalla parete della cucina dopo il tentativo di omicidio nei confronti di Ebba...» «Ma sì, sì.» Mellberg agitò una mano. «Ho capito l’antifona.» «... probabilmente sono state sparate dalla stessa arma.» Quattro paia di occhi increduli lo fissarono. Patrik annuì. «Sembra assurdo ma è così. Quando, nel 1974, diversi membri della famiglia Elvander sono stati uccisi, con ogni probabilità è stata usata la stessa arma che ieri ha sparato a Ebba Stark.» «Può davvero essere lo stesso assassino dopo tutti questi anni?» Paula scosse la testa. «Sembra folle!» «Io ho creduto fin dall’inizio che i tentativi di far fuori lei e suo marito avessero a che fare con la scomparsa della famiglia, e questa è la conferma.» Patrik spalancò le braccia mentre nella mente gli riecheggiavano domande simili poste durante la conferenza stampa. Aveva potuto solo limitarsi a rispondere che era una teoria, ma finalmente aveva la prova dei sospetti che aveva nutrito fin da subito. «Inoltre l’analista del laboratorio è riuscito a stabilire, basandosi sulle striature, l’arma usata» aggiunse. «Quindi dobbiamo controllare se qualcuno in zona ha o ha avuto un revolver di marca Smith & Wesson calibro 38.» «Volendo vedere gli aspetti positivi, questo significa che l’arma con cui è stata assassinata la famiglia Elvander non si trova in fondo al mare» osservò Mellberg. «Diciamo che non era lì ieri quando ha sparato a Ebba, ma può esserci finita dopo» puntualizzò Patrik. «Io non credo» disse Paula. «Se qualcuno ha conservato l’arma per tanto tempo faccio fatica a immaginare che se ne sia disfatto adesso.» «Può darsi. Forse la persona in questione la considera addirittura un trofeo e la tiene come una sorta di ricordo di quegli avvenimenti. In ogni caso queste nuove informazioni dimostrano che dobbiamo concentrarci ancora di più sull’analisi dei fatti del 1974. Dovremo interrogare di nuovo i quattro con cui abbiamo parlato e orientarci in particolare sulla sequenza degli avvenimenti di quella giornata. E bisogna anche trovare al più presto Percy von Bahrn. Naturalmente avremmo già dovuto farlo, ma la responsabilità è mia. Lo stesso vale per quell’insegnante ancora vivo. Come si chiamava? Quello che era in vacanza per Pasqua, dai...» Patrik fece schioccare le dita. «Ove Linder» gli venne in aiuto Gösta, che di colpo aveva assunto un’espressione abbattuta. «Esatto, Ove Linder. Non abita a Hamburgsund adesso? Con lui dovremo parlare al più presto, possibilmente domattina. Pare che abbia informazioni preziose su cosa succedeva nella scuola. Ci andiamo domani io e te.» Si allungò a prendere carta e penna dal tavolo e cominciò a fare uno schizzo dei compiti che andavano svolti al più presto. «Ecco...» disse Gösta passandosi una mano sul mento. Patrik continuò a scrivere. «Nella giornata di domani dobbiamo parlare con i cinque ragazzi. Bisognerà dividerceli. Paula, magari tu puoi anche scavare nella faccenda dei soldi inviati mensilmente sul conto per Ebba?» Paula s’illuminò. «Certo. Anzi, ho già contattato la filiale della banca per chiedere assistenza.» «Senti, Patrik» ripeté Gösta, ma lui non ascoltava, preso com’era a suddividere gli incarichi. «Patrik!» Tutti si voltarono a guardarlo. Non era da lui alzare la voce a quel modo. «Sì? Cosa c’è?» Patrik lo scrutò e si rese conto che probabilmente non avrebbe affatto apprezzato quello che il collega faceva tanta fatica a dire. «Ecco, vedi, quell’insegnante, Ove Linder...» «Sì?» «Qualcuno è già andato a parlargli.» «Qualcuno?» chiese Patrik aspettando la continuazione. «Ho pensato che non sarebbe stato un male se al caso avesse lavorato qualche persona in più. Non si può negare che è molto brava a scoprire dettagli e dopotutto noi non abbiamo grandi risorse. Così mi sono detto che un piccolo aiuto poteva servirci. Come hai appena spiegato anche tu, ci sono alcune cose che avremmo già dovuto fare, e in effetti è andata così. Quindi in fondo è positivo.» Gösta prese fiato. Patrik lo guardò. Gli aveva dato di volta il cervello? Stava cercando di giustificare il fatto che aveva agito alle spalle dei colleghi facendolo passare per un vantaggio? Poi fu colto da un sospetto che sperava non si verificasse fondato. «Brava, hai detto? Sta parlando di mia moglie? Quindi è stata lei a parlare con quell’insegnante?» «Ehm... sì.» «Ma insomma, Gösta!» Paula sembrava essersi rivolta a un bambino colto a rubare un biscotto. «C’è altro che dovrei sapere?» disse Patrik. «È meglio che racconti tutto. Cos’ha combinato Erica questa volta? E anche tu, già che ci siamo!» Con un profondo sospiro, Gösta riferì il resoconto fattogli da Erica dopo la visita a Liza e quella a John, aggiungendo i fatti riferiti da Kjell sul passato del leader degli Amici della Svezia e la questione del biglietto che aveva trovato. Infine, dopo un attimo di esitazione, gli disse anche dell’intrusione in casa loro. Patrik si sentì gelare. «Cosa?» Gösta abbassò vergognoso lo sguardo a terra. «Eh no, adesso basta.» Patrik si alzò di scatto, uscì a precipizio dalla stazione e salì in macchina sentendo ribollire la rabbia. Dopo aver girato la chiavetta d’accensione si costrinse a fare alcuni respiri profondi. Poi premette l’acceleratore a tavoletta. Ebba non riusciva a smettere di guardare quelle foto. Aveva chiesto di essere lasciata da sola per un po’ e poi, preso tutto il materiale sulla sua famiglia, era salita nello studio di Erica. Dopo aver lanciato un’occhiata alla scrivania sovraccarica si era seduta sul pavimento e aveva sparso a ventaglio intorno a sé le copie delle foto. Quella era la sua famiglia, la sua origine. Pur essendo stata bene con i suoi genitori adottivi, a volte aveva provato invidia nei confronti di chi sentiva di appartenere a un albero genealogico. L’unica cosa a cui era legata lei era un mistero. Ricordava tutte le volte che era rimasta a guardare le foto incorniciate sul grande cassettone in soggiorno: nonni materni e paterni, zie e cugini... insomma, quelli che facevano sentire una persona un anello di una lunga catena. Ritrovarsi a guardare le foto dei suoi parenti le dava una sensazione strana e meravigliosa. Prese la foto della fabbricante di angeli. Che nome stupendo per qualcosa di tanto orribile. Avvicinò il foglio agli occhi e cercò di vedere se nello sguardo di Helga qualcosa svelasse gli atti malvagi che aveva compiuto. Non sapeva se la foto fosse stata scattata prima o dopo gli omicidi, ma probabilmente risaliva al 1902 perché la bambina ritratta con lei, che doveva essere Dagmar, era molto piccola. Indossava un vestitino chiaro a balze ed era ancora del tutto ignara del destino che l’aspettava. Dov’era finita? Annegata, come pensavano in tanti? La sua morte era stata la conclusione naturale di una vita andata in pezzi nell’attimo stesso in cui era venuto alla luce il crimine dei suoi genitori? E Helga aveva provato rimorso o almeno capito che, se fosse stata smascherata, sua figlia ne avrebbe sofferto le conseguenze, oppure era del tutto convinta che nessuno avrebbe sentito la mancanza di quei neonati non voluti? Le domande le si accavallavano nella mente e sapeva che non avrebbero mai avuto risposta. Eppure sentiva che tra lei e quelle donne c’era un legame. Osservò l’immagine di Dagmar. Il viso mostrava chiari i segni di una vita dura, ma si vedeva che un tempo era stata molto bella. Dove finiva nonna Laura quando sua madre veniva portata via dalla polizia o ricoverata a forza? A quanto aveva capito, non aveva altri parenti. C’erano degli amici che si occupavano di lei oppure la relegavano in un orfanotrofio o presso qualche famiglia? D’un tratto le venne in mente di aver pensato alle proprie radici nel periodo in cui aspettava Vincent. Dopotutto era anche la sua storia. Stranamente, dopo la nascita quei pensieri non l’avevano più sfiorata. Da un lato non aveva più avuto tempo di pensare a niente, dall’altro lui le aveva invaso l’esistenza con il suo buon odore, la testolina lanuginosa e le fossette nelle manine, e tutto il resto le era sembrato di nessuna importanza. Persino lei stessa non ne aveva più. Come Mårten, era diventata una specie di comparsa nel film su Vincent. Aveva adorato il suo nuovo ruolo, ma il vuoto che lui aveva lasciato era tanto più grande. L’aveva trasformata in una madre senza figli, una comparsa insignificante di un film in cui di colpo mancava il protagonista. Ma le foto davanti a lei la inserivano in un contesto che prima non aveva. Sentiva Erica armeggiare in cucina e i bambini strillare e fare chiasso, mentre lei era lì circondata dai suoi antenati. Ormai erano tutti morti, ma sapere che c’erano stati le era comunque di grande conforto. Tirò su le ginocchia verso il mento e si circondò le gambe con le braccia in un gesto protettivo. Si chiese come stesse Mårten. Non aveva quasi pensato a lui da quando era lì e a dire il vero non si curava di lui da quando era morto Vincent. Come avrebbe potuto farlo, quando il dolore aveva preso possesso di lei? Ma era come se il nuovo contesto in cui si sentiva inserita le avesse fatto capire che Mårten faceva parte di lei, perché Vincent li legava per sempre l’uno all’altra. Con chi, se non con lui, avrebbe potuto condividere i ricordi? Lui era stato al suo fianco, aveva accarezzato la pancia che cresceva e visto il cuore di Vincent pulsare sul monitor dell’ecografia. Le aveva asciugato il sudore dalla fronte, massaggiato la schiena e dato da bere durante il parto, quelle lunghe, terribili e insieme meravigliose ventiquattr’ore di lotta per far venire al mondo il loro bambino. Vincent aveva opposto resistenza, ma quando finalmente aveva battuto gli occhietti leggermente strabici verso di loro, Mårten le aveva stretto forte la mano senza cercare di nascondere le lacrime ma limitandosi ad asciugarsele con la manica. Poi avevano condiviso le notti di pianto, il primo sorriso, i dentini che spuntavano. Avevano fatto il tifo per Vincent quando si dondolava a quattro zampe per imparare a gattonare e Mårten aveva filmato il suo primo passetto incerto. Le prime parole, la prima frase e il primo giorno al nido; risate e pianti; giornate belle e giornate brutte. Mårten era l’unico che avrebbe davvero capito se lei ne avesse parlato. Non c’erano altri. Seduta sul pavimento, sentì che il cuore le si scaldava. Quel pezzetto rimasto duro e freddo si stava lentamente scongelando. Si sarebbe fermata lì quella sera. Poi sarebbe andata a casa. Da Mårten. Era venuto il momento di lasciar andare il senso di colpa e cominciare a vivere. Anna puntò la prua verso il largo e rivolse il viso al sole. Quella breve parentesi senza compagno e senza figli la riempiva di un inaspettato senso di libertà. Aveva chiesto in prestito a Patrik ed Erica la loro barca perché la Buster era senza benzina e le piaceva da morire governare quel beccaccino così familiare. La luce serale tingeva di oro cangiante la roccia che circondava il porto. Sentì una risata dal Café Bryggan. A giudicare dalla musica era di nuovo una serata danzante. Nessuno sembrava essersi ancora avventurato sulla pista, ma di lì a un paio di birre si sarebbe riempita. Lanciò un’occhiata alla borsa con i campioni delle stoffe appoggiata al centro della barca e si assicurò che la cerniera fosse ben chiusa. Ebba le aveva già viste e ne aveva subito trovate alcune che le piacevano, e voleva fossero mostrate anche a Mårten. Le sue parole le avevano fatto venire l’idea di andare a Valö già quella sera. All’inizio aveva esitato un po’: l’isola non era un posto sicuro, come aveva avuto modo di constatare già il giorno prima, e quell’improvvisata somigliava più a una delle cose che avrebbe fatto nella sua vecchia vita, quando raramente pensava alle conseguenze delle proprie azioni. Per una volta, però, aveva deciso di seguire l’istinto. Cosa poteva succedere, in realtà? Sarebbe andata lì, gli avrebbe mostrato il campionario e poi sarebbe tornata indietro. Era solo un modo per passare il tempo, si disse. Forse Mårten sarebbe stato contento di avere un po’ di compagnia. Ebba aveva deciso di fermarsi un’altra notte da Erica per esaminare in maniera più approfondita il materiale sulla famiglia. Anna sospettava che fosse un pretesto, ma era comprensibile che non fosse ansiosa di tornare sull’isola. Avvicinandosi al pontile vide che Mårten l’aspettava. Aveva chiamato per avvertirlo e lui probabilmente aveva tenuto d’occhio il mare dalla finestra. «Vedo che hai il coraggio di tornare nel selvaggio West» le disse con una risata, prendendo la prua. «Ho sempre amato sfidare il destino.» Anna lanciò la cima e lui ormeggiò la barca con gesti esperti. «Sembri già un vero lupo di mare» si complimentò lei indicando il nodo parlato doppio intorno a una delle bitte più esterne del pontile. «Se si va a vivere in un arcipelago, certe cose bisogna saperle fare.» Le tese una mano per aiutarla a scendere a terra. L’altra era fasciata. «Grazie. Ehi, cos’hai fatto alla mano?» Mårten guardò il bendaggio come se non l’avesse mai visto prima. «Oh, niente, cose che capitano quando si ristruttura una casa. È compreso nel lavoro.» «Wow, che cosa virile» disse Anna accorgendosi di avere un sorriso idiota stampato sulla faccia. Provò una punta di senso di colpa per essere lì a flirtare con il marito di Ebba, ma era solo per scherzo e del tutto innocuo, anche se doveva ammettere che lo trovava molto attraente. «Quella la prendo io.» Mårten le tolse dalla spalla la pesante tracolla con i campioni di stoffa e Anna lo seguì fino alla casa. «Normalmente avrei proposto di metterci in cucina, ma al momento c’è un po’ di corrente» disse Mårten quando entrarono. Anna rise. Si sentiva il cuore leggero. Parlare con una persona i cui pensieri non correvano tutto il tempo al suo incidente era liberatorio. «Anche in sala da pranzo qualche problemino c’è. Manca il pavimento» continuò lui strizzandole l’occhio. Il Mårten dall’aria cupa che aveva conosciuto prima era sparito, ma forse non era così strano. Anche Ebba era sembrata di umore più allegro quando Anna l’aveva vista a casa di Erica. «Se non hai niente in contrario a sederti per terra, secondo me la stanza migliore è la camera da letto di sopra.» Imboccò la scala senza aspettare risposta. «In effetti dà una sensazione strana occuparsi di queste cose dopo quello che è successo ieri» disse lei in tono di scuse. «Niente paura. La vita continua. In questo io ed Ebba ci somigliamo. Abbiamo tutti e due un notevole spirito pratico.» «Però avete un bel coraggio a restare.» Mårten alzò le spalle. «A volte non si ha scelta» disse appoggiando la borsa al centro della stanza. Anna si mise in ginocchio e cominciò a tirare fuori le stoffe disponendole una accanto all’altra sul pavimento. Poi cominciò a illustrare entusiasta quali si sarebbero potute utilizzare per mobili, tende e cuscini, e come abbinarle. Dopo un po’ smise di parlare e guardò Mårten. Invece che sulle stoffe, i suoi occhi erano puntati su di lei. «Ti vedo molto interessato» disse ironica, sentendo però avvampare le guance. Si portò i capelli dietro le orecchie in un gesto nervoso. Mårten continuò a guardarla. «Hai fame?» chiese. Lei annuì piano. «Sì, abbastanza.» «Bene.» Mårten si alzò di scatto. «Fermati qui e togli le stoffe. Arrivo subito.» Si dileguò al piano di sotto e Anna rimase seduta tra i riquadri sparsi intorno a lei sul bel pavimento in legno appena lamato. Il sole che filtrava obliquo dalla finestra le fece capire che era più tardi di quanto pensasse. Per un attimo pensò che doveva tornare a casa dai bambini, ma poi le venne in mente che non c’era nessuno. L’unica cosa che poteva aspettarsi era una cena solitaria davanti al televisore in una casa vuota, per cui tanto valeva fermarsi. Anche Mårten era solo e mangiare insieme sarebbe stato molto più piacevole. Inoltre stava già preparando qualcosa e sarebbe stato scortese da parte sua andarsene dopo aver già accettato. Cominciò a ripiegare i campioni con gesti nervosi. Quando ebbe finito e li ebbe sistemati in una pila su un cassettone addossato a una parete sentì i passi di Mårten sulle scale e il tintinnio di bicchieri. Poco dopo lo vide entrare con un vassoio in mano. «Sarà una cena stile Cajsa Warg: affettati, qualche formaggio e un po’ di pane tostato. Con un buon vino rosso forse può funzionare.» «Certo. Ma credo che per quanto mi riguarda mi fermerò a un bicchiere. Sarebbe uno scandalo in paese se venissi fermata per guida in stato di ebbrezza mentre rientro in porto.» «Ah be’, non voglio certo rendermi corresponsabile di uno scandalo!» Mårten appoggiò il vassoio e Anna sentì il cuore battere più forte. In realtà non si sarebbe dovuta fermare a mangiare formaggio e bere vino con un uomo che le faceva sudare i palmi delle mani. Nello stesso tempo, era proprio quello che voleva fare. Si allungò a prendere una fetta di pane. Due ore dopo si rese conto che si sarebbe fermata anche più a lungo. Non era una decisione conscia e non ne avevano parlato, ma le parole non servivano. Quando scese il crepuscolo Mårten accese qualche candela e nella luce delle fiammelle guizzanti Anna decise di vivere nel presente. Per un breve attimo voleva dimenticare tutto quello che era stato. Mårten la faceva sentire di nuovo viva. Adorava la luce serale. Era molto più indulgente e lusinghiera di quella impietosa del pieno sole. Ia scrutò il proprio viso allo specchio e si passò una mano sulla pelle liscia. Da quando si curava tanto del proprio aspetto? Ricordava che all’epoca in cui era giovane altre cose avevano avuto molta più importanza. Poi l’amore era diventata l’unica che avesse un significato e Leon era abituato a essere circondato dalla bellezza. Fin da quando i loro destini erano diventati uno solo, lui aveva cercato sfide sempre più grandi e pericolose. Quanto a lei, l’aveva amato con sempre maggiore intensità e dedizione. Aveva lasciato che i desideri di Leon governassero la sua vita e da allora non c’era più stato ritorno. Si avvicinò allo specchio per cercare di scorgere una traccia di ripensamento nel proprio sguardo. Finché Leon era stato legato a lei quanto lei lo era a lui, aveva sacrificato tutto, ma poi lui aveva cominciato a isolarsi e a dimenticare il destino che li univa. L’incidente gli aveva fatto capire che solo la morte avrebbe potuto separarli. Il dolore quando lo aveva estratto dalle lamiere dell’auto non era nulla rispetto a quello che avrebbe provato se lui l’avesse lasciata. Non sarebbe sopravvissuta, non dopo tutto ciò a cui aveva rinunciato per lui. Ora però non poteva più restare. Non capiva perché Leon avesse voluto tornare e non avrebbe dovuto permetterglielo. Perché immergersi nel passato, se comportava tanto dolore? Nonostante questo aveva ancora una volta assecondato il suo desiderio, ma era l’ultima volta. Non poteva stare a guardare mentre lui si gettava nella rovina. Non le restava che andare a casa e aspettare che lui la seguisse, in modo da poter continuare la vita che si erano costruiti insieme. Non era in grado di cavarsela da solo e se ne sarebbe accorto. Raddrizzò la schiena e lanciò una lunga occhiata a Leon, seduto di spalle sulla terrazza. Poi andò a fare le valigie. Quando sentì spalancarsi la porta d’ingresso, Erica era in cucina. Un attimo dopo Patrik irruppe nella stanza. «Cosa cazzo credi di fare, si può sapere?» urlò. «Perché non mi hai detto che qualcuno si è introdotto in casa nostra?» «Ma non sono neanche sicura che...» tentò di giustificarsi, pur sapendo che non aveva senso. La furia di Patrik era esattamente quella prevista da Gösta. «Gösta ha detto che sospettavi che fosse opera di John Holm, eppure hai taciuto. Quelle persone sono pericolose!» «Abbassa la voce, per favore. Ho appena addormentato i bambini.» In realtà glielo chiedeva anche per se stessa. Detestava i conflitti e quando qualcuno urlava il suo corpo si chiudeva completamente. Soprattutto se era Patrik a gridare, forse perché era così raro che alzasse la voce con lei. E quella volta era ancora peggio perché sapeva di dovergli dare ragione, almeno in parte. «Siediti e parliamone. Ebba è su nel mio studio e sta esaminando il materiale.» Si accorse che Patrik stava cercando di dominarsi facendo alcuni respiri profondi. Sembrò funzionare, anche se quando annuì e si sedette era ancora piuttosto pallido. «Spero che tu abbia una spiegazione a prova di bomba, sia per questa faccenda sia per il fatto che tu e Gösta avete agito alle mie spalle.» Erica gli si sedette davanti e abbassò gli occhi sulla tavola per qualche istante. Stava cercando di pensare a come esprimersi in modo da essere del tutto sincera nei confronti di Patrik e da apparire nello stesso tempo nella luce più favorevole possibile. Poi prese lo slancio e gli raccontò di come aveva contattato Gösta perché Patrik le aveva riferito quanto fosse coinvolto nel caso della scomparsa della famiglia Elvander. Ammise di non averglielo voluto dire perché sapeva che non avrebbe approvato e di aver convinto Gösta a collaborare. Patrik non sembrava affatto contento ma se non altro l’ascoltava. Quando passò alla visita a casa di John Holm e a come avesse scoperto che qualcuno aveva tentato di entrare nel suo computer, lui impallidì di nuovo. «Ti è andata bene che non te l’abbiano portato via. Immagino che ormai sia troppo tardi per far venire qui qualcuno che rilevi le impronte digitali.» «Già, temo che ormai non abbia senso. L’ho usato continuamente e i bambini girano dappertutto con le loro ditine appiccicose.» Patrik scosse la testa, rassegnato. «Non so se poi sia davvero John il responsabile» continuò Erica. «L’ho solo ipotizzato dato che è successo dopo che per caso mi sono portata via quel foglietto.» «Per caso, eh?» sbuffò Patrik. «Comunque adesso l’ho consegnato a Kjell e quindi non c’è problema.» «Ma loro non lo sanno, scusa.» Patrik la guardò come se fosse scema. «No, è chiaro. Però da allora non è più successo niente.» «Kjell è arrivato a una conclusione? Avresti dovuto parlarmi anche di questo, veramente. Potrebbe avere a che fare con le indagini.» «Non lo so. Puoi parlargliene tu» rispose lei evasiva. «Sì, ma sarebbe stato meglio saperlo prima. Comunque Gösta ci ha riferito una parte di quello che avete scoperto.» «Sì, e domani andremo da Olle il rigattiere per farci consegnare gli effetti personali della famiglia.» «Olle?» «Gösta non te l’ha detto? Ci è venuto in mente dove potevano essere finiti. Pare che Olle fosse una specie di tuttofare alla colonia durante il periodo in cui era utilizzata come collegio e quando Gösta gli ha telefonato ha detto: “Certo che ce ne avete messo di tempo a farvi sentire per quella roba!”» Erica scoppiò in una risata. «Quindi Olle il rigattiere ha tenuto tutto da allora?» «Sì, e domani alle dieci vado là con Gösta per esaminare quello che ha.» «Non se ne parla» disse Patrik. «Vado io con lui.» «Ma...» protestò lei, rendendosi però conto che non era il caso di insistere. «Va bene.» «D’ora in poi tu stai alla larga da questa faccenda» l’ammonì lui, ma con suo grande sollievo Erica vide che la rabbia era sbollita. In quel momento si sentirono dei passi sulla scala. Ebba stava scendendo ed Erica si alzò per continuare a lavare i piatti. «Pace?» chiese. «Pace» rispose Patrik. Semiseduto nella penombra, la guardò. Era tutta colpa di Anna. Aveva sfruttato la sua debolezza inducendolo a rompere le promesse fatte a Ebba, a cui aveva giurato di amarla nella buona e nella cattiva sorte finché morte non li avesse separati. Il fatto che avesse capito che la colpa di quanto accaduto era sua non cambiava niente. Lui l’amava e voleva perdonarla. In abito da cerimonia, guardandola in viso, le aveva promesso di esserle fedele. Lei era bellissima in quel semplice vestito bianco e l’aveva fissato dritto negli occhi, ascoltando le sue parole e serbandole nel proprio cuore. Ma Anna aveva rovinato tutto. Lei mugugnò qualcosa e seppellì la testa nel cuscino. Il cuscino di Ebba. Mårten voleva strapparglielo per evitare che il suo odore lo contaminasse. Ebba usava da sempre lo stesso shampoo e la federa sapeva dei suoi capelli. Chiuse le mani a pugno. Avrebbe dovuto esserci Ebba, lì, il suo bel viso illuminato dalla luce lunare che creava ombre intorno a naso e occhi. Avrebbe dovuto essere il petto nudo di Ebba ad alzarsi e abbassarsi appena sopra il bordo del lenzuolo. Fissò i seni di Anna, tanto diversi da quelli simili a due boccioli della sua Ebba. Appena sotto, le cicatrici si snodavano su tutto il ventre. Poche ore prima le aveva sentite sotto le mani e quella vista lo disgustava. Si sporse in avanti e, afferrato il lenzuolo, lo tirò su piano per coprire il corpo ributtante che si era premuto contro il suo cancellando il ricordo della pelle di Ebba. Quel pensiero gli fece venire la nausea. Doveva annullare l’accaduto per permettere a Ebba di tornare. Rimase un attimo completamente immobile. Poi prese il proprio cuscino e lo abbassò lentamente sul viso di Anna. Fjällbacka 1951 Era successo in maniera del tutto inaspettata. Non che lei fosse prevenuta nei confronti di eventuali figli, ma via via che gli anni passavano senza che accadesse niente si era convinta di non poterne avere. Sigvard aveva già due maschi adulti e quindi anche lui sembrava indifferente alla sua sterilità. Poi però, all’improvviso, aveva cominciato a sentirsi inspiegabilmente stanca. Sigvard aveva temuto il peggio e l’aveva mandata dal medico per una visita approfondita. Anche lei aveva avuto il dubbio che potesse trattarsi di cancro o di qualche altra malattia mortale ma era invece saltato fuori che a trent’anni suonati era rimasta incinta. Il medico non aveva spiegazioni da darle e Laura aveva impiegato diverse settimane a digerire la notizia. La sua vita priva di avvenimenti le andava benissimo, ben contenta com’era di non dover lavorare. In casa sua aveva il dominio assoluto e tutto era predisposto secondo il suo volere. L’arrivo di un figlio avrebbe compromesso l’ordine perfetto che aveva creato con tanta dedizione. La gravidanza aveva comportato strani disturbi e mutazioni fisiche tutt’altro che desiderabili. La consapevolezza che dentro il suo corpo cresceva qualcosa su cui non aveva potere la gettava quasi nel panico. Il parto era stato orribile e le aveva fatto giurare di non trovarsi mai più ad affrontare una situazione del genere. Si rifiutava di sottoporsi di nuovo a quell’atto doloroso e animalesco che l’aveva fatta sentire impotente e Sigvard aveva dovuto accettare di trasferirsi definitivamente nella camera degli ospiti. Non sembrava avere niente in contrario, comunque, soddisfatto com’era della propria esistenza. Il primo periodo con Inez era stato devastante. Poi aveva trovato Nanna, la meravigliosa Nanna che l’aveva sollevata da quella responsabilità permettendole di riprendere la sua vita di sempre. Si era subito trasferita da loro, nella camera accanto a quella della bambina in modo che di notte potesse andare da lei ogni volta che serviva. Si occupava di tutto e Laura era libera di andare e venire come voleva. Passava a vedere la bambina solo di tanto in tanto e in quei momenti riusciva a rallegrarsene. Di lì a poco Inez avrebbe compiuto sei mesi e, quando non piangeva perché aveva fame o era bagnata, era davvero incantevole. Ma a quelle necessità provvedeva Nanna e Laura riteneva che le cose fossero andate per il meglio, nonostante la piega inaspettata presa dalla sua vita. I cambiamenti non erano una cosa che apprezzasse e meno la nascita della bambina avesse modificato le sue abitudini più facile sarebbe stato per lei accettarla. Laura raddrizzò le cornici sul cassettone. Erano foto di lei e Sigvard e dei due figli di lui con le famiglie. Di Inez non ne avevano ancora fatte incorniciare e di Dagmar non ne avrebbe mai esposta una. Preferiva che l’identità di sua madre e quella di sua nonna cadessero nell’oblio. Con suo grande sollievo, Dagmar sembrava essere sparita per sempre. Da due anni, ormai, non ne aveva notizie e nessuno l’aveva più vista in zona. Laura aveva ancora fresco in mente il ricordo del loro ultimo incontro: la madre era stata dimessa dall’ospedale psichiatrico più di un anno prima ma non aveva osato presentarsi da lei e Sigvard. Si diceva che vagasse senza meta in paese come quando lei era piccola. Quando alla fine se l’era trovata davanti alla porta, sdentata, sporca e con i vestiti stracciati, era pazza come sempre, tanto che non si capiva come avessero fatto a dimetterla. Se non altro, in ospedale le davano dei farmaci e non le permettevano di bere. Pur provando l’intenso desiderio di mandarla via, Laura si era affrettata a farla entrare per evitare che i vicini la vedessero. «Caspita, che lusso» aveva detto Dagmar. «A quanto vedo ti sei conquistata una posizione.» Laura aveva nascosto dietro la schiena i pugni chiusi. Tutto quello che aveva cercato di allontanare e che compariva soltanto nei suoi sogni era di nuovo in agguato, lì davanti a lei. «Cosa vuoi?» «Mi serve aiuto.» La voce era piagnucolosa. Dagmar si muoveva in modo strano, come a scatti, e il viso aveva dei tic nervosi. «Hai bisogno di soldi?» Laura aveva preso la borsetta. «Non per me» aveva risposto lei senza staccare gli occhi dalla borsa. «Mi servono per andare in Germania.» Laura l’aveva fissata, incredula. «In Germania? A fare cosa?» «Non ho mai avuto occasione di dire addio a tuo padre. Non ho potuto congedarmi dal mio Hermann.» Si era messa a piangere e Laura si era guardata intorno, a disagio. Non voleva che Sigvard sentisse e venisse nell’ingresso per vedere cosa succedeva. Non doveva trovare sua madre lì. «Sch! Ti darò i soldi, ma stai calma, santo cielo!» Le aveva teso un fascio di banconote. «Tieni. Dovrebbero bastare per arrivare in Germania.» «Oh, grazie!» Dagmar si era lanciata in avanti e aveva preso i soldi e la mano di Laura tra le proprie per poi mettersi a sbaciucchiarla. Schifata, lei l’aveva ritirata per asciugarsela sulla gonna. «Vai ora» aveva detto. Voleva solo che la madre uscisse dalla sua casa, dalla sua vita, in modo che potesse tornare perfetta. Una volta richiusa la porta si era accasciata su una sedia nell’ingresso con un sospiro di sollievo. Ormai erano passati due anni da quel giorno ed era improbabile che Dagmar fosse ancora viva. Laura dubitava che fosse arrivata molto lontano con i soldi che le aveva dato, soprattutto considerando il caos che regnava dopo la fine della guerra. Se poi si era messa a delirare dei suoi propositi di congedarsi da Hermann sicuramente l’avevano presa per la pazza che era e fermata in qualche punto del percorso. Göring non era una persona che si nominasse a voce alta, ormai. I suoi crimini non erano diminuiti dal fatto che si fosse tolto la vita in prigione a un anno dalla fine del conflitto. Laura rabbrividì al pensiero che la madre avesse continuato a spargere la voce che era suo padre. Non era più una cosa di cui vantarsi. La visita fatta alla moglie, a Stoccolma, era un ricordo molto vago, ma le erano rimasti impressi nella memoria la vergogna e lo sguardo di Carin Göring, uno sguardo pieno di calore e compassione. Probabilmente era stato per rispetto alla presenza di una bambina che non aveva chiamato aiuto, sebbene avesse sicuramente paura. Comunque, ormai tutto questo apparteneva al passato. Sua madre era sparita e nessuno parlava più delle sue folli fantasie. E Nanna aveva fatto in modo che Laura potesse vivere la sua vita come era abituata a fare. L’ordine era ristabilito ed era tutto perfetto. Esattamente come doveva essere. Gösta osservò Patrik che tamburellava con le dita sul volante, lo sguardo fisso sulle auto davanti. Il traffico estivo era intenso e le strette strade di campagna non erano fatte per incrociare certi veicoli, il che lo costringeva a stare molto vicino al ciglio della strada. «Non sei stato troppo duro con lei, vero?» Gösta girò la testa e guardò fuori dal finestrino del passeggero. «Ritengo che entrambi vi siate comportati in maniera molto stupida, e lo confermo» rispose Patrik, ma con voce molto più calma del giorno prima. Gösta scelse il silenzio, troppo stanco per ribattere. Era rimasto alzato praticamente tutta la notte per ripassare in rassegna tutto il materiale ma non aveva nessuna intenzione di dirlo a Patrik, che al momento non avrebbe sicuramente apprezzato altre iniziative prese di testa propria. Nascose uno sbadiglio con la mano. La delusione per il lavoro inutile della nottata non voleva andarsene. Non aveva trovato niente di nuovo, niente che risvegliasse il suo interesse: solo le solite informazioni che da tanto tempo sembravano prendersi gioco di lui. Eppure non riusciva a liberarsi dalla sensazione che la risposta fosse lì, sotto il suo naso, nascosta in qualcuno di quei mucchi di carta. Prima lo irritava non averla trovata e aveva cercato di scoprire cosa fosse accaduto per curiosità o forse per orgoglio professionale, ma da qualche tempo la forza motrice era l’ansia: Ebba non era più al sicuro e la sua vita dipendeva da loro, dal fatto che trovassero il responsabile di ciò che aveva dovuto subire. «Prendi a sinistra laggiù.» Indicò una strada secondaria poco più avanti. «Conosco il percorso» rispose Patrik imboccando la svolta con una manovra alquanto arrischiata. «Non hai ancora preso la patente, vedo» borbottò Gösta attaccandosi alla maniglia sopra la portiera. «Io guido benissimo.» Gösta alzò gli occhi al cielo. Vedendo che si stavano avvicinando alla meta, accennò con la testa agli edifici davanti a loro. «I suoi poveri figli avranno un bel da fare quando dovranno sistemare questo posto.» Più che un’abitazione, sembrava una discarica. In zona era universalmente noto che se ci si voleva liberare di qualcosa si doveva chiamare Olle. Lui andava a ritirare di tutto, per cui intorno a un paio di costruzioni e magazzini si vedevano auto, frigoriferi, traini, lavatrici e tutto l’immaginabile. Persino un casco da parrucchiere, notò Gösta quando Patrik parcheggiò tra un freezer e una vecchia Amazon. Un omino rinsecchito in salopette venne loro incontro. «Era ora. Non potevate arrivare un po’ prima? Se aspettavate ancora un po’ andavo a pranzo.» Gösta guardò l’orologio. Erano le dieci e cinque. «Ciao, Olle. Hai detto che avevi un po’ di roba per noi.» «Ve la siete presa comoda. La polizia batte proprio la fiacca, non c’è che dire. Nessuno è venuto a chiedermi di quella roba e io l’ho lasciata dov’era. È qui insieme a quella del conte pazzo.» Lo seguirono in un magazzino buio. «Il conte pazzo?» «Non so se fosse veramente conte, comunque aveva un nome da nobile.» «Parli di von Schlesinger?» «Proprio di lui. In paese aveva una pessima reputazione perché simpatizzava per Hitler e perché suo figlio era partito per andare a combattere a fianco dei tedeschi. Poveraccio, non fece in tempo ad arrivare che si beccò una pallottola in testa.» Olle si mise a frugare in mezzo al ciarpame. «E se il vecchio non era pazzo prima, lo diventò a quel punto. Era convinto che gli Alleati sarebbero venuti ad attaccarlo lì sull’isola e se vi raccontassi quello che faceva laggiù non mi credereste. Alla fine gli venne un colpo e tirò le cuoia.» Olle si fermò e li guardò nella penombra grattandosi la testa. «Era il ’53, se non vado errato. Poi ci fu una serie di altri proprietari e alla fine il posto venne comprato da quell’Elvander. Dio santo, che idea quella di farci un collegio e portarci una sfilza di ragazzini con la puzza sotto il naso. Lo capiva chiunque che sarebbe andata a finire male.» Continuò a frugare borbottando tra sé e sé e sollevando una nuvola di polvere che fece tossire sia Gösta sia Patrik. «Eccoli qui: quattro scatoloni. I mobili sono rimasti là quando la casa è stata affittata, ma qualcosina sono riuscito a portare via. Non ha senso buttare le cose a caso, e poi non si poteva mai dire: magari un giorno o l’altro sarebbero ricomparsi. Anche se la maggior parte della gente, me compreso, pensava che fossero morti, da qualche parte.» «Non ti venne in mente di contattare di persona la polizia per dire che avevi qui la loro roba?» chiese Patrik. Olle raddrizzò la schiena e incrociò le braccia sul petto. «L’avevo detto a Henry.» «Cosa? Vuoi dire che Henry sapeva che era tutto qui?» chiese Gösta. In effetti non era l’unico dettaglio sfuggito al suo collega e in ogni caso non aveva senso prendersela con qualcuno che ormai era morto e non poteva difendersi. Patrik diede un’occhiata agli scatoloni. «Secondo me ci stanno in macchina. Tu cosa dici?» Gösta annuì. «Sì, almeno se abbassiamo lo schienale dei sedili posteriori.» «Roba da matti» rise Olle. «Ci avete messo più di trent’anni a venire a prendere questa roba!» Gösta e Patrik lo incenerirono con lo sguardo ma tennero la bocca chiusa. A certe battute si poteva rispondere solo con il silenzio. «Cosa te ne farai di tutta la roba che hai qui, Olle?» non poté fare a meno di chiedere Gösta, che alla vista di quella sterminata distesa di ciarpame si sentiva quasi prendere dal panico. Forse non aveva una casa particolarmente moderna ma era molto orgoglioso di averla tenuta pulita e in ordine invece di essere diventato uno di quegli uomini soli che giravano tra montagne di scarti. «Non si sa mai quando qualcosa può tornare utile. Se fossero tutti previdenti come me, il mondo sarebbe diverso, ve lo dico io.» Patrik si chinò e fece per sollevare uno scatolone ma rinunciò sbuffando. «Dobbiamo tirarlo su insieme. È troppo pesante.» Gösta lo guardò atterrito. Uno stiramento poteva compromettere il resto della stagione golfistica. «Sai, è meglio che eviti i pesi. Devo stare attento alla schiena.» «Dai, avanti. Muoviti.» Gösta capì di non averlo convinto e, suo malgrado, piegò le ginocchia afferrando lo scatolone da sotto. La polvere gli s’infilò nel naso facendolo starnutire più volte. «Salute» gli disse Olle, mettendo in mostra sorridendo l’arcata superiore in cui mancavano tre denti. «Grazie» rispose Gösta. Poi, non senza lamentarsi, aiutò Patrik a caricare tutti gli scatoloni nel bagagliaio. Tuttavia si sentiva anche lui speranzoso. Forse lì dentro c’era qualcosa che avrebbe fornito loro il filo conduttore che aspettavano, ma soprattutto era contento di poter dire a Ebba che erano stati ritrovati gli effetti personali della sua famiglia. Anche se la schiena ne avesse risentito, ne sarebbe comunque valsa la pena. Per una volta, Kjell e Carina si erano concessi di rimanere a letto più a lungo del solito. La sera prima lui aveva lavorato fino a tardi e sentiva di meritarselo. «Santo cielo» disse Carina mettendogli una mano sulla spalla. «Pensa che ho ancora sonno.» «Anch’io, ma chi dice che dobbiamo alzarci proprio adesso?» Kjell le si avvicinò e la strinse a sé. «Mmh... sono troppo stanca.» «Voglio solo fare un po’ di coccole.» «E secondo te dovrei crederci?» rispose lei, assecondandolo. Il cellulare di Kjell si mise a squillare dalla tasca dei pantaloni appesi in fondo al letto. «Non rispondere.» Carina gli si strinse contro, ma la suoneria non accennava a tacere e alla fine lui si alzò a sedere, afferrò i pantaloni e lo tirò fuori, vedendo sul display il nome di Sven Niklasson. Si affrettò a premere il pulsante di risposta. «Pronto, Sven? No no, non stavo dormendo.» Guardò l’orologio. Le dieci passate. Si schiarì la voce. «Sei riuscito a trovare qualcosa?» Sven Niklasson parlò a lungo e Kjell ascoltò con stupore crescente, rispondendo a monosillabi e accorgendosi che Carina lo osservava con la testa appoggiata al braccio. «Posso venire a prenderti all’aeroporto di Malöga» disse alla fine. «Apprezzo che tu mi coinvolga. Non tutti i colleghi lo farebbero. La polizia di Tanum è stata avvisata? Göteborg? Sì, forse è meglio, data la situazione. Sì, ieri c’è stata la conferenza stampa e hanno già il loro da fare. Avrai saputo tutto dal vostro inviato. Comunque ne parliamo quando vengo a prenderti. Ci vediamo tra poco.» Quando riattaccò aveva quasi il fiatone. Carina lo guardò sorridendo. «Immagino che ci sia in ballo qualcosa di grosso, se Sven Niklasson sta venendo qui.» «Se solo sapessi.» Kjell scese dal letto e cominciò a vestirsi. La stanchezza era stata spazzata via. «Se solo sapessi» ripeté, questa volta più a se stesso che a Carina. Tolse velocemente le lenzuola dal letto della camera degli ospiti. Ebba era partita. Aveva chiesto di poter portare via il materiale sulla sua famiglia ma Erica le aveva proposto di farle delle copie, cosa a cui naturalmente avrebbe dovuto pensare fin dall’inizio. «Noel! Non picchiare Anton!» gridò rivolta verso il soggiorno senza neanche dover controllare chi avesse dato inizio al tumulto. Nessuno parve darle ascolto e il pianto s’intensificò. «Mamma! Mammaaa! Noel dà le botte!» chiamò Maja. Con un gran sospiro, Erica mollò le lenzuola. Il desiderio di portare a termine un qualsiasi compito senza che uno dei figli si mettesse a piangere e richiedesse la sua attenzione era quasi fisico. Aveva bisogno di tempo per sé, di poter essere adulta. I bambini erano la cosa più importante della sua vita ma a volte aveva l’impressione di dover rinunciare a gran parte di quello che avrebbe voluto fare. Sebbene Patrik avesse preso qualche mese di congedo parentale, la responsabilità di far funzionare tutto ricadeva su di lei. Lui dava una grossa mano, ma era proprio quello il concetto: dava una mano. E se uno dei piccoli si ammalava era lei a dover posporre una scadenza o disdire un’intervista in modo che Patrik potesse andare al lavoro. Pur cercando di evitarlo, cominciava a provare un po’ di amarezza per il fatto che i suoi bisogni e il suo lavoro finissero sempre in secondo piano. «Smettila, Noel!» disse staccandolo bruscamente dal fratello che, steso a terra, stava piangendo. Subito si mise a strillare anche Noel ed Erica si sentì in colpa per averlo preso troppo forte per il braccio. «Brutta mamma» disse Maja guardandola torva. «Sì, hai ragione.» Erica si sedette sul pavimento e prese tra le braccia i gemellini singhiozzanti. «C’è qualcuno?» chiamò una voce dall’ingresso. Erica fece un salto ma capì subito chi era. Solo una persona entrava in casa loro senza suonare il campanello. «Ciao, Kristina» disse alzandosi faticosamente. I bambini smisero di piangere di colpo e corsero incontro alla nonna. «Ordini dal capo. Pare che debba darti il cambio io qui» disse la suocera asciugando le lacrime ai due bambini. «Cambio?» «Devi andare alla stazione di polizia, a quanto ho capito.» Kristina la stava guardando come se fosse scontato. «Non so altro. Sono solo la pensionata da cui ci si aspetta piena disponibilità con un minuto di preavviso. Patrik mi ha telefonato chiedendo se potevo venire qui subito ed è stata una bella fortuna che fossi in casa, perché potevo benissimo avere un impegno. Chissà, magari addirittura un appuntamento galante! Comunque, gli ho detto che per questa volta potevo anche farlo, ma che in generale avrei preferito un po’ più di pianificazione. Ho una vita anch’io, sebbene evidentemente voi pensiate che sia troppo vecchia per averla.» Si fermò un attimo a prendere fiato e la guardò. «Cosa stai aspettando? Devi andare alla stazione, da Patrik.» Pur non capendoci niente, Erica decise di non fare domande: di qualsiasi cosa si trattasse, avrebbe avuto un attimo di respiro e al momento non chiedeva altro. «Come ho detto a Patrik posso fermarmi solo fino al pomeriggio perché stasera in tv c’è Sommarkrysset e non voglio perdermelo. E prima devo fare il bucato e la spesa, quindi bisogna che vada via non più tardi delle cinque al massimo perché altrimenti non faccio in tempo e anche a casa ho un po’ di cose da sistemare. Non posso essere solo al vostro servizio, anche se non c’è alcun dubbio sul fatto che qui da fare ce ne sia da vendere.» Erica si chiuse la porta alle spalle con un colpo secco e il viso le si aprì in un sorriso. Libertà. Salendo in macchina, però, tornò a essere pensosa. Che motivo poteva esserci di tanta fretta? L’unico che le veniva in mente era che avesse a che vedere con la visita di Patrik e Gösta da Olle il rigattiere. Dovevano aver trovato gli effetti personali della famiglia. Partì in direzione di Tanumshede fischiettando tra sé e sé e pentendosi, almeno in parte, di quello che aveva pensato di Patrik poco prima. Se le avesse permesso di esaminare il materiale recuperato da Olle avrebbe gestito da sola casa e famiglia per un mese senza un lamento. Svoltò nel parcheggio davanti alla stazione e si affrettò a entrare nel brutto edificio a un piano. In segreteria non c’era nessuno. «Patrik?» chiamò in direzione del corridoio. «Siamo qui. In sala riunioni.» Seguì la sua voce ma si fermò di botto sulla soglia. Il tavolo e il pavimento erano ingombri di oggetti. «Non è stata un’idea mia» disse Patrik, girato di spalle. «È stato lui a dire che meritavi di venire.» Erica lanciò un bacio con la mano a Gösta che distolse lo sguardo arrossendo. «Trovato niente d’interessante finora?» chiese guardandosi intorno. «No, stiamo ancora tirando fuori tutto.» Patrik soffiò via la polvere da alcuni album di fotografie che piazzò sul tavolo. «Vi do una mano con gli scatoloni o preferite che cominci a esaminare gli oggetti?» «Ormai sono quasi vuoti, quindi parti pure.» Si girò e la guardò. «È venuta mia madre?» «No, ormai i bambini sono così grandi che secondo me possono cavarsela da soli.» Rise. «Certo che è venuta Kristina. Come avrei fatto a sapere che dovevo venire, se no?» «A dire il vero prima ho provato a cercare Anna, ma non rispondeva né a casa né sul cellulare.» «Ma va’? Strano.» Erica aggrottò le sopracciglia. Era difficile che sua sorella si allontanasse dal cellulare di più di un metro. «Visto che Dan e i bambini sono via, sarà spaparanzata su una sdraio.» «Sì, probabilmente è così.» Si scosse di dosso la preoccupazione e si dedicò al materiale sparso davanti a lei. Lavorarono in silenzio per un pezzo. La maggior parte degli oggetti usciti dagli scatoloni erano quelli normali che si trovano in casa di tutti: libri, penne, spazzole per capelli, scarpe e abiti che sapevano di muffa e di chiuso. «Che fine avranno fatto gli arredi e i soprammobili?» chiese Erica. «Erano rimasti nella casa. Sospetto che quasi tutto sia sparito negli anni con l’avvicendarsi dei diversi inquilini. Chiederemo a Ebba e Mårten. Si spera che qualcosina ci fosse ancora quando si sono trasferiti lì la scorsa primavera.» «A proposito, ieri Anna ha detto che sarebbe andata da Mårten e ha preso in prestito il beccaccino. Chissà se è tornata a casa senza problemi.» «Vedrai che è tutto a posto, ma se sei in ansia chiama Mårten e chiedigli a che ora è ripartita da là.» «Mi sa che lo faccio.» Tirò fuori dalla borsa il cellulare e cercò il numero. La telefonata fu breve e quando ebbe finito Erica guardò Patrik. «Anna si è fermata lì solo un’oretta ieri sera e quando si è rimessa in barca il mare era calmissimo.» Patrik si pulì le mani impolverate sulle gambe dei pantaloni. «A posto, allora.» «Sì, meno male.» Erica annuì ma sotto sotto covava un dubbio. Qualcosa non tornava. D’altra parte sapeva di essere iperprotettiva ed eccessiva nelle sue reazioni e così scacciò quei pensieri e continuò a esaminare gli oggetti. «Pensa che strana questa cosa, in realtà» disse sollevando un foglietto. «Deve averlo scritto Inez. Sembra impossibile che abbia vissuto una vita quotidiana fatta di liste della spesa: latte, uova, zucchero, composta di frutta, caffè...» La passò a Patrik. Lui la guardò, sospirò e gliela restituì. «Non abbiamo tempo per questi dettagli, adesso. Dobbiamo concentrarci su quello che può risultare determinante per la soluzione del caso.» «Okay» disse Erica mettendo il foglietto sul tavolo e riprendendo a esaminare sistematicamente tutto quanto. «Quel Rune era un tipo meticoloso.» Gösta mostrò un quaderno che sembrava contenere la registrazione di tutte le spese. La calligrafia era talmente regolare che sembrava quasi scritta a macchina. «Evidentemente non c’era importo troppo esiguo per non essere annotato» aggiunse continuando a sfogliare. «Non mi sorprende, considerando quello che ho sentito dire di lui» commentò Erica. «Guardate qui. Sembra che qualcuno corresse dietro a Leon.» Patrik mostrò un foglio di un taccuino scarabocchiato. «A cuoricino L» lesse Erica a voce alta. «E poi si è esercitata a fare la sua futura firma: Annelie Kreutz. Quindi Annelie aveva una cotta per Leon, il che corrisponde a quello che ho sentito.» «Chissà cosa ne pensava papà Rune?» disse Gösta. «Considerando la sua tendenza al controllo compulsivo, una storia tra quei due avrebbe potuto scatenare una catastrofe» osservò Patrik. «Bisogna vedere se era corrisposta.» Erica si sedette sul bordo del tavolo. «Annelie aveva un debole per Leon, ma valeva lo stesso per lui? Secondo John no, ma naturalmente potrebbe averlo tenuto segreto agli altri.» «I rumori notturni» intervenne Gösta. «Hai detto che Ove Linder ha parlato di strani rumori intorno alle ore piccole. Potevano essere Annelie e Leon che s’incontravano di nascosto?» «Magari erano fantasmi» disse Patrik. «Ma dai» fece Gösta prendendo un fascio di fatture e cominciando a esaminarle. «Ebba è tornata sull’isola?» «Sì, le ha dato un passaggio il postale» rispose Erica assente. Aveva preso dal tavolo uno degli album e stava scrutando con attenzione le foto. Ce n’era una di una giovane donna dai lunghi capelli lisci con un bambino in braccio. «Non ha l’aria propriamente felice.» Patrik sbirciò da sopra la sua spalla. «Inez con Ebba.» «Sì, e questi devono essere gli altri figli di Rune.» Stava indicando tre ragazzi di età e altezze diverse schierati con evidente riluttanza davanti a un muro. «Ebba sarà felicissima di vederle» disse Erica girando pagina. «Significherà molto per lei. Guarda, questa dev’essere sua nonna Laura.» «Ha l’aria perfida» disse Gösta, che le si era messo di fianco. «Quanti anni aveva quando è morta?» chiese Patrik. Erica ci pensò su un attimo. «Cinquantatré, credo. La trovarono dietro la casa una mattina.» «Niente di sospetto?» «No, almeno a quanto ne so. Tu hai sentito qualcosa in proposito, Gösta?» Lui scosse la testa. «Fu chiamato il medico che constatò che per qualche ragione doveva essere uscita di notte e che il decesso era dovuto a un infarto. Non c’era motivo di pensare a qualcosa di diverso da una morte naturale.» «Era stata sua madre a scomparire?» domandò Patrik. «Sì, Dagmar svanì nel nulla nel 1949.» «Una vecchia ubriacona. Almeno a quanto ho sentito io» disse Gösta. «È un miracolo che Ebba sia venuta fuori così, con la famiglia che aveva» osservò Erica. «Forse perché è cresciuta in Rosenstigen invece che a Valö.» «Penso anch’io» disse Patrik continuando a frugare tra gli oggetti. Due ore dopo avevano finito e si guardarono delusi. Ebba sarebbe sicuramente stata contenta di avere delle foto e degli oggetti appartenuti alla sua famiglia, ma non avevano trovato niente che potesse contribuire alle indagini. Erica era sull’orlo delle lacrime. Aveva nutrito tante speranze e invece si ritrovava lì in una sala riunioni ingombra di oggetti di nessuna utilità. Guardò suo marito. C’era qualcosa che non lo lasciava tranquillo ma che non riusciva a identificare. Gliel’aveva già vista in faccia altre volte, quell’espressione. «A cosa pensi?» «Non lo so. C’è qualcosa... niente, lascia perdere. Prima o poi mi verrà in mente» disse infine in tono scocciato. «Bene, allora adesso rimettiamo via tutto» sospirò Gösta cominciando dallo scatolone più vicino. «Sì, non c’è molto altro da fare.» Anche Patrik cominciò a riordinare, mentre Erica rimase per un po’ immobile senza accennare ad aiutarli. Spaziò con lo sguardo sulla stanza in un ultimo tentativo di trovare qualcosa di interessante, e stava per arrendersi quando le cadde l’occhio su alcuni libriccini neri. Erano i passaporti della famiglia che Gösta aveva ordinatamente impilato in un angolo del tavolo. Socchiuse gli occhi, si avvicinò per vedere meglio e contò in silenzio. Poi li prese e li dispose uno accanto all’altro. Patrik smise di lavorare e alzò gli occhi. «Cosa fai?» «Non vedi?» Stava indicando i passaporti. «No, cosa?» «Contali.» Lui ubbidì e sbarrò gli occhi. «Ce ne sono quattro» disse Erica. «Non dovrebbero essere cinque?» «Sì, se consideriamo che Ebba non doveva averne ancora uno suo.» Patrik si avvicinò e li prese, aprendoli uno dopo l’altro e controllando nome e foto. Poi si girò verso la moglie. «Allora? Chi manca?» «Annelie. Il suo passaporto non c’è.» Fjällbacka 1961 La mamma aveva sempre ragione. Era una verità che Inez aveva impressa nella mente fin da piccola e che dava per scontata. Del padre non aveva alcun ricordo. Quando aveva avuto un infarto, per poi morire dopo alcune settimane in ospedale, lei aveva tre anni. Da allora c’erano state solo lei, la mamma e Nanna. A volte si chiedeva se voleva bene alla mamma. Non ne era del tutto sicura. Ne voleva a Nanna e all’orsacchiotto che teneva nel letto fin da quando era piccola, ma alla mamma? Sapeva che avrebbe dovuto volergliene, come i suoi compagni di scuola. Le poche volte che era andata a giocare da una sua amica aveva visto la gioia negli sguardi di entrambe quando la bambina si era gettata tra le braccia della madre. Guardando le compagne con le loro mamme le veniva sempre un nodo allo stomaco. Poi, quando tornava a casa, faceva come loro gettandosi tra le braccia di Nanna, sempre aperte per lei. Sua madre non era cattiva e Inez non ricordava di averla mai sentita alzare la voce. Era Nanna a sgridarla se era disubbidiente, ma la mamma prendeva tutte le decisioni e Inez non poteva assolutamente contraddirla. L’importante era fare tutto a modo. La mamma lo diceva sempre: «Ogni cosa che vale la pena di fare merita di essere fatta per bene.» Improvvisare era severamente vietato. I compiti di bella scrittura andavano eseguiti con le lettere perfettamente allineate sulle righe e i conti sul quaderno di matematica dovevano essere corretti. Le leggere impronte lasciate sulla carta dai numeri erano proibite anche se si era cancellato tutto. Quando si sentiva insicura doveva prima scrivere in brutta e poi riportare sul quaderno le operazioni corrette. Era fondamentale anche non mettere in disordine, perché se la casa era in disordine poteva succedere qualcosa di terribile. Cosa non lo sapeva esattamente, ma la sua cameretta doveva sempre essere impeccabile. Non si poteva mai prevedere quando sarebbe entrata la mamma e se non era tutto al suo posto lei rimaneva delusa e diceva che voleva parlarle. Inez detestava quei momenti. Non voleva rattristarla e i colloqui erano spesso incentrati proprio su questo: Inez l’aveva delusa. Non doveva mettere in disordine nemmeno nella stanza di Nanna o in cucina. Nelle altre stanze (la camera della mamma, quella degli ospiti, il soggiorno e il salone) non poteva neanche mettere piede, perché avrebbe potuto rompere qualcosa. Non erano posti per i bambini. Lei ubbidiva perché era la cosa più semplice. Non le piaceva litigare e non le piacevano i colloqui con la mamma. Se faceva quello che le diceva, poteva evitare entrambe le cose. A scuola stava per conto suo e faceva diligentemente il proprio dovere. Era chiaro che alla maestra andava bene. Agli adulti sembrava far piacere che i bambini ubbidissero. I compagni la ignoravano, come se non valesse neanche la pena di darle fastidio. Qualche volta la prendevano in giro e lanciavano frecciate su sua nonna, cosa che a Inez sembrava strana perché non ne aveva una. Aveva chiesto alla mamma ma, invece di risponderle, lei aveva deciso che dovevano parlare. Inez aveva persino consultato Nanna, e lei aveva inaspettatamente storto la bocca dicendo che non toccava a lei dirle qualcosa. Così Inez non aveva più fatto domande. Non era abbastanza importante da rischiare l’ennesimo colloquio, e poi la mamma aveva sempre ragione. Ebba saltò sul pontile a Valö e ringraziò per il passaggio. Per la prima volta da quando si erano trasferiti sull’isola, risalendo il sentiero provava un senso di aspettativa e di gioia. C’erano tante cose che voleva raccontare a Mårten. Avvicinandosi notò quanto fosse bella la casa. Certo, ci sarebbe voluto ancora parecchio per finirla, considerando che nonostante la fatica erano ancora all’inizio, ma aveva un bel potenziale. In mezzo a tutto quel verde spiccava come un gioiello bianco e anche se il mare non si vedeva se ne avvertiva la presenza tutt’intorno. Lei e Mårten avrebbero impiegato del tempo a riavvicinarsi e la loro vita sarebbe stata diversa, ma questo non significava che dovesse essere per forza peggiore. Forse il loro rapporto poteva addirittura rinsaldarsi. Prima non aveva osato concepire quel pensiero, ma magari nella loro vita ci sarebbe stato posto anche per un bambino. Non quando era ancora tutto così nuovo e fragile, anche considerando il lavoro che restava da fare sia sulla casa sia su loro stessi, ma più avanti Vincent avrebbe potuto avere un fratellino. Era così che lo immaginava: un fratellino per il loro angioletto. Era riuscita anche a calmare i suoi genitori. Aveva chiesto scusa per non aver detto quello che era successo e li aveva convinti a non partire per Fjällbacka. La sera li aveva richiamati per raccontare quello che aveva scoperto della sua famiglia e sapeva che erano contenti e capivano quanto per lei quelle nuove informazioni fossero importanti. Non volevano però che tornasse sull’isola prima che fosse stato chiarito cosa stava succedendo e così li aveva tranquillizzati con una bugia innocente, dicendo che avrebbe dormito un’altra notte da Erica e Patrik. Anche lei era spaventata all’idea che qualcuno volesse fare loro del male, ma Mårten era rimasto e lei aveva deciso di essere al suo fianco, scegliendolo per la seconda volta nella sua vita. Il terrore di perderlo era più grande del terrore dell’ignoto che li minacciava. Non tutto si riusciva a governare, gliel’aveva insegnato la morte di Vincent, e il suo destino era restare con Mårten a prescindere da ogni altra cosa. «Mårten?» Appoggiò la borsa nell’ingresso e lo chiamò. «Dove sei?» La casa era immersa nel silenzio e mentre saliva lentamente le scale Ebba tese le orecchie. Che fosse andato a Fjällbacka per qualche commissione? No, aveva visto la barca ormeggiata al pontile, insieme a un’altra. Forse avevano visite? Chiamò di nuovo ma l’unica risposta fu l’eco della sua voce che rimbalzava tra le pareti spoglie. Il sole penetrava intenso dalle finestre illuminando la polvere che si sollevava nell’aria al suo passaggio. Andò in camera da letto. «Mårten?» Guardò perplessa il marito che, seduto sul pavimento con la schiena contro la parete e lo sguardo fisso davanti a sé, non reagì. Preoccupata, si accovacciò e gli fece una carezza sui capelli. Sembrava stanco e tormentato. «Cosa c’è?» gli chiese. Lui rivolse lo sguardo verso di lei. «Sei tornata?» chiese con voce piatta, e lei annuì con slancio. «Sì, ho tante cose da raccontarti che non ne hai idea. Mentre ero da Erica ho avuto il tempo di riflettere. Ho capito quello che credo tu sappia già da tempo: che ora siamo rimasti solo tu e io e che dobbiamo stare uniti, fare un tentativo. Ti amo, Mårten. Vincent sarà sempre qui» si portò una mano al cuore, «ma non possiamo vivere come se fossimo morti anche noi.» Smise di parlare e aspettò una reazione, ma lui rimase in silenzio. «Tante tessere sono finite al loro posto quando Erica mi ha raccontato della mia famiglia.» Si sedette accanto a lui e cominciò a parlargli infervorata di Laura, di Dagmar e della fabbricante di angeli. Quando ebbe finito, Mårten annuì. «La colpa è stata tramandata.» «Cosa vuoi dire?» «La colpa è stata tramandata» ripeté lui, questa volta con la voce in falsetto. Si passò di scatto una mano nei capelli, spettinandoli. Lei allungò una mano per lisciarglieli ma lui gliela scostò. «Tu non hai mai voluto riconoscere la tua colpa.» «Quale colpa?» Sentì insinuarsi una sensazione sgradevole, ma cercò di scacciarla. Era Mårten, suo marito. «Della morte di Vincent. Come facciamo ad andare avanti se tu non l’ammetti? Ora però capisco perché: ce l’hai dentro. La nonna di tua nonna era un’infanticida e tu hai ucciso nostro figlio.» A quelle parole Ebba arretrò di scatto come per uno schiaffo. Lei avrebbe ucciso Vincent? La disperazione le risalì dal petto e avrebbe voluto urlare, ma capiva che Mårten aveva qualcosa che non andava. Non sapeva quello che diceva, era l’unica spiegazione possibile. Altrimenti non avrebbe mai pronunciato una frase tanto terribile. «Mårten» disse nel tono più calmo che riuscì a trovare. Ma lui le puntò addosso l’indice e continuò: «Sei stata tu a ucciderlo. La colpa è tua e te la porti addosso da sempre.» «Per favore, Mårten, di cosa stai parlando? Sai che non è andata così. Io non ho ucciso Vincent. Non è stata colpa di nessuno e tu lo sai!» Lo afferrò per le spalle e cercò di fargli tornare un’ombra di ragione negli occhi. Si guardò intorno e di colpo vide il letto sfatto e, sul pavimento, i piatti con gli avanzi e i due bicchieri con un fondo di vino rosso. «Chi è stato qui?» chiese, senza ottenere risposta. Lui si limitò a guardarla con occhi gelidi. Ebba cominciò lentamente a strisciare all’indietro. L’istinto le diceva di allontanarsi. Quello non era Mårten ma qualcun altro e per un attimo si chiese da quanto tempo fosse la persona che aveva davanti in quel momento. Da quanto tempo c’era nei suoi occhi quel gelo che lei non aveva mai notato prima? Continuò ad arretrare ma lui si alzò con movimenti rigidi, senza toglierle gli occhi di dosso. Terrorizzata, accelerò e fece per mettersi in piedi ma lui allungò una mano e la spinse di nuovo a terra. «Mårten?» ripeté Ebba. Non aveva mai alzato un dito su di lei, mai. Era quello che protestava se lei voleva uccidere un ragno e insisteva per portarlo fuori in libertà, prendendolo con delicatezza. Lentamente, Ebba si rese conto che quel Mårten non esisteva più. Forse era andato in pezzi alla morte di Vincent, solo che lei, troppo presa dal proprio dolore, non se n’era accorta. E ormai era troppo tardi. Mårten inclinò la testa di lato e la studiò come se fosse una mosca rimasta impigliata nella sua ragnatela. Ebba sentiva il cuore battere forte nel petto ma non riusciva a opporre resistenza. Dove poteva scappare? Era più semplice arrendersi. Si sarebbe riunita con Vincent e nella morte non c’era nulla che la spaventasse. Provava solo tristezza. Tristezza per quello che si era rotto in Mårten e per il fatto che la speranza di un futuro fosse andata in frantumi così presto. Quando lui si chinò e le sue mani le si chiusero intorno alla gola sostenne calma il suo sguardo. Erano calde e familiari perché le avevano accarezzato tante volte la pelle. Premevano sempre più forte e il cuore impazzì mentre dietro le palpebre la luce esplodeva e il corpo recalcitrava cercando l’ossigeno, ma con la volontà lei gli impose di rilassarsi. Mentre il buio le calava nella mente Ebba si riconciliò con il suo destino. Vincent la stava aspettando. Gösta era rimasto seduto nella sala riunioni. L’eccitazione scatenata dalla scoperta del passaporto mancante aveva cominciato ad attenuarsi. Forse era solo un vecchio scettico, ma non poteva fare a meno di pensare che potevano esserci molte spiegazioni. Magari il passaporto di Annelie si era strappato o era stato perso, oppure veniva conservato in un luogo diverso dagli altri ed era sparito quando era stata svuotata la casa. Nello stesso tempo non era inverosimile che avesse un significato, ma sarebbe toccato a Patrik scoprirlo. Quanto a lui, sentiva il bisogno di ripassare tutto in rassegna con la massima precisione. Lo doveva a Ebba. Poteva esserci qualcosa che avevano visto senza capirne l’importanza, qualcosa che non avevano esaminato con la dovuta attenzione. Maj-Britt non l’avrebbe mai perdonato se non avesse fatto tutto il possibile per aiutare quella ragazza. Ebba era tornata a Valö. Là l’aspettava qualcosa di cupo e minaccioso e lui doveva proteggerla. Quella bambina si era conquistata un posto speciale nel suo cuore fin da quando gli si era aggrappata alla gamba nel momento in cui doveva andare via. Era stato uno dei giorni peggiori della vita di Gösta. La mattina in cui l’assistente sociale era venuta per portare Ebba dalla sua nuova famiglia gli era rimasta impressa per sempre nella memoria. Maj-Britt le aveva fatto il bagno, l’aveva pettinata, le aveva legato i capelli con un fiocco e le aveva messo l’elegante vestitino bianco con il nastro in vita che aveva confezionato stando alzata fino a tardi diverse sere di seguito. Lui quasi non era riuscito a guardare la piccola, quella mattina, tanto era bella. Per paura che gli si spezzasse il cuore non voleva neanche dirle addio, ma Maj- Britt aveva detto che dovevano salutarla per bene. Così, si era accovacciato e aveva spalancato le braccia e lei gli era corsa incontro con il fiocco che sobbalzava e la gonnellina che le si apriva dietro come una vela bianca. Gli aveva stretto le braccia al collo e l’aveva tenuto forte, come se sapesse che era l’ultima volta che si vedevano. Gösta deglutì e tirò fuori i vestitini di Ebba da uno scatolone appena chiuso da Patrik. «Gösta.» Patrik era sulla porta. Lui trasalì e si voltò. Tra le mani aveva ancora una magliettina bianca da neonata. «Come mai conoscevi l’indirizzo dei genitori di Ebba a Göteborg?» Gösta rimase in silenzio. Cercò una spiegazione plausibile mentre i pensieri gli si accavallavano nella mente: aveva visto l’indirizzo da qualche parte e l’aveva memorizzato... Sarebbe sicuramente riuscito a farlo credere a Patrik, ma invece sospirò e disse: «Ero io che mandavo gli auguri di compleanno.» «“G”» disse Patrik. «Devo essere veramente lento di comprendonio a non aver neanche pensato alla possibilità che fossi tu.» «Avrei dovuto dirtelo, e ci ho provato più volte.» Chinò il capo, pieno di vergogna. «Ma ho solo mandato gli auguri. L’ultima cartolina, quella che ha portato Mårten, non era mia.» «Me lo immagino. A dire il vero mi ha lasciato perplesso fin dall’inizio proprio perché si scostava così tanto dagli altri biglietti.» «E neanche l’imitazione della scrittura era particolarmente riuscita.» Gösta mise giù la minuscola maglietta e incrociò le braccia sul petto. «Già, il tuo stile a zampa di gallina non deve essere stato facile da copiare.» Gösta sorrise, sollevato all’idea che Patrik avesse deciso di mostrarsi così comprensivo. Non era sicuro che, al suo posto, sarebbe stato altrettanto magnanimo. «So che questo caso è speciale per te» continuò Patrik come se gli avesse letto nel pensiero. «Non posso permettere che le succeda qualcosa.» Gösta si voltò e ricominciò a frugare tra gli oggetti nello scatolone. Patrik rimase dov’era finché il collega non tornò a girarsi. «Se Annelie fosse in vita, o almeno se lo fosse stata allora, cambierebbe tutto. Hai contattato Leon per dirgli che vogliamo parlargli di nuovo?» «Preferisco coglierlo di sorpresa. Se riusciamo a prenderlo in contropiede abbiamo qualche possibilità in più di farlo parlare.» Patrik chiuse la bocca e sembrò non sapere se continuare o no. Poi disse: «In realtà penso di aver indovinato chi ha mandato quella cartolina.» «Chi?» Patrik scosse la testa. «È stata solo un’idea che mi è venuta in mente e ho chiesto a Torbjörn di verificare una cosa. Saprò di più quando mi risponderà. Prima di allora preferisco non dire niente, ma prometto di riferirlo a te prima che a chiunque altro.» «Lo spero davvero.» Gösta gli voltò le spalle. Gli restava parecchio da controllare. C’era qualcosa che aveva già visto che richiedeva la sua attenzione e non si sarebbe arreso finché non avesse scoperto cos’era. Probabilmente Rebecka non avrebbe capito, ma Josef le aveva lasciato lo stesso una lettera perché almeno sapesse che provava riconoscenza per la vita che avevano trascorso insieme e che la amava. Si era reso conto di aver sacrificato al suo sogno sia lei sia i figli. La vergogna e il dolore l’avevano reso cieco, impedendogli di vedere quanto significavano per lui, e ciononostante loro erano rimasti al suo fianco. Aveva imbucato anche due biglietti per i figli. Non contenevano una spiegazione, ma solo qualche parola di commiato e delle indicazioni su cosa si aspettava da loro. Era importante che non dimenticassero di avere una responsabilità e un compito da portare a termine, anche se lui non sarebbe stato lì a ricordarlo a entrambi. Mangiò lentamente l’uovo che si era preparato per pranzo facendolo bollire esattamente otto minuti. All’inizio del loro matrimonio Rebecka non era mai precisa: a volte erano sette, a volte nove. Ormai era passato un sacco di tempo dall’ultima volta che aveva sbagliato la cottura. Era stata una moglie brava e leale ed era piaciuta anche ai suoi genitori. Nei confronti dei figli, invece, era spesso troppo remissiva e questo lo preoccupava. Sebbene fossero adulti, avevano ancora bisogno di essere guidati con mano ferma e non era sicuro che Rebecka fosse in grado di farlo. Dubitava anche che riuscisse a mantenere vivo in loro il retaggio ebraico. Ma che alternativa gli restava? La sua vergogna sarebbe rimasta appiccicata a tutti loro impedendo ai ragazzi di affrontare la vita a testa alta. Era costretto a sacrificarsi per il loro futuro. In un momento di debolezza era stato sfiorato dal pensiero della vendetta, ma l’aveva scacciato subito. Sapeva per esperienza che non portava mai niente di buono, ma solo tenebre ancora più profonde. Dopo aver finito di mangiare l’uovo si pulì la bocca con cura e si alzò da tavola. Quando uscì di casa per l’ultima volta non si voltò indietro. Anna fu svegliata dal rumore di una pesante porta che veniva aperta. Confusa, socchiuse gli occhi verso la striscia di luce che si era formata. Dov’era? Sentendo pulsare le tempie, si alzò a sedere con uno sforzo. Faceva freddo e sul corpo aveva solo un lenzuolo sottile. Si raggomitolò tremando, le braccia strette intorno alle gambe, sentendo insinuarsi il panico. Mårten. Era l’ultimo ricordo che aveva. Si trovavano nel letto. Avevano bevuto del vino e lei si era sentita colmare da un intenso desiderio. Cercò di scacciare quel ricordo, ormai nitido, ma le immagini del proprio corpo nudo contro il suo le balenarono nella mente. La luce lunare sul letto dove si muovevano, e poi solo buio. Non ricordava altro. «C’è qualcuno?» chiamò rivolta alla porta, senza ottenere risposta. Sembrava tutto irreale, quasi fosse finita in un altro mondo come Alice nel Paese delle Meraviglie quando era precipitata nella tana del coniglio. «C’è qualcuno?» chiamò di nuovo cercando di alzarsi in piedi, ma le gambe le cedettero facendola rovinare di nuovo a terra. Qualcosa di grosso fu gettato dentro e poi la porta si richiuse con un colpo. Anna rimase immobile nella stanza di nuovo buia come la pece. Non filtrava neanche un filo di luce ma in qualche modo doveva capire cos’era l’oggetto e così avanzò strisciando lentamente, tastoni. Il pavimento era talmente freddo che le si intorpidirono le dita, mentre le ginocchia si graffiavano sulla superficie ruvida. Alla fine sfiorò qualcosa che le sembrò stoffa. Continuò a tastare e quando sentì della pelle sotto i polpastrelli arretrò di scatto. Era un corpo umano. Gli occhi erano chiusi e all’inizio le sembrò che non respirasse, ma era caldo. Scivolò tastoni con le dita fino alla gola, avvertendo un debole battito, e senza pensare strinse il naso della donna mentre con un solo movimento le sollevava la testa all’indietro e, chinandosi, appoggiava la bocca alla sua. Perché era una donna, ne era certa: lo capiva dall’odore e dai capelli e mentre le immetteva aria nella bocca, ancora e ancora, le sembrò di riconoscerla all’olfatto. Non sapeva per quanto fosse durato il tentativo di rianimazione. A intervalli regolari appoggiava una mano sull’altra premendo sul petto della donna. Non era del tutto sicura di compiere il movimento giusto: l’aveva visto fare solo in televisione, nelle serie sulla vita in corsia, e sperava che avessero riportato ciò che accadeva nella realtà e non una versione inventata del massaggio cardiaco. Dopo quella che le sembrò un’eternità, la donna diede un colpo di tosse, seguito da un conato. Anna si affrettò a girarla sul fianco e le massaggiò la schiena. La tosse si calmò e la donna inspirò aria in lunghi respiri fischianti. «Dove sono?» gracchiò. Anna le accarezzò i capelli per calmarla. La voce era talmente strozzata da renderla quasi irriconoscibile, ma non era difficile tirare a indovinare. «Ebba, sei tu? È talmente buio, qui, che non si vede niente.» «Anna? Pensavo che fossi io a essere diventata cieca.» «No, non sei cieca. È buio, e non so dove siamo.» Ebba fece per dire qualcosa ma fu interrotta da un accesso di tosse che le sconquassò il corpo. Anna continuò ad accarezzarle i capelli finché lei fece capire che voleva alzarsi a sedere. L’aiutò tenendola per il braccio e dopo qualche secondo la tosse si calmò. «Non lo so neanche io» disse. «Come siamo finite qui?» Ebba non rispose subito. Poi sussurrò: «Mårten.» «Mårten?» Anna rivide davanti agli occhi l’immagine dei loro corpi nudi. Il senso di colpa le fece venire la nausea, ma lo ricacciò giù. «Ha...» Ebba tossì di nuovo. «Ha cercato di strozzarmi.» «Ha cercato di strozzarti?» ripeté Anna incredula, ma le sue parole le risvegliarono un pensiero nel profondo. Aveva intuito, seppure vagamente, che in Mårten qualcosa non andasse, più o meno come un animale riesce a capire dall’odore se un membro del branco è malato. Ma questo non aveva fatto che aumentare l’attrazione nei suoi confronti. Il pericolo era qualcosa a cui era abituata e che riconosceva, e il giorno prima aveva riconosciuto Lucas in Mårten. La nausea risalì prepotente e il freddo le si propagò nel corpo dal pavimento, facendola tremare sempre più forte. «Dio santo, che freddo. Dove può averci rinchiuse?» chiese Ebba. «Ci farà uscire, no?» disse Anna, ma si accorse da sola di quanto suonasse poco convinta la sua voce. «Non lo riconoscevo più. Era come se fosse diventato un altro. Gliel’ho letto negli occhi. Ha detto...» Si fermò e di colpo scoppiò a piangere. «Ha detto che avevo ucciso Vincent. Nostro figlio.» Senza una parola, Anna l’abbracciò e le fece appoggiare la testa alla propria spalla. «Come è successo?» chiese dopo un po’. Ebba piangeva così forte che all’inizio non riuscì a rispondere. Poi il respiro si fece più calmo. «È stato all’inizio di dicembre. Eravamo molto impegnati. Mårten stava seguendo tre cantieri in contemporanea e anche io lavoravo fino a tardi. Probabilmente Vincent ne risentiva, perché era capricciosissimo e ci metteva continuamente alla prova. Eravamo distrutti.» Tirò su col naso e Anna sentì che si passava la manica sul viso. «La mattina in cui è successo stavamo per andare tutti e due al lavoro. Mårten avrebbe dovuto portare Vincent al nido ma l’hanno chiamato da un cantiere dicendo che doveva andare subito. Come al solito c’era un’emergenza. Mi ha chiesto di pensare io a Vincent per poter uscire subito, ma io avevo una riunione importante e mi sono arrabbiata perché secondo lui il suo lavoro era più importante del mio. Ci siamo messi a litigare e alla fine Mårten se n’è andato e mi ha lasciato sola con il bambino. Mi sono resa conto che sarei arrivata tardi alla riunione, per l’ennesima volta, e quando Vincent ha cominciato a fare i capricci non ce l’ho più fatta. Mi sono chiusa in bagno e mi sono messa a frignare. Vincent piangeva e batteva alla porta ma dopo un minuto circa è sceso il silenzio e io ho dato per scontato che si fosse arreso e fosse andato in camera sua. Così ho aspettato qualche minuto e mi sono lavata la faccia, per calmarmi un po’.» Ebba parlava talmente veloce che le parole si accavallavano e d’istinto Anna avrebbe voluto chiudersi le orecchie con le mani per non sentire, ma era costretta ad ascoltare. Lo doveva a Ebba. «Ero appena uscita dal bagno quando ho sentito un tonfo dal vialetto d’ingresso e poi Mårten si è messo a gridare. Non avevo mai sentito grida simili. Erano disumane. Sembravano di un animale ferito.» La voce le s’incrinò, ma dopo un attimo riuscì a continuare: «Ho capito subito. Sapevo che Vincent era morto, lo sentivo dentro. Eppure mi sono precipitata fuori e l’ho visto lì, dietro la nostra macchina. Era uscito solo con il maglioncino e sebbene vedessi benissimo che era morto non riuscivo a smettere di pensare che era nella neve senza la tuta termica e che si sarebbe ammalato. Era questo che pensavo quando l’ho visto lì disteso: che si sarebbe ammalato.» «È stato un incidente» disse Anna piano. «Non è stata colpa tua.» «Sì invece, Mårten ha ragione. Ho ucciso io Vincent. Se solo non fossi andata in bagno, se solo me ne fossi fregata del ritardo, se solo...» Il pianto si trasformò in un ululato e Anna se la strinse addosso ancora di più, lasciandola sfogare mentre le accarezzava la testa e mormorava parole di conforto. Il dolore di Ebba le penetrò nel corpo scacciando per un attimo la paura. In quel momento erano solo due madri che avevano perso i loro bambini. Quando il pianto si fu calmato, Anna tentò di nuovo di alzarsi. Le gambe reggevano meglio. Si mise lentamente in piedi, non sapendo se avrebbe sbattuto la testa, ma si accorse che poteva stare eretta. Fece un passo avanti. Qualcosa le sfiorò il viso facendole cacciare un urlo. «Cosa c’è?» Ebba le si avvinghiò a una gamba. «Ho sentito qualcosa sulla faccia, ma sarà stata una ragnatela.» Sollevò tremando la mano nell’aria. Davanti a lei c’era qualcosa, ma prima di riuscire ad afferrarlo dovette fare diversi tentativi. Un filo. Provò a tirare. La luce che si accese l’abbagliò, costringendola a chiudere gli occhi. Quando li riaprì, si guardò intorno sbigottita. Ai suoi piedi, Ebba trattenne il respiro di scatto. Aveva goduto del suo potere per tanti anni, anche nei casi in cui aveva scelto di non esercitarlo. Pretendere qualcosa da John sarebbe stato troppo pericoloso. Non era più la persona che Sebastian aveva conosciuto a Valö: sembrava così pieno d’odio, anche se lo nascondeva bene, che sarebbe stato azzardato sfruttare l’opportunità che il destino gli aveva offerto. Non aveva preteso nulla neanche da Leon, semplicemente perché era l’unica persona, a parte Sopravvento, per cui avesse mai provato rispetto. Dopo quello che era successo era sparito in fretta, ma Sebastian l’aveva seguito sui giornali e per mezzo delle dicerie che arrivavano fino a Fjällbacka. Di punto in bianco Leon si era immischiato nel gioco fino a quel momento portato avanti da lui, ma se non altro Sebastian era riuscito a trarne i vantaggi che aveva voluto. Il folle progetto di Josef era soltanto un ricordo. Il terreno e il granito erano le uniche cose che avessero un valore e lui le aveva trasformate in monete sonanti, secondo il contratto che Josef aveva firmato senza neanche scorrerlo con gli occhi. E poi Percy. Sebastian rise tra sé e sé mentre guidava la Porsche gialla nelle strade strette di Fjällbacka salutando una persona ogni due. Percy viveva cullandosi nel proprio mito da tanto di quel tempo che era convinto di non poter perdere tutto. Certo, prima che lui arrivasse come un angelo salvatore si era preoccupato, ma probabilmente non aveva mai realmente concepito l’idea di venire privato di ciò che aveva avuto per diritto di nascita. Così il castello era passato nelle mani dei due fratelli minori, ed era stata colpa sua. Non aveva saputo amministrare l’eredità e Sebastian aveva solo fatto in modo che la catastrofe si verificasse un po’ prima di quanto sarebbe successo altrimenti. Anche su quell’affare aveva guadagnato bene, ma era quasi un di più: era il potere a dargli veramente soddisfazione. La cosa buffa era che né Josef né Percy sembravano averlo capito prima che fosse troppo tardi. Nonostante tutto, avevano sperato nella sua benevolenza, convinti che avesse voluto davvero aiutarli. Che imbecilli. Be’, comunque Leon avrebbe pensato a concludere il gioco. Probabilmente era per questo che voleva che si vedessero tutti. La domanda era fino a che punto avesse intenzione di spingersi. In realtà, Sebastian non era preoccupato. La sua fama era già talmente diffusa che difficilmente qualcuno poteva restare sorpreso. Però era curioso di come avrebbero reagito gli altri. Soprattutto John, quello che aveva più da perdere in assoluto. Parcheggiò e rimase in auto per qualche istante. Poi scese, si assicurò di avere la chiave nella tasca dei pantaloni e andò alla porta per suonare il campanello. Showtime. Erica leggeva sorseggiando il caffè. Aveva un sapore orribile, perché la caraffa era sulla piastra della macchina da troppo tempo, ma non aveva voglia di prepararne dell’altro. «Sei ancora qui?» Gösta entrò nella saletta del personale e si riempì la tazza. Lei chiuse la cartellina che stava sfogliando. «Sì, mi è stato concesso di restare ancora un pochino per leggere questa vecchia indagine. E sono qui che mi chiedo cosa significhi il fatto che manchi il passaporto di Annelie.» «Quanti anni aveva? Sedici?» chiese Gösta sedendosi. Erica annuì. «Sì, sedici, e a quanto pare era innamorata cotta di Leon. Forse hanno litigato e lei ha deciso di andare via. Non sarebbe la prima volta che un amore adolescenziale causa una tragedia, se così fosse. Però faccio fatica a credere che una sedicenne abbia sterminato la sua famiglia.» «Infatti non è molto credibile. In questo caso dovrebbe essere stata aiutata. Da Leon, magari, se stavano insieme? Il papà aveva posto il veto, loro si erano infuriati...» «Sì, potrebbe essere andata così, ma qui c’è scritto che Leon era a pescare con gli altri. Perché avrebbero dovuto dargli un alibi? Cosa ci avrebbero guadagnato?» «Mi sembra difficile che stessero tutti con Annelie» disse Gösta pensoso. «No, non credo che si trastullassero con giochi così spinti.» «Anche ammesso che si tratti di Annelie, ed eventualmente di Leon, che ragione ci sarebbe stata di far fuori tutta la famiglia? Sarebbe dovuto bastare togliere di mezzo Rune.» «Sì, ho pensato esattamente la stessa cosa.» Erica sospirò. «Per questo sono qui che rileggo il materiale sugli interrogatori. Ci dev’essere qualcosa che non torna nei resoconti dei ragazzi, e invece hanno detto tutti la stessa cosa: erano fuori a pescare sgombri e quando sono tornati la famiglia era sparita.» Gösta si fermò con la tazza a mezz’aria. «Hai detto sgombri?» «Sì, così c’è scritto nei verbali.» «Come ho fatto a non accorgermi di una cosa del genere?» «Cosa vuoi dire?» Gösta mise giù la tazza e si passò una mano sul viso. «Evidentemente si può esaminare un rapporto di polizia un numero infinito di volte senza vedere quello che è chiarissimo.» Rimase in silenzio per un po’ e poi le sorrise trionfante. «Sai una cosa? Penso che abbiamo appena fatto saltare l’alibi dei ragazzi.» Fjällbacka 1970 Inez teneva molto ad assecondare sua madre. Sapeva che voleva il suo bene e che desiderava assicurarle un futuro sereno. Tuttavia non poteva negare che, seduta sul divano del salotto buono, si sentiva a disagio. Lui era così vecchio. «Con il tempo imparerete a conoscervi.» Laura guardò decisa la figlia. «Rune è un uomo onesto e affidabile e si prenderà cura di te. Sai bene che sono cagionevole di salute e quando non ci sarò più non ti rimarrà nessuno. Non voglio che tu debba essere sola come lo sono stata io.» La madre le appoggiò la mano rinsecchita sulla sua in un gesto inconsueto. Inez ricordava pochissime occasioni in cui l’aveva toccata in quel modo. «Capisco che la notizia arrivi un po’ all’improvviso» disse l’uomo che aveva davanti, guardandola come se fosse un cavallo premiato. Forse era ingiusto, ma Inez si sentiva esattamente così. E sì, era arrivata all’improvviso. La madre era stata ricoverata tre giorni in ospedale per il cuore e quando era tornata a casa aveva portato una proposta: che Inez sposasse Rune Elvander, rimasto vedovo un anno prima. Dalla morte di Nanna, erano rimaste solo loro due. «La mia cara moglie ha detto che dovevo trovare qualcuno che mi aiutasse a tirare su i figli. E tua madre dice che sei una brava ragazza» continuò l’uomo. Inez intuiva vagamente che non era così che funzionavano le cose. Gli anni Settanta erano appena cominciati e le donne avevano possibilità del tutto nuove di scegliersi la vita che volevano, ma lei non era mai stata parte del mondo reale, solo di quello perfetto creato dalla madre in cui la sua parola era legge, e se lei diceva che per Inez la scelta migliore era sposare un vedovo ultracinquantenne con tre figli non poteva metterlo in discussione. «Sto progettando di comprare la vecchia colonia di Valö per fondare un collegio maschile. Ho bisogno di avere qualcuno al mio fianco che mi aiuti anche lì. Sai preparare da mangiare, giusto?» Inez annuì. Aveva passato molte ore in cucina con Nanna, che le aveva insegnato tutto quello che sapeva. «Bene, allora è deciso» concluse Laura. «Naturalmente bisognerà prevedere un fidanzamento della durata adeguata. Cosa ve ne pare di un matrimonio tranquillo intorno alla festa di mezz’estate?» «Mi sembra perfetto» disse Rune. Inez rimase in silenzio, studiando il futuro marito e notando le rughe che avevano cominciato a formarsi intorno agli occhi e alla bocca sottile e decisa. I capelli scuri, un po’ radi sulle tempie, erano spruzzati di grigio. Dunque quello era l’uomo con cui si sarebbe sposata. I figli non li aveva ancora conosciuti. Sapeva solo che avevano quindici, dodici e cinque anni. Non aveva conosciuto molti bambini nella sua vita, ma sarebbe andato tutto bene. L’aveva detto la mamma. Seduto in macchina, Percy guardava l’imbocco del porto di Fjällbacka, ma in realtà non vedeva né le onde né le barche. Davanti agli occhi aveva solo il suo destino, il passato che si congiungeva con il presente. Quando gli avevano telefonato, suo fratello e sua sorella erano stati cortesi ma distanti. Faceva parte del bon ton comportarsi bene nei confronti dello sconfitto. Percy sapeva benissimo cosa si nascondeva dietro le loro frasi di convenienza. La gioia malevola era sempre uguale, che si fosse poveri o ricchi. Avevano comprato il castello, gli avevano comunicato, ma non era una novità. Dall’avvocato Buhrman aveva già saputo che Sebastian aveva agito alle sue spalle. Con le stesse parole e frasi usate da quest’ultimo, gli avevano spiegato che l’avrebbero trasformato in un centro congressi esclusivo. Era un peccato che fosse andata così, ma volevano che si trasferisse entro la fine del mese. Naturalmente il trasloco sarebbe avvenuto sotto la supervisione del loro avvocato, in modo che Percy non si portasse via per sbaglio qualcosa che rientrava nell’acquisto della proprietà. Lo stupiva che Sebastian si fosse presentato, quel giorno. Percy l’aveva visto passare e imboccare la salita per la casa di Leon. Abbronzato, camicia sbottonata, occhiali neri costosi e capelli pettinati all’indietro. Lo stesso di sempre. E sicuramente per lui era tutto come sempre. Solo business, come avrebbe detto con ogni probabilità. Lanciò un’ultima occhiata al proprio viso nello specchietto dell’aletta parasole. Aveva un aspetto orrendo. Gli occhi iniettati di sangue per colpa della mancanza di sonno e dell’eccesso di whisky. La pelle grigiastra e gonfia. Il nodo alla cravatta però era perfetto. Quello era un punto d’onore. Sollevò l’aletta con un colpo secco e scese dall’auto. Non c’era motivo di rimandare l’inevitabile. Ia appoggiò la testa contro il finestrino fresco del taxi. Il tragitto fino a Landvetter sarebbe durato poco meno di due ore, o forse di più, a seconda del traffico, e valeva la pena di provare a dormire un po’. Prima di andarsene l’aveva baciato. Sarebbe stato un inferno, per lui, doversela cavare da solo, ma lei non aveva intenzione di essere lì quando fosse esploso tutto. Leon le aveva assicurato che sarebbe andata bene. Era costretto a farlo, aveva detto. Altrimenti non avrebbe mai trovato pace. Ripensò per l’ennesima volta a quel viaggio in auto lungo le stradine ripide di Monaco. Lui stava per lasciarla. Le parole gli erano uscite di bocca. Si era messo a delirare di situazioni cambiate e di bisogni mutati, del fatto che avevano passato tanti begli anni insieme ma che aveva conosciuto una persona di cui si era innamorato, e che anche lei avrebbe trovato qualcuno con cui essere felice. Lei aveva staccato lo sguardo dalla strada tortuosa per guardarlo negli occhi e mentre lui continuava a vomitare frasi fatte aveva pensato a tutto quello che aveva sacrificato per amor suo. Quando l’auto aveva sbandato l’aveva visto sbarrare gli occhi. La valanga di parole insensate era cessata. «Guarda la strada mentre guidi» le aveva detto. L’ansia gli si leggeva chiara in faccia, su quel viso bellissimo, e lei quasi non ci credeva. Per la prima volta in vita sua, Leon aveva paura. Inebriata da quell’inedito senso di potere, aveva premuto il pedale sentendo che il corpo veniva schiacciato contro il sedile dall’accelerazione. «Rallenta, Ia» aveva detto Leon. «Vai troppo veloce!» Lei non aveva risposto, aumentando invece la pressione del piede. La piccola auto sportiva quasi non toccava l’asfalto. Sembrava che fosse sospesa nell’aria e in quel momento Ia si era sentita completamente libera. Leon aveva cercato di prendere il volante ma l’auto aveva sbandato di nuovo e così l’aveva lasciato andare. L’aveva implorata ancora di rallentare e il terrore nella sua voce l’aveva resa più felice di quanto non fosse da un sacco di tempo. Ormai l’auto stava quasi volando. Aveva visto l’albero ed era stato come se un’energia proveniente dall’esterno si fosse impossessata di lei. Aveva sterzato calma un po’ a destra, puntando verso il tronco. Sentiva la voce di Leon a distanza, ma il ronzio nelle orecchie sovrastava tutto il resto. Poi intorno a lei era sceso il silenzio. Pace. Niente li avrebbe divisi. Sarebbero rimasti insieme per sempre. Quando si era accorta di essere viva aveva reagito con sorpresa. Accanto a lei, Leon aveva gli occhi chiusi e il viso coperto di sangue. Il fuoco si era sviluppato in fretta. Le fiamme cominciavano a lambire i sedili, allungandosi verso di loro. L’odore le pizzicava le narici. Doveva prendere una decisione: arrendersi e lasciare che entrambi fossero fagocitati dal fuoco o salvare se stessa e Leon. Osservò il suo bel viso. Il fuoco gli era arrivato vicino alla guancia e lei lo guardò affascinata attecchire alla pelle. Poi decise. Ormai lui era suo e solo suo. E così era stato dal giorno in cui lo aveva estratto dall’auto in fiamme. Ia chiuse gli occhi e sentì il freddo del vetro sulla fronte. Non voleva essere parte di quello che Leon si accingeva a fare ma aspettava con ansia il momento in cui si sarebbero ricongiunti. Anna si guardò intorno nella stanza spoglia illuminata da una nuda lampadina. C’era odore di terra e di qualcos’altro che era difficile identificare. Sia lei sia Ebba avevano tentato, invano, di aprire la porta strattonando la maniglia. Era chiusa a chiave e non si smuoveva. Lungo una parete c’erano quattro grandi bauli con gli inserti in ferro e sopra era appesa la bandiera, la prima cosa che avevano visto accendendo la luce. Era scurita dall’umidità e dalla muffa, ma la svastica si stagliava ancora nitidamente sullo sfondo rosso e bianco. «Forse lì dentro c’è qualcosa che puoi metterti» disse Ebba, guardandola. «Stai tremando come una foglia.» «Sì, qualsiasi cosa. Sto morendo di freddo.» Anna si vergognava della propria nudità, intuibile sotto il lenzuolo. Era una di quelle persone che detestava mostrarsi nuda persino negli spogliatoi e dall’incidente il disagio si era acuito, con tutte le cicatrici che le attraversavano il corpo. E sebbene il pudore potesse sembrare il minore dei guai, data la situazione, la sensazione era talmente intensa che penetrava attraverso la paura e il gelo. «Quei tre sono chiusi a chiave, ma questo è aperto.» Ebba indicò il baule più vicino alla porta. Sollevò il coperchio: in cima c’era una pesante coperta di lana grigia. «Tieni» disse lanciandola ad Anna, che se l’avvolse sopra il lenzuolo. Puzzava terribilmente, ma scaldava e proteggeva, e tanto le bastava. «C’è anche del cibo in scatola» disse Ebba sollevando alcuni barattoli impolverati. «Nella peggiore delle ipotesi dovremmo riuscire a cavarcela per un po’.» Anna la scrutò. Il suo tono quasi allegro non si addiceva né alla situazione né allo stato psichico in cui si trovava fino a qualche giorno prima. Doveva trattarsi di un qualche meccanismo di difesa. «Non abbiamo acqua» le fece notare, lasciando la frase sospesa nell’aria. Senza niente da bere non avrebbero resistito a lungo, ma Ebba continuò a frugare nel baule senza ascoltarla. «Guarda!» disse tirando fuori un capo di vestiario. «Un’uniforme nazista? Da dove arriva quella roba?» «Pare che durante la guerra la casa fosse di proprietà di un vecchio pazzo. Dev’essere sua.» «Assurdo» disse Anna, che non aveva ancora smesso di tremare. Il calore della coperta aveva lentamente cominciato a trasmettersi al corpo, ma era congelata fino al midollo e le ci sarebbe voluto un po’ per scaldarsi. «Ma tu come mai sei qui?» chiese Ebba di colpo, voltandosi verso di lei. Era come se solo in quel momento si fosse resa conto di quanto fosse strano che si trovassero entrambe in quella stanza. «Mårten deve aver aggredito anche me.» Anna si strinse meglio nella coperta. Ebba aggrottò le sopracciglia. «Perché? È successo senza un motivo oppure c’è stato qualcosa che...?» Si coprì la bocca con una mano e lo sguardo si fece duro. «Ho visto il vassoio in camera. Perché sei venuta qui ieri, in realtà? Ti sei fermata a cena? Cos’è successo?» Le parole mitragliavano le pareti come pallottole e a ogni domanda Anna trasaliva come per uno schiaffo. Non ebbe bisogno di dire niente. Sapeva che la risposta le si leggeva in faccia. Gli occhi di Ebba si riempirono di lacrime. «Come hai potuto? Sai bene cos’abbiamo passato, cosa stiamo passando.» Anna deglutì più volte ma aveva la bocca secchissima e non sapeva come spiegare quello che aveva fatto né come chiedere perdono. Ebba la fissò a lungo con gli occhi pieni di lacrime. Poi inspirò a fondo e fece uscire lentamente l’aria. In tono calmo e controllato, disse: «Adesso non ne parliamo. Per uscire di qui dobbiamo stare unite. Forse nei bauli possiamo trovare qualcosa per forzare la porta?» Le girò le spalle, il corpo irrigidito dalla collera trattenuta. Anna accolse riconoscente l’offerta di armistizio. Se non fossero uscite di lì non avrebbero avuto motivo di risolvere la questione. Nessuno si sarebbe accorto della loro sparizione per un po’. Dan e i bambini erano via e i genitori di Ebba si sarebbero preoccupati solo di lì a qualche giorno. Restava Erica, che spesso se non riusciva a mettersi in contatto con lei si agitava. Di solito la cosa la mandava in bestia ma in quel momento desiderava soltanto che sua sorella fosse in ansia e cominciasse a fare domande e diventasse ostinata come faceva sempre quando non riceveva le risposte giuste. Per favore, Erica adorata, sii ficcanaso e ansiosa come sempre, pregò Anna in silenzio nella luce della lampadina. Ebba aveva cominciato a dare calci alla chiusura del baule di fianco a quello aperto. Il lucchetto non sembrava cedere di un millimetro, ma lei non si arrese e alla fine qualche risultato cominciò a vedersi. «Vieni a darmi una mano» disse, e unendo gli sforzi riuscirono a far saltare la chiusura. Chinandosi, presero il coperchio ai due lati e cercarono di aprirlo. A giudicare dalla polvere e dalla sporcizia era chiuso da moltissimi anni e dovettero mettercela tutta. Alla fine si spalancò di colpo. Guardarono nel baule e poi si fissarono a vicenda. Anna vide il proprio orrore rispecchiato nel viso di Ebba. Poi sentì un grido echeggiare tra le pareti spoglie senza capire se venisse da lei o dall’altra. «Ciao, sei tu Kjell, vero?» Sven Niklasson gli andò incontro con la mano tesa e si presentò. «Non hai portato un fotografo?» Kjell si guardò intorno nello spazio ristretto vicino al nastro dei bagagli. «Ne arriva uno da Göteborg. Viene in macchina e ci troviamo direttamente là.» Sven aveva con sé solo un piccolo trolley da cabina. Si capiva che era abituato a fare le valigie in fretta e viaggiare leggero. «Pensi che dovremmo informare la polizia di Tanum, in fin dei conti?» chiese prendendo posto sul sedile del passeggero nella grossa auto familiare. Kjell ci pensò su mentre usciva dal parcheggio e girava a destra dopo il rettilineo. «Sì, secondo me sì. Però devi parlare con Patrik Hedström. Nessun altro.» Lanciò un’occhiata al collega. «Di solito non vi preoccupate di quali distretti di polizia sono informati, o sbaglio?» Sven sorrise e guardò verso il paesaggio oltre il finestrino. Aveva avuto fortuna: illuminato dal sole estivo, Trollhättebron era stupendo. «Non si sa mai quando può servire un favore da qualcuno addentro agli ingranaggi. Io mi sono già messo d’accordo con quelli di Göteborg perché possiamo essere presenti quando agiscono, dato che siamo stati noi a offrire loro questa possibilità. Informare la polizia di Tanum sarà un puro atto di cortesia.» «Temo che la polizia di Göteborg non abbia avuto le stesse attenzioni, quindi farò notare a Hedström la tua generosità.» Kjell abbozzò un sorrisino. Quanto a lui, era profondamente grato a Sven Niklasson di avergli concesso di partecipare a margine. Quello non era solo uno scoop ma qualcosa che avrebbe rivoluzionato la politica svedese e scioccato l’intera popolazione. «Grazie di avermi permesso di partecipare» mormorò, sentendosi improvvisamente in imbarazzo. Sven alzò le spalle. «Se tu non mi avessi fornito quelle informazioni, non saremmo stati in grado di arrivare in fondo alla questione.» «Quindi siete riusciti a decifrare il codice?» Kjell stava scoppiando per la curiosità. Al telefono Sven non aveva avuto il tempo di rivelargli tutti i particolari. «Era di una semplicità al limite del ridicolo» rise Sven. «L’avrebbero decrittato i miei figli in un quarto d’ora.» «Come?» «Uno corrisponde alla A, due alla B e così via.» «Stai scherzando.» Kjell guardò Sven e per poco non andò fuori strada. «No, anche se vorrei. Questo la dice lunga su quanto pensano che siamo scemi.» «E cosa è venuto fuori?» Kjell cercò di rivedere davanti agli occhi la combinazione, ma già a scuola aveva una pessima memoria numerica e ormai ricordava a stento il suo numero di telefono. «Stureplan. C’era scritto Stureplan, e poi una data e un orario.» «Porca troia. Poteva andare veramente a finire malissimo» commentò Kjell girando a destra all’altezza della rotatoria di Torp. «Sì, ma stamattina presto la polizia ha preso gli esecutori materiali dell’attentato. Adesso non hanno la possibilità di comunicare con nessuno e rivelare che noi e la polizia siamo al corrente di tutto. Per questo c’era tanta fretta. Non passerà molto tempo prima che i responsabili del partito si accorgano che non si fanno vivi e non sono rintracciabili, e allora sì che cominceranno a temere il peggio. È gente che ha contatti in tutto il mondo e non avrebbe problemi a sparire. E in quel caso avremmo perso la nostra occasione.» «In un certo senso il piano era geniale» disse Kjell. Non riusciva a smettere di pensare a quello che sarebbe potuto succedere se fosse stato portato a termine. Le immagini nella sua mente erano nitide. Sarebbe stata una catastrofe. «Sì, e nonostante tutto dovremmo essere contenti che abbiano mostrato il loro vero volto. Sarà un brusco risveglio per chi ha creduto in John Holm. Per fortuna. Poi spero che passi un bel pezzo prima che succeda di nuovo qualcosa del genere. Purtroppo però temo che noi esseri umani abbiamo la memoria corta, a volte.» Sospirò e si girò a guardare Kjell. «Vuoi chiamare quell’Hedman allora?» «Hedström. Patrik Hedström. Sì, adesso lo chiamo.» Tenendo d’occhio la strada, compose il numero. «Cos’avete da sbraitare?» chiese Patrik entrando nella saletta del personale con un sorriso sulle labbra. Erica l’aveva chiamato a voce alta e lui si era affrettato a raggiungerla. «Siediti» disse Gösta. «Sai bene quante volte ho passato in rassegna questo vecchio materiale, no? I ragazzi avevano fornito tutti la stessa versione ma io ho sempre sentito che qualcosa non tornava.» «E adesso abbiamo scoperto cos’era.» Erica incrociò soddisfatta le braccia sul petto. «Cosa?» «Gli sgombri.» «Gli sgombri? Non è che potreste spiegarvi meglio?» «Non avevo visto che pesci avevano con sé in barca» disse Gösta. «E per qualche insondabile motivo durante gli interrogatori non ci pensai.» «Non pensasti a cosa?» chiese Patrik impaziente. «Al fatto che gli sgombri non si possono pescare prima della mezz’estate» rispose Erica parlando molto chiaramente, come se si rivolgesse a un bambino. Patrik cominciò a intuire lentamente dove volevano arrivare. «Negli interrogatori tutti i ragazzi dicevano di essere andati a pesca di sgombri.» «Esatto. Uno poteva anche essersi sbagliato, ma il fatto che sostenessero tutti la stessa cosa significa che si erano messi d’accordo. E non avendo sufficienti competenze in materia avevano scelto il pesce sbagliato.» «È stato grazie a Erica che ci sono arrivato» ammise Gösta con aria leggermente vergognosa. Patrik le lanciò un bacio. «Sei la migliore!» E diceva sul serio. Nello stesso istante squillò il telefono e dal display vide che era Torbjörn. «Devo rispondere. Comunque bravi, tutti e due!» Sollevò il pollice, andò nel suo ufficio e chiuse la porta. Poi ascoltò attentamente quello che aveva da dire il capo della scientifica e prese qualche appunto al volo sul primo foglio che trovò sulla scrivania. Per quanto strano, il suo sospetto era stato confermato. Mentre ascoltava Torbjörn rifletté sulle implicazioni. Quando chiusero la telefonata sapeva di più ma, nello stesso tempo, la confusione che aveva in testa era aumentata. Dal corridoio sentì dei passi pesanti e aprendo la porta vide arrivare Paula con il pancione in resta. «Non ce la faccio più a stare a casa ad aspettare. La tipa della banca con cui ho parlato aveva promesso di farsi viva oggi ma non ha ancora chiamato...» Dovette interrompersi per riprendere fiato. Patrik le appoggiò una mano sulla spalla, cercando di tranquillizzarla. «Respira, santo cielo» disse aspettando che si calmasse. «Te la senti di partecipare a una riunione per fare il punto?» «Certo.» «Dove cavolo eri finita?» Alle sue spalle spuntò Mellberg. «Quando sei sparita senza dire niente Rita si è preoccupata e mi ha spedito a cercarti.» Si asciugò il sudore dalla fronte. Paula alzò gli occhi al cielo. «Sto bene, non c’è niente che non vada.» «Meglio così, almeno ci siamo tutti. Abbiamo parecchio da discutere.» Patrik li precedette verso la sala riunioni e si fermò a chiamare anche Gösta. Dopo qualche secondo di esitazione tornò nella saletta del personale. «Puoi venire anche tu» disse con un cenno rivolto a Erica che, come prevedibile, saltò su dalla sedia all’istante. Nella stanza si stava stretti ma Patrik voleva che la riunione si svolgesse proprio lì, in mezzo agli effetti personali della famiglia Elvander che servivano a ricordare a tutti il motivo per cui era fondamentale riannodare tutti i fili. Spiegò brevemente a Mellberg e Paula che lui e Gösta erano andati a prendere gli scatoloni da Olle il rigattiere e che poi avevano passato in rassegna tutto. «Qualche tessera è finita al suo posto, ma dobbiamo unire le forze per andare avanti. Prima però posso dirvi che il misterioso “G” che inviava i biglietti di auguri a Ebba era qualcuno di nostra conoscenza.» Indicò Gösta, che arrossì. «Ma dai...» disse Paula. Mellberg, paonazzo, sembrava sul punto di esplodere. «Sì, lo so che avrei dovuto dirlo, ma ho già discusso della cosa con Hedström.» Gösta guardò il capo di sottecchi. «Con l’ultima cartolina lui non c’entra, e in effetti la differenza dagli altri biglietti è notevole» continuò Patrik appoggiandosi al bordo del tavolo. «Mi è venuta un’idea su cosa poteva essere successo e Torbjörn, con cui ho appena parlato, ha confermato i miei sospetti. L’impronta digitale che ha trovato sul retro del francobollo, e che è congruo pensare appartenga a chi ha affrancato e spedito il biglietto, corrispondeva a una delle impronte trovate sulla bustina di plastica in cui era stato inserito quando Mårten ce l’ha consegnato.» «Ma scusa, quella bustina l’avete presa in mano solo voi e Mårten, no? Allora è...» Erica impallidì e Patrik vide che i pensieri le si accavallavano nella mente. Cercò affannosamente il cellulare nella borsetta e, con gli occhi di tutti puntati addosso, premette un tasto di chiamata rapida. Nella stanza regnava il silenzio più completo. Si sentirono diversi squilli e poi scattò quella che doveva essere una segreteria telefonica. «Merda» disse Erica, componendo un altro numero. «Adesso chiamo Ebba.» Gli squilli si susseguirono senza che rispondesse nessuno. «Cazzo» imprecò facendo un terzo tentativo. Patrik non accennò a continuare. Anche lui aveva cominciato a preoccuparsi del fatto che Anna non fosse rintracciabile dal giorno prima. «Quando è andata là?» chiese Paula. Erica aveva ancora il cellulare contro l’orecchio. «Ieri sera, e da allora non sono più riuscita a parlarle. Adesso sto chiamando il postale. Stamattina hanno dato un passaggio a Ebba e forse sanno qualcosa... Pronto? Sì, sono Erica Falck... Esatto. Avete accompagnato Ebba... E l’hai lasciata là? Per caso hai visto se c’era un’altra barca?... Un beccaccino di legno? Ah, okay, quindi era ormeggiato al pontile della colonia. Grazie.» Erica chiuse la telefonata e Patrik vide che la mano le tremava leggermente. «La nostra barca, usata ieri da Anna per andare all’isola, è ancora là. Quindi sia lei sia Ebba sono a Valö con Mårten e nessuna delle due risponde.» «Non sarà successo niente. E magari nel frattempo Anna è tornata a casa» disse Patrik cercando di suonare più calmo di quanto non fosse realmente. «Ma Mårten ha detto che si era fermata solo un’ora. Perché ha mentito?» «Sicuramente c’è una spiegazione. Andiamo a controllare appena abbiamo finito qui.» «Per quale motivo Mårten dovrebbe spedire una lettera minatoria a sua moglie?» chiese Paula. «Significa che è lui ad avere tentato di ucciderla?» Patrik scosse la testa. «Al momento non lo sappiamo. Per questo dobbiamo rivedere tutto quello che abbiamo scoperto per verificare se ci sono delle lacune da colmare. Gösta, riferisci quello che hai scoperto sulla testimonianza dei ragazzi, per favore.» «Certo.» Gösta spiegò la faccenda degli sgombri e il motivo per cui le dichiarazioni dei ragazzi non potevano coincidere con la realtà. «Dimostra che mentivano» disse Patrik. «E se hanno mentito su quel particolare avranno sicuramente mentito su tutto. Perché altrimenti avrebbero dovuto mettersi d’accordo e inventare una storia del genere? Secondo me possiamo dare per certo che erano coinvolti nella scomparsa della famiglia e adesso abbiamo un elemento in più con cui metterli alle strette.» «Ma come si collega tutto questo a Mårten?» chiese Mellberg. «Lui all’epoca non c’era, eppure secondo Torbjörn nel 1974 era stata usata la stessa arma di pochi giorni fa.» «Non lo so» rispose Patrik. «Procediamo un passo alla volta.» «Poi abbiamo il passaporto mancante» disse Gösta cambiando posizione sulla sedia. «Sì, manca il passaporto di Annelie. Potrebbe significare che era coinvolta in qualche modo ma che dopo è fuggita all’estero.» Patrik lanciò un’occhiata a Erica, pallidissima, e capì che non riusciva a non pensare ad Anna. «Annelie? La figlia sedicenne?» chiese Paula nello stesso istante in cui cominciò a squillare il suo cellulare. Rispose e ascoltò con un’espressione sorpresa e insieme decisa. Alla fine chiuse la chiamata e guardò gli altri. «I genitori adottivi di Ebba avevano detto a Patrik e me che qualcuno depositava dei soldi su un conto intestato a Ebba ogni mese fino al suo diciottesimo compleanno. Non erano mai riusciti a sapere chi fosse, ma naturalmente noi abbiamo pensato che potesse avere a che fare con gli avvenimenti di Valö. Così ho cercato di scoprire qualcosa di più...» Inspirò a fondo sentendo che le mancava l’aria e Patrik ricordò che Erica aveva avuto lo stesso problema, in gravidanza. «Vieni al punto!» Gösta si era raddrizzato sulla sedia. «Ebba non aveva parenti interessati a occuparsi di lei e probabilmente neanche a inviarle dei soldi, quindi l’unico motivo che mi viene in mente è che qualcuno lo facesse per mettere a tacere i sensi di colpa.» «Non ho idea delle motivazioni» rispose Paula, con l’aria di crogiolarsi nel piacere di avere l’informazione in esclusiva, «ma i soldi venivano da Aron Kreutz.» Scese un silenzio tale che nella stanza penetrò il rumore delle auto per strada. Gösta fu il primo a romperlo. «Il padre di Leon mandava soldi a Ebba? Ma perché...?» «Dobbiamo scoprirlo» disse Patrik. Di colpo gli fu chiaro che per risolvere il mistero della scomparsa della famiglia era diventato prioritario dare una risposta a quel dubbio. Sentì vibrare la tasca e guardò il display per vedere chi lo stava chiamando. Kjell Ringholm, del Bohusläningen. Probabilmente voleva fare qualche domanda per approfondire gli argomenti della conferenza stampa, ma avrebbe dovuto aspettare. Rifiutò la telefonata e rivolse di nuovo l’attenzione ai suoi colleghi. «Gösta, io e te andiamo a Valö. Prima di cominciare gli interrogatori con i cinque dobbiamo controllare che Anna ed Ebba non abbiano problemi e fare alcune domande a Mårten. Paula, tu intanto vedi se riesci a trovare qualcosa di più sul padre di Leon.» Quando lo sguardo gli cadde su Mellberg smise di parlare. Dove avrebbe potuto fare meno danni? A dire il vero lavorava il meno possibile, ma era importante che non si sentisse scalzato. «Commissario, come al solito lei è il più adatto a tenere le posizioni con la stampa. Ha qualcosa in contrario a fermarsi qui alla stazione e mettersi a disposizione se chiama qualche giornalista?» Mellberg s’illuminò. «No, è ovvio. Ho molti anni di esperienza in questo campo, quindi per me sarà un gioco da ragazzi.» Dentro di sé, Patrik sospirò. Il prezzo che doveva pagare per far filare lisce le cose era alto. «Posso venire anch’io a Valö?» chiese Erica, che teneva ancora il telefono in una stretta convulsa. Patrik scosse la testa. «Non se ne parla.» «Ma sarebbe meglio, davvero. Pensa se è successo qualcosa...» «Fine della discussione» la interruppe Patrik accorgendosi da solo della durezza della sua voce. «Scusami, ma è meglio che ce ne occupiamo noi» aggiunse abbracciandola. Erica annuì suo malgrado e uscì per tornare a casa. Lui la seguì con lo sguardo, prese il telefono e chiamò Victor. Dopo otto squilli scattò la casella vocale. «Alla guardia costiera non risponde nessuno. Proprio adesso che la nostra barca è ormeggiata a Valö, a quanto pare.» Dalla porta si sentì qualcuno schiarirsi la voce. «Purtroppo non posso andare da nessuna parte. La macchina non parte.» Patrik guardò la moglie con occhi dubbiosi. «Strano. Magari dalle tu un passaggio fino a casa, Gösta, così io intanto finisco un paio di cose qui. Tanto dobbiamo comunque aspettare di avere una barca.» «Certo» rispose Gösta senza guardare Erica. «Bene, allora ci vediamo poi giù al porto. Riprovi tu con Victor?» «Va bene.» Di nuovo gli vibrò la tasca e Patrik guardò automaticamente il display. Kjell Ringholm. Tanto valeva rispondere. «Okay, ciascuno faccia quello che deve» disse premendo il pulsante verde mentre guardava gli altri sfilare fuori. «Sì, parla Hedström» disse con un sospiro. Kjell gli andava a genio, ma in quel momento non aveva tempo per i giornalisti. Valö 1972 Annelie l’aveva odiata fin dall’inizio, e lo stesso valeva per Claes. Ai loro occhi non valeva niente, non in confronto alla loro mamma che doveva essere stata una santa. O almeno così pareva a sentire Rune e i suoi figli. Quanto a lei, aveva imparato parecchio sulla vita. La lezione più importante era che sua madre non aveva sempre ragione. Il matrimonio con Rune era stato l’errore più grande che avesse potuto commettere, ma Inez non vedeva una via d’uscita. Non più, visto che aspettava un figlio da lui. Si asciugò il sudore dalla fronte e poi continuò a sfregare il pavimento della cucina. Rune pretendeva che fosse tutto pulito e scintillante per l’apertura della scuola. Niente doveva essere lasciato al caso. «È in gioco la mia reputazione» diceva impartendole nuovi ordini. Lei sgobbava dalla mattina alla sera con la pancia che cresceva ed era così stanca che quasi non si reggeva in piedi. Di colpo lui era lì. L’ombra cadde su di lei facendola sussultare. «Oh, scusa. Ti ho spaventata?» disse con quella voce che le provocava sempre dei brividi lungo la schiena. L’odio era palpabile e come al solito la fece irrigidire al punto da toglierle il respiro. Non c’erano mai prove tangibili, niente che potesse riferire a Rune, e comunque lui non le avrebbe mai creduto. La sua parola valeva quanto un’altra e Inez non si faceva illusioni sul fatto che potesse prendere le sue parti. «È rimasta una macchia» disse Claes indicando un punto dietro di lei. Inez strinse i denti e si girò per pulire ma in quel momento sentì un rumore e si ritrovò con le ginocchia e le gambe bagnate. «Oh, che sbadato, mi sa che ho rovesciato il secchio» disse Claes con un tono fintamente dispiaciuto contraddetto dal suo sguardo. Lei si limitò a lanciargli un’occhiata. La rabbia le imperversava dentro intensificandosi a ogni giorno, ogni insolenza e ogni dispetto. «Ti aiuto io.» Johan, il figlio minore di Rune. Solo sette anni, ma due occhi saggi e pieni di calore. Le si era affezionato subito: già la prima volta che si erano visti le aveva infilato la manina nella sua. Con un’occhiata ansiosa al fratello maggiore le si inginocchiò accanto, le prese lo straccio e cominciò a raccogliere l’acqua che aveva allagato il pavimento. «Così ti bagni anche tu» gli disse commossa guardando la testa china e la frangia che gli ricadeva sugli occhi. «Non fa niente» rispose lui continuando ad asciugare. Claes rimase alle loro spalle con le braccia conserte sul petto. Negli occhi gli passò un lampo ma non osava prendersela con il fratellino. «Rammollito» disse andandosene. Inez tirò il fiato. In realtà era ridicolo: Claes aveva solo diciassette anni e anche se lei non ne aveva tanti di più era pur sempre la sua matrigna e portava in grembo quello che sarebbe stato suo fratello, o sua sorella. Non avrebbe dovuto lasciarsi intimorire da un ragazzino, ma senza che riuscisse a spiegarne il motivo le si rizzavano i peli delle braccia se solo lui si avvicinava troppo. Sentiva istintivamente che doveva stargli alla larga ed evitare di provocarlo. Si chiese come sarebbe cambiata la vita una volta arrivati gli allievi della scuola. Ormai mancava poco. Forse l’atmosfera sarebbe stata meno opprimente, con una casa piena di ragazzi le cui voci avrebbero riempito i vuoti? Lo sperava, altrimenti sarebbe soffocata. «Sei un bravo bambino, Johan» disse accarezzandogli la zazzera bionda. Lui non rispose, ma lei si accorse che sorrideva. Prima che arrivassero era rimasto seduto a lungo alla finestra a guardare in direzione di Valö osservando le imbarcazioni di passaggio e i villeggianti che si godevano qualche settimana di ferie. Pur sapendo che quella vita non faceva per lui, un po’ li invidiava. Sembrava un’esistenza meravigliosa in tutta la sua semplicità, anche se forse loro non se ne rendevano conto. Quando era suonato il campanello aveva spinto la sedia a rotelle lontano dalla finestra dopo un’ultima lunga occhiata all’isola su cui tutto era cominciato. «È venuto il momento di chiudere il cerchio.» Leon li squadrò. L’atmosfera era stata opprimente fin da quando erano arrivati alla spicciolata. Notò che né Percy né Josef guardavano Sebastian, il quale sembrava prendere la cosa senza scomporsi. «Che sfiga ritrovarti in sedia a rotelle con il viso completamente rovinato. E pensare che eri così bello» disse quest’ultimo appoggiandosi allo schienale del divano. Leon non se la prese. Sapeva che quelle parole non miravano a offendere. Sebastian era sempre stato molto schietto, tranne quando voleva fregare qualcuno. In quel caso mentiva. Incredibile che le persone cambiassero così poco. Anche gli altri erano gli stessi di sempre. Percy con quell’aria deboluccia e Josef con gli occhi seri come allora. John, che emanava lo stesso fascino di un tempo. Prima di arrivare a Fjällbacka con Ia si era informato su di loro. Un detective privato aveva fatto un ottimo lavoro, dietro un compenso generoso, e Leon sapeva tutto sulla piega presa dalle rispettive vite. Ma era come se niente di quanto successo dopo Valö avesse importanza, una volta riuniti tutti quanti. Non rispose all’affermazione di Sebastian e ripeté soltanto: «È venuto il momento di parlare.» «A che pro?» intervenne John. «Fa parte del passato.» «So che è stata un’idea mia, ma più passano gli anni più mi rendo conto che abbiamo sbagliato tutto» rispose Leon fissandolo. Si era aspettato che fosse difficile convincerlo, ma non aveva intenzione di lasciarsi fermare. A prescindere dal fatto che riuscisse o meno a coinvolgere tutti aveva deciso di rivelare la verità, ma per rispetto del fair play aveva preferito avvertirli prima di compiere un passo che avrebbe compromesso tutti loro. «Sono d’accordo con John» disse Josef con voce piatta. «Non c’è motivo di scoperchiare qualcosa che è ormai sepolto e dimenticato.» «Eri tu quello che parlava sempre dell’importanza del passato. Di assumersi la responsabilità. Non te lo ricordi?» rispose Leon. Josef impallidì e distolse il viso. «Non è la stessa cosa.» «Lo è eccome. Quello che è successo c’è ancora. Io me lo porto dietro da allora e so che è così anche per voi.» «Non è la stessa cosa» insistette Josef. «Parlavi del fatto che i responsabili delle sofferenze dei tuoi familiari dovevano rispondere di quello che avevano fatto. Non dovremmo rispondere anche noi e confessare la nostra colpa?» La voce di Leon era dolce ma si vedeva che quelle parole avevano turbato Josef. «Io non lo permetterò.» Seduto sul divano di fianco a Sebastian, John allacciò le mani sulle ginocchia. «Non puoi stabilirlo tu» rispose Leon, ben consapevole di svelare con quella frase di aver già preso una decisione. «Fai quel cazzo che ti pare, Leon» sbottò Sebastian all’improvviso. Si frugò nella tasca dei pantaloni e un attimo dopo ne estrasse una chiave. Si alzò e la diede a Leon, che la prese esitante. Erano passati tanti anni dall’ultima volta che l’aveva tenuta in mano, tanti anni da quando aveva segnato il loro destino. Nella stanza scese il silenzio mentre tutti loro rivedevano davanti agli occhi le immagini rimaste impresse nella memoria. «Dobbiamo aprire la porta.» Leon chiuse la chiave nel pugno. «Preferisco farlo con voi, ma se non volete lo farò da solo.» «E Ia...» cominciò John, ma Leon lo interruppe. «Ia sta tornando a Monaco. Non sono riuscita a convincerla a fermarsi.» «Già, voi potete fuggire» disse Josef. «Andarvene all’estero mentre noi restiamo qui nella merda.» «Non ho intenzione di partire finché non sarà stato tutto chiarito» disse Leon. «E torneremo.» «Nessuno andrà da nessuna parte» intervenne Percy, rimasto fino a quel momento muto su una sedia un po’ in disparte. «Cosa intendi dire?» Sebastian si appoggiò di nuovo allo schienale. «Nessuno andrà da nessuna parte» ripeté Percy. Poi si chinò lentamente a frugare nella cartella appoggiata alla gamba della sedia. «Stai scherzando?» disse Sebastian fissando incredulo la pistola che l’altro si era appoggiato sulle ginocchia. Percy la sollevò e gliela puntò addosso. «No, che motivo avrei di scherzare? Tu mi hai portato via tutto.» «Ma era solo business. E non dare la colpa a me. Sei stato tu a sperperare il tuo patrimonio.» Partì un colpo e tutti si lasciarono scappare un grido. Sebastian si portò sconvolto una mano alla guancia e tra le dita affiorò un po’ di sangue. La pallottola gli aveva sfiorato il lato sinistro del viso per poi continuare la sua corsa perforando la grande finestra panoramica che si affacciava sul mare. Lo sparo aveva fatto fischiare le orecchie a tutti e Leon si accorse che stava stringendo i braccioli della carrozzella tanto forte da non riuscire quasi più a staccare le dita. «Che cazzo fai, Percy?» gridò John. «Sei impazzito? Metti giù quella pistola prima che qualcuno si faccia del male.» «È troppo tardi. Troppo tardi.» Percy appoggiò la pistola sulle ginocchia. «Ma prima di uccidervi tutti voglio che vi assumiate la responsabilità di quello che avete fatto. Su questo io e Leon siamo d’accordo.» «Cosa vuoi dire? A parte Sebastian, siamo anche noi vittime quanto te, no?» John lo guardava furibondo, ma dalla voce traspariva chiaramente anche la paura. «Siamo tutti parte di questa storia. Mi ha rovinato la vita. Anche se tu hai la responsabilità più grossa e morirai prima di tutti.» Di nuovo puntò la pistola su Sebastian. Nel silenzio sentivano solo il proprio respiro. «Devono essere loro.» Ebba abbassò lo sguardo sul baule. Poi si girò e vomitò. Anche Anna sentì arrivare i conati ma si costrinse a continuare a guardare. Il baule conteneva uno scheletro. Un cranio con tutti i denti ancora intatti la guardava dalle orbite vuote. C’era ancora qualche ciuffo di capelli e qualcosa le diceva che si trattava di un maschio. «Sì, mi sa che hai ragione» disse accarezzando sulla schiena Ebba che, dopo qualche ulteriore singulto, si accovacciò mettendo la testa tra le ginocchia come se si sentisse sul punto di svenire. «Dunque è qui che sono sempre stati.» «Sì, e immagino che gli altri siano lì dentro.» Anna accennò ai due bauli ancora chiusi. «Dobbiamo aprirli» disse Ebba alzandosi. Anna la guardò scettica. «Non sarebbe meglio lasciar perdere finché non saremo certe di poter uscire di qui?» «Devo sapere.» Gli occhi di Ebba mandavano lampi. «Ma Mårten...» disse Anna. Ebba scosse la testa. «Non ci tirerà fuori da questa stanza. Gliel’ho letto in faccia. E poi penso sia convinto che io sia già morta.» Quelle parole riempirono Anna di terrore. Sapeva che era così. Lui non avrebbe aperto la porta. Dovevano uscire da sole, altrimenti sarebbero morte lì. Anche se Erica si fosse impensierita e avesse cominciato a fare domande non sarebbe servito a niente se non fosse riuscita a trovarle. Quella stanza poteva trovarsi in qualsiasi punto dell’isola, e perché avrebbero dovuto trovarla se durante le ricerche della famiglia Elvander non era mai stata individuata? «Okay, allora facciamo un tentativo. Può darsi che ci sia qualcosa per forzare la porta.» Ebba non rispose e si mise a dare calci al baule a destra di quello che avevano appena aperto, ma la serratura sembrava più robusta. «Aspetta un attimo» disse Anna. «Mi presti il tuo ciondolo a forma di angioletto? Può darsi che riesca a usarlo per allentare le viti.» Ebba si tolse la catenina e gliela porse con qualche esitazione. Anna cominciò a lavorare sulle viti e quando fu riuscita a rimuovere le fibbie che tenevano chiusi i due bauli guardò Ebba. A un cenno, aprirono i due coperchi. «Sono qui. Tutti» disse Ebba, mantenendo questa volta lo sguardo sui resti della sua famiglia gettati in quei bauli come rifiuti. Nel frattempo Anna contò in silenzio i crani. Poi li ricontò per essere sicura. «Manca qualcuno» disse calma. Ebba trasalì. «Cosa vuoi dire?» La coperta le stava scivolando sulle spalle e Anna se la strinse addosso. «Non erano cinque le persone scomparse?» «Sì.» «Qui ci sono solo quattro crani, cioè quattro corpi, a meno che uno sia stato privato della testa» spiegò Anna. Ebba fece una smorfia e si chinò per contare a sua volta. Poi trattenne il respiro di scatto. «Hai ragione. Manca qualcuno.» «La domanda è: chi?» Anna guardò gli scheletri. Lei ed Ebba sarebbero finite così se non fossero riuscite a uscire da quella stanza. Chiuse gli occhi e si vide davanti Dan e i bambini. Poi li riaprì. Non doveva succedere. In qualche modo ce l’avrebbero fatta. Accanto a lei, Ebba scoppiò in un pianto dirotto. «Paula!» Patrik le fece cenno con la mano di seguirlo nel suo ufficio. Gösta ed Erica erano partiti per Fjällbacka e Mellberg aveva chiuso la sua porta per occuparsi dei mezzi d’informazione, almeno a suo dire. «Cos’è successo?» chiese lei sedendosi con qualche sforzo sulla scomoda poltroncina davanti alla scrivania. «Mi sa che oggi non si riuscirà a parlare con John Holm.» Patrik si passò una mano nei capelli. «In questo momento la polizia di Göteborg sta per intervenire nei suoi confronti. Era Kjell Ringholm al telefono. Pare che lui e Sven Niklasson dell’Expressen siano sul posto.» «Di che genere di intervento si tratta? E perché noi non siamo stati informati?» Scosse la testa. «Kjell non mi ha dato i particolari. Ha parlato di sicurezza nazionale e ha detto che era una cosa grossa... Insomma, sai com’è fatto.» «Ci andiamo?» chiese Paula. «No, e sicuramente non ci vai tu, nelle tue condizioni. Se l’operazione è condotta dalla polizia di Göteborg è meglio che per il momento ne stiamo fuori, ma ho intenzione di dare un colpo di telefono per scucire qualche informazione in più su quello che sta succedendo. In ogni caso, sembra che non avremo a disposizione John Holm per un pezzo.» «Chissà di cosa si tratta...» Paula cambiò posizione sulla poltroncina. «Lo sapremo a tempo debito. Se c’erano sia Kjell sia Sven Niklasson lo leggerai presto sui giornali.» «Per il momento ci toccherà cominciare dagli altri.» «Come dicevo, purtroppo bisogna rimandare» disse Patrik alzandosi. «Devo trovarmi con Gösta e andare a Valö per cercare di scoprire cosa succede lì.» «Il padre di Leon» disse Paula pensosa. «Strano che i soldi arrivassero da lui.» «Parleremo con Kreutz appena saremo di ritorno io e Gösta» disse Patrik. «Leon e Annelie. Forse, in fin dei conti, è proprio di loro due che si tratta.» Tese una mano per aiutarla ad alzarsi e lei l’afferrò, riconoscente. «Allora vado a controllare un po’ di cose su Aron» disse avviandosi lungo il corridoio. Patrik prese la giacca estiva e uscì dall’ufficio. Sperava che Gösta fosse riuscito a riportare a casa Erica. Sicuramente lei gli aveva dato il tormento per tutta la strada, ma questa volta non aveva intenzione di arrendersi. Anche se non era in ansia quanto lei, sentiva che sull’isola qualcosa non andava e non voleva che sua moglie finisse in mezzo ai guai. Era nel parcheggio quando Paula lo richiamò dalla porta. Si voltò. «Cosa c’è?» Lei gli fece cenno di avvicinarsi e vedendo la sua espressione seria Patrik ubbidì subito. «Sparatoria. A casa di Leon Kreutz» ansimò lei. Patrik scosse la testa. Perché tutto nello stesso momento? «Chiamo Gösta e gli dico di trovarsi lì. Puoi andare a svegliare Mellberg? Ci serve aiuto da tutti, adesso.» Sälvik si aprì davanti a loro con le case che scintillavano sotto la luce del sole. Dalla spiaggia a poche centinaia di metri si sentivano schiamazzi di bambini e risate allegre. Era un ritrovo popolare tra le famiglie e quell’estate Erica ci era andata quasi tutti i giorni, quando Patrik era al lavoro. «Chissà dov’è andato a cacciarsi Victor» disse. «Mah» fece Gösta. Non era riuscito a rintracciare nessuno della guardia costiera ed Erica l’aveva convinto a fermarsi per bere un caffè con lei e Kristina. «Riprovo» disse componendo il numero per la quarta volta. Erica lo scrutò. Doveva convincerlo a permetterle di andare con loro. L’attesa l’avrebbe fatta impazzire. «Niente, non risponde. Ne approfitto per andare in bagno.» Si alzò e uscì. Il telefono rimase sul tavolo. Non era passato neanche un minuto quando partì la suoneria ed Erica si sporse a guardare il display. “Hedström” si leggeva a grandi caratteri. Soppesò velocemente tra sé e sé le varie possibilità. Kristina era in soggiorno a rincorrere i bambini e Gösta non era ancora tornato. Esitò un secondo e poi rispose: «Ciao, sono io... Gösta è in bagno. Devo dirgli qualcosa?... Sparatoria?... Okay, riferisco... Ma sì, sì, adesso riattacca che lo faccio partire. Sarà in macchina tra cinque minuti.» Chiuse la chiamata e una serie di alternative le si presentarono alla mente. Da un lato, Patrik aveva bisogno di rinforzi, dall’altro dovevano andare a Valö il più rapidamente possibile. Tese le orecchie per sentire se Gösta stava arrivando. Di lì a poco sarebbe tornato e lei doveva prendere una decisione. Agguantò il proprio cellulare e dopo un attimo di incertezza compose un numero. Martin rispose al secondo squillo. Gli spiegò mormorando la situazione e quello che bisognava fare e lui afferrò al volo. Bene, quella parte era risolta. Restava solo da mettere in atto una prestazione da Oscar per la migliore attrice. «Chi era?» chiese Gösta. «Patrik. Ha detto che ha rintracciato Ebba e che a Valö è tutto tranquillo. Lei gli ha riferito che Anna doveva fare un giro per aste in campagna oggi e che per questo non aveva avuto il tempo di rispondere. Secondo lui però era meglio che io e te andassimo lo stesso sull’isola a fare una chiacchierata con Mårten ed Ebba.» «Noi?» «Sì, dato che la situazione non è più d’emergenza.» «Sei sicura...?» Gösta fu interrotto dallo squillo del suo cellulare. «Ciao Victor... Sì, ti ho cercato. Avremmo bisogno di uno strappo fino a Valö. Subito, possibilmente... okay, siamo lì tra cinque minuti.» Chiuse la telefonata e guardò sospettoso Erica. «Puoi chiamare Patrik se non mi credi» disse lei sorridendo. «No, non penso ce ne sia bisogno. Allora andiamo.» «Ma stai uscendo di nuovo?» Kristina fece capolino nella veranda tenendo stretto per un braccio Noel che tentava di divincolarsi e dal soggiorno si sentivano gli strilli di Anton mescolati ai richiami di Maja: «Nonna! Noooonna!» «Starò via pochissimo» rispose Erica ripromettendosi di concepire sulla suocera pensieri molto più buoni se solo le avesse dato la possibilità di andare a Valö. «Be’, è l’ultima volta che mi rendo disponibile in questo modo. Non potete dare per scontato che dedichi a voi un’intera giornata e dovresti anche capire che non riesco più a sopportare questi ritmi e questi livelli di rumore e anche se i bambini sono tanto carini devo dire che potrebbero essere più educati. Non ricade sotto la mia responsabilità perché è nella vita quotidiana che si prendono le abitudini...» Erica fece finta di non sentire e la ringraziò per poi scappare nell’ingresso. Dieci minuti dopo erano a bordo della MinLouis diretti a Valö. Cercò di rilassarsi e convincersi che andava tutto bene, come aveva assicurato a Gösta, mentendo, ma non ci credeva: l’istinto le diceva che Anna era in pericolo. «Devo aspettarvi?» chiese Victor accostando al pontile con una manovra elegante. Gösta scosse la testa. «No, grazie, ma forse poi ci servirà un passaggio per tornare. Possiamo telefonare?» «Certo, basta uno squillo. Io faccio un giro e controllo la situazione.» Erica lo guardò ripartire e si chiese se fosse una decisione saggia, ma ormai era troppo tardi per cambiare idea. «Senti, ma quella non è la vostra barca?» chiese Gösta. «Sì. Che strano.» Erica si finse sorpresa. «Forse Anna è tornata qui. Saliamo alla casa?» Si avviò e Gösta la seguì borbottando. Davanti a loro si vedeva il bell’edificio in ristrutturazione. Regnava una calma sinistra ed Erica aveva tutti i sensi all’erta. «C’è qualcuno?» chiamò dai piedi della larga scalinata in muratura. La porta d’ingresso era aperta, ma non arrivò risposta. Gösta si fermò. «Strano. Sembra che non ci sia nessuno. Patrik ha detto che Ebba era qui?» «Sì, così ho capito io.» «Che siano scesi in spiaggia a fare un tuffo?» Gösta avanzò di qualche passo e guardò sul retro. «Può darsi» disse Erica avviandosi verso la porta. «Non possiamo mica entrare così, no?» «Ma sì, dai. Ehi, di casa!» chiamò verso l’interno. «Mårten? C’è qualcuno?» Gösta la seguì esitante nell’ingresso. Anche dentro regnava il silenzio, ma d’un tratto Mårten comparve sulla porta della cucina. Il nastro segnaletico era stato strappato e pendeva lungo lo stipite e sul pavimento. «Ciao» disse con voce sorda. Vedendolo, Erica fece un salto. I capelli gli cadevano sulla fronte a ciocche, come se avesse sudato abbondantemente, e sotto gli occhi aveva dei cerchi scuri. Lo sguardo era vuoto. «C’è anche Ebba?» chiese Gösta con un solco profondo tra le sopracciglia. «No, è andata dai suoi genitori.» Gösta guardò Erica, sorpreso. «Ma Patrik non ha parlato con lei? Doveva essere qui.» Erica spalancò le braccia e dopo qualche secondo lo sguardo di Gösta s’incupì, ma senza che dalla bocca gli uscisse una parola. «Non è ripassata. Ha chiamato dicendo che avrebbe preso la macchina e sarebbe andata direttamente a Göteborg.» Erica annuì, ma sapeva che doveva essere una bugia. Maria, del postale, aveva detto di averla lasciata sull’isola. Si guardò intorno cercando di non farsi notare e lo sguardo le cadde su qualcosa tra la parete e la porta d’ingresso. La borsa di Ebba, quella che si era portata a Fjällbacka per pernottare da loro. Era la dimostrazione che non poteva essere andata direttamente a Göteborg. «Dov’è Anna?» Mårten continuò a fissarli con lo sguardo vuoto. Alzò le spalle. Le bastava. Senza riflettere oltre Erica lasciò cadere la borsetta sul pavimento e corse su per le scale chiamando forte: «Anna! Ebba!» Nessuna risposta. Alle proprie spalle sentì dei passi veloci e si rese conto che Mårten la stava seguendo. Continuò fino al ballatoio, si precipitò nella camera da letto e si bloccò al centro della stanza. Accanto a un vassoio con degli avanzi e due bicchieri da vino vuoti c’era la borsetta di sua sorella. Prima la barca e poi la borsa. Pur non volendo farlo, tirò la conclusione più ovvia: Anna era ancora sull’isola, e lo stesso valeva per Ebba. Si girò di scatto per mettere Mårten con le spalle al muro, ma il grido le morì in gola: lui era in piedi dietro di lei e le puntava addosso un revolver. Con la coda dell’occhio vide Gösta bloccarsi di colpo. «Ferma» disse Mårten facendo un passo avanti. La canna della pistola si trovava ormai a un centimetro dalla fronte di Erica e la mano era ferma. «E tu mettiti lì!» Accennò con la testa a destra di Erica. Gösta ubbidì subito. Con le mani sollevate e lo sguardo fisso su Mårten si avvicinò e si mise di fianco a lei. «Seduti!» ordinò Mårten. Entrambi fecero come aveva detto. Erica guardò il revolver. Dove poteva averlo preso? «Metti via quella pistola e poi risolviamo questa cosa insieme» tentò di dirgli. Mårten la fissò astioso. «Ah sì? E come? Mio figlio è morto per colpa di quella sgualdrina. Come pensavi di risolvere la faccenda?» Per la prima volta lo sguardo vuoto prese vita ed Erica arretrò di fronte alla follia rispecchiata in quegli occhi. C’era sempre stata, nascosta dietro la facciata composta? Oppure era stato quel posto a farla emergere in superficie? «Mia sorella...» La preoccupazione era così forte da toglierle il respiro. Voleva solo la conferma che Anna fosse viva. «Non le troverete mai. Esattamente come non sono mai stati trovati gli altri.» «Gli altri? Parli della famiglia di Ebba?» chiese Gösta. Mårten rimase in silenzio. Si era accovacciato, l’arma ancora puntata su di loro. «Anna è viva?» chiese Erica senza aspettarsi davvero una risposta. Mårten sorrise e sostenne il suo sguardo ed Erica si rese conto che la decisione di mentire era stata più rischiosa di quanto avesse mai potuto immaginare. «Cos’hai intenzione di fare?» chiese Gösta come se le avesse letto nel pensiero. Mårten alzò di nuovo le spalle e non rispose. Si sedette invece sul pavimento, incrociò le gambe e continuò a osservarli. Era come se aspettasse qualcosa senza sapere cosa, apparentemente in pace con se stesso. Solo il revolver e il riverbero freddo dei suoi occhi contraddicevano quell’immagine. E da qualche parte sull’isola c’erano Anna ed Ebba. Vive o morte. Valö 1973 Laura si girava e rigirava sullo scomodo materasso. Rune e Inez avrebbero potuto prepararle un letto migliore, considerando la frequenza con cui stava da loro. Dopotutto non era più così giovane e avrebbero dovuto tenerne conto. Per di più le scappava anche la pipì. Appoggiò i piedi sul pavimento e rabbrividì. Il freddo di novembre aveva preso possesso dell’isola e quella vecchia casa era impossibile da scaldare davvero. Laura sospettava anche che Rune tenesse il riscaldamento basso per ridurre le spese. Suo genero non era mai stato particolarmente prodigo. La piccola Ebba era graziosissima, in ogni caso, questo doveva ammetterlo, ma era piacevole occuparsene solo una volta ogni tanto, e non troppo a lungo. I neonati non le erano mai andati granché a genio e poi le mancavano le forze per lasciarsi coinvolgere nelle cure della nipotina. In punta di piedi si spostò sulle tavole di legno che scricchiolarono sotto il suo peso. Negli ultimi anni i chili avevano cominciato a depositarsi con una velocità preoccupante e la linea a cui teneva tanto un tempo era ormai un pallido ricordo. Ma perché avrebbe dovuto sforzarsi? Per lo più era sola nel suo appartamento e l’amarezza aumentava di giorno in giorno. Rune non si era mostrato all’altezza delle sue aspettative. Effettivamente le aveva comprato l’appartamento, ma Laura si era pentita di non aver aspettato un miglior partito per Inez. Bella com’era, avrebbe potuto avere chi voleva. Rune Elvander teneva troppo tirati i cordoni della borsa e costringeva la giovane moglie a sfinirsi a forza di lavorare. Era diventata magra come un chiodo e non aveva un attimo di tregua. Se non faceva le pulizie, cucinava o aiutava Rune a tenere a bada gli allievi della scuola, le toccava fare da serva ai maleducati figlioli del marito. Il piccolo era un bravo bambino, ma i primi due erano davvero insopportabili. Mentre scendeva in punta di piedi, la scala scricchiolò. Era una vera seccatura che la vescica non tenesse più per tutta la notte, soprattutto se si doveva andare in bagno con quel freddo. Si bloccò. Qualcun altro si aggirava al piano terra. Tese le orecchie. La porta d’ingresso si aprì e la sua curiosità fu decisamente risvegliata. Chi poteva vagare di nascosto per casa in piena notte? Non c’era motivo di uscire, a meno di avere in mente qualche corbelleria. Sicuramente era uno di quei ragazzini viziati che stava per combinarne una, ma avrebbe pensato lei a mettergli i bastoni tra le ruote. Sentendo richiudersi la porta si affrettò a scendere gli ultimi gradini e s’infilò gli stivali. Poi si avvolse in uno scialle pesante, aprì e guardò fuori. Era difficile vedere qualcosa nel buio ma uscendo sulla scalinata scorse un’ombra sparire dietro l’angolo a sinistra. Doveva essere scaltra. Scese cauta, nel caso la brina avesse reso scivolosi i gradini. Una volta sullo spiazzo, girò a destra invece che a sinistra: avrebbe tagliato la strada alla persona in questione dalla parte opposta in modo da coglierla con le mani nel sacco, qualsiasi cosa stesse macchinando. Girò lentamente l’angolo e strisciò contro il muro. Al cantone successivo si fermò e sbirciò cauta per vedere cosa succedeva sul retro della casa. Non si vedeva un’anima. Laura aggrottò la fronte e si guardò intorno delusa. Che fine aveva fatto l’ombra che aveva visto? Fece qualche passo esitante scrutando il terreno intorno alla casa. Che fosse scesa alla spiaggia? Lì non osava andare perché avrebbe corso il rischio di scivolare e restare a terra. Il medico le aveva raccomandato di non fare sforzi. Aveva il cuore affaticato e non doveva metterlo sotto pressione. Rabbrividendo, si strinse nello scialle. Il freddo cominciava a insinuarsi sotto la camicia da notte e le battevano i denti. Di colpo una figura scura le si parò davanti, facendola sussultare. Poi vide chi era. «Oh, sei tu. Cosa ci fai qui fuori?» Gli occhi gelidi, scuri come la notte tutt’intorno, le fecero venire ancora più freddo. Lentamente, cominciò ad arretrare. Senza che nessuno dovesse dirglielo, capì di aver commesso un errore. Ancora qualche passo. Solo qualche passo, poi sarebbe stata dietro l’angolo e sarebbe riuscita a tornare alla porta d’ingresso. La distanza era minima, ma sarebbe potuta essere di chilometri. Laura fissò atterrita gli occhi neri come la pece e seppe che non sarebbe mai più rientrata in casa. Di colpo le tornò in mente Dagmar e provò la stessa sensazione di allora: era in trappola, impotente e senza una via d’uscita. D’improvviso qualcosa nel petto cedette. Patrik guardò l’orologio. «Dove diavolo è Gösta? Sarebbe dovuto arrivare prima di noi.» Lui e Mellberg erano in macchina e aspettavano, lo sguardo fisso sulla casa di Leon. Nello stesso istante un’auto dall’aria alquanto familiare si accostò alla loro e Patrik guardò stupito Martin, seduto al volante. «Cosa ci fai tu qui?» chiese scendendo. «Ha chiamato tua moglie dicendo che c’era un’emergenza e che vi serviva aiuto.» «Come...?» cominciò a dire Patrik, ma s’interruppe e serrò le labbra. Al diavolo! Naturalmente Erica aveva convinto Gösta con l’inganno ad andare con lei a Valö. La rabbia si mescolò all’ansia. Era proprio l’ultima cosa che gli sarebbe servita in quel momento. Non avevano idea di cosa stesse succedendo in casa di Leon e doveva concentrarsi. Però era contento che Martin si fosse reso disponibile. Aveva l’aria stanca e sciupata, ma nell’emergenza era meglio un Martin stanco di un Gösta Flygare. «Cos’è successo?» Martin si schermò gli occhi con la mano e guardò verso la casa. «Sparatoria. Non sappiamo altro.» «Chi c’è lì dentro?» «Non sappiamo neanche questo.» Patrik sentì aumentare i battiti. Era il genere di situazione che più detestava, come poliziotto. Non aveva informazioni sufficienti per valutare le circostanze e spesso quelle occasioni si rivelavano le più pericolose. «Non è meglio che chiediamo rinforzi?» chiese Mellberg dall’auto. «No, non c’è tempo. Dovremo suonare il campanello.» Mellberg stava per protestare ma Patrik lo prevenne. «Lei rimanga qui a tenere le posizioni. Ce ne occupiamo noi.» Guardò Martin, che annuì in silenzio e tolse dalla fondina l’arma d’ordinanza. «Sono passato a prenderla alla stazione. Ho pensato che potesse tornare utile.» «Bene.» Patrik seguì il suo esempio e insieme si avvicinarono cauti alla porta d’ingresso. Il suono del campanello risuonò all’interno e poco dopo si sentì una voce dire: «Avanti, è aperto.» Patrik e Martin si scambiarono un’occhiata sbigottita. Poi entrarono. Quando videro le persone riunite nel soggiorno lo stupore aumentò ulteriormente. C’erano Leon, Sebastian, Josef e John. E un uomo ingrigito che doveva essere Percy von Bahrn. Stringeva in mano una pistola, lo sguardo sfuggente. «Cosa sta succedendo qui?» chiese Patrik, tenendo l’arma lungo il fianco. Con la coda dell’occhio vide che Martin faceva altrettanto. «Lo chieda a Percy» disse Sebastian. «Leon ci ha convocati qui per mettere fine a tutto. Ho pensato di prenderlo in parola.» La voce di Percy tremava. Quando Sebastian si mosse sul divano, sussultò e gli puntò la pistola addosso. «Stai calmo, per la miseria.» Sebastian sollevò le mani in aria. «Mettere fine a cosa?» chiese Patrik. «A tutto. A quello che è successo allora e non sarebbe dovuto succedere. A quello che abbiamo fatto» rispose Percy. Poi abbassò la pistola. «Cos’avete fatto?» Nessuno rispose e Patrik decise di aiutarli ad andare avanti. «Sotto interrogatorio avevate detto tutti di essere usciti a pescare, quel giorno. Non si pescano gli sgombri a Pasqua.» Scese il silenzio. Alla fine Sebastian sbuffò sprezzante: «Che abbaglio da viziati mocciosi di città.» «All’epoca non avevi mosso obiezioni» disse Leon in tono quasi divertito. Sebastian alzò le spalle. «Perché suo padre ha versato dei soldi su un conto intestato a Ebba fino al suo diciottesimo compleanno?» chiese Patrik guardando Leon. «Avevate chiamato lui, quel giorno? Un uomo ricco e potente con un’ampia rete di conoscenze? Fu lui ad aiutarvi dopo che avevate ucciso la famiglia? Cos’era successo? Rune si era spinto troppo oltre? Eravate stati costretti a uccidere gli altri per togliere di mezzo i testimoni?» Si accorse da solo di quanto fosse incalzante la sua voce, ma voleva scuoterli e indurli a parlare. «Sarai contento, adesso, Leon» disse Percy sarcastico. «Eccoti la possibilità di mettere tutte le carte in tavola.» John balzò in piedi. «È una follia. Non ho intenzione di lasciarmi coinvolgere in questa faccenda. Ora me ne vado.» Fece un passo, ma Percy mirò alla sua destra e sparò. «Cosa fai?» urlò lui risedendosi. Patrik e Martin puntarono le armi su Percy ma le abbassarono vedendo che teneva ancora sotto tiro John. Era troppo rischioso. «La prossima volta non mirerò di fianco. Se non altro, quest’eredità mi è rimasta. Finalmente tutte le ore di tiro al bersaglio a cui mi costringeva mio padre mi torneranno utili. Se volessi potrei tranciarti di netto quella frangia tanto fascinosa.» Percy inclinò la testa di lato e guardò John, pallido come un morto. Solo in quel momento a Patrik venne in mente che la polizia di Göteborg doveva essere andata a cercarlo a casa e con ogni probabilità ignorava che si trovasse lì. «Calma, Percy» disse Martin lentamente. «Evitiamo che qualcuno si faccia del male. Nessuno va da nessuna parte finché non avremo risolto questa faccenda.» «Era di Annelie che si trattava?» Patrik si era di nuovo rivolto a Leon. Perché esitava, se davvero voleva rivelare cos’era successo quella vigilia di Pasqua del 1974? Aveva cambiato idea? «Abbiamo ragione di credere che dopo gli omicidi abbia preso il suo passaporto e sia fuggita all’estero. Perché è di un omicidio plurimo che stiamo parlando, no?» Sebastian si mise a ridere. «Cosa c’è di tanto divertente?» chiese Martin. «Niente. Assolutamente niente.» «È stato suo padre ad aiutarla a sparire? Lei e Annelie eravate una coppia e quando Rune vi ha sorpreso la situazione vi è sfuggita di mano? E se è così, come è riuscito a indurre gli altri ad aiutarvi e a tacere per tutti questi anni?» Patrik indicò con un gesto il gruppetto di uomini di mezz’età. Rivide davanti agli occhi le foto scattate dopo la scomparsa. L’espressione di sfida. L’autorevolezza innata di Leon. Nonostante i capelli ingrigiti e i volti invecchiati, non erano cambiati. E stavano uniti. «Sì, racconta di Annelie.» Sebastian sogghignò. «Tu che tieni tanto alla verità. Racconta di Annelie.» Nel cervello di Patrik balenò un lampo. «Ho già conosciuto Annelie, vero? È Ia.» Nessuno fece una piega. Guardavano tutti Leon con uno strano misto di paura e sollievo negli occhi. Il padrone di casa raddrizzò lentamente la schiena sulla sedia a rotelle. Poi girò il viso verso Patrik con la luce del sole che illuminava il lato pieno di cicatrici e disse: «Parlerò di Annelie. E di Rune, Inez, Claes e Johan.» «Pensa a quello che fai, Leon» disse John. «Ho già pensato abbastanza. È venuto il momento.» Inspirò a fondo ma non aveva ancora detto una parola che la porta d’ingresso si aprì. Sulla soglia c’era Ia. Passò con lo sguardo da uno all’altro e quando vide Percy che stringeva tra le dita la pistola sbarrò gli occhi. Per un attimo sembrò esitare. Poi si avvicinò al marito, gli mise una mano sulla spalla e disse dolcemente: «Avevi ragione. Non è più possibile fuggire.» Leon annuì. Poi cominciò a parlare. Anna era più preoccupata per Ebba che per sé. Era pallida in viso, con striature rosse sul collo lasciate dalla pressione di due mani. Le mani di Mårten. Lei invece non sentiva dolore intorno alla gola. Forse l’aveva drogata? Non lo sapeva, il che le faceva quasi più paura. Si era addormentata tra le sue braccia, ebbra di un senso di intimità e di conferma, e poi si era svegliata su quel gelido pavimento. «Qui riposa mia madre» disse Ebba abbassando gli occhi su uno dei bauli. «Non puoi esserne certa.» «Solo uno dei crani ha i capelli lunghi. Dev’essere mia madre.» «Potrebbe anche essere tua sorella» le fece notare Anna, chiedendosi se abbassare il coperchio. D’altra parte quella era una sorta di risposta alle tante domande sul destino dei suoi familiari. «Che posto è questo?» chiese Ebba con lo sguardo ancora incollato agli scheletri. «Una specie di rifugio, penso. E considerando la bandiera e le uniformi, immagino risalga più o meno alla Seconda guerra mondiale.» «Pensa, sono sempre stati qui. Perché nessuno li ha trovati?» La voce di Ebba suonava sempre più assente e Anna si rese conto che se voleva uscire di lì doveva prendere in mano la situazione. «Vediamo di trovare qualcosa per allentare le cerniere della porta» disse dandole una spintarella. «Se tu guardi bene nel mucchio di ciarpame là nell’angolo io controllo...» Esitò. «Io controllo nei bauli.» Ebba la guardò inorridita. «E se... e se si rompono?» «O apriamo quella porta oppure moriremo qui dentro» rispose Anna in modo calmo e scandendo bene le parole. «Nei bauli potrebbe esserci qualche attrezzo. Preferisci frugarli tu o vuoi che lo faccia io?» Ebba rimase immobile per un istante riflettendo sulle sue parole. Poi le voltò le spalle e si mise a cercare nell’angolo. In realtà Anna non aveva grandi speranze che ci trovasse qualcosa, ma era bene tenerla occupata. Dopo un’inspirazione profonda infilò la mano in uno dei bauli. Quando sfiorò le ossa sentì montare la nausea e sentendosi solleticare la pelle dai capelli secchi e fragili non riuscì a trattenere un grido. «Cosa c’è?» Ebba si girò. «Niente» rispose Anna. Poi si fece forza e continuò a far scendere lentamente la mano verso il basso. Finalmente sentì il fondo di legno sotto i polpastrelli e, cercando, si sporse oltre il bordo. D’un tratto toccò qualcosa di duro e lo prese tra pollice e indice. Era troppo piccolo perché potesse essere utilizzabile, ma lo tirò fuori lo stesso per vedere cos’era. Un dente. Disgustata, lo lasciò ricadere e si pulì la mano sulla coperta. «Trovato qualcosa?» chiese Ebba. «No, non ancora.» Con uno sforzo di volontà, Anna frugò anche il secondo baule e quando ebbe finito si sedette sui talloni. Non c’era niente. Non sarebbero mai uscite. Non restava che la morte. Poi si costrinse ad alzarsi in piedi. Mancava un baule e non doveva ancora arrendersi, anche se il pensiero di dover fare un nuovo tentativo la stomacava. Si avvicinò decisa. Ebba aveva abbandonato le ricerche e piangeva addossata alla parete. Anna le lanciò un’occhiata e infilò la mano nel baule. Deglutì, scese fino al fondo e, quando sentì il legno contro le dita, le spostò piano avanti e indietro. C’era qualcosa. Sembrava carta, ma con la parte superiore liscia. Tirò fuori la mano e la spostò sotto la luce della lampadina. «Ebba» disse. Non ricevendo risposta andò a sedersi accanto a lei e le mostrò quello che aveva in mano. Fotografie. «Guarda.» Aveva una voglia matta di sfogliarle direttamente ma intuiva che fossero parte della storia di Ebba ed era giusto che fosse lei la prima a vederle. Con le mani tremanti, Ebba guardò le polaroid. «Cos’è questa roba?» disse scuotendo lentamente la testa. Entrambe fissarono le foto, anche se avrebbero voluto distogliere gli occhi. Davanti a loro c’era la spiegazione di quello che era avvenuto quella vigilia di Pasqua. Mårten era sempre più assente. Le palpebre pesanti e la testa penzolante fecero capire a Erica che stava per addormentarsi. Non osava neanche guardare Gösta. Mårten teneva ancora il revolver stretto in mano e fare un gesto improvviso sarebbe stato pericolosissimo. Alla fine le palpebre si chiusero del tutto. Erica girò lentamente la testa verso Gösta e si portò un dito alle labbra. Lui annuì. Lei si voltò a guardare la porta ma Gösta scosse la testa. No, pensava anche lei che non potesse funzionare. Se Mårten si fosse svegliato mentre cercavano di uscire c’era il rischio che cominciasse a sparare alla cieca. Rifletté. Dovevano cercare aiuto. Guardò di nuovo Gösta e imitò con la mano la forma di una cornetta portandosela all’orecchio. Lui capì al volo e cominciò a frugarsi nelle tasche della giacca, ma ben presto le rivolse un’occhiata abbattuta. Non aveva con sé il cellulare. Erica si guardò intorno nella stanza. La borsetta di Anna non era troppo lontana. Lentamente, cominciò a strisciare in quella direzione. Mårten trasalì nel sonno e lei si bloccò, ma poi vide che continuava a dormire, il mento premuto sul petto. Poco dopo sentì la borsa sotto le dita e, spostandosi ancora di qualche centimetro, riuscì a prendere i manici. Trattenne il respiro, la sollevò e se la portò vicino senza che si sentisse il minimo rumore. Cominciò a frugare sul fondo, cauta, avvertendo lo sguardo di Gösta su di sé. Lo vide soffocare un colpo di tosse e aggrottò le sopracciglia. Mårten non doveva svegliarsi proprio in quel momento. Finalmente la mano si strinse sul cellulare di Anna. Si assicurò che fosse impostato in modalità silenzioso e di colpo si rese conto che non conosceva il suo pin. Non le restava che provare a caso. Inserì la data di nascita di Anna. Sul display comparve la scritta “Pin errato” ed Erica imprecò tra sé e sé. Magari Anna non aveva neanche cambiato il pin originario e a quel punto sarebbe stato impossibile scoprirlo, ma non doveva ragionare così. Aveva ancora due tentativi a disposizione. Rifletté un attimo e provò con la data di nascita di Adrian. “Pin errato”. Poi le venne un’idea. C’era un’altra data importante nella vita di Anna: quella del giorno in cui era morto Lucas. Erica inserì le quattro cifre e una luce verde le diede il benvenuto nel meraviglioso mondo del telefono. Lanciò un’occhiata a Gösta, che tirò un sospiro di sollievo. Bisognava agire in fretta. Mårten poteva svegliarsi da un momento all’altro. Per fortuna lei e Anna avevano lo stesso modello di cellulare e i menu le erano familiari. Cominciò a scrivere un sms, breve ma nello stesso tempo sufficientemente denso da far capire a Patrik la gravità della situazione. Mårten si agitò nel sonno e proprio quando stava per inviare l’sms Erica si fermò e aggiunse rapidamente altri destinatari. Se Patrik non l’avesse visto subito qualcun altro se ne sarebbe accorto e avrebbe agito. Premette il tasto invio e allontanò velocemente la borsa, nascondendo il cellulare sotto la coscia destra in modo da poterlo prendere se fosse stato necessario, senza per questo lasciarlo nel campo visivo di Mårten se si fosse svegliato. Ormai non restava che aspettare. Kjell si appoggiò alla macchina e guardò nella direzione in cui erano sparite le auto della polizia. L’operazione era fallita ed erano ripartite con la sola moglie di John Holm sul sedile posteriore. «Dove diavolo è lui?» Dentro e intorno alla casa ferveva ancora l’attività. Ogni millimetro della superficie doveva essere perlustrato e il fotografo dell’Expressen stava correndo avanti e indietro per immortalare ogni dettaglio. Non doveva avvicinarsi troppo all’abitazione ma con gli obiettivi che aveva a disposizione non era un problema. «Può essere fuggito all’estero?» chiese Sven Niklasson, che, seduto nell’auto di Kjell, aveva già scritto la prima bozza dell’articolo per inviarla alla redazione. Kjell sapeva che avrebbe dovuto lasciarsi trasportare dalla sua stessa sete di gloria e andare dritto alla redazione del Bohusläningen, dove sarebbe stato accolto come l’eroe di quel giorno. Quando aveva telefonato facendo rapporto sull’accaduto il direttore responsabile si era messo a urlare di gioia, tanto forte da spaccargli i timpani. Il fatto era che non voleva andarsene di lì finché non avesse scoperto dove si era cacciato John Holm. «No, non credo che sarebbe partito senza Liv. Lei non sembrava affatto aspettarsi l’irruzione della polizia e se non lo sapeva lei non lo sapeva neanche John. Pare che siano un duo affiatatissimo.» «Ma in posticini come questi le voci girano alla velocità della luce e quindi anche se non se n’è ancora andato si corre il rischio che lo faccia ora.» Sven Niklasson strinse le labbra guardando in direzione della casa. «Mmh» rispose Kjell distratto mentre ripassava mentalmente in rassegna tutto quello che sapeva di John e si chiedeva dove potesse trovarsi. Il capanno era già stato perquisito dalla polizia, senza risultato. «Hai saputo altro su com’è andata a Stoccolma?» chiese. «Sembra che per una volta la Säpo e la polizia siano riuscite a collaborare e a mettere a segno un’operazione perfetta. Tutti i responsabili del partito sono stati messi in custodia cautelare senza che scoppiassero disordini. Quella gente abbassa la cresta, quando è il momento.» «Già, pare proprio di sì.» Kjell pensò ai titoloni che avrebbero riempito i giornali nei giorni a venire. Non sarebbe stata una questione meramente interna ai confini nazionali: anche il mondo circostante si sarebbe sorpreso, ancora una volta, che qualcosa del genere potesse succedere nella piccola Svezia, il Paese in cui tante persone in giro per il globo ritenevano vigesse un ordine quasi eccessivo. Squillò il telefono. «Ciao Rolf... Sì, be’, qui c’è un po’ di confusione. Non sanno dove si trovi John... Cosa dici? Una sparatoria? Okay, veniamo subito.» Chiuse la telefonata e rivolse un cenno a Sven. «In macchina. È arrivata voce di una sparatoria a casa di Leon Kreutz. Ci andiamo subito.» «Leon Kreutz?» «Uno dei compagni di collegio di John a Valö. C’è qualcosa di losco in quella faccenda e siamo in parecchi a esserne convinti.» «Non lo so... John potrebbe tornare da un momento all’altro.» Kjell appoggiò il braccio sul tettuccio dell’automobile e guardò Sven. «Non chiedermi perché, ma io credo che John sia in quella casa. Deciditi: vieni o no? La polizia di Tanum è già lì.» Sven aprì la portiera del passeggero e salì. Kjell si mise al volante, ingranò la marcia e partì. Sapeva di avere ragione. I ragazzi di Valö avevano nascosto qualcosa, e ora sarebbe venuto a galla. Di sicuro non aveva intenzione di perdersi il momento in cui la notizia sarebbe esplosa. Valö 1974 Era come se qualcuno la osservasse continuamente. Inez non avrebbe saputo descriverlo meglio di così. La sensazione l’accompagnava dalla mattina in cui avevano trovato sua madre morta. Perché fosse uscita in piena notte, a novembre, non lo sapeva nessuno. Il medico che era venuto aveva constatato che il cuore aveva ceduto. L’aveva avvertita, diceva. Inez aveva comunque dei dubbi. Qualcosa era cambiato, in casa, dopo la morte di Laura. Lo sentiva ovunque andasse. Rune era diventato più silenzioso e severo e Annelie e Claes la sfidavano ancora più apertamente. Era come se il padre non se ne accorgesse e questo li rendeva più arditi. Di notte le capitava di sentire qualcuno piangere dalla camerata dei ragazzi. Non forte: i singhiozzi si percepivano appena, come se qualcuno cercasse di soffocarli. Aveva paura. Le ci erano voluti mesi a capire che era quella la sensazione che provava. Qualcosa non andava. Ci giravano attorno e sapeva che se avesse parlato della sua ansia a Rune lui le avrebbe riso in faccia liquidando la cosa. Eppure vedeva benissimo che era consapevole quanto lei del pericolo incombente. Anche la stanchezza faceva la sua parte. Doversi occupare della scuola e della bambina la logorava, e lo sforzo di tacere quello che doveva restare un segreto le prosciugava le energie. «Mamma-ma-ma-ma» piagnucolò Ebba dal box. Aggrappata al bordo, in piedi, la stava fissando. Inez la ignorò. Non ne aveva la forza. Quella bambina pretendeva da lei tante cose che non riusciva a darle, e poi era figlia di Rune. Il naso e la bocca erano identici a quelli del padre e questo le rendeva ancora più difficile affezionarsi alla figlia. Si prendeva cura di lei, la cambiava, la nutriva, la teneva in braccio e la consolava quando si faceva male, ma più di così non era in grado di darle. La paura occupava troppo posto. Per fortuna c’era il resto, quello che le dava la forza di andare avanti, almeno un altro po’, invece di scappare e basta, prendere la barca per andare sulla terraferma e lasciarsi tutto alle spalle. Nei momenti più bui in cui si era trastullata con quell’idea non aveva osato chiedersi se avrebbe portato con sé Ebba. Non era certa di voler conoscere la risposta. «Posso prenderla in braccio?» La voce di Johan la fece sussultare. Non l’aveva sentito entrare nella lavanderia, dove stava piegando le lenzuola. «Certo, prendila» disse. Anche Johan era un motivo per restare. Lui le voleva bene e voleva bene alla sorellina. Un affetto ricambiato: quando Ebba lo vide s’illuminò in viso e tese le braccia verso di lui. «Vieni, Ebba» disse Johan. La piccola gli si appese al collo e si lasciò tirare fuori dal box, premendogli il faccino contro il viso. Inez smise di piegare il bucato e li osservò, sorpresa di provare una fitta di gelosia. Ebba non la guardava mai con lo stesso amore incondizionato. Negli occhi le si scorgeva sempre un misto di tristezza e desiderio. «Andiamo a vedere gli uccellini?» chiese Johan mentre strofinava il proprio naso contro quello della bambina, facendola strillare dalle risate. «Posso portarla fuori?» Inez annuì. Si fidava di Johan e sapeva che non avrebbe mai lasciato che accadesse qualcosa a Ebba. «Certo, fai pure.» Si chinò e prese un altro lenzuolo. Mentre uscivano, Ebba rise e fece dei versolini felici. Dopo un po’ non li sentì più. Il silenzio echeggiava tra le pareti e Inez si accovacciò a terra appoggiando la testa tra le ginocchia. La casa la teneva stretta nella sua morsa rischiando di toglierle il respiro e il senso di prigionia s’intensificava di giorno in giorno. Stavano scivolando verso un precipizio, ma non c’era niente, assolutamente niente che potesse fare per impedirlo. All’inizio Patrik aveva pensato di ignorare il segnale acustico del cellulare. Percy sembrava sul punto di crollare da un momento all’altro e considerando l’arma che aveva in mano poteva succedere di tutto. Nello stesso tempo, erano tutti come ipnotizzati dalla voce di Leon. Aveva raccontato di Valö, delle amicizie nate in collegio, della famiglia Elvander e di Rune e di come la situazione avesse lentamente cominciato ad andare alla deriva. Ia gli era rimasta accanto tutto il tempo accarezzandogli la mano. Dopo aver lentamente descritto il contesto, Leon sembrò esitare e Patrik capì che si stava avvicinando all’evento che aveva posto fine alla loro amicizia. Presto avrebbero scoperto la verità, ma la preoccupazione per Erica lo costrinse a tirare fuori il telefono e sbirciare il display. Un messaggio da Anna. Lo aprì velocemente e, mentre leggeva, la mano prese a tremargli in maniera incontrollata. «Dobbiamo andare a Valö, subito!» esclamò interrompendo Leon a metà di una frase. «Cos’è successo?» chiese Ia. Martin annuì. «Sì, mantieni la calma e spiegati meglio.» «Credo sia stato Mårten a dare fuoco alla casa e a sparare a Ebba qualche giorno fa. Adesso Gösta ed Erica sono in mano sua, sull’isola. Anna ed Ebba sono sparite, nessuno ha più loro notizie da ieri e...» Patrik si rese conto di parlare in maniera sconnessa e si costrinse a calmarsi. Se voleva aiutare Erica doveva mantenere il controllo. «Mårten ha un’arma che crediamo sia stata utilizzata quella vigilia di Pasqua. Vi dice qualcosa?» Gli uomini si guardarono. Poi Leon tese una chiave. «Deve aver trovato il rifugio. Il revolver era lì. Vero, Sebastian?» «Sì, io non ho mai più toccato niente dopo che abbiamo chiuso quella porta. Non capisco come ci sia entrato. A quanto ne so, questa è l’unica chiave.» «Il fatto che voi ne abbiate una non significa che non ce ne fossero altre.» Patrik si avvicinò e la prese. «Dove si trova il rifugio?» «In cantina, dietro una porta segreta. È impossibile individuarla se non se ne conosce l’esistenza» disse Leon. «Può essere lì che Ebba...?» Ia era impallidita. «Mi sembra una possibilità concreta» rispose Patrik andando verso la porta. Martin indicò Percy. «E di lui cosa facciamo?» Patrik si voltò, andò dritto da Percy e gli sfilò di mano la pistola prima che lui avesse il tempo di reagire. «Adesso basta con queste sciocchezze. Sbroglieremo tutto dopo. Martin, tu chiama rinforzi mentre noi andiamo, così io telefono alla guardia costiera per farci dare un passaggio. Chi ci accompagna per mostrarci dove si trova il rifugio?» «Io» rispose Josef alzandosi. «Vengo anch’io» disse Ia. «Basta che ci sia Josef.» Ia scosse la testa. «Vengo anch’io e non riuscirete a farmi cambiare idea.» «Okay, allora andiamo.» Mentre scendeva verso l’auto per poco non andò a sbattere contro Mellberg. «John Holm è là dentro?» Patrik annuì. «Sì, ma noi dobbiamo andare a Valö. Gösta ed Erica sono nei guai.» «Ah.» Mellberg era stato preso alla sprovvista. «Ma ho appena parlato con Kjell e Sven, che sono qui, e pare che John sia ricercato. I colleghi di Göteborg non sanno che si trova da Leon Kreutz e così ho pensato...» «Se ne occupi lei» disse Patrik. «Dove siete diretti?» Kjell Ringholm si avvicinò insieme a un uomo biondo dall’aspetto vagamente familiare. «C’è un’altra emergenza. Se cercate John Holm, è lì dentro. Mellberg è a vostra disposizione.» Proseguì a corsa leggera verso la macchina. Martin lo seguì a ruota, ma Ia e Josef erano rimasti un po’ indietro e Patrik spalancò loro la portiera, impaziente. Era contro ogni regola trasportare sull’auto di servizio dei civili quando si era diretti in un luogo potenzialmente pericoloso, ma aveva bisogno del loro aiuto. Durante il tragitto fino a Valö rimase a prua continuando a spostare il peso da un piede all’altro, come per incitare la motovedetta ad andare più veloce. Dietro di lui, Martin parlava a voce bassa con Josef e Ia, dando loro istruzioni di tenersi in disparte il più possibile e seguire le loro indicazioni. Non riuscì a trattenere un sorriso. Negli anni Martin si era trasformato, da giovane poliziotto inquieto e nervoso, in un collega solido e affidabile. Quando si avvicinarono a Valö afferrò strettamente la battagliola. Aveva guardato il cellulare almeno una volta al minuto, ma non erano arrivati altri messaggi. Dopo aver valutato l’opportunità di rispondere per dire che stavano arrivando aveva rinunciato perché temeva che in qualche modo potesse rivelare che Erica aveva un telefono. Si accorse che Ia lo stava osservando. Erano tante le cose che avrebbe voluto chiederle. Perché era fuggita, tornando solo in quel momento? Che ruolo aveva giocato nella morte del padre e della famiglia? Ma tutte quelle domande avrebbero dovuto aspettare. A tempo debito sarebbero andati a fondo della faccenda. In quel momento doveva solo concentrarsi sul fatto che Erica era in pericolo. Nient’altro aveva importanza. Era arrivato vicinissimo a perderla nell’incidente d’auto di un anno e mezzo prima e già allora si era reso conto di dipendere da lei e dello spazio che occupava nella sua vita e nel suo futuro. Quando scesero a terra, come a un segnale sia lui sia Martin afferrarono l’arma d’ordinanza. Poi dissero a Ia e Josef di stare dietro di loro e cominciarono a salire verso la casa. Percy fissava spiazzato un punto indefinito della parete. «Si può sapere che cazzo ti è preso?» John si passò una mano nella frangia bionda. «Pensavi di farci fuori tutti?» «Mah, veramente avevo intenzione di sparare solo a me. Prima però volevo divertirmi. Spaventarvi un po’.» «Perché volevi ucciderti?» Leon guardò il vecchio amico con tenerezza. Era così fragile nella sua supponenza e fin dai tempi di Valö Leon si era reso conto che sarebbe potuto andare in pezzi da un momento all’altro. Era un miracolo che non fosse già successo. Era stato facile prevedere che Percy avesse difficoltà a convivere con i ricordi, ma forse aveva ereditato anche la capacità di rimuovere. «Sebastian mi ha portato via tutto. E Pyttan mi ha lasciato. Diventerò lo zimbello del paese!» Sebastian spalancò le braccia. «Ma sentitelo! Chi è che usa la parola zimbello, di questi tempi?» Erano come bambini. Leon ebbe modo di constatarlo con chiarezza. Si erano fermati tutti nello sviluppo ed erano ancora là, nei ricordi. In confronto a loro sapeva di essere stato fortunato. Guardò gli uomini che aveva davanti e li vide come i ragazzi che erano un tempo. E, per quanto potesse sembrare strano, si accorse di provare affetto per loro. Avevano condiviso un’esperienza che li aveva mutati nel profondo e che aveva segnato la vita di tutti e il legame tra loro era talmente forte che nessuno avrebbe potuto spezzarlo. Aveva sempre saputo che sarebbe tornato, che quel giorno sarebbe arrivato, ma non che Ia sarebbe stata al suo fianco. Il suo coraggio lo sorprese. Forse aveva scelto consapevolmente di sottovalutarla per non sentirsi in colpa per il sacrificio che aveva compiuto, più grande di quello di qualsiasi altro. E perché proprio Josef aveva avuto il coraggio di alzarsi e andare con la polizia? Leon pensava di conoscere la risposta a quella domanda. Fin dal momento in cui aveva varcato la soglia, gli aveva letto negli occhi che era pronto a morire prima di sera. Era uno sguardo che conosceva bene. Lo aveva visto sull’Everest, quando era arrivata la tempesta, e sulla zattera di salvataggio dopo che la barca a vela era colata a picco nell’oceano Pacifico. Lo sguardo di un essere umano pronto a rinunciare alla vita. «Non ho intenzione di partecipare oltre.» John si alzò e raddrizzò la piega dei pantaloni. «Questa farsa è già durata anche troppo. Io negherò tutto. Non ci sono prove e sarai tu a dover rispondere di quanto dirai.» «John Holm?» disse una voce dalla soglia. John girò la testa. «Bertil Mellberg. Ci mancava solo questa. Cosa vuole? Se pensa di usare lo stesso tono dell’ultima volta, si rivolga pure al mio avvocato.» «Non ho commenti da fare.» «Bene. Allora io vado a casa. Piacere di avervi visto.» Si avviò verso la porta ma Mellberg gli si parò davanti. Alle sue spalle spuntarono altri tre uomini, uno dei quali sollevò una macchina fotografica e scattò una foto dietro l’altra. «Deve venire con me» disse Mellberg. John sospirò. «Che sciocchezze sta dicendo? Questa è vessazione, nient’altro, e le garantisco che ci saranno conseguenze.» «La dichiaro in arresto per istigazione a delinquere. Deve venire con me. Immediatamente» disse Mellberg con un largo sorriso sulla faccia. Leon seguiva la scena dalla sedia a rotelle e anche Percy e Sebastian, tesissimi, osservavano quello che stava succedendo. Paonazzo, John tentò di passare, ma Mellberg lo spinse contro il muro e con una manovra plateale gli unì a forza i polsi e gli mise le manette. Il fotografo continuò a scattare e gli altri due uomini si avvicinarono. «Cos’ha da dichiarare in merito al fatto che la polizia ha smascherato quello che all’interno degli Amici della Svezia chiamate “progetto Gimle”?» chiese uno dei due. A John cedettero le gambe e Leon osservò la scena con estremo interesse. Prima o poi tutti dovevano rispondere delle proprie azioni. Fu colto da un’improvvisa ansia per Ia, ma scacciò quel pensiero. Qualsiasi cosa fosse successa, era destino che succedesse. Ia doveva fare quello che si era ripromessa per liberarsi del senso di colpa e della nostalgia che l’aveva spinta a vivere solo per lui. L’amore nei suoi confronti aveva sempre sfiorato l’ossessione, ma lui sapeva che dentro le bruciava lo stesso fuoco che lo spingeva a raccogliere ogni sfida. Alla fine, nell’auto sulla ripida salita a Monaco, il fuoco aveva consumato entrambi. Non avevano scelta: dovevano portare a termine quel compito insieme. Leon l’amava ed era fiero di lei. Finalmente Ia avrebbe trovato la sua strada e il cerchio si sarebbe chiuso. Poteva solo sperare in un lieto fine. Mårten aprì lentamente gli occhi e li guardò. «Ero così stanco.» Non risposero. Di colpo anche Erica provò una stanchezza infinita. L’adrenalina le era scivolata via dal corpo e la consapevolezza che forse sua sorella era morta le faceva sentire le membra paralizzate. Voleva solo stendersi sul pavimento in legno e raggomitolarsi in una pallina. Chiudere gli occhi, addormentarsi e svegliarsi una volta che fosse tutto finito, in un modo o nell’altro. Aveva visto illuminarsi il display. Dan. Dio santo, doveva essere fuori di sé dalla preoccupazione dopo aver letto il messaggio che aveva mandato. Invece da Patrik non era arrivata risposta. Forse era impegnato e non l’aveva visto? Mårten continuò a scrutarli. Il corpo era rilassato e l’espressione indifferente. Erica si pentì di non aver chiesto a Ebba cos’era successo al figlio. Quell’evento doveva aver messo in moto qualcosa che alla fine aveva portato Mårten alla follia. Se solo avesse saputo come si erano svolti i fatti forse avrebbe trovato il modo di parlargli. Non potevano stare semplicemente lì ad aspettare che lui li ammazzasse. Perché non dubitava che quella fosse la sua intenzione. L’aveva capito appena aveva visto il riverbero gelido nei suoi occhi. Aprì la bocca e chiese dolcemente: «Raccontami di Vincent.» All’inizio lui non rispose. Si sentivano solo il respiro di Gösta e il rumore dei motori delle imbarcazioni in lontananza. Erica aspettò e alla fine Mårten disse con voce atona: «È morto.» «Cos’è successo?» «È stata colpa di Ebba.» «In che senso?» «Non l’ho capito veramente fino adesso.» Erica sentì insinuarsi nel corpo l’impazienza. «L’ha ucciso?» chiese trattenendo il respiro e vedendo con la coda dell’occhio che Gösta seguiva attentamente la conversazione. «È per questo che hai cercato di uccidere lei?» Mårten giocherellava con il revolver, soppesandolo in mano. «Non era nei piani che l’incendio si sviluppasse così tanto» disse appoggiando di nuovo l’arma sulle ginocchia. «Volevo solo che capisse che aveva bisogno di me. Che ero io a poterla proteggere.» «E sempre per questo le hai sparato?» «Doveva rendersi conto che io e lei dovevamo stare uniti. Ma in realtà niente aveva più importanza. Ora lo capisco. Mi ha manipolato perché non vedessi quello che era evidente. Che l’aveva ucciso lei.» Annuì, come per sottolineare le proprie parole, e il suo sguardo spaventò Erica al punto che dovette farsi forza per mantenere la calma. «Che aveva ucciso Vincent?» «Esatto. E dopo che è stata da te ho capito tutto. Ha ereditato la colpa. Una malvagità così grande non può sparire e basta.» «Parli della nonna di sua nonna? La fabbricante di angeli?» chiese Erica sorpresa. «Sì. Ebba mi ha raccontato che annegava i bambini e li seppelliva in cantina perché pensava che nessuno li volesse, che non sarebbe venuto nessuno a cercarli. Ma io volevo Vincent. L’ho cercato, ma non c’era già più. L’aveva annegato lei. Era sepolto insieme agli altri bambini morti e non poteva tornare su.» Aveva sputato le parole con tanta foga che da un angolo della bocca gli colava un rivoletto di saliva. Erica si rese conto che non sarebbe riuscita a parlare con lui. Realtà diverse erano scivolate una nell’altra creando uno strano paese d’ombre in cui non era più raggiungibile. Sentendo montare il panico lanciò un’occhiata a Gösta e la sua espressione scoraggiata le fece capire che aveva tirato la stessa conclusione. Non potevano fare altro che pregare e sperare di sopravvivere, in un modo o nell’altro. «Sch» fece Mårten all’improvviso, raddrizzando la schiena e facendo sussultare entrambi con quello scatto improvviso. «Arriva qualcuno.» Afferrò il revolver e balzò in piedi. «Sch» disse di nuovo portandosi l’indice alle labbra. Corse alla finestra e guardò fuori. Per un attimo sembrò soppesare le diverse alternative. Poi li indicò. «Voi due restate qui. Io vado. Devo controllarli. Non posso permettere che le trovino.» «Cos’hai intenzione di fare?» Erica non era riuscita a trattenersi. La speranza che qualcuno stesse venendo in loro soccorso si mescolava al terrore che comportasse un pericolo per la vita di Anna, ammesso che non fosse già troppo tardi. «Dov’è mia sorella? Devi dirmelo.» La voce era andata in falsetto. Gösta le appoggiò una mano sul braccio per tranquillizzarla. «Noi aspettiamo qui, Mårten. Non andiamo da nessuna parte. Quando torni ci ritroverai nella stessa identica posizione.» Lo stava guardando dritto negli occhi. Alla fine lui annuì, fece dietrofront e si precipitò giù dalle scale. Erica avrebbe voluto alzarsi subito e corrergli dietro, ma Gösta l’afferrò saldamente per il braccio e sussurrò: «Calma. Prima dobbiamo guardare dalla finestra per vedere dove va.» «Ma Anna...» rispose lei disperata, cercando di liberarsi. Gösta non si diede per vinto. «Rifletti, invece di agire in modo avventato. Guardiamo fuori, poi scendiamo e andiamo incontro a chi sta arrivando. Saranno sicuramente Patrik e gli altri, e ci aiuteranno.» «Okay» rispose Erica alzandosi sulle gambe intorpidite e malferme. Insieme sbirciarono cauti dalla finestra. «Vedi qualcuno?» «No» rispose Gösta. «Neanche tu?» «No, è difficile che scenda al pontile, altrimenti rischierebbe di finire dritto in braccio a chi sta arrivando.» «Deve aver girato intorno alla casa. Dove sarebbe andato altrimenti?» «In ogni caso non lo vedo. Adesso io scendo.» Erica andò alla scala in punta di piedi e raggiunse l’ingresso. Regnava il silenzio e non si sentivano voci, ma sapeva che avrebbero cercato di avvicinarsi facendo il minimo rumore possibile. Guardò fuori e sentì salire il pianto in gola. Lo spiazzo era deserto. In quel momento vide qualcosa muoversi tra gli alberi. Socchiuse gli occhi e il sollievo fu enorme. Era Patrik e alle sue spalle scorse Martin e altre due persone. Impiegò un attimo a riconoscere Josef Meyer. Accanto a lui c’era una donna in abiti eleganti. Possibile che fosse Ia Kreutz? Agitò una mano, in modo che Patrik la vedesse, e poi si ritrasse nell’ombra. «Noi restiamo qui» disse a Gösta che stava scendendo le scale. Si addossarono al muro in modo da non essere visti nello specchio della porta. Mårten poteva essere ovunque, là fuori, ed Erica non voleva rischiare di fargli da bersaglio. «Dove può essersi cacciato?» Gösta si girò verso di lei. «Forse è ancora qui dentro?» Erica si rese conto che poteva avere ragione e si guardò intorno in preda al panico, come se Mårten potesse spuntare da un momento all’altro e sparare a entrambi, ma non si vedeva da nessuna parte. Quando finalmente Patrik e Martin arrivarono nell’ingresso, Erica incrociò lo sguardo del marito e vi lesse sollievo e ansia. «Mårten?» sussurrò, e lei gli riferì in breve cos’era successo da quando li aveva sentiti arrivare. Patrik annuì e insieme a Martin fece un rapido giro del pian terreno con la pistola stretta in mano. Quando tornarono nell’ingresso scossero la testa. Ia e Josef erano immobili. Erica si chiese cosa ci facessero lì. «Non so dove siano Anna ed Ebba. Mårten ha detto qualcosa a proposito del fatto che doveva controllarle. Può averle chiuse da qualche parte?» Non riuscì a trattenere un singhiozzo. «Da quella parte» disse Josef indicando una porta in fondo all’ingresso. «Cosa c’è in cantina?» domandò Gösta. «Ve lo spiegheremo dopo, adesso non c’è tempo» rispose Patrik. «Tu rimani sempre dietro di me. E voi fermatevi qui» disse a Erica e Ia. Erica fece per protestare ma vide l’espressione di Patrik. Non era il caso di fare obiezioni. «Noi scendiamo» disse lui lanciandole un’ultima occhiata e lei gli lesse nello sguardo la paura di quello che avrebbe trovato un piano più sotto. Valö, vigilia di Pasqua 1974 Doveva essere tutto come sempre: Rune se lo aspettava. La maggior parte degli allievi era a casa per le vacanze e lei aveva chiesto timidamente se i ragazzi rimasti potevano pranzare con loro, ma Rune non l’aveva neanche degnata di una risposta. Era evidente che il pranzo pasquale doveva essere riservato alla famiglia. Aveva cucinato per due giorni: cosciotto d’agnello, uova ripiene, salmone in guazzetto... I desideri di Rune non finivano mai. Anzi, chiamarli desideri non era corretto: si trattava piuttosto di pretese. «Carla preparava sempre tutto questo. Ogni anno» le aveva comunicato dandole l’elenco dei piatti da cucinare in vista della loro prima Pasqua insieme. Inez sapeva che non era il caso di protestare. Se lo faceva Carla, doveva essere così. Dio non volesse che lei si arrogasse il diritto di fare diversamente. «Metti Ebba nel seggiolone, Johan?» chiese portando in tavola il grosso cosciotto. Pregò Dio che fosse venuto bene. «Deve proprio esserci anche la bambina? Disturba e basta.» Annelie entrò strascicando i piedi e si sedette. «Secondo te cosa dovrei farne?» chiese Inez. Dopo tutte quelle ore ai fornelli non era proprio dell’umore giusto per le rimostranze della figliastra. «Non lo so, ma quando c’è anche lei a tavola mi viene da vomitare.» Inez non riuscì a trattenersi. «Se è così fastidiosa, forse potresti fare a meno di mangiare tu con noi» sibilò. «Inez!» Fece un salto. Rune, entrato nella stanza in quel momento, era paonazzo in viso. «Cosa stai dicendo? Che mia figlia non è la benvenuta a tavola?» La voce era gelida e lo sguardo inchiodò Inez. «In questa famiglia tutti sono invitati a partecipare al pasto.» Annelie non aprì bocca ma Inez la vide gongolare. «Scusa. Ho parlato senza riflettere.» Si girò e spostò la terrina delle patate, ribollendo dentro. Avrebbe soltanto voluto urlare, seguire il suo cuore e fuggire di lì. Non ne poteva più di quell’inferno. «Ebba ha rigurgitato un po’» disse Johan ansioso, asciugando il mento della bambina con un tovagliolo. «Non sarà mica malata?» «No, avrà solo mangiato un po’ troppa farina lattea» lo rassicurò Inez. «Meno male» rispose il bambino, senza suonare del tutto convinto. Diventava ogni giorno più iperprotettivo, pensò Inez, chiedendosi ancora una volta come potesse essere così diverso dai suoi fratelli. «Cosciotto d’agnello. Sicuramente non sarà buono come quello della mamma.» Claes entrò e si sedette accanto ad Annelie, che si mise a ridacchiare e gli fece l’occhiolino. Lui però non la degnò di uno sguardo. Quei due avrebbero dovuto essere amici per la pelle, ma il maggiore sembrava non curarsi di nessuno al mondo. A parte la madre, di cui non smetteva mai di parlare. «Ho fatto quello che ho potuto» disse Inez. Claes sbuffò sprezzante. «Dove sei stato?» chiese Rune allungandosi verso le patate. «Ti ho cercato. Olle ha scaricato giù al pontile le assi che gli avevo chiesto. Devi aiutarmi a portarle su.» Il ragazzo alzò le spalle. «In giro per l’isola. Le assi posso portarle più tardi.» «Subito dopo mangiato, allora» disse Rune, ma si accontentò della risposta. «Doveva essere più rosata» si lamentò Annelie arricciando il naso. Stava guardando la fetta di carne d’agnello che si era messa sul piatto. Inez strinse i denti. «Il forno purtroppo non funziona granché bene. La temperatura non rimane costante. Come ho detto, ho fatto quello che ho potuto.» «Che schifo» disse Annelie scostando la carne. «Mi passi la salsa?» chiese a Claes che aveva la salsiera alla sua sinistra. «Certo» rispose. «Oh...!» esclamò senza distogliere gli occhi da Inez. La salsiera era finita a terra con uno schianto e la salsa si era sparsa sul pavimento filtrando in mezzo alle tavole. Inez sostenne il suo sguardo. Sapeva che aveva fatto apposta. E lui sapeva che lei sapeva. «Stai un po’ attento» disse Rune guardando il pavimento. «Pulisci, Inez.» «Certo» rispose lei con un sorriso forzato. Naturalmente non gli era neanche passato per la mente che potesse farlo Claes. «Porti anche dell’altra salsa?» le chiese quando lei si diresse verso la cucina. Inez si girò. «Era tutta lì.» «Carla ne teneva sempre un po’ di riserva in cucina, nel caso finisse.» «Be’, io invece non l’ho fatto. L’avevo messa tutta nella salsiera.» Quando ebbe ripulito la salsa, ginocchioni di fianco alla sedia di Claes, tornò al proprio posto. La roba sul piatto era ormai fredda, ma tanto aveva perso l’appetito. «Era buonissima, Inez» disse Johan allungando il piatto per averne ancora. «Sei proprio una brava cuoca.» Aveva degli occhi così azzurri e così innocenti che le venne da piangere. Mentre Inez gli riempiva di nuovo il piatto, lui imboccava Ebba con il suo cucchiaino d’argento. «Ecco che arrivano le patate. Mm, che bontà» disse, illuminandosi ogni volta che la bambina apriva la bocca e mandava giù. Claes scoppiò in una risata cattiva. «Sei proprio un bamboccio rammollito.» «Non parlare così a tuo fratello» sibilò Rune. «Ha il massimo dei voti in tutte le materie ed è più intelligente di voi due messi insieme. Non è che tu a scuola abbia dato risultati propriamente brillanti e quindi mi aspetto che ti rivolga in maniera appropriata a tuo fratello, almeno finché non avrai dimostrato di valere qualcosa. Tua madre si sarebbe vergognata se avesse visto la tua pagella e quanto ti sei rivelato incapace.» Claes trasalì e Inez vide che il suo viso era scosso da fremiti che non riusciva a controllare. Gli occhi si erano incupiti, diventando due pozzi neri senza fondo. Per un istante intorno alla tavola scese il silenzio. Anche Ebba smise di fare i suoi versolini. Claes guardava Rune dritto negli occhi e Inez chiuse le mani a pugno sotto il tavolo. Quello a cui stava assistendo era un duello e non era certa di voler vedere come sarebbe andato a finire. Rimasero a fissarsi per diversi minuti. Poi Claes distolse lo sguardo. «Scusa, Johan» disse. Inez rabbrividì. La voce grondava odio e di colpo sentì che doveva seguire il proprio istinto. Aveva ancora una possibilità di alzarsi e scappare. Avrebbe dovuto coglierla, qualsiasi fossero state le conseguenze. «Scusate se vi disturbo durante il pranzo, ma avrei bisogno di parlare con lei, direttore. È urgente.» Leon era sulla porta, la testa educatamente china. «Non puoi aspettare? Stiamo mangiando» rispose Rune con un solco profondo tra le sopracciglia. Essere disturbato a metà di un pasto era una cosa che non tollerava, nemmeno nelle normali giornate feriali. «Lo capisco perfettamente e non mi permetterei mai, se non fosse importante.» «Di che si tratta?» chiese Rune pulendosi la bocca con il tovagliolo. Leon esitò. Inez guardò Annelie che non riusciva a staccare gli occhi dal ragazzo. «Una situazione d’emergenza a casa. Mio padre mi ha chiesto di parlarle.» «Ah, tuo padre. Perché non l’hai detto subito?» Si alzò da tavola. Per i ricchi genitori dei suoi allievi aveva sempre tempo. «Voi continuate a mangiare. Non ci metterò molto» disse dirigendosi verso la porta dove lo aspettava Leon. Inez seguì Rune con lo sguardo e lo stomaco le si annodò. Tutte le emozioni degli ultimi mesi si riunirono in un unico grumo duro. Stava per succedere qualcosa. Il paesaggio gli sfilava accanto oltre il finestrino e sul sedile davanti quello sgradevole Mellberg parlava concitato al telefono. Sembrava che non volesse saperne di consegnarlo ai poliziotti sul posto a Fjällbacka e insistesse per portarlo di persona fino a Göteborg. Be’, per lui non faceva differenza. John si chiese come l’avrebbe presa Liv. Anche lei aveva puntato tutto su una carta. Forse avrebbero dovuto accontentarsi di quello che avevano già realizzato, ma la tentazione di imprimere una svolta decisiva e riuscire in un’impresa mai realizzata da nessun partito nazionalista in Svezia, e cioè acquisire una posizione politica dominante, era stata troppo forte. In Danimarca il Partito del popolo danese aveva portato a termine gran parte degli obiettivi sognati dagli Amici della Svezia. Era stato un errore affrettare quell’evoluzione anche in Svezia? Il progetto Gimle avrebbe dovuto riunire gli svedesi in modo che potessero finalmente restaurare il Paese insieme. Era un piano semplice, e sebbene a tratti si fosse sentito prendere dall’ansia era convinto che sarebbe riuscito. E invece era crollato tutto. Tutto quello che avevano costruito sarebbe stato spazzato via e dimenticato a causa delle ripercussioni del progetto Gimle. Nessuno avrebbe capito che il fine ultimo era creare un nuovo futuro per gli svedesi. Era cominciato con una proposta lanciata per scherzo all’interno della cerchia più ristretta. Liv ne aveva subito intuito il potenziale e aveva spiegato a lui e agli altri in che modo si sarebbe potuto provocare un balzo in avanti che normalmente avrebbe richiesto l’avvicendamento di un’intera generazione. Nel giro di una notte avrebbero fatto una rivoluzione mobilitando gli svedesi in una lotta contro i nemici che si erano annidati nella società e rischiavano di demolirla. Il ragionamento era logico e il prezzo da pagare era sembrato congruo. Una sola bomba, piazzata nel bel mezzo del centro commerciale Sturegallerian all’ora di punta. Tutte le piste seguite dalla polizia avrebbero portato a nuclei di terroristi islamici. Era più di un anno che pianificavano, esaminavano i dettagli e verificavano come fare in modo che non si potesse trarre altra conclusione che quella di un attacco islamico al cuore di Stoccolma, al cuore della Svezia. I cittadini si sarebbero impauriti, e la paura porta alla rabbia. A quel punto gli Amici della Svezia si sarebbero fatti avanti e li avrebbero presi per mano, confermando le loro paure e spiegando cosa fare per tornare a vivere al sicuro, per poter condurre un’esistenza da svedesi. Niente di tutto ciò sarebbe diventato realtà. La paura di quello che poteva rivelare Leon era di colpo ridicola e assurda in confronto allo scandalo che gli si prospettava. Sarebbe stato al centro dell’attenzione, ma in modo opposto a quello previsto. Il progetto Gimle avrebbe segnato la sua caduta, non il suo trionfo. Ebba guardò le foto che aveva sparso sul pavimento. I ragazzini nudi fissavano l’obiettivo con lo sguardo vuoto. «Hanno un’aria così inerme.» Distolse gli occhi. «Questo non ha niente a che vedere con te» disse Anna accarezzandole un braccio. «Sarebbe stato meglio che non avessi mai scoperto niente della mia famiglia. L’unica immagine che ne avrò, se...» Non completò la frase, ma Anna sapeva che non voleva pronunciare a voce alta quell’ipotetica: se usciremo di qui. Ebba guardò di nuovo le foto. «Dovevano essere allievi di mio padre. Capisco che l’abbiano ucciso, se li obbligava a cose di questo genere.» Anna annuì. Si vedeva che i ragazzini avrebbero voluto coprirsi con le mani ma che il fotografo non glielo permetteva. Sui loro volti si leggeva chiaramente il tormento e non le riusciva difficile intuire la rabbia che doveva essere scaturita da quell’umiliazione. «Quello che non capisco è perché siano dovuti morire tutti» disse Ebba. D’un tratto sentirono dei passi fuori dalla porta. Si alzarono in piedi e la fissarono tese. Qualcuno stava armeggiando con la serratura. «Dev’essere Mårten!» sussurrò Ebba atterrita. Si guardarono istintivamente intorno in cerca di una via di fuga, ma erano come topi in trappola. La porta si aprì lentamente e Mårten entrò con un revolver in mano. «Sei viva?» disse guardando Ebba e Anna rimase allibita dal suo tono indifferente. «Perché? Perché stai facendo tutto questo?» Ebba fece per avvicinarglisi, piangendo. «Ferma.» Sollevò il revolver e glielo puntò addosso, facendola bloccare a metà di un passo. «Lasciaci uscire di qui.» Anna cercò di attirare la sua attenzione. «Promettiamo di non dire niente.» «E dovrei crederci? Comunque non ha importanza. Non ho alcun desiderio di...» Si zittì e guardò i bauli da cui si vedevano spuntare le ossa. «Cos’è quella roba?» «La famiglia di Ebba» rispose Anna. Mårten non riusciva a staccare lo sguardo dagli scheletri. «Sono stati qui per tutto il tempo?» «Sì, dev’essere andata così.» In lei si accese la speranza che Mårten fosse rimasto abbastanza scosso da essere di nuovo ricettivo. Si chinò, ma lui trasalì e le puntò addosso il revolver. «Voglio solo farti vedere una cosa.» Raccolse le foto da terra e le porse a Mårten, che le prese con aria diffidente. «Chi sono questi?» chiese, e per la prima volta la voce suonava quasi normale. Anna sentì il cuore battere forte nel petto. Da qualche parte, lì dentro, c’era ancora il Mårten ragionevole ed equilibrato che aveva conosciuto. Lui si avvicinò le foto al viso e le scrutò. «Dev’essere stato mio padre a obbligarli» disse Ebba, i capelli davanti al viso. Tutta la sua postura indicava che si era arresa. «Rune?» chiese Mårten, ma si raddrizzò di scatto sentendo dei rumori da fuori e si affrettò a chiudere la porta. «Chi era?» chiese Anna. «Vogliono rovinare tutto» rispose Mårten. La luce negli occhi si era spenta e Anna si rese conto che non c’era più speranza. «Ma qui non possono entrare. Ho io la chiave. Era sopra la cornice della porta della cantina, arrugginita e dimenticata. Ho provato a infilarla in tutte le serrature ma non entrava da nessuna parte. Poi, una settimana fa, ho trovato per caso l’entrata di questo posto, costruita in modo davvero geniale e quasi impossibile da vedere.» «Perché non me l’hai detto?» chiese Ebba. «Avevo già cominciato a capire come stavano le cose, e cioè che tu eri colpevole della morte di Vincent ma non volevi riconoscerlo. Che cercavi di scaricare tutto su di me. E nel baule aperto ho trovato questo.» Agitò il revolver. «Sapevo che avrei avuto modo di usarlo.» «Riusciranno a entrare, lo sai» intervenne Anna. «Tanto vale che tu apra la porta.» «Non posso più farlo. Una volta probabilmente c’era una maniglia qui all’interno, ma qualcuno l’ha tolta. La porta si chiude da sola e loro non hanno la chiave, quindi anche se contro ogni previsione dovessero trovare l’ingresso nascosto non riuscirebbero a entrare qui. È una porta costruita da una persona paranoica ed è molto resistente.» Mårten sorrise. «E quando si saranno procurati l’attrezzatura per forzarla sarà troppo tardi.» «Per favore, Mårten» disse Ebba, ma Anna si rese conto che cercare di parlargli non aveva senso. Se lei non avesse fatto qualcosa, sarebbe morto lì, con loro. Nello stesso momento una chiave fu inserita nella serratura e Mårten girò la testa di scatto, ammutolito. Era l’occasione che Anna aspettava: con la mano afferrò il gioiello a forma di angelo rimasto a terra e gli si lanciò addosso, incidendogli un lungo taglio nella guancia mentre con l’altra mano cercava di togliergli l’arma. Proprio quando sentì l’acciaio freddo sotto le dita sentì esplodere un colpo. In realtà aveva deciso di morire quel giorno. Gli sembrava la logica conseguenza del suo fallimento e la decisione l’aveva riempito soltanto di sollievo. Al momento di uscire di casa non aveva ancora deciso come sarebbe successo, ma quando Percy aveva agitato la pistola era stato sfiorato dal pensiero di poter morire da eroe. Poche ore dopo, quella decisione gli sembrava di colpo affrettata. Mentre scendeva lungo la scala buia, Josef aveva provato più forte che mai la voglia di vivere. Non voleva morire, e soprattutto non nel luogo in cui per tanto tempo si erano svolti i suoi incubi. Davanti a sé vedeva i poliziotti e senza armi si sentiva sgradevolmente nudo. Non avevano dovuto discutere dell’opportunità di scendere con loro in cantina: era l’unico in grado di mostrare la strada, l’unico che sapesse dove si trovava l’inferno. I poliziotti lo aspettarono ai piedi della scala. Patrik Hedström sollevò un sopracciglio con aria interrogativa e Josef indicò la parete di fondo, apparentemente normalissima, con mensole storte cariche di vecchie latte sporche di vernice. Vide l’espressione scettica di Patrik e lo precedette per mostrargli come funzionava. Ricordava tutto perfettamente: gli odori, la sensazione del cemento sotto i piedi, l’aria viziata che veniva inspirata nei polmoni. Dopo un’occhiata a Patrik, premette il lato destro della mensola centrale e la parete ruotò verso l’interno facendo comparire un passaggio che conduceva a una porta robusta. Poi fece un passo di lato. I poliziotti lo guardarono stupiti ma dopo un attimo si riscossero ed entrarono. Arrivati alla porta, si fermarono e tesero le orecchie. Al lato opposto si percepiva un basso borbottio. Josef sapeva esattamente cosa c’era nella stanza: bastava che chiudesse gli occhi perché l’immagine risultasse nitida come se fosse stato ieri. Le pareti spoglie, la lampadina nuda appesa al soffitto. E i quattro bauli. In uno avevano messo il revolver e doveva essere stato lì che l’aveva trovato il marito di Ebba. Josef si chiese se avesse aperto anche quelli chiusi a chiave, se fosse al corrente di cosa contenevano. In ogni caso, di lì a poco l’avrebbero saputo tutti. Non si poteva più tornare indietro. Patrik estrasse la chiave dalla tasca, la infilò nella serratura e girò lanciando un’occhiata a Josef e ai colleghi, uno sguardo da cui si capiva che temeva il peggio. Poi aprì cauto la porta. Si sentì echeggiare un colpo e Josef vide i poliziotti irrompere con le armi in pugno, ma rimase nel passaggio. Il caos all’interno rendeva difficile capire cosa stesse succedendo, però sentì Patrik gridare: «Metti giù quell’arma!» Poi un lampo e uno sparo così forte da far male dentro. Infine, il tonfo di un corpo umano che cadeva a terra. Nel silenzio che seguì sentì fischiare le orecchie e si accorse di respirare a scatti, superficialmente. Era vivo, sentiva di essere vivo e provò un’immensa gratitudine. Rebecka sarebbe stata fuori di sé dalla preoccupazione quando avesse trovato la sua lettera, ma avrebbe cercato di spiegarle tutto. Perché non sarebbe morto quel giorno. Qualcuno arrivò di corsa giù dalla scala della cantina. Voltandosi vide Ia venirgli incontro, l’espressione terrorizzata. «Ebba» disse. «Dov’è Ebba?» Il sangue era schizzato sui bauli e fino a metà parete. Alle sue spalle Anna sentiva le urla di Ebba, ma come in lontananza. «Anna.» Patrik la prese per le spalle e la scosse. Lei indicò un orecchio. «Credo di essermi spaccata un timpano. Non sento niente.» La voce suonava strana, sorda. Era successo tutto così in fretta. Abbassò gli occhi sulle mani insanguinate e si esaminò il corpo per vedere se c’erano ferite, ma non sembrava. Stringeva ancora forte l’angelo di Ebba e si rese conto che il sangue doveva venire dal taglio sul viso di Mårten. Poi lo vide steso a terra, gli occhi aperti. Una pallottola gli aveva trafitto la testa. Anna distolse lo sguardo. Ebba urlava ancora e di colpo una donna entrò a precipizio e la strinse tra le braccia. Si mise a cullarla e lentamente le urla si stemperarono in un basso gemito. Anna indicò muta i bauli e Patrik, Martin e Gösta fissarono gli scheletri, qui e là chiazzati del sangue di Mårten. «Dobbiamo portarvi via.» Patrik sospinse dolcemente Anna ed Ebba verso la porta, con Ia che le seguiva a ruota. Quando si trovarono in cantina Anna vide Erica scendere a precipizio la ripida scala in fondo, due gradini alla volta, e le corse incontro. Solo dopo aver nascosto il viso contro il collo della sorella maggiore sentì arrivare le lacrime. Quando tornarono nell’ingresso socchiusero gli occhi per ripararli dalla luce intensa. Anna era ancora scossa dai brividi e, leggendole nel pensiero, Erica andò al piano di sopra a prendere i suoi vestiti, senza fare commenti sul fatto che si trovassero in camera da letto, ma Anna sapeva che avrebbe avuto parecchio da spiegare, non solo a lei ma anche a Dan. Provò una fitta al cuore all’idea del male che gli avrebbe fatto, ma non aveva la forza di pensarci in quel momento. Avrebbe rimandato a dopo. «Ho chiamato i rinforzi e stanno arrivando» disse Patrik, aiutando lei ed Ebba a sedersi sulla scalinata esterna. Ia si mise di fianco a Ebba, stringendola forte. Gösta si sedette al lato opposto e le osservò. Patrik si chinò verso di lui e disse: «È Annelie. Ti spiego dopo.» Gösta gli rivolse un’occhiata interrogativa. Poi un lampo gli attraversò la mente e di colpo fu tutto chiaro. Scosse la testa. «La calligrafia. Ecco cos’era.» Sapeva che gli era sfuggito qualcosa quando aveva passato in rassegna gli scatoloni. Qualcosa che aveva visto senza capirlo. Si girò verso Ia. «Avrebbe potuto restare da noi, ma è stata bene anche dove è andata.» Si accorse che gli altri ascoltavano senza capire di cosa stesse parlando. «Non avevo la forza di pensare a chi si fosse preso cura di lei. Non riuscivo proprio a pensare a lei. Era la cosa più facile» disse Ia. «Era così carina. Quell’estate ci aveva incantati e avremmo voluto tenerla con noi, ma avevamo perso un figlio ed era come se avessimo rinunciato all’idea di avere un bambino per casa...» Distolse lo sguardo. «Sì, era bella. Un vero angioletto» disse Ia con un sorriso triste. Ebba li stava fissando perplessa. «Come l’ha capito?» chiese Ia. «Dalla lista della spesa. Tra gli oggetti lasciati c’era una lista della spesa scritta a mano. E io avevo ricevuto il foglietto con l’indirizzo, scritto da lei. Era la stessa scrittura.» «Qualcuno può essere così gentile da spiegare di che si tratta?» chiese Patrik. «Magari tu, Gösta.» «Fu un’idea di Leon quella di farmi usare il passaporto di Annelie invece del mio» disse Ia. «In effetti c’era qualche anno di differenza tra noi, ma ci somigliavamo abbastanza perché potesse funzionare.» «Non capisco.» Ebba scosse la testa. Gösta la guardò dritto negli occhi. Vide la bambina che scorrazzava nel loro giardino e che aveva lasciato un’impronta indelebile nel suo cuore e in quello di Maj- Britt. Era venuto il momento di darle le risposte che aspettava da tanto tempo. «Ebba, questa è tua madre. Inez.» Scese il silenzio più completo. Si sentiva solo il vento tra le betulle. «Ma... ma...» balbettò Ebba indicando un punto alle proprie spalle, in direzione della cantina. «Chi è allora quella con i capelli lunghi?» «Annelie» disse Ia. «Avevamo tutte e due i capelli lunghi e scuri» disse facendole una carezza sulla guancia. «Perché non hai mai...?» La voce di Ebba era turbata da mille emozioni. «Non ho risposte semplici. Ci sono molte cose che non posso spiegarti perché non le capisco neanche io stessa. Ero costretta a non pensare a te, altrimenti non sarei mai riuscita a lasciarti.» «Leon non ha fatto in tempo a finire di raccontare quello che è successo veramente» disse Patrik. «Credo che sia venuto il momento di farlo.» «Sì, lo credo anch’io» disse Inez. Non lontano dall’isola si vedevano delle motovedette in arrivo. Gösta era contento che qualcuno stesse per dare loro il cambio, ma prima avrebbe finalmente saputo cos’era successo quella vigilia di Pasqua del 1974. Prese una mano di Ebba tra le sue e Inez afferrò l’altra. Valö, vigilia di Pasqua 1974 «Cos’è questa roba?» Rune, sulla soglia della sala da pranzo, era bianco in viso. Alle sue spalle si intravedevano Leon e gli altri ragazzi: John, Percy, Sebastian e Josef. Inez li guardò meravigliata. Non aveva mai visto Rune perdere le staffe a quel modo. Il turbamento era tale che tremava tutto. Andò a mettersi davanti a Claes. In mano teneva alcune fotografie e un revolver. «Cos’è questa roba?» ripeté. Claes rimase in silenzio, gli occhi inespressivi. I ragazzi avanzarono di qualche passo nella stanza e Inez cercò lo sguardo di Leon, che era però fisso su Claes e Rune. Per un lungo istante regnò il silenzio più completo. L’aria era densa e difficile da respirare e Inez si afferrò al bordo del tavolo. Davanti a lei stava per accadere qualcosa di terribile e qualsiasi cosa fosse sarebbe andata a finire male. Sulle labbra di Claes si aprì lentamente un sorriso. Prima che suo padre avesse il tempo di reagire si alzò, gli prese di mano il revolver e fece esplodere un colpo. Rune si accasciò senza vita. Il sangue scorreva da un foro nero di polvere da sparo al centro della fronte e Inez si rese conto di urlare. Sembrava che il grido venisse da qualcun altro ma lei sapeva che la voce che echeggiava tra le pareti mescolandosi in un macabro duetto a quella di Annelie era la sua. «Chiudete quella boccaccia!» gridò Claes, il revolver ancora puntato su Rune. «Chiudete quella boccaccia!» Ma Inez non riusciva a trattenere l’urlo che le usciva dalla bocca mentre gli occhi non si staccavano dal corpo senza vita del marito. Ebba piangeva in modo straziante. «Chiudete la bocca, ho detto!» Claes sparò al padre una seconda volta e il corpo a terra sussultò. La camicia si tinse lentamente di rosso. Lo shock zittì Inez di colpo. Anche il grido di Annelie si interruppe all’improvviso, mentre Ebba continuò a piangere. Claes si passò una mano sul viso. L’altra stringeva ancora il revolver. Sembra un ragazzino che gioca ai cowboy, pensò Inez, ma scacciò subito quell’idea assurda. Nel suo aspetto non c’era niente di infantile e nemmeno di umano. Aveva lo sguardo vuoto e l’orribile ghigno ancora dipinto sulle labbra, come se il viso si fosse irrigidito in quell’espressione. Il respiro era veloce e irregolare. Con un gesto improvviso si girò verso Ebba e prese la mira. La bambina continuò a strillare, il viso paonazzo, e Inez vide raggelata il dito di Claes piegarsi sul grilletto e Johan che di colpo si gettava in avanti ma si bloccava a metà. Sorpreso, il bambino abbassò gli occhi sulla propria camicia dove si stava allargando una macchia rossa. Poi rovinò a terra. Di nuovo scese il silenzio, un silenzio innaturale. Persino Ebba si zittì e si ficcò il pollice in bocca. Johan era riverso a terra sotto il seggiolone. La frangia bionda gli era ricaduta sugli occhi azzurri che guardavano il soffitto senza vederlo. Inez soffocò un singhiozzo. Claes arretrò fino a ritrovarsi con le spalle contro la parete. «Adesso fate quello che vi dico. E in silenzio. È la cosa più importante.» Parlava con una calma sinistra, come se godesse di quella situazione. Con la coda dell’occhio Inez percepì un movimento vicino alla porta e anche Claes sembrò coglierlo. Con la velocità del lampo, puntò l’arma contro i ragazzi. «Nessuno si muova. Nessuno deve uscire di qui.» «Cosa vuoi farci?» chiese Leon. «Non lo so. Non ho ancora deciso.» «Mio padre ha molti soldi» disse Percy. «Se ci lasci andare può pagare.» Claes sbottò in una risata metallica. «Non sono i soldi che voglio. Dovresti saperlo.» «Promettiamo di non dire niente» lo implorò John, ma Claes non lo ascoltava neanche. Inez sapeva che era inutile. Ci aveva visto giusto. Aveva sempre intuito che a Claes mancasse qualcosa. Qualsiasi torto avesse fatto ai ragazzi, l’avrebbe tenuto nascosto a ogni costo. Aveva già ucciso due persone e non avrebbe lasciato uscire vivo di lì nessuno di loro. Sarebbero morti tutti. Leon cercò d’improvviso il suo sguardo e lei capì che aveva pensato la stessa cosa. Non avrebbero mai più avuto i momenti che avevano condiviso di nascosto. Avevano fatto dei piani e fantasticato sulla loro vita insieme, convinti che, se solo avessero aspettato e avuto pazienza, avrebbero avuto un futuro. E invece non sarebbe stato così. «Lo sapevo che quella puttana aveva una tresca» disse Claes di colpo. «Quello sguardo non inganna. Da quanto tempo ti scopi la mia matrigna, Leon?» Inez rimase in silenzio. Annelie guardò prima lei e poi Leon. «È vero?» Per un attimo sembrava aver dimenticato la paura. «Brutta troia! Non c’era nessuno della tua et...» La frase s’interruppe a metà. Claes aveva puntato il revolver sparandole un colpo alla tempia. «Ti avevo avvertito di tenere la bocca chiusa» disse con voce atona. Inez sentì le lacrime bruciare sotto le palpebre. Quanto era rimasto da vivere a lei, a tutti gli altri? Erano impotenti e non potevano far altro che aspettare di essere massacrati uno a uno. Ebba si rimise a strillare e Claes sobbalzò. Gridava sempre più forte e Inez sentì il corpo tendersi come una molla. Avrebbe dovuto alzarsi ma non ci riusciva. «Fai tacere quella mocciosa.» Claes la guardò. «Falla tacere, ho detto!» Lei aprì la bocca ma non ne uscì neanche una parola e Claes alzò le spalle. «Va bene. In questo caso ci penserò io» disse puntando di nuovo l’arma sulla bambina. Nell’istante esatto in cui premette il grilletto, Inez si lanciò in avanti per proteggerla con il suo corpo. Invece non successe niente. Claes premette di nuovo il grilletto ma il colpo non partì e lui guardò il revolver. Nello stesso istante Leon gli si gettò addosso. Inez prese in braccio Ebba e se la strinse al petto con il cuore che batteva all’impazzata. Claes era intrappolato sotto il peso di Leon e si divincolava per liberarsi. «Aiutatemi!» gridò Leon con un urlo soffocato quando un pugno duro lo colpì allo stomaco. Sembrava che stesse per perdere la presa su Claes che si agitava selvaggiamente, ma un calcio ben calibrato di John lo colpì alla testa e si sentì un orribile schianto secco. Il corpo si rilassò e la lotta cessò. Leon rotolò via velocemente, ritrovandosi carponi sul pavimento di legno. Percy assestò un calcio a Claes nello stomaco mentre John continuava a tempestargli la testa. All’inizio Josef rimase a guardare, poi si avvicinò con aria tesa alla tavola apparecchiata, scavalcò il corpo di Rune e si allungò a prendere il coltello che era stato usato per tagliare il cosciotto d’agnello. Cadde in ginocchio di fianco a Claes e alzò gli occhi su John e Percy che, ansimanti, smisero di sferrare calci. Dalla bocca di Claes usciva un rantolo gorgogliante e gli si vedeva il bianco degli occhi. Lentamente, quasi con piacere, Josef sollevò il grosso coltello e gli appoggiò la lama affilata contro la gola. Poi diede un taglio netto e subito cominciò a sgorgare il sangue. Ebba piangeva ancora a pieni polmoni e Inez se la strinse ancora di più al petto. L’istinto di proteggerla era più forte di qualsiasi cosa avesse mai provato fino ad allora. Tremava tutta, ma Ebba le si rannicchiò contro, stringendole talmente forte il collo con le braccia da impedirle quasi di respirare. Sul pavimento, davanti a loro, Percy, Josef e John erano accovacciati di fianco al corpo massacrato di Claes come un branco di leoni intorno a una preda. Leon si avvicinò a lei ed Ebba e fece alcuni profondi respiri. «Dobbiamo mettere tutto a posto» disse a voce bassa. «Non preoccuparti, me ne occuperò io.» Poi le diede un bacio leggero sulla guancia. Come in lontananza, lo sentì impartire ordini agli altri. Le arrivò alle orecchie qualche parola sparsa su quello che aveva fatto Claes, sulle prove da far sparire, sulla vergogna, ma era come se venissero da un luogo lontanissimo. Gli occhi chiusi, continuò a cullare Ebba. Presto sarebbe stato tutto finito. Ci avrebbe pensato Leon. Si sentivano stranamente vuoti. Era lunedì sera e gli eventi degli ultimi giorni avevano cominciato a depositarsi. Erica aveva continuato a rimuginare su quello che era successo ad Anna e su quello che sarebbe potuto accadere in generale. Il giorno prima Patrik l’aveva coccolata come se fosse una bambina piccola. All’inizio le aveva fatto piacere, ma poi aveva cominciato a sentirsi soffocare. «Vuoi che ti porti una coperta?» chiese Patrik dandole un bacio sulla fronte. «No, grazie, niente coperta: qui dentro ci saranno trenta gradi. E ti avverto: se mi dai un altro bacio in fronte giuro che farò lo sciopero del sesso per un mese.» «Scusa, sai, se cerco di essere carino.» Patrik andò in cucina. «Hai visto il giornale di oggi?» gli gridò dietro lei, ma ottenne in risposta solo un borbottio. Si alzò dal divano e lo seguì. Nonostante fossero le otto di sera, il caldo non accennava a diminuire e le era venuta voglia di un gelato. «Sì, purtroppo. Mi è piaciuta in particolare la prima pagina con Mellberg che posa con John di fianco all’auto della polizia sotto il titolo L’eroe di Fjällbacka.» Erica scosse la testa, aprì il freezer e tirò fuori una confezione di gelato al cioccolato. «Ne vuoi?» «Sì, grazie.» Patrik si sedette. I bambini dormivano e in casa regnava la pace. Bisognava cogliere l’attimo e goderne il più possibile finché durava. «Sarà soddisfatto, immagino.» «Soddisfatto è dir poco. E i colleghi di Göteborg sono offesi perché si è preso gli onori della cronaca. Comunque l’importante è che i loro piani siano stati portati alla luce e che l’attentato sia stato fermato. Credo che passerà un bel po’ di tempo prima che gli Amici della Svezia si riprendano da questa batosta.» Erica desiderò di poterci credere. Guardò seria Patrik. «Adesso dimmi com’è andata da Leon e Inez.» Lui sospirò. «Non lo so. Hanno risposto alle mie domande, ma non sono sicuro di capire.» «In che senso?» «Leon ha spiegato come si sono svolti i fatti, solo che non sempre il suo ragionamento filava. Era cominciato tutto quando aveva preso a sospettare che a scuola qualcosa non andasse per il verso giusto, e alla fine Josef era crollato e aveva rivelato quello che Claes faceva a lui, John e Percy.» «L’iniziativa di raccontare tutto a Rune era venuta da Leon?» Patrik annuì. «Loro erano restii, ma lui li convinse. Ho avuto l’impressione che si sia domandato molte volte cosa sarebbe successo e come si sarebbero evolute le loro vite se non li avesse spinti a farlo.» «Era l’unica cosa giusta da fare. Non poteva sapere fino a che punto arrivasse la follia di Claes. Era impossibile prevedere le conseguenze.» Erica raccolse gli ultimi resti di gelato dalla coppetta senza staccare gli occhi da Patrik. Avrebbe voluto essere presente anche lei quando era andato da Leon e Inez, ma lui aveva posto il veto. Così, doveva accontentarsi del resoconto. «È esattamente quello che ho detto.» «E dopo? Come mai non chiamarono subito la polizia?» «Avevano paura di non essere creduti. Penso che anche lo shock abbia fatto la sua parte. Non riuscivano a ragionare con chiarezza. E poi non bisogna sottovalutare la vergogna. Il pensiero che venisse fuori quello che avevano dovuto subire li indusse ad accettare il piano di Leon.» «Ma lui non aveva niente da perdere se avesse lasciato che se ne occupasse la polizia. Non era una delle vittime di Claes e nemmeno aveva partecipato quando lo avevano ucciso.» «Rischiava di perdere Inez» rispose Patrik. Mise giù il cucchiaino anche se aveva a malapena assaggiato il gelato. «Se fosse venuto fuori tutto, lo scandalo sarebbe stato di proporzioni tali che probabilmente non sarebbero potuti stare insieme.» «E di Ebba cosa mi dici? Come hanno potuto lasciarla lì?» «Sembra che sia la cosa che più l’ha tormentato negli anni. Non l’ha detto chiaramente, ma credo che non abbia mai smesso di rimproverarsi per aver indotto Inez ad abbandonare Ebba. E ti dirò che ho evitato di fare questa domanda. Sono convinto che entrambi abbiano sofferto a sufficienza per quella decisione.» «Non riesco a capire come sia riuscito a convincerla.» «Erano follemente innamorati. Avevano una relazione appassionata che avevano temuto venisse scoperta da Rune. L’amore proibito porta a scelte estreme. E una parte di colpa può forse essere attribuita al padre, Aron. Leon gli telefonò per chiedergli aiuto e lui gli spiegò che Inez sarebbe potuta uscire dal Paese, però non con una bambina piccola.» «Sì, capisco che Leon abbia accettato, ma Inez? Anche se era innamorata persa, dove trovò il coraggio di abbandonare la sua bambina?» Erica sentì che le si stava incrinando la voce al pensiero di staccarsi da uno dei suoi figli senza speranza di poterlo rivedere. «Neanche lei riusciva a ragionare a mente fredda. Leon deve averla convinta che era la cosa migliore anche per Ebba. Immagino che l’abbia spaventata dicendo che se fossero rimasti sarebbero finiti in prigione, e in questo caso lei avrebbe comunque perso la bambina.» Erica scosse la testa. Non importava. Non avrebbe mai capito come un genitore potesse abbandonare volontariamente un figlio. «Quindi nascosero i corpi e si misero d’accordo sulla versione da fornire.» «Secondo Leon, suo padre aveva suggerito di scaricare i corpi in mare, ma lui aveva paura che tornassero a galla e gli venne in mente di nasconderli nel rifugio. Così tutti insieme portarono giù i corpi e li misero nei bauli insieme alle foto. Il revolver lo lasciarono dove pensavano che l’avesse trovato Claes. Poi chiusero a chiave, contando sul fatto che il rifugio fosse sufficientemente nascosto da impedire alla polizia di trovarlo.» «E infatti così fu» disse Erica. «Già, quella parte del piano funzionò alla perfezione, a parte il fatto che Sebastian riuscì ad accaparrarsi la chiave. Pare che da allora l’abbia sempre tenuta come una spada di Damocle sulla testa degli altri.» «Ma perché la polizia non trovò traccia di quello che era successo?» «I ragazzi avevano lustrato il pavimento facendo sparire tutto il sangue visibile a occhio nudo. Devi ricordarti che era il 1974 e che il sopralluogo tecnico veniva fatto dalla polizia del posto, quindi non era proprio una procedura da Csi. Poi si cambiarono e uscirono in barca, dopo aver fatto una soffiata anonima.» «E Inez dove si era cacciata?» «Si era nascosta. Anche questa un’idea di Aron, secondo Leon. Forzarono la porta di una seconda casa vuota su un’isola vicina, dove poteva restare finché le acque si fossero calmate a sufficienza perché lei e Leon potessero lasciare il Paese.» «Quindi mentre la polizia cercava la famiglia lei rimase per tutto il tempo in una casa di villeggiatura nelle vicinanze di Valö?» chiese Erica incredula. «Sì, sicuramente verso l’estate, quando arrivarono i proprietari, sporsero denuncia, ma la cosa non fu messa in correlazione con la scomparsa della famiglia.» Erica annuì e provò la soddisfazione di vedere tutte le tessere del puzzle finire al loro posto. Dopo le tante ore passate a rimuginare su cosa potesse essere accaduto alla famiglia Elvander finalmente sapeva quasi tutto. «Mi chiedo come va tra Inez ed Ebba, adesso» disse allungandosi verso la coppetta di Patrik per mangiare anche il suo gelato ormai mezzo sciolto. «Non ho voluto disturbarla, ma immagino che sia andata a Göteborg dai suoi genitori.» «Ah, quindi non hai saputo?» disse lui, illuminandosi per la prima volta dall’inizio di quella conversazione. «No, cosa?» Erica lo guardò curiosa. «È andata a stare qualche giorno nella stanza degli ospiti di Gösta, per riprendersi. Stasera Inez andrà a cena da loro. Quindi immagino che vogliano almeno tentare di conoscersi.» «Mi fa piacere. Ne avrà bisogno. Questa faccenda di Mårten dev’essere stata uno shock. Il solo pensiero di essere vissuta con qualcuno che si ama e di cui nonostante tutto ci si fida e che poi si dimostra capace di una cosa del genere...» Scosse la testa. «Ma immagino che Gösta sia felice di averla lì. Pensa se solo...» «Sì, lo so. E credo che si sia fatto quella domanda un numero inimmaginabile di volte. Ma Ebba ha avuto comunque un’infanzia felice, e in un certo senso penso che questo gli basti.» Interruppe di colpo la conversazione, come se fosse troppo doloroso pensare a quello che Gösta si era perso. «E Anna come sta?» Erica aggrottò la fronte, preoccupata. «Non l’ho ancora sentita. Dan è tornato subito a casa dopo l’sms che ho mandato io e so che lei aveva intenzione di raccontargli tutto.» «Tutto?» Lei annuì. «Come pensi che reagirà?» «Non lo so.» Erica prese ancora due cucchiaiate di gelato e poi mescolò quello che restava nella coppetta trasformandolo in una pappetta sciolta. Era un’abitudine che aveva fin da piccola, come anche Anna. «Spero che risolvano tutto.» «Mmh» mugolò Patrik, ma Erica notò la sua espressione scettica. Questa volta fu lei a cambiare argomento. Non voleva riconoscerlo, né a se stessa né a Patrik, ma negli ultimi giorni la preoccupazione per la sorella era stata talmente grande da impedirle di pensare ad altro. Tuttavia si era imposta di non telefonarle. Lei e Dan avevano bisogno di calma e tranquillità per avere una chance di risolvere i loro problemi. Si sarebbe fatta viva al momento opportuno. «Per Leon e gli altri non ci saranno conseguenze penali?» «No, il reato è caduto in prescrizione. L’unico che avrebbe potuto essere processato è Mårten. E vedremo cosa succederà per Percy.» «Spero che Martin non stia troppo male per aver sparato a Mårten. Gli manca solo questo» disse Erica. «Oltretutto mi sento un po’ in colpa per averlo coinvolto.» «Non devi ragionare così. Sta come può stare, e sembra intenzionato a riprendere servizio appena possibile. Le terapie di Pia richiederanno parecchio tempo e sia i genitori di lui sia quelli di lei gli daranno una mano. Ne hanno parlato e ha deciso di lavorare part-time, per il momento.» «Mi sembra ragionevole» disse Erica, senza riuscire però a scacciare del tutto il senso di colpa. Patrik la scrutò. Allungò una mano e le fece una carezza sulla guancia. Erica lo guardò negli occhi. Come per un tacito accordo, non avevano neanche sfiorato con le parole il fatto che lui era stato di nuovo sul punto di perderla. Era lì, e si amavano. Era l’unica cosa che contava. Stoccolma 1991 Due Carin Göring? Le spoglie rinvenute tempo fa in una cassa di zinco nei pressi di quella che un tempo era Carinhall, la proprietà di Hermann Göring, sono state analizzate nel laboratorio di medicina legale di Linköping, che ne ha determinato l’appartenenza a Carin Göring, nata Fock, deceduta nel 1931. Il fatto è che già nel 1951 una guardia forestale aveva trovato parti di uno scheletro che si pensava fosse quello della moglie del politico tedesco, in seguito cremate in gran segreto. Le ceneri erano poi state portate in Svezia da un pastore svedese per essere interrate. Si trattava della terza sepoltura per Carin Göring: la prima aveva avuto luogo nella tomba della famiglia Fock nel cimitero di Lovön e la seconda a Carinhall. Infine le ceneri sono appunto tornate in Svezia. Ora questa storia singolare si allunga dunque di un capitolo. Dall’analisi del dna risulta infatti che l’ultimo ritrovamento riguarda i resti di Carin Göring. La domanda è dunque: a chi appartengono quelli interrati nel cimitero di Lovön, alle porte di Stoccolma? Postfazione e ringraziamenti Quando scrivo queste parole è passata una settimana dalla bomba di Oslo e dalla strage di Utøya. Ho seguito sbigottita i telegiornali con lo stesso nodo allo stomaco di tutti gli altri cercando invano di capire come qualcuno possa essere capace di una malvagità così grande. Le immagini della devastazione a Oslo mi hanno fatto capire che alcuni eventi descritti in questo libro sfiorano proprio quel genere di malvagità, ma purtroppo è vero che la realtà supera sempre l’immaginazione. È un puro caso che questa storia in cui le persone giustificano le proprie azioni malvagie con la politica sia arrivata prima degli avvenimenti in Norvegia, ma forse è un’indicazione del genere di società in cui viviamo. Ci sono tuttavia altri elementi del Segreto degli angeli che si basano volutamente su eventi reali. Voglio ringraziare Lasse Lundberg che, durante la visita guidata di Fjällbacka, ha messo in moto la mia fantasia parlando del granito del Bohuslän scelto da Albert Speer per la trasformazione di Berlino nella cosiddetta Welthauptstadt Germania e della visita che si dice abbia fatto Hermann Göring su una delle isole dell’arcipelago di Fjällbacka. Mi sono presa la libertà di imbastire un racconto mio a partire da tali aneddoti. Per scrivere questa storia ho dovuto fare approfondite ricerche documentarie su Hermann Göring. Il libro di Björn Fontander Carin Göring skriver hem (Carin Göring scrive alla famiglia) ha rappresentato un’eccezionale fonte di informazioni, soprattutto per quanto riguarda il periodo trascorso in Svezia da Hermann Göring. Sempre in quelle pagine ho trovato anche un autentico mistero che ho potuto intessere nella trama, in quel modo magico che capita a volte quando si è scrittori. Ed è sempre una sensazione meravigliosa. Grazie, Björn, per l’ispirazione che ho ricevuto dal tuo libro. Non esiste una tristemente nota fabbricante di angeli originaria di Fjällbacka, ma naturalmente tra la Helga Svensson del romanzo e la Hilda Nilsson di Helsingborg impiccatasi nella propria cella nel 1917 poco prima che la sua esecuzione venisse messa in atto esistono diverse somiglianze. La colonia di Valö c’è davvero e occupa un posto importante nella storia di Fjällbacka. Io stessa vi ho trascorso molte settimane di campi estivi e credo che quasi tutti gli abitanti del paese siano in qualche modo venuti a contatto con la grande casa bianca. Oggi è un ostello con ristorante e vale la pena di essere visitato. Mi sono presa la libertà di cambiare anni e proprietari in modo che si adattassero al mio racconto. Per tutti gli altri particolari su Fjällbacka mi sono come al solito avvalsa dell’insostituibile aiuto di Anders Torevi. Il giornalista Niklas Svensson mi ha generosamente dato una mano per gli aspetti politici, di cui è molto esperto. Un grosso grazie per questo. Per riassumere, come al solito ho mescolato fatti tratti dalla storia ad altri scaturiti dalla fantasia. Tutti gli eventuali errori sono da attribuire soltanto a me. Ho anche ambientato la vicenda in un’epoca in cui i tempi di prescrizione per l’omicidio erano di venticinque anni, termine cambiato da una nuova legge. Ci sono molte altre persone che voglio ringraziare. La mia editor Karin Linge Nordh e la mia redattrice Matilda Lund, che hanno fatto sul manoscritto un lavoro erculeo. Mio marito Martin Melin, che è sempre di grande sostegno. Poiché questa volta stava lavorando anche lui a un suo manoscritto, durante le lunghe ore alla scrivania abbiamo potuto stimolarci a vicenda. Naturalmente per me è un grande vantaggio anche disporre di un poliziotto tutto mio con cui consultarmi per qualsiasi quesito abbia a che fare con l’attività investigativa. I miei figli Wille, Meja e Charlie, che mi danno un sacco di energia da riversare nei libri. E tutta la rete intorno a loro: la nonna Gunnel Läckberg e Rolf “Sassar” Svensson, Sandra Wirström, il padre dei miei figli maggiori Mikael Eriksson e Christina Melin che è sempre stata pronta a intervenire per le emergenze. Grazie a voi tutti. La Nordin Agency, cioè Joakim Hansson e tutta la squadra: voi tutti sapete che vi sono enormemente grata per il lavoro che fate in Svezia e nel mondo. Christina Saliba e Anna Österholm di Weber Shandwick hanno investito moltissime energie in tutto ciò che riguarda la carriera di chi opera nell’ambito della scrittura. Fate un lavoro straordinario. I colleghi. Non faccio nomi per non dimenticarne nessuno. Non ho il tempo di vedervi con la frequenza che vorrei, ma quando ci incontriamo mi sento carica di energia positiva e gioia della scrittura. E so che ci siete. Un posto speciale nel mio cuore è occupato da Denise Rudberg, amica, collega e paladina da molti anni. Cosa farei senza di te? Non potrei mai scrivere questi libri se gli abitanti di Fjällbacka non mi permettessero di buon grado e con estrema benevolenza di ambientare nel loro piccolo mondo ogni genere di atrocità e brutture. A volte mi preoccupo dei guai che posso procurarvi, ma sembra che non siate disturbati dalle orde di troupe cinematografiche che vi invadono a intervalli regolari. Quest’autunno succederà di nuovo e spero che sarete fieri del risultato quando per l’ennesima volta Fjällbacka avrà occasione di mettere in mostra le sue bellezze uniche, ora anche al di fuori dei confini della Svezia. Per finire voglio ringraziare i miei lettori, che aspettano sempre pazientemente il libro successivo. Mi sostenete nei momenti difficili, mi date una pacca sulla spalla quando ne ho bisogno e siete al mio fianco da tanti anni. Vi apprezzo. Moltissimo. Grazie. Måsholmen, 29 luglio 2011 Camilla Läckberg www.camillalackberg.se
Scarica