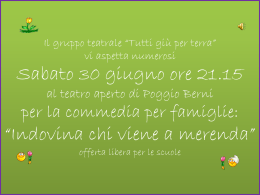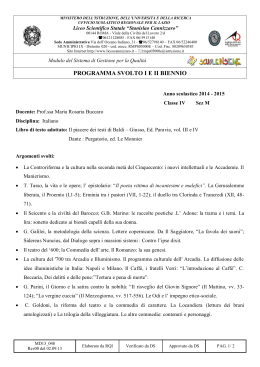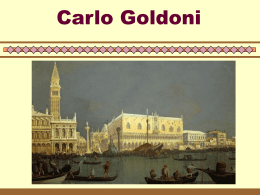F. Taviani, M. Schino Il segreto della Commedia dell’Arte Firenze, La Casa Usher 1982, pp. 309-29. La produzione di teatro SOMMARIO: L’evanescente concetto di improvvisazione – Teatro scritto e teatro non scritto – Le azioni e la dicitura – La concezione classica della drammaturgia alla base della Commedia dell’Arte. Un solo elemento attraversa sempre apparentemente uguale i disparati fenomeni e i diversi momenti di teatro raccolti nell’idea di Commedia dell’Arte: l’improvvisazione. Sembra essere questo il nocciolo reale di quell’immagine ideale di teatro emanata — soprattutto nell’emigrazione — dalle multiformi attività dei comici italiani. I loro disparati teatri sarebbero, cioè, riconducibili ad un’unica varietà, ad una specificità che li apparenta, poiché il tema dell’improvvisazione, dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento, offrirebbe una continuità tale da giustificare che, a dispetto di ogni altra considerazione, si parli di un teatro unitario. di uno stile, forma o genere preciso. La tecnica dell’improvvisare, dagli italiani — soli fra tutti — posseduta, sviluppata, trasmessa di generazione in generazione, costituirebbe il segreto della Commedia dell’Arte, sia esso un semplice segreto di fabbricazione o un più sostanziale segno di saggezza teatrale. Nel 1700, quando i comici italiani erano già stati cacciati da Parigi, Evaristo Gherardi presentando il loro repertorio di commedie scriveva così: Non dovete aspettarvi di trovare in questa raccolta tutte intere le commedie [...] Il teatro degli italiani non può essere stampato, perché sono attori che non imparano testi a memoria e basta loro, per rappresentare una commedia, d’averne letto il soggetto un attimo prima di entrare in scena. La più grande bellezza delle loro storie sceniche, per ciò, è inseparabile dall’azione, perché il successo delle loro commedie dipende in tutto e per tutto dagli attori che le rendono più o meno piacevoli a seconda che abbiano più o meno abilità e intelligenza o a seconda della situazione in cui si trovano a recitare. E questa necessita di recitare da un momento all’altro, senza preparazione, che fa sì che sia tanto difficile sostituire un attore italiano quand’egli viene a mancare. Tutti possono imparare a memoria un testo e poi recitarlo; ma occorre ben altro per essere un buon attore della Comédie Italienne. Chi dice “buon attore della Comédie Italienne” dice un uomo che ha una sua personalità, che recita più con la propria immaginazione che con la memoria, che compone quel che dice nel momento stesso in cui lo recita, che sa assecondare colui con il quale si trova sul palcoscenico, che sa, cioè, sposare cosi bene le proprie parole e le proprie azioni alle parole e alle azioni del compagno da inserirsi subito nella linea d’azione dell’altro e muoversi così come questa gli richiede, tanto da far credere a tutti che sia una cosa preparata. L’intento di Evaristo Gherardi non era, però, quello di spiegare ai lettori quali fossero i procedimenti degli attori italiani, era piuttosto il desiderio di affermare che solo in loro l’arte scenica trovava compimento. Affermava, infatti: Un attore che recita semplicemente a memoria non entra in scena altro che per dir giù la sua parte il più presto possibile così come l’ha imparata, ed è troppo occupato per prendersi cura dei movimenti e dei gesti del compagno. Egli va diritto per la sua strada con la sfrenata impazienza di liberarsi della sua parte come di un peso da gettar via per riposarsi. Di questi attori si può dire che sono come scolari che vengono a ripetere, tremando, la lezione imparata con cura. O meglio: sono simili all’eco, che mai parlerebbe se un altro non avesse parlato prima. (Gherardi, 1700, Avertissement) Più che essere un documento sulla tecnica dell’improvvisazione, la pagina del Gherardi documenta la volontà di celebrare i comici italiani in un documento in cui la loro fama poteva affidarsi soltanto al ricordo, alle parole scritte o alle rievocazioni dei pittori. Si può pensare, infatti, che quel che Gherardi scrive sia altrettanto lontano dalla realtà di quanto lo fossero i quadri e le stampe di Gillot o Watteau che pretendevano di rappresentare la Comédie Italienne. L’effetto che il Gherardi ottiene, quell’idealizzazione dell’improvvisazione, cioè, che più tardi, sposandosi con la mentalità romantica, produrrà l’idea più comune e sbagliata della Commedia dell’Arte come teatro della spontaneità e della libera fantasia creatrice, deriva da un accostamento strampalato, che a dispetto d’ogni logica contrappone l’attore che improvvisa non a quello che non improvvisa, ma semplicemente al cattivo attore. Il trucco è talmente smaccato che rischia d’esser controproducente, tanto che il Gherardi, prima di chiudere il discorso, si affretta a smorzare l’enfasi ricordando come vi siano eccellenti attori anche fra quelli che recitano a memoria, ma affermando che in questo caso essi sono eccellenti proprio perché riescono a mascherare l’arte con l’arte, così come i pittori fan sembrare naturale l’artificio. Due dei diversi temi che si alternano nelle testimonianze sull’improvvisazione dei comici italiani, i due temi più appariscenti, sono ben esemplificati dalla pagina del Gherardi: da una parte lo stretto collegamento fra idealizzazione dell’improvvisazione e difesa della Commedia dell’Arte; dall’altra la tendenza ad identificare recitazione naturale e recita improvvisata. Mario Apollonio (1930, p. 188) avvisa, a proposito delle discussioni intorno ai limiti dell’improvvisazione dei comici dell’arte, che «sarà bene notare che fra i contemporanei della Commedia dell’Arte chi le è favorevole ammette la recitazione improvvisa, chi le si oppone parla di repertorio e di zibaldoni». Il che è vero almeno nel senso che la magnificazione dell’improvvisazione, come metodo compositivo proprio del modo italiano di far teatro, ritorna ogni volta in cui siano in pericolo la presenza o gli usi delle compagnie italiane. È questo il contesto, per esempio, in cui Carlo Gozzi, sul finire del XVIII secolo, alla fine dell’ultima grande battaglia sui comici dell’Arte — la battaglia che meno servì alla loro vita materiale e più alla loro sopravvivenza ideale — parla ancora una volta dell’improvvisazione come tecnica della recitazione naturale (cfr. Gozzi, 1797, parte II, cap. I). La tendenza ad identificare recitazione naturale e recita improvvisata deriva dalla contrapposizione fra attori italiani e attori francesi; è questa contrapposizione a essere concretamente sperimentata dagli spettatori, che poi immaginano di individuare la causa nell’elemento più evidente — o più appariscente e noto — degli italiani. Così Charles De Brosses, in una delle sue Lettres de l’Italie (cfr. Duchartre, 1955, p. 39), dopo aver rilevato come il sistema di recitare all’improvviso renda più incerto lo stile, afferma che esso dà però agli attori un’aria naturale, per cui vanno e vengono sulla scena e parlano fra di loro come se fossero sulla via o nella propria casa. Ma la connessione improvvisazione-naturalezza avviene, nello sguardo dello spettatore De Brosses, perché egli — dice — confronta mentalmente gli italiani ai francesi. Possiamo cioè vedere, nel concreto riflesso condizionato di uno spettatore, l’origine — in senso logico, non cronologico — della retorica e inconsistente contrapposizione tracciata dal Gherardi. È bene insistere su questo fatto: è per il confronto con i francesi, non per l’improvvisazione, che gli italiani appaiono naturali. Ed è perché appaiono naturali, che l’improvvisazione viene identificata come portatrice di naturalezza. L’idea base, in altre parole, è quella che contrappone stile italiano a stile francese, una contrapposizione che istituisce un modo di guardare il teatro che Watteau aveva fissato nei due quadri contrapposti L’Amour au Théâtre Italien e L‘Amour au Théâtre Français e nelle stampe da essi derivate, e che — naturalmente — colora il modo in cui si guarda l’improvvisazione scenica, i suoi caratteri, i suoi effetti, la sua giustificazione. Si direbbe, però, che più ci si allontana dall’ambiente francese e dall’esigenza di difendere la Commedia dell’Arte, più l’improvvisazione trascolora. Torniamo, allora, a Luigi Riccoboni, che scrive in Francia per i francesi, ma incarna l’atteggiamento degli intellettuali italiani verso il teatro. Ne L’Histoire du Théâtre Italien scrive: L’improvvisazione permette una variazione nel recitare, di modo che, anche se si vede più volte lo stesso canovaccio, si può vedere ogni sera una diversa rappresentazione. L’attore che recita all’improvviso recita in maniera più vivace e più naturale di quello che recita una parte imparata a memoria: è più facile sentire e quindi si dice meglio quel che si è composto da sé, che non quel che si prende dagli altri con l’aiuto della memoria. Ma questi vantaggi della commedia recitata all’improvviso sono pagati da molti inconvenienti: essa richiede attori ingegnosi e più o meno ugualmente bravi, perché lo svantaggio dell’improvvisazione consiste nel fatto che la recitazione del miglior attore dipende assolutamente da colui con cui dialoga: se si trova con un attore che non sa cogliere con precisione il momento della replica, e che l’interrompe a sproposito, il suo discorso langue e la vivacità dei suoi pensieri viene soffocata. (Riccoboni, 1728, pp. 61-62) Apparentemente, l’impianto del discorso del Riccoboni è simile a quello del Gherardi, anche se con più attenzione al concreto e maggior ricchezza di dettagli. Ma questi dettagli spostano il discorso dalla generale valutazione dell’improvvisazione per l’arte dell’attore, ad una sua più circostanziata valutazione sul piano della drammaturgia e della veste letteraria della commedia. Tutti gli elementi del brano si muovono con sicurezza in questa direzione: la possibilità di operare variazioni sullo stesso canovaccio; il vantaggio, per l’attore, di trovar da sé le proprie battute; la difficoltà d’alternarsi bene nel dialogo quando le battute non siano fissate e non si sappia, quindi, quando il compagno ha finito di parlare. Nella stessa direzione, infine, Riccoboni spinge il discorso quando esamina gli aspetti più negativi dell’uso di recitare all’improvviso: Per facilitare gli attori mediocri a recitare la commedia all’improvviso è stato necessario ricorrere ai monologhi e a quei luoghi comuni che gli italiani chiamano robbe generiche di cui gli attori si servono a seconda delle necessità e delle situazioni sceniche. Questo modo di dialogare non vale nulla, perché spesso accade che si piazzano delle belle massime così mal a proposito che esse non quadrano con ciò che l’interlocutore ha appena detto e sono del tutto fuori tema. (Riccoboni, 1728, p. 63) A differenza di ciò che capiscono alcuni moderni, Riccoboni non dice che il ricorso alle robbe generiche è dannoso perché rompe l’improvvisazione, ma perché è un uso letterariamente inadeguato di luoghi comuni al posto di testi appropriati ed adattati all’individualità della situazione. Benché le parole del Riccoboni siano spesso simili a quelle del Gherardi, egli si trova in una zona del tutto diversa e si occupa dei pregi e dei difetti dell’improvvisazione non per il gioco scenico degli attori, ma per la composizione della commedia, per la sua scrittura in azione. Essenziale non è più il fatto che il testo sia improvvisato dall’attore, ma che sia composto da lui. L’improvvisazione, cioè, viene a significare una personalizzazione del testo, più che una composizione all’improvviso. È questo l’aspetto che Riccoboni discute per i francesi: la drammaturgia dell’attore italiano, il quale parla in scena con parole che egli stesso ha composto, che vengono dalla sua immaginazione e che non ha preso dal di fuori, da un poeta. (cfr. Riccoboni, 1728, p. 63) Ma negli stessi anni, e forse negli stessi mesi, Riccoboni scrive dell’improvvisazione anche in italiano e per gli italiani: Non vi fu mai chi più di me avesse in odio la stravagante usanza di recitar comedie a l’improvviso e chi forse più di me si sia servito di questo comodo. Per un comico diligente, morigerato e non affatto ignorante, confesso che l’invenzione non è pericolosa servendogli anzi di stimolo per ben parlare e per erudirsi. Ma io l’ho sempre abborrita poiché per esperienza ho conosciuto che al comico ignorante e scostumato (che pur troppo alle volte se ne trovano) l’uso di recitare a l’improvviso gli serve di facilità per studiar solamente come inserire ne’ suoi discorsi qualche oscenità. (Riccoboni, Scenari inediti, p. 30) In questo caso, l’improvvisazione è solo — come Riccoboni (Scenari inediti, p. 11) ha scritto qualche pagina prima — un «uso inveterato» o un «comodo» che marchia, facilitandolo, il lavoro teatrale delle compagnie, lo rende più veloce, ma anche più aperto agli arbitri e alle prepotenze sceniche dell’uno e dell’altro attore. Cominciamo così lentamente a vedere che il filo dell’improvvisazione, che sembra percorrere tutti i teatri delle compagnie italiane dal XVI al XVIII secolo e in realtà composto di due fili che spesso sono fra loro intrecciati, ma che possono anche correre separati: l’uno è costituito dalla drammaturgia d’ogni singolo attore della commedia; l’altro dall’uso di rappresentare commedie con poca o punta premeditazione, come per sorpresa o su due piedi. Si tratta di due cose diverse, che possono essere di fatto unite, ma che non lo sono di diritto, e possono, quindi, non aver nulla a che vedere l’una con l’altra. Nelle testimonianze dei contemporanei, per il peso della pratica, le due cose si mischiano, ma se si osserva bene, ci si accorge che è possibile una commedia premeditata, che però è prodotta dal comporsi dei diversi interventi drammaturgici dei diversi attori attorno allo scheletro del canovaccio, mentre d’altra parte è possibile una commedia all’improvviso in cui, però, non c’è l’intervento della personale drammaturgia degli attori. Il primo caso è quello forse più diffuso nella Commedia dell’Arte, in cui commedie molte volte recitate e ben concertate risultano dagli apporti dei loro singoli attori e necessitano una nuova concertazione quando cambia un attore. Il secondo è quello di commedie stese in ogni loro parte, che però gli attori non imparano a memoria — per necessità o pigrizia — e che in qualche modo ricostruiscono all’improvviso, in poco tempo. supplendo con l’invenzione al non saputo o — come si diceva nel gergo teatrale — andando a suggeritore. Accenna a questa seconda possibilità una testimonianza della metà del Seicento: Orsù, diciamo che il virtuoso recitare in scena è una bella grazia, anzi è un compendio di molte grazie, le quali molti mercenari e moderni comici scuoprono improvvisamente nel moderno teatro. Non hanno tutte le rappresentazioni stese di parola in parola; o se pur le hanno, essi non le mandano alla memoria nel modo de’ recitanti fanciulli o de’ verbali auditori, ma, apprendendole bene prima in sostanza, come per brevi capi e punti ristretti, recitando poi improvvisamente, o quasi improvvisamente, così addestrandosi ad un modo di recitar libero, naturale e grazioso. (Ottonelli, V, capo IV, punto VIII) L’accenno ai «recitanti fanciulli» è forse lo spunto concreto da cui il Gherardi, nel brano citato all’inizio del capitolo, svilupperà la similitudine fra attore che impara a memoria il testo e scolaro che ripete tremando la lezione. La testimonianza del gesuita Ottonelli, forse la persona più attenta ai teatri degli attori fra quante se ne interessarono fra Cinque e Settecento, persona straordinariamente attenta perché non interessata al teatro per il teatro, ma perché spinta da preoccupazioni morali, civili, religiose, da simpatie e indignazioni che nascevano fuori dal teatro e al teatro tornavano con tutta la forza, l’interesse e la fascinazione di una vera vocazione anti-teatrale, la testimonianza dell’Ottonelli, dunque, passa velocemente dall’uno all’altro dei due poli fra cui oscillano le testimonianze sull’«uso inveterato», il «comodo» di recitare all’improvviso: la coscienza del pressappochismo e lo stupore per il virtuosismo. Come la tradizione aneddotica dei comici dimostra, fino alle soglie del nostro secolo, pressappochismo comico e virtuosismo d’attore sono l’uno l’altra faccia dell’altro, basta cambiare il punto di vista perché l’uno diventi l’altro e viceversa. Uno degli schemi più ricorrenti dell’aneddotica teatrale è quello che mostra la bravura di un attore attraverso il modo in cui ripara ad un errore, ad una trascuratezza o ad una mancanza di preparazione sua o di un compagno. Le bravure dell’improvvisazione, in questo caso, non sono altro che il rimedio alle lacune della professione. Ma in questo caso esse non hanno o non dovrebbero aver nulla a che vedere con ciò che e stata chiamata Commedia all’improvviso. Eppure il problema dell’improvvisazione nella Commedia dell’Arte è così confuso e poco chiaro che si fanno confusioni anche fra teatro improvviso e aneddotica del rimedio improvvisato. È il caso di Carlo Gozzi, che racconta — nelle Memorie inutili — quel che gli capitò un giorno a Zara, mentre per diletto recitava una farsa improvvisata al teatro di corte, interpretando il personaggio di Luce, moglie «mal maritata di Pantalone vizioso, rotto e fallito». A causa del ritardo dell’attore che doveva interpretare Pantalone, Gozzi improvvisò — racconta — una serie di azioni ed un lungo monologo in cui fece la satira del malcostume di una donna ch’era tra il pubblico e a causa della quale aveva avuto da soffrire, ottenendo, così, un grande successo (Gozzi, 1797, parte I, cap. XIII). Aneddoti di questo tipo percorsero le conversazioni, le cronache e le memorie dei comici, e ancora le percorrono. La morale della favola, al di là del carattere divertente della storia, è che un buon attore deve saper far fronte all’imprevisto e riempire gli eventuali buchi della rappresentazione. Ma Gozzi formula così questa conclusione: «Che un buon Comico all’improvviso non si deve sbigottire e non deve mancare di ciarle», attribuisce, cioè, al comico all’improvviso una dote che invece dev’esser propria d’ogni comico. La confusione fra improvvisazione come pratica scenica peculiare delle compagnie italiane e quel tipo di improvvisazione o capacità di comporre per necessità su due piedi — che caratterizza, invece, qualsiasi professionista — mostra quanto siano fragili — se osservate da vicino — le testimonianze sul carattere improvviso della Commedia Italiana che invece, viste dall’alto e prese tutte quante insieme e all’ingrosso, sembrano individuare con sicurezza un genere di teatro preciso e circoscrivibile. C’è, poi, un’altra confusione: quella fra improvvisazione come modo di produzione del teatro e improvvisazione come dimostrazione ed esercitazione accademica. Questa confusione è facilitata dal fatto che alcune delle più dettagliate testimonianze sul recitare all’improvviso sono di dilettanti accademici; dal desiderio dei comici di nobilitare il proprio lavoro; da un generico riconoscimento di una predisposizione italiana all’improvvisazione visibile sia nel teatro prodotto dalle compagnie italiane che nel fenomeno tipicamente italiano dei verseggiatori all’improvviso; e infine da alcuni casi obiettivi di riutilizzazione teatrale di tecniche accademiche di improvvisazione. Persino il Perrucci, per il quale la recitazione all’improvviso individua un genere preciso di teatro, tende poi a sovrapporla all’esercitazione e ai giochi accademici basati sull’improvvisazione. (cfr. Perrucci 1699, qui come Ill. Lett., VI, 13) Ancor più sintomatico il fatto che nelle pagine di Scipione Maffei — colui che con l’alleanza del Riccoboni condusse la campagna contro la pratica del teatro improvviso, per la formazione di un repertorio classico nazionale — il tema dell’improvvisazione inneschi il passaggio dalla denuncia della pigrizia e del pressappochismo dei comici all’ammirazione del loro virtuosismo, fino a rivendicare agli italiani il genio dell’improvvisazione in generale, mischiando commedia all’improvviso e poeti estemporanei. Il Maffei sta parlando dell’uso del verso nelle tragedie e nelle commedie e deprecandone l’abbandono: Or benché non poche commedie si venissero poi anche in prosa rappresentando, si ritenne però insieme l’uso del verso per tutto il secolo decimosesto; ma nel susseguente gustando i comici nel parlar comune e sciolto il piacere della libertà, per non restar legati a parole e per poter in tal modo recitare senza applicazione, cotal pigrizia gli fece a poco a poco abbandonare il verso del tutto, tanto più che l’uso della moderna commedia li costrinse a riempire le compagnie di persone incapaci di ben proferirlo. Si aggiunse, per invaghirli della prosa, la mirabil facilità loro, affatto incognita ai comici d’altre nazioni antiche e moderne, di parlare in tal forma ottimamente a soggetto, cioè all’improvviso. Egli è noto che scene abbiam moltissime volte udito in tal guisa, senza precedente concerto alcuno, tanto graziose, tanto ben girate e con tal vivezza di facezie e con tal naturalezza di sentimenti e con tal prontezza di risoluzioni che non sarebbe possibil mai di scriverle meglio al tavolino. La qual dote cominciò in alcuni di costoro fin nel primo formarsi delle compagnie, poiché Adriano Valerini, famoso comico veronese e autor di rime e dell’Afrodite tragedia, in un’orazione che pubblicò il 1570 nella morte d’una donna di tal professione, racconta come l’Accademia de gl’lntronati di Siena avea giudicato riuscir costei «meglio assai parlando d’improvviso, che i più costumati autori scrivendo pensatamente» [cfr. Valerini 1570, qui come Ill. Lett. II, 8]. Gli stranieri che ciò non credono, procurino d’udire i nostri odierni poeti estemporanei, ed abbian per certo che da poi crederanno de gl’italiani in materia d’ingegno e di talento ogni cosa. Sia lecito il farsi qualche volta giustizia da sé. (Maffei, 1723, pp. IX-X) L’andamento del discorso del Maffei può apparire inconseguente: non solo, infatti, egli opera una digressione dal suo argomento — l’uso del verso nei testi teatrali — ma attraverso minuscoli slittamenti dell’attenzione passa da un atteggiamento negativo nei confronti degli attori che con i loro usi contribuiscono ad allontanare il verso dal teatro, ad una chiacchierata in lode dei comici che recitano all’improvviso. Pochi anni prima del Maffei, il suo amico Ludovico Antonio Muratori aveva affrontato lo stesso argomento nel 6° capitolo del 3° libro Della perfetta poesia italiana (pubblicato a Modena nel 1706 e in seconda edizione nel 1724), procedendo in linea retta dalla considerazione dei pregi del verso nella poesia drammatica alla necessità di buoni attori che sappiano recitar in versi, e da qui alla condanna di quegli istrioni moderni, «uomini per ordinario ignoranti», i quali non fanno altro che recitare «quel solo che loro piace» e vanno in scena servendosi «del solo soggetto, come lo chiamano, cioè della sola ossatura delle commedie, che poscia all’improvviso è da loro rivestita con le parole». Un discorso talmente rettilineo che il Muratori concludeva esortando i principi e i governanti delle città a proibire le commedie all’improvviso ed altre «scipitezze» del genere. Il discorso del Maffei, invece, pur partendo dalle stesse premesse e svolgendosi alla luce degli stessi principi, è come se si lasciasse a poco a poco dirottare da una simpatia per la Commedia dell’Arte che si insinuava fra le crepe della sua pur severa presa di posizione culturale. Accade cioè al Maffei quel che accade, nello stesso anno 1723, a Pier Jacopo Martello nella lettera a Giovan Battista Recanati sull’insuccesso della Scolastica dell’Ariosto messa in scena dal Riccoboni (Ill. Lett. VI, 16): nell’un caso come nell’altro sembra quasi che il discorso scritto si lasci andare, come nel parlar rilassato può avvenire, a concludere il contrario di ciò per cui era partito. Ma si tratta soltanto di un’impressione dovuta alla nostra ottica. Per il Maffei, come per il Martello o per il Riccoboni, non c’è contraddizione fra un giudizio negativo in nome delle virtù dell’Arte e della Poesia e la curiosità divertita e un po’ campanilistica, sul piano dell’aneddoto, per il virtuosismo degli attori di mestiere. Il teatro di cui loro parlano è il teatro come «per sua natura dovrebbe essere», e non ha nulla a che vedere con ciò che in palcoscenico fanno i comici. Ciò non toglie che quei comici siano bravi e divertenti nel loro genere, anche se abusivi. È, insomma, l’atteggiamento di autorità e condiscendenza, di commiserazione e tenerezza che l’intellettuale ha verso una miseria ingegnosa. Così, mentre nella cultura francese — o parigina — i teatri delle compagnie italiane venivano proiettati nell’irrealtà di un genere teatrale ideale, che presto coinciderà con l’idea stessa di fiaba scenica e di grottesco che vivifica l’immaginazione degli uomini di teatro europei; nella cultura italiana i teatri dell’Arte venivano proiettati nell’irrealtà dell’aneddotica che continuerà a lungo a suscitare la divertita curiosità di coloro stessi che persevereranno a bollare il fenomeno come sintomo di decadenza artistica e culturale. Questa distinzione dura fin quasi ai giorni nostri: mentre gli uomini di teatro e gli studiosi europei rischiano di farsi un’idea completamente immaginaria della Commedia dell’Arte; gli studiosi italiani, più legati al particolare e apparentemente più attenti ai fatti, rischiano di perdere continuamente il rispetto per l’argomento del loro studio, e lasciano che le loro pagine siano percorse dal riso di superiorità di chi si illude d’esser meno futile dei capricci che scava dal passato. (cfr. nota 36 [qui omessa]) Sia per l’uno che per l’altro atteggiamento, l’improvvisazione di cui tutti parlano per affermarne o per negarne la presenza nella Commedia dell’Arte, o per limitarne l’estensione, ma sempre come di cosa che si sa cosa sia, diventa a ben guardare un concetto evanescente in cui si mischiano il giudizio su un modo naturale di recitare, la definizione di uno stile italiano di recitazione contrapposto al francese, la drammaturgia degli attori, l’esercitazione e la dimostrazione accademica, il gioco prestigioso della composizione estemporanea, il rimedio improvvisato e la ripetizione imprecisa, andando a suggeritore, di un testo mal appreso. A tutto questo deve aggiungersi ciò che è forse fondamentale per l’improvvisazione scenica: la capacità di improvvisare usando il pubblico come interlocutore, sorprendendo le sue attese e giocando con le sue reazioni (su questo cfr. Apollonio 1968, p. 164 e Ill. Lett. VI, 16). Proprio perché si tratta di un elemento fondamentale, però, riguarda tutto il teatro comico, e non ha nessun titolo per caratterizzare in particolare la Commedia dell’Arte. Ma la causa principale della difficoltà ad orientarsi, quando si parla dell’improvvisazione della Commedia dell’Arte, non sta nel suo ridursi a concetto evanescente. La difficoltà diventa, anzi, tanto maggiore quanto più si cerca di analizzare con precisione il problema, perché l’improvvisazione — teatrale o no — si trascina dietro quasi per necessità una serie d’altri problemi che non si identificano con essa, ma che vi aderiscono così strettamente da ricoprirla quasi del tutto. Attraverso l’esame delle tecniche dell’improvvisazione e dei problemi pratici e teorici che esse comportano, infatti, emergono con particolare chiarezza — quasi per l’accelerazione cui sono sottoposti per il fatto di svolgersi allo scoperto — i problemi riguardanti le tecniche di composizione. E evidente che una cosa è la composizione scenica e altra cosa l’improvvisazione, ma altrettanto evidente è che a volte i principi dell’improvvisazione altro non sono che principi di composizione così ben posseduti da poter essere applicati velocemente e quasi per istinto, così come — reciprocamente — a volte alcuni problemi per la composizione emergono chiari quando si immagina che la loro concatenazione logica riproduca una catena cronologica di fatti, come se elementi implicati logicamente l’uno dall’altro comparissero storicamente uno dopo l’altro nel corso del lavoro teatrale. Così, per esempio, Maurice Sand (Ill. Lett. 1, 1) crede che ciò che emerge in una seduta di improvvisazione teatrale rispecchi nelle sue diverse fasi lo sviluppo storico del teatro dell’Arte; e altri credono che elementi che derivano la loro necessità l’uno dall’altro, caratterizzino altrettante fasi storiche. Secondo questo modo di guardare, che identifica modello logico e sviluppo storico, il fatto che la drammaturgia degli attori determini l’esistenza degli zibaldoni o «robbe generiche» fa credere che nella storia dell’improvvisazione dei comici si siano succedute fasi ed epoche diverse caratterizzate prima da una vera e propria creazione drammaturgica, e poi dalla decadenza con l’uso di pezzi precostituiti e generici. Il primo responsabile di questo equivoco fu probabilmente Francesco Saverio Quadrio che nella seconda parte del terzo volume Della storia e della ragione d’ogni poesia (Milano 1744, p. 223) dice che il «provvedersi di certi squarci imparati a memoria, quasi di luoghi topici, onde valersi non pur nei soliloqui […] ma ancor nei dialoghi» fu dovuto alla decadenza degli attori dopo il 1680. È stata una lettura approssimativa del Riccoboni (1728, p. 63) a spingere il Quadrio a questa strana affermazione, contraddetta sia dalle notizie documentate che dal buon senso. È, invece, una lettura troppo fiduciosa del Quadrio a perpetuare l’equivoco: quando il suo modo meccanico di concepire il divenire storico viene accettato e riletto con occhi moderni (cfr. ad es. Tessari, 1969, pp. 80 e 225) esso determina l’abbaglio secondo cui ad una fase dell’improvvisazione come naturalezza e talento naturale succederebbe un momento di riflusso in cui l’improvvisazione non sarebbe più nient’altro che una tecnica compositiva. Ma la contrapposizione fra un’inesistente improvvisazione «vera e propria», naturale e antiletteraria, e un’improvvisazione come composizione e montaggio di pezzi precostituiti e variazione attorno ad essi è una contrapposizione anacronistica. Forse la più interessante analisi dell’improvvisazione della Comédie Italienne e quella di JeanAugustin-Julien Desboulmiers, uno scrittore parigino di racconti e romanzi piccanti, specializzato nell’aneddotica indiscreta, morto quarantenne nel 1771. Nel 1769, Desboulmiers pubblica 7 volumetti di Histoire anedoctique et raisonnée du Théâtre Italien, nel primo dei quali affronta, fra l’altro, il tema dell’improvvisazione: Un attore riempie la sua immaginazione di tutte le idee dell’autore e cerca le differenti vie per condurre il dialogo a coincidere con tutti i punti dell’azione. Un altro, che deve aver parte anche lui alla stessa scena, la studia anch’egli fra sé, e naturalmente immagina di costruirne il dialogo in tutt’altra maniera. Ed ora ecco i due attori in scena, pieni ciascuno del proprio carattere e della propria situazione. Tutti e due tendono allo stesso punto dell’azione, ma obbligati a rispondersi sensatamente e legati, per necessità, agli stessi argomenti, sono forzati ad abbandonare a poco a poco la via che avevano premeditato, per adeguarsi a quella che l’altro vuol seguire. È questo che dà alla scena un carattere di naturalezza e verità tale che anche il miglior scrittore può raggiungerlo solo raramente. Nasce qualcosa di più di quel che può nascere da un testo scritto, qualcosa che nasce come per un lampo e nell’istante stesso della rappresentazione. (Desboulmiers, 1769, I, p. 33) La descrizione che Desboulmiers fa dell’improvvisazione è particolarmente acuta, lascia da parte tutti i luoghi comuni e si ferma su di un aspetto centrale ed in genere ignorato: come l’effetto di naturalezza e di verità nasca dal conflitto fra due opere di creazione non coincidenti, da una tensione che crea energia o dalla sfasatura fra le due ottiche diverse dei due attori, che tendendo per vie diverse allo stesso punto, creano la profondità del campo drammatico. È evidente, però, che più che un discorso sull’improvvisazione, Desboulmiers fa un discorso sulla composizione, e cioè su come la commedia possa essere tessuta tendendo ed intrecciando i fili delle diverse drammaturgie dei diversi attori. Egli, infatti, continua così: D’altra parte, quando si rappresenta la stessa commedia, gli attori hanno gran cura di ricordarsi tutti i particolari che han fatto buon effetto il primo giorno e non mancano di rimetterli allo stesso posto, il che non impedisce di far sbocciare nuovi fiori improvvisati che si aggiungono ai primi nella memoria degli attori. La commedia resta in repertorio, cento attori differenti si succedono gli uni agli altri nel rappresentare lo stesso canovaccio e vi introducono sempre qualcosa di nuovo. Alla fine, le scene sono così piene che si rimane colpiti dalla quantità di particolari e di trovate teatrali che contengono. Per recitare perfettamente occorre solo essere ben istruiti della tradizione teatrale. Così, l’improvvisazione è, in fondo, una questione di memoria. (Ibidem) L’improvvisazione, insomma, non è l’improvvisazione; e la rappresentazione premeditata si distingue dall’altra, detta «all’improvviso», perché meno «a memoria», perché si rifà solo ad un testo fisso, e non ad una tradizione fissata in tutti i suoi particolari. I paradossi cui ci conduce JeanAugustin-Julien Desboulmiers son meno paradossali di quanto sembra. Nel momento in cui il discorso si fa più preciso e non si aggira più intorno ad un concetto evanescente, esso va oltre l’improvvisazione e mostra come abbia veramente consistenza, piuttosto, il problema della composizione delle commedie alla maniera dei comici. È di questo che in realtà parlano studiosi contemporanei come Mic ed Apollonio nelle pagine che formalmente dedicano, invece, all’improvvisazione. E da questo punto di vista diventa futile, diventa la traccia di una vecchia confusione e l’eco di quel concetto vuoto di cui s’è parlato, la discussione, tanto annosa quanto imprecisa, sui limiti dell’improvvisazione in rapporto all’uso dei pezzi precostituiti. Così come diventa inutile o per lo meno non essenziale tentare di «salvare» l’esistenza dell’improvvisazione della Commedia dell’Arte spostandola idealmente, dall’improvvisazione dei materiali all’improvvisazione del loro montaggio. Tutto questo può essere vero, e certamente in molti casi lo fu. Ma quel che è più importante rilevare è che il tema dell’improvvisazione dei comici dell’Arte, con tutte le implicazioni e le associazioni che esso trascina con sé, è il riflesso di un altro problema e ne è, insieme, lo schermo. Scrive il Nicoll: La virtù dell’improvvisazione fa degli attori altrettanti autori. La misura dell’improvvisazione certamente variò a date diverse, in diverse compagnie e da un attore all’altro; ma dal principio alla fine essa fu il fattore che determinò la particolare qualità dello stile italiano, distinguendolo da altri metodi teatrali. E aggiunge: Di recente sono stati fatti alcuni tentativi di negare questa virtù, che però rimane tale. (Nicoll, 1963, pp. 27-28) Di fronte a frasi come questa, siamo ora in grado di diffidare. Il luogo comune di un genere teatrale che si distingue dagli altri perché in possesso del segreto dell’improvvisazione si è dimostrato costruito di pezzi eterocliti, che non stanno insieme. Sappiamo che non è l’improvvisazione l’essenziale, ma ciò che essa cela, cioè la drammaturgia degli attori. Il Mic lo dice con queste parole: Sembra improbabile che un teatro che portava in scena soggetti estremamente complicati, con un numero rilevante di personaggi, potesse basarsi sulla pura improvvisazione [...] Il carattere essenziale della Commedia dell’Arte, comunque non consisteva nell’improvvisazione [...] ciò che la caratterizzava era piuttosto il fatto che uno spettacolo dell’Arte non era sottomesso alla volontà d’un unico aurore. (Mic, 1927, p. 125) Il Mic prosegue ripetendo ciò che diceva Riccoboni, in uno dei brani citati nel corso di questo capitolo, e cioè che per gli attori sarebbe più facile «sentire» ciò che hanno loro stessi composto, piuttosto che ciò che è stato scritto da altri e da loro imparato a memoria. Ma noi non lo seguiremo su questa strada. Ci domandiamo, invece, cosa significhi, storicamente, la produzione di uno spettacolo non sottoposto alla volontà di un unico autore. Per comprenderlo dobbiamo risalire indietro nel tempo, alla metà del Cinquecento, negli anni in cui s’era svolto il Concilio di Trento e se ne applicavano le riforme; e in cui nasceva, ad opera delle compagnie italiane, il «teatro moderno in quanto teatro» (cfr. Ill. Lett. IV, 8). * * * La data simbolica per l’origine della Commedia dell’Arte, il 1545, anno a cui risale il primo contratto a noi noto della formazione d’una compagnia (Ill. Lett. IV, 3), è anche la data d’inizio del Concilio di Trento. I rapporti fra i comici di professione e gli uomini che rappresentavano l’ideologia morale e religiosa sancita dal Concilio non furono facili, anche se furono infinitamente più facili e morbidi di quelli che intercorsero fra i professionisti del teatro e i religiosi delle confessioni non romane. Se da quei rapporti e da quegli scontri non derivarono atti di intolleranza definitiva, derivarono, però, pagine e pagine polemiche e predicatorie, editti, lettere, pareri, che sono, sì, la testimonianza di un’attenzione fatta di minacce e di irritazione, ma che trasmettono più notizie sull’ambiente del teatro di quante ne abbiano trasmesse tutti assieme i teatri e i loro spettatori di quegli anni (cfr. Ill. Lett. V; Taviani 1969 e 1971). C’è, fra queste notizie, anche una delle prime testimonianze sull’improvvisazione degli attori italiani, e proviene da un Cardinale. Gabriele Paleotti, creato cardinale il 12 marzo 1564, alla chiusura del Concilio di Trento, Arcivescovo di Bologna dal 1566, aveva lavorato a lungo alla Curia di Roma, dove s’era fatto una particolare esperienza in materia di libri proibiti. Come Arcivescovo sapeva quindi servirsi bene degli strumenti che il Concilio metteva in mano alle autorità ecclesiastiche per regolare la trasmissione della cultura, dando loro il potere di permettere o proibire le nuove pubblicazioni e le rappresentazioni teatrali pubbliche che — secondo un’opinione rigorosa — dovevano regolarsi per analogia con la stampa. Ma nel caso delle commedie fatte dai comici di professione, sosteneva il Paleotti, esse andavano proibite in blocco: ciò che il Cardinale innanzi tutto notava era che di quelle commedie mancava il libro. Erano bensì vere commedie, e non zannate, non erano pure e semplici rappresentazioni carnevalesche e buffonesche, ma erano commedie senza un libro di riferimento. Nel 1578, il Paleotti comunicava così il suo parere alla Curia di Roma: Non basta il dire che prima si rivedano queste commedie e si levi il cattivo, perché in pratica non riesce, perché sempre vi aggiungono parole o motti che non sono scritti, anzi non mettono essi in iscritto se non il sommario o l’argomento, e il resto fanno tutto all’improvviso (in Taviani, 1969, p. 39). Un aspetto interessante di questa testimonianza e il modo in cui passa da una generica osservazione degli usi dei comici («sempre vi aggiungono parole o motti che non sono scritti»), ad uno sguardo più ravvicinato che individua una precisa organizzazione nella produzione degli spettacoli («non mettono per iscritto se non il sommario...» ecc.), quasi la frase rispecchiasse, con la ripresa di quell’anzi, le esperienze sempre più precise fatte dal Cardinale nell’esercizio delle sue funzioni. Già una decina di anni prima (cfr. Taviani, 1969, p. 38), la Curia bolognese s’era occupata delle commedie portate in giro dalle compagnie professionistiche: ciò che agli occhi dei giudici della pubblica moralità era emerso sempre più chiaramente era che il pericolo consisteva in qualcosa che precedeva il contenuto delle commedie, e si annidava nel fatto stesso per cui esse avvenivano in assenza di un testo scritto: è solo il testo scritto che permette il controllo prima che lo spettacolo avvenga. Lo spettacolo senza un libro che lo preceda elude, per definizione, i decreti di controllo dei libri: è controllabile non in quanto pubblicabile, ma solo in quanto già pubblico. Ma il Cardinale sa bene — a differenza di molti frettolosi moderni — che dallo spettacolo non è assente un testo, un testo che può essere in tutto simile ai testi scritti. Ciò che è assente è solo la scrittura che renda presente (e controllabile) il testo anche senza lo spettacolo. L’improvvisazione, cioè, non si oppone alla premeditazione, come la parola sembrerebbe indicare; si oppone, in questo caso, alla scrittura. La cosa di cui parla il Paleotti, ci porta così a scoprire un altro significato possibile della qualifica di «improvvisato» data al teatro dei professionisti, il significato più concreto e ristretto di «teatro non scritto». Quando torniamo a sentire ancora oggi quel vero e proprio ritornello secondo cui la Commedia dell’Arte si baserebbe sul rifiuto del testo letterario, non possiamo non meravigliarci di quanto forte sia l’illusione ottica che fa confondere testo letterario con testo scritto. Un’illusione ottica pari a quella di chi considera la lingua solo dal punto di vista della lingua scritta, e che nasce dalla deformazione del letterato e del lettore che nella loro esperienza identificano composizione e scrittura, conoscenza e lettura, e sono quindi portati a giudicare non composto quel che non è scritto, e non esistente quel che non è leggibile. Tranne casi estremi, è difficile che esista, nella nostra civiltà, un poema o un romanzo non scritto. Persino una raccolta di poesie, per lo meno in ambiente colto, se c’è vuoi dire che è scritta. Ma con il teatro è diverso, e la pratica dei comici dell’Arte dovrebbe dimostrarlo: in quel caso era quasi normale che esistessero commedie — con il loro bravo testo letterario — ma non scritte. Dove stava, allora, il testo, ci si domanderà, se non stava per iscritto? Esso compariva all’improvviso nello spettacolo, non prima. Compariva all’improvviso non era improvvisato. Il problema dell’improvviso è innanzi tutto un problema del lettore e del Cardinale Paleotti, che non hanno nulla da leggere. Non degli attori che non avrebbero nulla di composto prima dello spettacolo. Ciò che il teatro delle compagnie professionistiche rifiuta — o ciò di cui più semplicemente fa a meno — non è il primato e la centralità del testo, ma il primato e la centralità del libro. Se non si vede in tutta la sua complessità questo problema concreto, si devia verso la semplicistica astrazione di un teatro che — rifiutando il testo drammatico — viene da noi immaginato come un teatro che privilegia il gesto sulla parola, un teatro della fisicità o della teatralità pura. Sono equivoci che corrono sul filo delle associazioni arbitrarie di parole: popolano le storie del teatro di luoghi comuni, di fantasmi privi d’ogni radice storica, e si nutrono della cattiva lettura dei documenti. Lo scritto in cui meglio sono rappresentati gli atteggiamenti dei comici professionisti italiani nei confronti del testo teatrale è il primo dei due prologhi de Il finto marito di Flaminio Scala. Siamo nel 1618, Flaminio Scala, che ha composto molti scenari di commedie ed è stato accanto ai più grandi comici del suo tempo, che ha diretto compagnie, ora ha settant’anni, e immagina che un forestiero giunga nel teatro dove sta per recitarsi una sua commedia scritta — eccezionalmente — per intero. Scala immagina il disprezzo del forestiero letterato, immagina di non essergli neppure noto, lui che non è autore vero di libri e che «a’ suoi dì ha fatto mille suggetti» senza scrivere commedie, e si lascia difendere da un comico. Un professionista del teatro non scritto e un osservatore del teatro scritto si affrontano, così, su una scena ancora vuota: Comico Forestiero Comico Forestiero Comico Forestiero — Ma non mi negherete già, che dove lo Scala ha portato i suoi suggetti, sempre hanno dato gusto e son piaciuti. — È vero, ma perché? Perché egli ha cercato fargli apparire con le azzioni; e le buone compagnie di comici son quelle che, ben recitando, nobilitano i suggetti; ma quella composizione, poich’è solamente scritta sopra un foglio, s’ella non ha in sé l’arte del bene scrivere che l’accompagni, resta fredda e cade. — Dunque questa, ora recitata, piacerà, perché hanno fatto scelta de’ personaggi. — Sta bene; ma essendo imparata a mente, se il disteso non è vago proprio e di buona lingua, non daranno in nulla. — Cotesto è vero quando con un bello e nobile encomio si vuol celebrare chi che sia, o pure narrare un fatto seguìto, ma nella commedia basta che vi sia buona imitazione et il verisimile, e che la locuzione non sia scabrosa o barbara; anzi la familiare, senza tanta arte, è la più propria, perché la commedia rappresenta azioni comuni, e non di uomini di alta qualità; onde l’esquisitezza gli è impropria. — Ben dite nel troppo; ma per imitare più parti et introdurre ciascuna a parlar propriamente bisogna saperne assai, perché non si può dilettare con la variazione o del bergamasco o del veneziano o del bolognese, ma bisogna con la proprietà delle parole, ancorché non si muti linguaggio, ben imitare; et a questo ci vuol del buono. Sì che torno a ridire che non spero molto di questa, perché ognuno val ne l’arte sua. (Scala, 1618, p. CX). La discussione, come si vede, non riguarda la capacità dei comici a fare un buon teatro — il forestiero è anche lui d’accordo che il loro teatro funziona — ma la loro capacità di scrivere una commedia, fissando e traducendo completamente in parole gli effetti delle azioni sceniche. Il professionista del teatro non scritto sostiene che lo Scala, nel momento in cui vuole, può anche scrivere una commedia, perché il livello della dicitura, della locuzione, non e il più importante, e la lingua, purché sia famigliare e corretta, non deve essere particolarmente curata. L’osservatore del teatro scritto, al contrario, sostiene che tutta la sostanza della commedia scritta si esprime appunto nella superficie della sua dicitura o locuzione, e che quindi Scala è destinato al fallimento, perché in questo caso pratica un’arte non sua. E indicativo l’esempio che porta: in una commedia occorre caratterizzare anche verbalmente i diversi personaggi. Ma mentre gli attori in scena possono caratterizzarli all’ingrosso, dando direttamente ad ognuno lingue o dialetti diversi, come fanno i comici di professione che fanno parlare un personaggio in bergamasco, un altro in veneziano e un altro ancora in bolognese, quando la commedia è scritta le diverse caratterizzazioni linguistiche dei personaggi debbono essere realizzate attraverso gli strumenti offerti da una sola lingua, debbono essere, cioè, più raffinate e richiedono la specializzazione di un letterato. Il comico risponde: Comico — L’arte vera del ben far commedie credo io che sia di chi ben le rappresenta, perché se l’esperienza è maestra delle cose, ella può insegnare, a chi ha spirito di formare o meglio rappresentare i soggetti recitabili, il ben distenderli ancora, quando però quel tale non sia nato in Voltolina o dove si lascia l’io per il mi. Ancora una volta, cioè, ribadisce che per scriver bene teatro non occorre nessuna particolare specializzazione letteraria, ma la conoscenza dell’uso corretto della lingua e nulla più. Il tema in discussione fra il comico e il letterato è, in fondo, molto limitato: non riguarda il teatro all’improvviso, non l’arte del recitare e neppure — come si vedrà — il conflitto gesto-parola. Non è nient’altro che la discussione su quel che serve per scrivere (ancora una volta: scrivere, non rappresentare) una buona commedia. Attraverso il dialogo fra il comico e il forestiero — e ancor più attraverso il dialogo a distanza con i suoi moderni interlocutori, gli studiosi della Commedia dell’Arte — Flaminio Scala mostra quanto siano celate e profonde le conseguenze dell’identificazione fra testo drammatico e scrittura del testo drammatico; come esse si travestano in semplici contrapposizioni di poetica e come nascondano la complessità del concreto lavoro teatrale. Il primo prologo del Finto marito, infatti, è stato recentemente messo in luce, citato, analizzato più volte come uno dei documenti migliori della così detta poetica della Commedia dell’Arte (cfr. Jannaco, 1960; Marotti, 1976, pp. XLVIII-L; Tessari, 1969, pp. 69-78 e 1981, pp. 50-54), ma le analisi rischiano continuamente di inciampare sulla parola azione» usata dallo Scala e di cadere nella sfera d’attrazione delle discussioni teatrali dei nostri anni, ritrovando nelle pagine dello Scala una poetica del gesto o della mimesi cinetica o del diretto rapporto fra gesto dell’attore e reazione fisica dello spettatore, o — più in generale — una teoria del teatro come arte libera dal legame con la letteratura. Ma, in realtà, le parole dello Scala riguardano un livello del teatro molto diverso e molto più raffinato. Dice Flaminio Scala che «le commedie nell’azzioni consistono propriamente e in sustanzia», perché «alle azzioni son più simili l’azzioni che le narrazioni » (Scala, 1618, p. CXIII). Poi, per convincere il suo interlocutore, introduce l’esempio del gesto che è più efficace della parola. Ma notiamo, intanto, che per lui «gesto» e «azzione» sono due cose ben distinte, e che usa il «gesto» come esempio per spiegare la forza dell’«azzione»: Per tale cagione adunque l’orazione o locuzione ancora, e le parole sole, poca arte avranno in questo dell’imitazione, perché ogni minimo gesto a tempo et affettuoso farà più effetto che tutta la filosofia di Aristotile, o quanta retorica suppone Demostene e Cicerone. E che sia vero che gl’affetti si muovono più agevolmente da’ gesti che dalle parole, ciascuno che ha intelletto et anco gli animali bruti sempre faran più caso e moverannosi più a chi alza il bastone che a chi alza la voce. (Scala, 1618, p. CXIII). Poco più avanti aggiunge: E considerisi ciò ne gl’amanti, che più da una lacrimuzza, da uno sguardo, da un bacio, per non dir di più, e da simili cosarelle vengono dal subbietto amato tirati e mossi, che dalla persuasiva di qual si voglia gran filosofo morale, che con ben ordinata scrittura, perfetti concetti, ottima locuzione et esquisite parole e migliori ragioni esorti alla virtù, persuadendo a lasciar da canto la sensualità. (Scala, 1618, p. CXIV). Ora è chiaro che qui Flaminio Scala contrappone il gesto alla parola non per contrapporre un teatro basato sul gesto «gestuale») ad un teatro basato sul testo — come la pubblicistica teatrale dei nostri anni si è abituata a contrapporre — ma per rafforzare con una similitudine lampante il suo argomento secondo cui ciò che è importante in una commedia non è la coltre della dicitura ma la sostanza costituita dalla serie dei fatti. I due termini, «dicitura» e «serie dei fatti», sono una traduzione moderna e meno aperta ad equivoci di ciò che Scala intende con «azzioni» e «locuzione». Derivano dal Manzoni, nell’Introduzione a I promessi sposi: «Perché non si potrebbe, pensai, prender la serie de’ fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura?». È lecito immaginare simili parola in bocca ad un comico: perché non si potrebbe fissare l’ossatura delle commedie e lasciare che la loro epidermide cambi e ondeggi, abbandonandone la responsabilità agli attori? Un progetto del genere non ha nulla a che vedere con il progetto d’un teatro del gesto. È, piuttosto, un progetto che vede l’attore come traduttore — alla lettera — d’una commedia letterariamente composta. Per comprendere come questo possa avvenire, e che cosa significhi il fatto che avvenga, occorre ritornare alle parole dello Scala e alla deformazione con cui noi oggi siamo tentati di leggerle. Ci troviamo in uno di quei casi, infatti, in cui per comprendere un fenomeno del passato, più che impossessarci delle sue categorie, dobbiamo liberarci delle nostre. Per la nostra mentalità, il livello verbale — la dicitura — di un’opera coincide con il suo livello sostanziale. Ci troviamo quindi in difficoltà e quasi bloccati quando si tratta di distinguere le «parole» dalle «azioni» di un dramma. Parlare di un teatro basato sulle azioni finisce per noi fatalmente con il confondersi con il parlare di un teatro eminentemente visivo, dove prevale l’espressione fisica e mimica dell’attore, dove si nega o si svaluta l’importanza della parola e del testo drammatico. La confusione è aumentata dal fatto che quasi sempre, quando uomini di teatro moderni hanno rivendicato la necessità di basare lo spettacolo sull’espressione fisica dell’attore, sugli aspetti mimici e visivi del teatro e non sui suoi aspetti letterari, hanno fatto riferimento alla Commedia dell’Arte. Ma l’azione di cui parla Flaminio Scala quando si dice che su di essa si basa essenzialmente il teatro non coincide con l’agire in scena dell’attore. Tanto meno coincide con la sua gestualità. L’esistenza di un problema dell’azione come problema drammatico che non e pertinente a quello della gestualità dell’attore o dell’aspetto visivo e cinetico del teatro noi la riconosciamo facilmente quando pensiamo al cinema e alla sua composizione drammatica. Nessuno vedrebbe alcun riferimento all’espressione fisica dell’attore, all’idea di uno spettacolo gestuale, se leggesse che il cinema «nell’azzioni consiste propriamente e in sustanzia», e che per scrivere un film basta saperne concepire e comporre la serie dei fatti e poi stendere i dialoghi nella normale lingua famigliare, senza preoccuparsi, addirittura, se gli attori li cambieranno, poi, nel momento della realizzazione, o se li adatteranno a sé o ne ripeteranno con parole proprie la sostanza. Il film, insomma, non e uno spettacolo per cui abbia senso dire che il gesto prevale sulla parola o che l’elemento visivo in movimento prevale sul racconto. Ha un testo alla base, ma e molto raro che qualcuno ne giudichi la qualità giudicando il valore letterario dei suoi dialoghi, Il valore strumentale dei dialoghi, della parola, è qualcosa che viene riconosciuto proprio in rapporto alla composizione drammatica, non in opposizione ad essa. Sono simili le constatazioni di Flaminio Scala nel primo prologo al Finto marito: il tessuto letterario dei dialoghi non è importante in una rappresentazione teatrale e neppure nella scrittura d’una commedia. Egli non sostiene né un teatro basato sulla fisicità del gesto, né i1 suo contrario — un teatro basato sulla mediazione della parola: queste distinzioni gli sono estranee. Le azioni di cui parla non hanno nulla di paragonabile con le azioni che compongono una partitura gestuale in un teatro moderno: sono, invece, racconto, rappresentazione, messinscena di un intreccio, anche se le parole che gli attori debbono dire non sono particolarmente importanti. Ma non sono importanti non perché possano essere eliminate, ma perché possono essere non particolarmente curate dal punto di vista letterario. Dovrebbe apparire ormai chiaro che è un errore interpretare le dichiarazioni dello Scala come se fossero in favore di un teatro basato più sugli elementi visivi e mimici, più sul virtuosismo degli attori e sulla loro dote d’improvvisare senza testo, che non sulla tecnica di composizione del testo drammatico. Dovrebbe risultar chiaro, anzi, che è vero il contrario. Quando parla del teatro come di un’imitazione delle azioni attraverso le azioni, lo Scala intende sottolineare proprio l’importanza della composizione drammatica contro una concezione che invece rischia di lasciare in secondo piano il dramma — l’azione — per mettere in rilievo l’eleganza dell’eloquio, la preziosità del livello verbale. Ciò che a noi sembra paradossale, e cioè che l’elemento letterario di una commedia venga considerato come un suo materiale, un suo ingrediente non più importante dell’ambientazione scenografica, è invece opinione comune allo Scala, ai suoi colleghi, ai suoi contemporanei (cfr. Francesco Andreini nella premessa a Scala, 1611, p. 13, e Seragnoli, 1980, pp. 174-180). Per noi, il livello verbale di un dramma è ciò in cui si esprime la sua azione. Per Flaminio Scala e per molti del suo tempo era esattamente il contrario: ciò che rischiava di nascondere l’azione. Una preoccupazione, questa, tipicamente classica: «Qualcuno — racconta Plutarco nel suo opuscolo Dell’udire — domandò a Melanto cosa ne pensasse della tragedia del poeta Dionisio. Melanto rispose: “Non sono riuscito a vederla, tanto era coperta dal velo delle parole”». Nel momento stesso in cui Flaminio Scala spiega perché egli — autore di scenari — sia in grado di scrivere per disteso una commedia, spiega anche perché normalmente di commedie non ne abbia scritte e perché i comici professionisti potessero recitare un teatro non scritto: perché, appunto, le parole della commedia altro non sono che un velo che copre l’essenziale, il montaggio delle azioni o secondo la formula aristotelica — la «composizione dei casi». Se ne deduce, contro tutte le previsioni, che la visione drammaturgica dello Scala è rigorosamente classica, e che se essa sembra irregolare, lo sembra solo perché si distingue dalla posizione classicista che vigeva presso i letterati del suo tempo e che lascia tracce ancora presso il nostro modo di pensare il problema della drammaturgia. Ma prima di procedere in questa direzione, conviene voltarci indietro per considerare il cammino percorso: i luoghi comuni sull’improvvisazione degli attori italiani sembravano celare o un multiforme intreccio d’usi e abusi comici, o la particolare pratica di produzione di teatro che affidava agli attori la composizione della commedia. L’antinomia commedia improvvisata/commedia premeditata, cioè, velava l’antinomia più concreta fra commedia composta e commedia eseguita. Seguendo questa traccia, e vedendo come la produzione dei comici si manifestava nei primi decenni di vita delle compagnie, siamo giunti a un’antinomia ancora più concreta: teatro scritto/teatro non scritto. Quest’ultimo, però, non poteva esser confuso con un teatro anti-letterario, gestuale, mimico, ma — al contrario — si mostrava come un teatro che svalutava la stesura della dicitura in nome della composizione dei casi, delle azioni, e che quindi in nessun modo poteva esser visto come un teatro senza testo letterario, anche se questo testo era prodotto in maniera tale da comparire solo nello spettacolo. Si possono dedurre da tutto questo ancora due corollari che riguardano l’improvvisazione. Innanzi tutto, siamo ora in grado di circoscrivere il livello in cui è possibile vedere all’opera, in maniera continua e sistematica, l’improvvisazione: il livello estremamente superficiale della dicitura, cioè della traduzione operata dall’attore, con parole sue, della serie dei fatti e degli argomenti fissati. In secondo luogo, risulta ora evidente almeno una ragione per cui è stata l’improvvisazione a colpire tanto l’immaginazione degli osservatori della Commedia dell’Arte e dei suoi studiosi. Essi restavano e restano colpiti proprio dall’elemento più superficiale (l’improvvisazione nella traduzione della coltre della dicitura) a causa dei propri interessi particolari: come il Cardinale che a causa delle sue funzioni è soprattutto interessato al fatto di non poter leggere le commedie, anche per lo studioso moderno la non trascrizione dei testi delle compagnie professionistiche diventa il fatto più importante perché è per lui il più importante: quello che gli impedisce di conoscere a distanza di secoli le commedie dei professionisti. Se gli attori, infatti, possono tramandarsi le commedie attraverso la composizione dei casi e la serie degli argomenti trasmessi oralmente o velocemente appuntati, tali da poter essere poi tradotti nelle parole dello spettacolo; per i lettori le commedie si trasmettono solo attraverso i dialoghi distesi. Nel primo caso la composizione dei casi trasmette le parole dei dialoghi sotto forma di «soggetti» che gli attori possono tradurre. Nel secondo, sono i dialoghi a trasmettere la composizione dei casi attraverso azioni che i lettori possono immaginare. Ritorniamo, così, all’ipotesi che si faceva poco fa: la differenza delle compagnie italiane — cioè della Commedia dell’Arte — dai teatri circonvicini e dall’idea di teatro vigente nell’alta cultura del secolo XVI e XVII non deriverebbe dal loro distaccarsi dalla tradizione del teatro letterario, ma dal combinare in maniera diversa gli elementi di quella tradizione. È legittimo sostenere, infatti, che il teatro ideato dalle compagnie professionistiche italiane, il teatro all’improvviso, fu, per eccellenza, un teatro classico, e che proprio per questo apparve subito così diverso dal teatro «di imitazione classica», cioè dal teatro classicista. Il primo continuava ad utilizzare i processi compositivi classici. Il secondo si ispirava ai risultati. Il primo era classico perché tutto concentrato sull’azione, sul dramma, da cui tutti gli altri elementi venivano dedotti. Il secondo era classicista perché si concentrava sulle reliquie del teatro antico, sui testi sopravvissuti, e deduceva l’importanza della dicitura non dalla sua essenzialità, ma dalla sua permanenza. L’idea classicista vede il teatro come qualcosa che deve discendere dal libro, perché ha i libri davanti e risale al teatro antico attraverso i libri. Teoricamente, distingue fra «composizione dei casi» e materiale verbale, ma praticamente trova, nei testi che legge, che l’uno è l’altro. La moderna ideologia teatrale, cioè, si costruisce ipostatizzando le regole della sua trasmissione, e diventa incommensurabile con l’idea di teatro dei comici, che si costruiva su altre regole di trasmissione, quelle per cui, fra composizione dei casi e materiale verbale della commedia, poteva essere trasmesso l’uno e l’altro o soltanto l’uno. Quello delle compagnie italiane apparirà presto come una forma bizzarra o mostruosa di teatro, una varietà folcloristica o eretica, nata non si sa dove né come. Ed in realtà si distingueva davvero dai teatri che contemporaneamente nascevano in diversi paesi d’Europa. Ma si distingueva perché, mentre le compagnie professionistiche degli altri paesi si legavano alle composizioni drammatiche degli scrittori, e quindi ad una drammaturgia che privilegiava lo scritto, gli italiani si legarono al processo di produzione della letteratura drammatica e lo adattarono, fuori dalla pratica della scrittura, ad altre pratiche professionali di produzione di teatro. Se il teatro degli italiani, infatti, appare così diverso dal teatro degli scrittori, è perché gli italiani usano gli stessi metodi degli scrittori per ottener altri risultati. Il che vuoi dire che l’indipendenza dalla volontà di un unico autore, che risultava celarsi dietro i luoghi comuni sull’improvvisazione, cela a sua volta più complesse strategie di rapporti dove i confini fra la produzione di teatro e la politica dei teatri si fanno labili. OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA Apollonio 1930 Mario Apollonio, Storia della Commedia dell’Arte, Roma-Milano, Augustea, 1930 (reidiz. fotomeccanica: Firenze, Sansoni, 1982). Apollonio 1968 Mario Apollonio, Prelezioni sulla Commedia dell’Arte, in AA.VV., Contruti dellIstituto di Filologia Moderna – Serie Storia del Teatro, vol. I, Milano, Vita e Pensiero, 1968, pp. 144-190. Desboulmiers 1769 Jean Auguste Jullien dit Desboulmiers, Histoire Anedoctique du Théâtre Italien depuis son rétablissement en France jusqu’à l’année 1769, Paris, Lacombe, 1769, 7 voll. Duchartre 1955 Pierre-Louis Duchartre, La Commedia dell’Arte et ses enfants, éd. d’Art et Industrie, 1955, (è la versiona ampliata di un’opera già apparsa nel 1925). Gherardi 1700 Le Théâtre Italien de Gherardi ou Recueil général de toutes les Comédies et Scènes Françoises jouées par les Comédiens Italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au service, Paris, Cusson et Witte, 1700, 6 voll. (ed. definitiva che fa seguito a quelle parziali, pubblicate a Parigi nel 1694, 1695, 1697 e 1698. L’edizione del 1700 è stata ripubblicata ad Amsterdam nel 1701, 1707 e 1721 e a Parigi nel 1717, 1738 e 1741. Un’antologia del Recueil del Gherardi è stata pubblicata da Marcello Spaziani nel 1966 (vedi). È da questa raccolta che vengono tratte le citazioni. Gozzi 1797 Carlo Gozzi, Memorie inutili della vita di Carlo Gozzi scritte da lui medesimo e pubblicate per umiltà, Venezia, Palese, 1797. (Ed. moderna: Bari, Laterza, 1910, a cura di Giuseppe Prezzolini, 2 voll., collana «Scrittori d’Italia». È da questa che citiamo). Jannaco 1960 Carlo Jannaco, Stesura e tendenza letteraria della commedia improvvisa in due prologhi di Flaminio Scala, in «Studi Secenteschi», I, 1960, pp. 195-207. Maffei 1723 [Scipione Maffei], Istoria del teatro e difesa di esso, in Teatro italiano, o sia scelte di tragedie per uso della scena, tomo I, Verona, Vallarsi, 1723, pp. I-XVIV. Marotti 1976 Studio critico e raccolta di documenti sugli inizi della Commedia dell’Arte a cura di Ferruccio Marotti per il volume Flaminio Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, 2 tomi, Milano, Il Polifilo, 1976. Mic 1927 Constant Mic (Konstantin Miklashevskij), La Commedia dell’Arte, ou le théâtre des comédiens Italien des XVI, XVII et XVIII siècle, Paris, Schiffrin, aux Editions de la Pléiade, 1927 (traduzione italiana in versione ridotta di Carla Solivetti, Padova, Marsilio, 1981). Nicoll 1963 Allardyce Nicoll, The World of Arlequin. A critical Study of the Commedia dell’Arte, Cambridge, University Press, 1963. (Trad. italian, Il mondo di Arlecchino, Milano, Bompiani, 1965. Nuova edizione a cura di Davico Bonino: ivi, 1980. È questa l’edizione da cui sono tratte le citazioni). Ottonelli V Giovan Domenico Ottonelli, Della Christiana Moderatione del Theatro. Libro detto l’Istanza, Firenze, Bonardi, 1652. (Un’ampia antologia dell’opera dell’Ottonelli si trova in Taviani 1969, pp. 320-526). Perrucci 1699 Andrea Perrucci, Dell’arte rappresentativa premeditata e all’improvviso. Parti due. Giovevole non solo a chi si diletta di rappresentare, ma a’ predicatori, oratori, accademici e curosi, Napoli, Mutio, 1699. Riccoboni 1728 Luigi Riccoboni, Histoire du Théâtre Italien depuis la decadence de la Comédie Latine, avec un catalogue des Tragedies et Comédies imprimées depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1600 et une dissertation sur la tragedie moderne, Paris, Delormel, 1728. (Rist, anastatica: Bologna, Forni, 1969). Riccoboni, Scenari inediti Luigi Riccoboni, Discorso della Commedia all’improvviso e scenari inediti, a cura di Irene Mamczarz, Milano, Il Polifilo, 1973. (Pubblica un manoscritto inedito di Luigi Riccoboni conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi [...]). Sand 1862 Maurice Sand, Masques et bouffons. Comédie Italienne, textes et dessins par Maurice Sand, gravures par A. Manceau, préface par Georges Sand Paris, Lévy, 1862. Scala 1611 Flaminio Scala, Il teatro delle Favole Rappresentative, overo la ricreazione comica, boscareccia e tragica, divisa in cinquanta giornate, Venezia, Pulciani, 1611 (ed. moderna a cura di Ferruccio Marotti, Milano, Il Polifilo, 1976, 2 voll.. È questa l’edizione da cui citiamo). Scala 1618 Flaminio Scala, Il finto marito, Venezia, Baba, 1619 [ma 1618]. (I due prologhi al Finto marito sono pubblicati in Marotti 1976, pp. CIX-CXVIII). Seragnoli 1980 Daniele Seragnoli, Il teatro a Siena nel Cinquecento. “Progetto” e “modello” drammaturgico nell’Accademia degli Intronati, Roma, Bulzoni, 1980. Spaziani 1966 Il “Théâtre Italien” di Gherardi, otto commedie di Fatouville, Regnard e Dufresny presentate da Marcello Spaziani, Roma, ed. dell’Ateneo, 1966. Taviani 1969 Ferdinando Taviani, La Commedia dell’Arte e la società barocca: la fascinazione del teatro, Roma, Bulzoni, 1969. Taviani 1971 Ferdinando Taviani, Studio introduttivo a N. Barbieri, La Supplica, Milano, Il Polifilo, 1971. Tessari 1969 Roberto Tessari, Commedia dell’Arte. La maschera e l’ombra, Milano, Mursia, 1981. Valerini 1570 Adriano Valerini, Oratione in morte della divina Signora Vincenza Armani, comica eccellentissima, Verona, [1570].
Scaricare