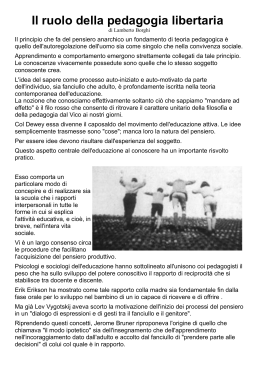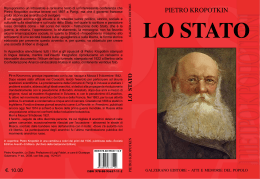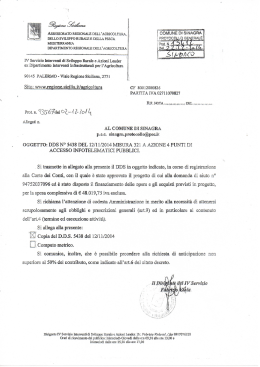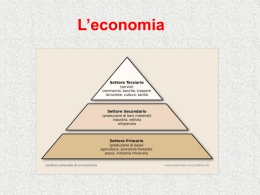DOTTORATO DI RICERCA - XVI CICLO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Geografia e pianificazione del paesaggio per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale TESI FINALE DI DOTTORATO “ALTERNATIVE PER LA PRODUZIONE AGRICOLA CONTADINA NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO LOCALE AUTOSOSTENIBILE ” Dottoranda: Dott. Valeria de Marcos Tutor: Prof. Massimo Quaini Aprile 2004 Genova - Italia A Walter Yukio Homma (in memoria) perché il tuo sogno, che ora è anche il mio, è già una realtà 2 RINGRAZIAMENTI Iniziare a scrivere questi ringraziamenti mi è tanto difficile. Non perché non mi piaccia ringraziare, anzi, ma perché con essi si chiude un altro ciclo della mia vita personale e accademica. Il sentimento che mi prende ora è un misto di allegria e tristezza ma, siccome non potrei consegnare questa tesi senza ringraziare tutti quelli che di essa hanno fatto parte, comincio il difficile compito di mettere il punto finale di questo ciclo. Innanzitutto ringrazio le tre persone che hanno reso possibile l’inizio di questo percorso: • il Sig.re. Walter Yukio Homma, purtroppo in memoria, per tutto quello che mi ha dato e insegnato durante gli anni in cui ho vissuto nella Comunità Sinsei (a San Paolo/Brasile), durante la ricerca per la tesi di Master. L’idea di questa tesi è nata da quell’esperienza e da tutte le conversazioni che abbiamo avuto sin da quando ci siamo conosciuti. È stato lui a insegnarmi a sognare e a credere nella realtà dei miei sogni; • il Prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, mio tutor della tesi di Master, amico e punto di riferimento accademico, che ha ancora una volta creduto in me prima ancora che io l’avessi fatto, incoraggiandomi – in realtà quasi spingendomi – a provare a fare questa esperienza di dottorato all’estero e a cercar il Prof. Quaini come tutor della tesi; • il Prof. Massimo Quaini, mio tutor per questa tesi, per aver creduto nell’idea e accettato di guidarmi in questo cammino, trasformando così il mio sogno in realtà e per la sua preziosa collaborazione in questo lavoro. Poi, a quelli che mi hanno dato le condizioni logistiche di realizzare questo percorso: • all’Agenzia Capes, l’agenzia di finanziamento alla ricerca che ha creduto nella validità del progetto di ricerca che ho consegnato, offrendomi una borsa di studio per svolgere il corso di dottorato all’estero per quattro anni. In particolare alla Prof.ssa Marigens Carvalho, che si è sempre resa disponibile a risolvere i problemi comparsi nel trascorrere del tempo; 3 • il Departamento di Geociências dell’Universidade Federal da Paraíba, dove lavoro, per avermi concesso il nulla osta alla mia partecipazione a questo dottorato di ricerca; • l’Istituto Interfacoltà di Geografia dell’Università degli Studi di Firenze, in particolare il Prof. Leonardo Rombai e la Prof.ssa. Teresa Isemburg che mi hanno gentilmente accolto al mio arrivo; • i professori Diego Moreno e Osvaldo Raggio del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea che mi hanno offerto importanti aiuti anche prima dell’inizio del corso di dottorato; • i professori del collegio docenti del Corso di Dottorato in Geografia e Pianificazione del Paesaggio per la Valorizzazione del Patrimonio StoricoAmbientale, per gli importanti contributi offerti durante gli anni di svolgimento della ricerca, in particolare ai Professori Stringa, Montanari, Moreno, Orlando, Pinto, Quaini, Raggio e Spotorno e alle Professoresse Balletti, Cristina e Mazzino. Alle persone che ho intervistato per lo svolgimento di questa ricerca, per la loro gentilezza e disponibilità ad aiutarmi, sia attraverso le interviste che le innumerevoli altre domande fatte e risposte via email e per il materiale che buona parte di loro mi ha concesso: • il Prof. Alberto Magnaghi che pazientemente ha letto il mio progetto di ricerca e mi ha offerto un importante contributo, mettendomi in contatto con le esperienze più interessanti che compongono i capitoli otto e nove di questa tesi; • il Prof. Omodeo Zorini, della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze; • Libereso Guglielmi, che mi ha gentilmente concesso un’intervista a casa sua, a Sanremo, per la lezione di vita lasciatami e la persona bellissima che è; • Walter Gasperini, del Consorzio Radici, a Suvereto, Toscana; • David Fanfano – Laboratorio Anci Toscana Val di Bisenzio – Prato, Toscana; • Antonio De Falco – Agricoltura sinergica, che mi ha portato anche a vedere un orto sinergico a Ontignano, nella proprietà di Giannozzo Pucci; • Giannozzo Pucci – Fierucola di Santo Spirito a Firenze; • Marilia Zappalà e Marco Naldini – Ecovillaggio Basilico; Ai personali della Biblioteca Franco Serantini di Pisa e della Sala Consultazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dove ho svolto buona parte della ricerca. Ai miei genitori che mi hanno sostenuto emozionalmente durante questi lunghi anni di assenza. Ai miei amici brasiliani che mi sono stati sempre vicini, nonostante l’Oceano che ci separava. 4 Ai nuovi amici di Firenze che hanno reso il mio soggiorno molto più piacevole, facendomi sentire voluta bene e integrata da questa parte dell’Oceano. In particolare a quelli del Circolo Vie Nuove (Lamberto e Paola, Anna e Silvio, Bruno e Angela, Orlando) e alle amiche che ho fatto durante l’ultimo anno passato nella “Nazionale” e che mi hanno dato la forza che mi mancava nei momenti più duri da affrontare: Francesca Battaglini, Cristina Monni, Vanessa Castelnovi, Sara Centi e Cecilia Calabri. A Donata Vitali, l’italiana più brasiliana che conosco, che mi ha mostrato una Firenze vista dagli occhi di una marchigiana e che mi è stata sempre vicina, anche se non sempre fisicamente. A Pinuccia, una delle mie più belle scoperte e mio “angiolo custode” italiano, e a Giancarlo per il prezioso aiuto tecnico. A Pierluigi Benevieri, per l’amore che mi ha dedicato, senza il quale questo cammino sarebbe stato molto meno colorato. 5 In alto la testa! avete un bisogno vitale Di questa alba che brilla e si leva per voi. Alzate gli occhi, guardate E ridate nascita Al sogno. Maya Angelou 6 INDICE PARTE I – INQUADRAMENTO STORICO INTRODUZIONE ………………………………………………………………….………….. 12 CAPITOLO 1 – LE RADICI STORICHE DELLA DISCUSSIONE ………………………………… 17 1. Il mondo alle porte delle rivoluzioni industriale e francese ………………………... 17 2. La rivoluzione industriale …………………………………………………………. 19 3. La rivoluzione francese …………………………………………………………… 22 4. Camminando verso il 1848 ……………………………………………………….. 29 5. E il mondo gira … ………………………………………………………………... 33 CAPITOLO 2 – IL MOVIMENTO ANARCHICO E LE PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PRODUZIONE ……………………………………………………………… 36 1. Le origini dell’anarchia ………………………………………………….………… 36 2. GODWIN e la prima sistemazione del pensiero anarchico ……………………….. 41 3. Che cos’è l’anarchia ………………………………………………………………. 46 4. Le scuole di pensiero anarchiche e le proposte di organizzazione sociale della produzione ….……………………………………………………………………. 50 CAPITOLO 3 – L’EMIGRAZIONE ITALIANA IN BRASILE DALLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO FINO ALLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO …………………………... 80 1. Introduzione ……………………………………………………………………… 80 2. Perché emigrare ? …………………………………………………………………. 81 3. Mentre questo in Brasile … ……………………………………………………….. 85 4. Verso la “Mérica”: la lunga distanza tra l’Italia e il Brasile …………………………. 86 5. L’arrivo alla “terra promessa” …………………………………………………….. 88 6. Il lavoro nelle fazendas di caffè …………………………………………………… 89 7. Le colonie agricole nel sud del Brasile …………………………………………….. 94 8. Conclusione ………………………………………………………………………. 98 PARTE II – LE «VECCHIE» UTOPIE CAPITOLO 4 – LA PRASSI ANARCHICA: GIOVANNI ROSSI E LA COLONIA CECILIA ……….. 101 1. Giovanni Rossi: vita e idee ………………………………………………………... 101 2. L’(u)topia di Giovanni Rossi: Un comune socialista ………………………………….. 106 7 2.1. L’analisi del libro …………………………………………………………………. 108 3. Il veterinario anarchico: il soggiorno di Rossi a Gavardo e i primi passi verso la realizzazione della sua utopia ……………………………………………………... 116 4. La necessità di “sperimentare”: la difesa dello sperimentalismo e la polemica con gli anarchici ………………………………………………………………………….. 120 4.1. «Lo Sperimentale» numero a numero …………………………………………….. 124 5. Cittadella ………………………………………………………………………..... 134 6. Dove c’è autorità non c’è libertà: la Colonia Cecilia e l’utopia del comunismo anarchico ….……………………………………………………………………… 141 Dopo Cecilia: il legato di Giovanni Rossi ………………………………………… 161 CAPITOLO 5 – ALTRE ESPERIENZE DI COLONIE SOCIALISTE …………………………….. 164 1. Le colonie americane ……………………………………………………………... 164 2. Altre esperienze …………………………………………………………………... 172 3. I collettivi durante la Guerra Civile Spagnola ……………………………………... 183 3.1. La struttura agraria e l’agricoltura spagnola ……………………………………….. 183 3.2. Verso la guerra civile ……………………………………………………………… 189 3.3. La formazione dei collettivi spagnoli ……………………………………………… 195 3.4. I collettivi visti dall’interno ……………………………………………………….. 200 3.5. Gli insegnamenti della Guerra di Spagna: successi e fallimenti della collettivizzazione …………………………………………………………………. 220 La fine della guerra: la sconfitta della Repubblica …………………………………. 225 7. 3.6. CAPITOLO 6 – PER UNA TEORIA DELLA PRODUZIONE COLLETTIVA E COMUNITARIA ALL’INTERNO DEL MOVIMENTO ANARCHICO ……………………………………………... 227 1. La pratica nella storia ……………………………………………………………... 227 2. La teoria ………………………………………………………………………...… 232 2.1. BAKUNIN e il collettivismo ……………………………………………………... 232 2.2. KROPOTKIN e il comunismo anarchico ………………………………………… 237 2.2.1. I cardini del pensiero di KROPOTKIN e del comunismo anarchico ……………... 240 PARTE III – LE «NUOVE» UTOPIE CAPITOLO 7 – SVILUPPO LOCALE AUTOSOSTENIBILE: UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE ……………………………………… 261 1. Dal territorio come supporto al territorio come patrimonio ………………………. 261 2. La valorizzazione del patrimonio territoriale e lo sviluppo locale autosostenibile ….. 270 2.1. L’origine del concetto di sviluppo locale autosostenibile ………………………….. 270 2.2. Lo sviluppo locale autosostenibile come progetto per la valorizzazione del patrimonio territoriale ……………………………………………………………. 281 8 2.3. Verso il cambiamento ……………………………………………………………... 285 CAPITOLO 8 – LO SVILUPPO LOCALE AUTOSOSTENIBILE NELLA PRATICA I. VERSO UN’ALTRA PRODUZIONE ……………………………………………………………………. 300 1. «Laboratorio Toscana»: l’ANCI TOSCANA e l’università per la sostenibilità dell’agricoltura ……………………………………………………………………. 300 1.1. Un manifesto per la Toscana ……………………………………………………... 301 1.2. Dal manifesto all’azione: il Laboratorio ANCI Val di Bisenzio …………………… 303 1.2.1. Il quadro normativo di riferimento ……………………………………………….. 303 1.2.2. La Val di Bisenzio e la costruzione di una rete di economia integrata nell’ambito del recupero dell’agricoltura tradizionale ….………………………………………….. 307 2. Dall’agricoltura naturale all’agricoltura sinergica ………………………………….. 327 2.1. Tante agricolture ………………………….……………………………………… 327 2.2. FUKUOKA e l’agricoltura naturale …………….………………………………… 330 2.3. I principi dell’agricoltura naturale …………………………………………………. 333 2.4. L’agricoltura naturale nella pratica ……………………………….………………... 338 2.5. Un futuro per l’agricoltura naturale …………………………..…………………… 343 2.6. L’agricoltura sinergica ……………………………….……………………………. 347 3. Lo Slow Food ……………………………………………………………….…… 352 3.1. Le origini e lo svolgersi del movimento …………………………………………… 353 3.2. Le fondamenta di Slow Food e le strategie per diffondere la sua filosofia ………... 361 3.3. Operazione Salvezza: l’Arca, il Presìdio e il Premio Slow Food ………………….. 367 3.3.1. L’Arca del Gusto …………………………………………………….…………… 367 3.3.2. I Presìdi Slow Food …………………………………………….………………... 371 3.3.2.1. I Presìdi Slow Food in Italia ………………….………………………………….. 376 3.3.2.2. I Presìdi Slow Food Internazionali …….………………………………………… 381 3.3.3. Il Premio Internazionale Slow Food per la difesa della biodiversità ……………… 385 4. Dalle comunità agli ecovillaggi ……………………………………………………. 386 4.1. Un passo indietro: le radici degli ecovillaggi ………………………………………. 391 4.2. Due passi in avanti – gli ecovillaggi nell’attualità: un’idea, tante realtà …………….. 403 4.2.1. Gli ecovillaggi appartenenti alla RIVE ……………………………….…………… 405 4.2.1.1. Torri Superiore …………………………………………………….……………... 405 4.2.1.2. Federazione Comunità di Damanhur …………………………………….……….. 407 4.2.1.3. Cooperativa Agricola Mogliazze ……………………………………….…………. 412 4.2.1.4. La Confederazione dei Villaggi Elfici ………………………………..……………. 414 4.2.1.5. La Comune di Bagnaia ………………………………………………..…………... 418 4.2.1.6. Il Villaggio Upacchi ………………………………………………..……………… 419 4.2.1.7. L’Ecovillaggio Basilico ………….………………………………………………… 420 4.2.2. Gli ecovillaggi fuori della RIVE ……..………………………….………………… 426 9 CAPITOLO 9 – LO SVILUPPO LOCALE AUTOSOSTENIBILE NELLA PRATICA II. VERSO UN ALTRO MERCATO …………………………………………………….……………………… 431 1. Il Consorzio Radici ……………………………………...………………………... 431 2. La Fierucola a Firenze: produzione e consumo alternativo ……………………….. 438 3. I GAS – gruppo di acquisto solidale – e il consumo critico ……………………….. 447 4. La CTM ALTROMERCATO e il commercio equo e solidale …..……………………. 457 CONCLUSIONE …………………………………………………………………………..…... 462 BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………………………. 472 INDICE DEI SITI WEB VISITATI ……………………………………………………………… 484 ALLEGATI 1. La produzione intellettuale di Piotr KROPOTKIN …………………………….. 492 2. Manifesto dello Slow Food ………………………..……………………………. 521 3. Manifesto dell’Arca ………………………………….………………………….. 522 4. Depliant “Carciofo Violetto della Val di Cornia” ..…..………………………….. 523 5. Scheda Produttori – GAS …………………………..…………………………… 525 6. Intervista a Libereso Guglielmi – Sanremo, luglio 2003 ………………………… 530 7. Intervista a David Fanfano – Firenze, dicembre 2003 …..………………………. 565 8. Intervista ad Antonio De Falco – Settignano, novembre 2003 ………………….. 575 9. Intervista a Marilia Zappalà e Marco Naldini ………..…………………………... 587 10 Intervista a Walter Gasperini – Suvereto, luglio 2003 …………………………… 609 11. Intervista a Giannozzo Pucci – Firenze, dicembre 2003 ..……………………….. 621 10 PARTE I INQUADRAMENTO STORICO 11 INTRODUZIONE Il tema centrale di questa tesi di dottorato svolta all’interno del Corso di Dottorato di Ricerca Geografia e Pianificazione del paesaggio per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, è quello delle Alternative per la produzione agricola contadina nell’ottica dello sviluppo locale autosostenibile. Il suo punto di partenza sono stati i risultati raggiunti da due altre ricerche da me realizzate negli anni ’90. Una, sulla produzione collettiva e comunitaria, svolta per l’ottenimento del titolo di Master in Geografia Umana e l’altra, un’indagine multidisciplinare richiesta dalla CPT – Commissione Pastorale della Terra – e condotta da un gruppo di professori dell’UFPB – l’Università Federale della Paraiba – sulla qualità della vita nelle aree di riforma agraria nel nord est brasiliano, alla quale ho partecipato come ricercatrice responsabile della raccolta dei dati economici. La prima ricerca mi aveva messo in contatto con la pratica della produzione comunitaria e collettiva svolta da una comunità di giapponesi nella campagna dello stato di San Paolo e mi aveva spinto alla ricerca di altre forme di produzione con un livello di socializzazione del lavoro e della produzione minore, avvenute in Brasile e all’estero, nonché alla ricerca degli studi teorici su questi tipi di produzione. Gli studi e le analisi svolte mi hanno condotto alla conclusione della pertinenza e praticabilità della produzione comunitaria e collettiva, ma allo stesso tempo dell’estrema difficoltà di raggiungimento di risultati positivi nei tempi e nei modi in cui queste pratiche venivano proposte per esempio dal MST – Movimento dei Senza Terra – per le sue aree di riforma agraria. Mi hanno rivelato anche la necessità di realizzare un lavoro di sistematizzazione delle discussioni teoriche su questi tipi di produzioni, svolte all’interno del movimento anarchico e socialista a partire dal XIX secolo, davanti a quello che sembrava essere l’imminenza del superamento del modo capitalista di produzione tramite la rivoluzione sociale. Il contatto con la realtà delle aree di riforma agraria del nord est brasiliano, avvenuto con la seconda ricerca, mi ha convinto della necessità di cercare alternative a 12 quella forma di produzione, realizzata in forma arcaica e senza risorse economiche. L’alternativa della produzione collettiva e comunitaria si situavano in un orizzonte distante. Era, però, necessario iniziare il percorso in quella direzione, cercando altri tipi di esperienze che potessero servire di esempi, di che cosa potesse funzionare o meno in quelle aree. In questa prospettiva ho iniziato il Corso di Dottorato di Ricerca avendo davanti a me i seguenti obiettivi: lo studio della discussione teorica sulla produzione collettiva e comunitaria; lo studio di altre forme di esperienze di questo tipo di produzione in modo da trovare la conferma o meno di quello che veniva proposto teoricamente, così come somiglianze o differenze riguardo alle esperienze da me previamente studiate; lo studio di forme alternative attuali di produzione nell’agricoltura, svolte all’interno della prospettiva dello sviluppo locale autosostenibile e della valorizzazione del patrimonio territoriale che potessero essere messe in pratica nelle aree di riforma agraria brasiliane. Così, avendo questi obiettivi definiti, mi sono occupata inizialmente dello studio della discussione teorica sulle produzioni collettiva e comunitaria e altre esperienze svolte nell’ambito di queste discussioni. Per rispondere al primo obiettivo, mi sono dedicata allo studio del movimento anarchico e dei suoi principali rappresentanti, in particolare alle proposte di organizzazione della produzione presentate da BAKUNIN – la produzione collettiva – e da KROPOTKIN – la produzione comunitaria. Il risultato di questa ricerca è stata la redazione dei due primi capitoli di questa tesi. In seguito mi sono occupata delle esperienze concrete realizzate all’interno di questa discussione. Ho studiato la Colonia Cecilia, esperienza di produzione comunitaria realizzata nel sud del Brasile da un gruppo di italiani anarchici alla fine dell’Ottocento, le esperienze realizzate dalle colonie americane, di carattere religioso, sempre alla fine dell’Ottocento, e altre esperienze avvenute in diversi luoghi e momenti della storia e infine i collettivi spagnoli durante la guerra civile degli anni 1936-‘39. Il risultato di questa ricerca è stata la redazione dei capitoli tre, quattro, cinque e sei di questa tesi. L’obiettivo è stato quello di trovare, tra tutti questi casi, punti in comune che potessero portare a una teoria della produzione collettiva e comunitaria nell’ottica del movimento anarchico. Conclusa questa parte più storica, mi sono dedicata allo studio dei casi attuali messi in pratica nell’ottica dello sviluppo locale autosostenibile come modo di produrre la valorizzazione del patrimonio territoriale. Mi sono dedicata allo studio del concetto di sviluppo locale autosostenibile, cercando di capire quali sono state le sue origini, quali sono i suoi assi fondanti per poi passare a occuparmi dello studio delle esperienze messe in pratica a partire di questa prospettiva. Di fondamentale importanza è stato l’aiuto che 13 mi è stato offerto dal Prof. MAGNAGHI, che ha letto il mio progetto di ricerca e mi ha suggerito la maggior parte dei casi di studio che compongono i capitoli otto e nove di questa tesi. Ugualmente importante per lo svolgere dei lavori d’indagine sono state le costanti verifiche fatte dal collegio docente del Corso di Dottorato, esperienza che ritengo molto produttiva. Da un lato, attraverso l’obbligo della consegna delle tesine annuali, che ci ha imposto sin dall’inizio un ritmo di lavoro intenso, i cui risultati diventavano via via evidenti. Dall’altro, il confronto con un collegio docente tanto plurale che ci ha permesso una valutazione del lavoro in chiave più globale e meno specialistica. Questo è stato, a mio parere, il punto più ricco e allo stesso tempo più difficile da affrontare e, proprio per questo, più stimolante del Corso di Dottorato che concludo con la consegna e discussione di questa tesi. Spero di essere stata in grado di rispondere attraverso questa tesi almeno parte delle obiezioni che mi sono state fatte nel trascorrere di questi tre anni. Ho sicuramente imparato ad affrontare approcci e sguardi diversi allo stesso problema e credo di averli incorporati, anche se sotto uno sguardo e un discorso più geografico, all’interno di questa tesi e della mia pratica futura. Infine, credo di poter dire che esco da questo percorso molto più matura di quando sono entrata. La tesi che ora presento in discussione è composta di nove capitoli divisi in tre parti. La prima parte, intitolata INQUADRAMENTO STORICO, è suddivisa in tre capitoli. Il primo, Le radici storiche della discussione, tratta del quadro storico che ha dato origine al movimento anarchico, attraverso l’analisi della rivoluzione Industriale, della Rivoluzione Francese, e degli avvenimenti che le hanno succedute. Il secondo capitolo, Il movimento anarchico e le proposte di organizzazione sociale della produzione, tratta delle origini dell’anarchia, della prima sistemazione del pensiero anarchico con GODWIN, del significato vero e proprio dell’anarchia e delle scuole di pensiero anarchiche – individualista, mutualista, collettivista e comunista – e delle loro proposte di organizzazione sociale della produzione. Il terzo capitolo, L’emigrazione italiana in Brasile dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento, tratta della situazione vissuta sia dall’Italia che dal Brasile e che ha scatenato il processo migratorio dall’Italia verso il Brasile, dell’introduzione degli emigranti in Brasile nelle fazendas di caffè a San Paolo e nelle colonie nel sud del paese, cercando di sottolineare l’importanza dell’emigrazione italiana nel cambiamento del paesaggio agrario brasiliano e di ricostruire il momento storico che ha dato origine a una delle più importanti esperienze di produzione comunitaria anarchica in Brasile. La seconda parte, LE «VECCHIE» UTOPIE, è anch’essa suddivisa in tre capitoli. Il quarto capitolo, La prassi anarchica: Giovanni Rossi e la Colonia Cecilia, tratta del percorso 14 tracciato da Giovanni Rossi, uno dei più importanti anarchici sperimentalisti, dalla realizzazione della sua utopia Un comune socialista fino alla messa in pratica delle sue idee attraverso la realizzazione della Colonia Cecilia, cercando di sottolineare l’evolvere delle sue idee, dalla difesa dello sperimentalismo attraverso la pubblicazione della sua utopia e del giornale «Lo Sperimentale» e la polemica con gli anarchici, dal tentativo di costruzione di una colonia socialista sperimentale in Italia durante il suo soggiorno come veterinario a Gavardo, nel nord d’Italia attraverso Cittadella fino alla realizzazione della colonia Cecilia avendo come base il comunismo anarchico. Il quinto capitolo, Altre esperienze di colonie socialiste tratta, appunto, basandosi sui casi citati da Rossi nel suo «Lo Sperimentale», di altri casi di colonie socialiste realizzati in diverse località, con speciale attenzione alle colonie americane, così come dell’esperienza di produzione collettiva attraverso i collettivi spagnoli durante la guerra civile del 1936-‘39. Il sesto capitolo, Per una teoria della produzione collettiva e comunitaria all’interno del movimento anarchico, corrisponde a un tentativo di costruzione di una teoria della produzione collettiva e comunitaria a partire da un lato, dagli esempi studiati in questa tesi e dalle conoscenze accumulate dagli studi precedenti e, dall’altro, dalla produzione teorica dei suoi più importanti difensori, BAKUNIN e KROPOTKIN. La terza parte, LE «NUOVE» UTOPIE è anch’essa suddivisa in tre capitoli. Il settimo capitolo, Sviluppo locale autosostenibile: un progetto per la valorizzazione del patrimonio territoriale, tratta della discussione teorica sullo sviluppo locale autosostenibile: della trasformazione del territorio da supporto a patrimonio; delle origini del concetto di sviluppo locale autosostenibile; di come esso può essere utilizzato per la valorizzazione del patrimonio territoriale e delle tappe che devono essere percorse verso il raggiungimento dell’autosostenibilità dello sviluppo locale. L’ottavo capitolo, Lo sviluppo locale autosostenibile nella pratica I. Verso un’altra produzione, tratta di quattro tipi diversi di esperienze di una produzione alternativa nell’ottica dello sviluppo locale autosostenibile: il Laboratorio ANCI Val di Bisenzio, esperienza pilota di realizzazione pratica delle idee contenute nel capitolo precedente; la pratica di un’agricoltura nel totale rispetto della natura attraverso l’agricoltura naturale e l’agricoltura sinergica; la proposta di recupero e valorizzazione dei prodotti locali in via d’estinzione messe in moto dal movimento Slow Food soprattutto attraverso i suoi Presìdi; il ritorno al tema delle comunità attraverso gli ecovillaggi. Il nono capitolo, Lo sviluppo locale autosostenibile nella pratica II. Verso un altro mercato, tratta dei mercati alternativi nati sempre all’interno di quest’ottica di ricerca dell’autosostenibilità dello sviluppo. In questo capitolo, vengono studiati i casi del Consorzio Radici, a Suvereto, tentativo di recupero di prodotti locali attraverso una 15 pratica agricola capace di promuovere la valorizzazione del patrimonio territoriale e di rimessa di questi prodotti nel circuito commerciale; la Fierucola di Firenze, tentativo di unire produzione e commercializzazione alternative, attraverso la costruzione di un mercato con una morale; i Gruppi di Acquisto Solidale e l’esperienza del consumo critico; la pratica di un commercio equo e solidale messo in moto dalla Ctm altromercato. Infine, nella Conclusione, viene riassunta la tesi maturata nel corso del lavoro e cioè che le idee contenute nella nuova utopia dello sviluppo locale autosostenibile e praticate attraverso le nuove utopie analizzate nell’ottavo e nono capitolo erano state già enunciate attraverso le vecchie utopie della società libertaria anarchica. In fondo a questa tesi, come Allegati, si possono trovare i seguenti documenti: 1. La Produzione intellettuale di Piotr KROPOTKIN: analisi dei libri Parole di un ribelle, La conquista del pane, Il mutuo appoggio, Campi, fabbriche e officine. 2. Manifesto Slow Food 3. Manifesto dell’Arca 4. Depliant “Carciofo violetto della Val di Cornia: una coltura tipica e autoctona che vogliamo promuovere e rilanciare per la salubrità e la qualità nel territorio e sulla tavola” 5. Scheda Produttori GAS 6. Intervista a Libereso Guglielmi 7. Intervista a Walter Gasperini – Consorzio Radici – Suvereto, Toscana. 8. Intervista a David Fanfano – Laboratorio Anci Toscana Val di Bisenzio – Prato, Toscana 9. Intervista ad Antonio De Falco – Agricoltura sinergica 10. Intervista a Giannozzo Pucci – Fierucola a Firenze 11. Intervista a Marilia Zappalà e Marco Naldini – Ecovillaggio Basilico. 16 CAPITOLO 1 LE RADICI STORICHE DELLA DISCUSSIONE La discussione sulle forme di organizzazione sociale della produzione fu realizzata all’interno di una discussione più ampia, relativa all’organizzazione di una nuova società, fatta da intellettuali e militanti di partiti politici con differenti concezioni sul tema. Perché si possa capire non solo lo svolgimento di questa discussione nella sua integrità, ma soprattutto il significato delle proposte da essa risultanti, è necessario situare sinteticamente il contesto e il momento storico in cui si svolse. L’Ottocento è stato un secolo senza pari per l’umanità. È stato un secolo di intensi dibattiti a livello politico, intellettuale, sociale; di formazione di una classe operaia e di costituzione di una coscienza di classe; della realizzazione di innumerevoli movimenti e rivoluzioni sociali; di sviluppo delle scienze e delle ricerche di forme di superamento di una realtà di sfruttamento e oppressione dovuta al modo in cui si sviluppava il capitalismo. Il punto di partenza di questi importanti cambiamenti dev’essere cercato alla fine del Settecento, più specificamente nelle due rivoluzioni che hanno segnato l’inizio di queste trasformazioni: la Rivoluzione Industriale e la Rivoluzione Francese. 1. Il mondo alle porte delle rivoluzioni industriale e francese Secondo HOBSBAWM, il mondo alle porte di ciò che viene da lui chiamata “la duplice rivoluzione”, ossia nel decennio 1780, era allo stesso tempo più piccolo e molto più vasto di quanto lo conosciamo oggi. Più piccolo perché anche le persone più istruite conoscevano appena una parte di esso, perché la popolazione era numericamente minore dell’attuale e più sparsamente distribuita. Molto più vasto perché le difficoltà di comunicazioni – il trasporto era soprattutto fluviale e marittimo – lo rendevano ancora 17 più irraggiungibile e facevano sì che la maggioranza delle persone morisse senza mai aver messo piede fuori del suo “piccolo mondo”. Nel decennio 1780 il mondo era anche prevalentemente rurale, anche nelle aree con forte tradizione urbana. Il problema agrario era poi fondamentale, e il suo punto cruciale era “quello dei rapporti tra quelli che coltivavano la terra e quelli che ne erano i proprietari, tra quelli che producevano ricchezza e quelli che l’accumulavano” (HOBSBAWM, 1988:26/27). L’Europa – il complesso economico il cui centro si trovava nell’Europa occidentale – era divisa in tre grandi settori. A ovest dell’Europa erano le colonie, la cui economia era parte integrante di quella europea, e si basava sulle grandi proprietà (latifondi) dove schiavi si dedicavano a piantagioni di alcune derrate di vitale importanza destinate all’esportazione, come zucchero, tabacco, caffè, sostanze coloranti (come il pau brasil, albero tipico brasiliano) e, dopo la Rivoluzione Industriale, il cotone. A est dell’Europa occidentale si stendeva la regione della servitù della gleba, con qualche piccola zona dove i contadini erano tecnicamente liberi. Nel resto dell’Europa, nonostante la struttura agraria fosse socialmente simile, ossia, chiunque possedesse una proprietà era un “signore” e membro della classe dirigente e per quanto la nobiltà o la signoria fosse inconcepibile senza la proprietà terriera, dal punto di vista economico la società rurale era molto diversa. “Il tipico coltivatore del suolo era il contadino, più o meno libero, che gestiva appezzamenti di grande, media o piccola estensione” (HOBSBAWM, 1988:31). La proprietà tipica era stata trasformata in una forma di affitto o altri rendimenti monetari, e il contadino continuava a dovere una serie di obblighi al signore locale, tasse al principe e decime alla Chiesa. Ma se tutto ciò venisse tolto, questa parte dell’Europa si sarebbe presentata come un’enorme area di agricoltura contadina, dove pochi contadini sarebbero diventati grandi produttori commerciali e una maggioranza, invece, avrebbe vissuto della sua propria proprietà di forma più o meno autosufficiente. Soltanto poche aree – tra le quali l’Inghilterra era la più importante – si erano sviluppate verso un tipo di agricoltura tipicamente capitalista. In queste aree la proprietà era molto concentrata e il produttore tipico era un affittuario che lavorava la terra basandosi sulla manodopera salariata. Il mondo del commercio e dei manufatti era, invece, molto dinamico e vivace, e cresceva soprattutto grazie alle colonie. Si esportavano i manufatti e s’importavano i prodotti agricoli e, nel caso dell’Africa, anche gli uomini, che venivano schiavizzati nelle Americhe1. Lo Stato più importante era la Gran Bretagna grazie al suo sviluppo economico. Tutti gli altri stati europei che volevano raggiungere lo stesso successo cercavano di imitarla, investendo nello sviluppo economico, in particolare del settore 1 Questo tipo di commercio perdurerà fino ai primi decenni dell’Ottocento, quando allora esso verrà vietato dall’Inghilterra. 18 industriale. Le scienze, non ancora divise dall’accademismo, si dedicavano alla risoluzione di problemi pratici e contribuivano così al progresso economico. Dal punto di vista politico, a eccezione della Gran Bretagna e di alcuni pochi stati minori, la monarchia assoluta regnava in Europa e, nonostante essa fosse circondata da una classe media “illuminata”, non aveva intenzione di dedicarsi alla totale trasformazione economica e sociale che il progresso dell’economia e i gruppi sociali ascendenti richiedevano. “Vi era dunque un antagonismo latente, che ben presto sarebbe sfociato in un aperto conflitto, tra le forze della vecchia e della nuova società, la società «borghese», e quest’ultima non poteva essere inserita nel quadro degli esistenti regimi politici, tranne, naturalmente, là dove essi impersonavano già il trionfo della borghesia, ad esempio in Gran Bretagna. Ciò che rendeva ancora più vulnerabili tali regimi era il fatto che venivano sottoposti a una triplice pressione, dovuta alle nuove forze, alla resistenza intransigente e sempre più tenace degli antichi interessi padronali, e alle rivalità straniere” (HOBSBAWM, 1988:39/40). La rapida e crescente espansione del commercio e dell’iniziativa capitalista europea in tutte le parti del mondo minava alla base l’ordine sociale delle civiltà preesistenti. “Quella che è stata chiamata «l’èra Vasco da Gama», i quattro secoli di storia mondiale nei quali un gruppo di stati europei e le forze del capitalismo stabilirono una dominazione completa anche se temporanea (…) sul mondo intero, stava per raggiungere il suo apice. La duplice rivoluzione avrebbe reso vana ogni resistenza all’espansione europea, ma avrebbe anche fornito al mondo extra-europeo le condizioni e i mezzi per sferrare il contrattacco finale” (HOBSBAWM, 1988:42). 2. La Rivoluzione Industriale Secondo HOBSBAWM, le ripercussioni della Rivoluzione Industriale – iniziata nel decennio 1780 e realizzata tra il 1780 e il 1800 – non si fecero sentire fuori dell’Inghilterra prima del 1830 oppure del 1840. Ritenuta uno degli avvenimenti più importanti della storia, la Rivoluzione Industriale non fu un episodio con un principio e una fine. Infatti sarebbe più corretto domandarsi quando “le trasformazioni economiche siano giunte ad una fase tanto avanzata da determinare la formazione di un’economia sostanzialmente industriale, capace di produrre qualsiasi merce nei limiti imposti dai mezzi tecnici esistenti, cioè, detta in linguaggio tecnico, un’economia industriale matura” (HOBSBAWM, 1988:47). Inoltre, furono necessarie poche raffinatezze intellettuali per realizzarla dato che, almeno all’inizio, le sue innovazioni erano molto modeste. 19 In Gran Bretagna il processo iniziò in un certo momento tra gli anni 1780 e 1800, dopo l’improvvisa ascesa economica verificatasi in quegli anni, e finì con la costruzione delle ferrovie e la creazione dell’industria pesante nel decennio successivo al 1840. Infatti, la maggior parte dell’espansione industriale del XVIII secolo non aveva portato immediatamente a una rivoluzione vera e propria, ossia, alla creazione di un “sistema di fabbriche” che producesse in modo totalmente meccanizzato una quantità sempre più crescente di merce, a prezzi sempre più decrescenti, capace così di creare il suo proprio mercato. Anzi, l’aumento della produzione continuava a darsi nella fase iniziale, sostanzialmente alla vecchia maniera. Perché la Rivoluzione Industriale potesse avvenire erano necessari non solo un’industria già esistente che offrisse guadagni in grado di stimolare i fabbricanti a sviluppare rapidamente la sua produzione, basandosi su piccole innovazioni non tanto costose, ma anche un mercato mondiale ampiamente monopolizzato da un’unica nazione produttrice. Soltanto la Gran Bretagna aveva un’economia sufficientemente forte e uno Stato sufficientemente aggressivo per poter conquistare i mercati e avviare così il processo di industrializzazione. La prima industria britannica a svilupparsi fu quella cotoniera, inizialmente come un prodotto marginale del commercio d’oltreoceano. Il successo ottenuto da essa nel mercato nazionale fu modesto, ma proficuo. Fu il commercio coloniale a creare e alimentare per molto tempo questa industria, tanto da poter descrivere la Rivoluzione Industriale come il trionfo del mercato di esportazione su quello nazionale. E all’interno del mercato esterno, quello coloniale o semi coloniale si costituì nel principale sbocco per le merci britanniche. Le possibilità di guadagni offerti dal cotone incentivavano gli impresari privati a lanciarsi all’avventura della Rivoluzione Industriale. Le innovazioni tecniche erano a basso costo e presto venivano ammortizzate dagli alti rendimenti provenienti del commercio. Inoltre, le materie prime provenivano dall’estero (soprattutto dagli USA), dove non esistevano problemi per l’espansione delle coltivazioni. Così, l’industria cotoniera fu la prima a beneficiare dei progressi tecnologici2 ed ebbe un gran dominio sui movimenti di tutta l’economia britannica per molto tempo. Ma questa crescita non fu sempre tranquilla e negli anni intorno al 1830 la miseria e il malcontento popolare derivati dal passaggio dalla vecchia alla nuova economia erano sempre più preoccupanti. Oltre ai lavoratori e ai poveri della città, i modesti uomini d’affari, la piccola borghesia e altri settori particolari dell’economia erano anch’essi vittime delle 2 La produzione meccanizzata in altri settori tessili, come quello del lino, ebbe uno sviluppo lento fino al decennio 1840 e in altri settori fu quasi trascurabile. 20 trasformazioni in corso ed erano molto insoddisfatti della direzione che esse avevano preso. Lo sfruttamento dei lavoratori tramite il contenimento dei salari sulla soglia della sussistenza, mentre i ricchi accumulavano guadagni che finanziavano l’industrializzazione, creava un conflitto con il proletariato. Ma nell’ottica capitalista ciò che veramente preoccupava erano le falle che cominciavano a minare la forza motrice fondamentale di tutta l’economia. “Le tre falle più evidenti erano il ciclo commerciale del rialzo e del ribasso, la tendenza dei profitti a diminuire, e – ciò che era poi lo stesso – l’impossibilità di investimenti redditizi” (HOBSBAWM, 1988:60). Il primo non era considerato un problema serio, ma il secondo sì e, per evitarlo, si investiva nella meccanizzazione, aumentando la produttività della manodopera; si dava la preferenza alla contrattazione di donne e bambini che percepivano salari ancora più bassi; si riducevano i costi della produzione, tramite la riduzione dei salari, la contrattazione di manodopera non specializzata e l’utilizzo maggiore delle macchine. Ma esisteva un minimo fisiologico oltre al quale non si poteva andare, pena il non garantire la riproduzione fisica dei lavoratori. Per poter oltrepassare tale minimo era necessario diminuire il costo della vita, e con tale obiettivo gli impresari cominciarono a far pressione sul governo per abolire le leggi di protezione all’agricoltura, pensando che così il costo della vita sarebbe diminuito automaticamente. Ma questo non avvenne con la velocità attesa e ciò costrinse l’industria a meccanizzarsi ancora di più per compensare la diminuzione dei margini di profitto. Un altro fatto importante è che nessuna economia industriale può svilupparsi oltre certi limiti se non possiede una capacità adeguata di capitale-merce. Ma in un contesto di imprese private, l’investimento di capitale necessario è estremamente alto e non attrae gli investitori perché non esiste un mercato di massa per la sua produzione. Questi svantaggi colpivano particolarmente la metallurgia, specialmente la siderurgia, ma non toccavano l’industria mineraria, principalmente costituita da miniere del carbone, che era, allo stesso tempo, la principale energia motrice delle industrie e il principale combustibile per uso domestico. L’industria del carbone non chiedeva e né passò per un’importante rivoluzione tecnologica, ma ebbe la forza sufficiente per diventare la responsabile per lo stimolo all’invenzione che avrebbe trasformato le industrie delle materie prime: la ferrovia. Questa fu la risposta dell’industria mineraria del carbone alla necessità di trovare “mezzi adeguati per trasportare enormi quantità di carbone dal fronte carbonifero ai pozzi e specialmente dai pozzi ai punti di imbarco. Una soluzione semplice era la «tramvia» o la «strada ferrata» su cui far scorrere le ruote dei carrelli (…). La ferrovia è figlia della miniera, e in particolare della miniera di carbone dell’Inghilterra settentrionale” (HOBSBAWM, 1988:66). 21 Il capitale necessario a tale espansione proveniva da una classe media che per anni aveva risparmiato e che ora cercava un settore lucrativo nel quale poter investire. Ma non bastava il capitale per portare avanti l’attività industriale: ci volevano i lavoratori. Se trovare i lavoratori era già un’impresa difficile, trovare quelli con le necessarie qualificazioni e abilità lo era ancora di più. Fu necessario trasformare il lavoratore. Ogni operaio dovette imparare a lavorare a un ritmo regolare, giornaliero e ininterrotto, necessario alla produzione industriale. Dovette anche imparare a rispondere agli incentivi monetari: la strategia utilizzata fu il pagamento di salari molto bassi, in modo che i lavoratori fossero obbligati a lavorare instancabilmente per tutta la settimana per poter riuscire ad avere un guadagno minimo. Per risolvere i problemi della disciplina del lavoro all’interno delle fabbriche gli industriali contrattavano le donne e i bambini – “più facili da trattare” – o si servivano del subappalto, ossia, contrattavano effettivamente solo i lavoratori specializzati che dovevano cercare gli aiutanti per conto proprio, trasformandosi così nei veri datori di lavoro dei loro aiutanti e, soprattutto, nei responsabili per la disciplina del lavoro. Paragonati ai problemi con i lavoratori, i problemi che riguardavano il capitale diventavano insignificanti. 3. La Rivoluzione Francese “Se l’economia del mondo del secolo XIX scaturì soprattutto dall’influenza della Rivoluzione Industriale britannica, la sua politica e la sua ideologia scaturirono soprattutto dalla Rivoluzione Francese. La Gran Bretagna fornì al mondo il modello per la costruzione delle ferrovie e delle fabbriche, l’esplosivo economico che fece crollare le tradizionali strutture economiche e sociali del mondo non europeo; ma la Francia ebbe le sue rivoluzioni e infuse in esse degli ideali tanto potenti che la bandiera tricolore divenne l’emblema di quasi tutte le nazioni nuove (…). La Francia fornì alla maggior parte del mondo il vocabolario e le finalità della politica liberale e democratico-liberale. La Francia fornì il primo grande esempio, il concetto e il vocabolario del nazionalismo. La Francia fornì a moltissimi paesi i codici legali, il modello di un’organizzazione scientifica e tecnica, il sistema metrico decimale. Grazie all’influenza francese l’ideologia del mondo moderno fece breccia per la prima volta in quelle antiche civiltà che, fino a quel momento, avevano resistito alle idee europee. Tutto ciò fu opera della Rivoluzione Francese” (HOBSBAWM, 1988:81/82). Secondo HOBSBAWM, la Rivoluzione Francese non fu un fenomeno isolato, ma fu molto più radicale di qualunque altra rivoluzione contemporanea. Le sue conseguenze furono molto più profonde, e questo per tre motivi: primo, perché essa avvenne in quello 22 che era il più potente e popoloso Stato d’Europa (esclusa la Russia); secondo, perché fu l’unica rivoluzione sociale di massima, infinitamente più radicale di qualunque altra sollevazione popolare; terzo, tra tutte le rivoluzioni contemporanee, fu l’unica ecumenica. La Rivoluzione Francese rimane così la rivoluzione di quel tempo, e le sue origini debbono essere ricercate non solo nelle condizioni generali dell’Europa ma in quella specifica della Francia. Essa fu, durante tutto il XVIII secolo, la maggiore rivale economica internazionale della Gran Bretagna, ma senza essere mai una potenza di quel porte. La situazione della nobiltà in Francia era piuttosto tranquilla: i nobili godevano di molti privilegi, come l’esenzione fiscale e il diritto di percepire tributi feudali. Politicamente, però, la monarchia assoluta li aveva privati dalla loro indipendenza e iniziativa politica e aveva abolito, a più riprese, le loro antiche istituzioni rappresentative, come gli états e i parlements. Quando la situazione economica cominciò a cambiare, per poter controbilanciare il declino delle loro rendite, cercarono di sfruttare l’unica loro prerogativa: i privilegi riconosciuti della loro classe. E lo fecero tramite l’usurpazione delle cariche ufficiali che la monarchia assoluta aveva preferito affidare a uomini della borghesia, e attraverso lo sfruttamento al massimo dei loro diritti feudali di esigere denaro o prestazioni dai contadini. Nel fare questo, i nobili esasperavano allo stesso tempo la borghesia e i contadini, questi ultimi nella loro maggioranza nullatenenti o quasi, la cui situazione si aggravava con i tributi che dovevano pagare – i diritti feudali, le decime e le tasse – che toglievano una parte sempre più grande delle loro entrate. Le difficoltà finanziarie della monarchia precipitarono gli eventi: i tentativi di riforma per sanare la struttura amministrativa e fiscale del regno, compiuti nel 1774-76, furono sconfitti dagli interessi padronali rappresentati dai parlements. Inoltre, la Francia fu coinvolta nella guerra d’indipendenza americana, ed ebbe la vittoria sull’Inghilterra al prezzo della sua completa bancarotta. L’aristocrazia e i parlements approfittarono della crisi del governo e “si rifiutarono di pagare se non fossero stati estesi i loro privilegi. (…) La Rivoluzione cominciò quindi col tentativo dell’aristocrazia di impadronirsi nuovamente dello stato. Fu un tentativo sbagliato per due motivi: esso sottovalutava le aspirazioni indipendentiste del «terzo stato» – quell’entità fittizia che avrebbe dovuto rappresentare tutti coloro che non appartenevano né alla nobiltà né al clero, ma che in realtà era dominata dalla borghesia – e trascurava la profonda crisi economica e sociale in mezzo alla quale faceva cadere le sue richieste politiche” (HOBSBAWM, 1988:87). 23 La Rivoluzione Francese ebbe uno straordinario consenso di idee generali in seno a un gruppo sociale abbastanza compatto: la borghesia. Le “sue idee erano quelle del liberalismo classico, quali erano state formulate dai «filosofi», dagli «economisti» e propagate dalla massoneria e da associazioni a carattere non ufficiale. Sotto questo aspetto il merito della Rivoluzione può essere giustamente attribuito ai «filosofi». Sarebbe certo scoppiata anche senza di loro; ma grazie a loro essa non segnò soltanto il crollo di un vecchio regime, bensì l’avvento rapido ed effettivo di un regime nuovo” (HOBSBAWM, 1988:88). In termini generali, l’ideologia del 1789 era quella massonica. “In particolare, le richieste dei borghesi del 1789 sono contenute nella famosa Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino pubblicata in quello stesso anno. Questo documento è un manifesto contro la società gerarchica e i privilegi dell’aristocrazia, ma non in favore di una società democratica o fondata sull’uguaglianza. «Gli uomini sono nati per vivere liberi e uguali di fronte alla legge», dice il primo articolo; ma poi ammette l’esistenza di talune distinzioni sociali, sia pur determinate «soltanto sulla base dell’utilità collettiva». La proprietà privata è un diritto naturale, sacro, inalienabile e inviolabile. Gli uomini sono uguali di fronte alla legge e tutte le carriere sono ugualmente aperte al talento: ma anche se la corsa s’inizia alla pari, si presuppone già che non tutti i concorrenti arriveranno insieme al traguardo. La dichiarazione stabiliva (…) che «tutti i cittadini hanno il diritto di collaborare alla formazione della legge»: ma «o personalmente o tramite i loro rappresentanti». E l’assemblea rappresentativa di cui essa prevedeva l’esistenza quale organo fondamentale di governo non era necessariamente un’assemblea democraticamente eletta, né il regime da essa proposto escludeva l’esistenza dei re. Una monarchia costituzionale basata su una oligarchia dei proprietari che facesse sentire la propria voce attraverso un’assemblea rappresentativa era più conforme alle aspirazioni della maggior parte dei borghesi liberali di quanto non lo fosse una repubblica democratica, che pure sarebbe sembrata un’espressione più logica delle loro aspirazioni teoriche (…). Tutto sommato, dunque, il classico borghese liberale del 1789 – e il liberale del 1789-1848 – non era un democratico, bensì uno che credeva nel costituzionalismo, cioè in uno stato laico caratterizzato dalle libertà civili, che garantisse l’iniziativa privata, governato dai contribuenti e dai proprietari” (HOBSBAWM, 1988:88/89). Per rappresentare il Terzo Stato furono eletti 610 uomini, tra contadini e poveri della città, avvocati, capitalisti e uomini d’affari. La borghesia lottò prima per ottenere una rappresentanza altrettanto numerosa di quella della nobiltà e del clero uniti, e poi per il diritto di sfruttare la maggioranza potenziale dei suoi voti, trasformando gli Stati Generali in un’assemblea di deputati con diritto di voto individuale, in sostituzione della tradizionale assemblea feudale dove si votava e si deliberava per “stato”. Questa fu la 24 prima vittoria rivoluzionaria. Poco dopo la convocazione degli Stati Generali, i Comuni si costituirono come Assemblea Nazionale con il diritto di riformare la costituzione. Il Terzo Stato vinse la resistenza del re e degli altri ordini privilegiati perché rappresentava non solo le aspirazioni di una minoranza colta e militante, ma anche di forze molto più potenti: i lavoratori della città e i contadini rivoluzionari. La profonda crisi economica e sociale che colpiva questi ultimi in modo significativo trasformò un’agitazione di riforma in una rivoluzione. In più, mise alle spalle del Terzo Stato un popolo in rivolta. “La controrivoluzione trasformò una sollevazione potenziale delle masse in una sollevazione reale. (…) La conseguenza più sensazionale di questa mobilitazione fu la presa della Bastiglia, [la quale] (…) ratificò la caduta del despotismo e fu salutata in tutto il mondo come l’inizio della liberazione” (HOBSBAWM, 1988:91). Tre settimane dopo, la struttura sociale del feudalesimo rurale francese e la macchina statale erano state distrutte ed “entro il 1793 tutti i privilegi feudali vennero ufficialmente aboliti. Alla fine d’agosto la Rivoluzione ebbe anche il suo manifesto formale: la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino” (HOBSBAWM, 1988:92). Solo il re continuò a resistere. Secondo HOBSBAWM, la singolarità della Rivoluzione Francese si deve al fatto che un settore della borghesia era deciso a rimanere rivoluzionario: il giacobino. Questo perché, da un lato, la borghesia non aveva ancora nulla da temere; dall’altro, non esisteva un’altra classe che potesse offrire un’alternativa sociale coerente. Essa sarebbe creata in seguito, nel corso della Rivoluzione Industriale, col proletariato. Ma durante la Rivoluzione Francese la classe operaia non aveva una voce propria: si ribellava, è vero, ma lo faceva seguendo i capi non proletari. L’unica alternativa al radicalismo borghese giacobino erano i sans-culottes, un movimento informe, soprattutto urbano, formato da lavoratori poveri, che cercava di esprimere gli interessi della massa di “piccoli uomini” compresa tra la “borghesia” e il “proletariato”, più vicina a quest’ultimo perché sostanzialmente composta dalla povera gente. Ma nemmeno loro riuscirono a offrire un’alternativa reale. Tra il 1789 e il 1791 la borghesia moderata attuò, attraverso l’Assemblea Costituente, la razionalizzazione e riforma della Francia, compiendo realizzazioni importanti a livello internazionale. “Dal punto di vista economico, l’indirizzo dell’Assemblea Costituente era completamente liberale: la sua politica prevedeva per i contadini la suddivisione delle terre comuni e l’incoraggiamento delle imprese agricole, per la classe operaia l’abolizione delle associazioni sindacali, per i piccoli artigiani l’abolizione delle corporazioni e delle associazioni d’arti e mestieri. Essa diede ben poche soddisfazioni concrete 25 alla gente comune, se si eccettua, dal 1790 in poi, la confisca e la vendita delle proprietà della chiesa e di quelle dei nobili emigrati; il che ebbe il triplice vantaggio di indebolire il clero, di rafforzare le imprese provinciali e contadine e di dare a molti un compenso tangibile per la loro attività rivoluzionaria. La Costituente del 1791 scongiurava il pericolo di una eccessiva democrazia mediante un sistema di monarchia costituzionale basato sul diritto di libera proprietà concesso ai «cittadini attivi»” (HOBSBAWM, 1988:95). Da parte sua, la monarchia non accettava questa situazione e la corte sognava e tramava una crociata per restituire il potere al re. Ma “la Costituzione civile del clero (1790), (…) inteso a distruggere non la Chiesa ma il potere assolutista romano della Chiesa, spinse la maggioranza del clero e dei fedeli a passare all’opposizione, e contribuì ad indurre il re a compiere il tentativo disperato – e (…) suicida – di fuggire dal paese” (HOBSBAWM, 1988:95). Egli venne ripreso e da allora in poi il repubblicanesimo divenne una forza di massa. Per completare il quadro, l’economia delle libere imprese private accentuava la fluttuazione dei prezzi e, insieme a essi, del malcontento delle masse rivoluzionarie. Scoppiò la guerra e questo aggravò ancora di più la situazione, portando a una seconda rivoluzione nel 1792, alla Repubblica Giacobina dell’Anno II, e in seguito a Napoleone. Secondo HOBSBAWM, due forze portarono la Francia a una guerra generale: l’estrema destra e la sinistra moderata. La destra cercò in tutti i modi, attraverso l’intervento straniero, di restaurare l’antico regime. Allo stesso tempo, i liberali moderati erano una forza belligerante, poi ritenevano che “la liberazione della Francia non era che il primo passo verso il trionfo universale della libertà (…). [Fino al 1848, tutti] i progetti di liberazione europea furono imperniati su una sollevazione unanime di tutti i popoli sotto la guida della Francia per abbattere la reazione europea” (HOBSBAWM, 1988:97). Inoltre, la guerra avrebbe potuto risolvere vari problemi interni, attribuendo le difficoltà del nuovo regime alle macchinazioni degli emigrati e degli stranieri e riversando su di loro il malcontento popolare. In più, piano piano si costruiva l’idea, soprattutto tra gli uomini d’affari, che la supremazia economica era frutto di una sistematica aggressività. Per questi motivi la maggioranza della nuova Assemblea Legislativa predicava la guerra. E anche per questo, quando essa arrivò, le conquiste della rivoluzione portarono la libertà, ma anche le speculazioni e le deviazioni politiche. “La guerra venne dichiarata nell’aprile 1792. La sconfitta, che il popolo (…) attribuì ai sabotaggi e ai tradimenti perpetrati dal re, portò alla radicalizzazione. Nell’agosto-settembre venne rovesciata la monarchia, istituita la Repubblica una e indivisibile, proclamata una nuova era della storia dell’umanità con l’istituzione dell’Anno I del calendario rivoluzionario, in 26 seguito all’insurrezione armata dei sans-culottes di Parigi. L’età ferrea ed eroica della Rivoluzione Francese iniziò con i massacri dei prigionieri politici, con l’elezione della Convenzione Nazionale (…) e l’incitamento alla resistenza totale contro gli invasori” (HOBSBAWM, 1988:97). Nella guerra della rivoluzione non esistevano forze stabilite: si oscillava tra la massima vittoria che avrebbe portato alla rivoluzione mondiale, e la massima sconfitta, che avrebbe significato il trionfo della controrivoluzione. Soltanto con metodi rivoluzionari senza precedenti si poteva vincere una guerra come questa. E questi metodi furono trovati. “In quel periodo di crisi, la giovane Repubblica Francese scoperse o inventò la guerra totale: la mobilitazione generale di tutte le risorse nazionali mediante la coscrizione, il razionamento e un’economia di guerra rigidamente controllata, e abolendo praticamente, in patria e all’estero, ogni distinzione tra soldati e civili” (HOBSBAWM, 1988:98/99). Nel marzo 1793 la Francia era in guerra contro la maggior parte dell’Europa e aveva già iniziato le annessioni dei territori stranieri. L’immagine “comune” della Rivoluzione Francese è quella della Repubblica Giacobina dell’Anno II. I conservatori crearono un’immagine indimenticabile del “Terrore”, della dittatura e della furia sanguinaria che vigeva, ciò nonostante, se paragonata ad altre repressioni o rivoluzioni sociali, le sue furono azioni modeste. Per i rivoluzionari, invece, essa fu la prima repubblica del popolo, l’ispirazione di tutte le rivolte che le successero. Per loro, e per la maggioranza della Convenzione Nazionale, anche con tutti i suoi difetti, il Terrore era l’unica forma di preservare la Rivoluzione, lo Stato Nazionale, la Nazione. Il primo compito dei giacobini fu quello di mobilitare le masse contro la dissidenza della Gironda e dei notabili provinciali, conservando allo stesso tempo l’appoggio massiccio dei sans-cullotes. “Venne proclamata una costituzione nuova di indirizzo piuttosto radicale (…). In base a questo nobile ma accademico documento veniva concesso al popolo il suffragio universale, il diritto all’insurrezione, al lavoro e all’assistenza, nonché – più importante di tutto – la dichiarazione ufficiale che lo scopo del governo era il benessere di tutti e che i diritti del popolo dovevano essere non soltanto potenziali ma operanti. Era la prima costituzione veramente democratica proclamata da uno stato moderno” (HOBSBAWM, 1988:101). Concretamente, i giacobini abolirono tutti i diritti feudali senza indennizzo, facilitarono ai piccoli risparmiatori l’accesso alle terre confiscate dagli emigrati e abolirono la schiavitù nelle colonie francesi con l’obiettivo di stimolare i neri di San Domenico a combattere per la Repubblica contro gli inglesi. 27 Il centro del governo si spostò a sinistra, e la prova di ciò fu il rimaneggiamento del Comitato di Salute Pubblica che presto diventò il Ministero della Guerra Francese. Robespierre divenne il membro più influente. Per lui, la Repubblica Giacobina “era un ideale: il terribile e glorioso regno della giustizia e della virtù, dove tutti i buoni cittadini erano uguali agli occhi della nazione e il popolo annientava i traditori. Attingeva tutta la sua forza dagli insegnamenti di Jean-Jacques Rousseau e dalla cristallina convinzione della propria rettitudine. (…) La sua forza era quella del popolo, quella delle masse parigine; il suo terrore era il loro terrore. E quando le masse lo abbandonarono egli cadde. La tragedia di Robespierre e della Repubblica Giacobina fu che entrambi furono costretti a rinunciare all’appoggio delle masse. (…) Le esigenze economiche della guerra finirono per allontanare il popolo” (HOBSBAWM, 1988:103). Il congelamento dei salari nelle città e la sistematica requisizione dei prodotti alimentari nelle campagne segnarono questo allontanamento. Secondo HOBSBAWM, nell’aprile del 1794 sia la destra che la sinistra erano finite sotto la ghigliottina. I seguaci di Robespierre erano rimasti politicamente isolati e resistevano ancora al potere dovuto alla crisi della guerra. Ma quando, alla fine del giugno 1794, il nuovo esercito della Repubblica riuscì a sconfiggere gli austriaci e occupare il Belgio, essi capirono che la fine era ormai prossima. “Il 9 termidoro, secondo il calendario rivoluzionario (27 luglio 1794), la Convenzione rovesciò Robespierre. Il giorno successivo egli, Saint-Just e Couthon vennero giustiziati, e la stessa sorte toccò pochi giorni dopo ad altri ottantasette membri della Comune rivoluzionaria di Parigi” (HOBSBAWM, 1988:104). Il Termidoro è la fine della fase eroica e più memorabile della rivoluzione. Una fase irreversibile, che trasformò tutta la storia e spazzò via gli eserciti dei vecchi regimi europei. Il problema che la borghesia si trovò ad affrontare durante il resto di ciò che viene definito il periodo rivoluzionario (1794-99) era quello di raggiungere la stabilità politica e il progresso economico sulla base del programma liberale originario del 1789-91. La debolezza dei Termidoriani fu quella di non aver mai avuto alcun appoggio politico. I continui spostamenti a destra e a sinistra permettevano un equilibrio del tutto instabile. L’unica forma di disperdere l’opposizione era contare sull’esercito. E fu questo che successe. L’esercito risolse il problema apparentemente insolubile del governo, conquistando, pagando da sé le proprie spese e in più, anche quelle del governo. “Questo esercito rivoluzionario fu il prodotto più formidabile della Repubblica Giacobina. Da un levée en masse di cittadini rivoluzionari esso si trasformò ben presto in una forza composta di combattenti professionisti (…). Esso perciò mantenne le caratteristiche della Rivoluzione e assunse nello stesso tempo quelle degli interessi acquisiti: la tipica mistura 28 bonapartista” (HOBSBAWM, 1988:106). La rivoluzione diede all’esercito una superiorità senza precedenti: senza contare su molte risorse, esso conquistò tutta l’Europa non tanto perché poteva ma soprattutto perché doveva farlo. E Napoleone seppe poi sfruttare il prestigio acquisito dalle vittorie dell’esercito da lui condotto. “Divenne Primo Console, poi Console a vita, poi Imperatore. E al suo arrivo, come per miracolo, i problemi insolubili del Direttorio trovarono una soluzione. Nel giro di tre anni la Francia ebbe un Codice Civile, un concordato con la Chiesa e persino, simbolo importantissimo di una stabilità borghese, una Banca Nazionale. E il mondo ebbe il suo primo mito secolare” (HOBSBAWM, 1988:108). Per il mondo, Napoleone era allo stesso tempo l’uomo che aveva fatto la Rivoluzione e quello che aveva riportato l’ordine. Per i francesi, era il sovrano più fortunato di tutta la loro storia. “Aveva trionfato gloriosamente all’estero; ma in patria aveva anche instaurato o restaurato tutto il sistema delle istituzioni francesi quali esistono fino ad oggi. Vero è che la maggior parte delle sue idee – forse tutte – erano già state anticipate dalla Rivoluzione e dal Direttorio (…). Ma i suoi predecessori le avevano soltanto anticipate: egli le metteva in pratica. Il grande e luminoso monumento della giurisprudenza francese, il Codice che venne preso a modello in tutto in mondo borghese non anglosassone, era napoleonico. Sua era la gerarchia dei funzionari, dai prefetti in giù, dei magistrati, delle università e delle scuole. Le grandi «carriere» della vita pubblica francese, l’esercito, i servizi di stato, l’istruzione, il diritto, recano ancor oggi l’impronta di Napoleone” (HOBSBAWM, 1988:109/110). 4. Camminando verso il 1848 Secondo HOBSBAWM, il periodo tra il 1789 e il 1848 fu un’età di superlativi. La superficie conosciuta, mappata e in comunicazione tra sé, così come la popolazione mondiale, era più grande che mai. Le città si moltiplicavano rapidamente, la produzione industriale raggiungeva cifre superate solo dal commercio internazionale. La scienza progrediva, l’inventiva umana rivoluzionava il mondo e la conoscenza veniva ampiamente diffusa, con un numero di pubblicazioni tra libri e giornali mai visto prima. Ma tanti trionfi avevano anche un lato oscuro. La rivoluzione industriale aveva reso il mondo il più squallido e insicuro in cui l’uomo aveva mai vissuto. C’era tantissima povertà. Le condizioni materiali dei lavoratori non erano migliori che nel passato e, in alcuni casi, era anche peggiori. I paladini del progresso attribuivano tale situazione agli ostacoli che la vecchia società imponeva alla libera iniziativa; i nuovi socialisti l’attribuivano invece alla forma di conduzione della nuova società. Ma entrambi credevano in “un avvenire di 29 prosperità materiale che avrebbe eguagliato i progressi compiuti dall’uomo nel controllo delle forze della natura” (HOBSBAWM, 1988:409). Riguardo alla struttura politica e sociale del decennio 1840-’50, invece, cessavano i superlativi. Secondo HOBSBAWM, socialmente la maggior parte degli abitanti della terra era ancora fatta di contadini, ciò nonostante alcune zone dove l’agricoltura era già il mestiere di una minoranza e la popolazione urbana stava per superare la rurale. C’erano meno schiavi di prima, dato che la tratta internazionale era stata ufficialmente abolita nel 1815 (in alcuni posti la schiavitù fu abolita nel 1834). Ma essa continuava a crescere nelle due roccaforti dello schiavismo – il Brasile e gli Stati Uniti – stimolati dallo stesso progresso dell’industria e del commercio3. Parallelamente, si creavano nuove forme di semischiavitù, come la manodopera a contratto che veniva presa dall’India e, dopo la metà dell’Ottocento, anche dall’Italia. In gran parte dell’Europa la servitù della gleba era già stata abolita ma i cambiamenti delle condizioni economiche dei lavoratori rurali erano irrilevanti. Anche la situazione dell’aristocrazia, nell’altro estremo della piramide sociale, era poco cambiata e le maggiori concentrazioni di ricchezza erano ancora quelle della nobiltà. Ma “i redditi dei nobili dipendevano sempre più dall’industria, dai titoli azionari, dall’accrescersi delle proprietà immobiliari della disprezzata borghesia” (HOBSBAWM, 1988:411). I ceti medi erano aumentati rapidamente, ma non erano ancora predominanti né tutti erano ricchi. “La classe lavoratrice (…) cresceva con una rapidità assai maggiore. (….) [Comunque, di] fronte alla popolazione totale del mondo, era un’entità numericamente trascurabile e, (…) [quasi sempre] una classe disorganizzata. Pure, (…) la sua importanza politica era già enorme e del tutto sproporzionata alla sua consistenza o alle sue capacità” (HOBSBAWM, 1988:411/412). Nonostante la struttura politica del mondo fosse stata molto meno trasformata di quanto non si possa pensare, erano successi importanti cambiamenti. La rivoluzione del 3 La proibizione ufficiale della tratta internazionale degli schiavi fece nascere un traffico interno, delle aree più arretrate a quelle più sviluppate, ancora più redditizio di prima. 30 18304, aveva introdotto “nei principali Stati dell’Europa Occidentale delle costituzioni borghesi modernamente liberali (antidemocratiche, ma anche nettamente anti-aristocratiche). Esse contenevano indubbiamente dei compromessi, imposti dal timore di una rivoluzione in massa che avrebbe trasceso le aspirazioni del ceto medio moderato (…). Ma erano compromessi che decisamente facevano pendere la bilancia politica verso la borghesia” (HOBSBAWM, 1988:412/413). Anche la democrazia radicale aveva fatto importanti progressi, finendo per essere instaurata negli Stati Uniti. Nella politica internazionale c’era stata una rivoluzione totale. “Dal 1840 in poi il mondo era completamente dominato dalle potenze politiche ed economiche europee, a cui si aggiungeva la potenza crescente degli Stati Uniti. (…) E in mezzo a questo predominio generale dell’occidente la Gran Bretagna era in testa (…). (…) Mai, in tutta la storia del mondo, una potenza ha esercitato da sola un’egemonia universale come quella esercitata dall’Inghilterra verso la metà del secolo XIX (…). (…) Nondimeno, i primi segni del futuro declino della Gran Bretagna erano già visibili. Già nel quarto e nel quinto decennio del secolo XIX osservatori (…) avevano predetto che per la loro estensione e per le loro risorse potenziali gli Stati Uniti e la Russia avrebbero finito col diventare i due massimi giganti del mondo; e all’interno dell’Europa, ben presto la Germania (…) sarebbe entrata in concorrenza su un piano di parità. Solo la Francia era rimasta definitivamente battuta nella corsa all’egemonia” (HOBSBAWM, 1988:413/414). Nel decennio 1840 il mondo si trovava fuori dell’equilibrio. Non c’era un analogo delle forze del cambiamento economico, tecnico e sociale dei cinquant’anni precedenti. “Era inevitabile (…) che prima o poi la schiavitù e la servitù della gleba scomparissero ufficialmente (…), come era inevitabile che la Gran Bretagna non potesse rimanere per sempre il solo paese industrializzato. Era inevitabile che le aristocrazie terriere e le monarchie assolute dovessero capitolare in tutti i paesi nei quali si stava sviluppando una forte borghesia, 4 La Rivoluzione del 1830 attinse tutta l’Europa a ovest della Russia e il continente americano, e fu composta da sollevamenti rivoluzionari in diverse parte dell’Europa. Essa segnò “la sconfitta definitiva del potere aristocratico da parte della borghesia nell’Europa occidentale. Nei cinquant’anni successivi la classe dirigente sarebbe stata la grande bourgeoisie dei banchieri, dei grossi industriali e, talvolta, degli alti funzionari statali, accettata da un’aristocrazia che si teneva in disparte o si rassegnava ad adottare una politica precipuamente borghese, non ancora minacciata dal suffragio universale, ma bersagliata dall’esterno dalle agitazioni degli speculatori insoddisfatti o di minor calibro, della piccola borghesia e dei primi movimenti operai. Il sistema politico, in Gran Bretagna, in Francia e in Belgio, era fondamentalmente lo stesso: istituzioni liberali, difese contro il pericolo della democrazia dai requisiti patrimoniali o culturali che si richiedevano ai votanti (…) sotto un monarca costituzionale (…). (…) Ma, (…) il 1830 segna un’innovazione ancora più radicale: l’apparizione della classe operaia come forza indipendente e autocosciente sulla scena politica della Gran Bretagna e della Francia, e di movimenti nazionalisti in moltissimi paesi europei. Alla base di queste grandi trasformazioni politiche stanno altre grandi trasformazioni nello sviluppo economico. In ogni aspetto della vita sociale il 1830 segna una svolta; di tutte le date, tra il 1789 e il 1848, questa è indubbiamente la più memorabile” (HOBSBAWM, 1988:159/160). 31 quali che fossero i compromessi o le formule escogitate per conservare il proprio stato, la propria influenza e persino il potere politico. E inoltre, era inevitabile che l’infusione di una coscienza politica e di un’attività politica permanente nelle masse, che era la grande eredità lasciata dalla Rivoluzione Francese, dovesse prima o poi significare che queste masse avrebbero avuto la loro parte ufficiale nella politica” (HOBSBAWM, 1988:415). Tutto ciò bastava per far crescere, in tutta l’Europa, la coscienza di una imminente rivoluzione sociale presente tra tutti i segmenti della società: tra i rivoluzionari, tra le classi governanti e anche tra le masse povere. E questo perché la crisi di ciò che era rimasto della vecchia società sembrava coincidere con la crisi di quella nuova. Inoltre, tra il 1830 e il 1840 non sembrava “che la nuova economia dovesse o potesse superare le difficoltà che pareva andassero sempre crescendo con la capacità di produrre quantitativi sempre maggiori di merci con metodi sempre più rivoluzionari. Gli stessi teorici erano assillati dallo spettro dello «stato stazionario», cioè di un esaurimento della forza motrice che animava il progresso dell’economia, che (…) essi consideravano come un pericolo imminente e non semplicemente come una prospettiva storica” (HOBSBAWM, 1988:416). Nel 1841-42 sembrava ai capitalisti che l’industria corresse il pericolo di uno strangolamento generale che l’avrebbe portata al collasso. “Per le masse popolari, il problema era ancora più semplice. (…) [Le] loro condizioni nelle grandi città e nelle zone industriali dell’Europa occidentale e centrale le spingevano inevitabilmente verso la rivoluzione sociale. (…) Era questo lo «spettro del comunismo» che incombeva l’Europa, la paura del «proletariato» (…). E giustamente. Perché la rivoluzione che scoppiò nei primi mesi del 1848 non fu una rivoluzione sociale solo nel senso che coinvolse e mobilitò tutte le classi sociali. Essa fu né più né meno che l’insurrezione delle classi lavoratrici di tutte le città – e specialmente delle capitali – dell’Europa occidentale e centrale. Fu la loro forza, e quasi da sola, a rovesciare gli antichi regimi (…). E dalla polvere delle loro rovine, i lavoratori (…) si levarono a domandare non solo pane e lavoro, ma un nuovo stato e una nuova società” (HOBSBAWM, 1988:417). Mentre i lavoratori poveri si agitavano, il mondo dei ricchi e influenti si vedeva davanti una crisi senza precedenti. La crisi nella politica della classe governante “coincise con una catastrofe sociale: la grande carestia che dilagò in tutto il continente dal 1845 in poi. Il raccolto (…) era scarsissimo; intere popolazioni (…) morivano di fame (…). La crisi industriale moltiplicava la disoccupazione, e le masse lavoratrici venivano private del loro modesto reddito proprio nel momento in cui il costo della vita saliva alle stelle. (…) Fortunatamente per i regimi esistenti, le popolazioni più misere (…) erano anche politicamente tra le più immature (…). Ma (…) la 32 catastrofe del 1846-48 fu una catastrofe universale e l’umore delle masse, sempre ridotte quasi al livello dei mezzi di sussistenza, era teso e agitato. Un cataclisma economico europeo coincideva dunque con la visibile corrosione degli antichi regimi. (…) Raramente una rivoluzione è stata prevista in maniera più universale (…). Tutto un continente aspettava, e la notizia della rivoluzione sarebbe ora passata quasi istantaneamente di città in città grazie al telegrafo elettrico. Nel 1831, Victor Hugo aveva scritto che già sentiva «il suono cupo della rivoluzione, ancora nelle profondità della terra, che scavava le sue gallerie sotterranee sotto tutti i regni d’Europa, partendo dal pozzo centrale della miniera, che è Parigi». Nel 1847 quel suono era forte e vicinissimo. Nel 1848 avvenne l’esplosione” (HOBSBAWM, 1988:419/420). 5. E il mondo gira… La transizione dalla fase concorrenziale a quella monopolista del capitalismo, iniziata nella seconda metà del XIX secolo, introdusse cambiamenti strutturali nel modo di produrre finora realizzato. Le industrie già esistenti furono modernizzate, nacquero nuovi settori industriali e la scienza diede il suo importante contributo per il progresso economico. L’industria aveva un ruolo decisivo nell’economia di diversi paesi, e non è sbagliato affermare che essa cominciava a comandare il mondo. Nei paesi di economia più avanzata una società urbano-industriale si consolidò e, in seno a tutti questi cambiamenti, si formò la classe operaia. Ma il capitalismo non tardò a conoscere una crisi che sembrava stesse per segnare la sua fine. Inoltre, il vento della Rivoluzione Francese aveva sparso il sogno della libertà per il mondo. Le monarchie assolute erano state rovesciate e una nuova classe aveva raggiunto il potere: la borghesia. Essa, che tanto aveva promesso, poco aveva fatto per il miglioramento materiale della vita dei lavoratori. La crisi e il ciclo di ribasso economico aumentavano il malcontento tra le masse povere, che si trovavano senza soldi, senza lavoro e con molta fame. Le agitazioni si propagavano per tutta l’Europa Occidentale. Il popolo ormai aveva imparato a esprimersi attraverso i sollevamenti di massa e in tutti i canti soffiava il vento della rivoluzione sociale. Gli industriali cercarono di uscire dalla crisi introducendo altri cambiamenti tecnologici. Essi, a loro volta, crearono la necessità di altri mutamenti nella forma di produrre, che furono resi possibili tramite l’intensificazione della divisione del lavoro e la standardizzazione delle operazioni. La risposta a questa necessità fu concretizzata più tardi, con l’impianto nelle industrie dell’organizzazione scientifica del lavoro, mondialmente 33 conosciuta come taylorismo. L’obiettivo era aumentare la produttività del lavoro, eliminando qualsiasi perdita di tempo durante il processo produttivo, il che si garantiva tramite la riduzione della complessità dei gesti e movimenti del lavoratore. Diversi cambiamenti accaddero all’interno dell’industria con la taylorizzazione della produzione. Il più significativo, a mio giudizio, fu il consolidamento della separazione tra il lavoro intellettuale e il lavoro manuale. I lavoratori, a loro volta, non accettarono questi cambiamenti passivamente, scatenando una serie di scioperi che finirono per stimolare la loro organizzazione nei sindacati. Piano piano il sindacalismo – che fece dello sciopero generale e delle cooperative di produzione le sue principali armi di lotta – si costituì in uno dei poli più importanti delle lotte vissute dai lavoratori nei paesi industrializzati. La sua formazione si basò sul pensiero socialista, inizialmente sul socialismo utopico e, posteriormente, sul socialismo scientifico di MARX ed ENGELS. Il Manifesto del Partito Comunista, pubblicato nel 1848 e scritto dai due intellettuali per la Lega dei Comunisti, rappresentò un passo importante nel rafforzamento del processo di organizzazione dei lavoratori, fino a proporre l’internazionalizzazione del movimento operaio. In conseguenza dei progressi delle organizzazioni dei lavoratori fu fondata in Germania, nel 1863, l’Associazione Generale dei Lavoratori Tedeschi, che rivendicava il voto a suffragio universale e l’appoggio dello Stato alle cooperative di produzione. Nell’anno successivo, a Londra, fu fondata l’AIL – Associazione Internazionale dei Lavoratori, mondialmente conosciuta come Prima Internazionale. Questa associazione aggregava sindacalisti, leader operai e intellettuali dei grandi centri industriali dell’Europa, tra i quali MARX. Egli, parlando ai lavoratori, sottolineava la diversità e disuguaglianza esistenti all’interno della classe operaia, frutto delle differenti esperienze storiche vissute nelle varie parti del mondo, e avvertiva sui pericoli di delegare ad altre classi e/o categorie sociali la soluzione dei loro problemi particolari. La Prima Internazionale fu anche segnata dai dibattiti realizzati da un lato, tra i seguaci delle tesi di MARX e gli anarchici guidati da BAKUNIN e, dall’altro, tra i seguaci delle tesi di MARX e i riformisti piccolo-borghesi. È giustamente il dibattito tra marxisti e anarchici che interessa più da vicino questa parte del lavoro. Il grande punto di discordia tra loro era la comprensione del modo in cui si sarebbe arrivati al socialismo. Per i marxisti il socialismo sarebbe stato possibile soltanto tramite la rivoluzione proletaria. Nel momento in cui i lavoratori avessero preso coscienza del quadro di sfruttamento in cui erano inseriti, sarebbero stati capaci di realizzare la rivoluzione e assumere il potere, cosa che avrebbe significato l’istituzione della dittatura del proletariato. Gli anarchici, a loro volta, 34 ritenevano che la rivoluzione dovesse essere realizzata da tutta la società – e non solo dagli operai – e sarebbe culminata con la caduta dello Stato e di qualsiasi altra forma di potere, e non con la sostituzione di una classe al potere con un'altra. Per gli anarchici la vittoria del socialismo sarebbe stata anche la vittoria della società anarchica, intesa come una società senza poteri stabiliti. Se tra i marxisti esisteva una certa uniformità nel capire la società futura, lo stesso non si può affermare degli anarchici. All’interno del movimento anarchico, mai un argomento provocò tanta polemica come quello che si riferiva a ciò che sarebbe stata l’organizzazione socioeconomica della società futura. Le posizioni diverse e tante volte contrastanti degli anarchici dipendevano dalle premesse delle scuole di pensiero alle quali appartenevano. Tra queste, si possono citare l’individualista, rappresentata da STIRNER; la mutualista, rappresentata da PROUDHON e la socialista, suddivisa in due correnti diverse, la collettivista, rappresentata da BAKUNIN e la comunista, rappresentata da KROPOTKIN. Al fine di comprendere i contributi dati da queste diverse scuole per la discussione delle forme di produzione collettiva e comunitaria, si passerà nel prossimo capitolo a sottolineare le caratteristiche principali di ognuna di esse. 35 CAPITOLO 2 IL MOVIMENTO ANARCHICO E LE PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PRODUZIONE 1. Le origini dell’anarchia Secondo NETTLAU, una storia dell’idea anarchica è inseparabile dalla storia delle “evoluzioni progressive e dalle aspirazioni verso la libertà, cioè dal momento storico favorevole in cui sorse quella coscienza di una libera esistenza propugnata dagli anarchici, garantibile soltanto dopo la completa liberazione dai ceppi autoritari e sempre che, nello stesso tempo, siano bene sviluppati ed abbiano libera espansione i sentimenti sociali di solidarietà, di reciprocità, di abnegazione, etc.” (NETTLAU, 1964:1). Lo studio delle origini del movimento anarchico presenta molte divergenze. Tutti gli storici dell’anarchismo sono unanimi nell’attribuire a GODWIN i primi passi nel senso di una sistemazione della dottrina anarchica anche se, secondo WOODCOCK, egli non abbia mai usato il termine anarchico per definire sé stesso, né abbia mai usato la parola “anarchia” nel suo significato positivo. Rispetto alle origini più lontane del movimento, l’unanimità di prima dà luogo a una grande diversità. Alcuni, come KROPOTKIN, identificano le origini del movimento nella massa anonima del popolo; altri scoprono elementi anarchici nel pensiero di filosofi e scrittori del passato, come Lao-Tse, Aristippo, Zenone, Étienne de La Boëtie, Fénelon, Diderot, Rabelais, Meslier, Morelly (o Morelli), Tory5, il filosofo libertino6 Gabriel de Foigny, il monaco benedettino francese Don Deschamps e anche Thomas Jefferson. Anche Rousseau, soprattutto per le sue idee sulla 5 6 Per il suo libro Viaggi di Gulliver. Il libertinismo, altro movimento identificato all’anarchismo, si caratterizzava per l’esaltazione del libero pensiero, la fiducia nella ragione individuale e la critica nei confronti della religione e del pensiero metafisico. 36 Natura7 e su un’educazione razionale, viene ritenuto da JOLL “il vero progenitore settecentesco dell’anarchia, come di quasi tutte le successive dottrine politiche” (JOLL, 1970:30). Le origini del movimento anarchico sono ricercate anche tra i movimenti religiosi avvenuti dal XIII secolo in poi – come i movimenti eretici, le sette gnostiche, gli anabattisti, ecc. – nonché tra i movimenti contadini svoltisi in Inghilterra nel XIV secolo e in Germania agli inizi del XV secolo oppure tra le comunità popolari primitive o medioevali. WOODCOCK si discosta da queste posizioni. Riguardo ai filosofi e scrittori, ritiene che in “generale, gli storici anarchici hanno confuso certi atteggiamenti che costituiscono il nucleo dell’anarchia – fiducia nell’essenziale bontà e onestà dell’uomo, desiderio di libertà individuale, intolleranza dell’autorità – con l’anarchia come un movimento e un credo apparsi in un dato momento storico, con teorie, fini e metodi propri. Manifestazioni degli atteggiamenti di base si possono certamente rintracciare nella storia, indietro nel tempo fino agli antichi greci, ma l’anarchia in quanto movimento consapevole e chiaramente identificabile appare solo nei tempi moderni, di consapevoli rivoluzioni sociali e politiche” (WOODCOCK, 1966:33). Il vero movimento anarchico apparse soltanto dopo il crollo dell’ordine medioevale, e fino alla fine del XVIII secolo “le critiche estremistiche alla società non furono espresse da umanisti ma dai dissidenti religiosi fondamentalisti che attaccarono sia la Chiesa sia i sistemi contemporanei di autorità e di proprietà sulla base di un’interpretazione letterale della Bibbia” (WOODCOCK, 1966:33/34). Rispetto ai movimenti contadini, WOODCOCK ritiene trattarsi di uno sbaglio perché le richieste dei contadini non erano in sé rivoluzionarie e solo tra i loro capi si potevano trovare per la prima volta espressioni di una critica sociale che poi avrebbe dato origine all’anarchia. Ma questo sarebbe avvenuto più tardi. In quei tempi, non sembrava che si potesse fare a meno del potere, e dietro alle richieste di uguaglianza c’era sempre una struttura autoritaria. Inoltre, mancava in questi avvenimenti, da un punto di vista anarchico, l’elemento individualistico che avrebbe controbilanciato il loro egualitarismo, e ciò succede anche nel caso delle comunità popolari primitive o medioevali. Tutte queste nuove tendenze – laiche e religiose - portarono il XVII secolo in direzione di una coscienza sempre più elevata del valore della libertà individuale e finirono 7 L’autore si riferisce in particolare all’idea del “Nobile Selvaggio”, tanto cara agli anarchici, e alla nozione di uno “stato di natura” in cui gli uomini, lungi di essere impegnati in una lotta costante tra loro, vivono in uno stato di collaborazione reciproca – idea che sarà poi sviluppata da KROPOTKIN nell’opera El apoyo mutuo. Secondo JOLL, il “concetto fondamentale di Rousseau, che l’uomo è buono per natura e che sono le istituzioni a corromperlo, è rimasto alla base di tutto l’anarchismo (…)[:] nella società anarchica si presuppone che (…) l’istinto naturale del bene presente in ogni uomo possa svilupparsi e fiorire” (JOLL, 1970:31). 37 per produrre durante la Guerra Civile Inglese il primo movimento che, secondo l’autore, può essere definito veramente anarchico: i Levellers (Livellatori). Emerso dalle classi inferiori e spinto dallo stesso individualismo che spinse le classi medie a una lotta politica e militare per la creazione di un’oligarchia di classe, i Levellers si costituirono negli “antenati dei cartisti e nei fautori del suffragio universale. Benché alcuni di loro (…) accennassero alla comunanza dei beni, essi chiedevano in genere eguaglianza politica più che economica, e una costituzione democratica che eliminasse i privilegi rivendicati dagli ufficiali superiori del Nuovo Esercito Modello. … Ma l’ala veramente anarchica del movimento rivoluzionario inglese nel diciassettesimo secolo non fu rappresentata dai Levellers, bensì dall’effimero gruppo la cui forma peculiare di protesta sociale guadagnò ai suoi membri il nome di Diggers, Zappatori. I Levellers provenivano per la maggior parte dai bassi ranghi del Nuovo Esercito Modello, e volevano partecipare in giusta misura al governo del paese che, con la loro opera di combattenti, avevano contribuito a liberare del dominio dei re per diritto divino. Invece i Diggers erano per lo più uomini poveri, vittime della crisi economica (…) e le loro richieste erano principalmente d’ordine sociale ed economico. Essi si consideravano derubati da coloro ch’erano rimasti ricchi, non solo dei diritti politici, ma anche dell’elementare diritto ai mezzi di sopravvivenza. La loro protesta era un grido di fame, e i loro capi, Gerrard Winstanley e William Everard, avevano sofferto entrambi per i disordini dell’epoca” (WOODCOCK, 1966:37/38). La visione di società egualitaria di Winstanley presenta molte delle caratteristiche della società ideale presentata dagli anarchici due secoli dopo. “Comune partecipazione al lavoro ed equa divisione dei suoi prodotti; assenza di governanti e pacifica vita comune di tutti gli uomini, secondo i dettami della coscienza; abolizione del commercio, sostituito da un sistema di depositi aperti a tutti: sembra un abbozzo della società comunista anarchica di Kropotkin; e a questo schizzo Winstanley dà l’ultimo tocco, rendendolo ancora più somigliante e anticipando le argomentazioni di tutti i pensatori libertari, là dove condanna il sistema delle punizioni e afferma che il delitto ha le sue cause nell’ineguaglianza economica” (WOODCOCK, 1966:40). Winstanley riteneva che il popolo doveva agire impadronendosi della terra e lavorandola. Senza che ci fosse bisogno di usare la forza per impadronirsi delle terre dei ricchi, i poveri potevano, secondo lui, “prendersi i pascoli comuni e le terre incolte (…) e lavorarli insieme. Dal loro esempio gli uomini potranno imparare i vantaggi della solidarietà e dell’abolizione della proprietà privata, e la terra diventerà un «tesoro comune» che a tutti offrirà di che vivere nell’abbondanza e nella libertà” (WOODCOCK, 1966:40). All’inizio 38 dell’aprile 1649, Winstanley e i suoi compagni iniziarono la loro campagna di azione diretta, trasferendosi a St. George’s Hill, dove cominciarono a dissodare le terre incolte e a coltivarle. Ma i Diggers provocavano ostilità fra il clero e i proprietari di terre locali e nemmeno fra i loro poveri vicini raccoglievano le simpatie. Contrari alla violenza, resistettero alla repressione dei loro avversari durante un po’ di tempo, ma alla fine si arresero e nel marzo 1650 abbandonarono St. George’s Hill e, insieme a essa, il sogno di conquistare l’Inghilterra al comunismo agrario. Il movimento dei Diggers finì senza lasciare un’eredità tra i movimenti sociali e politici che lo succedettero. Persino GODWIN, “nella sua History of Commonwealth, non dimostra di aver capito quanto simile fosse la dottrina dei Diggers a quella che egli stesso espose in Political Justice. L’importanza di Winstanley come precursore delle ideologie sociali moderne fu riconosciuta solo alla fine del diciannovesimo secolo” (WOODCOCK, 1966:42). Dal punto di vista delle singole persone, WOODCOCK ritiene che colui che avrebbe maggior diritto a essere studiato come precursore dell’anarchismo sarebbe Thomas Paine. La sua “estrema diffidenza (…) per il governo influenzò indubbiamente Godwin (…). Paine era uno di coloro che pensano che il governo sia una necessità, ma una necessità sgradevole impostaci dal corrompersi dell’originaria innocenza dell’uomo” (WOODCOCK, 1966:43). Nella sua opera The Rights of Man, Paine “parla del governo come di un ostacolo alla «naturale propensione alla società,» e afferma che «quanto più perfetta è la civiltà, tanto meno occasioni offre alla formazione di un governo, perché tanto più regola da sé i suoi affari e si governa da sola». Troviamo qui formulato un punto di vista che (…) caratterizza l’anarchico tipico: egli vive in un presente pessimo, dominato dal governo, e guarda indietro, a un perduto paradiso di innocenza primitiva, e avanti, a un futuro che nella sua civile semplicità tornerà a creare l’età dell’oro della libertà. Per temperamento e ideali, Paine era molto vicino agli anarchici; soltanto la sua mancanza di ottimismo per quanto riguardava il futuro immediatamente prevedibile gli impedì di diventare uno di loro” (WOODCOCK, 1966:44). Un altro punto di riferimento importante per lo studio delle origini dell’anarchismo fu la Rivoluzione Francese, soprattutto in ciò che riguarda i concetti di libertà, uguaglianza e fratellanza; l’idea del progresso dell’uomo verso una libertà senza classi, della mutualité e del progetto di una grande associazione di mutuo soccorso tra i lavoratori, difese da Condorcet e poi riprese da PROUDHON; e il concetto di federalismo provato anche durante la Comune di Parigi, anch’essi un altro pilastro del sistema proudhoniano. WOODCOCK però è del parere che si deve guardare oltre il mutualismo di Condorcet e il federalismo della Comune per trovare i veri antenati degli anarchici durante 39 la Rivoluzione Francese. Essi devono essere cercati tra Jacques Roux, Jean Varlet e nel movimento degli Enragés (Arrabiati) che si riunirono intorno a loro. Questo movimento cominciò nel 1793 e durò per tutti gli anni del Terrore. Nacque in un momento di crisi economica, come risposta al gravissimo disagio economico dei poveri di Parigi e Lione, nonché “una reazione alle distinzioni sociali che caratterizzavano l’affermarsi del potere della borghesia in ascesa. Gli Enragés (…) erano soltanto un gruppo di rivoluzionari che cooperavano nel modo più rudimentale, ma erano concordi nel respingere la concezione giacobina dell’autorità statale. Affermavano la necessità di un’azione diretta da parte del popolo e vedevano in misure economiche comunistiche più che nell’azione politica un modo di porre fine alle sofferenze dei poveri” (WOODCOCK, 1966:47). Trattando sempre dell’influenza della Rivoluzione Francese per le origini del movimento anarchico, JOLL ritiene che essa “lasciò dietro di sé almeno tre miti, che dovevano alimentare il credo rivoluzionario del secolo XIX, e divennero parte integrante delle dottrine anarchiche. Il primo fu il mito della rivoluzione vittoriosa. Da quel momento la rivoluzione violenta era possibile; e (ecco il secondo mito) la prossima sarebbe stata una vera rivoluzione sociale non la pura e semplice sostituzione di una classe dominante con un’altra. (…) Infine, questa rivoluzione sarebbe stata possibile solo dopo che una congiura di rivoluzionari pronti al sacrificio avesse minato le basi della società esistente. Queste dottrine dovevano essere il patrimonio comune dei marxisti tedeschi, populisti russi, e degli anarchici francesi e spagnoli. Da allora, le rivoluzioni dovevano essere fatte per le strade non meno che negli studi dei filosofi” (JOLL, 1970:58). Con il passare del tempo, nella “generazione seguita alla rivoluzione, nuove utopie visionarie apparvero, tutte basate sulla consapevolezza (…) sia delle capacità produttive dell’industria e delle macchine, sia dell’impotenza della rivoluzione francese a soddisfare se non una piccola parte delle aspirazioni economiche e sociali dei poveri. Al mito della rivoluzione si aggiunsero nuovi miti di una società futura. I socialisti utopisti, fra cui i più notevoli e influenti furono Fourier e Saint-Simon, si preoccuparono più dello stato futuro della società, che dei mezzi che avrebbero reso possibile la rivoluzione. Essi credevano, e in questo furono i veri eredi del Settecento, che la ragione e il progresso umano avrebbero operato le trasformazioni necessarie senza bisogno di violenza. (…) Ma le loro concezioni di una società nuova contengono molte idee destinate a ricorrere nel futuro pensiero anarchico, e Saint-Simon, ma soprattutto Fourier, contribuirono a modellare il tipo dell’anarchico mite, pacifico e razionale” (JOLL, 1970:58/59). 40 Secondo JOLL, ciò “che rese importanti i socialisti utopistici nello sviluppo dei grandi movimenti rivoluzionari dei secoli XIX e XX (sia anarchici che comunisti) (…) fu la diffusione della credenza che la trasformazione sociale ed economica debba precedere ogni riforma puramente politica, e che la discussione dei rapporti fra produttore e consumatore, o fra capitale e lavoro, sia più importante che la critica delle forme costituzionali e degli istituti politici. Questa coscienza della «questione sociale» aveva, naturalmente, tratto origine dalle condizioni sociali ed economiche del primo Ottocento, un’epoca in cui nuove forme di attività industriale e nuovi procedimenti tecnologici, insieme con l’incremento della popolazione urbana in tutta l’Europa occidentale, andavano suscitando una quantità di conflitti e problemi sociali e politici fin allora sconosciuti” (JOLL, 1970:67/68). Con Hegel – in realtà con i suoi discepoli – fu data la spinta finale. “La rivoluzione francese aveva dimostrato la possibilità di distruggere le forme tradizionali di governo. A loro volta, i socialisti utopistici avevano disegnato il quadro ideale di un mondo nuovo. Furono gli hegeliani a instillare nella nuova generazione rivoluzionaria la fede che la storia era dalla loro parte; e a munirli di una filosofia di radicale innovazione. I successori di Hegel (…) presero la dottrina del maestro e la misero al servizio di finalità rivoluzionarie: mentre Hegel aveva usato la propria filosofia a giustificazione dello Stato prussiano, i suoi discepoli (…) capovolsero la dialettica hegeliana per derivarne una teoria della rivoluzione” (JOLL, 1970:64). 2. GODWIN e la prima sistemazione del pensiero anarchico GODWIN fu un filosofo libertario che rimase fuori dal movimento anarchico. Ebbe “poca influenza diretta su di esso, e molti fra i leader anarchici, le cui teorie sono tanto vicine alle sue, ignorarono in quale misura egli le avesse anticipate” (WOODCOCK, 1966:51). L’unico a leggere la sua opera più importante, l’Enquiry Concerning Political Justice (1793) fu Kropotkin, ma questo successe quando le sue idee e teorie erano già completamente formate. Anche se GODWIN, come più tardi tutti i pensatori libertari, “vedeva la società come un fenomeno che si sviluppa naturalmente e può operare in completa indipendenza da ogni governo (…) non condivideva la fiducia dei suoi successori negli istinti spontanei del popolo abbandonato a se stesso. In questo senso, rimase un illuminista; per lui l’educazione era l’unica vera chiave alla libertà” (WOODCOCK, 1966:51). Egli era convinto delle tendenze distruttive dell’autorità e riteneva che il disordine estremo era infinitamente più desiderabile della subordinazione. 41 “In Godwin convergono eterogeneamente elementi desunti da differenti esperienze culturali: fondendoli tra di loro non senza contraddizioni, il filosofo inglese diede così inizio, inconsapevolmente, ad una nuova tradizione di pensiero. Dal radicalismo protestante Godwin deduce l’intransigente individualismo, il tema dell’autonomia etica e intellettuale del singolo; dal liberalismo ricava l’esaltazione della libertà e la teoria del potere minimo; dall’illuminismo desume la fiducia nella ragione e nella perfettibilità dell’uomo assommata alla critica nei confronti dei poteri tradizionali, che egli traduce in critica al potere tout court” (PANI & VACCARO, 1997:34/35). GODWIN fu l’iniziatore della tradizione anarchica intesa nel suo senso positivo, “poiché le idee da lui formulate nell’Enquiry Concerning Political Justice (1793) presentano tutti i tratti essenziali della dottrina anarchica” (WOODCOCK, 1966:52). Respingendo ogni sistema sociale dipendente da un governo, formulò la sua concezione di una società semplificata e decentrata basata su un minimo di autorità sempre meno necessaria e sulla spartizione volontaria dei beni materiali. Secondo WOODCOCK, questa dottrina era sostanzialmente la stessa proclamata da Proudhon fra il 1840 e il 1850. Sono tante le influenze subite da GODWIN nell’organizzazione del suo pensiero. WOODCOCK cita la dottrina sandemanista, i Dissent, i sociologi francesi e alcuni autori inglesi come John Locke e Thomas Paine. Fa un richiamo speciale sull’influenza della Rivoluzione Francese che non solo gli diede l’impulso immediato a scrivere Political Justice, ma anche gli assicurò un pubblico disposto ad accoglierlo con entusiasmo. Ma le idee chiave che trovarono espressione in Political Justice erano maturate in lui prima della Rivoluzione, quando nel 1784 progettò di fondare una scuola privata e pubblicò un breve prospetto intitolato An Account of the Seminary That Will Be Opened on Monday the Fourth Day of August at Epsom in Surrey, dove espose le sue teorie sulla natura della società e la funzione generale dell’educazione. In An Account of the Seminary, una “società naturale, egualitaria, è contrapposta a una società artificiale dominata da un governo; è sottolineato il potere del pensiero; è data particolare importanza all’educazione, in obbedienza alla convinzione di Godwin che il carattere sia determinato dall’ambiente più che dall’eredità, e che i difetti siano la conseguenza di una cattiva educazione. (…) E, pur non essendo ancora arrivato alla logica conclusione che il governo è positivamente un male, Godwin è già pronto a sostenere che ha ben poco di positivamente buono” (WOODCOCK, 1966:53/54). Quando più tardi scrisse Political Justice e soprattutto quando la Rivoluzione Francese degenerò in violenza e dittatura GODWIN, data l’indipendenza della sua opera rispetto a ciò che accadeva in Francia, 42 rafforzò le sue idee che i cambiamenti politici non servono a niente se non sono frutto di cambiamenti morali. Political Justice, è la sua opera più importante, e per capirla è fondamentale capire l’idea di Necessità che la percorre dall’inizio alla fine. GODWIN la vede come “la legge immutabile e impersonale che muove l’universo, si esprime nelle leggi della natura, determina le azioni umane” (WOODCOCK, 1966:60). Per sfuggire al rischio delle conclusioni deterministiche a cui questo tipo di interpretazione poteva portare, e che erano in evidente contraddizione con l’idea della libertà e dell’azione individuale, egli optò per un compromesso fra l’idea di necessità e quella di libertà, non sempre evidente. La struttura di Political Justice è costruita sulla regione sospesa fra il necessario e il volontario. “Parte dall’assunto che «la felicità della specie umana è l’obiettivo più desiderabile che la scienza dell’uomo possa perseguire» e fra tutte le forme di felicità dà il primo posto a quella «intellettuale e morale»; i più potenti nemici di questa felicità sono per lui i «governi incapaci e corrotti». Il suo libro ha così un duplice proposito: è un’indagine sul funzionamento politico della società, (…) [e] un «veicolo di miglioramento morale …»” (WOODCOCK, 1966:63). JOLL a questo proposito sottolinea che il cardine della teoria politica di GODWIN è che giustizia e felicità sono indissolubilmente unite, e la pratica della virtù la vera via alla felicità individuale. GODWIN si basa su quattro proposizioni fondamentali. “In primo luogo, afferma che «il carattere morale degli uomini è il risultato delle loro percezioni», e che né il bene né il male sono innati. L’eliminazione di fattori esterni nocivi può dunque eliminare anche le tendenze criminali dal carattere degli essere umani” (WOODCOCK, 1966:63). La seconda proposizione è che, fra “tutti i mezzi di «operare sulla mente» il più potente è il governo. (…) In Political Justice, egli osserva che «l’istituzione politica è particolarmente forte là dove l’efficacia dell’educazione è deficiente, cioè nell’ampiezza del raggio d’azione»” (WOODCOCK, 1966:64). “La terza proposizione è in realtà un corollario della seconda: il governo è tanto cattivo nella pratica quanto nei principi. Nel dimostrare quanto afferma, Godwin pone l’accento soprattutto sui fortissimi dislivelli economici fra le classi nel mondo del diciottesimo secolo. (…) Godwin è così uno dei primi ad illuminare quell’intimo rapporto fra proprietà e potere che ha reso gli anarchici nemici del capitalismo non meno che dello stato. La quarta proposizione fondamentale è quella, famosa, riguardante la perfettibilità dell’uomo. «La perfettibilità è una fra le caratteristiche più indiscutibili della specie umana, tanto che si può presumere che lo stato così politico come intellettuale dell’uomo sia in corso di progressivo miglioramento»” (WOODCOCK, 1966:64). 43 Partendo da queste proposizioni per analizzare i principi della società, GODWIN pone l’accento sulla giustizia e conclude che la società adempie i suoi veri scopi quando aiuta l’uomo a vivere da essere morale. GODWIN ritiene anche che tutti gli uomini sono uguali sul piano della morale, in virtù della loro essenziale indipendenza. Essendo così, eguale “per tutti dev’essere la giustizia, e a tutti si devono offrire possibilità e incoraggiamenti in eguale misura” (WOODCOCK, 1966:66). Affrontando il problema della confusione tra giustizia e legge umana, egli afferma che la prima “è basata su verità morali immutabili, la seconda sulle decisioni, che possono essere erronee, di organismi politici. L’uomo deve giudicare da sé del giusto e dell’ingiusto, e sua guida deve essere l’evidenza, non l’autorità” (WOODCOCK, 1966:66). Analizzando poi il problema delle necessarie restrizioni alla libertà, GODWIN si chiede come mai si debba rinunciare al giudizio individuale che è, a suo parere, necessario per il bene pubblico e dopo essersi chiesto quale sia il fondamento del governo politico, conclude che l’unica finalità della comunità è la pubblica difesa della giustizia. Quando questo si effettua, gli uomini devono cooperare; altrimenti, devono resistere alle sue decisioni. La fiducia nel potere della ragione è, secondo WOODCOCK, quasi esclusiva del secolo in cui GODWIN è vissuto. L’idea di resistenza proposta da GODWIN segna l’inizio delle controversie tra gli anarchici sui fini e i mezzi. GODWIN difende la superiorità della persuasione morale e la resistenza passiva sulla resistenza violenta e attiva, ritiene che la miglior forma di resistenza è la diffusione della verità e avverte che la persuasione dev’essere, sempre che possibile, diretta e individuale. L’unica forma di associazione da lui ammessa è quella creata in situazioni d’emergenza, per resistere agli attentati contro la libertà. Questa però deve essere sciolta appena cessata la sua necessità. Inoltre, suggerisce la formazione di gruppi di discussione che potrebbero a loro volta formare un movimento mondiale, ma richiama l’attenzione sulla necessità di non creare un’uniformità di pensiero. In più, “nell’opposizione a partiti politici altamente organizzati e nell’insistenza su piccoli gruppi dall’organizzazione fluida, che potrebbero riunirsi spontaneamente in un più vasto movimento, Godwin traccia il primo modello di tutte le successive forme di organizzazione anarchica” (WOODCOCK, 1966:69). Una volta gettate le basi morali della sua argomentazione, GODWIN passa ad analizzare ciò che chiama “i particolari pratici dell’istituzione politica”, trattando dei “quattro aspetti della vita politica: amministrazione generale, o governo; educazione; delitto e legge; regolamentazione della proprietà” (WOODCOCK, 1966:69). Ritiene la democrazia come la forma di governo che offre maggiori possibilità di progredire verso qualcosa di meglio. 44 Trattando del funzionamento pratico del governo democratico, espone i vantaggi della semplificazione e del decentramento di tutte le forme d’amministrazione, e propone la creazione di istituzioni amministrative localizzate capaci di trasformare il mondo in una grande repubblica, in cui gli uomini potrebbero muoversi e discutere liberamente, senza l’impedimento delle barriere nazionali8. L’educazione ha nel suo pensiero un ruolo fondamentale. GODWIN ritiene il piccolo gruppo sociale come il più adatto nel processo di formazione di opinioni giuste. Non vede i pericoli della censura reciproca, ma avverte sugli usi pericolosi che il governo può fare dell’educazione una volta che ne abbia il controllo. La parte più famosa del Political Justice è l’ultima, nella quale GODWIN esamina l’istituto della proprietà e anticipa le teorie economiche socialiste. Ma lo fa “solo nell’esposizione degli effetti del sistema di proprietà e nell’insistenza sullo stretto rapporto fra proprietà e sistemi di governo; le sue proposte positive circa cambiamenti nel sistema di proprietà sono uniformemente anarchiche. Godwin comincia con l’osservare che l’abolizione del «sistema di coercizione e punizione è intimamente connessa con un’equa distribuzione della ricchezza.» Ogni uomo ha «diritto, finché bastino le riserve comuni, ai mezzi non solo per vivere, ma per vivere bene.» Ma questo diritto a una giusta parte dei beni comuni implica il dovere di partecipare in giusta misura al lavoro comune: La giustizia vuole che ogni uomo, a meno forse che possa essere impiegato altrimenti con maggior vantaggio della comunità, contribuisca alla produzione del raccolto comune, di cui ciascuno consuma una parte. Questa reciprocità … è l’essenza stessa della giustizia. Nel quadro abbozzato da Godwin di una società in cui non esiste il diritto di proprietà riconosciamo la stessa visione di una società rurale delineata nelle opere di Moro, Winstanley, Morris e Kropotkin: la visione di uomini che lavorano insieme nei campi e poi attingono, secondo una stima individuale dei loro giusti bisogni, ai granai e ai depositi comuni, senza alcun meccanismo di pagamento o di scambi, «fra tutte le pratiche la più perniciosa.» Come altri più tardi scrittori anarchici, Godwin vagheggia una drastica semplificazione della vita, perché il lusso corrompe (…) e il lavoro è necessario alla felicità dell’uomo. (…) L’«accumulo della proprietà» – con questo termine premarxista Godwin indica quello che noi chiamiamo capitalismo – è un ostacolo all’arricchimento qualitativo della vita” (WOODCOCK, 1966:74/75). GODWIN ritiene inoltre che questo sistema “eliminerebbe anche le principali cause della criminalità, le cui radici sono nel fatto che «l’uno possiede in abbondanza ciò di cui l’altro è privo.»” (WOODCOCK, 1966:76). 8 Questo è, almeno in teoria, ciò a cui si propone la società globalizzata dei nostri giorni. 45 “Nonostante la diffidenza per la cooperazione9, Godwin è ben lontano dal pensare che l’umanità liberata debba vivere nell’isolamento e nel sospetto reciproci. Al contrario, prevede la possibilità di una specializzazione nei vari mestieri, che permetterà all’uomo di dedicarsi all’occupazione per la quale ha maggior attitudine, distribuendo il sovrappiù della produzione a chiunque ne abbia bisogno e ricevendo quanto gli occorre del sovrappiù prodotto dagli altri; sempre però sulla base della distribuzione gratuita, non dello scambio. È evidente che, nonostante le sue congetture sul futuro della macchina, la società ideale di Godwin è fondata su un’economia agraria e artigianale” (WOODCOCK, 1966:77). GODWIN scrisse un’altra opera, Caleb Williams, ma niente che somigliasse in importanza al suo capolavoro, Political Justice. Ebbe molta influenza sullo scrittore SHELLEY e sui socialisti inglesi Robert OWEN, Francis PLACE e William THOMPSON ma l’influenza delle sue idee sul movimento anarchico cominciò in una fase già avanzata della storia del movimento. Gli anni di prestigio furono pochi ma, secondo WOODCOCK, la più importante influenza esercitata da GODWIN avvenne negli anni in cui la sua fama era al livello più basso. 3. Che cos’è l’anarchia? Descrivere una teoria essenziale dell’anarchismo è un’opera difficile, proprio “perché la natura stessa dell’atteggiamento libertario – il suo rifiuto di ogni dogma e di ogni teoria rigidamente sistematica, e, soprattutto, la sua insistenza sull’estrema libertà di scelta e sull’importanza primaria del giudizio individuale – rende possibile una varietà di punti di vista inconcepibile in un sistema rigorosamente dogmatico. L’anarchia è insieme varia e mutevole (…). Come dottrina, cambia continuamente; come movimento cresce e si disintegra, in fluttuazione costante, ma non scompare mai del tutto. Esiste in Europa, senza interruzioni, dal decennio 1840-50, e la sua stessa qualità proteica gli ha permesso di sopravvivere mentre molti movimenti assai più potenti ma meno adattabili dell’ultimo secolo sono completamente scomparsi” (WOODCOCK, 1966:12/13). L’anarchia “è una dottrina che critica la società esistente, preconizza un nuovo ordinamento sociale, indica i mezzi per passare dall’uno all’altro. (…) L’anarchia, storicamente parlando, ha in vista soprattutto l’uomo nei suoi rapporti con la società. Il suo fine ultimo è sempre di condanna della società, anche se può derivare da una concezione individualistica della natura umana; il suo metodo è sempre quello della rivolta, violenta o meno, contro la 9 GODWIN, come poi “Proudhon e Stirner, (…) [considera] con profonda diffidenza ogni tipo di collaborazione suscettibile di cristallizzarsi e perpetuarsi in forma istituzionale” (WOODCOCK,1966:76). 46 società” (WOODCOCK, 1966:5). Sono due le definizioni dell’anarchico presenti nei dizionari: una lo presenta come un uomo convinto che il governo deve morire prima che possa vivere la libertà; l’altra lo liquida sbrigativamente come un semplice promotore di disordini che non offre nulla in cambio dell’ordine che distrugge. Nel pensiero popolare è quest’ultima che prevale: anarchia come sinonimo di caos. Questo si deve, da un lato, all’attitudine di una parte degli anarchici che preferivano sottolineare l’aspetto distruttivo della dottrina, molte volte tramite l’uso della violenza. Dall’altro, dalla visione distorta che è stata fornita da una parte importante della storiografia, di destra e di sinistra. Dal punto di vista scientifico, l’anarchia deve essere intesa “come un sistema di pensiero sociale, mirante a cambiamenti fondamentali nella struttura della società e in particolare – perché questo è l’elemento che accomuna tutte le sue varie forme – alla sostituzione dello stato autoritario con qualche forma di cooperazione tra individui liberi” (WOODCOCK, 1966:9). Ci sono diverse questioni importanti all’interno della filosofia anarchica. La questione dei mezzi usati per raggiungere i fini è una di esse. Gli anarchici sono d’accordo rispetto ai fini della loro lotta, ma non sui mezzi utilizzati per raggiungerli. A questo riguardo l’uso o meno della violenza diventa centrale. Non tutti erano d’accordo sull’uso della violenza, ma la negazione dell’autorità da parte degli anarchici fece diventare automatica l’associazione tra anarchismo e violenza. La questione dello Stato è quella centrale all’interno di questa filosofia. Esiste unanimità sulla necessità di distruggerlo – e questo è uno dei fini della loro lotta, se non il principale. Gli anarchici rifiutano l’azione politica in quanto tale e soprattutto l’idea che si possa trasformare la società con misure parziali e graduali. Così, “basano (…) la loro tattica sulla teoria dell’«azione diretta,» e affermano che i loro mezzi di lotta comprendono tutta una gamma di tattiche – dallo sciopero generale e dal rifiuto di prestare servizio militare alla formazione di cooperative e società di credito – miranti a distruggere l’ordine esistente e a preparare la rivoluzione sociale o a fare in modo che, una volta cominciata, essa non sfoci nell’instaurazione di un regime autoritario” (WOODCOCK, 1966:26). Una volta distrutto lo Stato, si doveva pensare a come organizzare la società senza di esso. Gli anarchici sono unanimi nel sottoporre il socialismo “autoritario” – quello difeso da Marx e i suoi discepoli – a una critica severa, sottolineando come fanno STIRNER e PROUDHON, la subordinazione dell’individuo alla collettività e di conseguenza, il non rispetto della libertà individuale. Gli anarchici vedono la collettività come un insieme di individui sovrani la cui individualità deve essere rispettata, il che non si effettua nel socialismo autoritario. Dopodiché, ognuno, d’accordo con la sua 47 interpretazione dell’anarchia, passa a presentare le proposte di ciò che ritiene essere la vera società futura. Riguardo alla questione dell’organizzazione, non tutti gli anarchici la respingono “in linea di principio, ma nessuno di loro cerca di darle una continuità artificiosa; importante è soltanto la fluida sopravvivenza dell’atteggiamento libertario. I principi anarchici fondamentali, che attribuiscono tanta importanza alla libertà e alla spontaneità, precludono anzi in partenza la possibilità di un’organizzazione rigida, in particolare di tutto ciò che somigli anche lontanamente ad un partito organizzato per la conquista e il mantenimento del potere. (…) All’idea dell’organizzazione di partito gli anarchici sostituiscono la loro mistica dell’impulso individuale e popolare, che nella pratica ha trovato espressione in una serie di gruppi fluidi ed effimeri e in federazioni di propagandisti convinti che loro dovere non sia guidare il popolo ma illuminarlo e offrirgli un esempio” (WOODCOCK, 1966:13). L’altro pilastro della filosofia anarchica è la visione naturalista della società, frutto dell’influenza illuminista nella formazione del pensiero anarchico10. “Tutti gli anarchici (…) sarebbero pronti a sottoscrivere l’affermazione che l’uomo possiede per natura tutti gli attributi necessari per vivere in libertà e concordia sociale. Forse non credono che l’uomo sia buono per natura, ma sono fermamente convinti che l’uomo sia per natura «sociale»” (WOODCOCK, 1966:17). Gli anarchici pretendono quello che è, per certi versi un ritorno alla semplicità come per esempio, quella del mondo contadino. Possedere ciò che basta per essere liberi: questo è tutto quanto chiedono gli anarchici. Il progresso è concepito dall’anarchico “non nei termini di un continuo aumento della ricchezza materiale e della complessità della vita, ma piuttosto come moralizzazione della società attraverso l’abolizione dell’autorità, dell’ineguaglianza, dello sfruttamento economico. Una volta raggiunta questa meta, gli uomini potranno tornare ad una condizione in cui i processi naturali eserciteranno un’influenza sulla vita delle società e degli individui; e allora l’uomo potrà svilupparsi interiormente in armonia con lo spirito che fa di lui un essere superiore agli animali” (WOODCOCK, 1966:24). Per gli anarchici non esistono avvenimenti inevitabili, soprattutto nella società umana. Loro ritengono che la storia cammina seguendo le linee della lotta, e che la lotta umana è prodotto dell’esercizio della volontà dell’uomo, basata sulla coscienza che esiste dentro di lui, reagendo a uno stimolo capace di risvegliare la sua eterna ansia di libertà. Tutte le varie tattiche proposte dagli anarchici si basano su decisioni personali dirette: non esiste coercizione nemmeno delega di responsabilità. È l’individuo che decide che cosa fare o non fare, d’accordo con le sue convenienze. Il popolo è visto non come una massa 10 In particolare quella di Rousseau. 48 nel senso marxista, ma come una collezione di individui sovrani, e ognuno deve decidere da solo se e quando agire. Altre tematiche importanti che caratterizzano l’anarchismo sono l’anticlericalismo, l’antimilitarismo e il rapporto contraddittorio nei confronti della scienza e del progresso. Infine, vale sottolineare il punto nevralgico delle differenze tra l’anarchismo e il marxismo, quello dell’abbattimento dello Stato e dell’imputazione delle origini delle disuguaglianze sociali. Secondo l’anarchismo esse si riproducono proprio attraverso lo Stato attraverso la “divisione gerarchica del lavoro – tra manuale e intellettuale – e al conseguente monopolio del sapere cui ha accesso esclusivo la parte minoritaria dei lavoratori intellettuali; infine, nel dominio politico ed economico che il monopolio del sapere rende possibile. Scopo principale di una società anarchica diventa dunque quello di favorire un processo di istruzione integrale che elimini la divisione verticale del lavoro e che permetta l’integrazione delle varie forme del sapere umano, superando la dicotomica contrapposizione tra le classi, l’antagonismo tra mente e corpo, la divisione tra città e campagna, la contrapposizione tra stato e società” (PANI & VACCARO, 1997:18). Finalmente, un’altra differenziazione del movimento anarchico riguarda la sua distribuzione geografica. “In linea di massima, si può affermare che, da un punto di vista geografico, l’anarchismo di matrice europea sviluppò maggiormente una visione collettivistica, classista e insurrezionale, mentre quello di origine statunitense si rivolse prevalentemente verso principi individualistici e non-violenti. Tale differenza si spiega sia con motivi storici che culturali: in Europa, il movimento anarchico, che si rivolgeva soprattutto alla classe operaia e contadina, si trovò a fronteggiare soprattutto regimi dispotici o non pienamente democratici (Spagna, Russia, Italia) ed era dunque più predisposto ad adottare una concezione rivoluzionaria. L’imparentamento con il movimento socialista, poi, lo rese incline a optare per una visione di tipo collettivista, anche perché le forti disparità sociali e l’altissima conflittualità tra le classi rendeva più auspicabile, da parte di queste ultime, la fine del regime di proprietà privata. In America11 (…), invece, dove si era già compiuta una rivoluzione, quella liberale, e dove la sterminata estensione territoriale e l’ampiezza delle risorse rendeva scarsamente accettabile una organizzazione sociale di tipo comunista, si sviluppò una corrente anarchica individualista e non violenta: quest’ultima si proponeva la diffusione e la socializzazione delle libertà esistenti, e non mancò di entrare in conflitto con l’anarchismo socialista importato dall’Europa nella seconda metà del XIX secolo dagli esuli politici europei e propagandato 11 Gli autori qui si riferiscono agli Stati Uniti già che nell’America Latina l’anarchismo fu introdotto dagli immigrati e quindi si caratterizzò come una riproduzione di quello europeo. 49 nelle comunità di immigrati, soprattutto delle grandi città della costa orientale degli Stati Uniti” (PANI & VACCARO, 1997:16). 4. Le scuole di pensiero anarchiche e le proposte di organizzazione sociale della produzione Nonostante lo stimolo a forme di approccio e interpretazione individualizzate, frutto del rispetto della libertà e dell’individualità, è possibile identificare “scuole” o “correnti” di pensiero ben definite. All’interno della dottrina anarchica convergono tendenze di carattere marcatamente individualistico (l’anarchismo individualista difeso da STIRNER); che preconizzano una società di piccoli produttori o di associazioni di produttori in libera concorrenza tra di loro (il mutualismo difeso da PROUDHON); tendenze più marcatamente socialiste, che prevedono, accanto all’autogestione dei produttori e a suo stesso presidio, dei freni e delle regolamentazioni che limitino la concorrenza fra i gruppi economici (il collettivismo difeso da BAKUNIN); tendenze più spiccatamente collettiviste o comuniste (il comunismo difeso da KROPOTKIN e il sindacalismo libertario del quale SOREL è ritenuto il suo più importante teorico). Secondo la scuola individualista, l’organizzazione della futura società avrebbe dovuto obbedire al principio della massima libertà individuale. Per gli anarchici individualisti, l’interesse individuale è la misura di tutte le cose. L’individuo non dovrebbe preoccuparsi del benessere della società, ma della sua felicità personale e la società gli sarebbe servita solo come mezzo per raggiungerla. “La vita sociale, secondo tale punto di vista, trascorre sotto costante e irreversibile tensione, già che l’individuo ha bisogno di stare sempre a difendere la sua libertà e a preservare la sua singolarità” (LUIZETTO, 1987:17). Gli individualisti non scartano la possibilità che nella società futura possa esistere qualche struttura associativa, ma essa deve avere un carattere provvisorio, esistendo soltanto in quanto necessaria. È il caso, per esempio, dell’“Unione degli Egoisti”, proposta da STIRNER. Essa doveva essere organizzata spontaneamente con lo scopo di difendere gli interessi particolari dei suoi membri, sciogliendosi non appena avesse raggiunto il suo obiettivo. L’esponente più importante dell’anarchismo individualista fu Max STIRNER, anche se, secondo autori come WOODCOCK e PANI & VACCARO, egli non abbia mai usato il termine “anarchico” per riferirsi a se stesso e, in più, sia stato scoperto dagli anarchici solo dopo la sua morte. Nella sua opera più importante, L’Unico, STIRNER critica la società esistente per il suo carattere autoritario e anti-individualista e indica una situazione 50 desiderabile che però si realizzerebbe soltanto con l’abolizione dello Stato e delle istituzioni governative; chiede l’uguaglianza fra gli egoisti, anche se si rende conto che ciò comporterebbe una tensione nell’equilibrio delle forze e poteri e, infine, suggerisce mezzi insurrezionali per la trasformazione della società nell’“Unione degli Egoisti”. Egli “nega tutte le leggi naturali e un’umanità comune; indica il suo ideale nell’egoista, l’uomo che realizza se stesso in conflitto con la collettività e gli altri individui, che non rifugge dall’uso di nessun mezzo nella «lotta di ciascuno contro tutti,» che spietatamente giudica ogni cosa dal punto di vista del benessere e che, avendo proclamato la sua sovranità, può formare con altri individui che la pensano come lui un’«unione di egoisti,» senza norme né regole, per provvedere a questioni di interesse comune” (WOODCOCK, 1966: 81/82). Secondo STIRNER, “l’individuo non deve esercitare il suo potere sugli altri. Ogni uomo difende con la forza la sua unicità, ma deve mirare soltanto alla realizzazione di sé propria del vero egoismo, non già sovraccaricarsi di proprietà inutili, né cercar di esercitare sugli altri un predominio che distruggerebbe la sua indipendenza. (…) Nel mondo di Stirner non vi saranno padroni né servi, e lo stesso ritrarsi di ogni uomo nella sua unicità, lungi dal provocare conflitti, contribuirà ad eliminarli” (WOODCOCK, 1966:88). Inoltre, per lui, l’egoismo non impedisce l’unione fra individui, anzi, favorisce unioni vere e spontanee. STIRNER critica la convinzione dei socialisti e dei comunisti che il problema della proprietà potesse risolversi in forma amichevole. Secondo lui, ogni uomo deve avere e prendere ciò che gli è necessario, e ciò implica la “guerra di ciascuno contro tutti”. Stando così le cose, per STIRNER il rifiuto a qualsiasi progetto sociale proposto dalle altre scuole aveva una ragione in più: “in qualsiasi delle modalità di socialismo suggerite, sarebbe necessario ammettere l’esistenza di qualche istanza sovraindividuale di potere, capace di definire procedimenti collettivi, di imporre regolamenti generali e di arbitrare tutti i casi di divergenze e conflitti. Con questo, l’individuo si sarebbe sottomesso a un insieme di interessi stranei, dato che i suoi obiettivi particolari non coincidono con quelli della collettività” (LUIZETTO, 1987:18). Secondo WOODCOCK, L’Unico rimane un libro estremamente personale, in cui STIRNER manifestò tutto il suo scontento su tutto ciò che l’opprimeva e distruggeva. Ma è anche l’espressione di un punto di vista di un estremo del vario “spettro” delle teorie anarchiche. Le idee suddette furono ampiamente difese da Max STIRNER, ma chi di fatto le ha messe in pratica fu Josiah WARREN. Egli, nel 1825, aderì ai piani di Robert OWEN e, 51 insieme a circa ottocento persone, aiutò a fondare, in Indiana-EUA, la Colonia New Harmony. L’obiettivo di OWEN nel creare questa comunità era quello di, avendo per principio fondante il comunismo, ricostruire la società secondo l’ideale della proprietà comune, credendo che così avrebbe posto le basi per la felicità personale e per la costruzione di un rapporto più armonioso tra gli uomini. Secondo LUIZETTO, due anni dopo il suo ingresso nel gruppo, WARREN lo abbandonò, deluso dai risultati raggiunti dall’esperienza, affermando che l’uniformità richiesta alle persone aveva fatto diventare l’ambiente insopportabile. Per WARREN, il problema principale non era il livellamento economico imposto, ma il fatto che il tempo aveva fatto diventare “sempre più difficile l’esistenza di divergenze di opinioni, sempre più criticata la pretesa di raggiungere certi obiettivi personali e sempre più ostacolata la ricerca della realizzazione di certi gusti particolari. Tutte queste manifestazioni erano viste con diffidenza e giudicate pericolose per l’esito della colonia” (LUIZETTO, 1987:20). WARREN riteneva che la colonia non era riuscita a risolvere, in forma soddisfacente, il conflitto tra gli interessi individuali e collettivi. Le questioni più rilevanti erano sempre risolte direttamente da OWEN o per decisione della maggioranza, tramite l’assemblea. Per la minoranza, però, quest’assemblea aveva un’aria tirannica. Secondo lui, tramite la manifestazione dell’interesse generale, tutti hanno avuto un progetto o un desiderio personale contestato. Inoltre, questa esperienza l’indusse “a dedurre che è impossibile la convivenza sociale disinteressata appunto a causa della diversità naturale degli individui. Lo indusse altresì alla conclusione sull’individualizzazione completa della vita sociale, cioè nei rapporti di scambio eguale, di stretta reciprocità tra gli uomini e lo portò infine a considerare il tempo che richiede un prodotto od un servizio come misura del valore di scambio ed a seconda della moralità di ciascuno. Warren concluse anche per il ripudio di tutto ciò che una collettività potrebbe imporre ai singoli per i servizi pubblici, giacché – egli dice spetta agli individui, se lo vogliono, di decidersi per fare eseguire questi servizi da persone impiegate e pagate a seconda del tempo che impiegano in detti lavori” (NETTLAU, 1964:37). Nello stesso anno in cui abbandonò New Harmony, WARREN passò a dedicarsi all’elaborazione del suo proprio piano per la costruzione del nuovo ordine sociale, che aveva come obiettivo principale il rispetto della libertà completa dell’individuo. Il suo piano, che derivava delle idee di OWEN, prevedeva il libero accesso delle persone alle risorse naturali, la libertà dell’individuo di disporre della sua persona, del suo tempo, della sua proprietà e dell’accesso all’acquisizione di beni tramite il proprio lavoro. Per tale, il sistema doveva essere guidato da un principio di giustizia, che prevedeva l’instaurazione 52 “di rapporti economici limitati all’interscambio equo di prodotti del proprio lavoro, essendo il valore di ogni prodotto determinato soltanto dal (…) tempo necessario alla sua produzione” (LUIZETTO, 1987:22). Dopo aver fissato il suo piano, WARREN lo mise in pratica creando nel 1827 a Cincinnati-USA uno stabilimento chiamato Equity Store/Time Store12 “(uno spaccio nel quale vendeva o comprava egli stesso le mercanzie a seconda della misura del tempo); propagandò questo sistema con la sua azione personale, con gli scritti e col giornale The Peaceful Revolutionist, nel 1833, in Cincinnati – il primo giornale anarchico secondo ogni probabilità – ed intrattenne una corrispondenza con le cooperative inglesi; in breve, riuscì ad attrarre l’attenzione sulle esperienze e sulle sue idee” (NETTLAU, 1964:37). Più tardi, fondò in Ohio una comunità basata su imprese individualiste. Molti furono i tentativi, negli Stati Uniti, di mettere in pratica esperienze di questo tipo. NETTLAU cita quelli che, “dal 1851 e per i dieci anni successivi, vissero a Trianville (la città meglio conosciuta come Modern Times, in Long Island, non molto distante di New York), ciascuno a suo modo, servendosi localmente dallo scambio tra di loro ed usando dei buoni di lavoro. Fu prevalentemente una comunità di vita indipendente e senza autorità ufficiale, che attrasse buoni elementi e che dimostrò come la libertà unisca gli uomini e come invece l’autorità li divida” (NETTLAU, 1964:38). La Guerra Civile, però, intiepidì gli animi di quelli che si dedicavano all’esecuzione di tali progetti. La seconda scuola, la mutualista, ebbe in PROUDHON il suo rappresentante più importante e occupò una posizione intermedia tra la scuola individualista e quella socialista. Secondo WOODCOCK, PROUDHON fu il primo a usare la parola “anarchia” in senso positivo e ad autodenominarsi “anarchico”, diventando il precursore diretto del movimento anarchico organizzato. Le sue idee aiutarono a formare l’Associazione Internazionale dei Lavoratori, la Comune del 1871 nonché le idee della maggior parte dei sindacalisti francesi tra il 1890 e il 1910. L’influenza esercitata da PROUDHON si deve alla natura sociologica del suo pensiero. Secondo WOODCOCK, PROUDHON dev’essere “considerato un individualista sociale. (…) Per Proudhon l’individuo è insieme il punto di partenza e la meta ultima dei nostri sforzi, ma la società rappresenta la matrice – l’ordine seriale, direbbe lui – in cui la personalità di ogni uomo deve trovare la sua funzione e realizzazione” (WOODCOCK, 1966:93). Più che un semplice teorico anarchico, PROUDHON fu uno fra i grandi europei del XIX secolo. Tutta la sua opera, sottolinea GUÉRIN, fu la ricerca di un equilibrio fra le preoccupazioni degli individui e l’interesse della società. 12 Il primo nome appare in LUIZETTO e il secondo in NETTLAU. 53 Secondo PROUDHON, l’individualismo è il fatto primordiale dell’Umanità e l’associazione il complementare, non si può avere l’egemonia di uno sull’altro. E conclude: né comunismo, né libertà illimitata. Inoltre, secondo NETTLAU, PROUDHON aveva molta fiducia nelle tendenze associative e federative degli uomini. Riteneva che ristabilire l’azione libera delle associazioni e delle federazioni contro l’intervento del monopolio creerebbe l’isolamento e la conseguente liquidazione degli Stati, dando luogo all’associazione e alla federazione degli organi di vera utilità sociale. D’altra parte, PANI & VACCARO richiamano l’attenzione sul fatto che, per PROUDHON, l’obiettivo prioritario della lotta per l’emancipazione umana doveva essere l’abolizione dello Stato e del capitalismo, il che sarebbe avvenuto tramite la loro sistematica riduzione. Al loro posto, proponeva il mutualismo come sistema di produzione e di scambio e il federalismo politico come sistema decentrato di potere, nel quale l’autorità salirebbe dal basso verso l’alto. L’idea di giustizia immanente occupa una posizione centrale nel pensiero di PROUDHON, e l’elemento chiave del suo pensiero sociale e politico è l’ideale della vita libera contadina. Il primo si deve alla tradizione rivoluzionaria francese del suo tempo; il secondo, alle sue origini. È in questo quadro che deve essere analizzato il pensiero e il contributo di PROUDHON all’anarchia. PROUDHON scrisse diverse opere. La prima, Célébration du dimanche fu scritta per partecipare a un concorso promosso dall’Accademia di Bensançon in cui si doveva presentare un saggio sulla Celebrazione della Domenica. Secondo WOODCOCK, in quest’opera PROUDHON esprime l’approvazione per l’istituzione di un giorno di riposo e dedica buona parte del saggio a un’idillica descrizione della pacifica vita rurale. Propone Mosè non solo come un leader religioso ma anche come il padre della riforma sociale. Mette in dubbio la traduzione dell’ottavo comandamento, interpretandolo come “Non mettere da parte nulla per te stesso” e denuncia chiaramente l’istituto della proprietà, affermando categoricamente che “l’eguaglianza di condizioni è… il fine ultimo della società”. “L’atteggiamento di Proudhon nei confronti dei problemi sociali era già quello che avrebbe mantenuto per il resto della vita, e nel suo pensiero erano già presenti quelli che ne sarebbero rimasti gli elementi essenziali: l’egualitarismo, la teoria che l’accumulo della proprietà è un male, il senso di una giustizia naturale e immanente” (WOODCOCK, 1966:98). 54 PROUDHON parte all’attacco diretto con Che cos’è la proprietà?, opera pubblicata nel 1840 e che gli diede notorietà13. La risposta è diventata slogan per tutto il movimento anarchico: “La proprietà è un furto!”. Si trattava, come spiegò lui stesso più tardi, di una frase ad effetto. Per “proprietà egli intendeva (…) «la somma dei suoi abusi.» Voleva denunciare la proprietà dell’uomo che se ne serve per sfruttare il lavoro di altri senza alcuno sforzo da parte sua. Per il «possesso,» il diritto dell’uomo all’effettivo controllo della casa in cui abita, della terra, degli utensili di cui ha bisogno per lavorare, Proudhon aveva soltanto approvazione; lo considerava anzi la chiave di volta della libertà, e la principale critica da lui rivolta ai comunisti fu che essi volevano distruggerlo. (…) L’uomo che lavora ha un diritto assoluto su ciò che produce, ma non sui mezzi di produzione. «Il diritto ai prodotti è esclusivo, jus in re; il diritto ai mezzi è comune, jus ad rem.» Così dev’essere, non soltanto perché le materie prime sono fornite dalla natura, ma anche a causa di quel retaggio di installazioni e tecniche che è la vera fonte della ricchezza umana, e a causa di quella collaborazione che rende il contributo di ciascuno tanto più efficace che se ciascuno lavorasse in solitudine” (WOODCOCK, 1966:99). Secondo PROUDHON, “la proprietà è (…) incompatibile con la giustizia, in quanto in pratica determina l’esclusione della maggioranza dei produttori dal diritto ad una giusta parte dei prodotti del lavoro comune” (WOODCOCK, 1966:99). PROUDHON si dedica a cercare alternative alla proprietà e all’organizzazione sociale basata sulla proprietà e la trova nell’“anarchia”, “un governo che non è governo”. È “nell’«anarchia» o «libertà» [che] Proudhon (…) trova una sintesi che elimina le deficienze di entrambi e apre la strada ad una società in cui potranno fiorire insieme eguaglianza, giustizia, indipendenza, riconoscimento di meriti individuali, in un mondo di produttori uniti da un sistema di liberi contatti” (WOODCOCK, 1966:100). Che cos’è la proprietà? contiene gli elementi di base su cui poi saranno costruite le dottrine libertarie e decentraliste. 13 In questo libro, che sconvolse non solo la Francia ma anche l’Europa di quegli anni, PROUDHON usa per la prima volta il termine anarchia nella sua accezione positiva e allo stesso tempo richiede a se stesso il titolo di anarchico. E lo fece “in parte per sfida, in parte con l’idea di sfruttare le qualità paradossali del termine. Aveva capito l’ambiguità del greco anarchos, ed era risalito ad esso appunto per questo motivo, per sottolineare che la critica dell’autorità cui si accingeva non implicava necessariamente una difesa del disordine” (WOODCOCK, 1966:7). Questo termine verrà usato dagli anarchici solo dopo la rottura tra i seguaci di Marx e quelli di Bakunin, accaduta negli anni 1870 durante la I Internazionale. Prima gli anarchici si autoidentificavano e cercavano di attrarre simpatie verso le sue idee usando termini come federalista (usato da Proudhon), mutualista (usato da PROUDHON e dai suoi discepoli), collettivista (da Bakunin e suoi discepoli) oppure libertario (termine coniato da J. Déjacque). Ma, come afferma GUÉRIN, “la maggior parte di questi termini (…) trascurano di esprimere l’aspetto fondamentale delle dottrine che pretendono di descrivere. Infatti, anarchia è, innanzitutto, sinonimo di socialismo. L’anarchico è, in primo luogo, un socialista che mira ad abolire lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. L’anarchismo non è che una delle tendenze del pensiero socialista. Una tendenza in cui predominano la preoccupazione della libertà, la fretta di abolire lo Stato” (GUÉRIN, sdp:9). 55 Nell’autunno 1846 PROUDHON pubblicò il suo Sistema delle contraddizioni economiche, o Filosofia della miseria, dove si dedica a dimostrare perché, nella società, le buone possibilità si trasformano in cattivi risultati. Critica il comunismo che, secondo lui, assume come principio la fratellanza umana ma finisce per distruggerla stabilendo il monopolio. Non mira a eliminare le contraddizioni economiche ma sì a stabilire fra di esse un equilibrio dinamico. “Questo equilibrio (…) egli lo vede nel mutualismo, un concetto in cui entrano (…) le idee di dissoluzione del governo, di equa distribuzione della proprietà, di libertà del credito” (WOODCOCK, 1966:106). PROUDHON che aveva previsto la rivoluzione del febbraio 1848, vi partecipò attivamente. Ma non tardò a concludere che si trattava di “una rivoluzione senza idee”. Decise allora di fornire queste idee, mettendo in moto “il processo attraverso il quale, nei due decenni successivi, l’anarchia avrebbe cessato di essere una semplice tendenza teorica, senza alcun rapporto con gli eventi immediati, e si sarebbe invece volta alla propaganda e ad un’azione mirante a una trasformazione sociale in un futuro prevedibile. Nel 1848, anno della rivoluzione, e nel 1849, anno della reazione, la sua attività ebbe per oggetto principalmente tre attività: la serie di periodici avviata con la pubblicazione del primo numero di Le Représentant du peuple il 27 febbraio 1848; il tentativo di creare una Banca del Popolo e un sistema di scambio mutualistico; e l’unico, deludente esperimento parlamentare, iniziato quando un’elezione straordinaria nel giugno 1848 lo portò all’Assemblea Costituente. «Che cos’è il produttore? Nulla. Che cosa dovrebbe essere? Tutto.» Con questo motto stampato sotto la testata Le Représentant du peuple iniziò la sua carriera di primo periodico anarchico regolarmente pubblicato14” (WOODCOCK, 1966:108). L’indipendenza del giornale e lo stile inflessibile di PROUDHON garantirono un successo immediato. Lì difese l’idea che “il proletariato si deve emancipare senza l’aiuto del governo”, denunciò il mito del suffragio universale “e sottolineò che la democrazia politica senza cambiamenti economici avrebbe potuto risultare in un regresso anziché in un progresso” (WOODCOCK, 1966:109). Secondo WOODCOCK questo fatto rende ancora più incomprensibile il desiderio di PROUDHON di farsi eleggere all’Assemblea Costituente ma, comunque sia, l’esperienza rivelandosi quasi subito deludente “accrebbe la sua diffidenza per i metodi politici e contribuì all’anti-parlamentarismo che caratterizzò i suoi ultimi anni e che egli avrebbe lasciato in eredità a tutto il movimento anarchico” (WOODCOCK, 1966:110). Nel luglio 1848, a causa di un articolo contro Luigi Napoleone, PROUDHON ebbe il suo 14 “Il primo periodico anarchico in assoluto fu probabilmente un giornale intitolato El Porvenir che lo spagnolo Ramón de la Sagra, discepolo di Proudhon, pubblicò per breve tempo in Galizia nel 1845” (WOODCOCK, 1966:108). 56 giornale chiuso. Decise allora di trasformare l’Assemblea Costituente nel suo foro, ma le sue proposte erano sempre rifiutate. PROUDHON era riuscito a riaprire il suo giornale, ma subito dopo esso venne chiuso definitivamente. Con alcuni amici creò un altro giornale, Le Peuple, e mentre esso non cominciava a pubblicare, PROUDHON si dedicò a maturare “i suoi progetti per la Banca del Popolo. Doveva essere uno strumento per favorire uno scambio di prodotti fra i lavoratori basato su buoni di lavoro e per fornire crediti ad un bassissimo tasso d’interesse, il cui gettito sarebbe servito a coprire le spese d’amministrazione. Proudhon riteneva possibile creare con questi mezzi una rete di artigiani e agricoltori indipendenti e di associazioni operaie che avrebbero contrattato al di fuori del sistema capitalistico e avrebbero infine operato la trasformazione della società: una trasformazione che Proudhon sperava sempre (…) dovesse essere pacifica. Ma, benché fosse costituita in ente il 31 gennaio 1849 e ben presto raccogliesse le adesioni di 27.000 membri, la Banca non iniziò mai le operazioni a causa delle vicende della carriera giornalistica del suo promotore” (WOODCOCK, 1966:112/113). A causa di altri due articoli pubblicati ne Le Peuple contro Luigi Napoleone PROUDHON venne dichiarato decaduto dall’immunità parlamentare e condannato a tre anni di prigione e a tremila franchi di multa. Si appellò contro l’accusa e fuggì in Belgio ma dopo due settimane tornò a Parigi dove liquidò la Banca del Popolo e continuò a pubblicare il suo giornale. Fu scoperto, arrestato e portato in carcere. Gli anni che trascorse in prigione (1849-1852) furono tra i migliori della sua vita. Fu alloggiato confortevolmente, poté studiare, scrivere, ricevere gli amici e addirittura gli fu concesso di uscire dal carcere ogni tanto per curare i suoi affari. “In questo periodo scrisse tre libri, due dei quali sono tra i suoi migliori, continuò a pubblicare giornali, addirittura si sposò e procreò” (WOODCOCK, 1966:113). Pubblicò anche tre giornali diversi. Dopo il fallimento dell’insurrezione del giugno 1849 contro Luigi Napoleone aver segnato la fine di Le Peuple, lui si dedicò a creare un altro giornale, chiamato La Voix du peuple, ancora più popolare degli altri. Questo giornale circolò dal settembre 1849 al maggio 1850. Poco dopo la definitiva soppressione di La Voix PROUDHON cominciò a pubblicare un quarto giornale, chiamato Le Peuple come il secondo, ma la mancanza di fondi faceva sì che la sua uscita si desse in intervalli irregolari. Esso venne chiuso definitivamente, nell’ottobre 1850. Senza dover dedicarsi alla pubblicazione dei giornali, PROUDHON passò a impegnarsi nella scrittura dei suoi libri. “Les confessions d’un révolutionnaire, apparse nel 1850, analizzano i fatti del 1848 da un punto di vista anarchico, giungendo alla conclusione che il vero fine rivoluzionario non sarà 57 raggiunto finché non si accetterà il vero principio della rivoluzione: «non più governo dell’uomo da parte dell’uomo, attraverso il mezzo dell’accumulo di capitale.»” (WOODCOCK, 1966:115). “L’idée générale de la Révolution au XIX siécle, pubblicata nel luglio 1851, è quanto a stile molto meno brillante delle Confessions, ma più importante come documento d’una fase nel processo del pensiero anarchico” (WOODCOCK, 1966:115). È in quest’opera che PROUDHON presenta l’esame attento della società che aveva annunciato cinque anni prima come supplemento alle Contraddizioni economiche. L’idée générale de la Révolution comincia con uno studio del processo rivoluzionario inteso come un fenomeno necessario e naturale. Secondo lui, bisognava costruire il nuovo edificio dalle istituzioni industriali, e ciò sarebbe avvenuto attraverso l’Associazione, sempre che intesa come mezzo per un fine più grande e non come fine a sé stessa. Nella generalizzazione del principio del contratto – che oppone a quella del governo – e nella trasformazione della società in una rete di volontari accordi fra individui liberi, PROUDHON vede il nuovo ordine di organizzazione economica, nettamente distinta da quella politica. Una volta instaurato quell’ordine, non vi sarà più nessun bisogno d’un governo e, tornando alla sua vecchia dottrina serialista, conclude che l’anarchia è la fine della serie di cui l’autorità è l’inizio. Ma non si ferma a queste considerazioni in termini generali e presenta invece un rapido quadro dell’organizzazione che si potrà dare alla società quando avrà trionfato l’idea di contratto. Sono già presenti elementi che caratterizzeranno le visioni di anarchici e sindacalisti in un periodo successivo: decentramento, federalismo, controllo diretto da parte dei lavoratori. De la justice dans la révolution et dans l’église, la sua opera più grande e voluminosa, apparve nel 1858. Nacque “come replica allo scandalistico attacco personale di un dubbio apologista cattolico che scriveva sotto il nome di Eugène de Mirecourt, ma si sviluppò strada facendo in un ampio trattato in cui la giustizia trascendente – la giustizia della Chiesa – era posta a confronto con la giustizia immanente, che vive nella coscienza dell’uomo ed è la vera forza animatrice della rivoluzione” (WOODCOCK, 1966:119). Per quanto riguarda la storia del pensiero anarchico, secondo WOODCOCK, questo è un libro secondario. Ma le idee lì espresse gli procurarono un’altra condanna. Ancora una volta ricorse in appello e fuggì in Belgio, dove “cominciò a scrivere La Guerra et la Paix, un’opera stimolante sulla sublimazione degli impulsi bellicosi dell’uomo in impulsi sociali creativi. In quel periodo gli divenne anche chiaro che fra gli intellettuali russi e gli operai francesi stava rinascendo l’interesse per le sue idee” (WOODCOCK, 1966:119). 58 PROUDHON ritornò in Francia nell’autunno del 1862. Negli ultimi mesi dell’esilio in Belgio aveva cominciato a interessarsi dalla questione del nazionalismo, motivato dal rapido progresso vissuto dall’Italia verso l’unificazione. Secondo WOODCOCK il nazionalismo era il retaggio più dinamico della Rivoluzione Francese, ma PROUDHON non fu mai un nazionalista nel vero senso della parola. “Per lui, l’unità che contava non era quella politica e nell’Idée générale del la Révolution espresse apertamente il desiderio che fossero abolite le frontiere nazionali, con tutte le divisioni che comportano. Fu, tra gli uomini del 1848, uno dei pochi che si resero conto degli aspetti reazionari del nazionalismo” (WOODCOCK, 1966:121). “Di nuovo a Parigi, si mise a lavorare ad un libro che doveva essere un sommario delle sue idee sul nazionalismo e presentare l’alternativa federalistica. Du principe fédératif, apparso nel 1863, è una delle sue opere più caotiche (…); buona parte del libro era consacrata a diatribe con critici nazionalistici, ma l’intenzione centrale era trasferire la sua idea di anarchia dal livello dei rapporti economici e industriali alla società in generale. Egli vedeva infatti la federazione come una tappa sulla strada verso quell’anarchia definitiva che si sarebbe realizzata – ora lo ammetteva – solo di lì a qualche secolo; alla base di entrambe vedeva «l’ordine pubblico direttamente fondato sulla libertà e coscienza del cittadino.» Nella sua concezione, il principio federativo avrebbe dovuto operare partendo dal più semplice livello della società. L’organizzazione amministrativa doveva cominciare al livello locale, rimanendo il più vicino possibile al diretto controllo del popolo; gli individui dovevano dare inizio al processo federandosi in comuni e associazioni. Al di sopra di quel livello primario l’organizzazione federativa sarebbe divenuta meno un organo amministrativo e più un organo di coordinamento fra unità locali. Alla nazione si sarebbe così sostituita una confederazione geografica di regioni, e l’Europa sarebbe divenuta una confederazione di confederazioni, in cui gli interessi della più piccola provincia avrebbero avuto lo stesso peso di quelli della più grande e tutte le questioni sarebbero state risolte mediante reciproci accordi, contratti, arbitrati. Dal punto di vista dell’evoluzione delle idee anarchiche Du principe fédératif è uno fra i libri più importanti di Proudhon in quanto è il primo che sviluppò a fondo in senso libertario l’idea di organizzazione federale come alternativa pratica al nazionalismo politico” (WOODCOCK, 1966:122/123). Un’altra questione a cui si dedicò fu quella della partecipazione alla vita politica. Non tutti i lavoratori che aderivano ai principi federalisti e mutualisti proudhoniani erano d’accordo con la sua idea di astenersi dalla vita parlamentare. Tre tra questi operai presentarono la loro candidatura nel 1863, senza però ottenere successo. La loro posizione divenne chiara nel 1864 quando il gruppo che li aveva sostenuti pubblicò il 59 famoso Manifesto dei Sessanta, uno fra i documenti chiave del socialismo francese. In questo documento, sostanzialmente viene difeso il loro diritto a partecipare alla vita parlamentare come rappresentanti dei lavoratori, dato che i deputati di allora rappresentavano l’interessi di una sola parte della società. Benché non fosse totalmente d’accordo con i firmatari del Manifesto, PROUDHON discusse con loro e si servì di questo documento per scrivere il suo ultimo libro, De la capacité politique des classes ouvriéres, il quale “influenzò lo sviluppo del movimento operaio in Francia e indirettamente, attraverso il sindacalismo, lo sviluppo dell’anarchia in tutta l’Europa e nelle Americhe. Inoltre esso diede l’ultimo tocco alla visione anarchica alla cui formulazione Proudhon aveva dedicato tutta la vita. In questo libro Proudhon elabora la sua dichiarazione del 1848 che «il proletariato si deve emancipare da solo» celebrando l’avvento dei lavoratori come classe indipendente nel campo della politica. «Possedere capacità politica,» dichiara, «significa avere coscienza di se stesso come membro della comunità, proclamare l’idea che deriva da questa coscienza, e perseguirne la realizzazione. Chiunque riunisca queste tre condizioni è politicamente capace.» Il Manifesto dei Sessanta, nonostante gli errori che contiene, dimostra che il proletariato francese comincia a soddisfare le tre condizioni. Ha coscienza15 che la sua vita e le sue necessità ne fanno un gruppo separato, con un suo posto nella società e una sua missione nell’evoluzione sociale. L’idea che emerge da questa consapevolezza è quella di mutualità, che, mirando all’organizzazione della società su una base egualitaria, dà alla classe operaia un carattere progressista. La realizzazione avverrà attraverso il federalismo, che assicurerà al popolo un’autentica sovranità in quanto il potere verrà dal basso e avrà il suo fondamento in «gruppi naturali,» uniti in corpi con compiti di coordinazione per attuare la volontà generale. La sensibilità del sistema sarà assicurata dall’immediata revocabilità di qualsiasi delega. I «gruppi naturali» saranno una sola cosa con le unità operanti (della società), e così lo stato politico scomparirà per essere sostituito da una rete di organi d’amministrazione sociale ed economica: sarà l’anarchia, nel senso positivo della parola. Proudhon morì nel gennaio 1865, prima che fosse pubblicata questa sorta di testamento; era vissuto abbastanza da poter ricevere, con gioia, la notizia della fondazione della Prima Internazionale, in gran parte per iniziativa dei suoi seguaci” (WOODCOCK, 1966:124/125). Nel frattempo le esperienze del proletariato nei paesi latini rendevano le sue idee più ricettive. “Da questo rapprochement fra le idee dei rivoluzionari e i desideri nascenti di un vasto settore della classe operaia l’anarchia doveva finalmente emergere come movimento verso la fine del decennio 1860-1870. Proudhon non fondò il movimento anarchico – benché vada 15 Il corsivo è mio. 60 considerato, insieme a Godwin, il fondatore dell’anarchia – e probabilmente avrebbe sconfessato molte delle sue manifestazioni successive; ma senza il suo lavoro preparatorio quel movimento non sarebbe potuto nascere sotto la guida del suo più pittoresco e più eretico discepolo, Michail Bakunin” (WOODCOCK, 1966:125). Il grande contributo di PROUDHON resta, come sottolinea NETTLAU, la critica all’autorità, la difesa dell’azione economica e qualsiasi altra azione umana diretta; la proposta della federazione e del patto, inteso come legami tra individui o gruppi, sempre temporaneo e revocabile. In intenso contrasto con le scuole individualista e mutualista era la scuola socialista, la cui proposta, apparentemente, sembrava essere in contraddizione col principio della società libertaria, soprattutto con la libertà individuale. Tale contraddizione era soltanto apparente in quanto per i membri della scuola socialista le due questioni principali dell’anarchismo – quella dei rapporti degli individui tra di loro e dei rapporti tra gli individui e la società – erano analizzate partendo da premesse diverse. Per la scuola socialista la vita societaria non era condannata a svolgersi in lotta permanente tra gli individui, ognuno dei quali preoccupato soltanto di difendere e garantire la sua individualità rispetto al prossimo. Per questa scuola, era necessario saper distinguere tra la singolarità degli individui e i conflitti individuali. I socialisti non hanno mai negato l’esistenza dei conflitti individuali nella società, solo non li attribuivano alla difesa della singolarità dell’individuo, ma sì a un processo storico che diffondeva principi antisociali, come la competizione, protetti soprattutto dallo Stato. Nella loro visione, la società era l’ambiente dove si sviluppava l’individualità e, perciò, non era ostile a essa. Anzi, era in questo ambiente che si sviluppavano anche i sentimenti sociali inerenti agli uomini, come la solidarietà e la cooperazione. Credevano così che l’“egoismo” difeso dagli individualisti fosse un comportamento acquisito e che, come tale, dovesse essere modificato. Altrimenti, a che cosa servirebbe la rivoluzione sociale? Era partendo da queste premesse che i socialisti difendevano la possibilità di conciliare la libertà e la singolarità individuali con le necessità e gli interessi collettivi. Sarà rispetto alla realizzazione di tale piano che si presenteranno le differenze tra le correnti collettivista e comunista. La corrente collettivista aveva in BAKUNIN il suo principale rappresentante. Secondo JOLL, BAKUNIN fu colui che, oltre a dare “alle generazioni successive un esempio di ardore rivoluzionario in azione[,] (…) mostrò [anche] quale distanza nella teoria e nella pratica, separasse l’anarchia dal comunismo marxista, rendendo così esplicita quella 61 frattura nel movimento rivoluzionario internazionale che era già stata implicita nelle divergenze fra Proudhon e Marx nel decennio 1840-50” (JOLL, 1970:107). BAKUNIN è ritenuto da diversi studiosi il fondatore del movimento anarchico e il pensatore che primo dotò l’anarchismo di una ideologia specifica e di una strategia rivoluzionaria. Tutto il suo “pensiero (…) ruota intorno alla coppia antinomica autoritàlibertà (…). Bakunin concepisce questi due elementi come inconciliabili e irriducibili l’uno all’altro: dove vi è l’uno non vi può essere l’altro, per cui il loro rapporto non può che darsi in termini di conflittualità” (PANI & VACCARO, 1997:57). Come tanti altri, BAKUNIN era un uomo di campagna. Con la sua famiglia, viveva una vita semplice, ma questo non lo impedì di imparare il tedesco, il francese, l’inglese e l’italiano, lingue che le furono utile durante la sua vita di rivoluzionario. Stette un anno alla Scuola d’Artiglieria a Pietroburgo e in seguito andò a Mosca, dove conobbe Nikokaj Stankevic, il primo ad avviarlo sulla strada della rivoluzione. Nel 1839 fuggì in Germania, restando a Berlino per due anni, come uno studente entusiasta alla ricerca del sapere, esplorando i circoli intellettuali e la società bohémienne di Berlino. Nel 1841 fece un viaggio a Dresda dove conobbe Arnold RUGE, uno fra i più influenti Giovani Hegeliani16 e l’uomo che iniziò la sua conversione. BAKUNIN si dedicò allo studio di questi filosofi e celebrò la sua “conversione pubblicando nei Deutsche Jahrbücher di Ruge, con il nom de plume di Jules Elysard, il suo primo saggio, uno dei suoi più importanti: La reazione in Germania. È per la maggior parte, un tipico tentativo di Giovane Hegeliano di presentare la dottrina di Hegel come una dottrina fondamentalmente rivoluzionaria; ma vi è qualcosa di veramente bakuniano nel tono apocalittico e nell’insistenza sulla distruzione come necessario preludio alla creazione” (WOODCOCK, 1966:131). Quando scrisse questo saggio BAKUNIN non era ancora un anarchico, ma fece qui la sua prima dichiarazione di perpetua rivolta e sottolineò l’elemento distruttivo che esiste in tutto il processo rivoluzionario. Questo marcò le sue idee fino a diventare uno degli elementi più importanti della sua visione dell’anarchia. Un anno dopo, a Zurigo, BAKUNIN conobbe WEITLING, il primo rivoluzionario militante che egli facesse la conoscenza. Fu WEITLING a farlo diventare un ribelle pratico. Quando più tardi WEITLING fu arrestato, BAKUNIN venne coinvolto e per sfuggire dall’esilio a cui fu condannato, se ne andò a Parigi, dove conobbe importanti ribelli come Marx, Leroux, Cabet e Proudhon. 16 Un gruppo di studiosi che aveva capovolto le teorie del Maestro al sostenere che il metodo dialettico poteva essere usato per dimostrare che tutto è in perpetuo flusso e che quindi la rivoluzione è più reale della reazione. 62 Secondo TARIZZO, durante “gli anni del soggiorno parigino Bakunin elabora l’embrione della sua concezione rivoluzionaria: il concetto di rivolta, come istinto innato dell’uomo, che deve ribellarsi per arrivare alla libertà contro tutti i valori e le convenzioni morali imposte dalla società, e soprattutto contro l’idea di Dio, fonte primaria di ogni autorità; la necessità di distruggere lo stato di cose esistente e di conseguenza la necessità della rivoluzione. Bakunin intravede nei popoli slavi, ancora non corrotti dalla civiltà e portati a vivere una vita comunitaria, lo strumento per ribaltare la società ed attuare la rivoluzione, e si mette in contatto con l’emigrazione polacca, perorando la causa delle nazionalità oppresse” (TARIZZO, 1976:36/37). Nel novembre 1847, a Parigi, BAKUNIN fa il suo primo discorso pubblico, enunciando “per la prima volta (…) quello che doveva essere il tema chiave del periodo di mezzo della sua esistenza: l’unione dei popoli slavi nella rivolta e la conseguente rigenerazione dell’Europa” (WOODCOCK, 1966:133). Nel 1849 “scrisse l’Appello agli Slavi, il più importante documento del periodo nazionalistico, in cui (…) esortava alla creazione d’una grande federazione di tutti gli slavi. Profetizzava al popolo russo un ruolo messianico, e vedeva il suo paese come la chiave alla distruzione su scala mondiale dell’oppressione. (…) Per Bakunin le rivoluzioni nazionaliste avevano già implicazioni internazionalistiche, ed egli fece un altro passo sulla strada verso l’anarchia dichiarando che movimenti del genere potevano avere successo solo se includevano una rivoluzione sociale” (WOODCOCK, 1966:135). Secondo JOLL, nell’Appello agli Slavi e nelle Fondamenta della politica slava “si trovano già formulate alcune delle idee che faranno parte integrante del suo bagaglio teorico. Gli slavi dovevano federarsi (scriveva) in modo che «la nuova politica fosse una politica non di Stati, ma di popoli, di individualità libere e indipendenti»” (JOLL, 1970:110). Piano piano BAKUNIN si avviava verso una concezione sempre più radicale dell’avvenire. “Idee come quelle del primato della rivoluzione sociale, dell’indivisibilità della libertà (che implica il rifiuto dell’individualismo di Stirner), della necessità di distruggere l’ordine sociale esistente per ricominciare tutto da capo dovevano entrare nella dottrina anarchica formulata da Bakunin nel decennio 1860-70, insieme a certi elementi dell’Appello agli slavi, come l’idea della funzione rivoluzionaria della classe contadina e il rifiuto della democrazia parlamentare. Ma nel 1848 Bakunin non aveva ancora elaborato le sue più tarde concezioni dell’organizzazione libertaria: il rifiuto dello stato borghese non era incompatibile, in quest’epoca, con l’idea di una dittatura rivoluzionaria, carezzata per tutto il periodo panslavico” (WOODCOCK, 1966:135/136). 63 A causa della sua partecipazione affianco ai tedeschi nella lotta contro i re di Sassonia e Prussia, BAKUNIN fu catturato e portato in prigione, dove stette per sei anni. In questo periodo, diversamente da ciò che accadde a PROUDHON, l’unica cosa che gli fu permesso di scrivere furono le Confessione allo zar, richiesta dallo zar stesso, in cui doveva pentirsi delle sue attività di rivoluzionario. BAKUNIN le scrisse ma non convinse lo zar, che non gli consentì il suo trasferimento in Siberia, ottenuto solo nel 1857. Lì rimase fino al 1861 quando ottenne il permesso di fare un viaggio lungo l’Amur, riuscendo in quell’occasione a scappare. Una volta in libertà, BAKUNIN passò a dedicarsi alla causa panslava. Interruppe i suoi sforzi di unire tutti gli elementi della ribellione panslava quando scoppiò la rivoluzione polacca nel 1863 alla quale provò a partecipare. Ma la “fallita rivolta polacca del 1863 e l’eccessivo sciovinismo dimostrato dai polacchi indurranno Bakunin a rivedere il suo concetto di rivoluzione basato su ideali nazionalistici, facendolo approdare alla conclusione che la vera rivoluzione può avere soltanto un carattere sociale, punto fermo del suo pensiero dal quale non si discosterà più” (TARIZZO, 1976:37). Dopodiché BAKUNIN lasciò Londra e si diresse in Italia, dando inizio al periodo più attivo della sua carriera. Scelse la sua prima residenza a Firenze e lì fondò la sua prima Fratellanza segreta, una associazione dell'esistenza dubbiosa che si sciolse prima che lui se ne andasse a Napoli, all’inizio dell’estate del 1865. A Napoli trovò un ambiente molto più ricettivo e molti di quelli che conobbe in quell’occasione diventarono dopo devoti propagandisti delle sue idee17. Lì egli fondò “la sua Fratellanza Internazionale, che nel 1866 aveva reclutato un seguito e raggiunto una certa complessità d’organizzazione, almeno sulla carta” (WOODCOCK, 1966:140). Il Catechismo del rivoluzionario documento scritto da Bakunin per i membri della società, dimostra che egli e i suoi seguaci stavano facendo gli ultimi passi verso l’anarchia. In questo documento BAKUNIN dava un’importante enfasi alla questione della libertà, ritenendo che essa doveva essere assoluta e completa. “Bakunin va oltre la concezione individualistica della libertà, di stampo liberale (…) [e] ne afferma l’intima valenza sociale. La libertà altrui, lungi dall’essere un freno alla mia libertà, ne è anzi la conferma più esplicita, perché io non posso essere libero se anche gli altri non lo sono. Di qui lo stretto legame che unisce la libertà e l’uguaglianza: la realizzazione di un termine deve comportare la realizzazione dell’altro, perché non vi può essere vera libertà senza uguaglianza né vera uguaglianza senza libertà. Di qui la critica al socialismo (marxista) e 17 Secondo NETTLAU, a Napoli, oltre alla Fratellanza fu fondata nel febbraio 1867 dai compagni di BAKUNIN la società Libertà e Giustizia, che pubblicò dall’agosto fino agli inizi del 1868 un periodico omonimo. 64 al liberalismo, considerati rispettivamente una dottrina parziale dell’eguaglianza e una dottrina parziale della libertà. La libertà comunque, per Bakunin, non è solo un fine, una meta mai completamente raggiungibile alla quale tendere, non ha cioè solo una valenza etica. La libertà è anche un mezzo, una scienza, una prassi politica, e come tale ha dunque una diretta ed immediata valenza operativa” (PANI & VACCARO, 1997:58). Più avanti, BAKUNIN dichiara che l’autorità è la nemica naturale della libertà e afferma che essa si incarna in due archetipi, l’uno ideale, dio, e l’altro materiale, lo Stato. Secondo lui, la “scienza della libertà permette di cogliere gli elementi generali che compongono la struttura autoritaria della società, e che si trovano sempre presenti in ogni società aldilà della diversa forma che assumono in tempi e luoghi diversi. Essi sono: la divisione gerarchica del lavoro, il monopolio del sapere socialmente utile ai fini del comando politico, le classi e lo stato. Questi elementi sono intimamente legati tra di loro come in una catena, per cui è impossibile pensare di assolutizzarne uno e di far passare in secondo piano tutti gli altri, pensare che l’abolizione di uno possa comportare l’abolizione di tutti gli altri. La divisione generale e gerarchica del lavoro tra manuale e intellettuale produce ed è prodotta dal monopolio del sapere che rende possibile la subordinazione del lavoro manuale a quello intellettuale. Questi fattori sono l’origine e la causa della diseguaglianza sociale: la loro cristallizzazione gerarchica determina la divisione in classe della società (distribuzione gerarchica della proprietà, monopolio dei mezzi di produzione) e l’esistenza dello stato (distribuzione gerarchica del potere, monopolio del potere politico)” (PANI & VACCARO, 1997:60). “Allo Stato Bakunin vuol sostituire la libera federazione dei lavoratori: essi si riuniranno prima nelle associazioni, poi nei comuni cui è affidata la gestione della proprietà a livello locale; i comuni si federeranno in regioni, le regioni in nazioni e infine le nazioni in una grande federazione internazionale. Ogni organismo dovrà essere autonomo e potrà scindere anche i legami che lo uniscono alla federazione, così come ogni individuo potrà liberamente, se lo riterrà opportuno, allontanarsi dall’associazione, e dal comune18. Bakunin individua nelle classi più oppresse e miserabili della società, negli elementi déclassés, nel sottoproletariato della città e nei contadini, la forza motrice della rivoluzione sociale. Il suo proponimento è quello di collegare il sottoproletariato delle città e delle campagne per l’azione rivoluzionaria comune. Nella classe operaia così come la intende Marx, egli vede un’aristocrazia che sfrutta la massa dei lavoratori, in particolare modo i contadini” (TARIZZO, 1976:48). 18 La base di quest’organizzazione è il federalismo di PROUDHON. 65 Per BAKUNIN, l’associazione e la federazione costituiscono la base sulla quale si ricostruirebbe la società dopo l’abbattimento del sistema attuale. Inoltre, BAKUNIN afferma “che il fine supremo dell’umanità è «la conquista e la realizzazione della libertà e del pieno sviluppo materiale, intellettuale e morale di ognuno, attraverso la più completa solidarietà economica e sociale fra tutti gli esseri viventi sulla terra». Egli distingue nettamente fra società e Stato: la società per lui è qualcosa di naturale, comune all’uomo e a moltissime specie di animali, e va accettata perché fa parte dell’ordine naturale; lo Stato è invece la causa di ogni oppressione, politica ed economica, è forza bruta organizzata, creata al solo scopo «di organizzare il più vasto sfruttamento del lavoro a profitto del capitale concentrato in un ristrettissimo numero di mani. (…)» (Dio e lo Stato)” (TARIZZO, 1976:46). Davanti a tutti questi presupposti, la Fratellanza risultava, così, “avversa all’autorità, allo stato, alla religione, favorevole al federalismo e all’autonomia comunale; accettava il socialismo per la ragione che il lavoro «dev’essere l’unica base del diritto umano e dell’organizzazione economica dello stato»; affermava che la rivoluzione sociale non poteva affidarsi a mezzi pacifici. Per quanto riguarda però l’organizzazione, la Fratellanza Internazionale progettava una struttura gerarchica e diede un rilievo decisamente non libertario alla disciplina interna” (WOODCOCK, 1966:140/141). Nel settembre 1867 BAKUNIN partecipò a un congresso svoltosi a Ginevra “per discutere del «mantenimento della libertà, della giustizia e della pace» nell’Europa minacciata dal conflitto tra la Prussia e la Francia imperiale” (WOODCOCK, 1966:142). In quell’occasione venne fondata la “Lega della Pace e della Libertà” e BAKUNIN riuscì a essere eletto al suo comitato centrale. Al preparare i rapporti per il secondo Congresso che si sarebbe svolto l’anno successivo “compose una vasta tesi, pubblicata poi con il titolo Federalismo, socialismo e antiteologismo. La parte dedicata al federalismo era basata sempre sulle idee di Proudhon, e ancora Proudhon dominava in parte le sezione sul socialismo, che sottolineava la struttura classista della società contemporanea e l’inconciliabilità degli interessi di capitalisti e lavoratori. Bakunin definiva il suo atteggiamento socialista in questi termini: Ciò che chiediamo, è che sia nuovamente proclamato questo grande principio della rivoluzione francese: che ogni uomo deve avere i mezzi materiali e morali di sviluppare tutta la sua umanità. E questo principio, a nostro parere, va tradotto nel seguente problema: organizzare la società in modo tale che ogni individuo, uomo o donna, trovi nascendo mezzi il più possibile eguali per lo sviluppo delle sue differenti facoltà e per l’utilizzazione di esse attraverso il lavoro; organizzare una società che, rendendo impossibile per qualunque individuo, chiunque sia, lo sfruttamento di un altro, permetta a ciascuno di partecipare della ricchezza della 66 società – ricchezza non mai prodotta altrimenti che col lavoro – solo nella misura in cui col suo lavoro ha contribuito a produrla.19 La clausola finale, che noi abbiamo sottolineata, dimostra che anche su questo punto Bakunin era d’accordo con Proudhon. Diversamente dai comunisti anarchici del 1880-90, non credeva nella formula «da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni,» ma in quella radicalmente diversa «da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo quanto ha fatto»20 (…). Tuttavia Bakunin, benché non fosse, in termini kropotkiniani, un comunista, differisce da Proudhon in quanto fa dell’associazione (…) il principio centrale dell’organizzazione economica. Il gruppo di lavoratori, la collettività, prende il posto del lavoratore singolo come unità di base dell’organizzazione sociale. Con Bakunin la corrente principale dell’anarchia si stacca dall’individualismo, anche nella forma mitigata che ha in Proudhon; più tardi, nelle sessioni dell’Internazionale, i seguaci collettivisti di Bakunin si sarebbero battuti contro i seguaci mutualisti di Proudhon – gli altri eredi dell’anarchia – sulle questioni della proprietà e del possesso” (WOODCOCK, 1966:142/143/144). BAKUNIN non riuscì a fare il comitato centrale approvare il suo programma e la sua raccomandazione radicale al Congresso di Berna del 1868 in cui chiedeva l’eguaglianza economica e attaccava le autorità della Chiesa e dello Stato venne respinta dalla maggioranza del Congresso. BAKUNIN capì allora che non gli sarebbe riuscito fare della Lega lo strumento per promuovere la rivoluzione sociale. In quello stesso Congresso si dimise insieme a diciassette suoi seguaci – tra i quali Élisée RECLUS – e in mezzo a loro reclutò il nucleo della sua successiva organizzazione, l’Alleanza Internazionale della Democrazia Socialista. Essa assunse su scala internazionale la funzione di organizzazione di propaganda operante nella legalità assegnata alle Famiglie Nazionali nel piano originario della Fratellanza. Pensando in ampliare il raggio d’azione dell’Alleanza Internazionale, BAKUNIN chiese la sua ammissione come gruppo alla Prima Internazionale, già creata. Cominciarono allora le polemiche con MARX che, in quanto presidente del Consiglio Generale dell’Internazionale dei Lavoratori rifiutò la domanda, allegando che non riteneva utile alla causa dei lavoratori suddividere il movimento. BAKUNIN s’inchinò alla decisione del Consiglio e sciolse l’Alleanza. Nella primavera del 1869 le sue sezioni furono trasformate in sezioni dell’Internazionale, ma ciò non diminuì l’influenza di BAKUNIN all’interno dell’Internazionale. 19 20 Il grassetto è mio. Il corsivo è dell’autore. Il grassetto è mio. 67 Ci furono diversi scontri tra MARX e BAKUNIN all’interno dell’Internazionale, il più importante si svolse durante in Congresso di Basilea del settembre 1869, quando egli riuscì a battere i marxisti su un punto che, secondo WOODCOCK, non riguardava le differenze fondamentali tra i socialisti libertari e autoritari. “La materia del contendere è data, sul piano contingente, dal problema del diritto di successione, di cui Bakunin chiedeva con fermezza l’abolizione come «una delle condizioni indispensabili per l’emancipazione dei lavoratori»21[, mentre] (…) Marx sosteneva (…) che il diritto di successione era una semplice conseguenza della proprietà privata e che bisognava attaccare il sistema e non le conseguenze particolari dello stesso, come volevano i paladini dell’abolizione del diritto d’eredità” (WOODCOCK, 1966:148). BAKUNIN uscì vittorioso in quest’occasione, ma alla fine vinse MARX: il risultato dei diversi scontri tra loro fu l’espulsione di BAKUNIN dall’Internazionale nel Congresso dell’Aia nel 1872. In quell’occasione, MARX propose anche il trasferimento della sede del Consiglio Generale da Londra a New York. La proposta vinse ma questo segnò anche la fine della Prima Internazionale dei Lavoratori. Pochi giorni dopo il Congresso dell’Aia si svolse a Saint-Imier nel Giura “un congresso dei superstiti anarchici dell’Internazionale. Le decisioni raggiunte all’Aia furono ripudiate, e venne proclamata una libera unione di federazioni dell’Internazionale. Con l’Internazionale anti-autoritaria nata da quell’incontro Bakunin non ebbe nessun rapporto diretto; dal 1872 in poi la sua attività si andò restringendo, di pari passo con il rapido declinare della sua salute” (WOODCOCK, 1966:159). Prima ancora di lasciare definitivamente il movimento rivoluzionario BAKUNIN si unì a CAFIERO e al movimento italiano e in seguito agli anarchici insorti a Bologna nell’agosto 1874, un’insurrezione che neppure riuscì a cominciare. Fu l’ultimo tentativo rivoluzionario di BAKUNIN, che morì il 1° luglio 1876. Tra gli uomini che si raccolsero attorno alla sua tomba, c’era anche Elisée RECLUS. Secondo LUIZETTO, per l’elaborazione della sua proposta BAKUNIN assimilò alcune idee di PROUDHON, tra le quali la teoria dell’organizzazione federativa e la nozione che la parte della ricchezza socialmente prodotta corrispondente a ogni individuo deve essere proporzionale alla sua partecipazione nella produzione. Da ciò deriva l’espressione a ognuno secondo il suo lavoro. D’altra parte il distacco di BAKUNIN dalla scuola mutualista è significativo, soprattutto rispetto alla proposta di organizzazione della società in base alla collettivizzazione dei mezzi di produzione, che rappresentava la 21 BAKUNIN riteneva l’abolizione del diritto di eredità come primo passo verso l’instaurazione dell’eguaglianza sociale ed economica. E ciò faceva già parte, vale ricordare, del programma scritto per l’Alleanza Internazionale della Democrazia Socialista, come è stato suddetto. 68 sua condanna dalla proprietà privata, compresa la proprietà possesso difesa da PROUDHON. Sotto l’influenza di BAKUNIN, gli anarchici di questa corrente passarono a considerare la vita associativa come un dato inerente alla vita sociale, ritenendo che qualsiasi progetto di organizzazione sociale dovesse tenerla in considerazione. Il collettivismo proposto da BAKUNIN supponeva la fusione tra la teoria federalista di PROUDHON (la libera organizzazione dei produttori indipendenti) e la teoria socialista (la proprietà collettiva dei mezzi di produzione). Erano questi, secondo BAKUNIN, i due pilastri sui quali si sarebbe costruita la società libertaria futura. “Il funzionamento del sistema economico a partire dalla collettivizzazione della proprietà privata dei mezzi di produzione seguirebbe, in linee generali, il modello federalista proudhoniano: nella base, esisterebbero le unioni locali di lavoratori liberamente formate, che potrebbero proporre associazioni più ampie, d’accordo con i loro interessi e necessità. Si costituirebbe inoltre un’organizzazione di produttori-consumatori incaricati di amministrare l’economia, dalla produzione alla distribuzione. Bakunin immaginava che si strutturerebbe, con questo, l’unione mondiale di associazioni libere, di natura industriale e agricola. In un altro punto ancora il collettivismo secondo Bakunin seguiva il modello mutualista proudhoniano, ossia, nel problema dell’appropriazione individuale della ricchezza socialmente prodotta. In questo aspetto, Bakunin difendeva anche il sistema di retribuzione individuale rigorosamente proporzionale al lavoro effettivamente realizzato” (LUIZETTO, 1987:32/33). Secondo BAKUNIN, l’unica uguaglianza che dovrebbe esistere è quella dell’accesso ai mezzi di produzione, perché tutti gli individui, potenzialmente disuguali, possano svilupparsi secondo la loro capacità. Perciò BAKUNIN difendeva soltanto la collettivizzazione dei mezzi di produzione e chiedeva la fine della proprietà ereditaria, affermando essere questa la fonte delle disuguaglianze artificiali tra gli uomini. Nelle sue parole, “fin quando ci sarà l’eredità, ci sarà la disuguaglianza economica ereditaria, non la disuguaglianza naturale degli individui, ma quella artificiale delle classi, e (…) questa si tradurrà necessariamente sempre nella disuguaglianza ereditaria dello sviluppo e della cultura delle intelligenze e continuerà a essere la fonte e la consacrazione di tutte le disuguaglianze politiche e sociali” (BAKUNIN, 1988:37). In quel che si riferisce all’appropriazione del prodotto del lavoro, BAKUNIN difendeva l’idea che ognuno si appropriasse della ricchezza prodotta secondo la sua partecipazione, né più né meno. L’ultima corrente è infine quella anarchica comunista o comunista libertaria, rappresentata principalmente da KROPOTKIN. Questa corrente può essere caratterizzata 69 come un prolungamento dalla corrente collettivista. La grande differenza tra le due sta nell’introduzione del comunismo. Per BAKUNIN esso rappresentava la negazione della libertà individuale, mentre per KROPOTKIN questi due punti non erano escludenti, ma si completavano mutuamente, essendo non solo accettabili ma anche possibili. Durante tutta la sua vita KROPOTKIN credette nell’inevitabilità e desiderabilità della rivoluzione, ma non fu mai un rivoluzionario attivo come lo era stato BAKUNIN. Nonostante ammettesse la necessità della violenza, era contrario al suo uso. Ciò che attraeva la sua attenzione era l’aspetto positivo e costruttivo dell’anarchia, la visione di un paradiso terrestre alla quale si dedicò a edificare. KROPOTKIN era un uomo mite e l’originalità del suo pensiero “fece di lui uno scienziato e sociologo rispettato in tutto l’Occidente; (…) fu soprattutto merito suo se si cominciò a vedere nell’anarchia non un credo di violenza di classe e di distruzione indiscriminata, ma una teoria seria e idealista volta alla trasformazione della società” (WOODCOCK, 1966:162). Benché BAKUNIN e KROPOTKIN rappresentassero aspetti così distinti dell’anarchismo, le differenze fra loro non erano fondamentali. “La volontà di distruggere il mondo ingiusto dell’ineguaglianza e dell’autorità era implicito nell’atteggiamento di entrambi, come lo era la visione di un mondo nuovo, pacifico, un mondo di fratellanza umana che sarebbe nato (…) dalle ceneri dell’antico. Le differenze erano di accento, dettate dalle circostanze storiche non meno che dalle diversità di carattere” (WOODCOCK, 1966:162). Per KROPOTKIN, nato alla metà dell’Ottocento, l’idea di rivoluzione come un processo naturale era inevitabilmente più accettabile della concezione bakuniniana di rivoluzione come apocalisse. Le differenze tra loro sono il risultato delle trasformazioni accadute nelle circostanze storiche che accompagnarono la nascita e l’espansione dell’anarchismo. KROPOTKIN ebbe un ruolo fondamentale in questa espansione, ma come personalità e scrittore più che come organizzatore delle masse. Figlio di un alto ufficiale, tutto lo destinava a una carriera a servizio dello zar. Fu accolto nel Corpo di Paggi per indicazione personale dello zar Nicola I. Divenne lo studente più brillante della scuola ma quando uscì, nel 1862, le sue idee erano cambiate al punto d’impedirlo di accettare la carriera a cui i suoi maestri e genitori lo consideravano destinato. Due forti influenze positive avevano contribuito a farlo abbandonare l’idea della carriera militare: i suoi istinti liberali e il suo interesse per la scienza. Con l’obiettivo di “fuggire dell’atmosfera mefitica di Pietroburgo, continuare gli studi scientifici [e] giocare una parte nelle grandi riforme che sperava ancora sarebbero seguite all’emancipazione dei servi” (WOODCOCK, 1966:165), KROPOTKIN scelse di andare in Siberia. Lì, dove la riforma veniva ancora presa sul serio, trovò un’atmosfera ancora speranzosa. Il suo primo 70 compito fu l’investigazione del sistema penale in Siberia. Egli si dedicò con energia ed entusiasmo, ma col tempo divenne sempre meno fiducioso nella possibilità di realizzare le riforme e allora si rifugiò nella scienza. Durante il tempo in cui servì in Siberia viaggiò in Estremo Oriente un percorso di cinquantamila miglia. Questi viaggi gli resero una buona reputazione come geografo, grazie agli importanti contributi allo sviluppo della scienza che saranno da me studiati in futuro. Nel 1866 dopo un episodio con gli esuli polacchi, KROPOTKIN e il suo fratello decisero di dare dimissione dall’esercito zarista e tornare a Pietroburgo. KROPOTKIN si iscrisse all’Università e per guadagnarsi la vita, svolsi lavori occasionali per la Società Geografica Russa. Nel 1871 rifiutò l’offerta della carica di Segretario di quella Società Geografica e se ne andò in Svizzera, all’epoca la Mecca dei radicali russi. S’installò a Zurigo, ma più tardi la lasciò per Ginevra, un centro più attivo dell’Internazionale, dove si rese conto delle divisioni all’interno dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori. Conobbe Guillaume e Schwitzguébel, anarchici attivi in quella sede e, sotto l’influenza del primo, tornò in Russia dove passò ad attuare come propagandista e membro attivo del Circolo Čaikovskij. Ma era l’unico anarchico e le sue idee ebbero poche influenze. Fu in questo periodo che KROPOTKIN scrisse il suo primo saggio anarchico, un opuscolo intitolato Dobbiamo esaminare gli ideali di una società futura?. In questo saggio le sue idee si somigliavano molto a quelle di PROUDHON – la proposta che al denaro si sostituiscano buoni di lavoro e la raccomandazione di fondare cooperative di consumatori e produttori – e anche a quelle del collettivismo di BAKUNIN – l’idea che la terra e le fabbriche diventassero possesso di associazioni di lavoratori. Ma discordava dell’idea di rivoluzione con mezzi cospirativi. Secondo KROPOTKIN “i rivoluzionari non devono fare rivoluzioni, possono solo unire e guidare gli sforzi del popolo scontento” (WOODCOCK, 1966:172). Nel 1874 fu arrestato nella Fortezza di Pietro e Paolo e nel 1876, a causa di una malattia, fu trasferito all’Ospedale Militare di Pietroburgo, da dove riuscì a scappare. Nell’agosto di quell’anno raggiunse l’Inghilterra e all’inizio del 1877 la Svizzera, dove riprese i contatti con i membri della Fédération Jurassienne. Cominciò a scrivere per il Bulletin della Fédération e per altri fogli anarchici, partecipando attivamente dei lavori da essa svolti. Convinto di essere ricercato dalla polizia belga, tornò in Inghilterra, dove dopo aver passato un breve periodo a studiare al British Museum, passò a “collaborare con Andrea Costa e Jules Guesde alla fondazione dei piccoli gruppi che dovevano formare il 71 nucleo di un movimento anarchico a Parigi” (WOODCOCK, 1966:173). Nell’aprile del 1878 ritornò in Svizzera e lì rimase fino al 1880. Fu in questo periodo che cominciò il suo periodo più attivo come agitatore e pubblicista. A Ginevra, dopo la delusione con i risultati raggiunti dalla Fédération Jurassienne, cominciò a pubblicare insieme a Paul Brousse il giornale L’Avant Garde stampato clandestinamente con l’obiettivo principale di diffondere le idee anarchiche in Francia. Nel 1878 dopo la soppressione del giornale e l’arresto di Brousse, KROPOTKIN fondò Le Révolté, il più influente giornale anarchico dopo la sparizione del Le Peuple di PROUDHON, nel 1850. All’inizio KROPOTKIN pubblicava il giornale da solo e la ricerca di campi di attività pratica dominò il suo lavoro per Le Révolté. I suoi primi articoli trattavano di problemi d’attualità ed egli vedeva in ogni sciopero, in ogni tumulto popolare, un preannuncio dell’avvenire della rivoluzione sociale in Europa, attesa anche dai marxisti. Dopo passò a scrivere articoli di meno immediata attualità, criticando la società contemporanea e le sue istituzioni dal punto di vista di un sociologo libertario. KROPOTKIN diresse Le Révolté fino al luglio 1881, quando venne espulso dalla Svizzera dopo aver partecipato al Congresso Internazionale Anarchico di Londra. In realtà, due dei suoi primi libri Parole d’un ribelle e La conquista del pane sono una collana degli articoli scritti per il Le Révolté e per il suo successore parigino La Révolte. Secondo WOODCOCK sono attraverso questi articoli che si può datare l’influenza di KROPOTKIN come ultimo dei grandi teorici anarchici. In questi articoli è evidente il suo desiderio di stabilire un rapporto concreto tra teoria e pratica. Parte dallo stesso tema generale di cui era partito PROUDHON, le rivoluzioni, e afferma che esse “non si fanno solo a parole; bisogna anche saper quel che bisogna fare e volerlo fare” (WOODCOCK, 1966:175). Secondo KROPOTKIN dopo la realizzazione della rivoluzione, per assicurarsi che le cose non continuassero come prima, “tutto deve diventare proprietà della Comune[,] (…) per lui (…) un’associazione volontaria cui fanno capo tutti gli interessi sociali, rappresentati dai gruppi di individui che essi direttamente riguardano; l’unione fra diverse Comuni forma una rete di rapporti di cooperazione che sostituisce lo stato. Sul piano economico, la Comune troverà espressione nella libera disponibilità di beni e servizi per tutti coloro che ne hanno bisogno; e qui, in presto porre l’accento sul bisogno più che sulla quantità di lavoro fatto come criterio di distribuzione, Kropotkin si differenzia da Bakunin, collettivista, e da Proudhon, mutualista, che teorizzarono entrambi sistemi di distribuzione in diretto rapporto con la quantità di tempo dedicata al lavoro dal lavoratore 72 singolo. In altre parole, Kropotkin è un comunista anarchico: per lui il sistema salariale, in qualsiasi sua forma, e anche se affidato all’amministrazione di Banche del Popolo o di associazioni di lavoratori attraverso buoni di lavoro, è semplicemente un’altra forma di coercizione. In una società volontaria non ha più posto” (WOODCOCK, 1966:176/177). La teoria completa del comunismo anarchico fu sviluppata nel libro La conquista del pane pubblicato a Parigi nel 1892. La caratteristica che differenzia il comunismo anarchico dalle altre dottrine libertarie è l’idea della libera distribuzione, ma essa è più vecchia dell’anarchia stessa. Secondo WOODCOCK, pare “probabile che l’idea di Fourier fosse una tra le fonti del comunismo anarchico. Proudhon aveva condannato i fourieristi per quell’irreggimentazione che le loro comunità socialiste sembravano implicare, ma Elisée Reclus fu un fourierista attivo prima di collaborare con Bakunin nei primi tempi della Fratellanza Internazionale, ed è probabile che portasse con sé alcune idee di Fourier quando divenne uno fra i leaders del movimento anarchico francese nel decennio 1870-80” (WOODCOCK, 1966:177)22. “Il Congresso della Fédération Jurassienne nel 1880 fu la prima occasione in cui Kropotkin espose pubblicamente i principi del comunismo anarchico. Sotto lo pseudonimo rivoluzionario di Levašov presentò infatti un rapporto intitolato L’idea anarchica dal punto di vista della sua realizzazione pratica, pubblicato poi nel Révolté, che divenne da quel momento l’organo dei comunisti anarchici. Il rapporto sottolinea la necessità che la rivoluzione – quando sarebbe avvenuta – fosse basata sulle Comuni locali, che avrebbero compiuto le necessarie espropriazioni e collettivizzato i mezzi di produzione. Non indicava in modo specifico il metodo comunista di distribuzione, ma nel discorso con cui lo accompagnò Kropotkin disse chiaramente di considerare il comunismo – nel senso di libera distribuzione e di abolizione d’ogni forma di sistema salariale – il risultato che sarebbe immediatamente derivato dalla collettivizzazione dei mezzi di produzione. Nella Conquista del pane (…) Kropotkin dimostra di avere riflettuto più a fondo sui principi del comunismo anarchico. L’accento, qui, si è spostato (…) e l’attenzione dell’autore è assorbita in gran parte da un esame delle ragioni scientifiche e storiche che possono spingerci ad accettare la possibilità di una vita di «benessere a tutti». Kropotkin non vi propone un’Utopia, non vi presenta cioè l’immagine di un mondo ideale illustrato fin nei minimi particolari (…). Prende solo in considerazione alcuni dei più gravi problemi sociali del presente e cerca di stabilire come potranno essere risolti in un mondo in cui la produzione 22 Secondo WOODCOCK, la prima pubblicazione che mise insieme anarchismo e comunismo fu un opuscoletto scritto da François Dumartheray intitolato Aux travailleurs manuels partisans de l’action politique, datato dal 1876. 73 risponderà ai fini del consumo e non del profitto e in cui la scienza si consacrerà alla ricerca dei mezzi per conciliare e soddisfare le necessità di tutti. La conquista del pane prende le mosse dell’assunto – derivato da Proudhon – che il retaggio dell’umanità è un retaggio collettivo, in cui è impossibile isolare e misurare il contributo del singolo, e del quale dunque gli uomini devono godere collettivamente. Tutte le cose devono essere di tutti gli uomini, perché tutti gli uomini ne hanno bisogno, perché tutti hanno collaborato secondo le loro forze a produrle, perché non è possibile valutare la parte di ciascuno nella produzione delle ricchezze del mondo … Se l’uomo e la donna svolgono la loro giusta parte di lavoro, hanno anche diritto alla loro giusta parte di tutto ciò che è prodotto da tutti e quella parte è sufficiente ad assicurare il loro benessere. Ne segue che ineguaglianza e proprietà privata devono essere abolite; ma all’individualismo capitalistico non si dovrebbe sostituire la proprietà dello stato, come vorrebbero i socialisti autoritari bensì un sistema di cooperazione volontaria” (WOODCOCK, 1966:178/179). Secondo KROPOTKIN, le ingiustizie e le crisi economiche del capitalismo non hanno le sue radice nella sovrapproduzione ma sì nel sottoconsumo e nel fatto che buona parte del lavoro è applicato in occupazioni improduttive. Inoltre, ritiene che una volta reso l’ambiente di lavoro sano e piacevole, e offerte ai lavoratori variate occupazioni in grado di dargli “il senso dell’utilità, il lavoro cesserà di essere sgradevole, e il piacere che ciascuno vi potrà trovare sarà rafforzato dalla soddisfazione morale di sapersi un uomo libero che lavora per il bene generale. Tanto basta, secondo Kropotkin, a respingere le obiezioni di quanti sostengono che in un mondo comunista anarchico, dove ciascuno potrà prendere liberamente dai depositi comuni ciò di cui ha bisogno, verrà meno ogni incentivo al lavoro; il migliore incentivo non è la minaccia del bisogno ma la consapevolezza di fare qualcosa di utile. In questo, Kropotkin dimostra la caratteristica fiducia anarchica nella naturale tendenza dell’uomo ad assumersi le proprie responsabilità sociali. La società – sostiene – diversamente dal governo, è un fenomeno naturale; rimosse tutte le restrizioni artificiali, gli uomini si comporteranno da esseri socialmente responsabili, perché a questo li porta la loro natura. Naturalmente, egli non tiene conto del fatto che quando gli uomini sono stati condizionati alla dipendenza la paura della responsabilità diventa un’affezione psicologica che non scompare appena ne sono state eliminate le cause” (WOODCOCK, 1966:181). Nel 1882 KROPOTKIN lasciò Londra per Thonon, dove poteva stare più vicino ai compagni di Ginevra, ma scelse male il momento e arrivò proprio quando le autorità 74 francesi stavano dando la caccia ai rivoluzionari anarchici. Fu arrestato alla fine del 1882 e, nel 1883, condannato a cinque anni di carcere. Godendo del trattamento riservato ai carcerati politici, egli riempì il tempo con molte attività. Fu in questo periodo che “scrisse articoli sulla Russia per il Nineteenth Century e di argomento geografico per La Revue socialiste, collaborò all’Enciclopedia Britannica e alla monumentale Geografia universale di Élisée Reclus” (WOODCOCK, 1966:181). KROPOTKIN fu rilasciato dopo tre anni di carcere, nel gennaio 1886, e nel marzo era già tornato in Inghilterra, dove rimase per più di trent’anni. Ma questa volta prevalse in lui la tendenza al ritiro, a una vita di studioso e teorico, non più di attivista. “Per gli anarchici divenne il grande studioso e il profeta del movimento (…). Il pubblico inglese colto onorava in lui un simbolo della lotta russa contro l’autocrazia. I suoi articoli nel Times e nei periodici scientifici erano letti con rispetto: la sua autobiografia, Memorie di un rivoluzionario, e l’opera in cui illustrava il ruolo della cooperazione come fattore dell’evoluzione, Il mutuo appoggio, furono subito accettate come classici nel loro campo. Nello stesso tempo anche l’atteggiamento di Kropotkin si andava lentamente modificando. Egli dava sempre maggior rilievo all’aspetto evolutivo del cambiamento sociale, mettendolo in rapporto con pacifici sviluppi in seno alla società più che con violente sollevazioni rivoluzionarie; raccomandava sempre meno i metodi violenti, e già nel 1891 accennò in uno dei suoi discorsi alla possibilità che l’anarchia si affermasse grazie al semplice «maturare dell’opinione pubblica e con il minimo possibile di agitazione e disordini»” (WOODCOCK, 1966:184/185). WOODCOCK attribuisce il cambiamento nell’atteggiamento di KROPOTKIN soprattutto al contatto che egli ebbe con il movimento socialista inglese, rimanendo colpito dalla reciproca tolleranza fra le varie correnti del movimento operaio inglese. Ma ciò non significa che avesse abbandonato gli ideali d’un tempo. Anzi, fino alla fine della sua vita, contribuì per trasformare l’anarchia in “una dottrina che, senza essere rigidamente utopistica come in Cabet e nei più tardi fourieristi, presentava un’alternativa concreta e realizzabile alla società esistente. Gli ultimi contributi di Kropotkin alla teoria generale anarchica furono Il mutuo appoggio, pubblicato nel 1902, e un saggio pubblicato nel 1903 col titolo Lo Stato. I libri successivi, Ideali e realtà nella letteratura russa, La Grande Rivoluzione e L’Etica, pubblicata postuma, sono opere periferiche, espressioni di uno spirito libertario, ma non direttamente intese a difendere la causa del comunismo anarchico. 75 Il mutuo appoggio fu il contributo di Kropotkin a una controversia le cui origini remote vanno cercate nell'opera che segnò la nascita dell’anarchia teorica: Political Justice di Godwin” (WOODCOCK, 1966:186/187). Pensato come risposta agli argomenti di Malthus23 e Huxley24, KROPOTKIN comincia il suo libro sostenendo che in “tutto il mondo animale, dagli insetti su su fino ai mammiferi più evoluti, (…) «le specie i cui membri vivono solitari o in piccole famiglie sono relativamente poche, e il numero dei loro rappresentanti è limitato.» Spesso si tratta di specie in via d’estinzione, oppure il loro modo d’esistenza è determinato dalle condizioni artificiali che gli uomini hanno creato distruggendo l’equilibrio naturale. Ma il soccorso reciproco è la regola nelle specie meglio affermate, come Kropotkin dimostra con un’imponente serie di osservazioni raccolte da lui e da altri scienziati; è anzi l’elemento più importante nella loro evoluzione. (…) La facoltà intellettuale, secondo Kropotkin, è «eminentemente sociale,» in quanto alimentata dal linguaggio, dall’imitazione, dall’esperienza. Inoltre, il fatto stesso di vivere in società tende a sviluppare – in forma sia pure rudimentale - «quel senso collettivo di giustizia che finisce per diventare un abito mentale» e che è l’essenza stessa della vita in società. La lotta per l’esistenza è certamente importante, ma come lotta contro circostanze avverse più che fra individui della stessa specie. La lotta all’interno di una stessa specie, là dove esiste, è più nociva che altro, giacché distrugge i vantaggi derivanti dal vivere in comune. Lungi dal trarre profitto dalla competizione, la selezione naturale cerca i mezzi di eliminarla. Le stesse considerazione valgono per gli uomini. A Huxley (…), Kropotkin contrappone le osservazioni compiute su società primitive contemporanee (…). L’uomo è sempre stato, afferma Kropotkin, un animale sociale. La tendenza all’assistenza reciproca ha toccato l’apogeo nella ricca vita comunale delle società medievali, e anche la comparsa di istituzioni coercitive come lo stato non ha eliminato la cooperazione volontaria, che rimane il fattore più importante nei rapporti fra uomini e donne considerati come individui. La socialità naturale dell’uomo è il fondamento d’ogni credo di etica sociale, e se non condizionasse quasi tutti i nostri atti quotidiani, i quotidiani rapporti con i nostri simili, lo stato meglio organizzato non potrebbe impedire la disgregazione della società” (WOODCOCK, 1966:188-190). Secondo WOODCOCK, Il mutuo appoggio pecca di ottimismo, nel non riconoscere la 23 24 La sua teoria che la popolazione ha una tendenza naturale ad aumentare a un ritmo più rapido (progressione geometrica) delle riserve disponibili di cibo (progressione aritmetica), e che l’equilibrio è mantenuto solo da fenomeni come epidemie, carestie, guerre e dalla generale lotta per l’esistenza, nella quale i deboli vengono eliminati. La “sua visione del mondo animale come «un perpetuo spettacolo di gladiatori» e della vita dell’uomo primitivo come «una continua lotta libera»” (WOODCOCK, 1966:188). 76 tirannia imposta dalle abitudini e costumi come riconosce invece quelle imposte dai governi e dai regolamenti. Negli ultimi anni della sua vita ebbe una serie di problemi di salute. Nel 1914 lo scoppio della prima guerra mondiale lo separò improvvisamente dalla maggior parte degli anarchici che rimasero contro la guerra, mentre lui prese posizione a favore degli Alleati. La rottura con gli anarchici fu, secondo WOODCOCK, l’avvenimento più infelice della vita di KROPOTKIN. Nel marzo 1917 giunse la notizia che il popolo russo era insorto e la tirannia finita. KROPOTKIN ne fu felice e nell’estate di quell’anno, lasciò l’Inghilterra per tornare a Pietroburgo. Ma i quarant’anni che aveva trascorso all’estero l’avevano fatto perdere ogni contatto con la realtà russa, e non “capì in quanta misura la Rivoluzione di febbraio fosse stata motivata dalla stanchezza della guerra in un popolo coinvolto che non [la] capiva” (WOODCOCK, 1966:192). Cominciò così a esortare i russi a proseguire la guerra contro la Germania e questo suo atteggiamento lo isolò di tutta la sinistra. Rapidamente KROPOTKIN divenne una figura priva di significato e il suo riavvicinamento agli anarchici si diede solo con l’avvento dei bolscevichi al potere, dopo la Rivoluzione d’ottobre. In questa ultima fase della sua vita, il documento più importante da lui prodotto fu la Lettera ai lavoratori di tutto il mondo, in cui KROPOTKIN “distingueva nettamente la sua posizione da quella di coloro che si proponevano di distruggere i bolscevichi mediante il ricorso ad una forza esterna, ed esortava tutti gli elementi progressisti nei paesi occidentali a porre fine al blocco e alla guerra d’intervento, che avrebbero soltanto rafforzato la dittatura e reso più difficile il compito a quei russi che stavano lavorando a una genuina ricostruzione sociale. Illustrava poi la sua visione anarchica di una Russia organizzata sulla base di un’unione federale di libere comuni, città e regioni, ed esortava gli uomini di altri paesi ad imparare dagli errori della Rivoluzione russa. Lodava alcuni aspetti di quest’ultima, in particolare i grandi passi fatti verso l’eguaglianza economica e l’idea originale dei Soviet come istituzione che avrebbe portato alla diretta partecipazione dei produttori all’amministrazione dei loro campi d’attività. Ma osservava che, una volta caduti sotto il controllo di una dittatura politica, i Soviet dovevano ridursi alla funzione passiva di strumenti dell'autorità” (WOODCOCK, 1966:193). Nonostante tutto, KROPOTKIN era ancora ottimista, credeva in una rinascita del socialismo “ed esortava i lavoratori a fondare una nuova Internazionale, del tutto indipendente dai partiti politici e fondata su sindacati liberamente organizzati e miranti alla liberazione della produzione dal «suo presente asservimento al capitale»” (WOODCOCK, 1966:193). Ma non riuscì a cambiare gli eventi successivi. 77 Le idee di KROPOTKIN hanno grande accoglienza tra gli anarchici, principalmente per la collaborazione di MALATESTA, “che annunciava in una formula di grande effetto gli ideali della nuova corrente: «nella misura in cui si realizzi il comunismo sarà possibile realizzare l’individualismo, cioè, il massimo di solidarietà per usufruire dal massimo di libertà»” (LUIZETTO, 1987:34). KROPOTKIN non condivideva l’idea dell’applicazione delle teorie darwiniste nel campo della sociologia. Anzi, affermava che lo studio delle società umane in differenti epoche della storia aveva comprovato che le fasi di maggior sviluppo erano state quelle in cui le lotte tra gli individui furono ristrette al massimo, dando posto all’aiuto mutuo. Essendo così, concludeva che la garanzia dell’evoluzione dell’umanità stava nell’ampia diffusione di questi principi. Si nota, poi, un grande allontanamento tra la sua proposta – di cooperazione, solidarietà – e quella della scuola individualista – dell’egoismo. L’esistenza della proprietà personale della terra e degli strumenti di lavoro costituivano però un ostacolo alla realizzazione del suo piano di organizzazione della nuova società libertaria, per cui ne prevedeva l’abolizione. Fin qua ambedue le correnti socialiste – collettivista e comunista – coincidevano. La differenza stava nella forma di appropriazione individuale della ricchezza socialmente prodotta. BAKUNIN, come si è già detto, rifiutava il modello comunista perché vedeva in esso la negazione della libertà individuale. A loro volta, gli anarchici comunisti vedevano proprio nel modello collettivista tale negazione. Secondo questi ultimi, perché fosse possibile determinare, con la precisione definita da BAKUNIN, la parte che si doveva distribuire a ognuno in accordo con il suo lavoro, c’era la necessità d’ammettere una forma di potere sovraindividuale - come un corpo di esperti fiscali - responsabili di fiscalizzare e controllare tale appropriazione. In questo modo, l’uomo passerebbe a essere nuovamente governato dall’uomo, il che distruggerebbe il grande pilastro dell’anarchismo – la libertà. “In queste condizioni, un piano d’organizzazione sociale coerentemente anarchico dovrebbe essere completamente comunista: la partecipazione individuale alla ricchezza socialmente prodotta dovrebbe essere determinata esclusivamente dalle necessità individuali, applicandosi in tutti i casi, senza esclusioni, la formula: «da ciascuno secondo le sue possibilità e a ciascuno secondo le sue necessità»” (LUIZETTO, 1987:38)25. Consapevole del proprio isolamento e fallimento, KROPOTKIN passò a dedicarsi alla sua ultima opera, L’Etica. Morì l’8 febbraio 1921. Il suo contributo più importante alla tradizione anarchica fu, secondo WOODCOCK, l’umanizzazione dell’anarchismo. 25 Il grassetto è mio. 78 In termini generali, questa fu la discussione sulla produzione comunitaria fatta all’interno del movimento anarchico. Tra tutte le scuole suddette, le correnti della scuola socialista sono quelle che richiamano più l’attenzione riguardo alla mia tematica d’investigazione specifica. Ritengo che queste forme di organizzazione della produzione possono essere intese all’interno di un discorso più ampio riguardante la sostenibilità dell’agricoltura contadina. La condizione è che si realizzi un’utopia costruita da tutti i contadini che a essa si dedichino, e non soltanto dalla volontà dei leaders, come si verificò con la Colonia Cecilia26 e come quello che sta accadendo in alcune esperienze realizzate dal Movimento dei Lavoratori Senza Terra (MST) a San Paolo, in Brasile. È da quest’ottica che passerò ora ad analizzare la Colonia Cecilia, la cui storia non può essere intesa al di fuori della discussione realizzata dal movimento anarchico. 26 Anche se non è molto adeguato, in questo caso, parlare di leader. 79 CAPITOLO 3 L’EMIGRAZIONE ITALIANA IN BRASILE DALLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO FINO ALLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 1. Introduzione Prima di occuparmi della storia della Colonia Cecilia in quanto esempio di pratica alternativa di organizzazione socioterritoriale per la produzione agricola, tratterò in questo capitolo della storia dell’emigrazione italiana in Brasile avvenuta dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento e, in specifico, dell’emigrazione “agraria”, ossia, della storia degli italiani che a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, in ragione della crisi economica e sociale che attraversava l’Italia, decisero di abbandonare la loro patria con l’obiettivo di continuare a lavorare come contadini nelle terre brasiliane. Il destino della maggioranza degli emigranti furono le fazendas di caffè nello stato di San Paolo. Lì, lavorando come coloni, sostituirono il lavoro schiavo e contribuirono all’espansione delle piantagioni di caffè per tutto l’ovest dello stato di San Paolo. Solo una piccola parte si diresse verso i progetti di colonizzazione localizzati nel sud del paese – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná – pubblici o privati, nati con l’obiettivo di proteggere la frontiera sud dalle invasioni straniere e dagli attacchi delle tribù indigene locali e anche di “imbiancare” il Brasile nero della schiavitù. Infine, una parte ancora più piccola emigrò in Brasile per sperimentare, sempre nel sud, la vita anarchica attraverso la realizzazione della Colonia Cecilia, uno degli argomenti del prossimo capitolo. L’obiettivo di questo capitolo è evidenziare il contesto in cui avvenne l’emigrazione italiana in Brasile e il contributo dato da essa al cambiamento del paesaggio agrario brasiliano. 80 2. Perché emigrare? Nel periodo in cui si sviluppò il fenomeno migratorio italiano in Brasile, l’Italia aveva appena concluso il suo processo di unificazione politica e amministrativa e doveva risolvere una serie di problemi: trovare la sua unità “spirituale”, diventare una grande potenza e affrontare una grave crisi economica e sociale. Secondo GODECHOT, dopo l’unità l’Italia era rimasta un paese sostanzialmente agricolo27 e i contrasti tra la grande proprietà del mezzogiorno e la piccola proprietà dell’Italia centrale divennero ancora più evidenti. Il tentativo del governo di moltiplicare il numero di piccoli proprietari, mettendo in vendita una parte significativa dei beni della Chiesa, non ebbe l’effetto desiderato dato che essi furono acquistati soprattutto dalla borghesia. L’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli avvenuto tra gli anni 1849 e 1873 non aveva alterato la qualità materiale della vita dei contadini che vivevano un rapido incremento demografico dovuto al calo della mortalità, dando origine a una sovrappopolazione incapace di trovare occupazione sia in campagna che in città. A partire dal 1860, la notizia che oltremare c’era terra e lavoro per tutti corse in fretta per tutta la penisola, divulgata da giornali liguri, piemontesi, veneti e lombardi. Rapidamente il Brasile e l’Argentina, con i loro piani di colonizzazione e popolamento delle immense terre vergini, divennero la “terra promessa” dei contadini italiani. In Brasile, le terre nelle colonie del sud erano assegnate per pochi soldi o in cambio di alcuni anni di lavoro gratuito nelle opere messe in pratica dal governo brasiliano28. L’inserimento dei coloni era curato dalle amministrazioni locali. I paesi di accoglienza avevano aperto consolati nell’Italia settentrionale e nei porti principali, e una rete di agenti d’immigrazione diffondeva le notizie nei posti più sperduti. “Agenti di grandi compagnie di navigazione si facevano concorrenza per accaparrarsi clienti, spesso con promesse fasulle. Le famiglie contadine vendevano tutto e si indebitavano per affrontare le spese di viaggio, esposte a prestiti usurai, senserie nella compravendita e tangenti estorte a vario titolo. Fuggivano da tasse vessatorie, dal carovita, dalle carestie che distruggevano i raccolti e dalla sudditanza verso i padroni delle terre” (SALVATORI, 1999:33). Il suo processo di industrializzazione era stato interrotto dal Risorgimento e dai blocchi dell’epoca napoleonica. 28 Dal 1825 era già in pratica l’esperienza delle colonie di colonizzazione in Brasile, negli attuali stati del Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nel sud del paese, basati sull’emigrazione tedesca. Dovuto il successo raggiunto da questa esperienza il governo brasiliano decise di aprire il programma ad altri paesi nordeuropei, ragione per cui la prima ondata emigratoria italiana verso il Brasile proviene dal Settentrione. 27 81 Nel 1880 il paese manifestò un certo interesse coloniale verso l’Africa, ma questo non risolse la crisi economica in mezzo alla quale esso si trovava29. Così, l’emigrazione non tardò a trasformarsi nell’alternativa possibile per risolvere i problemi economici. Più che una libera scelta, essa fu, secondo GIADRESCO, una scelta politica, organizzata dallo Stato e concordata nei trattati stipulati dai governi. Lo svolgersi del processo emigratorio diede origine a un ampio dibattito politico tra i fautori dell’emigrazione di massa – fra i quali si schierò la classe dirigente liberale – e i suoi oppositori. Nonostante la paura dei proprietari riguardo allo spopolamento delle campagne e al conseguente rialzo dei salari, soprattutto nell’agricoltura, prevalse la tesi favorevole all’emigrazione, vista anche come “valvola di sicurezza”. Tra i vantaggi venivano citati “l’eliminazione delle punte più acute del ribellismo meridionale, l’attenuazione delle lotte operaie e contadine, l’attivazione di un prezioso canale di finanziamento in valuta, attraverso le rimesse, anch’esso destinato a sostenere l’industria del Nord più che l’economia meridionale” (GIADRESCO, 1998:27). Fu in questo quadro che ebbe inizio il processo di emigrazione di massa verso le Americhe (in particolare Stati Uniti, Brasile e Argentina), Tunisia e alcuni paesi dell’Europa, come la Francia e il Belgio. L’esodo contadino assunse lentamente un volto senza precedenti, obbligando il governo a intervenire. Secondo PITTAU & ULIVI, nel 1873 il ministro dell’interno Lanza ostacolò, con una circolare, l’esodo e invitò i sindaci a non concedere il “nulla-osta” per l’espatrio quando gli interessati non avessero i soldi sufficienti per il viaggio, per vivere durante il tempo necessario a trovare il lavoro e per il viaggio di ritorno. La circolare, gravemente lesiva della libertà, spinse all’esodo clandestino sempre più vertiginoso. Da parte sua l’emigrazione non era un fatto nuovo. Secondo SORI, il meccanismo di erosione della proprietà contadina – concretizzato dalla crescente necessità di soldi per pagare debiti di natura diversa – costruiva un’integrazione tra le aree di pianura e quelle di montagna, tramite la migrazione stagionale di una parte dei membri della famiglia verso le aree di economia capitalistica consolidata – agricole o urbane – alla ricerca di lavoro. Dall’ultimo quarto del XIX secolo in poi questo movimento cominciò a prendere contorni e intensità sempre più forti, fino a trasformarsi in un’emigrazione vera e propria30. La crisi agraria degli anni ’80, espressa attraverso il ribasso dei prezzi di alcune delle principali produzioni agricole italiane – soprattutto del grano – e l’incentivo dato alla 29 30 Secondo SORI, tale crisi era il risultato della sua difficoltà di adattamento ai ritmi imposti dalla rivoluzione industriale inglese e dalle nascenti relazioni capitalistiche europee. Rimanevano nell’economia italiana le caratteristiche dell’ancien régime, come crisi di sussistenza, epidemie e malattie endemiche. SORI cita l’aumento dei flussi di espatrio, della partecipazione femminile e del periodo di assenza come indicativi di questo cambiamento. 82 navigazione transoceanica dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima guerra mondiale – tanto da trasformarla nel veicolo tecnico-materiale ed economico della grande emigrazione europea verso il nuovo mondo – furono anch’essi fattori responsabili per l’inizio del processo migratorio. Le leggi dello Stato cominciarono a prendere in considerazione il fenomeno dell’emigrazione quando ormai essa era già avviata a pieno ritmo. Nel 1876 era già stato divulgato un primo dato, di centomila emigrati, cifra che nonostante sia di memoria e sottostimata, ha un valore storico in quanto rivelatrice del fenomeno emigratorio. Nel 1884 si fece una prima inchiesta sulle cause del fenomeno, da cui emersero quelle sociali come le determinanti. Ma fino al 1888 niente fu fatto per cambiare il corso degli avvenimenti e l’emigrazione, libera da norme e controlli, fu molto redditizia per le compagnie di navigazione e gli agenti di emigrazione che incitavano i contadini all’esodo con false promesse. Il governo cominciò ad agire nel 1888, approvando una legge che regolamentava l’emigrazione. Passarono così le prime norme: “necessità di un’autorizzazione per le agenzie intermediarie tra emigranti e vettori marittimi; speciale contratto di partenza tra agenti autorizzati ed emigranti; commissione provinciale di arbitri per le controversie tra emigrati e agenti” (PITTAU & ULIVI, 1986:15). Essa però non risolse il problema; anzi, le compagnie acquistarono una sovranità assoluta nel reclutare e trasportare gli emigranti. Questa situazione si sviluppò senza problemi perché nei primi anni della grande emigrazione, colui che desiderava emigrare doveva finanziare da solo i costi del viaggio, cominciando dal prezzo del biglietto marittimo che, nella fase iniziale, costituiva praticamente l’unica voce31. Quando, all’inizio del Novecento, l’emigrazione italiana assunse un notevole rilievo quantitativo e temporale, si affermarono una serie di strumenti di finanziamenti “autonomi”, come per esempio l’autofinanziamento32, o i cosiddetti prepaids33. Questi meccanismi prevalsero nel caso dell’emigrazione verso gli Stati Uniti. L’emigrazione verso l’America Latina, invece, fu in genere associata all’abolizione della schiavitù e alla conseguente necessità di offerta di lavoro “libero”. Questo problema era risolto vendendo tutto, servendosi della dote della sposa oppure tramite un settore creditizio privato che si sviluppò nelle aree di emigrazione e che si costituiva spesso nell’ultima usura alla quale il contadino si assoggettava verso l’incerta via dell’emancipazione economica. 32 Quando le rimesse inviate dagli emigrati erano risparmiate per essere utilizzate nell’emigrazione di un altro membro della famiglia. 33 Biglietti di viaggio prepagati, acquistati all’estero e inviati in Italia a un aspirante emigrante. Essi furono una trovata molto conveniente per le compagnie di navigazione per risolvere i problemi di flusso di entrate durante i periodi morti dell’emigrazione, così come un meccanismo utilizzato per raggiungere il pieno carico delle navi. L’emigrante poteva contare su biglietti più economici ma doveva assoggettarsi alle peggiori condizioni di viaggio. 31 83 L’emigrazione italiana si inserì nel quadro delle politiche latinoamericane – soprattutto brasiliane e argentine – di sovvenzione all’emigrazione, iniziate negli anni 1870 e intensificate negli anni 1880 e 1890. Tali politiche nacquero soprattutto dalle pressioni delle oligarchie di produttori di caffè di San Paolo sul governo statale e posteriormente federale, per risolvere il problema della mancanza di manodopera per la coltivazione del caffè che l’imminente fine della schiavitù portava con sé. Nel caso brasiliano, questa politica consistette nel reclutamento di emigranti nelle campagne italiane per il lavoro nelle fazendas di caffè e, in proporzione minore, per la creazione di nuclei coloniali nel sud del paese. Agli emigranti venivano offerti i biglietti gratuiti e la possibilità di diventare proprietari di un piccolo appezzamento di terra in cambio di alcuni anni di lavoro nelle fazendas o, nel caso di quelli che andavano al sud del Brasile, di lavoro nelle opere pubbliche di infrastruttura. A partire dagli anni 1870, e con maggiore intensità negli anni 188034 e primi anni 1890, l’emigrazione gratuita si sviluppò rapidamente, in accordo con i programmi di immigrazione di massa messi in pratica dal governo brasiliano35. Questo avvenne senza nessuna opposizione o interferenza da parte del governo italiano, anche davanti alle denunce di irregolarità alle quali dovevano assoggettarsi gli emigranti che andavano a San Paolo, come i maltrattamenti nelle fazendas, il non rispetto dei contratti, ecc. Questo sia perché l’Italia si trovava al centro dell’attenzione delle politiche migratorie latinoamericane, sia perché non aveva un’altra forma per “potersi liberare” di un proletariato eccedente e indigente. Il “via libera” dato al processo migratorio serviva a far risparmiare risorse che poi sarebbero state investite nel suo sviluppo economico. Secondo SALVATORI, con il passare degli anni il fenomeno migratorio cominciò a presentare effetti positivi dovuti alle rimesse di denaro che contribuirono a finanziare lo sviluppo dell’intera economia italiana e ad aumentare il reddito di intere zone rurali, permettendo ai contadini di innalzare il loro tenore di vita. 34 35 Soprattutto dopo l’abolizione della schiavitù avvenuta il 13 maggio 1888 e la proclamazione della Repubblica avvenuta il 15 ottobre 1889, quando i produttori di caffè assunsero il potere. Ma già all’inizio del 1888 le cose cominciavano a cambiare. Basta ricordare la legge provinciale di San Paolo, del 3-2-1888, che “autorizza l’indennizzo per il costo del passaggio della Società Promotrice dell’Emigrazione, che si era impegnata ad introdurre 100.000 immigrati europei per il settore agricolo, mentre dal 1893 vige un contratto tra governo e la società La Metropolitana per l’introduzione di un milione di immigranti, che dovevano essere per il 90% agricoltori organizzati in gruppi familiari” (SORI, 1984:299). È in questo quadro di immigrazione sovvenzionata che si inserirono le “grandi migrazioni agrarie” (contadini che emigravano per lavorare nell’agricoltura in Brasile) venete del 1888, 1891 e 1894-95. Secondo la relazione di SCALABRINI il governo brasiliano spese “per i contratti di introduzione (comprendenti il costo del viaggio, dello stazionamento per non più di 8 ore nei porti di sbarco, dell’avviamento ai luoghi di lavoro e della provvigione di 10-12 lire per emigrante agli agenti) somme pari a 46 milioni di lire nel 1890, 84 milioni nel 1891, mentre il solo Stato di San Paolo aveva erogato 20 milioni tra il 1881 e il 1888” (SCALABRINI apud SORI, 1984:302). 84 Le prime proibizioni all’emigrazione gratuita da parte del governo italiano si ebbero soltanto all’inizio del XX secolo, quando gli Stati Uniti divennero un importante mercato alternativo per lo sbocco dell’emigrazione transatlantica. Fu in questo contesto che fu promulgata la legge italiana del 31 gennaio 1901 sull’emigrazione, la quale soppresse gli agenti e i subagenti di emigrazione; istituì la patente di vettore degli emigranti; impose noli agli armatori; unificò i servizi emigratori centrali in un solo organo, il commissariato dell’emigrazione, con un consiglio consultivo e un proprio fondo e istituì nuove commissioni provinciali e ispettorati dell’emigrazione nei porti d’imbarco36. Nello stesso periodo anche la Chiesa intervenne, inviando missionari dediti a opere di assistenza agli emigranti nei paesi di accoglienza. Da parte sua, il Brasile sospese la politica immigratoria nel 1901 adducendo l’inservibilità della manodopera italiana – reclutata senza criteri – al lavoro nelle fazendas di caffè37. 3. Mentre questo in Brasile … Dall’altra parte dell’Atlantico il Brasile viveva una situazione particolare. La fine della schiavitù era imminente e la necessità di forza lavoro per le fazendas di caffè, in rapida espansione, era un problema urgente. Tutti erano d’accordo sul fatto che la nuova forza lavoro doveva essere libera, ma mancavano i lavoratori. La possibilità di contare sull’ex Secondo GRISPO, l’esigenza di un’organizzazione più razionale dei servizi relativi all’emigrazione e di una tutela più efficace degli emigranti, portò all’istituzione, nel 1901, di una serie di nuovi uffici, attraverso i quali lo Stato italiano si proponeva di seguire e proteggere l’emigrante in ogni tappa del suo viaggio, dal paese di partenza a quello di destinazione. “L’organo centrale, nel quale avrebbe dovuto concentrarsi tutto ciò che si riferiva ai servizi dell’emigrazione, era un commissariato dipendente dal ministro degli affari esteri e composto da un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro AA.EE., da tre commissari e dagli ufficiali d’ordine richiesti dal servizio (art. 7 legge 31 gennaio 1901) (…) La legge istituiva altresì un consiglio dell’emigrazione, organo consultivo da sentire nelle questioni più rilevanti relative all’emigrazione e nella trattazione degli affari di competenza di più ministeri” (GRISPO, 1986:1). Per garantire l’assistenza e la tutela degli emigranti venivano istituiti comitati mandamentali o comunali con funzioni gratuite. Nei porti d’imbarco la tutela e sorveglianza degli emigranti doveva essere fatta da un ispettore dell’emigrazione con funzione anche di ufficiale di pubblica sicurezza e, durante il viaggio, da un medico militare. La legge prevedeva anche l’istituzione, nei paesi di accoglienza, di uffici di protezione, informazione e avviamento al lavoro nell’interesse degli emigrati; quattro ispettori d’emigrazione viaggianti, tre per paesi transoceanici e uno per i principali centri d’emigrazione; regolari ispezioni a bordo dei piroscafi che trasportavano emigranti nei porti di transito e in quelli d’arrivo. Stipulava inoltre l’istituzione di commissioni per arbitrare i danni subiti dagli emigranti e la creazione di un Fondo d’emigrazione che doveva ricevere tutte le somme riscosse in seguito alla sua applicazione. La complessità della legge impediva il consolidarsi di un assetto definitivo e non tardarono a verificarsi una serie di lacune, come il numero ridotto di funzionari, il grande numero di comitati di scarsa operosità, la mancanza di fondi per spese varie. Con l’obiettivo di rendere più efficiente la legge furono introdotte modifiche nel 1906, 1907 e 1911, tra le quali l’introduzione della tutela anche all’emigrazione continentale. 37 Anche la contropropaganda, fatta dagli emigrati italiani in Brasile tramite i racconti delle situazioni in cui effettivamente si trovavano, contribuì per far cambiare la direzione del flusso migratorio. 36 85 schiavo dopo l’abolizione sembrava impossibile. Ugualmente impossibile era trasferire al ridotto numero di lavoratori liberi nazionali il compito di sostituire gli schiavi nelle fazendas. Così, dalla crisi del sistema schiavista e dall’impossibilità di contare sulla manodopera nazionale per il lavoro nelle piantagioni di caffè sorse la questione dell’immigrazione e della colonizzazione del paese: la soluzione doveva essere trovata oltre i confini brasiliani. Partendo da questa prospettiva il governo brasiliano passò all’azione. Nel 1850 alterò la Legge di Terre, impedendo l’accesso alla terra se non tramite l’acquisto38. Nel 1873 ampliò il credito ipotecario a tutti i municipi delle province di San Paolo, Paraná e Santa Catarina, avendo come sopporto la fazenda (piantagioni e installazioni) e non più lo schiavo, misura che fu responsabile dell’espansione del caffè per tutto l’ovest dello stato di San Paolo. Per incentivare l’immigrazione, vincolò la possibilità di accesso alla terra da parte dell’immigrante (tramite l’acquisto di un piccolo appezzamento) al lavoro iniziale nelle fazendas di caffè. Lavorare per diventare proprietario: questa fu la formula trovata per integrare l’immigrante nella produzione del caffè. Con questo obiettivo, riprese la politica di popolamento e, parallelamente alla creazione delle colonie ufficiali, diede inizio a un altro tipo di colonizzazione, caratterizzato dalla fissazione degli immigranti direttamente nelle fazendas attraverso un sistema simile alla mezzadria39. Infine, mise in pratica le politiche di incentivo all’immigrazione tramite l’immigrazione sovvenzionata. 4. Verso la “Mèrica”: la lunga distanza tra l’Italia e il Brasile In Italia, il boom del processo migratorio originò una rete composta da usurai, sacerdoti, sindaci, notai e segretari o impiegati comunali, agenti di emigrazione (sia italiani che stranieri) e compagnie di navigazione. Tutti, ognuno a modo suo, lucravano con l’emigrazione, soprattutto con quella transatlantica. Anche la borghesia, che si diceva rovinata dall’emigrazione contadina, ristrutturò la sua attività e si inserì nel circuito migratorio, svolgendo un ruolo dominante nelle campagne italiane, soprattutto nel Mezzogiorno (reintroducendo l’usura agraria); trasferendo il suo potere oltreoceano e interferendo nella distribuzione dei posti di lavoro, attraverso una rete di tipo mafiosa con In questo modo, allo stesso tempo in cui impediva l’accesso alla terra da parte degli ex schiavi e degli immigranti appena arrivati – senza soldi per comprarla – garantiva legalmente la continuità dello sfruttamento della forza lavoro. 39 In questo sistema il colono riceveva secondo il lavoro svolto. Era divisa a metà soltanto la somma appurata con la vendita del caffè da lui raccolto e consegnato al fazendeiro per essere venduto. 38 86 boss e banchieri e, infine, responsabilizzandosi per le pratiche di espatrio40. Inoltre, nei porti d’imbarco – ai quali molte volte erano incamminati una settimana prima della partenza per essere “puliti” – gli emigranti erano esposti all’azione di commercianti senza scrupoli, affaristi, esercenti, truffatori, ladri e faccendieri. Una volta imbarcati, erano soggetti a viaggi in condizioni subumane; a rischi di epidemie e molte volte di morte, dovuti sia alle pessime condizioni igienico-sanitarie, sia alle condizioni in cui viaggiavano – agglomerati in cabine senza ventilazioni – sia alla mancanza di alimenti. Si verificavano persino dirottamenti di destinazioni – dall’America del Nord all’America del Sud – senza previa conoscenza; sbarchi fraudolenti in porti europei; interminabili giorni di attesa per lo sbarco. E la situazione si aggravava quando si trattava di emigrazione clandestina. Ma tutto questo non ridusse l’importanza né l’intensità del movimento migratorio italiano. L’emigrazione transoceanica – principalmente quando si osservano i tre principali paesi recettori: gli Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina – fu sempre crescente. Secondo SORI esistette una “specializzazione” dalle regioni italiane riguardo ai posti di destinazione. Analizzando il periodo 1876-1914 e considerando tre destinazioni specifiche (Europa, Africa e altri paesi transoceanici), informa che da regioni come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Toscana si partiva quasi sempre verso l’Europa, con brevi periodi di emigrazione transoceanica41 che non vanno oltre la seconda metà degli anni 1890. La Liguria, per la presenza del porto di Genova, il sud, esclusa la Puglia, le regioni che cominciarono tardi l’emigrazione di massa (come la Sicilia e in parte la Puglia) e quelle che ebbero poca emigrazione (come la Sardegna e in parte la Puglia) furono sempre più propense all’emigrazione transoceanica. Le altre regioni dell’Italia Centrale (Marche, Umbria e Lazio) ora ebbero grandi flussi di emigrazioni europea, ora inviarono emigranti in direzione transoceanica, ma sempre con un’importanza secondaria. GIADRESCO, a sua volta, sottolinea la svolta meridionale dei flussi emigratori avvenuta nei primi anni del Novecento, con l’inizio del grande esodo transoceanico42 verso soprattutto gli Stati Uniti. I massimi storici furono raggiunti tra il 1901 e il 1915, periodo che registrò più di un terzo degli espatri di cent’anni dell’emigrazione italiana: emigrarono 9 milioni di persone, quasi 4 milioni dalle regioni meridionali, e più del 50 per cento del totale, oltreoceano. Questo tipo di pratica era valida per l’emigrazione verso gli Stati Uniti. “Il caso estremo è costituito dal Veneto, che ebbe accesso all’emigrazione transoceanica di massa praticamente solo attraverso le grandi punte di emigrazione sovvenzionata del 1888, 1891 e 1895-96” (SORI, 1984:64). 42 Prima l’emigrazione di massa era stata alimentata dall’Italia Settentrionale, soprattutto dal Veneto, Piemonte e Lombardia. 40 41 87 Un’altra caratteristica che merita di essere sottolineata riguarda il profilo dell’emigrante: nella maggior parte erano uomini con più di 15 anni, quasi sempre semplici erogatori di forza muscolare. Questa situazione si alterò durante il periodo di reclutamento massiccio di famiglie agricole verso l’America Latina, in particolare per il Brasile negli anni 1888, 1891 e 1895-96, nonché durante la prima guerra mondiale, quando il tasso di mascolinità ebbe una riduzione. Riguardo alle professioni, SORI informa che le prime leve erano formate soprattutto da antichi artigiani, i primi a sentire la crisi dell’antico sistema frutto della concorrenza delle merci capitalistiche. Solo più tardi furono i contadini43. 5. L’arrivo nella “terra promessa” Una volta sbarcati in Brasile, gli immigranti erano trasferiti nelle “Locande degli Immigranti” situate vicino ai porti di sbarco, dove rimanevano fino al trasferimento definitivo nelle fazendas di caffè a San Paolo oppure ai nuclei coloniali del sud del paese. Prima che il governo brasiliano assumesse la responsabilità sull’immigrazione, i costi del viaggio, del vitto e alloggio erano posteriormente riscossi in piccole rate, essendo scontata una parte per volta a ogni verifica annuale dei conti, soprattutto tra quelli che si dirigevano verso le fazendas di caffè. Dopodiché, queste spese furono assunte dal governo. Il trasporto dal porto principale – di solito quello di Rio de Janeiro – fino allo stato di destinazione era fatto in piccole navi. Da quel punto, fino ai luoghi di destinazioni finali, dipendeva dalle distanze da percorre, potendo essere a piedi o con l’uso di animali per trasportare le valigie, in diligenze per le strade appena sterrate oppure in treno utilizzando la linea che era stata costruita per il trasporto del caffè fino al porto di Santos. L’acquisto dei prodotti di prima necessità era fatto presso negozi all’interno delle fazendas o in piccole botteghe nei paesi vicini ai nuclei coloniali, in genere a prezzi maggiorati, incrementando ancora il debito iniziale del colono. 43 GIADRESCO cita ancora il cambiamento nella definizione dell’emigrante. Nella legge del 1901 è considerato emigrante quello che viaggia in terza classe o equivalente verso posti situati al di là dello Stretto di Gibilterra - escluse le coste europee – e del Canale di Suez. A partire dal 1913 saranno considerati emigranti quelli che si dirigono anche verso i paesi europei, muniti di passaporti individuali, non importando in quale classe, sempre che per cercare un lavoro manuale. È la prima volta che si fa l’associazione “lavoro manuale-emigrante”. Quindici anni più tardi, durante il regime fascista venne fatta un’ulteriore distinzione che divise gli emigranti in due categorie: i “lavoratori”, intendendo i soli manovali; e i “non lavoratori” intendendo coloro che andavano all’estero per altri motivi oppure che esercitavano una professione non manuale. 88 6. Il lavoro nelle fazendas di caffè La prima forma di introduzione dell’immigrante nelle fazendas di caffè avvenne tramite un sistema simile alla “mezzadria”. Esso vigeva anteriormente all’immigrazione di massa ed era regolato da un contratto firmato tra il fazendeiro e il colono-“mezzadro”. In esso veniva accordato che il colono doveva trattare un numero non determinato di alberi di caffè e poteva uscire dalla fazenda solo dopo aver liquidato il montante del debito a suo carico44. Il colono riceveva in cambio un appezzamento di terra dove poteva dedicarsi alla coltivazione di alimenti per il proprio consumo e una casa nella parte della fazenda destinata all’abitazione dei coloni, la cosiddetta “colonia”. Il suo reddito era composto da metà del rendimento netto del caffè sotto sua responsabilità e dalle colture alimentari, di cui poteva commercializzare l’eccedente, essendo obbligato a restituire le spese fatte per lui dal fazendeiro con almeno metà dei suoi guadagni annuali con il caffè. Questo sistema fu utilizzato per molto tempo nelle fazendas dello stato di San Paolo, sia per la sua maggiore efficienza nella dispersione dei rischi45 e costi46, sia perché era un metodo più efficiente del lavoro salariato. Vincolando il pagamento a una parte della produzione, il fazendeiro da un lato faceva sì che il lavoratore intensificasse da solo il suo sfruttamento per aumentare i suoi guadagni e, dall’altro, riduceva la necessità di supervisione del lavoro. Ma i coloni non tardarono a prendere coscienza dell’impossibilità di saldare i debiti e comprare un piccolo appezzamento di terra nei due o tre anni che gli avevano promesso e decisero allora di trovare una soluzione al problema. Siccome i contratti non determinavano il numero di alberi di caffè sotto l’incarico di ogni famiglia, né limitavano l’area destinata alla coltivazione di alimenti, i coloni passarono a dedicare più tempo alle colture alimentari, che offrivano guadagni diretti e immediati, non di rado abbandonando il trattamento del caffè che così perdeva produttività. Tale pratica fu frutto, da un lato, delle gravi irregolarità praticate dai fazendeiros nella stipula dei contratti – come frequenti errori nei calcoli realizzati da direttori incompetenti o senza scrupoli – e, dall’altro, dalla perdita di fiducia nel proprietario e dalla delusione da parte degli immigranti riguardo alle Il debito contratto dal colono era composto dalle spese del viaggio, dagli elevati interessi sugli anticipi fatti dal fazendeiro a suo favore e dai prezzi maggiorati dei prodotti venduti nel negozio della fazenda. L’aspettativa era che ogni famiglia dovesse lavorare in media quattro o cinque anni prima di azzerare i conti. 45 Nel caso di cattivi raccolti o di ribasso dei prezzi nel mercato internazionale, il fazendeiro non doveva compromettere una parte dei suoi guadagni per pagare gli stipendi ai lavoratori. 46 Permettendo ai coloni di coltivare le terre per la produzione di alimenti destinati al proprio consumo, i fazendeiros riducevano significativamente le spese per la manodopera. 44 89 condizioni di vita e di lavoro nelle fazendas. Il risultato fu la nascita di un gran numero di rivolte e il conseguente fallimento di questo sistema47. Secondo STOLCKE, i fazendeiros sperimentarono sistemi alternativi di lavoro libero, come il contratto di locazione di servizi, tramite il quale i lavoratori ricevevano un prezzo prestabilito per una certa quantità di caffè raccolto, misurato con l’area necessaria alla sua coltivazione, in genere un alqueire paulista (24.200 m2). Altro cambiamento fu l’instaurazione di un vincolo tra l’area destinata alla coltivazione per il proprio consumo – ceduta gratuitamente o affittata – e il numero di alberi di caffè trattati o affittati, in un tentativo di scoraggiare la sottrazione di tempo dal lavoro nel caffè verso le colture alimentari. Erano anche affittati ai coloni, a prezzi bassi, le abitazioni e il pascolo per il bestiame. Il beneficio del caffè tornò a essere realizzato dagli schiavi fino al decennio 1880-’90 e, dopo, passò a essere realizzato da lavoratori salariati. Ma tutti questi cambiamenti non risolsero il problema del debito come disincentivo e, conseguentemente, quello della produttività del lavoratore. L’alternativa utilizzata per diminuire il problema fu l’applicazione di multe per la non esecuzione della sarchiatura invece di multe per l’abbandono della fazenda, ma nell’essenza il problema rimaneva senza soluzione. La situazione diventò acuta nel 1870, in virtù dell’aumento delle piantagioni di caffè del decennio anteriore e dei colpi ricevuti dal sistema schiavista. All’inizio degli anni 1880, rispondendo alle pressioni dei coltivatori di caffè di San Paolo, il governo brasiliano mise in pratica un programma di immigrazione, stabilendo un accordo di immigrazione sovvenzionata con l’Italia per il rifornimento di lavoratori liberi per le fazendas di caffè. Il risultato fu immediato e permise ai fazendeiros di abolire la schiavitù e, incentivati dagli alti prezzi del prodotto nel mercato internazionale, di dare continuità al processo di ampliamento delle fazendas. Inizialmente gli immigranti erano inseriti nelle colonie ufficiali dove ricevevano un piccolo appezzamento di terra. Il governo assumeva le spese di viaggio dall’Italia per il Brasile, fino alla colonia, finanziava la terra e le spese iniziali e manteneva un regime di tutela sui coloni durante i primi due anni. Queste colonie erano localizzate in aree non adatte alla coltivazione del caffè e della canna da zucchero, servendo soltanto alla coltivazione di alimenti. L’obiettivo era formare un “vivaio di manodopera” per le fazendas di caffè: il governo garantiva all’immigrante la produzione di alimenti per il suo 47 Secondo HOLANDA, alcuni fazendeiros avevano optato per il pagamento di un salario mensile fissato previamente e per il rifornimento di alimenti o di terra per la loro coltivazione. Il colono era obbligato a realizzare tutti i servizi della fazenda. Questo tipo di contratto era più adatto ai lavoratori nazionali che non agli immigranti, abituati che erano a uno standard di vita relativamente più alto di quello dei lavoratori nazionali. 90 sostentamento, ma l’obbligava a lavorare nelle fazendas come bracciante per poter ricavare i soldi necessari all’acquisizione di vestiti, medicine, ecc. Questa pratica ebbe breve durata per gli innumerevoli lamenti dei proprietari che adducevano che non sempre le colonie erano situate vicine alle fazendas che più avevano bisogno di lavoratori. In poco tempo gli immigranti sovvenzionati dallo Stato cominciarono a essere incamminati direttamente alle fazendas, dando origine alle colonie particolari e determinando la sovvenzione pubblica alla formazione del capitale nella grande fazenda. Nonostante il fatto di essere appoggiata dai difensori della colonizzazione, tale pratica occasionò una forte reazione politica davanti alla deviazione di risorse pubbliche in un unico settore e, soprattutto, alla concentrazione regionale di queste risorse. Al di là delle polemiche questa decisione governativa ebbe come risultato la rapida espansione delle fazendas di caffè per tutto l’ovest di San Paolo dato che l’unica forma di incorporare il capitale fornito dallo Stato era reclutando nuovi coloni. La corsa per l’apertura di nuove fazendas48, a sua volta, originò l’industria della grilagem49 e i diversi espedienti da essa usati per fornire al fazendeiro un terra “libera e sbarazzata di qualsiasi contestazione giudiziale”. Così, il tributo prima pagato ai commercianti di schiavi passò a essere pagato al grileiro50. Ma oltre a garantire l’offerta di manodopera alle fazendas in quantità sufficiente, era necessario promuovere cambiamenti strutturali nelle relazioni di lavoro finora praticate. Il grande problema rimaneva quello di garantire la realizzazione del trattamento della piantagione di caffè. Cercando di risolverlo alcuni fazendeiros passarono a introdurre “un sistema misto di rimunerazione per incarico svolto e per misura raccolta, il colonato, formula che prevalse nelle fazendas di caffè dagli anni 1880 fino agli anni ’60 di questo secolo. In questo sistema, il trattamento della piantagione di caffè era pagato a un prezzo annuale fisso per mille alberi trattati, e la raccolta a un prezzo per alqueire di caffè raccolto” (STOLCKE, 1986:36)51. Inoltre, era permessa al colono la produzione diretta di alimenti per il proprio consumo52 e la commercializzazione dell’eccedente. Infine, è opportuno sottolineare che il colono non era un lavoratore individuale, ma familiare. Ogni famiglia preservava la sua individualità nel lavoro, ricevendo una quantità di alberi di caffè che restavano sotto la sua responsabilità diretta e che variava a seconda Secondo MARTINS, la formazione della fazenda di caffè, almeno nei primi tempi, era realizzata dai lavoratori liberi nazionali chiamati “camaradas”. Questo lavoro richiamava l’attenzione dei coloni perché rappresentava una possibilità di aumentare i loro guadagni e pagare i loro debiti in tempi più brevi. 49 L’“industria” di falsificazione di titoli di proprietà. 50 Nome dato a quello che falsifica i titoli di proprietà. 51 Il grassetto è mio. La scrittrice si riferisce al secolo XX. 52 La maggior parte dell’alimentazione del colono proveniva da questa coltivazione. 48 91 della grandezza della famiglia, in una proporzione di 2000 alberi/uomo adulto e 1000 alberi/donna e bambino con più di 12 anni. Tutti dovevano curare la pulizia della piantagione di caffè, realizzando da cinque a sei sarchiature annuali. Nel “raccolto il pagamento era fatto con base in una quantità determinata per alqueire di 50 litri di caffè raccolto e depositato nel tratturo” (MARTINS, 1986:82). Il colono combinava la produzione del caffè a quella dei mezzi di sussistenza/riproduzione. Nelle piantagioni di caffè nuove coltivava mais, fagioli o altro prodotto agricolo che potesse essere consorziato, intercalandoli agli alberi di caffè. Nelle piantagioni più antiche, dove il suolo aveva perso un po’ della sua fertilità naturale, gli veniva destinata un’altra area per la coltivazione di tali generi, fatto che lo forzava ad ampliare la giornata lavorativa53. I prodotti erano coltivati durante il periodo del trattamento del caffè, quando la domanda di lavoro era minore. Inoltre il colono era obbligato a lavorare gratuitamente per il fazendeiro durante sei giorni all’anno, in attività come la riparazione delle strade che collegavano la fazenda alla ferrovia, manutenzione del pascolo e dei confini della proprietà e altro, sotto pena di pagare una multa per il non rispetto del contratto. Gli era offerta anche la possibilità di integrare il suo reddito lavorando come giornaliero nelle terre del fazendeiro oppure di un altro colono54. I fazendeiros contrattavano ancora lavoratori singoli – nominati avulsi – che lavoravano come giornalieri e aiutavano nella raccolta del caffè e in altre attività, nonché lavoratori qualificati, come falegnami, muratori, fiscali, ecc. La principale fonte di risparmio dei coloni era la vendita degli eccedenti alimentari, ma la possibilità di ampliare le aree di coltivazione avveniva soltanto nei momenti di ribasso dei prezzi del caffè, occasione in cui i fazendeiros permettevano la coltivazione di generi alimentari intercalati agli alberi di caffè anche nelle aree antiche. Quando, però, i prezzi si alzavano un’altra volta, tale coltivazione era nuovamente vietata. In alcuni casi i coloni erano ricompensati con un piccolo aumento salariale che raramente compensava l’autosussistenza perduta. Tutte le transazioni realizzate tra i coloni e i fazendeiros erano annotate in un piccolo quaderno. Ognuno di loro possedeva il suo proprio quaderno e gli appunti contenuti in entrambi erano confrontati nel momento di fare la verifica dei conti. Si trattava di un sistema di conto-corrente dove venivano segnalati i crediti e i debiti del colono. L’apparente uguaglianza tra il fazendeiro e il colono, che si manifestava soltanto nel momento di fare la verifica dei conti, servì a rendere a quest’ultimo l’illusione che il Secondo STOLCKE, per minimizzare il problema i fazendeiros offrivano guadagni superiori (circa il 25%) ai coloni che dovevano coltivare i generi alimentari fuori dalle piantagioni di caffè. 54 In questo caso essendo pagato dal colono che contrattava i servizi. 53 92 lavoro che consegnava al fazendeiro sotto la forma di caffè fosse il tributo pagato per lavorare a se stesso. Il colono non era rassegnato a guadagni monetari ridotti e la fazenda era soltanto una tappa nel movimento della sua autonomia. Nel migrare non stava andando semplicemente da un posto all’altro, stava andando verso il lavoro autonomo. La proprietà era per lui la condizione dell’uguaglianza e libertà: l’unica forma di liberarsi dalla soggezione della proprietà era diventare un proprietario. Il successo del colonato può essere provato dalla straordinaria espansione della coltivazione di caffè. “Tra il 1890 e il 1907 la produzione di caffè a San Paolo quintuplicò. Lo stato diventò il principale produttore di caffè del paese e il Brasile diventò il principale fornitore di caffè sul mercato mondiale, posizioni queste che entrambi avrebbero mantenuto fino agli anni ’50. Il caffè costituiva in media il 50% delle entrate delle esportazioni del Brasile, con punte, come nel 1924, quando la partecipazione del caffè salì a 74%. Il predominio del caffè sarebbe diminuito soltanto negli anni ’60” (STOLCKE, 1986:53/54). L’espansione delle piantagioni di caffè, a sua volta, comportò una crisi di superproduzione con il conseguente ribasso dei prezzi. Il governo di San Paolo adottò diverse misure per risolvere il problema, come l’istituzione di un’imposta sui nuovi alberi di caffè e l’avvio di programmi di sussidio ai prezzi. Ma esse contribuirono soltanto a far espandere ancora di più le piantagioni fino alla crisi di 1929. Il nuovo sistema non impedì la continuità delle frodi sui nuovi contratti da parte dei fazendeiros, soprattutto di quelle legate ai conti. Queste notizie arrivarono al governo italiano. In reazione a questa situazione fu annunciata, nel 1902, la proibizione dell’emigrazione sovvenzionata a San Paolo, la quale, però, ottenne all’inizio poco esito. Nonostante i fazendeiros cercassero di reprimere ogni forma di manifestazione di malcontento da parte dei coloni, gli scioperi si verificavano con una frequenza sempre maggiore. L’aumento della disciplina sul lavoro – tenuta, non di rado, tramite metodi violenti – fece nascere tra i lavoratori le condizioni per un’azione collettiva molto più efficace. Ma i risultati raggiunti erano piccoli davanti alle perdite accumulate nel trascorrere degli anni. Le proteste passarono a essere sempre più frequenti e, in poco tempo, migliaia di immigranti sollecitarono al Consolato italiano il rimpatrio. Secondo STOLCKE, tra il 1902 e il 1913 il tasso di migrazione di ritorno tra gli immigranti italiani era del 65%, mentre tra quelli che rimanevano nelle fazendas, le fughe notturne prima della scadenza del contratto diventarono una pratica sempre più comune. Questa situazione diede inizio alla promulgazione delle prime leggi a tutela dei coloni che, in pratica, diventarono armi efficaci utilizzate dai fazendeiros per reprimere tutte le minacce da parte dei lavoratori. Il grande movimento di ritorno all’Europa ridusse 93 drasticamente il flusso migratorio verso il Brasile e l’alta mobilità della manodopera – da una fazenda all’altra e dalle aree più antiche a quelle più nuove – fu la risposta data dai coloni alle condizioni miserabili nelle fazendas e alla concorrenza tra i fazendeiros. Ma la fine di questo tipo di sfruttamento non era lontana. Lentamente l’accesso alla terra da parte dei compratori con poche risorse cominciò a diventare una realtà, in funzione dalla frammentazione delle fazendas nelle aree antiche. Acquistate dalle grandi compagnie private di colonizzazione, le antiche fazendas venivano divise in piccoli appezzamenti di terra, poi venduti ai coloni a condizioni agevolate55. In questo senso, gli anni ’20 furono significativi per i coloni. I prezzi del caffè, dopo il 1923, ebbero un rialzo repentino e si mantennero elevati fino alla crisi del 1929/30. Questo favorì gli immigranti europei che ricominciarono ad arrivare dopo la fine della prima guerra mondiale, così come i lavoratori nazionali che erano stati “riscoperti” dall’ondata nazionalista vissuta durante gli anni di guerra. Gli alti prezzi del caffè facevano sì che i fazendeiros offrissero compensi più alti per il trattamento e la raccolta del caffè, soprattutto nelle aree più antiche, permettendo ai coloni di risparmiare i soldi necessari all’acquisto di piccoli appezzamenti di terra in meno tempo. Gradualmente passarono a essere i coloni stessi a occuparsi della coltivazione del caffè e dei prodotti alimentari in piccoli appezzamenti di terra. Il risultato di questo processo fu la diversificazione della produzione agricola e il cambiamento, anche se non radicale, della struttura agraria e del paesaggio rurale dello stato di San Paolo. Aree anteriormente dominate dalla grande proprietà destinata alla monocoltura passarono a essere caratterizzate da un mosaico formato dalle proprietà contadine con colture diversificate. 7. Le colonie agricole nel sud del Brasile Il processo di colonizzazione del sud del paese (inizialmente del Rio Grande do Sul e più tardi di Santa Catarina e del Paraná) possiede caratteristiche molto diverse da quelle delle altre parti del Brasile. Durante molti anni questa area fu “emarginata” dalla politica economica della Metropoli portoghese che favoriva lo sviluppo delle aree economicamente più importanti, capaci di produrre generi agricoli tropicali di facile 55 Secondo STOLCKE queste compagnie facilitavano il pagamento, chiedendo soltanto una piccola soma come entrata e dividendo il restante in rate che potevano così essere pagate con il risultato dei primi raccolti. 94 sbocco nel mercato internazionale56. Possedendo caratteristiche climatiche somiglianti a quelle europee, il sud del Brasile rimase a lungo fuori del raggio di azione di queste politiche. La colonizzazione di questa regione fu, secondo SABBATINI, il risultato di un programma politico dettato dal Governo Imperiale. Aveva come obiettivo “imbiancare” il Brasile, il cui sviluppo economico si basava ancora sulla forza lavoro dello schiavo africano, nonché proteggere e occupare strategicamente la linea di frontiera, evitando invasioni indigene e straniere e collegando internamente il Rio Grande do Sul a Santa Catarina, Paraná e finalmente, a San Paolo. I maggiori ostacoli all’espansione della colonizzazione erano la struttura economica fondamentalmente basata sull’allevamento del bestiame per l’esportazione e l’inesistenza di un settore agricolo di produzione per il mercato. Inoltre, le distanze e la mancanza di comunicazioni, rendendo difficile la commercializzazione tra le aree di colonizzazione, fecero della policoltura per l’autoconsumo la forma economica iniziale obbligatoria per l’espansione della colonizzazione in quella regione. Secondo SABBATINI, la formazione della Regione Coloniale Italiana nel Rio Grande do Sul ebbe inizio nel 1875 con l’arrivo e l’installazione delle prime famiglie lombarde e venete in un area di foresta vergine situata al sud del Fiume das Antas (attuale Nova Milano) e nell’area di Campo dos Bugres (attuale Caxias do Sul). I primi immigranti erano veneti provenienti dalle aree di produzione contadina che affrontavano una crisi strutturale caratterizzata da sovrappopolazione, dal continuo frazionamento della proprietà e dall’impossibilità di trovare sbocco nella propria patria. Questo quadro era ancora più aggravato dalla crisi congiunturale scatenata dalla depressione economica del decennio 1870 che mise in evidenza la loro marginalità economica. Così, essi furono attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini in un sistema di “nuclei coloniali” (pubblici o privati) inizialmente come concessionari e poi come proprietari. Secondo GUARDINI, all’aspirante a emigrante la società colonizzatrice57 offriva il viaggio gratis e un piccolo appezzamento di terra in area di foresta, da pagare in un lungo periodo, tramite prestazioni gratuite di lavoro nella realizzazione di opere di competenza governativa, in particolare strade, scuole, chiese, ospedali, ecc. Da parte sua il governo si impegnava a realizzare opere di infrastruttura fondamentali come strade, centri e servizi di 56 57 L’economia brasiliana si sviluppò per cicli economici, ognuno dei quali dominati da un unico prodotto commerciale: inizialmente la canna da zucchero nel Nordest, seguita dall’oro nella regione di Minas Gerais e infine dal caffè a San Paolo, Rio de Janeiro e più tardi nel nord del Paraná. Le compagnie di colonizzazione ricevevano dal governo brasiliano una somma per immigrante introdotto nel paese, oltre a ciò che lucravano tramite gli accordi stabiliti con i proprietari di terre, con le compagnie di navigazione e con quelle del trasporto ferroviario. 95 rifornimento. Il trasporto dalle aree di origini fino alla stazione ferroviaria di partenza in Italia (Trento o Verona nel caso degli emigranti veneti), era a carico degli emigranti. Essi portavano con sé gli strumenti indispensabili – piantine di vite, sementi diverse58 – armi – per la caccia e per difendersi dagli attacchi delle tribù indigene locali che resistevano all’arrivo di altri uomini bianchi – strumenti di lavoro – i falcetti, le roncole, le zappe più piccole dell’attività agricola – utensili domestici – i mortai e i pestelli di legno, i mestoli, i recipienti delle cucine, le molinelle – gli strumenti dell’artigianato femminile – i fusi e le rocche – nonché la speranza di dare continuità alla riproduzione contadina nella nuova patria. In Brasile i coloni ricevevano dalla compagnia di colonizzazione gli animali come aiuto nel trasporto delle valigie fino ai nuclei coloniali, alcuni strumenti per il lavoro di preparazione della terra e, posteriormente, i buoi per l’arato a trazione animale. Secondo SABBATINI il flusso migratorio veneto verso il sud del Brasile rappresentò l’avanguardia di un movimento migratorio più intenso durante il periodo del boom de caffè, dal 1887 al 1897. Esso propiziò la formazione di una nuova società italobrasiliana che, per la ridotta dimensione della regione coloniale storica, si caratterizzò per la conservazione e riproduzione del modello di società contadina veneta in terre brasiliane, con un forte incremento demografico e con costanti movimenti migratori verso terre sempre più lontane. Secondo l’autore, abituate a dure fatiche per la sopravvivenza, le famiglie venete, si mostrarono adatte a portare avanti l’esperienza della colonizzazione tramite i nuclei coloniali. La fase iniziale di impianto degli insediamenti fu difficilissima, dovendo il colono “passare dal baraccone collettivo degli emigranti al disboscamento, alla costruzione dell’abitazione, all’attesa dei primi raccolti, che talvolta erano distrutti da varie calamità naturali” (SABBATINI, 1975:XX). Ma, anche se per l’alimentazione le condizioni di vita che i contadini si lasciavano alle spalle non erano migliori, in generale le condizioni essenziali della vita furono durante molto tempo peggiori di quelle lasciate. La durezza della lotta per la sopravvivenza, l’isolamento e la dispersione di piccoli nuclei coloniali determinò inizialmente una certa regressione culturale. Ma la prospettiva di avere la piena proprietà di un piccolo appezzamento di terra, aspirazione più profonda della famiglia contadina veneta, compensava tutti i tipi di fatiche e privazioni. Così, lentamente si disegnò la geografia delle nuove aree coloniali. Parallelamente alla costruzione delle case e alla preparazione dei campi, prendeva forma nel centro di 58 Furono portati anche i semi del baco della seta, la cui produzione non poté essere iniziata a causa dell’inesistenza di industrie di filatura della seta. Questa attività fu impiantata nello stato di San Paolo verso gli anni 50 del XX secolo, durante il periodo dell’emigrazione giapponese in Brasile con l’installazione dell’industria giapponese BRATAC. 96 ogni nucleo coloniale ciò che più tardi sarebbe diventato il centro del paese: la residenza dell’ingegnere responsabile del progetto, i magazzini per i rifornimenti indispensabili; gli uffici postali, sulle strade appena costruite. Sulle rive dei fiumi sorgevano molini, segherie, officine per la lavorazione dei metalli, tutti costruiti dai coloni. Al centro di ogni nucleo, le chiese, durante molto tempo l’unica istituzione effettivamente presente e responsabile per il contatto tra le piccole comunità disperse. A partire dagli anni ’50 l’espansione industriale dell’area di Caxias cambiò radicalmente le caratteristiche della regione di colonizzazione tradizionale. L’espansione delle vie di comunicazione ruppe l’isolamento contadino e portò alla crisi delle forme culturali il cui mantenimento e sopravvivenza dipendevano da tale isolamento. Secondo SABBATINI, il collegamento ferroviario tra Caxias e Porto Alegre, realizzato nel 1910, occasionò cambiamenti nella base economica della regione, inducendo una rapida sostituzione, avvenuta tra gli anni 1915 e 1925, della policoltura per la monocoltura della vite destinata alla produzione del vino. Da allora l’industria vinicola perse la sua funzione economica fondamentale che ebbe nel periodo tra le due guerre, ma la monocoltura viticola resta ancora oggi fondamentale per l’economia contadina dell’antica regione coloniale. La formazione di un’agricoltura commerciale, basata sulla viticoltura, può essere caratterizzata come una fase di transizione tra l’economia di sussistenza iniziale e l’industrializzazione successiva degli anni ’50, frutto della politica governativa di sviluppo industriale avviata dal governo Vargas. Piano piano Caxias diventò il centro commerciale e artigianale più importante della regione coloniale italiana, beneficiando della sua localizzazione privilegiata di punto di incrocio di tre aree geoeconomiche distinte: l’area della regione coloniale italiana a ovest e nord ovest, l’area lusobrasiliana di allevamento del bestiame di Campos de Cima da Serra a nord est e, infine, Porto Alegre, la capitale dello stato, tramite la regione delle colonie tedesche. Tale supremazia si concretizzò in un epoca (1890-1914) in cui le condizioni delle società contadine erano ancora basate sulla sussistenza. Secondo SABBATINI, questo meccanismo fu possibile per l’importanza del commercio d’importazione di generi di prima necessità come medicine, sale, polvere, strumenti di lavoro, vestiti, ecc. Inoltre, una parte del reddito familiare proveniva da lavori accessori nella costruzione delle strade e altre opere pubbliche. Infine, nella mancanza di soldi per l’acquisto dei generi necessari, il contadino si assoggettava al sistema del “conto-corrente”59 offerto dai commercianti che chiedevano prezzi maggiorati per le loro merci. 59 Piccoli quaderni dove venivano annotati i debiti contratti con i commercianti. 97 8. Conclusione Le esperienze vissute dagli immigranti italiani in Brasile discusse in questo capitolo hanno in comune l’importante segno lasciato da loro nel paesaggio agrario brasiliano e nella creazione di una nuova cultura contadina. A San Paolo gli immigranti italiani furono responsabili, da un lato, dell’espansione delle piantagioni del caffè per tutto l’ovest dello stato, nelle aree previamente occupate dalle foreste, dall’altro dell’introduzione di una serie di nuove colture – il grano, le patate, le vite e altre alberi di frutta – che risultarono nel cambiamento delle abitudini alimentari delle popolazioni locali. Dagli anni ’20 in poi, furono anche gli attori della diversificazione della produzione e conseguentemente del paesaggio agrario nelle antiche aree produttore di caffè, dove il latifondo monocolturale diede luogo a un mosaico di piccole unità di produzione contadine dove venivano coltivati generi agricoli di diversi tipi, destinati al consumo della famiglia e al commercio nei mercati locali. Nel sud del Brasile, nello stato di Rio Grande do Sul, essi furono responsabili della trasformazione di aree di foresta vergine in aree di effervescente produzione contadina, seguendo il modello delle comunità contadine venete: piccoli appezzamenti di terra destinati inizialmente alla policoltura per l’autoconsumo e posteriormente alla monocoltura della vite, introdotta da loro stessi, per la produzione del vino. Nel centro di queste aree un piccolo paese offriva i servizi indispensabili e la possibilità di socializzazione, portata avanti soprattutto dalla Chiesa, durante molto tempo l’unica responsabile per il contatto tra le varie comunità contadine disperse. Sempre nel sud, nello stato del Paraná, ebbe luogo la breve ma importantissima esperienza di comunismo anarchico, con la costruzione di una vera e propria comunità contadina, la Colonia Cecilia, che sarà trattata nel capitolo successivo. Anche qui, l’antico “mare verde” formato dalla foresta vergine diede luogo a un mosaico colorato formato dai campi di lavoro comunitario con le diverse coltivazioni destinate al consumo della comunità e alla commercializzazione, e dal nucleo della colonia composto dai laboratori artigianali, dalla scuola, dalle abitazioni delle famiglie e dal baraccone destinato all’abitazione dei singoli, dove avevano luogo anche i pasti collettivi, le serate dove si discutevano di filosofia e politica, si svolgevano le feste e le calorose assemblee che tracciavano il destino della comunità. La ridefinizione del paesaggio agrario brasiliano e l’innovazione per cui passò l’agricoltura tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento è, senza dubbio, opera della “brava gente” che lì immigrò portando con sé il sogno contadino della produzione 98 autonoma e della libertà del lavoro. L’introduzione, nella storia brasiliana, dell’allegria, della festa, della speranza, dell’amore per la terra, del fervore religioso, della mamma, del nonno, della minestra, degli gnocchi e della polenta; della fisarmonica e del violino, della famiglia numerosa, della conversazione allegra e rumorosa, del “ciao”, del gusto per i proverbi e di una bevanda semplice che rallegra l’anima, il vino, è merito loro. 99 PARTE II LE «VECCHIE» UTOPIE 100 CAPITOLO 4 LA PRASSI ANARCHICA: GIOVANNI ROSSI E LA COLONIA CECILIA 1. Giovanni Rossi: vita e idee “È un uomo onesto quanto lo può essere un pagano, filantropo quanto lo può essere un epicuro che cerca il benessere privato; cerca di far del bene anche agli altri privandosi se occorre anche del proprio per sollevare l’altrui miseria, materialista nega la spiritualità dell’anima e così via con tutti i pessimi principi della moderna civiltà”60 Nato a Pisa nel gennaio 1856, Giovanni Rossi era il primogenito di altri cinque fratelli di una famiglia media borghese. Si iscrisse al corso di medicina veterinaria presso l’università pisana61, diplomandosi nel 1875. Il contatto con il mondo universitario diede al suo orientamento politico un taglio marcatamente rivoluzionario: Rossi aderì alla sezione pisana dell’Internazionale, fondata alcuni anni prima della sua laurea, fatto che gli rese ben presto una schedatura in questura come elemento pericoloso e sovversivo62. Dopo l’improvvista morte del padre avvenuta nel 1875, Rossi si trasferì a Montescudaio, vicino a Cecina, per dedicarsi al podere di proprietà della famiglia, senza, però, rinunciare all’attività politica. Infatti, risalgono a questo periodo le collaborazioni con importanti giornali anarchici, tra cui il «Plebe»; l’inizio dei contatti con Andrea COSTA, che avrebbero poi avuto importanti sviluppi; la fondazione e direzione di una Lettera scritta da don Bonomelli, parroco di Gavardo a don Brunelli, vescovo di Cremona, pubblicata da A. FAPPANI in Gabriele Rosa fra democrazia e socialismo, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 1965..; cfr. inoltre ID., Un anarchico a Gavardo, in ‹‹La voce del popolo››, 19 aprile 1969. 61 Secondo GOSI egli terminò i suoi studi presso la Scuola Normale Superiore Agraria. 62 Secondo GOSI, negli anni dell’università ROSSI si legò in amicizia a Gustavo Berton, un giovane veneto noto alla polizia come “addetto alla società Internazionale” e “promotore dell’Associazione Universitaria”. Più tardi ROSSI gli renderà un omaggio nelle pagine di Un Comune Socialista. 60 101 “sezione” dell’Internazionale a Montescudaio63. Tutto questo mise Rossi sotto la costante sorveglianza della questura pisana. Ciò nonostante, egli riuscì a svolgere un ampio lavoro politico che giunse fino il capoluogo della Provincia. “Parallelamente all’impegno politico il Rossi proseguiva, in questo stesso periodo, una ricerca più propriamente scientifica, testimoniata in numerosi articoli e pubblicazioni, per ottenere una condotta veterinaria e un incarico universitario: sia l’uno che l’altro obiettivo furono preclusi all’anarchico in almeno un paio di circostanze, causa il negativo intervento delle autorità” (GOSI, 1977:09). Il 1878 fu per lui importante. Nel febbraio di quell’anno, con lo pseudonimo di CARDIAS64, pubblica sul giornale «Il Lavoro» l’articolo Del collettivismo. Sempre con lo pseudonimo di CARDIAS, Rossi pubblica nell’estate di quell’anno anche il libro Un Comune Socialista, dove “espone per la prima volta il suo programma per la realizzazione di una colonia collettivista anarchica. Nel libro vengono descritti la nascita e lo strutturarsi di un villaggio ove è stata instaurata la collettivizzazione della terra e della proprietà, posta «l’anarchia nelle relazioni sociali, la proprietà collettiva dei capitali, la distribuzione gratuita dei prodotti nell’assestamento economico, la negazione di Dio in religione». Un racconto (…) che fa emergere il Rossi dalla maggior parte degli internazionalisti dell’epoca per quella caratteristica che lo contraddistinguerà in futuro: la volontà di mettere immediatamente in pratica gli ideali rivoluzionari, la necessità di applicare alla ricerca delle idee socialiste la verifica empirica. Un impegno cioè tipicamente sperimentale” (ZANE, 1989:8). Ma la sua intensa attività politica non sfugge al controllo dello Stato e, nel novembre di quello stesso anno, dopo la scoperta di nuovi contatti dell’anarchico con il “Comitato Internazionale Imolese” e la pubblicazione di Un Comune socialista, egli venne arrestato, in seguito a una provocazione poliziesca, per “attentato contro la sicurezza interna dello Stato”. Rimase in carcere per circa cinque mesi, nonostante fosse stata riconosciuta la sua estraneità ai fatti. Secondo ANDREUCCI e DETTI, una volta uscito dalla prigione, l’anarchico si avvicinò sempre di più alle posizioni di Andrea Costa e all’evoluzionismo del gruppo della «Plebe», influenzando così il movimento operaio pisano. Sono esempi della sua influenza La “sezione” a cui fa riferimento la polizia, era stata, secondo GOSI, segnalata dallo stesso Rossi sul giornale ‹‹La Plebe›› fin dall’agosto ’77 come “partito socialista di Montescudaio”. 64 Con questo pseudonimo Rossi pubblicò numerosi scritti oltre ai libri Un comune socialista, uscito in prima stampa a Milano nel 1878, Cecilia comunità anarchica sperimentale. Un episodio d’amore nella colonia «Cecilia», uscito in prima stampa a Livorno nel 1893 e Utopie und Experiment, pubblicato a Zurigo nel 1897. Secondo MASINI, il termine cardias si riferisce all’apertura superiore dello stomaco. L’autore ritiene che l’anarchico, “da buon materialista e da buon veterinario, aveva preso quel nome probabilmente a significare che la questione sociale era anzitutto nell’Italia del macinato e della pellagra, una questione di stomaci vuoti da riempire” (MASINI, 1974:249). 63 102 il giornale «Sempre avanti!» di Livorno del 1891 – che propugnava la costituzione di un nuovo partito socialista e l’accettazione di “tutti i mezzi senza preconcetti” – e il giornale «Il Socialista» di Pisa del 1883, che sosteneva la partecipazione elettorale con candidature di protesta. In questo giornale Rossi pubblica in prima pagina, nel dicembre del 1883, sempre sotto pseudonimo, l’articolo Vantaggi e possibilità di una colonia socialista. “Il costante controllo delle autorità, unito probabilmente alla necessità di stringere più stretti rapporti con il movimento socialista romagnolo e lombardo, lo convincono, nel 1882, a partecipare ad un concorso di veterinario condotto a Gavardo, nella provincia bresciana65. Trasferitosi nel piccolo paese, non rinunc[iò] (…) a svolgere una intensa attività di propaganda, dando il via a tutta una serie di iniziative per i contadini della zona, dall’istituzione di una cooperativa di mutuo soccorso alla pubblicazione di un giornale, «Dal campo alla stalla», alla trasformazione della condotta veterinaria «a tutta cura gratuita». A Gavardo il Rossi intesse […] anche una fitta serie di relazioni con i maggiori esponenti del socialismo bresciano, iniziando la propria collaborazione all’«Avanti!» fondato dall’amico Andrea Costa, con cui [ebbe] frequenti rapporti epistolari” (ZANE, 1989:8) Fu in questo periodo che l’anarchico elaborò compiutamente la sua teoria sulla creazione delle colonie sperimentali in quanto strumento indispensabile per apprendere, dalla sperimentazione pratica, quali forme fossero più adatte alla prospettiva di un cambiamento sociale. Tanto che, nel 1884, nella quarta edizione del suo opuscolo Un comune socialista, inserì l’enunciazione “della necessità di applicare alla ricerca scientifica nel campo socialista il metodo sperimentale; realizzare cioè colonie socialiste sperimentali in modo da poter studiare «i fenomeni nuovi» che ne [fossero emersi] e «quali forme di vita sociale» siano «più consentanee all’indole umana», fondandosi sulla convinzione che l’evoluzione della società debba avvenire ineluttabilmente in senso socialista” (ANDREUCCI e DETTI, 1978:405). 65 Secondo ZANE, Gavardo era, nella seconda metà dell’Ottocento, un villaggio di economia sostanzialmente agricola ma con importanti attività industriali e artigianali. La popolazione era in buona parte dedita all’agricoltura. Il contratto più diffuso era quello a mezzadria, applicata su poderi di piccole dimensioni e con coltivazioni promiscue, soprattutto grano e vite. I braccianti di solito integravano i magri guadagni provenienti dai lavori agricoli stagionali impegnandosi in altre attività come facchini, mattonai, ecc. Di rilievo era anche l’allevamento dei bachi della seta che aveva importante commercio presso il setificio locale. Le coltivazioni della vite e dei cereali erano in linea di massima destinate al consumo familiare. Le tecniche agricole e di produzione rimasero inalterate per tutta la seconda metà dell’Ottocento, fatto a cui Giovanni Rossi si oppose svariate volte. Con l’arrivo del tram a vapore Gavardo ebbe maggiori opportunità di commercializzazione, fatto che contribuì a incentivare l’industria e l’artigianato locale. La vita politica era controllata da un gruppo delimitato e compatto, anche se non omogeneo, composto per esponenti della borghesia agraria. Nel mondo cattolico, un gruppo eterogeneo con alla testa don Giuseppe Brunelli, con cui Rossi ebbe numerosi scontri. 103 Nel frattempo collaborò con diversi giornali fra cui l’«Avanti!» di Costa, «La Favilla» di Mantova e «In marcia» di Fano-Pesaro, battendosi a favore dell’utilità e validità delle colonie socialiste, sulle quali si era acceso un interessante dibattito. Così, nel gennaio 1885 pubblica su «La Favilla» la proposta di creazione di una colonia agricola cooperativa, da trasformarsi successivamente in colonia socialista, seguita da un appello di sottoscrizione per la creazione di tale colonia in Italia. Tale appello fu inviato anche a tutte le federazioni, sezioni, circoli e nuclei socialisti in Italia. Dal dibattito iniziato dopo tale pubblicazione nacquero le premesse per la pubblicazione di un nuovo giornale, «Lo Sperimentale», “diretto dallo stesso Rossi, scritto e pensato a Gavardo e pubblicato a Brescia negli anni 1886-1887. Il nuovo periodico, dedicato quasi esclusivamente alla discussione ed alla propaganda del suo progetto di colonia socialista anarchica, raccoglierà attorno a sé alcuni fra i più importanti nomi del socialismo italiano e francese, da Filippo Turati al Candelari, da Reybaud a Reanaud, con un interessamento anche da parte del milanese Gnocchi Viani. Il fine [era] quello di dimostrare, con la realizzazione della colonia sperimentale, che se tali realizzazioni sono possibili in una società autoritaria e coercitiva, tanto più tali forme di vita e di organizzazione sociale saranno possibili ed auspicabili in una società libera” (ZANE, 1989:8/9). In questo giornale, che uscì per cinque numeri di modo indipendente – dal maggio 1886 al gennaio/febbraio 1887 – e per altri sette numeri dopo la fusione con il napoletano «Humanitas», Rossi espose la biografia di importanti socialisti utopistici e anarchici e fornì esempi di colonie socialiste di diversi tipi e svoltesi nei più variati luoghi66. La realizzazione del suo ambito progetto avvenne non a Gavardo, ma nella vicina provincia cremonese, “ove il Rossi si [trasferì] nel novembre del 1887 su invito del possidente Giuseppe Mori, ex-deputato mazziniano, e con l’intermediazione del socialista Leonida Bissolati. In questa occasione Rossi tenterà, inutilmente, di trasformare la cooperativa istituita fra i contadini della zona di Cittadella, nel comune di Stagno Lombardo, in una vera e propria colonia collettivista, tramite l’allargamento ad un gruppo di agricoltori socialisti. Il 66 Il n° 1, del maggio 1886, è dedicato a Robert Owen. Il n° 2, dell’agosto 1886, a Stefano Cabet. Il n° 3, del settembre 1886, a Francesco Natale Babeuf. Il n° 4, dell’ottobre/novembre 1886, a Carlo Fourier. Il n° 5, l’ultimo, uscito nel gennaio/febbraio 1887 lo è a Michele Bakounine. Dopo la fusione con il periodico napoletano «Humanitas» – che, a sua volta, cessò le sue pubblicazioni nell’ottobre 1887 – passò a disporre soltanto di una pagina, la quale era dedicata ai soli esempi di colonie socialiste nel mondo. I numeri usciti dopo la fusione furono: 7, uscito all’interno dell’«Humanitas» X; 10, con l’«Humanitas» XIII; 11, con l’«Humanitas» XIV; 12, con l’«Humanitas» XV; 13, con l’«Humanitas» XVI; 14, con l’«Humanitas» XVII e 16, con l’«Humanitas» XX. Con eccezione del numero XX, uscito senza la pagina de «Lo Sperimentale», i numeri mancanti sono stati sequestrati dalla polizia, non essendo possibile conoscere il suo contenuto. L’ultima uscita ebbe il numero XXIII, con data 2 ottobre 1887, ma sin dal numero precedente non era uscita la pagina de «Lo Sperimentale», senza previo avvertimento. 104 lavoro preparatorio sarà lungo e complesso, con la stesura di uno statuto che conserva in sé l’impronta delle idee del Rossi, ma i rancori mai sopiti fra alcuni coloni di Cittadella faranno ben presto naufragare il progetto appena avviato, sino allo scioglimento della colonia, avvenuto nell’ottobre del 1890. In questo stesso periodo il Rossi [tentò] di dare corpo ad iniziative similari nella campagna parmese, a Torricella di Sissa, e nella regione padovana e reggiana, ma la cronica mancanza di fondi e le innumerevoli difficoltà burocratiche sovrappostesi insabbia[ro]no definitivamente tutti i progetti” (ZANE, 1989:9). Rossi però non desistette dal suo intento. Quanto più l’Italia si mostrava refrattaria al suo progetto, più l’America gli appariva come possibilità. Dopo la delusione vissuta a Cittadella, l’anarchico decise di andare in America a integrare una delle colonie collettiviste che si erano appena formate e, mentre si organizzava per partire fu contattato da amici bresciani che lo invitarono a partire verso l’America del Sud per fondare una colonia socialista. Dopo una nuova e rapida campagna per la raccolta di fondi, Giovanni Rossi si imbarca a Genova, insieme a pochi compagni, il 20 febbraio 1890, per fondare in Brasile la sua colonia socialista, la colonia Cecilia67. Esistita dal 1891 al 1894, la colonia Cecilia conobbe alcuni anni di prosperità economica e sociale. I più di 150 coloni68 lavoravano vasti appezzamenti di terreno in modo comunitario, e la colonia era dotata di una farmacia e di una biblioteca. Un gruppo più ristretto di famiglie – in realtà una unica famiglia insieme a Rossi – si diede anche all’attuazione del principio “del libero amore”, attuato contro “l’azione micidiale dei rapporti di parentela”69. Ma anche in questo esperimento le incomprensioni fra vecchi e nuovi coloni aggravarono i difetti della colonia. Il colpo di grazia alla Cecilia viene inferto nel 1894 dallo scontro ormai arrivato a un livello insopportabile tra un gruppo di contadini parmensi arrivati nel maggio 1891 – a cui Rossi si riferisce come il “partito contadino” – e il gruppo formato da persone meno operose oppure incapaci di sostenere il lavoro manuale, e che culminò con la vendita dell’attivo della colonia al gruppo di contadini e la fine dell’esperienza. L’esperienza comunitaria vissuta nella colonia venne analizzata dal Rossi nell’opuscolo Un episodio d’amore nella colonia Cecilia, pubblicato nel 1893, con l’individuazione delle cause del parziale fallimento dell’esperimento, oltre a quella appena Il nome dato alla colonia fu un omaggio alla “Cecilia” presente nel suo libro “Un comune socialista”, il quale sarà trattato in sezione posteriore. Nel 1891 ROSSI pubblica l’articolo Notarelle di viaggio e di colonizzazione, dove tratta del viaggio e dei primi mesi di permanenza nel Paraná nella Rivista La Geografia per tutti, edita a Bergamo e diretta da A. Ghisleri. 68 Le cifre riguardanti il numero di membri della colonia Cecilia sono molto divergenti tra loro. Mi sono basata sull’informazione fornita dal Rossi stesso. 69 Una delle idee centrali dal pensiero di Rossi era l’influenza nefasta della famiglia per l’avvenire del socialismo. 67 105 menzionata, nella struttura familiare tradizionalmente intesa, inconciliabile con il concetto di libertà. “Scioltasi la colonia, Giovanni Rossi si [trasferì] in altre regioni brasiliane, dove [assunse] per breve tempo anche l’incarico di direttore di una stazione agraria sperimentale. Nel 1895 [diede] alle stampe il volume Il Paraná nel XX secolo. Utopia di G. R. (Cardias), in cui [cercò] di dare una pratica valutazione di una eventuale e futura rivoluzione sociale, utilizzando a piene mani le esperienze realizzate alla colonia «Cecilia», non mancando di evidenziare le forme di autoritarismo che potrebbero emergere da un regime di proprietà comunistica e rivalutando la figura della donna emancipata ed economicamente indipendente. Assunto alle dipendenze del governo brasiliano, Rossi [venne] trasferito come direttore di stazioni agronomiche a Rio dos Cedros70 e successivamente a Florianópolis. La morte, avvenuta a pochi anni di distanza, di due figlie in tenera età, lo [convinsero] a fare ritorno in Italia, dove giungerà con la famiglia nell’aprile del 1907; stabilitosi a San Remo prima e sulla costa versiliese poi, raggiungerà definitivamente la città natale di Pisa nel 1914, alla vigilia del primo conflitto mondiale. Lasciata in pratica la politica, Rossi si dedicherà all’agricoltura nel proprio piccolo podere, ma le ristrettezze economiche imposte dalla guerra lo costringeranno ad accettare una supplenza veterinaria presso Codegno, dove insegnerà anche nel locale istituto tecnico. È di questi anni il suo ultimo intervento sul giornale «Università popolare», in cui spiegherà, trent’anni dopo, il suo punto di vista sulle colonie sperimentali e sulla colonia «Cecilia». L’avvento del fascismo [trovò] Giovanni Rossi ormai stanco ed invecchiato, tanto da evitare qualsiasi schieramento pubblico. Morirà a Pisa, alla veneranda età di 87 anni, il 9 gennaio 1943” (ZANE, 1989:10)71. 2. L’(u)topia di Giovanni Rossi: Un comune socialista Secondo GOSI, Un Comune Socialista, bozzetto semi-veridico di Cardias, pubblicato in prima stampa nell’estate del 1878 come quarto nell’ordine della Biblioteca socialista del giornale milanese «La Plebe», rappresenta uno degli esempi più significativi, almeno in Secondo ANDREUCCI e DETTI, dopo la fine della Colonia Cecilia Rossi si stabilì prima a Curitiba e poi a Taquari, dove assunse l’incarico di direttore di una stazione agronomica sperimentale. Solo più tardi fu trasferito a Rio dos Cedros. 71 ANDREUCCI e DETTI fanno riferimento a un articolo del 1916 apparso sulla rivista Critica sociale, dal titolo Il socialismo dei margini in cui proponeva, tenendo conto delle difficoltà economiche dell’epoca, che lavoratori organizzati comunisticamente coltivassero i margini delle strade. 70 106 Italia, di letteratura socialista utopistica72. Accanto alla produzione teorica, il socialismo utopistico diede vita ad alcune realizzazioni pratiche, ma esse ebbero un successo assai limitato e non tardarono a spostare il loro campo d’azione dal Vecchio al Nuovo Mondo. In Italia, la produzione letteraria utopistica, di modeste proporzioni, riflesse la realtà sociale dell’epoca ed ebbe uno stampo marcatamente contadino, raramente andando oltre alla pura fantasticheria73. Il romanzo di Rossi, invece, segnò un importante cambiamento, configurandosi come l’enunciato teorico di un progetto portato avanti nel tempo fino alla sua concretizzazione in due precise realizzazioni: Cittadella e Cecilia. Il romanzo è strutturato in forma narrativa ed è diviso in due parti principali: la prima, intitolata propaganda, dove Rossi prova a convincere il lettore a convertirsi al Socialismo; la seconda, intitolata organizzazione, dove è descritta l’organizzazione e il funzionamento di Poggio al Mare, il paese immaginario situato sulla costa tirrenica, dopo la sua conversione al Socialismo. Il libro ebbe cinque ristampe. Quella da me analizzata, oggetto di questa sezione, fu la quarta, uscita nel 1884 a Brescia e pubblicata dalla Tipografia Sociale Operaia, con una prefazione di Andrea Costa. Oltre le due parti principali e la suddetta prefazione, il libro contiene ancora altre tre parti. Una parte introduttiva, intitolata sragionamenti, dove l’autore si rivolge ai borghesi nel tentativo di spiegare che cos’è veramente il Socialismo e come si sarebbe organizzata la società dell’avvenire. L’epilogo, dove difende la tesi della naturale tendenza dell’umanità alla vita socialista e fa un altro tentativo di sensibilizzare i borghesi. Infine l’appendice, dove difende lo sperimentalismo e propone la realizzazione di esperimenti pratici di vita anarchica, ambedue messi in fondo al libro. Nella quinta edizione del suo libro, pubblicata a Livorno, Rossi introdusse un capitolo sulla colonia Cecilia dove racconta i primi mesi della storia della colonia socialista in Brasile, in tono nitidamente propagandistico. Una produzione più ricca e complessa di questo tipo di letteratura ebbe posto in Francia e Inghilterra nella prima metà dell’Ottocento, quando alcuni pensatori elaborarono proposte di società “alternative” – di solito fondate sulla ragione, la verità e la giustizia – mossi dalle idee emerse con la Rivoluzione Francese. 73 GOSI cita il romanzo La colonia Felice. Utopia, di Carlo Dossi, uscito in Italia, nel 1874. Tale romanzo ebbe numerose ristampe, anche come appendice su importanti giornali d’epoca, tra i quali «La Riforma», «Il Sole» e «La Plebe». Questo romanzo, però, portava in sé poche proposte di cambiamento della società. Secondo l’autrice, nella nuova organizzazione sociale descritta nel libro, gli istituti fondamentali della società tradizionale, primo fra tutti la famiglia, erano mantenuti tali e quali. Per questa ragione, anche se si tratta di un’utopia, il romanzo viene messo nel campo del “socialismo conservatore”. 72 107 2.1. L’analisi del libro Andrea COSTA inizia la prefazione alla quarta edizione del libro di Rossi affermando che tra le accuse fatte dagli avversari, quella che lui teme di più è di essere considerato un “sognatore”. Ciò nonostante, dice di aver sognato anche lui, immaginando in Un sogno, una città della Romagna tutta convertita al socialismo74. COSTA sottolinea le somiglianze esistenti tra i due libri, pur riconoscendo quello di Rossi come più completo, “colorato” e pieno di raffinatezze e fondamenti scientifici. Riconosce soprattutto nel libro di Rossi la risposta alle domande sull’avvenire in un ordinamento socialistico. Secondo lui, il giorno in cui le persone avessero capito che il socialismo avrebbe dato luogo a una società dove i beni sarebbero aumentati e i mali diminuiti di molto, allora avrebbero cominciato a condividere il sogno socialista, oppure, avrebbero cominciato a pensare e dubitare. E conclude: “quando la parte più intelligente della società pensa e dubita, e la parte più numerosa, sicura di sé, si muove, oh! Allora può dirsi, che, dalle coscienze almeno, il vecchio ideale se n’è andato; e l’avvenimento del nuovo è questione di tempo. A questo rivolgimento della coscienza sociale tu coopererai certo, o amico Rossi, col tuo Comune Socialista, non poco; e di ciò grati ti saranno tutti quelli che camminano verso i nuovi orizzonti. Non discutiamo ora se, in tutto e per tutto, (…) andiamo d’accordo. (…). Il fondamento nostro è lo stesso: questo è l’importante. E con lo stesso fondamento e con lo stesso metodo, le conseguenze saranno le stesse. Il fondamento: comunità di mezzi e libertà. Il metodo: evoluzione per preparare; rivoluzione per attuare. Le conseguenze: prosperità e libertà per tutti; svolgimento progressivo infinito del genere umano” (COSTA in ROSSI, 1884:VIII). Il libro di ROSSI inizia, dopo questa prefazione, con gli sragionamenti, dove l’autore, rivolgendosi ai borghesi, spiega che cos’è il socialismo e la forma di organizzazione della società dell’avvenire. Inizia informando che il socialismo: elimina, per tutti gli uomini, le cause delle miserie economiche, organiche, morali e intellettuali, 74 Un Sogno, l’utopia di Andrea COSTA, fu pubblicato a Imola nel 1881 in un «Almanacco popolare». Secondo GOSI, in questo libro, COSTA tratta dell’Imola trasformata dopo una rivoluzione scoppiata contemporaneamente in tutta l’Europa. La città era completamente cambiata: le mura e la rocca erano state abbattute, le strade ferrate avevano sostituito le vecchie strade, i vicoli e gli edifici sudici avevano dato luogo a nuove strade e a edifici più belli e puliti. La proprietà apparteneva ai lavoratori. C’era la libera circolazione delle persone e non esistevano più le guardie, i soldati, i preti e i mendicanti. Pure la famiglia era scomparsa, regnando al suo posto l’amore libero (questi ultimi temi – la famiglia e l’amore libero – saranno ripresi più tardi da Rossi durante la realizzazione della Colonia Cecilia). 108 facendo scomparire le pagine di cronache nere della società; riconduce gli uomini alle benefiche leggi naturali, condizioni del progresso morfologico e funzionale; fa giustizia sulla produzione; elimina il concetto di autorità; afferma e conferma la legge del progresso storico indefinito; risolve la questione della soggezione femminile e, infine, si presenta come il prototipo del grande, del bello, dello splendido. Riassume: il socialismo è il posto della felicità e del benessere. ROSSI prosegue i suoi ragionamenti avvertendo i borghesi, e i lettori in generale, che manca l’esperimento a dare caratteristica di verità o meno al socialismo moderno, che il suo libro tenta di colmare. Allo stesso tempo, sottolinea che il socialismo moderno – da lui inteso come “anarchia nelle relazioni pubbliche e private; amore e nient’altro che amore nella famiglia; proprietà collettiva del capitale, proprietà personale o distribuzione gratuita dei prodotti nell’assettamento economico” (ROSSI (CARDIAS), 1884:5) – è una tendenza popolare e il suo studio è una scienza. In seguito, spiega che cosa intende per ciascuno di questi concetti. In ciò che riguarda la proprietà collettiva, ROSSI ritiene che siccome le generazioni passate hanno contribuito alla formazione del patrimonio sociale, esso deve appartenere all’umanità intesa come ente collettivo. I socialisti, informa l’anarchico, vogliono trasformare questo diritto in fatto: la presa di possesso del patrimonio sociale da parte della collettività significherebbe la rivoluzione sociale nel campo economico. Questo patrimonio, però, “non può, non deve andare diviso, pena il pronto ricomparire dell’oppressione economica; esso deve restare patrimonio indivisibile e inalienabile della collettività. Questa è la proprietà collettiva che sostituirà la proprietà individuale. Ove però a questo patrimonio non fosse associato il lavoro, presto diventerebbe infruttifero. Sarà questa convinzione, sarà l’interesse collettivo, sarà la ineluttabile necessità delle cose, che indurrà gli uomini al lavoro” (ROSSI (CARDIAS), 1884:9). Riguardo al consumo, ROSSI fa riferimento all’esistenza di due scuole di pensiero: quelli che associano il consumo alla quantità di lavoro svolto, ritenendo questa la forma per mantenere lo stimolo alla produzione, e quelli, invece, che difendono il consumo libero, a seconda dei bisogni personali e delle rendite sociali, sperando in metodi più razionali capaci di trasformare il lavoro in qualcosa di più attraente, facendo così aumentare la produzione in modo da non compromettere il libero accesso alla produzione sociale. Una volta fatti questi chiarimenti, ROSSI dà inizio alla sua utopia. Il libro si struttura in forma di romanzo. Nella prima parte, intitolata propaganda, egli ci porta al paese immaginario di Poggio al Mare, sulla costa tirrenica, dove si reca in visita ad Alessandro De Bardi, un suo vecchio amico. Appena arrivato, assiste a una lite tra due 109 contadini e, dopo aver incontrato e salutato il suo amico, gli richiama l’attenzione sugli effetti negativi della proprietà, in fondo la causa del litigio presenziato. ROSSI, accompagnato da una guida, fa un giro per la campagna e poi per il paese di Poggio al Mare. Si serve di questo giro per fare un’accurata descrizione del posto, prima della campagna, dissertando sull’agricoltura, sulle condizioni di vita dei contadini e del loro abbrutimento dovuto all’eccesso di lavoro, e poi del paese, affrontando gli aspetti della vita economica, sociale e culturale. Conclude che sono i principi guida della vita borghese i responsabili di tutta quella situazione. ROSSI, anzi CARDIAS, torna a casa del suo amico, dove rimarrà ospite per qualche giorno. Lì conosce Cecilia, la sorella di De Bardi, e scopre essere anche lei una socialista. Dopodiché questa parte del libro passa a svolgersi tramite una serie di dialoghi e lettere scambiate tra CARDIAS e Cecilia sui principi fondamentali del socialismo: la questione della proprietà, della giustizia sociale, della produzione e dello stimolo alla produzione, dei diritti all’eredità, della famiglia, dell’emancipazione delle donne, dei privilegi pecuniari, del collettivismo, dei valori morali e sociali degli uomini. Questi erano gli argomenti di animate serate di discussioni, di lettere appassionate scambiate tra i due che, oltre a servire di scambio di idee tra i due socialisti, avevano lo scopo di convertire il proprietario delle terre, Alessandro De Bardi, al socialismo. Questa prima parte finisce con l’unione di CARDIAS e Cecilia in matrimonio e con l’accettazione, da parte di De Bardi, delle idee da loro difese. Come prova di questa accettazione, De Bardi gli offre le terre in concessione perché fossero trasformate in socialismo per un periodo di dieci anni, rinnovabile in caso di successo e per espresso desiderio dei contadini. Restava, però, da convincere gli abitanti di Poggio al Mare a realizzare tale esperimento e CARDIAS affida la missione a un suo amico, Gustavo Berton75. Dopo un discorso appassionato fatto dal giovane anarchico nella piazza del paese, gli abitanti decidono di accettare la proposta. Ha così inizio la seconda parte dell’utopia, dove ROSSI passa a descrivere come si diede l’organizzazione di Poggio al Mare in socialismo. La seconda parte del libro, l’organizzazione, è senza dubbio quella più importante, poiché è quella in cui CARDIAS descrive l’organizzazione di Poggio al Mare in socialismo, ed è la base delle idee sull’organizzazione della produzione agricola che l’anarchico cercherà di mettere in pratica negli esperimenti di Cittadella e della Cecilia. Il primo passo, racconta l’autore, fu l’organizzazione di un Comitato Organizzativo Provvisorio e l’elaborazione di un contratto ufficiale, dove fu stabilita la forma di 75 In omaggio all’amico socialista delle lotte universitarie, morto ancora giovane. 110 organizzazione e funzionamento di Poggio al Mare. In questo contratto gli abitanti dichiaravano: di associarsi per dieci anni con l’obiettivo di coltivare le terre e dedicarsi ad alcune attività industriali; che i capitali – mobili e immobili – diventavano collettivi, e che la divisione degli utili sarebbe stata determinata in un altro momento; che passati dieci anni la società, a seconda dei risultati raggiunti, sarebbe stata sciolta oppure prorogata per altri dieci anni e che gli amministratori della società che si stava organizzando sarebbero stati nominati dai membri stessi. Furono adottati altri provvedimenti, come per esempio l’inventario delle proprietà di ciascuno in caso di scioglimento dell’esperienza; la denunzia delle entrate sociali all’agente delle imposte e, infine, dopo essere stata stabilita la cooperazione sociale all’interno delle associazioni, furono organizzate le associazioni di arti e mestieri a titolo di esperimento. Una volta organizzate tali associazioni, ciascuno dei partecipanti scelse liberamente a quale partecipare secondo le proprie inclinazioni e interessi. Il Consiglio Provvisorio suggeriva soltanto che le attività che richiedevano l’uso della forza muscolare fossero realizzate preferibilmente dagli uomini, causando così una sorta di divisione sessuale del lavoro. Inoltre, nonostante la attenzione di ROSSI verso l’emancipazione delle donne, nella sua utopia non esistettero associazioni miste. Ciascuna delle associazioni, riunite in assemblee generali76, ricevette il suo capitale sociale in custodia: i contadini ricevettero la terra, il bestiame e gli strumenti di lavoro, i tessitori i loro opifici e magazzini e così via. Sempre nelle assemblee generali furono scelti i direttori tecnici o maestri di lavoro. La produzione fu così organizzata in condizioni veramente razionali e scientifiche: la piccola e disorganizzata produzione di una volta diede luogo alla produzione grande e organizzata; il credito dell’associazione permetteva ai contadini l’introduzione di macchine che diminuivano la fatica mentre aumentavano il rendimento del terreno. Tutti erano interessati a introdurre innovazioni capaci di proporzionare allo stesso tempo il risparmio delle fatiche e l’aumento della produzione. Alcuni esperti esterni furono invitati a partecipare all’esperienza, contribuendo al continuo perfezionamento e miglioramento del lavoro e della produzione a Poggio al Mare. Il lavoro era organizzato in forma libera e anarchica. I lavoratori organizzati nelle rispettive associazioni si riunivano alla mattina per decidere il lavoro da svolgere durante la giornata. Decidevano anche quali ore erano più favorevoli al lavoro, nonché di quante ore sarebbe stata la giornata lavorativa, a seconda della stagione e della fatica richiesta. Ma questo non significava un compromesso fisso, dato che ciascuno era libero di dirigersi al 76 Le assemblee generali erano il posto dove venivano prese le decisioni più importanti riguardo alla conduzione del comune socialista. 111 lavoro quando lo riteneva più opportuno. Inoltre, era prassi anche l’aiuto ai lavoratori che svolgevano altre attività, sempre che la propria lo permettesse. Tutto il lavoro eccedente veniva registrato e poi convertito in tempo libero. ROSSI riteneva intrinseco all’uomo il rispetto per il benessere comune, anche se non considerava il benessere sociale al di sopra di quello individuale. Da questo l’attenzione costante, nella sua costruzione utopica, alla ricerca dell’equilibrio tra gli interessi collettivi e quelli individuali. In questa direzione il collettivismo fu valorizzato tramite l’incentivo alle associazioni e uno degli obiettivi del benessere collettivo era quello della preoccupazione con la salubrità del lavoro. Riguardo al consumo, perché si potesse raggiungere l’aspirazione socialista «a ciascuno l’intero prodotto del suo lavoro», si dovette organizzare anche lo scambio, dando ai prodotti un valore reale, composto dalla somma dei diversi valori attribuitigli durante la loro elaborazione. Inoltre, doveva essere possibile identificare, con facilità, tutte le sue frazioni costituenti, in modo che ciascuno potesse sapere quale era stata la sua “quota di proprietà” in ogni oggetto prodotto. Nelle parole di ROSSI, si “voleva in somma che la determinazione del valore avesse fondamento nelle condizioni organiche onde nasce, [in modo che] tutelasse l’interesse personale e si prestasse alle operazioni di scambio” (ROSSI (CARDIAS), 1884:37). E così, basandosi su esperienze chimico-fisiologiche che calcolavano il consumo organico indotto dai diversi tipi di lavoro muscolare e intellettuale svoltisi a Poggio al Mare, si arrivò alle unità di valore. Ogni associazione aveva un libro di registro dove venivano registrati i dati che poi avrebbero dato origine ai biglietti di valore consegnati a ciascuno dei lavoratori. In essi contavano il lavoro compiuto, il coefficiente attribuito e le unità di valore guadagnate. Con questi biglietti, i lavoratori si recavano al magazzino di deposito per scambiarli con altri, di tipo uniforme ma di taglio diverso, da un centesimo a cento unità di valore. Questa era la moneta – il warrant, come venne chiamata – che circolava a Poggio al Mare. I biglietti consegnati al magazzino andavano all’ufficio di statistica, dove venivano usati per calcolare il valore delle merce prodotte. Il valore delle merce introdotte “dal di fuori” era calcolato in base alle unità di valore della produzione degli oggetti scambiati per quella compra. L’ordinamento di questo metodo era di responsabilità delle associazioni cooperative di produzione, e tutti erano interessati a che non ci fossero irregolarità nel funzionamento77. 77 Secondo DE MELLO NETO, nella quinta edizione del libro, CARDIAS aveva abolito la moneta all’interno del comune. Inoltre, la produzione era tutta destinata al consumo, commercializzandosi soltanto l’eccedente. 112 CARDIAS aggiunge che i valori erano stati calcolati sulla media degli esperimenti e da questo emergeva il problema che più tardi preoccuperà KROPOTKIN: quelli che producono di più perché sono più capaci avrebbero un eccesso di unità di valore e ciò avrebbe potuto originare il problema dell’accumulazione capitalistica all’interno del comune socialista. Per evitare che ciò accadesse fu deciso di dare al warrant una scadenza annua. Così, da un lato si evitava il risorgere del capitalismo personale e, dall’altro, s’incentivavano i lavoratori alla totale soddisfazione dei propri bisogni. A scopo illustrativo, CARDIAS cita l’esempio di quelli che mettevano un po’ di moneta da parte e, prima della scadenza, la scambiavano per moneta legale alla cassa dell’associazione e se ne andavano in viaggio per le belle città d’Italia. Con la comunità in pieno funzionamento, il Comitato Provvisorio fu sostituito dal Consiglio Comunale, i cui membri furono eletti all’interno delle diverse Associazioni. Tale consiglio aveva funzioni esecutive: le proposte di innovazioni vi erano sottoposte per essere esaminate e discusse. Le decisioni prese erano presentate a tutte le associazioni lì rappresentate. Una volta approvate, la sua esecuzione passava a essere compito dalle associazioni. Così si diede l’organizzazione di Poggio al Mare in collettivismo, e l’autore passa a descrivere nei dettagli la vita comunitaria condotta da tutti, sottolineando le numerose trasformazioni in meglio che il comune aveva attraversato e che lo rendevano irriconoscibile. Particolare importanza fu data alle trasformazioni tecnologiche introdotte che determinarono l’aumento della produzione allo stesso tempo resero il lavoro meno faticoso e conseguentemente più piacevole, offrendo ai lavoratori più tempo libero. Fu così che il lavoro diventò un’abitudine per tutti, facendo sì che automaticamente sorgesse la domanda: perché ricompensare con misura determinata ciò che è diventata un’abitudine universale? Presto fu convenuto che il lavoro fosse libero da ogni determinazione di tempo e quantità, anche se continuava mantenendo la direzione tecnica delle maestranze. E dal “momento che la produzione è restata facoltà incontrollabile di tutti, anche il consumo non può essere determinato che dai bisogni di ciascuno soddisfatti senza controllo. E poiché è insegna che l’abuso avviene solamente dove vi ha deficienza della cosa della quale si abusa, (…) così in Poggio al Mare, dove è abbondanza di tutto, si abusa di niente. D’altronde tutti sappiamo che l’abuso è dannoso a chi lo esercita, e da buoni egoisti non abusiamo di cosa alcuna. Eccoci dunque in piena distribuzione gratuita dei prodotti del lavoro. Il socialismo nella più alta espressione fino ad oggi escogitata – il Comunismo agrario – si trova praticamente 113 applicato in Poggio al Mare” (ROSSI (CARDIAS), 1884:45). In più, CARDIAS sottolinea il fatto che il desiderio di fortuna aveva ceduto posto ai premi e riconoscimenti morali e sociali all’interno di Poggio al Mare. Dopo questa descrizione, CARDIAS fa un salto di dieci anni nel suo racconto, e simula una situazione in cui un suo amico era andato a trovarlo a Poggio al Mare. Facendo gli onori di casa, lui lo porta in giro per il comune. Nel percorso trovano contadini che preparano la terra per un frutteto, con un aratro mosso con l’energia prodotta da una cascata utilizzando un fiume lontano 3 km dalla proprietà. Vanno a vedere il bestiame, di tre razze diverse, da carne e da latte. Vanno alla stalla che rispettava gli standard di igiene già all’epoca. Gli fa vedere un silos, profondo 5 metri, dove venivano conservati freschi gli steli del granoturco Cuzco, ricevuti annualmente dagli amici d’America. Visitano l’Associazione delle lattaie, passano davanti alla scuola e raggiunta l’ora di pranzo, si recano al ristorante dove quelli che non vogliono avere il pasto a casa mangiano e chiacchierano animatamente. Dopo il pranzo continuano il giro per il paese e CARDIAS gli fa vedere l’edificio dove lavorano le sarte, le tessitrici e le stiratrici. A questo proposito il suo amico richiama l’attenzione sull’inesistenza di uniformità nel vestirsi, e CARDIAS gli risponde che tutti hanno la libertà di scegliersi il tessuto e il modello che più piace loro. Continuano la passeggiata e CARDIAS gli fa vedere gli edifici delle varie associazioni di Arti e Mestieri e, in fondo alla Piazza Tommaso Campanella, il teatro. CARDIAS richiama infine l’attenzione dell’amico sul fatto che tutte quelle innovazioni tecnologiche in un’unica proprietà erano possibili solo con quel tipo di organizzazione: un proprietario individuale non si può permettere tutto quanto. Dopo la passeggiata si dirigono a casa di CARDIAS, che fa vedere all’amico il piccolo appartamento, facendo notare che lì non manca niente né di necessario né di confortevole. Continuano a chiacchierare sul benessere raggiunto da Poggio al Mare e alla fine del pomeriggio si dirigono verso la piazza del paese, dove si sarebbe svolta la cerimonia delle distribuzioni delle pubbliche ricompense, consegnate ai lavoratori che si erano dimostrati più attivi e intelligenti. Questa parte del libro si conclude con il discorso fatto da Gustavo Breton che rammenta a tutti che sono passati dieci anni da quando avevano iniziato l’esperimento della vita in socialismo e che è arrivato il momento di decidere che cosa fare. A nome di Alessandro De Bardi, domanda loro se vogliono prendere ognuno la sua casa e dividere le terre e il bestiame, al che tutti rispondono: “No!”. Domanda allora se vogliono continuare a vivere in socialismo, e tutti uniti e insieme rispondono: “Sì!”. 114 Si procede poi alla cerimonia della distribuzione delle medaglie alle Associazioni. Terminata la cerimonia, la popolazione si sparge per il paese, chi rimane in piazza a ballare, chi si dirige a casa, chi va a fare una bella passeggiata, tutti secondo i propri gusti. Quella sera CARDIAS sogna un’Italia organizzata in socialismo. Nella terza e ultima parte, l’epilogo, l’autore richiama l’attenzione del lettore sulla naturale tendenza della vita al socialismo allo stesso tempo in cui afferma di credere che il passaggio dal capitalismo al socialismo non avverrà di modo tranquillo ed evoluzionista, ma tramite una rivoluzione sociale. Si tratta anche di un tentativo di sensibilizzare i borghesi verso le idee socialiste da lui concepite e difese. Infine, nell’appendice, si lancia a difendere lo sperimentalismo e, tramite questo, propone di realizzare nella pratica tutto quanto descritto nel libro. GOSI, analizzando l’utopia di ROSSI, sottolinea le somiglianze tra la sua opera e quelle di FOURIER e CABET. Con FOURIER, secondo l’autrice, tra i punti in comune riguardo ad alcuni aspetti dell’organizzazione della comunità – il lavoro come gioia, la spontanea aggregazione sociale, il rispetto delle inclinazioni individuali come chiave per l’equilibrio dell’esperienza – quello più importante è il carattere decisamente antiautoritario con cui ROSSI organizzò Poggio al Mare. GOSI ritiene anche possibile ipotizzare che ROSSI avesse conosciuto le idee di FOURIER non solo tramite la lettura dei suoi testi, ma anche tramite contatti con un nucleo fourierista genovese attivo già nel 1876. Con CABET, sono condivise l’idea della comunità dei beni – con il lavoro e l’educazione comune –, e soprattutto la convinzione dell’utilità della propaganda, tanto da trasformare ambedue oltre che in promotori di esperienze di questo tipo, anche in realizzatori in prima persona. CABET, infatti, credeva che Icaria, la sua colonia egualitaria e comunista, avrebbe esercitato un’attrazione su tutte le classi, facendo sì che tutta la società europea fosse in grado di realizzare il passaggio dal capitalismo al comunismo di modo pacifico e naturale. ROSSI però va oltre a queste influenze e nella sua utopia propone innovazioni importanti: l’accentuazione del senso libertario, particolarmente in quel che riguarda l’organizzazione del lavoro; il tentativo, sia pur impreciso, di formulazione di una teoria del valore e una interpretazione positiva della lotta per l’esistenza. 115 3. Il veterinario anarchico: il soggiorno di ROSSI a Gavardo e i primi passi verso la realizzazione della sua utopia Com’è già stato detto, nei primi di agosto del 1882, ROSSI partecipò al concorso aperto nel comune di Gavardo, provincia di Brescia, per coprire un posto di veterinario rimasto vacante dopo che il precedente veterinario era andato in pensione. La decisione di partecipare a questo concorso probabilmente fu dovuta al fatto che la sua attività politica in Toscana, e la costante sorveglianza da parte delle autorità locali da essa innescata – soprattutto dopo il suo arresto avvenuto nel 1879 – gli avevano reso praticamente impossibile la riuscita di uno sbocco professionale da quelle parti. Decise allora di presentare la domanda di iscrizione al sindaco di Gavardo, allegando alcune delle sue pubblicazioni scientifiche. Riuscì a vincere il posto, iniziando la sua attività verso l’ottobre dello stesso anno. Prima di partire, però, l’anarchico fece ancora parlare di sé per nuovi “scritti sovversivi”78 e per un suo intervento avvenuto a una riunione di socialisti a Livorno, dove difese la necessità di organizzarsi in modo da diffondere la propaganda delle idee socialiste anche nelle campagne. A Gavardo, ROSSI trovò un paese di salde tradizioni religiose e popolari, su cui poco aveva inciso l’unità d’Italia e dove la vita politica riguardava un numero ristretto di famiglie. Il primo contatto con gli esponenti del paese avvenne in clima di cordialità, atteggiamento che non tardò a cambiare verso alcuni di loro, come il parroco don Brunelli e l’ingegner Quarena. Nel mondo contadino, egli trovò un attaccamento alle conoscenze e le pratiche di medicina popolari e nessun segno di voler cambiare. Decise di lottare da solo contro questo stato di cose, e si diede alla pubblicazione e divulgazione di opuscoli sulle malattie più frequenti tra gli animali della regione, anche senza contare sull’appoggio delle autorità locali. Inoltre, secondo GOSI, le misure di sorveglianza sull’anarchico da parte delle autorità toscane non cessarono dopo il suo trasferimento a Gavardo. Anzi, la rete si allargò con i nuovi collegamenti stabilitisi con le autorità gavardesi, soprattutto con quelle della Prefettura del Circondario di Salò, sotto la cui giurisdizione Rossi si trovava. I frequenti spostamenti tra i paesi consorziati per motivi di lavoro79 gli permisero di continuare a realizzare la sua propaganda socialista. La stessa Gavardo offriva molte possibilità in questo senso, trattandosi di un borgo di grandi dimensioni, densamente popolato, prevalentemente rurale ma già con qualche traccia di industrializzazione. “Il paese presentava una certa vivacità dal punto di vista dell’organizzazione sociale, con la nascita, fino dal 1876, di una società di mutuo soccorso, nel momento in cui il movimento Secondo GOSI, le pubblicazioni sono probabilmente Il progresso e i contadini. A veglia in un podere toscano, stampato a Siena nel 1881 e l’edizione livornese di Un comune socialista, di quello stesso anno. 79 Oltre a Gavardo, ROSSI doveva prestare servizi ad altri sette comuni circonvicini. 78 116 mutualistico bresciano cominciava a espandersi in buona parte della provincia” (GOSI, 1977:30). Secondo GOSI e ZANE, anche se sotto costante sorveglianza da parte delle autorità, in pochi mesi Rossi era riuscito a incidere sulla realtà sociale del paese, mettendo in moto numerose iniziative. La pubblicazione del giornale «Dal Campo alla Stalla» – già edito a Montescudaio e rivolto ai contadini – è la sua prima realizzazione concreta. Il contenuto del giornale non è conosciuto, ma i suddetti autori credono trattarsi di articoli di divulgazione igienico-sanitaria, oltre che tecnica, per contadini e allevatori, non essendo possibile sapere se ci fossero accenni di propaganda politica o meno80. Un’altra sua realizzazione fu la creazione di una società agricola di cooperazione con circa 70 soci – secondo una lettera di don Brunelli a G. Bonomelli, vescovo di Cremona – ove gli animali dei soci, in gran parte bovini, entravano a far parte del patrimonio comune. Quest’ultima iniziativa ricevette la forte opposizione da parte del parroco locale, dato che concorreva con la già esistente “Società di Mutuo Soccorso Operaia Agricola di Gavardo”, legata alla chiesa e con scopi assai diversi da quella organizzata da Rossi81. Importante fu anche il ruolo svolto da Rossi per l’espansione del movimento socialista non solo sull’area del paese, ma anche sul nascente socialismo bresciano di fine secolo. Particolare attenzione deve essere data ai contatti stabilitisi con gli ambienti più progressisti dell’epoca, in particolare con il parlamentare romagnolo Andrea Costa. La fitta corrispondenza scambiata con il parlamentare aveva l’obiettivo di avvicinarlo ai socialisti bresciani, nonché di tenerlo aggiornato sull’andamento del clima politico bresciano, prova dell’impegno politico di Rossi per il diffondersi delle idee socialiste a Gavardo. Oltre ai contatti con il gruppo di Brescia, Rossi collaborò con numerosi giornali e riviste già citate nella prima parte di questo capitolo, e portò alla stampa la quarta edizione del suo libro Un comune socialista, questa volta con la prefazione di Andrea Costa. Il fervore rivoluzionario vissuto all’epoca gli fece credere alla possibilità di mettere in pratica l’antico progetto di realizzazione di una colonia agricola socialista in Italia. Il primo a essere contattato fu Costa, di cui non ebbe una risposta favorevole. Nonostante lo scontro – a cui Rossi si riferisce come “una doccia fredda sulla testa” – i rapporti tra i due non si ruppero. 80 81 GOSI non scarta la possibilità di che esso fosse, nonostante il suo titolo, un giornale soltanto di propaganda politica, anche se non gli sembra tanto probabile. Infatti, durante il suo soggiorno a Gavardo, la società cattolica ebbe il suo quadro di soci progressivamente ridotto, fatto che non piacque alle autorità ecclesiastiche. 117 I tentativi di ottenere appoggio da altre parti continuarono, come testimoniano due articoli pubblicati sull’«Avanti» di Costa. In un primo articolo, intitolato Accademia, Rossi sviluppò un confronto sui significati assunti dai termini “evoluzione” e “rivoluzione”, argomentando che se era vero che l’evoluzione era in grado di preparare gli animi per i cambiamenti necessari, soltanto la rivoluzione sarebbe stata in grado di realizzarli. In un secondo articolo sempre sullo stesso giornale, ma di cui non riusciamo a rilevare il titolo, egli propose un’altra volta la fondazione di una colonia agricola sperimentale. Per portare avanti il suo progetto, Rossi moltiplicò i suoi contatti. “Dopo aver illustrato a diversi esponenti socialisti e repubblicani82 il suo progetto, nel gennaio del 1885, sulle colonne del giornale mantovano «La Favilla», Giovanni Rossi formulò ufficialmente e pubblicamente la sua proposta per la creazione di una colonia agricola cooperativa socialista, chiedendo «un movimento espresso in lettere di adesioni […] di molti compagni per un’opera che tenti con l’efficacia seria dell’esperimento le vie segnate, fra l’empirismo e l’utopia, dell’umano destino»83” (ZANE, 1989:35) L’articolo, firmato da Rossi, portava il titolo Colonia Agricola Socialista, e trattava dello stesso progetto già esposto per il paese immaginario di Poggio al Mare nel suo libro Un comune socialista. “La colonia avrebbe dovuto sorgere in una zona mite per clima e di terreno fertile, non ancora dominata da un’agricoltura esercitata in modo intensivo; sarebbe stata costituita da una libera federazione di associazioni operaie; e ognuna di esse avrebbe disposto di tutti i mezzi occorrenti al suo lavoro e della massima libertà per l’organizzazione delle proprie funzioni interne” (GOSI, 1977:38). Secondo GOSI, tre erano gli obiettivi di Rossi rispetto a questo esperimento: primo, di assicurare benessere e giustizia sociale ai suoi partecipanti; secondo, di sperimentare forme alternative di cooperazione economiche, evidenziando forme migliori di quelle già esistenti da poter proporre; terzo, capire, nella prospettiva di un rinnovamento sociale, dove finiva l’attendibilità delle teorie innovatrici e dove invece aveva inizio l’utopia. Rispetto ai mezzi necessari per l’attuazione pratica dell’esperimento, fu stabilito che il capitale sociale sarebbe stato costituito da un numero indeterminato di azioni da L. 50, nominali, indivisibili e non trasmissibili. Una volta raggiunto il capitale necessario per un Secondo ZANE, Rossi chiese a Gabriele Rosa, in una lettera del 17 novembre 1884 spedita da Gavardo, più informazioni sulla colonia irlandese di Ralahine a cui lui aveva fatto riferimento in un articolo. Nell’occasione, gli spiegò che tale interesse era dovuto al fatto che egli, insieme a Filippo Turati e altri, stavano maturando il progetto di fondare nell’Italia meridionale o nella zona di bonifica intorno a Roma, una “Colonia agricola sperimentale”, con l’obiettivo di fornire argomenti sperimentali alla soluzione della questione sociale. Oltre a queste informazioni, Rossi chiese anche l’appoggio di Rosa alla sua colonia socialista. 83 In: Colonia Agricola Socialista, in ‹‹La Favilla››, 11 gennaio 1885. (Cfr. ZANE, 1989: nota 73, p. 35). 82 118 primo impianto, i partecipanti avrebbero comprato un primo lotto di terre nella zona di bonifica intorno a Roma o su quelle demaniali. Esse sarebbero assegnate a un gruppo di dieci coloni, che avrebbero dovuto dedicarsi, oltre che ai lavori agricoli tradizionali, alla frutticoltura e all’orticoltura. Concludendo l’articolo, Rossi presentava anche un preventivo di spesa per una colonia agricola cooperativa per l’Italia meridionale, con una superficie prevista di 100 ettari da essere coltivata con la frutticoltura e l’orticoltura. Avendo superato la fase del dibattito ideale e raggiunta quella dell’attuazione pratica, Rossi riteneva valida come punto di partenza l’idea della creazione di una colonia agricola cooperativa da trasformare, poi, con sviluppi e integrazioni, in una colonia agricola socialista84. Nel giro di un mese egli elaborò un documento indirizzato alla “Commissione Federale di Corrispondenza del partito Socialista Rivoluzionario” di Forlì, richiedendo che tutto il partito discutesse la proposta in seno alle associazioni locali e decidesse se e come partecipare all’attuazione dell’esperimento. Fu un tentativo di coinvolgere le maggiori forze socialiste italiane nella realizzazione del suo progetto. Lanciò anche un Appello per la fondazione di colonie agricole socialiste indirizzato a tutte le “federazioni, sezioni, circoli e nuclei socialisti d’Italia”, mettendo ancora una volta in evidenza la necessità di suffragare con esempi pratici la validità delle teorie socialiste, provando così la loro possibilità di realizzazione pratica. Inoltre, egli sosteneva che, una volta istituite, le colonie, dedicandosi a rami della produzione dove la concorrenza della produzione capitalistica fosse meno temibile, avrebbero potuto destinare una larga parte dei loro profitti al movimento socialista e alla promozione di altre colonie. Secondo GOSI, dall’esame di questi due documenti si può osservare una differenza di tono. Mentre nel primo, rivolto a un pubblico più ampio, l’accento è posto sull’aspetto cooperativistico dell’esperimento, nel secondo, rivolto a un pubblico più ristretto e impegnato nella causa, si radicalizza il senso dell’iniziativa, con una maggiore insistenza sulle sue implicazioni rivoluzionarie. Rossi, però, dovette aspettare ancora un altro momento per la realizzazione della sua colonia, perché nessuno degli esponenti consultati rispose positivamente e le sottoscrizioni arrivate non raggiunsero il numero necessario. Ma lo scopo di iniziare una discussione del suo progetto era stato raggiunto e, per mantenerla accesa, scrisse vari articoli sui giornali socialisti dell’epoca, tra cui «In Marcia» di Pesaro, «I Miserabili» di Padova e «La Questione Sociale» di Torino. 84 Secondo BETRI, in questo periodo, anche se criticato da alcuni dei suoi compagni, tra cui CANDELARI, Rossi aveva una posizione molto più aperta, ritenendo la cooperazione come un processo evolutivo verso l’inevitabile traguardo socialistico. 119 Il dibattito era ormai innescato e durante alcuni anni l’anarchico scambiò una fitta corrispondenza con numerose personalità del socialismo italiano. Sul progetto delle colonie socialiste si sollevarono voci a favore e contro la loro realizzazione. Tra le opposizioni, egli si difese da una in particolare, mossagli ripetutamente da Converti e ripresa più tardi da MALATESTA. Secondo loro, le colonie sottraevano forze preziose alla rivoluzione, allontanando i compagni dai luoghi di preparazione e propaganda. Rossi rispose a questa critica, argomentando che in una guerra dove le parti belligeranti si chiamavano borghesia e proletariato, la presenza di un centinaio di uomini in più o in meno era del tutto irrilevante. Inoltre, ribattete che tali colonie dovevano nascere in Italia e che, neppure se così non fosse, nessuno poteva essere considerato un “disertore” dato che la questione sociale era mondiale e nessuno poteva sapere dove essa sarebbe cominciata. Ma un discorso più approfondito sulle colonie fu realizzato tramite la pubblicazione del suo giornale «Lo Sperimentale» a partire dal maggio 1886, del quale parleremo in seguito. Intanto egli continuava a svolgere la sua attività di veterinario consorziale e, senza farsi intimidire dalle resistenze opposte, si spinse alla realizzazione di interventi che migliorassero la sua condotta, ma che tenessero conto anche della realtà economica e sociale dei contadini. Stando così le cose, nell’autunno del 1885, Rossi presentò al sindaco di Gavardo una relazione dettagliata trattando non solo della situazione igienico-sanitaria della zona ma anche di problemi di ordine economico e sociale. In conclusione, propose una serie di procedure da adottare ai fini di poter portare la condotta veterinaria “a tutta cura gratuita”, proposta che venne accettata dalla maggior parte dei paesi consorziati. Ma la realizzazione della colonia agricola socialista restava al centro della sua vita, ed egli cercava di rompere il suo isolamento a Gavardo con costanti contatti con i socialisti bresciani, romagnoli e milanesi. Alla fine del 1885 ROSSI chiese al sindaco di Gavardo un permesso di vacanza per i mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo, argomentando di dover andare a trovare la sua famiglia. Dietro a questa richiesta stava il desiderio di stringere i contatti che, credeva, avrebbero portato alla realizzazione della sua colonia socialista. 4. La necessità di “sperimentare”: la difesa dello sperimentalismo e la polemica con gli anarchici Da questo punto della sua vita in poi, Rossi non abbandonò mai più la difesa dello sperimentalismo e impiegò tutte le sue forze nel tentativo di convincere sempre più 120 persone a dedicarsi, insieme a lui e ai suoi compagni, alla realizzazione di una colonia agricola socialista. In seno al dibattito ormai acceso sul tema, decise di creare un giornale che avesse l’obiettivo “di studiare e di propagandare le colonie sperimentali, (…) di costruire anche centri e comitati d’appoggio, di promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari all’impresa (…). Già il 3 ottobre 1885, il «Farfarello», giornale della sinistra bresciana, pubblica un comunicato dal titolo Movimento Socialista, in cui, fra l’altro, viene annunciato come: «gli anarchici di Brescia vogliono riempire la lacuna che nella stampa socialista fu sempre lasciata aperta. Essa è la necessità di un foglio che dimostri praticamente la attuabilità della vita in comune, sia descrivendo e commentando tutti i tentativi fatti ed attuati a questo scopo, sia non tralasciando eziandio di provocarne continuamente. Intento precipuo della pubblicazione è quello di far toccare con mano che se tali associazioni sono possibili e possono sussistere fra gente povera, molto maggiormente attecchiranno e si svilupperanno in un ambiente sociale che avrà per base l’uguaglianza nei diritti e nei doveri di tutti gli uomini. Il foglio avrà per titolo “Lo Sperimentale”, fermo posta, Brescia. Ai compagni l’avviso che l’amico Cardias sarà il principale degli sgobboni dello “Sperimentale”»85” (ZANE, 1989:43). Pronto sin dall’autunno del 1885, «Lo Sperimentale» apparirà per la prima volta soltanto nel maggio 1886, stampato presso la Tipografia Rivetti, a Brescia. Sin dall’inizio sulla collaborazione fissa di Candelari, Reybaud, Reanaud e Turati, e con un interessamento senza seguito da parte di Lazzari e Gnocchi Viani. Ma fu soprattutto il giornale di Rossi, dove traspariva la sua grande fede nell’ideale anarchico e la sua insofferenza nei confronti di sterili accademismi che avrebbero potuto portare alla trasformazione del socialismo in un’ideologia senza presa sulla realtà. Sul primo numero, sotto il titolo Programma, firmato dalla Redazione, dopo aver chiarito che intendeva colmare il vuoto lasciato dal partito e dalla stampa socialista riguardo agli esempi concreti di che l’avvenire preconizzato è possibile, informa: «Lasciando in seconda linea la critica del presente e la glorificazione dell’avvenire, ci applicheremo a dimostrare con l’esame dei fatti e con l’esperimento, che questo avvenire è possibile. Per dare questa dimostrazione ci serviremo dei fatti avvenuti, e di quelli che avvengono, non solo, ma ne provocheremo anche. Descriveremo e commenteremo tutti gli esempi di vita comunistica che ci presenta la storia; procureremo corrispondenze dalle attuali colonie comuniste; studieremo quel tanto di comunismo che esiste nelle istituzioni moderne, come nella famiglia, nel monastero, nel Comune, nello Stato, nell’associazione; vedremo quale tendenza addimostra il movimento statistico del soccorso mutuo e della cooperazione; analizzeremo i conflitti tra autorità e libertà, procurando di determinare se e come e quanto lo Stato si atrofizza di fronte a quella inutilità del governo che è l’anarchia, propria degli uomini civili, liberi, onesti e perciò ingovernabili; solleciteremmo i nostri compagni di ogni città e di ogni borgata a raccogliersi in vita comune, onde dimostrare con i fatti che se una comunanza povera è possibile tra gli sfruttati della società 85 «Farfarello» 3 ottobre 1885 (Cfr. ZANE, 1989, nota 89 p. 43). 121 moderna, a maggior ragione sarà possibile una comunanza agiata tra i liberi produttori della società futura; che se la pratica dell’anarchia nelle relazioni private è possibile in mezzo a tanti eccitamenti autoritarî, onde è circondato e insidiato oggi l’uomo più mite e più libero, a maggior ragione sarà possibile, quando nell’armonia e nella giustizia economica il rispetto per l’altrui personalità non sarà controccambiato con un oltraggio alla personalità propria. E mentre in cento luoghi diversi solleciteremo la costituzione di gruppi in vita comunistaanarchica, (…) propugneremo la fondazione in Italia di un gruppo modello, o colonia socialista sperimentale, nel quale siano possibili su più vasta scala i tentativi e le prove di nuova vita sociale. Della esistenza intima di questi gruppi daremo conto esatto e conscienzioso nelle colonne dello ‹‹Sperimentale››, che per tale indirizzo non smentirà il suo nome.»86 Concludendo il primo numero del giornale, ROSSI firma l’articolo intitolato Sperimentiamo, dove insiste sulla necessità di partire alla sperimentazione, argomentando che perché tale sperimentazione potesse avere la forza dell’esempio, essa avrebbe dovuto aver luogo in Italia. Nelle sue parole: «Non si tratta di stabilire né di mostrare, come e quale sarà precisamente, e nei suoi minimi dettagli, la società dell’avvenire; neppure si deve credere di risolvere la questione sociale per via di fattorie socialiste. No, l’avvenire sarà quello che sarà, e la questione sociale verrà risolta dai bisogni invadenti, dallo svolgersi irresistibile dello spirito umano in tutte le sue manifestazioni. Ma in mezzo alla nebulosità del vago, dell’indeterminato troviamo questo di certo e di preciso: che la civiltà moderna si impenna sul cardine della proprietà privata dei capitali, e la società nuova avrà invece per asse di rotazione la proprietà comune. […] Se domani i lavoratori del mondo sapessero che si può fare a meno di proprietà privata, gli attuali ordinamenti sparirebbero a un tratto e senza violenza. Ecco dunque dove e per cosa deve entrare in campo l’esperimento. Solamente per mostrare con i fatti se la proprietà comune può essere a sua volta pernio della società umana. Questo il principio di massima da sottoporsi alla prova; i particolari, i dettagli non hanno poi che menoma importanza perché sono facilmente variabili. Ma per influire sulle moltitudini, bisogna che queste prove siano date in paese, tanto che possano verificarle con i loro occhi. I villaggi comunisti dell’America sono troppo lontani perché possano persuadere i contadini italiani. “Questi non sono i paesi” è la risposta abituale che si sente. Quando invece vedranno nella loro provincia una fattoria socialista coltivata a perfezione (…) comunismo oggi sconosciuto, deriso o calunniato, doventerà aspirazione popolare. Questa è la nostra convinzione, che speriamo sarà divisa dai compagni, non fraintesa né schiacciata sotto una valanga di ma e di se. (…) Facciamo dunque proposta di costituire in Italia una Colonia socialista sperimentale. Per mandarla ad esecuzione, prendendo in affitto un terreno e relativi fabbricati capaci di due a trecento persone, occorrerà una somma di 50 mila lire. Quindi invitiamo i privati e le società, che desiderano vedere attuata questa idea, a dichiararci quale somma possono prestare o donare per questa impresa. Appena le promesse di sussidio avranno raggiunta o superata la somma ritenuta necessaria, gli 86 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 1, maggio 1886, p. 1. 122 azionisti si costituiranno in Società con tutte quelle garanzie morali e giuridiche che hanno diritto di esigere».87 All’appello di sottoscrizione per la fondazione di una colonia socialista in Italia, lanciato sul primo numero del giornale, risposero alcuni fra i maggiori nomi del movimento contadino e di quello socialista, tra cui Turati, Bissolati, Bosco Garibaldi e Annamaria Mozzoni. L’iniziativa era così avviata. Nel secondo numero, Rossi informa che la somma raggiunta era di lire 2.050 e allega l’elenco dei sottoscrittori, informando inoltre che erano stati costituiti comitati locali a Milano, Brescia, Castenedolo, Gavardo, Padova, Ferrara, Pisa, S. Croce sull’Arno e Palermo. Secondo GOSI, perché la sua proposta potesse essere interpretata in senso “gradualista”, Rossi pubblicò, nel numero 3 del suo giornale, l’articolo intitolato L’utopia sperimentale di Lassalle, dove cercò di chiarire come era sbagliato pensare a una trasformazione graduale della società, insistendo sul fato che i “gruppi di vita socialistica valgono come mezzo di propaganda, non come graduata e pacifica soluzione della questione sociale”88. Ma questo non bastò per far aumentare il numero delle sottoscrizioni, che proseguirono a passi lenti. L’ultimo elenco delle offerte pervenute o promesse portava la somma di lire 2.150, somma ancora lontana dalle 50 mila lire necessarie per dare il via al progetto. I temi trattati da Rossi nel suo giornale sono quelli classici del rapporto fra socialismo e libertà, autorità e anarchismo. Inoltre, particolare attenzione era data all’analisi delle esperienze già realizzate da altre colonie, cercando di capire i motivi dell’insuccesso ed i limiti teorici. Il giornale uscì di forma indipendente per cinque numeri, dal maggio 1886 al gennaio-febbraio 1887, e ripeté lo stesso schema per tutti e cinque numeri. Sulle prime pagine, una biografia di uno dei fondatori delle dottrine socialiste utopistiche e altri figure importanti, come precedentemente informato. In seguito, una serie articoli che fornivano notizie e storie dei più diversi sperimenti di vita comunitaria, antichi o contemporanei, disfatti o in corso, in Italia o all’estero (Stati Uniti, Francia, Messico, Russia, Belgio, ecc). Con alcuni di esse, come per esempio l’Icaria, si realizzavano servizi dettagliati; con altri, invece, le notizie erano riportate da giornali o altri tipi di pubblicazioni straniere. Un altro spazio sul giornale era destinato a brani e citazioni di autori come Kropotkin, Mâlon, Lavelaye, Cernychewsky, oltre a quelli dei collaboratori Renaud e Reybaud. La rubrica Socialismo sperimentale, non firmata ma secondo GOSI probabilmente curata da CANDELARI, proponeva aspetti e caratteristiche di vita comunitaria in generale. Inoltre, uno spazio destinato ai fatti di cronaca, divisi in due parti: 87 88 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 1, maggio 1886, p. 8. Il grassetto è mio. «Lo Sperimentale», Brescia, n. 3, settembre 1886, p. 2. 123 sotto la rubrica «Vecchia Cronaca» venivano riportati gli omicidi, furti, tragedie d’amore, da Rossi classificati come «fatti [che] non sono mai avvenuti, né avverranno mai nei paesi che vivono in socialismo»89. In contrapposizione, sotto la rubrica «Cronaca Nuova», venivano registrati la nascita di nuove colonie, cooperative di braccianti, enopoli e società di mutuo soccorso. In conclusione, sotto la rubrica Colonia Socialista Sperimentale in Italia, Rossi informava la somma raggiunta dalle sottoscrizioni per la realizzazione della colonia socialista e i nuovi comitati nati, allo stesso tempo in cui rafforzava l’appello a nuove sottoscrizioni. Dopo il quinto numero, «Lo Sperimentale» si unì all’«Humanitas» di Napoli, e uscì ancora per altri sette numeri. Ma, com’è già stato detto, avendo a disposizione solo una pagina, passò a dedicarsi soltanto a esempi di colonie socialiste nel mondo. Nell’ottobre 1887 con la chiusura del periodico napoletano, «Lo Sperimentale» ebbe la sua fine definitiva. 4.1. «Lo Sperimentale» numero a numero Nel numero 1, del maggio 1886, dopo il suddetto Programma, il giornale passa trattare degli aspetti più importanti della biografia di Roberto OWEN (1771-1858). È sottolineato il successo raggiunto dalla sua impresa di colonizzazione di New-Lanark, diventato un paese modello grazie alla sua influenza morale e moralizzatrice, offrendosi al lettore una descrizione delle condizioni materiali di vita della popolazione lì abitante. “Con le sue idee, Owen condusse gli operai a costituire cooperazioni particolari per fondare e mantenere magazzini di consumo, infermerie, asili di allattamento, scuole ecc”90. Il successo raggiunto da questo esperimento spinse Owen a voler stendere le sue idee a tutta l’umanità. A questo scopo pubblicò, nel 1812, il libro Nuovi concetti di società, o saggio sul carattere umano. Egli credeva che la base di rigenerazione sociale stava nell’educazione morale e scientifica della popolazione e così propose la riforma dell’istruzione, il comunismo egualitario e la responsabilità personale. L’opera ebbe un gran successo, anche tra i membri del governo che decisero di metterlo in pratica appena lo spirito pubblico fosse preparato. Approfittando della sua popolarità, Owen si lanciò alla propaganda delle sue idee in diversi meeting organizzati dal governo. Nel 1817 decise di partire all’azione pratica: aprì delle sottoscrizioni per la fondazione di colonie sperimentali, partecipando in prima persona con una somma significativa. I fondi raccolti dovevano servire all’acquisto di 500 89 90 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 1, maggio 1886, p. 5. «Lo Sperimentale», Brescia, n. 1, maggio 1886, p. 1. 124 acri di terreno a Motherwell, in Scozia, dove si sarebbero costruiti gli edifici necessari per una colonia di prova. Ma i venti cominciarono a cambiare e nel 1819 egli si trovò isolato. Decise allora di partire per l’America per fondare la colonia comunista di New Harmony91. Il tentativo fallì, ma nonostante tutto, egli riuscì a diffondere le sue idee sulla cooperazione, a far riformare il sistema di istruzione in America e a riunire attorno a sé numerosi discepoli. Owen ritornò in Inghilterra, dove svolse nuovi e numerosi meeting, fondò il giornale Cooperative Magazine e, insieme ad altri, tentò di nuovo di realizzare una colonia sperimentale a Orbiston, sotto la direzione di Abramo Combe. Il tentativo, che ebbe successo all’inizio, si esaurì dopo la morte del suo direttore, dato che Owen, impegnato nella diffusione delle sue idee, non poteva occuparsene. “Sotto l’impulso di Bray si costituì un’altra lega «Equo scambio del lavoro nazionale»: questa lega aveva per scopo l’abolizione della moneta che era sostituita da buoni di lavoro; era stata fondata una banca, analoga a quella che più tardi tentò Proudhon, e vi si aggiunsero dei magazzini cooperativi. Owen si consacrò anche a quest’opera; ma la sua influenza maggiore e più efficace si esercitò nelle mutualità dei lavoratori, che egli allargò e trasformò. Per opera sua il mutualismo divenne l’«Associazione di tutte le classi e di tutte le nazioni» diretta da un comitato ove erano i suoi principali discepoli. All’antico giornale Cooperative Magazine si erano aggiunti l’Orbiston Register, la Gazetta de New-Harmony, Weeck’y Chronicle, la Crisis, il Pionner, Man (l’uomo), il Rationalist, Star of the East (la stella dell’Est), New-Moral World (il nuovo mondo morale)”92. Owen morì nel 1858 avendo dedicato tutta la sua vita alla trasformazione sociale. Sotto la rubrica Socialismo Sperimentale, sono offerti al lettore dati statistici, economici e morali sulle colonie comunistiche degli Stati Uniti. I dati sono presi nella maggior parte dal libro di Charles NORDHOFF, The Communistic Societies in the United States, from personal visit and observation. I lettori sono avvertiti che, ad eccezione di Icaria, le comunità di cui si occupavano in questa rubrica non si costituivano proprio in esempi di vita comunista nel senso stretto – la maggior parte di esse professavano fede religiosa – ma servivano in quanto riferimenti per l’organizzazione della colonia socialista sperimentale, proposta da Rossi e accettata dai membri di quel giornale. Le colonie comunistiche americane studiate in questa rubrica sono: “quella degli Shakers, stabilitasi nel 1794 nella parte occidentale degli Stati Uniti, e nel 1808 circa nella parte orientale di questi Stati; quella dei Rappists, stabilitasi nel 1805; dei Zoarites, stabilitasi nel 1817; la comunità di Amana, fondata nel 1844; quella di Bethel, costituitasi lo stesso anno; quella dei Ho trattato questo esperimento nel capitolo 2, all’interno delle idee diffuse dalla corrente individualista dell’anarchismo. 92 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 1, maggio 1886, p. 2-3. 91 125 Perfezionisti di Oneida stabilitasi nel 1848; quella degli Icariani o Cabetisti, che data dal 1849, e per ultimo quella di Aurora fondata nel 1852, – tutte negli Stati Uniti. Sebbene (…) queste comunità non sieno (sic) che otto, in realtà però esse formano non meno di settantadue comuni, dei quali 58 sono costituiti dagli Shakers, 7 dai comunisti di Amana, 2 dei Perfezionisti, ed uno da ciascuna delle rimanenti società”93. Dopo l’elenco delle esperienze, segue la descrizione della storia e della loro forma di organizzazione, fatta in forma comparativa. Per questioni di spazio destinato alla rubrica all’interno del giornale, tale studio è diviso e ripreso nei numeri tre, quattro, cinque e sette del giornale. Seguono poi due articoli sulle colonie di OWEN, uno su New Harmony e l’altro su Orbiston; un articolo intitolato Il socialismo colonizzatore e la lotta economica del proletariato, dove si tratta del valore delle esperienze delle colonie agricole socialiste sperimentali in quanto precursore della società dell’avvenire; uno sui comunisti di Jault in Francia; uno sulla vita a Icaria, negli Stati Uniti – ripreso poi in altri numeri del giornale –; un altro su una colonia societaria a Parigi; l’articolo intitolato Sperimentiamo già citato anteriormente e, in conclusione, un articolo sul comunismo a Sparta. Il numero 2, uscito nell’agosto 1886, porta la biografia di Stefano CABET (17881836). Sono sottolineate la sua formazione in giurisprudenza; la sua nomina a procuratore generale in Corsica dopo la rivoluzione del 1830, seguita dalla sua rapida revoca, dovuta al suo radicalismo; la sua condanna, nel 1834, quando occupava il cargo di deputato della Côte-d’Or, a due anni di carcere per aver sostenuto la causa polacca e criticato la politica di Guizot e dei Thiers e la sua scelta di passare cinque anni in esilio in Inghilterra. Infine il suo ritorno in Francia, avvenuto nel 1839, come comunista dovuto l’influenza owenista assorbita in Inghilterra. Il comunismo di Cabet fu abbracciato dal proletariato francese e il suo Viaggio in Icaria, del 1840, diede al comunismo una forma determinata, diventando poi il vangelo dei comunisti francesi, tanto da dare origine alla scuola icariana e, nell’anno successivo, alla nascita del loro giornale intitolato «Il Popolare». Sostenuto dagli icariani, esso spiegò e difese le dottrine contenute nel libro Viaggio in Icaria con gran successo. “Nel dicembre 1848 Cabet partì dalla Francia per recarsi agli Stati Uniti, in mezzo ai compagni che l’avevano preceduto, e fondare a Nauvoo una colonia comunista, che mostrasse a tutti la possibilità pratica ed i vantaggi della vita comunistica. Dopo sei anni di splendida riuscita, avvenne una scissione, in seguito alla quale Cabet lasciò Nauvoo alla testa di 200 membri della minoranza. Spezzato da questa lotta, che egli 93 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 1, maggio 1886, p. 2. La storia di queste comunità e delle altre studiate in questo giornale saranno trattate nel prossimo capitolo. 126 aveva provocata con i suoi modi autoritari, morì (…) a San Luigi (Missouri) l’8 novembre 1856. Aveva 69 anni”94. Segue un lungo articolo intitolato Icaria, dove sono riportate la storia di questa comunità, il suo svolgersi, i problemi da essa vissuti, la tensione creata all’interno tra i giovani e i vecchi icariani fino alla scissione della comunità. In fondo, sono riportati alcuni estratti dello statuto della nuova Comunità Icariana, stabilitasi in Iowa, negli Stati Uniti. Il numero 3 uscito nel settembre 1886, porta la biografia di Francesco Natale BABEUF (1764-?). Sono sottolineate la sua partecipazione attiva alla Rivoluzione Francese accanto a Robespierre e a Saint Just e la sua conversione al comunismo durante il periodo trascorso in carcere – da dove uscì con l’amnistia del 3 brumaio anno IV – quando entrò in contatto con le idee di Morelly nel suo libro Il codice della natura. È citato anche il tentativo di Babeuf e altri compagni di realizzare il comunismo in Francia, tramite la creazione della società degli uguali e la pubblicazione del giornale «Il tribuno del popolo», dove egli pubblicava articoli di forte appello rivoluzionario sotto la firma Caio Gracco Babeuf. La società venne sciolta dal Direttorio e gli uguali dovettero raddoppiare i loro sforzi per portare avanti le loro iniziative. “Fu pubblicata l’analisi della dottrina di Babeuf; si incaricarono agenti speciali di preparare l’insurrezione nei diversi quartieri e di spingere le truppe alla rivolta; altri agitatori percorrevano degli attruppamenti arringando la folla; si spargevano a piene mani fogli volanti ed opuscoli; si pubblicavano giornali a buon mercato, e in mezzo a questa agitazione pubblica si organizzava una formidabile congiura con ramificazioni nelle principali città della Francia. I mezzi d’azione dei congiurati erano formidabili (…). Ma Grisel, ufficiale dell’armata dell’interno, che avevano tentato di associare, li denunciò al Direttorio. Arrestati il 21 fiorile 1797, i capi della congiura furono rinviati davanti l’alta corte di Vendome, che condannò a morte Babeuf e Darthé”95. Questo studio finisce con la citazione di alcuni articoli del decreto preparato dai congiurati riguardanti l’organizzazione della società in una grande comunanza nazionale, la forma come si sarebbero svolti i lavori comuni, la distribuzione e l’uso dei beni della comunanza. L’articolo successivo è il già menzionato L’utopia sperimentale di Lassale. Seguono un articolo sulle Sette socialiste in Russia, estratto da HOPPÉ, La Russie inconnue; la rubrica Socialismo Sperimentale, con la sequenza dell’articolo sulle colonie comuniste degli Stati Uniti; un articolo sui Quacqueri, firmato da L. REYBAUD; un articolo sul MIR – 94 95 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 2, agosto 1886, p. 1. «Lo Sperimentale», Brescia, n. 3, settembre 1886, p. 1. 127 comune rurale russo, firmato da S r ff. MACK WALL; una citazione di due righe di KROPOTKIN sull’atteggiamento del piccolo proprietario davanti ai vantaggi dell’agricoltura comunistica; un articolo sui Fratelli moravi, firmato da H. RINK; un articolo intitolato L’opinione di Kropotkine, estratto dal suo libro Paroles d’un révolté che servivano a confermare l’indirizzo sperimentalista del giornale; un articolo intitolato Per la storia d’Icaria, trascritto dalla «Révue icarienne» del giugno 1886, scritto dalla parte cosiddetta autoritaria per denunciare gli arbitri dei pretesi libertari o anarchici. Il giornale si conclude con la rubrica Colonia Socialista Sperimentale in Italia, dove Rossi informa sulla somma raggiunta dalle sottoscrizioni fino a quel momento – L. 2100 – e sul compito dei comitati locali creatisi per portare avanti la proposta della colonia socialista. Il numero 4, dell’ottobre/novembre 1886, porta la biografia de Carlo FOURIER (1772-1837). Si scrive che lui, ancora giovanissimo, era stato “inviato a Lione come apprendista e poi viaggiatore di commercio; condizione che gli permise di visitare oltre le principali città di Francia, la Germania, il Belgio e l’Olanda”96. In seguito, è citato l’episodio che l’aveva condotto a scoprire la teoria dell’associazione, fino alla pubblicazione, avvenuta nel 1808 a Lione, della sua opera Teorie dei quattro movimenti e dei destini generali, dove fa una critica vigorosa alla società di allora. In seguito, si tratta del suo trasferimento a Belley, nell’inverno del 1815/1816, dove rimase per cinque anni, occasione in cui ricevette il suo primo discepolo, Giusto Muiron, già nel 1816; completò e svolse la sua teoria e preparò i materiali per il suo Trattato dell’associazione domestica agricola, pubblicato in due volumi nel 1822, senza avere il dovuto riconoscimento. In questa opera Fourier, “prendendo per archetipo dell’universo l’organizzazione passionale (cioè di tutte le forze o passioni) dell’uomo, applicando ovunque la legge della serie (cioè della unione spontanea dei gruppi) stabilisce il rapporto dei destini di tutti gli esseri, senza dimenticare lo scopo prossimo ed immediato della sua opera, l’associazione… della quale rivela la proprietà più meravigliosa, l’attrazione industriale, la proprietà di spandere tanto incanto su i lavori, che ciascuno vi sia trascinato per piacere, per passione”97. Avendo capito che per rovesciare le abitudini sociali servivano gli esempi concreti e non le parole, egli cercò, in tutti i modi, senza mai riuscirvi, di mettere in pratica le sue idee sull’associazione “sopra un primo gruppo di lavoratori associati, che egli chiamava falange, raccolti sopra un comune rurale, ed abitanti in una casa unitaria, da lui detta falanstero o abitazione della falange. Si rivolse successivamente a tutte le persone influenti del suo tempo, 96 97 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 4, ottobre/novembre 1886, p. 1 Idem ibidem. 128 da Owen ad Eufantin, da Napoleone I a Luigi Filippo, motivando sempre con nuove ragioni la necessità di sperimentare in piccolo il suo metodo di associazione”98. Nel 1832 la scuola societaria diede inizio alla pubblicazione del periodico settimanale il Falanstero o Riforma industriale con lo scopo di rendere popolari le sue dottrine e propugnare la costituzione di una colonia societaria di prova, il cui tentativo fu fatto a Condé-sur-Vesgre99. Ma le idee di Fourier ebbero poche applicazioni all’interno del movimento socialista. L’articolo segue con una spiegazione della Teoria di Fourier, chiarendo come lui riuscì “a concludere come esistano in noi passioni che si spronano inesorabilmente alla conquista del nostro benessere; alla costituzione di gruppi nei quali abbiano soddisfazione l’amor proprio, l’amicizia, l’amore, l’affetto domestico; alla fusione dei gruppi in riunioni più vaste, che egli chiama serie, e che servono ad applicare utilmente il nostro amore di lotta, la piena dei nostri entusiasmi, il bisogno di variare l’esistenza che nella monotonia s’infiacchisce. Queste passioni principali, lasciate a loro stesse, conducono all’armonia universale, per quella legge pure universale che è l’attrazione. (…) Qui sta il perno della dottrina di Fourier, che nei rapporti economici riesce all’associazione”100. In seguito, sotto il titolo L’organizzazione del comune secondo Fourier, si descrive come, secondo lui, si sarebbe svolta l’organizzazione e il funzionamento di un comune in forma associativa, elencando i diritti e i doveri degli associati. Tra i vantaggi di questo sistema sono sottolineati il fatto di esso far convergere gli interessi di tutti gli abitanti del comune che presto imparano che il lavoro svolto per il bene comune si converte in lavoro per il bene proprio e che le modificazioni introdotte hanno come risposta la riduzione delle fatiche individuali e l’aumento dei profitti e del tempo libero che può essere impiegato nella diversificazione della produzione101. Nella sequenza è spiegata l’origine del falanstero, edificio destinato all’abitazione comune degli abitanti del comune associato. In questa organizzazione, il lavoro non viene più realizzato in modo isolato, ma all’interno di un gruppo. Ogni lavoratore sceglie le attività a cui dedicarsi e divide la sua giornata lavorativa in sedute di due ore, spostandosi durante il giorno tra le varie attività scelte. Ogni gruppo è responsabile per la parte del lavoro che gli piace più realizzare. L’insieme dei gruppi all’interno di un settore della produzione è chiamata serie e la riunione di tutte le serie nel comune, falange. “Ogni sera i rappresentanti delle serie e dei gruppi Idem ibidem. Sempre su questo giornale seguirà un articolo su questo esperimento. 100 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 4, ottobre/novembre 1886, p. 2. 101 FOURIER parte da un esempio di comune agricola che, con il tempo, passa a dedicarsi anche a lavori industriali. È l’embrione delle attuali aziende agricole. 98 99 129 stabiliranno l’impiego del tempo per i giorni seguenti. In modo che, ad ogni ora della giornata, ciascuno saprà perfettamente dove deve recarsi, ed i trasferimenti si faranno con regolarità perfetta, senza esitazione né incaglio. Il territorio della falange sarà di una lega quadrata circa, e intorno al falanstero costruito al centro saranno riuniti i giardini, i frutteti, fabbricati rurali, officine, manifatture etc. Così gli spostamenti saranno in generale brevi, e solo i lavori di grande cultura chiameranno i lavoratori su punti lontani. Questa disposizione dei lavori in sedute brevi e variate, per quanto lo consente la natura dei lavori stessi, liberamente scelte dai lavoratori, soddisfa tutte le inclinazioni e determina nei rapporti sociali quell’armonia, che qui abbiamo potuto solamente accennare”102. Questa sezione si conclude con l’informazione della costituzione, nel 1876, di una Casa rurale di esperimenti societari a Ry, un piccolo comune vicino a Rouen, in Francia, secondo le idee di Fourier. Il giornale prosegue con la rubrica Socialismo Sperimentale; con un articolo firmato da I. RENAUD sulla Libertà falansteriana; un articolo sull’esperimento di Condé-surVesgre, la scuola falansteriana fondata da Baudet-Dulary secondo il metodo di FOURIER; una breve notizia sui Falansteri incompleti103, organizzati da Considerant nel Texas nel 1850 ma falliti; un articolo sul Familistero104 di Guisa, in Francia; un breve articolo sul Comunismo falansteriano, firmato anch’essi da I. RENAUD e, infine, la rubrica Colonia Socialista Sperimentale in Italia, dove Rossi comunica che le sottoscrizioni avevano raggiunto la somma di L. 2150, e informa della creazione di un comitato locale ad Alessandria. L’ultimo numero de «Lo Sperimentale» uscito nel gennaio-febbraio 1887 porta la biografia di M. BAKOUNINE (1814-1876), firmata da F. TURATI. Partendo dal presupposto che narrare la vita dell’anarchico russo significava narrare la storia del socialismo e della rivoluzione in Europa per più di 30 anni (1840-1876), l’autore domanda al lettore come vuole vedere Bakounine, se come agitatore o propagandista, oppure come un uomo di perno e morale, diventato cospiratore. Poi, rinuncia a seguire questi indirizzi e ritiene che la sua biografia vera era quella fatta da HERZEN e pubblicata postuma sotto il «Lo Sperimentale», Brescia, n. 4, ottobre/novembre 1886, p. 3. Vale la pena di sottolineare la somiglianza tra questa descrizione e quella fatta da Rossi nel suo Un comune socialista, provando così le somiglianze tra le idee dei due autori, accennata nel paragrafo precedente. 103 I falansteri incompleti sono, secondo Fourier, un’associazione avente uno scopo puramente economico. 104 Godin, discepolo di Fourier, decise di mettere in pratica le idee del suo maestro, facendo costruire grandi abitazioni destinate alle famiglie che lavoravano al suo impianto di officine metallurgiche, questo però organizzato capitalisticamente. 102 130 titolo La grande Lisa, dove sono descritti il carattere, la vita intima e perfino le debolezze dell’uomo. “La sua vita è irregolare e boema – vive di the e di tabacco, e veglia le intere notti a tavolino scrivendo lettere, opuscoli, con lena indiavolata, tenendosi in rapporti con rivoluzionari di tutti i paesi. Nulla gli sfugge, tutto assimila, tutto trasforma nel moto perpetuo del suo cervello. Sempre aperto alla confidenza, sempre pronto all’azione, avendo per canone supremo la inversione del binomio evoluzionista, ossia la necessità della rivoluzione come precedente logico e storico di ogni evoluzione progressiva, egli è sbalzato continuamente di luogo in luogo dal vario soffio delle speranze e della fortuna. Così i suoi scritti sono di rado compiuti; suscitati dall’occasione, dall’occasione o dall’evento interrotti. La sua vita è tutta nell’azione e non serve che all’azione”105. TURATI continua raccontando i fatti principali della vita di Bakounine, la sua gioventù come giovane hegeliano, il tempo rimasto nella Fortezza di Pietro e Paolo in Russia e il cambiamento che questo “soggiorno” determinò nel suo idealismo dottrinale. L’autore ritiene che soltanto se si considera la parola sperimentale in senso ampio, in quanto indirizzo pratico, si può considerare Bakounine come uno sperimentalista e afferma che per egli, l’unico esperimento da affrettare era l’insurrezione generale contro lo Stato e il vecchio mondo borghese. Conclude ricordando che egli è considerato il padre immediato dell’anarchismo. Il numero segue con la rubrica Socialismo Sperimentale; con una breve nota sulle Antiche comunità francesi estratta da E. BONNEMÈRE, Histoire des Paysans e da MALTON, Histoire du Socialisme; una piccola citazione estratta dal libro di KROPOTKIN, Paroles d’un révolté sul Lavoro comunistico e lavoro individuale e più avanti, sempre suo, una breve nota sulla Piccola proprietà; una breve nota sulle condizioni di vita di una comunità di contadini nel bacino dell’Amur, firmata da WENJUKOFF; una breve citazione sulla Proprietà collettiva del terreno nell’India, estratta da STRAFFORELLO, La terra e l’uomo; un’altra breve citazione sulla forma di organizzazione degli Incas, intitolata Nell’antico Perù ed estratta da MALOU, Histoire du Socialisme; una citazione intitolata Un po’ d’anarchia in Russia, estratta della rivista La Nuova Russia, Treves; un’altra breve citazione dal titolo Comunismo rurale in Serbia, estratta da R. RAJAESICH, Das Leben, die silten und Gebrânche der ir Kaiserl-hume Oesterreich lebenden Süd-Slaven, Vienna 1873. E, infine, il seguente avviso: “Lo Sperimentale, col numero prossimo, si fonda nell’Humanitas di Napoli. Una pagina sarà sempre esclusivamente destinata alla esposizione del socialismo sperimentale. Gli abbonati continueranno a ricevere il giornale fino al ventesimo numero. Abbiamo voluto 105 «Lo Sperimentale», Brescia, n. 5, gennaio/febbraio 1887, p. 1. 131 iniziare un movimento di raccolta che, se imitato, potrà assicurare l’esistenza ad un buon periodico di propaganda delle idee socialiste in generale. Invitiamo perciò i sostenitori dello Sperimentale a voler trasmettere i loro sussidi a questo solo indirizzo: Humanitas, Napoli. Gli scritti di carattere sperimentalista, al solito indirizzo. Il saldo delle partite pendenti con abbonati e rivenditori dovrà essere trasmesso ad: Humanitas, Napoli. Dr. Giovanni Rossi, gerente responsabile”106. Così, a partire dal numero 10 uscito il 6 aprile 1887, il giornale «Humanitas» di Napoli passa a riservare una pagina a studi di anarchia e comunismo sperimentale che continuò a chiamarsi «Lo Sperimentale». La prima uscita, come numero 7, porta quattro articoli essendo tre piccoli – uno comunismo cristiano, l’altro Progresso borghese entrambi senza riferimento all’autore e Pensiero societario di RENAUD – il quarto, più dettagliato, intitolato Un villaggio comunista con notizie aggiornate dell’Icaria. Portò anche quattro citazioni, una senza titolo, sui concetti di libertà, minimum e attrattiva industriale di FOURIER; e le altre tre così intitolate: comunismo del lavoro, estratto da CHATEAUBRIAND, Œuvres complètes, t. 7; Tra i settari russi, estratta da L. TIKHOMIROV, La Russie politique et sociale e Una forma di proprietà collettiva nella Scozia estratta da SKENE, Celtic Scottland, vol. 3. Il numero 10, uscito all’interno dell’«Humanitas» XIII, il 2 maggio 1887, porta una breve biografia di Paolina Roland, un articolo intitolato Le comunità americane (Bethel), firmato R.C. e due citazioni estratte da L. TIKHOMIROW, La Russie politique et sociale, una intitolata Il villaggio russo e l’altra Ancora del comunismo russo. In fondo, un appello redatto da Giovanni Rossi a favore del sostegno al giornale napoletano. Con il numero 11, uscito con l’«Humanitas» XIV, del 15 maggio 1887, inizia la serie Storia dell’Associazione Agricola di Ralahine. Essa parte dal Capitolo I – I mali secolari dell’Irlanda. Seguono due brevi note, una sul successo raggiunto dalla fabbrica cooperativa di stoviglie ad East Liverpool, l’altra, uscita sul The Advance, Detroit, dell’aprile 1887, sulla preparazione di una bottega cooperativa tra gli operai barbieri di New York. Completano il numero le seguenti citazioni: Il comunismo nell’Oural, estratta da LAVELEYE, De la proprieté; Un podere sociale e Società cooperativa di Calzolai, estratte da The Labour Leaf, e una citazione senza titolo, estratta da LE PLAY, Les ouvriers européens sul principio di comunanza tra i popoli nomadi e seminomadi senza specificare la località. Il numero 12, uscito con l’«Humanitas» XV, del 29 maggio 1887, porta solo delle citazioni, alcune più piccole, altre più dettagliate: Columbia – colonia cooperativa, estratta da The Avant-Courier, Portland, Oreg, vol. I, n°. 48; Le comunità scozzesi, estratta da 106 Idem, p. 4. 132 LAVELEYE, op. cit.; Una miniera sociale, dal The Advance, Detroit, Mich. 23 aprile 1887; Italia antica, dal MOMMSEN, Hist. Rom. Inoltre questo numero porta altre sei citazioni senza titolo con i seguenti argomenti: l’organizzazione della tribù celto-ibera dei Vaccei, estratta da Bibl. histor. l. V; l’agricoltura degli indios messicani, estratta da L’Année géographique (1873) per M. Vivien de Saint-Martin; la pratica dell’estrazione annua a sorte dei lotti di terreno, e qualche volta il lavoro in comune esistente in Irlanda, eredità dalle abitudini delle comunità dei villaggi, estratta da Hume, Hist. of England, cap. XLVI e Mac Culoch, statisti I; casi di lavori agricoli comuni in Tcheremisses, nell’Altmark e nello Iutland, estratte da pubblicazioni di Von HAXTHAUSEN; le comunità di villaggio africane, estratte dalla Relazione delle isole Pelew del capitano Wilson, tradotta dall’inglese da G. READ, Parigi 1788 e sulle società cooperative delle arti costruttrici e dei canepini a Bologna, estratte da La cooperazione italiana, maggio 1887. Il numero 13, dell’«Humanitas» XVI, del 12 giugno 1887 prosegue con la Storia della Colonia Agricola di Ralahine con i seguenti testi: Capitolo II – Miseria dei contadini nel 1830; Capitolo III – Progetto d’associazione – accordo tra Vandeleur e Craig; Capitolo IV – Stato delle persone e delle cose all’arrivo di Craig. Inoltre, porta alcune citazioni come Comunismo nella Magna Grecia, estratto da ARISTOTELE, Politica lib. IV – Cap. III); Comunità nel Medio Evo, estratto da LAVELEYE, op. cit., una piccola citazione senza titolo sulla storia della Sicilia, estratta da DIODORO, Bibl. histor. V. 9; infine l’annuncio della formazione della Società Cooperativa dei lavoratori bottai a Messina. Il numero 14, dell’«Humanitas» XVII, del 2 luglio 1887 è interamente dedicato alla Storia della Colonia Agricola di Ralahine con i seguenti testi: Capitolo V – Studio della lingua irlandese; Capitolo VI – Prime misure per organizzare l’associazione; Capitolo VII – Statuto dell’associazione. L’ultimo numero uscito fu il 16, con l’«Humanitas» XX, del 8 settembre 1887, anch’esso dedicato alla Storia della Colonia Agricola di Ralahine con la continuazione dello Statuto dell’associazione e poi con il Capitolo IX – Dettagli pratici sulla direzione. Comitato eletto; in conclusione, la notizia dell’organizzazione della Colonia Kaweach in California, seguita da invito d’adesione. Non si trova avvertimento sulla fine del giornale. Con il numero 16 «Lo Sperimentale» cessò definitivamente la sua esistenza. Ma il seme per la nascita della colonia agricola socialista non tarderà a dare i suoi frutti: ancora nel 1887 nascerà a Stagno Lombardo, nel territorio cremonese, l’«Associazione Agricola Cooperativa di Cittadella», di cui Giovanni Rossi, oltre che l’ideatore, fu il segretario. 133 5. Cittadella Secondo BETRI, i primi contatti tra Rossi e il gruppo cremonese di Giuseppe Mori, Bissolati, Sacchi e altri risalgono agli anni 1885/86107. Tra l’altro, questo fu il periodo in cui Rossi intensificò la propaganda della sua colonia sperimentale, parlando per la prima volta della creazione di una colonia cooperativa da trasformarsi in una colonia socialista, sembrando così moderare il carattere rivoluzionario del suo discorso. Ciò nonostante, rimase fedele all’idea di far nascere questa trasformazione dai nuclei contadini, fatto che, secondo BETRI e GOSI, rimanda al lungo dibattito sull’obščina russa durato dal 1875 fino agli ultimi anni di ENGELS108. La disposizione di appoggiare il progetto di Rossi era presente anche in Mori, proprietario del podere di Cittadella dove si svolse l’esperimento. Mazziniano e deputato di Estrema Sinistra, Mori si era impegnato a favore delle classi lavoratrici, svolgendo un ruolo importante tra i lavoratori, cercando di renderli consapevoli dei loro diritti e doveri come cittadini. Da tempo egli cercava di porre fine al sistema del lavoro salariato nelle sue terre e la proposta di organizzazione di una colonia agricola socialista presentata dal Rossi nel giornale «La Favilla» gli sembrò il modo migliore di realizzare il suo obiettivo. I primi contatti avvennero nel 1886 quando Mori e Bissolati si recarono a Gavardo a trovare l’anarchico. Dopo aver discusso sulla realtà locale, decisero di ripetere l’esperimento di Ralahine in Irlanda, offrendo così la Cittadella in appalto a una Il punto di incontro soprattutto tra ROSSI, MORI e BISSOLATI riguardava la questione dell’organizzazione della produzione agricola. Infatti, nell’opuscolo intitolato «I contadini del Circondario di Cremona», pubblicato dalla Tip. Sociale a Cremona nel 1886, BISSOLATI si mostrò un grande “sostenitore delle cooperative di produzione come uno dei mezzi più validi che si potessero offrire ai lavoratori agricoli per il miglioramento delle loro condizioni” (GOSI, 1977:50). Inoltre, l’autore suggeriva l’attivazione di “leghe cooperative che consentissero ai contadini di gestire direttamente l’azienda: il sistema dell’affitto (…) avrebbe dovuto essere sfruttato collettivamente dai lavoratori” (GOSI, 1977:50). Tali associazioni cooperative avrebbero dovuto svolgere una funzione emancipatrice, conducendo i lavoratori fino alla proprietà collettiva, segnando così l’evoluzione fino a un sistema economico diverso. 108 “I populisti russi ritenevano che la comune agricola (obščina), che amministrava terre comuni, tenute come proprietà collettiva e distribuite periodicamente tra le famiglie, fosse un fenomeno esclusivamente slavo. Il popolo russo sarebbe quindi stato imbevuto dei principi della proprietà comune, e quindi molto più vicino al socialismo che i popoli dell’Occidente europeo. A cominciare dagli anni ’60, fu lecito pensare che le comuni agricole russe, (…) potessero ancora servire da passaggio diretto al comunismo superiore eludendo la fase capitalistica” (BETRI, 1971:11/12). MARX e ENGELS credevano possibile che questo avvenisse, ma tenevano anche conto dei rapidi cambiamenti che rendevano questo passaggio sempre più difficile. Secondo i due intellettuali, “sfuggita la grande occasione storica di appoggiare alla comune agricola il passaggio al comunismo superiore, e avanzando il capitalismo in Russia, la possibilità di salvare la comune restava legata infine ad un'eventuale rivoluzione proletaria in Occidente; mancata anche questa, la Russia doveva inevitabilmente passare per la fase capitalistica e arrivare attraverso questa alla sua rivoluzione proletaria” (VENTURI apud BETRI, 1971:12). Rossi, insomma, credeva alla possibilità che il cambiamento potesse avvenire anche nelle campagne tra i contadini, perciò insisteva nella creazione di una colonia agricola socialista sperimentale. 107 134 associazione di contadini da costituirsi con i contadini che lì lavoravano come salariati. L’unica condizione imposta da Mori fu che Rossi vi partecipasse e seguisse il progetto nella qualità di segretario, condizione alla quale egli acconsentì senza esitare. Secondo GOSI, la scelta del podere di Cittadella in Stagno Lombardo non fu casuale, bensì in funzione del carattere socialmente più organizzato di quei contadini. Infatti, loro erano stati protagonisti degli scioperi del 1882 e del 1885 svoltisi in quella località e aree limitrofe. Anche se, secondo GOSI, “la prima ondata di azioni rivendicative fu improntata da un ribellismo generico, sostanzialmente incapace di scalfire lo strapotere dei conduttori di fondi nell’applicazione dei patti colonici, diverso carattere ebbero le agitazioni del 1885” (GOSI, 1977:49). Anche se lo sciopero dell’’85 fallì, quei contadini diedero prova della loro capacità di organizzazione e della coscienza dei diritti loro spettanti, fatto che richiamò l’attenzione dei nostri rivoluzionari. Le trattative tra Rossi e il gruppo cremonese furono seguite con interesse e apprensione dal parroco don Brunelli, che non tardò ad avvertire il vescovo di Cremona su ciò che stava per accadere. La preparazione delle condizioni d’appalto e l’elaborazione dello Statuto organico dell’Associazione – che contò sulla collaborazione di Maffi e Landriani – fu lunga e complessa. Le corrispondenze scambiate tra Mori e Rossi tra il gennaio e l’agosto 1887 rivelano le difficoltà dell’impresa e l’impegno di Rossi nella soluzione delle difficoltà che man mano apparivano. La più importante fu quella relativa al capitale circolante, per la cui soluzione “Rossi propo[s]e un accordo fra la Società dei contadini e la Ditta Cirio, in questi termini: a Cittadella si sarebbero piantate colture i cui prodotti la Ditta Cirio avrebbe comprato a prezzo prestabilito. Come caparra Cirio avrebbe sborsato L. 50.000 garantendosi sulle scorte e sui frutti pendenti. Questa caparra si sarebbe dovuta ammortizzare in un determinato numero di anni. Accanto a questa possibilità, viene poi avanzata l’ipotesi di ricorrere ad un’ipoteca” (BETRI, 1971:16). A metà dell’agosto 1887 il progetto di Statuto sembrava aver raggiunto buon termine. In seguito, l’opera di propaganda del progetto tra i contadini fu affidata a Bissolati e, quando tutto pareva pronto, i contadini furono convocati a una riunione in cui Bissolati gli spiegò l’idea di Mori di consegnargli in appalto, non appena si fosse costituita la Società, il podere di Cittadella su cui lavoravano. I contadini esultarono per quello che non parve loro vero. Ma le prime difficoltà apparvero con la lettura dello Statuto organico della società, scritto in base all’esperimento di Ralahine e perciò comunistico ed egualitario. “Quando Bissolati ed io spiegammo i vantaggi di questi ordinamenti, i contadini di Cittadella non ne vollero sapere e modificarono il progetto dello Statuto organico in modo 135 tale che dettero all’Associazione un’impronta puramente collettivistica, che differisse il meno possibile dal loro abituale tipo di vita e di lavoro. L’abitudine infatti è più dura da combattere e da vincere di qualunque altra cosa” (ROSSI apud BETRI, 1971:18/19). Fu per voler andare al di là del discorso utopico e partire alla sperimentazione che Rossi ridusse ancora di più il contenuto socialista della sua colonia. L’atto costitutivo dell’Associazione Agricola di Cittadella avvenne l’11 novembre 1887. Furono approvati lo Statuto109 – con le modifiche richieste dai contadini – e il capitolato d’affitto dello stabile; per votazione segreta fu eletto il segretario – Giovanni Rossi – e, per acclamazione, furono eletti tre membri per integrare la commissione tecnica; il rappresentante dell’Associazione nella Commissione Amministrazione e uno dei tre sindaci dell’Associazione, essendo gli altri due designati personalmente da Mori. Infine, si determinò l’organizzazione dell’Associazione: in quella occasione, trenta contadini e Giovanni Rossi presero atto della proposta di Mori di cedere in affitto fiduciario lo stabile di Cittadella a una associazione cooperativa di produzione formata dai contadini che lì abitavano e lavoravano come salariati. Essi dichiararono “di accettare (…) la proposta di Mori, stipulando con lui apposito contratto d’affitto[, nonché] di costituirsi in società sotto il nome di «Associazione Agricola Cooperativa di Cittadella in Comune di Stagno Lombardo, Cremona», onde esercitare collettivamente l’industria agraria ed ogni altra che [potesse sembrare] conveniente in avvenire” (BETRI, 1971:20). La riunione si sciolse con un applauso a Mori e subito dopo la commissione tecnica si riunì per decidere sui lavori da eseguire il giorno successivo. Cittadella era costituita “da venti case di contadini e da corrispondenti costruzioni agricole, raggruppate intorno a due grandi piazzali. Su un terzo piazzale adiacente si affacciavano l’abitazione del proprietario e l’asilo infantile, da lui fatto costruire e mantenuto. Intorno a questo nucleo di costruzioni si estendevano 120 ettari di terreno piano ben coltivato, diviso in due parti dall’argine principale del Po. I campi situati al di là dell’argine erano irrigati mediante un’imponente pompa centrifuga a vapore che si alimentava da un laghetto presso il paese. Vi si coltivavano frumento, mais, prato, viti e vi si allevavano bestiame e bachi da seta” (GOSI, 1977:55). 109 Lo Statuto Organico dell’Associazione Agricola Cooperativa di Cittadella in Comune di Stagno Lombardo, Cremona, approvato dall’Assemblea Generale dell’11 novembre 1887 è suddiviso in 11 Titoli e 53 articoli così disciplinati: I. Costituzione e scopo; II. Ammissione dei soci; III. Delle adunanze; IV. Organizzazione amministrativa; V. Diritti dei soci; VI. Capitale sociale ed utili; VII. Lavori agricoli; VIII. Magazzino di consumo; IX. Istruzione; X. Rapporti morali; XI. Dimissione espulsione dei soci e scioglimento della società. Per maggiori dettagli, vedere BETRI. L. (a cura di) Cittadella e Cecilia due esperimenti di colonia agricola socialista. Carte inedite a cura di Luisa Betri e un saggio introduttivo su l’utopia contadina. Milano: Edizioni del Gallo, giugno 1971. 395 p. 136 A Cittadella le decisioni e le deliberazioni più importanti erano prese tramite l’Assemblea Generale, avvenute due volte al mese, il primo e il terzo sabato sera. Alle donne era concessa la partecipazione, ma senza il diritto al voto. L’amministrazione dell’Associazione era invece responsabilità della Commissione Amministrazione, formata da un rappresentante dei lavoratori eletto annualmente dall’Assemblea, un rappresentante di Mori e da Rossi. Erano compiti di questa Commissione l’organizzazione amministrativa dell’Associazione, l’elaborazione del bilancio consuntivo e preventivo entro dicembre di ogni anno e la consultazione pubblica del libro ai soci in ore previamente accordate. Inoltre, la Commissione aveva autonomia di compra e vendita fino alla somma totale di L. 400. “Per la rimunerazione si prevede[va] il mantenimento di categorie diverse, a seconda della quantità del lavoro e della responsabilità di ogni singolo socio. I braccianti obbligati percepi[vano] L. 300; i famigli lire 340; i capi-stalla, capo bracciante e segretario L.. 360. Per i braccianti disobbligati e per le donne lo Statuto stabili[va] una rimunerazione per ogni giornata di lavoro da convenirsi di volta in volta” (BETRI, 1971:20)110. “Ogni nucleo familiare avrebbe avuto a disposizione una casa, un orto e cortile per l’allevamento di cinque galline ed avrebbe avuto inoltre diritto ai due quinti del prodotto dei bachi, a metà del valore di un maiale da ingrasso, a un terzo del prodotto di quella parte a granoturco e a lino assegnata in parti uguali. Gli utili netti aziendali sarebbero stati annualmente divisi come segue: il 50% a riscatto del capitale mobile, il 50% diviso fra i soci proporzionalmente alle mercedi guadagnate. Una volta riscattato il capitale mobile, il 40% sarebbe stato destinato ad aumentare il capitale comune indivisibile, ed il 60% a partecipazione proporzionale dei soci” (GOSI, 1977:56). Qualora “la società, in assemblea generale, pronunciasse il proprio scioglimento, si [sarebbe proceduto] alla liquidazione dell’azienda, conservando il capitale sociale a disposizione di un nuovo gruppo di lavoratori che si [costituisse], informato ai principi generali dell’Atto di costituzione e dello Statuto organico. [Era] assolutamente esclusa la divisione del capitale sociale fra i soci” (BETRI, 1971:21). Tutti i lavori agricoli svolti in Cittadella dovevano essere fatti in modo e per interesse collettivo. I lavori venivano diretti da una Commissione Tecnica composta da tre membri eletti in assemblea a maggioranza assoluta, e assistita dal Segretario. Essa lavorava insieme agli altri membri durante la giornata, e la sera si riuniva per decidere i lavori da svolgere il giorno successivo, così come la quantità di lavoratori necessari per le singole 110 Secondo BETRI, tutti questi valori erano superiori a quelli rivendicati dai lavoratori stessi durante lo sciopero del 1885. 137 attività. A tutti coloro che non erano d’accordo con le pratiche svolte veniva concessa una superficie di terreno determinata, affinché potessero realizzare l’esperimento desiderato a dimostrazione dei propri intendimenti. Come magazzino di consumo funzionava a Cittadella una succursale della Società Cooperativa di Consumo fra artigiani e braccianti di Pieve d’Olmi. La prima difficoltà che i contadini dovettero superare fu quella relativa ai soldi necessari per pagare la cauzione al proprietario (un anno di affitto in anticipo), comprare il materiale mobile necessario per l’avvio dell’esperimento e mantenersi fino ai primi incassi. Fu Mori che alla fine anticipò i soldi, all’interesse del 4,5%. Risolto questo problema, la vita dell’Associazione si sviluppò regolarmente. “I verbali delle Assemblee registra[va]no fedelmente tutto quanto si decide[va] in merito ai lavori da compiere, all’acquisto di concimi, sementi, bestiame, all’introduzione di nuovi attrezzi o di nuove macchine. L’Associazione si mant[en]ne tecnicamente all’avanguardia: [era] in contatto con numerose ditte fornitrici di concimi artificiali, con alcuni stabilimenti agrario-botanici, con la Regia Scuola di Agricoltura di Milano, con il Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio, con il Comizio Agrario di Piacenza, e con altri privati. Riceve[tte], ad incoraggiamento, subito dopo la costituzione, alcune partite gratuite di concime e di sementi. Speriment[ò] nuovi tipi di attrezzi: un aratro Sack e un bivomero Eckert; una sgranatrice di mais azionata a vapore, una centrifuga per il burro. Per migliorare il bestiame si deci[s]e di chiedere il prezzo di un toro di razza reggiana. Il Ministero dell’Agricoltura invi[ò] un sussidio di L. 200 per l’acquisto di una giovenca della Frisia Orientale” (BETRI, 1971:22/23). Nel 1889 l’Associazione partecipò all’esposizione di Parigi, vincendo la medaglia d’argento per produttività. I risultati raggiunti erano tali che i proprietari confinanti dovettero riconoscere un notevole miglioramento nelle coltivazioni di Cittadella. Ma tutti questi risultati, rammenta Rossi in una lettera, gli furono costati tante discussioni e tanta lotta contro la resistenza dei contadini a provare le novità proposte. Durante tutto il periodo di svolgimento di Cittadella, Rossi continuò la sua opera di propaganda per la diffusione delle cooperative agricole sperimentali, senza inoltre abbandonare l’idea di trasformare l’associazione cooperativa in una vera e propria colonia socialista. A tale scopo si costituì l’11 dicembre 1888 l’Unione Lavoratrice per la Colonizzazione Sociale in Italia, con l’obiettivo di colonizzare i terreni disponibili, organizzandovi socialmente la proprietà, il lavoro e la convivenza. Nella prima metà del 1889 si svolsero le 138 trattative per la costituzione di una colonia sociale a Torricela di Sissa111 in provincia di Parma e nel settembre dello stesso anno si parlava della costituzione di un’altra colonia a Padova. A Cittadella, però, le cose non sembravano svilupparsi verso le direttive proposte da Rossi: se dal punto di vista economico l’esperimento poteva considerarsi riuscito, lo stesso non si poteva dire da quello sociale. Con lo scopo di eliminare tutte le tracce di individualismo e conservatorismo che prevalsero a Cittadella fin dalla sua organizzazione, e prendendo spunto dall’allontanamento di due famiglie dall’esperimento, Mori e Rossi decisero di introdurre a Cittadella un gruppo di contadini di idee socialiste che servisse di esempio alle altre famiglie affinché si potesse trasformare gradualmente tutta la colonia. “Il nucleo socialista112 è già costituito nel maggio dell’’89113: il Rossi lo ha formato andando a prendere due famiglie di coloni fra le più miserabili del Parmigiano. Una è composta da marito, moglie e tre figli; l’altra da marito, moglie e sei figli. Ad essi si sono aggiunti due giovani contadini professanti idee socialiste e Cardias stesso. Sono in tutto sedici persone che lavorano: il guadagno è posto in comune. La casa è affidata alle donne che dirigono a turno le cose domestiche. All’inizio di ciascun turno di quindici giorni gli uomini domandano quanto c’è in cassa e quanto è necessario per mantenere la casa nella quindicina. Si discute la spesa e si dà il permesso alla massaia di recarsi all’Agenzia per farsi dare la somma; la donna che non attende alla casa si reca a lavorare nei campi. Nella cucina le pareti sono tappezzate di incisioni rappresentanti i capi del socialismo. Il guadagno riposto dal nucleo alla fine dell’anno sarà destinato all’acquisto di mobili, utensili, vesti” (BETRI, 1971:24). Ma neppure questo bastò a cambiare le cose. Il tentativo socialista non fu accettato dai contadini, che si opponevano principalmente all’idea ugualitaria. A questo punto i primi sintomi della crisi cominciarono a manifestarsi: i contadini opposero forte resistenza al nucleo socialista e si voltarono contro Rossi, che si trovò al centro di innumerevoli critiche e presto si rese conto dell’impossibilità di trasformare Cittadella in un esperimento basato sul collettivismo integrale. “Contemporaneamente il progetto di Torricella di Sissa incontrava difficoltà per il reperimento dei finanziamenti; altre iniziative analoghe promosse nel Reggiano, nella zona di Bracciano e nel Parmense si insabbiarono in incagli burocratici” (GOSI, 1977:61). Il “progetto contemplava la formazione di una società anonima per azioni che consentisse di acquistare in Torricella un fondo, chiamato «Il Palazzo». Per coprire il capitale necessario all’acquisto, 150.000 lire, furono emesse trecento azioni da 500 lire ciascuna” (GOSI, 1977:58/59). Tra i sottoscrittori figurano nomi quali quelli di De Azarta, Nathan, Odescalchi, Mori, Bissolati, Boldori, Garibotti e Sacchi. 112 Pensato all’interno della nozione di “leaders-guida” di BAKUNIN. 113 «Il Secolo», Milano 20-21 maggio 1889 (Cfr. BETRI, 1971, nota 28 p. 25). 111 139 Davanti a questi avvenimenti, Rossi decise di abbandonare Cittadella e di trasferirsi in America, in una delle Colonie appena fondate nell’America del Nord114. Successivamente gli apparse la possibilità di andare a fondare insieme ad altri compagni una colonia socialista nell’America del Sud, alla quale egli aderì senza esitare. Tramite una lettera inviata a Bissolati alla fine del dicembre 1889, chiese all’amico di lanciare un appello di sottoscrizione a favore dei pionieri sul giornale «Eco del Popolo». La lettera – in cui Rossi diceva di partire per l’Uruguay a realizzare l’esperimento115 – fu pubblicata nel numero 52 del suddetto giornale116, con le scuse di Bissolati per l’impossibilità dell’apertura delle sottoscrizioni data l’imminente chiusura del giornale, ma con un suo appello personale perché questa richiesta venisse in qualche modo soddisfatta. Fatto sta che Rossi s’imbarcò a Genova per il Brasile il 20 febbraio 1890, a bordo del “Città di Roma”, sorretto dalla “speranza di attuare finalmente il suo piano, in un paese che offriva, con le sue vastissime zone ancora vergini o appena popolate, condizioni ambientali più favorevoli. Anche gli elementi costitutivi della futura Colonia presentavano maggiori garanzie, essendosi distaccati dalle tradizioni e dalle remore consuetudinarie del mondo contadino” (BETRI, 1971:29). Dopo la partenza di Rossi, Mori decise di disdire il contratto d’appalto alla fine del secondo anno. Dovette però retrocedere, dopo che i contadini gli presentarono un documento scritto e firmato da tutti, invitandolo a cambiare idea. Tuttavia, la cooperativa venne sciolta su espresso desiderio di Mori alla fine del terzo anno, l’11 novembre 1890, nonostante il successo raggiunto. Secondo BETRI è difficile stabilire i motivi che portarono Mori a tale decisione. Basandosi su una lettera scritta da Ettore Guindani117, uno degli uomini di fiducia di Mori, l’autrice afferma che lui si era stancato delle contese provocate arbitrariamente dai contadini, così come della carica di cassiere che gli aveva provocato numerosi fastidi. La partenza di Rossi, secondo BETRI, è anch’essa un punto nodale per lo svolgersi dell’esperimento che senza di lui retrocedette fino allo scioglimento. GOSI individua anche come possibile causa del fallimento gli effetti del protezionismo granario varati nell’’87 e sentiti dai proprietari settentrionali alcuni anni dopo. Secondo l’autrice, è possibile pensare che si fosse messo fine all’esperimento perché non più favorevole nelle nuove condizioni economiche. Infine, cita le considerazioni fatte da Bissolati, secondo il Una in California e l’altra in Messico. Dai documenti da me analizzati, non sono riuscita ad arrivare alle circostanze che gli fecero cambiare destinazione dato che tale esperimento si riferisce alla Colonia Cecilia della quale parlerò in seguito. 116 Materiale pubblicato por BETRI, 1971, p. 305/306. 117 ROSSI dott. G., Utopie und Experiment. op. cit., pp. 93-94 (Cfr. BETRI, 1971, nota 30 p. 27). 114 115 140 quale la fine di Cittadella fu dovuta al fatto di essersi configurata isolatamente come nucleo innovatore in un contesto economico e sociale immutato. In ogni modo, la fine dell’esperimento, secondo MÜELLER, insegnò a Rossi la pertinenza di una delle questioni centrali dell’anarchismo, secondo la quale un cambiamento non può essere fatto dall’alto in basso, da fuori, ma dev’essere costruito dai suoi protagonisti. 6. Dove c’è autorità non c’è libertà: la Colonia Cecilia e l’utopia del comunismo anarchico All’erta compagni dall’animo forte / più non ci turbino il dolore e la morte all’erta compagni formiamo l’unione / evviva evviva la rivoluzione Ti lascio Italia terra di ladri / coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare / e formeremo la colonia social118 Il risultato ottenuto con Cittadella non scoraggiò Rossi. Senza essere riuscito a mettere in pratica il suo progetto di costituzione di una colonia agricola sociale in Italia, l’anarchico decise di cercare la realizzazione del suo ideale altrove. Quanto più l’Italia – e l’Europa in generale – si mostravano refrattarie alle sue idee, tanto più l’America si presentava come lo spazio possibile. Il primo posto nel quale l’anarchico pensò di andare fu l’America del Nord. Non esisteva però nessun legame tra lui e l’America. Qualsiasi fosse stato il posto dove si fosse diretto, esso sarebbe stato soltanto un laboratorio dove si sarebbe svolta l’esperienza. L’Italia rimaneva come il punto di riferimento, di partenza e di ritorno. Per quel che si riferisce alla scelta del Brasile, esistono delle divergenze tra la letteratura consultata. Secondo MÜELLER, questa scelta fu dovuta alla propaganda delle facilità offerte dal governo brasiliano agli immigranti, messa in moto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Rossi stesso, come abbiamo appena detto, parla inizialmente di una partenza per l’Uruguay e non si ha riferimento nei suoi scritti sulle ragioni del cambiamento della destinazione. Comunque sia, nel Brasile della fine dell’Ottocento, la schiavitù aveva i suoi giorni contati119 e la necessità di forza lavoro per le fazendas di caffè era un problema al quale il governo brasiliano non poteva restare indifferente. Sul fatto che la forza lavoro doveva essere libera erano oramai tutti d’accordo. Mancavano però i lavoratori. Secondo AMODEI, La Colonia Cecilia. In Quella sera a Milano era caldo … antologia della canzone anarchica in Italia 2, curato da BERMANI, C. Milano: I Dischi del Sole, Modena: Bravo Records, 1996. 119 La Legge Aurea che l’abolì fu firmata il 13 maggio 1888. 118 141 MARTINS l’utilizzo degli ex schiavi dopo l’abolizione della schiavitù era poco probabile dato che, per loro, la libertà passava ad assumere un senso di negazione del lavoro, anche se temporanea. Inoltre, era impossibile affidare al ridotto numero di lavoratori liberi, già esistenti durante il periodo schiavista, l’incarico di portare avanti il lavoro nelle fazendas di caffè. Così, dalla crisi del sistema schiavista e dall’impossibilità di contare sulla manodopera nazionale, emerse la questione dell’immigrazione e della colonizzazione: la soluzione doveva essere cercata altrove. Altrove c’era l’Italia con cui il Brasile stabilì un accordo di emigrazione. Fu questo il periodo in cui gli anarchici italiani decisero emigrare in Brasile per costruire l’utopia del comunismo anarchico. Il “20 febbraio 1890, Giovanni Rossi e altri cinque compagni – Cattina e Achille Dondelli, Evangelista Benedetti, Lorenzo Arrighini e Giacomo Zanetti partono da Genova per il Brasile, a bordo del «Città di Roma», antica nave da carico trasformata in nave da passeggeri” (MÜELLER, 1989:244/245). Portavano con loro la piccola somma di 2500 lire, raggiunta dalle sottoscrizioni. Ritenuti da una parte del movimento anarchico in Italia “disertori”, essi erano mossi dall’idea “di cercare nelle solitudini americane un pezzo di terra da coltivare – loro, inesperti e quasi sprovvisti di tutto – per vedere essi stessi e per mostrare agli altri se e come degli uomini vivrebbero senza leggi e senza padroni” (ROSSI (Cardias), 1993:23)120. Riguardo alla partenza per il Brasile ci sono delle divergenze tra le fonti consultate e, molte di esse, come sottolinea DE MELLO NETO, sono in realtà poco fondate scientificamente. L’autore si riferisce soprattutto a CERCHIAI, SCHMIDT, STADLER DE SOUZA, MASINI che si riferiscono a trattative realizzate negli ultimi anni della 120 A proposito della critica a loro diretta, Rossi nel suo discorso afferma che nessuno di loro aveva mai riconosciuto capi né discipline, neppure apparteneva a nessun esercito, ragione per cui non potevano essere chiamati disertori. Inoltre, ricorda che furono le circostanze, più che la loro volontà personale, a spingerli verso il Brasile. 142 Monarchia tra Rossi e l’Imperatore del Brasile D. Pedro II, per l’installazione della sua colonia socialista121. GOSI, d’altra parte, argomenta che la versione dei suddetti autori è più romanzata che vera. A suo parere alcune informazioni non corrispondono alla realtà. All’inizio del 1888 “l’esperimento di Cittadella era appena iniziato e faceva bene sperare; non si comprende, dunque, per quale motivo il Rossi si sarebbe dovuto cercare, allora, un’alternativa così lontana; inoltre la parentela con quel Rossi, professore al Conservatorio, i conseguenti contatti con il Gomez e la comunità brasiliana residente a Milano si sono rivelati, in ultima analisi, molto più incerti; infine l’anarchico, ricordando in vari scritti le circostanze che lo indussero, a suo tempo, a interrompere l’esperimento di Stagno per tentare, altrove, una nuova impresa più conforme ai suoi intendimenti, non fa di questo episodio alcuna menzione” (GOSI, 1977:64). Infine, lo stesso Rossi nell’edizione livornese del 1891 del suo Un comune socialista, racconta che, alla “fine del 1889, dopo che una prova imperfetta a Stagno Lombardo non aveva corrisposto alle mie speranze, mi ero deciso a passare in una delle due colonie collettiviste fondate recentemente nell’America del Nord (…) quando Achille Dondelli di 121 Secondo DE MELLO NETO, gli equivoci cominciano con delle imprecisioni, o comunque informazioni senza fonti precise, contenute in alcuni testi di CERCHIAI pubblicati sul periodico I quaderni della libertà, edito a San Paolo sin dal 1932 (non sono riuscita a sapere se questo periodico esiste tuttora). Diverse sono state le informazione aggiunte alla storia dell’esperienza anarchica, senza un riscontro nelle informazioni fornite sia da Rossi che da Cappellaro – il “cronista ufficiale” della Cecilia – dal cambiamento del titolo del libro Un comune socialista a Il commune in riva al mare fino a dettagli colorati riguardo a un incontro tra D. Pedro II e Rossi, argomento che fu dopo ripreso sia da Jean-Luis Comolli nel film La Cecilia, sia dallo sceneggiato televisivo intitolato Colonia Cecilia e veicolato dalla Rete Bandeirantes di Televisione alla fine degli anni ’80. Secondo gli autori, il Monarca, affetto da febbri palustri, si era recato in Europa nel 1887 per farsi curare dai più illustri clinici del continente, occasione in cui visitò le principali stazioni di riposo e di mondanità. Nell’aprile 1888 si era fermato a Milano, dove prese una pleurite secca che l’obbligò a starci più a lungo. Per distrarlo la comunità brasiliana ivi residente decise di organizzare un concerto del promettente musicista brasiliano Carlos Gomez, un talento scoperto da Lauro Rossi, secondo gli autori uno zio di Giovanni Rossi. SCHMIDT e MASINI fanno menzione di un incontro personale tra l’anarchico e il monarca in occasione del concerto, mentre STADLER DE SOUZA parla di uno scritto dell’anarchico consegnato al monarca tramite il Conte Mota-Maya, sempre durante il suddetto concerto. Secondo quest’ultimo autore, Don Pedro II di ritorno in Brasile, avrebbe letto il libro Un comune socialista e in seguito avrebbe scritto a Rossi informando di essere disposto a donare le terre affinché si potesse realizzare l’esperimento descritto nel libro. SCHMIDT, da parte sua, giustifica la cosiddetta concessione di terra, affermando che all’epoca in Brasile esisteva l’urgente problema di trovare forza lavoro sia per le fazendas di caffè sia per le colonie nel sud del paese, dove già esisteva una colonia di tedeschi del Volga organizzatisi sotto la forma di un «mir». Stando così le cose, continua l’autore, il governo decise di cedere altre terre perché pure gli anarchici italiani potessero installare la loro colonia, certo che la terra avrebbe finito per assorbire le preoccupazioni ideologiche. Sempre secondo lui, dopo aver ricevuto la lettera del Monarca sulla concessione delle terre, Rossi avrebbe cercato subito di stabilire contatti con quelli che s’erano offerti per realizzare insieme a lui l’esperienza di vita anarchica, attraverso la colonia sperimentale. In realtà Rossi racconta di essere stato ricercato da degli amici di Brescia per realizzare l’esperimento della colonia socialista nell’America del Sud. 143 Brescia, a nome suo e di altri compagni, mi propose di andare a fondare una colonia nell’America del Sud” (ROSSI apud GOSI, 1977:64). Dopo lunghi giorni di viaggio, il piccolo gruppo di pionieri arrivò al porto di Rio de Janeiro, in Brasile, il 18 marzo 1890. Dopo l’ispezione sanitaria, il gruppo si diresse all’Isola dei Fiori, sempre a Rio de Janeiro, alloggiando temporaneamente nella Casa degli Immigranti, dove rimase alcuni giorni122. La partenza a bordo del vapore Desterro verso Porto Alegre capitale dello stato di Rio Grande do Sul, nel sud del paese, avvenne il 26 marzo. Però, siccome durante il viaggio due di loro stettero molto male a causa del mal di mare, il gruppo decise di concludere il viaggio nel porto di Paranaguà nello stato del Paraná, dove arrivarono il 28 marzo123. Da Paranaguà il gruppo si diresse a Curitiba a bordo di un treno il cui tragitto si svolse tutto in mezzo alla Foresta Atlantica124, e l’anarchico descrive il paesaggio che vede con una ricchezza di dettagli che ci sembra di fare il viaggio insieme a lui. Tenendo conto delle preoccupazioni degli italiani che pensavano di emigrare e cercando di convincerli a farlo, Rossi tratta dell’abbondante caccia e dei bellissimi uccelli presenti nella regione. Cita i tordi, i merli, i picchi, i tucani, i pappagalli e tanti altri uccelli colorati di cui non conosceva il nome. Tra gli animali da caccia, cita il formichiere, l’armadillo, il porco, il coniglio selvatico, il cervo e il macaco, sottolineando però di aver visto soltanto gli ultimi due. Tra gli animali pericolosi, cita la tigre del Paranà (Felis uncia), l’onça parda (una tigre più piccola e timida), il tamandoà-bandeira o orso formichiere (Myrmecophaga jubata), il queixada o porco di bosco (Dicotilas labiatus) e i serpenti, distinguendo tra quelli che solo attaccano gli uomini se provocati, come il serpente a sonagli (cascavel), e quelli invece che lo attaccano comunque, come il jararaca, il Rossi, prendendo spunto dalla condizione degli emigranti e dallo splendido ambiente naturale trovato, scrisse un articolo sul viaggio in Brasile e sui primi mesi della Colonia Cecilia. La prima parte di questo articolo, riguardante il viaggio fino alla scelta delle terre per la fondazione della colonia, è stata pubblicata nella rivista «La geografia per tutti», edita a Bergamo e diretta dal geografo e anarchico A. GHISLERI in diversi “puntate”, uscite dal 31 maggio al 16 novembre 1891 nella rubrica Notarelle di viaggio e di colonizzazione. In questo articolo, tra le altre cose, Rossi parla con parole lusinghiere delle bellezze naturali del Brasile, della politica immigratoria brasiliana, della qualità del trattamento ricevuto nella maggior parte delle Case degli Immigranti in cui stette e del trasporto gratuito fino alle terre fertili delle colonie offerte dal governo. Secondo DE MELLO NETO, alcuni studiosi hanno giudicato il testo molto pubblicitario. Personalmente, tendo a essere d’accordo con questi ultimi, dato che la storia dell’immigrazione italiana in Brasile, almeno nella sua maggior parte, rivela contorni assai diversi da quelli descritti dall’anarchico. 123 Informazione pubblicata sul giornale brasiliano «O Paiz» il 19.03.1890 e riportata da DE MELLO NETO, 1996, p. 97. L’autore informa inoltre che tanto il registro del gruppo nella Casa degli Immigranti a Rio de Janeiro quanto la pubblicazione di una lettera di Rossi sul giornale «La Révolte» di Parigi confermano che la destinazione iniziale era il Rio Grande do Sul e non il Paranà. 124 Il treno esiste tuttora però ha funzione soltanto turistica. E ancora oggi, passati più di cento anni, il paesaggio che vi si ammira è tra quelli più belli del Brasile. 122 144 jararacussù, il jararaca preguiçosa (appartenenti al genere trigonocephalus), il quatiara e l’urutù. Inoltre cita l’aranha caranguejeira – un ragno grosso e coperto di peli con due denti grossi come quelli del topo nella mascella superiore), i cento piedi (Lacraia), lo scorpione, la mosca varejeira e la berne – zanzare che colpiscono uomini e animali – e, infine, la pulce penetrante – conosciuta come “bicho geográfico” – che al Paranà si trova soltanto nel litorale. Speciale attenzione è data al bosco, che Rossi descrive con grande ricchezza di dettagli, tanto dal punto di vista estetico quanto da quello economico. Inizia la sua descrizione citando le innumerevoli liane, il bambù e la taquara – canne a stecche flessibili utili per fare ceste, stuoie, crivelli e altri lavori d’intreccio – le felci arboree, utili come canne per la conduzione d’acqua; le orchidee e i fiori delle cactacee, di rara bellezza, tanto da fargli immaginare un giardino in mezzo alla foresta. Tratta in seguito degli alberi lì presenti, come l’imbuia – il cui legname, essendo imputrescibile, si presta alla preparazione di travi da poggiare sulle basi dei pilastri, messi nei posti della casa maggiormente esposti all’umidità, oltre a essere un bellissimo legname per l’ebanisteria. Cita l’Araucaria brasiliense, il cui legname imputridisce al contatto col terreno ma resiste per anni alla pioggia e al sole, essendo perciò utilizzata dal colono nella costruzione della casa. Per la lavorazione dei mobili, cita il cedro e la cajarana, i quali conservano inalterato il colore e sono anch’essi imputrescibili. Cita infine il Sassafrax (anice), anche questo resistente all’umidità del terreno oltre a essere pregiatissimo in Europa per la preparazione di liquori. Infine, cita l’“oro verde” brasiliano, l’albero del mate125 (l’Ilex paraguaiensis), utilizzato nella preparazione di un infuso dal gusto amaro, molto diffuso nel sud del Brasile (dov’è conosciuto come chimarrão), Argentina e Uruguay. In seguito tratta delle poche vie di comunicazione esistenti: la ristretta linea ferroviaria, le strade sterrate – senza nasconderne la difficile percorribilità durante il periodo delle piogge – e i fiumi, all’epoca anch’essi utilizzati come vie di comunicazione. Attribuisce tale precarietà alla recente creazione di quello stato e alle piccole dimensioni del paese dove si localizzava la colonia. Inoltre, ricorda che dato che non si pagavano le tasse, era già tanto che lo Stato avesse aperto tutte quelle strade. Conclude il suo articolo trattando della popolazione locale, descritta come gentile, servizievole e aperta allo straniero appena arrivato, tanto da regalare i primi animali per la colonia. Una volta a Curitiba i pionieri si diressero all’Ispettoria di Terre e Colonizzazione, dove il responsabile mostrò loro le aree destinate alla colonizzazione e gli appezzamenti 125 Tutti i nomi segnati con corsivo e grassetto sono stati riportati dal Rossi in portoghese. In alcuni di loro mi sono permessa di correggere la grafia. 145 disponibili. Davanti al loro manifesto desiderio di “stabilirsi presso un fiume navigabile fu loro suggerito il territorio di St. Mattheus, lungo il corso dell’Iguassù. Fu così che, lasciato momentaneamente a Curytiba il resto del gruppo su i primi dell’aprile 1890 [narrava il Rossi] […] Evangelista Benedetti ed io, dopo alcuni giorni di esplorazioni, ci stabilimmo in una casetta di legno abbandonata, a 18 Km. sud da Palmeira; sul margine di una zona di 10 Km. quadrati, costituita da prateria e da boschi, e riservata per noi al prezzo medio di L. 15 per ettaro pagabile ratealmente” (GOSI, 1977:65)126. Le campagne intorno a Palmeira erano, secondo Rossi, costituite da colline a declivio, in parte erbose – localmente chiamate “campos” – e in parte boscose, assai elevate sul livello del mare, con clima mite e salubre. Inoltre, esisteva una parte di terreno municipale divisa in lotti e con delle piccole abitazioni in legno che dovevano ancora essere assegnate ai nuovi contadini. Riguardo all’agricoltura, Rossi identificò due forme diverse di pratica agricola: una, quella del “campo” – dove si praticava la coltivazione della manioca127 – e quella del bosco, a cui si riferisce come “qualche cosa di originale. Qui vi sono boschi di ogni età (…). Tutti questi boschi possono essere roçati; vale a dire inceneriti e coltivati. Il brasiliano preferisce i boschi che hanno dai 40 ai 60 anni di età, perché di fronte ad una certa facilità di lavoro danno un reddito assai elevato. Durante l’inverno penetra in questi boschi, di proprietà sua o di proprietà pubblica, e con una scure particolare atterra le piante più sottili, mentre adopera una scure ordinaria per abbattere le piante più grosse. (…) Alla primavera successiva danno fuoco su diversi punti a tutto questo legname abbattuto, ed il bosco diviene una fornace. Se gli alberi abbattuti erano sottili e completamente essiccati, il terreno rimane coperto di brace e cenere; altrimenti vi si trovano tronchi incrociati per ogni verso. In un caso o nell’altro l’agricoltore entra nella roça e con la punta di un bastone fa in terra dei buchi, dove getta il seme del granturco, dei fagiuoli neri e delle zucche. Poi abbatte gli alberi attorno alla roça, facendoli cadere in modo che costituiscano una barriera insuperabile per il bestiame. Niente altro ha da fare fino al raccolto, che riesce fenomenalmente abbondante, se per eccezione la stagione non corre o troppo asciutta o troppo piovosa. Terminato il raccolto, il brasiliano abbandona la roça, che senza altro lavoro non produrrebbe bene il secondo anno, e va ad attaccare il bosco in un altro punto; il colono europeo, invece, dopo avere roçato il suo lotto di 126 127 Il testo scritto dal ROSSI e citato da GOSI è stato pubblicato sull’edizione livornese del 1891 del libro Un comune socialsta. Tubercolo con vari usi: da mangiarsi appena cotto oppure cotto e poi fritto come contorno alla carne. Dalla sua trasformazione industriale o artigianale si estraggono la farina di manioca – usata nei pasti in sostituzione al riso, soprattutto nel nord est – il pulviglio – usato nella produzione di biscotti – la farina di tapioca – usata nel nord est per un tipo di “crespelle” in sostituzione al pane, normalmente mangiato a colazione. 146 bosco, lo coltiva con la zappa e con l’aratro, secondo i metodi, più o meno razionali, della nostra agricoltura popolare” (ROSSI, 1891:123). Oltre a sottolineare la differenza di pratica agricola – e conseguentemente di uso del suolo e di rapporto con il territorio – Rossi si dedica all’esposizione di informazioni dettagliate sulla fertilità e la composizione del terreno; tipi, metodi ed epoche di piantagioni a seconda del prodotto; intervallo tra la semina e il raccolto; capacità di produzione per ettaro, ecc. Tratta anche dei prodotti preferibilmente coltivati a seconda della nazionalità dei coloni, informando che i russi, i tedeschi e i polacchi coltivavano la segale e il riso, mentre gli italiani il mais bianco, i fagioli e l’uva Isabel (per la produzione del vino), oltre ai primi tentativi di coltivazione del grano. Infine, informa che il periodo migliore per cominciare a preparare il terreno era agosto, per seminare novembre e per la raccolta aprile. Tratta infine dell’allevamento del bestiame di razze diverse – lasciato pascolare liberamente ovunque – della sua commercializzazione e di un’industrializzazione ancora incipiente, sottolineando positivamente l’inesistenza di malattie epidemiche tra gli animali. Nel suo racconto, si nota una certa perplessità davanti al «modo primitivo ma estremamente economico» con cui si creava la ricchezza locale. Tornando alla Colonia Cecilia, una volta scelti i lotti e adottata come abitazione provvisoria una piccola casa di legno che vi trovarono deserta, Rossi e Benedetti furono raggiunti dal resto del gruppo. L’utopia muoveva così i suoi primi passi nel cammino della sua realizzazione: nasceva, in quel momento, la Colonia Cecilia, senza programmi né piani di organizzazione previamente stabiliti: gli anarchici avrebbero cercato, sperimentalmente, una forma di convivenza sociale che più corrispondesse alle loro aspirazioni di giustizia e libertà. “Erano i primi di Aprile 1890. Il lavoro al quale tosto si accinsero i pionieri, fu di pulire la loro nuova dimora, e prepararvi un giaciglio di verdi felci, sulle quali dormirono, imperfettamente coperti dai loro mantelli. L’indomani, e nei giorni successivi, accomodarono un po’ meno peggio i loro giacigli di legna ed erbe secche, improvvisarono un focolare, pulirono intorno alla casetta, determinarono le più vicine sorgenti d’acqua e fecero qualche colpo di fucile per i loro pasti frugalissimi. In seguito, e cioè nei primi sei mesi di dimora, fu provvista di un poco di mobilio la casa, e fu una grande soddisfazione quando potemmo farci delle brande, dei pagliericci, delle piccole e sempre insufficienti coperte. Si stabilì un orticello; si ripararono e si ingrandirono gli steccati di difesa contro il bestiame vagante; si impiantò una vigna a fossati, seminando fagiuoli e patate negli interfilari; si preparò del legname per costruire un’altra casa; si fabbricò 147 la cucina; si vangò del terreno per piantarvi la mandioca; si fece un piccolo giardinetto davanti alla casa” (ROSSI (Cardias), 1993:23/24). E così, tra le spese di mantenimento e l’acquisto degli strumenti agricoli necessari a portare avanti i lavori, presto finì il piccolo capitale portato dall’Italia. Il lavoro da eseguire era tanto, soprattutto perché la maggior parte dei pionieri non era abituata a quel tipo di attività. Non si dettero un’organizzazione sociale, regolamenti, né capi. Spesso si accordavano sul lavoro da svolgere e, talvolta, alcuni decidevano da soli di che occuparsi. Le decisioni più importanti venivano ampiamente discusse e votate, e le assemblee erano lo spazio per questo scambio di opinioni. Rossi rammenta che non mancarono le dispute tra i membri, ma niente che portasse a qualcosa di serio. Verso la fine di ottobre 1890 i coloni ritennero che qualcuno doveva tornare in Italia per raccontare personalmente come andavano le cose a Cecilia. Rossi fu quello scelto e, partendo dal Porto di Paranaguà il 24 ottobre, sbarcò a Genova il 25 novembre. Dopo un giro di propaganda a Pisa, Cecina, Livorno, La Spezia, Torino, Milano e Brescia, numerose furono le persone che si offrirono di raggiungere la colonia. Dal febbraio al maggio numerosi gruppi si susseguirono, elevando il numero di integranti a 150 nel giugno 1891. Secondo GOSI, la campagna propagandistica aveva avuto successo e, oltre ai coloni, Cecilia ricevette libri e giornali raccolti da Turati e Bissolati, aiuti e sovvenzioni da parte del Museo Civico di Genova, dell’Orto Botanico di Pisa e della Fratellanza Artigiana di Firenze. Anche la stampa italiana seguì con attenzione l’esperimento anarchico, riportando notizie – non sempre vere – sulla colonia e sugli emigranti. Non mancarono anche le contrarietà e i dissensi in sede burocratica, tanto da obbligare Rossi a scrivere una lettera ad Andrea Costa pregandolo di inviare una circolare a tutte le prefetture dell’Italia Settentrionale e Centrale chiedendo ai prefetti di non opporre difficoltà agli emigranti che vi si presentassero con una sua lettera. Ma tali difficoltà non impedirono a Rossi di raggiungere il suo obiettivo. Egli colse anche l’occasione del suo soggiorno in Italia per preparare la quinta edizione del suo libro, nel quale incluse un capitolo sulla Colonia Cecilia, in un testo nitidamente propagandistico. Ma nonostante il successo della propaganda svolta e il numero sempre in crescita di candidati decisi a partecipare all’esperimento – o forse proprio per questo – non mancarono le polemiche con gli anarchici rispetto alla pertinenza o meno di considerare il socialismo sperimentale come parte integrante dell’anarchismo. La discussione più seria fu quella tenuta con Malatesta, legata alla questione legalitaria e alla scissione che essa causò nel movimento anarchico. 148 Malatesta era sostenitore della corrente dell’antilegalitarismo e aveva come preoccupazione centrale quella di svegliare il rivoluzionario che si trovava addormentato tra i socialisti per provocare l’insurrezione che, dal punto di vista degli anarchici, era sempre latente. Con tale finalità, pensava di organizzare un “partito” senza gerarchia, senza rigidità formale e, soprattutto, senza partecipare alle elezioni. Con l’obiettivo di ampliare le discussioni, l’anarchico convocò il Congresso Socialista Rivoluzionario Italiano, tenuto nel gennaio 1891 a Capolago. Anche Rossi vi partecipò, cogliendo l’occasione per fare propaganda alla Cecilia, invitando le persone a unirsi all’esperimento. Questo fatto dispiacque profondamente a Malatesta, che fece critiche severe al comportamento di Rossi, in una lettera pubblicata nel marzo 1891 sul giornale «La Rivendicazione» di Forlì. “La lettera [era] dura nella critica a ciò che chiama[va] «Colonia Rossi». Inoltre, [era] decisa non solo in relazione alle colonie, ma [era] contro l’emigrazione in generale. Per lui l’emigrazione rappresenta[va] un’ancora di salvezza che distanzia[va] l’emigrante dalla rivoluzione, una volta che ritira[va] il dominato dal luogo della dominazione e della latente insurrezione e, in più, non risolve[va] la ragione dell’emigrare” (MÜELLER, 1989:265/266). La principale preoccupazione di Malatesta era che i coloni venissero ad appassionarsi all’esperienza, trasformandola in un fine in sé, tralasciando il suo carattere di “laboratorio”. MÜELLER informa che Rossi rispose alla lettera di Malatesta soltanto nel 1893, nel suo libro Cecilia, Comunità anarchica sperimentale. Un episodio d’amore nella Colonia «Cecilia», dove un’altra volta riaffermò la libertà di scelta dei mezzi per arrivare al fine, questo sì unico: la rivoluzione sociale. L’autrice richiama l’attenzione sul fatto che Rossi aveva mantenuto viva la funzione utopica della sua colonia sperimentale, dal momento in cui non aveva “mai obbedito a un piano più elaborato o senza dubbio più ambizioso che non quello della ricerca costante della libertà. (…) Il quotidiano esige[va] piani perché la sopravvivenza [fosse] garantita: la coltivazione, la costruzione di piccole case e la preparazione dell’arrivo di nuovi compagni sarà la preoccupazione immediata dei pionieri. Chi saranno questi nuovi compagni non si sa[peva]. Non si ammett[eva]no regole o criteri per la loro accettazione” (MÜELLER, 1989: 272/273). Questo è, senza dubbio, un punto che merita di essere sottolineato. Dopo che Rossi era tornato in Italia, molte furono le persone che si candidarono a emigrare nella Colonia, al punto che, nel 1891, essa contava, com’è stato detto, più di centocinquanta membri. Questa crescita rapida fu, secondo Rossi stesso, disastrosa. Dal momento in cui la ricerca della libertà era l’unico piano stabilito, non si poteva impedire che le persone entrassero. E molti di quelli che si destinarono alla Cecilia non avevano niente in comune col progetto 149 di Rossi. Per questi, essa era soltanto una possibilità di diventare proprietari di terre, o soltanto di uscire dall’Italia. Alcuni vi arrivarono casualmente, altri non erano adatti alla rude vita dei pionieri. I mezzi di esistenza erano di gran lunga insufficienti per tutti: mancavano alimenti e la maggior parte di loro doveva alloggiare ammucchiata nel baraccone. Infine, la vita comune, il lavoro comunitario, la divisione del frutto del lavoro tra tutti era, per molti dei membri, inaccettabile. “Si fecero palesi però gli egoismi di famiglia, e la parentela spesso mangiava mentre gli altri digiunavano” (ROSSI (Cardias), 1993:25). Rossi rientrò in Brasile nel luglio 1891128. In quel periodo una “squadra numerosissima lavorò sempre alle strade dove fortunatamente (…) il lavoro richiesto era più apparente che reale. Altri terminarono la costruzione del baraccamento, ingrandirono l’orto della comunità, fecero un piazzale davanti all’abitazione, iniziarono la fabbricazione dei mattoni e costruirono una lunga paracinta per chiudervi il bestiame comprato dalla comunità. Come organizzazione, questo periodo fu caratterizzato da un grottesco sistema di referendum, per cui la popolazione perdeva molto tempo in assemblee oziose, dalle quali non emergevano commissioni, si votavano regolamenti, si parlamentarizzava fino a incretinire. La colonia, in quel tempo, non ebbe la coscienza anarchica che poteva salvarla, e dové morire” (ROSSI (Cardias), 1993:26). Questa situazione non tardò a cambiare. Quelli che non si adattavano alla realtà della Cecilia e che volevano ricostruire in Brasile la vita che avevano in Italia presto cominciarono a voler “organizzare” la colonia e a esercitare “funzioni di comando”. Lo scontro tra i due gruppi fu inevitabile, provocando un aumento del numero delle assemblee, senza che si riuscisse ad arrivare a un consenso. Verso la “metà di Giugno del 128 Nonostante la sua assenza, Rossi si mantenne informato su ciò che lì accadeva. Nel suo libro, informa che verso la fine del 1890 i coloni avevano atterrato un tratto di bosco per mettere il terreno a coltura e costruito una paracinta destinata a proteggere la piantagione di granturco dell’invasione del bestiame. Quest’ultima, però, non fu sufficiente per trattenerlo e, nei primi del 1891, esso vi riuscì a entrare, distruggendola. Nel gennaio 1891 arrivarono alcune famiglie di contadini che non andarono d’accordo con i pionieri, ma ciò nonostante i lavori agricoli continuarono. Alcuni coloni si diedero alla costruzione di un baraccone d’alloggio usato come abitazione comune per i nuovi arrivati, spazio di riunioni, di pasti collettivi e di abitazione per i celibi. Altri invece lavorarono nelle strade comunali del governo, a profitto della comunità. Dal marzo fino al maggio 1891 la colonia ricevette numerosi arrivi, raggiungendo più di 150 integranti. DE MELLO NETO, inoltre, informa che in un articolo pubblicato come supplemento letterario sulla rivista «La Révolte» di Parigi della settimana 01-07 ottobre 1892, CAPPELLARO informa che nel maggio 1891 la colonia aveva ricevuto dal governo brasiliano la somma di 2.884 franchi, sussidio destinato a titolo di aiuto a tutti gli immigranti stabilitisi nella regione durante il suo primo anno. Infine, l’autore cita anche una lettera scritta dal Rossi alla sua famiglia dove, oltre a smentire le accuse che responsabilizzavano la miseria come causa delle diserzioni nella Cecilia, menzionava un altro sussidio di L. 1.100, sempre dal governo, ma di cui la colonia non poté usufruire perché non rispettò l’esigenza che fosse costruita una piccola casa in legno per ogni singola famiglia, fatto che l’anarchico attribuiva alla pigrizia e alla distorsione culturale dei coloni. 150 1891 le sette famiglie stabilite per prime dichiararono di ritirarsi, sotto il pretesto di ricostituire la colonia con migliori elementi, e s’impossessarono del capitale sociale, che poi divisero tra loro” (ROSSI (Cardias), 1993:26). Un gruppo di giovani si organizzò per continuare l’esperienza, mentre il resto della popolazione ritornava alla vita individuale, abbandonando poco a poco la comunità129. Tra quelli che restarono, nonostante le defezioni, risorgeva lo spirito anarchico. La determinazione dei giovani a far prosperare l’esperienza e la volontà con cui si dedicarono alle attività fecero sì che quattro famiglie che prima avevano abbandonato la colonia chiedessero di essere riassunte nel loro gruppo, essendo accettate. “Per [ri]cominciare, [era] necessario produrre per soddisfare le necessità di base. Molto lavoro e molte difficoltà: questo [era] il quotidiano dei coloni. Come alternativa a completamento del lavoro nella colonia (…) alcuni coloni s’alternavano nel lavoro delle strade che lo Stato costruiva. Secondo Rossi, l’organizzazione di Cecilia si propone di essere comunista ma anche e principalmente anarchica. Tra i coloni esiste[va] un’estrema attenzione perché nessuno prevalesse sugli altri, perché non si stabilis[se] nessuna forma di rappresentazione o delega di diritti: tutti e ognuno rappresenta[va]no la colonia, tanto all’«esterno» (…) quanto tra di loro. La gerarchia [era] rifiutata” (MÜELLER, 1989: 275/276). In reazione allo sterile e dannoso formalismo del periodo appena passato, il nuovo gruppo decise di essere assolutamente non organizzato, non accettando nessun tipo di patto. “Nessun regolamento, nessun orario, nessuna carica sociale, nessuna delegazione di poteri, nessuna norma fissa di vita o di lavoro. La voce di uno qualunque dava la sveglia agli altri; le necessità tecniche del lavoro, palesi a tutti, ci chiamavano all’opera, ora divisi, ora uniti; l’appetito ci chiamava ai pasti, il sonno al riposo. Eppure si condu[ss]e un’esistenza traboccante di vitalità, fremente di nervosismo. Il celibato forzoso, la gravità della situazione, la risoluta volontà di riuscire in una impresa divenuta tanto difficile, l’azione irritante delle difficoltà stesse ci avevano reso mezzo spiritati. La nostra vita era piena di allegria clamorosa e di un sistematico spirito di contraddizione che, sul lavoro, ci faceva perdere molto tempo in discussioni interminabili e la sera dava alle nostre riunioni il carattere di club rivoluzionario, per cui il rumore delle nostre ordinarie 129 Secondo Rossi, le cause dell’abbandono erano molte: dalle famiglie che si ritirarono portando via il bestiame della comunità, al giovane che l’abbandona per seguire la donna amata; dal ladro spagnolo che fuggì svuotando la cassa comune, al marito che se ne andò per paura che gli conquistassero la moglie; dalla difficoltà di abituarsi ai lavori faticosi della campagna, alla difficoltà di abituarsi all’insufficienza nutritiva degli alimenti; dalla delusione davanti alla miseria in cui si trovarono alla volontà di riprendere vecchie abitudini, tante e diverse tra loro furono le ragioni dell’abbandono. Ma egli insiste nel sottolineare che nessuno l’ha mai abbandonata per avversione ai principi economici e politici fondamentali sui quali si posava; per la tendenza al possesso individuale della terra, si erano separati soltanto alcuni contadini. 151 conversazioni si sentiva da un chilometro di distanza dalla chiusa casetta” (ROSSI (Cardias), 1993:27/28). Entusiasmato dal lavoro di riorganizzazione della colonia su basi veramente anarchiche, Rossi scrisse alla sua famiglia nel secondo semestre del 1891 chiedendo l’invio di semi e piantine per poter aumentare e diversificare la produzione della Cecilia. La richiesta era specifica: ciliegi giganti, noci, castagni comuni e speciali, pesche di rapida maturazione, ulivi, arachidi, viti. L’anarchico, così, oltre che introdurre colture che avrebbero cambiato il paesaggio locale, contribuiva anche alla diversificazione/miglioramento delle abitudini alimentare brasiliane. Nel novembre del 1891, Cecilia ricevette nuove famiglie di contadini arrivati in due gruppi diversi. Il primo, attratto dall’aspettativa di diventare piccoli proprietari, si trattenne pochi giorni. Il secondo, invece, decise di rimanere e diede un grande impulso ai lavori agricoli. I coloni si divisero tra le diverse coltivazioni, la costruzione di un grande riparo alle seminagioni, di un forno e di un pozzo, oltre il lavoro sulle strade coloniali, quest’ultimo ai fini di assicurare il mantenimento della comunità nell’attesa dei nuovi raccolti. Nel 1892, pur contando su pochi integranti130, la colonia prosperò come mai prima. Nell’aprile “si raccolsero i fagiuoli e fu aperta una strada carreggiabile nei fianchi della collina occupata dalla coltivazione del granoturco. In Maggio si raccolse questo prodotto, che i compagni più robusti caricavano in ceste sulle spalle, ascendendo faticosamente le pendici fin alla strada rotabile, d’onde si trasportava col carro. In questo mese, si scavò un altro pozzo nella pietra viva. In Giugno e Luglio si zappò molto terreno ove fu seminata la segale, furono ancora piantati un centinaio d’aranci ed altri alberi fruttiferi. In Novembre piantammo vigna, mandioca e patate. In Dicembre incendiammo il bosco atterrato; si fece una estesa seminagione di granturco e di fagiuoli; si raccolse la segale. Sulla fine del 1892 arrivarono altre famiglie. Si stabilì allora la calzoleria e si iniziò la fabbricazione dei barili da imballaggio che vendono nella vicina Palmeira” (ROSSI (Cardias), 1993:28/29). Cecilia prosperò e, nel 130 GOSI, basandosi su una lettera anonima pubblicata dal giornale «La Révolte» di Parigi il 17.7.1892, informa che in quell’epoca la colonia contava 39 integranti di cui “20 uomini, 9 donne e 10 bambini per i quali era già stata costruita una scuola” (GOSI, 1977:71/72). Ma la situazione cambiò rapidamente. Poco tempo dopo, quelli che si occupavano del reclutamento per la colonia dovettero mettere un limite alle adesioni, passando a sollecitare persone con delle abilità specifiche: calzolai, agricoltori e uomini capaci di svolgere lavori faticosi. Inoltre, veniva fatta espressa richiesta che gli uomini partissero accompagnati di compagne, allo stesso tempo in cui si incentivava l’adesione femminile, cercando così di diminuire la differenza esistente tra uomini e donne. 152 dicembre 1892, chiuse il suo bilancio con un attivo netto di poco più di 7 milioni di reis, pari a 9.360 franchi131. “Dall’inventario generale risultava che Cecilia era composta a quell’epoca di 64 abitanti e disponeva di una farmacia, una scuola, una biblioteca. La colonia, in questa sua seconda fase, si era dunque notevolmente ingrandita, pur avendo attraversato un momento di impopolarità che le aveva fatto perdere molto «dell’antica stima e simpatia di cui godeva»; motivo di ciò erano stati alcuni furti e delitti commessi a Curytiba e nello stato del Paranà da ex-abitanti della colonia, in seguito ai quali, infatti, i responsabili erano stati arrestati. Inoltre, poiché alcuni anarchici avevano preso parte ad una tumultuosa manifestazione di coloni nella vicina Palmeira, si era diffusa la notizia che gli abitanti della Cecilia fossero dei continui provocatori di disordine, tanto che lo stesso governo italiano aveva raccomandato al governatore del Paranà di porre sotto sorveglianza la colonia” (GOSI, 1977:73). Nel 1893 i lavori continuarono a pieno ritmo: sì costruì un altro steccato per chiudere il bestiame al pascolo durante il giorno; si eseguirono delle sarchiature, delle piantagioni di igname e l’ingrandimento dell’orto; si raccolse fieno, patate, fagioli e tabacco132; si costruì il laboratorio per i bottai; si procedette alle riparazioni dei carri e alla correzione di una strada. Tutto questo senza disciplina né organizzazione del lavoro. E lo stesso valeva anche per la produzione industriale, di cui Rossi cita l’esempio dei barili da imballaggio che poi venivano venduti a Palmeira, descrivendo tutta la fase di produzione, dalla scelta e taglio del legname fino al trasporto dei barili in paese, tutto tramite il metodo anarchico, dove ciascuno partecipava alle diverse fase della produzione secondo le proprie abilità e possibilità. E conclude la sua descrizione con la seguente domanda: “Qual è la forza che fa muovere così armonicamente tutti gli elementi della produzione? È il buon senso, che conosce i bisogni e il modo di soddisfarli; in grado minore è la paura della critica, che certamente colpirebbe i restii al lavoro” (ROSSI (Cardias), 1993:32). Riguardo alle abitazioni, il villaggio chiamato da loro Anarchia era costituito da una ventina di piccole case in legno133, costruite lungo una strada e attorno a un piazzale. In una lettera indirizzata e pubblicata sul giornale «La Révolte», CAPPELLARO informa che la colonia aveva un’area totale di 200 ettari, 28 dei quali coltivati come segue: 15 con mais bianco, 6 con patate, 4 con fagioli, 3 con orto. Tutto il resto era occupato dal pascolo e foresta. Il bestiame era composto da 4 buoi, 2 mucche, 2 cavalli e 14 maiali. Inoltre, c’erano anche 50 galline. 132 DE MELLO NETO cita un’altra lettera di Rossi ai suoi fratelli, chiedendo che gli inviassero semi di pomodori, castagni, mandorle, zucche, albicocche, funghi, ciliegi, fichi e lenticchie, raccomandando vivamente di provvedere alla disinfestazione con una soluzione a base si solfato di rame. Nella stessa lettera, egli racconta dei progressi raggiunti dalla Cecilia, descrivendo il bel frutteto, composto da 50 alberi di arance a buona crescita, 150 piantine di more, 60 noci, 500 peschi, peri, meli e il vigneto con 15 mila viti. Dichiara inoltre di nutrire la speranza di vincere il primo posto in produttività tra le colonie. 133 Ogni casa aveva sei metri di fronte, quattro di fondo e tre di altezza. Alcune avevano il pavimento di tavole, altre appena di terra battuta. 131 153 L’arredamento di queste case consisteva in letti più o meno soffici, coperte e, in alcuni casi, un piccolo tavolo, panche e sgabelli. I vestiti erano ancora quelli portati dall’Italia, ormai pieni di rappezzature. Anche la biancheria era insufficiente. Soltanto le scarpe avevano una condizione migliore dovuta al lavoro dei calzolai della colonia. La giornata lavorativa cominciava verso il sorgere del sole, un po’ prima o un po’ dopo, a seconda delle persone e del lavoro da svolgere134. “Dopo un’ora o due di lavoro mattutino, alla spicciolata, a gruppi, tutti forniti di ottimo appetito, accorriamo al refettorio, ove si prende caffè e latte – un po’ lungo ma abbondante – con polenta arrostita e con pane di segale. Torniamo al lavoro [e] verso il mezzogiorno (…) [un’]altra visita al refettorio per il minestrone – anche questo poco saporito ma abbondante – e poi ci prendiamo un paio d’ore di riposo, tanto da fare il chilo e da fumare una sigaretta. Torniamo poi al lavoro fino al tramontare del sole, e la nostra cena consiste in polenta e insalata, con legumi, e qualche rara volta con ragù di pollastro o di carne suina” (ROSSI (Cardias), 1993:32/33). Gli alcolici non erano ammessi all’interno della colonia, sia per mancanza di soldi sia perché essi turbavano il cervello e la pace sociale. La vita intellettuale della colonia era limitata alle “conversazioni durante il lavoro e durante i pasti, le riunioni serali, la lettura di giornali socialisti e politici o di qualche libro, la scuola per i bambini aperta un po’ saltuariamente” (ROSSI (Cardias), 1993:33). Assorbiti dal lavoro produttivo, non gli fu possibile provvedere ad altro, come istruzione per gli adulti, musica, teatro, balli e passatempi di varie specie che tanto desideravano. Neppure all’ornamentazione del villaggio avevano potuto provvedere. Riguardo alla vita morale, Rossi informa che per liberare tutti dai pregiudizi e dalle storture morali acquisiti dalla società borghese ci sarebbe ancora voluto tanto tempo. “Non siamo mostri di perversità (…) neppure angeli di mansuetudine. (…) Di quando in quando un lamento, un rimprovero, un’accusa; delle simpatie e delle antipatie, delle tendenze a parteggiare” (ROSSI (Cardias), 1993:33/34). La causa di questi malumori, riteneva Rossi, stava nella miseria e nelle privazioni da cui passavano ma, forse soprattutto, nelle abitudini contratte in una società affatto opposta alla loro, e nella vita di famiglia, per lui la genitrice più feconda di egoismi e di rivalità e una delle cause più importanti del non completo successo in senso anarchico della Cecilia. Era talmente convinto di questo che riteneva che il suo ideale si sarebbe potuto svolgere integralmente soltanto quando, a una radicale trasformazione dei rapporti economici – già avvenuta in Cecilia – si fosse accompagnata una profonda evoluzione dell’istituzione familiare. 134 Nei periodi di intenso lavoro, il membro più mattiniero era incaricato di svegliare gli altri. 154 Eppure qualche cambiamento c’era già stato. Rossi riteneva che la vita morale da loro condotta era superiore a quella del mondo borghese. La consapevolezza di essere liberi ed eguali aveva impresso al loro carattere una maggiore franchezza, la vita in comune aveva insegnato ad abituarsi alle debolezze proprie e altrui, mentre la solidarietà degli interessi aveva condotto all’applicazione pratica del concetto di libertà e a un maggior rispetto nelle relazioni interpersonali. Una volta fatte queste considerazioni, Rossi passa a rispondere alle polemiche innescate dal suo esperimento. Il punto centrale del suo discorso gira in torno alla questione degli obiettivi e dei risultati raggiunti fino a quel punto dalla Cecilia, secondo lui, erroneamente interpretati dai critici. Tutti quelli che all’epoca l’avevano studiata e criticata si basavano su obiettivi che in nessun momento erano stati quelli di tutti coloro che si erano dedicati all’esperimento. Secondo Rossi, il loro obiettivo non fu né produrre lo specimen della società futura per poi brevettarlo e offrirlo all’indomani della rivoluzione sociale; né mostrare le magnificenze dell’avvenire sociale; neppure tentare la miniatura della nuova società: “il nostro proposito non è stato la sperimentazione utopistica di un ideale, ma lo studio sperimentale – e per quanto ci fosse possibile rigorosamente scientifico – delle attitudini umane in relazione a quei problemi” (ROSSI (Cardias), 1993:36). Inoltre, l’anarchico riteneva non essere vera la critica a loro rivolta che ciò che accade in piccolo non accade in grande e viceversa. Per essere valido l’esperimento, secondo lui, basterebbe farlo su un unico uomo, e loro lo hanno esteso a circa trecento persone di diverse appartenenze sociali, grado d’istruzione, qualità morali, attitudine tecniche al lavoro, abitudini di vita, ecc. che, per un periodo più o meno lungo, soggiornarono in Cecilia. “Tutte queste persone hanno vissuto all’infuori dello stimolo proprio alla società borghese, che è l’interesse esclusivamente personale. Infatti la proprietà della Cecilia è comune, ed ogni minima tendenza a dividerla un giorno è vivamente combattuta tanto che nessuno può nutrirne seria speranza. I prodotti dell’attività collettiva non sono mai stati attribuiti secondo la capacità produttiva dei singoli individui, ma secondo i bisogni generali; degli alimenti più grossolani ma più abbondanti ciascuno ne ha preso a sazietà; degli alimenti più saporiti e più scarsi si è fatto il razionamento in parti eguali; i cibi e le bevande più delicate sono stati forniti ai malati, in proporzione dei mezzi che ha avuto la comunità. La cassa sociale è sempre stata aperta a tutti, ed uno solo ne ha abusato, saccheggiandola. Finalmente tutti sappiamo che, uscendo dalla comunità, non possiamo reclamare parte alcuna della sua ricchezza. 155 Resulta evidente per ciò, che la produzione alla Cecilia non ha avuto altro stimolo all’infuori del desiderio di acquistare il benessere collettivo nel quale il nostro benessere particolare è compreso. L’attività produttiva si è quindi svolta malgrado e contro gli egoismi ristretti, e specialmente contro l’egoismo domestico, che ogni utilità vorrebbe far convergere nel senso della famiglia, e dalla famiglia vorrebbe respingere ogni equa parte di sacrifici e di privazioni. Eppure senza il sussidio dei moderni strumenti di produzione, senza altro stimolo che il buonsenso, malgrado la incapacità generale, sono stati eseguiti lavori di ogni specie” (ROSSI (Cardias), 1993:37/38). Lavori faticosi, pericolosi, intellettuali, industriali, domestici, di utilità immediata o a lunga scadenza sono stati svolti con successo in Cecilia, in gruppi sotto il controllo reciproco, oppure da soli e senza nessun controllo. Gli abitanti della comunità hanno vissuto senza leggi né regole, nella più completa libertà. “Non leggi, né regolamenti, né statuti, né liberi patti, non supremazia di maggioranze, né comizi popolari, né organi di governo o di amministrazione; tutt’al più influenze, energicamente contrastate, di parentado e di capacità. All’infuori di questo, libera iniziativa personale, accordo volontario, azione equivalente del criticismo e della tolleranza. In tali condizioni, ciascuno si abitua a salvaguardare facilmente il suo diritto, senza doverlo far dipendere dalla benevolenza altrui. E questo è l’essenziale” (ROSSI (Cardias), 1993:39). Rossi sottolinea anche il fatto che in Cecilia non sia mai successo un atto di violenza. Riguardo alla vita morale, egli riteneva che essa non si trovava ancora in rapporto con il suo ordinamento economico e politico, sia per il poco tempo trascorso perché si potessero sviluppare e consolidare le facoltà morali correlative al nuovo ordinamento sociale, sia per l’azione micidiale della miseria e delle privazioni che obbligava i coloni alla schiavitù del lavoro giornaliero senza permettere la libertà di scegliere le cose che concorrevano a costituire il benessere individuale. Questo stato di cose, secondo lui, non poteva fare a meno di inasprire e irritare le persone e più ancora le famiglie. Quando Rossi fece questi ragionamenti la Cecilia aveva tre anni ed esisteva ancora e, secondo lui, aveva già raggiunto il suo obiettivo. Infatti, egli afferma che tutti coloro che avevano partecipato più a lungo dell’esperimento erano ormai convinti della praticabilità del comunismo e dell’anarchia in tutta la vecchia società, e riteneva che, dinanzi le difficoltà estrinseche dalle quali l’esperimento era circondato, non c’era più bisogno di continuare. L’anarchico era sicuro che, per quelli che chiamava “il popolino intellettuale”, la fine della colonia avrebbe significato il fallimento dell’esperimento. Ma era altrettanto 156 sicuro che gli uomini intelligenti e di buona fede avrebbero invece capito la validità della loro realizzazione. “L’umanità d’oggi (…) può vivere in comunismo e in anarchia se, all’indomani della rivoluzione sociale, una minoranza intelligente ed operosa darà buone iniziative in tutti i rami della produzione. La nuova vita sociale non sarà, sul principio, che un semplice rapporto di interessi ed una reciproca difesa di diritti. Oggi la bontà è una piccola frazione della psiche umana, e non bisogna contarci sopra gran cosa. È falsa la propaganda che tende a mostrare il nuovo mondo sociale puro da ogni attrito maligno. Non seminiamo illusioni, se non vogliamo raccogliere disinganni” (ROSSI (Cardias), 1993:41). Rossi conclude questa parte del suo libro domandandosi cosa potrà accadere alla Cecilia. La prima risposta che offre al lettore è che essa finirà. Domandandosi la ragione, sottolinea la possibilità che l’egoismo di famiglia si sarebbe sviluppato in modo tale a rendere sempre più difficile la convivenza, portando alla fine dell’esperienza oppure alla sua trasformazione in una semplice cooperativa. Ma anche se egli identificò nell’azione della famiglia uno dei problemi più gravi vissuti all’interno della colonia, al punto di poterne causare la fine, credeva che in una realizzazione su scala più ampia, tale azione non avrebbe avuto la stessa importanza135. I fatti mostrarono che lui ormai aveva intuito che cosa stesse per accadere. In un ambiente di povertà, lo spazio della libertà restava compromesso. Davanti alla fame e alla miseria, l’egoismo s’esprimeva in ogni famiglia che cercava il refettorio durante la notte per prendere alimenti per sé stessa. Dall’appropriazione del prodotto collettivo alla difesa della proprietà individuale la distanza era molto piccola. Gradualmente la colonia fu minata. Gli unici che ancora formavano la “vera comunità” erano i celibi, mangiando collettivamente e abitando nel baraccone. Inoltre, un altro problema sorse e diventò ogni volta più acuto: il conflitto tra gli antichi membri di origine contadina e quelli di origine non contadina, che finì con l’imporsi dei primi sugli ultimi. Un’altra volta ci fu l’aumento delle assemblee, senza che ci fosse possibilità di un consenso. La tensione tra i due gruppi portò alla crisi finale e allo scioglimento della Cecilia nel aprile 1894. Anche con la fine della colonia, Rossi non ammise il suo fallimento. Secondo lui, com’è stato detto, l’importante fu ciò che essa riuscì a provare in quanto durò. È in ciò 135 Tra le altre possibilità, Rossi indica che la fine della Cecilia potrebbe essere risultato dell’azione del governo brasiliano oppure di quell’italiano, o ancora che essa non finisse, riuscendo a superare tutte le difficoltà e gli ostacoli che li fossero apparsi. 157 che stava il successo dell’esperienza. Da un punto di vista scientifico, Cecilia aveva provato l’idea organica dell’anarchia. Da un punto di vista della propaganda, aveva svolto un ruolo non indifferente nel movimento socialista soprattutto come diffusore delle sue problematiche tramite la stampa italiana e straniera. Inoltre, il “fallimento della colonia non rappresenta[va], necessariamente, il fallimento del progetto di Rossi. Un’utopia, nella misura in cui è l’espressione articolata del desiderio, non è compatibile con la nozione di fallimento: la sua realizzazione non sta nella continuità, nella longevità del progetto quando e se vissuto. Ciò che realmente importa è che la pulsione del desiderio di costruire un’altra società si mantenga viva” (MÜELLER, 1989: 279). Due anni dopo la fine della Cecilia, in una lettera all’editore Sanftleben, Rossi parlò delle cause dello scioglimento, sottolineando che nessuna di queste aveva compromesso l’ideale del comunismo o quello dell’anarchia. Cecilia, secondo lui, “non era caduta per il fatto di essere comunista o tantomeno (…) anarchica. Era caduta perché era povera; ed era povera «perché partì povera; ed era povera perché partì con mezzi estremamente miseri, con gente inadatta ai lavori agricoli, perché sola in un mondo che le era economicamente estraneo»136. L’entusiasmo iniziale – spiegava – non poteva durare sempre e andò infatti raffreddandosi anche tra gli abitanti della colonia che, pur godendo della più grande libertà nei rapporti interni, mancavano del benché minimo benessere materiale. Il nostro piccolo mondo anarchico era troppo piccolo e quindi povero per assicurarci il pane bianco, la bottiglia di vino, il posto a teatro, il letto soffice, la compagna da amare; contrariamente alla retorica dei poeti, abbiamo preferito le rose della schiavitù alle spine della libertà137” (GOSI, 1977:78). Poco tempo dopo, in un’altra lettera scritta sempre a Sanftleben, egli informava che per poter capire lo scioglimento della colonia “bisognava tornare indietro negli anni fino «alla fine del 1891» quando a Cecilia giunse un numeroso gruppo di contadini parmensi con le loro famiglie. Questi compagni, affermava il Rossi, portarono nella comunità anarchica un poderoso aumento di forza-lavoro; tuttavia molti di loro erano egoisti, di quell’egoismo «spilorcio da contadini che sono stati molto sfruttati», costretti per non soccombere a diventare diffidenti «di generazione in generazione». Motivati di tali sentimenti, i nuovi arrivati cominciarono a sottoporre ad un continuo confronto la produttività del proprio lavoro con quella del lavoro altrui; e facilmente trovarono motivo di lagnarsi nella attività svolta da coloro che erano poco esperti in lavori ROSSI (Cardia), G. Utopie und Experiment. Zürich: Verlag A. Sanftleben. 1897 apud GOSI, 1977 p. 78. La lettera è datata “Taquary , Rio Grande do Sul, 10 gennaio 1896”. 137 Idem ibidem. 136 158 agricoli o anche non sufficientemente operosi. Il risultato immediato (…) fu che alcuni contadini preferirono abbandonare subito la collettività, insediandosi come coloni indipendenti su terreno proprio; altri restarono. Dei rimasti i più spronarono implicitamente o esplicitamente i compagni ad una maggiore efficienza. «Di qui nacque il singolare fenomeno che in quella comunità anarchica ognuno sentì su di sé il controllo del compagno, un controllo, sebbene tacito e mascherato, molto più pesante e insopportabile di quello dell’imprenditore di un’officina europea»138. I contadini parmensi, uniti da una specie di identità di interessi, formavano qualcosa di simile a un partito, rafforzato da alcuni coloni più operosi, da altri legati ad essi da un vincolo di amicizia o di parentela recentemente contratta. Questo partito o gruppo entrò in conflitto «coi meno operosi, […] i più incapaci a sostenere il lavoro manuale, i più deboli, con un gruppo di nuovi arrivati e – aggiungeva il Rossi – con me, poiché non consentivo con loro e non provavo alcun desiderio di diventare il “Boulanger” di Cecilia». Anarchia era ormai divenuta una vuota parola ed il soggiorno a Cecilia andava mutando (…). Tuttavia, pur essendo i coloni stanchi della vita materiale condotta, logorati dalla miseria, non più sorretti dal primitivo entusiasmo che aveva consentito loro di reggere tutte le precedenti difficoltà, «ci si vergognava di provocare lo scioglimento su questa base». Venne infine colto il pretesto, banale, che doveva portare alla crisi risolutoria; con il gruppo di contadini parmensi era pure giunta una giovane donna, il cui libero comportamento la portò a stringere numerosi rapporti con molti uomini della colonia, tra cui lo stesso Rossi, e altri sposati. Davanti a ciò, affermava l’anarchico, «i borghesi dell’amore, quelli con la pancia piena, che non credono alla fame, sollevarono una tempesta di indignazione morale» e cominciarono ad abbandonare la colonia. La diaspora era così iniziata. Ciò avvenne nel maggio 1893, «quando Cecilia si era ridotta a cinquanta abitanti». «A questo punto – scriveva il Rossi – io considero finita la storia di Cecilia»” (GOSI, 1977:79/80). Nella colonia entrarono ancora, non contemporaneamente, due altri gruppi. Ma presto apparsero le rivalità e la situazione degenerò al punto di provocare lo scioglimento definitivo nell’aprile 1894. “«L’attivo di Cecilia [concludeva il Rossi] fu venduto a quel gruppo di contadini parmensi che avevano provocato la crisi e fu sufficiente a pagare i debiti nella comunità e le spese del viaggio degli ultimi coloni fino a Curytiba»” (ROSSI apud GOSI, 1977:80). MÜELLER, nell’analizzare i motivi che portarono la colonia alla fine, oltre a considerare quelli già menzionati da Rossi, richiama l’attenzione su altri due. Da un lato, l’isolamento della colonia che, sommato alla mancanza di mezzi materiali, rendeva difficile 138 ROSSI (Cardia), G. op. cit. apud GOSI, 1977 p. 79. La lettera è datata “Escola de Agricultura, Taquary , 6-4-1896”. 159 la convivenza, anche per quelli che possedevano un ideale da portare avanti, soprattutto perché tale ideale presupponeva una vita piacevole. Dall’altro, la grande differenza tra le persone che si dirigevano alla colonia, molte delle quali senza nessuna identificazione col movimento anarchico né col progetto di Rossi. Inoltre, richiama l’attenzione sulla convinzione dell’anarchico nella possibilità di costante cambiamento dell’essere umano. “Per lui, cambiate le condizioni esterne e date le condizioni perché ognuno potesse svilupparsi, l’essere umano gradualmente e naturalmente cambierebbe (…). Quello su cui non contava era la resistenza delle persone al cambiamento” (MÜELLER, 1989: 303). GOSI, inoltre, informa che Sanftleben, l’editore di Utopie und Experiment, cercando di offrire un altro sguardo sulla fine della Cecilia, ottenne da Malatesta e da Hebert, corrispondenti a Curytiba del giornale «Les Temps Nouveaux», altri particolari. Malatesta, in due lettere, una del maggio l’altra dell’agosto 1895, informava che la colonia non esisteva più perché il governo brasiliano, servendosi dal fatto che i coloni avrebbero appoggiato gli insorti contro il presidente Ma. Deodoro da Fonseca, si era riappropriato della terra, obbligando i coloni a disperdersi. Hebert, facendo riferimento a un’intervista fatta a Rossi, conclude che lo scioglimento della colonia si dovette alle troppe difficoltà incontrate, quali le difficoltà d’importare ciò di cui si aveva bisogno, il tempo impiegato e i costi con le autorità doganali e le società di trasporto. Mi piacerebbe, infine, richiamare l’attenzione sul fatto che Rossi, in nessun momento, abbia difeso l’uguaglianza nella colonia. Per lui, questa non esisteva perché gli esseri umani sono, naturalmente, disuguali: quel che esistette, sempre, furono opportunità uguali, perché tutti potessero svilupparsi nelle loro possibilità. Questo è il motivo per cui si privilegiava la libertà. Soltanto godendo di totale libertà l’uomo sarebbe capace di svilupparsi all’interno delle possibilità che gli erano offerte e in questo modo, costruire l’esperienza di vita anarchica. La libertà si manifestava anche in ciò che si riferisce alla distribuzione dei prodotti del lavoro all’interno della Cecilia e all’accesso alla cassa comune: nonostante le difficoltà imposte, tutti avevano la stessa libertà d’accesso alle risorse da essa prodotte, in modo che fossero soddisfatte tutte le necessità individuali. Infine, questa forma di condurre la Colonia avvicina Rossi ancora di più alle idee difese da KROPOTKIN. Garantendo ai membri della colonia, allo stesso tempo, la libertà necessaria perché potessero svilupparsi d’accordo con le loro possibilità e, all’interno dei limiti imposti, le risorse minime per la loro riproduzione, l’anarchico metteva in pratica il motto del comunismo libertario da ciascuno secondo le sue possibilità e a ciascuno secondo le sue necessità. 160 La colonia, nello sciogliersi, gli mostrò un’altra volta, così come era accaduto a Cittadella, che l’utopia – e i cambiamenti che essa porta con sé nella vita di quelli che si dispongono a realizzarla – dovrebbe essere costruita da tutti. Altrimenti, non sopravviverebbe. 7. Dopo Cecilia: il “legato” di Giovanni Rossi Le idee di Rossi sull’organizzazione della produzione agricola sono, secondo me, di grande interesse nell’attualità. L’esperienza della Colonia Cecilia, marcando il coronamento delle idee da lui difese, ci stimolano ad andare oltre, e a cercare le origini del suo pensiero. Questo capitolo ha seguito questa impostazione, seguendo un percorso all’indietro nel tempo, cercando le origini di queste proposte, il suo punto di partenza. Dalla Cecilia a Cittadella; da questa all’appello con richiesta di sottoscrizione a favore della realizzazione di una colonia agricola socialista in Italia; quindi all’elaborazione di un giornale, «Lo Sperimentale», che servisse da diffusore delle idee sperimentaliste, mettendo in discussione i diversi sperimenti di colonie socialiste in tutto il mondo, fino ad arrivare al suo punto di partenza, la sua (u)topia Un comune socialista. Stavano lì le idee che, per tutta la sua vita, egli cercò di realizzare, sia tramite una discussione chiara e scientifica svolta nel suo giornale, sia tramite il progetto della colonia agricola socialista, da svolgersi in Italia, ma che non uscì dalla carta, sia tramite il tentativo di trasformare l’Associazione Agricola di Cittadella di una colonia cooperativa in una colonia socialista, sia, infine, nell’anarchica colonia Cecilia, situata nel sud del Brasile. Un comune socialista parla di un comune convertitosi al socialismo e organizzato liberamente. Il lavoro è organizzato collettivamente e i contadini, liberi di scegliere le attività a cui sono più adatti, sono dopo organizzati tramite associazioni di arti e mestieri, ciascuna delle quali responsabile per la realizzazione delle attività di sua competenza. A tale scopo si organizzano commissioni tecniche che durante la giornata lavorano insieme agli altri e alla fine, si riuniscono per decidere il lavoro da svolgere l’indomani. Inoltre, tutte le decisioni più importanti sono prese in assemblee generali, aperte a tutti. Lavorando insieme e ottimizzando gli sforzi, presto il comune potrà godere delle più moderne innovazioni tecnologiche che renderanno il lavoro più produttivo e meno faticoso e, proprio per questo, più piacevole. Così quello che prima era un obbligo diventerà piacere e il comune passerà dal collettivismo al comunismo. 161 Erano queste le idee che Rossi cercò per tutta la sua via di mettere in pratica: la trasformazione del lavoro e del lavoratore, tramite una maggiore consapevolezza dei suoi diritti, un rapporto più armonico e cosciente con il territorio fino al raggiungimento di quello che per lui era il comunismo e che per noi, nelle dovute proporzioni, si può identificare con la sostenibilità dello sviluppo. A Cittadella Rossi mise in pratica le idee dell’organizzazione della produzione tramite le associazioni di arti e mestieri, quando propose che i contadini si dividessero a seconda delle loro abilità; del lavoro realizzato in modo e per il bene collettivo; delle commissioni tecniche che, riunite alla fine della giornata lavorativa, decidevano sui lavori da svolgere l’indomani – idea presente anche nei falansteri di FOURIER – delle assemblee generali come spazio delle discussioni e garante della partecipazione di tutti nella determinazione dell’avvenire dell’esperimento. Economicamente, com’è stato detto, Cittadella raggiunse presto il successo, ma Rossi non riuscì ad andare oltre. Il tentativo di introdurre una “cellula” socialista all’interno dell’Associazione, affinché l’esempio di vita comunitaria da essa condotta potesse funzionare di stimolo al cambiamento fino a trasformare la colonia cooperativa in una colonia socialista fallì in partenza, spingendolo a cercare un’altra possibilità di mettere la sua (u)topia in pratica. Anche l’appello di sottoscrizione per la formazione di una colonia socialista in Italia non ebbe il successo aspettato, pur contando su un luogo privilegiato di discussione quale era «Lo Sperimentale». Cecilia segnò così l’apice del suo percorso. Un comune socialista e «Lo Sperimentale» offrirono a Rossi gli spunti, le idee da mettere alla prova, mentre Cittadella fu per lui, allo stesso tempo, un’esperienza da non perdere di vista in quanto parametro di cose da ripetere o meno. Fu così che Rossi continuò a dare alle assemblee generali uno dei ruoli centrali nella conduzione della Cecilia; a garantire la libera scelta, nei limiti possibili, delle attività a cui dedicarsi; a organizzare collettivamente la produzione. Fu così anche che decise di evitare a tutti costi ogni tipo di formazione di potere, anche il più piccolo, all’interno della colonia, evitando così le commissioni tecniche di lavoro; di garantire momenti di socializzazione tramite i pasti comuni nel refettorio – e in alcuni momenti, per mancanza di altre alternative, tramite la vita in comune all’interno del baraccone –, di lasciare libero l’accesso alla cassa sociale a tutti i suoi membri; di cercare costantemente la libertà nei rapporti interpersonali. D’altra parte, Cittadella e Cecilia gli confermarono l’idea dell’illimitata possibilità di progresso di una colonia organizzata socialisticamente, idea che tra l’altro era già 162 presente nella sua (u)topia. Organizzando il lavoro in modo collettivo, i contadini ottimizzavano tempo e capitale, essendo poi in grado di introdurre, all’interno della colonia, innovazioni tecnologiche capaci di migliorare la qualità e la produttività non solo della produzione ma anche del lavoro, e che permettevano di usufruire per il proprio consumo e per il mercato di prodotti di qualità superiore a quelli della produzione contadina tradizionale. L’idea, poi, di trasformare la vita della colonia in una vita comunitaria avrebbe solo aumentato le possibilità di successo dell’esperienza. Ma su questo aspetto ritornerò in un altro momento. Ritengo infine che le idee difese da Rossi ed esposte in questo capitolo, al di là del discorso rivoluzionario, siano di grande interesse e attualità, e possono servire di base alla discussione dello sviluppo sostenibile, soprattutto se pensato in una prospettiva globale, ossia, in un approccio territorialista di cui ci parla MAGNAGHI. Dietro al tentativo di provare la possibilità della vita anarchica e la possibilità di una organizzazione socialistica della produzione promosso da Rossi, stava l’idea di offrire ai contadini la libertà del lavoro, migliorare e ottimizzare la loro produzione, permettendo loro di estrarre di più distruggendo di meno, migliorando così non solo la loro qualità della vita ma anche il loro rapporto con il territorio. È in questa prospettiva che cercherò di unire, nei capitoli successivi, gli esperimenti storici alla discussione attuale sullo sviluppo locale autosostenibile. 163 CAPITOLO 5 ALTRE ESPERIENZE DI COLONIE SOCIALISTE In questo capitolo mi occupo di esempi di colonie con un’organizzazione di tipo socialista, come alternativa all’organizzazione della produzione contadina tradizionale. I casi qui studiati, tutti ormai conclusi, servono come esempio di organizzazione della produzione e della distribuzione dei prodotti ottenuti. I dati presenti nei due primi paragrafi di questo capitolo, sono tratti dal giornale «Lo Sperimentale», diretto da Giovanni Rossi e menzionato nel capitolo precedente. Essi, a loro volta, sono stati presi dal libro di Charles NORDHOFF, The Communistic Societies in the United States, from personal visit and observation. 1. Le colonie americane Le colonie americane riportate in questo paragrafo sono “quella degli Shakers, stabilitasi nel 1794 nella parte occidentale degli Stati Uniti, e nel 1808 circa nella parte orientale di questi Stati; quella dei Rappists, stabilitasi nel 1805; degli Zoarites, stabilitasi nel 1817; la comunità di Amana, fondata nel 1844; quella di Bethel, costituitasi lo stesso anno; quella dei Perfezionisti di Oneida stabilitasi nel 1848; quella degli Icariani o Cabetisti, che data dal 1849, e per ultimo quella di Aurora fondata nel 1852”139. Queste otto comunità diverse occupavano, alla fine del 1870, settantadue comuni, cinquantotto dei quali costituiti dagli Shakers, sette dai comunisti di Amana, due dai Perfezionisti, e uno da ciascuna delle altre comunità. Nel totale queste settantadue comunità erano composte da circa cinquemila persone, e avevano una proprietà totale di 150 mila iugeri (equivalente a 375 mila ettari), valutati all’epoca in 60 milioni di lire. A eccezione degli Icariani che erano francesi, e degli Shakers che erano americani, tutti gli altri erano tedeschi. 139 «Lo Sperimentale», n. 1, maggio 1886, p. 2. 164 In genere in queste comunità esisteva una grande varietà di occupazioni. Il principio generale della vita comunistica era la subordinazione delle singole volontà individuali all’interesse e alla volontà generale, in pratica ottenuto con l’obbedienza agli anziani e ai capi. Ma siccome le deliberazioni venivano prese soltanto con il consenso unanime delle assemblee e si cercava di sistemare ciascuno nel lavoro che più gli piaceva, alla fine i capi non avevano un reale potere e, tutto sommato, si cercava di accontentare tutti nei limiti del possibile Riguardo al sistema politico esistevano alcune differenze tra le comunità studiate. Quello Icariano assomigliava a una democrazia: il presidente, eletto per un anno, era incaricato di eseguire le decisioni prese dalla maggioranza nelle adunanze settimanali, oltre che di dare la norma della condotta per la settimana successiva. Anche la comunità di Oneida possedeva un sistema politico democratico, ma qui il presidente e gli ufficiali esecutivi avevano ampi poteri decisionali. Ad Amana e tra gli Shakers, i capi erano scelti tra le persone con carattere spirituale più elevato. Essi raramente venivano cambiati e avevano poteri quasi illimitati. L’unica loro limitazione era quella di non poter prendere decisioni che potessero alterare l’armonia sociale o uscire dalle regole generali, ad esempio, contrarre debiti o impegnarsi in speculazioni arrischiate. Tra i Rappists i capi erano eletti dal capo spirituale, e a vita. Tra gli Zoariti e la comunità di Bethel il popolo non si occupava molto di queste elezioni né di altre funzioni amministrative, anche se gli Zoariti eleggevano dei fiduciari. La comunità di Aurora si trovava ancora sotto la direzione del suo fondatore. Indipendentemente dal vincolo religioso, in tutte queste comunità regnava l’uguaglianza più assoluta. I capi quando non erano occupati in doveri spirituali, erano attesi al lavoro manuale insieme agli altri, non essendo loro concesso nessun tipo di privilegio. Non esistevano i servi e, quando esistevano i domestici, essi erano assunti fra persone non appartenenti alla comunità e ricevevano un salario per il lavoro svolto. A eccezione degli Icariani, tutte le altre comunità avevano come principale vincolo della loro unione la fede religiosa. Le comunità di Bethel e di Aurora, i cui membri non avevano quasi pratiche religiose esteriori, erano tenuti insieme dalla convinzione che l’essenza di tutte le religioni e del Cristianesimo fosse l’altruismo, e che questo richiedesse la Comunità dei beni. Eccettuati gli Shakers e i Rappists che erano celibatari, la famiglia era fortemente rispettata e valorizzata tra queste comunità140, essendo le relazioni non strettamente rispondenti alla famiglia ammesse soltanto tra i comunisti di Oneida e i Perfezionisti. Le 140 Tra gli Icariani il celibato era anche vietato. 165 nozze erano fatte in gioventù, permettendo così la prosperità sociale. Quelli che si sposavano con una persona non appartenente alla comunità, venivano allontanati. Ogni singola famiglia aveva la sua propria abitazione e solo gli Icariani e i comunisti di Amana mangiavano in un refettorio comune. “Nelle comunità celibatarie si [erano] adottate molte precauzioni per tenere i sessi separati. Fra gli Shakers specialmente, le abitazioni [avevano] scale e porte speciali per ciascun sesso; i locali ove si lavorava [erano] divisi; si mangia[va] a tavole separate, e nelle adunanze gli uomini occupa[va]no una parte della sala e le donne un’altra. Inoltre nessun congregato vive[va] solo; persino gli anziani ed i capi [dividevano] la propria stanza con un confratello. Non [era] neppur permesso che gli uomini si [fermassero] a parlare soli con le donne per via. In molte delle loro scuole i sessi [erano] tenuti separati. (…) Raramente [avveniva] che taluno non osserv[asse] questa regola, e se avv[enisse], il trasgressore [veniva] espulso”141. I Perfezionisti erano essenzialmente manifatturieri, essendo l’agricoltura un ramo sussidiario dei loro affari. Tutte le altre comunità, invece, avevano per base della loro industria l’agricoltura, e molte di esse avevano anche qualche industria manifatturiera. Siccome il loro obiettivo era l’autosufficienza, esse cercavano di produrre tutto ciò di cui avevano bisogno. Per ottimizzare il lavoro, tutte le occupazioni – industriali, rurali o casalinghe – erano ripartite e adempiute secondo certe norme sistematiche intente a renderle più facili e più regolarmente eseguibili. Le giornate cominciavano di solito prima del sorgere del sole, ma non si lavorava mai fino all’esaurimento. In più, si curava molto la salubrità del lavoro. I registri amministrativi, quando esistevano, erano molto semplici. Nella maggior parte delle comunità i conti venivano controllati soltanto una volta all’anno e in alcuni casi non si rendeva nessun conto ai membri. I Perfezionisti erano quelli ad avere un sistema più completo di controllo, ma ciò si doveva al fatto di avere grandi stabilimenti manifatturieri e di essere anche grandi commercianti. Inoltre, per una ragione di economia, i comunisti facevano sempre le loro provviste all’ingrosso, usufruendo così di prezzi migliori. La regola generale di non contrarre debiti serviva come un regolatore naturale delle finanze delle comunità e dei singoli membri, oltre che a evitare qualsiasi speculazione arrischiata. Infatti, era loro principio generale l’abitudine antica di fare in modo di diminuire le uscite invece di aumentare le entrate. In più, dato che le ricchezze erano possedute in comune, la preoccupazione principale era quella di garantire un livello di 141 «Lo Sperimentale», n. 5, gennaio/febbraio 1887, p. 2. Il corsivo e il grassetto sono miei. 166 benessere e indipendenza generale e, quando avanzavano soldi, essi venivano convertiti in nuove proprietà oppure in titoli pubblici. Rispetto all’abbigliamento, regnava la semplicità che garantiva un risparmio di tempo e di fatica oltre che di soldi. Soltanto gli Shakers e i Rappisti avevano una divisa comune e gli Shakers erano gli unici ad aver adottato per le donne abiti che nascondessero le loro bellezze con l’obiettivo di renderle meno attraenti. Tutti gli altri producevano i loro abiti secondo i gusti personali, sempre con stoffe di buona qualità. Riguardo all’alimentazione, il cibo era abbondante e non mancava la frutta. In alcune comunità americane non era ammesso l’uso dell’alcool. In altre, invece, si faceva uso del tabacco e del vino, però con moderazione. Tutte le comunità offrivano ai loro membri un’istruzione di qualità, mantenendo anche l’antica abitudine di insegnare un mestiere ai ragazzi e di avviare le ragazze al cucito, alla cucina e al lavoro domestico. A eccezione degli Icariani, tutte le altre comunità insegnavano la religione. Gli Shakers e i Rappisti includevano anche l’insegnamento della musica, mentre i Perfezionisti erano gli unici a inviare alcuni giovani a scuole scientifiche fuori della comunità. Ciò nonostante, erano poche le comunità ad avere biblioteche di carattere generale e queste, quando esistevano, erano normalmente poco fornite, eccezione fatta per i comunisti di Oneida che possedevano anche libri e giornali aggiornati. Tranne i Perfezionisti e gli Icariani – a cui piacevano la musica e le rappresentazioni teatrali142 – nella maggior parte dei casi queste comunità non badavano molto al divertimento, essendo nella maggior parte dei casi le riunioni religiose le principali “ricreazioni”. I Perfezionisti facevano grande uso della stampa, pubblicando un giornale settimanale e diversi opuscoli che venivano inviati a tutti quelli che desideravano conoscere la loro dottrina, e questa attività portava frequenti nuove adesioni. La comunità di Bethel, fondata nel 1844 possedeva circa 4000 acri (circa 1618,8 ettari) di terra a Nineveh, vicino ad Adair e, nel 1875 contava circa 200 membri distribuiti in 25 famiglie, tutti di origine tedesca. Il possedimento originario di Bethel era sopra una vasta tenuta ma, siccome nel 1847 alcuni soci insoddisfatti chiesero la ripartizione della proprietà, la terra fu divisa e assegnata a ogni capo di casa una porzione, affinché ognuno fosse libero e si potesse vedere quali fossero inclini alla vita individualista, e quali alla vita comunistica. Inoltre, quando uno dei giovani desiderava lasciare la comunità, dato che la 142 I Perfezionisti avevano anche dei comitati responsabili per organizzare la ricreazione. 167 distribuzione dei beni era stata fatta prima della nascita della nuova generazione, gli veniva data una somma in denaro. La comunità aveva una segheria, un molino, una conceria, alcuni telai, un magazzino generale, una drogheria e botteghe di falegnami, ferrai, ramai, stagnai, sarti, calzolai, cappellai. Tutte piccole botteghe, ma in grado di soddisfare alle necessità della comunità e delle fattorie più vicine. Avevano avuto anche una distilleria e un lanificio, entrambi distrutti da un incendio. Vi si trovavano anche un argentiere e un fotografo che, in cambio dei loro lavori, ricevevano dagli altri membri le eccedenze delle loro piccole tenute. Nonostante questa grande diversità di occupazioni, a Bethel non vi erano innovazioni in grado di ottimizzare il lavoro. La disposizione della città era simile a quella di Aurora, ma le abitazioni erano più grandi. Nella via principale, sterrata, si trovavano i servizi principali come la segheria, il molino, due farmacie, il magazzino principale e due botteghe, oltre all’unico albergo della città e alla chiesa, quest’ultima in mezzo a un boschetto. Gli abiti erano ugualmente distribuiti a tutti gli integranti nel magazzino comune. Per l’alimentazione, composta da tre pasti, ogni famiglia riceveva una quantità sufficiente di maiali per la carne e di vacche – allevate per la comunità – per il latte e il burro. Inoltre, ogni casa possedeva un orto nel quale le donne coltivavano verdure e legumi per il consumo della famiglia. Era pur sempre possibile ricavare una eccedenza di galline, di uova, di frutta, ecc., che si vendeva al magazzino per ricavarne caffè, zucchero e altri generi non prodotti dalla comunità. La farina era a disposizione di tutti nel mulino, e ognuno ne prendeva senza che gliene fosse fatto addebito. La legna utilizzata per il fuoco era tagliata da alcuni uomini salariati e poi trasportata dentro il paese per essere distribuita dai membri della comunità. Toccava a ogni famiglia, poi, segare e spezzare la propria provvista. Rispetto all’organizzazione amministrativa, la comunità contava un capo e sei fiduciari scelti dai membri, con cariche temporanee143. Anche qui si rendeva conto ai membri degli affari della comunità e il capo, insieme ai fiduciari, esaminava i conti una sola volta all’anno. Icaria fu la comunità più studiata dal gruppo de «Lo Sperimentale» e merita perciò più attenzione. Era un villaggio comunista situato presso la città di Corning (Adam’s County, Iowa, Stati Uniti), nata dal desiderio di CABET di uscire dalla teoria e partire alla pratica. Le prime fondamenta della comunità furono gettate nel giugno 1848 nella Fanin County, Texas, dove i pionieri costruirono alcune capanne e intrapresero dei 143 I fiduciari erano anche i direttori dei lavori. 168 dissodamenti. Presto essi furono ridotti all’impotenza da una malattia che infierì su di loro, uccidendo cinque compagni in pochi giorni e li obbligò ad abbandonare il luogo. Cinque di loro rimasero nel posto, mentre gli altri batterono in ritirata su Shrenfort e Nuova Orléans, dove speravano di trovare altri compagni che venissero a raggiungerli. Il gruppo si divise in tre colonne più o meno uguali e si diresse verso il luogo del loro ritrovo, ma le colonne si spezzarono per la strada a causa della malattia dei loro integranti. I superstiti riuscirono a raggiungere Nuova Orléans verso la fine del 1848. Nel frattempo, altre persone, tra cui CABET, avevano lasciato Parigi per unirsi ai pionieri e, nel marzo 1849, gli icariani in numero di 280 si stabilirono a Nauvoo, nell’Illinois. Dal 1850 al 1855 innumerevoli arrivi contribuirono a far crescere la comunità che, nel 1855, contava 500 integranti quasi esclusivamente francesi. La colonia prosperò e si consolidò. Aveva officine e fattorie, un molino, una distilleria e scuole per i giovani. Pubblicava un giornale e ogni tanto lanciava degli opuscoli di propaganda. Aveva un ufficio a Parigi e corrispondenti dovunque. Non trascurava i divertimenti: vi era un teatro e una banda musicale composta da circa cinquanta elementi. Nel 1853 gli icariani comprarono 3000 acri (circa 1214,1 ettari) di terreno nello Iowa dove si sarebbe stabilita definitivamente la comunità. Alcuni membri furono inviati per preparare il trasferimento definitivo. Ma l’isolamento, le privazioni, un lavoro faticoso e forse anche l’età avevano cancellato totalmente agli occhi degli icariani la missione morale d’Icaria. D’altra parte, la nuova generazione che cresceva, diversamente dalla vecchia, credeva nel progresso e non tardò a manifestare l’impazienza verso la resistenza opposta dalla vecchia generazione ad ogni nuovo impulso. Tale divergenza portò a una lotta inizialmente pacifica e fraterna ma che gradualmente diede origine a due gruppi chiaramente identificati durante le discussioni nelle assemblee: quello dei giovani icariani e quello dei vecchi icariani, i progressisti e i non progressisti. La situazione si fece sempre più tesa e per più di una volta la minoranza (i giovani) chiese alla maggioranza l’autorizzazione a staccarsi, proponendo di stabilirsi in una piccola parte delle terre che sarebbero comunque rimaste proprietà di tutta la comunità. Tale proposta, però, fu respinta e la situazione diventò sempre più insostenibile. Dopo diversi tentativi infruttuosi di accomodamento amichevole, “il tribunale di Iowa, su domanda della minoranza, pronunziò il 17 agosto 1878 l’annullamento dello statuto di fondazione della Comunità, e designò tre cittadini per liquidare i suoi affari. Alcuni mesi dopo, questo incarico fu rimesso ad una commissione arbitrale, che dal 15 gennaio al 25 febbraio 1879 tenne le sue sedute con dei delegati icariani al fine di determinare i diritti per ciascun gruppo”144. Alla fine, 144 «Lo Sperimentale», n. 2, agosto 1886, p. 3. 169 divenne obbligo irrevocabile ciò che era stato inizialmente proposto come soluzione amichevole e, dopo l’indennizzo di 7500 lire, la maggioranza si ritirò da Icaria. Ventotto dei suoi antichi membri diedero inizio a un nuovo stabilimento – la nuova comunità icariana – nel luogo stesso dove due anni prima la minoranza aveva offerto di stabilirsi, rimanendo fedele alle idee di CABET, mentre la Giovane Icaria si adeguò ai nuovi tempi. La nuova comunità icariana rimase essenzialmente agricola e la proprietà sociale rimase comune e indivisa. Possedeva 300 acri (circa 121,41 ettari) di terreno in coltura e alla fine degli anni ‘80, si preparava a dissodarne altri 80 (circa 32,38 ettari) per la coltivazione del granturco da destinare agli animali. Ciascuno lavorava secondo le proprie forze e capacità: i vecchi erano incaricati dei lavori più sedentari – quali preparare la legna per la cucina, sorvegliare il bestiame, curare i giardini, preparare il pane – i giovani eseguivano i lavori più faticosi – quali il trasporto della legna dalla foresta al villaggio durante l’inverno, il trasporto dei prodotti alla stazione ferroviaria più vicina, oltre che i lavori agricoli più pesanti – mentre le donne e le ragazze avevano il compito di preparare e conservare gli abiti di tutta la comunità, lavare la biancheria, cucinare, lavare i piatti e servire alle mense. I bambini andavano alla scuola e non appena cominciavano a crescere, cominciavano anche ad aiutare a fare piccoli lavori. L’alimentazione era composta da tre pasti – colazione, pranzo e cena – ricchi e abbondanti. Nei giorni festivi era permesso anche il consumo del vino. Riguardo alle abitazioni, ogni famiglia aveva una casa separata, composta di quattro stanze e circondata da un bel giardino. I vedovi e i celibi avevano ciascuno una camera sopra il refettorio. La casa comune, dove si trovava il refettorio e la cucina al pianterreno, aveva sei camere al primo piano e, sotto, una buona cantina in pietra, dove si conservavano le loro provvigioni di legumi durante l’inverno e il vino quando fosse iniziata la produzione. Tutte le case erano ben riscaldate durante l’inverno e bene aerate durante l’estate. Inoltre, erano arredate in modo da assicurare le maggiori comodità possibili. Il vestiario era semplice, senza lusso né esagerazione. Negli anni ‘80 essi si dedicavano alla coltivazione dell’avena, fieno, patate, granturco per la razione animale, legumi e frutta di vari tipi. Inoltre, avevano dei capi di maiali all’ingrasso e delle api per la produzione del miele, oltre a produrre formaggio tipo gruyère e limbourg. Un altro esempio citato, sempre negli Stati Uniti, fu quello dei Natches, una tribù americana che aveva trovato “un mezzo di eliminare la proprietà individuale evitando gli inconvenienti della proprietà comune. Il campo pubblico fu diviso in tante parti quante erano 170 le famiglie. Ogni famiglia portava a casa il raccolto contenuto in una di queste parti. Così fu soppresso il granaio pubblico, ma rimase il campo comune, e siccome ciascuna famiglia non raccoglieva precisamente il prodotto della parte che aveva lavorato e seminato, non poteva dire di avere un diritto particolare al godimento di quanto aveva ricevuto. Non fu più la comunanza della terra, ma la comunanza del lavoro, che fece la proprietà comune”145. Dagli Stati Uniti fu riportata l’esperienza di Orbiston, tratta dalle idee di Owen: una società cooperativa fondata negli anni 1820 presso Edimburgo, con succursali in tutta la Gran Bretagna e guidata da Abramo Combe. Per diffondere le idee comuniste su cui si basava l’esperimento, oltre alle numerose assemblee pubbliche – alle quali di solito seguivano delle sottoscrizioni per fondare una colonia di prova – era stato fondato anche un periodico, il Cooperative Magazine. Orbiston prosperò, alimentando industrie quali fonderie e officine di macchine. Ma, una volta morto il leader, l’esperimento si esaurì. Sempre dagli Stati Uniti proviene l’esempio della colonia cooperativa creata nel 1887 in Columbia, negli Stati Uniti, con l’obiettivo di illustrare i vantaggi della libera cooperazione, partendo dal presupposto che il benessere di ciascuno dipendeva dal benessere di tutti. I membri della colonia intendevano sviluppare la loro vita cercando l’equilibrio tra l’individualismo e l’altruismo, vivendo secondo la massima “uno per tutti, tutti per uno”. L’area della colonia era di 960 acri (circa 388,51 ettari), ma i coloni intendevano aumentarla, non appena avessero trovato altre persone disposte a lavorare secondo i loro principi. Cercando l’indipendenza economica in ciò che si riferiva alle necessità di base, essi avevano procurato una provvista abbondante di alimenti e un alloggio buono e sufficiente per tutti e, avevano stabilito di comprare abiti per tutti e una filatura di lana non appena avessero cominciato a vendere la loro produzione. Un’altra preoccupazione dei coloni era quella di raggiungere, per quanto possibile, l’equilibrio tra uomini e donne all’interno della colonia. I coloni avevano anche preso la decisione di dividersi in due categorie: soci residenti e non residenti. Quelli più adatti al lavoro di pionieri e che si occupavano dei lavori di bonifica del terreno sarebbero diventati soci residenti, mentre gli altri avrebbero contribuito con 5 dollari al mese ciascuno per garantire il lavoro dei soci residenti. Era anche prevista una quota di ammissione nella seguente forma: uomo o donna adulti, 100 dollari; coppia di sposi con figli, 150 dollari; ragazzi sopra i 14 anni, da definire. 145 «Lo Sperimentale» n. 7 in «HUMANITAS» Anno I n. X, Napoli 10 aprile 1887, p. 3. 171 Tutti i soci, effettivi o in prova, dovevano pagare la rata mensile di 5 dollari. Nel caso si trovassero impossibilitati a pagarla, dovevano comunicare le ragioni al segretario che le avrebbe trasmesse all’assemblea. Toccava a questa, a maggioranza, decidere il condono o meno del socio. Inoltre, un socio definitivo poteva diventare socio residente sempre che lo desiderasse, essendo da quel momento in poi dispensato dalla rata mensile. I lavori straordinari compiuti dai soci di prova erano computati e pagati, fino alla somma massima di 5 dollari al mese. Inoltre, il lavoro eccedente effettuato dal singolo socio a favore della collettività gli veniva ugualmente risarcito. Una volta diventato residente, e fino a quando rimaneva tale, il socio aveva diritto a un pezzo di terra di 40 mila piedi quadrati, (circa 3720 m2) destinato al suo uso personale. La scelta dell’appezzamento spettava al nuovo socio sempre che non ci fossero conflitti tra la sua scelta e gli interessi collettivi. Gli era permesso utilizzarlo come meglio credeva, potendo fabbricare o migliorarlo in altro modo. Nel caso in cui per l’introduzione di tali migliorie, egli se fosse servito dei fondi o dei mezzi collettivi, nel momento in cui decidesse di abbandonare la colonia, tutto quanto sarebbe andato al fondo collettivo. La terra, gli strumenti e gli utensili di produzione, acquistati con il fondo collettivo dei soci, erano considerati proprietà collettiva della colonia, e il suo uso doveva obbedire al parere della maggioranza. La cessione in affitto della terra e degli strumenti di lavoro era decisa di volta in volta. Ogni socio separatamente, e tutti i soci insieme, erano interessati al terreno e agli strumenti adoperati per il profitto maggiore. Tutte le questioni relative allo sviluppo e all’uso della proprietà collettiva così come le ore da dedicare al lavoro venivano decise dal voto di tutti i soci nelle assemblee. Infine, ciascuno era lasciato libero di vendere o di offrire in affitto alla collettività o ai singoli soci tutto ciò che possedeva prima di entrare a far parte della colonia. Inoltre, i soci stabilivano che ogni socio adulto aveva parte uguale nell’Amministrazione degli affari sociali, che l’ordine e la condotta della colonia doveva rispettare soltanto ciò che i coloni stessi avrebbero stabilito e che l’ammissione di nuovi soci si sarebbe effettuata soltanto nel caso in cui la colonia dimostrasse di essere in grado di restituire il capitale al socio che decidesse di andare via. 2. ALTRE ESPERIENZE Il più importante esempio di esperimento socialista citato da Rossi nel suo giornale fu quello della colonia irlandese di Ralahine, che egli poi riprese nei suoi tentativi di realizzazione di una colonia socialista, com’è stato trattato nel capitolo precedente. La 172 storia di questa colonia fu oggetto di vari numeri del suo giornale, pubblicati dopo la fusione con l’«Humanitas» di Napoli. Rossi cominciava il suo studio informando che in Irlanda, prima della dominazione inglese, non esisteva la proprietà individuale della terra. La legge irlandese prevedeva invece la proprietà comune, a servizio delle famiglie. “Il popolo eleggeva un capo nominato a vita, e che non era altro che il direttore di una associazione. Esso attribuiva le terre ai membri, ma la terra non poteva essere venduta. Il capo attribuiva o ritirava le diverse porzioni di terreno, secondo che i membri si rendevano più o meno utili. Naturalmente sotto un tale regime, la terra era tanto più divisa quanto più la popolazione era numerosa”146. Ma, sin dall’inizio della dominazione, gli inglesi cambiarono questo quadro, introducendo il modo di proprietà individuale. Nel 1830, quando si diede l’organizzazione di Ralahine, l’Irlanda contava circa sette milioni e mezzo di abitanti. La terra era concentrata nelle mani di pochi proprietari che, inoltre, non si dedicavano all’agricoltura, l’unica fonte di sostentamento del popolo. Gli affitti richiesti per l’uso della terra erano elevatissimi e il contadino era obbligato a destinare la maggior parte della sua produzione al loro pagamento. La crisi del raccolto avvenuta a sud e a ovest dell’Irlanda di quell’anno aveva peggiorato ancora di più la situazione. Molti proprietari cominciavano a licenziare i loro lavoratori e a coltivare appena una parte delle terre, destinando l’altra al pascolo che richiedeva meno manodopera. Da tutte le parti, i salari erano stati ribassati, portando i contadini alla fame e alla miseria. Tale situazione scatenò una rivolta sociale generale con i contadini, affamati, che reclamavano la proprietà della terra, il lavoro e l’alimento. Per reprimerli si passò all’uso della forza militare. Davanti a tale situazione, Vandeleur, proprietario di terre nella contea di Clare e discepolo di OWEN, decise di realizzare un suo antico desiderio di fondare un’associazione agricola e manifatturiera con i contadini di Ralahine. A tale scopo voleva abbandonare la tenuta di Ralahine per farne un’azienda cooperativa, ma per portare avanti il suo progetto, aveva bisogno di aiuto. Questo aiuto lo trovò in Craig, un giovane inglese che si interessò molto delle sue idee, decidendo di aiutarlo in tale impresa, convinto “che prendere in affitto, per conto di un’associazione, una fattoria – fondi e fabbricati – era un’impresa pratica e desiderabile, che se gli sforzi necessari erano sostenuti da un’intelligente direzione, e se il lavoratore era chiamato a partecipare dei profitti netti, pagato l’affitto e l’interesse del capitale impegnato, il sistema potrebbe essere vantaggioso per tutti gli interessati. Credeva inoltre che se il piano riuscisse in Irlanda, avrebbe esercitato qualche influenza sul movimento generale, e avrebbe portato i suoi buoni frutti sull’Europa e 146 «Lo Sperimentale» n. 11 in «HUMANITAS» Anno I n. XIV, Napoli 15 maggio 1887, p. 3. 173 sull’America”147. Così, dopo aver discusso su tale progetto, decisero che Craig sarebbe partito in Irlanda appena fosse stato possibile, per preparare la popolazione di Ralahine su ciò che stava per accadere, redigere gli statuti dell’associazione e prendere le misure indispensabili per l’organizzazione. La tenuta di Ralahine aveva 375 ettari, di cui metà coltivati. Inoltre, possedeva dei fabbricati – uno dei quali poteva essere utilizzato come refettorio comune, l’altro come salone di lettura, di conferenze o di scuola – uno stagno di oltre 38 ettari che forniva la torba, un mulino, una segheria e un tornio messi in movimento da un piccolo emissario di un lago confinante con la proprietà e, a poca distanza, una cascata che poteva essere utilizzata per operazioni industriali. A pochi metri dal fabbricato principale, si trovavano sei casette in via di costruzione e qualche centinaio di metri più lontano, sorgeva l’antico castello di Ralahine con le tre imponenti torri quadrate. Malgrado i vantaggi materiali della situazione, lo stato e i pregiudizi della popolazione non erano incoraggianti. I contadini, ignari delle vere intenzioni di Craig e di Vandeleur, erano ostile al primo, così come lo erano la famiglia di Vandeleur e l’aristocrazia, queste ultime invece proprio perché conoscevano bene le loro idee. Niente di questo, però, scoraggiò Craig che, mentre studiava le persone e le cose intorno a sé, redigeva il progetto di regolamento destinato all’organizzazione dell’associazione. Essendo riuscito a guadagnare la fiducia di uno o due tra gli operai del paese, egli presto comprese che semplici modificazioni nel regime del salario non sarebbero bastate a convincere i lavoratori di Ralahine ad accettare di partecipare all’esperimento. Occorrevano dei cambiamenti più radicali, più profondi, e i loro progetti rispondevano a questa necessità. Il difficile, però, era far comprendere e accettare ai lavoratori i nuovi piani. La situazione di estrema tensione causata dalla lotta sociale in corso fece precipitare gli avvenimenti. Vandeleur e Craig convocarono in assemblea generale la popolazione occupata sulla fattoria di Ralahine, presentando a loro lo scopo dell’associazione progettata. I contadini avevano poca fiducia nei vantaggi offerti dal nuovo sistema, e la maggior parte di loro credeva che il piano sarebbe stato abbandonato in poco tempo. Soltanto una piccola parte credeva alla riuscita del piano. Davanti a questa situazione, “Craig propose di chiamarli tutti in blocco alla costituzione della società, sottoponendo l’ammissione di ciascuno al voto di tutti. 147 «Lo Sperimentale» n. 13 in «HUMANITAS» Anno I n. XVI, Napoli 12 giugno 1887, p. 3. 174 Questa misura, che fu adottata anche riguardo a Craig, ebbe l’effetto salutare di condurre ciascuno all’esame di sé stesso. Nessuno fu respinto, ma le critiche reciproche ebbero eccellenti resultati”148. Furono ammesse in totale 53 persone, di cui 40 adulti (28 uomini e 12 donne), 8 giovani (5 ragazzi e 3 ragazze dai 9 ai 17 anni) e 5 bambini inferiori ai 9 anni. “Stabilita la lista dei primi soci, un’assemblea generale presieduta da Vandeleur ebbe luogo il 10 novembre 1831 per la costituzione della società. Gli statuti seguenti furono sottoposti all’esame ed all’approvazione dei nuovi associati”149. Lo statuto disponeva sugli scopi dell’associazione, sulla proprietà del podere; sull’entrata e uscita dei soci nell’associazione; sulla forma di amministrazione dell’associazione e sulle eventuali visite fatte da stranieri150. Riguardo alla produzione, fu stipulato: che tutti i soci dovevano mettere a servizio dell’associazione i talenti che possedevano, lavorando direttamente o insegnando ai giovani, quando richiesto, il suo mestiere; che sempre che possibile tutti dovevano lavorare nelle attività agricole, soprattutto durante le raccolte; che non esistevano intendenti; che, oltre ai lavori agricoli, i giovani dovevano imparare un mestiere. Fu stabilita anche la giornata lavorativa e il salario pagato (80 pences per gli uomini e 50 per le donne) e fu determinato che gli acquisti dovevano essere fatti nei magazzini di approvvigionamento della società, essendo permesso comperare altrove soltanto le derrate non prodotte né vendute dall’associazione. Inoltre, fu determinato che il comitato si riuniva tutte le sere per decidere i lavori per il giorno successivo. Quando fosse ritenuto che un lavoratore non lavorava in modo giusto, il fatto doveva essere riferito al comitato che, a sua volta, doveva portare la questione in assemblea generale, la quale decideva sull’espulsione o meno del socio. Rispetto alla distribuzione ed economia domestica, fu stipulato che i lavori domestici fossero eseguiti dai giovani inferiori ai 17 anni, a turno o per scelta, e che le spese concernenti vitto, vestiti, alloggio e istruzione di questi fino ai 17 anni – età in cui poteva essere eletto associato – rimanessero a carico della cassa sociale. Infine, furono stipulate le costruzioni da eseguire, la necessità di autorizzazione del proprietario per abbattere gli alberi e determinate le aree di cui era assolutamente vietato l’uso sia per la coltivazione che per i pascoli. «Lo Sperimentale» n. 14 in «HUMANITAS» Anno I n. XVII, Napoli 2 luglio 1887, p. 3. Idem ibidem. 150 Fu stabilito che il materiale d’agricoltura e tutta la proprietà sarebbe rimasta nelle mani di Vandeleur fino a che l’associazione non avesse risparmiato il capitale necessario al suo acquisto. Dopodiché il terreno, il materiale e tutta la proprietà sarebbero diventati proprietà sotto forma di azioni della società stessa. Inoltre, veniva dato il diritto a Vandeleur, nei primi dodici mesi, di pronunziare il rinvio per ogni associato che avesse violato le regole. 148 149 175 Inoltre, fu stabilito che, trascorso un anno dall’inizio dell’esperimento, se una serie di requisiti fossero stati rispettati i lavoratori avrebbero avuto un aumento dello stipendio e, se fosse avanzata qualche somma, essa sarebbe stata destinata al fondo sociale. I lavoratori che, a quel punto, avessero deciso di abbandonare l’associazione potevano prendere la loro parte di questi soldi, ma coloro che avessero deciso di rimanere avrebbero dovuto lasciarli. Tutti i profitti dovevano essere accumulati fino a raggiungere la somma portata in inventario per i fondi e il materiale della società, affinché si potesse rimborsare Vandeleur. Una volta che tutti i conti fossero stati pagati, un’assemblea generale degli associati avrebbe deciso quale uso sarebbe stato fatto dei profitti comuni. Se, invece, i compromessi non fossero stati onorati, tutto l’insieme delle cose, derrate, strumenti, fondi, scorte ecc. sarebbero tornati alle mani di Vandeleur che, tra l’altro, a quel punto avrebbe avuto il potere di scegliere tra i soci quelli che riteneva più adatti a comprendere e sostenere il sistema di associazione, oppure di fare del suo possesso ciò che credesse più conveniente. Infine, anche se non specificato, era permesso fabbricare degli alloggi addizionali per l’aumento del numero dei soci, servendosi della pietra da calce e della torba disponibili nella proprietà. Il proprietario prendeva in carico le spese dei cristalli e dell’ardesia mentre gli associati si responsabilizzavano per tutti i lavori richiesti dalla costruzione. In quella data fu stabilito anche che il pagamento dell’affitto e degli interessi era eseguito in natura fino alla somma totale di L. 22.500, valore distribuito tra affitto, bestiame, fabbricati, materiale, macchine e capitali anticipati al lavoro. Nei primi due mesi dopo la firma del contratto di società non vi fu nessuna domanda di ammissione, anche se mancavano lavoratori per poter aumentare l’estensione delle terre coltivabili. Ma dopo alcune settimane il clima migliorò e le cose assunsero un aspetto più soddisfacente. Gli affari della società erano sotto il controllo di un comitato eletto secondo le prescrizioni statutarie. Esso si riuniva tutte le sere e stabiliva la distribuzione del lavoro per il giorno successivo. Ogni associato e ogni strumento agrario avevano un numero d’ordine. “Le direzioni concernenti l’impiego degli uomini e delle cose erano inscritte su delle lavagne, per mezzo di questi numeri. Alla fine della seduta, le lavagne erano affisse su i muri della sala delle riunioni pubbliche, in modo che l’associato, senza ricevere nessun ordine verbale che potrebbe sembrare duro ed autoritario, conosceva, esaminando il quadro, quali erano le istruzioni del comitato a suo riguardo. Le istruzioni giornaliere erano riprodotte ogni settimana in un quadro speciale, affisso nella sala di lettura, in modo che ciascuno poteva controllare il lavoro 176 compiuto, vedere se le decisioni del comitato erano giudiziose e se il lavoro generale era bene ordinato. Se il tempo o qualche circostanza impreveduta rendeva urgente la modificazione dell’ordine dei lavori nel corso di una stessa giornata, i membri del comitato agivano in qualità di sotto-commissari, dando gli ordini necessari per evitare ogni perdita ed ogni spreco”151. Nei casi in cui il comitato ordinava qualche operazione sbagliata, oppure se ritardava un lavoro importante, ogni socio adulto aveva il diritto di segnalare il fatto sul libro di osservazioni, tenuto a disposizione di tutti nella stanza del comitato. Esso era esaminato dal comitato ogni sera prima di designare i lavori per il giorno successivo. Inoltre, nelle assemblee generali settimanali, Craig leggeva le osservazioni della settimana e informava sulle procedure che erano state adottate dal comitato per risolvere il problema.. Erano messi in discussione durante l’assemblea i processi verbali delle sedute del comitato, l’indirizzo dato ai lavori nella settimana precedente e altri problemi che eventualmente si fossero presentati, con l’obiettivo di garantire a tutti una legittima influenza sulle operazioni sociali. Questa procedura dette risultati positivi, originando una corrente favorevole al progresso della società. Un’altra forma di proprietà collettiva poco conosciuta era il sistema comunale praticato nell’Ulst settentrionale e nelle ultime Ebridi, nella Scozia. Lì, i coloni formavano tra loro una comunità, pur pagando una rendita al proprietario per la terra che, però, possedevano in comune. Verso la fine d’autunno, una volta terminato il raccolto, i coloni si riunivano per decidere quale porzione del terreno doveva essere sottoposta a coltivazione nell’anno successivo, ripartendola tra loro. Anche le decisioni relative alla convenienza di aprire o riparare una strada, scavare un fosso, comprare o vendere un bue ecc. erano prese in assemblee. La ripartizione delle terre avveniva tramite un sorteggio di quote, e il possesso della parte assegnata aveva la durata di tre anni. Alcune volte la semina e la raccolta erano eseguite in comune, e i prodotti ripartiti egualmente per sorteggio. Una parte della produzione era sempre destinata agli orfani e agl’infermi e, quando un colono si ammalava, un altro lavorava per lui. La comunità aveva un pastore, un mandriano, un custode del mercato e un vigilatore del pascolo. Le pecore, i cavalli e tutto il bestiame pascolavano insieme e ogni colono poteva tenere soltanto una quantità di bestiame previamente determinata. La vendita della lana e altro si faceva in comune. In giugno la popolazione trasferiva la sua dimora dalla spiaggia coltivata alle coline riservate al pascolo. 151 «Lo Sperimentale» n. 16 in «HUMANITAS» Anno I n. XX, Napoli 8 settembre 1887, p. 3. Questa organizzazione fu ripetuta in quasi tutti gli esperimenti riportati studiati finora, dall’utopia di Rossi alla Colonia Cecilia, ai falansteri foureriani, ai collettivi agricoli spagnoli, come si vedrà in seguito. 177 Anche l’organizzazione agraria dei piccoli comuni scozzesi trattate da Walter Scott nel romanzo Monastero servì da esempio al giornale. Secondo il breve articolo sull’argomento, in quei comuni gli “abitanti si davano in tutto aiuto e protezione. Essi possedevano il terreno in comune, ma per coltivarlo lo ripartivano in lotti, posseduti temporaneamente come proprietà privata. Tutta la corporazione partecipava indistintamente ai lavori agricoli, ed il prodotto era distribuito, dopo la raccolta, secondo i diritti rispettivi di ciascuno. Le terre lontane erano successivamente coltivate, poi abbandonate fino a che la vegetazione fosse ricostituita. Le mandre appartenenti agli abitanti erano condotte sul pascolo comune da un pastore, funzionario comunale al servizio di tutti”152. Dalla Francia, Rossi riportò il caso del primo tentativo sperimentale dei falansteri fourieriani, stabilitosi a Condé-Sur-Vesgre, sul confine della foresta di Rambouillet, a Chesnay, in un area di 500 ettari. I lavori furono iniziati nel 1832 e proseguirono nel 1833. La decisione di iniziare i lavori dalla riforma degli stabilimenti anziché di impegnare il capitale disponibile nelle attività agricole, compromise il successo dell’esperimento. Baudet-Dulary, il proprietario del podere, dovette vendere una parte delle terre, conservando soltanto un mulino sul fiume Vesgre e alcune terre vicine, dove si stabilì con la sua famiglia, sperando nell’avvenire. Nel 1848 quattro o cinque famiglie falansteriane lì si recarono, seguite poi da alcuni soci che ingrossarono le rendite con la loro pensione. Tra gli obiettivi della nuova società c’erano quelli di attivare un’Associazione tra il capitale e il lavoro e di integrare lavoro agricolo e lavoro industriale. “Il gruppo militante iniziatore, prese possesso della terra, innalzò un fabbricato ed ivi installò diverse industrie. Si cominciò con la fabbrica di cartone (…). Si pensava di fondare una fabbrica di maiolica e di mattoni, essendovi le terre opportune nelle vicinanze. Un anno intiero questi pionieri lottarono contro immense difficoltà e dovettero sciogliere la società il 2 marzo 1850”153. Nello stesso anno un nuovo gruppo organizzò un’altra società sullo stesso terreno, con più successo. Gli abitanti della nuova colonia variavano da 12 a 15 nell’inverno e da 30 a 40 nell’estate, e verso il tempo dell’assemblea ordinaria realizzata il 7 di aprile, giorno in cui si festeggiava il giorno di Fourier, raggiungevano circa 50. Le abitazioni erano composte da un edificio principale lungo 40 metri e largo 15, ripartito in stanze e sale d’uso comune – cucina e annessi, sale da pranzo, di lettura, di conversazione, di gioco, d’amministrazione, di biancheria, di lavanderia, le scuderie, i magazzini, i cantieri ecc., oltre alle 25 camere per i coloni e per gli invitati – e di due casette separate da una piccola distanza. Tutto era 152 153 «Lo Sperimentale» n. 12 in «HUMANITAS» Anno I n. XV, Napoli 29 maggio 1887, p. 3. «Lo Sperimentale», n. 4, ottobre/novembre 1886, p. 4. 178 semplice, quasi rustico, ma sufficiente. Ai locatari non era permesso avere la cucina a parte e i pasti in comune erano ritenuti dai coloni il legame più potente che manteneva l’unità. L’amministrazione era regolata in tutti i suoi particolari dai soci medesimi; tutti, uomini e donne, avevano diritto di voto, anche per ammettere o respingere i nuovi soci dopo una prova di 15 giorni. L’importo di tutte le spese (nutrimento, imposte, nettezza, fuoco, illuminazione ecc.) variava secondo le stagioni ma era mediamente di 900 lire all’anno. Sempre a proposito della Francia, Rossi citò le antiche comunità o fratellanze, “una comunità di abitanti, una piccola repubblica, col suo presidente elettivo e revocabile, un’associazione di 30 a 40 famiglie, più o meno, che vivevano insieme una vita comune ed eseguivano, in comune, la coltivazione della terra, che sarebbe stata impossibile ad esseri isolati e senza soccorso. Gli associati prendevano il nome di parçonniers (…). Si viveva, si mangiava insieme lo stesso pane, si era compagni, (…) in una parola vi era abitazione e spese comuni; ciascuno portava i suoi beni alla casa comune”154. Ancora alla fine dell’Ottocento queste fratellanze resistevano. Era il caso dei comunisti di Jault, dei Pingons, degli iloti bretoni di Hoedie e d’Houat, e delle associazioni semi-comuniste del Jura. I comunisti di Jault, appena citati, erano una piccola comunità contadina, composta da trentasei persone tra uomini, donne e bambini situata presso Saint-Saulge, nel comune di Saint-Benin-les-Bois. Questi contadini si dedicavano all’agricoltura in comune, vivendo come una unica famiglia, coltivando insieme un terreno che era di tutti e consumando insieme i prodotti del loro lavoro. Essi avevano un capo – il maestro – che riassumeva in sé i poteri e i diritti di un capo di famiglia contadino. Dalla Russia, furono prese come esempio le sette cristiane e razionaliste caratterizzate da un grande spirito di solidarietà. Si trattava di sei gruppi – i Nemoliakis (che non pregano più), i Doukhobortsi (difensori del pensiero), i Molokonis, gli Obstchiis (comunisti), gli Schîoundistes, gli Staroveris (vecchi credenti) – per un totale di circa 13 milioni di abitanti, tutte socialiste, alcune moderate – Molokanis e i Doukhobortsi – altre più dichiarate. In generale queste sette conducevano una vita pacifica e austera. Le diverse comunità di una stessa setta, formavano delle federazioni politico-sociali. Ognuna di esse godeva di una autonomia quasi assoluta e solo in casi gravi si convocava un consiglio generale – sobor – a cui partecipavano alcuni membri eletti delle varie comunità. Per corrispondere tra di loro, i diversi gruppi impiegavano dei messaggeri che, travestiti da 154 «Lo Sperimentale», n. 5, gennaio/febbraio 1887, p. 3. 179 mendicanti, percorrevano il paese in ogni direzione e trasmettevano verbalmente le comunicazioni. Riguardo alla proprietà, le sette ne ammettevano due forme diverse: una, la proprietà comune – i valori immobili (terreno, case ecc.) e gli strumenti necessari al lavoro in comune del terreno e delle industrie; l’altra, la proprietà individuale e mobile, come il mobilio personale, il denaro ecc. Le sette che professavano il comunismo puro – fra cui gli Obtchiis e i Régounis – erano rare e non ammettevano nessun tipo di proprietà individuale. Tutte le sette indistintamente protestavano contro l’accaparramento del terreno da parte delle classi privilegiate. L’altro esempio di pratica di agricoltura in comune era quello della Comune russa, la quale aveva un carattere completamente democratico. Il sindaco – l’elder – rappresentava soltanto il potere esecutivo. L’autorità di fatto risiedeva tutta nell’Assemblea, della quale erano membri tutti i capi delle famiglie. Le riunioni erano tenute all’aperto e quasi sempre avevano luogo le domeniche o i giorni di festa, quando i contadini avevano più tempo libero. L’Assemblea discuteva tutte le questioni che riguardavano il benessere generale della Comune, avendo una competenza assai estesa. Essa divideva e assegnava la terra comunale fra i membri della Comune; determinava l’epoca del raccolto e il giorno dell’inizio dei lavori nei campi; decretava le misure da prendere contro coloro che non pagavano puntualmente le loro tasse; decideva sull’ammissione di un nuovo membro, sul cambiamento di domicilio di un membro antico; dava o ritirava il permesso di fabbricare nuove case; preparava e firmava tutti i contratti stabiliti con i suoi membri o con uno straniero; interveniva negli affari domestici dei suoi membri; eleggeva il sindaco, il collettore delle tasse, il guardiano notturno e il pastore del villaggio. Nei villaggi russi i contadini erano legati da relazioni, impegni e interessi comuni. Erano legati dalla proprietà in comune e alcune volte anche dal lavoro in comune. In teoria, le terre stesse occupate dalle case erano proprietà comunali. I contadini russi alcune volte, oltre alle terre comunali avevano anche qualche appezzamento di proprietà personale. Oltre alle terre, i comuni possedevano anche proprietà di altro genere come laghi da pesca, molini comunali, mandra comunale per il miglioramento delle razze bovine ed equine; magazzini di provvigioni destinati alla distribuzione dei semi per i loro campi o degli alimenti per le loro famiglie. Altro esempio citato fu quello dei fratelli moravi, un gruppo formato dai seguaci di Giovanni Hus (1415) che, fuggendo dalle persecuzioni, si ritirarono nelle montagne sui confini della Boemia e della Moravia. Avendo sentito il bisogno di aggrupparsi per 180 prestarsi assistenza reciproca, essi formarono dei piccoli centri di popolazione, uniti dai vincoli di carità, anche se non sembrava che vi fosse stato tra loro un vero comunismo. Più probabilmente ogni famiglia aveva la sua casa separata e non si univa alle altre che per prestare soccorsi e servizi reciproci. Queste associazioni subirono molte persecuzioni, tanto che all’inizio del XVIII secolo erano molto ridotte. “Fu allora che il conte di Zinzindorf offrì loro per asilo una terra che egli possedeva nell’alta Alsazia, ove fu fondato nel 1722, il villaggio d’Herrnhut, primo stabilimento dei fratelli moravi attuali. I moravi dei due sessi viv[eva]no in comune in vasti stabilimenti. Ogni fratello esercita[va] un mestiere o un’arte, e il prodotto del suo lavoro [era] versato alla massa. Quindi il loro regime [era] quello di una eguaglianza assoluta e di una comunanza completa, quanto agli interessi. Non vi [era]no distinzioni, non vi [era]no categorie; non vi [era]no che fratelli (…). La sola gerarchia che esiste[va] presso i moravi, [era] volontaria. Ogni casa sceglie[va] un maestro, che non [aveva] altro privilegio se non quello di una responsabilità maggiore. Esso tratta[va] per la comunità, e rende[va] poi conto della suggestione. D’altra parte, la maestra presiede[va] all’economia domestica della casa. Il maestro e la maestra non po[teva]no essere sposi, ed i loro parenti non god[eva]no di alcun privilegio. I matrimoni [era]no tra i moravi l’oggetto di attenzioni delicate e di cure scrupolose. L’interesse non vi [aveva] niente che vedere: [era] l’inclinazione sola che li decide[va] (…). La comunità forni[va] i mobili ai fidanzati; e un vecchio alla presenza di tutti, benedice[va] la loro unione. Vi [era]no pochi celibatari tra di loro. In ogni Casa o stabilimento (…) i fanciulli [era]no allevati insieme. L’educazione si [dava] in comune a tutti, sotto la sorveglianza di dodici fratelli, e giunti ad una certa età si [dava] loro un’arte o un mestiere. La casa intera si riuni[va] per il pasto (…). Alla morte di un fratello, la comunità eredita[va] ciò che egli possedeva in proprio. Le diverse case morave [era]no legate tra loro da relazioni permanenti”155. Un altro esempio citato dal giornale fu quello di una piccola borgata semi- barbara della Laconia, avvenuto ormai più di 2000 anni fa dove, per mettere fine ai litigi fra i cittadini, Licurgo persuase alcuni dei capi più influenti e, con le armi e insieme ai suoi seguaci, impose la nuova organizzazione. “La terra fu divisa in parti uguali, e questo non era comunismo, ma la maggior parte dei prodotti veniva consumata in comune, precisamente al rovescio di quello che vogliono gli attuali collettivisti156. Gli oggetti mobili furono posti in vera comunanza, e ciascuno poteva adoperare gli schiavi (a quei tempi la schiavitù esisteva da per tutto, e si riteneva una cosa giusta), i carri, i cavalli e tutto quanto apparteneva ad un altro 155 156 «Lo Sperimentale», n. 3, settembre 1886, p. 3. Proprietà comune del capitale (terreno, macchine ecc.) e proprietà personale dei prodotti. 181 spartano. Gli iloti, specie di servi della gleba, erano considerati come proprietà pubblica; ed erano essi che coltivavano la terra ed esercitavano tutti i mestieri, mentre gli schiavi erano addetti specialmente al servizio domestico e personale. Il sistema economico di Licurgo, fu dunque un misto di legge agraria (cioè di divisione delle terre) e di comunismo”157. Altro esempio di pratica comunista era quello che avveniva tra i nomadi del versante asiatico dell’Ural: i membri di uno stesso gruppo/comunità riunivano i loro strumenti di lavoro e sfruttavano collettivamente la proprietà immobile e il bestiame, essendo il regime della proprietà comune una conseguenza diretta della vita pastorale e dell’organizzazione della famiglia. Tra i nomadi, i discendenti diretti di uno stesso padre restavano ordinariamente aggruppati in fascio, e vivevano sotto l’autorità assoluta del capo di famiglia, in regime di comunanza. Eccettuati gli abiti e le armi, tutto il resto era indiviso. Quando la crescita di una famiglia non permetteva più a tutti i membri di restare riuniti, il capo provocava una separazione amichevole e determinava la quota delle proprietà comuni da attribuirsi a ciascuno dei gruppi. La comunità si manteneva unita anche dopo la morte del capo di famiglia, a questo punto sotto la direzione di quello che poteva esercitare con maggiore ascendente l’autorità patriarcale. Il principio della comunanza si adattava egualmente all’organizzazione dei popoli sedentari. Tra i semi-nomadi sottomessi alla dominazione russa, la terra da coltivare, anche quella coltivata ordinariamente a titolo individuale da ogni famiglia, era posseduta indivisa. L’altra pratica studiata da Rossi fu il regime delle comunità di villaggio, che era presente tra molte popolazioni dell’Africa tra cui quella degli Yoloff della costa di Gorea, a Giava, in Russia e in alcune isole dell’Oceano Pacifico. In tale sistema, la terra apparteneva in comune ai villaggi e ogni anno, il capo villaggio, assistito dal consiglio degli anziani, faceva la ripartizione delle terre da coltivare, calcolando i lotti secondo i bisogni di ogni famiglia. Dall’America Latina fu citato il caso dell’Impero Inca, nell’antico Perù, esistente dal XI al XVI secolo, fino all’arrivo degli spagnoli. La proprietà era divisa in quattro lotti: le terre consacrate al sole (granai d’abbondanza); le terre degli orfani, degli infermi e dei malati; le terre degli agricoltori e delle loro famiglie e le terre del re. Gli agricoltori lavoravano tutte queste terre, e la raccolta era divisa in tre parti: un terzo era versato nei granai d’abbondanza; un terzo destinato al servizio dell’Inca e dei funzionari e l’altro 157 «Lo Sperimentale», n. 1, maggio 1886, p. 8. 182 apparteneva alla comune. Negli anni di scarso raccolto, la comune prendeva prima il suo necessario e lasciava il resto all’Inca che, a sua volta, prendeva quello che gli mancava dai granai d’abbondanza. Ogni famiglia riceveva dalla comune quanto occorreva ai suoi bisogni e, ogni due anni, riceveva anche la quantità di cuoio e di lana necessaria per le calzature e le vesti. Ogni individuo sano aveva l’obbligo di lavorare. I malati, i vecchi e gli invalidi ricevevano tutto ciò di cui avevano bisogno. Non vi erano privilegiati e i funzionari non erano altro che i servitori della cosa pubblica. Infine, il caso delle tribù indigene messicane, dedicate all’agricoltura. Esse abitavano in villaggi e possedevano la terra in comune. L’unica proprietà privata esistente erano la casa e il giardino attiguo. Una parte del territorio era annualmente ripartita tra gli abitanti, un’altra era coltivata in comune e il prodotto era destinato ai bisogni pubblici. In certi distretti, solo il terreno arabile era comune. 3. I collettivi durante la Guerra Civile Spagnola Secondo PRESTON, la guerra civile spagnola rappresentò il culmine di una serie ininterrotta di lotte tra le forze riformiste e quelle reazionarie sin dal 1808. Diversi furono i tentativi di realizzazione di riforme radicali, soprattutto in campo agrario, con lo scopo di distribuire meglio la ricchezza. Ma tutte le volte la reazione rispose cercando di ristabilire gli equilibri di potere economico e sociale tradizionali. Così, la guerra civile del 1936-1939 non fu che l’ultimo tentativo da parte dei reazionari di lasciare le cose come stavano, reprimendo qualsiasi tipo di riforme che potesse minacciare i loro privilegi. 3.1. La struttura agraria e l’agricoltura spagnola Secondo PEIRATS, la Spagna era stata per molto tempo un paese eminentemente agricolo. L’uso intensivo del suolo, la pratica agricola estensiva, la siccità del clima e le erosioni, soprattutto nell’altipiano centrale, avevano ridotto di molto la fertilità naturale del suolo. Il regime di proprietà, le guerre e l’abbandono dell’agricoltura a causa di guerre o spopolamento contribuivano alla desertificazione e ad accelerare il processo di impoverimento del suolo. Per diminuire l’impatto di queste avversità e ridurre il danno subito individualmente esisteva, tra i contadini spagnoli, una tradizione di sfruttamento collettivo del suolo che, però, fu gradualmente persa in seguito a invasioni e dominazioni straniere e alla formazione del latifondo. 183 L’inizio della riconquista non cambiò strutturalmente le cose: i nobili, il clero e gli ordini militari si riservarono grandi estensioni di terre che rimasero deserte. Per stimolare il ripopolamento di alcuni territori furono concessi ai lavoratori alcuni privilegi e garanzie politiche, espressi nelle “carte di popolazione” che prevedevano la fondazione di nuovi paesi e villaggi o il ripopolamento di quelli previamente abbandonati. In tale processo ebbero grande importanza i municipi – i fueros – che non tardarono a conquistare il diritto di rappresentanza alle Cortes, a fianco alla nobiltà e al clero. Ma l’unità politica e legislativa, concretizzata nella formazione dello Stato nazionale, segnò la ripresa dei privilegi anteriori e la decadenza di queste istituzioni. Un’altra volta la terra fu lasciata improduttiva. Il latifondista che viveva di rendita a Madrid o all’estero e non di rado occupava qualche incarico politico, lasciava la sua proprietà sotto la responsabilità di un amministratore e agente politico che agiva spalleggiato dalle autorità locali e dalle guardie civili. La popolazione fluttuante di braccianti e fittavoli, che lavorava e viveva in queste terre, costituiva il suo censo elettorale158. Il problema fondamentale della Spagna era, poi, come afferma BRENAN, la questione agraria e i suoi rapporti con l’industria. Nonostante il predominio dell’agricoltura e dell’allevamento, il valore della maggior parte delle terre era basso, dovuto alla bassa fertilità naturale e alla scarsità di precipitazioni che rendevano difficile la pratica agricola159. Un altro problema era la struttura fondiaria spagnola, caratterizzata da un lato dalle piccole proprietà del centro e del nord – spesso incapaci di garantire la riproduzione sociale contadina – e, dall’altro, dai latifondi del sud sfruttati capitalisticamente con salari mantenuti ai limiti della sopravvivenza oppure offerti in affitto a prezzi proibitivi. Questo quadro diede origine alla seguente configurazione agricola: nella “Catalogna, Valencia e [ne]i paesi baschi predomina[va] il sistema dell’affittanza. I fittavoli paga[vano] le pigioni parte in danaro, parte in natura. Nella Galizia (nord est) la proprietà [era] divisa; campi misuranti meno di un ettaro apparten[eva]no a tre proprietari. Nell’altipiano centrale e nell’Andalusia predomina[va]no i grandi latifondi coltivati a cereali e ad ulivi. Le macchine agricole [erano] quasi sconosciute nel latifondo. Questo sistema veniva chiamato “caciquismo”. Gli amministratori – i “caciques” – organizzavano la vittoria elettorale del padrone obbligando i sottoposti a votare – tramite minaccia di perdere il posto di lavoro – o comperando i voti. 159 La distribuzione delle piogge faceva sì che i terreni peggiori fossero quelli più irrorati, mentre quelli migliori fossero totalmente aridi. 158 184 Il risultato [era] (…) [che] la Spagna, paese agricolo per eccellenza, [doveva] importare dall’estero tutte le specie di prodotti agricoli per molti milioni di pesetas. (…) Altra piaga [erano i] (…) grandi consorzi dei grandi allevatori di bestiame” (PEIRATS, 1962:45). Così, accanto a vaste terre incolte, destinate ai pascoli oppure riservate alla caccia, stavano i contadini con poca o nessuna terra, i fittavoli e i braccianti che per metà dell’anno restavano senza lavoro. Riguardo alle piccole proprietà, la Galizia era l’esempio migliore. Durante il medioevo la maggior parte delle terre appartenevano alla Chiesa, che le cedeva in affitto tramite un tipo speciale di contratto, il foro, una sorta di enfiteusi ereditaria. L’affittuario pagava un canone pari al 2% del valore della proprietà, provvedeva alla manutenzione della fattoria e degli edifici annessi, e non poteva essere sfrattato. Nei secoli XIII e XIV questa forma di possesso si estese alla maggior parte della Spagna centrale. In Castiglia fu denominata censo e aveva una scadenza stipulata. Nei secoli XVII e XVIII, l’aumento della popolazione portò all’aumento dei valori fondiari. I fittavoli passarono a suddividere le loro terre e sublocarle a canoni più elevati, dando origine a una nuova classe di speculatori fondiari e, subordinata a essa, a una nuova categoria di affittuari, i subforados. La Chiesa e i nobili cercarono di risolvere il problema introducendo una scadenza ai contratti d’affitto, ma i foreros vi opposero resistenza. La lunga vertenza tra le parti che si trascinò per più di un secolo finì con la vittoria di questi ultimi. Quando, più tardi, le terre della Chiesa furono messe in vendita, furono i foreros ad acquistarle nella maggior parte, diventando così foristas. Questo fatto ebbe una ripercussione diretta nell’economia locale, poi l’eccessiva suddivisione della terra – aggravata dalla chiusura dello sbocco costituito dall’emigrazione in America – impediva il raggiungimento della massima produttività. Gli appezzamenti bastavano appena a sostenere una famiglia. Ognuno viveva del proprio raccolto e l’unico modo di guadagnare un po’ di denaro era vendere un vitello o lavorare nella mietitura in altre regioni. Diversa era la situazione delle Asturie, regione che viveva dell’esportazione del bestiame e dei prodotti caseari. Le proprietà unifamiliari erano meno divise, il foro quasi non esisteva e i contadini potevano usufruire di vasti pascoli comunali. Anche le Province Basche, favorite dalle abbondanti precipitazioni e dalla ricchezza del suolo, differivano dalla Galizia, essendo caratterizzate da una zona di piccoli proprietari o affittuari che vivevano con agiatezza lavorando i loro appezzamenti su base familiare. In queste due regioni esistevano “due forme di proprietà terriera: la terra [poteva] appartenere alla famiglia che la coltiva[va] oppure esser ceduta in affitto a terzi. Nel primo 185 caso, diffuso nell’intera regione pirenaica, vige[va] il «sistema della comunità familiare». La proprietà appart[eneva] alla famiglia e il capo del consiglio di famiglia sceglie[va] il successore tra i figli o altri parenti. La casa, chiamata lar o llar (…), circondata dal frutteto, dai campi e dai vigneti, [era] inalienabile e [veniva] trasmessa di generazione in generazione. (…) Accanto ai proprietari coltivatori, ve n’[erano] altri che ced[eva]no in affitto la propria terra. La forma di locazione più in uso, (…) [era] l’aparcería a medias o mezzadria. Il proprietario forni[va] la terra, il colono la coltiva[va] e paga[va] le tasse: le piccole spese e il raccolto [erano] suddivisi. (…) [Era] indispensabile un clima con regolari precipitazioni: infatti, (…) il mezzadro rischia[va], se le condizioni atmosferiche [fossero] avverse, di non avere un raccolto sufficiente per dare al padrone la parte che gli spetta[va]. (…) I contratti, spesso orali, [erano] trasmessi di padre in figlio come se si trattasse di proprietà ereditaria” (BRENAN, 1970: 95/96). Il sistema delle piccole fattorie veniva integrato dalle foreste e dai pascoli comunali che contribuivano in modo significativo alla prosperità delle comunità contadine. Anche nelle pianure della Vecchia Castiglia i piccoli proprietari e i coloni vivevano dei prodotti del suolo. In Aragona, invece, tre realtà diverse convivevano. Da un lato, un’economia rurale primitiva basata su piccole proprietà trasmesse nella stessa famiglia di generazione in generazione oppure affittate con contratti a lungo termine. Dall’altro, piccole ma prospere proprietà contadine. Infine, le zone aride con precipitazioni scarse, caratterizzate da vaste proprietà, da contadini carichi di debiti e da miseri braccianti, dove il sindacalismo anarchico ebbe grande influenza. Nella Catalogna, anche se esistevano piccoli coltivatori diretti, quasi tutta la terra apparteneva a piccoli proprietari che la cedevano in affitto a terzi tramite due tipi di contratto: l’enfiteusi ereditaria o censo e una forma speciale di mezzadria in uso nelle aree coltivate a vigneti, la cui durata era basata su quella delle viti. “La terra ritorna[va] al proprietario quando tre quarti delle viti piantate [fossero] morte (…) e il contratto [poteva] essere rinnovato a sua discrezione” (BRENAN, 1970: 99). I mezzadri che lavoravano su questi contratti venivano chiamati rabasseires. Lungo la costa mediterranea il basso livello di precipitazioni rendeva precaria la coltivazione di cereali, eccezione fatta a Tortosa, Valencia e Murcia, centri di piane irrigate che potevano avere da tre a cinque raccolti nello stesso anno, bastando una piccola area coltivabile per sostenere una famiglia. Infine, nella regione di Granada, la coltura della barbabietola da zucchero consentiva la realizzazione di notevoli fortune e l’aumento dell’affitto a 8% del valore della terra, fatto che scatenò un conflitto sociale senza pari in Spagna. 186 Verso la fine del XVII secolo immense zone erano state trasformate in un deserto percorso da greggi e mandrie, e numerosi villaggi e città erano scomparsi. Secondo BRENAN, tale crollo aveva vari motivi, tra cui l’incremento del commercio estero della lana – soprattutto con l’introduzione della pecora merino dall’Africa – che aveva soppiantato quello della setta e “rubato” le terre alle coltivazioni agricole di alimenti. Castiglia s’avvantaggiò e trasformò i suoi campi in pascoli, mentre le fabbriche lì installate cominciarono a provvedere alla filatura. Tramontò così il tempo della civiltà andalusa e della sua complessa, ma fragile, economia basata sull’equilibrio tra un’agricoltura e un’industria altamente sviluppate. Nei quattro secoli successivi, l’allevamento ovino spodestò ampiamente l’agricoltura e portò la scarsa popolazione del paese sull’orlo della fame. Furono realizzati molti progetti per tentare di risolvere il problema, ma lo Stato non possedeva né le risorse economiche né l’autorità necessaria per renderli operanti. Soltanto nel XVIII secolo, soprattutto nel 1766 quando la grave crisi economica provocò disordini in tutta la Spagna, il governo di Carlo III decise di dare nuovo impulso all’agricoltura, affrontando il problema di rendere alienabili i mayorazgos160 e le terre affittate di proprietà dei comuni161. “Nel 1771 fu compilato il famoso Expediente consultivo (…). Il documento raccomandava in particolare i seguenti punti: concedere agli affittuari adeguate garanzie (canoni d’affitto fissi, il divieto di sublocazione e di sfratto); obbligare i grandi proprietari ad affittare le terre incolte; suddividere tra i vicini più poveri i bienes di propio in appezzamenti inalienabili; creare in prossimità dei villaggi speciali lotti di terreno produttivo. Si dovette attendere l’avvento della Repubblica nel 1931 perché tutte queste misure (…) avessero forza di legge” (BRENAN, 1970:108/109)162. Nel 1812 le Cortes di Cadice misero in vendita sul mercato le terre comunali per pagare il debito pubblico, scatenando la corsa dei borghesi desiderosi di L’istituzione del mayorazgo o maggiorasco era antichissima e consisteva nella consegna dell’eredità al figlio primogenito che restava impedito di venderla. Dopo alcune generazioni questa pratica propiziò la formazione di grandi latifondi, dato che normalmente il primogenito cercava di unirsi in matrimonio a donna di pari condizioni. 161 “I comuni possedevano in Spagna due tipi di terre: i bienes de propio, destinati all’affitto, e con il ricavato dei quali erano pagate le spese della municipalità; le tierras comunes o concejiles, terre di uso pubblico aperte a tutti gli abitanti del villaggio e raramente affittate. (…) Ma la legge del 1° maggio 1855 ne impose la vendita e la somma ricavata (dopo le consuete detrazioni operate dai caciques e dai funzionari locali) fu versata all’erario dello Stato subendo poi una forte svalutazione” (BRENAN, 1970, nota 2 p. 108). 162 Le riforme obiettivavano mettere a disposizione dei contadini le immense superficie incolte appartenenti ai comuni, di cui in realtà si erano impossessati i caciques o i poderosos per far pascolare il loro bestiame. “Furono suggeriti due metodi: a) lasciare le terre ai comuni e distribuire in lotti quelle arabili ai vicini più poveri, a intervalli di qualche anno (sorteo periódico de las tierras de labor). (…); b) creare proprietà individuali (cotos) inalienabili, indivisibili, non cumulabili, che avrebbero pagato un canone fisso (censo) allo Stato. (…) Per quanto riguardano le grandi proprietà, era opinione generale che si dovessero obbligare i proprietari ad affittarle in piccoli appezzamenti, a un canone fisso e in perpetuo: in altre parole si suggeriva l’adozione del contratto enfiteutico o censo, considerato più prudente dell’espropriazione” (BRENAN, 1970, nota 1 p. 109). (Il grassetto è mio). 160 187 investire i propri risparmi e di acquistare prestigio diventando proprietari terrieri. Ai contadini e alla gente modesta mancò il denaro per acquistare la terra, e l’area occupata dalle grandi proprietà continuò ad aumentare. Successivamente, le leggi del 1836, 1855 e 1856 imposero la vendita sul libero mercato di tutti i bienes di propio e delle terre comunali non reclamate dai villaggi per lo sfruttamento immediato. Questi provvedimenti, assai impopolari, trovarono opposizione tra le piccole città e interi villaggi in Spagna, soprattutto perché oltre a favorire la formazione dei latifondi, privarono i contadini dall’accesso ai beni comunali, specialmente ai pascoli, ai diritti di caccia, alla legna da ardere e al carbone di legna. La risposta a questi misfatti non tardò: già nel 1855 scoppiarono le prime rivolte che, nei sessant’anni successivi, divennero sempre più numerose e frequenti. Nella Vecchia Castiglia nella maggior parte dei casi la proprietà della terra apparteneva ancora ai nobili che la concedevano in uso ai contadini e, non di rado, si trovavano interi villaggi che possedevano e lavoravano la terra in comune. Il contratto più comune era il censo e, verso la fine del medioevo, i tributi pagati ai feudatari in cambio di una concessione di terra furono trasformati in un contributo fisso che ogni singolo contadino versava al granaio del castello in cambio del diritto di abitare la propria casa e coltivare il proprio podere in perpetuo. Oltre al piccolo appezzamento, ogni affittuario possedeva un paio di buoi e una casa al villaggio. Si produceva orzo, frumento e pochi ortaggi. Il terreno povero, le piogge irregolari e la minaccia costante della siccità spesso compromettevano i raccolti e, con essi, la possibilità di pagare gli affitti. Nel corso del XIX secolo, i costanti fallimenti dettero origine a contratti a più breve scadenza. Verso La Mancia e l’Estremadura, le grandi proprietà – denominate encomiendas163 – appartenevano a ordini militari. Soltanto una parte delle terre veniva coltivata, mentre l’altra veniva lasciata in pascolo. Le condizioni locali erano nel complesso peggiori che nelle altre regioni: la terra era più povera e la pioggia più scarsa. In alcune zone i vigneti e in altre il frumento si sviluppavano con una certa prosperità, mentre in altre grandi estensioni rimanevano incolte. Il contratto di affitto più diffuso era quello a breve scadenza, i contadini erano in genere yunteros164 e i conflitti tra loro e i proprietari erano frequenti, soprattutto quando questi ultimi decidevano di lasciare incolte alcune terre. L’Andalusia, la terra dell’agricoltura a clima secco, era la classica terra di latifondi coltivati dagli schiavi, due terzi dei quali formati dallo smembramento delle terre della Chiesa e di quelle comunali nel XIX secolo. Essa offriva una maggior varietà di prodotti 163 164 Stesso nome dato ai latifondi coltivati dagli schiavi nelle colonie spagnole dell’America del Sud. Contadini proprietari soltanto di due muli. 188 agricoli rispetto all’altipiano centrale: si coltivava l’olivo, il frumento, il granturco, le leguminose, l’uva e in alcune zone anche il cotone. Il sistema tradizionale in questa regione consisteva nel lasciare la terra per un anno a stoppia, poi nel dissodarla e lasciarla per un altro anno a maggese e solo nel terzo anno seminarla. Più tardi, la tendenza passò a essere quella di seminarla ogni due anni, ma il principale ostacolo era quello di mantenere, allo stesso tempo, la fertilità e l’umidità del suolo. Esisteva un’enorme disparità nella distribuzione della ricchezza e la situazione peggiore era quella vissuta dai contadini completamente privi di terra165. 3.2. Verso la guerra civile Come si capisce da quanto finora esposto, il capitalismo spagnolo ebbe, fino agli anni ’50, un carattere fondamentalmente agricolo e, nonostante esistessero alcune zone dove le piccole e medie aziende operavano con successo166, quelli che detenevano l’egemonia erano soprattutto i latifondisti delle regioni centrali e meridionali della Nuova Castiglia, Estremadura e Andalusia, e anche alcuni nella Vecchia Castiglia e a Salamanca. Il continuo aumento degli investimenti fondiari e il matrimonio fra borghesia urbana e oligarchia rurale finì per indebolire le forze interessate alle riforme. Inoltre, la debolezza della borghesia come classe rivoluzionaria s’intensificò nel periodo fra il 1868 e il 1873, culminando nel caos della Prima Repubblica. L’ultimo decennio dell’Ottocento fu un periodo di depressione economica che aumentò ancora di più le sofferenze dei lavoratori, soprattutto nelle campagne, avvicinandoli al movimento anarchico. Verso la fine del secolo, l’espansione dell’industria carbonifera, tessile e dell’acciaio diede origine anche a un proletariato industriale militante. Negli anni antecedenti alla prima guerra mondiale, la crisi fu avvertita dalla borghesia e in seguito dal proletariato e dai militari, dando origine a un’alleanza tra loro con l’obiettivo di ripulire la politica spagnola dalla corruzione del caciquismo. Ma le cose non andarono a buon termine e la crisi del 1917 finì per consolidare l’oligarchia terriera al potere. “Superata la crisi del 1917, l’ordine costituito sopravvisse sia per l’ingenuità organizzativa della sinistra, e ancor più per la grande disponibilità dei governi a ricorrere alla repressione armata. (…) Fra il 1918 e il 1921, (…) i braccianti anarchici del Sud organizzarono Esso era composto dai braccianti senza terra, assunti alla giornata, al mese oppure alla stagione, in condizioni di totale sfruttamento: giornate lavorative di 12 ore, insalubrità e salari bassissimi, situazione che peggiorava quando si trattavano delle donne. Questi lavoratori restavano disoccupati per circa metà dell’anno e la loro sopravvivenza era dovuta al credito a loro fornito dai commercianti locali. 166 Nelle valli e colline del Nord, nelle Asturie, nella Catalogna e nelle provincie basche. 165 189 numerose sommosse. Gli scioperi e l’occupazione della terra avvenuti in quegli anni (…) inasprirono il risentimento sociale nelle campagne del Meridione. Nello stesso periodo gli anarchici entravano in conflitto con il sistema anche nelle città” (PRESTON, 2000:24). Nel settembre 1923 ci fu il colpo di stato e la presa del potere da parte del generale Primo de Rivera, che mise fuori legge il movimento anarchico e strinse un patto con l’UGT – l’Unión General de Trabajadores, la federazione sindacale legata al partito socialista spagnolo –, alla quale concesse il monopolio nelle relazioni sindacali, e dette l’avvio a una serie di opere pubbliche che modernizzarono il capitalismo spagnolo. Ciò nonostante, perse il consenso tra le classi che lo appoggiavano – l’esercito, gli industriali e gli agrari – e finì per presentare le sue dimissioni nel gennaio 1930. Il suo successore, Dámasco Berenguer, non riuscì nel suo intento di portare al potere una monarchia costituzionale e, alle elezioni amministrative del 1931, i socialisti e i repubblicani ebbero una vittoria schiacciante nelle città, mentre i monarchici vinsero i seggi rurali dove il potere dei capi locali era rimasto inalterato. La nuova Repubblica, però, dovette fare i conti con un Sud in intermittente stato di guerra sociale, riducendo di molto le possibilità di riforme pacifiche. L’avvento della Seconda Repubblica – che segnò il passaggio del potere politico nelle mani della sinistra moderata – costituì una minaccia per i ceti privilegiati, allo stesso tempo in cui risvegliò enormi aspettative tra quelli più umili. I poteri sociale e economico, però, restarono nelle mani dell’oligarchia. Stando così le cose, si “può affermare in ultima analisi che a causare la guerra civile fu il tentativo dei leader progressisti di attuare alcune riforme contro il desiderio dei settori più potenti della società spagnola” (PRESTON, 2000:30). Per sopravvivere la Repubblica avrebbe dovuto aumentare i salari e diminuire la disoccupazione, ma la depressione economica gli impediva di riuscire in questo compito. “Il governo repubblicano si dibatteva in un terribile dilemma: se avesse accolto la richiesta delle classi inferiori di espropriare i grandi latifondi e occupare le terre, sarebbe probabilmente intervenuto l’esercito, annientando la Repubblica. Se avesse represso le agitazioni rivoluzionarie per tranquillizzare le classi abbienti, avrebbe perso il sostegno della classe operaia. La coalizione repubblicano-socialista tentò di percorrere la via mediana, finendo per scontentare gli uni e gli altri” (PRESTON, 2000:39). L’esempio più chiaro della difficile situazione in cui si trovava la Repubblica era quello riguardante la questione agraria. Gli anarchici chiedevano l’esproprio delle terre e la creazione di collettivi agricoli, ma i repubblicani non erano disposti ad accogliere tale rivendicazione. I quattro decreti promossi dal Ministro del Lavoro avevano portato qualche miglioramento alla situazione dei braccianti, ma ciò era ancora molto lontano 190 dalle loro aspettative. Si susseguirono una serie di manifestazioni e scioperi che furono repressi dalla polizia. La legge sulla riforma agraria, uscita alla fine del 1932, cambiò di poco la situazione. Essa prevedeva che i possedimenti superiori a 56 acri (circa 22,66 ettari) fossero lottizzati, non prendendo nessun provvedimento a favore dei piccoli proprietari del Nord. Ma i latifondisti si servirono di una serie di espedienti per non dichiarare la reale estensione delle loro terre. Nei primi d’agosto del 1932, il tentativo fallito di colpo di stato promosso dall’esercito e dall’estrema destra, la Sanjurjada, se da un lato diede forza e prestigio al governo, dall’altro svelò la grande ostilità di queste due classi nei confronti della Repubblica. Mentre gli scioperi e le manifestazioni popolari finivano sempre in violenza, destabilizzando il governo, la destra si organizzava nella CEDA – Confederación Española de Derechas Autónomas – un embrione del fascismo in Spagna. La nuova organizzazione insisteva nel rinfocolare i circoli agrari nei confronti della Repubblica, allo stesso tempo in cui, mettendo enfasi sull’autorità, la patria e la gerarchia, conquistava sempre più le simpatie della destra spagnola. Fu questo il quadro in cui si andò alle urne nel novembre 1933: una sinistra divisa contro una destra compatta. Vinse quest’ultima, avida di smantellare le riforme del biennio precedente. Ma, al primo tentativo del governo di riportare le cose come prima, la rabbia popolare esplose. Alla fine del 1933 la disoccupazione in Spagna aveva tassi del 12%, arrivando al 20% nel sud. La vittoria della destra fu festeggiata con riduzione dei salari, licenziamenti, aumento dei prezzi degli affitti e la completa inattuazione delle leggi sul lavoro. Tutto questo scatenò l’indignazione e la rivolta popolare, segnando l’inizio di un periodo di intensi scontri e di dura repressione di tutte le manifestazioni dei lavoratori indette e organizzate dalla sinistra. Allo stesso tempo, una crisi sempre più acuta all’interno della destra stessa si traduceva nel continuo cambiamento dei ministri e nella rottura rispetto alle posizioni più o meno radicali sostenute dalla classe dirigente. Le elezioni successive, indette per il febbraio 1936, furono questa volta vinte – di stretta misura ma con una maggioranza schiacciante alle Cortes – dalla sinistra del Fronte popolare. La destra non accettò pacificamente la sconfitta, e decise che era ora di distruggere la Repubblica. Anche l’esercito passò a complottare sul serio. Nelle campagne gli agrari e gli imprenditori erano sempre più ostili ai lavoratori che, a loro volta, volevano essere risarciti della violenza sindacale subita nel periodo precedente. In mezzo, impotente e paralizzato, stava il governo del Fronte popolare, per nulla rappresentativo della coalizione che gli aveva dato la vittoria. 191 Decisi a non farsi ingannare dalla sinistra un’altra volta, i lavoratori scesero in piazza in difesa dei loro diritti e organizzarono una serie di scioperi dei più svariati tipi: corporativi, politici, di solidarietà, generali, locali e regionali. La destra non tardò a rispondere, finanziando l’esercito e le squadre falangiste, mentre i padroni rispondevano con le serrate, facendo diventare la situazione sempre più tesa. Mentre l’esercito tramava di rovesciare il governo, giovani attivisti di destra e di sinistra si scontravano nelle piazze. Mancava alla Seconda Repubblica un governo autorevole e deciso capace di salvaguardarla. La situazione di caos instaurata diffondeva l’idea, a tutti i livelli, che l’esercito avesse il diritto di intervenire in politica per difendere l’ordine sociale e l’integrità territoriale della Spagna. Il colpo di stato avvenne il 17 luglio 1936, ma i cospiratori non avevano previsto che l’insurrezione si sarebbe trasformata in una lunga guerra civile. Secondo PRESTON, nelle località dov’era forte la componente operaia e in cui la Guardia Civil e le Guardie d’assalto rimasero fedeli al governo, i militari ribelli ebbero la peggio. La morte di Sanjurjo, avvenuta subito all’inizio della guerra, ebbe ripercussioni notevoli sul corso della guerra e sulla carriera di Franco che, dopo una serie di avvenimenti a lui favorevoli, diventò il principale uomo tra gli insorti. I diversi gruppi in concorrenza esistenti all’interno della destra si diedero una sorta di moratoria e iniziarono a collaborare fra di loro, mossi dall’obiettivo comune di creare uno stato corporativo autoritario, annientare le organizzazioni operaie e smantellare le istituzioni democratiche. D’altra parte, i repubblicani dovettero fare i conti con una serie di problemi ignoti ai nazionalisti: la mancanza di unità di intenti; le rivalità politiche; la non lealtà delle forze armate e i numerosi casi di tradimento, sabotaggio, negligenza colpevole e diserzione che contribuivano a destabilizzare la difesa della Repubblica. Il vuoto lasciato dalle defezioni militari fu presto colmato con le formazioni spontanee di miliziani non addestrati, ma restava il problema della Guardia Civil e delle Guardie d’assalto. Ci fu una breve fase di terrorismo diffuso, con attentati diretti soprattutto contro i militanti di destra e il clero. Le corti di Giustizia furono sostituite dai tribunali del popolo. Ma dopo l’autunno del 1936 i venti cambiarono e il terrore passò a prendere di mira i rivoluzionari. Il primo problema affrontato dai rivoluzionari fu quello della distribuzione dei generi alimentari. Gli alimenti venivano presi nei dintorni. Questi atti di espropriazione, chiamati requisas, diedero origine ai Comités de Abastos. Essi concentravano in depositi i prodotti di commerci particolari. Furono loro a stabilire le prime misure di distribuzione normale e di razionamento: gli articoli più pregiati, come il latte, la carne di pollo e le uova furono riservati agli ospedali e, nell’assegnazione di questi generi, si dava la precedenza ai 192 bambini, ai malati, ai vecchi e alle donne incinte. Gli articoli razionati ma non di prima necessità erano distribuiti mediante la presentazione dei buoni con turno rotatorio e, in alcuni casi, mediante ricetta medica. Così, prima della produzione, si organizzò la distribuzione. All’inizio si mise in pratica un sistema di scambio libero con i produttori: gli articoli industriali venivano scambiati per generi alimentari tenendo conto soltanto delle necessità. Il denaro non aveva più alcun valore e le requisas erano pagate con buoni che poi venivano risarciti dal Governo. Alle requisizioni seguivano le espropriazioni degli edifici e altri immobili da destinare ai sindacati, ai comitati, ai vari organismi rivoluzionari oppure al governo repubblicano. La collettivizzazione dei centri di produzione sequestrati fu un atto spontaneo dei lavoratori al termine di uno sciopero generale. Essi costituirono comitati di impresa e, insieme a tecnici specializzati, si incaricarono di assicurare la produzione e il funzionamento dei servizi nella forma più efficiente possibile. “Ogni industria espropriata si organizzò in uno sfruttamento collettivo orientato da operai (…) nominati dalle assemblee dei lavoratori riunite nei luoghi di produzione” (PEIRATS, 1962:35). In alcune industrie la collettivizzazione abbracciò l’intero ciclo di lavorazione, dalla fonte delle materie prime fino al prodotto finito. Le industrie così riunite erano chiamate industrias socializadas. Nel caso delle industrie dipendenti dal mercato estero sia per la commercializzazione che per l’acquisto delle materie prime, la collettivizzazione fu più difficile perché mentre il governo autonomo controllava le divise estere e quello centrale controllava i trattati commerciali, i capitalisti stranieri imponevano una serie di ostacoli al rifornimento delle materie prime e all’acquisto dei prodotti manufatti. “Le imprese che per diverse ragioni non potevano essere collettivizzate erano poste sotto la vigilanza del Control Obrero. La vigilanza consisteva nel controllo strettamente amministrativo dell’azienda. I comitati di controllo, installati in ogni fabbrica e annessi al personale amministrativo, potevano conoscere il valore reale dei prodotti sul mercato di vendita. Si informavano delle domande e delle offerte, del prezzo delle materie prime e delle transazioni corrispondenti (…)[,] del valore delle macchine e della mano d’opera, controllavano l’attivo e il passivo dei bilanci, vigilavano sulle frodi fiscali e (…) sul sabotaggio alla rivoluzione” (PEIRATS, 1962:38). Nelle città più piccole furono istituiti comitati locali del Fronte popolare e di Salute pubblica, veri e propri governi su scala regionale e provinciale. “Tutti i Comitati, per quanto diversi (…) nei giorni che segu[ir]ono la rivolta, si [impadronirono] di ogni potere locale attribuendosi funzioni legislative ed esecutive, decidendo sovranamente nella propria regione non soltanto sui problemi immediati come il mantenimento dell’ordine e il controllo 193 dei prezzi, ma anche dei compiti rivoluzionari del momento, socializzazione o sindacalizzazione delle imprese industriali, espropriazione dei beni del clero, dei «faziosi» o più semplicemente dei grandi proprietari, distribuzione ai mezzadri delle terre o sfruttamento collettivo delle medesime, confisca dei conti bancari, municipalizzazione degli alloggi, organizzazione dei servizi informativi, scritti o verbali, dell’insegnamento e dell’assistenza sociale” (BROUÉ e TÉRMINE, 1980:136). A Barcellona furono chiuse le case di tolleranza e i locali notturni, e i mendicanti furono assunti dalle organizzazioni sindacali di assistenza. Tranne la cattedrale, che fu chiusa, tutte le altre chiese furono bruciate. Gli alberghi di lusso furono requisiti e le sale da pranzo trasformate in mense. Dovunque, scritte informavano che l’impresa era stata “collettivizzata dal popolo” o che “apparteneva alla CNT”. Gli “operai, fin dai primi giorni, si [impadronirono] dei trasporti (…), delle ferrovie (…), del gas e dell’elettricità, dei telefoni, della stampa, dei teatri, degli alberghi e dei ristoranti, della maggior parte delle grosse imprese meccaniche e industriali (…). Ogni partito e ogni sindacato si impadron[ì] di un locale o di una stamperia. (…) I pubblici servizi [erano] in mano a Comitati misti C.N.T. – U.G.T.” (BROUÉ e TÉRMINE, 1980:165). Furono collettivizzati anche le sale cinematografiche, il commercio a dettaglio e l’industria della pesca167. Ogni impiegato si sentiva proprietario del proprio impiego, ma le differenze di salari tra le diverse categorie, così come quelle relative al sesso del lavoratore, persistettero, nonostante i principi anarchici egualitari. A Madrid, invece, le cose andarono diversamente. Gli operai armati erano rari, la polizia aveva ripreso il suo normale servizio per la strada, gli alberghi e i ristoranti di lusso funzionavano normalmente, i mendicanti restavano per la strada e le chiese, pur chiuse, rimanevano in piedi. L’errore dei rivoluzionari fu credere che il controllo sui mezzi di produzione era la rivoluzione. Ma l’avanzata dell’armata d’Africa di Franco e dell’esercito del Nord di Mola fecero loro capire la necessità di un coordinamento militare ed economico. “Alla fine di settembre il Comitato delle milizie fu disciolto e la CNT entrò nel governo della Catalogna, la Generalitat, insieme al PSUC e alla Esquerra” (PRESTON, 2000:182). I movimenti popolari rivoluzionari, nel ritenere che soltanto una guerra rivoluzionaria avrebbe potuto sconfiggere Franco, costituivano un ostacolo al compito prioritario di creare un esercito forte per vincere la guerra. In fondo questa era anche 167 Il «decreto di collettivizzazione» pubblicato dalla Generalitat rendeva “obbligatoria la collettivizzazione in tre casi: 1) in caso di abbandono dell’azienda da parte del padrone o di una sua implicazione in un «complotto fazioso», constatato da un tribunale popolare; 2) per ogni azienda con oltre cento salariati; 3) per quelle imprese in cui un’assemblea generale mista (padroni-salariati) ne faccia domanda” (VILAR, 1988:95). 194 l’opinione delle autorità repubblicane che il 18 luglio avevano esitato ad armare gli operai temendo che i lavoratori, armati per sconfiggere i militari ribelli, avrebbero scatenato la rivoluzione proletaria. Nonostante tutte le divergenze interne, gli sviluppi rivoluzionari della guerra nei suoi primi giorni furono una realtà da non ignorare. Anche se l’orientamento generale della CNT era di unire le forze per sconfiggere il nemico comune, lasciando la rivoluzione libertaria per il momento successivo, sotto la pressione della base le singoli sezioni ignorarono queste direttive e permisero la presa del potere rivoluzionaria. “Nell’industria e nel commercio si verificò un ampio processo di collettivizzazione che coinvolse (…) anche le botteghe artigiane” (PRESTON, 2000:185). Nel luglio 1936 furono i contadini a realizzare la riforma agraria, restando al governo solo di sanzionare l’occupazione. In poche settimane erano stati espropriati e in gran parte collettivizzati 5.692.202 ettari, contro gli 876.327 che la Repubblica aveva distribuito nei cinque anni precedenti. Tuttavia, l’occupazione della terra e delle fabbriche ebbe un’estensione diversa a seconda dei luoghi. I “collettivi erano molto diversi fra loro sia nelle modalità istitutive, sia nella conduzione. Non tutti erano controllati dalla CNT. (…) Non tutta la terra espropriata fu collettivizzata e non nella stessa misura per tutte le regioni. (…) In generale si può comunque affermare che nella zona repubblicana la collettivizzazione fu più intensa dove era più forte la CNT, come dimostra con particolare evidenza il caso dell’Aragona168” (PRESTON, 2000:186/187). 3.3. La formazione dei collettivi agricoli Nel parere di BROUÉ e TÉRMINE, la collettivizzazione rurale fu uno degli argomenti più controversi della storia della guerra civile spagnola. Secondo gli anarchici, essa era il risultato di una potente spinta all’associazione volontaria, provocata dalla propaganda e dagli esempi collettivisti di gruppi anarchici. Secondo i comunisti e i repubblicani, più che una creazione spontanea, i collettivi erano stati imposti con la forza e il terrore dagli anarchici. “Sotto la guida degli anarchici, il movimento di collettivizzazione riun[ì] oltre tre quarti delle terre, quasi esclusivamente in comunità affiliate alla C.N.T.: se ne conta[va]no più di 450 che raggruppa[va]no all’incirca 430.000 contadini. (…) I piccoli proprietari po[teva]no teoricamente continuare ad esistere a patto di coltivare da soli le proprie terre e di non utilizzare mano d’opera salariata. Il bestiame necessario al consumo familiare resta[va] proprietà individuale. La Federazione contadina [fece] grandi sforzi per 168 Secondo BROUÉ e TÉRMINE, i collettivi potevano: riunire tutti gli abitanti di un villaggio; essere guidati dalla CNT-UGT insieme oppure soltanto dalla CNT; coesistere con le proprietà individuali fondate esclusivamente su terre confiscate oppure sulla collettivizzazione di piccoli lotti individuali o ancora su tutte e due le basi. 195 organizzare delle fattorie modello, dei vivai, delle scuole tecniche e rurali. (…) La cosa più singolare (…) dell’esperienza libertaria di Aragona fu l’applicazione sistematica dei principî e delle teorie anarchiche sul danaro e sui salari. Il salario [era] un salario familiare uniforme: 25 pesetas alla settimana per un produttore isolato, 35 per una coppia con un solo lavoratore, 4 pesetas in più per ogni figlio a carico. Ma non [era] denaro in circolazione, bensì dei buoni – i vales – cambiabili con prodotti nei negozi della collettività. Il sistema funziona[va]. L’esperienza però [era] poco concludente, in quanto le collettività per rifornirsi di merce nel resto della Spagna, d[oveva]no, volenti o nolenti, utilizzare il denaro teoricamente scomparso…” (BROUÉ e TÉRMINE, 1980:173). Era stata decisa anche la costituzione di un fondo comunale in tutti i collettivi – che nella maggior parte dei casi era composto dell’eccedente della produzione – da essere usato ai fini di scambi dei prodotti con altre regioni o collettivi, oppure venduto all’estero. Secondo DELLACASA, i collettivi agricoli si formarono subito all’inizio della guerra civile. Erano più di 1200 e interessavano oltre tre milioni di contadini. Le principali regioni erano l’Aragona – dove, secondo RANZATO, tre quarti delle terre erano state collettivizzate –, il Levante e la Nuova Castiglia, e un po’ meno numerosi nella Catalogna. Il processo di formazione dei collettivi era, secondo l’autore, uguale dappertutto. Dopo aver sopraffatto o sostituito le autorità locali con i comitati rivoluzionari, veniva indetta un’assemblea di tutti gli abitanti della zona per decidere la linea d’azione da seguire. Uno dei primi passi era provvedere al raccolto nei campi dei piccoli ma soprattutto dei grandi proprietari e con questo obiettivo venivano organizzati gruppi per mietere e battere il grano di questi ultimi. Poi, per evitare che ci fossero delle ingiustizie nella distribuzione del prodotto, esso veniva messo sotto il controllo di un comitato locale, affinché potesse essere usato da tutti gli abitanti sia per il proprio consumo, sia per scambiarlo con altri generi agricoli o manufatti. Dopodiché era necessario provvedere alla coltivazione delle terre dei grandi proprietari, di regola le più estese e fertili della regione. Per decidere come farlo era, di solito, convocata un’altra assemblea del villaggio. A questo punto il collettivo veniva costituito. Il Comitato era l’organo regolatore dei collettivi. Dopo aver provveduto al censimento e all’unificazione delle proprietà, esso passava a pianificare le opere e distribuire il lavoro tra gli aderenti al collettivo. “Veniva nominato un delegato per l’agricoltura e per l’allevamento del bestiame, e diversi delegati per la distribuzione, gli scambi, i lavori pubblici, l’igiene, l’educazione e la difesa rivoluzionaria … Quindi venivano formati i gruppi di lavoratori. Questi gruppi generalmente erano divisi per il numero di zone in cui era stato diviso il territorio municipale, in modo da includere più facilmente ogni genere di lavoro. Ogni gruppo di lavoratori 196 nominava il suo delegato. I delegati si incontravano con i consiglieri dell’agricoltura e dell’allevamento ogni due giorni, oppure ogni settimana, in modo da coordinare tutte le diverse attività. In questa nuova organizzazione la piccola proprietà [era] quasi completamente scomparsa” (DELLACASA, 1973:100). Il lavoro collettivo cominciò, poi, spontaneamente, così come fu spontanea la decisione di aderire o meno ai collettivi. Presto esso rese possibile il raggiungimento sia nell’agricoltura che nell’industria di una razionalizzazione del lavoro impossibile da ottenere individualmente nella piccola o nella grande proprietà. Essa si verificava nell’utilizzo di semi selezionati, di macchinari e tecniche di produzione moderne che avevano come risultato l’aumento della produzione e della produttività. Inoltre, i contadini appartenenti ai collettivi avevano a disposizione un piccolo appezzamento di terre per uso proprio, dove potevano coltivare quello che preferivano e come preferivano, sempre per l’autoconsumo. I collettivi avevano un Regolamento che stabiliva alcune regole riguardanti la sua amministrazione; l’organizzazione e le funzioni del comitato; gli obblighi dei membri aderenti al collettivo169; la forma di allevamento del bestiame; l’immagazzinamento dei prodotti commestibili e del raccolto agricolo; la creazione di cooperative di consumo; l’aumento della produzione; il consumo dei prodotti da parte dei membri del collettivo; la determinazione dei giorni di festa; l’uso del denaro – nella maggior parte dei casi non circolante all’interno del collettivo –; l’elezione dei delegati di ogni ramo del lavoro; l’età minima e massima per il lavoro all’interno del collettivo e le attività da svolgere; i diritti o meno che spettavano a coloro che decidessero allontanarsi oppure trasferirsi dal collettivo; come venivano prese le decisioni più importanti relative alla sua conduzione e, infine, la sovranità e il ruolo dell’Assemblea all’interno del collettivo. Questa, vale la pena di sottolineare, aveva una grande importanza in quanto garante del mantenimento dell’organizzazione comunale e della realizzazione delle attività nel migliore dei modi. Sempre secondo DELLACASA, salvo in quelle zone specializzate nella produzione per l’esportazione, che non avevano la possibilità di cedere i prodotti locali in cambio dei generi alimentari di cui avevano bisogno, le condizioni economiche dei contadini erano in genere migliorate. Riguardo al consumo, fu applicato il principio anarchico a ciascuno secondo i suoi bisogni, “in due modi diversi: senza denaro in molti villaggi aragonesi, e con moneta locale in altri, e nella maggior parte dei «collettivi» istituiti in altre regioni. Il salario familiare [veniva] pagato con questo denaro, e varia[va] secondo il numero dei membri in 169 I membri avevano l’obbligo di consegnare alla collettività tutti i suoi beni, mobili e immobili, alla quale consegna veniva fornita una ricevuta. 197 ciascuna famiglia. [Erano] i bisogni, e non solo la produzione considerata nel senso strettamente economico, che regola[va]no la misura dei salari o quella della distribuzione dei prodotti dove non esist[eva]no salari. Questo principio di giustizia [veniva] continuamente esteso. Esso [mise] fine alla carità, all’accattonaggio e ai fondi speciali per i poveri”170 (DELLACASA, 1973:102). Nei collettivi che avevano scelto la forma senza denaro, veniva creato un libretto di consumo uguale e valido in tutti i collettivi. Il salario e il valore dei prodotti erano stati sostituiti da un sistema di “punti”. Ogni lavoratore singolo e ogni famiglia aveva un suo libretto di consumo, dove venivano segnalati i punti ai quali avevano diritto in quella settimana, i punti dei prodotti acquistati e i punti rimasti. In questo modo ognuno poteva controllare il suo budget settimanale e acquistare i prodotti secondo le proprie necessità. In alcuni casi era stato determinato un razionamento dei prodotti di scarsa produzione, mentre quelli più abbondanti erano rimasti di libero accesso. Poi, per sfuggire all’obbligatorietà del consumo che questo sistema comportava, si decise di dare anche a quei prodotti un valore in punti e di dare ai lavoratori un totale massimo, sempre in punti, di prodotti di scarsa produzione da consumare durante la settimana. In questo modo, ogni lavoratore o ogni famiglia regolava da sé il consumo di questi prodotti e decideva liberamente come consumarli, a seconda dei gusti personali. La produzione veniva ammassata nel magazzino del collettivo – normalmente l’antica chiesa che passava a essere adibita a tale scopo – e, in seguito, il Comitato provvedeva alla distribuzione dei prodotti prima fra i membri del collettivo, secondo le loro necessità e, poi, allo scambio dei prodotti eccedenti tramite la Federazione171. PEIRATS informa anche che gli scambi tra i vari collettivi avvenivano senza l’uso del denaro. Un altro punto sottolineato dall’autore riguarda l’approvvigionamento del fronte: ciascun collettivo inviava al fronte i prodotti di cui poteva disporre, fatto che tante volte significava un eccesso di lavoro da parte degli anziani e delle donne, dato che la maggior parte degli uomini e dei giovani erano impegnati nella lotta. Vale la pena di ricordare che il comunismo libertario prevedeva la fine dei salari e il libero accesso al risultato della produzione, da alcuni detta ricchezza sociale. 171 RANZATO richiama l’attenzione sul fatto che non sempre le cose andarono come avrebbero dovuto andare. Si verificarono una serie di problemi come la “concorrenza fra comunità, gestioni proprietaristiche delle collettività da parte dei Comitati, e molti sperperi, perché a volte, se in una collettività vi era abbondanza di un prodotto, si distribuiva fra i membri a volontà, mentre magari in una comunità vicina quel prodotto scarseggiava” (RANZATO, 1972:331). L’Aragona fu la regione dove le cose andarono meglio. Secondo l’autore questo fu dovuto alla maggiore diffusione e omogeneità dei collettivi. Inoltre, l’autore sottolinea che la collettivizzazione totale si realizzò soprattutto nelle piccole comunità già caratterizzate da un’economia quasi completamente chiusa. 170 198 I collettivi si organizzarono tra loro e nel febbraio 1937 fu convocato ad Aragona un Congresso che vide la partecipazione di 500 delegati. In quell’occasione fu creata la FRC – Federazione Regionale delle Collettività – “approvando un Regolamento, secondo cui la FRC doveva difendere gli interessi dei collettivisti, propagandare i vantaggi della collettivizzazione basata sul mutuo appoggio, promuovere lo sviluppo tecnico e la preparazione tecnica dei giovani, organizzare gli scambi172, istituire una Cassa per fronteggiare tutte le eventualità finanziarie, elevare la cultura dei collettivisti. Le collettività federate dovevano portare alla FRC delle statistiche veritiere su produzione, consumo, forza lavoro, ecc.; creare una moneta locale, eliminando quella nazionale; contribuire alla Cassa della FRC; prestare la manodopera eccedente alle collettività che ne scarseggiavano, ecc.” (DELLACASA, 1973:106). Secondo RICHARDS, un altro compito svolto dalla Federazione fu quello di cercare di controbilanciare le avversità naturali, fornendo ai collettivi delle zone di suolo povero oppure di bassa precipitazione, le sementi, gli animali e i macchinari necessari per migliorare la produttività del suolo e la qualità dei prodotti coltivati. LEVAL (1983), a questo proposito, rammenta che, secondo una determinazione della Federazione, ogni collettivo doveva creare dei progetti di sviluppo e miglioramento dell’agricoltura, lasciando da parte una parcella di terra da trasformarsi in stazione agricola sperimentale, dove tecnici specializzati avrebbero condotto delle ricerche con lo scopo di migliorare la qualità del bestiame e delle varietà vegetali coltivate. Riguardo alla regione aragonese, era prevista la creazione di tre vaste zone destinate alla produzione di sementi per tutti i collettivi, anche quelli non appartenenti all’Aragona. Queste tre zone dovevano anche scambiare i risultati delle loro ricerche e lavorare in modo coordinato, sotto la supervisione di tecnici specializzati che poi, riunitisi con tecnici di altre regioni, avrebbero confrontato i loro risultati e scambiato le loro esperienze. L’obiettivo era, oltre a stimolare lo spirito comunitario al posto di quello regionalista, di arrivare alla pianificazione dell’economia agraria. La Federazione Regionale provvedeva anche alla distribuzione di prodotti di circa una cinquantina di collettivi, chiedendo a loro nome ai centri industriali e di allevamento 172 Secondo PEIRATS, i collettivisti potevano tenere per sé, rispettando i limiti di consumo imposto, i prodotti che avevano coltivato. L’eccedente era inviato alla Federazione che si incaricava di distribuirli tra tutte le collettività. I prezzi erano fissati in base al valore della località di produzione oppure con il parere di un organismo nazionale regolatore dei prezzi. In più, i “coltivatori avrebbero ricevuto i generi di consumo necessari alle cooperative, fertilizzanti, macchine e altri mezzi per il maggiore sfruttamento agropecuario a prezzo di costo, con il solo carico delle spese amministrative e di trasporto” (PEIRATS, 1962:62). 199 del bestiame i prodotti di cui essi avevano bisogno173. Inoltre, essa doveva facilitare il trasferimento dei contadini da una zona a scarso impiego di forza lavoro a un'altra che ne aveva più bisogno, oltre ad avviare all’uso comune degli strumenti di lavoro tra i collettivi. Riguardo a quei contadini che avevano deciso di non aderire ai collettivi, DELLACASA informa che ogni collettivo aveva adottato un conto corrente speciale e aveva stampato per loro dei tagliandi di consumazione, in modo da assicurare loro i prodotti industriali oppure i generi agricoli di cui essi avessero bisogno. Nelle zone dove la proprietà individuale aveva prevalso, si formarono delle cooperative di produzione in cui i piccoli proprietari si associavano, ma via di regola la distribuzione restava nelle mani dei privati. Va sottolineato, però, che quelli che decidevano di non far parte dei collettivi potevano mantenere come proprietà individuale soltanto le terre che fossero in grado di coltivare attraverso l’uso della manodopera familiare, non essendo permessa la contrattazione di braccianti. Le proprietà dei fascisti e quelle lavorate dai fittavoli, invece, furono tutte consegnate all’usufrutto dei sindacati e dei collettivi. 3.4. I collettivi visti dall’interno Con l’obiettivo di capire meglio l’esperienza della collettivizzazione in Spagna, LEVAL si dedica allo studio di alcuni collettivi, mettendo in evidenza il loro processo di formazione, la loro organizzazione interna, la forma come fu organizzata la produzione, l’accesso ai prodotti coltivati, ecc. Si occupa delle tre regioni dove queste esperienze furono più significative: il Levante, l’Aragona e la Castiglia e, per le due prime, riporta alcuni casi dall’interno, utili per farci capire le somiglianze e le particolarità del processo di collettivizzazione spagnola. Per il Levante, analizza i collettivi di Jativa e Magdalena de Pulpis. Per l’Aragona, la più ricca di esperienze, analizza i collettivi di Fraga, Alcolea di Cinca, Binefar, Graus, Alcorisa, Mas de las Matas, Esplus e Andorra. Per la Castiglia rimane soltanto nelle caratteristiche generali della collettivizzazione, dato che non furono ritrovate differenze significative rispetto a quelle delle altre regioni studiate. La Federazione Regionale del Levante era tra quelle più attive della Spagna. Era parte integrante della Confederazione Nazionale del Lavoro, costituita dai Sindacati Operai e dei Contadini, tradizionalmente organizzata dai libertari spagnoli. Essa servì di base alla Federazione parallela dei collettivi agrari del Levante, la quale comprendeva cinque province – dal nord al sud, Castellon de la Plana, Valenza, Alicante, Murcie e Albacete. 173 Senza riferirsi alla Federazione, VILAR argomenta che teoricamente “ogni comune copriva i suoi bisogni e riservava i suoi surplus alle comunità superiori («comarca», «regione»)” (VILAR, 1988:99). 200 Nel 1936 i villaggi di queste province si raggrupparono in 23 cantoni (“comarche”). La provincia di Murcie aveva sei federazioni cantonali, Alicante nove, Castellon de la Plata otto e Albacete quattro. Vale la pena di sottolineare che la struttura di queste organizzazioni cantonali non aveva niente a che vedere con i cantoni tradizionali dell’amministrazione pubblica o dello Stato. Più che un criterio politico, essa rispondeva al bisogno di unione diretta. Lo sviluppo e la moltiplicazione dei collettivi levantini stupirono anche quelli che si mostravano più ottimisti riguardo alle possibilità di ricostruzione sociale. Nonostante tutte le difficoltà, essi passarono dai circa 400 nel novembre 1937 agli 800 alla fine del 1938, raggruppando più del 40% della popolazione della regione. Per meglio capire queste cifre basta dire che le cinque province levantine totalizzavano 1.172 località. Di queste, il 78% furono organizzate collettivamente, dando origine a 800 collettivi, numero più elevato di quello dell’Aragona. Tale fatto era dovuto al maggiore consolidamento delle classi sociali e alle caratteristiche dei contadini che, dovuto all’azione del sindacato locale, erano più organizzati, avevano più fiducia nelle loro possibilità, più attitudine alla lotta e potere materiale, nonostante gli ostacoli alla collettivizzazione imposti dalle autorità rimaste al posto delle Guardie d’Assalto. “Quasi sempre, nel Levante, le collettività174 [nacquero] per iniziative del sindacato dei contadini del luogo; ma non tardarono a costituire un’organizzazione autonoma. Col sindacato si mantenne solo un contatto esterno costituendo esse la congiunzione necessaria tra collettivisti e individualisti. Infatti questi vi portavano i loro prodotti per scambiarli con altri generi. (…) Nel suo seno erano state create delle commissioni – per il riso, le arance, l’orticoltura, le patate, ecc. –, che facevano capo all’amministrazione di un magazzino di raccolta e di ridistribuzione. Anche la collettività aveva il suo magazzino e le sue commissioni. Più tardi però quest’inutile sdoppiamento fu eliminato. I magazzini furono unificati; le commissioni furono composte di collettivisti e individualisti iscritti al sindacato” (LEVAL, 1952:146). Fu creata anche una commissione mista per l’acquisto delle macchine, sementi, concimi, pesticidi e prodotti veterinari. Avvenne così la socializzazione. Rapidamente si verificò la tendenza a unificare e razionalizzare tutto. Il razionamento e il salario familiare175 furono stabiliti per cantone e i villaggi più ricchi LEVAL si riferisce ai collettivi usando questo termini. Sempre che si tratti di una sua citazione, rispetterò la terminologia usata da lui. 175 Le categorie salariali erano di solito: uomo solo; donna sola; coniugi senza figli; figlio o fratello a carico del collettivista; ragazzo con età compresa tra i 10 e i 14 anni; ragazza con età compresa tra i 10 e i 14 anni; ragazzo in inizio di attività lavorativa; ragazza in inizio di attività lavorativa. Nonostante l’impostazione libertaria di questi collettivi, nella maggior parte dei casi il salario delle donne era inferiore a quello degli uomini, e in alcuni casi, come a Jativa, corrispondeva alla metà. 174 201 aiutavano quelli più poveri attraverso i comitati cantonali. Tutti i centri cantonali possedevano un nucleo di tecnici specialisti tra cui contabili, veterinari, agronomi e tecnici agricoli, ingegneri, architetti e esperti di commercializzazione. Tutti lavoravano integrati tra loro, pianificando le attività produttive e garantendo così il successo dei collettivi. La vicinanza dei villaggi, d’altra parte, facilitava lo stabilimento di una solidarietà tra loro. Il lavoro era spesso intercomunale, fatto che facilitava la sincronizzazione degli sforzi e l’elaborazione di un piano generale. Le équipe si mettevano insieme per combattere le malattie delle piante, ramare, tagliare, innestare, sottrarre gli alberi, arare il suolo, iniziare nuove coltivazioni. Tutto ciò facilitava il coordinamento degli sforzi e la sincronizzazione di un piano generale elaborato a seconda degli insegnamenti pratici del lavoro. “Le (…) collettività e sezioni di sindacato della regione del Levante erano suddivise in 54 federazioni cantonali, che si raccoglievano in cinque federazioni provinciali, le quali sboccavano nel Comitato Regionale (…). Questo Comitato, nominato dai congressi annuali e responsabile di fronte ad essi (…), si componeva di 26 sezioni tecniche: frutticoltura in generale, agrumi, vigne, oliveti, orticoltura, riso, bestiame ovino e caprino, bestiame suino, bestiame bovino; venivano poi le sezioni industriali: vinificazione, fabbricazione d’alcools, di liquori, di conserve, di olio, di succo di frutta, di essenze e profumi così come altri prodotti derivati; in più si lanciavano le sezioni di produzioni diverse, d’importazione-esportazione, di macchinari, trasporti, concimi; quindi la sezione di costruzione orientante e stimolante la costruzione locale di edifici d’ogni specie; infine, la sezione igiene e dell’insegnamento” (LEVAL, 1970: 148/149). Tutte queste attività, dalla produzione alla distribuzione, erano sincronizzate tra tutti i collettivi della regione, grazie alla coordinazione del lavoro esistente. Sempre secondo LEVAL, la sede delle federazioni cantonali era scelta di solito in funzione della prossimità alle vie di trasporto delle merci. I collettivi di tutti i cantoni vi inviavano i prodotti eccedenti che venivano contabilizzati, classificati e immagazzinati. Le cifre corrispondenti erano inviate alle differenti sezioni del Comitato Regionale di Valenza, di modo che la Federazione potesse sapere esattamente di quali riserve disponeva per poter avviare gli scambi, le esportazioni e le importazioni. Le procedure per l’installazione di una nuova industria servono di esempio del coordinamento esistente tra i collettivi. Quando i membri di un collettivo o un comitato locale credevano utile fondare una nuova industria, qualsiasi essa fosse, dovevano presentare il progetto alla sezione industriale del Comitato Regionale Federale di Valencia che l’esaminava e decideva sulla sua possibilità. Se dopo l’analisi della domanda, delle materie prime disponibili, ecc. l’idea fosse ritenuta interessante, essa veniva adottata; 202 altrimenti, venivano fornite spiegazioni sul perché la proposta era stata rifiutata. Uno dei motivi poteva essere l’esistenza di fabbriche già installate da altre parti. L’accettazione dell’iniziativa non significava che i suoi promotori diventassero i suoi proprietari. Siccome alla sua fondazione venivano impiegate risorse fornite dall’insieme dei collettivi, la Federazione diventava la proprietaria della nuova fabbrica e il collettivo locale aveva il diritto di vendere al suo beneficio i suoi prodotti. Spese e guadagni erano dunque affari di tutti. Era la Federazione che ripartiva le materie prime fornite a tutte le fabbriche e tutte le località, a seconda del loro tipo di produzione e dei loro bisogni. Le sedi delle federazioni cantonali spesso erano scelte per le sue vicinanze a strade o ferrovie, facilitando così il trasporto e l’immagazzinamento delle merci. Infine, accanto agli sforzi di organizzazione e di giustizia economica stavano quelli culturali e di istruzioni. Così, ogni collettivo creava una o due scuole con la stessa prontezza con cui procedeva alle prime creazioni economiche. Il salario familiare permetteva l’invio di tutti i bambini alla scuola. L’ultima grande novità era stata la creazione dell’università agricola di Moncada, nella provincia di Valencia, che avrebbe dovuto offrire 300 posti. Lo scopo era quello di formare tecnici agricoli, con l’insegnamento delle diverse specialità del lavoro della terra e della zootecnia (come dedicarsi al bestiame, metodi di selezioni, caratteristiche delle razze, orticoltura, frutticoltura, apicoltura, silvicoltura, ecc.). Passando a trattare dei casi specifici, LEVAL cita il collettivo di Jativa, dove il numero degli aderenti per collettivi veniva limitato in modo a ridurre l’eccesso di persone all’inizio dello sperimento. “Ogni aderente compila[va] un formulario specificando la sua identità e quella della famiglia o di coloro che [erano] a suo carico, ed inoltre i particolari del suo capitale attivo e del suo conto passivo: contanti, utensili, terre, debiti, ecc.” (LEVAL, 1970:156). Il collettivo produceva riso e arance in metà delle terre (un quarto e un quarto) e ortaggi nell’altra metà, ma si preparavano progetti di allevamento del bestiame e del pollame, l’impianto dell’apicoltura e lavori di rimboschimento. Inoltre, il collettivo aveva comprato quattro autocarri e stava iniziando una vasta opera d’irrigazione e la costruzione del magazzino d’approvvigionamento. Le bestie da soma erano curate e usate in comune. L’altro esempio citato da LEVAL fu il villaggio di Magdalena de Pulpis, all’epoca con 1400 abitanti. Nelle località predominavano le piccole proprietà: dei 6654 ettari di terreno, 6254 erano occupati da esse. Nella maggior parte dei casi i contadini realizzavano ancora lo scambio in natura, ragione per cui dopo la rivoluzione essi vollero subito realizzare il comunismo libertario. Furono organizzati i collettivi e fu aperta una lista di iscrizioni. Tutti gli abitanti si iscrissero a far parte dei collettivi, alcuni meno 203 convinti degli altri, ma nessuno costretto. In seguito, tutto fu messo in comune: terre, denaro, animali, strumenti di lavoro, case, ecc. Il sindacato dirigeva la produzione, ma soltanto in quanto strumento tecnico: era l’assemblea comunale quella che presiedeva tutto. Fu costituito un comitato amministratore della vita locale, il quale controllava il denaro, assegnava i mezzi di sussistenza a ogni famiglia e una volta alla settimana, leggeva il rapporto delle sue attività – in particolare il bilancio tra gli acquisti e le vendite – perché fosse discusso e approvato dall’assemblea. Nei primi tempi, data la necessità di provvedere a un razionamento, fu determinata quale dovesse essere la quantità di viveri – in moneta – capace di garantire la sussistenza delle famiglie. Libero accesso invece fu garantito all’olio e alla legna, data la loro abbondanza. Per poter accedere agli altri alimenti, “era stato fatto uno schedario nel quale figurava ogni famiglia, col numero e l’età delle persone componenti. Ogni persona aveva diritto a ciò che si chiamava (…) una razione. La razione degli uomini era fissata in una peseta e venti, quella delle donne in una peseta e dieci. (…) I ragazzi più piccoli avevano mezza razione. A partire dai sei anni, (…) si passava alla razione intera. Una volta stabiliti il numero delle razioni e le quantità corrispondenti dei prodotti per ogni famiglia, questa riceve[va] una tessera speciale. La cosa più importante in essa [era] un cartellino attaccato alla copertina interna nel quale si legge[va]: anno 1937 – primo trimestre – numero di razioni – valore in pesetas – resto dell’anno precedente – totale. In calce una nota: vale per procurarsi ogni genere di prodotti, eccetto l’olio, la legna ed il vino che sono di libero consumo. In ogni pagina cinque caselle uguali per scrivervi il valore delle spese fatte; le famiglie po[teva]no così sapere se consuma[va]no in un mese o trimestre più di quanto loro spetta[va]. Po[teva]no quindi acquistare per il valore indicato nella tessera ed al ritmo che loro conv[eniva]. Se vo[leva]no conservare un fondo di riserva, questa riserva [veniva] annotata, e rimane[va] per il trimestre successivo. Non si paga[va]no più affitti. L’abitazione [era] completamente socializzata. Le cure mediche [erano] gratuite. (…) Anche la farmacia fu collettivizzata. (…) I denari occorrenti si procuravano mediante il commercio. Si vendevano i prodotti all’esterno e se ne riscuoteva il prezzo. Con queste pesetas che costitui[va]no un fondo comune, si comperava fuori ciò che occorreva alla collettività o si pagavano i servizi ricevuti. Ma all’interno il piccolo commercio era sparito. I commercianti erano entrati spontaneamente nella collettività. Alla loro attività di prima si sostituì una cooperativa” (LEVAL, 1952: 183/184). Riguardo al lavoro agricolo, l’autore sottolinea che l’area seminata si era triplicata, e questo perché prima buona parte dei contadini, non avendo soldi per comprare le 204 sementi e i concimi, finiva per lasciare incolta una parte delle sue terre. Il comune era stato diviso in tre sezioni, ognuna con un delegato responsabile per i lavori. I delegati si riunivano una volta alla settimana per discutere del lavoro da svolgere nella settimana successiva. I lavoratori erano divisi in gruppi di quindici uomini. I lavori da svolgere venivano assegnati dai delegati in una lavagna. I gruppi di lavoratori si segnavano a seconda delle attività da svolgere e, così, sapevano che cosa dovevano fare durante la settimana. Essi si spostavano da una località all’altra, a seconda delle necessità. L’altra regione studiata dall’autore fu l’Aragona, dove vaste distese di terre, disabitate e incolte, appartenevano ai latifondisti. La maggioranza della popolazione era costituita da contadini proprietari di un piccolo appezzamento di terre, mezzadri e giornalieri. Esisteva una forte polemica riguardo a come organizzare la società dopo l’avvento della rivoluzione: comunisti, socialisti e i membri dell’UGT parlavano di nazionalizzare le terre – i comunisti parlavano semmai dell’organizzazione delle cooperative agricole – mentre gli anarchici parlavano della socializzazione in quanto base per una collettivizzazione generale. Ma dopo l’esproprio dei fascisti, le terre espropriate costituirono il nucleo iniziale dei collettivi agricoli, aumentate poi da successive adesioni dei contadini proprietari e da donazione di terre. Furono organizzati dei collettivi locali dopo la convocazione di assemblee generali realizzate subito dopo la cacciata dei fascisti, ma fu garantita a tutti la libertà di scegliere se entrare a far parte dei collettivi oppure continuare producendo individualmente. Ogni collettivo fu diviso internamente in “gruppi di lavoro, composti da 5 o 10 o più persone unite da spirito di vicinato o simpatia. E ogni gruppo [aveva] il suo delegato che, insieme agli altri, distribui[va] il lavoro giorno per giorno o settimana per settimana, secondo la stagione e le necessità. Le collettività locali d’un distretto innerva[va]no la Federazione Comarcale. C’[era] una commissione che riceve[va], da ogni collettività di villaggio, un inventario sempre aggiornato sull’estensione delle terre, sulla quantità di macchine utensili e mezzi di trasporto in sua proprietà, sul numero di famiglie che la compon[eva]no e statistiche sulla produzione. La Federazione Comarcale dispone[va] dei prodotti in eccedenza, li invia[va] alla Federazione Regionale e, in alcuni casi, a Barcellona per l’interscambio. Per la strada inversa, i villaggi e le collettività venivano riforniti di ciò di cui mancavano, spesso secondo le richieste, ma altre volte secondo le disponibilità. La Federazione Comarcale si componeva dei delegati eletti dalle collettività” (LEVAL, 1952:189). Inoltre, tutte le Federazioni Comarcali facevano capo alla Federazione Regionale. 205 Tracciato questo quadro generale, l’autore ci fornisce alcuni esempi. Il primo fu quello del collettivo di Fraga, i cui abitanti disponevano di 30.000 ettari di terre passibili di essere utilizzati per le coltivazioni, oltre ai 18.000 composti da steppa o terre aride. Il collettivo cominciò a organizzarsi nei primi giorni dell’agosto, essendo il comitato locale una continuazione di quello rivoluzionario. Esso era responsabile della direzione di tutta la vita sociale in tutte le specializzazioni del lavoro: agricoltura, l’allevamento del bestiame, industria, distribuzione, igiene, assistenza sociale, lavori pubblici, organizzazione scolastica. I membri del comitato erano eletti dai lavoratori direttamente interessati. L’unica eccezione era fatta per il responsabile della distribuzione, nominato da un’assemblea di rappresentanti di tutte le attività locali, con il compito di risolvere i problemi riguardanti a tutti gli abitanti, anche di quelli che non appartenevano ai collettivi. In campo agricolo il collettivo dei contadini e dei pastori era diviso in due sezioni, uno dei contadini, l’altro dei pastori. “Settecento famiglie, metà delle quali vivevano del lavoro dei campi, componevano la prima. Gli agricoltori erano divisi in cinquantuno gruppi, venti specializzati nella cultura intensiva – soprattutto l’orticoltura – e trentuno nella cultura estensiva – specialmente cerealicola. Ogni gruppo aveva il suo responsabile. Responsabili e collettivisti si riunivano ogni sabato per decidere sull’indirizzo generale del lavoro. Il consigliere del lavoro agricolo assisteva alle riunioni per coordinare l’attività dei contadini collettivisti con quella dei contadini individualisti e dei pastori. (…) [I pastori], in numero di sessanta, si occupavano di seimila pecore madri, quattromila montoni, centocinquanta vacche, seicento capre e duemila porci. Quasi tutto questo bestiame era appartenuto a grandi proprietari. (…) Ogni gregge aveva due o tre pastori, uno dei quali era il responsabile. I responsabili si riunivano pure ogni sabato ed il consigliere dell’agricoltura assisteva anche alle loro riunioni. Veniva deciso in questa sede in che luoghi le greggi dovessero pascere nella seguente settimana, quali mezzi adoperare per custodirle, quali lavori compiere nelle stalle, quali animali uccidere. In questo modo le terre coltivabili ed i pascoli si utilizzavano con metodo, in perfetto accordo con gli agricoltori. I risultati erano rilevanti” (LEVAL, 1952:193). Oltre ai collettivi citati esistevano anche quelli dei lavori industriali (di solito divisi a seconda delle specialità), della distribuzione dei prodotti, dell’igiene, dell’assistenza sociale, dei lavori pubblici, ecc. Essi non avevano esistenza indipendente, ma convergevano in un’unica amministrazione economica comunale. I salari erano determinati dal consiglio comunale, pagati in moneta locale, e variavano da 40 pesetas alla settimana per un uomo singolo a 70 pesetas per una famiglia composta da dieci persone. Le categorie erano di solito le stesse già citate, ma in questo caso uomini e donne 206 percepivano lo stesso salario, che qui passò a essere chiamato credito. Quelli che rimasero individualisti erano rispettati ma dovevano produrre in modo da non pregiudicare l’economia generale. Con questo obiettivo, il delegato assisteva alle loro riunioni, indicando ciò che conveniva seminare, piantare, sopprimere e perfezionare. Inoltre, egli comprava i loro prodotti pagandoli secondo le tariffe stabilite dal sindacato, al quale appartenevano, tra l’altro, anche i produttori individualisti. La distribuzione era così completamente socializzata. Riguardo al consumo, si applicò un sistema dei buoni, essendo stata eliminata la moneta locale. Gli articoli più difficili da trovare erano razionati, fatto che evitava gli squilibri tra i membri del collettivo. Ogni famiglia possedeva un libretto sul quale figuravano le quantità dei prodotti che aveva diritto di consumare. Tutti i prodotti di consumo locale erano distribuiti dai magazzini comunali e anche dalle cooperative, sotto il controllo del consigliere del vettovagliamento. Esisteva un magazzino generale per il pane, tre per i prodotti di spezierie/drogherie, tre macellerie e tre salumerie. Il grano, di accesso libero tanto agli individualisti quanto ai collettivisti, veniva consegnato a un magazzino destinato ai cereali. Poi, a seconda del consumo, veniva consegnato ai mulini comunali che distribuivano la farina a undici forni che preparavano il pane e lo consegnavano subito alla distribuzione. Il consiglio comunale applicava un sistema di credito. Quando un collettivista o un produttore individuale aveva bisogno di moneta per un acquisto importante, si dirigeva all’organizzazione delle finanze locali e formulava la sua domanda. Si calcolava allora, sulla base di una valutazione fatta da due delegati collettivi e due individualisti, il valore di ciò che, nel lasso di tempo proposto, salvo gli eventuali incidenti naturali, egli avrebbe potuto ottenere dal suo lavoro. In seguito, si faceva un esame della media delle spese normali fatte da lui durante un periodo di tre mesi, e su questa base, gli veniva fornito un credito senza interessi. Inoltre, quando una persona aveva bisogno di qualcosa – un abito, la riparazione della casa, degli strumenti del lavoro, ecc. – si rivolgeva direttamente al responsabile dell’attività e si accordavano sui tempi di realizzazione del lavoro. I prezzi erano fissi, stabiliti insieme dal delegato generale del lavoro, i tecnici del consiglio municipale delle industrie, i rappresentanti delle sezioni produttive e i consumatori. Il compratore pagava al delegato, che consegnava il denaro al consigliere del lavoro. Il controllo sul pagamento effettuato era realizzato tramite un libretto a madre e figlia con due ricevute, delle quali una rimaneva al compratore e l’altra al responsabile della sezione produttiva che eseguiva il lavoro. 207 Il consiglio comunale applicava un sistema di conto corrente per i contadini individualisti che non avevano denaro per acquistare i prodotti di cui avevano bisogno, calcolando sulla base dei “dati forniti dai delegati collettivisti e dai due delegati individualisti, il valore dei prodotti che potevano essere consegnati al prossimo raccolto. Si esaminava quindi la media delle spese fatte dalla famiglia interessata negli ultimi tre mesi e su questa base si apriva un conto corrente. Le medesime possibilità erano concesse ai collettivisti” (LEVAL, 1952:197). L’organizzazione sanitaria non era stata dimenticata: la medicina era quasi integralmente collettivizzata, l’ospedale era stato rapidamente ingrandito, passando da venti a cento posti letto; l’ambulatorio era stato concluso, permettendo la realizzazione di urgenze e piccole chirurgie e, infine, anche le due farmacie erano anche esse integrate nel nuovo sistema. L’altro esempio fu quello di Alcolea di Cinca, secondo LEVAL uno dei collettivi più poveri da lui visitati. In questo collettivo la moneta ufficiale era stata sostituita da una moneta locale, il salario familiare era stato abolito ed erano state create altre categorie salariali: dalla “nascita fino ai 14 anni, 50 centesimi al giorno; dai quattordici ai diciassette, 90 centesimi; dai diciassette ai sessantotto, 1 peseta e 20. Le donne, sposate o no, avevano 70 centesimi dai quattordici ai diciassette anni, 90 centesimi a partire da questa età” (LEVAL, 1952:218/219). Inoltre, alcuni giovani vivevano una vita indipendente, aderendo al collettivo individualmente, mentre i loro genitori continuavano contadini individualisti. In questo collettivo si creò anche un refettorio comune e i membri ricevevano alimenti e abiti. Non ricevevano denaro, salvo piccole somme perché potessero comprarsi delle sigarette oppure bersi un caffè quando ne avessero voglia. Binefar, il centro più importante dei collettivi della provincia di Huesca, fu l’altro collettivo studiato da LEVAL. Un decimo dei 5.000 abitanti lavoravano presso le piccole industrie che servivano tanto la località quanto il cantone. La maggior parte degli abitanti, invece, erano lavoratori agricoli che godevano di una situazione prospera: la natura favorevole e lavori di irrigazioni erano i benefici su cui tali lavoratori potevano contare. I 2.000 ettari di terre coltivabili a disposizione erano destinati alla coltura intensiva. Foraggio, barbabietola da zucchero, legumi diversi e ulivi costituivano i principali fondi da reddito. Nel luglio, davanti alla minaccia fascista, fu costituito un comitato rivoluzionario al quale aderì la maggioranza, a fianco dei membri del Fronte Popolare. I lavoratori che coltivavano le terre sotto gli ordini del padrone decisero di continuare a lavorare da soli. Furono organizzate squadre con dei delegati che si riunivano per coordinare i loro sforzi una volta alla settimana. Iniziata la raccolta si socializzarono le 208 industrie e poi il commercio. Un’assemblea generale riunita approvò il regolamento del collettivo che determinava il suo funzionamento. Credo interessante riproporlo in quanto fornisce un’idea di come i collettivi venivano organizzati: “Art. 1° - Il lavoro sarà eseguito da gruppi di dieci persone. Ciascun gruppo nominerà il suo delegato. Il delegato dovrà organizzare il lavoro e mantenere l’armonia necessaria fra i produttori e potrà, in caso di necessità, applicare le sanzioni votate dall’assemblea. Art. 2° - I delegati dovranno presentare ogni giorno alla Commissione dell’Agricoltura un rapporto sul lavoro fatto. Art. 3° - Nell’assemblea generale della comunità di Binefar sarà nominato un Comitato Centrale, composto da un membro di ciascun ramo della produzione; il Comitato renderà conto, nell’assemblea che si terrà ogni mese, del consumo della produzione, e darà notizie delle collettività nel resto della Spagna e degli avvenimenti spagnoli e stranieri. Art. 5° - Tutti i dirigenti il lavoro della Collettività, saranno eletti dall’assemblea generale dei collettivisti. Art. 6° - Ogni aderente riceverà una nota dei beni da lui rapportati alla Collettività. Art. 7° - I membri della Collettività, senza eccezione, avranno gli stessi diritti ed i medesimi doveri. Non potranno essere obbligati ad iscriversi all’una o all’altra organizzazione sindacale. Basta accettino completamente le decisioni prese dalla Collettività. Art. 8° - I fondi dell’attivo non potranno essere ripartiti. Faranno parte del patrimonio collettivo. Gli alimenti saranno razionati; se ne serberà una parte, in previsione di malannata agricola. Art. 9° - Quando le circostanze lo esigano – ad esempio, per alcuni lavori agricoli urgenti – la Collettività potrà far lavorare le compagne. Queste si applicheranno a lavori che loro si addicono. Un controllo rigoroso sarà effettuato affinché anche le compagne apportino il loro sforzo produttore alla comunità. Art. 10° - Nessuno lavorerà prima dei quindici anni. Trattandosi di lavoro pesante l’età stabilita è 16 anni. Art. 11° - Per quanto concerne l’organizzazione della Collettività e l’elezione periodica della Commissione Amministrativa, le Assemblee prenderanno le decisioni necessarie” (LEVAL, 1952: 235/236). La produzione era organizzata a seconda dei bisogni locali e delle necessità di scambio. Produzione e utilizzo dei beni, lavoro e distribuzione erano legati tra loro. Le sezioni della produzione erano ingranaggi di un unico meccanismo generale. L’industria e l’agricoltura avevano una cassa comune e non esisteva differenza tra il salario di un meccanico e di un contadino. Una commissione amministrativa appositamente eletta era 209 composta da un presidente (che coordinava i lavori), un tesoriere, un segretario e due membri in contatto permanenti con i delegati dei gruppi, incaricati di controllare il lavoro e i suoi risultati. Tale commissione era responsabile della contabilità amministrativa generale, ma doveva anche saper separare, per rettificare e adattare se necessario, i conti di ognuna delle sezioni specializzate. Le sezioni specializzate (metallurgici, muratori, braccianti, ecc.) si riunivano separatamente per discutere sui problemi e pensare a eventuali cambiamenti necessari. Poi, a seconda delle necessità, la commissione amministrativa li convocava, direttamente o tramite i delegati, per decidere quello che doveva essere fatto. Riguardo all’agricoltura, si diede un aumento del 30% delle terre seminate a grano, senza diminuire le altre colture. Dopo alcuni mesi furono costituiti dei gruppi agricoli per l’organizzazione del lavoro. Furono organizzate sette cascine, ciascuna con un centinaio di lavoratori e un delegato. Inoltre, la sezione dei contadini aveva determinato che, in caso di necessità, gli operai dell’industria e le donne sarebbero stati chiamati ad aiutare nei lavori da compiere a breve termine. I delegati di ogni gruppo agrario, o di sezione industriale, prendevano nota tutti i giorni, sul libretto del produttore di ogni collettivista, della sua presenza al lavoro. Tale pratica aveva l’obiettivo di evitare le infrazioni o, nel caso in cui esse si verificassero costantemente, aiutare a pensare a misure disciplinari. Il collettivo assicurava gratuitamente a tutti i suoi membri l’alloggio, il pane, l’olio e i prodotti farmaceutici. Il restante doveva essere acquistato in moneta locale e a seconda del salario familiare. I beni di consumo e le merci erano distribuite dai magazzini comunali. Binéfar ne contava parecchi: per il vino, per il pane, per l’olio, per i prodotti di spezierie in generale, per le mercerie e tessuti; si aggiungevano tre latterie comunali, tre macellerie, un magazzino di oggetti vari e un magazzino di mobili, dove si centralizzava la produzione degli artigiani. I piccoli proprietari che avevano deciso di rimanere tali erano una minoranza del 5%. Essi venivano rispettati con la condizione che non conservassero più terre di quanto fossero capaci di coltivare. La sezione di scambi assegnava a loro un libretto speciale dove nella copertina erano scritti i diritti e i doveri e dove erano confrontate le date, qualità, quantità e valore dei prodotti liberi per loro, così come la loro riscossione. Essi non potevano oltrepassare i limiti di consumo stabiliti per tutti, sotto pena di una misura vessatoria rappresentata dalla perdita del diritto a partecipare alle assemblee dei collettivi e alle tabelle dei prezzi degli stabilimenti. Perdevano inoltre il diritto, in termini più generali, di utilizzare i materiali tecnici di lavoro a disposizione del collettivo. 210 L’altro esempio riportato da LEVAL fu quello del collettivo di Graus, a nord della provincia di Huesca. In questo, nonostante la difficoltà “naturale” alla socializzazione dovuta alla conformazione del terreno – il paese è situato sui Pirenei, tra rocce e boschi e con poche terre coltivabili – essa si verificò con successo. Iniziò dal commercio e gradualmente si estese per tutte le altre attività, inclusa l’agricoltura. “Sebbene l’estensione della terra non irrigua coltivata fosse aumentata del 5%, la soppressione delle divisioni aveva permesso di guadagnare terreno sulle brughiere ed i sentieri. Si era aumentata la semina di patate del 50%. Si sperava di ottenere una maggiore quantità di sparto e di barbabietole. Si piantarono anche quattrocento alberi da frutta. La collettività aveva anche acquistato una trebbiatrice, una legatrice, delle seminatrici, pompe per la solforazione delle vigne. Si faceva più grande uso di concimi. Il che fa capire come tra le terre seminate dagli individualisti, che più tardi aderirono al lavoro comune, e quelle seminate dai collettivisti la differenza di rendimento fosse del 50%. L’allevamento del bestiame era continuato in questo tempo. La collettività possedeva 310 montoni dei quali 300 erano stati acquistati per suo conto. Il gregge diventava sempre più numeroso nei pascoli della montagna” (LEVAL, 1952:249). I prodotti venivano distribuiti nelle diverse cooperative. Tutta la produzione veniva accumulata in un magazzino centrale sotto la responsabilità della Commissione Amministrativa che provvedeva alla sua distribuzione e alla determinazione dei prezzi, tenendo conto del costo di produzione, delle spese di trasporto e dei salari pagati agli impiegati. In questo modo i movimenti di tutte le attività economiche – produzione, commercializzazione, mezzi di trasporto, distribuzione – venivano controllati da un gruppo di lavoratori che tenevano separatamente libri e schede per ogni attività. Tutti i giorni venivano registrati i movimenti e le riserve dei beni di consumo e di produzione, i prezzi di acquisto e di vendita, il totale delle somme versate e prelevate, gli utili e i deficit per ogni produzione o attività. Nonostante ogni attività produttiva avesse la sua propria contabilità, la cassa era comune. Le attività in passivo, ma necessarie, erano aiutate da quelle in attivo, creando così l’equilibrio tra le attività all’interno del collettivo tramite lo spirito di solidarietà. Alcorisa, un altro esempio riportato da LEVAL, era il centro di 19 villaggi. La terra era meno povera rispetto ad altri luoghi, l’irrigazione era sufficiente e la vita economica privilegiata dal rapporto con il resto del cantone. I proprietari erano in maggioranza rispetto ai fittavoli, ma i grandi proprietari possedevano tanta terra come dalle altre parti. L’industria occupava il 5% della manodopera e i giornalieri mal pagati dominavano per il numero. 211 Dopo essere caduta nelle mani dei fascisti, Alcorisa fu riconquistata da una colonna di rivoluzionari. Dopo la ripresa fu organizzato un comitato locale di difesa composto da rappresentanti della CNT, della sinistra repubblicana, dell’Alleanza repubblicana e della Federazione Anarchica Iberica. Essi nominarono un “comitato centrale di amministrazione” che decise di evitare possibili sabotaggi controllando i movimenti delle merci e la vendita degli articoli di consumo corrente. La libertà di commercio fu abolita e ogni famiglia poteva acquistare soltanto secondo le sue risorse. L’uguaglianza integrale cominciò dal consumo. Convocata nel terzo giorno, l’assemblea degli agricoltori decise di organizzare ventitré squadre. Ciascuna delle quali scelse il loro delegato, che distribuiva le macchine e il lavoro. Tre settimane più tardi, le ventitré sezioni improvvisate furono definitivamente costituite, dopo una divisione minuziosa del territorio municipale, basata sulle caratteristiche del suolo, dei tipi di coltivazioni da realizzare, dell’importanza numerica degli abitanti, delle varietà e del numero del bestiame e dei mezzi tecnici disponibili. Tutto questo contribuì a fare di ciascuna delle sezioni un’unità economica il più completa possibile. Il collettivo fu così definitivamente costituito e il suo statuto aveva un carattere più giuridico rispetto agli altri, dovuto all’influenza di due avvocati tra i suoi membri. Cito il seguente estratto perché si possa capire le diverse possibilità di organizzazione all’interno dei collettivi: “Beni di proprietà. – I beni mobili ed immobili così come le macchine, gli utensili, il denaro e i crediti apportati dal Sindacato Unico dei Lavoratori, dal Consiglio Municipale e dagli aderenti alla Collettività, costituiranno i beni di sua proprietà. Usufrutto. – La Collettività avrà in usufrutto i beni che le saranno consegnati dal Consiglio Municipale e dal Comitato di Difesa, al fine di farli produrre e provvisoriamente si approprierà dei fondi che i proprietari, per ragioni d’età o malattia o sesso, non coltivassero o coltivassero male. Membri della Collettività. – Tutti gli aderenti al Sindacato Unico, al momento in cui si costituisce la Collettività, saranno considerati come membri fondatori; anche coloro che aderiscono più tardi al sindacato, saranno membri della Collettività. Coloro che non siano soci del sindacato e desiderino tuttavia entrarvi, saranno ammessi, previa decisione della assemblea. Ad ogni domanda d’ammissione si dovranno allegare un documento sugli antecedenti politici e sociali ed una lista dei propri beni. Separazione. – Qualsiasi membro della Collettività potrà ritirarsi volontariamente; ma l’assemblea si riserva il diritto di stabilire se la separazione è o no giustificata. Quando non lo 212 sia, colui che se ne va non potrà riavere i beni che vi aveva immesso. Così pure l’individuo espulso perde il diritto di rivendicare ciò che ha apportato al momento della sua ammissione. Amministrazione. – L’amministrazione della Collettività sarà affidata a una commissione composta da cinque membri: uno per l’alimentazione, uno per l’agricoltura, uno per il lavoro, uno per l’istruzione pubblica ed un segretario generale. Seguono gli articoli riguardanti il ruolo dell’Assemblea generale, quelli sui diritti e doveri dei collettivisti, quelli sulle condizioni di scioglimento della Collettività, ecc.” (LEVAL, 1952: 263/264). Furono però le assemblee successive a definire le risoluzioni relative all’organizzazione interna del collettivo di Alcorisa. Fu mantenuta la decisione che i ventitré delegati dell’agricoltura si riunissero ogni settimana per dirigere il lavoro dei campi. Ci fu una formula originale riguardo al modo di distribuzione con l’applicazione del libero consumo integrale, uno dei principi del comunismo libertario. Ogni famiglia riceveva dal comitato di amministrazione un bonus dove si ordinava al responsabile del magazzino di approvvigionamento di consegnare al portatore l’olio, patate, legumi freschi o secchi, zucchero, abiti ecc. che lui aveva richiesto. Furono razionati per un certo periodo la carne e il vino, ma più tardi anch’essi furono liberati. Si poteva andare gratuitamente al cinema, al caffè, a prendere esclusivamente la limonata, a farsi rasare o tagliarsi i capelli. Per l’acquisto di alcuni articoli come gli abiti, le scarpe, gli utensili della casa, caffè e tabacco, quando la domanda sorpassava le possibilità di approvvigionamento e per evitare gli abusi, veniva usata una moneta locale. Un uomo disponeva di 1 peseta al giorno, una donna 70 centesimi e un bambino al di sotto dei quattordici anni, 40 centesimi “per i vizi”. Fu stampata una scheda dove veniva scritto ciò che ogni individuo poteva ricevere. La razione fu assicurata, con qualche variazione, fino al novembre 1936: 100 gr di carne al giorno; 500 di pane; zucchero, riso, fagioli secchi, 40 gr al giorno; mezzo litro di vino, una scatola alla settimana di sardine. Ciascuno aveva anche diritto a mezzo kg di sale, un kg di sapone, azzurro per la biancheria, una scopa e mezzo litro di detersivo al mese. Questa soluzione, però, non piacque ai libertari né ai repubblicani, che criticavano la rigidità e l’imposizione del consumo. Gli ideatori del collettivo, volendo evitare il ritorno alla moneta locale, trovarono la soluzione in un sistema di punti. Tutti gli articoli ricevevano un certo numero di punti. Un uomo aveva diritto a 450 punti alla settimana, una donna 375, una donna sposata 362, un neonato 167. La somma dei punti di ogni collettivista e il valore in punti di ogni articolo erano registrati sulla sua tessera di rifornimento. Entro certi limiti, ogni famiglia o ogni 213 singolo individuo poteva disporre come voleva dei propri punti, prendere più di un prodotto e meno di un altro, a seconda dei propri gusti e bisogni. Si evitava così un consumo eccessivo e si rispettava la libera scelta di ciascuno. Per le scarpe, gli abiti e gli utensili domestici si teneva una contabilità propria e in un libretto speciale si registrava nella prima pagina il numero di punti di ogni famiglia: 24 punti di utensili domestici, 60 di scarpe, 120 di abiti, ecc. Oltre al magazzino generale, Alcorisa aveva quattro spezierie collettivizzate, un magazzino chiamato cooperativa di tessuti, una merceria e quattro macellerie molto igieniche. Tutto quello che era distribuito ai magazzini e consegnato a ogni famiglia veniva registrato in un libro di registro generale destinato allo studio delle tendenze di consumo e a una contabilità dettagliata che poteva essere controllata dall’amministrazione in qualsiasi momento. Nonostante cinquecento degli uomini di Alcorisa stessero al fronte si ottenne un aumento del 50% delle terre coltivate con la messa in coltivazione di una parte delle terre prima lasciate in maggese. Lo sforzo veniva facilitato dall’acquisto di eccellenti arati, oltre che di concimi chimici. Come negli altri villaggi, i piccoli proprietari individualisti potevano scambiare i loro prodotti con il collettivo. Essi inviavano i loro prodotti al consiglio municipale e venivano pagati con una moneta specialmente creata per loro. Riguardo al consumo, essi dovevano rispettare il razionamento comune in ragione della guerra. Il matrimonio legale era sparito ma le unioni libere venivano ufficialmente registrate sul libro della municipalità. Mas de las Matas, sempre nell’Aragona, era il capoluogo del cantone che portava il suo nome e che comprendeva diciannove villaggi e 2.300 abitanti. Nel maggio 1917 sei di questi villaggi erano interamente collettivizzati, quattro lo erano quasi integralmente e cinque lo erano al 50%. Qui il movimento libertario precedette quello sindacale e la proposta di organizzazione di un collettivo agrario presentata dagli anarchici all’insorgere del fascismo fu accettata dall’unanimità dei contadini sindacalizzati, avendo i piccoli proprietari che non appartenevano al sindacato costituito un gruppo a parte. In seguito alla proposta fu fatta circolare una lista di adesioni volontarie. In quindici giorni, 200 famiglie si erano iscritte e, in poco tempo 550 delle 600 famiglie che componevano il villaggio avevano deciso di aderire all’iniziativa. In tutto il cantone fu applicato lo stesso principio: o la libera adesione al collettivo o la continuità dello sfruttamento individuale del suolo, testimoniati dai diversi gradi di socializzazione presenti nel villaggio. Alcuni di questi villaggi non adottarono un regolamento scritto né statuti. Semplicemente, tutti i mesi, l’assemblea dei membri di ogni collettivo indicava alla 214 commissione composta di cinque membri eletti le direttive a seguire, e i problemi concreti venivano liberamente esaminati. A Mas de las Matas furono costituiti trentadue gruppi di lavoratori, più o meno importante a seconda delle attività da compiere, delle dimensione delle zone agricole da lavorare e dei limiti imposti dalle montagne. Ogni gruppo lavorava una parte di terre irrigate e una di terre secche. L’acqua permetteva di ottenere legumi e frutta in abbondanza. I gruppi di lavoratori sceglievano i loro delegati tra tutti i collettivi del cantone, nominando la loro commissione amministrativa. I delegati indicavano tutti i giorni i lavori da compiere, mantenendo così il villaggio interamente collettivizzato. Gli sforzi erano costantemente coordinati. Una volta che le terre irrigabili erano già totalmente sfruttate, per poter aumentare la superficie localmente coltivata fu deciso che le terre secche, da sempre utilizzate per l’allevamento del bestiame, fossero destinate alla produzione di cereali (grano, avena e segale) e, per compensare questo cambiamento i montoni furono rinchiusi nelle montagne. Il numero dei capi di bestiame ebbe un notevole aumento. Furono acquistati anche un grande numero di porcellini che poi furono distribuiti alla popolazione dovuto alla mancanza di manodopera per intraprendere la costruzione di porcili collettivi. Ogni famiglia allevava uno o due maiali e nel momento della macellazione la carne era distribuita a seconda dei bisogni di ciascuno. Inoltre, fu lasciato a ogni famiglia un piccolo pezzo di terra perché potesse coltivare per l’autoconsumo un po’ di legumi, frutta, oppure allevare qualche coniglio. Oltre all’aumento e alla diversificazione della produzione agricola e del bestiame, si svilupparono piccole industrie: costruzione, calzoleria, abbigliamento, macelleria, ecc. Ciascuna di queste specialità costituiva una sezione del “Collettivo Generale” e lavorava per tutti. Se la sezione agraria aveva bisogno di determinati utensili, si rivolgeva, tramite il suo delegato, alla commissione amministrativa che rilasciava al delegato dei metallurgici un tagliando dove diceva di rispondere alle necessità dei compagni. Tale meccanismo era uguale per tutte le attività e per tutti i gruppi di produttori o le singole famiglie. La scala di consumo – alimenti, abbigliamento, calzatura – era registrata nel libretto standard editato dalla Federazione Regionale dei Collettivi. La moneta era stata abolita in tutti i collettivi del cantone. La socializzazione del commercio fu una delle prime tappe. Secondo le norme stabilite ad Aragona, nessun collettivo poteva commercializzare per conto proprio. Questo serviva a evitare la tendenza alla speculazione possibile durante i tempi di guerra. Questa misura era applicata in tutti i 215 villaggi socializzati. Ogni collettivo comunicava al comitato cantonale la lista dei suoi prodotti eccedenti e quelle di cui ne aveva bisogno. Esse erano poi inviate al capoluogo che procedeva alla registrazione di tutti i prodotti ricercati e eccedenti, e in seguito alla distribuzione, a seconda delle possibilità. D’altra parte, se per esempio il villaggio che forniva l’olio non aveva bisogno del vino che l’altro villaggio poteva offrire, poteva domandare un altro articolo a un altro villaggio oppure tener da parte una riserva per essere cambiata in un’altra occasione, quando altri collettivi del cantone avessero i prodotti che li servivano. Era un tipo di clearing. I villaggi che attraversavano difficoltà e che non avevano niente da scambiare venivano ugualmente riforniti e avevano tutto l’anno per rimborsare la Federazione. I servizi medici e i prodotti farmaceutici erano gratuiti. Esistevano due biblioteche pubbliche, una del sindacato e l’altra della gioventù libertaria. L’istruzione era obbligatoria fino all’età di 14 anni. Presso le montagne, vicino al villaggio, fu costruita una scuola per gli adolescenti che non erano mai andati alla scuola. In più, furono improvvisate due aule per ricevere ciascuna cinquanta bambini la cui educazione era affidata ai giovani che avevano compiuto gli studi superiori. Gli spettacoli pubblici erano gratuiti tanto per i collettivisti quanto per gli individualisti. L’altro collettivo studiato da LEVAL, Esplus, disponeva di 11.000 ettari, 9.000 dei quali irrigati, per i suoi 1000 abitanti. I più ricchi disponevano di 70 a 100 ettari ciascuno. La maggior parte delle persone lavoravano a mezzadria per i ricchi, in un sistema denominato “a terraja”, e che consisteva nel dissodare il suolo non coltivato, prepararlo, livellarlo e farlo produrre, consegnando al proprietario la quarta parte di ciò che era stato ottenuto, oltre che l’affitto di 6 pesetas per ettaro seminato a grano. Dopo otto mesi che il collettivo era stato organizzato, soltanto due famiglie continuavano a produrre individualmente. Il nuovo modo di organizzazione era già stato immaginato da un gruppo che preparava l’organizzazione di una comunità agraria, acquistando strumenti, macchine e sementi. L’insieme del lavoro agricolo fu assunto da 10 équipe di agricoltori e i principali ausiliari erano 10 paia di muli per équipe. Quattro équipe supplementari si occupavano dei lavori più difficili (la sarchiatura, la scelta delle sementi, ecc.). I giovani aiutavano quando c’era bisogno. Le donne sposate, soprattutto quelle con bambini, erano dispensate dal lavoro. Eccezionalmente, quando un lavoro di carattere pubblico doveva essere compiuto urgentemente, si chiedeva aiuto a volontari. Solo le donne più anziane erano dispensate, e rimanevano badando i bambini. Con 110 uomini al front, l’aumento della superficie coltivata era stato minimo: ci fu principalmente la 216 diversificazione delle colture, la preparazione di un grande orto e l’intensificazione dell’allevamento. Il collettivo costruì 4 porcili: uno per le troie, uno per i neonati, uno per gli adulti e uno per quelli all’ingrasso. Duecento maiali erano stati acquistati all’inizio e nel luglio 1937 alcune centinaia erano già nati. Le mucche erano rinchiuse in due buoni stabilimenti e soltanto quelle che davano poco latte venivano sacrificate. Quanto ai montoni, il loro numero passò da 600 a 2.000. La scuderia collettiva era stata costruita, ma il loro numero era ancora insufficiente. Una parte dei muli continuava provvisoriamente con i loro antichi proprietari, e furono usati soltanto dopo la pianificazione razionale del lavoro decisa dal collettivo. I servizi medici, i prodotti farmaceutici, l’alloggio, l’illuminazione, i parrucchiere erano assicurati gratuitamente. Come d’altre parti, ogni famiglia disponeva di un pezzo di terra dove coltivava i suoi legumi, fiori, allevava qualche coniglio o gallina, a seconda dei propri gusti. Un uomo celibe riceveva 25 pesetas alla settimana, uno sposato 35, al quale aggiungeva 4 pesetas per bambini al di sotto dei 14 anni e 13 pesetas da quell’età in avanti. I prezzi delle merci erano instabili in Spagna dovuto alla guerra, ma non aumentavano più nella maggior parte di quelli che avevano adottato una moneta locale. I buoni monetari erano garantiti dalla produzione. Il meccanismo della loro circolazione era molto semplice: distribuiti il sabato dopo mezzogiorno, essi venivano scambiati per prodotti nel magazzino comunale di distribuzione, chiamato cooperativa, durante la settimana. Il sabato i bonus venivano consegnati al comitato locale, il quale stampava nuovi buoni e li riconsegnava al collettivo, in un movimento circolare. Le persone disabili al lavoro venivano pagate come le altre. Era stato preparato un albergo per i celibi e un altro per i rifugiati del territorio aragonese occupati dalle forze di Franco. Esplus praticava lo scambio dei prodotti attraverso Binéfar, il capoluogo del cantone. Come un villaggio naturalmente ricco, esso l’inviava circa 200.000 pesetas di merce che il comitato cantonale distribuiva sia nel rifornimento dei soldati sul front, sia per aiutare i villaggi più poveri. Infine, il caso di Andorra, dove prima della collettivizzazione non esisteva la grande proprietà e le famiglie possedevano in media due bestie da traino, mentre quelle più povere possedevano un ciuco usato per mietere i cereali. Le colture erano estensive e si raccoglievano soprattutto frumento, riso e olive e, al secondo posto, orzo, avena e segale. Le poche terre irrigate erano utilizzate per piccoli periodi e, durante gli anni di siccità, quando le fonti si esaurivano, Andorra diventava un “paese fantasma” in più. 217 Le condizioni naturali obbligavano 300 famiglie a vivere in ‘proprietà’ molto povere chiamate masserie, disseminate nelle montagne. Il restante della popolazione doveva migrare per due terzi dell’anno, lasciando il villaggio praticamente vuoto. Le persone rientravano il sabato sera e ripartivano il lunedì mattina, portando i viveri per la settimana. Esisteva una categoria sociale ancora più miserabile, situata al di sotto della scala sociale: erano i diseredati che lavoravano in affitto le terre delle vedove, degli anziani, delle zitelle, dei medici, dei farmaceutici, di certi proprietari impotenti o incapaci di far produrre i loro campi. Questi fittavoli, detti “mezzadri”, consegnavano ai proprietari la metà della raccolta ottenuta dal loro lavoro. Il collettivo locale che inglobò tutto il villaggio e tutti gli abitanti, fu costituito il 1° novembre 1936, quando, su iniziativa delle tre forze già nominate – la sinistra repubblicana, l’UGT e la CNT – fu convocata un’assemblea generale e proposta la nuova organizzazione sociale. L’approvazione fu unanime. Fu lasciata libertà d’azione agli individualisti, ma essa non interessò a nessuno. All’inizio il comitato rivoluzionario fu incaricato dell’amministrazione del collettivo. Poi, per assicurare la sua libertà, fu costituita una commissione amministrativa che assunse una responsabilità vitale per la vita locale. Essa fu divisa in cinque sezioni: presidenza e finanze, distribuzione e approvvigionamento, industria e commercio, produzione agraria e allevamento, lavori pubblici, incluso l’insegnamento. Due sezioni erano nelle mani dell’UGT, due nelle mani della CNT e una nelle mani della sinistra repubblicana. L’agricoltura fu organizzata “dividendo il territorio municipale in quaranta cascine: in ciascuna cascina risiedeva un gruppo di famiglie e di lavoratori, che scendevano al paese il sabato sera e ritornavano alla montagna il lunedì mattina. La lettura del regolamento, (…) ci permetterà di conoscere la loro organizzazione interna: «1° - In ciascuna cascina si nominerà un delegato eletto tra il personale della medesima, e un sottodelegato per assicurare il buon andamento del lavoro. 2° - Il delegato si curerà di ordinare il lavoro dentro la cascina, sempre, naturalmente, in accordo coi compagni componenti la stessa. 3° - Il delegato saprà ad ogni momento in che luogo sta lavorando il personale della cascina, e in che lavoro è occupato. 4° - Egli si preoccuperà però, sempre che ce ne sia bisogno, di preparare il materiale che è necessario, gli attrezzi di lavoro ed altri oggetti, contando sempre sulla Delegazione del Lavoro, la quale darà tutte le autorizzazioni necessarie. 218 5° - È anche missione del delegato eseguire il controllo di tutta la cascina, segnare nel libretto, all’uopo consegnatogli, tutti i prodotti forniti alla Collettività o ricevuti dalle cascine; ossia le entrate ed uscite. 6° - Quando si consegneranno dei prodotti alle cascine, il delegato dovrà recarsi alla Delegazione del Lavoro, per accusare ricevuta. 7° - Ogni qualvolta un compagno della cascina abbia bisogno di assentarsi dalla stessa per un motivo qualsiasi, come per malattia, ne metterà a conoscenza il delegato e quando un compagno manchi al lavoro senza compiere quanto richiesto, il delegato ne metterà a conoscenza la Delegazione del Lavoro. 9° - In caso di malattia, assenza od altro del delegato, il sottodelegato della cascina ne farà le veci. Articolo supplementare. – In ciò che concerne il pascolo del bestiame, la semina di foraggi ed altre cose similari, il delegato della cascina si metterà d’accordo coi delegati del bestiame e gli altri pastori facenti parte della medesima, per la buona amministrazione ed il mutuo appoggio. Se per cause estranee alla sua buona volontà un pastore non potesse condurre al pascolo il gregge in sua custodia, lo farà un compagno della medesima cascina fintantoché i delegati al bestiame trovino personale adeguato». I delegati delle cascine si riunivano pertanto tutti i sabati con il delegato generale del lavoro, facendo le domande di materiali e di viveri che abbisognassero. Si rivedevano i conti di ciò che era stato mandato. Tutto trovavasi coordinato, diretto, controllato sotto la vigilanza e l’iniziativa del popolo” (LEVAL, 1952: 273/274). Come a Fraga e a Binéfar, il collettivista che aveva bisogno di un oggetto qualsiasi doveva ordinarlo alla commissione amministrativa, che lo faceva fabbricare. L’oggetto doveva poi essere pagato alla commissione al momento della consegna. Fu coniata una moneta locale e stabilita una scala di salari dando grande importanza alle famiglie. Una persona sola riceveva 2,25 pesetas al giorno; due persone adulte, 4,50; 3 persone adulte, 6 pesetas; 4 persone, 7 pesetas, 5 persone, 8 pesetas. Oltre, il salario aumentava a ragione di una peseta per persone che la famiglia possedesse, fosse essa un lavoratore o no. Inoltre, esisteva un’aggiunta di 1,50 pesetas sul salario base se c’erano due produttori in famiglia; 3 pesetas per 3 produttori; 4 pesetas per 4 produttori e così successivamente. L’alloggio, l’illuminazione elettrica, i servizi di parrucchiere, i servizi medici e i prodotti farmaceutici erano gratuiti, così come il consumo del pane. Erano distribuiti 18 litri di olio d’oliva a persona all’anno. La carne, destinata al consumo dei soldati, era razionata a un etto al giorno. Tutti i beni di consumo erano distribuiti dai magazzini 219 comunali. Uno di questi era destinato all’olio, al sapone e al vino; un altro al forno, un altro alla macelleria. L’insegnamento era obbligatorio. Il nuovo ordinamento non accettava che i bambini rimanessero a casa e questo aveva portato a un sensibile aumento del numero degli studenti, soprattutto di quelli prescolastici. Degli otto insegnanti che lavoravano nel collettivo, tre erano pagati dallo Stato e cinque dal collettivo che, inoltre, supervisionava il lavoro di tutti. Nella regione di Castiglia, la struttura organica delle collettività era essenzialmente la stessa di quella delle collettività di Aragona e del Levante: commissione amministrativa nominata dall’assemblea dei collettivisti; gruppi di produttori secondo l’età e i lavori da eseguire; delegati dei gruppi che si riunivano periodicamente per decidere sull’organizzazione della settimana lavorativa; istituzione del salario familiare dappertutto. Inoltre, il “Consiglio di economia era a sua volta consigliato dagli specialisti – diplomati o no – in questioni agrarie e pecuarie. Le funzioni amministrative erano decentralizzate. La contabilità locale, affidata a un contabile che registrava tutto ciò che si riferiva alla produzione, al consumo, ai salari versati, ai prodotti immagazzinati, era controllata non solamente dai contadini della località, ma anche dalla commissione speciale della federazione cantonale” (LEVAL: 1952:292). Altre funzioni dell’organizzazione regionale erano quelle di consigliare e guidare, per quanto possibile, le collettività locali. Secondo l’autore, gli sforzi di miglioramento e di orientamento furono notevoli e presto si fecero sentire, dato che permettevano una razionalizzazione rapida dell’agricoltura. 3.5. Gli insegnamenti della Guerra di Spagna: successi e fallimenti della collettivizzazione LEVAL riassume gli insegnamenti della guerra di Spagna in vari punti. Quelli più attinenti all’argomento studiato sono i seguenti: “1° - Il principio giuridico delle Collettività era completamente «nuovo». Non erano né «il sindacato» né «il municipio», nel senso tradizionale delle parole, e neppure il municipio del Medioevo. Tuttavia, erano più prossime allo spirito comunale che allo spirito sindacale. Le Collettività, spesso avrebbero potuto chiamarsi egualmente Comunità, com’[era] il caso di quella di Binefar e costituivano veramente un tutto nel quale i gruppi professionali e corporativi, i servizi pubblici, gli intercambii, le funzioni municipali restavano subordinati, dipendenti dall’insieme, quantunque godessero di autonomia nella loro struttura, nel loro funzionamento interno, nella applicazione dei loro compiti particolari. 220 2° - Malgrado la loro denominazione, le Collettività erano praticamente organizzazioni libertarie comuniste, che applicavano la regola: «da ciascuno secondo le sue forze ed a ciascuno secondo i suoi bisogni»; sia per la quantità di risorse materiali assicurata a ciascuno dove il denaro era abolito, sia per mezzo del salario familiare dove il denaro [era] stato mantenuto. Il metodo tecnico differiva, ma il principio morale e i risultati pratici erano i medesimi. Questa pratica era in effetti senza eccezioni nelle Collettività agrarie; poco frequente invece nelle collettivizzazioni e socializzazioni industriali (…). 3° - La solidarietà portata al grado estremo era la norma generale delle Collettività agrarie. Non solo vi era assicurato il diritto di tutti alla vita, ma nelle federazioni comarcali si stabiliva sempre più il principio dell’appoggio mutuo, coll’ammasso comune, di cui si giovavano i paesi meno favoriti dalla natura. Nella Castiglia si stabilirono a questo scopo le Casse di Compensazione. Nel campo industriale questa pratica pare sia stata iniziata in Hospitalet, nelle ferrovie catalane e più tardi si applicò in Alcoy” (LEVAL, 1952:313/314). Inoltre, l’autore cita la costituzione dei gruppi di lavoro, la scelta di un delegato per ogni gruppo e le riunioni dei delegati eletti insieme al delegato dell’agricoltura per impostare il lavoro generale; le assemblee generali alle quali partecipavano tutti i membri del collettivo, e che si svolgevano a cadenza settimanale, quindicinale o mensile, a seconda delle decisioni da prendere e dell’organizzazione del collettivo; la concentrazione industriale e l’ottimizzazione delle industrie, con la sparizione di quelle antieconomiche; il miglioramento dell’insegnamento dovuto all’aumento delle scuole e la qualità degli insegnanti; l’aumento continuo del numero dei collettivi; il riconoscimento del diritto della donna alla vita, tramite il pagamento di un salario anche se, in alcuni casi, minore di quello degli uomini; lo stesso valeva per i bambini che ricevevano un salario anche loro. Riguardo alle pratiche agricole, l’aumento dei macchinari e l’irrigazione, l’aumento della policoltura e la pratica del rimboschimento. Riguardo all’allevamento del bestiame, una maggiore selezione e moltiplicazione delle specie e la costruzione di stalle, porcili e ovili collettivi. Infine, il rispetto dei piccoli contadini che decidevano di produrre individualmente, i quali avevano gli stessi diritti dei collettivisti riguardo al consumo, ma era loro proibito avere più terre di quanto non fossero in grado di coltivare e di commercializzarne i prodotti individualmente. Un altro punto positivo riguardava gli scambi: 221 “9° - Si estendeva continuamente l’armonia nella produzione e nella coordinazione degli scambi, così come l’unità nel sistema di ripartizione. L’unificazione comarcale si completava con l’unificazione regionale. La Federazione Nazionale era sorta. Alla base, la «comarca» organizzava l’intercambio. Eccezionalmente lo praticava il Comune isolato, ma su autorizzazione della Federazione comarcale, che prendeva nota degli scambi e poteva interromperli se pregiudizievoli all’economia generale. (…) (…) La tendenza all’unità s’era fatta più chiara con l’adozione di una tessera di «produttore» unica, e di una tessera di «consumatore» egualmente unica, che implicavano la soppressione di tutte le monete, locali o no, secondo la risoluzione presa nel Congresso costitutivo del febbraio 1937. Riguardo agli scambi con le altre regioni ed alla vendita all’estero, la coordinazione migliorava sempre più. Nel caso di utili per differenze nel cambio, o per l’ottenimento di prezzi superiori ai prezzi base già eccedenti, la Federazione Regionale li impiegava per aiutare le Collettività più povere” (LEVAL, 1952:316/317). Eliminata la proprietà privata, restava agli anarchici il compito di edificare la nuova società libertaria. Tale compito, di grande complessità, fu affrontato secondo BROUÉ e TÉRMINE con nozioni semplicistiche e con principi generali utilizzati fino a quel momento nella propaganda e nella critica del sistema capitalistico. “Non [era] sufficiente convertire le officine private in proprietà collettive, (…) per costruire una nuova economia e farla funzionare. Il problema del credito restava inalterato. C’era bisogno di denaro, di banconote per gli acquisti all’estero, di fondi per le imprese collettivizzate. Il governo di Madrid, amministratore dell’oro, rifiuta[va] ogni credito anche quando la Catalogna offr[iva] in garanzia il miliardo di depositi delle sue Casse di risparmio. La maggior parte delle imprese collettivizzate vive[vano] dunque sulla disponibilità di cui si [erano] impadroniti con la rivoluzioni. I Comitati-governo cerca[va]no di sopperire giorno per giorno, con mezzi di fortuna: confisca dei conti in banca dei «faziosi», confisca e vendita dei gioielli e degli oggetti preziosi appartenenti ai ribelli, alle chiese, ai conventi. Ma il problema si ripropone[va] continuamente” (BROUÉ e TÉRMINE, 1980:173)176. Tutte le fattorie collettive dovettero affrontare il problema di come mettere in pratica quello che fino a quel momento conoscevano soltanto in teoria: il comunismo 176 Secondo DELLACASA, nel 1937 il governo riaprì l’Istituto della Riforma Agraria (l’IRA) per dare continuità alla politica di formazione della piccola proprietà contadina. Inoltre, creò anche una Sezione delle Cooperative con un ente di credito che prestava denaro alle cooperative ma non ai collettivi. In più, l’IRA distribuì ai contadini 4 milioni di ettari di terre requisiti ai borghesi fuggiti, uccisi o compromessi e, un’altra volta, niente fu destinato ai collettivi. 222 libertario. Con questo obiettivo, ai primi d’ottobre del 1936 fu creato il Consiglio di Aragona, per colmare il vuoto lasciato dall’insurrezione militare e dalla diffusione della collettivizzazione. A dicembre di quell’anno esso fu riconosciuto ufficialmente dal governo di Largo Caballero, il che significò l’istituzione dei consigli comunali e l’inclusione nel consiglio di rappresentanti degli altri partiti del Fronte popolare. Dovendo fare i conti con tale situazione, il consiglio presto si “trovò costretto a intraprendere la centralizzazione economica e ad abbandonare il principio anarchico dell’autonomia dei governi locali” (PRESTON, 2000:188). Anche a Valencia i problemi si fecero sentire presto. I collettivi furono lasciati in totale indipendenza e autonomia, fatto che ebbe effetti disastrosi sull’agricoltura della regione. “L’esportazione di riso e di arance, fonte essenziale di valuta estera per la Repubblica, entrò in collasso. L’economia si trovava in uno stato di tale caos che persino i dirigenti rivoluzionari provinciali riconobbero la necessità di imporre norme unitarie. Fu allora istituito il Consejo de Economia de Valencia, che però ebbe scarsi effetti, se non nulli. In realtà i casi di collettivizzazione totale e di proclamazione del comunismo libertario furono pochi in Aragona, ed ebbero vita breve. La guerra non costituiva di certo il contesto più favorevole ai grandi esperimenti economici. La socializzazione della terra tendeva a disgregare la continuità della produzione e i meccanismi di mercato in un momento in cui il bisogno di programmazione e coordinamento era più grande che mai. In generale la collettivizzazione fu accolta con grande fervore dai braceros ma suscitò risentimento nei piccoli proprietari che si vedevano prosciugare il mercato della manodopera, temevano la concorrenza di unità abbastanza grandi da godere dei benefici dell’economia di scala, se non di essere a loro volta espropriati” (PRESTON, 2000:188). Senza poter contare sui finanziamenti del governo, in città la collettivizzazione finì per mantenere le stesse disuguaglianze e gli stessi problemi del sistema capitalistico. Nelle campagne il risultato nonostante tutto, fu limitato. Secondo BROUÉ e TÉRMINE essa risolse alcuni problemi e permise ai contadini di lavorare più razionalmente e, conseguentemente, di aumentare la loro produzione e di migliorare il loro tenore di vita. Ma perché questo progresso fosse efficace e potesse servire di esempio ad altre collettivizzazioni, ci voleva un appoggio tecnico che l’industria spagnola non fu in grado di offrire. “Misure radicali come la vendita esercitata dal Consiglio d’Aragona a favore delle collettività, dei gioielli requisiti, non copr[iva]no che un’intima parte dei bisogni. Ci [sarebbero volute] macchine agricole, concimi, agronomi” (BROUÉ e TÉRMINE, 1980:178). Ma in quel momento, il problema della terra in Spagna si riduceva alla soppressione di fatto delle sopravvivenze feudali e alla confisca delle terre dei grandi proprietari. 223 Il successo raggiunto dai collettivi cominciava a declinare a causa, oltre che degli ostacoli interni177 anche dell’azione del governo. Secondo RANZATO, nell’ottobre 1936 il ministro dell’Agricoltura, Uribe, elaborò un decreto che “stabiliva che tutte le proprietà agricole appartenenti a persone implicate direttamente o indirettamente con la sollevazione militare venissero espropriate senza indennizzo a favore dello Stato: di queste, le proprietà che fossero state coltivate a conduzione diretta venivano consegnate ai sindacati agricoli in usufrutto perpetuo perché fossero sfruttate individualmente o collettivamente, secondo la volontà della maggioranza degli aderenti. Invece le proprietà che già fossero state coltivate in regime di fitto, mezzadria o colonia, da agricoltori, che rispondendo a determinate condizioni potessero essere considerati piccoli contadini, gli sarebbero state assegnate in usufrutto perpetuo trasmissibile ai discendenti. La terra assegnabili era progressivamente minore a seconda della fertilità del terreno. Le proprietà di coloro che non fossero compromessi con il fascismo, qualsiasi fosse la loro estensione, non sarebbero state toccate” (RANZATO, 1972:333/334). Il decreto non tardò a produrre malcontenti. Da un lato perché quelli che si ribellarono ai misfatti del padrone vennero puniti dato che nella maggior parte rimasero senza terre. Dall’altro perché, siccome il decreto non stabiliva una proporzione tra la terra assegnabile e la capacità lavorativa del singolo contadino, implicitamente esso legittimava lo sfruttamento della forza lavoro salariata. Inoltre, i collettivi vennero dichiarati illegali, eccezione fatta per quei pochi previsti dalla legge. L’obiettivo del governo era quello di promuovere la distruzione dei collettivi. Nel giugno 1937, davanti alla situazione di tensione creata dal decreto anteriore e cercando di garantire che i raccolti potessero avvenire senza problemi, lo stesso ministro elaborò un altro decreto legalizzando, per quell’anno agricolo, i collettivi in tutto il territorio spagnolo, qualsiasi fossero state le loro origini. Tale decreto, che sembrava a favore dei collettivi, in realtà nascondeva la reale intenzione di distruggerli. Infatti, subito dopo il raccolto – e caduto nel frattempo il governo Caballero –, il nuovo governo (Negrín) scatenò un’offensiva contro i collettivi, con ordini espressi di fargli sciogliere. Seguirono momenti di molta confusione e violenza che portarono all’interruzione dei lavori e all’impossibilità di seminare dato che le terre non erano pronte. A questo punto il governo cercò di riparare la situazione riconoscendo ad alcuni collettivi il diritto 177 LEVAL cita la coesistenza di strati conservatori dei partiti e delle organizzazioni che li rappresentavano; l’opposizione di certi piccoli proprietari; il timore manifestato da alcuni contadini membri dei collettivi di che, una volta finita la guerra, il governo distruggesse tutte queste organizzazioni e, infine, la lotta attiva contro i collettivi portata avanti dalle autorità. Vale la pena sottolineare, infine, che non tutti i collettivi furono opera esclusiva del movimento anarchico. Buona parte di essi furono formati da contadini cattolici e socialisti, ispirati o meno alla propaganda anarchica. Anche molti membri dell’UGT e alcuni repubblicani finirono per aderire ai collettivi. 224 all’esistenza. Ma ormai i contadini non avevano più fiducia e temevano un altro esproprio da un momento all’altro. Tutta questa violenza ebbe come effetto l’indebolimento dei collettivi e delle loro prospettive di sviluppo. In alcuni casi, dopo che la situazione si era calmata, esse si riorganizzarono nuovamente, ma ormai non ebbero più lo stesso slancio di prima. 3.6. La fine della guerra: la vittoria dei nazionalisti Presto si prospettò la possibilità di uno scontro, nelle campagne e nelle città, tra i proletari, i piccoli proprietari e i piccoli imprenditori, i primi facendo riferimento alla CNT e all’UGT, i secondi al governo repubblicano. Teoricamente dovevano vincere i proletari, dato che essi erano in maggioranza schiacciante. Ma la necessità di chiedere aiuto all’estero alterò ben presto i rapporti di forza. Il partito comunista diventò sempre più potente, e ciò significò la supremazia delle tesi che il cammino verso il socialismo in Spagna doveva passare dalle forme di democrazie borghesi. Seguì uno scontro sempre più dichiarato tra le forze all’interno del Fronte popolare che culminò con una piccola guerra civile all’interno della guerra civile tra, da un lato, il PCE, i repubblicani e i socialisti riformisti e, dall’altro, la sinistra socialista di Largo Caballero – all’epoca il primo ministro –, gli anarchici e il Partito Obrero de Unificación Marxista (POUM). I “contenuti proletari” della fase iniziale erano sempre più annacquati. Il bersaglio scelto dai comunisti fu il POUM, per l’accusa di tradimento della rivoluzione che rivolgeva ai comunisti. “I collettivi non ottennero più finanziamenti. La polizia segreta comunista cominciò a prelevare in segreto i militanti del POUM. Nell’aprile del 1937 la tensione toccò punte altissime. (…) La crisi esplose ai primi di maggio. (…) La CNT, il POUM e i gruppi anarchici estremisti (…) combatterono contro i comunisti per diversi giorni. (…) I combattimenti misero a nudo il dilemma in cui si dibattevano gli anarchici: essi potevano vincere a Barcellona soltanto a prezzo di una carneficina che avrebbe significato la perdita della guerra per la Repubblica. I dirigenti della CNT chiesero ai propri militanti di deporre le armi. La Generalitat perse il controllo autonomo dell’armata di Catalogna e la responsabilità dell’ordine pubblico fu assunta dal governo di Valencia. Nella vittoria i comunisti non (…) vollero accettare altro se non la completa distruzione del POUM” (PRESTON, 2000:196/197). Caballero si rifiutò di sciogliere il POUM e arrestarne i capi ma, bloccato dai comunisti riguardo ai suoi piani di offensiva in Catalogna, egli rimase senza maggioranza. Non gli restò che dare le dimissioni e l’incarico di formare un altro governo fu affidato a 225 Juan Negrín. “Da quel momento in poi le conquiste rivoluzionarie della prima ora vennero sistematicamente smantellate, e la guerra seguì il corso dettato dai repubblicani” (PRESTON, 2000:197/198). Secondo BROUÉ e TÉRMINE, la grande debolezza delle conquiste rivoluzionarie fu il loro carattere incompiuto. La rivoluzione, appena nata, dovette difendersi: la guerra ridusse in briciole le conquiste rivoluzionarie prima che esse avessero potuto maturare e trasformarsi in pratica quotidiana. Inoltre, il Fronte popolare passò a essere caratterizzato come l’alleanza dei comunisti con le forze democratiche borghesi nell’interesse delle relazioni russe. Franco arrivò al potere nei primi del 1938 istituendo il suo primo governo regolare, chiudendo così l’epoca della Junta militare di Burgos. Mantenne i principali ministeri in mano all’esercito – quello della Difesa, dell’Ordine pubblico e degli Affari – e spartì gli altri tra le rappresentanze dei monarchici, dei carlisti e dei falangisti. Alla chiesa venne data la concessione di autorità assoluta nella sfera educativa. Ma, per la vittoria finale, Franco dovette ancora aspettare fino al 1° aprile 1939. 226 CAPITOLO 6 PER UNA TEORIA DELLA PRODUZIONE COLLETTIVA E COMUNITARIA ALL’INTERNO DEL MOVIMENTO ANARCHICO 1. La pratica nella storia Le esperienze storiche di produzione collettiva e comunitaria finora studiate, nonostante i diversi contesti in cui sono state prodotte e realizzate, hanno caratteristiche comuni che ci fanno pensare all’esistenza di un modello oppure di una teoria fondante. L’obiettivo di questo capitolo è individuare queste caratteristiche e le teorie che stanno dietro. In termini generali quattro sono i “punti cardinali” intorno a cui si svilupparono queste esperienze: l’organizzazione “amministrativa” della comunità, l’organizzazione del lavoro, la forma di retribuzione del lavoro svolto e il consumo dei beni prodotti. L’organizzazione amministrativa della comunità era basata su tre punti. Il primo era lo statuto scritto178, che determinava la forma di funzionamento della comunità e le regole di condotta dei suoi membri. Nella maggior parte dei casi, esso era frutto di un’intensa discussione svolta all’interno delle assemblee generali e alla quale partecipavano attivamente tutti i suoi integranti. Talvolta, però, lo statuto veniva preparato da una commissione e presentato alla comunità durante l’assemblea. In alcuni casi, tale commissione poteva essere stata previamente eletta dai membri della comunità durante l’assemblea e investita di pieni poteri per redigere lo statuto dopo previa discussione riguardo ai contenuti, come nel caso dell’utopia di ROSSI (Poggio al Mare) e nella maggior parte delle esperienze dei collettivi spagnoli. In altri casi, la commissione era scelta dagli organizzatori e disponeva di pieni poteri per elaborare lo statuto in base a criteri previamente discussi, come nel caso di Ralahine e di Cittadella. 178 Nel caso dell’utopia di ROSSI si trattava di un contratto. 227 Nei casi in cui la commissione era scelta dagli organizzatori dell’esperimento, due procedure si potevano verificare: lo statuto poteva essere presentato alla comunità come un prodotto finito – come nel caso di Ralahine – oppure come un documento aperto a discussioni e aggiustamenti, come nel caso di Cittadella. Alcune comunità scelsero di non elaborare nessuno statuto e di pensare alla soluzione dei problemi quando questi si fossero presentati concretamente, come accadde in alcuni collettivi spagnoli. Tra gli argomenti trattati all’interno dello statuto (regolamento), come menzionato nel capitolo precedente, figuravano alcune regole riguardanti la sua amministrazione; l’organizzazione e le funzioni dei comitati; gli obblighi dei membri aderenti al collettivo; la forma di allevamento del bestiame; l’immagazzinamento dei prodotti commestibili e del raccolto agricolo; la creazione di cooperative di consumo; l’aumento della produzione; il consumo dei prodotti da parte dei membri del collettivo; la determinazione dei giorni di festa; l’uso del denaro (nella maggior parte dei casi non circolante); l’elezione dei delegati di ogni ramo del lavoro; l’età minima e massima per il lavoro all’interno del collettivo e le attività da svolgere; i diritti che spettavano a coloro che decidessero di allontanarsi oppure trasferirsi dal collettivo; la sovranità e il ruolo dell’assemblea all’interno del collettivo, in quanto luogo decisionale per eccellenza. Il secondo punto era l’elezione dei comitati amministrativi e tecnici responsabili per l’esecuzione dei lavori. Il comitato amministrativo era responsabile dell’amministrazione della comunità, avendo come obblighi, come già sottolineato nel capitolo precedente: il rispetto dello statuto; la rappresentazione della comunità all’esterno, soprattutto per la commercializzazione; il controllo contabile e l’elaborazione di un libro per la prestazione dei conti ai membri della comunità; la convocazione e la conduzione delle assemblee generali e la compilazione dei verbali, ecc. I comitati tecnici erano responsabili per la buona conduzione delle attività; la determinazione dei lavori da svolgere e la pianificazione della produzione, ed erano organizzati secondo le attività svolte dalla comunità: agricoltura, allevamento del bestiame, industria, approvvigionamento, igiene e sanità, educazione, ecc. I membri dei comitati erano eletti all’interno dell’assemblea generale. Il terzo punto – e forse il più importante di tutti – era l’assemblea generale. Convocata con periodicità variabile – settimanale, quindicinale o mensile – essa era sovrana riguardo alle decisioni più importanti prese dalla comunità. A essa partecipavano tutti i membri; in alcuni casi le donne avevano diritto di parola, ma non di voto. Nell’assemblea venivano discussi i problemi più importanti della comunità. Le decisioni venivano prese, a seconda dell’importanza dei problemi in questione, a maggioranza 228 semplice o all’unanimità. L’assemblea generale aveva anche poteri per cambiare lo statuto, se ritenuto necessario e dopo esaustiva discussione. L’organizzazione del lavoro e della produzione era un altro pilastro importante di queste esperienze. Il lavoro era svolto di regola collettivamente e soltanto in casi eccezionali in forma individuale. Le decisioni sui prodotti da coltivare, le attività da iniziare e quelle da interrompere erano tutte prese in assemblea con la partecipazione di tutti i membri della comunità. A seconda delle attività da svolgere i lavoratori venivano divisi – o autorganizzati – in équipe di lavoro, e ogni lavoratore era libero di scegliere a quale gruppo partecipare. Ciascun gruppo eleggeva poi il suo delegato, il quale era responsabile per la conduzione delle attività e rappresentava l’équipe nelle riunioni con i comitati tecnici, non godendo però di nessun potere speciale. Ogni mattina i vari gruppi di lavoro si riunivano per prendere atto dei lavori da eseguire durante l’arco della giornata. Non esisteva un orario fisso di lavoro, ma un orario consigliabile. Ciascun lavoratore era libero di decidere quando recarsi al lavoro, dovendo però lavorare il numero di ore previamente determinato, a seconda dell’attività svolta e della stagione in cui si trovava. La determinazione delle ore di lavoro teneva in considerazione la fatica occasionata dal lavoro, la stagione, la durata della giornata e il periodo di coltivazione. I vari delegati delle équipe si riunivano con il comitato tecnico normalmente una volta alla settimana, per discutere sull’andamento dei lavori, i problemi eventualmente sorti e decidere sui lavori da eseguire, i cambiamenti da introdurre, ecc. Le decisioni prese erano poi comunicate alle varie équipe e messe in pratica. I problemi che persistevano venivano riportati al comitato tecnico che doveva pensare ad altre soluzioni più efficienti. Nei collettivi spagnoli esistevano anche comitati composti da tecnici specializzati responsabili dell’esecuzione di ricerche rivolte al miglioramento della produzione e a controbilanciare le avversità naturali. A tal fine venivano istituite all’interno dei collettivi delle stazioni sperimentali dove venivano realizzati gli esperimenti necessari. Le diverse ricerche venivano poi confrontate tra loro, in modo da diffondere le conoscenze prodotte e migliorare così la produttività di tutti i collettivi. La forma di retribuzione/remunerazione per il lavoro svolto era molto diversa tra le varie esperienze e, tra tutta la discussione fatta all’interno del movimento anarchico, ma non solo, questo era il punto di più difficile consenso. Nella maggior parte dei casi era previsto un salario che poteva essere individuale o familiare179. In altri non era prevista 179 Anche se il termine è lo stesso, la sua forma di determinazione è molto diversa da quella del sistema capitalista. 229 nessuna forma di retribuzione/remunerazione, dato che veniva garantito a tutti il libero accesso a tutti i prodotti della comunità, a seconda dei propri bisogni, stabilendosi così il comunismo anarchico. Fu il caso di Poggio al Mare nella sua fase conclusiva, della colonia Cecilia, della nuova comunità icariana e delle fratellanze francesi, tra cui i comunisti di Jault. Il salario individuale, vigente a Cittadella e, nella sua fase iniziale, a Poggio al Mare – l’utopia di ROSSI – variava a seconda del tipo di lavoro svolto e delle ore a esso dedicate. Si possono considerare questi due come esempi di pratica di collettivismo. Nel caso di Cittadella furono mantenute diverse categorie di retribuzione, che variavano a seconda della quantità di lavoro svolto e della responsabilità di ogni singolo socio all’interno del ciclo produttivo. Per decidere la remunerazione per ciascuna categoria, fatta in moneta ufficiale, la commissione amministrativa prese come basi per il calcolo la remunerazione nazionale aggiungendo qualcosa in più. Nel caso dell’utopia di Poggio al Mare, si cercò di mettere in pratica la massima collettivista «a ciascuno l’intero prodotto del suo lavoro» che si concretizzava nel consumo. Così, servendosi di un metodo scientifico che calcolava il consumo organico di ogni lavoratore per la produzione di un determinato bene, si arrivava, da un lato, alla quantità di “unità di valore” a cui ciascun lavoratore aveva diritto, dall’altro al numero di “unità di valore” che costava ogni prodotto, essendo la moneta ufficiale sostituita da queste “unità”. Ogni oggetto portava l’indicazione delle unità di valore che, secondo i calcoli, erano costate a tutti quanti avevano contribuito alla sua fabbricazione e, con le unità di valore che ciascun lavoratore guadagnava ogni giorno, era possibile acquistare i prodotti di cui si aveva bisogno, arrivando così alla messa in pratica della suddetta massima. Il salario familiare esistette soprattutto nei collettivi spagnoli. Le categorie salariali erano determinate a seconda delle situazioni coniugali, dell’età e, nella maggior parte dei casi, del sesso180, non esistendo differenze tra le attività svolte. A ciascun membro della famiglia veniva poi conferita la sua parte, sia in moneta ufficiale, sia in moneta locale, oppure, nei casi in cui era stato abolito completamente l’uso della moneta, tramite dei bonus o ancora tramite un sistema di punti segnati su un libretto di consumo. Dalla bibliografia consultata non risulta chiara la forma in cui venivano determinati i prezzi dei prodotti. Si intuisce l’esistenza di un controllo dalla parte della Federazione Regionale dei Collettivi per la determinazione e la stabilità dei prezzi, nei collettivi che avevano optato per il mantenimento della moneta, fosse essa ufficiale o locale. Sembra che quelli che avevano scelto il sistema dei bonus o dei punti, avessero trasformato i 180 Nonostante si trattassero tutti di esperienze anarchiche, soltanto in alcuni collettivi fu abolita la differenza di salario tra uomini e donne. 230 prezzi vigenti in punti. D’altra parte nella letteratura si riferisce dell’istituzione della “razione”, cioè, l’insieme dei prodotti necessari al consumo della famiglia durante la settimana. Questa veniva garantita a tutti i membri del collettivo, a seconda delle loro risorse e della disponibilità dei prodotti. Un’altra caratteristica esistente in alcuni collettivi e a Cittadella era il mantenimento di un piccolo appezzamento di terra a disposizione di ogni famiglia, in modo che essa potesse coltivare i prodotti di prima necessità di cui avesse bisogno oppure allevare qualche piccolo animale. Questo riduceva le spese per il sostentamento della famiglia e migliorava le sue condizioni materiali di esistenza. Il consumo dei beni prodotti variava a seconda della forma di retribuzione del lavoro. Nei casi in cui fu abolita la remunerazione, come appena detto, fu istituito il libero accesso alla produzione. Nei casi in cui continuarono a circolare moneta oppure bonus, i lavoratori ricevevano settimanalmente sia la moneta che i bonus con i quali si recavano ai magazzini di approvvigionamento per rifornirsi delle derrate necessarie al consumo settimanale. Nei casi in cui era stato istituito il sistema dei punti, veniva consegnato a ogni lavoratore un libretto di consumo su cui registrare i punti ai quali la famiglia aveva diritto durante la settimana e i punti che erano stati utilizzati per acquistare i prodotti. Per rifornirsi bastava presentarlo nei magazzini. Il responsabile, nel momento della consegna del prodotto richiesto, sottraeva dal totale dei punti disponibili quelli relativi ai prodotti acquistati. Così ogni famiglia aveva il controllo dei punti ancora rimanenti per l’acquisto di altre derrate. In tutti i casi fu stabilito il razionamento dei prodotti più pregiati o di più scarsa produzione, come la carne, mentre fu garantito a tutti il libero accesso a quelli più abbondanti, come il grano e l’olio. Relativamente al razionamento, inizialmente fu stabilita e distribuita una quota di ogni prodotto razionato a ciascuna famiglia o lavoratore non sposato. Poi, per garantire più libertà di consumo e di scelta, fu deciso di istituire anche per questi casi un sistema di punti, contati a parte. Per ciascun prodotto razionato fu stabilito un numero di punti e a ogni famiglia veniva segnalato sul libretto di consumo un numero determinato di punti da essere utilizzati con i prodotti razionati. Così ogni famiglia decideva da sola come utilizzare i suoi punti, a seconda dei propri bisogni e delle proprie preferenze. 231 2. La teoria 2.1. BAKUNIN e il collettivismo L’asse portante di tutti gli esperimenti svoltisi all’interno del movimento anarchico e trattati nei capitoli precedenti fu il tentativo di raggiungere la completa libertà degli individui. Sin dai suoi precursori, come STIRNER, era questa la questione intorno alla quale ruotavano tutte le proposte di organizzazione della società dell’avvenire. Con STIRNER e con PROUDHON – anche se con quest’ultimo in una forma meno radicale – si privilegiava soprattutto la libertà individuale nel senso stretto della parola. Fu soltanto con BAKUNIN che si cominciò a pensare alla possibilità di raggiungere questa libertà all’interno di un’organizzazione sociale e, di conseguenza, a pensare a proposte di organizzazioni effettivamente sociali della società futura. Secondo BAKUNIN, il raggiungimento della completa libertà individuale – il vero scopo della rivoluzione sociale dal punto di vista anarchico – dipendeva dall’instaurazione della completa uguaglianza – e non soltanto di quella politica, dei cittadini davanti alla legge, difesa e promossa dalla Rivoluzione Francese – ma soprattutto di quella economica e sociale tra gli uomini. Egli riteneva che l’uguaglianza politica, difesa dalla suddetta rivoluzione, era servita soltanto a gettare le basi per un altro tipo di dominazione, e che neppure la fratellanza, altro ideale rivoluzionario, era riuscita a mascherare questa contraddizione, data l’impossibilità di realizzare una vera fratellanza tra disuguali. Aggiungeva ancora che finché non si fosse stabilita una vera “uguaglianza economica e sociale, finché una minoranza qualunque [potesse] divenire ricca, proprietaria, capitalista non per il lavoro proprio di ognuno, ma per eredità, l’uguaglianza politica [sarebbe stata] una menzogna”181 (BAKUNIN, 1977c:49). 181 BAKUNIN citava il caso dell’insurrezione di Babeuf come l’ultimo tentativo rivoluzionario del XVIII secolo di raggiungimento di questa uguaglianza. Babeuf e i suoi volevano “espropriare tutti i proprietari e tutti i detentori degli strumenti di lavoro e di altri capitali a beneficio dello Stato repubblicano, democratico e sociale, di modo che lo Stato (…), solo proprietario di tutte le ricchezze mobili e immobili diveniva anche l’unico datore di lavoro, l’unico padrone della società; e munito al tempo stesso della onnipotenza politica avocava esclusivamente a sé l’educazione e l’istruzione uguale per tutti i fanciulli, e obbligava tutti gli individui in età maggiore a lavorare e vivere secondo l’uguaglianza e la giustizia” (BAKUNIN, 1977:54). In questa società, però, secondo l’anarchico, ogni libertà spariva, schiacciata dal potere dello Stato. BAKUNIN sottolineava che la teoria dell’uguaglianza stabilita forzatamente dallo Stato aveva i suoi fondamenti nella Repubblica di Platone e che altri esempi di tentativi di instaurazione dell’uguaglianza sociale potevano essere trovati tra i primi cristiani oppure nella rivolta contadina guidata da Thomas Mûnzer in Germania, nel XVI secolo. Tutti questi tentativi, però, fallirono sia perché le persone non erano sufficientemente pronte per poter praticare l’uguaglianza, sia perché nell’unire l’uguaglianza al potere, tutti questi tentativi finirono per escludere la libertà. 232 Il raggiungimento della completa uguaglianza e libertà, sempre secondo BAKUNIN, sarebbe avvenuto “per mezzo dell’organizzazione spontanea del lavoro e della proprietà collettiva delle associazioni produttrici liberamente organizzate e federate nelle comunità e per mezzo della federazione pure spontanea dei comuni” (BAKUNIN, 1977c:75). In una lettera indirizzata a Celso Ceretti, chiarisce meglio in quale modo, secondo lui, sarebbe organizzata la società dell’avvenire: come “organizzazione politica, è la federazione spontanea, assolutamente libera dei comuni e delle associazioni operaie; come organizzazione sociale è l’appropriazione collettiva del capitale e della terra da parte delle associazioni operaie” (BAKUNIN, 1976b:263). Davanti a questo scopo, gli anarchici si organizzarono in previsione della distruzione dello Stato e del raggiungimento della libertà, così come della diffusione della scienza in sostituzione della fede, affinché l’organizzazione in comuni e la federazione potessero avvenire come un atto spontaneo, frutto della convinzione delle persone e a seconda dei loro reali interessi, e non in virtù della forza o dell’imposizione dallo Stato182. Fu questa forma di organizzazione spontanea che ROSSI descrisse nella sua utopia e che poi, in parte, cercò di mettere in pratica in Cittadella e soprattutto nella Colonia Cecilia183; che in grado maggiore o minore le comunità religiose e laiche studiate nel capitolo precedente cercarono di realizzare e, soprattutto, che gli anarchici spagnoli cercarono di mettere in pratica con l’esperienza dei collettivi durante la guerra civile184. L’altro pilastro delle idee anarchiche, e che era alla base della società dell’avvenire e di tutte le proposte per la sua organizzazione economica e sociale, era la giustizia, non quella dei codici, ma quella basata sulla coscienza degli uomini. La società organizzata su queste basi avrebbe dovuto fare in modo che ogni uomo potesse avere “i mezzi materiali e morali per sviluppare tutta la propria umanità; tale principio si [sarebbe tradotto], (…) nel seguente problema: Organizzare la società in tal modo che qualunque individuo, uomo o donna, venendo alla luce, trovi dei mezzi pressoché uguali per lo sviluppo delle proprie facoltà e per l’utilizzazione delle stesse col proprio lavoro; organizzare una società la quale, rendendo impossibile a chiunque lo sfruttamento del lavoro altrui, permetta a ciascuno di partecipare al godimento delle ricchezze sociali (in realtà prodotte dal solo lavoro), solo in quanto avrà direttamente contribuito a produrle con la propria opera” (BAKUNIN, 1922:55/56). Queste erano le basi Gli anarchici credevano nell’esistenza di un forte spirito pratico tra le masse popolari, e che si fosse ormai raggiunta l’ora di lasciarle agire per conto proprio. 183 ROSSI privilegiò soltanto la libera organizzazione delle persone. 184 Nel caso dei collettivi spagnoli, oltre che l’organizzazione spontanea tra le persone in comuni e la loro distribuzione, anch’essa spontanea, all’interno delle attività svolte, ci fu anche l’organizzazione dei collettivi in federazione. 182 233 dell’organizzazione collettiva della produzione che più tardi furono tradotte nel motto «da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo quanto ha fatto». Gli anarchici erano dunque contrari a qualsiasi forma di organizzazione che per poter esistere si dovesse basare su un’autorità regolatrice esterna. L’unica azione che essi accettavano dallo Stato era il cambiamento del diritto d’eredità fino alla sua completa abolizione. Lo scopo era quello di abolire l’ineguaglianza economica ereditaria/artificiale delle classi, in quanto garante dell’ineguaglianza di accesso ai mezzi materiali di sviluppo: la “giustizia vuole l’eguaglianza del punto di partenza all’inizio della vita, affinché tale eguaglianza dipenda dall’organizzazione economica e politica della società, e affinché ciascuno, fatta astrazione dalle naturali differenze, sia soltanto figlio delle proprie opere” (BAKUNIN, 1922:57). L’unica ineguaglianza accettata da BAKUNIN e da quelli che gli succedettero era dunque quella naturale, appartenente all’individuo. Tale ineguaglianza era, tra l’altro, ritenuta un bene, una qualità, la vera ricchezza dell’umanità, ciò che la rendeva “un tutto collettivo nel quale ciascuno completa[va] tutti gli altri e di tutti gli altri [aveva] bisogno: di modo che la infinita diversità degli individui umani [era] la causa, la base principale della loro solidarietà, [e] un argomento onnipotente a favore dell’uguaglianza” (BAKUNIN, 1922:242). A questo proposito, BAKUNIN argomentava che soltanto quando si fosse stabilita “l’eguaglianza del punto di partenza per tutti gli uomini sulla terra, solo allora – salvaguardando tuttavia i diritti superiori della solidarietà, che [era] e [sarebbe restata] sempre il più potente produttore di tutte le cose sociali, intelligenza e beni materiali, solo allora [avremo potuto] dire (…) che ogni uomo [era] figlio delle proprie opere. Ed ecco la conclusione: affinché le capacità singole [potessero prosperare] e (…) dare tutti i loro frutti, [era] necessario cioè che le classi [fossero] abolite: [dovevano] scomparire la proprietà individuale ed il diritto d’eredità, [doveva] venire il trionfo economico, politico e sociale dell’eguaglianza” (BAKUNIN, 234 1922:241). BAKUNIN proponeva che la terra appartenesse soltanto a quelli che la coltivassero con le proprie braccia185 e che l’unico erede possibile fosse il fondo di educazione e istruzione che avrebbe avuto il compito di garantire la formazione e il mantenimento di tutti, dalla nascita fino alla maggiore età. L’altro tema affrontato da BAKUNIN fu quello della cooperazione. Anche lui ne era un difensore, ma su altre basi rispetto alla cooperazione di tipo borghese che, secondo lui, avrebbe avuto come risultato o il completo fallimento dell’esperienza, o il successo e il cambiamento della vita di pochi, dando seguito alla formazione di un quarto stato e, al di sotto di questo, di un quinto stato, ancora più miserabile186. Secondo lui, una possibilità di azione pratica che avesse come risultato il cambiamento materiale delle condizioni di vita della classe operaia tramite l’emancipazione del lavoro dalla dominazione del capitale poteva compiersi tramite la formazione di associazioni e di società cooperative di prestito, di consumo e soprattutto di produzione. A questo proposito, BAKUNIN richiamava l’attenzione su ciò che aveva già detto l’AIL: “La cooperazione sotto tutti i suoi aspetti è incontestabilmente una forma equa e razionale del futuro sistema di produzione. Ma affinché essa possa raggiungere i suoi scopi, che sono l’emancipazione delle masse lavoratrici, la loro retribuzione in funzione del prodotto integrale del loro lavoro e la soddisfazione dei loro bisogni, la terra ed il capitale, sotto qualunque forma, devono essere convertiti in proprietà collettiva” (BAKUNIN, 1977b:223). Organizzate su queste basi, le cooperative 185 Queste furono le idee che BAKUNIN cercò, senza successo, de introdurre all’interno del programma della Lega della Pace e della Libertà, al quale aveva contribuito a redigere (il testo si incontra all’interno del libro L’idea anarchica e l’Internazionale sotto il titolo Federalismo e Socialismo). Sempre nello stesso libro, sotto il titolo La questione dell’eredità: rapporto della commissione sulla questione dell’eredità, adottato dall’Assemblea Generale della Sezione di Ginevra, BAKUNIN insisteva sull’importanza dell’abolizione del diritto di eredità come l’unica possibilità di eliminare lo sfruttamento del lavoro dalla parte del capitale e della proprietà. Per lui, in quanto la proprietà e il capitale si trovassero monopolizzati nelle mani di una classe – la borghesia – che, proprio per questo monopolio era dispensata di lavorare, lo sfruttamento e l’oppressione del lavoro e del lavoratore continuerebbero a esistere. L’unica forma di eliminare questo privilegio e quindi eliminare l’ineguaglianza artificiale tra gli uomini sarebbe attraverso l’eliminazione del diritto di eredità, non da ciò che chiama eredità sentimentale e che consiste nella trasmissione di piccoli oggetti e/o abilità di generazione in generazione tra familiari o amici, ma sì di quello fondato sulla giurisprudenza, base della famiglia giuridica e dello Stato e che assicura agli eredi la possibilità di vivere senza lavorare. “Noi vogliamo che tanto il capitale quanto la terra, in una parola tutti gli strumenti e tutte le materie prime del lavoro, cessando di essere trasmissibili per diritto d’eredità, divengano una volta per sempre proprietà collettiva di tutte le associazioni produttive. L’eguaglianza e per conseguenza l’emancipazione del lavoro e dei lavoratori si ottengono soltanto a questa condizione” (BAKUNIN, 1922:196). Per raggiungere questo obiettivo dal punto di vista della giustizia umana, ci sono due cammini: quello delle riforme e quello della rivoluzione, l’ultimo dei quali, riteneva l’anarchico, era quello più breve. 186 La cooperazione di tipo borghese, se aveva insegnato ai lavoratori i vantaggi dell’unione, li aveva anche fatto capire che quel cammino non li avrebbe mai condotto alla loro auspicata emancipazione. Il risultato di questo fatto fu l’abbandono della cooperazione come strumento di lotta da parte dei lavoratori e l’indebolimento del sistema cooperativo. 235 avrebbero condotto alla vera emancipazione del lavoro187 e avrebbero reso più facile il passaggio alla società anarchica basata sull’eguaglianza e la giustizia. Vale la pena di sottolineare che gli scopi della cooperazione elencati dall’AIL diventeranno gli scopi del collettivismo nato con BAKUNIN e verranno messi in pratica a tutti gli effetti nelle esperienze dei collettivi spagnoli. Le linee generali di questa proposta si trovavano anche tra le comunità religiose americane – le comunità di Amana, di Bethel, di Aurora, tra gli Shakers, gli Zoarites, i Rappists, i Perfezionisti, gli Icariani; tra la tribù americana dei Natches; nella colonia irlandese di Ralahine, anche se in questo caso i lavoratori percepivano un salario a seconda del sesso188; tra i piccoli comuni scozzesi trattati da Walter Scott nel romanzo Monastero; tra le fratellanze francesi, tra cui i comunisti di Jault, i Pingons, gli iloti bretoni di Hoedie e Honat e tra le associazioni semi-comunistiche del Jura; tra le comuni e i villaggi russi e tra i nomadi. Va sottolineato che, con eccezione dei collettivi spagnoli, nessuna delle esperienze citate era anarchica. Le leggi o i principi fondamentali che reggevano la proposta bakuniana di organizzazione della società erano: il rispetto umano, la giustizia umana, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la scienza e il lavoro. BAKUNIN riteneva fondamentale il rispetto da parte di ogni individuo della libertà e dignità umana di ciascuno e di tutti. Per giustizia intendeva l’intera libertà di tutti di vivere in condizioni di uguaglianza e sviluppare tutte le proprie facoltà, attraverso la solidarietà e, di conseguenza, riteneva impossibile l’esistenza di privilegi o di qualsiasi possibilità di sfruttamento degli altri. Per libertà, intendeva il diritto di ciascuno alla vita, all’educazione, all’istruzione integrale, il diritto di sviluppare pienamente tutte le proprie facoltà, di non essere governato né comandato da nessuno o nient’altro che non dalle sue proprie convinzioni. Secondo lui, il diritto di decisione era la condizione assoluta della libertà. La solidarietà, uno dei pilastri fondanti del pensiero bakuniano, veniva intesa come la legge fondamentale e naturale di ogni società umana. Anche attribuendo a essa un valore positivo, l’anarchico riconosceva che essa era stata spesso utilizzata con scopi negativi. Secondo lui, affinché la solidarietà umana potesse diventare “una madre salutare e giusta per ciascuno, una provvidenza per tutti, occorre[va] che essa [avesse] per anima la libertà e per base l’uguaglianza. Occorre[va] che [fosse] illuminata dalla scienza positiva che tende[va] e che [sarebbe pervenuta] sempre più a rimpiazzare nella coscienza delle masse popolari le superstizioni Da lui intesa come “espropriazione dei capitalisti e trasformazione di tutti i capitali necessari al lavoro in proprietà collettiva delle associazioni operaie” (BAKUNIN, 1976b:264). 188 80 pences per gli uomini e 50 per le donne. 187 236 religiose. Occorre[va] che essa [fosse] realizzata dalla cooperazione sempre più meditata, dall’inevitabile lavoro, ma libero, uguale, sia muscolare che intellettuale di ciascuno e di tutti. Per tutti la stessa luce della scienza; per tutti la stessa necessità del lavoro: uguaglianza dei mezzi di sviluppo corporale, di educazione, di istruzione, delle condizioni di lavoro e di vita: uguaglianza dei doveri e dei diritti; e la libertà di ciascuno, cessando di essere un privilegio o un limite per l’altrui libertà, divente[rebbe] la risultante infinitamente ampia della libertà di tutti” (BAKUNIN, 1977a:127/128). Tutti questi princìpi faranno parte integrante dei programmi delle varie associazioni segrete create da BAKUNIN anche se alcune di esse sembrano essere esistite soltanto nella sua testa189. 2.2. KROPOTKIN e il comunismo anarchico L’altro autore che ha portato un importante contributo alla discussione sulla produzione collettiva e comunitaria è stato KROPOTKIN. Scienziato, geografo pratico e anarchico, egli fornì un grande contributo alle discussioni svolte non solo all’interno del movimento anarchico ma anche al di fuori di esso, contribuendo alla diffusione delle idee anarchiche e al cambiamento dell’immaginario sociale relative a quel movimento. Com’è stato detto nel secondo capitolo di questa tesi, KROPOTKIN era figlio di nobili russi e, dopo aver finito i suoi studi nel Corpo dei Paggi a Pietroburgo, scelse di andare in Siberia, con la speranza di poter mettere in pratica, in quella regione così lontana, le riforme in corso nella società russa. Lì restò dal 1862 al 1867, con l’incarico di attaché al Governatore Generale della Siberia Orientale per le questioni cosacche. Avendo capito, però, che nemmeno lì le riforme sarebbero state applicate, decise di accettare la proposta di fare un viaggio di esplorazione geografica nella Manciuria, dove entrò sotto la falsa identità di “mercante della seconda guilda di Irkutsk”190 dato che il trattato tra la Cina e la Russia non nominava la Manciuria. Da questa esperienza nacque il suo interesse per la geografia. Di ritorno dal viaggio, decise di fare un’inchiesta sulle condizioni economiche dei Cosacchi dell’Usurì che tutti gli anni perdevano il raccolto obbligando il governo a prendere provvedimenti per evitare le carestie invernali. Il rapporto gli fruttò premi e promozioni, i provvedimenti da lui consigliati furono accettati e vennero concesse sovvenzioni speciali in danaro “per aiutare gli uni ad emigrare, per fornire bestiame agli altri (…). Ma l’attuazione pratica di queste misure fu affidata a qualche ubriacone, che dava fondo 189 190 Maggiori informazioni su questo argomento si trovano nel capitolo 2 di questa tesi. KROPOTKIN, 1923, p. 198. 237 al denaro e fustigava spietatamente i disgraziati Cosacchi per veder di farne dei buoni agricoltori. Questo succedeva dappertutto, cominciando dal palazzo d’inverno a Pietroburgo per finire all’Usurì ed al Kamchutku” (KROPOTKIN, 1923:209). Perse le speranze di possibilità di cambiamento, KROPOTIN decise di dedicarsi alle esplorazioni scientifiche: nel 1865 visitò i Suyani occidentali, scoprendo un’altra regione vulcanica lungo la frontiera cinese; nel 1866 si dedicò alla ricerca di una via di comunicazione diretta fra le miniere d’oro della provincia di Guhutsk (sul Vitim e l’Olokma) e la Transbaikalia191, in un viaggio che durò tre mesi. Il colpo finale alla speranza di cambiamenti avvenne con il duro intervento dell’esercito russo contro la rivolta dei Polacchi nel 1866. L’anno successivo, KROPOTKIN abbandonò l’esercito e, insieme alla famiglia del fratello Alessandro al quale era molto legato, si trasferì a Pietroburgo. Lì egli realizzò il vecchio sogno di andare all’università, scegliendo la facoltà di fisica e matematica, senza però abbandonare i suoi studi geografici, soprattutto quelli relativi alla geografia fisica. Decise allora di scoprire il vero principio che regolava la distribuzione delle montagne dell’Asia e, dopo lunghi e dettagliati studi, riuscì a scoprire che le “principali linee di struttura dell’Asia non [andavano] dal nord al sud, e dal tramonto all’oriente, ma [andavano] dal sud-ovest al nord-ovest, come le montagne Rocciose e gli altipiani dell’America [andavano] dal nord-ovest al sud-est; soltanto le catene secondarie si [spingevano] verso il nord-ovest. Di più le montagne dell’Asia non [erano] catene separate come le Alpi, ma [erano] subordinate ad una immensa pianura, un vecchio continente che anticamente si protendeva verso lo stretto di Bering. Altre catene [torreggiavano] ai suoi confini; e nell’andar dei secoli, terrazze formate da depositi posteriori, si [erano] alzate dal mare, aggiungendosi così dalle dure parti a quella primitiva spina dorsale dell’Asia” (KROPOTKIN, 1923:220/221). Nel frattempo iniziò a lavorare per la Società Geografica Russa come Segretario della Sezione di Geografia Fisica, prendendo parte agli studi svolti dalla Società tra cui le esplorazioni artiche, il cui interesse era stato destato dall’apertura del mar di Kara alla navigazione. A questo proposito KROPOTKIN si dedicò all’elaborazione di un rapporto indicando le ricerche da eseguire in una spedizione scientifica in quella regione. Gli fu offerto il commando della spedizione ma i soldi non arrivarono ed egli fu mandato invece in Finlandia e Svezia, per esplorare i depositi glaciali. Nel tempo in cui collaborò con la Società Geografica Russa diversi argomenti relativi alla geografia russa passarono tra le sue mani al punto di fargli pensare 191 KROPOTKIN, 1923, pp. 209 e segg. 238 all’elaborazione di un trattato di geografia fisica di quella regione, dove indicare anche le diverse forme di vita economica che avrebbero dovuto predominare in quelle diverse regioni fisiche. Ma egli riteneva che un tale lavoro gli sarebbe stato possibile solo se avesse occupato il posto di Segretario della Società. L’invito arrivò nel 1871, ma era ormai troppo tardi: il viaggio fatto in Finlandia aveva dato un’altra direzione alla sua vita: da quel momento, l’interesse per le questioni sociali cominciarono a occupare una posizione sempre più importante tra i suoi pensieri. “Io vidi quale immenso sforzo di lavoro il contadino impiegasse nel dissodare la terra, e nel rompere la dura argilla, e dicevo a me stesso: - Io voglio scrivere, per esempio, la geografia fisica di questa parte della Russia, e insegnare al contadino i metodi migliori per coltivare il suo suolo. Qui avrebbe un inestimabile valore uno sradicatore americano; qui certi metodi di concime dovrebbero essere indicati dalla scienza… Ma a che pro parlare a questo contadino delle macchine americane, quando egli ha appena tanto poco per vivere da un raccolto all’altro; quando il fitto che deve pagare per questo duro suolo argilloso diventa di più in più grave proporzionatamente ai successi del miglioramento?” (KROPOTKIN, 1923:230/231). Nella primavera del 1872 KROPOTKIN fece il suo primo viaggio nell’Europa occidentale. Si installò a Zurigo e poi a Ginevra, dove prese contatto con la sezione locale dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, si mescolò ai lavoratori apprezzando gli effetti che lo sviluppo dell’AIL aveva su di loro e, dopo la delusione con la direzione presa dalla prima sezione alla quale si era inscritto192, decise di stabilire contatti con l’altra sezione esistente, conosciuta come “quella dei bakunisti”. Fu in quell’occasione che egli prese contatto con la Federazione del Giura che nel 1872 cominciava a ribellarsi all’autorità del concilio generale dell’AIL che intendeva controllare tutte le sezioni esistenti dell’Internazionale. Stabilì un contatto con importanti rivoluzionari locali e con gli orologiai a Neuchatel e a Sonvilliers, rimanendo colpito dall’assenza di divisione fra i capi e le masse nella Federazione del Giura e dallo spirito di fratellanza che dominava in quella Federazione. “Le teorie anarchiche, come allora cominciavano ad essere formulate nella Federazione del Giura – soprattutto da Bakunin; la critica fatta al socialismo di Stato – la paura di una tirannia economica molto più pericolosa di una semplice tirannia politica che ivi sentivo formulare; ed il carattere rivoluzionario preso dall’agitazione, mi impressionarono molto favorevolmente. Ma i rapporti fraterni che prevalevano nel Giura, l’indipendenza di pensiero e di parola che scorgevo in mezzo agli operai, e la loro sconfinata devozione alla causa fece[ro] un appello ancora più potente ai miei sentimenti; e quando lasciai quelle montagne dopo una sosta di una settimana cogli orologiari, le mie idee in fatto di socialismo erano fissate. Ero anarchico” 192 Essa viene identificata da lui dal luogo dove si svolgevano le riunioni: Temple Unique. 239 (KROPOTKIN, 1923:274)193. Il viaggio che fece più tardi in Belgio gli diede la conferma della scelta fatta. Da questo momento in poi, KROPOTKIN passò a partecipare attivamente alla discussione svolta all’interno del movimento anarchico attraverso una serie di articoli pubblicati su giornali anarchici come «L’Avant Garde», «Le Révolté», il «Bulletin de la Fédération Jurassienne», «La Révolte», il «Nineteenth Century»* (con articoli sulla Russia), «La Revue Socialiste»* (con articoli di carattere geografico), l’Enciclopedia Britannica*, (con un articolo sul concetto di anarchismo e l’evoluzione del pensiero anarchico, soprattutto del comunismo anarchico), la Geografia Universale* di Elisée Reclus, il «Times» e altri periodici scientifici londinesi194. Buona parte di questi articoli sono stati raccolti in libri che sono diventati lettura obbligatoria per quelli che appartenevano al movimento o che si sono dedicati al suo studio. È il caso di Parole di un ribelle, La conquista del pane, Il mutuo appoggio e Campi, fabbriche e officine, tutti di grande importanza per l’argomento trattato nel presente capitolo e che saranno analizzati in seguito195. 2.2.1. I cardini del pensiero di KROPOTKIN e del comunismo anarchico L’analisi della vasta opera di KROPOTKIN196 ci permette di capire l’esistenza di un’idea o, più correttamente, di una meta da raggiungere per la realizzazione della società futura: la soddisfazione di tutti i bisogni degli individui, nelle sue parole, l’agiatezza per tutti. Secondo lui, bastava cambiare l’impostazione rispetto alla produzione e privilegiare la produzione di beni di necessità anziché di beni di lusso per avere un aumento naturale della produzione e, di conseguenza, la garanzia a tutti di tutto quanto avessero bisogno per vivere e sviluppare tutte le loro facoltà. L’unico modo per raggiungere questo obiettivo, secondo lui, era attraverso l’organizzazione della società in comunismo anarchico, da lui Il corsivo e il grassetto sono miei. I periodici segnati con l’asterisco indicano i contributi realizzati, secondo WOODCOCK, durante il periodo in cui stette in carcere per la seconda volta, prima a Lione (dall’arresto fino al marzo del 1883) e poi a Clairvaux (fino alla liberazione nell’autunno 1885). KROPOTKIN era stato incarcerato insieme ad altri anarchici in seguito ad alcuni attentati avvenuti presso il caffè Théatre Bellecour e presso un ufficio di collocamento non specificato. Fu condannato in base al sistema gesuistico per appartenenza all’AIL – anch’essa un’accusa falsa – data la non esistenza di prove riguardo ai suddetti attentati. La legge sulla quale si basò la sua condanna era stata votata subito “dopo la sconfitta della Comune, secondo la quale gli imputati di appartenere a quella Associazione possono essere tradotti in tribunale correzionale. Il massimo della pena [era] di cinque anni di reclusione, ed un tribunale correzionale [era] sempre disposto a pronunciare la condanna desiderata dal governo” (KROPOTKIN, 1923:423/424). KROPOTKIN, però, non fa menzione di questa collaborazione nelle sue Memorie. 195 Di grande interesse anche il suo Memorie di un rivoluzionario dove racconta del suo avvicinamento alla geografia, oltre che degli avvenimenti più importanti della sua vita. 196 Uno studio più dettagliato delle sue principali opere – Parole di un ribelle, La conquista del Pane, Il mutuo appoggio e Campi, fabbriche, officine – si trova in fondo a questa tesi come ALLEGATO N° 1. 193 194 240 inteso come il punto di arrivo naturale verso il quale la società, già nella sua epoca, cominciava a muoversi. Tutta la sua opera è dedicata alla difesa di questo punto di vista, all’indicazione di un possibile cammino da seguire e al disegno dei risultati che si sarebbero ottenuti una volta che tale meta fosse stata raggiunta. Secondo KROPOTKIN – così come secondo BAKUNIN – nella società dell’avvenire tutti avrebbero avuto lo stesso diritto di accesso alle ricchezze. Secondo lui, tutto doveva appartenere a tutti e, poiché ognuno aveva contribuito con il proprio lavoro a produrre le ricchezze, avrebbe avuto diritto – e qui sta la differenza rispetto a BAKUNIN – a prendere da queste quanto avesse bisogno per garantire la soddisfazione dei suoi bisogni con agiatezza, da dove il motto: «a ciascuno secondo i suoi bisogni». Con questa concezione dell’accesso alle ricchezze egli si dichiarava contrario alle formule di retribuzione del lavoro proposte dai collettivisti basate sul totale di ore lavorate e riassunte nel motto «a ciascuno il prodotto integrale del suo lavoro», allo stesso tempo in cui creava gli assi fondanti del comunismo anarchico. La garanzia dell’agiatezza per tutti sarebbe stata possibile, per lui, grazie alla diffusione dei progressi della scienza – soprattutto attraverso l’impiego delle macchine – in tutti i settori della produzione, nonché al cambiamento della stessa impostazione della produzione. Tale cambiamento, inteso come il privilegio della produzione di beni di necessità anziché di beni di lusso, che avrebbe avuto come risultato l’aumento naturale della produzione, dipendeva dalla trasformazione di tutte le proprietà private in proprietà comuni. È questo il motivo per cui KROPOTKIN riteneva che l’obiettivo principale della rivoluzione fosse quello di realizzare l’espropriazione in tutti i settori dell’economia. Tale espropriazione avrebbe avuto tre obiettivi fondamentali: riconoscere a tutti il diritto alla vita; pensare alle necessità dei lavoratori prima che ai loro doveri; riconoscere il diritto all’agiatezza anziché al lavoro come la principale meta da raggiungere. L’anarchico riteneva che, affinché essa potesse essere efficace, essa doveva essere realizzata al di fuori della società capitalista. Secondo lui, a “ogni fase economica corrisponde[va] la sua fase politica, e [sarebbe stato] impossibile di colpire la proprietà senza trovar nel medesimo istante una nuova maniera di vita politica” (KROPOTKIN, 1948:29). Stando così le cose, l’espropriazione avrebbe dovuto agire ad ampio raggio, in modo da non permettere di tornare indietro: il suo scopo doveva essere la fine della possibilità di sfruttamento del lavoro. Essa avrebbe dovuto restituire a tutti la possibilità di accedere ai mezzi necessari per sviluppare le facoltà di ognuno e per poter lavorare senza per questo dover vendere la forza lavoro a chiunque fosse. Nelle sue parole: “vogliamo organizzarci in maniera che ogni essere umano che venga al mondo, abbia la possibilità assicurata di imparare 241 dapprima un lavoro produttivo, e acquistarne l’abitudine; e in seguito di poter fare questo lavoro senza domandarne il permesso al proprietario e al padrone, e senza pagare agl’incettatori della terra e delle macchine la parte del leone su tutto ciò ch’egli produrrà. (…) Il giorno in cui il contadino potrà lavorar la terra senza rilasciar la metà di ciò che ha prodotto; il giorno in cui le macchine necessarie per preparare il suolo alle grandi raccolte saranno in abbondanza, alla libera disposizione dei coltivatori: il giorno in cui l’operaio dell’officina produrrà per la comunità e non per il monopolio, i lavoratori non saranno più ricoperti di cenci; e non vi saranno più Rothschild, né altri sfruttatori. Nessuno avrà più bisogno di vendere la sua forza lavoro per un salario che non rappresenta che una parte di ciò ch’egli ha prodotto” (KROPOTKIN, 1948:31/32). Secondo lui, dal momento in cui ogni membro della società si rendesse conto che gli sarebbero bastate poche ore di lavoro al giorno per poter accedere a tutti i piaceri che la civiltà gli poteva propiziare, non ci sarebbe stato più nessuno che si sarebbe reso disponibile a vendere la propria forza lavoro a chiunque fosse. “L’espropriazione [dovrebbe] comprendere tutto ciò che [potrebbe permettere] a chicchessia – banchiere, industriale o coltivatore – di appropriarsi il lavoro altrui. La formula è semplice e comprensibile. Noi (…) vogliamo restituire ai lavoratori «tutto» ciò che permette a chiunque siasi (sic) di sfruttarli: e noi faremo tutti i nostri sforzi perché, pur non essendovi nessuno che manchi di nulla, non esista «un solo individuo» il quale sia costretto a vendere le proprie braccia per vivere insieme coi suoi figliuoli. Ecco in qual modo noi intendiamo l’espropriazione!” (KROPOTKIN, 1948:36). Questa forma di espropriazione avrebbe gettato le basi di un’altra scienza economica, dedicata allo studio dei bisogni dell’umanità e dei mezzi economici migliori per soddisfarli. Questo cambio di prospettiva avrebbe avuto come risultato una nuova organizzazione della produzione, con lo scopo di soddisfare tali bisogni con il minimo spreco possibile di energie, materie prime e forza lavoro. Riorganizzata su queste basi, la nuova economia avrebbe rotto con il primato capitalista della produzione sul consumo, stabilendo il suo opposto, cioè, il primato del consumo sulla produzione: era la necessità di consumare che doveva stabilire che cosa, come e quanto produrre, e non l’inverso. Questo era, secondo KROPOTKIN, il cammino da seguire verso il comunismo anarchico. Una volta compiuta la rottura con la proprietà privata, la società dell’avvenire sarebbe portata naturalmente e inevitabilmente a organizzarsi in comunismo anarchico. Considerando che tutti i tipi di lavoro avessero la stessa importanza per il progresso della 242 società e che fosse impossibile stabilire e valutare il contributo portato da ciascuno al raggiungimento di tale progresso a seconda della qualità, importanza e grado di impegno nello svolgimento del suo lavoro, e dal momento in cui tutti avessero lavorato, secondo lui, dovrebbero essere i bisogni di ciascuno, e non il totale di ore lavorate, a regolare il consumo. Infatti, KROPOTKIN ritiene che, partendo “da questo punto di vista generale e sintetico della produzione, (…) [non era possibile] ammettere con i collettivisti che [potesse] essere un ideale, o anche un passo innanzi verso questo ideale, la rimunerazione proporzionale alle ore di lavoro da ciascuno effettuate per la produzione delle ricchezze. Senza discutere qui se realmente il valore di scambio delle merci [fosse] calcolato nella società attuale dalla quantità di lavoro necessario per produrle (…), ci [basta] dire (…) che l’ideale collettivista ci pare irrealizzabile in una società che consideri gli strumenti di produzione come un patrimonio comune. Basata su tale principio, essa si [sarebbe vista] poi costretta ad abbandonare immediatamente ogni forma di salario197. Noi siamo persuasi che l’individualismo attenuato dal sistema collettivista non [avrebbe potuto] esistere a lato del comunismo parziale del suolo e degli strumenti di lavoro posseduti da tutti. Una nuova forma di produzione non potrebbe conservare l’antica forma di consumo, come non potrebbe adattarsi alle antiche forme d’organizzazione politica. (…). Il possesso comune degli strumenti di lavoro [apporta] necessariamente il godimento in comune dei frutti del lavoro comune” (KROPOTKIN, 1948:22). Secondo lui, l’unica forma possibile di retribuzione del lavoro era: “collocare i «bisogni» al di sopra delle «opere», e riconoscere dapprima il diritto alla vita – poi all’agiatezza – per tutti coloro che [avessero preso] una certa parte nella produzione” (KROPOTKIN, 1948:134). In altre parole, il possesso comune degli strumenti di lavoro portava necessariamente al godimento in comune dei frutti del lavoro. Da questo il motto del comunismo anarchico: «a ciascuno secondo i propri bisogni». Dando seguito alla sua argomentazione, egli elenca una serie di fatti considerati da lui come la manifestazione della tendenza specificamente comunista già all’interno delle società che predicavano l’individualismo, quali la crescita di nuove organizzazioni basate sul principio «a ciascuno secondo i propri bisogni»; le tendenze a non misurare il consumo; a collocare i bisogni degli individui al di sopra della valutazione dei servizi da essi prestati o da prestare alla società; l’aumento della solidarietà tra le persone e la nascita di organizzazioni libere, di tipi e funzioni diverse. Davanti a quanto appena detto, si domanda come fosse possibile dubitare che questi principi non fossero in grado di diventare i principi della vita sociale della nuova società. 197 “Ed è logico. Poiché, quando gli strumenti di lavoro fossero di proprietà comune, sarebbero i lavoratori che retribuirebbero se stessi! Ciò che sarebbe assurdo. N.d.T.” (KROPOTKIN, 1948:22 n. 2). 243 Realizzata l’espropriazione e stabilito il comunismo anarchico, c’era da pensare a come far funzionare la società. La prima cosa da decidere era la sua organizzazione territoriale. KROPOTKIN propone che essa si organizzasse in comuni, da lui intese come gruppi di eguali. Gli unici interessi che ciascuna comune avrebbe ammesso al di sopra dei suoi sarebbero stati quelli della Federazione delle Comuni liberamente organizzate. Ogni comune sarebbe lasciata libera di fare tutte le riforme e creare tutte le istituzioni necessarie al suo pieno funzionamento; sarebbe diventata comune non soltanto nel nome ma in tutti gli aspetti della vita quotidiana, fossero essi politici (abolizione di qualsiasi forma di governo) o economici (produzione e commercializzazione); avrebbe cercato di universalizzarsi e di creare vincoli di solidarietà con le altre comuni che si sarebbero messe in relazione tra di loro per scambio di merce e di cultura, non avendo quindi da temere nessun tipo di isolamento198. Precisa infine che, per gli anarchici, “«Comune» non è più una agglomerazione territoriale; è piuttosto un nome generico; sinonimo di gruppo d’eguali, che non conoscono mura né frontiere. La Comune sociale cesserà ben presto d’essere un tutto precisamente definito. Ogni gruppo della Comune sarà necessariamente attratto verso gli altri gruppi affini delle altre Comuni; si unirà, si federerà con essi, con legami per lo meno solidi come quelli che lo riannodano ai suoi concittadini, costituirà una Comune d’interessi, i cui membri sono sparsi dentro mille città e villaggi. Un individuo troverà la soddisfazione dei suoi bisogni unendosi con altri individui dagli stessi gusti e abitanti cento altre Comuni” (KROPOTKIN, 1921:129). La messa in pratica del motto «a ciascuno secondo i propri bisogni» dipendeva, però, anche dalla forma di organizzazione dell’accesso al vitto, all’alloggio e all’abbigliamento. KROPOTKIN crede possibile garantire a tutti sin dall’inizio l’accesso a questi tre generi, attraverso un principio di uguaglianza fra tutti. Per quanto riguardava le derrate, ritiene che la messa a coltivazione delle terre prima mantenute incolte avrebbe portato all’aumento della produzione garantendo così a tutti la soddisfazione dei propri fabbisogni. Secondo lui, si sarebbe organizzato un gruppo di volontari – i volontari delle derrate – responsabile per la realizzazione di un inventario di tutto quanto disponibile nonché per la diffusione pubblica dei risultati di tale lavoro e dei posti dove si trovavano le merci. Per i prodotti in abbondanza si prevedeva il libero accesso, per quelli scarsi, il 198 A quelli che ritenevano impossibile il funzionamento della società senza lo Stato, KROPOTKIN risponde argomentando che non sempre era lo Stato il responsabile per il funzionamento della società e dell’economia in particolare. Alcune volte erano le industrie da sole a stabilire degli accordi tra loro in modo da ottimizzare i loro guadagni. Altre erano i cittadini che si organizzavano da soli per provvedere all’aiuto reciproco e coprire le lacune lasciate dallo Stato. E, secondo lui, se questo avveniva già all’interno della società capitalista, non c’erano motivi per credere che non continuerebbe a succedere nella società anarchica. 244 razionamento, come succedeva tra i comuni agrari europei e come più tardi fu messo in pratica all’interno dei collettivi spagnoli e dell’esperienza della Colonia Cecilia di Giovanni ROSSI di cui abbiamo trattato nei capitoli precedenti. Contrario alle mense, considera che gli alimenti dovessero essere consumati rispettando i gusti personali. Per quanto riguardava il rifornimento delle città, prevede un accordo tra città e campagna in modo che le città offrissero ai contadini i prodotti di cui essi avessero bisogno – e non i famosi bonus di lavoro che altro non erano che carte senza valore – ricevendo in cambio gli alimenti di cui necessitavano. In un secondo momento, prevede che anche gli abitanti delle città passassero a dedicarsi a un piccolo orto in modo da garantire almeno una parte della loro alimentazione e ancora una volta fa riferimento ai progressi della scienza riguardanti l’agricoltura – come i macchinari, serre, concimi, ecc. – come propiziatori di tale pratica. Inoltre, crede che con il passare del tempo si sarebbe sviluppata una tendenza alla combinazione dell’attività agricola con quella industriale – tema su cui ritornerà nel libro Campi, fabbriche, officine – permettendo così uno sviluppo equilibrato di tutte le regioni di uno stesso paese e di tutti i paesi del mondo199. Lo stesso schema dei gruppi di volontari era previsto per quanto riguardava l’alloggio e l’abbigliamento: si sarebbero organizzati gruppi che avrebbero fatto un inventario di quanto disponibile – delle abitazioni vuote o sottoccupate; degli abbigliamenti disponibili nei grandi magazzini – i quali avrebbero provveduto alla diffusione pubblica dei risultati e all’indicazione delle procedure da adottare per aver accesso sia alle abitazioni che al vestiario. Nel caso dell’alloggio, i primi a essere beneficiati sarebbero quelli peggio alloggiati e così successivamente. Le abitazioni insalubri sarebbero state restaurate e ad altre eventuali mancanze avrebbero provveduto gruppi di lavoratori specializzati200. Per il vestiario, quelli che non avessero avuto accesso ai vestiti già pronti avrebbero potuto richiedere il materiale necessario nei magazzini e confezionarli da sé oppure ordinarli nei laboratori comunali, a seconda dei propri gusti. In tutti questi casi, sono due le idee di fondo: una, che ciò che esisteva di già sarebbe bastato a garantire, almeno in un primo momento, la soddisfazione dei bisogni di tutti; l’altra, la fiducia nella diffusione dei progressi della scienza in tutti i settori della produzione. Tali idee sono criticate da MALATESTA che ritiene la proposta di KROPOTKIN molto semplificata. Secondo lui, KROPOTKIN da un lato presenta la cosa come se fosse l’ordine naturale delle cose, come se stesse per accadere da un momento all’altro; dall’altro egli accetta l’idea che i Vale le pena di ricordare che lui crede alla diffusione della rivoluzione sociale in tutti i paesi del mondo. 200 KROPOTKIN sottolinea l’importanza che l’idea dell’espropriazione venisse accettata da tutti, fatto che avrebbe dato alla rivoluzione un carattere comunista. 199 245 prodotti accumulati sia nell’agricoltura che nell’industria fossero sufficienti per soddisfare i bisogni di tutti e, quando scopre che non sempre era così, si concentra sulle possibilità offerte dai progressi della scienza che a suo parere si sarebbero diffusi dappertutto, senza tenere in considerazione la resistenza da parte dei piccoli produttori – soprattutto dei contadini – alle novità nel processo produttivo e le difficoltà che tale diffusione avrebbe dovuto affrontare. Per quanto riguardava la giornata di lavoro, egli riteneva che se tutti lavorassero dall’età di 20 a 50 anni in un’attività produttiva considerata necessaria, sarebbero bastate quattro o cinque ore di lavoro al giorno per garantire a tutti l’agiatezza. L’altra parte della giornata, secondo lui, doveva essere dedicata ad attività artistiche o scientifiche a cui ciascuno si sentisse più portato, garantendo così a ogni individuo il totale sviluppo di tutte le sue facoltà e portando così alla fine della differenziazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, accettata anche da alcuni dei collettivisti sotto forma di lavoro distinto (intellettuale) e lavoro semplice (manuale). Richiama l’attenzione sulla necessità di trasformare l’ambiente di lavoro in un posto piacevole e sui vantaggi che tale trasformazione avrebbe comportato come l’aumento della produttività e della qualità del lavoro svolto, senza che per questo si dovesse aumentare la quantità delle ore lavorate201. Inoltre, sottolinea la necessità di garantire a tutti spazi individuali dove poter usufruire del tempo libero come meglio ritenuto da ogni individuo, dichiarandosi contrario all’organizzazione della vita sociale in falansteri o familisteri. KROPOTKIN risponde ancora a due delle principali obiezioni che spesso venivano fatte riguardo all’istituzione del comunismo anarchico nella società futura. La prima si riferiva al non lavoro e alla proprietà: secondo i suoi critici, dal momento in cui il lavoro non sarebbe stato più un obbligo/costrizione, ciascuno avrebbe cercato di scaricare sugli altri le proprie responsabilità, lavorando malvolentieri e il minimo possibile o non lavorando punto, fatto che avrebbe provocato la diminuzione della produzione/produttività del lavoro. KROPOTKIN contraddice questa obiezione, affermando essere esattamente l’opposto quello che si verifica, e cioè, che si lavora meglio quando il lavoro è libero, quando il lavoratore, padrone anche lui della terra e degli altri strumenti di produzione, sente di lavorare per sé e non si sente sorvegliato da nessuno né obbligato a niente e, meglio ancora, quando il lavoro viene svolto collettivamente. 201 Secondo l’anarchico, una volta che il lavoro fosse diventato libero e piacevole e che al lavoratore fosse data l’opportunità di scegliere a quale attività dedicarsi, egli si sarebbe sentito molto più stimolato e, una volta padrone del proprio lavoro, sentendo di lavorare per sé, avrebbe lavorato molto di più. Tale pratica avrebbe portato alla sparizione del lavoro noioso e alienante, nonché dei cosiddetti lavoratori pigri. 246 Sempre rispetto alla questione dello stimolo al lavoro, difendendo l’idea del lavoro piacevole – uno dei pilastri delle idee anarchiche – come il vero stimolo al lavoro, KROPOTKIN afferma che quando il lavoro fosse diventato libero – sempre che ciascuno dedicasse le quattro o cinque ore giornaliere allo svolgimento di un lavoro produttivo e che ciascuno potesse scegliere liberamente il lavoro che più gli piacesse – sarebbero stati i lavoratori stessi a scegliere i compagni con cui lavorare, a seconda della qualità del lavoro svolto da loro stessi e dagli altri. Secondo lui, una persona che lavorasse poco o male verrebbe naturalmente invitata dai suoi compagni che invece lavorano molto e bene a cercare un gruppo che lavorasse secondo i suoi ritmi202. Argomenta infine che la cosiddetta pigrizia tanto attribuita ai lavoratori era dovuta, da un lato, al lavoro noioso, ripetitivo e alienante a cui erano spesso soggetti i lavoratori e, dall’altro, al frequente non adeguamento del lavoro alle qualità presenti nel lavoratore. “Il benessere, cioè la soddisfazione dei bisogni fisici, artistici e morali, e la sicurezza di questa soddisfazione, sono sempre stati lo stimolo più potente al lavoro. E dove il salariato [arrivava] appena a produrre lo stretto necessario, il lavoratore libero, il quale [avrebbe visto] crescere il lusso e l’agiatezza per sé e per gli altri in ragione dei suoi sforzi, [avrebbe dispiegato] (…) maggiore energia ed intelligenza, ed [avrebbe ottenuto] prodotti di prim’ordine molto più abbondanti. L’uno si [sentiva] inchiodato alla sua miseria; l’altro [poteva] sperare nell’avvenire agi e godimenti. Tutto il segreto [era] qui” (KROPOTKIN, 1948:114). La seconda obiezione si riferiva alla differenza tra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale e la discriminazione in essa contenuta. L’anarchico afferma che nella società dell’avvenire tale differenziazione sarebbe stata abolita e che tutti sarebbero stati, allo stesso tempo, lavoratori manuali e intellettuali, fatto che avrebbe comportato l’esercizio e il libero sviluppo di tutte le facoltà dell’uomo. L’idea di fondo presente nella proposta kropotkiniana di organizzazione della società futura era che il vero fattore di sviluppo e di evoluzione dell’umanità fosse la cooperazione, il mutuo appoggio e non la lotta continua per la sopravvivenza come era stata presentata da Darwin. Queste idee erano il risultato delle sue osservazioni durante le spedizioni realizzate nel periodo in cui servì l’esercito in Siberia e trovarono conferma negli specialisti, per esempio nella conferenza di KESSLER del 1880 Sulla legge dell’aiuto reciproco. L’eminente zoologo riteneva che, accanto alla legge della lotta reciproca, era 202 Tale affermazione fa capire che, in realtà, la società anarchica non era amorale e senz’ordine, come tanti volevano far credere. Questa è una delle questioni più polemiche presenti all’interno del movimento anarchico e alla quale i suoi critici dedicano più attenzioni. Secondo loro, tale giudizio era anch’esso una restrizione alla libertà altrui e, quindi, nemmeno nella società anarchica si sarebbe verificata la tanto propagata libertà totale dell’individuo. 247 possibile osservare nella natura la legge dell’aiuto reciproco, secondo lui molto più importante per il successo della lotta per la vita nonché per l’evoluzione progressiva della specie. KROPOTKIN decise allora di raccogliere materiale per poter sviluppare tale idea che, credeva non fosse altro che lo sviluppo delle idee espresse dallo stesso Darwin nell’Origine dell’Uomo203. Gli servirono da stimolo ai suoi studi anche il dissenso rispetto alle discussioni che si svolgevano sui rapporti tra il darwinismo e la sociologia. La pubblicazione del manifesto di lotta per la vita di HUXLEY – lo Struggle for Existence and its Bearing upon Man – uscito nel 1888 fu la spinta che mancava alla decisione della redazione di una pubblicazione sull’argomento. KROPOTKIN crede che la cooperazione e il mutuo appoggio erano non solo le armi più efficaci nella lotta per la sopravvivenza contro le forze ostili sia della natura sia delle specie nemiche, ma che esse erano anche lo strumento principale dell’evoluzione progressiva all’interno di una stessa specie, permettendo a tutti longevità, sicurezza e progresso intellettuale. “Così [avveniva] che le specie (…) che [praticavano] di più il mutuo appoggio, non solo [sopravvivevano] meglio delle altre, ma [occupavano] anche il primo posto – ciascuna nella sua classe rispettiva (d’insetti, di uccelli o di mammiferi) – per la superiorità della loro struttura fisica e della loro intelligenza” (KROPOTKIN,1922:48). Secondo lui, tutte le volte che gli individui di una stessa specie dovevano lottare contro l’insufficienza di viveri, essi uscivano da questa esperienza talmente diminuiti in vigore e salute che era impossibile pensare che da tale lotta potesse derivare l’evoluzione progressiva delle specie. Questa forma di concepire la solidarietà e il mutuo appoggio come il vero motore dell’evoluzione sia delle specie animali che dell’uomo – e di conseguenza anche della società – metteva in discussione non solo la teoria naturalista dell’evoluzione delle specie di Darwin ma anche la concezione e la valorizzazione della lotta di classe e della lotta per la conquista del potere come il motore della società. Nel dare un valore positivo alle manifestazioni di solidarietà tra gli uomini e non alla lotta di classe quale intesa per esempio da MARX, KROPOTKIN riteneva che il vero obiettivo della lotta politica – la cui esistenza era da lui ammessa – doveva essere la definitiva eliminazione del fenomeno di formazione delle classi e la sua sostituzione con l’unità del gruppo retto dal mutuo appoggio e non la sostituzione al potere di una classe con un’altra. È da questa tesi che nasce la sua proposta dell’organizzazione territoriale della nuova società in comuni destinati a federarsi con altri, dando origine a vaste unioni volontarie. Gli eventuali gruppi 203 KROPOTKIN non era d’accordo con KESSLER in ciò che si riferiva alle origini delle tendenze solidaristiche degli animali – da questi attribuite ai sentimenti familiari e alla cura della prole – neppure con altri come BÜCHNER che invece attribuivano la loro socievolezza all’amore e alla simpatia. 248 esistenti all’interno dei comuni sarebbero legati tra loro da legami di auto aiuto rivolti a soddisfare i bisogni della società. Rispetto alla questione dei bisogni KROPOTKIN si pone ancora una volta in polemica con i suoi contemporanei nel ritenere che essi sono in realtà una conseguenza dello sviluppo culturale dell’uomo e delle situazioni evolutive che tale sviluppo determinava e che, quindi, dipendevano enormemente dai vari condizionamenti a cui l’uomo era soggetto nella sua vita. Stando così le cose, secondo lui, sono i bisogni che precedono la produzione e non il contrario, come spesso veniva affermato dagli economisti e pure dai marxisti. KROPOTKIN pone la soddisfazione dei veri bisogni degli individui – e non di quelli indotti dalla società in cui si trovava – come la principale meta da raggiungere dalla nuova società e, inoltre, ritiene che dovevano essere i bisogni, o la necessità di consumare, a determinare la produzione. Sotto questa nuova prospettiva, il compito dell’economia politica diveniva quello di studiare i mezzi migliori per soddisfare i bisogni della società dal punto di vista del risparmio di energia, tempo, materie prime ecc. come aveva già affermato anteriormente. La democratizzazione dei processi decisionali che avrebbe dovuto avvenire all’interno dei comuni – caratterizzata da un alto livello di partecipazione degli individui – sarebbe stata quindi la garanzia di assicurare un’effettiva corrispondenza tra bisogni e azioni collettive atte a soddisfarli204. Gli studi da lui condotti sul mutuo appoggio tra le specie hanno confermato le sue idee che, altro non erano, che lo sviluppo delle idee espresse dallo stesso Darwin nell’Origine dell’Uomo. Egli parte dallo studio del mutuo appoggio tra gli animali, sottolineando i rischi che l’uso del concetto darwiniano di lotta per l’esistenza in senso stretto poteva occasionare riguardo alla comprensione dei fatti come avvenivano nella natura. Secondo KROPOTKIN, lo studio degli animali nei loro ambienti naturali faceva vedere che nonostante ci fosse tra le specie diverse un’enorme guerra per la sopravvivenza, all’interno di una stessa specie ciò che si verificava era il mutuo sostegno, l’aiuto reciproco, la mutua difesa, essendo quindi la sociabilità una legge della natura tanto quanto lo era la lotta tra i simili. Da ciò risultava che quelli più atti erano quelli che avevano acquisito le abitudini di solidarietà oppure quelli che avevano avuto una maggiore capacità di adattamento alle nuove circostanze, fatto che non aveva nessun legame diretto con la forza. L’anarchico, ritenendo essere sbagliato parlare di competizione e concludere che 204 Dal suo cambiamento di prospettiva – dal guardare la società non da un punto di vista conflittualista ma cooperativista – emerge il suo interesse per l’etica come legame tra necessità esistenziali e vie d’azione. La conclusione a cui arriva alla fine della sua vita – contenuta nel suo libro postumo, Etica – è che il tanto atteso cambiamento sociale verso il comunismo anarchico avrebbe dovuto essere rinviato a tempi più maturi, quando gli uomini sarebbero diventati interiormente pronti a modificare le loro istituzioni, portati da nuovi costumi e abitudini. 249 i più atti fossero sempre i più forti, afferma che in quanto fattore dell’evoluzione delle specie era il mutuo appoggio, e non la lotta tra le specie, quello più importante e decisivo. Il primo articolo, Il mutuo appoggio negli animali205, inizia dalla discussione del concetto della lotta per l’esistenza come fattore dell’evoluzione secondo Darwin e Wallace. Secondo KROPOTKIN, lo studio degli animali nei loro habitat naturali metteva in evidenza il fatto che nonostante ci fosse tra le specie diverse un’enorme guerra per la sopravvivenza, all’interno di una stessa specie ciò che si verificava era il mutuo sostegno, l’aiuto reciproco, la mutua difesa, essendo quindi la socialità una legge della natura tanto quanto lo era la lotta tra i simili. Da parte sua, la natura metteva in evidenza il fatto che i più atti alla sopravvivenza erano quelli che avevano acquisito le abitudini di solidarietà – come per esempio l’aiuto per l’allevamento della prole, la sicurezza e la soddisfazione dei fabbisogni degli integranti di uno stesso branco – da ciò risultando che in quanto fattore dell’evoluzione delle specie era il mutuo appoggio, e non la lotta tra le specie, quello più importante e decisivo. L’anarchico non nega l’esistenza della lotta per la vita né il fatto che soltanto i più adatti sopravvivono, ma domanda con quali armi questa lotta fosse meglio sostenuta e quanta influenza essa avesse esercitato nell’evoluzione del regno animale. KROPOTKIN fa notare che in certi casi la capacità di sopravvivenza era legata non alla forza, ma alla capacità di adattamento alle nuove circostanze. Ritiene pertanto del tutto sbagliato l’uso dell’espressione competizione, anche perché poteva succedere che fossero proprio le specie più deboli quelle che riuscivano a rispondere più velocemente ai cambiamenti avvenuti. La stessa considerazione vale per ciò che riguarda una stessa specie. Inoltre, secondo l’anarchico, prima di arrivare allo sterminio dovuto alle eventuali difficoltà di adattamento alle nuove caratteristiche dell’ambiente in cui vivevano, le specie avevano l’alternativa della migrazione verso ambienti meno ostili, fattore la cui importanza non poteva essere trascurata. Quindi, conclude l’anarchico, “la competizione non è la regola del mondo animale né nel genere umano. Essa è ristretta negli animali a periodi eccezionali, e la selezione naturale trova molte migliori occasioni per operare. Delle condizioni migliori sono create dalla eliminazione della concorrenza per mezzo del reciproco aiuto e del 205 Nel libro esso è composto dei due primi capitoli. 250 mutuo appoggio. Nella grande lotta per la vita (…) la selezione naturale cerca sempre i mezzi di evitare la competizione quanto è possibile” (KROPOTKIN, 1992:123)206. La pratica di mutuo appoggio che egli aveva trovato tra gli animali esisteva anche tra gli uomini, ed è di questa pratica che lui passa a occuparsi attraverso il seguente percorso: dal mutuo appoggio fra i selvaggi passa al mutuo appoggio presso i barbari, poi al mutuo appoggio nelle città del Medio Evo, fino ad arrivare al mutuo appoggio ai nostri giorni. Tra i selvaggi, KROPOTKIN sottolinea il forte senso di appartenenza alla tribù e le varie pratiche di solidarietà esistenti all’interno di uno stesso gruppo, al punto di parlare dell’esistenza della regola ciascuno per tutti alla quale egli lega le radici dello spirito di socialità tra gli uomini. Ancora una volta l’anarchico afferma che le specie che meglio sapevano unirsi per evitare la concorrenza erano quelle che avevano sia le maggiori possibilità di sopravvivenza che di ulteriore sviluppo progressivo207. Secondo KROPOTKIN, la prova che era il mutuo appoggio e non la guerra continua il vero fattore dell’evoluzione era il fatto che era stato il branco e non la famiglia, la prima forma di organizzazione della vita sociale, cosa che aveva permesso la nascita e il consolidamento di un forte senso di appartenenza e solidarietà tra i membri dello stesso gruppo. Tra i barbari, l’anarchico sottolinea le difficoltà vissute dalle tribù dovute allo sviluppo della famiglia patriarcale al suo interno, all’accumulazione e trasmissione ereditaria della ricchezza, alle migrazioni e alle guerre. Tali difficoltà misero le tribù davanti a un bivio: lo scioglimento o la creazione di una nuova forma di organizzazione, diventata la cellula fondamentale della futura organizzazione208 – il comune rurale – basato anziché sull’origine comune su un territorio comune, acquistato e protetto dagli sforzi comuni. Avviene quindi quello che si può chiamare la territorializzazione del mutuo appoggio e della solidarietà, dal momento in cui ciò che passò a essere il vincolo tra i KROPOTKIN sottolinea i progressi compiuti dalla scienza con l’apparizione di questo concetto, ma richiama l’attenzione anche sui rischi del suo uso in senso troppo stretto. Secondo lui Darwin non si era reso perfettamente conto dell’importanza generale del fattore che aveva affermato. Nonostante avesse richiamato l’attenzione sui rischi che l’uso in senso stretto del termine da lui creato avrebbe occasionato – la perdita del suo significato filosofico – gli innumerevoli dati da lui raccolti per dimostrare le conseguenze di una reale competizione per la vita nascosero tali considerazioni. Inoltre, secondo KROPOTKIN, lo stesso Darwin aveva fatto questo avvertimento sia nei primi capitoli della sua Origine delle specie sia nell’Origine dell’uomo dove, tra l’altro, rilevò come nelle varie società animali la lotta per l’esistenza fosse sostituita dalla cooperazione e come tale sostituzione contribuisse allo sviluppo delle facoltà intellettuali e morali assicurando alle specie le migliori condizioni di sopravvivenza. 207 L’autore ritiene tale regola valida anche tra gli uomini, in contrapposizione ad altri autori – tra cui Hobbes e i suoi discepoli – che affermano l’esatto opposto, ossia, che gli uomini avessero fondato la loro evoluzione sulla guerra di tutti contro tutti. 208 KROPOTKIN richiama l’attenzione sul fatto che si può notare tale fase di sviluppo dell’umanità – il comune rurale – tra tutti i popoli del mondo, non essendo quindi essa una caratteristica dei popoli slavi, come comunemente si credeva. 206 251 membri della comunità è stata l’appartenenza a uno stesso territorio e l’identificazione degli individui con esso. Essendo frutto di creazioni spontanee, i comuni rurali erano molto diversi tra loro, potendo inglobare una serie di famiglie oppure essere composti da famiglie di una stessa origine. Lo stesso si può dire rispetto alla forma di abitazione: le persone potevano vivere sotto lo stesso tetto condividendo tutti i momenti della vita, oppure vivere in case separate, condividendo appena una parte della vita, soprattutto quella legata alle attività produttive, ma sempre nello stesso territorio comune. Il comune rurale era un mondo a sé: più che “un’unione per garantire a ciascuno una parte della terra comune, esso (…) [era anche un’]unione per la coltivazione della terra in comune209, per il mutuo appoggio sotto tutte le forme possibili, per la protezione contro la violenza e per un accrescimento ulteriore del sapere, dei concetti morali come dei vincoli nazionali” (KROPOTKIN, 1992:169). Nessun cambiamento avveniva senza esser stato deciso dall’assemblea del villaggio, dalla tribù o dalla confederazione. L’unione di vari comuni formava una tribù e quella di varie tribù una federazione. Il comune rurale riconosceva non solo l’accumulo privato della ricchezza all’interno di una famiglia ma anche la sua trasmissione ereditaria. La ricchezza che poteva essere trasmessa, però, era esclusivamente quella sotto la forma di beni mobili quali il bestiame, gli utensili per il lavoro, le armi e l’abitazione personale. La terra invece era considerata proprietà comune della tribù e il comune rurale possedeva la sua parte di territorio fino a che la tribù non reclamasse una nuova ripartizione delle terre appartenenti ai diversi villaggi. I terreni all’interno del comune venivano considerati proprietà di ciascuna famiglia per un periodo di quattro, dodici o vent’anni. Dopodiché diventavano terreni coltivabili posseduti in comune210. La caccia, la pesca e la coltivazione degli ortaggi e delle piantagioni degli alberi da frutto in comune erano regola tra le antiche gentes mentre l’agricoltura in comune diventò la regola nei comuni rurali – pratica che si riscontra in alcuni casi fino ai giorni nostri – dando origine a uno sviluppo mai visto prima e che portò con sé lo sviluppo dell’industria domestica. “Certe parti del terreno [erano] in molti casi coltivate in comune, sia a beneficio Questo tipo di pratica si iniziò con il comune rurale e rimase a lungo come pratica agricola tra le comunità contadine. Succedeva spesso che una parte delle terre coltivate in comune fosse destinata ad aiutare i più deboli – orfani, vedove, invalidi –, a servire da prestito ai contadini in difficoltà oppure a essere usata in beneficio della comunità – in questo caso il prodotto poteva essere consumato in natura da tutti oppure venduto, usandosi il ricavato in qualche bonifica riguardante l’intera comunità. Oltre alla coltivazione delle terre in comune, spesso anche i lavori che riguardavano tutta la comunità venivano svolti collettivamente. Nota mia. 210 L’accettazione della proprietà fondiaria individuale avviene molto tempo dopo, e sotto influenza della legge romana e della chiesa cristiana. 209 252 degli indigenti, sia per riempire i granai comunali, sia per servirsene nelle feste religiose. I canali irrigatori [erano] scavati e riparati in comune. Le praterie comunali [venivano] falciate in comune (…). In queste circostanze il fieno [veniva] diviso tra le diverse case” (KROPOTKIN, 1992:171). Gli alimenti prodotti in comune, una volta tolta la parte che veniva messa da parte per l’uso collettivo, venivano spesso divisi tra le diverse case affinché fossero consumati a seconda dei gusti personali. Inoltre, furono stabiliti dei mercati, costruiti fortificazioni e santuari per il culto in comune. Come nella tribù, la vita del comune rurale era retta da un severo codice morale e ogni sorta di lite tra le persone veniva trattata come un affare pubblico. A seconda della gravità, il caso veniva giudicato da alcuni mediatori e arbitri oppure portato all’assemblea del comune e il principio della vendetta spesso usato non tardò a essere sostituito da forme di risarcimento, sufficienti a non incoraggiare nuove liti. Un’altra caratteristica degli antichi comuni rurali, sottolineata da KROPOTKIN, era l’estensione dei legami di solidarietà in diverse forme di associazioni sempre più numerose: le tribù si federavano in colonie di diversi tipi e funzioni ed esse in confederazioni. Tale fatto diede origine a un concetto di unione estesa a intere popolazioni, nonché a una nuova concezione della giustizia tendente a impedire l’oppressione delle masse da parte di una minoranza, fatto considerato dall’anarchico un esempio di mutuo appoggio. Tra le città del medioevo, KROPOTKIN sottolinea tre punti importanti oltre alla nascita stessa della città. Il primo, la nascita di una nuova concezione della giustizia fondata su leggi e diritti e che servivano a impedire a una minoranza dotata di poteri di imporre le sue volontà alla maggioranza ignara. Le liti tra comuni o tra membri di comuni diversi venivano decise da arbitri imparziali capaci di imporre la giustizia e di mettere fine alla discordia, guidati da un insieme di regole – le leggi – che passarono a essere custodite e trasmesse di generazione in generazione all’interno del gruppo degli arbitri211. Il secondo punto da lui sottolineato è stata la nascita delle corporazioni di mestieri o le fratellanze – le gilde –, unioni tra persone che si dedicavano a uno stesso mestiere, legate tra loro da degli obiettivi comuni e da forti sentimenti di solidarietà e mutuo appoggio, nonché da un grande senso di uguaglianza tra i suoi integranti, guidate da una rigida condotta; queste corporazioni ebbero un grande successo e diffusione perché, secondo l’anarchico, rispondevano allo stesso tempo sia alla soddisfazione dei bisogni di unione che alla possibilità dell’iniziativa individuale. 211 Secondo KROPOTKIN tale pratica fu mantenuta anche durante il feudalesimo, quando i contadini erano riusciti a mantenere due elementi importanti esistenti durante il tempo del comune rurale: il possesso in comune della terra e l’autogiurisdizione. Essi erano anche riusciti a far eleggere da sei a dodici giudici che sedevano con il giudice del signore alla presenza dell’assemblea e agivano come arbitri per promuovere le sentenze. 253 Il terzo punto sottolineato da lui, la pratica del “giorno del pasto comune”, esistente nei comuni rurali e mantenuta all’interno della fratellanza in quanto occasione per rafforzare i legami tra i membri e discutere sugli eventuali problemi esistenti nel suo interno. Esso veniva di solito realizzato il giorno dell’elezione degli arbitri o quello successivo in quanto forma di affermazione della fratellanza, occasione in cui si discutevano i cambiamenti da portare agli statuti, si giudicavano le controversie tra fratelli e si rinnovava il giuramento alla gilda. Secondo KROPOTKIN, la forza di queste fratellanze stava nel fatto di garantire sia il mantenimento della giustizia che l’appoggio mutuo in tutte le circostanze e per tutti gli incidenti della vita, “con opera e consiglio”. Della società ai nostri giorni, KROPOTKIN richiama l’attenzione sull’ideale costruttivo di vita in comunità fraterne e libere che esisteva all’interno del movimento della Riforma212 e di come, durante i tre secoli successivi, lo Stato cercò di annientare, distruggere o mettere sotto stretto controllo tutte le manifestazioni di aiuto reciproco tra le popolazioni, quali le assemblee e i tribunali popolari, le pratiche di amministrazioni comunali, le terre di uso comune, le corporazioni, ecc. Ciononostante, sostiene che le pratiche di mutuo appoggio continuarono a esistere, ed è di queste pratiche che lui passa a occuparsi. Tra queste pratiche, KROPOTKIN sottolinea la permanenza del comune rurale, organizzato in una forma un po’ diversa da quella trovata tra i barbari, nonostante i colpi inferti dagli Stati rivolti a distruggerlo213. In alcuni casi si manteneva la proprietà comune di almeno una parte delle terre, mentre in altri soltanto le pratiche di coltivazione in comune. Era però regola che tra i comuni fossero state mantenute le assemblee per le decisioni più importanti; la proprietà comunale delle foreste, boschi e aree da pascolo; le associazioni tra i contadini per l’acquisto di strumenti di lavoro e per la realizzazione dei 212 213 L’anarchico giustifica questa affermazione citando i «Dodici Articoli» professati da contadini e operai tedeschi e svizzeri i quali, oltre a sostenere il diritto di ciascuno d’interpretare la Bibbia seguendo il proprio giudizio domandavano anche la restituzione delle terre comunali ai comuni rurali e l’abolizione delle servitù feudali. Altro fatto citato da lui come esempio di questa pratica è stato la costituzione delle confraternite comuniste di Moravia che riunivano decine di migliaia di uomini e di donne che donavano tutti i loro beni formando degli istituti numerosi e prosperi, organizzati secondo i principi del comunismo. (Il caso dei fratelli Moravi sono stati citati all’interno del capitolo 5 di questa tesi). KROPOTKIN usa come esempio il caso francese ma sottolinea che questo processo si era verificato dappertutto nell’Occidente e centro Europa. Tra i colpi inferti ai comuni rurali cita le espropriazioni delle terre più tardi restituite divise in appezzamenti individuali (disposizione che non fu rispettata dai contadini che riuscirono a riavere le loro terre); la confisca delle terre da usare come ipoteche per i prestiti dello Stato; le leggi promulgate nel 1816 che inducevano alla divisione delle terre comunali, fatti che ebbero conseguenze anche sull’autonomia delle loro istituzioni. 254 lavori che riguardavano tutta la comunità214. Tale movimento a favore della proprietà comunale era contraddetto dalle teorie economiche che ritenevano essere la coltura intensiva incompatibile con il comune rurale. L’anarchico sostiene l’esatto contrario, e cioè, il comune rurale era il solo mezzo in grado di permettere l’introduzione di perfezionamenti sia nell’agricoltura che nella vita del comune215 a cui i singoli contadini senza tante risorse non avrebbero mai avuto accesso. Secondo lui, i comuni rurali si sono mantenuti per più di mille anni e, a meno che i contadini non fossero stati rovinati dalle guerre e dalle tasse, i loro metodi di coltivazione continuarono a essere perfezionati. Di queste pratiche, più che l’importanza economica era l’importanza morale – essendo i comuni visti come diffusori dei costumi e abitudini di mutuo appoggio – quella sottolineata da KROPOTKIN che attribuisce a questo spirito la diffusione di diverse forme associative di mutuo appoggio come i sindacati agrari e operai; le associazioni di contadini con scopi diversi216; le associazioni politiche; il movimento cooperativistico, le associazioni per lo studio, la ricerca e l’istruzione e le associazioni religiose di carità, anche se questi ultimi tre non senza critiche. Oltre a immaginare la nuova società, KROPOTKIN si dedica anche all’analisi di quella in cui viveva, presentando proposte di cambiamento che non dipendevano della realizzazione della rivoluzione, anche se era sottinteso che nella società futura quale pensata da lui, queste cose sarebbero accadute. Due sono i temi principali che hanno meritato la sua attenzione e che ci interessano per quanto riguarda il tema di questo capitolo: da un lato, il decentramento delle industrie e, legato a esso, la discussione sulla sparizione o meno delle piccole attività industriali; dall’altro, l’impasse e le possibilità dell’agricoltura europea, soprattutto davanti alla crisi che la concorrenza dei prodotti americani aveva provocato. KROPOTKIN ricorda la pratica esistente in Svizzera del taglio degli alberi da usare nella costruzione o come legna da ardere, svolto collettivamente dai giovani del cantone, nonché l’esistenza delle «Bürgernutzen», ossia, la proprietà in comune da parte di un gruppo di persone di un certo numero di capi di bestiame o la coltivazione in comune di un pezzo di terra con la divisione del raccolto. Cita anche le “riunioni serali per sgusciare le noci, volta a volta in ogni casa; [la] veglia per cucire il corredo d’una giovane che [stava per sposarsi] (…); [l’]appello di «aiuti» per costruire le case e portar dentro le messi, come per ogni specie di lavoro del quale [poteva] aver bisogno uno dei membri della comunità; [l’]abitudine di far il cambio di fanciulli di un cantone con quelli d’un altro, allo scopo di far loro imparare due lingue” (KROPOTKIN, 1992:268), fatti che ebbero come risultato, secondo lui, la grande diffusione della pratica della cooperazione agricola in Svizzera. 215 KROPOTKIN sottolinea la ripresa, tra i comuni rurali russi, della pratica dei campi di coltivazione collettiva dove tutti si recavano un giorno alla settimana e il cui raccolto veniva usato per fare prestiti ai più poveri senza condizioni di rimborso, per sostenere gli orfani e le vedove oppure per rimborsare un debito comunale. 216 Tra cui la compra e vendita dei prodotti, i lavori di miglioramento delle terre, l’acquisto di macchinari per l’uso agricolo e a beneficio della produzione, ecc. 214 255 Riguardo alla questione del decentramento delle industrie, l’anarchico ritiene che tale processo era frutto di ciò che chiama sviluppo consecutivo delle nazioni, il cui risultato era la diffusione dell’attività industriale per i paesi cosiddetti nuovi. La via d’uscita per la crisi che aveva colpito i paesi di più antica tradizione industriale era, secondo lui, l’integrazione dell’economia, ossia, l’integrazione tra l’attività agricola e quella industriale all’interno di un singolo paese e, allo stesso tempo, il privilegio del mercato interno anziché di quello esterno. Secondo l’anarchico, ogni nazione avrebbe dovuto avere come obiettivo lo sviluppo completo della sua economia, cercando il più possibile di produrre tutto quello di cui avesse bisogno – generi agricoli e industriali – e riducendo al minimo indispensabile la dipendenza dal mercato esterno. Questo avrebbe garantito lo sviluppo simultaneo e integrato di tutti i settori dell’economia e i paesi che per primi avessero deciso di prendere questa strada sarebbero stati quelli che avrebbero avuto più possibilità di riuscita tanto a corto quanto a lungo andare. Sempre sulla questione industriale, KROPOTKIN ritiene sbagliata la tesi difesa da tanti studiosi sulla sparizione delle piccole industrie, credendo, anzi, che esse continuerebbero comunque a esistere, nonostante la diffusione delle grandi fabbriche. Secondo lui, sempre che il lavoro da esse svolto fosse conveniente alla grande industria – sia perché in grado di adattarsi più facilmente ai diversi cambiamenti richiesti dal mercato, sia perché fornitrici di materie prime fondamentali alla grande industria, sia ancora perché si trattava di un settore non abbastanza redditizio per servire da stimolo alla sua trasformazione in grande industria oppure di un nuovo settore la cui non conoscenza in profondità impediva il rischio della produzione in grande scala – esse avrebbero avuto la loro sopravvivenza assicurata. D’altra parte, egli richiama l’attenzione sul fatto che la sparizione tanto discussa non significava necessariamente la fine dell’attività, ma poteva significare anche la sua evoluzione in settori più ampi e moderni oppure la sua trasformazione in nuovi settori. Infine, ricorda che le nuove attività produttive avevano sempre mosso i loro primi passi come una piccola industria, soprattutto per il fatto che, senza conoscere la reazione del mercato ai nuovi prodotti, si rischiava meno cominciando come piccola attività che non partendo già come grande fabbrica. Inoltre, l’anarchico sostiene, in sintonia con la sua proposta precedente, che un’altra possibilità di garanzia di sopravvivenza della piccola industria era la sua integrazione il più possibile con le attività agricole, sia come industria di trasformazione che per offrire al contadino tutto il necessario per l’ottenimento di migliori risultati. Rispetto alle possibilità dell’agricoltura, KROPOTKIN riparte dalla suddetta tesi della ricerca dell’autosufficienza per affermare che ogni comune doveva dedicarsi alla 256 produzione delle derrate necessarie al fabbisogno integrale dei suoi membri e, riprendendo anche la questione della necessità di sviluppo integrale del lavoratore, afferma che una parte di questo fabbisogno doveva essere prodotta dal lavoratore stesso. Per questo egli si sarebbe dedicato oltre che al suo proprio lavoro anche alla coltivazione di un piccolo orto, destinando a questo lavoro una piccola quantità di ore al giorno. Per lo svolgimento di tale attività i lavoratori avrebbero potuto contare sui progressi della scienza applicati all’agricoltura, quali macchinari, concimi, serre, semi selezionati, ecc. Inoltre, riprendendo quanto detto riguardo alle industrie, ritiene che una forma per uscire dalla crisi in corso ed evitarne altre era dare la precedenza al mercato interno anziché a quello esterno, nonché cercare di integrarsi per quanto possibile con l’industria, soprattutto con quella di piccole dimensioni, chiudendo così le filiere economiche, idea che viene riproposta ora nelle pratiche di sviluppo locale autosostenibile come si tratterà nei capitoli successivi. Secondo lui, per raggiungere tale autosufficienza non era necessario provvedere a grandi cambiamenti nella struttura produttiva. Bastava fermare il processo di diminuzione o sostituzione della produzione agricola in pascolo e, avendo come scopo la soddisfazione dei bisogni della popolazione, utilizzare tutte le terre coltivabili nel modo più adatto a ogni singola realtà, cercando di ricavare dal suolo la massima produttività. Ma, cosa più importante, tale pratica agricola doveva essere messa in pratica considerando la terra come un patrimonio comune, di cui disporre a vantaggio di tutti e di ciascuno: questa era, evidentemente, una premessa indispensabile. Inoltre, egli riteneva che non sarebbe stato necessario escogitare nuovi metodi di coltivazione, ma semplicemente generalizzare e applicare largamente quelli che avevano resistito alla prova dell’esperienza217. Questa sua proposta, altro non è che il fondamento delle attuali tesi di sviluppo locale autosostenibile delle quali ci occuperemo nei capitoli successivi: la necessità di pensare al territorio come un patrimonio da valorizzare, come parte integrante del processo produttivo e non soltanto come supporto a esso, nonché la necessità di valorizzare le pratiche e i saperi locali – o se si vuole la self-reliance, incentivando così lo sviluppo endogeno – in quanto parte fondamentale della costruzione dei progetti di sviluppo locale autosostenibile. Il successo della produzione agricola, quindi, secondo lui, dipendeva dalla conoscenza dei reali bisogni della popolazione locale; dalla messa a coltivazione di tutte le terre potenzialmente coltivabili, tenendo conto delle peculiarità di ogni area, dei saperi 217 Il testo in corsivo e grassetto sono una citazione di KROPOTKIN, 1975, p. 118/119. 257 locali riguardo alle pratiche agricole di successo e pensando alla terra come un patrimonio comune di cui disporre con cura a vantaggio di tutti, incluse le generazioni future; dalla chiusura dei cicli ecologici messa in pratica con le filiere economiche, attraverso l’integrazione, per quanto possibile, con l’attività industriale, soprattutto quella piccola, di base locale. Infine, per ottimizzare ancora di più il lavoro e ottenere risultati ancora più soddisfacenti, KROPOTKIN suggerisce il ricorso alle pratiche di lavoro associato, che avrebbero condotto a una serie di vantaggi come la riduzione degli sforzi per produrre attraverso il lavoro collettivo; la possibilità di acquisto di macchinari e l’introduzione di ogni tipo di infrastruttura necessaria ad aumentare la produttività della terra grazie anche all’aumento dell’uso di concimi, sementi selezionate, ecc. prima impossibili per gli alti costi; la diversificazione della produzione che avrebbe garantito a tutti il miglioramento delle loro qualità nutrizionali. Le proposte di KROPOTKIN discusse in questo capitolo, come l’ideale comunitario e la democrazia diretta in esso contenuto; la chiusura dei cicli ecologici attraverso l’integrazione tra l’agricoltura e l’industria, soprattutto di quella piccola e a base locale; la necessità di agire e lavorare sulla terra considerandola come un patrimonio comune, di cui disporre a vantaggio di tutti e di ciascuno e, infine, la necessità di recuperare e valorizzare i saperi locali, lavorando la terra servendosi dei metodi e delle tecniche che avevano resistito alla prova dell’esperienza, riemergono oggi con la diffusione dei movimenti ecologici, di cui egli è ritenuto il precursore218. Questa mia constatazione, che si chiarirà dalla lettura della prossima parte di questa tesi – tanto dalla lettura del capitolo teorico sullo sviluppo locale autosostenibile quanto sui vari esempi di pratica di questo progetto di sviluppo locale autosostenibile, sia quelle legate alla produzione che quelle legate alla commercializzazione – è rafforzata dalle considerazioni di autori di peso della geografia mondiale, tra cui CASTELLS, quando afferma essere stato “dal nido di qualche utopia comunitaria che i primi ecologisti politici hanno preso il loro volo, quale Kropotkin che ha legato per sempre anarchia ed ecologia di cui oggi il miglior rappresentante è Murray Boockin” (CASTELLS, 1998-1999, II:153). E, ancora, quando scrive che “la democrazia diretta è il modello politico implicito della grande maggioranza dei movimenti ecologici: nei progetti alternativi più elaborati si uniscono il controllo sullo spazio, l’affermazione del luogo come fonte di senso e l’accento messo sull’amministrazione locale, che appartengono agli ideali di autogestione della tradizione anarchica, come è anche il caso 218 “Kropotkin riteneva fondamentale un rapporto equilibrato tra l’uomo e l’ambiente (inteso come insieme di fattori culturali, sociali, economici, geografici): solo rispettando la specificità dell’ambiente la società libera avrebbe davvero creato le condizioni per una vita armonica e ‘a misura d’uomo’. Sotto questo profilo, è lecito vedere in Kropotkin uno dei precursori delle moderne teorie ecologiste” (PANI & VACCARO, 1997:74). 258 della produzione a piccola scala, della preoccupazione dell’autosufficienza, che implicano di assumere l’austerità, di criticare il consumo ostentatorio e di sostituire il valore d’uso della vita al valore di scambio del denaro” (CASTELLS, 1998-1999, II:156). Sono esempi di questo riemergere delle sue proposte le seguenti esperienze di cui si tratterà nei capitoli successivi: - la ricerca della chiusura dei cicli ecologici – difesa anche da MAGNAGHI – che viene ricercata e in parte realizzata attraverso l’esperienza pilota di sviluppo locale autosostenibile della Val di Bisenzio in Toscana, coordinata da MAGNAGHI, messa in pratica e seguita da FANFANO, così come attraverso le proposte dei progetti di sviluppo rurale svolti nel terzo mondo e messi in pratica dalla Ctm altromercato e in alcuni dei prodotti commercializzati dal Consorzio Radici a Suvereto, in Toscana; - la produzione in piccola scala, la preoccupazione dell’autosufficienza, l’assunzione dell’austerità e la critica al consumo ostentatorio, la sostituzione del valore d’uso al valore dello scambio, attraverso le esperienze messe in pratica da buona parte degli ecovillaggi, come per esempio quello degli Elfi; - un’altra forma di scambio attraverso un mercato con morale, quale quello della fierucola a Firenze, dei gruppi di acquisto solidali (GAS) e del commercio equo e solidale, sparso per tutta l’Europa ma non solo. Tutte queste esperienze sono apparse all’interno dei movimenti sociali contro l’omologazione e la massificazione imposte dalla globalizzazione. Tali esperienze richiamano l’attenzione sul fatto importante della loro natura locale, ed è quindi, al locale che dobbiamo rivolgere i nostri sguardi nella ricerca di alternative alla globalizzazione stessa. Nel momento storico che stiamo vivendo, lascio parlare QUAINI, oltre “al controllo sullo spazio, l’altra fondamentale posta in gioco è oggi costituita dal controllo del tempo. Così come nel primo caso i movimenti sociali alternativi mettono l’accento sul locale, sulla comunità locale e la partecipazione dei cittadini, riscoprendo gli ideali di autogestione della tradizione anarchica, nel controllo sul tempo si cercano di costruire temporalità nuove, rivoluzionarie, come quella che è alla base del concetto di sostenibilità che, come noto, significa misurare la nostra vita e le nostre scelte sul metro del tempo lungo delle generazioni che verranno e prima ancora dell’evoluzione della natura” (QUAINI, 2002:326). È in questo sfondo che si inseriscono le nuove utopie di cui si passerà a trattare in questa ultima parte della tesi. 259 PARTE III LE «NUOVE» UTOPIE 260 CAPITOLO 7 SVILUPPO LOCALE AUTOSOSTENIBILE: UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE 1. Dal territorio come supporto al territorio come patrimonio Secondo MAGNAGHI, il territorio deve essere inteso come il “prodotto storico di processi co-evolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, fra natura e cultura e, quindi, come esito della trasformazione dell’ambiente ad opera di successivi e stratificati cicli di territorializzazione. (…) Il territorio è (…) un prodotto antropico: esso pertanto non esiste in natura, è un costrutto storico la cui “massa” si accresce nella lunga durata. Come esito di un processo esso è un sistema relazionale fra ambiente fisico, ambiente costruito, ambiente antropico. Questo processo produce un insieme di luoghi dotati di profondità temporale, di identità, di caratteri tipologici, di individualità: dunque sistemi viventi ad alta complessità” (MAGNAGHI, 1998:3/4). L’autore richiama ancora l’attenzione sul fatto che il territorio, in quanto ambiente fisico, nonostante sia altro dalla natura originaria, in quanto integra caratteri naturali e culturali in una nuova individualità, risponde comunque alle leggi di riproduzione dei sistemi viventi e degli ecosistemi e, come tale, deve essere curato. La produzione del territorio – ottenuta dalla trasformazione dello spazio per opera dell’uomo – avviene tramite il processo di territorializzazione, risultato, a sua volta, dell’azione territoriale, “una forma specifica dell’azione collettiva che «accoglie, deposita, stratifica, connette lavoro socialmente mediato e quindi più o meno esplicitamente normato»” (GATTI, 1990: 286). Stando così le cose, lo studio del processo di territorializzazione diventa di fondamentale importanza per la comprensione dell’identità del luogo e delle sue dinamiche riproduttive. 261 GATTI ritiene che sia possibile effettuare una lettura dei processi di territorializzazione “in senso cronologico, come produzione di logiche determinate storicamente, ma anche in senso «orizzontale» e sistemico, come «valore» che l’azione territoriale progressivamente attribuisce al territorio, caricandolo continuamente di «massa territoriale», e rendendolo sempre più «artificiale». Ma non tutto il lavoro operato sullo spazio può essere compreso come azione territoriale: questa infatti deve presentare tre caratteristiche precise che simultaneamente qualificano l’azione stessa: a) compiere un processo di trasformazione materiale dello spazio, attraverso l’uso del suolo e la disseminazione di oggetti, che sia progressivamente orientata alla liberazione dalle costrizioni dello spazio fisico; b) il processo di trasformazione materiale presenta sempre un aspetto simbolico: l’uomo non può trasformare fisicamente uno spazio senza caricarlo di simboli. (…) c) inoltre non si può territorializzare lo spazio senza caricarlo di informazioni e costruire forme di scambio, cooperazione e comunicazione più complesse del semplice livello naturale etologico” (GATTI, 1990: 286/7), essendo questo l’aspetto immateriale dell’azione territoriale. L’azione territoriale – nei suoi tre aspetti indissolubili fra loro: materiale, simbolico, immateriale – si realizza per mezzo di atti territorializzanti e si concretizza tramite il processo di territorializzazione. Nonostante essi siano variabili, è possibile identificare le tappe in cui si svolgono. TURCO ne identifica tre: la denominazione, la reificazione e la strutturazione. GATTI, riprende e amplia questa classificazione, identificando cinque tappe: la denominazione, la perimetrazione, la trasformazione materiale, la comunicazione e la strutturazione. La denominazione è il primo atto svolto da chi crea un territorio. Dare un nome implica la conoscenza del luogo – dato che il nome possiede in sé informazioni importanti sul territorio, è un’abbreviazione di descrizioni, un’agglomerazione di concetti – e determina il controllo simbolico sull’ambiente. Secondo TURCO, la denominazione è un processo continuum che racchiude, elabora e trasmette informazioni. L’atto denominativo è un lavoro sociale che raccoglie in sé strategie cognitive – legate alla conoscenza del territorio – e comunicative – legate alla trasmissione di queste conoscenze alle comunità insediate. TURCO identifica tre livelli di organizzazione semiotica del territorio: il primo, la denominazione referenziale, istituisce dei riferimenti sul territorio e conduce a una rappresentazione che permette al soggetto di localizzarsi, di situarsi rispetto a delle posizioni prestabilite; il secondo, la denominazione simbolica, si basa su valori socialmente prodotti e il terzo, la denominazione performativa, si basa su informazioni di tipo sperimentale, 262 soggette alla prova dei fatti e modificabili in base ai suoi esiti. Le denominazioni simboliche e performative, “non solo «denotano» un tratto della superficie terrestre, ma la «connotano» in virtù di uno o più codici secondari – o sottocodici – che incorporano” (TURCO, 1988:87). La reificazione, la seconda fase del processo di territorializzazione identificata da TURCO, consiste nella capacità dell’attore di governare praticamente la forma geografica dell’universo sociale nel quale è immerso. Essa presenta un duplice ordine: quando si rivolge allo spazio, consiste nella trasformazione di una materialità naturale in una materialità costruita; quando invece si rivolge al territorio, consiste nella trasformazione di una materialità costruita in un’altra. La reificazione è, sempre secondo TURCO, un atto sociale trasformativo, con il quale l’uomo interferisce nelle dinamiche della materia, trasformando il paesaggio e realizzando il trapasso dal vecchio al nuovo ordine. Reificata, la superficie terrestre diventa un insieme di proprietà che può essere soppressa, incrementata o modificata, a seconda dei canoni di flessibilità imposti dal progetto di cui l’attore sociale è portatore. GATTI suddivide questa fase in tre momenti: la perimetrazione, intesa come lo stabilimento dei confini che consentono l’identificazione e il confronto con gli altri; la trasformazione materiale, che consiste nella trasformazione del paesaggio e di ciò che chiama “«naturalità dei luoghi» e consente l’espressione concreta dei modi diversi di territorializzare un luogo, cioè, consente la differenziazione attraverso elementi artificiali di tipo materiale e simbolico che a loro volta svolgono un ruolo immateriale di comunicazione” (GATTI, 1990:288); la comunicazione, intesa come la capacità di uscire dai limiti fisici naturali attraverso lo stabilimento di forme di comunicazione, quali reti, maglie, nodi, i quali influiranno posteriormente sui successivi atti territorializzanti. La terza fase del processo di territorializzazione identificata da TURCO è la strutturazione, intesa come l’espressione e il supporto del controllo sensivo che si dispiega geograficamente, manifestandosi come preordinamento convenzionale e processivo della massa territoriale e ricavando dall’ambiente ipercomplesso – dunque da uno spazio già denominato e reificato – luoghi fisici oggettivabili, di complessità in vario grado ridotta, a disposizione degli attori. GATTI definisce questa fase – chiamata anche da lui strutturazione – come la combinazione dei fattori precedenti in “strutture dotate di senso e orientate ad uno scopo” (GATTI, 1990:288). La struttura è dunque territoriale e, affinché possa sopravvivere in un ambiente mutevole, deve essere multistabile, ossia deve avere una grande varietà e velocità di risposte alle perturbazioni imposte. A questo scopo la strutturazione tende a conservare all’interno delle formazioni geografiche la massima differenziazione, da cui possono 263 emergere le possibilità combinatorie e le virtualità innovative che sostanziano la complessità. In tal modo, la struttura non solo è capace di difendersi dalle perturbazioni, ma possiede altresì la proprietà di integrare le perturbazioni trasformandole in fattori di organizzazione. È poi un sistema autorganizzatore che fa del disturbo un principio d’ordine. Una struttura che evolve esprime l’attitudine sistemica a sopravvivere anche al prezzo di trasformazioni che investono le modalità di funzionamento del sistema. La tendenza al decentramento, un portato della complessità elevata, segno e strumento della multistabilità, è soltanto un’occorrenza possibile. L’altro garante della sopravvivenza è l’autopoiesi, “processo attraverso il quale un sistema produce, trasforma o anche distrugge i suoi componenti, dalla cui interazione il sistema stesso trae individualità” (TURCO, 1988:131). Stando così le cose, l’efficienza degli apparati è una garanzia di sopravvivenza/autopoiesi orizzontale, mentre l'incremento di multistabilità (la capacità di adattamento per sopravvivere) obbliga l’autopoiesi a realizzare un processo verticale che consiste nell’intensificare l’operazionalità della struttura. Compaiono, così, accanto alla funzione costitutiva, alcune funzioni accessorie (autoprodotte), destinate ad assorbire gli effetti negativi delle perturbazioni e a trasformarli in effetti positivi/di ordine, con funzione protettiva, consolidando in questa forma il processo di autoafermazione. POLI, riferendosi allo studio di due biologi cileni, fa un’interessante considerazione sul sistema autopoietico. L’autrice sottolinea che esso è “un sistema cognitivo, che si caratterizza per essere conservativo e al tempo stesso innovativo. Il sistema autoproduce la propria organizzazione interna – la parte invariante – dove sono conservati i caratteri dell’identità, mentre reagisce alle perturbazioni esterne, selezionando, adattando e trasformando la struttura – la parte variabile – per conservarne l’organizzazione219. Il sistema autopoietico è stato trasferito nell’immagine del milieu come rappresentazione territoriale di un contesto fisico-sociale che interpreta e sceglie, in base alle opportunità offerte dal patrimonio, quale innovazione attivare” (POLI, 1998: 41). 219 “Due fenomeni centrali caratterizzano i sistemi autopoietici: l’organizzazione e la struttura. Secondo questa teoria l’organizzazione denota le relazioni invarianti nel tempo, mentre la struttura denota le relazioni variabili in un certo istante della vita. La trasformazione della struttura avviene seguendo le regole dettate dall’organizzazione. Per adattarsi al suo ambiente ed evitare di disintegrarsi, morire o diventare altro da sé, il sistema mette in atto l’accoppiamento strutturale, una modalità interattiva che produce un adattamento reciproco fra sistema e ambiente in grado di non alterare le caratteristiche fondative del sistema, grazie alla chiusura dell’organizzazione e all’apertura della struttura. L’organizzazione autopoietica costituisce quindi «la configurazione invariante di relazioni intorno alla quale ha luogo la selezione dei loro cambiamenti strutturali durante la loro storia di interazioni» Maturana H. R., Varela, F. J., Autopoiesi e Cognizione. La realizzazione del vivente, Marsilio, Venezia 1985, [ed. orig. 1980]” (POLI, 1998: 41 nota 4). 264 Il territorio evolve tramite un processo identificato da RAFFESTIN come territorializzazione-deterritorializzazione-riterritorializzazione (processo TDR). “Il primo termine del processo, la territorializzazione, implica che, quando uno stato è compiuto, esso sia una territorialità, vale a dire un insieme codificato di relazioni. In realtà questo stato è piuttosto un equilibrio instabile in quanto è sufficiente una variazione nell’informazione ricevuta perché esso cambi ovvero i rapporti all’interno del sistema si modifichino. La deterritorializzazione è, in senso primo, l’abbandono del territorio, ma può essere anche interpretata come la soppressione dei limiti, delle frontiere (…). La deterritorializzazione corrisponde a una crisi, vale a dire alla scomparsa dei limiti. (…) La riterritorializzazione, (…) può farsi su qualunque cosa, oltre allo spazio, la proprietà, il denaro, ecc.” (RAFFESTIN, 1984:78) e corrisponde allo stabilimento di un nuovo equilibrio e di un nuovo ciclo di territorializzazione. Ogni ciclo di territorializzazione, ad eccezione del primo, si stabilisce su un territorio già costruito, reificato, che viene reinterpretato dagli attori del processo, i quali depositano la loro sapienza ambientale, sopprimendo ciò che viene considerato superato e utilizzando/valorizzando ciò che viene invece ritenuto utile/importante per il funzionamento del sistema. L’interazione fra i successivi cicli di territorializzazione determina la massa territoriale, la quale offre importanti indicazioni sul valore del patrimonio territoriale e le sue possibilità di usi futuri. Il territorio ha dunque una profondità storica, il cui studio serve ad acquisire le regole di sapienza ambientale responsabili per la realizzazione del tipo e della personalità del luogo in epoche precedenti. Le strutture territoriali che vengono conservate da un ciclo di territorializzazione a un altro sono chiamate invarianti strutturali e costituiscono i sedimenti attraverso i quali è possibile realizzare tale studio. MAGNAGHI identifica tre tipi diversi di sedimenti: i sedimenti di sapienza ambientale, riguardanti i saperi relativi ai rapporti della comunità insediata con l’ambiente, importanti per la riqualificazione ambientale e la proposizione di nuovi modelli di sviluppo; i sedimenti identitari, riguardanti i saperi relativi alla presenza di modelli socioculturali di lunga durata, responsabili per la determinazione dell’identità del luogo; i sedimenti materiali, riguardanti gli elementi di memoria reificata nel paesaggio che continuano a far parte, anche se reinterpretati e con usi diversi, della cultura e della vita quotidiana del ciclo di territorializzazione successivo. “L’interazione fra i successivi atti territorializzanti determina in ogni luogo la massa territoriale che è costituita dall’accumulo storico di atti territorializzanti di diversa natura (...) che nel loro insieme ne determinano il valore” (MAGNAGHI, 2001:24). 265 L’accumulo degli atti territorializzanti nel tempo trasforma lo spazio naturale in territorio e dà origine ai “luoghi”, ambienti dotati di identità, personalità e individualità paesistica. “Ogni luogo assume, in questa relazione di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, una sua identità specifica data dalla particolarità degli elementi della relazione. Questa identità si darà a due livelli: quello che definisce i caratteri tipologici del luogo (che riguardano le tipologie edilizie, urbane e territoriali[,] (…) [i] “tipi territoriali”); e quello che definisce la personalità e l’individualità del luogo, ovvero i caratteri peculiari in cui un tipo territoriale si materializza in uno specifico paesaggio (…). Tipo territoriale e individualità definiscono i caratteri identitari del luogo; entrambi i livelli sono necessari per una utilizzazione a fini progettuali del processo di territorializzazione” (MAGNAGHI, 2001: 21). La deterritorializzazione, la seconda fase del processo TDR, avviene con l’interruzione del processo di costruzione dei luoghi, con la separazione tra natura e cultura, con il non rispetto delle identità dei luoghi e con l’utilizzazione del territorio come semplice supporto delle attività economiche che risultano, così, standardizzate, uguali in qualsiasi punto della superficie terrestre. Oltre alla deterritorializzazione, che evidenzia gli aspetti strutturali dell’interruzione dei cicli storici di crescita e sviluppo del territorio, MAGNAGHI cita altre due forme possibili di identificazione di questo processo: “la decontestualizzazione[, che] evidenzia gli aspetti morfologici della distruzione delle identità paesaggistiche operata dalla rottura, nelle modalità insediative, del rapporto sinergico attivo fra comunità insediate e ambiente; (…) [e] il degrado[, che] pone l’accento sulla rottura di equilibri ambientali, dovuto all’eccesso di carico antropico sull’ambiente e alla dissipazione e distruzione di risorse non rinnovabili” (MAGNAGHI, 2001: 34). La deterritorializzazione, sottolinea l’autore, non segna l’inizio del processo di riterritorializzazione, e quindi di un nuovo ciclo di territorializzazione, ma caratterizza invece il modo di produzione capitalista nella sua fase attuale, di per sé deterritorializzato, dovuto alla fiducia nella capacità delle innovazioni tecnologiche di superare tutti gli ostacoli imposti dalla natura, sempre più artificiale e destrutturante. Questo modello di crescita economica quantitativa e illimitata non solo ha trasformato il territorio in supporto alle attività economiche e distrutto tutte le forme di cultura, identità locali e tutto ciò che potesse significare diversità, ma ha anche propiziato la nascita di ciò che l’autore chiama nuove povertà – di qualità urbana, ambientale, identitaria e territoriale – legate, in genere, al processo di riduzione dei valori d’uso dei beni di mercato e strettamente connesse al peggioramento della qualità ambientale e urbana. Citando SACHS, MAGNAGHI sottolinea come la crescita illimitata abbia aumentato nelle città, ma lo stesso si può dire 266 anche delle aree rurali, la vulnerabilità biologica, strutturale, dei supporti vitali, economica e funzionale. Stando così le cose, l’avanzamento di questo processo può essere fermato soltanto da nuove forme di sviluppo prodotte dalle necessità indotte dalle nuove povertà. Il problema che si pone è quello di promuovere l’inizio del processo di riterritorializzazione, basandosi su un riavvicinamento tra natura e cultura, società insediata e ambiente. Un passo importante in questa direzione, sottolinea l’autore, è quello dell’individuazione dell’identità territoriale, attraverso la lettura dei “processi di formazione del territorio nella lunga durata per reinterpretare invarianze, permanenze, sedimenti materiali e cognitivi in relazione ai quali produrre nuovi atti territorializzanti” (MAGNAGHI, 2000a:63). L’obiettivo di questo studio è l’identificazione delle relazioni virtuose fra insediamento umano e ambiente, storicamente esistite, che possono servire da esempio o suggerire la promozione di nuovi atti territorializzanti capaci di avviare un nuovo ciclo di territorializzazione basato su forme di sviluppo locale autosostenibile. Ogni ciclo di territorializzazione, nel riorganizzare e trasformare il territorio, accumula e deposita una propria sapienza ambientale che arricchisce la conoscenza e contribuisce alla conservazione e riproduzione dell’identità territoriale nel tempo lungo. L’interazione fra i vari e successivi atti territorializzanti, la massa territoriale, indica il valore del patrimonio territoriale e le sue peculiarità per gli usi futuri. Si tratta quindi di cambiare gli indicatori di sviluppo e di mettere al centro dell’attenzione non più la crescita economica come fine a se stessa, ma la ricerca di soluzioni ai nuovi problemi emersi tramite la valorizzazione del patrimonio territoriale. In questo contesto, la “verifica di sostenibilità della forma e delle regole costitutive dell’insediamento umano assume (…) estrema importanza, (…) dal momento che la qualità ambientale e urbana e i problemi identitari sono ritenuti centrali nei nuovi indicatori di benessere e hanno molto a che fare con la ridefinizione del rapporto di una comunità insediata con il proprio territorio” (MAGNAGHI, 2000a:47). Sempre secondo l’autore, i segni di questa ricerca si possono notare nella riapparizione della cultura dei valori territoriali “locali” in due momenti fondamentali: il primo, nella rivitalizzazione delle economie a base territoriale; il secondo, nell’affermazione del “locale” e della “territorialità” come problemi essenziali per lo sviluppo, sia tramite l’insorgere della dimensione etnica, linguistica, identitaria come principale motore del conflitto, sia tramite l’esplodere della questione ambientale costringendo a internalizzare sempre di più la riproducibilità delle risorse naturali nel calcolo costi-benefici dell’insediamento umano. 267 “Economie territoriali, questione identitaria e questione ambientale modificano radicalmente gli indicatori di sviluppo che si vanno allontanando dal PIL in maniera vertiginosa. Economie locali, identità e ambiente ripropongono dunque un ripensamento del ruolo del territorio (e della sua cura e valorizzazione) nella produzione della ricchezza. In sintesi, se intendiamo la territorialità come «la mediazione simbolica, cognitiva e pratica che la materialità dei luoghi esercita sull’agire sociale»220 (…), la produzione di territorialità (intesa come produzione di qualità ambientale, abitativa, come valorizzazione di identità territoriali e urbane, di nuove municipalità e appartenenze, produzioni tipiche in paesaggi tipici, di crescita delle società locali) diviene problema interno, per alcuni addirittura fondativo, della produzione di ricchezza, riferita a modelli di sviluppo sostenibili” (MAGNAGHI, 2000a:48). Il primo passo nella direzione della produzione di territorialità e di territorializzazione consiste nel rovesciamento del ruolo del territorio, da supporto/contenitore a produttore dello sviluppo. Ciò “richiede una descrizione e una rappresentazione dei valori territoriali e ambientali che consenta di «trattarli» come opportunità e risorse nei processi di trasformazione, garantendone l’autoriproducibilità e la durevolezza” (MAGNAGHI, 2000b:21). Inoltre, presuppone la restituzione al territorio della sua dimensione di “soggetto vivente”, di cui bisogna rispettare le regole di riproduzione, nonché il riconoscimento del territorio in quanto patrimonio221, qualcosa DEMATTEIS, 1999. L’autore precisa che la territorialità a cui si riferisce non è soltanto quella che riguarda la demarcazione e il controllo del territorio, ma soprattutto quella “in positivo che consiste nel valorizzare le condizioni e le risorse potenziali dei diversi contesti territoriali (milieu) in processi di sviluppo e riqualificazione, di regola conflittuali, ma anche suscettibili di essere condivisi e partecipati proprio grazie alle risorse aggiuntive che questo tipo di territorialità attiva permette di creare durante il processo” (DEMATTEIS, 1999:119/120). Inoltre, richiama l’attenzione sul fatto che la territorialità non dipende solo dal milieu “ma anzitutto dai rapporti intersoggettivi, per i quali il milieu è un insieme di “prese”, “leve”, mezzi del loro concretizzarsi, in un processo co-evolutivo complesso. Al centro di esso si situano le reti locali di soggetti che fanno da interfaccia tra i rapporti col resto del mondo e quelli con il milieu urbano locale e, attraverso ad esso, con l’ecosistema” (DEMATTEIS, 1999:122). 221 Secondo MAGNAGHI, la categoria patrimonio territoriale, composto da ambiente fisico, antropico e costruito, riemerge in epoca tardo moderna, con la crisi e l’insostenibilità del modello di sviluppo “fondato sulla crescita economica illimitata, sul divorzio fra natura e cultura, sulla riduzione del territorio a spazio funzionale e zonizzato e sulla omologazione delle culture nel processo di globalizzazione” (MAGNAGHI, 2000b:22). In questa accezione, il patrimonio territoriale è il risultato dell’interpretazione che viene data da chi lo usa, cioè, il prodotto dell’interazione di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, frutto di un lungo processo composto dall’addizione di atti territorializzanti o deterritorializzanti che, nel trascorrere del tempo, gli aggiungono o gli sottraggono ricchezza e complessità. In quanto sistema vivente, il patrimonio territoriale presenta regole di crescita e riproduzione il cui non rispetto può favorire la sua distruzione e di conseguenza l’impossibilità della sua valorizzazione tramite nuovi usi. In questo modo il territorio, in quanto patrimonio, è visto e inteso come agente attivo nella produzione di ricchezza e di sviluppo, e non come un semplice supporto ad esso. 220 268 che possiede valore e che, perché possa continuare ad esistere, deve essere trasformato in risorsa e valorizzato dagli attori locali222. Per trasformare il patrimonio in risorsa occorre promuovere nuovi atti territorializzanti capaci di ricostruire, su nuove basi, quello che MAGNAGHI chiama relazioni virtuose tra l’ambiente fisico, l’ambiente costruito e l’ambiente antropico. Conseguenza di un nuovo modo di pensare e produrre il territorio, queste relazioni virtuose, nel rispetto delle regole del suo funzionamento, hanno come risultato la creazione di insediamenti ad alta qualità che, simultaneamente, si autosostengono e aggiungono valore al territorio, ossia, lo riterritorializzano. Solo questo nuovo approccio verso il territorio è in grado di dare inizio a un nuovo ciclo di territorializzazione, cioè di produrre allo stesso tempo territorio e sviluppo. È questo il punto nevralgico dell’approccio territorialista, corrente all’interno dell’urbanistica che, riferendo la sostenibilità dello sviluppo al territorio inteso come neoecosistema prodotto dall’uomo, ritiene che soltanto la promozione di nuovi atti territorializzanti che ricostruiscano, in nuove forme, le relazioni tra le tre dimensioni dell’ambiente – tramite il recupero della sapienza ambientale e del ruolo centrale degli abitanti in quanto produttori di territorialità – siano in grado di scatenare un nuovo modo di produzione del territorio, sensibile alle regole del suo funzionamento e allo stabilimento di relazioni sinergiche tra tutte le dimensioni dell’ambiente. In questa prospettiva, “il territorio non è un bene da salvaguardare a lato dello sviluppo, a suo corollario, ma è il bene che produce la forma, la qualità, lo stile dell’insediamento umano” (MAGNAGHI, 1990:32) e dello sviluppo, la cui sostenibilità passa a essere “misurata dalla capacità del modello socioeconomico di alimentare la conservazione e la crescita dei luoghi attraverso atti che ne valorizzino (o ne curino) il «tipo territoriale» e l’individualità” (MAGNAGHI, 2000a:62). Inteso come riabilitazione delle peculiarità territoriali, lo sviluppo locale diventa così il punto centrale all’interno del dibattito sulla sostenibilità dello sviluppo, soprattutto con il non riconoscimento del primato della crescita economica come fattore di sviluppo. Tale fatto, a sua volta, apre la strada a molti interrogativi, quali: “quale sviluppo locale? in che relazione con i processi di globalizzazione? in quale contesto economico e politico? in quale territorio?” (MAGNAGHI, 2000a:49). 222 MAGNAGHI richiama l’attenzione sul fatto che “il valore complessivo del patrimonio territoriale non si limita al suo valore d’uso (che deriva dal suo uso diretto nella produzione e nel consumo); ma occorre tenere in conto il valore di opzione (che può derivare dagli usi potenziali da una probabilità di uso futuro con diverse accezioni di valore) e il valore di esistenza (valore attribuito a una risorsa in quanto tale, «materia», manufatto, ecosistema trasformato nel tempo e divenuto parte del patrimonio naturale e territoriale)” (MAGNAGHI, 2000a:88). 269 2. La valorizzazione del patrimonio territoriale e lo sviluppo locale autosostenibile 2.1. L’origine del concetto di sviluppo locale autosostenibile Prima di passare a trattare dell’argomento centrale di questo paragrafo, vale la pena di fare un breve chiarimento sull’origine e il significato del concetto di sviluppo locale autosostenibile. Secondo TAROZZI, il concetto di sostenibilità è un concetto che, nel trascorrere del tempo, si è molto modificato, passando ad assumere una serie di significati che l’hanno reso troppo generico, talvolta anche ambiguo, e quindi poco utile ai fini degli obiettivi di un progetto di valorizzazione del patrimonio territoriale. È per queste ragioni che l’autore – insieme ad altri – propone il concetto di autosostenibilità, intendendo che “se sviluppo ha da essere, esso debba basarsi sulle forze di chi lo progetta e debba implicare solidarietà sincronica con le generazioni presenti e solidarietà diacronica con le generazioni future” (TAROZZI, 1998:23). Alle origini del concetto di sostenibilità TAROZZI pone l’anno del 1972 per due avvenimenti importanti. Il primo è la Conferenza di Stoccolma, organizzata dalle Nazioni Unite sull’ambiente umano con l’obiettivo di definire una forma di sviluppo compatibile con la sopravvivenza fisica del pianeta, dopo aver identificato negli stili di consumo e di vita delle popolazioni, soprattutto di quelle occidentali, una delle cause del problema sempre più evidente del rapporto sviluppo/ambiente. Il risultato di questa conferenza è stato la proposta di un piano d’azione, anche se senza valore legale, per dare corpo alla consapevolezza ivi emersa di che tutti gli uomini hanno il diritto a vivere in un ambiente sano e il dovere di lasciare in eredità alle generazioni future le risorse naturali così come le hanno ricevute dalle generazioni precedenti. “Tra i vari punti dell’Action Plan ve n’è uno che indica espressamente la necessità di avviare uno sviluppo economico di tipo nuovo, che sia in maggiore armonia con l’ambiente” (GRECO, 2002:09)223. L’altro avvenimento sottolineato da TAROZZI è l’uscita del Rapporto del Club di Roma, Limits to growth, nel quale si denunciava per la prima volta l’esaurimento delle risorse e delle materie prime non rinnovabili, indispensabili al modello di sviluppo messo in pratica dai paesi industrializzati. 223 Secondo GRECO, dopo la Conferenza di Stoccolma una serie di studiosi tra cui I. SACHS, B. WARD e M. STRONG hanno cominciato a lavorare sui fondamenti su cui appoggiare un’economia che si sviluppi in modo armonico, concentrandosi sull’interdipendenza di tre fattori globali: la crescita demografica, il degrado ambientale e lo sviluppo economico. È da questi studi che emergerà più tardi il concetto di ecosviluppo proposto da I. SACHS. Inoltre, dopo “Stoccolma le Nazioni Unite hanno cercato di definire meglio i fattori ambientali che costituiscono problemi comuni, organizzando in successione una ‘Conferenza mondiale sulla popolazione’ (1974), una ‘Conferenza sull’acqua’ (1977) e la prima ‘Conferenza mondiale sul clima’ (1979)” (GRECO, 2002:11). 270 L’indagine commissionata dal Club di Roma e realizzata dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) aveva come compito principale “lo studio, nel contesto mondiale, dell’interdipendenza e delle interazioni di cinque fattori critici: l’aumento della popolazione, la produzione di alimenti, l’industrializzazione, l’esaurimento delle risorse naturali e l’inquinamento” (MEADOWS, 1972:24). Il punto di partenza della ricerca è stato il dilemma dell’umanità davanti alla forma di sviluppo in corso, e cioè, i problemi della crescita illimitata della popolazione davanti ai limiti e alle conseguenze indesiderabili dello stile di sviluppo della società tecnologica che riguardano tutta l’umanità. Il rapporto richiama l’attenzione sul fatto che “l’uomo è ovunque messo di fronte a problemi stranamente difficili da impostare ed elusivi: il deterioramento dell’ambiente, la crisi delle istituzioni, la burocratizzazione, l’espansione incontrollata delle città, l’insicurezza del lavoro, l’alienazione della gioventù, il rifiuto del sistema di valori sociali da parte di un sempre maggior numero di persone, l’inflazione e ogni altro squilibrio monetario ed economico, per citarne solo alcuni. Questi problemi, apparentemente diversi, hanno tre caratteristiche in comune: hanno dimensioni o effetti su scala mondiale e si manifestano in tutti i paesi a certi livelli di sviluppo, indipendentemente dai sistemi politici e sociali vigenti; sono complessi e variano in funzione di molteplici elementi tecnici, sociali, economici e politici; interagiscono intensamente tra loro secondo modalità non ancora chiarite. È questo intricato miscuglio di problemi che noi esprimiamo col termine ‘la problematica’. L’intreccio delle relazioni è a un livello tanto fondamentale e tanto critiche esse sono diventate, che non è più possibile isolarle una per una dal groviglio della problematica e trattarle separatamente” (MEADOWS, 1972:22). Lo studio è stato strutturato in sei capitoli: una premessa, dove vengono fatte alcune considerazioni sulla condizione umana, la problematica appena accennata e il progetto del MIT; un’introduzione, dove vengono elencati gli interessi umani, i problemi e i modelli a cui fa ricorso la ricerca; un capitolo sulle caratteristiche della crescita esponenziale della popolazione e dello sviluppo economico nel mondo; uno sui limiti della crescita esponenziale; un altro sullo sviluppo nel sistema mondiale; un altro ancora sulla tecnologia e i limiti dello sviluppo e, infine, un ultimo capitolo sullo stato di equilibrio globale. La tesi centrale di questa ricerca è che, perché si possa “ottenere insieme uno standard di vita materiale accettabile e una situazione più stabile, bisogna combinare l’adozione dei ritrovati della tecnologia con il cambiamento di alcuni dei valori fondamentali della società umana in modo da ridurre la tendenza del sistema verso lo sviluppo” (MEADOWS, 1972: 130/131). Partendo da questo presupposto, gli autori simulano una serie di situazioni rispetto all’evoluzione della crescita della popolazione mondiale, dello sviluppo economico e dell’accesso alle risorse, sottolineando i risultati a cui si arriverebbe con e senza l’intervento di politiche di controllo e di 271 cambiamento dello stile di sviluppo224. Le conclusioni più importanti di questo studio sono le seguenti: “1) Nell’ipotesi che l’attuale linea di sviluppo continui inalterata nei cinque settori fondamentali (popolazione, industrializzazione, inquinamento, produzione di alimenti, consumo delle risorse naturali) l’umanità è destinata a raggiungere i limiti naturali dello sviluppo entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un improvviso, incontrollabile declino del livello di popolazione e del sistema industriale. 2) È possibile modificare questa linea di sviluppo e determinare una condizione di stabilità ecologica ed economica in grado di protrarsi nel futuro. La condizione di equilibrio globale potrebbe essere definita in modo tale che venissero soddisfatti i bisogni materiali degli abitanti della Terra e che ognuno avesse le stesse opportunità di realizzare compiutamente il proprio potenziale umano. 3) Se l’umanità opterà per questa seconda alternativa, invece che per la prima, le probabilità di successo saranno tanto maggiori quanto più presto essa comincerà a operare in tale direzione” (MEADOWS, 1972:32). Per la prima volta viene dichiarata, anche se implicitamente, l’insostenibilità per il genero umano e per tutto il pianeta dei processi di sviluppo in corso fino a quel momento. Ma a tale denuncia, argomenta TAROZZI, non sono seguite le proposte alternative di sviluppo, nemmeno sono stati identificati quali potevano essere i soggetti atti a pensarle e a metterle in pratica. Tre anni più tardi, a Uppsala, la Dag Hammrskjöld Foundation pubblica il documento What now? Another development, dove vengono elencati tre punti, non separabili l’uno dall’altro, che diventeranno i precetti normativi dello sviluppo alternativo, e cioè: “1. Essere orientato alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di tutti gli appartenenti al sistema, a cominciare dallo sradicamento della povertà per giungere, per ciascuno e per tutti, al conseguimento di garanzie di base lungo le coordinate della salute, dell’informazione, dell’istruzione, della libertà individuale (basic needs); 2. essere endogeno (etnosviluppo) e basato sulle proprie forze, fare cioè affidamento sulle risorse delle società che lo intraprendono (self-reliance), nel senso di azzerare i processi di internalizzazione dei benefici e quelli di esternalizzazione dei costi che si potrebbero realizzare nell’interazione con gli altri sistemi; 224 Vengono simulate una situazione di intervento sin dal 1975 e un’altra 25 anni più tardi. 272 3. essere in armonia con l’ambiente (ecodevelopment225) (I. Sachs, 1980), vale a dire stabilire delle relazioni di solidarietà diacronica con le generazioni future degli abitanti del pianetaTerra” (TAROZZI, 1998:26/27). In altre parole, si passa a capire che non ci può essere sviluppo sostenibile senza la soddisfazione dei bisogni fondamentali e senza che esso nasca dalle comunità insediate. Il rapporto della Dag Hammrskjöld Foundation sottolinea per la prima volta la necessità di cambiare la linea conduttrice delle politiche di sviluppo e di mettere al centro degli sforzi la soddisfazione dei bisogni umani tramite anche politiche di ridistribuzione del reddito. Gli autori del rapporto insistono sul fatto che lo sviluppo debba essere considerato come sviluppo dell’uomo e, così essendo, che esso nasca dall’interno della società che deve definire stili di vita e di sviluppo propri. Uno sviluppo così, oltre a tenere in considerazione quelli che vengono chiamati i «limiti ultimi» riferiti sia all’uso delle risorse, sia al contesto in cui sono utilizzati, stimolerebbe la creatività e condurrebbe a una migliore utilizzazione dei fattori di produzione, allo stesso tempo in cui ridurrebbe la vulnerabilità e la dipendenza verso l’esterno. Un altro importante pregio di questo rapporto è quello di aver messo un’altra luce sul rapporto accesso alle risorse/questione demografica. “Dando per scontato che le risorse sono limitate, una discussione rigorosa deve prima identificare chi consuma le risorse e per 225 Emerso dalla polemica tra i difensori della crescita selvaggia e quelli della non-crescita, il concetto di ecosviluppo si fonda in primo luogo “sui postulati etici complementari di solidarietà sincronica con la presente generazione e di solidarietà diacronica con le generazioni future. (…) In secondo luogo, l’ecosviluppo è uno strumento euristico per porre un insieme coerente di questioni sull’ambiente, inteso come potenziale di risorse che possono e debbono essere costantemente al servizio dell’umanità” (SACHS, 1988:63). Non si tratta, quindi, di proporre la non-crescita, ma di prospettare nuove modalità di crescita, nel rispetto delle dinamiche dell’ambiente e delle realtà sociali, culturali ed economiche locali. Così, l’ecosviluppo rifiuta le scelte universaliste e stimola quelle endogene, plurali, e offre al pianificatore un nuovo ruolo, quello di “stimolare lo sforzo di immaginazione sociale concreta necessario per identificare tanto i bisogni materiali e immateriali, quanto i mezzi per soddisfarli, cambiamenti strutturali compresi, sempre vigilando affinché i risultati immediati non comportino costi sociali ed ecologici eccessivi per l’avvenire. Un «altro sviluppo» si appoggia su cinque pilastri: deve essere endogeno; contare sulle proprie forze; prendere come punto di partenza la logica dei bisogni; dedicarsi a promuovere la simbiosi tra le società umane e la natura; restare aperto al cambiamento istituzionale” (SACHS, 1988:65). L’ecosviluppo è, quindi, “uno stile di sviluppo che, in ogni ecoregione, insiste sulle soluzioni specifiche dei loro problemi particolari, tenendo conto dei dati ecologici nello stesso modo di quelli culturali, delle necessità immediate così come di quelle a lunga scadenza. Opera, pertanto, con criteri di progresso relativizzati a ogni singolo caso, con particolare attenzione all’adattamento all’ambiente, di cui parlano gli antropologi. Senza negare l’importanza degli interscambi (…), l’ecosviluppo cerca di evitare le soluzioni universaliste e le formule generalizzate. Anziché attribuire uno spazio eccessivo all’aiuto esterno, dà un voto di fiducia alla capacità delle società umane di identificare i loro problemi e di proporre soluzioni originali, anche se ispirandosi alle esperienze altrui. Reagendo contro il trasferimento passivo e lo spirito d’imitazione, stimola la fiducia in sé stessi. Resistendo a un ecologismo esagerato, suggerisce la costante possibilità di uno sforzo creativo affinché si possa utilizzare con libertà le possibilità offerte dall’ambiente (…). La diversità delle culture e delle realizzazioni umane ottenute in ambienti paragonabili sono testimoni eloquenti di queste possibilità. Il successo presuppone la conoscenza dell’ambiente e la volontà di raggiungere un equilibrio durevole tra l’uomo e la natura” (SACHS, 1986:18). La traduzione è mia. 273 quali scopi vengono usate. Le economie industriali di mercato, con il 18% della popolazione del mondo, consumano il 68% dei suoi nove minerali principali (petrolio escluso), mentre il Terzo Mondo (Cina esclusa) con il 50% della popolazione ne sta consumando il 6%. Chiaramente la pressione sulle risorse, che è reale e complessa, ha poco a che fare con la pressione demografica di per se stessa. Al massimo, suggerisce che lo stile di consumo dei paesi industrializzati non potrebbe essere tollerato se 4 o 10 miliardi di esseri umani cercassero tutti di adottarlo, sebbene questo sia un argomento per un cambiamento negli stili di consumo delle società avanzate, piuttosto che uno in favore del consigliare i poveri di ridurre i loro tassi di natalità. (…) La situazione è chiara: a livello globale, non sono i poveri, né tantomeno la soddisfazione dei loro bisogni, a minacciare i limiti ultimi, ma la monopolizzazione e il cattivo uso da parte di una minoranza. Detto questo, l’esistenza di un serio problema demografico non dovrebbe essere negata, ma affrontata seriamente. La storia delle società industrializzate e, più recentemente, quella di certe società del Terzo Mondo, mostra che la gente ha meno bambini quando aumentano i propri standard di vita” (DAG HAMMARSKJÖLD FOUNDATION, 1990:53/54). È in questo quadro che deve essere inserita la discussione fatta da autori come SACHS e SCHUMACHER sulla necessità di cambiare lo stile e il ritmo dello sviluppo, affinché si possa garantire l’accesso alle risorse naturali della Terra a tutti i suoi abitanti. SACHS difende la necessità della ricerca di uno stile di sviluppo alternativo, non più basato soltanto sulla crescita economica – che passa a non essere più considerata come sinonimo di sviluppo – ma che tenga conto anche dello sviluppo umano. L’autore richiama l’attenzione su quelle che, secondo lui, dovrebbero essere le fondamenta di questo sviluppo: da un lato, la necessità di trovare dei limiti alla crescita senza che ciò significhi la sua interruzione; dall’altro, la necessità di “valutare” lo sviluppo da un punto di vista più ampio, cioè che insieme al PIL – per molti anni ritenuto l’indice di sviluppo – vengano considerati altri fattori tra cui quelli sociali, culturali e ambientali; infine, la necessità di restituire allo sviluppo la sua dimensione endogena, locale, stimolando il processo di consolidamento dell’autonomia locale e facendo sì che le società locali diventino produttrici attive del loro sviluppo226. SACHS mette enfasi sull’endogeneità dello sviluppo, sulla self-reliance e sulle “altre tre condizioni che dovevano essergli associate: il primato della logica dei bisogni sociali su quella del produttivismo stretto; la ricerca di 226 Secondo SACHS non esiste altro sviluppo che quello locale. Esso, attraverso l’esempio, avrebbe potuto stimolare cambiamenti nei livelli gerarchici superiori. 274 strategie socioeconomiche che permettano di vivere in armonia con la natura; una larga apertura verso l’innovazione sociale e le riforme istituzionali” (SACHS, 1988:128). L’autore ritiene che la crisi in corso negli anni ’70 e ’80 poteva essere lo stimolo necessario a cambiare i parametri di misurazione dello sviluppo, da quelli strettamente quantitativi a quelli più qualitativi, basati quindi su altri valori e altri principi, capaci di renderlo umano oltre che economico. Anche SCHUMACHER abbraccia la tesi della necessità di cercare un nuovo stile di vita, “con nuovi metodi di produzione, e nuovi modelli di consumo: uno stile di vita progettato per durare stabilmente” (SCHUMACHER, 1978:12). L’autore tratta, tra altri temi, della questione della scala nell’analisi dello sviluppo, dell’importanza dell’istruzione, delle pratiche agricole, di ciò che chiama tecnologia intermedia e di quello che, secondo lui, dovrebbero essere la base e il compito dello sviluppo economico. Riguardo alla questione della scala, richiama l’attenzione sulla necessità di saper affrontare il problema dello sviluppo a scale diverse, a seconda del problema da risolvere, privilegiando per quanto possibile la scala locale. Rispetto all’istruzione, sottolinea la sua estrema importanza, soprattutto di quella capace di stimolare la sensibilità e l’immaginazione e, così facendo, di creare esseri umani completi, con un’ampia veduta dei problemi della società, e non scienziati “non-cittadini”. In ciò che si riferisce alle pratiche agricole, ritiene che l’uomo debba cercare di interrompere la tendenza all’industrializzazione e alla spersonalizzazione dell’agricoltura, e passare a dedicarsi a un’agricoltura diversificata, decentrata, che rispetti l’ambiente e le caratteristiche naturali del luogo dove viene praticata. Riguardo allo sviluppo della tecnologia, richiamando GANDHI, ritiene che si debba passare da una tecnologia di massa a una tecnologia da parte delle masse. Nelle sue parole: la “tecnologia della produzione di massa è intimamente violenta, ecologicamente dannosa, si distrugge da sé perché consuma risorse non rinnovabili, ed è degradante per la persona umana. La tecnologia per la produzione da parte delle masse, facendo uso del meglio della conoscenza e dell’esperienza moderna, conduce al decentramento, è compatibile con le leggi dell’ecologia, attenta nell’uso di risorse scarse e progettata per servire la persona umana invece di renderla serva delle macchine. L’ho chiamata tecnologia intermedia per significare che è molto superiore alla tecnologia primitiva delle epoche passate ma, nello stesso tempo, molto più semplice, economica e libera della supertecnologia dei ricchi. Si potrebbe anche chiamarla tecnologia di autoassistenza, o tecnologia democratica, o del popolo: una tecnologia a cui tutti possano avere accesso e che non è riservata a chi già è ricco e potente” (SCHUMACHER, 1978:124/125)227. 227 Il corsivo è mio. 275 Infine SCHUMACHER richiama l’attenzione sulla necessità che lo sviluppo debba partire dal popolo attraverso la sua educazione, organizzazione e disciplina, in modo da accelerare il progresso, e non dalla produzione di beni che diventano nella maggior parte dei casi accessibili a soltanto una minoranza della popolazione. Seguendo questa logica, l’autore ritiene che il compito dello sviluppo sia quello di creare nuovi posti di lavoro per la popolazione che ne ha bisogno e che tale compito potrà essere pienamente realizzato, soprattutto nei paesi poveri, soltanto se basato su ciò che ha chiamato tecnologia intermedia ad alta intensità di lavoro. Da questo punto in poi, secondo TAROZZI, i concetti di “ecosviluppo e self-reliance verranno utilizzati in connessione tra loro per confluire nel concetto di sviluppo sostenibile, dove il ruolo della self-reliance sarà destinato, soprattutto sul finire degli anni ‘80, a perdere progressivamente di rilevanza” (TAROZZI, 1998:27). L’autore attribuisce tale fatto a tre ordini di metamorfosi in corso negli anni ’80. La prima, da lui chiamata universalistica, si caratterizza per l’espandersi del dibattito sull’ecosviluppo e lo sviluppo alternativo in tutto il mondo e, concomitantemente, per l’espandersi del movimento delle ONG, delle agenzie di cooperazione allo sviluppo e delle agenzie internazionali e transnazionali che si collegano a istanze intergovernative come le Nazioni Unite e la Comunità Europea, rappresentando da un lato una svolta rispetto ai principi dello sviluppo e, dall’altro, l’alzarsi delle voci dei paesi del Sud del mondo all’interno di questo dibattito. La seconda, di carattere tecnico-operativo, è frutto dal bisogno di dare concretezza al discorso, di stimare, pianificare e valutare il lavoro svolto. È in questo contesto che la parola sostenibilità (sustainability) trova una sua prima definizione ufficiale e, insieme a essa, altre quattro che diventeranno parole chiave nei discorsi sullo sviluppo alternativo: impatto (impact), efficacia (effectiveness), stima ex ante (appraisal ex ante) e valutazione (evaluation)228. TAROZZI richiama l’attenzione sul fatto che tra queste, “solo la effectiveness (…) si limita a valutare i risultati di un progetto sulla base del conseguimento degli obiettivi previsti. Già lo impact (…) comporta la presa in considerazione delle ricadute socioculturali e ambientali del progetto, dei risultati che fuoriescono dalla sfera degli obiettivi programmati, indipendenti dalle intenzioni del progettista: si tratta di un criterio che implica giudizi da stilare solo a progetto concluso o avanzato, giudizi su quanto il progetto ha già causato, da cui potrebbe conseguire la scelta di modificare o non replicare l’intervento” (TAROZZI, 1998:31). La terza metamorfosi identificata dall’autore è quella disciplinare e si riferisce al ridimensionamento del ruolo delle scienze per quanto riguarda l’elaborazione dei piani di 228 Per la definizione di questi concetti fatta dall’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) vedere TAROZZI, 1998, p. 30-31. 276 sviluppo: anziché indicare i criteri da usare per elaborare un progetto esse dovranno indicare come fare a convincere le popolazioni coinvolte dell’idoneità e validità di un progetto di solito elaborato da specialisti, dall’alto, senza la loro partecipazione o consultazione. Si tratta, dunque, di uno scollamento sempre più evidente tra i criteri dell’ecocompatibilità da un lato e quelli della basic needs e della self-reliance dall’altro. Questa pratica si è accentuata fino alla fine degli anni ’80 quando finalmente è emerso un concetto di sostenibilità opposto a quello dominante. Da allora si è passato ad accentuare sempre di più l’enfasi sulla self-reliance, messa in evidenza, da un lato, da rapporti tecnicoscientifici come il Rapporto Bruntland e quello del Wuppertal Institut e, dall’altro, dalla necessità di tenere conto anche della componente sociale all’interno degli studi di impatto ambientale. Il Rapporto Brundtland propone un concetto di sviluppo allargato, “non più nel ristretto contesto della crescita economica delle nazioni in via di sviluppo, bensì in quello della necessità di un nuovo modello di sviluppo capace di sostenere il progresso umano, non solo in pochi luoghi e per pochi anni, ma sull’intero pianeta e per un futuro di lunga durata” (WCED, 1988.27). Il rapporto mette in luce alcuni punti importanti riguardo alle politiche di sviluppo condotte dai paesi sviluppati e alla mancata attenzione alle conseguenze di queste politiche sull’ambiente, sulle popolazioni povere e sulle generazioni future. Inoltre, collega il ritardo nello sviluppo dei paesi poveri alle politiche dei paesi ricchi che, nella maggior parte dei casi, pensano soltanto i loro interessi anche quando si dedicano a politiche di aiuto allo sviluppo nei paesi poveri. Un altro problema sollevato da questo rapporto è il peso della dinamica di incremento della popolazione sulla sostenibilità dello sviluppo. Si sottolinea la necessità di promuovere politiche di controllo della crescita della popolazione nei paesi in via di sviluppo ma, allo stesso tempo si richiama l’attenzione sull’impatto che lo stile di vita delle popolazioni dei paesi sviluppati possiede sul consumo delle risorse mondiali. Non si tratta, quindi, soltanto di un problema di controllo demografico, ma anche – se non soprattutto – della necessità di cambiamento dello stile di consumo soprattutto tra le popolazioni occidentali. La tesi centrale contenuta in questo rapporto è che lo sviluppo sostenibile deve essere in grado di soddisfare i bisogni umani della generazione presente – garantendo anche un miglioramento del suo tenore di vita – senza però compromettere quelli delle generazioni future. Per raggiungere questo obiettivo non basta la crescita economica: bisogna assicurare eque opportunità a tutti e questo può avvenire soltanto tramite una più equa distribuzione del reddito. Stando così le cose, lo sviluppo deve avere un carattere globale e presupporre trasformazioni importanti sia nello stile di vita della società che 277 nello stile e ritmo di sviluppo dell’economia. Ciò potrà avvenire soltanto attraverso cambiamenti importanti come lo sviluppo di tecnologie che tengano conto della sostenibilità dello sviluppo, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle risorse energetiche e la capacità di assorbimento dei rifiuti; un consumo delle risorse che tenga conto delle necessità delle generazioni future; l’integrazione dei problemi di ordine economico e di ordine ecologico. Si afferma inoltre che non bastano leggi prodotte dai singoli Stati che regolamentino lo sviluppo. Affinché tali leggi siano rispettate ci vuole la partecipazione attiva della comunità in difesa dei suoi diritti e interessi. In altre parole, ci vuole il rafforzamento di pratiche di democrazia partecipativa perché questo nuovo sviluppo possa essere gestito in modo democratico in ogni suo livello. “In sostanza, lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, l’andamento degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i mutamenti istituzionali sono in reciproca armonia e incrementano il potenziale attuale e futuro di soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni umani” (WCED, 1988:75). Dal rapporto Wuppertal, a sua volta, emerge un’idea di sviluppo sostenibile in quanto “sviluppo in cui le necessità delle generazioni odierne vengano soddisfatte senza mettere a repentaglio le basi per la vita delle generazioni future. Con questa nuova idea guida, si collega la nozione che i problemi di politica ambientale non possono essere considerati in modo separato rispetto agli sviluppi economici e sociali. La sostenibilità è in sintesi un concetto normativo e richiede giudizi di valore. (…) La prima fondamentale affermazione è: le generazioni future devono avere uguali opportunità di vita Ogni generazione deve usare la terra come in prestito e lasciare alle generazioni successive una natura il più possibile intatta. La seconda scelta di valore è: ogni persona ha lo stesso diritto ad un ambiente intatto e parimenti uguale diritto a disporre delle risorse globali, nei limiti in cui ciò non compromette eccessivamente la natura. L’obiettivo di mantenere globalmente inalterati i fondamenti per la vita richiede un preciso quadro operativo. Adottando un concetto formulato da Opschoor, definiamo come «spazio ambientale» questo quadro operativo. Esso riconosce l’esistenza di «nuovi limiti alla crescita», all’interno dei quali l’uomo si può sviluppare liberamente. Il concetto di «spazio ambientale» non contiene solo la dimensione ecologica ma anche quella dell’equità internazionale” (WUPPERTAL INSTITUT FÜR KLIMA, 1996:17). Inoltre, il rapporto suggerisce alcune misure da adottare rispetto all’uso delle risorse, quali il non sfruttamento di una risorsa oltre la sua capacità di rigenerazione; la non 278 emissione nell’ambiente di più sostanze di quelle che esso è in grado di assorbire; la riduzione dei flussi di energia e di materiali a livelli meno rischiosi. Rispetto alla discussione fatta su sviluppo e crescita, GRECO sottolinea le tre posizioni più importanti. La prima, quella proposta da H. DALY con il modello di steadystate (stato stazionario)229, riprendendo il discorso greco dell’eudoeconomia – benessere e sviluppo delle relazioni umane – ritiene che lo sviluppo debba basarsi sulla crescita della produzione di beni immateriali anziché di beni materiali. DALY, infatti, concepisce lo sviluppo sostenibile come “sviluppo senza crescita – ossia senza crescita del volume della produzione (inclusa quella intermedia) oltre le capacità di rigenerazione e di assorbimento dell’ambiente. Il cammino del progresso futuro è sviluppo, non la crescita” (DALY, 2001:21). La seconda posizione sostiene che non esiste nessuna necessità di cambiare il modello di sviluppo in quanto lo stesso evolvere della tecnica e della tecnologia avrebbe reso la crescita economica compatibile con l’ambiente, attraverso la diminuzione dell’intensità di materia ed energia necessarie a produrre la stessa quantità di ricchezza. La terza, invece, richiama l’attenzione sulla necessità di cambiare il modello economico, sottolineando il fatto che l’aumento dei consumi determina comunque l’aumento della quantità di materia ed energia necessarie alla produzione di ricchezza, fatto che invalida la tesi difesa della seconda posizione. Quelli che condividono quest’ultima posizione ritengono che in “una società avanzata che ha soddisfatto le esigenze fondamentali di beni materiali dei suoi cittadini lo sviluppo dell’uomo può essere perseguito attraverso la ricerca di uno stato immateriale di benessere: la salute, la cultura, la qualità della vita. In questa visione dello sviluppo è contenuta non solo la sostenibilità ambientale (stato stazionario dei consumi di materia/energia, attenzione alla qualità dell’ambiente quale aspetto primario della qualità della vita) ma anche la sostenibilità sociale (è prioritario fornire tutti i cittadini dei beni materiali fondamentali), condizione senza la quale lo sviluppo sostenibile perde di significato e diventa, semplicemente, irrealizzabile” (GRECO, 2002:45). È in questo contesto che TAROZZI richiama l’attenzione sulla necessità di restituire al termine sostenibilità la sua dimensione di auto, ossia, la self-reliance. Pensare, dunque, a un concetto di autosostenibilità “come una miscela di sostenibilità (il continuare a conseguire gli obiettivi di un progetto nel tempo, anche quando non vi sia più assistenza al 229 DALY si basa sugli scritti di economia classica di MILL il quale, anziché identificare lo stato stazionario con la fine del progresso, riteneva che “«una condizione stazionaria del capitale e della popolazione non implica affatto uno stato stazionario del progresso umano» e che in effetti vi sarebbe stata maggiore possibilità di «perfezionare l’arte della vita […] una volta che le menti degli uomini non fossero più assillate dalla gara per la ricchezza». Diversamente da molti economisti classici, Mill credeva che le leggi che governano la produzione non determinassero rigidamente la distribuzione (…). Nel linguaggio di oggi, Mill argomentava a favore dello sviluppo sostenibile – sviluppo senza crescita – vale a dire, sviluppo qualitativo senza crescita quantitativa” (DALY, 2001:6). 279 progetto dall’esterno, secondo la volontà e le possibilità dei gruppi cui il progetto era dedicato e che continuano a farsene carico) e di self-reliance (l’autopromozione di una progettualità endogena e in grado di contare sulle proprie forze)” (TAROZZI, 1998:36). L’autore sottolinea tre avvenimenti importanti che, secondo lui, indicano questo cambiamento di direzione. Il primo, il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite che dal 1990 pubblica materiali di documentazione statistica relativi al concetto di sviluppo, stabilendo una graduatoria dei paesi a seconda dello sviluppo umano raggiunto. Per la prima volta il peso del PIL come indice di sviluppo viene circoscritto e, accanto a esso, vengono inseriti dati sulla ricchezza, salute e istruzione. Anche se tale graduatoria è passibile di critiche, se mancano criteri fondamentali quali la distribuzione del reddito, dati sulla questione di genere, qualità dell’ambiente, dell’istruzione, della vita, ecc., è già un segno importante del fatto che si comincia a pensare a uno sviluppo che non sia soltanto sinonimo di crescita economica. Il secondo avvenimento sottolineato da TAROZZI è stata la Conferenza di Rio sull’ambiente e sviluppo del 1992230 dove è stato messo in evidenza un punto fondamentale sulla questione sviluppo/ambiente con la conseguente presa di coscienza del fatto che «senza sviluppo non si può pensare di salvare l’ambiente»231. Tale conferenza ha dato “vita a una serie di strumenti legali, oltre che di solenni impegni morali: due Convenzioni, giuridicamente vincolanti, sul clima e sulla diversità biologica; l’Agenda 21, una sorta di programma di sviluppo economico e ambientale del pianeta; la Dichiarazione di Rio, con la definizione di alcuni principi – tra cui il principio di precauzione – ritenuti fondamentali per affrontare i problemi ecologici ed economici a livello globale e locale; una Dichiarazione di intenti sulle foreste, giuridicamente non vincolante” (GRECO, 2002:06). Infine, il terzo avvenimento è stata la Conferenza di Istambul del 1996, dov’è stata compilata l’Agenda Habitat II che, a sua volta, cerca di mettere in moto un’altra idea di partecipazione e cittadinanza, stimolando il coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali, accanto alle autorità competenti, incoraggiando l’associazionismo e la promozione di azioni di base al fine di dare origine a forme di sviluppo endogeno del tipo top down. Si vede, quindi, “il riaffiorare di termini come empowerment, come capacity building, il richiamo allo sviluppo endogeno, che sembrano altrettanti riferimenti alla self-reliance di qualche anno prima e alla riaffermazione di una sostenibilità che non può effettivamente fregiarsi di questo nome se sprovvista di soggetti in grado di rendere praticabili i progetti e di gestirne l’impatto nel corso del tempo” (TAROZZI, 1998:38). 230 231 La “United Nations Conference on Environment and Development” (UNCED). Apud TAROZZI, 1998, p. 37-38. 280 Emerge, dunque, da queste considerazioni, che ciò che deve essere la caratteristica discriminante di un progetto autosostenibile è che esso sia formulato e gestito dai suoi principali interessati. Secondo l’autore il successo di esperienze di questo tipo sta nell’essere, allo stesso tempo, endogeno, e cioè fatto dalla comunità locale, e aperto, e cioè capace di stabilire un dialogo con l’ambiente esterno – naturale e sociale – e quindi di essere in grado di valutare il suo impatto su di esso e di pensare a nuove strategie di azioni sempre che esse si mostrino necessarie. 2.2. Lo sviluppo locale autosostenibile come progetto per la valorizzazione del patrimonio territoriale Frutto dall’emergere del locale in quanto punto centrale nel dibattito sulle alternative di sviluppo232, il “concetto di sviluppo locale si fonda (…) sulla riscoperta del territorio inteso come patrimonio, come “milieu” (…) entro cui reperire valori e risorse per l’accrescimento della ricchezza. Occorre tuttavia ben distinguere fra “valori” e “risorse”: i valori territoriali indicano gli elementi costitutivi del patrimonio il quale è indipendente dalle forme specifiche e temporanee del suo uso; questi stessi valori possono essere intesi come risorse quando una determinata società li reinterpreta attivamente” (MAGNAGHI, 1998: 11). 232 L’autore sottolinea l’esistenza di tre atteggiamenti generali relativi all’approccio locale-globale e le alternative allo sviluppo. Il primo, top down o funzionale alla globalizzazione, si basa soprattutto sulla competizione fra aree produttive nella corsa “verso l’alto” attraverso lo sfruttamento delle risorse locali da parte degli attori economici forti. Questo approccio non solo scatena un processo di omologazione come anche stimola processi di differenziazione e di ricerca di prodotti legati alle peculiarità locali a dispetto delle reali esigenze degli attori sociali più deboli così come della valorizzazione del territorio. Il secondo, di ricerca di equilibri fra locale e globale, il glocale, propone “ipotesi correttive che perseguono un rapporto di equilibrio fra necessità di valorizzazione delle peculiarità locali per la qualificazione e la differenziazione competitiva delle merci sul mercato e il contemporaneo rafforzamento delle società locali come strumento di allargamento dei centri di decisioni nel processo di globalizzazione. Questo approccio insiste sul fatto che solo le società locali capaci di connettersi alle «reti lunghe» del globale (…), o di connettere in modo attivo le relazioni «verticali» del milieu con le relazioni «orizzontali» esterne, sono in grado di rinnovare l’uso del proprio patrimonio territoriale come risorsa” (MAGNAGHI, 2000a:79). Questo approccio rischia, secondo MAGNAGHI, di sottovalutare il fatto che la relazione fra locale e globale sia fortemente squilibrata a favore del globale, potendo, a lungo andare, “irretire” il locale alle reti lunghe del globale e condizionare il suo inserimento nella competizione solo se adeguandosi alle regole di sviluppo date. Infine, il terzo approccio, sviluppo locale versus globale o bottom up, globalizzazione dal basso, dal locale al centro, sul quale MAGNAGHI costruisce la sua tesi e del quale mi servo per costruire questa seconda parte della tesi, interpreta “la crescita di società locali e di stili di sviluppo peculiari ad ogni contesto come avvio di un multiverso in grado di attivare relazioni non gerarchiche, cooperative, fra città, regioni, nazioni verso un sistema di relazioni globali costruite «dal basso» e condivise. In questa ipotesi lo sviluppo locale fondato sulla valorizzazione del patrimonio territoriale assume i valori locali (culturali, sociali, produttivi, territoriali, ambientali, artistici), come elemento principale della forza propulsiva necessaria all’attivazione di modelli di sviluppo autosostenibili” (MAGNAGHI, 2000a:80). 281 L’autore pone all’origine “del concetto di sviluppo locale gli approcci normativi (selfreliance, basic needs, sviluppo autocentrato, ecosviluppo) che hanno insistito sulla valorizzazione delle risorse territoriali e delle identità locali considerandola come atto fondativo di modelli alternativi di sviluppo (…). [Ciò ha] modificato profondamente i criteri di valutazione e gli indicatori dello sviluppo stesso (dal PIL a sistemi di parametri qualitativi: bisogni umani fondamentali, democrazia, salute, sicurezza, autogoverno, equilibrio ecologico, identità, spazio collettivo ecc.)” (MAGNAGHI, 2000a:76). In questa prospettiva, il locale in quanto patrimonio da valorizzare, diventa centrale nelle ricerche di forme alternative di sviluppo, soprattutto di quello autosostenibile. La valorizzazione del locale attraverso lo sviluppo locale autosostenibile ha come risultato la ripresa del processo di riterritorializzazione e la restituzione al territorio della sua dimensione di “soggetto vivente”, attraverso una lunga fase di “bonifica” destinata a curare e ricostruire il territorio. Tale processo deve essere messo in pratica dall’interno, dalle comunità insediate, dopo un lungo processo di autoriconoscimento e di costruzione/crescita dell’identità locale. Perché ciò possa avvenire, MAGNAGHI sottolinea la necessità di fare società locale, e cioè, trasformare il residente in cittadino, partecipe e produttore della società alla quale appartiene. “La ricostruzione della comunità è l’elemento essenziale dello sviluppo autosostenibile: la comunità che «sostiene se stessa» fa sì che l’ambiente naturale possa sostenerla nella sua azione (…). Si delinea dunque un processo che dalla partecipazione evolve verso la produzione sociale del piano (…), fino alla produzione sociale del territorio. Il concetto di autosostenibilità, [infatti], si fonda sull’assunto che solo una nuova relazione coevolutiva fra abitanti-produttori e territorio è in grado, attraverso la «cura», di determinare equilibri durevoli fra insediamento umano e ambiente, riconnettendo nuovi usi, nuovi saperi, nuove tecnologie alla sapienza ambientale storica” (MAGNAGHI, 2000a:91). Perché si arrivi alla produzione sociale del territorio, GIANGRANDE sottolinea la necessità che esista una comunità locale autodeterminata233, capace di promuovere una riforma sia nell’assetto politico-istituzionale – garantendo così una più alta partecipazione dei cittadini alla vita politica e ai processi decisionali riguardanti la comunità – sia nel modello del sistema economico – attraverso il recupero/riscoperta dei saperi e della produzione locale e la messa in atto di nuovi valori capaci di dare al consumo un significato etico e sociale. Partendo dal presupposto che la progettazione possa contribuire a modificare i meccanismi di scelta sociale e quindi contribuire a trovare i percorsi che conducano a 233 L’autore intende per comunità locale autodeterminata quello che MAGNAGHI chiama società locale. 282 pratiche di sviluppo locale autosostenibile, GIANGRANDE si domanda quali possono essere le strategie da seguire per favorire processi di autoidentificazione e di sviluppo di comunità capaci di raggiungere quello che DRYZEK chiama razionalità ecologica, e cioè, “la capacità degli ecosistemi di procurare costantemente ed efficacemente il bene «sostentamento della vita umana»” (DRYZEK, 1989:48). Considerando che i meccanismi di azione più diffusi nell’attualità non rispettano tale criterio, GIANGRANDE riprende DRYZEK per argomentare sulla necessità di pensare a una strategia di azione fondata su tre principi: “- Rinuncia a una razionalità analitico-strumentale a favore di un tipo di razionalità fondata sulla ragione pratica e sulla decentralizzazione radicale234; - Graduale transizione al nuovo sistema attraverso un processo interattivo per tentativi ed errori; - Identificazione di meccanismi capaci di facilitare, se necessario, la loro stessa capitolazione, attraverso l’esercizio della scelta sociale collettiva autocosciente” (GIANGRANDE, 1998:112). Le strategie di produzione sociale del territorio possono avvenire all’interno di laboratori di progettazione ecologica e territoriale. Essi, “oltre a promuovere la partecipazione degli abitanti alla produzione di piani e progetti, hanno il compito di avviare il processo di autoidentificazione e sviluppo delle comunità locali con attività dirette a favorire la trasformazione degli attuali meccanismi di scelta sociale in altri più rispondenti ai criteri di razionalità ecologica” (GIANGRANDE, 1998:114). L’autore richiama l’attenzione sulla difficoltà di partecipazione dei cittadini a questi laboratori e considera che essa, anche se non impedisce lo svolgimento delle attività più propriamente progettuali, pone dei limiti alla possibilità di sperimentare azioni di più vasta portata235. Per ragione pratica, l’autore intende le scelte collettive orientate all’azione e operate, prese per via discorsiva, ossia, le scelte risultate da un ampio dibattito dove ogni partecipante sia capace di prendere parte alla discussione per sostenere le proprie idee e confutare le altrui. Per decentralizzazione radicale, invece, intende la capacità delle comunità locali di operare in relativa autonomia e di prendersi cura degli ecosistemi da cui dipendono. Perché ciò si possa concretizzare, il cambiamento deve venire dall’interno, attraverso un processo di costruzione di identità capace di dare origine a quello che egli chiama le comunità autodeterminate. 235 Tra le ragioni della non partecipazione, GIANGRANDE elenca quelle che ritiene essere le più importanti: il rifiuto da parte di alcuni, ormai abituati a delegare ad altri la gestione della cosa pubblica, di svolgere attività che richiedono impegno e volontà di autodeterminazione; la diffidenza, da parte di altri, verso la validità e il potere dell’azione di questi laboratori contro un potere ben organizzato che non esita in difendersi; la mancanza di tempo libero necessario alla partecipazione da parte di quelli più motivati. 234 283 Avendo come scopo la valorizzazione del patrimonio territoriale236 messo in pratica dalla società locale, la questione della sostenibilità assume un'altra dimensione. Innanzitutto, essa viene rivolta al territorio, e ciò richiede l’utilizzazione di un sistema complesso e multisettoriale di indicatori di sostenibilità – la sostenibilità politica, economica, sociale, territoriale e ambientale237 –, attraverso un approccio plurale che sposti l’obiettivo degli interventi dalla salvaguardia e recupero dell’ambiente a quello della valorizzazione del territorio, tenendo conto dello stretto legame esistente tra stili di sviluppo e sostenibilità. Fondamentale a questo scopo è lo studio dell’identità del luogo e l’individuazione del tipo territoriale, indici capaci di fornire le regole da rispettare, gli esempi e gli indizi da seguire in modo da accrescere il suo valore. Tale processo, quando condotto dalla società locale, induce alla riappropriazione dei saperi locali e rimette alla luce i valori della cooperazione, della solidarietà, del mutuo appoggio e delle relazioni comunitarie. Il territorio così riacquista profondità e ricchezza, tramite l’inizio di un nuovo ciclo di territorializzazione. In altre parole, è necessario considerare il territorio “un patrimonio da cui attingere per produrre ricchezza, continuando, attraverso la produzione di nuovi atti territorializzanti, ad aumentarne il valore” (MAGNAGHI, 2000b:24). L’avvio del processo di produzione/valorizzazione del territorio si dà, secondo l’autore, a partire dal rifiuto di modelli di sviluppo esogeni e dal recupero dell’identità locale nelle sue forme espressive, comunicative e tecniche, fondanti lo stile di sviluppo. La produzione di territorio e di sviluppo, quindi, non può essere esportabile ma deve essere frutto di un rapporto armonico fra insediamento umano e ambiente, della valorizzazione delle differenze che caratterizzano i diversi luoghi e ne donano individualità. In altre parole, esso dev’essere, come sottolineato nel paragrafo precedente, un processo endogeno. Così, in uno scenario in cui la crescita economica non è più sinonimo di crescita di ricchezza, un progetto di sviluppo locale che abbia come obiettivo la valorizzazione del patrimonio territoriale deve avere come referente gli abitanti/produttori e la loro Il patrimonio territoriale viene inteso come il risultato del processo storico della territorializzazione nel quale si integrano le componenti ambientali, edificate e antropiche e le cui modalità di integrazione esprimono il valore relazionale del patrimonio e il suo potenziale di produzione di ricchezza durevole, come trattato nel primo paragrafo. 237 L’autore intende per sostenibilità politica una elevata capacità di autogoverno di una comunità insediata rispetto alle relazioni con sistemi decisionali esogeni e sovraordinati; per sostenibilità economica, la capacità di un modello di crescita di produrre valore aggiunto territoriale; per sostenibilità sociale, il raggiungimento di un elevato livello di integrazione degli interessi degli attori deboli nel sistema decisionale locale (equità sociale e di genere); per sostenibilità territoriale, la capacità di un modello insediativo e delle sue regole di produzione e riproduzione di promuovere processi di riterritorializzazione; infine, per sostenibilità ambientale, l’attivazione di regole virtuose dell’insediamento umano, atte a produrre “autosostenibilità” (MAGNAGHI, 2000a, 68 e ss.gg). 236 284 riconquista del territorio238. Inoltre, l’autore richiama l’attenzione sul fatto che “la sostenibilità dello sviluppo richiede una dimensione complessa, integrata della trasformazione ecologica del territorio, rendendo compatibili e coerenti sostenibilità culturale (il rito di fondazione, la cittadinanza, il municipio, l’autogoverno), economica (la conversione ecologica dell’economia, l’affermazione dell’economia della natura, lo sviluppo di economie territoriali dove siano garantiti gli interessi dei più deboli), geografica (la democrazia territoriale, le reti non gerarchiche e solidali di città), ambientale (la coerenza degli insediamenti umani con la qualità degli ecosistemi)” (MAGNAGHI, 2001:40). Per avviare questo processo, un passo fondamentale è l’individuazione sul territorio degli attori che si muovono nella direzione della sostenibilità. “Autosostenibilità e autodeterminazione, sviluppo sostenibile e sviluppo autocentrato divengono [così] concetti strettamente interdipendenti; il concetto di autosostenibilità allude alla necessità di un profondo ridimensionamento dell’«economico» (…) e alla necessità di un contemporaneo sviluppo del ruolo delle istituzioni locali. È necessario un forte processo di decentralizzazione che consenta il rafforzamento di pratiche di cooperazione e di partecipazione, e sviluppi nuove forme di comunità che garantiscano a loro volta nuovi processi di accumulazione di capitale sociale” (MAGNAGHI, 2000a:91). 2.3. Verso il cambiamento Perché si possa avviare il progetto di sviluppo locale autosostenibile, sottolinea MAGNAGHI, bisogna che ci siano gli “attori della trasformazione”, soggetti portatori di idee capaci di aprire la strada verso la costruzione della società locale e quindi dello sviluppo locale autosostenibile. Tali attori emergono dai movimenti sociali, dal conflitto con le istituzioni, dal tentativo di superamento delle nuove forme di povertà di cui si è trattato nel primo paragrafo. Bisogna saperli identificare e fare del conflitto un’occasione di avvio di un processo rivolto alla ricostruzione di un’identità locale. È nel riconoscimento di questi attori all’interno del territorio e nella ricostruzione della loro identità che si basa il 238 La valorizzazione del patrimonio territoriale è qui intesa come la produzione di nuovi atti territorializzanti capaci di aumentarne il valore. Oltre a questo atteggiamento verso il patrimonio territoriale, l’autore sottolinea l’esistenza di altri due che per molto tempo sono stati alla base delle politiche di progettazione territoriale, e cioè la dissipazione o distruzione e la conservazione. I primi due sono intesi sia come la decadenza e il degrado di intere aree per abbandono, mancanza di manutenzione e consumo di risorse non rinnovabili, sia come la messa in atto di azioni deterritorializzanti che intenzionalmente distruggono elementi del patrimonio in conflitto con gli interessi economici prevalenti. L’ultimo, la conservazione per le generazioni future, è intesa come lo stabilimento di limiti all’uso delle risorse attraverso il riferimento all’ecocompatibilità dello sviluppo economico. 285 processo di riterritorializzazione concretizzato attraverso la rifondazione/ricostruzione della città239. Il risultato di questo processo è il disseminarsi di comunità locali, intese come il “prodotto di relazioni fra differenze che trovano riconoscimento reciproco e regole di convivenza” (MAGNAGHI, 2000a:109). Facendo riferimento soprattutto a ciò che accade nelle città, MAGNAGHI richiama l’attenzione su quattro caratteristiche importanti di questo processo di costruzione delle comunità locali. La prima è il suo carattere diffuso, cioè, il passaggio da movimenti puntiformi sul territorio ad atteggiamenti che attraversano la vita quotidiana quali forme di associazionismo, di mutuo soccorso, ecc. La seconda è il suo carattere sempre più integrato, che si manifesta nell’allargamento della ricerca di soluzioni di problemi specifici ad altri settori apparentemente “esterni”; costruendo in tal modo soluzioni globali e più strutturate. La terza caratteristica è la diffusione di esperienze professionali autoriflessive, riscontrata nel cambiamento dell’atteggiamento di diversi professionisti che passano ad avere un’azione di maggior compromesso e interazione con la comunità locale, nel senso di cui ci parlava SCHUMACHER. La quarta “è l’uscita di molte esperienze comunitarie, in particolare esperienze di produzione economica «alternativa», dal loro carattere di nicchia e di marginalità per integrarsi con i tessuti produttivi in trasformazione, per segnarne l’evoluzione verso modelli di sviluppo sostenibili” (MAGNAGHI, 2000a:113). Un esempio di questo caso sono le esperienze che mettono insieme una pratica di valorizzazione delle risorse e culture produttive locali con nuovi circuiti di scambio, come è il caso della Fierucola biologica che si svolge a Firenze una volta al mese, dall’esperienza del Consorzio Radici di Suvereto, dal circuito del commercio equo e solidale. Queste esperienze, sottolinea MAGNAGHI, “si vanno consolidando in un contesto istituzionale in profonda mutazione, tanto che si può delineare un incontro a «mezza strada» fra iniziative istituzionali che scendono verso il basso e iniziative di base che salgono verso l’alto. Va sicuramente affermandosi il ruolo istituzionale dello sviluppo locale nella ricerca di modelli di sviluppo sostenibile nei quali il senso di appartenenza, le identità locali, i modelli socio-culturali di lunga durata, in breve la costruzione delle società locali, divengono il prerequisito per una corretta valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali” (MAGNAGHI, 2000a:115). La costruzione delle società locali – che, sottolinea MAGNAGHI, non può essere inventata, ma deve fondarsi sulla valorizzazione del tessuto comunitario esistente – diventa così un’importante garanzia della sostenibilità dello sviluppo. In questo senso, il compito delle istituzioni è quello di valorizzare le 239 Secondo l’autore, i principali attori di questa trasformazioni sono gli esclusi, quello che costruiscono ciò che, richiamando PABA, egli chiama “insurgent city”. 286 iniziative positive esistenti sul territorio per poter dare attuazione a strategie di sviluppo locale autosostenibile. I requisiti per il successo delle esperienze di questo genere sono: • la trasformazione dell’abitante utente in abitante produttore, attraverso l’incentivo alla partecipazione cittadina ai processi decisionali e alla progettazione e cura del suo territorio; • la promozione di azioni capaci di rendere praticabili i progetti, attraverso finanziamenti pubblici e sviluppo di sinergie fra progetti di settore, ecc.; • la promozione di integrazione e intersettorialità, attraverso l’incentivo alla realizzazione di progetti integrati di sviluppo dei vari settori in un modo sinergico; • lo sviluppo di partnership, attraverso la costruzione di reti di scambio, soprattutto intersettoriali, rendendo così possibile il raggiungimento di tutte e cinque dimensioni della sostenibilità; • la realizzazione di sussidiarietà, attraverso l’attivazione di politiche integrative alle azioni e ai progetti locali già esistenti, ai fini di rendere possibile la costruzione della società locale; • la costruzione di addizionalità, attraverso la produzione di scenari locali condivisi da diversi attori – pubblici o privati – che, alla fine, abbia come risultato l’incentivo a una partecipazione sempre maggiore; • la promozione di diversità, attraverso l’incentivo alla ricerca di soluzioni locali, autoctone, endogene; • lo sviluppo e la valorizzazione dei saperi locali e, attraverso essi, la valorizzazione del patrimonio territoriale240. Un altro passo importante verso il cambiamento e quindi verso lo sviluppo locale autosostenibile è stato il riconoscimento della centralità del territorio e della comunità locale nell’elaborazione di ogni tipo di progetto di trasformazione e sviluppo socioeconomico del territorio. Tale cambiamento si è sviluppato, secondo CINÀ, in torno alle seguenti coordinate: “1) l’irruzione dei temi della questione ambientale, dei limiti dello sviluppo, della finitezza delle risorse ambientali; 2) la riscoperta dell’identità del territorio e del suo carattere evolutivo; il suo affermarsi come centro di un nuovo progetto sociale, a conclusione di un processo di concreto posizionamento del piano urbanistico nel quadro delle politiche territoriali; 3) la riscoperta della comunità locale come soggetto capace di elaborare istanze di sviluppo e di valorizzazione con forti ricadute sugli assetti insediativi; 240 MAGNAGHI, 2000a, p. 118 e ss.gg. 287 4) la (parziale) apertura ai saperi esperti extradisciplinari e ai saperi locali, che interagiscono con i percorsi conoscitivi tradizionali” (CINÀ, 2000:10). Il risultato di questo processo può essere ritrovato in due regioni italiane. Una, la Toscana, attraverso la Legge Regionale 5/95 e la creazione del concetto di statuto dei luoghi. L’altra, la Liguria, con l’introduzione nella legge urbanistica regionale del 1997 del dispositivo della descrizione fondativa. La legge toscana, oltre a stipulare l’identificazione delle invarianti strutturali – ciò che non può cambiare all’interno di un determinato territorio – “stabilisce anche di strutturare tale sistema di invarianti a favore dello sviluppo sostenibile, mediante la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini. (…) (…) Il documento SdL241 dovrebbe allora contenere almeno due cose: la descrizione/interpretazione della realtà territoriale nei suoi valori costitutivi e l’affermazione dei principi che devono orientarne la conservazione e/o il cambiamento. Tale documento potrebbe qualificarsi come un’intesa, un programma, un contratto o una carta di principi. La legge non dice nulla a proposito, ma riferisce lo statuto ai luoghi. Questo porta a una differenza sostanziale (…). Non si tratta di uno statuto che disciplina l’organizzazione e il funzionamento di organi istituzionali (come quello previsto dalla L. 142/90) o di strutture associative, ma piuttosto di un atto costitutivo di principi, obiettivi, valori; e soprattutto non disciplina i rapporti tra individui ma tra comunità e territorio” (CINÀ, 2000:11). Il carattere non vincolante della legge in ciò che si riferisce all’elaborazione dello statuto dei luoghi, secondo GIOVANNELLI, fa sì che esso possa essere formulato in tre modi diversi, a seconda delle impostazioni teoriche utilizzate. Nel primo caso, attenendosi letteralmente alla formulazione della legge242, lo statuto dei luoghi diventa “statuto delle invarianti strutturali”. Nel secondo caso, proponendo un’interpretazione più ampia della legge, lo statuto dei luoghi si occupa delle invarianti ma non solo, essendo in questo caso necessario precisare il concetto di luogo e di invariante strutturale. Nel terzo caso, sostituendo il concetto di luogo con quello di territorio, lo statuto dei luoghi diventa lo statuto del territorio. Sempre secondo l’autore, ogni “invariante può essere classificata in quattro categorie fondamentali: 241 242 SdL sta per statuto dei luoghi. “Articolo 5 – Norme generali per la tutela del territorio Comma 6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente legge inquadrano prioritariamente invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi descritti dall’articolo 1. Articolo 1 – Lo sviluppo sostenibile Comma 2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio”. Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995. Norme per il governo del territorio. 288 a) l’invariante è un «oggetto fisico»; b) l’invariante è una «caratteristica», una «regola», un «sistema di relazioni», ecc.; c) l’invariante è un «obiettivo prestazionale»; d) l’invariante individua i «caratteri fondativi» che contribuiscono a definire «l’identità dei luoghi»” (GIOVANNELLI, 2000:209). Rispetto alla nozione di invarianza, GIOVANNELLI sottolinea che essa può avere un carattere di natura intrinseca, cioè essere collegata a un concetto di persistenza positiva nel tempo, indipendente dalle scelte fatte dal piano, oppure avere un carattere meramente normativo, e, pertanto, essere completamente dipendente dalle scelte che nel piano vengono fatte. Un’altra precisazione che deve essere fatta si riferisce al termine strutturale. Secondo l’autore, esso “indica due possibili proprietà: quella di «porre in relazioni diversi elementi» e quella di «definire i caratteri di alcuni elementi dipendenti». Nel primo caso il concetto di struttura è prossimo a quello di «sistema»; nel secondo caso, strutturale è quello che condiziona – anche se non necessariamente determina – la forma di altri elementi” (GIOVANNELLI, 2000:210). L’autore richiama l’attenzione su quanto possa essere restrittivo pensare allo statuto dei luoghi come semplice elenco delle invarianti strutturali e sottolinea la necessità di aver ben chiaro il concetto di luogo intorno al quale si costruisce quello di statuto. Secondo lui, un “«luogo» può essere definito semplicemente come una parte di territorio che presenta una identità non banale, uno spazio dove interagisce una pluralità di dimensioni sia di natura geofisica, che di natura socio-economica e ambientale. (…) [Gli] elementi di invarianza in termini strutturali e culturali certamente concorrono alla definizione dell’identità di un luogo, perché contribuiscono alla sua riconoscibilità, alla consapevolezza da parte di una comunità dei suoi valori, ma da soli non ne esauriscono le componenti identitarie. Lo SdL dovrebbe pertanto basarsi sul riconoscimento di quelle regole, valori e caratteristiche che definiscono l’identità strutturale e culturale di un luogo, senza che necessariamente tali regole, valori e caratteristiche debbano essere tutte espresse in forma di invarianza. In quest’ottica si dovrebbe riconoscere che il territorio è formato da parti di maggior valore – i «luoghi» – e parti di minore valore – i «non luoghi» – che non necessitano di uno specifico Statuto per la loro tutela” (GIOVANNELLI, 2000:211). Per ciò che riguarda l’identificazione di statuto dei luoghi come statuto del territorio, l’autore sottolinea due possibili approcci. Il primo considera il territorio come un insieme di luoghi, ognuno dei quali dotati di un’identità propria. L’altro sostituisce semplicemente il concetto di luogo con quello di territorio. In questa identificazione, il concetto di invarianza, assumendo un carattere meramente normativo, viene assimilato alle condizioni 289 di trasformabilità, finendo lo statuto dei luoghi “per coincidere con le prescrizioni di un normale piano regolatore che definiscono (…) nient’altro che i criteri con cui si può intervenire sul territorio” (GIOVANELLI, 2000:211). Pensando quindi al territorio come un insieme di luoghi, ognuno dei quali dotati di un’identità propria, il primo passo verso la costruzione dello statuto dei luoghi sta nell’identificazione – tramite la ricerca di forme di descrizione, interpretazione e rappresentazione dell’identità del luogo – dei caratteri identitari e dei valori del territorio. Tale identificazione consente di elaborare un insieme di regole per la trasformazione del territorio, le quali, per il buon esito del piano, devono essere condivise dagli attori che in esso interagiscono. Tali regole hanno lo scopo di valorizzare il territorio nelle sue peculiarità e di dare a questa trasformazione durabilità243. Il cambiamento di questo approccio riguardo al territorio, che ha il suo apice nella costruzione dello statuto dei luoghi, è frutto del cambiamento del ruolo del territorio nella produzione della ricchezza, nel suo passaggio da supporto a risorsa, quale discusso nel primo paragrafo del presente capitolo. Stando così le cose, secondo MAGNAGHI, lo “statuto in quanto strumento di pianificazione per lo sviluppo locale, è un passaggio successivo alla descrizione dell’identità del luogo; esso definisce le invarianti strutturali, le modalità di trattamento dei valori territoriali (in quanto potenziali risorse), le regole di trasformazione e le loro ricadute sulla pianificazione ordinaria. Queste regole si precisano attraverso il confronto fra ciò che muta, che si trasforma, che viene usato e ciò che invece deve rimanere – le invarianti – come condizione necessaria non solo per la sopravvivenza e la stessa riconoscibilità dei luoghi, dotati ciascuno di un proprio statuto, di un ordinamento, di proprie regole costitutive, ma anche per la stessa proponibilità e sostenibilità del progetto di trasformazione” (MAGNAGHI, 2000a:124). La descrizione identitaria è, quindi, un documento che individua la struttura e il carattere di lungo periodo di un luogo, indipendentemente dagli usi che da esso si fanno o che possono essere fatti. Essa serve “ad arrivare ad un insieme di regole e norme che, riprendendo la tradizione locale, (…) può essere definito lo «Statuto dei luoghi». Ogni unità locale o paesaggistica o ambientale, identificata e riconosciuta localmente, sulla base non solo delle caratteristiche intrinseche del territorio ma anche e soprattutto delle pratiche e dei saperi territoriali locali, esprime un insieme di norme e modelli che regolano 243 “La norma fondamentale della Legge 5 relativa alla sostenibilità dello sviluppo rispetto alla dotazione delle risorse essenziali del territorio, implica che il quadro conoscitivo di ogni atto di pianificazione debba comunque contenere, oltre all’individuazione delle risorse essenziali presenti nel territorio oggetto del piano stesso, anche la loro quantificazione e l’apprezzamento del loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità” (GAMBERINI e GANDOLFI, 2000: 167). 290 tanto i processi di conservazione e riqualificazione quanto i processi di trasformazione” (QUAINI, 2000:63). Lo statuto dei luoghi è, poi, un atto “costituzionale” per lo sviluppo locale, un progetto socialmente condiviso tra i diversi soggetti che interagiscono nel territorio, gli “attori del cambiamento”. Ciò presuppone una conoscenza approfondita del territorio oltre che la condivisione, tra le parti coinvolte, della visione del territorio come patrimonio, come risorsa da valorizzare con l’obiettivo di arrivare all’autosostenibilità dello sviluppo. È, quindi, la costruzione di scelte di scenari strategici verso la realizzazione dello sviluppo locale autosostenibile244. La sua costruzione e soprattutto la sua messa in pratica costituisce una tappa fondamentale del fare società locale e, come tale, non può risultare un atto puramente amministrativo, ma deve coinvolgere tutti i settori della società interessati e persino attivare forme di democrazia partecipativa, dando così al nuovo municipio un nuovo ruolo. Costruzione “di scenari strategici, attivazione di istituti di concertazione, costruzione dello statuto dei luoghi fanno dunque parte di un complesso processo di trasformazione del modello di sviluppo verso la sostenibilità, che è insieme politico, culturale, progettuale, tecnico, amministrativo. (…) (…) Statuto dei luoghi e nuovo protagonismo del municipio costituiscono due movimenti convergenti. (…) Il nuovo municipio, che fonda lo sviluppo sulla valorizzazione del patrimonio, indirizza lo sviluppo economico: dunque si ipotizza un passaggio rifondativo dalla «amministrazione» al «governo» del territorio di cui lo statuto è la carta costituzionale” 244 “Lo scopo principale dello scenario è di aprire concreti spazi di intervento sociale (…) cambiando le variabili considerate nelle decisioni o modificandone il peso relativo” (MAGNAGHI, 1999:136). Esso disegna un futuro possibile, basandosi su comportamenti anomali o deboli, ma reali. “Il metodo di costruzione dello scenario consiste nell’interpretazione del progetto implicito in comportamenti e pratiche quotidiane, nell’evoluzione dei bisogni, nelle modificazioni strategiche del modello sociale e nella composizione sociale del lavoro. Ma occorre chiarire che lo scenario, inteso come interpretazione, non è una semplice trascrizione lineare di aspirazioni, bisogni, progetti espressi dal sociale; richiede una estrapolazione, uno scarto progettuale fra la lettura degli input provenienti dal sociale e il loro inserimento in un processo trasformativo della città e del territorio: il “compito” proveniente dal sociale deve essere armonizzato nel progetto rispetto all’obiettivo generale della sostenibilità: che consiste (…) nell’aumento del valore del patrimonio territoriale per le generazioni presenti e future. Lo scenario si crea nell’incontro fra la denotazione di energie innovative, contraddittorie con l’attuale sviluppo e l’interpretazione dei valori territoriali e ambientali di lunga durata (…) (…) La ricerca dello scenario strategico si alimenta, in sintesi, di due percorsi interagenti: a) evidenziare le tensioni, le forme, i movimenti, i comportamenti che potrebbero costituire la base concreta della costruzione del modello: si tratta di verificare e rendere progettualmente espliciti gli input che vengono dalle varie linee di opposizione alla globalizzazione dall’alto interpretandole rispetto all’organizzazione urbana e territoriale; b) sulla base di questa progettualità implicita elaborare (…) visioni di scenario urbano e territoriale, con una particolare attenzione alla contraddizione implicita fra modello idealtipico (…) e teoria dello sviluppo locale” (MAGNAGHI, 1999: 138/139). 291 (MAGNAGHI, 2000a:128). Uno dei compiti dello statuto dei luoghi è, quindi, quello di evidenziare qualitativamente e quantitativamente sia le attività economiche che i modelli insediativi con valori d’uso singoli e civici – diversi pertanto da quelli di puro sfruttamento economico e di mercato – con l’obiettivo di attuare trasformazioni che aumentino il valore del patrimonio territoriale. Secondo VENTURA, una sorta di statuto dei luoghi esiste già, ed è costituito dalle diverse norme contenute “nel coacervo di leggi che a vario titolo regolano, o vincolano, direttamente l’edificazione e l’uso del suolo. Alcune di esse sono indipendenti dai luoghi, ovvero sono le stesse in ogni luogo, altre sono in funzione della natura delle cose contenute nei luoghi (…). (…) E in ogni luogo possono giustapporsi le une alle altre i più vari tipi di norme” (VENTURA, 2000:170). Sempre secondo l’autore, gli studi da fare – le indagini e osservazione sul terreno, la descrizione e l’interpretazione dei dati ottenuti al fine di mettere in evidenza i valori ritenuti intrinseci di quel territorio – devono fondarsi sui principi dell’edificazione intesa come “l’arte, la téchne, la sapienza del costruire e abitare i luoghi” (VENTURA, 2000:179), da sempre presenti nel nostro pensare e agire. I tre principi che fondano questa accezione dell’edificazione sono la sicurezza, la bellezza e la comodità. Ognuno di questi gode, in occasione di una presa di decisione, dello stesso diritto di diventare il determinante, oppure di complementarsi con gli altri. In questa prospettiva, lo statuto dei luoghi diventa lo strumento che permette di integrare tra loro questi tre principi sia amministrativamente che concettualmente, attraverso l’interpretazione e la descrizione della totalità del territorio fatta di modo unitario. Da quanto detto si capisce che la prospettiva di azione e gli scopi dello statuto dei luoghi sono molto diversi da quelli della scienza moderna, soprattutto per quanto riguarda lo stabilimento dei vincoli e dei limiti all’uso delle risorse presenti in un territorio245. L’autore ricorda la necessità di descrivere il territorio luogo per luogo, e questo perché ognuno è diverso da un altro, ognuno ha le sue qualità, le sue caratteristiche, i suoi valori, affinché sia possibile identificare ciò che esiste “da conservare e riprodurre, da curare e mantenere in essere o da lasciare al corso naturale del ciclo di vita; quali sono le risorse suscettibili di uso senza consumo, di trasformazione senza distruzione. Occorre identificare (…) i vari luoghi e valutare quale loro identità si vuol mantenere nel tempo e nello spazio. E 245 VENTURA ritiene che mentre la scienza indaga sui vincoli della natura per poterli violare e così propiziare il progresso della tecnica e della tecnologia, lo statuto dei luoghi cerca di stabilire limiti al suo uso per garantire la sua valorizzazione e trasmissione alle generazioni future. Per questa ragione, secondo lui, esso non può essere fondato soltanto sulla scienza, ma deve servirsi di principi, quali quelli appena citati, che hanno una logica che va oltre quella proposta dalla razionalità scientifica. 292 dovrà essere questa complessa, molteplice e varia realtà territoriale, democraticamente e istituzionalmente riconosciuta, nelle sue articolazioni locali e nell’insieme regionale, il limite e il riferimento della pianificazione, come di ogni altra azione sociale e individuale” (VENTURA, 2000:211). Lo statuto dei luoghi deve, inoltre, “considerare la totalità del territorio come una «bellezza naturale» variamente articolata: molteplice varietà, insieme di bellezze e bruttezze (…), manifestazione processuale della sua complessa storia civile e naturale. Esso potrà così tradurre in diritto pubblico la tutela di quei valori di bellezza, tradizione, esperienza convenuti dagli abitanti, residenti abituali e saltuari” (VENTURA, 2000:191/2) 246. Nel documento che compone lo statuto dei luoghi, viene lasciato spazio a una dialettica considerata costruttiva tra i diversi livelli territoriali di governo. “Da un lato, si vuole che ogni livello amministrativo pianifichi nell’ambito di funzioni chiaramente definite, in modo da evitare conflitti di competenze, garantire l’efficienza dell’azione e non avere subordinazioni gerarchiche. Dall’altro, si afferma che tra i diversi livelli debba stabilirsi cooperazione e sussidiarietà, perché si vuole che la molteplicità delle azioni di piano converga «in un progetto di trasformazione sostenibile del territorio»” (VENTURA, 2000:200/1)247. In quest’ottica, lo statuto rappresenta il principio, il piano, l’azione di sviluppo, in particolare di quello autosostenibile. VENTURA richiama ancora l’attenzione sul fatto che qualsiasi forma di pianificazione, a qualunque livello, che abbia come obiettivo il raggiungimento di forme di sviluppo locale autosostenibile deve confrontarsi con la realtà presente nel territorio e allo stesso tempo essere con essa compatibile e condivisa dalla comunità insediata. Deve, quindi, essere elaborata in conformità con lo statuto dei luoghi il quale, “aderendo a quell’unicum che è la realtà del territorio riconosciuta e codificata dalla comunità, garantisce la continuità e la stabilità, a tempo indeterminato, delle sue varie risorse e delle sue molteplici qualità, per le generazioni presenti e per quelle future” (VENTURA, 2000:210). Infine, sottolinea l’importanza – per quello che riguarda l’elaborazione di progetti di sviluppo locale autosostenibile – dei valori estetici e di quelli che trascendono l’aspetto meramente utilitario rispetto a un luogo o a un territorio, e ritiene che l’elaborazione dello statuto dei luoghi possa essere una delle occasioni di dare concretezza a questi valori. Secondo lui, essi “devono fondarsi su una conoscenza del territorio che unisca, e integri organicamente, alle analisi delle scienze naturali le descrizioni estetiche luogo per luogo. E se 246 247 La legge sulla tutela delle bellezze naturali e storiche vincola la bellezza alla tradizione, in un tentativo di ridurre l’aleatorietà che un giudizio strettamente estetico rischia di realizzare. L’autore richiama l’attenzione sul fatto che il termine sussidiarietà indica due cose diverse: da un lato, sussidio, aiuto; dall’altro, il fondamento della cooperazione tra i diversi livelli di governo. 293 le prime hanno per protagonisti soprattutto gli esperti, nelle seconde anche tutti i cittadini hanno capacità potenziale di partecipazione: ciascuno è in grado di sentire, valutare, descrivere ed esprimere i sentimenti correlati al paesaggio, alla città nel paesaggio e al paesaggio nella città, alle «bellezze naturali», ai valori estetici e figurali dei luoghi abitati. Di ciò è testimonianza la sempre più frequente e diffusa formazione spontanea di comitati locali di cittadini quando vi è un progetto di trasformazione che incombe sul loro ambiente di vita. Tutto sta a organizzare la partecipazione, coinvolgendo, ad esempio, anche le associazioni ambientaliste e culturali. Gli «statuti dei luoghi» dovranno articolare, specificare e rendere concretamente operativa – oltre la consueta tutela del patrimonio storico, opportunamente potenziata, rinvigorita e arricchita – la regola generale riguardante la totalità dello spazio: niente può essere posto in funzione che non sia anche in rappresentazione, e – quale suo corollario – un intervento di trasformazione non può essere attuato se non è possibile conferirgli la rappresentazione richiesta, se la sua intrinseca natura è tale da sconvolgere e sovvertire la locale composizione del paesaggio” (VENTURA, 2000:218/9). La veste giuridica dello statuto dei luoghi “può essere quella di un sistema di vincoli, limiti e restrizioni allo sfruttamento economico del territorio, modulato sui luoghi che lo compongono e lo strutturano. Dovrà completare lo Statuto un «Regolamento edilizio e d’uso» (…). Lo Statuto ha validità a tempo indeterminato, riguarda l’intero territorio comunale, e deve essere approvato da una maggioranza qualificata. La natura giuridica dei vincoli che impone, essendo essi fondati su valori riconosciuti intrinseci dei beni interessati, è identica, sul piano del diritto, a quelli paesistici e simili” (VENTURA, 2000.172/3). Esso ha sul territorio lo stesso valore della Carta Costituzionale, e per questo deve, oltre a essere sovraordinato, avere validità per tempo indeterminato, e cioè, deve rimanere in vigore fin quando gli abitanti di quel luogo continuino a riconoscersi in esso, a considerare i suoi valori utili, fondati e validi. Esso può essere modificato tramite la presentazione di progetti o di qualsiasi altro tipo di evento che testimoni che i valori sui quali esso era stato costruito non sono più condivisi. Secondo MAGNAGHI lo statuto dei luoghi potrebbe essere composto di quattro capitoli. Il primo, intitolato L’identità del luogo: descrizione, interpretazione, rappresentazione e organizzato sotto forma di una mappa, ha un’importanza fondamentale nel rappresentare le diverse fasi del processo di territorializzazione, permettendone così una migliore interpretazione e una migliore identificazione del tipo territoriale, delle invarianti strutturali, dell’identità del luogo con l’obiettivo di una migliore definizione delle strategie verso la valorizzazione del patrimonio territoriale. Tale mappa deve essere organizzata 294 attraverso “la costruzione di un sistema complesso di trasmissione di conoscenze territoriali, articolato su tutto lo spettro delle forme e dei mezzi di descrizione, raffigurazione, comunicazione e racconto. Un sistema informativo che contiene la rappresentazione dei caratteri identitari e paesistici di lunga durata, dei sistemi ambientali e del loro funzionamento, del milieu locale, della società locale e dei suoi attori. Una specie di ipertesto che integra sistemi di rappresentazione premoderna e sistemi informatizzati per costruire un ritratto del territorio” (MAGNAGHI, 2000a: 132/3). Tutto questo deve essere fatto tenendo conto “a) che non tutto [può] essere trasformato e che le strutture territoriali e ambientali che definiscono l’identità di lungo periodo di un luogo [devono] permanere ed essere valorizzate; b) che ciò che può essere trasformato deve sottostare a regole che producano incremento di territorialità (riproducibilità del ‹‹tipo territoriale››, delle risorse, aumento della fertilità dei suoli, sviluppo della comunità locale, incremento della qualità ambientale ed estetica, ecc.)” (MAGNAGHI, 2000b:30). Il secondo capitolo, L’atlante identitario, avendo come contenuto i valori territoriali, ambientali e socioculturali del luogo in questione, è composto come un sistema informativo dei caratteri costitutivi del patrimonio attraverso una rappresentazione di tipo unitaria. Esso potrebbe essere suddiviso in tre “paragrafi”248, tutti e tre costruiti con un approccio innovativo rispetto alle forme di rappresentazione tradizionali: “a) il patrimonio ambientale e costruito dei luoghi (geografia fisica); b) il patrimonio socioeconomico e culturale (geografia socioeconomica); c) le nuove pratiche sociali (geografia politica)” (MAGNAGHI, 2000a:134). Nel primo “paragrafo”, la parte relativa al patrimonio ambientale, prevede il passaggio dalla definizione discontinua delle aree protette (“riserve di natura”) all’intero territorio (compreso quello urbanizzato) analizzato e definito in chiave ecosistemica. La parte relativa al territorio costruito, prevede a sua volta la descrizione della costruzione storica del territorio e della formazione della sua identità in coevoluzione con i caratteri dell’ambiente e riguarda il processo di territorializzazione, i sedimenti di lunga durata e i valori territoriali. MAGNAGHI sottolinea l’importanza di questo cambiamento, una volta considerato il ruolo che gli spazi aperti assumono sia nel processo di riqualificazione ambientale sia nello stabilimento di ciò che egli chiama relazioni virtuose tra città e territorio. Nel secondo “paragrafo”, quello sul patrimonio socioeconomico e culturale, vengono sottolineati due aspetti importanti: uno, la necessità di inserire la descrizione delle identità socioculturali collettive di lungo periodo data la loro importanza nella formazione di 248 L’autore usa il termine “capitolo”, ma ho preferito cambiare il termine per non confondere con le divisioni più generali da lui proposte per la costruzione dello statuto dei luoghi. 295 statuti condivisi tra i diversi attori coinvolti, così come di stili di sviluppo peculiari, incentrati soprattutto sulla valorizzazione delle identità collettive presenti nel territorio. L’altro aspetto, lo “studio e descrizione dei sistemi territoriali locali per individuare: attori e sistemi di attori potenziali interagenti con il milieu in chiave di trasformazione dei valori in risorse verso esiti di sostenibilità; reti di attori per la formazione di patti condivisi che stanno alla base del progetto di statuto e delle sue regole di trasformazione del territorio; sistemi di azione economica (nodi e reti del sistema locale) che si fondano sulla sostenibilità attraverso la valorizzazione del patrimonio territoriale e della municipalità nel governo dello sviluppo” (MAGNAGHI, 2000a:135). Infine, il “paragrafo” sulle nuove pratiche sociali, “evidenzia in particolare la nuova geografia sociale del territorio che descrive le insorgenze contro l’omologazione e l’impoverimento prodotti dalla globalizzazione” (MAGNAGHI, 2000a:136). Il terzo capitolo, intitolato Le norme statutarie, sarebbe anch’esso suddiviso in due parti: “a) una serie di principi generali e specifici di sostenibilità; b) un capitolo dedicato all’integrazione dei vincoli e alle invarianti strutturali” (MAGNAGHI, 2000a:138). Rispetto alla prima parte, l’autore sottolinea l’importanza della definizione dei principi generali e specifici di sostenibilità come prerequisiti a ogni statuto dei luoghi dato che a diversi livelli di degrado devono corrispondere diverse risposte. Rispetto alla seconda parte, sottolinea il suo carattere sperimentale data l’unicità dei componenti che integrano e determinano l’identità di ogni luogo. Secondo lui, le “invarianti strutturali dovrebbero indicare i caratteri identitari di questi «beni»249, costituenti il valore di un luogo rispetto ai quali caratteri attivare direttive, prescrizioni, azioni per la tutela e la valorizzazione secondo obiettivi prestazionali riferiti alla sostenibilità dello sviluppo, dal momento che è la permanenza e la durevolezza di tali caratteri a costituire l’indicatore principale della sostenibilità” (MAGNAGHI, 2000a:141). Infine, il quarto capitolo, intitolato Le regole della trasformazione, sarebbe composto da una serie di regole identificate con l’obiettivo di promuovere l’aumento del valore del patrimonio territoriale in modo durevole – per esempio regole a carattere multisettoriale e integrato per gli spazi aperti e l’agricoltura; regole per la riqualificazione, espansione e costruzione di nuovi insediamenti; regole finalizzate alla chiusura dei cicli – di acqua, rifiuti, ecc. -; relative all’uso di materiali da costruzione, ecc. – tutto questo avendo come scopo il raggiungimento della sostenibilità dello sviluppo. 249 L’autore si riferisce “a «beni» che possono configurarsi come i caratteri fondativi dell’identità locale, invarianti non per disposto normativo, ma nel senso che non sono variati nei tempi lunghi dei cicli di territorializzazione e che riguardano sistemi ambientali, reti ecologiche, bacini idrografici, sistemi costieri, paesaggi storici, tipologie insediative territoriali e urbane caratterizzanti l’identità di lunga durata, tessuti agrari” (MAGNAGHI, 2000a: 141), ecc. La nota è mia. 296 Da parte sua, la legge urbanistica ligure del 1997 introduce il dispositivo della descrizione fondativa a scala provinciale e comunale. D’accordo con questa legge, le finalità della descrizione fondativa “sono essenzialmente quattro: 1. individuare le identità dei luoghi ovvero le peculiarità e le potenzialità dei diversi ambiti o sistemi locali del territorio, rappresentando e interpretando gli assetti e i processi territoriali che ne sono all’origine (punto di vista verticale o del «milieu» locale); 2. individuare le prospettive di trasformazione, valutando le opportunità di natura economicosociale in rapporto alle risorse locali e alle reti che connettono i sistemi locali ad ambiti più vasti (punto di vista orizzontale); 3. incrociando il punto di vista verticale e quello orizzontale, costruire il modello di sviluppo locale sostenibile, che, valutando il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni di ogni singolo ambito (= verifica di sostenibilità), permette di fondare la distinzione fra ambiti di conservazione e riqualificazione e distretti di trasformazione, sia relativi alle aree di trasformazione urbanistica che alle aree di produzione agricola (a loro volta distinte in aree di presidio ambientale e aree non insediabili) e definire la disciplina paesistica di livello puntuale, la dotazione di servizi e infrastrutture, le norme di conformità, ecc.; 4. costruire un GIS locale che alimentandosi alla banca-dati del sistema informativo territoriale della Regione, possa a sua volta alimentarlo” (QUAINI, 2000:92). A livello provinciale, la funzione più significativa della descrizione fondativa è quella di “individuare gli ambiti «caratterizzati dalla ridotta complessità dei processi urbanistici e insediativi, dalla omogeneità degli aspetti fisici e paesistici dei siti, dalla sostanziale identità dei processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative, dalla affinità dei processi socio-economici in atto e da un assetto delle reti e delle infrastrutture di urbanizzazione appoggiate su di un impianto principale di scala sovracomunale» (art. 18). (…) Al livello comunale «la descrizione fondativa analizza le peculiarità, gli eventuali squilibri e le potenzialità del territorio in vista dell’individuazione dei conseguenti obiettivi di piano e della definizione dei contenuti del piano urbanistico comunale (Puc)» (art. 25)” (CINÀ, 2000:13). Sempre a livello comunale, secondo QUAINI, essa si caratterizza come un patto fra i cittadini per promuovere comportamenti virtuosi e progetti sostenibili. Per poter raggiungere questo obiettivo, la descrizione fondativa deve essere partecipata e coinvolgere i saperi locali e quelli tecnici e professionali. L’autore ritiene che è soltanto attraverso la valorizzazione effettiva del livello locale che la descrizione fondativa può raggiungere il suo scopo e la sua reale efficacia fondativa del progetto. Insomma, così come lo statuto dei luoghi, la descrizione fondativa precede il piano, fornendo le conoscenze necessarie – le condizioni e le risorse del territorio – su cui fondare i suoi obiettivi e 297 definire le strategie di azione per la sua valorizzazione, nell’ottica dello sviluppo locale autosostenibile. L’analisi che essa contiene riguarda i seguenti aspetti: “a) i caratteri fisici e paesistici dei siti (naturali e storico-antropici, vegetazionali ed insediativi), nonché i principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità; b) i processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto nonché i prevalenti caratteri d’identità dei luoghi; c) i processi socio-economici in atto e le reti di relazione (locale e territoriale) anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative; d) le prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e il complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato; e) il quadro di riferimento dei vincoli territoriali esistenti e dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente (…) Se quelli citati sono i nuovi riferimenti concettuali dell’impianto normativo della DF quali siano le forme e i mezzi per operare dette analisi e sintesi interpretative la norma non lo dice. Essa precisa però i risultati che si vogliono ottenere: a) una descrizione/interpretazione degli assetti e dei processi territoriali; b) la valutazione del grado di stabilità ambientale e della suscettività alle trasformazioni; c) la valutazione delle opportunità di natura economico-sociale rapportate all’uso delle risorse territoriali ed alle prospettive della loro trasformazione; d) la definizione della disciplina paesistica di livello puntuale degli ambiti di conservazione e riqualificazione e dei distretti di trasformazione; e) l’implementazione del sistema delle conoscenze” (CINÀ, 2000:13/4). Per rispondere a tale sfida si richiede implicitamente un cambio nella metodologia di indagine che sia in grado di costruire un piano che allo stesso tempo presenti scenari di sviluppo per il territorio, sia progettuale, condiviso dagli attori sociali coinvolti e che faccia riferimento non solo ai saperi tecnici ma anche a quelli locali. È ancora QUAINI a richiamare l’attenzione sul fatto che, così “come storicamente l’insediamento sparso è andato di pari passo con la colonizzazione agricola, (…) oggi una nuova forma di colonizzazione o comunque di conservazione attiva e sostenibile delle risorse richiede nuove forme insediative da studiare al di fuori degli schemi conservazionistici troppo 298 rigidi espressi dal Parco naturale e dal PTCP. Infatti la normativa dell’uno e dell’altro tendevano a confondere lo spazio agrario abbandonato con lo spazio naturale e conseguentemente a proteggerlo da ogni tipo di intervento nella speranza, che si è rivelata un’illusione, che tale spazio evolvesse naturalmente verso ecosistemi in equilibrio. A prescindere dalla conseguenza negativa di scoraggiare qualsiasi ripresa delle pratiche agro-silvo-pastorali (le uniche in grado di conservare attivamente questi spazi), l’unica conseguenza positiva è stata quella di bloccare, laddove vi era una pressione di questo tipo, l’edificazione selvaggia e diffusa e quindi di mantenere alla collettività un’ampia riserva di spazio che tuttavia oggi, proprio per essere goduta dalla collettività, deve essere suscettibile di trasformazione o antropizzazione controllata” (QUAINI, 2000:100). Per concludere, CINÀ richiama l’attenzione sulle differenze esistenti tra le due leggi. La legge ligure presenta la descrizione fondativa come un elenco articolato “di componenti, corrispondenti a specifiche analisi conoscitive e sintesi interpretative[, amplificando] (…) sensibilmente il tradizionale campo di applicazione del piano, nel senso che guarda a dimensioni del territorio prima poco o punto esplorate, e che per tale occorrenza presuppone un allargamento delle ottiche disciplinari da impegnare nello studio del contesto territoriale. (…) Per contro la norma toscana non offre una specificazione delle operazioni da condurre per costruire lo [statuto dei luoghi] (…). (…) Non si costituisce come norma regolativa, ma piuttosto come affermazione di un principio; è portatrice di una valenza politica riferita alle istanze della sostenibilità dello sviluppo del territorio e della società locale” (CINÀ, 2000:14/5). La ricerca di forme alternative di sviluppo, come lo sviluppo locale autosostenibile discusso in questo capitolo, implica un cambiamento di prospettiva e di atteggiamento rispetto allo sviluppo economico, la ridefinizione di contenuti e modi di produzione, selezionati e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio territoriale. È il caso, per esempio, di ciò che avviene con esperienze pilota quali il progetto integrato di agricoltura sostenibile della Val Bisenzio; la pratica dell’agricoltura naturale e l’agricoltura sinergica; le esperienze di produzione biologica con la vendita diretta al consumatore attraverso la fierucola a Firenze; l’esperienza Radici, nella Maremma, composta da una rete di produttori agricoli con funzioni educative e di rete di commercializzazione; i vari gruppi di Acquisto Solidale (GAS), concretizzati tramite accordi diretti tra produttori e consumatori; l’esperienza del commercio equo e solidale, esperienze queste che saranno trattate nel capitolo successivo. 299 CAPITOLO 8 LO SVILUPPO LOCALE AUTOSOSTENIBILE NELLA PRATICA I. VERSO UN’ALTRA PRODUZIONE 1. «Laboratorio Toscana»: l’ANCI Toscana e l’Università per la sostenibilità dell’agricoltura Partendo dalla necessità di trovare la strada verso una pratica agricola autosostenibile per il territorio toscano, l’ANCI Toscana250 mise in pratica nel 1994 un piano d’azione rivolto al potenziamento del ruolo dei Comuni nell’ambito dell’agricoltura. L’obiettivo, più che salvaguardare il paesaggio toscano, era quello di trovare un modo di valorizzarlo, sulla base delle discussioni che erano state iniziate dalla scuola territorialista di MAGNAGHI quali trattate nel capitolo precedente. Nel 1995 si videro i primi risultati con la realizzazione di un convegno promosso dall’associazione e svoltosi a Lido di Camaiore, con la partecipazione di amministratori, cittadini e mondo scientifico, dando vita a un proficuo dibattito sulle possibilità di messa in pratica di uno sviluppo sostenibile nella campagna toscana e sul ruolo dei Comuni in questa direzione. Da questo convegno emerse la necessità di pensare a nuovi criteri di progettazione, pianificazione e regolamentazione degli spazi aperti che comprendessero tutti i settori economici e non solo quello agricolo. A questo scopo fu nominata una commissione coordinata dal Prof. Alberto MAGNAGHI e composta da membri dell’ANCI Toscana ed esperti delle tre università toscane, del CNR e dell’IPERT con l’obiettivo di delineare tali criteri. Nel frattempo l’ANCI Toscana firmò un “protocollo d’intesa con il CTPB (Coordinamento Toscano Produttori Biologici) per l’utilizzazione di prodotti biologici nelle mense comunali. (…) Al tempo stesso, poiché un solo Comune non [poteva] essere in grado di rispondere, con qualunque programmazione, a 250 Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione Toscana. 300 tutte le esigenze della collettività – i confini amministrativi, sia comunali che provinciali, possono divenire anacronistici e non funzionali – [si ritenne] che [dovesse essere] valutato il potenziale delle ‘omogeneità territoriali’, base per una vera valorizzazione oggettiva e soggettiva del regionalismo” (ANCI TOSCANA, 1996: 6). Il risultato di questi lavori è stato la pubblicazione del manifesto Agricoltura e territorio: un laboratorio per lo sviluppo sostenibile della Toscana e al tempo stesso l’individuazione di tre aree, tenendo conto del concetto di “omogeneità territoriali”, dove si potesse verificare la validità dell’approccio proposto: la Valdichiana, la Val di Cornia/Colline Metallifere e la Bassa Valdelsa/Valdarno inferiore. 1.1. Un manifesto per la Toscana Il punto di partenza del suddetto manifesto è stata la consapevolezza che la crescita della produzione non vuol dire necessariamente crescita del benessere. Anzi, il modello di sviluppo dominante ha spesso trascurato questo secondo punto, a spese dell’ambiente e della qualità della vita della collettività insediata. Gli autori del manifesto ammettevano quindi come priorità l’identificazione di nuovi indicatori di misura dello sviluppo, della qualità ambientale, della ricchezza, “in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate; di selezionare processi che [aumentassero] la produttività media delle risorse; di valutare in modo appropriato il peso e il ruolo del capitale naturale, dei cicli della biosfera, della materia e dell’energia. In questo cambiamento epocale della scala di valori dello sviluppo [assumevano] un ruolo centrale proprio i fattori rimossi o degradati dalla crescita industrialista e dal potere esclusivo del mercato: i valori e le identità territoriali e urbane; l’agricoltura tradizionale e la sapienza ambientale che l’[accompagnava]; i sistemi ambientali relitti ma non ancora desertificati; i luoghi e gli insediamenti storici accerchiati dalle periferie della metropoli; i saperi e le culture contestuali; le manifatture locali e i sistemi appropriati di produzione e di servizio; gli ordinamenti insediativi e colturali della collina e della montagna” (ANCI TOSCANA, 1996: 7/8). La scommessa era quella di trovare un dialogo tra le energie creatrici della società e i sedimenti di lunga durata presenti nel territorio che si voleva valorizzare. Gli autori del manifesto ritenevano all’epoca che nella Toscana esistessero tante risorse da valorizzare come per esempio il patrimonio storico archeologico, forestale e naturalistico; il paesaggio agricolo collinare che conservava ancora i suoi caratteri originari; il paesaggio montano; il paesaggio costiero; il mantenimento di modelli socioculturali antichi (le tradizioni civiche, le feste, i momenti di identificazione collettiva, l’abitudine 301 dell’autogoverno); la microimprenditorialità diffusa; la qualità della cultura amministrativa (regole del “buon governo”), ecc. Secondo loro, mantenendosi i livelli e i ritmi di sviluppo in corso, essi rischiavano non solo il degrado ma contribuivano a suddividere il territorio in aree “ricche” e “povere”. Con lo scopo di evitare tale spaccatura, gli autori proponevano il superamento dell’idea di doppio regime d’uso del territorio e la sua conseguente divisione in aree degradate e aree risanate (tra cui i parchi e le aree protette). Il cammino verso la sostenibilità passava, secondo loro, dall’unione di queste due aree: era il territorio nel suo complesso, inteso come un tutto unico – e non le singole aree – che doveva essere valorizzato. Pensando sempre al territorio toscano e più specificamente alle reti di relazioni tra le piccole città esistenti, gli autori consideravano già presenti gli elementi che avrebbero permesso di vincere la sfida dello sviluppo sostenibile, intesa come produzione di “ricchezza diffusa – calcolata secondo i nuovi parametri di valutazione –, alta qualità territoriale e alti livelli di comunicazione, senza distruggere l’ambiente, senza inseguire la logica della concentrazione, dell’omologazione, dell’intasamento, dell’agglomerazione” (ANCI TOSCANA, 1996: 12). Riguardo al settore agricolo, gli autori ritenevano superata la visione dell’agricoltura come un settore marginale e residuale – frutto della suddetta concezione di sviluppo economico – ritenendo necessario passare da uno sviluppo tradizionale che privilegiava un solo tipo di agricoltura – realizzata in superfici di coltivazione ridotte e con l’abbandono delle aree marginali – a un’agricoltura diversificata e con sistemi di coltivazione che rispettassero le caratteristiche del suolo, del clima, dell’ambiente nonché le forme tradizionali di coltivazioni locali che rispettavano l’ambiente, tramandate nel tempo. Tale riorganizzazione del ciclo produttivo agricolo doveva avvenire tenendo conto dell’impatto ecologico e mirando a una produzione di qualità. Gli autori, infatti, insistevano sul fatto che la “produzione ricca e diversificata [rendeva] competitivo l’uso agricolo del territorio frenando i processi di erosione urbana e suburbana. L’agricoltura che [esaltasse] le cultivar autoctone, la complessità biologica, le qualità ambientali e costruttive del luogo [avrebbe costituito] un codice genetico delle identità dei luoghi e dei loro processi di trasformazione di lunga durata” (ANCI TOSCANA, 1996: 16). La pratica dell’agricoltura di qualità serviva inoltre a bonificare, salvaguardare e valorizzare i sistemi ambientali e, quindi, a produrre sviluppo locale autosostenibile. Tra le azioni che si sarebbero potute fare in questa direzione sono state elencate dagli autori le seguenti: “- rinaturalizzazione di sistemi ambientali degradati mediante rimboschimenti, con utilizzazione privilegiata di specie originarie e tradizionali; 302 - costruzione di zone cuscinetto e corridoi biotici (wildlife corridors) per connettere spazi e habitat relitti e interclusi nelle periferie urbane e nella città diffusa, e connessione dei sistemi ambientali attraverso reti ecologiche; - fasce agricole e forestali periurbane; - uso delle foreste e della sistemazione tradizionale dei suoli come strumento di difesa idrogeologica; - creazione di orti urbani, campi scuola per l’agricoltura biologica, vivai civici, compostaggio dei rifiuti urbani, produzione mirata al fabbisogno alimentare urbano; - ecosistemi filtro per la biodepurazione delle acque e il loro recupero irriguo e la creazione di zone umide” (ANCI TOSCANA, 1996: 17). Gli autori sottolineavano, infine, quanto la pratica dell’agricoltura sostenibile richiedesse inoltre la manutenzione attiva del territorio da parte della comunità insediata, e di conseguenza un forte senso di comunità, fondato sulla cooperazione e l’aiuto reciproco – proprio come sottolineato da KROPOTKIN – e in collaborazione con le istituzioni. Organizzato su queste basi, il settore agricolo produrrebbe non solo merci per il mercato, ma capitale sociale, utilità collettiva, qualità ambientale, fruibilità del territorio, in sintesi sviluppo locale autosostenibile. Vale infine la pena di sottolineare che la grande novità presente in questo manifesto e ispirata dall’approccio territorialista di cui si è trattato nel capitolo anteriore, è la concezione del territorio agricolo come risorsa culturale da salvaguardare e valorizzare nei suoi diversi aspetti, non solo in quello economico. L’applicazione del risultato di questa proposta si può verificare nell’area pilota della Val di Bisenzio. 1.2. Dal manifesto all’azione: il Laboratorio ANCI Val di Bisenzio 1.2.1. Il quadro normativo di riferimento Il problema dello sviluppo rurale è sentito non solo in Italia ma anche all’interno dell’Unione Europea, dove, secondo FANFANO, le zone rurali costituiscono più dell’80% del territorio e ospitano circa un quarto della popolazione comunitaria. Questo senza far riferimento all’attuale processo di decentramento insediativo di molti poli urbani nei diversi paesi comunitari nonché ai problemi relativi all’allargamento della comunità ai paesi del centro e dell’est Europa. Sin dagli anni ’80 l’Unione Europea venne orientando le proprie politiche sul territorio rurale, culminando nel 1992 con la definizione di obiettivi, strumenti e mezzi finanziari specifici rivolti al mantenimento di comunità rurali vitali e di salvaguardia della cultura e tradizione locale; alla coesione economica e sociale attraverso 303 l’incremento economico e la creazione di posti di lavoro; alla differenziazione e integrazione dell’economia rurale e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni rurali. Per raggiungere tali obiettivi sono stati creati strumenti come i Programmi dei Fondi Strutturali; le misure di accompagnamento della PAC (Politica Agricola Comunitaria); le Politiche per la silvicoltura e l’ambiente; l’incentivo alla ricerca nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale; lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura, con particolare riferimento alla diversificazione e miglioramento della produzione e alla tutela ambientale. Quattro anni dopo, nel 1996, venne compiuto un ulteriore passo verso il raggiungimento di tali obiettivi attraverso la dichiarazione di Cork, occasione in cui venne messa in evidenza “la necessità di un cambiamento di prospettiva per la politica agricola comunitaria verso il riconoscimento – e la promozione – del suo ruolo di produttrice di beni pubblici (ambientali, paesistici, culturali e sociali). In questo senso si [auspicava] uno sviluppo rurale sostenibile da perseguire nell’ambito di un quadro normativo, strumentale e finanziario unitario” (FANFANO, 2000:9). Il processo di revisione della politica agricola e di sviluppo rurale comunitaria è stato concretizzato nel contesto dell’Agenda 2000. La nuova politica di sviluppo rurale diventava il secondo pilastro della politica agricola comunitaria, permettendo di meglio affrontare le nuove sfide poste dai mercati esterni, dai consumatori e dalla società in termini ambientali. È in questo contesto che devono essere intese le quattro linee di azione/principi conduttori – la stabilizzazione del mercato (SM); i pagamenti per la tutela ambientale del paesaggio e della cultura rurale (PAP); gli incentivi allo sviluppo rurale integrato e multisettoriale (ISR) e l’assistenza transitoria all’aggiustamento della struttura produttiva alle nuove condizioni di mercato e di finanziamenti (ATA)251 – le quali, d’accordo con il rapporto Buckwell, avrebbero dovuto orientare le misure della nuova 251 La “stabilizzazione del mercato (SM), mira a creare una rete protettiva per merci che possono essere soggette a fluttuazioni incontrollabili del mercato. I pagamenti a favore dell’ambiente, del paesaggio e dei valori culturali (PAP) sono orientati alla protezione e allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale, oltre che a valorizzare le risorse e il tessuto sociale delle aree rurali. In teoria, questo tipo di sostegno dovrebbe interessare tutto il territorio. (…) Gli aiuti vengono chiamati pagamenti, non sussidi o rimesse, in quanto vengono pagati con denaro pubblico coloro che forniscono servizi ambientali di interesse collettivo. Si tratta di pagamenti per servizi, e non di trasferimenti assistenzialistici. Per questo motivo, essi non sono dovuti se il servizio non viene fornito. (…) Il terzo elemento, gli incentivi allo sviluppo rurale (ISR), riguarda tutti gli aspetti dello sviluppo rurale, compreso quello agricolo, ma mira soprattutto a stimolare l’impiego non agricolo delle risorse dell’impresa agricola o delle risorse connesse all’esercizio dell’agricoltura. Il quarto elemento, l’assistenza temporanea all’aggiustamento, ha lo scopo di facilitare il passaggio da una politica agricola ad una politica rurale. I primi tre elementi (SM, PAP e ISR) hanno carattere duraturo. L’ultimo (ATA), (…) prevede una forma di sostegno transitorio” (BUCKWELL, 1998a: 15/16). L’assistenza transitoria all’aggiustamento (ATA) si configura quindi come una forma di assistenza destinata ad aiutare l’adattamento necessario alle nuove esigenze della nuova politica agricola comunitaria, soprattutto per quanto riguarda le esigenze ambientali. 304 Politica Agricola e Rurale Comune per l’Europa (CARPE), con l’obiettivo “di assicurare una politica agricola e rurale economicamente efficiente e ambientalmente sostenibile e stimolare lo sviluppo integrato delle aree rurali dell’Unione Europea” (BUCKWELL, 1998a:14). La nuova politica agricola e rurale comunitaria ha quindi una base d’appoggio più ampia. Essa infatti si fonda non solo sulle esigenze dei produttori ma anche su quelle dei consumatori e quelle dell’ambiente, del paesaggio e della cultura rurale. I principi fondanti sono: “- la plurifunzionalità dell’agricoltura, soprattutto alla sua capacità di fornire servizi pubblici e non solo derrate; - l’impostazione plurisettoriale ed integrata dell’economia rurale, attraverso la differenziazione delle fonti di reddito e delle attività in più o meno diretta connessione con quella agricola; - la flessibilità degli aiuti allo sviluppo rurale fondata sul principio di sussidiarietà e di partnership a livello locale; - la trasparenza nella elaborazione e gestione dei programmi attraverso una normativa più semplificata e favorendo la concertazione locale. Gli assi portanti sui quali si sviluppano poi le diverse misure in relazione ai principi richiamati riguardano: - la salvaguardia del settore agricolo e forestale; - la competitività economica delle zone rurale; - la salvaguardia ambientale e la tutela del patrimonio rurale” (FANFANO, 2000:10). In adempimento di queste direttive, in Italia la Regione Toscana si è dotata di uno strumento normativo quadro – la LR 5/95 – contenente gli indirizzi e principi chiave – tra cui il più importante era la sostenibilità – per il governo e la pianificazione su diverse scale del territorio regionale. In questo contesto i diversi livelli di governo del territorio vengono chiamati a riconoscere le risorse del territorio in quanto “invarianti strutturali” e a pensare a forme di sviluppo che siano in grado di trasformarli in valori con lo scopo di valorizzare il loro patrimonio territoriale. Le successive leggi regionali 64/95 e 25/97 hanno posto l’accento sulla centralità del territorio rurale per il raggiungimento della sostenibilità dello sviluppo. Attraverso queste leggi l’agricoltura passa a essere vista come un “settore in grado di fornire ‘servizi senza mercato’ e di supportare le naturali vocazioni locali che hanno come base il territorio” (FANFANO, 2000:11). Viene incentivata la multisettorialità dello sviluppo rurale, in particolare i fenomeni come il part-time e l’autoconsumo. Nell’ambito, poi, del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale), “la sostenibilità dello sviluppo del territorio aperto viene perseguita (…) attraverso obiettivi di: 305 - valorizzazione del ruolo di presidio ambientale e paesistico; - promozione di misure atte a supportare la tipicità delle produzioni; - difesa del suolo e recupero del degrado e tutela ambientale anche attraverso politiche attive di promozione turistica, infrastrutturazione e promozione delle aree a protezione naturale; - riequilibrio fra utilizzazione delle risorse idriche e politiche di sviluppo della pianificazione territoriale” (FANFANO, 2000:11). Inoltre, veniva riconosciuta e valorizzata la pluralità di ambienti rurali e agricoli del territorio toscano e soprattutto il ruolo da essi giocati – soprattutto da quelli a bassa resa economica – nel mantenimento e tutela dell’ecosistema ambientale, umano e del paesaggio toscano. In sintonia con queste misure il PRS 1998-2000 (Piano Regionale di Sviluppo) perseguiva per il territorio rurale, in un ottica di pianificazione bottom up, una strategia di azione finalizzata al rafforzamento delle reti socio-economiche locali e delle produzioni tipiche ad alta qualità, strategia che viene mantenuta nel PRS 2000-2006 che, a sua volta, riconosce al settore agricolo un ruolo fondamentale per la valorizzazione e tutela di importanti settori e risorse del territorio toscano, tra cui quelli turistico e ambientale. Con questo scopo “si configura una impostazione di tipo multisettoriale tesa da un lato al sostegno diretto e alla innovazione della produttività rurale e, dall’altro a rafforzare le funzioni plurime del territorio rurale. Questo soprattutto attraverso il miglioramento delle condizioni di vita per gli abitanti e il supporto alla produzione e mantenimento di beni ambientali-paesistici e della offerta turistica. Tutto ciò in ragione del mantenimento dello specifico modello toscano di sviluppo rurale (…). Tale strategia viene articolata dal P.S.R. in tre obiettivi generali (…): a) Il sostegno al miglioramento della competitività aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità; b) Il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali; c) Il sostegno alla fruizione delle opportunità offerte dalle zone rurali” (FANFANO, 2000:13). Infine, con l’obiettivo di mettere in pratica quanto detto la Regione Toscana ha creato programmi di finanziamento nel settore della produzione biologica (contributi per i costi di controllo delle aziende); della tutela delle risorse autoctone; del miglioramento genetico di alcune specie animali e dell’incentivo all’accesso dei giovani in agricoltura. 306 1.2.2. La Val di Bisenzio e la costruzione di una rete di economia integrata nell’ambito del recupero dell’agricoltura tradizionale Dopo l’elaborazione e divulgazione del manifesto, l’ANCI Toscana insieme alle università di Firenze, Pisa e Siena e ad altre associazioni del terzo settore, tra cui ARCI e WWF, hanno bandito un concorso dove sono state offerte tre borse di studio, una per ciascuna delle tre aree d’intervento previamente identificate dal manifesto, perché potessero essere effettuati gli studi di cui ora si passerà a trattare252. In tutti e tre casi, e in particolare per l’area oggetto di studio in questo paragrafo – la Val di Bisenzio – le esperienze si basano sulla consapevolezza dell’importanza della sostenibilità dello sviluppo degli spazi rurali per il raggiungimento dell’autosostenibilità dello sviluppo di un intero territorio. Tale consapevolezza occasiona un ribaltamento logico nel modo di intendere il rapporto sviluppo urbano/sviluppo rurale, soprattutto per quanto riguarda una nuova concezione del territorio aperto, inteso come un “territorio ‘denso’ di qualità che, in quanto tale, è in grado di esprimere le proprie peculiarità e caratteristiche, prima fra tutte quella di produrre ‘beni pubblici’ in termini di risorse rare e non riproducibili” (FANFANO, 2000: 7). Si parte quindi dall’assunto che senza la ricerca di un rapporto virtuoso tra città e territorio circostante lo sviluppo locale autosostenibile quale discusso nel capitolo precedente è difficilmente raggiungibile. Secondo FANFANO, il “perseguimento della sostenibilità del territorio rurale passa per un arricchimento culturale e funzionale delle diverse attività economiche ove, in un generale contesto di multisettorialità e differenziazione produttiva, si persegua l’obiettivo di produrre beni orientati a nicchie di mercato qualitativamente elevate, rivolte tendenzialmente al mercato e consumo locale, ma anche in grado di avvalersi dei benefici della ‘new economy’ soprattutto quando il mercato locale non sia in grado di supportare adeguati livelli di produzione e guadagno. Il riavvicinamento fra abitante e produttore e fra produttore e consumatore, attraverso ‘reti corte’, consente di ‘chiudere’ localmente sia il ciclo del prodotto (…) sia quello della produzione, riportando così a livello locale il ‘valore aggiunto territoriale’ di alcune produzioni tipiche. Inoltre il rapporto più diretto fra produttore e consumatore, oltre alla ‘riconoscibilità’ del territorio, porta a rafforzare il rapporto di reciproca fiducia connesso ad una crescente domanda locale di generi alimentari qualitativamente garantiti. 252 La borsa di studio per la Val di Cornia è stata attivata nel 1998 mentre quella per la Val di Bisenzio nel 1999. 307 Il rafforzamento, insieme con l’autonomia economica del territorio rurale, porta inoltre allo sviluppo di un modello integrato di economia locale ove la valorizzazione delle risorse ambientali e paesistiche ottenuta attraverso una agricoltura di qualità costituisce richiamo per la domanda turistica, per quella insediativa e per la conseguente creazione di nuove attività di servizio alla produzione e alle famiglie” (FANFANO, 2000: 7/8). L’esperienza della Val di Bisenzio si basa su un doppio punto di partenza: da un lato, le proposte nate dal Laboratorio ANCI per la Val di Bisenzio come trattato nella prima parte di questo paragrafo e, dall’altro, le nuove direttive europee, nazionali ma soprattutto regionali per la pianificazione dello sviluppo territoriale locale, tenendo conto in particolar modo del ruolo della componente ambientale e dello sviluppo rurale per il raggiungimento dell’autosostenibilità di uno sviluppo che sia al tempo stesso locale e costruito “dal basso”. A questo proposito, il primo passo è la realizzazione di un’analisi dettagliata del milieu locale con l’obiettivo di identificare indirizzi d’azione che siano in sintonia con quanto appena detto nonché attori disponibili a metterle in pratica. Una caratteristica del territorio della Val di Bisenzio è, secondo FANFANO, la sua varietà e, al tempo stesso, l’integrazione fra le varie componenti che lo costituiscono. Esso è composto da pendici molto inclinate e estremamente boscose – che offrono proprio per questo scarse possibilità di insediamento umano – e da aree di acclività meno accentuate e con un’attività umana più presente. Oltre il 62% del territorio è riconducibile a una generica “destinazione agricola e forestale” anche se, da un punto di vista socioeconomico, tale attività è marginale rispetto all’economia industriale e artigiana del distretto pratese. Secondo FANFANO il settore agricolo e forestale contribuisce soltanto con l’1% del personale occupato e con il 0,4% del reddito prodotto, ma questi dati non prendono in considerazione il carattere di part- time dell’attività253, neppure l’importante “ruolo del settore agricolo nel produrre ‘beni pubblici’ in termini di protezione, cura e messa in sicurezza dell’ambiente non valutabili, per la loro stessa natura, in termini esclusivamente monetari” (ZAMAGNI apud FANFANO, 2000: 19). Da prendere in considerazione anche la pressione svolta dal sistema urbano sul settore agroforestale, evidenziata dalla frammentazione sia della struttura fondiaria del cosiddetto “territorio aperto” che dalla struttura aziendale del settore agricolo. Tale processo, per quanto riguarda il territorio in questione, cominciò all’inizio del secolo scorso e, accentuandosi soprattutto negli anni ’50, provocò il sostanziale dissolvimento della struttura mezzadrile prima esistente. 253 Secondo FANFANO molti proprietari di aziende o terreni agricoli dedicano all’attività solo una parte del loro tempo di lavoro con l’obiettivo di “ricrearsi” oppure di mantenere un legame, sia pure sottile, con l’attività agricola. 308 Per quanto riguarda l’uso del suolo agricolo, nell’ambito del territorio della Comunità Montana Val di Bisenzio prevale la destinazione a prato-pascolo, soprattutto nei comuni di Vaiano e Cantagallo, anche se nel decennio 1981-1991 Vaiano ha incrementato la superficie destinata a olivo, Cantagallo a castagneti da frutto e Montemurlo a vite e olivo. Riguardo alla superficie boscata, Cantagallo e Vernio sono i comuni a presentare la maggior area occupata, anche se il calo della superficie aziendale ha colpito soprattutto le superfici a colture permanenti e i boschi. La fragilità e destrutturazione del settore agricoloforestale è, secondo l’autore, testimoniata anche dalla forma di conduzione aziendale, con la sparizione quasi totale della mezzadria. Prevalgono nettamente la conduzione diretta con la forza lavoro familiare part-time seguita dall’utilizzazione del “contoterzi”254, quest’ultima la pratica più diffusa nell’alta Val di Bisenzio255. FANFANO sottolinea anche l’estrema frammentazione del tessuto produttivo agricolo: le proprietà al di sotto di un ettaro di SAU256 rappresentano circa 54% del totale le quali, sommate a quelle con l’area compresa tra 1 e 5 ettari, arrivano all’87% della SAU totale. L’altro aspetto sottolineato dall’autore riguarda il cambiamento dell’uso del suolo agricolo. Attualmente le superfici boscate rappresentano il 52% del territorio, 14% in più rispetto a quella degli anni ’50, fatto che metteva in evidenza la necessità di pensare ad azioni che portassero alla valorizzazione di questa importante risorsa. All’aumento delle superfici boscate segue la diminuzione di quelle a colture permanenti, soprattutto vite – che resiste ancora soltanto nel comune di Montalbano – e olivo, nonché l’aumento dell’area interessata da fenomeni di edificazione e urbanizzazione. In funzione della sua frammentazione, la struttura aziendale agricola appare debole e precaria e fortemente condizionata dalla congiuntura economica e dalle pressioni “urbane”. A questo si somma la forte presenza della conduzione part-time e “una inevitabile tendenza all’abbandono che in alta collina e in montagna assume la forma della ricolonizzazione boschiva, mentre più in basso quella dell’«attesa edificatoria». La pressione urbana e la tendenza all’abbandono sono particolarmente presenti [nei comuni] di Vernio (…) Montemurlo e Vaiano” (FANFANO, 2000:22). Ciononostante, la rilevante incidenza di aziende medio-grandi, la permanenza, almeno formalmente, di una grande quantità di I contoterzi sono aziende, non necessariamente agricole, che possiedono macchine e macchinari agricoli e che fanno le varie operazioni di lavorazione della terra per conto di altri. La maggior parte delle persone che ricorrono a questo tipo di servizio sono affittuari che, non possedendo la proprietà della terra, non investono nell’acquisto di macchinari. Il pagamento viene effettuato in denaro o tramite quote del raccolto. 255 Per quanto riguarda la superficie media delle aziende, quelle a conduzione indiretta sono oltre venti volte più grandi di quelle a conduzione diretta. 256 Superficie Agricola Utilizzata. 254 309 suolo a destinazione agricola e la grande quantità di territorio “pseudo-agricolo”257 offrono un’immagine di un settore agricolo meno residuale di quanto non si possa pensare e fa emergere la necessità di pensare a politiche di valorizzazione e governo del patrimonio territoriale. Infine, FANFANO sottolinea la necessità di comprendere le caratteristiche dell’economia agraria della Val di Bisenzio tenendo conto anche del contesto geograficoterritoriale, o meglio, dei diversi ambienti naturali e insediativi. L’autore identifica e caratterizza due ambienti: la montagna e colle-monte e il pedecollina. Per quanto riguarda la montagna e colle-monte, nonostante i diversi paesaggi si nota la prevalenza del bosco rispetto alle superfici coltivate o a prati-pascoli con un forte decremento della SAU nel periodo ‘71-’91. Rispetto all’attività agricola, domina l’allevamento del bestiame a grande taglia (mucche e cavalli) e ovini ma, per la scarsa presenza dell’imprenditorialità agricola, l’attività viene svolta normalmente senza tenere in considerazione le precauzioni necessarie soprattutto per quanto riguarda i rischi per l’assetto idrogeologico258. D’altra parte, la presenza dell’attività part-time, sebbene non importante dal punto di vista economico, consente la manutenzione e cura di circa il 37% del territorio di questo ambiente. Nell’ambiente di Pedecollina, invece, la mezzadria aveva strutturato fino agli anni ’50 un paesaggio ricco e vario, incentrato su di una minuta rete di colture promiscue e sull’allevamento, conferendo al territorio un ruolo di presidio ambientale. Dagli anni ’50 in poi, con la destrutturazione della mezzadria, l’attività passò a essere svolta in parte da aziende residenziali e in parte dalla conduzione familiare part-time. In quest’area, secondo FANFANO, le attività dirette da piccole e medie aziende e sostenute da redditi integrativi dai proprietari contribuiscono oggi a salvaguardare le caratteristiche di pregio ambientale della zona e a curare l’assetto idrogeologico in modo più responsabile. Prova di una certa vitalità del settore agricolo è il recupero, anche se su piccola scala, della produzione dell’olivo, incentivata anche dalla realizzazione, da parte del comune di Vaiano, di un frantoio consortile di servizio ai piccoli produttori olivicoli presenti nell’area. Tale iniziativa è rivolta anche a incentivare la presenza residenziale nell’area – anche a titolo di L’autore si riferisce alle ville-fattoria di Montemurlo e della media valle del Bisenzio che, per motivi di origine storica e di collocazione geografica, si presentano come aziende capitalistiche in grado di competere sui mercati internazionali, ma che “necessitano del mantenimento degli equilibri agropaesistici del proprio territorio per poter continuare a immettere sul mercato un prodotto nel quale l’immagine e la qualità territoriale stessa sono veri e propri fattori costitutivi del valore aggiunto del prodotto medesimo” (FANFANO, 2000:23). 258 Oltre allo svolgimento non corretto delle attività del pascolo, contribuiscono ad aumentare i rischi per l’assetto idrogeologico la crescente frammentazione aziendale e della SAU, nonché l’abbandono dell’attività o la sua attribuzione a terzi. 257 310 residenza extraurbana –, attraverso il ripristino e il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle case. FANFANO sottolinea ancora come, anche senza presentare un ruolo economico di rilievo, l’agricoltura nella Val di Bisenzio abbia permesso l’occupazione, organizzazione e uso dell’intero territorio in modo da garantire il sostentamento degli abitanti e la produzione di un eccedente economico e ambientale che ha consentito il nascere e l’evolversi dell’industria tessile259. Manca però il riconoscimento all’agricoltura del suo ruolo di produttrice di beni e risorse ambientali non monetizzabili ma responsabili anch’esse dell’equilibrio della zona. Da quanto esposto, l’autore sottolinea la necessità di individuare indirizzi e azioni atte a: “- ricostruire economie agrarie locali incentrate su iniziative ‘dal basso’ di più attori in grado di supportare un adeguato ruolo di presidio del territorio agro-forestale soprattutto nelle aree montane e di alta collina (…); - favorire il consolidarsi di iniziative produttive che, seppure attualmente marginali, come quella dell’allevamento di bestiame grosso, possono costituire voci estremamente redditizie sia in continuità con il passato (…) che innovando aspetti della tradizione; - costituire iniziative volte a far progredire il Know-how del sistema agricolo cercando di valorizzare la produzione di qualità e biologica, orientata prevalentemente al mercato locale, attraverso la creazione di centri di ricerca, sperimentazione, formazione e diffusione di una cultura della produzione agricola orientata da principi di compatibilità ecologica, iniziative di cooperazione fra produttori; - attivare iniziative sia di tipo pubblico che privato finalizzate alla cura e presidio ambientale volte per esempio alla manutenzione e cura del bosco, sempre più raramente effettuata dai proprietari privati” (FANFANO, 2000: 25). È in questo quadro di cambiamenti e di supporto offerto da alcuni incentivi economici locali e sovralocali, nonché dalle prospettive aperte dalla nuova politica agricola comunitaria (CARPE) che deve essere intesa almeno parte del rinnovato interesse per l’attività agricola di qualità, anche se quella part-time. Tale interesse ha avuto come risultato non solo un cambiamento di approccio rispetto alla pratica agricola vera e propria – la riduzione dell’uso di sostanze chimiche, il recupero di pratiche tradizionali fino alla 259 L’autore costruisce il quadro evolutivo del processo insediativo e di sfruttamento economico dell’area, dai primi insediamenti ancora nell’epoca neolitica ed eneolitica fino all’attualità. A suo avviso, anche se il processo di antropizzazione dell’area si fa notare sin dall’epoca neolitica ed eneolitica, è con la presenza etrusca che il processo di territorializzazione inizia a manifestarsi e a trasformare in maniera significativa il territorio. 311 realizzazione di coltivazioni biologiche certificate – ma anche l’aumento del territorio interessato da misure ambientali: circa il 10% del territorio appartenente alla Comunità Montana, il 5,6% circa del territorio provinciale260. Questo fatto lascia intravedere una possibilità sempre più concreta di attivazione di un circuito economico relativo a una produzione agricola di qualità non solo per i prodotti commercializzabili ma anche per i beni paesistico-ambientali e la qualità territoriale stessa. Secondo FANFANO, nel 2000, delle 14 aziende operanti nel settore della produzione biologica – tra aziende miste, aziende in conversione, aziende biologiche e preparatori – 12 si situavano nel territorio della Comunità Montana261. Allora il poco tempo di vita delle suddette aziende non permetteva il consolidamento di quella esperienza come una alternativa effettiva dal punto di vista commerciale, ma tutto portava a considerarla possibile in un futuro non troppo lontano. Questo per due ordini di motivi, diversi ma collegati tra loro: da un lato, la dotazione di incentivi economici, finanziari e legislativi interessanti direttamente la produzione agricola di qualità; dall’altro l’aumento della domanda di prodotti di qualità certificata per quello che si riferiva al mercato provinciale e i circuiti commerciali lì presenti, come la “fierucola” che si svolge mensilmente a Prato, la rete commerciale Natura sì e la stessa Coop. FANFANO aggiunge anche la mentalità imprenditoriale locale – i potenziali soggetti del cambiamento, di cui ci parla MAGNAGHI come trattato nel capitolo precedente – che potrebbe essere sfruttata nel senso di essere riorientata verso lo sviluppo dell’attività agricola di qualità. Nell’ambito della provincia di Prato – e soprattutto nel territorio della Comunità Montana – la superficie boscata rappresenta la forma di uso del suolo prevalente, le cui prospettive di uso e valorizzazione, sottolinea l’autore, devono fare i conti “con un complesso insieme di fattori che vanno sapientemente dosati ai fini di un utilizzo ‘sostenibile’ della risorsa medesima. Da un lato troviamo infatti necessità di intervento antropico in grado di ricostituire un adeguato equilibrio colturale ed idrogeologico all’interno dei boschi, in maniera tale che questi possano realizzare al meglio la loro funzione di ‘protezione’ dei territori di valle. D’altra parte tale esigenza va combinata con una naturale ‘vocazione’ produttiva del bosco” (FANFANO, 2000:33). Una delle principali potenzialità produttive del bosco è, secondo l’autore l’economia del castagno. Nel territorio della Comunità Montana si trovano 698 ha di castagneti, di cui Provincia di Prato (1999), Dati statistici in agricoltura, in Materiali della Conferenza sul piano di sviluppo rurale provinciale, Prato, P.zo. Novellucci, 12.05.2000. Riportato da FANFANO, 2000:32. 261 Conformi dati del Bollettino Ufficiale Regione Toscana, Supplemento Straordinario n. 50, Parte II, n. 14 del 05.04.2000. Riportato da FANFANO, idem ibdem. 260 312 soltanto 135 coltivati262. In passato l’economia della castagna era destinata al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione locale attraverso la produzione della farina che, al tempo stesso, “strutturava una complessa rete fruitiva dell’alta collina che si snodava attraverso castagneti, mulattiere, essiccatoi e mulini ad acqua e che rappresentava al contempo un importante strumento di sussistenza e di controllo e mantenimento del territorio montano” (FANFANO, 2000:33). Tale equilibrio è stato interrotto dal processo di parcellizzazione delle proprietà iniziato come già detto sin dall’inizio del secolo scorso e in modo accentuato dagli anni ’50 in poi, portando all’abbandono e conseguentemente alla cattiva conservazione dei castagneti. Nel 2000, tenendo conto del cambiamento di atteggiamento dei consumatori e della richiesta sempre più crescente di prodotti alimentari tradizionali e di qualità – data quasi sempre dalla certificazione biologica – la Comunità Montana, in collaborazione con la Provincia di Prato, ha dato inizio a un’azione di recupero e valorizzazione dell’economia della castagna attraverso l’erogazione di fondi per il recupero e ricostituzione dei castagneti e, insieme a essi, di tutta la sua filiera produttiva. Le linee di intervento proposte sono state: “- recupero dei castagneti da frutto; - realizzazione di nuovi impianti; - recupero e potenziamento essiccatoi; - recupero mulini ad acqua; - valorizzazione e creazione marchio d’area”263 (COMUNITÀ MONTANA apud FANFANO, 2000:34). Insieme a tali azioni c’era anche l’obiettivo di ottenere il marchio europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta). I primi stanziamenti erano serviti al recupero soltanto di circa 10 ettari di castagneti ma aprivano la strada alla valorizzazione di una forma importante di uso del territorio montano nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali e ponevano allo stesso tempo una prospettiva concreta di commercializzazione della produzione soprattutto della farina di castagna all’interno del mercato provinciale264. FANFANO riteneva necessario, ai fini di garantire il successo dell’esperienza, che venissero intraprese alcune azioni quali l’instaurazione di una forma cooperativa e consorziale tra quelli che si interessavano della Dati relativi al febbraio 2000 ottenuti dalla Comunità Montana Val di Bisenzio. Riportati da FANFANO, op. cit, p. 33. 263 COMUNITÀ MONTANA “Val di Bisenzio”, Progetto di recupero dei castagneti da frutto nel territorio della Comunità Montana Val di Bisenzio, Vernio (PO), Febbraio 2000. Riportato da FANFANO, op. cit., p. 34, nota 38. 264 In intervista concessa il 17 dicembre 2003, FANFANO ha informato che l’attività si sta piano piano recuperando, grazie ai suddetti incentivi. Favorisce la ripresa dell’attività l’esistenza di molti essiccatoi sparsi per il territorio dell’Alta Valle, chiamati “Carniciaie”, nonché di un mulino che macina le castagne prodotte nella zona per la produzione della farina che viene in seguito smerciata nella rete locale pratese di commercializzazione. 262 313 castagna; il ripristino dell’accessibilità ai castagneti – anche attraverso l’integrazione tra le vecchie mulattiere che servivano il territorio in passato; la reintroduzione del trasporto a trazione animale, in concomitanza con il programma della Regione Toscana d’incentivo all’allevamento di ciuchi e muli, dando così una più forte caratterizzazione biologica all’attività; lo sviluppo della coltivazione del marrone anche per la produzione della farina, dato il mutare della domanda di mercato verso prodotti di qualità. Oltre ai castagneti, i “tipi di attività che il bosco può consentire riguardano in particolare la ceduazione, la raccolta dei prodotti del sottobosco, l’allevamento in pascolo boscato, la fruizione ambientale e ricreativa” (FANFANO, 2000:35). Tali usi vengono però compromessi sia dalla scarsa rilevanza di mercato di alcune risorse che dalla difficoltà di accesso ad esse. Si pone, quindi, la necessità di pensare a forme di uso e valorizzazione del bosco che siano in grado di garantire il ritorno economico e, attraverso questo, il presidio sul territorio da parte dell’uomo. Rispetto alla ceduazione, FANFANO informa che essa veniva svolta senza coordinamento da imprese che lavoravano in forma terzerizzata, suggerendo come alternativa la creazione di un consorzio silvopastorale in grado di permettere la realizzazione di politiche e strategie di mercato coordinate attraverso, per esempio, la ricostituzione della filiera produttiva e l’orientamento non solo verso il settore della legna da ardere ma anche verso la produzione di legname per uso artigianale e edilizio. L’attività di raccolta dei prodotti del sottobosco veniva, secondo l’autore, lasciata allo spontaneismo e svolta soprattutto come attività ricreativa265. FANFANO ritiene che anche in questo caso l’attività di raccolta dei funghi e altri prodotti – come il tartufo, frutti di bosco, ecc. – potevano diventare una voce integrativa del reddito aziendale se facesse riferimento ad una forma di organizzazione e coordinamento tra le imprese, attraverso la costituzione di una filiera che comprendesse anche la commercializzazione in loco dei prodotti. L’allevamento costituiva anch’esso una ulteriore possibilità di uso del bosco, soprattutto davanti alla prospettiva del rilancio dell’allevamento della razza Calvana – supportato anche da misure regionali di sostegno economico al mantenimento di specie a rischio di estinzione266 – e dell’interesse verso l’allevamento equino – soprattutto di razze pregiate per uso ippico, settore che può contare anche su una collocazione geografica particolare in grado di permettere la sua integrazione con il settore turisticoescursionistico. Per quanto riguarda la commercializzazione di questi capi, l’autore 265 266 Il pagamento per la raccolta dei funghi è stato introdotto dalla Provincia di Prato soltanto nel 1999. A questo proposito si trova presenti nel territorio anche l’allevamento del suino di razza “cinta senese”. 314 propone il rafforzamento di reti commerciali corte attraverso, per esempio, il rifornimento delle mense scolastiche, ecc. Nonostante il rinnovato interesse verso l’attività primaria nell’economia della Val di Bisenzio, le iniziative economiche sono caratterizzate da una forte frammentazione e marginalità. L’unico modo per cambiare questo quadro, secondo FANFANO, è pensare a nuove forme di sviluppo che tengano in considerazione “la creazione di una mentalità e di strutture di carattere cooperativo in grado di raggiungere soglie minime di efficienza in termini di gestione e miglioramento delle fasi produttive cercando di sviluppare e rafforzare la filiera produzione-trasformazione-commercializzazione. L’autosostenibilità del modello di sviluppo socioeconomico della valle passa proprio attraverso l’acquisizione di questa capacità di governare localmente le relazioni fra uso delle risorse-resa economica e valorizzazione del territorio sottraendo il più possibile le diverse opzioni e modelli produttivi alle pure logiche di mercato che peraltro sembrano relegare quest’area in una condizione di marginalità. Il rafforzamento delle reti cooperative fra i diversi attori, oltre a offrire la possibilità di trasformare le “economie di scala” in “economie di scopo” attraverso sinergie e complementarità tra i vari centri, consentendo di svincolare il concetto di prossimità da quello di agglomerazione, può consentire anche il perseguimento di: - attivazione di servizi all’impresa grazie all’economia di scala; - maggiore forza ‘contrattuale’ nei confronti degli attori politico-amministrativi; - sviluppo di relazioni di innovazione, complementarità e sinergia riguardo al perseguimento di obiettivi specifici e nella costituzione di filiere integrate e reti commerciali locali; - riconoscibilità esterna delle varie iniziative produttive anche attraverso politiche di marchio; - maggiore ponderazione ed efficienza nella selezione delle politiche di mercato da perseguire; - maggiore facilità nella elaborazione di progetti ed istanze per l’accesso a finanziamenti pubblici; - creazione di ‘valore aggiunto territoriale’ attraverso la riconoscibilità della produzione locale di qualità e del suo legame con il territorio” (FANFANO, 2000:37/38)267. 267 Secondo FANFANO una prova che questa era la strada da prendere è la creazione, nel comune di Vaiano, del frantoio per i piccoli produttori olivicoli riuniti in consorzio come trattato precedentemente. 315 La messa in pratica di tali azioni è garantita da varie misure di finanziamento a livello europeo268, nazionale, regionale e provinciale. Da sottolineare anche l’iniziativa di programmazione negoziata iniziata ma interrotta in fase contrattuale del Patto territoriale dell’Appennino Tosca-Emiliano-Romagnolo che avrebbe permesso l’accesso a significative forme di finanziamento per lo sviluppo territoriale delle aree interessate da marginalità economica o ritardo di sviluppo269. L’autore cita anche l’azione del Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Appennino Pistoiese e Pratese che ha coordinato per la Val di Bisenzio azioni integrate finalizzate alla valorizzazione turistica dell’area, promuovendo l’attivazione di consorzi privati fra proprietari agro-forestali, così come il recupero e sostegno di 268 269 In quanto politiche di sostegno allo sviluppo rurale inteso in senso lato (quale proposto dalla CARPE) e non soltanto di sostegno all’agricoltura. Per quanto si riferisce alla Val di Bisenzio, le linee guida prevedevano forme di sviluppo rurale integrato, di sviluppo turistico, di sviluppo dell’imprenditoria artigiana e di rafforzamento o completamento di infrastrutture, ecc. Anche se l’iter del Patto è stato interrotto prima della fase del bando da una delibera CIPE che stabiliva “l’ammissione a finanziamento dei soli Patti che avessero concluso l’iter entro Luglio 2000” (FANFANO, 2000:50 n. 72), l’insieme dei progetti presentati permette di avere un quadro delle caratteristiche che lo sviluppo locale potrebbe avere e dei soggetti su cui avrebbe potuto contare. Secondo FANFANO l’insieme delle proposte si orientavano verso i settori turistico e agrituristico (67% delle previsioni di investimento), seguito dal settore agricolo (8%), facendo intravedere la possibilità di orientare una forma di sviluppo in grado di valorizzare le risorse ambientali e storiche locali. Tali possibilità venivano rafforzate anche dalla capacità imprenditoriale locale – di solito imprenditori del settore agricolo o tessile originari della valle – come è già stato sottolineato. I progetti legati all’industria e all’artigianato coprivano insieme la seconda fascia più ampia (17%), anche se quelli industriali si riferivano nella maggior parte dei casi a progetti di ammodernamento tecnologico. Deboli invece i progetti relativi al settore commerciale e di servizi (8%), prevalentemente orientati a supporto delle attività agricola e turistica. “Dal punto di vista della articolazione territoriale dei progetti presentati si osserva (…) il rilevante ruolo giocato da Montemurlo e Cantagallo relativamente all’ambito agrituristico e il significativo peso dei progetti di investimento nel settore turistico per quanto riguarda il territorio dei comuni di Vaiano e Vernio” (FANFANO, 2000:51), legati soprattutto alle aree naturali lì esistenti (per i primi due comuni) e alla valorizzazione del patrimonio storico-antropico attraverso la creazione di circuiti turistico-didattici (per gli ultimi due). Rispetto al settore dei servizi, FANFANO richiama l’attenzione sulle proposte di “attivazione di servizi e attività formative finalizzate all’ottenimento della certificazione di qualità per le piccole e medie imprese dell’area del Patto (norme UNI EN 14001 e reg. CEE 1836/93 Emas) con particolare riguardo a quelle operanti nel settore agro-alimentare. In questo secondo caso un progetto specifico [prevedeva] la attività di consulenza e formazione per la certificazione di qualità dei prodotti tipici dell’area della Comunità Montana con particolare riferimento alle norme UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 14001 e alla metodologia di controllo della produzione HACCP. Questi primi due progetti si orientano dunque al supporto di obiettivi di qualità integrale del processo produttivo nel territorio considerato, sia sotto il profilo dell’impatto ambientale delle attività, soprattutto di quelle tessili, sia in ordine al miglioramento del profilo qualitativo dei prodotti legati al settore agroambientale” (FANFANO, 2000:52). Quest’ultimo aspetto veniva anche rafforzato da proposte di creazione di reti telematiche per la promozione e valorizzazione della qualità ambientale e territoriale come motore dello sviluppo economico. 316 produzioni tipiche attraverso la creazione di attività di trasformazione e operazione di marchio270. Lo sviluppo autosostenibile della Val di Bisenzio passa, secondo FANFANO, per la costruzione di una economia agro-ambientale complessa che, a sua volta, “presuppone la attivazione di tutta una serie di attività che possano svolgersi in complementarità rispetto a quella agro-forestale e zootecnica ma che siano anche in grado di utilizzare le ‘esternalità positive’ indotte dalle attività principali, soprattutto se condotte secondo pratiche rispettose dei principi e requisiti di qualità ambientale ed ecologica. Tale tipo di impostazione consente di ampliare ed arricchire la catena di produzione di valore territoriale consentendo al contempo di ‘catturare’ in un ambito di mercato beni che di per sé, come quelli ambientali e pubblici in genere, sono difficilmente monetizzabili. Nell’area della Comunità Montana Val di Bisenzio sicuramente le qualità e le esternalità ambientali del territorio possono essere valorizzate attraverso il potenziamento e miglioramento del settore turistico-ricettivo e della ricreazione. Questo in particolare attraverso: 270 FANFANO ha informato, in un’intervista concessa il 17 dicembre 2003, che il GAL Appennino Pistoiese e Pratese aveva operato nell’area della Val di Bisenzio nell’ambito dei Programmi Leader I (1988-1993) e Leader II (1994-1999). Con il Programma Leader Plus (2000-2006) la Val di Bisenzio era stata scorporata dal suddetto GAL ed era passata a far parte del GAL Val di Bisenzio-Mugello. Il Programma LEADER – Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale – è finanziato in parte dagli Stati e in parte dall’Unione Europea ed è rivolto a incentivare la programmazione “dal basso” e l’innovatività delle azioni nell’ottica dell’approccio territoriale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo rurale nelle aree a bassa densità di popolazione e minore diffusione dei servizi. Attivo sin dal 1988, il Programma Leader ha avuto tre fasi: il “Leader I ha segnato l'inizio di un nuovo approccio nei confronti della politica di sviluppo rurale che ora è ancorata al territorio, integrata e frutto di partecipazione. Con Leader II l'approccio di Leader I viene sensibilmente esteso e l'accento è posto sugli aspetti innovativi dei progetti. Leader+ svolge tuttora il suo ruolo di laboratorio destinato ad incoraggiare la messa a punto e la sperimentazione di nuovi approcci di sviluppo integrato e durevole che potrà influenzare, integrare e/o rafforzare la politica di sviluppo rurale nella Comunità. Leader+ è incentrato su tre azioni, oltre all'assistenza tecnica: Azione 1: Sostegno alle strategie pilota di sviluppo integrato del territorio fondate sull’approccio ascendente. Azione 2: Sostegno a favore della cooperazione fra territori rurali. Azione 3: Creazione di reti. Assistenza tecnica” (UNIONE EUROPEA, 2003:snp). Una volta uscito il bando e individuato il territorio di azione, vengono organizzati i GAL – Gruppo di Azione Locale –, a cui viene affidata l’azione 1 del Programma Leader+. I GAL sono soggetti consortili privati che coinvolgono enti pubblici e attori e soggetti privati di riferimento nel territorio oggetto d’intervento. Il GAL è responsabile per l’elaborazione e definizione del PAL – Piano di Azione Locale – il quale viene presentato alla Commissione del Programma Leader+ che l’analizzerà e deciderà se concedere o meno il finanziamento. I GAL possono essere considerati una sorta di agenzia di sviluppo locale. Nella Regione Toscana sono attivi otto GAL: GAL Start s.r.l; GAL Consorzio Appennino Aretino S.c.r.l; GAL Eurochianti S.c.r.l; GAL Siena S.c.r.l; GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo S.c.r.l.; GAL Farmaremma S.c.r.l; GAL Sviluppo Lunigiana Leader S.coop.r.l.; GAL Etruria S.c.r.l (ex GAL Arcipelago Toscano, Costa degli Etruschi e Colline Pisane). Essi operano nel 71,6% del territorio – chiamate aree Eligibili Leader+ – e coinvolgono circa il 22% della popolazione. 317 - creazione di una rete ricettiva impostata sulle strutture agrituristiche ma estesa anche ad altre forme di ricettività; - completamento del sistema provinciale delle aree protette e delle strutture minimali di ricettività connesse; - miglioramento della viabilità secondaria e della sentieristica di avvicinamento e fruizione del territorio aperto (viabilità storica, sentieri CAI, ippovie, percorsi per mountain bike)” (FANFANO, 2000:41). L’autore sottolinea come il settore dell’agriturismo aveva avuto una rapida evoluzione, arrivando nel 2000 a 133 posti letto sparsi in tredici agriturismi, otto dei quali (92 posti letto) situati nel territorio della Comunità Montana271. L’aumento del numero degli agriturismi evidenziava l’aumento anch’esso dell’interesse verso la valorizzazione turistica alternativa del territorio, potenzialità che l’autore ritiene importante incentivare soprattutto per le caratteristiche ambientali e architettoniche dell’area. Nonostante le prospettive di sviluppo di questo settore, due fattori ancora ostacolavano la sua velocità di crescita: da un lato, la mancanza di supporto da parte degli enti locali nel rilascio delle autorizzazioni di apertura, dall’altro la limitata accessibilità a molti insediamenti rurali potenzialmente destinati a diventare agriturismi272. La presenza delle aree protette nel territorio della Provincia – due già create – ANPIL di Monteferrato e quella di Monti della Calvana273 – due in fase di studio – l’ANPIL di Carigiola-Monte delle Scalette di prossima istituzione e l’ANPIL di Acquerino Luogonamo, all’interno dell’ANPIL di Monteferrato –, tutte e quattro inglobanti il 28% del territorio, con valori di carattere naturalistico, paesitico-antropico e biotico – rappresenta un’ulteriore possibilità di sviluppo di questo ramo del turismo, soprattutto perché i benefici finanziari che tali aree ricevono, rivolti sia al settore di servizi turisticoricettivi che al recupero e valorizzazione delle attività locali tradizionali, specialmente di Dei tredici agriturismi, secondo FANFANO, soltanto due risultavano iscritti anche nell’albo dei produttori biologici della Toscana aggiornato al 31.12.1999. 272 Secondo FANFANO, in un’intervista concessa il 17 dicembre 2003, il numero degli agriturismi non era cresciuto rispetto ai dati rilevati nel rapporto. Qualcuno era stato addirittura chiuso per non conformità alle normative. Le domande di apertura di nuovi posti attualmente sono in crescita ma devono fare i conti con le limitazioni impone dalla legge: per poter costituirsi in agriturismo, l’azienda agricola deve ottenere come reddito agricolo proveniente dalla produzione agricola il doppio di quanto può ottenere come agriturismo. La legge lascia però aperta la possibilità di offrire un minimo di sei posti letto, indipendentemente dal reddito che ottiene come azienda agricola. Il fatto che le aziende locali siano in larga misura piccole e poco redditizie fa sì che il numero di posti letto presenti nella Val di Bisenzio sia anch’esso piccolo. 273 Questa di creazione recente e interprovinciale. 271 318 quella artigianale, vengono sfruttati con lo scopo della valorizzazione del territorio274. In un secondo momento un altro settore a essere beneficiato dagli investimenti è quello agro-zootecnico. Il solo fatto di essere proveniente da un’area protetta rappresenta una potenzialità promozionale addizionale che, se sommata a una pratica agricola di qualità certificata, può significare guadagni più elevati sia monetari che ambientali. Inoltre, la creazione stessa delle aree protette dà origine alla creazione di figure professionali e di attività economiche rivolte al suo funzionamento, proporzionando di per sé già uno sviluppo dell’economia locale. A questo proposito FANFANO cita una serie di azioni che potrebbero essere perseguite con l’obiettivo di raggiungere la valorizzazione del patrimonio territoriale delle aree protette. Esse vanno dal mantenimento e ricostituzione del patrimonio paesisticoambientale locale fino al recupero delle feste tradizionali, passando per l’incentivo della produzione di qualità certificata – agricola e animale – e, legata a essa, la creazione del marchio di qualità che siano in grado di rendere riconoscibile il collegamento tra qualità del prodotto e qualità ambientale del territorio dove esso viene coltivato e, infine, l’incremento delle capacità ricettive e fruitive. Da auspicare anche, secondo lui, la creazione di un consorzio o associazione in grado di meglio coordinare le azioni tra i diversi organismi di gestione, sempre con l’obiettivo di raggiungere la valorizzazione del patrimonio territoriale e con esso lo sviluppo autosostenibile dell’area. Secondo FANFANO, una delle strategie da privilegiare per la valorizzazione del patrimonio territoriale e il raggiungimento dello sviluppo locale autosostenibile è quella del recupero di un’economia territoriale complessa. Essa, da parte sua, “richiede necessariamente di saper combinare innovazione e tradizione in maniera tale che anche attività economiche trasformate e nuovi processi di messa in valore del territorio si muovano comunque nell’ambito di una utilizzazione ‘sapiente’ e riconoscibile delle risorse” (FANFANO, 2000:44). A questo proposito il settore agricolo, dovuto anche alla sua importanza per l’economia locale, è stato quello che più si è organizzato verso quella direzione, sia attraverso la realizzazione di corsi di formazione di operatori che di pratiche colturali nel rispetto dell’ambiente in accordo con le direttive stabilite dall’Unione Europea. L’autore suggerisce anche la preparazione di corsi di operatori in grado di attuare nel mantenimento di opere forestali e di regimazione idraulica e, l’azione più 274 Secondo FANFANO, nel PTC di Prato sono state inserite, su richiesta dei comuni interessati, altre tre aree protette, una nel comune di Poggio a Caiano e altre due nel comune di Carmignano (Montalbano). Sempre secondo l’autore, “le ANPIL della Provincia di Prato sono un po’ anomale rispetto agli intendimenti della legge regionale (…)[: esse] devono essere di limitate dimensioni e di interesse sostanzialmente comunale. Vengono proposte dai comuni ed inserite in programmi triennali che la Provincia presenta alla regione” (FANFANO, 2004). 319 interessante, la “ricostituzione di alcuni legami di filiera fra le diverse attività legate al territorio aperto [la quale] implica inoltre il recupero di alcuni mestieri artigianali che tendono se non a scomparire quantomeno a ridursi drasticamente in termini di maestranze” (FANFANO, 2000:45)275. Gli strumenti amministrativi per la messa in atto di tale proposta sono individuati a livello provinciale, regionale ed europeo. La valorizzazione del patrimonio territoriale mette in discussione anche la questione dell’occupazione e delle attività connesse a nuovi modi di produzione di reddito. Uno dei motivi dell’emergere di questa questione è dovuto al raggiungimento dei limiti strutturali per l’espansione dell’attività tessile sia per quanto riguarda la sua collocazione in termini logistici e di accessibilità che per quanto riguarda le sue caratteristiche ambientali. Il risultato della crisi vissuta dal settore è sentito sia dalla dismissione di alcuni opifici di localizzazione sfavorevole dal punto di vista dell’accessibilità, sia dalla riduzione di posti di lavoro direttamente nel settore tessile che nella sua filiera economica. Parallelamente il settore terziario presenta una crescita considerevole in termini di attività – servizi professionali e finanziari, servizi ricettivi e di ristorazione – e di posti di lavoro – anche se tali posti non sono occupati maggiormente dai locali. L’autore sottolinea inoltre il fatto che tale crescita non era ancora in grado di offrire un modello alternativo con conseguente miglioramento delle condizioni globali del sistema insediativo. Da parte sua la gestione dei beni storico-ambientali, anche in termini di offerta turistica, pone, secondo FANFANO, “allo stesso tempo problemi ed opportunità. Da un lato infatti si segnala una crescente serie di iniziative ed attività volte a far conoscere ed apprezzare le non trascurabili dotazioni della valle, ma dall’altro tali iniziative spesso si sovrappongono, si incentrano prevalentemente su alcuni oggetti e situazioni eclatanti, mancano di valorizzare e riportare all’attenzione eventi e situazioni che costituiscono un patrimonio importante anche per gli abitanti della valle” (FANFANO, 2000:47). Nel tentativo di trovare una soluzione per questa problematica si era organizzato informalmente un gruppo di attori locali che cercavano di mettere in pratica il recupero della fruizione di alcuni luoghi importanti della Val di Bisenzio, inizialmente attraverso una sua riappropriazione da parte degli abitanti e visitatori, attività che secondo l’autore poteva essere rafforzata da un’azione connessa con il Centro di Documentazione Storico Etnografica (CDSE) di Vaiano che agisce su tutta la valle. I primi segni verso il cambiamento di tale quadro furono dati già dal Piano di Sviluppo della Comunità Montana 1999-2000 che, secondo l’autore, individuava la 275 A questo proposito l’autore ricorda le attività artigianali legate al settore della falegnameria ed ebanisteria (soprattutto legati alla produzione di mobili) e alle tecniche di lavorazione della paglia e della pietra. 320 necessità di interventi per la creazione di una struttura logistica di supporto alle attività zootecniche e agroalimentari; il recupero di alcuni edifici rurali da destinare all’agriturismo e la creazione di una rete telematica per il miglioramento della comunicazione interna che, da parte sua, avrebbe anche dato origine a nuovi posti di lavoro. Inoltre era prevista all’epoca la realizzazione del frantoio consortile che doveva avere “una certa flessibilità di utilizzo tale da consentire al suo interno anche attività di tipo promozionale e formativo connesse alla produzione e promozione del settore agro-alimentare e zootecnico locale” (FANFANO, 2000:48). Da prendere in considerazione, secondo FANFANO, anche la possibilità di aggiungere attività di confezionamento e commercializzazione diretta della produzione locale, anche di tipo biologico, favorendo la costruzione di un legame diretto fra produttori e consumatori atto a promuovere una maggiore conoscenza e valorizzazione del territorio276. “Sul versante della formazione appare necessaria una azione orientata al recupero delle competenze e delle tecniche tradizionali nell’ambito agro-paesistico ed una parallela iniziativa orientata all’aggiornamento degli operatori agricoli riguardo alle tecniche ed opportunità delle produzioni ambientalmente compatibili (lotta guidata, biologiche). Tale azione dovrà riguardare in generale sia le tecniche colturali che quelle relative alle diverse tipologie di sistemazione agraria caratteristiche del paesaggio locale (terrazzamenti, ciglionamenti, muri a secco, opere idrauliche e di regimazione)” (FANFANO, 2000:49). Tali azioni sono supportate da regolamenti e strumenti europei, regionali e provinciali. Questo era il quadro di riferimento per le azioni trovato da FANFANO nella Val di Bisenzio, il quale faceva intravedere l’attenzione da parte di soggetti pubblici e privati verso le attività legate al turismo e all’agricoltura di qualità in quanto cardini della valorizzazione del patrimonio territoriale e ambientale locale. Tale potenzialità doveva però essere messa in atto attraverso l’individuazione di circuiti economici che, interagendo in complementarità e sinergia, permettessero la costruzione di una rete di economia integrata volta al soddisfacimento della domanda locale, al radicamento locale dei produttori e a un maggiore coinvolgimento da parte degli abitanti in quanto promotori di uno sviluppo locale autosostenibile. 276 Come informa FANFANO, in un’intervista del 17 dicembre 2003, il consorzio per il Frantoio era stato creato circa due anni fa, coinvolgendo come soci soltanto soggetti pubblici come i comuni, la Provincia e la Camera di Commercio, quest’ultima proprietaria anche dello stabilimento. Oltre all’attività di frangitura, FANFANO insisteva sull’importanza che esso svolgesse anche attività didattiche, di promozione commerciale, di servizi alla comunità (sede per eventi, corsi ecc.), di controllo veterinario per l’abbattimento (anche per gli ungulati, grossa risorsa per la regione) e che, tramite i suoi soci, si costituisse un’agenzia di sviluppo locale per la Val di Bisenzio. 321 Avendo tracciato questo quadro di riferimento, l’autore presenta cinque proposte di azioni strategiche per il raggiungimento dell’autosostenibilità dello sviluppo del territorio rurale della Val di Bisenzio, partendo dal presupposto che esso “venga disegnato, perseguito e valutato su una visione relazionale ed integrata della dotazione territoriale, visione in grado di sviluppare al massimo le sinergie e le complementarità sussistenti e possibili fra le diverse risorse locali, siano esse antropiche, ambientali od economiche” (FANFANO, 2000:54). La prima azione proposta riguarda il rafforzamento del sistema insediativo policentrico attraverso il recupero dei centri storici minori. Tale azione è rivolta al “recupero insediativo e funzionale di alcuni dei centri sui quali si è strutturato nei secoli il processo di ‘territorializzazione’ che ha permesso al contempo l’evolvere della economia primaria della valle e l’opera di presidio umano sul territorio stesso” (FANFANO, 2000:54). Si tratta, secondo l’autore, di mettere in rete e connettere in modo coerente ipotesi di intervento già formulate dalle diverse amministrazioni locali o da alcuni privati. Le azioni proposte in questo ambito riguardano la valorizzazione e rivitalizzazione dell’insediamento attraverso opere di sistemazioni delle case e introduzione di attività ricettivo-culturali e di servizio, quali agriturismi, agricamping, ristorazioni, creazione di un Centro Convegni, incentivo alla produzione agricola di qualità e di vendita della produzione, visite guidate, stimolo a un turismo didattico legato alle varie aree naturali protette esistenti nel territorio della Comunità Montana; creazione di un parco fluviale e recupero dei mulini; recupero del sistema di coltivi coltivazioni e dei pascoli sommitali nel comune di Fossato; miglioramento della fruibilità del territorio e delle infrastrutture legate al turismo come spazi pubblici per il ristoro e parcheggi; infine, creazione dell’Ecomuseo dell’Appennino Pistoiese. La seconda azione riguarda l’integrazione fra agricoltura e ambiente per il mantenimento e recupero delle forme di paesaggio storico-ambientale tradizionale come valore aggiunto del sistema economico rurale. Tale azione è quella, secondo l’autore, che dovrebbe diffondersi maggiormente sul territorio e coinvolgere un numero significativo di attori e imprenditori del settore agroambientale, ridando così centralità economica all’attività agricola. FANFANO identifica due soggetti potenzialmente interessati a questo tipo di azione: da un lato, le aziende agrituristiche o agricole di produzione biologica o di qualità e, dall’altro, il sistema delle ville-fattoria. Per quanto riguarda le attività agrituristiche, si è già sottolineato quanto queste siano in crescita – soprattutto per ciò che si riferisce agli agriturismi e agricampeggi – nonché l’importanza di guidare queste iniziative verso forme di intervento che tengano conto delle caratteristiche ambientali e 322 paesistiche del luogo e che siano in grado di muoversi secondo criteri di durevolezza dello sviluppo. Inoltre, tenendo conto dell’importanza delle aree protette presenti nel territorio della Comunità Montana, l’autore ritiene interessante che le attività agrituristiche si integrino a quelle del turismo didattico. “Il rafforzamento dell’offerta agrituristica dell’area trarrebbe poi giovamento dalla ‘messa in rete’ dei diversi soggetti al fine di ottimizzare da un lato la fruizione dei principali servizi fruiti dalle aziende e, dall’altro, di comunicare verso l’esterno una immagine unitaria del sistema agrituristico della area” (FANFANO, 2000:59). Anche la produzione biologica o di qualità è in crescita nel territorio in questione, agevolato dalle varie normative e misure di incentivo sia a livello europeo che regionale. La crescita di questo tipo di produzione viene sostenuta dall’aumento dell’interesse da parte dei consumatori e dal potenziale mercato che essa apre, nonché da manifestazioni di carattere enogastronomico. A questo proposito “appare necessario uno sforzo comune da parte dei privati e delle amministrazioni, in particolare della Provincia, verso la costituzione di una rete cooperativa e sinergica che consenta di attivare una strategia unitaria di qualificazione e collocazione commerciale della produzione che vada dalla vendita diretta alla commercializzazione verso altri mercati. Da questo punto di vista appare necessario il rafforzamento di alcune filiere produttive (p.e. apicoltura, conserve, castanicoltura o olivicoltura) affinché il valore aggiunto costituito dalla tipicità della produzione non venga fruito in altri contesti territoriali” (FANFANO, 2000:59). Per quanto riguarda il sistema delle ville-fattoria, l’autore sottolinea la possibilità, attraverso iniziative di carattere promozionali e organizzative, di connettere in rete alcuni complessi edilizi intorno ai quali si è strutturata un’attività di valorizzazione agraria e paesistica del territorio. Una volta in atto, tale potrebbe costituirsi in un percorso tematico turistico e promozionale basato sul binomio produzione agricola tipica e di qualità/valori storici e ambientali. La terza azione si riferisce al recupero antropico-ambientale del sistema fluviale. FANFANO ritiene necessario un intervento volto da un lato alla riduzione dell’impatto ambientale degli opifici e dall’altro al recupero della fruizione a scopo ricreativo-culturale e di ricerca di alcuni manufatti dismessi e degli ambiti fluviali. Tali obiettivi sarebbero raggiunti attraverso: un’azione di bonifica ambientale; il blocco di nuovi impegni del suolo vicino all’alveo fluviale; la strutturazione di un percorso tematico di archeologia industriale di tipo Ecomuseo, riguardante edifici dismessi o no, mulini e frantoi; il completamento della pista ciclabile fino a Vaiano e il suo prolungamento fino a Vernio. 323 La quarta azione prevede il potenziamento della rete del trasporto pubblico ed uso locale della linea ferroviaria Prato-Vernio. Prevede anche il recupero ed integrazione ad uso locale di alcuni tratti di viabilità minore. Il programma di potenziamento della rete di trasporto pubblico ha come obiettivo il miglioramento del collegamento delle frazioni più distanti ai comuni di appartenenza e al capoluogo della provincia, permettendo così una migliore fruibilità dei servizi oltre che la riduzione del traffico negli orari di punta. Il potenziamento della linea ferroviaria prevede il rafforzamento della stazione di Vernio come principale stazione di collegamento PratoVal di Bisenzio, attraverso lo sfruttamento della linea verso Bologna soprattutto dopo l’entrata in vigore della linea ad alta velocità277. Il recupero della viabilità minore, a sua volta, ha come obiettivo il ripristino dell’accessibilità ai principali borghi ed edifici rurali sparsi per il territorio della Comunità Montana, in modo a consentire migliori condizioni di abitabilità278. La quinta e ultima azione riguarda il potenziamento dei servizi all’impresa di tipo agro-ambientale e al sistema insediativo rurale. Secondo l’autore, il recupero e valorizzazione di una vita economica dinamica nella Val di Bisenzio dipende da un’offerta di servizi adeguati, sia quelli riferiti alle imprese che quelli riferiti agli abitanti. Riguardo ai servizi alle imprese, FANFANO si riferisce a normative di certificazione ambientale dei processi produttivi, di creazione di marchio e certificazione geografica di provenienza, recupero di attività artigianali tradizionali, fornitura dell’infrastruttura necessaria a potenziare le attività turistiche, ecc. Per quanto riguarda gli abitanti, l’autore sostiene che il recupero e valorizzazione della vita economica della Valle possono avvenire attraverso la dotazione di servizi primari quali il miglioramento del sistema di mobilità, dell’offerta di servizi sociali quali scuole materne e asili nido, creazione di impianti sportivi, adeguamento del cinema di Vaiano, utilizzazione di alcune fabbriche dismesse come aree/laboratori per attività musicali, arti visive e teatrali, ecc. Con la conclusione del rapporto ANCI le attività che l’originarono sono state interrotte279. Però, anche senza una continuità temporale, a parere di FANFANO il suddetto rapporto ha costituito un precedente importante – anche se non l’unico – per la formazione di un approccio diverso di attuazione degli Enti presenti nell’area, rivolto al In funzione dei lunghi tempi necessari alla realizzazione della linea ad alta velocità si cercava già all’epoca di provvedere all’avviamento di tale servizio anche prima che essa cominciasse a funzionare. 278 L’autore suggerisce che sia data preferenza all’uso della “terra battuta o altri materiali innovativi ad alta stabilità e capacità drenante e a basso impatto visuale” (FANFANO, 2000:62) anziché all’asfalto. 279 FANFANO, come da intervista concessa il 17 dicembre 2003, ha però continuato a operare nell’area partecipando come architetto all’elaborazione del PTC della Provincia di Prato. 277 324 raggiungimento di uno sviluppo locale endogeno e autosostenibile. Il primo risultato è stato l’elaborazione, nella primavera del 2003, di un progetto pilota di Piano Integrato di Sviluppo Locale, da parte del comune di Vaiano e del gruppo di progetto del PTC di Prato. Tale progetto ha coinvolto nella fase di elaborazione diversi attori pubblici e privati280. Tra i soggetti pubblici, oltre il comune di Vaiano che, come promotore del progetto, ha funzione di guida del processo di promozione del patto, sono firmatari del piano e partecipi alla sua formalizzazione presso la Regione Toscana i comuni di Cantagallo e Vernio, la Comunità Montana Val di Bisenzio, la Provincia di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) di Prato, la Regione Toscana, l’Università di Firenze, il Centro di Documentazione Storico-Etnografico (CDSE) della Val di Bisenzio, l’Agenzia Regionale di Innovazione dello Sviluppo Agricolo (ARSIA) e il Servizio veterinario ed igiene degli alimenti dell’ASL281. Gli obiettivi di questo progetto sono: “- favorire la formazione, il consolidamento e la crescita coordinata di imprese agricole e agrituristiche che: sviluppino la produzione di prodotti agricoli e zootecnici tipici e di alta qualità, estendendo, dove possibile, la già avviata conversione verso tecniche biologiche (olio – come prodotto quantitativamente e qualitativamente trainante – ma anche ortaggi, farro, frutta, prodotti del sottobosco, castagna da frutto, animali da cortile, bovini di razza calvana, cinta senese, miele, ecc.); integrino a livello locale la coltivazione, l’allevamento e la cura del bosco (chiusura naturale del ciclo); intervengano nella manutenzione ordinaria dell’ambiente e del paesaggio; - organizzare centri di servizi multifunzionali per la produzione delle cultivar autoctone, la produzione biologica vivaistica di servizio delle aziende, l’assistenza formativa, tecnica e organizzativa alle aziende; - organizzare attività didattiche per la formazione rurale e ambientale; - organizzare la promozione culturale e commerciale dei prodotti locali; - organizzare filiere integrate interaziendali per la chiusura locale del ciclo: coltivazione, foraggio, alimentazione, concimazione (naturale e da compostaggio); - organizzare filiere di lavorazione, trasformazione e certificazione dei prodotti agroforestali, dell’allevamento e della caccia; - organizzare reti locali di commercializzazione dei prodotti biologici e tipici sui mercati locali ed esterni; Tra questi ultimi, diverse aziende agricole a produzione biologica o in conversione che, però, non hanno partecipato alla formalizzazione del progetto presso la Regione Toscana. 281 Di questi, soltanto i primi sei hanno firmato il protocollo di intesa presentato alla Regione Toscana. 280 325 - produrre un primo nucleo di azioni con valenza espansiva per la costruzione del distretto rurale della valle e le sue connessioni con il sistema territoriale provinciale; - migliorare la qualità della vita sul territorio, rilanciando il mondo rurale e il suo rapporto attivo e rigenerativo con la città” (COMUNE DI VAIANO E GRUPPO DI PROGETTO DEL PTC DI PRATO, 2002:4/5). Per la messa in pratica di questi obiettivi è prevista la creazione di un “CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI PER LO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE PRESSO L’EX FORESTALE DI VIVAIO VILLANOVA”, denominato BIAS (Bisenzio Agricoltura Sostenibile) e che dovrebbe lavorare in sinergia anche con il Frantoio Consortile di Vaiano. Tale centro ha quindi come obiettivi “sperimentare e diffondere processi economici di sviluppo locale, sostenibili e rispettosi delle risorse ambientali ed umane, capaci di modificare o arricchire le attuali filiere agro-silvo-pastorali ed alimentari presenti, sia nel territorio della valle del Bisenzio, sia in quello della Provincia di Prato” (PROVINCIA DI PRATO, 2003:1) Il centro articolerà le sue funzioni su due assi di azioni principali, uno bio-ecologico e l’altro bio-economico. Sull’asse bio-ecologico “s’inseriscono tutte quelle azioni tese al recupero di saperi, pratiche e attività, tipiche del patrimonio rurale del territorio della Valle e della Provincia di Prato, recuperate o riviste in chiave biologica o biodinamica” (PROVINCIA DI PRATO, 2003:2). I settori di attuazione di quest’asse sono: biodiversità, agrofarmacopea, qualificazione delle filiere agro-silvo-pastorali ed alimentari con tecniche biologiche o biodinamiche, aggiornamento/informazione e formazione. Le attività vanno dallo studio, tutela, recupero e messa a coltura di specie autoctone all’individuazione di colture utili in campo medico o cosmetico, passando per la sperimentazione e recupero di metodi di coltivazione rivolti al miglioramento qualitativo delle produzioni, per la creazione di canali d’aggiornamento e informazione per gli operatori del settore, nonché l’organizzazione di corsi formativi, con particolare attenzione all’orientamento dei giovani. Sull’asse bio-economico “s’inseriscono tutta una serie di funzioni finalizzate a creare delle ‘relazioni strategiche’ tra settori o funzioni apparentemente isolate o sconnessi, ma che in realtà hanno livelli d’interazione, solo parzialmente evidenti” (PROVINCIA DI PRATO, 2003:2). I settori di attuazione di quest’asse sono: agricoltura e tessile, agrofarmacopea, filiere agro-silvo-pastorali ed alimentari, agriturismo, marketing territoriale, ricettività e convegnistica, colture e culture. Tra le attività che dovranno essere svolte si possono citare la sperimentazione della coltivazione di piante da fibra oppure di piante utili alla rifinitura e colorazione per l’utilizzo in campo tessile, in collaborazione con altri organismi di ricerca; promozione di colture e attività agroambientali di prodotti utili all’industria 326 chimico/farmaceutica o cosmetica; “promozione e sostegno di reti di commercializzazione delle produzioni locali, sia su ‘reti lunghe’ (mercati sovra locali), sia su ‘reti corte’ (mercati provinciali)” (PROVINCIA DI PRATO, 2003:3); promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale della valle con l’obiettivo di sviluppare l’attività agrituristica; avviare “azioni di marketing territoriale in grado di facilitare l’individuazione di strumenti finanziari o normativi a sostegno della progettualità ed all’attività d’enti pubblici e privati” (PROVINCIA DI PRATO, 2003:3); creazione di un centro di ricettività e convegnistica con la costruzione di una sala multifunzionale, destinata a essere usata per convegni, seminari o giornate di alto livello, in grado di accogliere 200 persone nonché la creazione di una struttura di accoglienza con 30 posti letto situata nello stesso edificio della sala multifunzionale e di un agricampeggio adatto ad accogliere il turismo scolastico e ambientale. Il centro sarà anche dotato “di un campo scuola, in cui i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado potranno svolgere esperienze di natura scientifico-ambientale, storicoetnografica o artistico-espressiva, finalizzate ad illustrare lo stretto rapporto tra ambiente, uomo e impresa, coerente con le indicazioni metodologiche individuate in occasione dell’adesione al bando provinciale del Progetto INFEA, e condivise nell’ambito del Protocollo d’intesa per il Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, a quale aderiscono gli enti e le istituzioni scolastiche della Valle del Bisenzio” (PROVINCIA DI PRATO, 2003:3). I vari enti che firmano il protocollo d’intesa – Provincia di Prato, Comunità Montana Val di Bisenzio, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Vaiano – s’impegnano a far funzionare il centro nel migliore dei modi, cercando fonti di finanziamento nei più variati livelli e assumendo le sue responsabilità quali la messa a disposizione di strutture e terreni, la sua eventuale sistemazione, ecc. 2. Dall’agricoltura naturale all’agricoltura sinergica 2.1. Tante agricolture Prima di trattare dell’agricoltura naturale vale la pena di chiarire in quale modo essa viene messa a fuoco da FUKUOKA. L’autore distingue cinque tipi diversi di agricolture: l’agricoltura tradizionale, moderna, scientifica, organica, naturale Mahayana e naturale Hinayana. A esse va aggiunta un’altra, l’agricoltura sinergica, sviluppata da HAZELIP a partire dagli insegnamenti di FUKUOKA, nel tentativo di adattarli alla realtà europea. Per agricoltura tradizionale FUKUOKA intende quella che fa uso di cavalli e buoi per l’aratura dei campi. Per agricoltura moderna quella che ricorre alla meccanizzazione per 327 l’aratura. Per agricoltura scientifica quella che fa ampio uso dei risultati della ricerca scientifica per aumentare la produttività del suolo (come per esempio l’uso di sostanze chimiche, sementi migliorate, gli stessi macchinari per l’aratura, ecc.). Questo tipo di pratica agricola, secondo lui, conduce a un allontanamento dalla natura nonché alla produzione di cibi “artificiali”. Secondo l’autore, i risultati da essa ottenuti possono essere considerati eccellenti in senso ristretto ma inferiori se considerati ampiamente e soprattutto se paragonati ai risultati ottenuti dall’agricoltura naturale282. L’autore critica le ricerche scientifiche che contemplano ogni elemento isolatamente e non tengono conto del problema nella sua totalità. FUKUOKA ritiene che l’agricoltura scientifica cammini in una direzione diametralmente opposta a quella della natura e quindi dell’agricoltura naturale. Secondo lui, essa si serve della natura in quanto fonte di conoscenza, da studiare e analizzare in tutte le sue componenti in modo da poter capire il suo funzionamento per superare i suoi limiti, non per andare in cooperazione e armonia con essa, pratica che conduce a un allontanamento sempre maggiore tra uomo e natura. Secondo lui, i “metodi scientifici avranno sempre la meglio quando la coltivazione si svolge in un ambiente innaturale e in condizioni innaturali che negano alla natura i suoi pieni poteri, come una crescita accelerata delle colture e la coltivazione in appezzamenti di terra ristretti, vasi di argilla, serre e ‘letti caldi’. E questo solo perché in così innaturali condizioni l’agricoltura naturale non ha neanche una possibilità di esistere” (FUKUOKA, 2001: 110). L’agricoltura organica attualmente in espansione nell’Occidente, secondo lui, si basa sugli stessi principi dell’agricoltura tradizionale orientale come era stata praticata per molti secoli in Giappone, Cina e Corea. Si trattava di “un metodo che accentuava la fondamentale importanza del compost[aggio] e del riciclaggio dei rifiuti umani e animali. La forma di coltivazione era intensiva e comprendeva pratiche come la rotazione, la consociazione e l’uso di concimazioni verdi (sovesci). Poiché lo spazio era limitato, i campi non venivano mai lasciati a riposo e i programmi di semina e raccolto procedevano con precisione. Tutti i residui organici venivano trasformati in composto e ritornavano ai campi. L’uso del composto era incoraggiato ufficialmente e la ricerca agraria si occupava principalmente delle tecniche di preparazione della materia organica e di compostaggio” (FUKUOKA, 1980: 137). L’agricoltura naturale, invece, diversamente degli altri tipi di agricoltura, si basa su una filosofia che va al di là delle considerazioni degli aspetti tecnici e produttivi come l’analisi 282 FUKUOKA insiste sul fatto che i raccolti superiori ottenuti dall’agricoltura scientifica in condizioni artificiale sono ottenuti attraverso un elevato costo energetico e che alla fine, se si facessero i conti costo energetico/raccolto, si arriverebbe alla conclusione di che questi non sono vantaggiosi e che i raccolti ottenuti non giustificano l’alto consumo energetico impiegato per produrli. 328 del suolo, del ph e delle rese produttive. Secondo l’autore esistono due tipi diversi di agricoltura naturale: una, l’agricoltura naturale completa – chiamata da lui agricoltura Mahayana – e l’altra, l’agricoltura naturale limitata al mondo relativo – chiamata da lui agricoltura Hinayana. “L’agricoltura naturale Mahayana nasce da sola quando esiste un’unità fra uomo e natura. Si conforma alla natura com’è, e alla mente come è. Deriva dalla convinzione che se la persona abbandona temporaneamente la volontà umana e si lascia guidare dalla natura, questa risponde provvedendo tutto. (…) D’altra parte l’agricoltura naturale ristretta cerca di seguire la via della natura; consapevolmente tenta con l’«organico» o altri metodi di seguire la natura. (…) Il punto di vista ristretto dell’agricoltura naturale dice che è bene per il coltivatore portare materiali organici al suolo, è bene allevare animali, e che questa è la maniera migliore e più efficiente per usare la terra. (…) L’agricoltura naturale pura, invece, (…) non va da nessuna parte e non cerca nessuna vittoria. (…) Lo scopo vero dell’agricoltura non è coltivare le piante, ma la coltivazione e il perfezionamento degli esseri umani” (FUKUOKA, 1980:138/139). Secondo l’autore, l’agricoltura naturale Hinayana e quella scientifica – alle quali aggiungo anche quella organica – derivano dalla natura studiata con conoscenze analitiche. La differenza è che, mentre l’agricoltura Hinayana “cerca di eliminare le conoscenze e le azioni umane per dedicarsi al maggior uso possibile delle sole forze della natura, (…) quella scientifica usa i poteri della natura e aggiunge le conoscenze e le azioni umane nello sforzo di creare un modo superiore di coltivare” (FUKUOKA, 2001:107). FUKUOKA ritiene essere ormai impossibile raggiungere la vera agricoltura naturale Mahayana dato che i raccolti e gli animali domestici non appartengono più alla natura. Questo non vale però per l’agricoltura naturale Hinayana, che cerca di avvicinarsi il più possibile alla natura. Per raggiungerla, è necessario esaminare attentamente una situazione di laissez-faire, e cioè, di osservare la natura abbandonata dall’uomo e cercare di ricostruire, per quanto possibile, quella situazione. Infine, l’agricoltura sinergica, praticata e diffusa da Emilia HAZELIP, si è sviluppata a partire dal lavoro di FUKUOKA. Trattasi di una agricoltura che permette al suolo coltivato di mantenersi selvaggio, anche con alcuni adattamenti come può essere l’uso delle macchine. Questa agricoltura richiede molto lavoro per mantenere in un suolo coltivato fertile e sano la sua dinamica selvaggia, non potendo quindi essere definita come l’agricoltura del «Non Fare» di Fukuoka. “La Sinergia implica il funzionamento dinamico e concertato di vari organi per realizzare una funzione. (…) [Questa] sinergia è presente tra la terra ed i microrganismi che la 329 abitano – arricchendola – o tra i legumi e i batteri fissatori di azoto atmosferico o nell’associazione tra piante che si danno mutuo beneficio. Questo sistema di agricoltura naturale (…) protegge l’ecosistema del suolo permettendo alla terra di mantenere i suoi propri strati, senza agitarla né rivoltarla, comprendendo che la terra ha capacità di autofertilizzarsi. Lavorando su bancali (aiuole), di 120 cm di larghezza e 50 di altezza, il suolo si copre con pacciamatura, strato di resti organici che fa da filtro protettore tra la superficie della terra e i gas atmosferici, la forza disseccante del sole, e quella compattante ed erosiva della pioggia e il vento. Copertura che diventa anche un concime di superficie che va ad alimentare la terra da sopra a sotto. Così si stabilisce nel suolo un equilibrio stabile tra i suoi abitanti, siano lombrichi lavoratori di profondità, lombrichi rossi del mantello (strato superficiale) o i miliardi di ogni specie di essere microscopici vegetali o animali che vivono e muoiono nel suo seno. In nessun momento vanno traumatizzati modificando e sconvolgendo il loro abitat. Imitare ciò che fa la natura implica lasciare la terra sempre coperta con una pacciamatura, aperta solo negli spazi o nelle linee di semina. La pacciamatura si va trasformando in mantello, in humus. Affinché la terra disponga di materia organica dentro di sé, senza la necessità di interrarla, si lasciano sempre dentro le radici, eccetto quelle che si raccolgono per il consumo. Questi resti nutrono la flora intestinale della terra e questa a sua volta permette la nutrizione delle piante” (HAZELIP, 2003:22/23). 2.2. FUKUOKA e l’agricoltura naturale «Quando si capisce che si perde la gioia e la felicità nello sforzo di possederle, si arriva all’essenza dell’agricoltura naturale»283 L’agricoltura naturale è, oltre che una forma di coltivazione, una filosofia di vita. Nonostante le importanti novità introdotte – come l’uso della paglia, la semina deliberata di leguminose come il trifoglio e l’erba medica – la pratica e la filosofia di questa tecnica sono molto vicine a quelle dei popoli nativi prima dell’introduzione dell’agricoltura europea. FUKUOKA – scienziato agricolo specialista in microbiologia e patologia vegetale – ha avuto l’imput per cominciare a dedicarsi a questa forma di coltivazione quando, “passando nella provincia di Kochi per un vecchio campo di riso che era stato lasciato abbandonato e incolto per molti anni, [vide] del giovane riso sano che vegetava su attraverso un groviglio di erbacce e paglia che si erano accumulate sulla superficie del campo” (FUKUOKA, 1980:193). Tale osservazione gli fece pensare che la natura lavorasse da sé e 283 FUKUOKA, 1980, p. 14. 330 che molte delle azioni svolte dagli uomini nella coltivazione delle piante fossero del tutto inutili. Deciso a mettere in pratica il suo pensiero per capire se aveva ragione o torto, egli risolse di spendere la sua vita a produrre riso e cereali invernali. “Da quel momento in poi smise di allagare il suo campo per coltivare il riso. Smise di seminare il riso in primavera e invece cominciò a buttare il seme in autunno direttamente sulla superficie del campo nel periodo in cui sarebbe caduto al suolo naturalmente. Invece di arare il terreno per liberarlo dalle erbacce, imparò a controllarle con una copertura più o meno permanente di trifoglio bianco e pacciame di paglia di riso e di orzo” (KORN in FUKUOKA, 1980:19/20). Nel suo podere, situato nella provincia di Ehime in Giappone, FUKUOKA oggi possiede un frutteto e un orto284. Nel frutteto ci sono delle capanne dove vengono ospitate le persone che lì si recano per imparare la pratica dell’agricoltura naturale. La giornata inizia alle otto e finisce poco prima del tramonto, con un ora di intervallo per il pranzo che diventano due o tre nelle giornate calde dell’estate. Le attività cambiano a seconda delle condizioni climatiche e della stagione. “Oltre ai lavori agricoli ci sono gli incarichi quotidiani del trasporto dell’acqua, del taglio della legna, cucinare, preparare il bagno caldo, accudire le capre, dar da mangiare alle galline e raccogliere le uova, star dietro alle arnie delle api, riparare e ogni tanto costruire nuove capanne e preparare il miso (pasta di soia) e il tofu (cagliata di soia)” (KORN in FUKUOKA, 1980:18). FUKUOKA provvede circa 35 dollari al mese285 per le spese di prima necessità che non vengono prodotte all’interno della comunità, quale salsa di soia, olio vegetale, ecc. Per tutto il resto gli studenti devono contare sul raccolto e le risorse locali. FUKUOKA lavora insieme agli studenti nei campi, insegnando loro i modi in cui il lavoro può essere compiuto più facilmente, trattando del ciclo vitale di un’erba, spiegando gli effetti di una malattia, ecc. Secondo lui, uno dei principali problemi dell’agricoltura tradizionale è l’eccesso di lavoro inutile, motivo per cui chiama il suo metodo l’agricoltura del non-fare, anche se questo non significa che non si lavori. Anzi, il suo podere è condotto secondo un preciso calendario di giornate lavorative e il lavoro da compiere deve essere fatto con cura e precisione. Secondo KORN uno dei maggiori vantaggi del metodo praticato da FUKUOKA è la possibilità di coltivare riso senza dover inondare il campo durante il periodo di vegetazione. Inoltre, l’uso della pacciamatura, nell’aumentare la capacità del terreno di trattenere l’acqua, oltre a eliminare la necessità di irrigare, rende possibile la messa in coltivazione di aree prima ritenute inadatte, tra cui i terreni in pendenza, senza rischi di 284 285 Non sono riuscita, purtroppo, a rilevare l’area del suo podere. I dati sono relativi agli anni ’70. 331 erosione. Anzi, con l’agricoltura naturale, il suolo già danneggiato da pratiche agricole viene gradualmente riabilitato. Le malattie e gli insetti sono presenti nel frutteto e nei campi, ma colpiscono soltanto le piante più deboli senza compromettere il raccolto. Gli alberi da frutta non sono potati ma lasciati crescere nelle loro forme naturali. Inoltre, lungo i pendii del frutteto e con un minimo di preparazione del terreno, possono essere seminati ortaggi ed erbe aromatiche mescolati insieme alle erbacce e al trifoglio. “Le erbacce devono essere tagliate quando le piantine degli ortaggi sono giovani, ma quando queste hanno attecchito bene, si lasciano crescere insieme alla copertura naturale del terreno. Non tutti gli ortaggi vengono raccolti, di qualcuno si lasciano cadere i semi perché dopo una o due generazioni ritornino alle abitudini di crescita dei loro antenati selvatici, che erano più forti e di sapore leggermente amaro. Molti di questi ortaggi crescono completamente senza cure” (KORN in FUKUOKA, 1980:23). FUKUOKA centra la sua attenzione nell’importanza della paglia per l’agricoltura. Per la coltivazione del riso e dei cereali invernali la semina viene fatta semplicemente gettando i semi di segale e orzo in campi separati durante l’autunno, mentre il riso è ancora in piedi. Poche settimane dopo il riso è raccolto e la sua paglia sparsa nei campi seminati di cereali. Per la semina del riso il processo è lo stesso: due settimane prima di raccogliere il cereale si semina il riso e, dopo la mietitura e la battitura dei cereali, la paglia è sparsa nei campi di riso. Oltre al riso e i cereali ci sono il trifoglio e le erbacce. Il trifoglio è seminato fra le piante di riso all’inizio del mese, poco prima di seminare i cereali mentre le erbacce crescono da sole. “L’ordine delle semine in questo campo è perciò il seguente: ai primi di ottobre il trifoglio in mezzo al riso, il cereale d’inverno segue a metà mese. Ai primi di novembre si raccoglie il riso e si risemina subito dopo quello dell’anno seguente, dopodiché si sparge la paglia per tutto il campo” (FUKUOKA, 1980:32). Questo metodo di coltivazione permette di ottenere una produzione uguale o superiore a quella di una moderna azienda media giapponese senza usare grossi macchinari, concime preparato, né alcun prodotto chimico. Per più di quarant’anni FUKUOKA si è occupato di sviluppare nei migliori dei modi il suo metodo del non fare, domandandosi sempre quale delle pratiche agricole tradizionali potessero non essere fatte senza compromettere la produzione. Alla fine, ha concluso per la non necessità di arare, dare fertilizzanti né pesticidi. Secondo lui, la maggior parte delle tecniche che sembravano indispensabili in realtà lo erano diventate per la rottura dell’equilibrio naturale: ristabilendo tale equilibrio, queste tecniche perdono la loro ragione d’essere. 332 FUKUOKA parlò per la prima volta negli anni ’50 del suo metodo di coltivazione. La risposta arrivò soltanto vent’anni dopo, quando il numero di persone interessate all’agricoltura naturale aumentò considerevolmente, segnale, secondo lui, che il limite dello sviluppo scientifico era stato raggiunto. Coltivare naturalmente significa un ritorno alle fonti dell’agricoltura. Far crescere dei raccolti in campi non arati può sembrare un regresso all’agricoltura primitiva, ma diversi esperimenti scientifici – oltre che i risultati pratici da lui ottenuti – hanno provato che si tratta di un metodo semplice, avanzato e il più efficiente di tutti. 2.3. I principi dell’agricoltura naturale «Passate con attenzione attraverso questi campi. Libellule e farfalle che volano in un turbinio di vita. Api che ronzano di fiore in fiore. Scostate le foglie e vedrete insetti, ragni, rane, lucertole e molti altri piccoli animali che si danno da fare nell’ombra fresca, e talpe e lombrichi che scavano sotto la superficie. Questo è l’ecosistema del campo di riso in equilibrio. Le popolazioni di piante e insetti qui mantengono fra loro dei rapporti stabili. Non è raro che qualche malattia delle piante venga a devastare questa regione, lasciando intatti i raccolti di questi campi»286 La ricerca dell’equilibrio naturale è, dunque, il motore dell’agricoltura naturale proposta da FUKUOKA. Per raggiungere questo equilibrio egli si basa su cinque principi fondamentali287 i quali, nel rispetto dell’ordine naturale, portano alla ricostruzione delle ricchezze della natura e quindi procedono al recupero della fertilità naturale del suolo. Il primo principio è: “NESSUNA LAVORAZIONE, cioè niente aratura né capovolgimento del terreno. (…) La terra si lavora da sola per natura con la penetrazione delle radici delle piante e l’attività dei microorganismi, dei piccoli animali e dei lombrichi” (FUKUOKA, 1980:58). Secondo FUKUOKA, arare “la terra e seminarvi un solo raccolto fa diminuire rapidamente la fertilità del suolo e richiede che il terreno venga ingrassato con concimi animali, vegetali decomposti, fertilizzanti chimici o una leguminosa miglioratrice come un trifoglio. La diminuzione di fertilità porta ad un indebolimento delle piante che diventano così più accettabili dalle malattie e dalle infestazioni da parassiti” (FUKUOKA, 1980:10). Secondo lui, nel dissodare una zona naturale, le erbacce più invadenti tendono a prendere il sopravvento, rendendo obbligatorio il lavoro di diserbo ogni anno. Inoltre, rivoltando il terreno, il contadino lo frantuma in particelle sempre più piccole, facendolo 286 287 FUKUOKA, 1980, p. 57. Nel libro La rivoluzione del filo di paglia, FUKUOKA si riferisce a quattro pilastri. Nell’introduzione del suo La fattoria biologica, ai quattro citati nel La rivoluzione… di cui ora si tratterà egli aggiunge un quinto. 333 diventare sempre più denso e più duro. FUKUOKA sottolinea la necessità di un terreno gonfio e poroso affinché i microrganismi si moltiplichino, lasciando il terreno più fertile e permettendo così che le radici penetrino più a fondo dando più forza e resistenza alla pianta. Egli non ritiene sbagliato rimuovere il terreno per aumentare la sua porosità, solo che, a tal fine non è necessaria l’aratura: basta semplicemente spargere la paglia e seminare il trifoglio perché l’ambiente naturale torni in equilibrio, il terreno riprenda la sua fertilità naturale e le erbacce infestanti siano così messe sotto controllo. Il secondo principio è: “NESSUN CONCIME CHIMICO NÉ COMPOSTO PREPARATO. (…) Lasciato a se stesso, il suolo conserva naturalmente la propria fertilità, in accordo con il ciclo ordinato della vita vegetale e animale” (FUKUOKA, 1980:58). L’autore non ritiene che la fertilizzazione non è importante, soltanto mette in dubbio la necessità di usare i prodotti chimici, sostenendo che la natura offre da sola tutti i fertilizzanti necessari per far crescere le piante288. Secondo lui, se la natura è lasciata a se stessa, la fertilità aumenta grazie ai resti organici delle piante e degli animali che si accumulano e decompongono sulla superficie dai batteri e dai funghi. L’acqua piovana avrebbe trasportato, poi, le sostanze nutritive profondamente nel terreno, facendoli diventare alimento per i microrganismi, i lombrichi e gli altri piccoli animali. Infine, le radici delle piante, raggiungendo gli strati più bassi del suolo, le avrebbe riportati alla superficie. Per provvedere il concime animale, aiutare a decomporre la paglia messa sul campo e mantenere le erbacce sotto controllo, FUKUOKA consiglia che alcune anatre siano lasciate libere sul campo289. In alternativa all’uso delle anatre, egli consiglia l’uso della pollina. Il terzo principio è: “NESSUN DISERBO, NÉ CON L’ERPICE, NÉ COI DISERBANTI. Le erbacce hanno il loro ruolo nella costruzione della fertilità del suolo e nell’equilibrare la comunità biologica. Come norma fondamentale le erbacce dovrebbero essere controllate, non FUKUOKA richiama l’attenzione su quattro effetti che l’uso dei fertilizzanti chimici causano sull’equilibrio prima esistente. Primo, se è vero che i fertilizzanti (così come gli ormoni) accelerano la crescita dei raccolti, è altrettanto vero che tale effetto ha azione temporanea e locale e non elimina il loro inevitabile indebolimento. Secondo, le piante indebolite dai fertilizzanti hanno meno resistenze a malattie, insetti nocivi e ad altri eventuali ostacoli. Terzo, oltre il 70% dei tre fertilizzanti più usati – il solfato di ammonio, il perfosfato e il solfato di potassio – contengono acido solforico che, rendendo il terreno acido, uccide i microrganismi del suolo e, paradossalmente, compromette la fertilità naturale. Quarto, la carenza di oligoelementi essenziali alle piante occasionata dall’uso eccessivo dei fertilizzanti causa alla lunga la diminuzione dei raccolti. Oltre a questo, ricorda anche che l’alto prezzo di queste sostanze contribuisce a diminuire i guadagni ottenuti con la vendita della produzione. 289 Secondo lui, dieci anatre erano sufficiente per provvedere il letame necessario a mille metri quadrati di terreni. 288 334 eliminate. Del pacciame di paglia, una copertura del terreno con trifoglio bianco consociato alle colture e una temporanea sommersione provvedono un efficace controllo delle erbacce nei miei campi di riso” (FUKUOKA, 1980: 58). Le radici delle erbacce contribuiscono a smuovere il terreno e, quando esse muoiono, lo arricchiscono con l’humus che permette la proliferazione dei microbi, facendo sì che le piogge filtrino meglio nel suolo e che l’aria penetri in profondità, nutrendo i lombrichi che a loro volta attraggono le talpe. Inoltre, l’assenza delle piante sul terreno contribuisce all’erosione o comunque alla perdita dello strato superficiale, riducendo, a lungo andare, la fertilità del terreno. Il metodo proposto da FUKUOKA prevede la coltivazione con zolle erbose e piante da sovescio che prendono il posto delle erbacce indesiderate, evitando così la necessità di sarchiare, oltre ad arricchire il terreno e prevenire l’erosione. Secondo l’autore, non appena le lavorazioni sono interrotte il numero di erbacce e le varietà presenti nel campo cambiano sensibilmente. In più, se i semi sono sparsi quando la coltura precedente è ancora a maturare nel campo, essi germinano prima delle erbacce e quindi non si hanno effetti negativi. Per ultimo, se subito dopo la mietitura tutto il campo è ricoperto di paglia si riesce a fermare la germinazione delle erbacce. Il quarto principio è: “NESSUNA DIPENDENZA DA PRODOTTI CHIMICI. Dall’epoca in cui si svilupparono delle piante deboli per effetto di pratiche innaturali come l’aratura e la concimazione, le malattie e gli squilibri fra insetti divennero un grande problema in agricoltura. La natura, lasciata fare, è in equilibrio perfetto. Insetti nocivi e agenti patogeni sono sempre presenti, ma non prendono il sopravvento mai fino al punto da rendere necessario l’uso di veleni chimici. L’atteggiamento più sensato per il controllo delle malattie e degli insetti è avere delle colture vigorose in un ambiente sano” (FUKUOKA, 1980:58/59)290. L’autore richiama l’attenzione sui pericoli dell’uso indiscriminato dei pesticidi sia per quanto riguarda la loro azione di rottura dell’equilibrio naturale – e il rischio della distruzione dell’ecosistema naturale – che per quanto riguarda i suoi effetti sulla salute umana. Egli ricorda che oltre all’insetto che si pretende di eliminare con l’uso di un determinato insetticida, vengono eliminati anche i loro predatori naturali nonché colpite altre catene di avvenimenti naturali fondamentali alla manutenzione di tale equilibrio. Il metodo proposto da FUKUOKA è efficace quando c’è ancora qualcosa da salvare ma, una volta che l’ecosistema è stato distrutto, non resta più nulla da fare. Inoltre un altro 290 FUKUOKA “coltiva i suoi cereali senza sostanze chimiche di nessun tipo. Su alcune piante da frutta ogni tanto usa irrorare con la macchina a spalla un’emulsione d’olio per il controllo delle cocciniglie. Non usa nessun veleno persistente né ad ampio spettro e non ha un programma di trattamenti antiparassitari” (FUKUOKA, 1980: 58/59 n. *). 335 pregio dell’agricoltura naturale è la possibilità di riportare campi danneggiati da lavorazioni e uso di sostanze chimiche alla loro fertilità naturale, provvedendo da sé all’abbandono dell’uso dei prodotti chimici. Il quinto principio è NIENTE POTATURA. Secondo FUKUOKA, i frutticoltori non si preoccupano della forma naturale dell’albero ma cercano di adattarlo il più possibile alle varie attività che devono svolgere quotidianamente come la sarchiatura, l’aratura, la lotta contro le malattie, la concimazione, l’applicazione di pesticidi, la fumigazione e la raccolta. Per questo potano e controllano la crescita periodicamente, adattando l’albero alle loro necessità. Basta però una semplice spuntata per danneggiare la crescita naturale di un albero e rendere obbligatori altri lavori di potatura. Una volta che un albero è potato, esso non può più essere trascurato, altrimenti i rami si intrecciano e si aggrovigliano tra loro, rendendo impossibile il lavoro di raccolta e contribuendo alla facile propagazione delle malattie da un albero all’altro, oltre a provocare il suo indebolimento e la morte. Invece, lasciata da sé sin dall’inizio, la pianta cresceva armonicamente. Per passare a coltivare gli alberi da frutti attraverso l’agricoltura naturale, il primo – e principale – problema da risolvere è sapere qual è la loro forma naturale e cercare di avvicinarsi a essa il più possibile. FUKUOKA affronta il problema cercando la corretta spaziatura tra i rami291. Tra i vantaggi dell’uso della forma naturale si possono citare il migliore adattamento alle condizioni di coltivazione e alle condizioni ambientali, fatto che favorisce la massima crescita e la massima esposizione alla luce solare, permette la migliore distribuzione e fornitura di nutrienti ai rami principali e secondari e, conseguentemente, garantisce il massimo rendimento. FUKUOKA cita due delle difficoltà più frequentemente trovate per la pratica della frutticoltura naturale, e indica anche il modo migliore di risolverle. La prima è la scarsa quantità di rami, foglie e frutti che alcuni tipi di alberi come il kaki, il pero, il melo e le viti possiedono nella loro forma naturale, problema che si può risolvere con una potatura prudente volta a incrementare la densità di formazione di frutti nei rami. La seconda è l’altezza raggiunta da alcuni alberi a forma piramidale, tale da creare alcune difficoltà per il 291 Prima egli aveva provato con la semplice interruzione della potatura, ma i risultati erano stati deludenti: i rami si erano infittiti e gli alberi erano morti. Poi aveva provato a piantare il seme direttamente nel frutteto, ma questo era servito soltanto a farlo capire quale avrebbe potuto essere questa forma. Dopo molti studi, concluse che la differenza di forma tra gli alberi dipendeva soprattutto dal diverso numero, angolatura e direzione dei rami principali che crescevano dal fusto centrale e che li facevano assomigliare agli alberi delle foreste. Gli studi hanno portato FUKUOKA a concludere che la “forma naturale consiste in un eretto tronco centrale, che evita un intreccio con gli alberi vicini e un aggrovigliamento di rami e foglie. La necessità di potatura gradualmente diminuisce e si verificano solo lievi danni da malattie e insetti; le cure necessarie sono pertanto minime” (FUKUOKA, 2001:245). 336 raccolto dei frutti più alti, problema che si risolve da solo quando l’albero attinge l’età matura, quando la disposizione dei rami permette un facile arrampicata. Rispetto ai meriti di questo tipo di pratica, FUKUOKA ne cita cinque: “1. Raggiungere la forma naturale per mezzo di una precoce potatura formativa riduce al minimo il lavoro e gi sprechi e favorisce alti rendimenti. 2. Un albero a radici profonde adattato all’ambiente circostante, la cui porzione superiore sia in equilibrio con il sistema radicale, cresce rapidamente, è sano, resistente al freddo, al gelo e alla siccità e sopporta strenuamente le calamità naturali. 3. L’assenza di rami superflui riduce al minimo la necessità di potare. La buona penetrazione della luce solare e la ventilazione riducono le possibilità di produrre un raccolto pieno solo ad anni alterni e di attacchi di malattie e insetti. 4. Se la forma dell’albero dovesse per forza essere cambiata per adattarlo alla topografia locale o a pratiche meccanizzate, il ritorno alla potatura sarebbe un’operazione semplice e senza difficoltà inutili. 5. Le tecniche di potatura usate in frutticoltura tendono a cambiare con il passare del tempo, ma la forma naturale di un albero rimane sempre la stessa. L’uso della forma naturale è il migliore approccio possibile per una coltivazione di frutti stabile e ad alti rendimenti senza spreco di lavoro” (FUKUOKA, 2001:248). La proposta di FUKUOKA per la frutticoltura naturale rispetta le stesse regole della sua agricoltura naturale. Nel suo podere FUKUOKA coltiva diverse varietà di agrumi sulle pendici del monte vicino a casa sua e il suo agrumeto si è formato rilevando la terra dei pendii circostanti che erano stati abbandonati. Dato che in diversi di questi pendii i pini erano stati tagliati pochi anni prima, il suo lavoro è stato quello di scavare delle fosse secondo le linee ipsometriche e piantare gli alberi di agrumi. “Tagliai la maggior parte dei germogli di pino, ma lasciai che alcuni ricrescessero come frangivento. Poi ho interrotto la crescita dei cespugli e del manto erboso del terreno e ho seminato il trifoglio. Dopo sei o sette anni finalmente le piante di agrumi fruttificarono. Ho tolto la terra di dietro le piante per formare terrazze e il frutteto appare adesso un po’ diverso da tutti gli altri” (FUKUOKA, 1980:82). Secondo lui, mentre le piante crescevano sotto le piante forestali rigermogliate non esisteva nessuna traccia di danni di insetti. Soltanto quando i cespugli e i nuovi getti degli alberi furono tagliati, rendendo la terra più simile a un frutteto è che apparvero gli insetti. Per migliorare il terreno del frutteto FUKUOKA fece uso anche dell’acacia Morishima: questa “pianta [cresceva] tutto l’anno e [metteva] fuori nuovi germogli in tutte le 337 stagioni. Gli afidi che si [nutrivano] di questi germogli cominciarono a moltiplicarsi. Le coccinelle trovarono negli afidi un cibo abbondante e presto anche loro cominciarono ad aumentare di numero. Dopo che le coccinelle ebbero divorato tutti gli afidi, scesero sulle piante di agrumi e cominciarono ad alimentarsi di altri insetti come acari, cocciniglie virgole e cocciniglie cotonose” (FUKUOKA, 1980:84)292. L’altra procedura usata da lui per migliorare il terreno è stata il seppellimento di legno che, al decomporsi, aumentava la quantità di terriccio fertile. Inoltre, per migliorare lo strato superficiale del suolo, egli seminò un miscuglio di trifoglio bianco ed erba medica. Seminò anche il ramolaccio le cui radici penetravano nel terreno aggiungendo sostanza organica e aprendo canaletti che favorivano la circolazione di aria e acqua. FUKUOKA ricorda che con il miglioramento del suolo ritornarono le erbacce, ma il suo controllo era stato fatto con una nuova semina di trifoglio. 2.4. L’agricoltura naturale nella pratica FUKUOKA espone nei dettagli il piano annuale di lavoro nel suo podere. “All’inizio di ottobre, prima della mietitura, il trifoglio bianco e i semi delle varietà di cereali invernali a rapida crescita vengono buttati a spaglio fra gli steli del riso che sta maturando. Il trifoglio e l’orzo o la segale germogliano e crescono un pollice o due (cm. 2,5 – cm. 5) prima che il riso sia pronto per essere raccolto. (…). Quando la battitura è finita, la paglia del riso viene sparsa sopra il campo. Se si semina il riso in autunno e si lascia scoperto, i semi vengono spesso mangiati dai topi e dagli uccelli, oppure a volte marciscono sul terreno; per evitare questi inconvenienti nascondo i semi del riso in piccole pallottoline di argilla prima di seminare. Si sparge il seme in una casseruola o in un canestro piatto e si scuote avanti e indietro con un movimento circolare. Si cosparge di argilla finemente polverizzata e si aggiunge un leggero spruzzo 292 FUKUOKA non risparmia complimenti all’acacia Morishima. In un altro punto del libro, ritorna sull’argomento per sottolineare altri punti positivi: il “suo legno [era] duro, i fiori [attiravano] le api, e le foglie [erano] buone da foraggio. [Aiutava] a prevenire i danni degli insetti nel frutteto, [funzionava] da frangivento e i batteri del genere rhizobium che [vivevano] in simbiosi con le radici [fertilizzavano] il suolo” (FUKUOKA, 1980:86). Inoltre, quest’albero fissava l’azoto e, grazie alla sua profonda radice fittonante, aiutava a migliorare gli strati profondi del terreno. 338 d’acqua ogni tanto. In questo modo si forma una piccola pallottolina di circa un centimetro di diametro293. (…) A seconda delle circostanze a volte metto i semi di altri cereali e ortaggi nelle pallottoline di argilla prima di seminare. Fra la metà di novembre e la metà di dicembre è un buon periodo per spargere le pallottole contenenti il seme di riso in mezzo alle giovani pianticelle di orzo o di segale, ma si possono anche gettare in primavera. Un sottile strato di pollina viene steso sopra il campo per aiutare a decomporre la paglia, e le semine dell’intera annata è finite. In maggio si miete il cereale invernale. Dopo la battitura si sparge tutta la paglia sul terreno. A questo punto si può tenere l’acqua nel campo per una settimana o dieci giorni. Ciò provoca l’indebolimento delle erbacce e del trifoglio aiutando il riso a venir su attraverso la paglia. L’acqua delle piogge è sufficiente da sola alle piantine in giugno e luglio; in agosto si fa passare a scorrimento acqua fresca per il campo circa una volta la settimana senza lasciare che si fermi. Il raccolto d’autunno è adesso a portata di mano. Questo è il ciclo annuale della coltivazione riso/cereale invernale col metodo naturale” (FUKUOKA, 1980: 66-68). Parallelamente al lavoro nei campi c’è anche quello nel frutteto, con la raccolta degli agrumi da metà novembre fino ad aprile. Il suo metodo di coltivazione è stato sviluppato tenendo conto delle condizioni naturali delle isole giapponesi, ma esso può essere adattato in altre zone e con altri tipi di colture. Si tratta soltanto di scoprire quali sono le combinazioni più efficaci alle diverse condizioni naturali. Inoltre, l’autore sottolinea che nella “fase di transizione a questo tipo di agricoltura, un po’ di diserbo manuale, di composti organici o potature possono essere necessari (…), ma queste misure dovrebbero essere ridotte gradatamente ogni anno” (FUKUOKA, 1980:69). FUKUOKA insiste sull’importanza dell’uso della paglia nel suo metodo di coltivazione. Per l’ottenimento di un risultato sicuro, è fondamentale che la paglia sia sparsa disordinatamente, in ogni direzione, come se fosse caduta spontaneamente, per permettere ai germogli di attraversarla senza problemi. Inoltre, la combinazione riso/cereali invernali non è un caso. I due prodotti si aiutano a vicenda. La paglia del riso funziona bene come pacciame per il cereale invernale e viceversa. La paglia del riso fresca 293 “C’è anche un altro metodo per fare le pallottoline. Prima si immerge il seme del riso vestito in acqua per diverse ore; poi si levano i semi e si mescolano con argilla umida impastando con le mani o i piedi. A questo punto si passa l’argilla attraverso un setaccio di rete da polli per dividerla in piccole zolle. Le zolle dovrebbero essere lasciate ad asciugare per un giorno o due o finché possano essere facilmente trasformate in pallottole facendole rotolare fra le palme delle mani. Teoricamente ci dovrebbe essere un seme in ogni pallottolina. In un giorno si possono fare abbastanza pallottoline da seminare parecchi acri (un acro = 4050 metri quadri)” (FUKUOKA, 1980:67). 339 possiede una serie di malattie che potrebbero infettare il riso ma che non hanno nessun effetto sui cereali e viceversa. Inoltre, essendo stata messa in autunno, essa arriverebbe alla primavera successiva – momento in cui il riso comincia a venire su – completamente decomposta, non presentando più nessun rischio di contaminazione294. Insiste, infine, perché tutta la paglia e la pula che restano dopo la trebbiatura siano restituite al campo. Le difficoltà con gli animali durante la semina – che potrebbero mangiare i semi – sono risolte attraverso l’uso delle pallottoline di argilla per avvolgere i semi. Attraverso questo metodo i semi germinano bene e non marciscono anche quando ci sono troppe piogge. Invece il problema degli uccelli viene risolto spargendo i semi quando la coltura precedente è ancora nel campo. Così, i semi rimangono nascosti tra le erbe e il trifoglio e protetti dalla pacciamatura di paglia. Riguardo alla coltivazione del riso in campo asciutto, FUKUOKA richiama l’attenzione sull’importanza di seminarlo fitto e mantenere le piante il più compatte possibile, lasciandole crescere libere nella forma naturale anziché cercare di ottenere piante alte a rapida crescita. Secondo lui le piante alte spendono la maggior parte della loro energia nella crescita vegetativa, lasciandone poca per i semi, mentre in quelle piccole la maggior parte delle energie viene spesa nella produzione dei semi295. FUKUOKA osserva che le piante di riso coltivate in campo asciutto non vengono molto alte perché la luce del sole viene assorbita uniformemente, raggiungendo la base delle piante e le foglie più basse. In campo non inondato le piante sviluppano radici più forti diventando più resistenti agli attacchi delle malattie e degli insetti296. Spiegando la procedura da lui usata da più di vent’anni con risultati sempre migliori, egli informa che in “giugno, all’epoca dei monsoni, tiene l’acqua nel campo per circa una settimana. Sono poche le erbacce del campo asciutto che riescono a sopravvivere anche un periodo così corto senza ossigeno e anche il trifoglio patisce e diventa giallo. (…) Quando l’acqua viene tolta (il più presto possibile) il trifoglio riprende e si propaga fino a coprire di nuovo la superficie del terreno sotto le piante di riso che crescono. Dopo questo non fa quasi più nulla come regimazione delle acque. Nella prima metà della stagione non irriga per niente. (…) In agosto fa entrare l’acqua ma poca per volta e non lascia mai che ristagni” (FUKUOKA, 1980:79). FUKUOKA avverte invece che la paglia fresca dei cereali invernali come il frumento, l’orzo e la segale non dovrebbe essere usata come pacciame per altri cereali invernali perché, come nel caso del riso, può trasmettere qualche malattie. 295 Secondo lui, mentre per le piante alte 9 quintali di paglia corrispondono a circa 4,5 o 5 quintali di riso, per quelle piccole 9 quintali di paglia producono 9 quintali di riso o di più. 296 FUKUOKA sottolinea anche che il riso è coltivato in campo inondato per controllare le erbacce, creando così un ambiente in cui soltanto poche varietà riescono a sopravvivere. Attraverso il suo metodo invece, mantenendo le erbacce sotto controllo, non c’è bisogno di inondare il campo. 294 340 FUKUOKA afferma essere possibile coltivare anche l’orto attraverso il metodo dell’agricoltura naturale, sia quello dietro casa per il consumo della famiglia, sia quello all’aperto per la commercializzazione, utilizzando per questo un’area specifica oppure approfittando degli spazi aperti del frutteto. Uno dei punti forti di questo tipo di coltivazione è, quindi, la possibilità che viene concessa al contadino di usare un terreno prima ritenuto improduttivo o non adatto alla coltivazione, come gli spazi tra gli alberi del frutteto. La cosa fondamentale è coltivare gli ortaggi giusti nel momento giusto in terreno preparato con composto organico e letame. L’autore ricorda che, in “una fattoria naturale, gli alberi da frutto, le verdure, gli ortaggi, i cereali e le altre produzioni vengono piantate e coltivate in un insieme organico di mutuo vantaggio. In particolare, un efficace schema per l’avvicendamento delle colture si deve basare essenzialmente sull’uso permanente della terra, senza che questa perda la sua fertilità. Gli alberi da frutto non devono essere separati dal bosco di bordura o dalle piante del sottobosco. Infatti, è solo con una intima associazione tra di essi che si riesce a ottenere una crescita sana e regolare. Per quanto riguarda le verdure, quando vengono lasciate a loro stesse in un campo, (…) si sviluppano in splendide piante a cui la natura provvede risolvendo i problemi di crescita continua, di spazio, di malattie e parassiti, e ridonando fertilità al terreno” (FUKUOKA, 2001:165). Secondo l’autore, gli ortaggi cresciuti in un campo equilibrato dall’azione dei lombrichi, dei microrganismi e del letame animale decomposto sono più puliti e completi di quelli coltivati con sostanze chimiche. “La cosa importante è conoscere il momento giusto per seminare. Per gli ortaggi di primavera il momento giusto è quando le erbacce invernali stanno morendo e appena prima che germinino quelle estive297. Per la semina autunnale, i semi dovrebbero essere buttati quando le erbe estive stanno appassendo e le erbacce invernali non sono ancora apparse. La miglior cosa è aspettare una pioggia che prometta di durare diversi giorni. Si taglia una striscia nel manto di erbacce e si buttano i semi di verdure. Non c’è alcun bisogno di coprirli di terra, basta rimettere le erbacce tagliate sopra i semi in modo che servano da pacciamatura e li nascondano agli uccelli e ai polli finché non germinano. Di solito le erbacce devono essere tagliate due o tre volte per dare un po’ di vantaggio ai germogli degli ortaggi, ma in certi casi basta solo una volta” (FUKUOKA, 1980:89/90)298. Nel caso degli ortaggi che non germinano tanto facilmente – come la carota e lo spinacio – FUKUOKA “Questo modo di coltivare gli ortaggi è stato sviluppato da Fukuoka con prove ed esperimenti in armonia con le condizioni locali. Dove vive lui ci sono piogge primaverilì sicure e un clima sufficientemente caldo da far crescere ortaggi in tutte le stagioni. (…) (…) Sta a ogni contadino che vuole produrre verdura nel modo semi-selvatico di sviluppare una tecnica adatta alla sua terra e alla vegetazione naturale che ci cresce sopra” (FUKUOKA, 1980:89 n. *). 298 Secondo FUKUOKA, nei luoghi dove le erbacce e il trifoglio non sono tanto fitti è possibile semplicemente buttare i semi. 297 341 consiglia di lasciare i semi in ammollo per circa due giorni e poi avvolgerli nelle pallottoline di argilla. Inoltre, seminati fitti, i ramolacci, le rape e altri ortaggi verdi autunnali da foglia sono in grado di competere con le erbacce invernali e con quelle dell’inizio della primavera. Consiglia anche che vengano lasciati alcuni di questi nei campi affinché germinino da soli l’anno successivo. Per i legumi, FUKUOKA consiglia la semina durante la primavera. I pomodori e le melanzane devono essere prima coltivati in vivai e poi trapiantati, altrimenti non riescono a vincere le erbacce299. Per i cetrioli, la varietà strisciante è quella migliore, essendo necessario pulire il terreno delle erbacce ogni tanto quando le piante sono ancora piccole. Consiglia anche che siano estesi sul terreno dei bambù o rami di alberi affinché i cetrioli – e lo stesso vale per i cocomeri, i meloni e i poponi – possano attorcigliarsi, evitando così che i frutti in contatto con il terreno marciscano. Le patate sono forti e una volta attecchite, continuano a crescere sul terreno ogni anno. Nei casi di suolo duro, FUKUOKA consiglia di seminare i ramolacci prima delle patate, affinché le loro radici rendano soffice il terreno. Inoltre, l’autore ha riscontrato che se “il trifoglio è seminato mescolato col seme degli ortaggi, farà le funzioni di una pacciamatura viva, arricchendo il suolo e tenendo il terreno umido e areato. Come per la verdura, è importante scegliere il momento giusto per seminare il trifoglio. La cosa migliore è seminare nella tarda estate o in autunno; le radici si sviluppano nei mesi freddi, dando al trifoglio un vantaggio sulle erbe annuali di primavera. Il trifoglio farà anche bene seminato presto in primavera. (…) Quando il trifoglio ha attecchito non c’è più bisogno di riseminarlo per cinque o sei anni” (FUKUOKA, 1980:92). Rispetto ai frutteti, FUKUOKA sottolinea gli effetti benefici dell’uso degli spazi aperti con la rotazione delle colture. Secondo lui, la protezione del frutteto con alberi sempreverdi e frangivento, insieme alla creazione di un sottobosco con piante da sovescio associate a quelle del sottobosco stesso rappresenta un’importante alternativa per risolvere il problema dell’indebolimento del suolo frutto della coltivazione continua di piante perenni. Inoltre, la coltivazione delle verdure sotto gli alberi da frutto aiuta a diminuire il numero degli insetti nocivi. 299 FUKUOKA consiglia di lasciare i pomodori senza sostegno affinché dai nodi lungo lo stelo si formino nuovi ributti e nuovi frutti. 342 2.5. Un futuro per l’agricoltura naturale All’agricoltura naturale FUKUOKA accosta l’alimentazione naturale, intesa come il consumo di alimenti di stagione ottenuti attraverso l’agricoltura naturale. Per arrivare a questa alimentazione FUKUOKA ha costruito un mandala dell’alimentazione naturale (un tipo di calendario agricolo) dove vengono elencati, mesi a mesi, i prodotti di stagione relativi sia all’agricoltura che alla pesca [Figure 1 e 2]300. Secondo lui, anche senza la conoscenza del mandala è possibile arrivare a una dieta naturale se l’istinto funziona nel modo giusto. L’autore insiste sul quanto sia “irragionevole aspettarsi che una dieta integrale, bilanciata, potesse essere raggiunta fornendo semplicemente una grande varietà di alimenti indipendentemente dalla stagione. In confronto alle piante che maturano naturalmente, la verdura e la frutta coltivate fuori stagione in condizioni necessariamente innaturali contengono poche vitamine e minerali” (FUKUOKA, 1980:158)301. Un modo di favorire la diffusione della dieta naturale può essere, secondo FUKUOKA, la diffusione dell’agricoltura naturale e soprattutto l’aumento delle possibilità di commercializzazione dei prodotti naturali. Ma a questo proposito ritiene necessario chiarire alcuni equivoci. Uno di questi è la questione dell’apparenza: i consumatori cercano prodotti naturali ma li vogliono “belli”, grandi, senza macchie, scintillanti e “freschi” Nella Figura 1 sono elencati gli alimenti più facilmente ottenibili. Nella Figura 2, gli alimenti disponibili mese a mese. 301 FUKUOKA identifica “quattro principali tipi di diete: 1. Una dieta permissiva che soddisfa desideri abitudinari e preferenze di sapore. La gente che segue questa dieta oscilla di qua e di là irregolarmente secondo i capricci e le fantasie. Questa dieta potrebbe essere chiamata dell’indulgenza verso se stessi, del vuoto mangiare. 2. La dieta nutritiva media della maggior parte della gente, che deriva da conclusioni biologiche. Gli alimenti nutritivi sono mangiati con lo scopo di far sopravvivere il corpo. Lo si potrebbe chiamare mangiare materialista, scientifico. 3. La dieta fondata su principi spirituali e su una filosofia idealistica. Limitando gli alimenti, mirando alla compressione dei bisogni, le diete «naturali» ricadono in massima parte in questa categoria. Questa potrebbe essere chiamata la dieta di principio. 4. La dieta naturale, seguendo la volontà del cielo. Lasciando da parte tutto il sapere umano, questa dieta la si potrebbe chiamare la dieta della non-discriminazione” (FUKUOKA, 1980:159). Quest’ultima, sottolinea l’autore, viene definita a seconda dell’ambiente locale, dei bisogni e della costituzione fisica della persona che la pratica. L’unica cosa da fare è lasciare che il corpo scelga da solo il cibo di cui ha bisogno. 300 343 figura 1 Mandala dell’alimentazione naturale secondo diagrama 344 Figura 2 Il mandala del cibo naturale – piante e animali 345 come quelli che subiscono trattamenti chimici302. L’altro è l’associazione qualità/prezzo fatta spesso dai consumatori che, di solito, collegano la qualità al prezzo e pretendono che la qualità dei prodotti naturali possa essere “certificata” da alti prezzi. FUKUOKA sostiene l’esatto contrario: proprio perché l’agricoltura naturale non fa uso di sostanze chimiche i suoi prodotti dovrebbero arrivare al consumatore a un prezzo più basso rispetto a quelli dell’agricoltura tradizionale che le usa. FUKUOKA centra le sue aspettative di diffusione della vendita diretta degli alimenti naturali nella crisi vissuta dall’agricoltura tradizionale e nella formazione delle comunità hippy e religiose – che cercano la naturale essenza umana attraverso un ritorno alla natura – avvenuta dagli anni ’70 in poi in quanto veicolo per la costituzione di ciò che chiama il prototipo del nuovo contadino. I bassi guadagni da essa comportati ai contadini potrebbero essere usati come argomenti favorevoli alla conversione in agricoltura naturale una volta che, tra i suoi pregi, c’è quello del basso costo economico e del risparmio di fatica da parte del contadino, il che vuol dire costi di produzione più bassi e guadagni più alti. Il principale problema da risolvere è, secondo lui, quello della distribuzione a livello locale e questo è un altro motivo per cui egli ritiene che i prodotti dell’agricoltura naturale devono costare meno. Per poter incentivare la diffusione di questo tipo di produzione allora è necessario incentivare il suo consumo, fatto che potrebbe avvenire solo se essi arrivano al commercio a prezzi competitivi. Altrimenti, diventerebbero prodotti di lusso destinati a una nicchia di consumatori, proprio come avviene con i prodotti biologici in Italia nell’attualità, anche se le cose si sono cambiate negli ultimi anni. Per la diffusione dell’agricoltura naturale FUKUOKA ha anche una proposta molto simile a quella difesa da KROPOTKIN303: secondo lui, “l’ideale sarebbe che il 100% della popolazione coltivasse la terra. (…) Se a ogni singola persona venissero dati mille metri A questo proposito, FUKUOKA dedica un capitolo molto interessante per discutere sul vicolo cieco in cui la gente si trova con il diffondersi dell’agricoltura del fuori stagione e della cultura dell’apparenza. Sottolinea il quanto la gente si sia ormai abituata a pagare alti prezzi per poter avere a disposizione tutti i generi agricoli sempre “belli” nell’arco di un intero anno, senza rendersi conto dei costi ambientali e alla salute e del distanziamento dalla natura che una tale richiesta comporta. Egli richiama l’attenzione su tutti i trattamenti chimici per cui passano gli alimenti dell’agricoltura scientifica prima di arrivare alla tavola del consumatore – coloranti, dolcificanti, lucidanti, maturazione in camere a gas, ecc. – sui suoi effetti sia all’ambiente come alla salute umana e sulla responsabilità che anche i consumatori – nel pretendere tali prodotti – hanno rispetto all’uso indiscriminato di tale sostanze. Molto interessante la descrizione delle tappe per cui passano i mandarini, dal raccolto anticipato fino alla commercializzazione, presente nel La rivoluzione del filo di paglia. Tale problema, secondo lui, si risolverebbe soltanto con il rovesciamento del senso dei valori, affinché l’apparenza cedesse posto alla qualità. 303 L’idea è la stessa anche se in nessun momento FUKUOKA fa alcun tipo di riferimento agli ideali anarchici. Anzi, semmai, i suoi riferimenti sono di carattere religioso. Ciò non impedisce che la sua proposta sia uguale a quella presentata dall’anarchico alla fine dell’Ottocento e, secondo me, serve solo a comprovare l’attualità e validità delle sue idee. 302 346 quadrati, cioè mezzo ettaro per una famiglia di cinque, sarebbe più che sufficiente al sostentamento della famiglia per tutto l’anno. Se poi venisse praticata l’agricoltura naturale, un contadino avrebbe anche un sacco di tempo per la libertà e le attività sociali nella comunità di villaggio. Io credo che questa sia la strada più diretta per rendere questo paese una terra felice da viverci” (FUKUOKA, 1980:130). 2.6. L’agricoltura sinergica L’agricoltura sinergica è stata introdotta e sviluppata in Europa da Emilia HAZELIP. In Italia essa è stata diffusa dai suoi discepoli Antonio DE FALCO e Fortunato FABBRICINI che da circa dieci anni si occupano di orti sinergici, sia coltivandoli che insegnando a prepararli. Attraverso l’agricoltura sinergica si possono coltivare sia l’orto che i campi aperti come quelli di FUKUOKA. I principi sono quelli dell’agricoltura naturale ma in questo caso si tratta di un’agricoltura addomesticata, anche se naturale: si basa sui principi dell’autofertilità del suolo, non usa concimi né diserbanti di nessun tipo, non smuove più il terreno, ma il terreno selvaggio viene ricreato attraverso l’intervento dell’uomo con la preparazione dell’orto o dei campi e la scelta delle piante. Il procedimento è diverso da quello di FUKUOKA, che semplicemente semina e lascia fare alla natura. Per questo, secondo DE FALCO, non la si può chiamare agricoltura naturale ma agricoltura sinergica perché sfrutta la sinergia che si stabilisce tra le diverse piante, gli animali e il terreno per ricostruire l’ambiente selvaggio da cui parte FUKUOKA. Per iniziare la pratica dell’agricoltura sinergica la prima cosa da fare è preparare il terreno. Sarà l’unica volta in cui verrà fatto questo lavoro, che consiste nel togliere le erbe superficiali a mano o con un sarchiatore, senza stare a togliere le radici. Se invece si tratta di un terreno troppo calpestato, allora c’è bisogno di muoverlo un po’, per renderlo più facile da essere lavorato. Per la preparazione dell’orto, è molto importante la scelta del posto. Siccome per questo tipo di orto non importa tanto la sua grandezza ma sì la quantità e diversità di piante che si riesce a coltivare al suo interno – si tratta di un tipo di coltivazione intensiva – DE FALCO304 consiglia che si scelga un posto vicino alla casa per facilitare il lavoro al suo interno. L’orto sinergico richiede un lavoro continuo e la vicinanza alla casa permette un miglior uso del tempo nel senso che ogni momento libero può diventare un’occasione di fare un salto a controllare se c’è qualcosa da fare come qualche erba da togliere manualmente, qualche piantina da trapiantare, qualche pomodoro da raccogliere. Inoltre, 304 Antonio DE FALCO in intervista concessa il 5 novembre 2003. 347 l’orto vicino a casa, riduce il tempo della raccolta e permette di preparare il cibo usando i prodotti appena raccolti, aumentando così il suo valore energetico. Una volta scelto il posto, il passo successivo consiste nell’eseguire un disegno della disposizione dell’orto. Siccome il terreno che sarà coltivato non dovrà essere mai più pestato né mosso, è necessario separare molto bene la parte dove si potrà camminare da quella dove invece non si potrà mai più mettere i piedi. Di solito viene fatta una parte a spirale e l’altra a fasce parallele. In seguito si passa, seguendo il disegno, alla costruzione delle aiuole con 120 cm di larghezza e 50 cm di altezza, dove sarà fatta la semina305. Tutti i lavori successivi di semina, pulizia del terreno e raccolta dovranno essere fatti senza pestare le aiuole. Una volta preparate le aiuole, il passo successivo è impiantare un sistema d’irrigazione. Per l’irrigazione di solito viene usato il sistema goccia a goccia. Sopra le aiuole vengono collocati dei tubicini bucati a mano ogni quindici centimetri. Secondo DE FALCO306, questo sistema è molto più economico e funziona meglio di tutti i piccoli erogatori in commercio che s’intasano spesso. In questo caso, quando succede un intasamento, basta fare un altro buco e il problema è risolto. Preparata l’irrigazione si passa alla sistemazione dei tutori permanenti, “costituiti da tondini di ferro «ritorto» da 12 mm e 6 metri di lunghezza (gli stessi di quelli utilizzati in edilizia per armare il cemento) che si conficcano nel terreno, ai lati delle aiuole, formando così gli archi. L’altezza dell’arco sarà data dalla distanza tra le punte delle stecche (2 metri dal piano di passaggio è una buona misura). In ogni punto dove i tondini s’incrociano tra loro, si legano con un filo metallico. Sempre con filo metallico (di maggiore spessore) si uniscono poi tutti gli archi, da cuspide a cuspide, a partire dal primo incrocio. Ai tutori, e ai fili metallici che li collegano, vanno appese delle cordicelle in materiale biodegradabile (canapa, sisal…) che serviranno da guida ai pomodori e alle piante rampicanti nella loro crescita” (FABBRICINI e DE FALCO, 2003:71). Preparate le aiuole, il sistema di irrigazione e sistemati i tutori, si può passare alla semina e al trapianto. Secondo FABBRICINI e DE FALCO, il momento migliore è la primavera, ma è possibile farlo anche durante l’autunno. È necessario farsi guidare dal clima e parlare con i contadini del luogo per poter scegliere le piante più idonee e l’epoca più indicata per semine e trapianti. “Ad ogni modo, giacché il terreno ha bisogno soprattutto di radici per vivere, quando l’orto è pronto, è bene effettuare semine e trapianti anche se le Queste aiuole sono chiamate anche bancali. Le aiuole alte servono a impedire i ristagni d’acqua nelle radici. Impediscono anche che le piogge piu’ intense portino via la parte più ricca del suolo. In alcuni casi esse fanno anche da barriera, trattenendo l’acqua che scorre e facendo sì che questa finisca per scendere in profondità, alzando il livello delle acque sotterranee. 306 Antonio DE FALCO in intervista concessa il 5 novembre 2003. 305 348 condizioni ambientali non sono le più opportune. Se la terra delle aiuole è idonea, si può subito iniziare con le semine degli ortaggi, altrimenti si possono utilizzare le cosiddette piante «pioniere» (es. piante foraggiere, senape bianca, cicorie, coste, ecc.), specie botaniche che meglio si adattano ai suoli poveri, contribuendo nel contempo a migliorarli” (FABBRICINI e DE FALCO, 2003:70). Ci sono poi alcune regole da seguire nella disposizione dei semi. “Nei bordi e soprattutto alle estremità delle aiuole si potranno piantare anche aromatiche e fiori; in particolare calendula, tagete e nasturzio che oltre ad attrarre insetti benefici, svolgono una funzione antibatterica e allontanano i nematodi ed altri parassiti. Inoltre, la presenza di fiori rende l’orto-giardino più piacevole, colorato e profumato307. I lati delle aiuole potranno ospitare anche piante selvatiche perenni, utili e gustose, come ruchetta, silene, finocchietto, pimpinella e raperonzolo, piante che comunque andranno controllate poiché essendo autoctone e molto forti tenderanno a prevalere sulle altre. La parte piana delle aiuole, oltre alle (…) leguminose, conterrà le altre famiglie degli ortaggi coltivati” (FABBRICCINI e DE FALCO, 2003:71). DE FALCO non si attiene molto alle consociazioni308, ritenendo più importante che il terreno sia sano e pieno di piante. Alcune attenzioni però devono essere fatte. Siccome, oltre alle radici vive, anche i residui vegetali delle piante morte contribuiscono all’aumento della fertilità, si consiglia di lasciare sulle aiuole, come pacciamatura e compostaggio, tutto quello che non sarà consumato, incluse le radici che funzionano da “corsia preferenziale” agli apparati radicali nuovi. L’altra attenzione è alternare piante che lasciano radici con piante che non le lasciano, nonché scegliere piante appartenenti a famiglie diverse. Questo serve sia a evitare di saturare la rizosfera con radici dello stesso tipo che a bloccare la proliferazione di elementi patogeni come i parassiti animali e vegetali. Si consiglia, pertanto, che nelle aiuole ci siano almeno tre famiglie diverse, una delle quali deve, per forza, essere quella delle leguminose per la loro alta capacità di fissare l’azoto atmosferico nelle radici per poi liberarlo nel terreno, soprattutto alla morte delle piante. Si possono utilizzare molti tipi di leguminose – come quelle che fanno da concime verde – ma si consiglia l’uso di quelle commestibili come i fagioli, le fave e i piselli che, secondo FABBRICINI e DE FALCO, dovranno essere posizionate nel centro delle aiuole309. “Nelle fasce laterali (…), si privilegeranno le Liliacee, come aglio, cipolle o porri che, grazie alla loro forma longilinea, non impediscono l’accesso alla parte centrale dell’aiuola e Aiuta anche ad attrarre gli insetti benefici, quelli che aiuteranno nella lotta ai parassiti. Nota mia. La consociazione è un termine tecnico per dire la coltivazione di due o tre prodotti che vanno d’accordo tra loro nella stessa area. L’esempio tipico è mais e fagioli. 309 Gli autori sconsigliano invece la coltivazione di ceci e lenticchie nell’orto perché fissano poco azoto e lasciano poca biomassa. Secondo loro esse vengono coltivate meglio nei campi aperti. 307 308 349 non sbordano sopra i corridoi tra le aiuole. Inoltre, tali specie presentano proprietà antibatteriche e antinematelmintiche, formando una barriera protettiva per gli altri ortaggi. Le liliacee andranno piantate a zig zag, sfruttando l’altezza dei bordi e, nei vuoti, saranno inseriti vari tipi d’insalata, dalla lattuga alla cicoria. In questo modo, si lascia anche una biomassa di radici nei lati delle aiuole. In ogni caso, è ben ricordarsi di non ripetere la coltivazione degli stessi ortaggi nella medesima area di terreno, e questo sia per evitare la proliferazione dei parassiti che si trasmettono più facilmente quando si ripete per anni la coltivazione di uno stesso ortaggio sullo stesso terreno, sia per ottimizzare la quantità di biomassa e l’utilizzo della rizosfera nei lati dei bancali” (FABBRICINI e DE FALCO, 2003:71). Infine, si copre con la pacciamatura di paglia, cartone o altro materiale e l’orto è pronto. Il lavoro successivo è quello di tenerlo sempre pulito, cioè, bisogna stare attenti alle erbe spontanee che vengono tolte manualmente. Si devono anche identificare spazi vuoti e riempirli con altre piante, e separare le eventuali concentrazioni di piante dello stesso tipo, spostandole e mescolandole insieme alle altre. “L’attenzione è quella di tenere il terreno sempre il più occupato possibile. Più è occupato, più è pieno di radici e più è vivo, perché le radici sono quelle che danno nutrimento alla ‘flora intestinale’ della terra, ai microrganismi e ai batteri. Attraverso ai loro essudati creano degli zuccheri che i batteri vanno a succhiare. Contemporaneamente loro forniscono invece tutta un’altra serie di sostanze. Essenzialmente mettono in moto quello che si chiama ciclo ossigeno-etilene, cioè, sviluppano etilene, che è un gas che è in grado di, attraverso il suo ciclo, le sue trasformazioni chimiche, il suo procedimento chimico, rendere solubili i minerali e in più li trattiene alla terra. Perché la presenza di etilene trasforma il ferro, dalla forma ferrosa in forma ferrica. (…) Quando è in forma ferrica, (…) fa da calamita, trattiene a sé gli altri minerali, microrganismi. Quando c’è molto etilene la vita microbiana, microbiologica si ferma, si arresta. Non muoiono, ma restano come paralizzati. È un ciclo che dura sui venti minuti più o meno. Resta paralizzata. E in questo momento di fermo dei batteri, l’ossigeno rientra nei micrositi, l’etilene va fuori e si espande nell’aria come gas che aiuta tra l’altro la vegetazione, e rientra ossigeno. Rientrando ossigeno si riossida il ferro. Il ferro quando è ossidato perde la capacità magnetica, quindi molla questi oligoelementi, minerali, ecc. che restano in forma solubile, quindi la pianta li può assorbire. Subito dopo ricomincia la vita dei batteri, ricominciano a riprodurre etilene e riblocca la vita. È come una respirazione della terra che dura venti minuti. Questo tipo di respirazione ce l’hai però solo nei terreni che sono non traumatizzati. Laddove viene pestato, i micrositi vengono schiacciati, la vita batterica si allontana”310. Secondo DE FALCO, il lavoro più grosso da fare il primo anno è il controllo delle erbe spontanee, che vanno tolte preferibilmente a mano. L’uso di qualche strumento è 310 Antonio DE FALCO, in intervista concessa il 5 novembre 2003. 350 consigliato soltanto nel caso delle piante con radici più profonde, come il vilucchio. L’uso di diserbanti è invece vietato. Dal secondo anno in poi questo tipo di lavoro va piano piano diminuendo perché, a mano a mano che le erbe sono tolte con le loro radici e il terreno viene mantenuto pacciamato, la pacciamatura impedisce che arrivino semi indesiderati. L’altra cosa da fare, ricorda DE FALCO, è costruire una barriera naturale, per esempio con la siepe, la ginestra o il corbezzolo, in modo che anche dall’esterno arrivino meno semi indesiderati portati con il vento, e che l’orto diventi sempre più un luogo dove ci sono le piante che interessano a chi coltiva311. Così, piano piano si arriva a un equilibrio per cui le erbe che rimangono non compromettono la vita delle piante ma danno equilibrio all’orto, stanno quindi in sinergia con le altre piante lì presenti. Per la raccolta, ad eccezione dei prodotti di si consumano proprio la radici – come le carote e i ravanelli – come è stato già detto, si deve cercare di lasciare la radice: la pianta dev’essere tagliata un po’ più su della sua attaccatura al terreno. Questo fa sì che la pianta ributti, essendo possibile mangiare la stessa insalata o lo stesso porro diverse volte. Nei casi dove non occorre questo, le radici rimangono come materia organica per il suolo. L’altro consiglio dato dagli esperti è quello di preparare la spirale degli aromi: una costruzione fatta in pietra dove rimangono concentrate tutte le piante aromatiche, utile sia per l’uso in cucina che per il suo effetto medicinale, aiutando ad allontanare gli insetti che potrebbero danneggiare le piante dell’orto. Così come succede con l’orto, anche la spirale dev’essere situata vicina alla casa, perché, tenendo tutte le piante vicine, oltre a formarsi un microclima con tutte le piante insieme, si facilita il lavoro di raccolta quando uno ne ha bisogno. Inoltre, queste piante hanno un effetto anche medicinale dato che il loro profumo diffuso nell’aria ha un effetto antiparassitario. Un altro punto positivo di questo tipo di orto consiste nel minore consumo d’acqua per annaffiature. In questo sistema buona parte delle piante rimangono all’ombra soffrendo di meno gli effetti della siccità. Inoltre la pacciamatura contribuisce a trattenere l’acqua, impedendo che essa evapori e anche impedendo, nei momenti di alta intensità di pioggia, che l’acqua compatti il terreno e lo dilavi, portando via le parti più sottili e più ricche. Per i campi all’aperto il sistema è diverso. Se, come è stato detto all’inizio di questo paragrafo, il terreno è stato molto impoverito dall’uso e dal tempo, se è indurito e spaccato, bisogna ridargli vita e iniziare una lavorazione preparatoria prima di passare alla semina propriamente detta. La prima cosa è seminare le piante pioniere – le leguminose che fanno da concime verde – e lasciare a loro il lavoro. Piano piano esse cominciano a 311 Questa barriera serve anche a proteggere dal vento, nel caso questo rappresenti un problema. 351 spaccare le zolle, a lasciare l’azoto, a far respirare la terra, a far venire vita. Secondo DE FALCO, bisogna ripetere questa semina per un paio d’anni. Dopodiché si avrà una terra eccezionale e quindi si potrà iniziare una coltivazione più proficua, per il sostentamento, per esempio con i cereali. Vale la pena di ricordare che anche in questo caso si deve cercare di pestare il terreno il meno possibile, per evitare così di chiudere i micrositi e impedire la respirazione della terra. Prima di seminare nei campi aperti bisogna fare l’impallinatura, come spiegato da FUKUOKA. DE FALCO suggerisce la costruzione di un tipo di betoniera, fatta con un vecchio bidone e dello spago, che viene fatta girare manualmente. Dentro la betoniera “fai andare i semi spruzzando acqua con un polverizzatore e argilla, polvere di argilla. Man mano [che] il seme è umido, incomincia ad attaccarsi l’argilla in torno a ogni semino si forma una pallina di argilla. Ecco e poi, come dice anche Fukuoka, è quello che salvaguardia dagli insetti”312. Per la semina, “la cosa migliore, come dice Fukuoka, è spargere quando l’erba è alta. Si sparge e dopo si taglia l’erba. In questo modo tutta l’erba resta, va giù come pacciamatura, e la piantina resta nella pallina di argilla e sotto l’erba. Quando arriva l’umidità, la pioggia, si apre, è già protetta, e quindi poi rispunta fuori”313. Anche qui vale il discorso di mescolare le specie. In realtà i semi vengono mescolati già quando si fa l’impallinatura e poi basta spargere per il campo. Nei casi in cui l’erba è stata tagliata prima di seminare, allora c’è bisogno di coprire con la pacciamatura. 3. Lo Slow Food Lo Slow Food è un movimento nato in Italia che poi si è diffuso in vari paesi nel mondo – diventando Slow Food internazionale – in contrapposizione e come alternativa al fast food, non solo al fast food inteso come luoghi tipo McDonald’s, ma più in generale al mangiar di corsa come stile di vita. Secondo PETRINI, il suo fondatore, esso è soprattutto un insieme di idee che hanno come base “la convinzione che l’alimentazione è parte essenziale della vita, e che dunque la qualità della vita è inevitabilmente legata al piacere di mangiare in modo sano, gustoso, vario. Il contrario di quanto ci propone il fast food (…). Slow Food (…) significa dare la giusta importanza all’atto nutritivo, imparando a godere della diversità delle ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio” (PETRINI, 2003:V). Slow Food 312 313 Idem ibidem. Idem ibidem. 352 internazionale, che ha scelto come simbolo la chiocciola come emblema della lentezza314, è un movimento che mette insieme piacere, consapevolezza, responsabilità, studio e conoscenza, cercando “di offrire, attraverso un nuovo modello di agricoltura, prospettive di sviluppo anche a regioni povere e depresse” (PETRINI, 2003:V). Secondo PETRINI, Slow Food propone di salvaguardare e rilanciare i singoli patrimoni gastronomici, recuperare la memoria dei codici gastronomici regionali, promuovere una campagna di educazione permanente al gusto, attraverso la riscoperta del piacere di mangiare cibo sano in locali accoglienti, la promozione di coltivazioni capaci di rispettare la natura, come pure lo scambio di documenti, analisi, ricerche storiche e tecniche produttive. La strategia è quella di concentrare gli sforzi sul recupero di ciò che si sta perdendo anziché incalzare il nuovo che non piace. Nel difendere una “nuova agricoltura” si cerca di incentivare una pratica di agricoltura più consapevole e più rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. Si tratta, quindi, di un nuovo modo di concepire la cultura dello sviluppo, dell’alimentazione e della produzione agricola. 3.1. Le origini e lo svolgersi del movimento Lo Slow Food è stato fondato con il nome Arcigola da Carlo PETRINI nel luglio 1986, a Bra, nel Piemonte. Però le sue radici devono essere ricercate nelle attività del suo fondatore, soprattutto dagli anni ’70 in poi. I primi segni di un percorso che avrebbe più tardi portato al movimento in discussione sono apparsi nel 1971 con la creazione, a Bra, della “Cooperativa Circolo Leonardo Concito”. Essa, nel 1974 ha dato vita al periodico In Campo Rosso e, nel 1975, alla Radio Bra Onde Rosse. Dello stesso anno sono anche l’ingresso di PETRINI nel Consiglio Comunale di Bra e la fondazione dello spaccio di Unità Popolare, Circolo Cica-Crass, legato all’ARCI. I festival di musica popolare Canté j’euvre svolti a Bra dal 1979 al 1981 e, negli anni successivi, i campi scuola estivi, hanno portato a Bra ragazzi di tutta Italia. “Da queste esperienze di «turismo sociale», intrecciate con le riflessioni comuni al gruppo promotore della rivista La Gola, germinano le idee ispiratrici di Arcigola. Il periodo 1979-86 è di incubazione e formazione. Eletto nel consiglio nazionale dell’Arci, Carlin315 viaggia per l’Italia, prendendo contatto con altre realtà territoriali e di mercato; visita le grandi aree enogastronomiche “La chiocciola è un animale piccolo e prudente, con un’innegabile vocazione cosmopolita. La chiocciola di Slow Food è un amuleto contro l’ossessione del mondo moderno: la velocità” [Cos’è Slow Food. Consultabile on line all’indirizzo: <http://www.slowfood.it> seguendo il percorso: cos’è slow foodÆstoriaÆIl movimento internazionale Slow Food. L’ultima consultazione è stata effettuata il 30 gennaio 2004]. 315 Il soprannome di Carlo Petrini. 314 353 d’Europa, partecipando nell’82-83 (con Gigi Piumatti e Massimo Martinelli) ai corsi di conoscenza dei vini che si tengono a Beaune, in Borgogna”316. Attraverso la Libera e Benemerita Associazione degli Amici del Barolo, nasce negli anni ’80 il primo nucleo della futura Arcigola. In essa PETRINI riversa le esperienze accumulate in momenti di diffusione della cultura del gusto e della convivialità, dentro e fuori dei confini di Bra. L’obiettivo dell’Associazione è quello di essere “veicolo per la diffusione di conoscenze e di prodotti, stimolo al risveglio dell’attenzione per il cibo e il vino e per una loro corretta fruizione. Nascono così i primi corsi di degustazione, la proposta di momenti di assaggio e di convivialità, l’attivazione di circuiti distributivi, le vendite di vino e specialità per corrispondenza” (PETRINI, 2003:6). Sono di questo periodo la realizzazione di “una grande festa in riva al Lago Maggiore, una cena di gala nell’ambito di un convegno di filosofi all’Università di Urbino, una giornata di promozione dei vini e della cucina di Langa a Mira (Ve), corsi di avvicinamento al vino per studenti torinesi”317, così come la realizzazione della Settimana del Barolo e del Barbaresco a Bra. Queste attività consentono, secondo PETRINI, di stabilire contatti con le persone insieme alle quali si sarebbe costituito il nucleo dirigente di Arcigola, più tardi diventato Slow Food. All’inizio degli anni ’80 PETRINI inizia la sua collaborazione di cronaca e critica gastronomica a giornali e guide (Barolo & C., Il Tanaro, la guida ai ristoranti dell’Espresso). All’interno del direttivo nazionale dell’ARCI egli “patrocina la costituzione di una ‘lega gastronomica’ che sintetizzi, anche nel nome, quanto sta maturando nella realtà associativa braidese e nel dibattito sviluppatosi sulle pagine de La Gola”318. Sempre a Bra “si costituisce una cooperativa che organizza il turismo e le diverse attività di vendita e promozione, e in seguito apre i battenti l’Osteria del Boccondivino, originale tentativo di coniugare buona ristorazione di ispirazione territoriale, vini di qualità e prezzi modesti” (PETRINI, 2003:7). Nel luglio 1986, dopo che “il Congresso dell’Arci di Albano Terme aveva ratificato una federazione che lasciava piena indipendenza operativa alle diverse realtà nate (…), la fondazione di Arcigola (…) dà autonomia e legittimità di «lega enogastronomica» a una realtà già esistente e parzialmente consolidata” (PETRINI, 2003:8). Dopo tre anni di esistenza il numero di tessere passa da 500 a 8.000, prova di che le proposte della nuova Associazione trovano eco e superano la diffidenza iniziale. SLOW FOOD. Cos’è Slow Food. Consultabile on line all’indirizzo: <http://www.slowfood.it> seguendo il percorso: cos’è slow foodÆdizionario slow foodÆLa storiaÆCarlo Petrini. L’ultima consultazione è stata effettuata il 23 gennaio 2004. 317 Idem ibidem. 318 Idem ibidem. «La Gola» (1982-1989) è un periodico milanese che proponeva un approccio originale alla cultura enogastronomica, con l’ausilio di discipline come la filosofia, la sociologia, la letteratura e l’antropologia. 316 354 L’anno del 1986 segna la nascita di «Gambero Rosso», inserto del quotidiano «il manifesto» dedicato all’enogastronomia con la partecipazione in prima persona dell’Arcigola319. È all’interno di questo inserto che viene lanciato il Manifesto dello Slow Food (ALLEGATO N° 2), redatto da Folco Portinari e firmato da tredici personalità del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo. L’anno si chiude con l’uscita della prima edizione di Vini d’Italia, la guida al bere bene per esperti e curiosi, realizzata dall’Arcigola Slow Food in collaborazione con Gambero Rosso, avendo come curatori Daniele CERNILLI e Carlo PETRINI320. La guida è diventata sin da subito un punto di riferimento sull’argomento, arrivando nel 2001 alla quattordicesima edizione. Nel aprile 1988 avviene a Vicenza la Prima Assemblea dei Fiduciari Arcigola, assise che passerà ad avere cadenza annuale. Alla fine dello stesso mese Arcigola organizza la prima edizione del Gioco del Piacere, una cena-degustazione di vini del mondo che si svolge in contemporanea in ristoranti di tutta l’Italia. L’evento si svolge ancor’oggi, arrivando alla sua ventitreesima edizione, contando con una partecipazione media di quattromila commensali. Nel luglio dello stesso anno Arcigola organizza ad Alba un’assemblea degli operatori enogastronomici delle Langhe avendo come tema «Può la Langa stare al Piemonte come la Côte d’Or sta alla Borgogna?». L’anno si chiude con la realizzazione, nel mese di novembre, del Primo Congresso Nazionale di Arcigola a Siena, San Gimignano e Montalcino. Dal 1988 al 1990 Arcigola passa a collaborare anche con il quotidiano «l’Unità», prima attraverso le rubriche del supplemento dedicato al turismo e alla gastronomia chiamato «AR» e poi attraverso le pagine dell’«Arcigoloso». Nel giugno del 1989 esce la Guida turistica enogastronomica delle Langhe e del Roero. Nel dicembre di quello stesso anno, i soci erano già 11.000 e Argicola era diventata un’associazione internazionale, passando a chiamarsi Arcigola Slow Food, ufficialmente riconosciuta quando con rappresentanti di 15 paesi, riuniti nell’Opéra Comique di Parigi, hanno siglato il Manifesto dell’87 (ALLEGATO N° 2). In quell’occasione viene presentato l’Almanacco dei golosi, inventario della produzione alimentare italiana e tradizione artigianale realizzato da Gambero Rosso e da Arcigola Il Gambero Rosso si distacca dal quotidiano «il manifesto» nel 1992, diventando una rivista autonoma e passando ad accentuare progressivamente gli aspetti propri della pubblicistica come test e inchieste, degustazioni, servizi sulle star del mangiarbere (cuochi, artigiani, vignaioli) ecc. 320 Il libro è passato dalle 5.000 copie iniziali a più di 100.000, delle quali più di 25.000 in tedesco e altrettanto in inglese. La guida contiene un sistema di classificazione – una graduatoria di merito – composta da «Bicchieri»: uno, due o tre, per i vini di eccellenza, classificazione che è entrata nell’immaginario, diventando così un titolo di merito. “Un «vino da Tre Bicchieri» indica, per antonomasia, qualsiasi prodotto perfetto, e non necessariamente raro. La prima edizione di Vini d’Italia presentava 32 «Tre Bicchieri», 500 produttori e 1.500 vini. L’edizione del 2001 esordiva con numeri che hanno del miracoloso in poco più di un decennio: 230 «Tre Bicchieri», 1.681 produttori e 12.045 vini (…). Le degustazioni avvengono sempre «alla cieca», cioè senza conoscere l’etichetta della bottiglia” (PETRINI, 2003:46). 319 355 Slow Food. Il corpo associativo piano piano prende forma, proseguono le attività create – corsi degustativi, le attività divulgative, assemblee e congressi, ecc. – e se ne studiano di altre. L’anno del 1990 è un anno di molte attività per l’Arcigola Slow Food. Si costituisce Slow Food Germania. Dall’aprile al luglio si svolgono ad Alba i Comizi Agrari, dodici incontri su temi vitivinicoli ed enologici tenuti da esperti di tutto il mondo. Nel novembre, sempre ad Alba, si svolge la Prima Convention Internazionale sui Vini Piemontesi321, nel corso del quale viene presentato l’Atlante delle grandi vigne di Langa, il Barolo322. Nel novembre, con Osterie d’Italia, sussidiario del mangiarbere all’italiana, una guida ai locali della buona cucina regionale a prezzi contenuti323 nasce Slow Food Editore. Sin dalla sua nascita la nuova casa editrice ha messo in catalogo più di 70 titoli che celebrano le tradizioni alimentari in Italia e in altri paesi del mondo. Nel 1991, anno del Secondo Congresso Nazionale avvenuto nel mese di giugno a Perugia, l’associazione era già diventata un fenomeno inedito nel mercato italiano del cibo e del vino, contando su un’équipe di operatori enogastronomici attivi sul territorio, composta dai suoi “Fiduciari” (responsabili territoriali) e collaboratori. Nel novembre dello stesso anno avviene la Prima Convention Internazionale sui Vini Toscani. Gli epicentri sono Firenze e Siena, con escursioni nelle aree del Chianti, del Vino Nobile di Montepulciano, del Morellino di Scansano e del Brunello di Montalcino e assaggi di vini avvenuti nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Nell’ottobre 1992 Arcigola Slow Food, La Cena di Colombo e Legambiente ricordano il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America con cinquecento cene in trenta paesi del mondo, finalizzate al finanziamento di programmi di difesa della foresta amazzonica e delle popolazione indigene. Nel novembre dello stesso anno Slow Food Editore pubblica la Guida ai vini del mondo in cinque edizioni (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo). Sempre in quel mese si svolge la Convention Internazionale sui vini del Friuli, questa volta sui vini bianchi. L’evento avviene a Gradisca d’Isonzo, nel cuore dei Tocai, del Sauvignon, dello Chardonnay e del Pinot Grigio. Durante la Convention vengono fatti “assaggiare i vini migliori del Piemonte in città, castelli e dimore storiche, e nelle cantine dei produttori, che per 3 giorni accompagnano gli eno-turisti e li ospitano, in piccoli gruppi, a pranzare nelle loro case, favorendo una conoscenza diretta del territorio e delle vigne” (PETRINI, 2003:46/47). 322 L’Atlante è la prima catalogazione dei cru del vino nobile della Langa, il Barolo. Nel 2000 esso viene ristampato, passando a comprendere anche la zona del Barbaresco. “Per realizzarlo si erano misurate le vigne, rintracciate le testimonianze degli anziani, raccontate le storie delle cantine e delle etichette. È un lavoro che individua, evidenzia e premia le differenze, le singole porzioni di vigneto, le caratteristiche singolari di ogni cru: dando anche una diversa rilevanza economica a quelle porzioni di terra, finalmente delimitate” (PETRINI, 2003:39). Prima ancora dell’Atlante, nel giugno 1989, c’era stata la pubblicazione della Guida enogastronomica e turistica delle Langhe e del Roero. 323 Da allora il libro ha avuto pubblicazione annuale ed è arrivato nel 2001 all’undicesima edizione. 321 356 Nel 1993 si costituisce Slow Food Svizzera. Nel mese di giugno, Arcigola Slow Food organizza la I Settimana del Gusto, dedicata all’educazione alimentare delle giovani generazioni, iniziativa che si ripeterà fino al 1997. Nel giugno, Slow Food Editore pubblica Il piacere del vino, manuale per imparare a bere meglio324. Nel novembre avviene la Seconda Convention Internazionale sui Vini Piemontesi. Il 1994 è anch’esso un anno pieno di attività. Si costituisce Slow Food Grecia. Nell’aprile, a Verona, in occasione del Gran Menu, sezione gastronomica di Vinitaly, Arcigola Slow Food lancia i Laboratori del Gusto. Tra la fine di settembre e l’inizio di novembre avviene a Palermo il Terzo Congresso Nazionale Arcigola Slow Food. Nel novembre, avviene la Seconda Convention Internazionale sui Vini della Toscana e, in dicembre, Arcigola Slow Food organizza a Milano la Milano Golosa, embrione del futuro Salone del Gusto. Nel 1995 si costituiscono gli Slow Food Slovenia, Australia e Cayman Islands. Nel gennaio di quell’anno nascono le Tavole Fraterne, progetti di solidarietà collegati a tematiche alimentari in zone del mondo oggetto di guerre, carestia e miserie. I primi interventi sono fatti in Amazzonia e a Sarajevo. Il 1996 è un anno importante. Si costituiscono gli Slow Food Usa e Messico. Nell’aprile, esce con periodicità trimestrale in tre lingue – italiano, inglese e tedesco – il primo numero di «Slow, messaggero di gusto e cultura», periodico diretto da Alberto Capatti e strumento del progetto Slow Food Internazionale. Con il numero 11, del settembre 1998, si aggiungono altre due lingue: lo spagnolo e il francese. La rivista “tratta di cibo, tendenza dei consumatori, vini e cultura, biodiversità e sviluppo sostenibile, gusto e tecnologia, proponendo tutte le tematiche secondo i diversi aspetti: scientifico, storico, sociologico, giornalistico e letterario”325. Nata su internet ma anche stampata su carta, «Slow» è la misura culturale, oltre che l’organo, del movimento. Sempre in quell’anno, con la realizzazione della prima edizione Salone del Gusto di Torino, viene lanciato il progetto «L’Arca del Gusto per salvare il pianeta dei sapori», occasione in cui Arcigola Slow Food assume a sé il compito “di coniugare modi ed espressioni sino a quel momento ritenuti incompatibili: qualità eccellenti e prezzi abbordabili, godimento e 324 325 Il libro ha come proposta da un lato insegnare/divulgare i criteri del buon bere e dall’altro rispondere alle esigenze di un pubblico curioso, sempre più giovane e ampio. In otto anni il libro ha avuto cinque edizioni e ha venduto 50.000 copie. SLOW FOOD. Cos’è Slow Food. Consultabile on line all’indirizzo: <http://www.slowfood.it> seguendo il percorso: cos’è slow foodÆstoriaÆSlow Food Editore. L’ultima consultazione è stata effettuata il 30 gennaio 2004. 357 salute, dolcezza del vivere e consapevolezza sociale, velocità e ritmi lenti” (PETRINI, 2003:14)326. Il 1997 è un altro anno pieno di avvenimenti. A maggio si svolge a Roma il convegno «Dire, fare, gustare. Discorsi, progetti, esperienze intorno all’educazione sensoriale». Il convegno è abbinato a una serie di Laboratori del Gusto tenuti da animatori Slow Food nelle scuole romane. Sempre a maggio si tiene a Münster, in Germania, il primo Slow Food Festival. Nel giugno, Slow Food pubblica il Manifesto dell’Arca (ALLEGATO N° 3). Nel settembre, si svolge a Bra la prima edizione di Cheese, le forme del latte, rassegna internazionale dei formaggi di qualità. Il programma prevede un mercato, Laboratori del Gusto, itinerari turistico-gastronomici, appuntamenti conviviali e sedute didattiche. Si tratta di una delle principali kermesse dedicate al mondo del formaggio e del latte, un evento che coniuga l’educazione del gusto e il piacere della scoperta dei sapori. Infine, in ottobre si svolge a Orvieto il Secondo Congresso del Movimento Internazionale Slow Food, avendo come filo conduttore il dibattito sull’Arca e la salvaguardia dei prodotti a rischio di estinzione. Nel 1998 si costituisce Slow Food Giappone. Nel mese di giugno, a Rovereto, si svolge il Quarto Congresso di Arcigola Slow Food Italia: nuovamente viene discusso il tema l’Arca insieme a quello dell’educazione del gusto. Nel luglio, si costituisce per iniziativa di Slow Food l’Agenzia di Pollenzo Spa, società a cui partecipano soggetti privati e enti pubblici finalizzata al recupero di una residenza di Casa Savoia in cui troveranno sede un albergo, un ristorante, una banca del vino e l’Università delle Scienze Gastronomiche. Nel novembre, a Torino, avviene la seconda edizione del Salone del Gusto: 52.000 metri di superficie espositiva, 354 espositori, 311 Laboratori del Gusto, 4 Gran Sale Tematiche, 3 Enoteche con 3.000 vini di tutto il mondo, 40 appuntamenti conviviali, corsi di cucina e di degustazioni, presentazioni di libri, convegni, itinerari turistico-gastronomici. I numeri rivelano l’accettazione che il movimento aveva già avuto della società: 120.000 visitatori, 35.000 partecipanti ai Laboratori, 628 giornalisti accreditati di cui 243 stranieri. All’interno del Salone si svolge anche il Congresso Straordinario del Movimento Internazionale Slow Food che approva lo Statuto Internazionale327. Nel maggio 1999 Slow Food lancia un appello in difesa del patrimonio enogastronomico italiano, con una raccolta di firme per chiedere la revisione del “Il progetto dell’Arca (…) prende atto del grave rischio di scomparsa di specie ortifrutticole, razze animali e prodotti che fanno parte della nostra memoria e del nostro patrimonio di sapori; il successivo progetto dei Presìdi [reinventerà] modi di produzione e [rivitalizzerà] economie locali, indicando una nuova via all’agricoltura mondiale” (PETRINI, 2003:17). 327 Il testo originale dello Statuto Internazionale Slow Food approvato dal Congresso Internazionale l’8 novembre 2003, a Napoli, Italia, può essere consultabile on line sul sito web <http://www.slowfood.it> seguendo il percorso: cos’è slow foodÆStruttura StatutiÆStatuto Internazionale. L’ultima consultazione è stata effettuata il 4 febbraio 2004. 326 358 regolamento HACCP – Hazard Analysis Control Critical Point – che l’Unione Europea vorrebbe applicare senza distinzioni a tutte le aziende del settore alimentare, con gravi rischi per le piccole produzioni artigianali328. Nel settembre di quell’anno si svolge a Bra la seconda edizione di Cheese, le forme del latte. L’evento era già diventato un appuntamento: centomila i visitatori, trecento giornalisti accreditati di cui ottanta stranieri, con una grande vendita di formaggi e altri derivati dal latte. Nel novembre, una delegazione di Slow Food visita la Cina, dove si organizzano i Laboratori del Gusto sui prodotti dell’enogastronomia italiana. Nel 2000 si costituiscono gli Slow Food Cina e Nuova Zelanda. Nel gennaio di quell’anno parte il progetto dei Presìdi, interventi mirati di azione sul territorio per salvaguardare e rilanciare piccole produzioni tradizionali a rischio di scomparsa. Nel Salone del Gusto che avviene nell’ottobre di quell’anno sono stati presentati ben 91 Presìdi. Nel luglio esce il primo numero di «L’Arca, quaderni dei Presìdi». Nell’ottobre tre avvenimenti importanti. Primo, esce in italiano e inglese il primo numero di «Slowine», periodico dedicato al vino. Secondo, a Bologna, avviene la Prima Edizione del Premio Slow Food, con la premiazione di tredici benemeriti della salvaguardia della biodiversità nel mondo. Terzo, a Torino, avviene la terza edizione del Salone del Gusto: 572 espositori, 250 Laboratori del Gusto, 91 Presìdi, 130.000 visitatori, circa 2.000 giornalisti accreditati. Nel gennaio 2001 s’inaugura il Master of Food, università popolare del gusto che prevede 20 corsi di studio della materia alimentare, dal vino alla birra, passando per il caffè, le spezie, la carni e l’ortifrutticoltura, ognuno dei quali articolato in quattro incontri. Slow Food: <http://www.slowfood.it>. A maggio i prodotti selezionati dai Convivium Slow Food per salire sull’Arca arrivano a seicento. Nel giugno i Convivium Slow Food attivi in tutto il Sempre 328 nel gennaio s’inaugura anche il sito internet dello L’HACCP – che in italiano sta per Analisi dei Rischi e Tenuta sotto Controllo dei Punti Critici – è un metodo creato nel 1959 dalla NASA per garantire l’integrità degli alimenti usati nel programma spaziale, diventato Direttiva Europea nel 1994. Nel 1999 l’HACCP è stata recepita e resa operativa in Italia, introducendo in tutte le imprese alimentari nuove normative e procedure per l’analisi dei rischi di contaminazione dei prodotti. La mancanza di chiarezza sulla sua applicazione ha lasciato spazio all’aumento delle pratiche burocratiche e dei costi per mettersi in regola, nonché una standardizzazione della produzione a svantaggio dei prodotti tipici tradizionali, la cui maggior parte, non rientrando nelle nuove norme, rischiavano di scomparire. Di fronte a questa situazione Slow Food ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di raccolta di firme nei mesi di maggio e giugno del 1999 – riuscendo a raccogliere 300.000 firme –, per chiedere al governo di fare chiarezza sulle regole e l’applicabilità della nuova normativa. La campagna ha ottenuto dal governo la realizzazione di alcuni emendamenti per una disciplina sanzionatoria più flessibile, per “salvaguardare i ‘prodotti alimentari che richiedono lavorazioni particolari e tradizionali’ e soprattutto per differenziare le procedure di autocontrollo tra piccole e grandi realtà produttive” [SLOW FOOD. Cos’è Slow Food. Consultabile on line all’indirizzo: <http://www.slowfood.it> seguendo il percorso: cos’è slow foodÆdizionario slow foodÆLe analisi e le procedureÆHaccp. L’ultima consultazione è stata effettuata il 04 febbraio 2004]. 359 mondo erano arrivati a quota 900, di cui 350 in Italia e 550 all’estero. Nel settembre, si svolge a Bra la terza edizione di Cheese, le forme del latte, con una novità: questa volta, la kermesse ospita tutti i Presìdi Slow Food dei formaggi. Il successo continua: 130.000 visitatori nel totale, 30.000 solo nella Gran Sala del Formaggio, più di 1.200 chili di mozzarella di buffala e 400 chili di gelato-yogurt di pecora venduti, solo per fare alcuni esempi. In più, vanno esauriti tutti i prodotti esposti negli stand dei Presìdi. Nel 2002 partecipano al Salone del Gusto 138.000 visitatori e più di 2.000 giornalisti accreditati di tutto il mondo. In quell’occasione circa 21.000 persone partecipano a corsi d’educazione nei Laboratori del Gusto o altre manifestazioni come i Comizi Agrari, assaggi di formaggi, vini e altri prodotti; si verifica la crescita del Master of Food, nonché l’aumento del numero di persone disposte a pagare la qualità al prezzo giusto, permettendo così una giusta rimunerazione ai produttori. I 520 espositori presenti nel Mercato – di cui 102 stranieri – sono divisi in bancarelle e stand, 130 prodotti dei Presìdi Italiani acquistabili e 30 specialità alimentari prodotte in forma artigianale nei parchi Italiani. Il Salone del Gusto 2002 marca un’altra svolta importante: la presentazione dei primi 19 Presìdi Internazionali, cifra che è in continua crescita. Il prossimo appuntamento con il Salone del Gusto è per l’ottobre 2004, occasione in cui si terrà il convegno “Terra Madre – Incontro mondiale tra le comunità del cibo”. L’evento coinvolgerà soprattutto i contadini e i lavoratori della produzione alimentare. Sono previste cinquemila persone di tutto il mondo rappresentanti delle loro comunità, oltre a partecipazioni di personaggi importanti come Vandana Shiva. Nel 2003 l’altro appuntamento fisso, la quarta edizione di Cheese: le forme del latte, avvenuta dal 19 al 22 settembre per le strade di Bra. La kermesse offre al visitatore un interessante percorso per le forme del latte. Nella Gran Sala del Formaggio localizzata sotto il porticato dell’Ala che domina il Corso Garibaldi, è possibile assaggiare tutti i 149 formaggi a marchio DOP e IGP europei. Nella Via Lattea si possono assaggiare altri derivati del latte, come il gelato di latte di capra Panna Elenna, il frappé di frutta fresca selezionata da Battaglio, il cioccolato al latte Lindt, gli yogurt biologici a marchio Coop. In più, mercati, Presìdi di formaggi vari, Laboratori del Gusto, Appuntamenti a Tavola e, tra gli eventi speciali, la Cheese Bimbi, il Treno del Formaggio, Comizi Agrari, Chioschi degustazioni e I locali del buon formaggio. Il movimento Slow Food è in continua crescita e nel 2003 contava 31.000 soci in Italia e 75.000 nel mondo (con presenze in più di 42 nazioni e sedi nazionali aperte in Germania, Svizzera, Stati Uniti e Barcellona). Per il 2004, oltre alla nuova edizione dell’ormai tradizionale Salone del Gusto avverrà a Genova, dal 4 al 7 giugno lo Slow Fish, nell’ambito di Sapore di Mare, il primo progetto italiano sulla pesca responsabile. È 360 prevista la realizzazione di un convegno che tratterà dei seguenti temi: acquacoltura di qualità, Il pesce ritrovato, La pesca artigianale – i Presìdi del mare. In più ci saranno il Grande Mercato del Pesce (il cuore di Slow Fish), attività didattiche come Il teatro del gusto, i Laboratori del Gusto, il Master of Food. Nel settore assaggi, saranno proposte le attività: L’isola del gusto, Le Osterie del Mare e gli Appuntamenti a Tavola329. 3.2. Le fondamenta di Slow Food e le strategie per diffondere la sua filosofia “Il fondamento su cui poggia la costruzione di Arcigola Slow Food è il concetto di territorio. Sono le culture locali la risposta alla pretesa omologazione indotta dal modello fast food (…). Dal territorio vengono il vino e le materie prime, le tecniche di cucina e le storie, l’identità e il costume di scambiare conoscenze, prodotti e progetti” (PETRINI, 2003:37). Arcigola è nata in una zona di antica tradizione agricola, di bei paesaggi, arricchita da miti letterari e da prodotti simbolo come il Barolo e il tartufo e più tardi anche da vini più sofisticati. È stato in questo territorio che l’Associazione ha deciso “di sperimentare la sua idea di costruzione di un territorio, inteso come sistema integrato, inventario delle risorse e progetto con specifiche finalità. (…) Per la prima volta si [è proposto] uno sforzo comune volto a una vasta operazione di promozione di immagine, con un invito a servirsi intelligentemente dei propri tesori” (PETRINI, 2003:39). I passi successivi verso la costruzione di un modello alternativo di valorizzazione delle produzioni locali sono stati dati da pubblicazioni come la Guida enogastronomica e turistica delle Langhe e del Roero e l’Atlante delle grandi vigne di Langa, il Barolo, da iniziative come i Comizi Agrari, finalizzati all’aggiornamento culturale degli operatori del settore, e le Convention sui vini, che hanno attratto un pubblico curioso e qualificato inaugurando un nuovo rapporto fra i consumatori. “La stessa formula organizzata dall’associazione, fondata su quelle che vengono chiamate «Condotte enogastronomiche», [è stata] il modo per superare divisioni amministrative spesso fittizie e recuperare identità antiche giustificate da risorse locali, tradizioni produttive e culinarie. La Condotta (che all’estero riceve il nome di «Convivium») è costituita da una porzione di territorio e da un gruppo di persone associate al movimento; nel suo ambito si organizzano le attività dell’associazione (incontri conviviali, assaggi, corsi di degustazione, visite a produttori, ecc.); a capo di ognuna di esse, un «Fiduciario», democraticamente scelto, coordina le attività e fa da tramite con la sede centrale, partecipando 329 Maggiori informazioni si possono trovare on line sul sito <http://www.slowfood.it> seguendo il percorso Grandi eventiÆSlow Fish: Salone del Pesce Sostenibile. L’ultima consultazione è stata effettuata il 6 febbraio. 361 alle assemblee che annualmente delineano strategie e politiche. (…) Ogni prodotto delimita e modella uno spazio portando alla costruzione di un mosaico geografico, con intersezioni molteplici, i cui confini sono tracciati dal mutare dell’ingrediente in un sugo, dall’imporsi di una certa cottura, dalla presenza, nei coltivi, di un vitigno, di una verdura, di un frutto, da una consuetudine conviviale, da una festa popolare” (PETRINI, 2003:39/40). Sono attive circa 700 Convivia nei più di 45 paesi dove Slow Food è presente, 330 delle quali in Italia. Le altre quattro sedi nazionali – Germania, Svizzera, Stati Uniti e Barcellona – sommano più di 130 Convivia. Uno dei fattori che ha contribuito all’aumento del numero di soci nonché dei simpatizzanti è stato l’aumento della qualità del vino e le iniziative realizzate dallo Slow Food per divulgarlo, tra cui le cinque Convention Internazionali sui Vini dei primi anni novanta. La svolta internazionale è stata data con la pubblicazione della Guida ai vini del mondo, con la prima edizione del 1992/93 e la seconda del 1995/6, guida che dà voce a chi vive in loco, lasciando che siano loro a giudicare i loro vini330. Oltre che al bere, il movimento si occupa del mangiare e, a questo proposito, focalizza le sue attenzioni “sulla cultura dell’osteria, promuovendo le identità locali, il buon uso delle materie prime, il rilancio dei valori conviviali, di gusti semplici e stagionali” (PETRINI, 2003:51). È in quest’ottica che, nel 1990, viene proposta l’elaborazione del libro Osterie d’Italia, sussidiario del mangiarbere all’italiana, cioè un repertorio di locali accoglienti dove si possono gustare piatti della cucina regionale e vini locali a prezzi giusti. “Setacciando l’intero territorio nazionale l’équipe di Slow Food (…) ha fatto emergere i locali «di uso quotidiano» che nascondono l’anima dell’osteria e, in qualche modo, ne sono gli eredi: trattorie casalinghe, ristorantini di città, mescite con cucina, ristoranti di campagna a conduzione familiare, enoteche che hanno allargato l’offerta a qualche piatto caldo, punti di ristoro annessi ad aziende agricole” (PETRINI, 2003:52). La guida ha fatto rinascere sia i piatti dell’antica tradizione sia nuovi locali che hanno assunto la proposta di Slow Food per la conduzione della propria attività. Le informazioni e i suggerimenti presenti nelle guide Slow Food offrono al lettore la possibilità di praticare un turismo enogastronomico consapevole e rispettoso della terra che ospita, molto diverso dal tradizionale stile “usa e getta”. “Gustare, in ogni terra, i piati particolari che essa vanta, significa ricercare i tramiti delle tradizioni e interrogare un 330 Questa procedura era valida sin dalla guida ai Vini d’Italia. Ai tempi in cui la guida è stata redatta Slow Food era presente in diciotto paesi, numero attualmente salito a ottantattre. La guida è stata scritta in cinque lingue e ha avuto una diffusione di 5.000 copie. In essa sono descritte 1.900 cantine, commentati 5.000 vini e assegnati a 150 vini il titolo di «Top Wine». 362 patrimonio costituito da persone, paesaggi, monumenti. Nessun prodotto è avulso dall’ambito di cui è espressione culturale” (PETRINI, 2003:58). Il mutato rapporto fra l’uomo contemporaneo e il cibo, caratterizzato dalla spersonalizzazione dei rapporti sia con il cibo che con chi lo produce e dalla perdita di un immenso patrimonio di saperi relativo alle pratiche di coltivazione e produzione ha spinto Slow Food a cercare un modo per ricostruire questo rapporto. Riconoscendo l’importanza della trasmissione della conoscenza di derrate, ricette, abitudini alimentari, ricorrenze gastronomiche, prima fatta all’interno delle famiglie, esso l’ha assunta come compito. Il primo passo verso questa rieducazione è l’uso dei sensi: Slow Food sostiene il primato dell’esperienza sensoriale – di tutti i nostri sensi e non soltanto del gusto – per l’educazione del gusto e della qualità. Il primo destinatario di questa azione dev’essere quello più ribelle, quello che preferisce il cibo che trova dai fast food a quello preparato con cura. È quindi al bambino in età scolare, che Slow Food si rivolge per primo. In questo senso, la prima azione verso questa rieducazione è stata l’educazione all’interno della scuola, servendosi del fatto che tra i soci Slow Food, tanti sono insegnanti. L’altra è stato l’iniziativa nata nel 1993 e intitolata «Settimana del Gusto». La settimana italiana è stata “articolata su due livelli. Da un lato, si realizzano una serie di interventi nelle scuole (dell’obbligo e non), nel corso dei quali operatori della cultura materiale (cuochi, pastai, norcini, pasticceri) coinvolgono i ragazzi in attività pratiche di degustazione guidata ma anche di manipolazione: le aule diventano così laboratori e cucine. Parallelamente, negli stessi giorni, i migliori ristoranti italiani aprono le porte a tutti i giovani fino a 25 anni offrendo loro un menu a prezzo ridotto: un’occasione inedita per avvicinarli al mondo dell’alta cucina e dell’arte culinaria. L’iniziativa Slow Food [ha culminato], nel maggio 1997, in un convegno promosso a Roma: «Dire, fare, gustare. Discorsi, progetti, esperienze intorno all’educazione sensoriale». Un appuntamento che [ha messo] a fuoco quanto si [era] realizzato e [ha rilanciato] a livello nazionale una tematica caratterizzante della filosofia del movimento” (PETRINI, 2003:77). Come risultato di questa esperienza, nel 1998, dopo la realizzazione della «Settimana del Gusto», viene pubblicata da Slow Food Editore, Dire fare gustare, percorsi di educazione del gusto nella scuola, realizzato da Rossano NISTRI. Il manuale riprende e sistematizza le attività didattiche messe in pratica durante gli anni di attività nelle scuole, di cui il principio del piacere era diventato il filo conduttore. In supporto alle attività svolte nelle scuole Slow Food organizza corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente – autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione e dai Provveditorati agli Studi –, con 363 l’obiettivo di fornire modelli didattici attraverso i quali trasmettere ai ragazzi una visione del cibo come cultura in un approccio scientifico-sperimentale. L’idea della «Settimana del Gusto» ha dato il via a un’altra strategia di educazione sensoriale permanente: i Laboratori del Gusto, inaugurati in occasione del Vinitaly avvenuto a Verona nel 1994. I Laboratori sono stati poi riproposti in molte altre attività svolte dal movimento e sono diventati un appuntamento fisso durante la realizzazione dei Salone del Gusto. Si tratta di un’occasione per esaminare un cibo o una bevanda in tutta la sua completezza. L’approccio diretto diventa un’esperienza formativa nel corso della quale i protagonisti della cultura materiale (vignaioli, casari, norcini, pasticceri, osti, ristoratori…) salgono in cattedra per trasmettere le loro conoscenze. Un’altra iniziativa importante è stata l’organizzazione del Salone del Gusto, di cui la prima edizione è del 1996. Trattasi di una manifestazione che sin dall’inizio ha andato oltre le tradizionali formule usate dalle fiere enogastronomiche puntando sul territorio, con le sue produzioni e i suoi artefici messi a confronto con i consumatori. L’evento si svolge all’interno del complesso espositivo del Lingotto a Torino. “Il pubblico accede ai padiglioni pagando un biglietto che dà diritto a frequentare un grande mercato di prodotti tipici artigianali, che ognuno può assaggiare e acquistare; a degustare i vini di tutto il mondo esposti nelle enoteche; a visitare gli stand di consorzi e associazioni. Linea-guida della nuova politica culturale è l’educazione del gusto, operata principalmente tramite i Laboratori del Gusto (…). Al Salone i temi del movimento sono rilanciati e dibattuti, e prende avvio la campagna dell’Arca: per la prima volta Slow Food parla, da un’importante ribalta mediatica, di salvaguardia del prodotto tipico, ufficializzando la sua posizione con un progetto ambizioso che vuole aprire strade nuove a produzione, mercato e consumo” (PETRINI, 2003:60). I buoni risultati ottenuti hanno incoraggiato a fissare una cadenza biennale all’evento e ad ampliare l’edizione successiva, del 1998, la quale h
Scarica