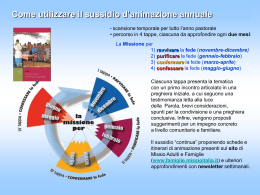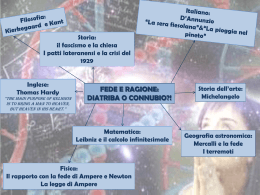GIUSEPPE COLOMBO Il giusto prezzo della felicità Pubblicazioni dell’I.S.U. Università Cattolica GIUSEPPE COLOMBO IL GIUSTO PREZZO DELLA FELICITÀ Milano 2005 © 2004 I.S.U. Università Cattolica – Largo Gemelli, 1 – Milano http://www.unicatt.it/librario Indice Introduzione ..................................................................................................7 Parte prima La felicità e l’angoscia L’universalità della condizione umana Capitolo primo La ricerca della felicità 1. Definizione formale di felicità .........................................................11 2. Atti dell’uomo e atti umani ..............................................................12 3. Riverbero soggettivo di una perfezione oggettiva ..........................12 4. Parole di pace, parole di guerra.........................................................13 5. Homo viator… al bene ......................................................................14 6. Il fine della vita come mio amore .....................................................16 7. Il fine misura l’uomo: dimmi che Dio hai, ti dirò chi sei ...............17 Capitolo secondo La condizione dell’uomo “per via”: autocoscienza e infelicità 1. Il “conosci te stesso” e il problema della vita ..................................19 2. L’uomo: un problema a se stesso .....................................................22 3. La lezione di Sofocle .........................................................................25 4. Umiltà fradicia e umiltà alta .............................................................28 5. Gli Antichi non andavano allo zoo ..................................................30 6. Inquietudine e ricerca di Dio: ragione e rivelazione .......................31 Capitolo terzo La ricerca della verità 1. Bisogna pur vivere: il sogno..............................................................33 2. Edipo e la Sfinge ................................................................................36 2.1 L’intellettuale, il bambino e… l’uomo .....................................37 2.2 La Natura noverca e l’uomo......................................................38 2.3 Il Caos vince l’uomo .................................................................38 2.4 Il sapere non basta: la persona, la potenza ...............................39 3 3. Gli intellettuali e i santi: gnosi e cristianesimo ...............................40 4. Ancora sull’essere nudi .....................................................................43 5. Il problema e il mistero.....................................................................44 Capitolo quarto Verità, angoscia e amore 1. La paura e l’angoscia..........................................................................47 2. L’ammirazione e l’angoscia...............................................................48 3. Trascendenza e contingenza.............................................................50 4. Non intratur in veritatem nisi per caritatem ...................................53 Parte seconda Amor, ch’a nullo amato amar perdona Capitolo primo Il primo Amore 1. Chiamati per nome............................................................................59 2. La vocazione “originaria”..................................................................62 3. Creazione, provvidenza, predestinazione........................................63 4. Ontologia, religione, etica ................................................................66 5. La priorità di Dio: uomo-chiamato e non uomo-domanda............68 6. Chi mi chiama per nome?: il “Tu” è più antico dell’”io”................73 Capitolo Secondo L’Essere e l’io: la dialettica di identità e di differenza 1. Vita-verità-via: il bello, il vero, il bene .............................................75 2. La vita: sotto il cuore: la formazione della coscienza umana .........78 3. La verità: nell’unità la differenza ......................................................81 3.1 La prima distinzione: il parto....................................................82 3.2 Sopra il cuore: vista e tatto........................................................83 3.3 La voce: chiamati per nome. .....................................................84 3.4 l’amore dà l’essere......................................................................85 3.5 Il sovrappiù ................................................................................86 3.6 Non come un ospite ..................................................................86 3.7 Il “no”: dallo stupor al dolor ......................................................87 3.8 La colpa ......................................................................................87 4 3.9 Un gioco e la morte...................................................................90 3.10 I genitori non sono Dio: il disagio fondamentale ...................92 4. La via: la pubertà e la scelta...............................................................93 Parte terza La dialettica di uomo di bisogno e uomo di desiderio Capitolo Primo L’uomo di bisogno 1. Piacere e dolore: due realtà positive.................................................99 2. Il dolore e il male.............................................................................100 3. Il dolore e il bisogno .......................................................................104 4. Scienza, tecnica, volontà e potere di fronte al dolore e al bisogno.............................................................................................105 5. Soddisfacimento reale e soddisfacimento surrettizio del bisogno.............................................................................................108 6. Risentimento e sublimazione, disprezzo di innamorato e sacrificio ...........................................................................................110 7. Finitudine dell’uomo di bisogno ....................................................113 Capitolo Secondo L’uomo di desiderio 1. Il desiderio vive nel bisogno e lo trascende ...................................115 2. Ut res et ut signa: come cosa e come segno ..................................116 3. Per natura l’uomo trascende la natura............................................117 4. I segni del desiderio.........................................................................117 5. La sete natural che mai non sazia… ...............................................119 6. Desiderio e sofferenza ....................................................................120 Capitolo Terzo L’autoerotismo e l’eteroerotismo 1. L’autoerotismo ................................................................................123 2. Un’eresia cristiana: il riduzionismo antropologico e lo scientismo nella cultura occidentale...............................................126 3. L’eteroerotismo...............................................................................128 5 Parte quarta In visione e in fede Capitolo Primo In principio è la religione 1. Grandezza e angoscia sono negli occhi .........................................135 2. La via: il razionale è nel religioso ...................................................137 3. La via: in essa si dà il Bene ..............................................................138 4. La via: al suo principio la Verità e l’Amore ...................................139 5. Lo stato religioso del bimbo...........................................................141 6. Può esservi un uomo non religioso? ..............................................141 Capitolo Secondo La fede 1. Una prima precisazione sul termine “fede”...................................143 2. La fede è atto di due persone: L’altro.............................................145 3. La fede è atto di due persone: l’io ..................................................148 4. La Ragione e la libertà .....................................................................149 5. La ragionevolezza “del” e “nel” credere.........................................150 6. Fede nella parola e fede nella persona ............................................152 7. La “fede” storico-giuridica..............................................................154 8. Fede negli uomini e fede in Dio .....................................................155 9. Fede, libertà e amore .......................................................................156 10. Una conclusione provvisoria ..........................................................157 Appendice ..................................................................................................161 6 Introduzione Cosa è veramente in gioco nelle aspettative che noi uomini abbiamo nei confronti dei nostri simili, dell’intera società, del mondo? Cosa chiediamo veramente quando domandiamo cultura, condivisione, comprensione, affetto? Cosa urla inespresso al fondo del nostro mutismo o nelle nostre esplosioni d’ira? A queste domande bisogna rispondere come adulti, sapendo che vi sono due opposte tentazioni da cui bisogna rifuggire: 1) quella del titanismo che, in preda a un delirio di onnipotenza, ritiene di potere risolvere ogni problema esistenziale grazie a modelli interpretativi e a tecniche a essi conformi; 2) quello dello scetticismo, del cinismo e della rassegnazione che ci induce a consegnarci fatalisticamente agli eventi. La risposta all’imperiosa richiesta esistenziale può venire invece soltanto dal recupero di una verità fondamentale: che in ogni domanda e in ogni disagio particolare passa la domanda di senso, di salvezza ultima, ovvero in ogni nostra richiesta è richiesto Dio. Per questo mi sforzerò di dimostrare che la dimensione religiosa non si aggiunge estrinsecamente all’esistenza, come se fosse una realtà “a lato” o una conclusione opzionale. Anzi, il religioso permea essenzialmente la vita, tanto che ogni nostro disagio, piccolo o grande che sia, si consustanzia e si palesa come bisogno di Dio: la domanda di sapere e di potere altro non è che una domanda di salvezza. Tenterò inoltre di vincere l’oblio o, addirittura, la rimozione del soggetto, meglio della persona e di ricollocare in primo piano la relazione delle persone come attori del dramma-storia che pongono, creano il non deducibile, il non previsto, perché frutto di libertà, appunto, come risposta alla domanda di senso di cui sopra. Il disagio è dunque innanzitutto una condizione normale dell’esistenza umana e soltanto in alcuni casi particolari può divenire una condizione 7 patologica, se è letto non superficialmente, arrestandosi ai livelli fenomenologico-psicologici e sociologici, ma se è approfondito antropologicamente, teologicamente (di teologia razionale e di teologia cristiana), cioè il disagio è condizione dell’homo viator: La sete natural che mai non sazia/se non con l’acqua onde la femminetta/samaritana domandò la grazia,/mi travagliava ... (Purg. XXI, 1-3) Ma non si vive di solo disagio: bisogna gustare qualcosa di buono! Scriveva san Tommaso: «Nessuno può fare a meno del diletto per molto tempo. E coloro, che non possono godere di diletti spirituali, passano a quelli carnali»1. Con questo lavoro intendo quindi offrire un conforto per chi è per via. Tuttavia, pur sapendo che l’oggetto di ogni filosofia è sempre qualche cosa di sempre più che filosofico, perché non solo la ragione e la natura non sono mai esistite e mai esisteranno allo stato puramente “naturale”, ma anche perché l’oggetto della filosofia è anche la rivelazione cristiana, è mia ferma volontà procedere nei limiti della formalità filosofica. Voglio dire che cercherò, per quel che mi è possibile, di non fondare i miei ragionamenti su argomenti di autorità, ma di offrire una dimostrazione razionale di quanto andrò a esporre. Affermava san Tommaso: «… bisogna servirsi di ragioni che portino l’investigazione fino alla radice della verità e facciano capire come sia vero ciò che si dice (quomodo sit): altrimenti, se il maestro definisce la questione con i nudi argomenti d’autorità, l’uditore sarà, sì, rafforzato nella certezza che la verità è quella (quod ita est), ma non acquisterà nulla di scienza e d’intelligenza e anzi se ne andrà con la testa vuota (vacuus abscedet)»2. Giuseppe Colombo 1 Summa theologiae, II, IIa, ae q 35, a4, ad 2um. Tommaso si colloca sulla scia di Aristotele, Etica Nicomachea, VIII, 6, II 58 a 23, 25. Decimo, 6, II 76 b19-20. 2 Quaestiones Quodlibetales, IV, q. 9, a. 3, ed. Taur. p. 83. 8 PARTE PRIMA La felicità e l’angoscia L’universalità della condizione umana Capitolo primo La ricerca della felicità «È giudizio sicuro di tutti coloro che godono in qualche misura della ragione, che tutti gli uomini aspirano alla felicità. Ma come essere o diventare felici? Ecco un problema che i mortali nella loro debolezza si sono sempre posti, e che ha suscitato molte e gravi controversie»3. Queste parole di Agostino meritano un adeguato commento, perché caratterizzano in modo preciso la condizione umana nella sua universalità, poiché riguardano ogni uomo e tutto l’uomo, cioè ogni singolo individuo nella sua totalità o intierezza. Soltanto coloro che sragionano, infatti, possono affermare che l’uomo non aspira alla felicità. Tutti gli altri, purché abbiano un minimo di ragione (non è quindi qui questione esclusiva di teologi, filosofi, scienziati in generale), con sicurezza quasi evidente riconoscono questa universale aspirazione degli uomini alla felicità. 1. Definizione formale di felicità Che cos’è la felicità?4 Un dizionario della lingua italiana ne dà questa definizione formale, astratta: la felicità è la «compiuta esperienza di ogni appagamento». Il termine «appagare» deriva poi da «pacificare» e quindi è pago colui che è in pace, cioè non solo non ha più guerre da compiere per conquistare ciò che gli manca, ma anche possiede perfettamente ogni cosa reale e, persino, quelle possibili. Perciò, con altre parole, si può dire 3 Agostino, De civitate Dei, X, 1. Molte sono le definizioni di felicità; eccone due celebri: Severino Boezio nel De consolatione philosophiae (III, prosa 2, 2-4) parla di «Status bonorum omnium congregatione perfectus» («lo stato perfetto costituito dalla riunione di tutti i beni»); Agostino parla anche di «gaudium de veritate» («gioia per la verità») (Conf., X, 23). 4 11 che l’uomo per essere felice, veramente felice, deve possedere pienamente la totalità del reale: se stesso, gli altri, le cose e l’Assoluto, Dio. La definizione, poi, parla di «compiuta esperienza» e in ciò indica chiaramente il momento personale della felicità. Il singolo uomo è felice perché possiede la totalità non come un semplice “dato”, fattualmente, per così dire, ma proprio perché sperimenta questo possesso in modo squisitamente “umano”. Bisogna allora distinguere tra “atto dell’uomo” e “atto umano”. 2. Atti dell’uomo e atti umani Molto spesso gli atti dell’uomo hanno sì nell’uomo il loro soggetto (senza l’uomo che li compie non esisterebbero e perciò – si dice – procedono dall’uomo, sono suoi atti), ma esprimono soltanto quella dimensione del suo essere per la quale egli rientra nel genere dei corpi animati, viventi. Questi atti sono quelli determinati da una “necessità di natura”: le operazioni della vita vegetativa, i gesti istintivi o irriflessivi, quelli compiuti a causa di una costrizione psichica, eccetera. Questi vengono chiamati “atti dell’uomo”, ma non sono “atti umani”. Gli “atti umani” sono allora quelli che portano l’impronta della differenza specifica dell’uomo, che lo distanzia da tutti gli animali, e cioè quelli che scaturiscono dalla sua razionalità e volontà libera Perciò non vi può essere «compiuta esperienza» della totalità e, quindi, non vi può essere felicità, se non vi è piena coscienza: luce di ragione e di libertà, trionfo di “autocoscienza”. 3. Riverbero soggettivo di una perfezione oggettiva Per questo possiamo dire, con un’altra e forse più appropriata definizione di felicità, che la felicità, appunto, è il riverbero soggettivo di una perfezione oggettiva. L’uomo infatti è “per via”, sempre, in questo mondo. Egli è quell’essere che, in virtù della sua propria natura o essenza, deve essere ciò che ancora non è palesato. In altri termini l’uomo è un atto potenziale 12 rispetto a un atto compiuto, ossia è in divenire rispetto al termine del suo mutamento, cioè alla sua perfezione di uomo5. Non vi può essere quindi felicità se non nell’uomo divenuto perfetto, ossia completamente attuato. E questa realizzazione piena è il momento oggettivo della felicità: è la perfezione ontologica, cioè la perfezione di quell’essere che è l’uomo. E, poiché, come visto, l’uomo è tale nella autocoscienza, la perfezione oggettiva ha un riverbero, un ritorno su se stessa, che è appunto la felicità considerata dal punto di vista soggettivo: l’uomo sa e gode della propria perfezione e questo godimento è la felicità, cioè lo splendore della sua perfezione. 4. Parole di pace, parole di guerra Ora Agostino afferma che fa problema ai «mortali» nella loro «debolezza» il «come» dell’«essere», cioè della natura, dell’essenza, e del «divenire», cioè dei mezzi, degli strumenti, della felicità. Notiamo innanzitutto che con semplicità e, al tempo stesso, con acuto realismo Agostino riconosce il limite intrinseco alla natura umana e rifugge ogni tipo di ybris prometeica. L’uomo è mortale, ossia – guardando alla storia delle vicende umane – tutti i suoi sforzi per conseguire la felicità concludono nella morte. Sì, l’uomo è un essere che sembra fatto per volare alto, ma l’ultima parola spetta al cimitero, alla morte, appunto. Notiamo poi che dalla sua debolezza (di ingegno, di volontà, di potere, di prassi) dipendono non solo i fallimenti finali (il cimitero), ma anche le interminabili e mai concluse discussioni sulla consistenza della felicità. Se, infatti, la definizione formale della felicità, sopra esposta, può ragionevolmente trovare tutti concordi, è pur vero che sulla definizione materiale o sostanziale della felicità, cioè sul suo contenuto, sul suo valore, sulla sua consistenza ontologica, gli uomini si dividono. Così, paradossalmente, una “parola di pace”, qual è la felicità (e quelle a essa correlate, come amore, giustizia, eccetera), diventa una “parola di guerra”: 5 Cfr. l’Appendice in questo volume. 13 gli uomini uniti e divisi, armati gli uni contro gli altri, nella ricerca della felicità e nella sua definizione sostanziale. Non fa neppure eccezione, da questo punto di vista, la parola “Dio”, l’oggettivazione più alta della felicità: tutti agiscono in nome di Dio, ma “per Dio” sono state combattute e vengono combattute le guerre più feroci. Si può transigere sulle minuzie, ma non su ciò che concerne l’essenza della felicità, perché in essa e per essa ne va della stessa vita umana. I Greci, a esempio, possono “commerciare” (e non solo in senso economico, ma anche culturale) con i Persiani, ma non possono scendere a patti con loro quando si tratta dell’”ideale”, cioè del Dio: meglio vedere Atene arsa e rasa al suolo che disconoscere i suoi Dèi, meglio morire che rinunciare al significato ultimo della vita, a ciò per cui soltanto vale la pena vivere, perché – come dirà anche Giovenale – il più grande dei crimini consiste nel preferire la sopravvivenza all’onore e, per amore della vita fisica, «perdere le ragioni del vivere»6. Così per Agostino le «molte e gravi controversie» suscitate dal nome «felicità» non possono venire superate con un facile irenismo, un semplice “pacifismo” (si direbbe oggi): esso è inane e impotente e lascia intatto il dramma dell’umano esistere. 5. Homo viator… al bene Torniamo ora alla definizione di uomo come un essere che è “per via” alla ricerca della felicità. A questa affermazione di Agostino il moderno esistenzialismo nichilista, che tanta parte ha avuto nel plasmare molte coscienze nel mondo contemporaneo, obietta che l’uomo è un «Essere per la morte» (Martin Heidegger). Con questa visione concordano anche i rappresentanti del mondo variegato dell’evoluzionismo, del relativismo, del pensiero debole, dell’ateismo razionalista o scientista. 6 Giovenale, Satirae, VIII, 838-4. 14 Questa obiezione non è però così nuova (moderna), come vuole apparire, tanto è vero che la troviamo citata e confutata anche da san Tommaso. Infatti, a quanti affermano che «il movimento proprio di una natura che viene dal nulla tende al nulla»7, il dottore comune della Chiesa risponde che «La tendenza al nulla non è il movimento proprio dell’essere naturale, che si dirige sempre a un qualcosa di buono (buono, però, significa: esistente); ma la tendenza al nulla si effettua precisamente col rifiuto di quel movimento proprio»8. E questo perché, semplicemente, il nulla non esiste e, dunque, non si può volere ciò che non è, ma si può volere solo ciò che esiste; però questa tendenza naturale all’essere può venire rifiutata e sostituita dalla tendenza al nulla. Tommaso preciserà che questo rifiuto può essere compiuto solo da un atto libero, quindi soltanto da esseri intelligenti, e che comunque la proclamata volontà di perseguire il nulla in realtà cela la non dichiarata volontà di ottenere un altro bene: insomma, chi vuole la morte (la nientificazione propria o altrui), in realtà vuole attraverso questa soppressione d’essere, un bene, un essere ritenuto, a volte, anzi spesso erroneamente, maggiore e migliore: mors tua, vita mea, ma anche la mia morte come affermazione di un ideale (buono o cattivo, non importa) 9. Dunque l’uomo non trascorre i suoi giorni errabondo sulla Terra, sospeso equamente tra l’essere e il nulla, ma ciascuno di noi è homo viator, uomo in cammino verso una meta, un bene, una ricchezza d’essere (e stabilire in cosa consista questo Essere è il compito fondamentale di ogni uomo). 7 Tommaso, Pot. 5, 1, obj. 16. Tommaso, Pot. 5, 1 ad 16. 9 Il suicida, togliendosi la vita, afferma che la vita non è degna di essere vissuta, e non lo è, proprio perché egli ha un alto ideale della vita che, confusamente, vuole affermare sopprimendo l’esistente visto come difettoso, mancante d’essere. 8 15 6. Il fine della vita come mio amore Appare allora in tutta la sua chiarezza il rapporto tra ricerca della felicità e amore, “amore di bisogno”, innanzitutto, cioè “eros” in senso squisitamente platonico. Leggiamo in una bella pagina di Fichte: «Rivelami quel che tu ami davvero, ciò verso cui tendi ed aspiri con tutte le forze del tuo desiderio, allorché tu speri di entrare nel perfetto possesso di te medesimo, – e mi avrai rivelato la tua vita. Il tuo amore è la tua vita»10. «Il tuo amore è la tua vita»: non solo il tuo amore è il Dio, ma è anche la tua perfezione e il «pieno possesso di te medesimo», cioè il tuo amore è la tua felicità. Le parole di Fichte mettono però in primo piano una “distanza attuale”, del qui e dell’ora, tra colui che cerca la felicità, l’uomo, e colui che è la meta di questo peregrinare, il Dio, e sottolineano il primato di quest’ultimo sull’uomo: è il Dio che perfeziona l’uomo; solo raggiungendo il Dio l’uomo diviene perfetto. In modo esemplare ancora una volta Agostino spiega questo fatto: «Il nostro riposo è il nostro luogo. Là ci solleva l’amore, e il tuo spirito buono eleva la nostra bassezza, strappandola alle porte della morte. Nella buona volontà è la nostra pace. Ogni corpo a motivo del suo peso tende al luogo che gli è proprio. Il fuoco tende verso l’alto, la pietra verso il basso, spinti entrambi dal loro peso a cercare il loro luogo. L’olio versato dentro l’acqua s’innalza sopra l’acqua, l’acqua versata sopra l’olio s’immerge sotto l’olio, spinti entrambi dal loro peso a cercare il loro luogo. Fuori dell’ordine regna l’inquietudine, nell’ordine la quiete. Il mio peso è il mio amore; esso mi porta dovunque mi porto. Il tuo dono ci accende e ci porta verso l’alto. Noi ardiamo e ci muoviamo. Saliamo la salita del cuore cantando il cantico dei gradini. Del tuo fuoco, del tuo buon fuoco ardiamo e ci muoviamo, salendo verso la pace di Gerusalemme. «Quale gioia per me udire queste parole: “Andremo alla casa del Signore!”» (Ps 121, 6.1). Là collocati dalla buona volontà, nulla desidereremo, se non di rimanervi in eterno»11. 10 11 Fichte, Anweisung zum seligen Leben, lez. I. Agostino, Il maestro interiore, a cura di A. Trapè, Edizioni Paoline Milano 1987, pp. 226. 16 7. Il fine misura l’uomo: dimmi che Dio hai, ti dirò chi sei Del brano di Agostino resti per ora solo questo: «il mio amore è il mio peso». A esso si deve però aggiungere che il «luogo», cioè Dio, in quanto è la “meta finale” è anche la “misura” dell’uomo. Ci soccorre, per chiarire questo concetto, un passo di Soren Kierkegaard che, parlando in generale del rapporto uomo – Dio, scrive: «L’io si potenzia in proporzione della misura adeguata all’io, e ha una potenza infinita se la misura è Dio. Più alta è l’idea di Dio, e più alto è l’io; più alto è l’io, e più è alta l’idea di Dio. Soltanto quando l’io, questo singolo io determinato, si rende conto di esistere davanti a Dio, soltanto allora l’io è infinito»12. E l’autore danese, perfezionando questa circolarità riferendosi esplicitamente al Dio Gesù Cristo, conclude: «Un io di fronte a Cristo è un io potenziato da un’immensa concessione di Dio, potenziato per l’importanza immensa che gli viene concessa dal fatto che Dio anche per amore di quest’io si degnò di nascere, s’incarnò, soffrì e morì. Come si è detto più sopra, più idea di Dio, più io, anche qui bisogna dire: più idea di Cristo, più io. Un io è qualitativamente ciò ch’è la sua misura. Nel fatto che Cristo è la misura, si esprime da parte di Dio con la massima evidenza l’immensa realtà che ha l’io; perché soltanto in Cristo è vero che Dio è méta e misura, ovvero misura e méta dell’uomo»13. Perciò, per condurre a buon fine questa disamina del desiderio della felicità, è necessario non solo e non tanto concentrare l’attenzione sulla realtà antropologica, quanto piuttosto su quella metafisico-teologica, perché non solo actus specificatur a obiecto, ma anche e in sovrappiù nihil volitum, nisi cognitum, ovvero è umana la felicità ricercata e raggiunta con un atto squisitamente umano e non solo con un atto dell’uomo: è necessario conoscere ciò che si vuole come propria perfezione e felicità. 12 S. Kierkegaard, La malattia mortale, in Opere a cura di C. Fabro, 3 voll., PM, Casale Monferrato 1995, vol. III, III, p. 92. 13 Ivi, p. 130. 17 Di conseguenza, eticamente, e non solo ontologicamente, se Dio esiste, Dio è l’infinita misura dell’uomo, perché questa, con le parole di Kierkegaard, è la definizione corretta di misura: «Come si possono addizionare soltanto grandezze omogenee, così ogni cosa è qualitativamente ciò con cui viene misurata; e ciò che, qualitativamente, è la misura, eticamente è la sua meta; viceversa la misura e la meta sono qualitativamente ciò che una cosa è»14. In altri termini, riallacciandoci a Fichte, il tuo amore è la tua vita. Potremmo dire: “dimmi chi è il tuo Dio e mi avrai detto te stesso, cioè la tua perfezione e la tua felicità”. 14 Ivi, p. 91. 18 Capitolo secondo La condizione dell’uomo “per via”: autocoscienza e infelicità 1. Il “conosci te stesso” e il problema della vita La ricerca della felicità e il suo eventuale possesso sono dunque cose “da uomini” e presuppongono non certo un tranquillo “lasciarsi vivere”, simile a quello degli animali, regolato dal carpe diem, l’afferrare e il godere immediatisticamente ciò che capita nel cerchio del proprio potere, ma un “impegno” che ha come suo momento iniziale e fondante la conoscenza di se stesso, del proprio autentico “io”. Scriveva il latino Giovenale: «Il conosci te stesso è disceso dal cielo e va scolpito, meditato nel proprio petto, quando ti accingi a cercar moglie o vuoi far parte del sacro senato»15. Il “conosci te stesso”, questo lascito di Socrate all’intera umanità, è quindi presupposto della vita sociale, e non solo; senza la conoscenza della propria natura umana, infatti, è impossibile discorrere della felicità e, dunque, intraprendere la sua ricerca. Del resto, ogni qual volta l’uomo indaga l’universo intero e, persino, almeno in prima battuta, il mistero dell’Assoluto, di Dio, compie questo atto con un fine neppure tanto celato: conoscere, attraverso le cose, se stesso. Di questa prospettiva si faceva interprete Amato Masnovo e, poiché il suo pensiero appartiene di diritto in modo vivo alla tradizione filosofica dell’Università Cattolica, ne riproduco un ampio stralcio: 15 Giovenale, Satire, undicesimo, vv. 27-30, trad E. Barelli. 19 «Ripresi in mano di questi giorni un mio vecchio libro: l’Al di là del bene e del male di Federico Nietzsche. Mi cadde l’occhio sopra alcune parole che avevo sottolineato forse vent’anni fa. Quelle parole suonano così: “Un po’ alla volta sono arrivato a farmi un’idea di ciò che è la grande filosofia: null’altro che la professione di fede del suo autore, quasi sue memorie che egli scrive involontariamente. Così pure, che il fine morale (o immorale) costituiva il vero nocciolo vitale di ogni filosofia, dal quale poi si è sviluppata la pianta tutta intera”16. Tolta qualche esagerazione, cara al genio paradossale del Nietzsche, qui ci è messa dinanzi una profonda e indiscutibile verità. Infatti filosofare non vuol dire altro che affrontare il problema della vita. Qui è tutta l’essenza della filosofia. In quanto mi preoccupo della vita io, filosofo, mi preoccupo degli altri problemi: i quali entrano nell’ambito filosofico appunto per il loro nesso col problema della vita. Il problema dell’universo interessa me, filosofo, solo in quanto mi aiuta a risolvere il problema della vita, cioè del mio fine ultimo in tutte le sue ripercussioni individuali ed extraindividuali. Dicasi il medesimo a proposito del problema della conoscenza. Anche questo sorge nel mio spirito di filosofo solo nel momento in cui si fa strada in esso la necessità di garantirsi intorno ai mezzi di marcia verso la conquista di una soluzione sia del problema dell’universo sia del problema della vita. Per sant’Agostino, non meno che per il Nietzsche, la filosofia è essenzialmente la ricerca di una soluzione del problema della vita. Qui soprattutto l’Agostino del primo periodo ne vide e il principio unificatore e il limite differenziale. L’Ortensio17 apre l’animo di sant’Agostino alla filosofia. […] Da Cartagine a Roma, da Roma a Milano, per undici anni ed oltre, cioè da 19 anni fino al di là dei 30, l’animo di sant’Agostino, e degli amici suoi, primo fra tutti Nebridio, è in affanno e in tensione […] Appunto sotto la pressione e in funzione del problema della vita sorgono nello spirito di sant’Agostino, durante questi undici anni, il problema dell’universo prima e il problema della conoscenza poi. E dalla soluzione del problema della conoscenza, superando la posizione accademica, passa alla soluzione del problema dell’universo, superando la posizione manichea, e viene finalmente alla soluzione del problema della vita: soluzione intesa per prima e conseguita per ultima. Non sarebbe difficile far constatare che il problema filosofico si atteggia alla medesima maniera presso san Tomaso d’Aquino. Del resto la prova migliore che il problema della vita è l’anima stessa del filosofare sta in ciò: che chi non fissi bene 16 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, tr. it. 3a ediz., Bocca, Milano 1906, p. 7. 17 È un libro di Cicerone andato perduto. 20 questo punto si trova nella impotenza di dare unità e limite differenziale alla filosofia. Eppure una unità e un limite differenziale bisogna assegnare: ché altrimenti ne va di mezzo la sua stessa esistenza. Nessuno vorrà vedere qui un atteggiamento prammatico. Il prammatismo, per così esprimermi, fa della vita, ossia della prassi e dell’azione, l’argomento per una soluzione; la filosofia, quale venimmo esponendo, fa della vita, ossia della prassi e dell’azione, un problema, di cui si cerca la soluzione. Nemmeno è da vedere in questa filosofia della vita una manifestazione di preoccupazione utilitaria: a meno che per utilità non s’intenda la stessa verità»18. Fermiamo alcuni punti chiave di questa lunga citazione. Il primo: l’«esagerazione», che è «cara al genio paradossale del Nietzsche», consiste evidentemente nel rischio del “soggettivismo”, cioè di un relativismo e di un arbitrarismo che, in ultima istanza, chiuderebbero ogni singolo individuo umano in se stesso, narcisisticamente, poiché, se il problema della vita è soggettivisticamente inteso, ognuno diventa prigioniero della propria opinione, vera o falsa è impossibile a dirsi, e quindi non può né giungere alla verità, né aprirsi agli altri, al dialogo, alla comunione tra uomini e, dunque, tra uomini e Dio. Il secondo: il no al soggettivismo passa attraverso anche il no al pragmatismo e all’utilitarismo; il primo ritiene che per risolvere il problema della vita sia sufficiente lasciarsi vivere, cioè affidarsi alla prassi (l’«argomento per una soluzione» non sta nel conoscere la verità, ma nell’azione); il secondo, l’utilitarismo resta anch’esso prigioniero del qui e dell’ora, del fatto, e quindi del soggettivismo, a meno che, dice Masnovo, non si faccia coincidere l’utile con la verità: la verità infatti è il sommamente utile. Il terzo: Agostino, sappiamo, perviene alla soluzione del problema della vita con la sua conversione al cristianesimo; è dunque “alla fine”, per così dire, al termine di una lunga ricerca che egli trova il «luogo» appagante il suo amore. Ma il punto di partenza di Agostino è stato quello della vita: afferma Masnovo che il problema della vita è «soluzione intesa per prima e conseguita per ultima», cioè ciò che da sempre ha mosso “coscientemente” Agostino è la ricerca della felicità, della propria 18 A. Masnovo, La filosofia verso la religione, Vita e pensiero, Milano 1977, pp. 19-21. 21 perfezione, ma a esse, perfezione e felicità, Agostino giunge dopo un lungo cammino. Il quarto: Nietzsche, Agostino e Tommaso sono tre tipi umani molto diversi tra loro, ma tutti accomunati dalla medesima preoccupazione; risolvere il problema della vita, cioè trovare perfezione e felicità. Possiamo allora fissare una prima conclusione: il “conosci te stesso” non è un atto che rimane prigioniero del soggetto, ma si apre alla “vita”: di ogni uomo, di tutto l’uomo, dell’universo e, quindi, anche di Dio, il «tuo Amore». 2. L’uomo: un problema a se stesso Il “conosci te stesso” è in realtà un’operazione molto strana, nella quale si alternano la scoperta dell’unità, dell’identità della propria persona e la scissione: mi conosco per sapere chi sono (unità-identità) e, conosciutomi, scopro di essere diviso (scissione), perché attratto da mille cose. Perciò, per rimediare all’impressione di essere uno, nessuno, centomila, riconverto il mio cammino a un rinnovato “conosci te stesso”. È dunque un continuo altalenarsi di interiorità e di esteriorità, di luce e di ombra, nelle quali ruotano come attori il mio “io” e le “cose” e persino “Dio”: chi è il mio Amore, il mio Dio? Scriveva Montaigne: «Queste variazioni e contraddizioni che si osservano in noi han fatto sì che certuni ci attribuissero due anime, altri due potenze, che ci accompagnino e agitino ciascuna a sua guisa, l’una verso il bene, l’altra verso il male: una così acerba diversità non potendo addirsi a un soggetto semplice»19. Scisso, teso tra terra e cielo, quasi lacerato, l’uomo comunque torna sempre a se stesso. Non dico sempre in pace, ritrovando la propria verità; anzi, spesso in guerra con sé e con gli altri, con il mondo, con Dio, ma pure torna a se stesso. Ecco due testimonianze: la prima, di Francesco Petrarca, propone la tensione che si agita nell’animo dell’uomo tra beni materiali e beni spirituali o, più semplicemente, tra le immagini e il 19 Montaigne, Essais, II, 1. 22 modello, tra le cose e Dio; la seconda, di Blaise Pascal, racconta di un mondo, nel quale la Terra, l’antica casa dell’uomo, non è più al centro, perché di lì è stata scacciata e sostituita dal Sole: e, dunque, anche l’uomo non sarebbe altro che un fenomeno tra i tanti, decentrato, appunto: ma Sole o Terra al centro o alla periferia, in un sistema o in un altro, in un qualsiasi sistema dell’universo, dovunque abiti – potremmo dire – l’uomo è sempre al centro: emerge sulla grande macchina del cosmo con il suo pensiero. Ecco quindi… Francesco Petrarca nell’aprile del 1336 si trovava in Provenza e saliva le pendici del Monte Ventoso, animato dal desiderio di giungere in vetta a un monte famoso per la sua altezza. Giunto in cima, ammirato il paesaggio, si siede e, distolto lo sguardo da ciò che lo circonda, prende e apre le Confessioni di sant’Agostino, il libro che portava sempre con sé. Ed ecco cosa legge, aprendo a caso: «E gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti del mare e i larghi letti dei fiumi e l’immensità dell’Oceano e il corso delle stelle; e trascurano se stessi». Ammutolito, Petrarca scende dal monte e torna al piano20: dobbiamo allora supporre che il “piano”, il proprio “io”, sia un abisso e un vertice più alto e più profondo, nella sua apparente e semplice umiltà, delle meravigliose “altezze” dell’universo intero? Quanto a Pascal leggiamo questo famosissimo passo: «L’uomo è solo una canna, la più fragile della natura, ma una canna che pensa. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo. Un vapore, una goccia d’acqua bastano per ucciderlo. Ma, quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire. E la superiorità che l’universo ha su di lui, mentre l’universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. Lavoriamo dunque a ben pensare21». 20 F. Petrarca, Lettera a Dionigi di Borgo San Sepolcro, in Familiarum rerum libri, IV, 1, cit. in F.Petrarca, Prose, Milano-Napoli 1955, p. 841. La cit. da Agostino è in Confessioni X, 8, 15. 21 B. Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Milano 1980(2), fr. 377, P. 253. 23 Affermavo poco sopra che non sempre il ritorno a se stesso avviene “in pace” e che, tuttavia, l’errore e la domanda aperta e, apparentemente, senza risposta testimoniano comunque questo ritorno. Martin Heidegger nel secolo scorso notava che nessun tempo era stato più ricco di conoscenze sull’uomo di quanto non lo fosse il suo e che tuttavia, paradossalmente, nessuna epoca ha saputo meno della sua che cosa sia l’uomo: «mai l’uomo ha assunto, concludeva, un aspetto così problematico come ai nostri giorni»22. Ora, prescindo dal giudicare se e in quale modo ciò sia stato vero; vera è comunque la percezione soggettiva che Heidegger ha di questa ignoranza circa l’identità umana. Sottolineo però, ed è ciò che mi importa qui, che, appunto, questa percezione del vuoto di senso circa il proprio io è resa possibile soltanto da una riflessione, cioè da un ritorno dall’esterno all’interno, dalle cose all’io. Ancora una volta ci soccorre Agostino per fissare bene questo punto. Egli racconta: «In quegli anni, all’inizio del mio insegnamento nella mia città natale, mi ero fatto un amico fedele, unito a me dalla comunanza degli studi. Aveva la mia stessa età e come me fioriva nella primavera della giovinezza. Egli era cresciuto assieme a me fin dalla fanciullezza, avevamo frequentato la stessa scuola e giuocato gli stessi giuochi. Questa amicizia era quanto mai profonda, maturata al calore degli stessi gusti». Ma un giorno la morte gli strappa l’amico: «Il mio cuore fu ottenebrato dal dolore, e tutto ciò che vedevo diventava per me immagine di morte. Persino la città natale si mutò per me in afflizione e la casa paterna in pena indicibile. Tutte le cose mi erano odiose perché non erano lui. Io stesso divenni un grosso enigma a me stesso»23. In altre parole, una «situazione limite » (K. Jaspers), in questo caso dolorosa, in altri, è pure possibile, gioiosa, induce a passare dalla superficie alla profondità dell’essere: e, appunto, l’uomo, l’”io”, diventa «magna quaestio», grande domanda. Ma, giunto a questo punto, che cosa 22 23 M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, Mursia, Milano 1962, pp. 275-276. Confessioni, IV, 4; 7-9. 24 desidera l’animo più della verità?: «Quid desiderat animus fortius quam veritatem?» E Agostino aggiunge: «… noi giudichiamo la nostra conoscenza mediante la verità, ma non possiamo sottoporre a giudizio la stessa verità. […] Non uscire da te, ritorna in te stesso, nell’interno dell’uomo abita la verità»24. Lo ribadiamo, a scanso di equivoci: il concetto biblico di “uomo interiore”, contrapposto a quello di “uomo esteriore”, è impiegato da Agostino come indicatore di uno stato esistenziale (ontologico, religioso, etico, ecc.) ed è simile alla nozione kierkegaardiana di “stadio religioso”, contrapposta a “stadio etico” e “stadio estetico”, eccetera. Perciò, ancora una volta, appare chiaro che la ricerca dell’uomo interiore, cioè il “conosci te stesso”, corrisponde non solo a “filosofare”, ossia a ricercare la verità, ma anche a incamminarsi (homo viator) verso la perfezione e la felicità. Scrive Agostino: «nulla est hominis ratio philosophandi, nisi ut beatus sit 25». 3. La lezione di Sofocle Sofocle, il poeta tragico greco che è contemporaneo di Socrate26, in una pagina mirabile dell’Antigone condensa in modo vero e profetico la condizione umana. Così infatti poeta il Coro nel Primo stasimo: Molte sono le cose mirabili al mondo, ma l’uomo le supera tutte. Anche oltre il mare spumeggiante, col vento impetuoso del sud, egli procede e trascorre sotto onde rigonfie, che mugghiano intorno. E affatica la Terra, suprema divinità, non mai stanca, immortale, d’anno in anno volgendo gli aratri 24 De Libero Arbitrio, II, 12, 34. De civitate Dei, XIX, 11. 26 Sofocle nasce a Colono nel 497-496 e muore ad Atene nel 406 a. C. 25 25 e sommuovendola con prole equina. E le famiglie gioiose degli uccelli egli insegue e depreda. Progenie di fiere selvagge, di creature marine, usando reti cattura l’acuto ingegno dell’uomo. Con la sua astuzia anche doma le belve agresti e montane, e aggioga il crinito cavallo e il toro dei monti instancabile. La parola, l’alato pensiero, i civili costumi conosce, e sa fuggire i colpi che gli inospiti geli lanciano, a cielo sereno, e le scroscianti piogge. Sagace affronta senza tema il futuro. Solo all’Hade non potrà opporre scampo veruno, pur sapendo guarire mali senza rimedio. E quantunque egli trovi espedienti saggi e utili oltre ogni speranza, ora va verso il male, ora verso il bene». Nei primi due versi Sofocle presenta il quadro d’insieme: il confronto tra il mondo e l’uomo è il confronto tra due realtà grandi e belle, non certo tra due cose di poco conto o, ancora, tra una realtà infima e disprezzabile, il mondo esterno, e una realtà di valore e stimabile, l’uomo. Perciò suona come una straordinaria esaltazione la superiorità dell’uomo sul mondo: l’uomo è più alto delle cose mirabili del mondo. Questa trascendenza dell’uomo sul mondo si manifesta come dominio: l’uomo ha potere sul mare e sulla terra, sugli animali e sul clima. 26 Unico tra i viventi della Terra, l’uomo conosce la parola, l’alato pensiero, e i civili costumi, cioè è capace di cultura e di civiltà: fa storia, fa società, e perciò … …sagace affronta senza tema il futuro. E qui prorompe in tutta la sua genialità la visione di Sofocle: Questo uomo, che è in grado di “guarire mali senza rimedio”, non “potrà” scampare all’Ade. E insiste: l’uomo, come a caso, va verso il male e verso il bene, quasi che ciò non sia in suo potere, eppure… l’uomo è in grado di trovare “espedienti saggi e utili oltre ogni speranza”. Faccio notare questi ossimori, ottenuti per opposizione di contraddittori e non di semplici contrari27: 1) guarire mali senza rimedio e 2) oltre ogni speranza. Qui il poeta è straordinario nella sua divinazione: da un lato, infatti, il realismo della conoscenza pone dei limiti al potere umano; ci sono mali inguaribili, c’erano ai tempi di Sofocle, ci sono ai nostri giorni; c’è pure un realismo della speranza: finché c’è vita, si dice, c’è speranza. E, tuttavia, come ai tempi di Sofocle, così ai nostri, vi è una utopia del potere e un gettare lo spirito oltre la speranza ragionevole: quel che sembra “impossibile” viene saputo tale, ma in fondo non lo “crediamo” tale. E infatti i “mali incurabili” sono guariti, “oltre ogni speranza”: quel che ieri dava la morte, oggi è reso innocuo (si pensi, semplicemente, ai “miracoli” dell’Aspirina!). Sofocle vedeva il nostro tempo, la modernità, ma in fondo vedeva il tempo che è proprio di ogni tempo umano: il tentativo, sempre rinnovato e sempre accresciuto, di dominare la terra e se stessi. 27 Propriamente l’ossimoro consiste nell’accostare nella medecima locuzione due concetti contrari: a esempio “lucida pazzia”, “luce tenebrosa”… Contrari sono gli opposti appartenenti a un medesimo genere. Contraddittorio, invece, è ciò che toglie ciò che è posto, come il “non-A” toglie l’“A”, ossia il “non-essere” toglie l’“essere”: cosa che è impossibile, se si vuole tenere ferma l’identità di una cosa: Pietro, cioè, nel medesimo tempo e sotto lo stesso aspetto non può essere vivo e morto. Così, dunque, se il male è “incurabile” non può venire “guarito”. 27 Ma… qualunque cosa faccia, qualunque politica, economia, ingegneria genetica attui, l’uomo ineluttabilmente va verso il bene e verso il male e, ultimamente, non può scampare all’Ade. Noto che quel “andare verso il bene e verso il male” sottende un potere diverso da quello del dominio scientifico-tecnologico: è il potere della libertà. Noto ancora che quello “scampare” («opporre scampo veruno») è traducibile con il verbo “salvare”, “liberare”. L’uomo è capace di “salute”, ma non di “salvezza”: cura i mali (fisici, psicologici, economici, politici), ma non “il male” per eccellenza: la morte, cioè la sua finitezza, la sua contingenza. In altri termini non è in grado di strappare dal proprio “io” la fondamentale condizione ontologica di essere un semplice “ente”, cioè di non essere l’Essere, ma di essere “posto”, di avere ricevuto l’essere. Qualunque cosa faccia, prima o poi precipiterà nell’Ade: non c’è scampo. L’utopia di realizzare l’eternità nel tempo è un controsenso, perché il tempo è segnato dal divenire e, dunque, dalla contingenza e, come affermava Hegel, allora “il finito merita di morire”. Dicevo geniale questa pagina di Sofocle e la dicevo anche profetica: sì, perché in essa è profondamente colto il nostro tempo che tenta appunto di rendere immortale il mortale: … «i mortali nella loro debolezza…», ci suggeriva Agostino. 4. Umiltà fradicia e umiltà alta Sofocle sa che l’uomo è terra, in modo simile agli altri esseri dotati di corporeità, ma è anche più della terra. Vi è qui una analogia con la «Vergine Madre», la Madre di Dio, che è… «umile e alta più che creatura»28: umile, humus, umanità, terra, appunto; ma anche “alta più che creatura”, più mirabile delle “cose mirabili” delle quali poetava Sofocle. Ma nel verso di Dante la “e” compie la cesura tra l’umiltà e l’altezza, come fin qui si è argomentato, ma compie anche una unione, per cui il secondo emistichio, il “più che creatura”, è reso possibile dal primo 28 Paradiso, XXXIII, 2. 28 emistichio, il “umile e alta”: poiché simultaneamente Maria è tanto umile e tanto alta, ella può essere considerata “più che creatura”; certo, resta ontologicamente una creatura, ma la sua peculiarità d’essere, appunto al tempo stesso, tanto umile e tanto alta la distaccano dalle altre creature: in analogia, semplice analogia, dell’uomo rispetto alle “cose mirabili”. Ora, “umile” e “alta” sono sinonimi di “profondità” e di “altezza”, coincidenza di opposti nell’unità dello spirito, cioè dell’”interiorità”, della quale si parlava sopra. In altri termini, l’umiltà fa l’altezza e, viceversa, l’altezza fa l’umiltà, perché lo spirito, ossia l’avvenuto ritorno nell’interiorità, il compiuto “conosci te stesso”, vede il proprio io come “creatura”: ente posto, voluto in modo sovrano e onnipotente da Dio. Mi si può giustamente obiettare che Sofocle non vedeva ciò che Dante contemplava: ed è vero. Ma Sofocle tenta, con le armi che ha a disposizione, di lasciarsi alle spalle l’”umanità fradicia”, che compiange se stessa (“si piange addosso”), che piange la propria impotenza. Tenta di percorrere la via “oltre ogni speranza”: Antigone ne è la prova vivente. Fallisce? Certamente, ma lo spirito non cede e non si arrende al “caso”, al “destino”, al cieco meccanismo dell’universo: protesta la propria superiorità rispetto a tutte le “cose mirabili”. Mi spiego con alcuni riferimenti alla cultura greca. Il primo riferimento mette l’accento sul fatto che gli uomini, più che agli dèi, somigliano agli enti naturali. Così Omero… «Come stirpi di foglie, così le stirpi degli uomini; le foglie, alcune ne getta il vento a terra, altre la selva fiorente le nutre al tempo di primavera; così le stirpi degli uomini: nasce una, l’altra dilegua»29. Insomma… «La cosa migliore per l’uomo sarebbe quella di non esser mai nato, di non aver mai visto la luce del sole; ma, una volta nato, la cosa migliore per lui è passare i cancelli della morte al più presto possibile»30. 29 Iliade, VI, 146-149. 29 5. Gli Antichi non andavano allo zoo Ma vi è un secondo punto della cultura greca che, tra l’altro, passa anche in Roma, ed è l’aspetto per il quale Cicerone poteva scrivere: «Quando egli [Apollo] dice “conosci te stesso”, intende “conosci la tua anima”. Il corpo infatti è per così dire un vaso o un contenitore dell’anima»31. Insomma, gli Antichi, da Socrate a Platone, da Aristotele agli stoici e poi ai neoplatonici, vedevano l’uomo più simile agli dèi che ai bruti, e questo a differenza dei “moderni”, come risalta da questo gustoso brano di Emilio Cecchi: «... perché gli antichi credevano alla creazione, e cioè a una gerarchia sacra e ascendente. Agli animali aveva pensato Dio, che può pensare a tutto. L’uomo, per suo conto, aveva abbastanza della sua parte d’uomo, cioè a dire d’esiliato figlio di Dio. Ma i moderni preferiscono credere all’evoluzione: in altri termini, a una gerarchia scientifica e degradante. E, mentre un antico andava in chiesa a ritrovare il suo posto su un’infinita, terrorizzante distanza che lo separava ancora da Dio, un moderno va al giardino zoologico a ritrovare il suo posto sull’infinita gloriosa distanza, che ormai lo separa dal cercopiteco. Un antico, per riconoscersi più uomo, si confrontava, umiliandosi e annullandosi, agli Dèi. Un moderno, per riconoscersi più uomo, si confronta, applaudendosi e congratulandosi, alle bestie. Uno guardava avanti, quest’altro è voltato indietro; uno sentiva di avere ancora da attuarsi; ma quest’altro si sente tutto attuato. E quel legame di operosa riconoscenza, che nella scala degli esseri si stabiliva tra l’uomo e Dio, il quale era appunto lassù affinché l’uomo avesse sempre presente la propria perfettibilità e imperfezione, si tramuta nella riconoscenza verso il barbuto gorilla, che porta la croce delle ultime imperfezioni e redime l’uomo alla gioia dei perfetti. Si capisce allora il significato di questi palazzi di cristallo, di queste serre e acquari e giardini: sono le case degli animali sacri, sono i monumenti della gratitudine, i termini del trionfo; sono i ricettacoli dei segni supremi, dai quali si misura il pregio del mondo, perché, guardando una scimmia che sbadiglia, nessuna donna potrà dubitare di non essere Venere o Giunone. Sono le nuovissime cattedrali. Gli antichi inventarono San Pietro e Westminster; i moderni hanno inventato lo zoo. 30 E. Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, XIII ed.,riveduta da Nestle, trad. Di L. R. Palmer, pp. 2-3. 31 Tusculanae disputationes, I, 52. 30 Gli antichi andarono in processione a San Pietro e Westminster, andarono crociati e pellegrini in Terrasanta; e noi andremo al Giardino di Villa Umberto»32. 6. Inquietudine e ricerca di Dio: ragione e rivelazione Nel dolore e nella gioia, quindi, l’uomo si trova a “disagio” (per usare un termine oggi di moda). Il disagio è perciò uno stato “normale” della condizione umana e solo in certi casi si trasforma in disagio patologico. Parimenti vi è per l’uomo sofferenza anche senza dolore: anzi, possiamo dire che “vivere è soffrire”, perché, come afferma Agostino,… «Ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te»33. Verrebbe da dire: beati gli inquieti, perché ricercano Dio. A essi, solo a essi, spetta la felicità. Affiora qui in tutta la sua forza e limpidità la sorgente dell’eros platonico, del senso religioso, del desiderio naturale di vedere Dio: il tuo amore è la tua vita. Ma di questo parleremo. Ora poniamo un altro punto fermo: si tratta dei due “mezzi” che Platone scorgeva come utili ad attraversare il mare dell’esistenza per giungere al porto della beatitudine. Nel Fedone, Simmia, che ha dubbi sull’immortalità dell’anima e sulla vita oltre la morte, propone a Socrate questa alternativa: «Perché, insomma, trattandosi di tali argomenti [=immortalità dell’anima], non c’è che una cosa sola da fare di queste tre; – o apprendere da altri dove sia la soluzione, – o trovarla da sé, – oppure, se questo non è possibile, accogliere quello dei ragionamenti umani che sia, se non altro, il migliore, e, lasciandosi trarre su codesto come sopra una zattera, attraversare così, a proprio rischio, il mare della vita; salvo che uno non sia in grado di fare il tragitto più sicuramente e meno pericolosamente su più solida barca, affidandosi a una divina rivelazione»34. 32 E. Cecchi, Le bestie sacre, da Pesci Rossi. Ai giardini di villa Umberto si trova appunto uno zoo. 33 34 Agostino, Confessioni, I, 1. Platone, Fedone, 85 C D. 31 Quindi la salvezza, e non solo la salute, per usare la formula impiegata sopra, secondo Platone può essere opera dell’uomo o del Dio: “ragione” è il termine che indica infatti lo sforzo ascetico umano; “rivelazione” invece l’opera liberatrice di Dio. Da questo punto di vista “ragione” e “rivelazione” sono due mezzi o strumenti differenti e anche opposti. Che, poi, vi sia un legame tra ragione e rivelazione è vero: ma allora i termini devono essere intesi in altro modo: non più come due diversi “natanti”, ma come il concorso dell’opera divina e di quella umana, concorso che si realizza sulla medesima “barca”. Ma anche di questo parleremo. 32 Capitolo terzo La ricerca della verità 1. Bisogna pur vivere: il sogno Vi è un racconto di Franz Kafka che dipinge molto bene un atteggiamento “moderno” di fronte alla vita: il “sogno”. Si tratta di Il messaggio dell’imperatore. Eccolo: «L’Imperatore – così si racconta – ha inviato a un singolo, a un misero suddito – minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal Sole imperiale –, proprio a te l’Imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all’orecchio. E gli premeva tanto che si è fatto ripetere il messaggio all’orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l’esattezza di quel che gli veniva detto. E, dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte – e tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute e sugli scaloni, che si elevano alti e ampi, sono disposti in cerchio i grandi del Regno –, dinanzi a tutti loro, ha congedato il messaggero. Questi si è messo subito in moto. È un uomo robusto, instancabile. Manovrando, or con l’uno, or con l’altro braccio, si fa strada nella folla. Se lo si ostacola, accenna al petto su cui è segnato il Sole, e procede così più facilmente di qualunque altro. Ma la folla è così enorme; e le sue dimore non hanno fine. Se avesse via libera, all’aperto, come volerebbe! E presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta. Ma, invece, come si stanca inutilmente. Ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle. E, anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco, scendendo tutte le scale. E, anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla. C’è ancora da attraversare tutti i cortili e, dietro a loro, il secondo palazzo. E così via, per millenni. 33 E, anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell’ultima porta – ma questo mai e poi mai potrà avvenire –, c’è tutta la città imperiale davanti a lui: il centro del Mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì: e tanto meno con il messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra e ne sogni, quando giunge la sera». L’agonia e la morte di Dio erano state proclamate già da molti intellettuali. Al principio dell’Ottocento il poeta tedesco Heinrich Heine ammoniva il suo prossimo con queste parole: «In ginocchio! Non sentite tintinnare la campanella? Si portano i sacramenti a un Dio che muore». In seguito, sul finire dell’Ottocento, un altro tedesco, Friedrich Nietzsche, proclamava «Dio è morto». Sempre gli intellettuali hanno poi spiegato con molte ragioni da loro ritenute inoppugnabili il perché e il come di questa morte. Essi hanno con i vari riduzionismi (antropologico, psicologico, sociologico, morale e razionalistico) svelato che Dio altro non è che una proiezione della mente umana, un “sogno” nato dal bisogno di felicità e di liberazione: reale il bisogno, irreale e, anzi, alienante, il sogno. Non restava che rimboccarsi le maniche e darsi da fare: l’uomo doveva liberare l’uomo e non più attendere, come se fosse ancora un bambino, l’aiuto di un Altro che per di più non esiste. Così gli intellettuali interpretano e spiegano e progettano uomini e società nuove. Così scienziati, tecnologi e politici realizzano mondi, società e persino uomini nuovi. Per un certo periodo nel Novecento i totalitarismi comunista e nazista sembravano avere avuto successo, ma sono caduti. Oggi si insiste sulla strada dell’autosalvazione, soprattutto, con il naturalismo e con la genetica. E, tuttavia, quel Dio dichiarato morto bussa alla porta di molte coscienze e in suo nome si creano comunità e si radunano folle in molte regioni della Terra: anche là dove fino a poco tempo fa era sconosciuto. 34 Sì, Dio è morto, «ma tu stai alla finestra e ne sogni, quando giunge la sera», quando scende nella tua coscienza il senso della tua finitezza e sale dal profondo del tuo “io” il tuo desiderio di perfezione e di felicità. Così, ineluttabilmente, l’uomo bambino deve diventare adulto e non lo diventa come un frutto che matura, sta lì, appeso al ramo, finché non cade. L’uomo deve superare il distacco dalla madre e non so quanti altri distacchi da non so quante età dell’oro, reali o soltanto sognate. Si diventa da bambini adulti, accettando il lutto delle perdite e si va avanti. Ma perché “andare avanti”, se la vita è un continuo susseguirsi di perdite sino a giungere alla perdita finale e definitiva, il cimitero? In modo irrazionale molti accettano il fatto e non ne danno una spiegazione. Ogni uomo – affermano alcuni intellettuali che si autodefiniscono “non dogmatici” – inventa storie per autoconsolarsi e quindi vivere (o tirare a campare). «Latet omne verum», la verità ci è del tutto nascosta, diceva già Porfirio, un intellettuale neoplatonico del III secolo dell’era cristiana, in opposizione ai cristiani che indicavano nel cristianesimo l’unica religio vera. E ai nostri giorni gli fanno eco gli evoluzionisti, gli esponenti del linguistic turn, la New Age e tutti coloro che hanno instaurato una sorta di “dittatura del relativismo”: non c’è verità, tutte le opinioni si equivalgono, tutte sono di eguale dignità, tutte le vie sono buone e percorribili… Insomma, non c’è una “regia”, tu sei libero… E se, invece, ci fosse una “regia occulta” che governa questo relativismo appunto in modo dittatoriale, legando ogni singolo uomo al proprio io, facendolo prigioniero di se stesso? Se poi fosse l’antica ybris, la prometeica autosufficienza, irragionevole e blasfema, a irrompere nell’esistenza umana e a guidarla all’autodistruzione? Se infine non fosse possibile vivere senza verità e la si ricercasse a ogni costo, anche a costo della propria perdizione, cosa accadrebbe allora? Soltanto i ragazzetti che con Pinocchio sul carro, quasi ormai ciuchini, dormono il sonno dell’incoscienza, non cercano più Dio. Essi sono retrocessi alla bestia, pericolo sempre presente quando Dio è morto nelle 35 coscienze, pericolo che lo stesso Nietzsche conosce bene e con forza denuncia35. Non rimane dunque che cercare la verità. 2. Edipo e la Sfinge Sempre Sofocle ci aiuta a capire. Nella tragedia Edipo re si narra che la città di Tebe è percossa da «terribili e duri colpi»: prima l’assassinio del re Laio, poi un breve respiro di sollievo quando Edipo diventa re e, di nuovo, lamenti e lutti per una crudele pestilenza. Ebbene, Edipo stesso vuole fare luce sulle ragioni della pestilenza e le cause dell’assassinio, perché soltanto nel chiarore della verità è ragionevolmente progettabile una via di liberazione e di salvezza. Perciò interroga i suoi concittadini «Che cosa vi ha impedito di indagare, quando il regio potere venne meno?» Gli risponde Creonte «Ben altri guai la Sfinge ci imponeva enigmatica! e non ce ne curammo». I Tebani erano infatti afflitti dalla Sfinge, un mostro che dimorava alle porte della loro città, e così, tutti oppressi da questo male, non avevano tempo e forze per indagare sulla morte di Laio, morte che si rivela soltanto ora essere causa di nuove afflizioni. Insomma, la Natura teneva ancora prigionieri gli uomini e li soverchiava al punto da impedire loro l’agire in modo umano, impiegando la ragione alla ricerca della verità e della giustizia: il “male naturale”, la Sfinge, era tanto potente da relegare in secondo piano e quasi annullare il “male sociale”, il “male storico”, l’omicidio del re Laio. 35 Cfr. G. Biffi, Contro mastro Ciliegia:Commento teologico a ‘Le avventure di Pinocchio’, Jaca Book, Milano 1978; cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1968. 36 In un solo cerchio si congiungono tutte le strade del dramma. Vediamo. 2.1 L’intellettuale, il bambino e… l’uomo La Sfinge è il mostro dal corpo di leonessa alata e dal petto e dalla testa di donna che affrontava i viandanti sulla via di Tebe. A tutti, anche a Edipo, rivolge una domanda semplice, anzi infantile, sotto forma di enigma: «Qual è quell’animale che al mattino ha quattro gambe, al meriggio due, alla sera tre?». E chi non sapeva rispondere, veniva divorato. L’enigma viene posto anche a Edipo che però sa dare la risposta esatta: «L’uomo», perché tutti sanno che il bambino gattona, l’uomo adulto cammina eretto e il vecchio si trascina appoggiandosi a un bastone. Edipo ha così la vita salva e regna felice in Tebe, finché … di dolore in dolore, di angoscia in angoscia, precipiterà nella morte. Ma perché gli altri uomini non erano stati capaci di rispondere correttamente alla domanda della Sfinge? Forse perché erano “intellettuali”, tronfi e pieni di sé, prometeici e sicuri di potersi salvare da soli con le loro proprie mani. Forse, più semplicemente, perché gli intellettuali non vedono le cose semplici e pensano sempre che ci sia il trucco dietro il fatto e la sua più normale spiegazione. Sono “maestri del sospetto” e, dopo averlo inoculato in se stessi, lo iniettano, se è loro possibile, in ogni uomo. Insomma, gli intellettuali non sono in grado di “ritornare come bambini” e cercano complicate soluzioni perché la più semplice li inchioderebbe alla loro fragilità e finitezza. Rispondere «uomo» alla domanda della Sfinge, infatti, equivale a riconoscere la propria figura effimera che sorge, passa e tramonta sull’orizzonte del mondo. Edipo perciò è semplice come un bambino e risponde correttamente: «uomo». Edipo capisce ed ha la vita salva: la Sfinge è precipitata dalla rube e muore: Tebe viene così finalmente liberata dal mostro che la opprimeva. 37 2.2 La Natura noverca e l’uomo Leonessa e donna: la forza della natura che dà la vita e la toglie, questa è la Sfinge. Di fronte a tante idolatrie a noi contemporanee della natura, la «Madre Natura», non si può non sorridere e poi ammutolire perché dalla Natura non viene la salvezza. La Natura è un mostro: l’avevano visto già alcuni Greci, l’hanno compreso Schopenhauer e Leopardi e anche Karl Marx che, prigioniero in certo modo del naturalismo, proprio a causa di ciò alla domanda sul senso della morte poteva solo rispondere che essa è «la dura vittoria della specie sull’individuo»: sì, perché in Natura l’uomo, come qualsiasi altro esistente, è in funzione del tutto, è una semplice parte del tutto; importa che viva il tutto, la specie, non l’individuo. Edipo sconfigge la Natura Noverca: dicendo «uomo» dimostra di sapere e il sapere lo innalza, come ci ha insegnato Pascal, infinitamente sopra la Natura. Edipo sconfigge la Natura, il caos, il disordine e può entrare in città: città madre di civiltà; città, dunque, e cultura contro Natura e caos. Fuori le mura della città sono i briganti, le fiere selvagge, i poco di buono… In città vivono i cittadini: e questo nell’antica Grecia non era solo simbolico, ma reale. Infatti, prima dell’arrivo dei Romani, che hanno distrutto l’ecosistema faunistico per alimentare i loro giochi, il territorio greco era abitato da orsi e leoni, oltre che da briganti. Era quindi davvero pericoloso stare fuori delle mura. Ed era quindi davvero luogo di salvezza la città. 2.3 Il Caos vince l’uomo Sconfitta la Sfinge Edipo entra in Tebe: la luce della conoscenza lo ha salvato, la luce della conoscenza lo ha innalzato sopra la Natura e ora lo innalza sopra gli altri uomini: Edipo diventa re di Tebe e sposa Giocasta, la vedova del re Laio: da lei avrà quattro figli: Eteocle e Polinice, Antigone e Ismene. 38 Edipo non sa però una cosa terribile: che il viaggiatore che l’aveva insolentito sulla via di Tebe e che lui aveva ucciso era Laio, che Laio era suo padre, che la donna che egli sposa è quindi sua madre ed egli fa dunque di lei la madre dei suoi figli. 2.4 Il sapere non basta: la persona, la potenza Edipo capisce e vince la Sfinge: ma questa vittoria è la sua condanna. Il suo sapere non lo mette in grado di difendersi dal Fato, dal Destino (prosaicamente noi diremmo “il caso”), che lavora contro di lui come vendicando un antico risentimento per un presunto torto subito. Il Fato è forse l’icona contraffatta e diabolica della Provvidenza: anche la “simia Dei”, il Diavolo, provvede a modo suo alla vita degli uomini, lui che, come antico Serpente, aveva inoculato nei progenitori il sospetto: Dio è invidioso e per questo vi ha proibito di mangiare il frutto dell’albero… «Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”36». Il sapere dunque non basta per salvare l’uomo. È vero che nulla entra nell’uomo in quanto uomo se non sotto la luce del giudizio, ma è altrettanto vero che il sapere per sé preso non libera. Infatti le parole di Gesù «conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”37 non vanno intese in senso gnostico-illuministico-prometeico-scientistico-tecnologico. La verità non è semplicemente il sapere umano: la verità è Persona, è Dio onnipotente, in Giovanni il Signore Gesù. Così, appunto, Edipo ha risolto l’enigma: tuttavia, pur venendo a conoscenza dell’equazione della vita, è stato comunque colpito e vinto dal male e dalla sofferenza. «Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture»38. Si «accorsero» di essere «nudi»: l’accorgersi indica il sapere, la nudità l’autentica condizione umana, ovvero la fragilità, la vulnerabilità, la 36 Gen., 3, 5. Gv., 8, 32. 38 Gen., 3, 7. 37 39 finitezza ontologica. Egualmente Edipo risponde alla Sfinge «uomo»: uomo che gattona, che cammina eretto, che procede appoggiandosi a un bastone: uomo fragile, uomo «mortale», come Agostino ci ha ricordato. Ma l’ybris del sapere non ha salvato Adamo ed Eva, e non salva Edipo che, anzi, insistendo nella ricerca della verità sulla morte di Laio, sottoscrive la propria condanna. Così, in definitiva, la Natura, che marchia Edipo con il segno della finitezza, e la vita sociale, che lo irretisce con le sue regole, lo stritolano come i ruotismi di un gigantesco orologio stritolerebbero chiunque. 3. Gli intellettuali e i santi: gnosi e cristianesimo Non si deve qui cadere in un pericoloso equivoco. Le mie parole non vanno certo nella direzione di una svalutazione del valore liberatorio della verità. Conoscere la verità, infatti, è la condizione necessaria e prima, perché l’uomo possa giungere alla propria liberazione. Nulla, l’ho spiegato sopra, può accadere in modo autenticamente umano se non sotto la luce del giudizio. Chi non conosce la verità rimane dunque prigioniero dell’errore: e l’errore è causa di mali così come è accaduto a Edipo, il quale non sapeva, cioè ignorava, che il viandante era suo padre, che Giocasta era sua madre… Ma la verità, benché sia prima e necessaria condizione di liberazione, non è una condizione sufficiente. A esempio, lo stato di salute non buono, in cui una persona versa, può essere conosciuto nelle sue cause (verità) oppure no (ignoranza). Nel secondo caso, l’ignoranza dei motivi del malessere, non consentono non dico di intervenire, ma neppure di pensare a un rimedio. Nel primo caso, invece, conosciute le cause, poniamo, di una malattia, è possibile intervenire a curarla. Ma come intervenire? Il sapere non basta: bisogna avere “potere” e, nell’esempio, questo potere non è, di norma, prerogativa della persona malata, ma di un’altra persona, del medico. Ed il potere del medico, poi, è limitato: banalmente dall’assenza di strumenti di cura (medicine o altro). 40 Come si vede, l’identificazione tra “sapere” e “potere” non è lecita: posso benissimo conoscere il male che mi affligge, ma altrettanto benissimo posso essere di fronte a esso “in-potente”: non avere potere. Il «conoscere è potere», che Francesco Bacone ha scolpito sul primo gradino della modernità, è dunque un assioma falso. Ma gli “intellettuali” laici e moderni non la pensano come me. Chi sono gli intellettuali? Per loro stessa definizione erano e sono “spiriti liberi”, “avventurieri della mente” e “guida” dell’umanità. Scrive lo storico Paul Johnson: «Con il declino del potere clericale nel XVIII secolo, un nuovo tipo di mentore emerse a colmare il vuoto e a catturare l’attenzione della società. L’intellettuale laico poteva essere indifferentemente deista, scettico o ateo, ma era pronto, non meno di un pontefice o di un ministro del culto, a insegnare al genere umano come doveva comportarsi. Fin dall’inizio si proclamò consacrato agli interessi dell’umanità e investito della missione evangelica di redimerla con il suo insegnamento. E a questo compito che si era autoassegnato si dedicò con uno zelo perfino maggiore di quello del clero che l’aveva preceduto. Non si sentiva più vincolato da nessuna religione rivelata: così la saggezza collettiva del passato, il retaggio della tradizione e i codici normativi dell’esperienza ancestrale esistevano soltanto perché egli potesse interamente respingerli, o parzialmente adottarli seguendo il suo buon senso». E Johnson conclude: «Non basta: essi pretesero anche di escogitare delle formule grazie alle quali sarebbe stato possibile trasformare in meglio non solo la struttura della società ma le consuetudini fondamentali degli esseri umani. A differenza dei sacerdoti loro predecessori, essi non erano servitori e interpreti degli dèi, ma li sostituivano. Il loro eroe era Prometeo, che rubò il fuoco celeste e lo portò sulla terra»39. A ben vedere, si tratta di un fenomeno che in epoca moderna ha certamente caratteristiche differenti da altri simili nel passato e, altrettanto certamente, ha una vastità nuova, mai verificatasi prima. Tuttavia non è un fenomeno del tutto nuovo quanto alla sua essenza perché, in fondo si tratta del rapporto uomo-liberazione inteso (si ricordi 39 P. Johnson, Gli intellettuali, Longanesi, Milano 1989, p. 8. 41 il brano sopra citato dal Fedone di Platone) come autosalvazione e perciò siamo di fronte all’opposizione della gnosi al cristianesimo, alla rivelazione. Nell’Antichità la gnosi, l’autosalvazione mediante la ragione, la conoscenza, era riservata a pochi (le masse ne erano escluse) e avveniva mediante arti pneumatiche, cioè spirituali, caratterizzandosi come ascesi dal terrestre al divino e quindi come progressiva purificazione. Pur con modalità profondamente differenti, Platone e Buddha praticavano quest’arte: la conoscenza, l’illuminazione sono gli strumenti di liberazione e di autosalvataggio. Gli intellettuali moderni differiscono da questi loro padri dell’Antichità perché vogliono divenire guida di tutta l’umanità alla quale, nella sua totalità, va estesa l’autoliberazione, e perché la loro gnosi (sapere) da pneumatologico si fa scientifico-tecnologico: la scienza politica di Marx, la società del benessere e dei consumi di massa, l’ingegneria genetica, eccetera. Ma rimane identica la pretesa, l’autosalvazione, e identico è anche l’avversario: il Dio che si rivela: certo, il Cristo non per Platone e per il Buddha storico, ma certamente sì per i vari neoplatonismi, buddismi e, ovviamente, per gli scientismitecnologici politici, economici, biomedici, eccetera, presenti in epoca moderna. Così il vero avversario del cristianesimo è la gnosi, anche quella della New Age e delle altre sette, per intenderci. Perciò all’intellettuale si contrappone il santo: quest’ultimo fa uso spregiudicato della ragione, e la storia lo dimostra, ma ritiene che il suo sapere non lo salva: solo Dio lo può salvare. Il santo mantiene quindi distinti sapere e potere e, infine, non cade nel tranello, vero annichilatore di ogni illuminismo della ragione, di nonvedere (conoscere, sapere) la propria indigenza e la propria finitezza ontologica. Il santo sa d’essere per l’infinito, ma sa anche di non potere salire la scala dalla Terra al Cielo soltanto con le sue proprie forze. Non faccio questione di moralismi: essere più o meno buoni, più o meno onesti, più o meno sinceri; certo, anche di etica si tratta, ma essa deve essere normata dall’ontologia, cioè dall’essere e dalla verità delle 42 cose. E le cose stanno come si è più volte detto: l’uomo è finito e di questo bisogna, per onorare la verità, “farsene una ragione”, una ragione vera. 4. Ancora sull’essere nudi Dicevo sopra di Adamo e di Eva che, dopo avere dato retta alle parole del serpente, si «accorsero di essere nudi». Ebbene, nudi, cioè finiti, erano anche prima di avere mangiato il frutto proibito, e se ne erano ben accorti: il comando divino di crescere e moltiplicarsi era già stato dato loro. Erano nudi «e non ne provavano vergogna»40. Ora, se la vergogna è il sentimento che accompagna la consapevolezza della propria pochezza, della propria mancanza, della propria colpa, ancora di più è il sentimento che è inscindibilmente unito alla “paura” di essere sorpresi e puniti, dove il “punire” va inteso come il venire privati di ciò che rimane di se stessi, della propria vita. «Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”»41. La differenza tra il prima e il dopo sta dunque tutta qui: prima Eva e Adamo conoscevano la loro finitezza come creaturalità voluta e amata da Dio; dopo, e per di più erroneamente, conoscono la loro finitezza come vulnerabile da quel Dio che aveva dato loro la vita. Infatti “prima” la proibizione di Dio di non mangiare aveva esattamente questo significato: “Io sono il Signore, tu sei la creatura: la vita viene da me; è contro natura, e perciò assurdo e contraddittorio, che tu possa metterti al mio posto”. “Dopo” il discorso non cambia: Dio “provvede” ancora amorevolmente al bene delle sue creature e promette loro la salvezza; l’uomo e la donna però, poiché hanno agito non come semplice “uomo”, ma 40 41 Gen., 2, 25. Gen., 3, 8-10. 43 “umanamente”, non possono non portare le conseguenze del loro atto di disubbidienza. L’avere creduto di potere congiungere il sapere e il potere, cioè l’essersi sostituiti a Dio, ovvero l’essersi fatti come Dio, questo li separa da Dio. Si badi: sono loro che si nascondono a Dio. Dio invece li cerca, come sempre. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma accontentiamoci per ora di legare il concetto di “santo” a quelli di “sapere” e di “obbedienza”42. 5. Il problema e il mistero Nella gnosi scientifico-tecnologica la fusione di sapere e di potere in un’unica facoltà avviene anche per la mancata distinzione di due modalità di approccio del reale che, con la terminologia impiegata da Gabriel Marcel, possiamo definire “problema” e “mistero”. Scrive il filosofo francese: «Un problema è qualcosa che incontro, che trovo davanti a me ma che posso delimitare e trasformare, mentre un mistero è qualcosa in cui sono impegnato e che quindi è possibile soltanto come una sfera in cui la distinzione fra lo “in mé” e il “davanti a me”, perde il suo significato e il suo valore iniziale. Un problema autentico dipende da una tecnica appropriata in funzione della quale si definisce, mentre un mistero trascende per definizione ogni possibilità di tecnica»43. Torno a casa stanco, la sera, dopo una giornata di lavoro. Un rubinetto perde: ci sono due modi, appunto, di guardare questa realtà. Così sotto la luce del “problema” mi chiedo certamente il “perché”, ma subito penso a una possibile soluzione del problema. Mi attivo e decido di porre in atto un rimedio, cioè opero per la soluzione del problema. Molto semplicemente, a esempio, non essendo in grado di sostituirmi all’idraulico, avvolgo uno straccio attorno al rubinetto. Gocciola ancora, ma almeno non odo più il suo fastidioso suono. E penso ad altro. Così sono tutti i problemi che incontriamo: le cose sono viste come “cose” e, 42 43 Su questi temi cfr. Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò, Città nuova, Roma 1987. G. Marcel, Giornale metafisico, Abete, Roma 1966, p. 112. 44 risolto il problema, si va avanti: a un altro problema. È la modalità propria del conoscere scientifico e dell’agire tecnologico; come nella soluzione di un’equazione: linearmente, di gradino in gradino, all’infinito, questo almeno nella vita concreta, perché ogni giorno ha i suoi problemi da risolvere. Il gocciolare dello stesso rubinetto, però, è da me conosciuto anche sotto un’altra luce, quella del “mistero”. “Perché proprio a me, mi chiedo, che sono stanco…, perché proprio contro di me si coalizzano tutti?”. Qui il gocciolare non è più semplicemente una “cosa”, ma diventa anche un “segno”: nella sua puntualità circoscritta rinvia all’universo, al senso ultimo della vita, alla mia stanchezza, icona della mia mortalità. Qui il sapere del mistero è il sapere l’uomo e Dio: e il sapere, qui, non sfocia naturalmente nel volere e nell’agire, così come accadeva nell’ambito del semplice problema. Qui “non si risolve Nulla”: qui bisogna stare e marciare sul posto, sempre, ogni giorno della vita, perché non si finisce mai di sapere se stessi e di sapere Dio: conosci te stesso, appunto. In un altro significativo passo Gabriel Marcel sembra riversare soltanto il positivo nel mistero: «”Mistero” è parola del linguaggio religioso e non si può trasferirla in sede filosofica senza il pericolo di deformarne il senso, confondendolo con la notte dell’inconoscibile. Mentre questo è soltanto un limite del nostro problematizzare, del problematico, qualcosa che il pensiero non potrebbe attualizzare senza abolirsi come pensiero. Il riconoscimento del mistero è invece un atto essenzialmente positivo dello spirito. Il “mistero” e il “problema” si pongono, in effetti, come un’apprensione inglobante e rassicurante il primo, e come un’apprensione parziale, provvisoria e sempre in via di accertamento o di smentita il secondo. Se il problema è qualcosa che sta davanti a me come un’operazione da eseguire o un’incognita da risolvere sulla base di dati cogniti, col mistero la distinzione dell’ in me e del davanti a me perde il suo significato. Perciò dell’essere che è in sé e dell’essere che siamo noi stessi non ci può essere problema né progresso o cambiamento di conoscenza: esso è essenzialmente “metaproblema”»44. 44 G. Marcel, Etre et avoir, Aubier, Paris 1935, p. 174. 45 Certamente ciò che è conosciuto, ed eventualmente risolto, come problema è sempre provvisorio, parziale, in via di accertamento o di smentita. Karl Popper concorderebbe con queste asserzioni e con lui concorderebbero molti cultori delle scienze e delle tecnologie. Ogni soluzione è perfettibile; non solo: alcune soluzioni possono rivelarsi come non-soluzioni. Anche la politica, l’economia e la medicina costituiscono altrettanti campi di verifica di quanto qui si afferma. Si “risolve” e subito si devono rimboccare le maniche per risolvere altri problemi: sempre veramente “altri” e nuovi o solo all’apparenza diversi? Diverso è il mistero. Dice Marcel che esso non è la notte dell’inconoscibile, che è un atto positivo dello spirito, che è una conoscenza («apprensione») inglobante e rassicurante. Verissimo, a patto però di essere in grado di penetrare fino in fondo nella luce del mistero perché, se questa penetrazione non fosse totale, allora quell’oltre di luce sarebbe per ciascuno di noi, almeno in principio, più inquietante e più repulsiva di ogni notte problematica: sarebbe appunto una notte dello spirito. Vediamo perché. 46 Capitolo quarto Verità, angoscia e amore 1. La paura e l’angoscia Sulla via della ricerca della felicità ogni uomo è sempre posto dinanzi all’enigmatica realtà: non solo al suo splendore che è degno di ammirazione (vedi il Coro dell’Antigone sopra citato), ma anche al suo lato oscuro, alla Sfinge che è icona di quel mostro di laidezza che è la morte con tutte le sue anticipazioni ed epifanie. Ogni uomo è allora dibattuto tra due opposti sentimenti: di speranza e di paura. Tommaso definiva l’oggetto della speranza il «bonum futurum ardumm quod quis potest adipisci» e quello della paura il «malum futurum arduum, quod non potest de facili vitari»45. È naturale allora che il moto della speranza sia quello della fiducia e che essa implichi il concetto di raggiungibilità. Sperando, il soggetto ammira ed è affascinato dall’oggetto: sia esso conosciuto come problema o sia esso appreso come mistero. Fiducioso l’uomo si prepara a risolvere il problema e a inabissarsi nel mistero. Il moto della paura è invece quello della fuga. Il soggetto si sente minacciato e quindi, per salvaguardare la propria integrità, si ritrae in se stesso. Così accade a chi è colpito da una improvvisa malattia…, come a colui che cerca un nascondiglio per celare se stesso alla vista del nemico e dunque sottrarsi “alle fauci del leone”. Si potrebbe avanzare l’ipotesi che la paura riguarda soltanto le cose conosciute come problema: là dove scienza e potere si dimostrano insufficienti e inefficaci, là appunto l’uomo indietreggia e fugge. Col che 45 Summa Th., I-II, q 42 a 3 c; C.G., 1,89). 47 si ammette anche che la paura può venire superata e annullata da un ulteriore progresso nell’ordine del sapere e del potere: più scienza, più tecnologia, meno paura: il dominio sulle cose più rasenta la perfezione, più elimina la paura. È questo il ritornello di ogni buon illuminismo immanentista. Ma faccio notare che, se sapere e potere sono disgiunti, anche solo momentaneamente, la paura assale l’uomo. Così, a esempio, la conoscenza delle cause del proprio stato di malessere non solo non fuga la paura, ma l’accresce, quando, saputa la gravità della malattia, ci si trova sprovvisti di potere sufficiente a debellarla. Solo, allora, come in un angolo, circondato da un branco di lupi, l’uomo teme: teme il “determinato”, cioè “quello specifico male”, e in questa paura, suscitata da quella specifica malattia, sorge insensibilmente ma ineluttabilmente un altro sentimento, che si è soliti chiamare “angoscia”. E, senza avvedersene pienamente, l’uomo dal piano del problema e delle cose intese come semplici cose è passato al piano del mistero e delle cose considerate come segni. Ora nella partita per la vita e per la morte non ci sono più l’uomo e una cosa, ma l’uomo e Dio, l’Assoluto. Molti hanno definito la paura “timore” di ciò che è determinato e l’angoscia “timore” di ciò che è indeterminato; qualcuno ha persino parlato di “angoscia del nulla”. Ma si può veramente provare turbamento del nulla, cioè di ciò che non esiste? Credo di no, e allora l’espressione “angoscia del nulla” è da intendersi come una metafora poetica che indica altro: ed è questo “altro” che è necessario scoprire e conoscere. 2. L’ammirazione e l’angoscia Una ragazza e un ragazzo vivono contenti nel loro mondo fatto di cose concrete e comprensibili: fiduciosi risolvono i problemi che si presentano loro. Capita, e non è affatto necessario che sia un’esperienza di male e di dolore, che il mondo delle cose fruibili e funzionali venga incrinato da un sussulto di dolore, appunto, ma anche di gioia (l’esperienza dell’innamoramento, a esempio). Allora, tanto più fine è il loro spirito, tanto più soffriranno intensamente, perché… 48 In un primo momento l’”oltre” rispetto alla trivialità del quotidiano appare come un invitante sentiero fiorito che conduce alla pienezza; quel sussurro sentito nelle cose ora si fa voce chiara e distinta; non una donna, non un uomo, ma “tu donna”, “tu uomo”: il tesoro della felicità nascosta sembra a portata di mano, sembra offrirsi spontaneamente: la “cosa” non solo si palesa come “segno”, ma addirittura la “cosa-segno” sembra in grado di veicolare per intero il “significato”: l’Assoluto, il Dio conosciuto come vero nome del mistero, proprio nell’amore uomo-donna, sembra offrirsi interamente; e quindi l’universale, il trascendente sembra concretarsi nel particolare, nell’immanente: «il tuo amore è la tua vita». Qui ha ragione Marcel: non è la notte dell’incomprensibile e non vi è opposizione tra io e tu: anzi, si fa unità, comunione perfetta. Qui, anche, è la verità e la forza dell’amore romantico: l’Essere che si cala e si identifica nell’amore di quella donna e di quell’uomo. In un secondo momento, però, non tanto le piccole disillusioni, quanto piuttosto la grande ammirazione diventa fonte di vera e di propria angoscia. Vediamo come ciò accada. Scriveva Aristotele: «Infatti gli uomini, sia nel nostro tempo, sia da principio, hanno preso dalla meraviglia lo spunto per filosofare, poiché chi è nella meraviglia, crede di essere nella ignoranza»46. Da principio… Socrate si professava sapiente perché sapeva la propria ignoranza; Al suo genio ciò, che ai più appare presuntuosamente come conosciuto, si disvela in realtà come incognito e dunque quello che appare come incognito è solo allora conosciuto veramente. Ai più quel “tu” appare come tutto lì: gli si possono “tagliare i panni addosso”; per Socrate invece quel “tu” sprofonda nelle altezze dell’abisso. Proprio come instancabilmente Platone ha modo di notare, non appena la ragione si distoglie dal quotidiano, dal contingente, dal funzionale, soltanto allora si inabissa nel veramente “esistente”. Di qui i diversi atteggiamenti, già 46 Aristotele, Metafisica, I, 2, 982, b. 49 marcati da Agostino e ripresi da Tommaso, quello dello stupidus che, sbalordito, non ricerca e fugge (torna stoltamente alla trivialità del funzionale per “lasciarsi vivere” e”non pensare”, perché “pensare fa male”), e quello del dolens, ovvero dell’admirans, che soffre, ricerca e… forse conosce nella luce del mistero47. Nel nostro tempo… Hegel, Kierkegaard, Heiddegger hanno concepito il filosofare, cioè l’atto specifico dello spirito umano che si pone dinanzi al mistero, come indissolubilmente e intimamente legato alla meraviglia e, a causa e tramite la meraviglia, allo sgomento, alla vertigine, all’angoscia. Ciò accade perché l’ammirazione consiste, almeno in principio, in una «felice perdita di sé», come diceva Kierkegaard, che si struttura da un lato come un trasporto ardente per la sublimità e la dignità dell’Essere, originato dalla promessa di autentica intelligenza che nel suo disvelarsi è contenuta, e dall’altro come dimenticanza del proprio “io”, del soggetto, a tutto vantaggio del “tu”, dell’oggetto. Supremo interesse per l’Essere, dunque, e supremo disinteresse per l’io. Ma proprio in questo “principio” appagante irrompe l’angoscia in tutta la sua essenza: essa infatti consiste nell’annullamento del familiare e rassicurante rapporto di forze che legano il soggetto e l’oggetto. Tutto è scompigliato: davvero l’amante amato e l’Essere agoniato vengono come angeli del Dio; in essi, in figura di segni, si palesa il fuoco della gloria che avvolge uomo e Dio. 3. Trascendenza e contingenza La scintilla che accende l’angoscia scaturisce quindi quando lo spirito umano mette in relazione la propria contingenza con la trascendenza di Dio. «Redi in teipsum», ritorna in te stesso: è un invito a cadere nell’angoscia e a sperimentarla? 47 Summa Th., I-II q 41 a 4 c et ad 5. 50 dal mondo funzionale al mondo dell’essere intensivo, questo è il tragitto spirituale per tentare l’avventura dell’auto-conoscenza. Ma proprio allora lo spirito si accorge che, per conoscere se stesso, deve conoscere l’Assoluto. In altri termini: lo spirito deve superare, oltrepassare, lasciarsi alle spalle ogni esistente finito (sé compreso) per giungere all’Essere. Infatti, come sul piano ontologico Dio è il principio per cui i finiti esistono, così su quello gnoseologico è il principio per cui il finito è conoscibile come tale: per conoscere il finito devo trascendere il finito. Ma conosciuto che l’Assoluto esiste, subito lo spirito umano concepisce che non è né finito, né propriamente “esistente”: è semplicemente ciò che per cui i finiti sono esistenti, e proprio per questo non è oggettivabile. Ma proprio qui sta la meraviglia e quindi l’angoscia: l’Assoluto resta intatto nella sua trascendenza e indifferente agli esistenti: che siano uno o infiniti, la loro totalità mai può aggiungere o togliere qualcosa a esso. Inoltre come principio non è definibile, ovvero circoscrivibile per genere e differenza specifica, e perciò rimane non concettualizzabile: l’Assoluto, il Dio conosciuto veramente come l’Essere, appare allora “come sconosciuto”. È la fonte che fa essere gli enti, è la luce che li fa conoscere, ma io non vedo né la fonte, né la luce, pur sapendo che esistono. Ma c’è ancora altro: non solo Dio nella sua trascendenza rimane quel che è sempre stato, intatto e inattingibile, ma anche l’uomo diventa una magna quaestio. Infatti, salito a Dio, spinto dal proprio «peso», è costretto dalla sua inafferrabilità a ridiscendere a se stesso, al mondo, per trovare un terreno in cui consistere. Il paradosso è però che per conoscere il finito lo spirito umano ha tentato la via del trascendente, ma non ha potuto dimostrare la propria derivazione e il proprio rapporto necessario con l’Assoluto: insomma, la ragione per cui io esisto e per cui sono quello che sono. Così, prima non trovavo in me, nella società e nel mondo la ragione sufficiente del mio esserci e del mio io; ora questa ragione, conosciuto 51 che l’Assoluto esiste, è da me vista consistere in lui, ma non ne vedo la necessità, il perché: potrei non esserci e l’Assoluto “è”, comunque. È un doppio scacco: non conosco l’Assoluto e non conosco più veramente me stesso. E, poiché la conoscenza della verità è condizione necessaria, sebbene non sufficiente, di ogni possibile liberazione e salvezza, allora da questa meraviglia, che nasce dalla contemplazione e che in virtù della conoscenza socraticamente termina all’ignoranza, sfocia inesorabilmente nell’angoscia: sono paralizzato, perché proprio a causa del mio conoscere mi sono privato del sapere corrente e non sono stato in grado di appropriarmi del sapere sostanziale, quello del mistero che unisce l’uomo a Dio e che mi fa noto l’uomo in Dio. Non si tratta però soltanto di uno scacco della conoscenza che, abbandonato il positivismo e il suo “stare ai fatti”, ora non sa rendere ragione del “perché dei fatti”, ma si tratta anche di uno scacco della volontà. Nel mondo tranquillo delle cause e degli effetti, l’uomo sceglie spinto da motivi: la conservazione e propagazione del proprio essere, il piacere e il bisogno, la suggestione socio-culturale e le spinte tradizionali… e prende cibo, moglie e marito, lavoro… Ma ora lo spirito, conosciuto che l’Assoluto è, sa che tutti gli esistenti sono beni finiti non necessari. La volontà è fatta libera: non è costretta a piegarsi a questo e a quello. Esultanza dello spirito, senza dubbio: nulla mi può piegare, posso persino disprezzare la mia vita e perderla, se guardo al valore che conta, all’Assoluto. Tuttavia questa esultanza del “libero arbitrio” è compagna del peso del “libero giudizio”: sì, perché “libero arbitrio” significa che la scelta è in mio potere e che quindi, nella scelta, sono io che do la vita e do la morte: tu sì, tu no. “Chi sei tu?”, “perché proprio tu?”: nel modo del conoscere e del volere libero scaturisce l’angoscia. Non che il singolo esistente sia per sé preso motivo di angoscia. Non che l’Assoluto per sé preso sia motivo di angoscia. Lo abbiamo visto: la pace, la perfezione e la felicità stanno nella congiunzione dell’uomo a Dio. L’angoscia sta piuttosto nello spirito che, 52 fattosi conoscente, conosce finalmente che “il conoscere più alto termina al non-conoscere” e che in lui il “conoscere” e il “potere” non si identificano e non si equivalgono. Se, in un angolo, circondato da un branco di lupi, l’uomo prova paura, perché la paura è quel sentimento che vede il minaccioso simultaneamente non così vicino da divenire inevitabile e neppure così lontano da essere astratto, prova contemporaneamente un sentimento di speranza, finché – s’intende – lo spirito non è messo fuori di sé e, quindi, non subentra il terrore panico paralizzante. Paura e speranza, insieme, perché, temendo il finito, la paura può cessare qualora si presenti lo sperato inatteso: il liberatore (qualunque sia la sua figura). Ma non c’è angolo fisico per l’angoscia. Essa, come abbiamo visto, non sorge dalla paura della morte, ma dall’atto più alto e più vivo dello spirito. È un fatto dello spirito in quanto tale: l’essere l’uomo uno spirito e un corpo può solo aggravare la situazione, ma non mutarla sostanzialmente. Non c’è angolo fisico, perché non ci può essere speranza di un finito che si opponga, più alto e più potente, ad altri finiti che mi minacciano: il cacciatore che trae viva Cappuccetto Rosso e la nonna! Qui il gioco è tra me, uomo finito, e l’Assoluto: non c’è possibilità di fuga (chi ha paura può fuggire, finché può); qui ci sono solo due possibilità: il rifiuto ostinato o la resa a Dio, che è il vero nome della speranza autentica. 4. Non intratur in veritatem nisi per caritatem L’angoscia è dunque una condizione necessaria dello spirito umano che, nel ritornare a se stesso e quindi nel conoscersi, conosce che Dio è. Essa scaturisce, per così dire, dalla congiunzione di due momenti spirituali: 1) dall’”ebbrezza del potente”, di colui che appunto possiede conoscenza e potere: non più ignoranza ma verità, non più determinismo ma libertà; 2) dallo “sgomento del potente” che constata che tutto il suo conoscere e il suo potere sono “impotenti” ad attingere e a dominare Dio, il fondamento delle cose e del suo stesso io e la loro gioia, e la sua propria persona: sì, “Dio e l’io non sono disponibili”: non c’è potere 53 sapienziale e pratico, per quanto alti, che siano in grado di avere in pugno Dio e il mio io. Questa è l’angoscia: non è la paura del timoroso, che teme i mali finiti, che ha “paura di perdere la propria vita”. L’angoscia è uno stato squisitamente spirituale e in questo senso veramente umano: è nella sincerità del redi in teipsum che io vedo la “mia grandezza misera” e mi sento perduto. Perciò è illusorio ritenere possibile di uscire da questa condizione esistenziale tipicamente umana con la gnosi, pneumatologica o scientifico-tecnologica che sia. Si tratterebbe semplicemente di un’uscita fantastica e perciò inane, non dissimile dal sogno che conclude nell’incubo: non si può illudere lo spirito. Non rimane che una “via” di scampo: che la verità assoluta sia una persona e che questa persona venga a salvare-liberare l’uomo. In altri termini, è l’irraggiungibile Dio che mi deve raggiungere, che mi deve dire «non temere» e che, infine, mi deve sollevare. «Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: Non temere!»48. Ho spiegato che il compito di Agostino filosofo consiste nel ricercare la “recta via vitae”, la via che conduce alla vita, alla perfezione e alla felicità. Agostino sa che ogni uomo cerca la felicità, ma sa anche che non tutti gli uomini trovano la retta via; anzi, sa perfettamente che nessun uomo avrebbe mai potuto incamminarsi sulla retta via, se la “via” non fosse venuta all’uomo: «se non avesse voluto essere egli stesso la via, saremmo andati errando. Si è fatto dunque via, perché tu possa venire. Non ti dico di cercare la via. È la via stessa che viene a te»49. 48 49 Apoc., I, 17. Agostino, Contra Academicos, I, 5 14. 54 Questa di Agostino non è una opzione irrazionale. Per tutto quello che fino a ora abbiamo detto, infatti, si mostra perfettamente ragionevole la seconda alternativa posta da Platone: il mare della vita può essere attraversato su una solida barca, se Dio si rivelasse: Agostino, semplicemente, dice che ciò è avvenuto, così come san Paolo lo aveva detto ai filosofi nell’aeropago di Atene. Si badi bene: la rivelazione è indeducibile, è grazia e nessuna filosofia ben posta può concludere che è necessario che Dio si riveli; tuttavia, posto che Dio si è rivelato, resta chiaro che questo fatto, che supera ogni comprensione umana, non è irrazionale, fuori o contro la ragione umana, anzi la conforta nelle sue indagini e nelle sue approssimazioni alla verità. Agostino però ammoniva: «Non intratur in veritatem, nisi per caritatem»50. E altrove specificava: «Et nemo nisi per amicitiam conoscitur»51. Soltanto l’amore (l’”amicizia”) è la via, è la chiave che schiude la porta della verità. Attenzione però: non solo l’amore di colui che cerca la verità, ma l’amore di Colui che dona la perfezione e la felicità. Nei capitoli che seguono approfondiremo alcuni dei temi qui abbozzati. Precisamente affronteremo la questione della ricerca di Dio. 50 51 Agostino, Contra Faustum, Lib. 32, cap. 18. Agostino, De div. Quaest., 83, 71, 5. 55 PARTE SECONDA Amor, ch’a nullo amato amar perdona Capitolo primo Il primo Amore Nella seconda e terza parte di questo lavoro non intendo fornire né un disegno di teologia rivelata, né un abbozzo di prova razionale dell’esistenza di Dio. Il mio intento è quello invece di sbozzare una analisi onto-fenomenologica delle comuni modalità esistenziali, nelle quali ogni uomo incontra la questione “Dio”, semplicemente vivendo. Infatti, in questa Parte Seconda, esamino la dinamica per cui dall’unità aurorale che vi è tra l’uomo e l’Essere, a partire da “sotto il cuore della madre”, attraverso una serie di fratture l’uomo approda alla necessaria domanda: se non è questo e non è quest’altro, chi è Dio? E, poi, nella Parte Terza mi interrogherò sulla logica interna alla dialettica di uomo di bisogno e uomo di desiderio. La conclusione ci sarà così nella Parte Quarta, quando il desiderio di felicità troverà sbocco nella fede: sia essa positiva o negativa, il che – è ovvio – comporta conseguenze ben diverse. 1. Chiamati per nome Nella Atene del nuovo governo democratico, dopo la caduta dei Trenta Tiranni, nel 399 a.c., Socrate viene accusato di introdurre divinità nuove nella città e di corrompere i giovani. Così, nel discorso pronunciato davanti ai giudici in propria difesa, tra le altre cose afferma… «Io dico dunque, o Ateniesi, che sarebbe una assai singolare e strana condotta la mia, se, mentre a Potidea e ad Anfipoli e a Delio, quando i comandanti che voi eleggeste a comandarmi mi assegnarono il posto, là dove allora essi mi ordinarono di rimanere io rimasi, come chiunque altro, e corsi pericolo di morire; qui invece, ordinandomi il dio, almeno come ho potuto interpretare e intendere io quest’ordine, che dovessi vivere filosofando e adoprandomi di conoscere me stesso 59 e gli altri, qui dico, per paura della morte e dell’altro simile male, avessi disertato il posto che il dio mi aveva assegnato»52. Socrate è quindi cosciente di avere “udito una voce divina” che gli ha ordinato, e continuamente gli ordina, di “filosofare”, ossia di cercare la verità, conoscendo se stesso, gli altri e l’Altro. Per questo, come per la difesa della patria terrena, così per quella celeste, la verità che è fondamento e fonte di perfezione e di felicità, occorre molto coraggio. Il compito che il Dio affida a Socrate implica un supremo interesse per la verità e un supremo disinteresse per se stesso, fino a disprezzare la propria vita e a non temere la morte. Questa chiamata del Dio obbliga Socrate a essere fedele alla consegna ricevuta e a non lasciare il posto che gli è stato affidato: in mezzo ai cittadini, e soprattutto ai giovani, per recare a tutti i benefici della sua coraggiosa indagine. In un’altra tradizione, quella ebraica, vi è un’altra capitale chiamata: è quella di Abramo… «Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò_ di te un grande popolo e ti benedirò, renderò_ grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò_ coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò_ e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra”. Allora Abram partì»53. Qui il Dio ha con Abramo un rapporto differente da quello tenuto con Socrate. Infatti, mentre aveva spronato Socrate nell’intero arco della sua esistenza, affacciandosi in incognito alla sua coscienza, come in figura 52 53 Platone, Apologia, 28-29. Gen., 12, 1-4. 60 di daymon, cioè di angelo, quasi la sua voce venisse sempre da lontano, da una terra futura che sta davanti a Socrate, sempre davanti, mai raggiunta, per quanta strada egli facesse, e lo aveva guidato verso la verità e il bene (cioè se stesso) come una sommessa luce sonora che era di bussola nella notte dell’ignoranza, ora Egli si accosta ad Abramo e la sua voce diventa una presenza al suo fianco, meravigliosa e terribile, ed Egli, addirittura, in modo esplicito, stipula con lui un’alleanza. «Poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle”. E soggiunse: “Tale sarà_ la tua discendenza”. Egli credette al Signore, che glielo accreditò_ come giustizia. […] [Dio] Gli disse: “Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un piccione”. Andò_ a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò_ ogni metà_ di fronte all’altra; non divise però_ gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì. […] Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: “Alla tua discendenza io do questo paese […]”»54. Socrate e Abramo sono chiamati in modi differenti e in modi differenti rispondono positivamente alla chiamata che, in termini religiosi, ancora oggi definiamo “vocazione”. La loro risposta positiva, consustanziata nella loro vita e nelle loro opere, diventa il solido fondamento su cui si erigono la civiltà europea e, poi, quella Occidentale. 54 Gen., 15, 5-18. 61 2. La vocazione “originaria” Questi uomini, e con loro tanti altri, hanno sentito, e sentono, nella loro coscienza risuonare quella “voce” che li chiama a compiere un compito che è affidato a loro in modo esclusivo: proprio io, non un altro, sento in me l’urgenza di compiere un dovere, di assolvere a un compito che mi è stato assegnato: di padre o di madre, di ricercatore della verità o di costruttore di città, di artista del bello o di operatore di conforto… Perciò, se si è convinti dell’esistenza di Dio in base a ragioni certe, come lo era Aristotele, allora è del tutto naturale che lo sforzo della ragione sfoci nell’atto di fede, quanto meno implicito, di fiducia e di affidamento a quel Dio che chiama 55. Se si è dimostrata l’esistenza del Dio creatore o se, ancora e infinitamente di più, si è prestata fede alla sua rivelazione, allora si fa chiara la coscienza di essere chiamati e non solo di dirigersi verso di lui come al thelos, alla causa finale che muove, che attira, sublime nella sua gloria, non diversamente da una donna meravigliosa, dalla quale non abbiamo però ricevuto la vita e non riceviamo nulla, neppure ora. Se vi è rivelazione, allora non vi è semplice eros, amore di bisogno, che dal nostro intimo ci sospinge a salire sempre più in su verso il Dio, ma è il Dio che mi chiama… è il Dio che viene a me. Se vi è una rivelazione, allora viene frantumato il paradosso dell’uomo amante di Spinoza, che ama il Dio sopra ogni cosa, ma non è amante ricambiato, perché quel Dio non lo conosce e, dunque, non lo ama. Di più: se Dio è creatore e se Dio si è rivelato, allora l’uomo non è “in principio” posto nel mondo e “poi”, in un’ora qualsiasi del tempo, chiamato da Dio. “In principio” Dio chiama il singolo uomo, e questo suo chiamare ha la radicalità del creare, del fare essere ciò che non è, e di 55 Per la conoscenza naturale di Dio, che è propria di ogni uomo, per la sua grandezza e i suoi limiti, si veda G. Colombo, Conoscenza di Dio e antropologia, Massimo, Milano 1988; questo testo e le sue argomentazioni permettono di condurre i ragionamenti contenuti in questo scritto. Werner Jaeger (Aristoteles, Berlin 1923, p. 404) ha dimostrato che «anche dietro alla sua [di Aristotele] metafisica c’è già il credo ut intelligam». 62 provvedere amorevolmente a colui (coloro) che è stato così abissalmente chiamato. E infine: se è Dio che per primo chiama, allora si spiega anche il motivo del mio cercarlo nell’apparenza dell’ignoranza: il Dio “sconosciuto” in realtà fin dal principio è la voce che mi chiama. Tutto questo è contenuto nel seguente splendido brano di Agostino: «Tardi ti ho amato, o bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato! Ecco tu eri dentro di me, io stavo al di fuori: qui ti cercavo e, deforme qual ero, mi buttavo su quelle cose belle che tu hai creato. Mi chiamasti, gridasti, e vincesti la mia sordità; folgorasti il tuo splendore e mettesti in fuga la mia cecità; esalasti il tuo profumo, lo aspirai ed anelo a te; ti degustai, e ora ho fame e sete di te; mi toccasti, ed ora brucio di desiderio per la tua pace. Abbi pietà di me, Signore! Ecco, non tengo nascoste le mie ferite: Tu sei il medico, io l’infermo; Tu sei il misericordioso, io la miseria”»56. 3. Creazione, provvidenza, predestinazione La vocazione, ovvero l’essere chiamati per nome, ha dunque un fondamento ontologico dal quale dipendono conseguenze religiose ed etiche. Per comprendere la natura del legame tra l’ontologico e l’etico, sottolineo ancora una volta la primordialità radicale del fatto: la “voce”, con cui Dio chiama ogni uomo, non va confusa con le altre “chiamate”; essa non è 56 Agostino, Confessioni, X, 27-28. 63 soltanto “più forte”, ma è di una natura totalmente differente; essa si pone in modo assoluto rispetto all’uomo che chiama, perché appunto lo chiama ad essere: è insomma la voce creatrice. Così scrive san Tommaso: «La creazione è la produzione di qualche cosa in tutta la sua sostanza senza che di questa ci sia presupposto alcunché sia creato sia increato»57. La voce che chiama non fa quindi essere l’uomo così come un “porre lì”: un trasformare, un assemblare, un dare inizio a qualcosa di nuovo, ma solo di relativamente nuovo. Quel “fare essere” consiste in un atto con il quale Dio possiede l’intimità dell’uomo infinitamente di più di quanto l’uomo non possieda se stesso. L’essere, poi, è non semplice “posizione” (ti “mette lì”), ma è atto intensivo, è vita, è perfezione presupposta e presente in ogni altra perfezione. La divina provvidenza non è perciò un’aggiunta estrinseca alla creazione, perché “provvedere” in senso proprio significa aiutare qualcosa a raggiungere il proprio fine, cioè la propria perfezione e felicità. Nessuno meglio di Dio, che è il creatore, può quindi provvedere alla creatura: ne ha stabilito e ne conosce perfettamente il fine58. Possiamo dire che la creazione fa essere ciò che non è e che la provvidenza conserva e accompagna e assiste tutte le creature perché realizzino il fine, il disegno che è inscritto nella loro natura. Perciò il termine «provvidenza» non indica soltanto la cooperazione, il concorso, L’azione continuata con cui Dio mantiene nell’essere le proprie creature, ma implica anche la ragione di scopo, di progetto: è il concorso di Dio teso a realizzare quel progetto che Egli stesso ha predisposto sia per le singole creature sia per l’universo intero. Sempre san Tommaso scrive: 57 Tommaso, Summa th., I, q. 63, a. 3. Tommaso scrive: «Siccome Dio è causa delle cose mediante l’intelletto e quindi la ragione di ogni sua opera preesiste necessariamente in lui, ne viene di necessità che l’ordinamento delle cose al loro fine preesiste nella mente divina. Ora, la provvidenza consiste precisamente in questo predisporre gli esseri al loro fine (ratio ordinandorum in finem, proprie providentia est)» (Summa Th., I, q. 22, a. 1). 58 64 «Dio provvede immediatamente a tutto, perché nella sua mente ha l’idea di tutti gli esseri, anche dei più piccoli, e a tutte le cause che ha prestabilito per produrre degli effetti, ha dato la capacità di produrre quei dati effetti»59. Va precisato che si chiama “predestinazione” l’atto con cui Dio ordina una cosa a un fine con una eterna e libera decisione della sua volontà60. Celebri sono in proposito le espressioni di san Paolo nella Lettera agli Efesini: «Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo»61. 59 Summa Th., I, q. 22, a. 3. Scrive Tommaso: «quando si tratta di un fine che un essere non può raggiungere con le forze naturali, è necessario che un altro ve lo porti, come la freccia è lanciata verso il bersaglio dall’arciere. Per tale motivo la creatura ragionevole, capace della vita eterna, è, strettamente parlando, condotta e come trasferita in essa da Dio. E il disegno di questo trasferimento (transmissionis) preesiste in Dio, come in lui preesiste il piano che dispone tutti gli esseri verso il loro fine, piano che abbiamo detto essere la provvidenza. D’altra parte l’idea di una cosa da farsi, esistente nella mente del suo autore, è una certa preesistenza in lui della cosa stessa. Perciò il disegno della predetta trasmissione o trasferimento della creatura ragionevole al fine della vita eterna, si chiama predestinazione: infatti destinare vuol dire mandare» (Summa Th., I, q 23, a. 1). 61 Ef., 1, 3-12. 60 65 4. Ontologia, religione, etica San Tommaso riprende questi concetti e istituisce un parallelo tra la creazione e la predestinazione: sia l’esserci delle creature, sia la partecipazione alla sua gloria non hanno altra causa che l’amore di Dio. E ciò appare chiaro tenendo presente che,poiché tra il finito e l’infinito vi è una distanza infinita, la beatitudine, ovvero la felicità perfetta nell’unione d’amore con Dio, oltrepassa tutte le forze umane e quindi solo Dio può realizzare questo disegno. In altri termini: con la creazione Dio pone nell’uomo il desiderio di contemplarlo, di riunirsi al suo “Amore”, con la redenzione realizza ciò che nessuna creatura potrebbe compiere; e perciò Tommaso afferma «L’esecuzione di questo disegno [della predestinazione] si trova al passivo (passive) nei predestinati; ma all’attivo (active) si trova in Dio»62. Nell’essere creati e persino nell’”inizio” della fede (lo vedremo) non vi è “merito”: come posso meritarmi qualcosa, se ancora non esisto? E, egualmente, come posso meritarmi di incontrare Cristo, se non ne conosco neppure l’esistenza? Però, assolutamente parlando, anche la predestinazione alla gloria dipende dalla misericordia di Dio, ma relativamente dipende anche dalla corrispondenza della libertà umana. Scrive ancora Tommaso: «la volontà ha il dominio del proprio atto ma senza l’esclusione della causa prima, perché la causa prima non agisce nella volontà in modo da determinarla di necessità a una sola cosa come determina invece la natura; per questo la determinazione dell’atto viene lasciata nel potere della ragione e della volontà»63. Questo discorso ha un primo e profondo significato: che Dio è l’attore primo della storia dell’uomo e che il legame tra ontologico, religioso ed etico è innanzitutto posto da lui. È Dio che crea l’uomo e che si preoccupa della sua perfezione e della sua felicità. Ciò non avviene se non nel rispetto della libertà umana che Dio stesso vuole e sorregge 62 63 Summa Th., I, q 23, a. 2. De Pot., q. 3, a. 7, ad 13. 66 nel suo esercizio quotidiano. San Tommaso ancora una volta con precisione afferma: «Dio è principio e fine d’ogni cosa e, di conseguenza, ha con le creature un duplice rapporto: quello secondo cui tutte le cose arrivano all’essere per causa sua, e quello secondo cui tutte le cose si dirigono a lui come a loro ultimo fine. Questo secondo rapporto si realizza nelle creature irrazionali diversamente che in quelle razionali: nelle prime si attua mediante l’assimilazione (per viam assimilationis), nelle seconde mediante la conoscenza della divina essenza oltre che mediante l’assimilazione. Infatti in tutte le cose che procedono da Dio è insita l’inclinazione verso il bene da conseguirsi mediante l’agire. Ora nel conseguimento di qualsiasi bene la creatura si rassomiglia a Dio. Ma le creature razionali possono raggiungere Dio oltre che mediante l’assimilazione anche con l’unione mediante le operazioni del conoscere e dell’amare, e quindi sono più in grado delle altre creature di essere beate»64. Ora, poiché Dio fa tutto questo per l’uomo, l’uomo risponde; e risponde innanzitutto come rispondono tutte le creature: in ragione della legge che governa la loro natura. La risposta a Dio è infatti, per così dire, anteriore a ogni presa di posizione pro o contro Dio stesso. A lui tutte le creature tendono in quanto egli è fonte della vita, del bene. Di nuovo: per capire il religioso e l’etico, e quindi il movimento della libertà, bisogna comprendere che essi non sono astratti, avulsi dall’essere e quindi dal piano della creazione, ma sono normati, appunto, dalla loro natura, che è quella che Dio ha voluto creando. Perciò scrive Tommaso: «Le cose esistenti in natura non solo hanno verso il loro bene l’inclinazione generale a cercarlo quando non lo hanno, e a riposarvisi quando lo possiedono; ma anche a effonderlo sulle altre per quanto è loro possibile. Per questo vediamo che ogni agente, nella misura in cui ha attualità e perfezione, tende a produrre cose a sé somiglianti. E quindi rientra nella natura della volontà il comunicare agli altri, nella misura del possibile, il bene posseduto»65. Bonum diffusivum sui: il bene è di per se stesso diffusivo, tende a comunicarsi. Ma l’uomo risponde appunto da uomo nell’«ora et labora» della sua vita: come orare che è atto positivo di accettazione e di adorazione e, all’opposto, come atto negativo di ripulsa e di bestemmia, e 64 65 De Ver., q. 20, a. 4. Summa Th., I, q. 19, a. 2. 67 come laborare che è atto positivo di costruzione di civiltà umana e, all’opposto, come atto di distruzione; il tutto nell’ottica, accettata o rifiutata, dell’amore per Dio e per il prossimo. Nella preghiera e nel lavoro l’uomo opera quindi secondo “giustizia”, cioè fa le cose vere, e questa operazione nel suo complesso si chiama “religione”. Con essa l’uomo e il mondo vengono ricongiunti a Dio, il che accadrebbe – nota acutamente san Tommaso – anche in assenza di peccato… «Si dice propriamente ligari (esser legato) chi viene talmente stretto a qualcuno da esser privato della libertà di dirigersi verso altri. Invece religatio comporta un legame reiterato (iteratam ligationem), e quindi significa che si viene legati a qualcuno a cui si era già in precedenza uniti e dal quale ci si era successivamente svincolati. Ora, ogni creatura esiste prima in Dio che in se stessa (prius in Deo existit quam in seipsa); poi, procedendo da Dio, incomincia in un certo senso a trovarsi lontana da lui, nel momento della creazione. Pertanto la creatura ragionevole si deve ricollegare (religari) con Dio, al quale era unita prima di esistere, affinché tutti i fiumi ritornino alla sorgente dalla quale sono sgorgati»66. A maggior ragione, la religione ha un grande ruolo dopo il peccato, poiché essa « comporta ordine a Dio (proprie importat ordinem ud Deum). «Egli [Dio] infatti è colui al quale principalmente dobbiamo legarci come a un principio indefettibile; e verso cui dobbiamo dirigere di continuo la nostra elezione, come a ultimo fine; è colui che perdiamo con la negligenza del peccato, e che dobbiamo ricuperare credendo e professando la nostra fede»67. 5. La priorità di Dio: uomo-chiamato e non uomo-domanda Insisto ancora sulla priorità di Dio in ordine a quella storia perenne che è la ricerca della felicità, priorità che è ontologica e soteriologica insieme, cioè non solo nell’ordine della creazione, ma anche della salvezza-redenzione. 66 67 Contra Impugn., c. 1. Summa Th., II-II, q. 81, a. 1. 68 Così la parola di Gesù «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi»68 ha il significato primario di indicare la “cura” con cui Dio stesso sostiene la sua creatura e quello secondario, derivato, di indicare come nell’essere chiamato all’essere, alla vita e alla salvezza l’uomo scopra la propria natura e identità e, insieme, il proprio ultimo fine e la sua propria felicità. Mi provo ora a invertire la prospettiva e prendo come punto di partenza quello soggettivo. Allora platonicamente possiamo affermare che ci troviamo di fronte all’originaria incompiutezza dell’uomo: se cerca, vuol dire che non possiede ancora, e quindi non è perfetto, compiuto. Ma questa affermazione ci conduce ad una prima conclusione che concerne il rapporto uomo-cosmo: l’uomo non è nel cosmo come un soggetto semplicemente naturale, come un sasso scagliato nell’universo. Infatti, è pur vero che se l’uomo domanda è perché vi è ignoranza, poiché chi sa non domanda, ma è altrettanto vero che chi domanda, domanda perché è in grado di sapere. Così l’uomo si rivela, in virtù della sua propria natura, come l’essere che è e che non è ancora ciò che deve essere, poiché è potenziale a un fine che è prima del suo domandare ed è la condizione stessa del suo domandare. In quest’uomo, che è Eros e Filosofo, secondo la profonda intuizione di Platone69, proprio a causa della dialettica coscienziale tra ignoranza e sapienza, sorge l’inquietudine esistenziale. «Ci hai fatti orientati a Te, scrive Agostino al principio delle Confessioni, e il nostro spirito (cor) è inquieto finché non riposi in Te» 70. Così la domanda nella sua semplicità immediata si presenta con il timbro del «Chi sono io?», mentre nella sua complessità maggiormente riflessa si duplica nel «da dove vengo?» e nel «dove vado?», ovvero - il che è lo stesso - «perché esisto?», interrogativo che è posto sotto il significato della causa efficiente e della causa finale, le quali sono cause che implicano vocazione e compito. 68 Gv., 15, 16. Platone, Simposio, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1991, pp. 511514; 516-518 [203 C – 204 B; 206 A – B; 208 E – 209 C: 210 A – 212 B1. I luoghi valgono anche per le citazione che seguono in questo scritto. 70 Agostino, Conf., I, 1, 1. 69 69 Il domandare, poi, pervade la dimensione del problema e quella del mistero, secondo la definizione che ne dà Gabriel Marcel71, e si fa pungente alla coscienza nelle «situazioni limite», di cui parla Karl Jaspers nella sua metafisica72 e che inchiodano gli individui e le comunità umane al crocevia tra la vita e la morte, del quale è una epifania la nostra crisi di civiltà (crisi di molti Cristiani e crisi della modernità), che può avere per esito la conversione o la perdita della fede73 con il superpotenziamento del prometeismo. Inoltre va notato che non solo l’uomo, poiché trascende l’apparire del fenomeno, è l’unico vivente corporeo capace di domandare (l’animale non trascende il proprio ambiente e quindi resta al di sotto della possibilità del domandare74), ma anche che l’uomo è al tempo stesso soggetto e oggetto della domanda e dunque della conseguente ricerca. Però, divenendo a se stesso magna quaestio (sant’Agostino), l’uomo trova mille vigili che dirigono il traffico, ma nessuno che sa dirgli da dove venga e dove vada75. e così sembra smarrirsi tra i meandri dei saperi. Eppure il suo non è un perdersi nelle tenebre assolute, ma un indirizzarsi come a tentoni verso la meta, quasi fosse nella condizione di una notte luminosa e di una dotta ignoranza, perché in realtà egli si trova posto in una strana ambiguità: si sa 71 Cfr. G. Marcel, Giornale metafisico, Abete, Roma 1966: «Un problema è qualcosa che incontro, che trovo davanti a me ma che posso delimitare e trasformare, mentre un mistero è qualcosa in cui sono impegnato e che quindi è possibile soltanto come una sfera in cui la distinzione fra lo “in mé” e il “davanti a me”, perde il suo significato e il suo valore iniziale. Un problema autentico dipende da una tecnica appropriata in funzione della quale si definisce, mentre un mistero trascende per definizione ogni possibilità di tecnica» 72 K. Jaspers, «Situazioni come queste: io sono sempre in situazioni, io non posso vivere senza lotta o dolore..., fatalmente sono destinato alla morte, si chiamano situazioni-limite. Situazioni tali sono immutabili, definitive, incomprensibili, irriducibili, intrasformabili, soltanto chiarificabili. Sono come un muro contro cui urtiamo fatalmente». (Metafisica, Mursia, Milano 1972, p. 38). 73 Lc., XVIII, 8, Gesù fa questa domanda, che richiama l’uomo alla sua libertà e responsabilità: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”». 74 Cfr. Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Frankfurt a. M. 1966, pp. 33 ss. 75 Cfr. T. S. Eliot, Cori da «La Rocca», III, in Poesie, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano 1996, p. 413. 70 come essere spiritualmente capace di autocomprendersi e padrone di sé e contemporaneamente si sperimenta intrinsecamente legato all’oscurità dell’essere materiale e contingente. Ma è proprio vero che primariamente è l’uomo a domandare e che egli primariamente domanda di se stesso? Così pare sia, se si accetta l’idea heideggeriana di uomo come progetto gettato. Se invece con Soren Kierkegaard si accoglie come vero che l’uomo nell’atto di costruire la propria autocoscienza, rapportandosi con se stesso, simultaneamente si rapporta con l’Altro che l’ha posto76, allora nel proprio io conosciuto, nella misura in cui è conosciuto con verità, conosce Dio, la meta e la causa del suo essere. E potremmo dire di più. Non solo l’autocomprensione di sé è un a priori, non puro, ma esperienziale, non oggettivabile e affonda nel mistero, ma anche e soprattutto «Chi tu sei» innanzitutto ti è detto da chi ti chiama all’essere. Chi ti chiama, originariamente, ti desta dal nulla. Così è per il bambino: sei messo al mondo da un atto che, rispetto a te che non sei, è onnipotente; non eri, ora sei. E tutto, dopo questa origine, seguita a chiamarti per nome: i genitori, i volti noti e meno noti, le cose. Il cosmo intero ci chiama, kantianamente nel suo aspetto naturale ed etico: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me77. E dunque tutto bussa alla tua porta: ti chiama, e tu devi rispondere. «Ci sono e sono io» e dici il tuo nome: conosci il tuo esistere e sai chi sei, ma conosci cosa significa veramente il tuo nome? Il nome, che non hai scelto ma ti è stato dato, è figura della relazione ontologica con i genitori, relazione di dipendenza ma non assoluta. Senza quei genitori non sarei, ma ora anche senza di essi io posso continuare a essere. Senza l’Essere assoluto, però, io non sarei mai stato e anche ora non sarei. Perciò l’alternativa tra 1) primariamente è l’uomo a porre le domande e 2) primariamente le domande sono poste all’uomo non si risolve innanzitutto 76 S. Kierkegaard, La malattia mortale, in Opere, Ed. P. M., Casale Monferrato 1995, vol. III. Pp. 12-149. 77 I. Kant qui è profondamente paolino; cfr. Lettera ai Romani, II. 71 sul piano gnoseologico78, ma su quello ontologico. L’uomo non è l’assoluto, ma è finito, di più: relativo; perciò l’origine non è nell’uomo, ma in Altro rispetto all’uomo. Questo Altro, al primo albeggiare della mia coscienza, mi chiama, mi interpella, mi chiede di prendere coscienza del dato esistenziale che io sono rapporto e della qualità essenziale dell’essere io questo tipo di rapporto. Perciò, interrogandomi, mi sospinge a formulare una risposta. Quindi, paradossalmente, l’uomo non è tanto l’Essere Chiamato che pone le domande, quanto piuttosto l’essere chiamato che dà le risposte. Si torna così al principio: chi veramente mi chiama è oltre il cosmo e la comunità umana. Perciò, se non conosco questo Altro che mi ha posto e che è il mio modello, non potrò sapere chi sono io, perché, io finito, sono sua immagine. Dunque l’heideggeriano progetto gettato antepone il domandare all’essere chiamati e ineluttabilmente rimane prigioniero delle contraddizioni dell’autocreazionismo. Al contrario la considerazione esistenziale dell’uomo rivela la primarietà dell’essere chiamato per nome (vocazione) sull’interrogarsi e sull’interrogare in genere. Inoltre questo Altro (Dio), che è causa efficiente e finale, come si è già accennato sopra, non solo determina l’essenza dell’esserci dell’uomo come vocazione (dal nulla all’essere), ma anche la qualifica come compito. E il compito è questo: sapere in modo riflesso l’originaria autocomprensione di sé e, sapendola, sopportarne le implicazioni, perché in ciò consiste il contenuto, la sostanza della felicità, che è appunto Dio e la mia perfezione, per dirla con una formula concisa. 78 Affermare “non innanzitutto” non equivale a negare che anche sul piano della conoscenza non vi sia chiara indicazione della priorità dell’altro rispetto al soggetto conoscente. Scrive Tommaso (De veritate, 10, 8): «Nullus autem percipit se intelligere, nisi ex hoc quod aliquid intelligit. Quia prius est intelligere aliquid, quam intelligere se intelligere». 72 6. Chi mi chiama per nome?: il “Tu” è più antico dell’”io” È pur vero che una conoscenza di Dio è implicita in ogni cosa che conosciamo, perché nulla è veramente conoscibile se non mediante la prima verità, il principio a cui tutto viene rapportato79. Ma è altrettanto vero che ciò non coincide con un’autentica conoscenza di Dio. Per questo il compito fondamentale della vita consiste nella risposta a questa domanda che viene posta all’uomo implicitamente o esplicitamente in tutte le domande che gli vengono fatte dagli uomini e anche in quelle domande, tanto mute quanto eloquenti, che sono poste dalle cose: Chi mi chiama per nome? Il cammino della risposta si imbatte innanzitutto in molte negazioni. Già lo insegnava Socrate: “non sei tu”, e la negazione riguardava le false verità; poi, nella storia biblica, la rimozione riguardava i “falsi dèi”. Così l’autentico lavoro della vita consiste nello scoprire che “il Tu è più antico dell’io” e, poi, che quel “Tu” è «Il primo amore»80, quell’Amore che solo è la perfezione e la felicità di ogni uomo, quell’Amore che unisce a sé, appassionatamente, non desistendo mai dal legare a sé l’uomo con lacci d’amore, appunto… «Amor ch’a nullo amato amar perdona»81. Non c’è che l’amore: positivo e negativo, e questo prende il nome di “odio”, ma non vi può essere in ultima istanza “indifferenza”: è sempre necessario prendere posizione con un “sì” o con un “no”, perché l’Amore non «perdona”, cioè non abbandona mai colui che ama. Meravigliosa e terribile storia questa, perché l’uomo non può liberarsi di Dio, in nessun modo: o la resa nell’amore, o la perenne ribellione nell’odio; niente altro. 79 «Omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet cognito»; «nihil est cognoscibile nisi per similitudinem primae veritatis» (De Veritate, q. 22, a. 2, ad I). 80 Paradiso, XXVI, v. 38. 81 Inferno, V, v. 103. 73 Capitolo Secondo L’Essere e l’io: la dialettica di identità e di differenza 1. Vita-verità-via: il bello, il vero, il bene Lo scopo di questo capitolo consiste nel fissare a livello ontologico l’apparire dei tipi fenomenologici fondamentali dell’esistenza umana nel suo venire all’essere, nel suo svilupparsi e accrescersi. Si tratta quindi di delineare una “ontologia della formazione dell’uomo in quanto uomo”. Il modello interpretativo può correttamente essere desunto dalla analisi delle parole di Gesù «Io sono la via, la verità e la vita»82. Queste parole valgono in modo analogico per ogni realtà, cose e uomo, perché, in quanto immagini del creatore e del redentore, in modi differenti, e sia pure infinitamente lontani dal loro esemplare e quindi imperfetti, conducono a Dio (via), indicano Dio (verità) e comunicano l’essere, l’esistenza, partecipata da Dio alle creature (vita). Da questo punto di vista il loro valore è puramente strumentale e perciò compito primario di ogni uomo è quello di non confonderli con il fine ultimo, che è anche la causa prima, cioè di distinguere tra modello e immagine, tra creatore e creature: insomma, di non fermarsi alle immagini riflesse nello specchio, ma di andare alla loro origine e consistenza. Dal punto di vista esperienziale umano, soggettivo, la sequenza dei tre termini, via-verità-vita, va poi invertita, perché l’uomo che, aprendosi alla coscienza delle cose, di se stesso e dell’Altro, procede con sempre maggiore consapevolezza verso Dio, che è la sua perfezione e felicità, nella sua prima tappa spirituale concepisce la vita nel suo splendore e solo 82 Gv., 14, 6. 75 in seguito, ritmate in due ulteriori tappe spirituali, la verità, prima, e la via, poi. Vita, verità e via sono da intendersi inoltre come figure dei tre trascendentali dell’essere: il bello, il vero, il bene. Dio è la vita, «suum vivere», dice Tommaso e la sua creazione è vita così come lo è la redenzione. Ogni uomo è originariamente avvolto, “fascinato”, dalla vita nella sua esultanza. È detto dal senso comune che «la vita è bella»: ed è bello vivere. Cosa significhi tutto questo è questione di non facile soluzione, ma è indubbio che la vita con la sua energia prorompente attiri e leghi a sé. La vita nella sua immediatezza è perciò come il trascendentale bello: e il bello viene definito da Tommaso come «lo splendore del vero». La vita è questo splendore: “vieni e vivi: è bello!”. Dio è anche la Verità: «Che cos’è la verità?»83, chiede Pilato a Gesù; e Gesù non risponde. Maleducazione, superbia? No: Pilato aveva la verità davanti ai suoi occhi e non la vedeva: «io sono la verità». In questo episodio, tra gli altri insegnamenti, ve ne è uno per noi fondamentale: la verità non è innanzitutto frutto di dimostrazione, cioè di potenza razionale umana, non è innanzitutto un possesso o addirittura una costruzione del raziocinio; la verità primariamente è un “fatto”: è Gesù, appunto, è Dio e, analogicamente, sono le cose. Vi è quindi una priorità della verità ontologica: la verità logica, quella frutto del giudizio e del ragionamento, viene dopo e su di essa si fonda. Quella verità fondamentale, il “fatto vero” o, per meglio dire, quel “vero” che è un trascendentale dell’”essere”, innanzitutto è intuito: è “visto”: la verità è lì: è quella cosa, è quell’uomo e, abissalmente, è Gesù-Dio. Perciò affermare che la verità è la seconda tappa dell’esistenza umana significa affermare che l’uomo, posto e affascinato dalla e nella vita, si chiede quale sia il vero di questo splendore, di questa “vita bella”. “Cosa è la verità?” può essere tradotto nell’affermazione “non sei tu”, che ogni uomo rivolge alle cose, 83 Gv., 18, 38. 76 alle situazioni e alle persone che incontra nel suo cammino ascensivo verso la perfezione e la felicità. “Non sei tu”: in queste parole risuona il desiderio erotico così bene espresso da Platone nel Simposio: il corpo bello, l’anima bella non sono il “Bello in sé”. C’è verità in questa cosa e in questa persona e in tante altre, certamente, ma non sono la “Verità”, il “Vero assoluto”, dal quale tutte le particolari verità dipendono. Per questo affermo che dal bello, che è vita e che affascina, ognuno di noi passa a domandarsi: ma questo bello è vero? O ancora: mi piace, ma è vero?, cioè ha veramente consistenza, oppure è semplice apparenza o, addirittura, è contro la Verità ultima? C’è quindi vita e vita, e solo una è la “Vita”, cioè è la vera Vita, la Verità che è legge intima dell’Essere stesso. Dio è anche il Bene. Come la verità è ciò a cui tende l’intelletto, così il bene è ciò a cui tende la volontà. Il bene, infatti, è quell’aspetto trascendentale dell’essere, in virtù del quale l’essere è desiderabile: non solo come bene di cui usufruire, ma anche come bene a cui donare se stesso, in tutto o in parte. Conosco (verità), a esempio, che il panorama dalla cima di un monte offre una certa visione sul mondo e conosco che per raggiungere quella vetta sono necessarie ore di tempo e fatiche fisiche non indifferenti; conosciuto tutto ciò, mi domando se per me è un “bene”: cosa mi può dare? Cosa sono disposto io a dare (fatica, tempo…) per entrare in possesso di quel bene? E, ancora di più, nell’innamoramento: ti conosco per quel che sei e conosco che sei un bene per me: come allora agire in modo conforme a quel bene che tu sei? Appare qui in tutta evidenza che per l’uomo che desidera la perfezione e la felicità non è sufficiente conoscere, ma è necessario volere e agire e che il conseguimento di un determinato “bene” comporta alcune disposizioni profonde, che vanno adottate, pena il fallimento. Perciò, al fondo, “il fine giustifica i mezzi”: nel senso che il fine a cui si tende, il bene desiderato, detta la sua legge: detta la “via”; non si può raggiungere la vetta dell’Everest così come si compie una passeggiata sui Colli Euganei! L’Everest “giustifica” solo alcuni mezzi, solo una “via”: allenamento, forza fisica e salute, fatica, attrezzature, abbigliamento…. Così è quella 77 Vita Vera: è quel Bene che, se voluto, può essere ottenuto soltanto a certe condizioni, a quelle dettate appunto dalla sua Verità. Amare Dio, cioè volerlo sopra ogni cosa così come si vuole il Bene al confronto di tutti gli altri beni, comporta l’incamminarsi verso di lui sull’unica “via” che conduce a lui: non tutte le strade portano infatti a Dio, ma solo quella conforme al Vero. Questa “via”, a ben vedere, in campo etico si chiama “obbedienza” alla legge morale e in campo religioso “corrispondenza d’amore”. Ma vediamo in dettaglio, ricordando che l’analisi fenomenologica e psicologica è strumento per fissare momenti ontologici essenziali del farsi dell’uomo. 2. La vita: sotto il cuore: la formazione della coscienza umana Mi chiedo: cosa accade quando il potenziale conoscitivo dell’uomo comincia ad attuarsi?, ossia Come avviene che l’uomo, che in potenza può conoscere, diventa effettivamente in atto un soggetto conoscente? Stando a quanto riferiscono i ricercatori (neurologi, psicologi, ecc.) già il bimbetto che è ancora nel grembo materno ha la sua prima aurora di coscienza, cioè si apre alla conoscenza e realizza così le sue prime azioni conoscitive. Quest’alba di coscienza è certamente resa possibile non solo dai sensi, ma anche dall’intelletto perché – non dimentichiamolo – l’uomo è uomo proprio perché è dotato di ragione.Senso e intelletto passano poi dalla potenza all’atto quando l’essere irrompe in loro. Come una fotocamera passa dalla potenza all’atto (dal “poter fotografare” al “fotografare effettivo”) quando la luce, le belle forme e i colori irrompono in essa, così il bimbetto, che è provvisto degli organi conoscitivi e perciò è in grado di conoscere, conosce effettivamente soltanto quando viene “in-formato”, cioè l’essere penetra e si imprime nella sua mente. Non è tuttavia l’essere nella sua totalità che irrompe in lui: l’essere si presenta e “in-forma” per gradi. 78 “In principio”, “sotto il cuore della madre”, i sensi che per primi passano dalla potenza all’atto sono il tatto e l’udito. Il tatto, come dice Aristotele, è il senso primario che appartiene in proprio a tutti gli animali e che distingue anche il meno evoluto fra di essi dai vegetali. Mediante il tatto il bimbetto viene in rapporto con se stesso e con il mondo. Così, grazie alla tattilità, si forma un’alba primitiva di autocoscienza e di coscienza. Infatti il tatto permette innanzitutto di conoscere se stesso come “motilità”: il movimento è non meccanico, ma sensibile, appunto. Quindi la motilità fornisce una primordiale “sensazione di sé”. D’altro canto, tatto e motilità fanno avvertire ciò che una riflessione evoluta distinguerebbe dall’io, cioè quello che solitamente chiamiamo “mondo”. Il bimbetto avverte, tattilmente, l’ambiente caldo, liquido e morbido che lo circonda. Potremmo dire allora che, tramite il tatto, che è, normalmente, in un essere umano sempre connesso con l’intelletto, l’Essere compie la sua prima irruzione formale nella coscienza umana e, si badi bene, non viene alla coscienza sotto la forma duale dell’”io” e del “non io”, ma esattamente sotto quella di un Essere unitario. Con la tattilità e la conseguente motilità il bimbetto non ha infatti modo di potere distinguere tra sé e l’altro da sé. “In principio”, perciò, non è la “differenza”, la “negazione” e la “contrapposizione” di una parte rispetto al tutto, ma è l’”unità”, l’”identità”: indistinta, certamente, e non riflessa. Ancora, in altri termini, “in principio” è il “positivo”, cioè, etimologicamente, il “posto “, ciò che è lì, fattualmente. Sotto il cuore della madre la vita si presenta dunque come uno-tutto e, sempre normalmente, essa coincide con l’Essere; detto altrimenti: il bimbetto avverte di essere (esistere): non di essere nell’Essere, ma semplicemente di “essere”, proprio perché non vi è per lui ancora distinzione tra io e non io. Con un azzardo possiamo affermare che avverte di “essere l’Essere”: coincidenza di io (soggettività) e non io (oggettività, mondo). La prima alba della coscienza è così illuminata dalla 79 indistinzione, cioè dalla vita (essere) come totalità onnicomprensiva: la mia vita è il tutto. E, se così è, l’irruzione dell’Essere nella coscienza umana produce un “benessere”, una sorta di felicità primigenia: manca, lo ricordo, la distinzione e quindi la negazione, la contrapposizione: è il momento del positivo (salvo patologie che, appunto, in quanto “fanno male” introducono una rottura). Veniamo all’udito. Il bimbetto sente senza dubbio rumori e voci provenire dall’esterno del grembo materno, sente anche i suoni “interni” alla madre (respiro, voce, rumori addominali), ma il suo udito è dominato primariamente dal battito regolare e continuo del cuore della madre. Se dorme il bimbetto “in atto” non esercita il suo tatto e il suo udito; ma, non appena è desto, gode della propria motilità e il suo udito è pervaso dal suono del cuore: un “tum-tum” che è onnipresente; non c’è luogo, per così dire, nel quale il bimbetto possa sottrarsi a questo continuo e incessante suono. E, appunto, il continuo dei battiti che si succedono ritmicamente forma nel bimbetto un’altra alba di coscienza: quella della “durata”. Così anche tramite l’udito l’essere si fa “presenza”: non solo un Essere caldo, liquido, morbido, ma anche sonoro. “In principio”, dunque, il bimbetto è nell’Essere come distensione e come durata senza confini: un positivo dato per lui “da sempre”. Ciò che egli tocca e ciò che egli ascolta sono infatti dati immediati di coscienza. È questo un punto capitale: non c’è un’anteriorità coscienziale, conoscitiva, ossia un “prima” rispetto all’Essere toccato e udito, perché la coscienza passa appunto dalla potenza (sorta di non-essere-ancora) all’atto (essere effettivo) unicamente e soltanto quando in essa irrompono l’Essere come distensione e l’Essere come durata. Il bimbetto non ha “in principio” esperienza del “non essere”, della negazione, della privazione: è nativamente nell’Essere ed è tutt’uno, quanto al suo conoscere, con l’Essere. Forzando i termini, il mio entrare nel mondo come uomo, cioè come essere cosciente, non mi consta come un “venire al mondo”, bensì come 80 un “essere da sempre nel mondo”. La conoscenza del “prima” è un sapere che a fatica si apprende. “In principio” ciò che io so è l’Essere infinito e la sua durata non come tempo ma come eternità: lì, nel grembo materno, è il tutto, infinito e da sempre e per sempre. Non c’è altra esperienza e, quindi, non c’è altra conoscenza: altra presenza alla mia coscienza che mi permetta di compiere un confronto, di formulare un giudizio. È un positivo, un “posto”, un dato immediato, appunto, di coscienza. È evidente che quell’Essere non è il vero “Essere”, perché, in verità, io e non io non si identificano, quel mondo non è il mondo, quella durata non è l’eternità e neppure tutto il tempo. Ma il bimbetto sotto il cuore della madre non sa nulla di tutto ciò. Anzi, il grande lavoro di un bimbo, di un ragazzo, di un uomo adulto e di un vecchio, fino all’ultimo suo respiro, consiste proprio nel distinguere tra l’io e il non io, tra l’Essere e gli esseri. La prima esperienza è nell’immediato, non nella distinzione tra ciò che appare e ciò che veramente è. Cielo, Sole e Terra erano lì per Tolomeo e per Copernico: diverse le loro letture di questa realtà; ma quale grande lavoro hanno comportato! La mia mano nella tua mano: immobili…, il medesimo calore…, viene meno la distinzione tra la mia e la tua mano, ma basta un leggero movimento, un minimo atto di intenzionalità e l’incantesimo dell’unità è rotto: ma per poterlo rompere occorre avere già l’esperienza dell’essere personale, il proprio io, separato da questo e da quell’ambiente, il non io (cosa che è impossibile per il bimbetto sotto il cuore della madre). In questa esperienza primaria sta una verità dell’idealismo: l’essere è conoscibile solamente in quanto è presente alla coscienza; errore dell’idealismo è ridurre l’essere alla coscienza. In realtà, infatti, l’Essere precede la coscienza umana, abissalmente. 3. La verità: nell’unità la differenza Compiamo un passo avanti. Dalla “vita” che ammalia nella sua indistinta grandezza primordiale (“è”, sovranamente, per me che non ho 81 altre esperienze), passiamo alla “verità”, la seconda figura o, meglio, trascendentale dell’essere. L’identità tattile primigenia di io e non io (il bimbetto e l’ambiente sotto il cuore della madre) e la durata eterna uditiva del battito del cuore materno sono una “cattiva infinità”: non “sperimento con il tatto tutto l’essere, e men che meno l’Essere, e quel tempo ritmato, che per me è senza inizio e senza fine, non è tutto il tempo e, a maggior ragione, non è l’eternità. 3.1 La prima distinzione: il parto Ma ecco: è il momento del parto e il bimbo “viene al mondo”. Questa espressione, “venire al mondo”, non è affatto banale, perché testimonia un secondo avvenimento primordiale: il compiersi della differenza nella identità. “venire al mondo” dice infatti il realizzarsi della distinzione tra io e non io e, precisamente, la distinzione tra io e mondo (l’insieme di altre persone e di cose). Per molti psicologi, se non per tutti, il parto è una sorta di piccola morte. Il bimbo abbandona non senza dolore e traumi un ambiente per lui completo e beatificante. Viene “espulso” dal grembo materno e viene “gettato” in un nuovo ambiente per lui ignoto e, in certo modo, ostile. In questo nuovo mondo, del resto, non potrebbe sopravvivere se non fosse circondato da mille cure. È un mondo dove dominano la riflessione e la mediazione (atti saputi, intenzionali e voluti) e non più l’immediata naturalità della vita intrauterina. Non saprei dire quale e quanta memoria crei nella coscienza dell’uomo l’esperienza della nascita. Giuseppe Pontiggia in una sorta di autobiografia afferma che l’angoscia da soffocamento sperimentata a causa del parto podalico rimane nell’io. È comunque certo che questa del parto è la prima esperienza di rottura: al positivo, il posto, alla posizione segue una negazione, una privazione, una distinzione. Se il bimbo potesse eseguire una riflessione compiuta, dovrebbe concludere che “egli non è l’Essere”, e neppure il mondo. E, benché non compia questa riflessione, sperimenta certamente il cessare, il venire meno di quel caldo, liquido e morbido ambiente: e s’interrompe anche il suono del battito del cuore 82 materno. Non cessa del tutto la relazione tattile e quella uditiva con elementi che non sono l’io, ma certamente nell’insieme uno-tutto primitivo si introduce una profonda distinzione. Sopra ho affermato che il bimbetto non possiede l’esperienza del “prima”, ovvero “in principio” l’uomo, qualunque uomo, si apre alla coscienza dinanzi a una pienezza: è una parte d’essere, non tutto l’essere e neppure l’Essere che gli si dà, ma lui non sa questo. Al primo farsi del suo conoscere, quindi, soggettivamente parlando, è l’Essere che gli si offre. Così, la negazione segue sempre alla posizione, il “non” all’Essere, il questo e il quello all’insieme dell’essere. E ancora: la prima esperienza che io ho del mio io non è quella della parte rispetto al tutto, del finito rispetto all’infinito. Ho affermato: c’è identità indistinta tra io e non io. E perciò l’esperienza della propria finitezza è secondaria, non primaria: il parto è la prima profezia di questa verità (e un uomo appena venuto al mondo conosce ciò che può di ciò comprendere). 3.2 Sopra il cuore: vista e tatto. Il bimbo è venuto al mondo: è nato, e normalmente viene messo “sopra il cuore della madre”. Deve infatti essere nutrito non solo con latte, ma anche con miele, secondo la felice espressione della Bibbia ripresa da Erich Fromm84, perché non necessita soltanto di alimenti materiali ma anche di cibo spirituale (affettività, innanzitutto, e, poi, educazione). Da “sotto” a “sopra” il cuore si palesa con l’udito che la primigenia unità non è del tutto scomparsa: torna alla coscienza il suono del battito del cuore materno. E anche il tatto ha la sua parte nel comunicare il calore e la morbidezza: l’accoglienza, insomma. Ma nel passaggio da sotto a sopra il cuore irrompe in tutta la sua importanza un senso nuovo: la vista. E la vista, combinata con il tatto, dà luogo a un nuovo evento, che conferma la distinzione introdotta 84 La Terra promessa è descritta nella Bibbia come il «paese dove scorre latte e miele» (Es 3, 8); cfr. E. Fromm, L’arte di amare, Mondadori, Milano 1991 (ed. originale 1956). 83 nell’unità dal parto (il “venire al mondo”). Infatti tu vedi e tocchi la medesima cosa, ma anche tu vedi una cosa, ma non la puoi toccare. Ciò che tocchi e vedi è “vicino”; ciò che vedi ma non tocchi è “lontano”. Così, grazie alla combinazione di questi due sensi, viene mantenuta l’unità dell’essere e, contemporaneamente, viene inserita nell’unità la differenza; vista e tatto, insieme, permettono la nascita nella coscienza della distinzione tra io e non io. Sul cuore della madre il bimbo vede il volto della madre e, quando questa lo bacia, lo può toccare; ma, trascorrendo i giorni, questa “vicinanza” tra l’essere del bimbo e l’essere della madre si rivela non essere una “identità”: ciò che vedo e tocco può essere sperimentato e saputo come mio corpo, ma anche come corpo della madre. 3.3 La voce: chiamati per nome. Anche l’udito non si limita a trasmettere l’antico legame con il suono del cuore. Esso, infatti, viene sempre più dominato non da rumori, ma da un suono unico e straordinario: quello della voce umana. La madre ti chiama per nome, dice il tuo nome, lo sussurra e lo modula con mille toni: ma è sempre il tuo nome. E, poi, al tuo nome si accompagnano altri nomi: della madre, del padre, delle cose più intime ed elementari. Così, progressivamente ma velocemente, il bimbo impara ad associare quel suono, quel nome, con il proprio io. Il proprio nome è una realtà straordinaria, perché ci insegna la distinzione più profonda, più ricca e più irriducibile: quello della persona umana rispetto al tutto; i nomi di persona non sono nomi di cose. “In principio”, come già abbiamo accennato, l’uomo non si pone domande e non è neppure interrogato. È infatti la sua apertura al mondo una sorta di apprensione pacifica, quella appunto che avviene sotto il cuore della madre. E, poi, sopra il cuore, viene ribadito questo positivo in una forma più alta: l’essere chiamati per nome conferma l’identità irripetibile del proprio io personale. Tu sei. Soltanto più tardi il bimbo diventerà soggetto a interrogazioni e diventerà soggetto capace di porre domande: solo quando la differenza si farà pungente e, magari, malevola. 84 Insomma, “in principio” a ogni uomo sono offerti contenuti positivi: è offerto, in modi vari, l’Essere. 3.4 l’amore dà l’essere Gradualmente, molto gradualmente, il bimbo giunge a distinguere tra essere e azione: più semplicemente, tra le persone (lui stesso, la madre, il padre) e gli atti che vengono compiuti. Così, a esempio, svegliandosi dal sonno il bimbo può rimanere tranquillo per qualche momento, ma poi strilla: ha fame e chiede, senza saperlo, che quell’essere, che è sua madre, svolga un’azione, quella del nutrimento. Capita poi che, pur non sentendo gli stimoli della fame, il bimbo strilli perché vuole rivedere il volto della madre per non essere più solo. Ebbene, questo agire, che ha per soggetto due attori, è propriamente lo “scambio d’amore”: è la donazione d’essere nell’amoredono, è la richiesta d’essere nell’amore-bisogno. E con ciò si affaccia alla coscienza un’altra verità: non solo vi è differenza tra l’io e l’Essere, e l’essere in generale, ma io non posso essere senza l’essere: agisco con un atto d’amore di bisogno per chiedere che mi sia dato, sotto la forma del cibo e del sorriso, la mia razione d’essere quotidiana, senza la quale mi è impossibile vivere. È pur vero che i protagonisti dell’amore sono sempre due: chi dà e chi riceve; e, primariamente, è la madre che dà e il bimbo che riceve. Ma i ruoli possono anche scambiarsi: il sorriso si dà e si riceve, perché consolando siamo consolati e il bimbo, pur non sapendo rispondere “io!”, scambiando il sorriso con la madre che lo chiama per nome, testimonia l’avvenuta autocoscienza: risponde a chi lo chiama, perché sa che quel nome è il suo nome: nomen numen, il nome è potenza d’essere. A margine faccio notare che la prima risposta, questa che avviene con il sorriso, non è propriamente la risposta che viene data a una domanda; ovvero non ha per contenuto la scoperta di un qualcosa prima ignoto. Il sorriso non segue al toglimento dell’ignoranza, ma alla avvenuta autocoscienza: è scambio d’amore che accade nel positivo, nell’essere, non è toglimento di una negazione o di una privazione, non è quindi frutto di indagine intellettuale. Il sorriso, alba di ogni autocoscienza 85 umana, è la risposta con il dono di sé al dono del sé dell’altro: la madre è lì, con il mio sorriso anch’io testimonio di essere lì, non come cosa, ma come uomo. 3.5 Il sovrappiù Che la Madre (o chi per essa) accudisca il bimbo è nella necessità dell’essere “naturale”. Ma attorno al bimbo non vi è soltanto questa figura. La stessa madre, sotto un altro aspetto, e poi il padre e i fratelli, tutte queste persone sono come un “sovrappiù”, una “sovrabbondanza” dell’essere che si dona. Sono volti che trascendono i bisogni fisici. Il bimbo nei primi anni della sua vita non sa propriamente nulla della generazione. Così il padre, in particolare, è per lui come una sovrabbondanza d’essere. È grande e la madre si appoggia a lui. E i fratelli?: da dove escono? Sono tutti una “grazia”. In altri termini: l’Essere non si riduce a ciò di cui io ho strettamente bisogno, è sempre “di più”, infinitamente. E coloro i quali non hanno nella loro infanzia fatto di ciò esperienza sono segnati per tutta la vita (non deterministicamente, però, poiché l’uomo è libero e l’Essere, come vedremo, non è né la madre né il padre). 3.6 Non come un ospite Quando un bimbo cresce e comincia a muoversi per casa e a fraseggiare senza parole, non si comporta come un ospite: la casa è sua, le cose sono sue, i genitori sono suoi: in una parola: l’Essere è suo. Non si comporta certo come un mendicante che, pur accolto con infinito amore, ha un profondo rispetto del luogo in cui si trova, poiché non è suo (parlo ovviamente di un mendicante che non sia imbevuto di secolarizzazione!). No, il bimbo si comporta “naturalmente” in modo radicalmente diverso: “mio” è l’aggettivo che qualifica l’Essere nel suo insieme come qualcosa che “deve” essere legato a lui; crede con ciò che l’Essere non sia per lui un “dono” che, come tale, potrebbe esserci e non esserci, ma sia semplicemente un “dovuto”, uno “scontato”. In altre parole: il bimbo si comporta come “signore” e come “padrone”, nel senso buono dei termini. L’Essere è a sua disposizione, completamente. 86 3.7 Il “no”: dallo stupor al dolor Accade però che il bimbo, ancora gattonando, tenti di prendere un oggetto o, magari, di infilare le dita in una presa: suona alto allora il “no”. Si ferma, guarda il babbo o la mamma come interdetto e, poi, accenna a riprendere l’azione interrotta. Il nuovo “no” – e la voce del padre o della madre viene accompagnata dal gesto e dalla espressione del volto – lo ferma di nuovo: preso in braccio, rapito via dal suo intento, strilla. E il “no” si ripete in altre occasioni. Si fa strada allora nella coscienza infantile quest’altra “verità”: non tutto l’essere è a mia disposizione. Perciò accanto al “mio”, che qualifica l’essere come un “dovuto”, un immediato per il bimbo, sorgono gradualmente altre due nozioni: quella di “donato” e quella di “proibito”, di “negato”. È questo un altro momento capitale con il quale il bimbo (uomo) comprende la propria finitezza: egli è una “parte”, non è l’Essere; non solo: la sua signoria sull’essere ha dei limiti, la cui estensione gli è ignota: e questo rende inquieti. Il bimbo passa così dallo stupor dello stupidus, che si bea tranquillamente di tutto, al dolor del dolens, per il quale l’Essere diventa un problema: e allora sì l’uomo comincia a domandare: “perché questo sì e questo no?”. Ora comincia a sapere di non sapere: e negli occhi è la scienza e l’angoscia. 3.8 La colpa Ciò che per il bimbo è proibito, non lo è per i genitori. Loro sì possono maneggiare le spine e le prese dell’energia elettrica! Guadagna così spazio nella coscienza, sempre più a livello riflesso, la verità di una dissimmetria: la mamma mi dà da mangiare e mi accudisce: non così io con lei; il babbo mi prende e mi fa volare in alto: non così io con lui. Di più: il loro volere e il loro potere sono qualitativamente differenti rispetto ai miei: non voglio staccarmi da un oggetto, ma non posso resistere al babbo che, contro il mio volere e il mio potere, mi strappa via da esso. Così agli occhi del bimbo i genitori si manifestano come coloro che possiedono l’essere e a loro piacimento lo possono donare: sono i 87 “signori”, sono “dèi”, sono l’”assoluto”. Non è un caso che un bimbo sia solito affermare “l’ha detto la mamma, l’ha detto il babbo”. Però, crescendo, il bimbo può, con un atto cosciente e libero, trasgredire la parola dei genitori, che per lui è norma e legge dell’essere. Non si tratta più qui di semplice errore, ma di colpa, in termini morali, e di peccato, in termini teologici. La colpa è l’atto di nientificazione che spezza e distrugge il canale d’amore tra coloro che dispongono dell’essere e tu che hai bisogno dell’essere e non ne disponi a tuo piacimento. Tu non sei in grado di donare a te stesso l’essere, ma tu sei in grado, compiendo colpa, di staccarti dall’essere, cioè dalla vita. È questa della colpa, quindi, una nuova esperienza che si colloca nella linea ontologica del parto: dell’espulsione, dell’essere gettato fuori; è, in fondo, un’esperienza di morte. Infatti, come l’ignoranza non salva dalla morte (le dita nella presa di corrente), così la colpa non apre alla vita vera: Mi si può obiettare che è necessario un lavoro dei genitori perché il bimbo si renda conto di essere in stato di colpa. Nel caso, si potrebbe affermare, che i genitori, per quieto vivere o per relativismo morale, minimizzassero l’accaduto, lasciassero correre (“non è successo niente”, “non parliamone più”…), allora il bimbo non si renderebbe conto di nulla e, tranquillamente, seguiterebbe a sperimentarsi nell’essere e a pensarsi amato dai genitori (l’opposto, dunque, dell’espulsione, della morte). Ma le parole falsamente rassicuranti non possiedono la forza per annullare la potenza dell’Essere. La verità delle cose ha sempre una rivincita su chi trasgredisce perché, appunto, non tutto è bene per l’uomo e, se tutto è relativo, tutto è triviale e senza senso: compresa la vita del bimbo. Perciò, anche se i genitori, minimizzando, commettono un atto profondamente immorale, perché va contro il bene della persona, nulla toglie che la “resa dei conti” non sia annullata, ma semplicemente procrastinata: il bimbo, prima o poi, sarà costretto a riconoscere che, qualunque siano i capricci da lui appagabili, non ha in ultima istanza il potere di dare a se stesso l’amore e la vita, cioè l’Essere. L’orgoglio e la tracotanza sono sempre maschere crudeli dell’impotenza. Ma pensiamo ora a un bimbo che, commessa la colpa, viene “ri-preso” dai genitori. Anche qui, sotto il linguaggio comune, si cela una grande 88 verità. “Ri-prendere”, infatti, non significa semplicemente sgridare e punire, ma accogliere di nuovo. Mi spiego. Innanzitutto i genitori quando sgridano e puniscono riposizionano l’atto compiuto dal bimbo nel tutto dell’Essere, attribuendogli il giusto peso. Non è vero che non è successo nulla: è stata compiuta una nientificazione, più o meno grave, tu non sei il padrone dell’essere e l’essere non è interamente a tua disposizione, vi è un Altro che è signore dell’essere… Questi i concetti che vanno sotto le parole semplici “guarda cosa hai fatto!”… o simili. Ora, quando la sgridata e la punizione sono ben lontani dalla loro natura corretta, che è finalizzata al “ri-prendere”, e manifestano unicamente lo sfogo, purtroppo anche violento, che nasce dall’ira e dalla frustrazione dell’avere constatato la propria impotenza a educare, e anche quando, comunque, i genitori si arrestano nei loro atti semplicemente alla denuncia, al rimprovero, alla punizione, allora il bimbo sperimenta solo l’espulsione e la morte, come accade in alcuni terribili racconti di Dostoevskij85. Invece, quando il genitore che punisce, punisce per edificare e perciò la punizione non è nientificante, cioè non è inscritta nella logica della vendetta (“occhio per occhio, dente per dente”: poiché tu hai trasgredito, io mi rivalgo su di te, togliendoti questo o quest’altro), allora il bimbo si sente sì espulso e come in pericolo di morte, ma questo sentire è momentaneo: è una sorta di “sosta” per un necessario ripensamento, è uno strumento per rendere comprensibile la gravità dell’accaduto, ma anche, e soprattutto, per aprire a una nuova donazione di essere. Come ho già detto (vedi la Parte Prima), la verità, quando è tale, è sempre edificante, ma non vi è verità senza carità, cioè senza amore. Perciò la “parola” (dialogo, spiegazione, conforto) prevale di gran lunga sulla punizione. Infatti il bimbo (e poi il ragazzo) deve essere aiutato a comprendere che se egli con la colpa ha interrotto il canale dell’amore, i genitori sono in grado di riaprirlo. E, tuttavia, perché ciò possa avvenire, al bimbo è richiesto il pentimento. Il pentimento non è un atto 85 Cfr. Fëdor Michàjloviè Dostoevskij, I fratelli Karamàzov, Garzanti, Milano 1999. 89 moralistico (nel senso di “Oh, come sono stato cattivo!”: e tutto finisce lì), ma è un atto di conversione alla verità: è riconoscere di avere volontariamente infranto l’essere: è riconoscere che l’essere è dono. Così, al primo accenno di pentimento, i genitori concedono il “per-dono” pieno: la sovrabbondanza di una nuova donazione d’essere. In questa dinamica la sgridata e la punizione sono veramente efficaci quando sfociano in un abbraccio e in un sorriso: non velleitari, moralistici, superficiali, ma ontologicamente conformi alla natura dell’essere. Quindi dal parto alla colpa il bimbo apprende a proprie spese la differenza nell’unità. Egli è nell’essere ma non è l’essere; anzi, la sua persona è tanto dipendente dall’Essere, dal quale egli si differenzia, che senza una continua donazione d’essere (amore) egli può venire meno: morire. Ma per approfondire questo tema facciamo un passo indietro nel tempo della vita infantile. 3.9 Un gioco e la morte Sigmund Freud racconta del gioco del “bau cetti”86: la mamma o il babbo nascondono il proprio volto; il bimbo lo cerca tra l’attonito e l’atterrito; se il volto non riappare entro breve tempo, scoppia in pianto; ma quando riappare sono sorrisi e risa di gioia. In questo semplice gioco il bimbo sperimenta la morte. Gabriel Marcel, infatti, afferma che noi conosciamo la morte non nella nostra morte, ma nella scomparsa delle persone amate, poiché della mia morte non ho esperienza, mentre la morte della persona amata colpisce me87. In 86 Il genitore si nasconde o, meglio, cela il volto e dice “bau…; qui il bimbo attende: e, quando il genitore rivela di nuovo il proprio volto dice appunto “cetti!”; varieranno le parole “magiche”, ma pare sia così nel mondo. 87 G. Marcel, Présence et immortalité, Paris 1959, p. 182: «Je n’hésite pas à dire que ma vie tout court-et la vie meme de mon esprit-se sont développées sous le signe de la mort d’autrui, et là est la lointaine origine de la controverse qui devait me mettre aux prises avec Léon Brunschvicg, au Congrès Descartes en 1937: lorsqu’il me reprocha d’accorder plus d’importance à ma propre mort 90 altri termini: qui la morte è saputa come il venire meno di coloro che, veri signori dell’essere, possono con i loro atti di amore dono farmi partecipe dell’essere, al quale io, nella mia fragilità, non posso con le mie sole forze accedere: e senza essere io non sono. Perciò nella morte dell’altro, sperimentata in prima battuta, io sperimento anche, in seconda battuta, la mia mortalità. Ma questo fatto, che si ripete nel gioco o nel richiamo gridato quando il bimbo è solo, a esempio, nel suo lettino, magari al buio, non è che la prima conoscenza, il cui approfondimento sarà reso possibile da altri avvenimenti (come quello della colpa). Si rifletta ancora su questo fatto: un bimbo che è stato cresciuto in braccio al padre e alla madre, una volta divenuto adulto, è in grado di affrontare la vita con maggiore coraggio e meno paura di un suo coetaneo che non ha avuto questa fortuna. E ancora: in braccio al padre e alla madre il bimbo va avanti, senza paura, perfino in un lager… In questi momenti in lui lavorano la ragione e la libertà: non devo avere paura perché mio padre e mia madre mi hanno sempre salvato, quando avevo bisogno. Finché loro sono a mia disposizione il canale dell’amore che dà la vita è aperto; ma questo canale si chiude perfino nel semplice gioco del “bau cetti”. Così si spiega anche il motivo per cui coloro i quali hanno perso i genitori faticano più degli altri a divenire adulti. Questo perché “il principio” è una pienezza. Ciò che per primo viene sperimentato è un positivo: una pienezza adeguata a una coscienza infantile, certamente, ma pur sempre una pienezza, sebbene non con la “P” maiuscola88: l’uomo non è, come già detto, per il nulla ed errante verso il nulla. Il bimbo non pensa e non dice tutte queste cose, ovviamente, ma le vive ed esse si stampano nella sua anima e perciò, gradualmente, la que lui n’en attribuait à la sienne, je lui répondis sans hésiter: «ce qui compte, ce n’est ni ma mort, ni la votre, c’est celle de qui nous aimons». En d’autres termes, le problème, le seul problème essentiel, est posé par le conflit de l’amour et de la morte». Cfr. Homo Viator, Paris 1944, p. 205. 88 Ed è proprio perché la Pienezza (con la P maiuscola) non sono i genitori, ma è Dio, che anche chi ha avuto una infanzia travagliata può alla fine, sia pure più faticosamente, maturare pienamente come uomo: il determinismo biologico e sociale non è mai assoluto. 91 coscienza della differenza tra Essere e io acquista distinzione e profondità. Ma allora, mi chiedo, perché tanto lassismo sul problema della colpapunizione-perdono? È un fatto che i bimbi, ai quali sono stati negate queste esperienze, una volta divenuti adulti a fatica riconoscono la verità della vita. 3.10 I genitori non sono Dio: il disagio fondamentale Compiamo un altro passo avanti. Abbiamo detto che per il bimbo i genitori sono come Dio: sono i signori dell’essere: lo possiedono e ne dispongono a loro piacimento. Ebbene, sotto e sopra il cuore della madre e ancora nei primi anni di vita il bimbo non ha coscienza del tempo in senso epocale, eppure ha coscienza della storia. Per lui vi sono fatti, accadimenti, che avvengono come in una sorta di eternità; non riesce, per così dire, ancora a distinguere ciò che è, perché sta avvenendo, da ciò che è, perché è contenuto nella memoria o nella immaginazione prospettica. Per lui passato e futuro non sono propriamente un “nulla d’essere fattuale” e perciò, non sapendo declinare i tempi al passato e al futuro, vive, appunto, come in un eterno presente. Molti sono i fatti e le riflessioni che fin dai primi momenti incrinano questa convinzione, ma fra tutti ve ne è uno di capitale importanza. Sono i nonni e, in particolare, le nonne a stimolare la riflessione critica: “La tua mamma è la mia bambina”, “No!, la mia mamma è la mia mamma!”; “quando la tua mamma era piccolina…”, eccetera. Tra le tante loro importanti funzioni in una famiglia, i nonni hanno quindi anche, sia pure non in esclusiva, quella di “formare” la mente del bimbo alla concezione della storia non come semplice durata istantanea, ma come durata cronologica e, dunque, irreversibile. Non è una concezione facile; anzi, dico che occorrono anni perché il bimbo apprenda veramente questo concetto. Infatti egli deve, per così dire, “digerire” nel suo spirito che babbo e mamma sono stati piccoli e sono addirittura nati! È difficile accettarlo, perché l’assenso dato a questa verità suscita nella mente del bimbo una inquietante domanda: “Se anche loro 92 come me sono nati, anche loro hanno avuto la vita; l’hanno avuta dai nonni, ma anche i nonni sono nati…. E allora chi è il signore dell’Essere? Chi dà la vita?”. La verità contenuta nel gioco del “bau cetti” qui diventa sangue che batte nelle vene e grida la propria impotenza: se nessuno di noi è signore dell’essere, noi tutti possiamo venire meno, morire! Chi mi può salvare, dal momento che neppure coloro che mi amano sono in grado di farlo? In questa domanda sta gran parte del dramma della vita umana. Il “disagio”, del quale tanto oggi si parla anche a proposito degli adolescenti nelle scuole, non nasce innanzitutto da casi particolari, che toccano come accidenti alcune persone e non altre, ma scaturisce da questa condizione esisteziale-ontologica propria di ogni uomo. 4. La via: la pubertà e la scelta Per il bimbo l’adulto è colui che detiene le chiavi dell’essere, della verità, della vita: non in un istante, ma in lunghi anni questa certezza gradualmente crolla, anche sotto i colpi delle cocenti delusioni provocate dal comportamento degli adulti stessi. E il tempo della adolescenza (a partire dalla pubertà) si rivela come quello nel quale la dialettica tra amore-vita e morte, che è la figura esistenziale della dialettica di unità e differenza tra la persona umana e l’Essere, acquista un vigore straordinario. La ragazza e il ragazzo conoscono, non per averlo sentito dire o studiato sui libri, ma perché lo sperimentano in se stessi, cosa è la generazione e quale potenza misteriosa le sia propria. In proposito due sono le idee fondamentali che si oppongono nelle loro menti: La prima: io sono il frutto di un colpo di fortuna, del caso e della necessità, insieme; infinite, infatti, sono le combinazioni bio-genetiche e, fra tutte, eccomi qui, frutto del caso; certo che, una volta dato inizio a quel processo, non poteva nascere che il sottoscritto, proprio io, così come sono, e dunque eccomi come frutto di necessità; ma il caso, a ben vedere, è il nome che noi diamo alla nostra ignoranza delle cause che, 93 incontrandosi, determinano un evento; il caso è quindi il nome della “cieca necessità” (cieca, appunto, per noi). La seconda: si pensi di me quel che si vuole, mi accada pure qualunque cosa, ma… “io sono io!”; il mio “io” emerge sul caso e sulla necessità; c’è un valore della mia persona che non trova spiegazione nella somma dei fattori genetici, sociali, mondani; che io possa distaccarmi dai genitori e dalla società e mettermi di fronte a tutti significa che il mio io viene fuori dalla palude del quotidiano come un sottomarino che emerge dal mare; io mi staglio di fronte al mondo e agli altri come un io irriducibile: i genitori, i professori, perfino il mio/a ragazzo/a non mi capiscono (anzi, quest’ultimo/a mi ha lasciata/o), tu dominerai il mio corpo, ma non il mio io: tu puoi ferirmi e persino uccidermi, ma non puoi impossessarti del mio io: io ho il potere di nascondermi in me stesso e, persino, all’occorrenza, di mentirti. La dialettica di necessità e di libertà sta proprio nell’opposizione di queste due idee: sono una rotella appartenente al grande ingranaggio dell’universo, in ultima istanza inutile perché la gran macchina del mondo andrebbe avanti anche senza di me, oppure sono frutto di un insondabile disegno d’amore? Il riduzionismo psicologico, per il quale nella adolescenza si realizza unicamente il distacco dai genitori (“arrivo io e cambio il mondo!”), non coglie la profondità dell’avvenimento. Questa dialettica, infatti, scaturisce dal fatto che noi siamo nell’essere ma non siamo l’Essere: l’essere non dipende da noi, ci è donato ma non ci è dovuto. Eppure, lo stesso fatto, per cui l’essere all’uomo è donato in un modo così particolare, manifesta la straordinaria dignità dell’uomo stesso: infatti non si dona a un cane! Vi è quindi, tra me che ricevo l’essere, e la fonte del mio essere un rapporto che non può essere inscritto tra quelli semplicemente naturali, biologici, meccanici. Si tratta propriamente di un rapporto tra persone o, in altre parole, tra esseri spirituali o, ancora, tra due libertà: libertà fontale illimitata di colui che mi dona l’essere tanto abissalmente da costituire il mio stesso io, e mia libertà di risposta, d’accoglienza o di rifiuto. 94 In questa linea si spiegano due fatti che accadono con una loro particolare specificità nel periodo dell’adolescenza: il primo: il “bullismo” o, di contro, il “mutismo” di ragazzi e di ragazze, segni inequivocabili della ricerca del proprio io e, di conseguenza, di Dio; il secondo: coloro, che scoprono di essere nati da inseminazione artificiale o di essere stati adottati, a volte con grandi sforzi tentano di ritrovare i loro genitori “naturali”; ciò, evidentemente, non accade per mera curiosità biologica, ma si inscrive nello sforzo, comune a tutti gli uomini, di scoprire, se mai è possibile, nel padre e nella madre gli indizi che conducono alla soluzione del mistero della vita, anzi: della mia vita. Insomma, i genitori sono “sognati” come segno di Dio: di qui, quasi sempre, la cocente delusione che assale chi, per caso, ritrova i genitori naturali, perché non aggiungono nulla al mistero, già sperimentato, del proprio io emergente sul bios. Entrambe queste esperienze, pur così diverse tra loro, lavorano nella mente dell’adolescente, il quale può a esse dare due risposte: il non senso della vita, oppure, ricongiungendo il suo “essere sospeso” sul mondo (sopra parlavo di “emersione”) all’idea di dono, il nascosto disegno d’amore. Il non senso come risposta blocca ogni ulteriore indagine razionale; il disegno d’amore, invece, trova appigli nella esperienza quotidiana. Con quale grande gioia ciascuno di noi vive l’esperienza appagante dell’”accoglimento”!: tu sei accolto e amato non per quello che sai, che fai, che rendi, ma perché, semplicemente, “sei”: il tuo valore è non il fare o l’avere, ma l’essere, il “tuo essere”, cioè il tuo stesso vivere. Due brevi esempi: il primo, l’adolescente difficile che, accolto, “si scioglie”, si affida per quel che è; il secondo, l’avere di nuovo tra le braccia la persona amata scampata a un pericolo mortale… Questi due momenti dialettici, cioè il caso e il disegno d’amore, provocano un vero e proprio terremoto nella mente e nel cuore dell’adolescente, terremoto le cui conseguenze si fanno sentire per tutta la restante esistenza. Infatti,anche secondo due autori così diversi tra loro 95 come san Tommaso e Jean Paul Sartre, l’adolescenza è il tempo della “decisione pro o contro Dio”: i “signori” dell’essere non sono i genitori, gli insegnanti, gli idoli passeggeri della giovinezza, bruciati molto velocemente, e, dunque, chi è il Signore dell’essere? Devo dare una risposta: ora davvero tocca a me, ora davvero sono “chiamato per nome” e devo rispondere a chi mi chiama e pronunciare il suo nome. 96 PARTE TERZA La dialettica di uomo di bisogno e uomo di desiderio Capitolo Primo L’uomo di bisogno Nella Prima Parte di questo lavoro avevo affermato, richiamandomi a una felice espressione di Gabriel Marcel, che la realtà si offre alla nostra conoscenza sotto le forme del “problema” e del “mistero”. Ora, sulla falsariga di questa distinzione, procedo all’analisi della dialettica di uomo di bisogno e uomo di desiderio, dialettica che si rivelerà anch’essa, come già quella di identità e differenza, come via all’Assoluto. 1. Piacere e dolore: due realtà positive Il punto di partenza della mia analisi è elementare e fa perno principalmente sulla vita corporale e psichica dell’uomo, quasi fosse un semplice ente di natura. Osserviamo che nella nostra esistenza il piacere e il dolore sono stimoli sensoriali che rivelano uno stato di benessere o di malessere. Entrambi sono, secondo la definizione che ne dà san Tommaso, un «moto dell’appetito sensitivo»89, vale a dire una azione che si compie nell’uomo e che scaturisce dalla sua naturale e spontanea tendenza90 a possedere e a non perdere l’essere. Perciò il piacere e il dolore sono «passioni dell’anima»91, perché rivelano che l’uomo riceve o perde (patisce) qualcosa, che è relativo al suo bene, e perché riguardano l’uomo nell’unità della persona, in cui non vi è separazione tra la dimensione corporea-sensibile e quella spirituale92. 89 Cfr. Summa th., I-II, q. 35, a. 1; q. 59, a. 1. Appetito: da ad-petere, tendere a. 91 Cfr. Summa th., I-II, q. 35, a. 1. 92 Cfr. Summa th., I-II, q. 22, a. 1. 90 99 Ora, in quanto sono stimoli, il piacere e il dolore esistono e perciò sono entrambe realtà “positive”. Non sto facendo un discorso esistenziale o morale, ma un discorso ontologico. Così, tralasciando per ora il piacere e ponendo in primo piano il dolore, faccio notare che il dolore come stimolo rivela una perturbazione o una perdita della perfezione del soggetto ed è quindi un “dato”, un “qualcosa” ed è perciò un “positivo”: lo posso conoscere e e, soprattutto, la sua esistenza è indispensabile alla nostra autodifesa: mi permette di correre ai ripari. L’assenza di dolore in un uomo è una patologia gravissima: l’uomo che non prova dolore non può difendersi dagli agenti che attaccano la sua integrità (bruciature, ferite, eccetera). Certo, sarebbe bello poter non provare dolore perché si possiede una potenza tanto grande da vincere ogni avversità, ma questa non è la condizione umana. Per questo Tommaso scrive: «supposto un fatto rattristante o doloroso, è cosa buona che uno si rattristi e si addolori del male presente. Se infatti non si rattristasse e non si dolesse, mostrerebbe o di non sentire, o di non stimare quel fatto come ripugnante: e l’una e l’altra cosa è certamente un male. Perciò è un bene, supposta la presenza del male, che si produca la tristezza o dolore»93. 2. Il dolore e il male In base a quanto si è detto, il dolore e il male non sono la stessa realtà, perché il primo è qualcosa di positivo e il secondo è invece qualcosa di negativo. Il dolore, infatti, in quanto è uno stimolo positivo, rivela, manifesta, denuncia la mancanza o la distruzione di un bene: a esempio, la mancanza di cibo e lo scemare delle forze fisiche. Questa “mancanza” e questa “distruzione” sono ciò che noi chiamiamo un “male”. Per questo san Tommaso afferma che «causa del dolore è il male, che ripugna [...] il male, oggetto del dolore, è repulsivo, perché privazione di bene»94. Dobbiamo però subito precisare che il male è sì, come comunemente ci esprimiamo, qualcosa di negativo, ma non è una semplice “negazione”: 93 94 Summa th., I-II, q. 39, a. 1; cfr. ivi, a. 4, ad 2. Summa th., I-II, q. 35, a. 6; cfr. ivi, q. 36, a. 1; De malo, q. 1, a. 4. 100 che un sasso non sia intelligente (negazione) non è un male. Allora, propriamente parlando, il male è “privazione”, cioè toglimento e assenza di un bene dovuto a un soggetto in virtù della sua natura: nell’uomo, per esempio, le forze fisiche e il cibo per ritemprarle. Quindi con il termine “male” non indichiamo una natura esistente, positiva. Scrive Tommaso: «Bisogna necessariamente affermare che l’essere e la perfezione di qualsiasi realtà hanno la natura di bene. Perciò non è possibile che il male indi-chi un qualsiasi essere, oppure una forma o entità positiva. È inevitabile, dunque, che col termine male si indichi una carenza di bene»95. Di conseguenza posso pensare l’opposizione tra il bene e il male unicamente come quella tra il possesso e la perdita, la privazione, di una certa determinazione positiva. Infatti il male «è la stessa corruzione o privazione del bene»96. Ma, se il male è privazione, il male per se preso è nulla! La conclusione è sconcertante, ma è vera. Infatti ciò che si è perso o ciò di cui si viene privati non esiste più: anche nel linguaggio comune si dice “perdere la salute”, per esempio. Per parlare del male come privazione siamo costretti a “entificarlo”, cioè a dare a esso un’esistenza, ma questa non può essere che un’esistenza ideale; anzi, propriamente parlando, noi non possiamo farci una idea vera e propria del male, perché è nulla, bensì possiamo pensare soltanto l’idea di un ente, esistente e dunque positivo, che è privo di perfezione. Così, ad esempio, dico di avere l’idea di “buco”, ma il buco non esiste!: se tolgo ciò che “sta attorno al buco “(l’espressione è scorretta, perché non è possibile che una cosa stia attorno a ciò che non esiste), non rimane lì il buco!: tolto il cannone, non rimane il foro della canna97. 95 Summa th., I, q. 48, a.1. Summa th., I, q. 48, a. 1, ad 4. 97 In proposito san Tommaso scrive: «non ogni mancanza di bene si dice male; poiché la carenza di bene si può prendere come privazione o come negazione. Ora, l’assenza di bene, presa come negazione, non è un male, perché altrimenti si dovrebbe dire che le cose che non esistono sono cattive, e ancora che sarebbe cattiva ogni realtà per il fatto che non ha il bene di un’altra, 96 101 Perciò giustamente san Tommaso rileva che «il male non può essere assoluto o allo stato puro senza alcuna mescolanza di bene»98. Perché «la privazione del bene si fonda su qualche bene»99. Quindi «Non esiste un male che corrompa totalmente il bene; poiché almeno il soggetto in cui il male risiede è un bene»100. Faccio notare che anche San Tommaso, per esprimersi e farsi comprendere, è costretto a impiegare un linguaggio improprio: è costretto a parlare del male come se fosse un ente positivo, pur sapendo bene che non lo è. Ora, in conclusione, possiamo fissare alcuni punti fermi. Il primo: diciamo che il male esiste, ma in realtà ciò che esiste è un soggetto che è privato di un bene; così esiste l’uomo poco intelligente, perché è privo di parte dell’intelligenza, ed esiste l’uomo cattivo, cioè privo di bontà, di retti principi morali: e diciamo che questo è male. La seconda: il male non può mai agire in forza di se stesso, cioè in quanto è una privazione, ma perché è connesso ad un bene; scrive San Tommaso: «Se non ci fosse un minimo bene, non si avrebbe un ente e non potrebbe esserci un’azione»101. cosicché l’uomo sarebbe cattivo perché non ha la velocità del capriolo, o la forza del leone. Invece si chiama male la carenza di bene, intesa come privazione» (Summa th., i, q. 48, a. 3). 98 Summa th., Suppl., q. 69, a. 7, ad 9. 99 Summa th., I, q. 11, a. 2, ad 1. 100 Contra Gentes, II, p. 127. 101 Summa th., I-II, q. 18, a. 1, ad 1; «Il male agisce in virtù di un bene manchevole» (S. th., III, q. 18, a. 1, ad 1; cfr. De malo, q. 3, a. 1, ad 14). 102 Quindi chi agisce è l’uomo poco intelligente o l’uomo cattivo, ed entrambi gli uomini sono due realtà esistenti (“positive”, cioè poste, che sono lì); ed anche le loro azioni “stupide” o “malvage”, in quanto sono, sono positive, e noi diciamo che “fanno male” o “fanno il male”, nel senso che i loro atti non soltanto sono privi di perfezione (manca loro, più o meno gravemente, il bene, l’essere che fa di un atto un atto buono, perfetto), ma hanno anche per effetto la ni-entificazione, la distruzione, più o meno parziale, del bene: un atto curativo sbagliato o un atto violento (come una percossa) mi fanno male, cioè mi privano di un bene dovuto. La terza: non possiamo volere direttamente il male in sé, come privazione, perché – come detto – è nulla. Quindi noi, dicendo di volere il male, in realtà vogliamo una cosa privata di un certo bene. In altri termini: voglio il male solo in forza del bene a cui è unito, fino al mors tua, vita mea: la tua soppressione, che è un male (privazione del bene “vita”), è unita al mio successo, che è un bene (ontologicamente parlando, non certo da un punto di vista morale). Quindi possiamo tranquillamente nei discorsi quotidiani parlare di male che genera dolore, ma dobbiamo sapere che il nostro dire è improprio. Il male non è una cosa, è un “ni-ente”, non ente. Ed è proprio da questo carattere del male, quello di essere ni-ente, che scaturisce per noi il suo aspetto terrificante, perché, appunto, di fronte al nulla noi siamo impotenti: come ci è possibile fare di nuovo essere ciò che non è più? Il nostro potere si esercita infatti sempre sull’essere: posso sostituire la cosa andata distrutta con un’altra cosa, ma non posso farla tornare all’essere. Persa la casa in un incendio, per esempio, posso ricostruirla: ma per farlo non posso fondare la mia azione su ciò che non è più, ma devo avere a disposizione un nuovo “essere”, cioè un nuovo “bene”: capacità di reagire alle avversità e danaro. 103 3. Il dolore e il bisogno Prendiamo ora in considerazione la catena dolore, mancanza (privazione, male) e bisogno, cercando di comprendere come essi siano uniti e, al tempo stesso, distinti. Come detto, il dolore è lo stimolo che rivela la mancanza di un bene finito. La mancanza del bene finito è ciò che chiamiamo male ed è responsabile dell’insorgere di quello stimolo che è il dolore: il toglimento dell’acqua mette in moto lo stato di sete. Il bisogno, infine, consiste in uno stato psico-fisico anch’esso positivo, in quanto esiste e in quanto muove a denunciare e a ricercare ciò di cui si è privi (ciò di cui si ha bisogno). Il bisogno può essere considerato quindi negativo solo in senso translato, in quanto viene messo a fuoco lo stato di disagio del soggetto. Così, mentre nel dolore l’accento è posto sul soggetto che prova dolore, nel bisogno l’accento cade sull’oggetto: non tanto su quello che è stato nientificato, ma su quello che può reintegrare il bene finito distrutto. Anzi, compiendo un ulteriore passo in avanti, il bisogno consiste nella denuncia della necessità di entrare in possesso di un bene finito integrativo o sostitutivo di quello perduto. La denuncia fatta dal bisogno può essere o non essere cosciente: nell’animale non lo è, ma esso denuncia il suo bisogno con segni spesso inequivoci. Ora, l’”uomo di bisogno” è l’uomo che denuncia la mancanza di uno o più beni finiti, che ne sia cosciente oppure no. Il lattante, a esempio, è “uomo di bisogno”, ma non sa di esserlo. Infatti, quando ha sete e fame, prova dolore, sperimenta cioè la privazione, la mancanza di un bene finito (cibo e bevanda), ma non conosce i beni finiti di cui manca e non ha neppure coscienza di averne bisogno; eppure con il pianto denuncia, cioè rende noto, che egli è “uomo di bisogno”. Perciò, perché si possa affermare che vi è un “uomo di bisogno” (volgarmente: che c’è qualcuno che ha bisogno di…), è necessario che vi sia un soggetto cosciente: può essere lo stesso soggetto che prova dolore, oppure un altro che osserva (la mamma che dice “vedo che ha bisogno 104 di…”). Così il dolore sgorga quasi senza alba di coscienza, mentre il bisogno è sempre necessariamente connesso a una coscienza. 4. Scienza, tecnica, volontà e potere di fronte al dolore e al bisogno Per gli uomini che aspirano alla felicità è naturale, quando vi è dolore e bisogno, agire per riguadagnare la perfezione perduta. I loro atti mirano al “soddisfacimento” del bisogno (satis-facere: fare a sufficienza) e, di conseguenza, al toglimento o annullamento del dolore. Infatti, reintegrato il soggetto del bene necessario assente di cui ha bisogno (l’acqua per chi ha sete), viene a cessare anche il dolore che è lo stimolo che ne denunciava la mancanza. Ora, per il toglimento o annullamento del dolore e per il soddisfacimento del bisogno sono necessarie quattro condizioni: la scienza, la tecnica, la volontà d’agire e il potere (quest’ultimo, vedremo, ha due aspetti). Prima condizione: la scienza L’atto di cura, qualunque esso sia (medico, politico, ecc.), per essere agito presuppone la conoscenza del soggetto, l’uomo di bisogno, della natura del dolore, del bene finito mancante e di cui vi è bisogno, delle condizioni necessarie per reintegrare il bene mancante, del soggetto che opera il toglimento del bisogno: insomma, è indispensabile conoscere il fine e i mezzi dell’azione di cura. Questa conoscenza, quando non è immediata, frutto del senso comune e della semplice esperienza, prende il nome di “scienza”. La scienza conosce la realtà sotto la luce del “problema”.Il suo oggetto sembra essere “concreto”, ma in verità è sempre “astratto” e proprio per questo motivo è quantizzabile, categorizzabile. Sia l’uomo di bisogno, sia il dolore, sia i beni finiti che servono al toglimento del bisogno sono sempre conosciuti dalla scienza non nella loro globalità d’essere, ma solo per quell’aspetto che serve, appunto, a risolvere il problema. Così, per esempio, di un certo dolore fisico si tralasciano le ripercussioni morali e spirituali per conoscere unicamente di quale patologia sia il sintomo. È 105 questo, si badi, un modo di procedere utile e legittimo: è però necessario avere coscienza dei suoi limiti. Così, vado dal medico perché ho un dolore allo stomaco. Personalmente so in un modo molto generico che questo dolore è segno della mancanza di salute. Sta però al medico innanzitutto interpretare il dolore: di chi cosa è segno? Egli deve, come è ovvio, padroneggiare la sintomatologia, cioè la scienza dei sintomi. Ben diverso è infatti interpretare quel dolore allo stomaco come sintomo di una vita stressante o come sintomo di un tumore. All’interpretazione del dolore il medico deve poi fare seguire la prescrizione della cura, atto che non può compiere senza la conoscenza del rimedio, cioè senza la scienza dei beni finiti mancanti che, una volta resi disponibili, possono soddisfare il bisogno. E via di questo passo. Seconda condizione: la tecnica Francesco Bacone al principio del Seicento aveva affermato che «conoscere è potere». In verità, però, il sapere è solo condizione necessaria, ma non sufficiente per potere. Infatti, se l’operatore sanitario non dispone anche di una adeguata strumentazione, il suo sapere è impotente a procurare salute. Per questo la scienza del dolore e dei bisogni deve essere accompagnata da una adeguata tecnica o, meglio, tecnologia. Per tecnica intendo l’attività pratica, la costruzione e l’uso di strumenti inventati “per caso” o/e dopo ripetute osservazioni empiriche e svariati tentativi. Per tecnologia, invece, intendo l’applicazione metodica alla pratica di una scoperta scientifica: qui non si va per caso e per tentativi, ma “per progetto scientifico”. Così la tecnica sta all’agricoltura tradizionale come la tecnologia sta all’agricoltura moderna, basata sulla genetica e scienze simili. Oggi, per indagare la natura e le cause del dolore, da un lato, e per apprestare i rimedi, dall’altro, la scienza-tecnologia impiega largamente il “laboratorio”: ricrea in un ambiente artificiale (risultato di ricerca scientifica applicata alla tecnologia) le condizioni ottimali per comprendere e risolvere il “problema”. Basta, per farsene un’idea, pensare per esempio agli esami di laboratorio (del sangue, lastre, TAC, eccetera) e 106 poi ai mezzi di guarigione (interventi chirurgici, medicinali, eccetera). Scienza e tecnologia, ovviamente, non trovano applicazione soltanto in campo medico, ma in tutti quei settori che riguardano l’uomo di bisogno. Così, ad esempio, la moderna economia è impensabile senza una serie di scienze e di tecnologie specifiche. Terza condizione: il volere e il potere soggettivi Il possesso di scienza e di tecnologia è condizione necessaria ma non sufficiente per operare un atto di cura. Infatti sono indispensabili il volere positivo e l’altrettanto positivo potere dell’operatore. Conosciuto il bisogno e i relativi mezzi di cura, l’operatore può non volere operare e così l’atto di soddisfazione del bisogno e di annullamento del dolore non ha neppure inizio. Ma anche ammesso che l’operatore si sia deciso per il sì, è ancora necessario che possieda un “potere” adeguato alla situazione. Un semplice esempio: il pedagogista, che possiede le conoscenze e gli strumenti pedagogici e che ha deciso per il sì, non sempre dispone di un effettivo potere pratico: se è sprovvisto di prudenza, la virtù che presiede a tutte le virtù pratiche, nonostante le sue buone intenzioni, è impotente a compiere l’atto pedagogico e va incontro a un fallimento. Il “potere soggettivo” è quindi un habitus, cioè una sorta di seconda natura, una abilità che una persona non ritrova come un dato immediato, ma che deve costruire nel tempo. Così il potere-forza è un habitus che consegue all’esercizio fisico, e non differentemente dobbiamo pensare l’habitus del genitore, dell’insegnante, eccetera. Quarta condizione: la disponibilità dei beni finiti Un bimbo piange perché ha sete: con la scienza so che il pianto è segno di un dolore che denuncia una mancanza, la mancanza d’acqua; sempre grazie alla scienza so che il bene finito da reintegrare per soddisfare il suo bisogno è appunto l’acqua. Grazie alla tecnologia dispongo degli strumenti adeguati (recipiente, pozzo, rubinetto…). Possiedo anche i due requisiti soggettivi: sono determinato ad aiutarlo e ho tutto il potere per farlo, ma…. Nel pozzo non vi è acqua!È questo il 107 problema delle “risorse”: i beni finiti, per loro stessa essenza, possono non esistere, cioè essere disponibili. In conclusione: l’annullamento del dolore e il soddisfacimento del bisogno, anche di un singolo dolore e di un singolo bisogno, sono e non sono in nostro potere. Per questo motivo non sono rari, infatti, gli appelli alla fortuna, alla buona sorte, alla divina provvidenza. 5. Soddisfacimento reale e soddisfacimento surrettizio del bisogno L’annullamento del dolore e il soddisfacimento del bisogno possono essere reali oppure surrettizi. Sono reali quando effettivamente il bene finito, di cui il soggetto è mancante, viene reintegrato. In altri termini: l’opera di cura parte dal bisogno e termina al dolore, e non viceversa: il dolore allora, soddisfatto il bisogno, viene meno, cioè è annullato: bevuta l’acqua, cessa lo stimolo-dolore della sete. Dolore e bisogno sono invece soltanto surrettiziamente tolti e soddisfatti, quando vengono impiegati strumenti che fanno cadere il soggetto di bisogno in un inganno. Questi strumenti non forniscono il bene finito richiesto dal bisogno, o non lo forniscono in modo del tutto adeguato, ma agiscono principalmente sul dolore. Si tratta di strumenti di analgesi, in senso lato, che tolgono, meglio, inibiscono lo stimolo del dolore, ossia mettono a tacere l’allarme che permette la denuncia del bisogno: actio sequitur esse, l’azione segue all’essere, e se non c’è dolore, non vi è neppure denuncia di una mancanza di bene. L’eliminazione del dolore pone il soggetto nella condizione di non rendersi più conto di essere soggetto di bisogno, di mancare di un bene finito, a volte indispensabile per proseguire la stessa esistenza. Come si vede, qui la sequenza di cura è invertita: non dal soddisfacimento del bisogno all’annullamento del dolore, ma dal toglimento del dolore al presunto soddisfacimento del bisogno, bisogno che invece seguita a sussistere in tutta la sua realtà. Così la soluzione surrettizia del dolore-bisogno è illusione, inganno, suggestione, plagio: insomma, è falsa salvezza. Questa operazione 108 surrettizia di annichilimento del dolore è messa in atto in molti casi dagli operatori per timore di palesare la propria impotenza a risolvere un bisogno. Attenzione: non ho detto che è sempre illegittimo lenire o annullare il dolore. Illegittimo è spacciare questa analgesi del dolore come soluzione del male, come risposta al bisogno: non è né cura del male, né risposta di senso e donazione di significato all’uomo che nel bisogno manifesta una mancanza. Infatti il lenire o l’annullare il dolore in questo modo surrettizio manifesta al tempo stesso una potenza e una impotenza: si riesce a fare qualcosa in favore del soggetto di bisogno, ma non si riesce a ridonare il bene finito perduto. L’operatore che sottolinea il positivo toglimento del dolore e non denuncia la permanenza del bisogno nasconde, come detto, la paura di palesarsi impotente o, comunque, fa prevalere i propri bisogni (interessi di potere, di danaro, eccetera) su quelli del soggetto del quale dovrebbe prendersi cura. È così per i medici “tronfi” che non ammettono sconfitte; ma è così soprattutto per certe categorie di genitori e di politici. La “democrazia televisiva”, per esempio, e cioè lo spettacolo offerto quotidianamente dai politici in TV, in fondo è uno strumento di inganno: il bisogno di reale partecipazione dei cittadini non è risolto con la donazione di una “democrazia reale”, ma si ingannano le persone annichilendo appunto il loro “dolore” (disagio, frustrazione, eccetera), ingannandolo con una virtuale partecipazione: le emozioni teletrasmesse mettono a tacere lo stimolo che denuncia il bisogno. Questo plagio morale e politico mette in ultima istanza fuori gioco il soggetto, la persona, perché gli tolgono una perfezione: la capacità di sentire e provare dolore, stimolo positivo, di avvertire la mancanza di un bene; il soggetto è così menomato perché gli è tolta una potenza, cioè la capacità di denunciare un bisogno. Ora, il medico che spaccia l’analgesi come cura del male compie un’operazione illegittima e immorale. Ma il medico che pratica una terapia del dolore, sapendo e dichiarando i limiti della sua azione, non 109 compie un’operazione illegittima; anzi, in certi casi ciò che egli fa va nella giusta direzione del bene del paziente. Anche nella vita quotidiana è legittimo un certo “inganno” del dolore: così la mamma che distrae il bimbo, così il “divertimento” (etimologicamente) per l’adulto. Ma va sempre ricordato che il toglimento del dolore non equivale al soddisfacimento del bisogno. 6. Risentimento e sublimazione, disprezzo di innamorato e sacrificio Ma neppure il corretto annullamento del dolore e soddisfacimento del bisogno è in grado di eliminare, una volta per sempre, dolori e bisogni. L’uomo è infatti soggetto di infiniti bisogni. Siamo così di fronte alla reiterabilità del singolo bisogno, ma anche alla serialità infinita dei bisogni. Un singolo bisogno che, soddisfatto una… mille volte, si ripresenta comunque per tutta la vita. Siamo qui di fronte, ad esempio, ai beni finiti elementari, la cui mancanza è insostenibile dal soggetto: il cibo, l’acqua, eccetera. Ho sete e mi soddisfo, ma il bisogno di bere mi si ripresenta ben presto. Vi è quindi una ripetizione puntuale del singolo specifico bisogno e perciò il soddisfacimento del bisogno deve ripetersi in continuazione, perché continuamente ho bisogno: ieri, oggi, domani. Questi bisogni reiterati non sono solo naturali (acqua, cibo, aria, eccetera), ma anche artificiali: dal vestire all’abitare che, per l’uomo, sono atti sempre mediati dalla cultura (leggi anche “moda”). Vi è così una serialità infinita, sempre riproponentesi, dei bisogni di beni finiti. La reiterabilità e la serialità dei bisogni si presenta poi anche sotto l’aspetto dello “spostamento” e della “sublimazione” del bisogno. Lo spostamento avviene nel caso in cui, soddisfatto con un bene finito un bisogno di possesso marcato da una valenza sociale, dirigo la mia attenzione su di un altro bene finito. Ho ottenuto l’auto sognata, ora penso alla barca…, e poi…: lo spostamento si muove all’infinito, perché infiniti sono i beni finiti oggetto del mio bisogno di possesso. 110 La sublimazione si ha invece quando, non essendo stato in grado di soddisfare quel bisogno con il bene finito a esso appropriato, permanendo quel bisogno, io dirigo la mia attenzione su di un altro oggetto e mi autoinganno, più o meno consciamente, perché penso di colmare ugualmente, ottenendo quest’altro bene finito, il bisogno di cui sono animato. Si tratta, insomma, di una consolazione e non di una vera e propria soddisfazione che può verificarsi però non con i beni finiti essenziali, come l’acqua, ma soltanto con quelli non essenziali, naturali e artificiali, come diceva Freud dell’esercizio della sessualità sublimata appunto in altro. Si badi bene: la mancanza del bene finito adeguato rimane, e rimane, al fondo, anche il dolore: è stato solo ingannato e messo a tacere con un altro bene finito. Così, si dice, è la zitella che si bea del suo pappagallo e dei pavimenti lucidi…! È importante poi sottolineare che lo spostamento e, a maggior ragione, la sublimazione sono fatti necessari che avvengono non a caso, ma secondo la struttura ontologica del soggetto di bisogno e dei beni finiti. Infatti il soggetto è davvero impotente a risolvere tutti i bisogni e i beni finiti sono davvero “finiti”, cioè non sono mai in grado di colmare l’infinita gamma di bisogni umani. Ora, questo spostamento dell’oggetto di bisogno può prendere due strade opposte: quella del risentimento e quella del sacrificio. Il risentimento è uno stato spirituale che nasce dalla coscienza della propria impotenza combinata all’invidia. Ora, la coscienza dei propri limiti non ha nulla di errato o di biasimevole: consta che l’uomo non basta a se stesso. Biasimevole ed errato è invece combinare tale coscienza con l’invidia, cioè, constatato il proprio limite, non percorrere le strade ascendenti di eros. Chi le percorre, infatti, è capace di ammirazione, cioè di una felice perdita di sé nel bene che può soddisfare il proprio bisogno. Chi invece non sale la via di eros, converte l’ammirazione in invidia, cioè in una infelice affermazione di sé: pur di non rischiare il proprio io finito, che ama di amore egoistico, affidandolo al bene intravisto, afferma, autoingannandosi, l’autosufficienza del proprio io e dichiara l’inutilità del 111 bene invidiato: vede che quel bene è cosa grande, ma mentisce sminuendone la realtà, denigrandolo, lordandolo, distruggendolo (la volpe e l’uva che da matura e appetibile diventa acerba e disgustosa). Nel risentimento, dunque, la rinuncia al bene finito che è oggetto di bisogno è estorta al soggetto, perché il soggetto è impotente e non può raggiungere il bene voluto con le sue sole forze e non si affida ad altri. In altre parole, il soggetto di bisogno è vinto dal risentimento, che egli stesso crea, ed è, alla fine, più povero e indigente di prima: dichiarando il bene finito o, addirittura, il mondo dei beni finiti come inutili, si rinserra nel suo rinsecchito io, aperto sul nulla. Invece, quando il soggetto di bisogno, posto di fronte alla scelta tra due beni finiti oppure, saputa la propria attuale impotenza a ottenere un determinato bene finito, compie la rinuncia in modo cosciente e volontario, compie un sacrificio: realizza la perdita di un bene finito a favore di un bene maggiore. Racconta Boccaccio: «Federigo degli Alberighi ama e non è amato, e in cortesia spendendo si consuma, e rimangli un sol falcone, il quale, non avendo altro, dà a mangiare alla sua donna venutagli a casa; la qual ciò sappiendo, mutata d’animo, il prende per marito e fàllo ricco»102. Il falcone, il bene finito, non è dichiarato nulla, non viene lordato, ma viene appunto sacrificato (distrutto), ma in vista di un bene maggiore. Per quanto sofferenza vi sia in tutto ciò, è positiva perché innalza sulla strada di eros. Si tratta, per dirla con Jacques Maritain, di un «disprezzo da innamorato»103. Perciò il “disprezzo del mondo”, che viene attribuito ai cristiani, non nasce dal risentimento, ma dallo spirito di sacrificio: è un disprezzo di chi, pur vedendo che tutte le cose sono buone, liberamente vi rinuncia in vista di un bene maggiore, anzi del Bene sommo. E, in realtà, che merito ci sarebbe a rinunciare a ciò che si disprezza? Non diventerà mai santo colui che non è capace di ammirazione per le cose belle e non sente lo struggente bisogno delle cose buone. 102 103 Decamerone, Quinta giornata, Novella nona. J. Maritain, Il contadino della Garonna, Morcelliana, Brescia 1980, p. 72. 112 In conclusione: è impossibile vivere senza continuamente scegliere tra gli innumerevoli bisogni da soddisfare e gli altrettanto innumerevoli beni finiti che sono in grado di colmare il bisogno e di togliere il dolore. Scegliere però significa “decidere” e decidere significa letteralmente “tagliare”, “fare cadere”: se scelgo A, taglio B, che pure è un bene. Per questo la scelta è sempre il luogo del sorriso e del pianto. Ma un conto è la via della sublimazione che nasce dal risentimento: si cerca altro per impotenza a raggiungere l’oggetto principale per la soddisfazione del bisogno. E un conto è la rinuncia volontaria, il sacrificio conseguente al disprezzo di innamorato: io non mentisco a me stesso e non infango il mondo dei beni finiti; io accetto d’essere uomo di bisogno, indigente e impotente. 7. Finitudine dell’uomo di bisogno Bene finito: soddisfazione finita (limitata). Questo breve aforisma sintetizza il fatto che ogni soddisfacimento di un bisogno (o di più bisogni) non è mai in grado di procurare un soddisfacimento pieno, ma sempre e solo momentaneo e circoscritto alla natura del bene finito: quel bicchiere d’acqua toglie qui e ora questa sete, non toglie né tutta la sete né la fame o altri bisogni. Uomo di bisogno: finitudine essenziale di ogni uomo. Quest’altro breve aforisma rivela invece che ogni uomo, qualunque sia il suo bisogno, proprio perché è uomo di bisogno è finito, vale a dire sempre mancante; perciò per l’uomo di bisogno l’”avere” è condizione dell’”essere”: se non ho, neppure sono. Per essere, infatti, ho bisogno innanzitutto di beni naturali elementari, quali l’aria, l’acqua, il cibo. E il fatto che senza di essi non sono rivela che non posso vivere senza e al di fuori della natura (ciò, almeno, secondo una considerazione fenomenologica). Questa condizione di finitudine, infine, è universale: non vi è alcuna categoria umana che sia esclusa. Cambiano i bisogni, certamente, ma sono “uomo di bisogno” sia il cittadino, lo studente e il malato, sia l’amministratore, il professore e il medico. 113 Quindi una corretta antropologia in primo luogo pone in luce l’universalità della condizione umana: tutti gli uomini sono indigenti e, per così dire, tutti sono pareggiati dal bisogno; in secondo luogo induce a riconoscere i propri limiti e suggerisce l’umiltà come virtù positiva e costruttiva. Infatti è pur vero che il soddisfacimento dei bisogni è sempre limitato nel tempo e nello spazio e non è in grado di procurare la felicità perfetta (vedi le prime pagine di questo lavoro), ma è altrettanto vero che nessun uomo può sottrarsi al compito di soddisfare ripetutamente anche i bisogni più elementari: ne va della sua vita. Questa verità fa piazza pulita di molti falsi spiritualismi: è vero che ciascun uomo è fatto per grandi cose (il cristianesimo dice per la vita eterna), ma è anche vero che qui e ora deve mangiare e bere. Così madre Teresa di Calcutta quando asciugava le piaghe di un moribondo dava soddisfazione a un suo contingentissimo bisogno, pur sapendo che di lì a poco sarebbe morto e pur conoscendo il suo più profondo desiderio: riposare felicemente in Dio. 114 Capitolo Secondo L’uomo di desiderio 1. Il desiderio vive nel bisogno e lo trascende Ma l’uomo di bisogno non è tutto l’uomo. Non “accanto”, ma “in” lui esiste infatti l’”uomo di desiderio”. Quando, la sera, un bimbo, dopo essersi preparato per andare a letto, generalmente beve un poco d’acqua, poi si infila sotto le coperte, ascolta una storia, recita una preghiera…: e questo, di norma, con la mamma o il babbo o con entrambi. Poi… bacio della buona notte, e poi…, di nuovo: “ho sete, mi dai da bere!?!”. Analogo il comportamento di un piccolo studente che ha un astuccio di penne e matite ben fornito, ma chiede in prestito al compagno una penna e una matita simile, se non addirittura uguale, a quelle che possiede. E non diverso il comportamento degli adulti che, insaziabili, cercano nelle cose quella felicità che, spesso, con il passare degli anni, vedono allontanarsi e sfumare. Perché il bimbo chiede di nuovo acqua? È evidente che non ha di nuovo sete e quindi non chiede acqua “sotto la forma del bisogno”. Egli non chiede acqua per avere semplice “acqua fisica”, ma per avere con l’acqua fisica (in essa e mediante essa) un conforto e l’assicurazione che il suo sonno, piccola morte notturna, non sarà senza ritorno perché, bevendo l’acqua che gli viene data da chi lo ama, beve la “compagnia”, cioè la certezza che chi lo ama resta con lui e lo conserva nell’essere. 115 Il bimbo, quindi, mentre palesa il limitato bisogno di un bene finito materiale, rivela di volere in esso ben più di quello che è per natura: vuole un “viatico” che gli renda salva la vita e vuole ciò che nell’acqua è simboleggiato: per lui l’acqua che disseta è l’acqua che dà la vita: Ebbene, io chiamo “desiderio” questo “volere altro”. Il desiderio è quindi il nostro tendere all’Essere e alla piena felicità. Il desiderio non è “accanto” alla serie infinita dei bisogni. Il desiderio passa nel singolo bisogno e nella serie infinita dei bisogni; è, per così dire, spirito che si incarna nel materiale e al tempo stesso lo trascende: va “oltre”. 2. Ut res et ut signa: come cosa e come segno Così, in analogia a quanto detto circa l’interconnessione tra problema e mistero, anche i beni finiti (materiali o spirituali che siano: acqua e amicizia, ad esempio) possono contemporaneamente venire considerati come semplici “cose” (res) e come “segni” (signa) o simboli. Come “cose” sono quel che per natura sono, sono oggetto di scienza e di tecnica e, secondo i limiti della loro essenza, soddisfano i bisogni. Come “segni”, pur non perdendo la loro essenza naturale o artificiale, indicano altro da sé: sono indizio o, meglio, segni di Dio Si noti: non ho ancora detto che l’uomo conosca “chi sia” Dio, questo “altro” rispetto ai beni finiti: anzi, a rigore dovremmo chiamarlo Assoluto o Infinito. Ho semplicemente detto che ogni uomo è contemporaneamente “uomo di bisogno” e “uomo di desiderio”: nel e tramite il bene finito desidera l’Infinito, l’Assoluto. Abbiamo una prova sperimentale di questa condizione umana nell’insaziabilità della conoscenza e del suo continuo progredire, nell’insaziabilità del volere che non si placa con ciò che già è posseduto e, infine, nella tempesta esistenziale che non si acquieta neppure quando l’uomo vive nell’opulenza. Questo è il desiderio come sete di infinito. 116 3. Per natura l’uomo trascende la natura Alcuni antropologi sostengono che l’uomo, a differenza di tutti gli animali, non è determinato dall’ambiente in cui vive, ma lo trascende104. Molti filosofi, poi, affermano che l’uomo esiste nella tensione tra l’essere e il dover-essere: io non sono ancora quel che io devo essere. Si può allora affermare che la natura dell’uomo consista proprio nel fatto che egli non sia semplicemente un essere naturale o, detto altrimenti, l’uomo, in virtù della propria natura, trascende la natura e si apre al mondo dello spirito, ossia “per natura l’uomo fa cultura”, cioè vive in modo non immediatisticamente naturale se stesso e il mondo. Per l’uomo non esiste nulla di “neutro”, di fissato una volta per sempre, ma tutto è da lui sottoposto alla logica della donazione di senso. Non dico che non esista un “dato naturale”, dico che questo dato è dall’uomo sempre culturalmente interpretato come segno (e non tutte le letture sono equivalenti perché quelle che contraddicono il dato sono errate). Così, ad esempio, è per la corporeità: è indubbio che vi sia una oggettività del bios corporeo, ma il corpo è anche un “vissuto”, ossia la determinazione bio-fisiologica è sempre “piegata” dall’uomo mediante la cultura. Per questo motivo la corporeità è un vissuto caricato di valori diversi da un buddista e da un cristiano: per il primo è limite e fonte di dolore, per il secondo è dono prezioso di Dio; per il primo non merita la soddisfazione dei bisogni,per il secondo è sempre degno di cure. 4. I segni del desiderio La dialettica di cosa-segno, bisogno-desiderio è rinvenibile in certi fondamentali aspetti del vivere umano. Eccone alcuni: – il matrimonio che, in tutte le culture, sia pure in modi diversi, sancisce e investe di senso il vincolo tra uomo e donna che è alla base della stessa esistenza della famiglia e della società; 104 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und Stellung in der Welt, Frankfurt 1966. 117 – la nascita che è un fatto naturale, ma che viene accompagnata da una iniziazione religiosa e sociale del neonato (l’imposizione del nome e il suo riconoscimento come membro della comunità); – la morte che è sempre un fatto naturale, ma che riceve due opposte donazioni di senso: in una cultura religiosa è vista come transito verso l’al-di-là, in una cultura ateista è considerata come fatto scomodo da rimuovere per non turbare l’al-di-qua; – il mangiare che è un bisogno naturale trasformato in cultura del cibo e della tavola, perché il mangiare umano non è mai un semplice nutrimento del corpo, ma è anche un alludere ad altro: è “cosa” e possiede una sua materialità di cibo e di tavola e possiede però anche la natura di “segno”, cioè una sua intenzionalità; infatti il cibo è mezzo di nutrimento fisico e spirituale del corpo e dell’anima (per noi bere, ad esempio, il vino che condensa in sé il lavoro di generazioni), e la tavola, che è strumento-cosa che rende possibile il cibarsi, diventa “altare” per rendimento di grazie a Dio e per scambio di umanità: com-pagni sono coloro che si cibano del medesimo pane; la cultura della tavola rivela l’uomo (religioso o ateo); – il vestire che non è solo risposta all’assalto del clima, ma anche strumento significante di relazione interumana, perché comunica la persona e non la semplice immediatezza del corpo; infatti l’abito celando il corpo rivela lo spirito: non un semplice nascondimento fisico (l’abito può sempre essere tolto), ma un nascondimento intenzionale: maschera l’immediato per rivelare ciò che immediatamente non è visibile, cioè lo spirito di una persona (qui una cosa materiale, l’abito, indica uno spirito, l’io); l’abito è dunque un velo che rivela ciò che non è detto immediatamente nella nudità del corpo: lo schiavo è nudo perché è “tutto lì” nella sua immediatezza naturale (non differentemente dagli animali), mentre l’uomo libero e soprattutto il potente sono vestiti, e i loro abiti indicano la loro dignità che è ben più alta della loro corporeità (così pensavano gli antichi, e noi non molto differentemente da loro, almeno in certi casi); perciò da questo punto di vista “l’abito fa il monaco”, perché velando rivela la persona; 118 – l’abitare che investe il bisogno naturale del riparo e lo trasforma in desiderio di “casa”, cioè di amore orizzontale e verticale tra gli uomini e Dio: il riparo semisferico dei primitivi (quello in rami e frasche degli Indios amazzonici, quello in ghiaccio degli Eschimesi), che nella sua forma riproduce la semisfera celeste e diventa casa come piccolo cosmo che ospita quel microcosmo che è l’uomo; l’abitazione a doppio spiovente (archetipo indoeuropeo assieme al cavallo) che non è solo efficace riparo contro la pioggia e la neve, ma anche casa come protezione e benedizione: le due mani tese sopra il capo della persona amata; l’abitazione cubica dei popoli mediterranei che nella sua forma dice semplicità e solidità e resistenza alle forze del destino (“tetragono a colpi di ventura”). 5. La sete natural che mai non sazia… Nello sposarsi, nel nascere, nel morire, nel mangiare, nel vestire e, infine, nell’abitare noi uomini non facciamo mai nulla di semplicemente naturale, non tentiamo mai di soddisfare dei semplici bisogni, ma ci sforziamo anche di appagare il desiderio di Infinito, quel desiderio di pienezza che ci sembrava realizzato (ma non era vero) sotto e sopra il cuore della madre. Dico “appagare” e non più “soddisfare”, perché il bisogno viene soddisfatto, ma il desiderio deve essere appagato. Infatti non si tratta più di “dare abbastanza”, ma di “dare la pace” (pacare), cioè di rendere perfetto l’uomo in modo che il suo desiderio sia colmo e la sua felicità piena. Così la dialettica di bisogno e di desiderio si rivela come “angelo del Dio”: inquieta l’uomo e non lo lascia mai tranquillo, finché non abbia trovato il vero riposo. Così poetava Dante, riprendendo l’episodio del colloquio tra Gesù e la donna di Samaria presso il pozzo di Giacobbe: La sete natural che mai non sazia se non con l’acqua onde la femminetta samaritana domandò la grazia, mi travagliava, e pungeami la fretta 119 per la ‘mpacciata via dietro al mio duca, e condoleami a la giusta vendetta105. L’uomo ha sete d’acqua, ma nella sua sete naturale vive la sua sete d’Infinito ed il travaglio della sete, che spinge a camminare veloci lungo la difficile strada dell’esistenza, può trovare ristoro – per dirla con termini nostri – non con scienza e tecnologia, ma “per grazia”, cioè per dono di Dio. 6. Desiderio e sofferenza Come detto, l’uomo, in quanto “uomo di bisogno”, è misera cosa, perché per esistere ha continuamente bisogno di avere beni finiti. Abbiamo però anche visto che ogni bene finito è, al tempo stesso, “cosa” e “segno”, cioè è anche il viatico per un “oltre”, un “al-di-là”, è angelo che annuncia la pienezza, la felicità, l’amore che supera e sana tutte le debolezze. Ma anche in questo modo l’uomo, in quanto “uomo di desiderio”, si rivela misero perché, divenendo cosciente che la sua dimora pacificante non è l’immediato (“sotto e sopra il cuore” e, a partire da lì, tutti gli ambienti che può abitare durante la sua esistenza), ma è l’Assoluto, l’Infinito, è costretto a constatare di non possedere la ragione stessa della sua vita: l’alfa e l’omega per cui è e deve essere (in termini filosofici la “causa efficiente” e la “causa finale” del suo stesso “io”). Non stupisce allora che il desiderio, al pari e più del bisogno, è all’origine della sofferenza umana, sofferenza che vive in ogni dolore e che infinitamente lo oltrepassa, apparendo inspiegabile con ragioni finite. Infatti la spiegazione ultima dell’esserci dell’esistenza umana è l’esistenza di Dio, dell’Assoluto, in questo senso preciso: l’uomo soffre perché, rotto l’incantesimo dell’unità primigenia ma parziale sperimentata sotto-sopra il cuore, non vive nella pienezza dell’unità e dell’Essere. Non solo: la sofferenza è data anche dalla contraddizione che scaturisce dall’impatto tra la presunzione che Dio si chini sull’uomo e lo 105 Purg., XXI, 1-6. 120 ami e lo salvi (cfr. nella prima parte la speranza platonica in una «divina rivelazione») e la constatazione che ciò non sembra proprio avvenire. Se così non fosse – se non vi fosse Dio o se vi fosse certezza che, pur esistendo, egli non può o non vuole aiutare gli uomini – non sarebbe giustificata l’esistenza stessa dell’uomo di desiderio, di quest’uomo che vive nell’attesa di Dio (cfr. nella prima parte il brano di Kafka) e staremmo, contenti o rassegnati, nel nostro parziale essere (prigionieri dell’ambiente, come gli animali). Insomma, avrebbe ragione Pindaro: «anima non ti affannare per l’eterno, ma sperimenta tutte le vie del possibile». Faccio infine notare che questa dinamica dell’uomo di desiderio avviene sotto la luce della coscienza, per cui vi deve essere una qualche conoscenza di Dio: nihil volitum nisi cognitum, nulla può essere voluto se non in quanto è conosciuto. Non dico una conoscenza determinata, certo, ma almeno la conoscenza dell’esistenza dell’Assoluto come luogo della mia pace. Testimonianze fattuali in merito sono innumerevoli. Basti pensare a come, nelle più diverse culture, si parli del porto finale, al quale approda l’esistenza umana, come la “casa del padre”. 121 Capitolo Terzo L’autoerotismo e l’eteroerotismo La risposta all’uomo sofferente, che è insieme e inscindibilmente uomo di bisogno e uomo di desiderio, può prendere due strade: la prima è la credente, che si fonda sull’affidamento nella fede, e la seconda è l’atea che nasce dallo scandalo e dal rifiuto di Dio che, pare, non toglie il male. A queste due strade corrispondono due fondamentali proposte pratiche di soluzione che io definisco eteroerotica e autoerotica. In queste definizioni emerge la relazione fondamentale che vi è tra l’amore (Fichte), la ricerca della felicità (sant’Agostino), da una parte, e il male, il dolore e la sofferenza, dall’altra 106. 1. L’autoerotismo Prendo le mosse dalla via atea, la quale, a ben vedere, si divide in due cammini paralleli ma distinti. Infatti entrambi sorgono da questa considerazione: il mondo è senza Dio ed è governato dal caso e dunque, in ultima istanza, dalla necessità, perché «a chi la tocca, la tocca», per via di un destino assurdo e cieco e, a ben vedere, necessario, appunto. Al caso, infatti, non si sfugge e, soprattutto, nel mondo regolato dalla necessità del caso, che è senza Dio, non vi è nessuno a cui chiedere conto di ciò che mi tocca. Questi due cammini però divergono, perché il primo è tragicocostruttivo e consiste nel tentativo, tanto vigoroso quanto inefficace, di operare un’autosalvazione dal male, mentre il secondo, meno superficiale e più riflesso, è tragico-distruttivo perché rifiuta in blocco l’esistenza (dalla rassegnazione al suicidio, al nichilismo) 106 Ho già espresso in parte queste idee nel mio Salute e salvezza dell’uomo: il male e la sofferenza, una sfida per la ragione e per la fede, in AA.VV., Il dolore e la Medicina, alla ricerca di senso e di cure, Casa Editrice Fiorentina, Firenze 2005, pp. 157-177. 123 Ora, nella linea atea l’eros, l’amore come desiderio bruciante di perfezione e di felicità, non si ammette che venga soddisfatto da un Altro, ma si ritiene che debba essere auto-soddisfatto dall’uomo stesso. Per questo parlo di autoerotismo: Perché ciò abbia successo, occorre che il mistero sia ridotto a semplice problema. Se vi è ignoranza, essa è solo contingente e provvisoria. Infatti nel motto «La verità vi farà liberi»107 per «verità» si intende quella prodotta dalla mente umana. Si tratta della «gnosi», la conoscenza umana intesa come arma vincente, sia sul piano teorico sia su quello pratico: «conoscere è potere» (Francesco Bacone). Perciò… pazienza e tempo: se l’uomo non ha ancora elaborato l’equazione perfetta con la quale estendere il proprio dominio sulla Terra e su se stesso, pazienza e tempo: «Dio - secondo un’espressione ironica e critica, molto penetrante, di Edmund Husserl - è l’uomo infinitamente lontano»108: anche se ora non è manifesto, saremo dio, necessariamente, sicuramente, un domani. In questa ottica, però, nella storia dell’umanità, e specialmente nel «mondo occidentale», si è verificata una schizofrenia antropologica: l’uomo è stato diviso in due, anima (spirito) e corpo (bios, psiche) e ora si tenta di salvare la prima, abbandonando l’altro, ora si tenta di salvare il secondo, tralasciando la prima (o dichiarandone la non esistenza). Così (e partiamo dall’approccio più antico) vi è un intervento pneumatologico, spiritualistico, platonico-buddistico (semplificando e mettendo insieme sistemi di pensiero molto diversi), in cui si abbadona il corpo al nulla, ma si salva l’anima, mediante una ascesi, una terapia dello spirito ben autocondodda. Vi è poi, soprattutto (lo ripeto) nel mondo occidentale, nella nostra società moderna, di massa, tecnologica, consumistica, il tentativo di salvare il soma e la psiche, ma non lo spirito. Si tratta di un progetto scientifico-tecnologico integrale che, secondo le intenzioni dei suoi autori, dovrebbe sconfiggere definitivamente il male (politico, economico, morale, fisico). Di qui le utopie della società perfetta (Marx, 107 Gv., 8, 32. E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Garzanti, Milano 1961, P. 93. 108 124 ma non solo), e della salute perfetta. Cosa vi è di meglio che trasferire il concetto di durata, proprio della fisica moderna, in medicina e operare l’infinitizzazione dell’esistenza presente e l’eternità del finitissimo corpo attuale? Lo pensava già a fine Ottocento Claude Bernard109, il padre della medicina sperimentale: la morte sarà sconfitta; lo pensano molti tra i padri del progetto «genoma»; lo ritengono possibile i sostenitori dei trapianti a oltranza (magari effettuati grazie al proprio clone); è la teoria che sostiene il consumismo (consumismo = appropriarsi di mezzi tecnici sempre più avanzati), consumismo salutista in particolare. La malattia e la morte, in questa ottica, sono solo incidenti di percorso: verrà il giorno in cui l’uomo finito sarà eterno! Ma finora questi tentativi hanno dato luogo a un duplice fallimento: al riduzionismo antropologico (non ci si cura che di una parte dell’uomo) e all’occultazione della sofferenza e all’emarginazione del sofferente e alla rimozione degli innumerevoli morti (accidentali, forse, per la politica e per la medicina, ma pur sempre morti). Ma se anche l’uomo riuscisse, con le sue sole forze, a costruire un mondo in cui la felicità è assicurata per ogni uomo e il dolore è debellato, chi sarebbe comunque in grado di rendere ragione del dolore passato, delle vite perse nel tentativo di perseguire questa “armonia finale immanente”? Nei Fratelli Karamàzov di Dostoevskij persino il Grande Inquisitore (colui che si oppone a Gesù Cristo) riconosce che «la nostra opera è soltanto agli inizi […] dovremo aspettare a lungo perché sia completata, e la terra ha ancora molte sofferenze da patire»110. Perché si dovrebbero legittimare tutte queste sofferenze? Solo perché un giorno si realizzerà il paradiso in Terra? L’utopia laicizzata di Isaia? E l’assurdità giunge sino all’aborto e all’eutanasia attiva: l’uomo è signore della vita e della morte: dispone della vita altrui e della propria, di quest’ultima, se non nel suo nascere, nel suo perdurare. 109 C. Bernard (Saint Juilien 1813-Parigi 1878), Introduzione allo studio della medicina sperimentale, Paris 1865, Milano 1975; Id, La scienza sperimentale, Paris 1878. 110 Fëdor Michàjloviè Dostoevskij, I fratelli Karamàzov, Garzanti, Milano 1999, p. 357. 125 A quest’ybris prometeica, che riduce lo spessore di mistero dell’uomo e l’ampiezza della sua perfezione e felicità, io antepongo e preferisco come più umanamente toccante e vero lo scetticismo tragico di Ivan Karamazov: «io dichiaro in anticipo che la verità tutta non vale un prezzo così alto [la sofferenza, soprattutto dei bambini]. Hanno fissato un prezzo troppo alto per l’armonia; non possiamo permetterci di pagare tanto per accedervi. Pertanto mi affretto a restituire il biglietto d’entrata. E se sono un uomo onesto, sono tenuto a farlo al più presto. E lo sto facendo. Non che non accetti Dio, […] gli sto solo restituendo, con la massima deferenza, il suo biglietto»111. 2. Un’eresia cristiana: il riduzionismo antropologico e lo scientismo nella cultura occidentale L’apparato scientifico e tecnico, che permette la conoscenza e il trattamento dell’uomo di bisogno, è è frutto di un processo secolare ed è, in modo particolare, tipico della cultura occidentale. Non tutte le culture, infatti, prestano attenzione al dolore e al bisogno nella chiave sopra descritta. Il buddismo, ad esempio, si costruisce come tecnica spirituale che ha come fine la liberazione definitiva dal dolore, ma non si cura di apprestare rimedi per i bisogni che possono essere soddisfatti con la donazione di beni finiti. In Occidente, invece, si sono sviluppate vere e proprie culture dei singoli bisogni: economie, politiche, pedagogie, psicologie, cure mediche in generale, istituzioni e strutture, laboratori, eccetera. Questo è accaduto perché il cristianesimo, che nei secoli ha plasmato l’Occidente, ha offerto l’impianto teorico per l’elaborazione della cultura dell’uomo come soggetto di bisogno. Infatti il Dio creatore e redentore dà senso a ogni cosa, traendola dall’insignificanza e dal nulla: l’intero universo è creatura amata e, in modo particolare, neppure un capello dell’uomo andrà perduto112. 111 112 Fëdor M. Dostoevskij, I fratelli Karamàzov, cit., pp. 339-340. Lc., 21, 18. 126 Ebbene, è in casa cristiana che si verifica la deificazione atea dell’uomo in terra. In base a un progetto culturale ben definito, a partire da alcuni settori dell’Illuminismo, si effettua una “riduzione antropologica” dell’uomo di desiderio a semplice uomo di bisogno. Tolta l’apertura all’Infinito, l’uomo è dunque immanentizzato in modo individualistico (Stirner, Nietzsche, Sartre), oppure in modo massificante (Compte, Marx). In entrambi i casi l’uomo è autore di se stesso (homo faber sui ipsius, self made man, ossia autoctisi: autogenerazione), secondo i canoni del relativismo soggettivistico o del totalitarismo sociale, che poggiano su di un’etica non dell’essere (metafisicamente fondata), ma del fare (praticamente fondata: la questione non è più se è vero, ma se siamo in grado di farlo, e ciò che possiamo fare è etico e quindi dobbiamo farlo. Di qui l’enfasi posta sulla scienza e sulla tecnologia come strumenti di salvezza, che surrogano la virtù e la fede. Ora, lo scentismo è in fondo una vera e propria “eresia cristiana”: eresia, letteralmente, significa separare una parte dal tutto e assumerla in modo surrettizio come se fosse l’intero. La “parte” assunta è qui quella cura tipicamente cristiana per l’uomo di bisogno, che ha fame e che ha sete, che è nudo, malato, prigioniero…, al quale va prestato soccorso, perché «ama il prossimo tuo come te stesso»113. Il “tutto” tralasciato comprende l’uomo di desiderio. L’eresia si manifesta inoltre nella sostituzione dell’uomo a Dio nel compito di condurre a termine l’opera globale di salvezza. Perciò una corretta critica di questa posizione culturale non consiste nel rifiutarla in blocco. Se si vuole, infatti, rimanere fedeli alle emergenze veritative, frutto delle analisi sopra condotte, bisogna riconoscere l’alto valore che essa ha, nel momento in cui mette a punto, con la scienza e con la tecnica, una cura dell’uomo di bisogno. L’errore non sta dunque nella scienza e nella tecnologia, ma nella loro erezione surrettizia a tutto salvifico e nella conseguente falsa eliminazione di quella dimensione umana, pur da salvare, che va sotto il nome di uomo di desiderio. 113 Mt., 22,29. 127 3. L’eteroerotismo Veniamo ora alla seconda risposta pratica, quella eteroerotica. In essa si pone per certo che l’eros (il desiderio di amore, di perfezione, di felicità) non trova in me, nell’uomo, il suo fine, il suo significato e nemmeno lo strumento, l’autore del suo appagamento; lo trova in un Altro: il Dio di cui parlano le grandi religioni dell’umanità. Oggi però alcuni sostengono che l’opzione religiosa sia irrazionale, perché chi crede non si cura di rispondere alle obiezione atee e, in ultima istanza, non prova neppure a difendere le cosiddette verità della sua fede. In fondo, dunque, ai credenti interessa trovare nella religione un farmaco che dia la forza di vivere: che sia efficace, salutare o meno, non importa; insomma, la religione è giudicata dagli atei ed è vissuta dai credenti come un «dado di senso per il brodo dell’esistenza»114. L’obiezione in realtà è vecchia; senza retrocedere troppo nel tempo, è sufficiente guardare all’Ottocento, a Schopenhauer che definiva la religione un «contravveleno alla certezza della morte»115, a Marx per il quale era «oppio dei popoli»116 e, infine, a Nietzsche che ne parla come di una «forma di sottomissione al male»117. 114 Cfr. Paolo Flores d’Arcais, Dio esiste?, in «Micromega» 2/2000, pp. 17-40; ecco la cit. completa a p. 28: «[…] la religione non ritiene più necessario replicare alle obiezioni scettiche e atee contro le verità della sua fede. Con ciò smette però di custodirle come verità (anche) di ragione, benché tali continui a proclamarle. Se si può permettere questa mossa di noncuranza, tuttavia, è solo perché il contenuto di verità di qualsiasi convinzione» o «concezione» o «fede» sembra oggi non interessare più l’uomo medio che pure le pratica e fruisce. E meno che mai sembra interessare la cultura postmoderna (che in realtà è piuttosto la cultura della «modernità elusa, dell’illuminismo rimosso, del disincanto tradito, della cittadinanza eclissata) attenta soprattutto alla capacità delle fedi di conferire senso alla vita. Al “dare sapore» (di contro a ogni vero sapere). Le fedi come dado di senso per il brodo dell’esistenza». 115 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Laterza, Bari 1968, I par. p. 54; II, 41. 116 Cfr. K. Marx, Critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, in K. Marx-F. Engels, Opere complete, III, a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma 1976-191, p. 91: per Marx la religione è “l’espressione di reale bisogno e la protesta contro il reale bisogno”; essa esprime cioè “il sospiro della creatura oppressa”, è “il cuore di un mondo senza cuore”, “lo spirito di una situazione priva di spirito”, “il fondamento universale di consolazione e 128 In questo gli atei hanno ragione: se la fede in Gesù Cristo unico vero Dio e unico vero redentore dell’umanità, consistesse solo in un semplice sentimento, un contravveleno oppiaceo al mal di vivere, essa sarebbe inutile, anzi dannosa: aggrapparsi a un’ancora di salvezza fradicia non strappa alla morte: affonderemmo assieme ad essa. In questo però hanno torto: il cristianesimo è sempre stato pensato e vissuto dagli autentici credenti come la religione vera, la religione del Dio d’amore, del Dio che dà la felicità. Esibisco ora, sia pure in modo estremamente sintetico, alcuni motivi di ragionevolezza della fede cristiana. Il primo motivo è frutto di una onestà intellettuale. Se si ammette che l’ultima parola sulla Terra spetta alla morte118, non vi sono che due strade da percorrere: 1) quella dell’ostinazione autoerotica che, esclusa l’utopia del «Dio è l’uomo infinitamente lontano» come irreale e irrazionale, termina ineluttabilmente nel nichilismo: non c’è verità, tutto è assurdo, il domani è già nell’oggi, ecc.: ma il male senza possibilità di redenzione è orrendo e se si pensa veramente che le cose stiano così, non resta che la pazzia o il suicidio119; 2) quella dell’umile affidamento eteroerotico che giustificazione”. Ma la liberazione che la religione dà al bisogno è falsa: funziona come una sostanza stupefacente: illude, non salva, anzi peggiora la condizione esistenziale: è «oppio dei popoli». 117 F. Nietzsche, Frammento n. 154. Dell’autunno 1887, in Id., Il caso Wagner Crepuscolo degli idoli. L‘Anticristo. Scelta di frammenti postumi 1887-1888, a cura di G. Colli e M. Montinari, Mondadori, Milano 1975, p. 289, dove tra. 118 Scrive Romano Guardini: «Siamo «vulnerabili» alla « spietatezza stessa dell’esistenza. Quel che ferisce è per l’appunto quel che nella vita vi è d’ineluttabile; la sofferenza, diffusa dovunque; la sofferenza degli inermi e dei deboli; la sofferenza degli animali, della creatura muta ... Il fatto che non vi si può cambiar nulla, che non si può toglierla di mezzo. Così è, e così sarà. E qui che sta la gravità della cosa. Feriscono le miserie dell’esistenza, ferisce il fatto che sia molto spesso tanto brutta, così piatta ...». (Ritratto della malinconia, Morcelliana, Brescia 1993, p. 37). 119 Aristotele affermava che vi è una grande differenza tra il dire e il pensare (posso tranquillamente dire di essere un elefante, ma se lo pensassi.. si aprirebbero per me le porte del manicomio!). Perciò un conto è dire che la vita non ha un senso (non c’è nessuna verità) e un 129 consiste nel «consegnare se stessi» a chi possiede verità e potere: al medico e, perché no?, al Dio che i filosofi hanno provato esistente e che la rivelazione ci ha fatto conoscere in Gesù Cristo. Insomma, spiegandomi con un esempio, è più realistico e più ragionevole per un alpinista che si trova in difficoltà, appeso a una parete a picco, ostinarsi a volere fare da solo oppure affidarsi al maestro che viene a salvarlo? Il secondo motivo è frutto di una considerazione storico-culturale. La nostra pratica politica (e per «nostra» intendo l’Europa, l’Occidente) è rispettosa del valore della persona: diritti del singolo, dei popoli, democrazia, diritti dei malati, eccetera. Ebbene, se si fosse onesti come lo era Benedetto Croce, che peraltro si proclamava non-credente, si deve ammettere che è il cristianesimo ad avere umanizzato-divinizzato l’umanità: e non altre religioni, altre culture120. Ma, irrealisticamente e irrazionalmente, oggi molti tentano di sganciare i valori della persona dalla loro origine cristiana; risultato: i valori perdono efficacia. Non è allora più realistico e più razionale chiedersi quale nesso lega i valori della persona a Gesù Cristo? Il terzo motivo rivela la ragionevolezza della fede nel fatto che essa è la conclusione naturale dell’eros, del desiderio che un Altro completi e renda perfetta la mia umanità, non solo dicendo la mia verità di uomo, ma anche operando con potenza in me questa verità, cioè facendomi libero: felice. Qui «la verità vi farà liberi» non è più ybris gnostico-scientisticotecnologica, ma è appunto fede nell’Altro: non è il «fai da te», ma è conto è pensare, cioè diventare una cosa sola con questo pensiero: non c’è verità, non c’è senso. Ma, se davvero non ci fosse verità, non potrei neppure sapere come mi chiamo, chi sono io. Martin Heidegger è di questo parere: «Lo scettico, se è effettivamente nel modo della negazione della verità, non ha neppure bisogno di essere confutato. In quanto è e si è compreso in questo essere, esso ha dissolto l’Esserci [cioè se stesso], e con esso la verità, nella disperazione del suicidio» (Essere e tempo, par. 44). 120 Nel 1942 nella sua rivista, «La critica», Benedetto Croce pubblicava il saggio Perché non possiamo non dirci cristiani: si noti la doppia negazione; obtorto collo, ma onestamente, resta solo il cristianesimo contro la barbarie di quel tempo come del nostro. 130 l’affidamento a un altro che possiede la verità, almeno in parte, ed ha potenza per farla essere nelle cose (l’insegnante che mi trae dall’ignoranza al sapere, il medico che mi toglie la malattia e mi dà la salute), o nell’Altro che è la verità ed è onnipotente. Quest’ultimo motivo si condensa in una parola: fede. E di essa parlerò nel prossimo capitolo. 131 PARTE QUARTA In visione e in fede Capitolo Primo In principio è la religione 1. Grandezza e angoscia sono negli occhi Nel Libro della giungla Rudyard Kipling con tocco d’arte raffinata dipinge l’eterna condizione umana: «Era una giornata caldissima, quando a Bagheera venne in mente un’idea nuova, suggeritale da qualche cosa che le aveva riferito, se ricordava bene, Ikki il Porcospino, e la disse a Mowgli, quando furono nel folto della jungla, mentre il ragazzo se ne stava disteso con la testa appoggiata sulla bella pelle di Bagheera: “Fratellino, quante volte ti ho ripetuto che Shere Khan121 è tuo nemico?” “Tante quante sono le noci su quella palma”, rispose Mowgli, che naturalmente non sapeva contare. “E con questo? Ho sonno, Bagheera, e Shere Khan è tutto coda e schiamazzi come Mao il Pavone.” “Ma non è tempo di dormire adesso. Baloo lo sa, io lo so e il branco lo sa, e anche i daini, che sono così stupidi, lo sanno e Tabaqui pure te l’ha detto. […] Apri gli occhi, fratellino, Shere Khan non osa ammazzarti nella jungla, ma ricordati che Akela è molto vecchio, e che arriverà ben presto il giorno in cui egli non avrà più la forza di uccidere il suo daino e allora non potrà essere più il capo. Molti dei lupi, che ti conobbero quando fosti presentato al Consiglio la prima volta, sono vecchi anche loro e i lupi giovani credono, come Shere Khan ha dato loro ad intendere, che un cucciolo d’uomo non ci stia bene nel branco. Fra poco tu sarai un uomo.” “E che cos’è un uomo che non può correre coi suoi fratelli? - disse Mowgli. Io sono nato nella Jungla; io ho obbedito alla Legge della Jungla e non c’è lupo dei nostri al quale non abbia tolto qualche spina dalle zampe. Essi sono i miei fratelli, non c’è dubbio!” Bagheera si distese tutta lunga e socchiuse gli occhi. 121 È la tigre dalle cui fauci i lupi hanno sottratto Mowgli, salvandogli la vita e adottandolo come uno di loro. 135 “Fratellino, - disse - toccami sotto la mascella.” Mowgli alzò la sua forte mano bruna e proprio sotto il mento vellutato di Bagheera, dove i giganteschi muscoli masticatori erano completamente nascosti dal pelo lucido e morbido, trovò un piccolo spazio spelato. “Nessuno nella jungla sa che io, Bagheera, porto questo marchio: il marchio del collare; eppure, fratellino, io sono nata fra gli uomini e mia madre è morta fra gli uomini, nelle gabbie del palazzo reale ad Oodeypore. Fu per questo che io pagai il prezzo del tuo riscatto al Consiglio quando tu eri un cucciolo spelato. Sì, anch’io sono nata fra gli uomini; non avevo mai visto la jungla; mi davano da mangiare tra le sbarre in una ciotola di ferro, finché una notte sentii che ero Bagheera, la Pantera, e non un giochino nelle mani degli uomini; ruppi la piccola serratura con un solo colpo di zampa, e me ne venni via, e dato che avevo imparato i costumi degli uomini, diventai più terribile di Shere Khan nella jungla. Non è vero? “Sì, - rispose Mowgli, - tutti nella jungla temono Bagheera, tutti meno Mowgli.” “Oh, tu sei un piccolo uomo, - rispose la pantera con gran tenerezza, e come io sono tornata alla mia jungla tu dovrai tornartene fra gli uomini, fra gli uomini che sono i tuoi fratelli, se non sarai ucciso al Consiglio.” “Ma perché, perché ci dev’essere qualcuno che vuole uccidermi? “- disse Mowgli. “Guardami”, - rispose Bagheera e Mowgli la guardò fissamente negli occhi. La grande pantera, dopo mezzo minuto, girò la testa da un’altra parte. “Ecco perché, - disse muovendo la zampa sulle foglie. - Nemmeno io posso guardarti negli occhi, e io sono nata fra gli uomini e ti voglio bene, fratellino. Gli altri ti odiano, perché i loro occhi non possono sostenere il tuo sguardo, perché tu sei furbo, perché hai levato le spine dai loro piedi, perché sei un uomo.” “Io non sapevo queste cose”, - disse Mowgli imbronciato aggrottando i folti sopraccigli neri». È questa la storia di un legame e di un distacco, non dissimile da quello da me illustrato a proposito del rapporto del bimbo con l’Essere, sotto-sopra il cuore della madre. L’uomo è nella natura, nel mondo, e si sente un membro della natura e del mondo e, a un certo momento, d’improvviso, si sente respinto, allontanato, buttato fuori. Crede siano gli altri a non volerlo più: ed è incredulo: perché gli amici lupi mi dovrebbero rifiutare? C’è del vero anche in questa domanda: la natura avverte l’uomo come un estraneo e non lo accoglie totalmente come “suo”. Ma la natura opera il suo rifiuto alla guisa di un atto di difesa. Sì, 136 perché la vera causa del distacco è nell’uomo: è la sua grandezza che sta nei suoi occhi. Nessuno può reggere il suo sguardo: l’intera natura deve abbassare il capo di fronte all’uomo che negli occhi ha il potere. È dunque quella di Mowgli la storia di una potenza crudele e di una luce spirituale. Ma facciamo ancora una volta attenzione a non confondere la “potenza crudele” con la “natura”. Infatti questa potenza crudele non è la natura, ma è l’angoscia che l’uomo stesso con i suoi occhi è in grado di scatenare. Con lo sguardo egli vede la propria solitudine come fosse una vertiginosa grandezza: lontano, infinitamente lontano dalla natura e al tempo stesso però – è qui il punto – infinitamente lontano da Dio. Ed è in questo luogo spirituale che si scatena appunto in lui l’angoscia, non per colpa della natura o del Dio, ma in virtù della sua stessa grandezza. Egli vede ciò che non vedeva (“io non sapevo”, dice Mowgli), proprio come il bimbo non vedeva che non era tutt’uno con l’Essere, quando era sotto il cuore della madre: e non l’avrebbe visto neppure dopo, per molto tempo. Non dissimile è il finale della dialettica di bisogno e di desiderio. Infatti l’uomo non solo si scopre soggetto di infiniti bisogni, in ultima istanza insoddisfacibili interamente nel tempo dell’esistenza, ma si scopre anche soggetto di desiderio, il cui appagamento, a meno di uno sfacciato riduzionismo autoerotico, appare chiaramente come in mano ad altri e a un Altro: e il “darsi” di costoro non è in potere dell’uomo di desiderio. 2. La via: il razionale è nel religioso “In principio”, sotto e sopra il cuore della madre, la vita, la verità e la via coincidevano: non vi era una profonda lacerazione tra il mio io e l’essere. Ma in seguito però, con il passare degli anni, nell’unità si radica la differenza e allora tocca a ogni uomo ricercare la verità della vita e la via da percorrere per andare alla vita vera, appunto. Come credo di avere dimostrato, questa via non è intellettualistica, ma concreta ed esistenziale, perché coinvolge e impegna tutto l’io. Non c’è un soggetto dato e neutro, la cui essenza consiste quasi esclusivamente 137 nella sua razionalità, che si interroga sul significato della vita, trova una risposta razionale vera, logicamente ben dimostrata, e, alla fine, conosciuto il Dio della ragione, si apre all’accoglienza del Dio della fede, come se l’adesione alla fede fosse la conseguenza necessaria d’un ragionamento rigoroso. Non si va, per dirla con le parole di Masnovo citato anche nella prima parte di questo lavoro, dalla filosofia alla religione. Certo, resta vero quanto avevo detto: si filosofa a partire dal problema della vita, e in questo concordo con Masnovo. Ma il “cominciamento” non è una sorta di assoluto razionale, rispetto al quale il religioso sta alla fine. Anzi, sostengo, e credo appunto di averlo dimostrato, che il “religioso” è già al principio e che il razionale è un momento del dispiegarsi e del farsi maturo del religioso. Infatti “in principio” è la relazione: c’è un tu, che è più antico dell’io, che chiama per nome quell’io che, essendo fatto oggetto d’amore, diventa soggetto d’amore e, poiché nell’amore non vi sono “cose”, il rapporto tra tu e io è relazione tra persone. In seguito, rotta l’identità originaria tra io e Essere, icona imperfetta della vera Unità, l’io viene interrogato da quell’Altro e dai suoi segni, gli uomini e le cose che compongono il mondo, e alle domande che affollano la sua mente deve rispondere con ragione e con libertà. Ma appunto: l’avventura della ragione avviene in un contesto relazionale, interpersonale. 3. La via: in essa si dà il Bene C’è poi un altro pericolo da vincere, ed è questo: la posizione di un cammino che dalla filosofia porta alla religione rischia di collocare il bene, ovvero quella perfezione che è il momento oggettivo della felicità, semplicemente come meta finale, estrinseco al cammino stesso. Detto con le parole da me già impiegate: il rischio è di mettere la verità della vita “oltre” la via, quasi il bene fosse una “cosa” che viene trovata soltanto dopo avere concluso il cammino ascensivo. Già Aristotele nel Libro I dell’Etica nicomachea era esplicito nell’indicare l’assoluta identità di oggetto tra scienza etica (il Bene) e ricerca pratica della felicità (il bene proprio dell’uomo). Se non esistesse 138 un Bene, che è Fine ultimo capace di orientare la scelta dei beni finiti intermedi, il desiderio sarebbe vuoto e inutile122, un’infinita rincorsa senza senso che non permetterebbe né allo scienziato etico di parlare del bene né all’uomo comune di agire in vista della felicità. Così la teoria aristotelica esclude dall’analisi etica un bene che non ha nell’uomo il suo riferimento. Per questo Aristotele aveva criticato l’idea platonica del Bene, come valore in sé, per le sue aporie logiche e ontologiche. Egli infatti obiettava che un bene in sé, separato da ogni altro concreto bene, è vuoto o è un inutile duplicato e che un tale bene, separato e distinto dal «bene supremo» della felicità, «non sarebbe oggetto d’azione né acquisibile per l’uomo» e, infine, che non aggiungerebbe nulla alla conoscenza specifica di quei beni di cui le arti e la scienza si occupano in vista del loro contributo alla felicità umana123. Insomma, il Bene si dà nei beni, come un “già e non ancora”, ed è non soltanto “per via”, ma “al principio della via”: è nel rapporto ontologico tra l’io e l’Essere, è nel rapporto “religioso” tra il bimbo e i suoi genitori. 4. La via: al suo principio la Verità e l’Amore La ricerca razionale (e per l’uomo la ricerca non può svolgersi altro che nella luce della ragione) prende le mosse quindi da un positivo ontologico, cioè dalla presenza di Dio all’io. Il pensiero è attirato da Dio stesso nell’abisso dell’ente. Dio è buono e vuole che naturalmente e facilmente l’uomo lo conosca. Intenzionando l’ente in quanto ente (l’ambiente relazionale madre-bimbo), l’uomo èposto dinanzi all’immagine di Dio. Infatti, se l’ente è prodotto da Dio, in quanto è un suo effetto, reca in sé l’impronta della propria causa, poiché omne causa causat sibi simile. E, poiché Dio è causa totale e adeguata dell’esistenza dell’ente, sin quando l’ente esiste, Dio deve essere presente come causa all’ente. Infatti, se cessasse la sua azione causale, l’essere dell’ente da lui prodotto verrebbe meno e così l’ente non sarebbe. Ma in Dio non vi è 122 123 Aristotele, Etica nicomachea, I, 1094a21-22. Ivi, 1096b19-20; e 1096b34. 139 distinzione tra la sua essenza e i suoi atti. Perciò Dio è presente in essenza all’ente. E ciò è possibile perché Dio è totalmente altro. Dunque, la condizione ontologica, in forza della quale è possibile la nostra conoscenza dell’esistenza di Dio, è la sua presenza creatrice nell’ente. Ma l’ordine ontologico non coincide con l’ordine gnoseologico, benché ne sia la condizione. Infatti, il primo conosciuto per noi è l’ente, non Dio. Così, il passaggio conoscitivo, che compiamo trasmigrando dall’ente a Dio, risale a Dio non come in visione, ma come a «causa totale e adeguata» dell’ente, di ogni ente. Detto in altri termini: Dio si muove per primo, chiamando l’uomo all’essere, e l’uomo risponde alla sua chiamata cercandolo, perché subito si accorge che non è “questo qui”: non sei tu, e neppure tu, viene da noi detto alle cose e agli altri uomini. Chi mi chiama per nome? È quindi Dio stesso che ci sospinge a desiderarlo e, dunque, ad amarlo ancor prima di conoscerlo in modo vero. Senza Dio, dunque, siamo incapaci di amare Dio. Di più: senza Dio siamo incapaci di cercarlo. Dio vuole che l’uomo lo possieda con l’amore, e perciò incita l’uomo a cercarlo. E vuole che lo cerchi con l’amore al fine di possederlo. Nemo te quaerere valet, nisi qui prius invenerit124. Detto in altri termini: Dio È, e alla pienezza del suo essere sono consustanziali l’intelletto e l’amore. Così, nel momento, in cui egli ha voluto questo mondo, lo ha voluto con leggi inscritte nella sua natura e, come è giusto, anche nella natura umana. Per questa ragione ontologica san Tommaso afferma: «impossibile est de naturale desiderio esse inane»125. Perciò la capacità di infinito, propria della ragione e della volontà, non È a caso, ma È perché vi È un “oggetto” realmente infinito, Colui che È, che le pone in movimento verso se stesso. Perciò è vero che l’amore di Dio, risiede primariamente e principalmente nell’uomo, ma ciò rinvia all’Amore primo, ontologico, 124 S. Bernardo, De diligendo Deo, VIII, 41; e cfr. B. Pascal, Pensieri, opuscoli e lettere, Rusconi, Milano 1984, fr.835: “Non si crederà mai [...], se Dio non inclina il cuore, e si crederà appena Lui lo inclinerà,”. Fr. 837 “[...] sentono di non averne la forza da soli; di essere incapaci di andare a Dio, e che, se Dio non viene a loro, sono incapaci di alcun rapporto con lui”. 125 S. Tommaso, Summa contra Gent., III, 51. 140 che per primo ha amato l’uomo: come desiderarlo, se Egli non ci desiderasse per sé?: amor ch’a nullo amato amar perdona126. 5. Lo stato religioso del bimbo Dunque “in principio” si dà lo stato di religione; anzi, meglio: “in principio” il bimbo sperimenta soprattutto quel lato della religione che è l’unione con Dio, perché solo crescendo e maturando diviene cosciente di quell’altro lato, che è la fatica del ricongiungimento: re-ligare, legare di nuovo. Poiché il bimbo si crede pienamente nell’Essere, egli non compie atti propriamente religiosi. Nel suo tempo senza tempo, con l’estasi dello stupore e l’azione del gioco (infinitamente reiterabili), il bimbo adora ed è adorato (lo dico ovviamente in modo metaforico). Persino il suo trasgredire non è un errare lontano dall’essere, ma sembra riprodurre il “vorrai ciò che io vorrò e vorrò ciò che tu vorrai”, sogno per gli amanti e realtà per i beati. Non dissimile la legge nei suoi giovani giorni: la sua eteronomia è subito convertita in autonomia, perché il precetto enunciato dai genitori diventa subito sua volontà, poiché egli lo sente come “suo”, promanante dal suo interno, dal momento che egli è tutt’uno con l’Essere. Insomma, il suo stato religioso è figura del paradiso, cioè del già pienamente realizzato. Ma, lo abbiamo visto, questa è una illusione che deve essere disincantata, cioè deve essere condotta a perdere l’incanto fallace dell’unità del sotto-sopra il cuore. 6. Può esservi un uomo non religioso? Così il bimbo ormai divenuto adulto non può non cercare di re-ligare se stesso all’Essere ed entrare in possesso della chiave che dà la vita. È questa la dinamica che muove gli uomini nell’ambito dell’evoluzionismo e dello scientismo, e non diversamente accade nel buddismo. Vana è la 126 Dante, Inferno, V, 103. 141 pretesa distringere quest’ultimo in una semplice morale. Nei fatti il buddismo filosofico hinayana (il “piccolo veicolo”) è stato largamente superato da quello religioso mahayana (il “grande veicolo”), nel quale la comunità dei credenti prende in certo modo forma di chiesa, con sacrifici e preghiere e con un Buddha divinizzato (Amida o Kwannon). Se vi è una differenza tra gli uomini, dunque, non è nel fatto che essi percorrano le vie del religioso inteso come via della ricerca dell’autentica unità, ma nel fatto che gli uni si dirigono verso un idolo, e quindi verso una falsa unità, e gli altri verso il Dio vero, e quindi verso l’autentica unità. 142 Capitolo Secondo La fede 1. Una prima precisazione sul termine “fede” Conoscere Dio, sia pure sotto una certa confusione, è avvenimento naturale, razionale, proprio di ogni uomo in quanto uomo; ed è evidente che un dio non vale l’altro. Il dio del bimbo è figura del Vero Dio e scoprire quest’ultimo è il lavoro della vita Ora, il dio e l’essere del bimbo non stanno davanti a lui come un oggetto contrapposto, ma sono attorno a lui: il suo io è realizzato dalla relazione con essi. Egli è visto e vede, egli è amato ed ama, si affida, si abbandona. Con una formula: egli è “in visione e in fede”: conosce e confida. È questa un’alba carica di promesse. Schopenhauer riteneva che «le religioni sono come le lucciole: per risplendere esse hanno bisogno dell’oscurità. Un certo grado di ignoranza generale è la condizione di tutte le religioni, è il solo elemento nel quale esse possono vivere”127. E Soren Kierkegaard scriveva: «Quando il ricco, in una notte buia ma piena di stelle, viaggia comodamente nella sua carrozza con le fiaccole accese: egli è sicuro, non teme nessuna difficoltà, egli porta con sé la luce, e tutt’attorno il buio quasi fugge. Ma proprio perché viaggia con le lanterne accese e con tanta luce vicino a sé, egli però non può vedere 127 A. Schopenhauer, Par. u. Paral., II, 174 Dialogo. Cfr. la trad. di P. Martinetti, in A. Schopenhauer, Morale e religione. Da Parerga e Paralipomena e Frammenti postumi, (presentazione commento di G. Riconda), Mursia, Milano 1981, p. 271 (I ed., Bocca, Torino 1908). 143 le stelle; le sue fiaccole oscurano le stelle che il povero contadino, il quale viaggia senza fiaccole, può vedere splendidamente nella notte buia ma piena di stelle»128. Per Schopenhauer solo l’ignoranza permette l’esistenza della religione: la piena conoscenza annichilisce il religioso129 per Kierkegaard, invece, solo la povertà di spirito consente il sorgere della vera religione, quellache lega al Dio. Mentre poi nel testo di Schopenhauer è posto in rilievo soltanto il momento gnoseologico, nel brano di Kierkegaard balza subito agli occhi l’accento posto sulla determinazione esistenziale: il conoscere, cioè l’uso della ragione, è guidato da uno “stato”, ossia da una condizione esistenziale che è previa; ed essa consiste nell’essere “legato” al cielo, perché senza questo legame è impossibile vedere le stelle. Di conseguenza, se stiamo al dettato di Schopenhauer, la conoscenza (ragione, scienza, visione) è contrapposta alla fede, anzi ne è un contraddittorio: la toglie. Per Kierkegaard invece la povertà, figura dell’eros, del desiderio di Dio, è condizione esistenziale del “vedere bene”, secondo verità. Per questo la “visione” non contraddice la “fede”. Dico di più: la contrapposizione corrente di scienza e fede non mira a togliere tutta la fede. Il suo fine, infatti, consiste nel sostituire il sapere della scienza al sapere che dà la fede (questo è l’intento di Schopenhauer). Ma la fede non è soltanto conoscenza, ma anche relazione, rapporto, cioè amore. E quest’ultimo aspetto non viene distrutto dalla scienza, perché anch’essa istituisce con le sue conoscenze un rapporto. A differenza della fede autentica, però, la scienza instaura un rapporto tra l’uomo e il “neutro”, cioè l’idolo: natura o leggi sono, in fondo, frutto di un pensiero umano, sua manipolazione (quando la scienza diviene “scientismo”, ovviamente). Non si dice forse… “fede” nella natura, nella scienza, nel progresso, nelle proprie forze? E chi non ha questa fede non viene guardato come si guarda a un uomo che “manca” di qualcosa, cioè manca di una relazione fondamentale per la vita? Progresso, natura, eccetera 128 S. Kierkegaard, Vangelo delle sofferenze, in Opere, III, cit., p. 514 e cfr. Papirer 1846-47, VII A 234; tr. it., Diario, Morcelliana, Brescia 1962, n. 1058, t. I, p. 540. 129 È un pensiero illuminista: la luce della ragione spazzera via le tenebre dell’ignoranza e di conseguenza verranno meno tutte le religioni positive (di fatto quelle esistenti), e fra esse innanzitutto il cristianesimo. 144 sono infatti nomi nei quali si con-fida, cioè su di essi si fonda la propria esistenza e da essi si spera venga la felicità: il tuo amore è la tua vita. La questione non sta dunque nel cercare l’essenza della fede considerandola come “altro” o, addirittura, contraddizione della ragione, ma nel coglierne la sua ontologia come fatto essenziale e ineliminabile dell’umano esistere, non solo Perché tramite la visione e la scienza (quella vera, non le sue caricature romanzate) conosciamo poche cose, mentre molte (vere o false che siano) noi apprendiamo dalla tradizione e dalla fede, intesa quest’ultima come confidenza in altri uomini, ma anche perché senza l’abbandono fiducioso (cioè di fede) negli altri non ci è possibile vivere: e l’abbandono fiducioso è un nome dell’amore. 2. La fede è atto di due persone: L’altro Vengo ora a esaminare il modo con il quale si struttura l’atto di fede espresso da una qualsiasi persona. Il venire all’essere dell’atto di fede non è innanzitutto in potere di colui che esprime l’atto di fede, ma è totalmente nelle mani di colui che si presenta, si rivela, parla una parola e provoca una decisione, ponendo una domanda: “credi tu in me e in quel che ti dico?”. In altri termini: l’origine ontologica dell’atto di fede non sta in me, ma nell’Altro: qui veramente il Tu precede l’io. C’è in questo processo una analogia con la conoscenza comune e quella scientifica. Infatti, nel conoscere io posso passare dalla potenza all’atto (dall’essere in grado di conoscere al conoscere effettivo), soltanto in quanto mi si offre un oggetto di conoscenza: posso essere in grado di scoprire continenti nuovi di sapere, ma se questi non mi si presentano… Perciò l’oggetto di conoscenza sta all’origine del fatto conoscitivo. Ma nel semplice conoscere è il soggetto conoscente che, per così dire, deve andare a scovare l’oggetto di conoscenza. Nella fede, invece, il principio è tutto nelle mani dell’Altro. Per comprendere meglio questo fatto esaminiamo la differenza che vi è tra senso religioso (o eros) e atto di fede. 145 Nell’eros come amore di bisogno sono io che mi metto in moto alla ricerca di ciò che può appagare il mio desiderio. Ma l’atto erotico è specificato non da un oggetto preciso, ma da un bene indefinito. Questo bene appartiene certamente a un genere determinato, a seconda del tipo di eros che mi anima. L’eros scientifico sarà quindi specificato da quel bene che è la verità delle cose, intesa però in modo appunto indeterminato (non posso sapere una verità prima di averla conosciuta); così l’atto erotico di un uomo che desidera una donna non è specificato se non da un oggetto vago: l’essere quella ancora ignota donna corrispondente a certe sue immagini o a certi suoi sogni, ma non è un “volto”. Identica cosa accade per il senso religioso o eros religioso, come nella seconda parte ho detto di Socrate: desiderava il Dio vero, conosceva i falsi dèi, ma non aveva dinanzi a sé il “volto” del Dio vero. Insomma, desiderare “una” donna non equivale a conoscere e amare “questa” donna e, in analogia, rispetto all’eros altro è la fede religiosa: non un’incognita che si spera si disveli, ma un “volto” che si manifesta e mi interpella. Non solo: a differenza di ciò che accade nella scienza, nella fede l’Altro non è “deducibile”, cioè non è il risultato di un ragionamento o di una pratica ben strutturate, e non è neppure “inducibile”, cioè non lo si può indurre a mostrarsi, impiegando pratiche pneumatologiche, magiche o tecnologiche. Come detto, è totalmente in potere dell’Altro il rivelarsi. Da quanto detto possiamo dedurre un’altra grande differenza tra l’atto di fede e l’atto del semplice conoscere. Nella conoscenza comune e in quella scientifica, infatti, l’altro è un oggetto, una “cosa”: può essere anche un uomo, ma viene considerato come “cosa”, ossia come un qualcosa che sta lì, a mia disposizione. Invece nella fede l’altro è un Altro con l’”A” maiuscola, perché è sempre “persona”, cioè è sempre un universo a se stante, non è una parte rispetto al tutto: ha una sua “autonomia”, che gli permette appunto di rivelarsi o di non rivelarsi. Per questo motivo l’Altro non è né deducibile, né inducibile: la persona è sempre imprevedibile, perché è libera; la persona è sempre inafferrabile nel suo intimo, perché, appunto, non fa parte di un tutto: 146 per questo un uomo può “stuprare” una donna: ma ciò che possiede non è la persona, ma la cosa-corpo. La persona sfugge a questa violenza: posso uccidere il corpo, ma non l’anima, cioè non la persona. Solo nell’amore la donna-persona si disvela e si dona: e come, del resto, si potrebbe pensare a un amore costretto? La persona sta dunque nel nascondimento e quindi l’Altro è sovranamente libero di rivelarsi o di nascondersi, di rivelarmi qualche verità o di tacermela. Chi di noi può dire di non essere mai stato tratto in inganno da un Altro che, così ci pareva, rivelava a noi, proprio a noi, se stesso e ci comunicava qualche verità? In sintesi: l’origine ontologica dell’atto di fede è nell’Altro che in assoluta libertà si propone. Ma in lui è anche l’origine gnoseologica e pratica: non solo con libertà sovrana egli mi si mostra, ma anche da lui dipendono la “parola” e l’impulso all’azione. Detto in altri termini: apparendomi, l’Altro, proprio mentre si rivela, mi offre la “visione” e la “relazione”, che sono i due costitutivi essenziali della fede: mi parla e, parlandomi, mi pone in relazione con lui. L’Altro non è infatti “cosa”, un fatto bruto e inintelligibile: l’Altro è, nel rivelarsi, luce per la ragione e provocazione per la libertà. In conclusione: l’atto di fede, che non ha nel soggetto che lo esprime la prima origine, ma ce l’ha nell’Altro, proprio per questo motivo ha un “cominciamento gratuito”: la fede, dice giustamente la dottrina cattolica, è “grazia”: se l’Altro non lo volesse, non ti si rivelerebbe mai e tu non avresti alcuna arma per farlo apparire. Puoi tenere in tuo potere lungo l’intero arco della sua esistenza il corpo di una donna, ma non potrai mai e poi mai possedere la sua anima. E Dio, poi, non puoi “stanarlo”!: di qui la grande differenza tra la magia, che pretende di possedere il divino (e in ciò è simile alle religioni pagane che pretendono di piegare Dio con preghiere e sacrifici, ma anche alla scienza-tecnica che pretende di possedere il mistero dell’Essere) e la vera religione che sa che sempre Dio trascende, infinitamente, l’uomo e che solo una sua libera rivelazione può 147 dare inizio all’atto di fede (e questo, a onore del vero, l’aveva intuito anche Platone, come abbiamo visto). Perciò, che la fede non possa avere inizio se non mediante la grazia, non è soltanto un dogma del cristianesimo, spesso presuntuosamente bollato come irrazionale, ma è anche una verità di ragione. E come grazia la fede è “dono”: non nel senso di un “posto lì”, ma di un “offerto” al mio conoscere e al mio libero consenso. L’Altro, che non si fa stuprare, a sua volta non mi stupra: mi si propone, lui persona a me persona. Si offre quindi alla mia responsabilità: mi interpella e mi invita a prendere una decisione: pro o contro. Così, mentre nell’eros la presa di posizione nei confronti della verità è autentico illuminismo della ragione, che elimina il falso per fare posto all’attesa e all’ascolto del vero che può presentarsi, nella fede la presa di posizione può sfociare o nell’accoglimento, saputo e liberamente voluto, o nel rifiuto, altrettanto cosciente e libero del Dio che si rivela. In entrambi i casi, colui che è stato interpellato non è più come prima: se accoglie, diventa fecondo e genera una via nuova; se rifiuta, infecondo è costretto a cercare ancora: ma una strada ormai gli è preclusa. 3. La fede è atto di due persone: l’io Nella conoscenza comune e in quella scientifica e anche in molte azioni quotidiane, anche eccellenti, non tutta la mia persona è impegnata. Nel conoscere matematico, ad esempio,non viene coinvolto il mio agire morale. Nell’atto di fede, invece, viene interpellato il cuore e il mio io: sono io a venire posto in discussione, sono io che devo rispondere come persona e non, poniamo, come semplice scienziato o studente. Ed in quanto tocca la mia persona, l’atto di fede coinvolge la mia ragione, la mia volontà libera, i miei sentimenti, i miei atti: la fede è onninvasiva: non si salva nulla! Ora, poiché chi ti impegna a esprimere un atto di fede, così come avveniva sopra il cuore della madre, ti chiama sempre per nome, anche se il Tu chiama molte persone, la relazione tra il Tu e gli altri non è mai come da soggetto a massa, ma sempre da persona a persona: il Tu sta di 148 fronte a un io, singolo, sempre, e il numero degli io in questione non toglie questo fatto. Quindi la fede è sempre un affare serio che accade tra due persone: e il suo esito o è un patto, un’alleanza, o è una rottura e una inimicizia. 4. La Ragione e la libertà Fin dal principio nell’atto di fede, che io sono invitato a esprimere dall’Altro che mi si rivela e mi interpella, la mia ragione e la mia libertà sono integralmente impiegate: la prima a tentare di comprendere, la seconda a decidere di rimanere lì sul posto e a non fuggire. La ragione è impegnata su due fronti: io devo capire chi è colui che mi si rivela e mi parla e devo capire ciò che mi dice. Questo accade perché non vi è una evidenza immediata di ciò che si è relazionato a me e che io vedo. Per esempio, Giovanni il Battista, che pure aveva visto aprirsi i cieli quando aveva somministrato il battesimo a Gesù nel Giordano130, messo in prigione manda i suoi discepoli perché chiedano a Gesù se egli è colui che doveva venire o se doveva attenderne un altro; e Gesù risponde: «Andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono e la buona novella è annunciata ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato in me!»131. Chi è costui? Cosa dice veramente? Non è affatto evidente. Ora la verità di una cosa può essere conosciuta in due modi fondamentali: immediatamente o mediatamente. Le verità immediatamente evidenti sono quelle di fatto (io sono in questa stanza) o di ragione (il tutto è maggiore della parte). Quelle mediatamente evidenti sono a loro volta suddivisibili in due gruppi: quelle conosciute per evidenza intrinseca e quelle conosciute per evidenza estrinseca. 130 131 Gv., 3, 14-17. Mt., 11, 4-6; Lc., 7, 23. 149 L’evidenza intrinseca è propria del sapere scientifico: è infatti quella verità che risulta dal fatto che io vedo il nesso che lega i due termini della proposizione (soggetto e predicato) dopo un’opera di di-mostrazione (non la vedo infatti immediatamente). Ad esempio: non vedo immediatamente che gli angoli interni di un triangolo sono pari a due retti, ma una volta dimostrata questa verità mi appare evidente per evidenza intrinseca: vedo, senza avere bisogno del soccorso di altro, che effettivamente dire “angoli interni di un triangolo” equivale a dire “due angoli retti”. È stato forse necessario che qualcuno mi aiutasse a comprendere questa verità, ma dal momento in cui ho “visto”, non ho più bisogno di nessuno per sapere, anzi “vedere”, che le cose stanno così. Invece la verità conosciuta per evidenza estrinseca è quella che io “non vedo”, ma “credo”: non vedo il nesso tra i due termini della proposizione, ma vedo che vi sono buoni motivi per ritenerla vera, poiché “credo in te e in ciò che tu mi dici”: questa è l’evidenza estrinseca che appartiene all’atto di fede: “bevi, ti farà bene”: non vedo né il perché né il come, ma ti credo. Vediamo di chiarire questi passaggi capitali. 5. La ragionevolezza “del” e “nel” credere L’Altro mi si rivela con il suo apparire fisico, per così dire, ma soprattutto con le sue azioni e le sue parole (vedi l’esempio citato sopra della risposta di Gesù a Giovanni). Perciò, se voglio comprendere chi è l’Altro, devo in primo luogo comprendere le sue parole e i suoi atti. Per questo, benché io non veda il nesso intrinseco che lega i due termini della proposizione, devo in certo modo capire cosa essi significano. Così, ad esempio, nella proposizione “io, Gesù, sono Dio”, devo avere un concetto preciso del significato del termine “uomo” (Gesù nel suo apparire “fisico” è un uomo) e del termine “”Dio” perché, se per esempio per me “dio” significa semplicemente “eroe”, “uomo straordinario”, non c’è difficoltà alcuna ad ammettere che Gesù sia Dio: parla con verità, fa grandi cose, meglio di tanti politici e di altrettanti filosofi! E, tra l’altro, intendendo “dio” in questo significato, io vedo il nesso che lega i termini 150 della proposizione: non c’è più bisogno di credere (fede), perché vi è evidenza intrinseca alla portata della mia ragione. Invece, se con il termine “dio” io intendessi colui che è l’Assoluto, l’Infinito che i Cieli e la Terra non possono contenere, allora… le cose cambiano radicalmente! Eppure, anche in questo caso non posso esprimere un atto di fede positivo (ti credo) o negativo (non ti credo), senza almeno capire i termini della proposizione (il nesso che li lega non lo vedo). La fede è un affare serio: ne va, come detto, della mia vita; e allora io impegno la ragione al massimo: non posso esprimere un autentico atto di fede (positivo o negativo), se prima non mi sono fatto un’idea di cosa vi è in gioco: se prima non capisco, per quel che mi è possibile, ciò che mi viene detto, il contesto in cui ciò che è detto è detto, e anche le ragioni per le quali l’Altro mi parla. La fede non è quindi da confondersi con la credulità dei babbei: la ragione e le scienze sono chiamate a concorrere ad esprimere l’atto di fede. Quando si afferma che la fede è un avvenimento “irrazionale” o si dice una stupidaggine o ci si esprime impropriamente. Certo, l’atto di fede non si basa sulla ragione misurata dall’evidenza intrinseca, ma si basa pur sempre sulla ragione: non si chiede a un cane di esprimere un atto di fede! Così, il “credo quia absurdum” (Tertulliano, Ugo di San Vittore, eccetera) non ha senso: è la fede un atto squisitamente razionale, lo è per tutto quel che fin qui ho cercato di dimostrare: appartiene all’essenza del nostro vivere. La fede è certamente oltre la ragione raziocinante della filosofia e delle altre scienze, ma non è “contro” la ragione: è “oltre” perché si consustanzia anche di libertà, come vedremo. Ma ancora: la comprensione dei termini della proposizione, accettata per fede, può spingersi molto lontano, ma non può mai arrivare all’evidenza intrinseca, altrimenti non vi sarebbe più fede. Perciò, poiché non sono in grado di chiarire con le mie sole forze intellettuali l’oggetto di fede (“io, Gesù, sono Dio”), per esprimere un atto di fede, negativo o 151 positivo, devo indagare le ragioni di credibilità sia dell’oggetto proposto, sia della persona che me lo propone. È credibile che un uomo sia Dio? Quali ragioni posso addurre a sostegno di un sì e quali a sostegno di un no? Non ho qui lo spazio per tentare di rispondere a queste domande, ma esse sono di capitale importanza, e tutti coloro che seriamente si sono lasciati interrogare dalle parole di Gesù hanno dovuto fare i conti con queste esse. Ma ancora: è credibile che tu, Gesù, proprio tu, non un altro uomo, sia Dio? Gesù stesso indica la direzione della ricerca razionale: i miracoli, la buona novella predicata… Si è mai visto qualcosa di simile, e lo si vedrà mai in futuro? A ben vedere il motivo di credibilità, che viene dedotto dall’esame della persona che mi interpella, si basa sulla sua “autorità”: autorità deriva dal latino augere, che significa aumentare, fare crescere. “credibile” è dunque colui che mi fa crescere. E qui la ragione, che tenta di penetrare nell’Altro e nella sua parola e nei suoi atti, viene affiancata dal sentimento: è credibile non solo perché mi pare ragionevole ciò che dice, ma anche perché faccio esperienza di qualcosa di nuovo: ho il sentimento di essere in pace, di avere trovato risposta al desiderio di felicità che mi bruciava nel cuore. Nell’atto di fede, dunque, oltre alla ragione, entra di prepotenza l’esperienza personale e i sentimenti a essa correlati. Va infine notato che chi testimonia ha un vantaggio su chi crede rispetto alla conoscenza della cosa in questione: ne ha una conoscenza immediata. Quanto alla certezza, però, anche chi crede non è affatto carente: la sua, se è fede autentica, è animata da una certezza irremovibile. 6. Fede nella parola e fede nella persona Tradizionalmente, per fides quae si intende il contenuto della fede, il ciò in cui credo; per fides qua, invece, si intende l’atto per mezzo del quale credo. Ora bisogna sgombrare il campo da alcuni pregiudizi. Vi è una concezione della fede di origine sentimentale, per la quale essa è una 152 “certezza pratica non giustificata dalla teoria”, cioè l’accettazione di una cosa per fede avviene solo quando vi è una insufficienza dell’intelletto (era l’opinione di Kant, ma anche di Schopenhauer, come visto). La fede sarebbe quindi un tenere per vero soggettivo che non ha valore sul piano oggettivo. Ma ci rendiamo tutti perfettamente conto che, se alla domanda “ci credi?”, io rispondessi con un “è probabile”, saremmo di fronte non a un atto di fede, ma ad una semplice opinione. Ed anche nella relazione interpersonale tra uomini vi è una bella differenza tra queste due risposte. Infatti la fede autentica è una decisa presa di posizione nei confronti della verità: nella non evidenza intrinseca del fatto io ho fede incondizionata nel fatto: lo ritengo vero. E la mia fede deve essere assoluta e incrollabile, altrimenti il mio interlocutore esclamerebbe: “tu non mi credi!” Perciò, quanto alla fides quae, al contenuto della fede, possiamo parlare di fede soltanto quando la parola detta è ritenuta vera. Quanto invece alla fides qua, cioè all’atto mediante il quale viene espresso il sì o il no, esso ha la sua “causa formale” nella ragione, perché è mediante essa che io conosco, ma la sua “causa efficiente” è la volontà libera. Per quanto infatti siano stringenti i motivi di credibilità, essi non giungono mai a costituire per me un’evidenza intrinseca e, di conseguenza, la mia ragione resta indeterminata: vedo e non vedo. Tocca così a un atto della libertà il farmi aderire o meno. Per approfondire questo punto capitale, prendiamo prima in considerazione quest’altro aspetto: l’atto di fede è specificato nella sua qualità esistenziale dall’oggetto creduto. Infatti, un conto è credere a una piccola cosa, un altro credere al medico che mi propone per i miei mali una cura lunga e dolorosa, un altro ancora è credere a questa donna che mi dice ti amo e, infine, un conto è credere che Gesù sia l’unico vero Dio e l’unico vero salvatore di ogni uomo. Come appare chiaro, vi sono due aspetti da sottolineare: il primo, più ne va della mia vita, più l’atto di fede è alto, perché più grande è l’impegno che mi è richiesto; il secondo, più alto è l’atto di fede, più diventa necessario per me accogliere sia la parola, sia colui che me la 153 rivela. Così, se chiedo dove si trova una certa strada, posso accogliere l’indicazione che mi viene data, senza per questo legarmi a colui che me la dà; diversamente con il medico che mi propone una cura; e a maggiore ragione con questa donna… e con questo Gesù-Dio! La parola pronunciata dall’Altro, là dove il mio impegno di fede è al culmine, funziona da allarme, da segnale che mi sospinge a posare lo sguardo su colui che mi parla: “Ti amo”, dice questa donna: come prendere per vere quelle parole senza “prendere lei”? Dico di più: è prendendo lei che gradualmente posso comprendere la verità di quelle parole. È impossibile affermare: credo in ciò che mi dici, ma non credo in te. Anzi, è vero dire: poiché credo in te, credo anche in ciò che mi dici. Non diversamente nel cristianesimo: essenza del cristianesimo è Cristo: o accolgo Cristo, o non accolgo il cristianesimo, perché il Cristo Gesù è la Parola, il Logos: in lui Essere e Verità sono identici. Così accogliendo la Parola accolgo Crist, e viceversa. 7. La “fede” storico-giuridica Ma ancora, proprio per comprendere la natura della fede autentica e del ruolo che in essa gioca la libertà, è necessario spendere due parole sulla cosidetta fede storico-giuridica. Lo storico e il giudice che prestano fede a una testimonianza lo fanno in vista dell’acclarazione del fatto. Ciò che il testimone dice è mezzo, strumento per andare a vedere come stanno le cose. Il loro atto di fede è quindi subordinato alla conoscenza comune e a quella scientifica, ovvero l’evidenza estrinseca di una proposizione è fatta propria solo in vista di una sua risoluzione in un’evidenza intrinseca. Non si può infatti basare un giudizio soltanto su alcune testimonianze: bisogna che vi siano i fatti, si dice, cioè bisogna “vedere” il fatto e non semplicemente “credere” a esso. Così, mentre la fede non produce evidenza e dominio dell’oggetto di fede, la fede giuridico-storica ha per proprio fine esattamente l’evidenza dell’oggetto e il dominio su di esso. 154 Inoltre, mentre nella fede autentica, più il testimone è coinvolto in ciò che dice e più è credibile (non ne va solo della mia, ma anche della sua vita), nella cosiddetta fede giuridico-storica meno il testimone è coinvolto in ciò che racconta, più è credibile. È esattamente l’opposto: credo alle parole di questa donna perché tutti i suoi atti dimostrano il suo amore per me; credo a questo testimone perché è “obiettivo”, cioè non è coinvolto nei fatti: è estraneo a essi. Per questo nella fede giuridico-storica vi è solo uno dei due elementi co-essenziali alla fede autentica: la ragione. Manca la libertà intesa come facoltà capace di spingere la persona che esprime l’atto di fede ad accogliere l’Altro e a donarsi a lui: manca l’amore, e quindi alla logica del dono è contrapposta la logica del dominio (il che, si badi, per questo tipo di fede strumentale è giusto). 8. Fede negli uomini e fede in Dio Ma ritorniamo a quanto detto sopra: la fede autentica è quella per cui io dico “accetto quanto tu dici per nessun’altro motivo che questo: l’hai detto tu!”. Ma mi chiedo: quanto una simile fede vale tra uomo e uomo? Certamente consta alla nostra esperienza che io credo a ciò che dice questa donna, proprio perché l’ha detto lei: non ho “prove”, ma l’ha detto mia moglie! Ma consta sempre alla nostra esperienza che la nostra fede non si estende su tutto ciò che lei dice: se parlasse di fisica meccanica, lei che io conosco digiuna di studi fisici, avrei buoni motivi per dubitare: e non le crederei (potrei dire, al massimo: “è probabile”, ma questa non è fede, come visto sopra). Vi è dunque anche fede assoluta negli uomini però essa è subordinata a una discriminazione e selezione di campi. E c’è anche una sorta di consolazione: che, se mi sbagliassi a prestare fede a quest’uomo, l’uomo non è l’ultima spiaggia e posso trovare in Altro, magari in Dio, una sponda di salvezza. Ma così non può andare con Dio, con quel Dio che, in particolare, ha parlato in modo definitivo in Cristo. Con lui non vi può essere che una fede assoluta e definitiva. Ogni tentennamento da parte di colui che esprime l’atto difede susciterebbe giustamente queste esclamazioni: “tu 155 non mi credi, tu non hai fiducia in me e non credi a ciò che ti dico!”. Non una piccola riserva su di un piccolo particolare, non una minuscola esitazione nel tempo: tutto e sempre: se non credo tutto e se non credo sempre, significa che non credo. È chiaro che una simile fede implica per l’uomo un profondo rischio della libertà. 9. Fede, libertà e amore Se intendessimo l’atto di fede come semplice atto di conoscenza, dovremmo ammettere che molte delle cose sopra esposte non hanno senso: soprattutto non avrebbe senso legare la parola alla persona che la testimonia. Ma la fede, come ho sostenuto fin da principio rifacendomi all’esperienza del bambino, è tale per cui implica sempre la ragione e la libertà, cioè il vedere e l’amore. Del resto, come si potrebbe accogliere una parola per fede, se non si amasse colui che la pronuncia? Si badi: amore erotico di bisogno: io senza di te non posso vivere; e amore estatico di dono: io ti dono me stesso. È questa una circolarità dell’amore: l’erotica conclude nell’accoglienza, la confidenza nell’oblazione del dono personale. Per questo chi accoglie la parola non può non accogliere chi la pronuncia, e viceversa. Per queste ragioni, mentre nella scienza vi può essere disgiunzione tra conoscenza e amore (conosco la legge morale, ma non la osservo), nella fede ciò non può accadere: chi conosce per fede ama e chi ama conosce per fede. Qui l’intelletto è un “intelletto d’amore” e il conoscere è un “conoscere biblico”: un lasciarsi espropriare del proprio potere per essere resi capaci di accogliere e di donarsi. La fede è dunque un affare serio che mette in moto la nostra ragione e la nostra libertà: pur vedendo che è ragionevole credere, non si è mai costretti a credere. Non a caso san Paolo congiungeva il rapporto tra Cristo e la Chiesa e il rapporto tra lo sposo e la sposa. Tutto testimonia che è ragionevole sposarti, ma nulla mi costringe a farlo; niente di più assurdo di un amore necessitato: l’amore è libero: ti credo e dunque mi affido a te (sposare significa «consegnarsi» e «accogliere» l’altro che si 156 consegna). Per questo l’amore è l’altro nome della fede, della fede autentica: «dimmi ciò che tu ami davvero … e mi avrai rivelato la tua vita» (Fichte). Da questi ragionamenti mi pare giusto trarre due conseguenze: la prima: l’atto di fede è in certo modo l’atto umano più simile all’onnipotenza di Dio, perché in esso si compie, per dirla con Platone, la generazione nel bello, il trascendentale che io ho nella Parte seconda abbinato alla vita; la seconda: nell’amore-fede sono «svelati i pensieri di molti cuori»132. Infatti diventa palese se un uomo si ostina nell’ybris autoerotica oppure eteroeroticamente si affida e decide di «vivere con»: vogliamo fare da soli o c’è un altro che ci guarisce?. Non c’è alcuna garanzia scientifica, nessuna soluzione di problema, ma mistero che, per essere conosciuto, necessita di un mio coinvolgimento personale: ne va della mia vita. L’amore-fede è cosa forte per uomini forti: è un rischio; si entra nell’amore-fede come varcando l’oceano per porre piede su di un nuovo continente. Non è un video gioco (si prova, si conclude, si torna al punto di partenza), non è come la reversibilità della fisica moderna. Nell’amore-fede si vive sperimentando su di sé: e la cosa ti cambia, profondamente, come è chiaro nel matrimonio. 10. Una conclusione provvisoria Dalle mie analisi risulta quindi che la virtù e la scienza non sono in grado di surrogare la fede come essenziale e qualificante atto umano. Molte altre cose si potrebbero dire in proposito, però qui basta, tirando le fila del discorso, ricongiungere 1) il desiderio di felicità che è proprio di ogni uomo, 2) il suo incarnarsi nel vissuto del bimbo, dell’adolescente e, poi, dell’adulto, 3) la dialettica di uomo di bisogno e uomo di desiderio e, infine, 4) quanto ora esposto circa l’atto di fede per rendersi conto che l’appagamento può incamminarsi sulla via dell’autoerotismo o dell’eteroerotismo a seconda dell’idea di fede che si ha e che si vive. 132 Lc. 2, 35. 157 Infatti, una fede ridotta a mero mezzo di conoscenza è giusto che muoia e lasci completamente posto alla visione non appena ciò si rende possibile: o prometeisticamente con la gnosi (pneumatologia e scienzatecnica) o con la visione paradisiaca (in certo cristianesimo “spiritizzato”). Se invece la fede è amore e conoscenza, nel pieno rispetto della razionalità, essa si colloca nella strada dell’eteroerotismo. È ragionevole ammettere la propria finitezza e impotenza ed è altrettanto ragionevole attendersi che un Altro mi salvi: è così nella mia vita di bimbo bisognoso e in quella di erotico amante. Perché non è ragionevole che lo sia in tutto, anche per la mia più profonda essenza? Questa fede amore-conoscenza, inoltre, è in grado di soddisfare all’esigenza aristotelica sopra ricordata, e cioè di dare “per via” quel Bene nei beni finiti. È nell’esperienza di fede, infatti, che io prendo parte al Bene, pur non possedendolo ancora pienamente: è il mio un amare di amante sempre sazio e sempre digiuno; è il mio un conoscere di chi penetra nel mistero e, sempre più inabissandosi, sempre più conosce che è altissimo. Ma… expertus solus potest dicere quam sit dulce Christum diligere!. Alla fine è spiegato anche il titolo di questo mio lavoro: La felicità al giusto prezzo. Sì, perché quale prezzo può avere la felicità, quella “vera”, se non quello della vita intera?: di Colui che mi si dona e di me che a Lui mi dono? Soren Kierkegaard scriveva: «si potrebbe sollevare la questione se sia lecito ricevere la comunione senza obbligarsi a morire per la fede»133. E Dietrich Bonhoeffer in Sequela distingue tra “grazia a buon mercato”, intesa come svendita della remissione, del conforto, del sacramento, come riserva inesauribile della chiesa a cui attingere a piene mani, senza problemi, senza limiti, senza conversione e senza sequela di Cristo e “grazia a caro prezzo”, così intesa 133 Søren Kierkegaard, Diario, n. 2930. 158 «un tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l’uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva (Mt. 13 v44); pietra preziosa per il cui valore il mercante dà tutti i suoi beni (Mt. 13 v45ss.); signoria regale di Cristo, per amore del quale l’uomo strappa da sé l’occhio che lo scandalizza (Mc. 9 v47); chiamata di Gesú Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si pone alla sua sequela (Mc. 1 vv1620)»134. Un’ultima parola: ho lavorato di ragione e ho trattenuto il valore che, come diceva Immanuel Kant, «ha saputo resistere al suo libero e pubblico esame»135. Se così non fosse, usatemi indulgenza e correggetemi. 134 Dietrich Bonhoeffer, Sequela, Queriniana, Brescia 2002, pp. 27-41. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, in ID., Werke 3, p. 13, nota tr. it., Critica della ragion pura, Laterza, Bari 1958, p. 7. 135 159 Appendice Questo breve scritto si limita a introdurre alle tematiche della persona. In esso, infatti, chiarisco il pensiero di Aristotele a proposito dell’essenza dell’uomo, correggendo alcuni travisamenti di Severino. Ad un altro lavoro il compito di inoltrarsi in tali tematiche. Con la «speranza» di farsi «capire», Emanuele Severino sul “Corriere” (I/12/04, p. 1) ritiene di produrre «per la prima volta» un «argomento decisivo» che proverebbe che la «logica» di coloro che «sostengono che l’embrione è un essere umano», se fosse «coerente ai propri principi», spingerebbe ad affermare che «l’embrione non è un essere umano». Ecco la sua argomentazione. Ammaestrati dalla teoria aristotelica della “potenza”, comunemente si pensa che «l’embrione prodotto dal seme dell’uomo e dall’ovulo della donna sia essere umano in potenza – ossia qualcosa che in condizioni «normali» ha la capacità di diventare un essere umano». Tuttavia, e lo ammettono anche i cattolici, il «processo che conduce dall’embrione all’uomo compiutamente esistente (uomo “in atto”, dice Aristotele) non è garantito, non è inevitabile, non ha un carattere deterministico, ossia tale da non ammettere deviazioni o alternative». Perciò, «proprio perché è «in potenza» uomo, l’embrione è in potenza anche non-uomo». Nell’embrione «questi due opposti sono uniti necessariamente», mentre «l’uomo autentico è uomo, e non è insieme non-uomo». Di qui si imporrebbe la conclusione: «l’embrione non è già un uomo – non è cioè quell’esser autenticamente uomo che rifiuta di unirsi all’esser nonuomo. Questo autentico esser uomo non è pertanto “contenuto” nell’unità potenziale dell’esser uomo e del non esser uomo». Per questo, «Non essendo, l’uomo, «contenuto» nell’embrione, non si può quindi dire che sopprimendo l’embrione si uccide l’uomo». Così, conclude in modo beffardo Severino, sono gli stessi cattolici, «gli amici più fedeli» 161 dell’embrione considerato alla «luce dell’idea di potenza», ad affermare, «sia pure inconsapevolmente», «che l’embrione non è un essere umano, e che la sua soppressione a fini terapeutici o eugenetici non è omicidio». Osserviamo che questa è l’argomentazione di Severino, ma non è quella di Aristotele (e neppure dei “cattolici”), come sembrerebbe dalle sue parole. Facciamo, in breve, tre osservazioni. La prima. In Aristotele la dottrina dell’atto e della potenza è alla base della spiegazione del divenire. Un soggetto (embrione, bambino, adulto) è metafisicamente composto da due principi (non due “cose”): la “forma”, detta anche “anima”, che è appunto l’”atto”, cioè il principio della perfezione, e la “materia”, che è la “potenza”, cioè il principio passivo, recettivo, al quale la forma comunica l’essere. Perciò per Aristotele non esiste alcun soggetto, neanche l’uomo adulto, che sia “atto perfetto”, proprio perché l’individuo è sempre composto anche di un aspetto potenziale suscettibile di sempre ulteriori determinazioni e perfezionamenti. La seconda. Sempre secondo Aristotele, l’embrione è uomo in potenza, perché possiede la forma, cioè l’anima, come «atto primo» di un corpo naturale che ha la vita in potenza (Sull’anima, II 1, 412 a 27-28). L’atto primo è la presenza di una capacità, come, ad esempio, la scienza, che è posseduta dallo scienziato anche nel sonno: non l’esercizio effettivo, che è posseduto solo nella veglia (la Scolastica chiamerà “atto secondo” questo esercizio effettivo) (Ibidem, 412 a 22-27. Così, analogamente, nell’embrione è presente, come “atto primo”, l’anima intellettiva, anche se essa, quanto all’”atto secondo”, cioè all’”esercizio”, non esercita tutte le sue facoltà fin da principio: comincia con quella vegetativa, poi segue quella sensitiva e, infine, sarà la volta di quella razionale. Ma si badi: per Aristotele non sono tre anime che si succedono, ma una sola anima che possiede tre facoltà (Ibidem, 414 b 28-415 a 12). Perciò l’embrione possiede, dal primo momento del suo esistere “separato”, cioè come individuo a sé stante, la sua “essenza”, o “forma”, o “atto primo” che è capace di “muovere” la materia (dalla prima cellula in poi) e quindi di generare i vari organi. Quest’anima, sempre per Aristotele, è 162 l’anima della specie umana: dell’uomo. Dunque l’embrione è uomo in potenza, come in modo diverso lo è il bambino, e lo sono l’adulto e l’anziano. Non esiste, come detto, per Aristotele un soggetto dotato di corporeità che sia solo e pienamente “atto”, cioè totalmente realizzato. La terza. Nel libro IX della Metafisica, Aristotele precisa che le cose aventi in sé il principio della loro generazione, cioè gli esseri naturali, sono in potenza quando possono attuarsi per virtù propria e non intervengano impedimenti dall’esterno alla loro attuazione (Metaph. IX 7, 1048 b 37-1049 a 14). Così l’embrione, se non intervengono impedimenti esterni, ma solo forze agenti coadiuvanti (l’organismo materno che lo nutre), diventa fetobambino-adulto per virtù propria, cioè da sé. Perciò Severino sbaglia clamorosamente quando afferma che, proprio in base alla teoria aristotelica, si può affermare che l’embrione sia insieme e sotto lo stesso aspetto “uomo” e “non-uomo”. Egli allude al fatto, riconosciuto, che il processo di sviluppo non è “garantito” e che non esclude “deviazioni” o “alternative”. Ma per Aristotele l’”alternativa” “non-uomo” è solo quella della morte dell’embrione perché, come visto, se nulla lo ostacola, diventa solo ed esclusivamente “uomo”, meglio “uomo bambino e poi adulto…”. Questa alternativa, l’essere in potenza “non-uomo”, è però propria di tutti: anche dell’adulto. Ma, a rigore, non di “potenza” qui si dovrebbe parlare, bensì di “possibile”. Si impone ora una conclusione. Se uccidere un adulto è omicidio, lo è anche l’uccidere un bambino, un embrione, un vecchio. Abbiamo detto “se”, perché infatti non è sufficiente la teoria della generazione di Aristotele per proclamare la sacralità di ogni vita umana, dal concepimento alla morte naturale, così come fa la Chiesa. Occorre dimostrare che quell’”atto primo”, l’”anima”, che conferisce il proprio essere al corpo, possiede una dignità tale da distinguerla come “universo a parte” nel cosmo. È quanto hanno tentato di fare, e con buone ragioni da ascoltare e da non fraintendere pregiudizialmente, molti filosofi, non solo cattolici. 163 Pubblicazioni dell’I.S.U. Università Cattolica
Scarica