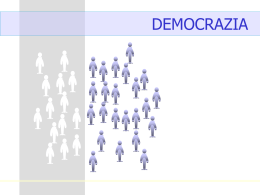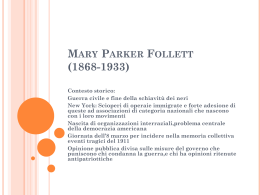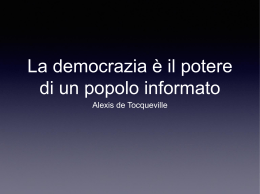SULLA DEMOCRAZIA
A cura di
CORRADO BEVILACQUA
Materiali per una discussione politica
Testi di
Luciano Canfora, Angelo Panebianco, Giuseppe Bedeschi, Gianfranco Pasquino, Maurizio Degli
Innocenti, Giovanni Sartori
I libri di
laprimaradice.myblog.it
INTRODUZIONE
di
CORRADO BEVILACQUA
Da molto tempo si parla di crisi della democrazia (Huntington e Crozier ). Alcuni autori hanno
parlato di post-democrazia (Crouch). Altri hanno parlato di democrazie senza democrazia
(Salvadori). In realtà, il vero problema è che esiste una grande confusione su ciò che è la
democrazia (Sartori).
Secondo la sua classica definizione risalente a Abramo Lincoln, la democrazia è governo del
popolo, con il popolo, per il popolo, sul popolo. Fondamentale, in tale contesto, è il problema
della rappresentanza politica. Ciò differenzia la democrazia rappresentativa dalla democrazia
diretta (Rensi).
Il referendum è uno strumento di democrazia diretta per mezzo del quale gli elettori,
essenzialmente tutti coloro che hanno già ottenuto il diritto di votare nelle normali
consultazioni elettorali, sono chiamati prevalentemente a decidere con un 'sì' oppure un 'no' su
una o più tematiche più o meno chiaramente delineate. In effetti, gli elettori non decidono in
tutti i tipi di referendum, ma soltanto in quelli nei quali la scelta è secca, con un'alternativa
chiaramente delineata fra due sole opzioni legislative ovvero di politiche pubbliche. Questo
tipo di referendum, che può essere definito 'deliberativo', è probabilmente quello che meglio
traduce l'essenza del referendum quale strumento di democrazia diretta. Una volta espressi e
contati i voti, l'opzione prescelta dagli elettori dovrebbe essere attuata, nei limiti del possibile,
senza ulteriori mediazioni né politiche né legislative. Esiste anche un altro tipo di referendum,
quello 'abrogativo', che dovrebbe escludere qualsiasi mediazione traducendosi nella
cancellazione di una legge o di sue parti. Pur intrinsecamente più limitato del referendum
deliberativo - in quanto, per l'appunto, circoscritto all'abrogazione di una o più norme o di loro
parti, da cui deriva però una certa indeterminatezza concernente l'organicità delle norme
rimanenti -, il referendum abrogativo pone anch'esso l'elettore di fronte all'alternativa sì/no, e
specificamente: abrogare in tutto o in parte un testo legislativo, oppure conservare, in tutto o in
parte, quel testo. Tuttavia alcune delle conseguenze di un voto favorevole all'abrogazione di
una o più norme o di loro parti possono richiedere interventi legislativi da parte delle assemblee
elettive, sia perché provocano un vero e proprio vuoto legislativo, sia perché comportano la
necessità di una ricucitura e di una precisazione delle norme rimanenti. Il caso italiano,
caratterizzato dall'esistenza di questo referendum a livello nazionale, offre numerosi esempi di
ritaglio di leggi, di abrogazione di alcune norme, di esigenza di ricorrere al Parlamento sia per
la stesura vera e propria di un testo legislativo che per l'adeguamento delle norme rimanenti alle
preferenze espresse dall'elettore, nonché di conseguenti critiche per l'operato del Parlamento,
accusato talvolta di manipolare la volontà degli elettori.
Esistono almeno altri due tipi di referendum meritevoli di attenzione: il referendum
'consultivo', definito anche, non del tutto propriamente, 'di indirizzo', e il referendum
costituzionale. Facendo ricorso al referendum consultivo, le autorità, i governanti, le assemblee
elettive esprimono l'esigenza di sondare le preferenze degli elettori su una determinata scelta da
compiere, senza sentirsi perciò necessariamente vincolati dal risultato del voto, oppure
vogliono delegare agli elettori la responsabilità di scelte particolarmente complesse,
controverse, sgradite. Naturalmente, se l'alternativa posta all'elettorato è fra due sole opzioni,
l'esito non si presterà a interpretazioni più o meno manipolative, ma comunque i governanti
manterranno una certa discrezionalità nell'adeguarsi al verdetto referendario. Tuttavia, per
quanto raramente, le opzioni praticabili possono essere più di due. Ad esempio, gli elettori
svedesi furono chiamati per ben due volte a scegliere fra tre alternative: nel 1957 tra differenti
sistemi pensionistici, nel 1980 tra la chiusura più o meno totale e immediata o la prosecuzione
dell'attività delle centrali nucleari. La conseguenza fu che nessuna delle tre alternative ottenne
la maggioranza assoluta, lasciando la responsabilità della decisione al governo.
Comprensibilmente, quando l'alternativa posta dal referendum non è secca, governo e
parlamento godono di una riserva interpretativa che potrebbe anche concretizzarsi in una
mancata osservanza delle preferenze dell'elettorato costretto a esprimersi in maniera non
decisiva. Di converso, una volta fatto ricorso a un referendum consultivo, governo e
parlamento devono comunque assumere quelle responsabilità decisionali che parevano voler
evitare proprio indicendo il referendum.
Quanto al referendum costituzionale, in linea di massima deve essere collocato fra i referendum
deliberativi. Possiede, però, alcune caratteristiche peculiari di significativa rilevanza politica
che vanno esplicitate e analizzate. In primo luogo, molte costituzioni, in particolare quelle
formulate dopo traumi politici - guerre, crisi di regime, mutamenti di confini, nascita di nuovi
Stati -, sono sottoposte all'approvazione popolare proprio al fine di acquistare una maggiore
legittimità. In secondo luogo, molti ordinamenti prevedono esplicitamente l'obbligatorietà del
referendum costituzionale per l'introduzione di qualsiasi modifica alla costituzione vigente, sia,
anche in questo caso, per accrescere la legittimità delle modifiche che per garantire le
minoranze, parlamentari, politiche, sociali, con il ricorso al corpo elettorale.
Diversamente dagli ordinamenti esistenti nelle democrazie contemporanee, la Costituzione
italiana, che codifica la possibilità del referendum abrogativo sulle leggi ordinarie, contempla
anche, esclusivamente per le leggi di revisione costituzionale, un altro tipo di referendum
definibile 'confermativo', ma in realtà 'ripudiativo'. Secondo l'art. 138 il referendum è
facoltativo e può essere attivato sia da un quinto dei membri di una Camera che,
alternativamente, da cinquecentomila elettori oppure da cinque Consigli regionali. La modifica
costituzionale è promulgata esclusivamente se approvata dalla maggioranza dei voti validi. Con
questo tipo di referendum l'elettorato è chiamato a rispondere 'sì' oppure 'no', accettando ovvero
ripudiando le modifiche introdotte a singoli articoli della Costituzione e non, si noti bene, testi
costituzionali organici e sostitutivi di quello attualmente in vigore. Finora questo tipo di
referendum non è mai stato utilizzato, anche perché le modifiche costituzionali, poche e poco
significative, sono state approvate da maggioranze parlamentari superiori ai due terzi delle due
Camere, tali, cioè, da impedire costituzionalmente la richiesta stessa di referendum.
Naturalmente, anche se una modifica prodotta dal Parlamento acquisirebbe maggiore rilevanza
politica e più consistente legittimità se confermata dagli elettori, è nel caso del ripudio che il
referendum appare più significativo. Infatti il ripudio popolare espresso dal referendum
segnalerebbe una grave discrepanza fra le preferenze del paese legale, che in Parlamento ha
approvato quella modifica costituzionale, e le preferenze del paese reale, espresse dal voto dei
cittadini che hanno invece respinto quella modifica.
Poiché le tipologie dei referendum sono svariate, è molto difficile ricondurle a poche e precise
categorie. Tuttavia almeno tre elementi, oltre alle modalità già brevemente esposte, servono a
differenziare in maniera sufficientemente limpida i tipi di referendum (per due di essi v. Smith,
1976). La prima grande distinzione riguarda chi ha il potere di attivare lo strumento
referendario; la seconda riguarda il livello politico al quale lo strumento può essere attivato e
utilizzato; la terza riguarda le conseguenze perseguite. Il potere di attivare il referendum viene
variamente attribuito alle autorità istituzionali (ad esempio, ai presidenti della Repubblica
oppure, ad altro livello, ai sindaci), ai governanti e al parlamento, ovvero a sue frazioni, a enti
locali (in Italia i Consigli regionali e comunali) e a un certo numero di cittadini. In qualche
caso, peraltro, come in Francia, i cittadini non hanno il potere di attivare i referendum: possono
farlo soltanto il governo e il Parlamento. In altri casi invece, ad esempio nella Costituzione
italiana, ai governanti è completamente precluso il ricorso al referendum. Qualche volta
l'intreccio fra governo e parlamento è tale che questa distinzione si perde. In Francia è la
maggioranza parlamentare, quindi il governo, che chiede al presidente della Repubblica di
indire un referendum. Ma se il presidente è anche il capo della maggioranza politica in
Parlamento, appare evidente che potrà sollecitare con successo, come ad esempio fece più volte
Charles de Gaulle, questa richiesta parlamentare. In Italia nel 1989 fu il Parlamento, con pieno
favore e sostegno del governo in carica, ad approvare una legge apposita per interrogare i
cittadini, con un referendum di indirizzo, sulla loro disponibilità a conferire poteri costituenti al
Parlamento europeo (una prevedibilmente schiacciante maggioranza rispose in senso
affermativo).
Poiché in Italia il referendum è abrogativo e come tale si configura - se il suo risultato è la
prevalenza dei no - anche il referendum costituzionale, proprio perché può essere richiesto,
come abbiamo anticipato, da un quinto dei componenti di una Camera, o da almeno
cinquecentomila elettori ovvero da almeno cinque Consigli regionali, nella tipologia elaborata
da Gordon Smith esso è definito di natura antiegemonica, vale a dire orientato a controllare il
potere politico e non a rafforzarlo con una delega potenzialmente di tipo plebiscitario
(caratteristica insita nelle consultazioni referendarie attivabili dai detentori del potere politico,
di governo). Nella Costituzione italiana esistono anche altri attori, spesso negletti, che possono
avanzare specifica richiesta di referendum (art. 132): i Consigli comunali che desiderino
procedere alla fusione di regioni esistenti o alla creazione di nuove regioni o all'aggregazione di
province e comuni da una regione a un'altra.Il tipo di referendum più distante da quello attivato
dai cittadini è comprensibilmente quello attivato dai governanti, per l'appunto collocabile nella
categoria da Gordon Smith definita egemonica poiché viene utilizzato al fine di rafforzare i
detentori del potere politico. Probabilmente sulla carta l'esempio migliore di questo tipo di
referendum è presentato dalla Quinta Repubblica francese, anche se referendum con
caratteristiche quasi plebiscitarie costellano tutta la storia costituzionale della Francia (v. Morel,
1994). In Francia è il presidente della Repubblica che indice il referendum ma, come già
rilevato, lo può fare esclusivamente "su proposta del governo per tutta la durata delle sessioni
parlamentari o su proposta congiunta delle due Assemblee pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale"
(art. 11). Se è vero che il presidente, quale capo riconosciuto della maggioranza politicoparlamentare, non avrà nessuna difficoltà a sollecitare e ottenere tutte le proposte che vuole, è
anche vero che, in caso di coabitazione con una maggioranza ostile, il presidente non potrà fare
ricorso al referendum, soprattutto se lo desidera in chiave plebiscitaria. Inoltre, il referendum
francese ha come oggetti specifici esclusivamente l'organizzazione dei poteri pubblici e la
ratifica di un trattato che incida sul funzionamento delle istituzioni. In sostanza il referendum
francese, da un lato, non consente al presidente e al governo della Quinta Repubblica di
legiferare in materie ordinarie e, dall'altro, non consente ai cittadini di attivarsi autonomamente
per influenzare l'agenda legislativa e la formazione e l'abrogazione di leggi.
La seconda importante distinzione riguarda il livello politico-territoriale al quale sono indetti i
referendum. Tra le grandi democrazie contemporanee ve ne sono cinque che non hanno mai
fatto ricorso a referendum nazionali: Giappone, India, Israele, Olanda e Stati Uniti. Nel
secondo dopoguerra la Repubblica Federale Tedesca (poi la Germania unita) ha rinunciato alla
possibilità di tenere referendum nazionali, cosicché persino la riunificazione tedesca del 1990 è
stata preceduta da un referendum svoltosi soltanto nei Länder della Germania dell'Est. Il Belgio
ha fatto ricorso a un solo referendum nazionale nel 1950 per accertare il favore dei cittadini al
ritorno del re, che venne approvato. Si potrebbe pensare che, fondati su una solida concezione
della supremazia della democrazia rappresentativa, siano in special modo i sistemi politici
legati all'esperienza costituzionale anglosassone - a partire, ovviamente, dalla Gran Bretagna - a
conoscere solo eccezionalmente referendum nazionali. Però, enunciata la regola, si fa presto a
scoprire le eccezioni, che sono in effetti molto significative. Gli Stati Uniti sono l'unica grande
democrazia anglosassone rimasta fedele alla regola 'nessun referendum nazionale' (ovvero
federale). La Gran Bretagna ha infranto questo precetto nel 1975, quando il governo laburista
indisse un referendum relativo alla partecipazione britannica al processo di unificazione
europea, allora ancora sotto forma di Mercato Comune (v. King, 1977). Il Canada ha tenuto
quattro referendum nazionali relativi all'assetto politico-istituzionale del suo territorio. I due più
importanti hanno riguardato il tentativo del Québec di abbandonare la federazione canadese:
nel maggio 1980 i favorevoli furono il 40% e nell'ottobre 1995 mancarono ai secessionisti poco
più di quarantaduemila voti. La Nuova Zelanda, attraverso tre tornate referendarie svoltesi tra il
1992 e il 1993, ha trasformato il suo sistema elettorale, perfettamente maggioritario, in un
sistema ancora maggioritario, ma con significative componenti proporzionali. L'Irlanda ha
tenuto quindici referendum tra il 1937 (approvazione della Costituzione della Repubblica
d'Irlanda) e il 1995, approvando fra l'altro la ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992. Infine
l'Australia ha tenuto tra il 1906 e il 1988 ben quarantaquattro referendum su una gamma molto
ampia di tematiche: costituzionali, fiscali, socioeconomiche.
Dove non si hanno referendum nazionali si ha spesso, quasi a compensazione, una grande
proliferazione di referendum a livello politico-territoriale degli Stati e persino delle contee, per
esempio negli Stati Uniti (v. Magleby, 1984; v. Cronin, 1989), e su una molteplicità di
tematiche, come in Svizzera (v. Korbach, 1994; v. Kriesi, 1994). Di per sé il caso svizzero
appare complicatissimo da sintetizzare. Anzitutto va messo in rilievo che in Svizzera esistono
tre tipi di referendum: il primo, relativo a tutte le modifiche della Costituzione, è obbligatorio e
deve ottenere l'approvazione sia della maggioranza degli elettori sia, affinché le minoranze non
siano schiacciate, della maggioranza dei 26 cantoni; è invece facoltativo e richiedibile da
almeno cinquantamila elettori il referendum riguardante tutte le leggi approvate dal
Parlamento; c'è infine il referendum che deriva da un'iniziativa legislativa popolare firmata da
almeno centomila elettori e non tradotta in legge dal Parlamento. Dal 1848 al 1990 si sono
tenuti 144 referendum costituzionali obbligatori, dei quali 103 sono stati approvati; 103
referendum facoltativi su leggi approvate dal Parlamento, 45 delle quali confermate
dall'elettorato; 105 referendum sulle iniziative legislative popolari, soltanto dieci delle quali
approvate (v. Kriesi, 1994, p. 68). Peraltro va aggiunto che, sotto pressione, il Parlamento
svizzero si era già espresso favorevolmente su 60 delle 183 iniziative popolari
complessivamente avanzate da vari gruppi, movimenti e partiti, vanificando di conseguenza la
precedente richiesta di referendum.
Alla terza distinzione - le conseguenze dei referendum - è già stato fatto cenno quando si sono
separati i referendum che, promossi dai detentori del potere politico, mirano a rafforzarli da
quelli che, promossi dai cittadini, mirano invece a metterli sotto controllo, qualche volta a
ridimensionarne il potere e l'arroganza o addirittura a delegittimarli, o comunque a bloccare,
impedire, cancellare alcune scelte, alcune decisioni, alcune politiche. I referendum e, in
particolare, le iniziative popolari sia nei singoli Stati degli Stati Uniti che in Svizzera
appartengono chiaramente alla categoria antiegemonica. Le materie sottoposte a referendum su
iniziativa popolare sono svariate. Ad esempio, S. Möckli (v. 1994, p. 55) ha contato,
classificato e paragonato quelle della California e della Svizzera dal 1970 al 1990. Sono state
rispettivamente 226 e 178, su temi come le questioni istituzionali (tema prevalente di poco in
California), la morale pubblica, le finanze, l'economia, lo Stato sociale (tema prevalente di poco
in Svizzera), i diritti civili, l'ambiente e il traffico, l'istruzione e la cultura, l'esercito.
A questo punto si pone la necessità di effettuare almeno una ulteriore distinzione relativa agli
oggetti dei referendum. Vale a dire, quali tematiche possono essere sottoposte a referendum e
quali vengono, invece, esplicitamente escluse? Le due tematiche classiche dei referendum,
quelle che si potrebbero considerare di spettanza quasi obbligatoria, riguardano, da un lato,
l'assetto territoriale dello Stato, dall'altro, la sua costituzione. Più precisamente, per annettere
territori e popolazione a uno Stato esistente o in formazione, il referendum - qualche volta
definito anche plebiscito - costituisce lo strumento principale con cui i cittadini dei territori
interessati esprimono direttamente la loro adesione (come avvenne nell'Italia che si andava
unificando) o la loro ripulsa. Tra il 1859 e il 1860 gli elettori, nell'ordine, della Toscana, del
Regno delle due Sicilie, delle Marche e dell'Umbria aderirono al Regno di Sardegna. Nel 1866
fu la volta del Veneto e nel 1870 si tenne il referendum nell'ex Stato pontificio. Le percentuali
di adesione furono tutte elevatissime, sopra il 90%, cosicché il termine plebiscito, con cui
vennero designate queste consultazioni referendarie, appare particolarmente appropriato.
Con il referendum, inoltre, si può procedere anche all'abbandono di uno Stato esistente da parte
di alcuni settori della sua popolazione, sia per creare uno Stato nuovo che per unirsi a uno già
esistente. Ad esempio, nel 1860 Nizza e la Savoia decisero, separatamente, di aderire alla
Francia; nel 1947 Tenda e Briga decisero di abbandonare l'Italia e di entrare a far parte della
Quarta Repubblica francese. Abbiamo già detto che per due volte i separatisti del Québec
furono sconfitti in Canada, anche se la seconda volta di stretta misura, ma sarà anche utile
menzionare il tormentato distacco dell'Algeria dalla Francia. Si tennero quattro referendum: nel
1958 a favore della permanenza nella comunità francese; nel 1961 per l'autodeterminazione;
nell'aprile 1962 per l'approvazione degli accordi di Evian e nel luglio 1962 per l'indipendenza
come era stata sancita da questi accordi. Va sottolineato che in generale le separazioni ovvero le
scissioni territoriali avvengono più spesso in maniera cruenta e senza verifiche referendarie, e
d'altronde l'indipendenza algerina era stata preceduta e accompagnata da una vera e propria
guerra di liberazione e da violente tensioni nel territorio metropolitano francese. Fa eccezione
la decisione consensuale di separazione della Slovacchia dalla Repubblica Ceca, presa a livello
di élites tra il 1992 e il 1993, con la tormentata esclusione di una verifica referendaria che,
secondo i sondaggi, avrebbe avuto come esito più probabile il rifiuto popolare della creazione
di due repubbliche.Il referendum viene in special modo utilizzato sia per definire la forma di
Stato (repubblica/monarchia) che per approvare la costituzione, e quindi anche la forma di
governo. Per referendum, ad esempio, l'Italia nel 1946 e la Grecia nel 1974 passarono dalla
monarchia alla repubblica. È opportuno ricordare, per l'importanza del caso, che con la
sconfitta nel plebiscito indetto sulla sua persona nell'ottobre 1988 il dittatore cileno Augusto
Pinochet Ugarte aprì la strada addirittura a un cambiamento di regime: uscita da un regime
autoritario fortemente repressivo e ritorno alla democrazia, per quanto non del tutto emancipata
dall'ipoteca militare. Quanto all'approvazione delle costituzioni e delle loro modifiche, gli
esempi sono moltissimi. Tuttavia non sempre le costituzioni sono ratificate ed emendate dagli
elettori. Ad esempio, dopo la sua stesura ad opera della Convenzione di Filadelfia nel 1787, la
Costituzione degli Stati Uniti venne ratificata, grazie all'intensa e splendida battaglia dei
federalisti, non dai cittadini ma dalle Assemblee degli Stati aderenti all'Unione, alcuni dei quali,
peraltro, sottoposero le loro specifiche Costituzioni al voto popolare. La Costituzione italiana,
nonostante qualche richiesta di sottoposizione all'elettorato, venne approvata soltanto in sede
parlamentare nel dicembre 1947. Nel frattempo si erano consumati in Francia due precedenti
referendari molto significativi: rispettivamente, nel maggio e nell'ottobre 1946, si ebbero il
rigetto popolare della prima Costituzione della Quarta Repubblica e l'approvazione della
seconda Costituzione ad opera, come rilevò sprezzantemente il generale Charles de Gaulle, di
una minoranza, poiché la maggioranza dei cittadini si era espressa votando contro o
astenendosi. Opportunamente, la Costituzione della Quinta Repubblica francese venne
sottoposta nel 1958 all'elettorato, che la approvò con una maggioranza dei quattro quinti, e de
Gaulle indisse anche un altro referendum, nel 1962, per inserire nella Costituzione della Quinta
Repubblica un'importante modifica concernente l'elezione popolare diretta del presidente della
Repubblica, che fu debitamente approvata, ma con una maggioranza inferiore alle aspettative
del generale. In Spagna gli elettori furono chiamati a pronunciarsi durante la transizione dal
franchismo alla democrazia, prima nel 1976 a favore di un progetto di modifica costituzionale,
poi nel 1978 sul testo stesso della nuova Costituzione, poi ancora, nel 1986, sulla permanenza o
meno nella NATO (decisione favorevole).
Per coloro che considerano la legge elettorale un meccanismo di importanza pari a quella delle
singole norme costituzionali sull'organizzazione dei poteri, pur se formalmente non fa parte
della Costituzione, va aggiunto che spesso anche le modifiche alle leggi elettorali costituiscono
oggetto di referendum. Basteranno due esempi che, nella loro diversità, possono essere
emblematici poiché la riforma della legge elettorale ha dimostrato di incidere
significativamente su tutto il sistema politico. Si è già detto della Nuova Zelanda, che tra il
settembre 1992 e il novembre 1993, attraverso tre consultazioni referendarie, è passata da un
sistema maggioritario a turno unico applicato in collegi uninominali a un sistema misto, ma con
una consistente prevalenza della formula maggioritaria per l'assegnazione dei seggi e con la
protezione della minoranza maori. Ma è stato il caso italiano ad attirare maggiormente
l'attenzione degli studiosi. Contro l'indifferenza e addirittura l'ostilità della classe politica, non
solo di governo, il tema della riforma elettorale fu posto sull'agenda politica da un Comitato per
le Riforme Elettorali che raccolse le cinquecentomila firme necessarie e ottenne un referendum
sulla preferenza unica. Tenutosi nel giugno 1991, questo referendum registrò la forte
propensione degli elettori ad appoggiare una riforma elettorale in senso maggioritario.
Seguirono le richieste di due referendum sui sistemi elettorali dei comuni e del Senato,
riformulati in maniera da rispondere alle obiezioni della Corte costituzionale che li aveva in
precedenza dichiarati inammissibili sia per l'oscurità della formulazione che per
l'indeterminatezza delle conseguenze. Stimolato dalla richiesta di referendum, il Parlamento
italiano varò una legge che rispondeva sostanzialmente al quesito sui comuni e introduceva un
sistema maggioritario con l'elezione diretta del sindaco. Cosicché, nell'aprile 1993 si tenne
soltanto il referendum sul sistema elettorale del Senato, che venne approvato dall'82,7% dei
votanti. Dopo la scrittura delle leggi elettorali derivanti dal referendum, superata la
proporzionale, l'intero sistema politico italiano cambiò volto e dinamica procedendo, seppur
faticosamente, verso una democrazia maggioritaria e bipolare.In conclusione, dopo aver
sottolineato che le tematiche che sono abitualmente, ma non universalmente - seppur in qualche
caso obbligatoriamente -, oggetto di referendum sono le modifiche territoriali e costituzionali,
va registrato l'accresciuto ricorso ai referendum nei sistemi politici contemporanei, dovuto a un
insieme di ragioni collegate, da un lato, all'esplosione (della ricerca) delle identità politiche,
dall'altro, all'aggiornamento o alla formulazione, nel caso di sistemi politici che si affacciano
alla democrazia, dei testi costituzionali. In generale, anche nelle democrazie consolidate le
dinamiche politiche, sociali e istituzionali spingono verso la sottoposizione a referendum di
molteplici materie. L'aumento quantitativo del ricorso al referendum come modalità decisionale
e di partecipazione politica dipende, come si argomenterà in seguito, in misura minore dalla
maggiore propensione delle élites ad accettarlo o a indirlo, e in misura maggiore da
un'accresciuta attivazione dei cittadini anche contro le preferenze delle élites.
Come si è visto negli inevitabilmente brevi cenni sopra dedicati a istanze concrete di
referendum, esistono materie specifiche sulle quali gli elettori sono effettivamente, e qualche
volta obbligatoriamente, chiamati a decidere, ma non è possibile individuare una volta per tutte
le materie sottoposte a referendum e quelle sistematicamente escluse. Ad esempio, la
Costituzione italiana dichiara esplicitamente inammissibile il ricorso al referendum sulle "leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati
internazionali". In altri ordinamenti, invece, alcune di queste leggi vengono tipicamente, e
qualche volta obbligatoriamente, sottoposte a referendum. Così, il presidente François
Mitterrand decise di sottoporre a referendum nel settembre 1992 il Trattato di Maastricht, tipico
trattato internazionale, perché implicava alcune revisioni della Costituzione francese, ma
soprattutto per ottenere un mandato popolare a procedere verso l'unificazione dell'Europa,
mandato che ottenne però in maniera alquanto risicata (51% di voti favorevoli). L'adesione al
processo di unificazione europea, che implica una qualche cessione di sovranità, è stata oggetto
di numerosi e molto significativi, persino laceranti, referendum. La Norvegia è risultata la più
riluttante delle democrazie europee ad aderire all'Europa. Nel referendum del 1972,
opponendosi alle preferenze dichiarate dei maggiori partiti e delle élites politiche ed
economiche, gli elettori norvegesi bocciarono la proposta di aderire al Mercato Comune. Più di
vent'anni dopo, nonostante che la Danimarca avesse capovolto la sua iniziale ripulsa del
Trattato di Maastricht (giugno 1992) approvandolo (maggio 1993) dopo la rinegoziazione di
alcuni termini, e la Finlandia e la Svezia avessero già aderito all'Unione Europea, gli elettori
norvegesi decisero nuovamente di rimanere fuori dall'Europa nel timore di essere costretti ad
accettare stili di vita non graditi.Su un piano molto diverso i cittadini californiani decisero nel
1973 di far iscrivere sulla scheda elettorale la proposta di abolire le tasse statali sugli immobili,
tipica materia fiscale, nota come Proposition 13. Vinsero gli 'abolizionisti', determinando una
serie di conseguenze fiscali ed economiche impreviste e sgradite (ad esempio la drastica
riduzione dei servizi sociali) e aprendo la strada alla cosiddetta Reaganomics, vale a dire alla
strategia della riduzione generalizzata delle tasse per rilanciare l'economia. È interessante
notare come in altri Stati americani proposte simili siano poi state bocciate dall'elettorato, reso
edotto della caduta del livello dei servizi californiani inevitabilmente prodotta dalla riduzione
delle tasse pagate dagli abbienti alle comunità locali. Queste non sistematiche osservazioni
mirano soltanto a segnalare come gli usi dello strumento referendario risultino comprensibili
soltanto se collocati e analizzati nell'ambito di un sistema politico e poco si prestino a
generalizzazioni di ampio respiro.
Ciò detto, rimane possibile individuare almeno quattro grandi obiettivi perseguibili grazie ai
referendum. Il primo obiettivo riguarda la scelta della forma di Stato, della Costituzione, delle
modifiche territoriali e costituzionali, tutte tematiche di cui si è già detto sopra. Il secondo
obiettivo consiste puramente e semplicemente nella legislazione su tutte le materie consentite
dai vari ordinamenti giuridici, che variano in maniera molto significativa raggiungendo il punto
più elevato in termini di quantità e di qualità in Svizzera e nei singoli Stati degli Stati Uniti
d'America. A livello considerevolmente diverso si deve ricordare che in Italia è grande la
varietà di tematiche passibili di referendum - ancorché sia limitato il ricorso - a livello
municipale e provinciale (v. Di Giovine, 1992). Il terzo obiettivo, in parte riconducibile al
secondo, consiste nell'abrogazione di leggi esistenti, tipica del caso italiano, e in parte di quello
svizzero, una sorta di referendum 'oppositivo', pur con tutte le cautele inscritte nella legge di
disciplina del referendum abrogativo italiano, che peraltro non sono valse a evitarne un uso
distorto. Questa distorsione si traduce nel quarto obiettivo, perseguibile e perseguito anche
attraverso le iniziative referendarie attuate sia nei singoli Stati degli Stati Uniti che in Svizzera:
stimolare le assemblee legislative ad agire in determinati campi secondo le preferenze espresse,
più o meno limpidamente e univocamente, nelle richieste referendarie. È soprattutto con
riferimento a questa fattispecie di stimolo che il referendum nelle sue varie modalità appare
come uno strumento di democrazia diretta tale da non contrapporsi alla democrazia
rappresentativa. Al contrario, il referendum complementa, integra, sostiene la democrazia
rappresentativa, forse la indirizza e talvolta la forza, a seconda della vitalità delle assemblee
rappresentative, della loro produttività e dell'efficacia della stessa forma di governo. Infine, il
referendum può anche incidere in maniera significativa sul sistema dei partiti producendone la
ridefinizione e la ristrutturazione duratura nel senso di una maggiore rispondenza dei singoli
partiti e del sistema nel suo complesso alle nuove domande e nuove preferenze dei cittadini.
I tanto temuti rischi di plebiscitarismo - che cioè i governanti eludano tutte le mediazioni della
democrazia rappresentativa, facendo ricorso diretto, frequente e quasi esclusivo alla volontà
popolare espressa per mezzo di referendum su quesiti posti dai governanti stessi - appaiono
oggi esagerati e sopravvalutati. In verità, nessun governante, né nei regimi democratici né nei
regimi autoritari, ha conquistato il potere attraverso appelli referendari e nessun governante è
stato in grado di ampliare il suo potere e mantenerlo grazie ad appelli e a procedure di questo
tipo. Cosicché se ne può concludere, almeno preliminarmente, che, per quanto non privo di una
carica semplificatrice, il referendum consente di sottoporre a verifica le preferenze dei cittadini
ed esplica compiti spesso altrimenti non fungibili nei regimi democratici. Questa affermazione
si rivela tanto più vera quando si guardi alla dinamica delle richieste di referendum e delle
consultazioni referendarie effettivamente tenutesi quando le assemblee rappresentative e
legislative non hanno né saputo né voluto intervenire sulle materie oggetto di referendum.
Regimi democratici vecchi e nuovi si sono nel corso del tempo dotati della possibilità di fare
ricorso al referendum, e hanno molto rapidamente sfruttato l'opportunità così creata. Inoltre in
alcuni paesi, come ad esempio l'Italia, il ricorso al referendum è cresciuto in maniera quasi
esponenziale, determinando l'aumento complessivo registrato nelle democrazie occidentali.
Comunque, poiché l'aumento non è da ricondursi esclusivamente al caso italiano, è opportuno
interrogarsi sull'esistenza di fattori comuni atti a fornire qualche spiegazione generalizzante.
Poiché i referendum sono strumenti che servono a prendere decisioni in un sistema politico,
almeno in prima approssimazione è possibile sostenere che il loro uso aumenta quando i
soggetti politici abilitati a prendere decisioni si rivelano titubanti, deboli, incapaci, comunque
non in grado di soddisfare le esigenze espresse dagli elettori. Se le cose stanno così, si capisce
perché il ricorso ai referendum è cresciuto e crescerà, entro certi limiti, ogniqualvolta i governi
siano instabili e mostrino carenze di decisionalità, ogniqualvolta i partiti non siano più in grado
di esercitare il loro potere. Se i governi non sanno oppure non vogliono prendere decisioni,
allora saranno gruppi di cittadini che si organizzano, le lobbies che si mobilitano, le minoranze
che si difendono e contrattaccano a mettere sull'agenda politica tematiche suscettibili di
richiedere e di ottenere una consultazione referendaria. Se le assemblee legislative intralciano e
rallentano i processi decisionali e se i partiti non dimostrano compattezza, allora si apre lo
spazio referendario. Naturalmente questo spazio può essere o no effettivamente colmato non
soltanto se i cittadini sono davvero in grado di organizzarsi e di mobilitarsi, ma soprattutto se lo
strumento referendario può essere attivato con facilità. Dopodiché, il livello di organizzazione e
di mobilitazione dei cittadini, delle lobbies e delle minoranze dipenderà, da un lato, dal grado
di insoddisfazione nutrito dagli attori rilevanti nei confronti dei processi decisionali e, dall'altro,
dalla loro fiducia nelle proprie capacità di influenzare la decisione nel senso desiderato.Il
circuito delineato - assemblee legislative, partiti politici, cittadini esigenti e influenti - viene
spesso completato dagli atteggiamenti e dai comportamenti delle élites di governo. Molte scelte
di politiche pubbliche sono oggi più complesse e controverse che nel passato. Quando in sede
di governo non viene raggiunto nessun accordo, quando persino l'opposizione si presenta divisa
su problematiche complesse, quando un processo decisionale viene, più o meno artificialmente,
esasperato, allora il ricorso al referendum serve anche a evitare, sia da parte del governo che da
parte dell'opposizione e persino dei singoli partiti, peraltro sempre investiti dagli effetti dei
referendum, scelte che potrebbero risultare laceranti; serve, infine, un po' a tutti a sfuggire
all'assunzione di responsabilità che potrebbero diventare troppo pesanti.
Agli occhi degli studiosi dei regimi e delle procedure democratiche il referendum occupa un
posto alquanto controverso. I problemi sollevati dal ricorso al referendum, dal suo svolgimento,
dalle sue conseguenze sul funzionamento dei regimi democratici sono molti e tutti di grande
importanza e di complessa valutazione (per una rassegna accurata della letteratura v. Morel,
1992). Un primo problema concerne il livello e la qualità delle informazioni disponibili e
acquisibili per i cittadini-elettori affinché la loro decisione risulti all'altezza della sfida
referendaria, vale a dire migliore di quella producibile da altre sedi. I critici del referendum
sostengono che la superiorità della democrazia rappresentativa deriva dalle migliori
informazioni disponibili e acquisibili dai rappresentanti eletti, sia attraverso i dibattiti nelle
assemblee che con apposite udienze conoscitive nelle quali i vari gruppi interessati alla
decisione apportano, oltre alla loro posizione specifica, anche elementi indispensabili alla
decisione e, presumibilmente, un po' di consenso politico. La grande maggioranza dei cittadinielettori, soprattutto quando le scelte sono tecnicamente complesse, avrà sempre
un'informazione inferiore, inadeguata, imperfetta, cosicché le decisioni degli elettori saranno
sempre esposte all'influenza di fattori tutt'altro che in grado di soddisfare i criteri
dell'accuratezza e della completezza. I sostenitori dei referendum ribattono che, proprio grazie
al clamore e all'interesse suscitati dai referendum, molti cittadini acquisiscono informazioni di
livello e di qualità superiori a quelle di partenza, e quindi il referendum ottiene il risultato di
educare parte della cittadinanza. Se poi il suo oggetto è formulato con chiarezza, il dibattito
referendario consente ai cittadini-elettori di scegliere almeno con la stessa consapevolezza con
la quale essi votano per un partito o per un candidato piuttosto che per un altro nelle varie
consultazioni elettorali. Chi nega che l'elettore possa acquisire tutta l'informazione desiderata
per poter oculatamente scegliere fra alternative di tematiche, di candidati, di partiti, finisce per
colpire al cuore lo stesso processo democratico.I critici del referendum, prendendo in parte lo
spunto dalle (presunte) carenze di informazione degli elettori, aggiungono che gli esiti dei
referendum sono spesso viziati anche dalla mancanza di competenza degli elettori. Non
soltanto essi, almeno quelli cosiddetti 'medi', che sono mediamente interessati alla politica, non
avrebbero un'adeguata informazione, ma anche se l'avessero non sarebbero in grado di
discriminare fra l'informazione corretta e quella manipolata. I sostenitori dei referendum
affermano invece che spesso neppure i rappresentanti eletti sono tutti in grado di procedere a
questa cruciale discriminazione e che, come nelle assemblee legislative ci sono esperti, fra gli
eletti e fra i funzionari, in grado di pilotare le decisioni, anche nel processo referendario fanno
la loro comparsa opinion makers ai quali alcuni o molti elettori si affidano. Naturalmente questi
leaders dell'opinione possono anche trovarsi nei partiti, cosicché l'elettore medio può sentirsi
rassicurato nel seguire l'opinione del suo partito, così come si sente sicuro l'elettore fiducioso
nella propria competenza - sia che segua il suo partito sia che lo contraddica -, convinto della
superiorità delle proprie conoscenze o semplicemente della preferibilità di un'alternativa.
D'altronde, e questa considerazione deve essere tenuta in gran conto, molte fra le tematiche
sottoposte a referendum non richiedono competenze particolari. Piuttosto, sollecitano prese di
posizione fondate su valori, su criteri etici e/o politici, ad esempio quando si tratta di divorzio e
aborto, oppure di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.
La verità, sostengono gli oppositori dei referendum, è che lo stesso processo referendario è
inevitabilmente esposto a una serie di distorsioni relative alle materie che possono essere
oggetto del referendum, ai soggetti che possono farsene promotori, alle modalità della
campagna referendaria, alla stessa validità dell'esito. È risaputo che spesso sono le minoranze
che attivano i referendum, sono alcune potenti lobbies che intervengono nella campagna
elettorale gettando sulla bilancia del voto tutto il denaro necessario, sono ancora minoranze
intensamente motivate che - in assenza della soglia percentuale richiesta per la validità del voto
(almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto) - possono imporre a maggioranze divise,
poco interessate e poco mobilitate decisioni che le assemblee elettive non produrrebbero mai.
Se le cose stanno così, replicano i sostenitori dei referendum, è però sempre possibile e anche
auspicabile che l'istituto referendario venga accuratamente regolamentato, con tutte le cautele
di cui già è circondato in molti paesi. Affinché venga richiesto, bisogna che un numero di
elettori relativamente elevato, ma non troppo elevato per non impedire alle minoranze di
difendersi contro l'eventuale tirannia della maggioranza, si esprima con le sue firme. Affinché
sia risolutivo, bisogna che il quesito sottoposto agli elettori sia limpido e univoco. Affinché la
campagna elettorale non venga inquinata dal denaro, occorrono accurati controlli sulle spese sia
del comitato promotore che degli oppositori, presumibilmente anch'essi organizzati in comitato.
Il controllo del denaro, che serve sostanzialmente per produrre informazioni di parte sui mass
media, TV in testa, sembra essere la condizione più difficile da garantire in assenza di una rete
di controlli sperimentata e a fronte dell'intervento di agenzie specializzate, in particolar modo
negli Stati Uniti e in Svizzera.
Infine, i critici dei referendum sostengono che, anche qualora venissero soddisfacentemente
risolti tutti i problemi di informazione e di competenza dell'elettorato e fosse evitata ogni
manipolazione del quesito e della campagna referendaria, si porrebbe comunque il problema
della partecipazione. Nei referendum la partecipazione degli elettori risulta sempre più o meno
nettamente inferiore alla partecipazione alle consultazioni politiche nazionali (o federali e
statali). Questo è tanto vero che in molti ordinamenti è stata esplicitamente introdotta la
clausola che, affinché l'esito del referendum sia valido, bisogna che partecipi alla consultazione
una certa percentuale di elettori, di norma almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Questa clausola esiste, ad esempio, nella legge che disciplina il referendum abrogativo italiano
e ha funzionato vanificando nel 1990 i referendum contro la caccia e contro l'uso dei pesticidi. I
sostenitori dei referendum controbattono che la minore partecipazione non è sufficiente a
dichiarare il fallimento del referendum in quanto tale. Essa è dovuta, in buona misura, a una
scelta consapevole e spesso deliberata degli elettori, parte dei quali si astengono poiché non si
ritengono adeguatamente informati o sufficientemente competenti per decidere.
Paradossalmente, in un certo senso questi elettori astensionisti consapevoli, tenendosi lontani
dalle urne, rispondono anche alle obiezioni degli antireferendari poiché non 'inquinano' l'esito
del voto, proprio come coloro che si astengono perché l'esito del voto appare loro ugualmente
irrilevante o ugualmente accettabile: entrambe motivazioni democraticamente comprensibili e
accettabili.In sostanza, lo strumento referendario contiene in sé un certo numero di vizi,
nessuno dei quali appare però particolarmente grave né più grave dei normali vizi democratici,
quelli cioè che attengono allo stesso processo democratico. Soltanto in parte alcuni di questi
vizi sono eliminabili, e alcuni sono, in parte, ridimensionabili. Ma il referendum contiene anche
un certo numero di non piccole virtù democratiche. Sarebbe sbagliato contrapporlo
frontalmente alla democrazia rappresentativa e ai suoi strumenti qualificanti, per due ragioni. In
primo luogo, perché la democrazia diretta, che pure si nutre anche di referendum, ha bisogno di
ben altri apporti e strumenti per essere e rimanere tale ed esclusivamente tale. In secondo
luogo, perché la democrazia rappresentativa, che è irrinunciabile in sistemi politici di
dimensioni medie e grandi, non può essa stessa rinunciare a quelle integrazioni, a quelle
correzioni, a quelle stimolazioni che soltanto il referendum può introdurre e mantenere nei suoi
processi decisionali. Cosicché, respinte le versioni estreme del 'partecipazionismo' e del
'rappresentativismo', appare pienamente in linea con l'analisi fin qui svolta la conclusione di A.
Ranney (v., 1994, p. 43) secondo cui la maggioranza dei democratici può e deve continuare a
"considerare lo strumento referendario come un supplemento talvolta utile per le istituzioni
della democrazia rappresentativa, ma mai un sostituto completo di esse".
Fino al 1900 si sono tenuti nel mondo 71 referendum. Dal 1901 al 1950 se ne sono tenuti 197;
dal 1951 al 1970 136; nel solo decennio 1971-1980 177; infine, dal 1981 al 1993 se ne sono
tenuti 218 (v. Butler e Ranney, 1994, p. 5). Nella Quinta Repubblica francese, nella quale il
referendum è limitato a materie riguardanti l'organizzazione dei poteri pubblici e ai trattati che
incidono sul funzionamento delle istituzioni, dal 1958 al 1996 si sono tenuti otto importanti
referendum. In Italia, dal 1974 al 1996, se ne sono tenuti 39. Buona parte di questi referendum
sono stati richiesti dal Partito radicale, anche se i più importanti, in sé e per le loro conseguenze
politiche, hanno avuto altri proponenti. Così, il referendum sul divorzio, che nel 1974 inaugurò
la legge di attuazione del referendum abrogativo, venne richiesto da numerose associazioni
cattoliche poi clamorosamente sconfessate dall'elettorato, anche da una parte di quello
cattolico. Nel 1985 il referendum sulla scala mobile venne richiesto dal Partito comunista che
dovette incassare una dura sconfitta. Nel 1987 il referendum sulla responsabilità civile dei
magistrati fu fortemente voluto, oltre che dai radicali, dai socialisti e dai liberali, ma fu poi
appoggiato anche dal Partito comunista. Nel 1991 l'importantissimo referendum sulla
preferenza unica venne richiesto, contro la volontà di tutti i partiti del pentapartito (PLI-DCPRI-PSDI-PSI), da un composito Comitato per le Riforme Elettorali, che ebbe anche il merito
di richiedere altri due referendum elettorali tenutisi nel 1993. Nello stesso anno si tennero
anche referendum sull'abolizione di quattro ministeri, intelligentemente richiesti da numerosi
Consigli regionali, e furono tutti approvati dall'elettorato. Infine, nel 1995 i cittadini italiani
vennero chiamati a votare simultaneamente il più alto numero di referendum, dodici, fra i quali
tre sul sistema televisivo, privato e pubblico, richiesti da appositi comitati e respinti
dall'elettorato.
Per ragioni diverse, facilmente collegabili alla natura e alla dinamica dei rispettivi sistemi
politici e partitici, la Francia, con i suoi referendum specificamente delineati, e in special modo
l'Italia, con la vastissima gamma di materie che possono essere sottoposte ad abrogazione,
fanno eccezione rispetto alle altre democrazie contemporanee, alquanto più contenute
nell'utilizzare il referendum, tranne la Svizzera, il meno noto caso dell'Australia, che ha tenuto
ben 23 referendum dal 1946 al 1988, e singoli Stati degli Stati Uniti, in special modo la
California.
Come abbiamo anticipato, non esistono altri motivi generali e generalizzabili che spieghino
perché si sia manifestato in questa fine di secolo e di millennio un accresciuto ricorso al
referendum, se non l'accesso di un elevato numero di sistemi politici alla democrazia e a libere
competizioni elettorali e l'introduzione nei loro ordinamenti dello strumento referendario. Che
questo strumento venga poi utilizzato più o meno di frequente dipende da variabili
idiosincratiche relative a ciascun sistema politico. Peraltro, poiché è improbabile che una
qualsiasi delle condizioni facilitanti il ricorso ai referendum enunciate nel cap. 3 - debolezza
dei governi, lentezza decisionale delle assemblee, frammentazione dei partiti, complessità delle
scelte, capacità di frazioni dell'elettorato di mobilitarsi ovvero di farsi mobilitare - sparisca in
tempi brevi, e meno che mai tutte assieme, è molto probabile che di referendum se ne faranno
molti un po' in tutti i regimi democratici, con alti e bassi condizionati essenzialmente, ma
tutt'altro che univocamente, dalla vitalità e dalla compattezza dei governi e delle loro
maggioranze, e dall'insoddisfazione e dalla capacità di mobilitazione dei cittadini (e delle
lobbies).
D'altronde, il normale ricorso al referendum, con le varie modalità sopra indicate, si configura
come una prospettiva accettabile. Sbagliano molto coloro che si ingegnano a escogitare ostacoli
procedurali e di varia natura (abitualmente l'innalzamento del numero delle firme) per impedire
ai cittadini di richiedere consultazioni referendarie. Infatti, in ciascuno dei sistemi politici che
hanno utilizzato il referendum - da molto tempo, come in Svizzera, oppure da poco tempo,
come in Italia, normalmente a livello statale, come negli Stati Uniti, oppure eccezionalmente a
livello nazionale, come in Gran Bretagna e nei Paesi Scandinavi - il bilancio può essere
considerato tutto sommato largamente positivo. Nel corso delle campagne referendarie
l'informazione dei cittadini è aumentata e si è diffusa la consapevolezza dell'importanza, più o
meno alta, della posta in gioco. Nei diversi sistemi politici l'esito dei referendum, costituzionali,
istituzionali, su diritti civili e su politiche pubbliche, è stato pacificamente accolto,
sostanzialmente osservato e conformemente applicato. I referendum hanno rappresentato
spesso il modo migliore per ratificare le costituzioni e i mutamenti territoriali. Sono
efficacemente serviti per concedere sovranità a entità federali e sovranazionali, con quel quid di
legittimità in più che solo un'apposita consultazione generale dell'elettorato può conferire. Sono
stati, e promettono di continuare a essere, talvolta una valvola di scarico delle tensioni
politiche, talaltra una modalità decisionale aggiuntiva. In definitiva, appare alquanto
improbabile che i sistemi politici che hanno inserito il referendum nei loro ordinamenti
intendano prossimamente farne a meno. È probabile, invece, che sistemi politici che ancora non
ne dispongono finiscano per accoglierlo presto.
L’idea di rappresentanza politica nasce nel medioevo, in corrispondenza con la nascita delle
istituzioni parlamentari. La nozione di rappresentanza politica era, infatti, sconosciuta sia al
mondo romano che al mondo greco: come ben messo in evidenza da B. Constant, sia a Roma
che nella Grecia antica la partecipazione politica si esplicitava nella partecipazione diretta
all’assemblea popolare, laddove la partecipazione alla vita politica dei moderni passa per la
rappresentanza politica, cioè attraverso l’elezione di un corpo politico incaricato di trattare gli
affari generali di uno Stato. La nozione di rappresentanza politica, quindi, postula una
differenziazione tra governanti e governati. D’altra parte, la rappresentanza politica è una
necessità ineliminabile della vita moderna: l’estensione territoriale degli Stati, infatti,
impedisce fisicamente che i cittadini si possano riunire in un unico luogo e deliberare
direttamente.
Occorre dire che vi è una profonda differenza tra la concezione medievale della rappresentanza
politica e quella moderna, in quanto le rappresentanze politiche medievali avevano un carattere
per lo più di tipo organico e corporativo, di natura sostanzialmente privatistica: i componenti
delle assemblee parlamentari medievali agivano come puri e semplici mandatari di coloro che
rappresentavano, laddove la rappresentanza politica moderna si caratterizza, invece, per gli
opposti principi della rappresentanza nazionale (il deputato rappresenta l’intera nazione e non
solamente i propri elettori) e del divieto del mandato imperativo (gli elettori non possono dare
istruzioni giuridicamente vincolanti agli eletti, né possono revocarli). Si può dire, anzi, che la
rappresentanza nazionale e il divieto del mandato imperativo costituiscano il fondamento
teorico della rappresentanza politica moderna e del costituzionalismo liberale, tant’è che sono
presenti in tutte le Carte costituzionali che si ispirano a tali principi (art. 7, sez. III, cap. I, tit.
III, Cost. Francia 1791; art. 41 Statuto albertino; artt. 34 e 35 Cost. Francia 1848; parr. 93 e 96
Cost. Francoforte 1849; art. 29 Cost. Germania 1871; art. 21 Cost. Germania 1919; art. 67
Cost.; art. 38 Legge fondamentale Germania 1949; art. 27 Cost. Francia 1958; art. 152 Cost.
Portogallo 1976; artt. 66 e 67 Cost. Spagna 1978; art. 161 Cost. Svizzera 1999), con le uniche
eccezioni rappresentate dalla Costituzione U.S.A. del 1787 e dalla Costituzione francese del
1793, la quale si limitava ad affermare che ogni deputato appartiene alla nazione intera (art.
29). Con l’affermazione dello Stato liberale (Forme di Stato e forme di governo) e il definitivo
superamento della società divisa in ceti, infatti, il Parlamento diventa il luogo della sintesi
politica degli interessi particolari nell’interesse generale e questa sintesi è logicamente (oltreché
giuridicamente) incompatibile con l’idea che i deputati siano i mandatari dei soli propri elettori.
Ben diverso è, invece, il caso degli Stati socialisti: la contestazione radicale dei principi del
costituzionalismo liberale porta, infatti, ad affermare, in tema di rappresentanza politica, gli
opposti principi del mandato imperativo e della revocabilità degli eletti (art. 142 Cost. U.R.S.S.
1936; artt. 1, 5 e 87 Cost. Polonia 1952; artt. 56 e 57 Cost. D.D.R. 1974; artt. 102 e 107 Cost.
U.R.S.S. 1977).
Laddove la rappresentanza politica non funzioni, la democrazia si trasforma da governo del
popolo, con il popolo, per il popolo in governo sul popolo. Ciò crea un problema di
legittimazione (Habermas) e la democrazia crolla. Ciò è quello che accadde alla repubblica di
Weimar (Rusconi).
Instaurata in Germania dopo la Prima guerra mondiale, fu così chiamata dalla città di W., dove
fu elaborata la sua Costituzione. Essa ebbe vita tra il 1919 e il 1933. La Repubblica di W.,
costituitasi dopo la sconfitta della Germania nella Prima guerra mondiale e la caduta
dell’impero, rappresentò un modello di democrazia parlamentare per l’intera Europa. La sua
Costituzione prevedeva il suffragio universale maschile e femminile, l’elezione diretta del
presidente della Repubblica e la responsabilità del governo di fronte al Parlamento. Poggiava
sui tre principali partiti politici affermatisi nel dopoguerra: il Partito socialdemocratico, il
Centro cattolico-moderato e il Partito democratico (liberali di sinistra). In realtà, questa
piattaforma rappresentò un’eccezione e fu messo in atto un costante sforzo per allargare il
consenso verso l’ala conservatrice del liberalismo tedesco, che diede con G. Stresemann
l’uomo di Stato e il ministro degli Esteri di maggiore statura politica. Condizionata dalle
clausole punitive imposte alla Germania dalla Pace di Versailles (1919) e indebolita prima dai
tentativi rivoluzionari dell’estrema sinistra, poi dal rafforzamento delle forze antidemocratiche
e nazionaliste, la Repubblica di W. ebbe una vita travagliata e non resse ai contraccolpi della
crisi economica mondiale del 1929. Colpita dalla depressione e dall’inadeguatezza dei mezzi
per far fronte alla disoccupazione dilagante, fu messa in crisi dalla gestione extraparlamentare
avviata dal cancelliere H. Brüning, con il sostegno del presidente P. Hindenburg, e soprattutto
dalla determinazione e dalla demagogia del Partito nazionalsocialista di A. Hitler. Quando
questi divenne cancelliere (1933), la Repubblica di W. subì il definitivo tracollo.
Il crollo della repubblica di Weimar ci pone di fronte al problema chiave della democrazia.
Abbiamo già visto che la repubblica di Weimar aveva un problema di legittimazione. Per molti
tedeschi essa era il prodotto della pugnalata alla schiena che era stata inferta da socialisti ed
ebrei all'esercito tedesco durante la Grande guerra (Rosenberg). Ciò rese debole l'impianto
istituzionale della repubblica di Weimar e la espose agli effetti negativi dei confitti economici,
sociali e politici che caratterizzarono la sua breve esistenza (Peukert).
I conflitti sono inseparabili dalla democrazia in virtù della natura della stessa democrazia. Non
solo, essi rendono forte la democrazia dove la democrazia è forte; cioè dove essa ha un forte
riconoscimento popolare e dove esiste una profonda condivisione dei valori sui quali si fondano
le istituzioni dello stato. (Tilly) Nella repubblica di Weimar ciò non esisteva. (Lacquer). In altre
parole, mancava del necessario consenso popolare (Weitz). Ciò fu la vera causa della sua crisi
la quale è diventata il simbolo stesso della crisi della democrazia.(Rosenberg)
Questa considerazione ci riporta al problema della sovranità popolare. Il principio della
sovranità popolare, che rinviene nel popolo la fonte e la giustificazione della potestà politica,
trova i suoi inizi nel concetto romano della lex come «ciò che il popolo ordina», e lo stesso
potere imperiale è frutto di delega da parte del popolo (pactum subiectionis: il popolo pattuisce
di sottomettersi al sovrano). Problema medievale, connesso con la lotta per le investiture e con
la generale questione del primato del potere papale o imperiale, fu di stabilire se il pactum
subiectionis implicasse la rinuncia da parte del popolo ai suoi diritti (alienatio) ovvero soltanto
una concessione (cessio) revocabile ove, per es., il monarca non assolvesse più i suoi compiti e
si trasformasse in tiranno, o, nel caso di conflitto con la Chiesa, in nemico della fede e dei
canoni. Il rapporto tra popolo e re si analizzò in un complesso di diritti e doveri regolati dal
patto intervenuto e dall’obbligazione reciproca di attuare la giustizia e di osservare la legge.
L’Umanesimo e la Riforma determinarono un movimento per cui si giunse a una specificazione
delle clausole del pactum attraverso la loro interpretazione alla luce del diritto privato; forte era
ancora l’influenza delle teorie medievali. Subito dopo il concetto di popolo cominciò a
trasformarsi; poi gli elementi elaborati da Calvino e dai monarcomachi confluirono nelle grandi
crisi politiche inglesi dei sec. 16° e 17°, nelle quali il principio della s. popolare si affermò in
modo nuovo (dopo la dissoluzione dei concetti giuridici medievali), sotto l’influenza delle
dottrine del diritto naturale allora rinnovate da U. Grozio: nacque l’idea atomistica del popolo
come composto dagli individui, liberi e sovrani prima ancora dell’ordinamento politico; la s.
popolare era perciò concepita come garanzia dei diritti individuali dei singoli. Le nuove idee
sulla s. popolare, depurate e ulteriormente elaborate da J. Milton, A. Sidney, J. Harrington, J.
Locke, ebbero grande diffusione nelle colonie della Nuova Inghilterra (R. Williams, T. Hooker,
W. Penn, J. Wise) e su di esse si fondarono poi i principi della Dichiarazione dei diritti e della
Costituzione degli Stati Uniti d’America. La rivoluzione americana ebbe grande ripercussione
in Francia, dove la filosofia politica del 18° sec. si era ispirata a questi stessi principi,
collegandoli, attraverso il ginevrino J.-J. Rousseau, con quelli provenienti dal pensiero politico
inglese; l’idea della s. popolare era alla base della ideologia rivoluzionaria. Nell’ambito del
costituzionalismo moderno, la teoria della s. poplare si collegò strettamente al suffragio
universale, come emerge in particolare nella Costituzione giacobina dell’anno I, là dove
afferma che la s. risiede nel popolo (art. 25 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del
1793) e che il popolo sovrano è costituito dall’universalità dei cittadini (art. 7 Cost. francese del
1793). Di contro, la Costituzione francese del 1791, che prevedeva un suffragio di tipo
censitario (esplicitato nella distinzione tra citoyens actifs e citoyens passifs) parlava, non a
caso, di s. della nazione.
Nel corso del 19° sec., proprio per negare il fondamento filosofico-giuridico del voto universale
e attenuarne la carica dirompente, alcuni studiosi non esitarono a parlare di una s. della Ragione
(F. Guizot), o, addirittura di s. dello Stato (è il caso, per es. dei massimi esponenti del
positivismo giuridico tedesco, come C.F. Gerber, P. Laband e G. Jellinek). Di s. popolare parlò,
invece, il massimo esponente dei radical whigs inglesi, J. Bentham, nel suo testamento politicospirituale, il Constitutional Code (1830). Dal punto di vista dei testi costituzionali, anche se non
mancano eccezioni già nel corso del 19° sec. (cfr. art. 1 Cost. francese del 1848), il principio
della s. popolare trovò la sua definitiva consacrazione nelle carte costituzionali successive al
primo dopoguerra.
Nella Costituzione italiana la s. popolare è accolta e proclamata nell’art. 1, nel quale si afferma
che la s. appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè
con un sistema di democrazia indiretta.
Il processo di democratizzazione dei sistemi politici contemporanei si può descrivere
essenzialmente nel passaggio dallo Stato liberale di d. ‘limitata’ (d. d’élite) allo Stato sociale di
d. ‘diffusa’ (d. di massa). R. Dahl pone alla base di questo processo due tendenze: la
liberalizzazione , ovvero il grado in cui sono ammessi il dissenso, l’opposizione e la
competizione tra le diverse forze politiche o politicamente rilevanti; l’inclusività , ovvero la
proporzione di cittadini che hanno titolo a partecipare in modo diretto o indiretto alle decisioni
collettive. Le diverse possibilità di incrocio fra queste dimensioni danno modo di costruire una
tipologia dei sistemi politici democratici, distinguendoli in oligarchie competitive, egemonie
includenti e poliarchie. La sequenza storica di questi modelli si può rintracciare nel passaggio
dalla d. di élite alla d. di massa, e questa transizione trova riscontro sia sul piano dei riferimenti
teorici che dei referenti storici. Sul piano teorico si riflette nel contrasto fra elitismo e
pluralismo.
Le analisi che si rifanno agli assunti elitistici (G. Mosca, V. Pareto e R. Michels) ritengono che
la sovranità popolare sia un ideale astratto che non può corrispondere a nessuna realtà di fatto,
perché in ogni regime politico, quale che sia la sua formula, è sempre una minoranza quella che
detiene il potere effettivo. Questa impostazione è in parte corretta da J. Schumpeter, secondo il
quale vi è d. laddove vi sono diversi gruppi in concorrenza fra loro per la conquista del potere
attraverso la competizione elettorale.
All’estremo opposto le teorie pluraliste (R. Dahl, R. Dahrendorf) puntano piuttosto a ridefinire
il concetto di leadership in termini democratici, innalzando il principio del pluralismo a dato
costitutivo della struttura sociale. Al suo interno la d. si definisce in particolare come un
sistema di istituzionalizzazione dei conflitti mediante precise regole del gioco. A proposito di
questo insieme di regole formalizzate che caratterizzano le poliarchie reali si è parlato di in
contrapposizione alla d. sostanziale (H. Kelsen). Sul piano delle generalizzazioni storiche il
processo di democratizzazione si caratterizza per l’estensione dei diritti di cittadinanza e per il
loro impatto sulla struttura sociale: più precisamente nella transizione da un regime di
cittadinanza civile, nel quale ci si limita a garantire i diritti di libertà personale, a un regime di
cittadinanza politica, che prevede l’istituzione del suffragio universale, fino al regime di
cittadinanza sociale che postula l’uguaglianza delle opportunità (R. Bendix).
Fondamentale, in questo contesto, è la distinzione tra intitolazioni e capacitazioni (Sen). A dire
che non è sufficiente che tutti i cittadini di uno stato siano dotati degli stessi diritti, ovvero,
siano posti nelle medesime condizioni di partenza (Einaudi). Occorre che essi siano posti in
grado di farli ugualmente valere. In altre parole, non può esistere democrazia senza uguaglianza
politica e non può esistere uguaglianza politica senza senza uguaglianza economica. (Sen,
Dahl)
Democrazia
Luciano Canfora
La democrazia nella Grecia antica
La democrazia nella Grecia antica, a giudicare dalle fonti di cui disponiamo, fu un fenomeno
dai contorni non molto definiti e, inoltre, oggetto sin dal principio di contrastanti valutazioni e
interpretazioni.
Consistendo, in sostanza, nell’attribuzione, a una assemblea deliberante composta di «cittadini»
di pieno diritto, del potere deliberativo, la democrazia fu, di necessità, nel mondo greco,
nozione troppo generica per essere racchiusa in una rigorosa definizione. Non è del tutto
arbitrario, per es., il giudizio di un pensatore politico che esercitò molta influenza nel 4° sec.
a.C., l’ateniese Isocrate, secondo cui sarebbe stata Sparta la «democrazia perfetta»
(Areopagitico, 61): a Sparta sono cittadini pleno iure solo gli spartiati, e sono tutti «uguali» e
tutti ugualmente partecipi dell’assemblea decisionale (apella), mentre tutti gli altri (perieci e
iloti) sono considerati estranei alla comunità degli «uguali», non solo perché sottomessi con la
forza, ma perché considerati appartenenti a un’altra «razza» rispetto alla «purezza» degli
spartiati. Entro questi limiti Sparta è addirittura il «regno dell’uguaglianza», stabilita in epoca
remotissima dal mitico legislatore Licurgo.
Sotto questo rispetto Atene è assai meno lineare. Certo il numero dei cittadini pleno iure è
molto più alto che a Sparta, ma anche ad Atene c’è un grandissimo numero di non-cittadini:
masse di schiavi; e c’è anche un numero rilevante di stranieri, anche benestanti, pur sempre
non-cittadini. E, comunque, ad Atene ceto politico dominante sono i ricchi che «accettano» la
«democrazia», che accettano cioè di misurarsi con l’assemblea e di subire il potere dei tribunali
popolari. La differenza non sta dunque solo nel numero. Ma a questo punto sarà già divenuto
chiaro perché è Sparta, ben più che Atene, il modello idoleggiato per es. da un pensatore
radicale quale l’abate Mably (1709-1785), ispiratore della democrazia giacobina, e perché
Sparta ben più che Atene sia stata il bersaglio polemico di un decisivo pensatore antigiacobino
come B. Constant.
Il paradosso è che invece nel 4° e 5° sec. a.C., sul piano dei rapporti politici tra stati, Sparta
veniva percepita come il punto di riferimento delle oligarchie, mentre Atene, una volta creato
l’impero (478 a.C.), ha «esportato», con il peso della sua forza militare, il suo modello di
democrazia (estensione della piena cittadinanza ai non possidenti) in tutte le città «alleate» (ben
presto «suddite»). Ulteriore paradosso: è Sparta che, nel 6° sec. a.C., combatte i «tiranni» nella
Grecia peninsulare, e i «tiranni» però sono, per un verso, i leader di una massa popolare invisa
alle grandi famiglie possidenti, e per l’altro – una volta abbattuti – diventano nella retorica
democratica l’antitesi, l’opposto diametrale, della «democrazia». E la «democrazia», per es. in
Atene, è ristabilita a opera soprattutto di una famiglia, quella di Clistene (gli Alcmeonidi), che
aveva prima collaborato coi tiranni (Pisistrato e i suoi figli) e poi, con l’aiuto di Sparta, li aveva
avversati.
La critica al sistema politico ateniese incomincia con un opuscolo intitolato, Athenaion Politeia,
attribuibile a Crizia, il capo dell’oligarchia detta dei «trenta tiranni» (404), e con suo nipote
Platone. In entrambi, ma soprattutto in Platone, il connubio perversamente demagogico tra
gruppi sociali abbienti e popolo è la sostanza stessa della «democrazia» (Repubblica, VIII).
Non è inutile ricordare che Crizia, ma anche Platone, furono ammiratori del «modello
spartano». Questa critica, che in Platone si presenta nella forma più compiuta, ha avuto una
influenza enorme nelle epoche successive, a partire dall’età romana e fino all’età nostra.
Quando nell’Europa del sec. 19°, finita da un pezzo l’esperienza giacobina, si fa strada un
modello «democratico» che è il risultato dell’incontro-scontro tra istanze popolari e predominio
parlamentare di élite proprietarie, e via via il modello si invera attraverso l’estensione del
suffragio, la storiografia liberale «progressista» (G. Grote) simpatizza vivamente per Atene, in
cui ravvisa il proprio modello remoto, mentre la storiografia conservatrice (E. Meyer, U.
Wilamowitz-Moellendorff , K.J. Beloch, J. Bogner) la avversa come antecedente remoto del
modello «terza repubblica francese».
Nella seconda parte della History of Greece (18622, XLVI), G. Grote descrive il funzionamento
della democrazia ateniese con adesione simpatetica in vivace opposizione rispetto alle critiche
tradizionali. Prende le mosse dalla descrizione dei «partiti»: «Pericle ed Efialte democratici;
Cimone oligarchico e conservatore». Già qui si coglie una forzatura, giacché difficilmente si
potrebbe definire «oligarchico» un politico, quale Cimone, il quale accetta il gioco politico
assembleare: «oligarchi» sono piuttosto coloro che, come Antifonte e Crizia, non avendo
alcuna fiducia in un organismo incontrollabile e a loro avviso «incompetente» come
l’assemblea popolare, puntano al colpo di Stato col proposito di modificare radicalmente
l’ordinamento politico della città. Non sfuggirà ovviamente la brillante attualizzazione, comune
un po’ a tutta la storiografia ottocentesca sull’antica Grecia, che porta Grote a parlare di
«partiti», con l’interessante dettaglio di imputare proprio a Cimone un comportamento
«demagogico»: evidentemente con riferimento alla «generosità», rimarcata da Plutarco, di
Cimone nel mettere a disposizione dei cittadini i suoi giardini e i suoi frutteti. Giustamente
Grote focalizza la sua attenzione sul funzionamento dei tribunali popolari e sull’abbattimento
del potere dell’areopago, ridimensionato, nei suoi poteri, dalla riforma di Efialte appoggiato dal
giovanissimo Pericle. Grote difende il buon nome dei tribunali popolari ateniesi, di solito
considerati il punto di forza del predominio popolare contro i ceti abbienti. E invoca a difesa
due argomenti: a) l’elevato numero dei componenti ciascuna corte fu «fondamentale per
escludere la corruzione»; b) i tribunali non erano composti solo di poveri, ma anche di cittadini
appartenenti alle classi medie. Grote afferma inoltre che la democrazia ateniese sarebbe rimasta
immutata fino all’instaurazione, alla fine del 4° sec., dell’egemonia macedone. Ciò però
significa sottovalutare il cambiamento prodottosi via via dopo la guerra civile del 404/403:
nella democrazia restaurata si accentua la professionalizzazione del ceto politico (W. Pilz, Der
Rhetor im attischen Staat, 1934) e viene meno l’indistinzione tra ruolo politico e ruolo militare.
Inoltre Grote attenua molto l’aspra realtà della insofferenza degli alleati, divenuti ormai sudditi
nei confronti della città egemone, Atene. E ciò, nonostante Pericle stesso abbia definito
l’impero «tirannide» in un discorso attribuitogli da Tucidide (II, 63, 2). Per Grote si trattava
piuttosto di «indifferenza o acquiescenza e non di sentimenti di odio». Grote conosce
ovviamente il celebre giudizio di Tucidide su Pericle come leader di una «democrazia che era
tale solo a parole», ma mette a frutto altre parti di quella importante pagina, e tralascia del tutto
la lettura estremamente significativa del ruolo «monarchico» di Pericle data da T. Hobbes, nella
importante sua prefazione alla traduzione inglese dell’opera tucididea (1648): lettura che trova
riscontro non solo nel soppesato giudizio tucidideo (II, 65, 9), ma anche nell’implacata
polemica dei comici, i quali, dalla scena (come riferisce Plutarco), lanciavano a Pericle l’accusa
di nutrire aspirazioni tiranniche e lo esortavano addirittura a «deporre la tirannide» (Vita di
Pericle, 16).
Alla luce di tutto ciò, non stupisce lo sguardo positivo che Grote rivolge anche a una figura
tradizionalmente malvista quale Cleone. In questo Grote era stato preceduto dal grande J.G.
Droysen, nel saggio sui Cavalieri di Aristofane (1838). Droysen è ben conscio di esprimersi
controcorrente in favore di Cleone, e perciò scrive: «Nessuno si presterà a tessere le lodi del
sanguinario Robespierre, o del selvaggio Mario; ma nella loro opera essi hanno incarnato i
sentimenti e hanno ricevuto l’approvazione di migliaia di uomini dai quali li separava solo
quell’infausta grandezza, o violenza di carattere che è capace di non inorridire davanti
all’azione» (Droysen, Aristofane: introduzione alle commedie, a cura di G. Bonacina, 1998).
Per meglio comprendere l’orientamento della History of Greece di Grote giova, certo, ricordare
che nella sua formazione hanno avuto importanza J. Mill, come insegnante di economia, e A.
Comte, come ispiratore di una visione filosofica del progresso umano. Ed è notevole che a
conclusioni in alcuni casi non dissimili giungesse un Droysen, la cui formazione era stata del
tutto diversa, non estranea al pensiero storico di Hegel. Il quale nelle Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte (1837) definì la democrazia greca «il capolavoro politico» e Pericle
«l’uomo di Stato più profondamente colto, autentico e nobile».
Del tutto diverso lo scenario, in ambiente tedesco, nell’epoca guglielmina. Il nome più
importante è quello di E. Meyer. Al contrario di Grote, Meyer, nella monumentale e purtroppo
incompiuta Geschichte des Altertums (IV, 1, 19112; 19393, a cura di H. Stier), pone al centro
della ricostruzione per l’appunto la smisurata e incongrua posizione di Pericle all’interno di un
ordinamento «democratico». Eppure neanche Meyer mise a frutto l’intuizione hobbesiana
intorno alla vera natura del potere di Pericle, ma puntò piuttosto sui difetti strutturali della
democrazia antica (greca), antesignana, appunto, di quella «occidentale».
Semmai Pericle gli appare come spinto sempre più verso un atteggiamento «conservatore»
dopo, e per effetto, della conquista del potere assoluto. Valutazione storico-politica da non
sottovalutare, nella quale si può forse riconoscere l’influsso della diagnosi plutarchea, secondo
cui il governo di Pericle si manifestò come «aristocratico», «in quanto fondato sulla sua
posizione di princeps» (Vita di Pericle, 9,1). Plutarco interpretava così Tucidide II, 65, 9, e
Meyer, probabilmente, interpreta e valorizza Plutarco.
È comunque degno di nota come anche Meyer resti almeno in parte impigliato
nell’applicazione al mondo greco della moderna nozione di «partito politico».
In tal senso, una terminologia esplicitamente modernizzante è presente invece nel quasi coevo
saggio di M. Croiset, Aristophane et les partis à Athènes (1906), dove si parla ripetutamente di
«partito oligarchico», «democratico», «moderato», pur nell’imbarazzo di trovare una
collocazione da assegnare ad Aristofane. Ben più pertinente, a tal proposito, le pagine di
G.E.M. De Sainte Croix (The Origins of the Peloponnesian War, 1973, Appendix 29) sulla
«politica» di Aristofane, giustamente definita, dallo storico marxista inglese, come di
ispirazione «cimoniana».
Piuttosto che seguire partitamente la costante divaricazione dell’apprezzamento dei moderni di
fronte al fenomeno della democrazia greca, segnaleremo alcuni momenti significativi
connotandoli attraverso studi emblematici degli opposti orientamenti: il primo conflitto
mondiale, la prima repubblica tedesca, l’età dei fascismi, la seconda metà del Novecento.
a) A partire dal 1914, nel corso della cosiddetta «guerra degli spiriti» innescata dal conflitto
mondiale tra studiosi tedeschi e l’intellettualità dell’Intesa, è in gioco l’immagine dell’Atene di
Demostene. Due libri vanno soprattutto ricordati: Aus einer alten Advocatenrepublik di E.
Drerup (1916) – dove l’«antica repubblica degli avvocati» è l’Atene di Demostene, identificata
attraverso quella formula con la nemica Francia «democratica» – e, di poco successivo alla fine
del conflitto, il Démosthène di G. Clemenceau, il vincitore, per parte francese, contro la
Macedonia-Prussia del kaiser Guglielmo II. L’identificazione di Clemenceau col suo eroe
positivo è totale e riguarda anche il destino personale sia dell’antico sia del moderno campione
della democrazia.
b) Per gli anni della Repubblica di Weimar, ricorderemo due opere «minori», ma molto
esplicite: da un lato Demokratie und Klassenkampf im Altertum di A. Rosenberg (1921), e sul
versante opposto Die verwirklichte Demokratie di H. Bogner (1930). Rosenberg è uno dei
maggiori storici tedeschi di epoca weimariana, allievo di Meyer e docente di storia antica a
Berlino, parlamentare per la KPD, esule nel 1933, rifugiato in USA, dove scomparve
prematuramente nel 1939, pienamente acquisito alle ragioni del new deal rooseveltiano. Bogner
(n. nel 1895) è un colto pubblicista di destra attivo al principio del regime nazionalsocialista,
traduttore di autori classici. Per Rosenberg l’esperimento democratico ateniese costituisce un
modello positivo in quanto coniuga la prevalenza dei ceti non possidenti con la pratica
democratica: non una dittatura volta a confiscare la ricchezza dei possidenti, ma un sistema in
cui la prevalenza politica dei non possidenti impone, o meglio rende ineludibile, l’uso sociale
della ricchezza. Per Bogner il sistema ateniese, la «democrazia realizzata», come egli lo
chiama, altro non è che l’antecedente della moderna «dittatura del proletariato»: al fine di
render chiaro quanto sia deprecabile tale sistema, Bogner traduce l’intero opuscolo intitolato
Athenaion Politeia (che non è imprudente attribuire a Crizia) e lo definisce come la migliore
descrizione di quel sistema: con la precisazione che è con l’uscita di scena di Pericle che il
sistema è apparso in tutta la sua negatività.
c) In epoca nazista si manifesta, per es. a opera di H. Berve, uno dei maggiori esponenti della
generazione che dominò nelle università durante il Terzo Reich, il tentativo di stabilire una
continuità che, movendo dal Pericle tucidideo, approda al Führer. Su ciò ha scritto un
importante libro B. Näf, Von Perikles zu Hitler? (1986), il quale traccia anche un essenziale
profilo del precedente dibattito storiografico sulla democrazia ateniese. Accanto a questo
inquietante filone si sviluppa poi, o meglio si riaccende, la discussione su Demostene. Malvisto
già in epoca guglielmina da studiosi di prim’ordine quali Beloch e Wilamowitz, Demostene
torna in discussione per merito del libro di W. Jaeger (Demosthenes. The origin and growth of
his policy) che esce prima in USA (1938) e subito dopo in Germania (1939). La discussione fu
sin dall’inizio virulenta. Il filodemostenismo di Jaeger venne stigmatizzato con forza da
importanti storici schierati col nazismo: H. Berve («Göttingische Gelehrte Anzeigen», 1940) e
F. Taeger («Gnomon» 1941). In Italia un pesante attacco venne da parte di G. Perrotta
(«Primato», novembre 1942), il quale approfittò della circostanza per sbeffeggiare anche il
Demostene e la libertà greca di P. Treves, nel frattempo scacciato dall’Italia perché ebreo.
Jaeger fu invece difeso, negli USA, dall’esule K. von Fritz («American Historical Review»,
1939).
d) Negli anni Sessanta del sec. 20° ha incominciato a farsi strada anche negli studi sul mondo
greco un’importante novità. Ci riferiamo a quell’orientamento di studi detto «prosopografico»
che da ben prima aveva influenzato gli studi di storia romana. Tale orientamento pone in rilievo
i legami personali, familiari e di clan vigenti anche in un mondo politicamente evoluto come
quello ateniese del 5° e 4° sec. a.C. Un frutto importante è il saggio di J.K. Davies, Athenian
propertied families, 600-300 B.C. (1971). Ne esce fortemente ridimensionata la visione
ottocentesca troppo modernizzante e incline a riconoscere nei gruppi politici dell’Atene di età
classica vere e proprie formazioni partitiche. Questa sana reazione può ben inquadrarsi, oltre
che nella corrente tipicamente anglosassone detta prosopografica, anche nel più generale
scontro tra «primitivisti» e «modernisti» che ha investito soprattutto l’interpretazione della
storia economica e sociale del mondo antico.
Ciò non ha impedito che l’interpretazione tradizionale dei conflitti politici ateniesi riprendesse
lena in vasti affreschi storico-politici. Così l’adesione emotiva alla democrazia attica si coglie
in studi come La démocratie athénienne di P. Cloché (1951), di cui si segnalano, per la nobile
ingenuità e l’imbarazzante difesa della gestione ateniese dell’impero, le pagine conclusive.
Analogo proposito affiora anche in un lavoro molto impegnato come la Democrazia (1995) di
D. Musti. Per una meditata messa a punto, che è anche una efficace ricostruzione critica e
documentata delle vicende che portarono dalla «tirannide» alla riforma clistenica, si può
ricorrere al saggio di G. Camassa (Atene. La costruzione della democrazia, 2007). Né vanno
trascurati i tentativi di lettura non demonizzante, ma politica, della vicenda dei trenta: The
Thirty at Athens di P. Krentz (1982). Questo libro ha il merito di porsi seriamente la questione
di quale fosse il «programma» dei trenta, e approda sensatamente alla conclusione che il loro
progetto era di rimodellare, con metodi violenti, Atene «on the lines of the Spartan
Constitution». Il che, se si considera quanto osservato in principio a proposito dell’immagine di
Sparta come «vera democrazia», induce a non adagiarsi passivamente nella damnatio memoriae
di cui, già subito dopo la loro sconfitta dovuta anche all’abbandono da parte di Sparta, i trenta
furono oggetto. Naturalmente suggestioni della storia vivente possono indurre a fervide e
suggestive analogie: per es. alla lettura della vicenda dei trenta proposta da J. Isaac (Les
Oligarques [scritto nel 1942], ed. a cura di P. Ory, 1989) in cui si legge, in filigrana, la nascita,
sotto l’urto della vittoria tedesca, del regime di Vichy (1940-1945).
In conclusione, sia lecito un bilancio: in quel laboratorio della politica che fu la città antica, da
un lato si svolgevano conflitti attuali e si esprimevano interessi contingenti, dall’altro però si
elaboravano concetti che hanno finito coll’avere valore ben oltre il tempo in cui nacquero: un
valore che si è rinnovato e riproposto nel corso di millenni.
Plebiscitarismo
Gianfranco Pasquino
1. Elementi per una definizione
Per pervenire a una definizione adeguata, precisa e, nei limiti del possibile, univoca di
'plebiscitarismo', è utile distinguere il plebiscitarismo dal cesarismo, dal bonapartismo e dalla
dittatura. Tenendo ben fermo che cesarismo, bonapartismo, dittatura e plebiscitarismo
attengono alle procedure di selezione dei capi politici, è tuttavia possibile rilevare che tali
procedure, tranne che nel caso della dittatura, implicano in qualche modo il ricorso a modalità
elettorali. Come osserva Weber, "il capo può arrivare in alto seguendo la via militaristica, di
dittatore militare - come Napoleone I - facendo sanzionare la sua posizione per mezzo di un
plebiscito; oppure per via civile, attraverso una sanzione plebiscitaria di un politico non
militare - come Napoleone III - alla quale si sottomette l'esercito" (v. Weber, 1918, tr. it., p.
166; v. Tuccari, 1993, p. 170). Weber ricorre a due fondamentali esempi storici, nei quali gli
elettori furono chiamati a sanzionare la conquista del potere politico con l'espressione di un
voto di approvazione a una persona. Di qui, quella che costituisce, probabilmente, la
caratteristica fondamentale del plebiscitarismo: elezioni totalmente personalizzate.
Il 'sì' oppure, in casi ben più rari, ma non impossibili, il 'no', ovvero la ripulsa, sono indirizzati
direttamente a una persona, al leader che si è sottoposto, per l'appunto, al plebiscito. Al
proposito, sarà utile in linea generale sottolineare che questa modalità di plebiscitarismo si
produce prevalentemente dopo la conquista del potere, quando il leader mira a rafforzare - con
l'esibizione dell'entità del consenso - il suo ruolo, a potenziare la sua autorità, a legittimare il
suo dominio. Le sorprese elettorali sono alquanto rare poiché, ovviamente, il leader utilizzerà
gli ingenti mezzi a sua disposizione per ottenere l'espressione positiva della fiducia popolare.
Ciononostante, in almeno un caso recente di enorme rilievo, il plebiscito a favore di un leader
non ha funzionato secondo le aspettative. Nell'ottobre 1988, il generale Augusto Pinochet
Ugarte - al vertice dello Stato cileno quale presidente della Repubblica dal 1973, anno in cui
rovesciò con la forza delle armi il legittimo governo di Unidad Popular - si sottopose con
eccessiva fiducia a un plebiscito. Il quesito riguardava il rinnovo del mandato presidenziale al
candidato unico: è questa, infatti, la caratteristica fondamentale di un'elezione plebiscitaria,
nella quale un solo nome compare sulla scheda. La maggioranza degli elettori cileni rifiutò
questo rinnovo, aprendo in tal modo la strada a nuove elezioni presidenziali, che si tennero
l'anno seguente e nelle quali il candidato unitario dell'opposizione al regime militare, il
democristiano Patricio Aylwin, ottenne la maggioranza assoluta dei voti popolari.
Quanto alla dittatura, tecnicamente essa è un caso di potere personale eccezionale che non
nasce da legittimazione elettorale, non ne ha nessuna e non la ricerca. Impropriamente, ma per
comprensibile estensione del termine, si parla di dittatura militare, forse per sottolineare il
carattere provvisorio di governi di questo tipo. Invece, sia il cesarismo che il bonapartismo,
spesso considerati sinonimi, differiscono dal plebiscitarismo, e ancor più dalla democrazia
plebiscitaria, per le modalità di conquista e di esercizio del potere. Cesarismo e bonapartismo e a questo proposito ci si riferisce naturalmente allo studio classico di Karl Marx, Il diciotto
brumaio di Luigi Bonaparte (1852) - nascono in fasi di transizione politica. Le propaggini di
un'esperienza rivoluzionaria conclusa sfociarono nel cesarismo di Napoleone Bonaparte;
analogamente, lo sfinimento della Monarchia di luglio e l'inconsistenza della Repubblica
francese nata dal 1848 culminarono in un equilibrio fra le classi sociali che consentì a Luigi
Bonaparte di diventare imperatore collocandosi per plebiscito al di sopra di esse. In entrambi i
casi, i sistemi politici non erano consolidati e la struttura di classe manifestava una
considerevole fluidità; in particolar modo, essa non si era ancora trasferita né assestata nei
partiti. In questi casi, il plebiscitarismo risultò, dunque, soprattutto una tecnica politicoelettorale utilizzata per la conferma popolare di un potere acquisito con altri mezzi.
2. Cenno su plebisciti e referendum
Se si esula dal problema dell'insediamento, della conferma ovvero del rafforzamento della
leadership politica personale, il plebiscitarismo come tecnica elettorale, che sarebbe comunque
meglio analizzare sotto forma di referendum popolare, viene abitualmente utilizzato in tre casi.
Il primo tipo è la scelta della forma di Stato: ad esempio, il plebiscito del 2 giugno 1946 in
Italia e la consultazione popolare del dicembre 1974 in Grecia ebbero per oggetto la scelta tra
monarchia e repubblica, che si risolse in entrambi i casi a favore della seconda. Il secondo è la
scelta tra l'approvazione oppure il rigetto delle carte costituzionali: si pensi, ad esempio, ai
referendum costituzionali francesi, con i quali nel maggio 1946 fu bocciata la prima
Costituzione della Quarta Repubblica (seguita nell'ottobre da una seconda proposta,
debolmente approvata dall'elettorato) e nel settembre 1958 fu approvata la Costituzione della
Quinta Repubblica. Il terzo è la scelta tra l'adesione a unità politiche statali e/o federali, oppure
la secessione da esse: ad esempio il referendum sulla permanenza o meno del Québec nella
federazione canadese, del 31 ottobre 1995. In tutti questi casi, il termine plebiscito è usato in
maniera intercambiabile con quello di referendum. Ciò rilevato, è evidente che ben maggiore
importanza ha il discorso sul plebiscitarismo nella versione della democrazia plebiscitaria.
Prima di analizzare tale argomento, sarà opportuno sottolineare che cesarismo, bonapartismo e
dittatura appartengono al genere dei regimi autoritari, mentre la democrazia plebiscitaria
appartiene al genere delle democrazie. Trattandosi tuttavia di una specie particolare di
democrazia, essa richiede un'analisi particolareggiata che ne illustri adeguatamente le modalità
di instaurazione e di funzionamento, nonché le conseguenze operative e politiche.
3. La concezione weberiana della democrazia plebiscitaria
Dobbiamo essenzialmente a Max Weber i concetti fondamentali dell'analisi della democrazia
plebiscitaria. Ma gli scritti weberiani in materia sono stati variamente interpretati e, a ogni buon
conto, necessitano di essere aggiornati alla luce dei recenti sviluppi delle democrazie
contemporanee. Infatti, in questo come in altri importanti casi, Weber scrive sia in riferimento
agli avvenimenti storici della Germania - anche al fine di influenzarli - sia in sede di
elaborazione della sua teoria sociologica complessiva. Per quel che riguarda la teoria, Weber è
in special modo interessato alle modalità di creazione della leadership nelle fasi di
trasformazione delle condizioni sociali e politiche. Proprio per questo duplice interesse teorico e pratico a un tempo - gli scritti di Weber si prestano a interpretazioni diverse e, talvolta,
addirittura contrastanti.Dal punto di vista programmatico, la democrazia plebiscitaria,
caratterizzata dall'elezione popolare diretta del Reichspräsident, dovrebbe rappresentare la
risposta politica alla grave crisi della Germania, dopo la sconfitta subita nella prima guerra
mondiale. Secondo Weber, soltanto un leader che abbia ottenuto un ampio consenso popolare
sarebbe in grado di tenere insieme il paese e, al tempo stesso, di introdurre le riforme
necessarie al nuovo ruolo che attende lo Stato tedesco: la Germania deve infatti prendere
consapevolezza di non possedere più le risorse necessarie per condurre la politica di una grande
potenza. Per il bene della Germania, il leader plebiscitario deve poter governare, finché è in
carica, senza essere intralciato, salvo sottoporsi, a fine mandato, a nuove elezioni, attraverso le
quali il suo operato possa venire sottoposto al controllo popolare. Il leader potrebbe essere
revocato, purché lo richieda almeno il 10 per cento del corpo elettorale.
Dal punto di vista teorico, l'elezione popolare diretta del presidente si inserisce nella riflessione
weberiana che mira a collocare la politica in posizione di supremazia.Weber è preoccupato sia
dall'incapacità delle forze economiche (imprenditori e industriali) di trascendere i loro interessi
particolaristici, sia dalla settorialità degli interessi corporativi rappresentati nei parlamenti. È
altresì preoccupato dal più generale processo di burocratizzazione che sta stringendo i sistemi
sociali in una gabbia d'acciaio, mentre i partiti stessi assumono sempre più le sembianze di
apparati di funzionari, tanto più necessari quanto meno capaci di produrre leadership. Per
evitare che tutto il sistema si burocratizzi e si corporativizzi, è assolutamente indispensabile,
secondo Weber, procedere all'elezione popolare diretta del presidente. Le figure carismatiche
che emergono nella storia, tuttavia, sono rare; esse, inoltre, agiscono per un breve periodo di
tempo e, in genere, non riescono a istituzionalizzare il loro carisma (v. Cavalli, 1995).
L'elezione diretta del presidente può non produrre carisma e non accompagnarvisi, ma
determina pur sempre una situazione nella quale emerge "il dittatore del campo di battaglia
elettorale". Essa, inoltre, può produrre intensi rapporti emotivi, creando legami di fiducia tra gli
elettori e l'eletto e offrendo a quest'ultimo opportunità di guida tali da non poter essere
ingabbiate né dalla burocrazia o dal sistema economico, né dai partiti o dai gruppi di interesse,
né dallo stesso parlamento.
Le controversie sul significato della democrazia plebiscitaria in Weber - e sulla collocazione di
tale concetto all'interno del suo pensiero - attengono fondamentalmente a due punti. Il primo
concerne l'interrogativo se la teorizzazione della democrazia plebiscitaria significhi una svolta
nel pensiero politico weberiano oppure ne costituisca soltanto un logico approfondimento.
Secondo David Beetham (v., 1985), si tratterebbe di una svolta teorico-politica, ovviamente
segnata dai tragici sviluppi della storia della Germania. In sintesi, Beetham sostiene che "dopo
aver cominciato da marxista, Weber chiuse la sua carriera da nietzschiano" (ibid.; tr. it., pp.
294-295). Vale a dire che, partendo dall'importanza delle classi sociali, anche nel fornire un
fondamento ai partiti politici, egli giunse a una posizione nettamente diversa, imperniata
sull'esaltazione dell'individuo. La leadership politica non poteva più essere affidata a una
classe, ad esempio la borghesia. "Negli ultimi scritti di Weber, la leadership politica è
presentata come un fatto individuale, che si svolge entro un contesto di istituzioni politiche,
sulla base di una relazione politica con un elettorato di massa" (p. 295). Inoltre, Weber
abbandona l'opinione secondo la quale la leadership politica può nascere nei partiti e nel
parlamento in favore di proposte costituzionali, "nelle quali egli separa il leader politico
dall'insieme del parlamento, e gli conferisce una base di potere autonomo nell'elettorato di
massa" (p. 297). Secondo Beetham, "queste proposte segnavano un deciso mutamento nelle
opinioni di Weber" (p. 321), tanto che "la figura del leader trovava legittimazione in una
concezione della democrazia tutt'altro che democratica" (p. 329).
Secondo Wolfgang Mommsen, al contrario, non si tratta di una svolta bensì della logica
prosecuzione del discorso weberiano sul carisma, sul potere, sulla leadership, sulla stessa
democrazia. "L'appassionata idea weberiana della potenza nazionale contribuì in modo
notevole a privare il concetto di democrazia dei suoi valori contenutistici e a preparare la strada
a una concezione puramente formalistica della democrazia" (v. Mommsen, 1974; tr. it., p. 583).
Se la democrazia è soltanto un insieme di tecniche per dare efficienza a un sistema, allora
bisogna saper scegliere, modificare e aggiornare queste tecniche a seconda dei compiti da
affrontare e dei problemi da risolvere. Poiché "senso e compito della democrazia parlamentare
si riducevano, nella concezione di Weber, sostanzialmente a due funzioni: la selezione di
personalità di capi politici e il controllo della burocrazia amministrativa" (ibid., p. 583), se
questo tipo di democrazia non riusciva più a svolgere tali compiti, allora diventava
indispensabile cambiarla, anche drasticamente; "con piena consapevolezza - conclude
Mommsen - Weber auspicò quindi la democrazia plebiscitaria del capo" (p. 587).
A sua volta, Francesco Tuccari (v., 1993, p. 286) oppone a Beetham che "il progetto del
Reichspräsident non implica affatto una frattura teorica forte [...], ma presuppone più
semplicemente un riassestamento programmatico che, indotto dalle mutate condizioni politiche
e istituzionali della 'nuova Germania', rimane per il resto legato a una nozione della democrazia
esattamente identica a quella formulata in Parlament und Regierung". Tuccari osserva inoltre
che i rischi di una torsione autoritaria ravvisati da Mommsen "sia nella debole idea del governo
parlamentare sia nell'ipotesi di un presidente eletto direttamente dal popolo sono in realtà
assolutamente distanti non soltanto dal progetto weberiano ma anche, e soprattutto, dalla teoria
che di quel progetto costituisce la sostanza". Tuttavia, l'argomentazione di Tuccari non sembra
provare in modo convincente la sua tesi, secondo la quale la formulazione weberiana della
democrazia plebiscitaria non è "una svolta contro il parlamentarismo in astratto, ma contro il
parlamento e i partiti della Germania post bellica", ragion per cui si tratta "non di svolta teorica
ma, al contrario, di una svolta programmatica che si compie, oltre che in relazione a una
contingenza politica nuova, proprio sul fondamento di una sostanziale continuità di teoria"
(ibid., p. 297). A mio parere, invece, tale svolta programmatica - che è reale e riconosciuta da
tutti gli autori summenzionati - retroagisce sulla teoria di Weber.Il punto è talmente
macroscopico che viene riconosciuto anche da Tuccari: "la stessa democrazia plebiscitaria non
è una ricetta politica desiderabile, invocata per sciogliere le contraddizioni della 'democrazia
acefala', ma è al contrario, e prima di tutto, il destino ineluttabile della democrazia in uno Stato
di massa, l'unica configurazione possibile della democrazia moderna, della 'democrazia come
professione"' (p. 305).
La svolta teorica di Weber sta, in effetti, tutta qui: nel passaggio da una concezione che
collocava la creazione di leaderships democratiche e autorevoli nel parlamento e nei partiti a
una concezione che non solo si rassegna a un ineluttabile destino di creazione della leadership
attraverso meccanismi plebiscitari, ma che elabora tale prospettiva con il vigore, la passione e
l'enorme immaginazione teorica di cui Weber era capace.
4. I caratteri della democrazia plebiscitaria
Nella concezione weberiana, la democrazia plebiscitaria, ovvero la democrazia con un capo
(Führerdemokratie), è chiaramente contrapposta alla democrazia senza capo, acefala. Quanto
alle sue origini, la democrazia plebiscitaria è resa non soltanto possibile, ma addirittura
necessaria dalla democratizzazione. Di contro, la parlamentarizzazione incide negativamente
sia sulla democratizzazione, poiché il potere rimane nelle mani di alcuni capi politici
oligarchici, sia sulla produzione di leadership politica. La democrazia plebiscitaria si
contrappone nettamente al potere dei partiti e al potere delle corporazioni. Entrambi sono
rappresentati in parlamento da funzionari "meschini e mediocri" che perseguono i propri
interessi personali o quelli delle loro organizzazioni e che non sono "personalità selezionate nel
corso della lotta politica" (v. Weber, 1918; tr. it., p. 164), ma uomini premiati per la loro
subordinazione alle rispettive organizzazioni. Capita qualche volta, ma raramente, che il
politico giunto al vertice del potere sia il prodotto di una lotta politica, ma la
parlamentarizzazione del sistema politico-costituzionale rende questo esito alquanto
improbabile."L'importanza della attiva democratizzazione di massa consiste nel fatto che il
capo politico non viene più proclamato candidato sulla base del riconoscimento della
affidabilità nell'ambito di un gruppo di notabili, per poi diventare capo in forza del suo
emergere in parlamento; al contrario egli si guadagna la fiducia e la fede delle masse e
conquista il suo potere con mezzi demagogici di massa.
Secondo l'essenza della cosa questo significa che la selezione dei capi assume una piega
cesaristica. E di fatto ogni democrazia tende a ciò. Il mezzo specificamente cesaristico è
proprio il plebiscito"(ibid., p. 166). In questo brano sono chiaramente individuate le
caratteristiche fondamentali della democrazia plebiscitaria. La precondizione è una attiva
democratizzazione di massa. Le due condizioni di base sono che né i partiti né il parlamento
risultano più in grado di produrre leadership. Il meccanismo centrale della produzione di
leadership è costituito dall'elezione popolare diretta del leader. Per vincere, infine, il leader
deve dimostrare di possedere qualità demagogiche, nel senso letterale del termine, ovverosia
deve avere la capacità di guidare il popolo anche attraverso l'appello alle emozioni.
Si delineano qui con chiarezza alcune caratteristiche di fondo della riflessione weberiana sulla
politica: la sua concezione puramente tecnica delle forme di Stato e di governo, la sua ricerca
ossessiva, quasi disperata, di meccanismi per la produzione della leadership politica, prima nei
partiti, poi nel parlamento, infine - cambiate alcune condizioni sociali e istituzionali di fondo nel popolo. Come ha notato Mommsen (v., 1974; tr. it., p. 582), "lo Stato costituzionale
democratico diventava così sostanzialmente una organizzazione tecnica per addestrare capi
politici e per mettere a loro disposizione canali di ascesa al potere". A questo punto, individuati
i canali di ascesa al potere nei meccanismi elettorali plebiscitari, il problema per Weber - e per i
sostenitori contemporanei della democrazia plebiscitaria (v. Cavalli, 1992) - cambia
profondamente. Una volta eletto 'plebiscitariamente', il capo deve sicuramente governare. Ma
quali controlli possono e debbono essere previsti ed esercitati nei confronti dei suoi
comportamenti, del suo potere, delle sue decisioni?
5. Le conseguenze della democrazia plebiscitaria
Assumendo l'ottica della svolta programmatico-teorica che Weber compie nella sua
formulazione della democrazia plebiscitaria, è importante sottolineare con Mommsen (v., 1974;
tr. it., p. 589) che "Weber, anziché ascrivere la 'democrazia plebiscitaria del capo' al tipo di
legittimità del 'potere legale', la considerò come una variante antiautoritaria del 'potere
carismatico"'. Ciò che rendeva questa variante specificamente antiautoritaria era, secondo
Weber, la possibilità periodica di rimozione elettorale del leader, in special modo se e quando
non aveva successo. Questa possibilità di rimozione elettorale è, ovviamente, molto importante,
ma rimane largamente insufficiente quale forma di controllo dei comportamenti, del potere,
delle decisioni del leader. Peraltro, Weber è convinto a tal punto della necessità di conferire
potere al leader da affermare che la guida del partito da parte di capi eletti plebiscitariamente
impone la "disanimazione" dei seguaci. Quanto al problema dei controlli, la sua
preoccupazione centrale riguarda le modalità di controllo del capo politico sulla burocrazia e
non quelle del parlamento sul leader.
Preso atto del drastico contrasto tra selezione plebiscitaria e selezione parlamentare dei capi,
Weber sostiene che "l'esistenza del parlamento non è perciò priva di valore. Infatti, di fronte al
fiduciario delle masse (oggettivamente) cesaristico, l'esistenza del parlamento garantisce in
Inghilterra: 1) la stabilità e 2) la controllabilità della sua posizione di potenza; 3) la
conservazione delle garanzie giuridiche civili contro di lui; 4) una forma ordinata di
sperimentazione politica, all'interno dell'attività parlamentare, degli uomini politici che cercano
di ottenere la fiducia delle masse e 5) una forma pacifica di rimozione del dittatore cesaristico,
quando egli abbia perduto la fiducia delle masse" (v. Weber, 1918; tr. it., pp. 166-167). Tuttavia,
queste parole scritte nel 1916-1917 vengono messe in secondo piano appena un anno dopo,
quando - con riferimento alla Germania e alla sua debole tradizione parlamentare - Weber
decide di accentuare il ruolo del leader eletto direttamente dal popolo e di attenuare i vincoli
costituzionali al suo comportamento. "Rifiutando la democrazia parlamentare a causa della sua
debolezza - la sua subordinazione alle cricche e agli interessi particolari - e ponendo
l'alternativa per il sistema politico tedesco tra 'democrazia autoritaria' e 'il dominio dei
professionisti della politica senza vocazione', Weber abbandonava nello stesso tempo quelle
forme di controllo sul leader cesarista che egli aveva in passato considerato un tratto essenziale
di un sistema parlamentare liberale" (v. Beetham, 1985; tr. it., p. 330).
Le condizioni storico-politiche di fondo rispetto alle quali era maturata la concezione
weberiana della leadership erano profondamente mutate. Con esse mutò anche il pensiero
weberiano, nel quale si produsse quindi una effettiva svolta programmatico-teorica. Questo,
peraltro, non significa affatto che Weber debba essere considerato un precursore del nazismo e
che la democrazia plebiscitaria possa costituire l'anticipazione ovvero il fondamento teorico del
Terzo Reich. Non si può, tuttavia, negare che il ribaltamento autoritario, come ha scritto
Mommsen, di una democrazia plebiscitaria basata su un mandato popolare conquistato anche
attraverso l'appello alle emozioni e senza controlli adeguati, trovi germi fecondi nella
concezione weberiana. Weber crede, con Schumpeter, che la democrazia sia la forma migliore
di selezione della leadership ad opera delle masse fra squadre in competizione per conquistare
il potere di governo. Ma è fermamente convinto che il leader della squadra vincente debba
disporre di un mandato plebiscitario a governare. Incidentalmente, Weber non è affatto un
precursore di Carl Schmitt. Né il decisore di Schmitt, che assume tutto il potere nello stato di
eccezione, né il suo custode della costituzione (v. Bendersky, 1983; v. Schwab, 1970),
ugualmente onnipotente e destinato a uno slittamento autoritario, possono essere assimilati al
leader, pur sempre democratico, della weberiana democrazia plebiscitaria. Fra una democrazia quella weberiana - innervata dalla leadership ma non insensibile ai controlli e un regime
autoritario del capo - quello schmittiano - che assume su di sé tutto il potere, la distinzione è
netta. Piuttosto che collocare Weber fra i teorici dell'autoritarismo personalistico, è possibile
sostenere che la sua possente teorizzazione abbia anticipato molti dei problemi politici e
suggerito alcune delle soluzioni istituzionali sperimentate dai sistemi politici contemporanei.
6. La democrazia plebiscitaria nei sistemi politici contemporanei
Non fu certo la teorizzazione weberiana della democrazia plebiscitaria ad aprire la strada ai
regimi fascisti e al nazismo. Anzi, paradossalmente, se si esclude il crollo della Repubblica di
Weimar (che non fu affatto un caso di democrazia plebiscitaria, nonostante l'elezione popolare
diretta del presidente della Repubblica) , i regimi fascisti nacquero sulle ceneri di democrazie
parlamentari e proporzionali deboli, sostanzialmente impotenti, in parte preda delle burocrazie
civili e militari. È persino possibile ipotizzare, contro l'opinione di Mommsen, che il
ribaltamento autoritario si produsse in sistemi politici nei quali il parlamento sembrava forte e i
partiti soffocavano la leadership piuttosto che in paesi, come la Gran Bretagna, dove il
parlamento era (e rimane) relativamente debole mentre la competizione fra partiti produceva (e
produce) leaderships in grado di acquisire almeno alcune caratteristiche plebiscitarie. In Italia,
in Portogallo, in Spagna e nella totalità dell'Europa orientale, le embrionali esperienze di
democrazie parlamentari acefale crollarono in sequenza dopo la prima guerra mondiale, dando
vita non a democrazie plebiscitarie, ma a esperimenti autoritari di maggiore o minore durata a
seconda della collocazione internazionale dei rispettivi paesi.
Nel secondo dopoguerra, la Francia della Quarta Repubblica continuò a percorrere la strada
delle democrazie parlamentarizzate, proporzionali e acefale fino al suo crollo subitaneo di
fronte al problema dell'indipendenza dell'Algeria, al putsch dei colonnelli e al salvataggio,
altrettanto subitaneo, della sua democrazia grazie all'instaurazione di un originale regime
politico, la Quinta Repubblica, che è quanto di più simile ovvero di più conforme ai canoni di
una democrazia plebiscitaria. Ricondotti i partiti alle loro funzioni essenziali di partecipazione
alla competizione elettorale e di sostegno di una maggioranza parlamentare, ridimensionato e
contenuto il ruolo del Parlamento con la conseguente emarginazione dei gruppi di interesse,
valorizzata l'elezione popolare diretta del presidente della Repubblica, la Quinta Repubblica
francese non sarebbe dispiaciuta a Weber se non per un aspetto, che tuttavia è alquanto
importante. Ci riferiamo all'eccessivo potere politico della burocrazia francese o, meglio, dei
burocrati francesi, accomodatisi sia nei banchi del Parlamento che nelle file del governo fino a
giungere ai vertici della Repubblica, in parte con Georges Pompidou e ancor più con Valéry
Giscard d'Estaing. Indubbiamente, però, la Francia della Quinta Repubblica ha prodotto una
leadership politica autorevole e una democrazia plebiscitaria funzionante con de Gaulle e con
Mitterrand.
Nel secondo dopoguerra, parecchi sistemi politici democratici hanno cercato di individuare
forme di personalizzazione e di stabilizzazione politica della leadership. Per ragioni collegate
alla inimitabile struttura bipartitica del suo sistema politico, il governo del primo ministro
inglese contiene elementi di democrazia plebiscitaria. In maniera più indiretta, la forma di
governo tedesco, con l'elezione del cancelliere ad opera del Bundestag, mira a conferire potere
politico al "dittatore del campo di battaglia elettorale". E certo la Germania non è stata priva di
leaders autorevoli quali Adenauer, Brandt, Schmidt, Kohl, ma non può in alcun modo essere
considerata un esempio di democrazia plebiscitaria. La stabilizzazione politica e il
consolidamento democratico nelle nuove democrazie dell'Europa meridionale (Grecia,
Portogallo, Spagna) sono avvenuti anche grazie alla comparsa di leaderships politiche
carismatico-plebiscitarie e di meccanismi, come il sistema semipresidenziale portoghese, tali da
agevolarne l'ascesa. In altri paesi - come in Italia e, pur trattandosi di casi molto diversi, nelle
transizioni dell'Europa centro-orientale - dove questi meccanismi non esistono, oppure sono
poco incisivi, il regime mantiene le sue caratteristiche democratiche, ma funziona a bassi livelli
di rendimento ed è esposto sia alle influenze dei gruppi di interesse che alle degenerazioni dei
partiti in parlamenti frammentati, senza acquisire mai abbastanza potere per controllare la
burocrazia.
Alla fine del XX secolo le democrazie acefale continuano a essere tanto deboli quanto Weber
aveva previsto e temuto. In presenza di gravi crisi internazionali o sociali, tale debolezza può
aprire la strada al loro crollo. Al contempo, però, sembrano emergere le condizioni
socioculturali e politiche di fondo per l'affermarsi di democrazie plebiscitarie. Le classi sociali
hanno raggiunto un grado di indifferenziazione che non ha riscontro nel passato. I partiti
politici non sono più strutture per la produzione di leadership, ma, nel migliore dei casi,
macchine per la raccolta dei voti. I parlamenti sono divenuti arene di compromessi sociali ed
economici, non luoghi per il tirocinio di leaders politici, con la sola eccezione del Senato degli
Stati Uniti d'America, i cui componenti sono tutti eletti direttamente dagli elettori di ciascuno
Stato e sono pertanto selezionati da una competizione con caratteristiche plebiscitarie. Per di
più, l'affermarsi e il diffondersi della televisione hanno creato enormi opportunità per
leaderships non politiche, non filtrate dai partiti, non previamente sperimentate in attività
parlamentari e governative.
Dove le organizzazioni intermedie sono poche, lontane dalla politica e interessate al
perseguimento esclusivo dei loro obiettivi sociali, mentre l'opinione pubblica, largamente
atomizzata, è esposta all'influenza dei media televisivi (come può essere il caso di non poche
società di massa), lì si aprono grandi spazi per una leadership creata attraverso meccanismi
plebiscitari. La videopolitica favorisce l'emergere di outsiders che catturano le emozioni forse
passeggere dell'opinione pubblica e le traducono in un consenso elettorale decisivo per vincere
la carica più ambita: l''effimero' diviene il canale per giungere a governare. Se, però, i controlli
sulla leadership sono scarsi e deboli e l'esercizio del suo potere sostanzialmente illimitato - fatta
salva la possibilità di sbalzare il detentore dalla sua carica in occasione di nuove elezioni allora i rischi, presenti e futuri, della democrazia plebiscitaria appaiono rilevanti.
Ciononostante, si tratta pur sempre di 'rischi'. Per un verso, quindi, è giusto preoccuparsene: per
dirla ancora con Mommsen (v., 1974; tr. it., p. 590) "il pericolo di un ribaltamento carismaticoautoritario del potere plebiscitario-democratico" è costantemente in agguato nelle democrazie
costruite secondo criteri plebiscitari. Per altro verso, tuttavia, occorre riconoscere che tale
rischio non sembra essersi materializzato nei cinquant'anni seguiti alla seconda guerra
mondiale. Anzi, più frequentemente, è accaduto che gli elementi plebiscitari abbiano consentito
di sventare pericoli autoritari e persino di instaurare esperimenti democratici. Tutto questo non
significa che, come sicuramente avrebbe pensato Weber, una democrazia plebiscitaria non
continui ad avere bisogno di qualche contrappeso in più, che non sia semplicemente il ricorso
periodico a elezioni non per conferire un mandato imperativo a funzionari che pensano di agire
"in accordo con la volontà espressa o supposta dell'elettorato", ma per consentire al leader di
agire "soltanto secondo le proprie convinzioni" (v. Beetham, 1985; tr. it., p. 317).
La democrazia plebiscitaria costituisce un'opzione sempre presente, spesso praticabile, ricca di
opportunità indissolubilmente collegate con pericoli. Saranno le donne e gli uomini, con la loro
partecipazione alla politica o con la loro astensione dalla politica, a decidere quanto la
democrazia plebiscitaria sarà democrazia e quanto sarà plebiscitaria.
(V. anche Autoritarismo; Cesarismo; Democrazia; Dittatura; Società di massa).
bibliografia
Beetham, D., Max Weber and the theory of modern politics, Oxford 1985 (tr. it.: La teoria
politica di Max Weber, Bologna 1989).
Bendersky, J.W., Carl Schmitt theorist for the Reich, Princeton, N.J., 1983 (tr. it.: Carl Schmitt
teorico del Reich, Bologna 1989).
Cavalli, L., Governo del leader e regime dei partiti, Bologna 1992.
Cavalli, L., Carisma. La qualità straordinaria del leader, Roma-Bari 1995.
Marx, K., Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in "Die Revolution", 1852, n. 1 (tr.
it.: Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, Roma 1964).
Mercadante, F., La democrazia plebiscitaria, Milano 1974.
Mommsen, W.J., Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920, Tübingen 1974 (tr. it.: Max
Weber e la politica tedesca, Bologna 1993).
Panebianco, A., Cesarismo, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. I, Roma 1991, pp. 714720.
Schwab, G., The challenge of the exception. An introduction to the political ideas of Carl
Schmitt between 1921 and 1936, Berlin 1970 (tr. it.: Carl Schmitt. La sfida dell'eccezione,
Roma-Bari 1986).
Tuccari, F., I dilemmi della democrazia moderna. Max Weber e Robert Michels, Roma-Bari
1993.
Tuccari, F. (a cura di), Weber, Roma-Bari 1995.
Weber, M., Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, München-Leipzig 1918
(tr. it.: Parlamento e governo nel nuovo ordinamento della Germania, Torino 1982).
Cesarismo
Angelo Panebianco
Per cesarismo si intende, in prima approssimazione, un regime politico il cui fondamento è
costituito da un rapporto diretto, veicolato da tecniche plebiscitarie di organizzazione del
consenso, fra un leader e gli appartenenti a una comunità politica. Nonostante l'ispirazione
provenga da due differenti epoche storiche e i termini evochino due figure diverse di leader
(Giulio Cesare e Napoleone Bonaparte), nel lessico politico contemporaneo cesarismo e
bonapartismo sono termini intercambiabili e come sinonimi verranno considerati anche in
questo articolo. La definizione di cesarismo sopra esposta corrisponde, grosso modo, alla
definizione che ne dà il senso comune.
A causa dell'eccessiva genericità, però, essa può servire solo per una prima delimitazione del
campo, in quanto consente di escludere dall'ambito del fenomeno politico considerato tutti i
casi in cui:
1) non esiste una leadership individuale, ossia al vertice del regime, o dell'organizzazione
politica, non c'è un solo leader ma una élite e, pertanto, le funzioni di leadership sono esercitate
collettivamente da un gruppo più o meno ristretto;
2) i rapporti di potere fra il leader e i seguaci non dipendono dall'impiego di tecniche
plebiscitarie di organizzazione del consenso.
Se ci si ferma alla definizione proposta, il concetto di cesarismo risulta molto ricco sotto il
profilo della denotazione (abbraccia moltissimi casi storici, fra loro diversissimi), ma povero
sotto il profilo della connotazione. Per procedere oltre occorre però considerare una difficoltà
che pesa su qualunque analisi dei fenomeni cesaristici e che consiste nel fatto che le scienze
sociali contemporanee, anche la scienza politica, concentrano tradizionalmente la propria
attenzione sulle dimensioni strutturali dei rapporti sociali e politici ed evitano normalmente di
trattare le componenti personali, idiosincratiche, di quei rapporti. Qualunque altra cosa sia il
cesarismo, esso comporta in primo luogo l'esistenza di un rapporto di potere fra un individuo (il
leader) e i suoi seguaci. Il cesarismo infatti appartiene al campo dei regimi politici
personalistici, ove ciò che conta sono, in primo luogo, le caratteristiche personali e le scelte di
un singolo individuo. La svalutazione del ruolo degli individui che è tipica delle scienze sociali
(quanto meno nelle versioni strutturalista e funzionalista-sistemica) ostacola quindi l'esame del
fenomeno cesaristico. Non è casuale che lo strumento interpretativo più utile resti, come
vedremo, la teoria weberiana del carisma; ma in Weber, a differenza di altri scienziati sociali,
era forte la convinzione dell'importanza delle singole personalità nella storia, una convinzione
ispirata dalla visione romantica e dal pensiero nietzschiano. Ciò spiega perché nella scienza
politica contemporanea non sia possibile reperire analisi persuasive del cesarismo (anche se è
possibile reperire indicazioni sulle condizioni politiche, economiche, ecc., che conducono a
esso). Il cesarismo non compare con la statura e la dignità di un fenomeno politico autonomo in
nessuno dei molti tentativi di classificazione dei regimi politici che la scienza politica ha fatto
in questo secolo. Ad esempio, non appare nelle classificazioni delle forme di dominio di
Lasswell e Kaplan (v., 1950): non in quella che, seguendo Aristotele, differenzia i regimi
politici a seconda del numero dei governanti (autocrazie, oligarchie, repubbliche, nei termini di
Lasswell e di Kaplan), né in quella, più originale, che li distingue a seconda delle modalità di
esercizio del potere entro il corpo politico (burocrazia, aristocrazia, etocrazia, demosocrazia,
virocrazia, plutocrazia, tecnocrazia, ideocrazia). Neppure la letteratura più recente offre
indicazioni (v. Linz, 1975; v. Morlino, 1986). Anche gli studiosi che utilizzano la teoria
marxiana del bonapartismo si limitano a segnalare quasi esclusivamente le dimensioni
strutturali del fenomeno. Così, ad esempio, Rouquié, per il quale un regime bonapartista "è il
regime sostenuto da una burocrazia civile e militare, relativamente indipendente dai gruppi
sociali dominanti, che si sforza di risolvere i conflitti che paralizzano la classe dirigente
depoliticizzando in modo non violento (o non terrorista) l'insieme delle classi della società" (v.
Rouquié, 1975, p. 1098).
Poiché la letteratura corrente non aiuta a decifrare il fenomeno, il primo passo da fare è tentare
di distinguere il cesarismo da altri tipi di rapporti politici con cui potrebbe essere confuso. Se la
presenza della condizione leadership individuale è cruciale per identificarlo, non è però
sufficiente: occorre infatti ancora distinguere il cesarismo da altri tipi di organizzazione politica
(cacichismo, caudillismo, sultanismo) in cui compare il fattore leadership individuale e nei
quali è anche presente la possibilità del ricorso a tecniche plebiscitarie di organizzazione del
consenso.
Per delimitare davvero il fenomeno occorre introdurre due specificazioni:
a) il legame emozionale leader/seguaci è, nel cesarismo, preminente rispetto ad altri tipi di
legami (clientelari, ecc.).
Ciò consente di differenziare il cesarismo da altre forme di organizzazione del potere (ad
esempio il cacichismo) in cui il legame leader/seguaci è fondato, prevalentemente, su una
transazione fra beni materiali e consenso;
b) l'organizzazione politica del cesarismo si afferma sempre a seguito di un processo di
deistituzionalizzazione (v. Huntington, 1968) delle organizzazioni e delle procedure politiche
preesistenti.
In altri termini, parleremo di cesarismo se, e solo se, la leadership individuale nasce sulle ceneri
di un'organizzazione politica istituzionalizzata che è stata colpita da un processo di decadenza e
di disorganizzazione.
Il cesarismo sorge in risposta alla crisi di un'organizzazione politica, in virtù di una
decomposizione del precedente ordine politico. Ciò consente di differenziare questa forma
politica da altre, come ad esempio il caudillismo, in cui sono presenti tanto la leadership
personale quanto, talvolta, le tecniche plebiscitarie, ma la cui genesi non è la risposta diretta e
immediata a una crisi politico-organizzativa. Quest'ultima specificazione aiuta a cogliere un
importante elemento distintivo del cesarismo nella sua forma pura: la provvisorietà. Il
cesarismo è un regime di transizione, intrinsecamente instabile. Sorge per fronteggiare uno
stato di disorganizzazione e di crisi acute della comunità politica ed è destinato a lasciare il
posto a forme diverse e più stabili di organizzazione del potere. I regimi di transizione fra una
forma stabile e l'altra possono assumere diverse fisionomie (v. Morlino, 1986; v. Linz e Stepan,
1978), e nell'interpretazione qui adottata il cesarismo è una di esse. La definizione che
proponiamo è allora la seguente: un regime politico di transizione, che sorge in risposta alla
decadenza di istituzioni politiche preesistenti ed è fondato su un rapporto diretto - ove la
componente emozionale (così come è descritta, ad esempio, da Freud) è preminente - fra un
leader e gli appartenenti alla comunità politica, veicolato da tecniche plebiscitarie di
organizzazione del consenso.
Due precisazioni sono necessarie. In primo luogo, non è ritenuto essenziale, ai fini della
definizione, che il leader sia in origine un capo militare. In molti casi il cesare è effettivamente
un militare (e proprio questo ci ricordano i termini cesarismo e bonapartismo): ciò accade
perché spesso un capo militare di successo è, al momento della crisi, nella posizione migliore
per convertire le risorse accumulate nella sua qualità di comandante (per esempio il prestigio
guadagnato sui campi di battaglia) nelle risorse politiche necessarie a fondare l'organizzazione
cesaristica. Tuttavia questa caratteristica non è essenziale. Spesso l'origine militare del leader è
alla base della formazione di regimi militari privi di componenti cesaristiche. E,
simmetricamente, accade che il leader che crea il regime cesaristico non sia un militare (è il
caso di Napoleone III).
La seconda precisazione è che la definizione che abbiamo adottata non basta, normalmente, a
definire compiutamente nessun regime politico (neanche quelli che sono stati così catalogati
nel corso del tempo), per la ragione che nessun regime politico può basarsi solo su legami
emozionali diretti fra un leader e il suo seguito. Anche in un regime cesaristico saranno sempre
presenti gruppi elitari di diversa estrazione (politica, economica, religiosa, ecc.) e
l'organizzazione cesaristica avrà connotati molto diversi a seconda delle caratteristiche di
queste élites e dei rapporti che esse instaurano con il leader. Inoltre, sono possibili variazioni
forti fra un caso e l'altro a seconda dei rapporti che esistono fra il capo e il 'cerchio interno' dei
seguaci, il che dipende dalle caratteristiche dell'organizzazione (militare, partitica, ecc.) che il
leader controlla. La definizione adottata lascia quindi del tutto indeterminata (varierà da caso
storico a caso storico) l'organizzazione del regime cesaristico: la distinzione fra i diversi tipi di
cesarismo deve essere lasciata all'indagine empirica.
Il cesarismo, inteso nel senso stretto della definizione, deve essere inoltre distinto dai regimi
politici in cui sono presenti, ma non in posizione predominante, componenti cesaristiche (sono
di questo genere, come vedremo, le democrazie plebiscitarie esaminate da Weber): in questi
regimi manca l'elemento della provvisorietà. A istituzioni politiche stabili si associano tecniche
e procedure di organizzazione del consenso che danno periodicamente luogo a fenomeni, sia
pure attenuati e diluiti, di cesarismo. Per spiegare ciò che qui si intende ricorreremo a due
esempi, entrambi tratti dalla storia francese. Il primo esempio è per così dire obbligato:
riguarda il caso del regime di Napoleone Bonaparte, che è il punto di riferimento inevitabile di
tutte le analisi del cesarismo.
Un regime cesaristico 'puro' è quello che Napoleone instaura con il colpo di Stato del 9
novembre 1799, ponendo fine al regime del Direttorio. Questa fase, a cui appartengono alcune
delle riforme (in particolare quella amministrativa) mediante le quali Bonaparte pone le basi
per l'istituzionalizzazione del suo regime, termina con il plebiscito del 1802, in virtù del quale
Bonaparte consolida definitivamente il suo potere diventando console a vita. Nella fase
successiva le caratteristiche plebiscitarie del regime non vengono meno (ancora un plebiscito
trasforma Bonaparte da console a imperatore dei Francesi nel 1804), ma la dittatura
napoleonica è ormai consolidata.
Il secondo esempio riguarda il caso del gollismo, e anche qui è possibile distinguere due
diverse fasi. È un regime cesaristico puro il regime di transizione che si afferma nella
primavera del 1958, quando il generale de Gaulle assume i pieni poteri, e termina con il
referendum dell'ottobre 1962 sulla modifica costituzionale che sancisce l'elezione diretta del
presidente della repubblica.
Da quella data il regime cesaristico puro lascia il posto a un regime semipresidenziale, che
contiene forti elementi cesaristici ma non è più (o è sempre meno) cesaristico nel senso della
definizione adottata. Le elezioni presidenziali del 1965, ove de Gaulle deve subire
l''umiliazione' del ballottaggio con il candidato socialista Mitterrand, segnano l'avvenuto
consolidamento delle nuove istituzioni (in termini weberiani, l'istituzionalizzazione del
carisma). Analogamente, il regime fascista italiano (per il quale, soprattutto da parte di studiosi
marxisti, è stato usato il termine bonapartismo) non è, alla luce della definizione adottata, un
regime cesaristico. È invece, esaurita la fase del consolidamento, un regime autocratico con
elementi cesaristici.
Per usare termini schmittiani potremmo dire che il cesarismo è il regime dello "stato
d'eccezione" in cui però l'assunzione di pieni poteri da parte del leader si sposa con un
consenso plebiscitario, o semiplebiscitario, della comunità politica (delle sue componenti
maggioritarie). In questa prospettiva si può spiegare facilmente anche la scarsa attenzione che
la scienza politica presta ai fenomeni cesaristici. Trattandosi di regimi di transizione, i regimi
cesaristici hanno una vita effimera. Essi sorgono in risposta a una crisi e si trasformano più o
meno rapidamente in regimi diversi. A parte la difficoltà di trattare il caso dei regimi
personalistici, anche la tipica provvisorietà e instabilità del fenomeno spiega la disattenzione
della letteratura. Ma si tratta di una disattenzione ingiustificata, soprattutto perché i fenomeni
cesaristici sono spesso all'origine dei più duraturi regimi politici che li seguono. E, in molti
casi, sono proprio le decisioni del leader nella fase cesaristica pura a forgiare il campo su cui si
edificheranno le istituzioni della fase successiva.
La disattenzione per il fenomeno fa sì che i principali punti di riferimento restino tutt'ora le
teorie di Marx e di Weber. 2. La teoria del bonapartismo
Fra gli strumenti concettuali dell'analisi marxista la categoria 'bonapartismo' occupa una
posizione particolare perché le è affidato il compito di riassorbire una vistosa anomalia che la
teoria si trova a fronteggiare. L'anomalia consiste nell'esistenza di situazioni politiche
manifestamente caratterizzate dall'azione autonoma dello Stato (rispetto alle classi sociali) e
dalla presenza di leaders i cui comportamenti non sono facilmente riconducibili entro la
categoria 'rappresentanza di interessi di classe'. Sotto il profilo logico la teoria del bonapartismo
assume, nel più vasto corpo della teoria politica marxista, il ruolo di un'ipotesi ad hoc introdotta
per spiegare fatti altrimenti inspiegabili, la cui esistenza rischia di falsificare il 'nucleo centrale'
della teoria. Nella versione originaria, formulata da Marx nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte (e
ripresa da Engels per il caso della Germania), la teoria è caratterizzata dai punti seguenti.
1. Il bonapartismo si afferma in presenza di una situazione di stallo nel conflitto fra le due
principali classi sociali, la borghesia e il proletariato.
2. Lo stallo fra le classi principali apre lo spazio a un'influenza politica delle classi tradizionali,
in particolare dei contadini.
3. I contadini però, a differenza della borghesia e del proletariato, sono dispersi sul territorio e
privi di legami organizzativi che li rendano capaci di agire continuativamente e con coerenza
sulla scena politica. Incapaci di risolvere il problema del free rider, sono impossibilitati a
trasformarsi in soggetto collettivo.
4. Sfruttando la forza rappresentata dagli apparati dello Stato (burocrazia, forze armate, corpi di
polizia, ecc.), il capo del regime, il leader, è in condizioni di operare come forza autonoma.
Il regime bonapartista è intrinsecamente instabile. Nato da una condizione di stallo fra le classi,
è destinato a perire quando l'una o l'altra delle classi in lotta riprenderà il sopravvento.
Sul solco di Marx molti studiosi hanno tentato di approfondire il tema del bonapartismo,
principalmente allo scopo, in questo secolo, di spiegare il fascismo. Nelle Note sul Machiavelli
Gramsci utilizza il termine cesarismo per una breve analisi del fenomeno che arricchisce su
alcuni punti l'analisi di Marx. Il cesarismo, per Gramsci, sorge in condizioni di "equilibrio
catastrofico" fra le classi e rappresenta una soluzione "arbitrale", volta a impedire che le classi
in lotta si distruggano a vicenda. Possono darsi due tipi di cesarismo, l'uno progressivo (Cesare,
Napoleone I), l'altro regressivo (Napoleone III, Bismarck): "È progressivo il cesarismo, quando
il suo intervento aiuta la forza progressiva a trionfare sia pure con certi compromessi e
temperamenti limitativi della vittoria, è regressivo quando il suo intervento aiuta a trionfare la
forza regressiva, anche in questo caso con certi compromessi e limitazioni, che però hanno un
valore, una portata e un significato diversi che non nel caso precedente" (v. Gramsci, 1966⁴, p.
58). Inoltre, per Gramsci, va considerata un'importante differenza fra i cesarismi del passato e
quelli dell'età contemporanea (ad esempio il fascismo italiano). Nel passato il cesarismo era
sempre associato all'elemento militare, mentre i mutamenti delle tecniche e dell'organizzazione
politica rendono il cesarismo contemporaneo meno legato al ruolo della forza militare. Nei
termini di Gramsci, esso è meno militare e più "poliziesco".
Una posizione a sé stante ha, fra le teorie marxiste del bonapartismo, quella di Lev Trockij. Il
problema di Trockij, infatti, non è spiegare il fascismo ma lo stalinismo, l'evoluzione politica
russa postrivoluzionaria. Qui il punto di partenza non è più lo stallo fra due classi sociali in
lotta, bensì l'oppressione esercitata dalla burocrazia ai danni del proletariato. Lo stalinismo è un
fenomeno collegato alla lotta fra burocrazia e proletariato ed è, per Trockij, un regime
cesaristico sui generis. È anch'esso temporaneo, al pari dei cesarismi in ambito capitalisticoborghese, ma la sua affermazione dipende dalle esigenze di predominio della burocrazia ai
danni della "classe generale".
Un altro autore marxista, Nicos Poulantzas, in quello che resta il più articolato tentativo di
elaborare una teoria marxista dello Stato, Potere politico e classi sociali, prende le distanze
dalla tesi dello stallo o equilibrio catastrofico. Per Poulantzas il bonapartismo è solo una
manifestazione particolare di una più generale autonomia dello Stato capitalista dalla classe
dominante. Egli polemizza con la tendenza di Engels ad accomunare fenomeni così diversi
come il bonapartismo, lo Stato assolutista e il bismarckismo. Per Poulantzas è propria del
capitalismo questa circostanza: "lo Stato capitalistico fa suo l'interesse politico della borghesia
e realizza per suo conto la funzione egemonica politica che quest'ultima non può assolvere. A
tale scopo lo Stato capitalistico è costretto ad assumere un'autonomia relativa nei confronti
della borghesia: sta qui il significato profondo delle analisi di Marx sul bonapartismo come tipo
capitalistico di Stato" (v. Poulantzas, 1968; tr. it., p. 365). Questa impostazione apre la strada a
una classificazione delle forme politiche dello Stato capitalistico. Il bonapartismo perde i
caratteri di eccezionalità che aveva nella teoria marxista tradizionale e diventa uno fra i molti
possibili modi di manifestarsi dell'autonomia relativa dello Stato.
La valutazione della teoria del bonapartismo, nelle sue diverse versioni, dipende ovviamente
dal giudizio che si dà sull'utilità degli strumenti di analisi offerti dalla più generale teoria
politica marxista. Lasciando da parte il caso di Poulantzas, il quale, utilizzando uno schema di
spiegazione funzionalistico, tenta di gettare le basi di una teoria generale dello Stato ma al
prezzo di diluire le specificità del fenomeno bonapartista, l'utilità delle categorie marxiste, per
l'esame del fenomeno in questione, non appare elevata. Il tentativo è viziato dal bisogno di
evadere, lasciando però intatto il nucleo della teoria, dalle insufficienze proprie di una
concezione che tratta le forze politiche come 'nomenclature' delle classi sociali, dalla necessità
di affermare, per difendere la teoria a fronte di evidenti anomalie empiriche, il carattere
eccezionale del fenomeno, la sua condizione di eccezione che confermerebbe la regola. Resta
tuttavia a suo merito il fatto che quello marxista è uno dei pochissimi tentativi relativamente
sistematici di spiegare il cesarismo. 3. La teoria del carisma
La teoria weberiana del carisma è stata più volte ricostruita nei suoi diversi aspetti (v., da
ultimo, Cavalli, 1981) e quindi non è il caso qui di rivisitarla compiutamente. Al fine dell'esame
del cesarismo la teoria del carisma ha il pregio, rispetto a qualsiasi altra teoria delle scienze
sociali, di spiegare le cause di quell'ascendente personale in virtù del quale un individuo, al di
fuori della tradizione e senza la sanzione di norme legali, arriva a essere acclamato come leader
da una moltitudine dando vita a regimi cesaristici.
Un regime cesaristico comporta invariabilmente la presenza del capo carismatico nell'accezione
weberiana. Il carisma è riconosciuto come tale e si afferma in presenza di uno stato di crisi, di
acuto stress sociale. Comporta una 'chiamata' che, per essere efficace, necessita di uno stato di
disorganizzazione sociale, una situazione che si ripercuote sugli individui incrinandone
credenze, identità e abiti mentali, e rendendoli disponibili alla mobilitazione carismatica. Nella
visione weberiana il carisma è il veicolo del cambiamento sociale e istituzionale, l'energia che
crea nuove istituzioni e/o determina trasformazioni nelle istituzioni preesistenti. Perché
l'innovazione introdotta sia duratura occorre però che intervenga l'istituzionalizzazione o
'routinizzazione' del carisma. La routinizzazione comporta la transizione da un regime
personale, centrato sull'autorità carismatica del leader, a un regime istituzionale, come esito di
un processo che Weber definisce di "legalizzazione".
Alla luce di questa teoria i fenomeni cesaristici possono essere distinti a seconda dei loro
differenti esiti storici. La differenza principale corre fra i (pochi) regimi cesaristici che
superano la soglia della routinizzazione del carisma e quindi sopravvivono al loro fondatore e
quelli, storicamente assai più numerosi, che non la superano. In questo caso la fine del regime
cesaristico apre una nuova fase di disorganizzazione sociale e politica simile a quella che ne
aveva favorito l'affermazione. 4. Cesarismo e democrazia: la democrazia plebiscitaria
La grande concentrazione di potere nelle mani di un solo individuo, che è propria del
cesarismo, nonché il carattere plebiscitario del conferimento della delega (nella forma pura
l'acclamazione sostituisce l'elezione del rappresentante) rendono apparentemente inconciliabili
cesarismo e democrazia. È certamente vero, peraltro, che nella maggioranza dei casi storici (il
gollismo è un'importante eccezione) il cesarismo è all'origine di regimi autocratici. Occorre
però notare che, a dispetto del suo nome, il cesarismo è un fenomeno squisitamente moderno,
legato alla "democratizzazione fondamentale" (Mannheim), all'ingresso delle masse nelle arene
politiche. Come la democrazia liberale e, sul versante opposto, il totalitarismo, il cesarismo
presuppone la 'società di massa'.
Seguendo una recente rilettura delle pagine weberiane (v. Cavalli, 1981, 1982 e 1987) è
possibile distinguere due diversi tipi di regime politico con componenti cesaristiche: le tirannie
carismatiche (la versione autocratica del cesarismo) e le democrazie plebiscitarie. La
democrazia plebiscitaria, o democrazia con un leader, viene distinta, da Weber, dalle
democrazie acefale. Essa si fonda su istituti e procedure che favoriscono la periodica
apparizione di fenomeni, sia pure attenuati, di cesarismo.
Anche se gli arrangiamenti istituzionali possono essere i più diversi, si può dire che la
formazione di democrazie plebiscitarie è favorita da sistemi elettorali maggioritari e/o
dall'istituto dell'elezione diretta del capo del governo, mentre le democrazie acefale sono più
facilmente associate a sistemi elettorali proporzionali e/o a forme di elezione indiretta
(parlamentare) del capo del governo. Nell'analisi weberiana della democrazia plebiscitaria
erano presenti due componenti. In primo luogo, l'influenza del classico studio di Mosei
Ostrogorski (v., 1902) sui partiti politici moderni: Ostrogorski aveva mostrato come e perché le
moderne macchine di partito favorissero l'affermazione di tendenze cesaristiche nelle
democrazie. In secondo luogo, e indipendentemente dall'opera di Ostrogorski, l'attenzione per
la Gran Bretagna di Gladstone e di Disraeli - termine di riferimento anche politico nella
polemica weberiana contro l'"eredità negativa" del bismarckismo - e per gli Stati Uniti. Nella
più pura tradizione del realismo politico, Weber vedeva nel moderno capo di partito del mondo
anglosassone un dittatore carismatico, e nelle elezioni il momento del 'riconoscimento' e
dell'acclamazione del capo anziché della scelta.
La democrazia plebiscitaria ha una collocazione ambigua nella più generale teoria politica
weberiana (v. Beetham, 1985²): descrizione e prescrizione si compenetrano. Per un verso la
democrazia plebiscitaria è per Weber la sola forma di democrazia congruente con le esigenze
della società occidentale contemporanea; per un altro verso è anche l'unica strada per
mantenere aperta la porta alla periodica irruzione del carisma, inteso come la forza capace di
contrastare o controbilanciare, almeno in parte, gli effetti negativi (la "gabbia d'acciaio") della
razionalizzazione.
Dopo Weber molti autori hanno messo in luce l'esistenza, nelle democrazie contemporanee,
delle tendenze da lui indicate (v. AA.VV., 1987). Essenzialmente due fenomeni, fra loro
intrecciati, sembrano favorire l'affermazione di tendenze plebiscitarie, e quindi cesaristiche,
nelle democrazie contemporanee. Il primo è rappresentato dal ruolo dei mass media e, in
particolare, della televisione nella competizione politica; il secondo dalla 'crisi degli
intermediari', ossia la crisi delle strutture-ponte, o cuscinetto, fra gli individui e il potere
politico (un tema classico della letteratura sulla società di massa). Quella che, sia pure con una
certa dose di esagerazione, è stata chiamata la "democrazia elettronica" (v. Saldich, 1979)
svolge un ruolo potentissimo nel guidare in direzione cesaristica i processi politici poliarchici.
La 'crisi degli intermediari' è in parte un effetto del ruolo assunto dai media, ma in parte, e forse
si tratta della parte preponderante, deriva anche da modificazioni più profonde delle società
occidentali: dai mutamenti della struttura di classe, dall'innalzamento dei livelli di istruzione,
dai cambiamenti nel ritmo della mobilità sociale, ecc.
La prima e fondamentale crisi, imputabile alla secolarizzazione, è il declino
dell'associazionismo religioso (anche la comparsa di 'minoranze intense' religiose è spiegabile
alla luce dell'ipotesi della secolarizzazione).
A quel declino si affianca la crisi dei vecchi partiti di massa, dotati di solidi apparati
burocratici, collocati al centro di ramificate subculture politiche, forti del consenso di ampi
settori dell'elettorato di appartenenza. Questi partiti vanno progressivamente trasformandosi in
partiti 'pigliatutto' (v. Kirchheimer, 1966), dotati di strutture tecnico-professionali (esperti in
mass media, tecnici dei sondaggi, pubblicitari, ecc.), alla perenne caccia del consenso, volubile
e aleatorio, dell'elettorato di opinione. Questi fenomeni favoriscono la cosiddetta
'personalizzazione del potere', lo spostamento della lealtà dai partiti ai candidati e il
conseguente rafforzamento del ruolo pubblico del leader. Là dove, come negli Stati Uniti,
l'assetto istituzionale di per sé già premia la democrazia plebiscitaria, le tendenze cesaristiche
ne vengono esaltate. Ma il fenomeno, sia pure in forma più attenuata, si manifesta anche in
quelle poliarchie dell'Europa continentale che, per il loro assetto istituzionale, Weber
definirebbe democrazie acefale. 5. Cesarismo e politica internazionale
È una regola riconosciuta quella secondo cui, all'interno di qualsiasi organizzazione, il potere
decisionale si concentra al vertice in presenza di sfide di origine esterna che minacciano la
sopravvivenza dell'organizzazione. In tutti gli ambiti organizzati il potere è normalmente
disperso: molti individui e molti gruppi, ai diversi livelli gerarchici, detengono risorse
utilizzabili per accumulare potere e/o per esercitarlo. Quando interviene una crisi organizzativa
per effetto di una sfida esterna, il potere rifluisce al vertice: emergono capi carismatici che
prendono decisioni 'strategiche', di ristrutturazione dell'organizzazione, necessarie per
fronteggiare la sfida esterna e far uscire l'organizzazione dal suo stato di crisi (v. Crozier,
1964).
La storia delle organizzazioni è spesso segnata da sequenze alternate di improvvisi 'drammi
sociali', dovuti, per lo più, a sfide provenienti dall'ambiente esterno, e di lunghe fasi di routine.
Alle due fasi corrispondono metodi decisionali diversi: nei periodi di routine (potere diffuso e
frazionato) prevale il metodo incrementale, il mutuo aggiustamento degli interessi (v.
Lindblom, 1959); nei periodi di crisi (potere concentrato) prevalgono le decisioni strategiche di
riorganizzazione (del tipo mixed scanning, nella terminologia di Etzioni, 1967). Il punto
cruciale, comunque, è che le crisi che scuotono le organizzazioni minacciandone la
sopravvivenza, e il cui effetto è quello di trasferire il potere decisionale nelle mani di capi
carismatici, sono normalmente originate da mutamenti nell'ambiente esterno delle
organizzazioni: cambiamenti ambientali provocano sfide, pressioni che si scaricano sulle
organizzazioni determinando una ridistribuzione del potere interno. Se dai contributi della
teoria dell'organizzazione passiamo a considerare le indicazioni della teoria delle relazioni
internazionali, scopriamo all'opera la stessa regola. I conflitti internazionali hanno sempre
l'effetto di determinare una forte concentrazione del potere entro gli Stati (v. Wright, 1970³). Le
guerre rappresentano, per i sistemi politici, quelle sfide esterne che favoriscono la
concentrazione del potere. In tutte le epoche storiche il grado di centralizzazione del potere
entro gli ordinamenti politici è stato influenzato dall'intensità delle sfide militari (v. Andreski,
1971²). Uno degli effetti delle guerre sulle democrazie rappresentative, in questo secolo, è stato
quello di rafforzare (temporaneamente, per la durata del conflitto) il potere personale dei
leaders (primo ministro, presidente) a fronte dei membri del governo e del parlamento. In caso
di guerra la normale dialettica fra maggioranza e opposizione (nonché all'interno dei partiti di
governo) viene meno, e i capi di governo acquistano una libertà d'azione che non possiedono in
tempo di pace (v. Stein, 1980).
Ciò ha attinenza con il fenomeno del cesarismo. Si è detto che il cesarismo si afferma in
condizioni di crisi dell'ordinamento politico preesistente. La crisi che apre la strada al regime
cesaristico è spesso conseguenza di una sfida internazionale (di carattere militare, per lo più)
che la classe politica non riesce a fronteggiare. La disorganizzazione che la sfida provoca apre
la strada a una soluzione cesaristica, all'affermazione di una 'tirannia' carismatica. Che la sfida
assuma sovente le sembianze dello stato di guerra contribuisce a spiegare perché il fondatore
del regime cesaristico sia spesso (anche se non sempre) un capo militare.
Anche l'affermazione di tendenze plebiscitarie nelle democrazie occidentali può essere
ricondotta, almeno in parte, a sfide che hanno nelle pressioni esterne, di carattere
internazionale, la loro origine. È questo il caso francese: il regime cesaristico di de Gaulle e la
nascita della Quinta Repubblica furono l'effetto della mancata soluzione del conflitto algerino
da parte della classe politica della Quarta Repubblica. Ma è anche, secondo diversi studiosi, il
caso degli Stati Uniti dove, nel corso del XX secolo, l'istituto della presidenza si è rafforzato a
spese degli altri poteri istituzionali. Le cause sono molte (l'ampliamento dei compiti del
governo federale, la formazione di una burocrazia professionale che ha lentamente sostituito, a
partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, la precedente amministrazione basata sul sistema
delle spoglie: v. Wilson, 1978), ma l'elemento decisivo è stato il mutamento di collocazione
internazionale degli Stati Uniti. La "presidenza imperiale" (v. Schlesinger, 1973) è, soprattutto,
il prodotto di un cambiamento radicale della posizione statunitense: da paese periferico a
superpotenza. Il rapporto fra sfide esterne, affermazione di un'egemonia politica internazionale
e rafforzamento del potere esecutivo è così descritto da Franz Schurmann: "C'è un legame fra
guerra, impero e potere esecutivo.
Lo stesso tipo di legame può essere osservato tra crisi, politica mondiale e potere presidenziale
per i decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Essi si alimentano reciprocamente. La
crisi porta a una nuova politica mondiale dell'America, la quale a sua volta aumenta il potere
presidenziale e la centralizzazione. Ma funzionano anche altre varianti di questa equazione.
Una volta aumentato il potere presidenziale, vengono annunciate nuove linee politiche
mondiali che a loro volta invariabilmente producono crisi. Gli uni erano e sono reciprocamente
causa ed effetto degli altri. La decisione americana di svolgere un ruolo imperiale nel mondo ha
reso inevitabile un contesto di crisi continue, un maggiore coinvolgimento in lontane parti del
mondo, e una concentrazione del potere senza precedenti alla Casa Bianca" (v. Schurmann,
1974; tr. it., pp. 36-37).
Se fu la crisi economica degli anni trenta a dare la spinta iniziale portando Roosevelt alla
presidenza, furono però tre eventi, tutti e tre attinenti ai rapporti internazionali, a consolidare
definitivamente il potere presidenziale. Il primo fu lo scoppio della seconda guerra mondiale
che, in accordo con una sequenza ricorrente, rafforzò la posizione del presidente. Questo effetto
è, in genere, temporaneo: dura quanto durano le ostilità. Nel caso statunitense non fu così
perché la fine del conflitto coincise con l'assunzione in via permanente, da parte degli Stati
Uniti, del ruolo di nazione-guida del mondo occidentale (il secondo evento). Il terzo fu
l'avvento dell'era nucleare. "Nessun'altra esigenza della politica postbellica giustificò altrettanto
il mantenimento di un immenso potere statale esercitato da un vertice esecutivo forte, come il
bisogno di controllare l'energia atomica e le sue armi. Nulla incoraggiò altrettanto il crescente
potere di quel governo come la richiesta universale di sicurezza dalla terribile possibilità di un
annientamento atomico" (ibid., p. 137). Leadership mondiale e politica della deterrenza
nucleare esaltarono il ruolo del presidente entro il sistema politico; soprattutto, resero definitivo
il primato presidenziale. Senza questa evoluzione, difficilmente il ruolo dei mass media, la crisi
dei partiti politici, ecc. sarebbero stati condizioni sufficienti per alimentare la democrazia
plebiscitaria.
Gli esempi della Francia e degli Stati Uniti suggeriscono che il rapporto fra concentrazione del
potere, tendenze cesaristico-plebiscitarie e sfide internazionali è assai stretto anche nel caso
delle democrazie rappresentative. Per restare alla terminologia weberiana, è possibile ipotizzare
che le democrazie acefale, ove il potere è diffuso e frazionato e ove è assente la componente
cesaristica, possono sopravvivere solo in condizioni di sicurezza esterna. È il caso di alcune
democrazie acefale europeo-continentali dopo la seconda guerra mondiale, la cui stabilità è
dipesa soprattutto, probabilmente, dall'esistenza dell''ombrello' politico-militare statunitense. È
quindi lecito ipotizzare che mutamenti delle condizioni internazionali e, in particolare, un
aumento della vulnerabilità di questi paesi a fronte di sfide esterne, ne favorirebbero la
transizione al 'tipo' della democrazia plebiscitaria.
Il potere monocratico, o monocrazia (v. Miglio, 1988), è la forma assunta da tutti gli
ordinamenti politici del passato in presenza di sfide militari. Il cesarismo è potere monocratico
nelle condizioni politiche proprie della società di massa. La democrazia plebiscitaria, involucro
di un cesarismo diluito, vincolato da norme costituzionali, potrebbe essere, a sua volta, la
versione occidentale contemporanea, democratico-rappresentativa, di un fenomeno antico e
ricorrente.
(V. anche Autoritarismo; Demagogia). bibliografia
AA. VV., Leadership e democrazia, Padova 1987.
Andreski, S., Military organization and society, Berkeley 1971².
Beetham, D., Max Weber and the theory of modern politics, Dales Brewery 1985².
Cavalli, L., Il capo carismatico, Bologna 1981.
Cavalli, L., Carisma e tirannide nel secolo XX. Il caso Hitler, Bologna 1982.
Cavalli, L., Il presidente americano, Bologna 1987.
Crozier, M., Le phénomène bureaucratique, Paris 1964 (tr. it.: Il fenomeno burocratico, Milano
1969).
Etzioni, A., Mixed-scanning: a 'third' approach to decisionmaking, in "Public administration
review", 1967, XXVII, pp. 385-392.
Gramsci, A., Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Torino 1966⁴.
Huntington, S., Political order in changing societies, New Haven, Conn., 1968 (tr. it.:
Ordinamento politico e mutamento sociale, Milano 1975).
Kirchheimer, O., The transformation of the Western European party systems, in Political parties
and political development (a cura di J. La Palombara e M. Weiner), Princeton 1966, pp. 177200 (tr. it.: La trasformazione dei sistemi di partito europeo-occidentali, in Sociologia dei partiti
politici, a cura di G. Sivini, Bologna 1979, pp. 243-267).
Lasswell, A., Kaplan, A., Power and society, New Haven, Conn., 1950 (tr. it.: Potere e società,
Milano 1969).
Lindblom, C., The science of muddling through, in "Public administration review", 1959, XIX,
pp. 517-526.
Linz, J., Authoritarian and totalitarian regimes, in Handbook of political science (a cura di F. J.
Greenstein e N. W. Polsby), vol. III, Reading, Mass., 1975.
Linz, J., Stepan, A. (a cura di), Breakdowns of democratic regimes, Baltimore 1978.
Miglio, G., Monocrazia, in Le regolarità della politica, Milano 1988.
Morlino, L., Autoritarismi, in Manuale di scienza della politica (a cura di G. Pasquino),
Bologna 1986, pp. 137-189.
Ostrogorski, M., La démocratie et l'organisation des partis politiques, Paris 1902.
Poulantzas, N., Pouvoir politique et classes sociales de l'État capitaliste, Paris 1968 (tr. it.:
Potere politico e classi sociali, Roma 1971).
Rouquié, A., L'hypothèse 'bonapartiste' et l'émergence des systèmes politiques
semicompétitives, in "Revue française de science politique", 1975, XXV.
Saldich, A., Electronic democracy, New York 1979.
Schlesinger, A. jr, The imperial presidency, London 1973 (tr. it.: La presidenza imperiale,
Milano 1980).
Schurmann, F., The logic of world power, New York 1974 (tr. it.: La logica del potere, Milano
1980).
Stein, A., The nation at war, Baltimore 1980.
Trockij, L., La révolution trahie, Paris 1936 (tr. it.: La rivoluzione tradita, Milano 1956).
Wilson, J., The rise of bureaucratic State, in Bureaucratic power in national politics (a cura di F.
Rourke), Boston 1978, pp. 54-78.
Wright, Q., A study of war, Chicago 1970³.
Liberalismo
Giuseppe Bedeschi
Il 20° secolo è stato il secolo dei grandi regimi totalitari e delle ideologie che li hanno ispirati.
Non si può intendere la storia del pensiero liberale della nostra epoca se non si parte da questo
dato di fatto. Comunismo e fascismo sono stati i due estremi con i quali il l. ha dovuto
misurarsi, le due sfide più ardue e più difficili con le quali ha dovuto confrontarsi. Tanto più
ardue e difficili, tali sfide, in quanto il comunismo si ispirava a un'ideologia la quale mirava nelle dichiarazioni di principio - alla costruzione di una società nuova, non più fondata sulle
disuguaglianze e sullo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo; una ideologia, inoltre, che
considerava il l. come l'espressione teorica della società borghese capitalistica, caratterizzata,
appunto, dalla disuguaglianza sociale e dallo sfruttamento. Ma anche il fascismo (sia italiano
che tedesco) considerava suo mortale avversario ideologico-politico, oltre che il comunismo,
anche il l., visto come espressione di un individualismo mercantile e di una mentalità
'bottegaia', che dovevano essere spazzati via da una civiltà nuova, fondata non più
sull'individuo ma sul popolo, concepito come razza, per il cui destino il singolo avrebbe dovuto
sacrificarsi incondizionatamente, e quindi anche immolarsi.
Il pensiero etico-politico di K.R. Popper (1902-1997), uno dei più significativi pensatori liberali
del Novecento, si forma appunto avendo come riferimento fondamentale le due grandi sfide
totalitarie, comunismo e fascismo. E infatti la sua opera The poverty of historicism, pensata
verso la metà degli anni Trenta e pubblicata nella rivista Economica del 1944-45 (e in volume
nel 1957), recherà sul frontespizio, nelle successive ristampe, questa dedica: "In memoria degli
innumerevoli uomini, donne e bambini di tutte le credenze, nazioni o razze che caddero vittime
della fede fascista e comunista nelle Inesorabili Leggi del Destino Storico".
È naturale, quindi, che la riflessione etico-politica di Popper sia caratterizzata in primo luogo
dalla forte sottolineatura di alcuni principi o valori, i quali soltanto possono assicurare la
vitalità e quindi la sopravvivenza della democrazia liberale. Ed è significativo che per Popper il
principio di maggioranza, per quanto importante, non possa costituire il fondamento di quella
che egli chiama la "società aperta" (ovvero la società liberal-democratica).
E ciò per il semplice motivo che anche una maggioranza liberamente espressa dagli elettori
attraverso il suffragio universale può essere una maggioranza antiliberale e antidemocratica:
può essere una maggioranza, insomma, che porta a una limitazione e poi a una soppressione
della società aperta (ed è appena il caso di rilevare che in questa posizione di Popper si avverte
l'eco drammatica dell'esperienza della Germania, dove il nazismo giunse al potere con un
imponente seguito di massa). Di qui quello che Popper chiama il "paradosso della tolleranza",
che egli caratterizza in questo modo: "Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che
sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco degli
intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti, e la tolleranza con essi" (Popper 1945; trad. it.
1973-74, i, p. 360).
La società aperta, dunque, deve difendersi dai propri nemici. Ma Popper è ben consapevole che
tale società non può difendersi semplicemente con misure coercitive o provvedimenti
amministrativi contro i propri avversari, allo stesso modo che le istituzioni non costituiscono di
per sé una garanzia assoluta contro le tentazioni autoritarie e totalitarie: e ciò tanto più in
quanto "le democrazie sono sempre aperte alle idee e specialmente a quelle provenienti
dall'opposizione", e "sono sempre pronte a dubitare di se stesse", poiché "esse sanno benissimo
che molte cose non sono come dovrebbero essere" (Revolution oder Reform? 1971; trad. it.
1977, p. 45). Invero, per riuscire a evitare i pericoli più gravi occorre che la cultura liberaldemocratica sia egemone nella società, e che sia in grado di incidere profondamente sulla
politica, tanto nel senso di ispirarla con i propri valori, quanto nel senso di formare personalità
politiche capaci e all'altezza dei compiti che le attendono. Ciò non significa che la società
aperta debba sottovalutare i pesi e i contrappesi con cui limita e fraziona il potere (pesi e
contrappesi indispensabili per difendere il cittadino dalle tentazioni e dagli abusi del potere
medesimo, secondo la classica teoria di Montesquieu); significa soltanto che essa è affidata
prima di tutto alle proprie ragioni ideali e alla propria capacità di farle trionfare attraverso la
discussione e il confronto più liberi e più larghi. Solo così essa potrà elaborare un complesso di
principi profondamente sentiti dalla maggioranza dei cittadini, principi che costituiranno il
presidio principale contro le involuzioni autoritarie e totalitarie.
Quali sono tali principi? Popper istituisce una stretta connessione fra il "razionalismo critico" o
scientifico e la società aperta. Per intendere il razionalismo critico di cui egli parla, bisogna
intendere la sua concezione della scienza. La quale, secondo il filosofo austriaco, procede per
"tentativi ed errori" o per "congetture e confutazioni", nel senso che la ricerca scientifica,
imbattutasi in un problema, ne tenta una soluzione, sottoponendola a un'accurata verifica. Se la
verifica conferma la teoria, quest'ultima, però, non è affatto definitiva, perché prima o poi
emergeranno altri fatti e problemi che imporranno la revisione o addirittura l'abbandono della
teoria medesima. Ne consegue, in primo luogo, che non c'è mai una teoria assolutamente vera,
e che ogni teoria è sempre e soltanto congetturale; in secondo luogo che, essendo l'errore
costitutivo di ogni ricerca scientifica, la scienza non può mai eliminarlo definitivamente, ma
solo correggerlo di volta in volta, attraverso falsificazioni e controlli rigorosi. La scienza,
dunque, è l'unico sapere fondato sull'esperienza e capace di progredire incessantemente, e al
tempo stesso è un sapere sempre fallibile e precario.
Se si applica questo razionalismo critico alla società, ne discende che, come non esiste una
teoria assolutamente vera, così non esiste una società perfetta. Ogni società può essere
riformata e migliorata. Ciò esclude, da un lato, qualunque tipo di società teocratica, o
comunque fondata su valori indiscutibili, dall'altro qualunque tipo di società 'definitiva', capace
di risolvere i problemi una volta per tutte (come era per Marx la società comunista). Ma se non
esiste una società perfetta, non esiste nemmeno un intervento politico risolutivo di tutti i
problemi sociali. Gli interventi per modificare la società devono essere sempre parziali,
graduali, per migliorare questa o quella situazione: non possono essere utopistici e olistici, ma
devono ispirarsi sempre all'ingegneria sociale. Essi, dice Popper, "ci riportano alla nostra
originaria affermazione che si devono pianificare misure per combattere i mali concreti,
piuttosto che per realizzare qualche bene ideale. L'intervento dello Stato dev'essere limitato a
quanto è veramente necessario per la protezione della libertà" (Popper 1945; trad. it. 1973-74,
ii, pp. 170-71).
In questo quadro di ingegneria sociale, la discussione e il confronto fra posizioni e soluzioni
diverse - discussione e confronto a tutti i livelli: dalla stampa ai partiti, ai sindacati, al
Parlamento - sono fondamentali e costitutivi della società aperta. Il pluralismo culturale e
politico deve dunque essere garantito e istituzionalizzato; e il momento del dissenso è ancora
più prezioso di quello del consenso. Sicché gli strumenti principali della società aperta sono la
libera competizione fra la maggioranza che governa e la minoranza che le si oppone, in modo
tale che la minoranza possa diventare a sua volta, con il consenso popolare, maggioranza; il
formarsi e il manifestarsi di un'opinione pubblica libera (cioè non manipolata) attraverso il
confronto e il dibattito fra i partiti, i sindacati, le associazioni, i giornali.
Liberalismo e democrazia
Uno dei grandi temi affrontati dal pensiero liberale del 20° secolo è costituito dai rapporti fra l.
e democrazia: la concezione liberale e la concezione democratica coincidono o divergono? Le
risposte date a tale quesito variano sensibilmente. Per H. Kelsen, uno dei più grandi
protagonisti della ricerca giuridico-politica del 20° secolo, l. e democrazia coincidono, ma nel
senso che la democrazia ha il proprio fondamento nella libertà, e quindi è democrazia liberale.
Infatti, polemizzando contro i marxisti, i quali oppongono alla democrazia fondata sul principio
di maggioranza (da essi considerata democrazia solo formale) la democrazia fondata
sull'eguaglianza sociale (da essi considerata sostanziale), Kelsen afferma: "Questa opposizione
deve essere respinta nel modo più assoluto. È il valore di libertà e non quello di eguaglianza a
determinare, in primo luogo, l'idea di democrazia" (Kelsen 1920; trad. it. 1981, p. 133). Certo,
per Kelsen, anche l'idea di eguaglianza ha una parte importante nell'ideologia democratica, ma
in un senso solo negativo e formale. Infatti, il rapporto libertà-eguaglianza si configura in
questo modo: poiché tutti debbono essere liberi nella maggior misura possibile, tutti debbono
partecipare in misura uguale alla formazione della volontà dello Stato. Il fine principale,
dunque, è la libertà, e l'uguaglianza ha un senso solo all'interno di essa: si tratta quindi
dell'uguaglianza formale nella libertà, cioè dell'eguaglianza nei diritti politici. Del resto,
sottolinea Kelsen, ciò è vero non solo concettualmente, ma anche storicamente, poiché la lotta
per la democrazia è storicamente una lotta per la libertà politica, vale a dire per la
partecipazione del popolo alle funzioni legislativa ed esecutiva.
Ma Kelsen aggiunge un altro argomento a favore della sua tesi che il principio fondamentale
della democrazia è la libertà e non l'uguaglianza. E cioè, che mentre non si può escludere
l'esistenza di una società perfettamente egualitaria ma non democratica (non libera), ovvero
autoritaria o addirittura totalitaria, non si può concepire invece una società democratica che non
garantisca le libertà fondamentali dell'individuo, e fra queste la libertà di pensiero, di parola, di
stampa: tutto quello che assicura, insomma, il libero formarsi di una pubblica opinione.
Sostiene Kelsen a questo proposito: "In una democrazia, la volontà della comunità è sempre
creata attraverso una continua discussione fra maggioranza e minoranza, attraverso un libero
esame di argomenti pro e contro una data regolamentazione di una materia. Questa discussione
ha luogo non soltanto in Parlamento, ma anche, e principalmente, in riunioni politiche, sui
giornali, sui libri e altri mezzi di diffusione dell'opinione pubblica. Una democrazia senza
opinione pubblica è una contraddizione in termini. In quanto l'opinione pubblica può sorgere
dove sono garantite la libertà di pensiero, la libertà di parola, di stampa e di religione, la
democrazia coincide con il liberalismo politico, sebbene non coincida necessariamente con
quello economico" (Kelsen 1945; trad. it. 1952, p. 293).
La società liberaldemocratica è caratterizzata per Kelsen - oltre che dal parlamentarismo e dalla
più ampia libertà a tutti i livelli nel processo di formazione della rappresentanza - anche da altri
fattori e strumenti: il suffragio universale in primo luogo, e poi i partiti politici. Secondo
Kelsen, è proprio della natura della democrazia che il suffragio sia universale: democrazia
significa infatti che la 'volontà' rappresentata nell'ordinamento giuridico dello Stato è identica
alla volontà dei sudditi (all'opposto dell'autocrazia, fondata sulla soggezione dei sudditi, i quali
sono esclusi dalla creazione dell'ordinamento giuridico). Perciò il minor numero possibile di
cittadini dev'essere escluso dal diritto di voto. In secondo luogo, non c'è democrazia liberale
senza partiti politici, i quali raggruppano gli uomini di una stessa opinione, e garantiscono loro
un influsso effettivo sulla gestione degli affari pubblici. Un individuo isolato non ha,
politicamente, alcuna esistenza reale, appunto perché non può esercitare alcun influsso sulla
formazione della volontà dello Stato. "Solo l'illusione o l'ipocrisia può credere che la
democrazia sia possibile senza partiti politici" (Kelsen 1920; trad. it. 1981, pp. 56-57).
La caratterizzazione kelseniana della democrazia liberale ha come proprio presupposto
filosofico-metodologico un atteggiamento culturale di tipo relativistico e fallibilista, per il
quale non esistono verità indiscutibili e valide una volta per tutte, non esistono valori assoluti.
"In effetti - dice Kelsen - la causa della democrazia risulta disperata se si parte dall'idea che sia
possibile la conoscenza della verità assoluta, la comprensione di valori assoluti" (Kelsen 1920;
trad. it. 1981, p. 139). Infatti, la fiducia nell'esistenza di verità assolute e di valori assoluti pone
le basi di una concezione metafisica e mistico-religiosa del mondo: una concezione che fa
tutt'uno, in politica, con un'attitudine autocratica. All'autorità (sia essa una casta di preti, di
nobili o di guerrieri, oppure una classe o un partito politico) che ritiene di possedere la verità
assoluta, si deve obbedienza incondizionata. All'opposto, chi ritiene inaccessibili alla
conoscenza umana la verità assoluta e i valori assoluti, considera come possibile non soltanto la
propria opinione, ma anche l'opinione altrui. Perciò il relativismo (ovvero la convinzione che
alla conoscenza umana siano accessibili soltanto verità relative, valori relativi, e che quindi
ogni verità e ogni valore debbano essere pronti, a ogni istante, a ritirarsi per fare posto ad altri
valori e ad altre verità) è la concezione del mondo che sta a fondamento dell'idea democraticoliberale. "La democrazia [liberale] - dice Kelsen - stima allo stesso modo la volontà politica di
ognuno, come rispetta egualmente ogni credo politico, ogni opinione politica di cui, anzi, la
volontà politica è l'espressione. Perciò la democrazia [liberale] dà a ogni convinzione politica la
stessa possibilità di esprimersi e di cercare di conquistare l'animo degli uomini attraverso una
libera concorrenza" (p. 141). Il libero confronto delle opinioni, la rigorosa tutela dei diritti delle
minoranze, la procedura dialettica adottata dal Parlamento nella creazione delle norme,
procedura che si svolge attraverso discorsi e repliche: tutto ciò costituisce l'essenza della
democrazia liberale. La quale si basa sì sul dominio della maggioranza, ma tale dominio "si
distingue da ogni altro tipo di dominio perché, secondo la sua più intima essenza, non soltanto
presuppone, per definizione stessa, un'opposizione - la minoranza - ma anche perché riconosce
politicamente tale opposizione e la protegge coi diritti fondamentali e con le libertà
fondamentali" (pp. 141-42). Il che significa che la minoranza può diventare in qualunque
momento maggioranza. "Questo - conclude Kelsen - è il senso proprio di quel sistema politico
che noi chiamiamo democrazia [liberale] e che si può opporre all'assolutismo politico soltanto
perché è l'espressione di un relativismo politico" (p. 143).
Sensibile, come Popper, ai presupposti filosofico-epistemologici del pensiero liberaldemocratico, Kelsen è meno sensibile al nesso che intercorre fra l. e struttura socio-economica
della società. È caratteristica, a questo proposito, la risposta che egli dà alla domanda se una
società socialista possa essere una società liberale. Che il socialismo - egli dice - come sistema
di economia pianificata sia in netto contrasto con il l. economico, è evidente. "La libertà
economica non costituisce però - aggiunge Kelsen - il problema decisivo". Infatti "non è la
libertà economica bensì quella intellettuale - la libertà religiosa, scientifica e di stampa - che è
essenziale alla democrazia [liberale]". E affermare, come fanno alcuni, che se la libertà
economica è soppressa, la libertà intellettuale non può essere mantenuta, significa commettere,
secondo Kelsen, lo stesso errore dei marxisti, i quali affermano che la libertà economica
determina la propria sovrastruttura ideologica, cioè intellettuale, e specialmente giuridica e
politica. Insomma, dice Kelsen: "Spiegare il totalitarismo politico come conseguenza di uno
specifico sistema economico significa dare un'interpretazione economica della società" (Kelsen
1955-56; trad. it. 1981, pp. 353-54).
Libertà intellettuale e libertà economica. - Il rapporto fra l. e liberismo ha una lunga storia nella
letteratura suscitata dal pensiero liberale. Restano esemplari, a questo proposito, le posizioni
espresse in Italia negli anni Trenta e Quaranta da B. Croce e L. Einaudi.
Croce aveva affermato nella Storia d'Europa nel secolo decimonono (1932) che se il
comunismo avesse avuto ragione nel ritenere che l'ordinamento capitalistico ha come effetto di
danneggiare e scemare la produzione della ricchezza, il l. non avrebbe potuto "se non approvare
e invocare per suo conto" l'abolizione della proprietà privata. Dopotutto, avvertiva Croce, "il
contrasto ideale del comunismo col liberalismo, il contrasto religioso, consiste in altro", ovvero
"nell'opposizione tra spiritualismo e materialismo, nell'intrinseco carattere materialistico del
comunismo, nel suo far Dio della carne o della materia" (v. Croce, Einaudi 1957, p. 43). Al che
Einaudi obiettava che un l. il quale accettasse l'abolizione della proprietà privata e
l'instaurazione del comunismo in ragione di una sua ipotetica maggiore produttività di beni
materiali, non sarebbe più l., e che l'essenza di quest'ultimo, che è la libertà spirituale, non può
sopravvivere là dove la società civile è interamente dominata e plasmata dallo Stato (p. 128).
In realtà, la concezione crociana e quella einaudiana del l. erano divise da un dissenso
fondamentale, che riguardava i presupposti del l. stesso. Poiché, mentre per Croce gli assetti
economico-sociali avevano scarsa o punta importanza per il trionfo dell'idea liberale, la quale
poteva quindi manifestarsi nelle situazioni più diverse, per Einaudi, invece, quegli assetti non
potevano essere trascurati, a meno che non si volesse proiettare il l. in una sfera tanto elevata da
essere completamente avulsa dai concreti rapporti fra gli uomini.
È significativa, in questo senso, la posizione che Croce espresse nella recensione al libro di H.J.
Laski, Le origini del liberalismo europeo (1936). Qui il filosofo italiano scriveva che "l'idea
liberale può avere un legame contingente e transitorio, ma non ha nessun legame necessario e
perpetuo con la proprietà privata delle terre e delle industrie", e che "essa si oppone
primamente e direttamente all'oppressione e falsificazione della vita morale, da qualunque parte
si eserciti, da assolutisti e da democratici, da capitalisti o da proletari, da czar o da bolscevichi,
e sotto qualunque funzione mitica, sia quella della razza ariana, sia l'altra della falce e
martello". Il promovimento della libertà, continuava Croce, è l'unico criterio con cui l'idea
liberale misura istituti politici e ordinamenti economici, in rapporto alle varie situazioni
storiche, a volta a volta accettandoli o respingendoli, secondo che quegli istituti serbino o
perdano efficacia per il suo fine. Del resto, precisava il filosofo, "l'ideale liberale ha natura
religiosa", e solo muovendo dalla libertà come esigenza morale è dato interpretare la storia
nella quale questa esigenza si è affermata e ha creato di volta in volta le proprie istituzioni,
secondo quel che di volta in volta è stato possibile nelle varie epoche: "come monarchie feudali
e come repubbliche comunali, come monarchie assolute e come monarchie costituzionali, e via
dicendo, e anche come vario ordinamento della proprietà nell'economia a schiavi, a servi e a
salariati, nella massima del lasciar fare e lasciar passare, e nell'altra, diversa, dell'intervento
statale, e via" (v. Croce, Einaudi 1957, pp. 134-35). A Einaudi ripugnava fortemente il carattere
metastorico che Croce attribuiva alla libertà, e non gli sembrava accettabile la tesi "che la
libertà possa affermarsi qualunque sia l'ordinamento economico, ed anche nell'economia a
schiavi e a servi". In realtà, egli ribatteva, "l'idea liberale trionfa e si perfeziona non con l'uso
dello strumento della schiavitù, bensì col negarlo e con lo sforzarsi di spezzarlo e di sostituirlo
con altro più congruo" (p. 136).
Per Einaudi, dunque, il rapporto fra l. e ordinamenti economici non era affatto estrinseco e
contingente, bensì profondo e organico. In particolare, a Einaudi sembrava che nel mondo
contemporaneo due sistemi economici, diversissimi fra loro nei presupposti ma assai simili nei
risultati, negassero in eguale misura la libertà umana: il comunismo e il capitalismo
monopolistico. Tali sistemi, diceva Einaudi, "tendono, per la indole loro propria, a ridurre gli
uomini a meri strumenti, anelli minimi di una ferrea catena che lavora e produce [...] a
imprimere uno stampo uniforme su tutti gli uomini, a farli svegliare, muovere, entrare in certi
luoghi di lavoro, che si direbbero di pena, alla stessa ora, a compiere i medesimi atti". Ma se
questo era vero, "perché affermare che la libertà morale può prosperare in qualunque
ordinamento economico? Se la filosofia indaga la realtà, perché chiudere gli occhi al fatto che
in certi ordinamenti economici la libertà è l'appannaggio di pochissimi eroi o ribelli?" (p. 144).
Ma la discussione sul rapporto fra l. e ordinamenti socio-economici, se ha avuto in Italia, con la
discussione fra Croce ed Einaudi, uno dei suoi momenti più alti e significativi, non si è svolta
soltanto in Italia. Infatti, la critica del liberismo ha avuto largo corso anche fra i pensatori
liberali nell'ambito della cultura anglosassone. Così, per J. Dewey, il l. non poteva superare la
gravissima crisi che aveva colpito il mondo capitalistico nel 1929 e negli anni successivi, se
non compiendo un enorme salto qualitativo: abbandonare ogni mentalità liberistica e costruirsi
strumenti ideali e politici di tutt'altro tipo. "Le credenze e i metodi del primo liberalismo diceva Dewey - si sono rivelati inefficaci ad affrontare i problemi dell'organizzazione e
dell'integrazione sociale; e la loro insufficienza è responsabile in larga misura della credenza
ora diffusa che qualsiasi liberalismo è dottrina fuori moda". Oggi, egli aggiungeva, limitarsi ad
attribuire allo Stato il compito di garantire l'ordine fra gli individui e di assicurare riparazioni a
una persona la cui libertà sia stata danneggiata da un'altra persona, equivale di fatto a
giustificare la brutalità e l'iniquità dell'ordine esistente. Il "nuovo liberalismo" auspicato da
Dewey mirava a realizzare un'organizzazione sociale che mettesse sotto controllo l'industria e
la finanza, affinché esse servissero alla liberazione economica e culturale degli uomini. La
causa del l., diceva Dewey, sarebbe stata perduta per molto tempo se esso non si fosse
preparato a socializzare le forze produttive, a instaurare un'economia socializzata (Dewey
1935; trad. it. 1946, pp. 33-34).
La risposta più efficace a Dewey, e alle posizioni simili alle sue (che avevano largo corso
nell'ambito delle correnti liberalsocialiste), è venuta da F.A. von Hayek, per il quale la libertà
spirituale e culturale (libertà di pensiero, di parola e di stampa) e la libertà socio-economica
(libertà di azione) sono inscindibili. A illuminare questo nesso Hayek ha dedicato una delle sue
opere più importanti, The constitution of liberty (1960).
La maggior parte degli studiosi e degli scienziati, dice Hayek, sa bene che noi non possiamo
progettare il progresso delle conoscenze, che nel viaggio nell'ignoto - com'è appunto la ricerca noi dipendiamo in larga misura dal capriccio del genio individuale e degli avvenimenti, e che il
progresso scientifico è il risultato di una combinazione tanto di concetti quanto di abitudini e di
circostanze prodotte dalla società, il risultato tanto di casi fortuiti quanto di uno sforzo
sistematico. E poiché siamo consapevoli del fatto che i nostri progressi nella sfera intellettuale
nascono spesso dall'imprevedibile e dal caso, siamo portati a sopravvalutare in questo campo
l'importanza della libertà e a sottovalutarla nell'ambito dell'azione.
"Ma - sottolinea Hayek - la libertà di ricerca e di opinione e la libertà di parola e di discussione,
la cui importanza è universalmente riconosciuta, sono importanti solo nell'ultimo stadio del
processo in cui vengono scoperte nuove verità. Esaltare il valore della libertà intellettuale a
detrimento della libertà di agire equivarrebbe a considerare il cornicione da solo come se fosse
tutto l'edificio. Abbiamo idee nuove da discutere e visuali diverse da adattare l'una all'altra,
perché quelle idee e quelle visuali nascono dagli sforzi fatti in tutte le nuove circostanze dagli
individui che nei loro compiti concreti usano i nuovi strumenti e le nuove forme d'azione che
hanno appreso" (Hayek 1960; trad. it. 1969, p. 54). Le svariate esperienze dalle quali sorgono
le differenze di opinione - dal cui confronto ha origine il progresso intellettuale - sono il
risultato delle diverse scelte d'azione compiute da persone diverse in circostanze diverse. Solo
là dove è possibile sperimentare un gran numero di modi diversi di fare le cose si otterrà una
varietà di esperienze e di conoscenze tale da consentire, attraverso la selezione ininterrotta delle
più efficaci fra queste, un miglioramento costante. D'altro canto, in una società moderna
fondata sulla divisione del lavoro e sul mercato, la maggior parte delle nuove forme d'azione
sorge nell'ambito economico. Di qui il nesso inscindibile fra l. politico e l. economico. I due l.
sono assolutamente inseparabili, e qualunque distinzione fra essi (sul tipo di quella teorizzata
da Croce fra 'liberalismo' e 'liberismo') deve, secondo Hayek, essere respinta.
Nel quadro tracciato da Hayek, la proprietà privata ha certo una grande importanza, al fine di
preservare quella sfera personale che ci protegge contro la coercizione (poiché raramente siamo
in grado di realizzare un piano d'azione coerente se non siamo sicuri del nostro esclusivo
dominio su certi oggetti materiali); e tuttavia essa non è l'elemento decisivo per assicurare
quella libertà e quella creatività personali che contraddistinguono una società libera. A questo
proposito Hayek afferma che nella società moderna il requisito essenziale per la libertà
dell'individuo non è tanto che egli possegga una proprietà, ma che i mezzi materiali, che gli
permettono di perseguire un piano d'azione autonomo e originale, non siano tutti sotto
l'esclusivo controllo di un altro. È una delle grandi realizzazioni della società libera - ha
sottolineato il pensatore austriaco - il fatto che possa godere della libertà una persona che
praticamente non ha niente di suo (eccetto le cose strettamente personali). Il punto decisivo,
insomma, è che il controllo delle risorse sia abbastanza diffuso, sicché l'individuo non dipenda
da particolari persone, uniche e sole in grado di fornirgli il necessario o di dargli lavoro, e possa
scegliere fra un'ampia gamma di possibilità. Di qui l'ispirazione antimonopolistica del l. di
Hayek e la sua difesa del frazionamento della ricchezza e della libera concorrenza.
Liberalismo ed eguaglianze. - Senonché, quando Hayek critica qualunque posizione di
monopolio, egli pensa non soltanto ai monopoli industriali, bensì anche ai privilegi che alcune
società democratiche concedono ai sindacati operai, i quali diventano istituzioni cui la legge
riconosce la facoltà di impiegare la coercizione in modi non consentiti a nessun altro. Questa
posizione dei sindacati operai ha reso largamente inoperante il meccanismo del mercato in fatto
di determinazione dei salari; ma è più che dubbio, secondo Hayek, che un'economia di mercato
possa continuare a sussistere quando la determinazione concorrenziale dei prezzi non vale
anche per i salari.
Hayek è favorevole a provvedimenti di sostegno agli indigenti, agli sfortunati, agli invalidi, agli
istituti sanitari ecc., e anzi afferma che "non c'è ragione perché con il generale aumento della
ricchezza, non aumenti anche il volume di queste attività di puri e semplici servizi"; è
decisamente contrario, invece, a qualunque organizzazione assistenzialistica della società che
sia basata su una ridistribuzione del reddito a favore di particolari ceti e gruppi sociali. A questo
proposito egli ritiene che sia necessaria un'importante distinzione tra due diversi modi di
concepire la sicurezza: nel senso che, egli dice, "c'è una limitata sicurezza che può essere
realizzata per tutti e che pertanto non è un privilegio, e una sicurezza assoluta che, in una
società libera, non può essere garantita a tutti. La prima è la sicurezza contro le privazioni
fisiche gravi, la certezza di un minimo di mezzi di sussistenza per tutti; la seconda è la certezza
di un dato livello di vita, che si determina mettendo a confronto il livello di vita di cui godono
gli uni con quello di cui godono gli altri. La distinzione da fare, quindi, è tra la sicurezza di un
reddito minimo uguale per tutti e la sicurezza di un particolare reddito che si ritiene che una
persona dovrebbe avere" (Hayek 1960; trad. it. 1969, pp. 292-94).
Il presupposto di tutto il discorso di Hayek è che il l. deve preoccuparsi della giustizia
commutativa, ma non della giustizia distributiva, ovvero della giustizia sociale (che è invece la
preoccupazione del socialismo). Il motivo per cui l'ideale della giustizia distributiva dev'essere
rifiutato dai liberali coerenti è, secondo Hayek, duplice: per un verso non esistono principi
generali di giustizia distributiva universalmente riconosciuti e accettati, né è possibile dedurli
razionalmente; per un altro verso, anche se fosse possibile raggiungere un accordo su principi
del genere, essi non potrebbero trovare applicazione in una società in cui gli individui siano
liberi di impiegare le loro cognizioni e le loro capacità per il conseguimento di fini privati. "Per
garantire specifici vantaggi ai privati quale compenso dei loro meriti (comunque essi siano
valutati) sarebbe necessario infatti un tipo di ordine sociale completamente differente da
quell'ordine che prenderebbe spontaneamente corpo qualora gli individui fossero vincolati solo
dalle norme generali della condotta lecita: un ordine (meglio sarebbe dire un'organizzazione) in
cui gli individui fossero posti al servizio di una comune e unitaria gerarchia di fini, e dove si
chiedesse loro di fare ciò che è necessario nella prospettiva di un programma autoritario"
(Hayek 1978, p. 990). Ma si tratterebbe, com'è ovvio, di un ordine o di un'organizzazione
illiberale per definizione.
Per Hayek il l. esige dunque soltanto che lo Stato, nel determinare le condizioni entro le quali
gli individui agiscono, fissi le medesime norme formali per tutti. Perciò esso si oppone a ogni
privilegio sancito per legge, a qualsiasi iniziativa governativa che conceda vantaggi speciali ad
alcuni senza offrirli a tutti. Ne discende che la società liberale non può essere una società
egualitaria, poiché, essendo gli individui molto differenti tra loro sia per conoscenze e capacità
personali che per il particolare ambiente sociale in cui si trovano a vivere, un trattamento
eguale all'interno delle medesime leggi generali produrrà necessariamente posizioni
differentissime per le diverse persone. "In altre parole, il liberalismo si limita a domandare che
la procedura, ovvero le regole del gioco da cui vengono determinate le posizioni relative dei
diversi individui, sia equa (o perlomeno non iniqua), ma non che siano equi anche i risultati
particolari che deriveranno da questo processo per i singoli individui, poiché questi risultati
dipenderanno sempre, in una società di uomini liberi, oltre che dalle azioni degli individui
medesimi, da numerose altre circostanze che nessuno è in grado di determinare né di prevedere
nella loro totalità" (Hayek 1978, p. 990). Eventuali correttivi di questo meccanismo devono
essere assai circoscritti, e quindi tali da non inceppare il meccanismo stesso. Sicché, se si può
pensare di attuare, con fondi pubblici, un sistema educativo universale che ponga tutti i giovani
indistintamente ai piedi di quella scala che in seguito ognuno potrà salire a seconda delle
proprie capacità, non si può pensare, invece, di manipolare profondamente l'ambiente sociale in
cui i singoli individui operano, poiché ciò sarebbe incompatibile con l'idea liberale di libertà.
Ciò significa, però, che la cosiddetta eguaglianza delle opportunità incontra dei limiti precisi e
invalicabili, dovuti alle inevitabili differenze degli ambienti di appartenenza dei singoli.
Su questi problemi, impostati da Hayek con grande rigore e lucidità, si è svolto negli ultimi
decenni, e continua a svolgersi, un intenso dibattito nel pensiero etico-politico di ispirazione
liberale, con esiti e soluzioni, però, radicalmente diversi tra loro. Così J. Rawls, in A theory of
justice (1971), ha espresso preoccupazioni di giustizia sociale, ed è partito nella sua riflessione
da due principi: il primo di ispirazione liberale ("ciascun individuo possiede un eguale diritto a
una libertà di base la più estesa possibile, compatibile con altrettanta libertà per gli altri"), il
secondo ispirato da ideali di giustizia distributiva ("le disuguaglianze sociali ed economiche
debbono essere strutturate in modo tale da essere: a) volte al vantaggio dei meno favoriti, e b)
connesse a posizioni e cariche accessibili a tutti in condizioni di equa eguaglianza di
opportunità"). R. Nozick, invece, ha teorizzato lo "Stato minimo", e, interessato soltanto alla
giustizia commutativa, fondata sui contratti fra privati (la cui tutela è l'unico compito dello
Stato), ha criticato aspramente qualunque forma di giustizia distributiva, fino ad affermare che
"la tassazione dei guadagni di lavoro è sullo stesso piano del lavoro forzato" (Nozick 1974). Le
posizioni di Rawls e di Nozick incarnano due ispirazioni radicalmente differenti (Nozick è
convinto che una società è tanto più ricca e più libera quanto più è ridotto il ruolo dello Stato),
e attestano una profonda lacerazione nel pensiero liberale degli ultimi decenni del nostro
secolo.
Dalla società liberale alla società liberal-democratica
I problemi visti finora (il rapporto fra giustizia commutativa e giustizia distributiva, l'intervento
dello Stato nella sfera economico-sociale, lo Stato-provvidenza o Stato del benessere ecc.),
problemi che sono al centro del pensiero liberale degli ultimi decenni, ci fanno intendere
meglio la complessità dei rapporti che intercorrono fra l. e democrazia. Già G. De Ruggiero
aveva osservato, nella sua Storia del liberalismo europeo (1925), che tali rapporti sono,
insieme, di continuità e di antitesi. Sono rapporti di continuità, perché i principi sui quali si
fonda la concezione democratica sono la logica esplicazione delle premesse ideali del l.
moderno. Tali principi si possono compendiare infatti in queste due formule: estensione dei
diritti individuali a tutti i membri della società, e diritto del popolo a governarsi da sé. Non
appena il l. ripudia il concetto della libertà come privilegio o monopolio tradizionale di pochi,
per assumere quello di una libertà come diritto comune, almeno potenzialmente, a tutti, esso è
già sulla stessa strada della democrazia. Sotto questo profilo una rigida divisione di ambiti tra l.
e democrazia non è più possibile, e il loro territorio è comune. Tant'è vero che l'estensione
democratica dei principi liberali - che si è realizzata con la concessione dei diritti politici a tutti
i cittadini e con l'immissione degli strati più bassi della società nello Stato - ha potuto
effettuarsi senza modificare sostanzialmente la struttura politica e giuridica delle istituzioni
liberali, confermando così l'unità dei principi.
Ma sarebbe erroneo, diceva De Ruggiero, trarre da ciò la conseguenza di un'identificazione
completa e senza residui fra l. e democrazia. In realtà, c'è una diversità profonda di mentalità
politica fra i due concetti, una diversità che dà luogo a seri e durevoli conflitti. Innanzitutto vi è
nella democrazia una forte accentuazione dell'elemento collettivo, sociale, della vita politica, a
spese di quello individuale. Del resto, è tutto il processo economico-sociale moderno che ha
spinto e spinge in questa direzione. Il sorgere della grande industria, il suo organizzarsi in
cartelli e in trust, la nascita dei grandi sindacati e dei grandi partiti di massa: tutti questi
elementi, che sono fondamentali e costitutivi della società moderna, non possono non limitare e
rimpicciolire sempre più il ruolo dell'individuo, dell'iniziativa individuale, della cooperazione
spontanea delle energie individuali. Di qui la grigia uniformità e il conformismo che
caratterizzano sempre più le grandi società democratiche di massa; i fenomeni di
burocratizzazione sempre più estesa che investono la società a tutti i livelli (la macchina statale
e le sue articolazioni, le grandi organizzazioni economiche, sindacali e politiche); il diffondersi
nelle grandi masse di una mentalità assistenziale, per cui tutti hanno diritto a tutto,
indipendentemente dallo sforzo e dal merito individuali, sicché lo Stato viene concepito come il
supremo elargitore, che deve garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze, senza tener alcun
conto degli apporti dei singoli.
L'ispirazione dell'analisi di De Ruggiero per quanto riguarda i rapporti fra l. e democrazia è
stata ampiamente confermata dal pensiero liberale successivo. Tipica, in questo senso, è la
posizione di Hayek. L'eguaglianza di fronte alla legge (che è l'unica eguaglianza riconosciuta e
rivendicata dal l.) - egli dice - implica l'esigenza che anche nel fare le leggi tutti gli uomini
abbiano una parte uguale. Questo è il punto d'incontro fra l. e movimento democratico. Ma la
coincidenza finisce qui, perché diversi sono gli obiettivi di l. e democrazia. Il l., infatti, si
preoccupa soprattutto di limitare i poteri coercitivi dello Stato, siano essi o no democratici,
mentre il democratico intransigente conosce un unico limite ai pubblici poteri: l'opinione della
maggioranza. Ancora: dal punto di vista del liberale è bene che solo quanto è accettato dalla
maggioranza diventi legge, ma non è da credere che questa circostanza la renda una buona
legge. Infatti il liberale cerca sempre di persuadere la maggioranza a osservare taluni principi
(liberali), e accetta il principio del governo della maggioranza solo come un metodo di
decisione, non come un criterio assoluto per stabilire quale contenuto la decisione debba avere;
al democratico dottrinario, invece, il solo fatto che la maggioranza voglia qualcosa basta per
considerare buono ciò che essa vuole: per lui la volontà della maggioranza determina non solo
cos'è la legge, ma altresì cos'è una buona legge.
La democrazia per Hayek è essenziale dunque come metodo, non come fine. Rifacendosi a
Tocqueville, egli sottolinea infatti che la democrazia è l'unico strumento efficace per educare la
maggioranza, in quanto la democrazia è soprattutto un processo di formazione dell'opinione
pubblica. Il suo maggior vantaggio sta quindi non nella sua immediata capacità di scelta dei
governanti, ma nel far partecipare attivamente alla formazione dell'opinione pubblica la
maggior parte della popolazione, e quindi nel permettere la scelta fra una vasta gamma di
individui. Ma, una volta accolta la democrazia all'interno del l., Hayek non si stanca di ripetere
che il modo in cui il liberale concepisce il funzionamento della democrazia è del tutto
peculiare. L'idea, infatti, che il governo debba essere guidato dall'opinione della maggioranza
ha senso solo se quell'opinione è realmente indipendente dal governo stesso, poiché l'ideale
liberale di democrazia è basato sul convincimento che l'indirizzo politico che sarà seguito dal
governo debba emergere da un processo spontaneo e non manipolato. L'ideale liberale di
democrazia presuppone, quindi, l'esistenza di vaste sfere indipendenti dal controllo della
maggioranza, entro le quali si formano le opinioni individuali. Questa è la ragione, dice Hayek,
per cui la causa della democrazia e la causa della libertà di parola e di stampa sono inseparabili.
Da ciò discende che l'idea ultrademocratica che gli sforzi di tutti debbano essere guidati
incondizionatamente dall'opinione della maggioranza o che la società sia tanto migliore quanto
più si conforma ai principi comunemente accettati dalla maggioranza, è un vero e proprio
capovolgimento del principio attraverso il quale si è sviluppata la civiltà (Hayek 1978, p. 990).
bibliografia H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1920, 1929² (trad. it.
in H. Kelsen, La democrazia, Bologna 1981, pp. 35-144). G. De Ruggiero, Storia del
liberalismo europeo, Bari 1925. B. Croce, Storia d'Europa nel secolo decimonono, Bari 1932. J.
Dewey, Liberalism and social action, New York 1935 (trad. it. Firenze 1946). H.J. Laski, The
rise of European liberalism. An essay in interpretation, London 1936 (trad. it. Firenze 1962). H.
Kelsen, General theory of law and state, Cambridge (Mass.) 1945 (trad. it. Milano 1952). K.R.
Popper, The open society and its enemies, 2 voll., London 1945 (trad. it. Roma 1973-74). H.
Kelsen, Foundations of democracy, in Ethics, 1955-56, 1/ii (trad. it. in H. Kelsen, La
democrazia, Bologna 1981, pp. 181-382). B. Croce, L. Einaudi, Liberismo e liberalismo, a cura
di P. Solari, Milano-Napoli 1957. K.R. Popper, The poverty of historicism, Boston 1957 (trad.
it. Milano 1975). F.A. von Hayek, The constitution of liberty, Chicago 1960 (trad. it. La società
libera, Firenze 1969).
Revolution oder Reform? Herbert Marcuse und Karl Popper: Eine Konfrontation, hrsg. F.
Stark, München 1971 (trad. it. Roma 1977). J. Rawls, A theory of justice, Cambridge (Mass.)
1971 (trad. it. Milano 1982). R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, New York 1974 (trad. it.
Firenze 1981). F.A. von Hayek, Liberalismo, in Enciclopedia del Novecento, 3° vol., Istituto
della Enciclopedia Italiana, Roma 1978, ad vocem.
Socialismo
Maurizio Degl'Innocenti
1. Il termine e il problema delle origini
Anche se sarebbe più corretto parlare di 'socialismi' (più che di 'socialismo') per la varietà e
l'evoluzione, nel XIX e nel XX secolo, delle dottrine e delle pratiche riassumibili sotto quel
concetto, in generale si può definire il socialismo come un progetto e movimento di riforma
della società nella libertà che, finalizzato all'estensione dei diritti di uguaglianza politici e
sociali, pone al centro di una pratica solidaristica l'etica del lavoro e della persona umana e
privilegia finalità e comportamenti collettivi contro l'esasperato utilitarismo individuale o di
gruppo proprio del mercato capitalistico.Le origini del socialismo sono state cercate perfino
nell'antichità classica, suggerendo che l'idea della comunità fraterna sia stata elaborata sul
modello dei concetti di 'eunomia', o fruizione egualitaria dei beni, e 'isonomia', o uguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge. È stato pertanto rappresentato come protosocialista lo stesso
Platone, per le sue formulazioni di un generico comunismo integrale all'indomani della guerra
del Peloponneso. A maggior ragione furono rintracciati prodromi di socialismo in talune
prospettive di rigenerazione collettiva presenti nel confucianesimo, nel taoismo, nell'islamismo,
e soprattutto nel cristianesimo delle origini, prima che diventasse la religione ufficiale del Sacro
Romano Impero.
Anche se è controversa l'attribuzione al cristianesimo degli aspetti egualitari del pensiero greco,
è un fatto che l'immagine del 'Gesù socialista' ebbe larga fortuna, in particolare tra Ottocento e
Novecento. E ancora, furono colte anticipazioni del socialismo nell'invocazione dell'avvento
del regno di Dio attraverso la trasformazione dell'ordine sociale e soprattutto nei movimenti
millenaristici, per lo più a sfondo rurale, che con la crisi del sistema feudale si formarono in
Inghilterra, in Boemia e in Westfalia, fino al movimento dei diggers e dei livellatori nel XVII
secolo. L'idea della città ideale, fondata su un comunismo di ispirazione umanitaria ma ancor
più religiosa, trovò espressione nel XVI e nel XVII secolo nelle utopie di Tommaso Moro e di
Tommaso Campanella, e nel secolo successivo nelle teorie di Gabriel Bonnot de Mably, di
Morelly e dell'abate Jean Meslier. Nella seconda metà del XVIII secolo l'idea di uguaglianza
sociale si secolarizzò con la proclamazione dei diritti dell'uomo in nome della ragione, della
quale il socialismo fu presentato come l'evoluzione più logica sul piano sociale ed economico.
Cosicché la congiura degli Eguali di Babeuf del 1796 - descritta in un saggio fortunato da
Filippo Buonarroti nel 1828 - fu assunta come inizio autentico del 'programma comunista' della
soppressione della proprietà privata e della comunione dei beni e del lavoro. Babeuf impersonò
la figura del cospiratore rivoluzionario capace di guidare la massa con l'esempio e con la
propaganda verso la società nuova, inaugurando una concezione dell'élite rivoluzionaria che
avrebbe avuto seguaci in Blanqui, nell'ala più radicale del cartismo inglese, in alcuni
protagonisti della Comune di Parigi e perfino in Lenin. D'altra parte, nelle istanze libertarie ed
egualitarie della Rivoluzione francese così come nel tessuto associativo e sindacale inglese
furono ricercate le basi del socialismo democratico inteso come movimento di riforma nella
libertà, anche in riferimento ai valori della civiltà europea.
In termini cronologici, invece, le origini del socialismo vanno collocate tra gli anni venti e
trenta dell'Ottocento, vale a dire quando le parole 'socialista' e 'socialismo' passarono dal
linguaggio teologico o giuridico, in relazione all'origine contrattualistica o socialis dello Stato o
alla socialitas umana, al linguaggio politico e poi, dal decennio successivo, al vocabolario
comune per indicare una dottrina, un movimento, un comune sentire rivolti alla costruzione di
una nuova organizzazione societaria o comunitaria del lavoro e, più in generale, della vita
collettiva, in contrapposizione al disordine competitivo, all'individualismo egoistico, alla
diseguaglianza sociale e allo sfruttamento del lavoratore attribuiti al "vecchio mondo
immorale" (Owen) e/o al sistema capitalistico. Contemporaneamente prendeva corpo l'auto- o
etero-rappresentazione del movimento, con la proiezione e l'interpretazione delle origini dettate
dai mutevoli indirizzi culturali e dalle circostanze pratiche: l'esegesi dei 'profeti' e degli
anticipatori va dunque collocata solo in questo capitolo.
2. L'idea societaria e il movimento operaio
Il paese della prima rivoluzione industriale e della liberalizzazione del mercato del lavoro fu
anche quello di incubazione del socialismo, termine con il quale vennero indicati gli
esperimenti pratici e le teorie di Robert Owen (1771-1858) - un capitano d'industria di New
Lanark in Scozia - e dei suoi seguaci, per lo più in simbiosi con il concetto di associazione e in
alternativa a quello di individualismo. I presupposti si ravvisano già, alla fine del Settecento,
nelle denunce degli effetti negativi dell'industrializzazione da parte di riformatori agrari e
sociali come William Ogilvie e Thomas Spence, e soprattutto Thomas Paine; e non meno nelle
istanze propugnate da William Godwin a favore di un associazionismo fondato sui legami di
parentela e sul vicinato in opposizione all'autoritarismo dello Stato. Owen, che derivò da
Godwin (e soprattutto da Helvétius) la teoria dell'influenza dell'ambiente sul carattere umano,
propagandò in A new view of society, or essays on the principle of the formation of human
character, 1813, e in New moral world, 1835-1844, un "sistema di cooperazione generale" o
"nuovo mondo morale" laico e solidale, fondato sul trinomio "verità, lavoro e scienza".
Teorizzò così la creazione di villaggi comunitari, composti in media da 500-2000 persone,
finanziati dalle parrocchie e dalle contee con la tassa sui poveri, da capitalisti filantropi o dalle
stesse associazioni operaie; in tali villaggi il lavoro sarebbe stato remunerato in base
all'assunto, ricavato dall'economia classica, che "l'unità di misura naturale del valore è, in linea
di principio, il lavoro umano". Dopo un primo esperimento filantropico a New Lanark Owen ne
promosse un altro nel 1825 nell'Indiana, negli Stati Uniti, con la comunità di New Harmony,
che ebbe però risultati deludenti. Tornato in Inghilterra nel 1829, si pose alla testa del
movimento sindacale tentando l'integrazione della società cooperativa di consumo con la trade
union, il cui sviluppo fu favorito dalle leggi del 1824-1825 sulle associazioni operaie. Ma
l'iniziativa più ambiziosa di Owen, la Grand National Consolidated Trade Union, ebbe vita
effimera e fu disciolta nel 1834.
Negli anni venti e trenta l'owenismo ebbe comunque larga diffusione anche a seguito di
un'efficace propaganda (realizzata con una media annua di due milioni e mezzo di opuscoli tra
il 1839 e il 1841) e lasciò tracce così profonde da far individuare in esso le origini delle
attitudini pragmatiche e moderate del movimento operaio inglese.Con Owen condivisero la
teoria economica classica del valore i cosiddetti 'socialisti ricardiani', che ebbero un'influenza
rilevante sullo stesso Marx. Tra essi Thomas Hodgskin sostenne in Labour defended against the
claims of capital (1825) che in regime capitalistico la salvezza per i lavoratori era
nell'organizzazione autonoma di resistenza, la sola capace di mettere in crisi la legge del
'prezzo naturale del lavoro' che lo eguagliava alla pura sussistenza. Si accostarono al
movimento cooperativo e sindacale di ispirazione oweniana John Gray e William Thompson,
che fu il primo a usare il termine 'plusvalore' (An inquiry into the principles of the distribution
of wealth, 1824; Labour rewarded, 1827).La mancata concessione del voto ai lavoratori nel
1832, il malcontento suscitato dalla legge sui poveri del 1834 che negava il sussidio agli abili, e
infine la campagna per la riforma delle fabbriche promossa nei distretti industriali furono
all'origine, tra il 1836 e il 1848, del cartismo, la più vasta agitazione di ceti operai e popolari
che abbia interessato l'Inghilterra (e l'Europa) nel XIX secolo.
Attraverso la petizione popolare esso si propose di ottenere una 'Carta del popolo', tra i cui
punti più qualificanti era il suffragio universale maschile. Il cartismo non manifestò caratteri
autenticamente socialisti anche se tra i promotori, per lo più appartenenti allo strato superiore
dei lavoratori qualificati e autodidatti come i tipografi e i sarti, vi furono oweniani come
William Lovett e Henry Hetherington. Tuttavia esso favorì la presa di coscienza di classe del
movimento operaio inglese inaugurandone le grandi agitazioni di massa, e diventò un punto di
riferimento essenziale nella tradizione democratica del socialismo europeo. Fallita una prima
agitazione nel 1838-1839, il movimento conobbe una ripresa negli anni quaranta (il 'decennio
della fame'), con un rinnovato gruppo dirigente nel quale risultarono più influenti socialisti e
fautori della 'violenza fisica' (in alternativa alla sola 'violenza morale') come James Bronterre
O'Brien, Julian Harney e l'irlandese Feargus O'Connor. Dopo il rigetto delle petizioni del 1842
e del 1848 i gruppi cartisti residui assunsero connotati più apertamente socialisti. O'Brien
pubblicò la prima parte di The rise, progress and phases of human slavery (1849), in cui tracciò
un parallelo tra la schiavitù antica di tipo patrimoniale e quella moderna di tipo salariale,
prospettando nella rivoluzione, violenta o pacifica, il solo mezzo per ottenere la libertà
dell'uomo. Qualche rilievo ebbe la riorganizzata National Charter Association, la cui direzione
passò da O'Connor a Ernest Jones e a Harney, con orientamento più marcatamente
internazionalista.
Nel 1850 Harney si adoperò perché i membri della Society of Fraternal Democrats, creata nel
1846, si associassero al gruppo dei blanquisti e di Karl Marx, di cui tradusse il Manifesto sul
"Red republican", per costituire la Lega universale dei comunisti rivoluzionari, con le parole
d'ordine "dittatura del proletariato", "rivoluzione permanente", "comunismo" come "forma
finale di organizzazione della società umana". Negli anni cinquanta però Jones ebbe maggiore
forza all'interno del sindacato e successivamente di un movimento di pressione che contribuì
alla riforma elettorale del 1867. Tra l'altro egli rilanciò la tesi della nazionalizzazione della
terra, già prospettata nel piano agrario cartista dopo il 1842, per collocarvi la manodopera
urbana disoccupata ("colonie in patria").
In opposizione alle agitazioni per le 'le carte del popolo' del 1848, sorse il movimento del
socialismo cristiano per iniziativa di esponenti della Chiesa d'Inghilterra come Frederick
Denison Maurice e Charles Kingsley, e dell'avvocato John Malcolm Forbes Ludlow, che aveva
seguito in Francia le iniziative di Blanc e Buchez. L'intento dei socialisti cristiani era quello di
unire fraternamente lavoratori e ceti abbienti mediante l'organizzazione della produzione.
Organo del movimento fu "Politics for the people" (1848), poi "The Christian socialist" (18501851), e infine "The journal of association" (1852). Mentre Ludlow fondò piccole associazioni
operaie di produzione, di ispirazione cristiana, Thomas Hughes si dedicò al movimento
sindacale e Edward Vansittart Neale al movimento cooperativo laico, dirigendo a lungo la
segreteria della Cooperative Union, nell'obiettivo comune di creare un movimento associativo
di tipo nuovo che coinvolgesse, attraverso il sindacato e la cooperazione, produttori e
consumatori.
La maggior parte delle cooperative locali e di produzione fallì, e il cointeressamento del
sindacato non fu soddisfacente, tanto che il gruppo di Ludlow e Maurice rinunciò al
cooperativismo per dedicarsi alla politica sanitaria e alla istruzione operaia fondando nel 1854
il Working men's college a Londra. Neale continuò invece il suo impegno nella cooperazione di
consumo, nella quale era destinata al successo, a Manchester, la North of England cooperative
whole sale society, poi organismo commerciale centrale per tutto il paese.Insieme all'Inghilterra
fu la Francia l'altro 'paese del socialismo', favorito dal precedente della grande rivoluzione che
aveva scosso il principio stesso di proprietà e posto la democrazia politica come condizione di
quella sociale. Furono chiamati per primi 'socialisti' i seguaci di Claude-Henri Saint-Simon
(17601825), di origine nobile ma caduto in rovina economicamente. A lui Émile Durkheim ha
attribuito addirittura la qualifica di 'padre del socialismo', nonché del positivismo, ma già
Mazzini aveva definito il saintsimonismo "la più avanzata manifestazione dello spirito di novità
che ha soffiato nel nostro secolo" ed Engels gli aveva riconosciuto un ruolo importante nella
diffusione e nella sistemazione delle idee del socialismo non strettamente economico.
In saggi come L'organisateur (1819-1820), Du système industriel (1821-1822), Catéchisme des
industriels (1823), Saint-Simon sostenne che sarebbe stata la scienza, più che la politica, a
risolvere il problema sociale lasciato aperto dalla Rivoluzione francese. E applicando al mondo
morale il principio di attrazione universale teorizzato da Newton nella fisica, attribuì
all'industrializzazione, se opportunamente coordinata, il passaggio pacifico dall'età organica dei
"secoli cristiani" all'età "positiva". Al dominio degli oisifs, cioè dei ceti parassitari
(aristocratici, militari e redditieri), si sarebbe così sostituito quello dei savants e degli
industriels o produttori, cioè dei possessori delle conoscenze scientifiche nonché degli
imprenditori e degli operai, impegnati insieme a conseguire lo sviluppo nell'ordine e nell'unità
armonica della società, a beneficio fisico e morale della "classe la plus nombreuse et la plus
pauvre". Ne sarebbe conseguito un "nuovo cristianesimo", non più basato sui dogmi teologici,
bensì sulla verità scientifica (Nouveau christianisme, 1825).
Tali principî furono ripresi, specialmente tra il 1830 e il 1832, dagli eredi più diretti di SaintSimon come Olinde Rodrigues, Prosper Enfantin e Saint-Amand Bazard. Essi rappresentarono
la storia dell'umanità come l'evoluzione dall'antagonismo di forze contrapposte e dallo
sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo (schiavo-padrone nell'età antica, servo-signore
nell'età medievale, operaio-padrone nell'età borghese) all'associazione, nella quale tale
sfruttamento sarebbe stato eliminato. In quest'ultima fase i mezzi di produzione sarebbero stati
socializzati con l'abolizione dell'eredità, mentre ai privati sarebbe rimasta la proprietà dei beni
di consumo. La socializzazione dei mezzi di produzione non si sarebbe confusa con la
comunione dei beni, perché ciascuno avrebbe avuto secondo le capacità e le opere
(disuguaglianza nella ripartizione). Una discussa evoluzione di tali teorie in senso tecnocratico
e misticheggiante si ebbe nel pensiero di Enfantin, mentre nei discepoli della seconda
generazione - come il tipografo autodidatta e laico Pierre Leroux - si manifestò un più spiccato
interesse per le organizzazioni autonome di lavoratori. L'eredità del sansimonismo correlò il
socialismo in Francia (e in Belgio) al positivismo, alleato della Scienza e del Progresso. Ma
esso ebbe rilevanza anche nella promozione di un ceto imprenditoriale nel settore mobiliare e
delle grandi infrastrutture negli anni del Secondo Impero.
Per la sua fiducia nell'industrialismo Saint-Simon apparve come l'anticipatore della teoria della
società industriale e della occupational community, elaborata poi da Durkheim, o, addirittura,
dell'economia pianificata.L'altro rappresentante della 'grande utopia' socialista nel periodo della
Restaurazione fu Charles Fourier (1772-1837), proveniente da una famiglia di commercianti.
Nei saggi Théorie des quatre mouvements (1808), Traité de l'association domestique et agricole
(1822), Le nouveau monde industriel et sociétaire (1829) e La fausse industrie (1835-1836),
Fourier teorizzò quattro stadi della storia umana (selvaggio, patriarcale, barbarico e della
civiltà); nella successione dalla condizione razionale e 'passionale' (lavoro e amore) alla
civilisation ("il mondo alla rovescia") le istituzioni avrebbero allontanato le passioni e il
matrimonio soffocato l'amore, mentre la coercizione sociale e l'organizzazione del lavoro
avrebbero reso quest'ultimo noioso, incerto e alienante e l'"anarchia commerciale" avrebbe
impedito al salariato di partecipare ai benefici dello sviluppo. Alla civilisation Fourier
contrappose la società di Armonia, articolata in piccole comunità, autosufficienti e pertanto
sottratte alla competizione, organizzate in falansteri, grandi edifici sociali costruiti per la vita
collettiva, dove il lavoro sarebbe stato svolto alternativamente da gruppi divisi per età e genere,
e retribuito in relazione al rendimento, al talento e al capitale.
La nuova società pertanto sarebbe risultata dalla giustapposizione di comunità autosufficienti e
autonome, dedite prevalentemente all'agricoltura, alla trasformazione dei prodotti della terra e
alla produzione dei beni di consumo. Per il suo rifiuto dell'industrialismo fu attribuita a Fourier
una visione arcaica, ma la sua critica radicale del sistema capitalistico fu anche valutata con
favore. In tempi più recenti sono state riconsiderate positivamente la sua denuncia degli aspetti
repressivi della civiltà, l'apertura alla vita istintuale - quasi un'anticipazione della pedagogia
moderna e perfino della cultura ecologica - nonché la progettualità degli insediamenti,
prefigurazione della moderna urbanistica. La scuola societaria o fourieriana degli anni trenta e
quaranta ebbe solo in apparenza un'influenza minore di quella sansimoniana. Vantò fortunati
divulgatori come Victor Considérant e conobbe un successo duraturo nella cooperazione,
specialmente di produzione, con Michel Derrion, Philippe Buchez e Jean-Baptiste Godin.
Assai più eclettico fu il comunismo comunitario di Étienne Cabet (1788-1856), nato da una
famiglia di artigiani, pubblicista e redattore del giornale "Le populaire", esule a Londra dopo il
1834. Nel noto saggio Voyage en Icarie (1842), ispirato all'Utopia di Tommaso Moro adattata a
un ambiente industriale, si pronunciò per l'abolizione della proprietà privata e per il lavoro
obbligatorio in grandi aziende pubbliche meccanizzate, coniando lo slogan fortunato: "Tutti
hanno il dovere di lavorare lo stesso numero di ore al giorno, secondo i propri mezzi, e il diritto
di ricevere una parte uguale di tutti i prodotti, secondo i propri bisogni".
Negli anni quaranta in Francia (dove Cabet era tornato nel 1841) 'comunismo' era in qualche
modo assimilato a cabetismo o a icarianesimo, anche nell'ultima versione ispirata a una sorta di
cristianesimo primitivo (Mon crédo communiste, 1845; Le vrai christianisme suivant JésusChrist, 1846).La questione della centralità del 'diritto al lavoro' nella società moderna fu
sollevata soprattutto da Louis Blanc (1811-1882), autore di L'organisation du travail (1839,
1848¹⁰). Critico nei confronti delle ipotesi comunitarie, egli attribuì allo Stato, reso "amico del
popolo" con il suffragio universale, il coordinamento di un sistema di aziende pubbliche: gli
ateliers sociaux, autonomi nella gestione, finanziati da un prestito statale gratuito, e resi più
competitivi delle imprese private, con il cointeressamento operaio alla produzione. Nella
rivoluzione del 1848 Blanc assunse una posizione di rilievo, diventando presidente della
Commissione del Lussemburgo, ma gli ateliers nationaux, simili alle fabbriche di carità, non
ebbero fortuna. Il fallimento di tale indirizzo determinò un sostanziale allontanamento dei
lavoratori dall'idea repubblicana; lo stesso Blanc fu esule in Inghilterra e quando tornò in
Francia assunse una posizione defilata, tanto da non aderire alla Comune.
E tuttavia nella storia del socialismo (grazie anche all'influenza cartista) egli, pur non essendo
stato un dottrinario, fu considerato come il primo teorico dell'interventismo statale e per la sua
visione graduale e pacifica della via al socialismo fu ritenuto perfino l'anticipatore della
socialdemocrazia.Agli antipodi della corrente 'statalista' o 'governativa' rappresentata da Blanc
si trova l''anarchismo positivo' di Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Egli riteneva il mondo
fondato su principî universali di contraddizione o antagonismo, e di interazione o reciprocità, la
cui espressione più compiuta era da individuarsi nella famiglia e, sul piano produttivo, nel
libero scambio delle merci regolato dai valori creati dal lavoro, secondo la teorizzazione dei
socialisti ricardiani e di Owen. In una serie di saggi - dal celebre Qu'est-ce que la proprieté?
(1840) dove definì la proprietà un furto, a Système des contraddictions économiques, ou
philosophie de la misère (1846), De la justice dans la révolution et dans l'Église (1858), De la
capacité politique des classes ouvrières (1865) - teorizzò un'organizzazione dal basso,
autogestita sul piano economico e amministrativo da individui, gruppi e comuni organizzati su
basi federative, ma con il sostegno di una banca popolare, nella quale le retribuzioni fossero
proporzionali al successo personale o alla composizione della famiglia. Rifiutando la proprietà
pubblica dei mezzi di produzione, compresa la terra, Proudhon delineò una società a carattere
artigiano e contadino (dal cui ambiente egli stesso proveniva), basata sui piccoli produttori e
sulla conservazione della famiglia patriarcale, in cui la donna avesse un ruolo subordinato.
E tuttavia egli e i suoi seguaci non solo ebbero largo successo in Francia negli anni cinquanta e
sessanta, ma rimasero i referenti più accreditati di tutte quelle correnti del movimento socialista
che si richiamarono all'antiautoritarismo, al mutualismo e al federalismo; in questo ambito
Proudhon fu considerato uno dei padri del movimento anarchico o anarco-sindacalista. La
polemica stessa in cui lo impegnarono Marx ed Engels contribuì a rafforzare tale opinione.Al di
fuori dell'Inghilterra e della Francia, cioè dei paesi delle rivoluzioni borghesi (industriale e
politica), gli sviluppi del socialismo furono più tardivi e stentati. In Germania, il socialismo si
diffuse inizialmente solo in ambito culturale e tra gli esuli politici. Così, dalla metà degli anni
quaranta prese corpo il movimento del 'vero' socialismo, o socialismo tedesco, come corrente
filosofica della sinistra hegeliana, i cui esponenti più noti furono Karl Grun e Moses Hess,
mentre nel 1834 era stata fondata a Parigi una Lega dei proscritti (Bund der Geatchen), di
tendenza democratico-repubblicana, trasformatasi nel 1836 in Lega dei giusti e infine, nel 1847
a Londra, in quella Lega dei comunisti che commissionò a Marx nel 1847 la redazione del
Manifesto, uscito nel febbraio dell'anno successivo. Influenzati dalla sinistra hegeliana e dalla
frequentazione degli esuli, a contatto con la classe operaia inglese ma in una prospettiva
internazionalista, Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) enunciarono una
concezione materialistica della storia vista come il succedersi di fasi segnate dall'antagonismo
di due classi in base ai rapporti di produzione. L'esasperazione delle antinomie, in ultimo tra
borghesia e proletariato, avrebbe infine prodotto una rivoluzione dalla quale, per la prima volta
nella storia dell'umanità, sarebbe scaturita una società senza classi, in cui "il libero sviluppo di
ciascuno fosse la condizione per il libero sviluppo di tutti".
Pur prevedendo in tempi brevi la socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio, Marx si
astenne dal fornire un quadro esaustivo dello stadio finale, ammettendo tuttavia la necessità di
misure giuridiche ed economiche corrispondenti alla "costituzione del proletariato in classe
dominante", e si limitò a definire "socialista" la fase di transizione al comunismo; nel 1852
introdusse la nozione di "dittatura del proletariato" poi precisata dopo la Comune. Ai comunisti
assegnò la funzione di 'avanguardia' dei partiti operai nella lotta contro la borghesia dove
questa fosse dominante, e in alleanza con essa, contro l'aristocrazia, nei paesi meno sviluppati.
Il Manifesto fu nell'immediato privo di influenza pratica, ma la ebbe enorme in seguito (fu
definito "il vangelo del socialismo moderno"), come parte qualificante di un corpus di scritti fra cui il primo volume del Kapital, tirato in mille copie nel 1867 esaurite solo nel 1871 (il
secondo e il terzo volume furono editi a cura di Engels nel 1885 e nel 1894; il quarto a cura di
Karl Kautsky nel 1895) - che era destinato a incidere profondamente sul movimento socialista,
a partire dagli anni ottanta e per oltre un secolo. Marx definì "scientifico" il suo socialismo per
differenziarlo da quello, precedente al Manifesto, che chiamò "utopico" ritenendo quest'ultimo
indirizzato alla ricerca di rimedi sociali "al di fuori del movimento operaio" e prescindendo
dalla questione del potere, nel presupposto che di volta in volta la scienza, l'atto di volontà o
addirittura il comportamento onesto e filantropico potessero dar vita a nuovi sistemi sociali più
o meno fantasiosi.
L'affermazione successiva del marxismo all'interno del movimento operaio contribuì a
consolidare questa immagine negativa del socialismo precedente al Manifesto, fino a inglobarvi
le posizioni di Blanc e perfino di Proudhon. La periodizzazione e le categorie interpretative di
Marx divennero poi di uso comune. Né cambiò la sostanza il fatto che in sede storiografica si
tentasse una correzione parziale di tale valenza negativa introducendo la categoria di
'protosocialismo', che si voleva calato nella realtà del proprio tempo, limitando invece la
qualifica di 'utopismo' alle teorie e alle pratiche cooperativistiche-associative che tendevano
alla progressiva giustapposizione di realizzazioni molecolari, per riscrivere dal basso l'intera
teoria delle relazioni sociali; oppure ancora distinguendo tra gli utopisti per eccellenza, o
'grandi utopisti', cioè i capiscuola come Saint-Simon, Owen, Fourier, Cabet, e i discepoli, più
solleciti alle sperimentazioni. In realtà, i socialisti cosiddetti utopici del XIX secolo dovrebbero
essere piuttosto considerati dei riformatori sociali che, al di là dei progetti ambiziosi e dei
tentativi falliti, non mancarono di lasciare tracce profonde nella cultura e nella realtà politica,
associativa, mutualistica, sindacale e cooperativa del tempo, spesso con risultati duraturi. Gli
stessi Marx ed Engels non possono essere considerati fuori da questo contesto.Nel trentennio
successivo al 1848, col favore di una fase economica propizia e, fino al 1873, del rialzo dei
prezzi, si registrò una forte spinta all'organizzazione sindacale (la 'prassi operaia') mediante la
quale furono erette le prime difese contro lo sfruttamento generalizzato della manodopera e
conseguiti i primi elementi di una legislazione sociale nonché, sia pure tra forti ostacoli, la
garanzia del diritto di coalizione (in Inghilterra fu rilevante al riguardo l'esito positivo dello
sciopero degli edili londinesi nel 1859). Il movimento dei lavoratori diventò un nuovo soggetto,
riconosciuto.
La testimonianza più significativa fu la costituzione della Associazione Internazionale dei
Lavoratori (o Prima Internazionale) il 28 settembre 1864 alla St. Martin Hall di Londra, dopo
gli incontri promossi dai sindacati inglesi e dalle società operaie francesi in occasione
dell'Esposizione internazionale di Londra nel 1862. Negli statuti e soprattutto nel preambolo
(Indirizzo alla classe operaia), a cui dette un contributo decisivo Marx, si affermò che
l'emancipazione della classe operaia doveva essere opera della classe stessa, a cominciare dalla
liberazione dalla soggezione economica, fonte di ogni servitù. Tuttavia, pur nel condiviso clima
di solidarietà internazionale, vi si palesarono subito prospettive assai diverse: i sindacati inglesi
ricercavano garanzie contro il crumiraggio, mentre le società francesi mettevano in primo piano
il mutualismo e il sistema del credito gratuito, e quelle belghe il libero pensiero. I primi
congressi (Ginevra, 1866; Losanna, 1867) furono dominati dalla delegazione francese, nella
quale era forte l'influenza dei proudhoniani contrari alla pratica dello sciopero. La sconfitta del
proudhonismo (congresso di Bruxelles, 1868) coincise con la piena legittimazione della lotta di
resistenza e soprattutto con la svolta a favore della collettivizzazione, per la quale risultò
decisivo l'appoggio del belga César de Paepe (1842-1890).
Al successivo congresso di Basilea (1869) fu riaffermato il duplice obiettivo della
collettivizzazione della terra e della promozione delle 'società di resistenza nei vari corpi di
mestiere'. Intanto una nuova e più agguerrita opposizione al marxismo veniva da parte dei
seguaci dell'esule russo Michail Bakunin (1814-1876), che negarono al Consiglio generale di
Londra la prerogativa di imporre disciplina e politica alle sezioni nazionali e locali, per le quali
reclamarono invece la piena autonomia. Il contrasto tra Bakunin e Marx fu dirompente e aprì
tra socialisti (e poi comunisti) e anarchici una divaricazione che non si sarebbe più ricomposta.
Il primo predicò l'abolizione dell'ereditarietà dei beni, laddove il secondo puntò sulla
soppressione della proprietà privata in quanto tale; l'uno concepì i partiti operai come fattori di
burocratizzazione e di subordinazione allo Stato per il tramite della legislazione sociale, l'altro
li considerò essenziali nella via al socialismo. Ma il dissenso fondamentale fu su due punti
ulteriori: il primo era rappresentato dal problema dello Stato, che i seguaci di Bakunin volevano
distruggere in tutte le sue forme (come del resto la religione, per l'autoritarismo dogmatico),
non escludendo neppure il ricorso al terrorismo, laddove nella strategia marxista la conquista
del potere, per via rivoluzionaria o democratica, rimase obiettivo centrale; il secondo punto
riguardava l'individuazione dei soggetti rivoluzionari, in quanto gli anarchici coinvolgevano
anche gli strati più emarginati della società, come i contadini poveri, gli artigiani in rovina e gli
studenti, mentre i socialisti puntavano sugli operai, specialmente di fabbrica, come classe
generale.
La tradizione bakuniana o anarchica o libertaria trovò consensi più diffusi in Spagna, in Italia,
nella Svizzera francese, nel Belgio vallone, ma non sarebbe corretto vedere in ciò l'aspetto
qualificante di un presunto socialismo mediterraneo.Il problema dello Stato si pose in maniera
tanto chiara quanto drammatica nel marzo 1871 con la Comune di Parigi, una sollevazione
popolare più o meno spontanea, dettata anche da motivi patriottici - forse l'ultima 'giornata'
nella tradizione rivoluzionaria del 1789 - alla quale parteciparono ceti operai, artigiani e
piccolo-borghesi. L'Internazionale vi fu estranea e manifestò la sua solidarietà solo a eventi
accaduti. Bakunin fu sollecito a cogliervi "la negazione audace e netta dello Stato" e, per
l'"azione spontanea delle masse", "l'istinto socialista". Marx la interpretò come il primo
esperimento di "governo della classe operaia", ma ne ricavò anche l'ammonimento a non
spezzare l'unità della nazione, "potente fattore della produzione sociale". Nonostante la brevità
dell'esperienza (settantadue giorni) e la modestia delle realizzazioni socialiste, la Comune (con
la precedente sconfitta francese a Sedan) ebbe conseguenze notevoli in Europa e in seno
all'Internazionale stessa, anche se è eccessivo affermare che rappresentò la discriminante tra 'il
socialismo di ieri' e quello 'di oggi'. Essa accelerò la spinta tradeunionistica dei sindacati inglesi
e contribuì a trasferire il centro di gravità del movimento socialista dalla Francia alla Germania.
Nell'immediato, il fallimento della Comune esasperò i contrasti tra i seguaci di Marx e di
Bakunin, e se il primo riuscì a far espellere il secondo al congresso dell'Aja del 1872, fu
tuttavia costretto a spostare la sede dell'Internazionale a New York decretandone così la fine
(1876). Pur nella brevità e nelle vivaci polemiche che ne caratterizzarono la vita,
l'Internazionale fornì un'importante esperienza di impegno intorno a una concezione di lotta più
definita e omogenea, contribuendo a radicare l'identità collettiva, tanto che tutte le successive
analoghe iniziative ne rivendicarono la continuità.
3. Il partito nazionale dei lavoratori e l'integrazione politica
A partire dalla fine del XIX secolo le vicende del socialismo furono contrassegnate
dall'affermazione e dalla vitalità di due soggetti apparentemente distanti o addirittura
antagonistici, ma in realtà connessi: la classe operaia e la nazione. L'interesse della Seconda
Internazionale, costituita nel 1889 da partiti nazionali per o della classe operaia, si volgeva a
entrambi.La costituzione del partito operaio e/o socialista, sollecitata dall'allargamento del
suffragio e dall'insorgente società di massa, rifletteva innanzitutto la grande frattura sociale tra
manodopera e capitale, tra ceti subalterni e leaderships tradizionali e/o borghesi, in una fase di
rafforzamento dello Stato-nazione, di integrazione del mercato e di un più marcato ruolo dello
Stato nell'economia e nella società. Per certi versi essa si poneva come punto d'approdo
dell'evoluzione del proletariato dalla condizione di 'rango inferiore', di 'plebe', di 'gente comune'
o di 'ceto lavoratore operaio' a quella di 'classe lavoratrice', il che aveva posto in primo piano il
rapporto tra coscienza e organizzazione, quest'ultima intesa anche come completamento della
personalità del singolo. Il partito, insieme al sindacato (generale e centrale), fu così la risposta
al nuovo tipo di conflittualità sociale determinatosi alla fine del secolo, che reclamava da un
lato modalità più complesse e 'aperte', e comunque più organizzate - la pratica diffusa dello
sciopero, il richiamo alle otto ore lavorative reso ricco di suggestioni dalla festa del primo
maggio, il rivendicato controllo del collocamento, la più generale definizione del contenzioso, a
cominciare dal contratto collettivo (in Inghilterra dal 1890) -, mentre dall'altro richiedeva
iniziative più decisamente orientate al compromesso sociale (legislazione sociale, uffici del
lavoro, istruzione).
L'affermazione e l'articolazione concreta del partito, dunque, dipesero dal congiunto rapporto
con i centri propulsivi del sistema capitalistico e con la democratizzazione di quello politico. La
perifericità rispetto ad essi facilitò l'affermazione del partito-avanguardia presentatosi come tale
per la classe, per di più intesa come classe generale, guida all'istruzione e al reclutamento, ma
ancor più alla rivoluzione; in determinate condizioni ciò sollecitò la subordinazione dello Stato
al partito e, successivamente, la sua trasformazione in regime. Viceversa, la vicinanza
determinò l'evoluzione del partito socialista in un partito elettorale di massa, che si definì nella
mobilitazione e nell'inquadramento di vasti strati popolari ai margini o al di fuori della
cittadinanza politica tradizionale, assumendo da allora un ruolo importante nell'evoluzione dei
sistemi democratico-rappresentativi e in ogni caso svolgendo un'accentuata funzione di
socializzazione politica nella propaganda di nuovi fini collettivi. A tale scopo il partito si
indirizzò all'interno verso la creazione di un vasto apparato - in buona parte finanziato dalle
quote sociali e articolato in sezioni particolari nonché in comitati o uffici a struttura gerarchicopiramidale - e all'esterno verso l'interrelazione con istituzioni o associazioni di sostegno e
collaterali.
Nella tipologia del 'grande partito', classista ma aperto alla confluenza di ceti piccolo- e medioborghesi, che rimase la più emblematica del socialismo europeo, alla proiezione elettorale si
sovrapposero l'attitudine educativa, che esaltava la funzione importante della dottrina nel
radicamento dell'obbligazione politica, ma anche l'attività di sostegno a strutture di solidarietà e
a organismi vari di partecipazione. Come luogo dell'aggregazione e della mediazione di nuovi
interessi sociali, o della canalizzazione delle tensioni e dunque dell'istituzionalizzazione della
'nuova' conflittualità, esso finì per ricoprire un ruolo essenziale ai fini della
stabilizzazione/destabilizzazione del sistema politico-istituzionale, delineando nel complesso,
ma non in modo lineare e senza soluzioni di continuità, un'evoluzione da 'associazione' e
'movimento' a 'istituzione', da 'forma' esterna ed extraparlamentare a funzione centrale del
sistema politico rappresentativo di massa, da istituto a fondamento classista a partito dello
sviluppo sociale. Infine, facendo riferimento specifico alla fase di insediamento, decisiva per il
codice genetico di un partito, occorre sottolineare che il partito 'secondo internazionalista'
rappresentò il superamento definitivo del settarismo cospirativo e del corporativismo e del
regionalismo 'primo internazionalista' assumendo, nella separazione dagli anarchici e poi dai
sindacalisti rivoluzionari, il metodo democratico come mezzo per la piena espressione del
movimento operaio, e ne collocò la prospettiva in una dimensione politica nazionale, portando
con ciò la lotta a ridosso dello Stato per la conquista e la gestione del potere. Inoltre,
identificando nella classe operaia la protagonista consapevole della propria emancipazione,
autonoma e distinta dalle altre forze politiche, il partito socialista postulava anche un
collegamento - e in taluni casi una vera e propria divisione dei compiti - con il sindacato, centro
di organizzazione dei lavoratori intorno alla difesa di interessi corporativi.
La Seconda Internazionale nacque appunto con questa duplice anima: politica (e democratica) e
corporativo-operaia. E tale duplice registro fu adottato da tutti i partiti operai o
socialdemocratici che si costituirono nel giro di una quindicina d'anni, adattandosi alle
tradizioni e agli ambienti, con il criterio dell'adesione ora collettiva, ora individuale. Nei partiti
della Seconda Internazionale fu rituale la professione di marxismo in vista della socializzazione
dei mezzi di produzione e di scambio, ma furono ugualmente importanti la pratica riformista e
la partecipazione alla lotta parlamentare e al governo delle amministrazioni locali, tanto che i
consensi elettorali furono presi a misura del successo politico. Dopo la fine delle ipotesi
catastrofiche di fine secolo e i successi elettorali e sindacali dovuti a una congiuntura
favorevole, l'alba del nuovo secolo sembrò quella dell''epoca socialdemocratica'. Sulla spinta
dell'industrializzazione e dei progressi scientifici, dell'urbanesimo e della diffusione
dell'istruzione, il vecchio mondo aristocratico e individualista parve destinato a crollare di
fronte ai crescenti successi del socialismo il cui edificio, come si teorizzò al congresso
dell'Internazionale a Stoccarda nel 1907, poggiava saldamente su tre pilastri: il partito, il
sindacato e il movimento associativo e cooperativo.Il primo partito nazionale fu fondato in
Germania, dove il mondo del lavoro si andò organizzando intorno all'Arbeitsverein con
obiettivi tradeunionistici e culturali.
Proprio rivendicando l'autonomia dei lavoratori dalle formazioni politiche borghesi, nel
presupposto che a essi spettasse il rinnovamento etico e sociale di uno Stato hegelianamente
inteso come pernio della vita pubblica, fu creato nel 1863 a Lipsia da Ferdinand Lassalle
(1825-1864) l'Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV). Lassalle considerò la borghesia
un'unica massa reazionaria e, richiamandosi alla 'legge ferrea dei salari', giudicò inutili gli
scioperi per proporre piuttosto la creazione di cooperative di produzione che competessero
efficacemente sul mercato con le imprese capitalistiche, così da assicurare in modo pacifico e
legale il passaggio a un nuovo ordine sociale conforme a giustizia, con la garanzia di uno Stato
conquistato politicamente con il suffragio universale e diretto. Grande comunicatore, egli
diventò assai popolare tra i lavoratori tedeschi, con forme di culto personale, finché non venne
ucciso in duello nel gennaio 1864. Gli succedette alla presidenza del partito l'avvocato Johann
Baptist von Schweitzer, direttore di "Der Sozial-Demokrat", il quale pur nella confermata
fedeltà allo Stato prussiano fu più sensibile all'azione sindacale. In contrapposizione ai
lassalliani nel 1869 fu fondata a Eisenach la Sozialdemokratische Arbeiter Partei (SDAP), che
si richiamò all'Internazionale affermando la simultaneità dell'azione politica con quella
sindacale. Ne furono promotori il tornitore autodidatta August Bebel (1840-1913), futuro autore
del celebre Die Frau und der Sozialismus (1883), che ebbe una cinquantina di edizioni, e il
pubblicista emigrato Wilhelm Liebknecht (1826-1900), i quali dalle iniziali posizioni
antiprussiane per la creazione della 'grande' Germania democratica in alleanza con le forze
borghesi, si erano gradualmente avvicinati a Marx, anche per la frequentazione delle sezioni
tedesche dell'Internazionale fondate da Philipp Becker. Nel 1875 i due partiti si fusero al
congresso di Gotha, con un programma che fu criticato da Marx per le concessioni fatte ai
lassalliani sui concetti della 'fratellanza dei popoli', della 'legge ferrea' dei salari, della
borghesia come unica massa reazionaria, della cooperazione di produzione.
Le critiche di Marx non ebbero influenza pratica (l'ebbero semmai nello sviluppo successivo
del pensiero leninista). L'organizzazione del partito, finalmente democratico e sociale, ne uscì
consolidata, tanto che nelle elezioni del 1877 conseguì il 9% dei voti, mentre le iniziative a
favore della cultura operaia e la stessa unità sindacale risultarono fortemente stimolate. Dal
1878 il partito subì la legislazione antisocialista voluta da Bismarck, che ne proibì giornali,
sedi, congressi, ma ne ammise la partecipazione alle elezioni, cosicché rimase in piedi una
struttura per fiduciari. In ogni caso restò più che mai attivo il movimento sindacale: l'imponente
sciopero dei minatori da esso organizzato nel 1889 contribuì a far abrogare la legislazione di
emergenza (1890). Alle successive elezioni i socialdemocratici ottennero un milione e
quattrocentomila voti (oltre il 20%) acquistando un'autorità indiscussa in tutto il movimento
socialista internazionale. Grande influenza ebbe anche la rivista teorica "Neue Zeit" diretta dal
1883 al 1917 da Karl Kautsky (1854-1938), al quale fu attribuito, con la paternità delle
categorie 'marxisti' e 'marxismo', un ruolo fondamentale nell'assunzione del pensiero di Marx a
'dottrina ufficiale del partito', anche e soprattutto ai fini della egemonia politica e ideologica
nelle lotte interne.
Il concetto stesso di 'socialdemocrazia', nato nel senso della tradizione del 1848, acquisì
definitivamente la duplice valenza classista e 'democratico-sociale', cioè di 'completo dominio
del popolo', contro lo sfruttamento e contro il privilegio, per l'eguaglianza e per la libertà. Il
programma del partito approvato al congresso di Erfurt del 1891, preparato da Kautsky con il
consenso di Engels, indicò gli obiettivi della socializzazione dei mezzi di produzione e di
scambio, dell'utilizzazione di ogni strumento di lotta legale e in particolare di quella
parlamentare per l'emancipazione dei lavoratori, del sostegno alla lotta di resistenza sindacale.
Ne uscì delineato così un partito di classe e di massa. Il programma di Erfurt diventò un punto
di riferimento essenziale per tutti i partiti della Seconda Internazionale, di cui la
socialdemocrazia tedesca fu l'asse portante: come disse Engels, essa "appariva come la massa
più numerosa, più compatta, la forza d'urto decisiva dell'esercito proletario internazionale". In
effetti, nel 1912-1913 il sindacato, diretto da Karl Legien, vantò due milioni e mezzo di iscritti;
nelle elezioni del Reichstag del 1912 la SPD ottenne oltre quattro milioni di voti (34,8% del
totale) e 110 seggi; i membri del partito, fondato sulle sezioni territoriali e finanziato dalle
quote individuali, raggiunsero un milione.
Ma nel sistema politico-istituzionale imperiale tale forza restò politicamente 'isolata' o
'separata', cosicché, al fine di superare tale isolamento in connessione al tramonto delle ipotesi
catastrofiche, già a cavallo del secolo non mancarono posizioni volte alla 'revisione' del
programma, che mettevano in discussione alcuni punti centrali del pensiero di Marx, in
particolare sulla proletarizzazione dei ceti medi e sulla concentrazione progressiva delle
ricchezze, sullo Stato come strumento operativo nelle mani delle classi dirigenti e sulla
dittatura del proletariato. Se ne fecero interpreti Georg von Vollmar (1850-1922), favorevole al
'riformismo di Stato' e alla piccola proprietà contadina, e soprattutto Eduard Bernstein (18501932), nutrito di filosofia neokantiana e vicino alla scuola economica marginalista, che in Die
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (1899) propose di
trasformare la SPD in un "partito di riforme socialiste e democratiche" in quanto "erede del
liberalismo per il suo contenuto spirituale", confutando la tesi della proletarizzazione dei ceti
medi e della dittatura del proletariato ("il movimento è tutto"). Difesero l'ortodossia marxista
Bebel e Kautsky, autore di Die Agrarfrage (1899), Bernstein und sozialistische Programm
(1899), Die soziale Revolution (1902) e Der Weg zur Macht (1909).
Negli anni successivi, dopo la prima Rivoluzione russa del 1905 e soprattutto dal 1910,
emersero critiche alla 'ortodossia di centro' anche da sinistra, in particolare da Herman Goster,
Anton Pannekoek, Alexander L. Helfand detto Parvus, e soprattutto da Rosa Luxemburg (18701919) secondo la quale, nell'ipotesi di una crisi rivoluzionaria determinata dalle presunte
contraddizioni dell'età dell'imperialismo, occorreva piuttosto educare la classe operaia perché si
rendesse spontaneamente protagonista della rivoluzione di massa, evitando così anche il
pericolo dell'autoritarismo presente sia nel partito burocratico che nelle leaderships
professionali (come quelle, rivoluzionarie, teorizzate da Lenin nel Che fare? del 1902). La SPD
respinse ufficialmente il revisionismo al congresso di Dresda del 1903, ma la prassi sindacale e
di tipo parlamentare portò ugualmente a una crescente integrazione politica e sociale, sancita
dal voto favorevole ai crediti di guerra nell'agosto 1914. Per taluni però fu un'integrazione 'in
negativo' perché, al di là dei miglioramenti materiali per i lavoratori, non fu tale da superare le
condizioni politiche discriminatorie messe in atto dalle forze conservatrici dell'Impero,
cosicché la socialdemocrazia avrebbe cercato e coltivato la sopravvivenza come 'corpo
separato' o 'Stato nello Stato', nel culto dell'organizzazione e nella vigilanza sull'ortodossia
dottrinaria. In ogni caso nell'evoluzione da partito 'della rivoluzione' a partito dello sviluppo e
'nazionale', la SPD riuscì a legarsi stabilmente alla classe operaia e a radicare nella società
l'immagine di una forza di progresso.
Sul modello tedesco di partito socialdemocratico di massa si riorganizzò la socialdemocrazia
austriaca, al congresso di Hainfeld del 1889, sotto la guida di Victor Adler (1852-1918).
Saldamente insediata nelle aree industriali, essa fu protagonista di lotte democratiche di massa,
come quella del 1905 per il suffragio universale, ottenuto infine nel 1907, e assunse posizioni
di grande originalità sul problema nazionale, fin dal congresso di Brünn del 1899, quando fu
posto l'obiettivo della trasformazione dell'Austria in "Stato democratico federale delle
nazionalità", con ampi riconoscimenti all'autonomia personale e culturale, su cui scrissero Karl
Renner (1870-1950) in Der Kampf der oesterreichischen Nationen um der Staat (1902) e Otto
Bauer (1882-1938) in Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie (1907).La questione
nazionale e con essa quella della democratizzazione dello Stato furono al centro anche della
storia del socialismo belga, diviso in fiammingo e vallone. Nel 1884 fu fondato il Parti Ouvrier
Belge (POB), in cui confluivano circoli, sindacati e cooperative. L'obiettivo politico più
rilevante fu la conquista del suffragio universale, per il quale il partito promosse grandi scioperi
nel 1886 e nel 1892. Con l'allargamento del suffragio il POB ottenne, nel 1894, 27 deputati, tra
i quali Édouard Anseele, in rappresentanza dell'area socialista fiamminga che ruotava intorno al
Vooruit di Gand (cooperativa di consumo), ed Émile Vandervelde (1866-1938), prolifico
divulgatore del socialismo positivista.
In Francia il movimento socialista si riprese molto tardi dalla sconfitta della Comune, senza più
recuperare tuttavia il ruolo propulsivo dei decenni precedenti. Comunque esso costituì pur
sempre un terreno di incubazione politica di notevole interesse, sollecitato dal tradizionale
rapporto con la Repubblica ad affrontare la questione decisiva delle alleanze con le forze
politiche 'affini', nonché per l'attenzione da sempre rivolta al fattore culturale ed educativo nei
processi di trasformazione della società di massa. Non ultimo, la Francia fu negli anni ottanta,
insieme al Belgio, l'area di diffusione dell''operaismo': per la prima ne furono simboli la bourse
du travail e il sindacato di mestiere, per l'altro la maison du peuple e la cooperativa di consumo.
Nel 1883 fu costituito da Paul Lafargue (1842-1911) e da Jules Guesde (1845-1922) il Parti
ouvrier con un'organizzazione centralizzata, largamente ispirata al marxismo. I 'possibilisti' di
Paul Brousse gli contrapposero un partito fondato su strutture locali e con l'obiettivo della
trasformazione graduale dello Stato in senso decentrato, in alleanza con la borghesia liberale.
Proprio i due gruppi, in concorrenza, assunsero l'iniziativa della costituzione della Seconda
Internazionale a Parigi nel 1889. Ma la 'litigiosità' interna continuò a indebolire fortemente il
movimento politico nei confronti di quello sindacale, che viceversa andò rafforzandosi fino alla
fondazione della Confédération Générale du Travail a Limoges nel 1895. Nel movimento
sindacale si affermò una corrente maggioritaria favorevole all'action directe, influenzata da
Fernand Pelloutier e poi da Hubert Lagardelle e da Georges Sorel (1847-1922), autore di
L'avenir socialiste des syndicats (1898) e Réflexions sur la violence (1908).
Il sindacalismo rivoluzionario e l'anarco-sindacalismo, che si diffusero nei paesi dell'Europa
meridionale, si contrapposero al cosiddetto marxismo della Seconda Internazionale (partito di
tipo socialdemocratico e lotta politico-parlamentare; centralizzazione dell'organizzazione
sindacale e legislazione sociale), privilegiando lo sciopero come strumento di educazione della
coscienza di classe e riservando allo sciopero generale la funzione di emancipare la classe
operaia fino all'atto decisivo dell'espropriazione, così da consentire ai lavoratori (i 'produttori')
di pervenire alla gestione delle imprese. La crisi boulangista e l'affaire Dreyfus fecero
precipitare i contrasti fra i gruppi socialisti in tema di alleanze con i repubblicani e i radicali.
Quando, nel giugno 1899, il socialista Alexandre Millerand entrò nel gabinetto borghese di
Waldeck-Rousseau per difendere le istituzioni repubblicane da un possibile colpo di Stato della
destra e per introdurre la scuola laica di Stato, si creò una divaricazione tra i 'guesdisti', contrari
a ogni collaborazione con la borghesia, e gli 'indipendenti' di Jean Jaurès (1859-1914), al
riguardo più possibilisti, divaricazione che rimase incolmabile fino al 1905, quando per i buoni
uffici dell'Internazionale le diverse componenti si unificarono nella Section Française de
l'Internationale Ouvrière (SFIO).Il problema sollevato dal caso Millerand, relativo all'appoggio
(ministerialismo) o addirittura alla partecipazione (ministeriabilismo) dei socialisti a governi a
maggioranza borghese, interessò tutti i partiti aderenti all'Internazionale, con modalità diverse
dettate nei vari paesi dalle effettive prospettive di trasformazione delle società borghesi liberali
in società democratico-parlamentari. Proprio sul sostegno o meno alla 'svolta liberale'
inaugurata da Giovanni Giolitti agli inizi del secolo, si verificò in Italia la prima irriducibile
frattura nel Partito Socialista che, sotto la guida di Filippo Turati (1857-1932), direttore della
"Critica sociale" dal 1891, era stato fondato a Genova nel 1892, con un programma ispirato a
quello di Erfurt.
Il contrasto, che si mantenne sotto diverse vesti fino all'avvento del fascismo, si verificò tra la
componente gradualista e riformista di Turati, Claudio Treves, Leonida Bissolati e poi dei
dirigenti della Confederazione Generale del Lavoro (CGdL), costituita nel 1906, e quella
intransigente e rivoluzionaria di Arturo Labriola e di Enrico Ferri, dalla quale poi si scissero i
sindacalisti rivoluzionari di Alceste De Ambris. Rispetto al socialismo delle aree
industrializzate e a tradizione liberale e a quello tipico delle aree rurali e a regime autocratico, il
socialismo italiano si collocò in una posizione mediana, con larga approssimazione più vicino a
quello francese dopo la Comune o a quello spagnolo per il ruolo sociale della Chiesa e
l'anticlericalismo, la frequente difformità di indirizzo tra sindacato e partito, il protagonismo
delle campagne e gli squilibri regionali, la permanenza di una vasta area sovversiva (in Spagna
gli anarchici ebbero basi di massa nonostante l'opposizione del Partito Socialista Obrero
Español, PSOE, fondato nel 1888 da Pablo Iglesias).Nell'Europa centrorientale e meridionale,
dove i processi di integrazione politica furono ancora più lenti, la penetrazione socialista
divenne significativa solo alla fine del XIX secolo, con un primo insediamento nei centri urbani
lungo i canali dell'emigrazione. Tipica figura di profugo socialista fu il bulgaro Christian G.
Rakovskij, che in Svizzera fu in contatto con Plechanov e in Germania con Liebknecht, e che al
congresso dell'Internazionale di Amsterdam del 1904 rappresentò la Serbia e in quello di
Stoccarda del 1907 la Romania. In Bulgaria fu costituito nel 1891 un partito nazionale, poi
Partito socialdemocratico bulgaro del lavoro (BRSPD), dal 1903 diviso tra i 'larghi', favorevoli
alla collaborazione con la borghesia, e gli 'stretti', ad essa contrari. In Serbia il partito fu
costituito nel 1903. In Polonia il Polska Parti Socjalistyczna, fondato da Jósef Pilsudski nel
1892, tenne il primo congresso a Varsavia nel 1894: pur nella professione di internazionalismo,
perseguì la realizzazione di uno Stato indipendente e democratico.
Le associazioni operaie di lingua jiddish si organizzarono invece nel 1887 in un Bund come
parte del movimento socialista russo.Anche in Russia il socialismo restò a lungo diffuso nella
cerchia di una piccola intelligencija, una minoranza rivoluzionaria ed elitaria che si opponeva
all'aristocrazia e alla Chiesa ortodossa. Dall'estero Aleksandr Herzen indicò una strada al
socialismo che, partendo dall' esperienza del mir, consentisse di superare o di evitare lo stadio
capitalistico. Pëtr Lavrov, fondatore a Parigi di "Vpered", la rivista teorica del populismo,
predicò la necessità di 'andare al popolo', cioè alle masse contadine, e assegnò un ruolo
determinante all'intellettuale rivoluzionario. Un tema che fu ripreso, in una prospettiva
insurrezionale e addirittura terroristica, da Bakunin, da Sergej G. Nečaev, da Pëtr N. Tkǎcev, e
poi, nella prospettiva bolscevica, anche da Lenin. Erede del populismo fu il Partito socialista
rivoluzionario costituito nel 1901. La diffusione del marxismo in Russia conobbe il filtro non
solo del pensiero populista, ma anche del Gruppo di liberazione del lavoro, fondato a Ginevra
nel 1883 da Georgij Plechanov (1857-1918), Pavel Aksel'rod e Vera Zasulič, che furono in
contatto con Marx ed Engels e con gli esponenti socialdemocratici tedeschi, anch'essi allora in
esilio in Svizzera. Dall'incontro tra gruppi di emigrati e settori della classe operaia di Mosca e
di San Pietroburgo, di Kiev e di Odessa, nacque a Minsk nel 1898 il Partito operaio
socialdemocratico russo, con un programma che recuperò la tradizione populista rivoluzionaria,
respingendone però i metodi terroristici, e attribuì al proletariato industriale il compito della
rivoluzione. Nel 1903 il partito si divise tra menscevichi (minoritari) e bolscevichi
(maggioritari).
I primi, con Plechanov e J. Cederbaum detto Martov (1873-1923), si professarono marxisti
'occidentalisti', cioè convinti che allo zarismo sarebbe dovuto succedere un regime
democratico-borghese prima di giungere al socialismo; i secondi, con Lenin, sostennero la tesi
del passaggio immediato dalla rivoluzione democratica alla dittatura del proletariato e dettero
vita a un partito di rivoluzionari di professione.Nelle aree più sviluppate o prive delle fratture
sociali e politiche tipiche dell'Europa centrorientale e meridionale, la penetrazione del
marxismo fu assai più stentata o praticamente assente. In Inghilterra, per esempio, dopo il
crollo del cartismo l'attività politico-partitica rimase a lungo modesta, specialmente se
confrontata con i vistosi successi della cooperazione e del sindacato, che nel 1868 fondò il
Trades Union Congress (TUC) e, dopo lo sciopero del 1889, ricevette ulteriore impulso dal
'nuovo unionismo', cioè dall'organizzazione di nuove fasce di lavoratori dei trasporti, del
carbone e dell'industria, semispecializzati e manovali (un milione e seicentomila iscritti nel
1892, che avrebbero raggiunto i quattro milioni e mezzo nel 1914). Il movimento operaio
inglese cercò piuttosto l'alleanza con i radicali e soprattutto con i liberali, per l'allargamento dei
diritti politici e per una più incisiva legislazione sociale e di tutela del lavoro, dando vita a
quella tattica lib-lab (liberal-labour) contro la quale con scarso successo si opposero la Social
Democratic Federation, fondata da H. Mayers Hyndman nel 1881, e la Socialist League,
promossa nel 1884 da William Morris (1834-1896), di ispirazione marxista. Influenza notevole
ebbe invece il gruppo di pressione, costituito tra gli altri da Sidney Webb e Beatrice Potter,
George Bernard Shaw, George Wells, raccolto nella Fabian Society (1884), che intese
promuovere un socialismo pragmatico e gradualista, come attestava la scelta della
denominazione stessa con il riferimento al generale romano Fabio Massimo il
Temporeggiatore.
Il volume Fabian essays in socialism, del 1889, circolò in due milioni di copie, preparando il
terreno culturale per i partiti non marxisti come l'Independent Labour Party di Keir Hardie
(1856-1915), fondato nel 1893, e poi, nel 1890, per il Labour Representation Committee, da cui
ebbe origine nel 1906 il Labour Party, che già nelle prime elezioni ottenne 26 seggi
parlamentari. Esso costituì il modello del partito a struttura indiretta, basata cioè sull'adesione
di gruppo, poi modificata dal riconoscimento di una quota politica individuale facoltativa per
gli aderenti alle Trade Unions (Trade Unions act, 1913) e in seguito, nel 1918, dall'esplicita
ammissione dell'iscrizione individuale.Nei Paesi Scandinavi le origini del movimento socialista
si legarono ai rapporti che emigranti, studenti e pubblicisti, come August Palm o Holtermann
Knudsen, stabilirono con la socialdemocrazia tedesca. Il movimento socialista ebbe una iniziale
diffusione nei centri urbani, innestandosi sulla tradizione corporativa artigiana, ma ben presto
allargò il consenso popolare agitando i grandi temi politico-istituzionali: le riforme elettorali in
Svezia, la riforma costituzionale in Danimarca (1916), la questione dell'indipendenza della
Norvegia nel 1905. Nel complesso, però, il movimento sindacale (e anche cooperativo)
mantenne una posizione predominante.
Ciò fu particolarmente evidente in Svezia dove il partito, fondato nel 1889 da Hjalmar
Brainting (1860-1925), condivise a lungo con il sindacato le strutture di base, ma anche gli
obiettivi politici di fondo: furono le Lands Organizationen a indire lo sciopero generale per il
suffragio universale nel 1902, e fu il partito, con i suoi 35 deputati nel 1905 e 73 nel 1914, a far
approvare dal Parlamento le assicurazioni contro la vecchiaia, le malattie e la disoccupazione,
facendo leva sulla recuperata capacità di mobilitazione sindacale dopo il grave insuccesso dello
sciopero generale dell'estate 1909 indetto in risposta a una serrata padronale. Il Partito
socialdemocratico o laburista diventò il più importante in Finlandia fin dal 1907, in Svezia dal
1914, in Danimarca dal 1924 e in Norvegia dal 1927. In Inghilterra e in quasi tutti i Paesi
Scandinavi i laburisti e i socialisti si fecero dunque sostenitori di un'evoluzione in senso sociale
del sistema liberaldemocratico, del resto assai più avanzato che altrove, presupponendo che lo
Stato, permeato con un'azione graduale e dal basso, o sottoposto a un'efficace pressione da
parte delle organizzazioni dei lavoratori, potesse assumere un ruolo 'amico' fondamentale. Nella
gerarchia che si stabilì allora in Europa tra sindacato e partito fu il primo a precedere il secondo
e a determinarne la natura organizzativa.Fuori dal Vecchio Continente, con la parziale
eccezione di alcuni dominions inglesi, il socialismo stentò a penetrare, per lo più tramite
l'emigrazione europea, e ancor più a radicarsi, anche limitatamente ai centri urbani e alle aree
minerarie (come in Cile).
In Giappone, nella seconda parte dell'era Meiji, si costituirono gruppi e partiti ('socialisti
orientali', 'conducenti di ricsciò', 'amici del popolo', 'semplici', 'per lo studio del socialismo'),
dalla vita breve e stentata, anche per le continue persecuzioni, dediti prevalentemente
all'istruzione e alla propaganda attraverso la stampa. Tuttavia la partecipazione del tipografo
Sen Katayama al congresso dell'Internazionale di Amsterdam del 1904 e ancor più la condanna
della guerra russo-giapponese da lui espressa insieme al russo Plechanov, conferirono al
movimento notorietà internazionale. Dall'America Latina ebbero una rappresentanza nei lavori
dell'Internazionale solo l'Uruguay e l'Argentina, dove nel 1894 era stato costituito un Partito
socialista da Alfredo Palacios e da Juan Baudista Justo. Il caso più significativo era comunque
rappresentato dagli Stati Uniti, che si apprestavano a diventare la massima potenza industriale e
'la terra promessa del capitalismo', senza avere neppure i pesanti condizionamenti dei vecchi
regimi di cui soffriva la società europea, e dunque erano apparentemente i destinatari dei più
ambiziosi progetti sociali, come del resto avevano inteso i primi profughi socialisti seguaci di
Fourier, Owen, Cabet e poi di Lassalle e Marx. Ma non si può certo dire che i risultati fossero
pari alle attese, nonostante gli iniziali modesti successi conseguiti con la costituzione di un
Socialist Labor Party nel 1877, che negli anni novanta trovò nuovo slancio sotto la guida di
Daniel De Leon (1852-1914); poi di una Social Democracy, nel 1897; e infine di un Socialist
Party of America nel 1901.
Né risultò decisivo ai fini dell'insediamento il fiancheggiamento di organizzazioni sindacali
come il Noble Order of Knights of Labor negli anni settanta e ottanta, o le Trades and Labor
negli anni novanta - dopo il vano tentativo di penetrazione nella più potente American
Federation of Labor di Samuel Gompers - o gli Industrial Workers of the World; e neppure lo
straordinario successo di opere come Progress and poverty (1879) del radicale Henry George e
di Looking backward (1888) di Edward Bellamy o l'attrazione esercitata su scrittori come Jack
London e Upton Sinclair. Nel momento della massima espansione, il 1912-1913, il Socialist
Party of America vantava meno di 120.000 iscritti e il suo candidato alle elezioni presidenziali,
Eugene Debbs, ottenne il 6% dei consensi. Il 'fallimento' del socialismo negli Stati Uniti fu
attribuito a molteplici fattori: il sistema politico istituzionale presidenziale bipartitico
imperniato sulle primarie e sulla rilevanza della 'macchina elettorale'; l'influenza dei
democratici dopo l'elezione alla presidenza di Thomas Woodrow Wilson (come più tardi negli
anni trenta di Franklin Delano Roosevelt); l'isolamento del movimento, chiuso nell'ambiente
dell'emigrazione; le caratteristiche della classe operaia formatasi per stratificazioni successive e
divisa per segmenti, e dunque non omogenea; e soprattutto la grande mobilità della società
americana che avrebbe impedito la stratificazione delle classi.
Tale insuccesso fu considerato la riprova della superiorità del capitalismo sul socialismo e
ancor più dei limiti del marxismo, specialmente nelle società complesse e aperte. Per contro,
l'accento posto sulla vocazione imperialistica degli Stati Uniti come valvola di sfogo della
conflittualità interna, e, quindi, come decisivo fattore di contenimento dell'area di diffusione del
socialismo, non sembrò avere uguale rilievo.Nell'età della Seconda Internazionale il socialismo
aveva acquisito le caratteristiche di movimento di massa: nel 1912 i partiti aderenti vantavano
3,4 milioni di iscritti (contro i 7,3 milioni di soci delle cooperative e i 10,8 milioni di
sindacalizzati) e circa 12 milioni di elettori, e disponevano di una rete di 200 grandi quotidiani.
Era tuttavia un movimento che sembrava presupporre uno sviluppo lineare della società e la
pace internazionale. La guerra mondiale ne segnò il collasso, dimostrandone l'incongruità
rispetto al compito che esso si era dato di difendere la pace in nome della solidarietà di classe,
ma al tempo stesso ne accelerò l'integrazione politica. Nel 1914, con pochi dissensi tra i quali
quello del Partito Socialista Italiano, i socialisti tedeschi, austriaci e francesi votarono i crediti
di guerra, con la motivazione di dover difendere il principio di nazionalità e di voler abbattere
gli uni l'autocrazia zarista, gli altri l'imperialismo e il militarismo tedesco.Tra le due guerre
l'area della democrazia e del socialismo arretrò di fronte all'espansione del fascismo e delle
politiche autoritarie in Italia, Germania, Austria e Spagna, nonché in Portogallo, Ungheria e
Romania.
In tali paesi socialismo e democrazia condivisero una identica sorte, si compenetrarono
ulteriormente, e tale identificazione costituì un'eredità importante per le leaderships costrette
all'emigrazione e per le generazioni successive. Ma il socialismo subì anche la sfida del
comunismo, dopo la rivoluzione bolscevica del 1917 e la creazione il 2 marzo 1919 della Terza
Internazionale, la quale nel giugno 1920 varò ventuno punti per l'ammissione, tra i quali il più
qualificante fu la creazione di un partito accentrato e disciplinato che combattesse in via
prioritaria le vecchie leaderships socialiste per affermare la sua superiore autorità. I comunisti
diventarono così i nemici implacabili dei regimi democratici e dei partiti socialisti, dando vita a
propri partiti (in Italia nel gennaio 1921), fino ad accusare gli ex compagni di 'socialfascismo',
cioè di essere la componente più moderata e più 'opportunista' della controrivoluzione. Queste
polemiche, ancora persistenti negli anni dell'ascesa al potere del nazismo, furono superate solo
con la politica dei fronti popolari dopo il 1935. Al Komintern si oppose l'Internationale
Ouvrière et Socialiste, ricostituita a Berna nel 1919 e poi ufficialmente ad Amburgo nel 1923
(IOS), sulla base della conferma della via democratica e parlamentare al socialismo nei paesi a
sviluppo capitalistico, e dunque della denuncia del totalitarismo bolscevico. Il tentativo dei
socialdemocratici austriaci di unificare socialisti e comunisti con l'Internazionale due e mezzo
fallì quasi subito e i più confluirono nell'IOS, di cui ricoprì la carica di segretario fino al 1939
Friedrich Adler (1879-1960).
Rimase comunque viva un'area centrista, che, pur respingendo il metodo bolscevico per i paesi
avanzati, ne ammise tuttavia la possibilità in quelli sottosviluppati o autocratici, come era stata
la Russia zarista, o nell'ipotesi della difesa da attacchi interni ed esterni. In seguito 'i centristi',
come del resto non pochi intellettuali di sinistra, furono pronti a concedere al regime sovietico
almeno il beneficio d'inventario per l'avvio di una direzione pianificata dell'economia e per i
progressi conseguiti tanto nella politica di industrializzazione quanto nello sviluppo
dell'istruzione e dei servizi sociali (cfr. Sidney e Beatrice Webb, Soviet communism: a new
civilization?, London 1935).Nonostante l'arretramento, è stata collocata nel periodo tra le due
guerre la definitiva sedimentazione ('cristallizzazione') socialdemocratica. Nel 1931 i partiti
aderenti alla IOS vantavano oltre 6 milioni di iscritti, 26 milioni di elettori, più di 1.300
deputati, e una rete di oltre 360 organi di stampa.
Anche nei paesi che sarebbero stati poi investiti dalla reazione fascista o autoritaria, l'area del
precedente consenso elettorale socialista acquisito nel primo dopoguerra risultò in qualche
modo consolidata, destinata cioè a confermarsi nelle prime elezioni 'libere' dopo il 1945. Altra
questione è quella dell'uso del potenziale socialdemocratico. Per molti esso non fu pari
all'obiettivo di difendere la democrazia là dove era minacciata (o per contro di indirizzare in
senso sovietico le presunte potenzialità rivoluzionarie dell'immediato dopoguerra), e tantomeno
di affrontare con una cultura economica di lungo periodo la crisi del 1923-1924 e soprattutto
del 1929, nel perdurante pregiudizio che fosse impossibile riformare la società capitalistica. In
realtà non mancò allora la ricerca di strade nuove: con i socialdemocratici Richard von
Moellendorf, Rudolf Wissel e Otto Neurath, questi ultimi anche in relazione al disegno dello
Stato 'organico' di Walther Rathenau, nonché con Georges Douglas H. Cole e Rudolf
Hilferding, si mirava alla parziale socializzazione delle imprese, nell'ambito di un'economia
'governata' ma rispettosa di ampi spazi di autogestione; Louis De Brouckère teorizzava la
"democrazia industriale" e il "controllo operaio" (Le contrôle ouvrier), mentre i guild socialists
inglesi affermavano la primogenitura dell'economia e della società sulla politica nell'ambito di
una concezione pluralistica dei rapporti sociali. Albert Thomas rilanciò in Francia la tesi della
'presenza nella nazione' in relazione allo sviluppo della produttività, e il belga Henri de Man
(1885-1953), che era stato critico severo del marxismo in nome di un socialismo nazionale,
etico-volontaristico e socio-psicologico in Au-delà du marxisme, 1927, teorizzò in Le
socialisme constructif, 1933, un'economia mista sottoposta a un "piano del lavoro" nazionale,
che fece adottare al POB alla vigilia della guerra. L'influenza del 'planismo' di de Man fu
grande in Olanda e in Svizzera, e in taluni ambienti del socialismo inglese e francese favorevoli
alla "économie dirigée" e alla "évolution constructive" ("néosocialisme").
Al di là dei risultati immediati, per la verità modesti, la pratica di economia mista o diretta
maturata tra le due guerre era destinata a incidere nel lungo periodo, entrando a far parte del
codice genetico del socialismo occidentale, di volta in volta come risposta alle crisi cicliche o
meno, come correttivo degli 'eccessi' della libera concorrenza, come volano rispetto agli
squilibri del mercato, addirittura come sinonimo di servizio pubblico impiegato per combattere
le ineguaglianze e per consolidare la coesione nazionale.Il punto centrale fu che in molti paesi i
socialdemocratici andarono allora al governo, per lo più di coalizione, e indipendentemente dai
risultati conseguiti perfezionarono il processo di integrazione politica e sociale avviato alla fine
del secolo precedente. In tale situazione quasi tutti promossero la revisione dei programmi
originari (un'esperienza che invece mancò al socialismo italiano, prematuramente disperso dal
fascismo e costretto all'esilio). Dopo la proclamazione della Repubblica in Germania, nel
novembre 1918, furono eletti presidente e cancelliere in un governo di coalizione i leaders della
SPD, Friedrich Ebert (1871-1925) e Philipp Scheidemann (1865-1939), forti del 38% dei voti
conseguiti nelle elezioni dell'Assemblea costituente il 19 gennaio 1919, nonostante
l'opposizione mossa dai 'socialisti indipendenti', costituitisi nel 1917, e dalla Lega spartachista,
la cui rivolta fu repressa nel sangue.
Esclusa dal governo del Reich dal 1923 al 1928, la SPD restò al governo in coalizione nella
Prussia, nel Baden, nell'Assia e in Amburgo con buoni risultati in campo amministrativo,
scolastico e urbanistico (in particolare con Walter Gropius e il Bauhaus di Weimar), e tornò al
cancellierato nel 1928 con Hermann Müller (e Hilferding, ministro delle Finanze) prima di
essere spazzata via dal nazismo.Anche in Austria i socialdemocratici risultarono il partito più
forte. Presidente della Repubblica, cancelliere e ministro degli Esteri furono eletti
rispettivamente Karl Seitz, Karl Renner e Otto Bauer. Renner fu anche capo dello Stato nel
1945-1950. Se la SPD avviò la revisione del programma al congresso di Görlitz (1921)
delineando già allora 'il partito di tutto il popolo', i socialdemocratici austriaci, fedeli custodi
dell'unità del partito, nel congresso di Linz del 1926 abbandonarono definitivamente la teoria
della dittatura del proletariato per ammettere la violenza a solo scopo difensivo. Grande
autorevolezza, anche all'estero, acquistò il piccolo gruppo degli 'austromarxisti', già noto per le
precedenti posizioni sulla questione nazionale e ora impegnato, in particolare con Bauer (Der
Weg zum Sozialismus, 1919), a delineare una rivoluzione politica per via democratica
attraverso un processo lento di socializzazione dei rapporti di produzione. La socialdemocrazia
austriaca ottenne risultati rilevanti con la legislazione sociale promossa tra il 1918 e il 1920 dal
ministro Ferdinand Hanusch, e soprattutto nell'amministrazione della città di Vienna, una delle
esperienze di governo della città culturalmente e socialmente più feconde in tutto il Novecento.
Nel febbraio 1934, dopo una repressione sanguinosa a Vienna, il governo reazionario di
Dolfuss distrusse la socialdemocrazia austriaca e con essa il regime democratico. La lotta al
fascismo fu alla base della politica dei fronti popolari inaugurata dopo il 1935 in quei paesi
dove la presenza comunista era consistente, e in Spagna si realizzò nella sfortunata difesa della
Repubblica.
L'esperienza più significativa si ebbe in Francia quando, nel 1936, il Front populaire portò al
governo una coalizione presieduta dal socialista Léon Blum (1872-1950), il quale ebbe però
vita difficile tanto che si dimise già nel giugno 1937. La politica del fronte popolare fu poi
messa in crisi dal patto di alleanza tra Hitler e Stalin nel 1939; fu ripresa solo nella Resistenza e
ancora negli anni 1945-1947 in Italia e in Francia, ma costituì un precedente importante anche
per i progetti di democrazia popolare nell'Europa orientale (1945-1949).Nei paesi dell'Europa
del nord, i partiti socialisti portarono a compimento l'integrazione politica e sociale assumendo
responsabilità di governo significative. In Inghilterra il Labour Party da terzo partito divenne in
pochi anni il primo, conquistando nel 1918 il 24% dei voti validi, e nel 1929 il 37%. Con l'aiuto
dei liberali riuscì a dar vita nel gennaio 1924 al primo governo presieduto da un laburista,
Ramsay Mac Donald (1866-1937), e a un secondo nel 1929. In entrambi i casi l'esperienza ebbe
risultati molto modesti, ma rivestì un grande valore simbolico anche in Europa. Il programma
del 1918 a favore della generalizzazione del minimo vitale e della gestione democratica e
decentrata delle industrie nazionalizzate, finanziata con una forte leva fiscale, fu rivisto nel
1928, dopo l'insuccesso dello sciopero generale per la nazionalizzazione delle miniere (1926),
con una diversa e più intensa attenzione ai problemi di politica estera e di politica sociale sotto
il titolo significativo: The Labour and the Nation. Dopo il fallimento dei governi Mac Donald il
Labour rimase all'opposizione per nove anni, ma nel 1940 fu chiamato da Winston Churchill
nel governo di unità nazionale. All'interno dei dominions britannici, si sviluppò un sistema di
Welfare State in Nuova Zelanda, dove il Labour Party, diretto da Michael Savage (1872-1940),
giunse al governo nel 1935 con il 46% dei voti e vi restò fino al 1949. Fin dal 1938 esso creò
un servizio sanitario nazionale gratuito con il Social security act. In Australia, dove era presente
un forte movimento sindacale (nel 1914 un iscritto ogni nove abitanti), il Labour Party assunse
la direzione del governo federale nel 1910, ma fu travagliato da polemiche e divisioni interne;
dette poi vita a un nuovo governo presieduto da J.H. Scullin (1876-1953), nel 1929, nel
momento economico più difficile. Nelle elezioni del 1931 subì una pesante sconfitta, da cui
però si riprese negli anni quaranta. I risultati più rilevanti e più duraturi verso il Welfare State
tuttavia furono conseguiti in Svezia, dove il leader socialdemocratico Karl H. Branting prima
partecipò al governo nel 1917, poi fu eletto primo ministro nel 1920-1923 e nel 1924-1925.
Ma la vera svolta avvenne dopo la formazione di un governo in alleanza con il partito dei
contadini, presieduto da Per Albin Hansson, il quale inaugurò la cosiddetta 'politica del
focolare', che prospettava una società priva di aspri antagonismi di classe, volta a ricercare la
piena occupazione con investimenti pubblici finanziati da una severa politica fiscale. Nelle
elezioni del 1936 i socialdemocratici ottennero il 46% dei voti. In Danimarca il leader del
Partito socialdemocratico, Thorvald Stauning, fu a capo di un governo di coalizione nel 1924,
poi nel 1929 e ancora nel 1933. In Norvegia i socialisti formarono governi di coalizione nel
1928 con Christopher Hornsrud, e nel 1935 con Johann Nygaardsvold. L'esperienza scandinava
parve addirittura definire una propria via al socialismo la quale, all'interno dell'accettata società
capitalista e dunque intervenendo sui meccanismi di redistribuzione del reddito piuttosto che su
quelli della produzione, in un clima di solidarietà sociale conciliasse, empiricamente e
gradualmente, libertà, giustizia, sicurezza e stabilità.
4. L'affermazione della socialdemocrazia nel secondo dopoguerra
Il 'socialismo nazionale' nel Terzo Mondo.Durante la guerra contro il fascismo quasi tutti i
partiti socialisti dell'Europa occidentale, in patria e in esilio, sostennero i governi di unità
nazionale, privilegiando la nazione e la democrazia rispetto alla classe e all'anticapitalismo. Nei
decenni successivi rinunciarono, dopo che lo avevano già fatto nella pratica, all'idea stessa della
violenza e della rivoluzione per la conquista del potere, e pervennero definitivamente a un
concetto più maturo di socialismo, inteso come un ideale sociale ed economico inseparabile dal
metodo democratico assunto come mezzo e come fine. I partiti socialisti europei, inseriti
compiutamente nel cosiddetto mondo libero, perseguirono una opposizione assoluta al
totalitarismo, che negli anni della guerra fredda identificarono nel comunismo per la sua
aggressività ideologica e politica; ciò li portò ad accogliere la protezione militare della NATO,
sia pure in un'ottica difensiva e non trascurando mai di incentivare le politiche di distensione e
di disarmo controllato. Fu esemplare a questo riguardo l'assunzione della carica di segretario
generale della NATO dal 1957 al 1961 da parte di Paul-Henri Spaak (1899-1972), leader dei
socialisti belgi, che aveva già ricoperto le cariche di presidente del Consiglio nel 1938-1939, di
ministro degli Esteri nel 1938-1949 (lo fu anche nel 1961-1969). I partiti socialisti si
trasformarono da partiti di classe, per la difesa degli interessi dei lavoratori dipendenti, in
partiti di popolo, per perseguire una prospettiva di più generale benessere, e sostituirono all'idea
della socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio come primo presupposto del
socialismo quella dell'espansione del pubblico controllo delle imprese e della pianificazione
democratica al fine di garantire la crescita e la distribuzione equa delle risorse, delineando con
ciò un'economia mista fra pubblico e privato.
Nel 1951 a Francoforte tali concetti furono posti a fondamento della Dichiarazione dei principî
del socialismo democratico della ricostituita Internazionale socialista che, nel passaggio dalla
fase della propaganda a quella delle realizzazioni, prese atto che in molti paesi il 'capitalismo
non controllato', prevaricatore dei diritti dell'uomo a favore di quelli della proprietà, lasciava il
campo a un regime economico nel quale l'intervento dello Stato o il possesso collettivo dei
mezzi di produzione conseguivano progressi considerevoli nella creazione di "un nuovo ordine
sociale". L'Internazionale si rivolse ai popoli dei paesi sottosviluppati proponendo il socialismo
come arma di lotta per la conquista dell'indipendenza nazionale e per il conseguimento di uno
standard di vita più elevato, contro le oligarchie indigene e lo sfruttamento neocoloniale. Essa
individuò nel comunismo non solo un grave fattore di divisione e di arretramento del
movimento operaio, ma un avversario pericoloso che a torto si richiamava al socialismo
('socialismo reale') perché rigidamente dogmatico e per giunta "incompatibile con lo spirito
critico del marxismo" e indirizzato all'esasperazione dei contrasti di classe nell'interesse della
dittatura di un partito unico, strumento di un "nuovo imperialismo". Il socialismo (democratico)
si definì dunque come "un movimento internazionale" che fondava i propri convincimenti,
fossero ispirati dal marxismo o da principî religiosi o umanitari, sul comune obiettivo di
costruire "un sistema di giustizia sociale, di vita migliore, di libertà e di pace".
Dalla constatazione che lo sviluppo delle scienze e della tecnica aveva dato all'umanità la
possibilità di distruggere se stessa, ma anche di migliorare continuamente la propria condizione
di vita, esso ricavò la conferma che la produzione non potesse essere lasciata al libero gioco
delle forze economiche ma dovesse essere 'pianificata', sia pure nel rispetto dei diritti
fondamentali delle persone umane. Un aggiornamento di tali principî di fronte alla
mondializzazione economica fu fatto con la Dichiarazione di Stoccolma al congresso
dell'Internazionale del 19-22 giugno 1989, con l'accentuazione delle motivazioni democratiche,
la valorizzazione del ruolo dell'uomo e della donna, e una maggiore attenzione alla solidarietà
tra il Nord e il Sud dei popoli della terra ("una nuova società democratica mondiale").In
Inghilterra, nel 1945, il Labour Party, ottenuta la maggioranza in Parlamento, avviò una vasta
politica di Welfare State, largamente ispirata alle idee di William Henry Beveridge e di John
Maynard Keynes, al fine di garantire la protezione generale, solidale e socialmente equa contro
la disoccupazione, la malattia, gli infortuni e la vecchiaia, e promosse un impegnativo
programma di nazionalizzazioni nelle industrie di base (ferrovie e trasporti, acciaio, carbone).
Ricacciato all'opposizione nel 1951, il Labour ebbe un'evoluzione profonda dopo la sconfitta
della sinistra interna di Aneurine Bevan e poi di Michael Foot. Ne fece fede il saggio The future
of socialism, scritto da Anthony Crosland nel 1956, nel quale si sosteneva che il fondamento
del socialismo era sociale più che economico, cioè volto a conseguire una più equa
distribuzione delle ricchezze e un più razionale sistema educativo per ridurre le differenze di
classe e la povertà, piuttosto che a interferire sui diritti di proprietà dei mezzi di produzione o
addirittura a esasperare gli interessi di classe. A tali principî si ispirò la nuova leadership
laburista negli anni 1955-1963, sotto la guida di Hugh Gaitskell (1906-1963), e poi, tra il 1963
e il 1976, di Harold Wilson. Con una campagna a favore della politica dei redditi e della
'rivoluzione tecnica e scientifica', in cui riecheggiavano le tesi non solo di Keynes e di
Schumpeter ma anche di Burnham e di Galbraith, i laburisti tornarono al governo nel 19641970 e poi ancora nel 1974-1976 e, dopo le dimissioni di Wilson, con James Callaghan nel
1976-1979. Fece seguito un lungo periodo di opposizione, rotto infine dalla clamorosa vittoria
elettorale del 1° maggio 1997, che ha portato al potere Tony Blair e ha attribuito al Labour 419
seggi su 659.In Svezia i socialdemocratici detennero il potere ininterrottamente per mezzo
secolo (dal 1932) con Hansonn, Tage Erlander e Olof Palme (1927-1986), e per molti decenni
in Norvegia e in Danimarca per poi alternarsi al potere con l'opposizione conservatrice. Il
socialismo scandinavo accentuò l'obiettivo della coesione nazionale come proiezione del
solidarismo dalla 'culla alla tomba', e della funzionalità fondata sulla 'parità delle occasioni' più
che sull'uguaglianza.
In Germania l'evoluzione della SPD ebbe la sua consacrazione al congresso di Bad Godesberg,
nel 1959, con la rinuncia al marxismo. Nel presupposto che una moderna società industriale
non possa essere governata da un principio uniforme, il congresso delineò i tratti di
un'economia mista e di una società fortemente pluralistica. L'istanza originaria della
collettivizzazione venne tradotta nell'esigenza del controllo pubblico, e per la prima volta ci si
dichiarò per la protezione e la promozione della proprietà privata e si accettò esplicitamente la
logica della libera competizione economica tra pubblico e privato con la parola d'ordine "libertà
finché possibile, pianificazione finché necessaria". Furono poste così le condizioni perché la
SPD accedesse al governo nella grande coalizione con i democristiani negli anni 1966-1969, e
poi tra il 1969 e il 1974 assumendo il cancellierato con Willy Brandt (1913-1992), già sindaco
di Berlino negli anni 1957-1964 e poi ministro degli Esteri. Brandt avviò il processo di
distensione con l'URSS e con la Repubblica Democratica Tedesca (Ostpolitik), e quando venne
sostituito dal compagno di partito Helmut Schmidt, negli anni 1974-1982, si dedicò
all'Internazionale socialista dilatandone l'area di intervento e rafforzandone il prestigio.In
Austria il processo di secolarizzazione del partito fu portato a compimento negli anni
cinquanta. Nel 1960 il presidente del partito, Bruno Pitterman, ebbe a dichiarare che "la
professione di fede nel marxismo per i socialisti di oggi è una questione privata esattamente
come la professione di una religione". I socialdemocratici dettero vita a una grande coalizione
con i democristiani nel 1959-1966, sotto la guida di Bruno Kreisky (1911-1990) che, dopo aver
ricoperto la carica di ministro degli Esteri nel 1959-1966, venne eletto cancelliere nel
1970.Anche in Francia i socialisti alla fine della guerra assunsero le massime cariche dello
Stato con Vincent Auriol (1884-1966), primo presidente della IV Repubblica dal 1947 al 1954,
e con Paul Ramadier, primo ministro di un governo tripartito, con la partecipazione dei
comunisti, fino al maggio 1947.
Dal 1946 al 1968, sotto la guida di Guy Mollet (1905-1975) che aveva sconfitto la corrente di
destra di Blum, favorevole a una più radicale revisione programmatica in nome di un
umanesimo socialista, la SFIO si collocò come la troisième force tra comunisti e gaullisti. Essa
tornò in primo piano solo nel 1956-1957 con il governo Mollet. Quest'ultimo però fu travolto
dalla crisi algerina e di Suez lasciando aperta la strada alla soluzione della V Repubblica. Il
socialismo francese piombò, come in passato, in una fase critica di divisioni e di polemiche
interne da cui uscì solo con il congresso di Epinay del giugno 1971, sotto la guida di François
Mitterrand (1916-1996). Con la firma del programma comune delle sinistre nel giugno 1972,
Mitterrand pose le condizioni della scalata alla presidenza della Repubblica, che infine ottenne
nel 1981 e poi ancora nel 1988, nel primo caso trascinando al successo elettorale i socialisti che
formarono un governo con la partecipazione dei comunisti, nel secondo in coabitazione con il
governo Chirac. Nel giugno 1997 le elezioni anticipate hanno sancito una nuova vittoria
socialista, che ha portato alla formazione del governo presieduto da Lionel Jospin.
In Italia la revisione programmatica dei socialisti fu più lenta e si compì con la svolta
autonomista e democratica del 1956 e soprattutto con i governi di centro-sinistra degli anni
sessanta. La vicenda socialista fu qui dominata dai rapporti con il più forte partito comunista
del mondo occidentale, rapporti che determinarono nel 1947 la scissione tra il Partito Socialista
di Pietro Nenni (1891-1980) e il Partito Socialista Democratico Italiano di Giuseppe Saragat
(1898-1988), e nel 1964 quella dell'ala sinistra che dette vita al Partito Socialista Italiano di
Unità Proletaria (PSIUP); nonché con la Democrazia Cristiana, grande partito di centro di
ispirazione cattolica. Partito di cerniera del sistema politico nonostante le dimensioni modeste
(10-14% dell'elettorato), e dunque con un forte potere di coalizione, il PSI assunse un ruolo di
primo piano negli anni ottanta, sotto la dinamica segreteria di Bettino Craxi, che fu presidente
del Consiglio tra il 1983 e il 1987, e con la popolare presidenza della Repubblica di Sandro
Pertini (1896-1990) tra il 1978 e il 1985; anche per questo subì i contraccolpi più pesanti nella
crisi della cosiddetta 'prima Repubblica' negli anni 1992-1994, fino alla frantumazione in
piccoli gruppi la cui sopravvivenza è stata resa difficile dal passaggio dal sistema elettorale
proporzionale a quello maggioritario.Mentre negli anni ottanta il 'consenso socialdemocratico'
si indeboliva per la prima volta nei paesi centroeuropei e scandinavi (dove l'elettorato era
stabilmente oltre il 35%), nei paesi dell'Europa meridionale esso si andava affermando in
maniera vistosa. Oltre alla Francia e all'Italia, i casi più significativi furono quelli dei paesi
usciti da regimi autoritari: in Grecia il Panellino Sosialistiko Kinima (PASOK) di Andréas
Papandreu andò al governo nel 1981; in Spagna il PSOE di Felipe Gonzales nel 1982; in
Portogallo il Partido socialista di Mario Soares nel 1983. Al governo per molti anni (anche nel
decennio successivo), questi partiti esercitarono un ruolo importante di stabilizzazione sociale
consolidando le nuove istituzioni democratiche e portando a compimento l'inserimento dei
propri paesi nella Comunità Europea. Al tempo stesso essi spostarono il baricentro dell'area di
diffusione del socialismo dai centri tradizionali dell'Europa centro-occidentale, scandinava e
britannica all'Europa meridionale, tanto che si è parlato di un socialismo mediterraneo,
caratterizzato da un più accentuato pragmatismo e dalla tendenza al leaderismo. Oltre alla
compiuta integrazione politica e sociale dei partiti socialdemocratici nell'Europa occidentale, e
tralasciando l'esperienza del socialismo reale nei paesi dell'Est (riconducibile però alla storia
del comunismo, ivi compreso quello non allineato e autogestionario della Iugoslavia), l'altro
fatto nuovo del secondo dopoguerra fu lo sviluppo del socialismo nel Terzo Mondo in
condizioni molto diverse da quelle della 'culla europea'.
Si affermò l'idea che nella seconda metà del XX secolo la rivoluzione, o il grande mutamento,
appartenesse alla campagna piuttosto che alle fabbriche e alla città, e si collegasse ai processi di
decolonizzazione del Terzo Mondo e di formazione di nuovi Stati indipendenti, che si
affermavano per lo più dopo lunghe e sanguinose guerre di liberazione contro le antiche
potenze coloniali. Il 'modello socialista' sembrò rappresentare meglio le esigenze della
modernizzazione e dello sviluppo rispetto a quello del capitalismo industriale e finanziario, e
parve in grado di soddisfare la ricerca da parte delle élites dominanti, spesso guidate da un
leader carismatico, di un'identità sociale e culturale che superasse in senso comunitario e al
tempo stesso nazionalistico le divisioni tribali, etniche e religiose. Esso di solito si identificò
nella prospettiva della nazionalizzazione delle industrie di base e nella creazione di partitiregime.Così, in Egitto, Giamāl 'Abd an-Nāṣir (Nasser, 1918-1970), che salì al potere nel 1952
con un colpo di Stato militare e assunse tutti i poteri nel 1954 con il titolo di rais e poi come
presidente della Repubblica, dopo la crisi di Suez del 1956 intensificò la lotta contro il capitale
straniero avviando una politica di nazionalizzazione di larghi settori dell'economia e
promuovendo la riforma agraria. Egli fece dell'Egitto una delle nazioni guida del non
allineamento, indicando al Terzo Mondo il socialismo nazionale come la terza via allo sviluppo
rispetto al socialismo reale dei paesi dell'Est e al capitalismo occidentale. In Siria, nel 1953, fu
fondato il partito Ba'th come "movimento nazionale, populista e rivoluzionario" impegnato nel
conseguimento dell'unità araba, della libertà e del socialismo. Il nazionalismo non era qui
circoscritto a uno Stato arabo in particolare, ma esteso al 'popolo arabo' nel suo complesso, di
cui si rivendicava la crescita spirituale e materiale, in una visione laica, non religiosa né tribale.
Il Ba'th andò al potere in Siria nel 1970, con un colpo di Stato diretto da Hafiz Assad. Si è
parlato poi di 'socialismo algerino' con Ahmed Ben Bella e con Houari Boumedienne, e negli
anni sessanta di 'socialismo tunisino' con al-Habib Burghiba.
In Africa, tra le diverse ideologie della liberazione e del potere, ebbe un ruolo significativo la
concezione del 'socialismo africano' e della 'negritudine' dello scrittore francofilo Léopold
Sédar Senghor, capo di Stato dell'ex Senegal francese dal 1960 al 1980. Ispirandosi al pensiero
comunitario e umanistico premarxista francese (ma anche di Léon Blum), Senghor parlò di una
'terza' rivoluzione, dopo quella capitalista e comunista, destinata a esaltare l'apporto dei popoli
di colore alla nuova 'civiltà planetaria'. Partendo da una valutazione negativa dell'assimilazione
coloniale egli riscoprì le tradizioni autoctone e l'anima collettiva negra, non in contrapposizione
ma a completamento dei valori universali della civiltà europea. Fautore di una concezione
dirigistica e di 'una dittatura democratica' fu invece Sekú Turé, presidente della Guinea dopo
l'indipendenza conseguita nel 1958. Convinto assertore di un 'socialismo panafricano' (e non
nazionale) fu infine il capo di Stato prima del Tanganica (1962) e poi della Tanzania (1964)
Julius Nyerere. Cattolico, dopo avere compiuto gli studi in Inghilterra questi delineò un
progetto di socialismo fondato sull'espansione della tradizionale famiglia allargata, allo scopo
di pervenire a una comunità in cui la proprietà privata venisse limitata e fosse concessa la
libertà di espressione, ma non l'organizzazione del dissenso. Un'ulteriore applicazione di una
democrazia dirigista nazionalista, legata al non allineamento internazionale, è riconducibile a
Sukarno (1901-1970), primo presidente dell'Indonesia nel 1945. Un esempio raro (a parte
l'eccezione giapponese) di una dinamica democratico-parlamentare per l'accesso al governo fu
dato in Cile nel 1970 dall'elezione alla presidenza della Repubblica di Salvador Allende (19081973). Alla testa della coalizione di Unidad Popular, composta da socialisti, comunisti, radicali
e cattolici di sinistra, egli governò per tre anni prima di essere rovesciato da un colpo di Stato
militare.
5. Verso il XXI secolo
Al suo XX congresso del 9 settembre 1996, a New York, l'Internazionale socialista ha vantato
l'adesione di oltre 140 partiti membri rispetto ai 110 nel 1992 (20 nel 1951 e 40 nel 1976). I
partiti che si riconoscevano nell'Internazionale socialista erano al governo in 13 paesi su 15
della Comunità Europea. Nell'Europa orientale erano diventati complessivamente la prima
forza politica, dopo la conversione degli ex partiti comunisti e l'efficace opposizione ai nuovi
nazionalismi etnici. Fuori dell'Europa erano al governo in Giappone, Pakistan, Nepal, India,
Cile, Giamaica, Costa Rica, Columbia e in moltissimi paesi dell'Africa. Anche se
l'Internazionale si configurava come un luogo di incontro di partiti sulla base di criteri di
adesione abbastanza larghi (conformità agli ideali di democrazia, sviluppo, pace; consistenza
reale; gestione interna democratica), la sua crescita attesta pur sempre che il socialismo era, più
che mai dopo il crollo del comunismo, una grande forza evocatrice in tutto il mondo.
L'espansione geografica del socialismo sembrava finalmente concretizzarne l'aspirazione
universalistica, presente fin dalle origini, e l'ambizione di farsi interprete dei processi di
democratizzazione dei paesi già governati da regimi dittatoriali o totalitari. L'esito di tale sfida,
tuttora in corso, coinciderà con le possibilità di affermazione nel Terzo Mondo dei valori di
tolleranza, di rispetto della persona, di uguaglianza dei diritti politici e sociali propri della
civiltà occidentale, ma anche di efficaci politiche di sviluppo, in grado tra l'altro di disinnescare
la 'bomba' demografica.
Più difficile è prevedere quante delle esperienze del socialismo nazionale nelle aree di
sottosviluppo preludano a un'effettiva nuova via che valorizzi le risorse indigene e con ciò
arricchisca anche il modello socialdemocratico originario nella globalizzazione delle relazioni
economiche e sociali.Eppure, nei paesi europei e anglosassoni, cioè nell'area storicamente
propulsiva del socialismo, si sono fatte oggi più frequenti le voci sulla vetustà o addirittura sul
declino della socialdemocrazia. La mondializzazione economica e la rivoluzione tecnologicoinformatica, l'esplosione demografica e la pressione immigratoria, le politiche di risanamento
dei bilanci pubblici mettono in discussione il 'compromesso' socialdemocratico su cui sono stati
fondati il Welfare State e il keynesismo, e perfino la tradizionale struttura a tre stadi imperniata
sul rapporto partito-sindacato-associazionismo collaterale. Più correttamente si dovrebbe
parlare di conclusione di un ciclo, fondato sul binomio classe operaia-nazione, iniziato oltre un
secolo fa, nell'epoca dell'industrializzazione diffusa. Nel codice genetico del socialismo
(europeo) il futuro apparteneva al lavoro dipendente, del quale il proletariato di fabbrica
sarebbe stato il nucleo aggregante e significativo, tanto più perché destinato a diventare più
omogeneo, più diffuso, più acculturato e più consapevole.
Era un socialismo che faceva riferimento al lavoro manuale, e quando si rivolgeva ad altri ceti
(impiegati, quadri, intellettuali, contadini) li coinvolgeva in quanto, nei comportamenti e nelle
attitudini, si rendevano 'popolo' o 'proletariato'. Nelle società postindustriali, il futuro
appartiene al terziario avanzato, sempre più informatizzato, piuttosto che al settore secondario.
E rispetto al lavoro, una volta termine di partenza e di arrivo della vita, uno spazio crescente
viene assunto dal tempo di non lavoro o 'libero'. D'altra parte l'affermazione preponderante
dell''io' e del privato sul pubblico parrebbe imporsi sulle pratiche di socializzazione e classiste,
e perfino comunitarie. La trasformazione del partito socialdemocratico da partito di classe in
partito catch-all ('pigliatutto') fa temere che ne vengano minate irrimediabilmente le 'radici
sociali' e vanificato il potere mobilitante dell'ideologia.
Sono ridimensionati gli itinerari tipici di acculturazione della massa dei lavoratori (quartieri,
luoghi di ritrovo, linguaggio) che rendevano omogenea la classe; e lo stesso processo
produttivo tende a 'individualizzarsi', con la flessibilità, il decentramento e l'informatizzazione.
Il frazionamento degli interessi facilita la promozione di movimenti monotematici e di gruppi
di pressione, mentre diviene più incisiva la presenza di organismi politico-economici e
monetari sovranazionali: il partito nazionale di grande apparato e di massa, in grado di
intermediare la domanda, per giunta inarticolata, registra una costante, inarrestabile flessione.
La percezione della chiusura di un ciclo pare comunemente avvertita, cosicché per il socialismo
sul finire del XX secolo si parla sempre più di un passaggio dalle nazionalizzazioni al mercato;
dalla fiducia nel progresso lineare alla prospettiva di uno sviluppo compatibile o sostenibile;
dallo statalismo alla valorizzazione delle associazioni non profit e alla responsabilità dei
cittadini; dalla lotta contro l'ingiustizia sociale a quella contro l'esclusione e contro presunte
nuove ineguaglianze, quali quelle prodotte nelle città dal degrado ambientale, dalla diffusione
della droga, dalla criminalità organizzata e dall'immigrazione. L'obiettivo è quello di portare la
cittadinanza al livello della quotidianità. Ai socialisti è affidato il compito, davvero difficile e
dall'esito incerto, di adattare ai problemi attuali il modello ricevuto dai padri in un secolo di
lotte per l'uguaglianza dei diritti e per la protezione sociale dell'individuo.
(V. anche Comunismo; Marxismo; Operai; Proletariato; Riformismo; Rivoluzione; Utopia).
bibliografia
Beer, M., A history of British socialism, London 1919-1920 (tr. it.: Storia del socialismo
britannico, Firenze 1964).
Bergounioux, A., La social-démocratie ou le compromis, Paris 1979.
Bergouniuoux, A., Manin, A., Le régime social-démocrate, Paris 1989.
Boggs, C., The socialist tradition: from crisis to decline, London 1995.
Braunthal, G., The West German social democrats, 1969-1982: profile of a party in power,
Boulder, Col., 1983.
Braunthal, J., Geschichte der Internationale, 3 voll., Hannover, 1961-1971.
Bravo, G.M. (a cura di), Il socialismo prima di Marx: antologia di scritti di riformatori,
socialisti, utopisti, comunisti e rivoluzionari premarxisti, Roma 1966.
Bravo, G.M., Storia del socialismo, 1789-1848: il pensiero socialista prima di Marx, Roma
1971.
Bronner, S.E., Socialism unbound, London 1990.
Brown, B.E. (a cura di), Eurocommunism and eurosocialism. The left confronts modernity,
New York 1979.
Castles, F.G., The social democratic image of society, London 1978.
Ciuffoletti, Z., Degl'Innocenti, M., Sabbatucci, G., Storia del PSI, voll. I e III, Roma-Bari 19921993.
Cole, G.D.H., A history of socialist thought, 5 voll., London 1953-1960 (tr. it.: Storia del
pensiero socialista, 5 voll., Bari 1967-1971).
Collotti, E. (a cura di), L'internazionale operaia e socialista tra le due guerre, Milano 1985.
Crosland, C.A.R., The future of socialism, New York 1957.
Degl'Innocenti, M., Geografia e istituzioni del socialismo italiano, 1892-1914, Napoli 1983.
Devin, G., L'Internationale socialiste: histoire et sociologie du socialisme international, 19451990, Paris 1993.
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international, diretto da J. Maitron e G.
Haupt, Paris 1964 ss.
Dolléans, É., Histoire du mouvement ouvrier, Paris 1936 (tr. it.: Storia del movimento operaio,
3 voll., Firenze 1968).
Droz, J., Le socialisme démocratique, 1864-1960, Paris 1966.
Droz, J. (a cura di), Histoire générale du socialisme, 4 voll., Paris 1972-1978 (tr. it.: Storia del
socialismo, 4 voll., Roma 1973-1981).
Foner, P., History of the labor movement in the United States, 4 voll., New York 1947-1965.
Fried, A., Socialism in America: from Shakers to the Third International, New York 1970.
Friedland, H.W., Rosberg, C.G. jr (a cura di), African socialism, Stanford, Cal., 1964.
Gallagher, T., Williams, A. (a cura di), Southern European socialism: parties, elections and the
challenge of government, Manchester 1989.
Gay, P., The dilemma of democratic socialism, New York 1962.
Gillespie, R., The Spanish socialist party, Oxford 1989.
Guttsman, W.L., The German social democratic party 1875-1933, London 1981.
Halévy, E., Histoire du socialisme européen, Paris 1948.
Hamon, L., Socialisme et pluralité, Paris 1976.
Harrington, M., Socialism past and future, New York 1989.
Haupt, G., L'internazionale socialista dalla Comune a Lenin, Torino 1978.
Haupt, G., Reberioux, M., La deuxième Internationale et l'Orient, Paris 1967.
Hindness, B., Parliamentary democracy and socialist politics, London 1983.
Jabar, K., The Arab Ba'ath socialist party, Syracuse, N.Y., 1966.
Joll, J., The Second International, 1889-1914, London 1955.
Karvonen, L., Sundberg, J. (a cura di), Social democracy in transition, Aldershot 1991.
Kolakowski, L., Glówne nurty marksizmu: powstanie, rozwój, rozklad, 3 voll., Paris 19761978 (tr. it.: Nascita, sviluppo, dissoluzione del marxismo, 3 voll., Milano 1979-1985).
Kriegel, A., Le pain et le roses: jalons pour une histoire des socialismes, Paris 1968.
Kriegel, A., Les internationales ouvrières, 1864-1943, Paris 1983.
Laclau, E., Mouffe, C., Hegemony and socialist strategy, London 1985.
Landauer, C., European socialism: a history of ideas and movements. From the industrial
revolution to Hitler's seizure of power, 2 voll., Los Angeles 1959.
Lemke, C., Marks, G. (a cura di), The crisis of socialism in Europe, Durham 1991.
Lichtheim, G., The origins of socialism, New York 1969 (tr. it.: Le origini del socialismo,
Bologna 1970).
Lindeman, A.S., A history of European socialism, New Haven, Conn., 1983.
Metha, A., Studies in Asian socialism, Bombay 1959.
Miller, S., Potthoff, H., A history of German social democracy. From 1848 to the present,
Leamington 1986.
Moschonas, G., La socialdémocratie de 1945 à nos jours, Paris 1994.
Nyerere, J.K., Socialismo in Tanzania, Bologna 1976.
Parent, J., Le modèle suédois, Paris 1970.
Paterson, W.E., Campbell, T.R., Social democracy in post-war Europe, London 1974.
Paterson, W.E., Thomas, A.H. (a cura di), Social democratic parties in Western Europe, New
York 1971.
Pelinka, A., Social democratic parties in Europe, New York 1983.
Pelling, H., A short history of the Labour Party, London 1961.
Przeworski, A., Capitalism and social democracy, New York 1985.
Rose, S., Socialism in Southern Asia, Oxford 1959.
Rosenberg, A., Democracy and socialism: a contribution to the political history of the past 150
years, New York 1939.
Roth, G., The social democrats in imperial Germany: a study in working-class isolation and
national integration, Totowa, N.J., 1963.
Rovan, J., Histoire de la socialdémocratie allemande, Paris 1978.
Salsano, A. (a cura di), Antologia del pensiero socialista, 5 voll., Roma-Bari 1979-1983.
Sassoon, D., One hundred years of socialism, London 1996.
Scase, R., Social democracy in capitalist society: working class politics in Britain and Sweden,
London 1977.
Schorske, E.C., German social democracy, 1905-1917: the development of great schism,
Cambridge, Mass., 1955.
Schumpeter, J.A., Capitalism, socialism and democracy, New York 1942 (tr. it.: Capitalismo,
socialismo e democrazia, Milano 1955).
Senghor, L.S., On African socialism, New York 1964.
Spini, G., Le origini del socialismo: da Utopia alla bandiera rossa, Torino 1992.
Stephens, J.D., The transition from capitalism to socialism, London 1979.
Storia del marxismo, 4 voll., Torino 1978-1982.
Storia del socialismo italiano, diretta da G. Sabbatucci, 6 voll., Roma 1980-1981.
Taylor, K., The political ideas of the utopian socialists, London 1982.
Telo, M., Le new deal européen: la pensée et la politique socialdémocrates face à la crise des
années trente, Bruxelles 1988.
Weinstein, J., The decline of socialism in America, 1912-1925, New York 1967.
Winock, M., Le socialisme en France et en Europe, Paris 1992.
Zangheri, R., Storia del socialismo italiano, 2 voll., Torino 1993-1997.
La democrazia ha un futuro?
Giovanni Sartori
Questa lezione mi viene, sia nel suo titolo come nella sua ispirazione, dalla raccolta di scritti di
Bobbio Il Futuro della Democrazia del 1984, e poi, in seconda edizione, del 1991. Il mio titolo
è dunque una parafrasi che converte il titolo di Bobbio in un interrogativo. Le date sono
importanti.Nel 1984 il muro di Berlino era ancora in piedi, mentre nel 1991 lo sfacelo del
comunismo appariva inevitabile e nell’ordine delle cose. E così nell’Introduzione del 1991
Bobbio poteva sfoggiare un inconsueto ottimismo. Riferendosi al libro di Revel Come le
Democrazie Finiscono (dell’83) Bobbio commentava: «Questa volta i profeti di sventura
avevano avuto torto, anche chi (Revel, appunto) aveva minuziosamente descritto la implacabile
macchina per l’eliminazione della democrazia che è diventato il mondo moderno». An
che io, nel ‘90, scrivevo che «la democrazia è oramai senza nemico; non è più fronteggiata [nel
mondo modernizzato] da le gittimità alternative.
Ma vincere la guerra non è vincere la pace. Anche il gioco democratico può essere giocato
male.Saprà la democrazia resistere alla democrazia?». Come si vede, ero molto cauto. Ma a suo
modo lo era anche Bobbio. Scriveva: «Sia chiaro: io non faccio alcuna scommessa sul futuro».
[...] La democrazia ha un futuro? Qui rispondo: dipende dal nostro cervello. Come ha scritto
Charles Lindblom, «la condizione umana è piccolo cervello, grandi problemi». E sta di fatto,
sembra a me, che il nostro cervello diventa sempre più picco lo, sempre più limitato, mentre i
problemi sonodiventati sempre più giganteschi.La forza delle idee ha raggiunto il suo apogeo,
il suo punto culminante, con l’Illuminismo, appunto,con il secolo dei Lumi. Io ci credo ancora
(comeBobbio), e quindi è esatto che di me si dica chesono un residuato dell’Illuminismo. Ma
siamo restati in pochi. Perché le idee sono da tempo sottosospetto. In parte sono state sost
ituite dalle ideologie (idee fossilizzate, ripetute meccanicamentesenza più essere pensate da
nessuno), e da ultimo perché sono indebolite e devastate da un'assordante crescendo di
inculture. Mi preme di precisare che per idee non dobbiamo intendere qualsiasi cosa che ci
passa per la mente. Di «i deuzze» non c’è mai carenza. Anzi, tutti «ideuzzano» sempre di più.
Ma mancano sempre di più le idee che sono un prodotto finito della ragione, il frutto del
pensare ragionando. Insomma, mancano sempre di più le idee autentiche, le idee serie, le idee
che arricchiscono il sapere. Il che spiega perché la teoria della democrazia vada maluccio, come
vedremo. Ma al momento restiamo alla pratica della democrazia, e per essa alla democrazia che
si attua votando e che così realizza, e si realizza, come un «governo di opinione» (è la nota
definizione di Dicey).
E’ esatto dire opinione, questa èla dizione giusta. Opinione è doxa, non è episteme, non è
sapere.Le opinioni sono, per così dire , «idee leggere» che non devono esse re provate: le
prendiamo per buone per come sono. Si racconta che un giudice del tribunale rivoluzionario
di Parigi, negando aLavoisier (il fondatore della chimica moderna) una richiesta di rinvio
dell’esecuzione capitale, gli abbia risposto: «La république n’a pas besoin de savants».
Quel giudice si sbagliava. La repubblica ha bisogno di sapienti; ma la democrazia elet
torale, il demos votante, no. E dunque il governo di opinione richiede soltanto - come
suo fondamento - l’esistenza di una pubblica opinione, di un pubblico che abbia opinioni.
La nozione va definita bene.
Ho già detto che una opinione non richiede prova. Aggiungo che leopinioni sono convinzioni
deboli e variabili. Sediventano convinzioni profonde e profondamenteradicate, allora sono da
dire credenze (e il problema cambia). E questa precisazione già basta asmontare l’obiezione
che la democrazia è impossibile perché il popolo «non sa». Questa è una obiezione forte contro
la democrazia diretta, contro un demos chiamato a governare e a governarsi da sé. Ma non è
una obiezione contro una democrazia rappresentativa nella quale il demos non decide le
questioni in proprio ma decide, con il voto, chi sarà a deciderle. Il che significa che alla
democrazia rappresentativa basta, per funzionare , che il pubblico abbia opinioni sue, opinioni
proprie; niente di più, ma anche niente di meno.
Ci stiamo contentando di troppo poco? A prima vista; ma a seconda vista ci accorgiamo che è
già difficile arrivare a quel poco. Opinione pubblica non è soltanto un opinare collocato nel
pubblico;deve anche essere, per alimentare e sostenere la democrazia, una opinione del
pubblico, un opinareautonomo, endogeno, che in qualche modo il demos si fa da sé. Inoltre
quando parliamo, nellteoria della democrazia, di pubblica opinione intendiamo una opinione
che investe la cosa pubblica,temi di natura pubblica: l’interesse generale, il bene comune. Una
pubblica opinione che si interessa di calcio, della bellezza delle donne, o di musica rock, ai fini
della democrazia è irrilevante.
Nessuno nasce, ovviamente, con opinioni innate. E questa constatazione apre il discorso su
comeuna opinione pubblica viene formata e si viene a formare. E’ un discorso lungo e
complesso che quidevo saltare. Dirò solo che mentre in passato unamolteplicità di fattori e
di processi riusciva acreare una opinione pubblica abbastanza autono ma, con l’avvento del
bombardamento dei massmedia e precipuamente della televisione l’opinione pubblica e
diventata sempre più video-diretta equindi etero-diretta. E con l’opinione etero-diretta sparisce
l’opinione del pubblico; resta solol’opinione nel pubblico; con tanti saluti, in tal caso,
allademocraziacome governo di opinione. Ma procediamo con calma.Quando Bobbio ed io (io
nel lontanissimo 1957) abbiamo cominciato a scrivere sulla democrazia, la televisione non
c’era, o meglio non risultava ancora un fattore determinante. Il mio primo scritto che attribuiva
centralità alla televisione si intitolava Video-potere e usciva nel 1989. non sono stato
sveltissimo (come diceva Hegel, l’uccello di Minerva spicca il volo solo al tramonto), ma altri
studiosi sono stati, e sono tutt’oggi, più lenti di me. Eppure noi stiamo vivendo un radicale
cambiamento antropogenico (di genetica dell’uomo): stiamo passando - mi sono abituato a dire
-dall’homo sapiens prodotto dalla cultura scritta fondata su parole, a un homo videns nel quale
laparola è spodestata dall’immagine.Sì, spodestata. E’ vero che le parole denotative, le parole
concrete (casa,tavolo, spaghetti) evocano anch’esse immagini; ma tutto il nostro sapere è
fondato su parole astratte che evocano concetti, cose concepite (concìpere) che non hanno
nessun equivalente visibile, che non sono traducibili inimmagini. Per esempio in tutta questa
lezione probabilmente la sola parola concreta che ho usato è Bobbio. I nomi propri sono,
ovviamente, denotativi. Ma democrazia, demos, potere, costituzione, libertà, Stato, sovranità,
legittimità, diritto, e cosìvia, sono parole astratte che rinviamo a un pensare per concetti che
capisco senza vedere, senza vederli.
Dunque, tutto il sapere dell’homo sapiens si sviluppa nella sfera di un mundus intelligibilis
(diconcetti, di concepimenti mentali) che non è inalcun modo il mundus sensibilis, il
mondopercepitodai nosri sensi. Il punto, allora,è questo: che l’impatto crescentedel televedere,
del video-vivere, inverte il progredire dal sensibile all’intelligibile. La televisione produce
immagini e cancella i concetti, e così atrofizza la nostra capacità astraente, e con essa il
concepire e tutta la nostra capacità di capire. Nell’homo videns il linguaggio concettuale
(astratto) è sostituito da un linguaggio
Scaricare