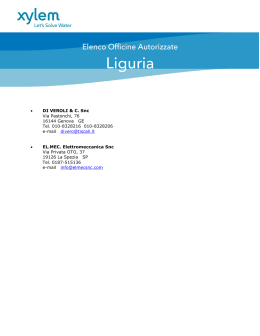GIUSEPPE TRULLI
VEROLI
PAGINE DI STORIA, EVENTI, PERSONAGGI
ANTOLOGIA
Progetto grafico ed impaginazione
Antonio Grella, Francesco Guercio
Supervisione testi
Loredana Stirpe
Copertina
Massimo Terzini
Correzione bozze:
Francesco Guercio
Le fotografie delle pagine 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50, 51, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 120, 129, 131, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 200, 201, 202, 203, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 286, 287, 288,
307, 377, 379, 412, 413, 414, 417, 418, 437, 452, 453, 454, 455, 474, 475,
476, 483 sono di Antonio Grella
La fotografia di pagina 100 è di Massimo Terzini
La fotografia di pagina 173 è di Daniele Patriarca
Le fotografie delle pagine 484 e 485 sono di Luciano Trulli
Le fotografie della pagina 167 sono di Alessandro Tarquini
Le fotografie ed i disegni delle pagine 20, 25, 27, 42, 46, 55, 70, 71, 172,
290, 292, 296, 299, 306, 308, 309, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 339, 348, 349, 350, 380,
381, 382, 385, 411, 415, 416, 435, 436, 441, 451, 456, 457, 460, 470, 471,
472, 473, 478 sono state fornite dall’autore.
Questo volume è stato realizzato
con il denaro dell’autore.
© - 2012 - Tutti i diritti sono riservati.
“I periodi felici dell’umanità
sono i fogli rimasti in bianco
nel libro della storia”.
LEOPOLD VON RANKE
A mia moglie Teresa
che mi ha sempre sostenuto
nell’idea di dare alle stampe
questo mio lavoro.
Il progresso, la modernità
non hanno fatto irruzione in Veroli
prepotenti e fragorosi come altrove:
sembrano fermarsi al limitare dell’abitato,
quasi che le mura pelasgiche e la grande torre avvolta nell’edera,
dominanti l’ingresso maggiore,
l’abbiano protetta da ogni profanazione.
GIULIO ALONZI
S
copo di questo volume1 è di far conoscere gran parte di ciò che su Veroli è stato scritto in articoli, saggi e pubblicazioni varie da verolani e
non verolani, tutti accomunati in un unico sentimento: l’interesse per
il mio paese. Essi formano un piccolo gruppo di persone (non tanto
piccolo se sono riuscito a scovare una settantina di autori) sinceramente innamorati di questo luogo tanto speciale. Cerchiamo di capire perchè.
Il paese. Una parola magica!
Scrive a riguardo MARINO MORETTI: «Voi che siete nati nelle piccole o nelle
grandi città, voi non sapete la dolcezza, l’orgoglio, la necessità, il privilegio d’essere “paesani” (...), Voi non sapete che cosa sia nel borgo selvaggio il mutarsi
del cielo, l’avvicendarsi delle stagioni, l’arrivo o la partenza delle rondini (...),
un temporale, un corteo, un organetto, una carrozza, una nuvola; tutte cose
bellissime che ci fanno ancora impressione».
E l’arte? Bèh, mura ciclopiche, preziosi reperti romani e chiese di ogni
secolo, veri e propri tesori, sono sparsi un po dappertutto a Veroli (anche se è
il medioevo a fare la parte del leone): basta andare a cercarli. Vediamo che cosa
scrive PIETRO SPAGNOLI a tale proposito:
«Veroli, così poggiata sulla sommità di una collina, sembra un gigantesco scrigno. E, come ogni scrigno che si rispetti, esso contiene un tesoro. Un
tesoro fatto di storia, architettura, scienza, arte. Un tesoro fatto di segni prodotti nel corso dei secoli, dalla creatività, dalla tenacia, dalla forza, dalla dignità
di un popolo dalle radici così profonde che ancora oggi è difficile capire da
dove hanno avuto origine.
Un risultato armonico del fare umano e della natura nel corso dei
secoli che costituisce la nostra eredità.
Un patrimonio da imparare a conoscere, conservare ed utilizzare per
aumentare il valore, anzichè consumarlo, perchè in ogni opera che lo compone
è misteriosamente racchiusa un’intera vita, una vita piena di dolore e di dubbi,
di ore di entusiasmo e di luce (...)».
Nella scelta dei brani che presento al lettore, ho avuto al mio fianco
due validissimi collaboratori che, con serietà e competenza, mi hanno dato
una mano, (anzi due). Si chiamano Loredana Stirpe e Antonio Grella. Lei, raffinata e gentile, bene educata e molto preparata, è una esperta di storia dell’arte
e si è vista spesso in televisione, disinvolta e sicura, accanto, per esempio, alle
1
Può capitare al lettore di non vedere sempre nel testo un immediato collegamento tra
i singoli capitoli e una visione più generale della storia. L’autore se ne scusa.
mura ciclopiche della Ciociaria o davanti alla “misteriosa” e famosa lastra dei
“Fasti Verulani”. Lui, simpatico ed ottimista, sempre di buon umore, è il mago
della fotografia, ed è incredibilmente abile nell’uso della telecamera. Riesce a
fare miracoli! Insieme formano una coppia ideale e, ne sono certo, non mi
faranno fare brutta figura.
P.S.
Nel volume che sottopongo al giudizio di chi vorrà leggerlo, vengono
riproposti molti degli argomenti già trattati, ma il tutto è stato sfoltito
e sintetizzato per evitare noiose ed inutili prolissità. Non mancano integrazioni e novità interessanti.
Sperando in giudizi non troppo severi e comprensivi, umilmente mi
congedo.
GIUSEPPE TRULLI
UNA STORIA ANTICA
Da quando era ancora l’alleata di Roma, Veroli ha fatto molta strada,
ma la sua storia la porta ancora sulla propria pelle: si può leggerla sulle pietre,
percorrendo i vicoli, entrando nelle chiese, ascoltando le numerose leggende
sulle sue origini.
In alcuni punti particolari del suo tessuto urbano, le epoche del passato hanno così abbondantemente lasciato reperti, che si ha percezione della
Storia in maniera quasi fisica, nella sua totalità: il romanico convive col ‘700,
indizi paleocristiani fanno da contraltare ai portali gotici, fortificazioni megalitiche affiorano qua e là sotto la trama minuta dell’edilizia medievale.
Tutto appare magicamente confuso, ma tutto è segno tangibile ed attuale, di quello che per Veroli ha rappresentato la Storia.
Tracce delle sue origini pelasgiche sono tuttora evidenti nel lungo tratto di cinta muraria della parte alta del paese, mentre testimonianza del prestigio raggiunto durante il felice periodo di alleanza con Roma sono i celeberrimi
“Fasti Verulani”, il frammento di calendario romano del I secolo dopo Cristo,
concesso a Veroli per premiarne la fedeltà, e visibile ancora oggi in uno degli
ambienti medievali più suggestivi della città: il cortile di casa Reali.
Ed è proprio il medioevo una delle epoche più favorevoli per lo sviluppo di Veroli: borgo S. Croce, borgo S. Paolo, il quartiere che dalla Civerta
scende giù fino a Largo Arenara, la zona di S. Leucio con la Rocca (dove venne
rinchiuso Papa Giovanni XIII) sono splendidi esempi di una situazione storica
e culturale che ha prodotto in urbanistica gioielli ambientali di ineguagliata
fattura.
La storia, così antica per Veroli e così ricca, è spesso confusa, imprecisa, controversa, ma i segni di tutto il tempo che è passato, da quando i primi
Ernici abitarono quello che sembrò loro un “sasso” sicuro ad oggi, ci sono ancora tutti; segni di eventi che altrove avrebbero prodotto i loro effetti sulla vera
Storia, quella grande, quella che porta cambiamenti nel mondo e di cui Veroli
registrava certo un’eco ovattata, stemperata nei fatti quotidiani di una storia
minore, meno emozionante, meno concitata, che a raccontarla somiglia più
all’aneddoto che alla cronaca ma non per questo meno nobile e meno appassionata.
É una storia che spesso non si trova scritta che sul volto degli uomini
che la raccontano oggi, i vecchi, quelli che a loro volta l’hanno ascoltata dai
loro vecchi: una storia a tratti lacunosa, fatta di episodi e curiosità, di belle
imprese e di momenti incerti, una storia che dopo gli ultimi sconvolgimenti
locali del IX secolo, dovuti alle sanguinose devastazioni saracene, registra una
sostanziale tranquillità sociale fino ai periodi più recenti.
Le successive guerre, le carestie, il terremoto del 1350, la peste del
1600, non hanno impedito più di tanto che Veroli percorresse fino in fondo il
proprio progressivo adeguamento ai tempi.
Oggi Veroli è una città bella ed accogliente, sufficientemente lontana
dai frastuoni di quella che un tempo le era alleata, e saggiamente appagata da
questa sua dimensione più modesta, vissuta ai margini di una realtà sempre un
tantino più veloce della sua, ma che proprio in questo ha saputo riporre tutto il
fascino che oggi, con orgoglio, vi invita a conoscere.
MASSIMO TERZINI
Architetto
SOMMARIO
1. IMMAGINI DI CIOCIARIA
1.1
Piccole città murate...
23
1.2
Un popolo armato di solitudine e di silenzio...
24
1.3
Belle spose dalla carnagione bruna...
26
2. “CUORI TRABOCCANTI DI POESIA...”
2.1
Le cantarelle
37
2.2
“Lu panu”
39
2.3
“La spica”
41
2.4
“Vérgli mia”
43
3. “LA TERRA MIA É ANCHE PER TE...”
3.1
Terra nostra
57
3.2
Vecchia Veroli
60
3.3
Veroli: il tessuto urbano
63
3.4
Il borgo di Santa Croce e quello di San Leucio
66
4. VEROLI E ROMA
4.1
Veroli, città ernica
81
4.2
Nello stemma di Veroli i colori di quello di Roma
84
4.3
Via Latina o Via Casilina?
86
4.4
“Camminamento militare segreto” e resti del Tempio di
Roma e Augusto
89
4.5
I “Fasti Verulani”
91
4.6
“A Lucio Alfio”
98
5. SANTA SALOME
5.1
Diffusione del Cristianesimo
109
5.2
Sulle epigrafi di Marturio e Filomena
113
5.3
Gracilia e Salome
115
5.4
Santa Salome
117
5.5
Culto di Santa Salome
121
5.6
Una catena a perenne ricordo
123
5.7
La chiesina della Madonna degli Angeli
125
5.8
Salome, una donna vestita di nero
130
5.9
2007: anno della Ricognizione Canonica
132
6. VEROLI AL CENTRO DELL’EUROPA
6.1
Veroli nel secolo XII e Alessandro III
145
6.2
Alessandro III, Thomas Becket e Veroli
151
6.3
La Rocca di San Leucio
154
6.4
Le chiese
156
7. IL TRIONFO DELLE “HUMANAE LITTERAE”
7.1
Veroli e la scuola umanistica
177
7.2
Giovanni Sulpicio
179
7.3
Giovanni Martello
181
7.4
Giovanni Antonio Campano
183
7.5
Aonio Paleario
185
7.6
Davanti al Tribunale dell’Inquisizione di Roma
188
7.7
L’ultimo giorno del Paleario
192
7.8
Come il futuro Cardinale croato Veranzio tentò di salvare la
7.9
vita al verolano Paleario
195
Campo de’ Fiori: a morte gli eretici
198
8. UN GRANDE CARDINALE
8.1
Il Cardinale Francisco Quiñones e Veroli
207
8.2
Lo Statuto di Veroli
211
8.3
Dallo Statuto di Veroli, alcuni articoli riguardanti gli Ebrei
221
8.4
Il miracolo eucaristico di Veroli
223
9. SEICENTO E SETTECENTO
9.1
Francesca Antonia Leni
235
9.2
Veroli in un manoscritto del settecento
240
9.3
Vittorio Giovardi
242
9.4
A Silvio de’ Cavalieri
248
9.5
Giovanni Trulli senior
250
9.6
A Carlo Maratti (o Maratta)
256
10. MASTRO TITTA, GIOACCHINO BELLI ED ALTRI
10.1
Veroli nella prima metà dell’ottocento
268
10.2
L’ultima esecuzione capitale. Mastro Titta
273
10.3
Il ruolo dei “confortatori” nelle prigioni papaline
275
10.4
“Er confortatore”
277
10.5
Gioacchino Belli a Veroli
278
10.6
Un gioiello di architettura neogotica
284
11. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
11.1
La scintilla
291
11.2
L’intervento dell’Italia
293
11.3
Strafexpedition (spedizione punitiva)
294
11.4
Caporetto
295
11.5
La Vittoria
297
11.6
Una lettera dal fronte
298
11.7
Il Milite Ignoto
300
11.8
La madre di Littoria (Latina)
301
11.9
Testamento spirituale del Duca d’Aosta
305
12. “O TEMPORA!, O MORES”
12.1
Il fascismo e i giovani verolani negli anni ‘30
313
12.2
Veroli, città ideale per gli studenti
316
12.3
Tutti in divisa! (fotografie da un album)
320
12.4
Pagelle
325
13. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
13.1
Cronologia: 1940-1945
335
13.2
Quell’infausto 8 settembre
341
13.3
Cosa avrei fatto io l’8 settembre 1943
344
13.4
“É bastata un’ambulanza!”
346
13.5
Una rondine
347
13.6
Camicia nera
348
14. PERSONE SPECIALI
14.1
Una marchesa: Isabella Campanari
353
14.2
Un vescovo: Mons. Francesco De Filippis
357
14.3
Un podestà: Giuseppe Scaccia Scarafoni
361
14.4
Uno scrittore: Luigi Alonzi (Luigino)
364
14.5
Un professore: Luigi Bisleti
370
14.6
Un arcivescovo: Fabio Bernardo D’Onorio
374
15. ALL’OMBRA DEL MONASTERO BENEDETTINO
15.1
La Beata Suor Maria Fortunata Viti
389
15.2
Il monastero benedettino
391
15.3
Madre Chiara De Felice
395
15.4
Padre Gabriele Locher
401
15.5
Il conte Stanislao De Witten
405
16. TEDESCHI I
16.1
La leggenda del tedesco invasore
421
16.2
Comportamento dei tedeschi a Veroli
425
16.3
Io ricordo...
427
17. TEDESCHI II
17.1
Morire a Veroli
443
17.2
Lili Marleen
448
18. TEDESCHI III
18.1
Il generale Frido Von Senger: un uomo esemplare
461
18.2
A Montecassino
463
18.3
Un piccolo libro per un grande generale
466
18.4
Il cimitero di Häg
469
PER FINIRE
19.1
La processione della Madonna dell’Olivello
479
CRONOLOGIA
487
ELENCO AUTORI
495
CAPITOLO I
Immagini di Ciociaria
Piccole città murate...
23
Un popolo armato di solitudine e di silenzio...
24
Belle spose dalla carnagione bruna...
26
1.1 Piccole città murate...
S
i visitano molto le piccole città della Toscana, dell’Umbria e del nord
dell’antico Stato Romano; si dimenticano invece quelle che sono a
sud di Roma. Pur non avendo la grazia austera e ridente delle prime,
quest’ultime non difettano di ben altre attrattive. Non alludiamo alle
città dei monti Albani: tutti le conoscono o pensano di conoscerle.
Ma più lontano, in quel semicerchio da tracciare presso a poco da Subiaco al
mare, racchiudente i monti Albani, i Lepini, e mettente capo a Terracina, in
quante città e paesi ci si imbatte dove ancor vive l’immagine di un passato pittoresco e raro!
Sovente appaiono testimonianze e ricordi di età molto inoltrate nel
tempo. Di queste piccole città murate, quasi tutte mantengono l’identico aspetto dell’epoca lontanissima in cui Volsci, Ernici ed Equi vi si fortificavano, prima assai che la tenacità romana venisse ad assediarle. Prima di Roma, esse
erano quali ora le vediamo. Dietro l’enorme barriera dei blocchi ciclopici che le
circondano, esse racchiudono, oggi come allora, vecchie piccole case di pietra
grigia o rosata. A sera, sotto le loro porte alte e solenni, oggi come allora, tornano dal pascolo i greggi con grande frastuono di campani e di belati, tornano
i pastori e gli agricoltori. Le porte si chiudono, la città dorme chiusa dai blocchi
che la circondano da tremila anni...
HENRY COCHIN
1. Immagini di Ciociaria Giuseppe Trulli
1911
23
1. Immagini di Ciociaria Giuseppe Trulli
1.2 Un popolo armato di solitudine e di silenzio...
24
È certo il trionfo di Roma che impoverì la vita della Ciociaria: ma è
pure una sorta di aristocratica misantropia, lo stoico dispetto del mondo, di
chi dovette subire e non potè accettare la ferrea legge del più forte. Crollati i
regni degli antichi pelasgi, le mura dei ciclopi rimasero deserte. L’amplesso
della terra le avvince. Esausti gli uomini guardano lungo le pendici sassose i
brevi greggi in pastura. Il silenzio sospeso vince il ruinoso corso degli evi e ha
conservato, oltre il tempo, il dramma della razza.
Un popolo armato di solitudine e di silenzio, cui basta una chiesa per
la solennità della vita, e che vive isolato nei campi, alla vigna, dove l’uomo è
ancora re e governa la sua casa con l’arte immutata dei padri. I saccheggi orrendi, gli imperi fugaci, i signori che hanno dominato via via non sono riusciti
ad impegnare questa gente, da allora unita con un tenace patto di comunanza
solo alla terra. Chi ha tralignato ha dovuto andar via, e ha portato a Roma imperiale e papale il dono prezioso di una forza millenaria ed intatta: sembra la
superba vendetta di un dio decaduto.
Uomini forti, con profondi occhi pensosi, si piegano sulla vanga con
gesti abitudinari di una arte casalinga. Ogni zolla è messa a cultura; anche il
calore, ricoperto di un pugno di terra rossa, che ha riempito le rughe e scola di
ruggine gli scheggioni, alimenta gli uliveti sereni.
Nella vigna è tutta la vita e la storia e la gioia di questo popolo. V’è
l’armonioso disordine della abitazione, l’amorosa corrispondenza di due esseri
che si amano. Pingue, discinta, la vigna accoglie nei solchi il neonato che piange e poi sorride, il vecchio che siede e guarda e pare che pensi.
Qua e là marmitte, la scopa, i panni stesi al sole: ai piedi dell’olmo
i bambini scalzi, in gioco; pei filari trotterella grufolando il porco o ruzza il
cane. Dove c’è una polla o un pozzo, non manca nemmeno l’orto, tra le viti,
coi peperoni, le zucche, i cetrioli, e fra il grano e la polenta è anche l’albero da
frutta.
Così dovette essere l’arte agricola allora, così è rimasta. Le violenze di
una storia più forte si sono spezzate contro questo popolo indomito.
Anche le donne sono in campagna. Scalze, sfiancate di fatica, con la
veste di sei metri di stoffa pieghettata, esse hanno tuttavia gesti essenziali di
statue. Le fanciulle, abbronzate, con le ciocie a pizzo come babbuccie d’odalisca, portano il busto sopra il corpetto, come un’armatura per il seno impetuoso. E nei neri occhi a mandorla hanno lo sguardo fermo della verginità
guerriera. Esse vanno non guardate e senza guardare: i giovani, a fronte, non
interrompono i loro canti quando elle passano. Ma da soli non si può cantare.
Come in un profondo cielo capovolto, tremano, mitiche costellazioni, le lumi-
narie nelle notti di agosto, ed i rimbombi festosi si fan eco di paese in paese;
estivi patroni di raccolti e di piogge, i Santi guardano con gli occhi imbambolati, tra il fumo di ceri, la folla prona, e girano a benedire il paese, traballando
sulle spalle dei portatori. A tratto a tratto, il grido di grazia aspro come una
fucilata. Questa gente terrestre è di una frugalità estrema e chiede umili doni
dal Protettore. Ma talora anch’essi falliscono...
1. Immagini di Ciociaria Giuseppe Trulli
LUIGI VOLPICELLI
25
1. Immagini di Ciociaria Giuseppe Trulli
1.3 Belle spose dalla carnagione bruna...
26
«Se le villane di tutta Italia fossero come queste, (scriveva delle contadine del Lazio meridionale quell’artista e cavaliere di perfetta creanza che fu
Massimo d’Azeglio) il loro nome, di sostantivo ch’ egli è, non si sarebbe mai
mutato in aggettivo».
E io direi che la ruvidezza dell’ambiente pare creata apposta per fare
meglio risaltare il tipo di delicata bellezza che offrono per molti esempi queste
altiere villane. Aspri paesi messi tutti per salita in cima ai monti, neri d’intemperie e di fumo e d’ogni feccia e rancidume di raccolta e di concio, uomini
bruciati dal sole, pelosi e accigliati come briganti; bestie da soma riottose, spelacchiate, irsuti caproni che sbucano con visi di demonio fuori di stregoneschi
abituri senz’aria e senza luce: e poi vedete scendervi incontro una di queste belle spose dalla carnagione d’un color bruno pallidissimo, quasi trasparente, dai
volti di madonna incornicati di capelli neri largamente ondulati, dagli occhi
grigioscuri, ora languidi e poi d’un subito stralucenti nel sorriso, dalle spalle
delineate con ogni morbidezza, dalle mani pulite e ben formate...
Il ricordo delle ciociare in costume, che a Roma offrivano violette al
forestiero su per la scalinata di piazza di Spagna ed altri luoghi raccomandati,
può soccorrervi fino a un certo punto. La ciociara, come altre buone «specialità» di queste parti, va mangiata sul posto, e quella della scalinata era già una
leziosa figura di commedia accomodata per gli acquarellisti di via Margutta.
Una ciociara di razza, che si rispetti, ne vuole tempo prima che arrivi
a porgerti un fiore! D’altro canto, non so nelle campagne, ma è certo che nei
maggiori abitati di Ciociaria (il ciociaro pronuncia: Ciocerìa) le ciòce e l’altre
parti di quella mascherata di piazza di Spagna oggi come oggi non si vedon
più che al piede e indosso di qualche vecchia; e la domenica le ragazzine già
abituano il piede, per questi ronchìosi lastricati, a calze e scarpette bianche.
Ora non v’aspettate di vedermi piangere sulla scomparsa delle ciòce.
Resta, bene in piedi, la ciociara. Anzi vorrei dire che l’armadura della ciòcia toglieva d’apprezzare al giusto merito una delle parti che maggiormente temono
il confronto della perfezione: dico il «fucile» e la polpa delle gambe, che pianella e scarpette mettono invece nel dovuto rilievo. E quanto a questo, evviva
la faccia dei paesi fabbricati in salita! Quel continuo esercizio del salire e dello
scendere, mentre sviluppa i muscoli della gamba, gli adusa alla prontezza dello
scatto e conferisce alla persona un’andatura piena di slancio che, una volta poi
trovato il piano, ritiene qualche cosa della danza.
Altra grazia particolarissima aggiunge all’andatura di queste donne
l’uso di portar dei pesi, anche ingenti, in bilico sul capo e sempre poggiando e
scendendo per queste selciate alla malandrina, come ceste ricolme di biancheria, mastelli di granaglie e, avanti e indietro dalla fontana, conche di rame per
l’acqua. Eretta ed immota la testa incercinata sotto il peso, le ciglia abbassate
per vedere dove mette il piede, ti par di vedere la statua camminante della Modestia; ma col mutar del passo le spalle fanno un movimento come se il busto
accennasse dolcemente a svitarsi, che si propaga più risentito alle anche dove
l’accentua lo sdondolìo della gonna a cannelloni: ed ecco che quasi ti comincia
a parer Salomè nel primo ingresso della danza...
ANTONIO BALDINI
1. Immagini di Ciociaria Giuseppe Trulli
1925
27
Veroli
Una torre delle mura medioevali di San Leucio
Ferentino
Avancorpo dell’Acropoli
Anagni
Sostruzioni con “Opus Reticulatum”
Alatri
Acropoli - Porta Maggiore
Arpino
Acropoli di Civita Vecchia - porta ad ogiva
“Busto di Ciociara”
Scuola francese - olio su tela, diam. cm. 51
CAPITOLO II
“cuori traboccanti di poesia...”
Le cantarelle
37
“Lu panu”
39
“La spica”
41
“Vergli mia”
43
2.1 Le cantarelle
Èkke la palma a chi vo’ fa’ la pace...
È il saluto mattinale, il primo, simboleggiato dalla umile pianta che in
questa terra grigia di desolazione più affonda le radici per suggere, ovunque
sia un’ombra di humus, gli alimenti del suolo, e quella che più si avvicina agli
uomini che la coltivano. Perciò nei canti della Resurrezione non è possibile
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
D
omenica degli Ulivi. All’orizzonte nuvolette orlate di riverberazioni solari. Si pensa, osservandole, ai pittori di un tempo, che
ne rubavano per i loro idilli, e v’assidevano dèe in atteggiamenti
molli, e frotte di amorini, avidi di piacere come pecchie al fiore.
Nei cantucci riposati degli orti, steso sulle spazzature, il gatto
attende che la lucertola sbuchi tra i ciuffi delle parietarie, sotto le coltri delle
edere, tra i fustelli del rosmarino. Sulle ortiche lavate dalle piogge d’aprile il
sole sboccia i succiamele cerulei e vi sciama api e farfalle.
A valle, lungo le prode dei fossi, le lavandaie sciorinano le biancherie;
e nei viali, fuori del sobborgo, la pelurie delle fioriture stende tappeti verdescuro a piè degli alberi. Sotto il sole d’aprile la vena dei torrenti scivola limpida e
canora, e i ciottoli del fondo, a mezzogiorno, vi palpiteranno come i fiori del
prato.
Nelle pievi dei villaggi i contadini hanno avuto stamane il dono dell’ulivo benedetto, e ora salgono in paese, sgargianti, con le robe d’occasione: le
donne in vesti piegose, collane di corallo con perle grandi come noci e orecchini che scendono sino a toccar le spalle. Sul capo, fazzoletti multicolori che
a guardarli dall’alto, di sulla piazza affollata, danno idea di un giardino semovente. La baldanza morata della gioventù s’è fatta più ardita piumando a nuovo
i feltri induriti dal maltempo; ma i vecchi sveltiscono anch’essi nelle brache a
metà gamba, strette, con lo spaccato filettato di bottoni, e nel corpetto di velluto.
Giorno di festa e di novità. Tra il brusìo della folla assiepata attorno
alla cattedrale si levano voci d’argento. Con gli adulti della campagna son venute le «cantarelle» a recare la buona novella in un serto di canti rusticani. Sono creature dagli otto ai dodici anni: vanno a coppie e vengono da
luoghi diversi: da Santa Francesca e dalla Vittoria, dal Giglio e dalle Prata. Portano il paniere per le offerte, e un bastoncello, addobbato a modo di conocchia,
con su legate le divozioni: nastri scarlatti, gialli, bianchi, rosari e crocifissi. Un
panno candido lo avvolge quando camminano o tacciono; ma se si desidera
udirle, e s’accenna, slegano e svolgono delicatamente l’oggetto, pongono i capi
inchinati l’uno contro l’altro al di sotto di esso, e cantano entrambe:
37
dimenticarla. Essa medesima è un insegnamento, essa ch’ è cibo e luce. Se ha
chinato la fronte alle nevi e al sole estivo, se alla furia dei venti ha mostrato
l’argento nascosto della sua chioma, se la tenacità ha soggiogato le asperità del
terreno — e nulla ha chiesto per sé e tutto ha dato — quale simbolo più certo
per gli uomini in cerca di pace?
E intorno al saluto dell’Ulivo tanti quadretti di vita religiosa quanti
ne può cavare la fantasia popolare dalla testimonianza evangelica, rilevati con
pochi tratti che riescono tuttavia a evitare quel senso d’asciuttezza e di stilizzato
che in altri luoghi, quasi sempre, vi s’accompagna. La grazia e la delicatezza
ch’ è in essi fa invece pensare che, come sono bambine e fanciulle quelle che li
cantano, debbono essere medesimamente donne le ignote creatrici:
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
Ke bella è la Madonna quanne lava:
lava gli panni de Nostro Signore.
Ke bella è kella prèta a do’ gli sbatte:
se ce faceano bianchi senza sapone.
Ke bellu è kellu prato a do’ gli spanne:
ce diventéano tutti quanti fiùri.
E san Giuseppe ce gli ripieghéva,
e a ‘na cassuccia d’oro gli metteva,
co’ ‘na chiavuccia d’oro gli ‘nzerreva...
38
Sì oggi i beati del paradiso scendono in terra per vivere la vita dura di
tutti i giorni, per reggere il braccio agli uomini che si travagliano nel lavoro, per
bendare le piaghe dei mortali. E il manto della Vergine è davvero la speranza
azzurra, simile alla cosa più bella — e forse solamente bella — della terra ciociara: il cielo. Oggi l’idillio dell’infanzia di Cristo rivive in cuori traboccanti di
poesia, poesia tessuta coi fili più ricchi di colore, d’innocenza, d’intimità. E il
canto che l’accompagna è una vena di dolce malinconia, che s’arresta improvvisa, contempla, per rompere in un grido di gioia e poi morire sospirando:
Èkke la palma a chi vo’ fa’ la pace:
ohi, la pace...
LUIGI ALONZI
2.2
“Lu panu”
Nelle due poesie che seguono, di Attilio Cestra, c’è una immediatezza espressiva straordinaria, per cui chi le legge ha la sensazione di vivere le scene che
l’autore descrive, partecipando ad esse. Ne Lu panu c’è la stupenda realtà dei
tempi andati, quando il pane, dal profumo inebriante, era il meraviglioso frutto di una promessa d’amore e di fedeltà dell’uomo alla terra, destinate a durare
tutta la vita: era il segno della benedizione di Dio che, premiandolo per la sua
fatica, gli donava serenità e pace. Ne La spica, nessuno meglio del poeta, che io
sappia, è riuscito a dare tanta voglia di nascere a... un chicco di grano, per molti versi simile ad un bambino che, nel ventre della madre, spinge impaziente
mani e piedi, quasi per affrettare il suo incontro con la luce e la vita. Solo una
vera concezione religiosa della vita ed un incondizionato amore per la natura,
oltre che una consumata esperienza poetica, potevano dare all’autore risultati
tanto lusinghieri.
Mangiate, mangiate, figlioli. Mangiate questo pane, questo pane che odora. È
fresco, sfornato da un’ora. È di papa questo pane! Ha seminato per voi il grano
e, quanto ha sudato per spingere i buoi davanti all’aratro! Lo ha seminato e ricoperto, lo ha concimato e sarchiato. Lo ha visto crescere e spigare. Ha soppesato la
spiga e, per la contentezza, (ha esclamato): «Gesù, possa essere lodato, onorato
e ringraziato per l’acqua che hai mandato, per il sole che l’ha maturato, per la
mietitura asciutta e per la raccolta tutta. E così sia».
LU PANU
Magnate, magnate, figliùcci,
magnate ‘stu pànu,
‘stu pànu ch’addora
— è friscu, sfurnàtu da ‘n’ ora,
è d’ tata ‘stu pànu — !
È mìssu p’ vùi lu grànu
i quanta sudoru è ittàtu
tucchènne gli vovi all’ aràtu!
L’ è sumentàtu i rabbelàtu,
stagghiàtu i sappeliàtu,
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
GIUSEPPE TRULLI
39
l’ è visto d’ crésci
i doppe spicàtu
la spica ha pesigliàtu
i p’ la cuntentezza:
— Giasù pezz’ èsse’ laudàtu
‘nuràtu i rengrazziàtu
p’ l’acqua ch’ è mannàtu
p’ lu sòlu eh’ l’ è maturatu,
p’ la metènza assutta
i la raccòta tutta
i accussì sia —!
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
ATTILIO CESTRA
40
2.3
“La spica”
II vento portava via, una per una, le foglie delle querce, e l’acqua, a catinelle, si
raccoglieva nei rivoli. Dormiva al calduccio, sotto terra, un chicco di grano e, tra
un sonno e l’altro, dormendo, sognava la primavera... Allungava verso l’alto le
braccine e spingeva in basso le gambette. Venne la neve e ci furono le gelate. Le
notti si allungarono e poi si accorciarono. La neve e le gelate si sciolsero e il chicco
di grano, spingendo sopra senza stancarsi, mise fuori una fogliolina sola, esile,
meravigliata, vergognosa. La colorò il sole e, dandosi coraggio, crebbe nel fusto,
tanto, fino a maggio. Da verde che era, scolorì e giugno mise l’oro ai chicchi. Non
era più il tempo dell’acqua a catinelle, delle foglie cadute e del vento; ma, per ogni
spiga, chicchi a cento a cento.
Lu vèntu s’ purteva una a una
l’ fronne d’ cérci
i l’acqua a catenelle
s’araccuglieva p’ le sciacquatore!
Durmeva a lu callùcciu sotto tèra
lu vachìllu d’ grànu
i tra nu sonnu i l’àtru,
durmenne, s’ sunnéva primavera...
i allunchéva alla ‘ncìma l’ vraccelle
i fulléva p’ sotte l’ sampétte.
Cadì la nevi i fùrene gilàte,
gli notti s’alluncàrne
i po’ s’ ci accurtàrne,
la nevi i la gilàta
s’ squagliarne
i lu vàcu d’ grànu,
fullènne sopre senza truvà’ pòsa,
la metti fore ‘na frunnélla sola,
lìsema, sbauttìta, bbrevugnosa.
La culurà lu solu i dènnese curàggiu
criscì d’ fustu tantu, fìnu a maggiu.
D’ verde ch’era s’ ci sculurà,
giugnu ci metti l’òru a le casèlle.
Nenn’ era chiù lu tèmpu dell’acqua a catenelle,
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
LA SPICA
41
delle fronne cadute, d’ lu ventù;
ma p’ ‘gni spica, vaca centu a centù!
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
ATTILIO CESTRA
42
Dopo la mietitura, a Pasqua, gruppi di contadini offrivano come dono alla Protettrice S. Salome,
grandi mazzi di gregne (covoni) di grano ornate con fiori di campo.
“Vérgli mia”
E una delle più belle poesie scritte in dialetto verolano dall’indimenticabile Prof. Mario Mezzacapo.
Il poeta è costretto a vivere molto tempo lontano da Veroli, perciò,
ogni tanto, si lascia malinconicamente cullare dai suoi ricordi più cari. Come
dimenticare i colori smaglianti di cui splendidamente si vestono, a primavera, i
prati e le montagne verolane, il profumo intenso delle ginestre e del rosmarino,
il canto del cuculo a S. Leucio! Come dimenticare i nidi delle civette in mezzo
al groviglio dei tronchi secchi degli olivi alla Civerta, il volo gioioso dell’allodola nel cielo; i gridi dei ragazzi che giuocano «a verde»... !
Il dolore e l’angoscia si impossessano di Lui, quando gli tornano in
mente i propri cari e quelli che, «in fretta», sono andati a dormire tra i cipressi
del cimitero verolano. Poi Egli si distende e, da Maestro quale è, disegna simpatiche ed efficaci scenette, che si identificano in pieno con l’atmosfera paesana: Domenica che si affaccia alla finestra; Agnese che rammenda le calze;
Ambrogio che impaglia una sedia; il compare Filippo che va a tagliare il fieno;
le donne, curiose, che ascoltano dietro i portoni. Che dire di quell’inebriante
odore di ciambelle, calde e fragranti, appena uscite dai forni a Santa Croce!
Il senso del tempo che passa e lo struggente desiderio di rivedere il
proprio paese tornano, infine, a impadronirsi dei suoi pensieri. E il poeta conclude: «Veregli mia, pecchì te sta luntano, ca scito è frustiero, tutte ste còse nze
le pò scurdà».
Sicuro che sarebbe piaciuto anche al Prof. Mezzacapo, dedico « Veregli
mia» a tutti i Verolani residenti all’estero e, in particolare, agli amici di Toronto
che, mai, hanno dimenticato la loro terra di origine.
GIUSEPPE TRULLI
Addì Vergli mia
ndó a mmonte a Ssanto Loce
lu cuculo se spirda de cantà
i nze stracca mmà;
ndó, quanno vè abbrilu,
l’ èreve e gli fiuri
stennene mandi de culuri,
depegnene prata i muntagne:
miraculi d’oro i orgento
ca mmidia fao allu firmamentu.
Addio, Veroli mia
dove su a San Leucio
il cuculo si strugge di cantare
e non si stanca mai;
dove, quando viene aprile,
l’erbe e i fiori
stendono manti di colori,
(e) dipingono prati e montagne:
miracoli d’oro e argento
che fanno invidia al firmamento.
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
2.4
43
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
44
Vergli mia...
ndó a mmonte alla Ciovèrta,
mése alle prete
antiche de mill’agni e fforse cchiù, o
drentro all’arragrùglio degli trunchi
sicchi de gliva,
l’agnìti le ciuvette fao.
Addì Vérgli mia,
ndó la notela ‘n celu,
vulenne cuntenta,
nze accorje dellu sperchiu
nfame dellu cacciatore.
Addoro de ginestra e cresmarino,
cridi de riazzi
ca giocane a vverde…
Agni cosa è pulisia
Ca recrea lo coru.
Maro sulenzia i amicu,
mese alle sebulludure
i a gli pricèssi
dellu cimmiteru,
fai megnì ‘ngustie
i recurdà duluri
pe cchigli ca primma s’ao partuti
o de prescia se n’ao iti.
Dumegneca s’affatta alla finestra
I ccanta,
Gnese rennàccia le casette
I Mbrosio ‘na seggia ‘mpaglia;
ntraménte lu cumpà Felippo,
cu lu surìcchio, va a taglià lu fenu.
I addoro sénti de ciammelle
appena scite dagli furni,
abballe a Ssanta Croce,
ndò le femmene, drete a gli purtuni,
stao sempre a addoselà.
Sòna abballe alla piazza
Lu reloggio…
Score lu tempo…
Ma pecchì te ne sta luntano,
ca scito è frustiero
e l’agliema tè drente de pueta,
Veroli mia...
dove su alla Civerta,
in mezzo alle pietre
antiche di mille anni e forse più,
dentro al groviglio dei tronchi
secchi degli olivi,
le civette fanno i nidi.
Addio Veroli mia,
dove l’allodola in cielo,
volando contenta,
non si accorge dello specchio
infame del cacciatore.
Odore di ginestra e rosmarino,
grida di ragazzi
che giocano a verde…
Ogni cosa è pulizia
Che ristora il cuore.
Amaro silenzio e amico,
in mezzo alle sepolture
e ai cipressi
del cimitero,
fai venire angoscie
e ricordare il dolore
per quelli che sono partiti prima
o se ne sono andati in fretta.
Domenica s’affaccia alla finestra e
canta,
Agnese rammenda le calze
e Ambrogio impaglia una sedia;
mentre il compare Filippo
con il falcetto, va a tagliare il fieno.
E senti odore di ciambelle,
appena uscite dai forni,
giù a Santa Croce, dove le donne,
dietro i portoni,
stanno sempre ad ascoltare.
Suona giù in piazza
l’orologio…
Scorre il tempo…
Ma per chi sta lontano,
perché è dovuto andar via
e tiene dentro l’anima di poeta,
Vergli mia, tutte ste còse Veroli mia, tutte queste cose
Nze le pò scurdà non le può scordare.
(...) «Mario Mezzacapo era ed è una parte della nostra città, parte viva, sensibile, capace di fare rivivere aspetti ignorati o dimenticati, strettamente connessa
con i vicoli e con gli archi, con le porte, con le fontane, con i paesaggi, con il
sole e con la pioggia di questa città, di questa terra che ha amato con un amore
che direi disperato e malinconico, ma che gli ha restituito, in cambio, una
forza enorme, la forza della sua poesia. Mario Mezzacapo, infatti, era ed è un
poeta, non solo perché ha scritto poesie, ma perché ogni sua opera pittorica è
carica di poesia. (...) Le case di Mezzacapo, le sue strade, le sue figure, i suoi paesaggi, hanno la poesia di un mondo che è insieme antico e moderno; che può
essere ancora un’oasi, un correttivo alla cultura industrializzata e falsamente
intellettualistica di cui si fregiano i grandi centri. (...) Mezzacapo, anche se
operava in una metropoli, riuscì a non dimenticare la sua antichissima terra di
origine, la semplicità di un mondo che non può scomparire. Per lui semplicità
era anche chiarezza nell’equilibrio, ricerca di valori eterni, dialogo continuo
con se stesso. (...) Mario ha conservato la tristezza del fanciullo che guarda,
ammira, scopre e vive in armonia con il mondo che l’ha visto crescere e farsi
uomo; ed è, io credo, proprio questa la lezione più profonda e più vera che egli
ha impartito ai suoi concittadini e non solo a loro».
MARIO BUSSAGLI
2. “Cuori traboccanti di poesia...” Giuseppe Trulli
MARIO MEZZACAPO
45
disegno di Giorgio Carapelli
“La spica”
Un campo di grano nella frazione di Santa Francesca - Veroli
La “Ciammella” verolana
L’impagliatrice di sedie Maria Mastracci
Borgo Santa Croce - Veroli
L’artista del rame Franco Passeri nella bottega del papà Luigi
Borgo Santa Croce - Veroli
Il maestro dell’Arte fabbrile Giovanni Zeppieri
Borgo Santa Croce - Veroli
CAPITOLO III
“La terra mia è anche per te...”
Terra nostra
57
Vecchia Veroli
60
Veroli: il tessuto urbano
63
Il borgo di Santa Croce e quello di San Leucio
66
Riposo i miei occhi
sui tetti di Veroli.
Nei vicoli accesi
il tempo è signore.
Le pietre nel vento
sussurrano fiere
di santi e mestieri.
Memorie e misteri
mi accolgono attenta.
Il suono è del fuoco,
il calore è potente,
apre i sensi,
va al cuore.
Ascolto i racconti.
I ritorni alla vita.
ORNELLA RICCA
3.1
Terra nostra
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
S
e nel tuo cuore c’è un posto per le umili cose, se la contemplazione
di tutto ciò che è trito o semplicemente modesto prende l’animo tuo,
se la vita buona dei campi ha un solco visibile nella maggese dei tuoi
rimpianti, la terra mia è anche per te: se vuoi amarla la conoscerai.
La terra mia è ruvida e sola come la galla nascosta sotto la fronda del
cerro: chi la colse e l’osservò e la tenne per bella, quegli la comprese.
La terra mia è ancora come la fonte che ebbe la prima goccia dal grembo della montagna: chi bevve la sua purezza in un giorno di solitudine avvicinò il suo cuore al mistero delle cose.
La terra mia amò il tabernacolo che il pastore costrusse fra il verde più
prossimo al cielo, e l’ebbe per suo conforto: chi tenne l’occhio affisato sulla parete del fondo, e sulla tavola rosa scoprì un volto che sognava l’azzurro, quegli
comprese la terra e gli uomini suoi, le sue memorie lontane, la voce degli anni
sepolti.
Ama le piccole cose e conoscerai la mia terra; ama le cose più povere,
le timide e inutili, ma non dimenticare la loro gaiezza: se non la vedi scoprila
nel loro profondo. Ama la falce di luna che sfiora la vetta del pioppo, il braccio
di fiume dove si specchia tremando il pagliaio che addita la casa, il somiero che
va alla montagna nell’ora più buia, quando i grilli non cantano più; ama l’aia
deserta, la giornata ventosa, la nebbia che sale dal basso nei giorni di pioggia, il
sereno che appare bordato di nuvole bianche sotto la quercia dopo la tempesta,
la margherita che nasce sul poggio in un giorno di sole invernale, le mille péste
della gallina nel recinto fangoso, a febbraio; e il viso di mela renetta, rosato, del
bimbo moccioso, che trema sulla strada deserta e non si muove, mentre fischia
la tramontana e turbinano le foglie risecche.
Nella mia terra le glorie non vollero segni di fasto per l’occhio degli
uomini: sempre e ovunque esse furono doni, e le memorie dei doni si affidano
al cuore. Se talvolta amarono il ricordo nei secoli, scelsero l’umile, il simbolo,
la leggenda dorata. Sulla soglia dello speco monastico, nostro, il dolce Santo di
una terra sorella, con angelica mano, innestò la rosa che odora sullo spino che
aveva franto le carni di un giovane Santo lontano. E il segno di un avvenimento
sì grande fu soltanto in un cespo di fiori, in un cespo di rovi e di rose vermiglie.
Nella mia terra gli uomini di ieri vissero come quelli che tu vedi adesso. Un solo pegno di amore ebbero in cuore: la casa; anche lontani l’amarono, e
la più bella fu sempre la loro. Legati al suolo da un’amicizia profonda, sul volto
dell’uno e degli altri visse la stessa semplicità. Se tu li osservi dormire nelle ore
lunghe dei mesi assolati, al fresco che danno le siepi o gli alberi verdi, tu li vedi
abbracciati alle cose, come ai figli, come alla donna della loro vita.
57
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
58
Nella mia terra la gente dei campi non conobbe povertà, perché fu
sempre povera. Amò il poco e lo credette ricchezza, e tuttavia non si ingannò.
In una antica città, cuore di nostra vita passata, il Santo dei monti e del piano,
degli uccelli e dei fiori, lasciò il suo mantello lacero e puro agli uomini che gli
baciarono il piede: e solo nostro fu l’unico dono della Regina signora di nulla.
Il suolo della mia terra è duro e difficile: dove tu volgi l’occhio il sasso affiora
con la tristezza della sua lichenata vecchiaia; il pendio scende ripido e sente
dello strapiombo; la piana è bella ma scarsa. Domina la montagna: e per l’inganno veste di azzurro anche quando ti è prossima. Perciò ogni campo che ci
appartiene è un’opera d’arte, edificata dalla mano callosa, solco per solco, di
innumerevoli generazioni.
Vita dura, difficile come la zolla. Ma per gli uomini della mia terra il
lavoro, nell’intimità, ha una luce che permea e illumina la durezza della sua
funzione, romana e biblica nel contempo. Armato di solitudine e di silenzio,
re della casa e custode geloso dell’arte immutata dei padri, l’uomo nostro gitta
senza posa sul dolore del vivere le scintille del suo faticato conforto; e mai
togliendo lo sguardo dal solco, che nel giro delle stagioni scompare e ritorna,
lascia che tutta la vita, la storia e la gloria, sua e della sua gente, si conchiuda
sul campo.
Se nell’animo tuo le cose povere e oscure si riflettono belle, se la campagna dove è signore l’ulivo ha per te un sorriso domestico, io t’insegnerò la
mia terra e il suo volto, la via che conduce dove il cuore suo è nascosto, la gola
fresca delle sue canzoni.
Bella è la fontana nostra, la fontana povera che l’estate rasciuga. A sole
pieno, l’acqua che stenta sul terreno accaldato è quasi mota. Vive appena, avvilita dalle vespe che la coprono di ronzii e dalle bestie che la calpestano. E
pure basta una notte di pioggia vigorosa perché al mattino tu la ritrovi tutto un
tesoro di luce liquida, tutta una voce di canto spiegato, gonfio, in letizia. Oh,
come ballano allora le piccole foglie dei pioppi all’aria rinnovata; e come bello
il cielo lavato che ti mostrano. Quanta frescura! Cade una foglia, e la corrente
va: dolce è il cammino in grembo alla fontana. Sul ciottolo tondo che emerge
la formica prigioniera cerca invano uno scampo; ogni fiocco di limo che si
alza dal fondo sfuma appena e scompare. E la fontana povera per un giorno è
signora.
E bello è il casolare, di nostra terra umile officina. Anche quando domina sul poggio, a pie della quercia che maternamente l’ombra, e a fronte all’aia
che sfiora la maggese (un piatto colmo se l’estate è colma!) vive con compostezza, sposo di poco, lieto del muglio dei bovi, che conforta.
E bello tanto è il sentiero di montagna, sentiero arido e solo, stretto da
fratte basse e da muricce grige, sentiero sparso di ciottoli, sentiero povero povero. A mezzodì, quando il solleone lo brucia, e il ramarro fruscia tra gli spini,
LUIGI ALONZI
Terra nostra in Graziani e la sua terra, Milano, 1937
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
soffre in silenzio: col somarello che passa, carico di legna, e il vecchio curvo e
sudato che lo segue.
Bello è il vicolo nostro, nelle notti brevi della città sopita. Vicolo stretto, vicolo buio, vicolo dove l’immagine custode può dir tutta la rassegnata mestizia. Ogni finestra chiusa è un occhio che dorme, ogni uscio serrato un cuore
in pace, ogni balconcino fiorito un sogno che attende l’alba. A notte fonda, il
vicolo ciociaro dorme il sonno dei buoni: i giorni del passato hanno i ricordi
più belli, ma nessun domani gli è triste. Una luce rossa vi dondola, un alito
fresco vi scorre, un cielo sereno e stellato vi s’apre, su in alto.
E bello è il mattino di maggio, quando la processione gira il paese e si
benedicono i campi. In cielo rondini e allodole, in terra piane di verde, campi
di lino ceruleo, canti sereni di stornellatrici: la natura, in quel giorno, è un salmo di beatitudine. Ogni fumo di frasca ha l’odore dell’incenso, ogni voce è una
preghiera; ogni cascinale un turibolo acceso. Entro il circolo delle montagne la
festa antica ritorna, e come nei tempi che furono l’uomo più vicino al sacerdote
è il seminatore.
Fresca benedizione della terra e del pane, quella del mattino di maggio. Ma mentre i doni si attendono, l’unica promessa è nella santificazione del
lavoro. Forse i colori della gaiezza sotto il sole di luglio non avranno i frutti
che il tempo lieto già annunzia; forse, dall’olmo, la cicala non canterà su di una
estate abbondante. Ma nella madia, che nacque dal legno duro della montagna,
il poco pane sarà più buono; e nell’orcio prezioso, liscio di unto e di vecchiezza,
l’olio che non trabocca avrà il colore dell’oro.
59
3.2
Vecchia Veroli
Così la vita verolana, sempre medioevale,
per non dire arcaica, sonnecchia lenta tra
le vie tortuose e i vicoli perduti nell’ombra,
queta, senza affanno, riposante sino alla noia.
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
GIULIO ALONZI
60
A ritornarci dopo lunghi intervalli di tempo, Veroli appare sempre più incanutita. È il colore ambiguo di ciò che si deteriora a dare questa impressione
quasi dolorosa, e il colore cinereo degli hernica saxa che domina ovunque il
paesaggio alto: ciò che si sgretola e nessuno ripristina, o che viene aggiustato,
ma alla buona e senza ricomporre.
D’inverno questa apparenza è più cruda, perché manca il verde dei
boschi montani, dei campi a grano e a trifoglio, dei giardini, dei viali; fin delle
erbe che allignano sulle muraglie. (Nella bella stagione — si sa — il verde nasconde, adorna, rallegra e dà riposo agli occhi). L’inverno a Veroli è più triste
che altrove.
Alla calata dei tordi o alla svinatura l’orizzonte è ancora di un’ampiezza
estrema, l’aria limpida, il cielo più luce che colore. E i venti, al mattino, sfiorano appena la zona dei Colli. Ma quando sulle distese brulle o rosseggianti
della valle cominciano a disegnarsi banchi di nebbia, o sul crinale dei Lepini
le prime nuvole grige, allora è il momento. Ho visto il paese incurvarsi sotto le
piogge del novembre e rialzar la schiena a maggio fatto.
Eppure questa città antica e vecchia, snodata, quasi in bilico su uno
sperone di monte che è arido dove lo coltivano e pittoresco e ardito dove precipita in dirupi, interessa e attrae. Perché questa sopravvivenza urbana sopra un
monte che sembra al termine del mondo? E chi l’abita? Come ci si vive?
Rispondere vuol dire tornare indietro di secoli, immaginando che tra
quelle mura forse tre volte millenarie, sotto la guardia delle torri medioevali,
dietro le porte anguste, la vita si sia fermata ai lontani tempi quasi per testimoniare di quanto allora fosse, per tutti, semplice e quieta. Dentro le mura sta chi
governa la città e il contado, e chi lavora per l’una e per l’altro; fuori la gente dei
campi, raccolta nelle ville, nei pagi e nei casali, che sale al mercato, il martedì,
per scambiarvi i prodotti del suolo con quelli dei mastri artigiani.
Ma le scese precipitose delle sue stradette, le antiche case che vi si affiancano, l’azzurro che le chiude come un velo alto di luce e di silenzio dicono
spesso a chi ha frequentato i banchi di scuola storie di vita spenta e lontana.
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
Ora sono i ruderi della casa materna di Aonio Paleario, con un fico spoglio là
dov’era il focolare; ora l’atrio di Sant’Erasmo, la bella chiesa romano-lombarda
del decimosecondo secolo, sotto le cui volte sfilarono cortei papali e imperiali
tra il devoto stupore di tessitori e bifolchi; ora il portale duecentesco di Santa
Maria dei Franconi, con l’arco a lunetta cieca, solidissimo, e la breve piazzetta
dove la gioiosa arguzia di Bernardino degli Albizzeschi risollevò il cuore di un
popolo laborioso, percosso più volte dalla peste e dal terremoto. Forse per questo sotto il giglio e le bifore, accanto alla pietra a vista del palazzo trecentesco,
i sediari di Santa Croce seguitano ancora a intrecciare il falasco.
Il progresso, la modernità non hanno fatto irruzione in Veroli prepotenti e fragorosi come altrove: sembrano fermarsi al limitare dell’abitato (tese al
nuovo, e visibilmente, sono invece le campagne), quasi che le mura pelasgiche
e la gran torre avvolta dall’edera, dominanti l’ingresso maggiore, l’abbiano protetta da ogni profanazione. Direi che i frammenti significativi, le testimonianze più evidenti di un suo indiscutibile passato, amino ritrarsi, rinchiudersi,
pudicamente occultarsi di là da cancelli in ferro battuto, ornati di simbologie
cristiane, di là da porte settecentesche polverose e massicce: tali il Tesoro sacro
della Cattedrale, tali i codici miniati, le pergamene, gli incunabuli della Giovardiana.
È vero: distrutto dalla guerra il palazzotto feudale che quasi sbarrava
l’accesso alla piazza principale, si è giustificata l’apertura di una nuova strada
verso il centro, sede del Municipio e del mercato; ma non si è fatto, così, niente
che sia molto meno scomodo della vecchia, che pure saliva al Castello e alla
civica Biblioteca tra caseggiati non indegni e scorci suggestivi, tra il magnifico portale cinquecentesco di Palazzo Quadrozzi, opera del Vignola, e una
sequenza di balconcini di stile gotico. E lo sventramento che ora si vede, fino a
quando non avrà un aspetto proprio — e chissà quando lo avrà, — fa pensare
ai guasti di un terremoto o ad altro dovuto alla guerra, tanto manca di ogni
motivo urbanistico, di una linea che non sia di ripiego.
Così la vita verolana, sempre medioevale per non dire arcaica, sonnecchia lenta tra le vie tortuose e i vicoli perduti nell’ombra, queta, senza affanno, riposante sino alla noia per chi vorrebbe trovare più ampio respiro e lavoro fuori di
quel mondo angusto; al quale, poi, molti ritornano stanchi e forse disillusi, ma
col conforto e la guida di una esperienza che non inganna.
Ma se salite alla Rocca e non vi fermate a compiangere la sorte di quel
baluardo che cade a pezzi, forse perché sin lassù non arrivano gli occhi della
Sovrintendenza, vi trovate dinanzi a un panorama veramente superbo e suggestivo. Un panorama che ricongiunge il cielo tirrenico a quello adriatico; le valli
del Sacco, del Liri e del Garigliano; l’ Appennino della Mèta con la Fragàra e
i Colli latini; la terra sannita con la volsca e l’ernica; abbazie benedettine e cistercensi; Arpino e Alatri, Frosinone e Anagni; e monumenti e vie secolari e
61
tanta storia dimenticata, affossata dalle miserie dei nostri tempi.
Questa è Veroli. Un millenario eremo sul quale sorge il sole prima
che altrove, con orizzonti e cieli che nessun pittore ha sinora messo su tela; e
tramonti splendidi come aurore boreali; con il suo silenzio che domina i sensi,
acquieta lo spirito e rende i pensieri limpidi come quelli dei poeti e dei santi.
Solo che i verolani sapessero togliere alla loro terra quella canizie — e
non vorrebbe troppo impegno — il loro eremo diverrebbe uno splendido rifugio di vita serena per il ristoro di chi, fortunato, può e sa godersela in pace.
GIULIO ALONZI
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
Vecchia Veroli
a cura dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone
per il trentennale della Provincia 1927-1957
62
Veroli: il tessuto urbano
Comune in provincia di Frosinone, situato su una delle ultime propaggini sud dei monti Ernici, di cui occupa uno sprone di calcare cretaceo,
compreso tra le valli del torrente Amaseno a est e del fiume Cosa ad ovest. La
città, compresa tra i 570 e 671 metri s.l.m., contava 13.000 abitanti all’inizio
dell’Ottocento, saliti a 18.188 nel 1951 e ridotti a 16.653 nel 1971.
La felice conformazione geologica del sito, naturalmente fortificato sul
lato sud-ovest da una parete verticale rocciosa alta circa cento metri, e la sua
posizione dominante sia sulla viabilità di collegamento della valle del Sacco,
attraverso Sora, per la piana di Avezzano (Abruzzo), che sul tratto inferiore
della stessa valle, verso Frosinone, hanno favorito la progressiva e ininterrotta stratificazione di successive strutture urbane sul primitivo insediamento di
origine Ernica.
Documentata a partire dal IV secolo d.C. come uno dei principali
centri della Lega Ernica, Veroli, pur subendo, come le altre città della valle
l’affermarsi del predominio romano (318 a.c), ottiene, grazie alla neutralità
mantenuta nel corso della rivolta del 307, di conservare tramite la propria cittadinanza una parziale indipendenza. Questa condizione di privilegio si protrae fino all’88 a.C. quando, terminate le guerre civili con la sconfitta di C.
Mario, Veroli che lo aveva sostenuto, viene da Silla ridotta a Colonia militare.
A questo periodo (I sec. a.C.) risale il primo ampliamento dell’area
urbana, fino ad allora delimitata dalla cinta di mura poligonali, ottenuto creando a sud del Foro un nuovo quartiere fortificato, con viabilità ad andamento
ortogonale.
Una parziale autonomia politico amministrativa viene recuperata dalla città solo nel 97 d.C. quando, per concessione dell’imperatore Nerva, riassume il carattere di municipium.
Le prime testimonianze del culto cristiano in Veroli compaiono a
partire dal IV secolo, ma la città risulta sede vescovile solo dall’VIII; il primo
Vescovo di cui si ha menzione è Martino, che sottoscrive il Sinodo indetto da
Papa Zaccaria nel 743.
Riflettendo la situazione di generale spopolamento che caratterizza i
primi secoli dell’altomedioevo, il tessuto urbano si contrae in due soli nuclei
abitati: il maggiore, raccolto attorno alla Cattedrale di S. Andrea, che insiste
sull’area del Foro, reimpiegandone gli edifici, e il minore ottenuto fortificando
il punto più elevato (671 metri s.l.m.) sull’estremo margine nord dell’abitato,
denominato da allora Rocca di S. Leucio. Nell’area abbandonata che rimane tra
questi due nuclei viene fondato nell’VIII secolo il monastero benedettino di S.
Erasmo.
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
3.3
63
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
64
Alle frequenti incursioni dei Saraceni, che nell’883 saccheggiano la
città, causandone il temporaneo abbandono a favore della più munita Rocca
di S. Leucio, fanno seguito quelle dei Longobardi che, a partire dalla metà del
IX secolo vi si stanziano stabilmente, fondendosi con la popolazione locale, e
dando vita ad un potere di tipo feudale che governa la città fino alla fine del
secolo X.
La netta ripresa demografica ed economica che si registra in tutta l’Europa nell’XI secolo, si riflette sulla città, che torna ad assumere le dimensioni
dell’epoca romana, ripopolando le aree del precedente insediamento, rimaste
disabitate.
Risale a questo periodo la fondazione dell’abbazia di Casamari (1036),
edificata sulle rovine della città romana di Cereate, sul confine orientale del
territorio verolano, da alcuni esponenti del clero locale che adottano inizialmente la regola benedettina. Tra l’XI e il XII secolo la città raggiunge il limite
massimo della sua espansione, annettendosi, con un ampliamento della cinta
muraria, il borgo formatosi a sud, oltre le mura romane, e strutturato su tre
principali tracciati viari convergenti su Porta S. Croce.
Al nuovo assetto urbano fa riscontro un diverso ordinamento politico che cresce e si sviluppa di pari passo: all’amministrazione di carattere precomunale che verso il 1070 si sostituisce alla famiglia feudale dei longobardi
Roffredo, fa seguito già nel 1134, una regolare magistratura elettiva che, sotto
la guida di due consoli, governa con ordinamenti comunali sulle nove Scriptae
in cui è divisa la città.
Ma il gravare su questo centro del potere ecclesiastico sotto il duplice
aspetto di Sede Vescovile e di Abbazia cistercense (nel 1140 per interessamento
di Innocenzo II Casamari ha accettato la regola di Cluny) e la sua posizione di
rilevante importanza ai confini dello Stato Pontificio con il Regno di Napoli, che
ne fa l’oggetto di particolari cure da parte della Santa Sede, sono tutti ostacoli
allo sviluppo di una forte autonomia comunale, a sostegno della quale sarebbe
d’altronde necessaria quella borghesia mercantile di cui l’economia, prevalentemente agricola, del centro non dispone. Il terremoto del 1350 e le successive
ricostruzioni portano gli ultimi interventi di rilievo nella struttura urbana e
nell’organizzazione funzionale della città, da identificarsi fondamentalmente
nella creazione della nuova piazza alle spalle della Cattedrale di S. Andrea, alternativa alla Piazza di S. Andrea, dove nel XIII secolo era stato costruito il
Palazzo Comunale. Il nuovo spazio urbano ha una lenta qualificazione formale
attraverso la ricostruzione della Concattedrale di S. Maria Salome (iniziata nel
1350 ma consacrata solo nel 1429), e del Seminario, costruito nel 1611.
Conseguente alla decadenza dell’abbazia di Casamari è la venuta, nel
1499, dei Francescani in città, ma sia questi che le monache Benedettine ed i
padri Agostiniani nel secolo successivo, non costruiscono nuovi edifici, limitandosi a trasformare alcuni già esistenti.
La progressiva perdita di potere del Comune, qui come in altri centri
del Lazio, è tale che già nel XVI secolo le istituzioni comunali sopravvivono
come semplici strutture amministrative dello Stato Pontificio, mentre il potere
effettivo è detenuto da un gruppo di famiglie nobili, legate alla Curia Pontificia
e proprietarie di grandi estensioni di terreno, come i Campanari, i Bisleti, i
Franchi de’ Cavalieri, gli Spani, ecc.
A queste famiglie si deve, a partire dal XVI secolo e per tutto il secolo
XVIII, la ristrutturazione di numerosi edifici (Palazzo Bisleti, Palazzo Giovardi, ecc.) ed in qualche caso di interi isolati, (Palazzo Campanari, ecc.) che vengono adeguati alla nuova funzione di dimore signorili.
Nel 1952 si ha l’ultima modifica della struttura urbana con lo sventramento nella zona centrale, del tessuto medioevale dalla chiesa di S. Agostino in
direzione della Porta Napoletana, per la creazione dell’attuale via del Traffico.
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
PATRIZIA ROSAZZA FERRARIS
Veroli, in Storia delle Città, Milano 1978
65
3.4
Il borgo di Santa Croce e quello di San Leucio
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
Santa Croce
66
L’antichissima, preromana «Verulae», piantata su un contrafforte dei
Monti Ernici, non ha la caratteristica forma planimetricamente compatta, circolare o poligonale, né la altimetricamente piramidale delle altre città erniche,
volsche, ausonie, lepine. Ha una forma ad «L» altimetricamente degradante dai
700 metri s.m. della «Rocca» ai 550 metri del «Borgo di Santa Croce».
L’arce, il nucleo difensivo primigenio non si trova al centro dell’abitato,
ma alla punta superiore della ideale lettera «L». Ai piedi di essa si trova l’antichissimo, semideserto «Borgo di San Leucio», con la sua Chiesa del VI secolo,
consacrata nel 1079, da poco restaurata.
Al centro, al gomito della «L», la cattedrale, la chiesa di Santa Salome,
il Vescovado, il Municipio, il Seminario ed altre testimonianze dell’importante
complesso socio-urbanistico elevato al rango di città da papa S. Zaccaria I nel
743. In basso, alla punta inferiore della «L», il Borgo di Santa Croce, caratteristico per la sua popolosità, le sue strutture urbanistico-edilizie, la sua Porta, la
sua Chiesa.
Per l’esattezza, la lettera «L» della topografia verolana, è «scritta alla
maniera di Leonardo»: da destra verso sinistra.
Questa speciale conformazione ha favorito in Veroli l’esistenza, fino
a pochi anni fa, di tre distinte «polis», complementari l’una dell’altra. In alto,
vicino alla Rocca ed alla chiesa di San Leucio, il Borgo dei carbonai. Al centro,
da Sant’Erasmo a Sant’Andrea, la nobiltà, le arti, le professioni, il commercio,
la direzione della vita cittadina laica e religiosa. In basso, a Santa Croce, gli
artigiani, gli operai, i «generici» di ogni arte e mestiere.
I contadini (i «villani») vivevano in campagna, nelle tante case rurali
del grande agro verolano (11821 ettari); salivano in città nei giorni di festa, di
fiera e di mercato, barattavano i prodotti dei loro campicelli e se ne tornavano
in campagna; caratteristico esempio di «pendolari» avanti lettera sugli ancestrali mezzi di trasporto: il somaro o le ciocie. Ora tutto è cambiato.
II Borgo di Santa Croce — come abbiamo detto — è il primo agglomerato cittadino che si incontra salendo gli otto chilometri della strada provinciale Giglio-Veroli. A monte di un ampio, panoramicissimo tornante si scorge, a
destra, a mezza costa, la pretenziosa fila delle case nuove che hanno recentemente sciamato dalla cerchia delle mura cittadine; a sinistra, in alto, le antiche
mura, la caratteristica Porta, la restaurata chiesa di Santa Croce, lo scenario
quasi da presepe delle vecchie case, dei giardini del Borgo. Sullo spiazzo-sagrato antistante la Porta e la Chiesa, quando... c’era più religione e più forza delle
GIULIO LAUDISA
Lazio ieri e oggi, dicembre 1975
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
tradizioni, si celebrava in pompa magna la «Festa di Santa Croce», la prima
domenica di settembre, con luminarie, addobbi, palco della «Banda», bancarelle, cuccagna, fuochi pirotecnici, fiera di merci e bestiame, solenni funzioni
in chiesa, imponente processione fra le strette e ripide vie del Borgo, animate,
pavesate, illuminate... come a Parigi. L’emulazione tra i «Patroni» della festa,
lo zelo delle Confraternite religiose e delle Corporazioni artigianali, lo spirito
campanilistico del rione più popoloso, popolare, estroverso verolano concorrevano, anno dopo anno, a dare alla festa un’impronta sempre più viva ed attraente. Gli sconquassi di quest’ultima guerra hanno spazzato via ogni cosa. Si
sono salvate, in tono molto minore, le cerimonie religiose, la fiera e il pallido
ricordo socio-folkloristico del tempo che fu.
Importante «biglietto d’invito» del Borgo di Santa Croce è la sua antica
Porta. Un archivolto esterno a tutto sesto in pietra squadrata ed un analogo
arco interno, poggianti su modanature d’imposta e sottostanti piedritti dai robusti cantonali in pietra viva; paramento murario superiore, interno e laterale
in pietrame ad «opus incertum» e spigoli squadrati; due finestrelle quadrate di
vedetta; cammino di ronda interno; due poderosi speroni di sostegno (di epoca posteriore); colorazione ferrigna, tipica delle antiche murature verolane: un
insieme (ai suoi tempi) militarmente funzionale, e (oggi) scenograficamente
notevole della Porta, della retrostante piazzetta, e del caratteristico palazzo del
Card. Quiñones prospettante su di essa.
Fino a non molti anni fa, un lampione ottocentesco a petrolio illuminava l’archivolto esterno della Porta. La pavimentazione stradale aveva la tipica
«guida rossa» centrale in mattoncini disposti a «pettine» o a «spina di pesce»,
mentre, la restante superficie era coperta dal non meno tipico acciottolato calcareo. Ora, tali romanticherie, sono scomparse: il lampione è stato sostituito
dal disco bianco e rosso del «divieto di transito», e l’acciottolato, dal bitume.
Così vuole la imperante motorizzazione che, per andare liberamente (a rotta
di collo) per gli stretti vicoli del Borgo, non esita a spianare antiche cordonate,
smussare spigoli, allargare, tagliare, distruggere vecchi archi e stipiti in pietra
viva. Le due vie principali del Borgo: Cavour e Carlo Alberto, strette, in salita,
tutte luci ed ombre di preziose case medioevali, ammantate di silenzio patriarcale, abitate dai «patiti» del Borgo che ancora non si decidono a lasciare la via
vecchia per quella nuova fuori di porta, formano un «unicum» socio-urbanistico di inestimabile valore che è un vero peccato vedere andare lentamente,
inesorabilmente alla deriva.
Si farà in tempo a salvarlo? Lo speriamo ardentemente.
67
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
San Leucio
68
II borgo di San Leucio era un tempo regno dei «carbonari», non quelli
delle simboliche e tenebrose «vendite» dei secoli XVIII e XIX, che soffiavano
sulla brace per attizzare il fuoco sotto i dorati Troni autocratici e teocratici
d’Europa; ma quelli, i carbonari (in lingua italiana), che da millenni realmente
preparavano e vendevano il combustibile necessario ai focolari domestici.
Un autentico «carbonaro ante litteram», il borgo San Leucio, lo aveva avuto nel «borghiciano» Antonio Pagliari, Aonio Paleario (1504-1570) che,
con l’intenzione di «dar fuoco» alle deviazioni delle Corti papali di Leone X,
Clemente VII e Paolo III, finì i suoi giorni sul rogo in Roma sotto il pontificato
del mite San Pio V.
La strada principale del borgo è intitolata ad Aonio Paleario, una lapide sui ruderi di una casetta ne indica il luogo di nascita, e la piazza della Prefettura di Frosinone si adorna del monumento eretto a lui, a Ricciotti ed altri
patrioti ciociari, opera di Ernesto Biondi (1910).
La predilezione dei «carbonari» per San Leucio era di natura fisiologica. Dalle loro case «altolocate» imbevute di aria pura e balsamica, verso la
fine di settembre, a San Michele, scendevano al piano, con armi e bagagli ed
elementi validi della famiglia, diretti alle Paludi Pontine, verso la Selva di Terracina, lo spettrale mefitico mondo fatto di fango, di acque e di verde, ricco di
legname vivo e morto, dominio incontrastato del silenzio e della «dea febbre».
La loro presenza era denunziata dai colpi di accetta e dalle fumate delle
loro pire che sfornavano a rotazione continua il prezioso combustibile dagli
svariatissimi nomi a seconda della «pezzatura»: ciocchi, tronchetti, mezzanello, cannellino, carbonella. Tornavano a Veroli per San Giovanni; un periodo
migratorio quasi uguale a quello dei terrazzieri, dei braccianti, dei pastori
abruzzesi da e per l’Agro Romano, Pontino, ed il Tavoliere delle Puglie. Portavano a casa il ricavato economico delle fatiche in palude che permetteva loro
di sfoggiare una certa agiatezza nei mesi estivi che trascorrevano a San Leucio.
Le loro mogli tornavano a volte anche col frutto coniugale di quei nove mesi
trascorsi nella selva.
Non tutti però tornavano in buona salute; parecchi di loro avevano
preso la malaria che, se era sotto forma di terzana o quartana benigna, l’acqua o la polvere di china, il chinino dello Stato, l’aria pura e le intercessioni di
San Leucio, riuscivano, in qualche modo, a risanare. Se invece si trattava della
micidiale perniciosa, dovevano fare, tra quattro assi, un’altra breve ascesa fin
dentro al sacro recinto a fianco della loro chiesa oppure, quando fu costruito il
nuovo cimitero in contrada Crocifisso, intraprendere, a spalla di quattro amici
o parenti, la loro ultima e definitiva discesa verso la valle.
Le diavolerie del progresso hanno di recente fatto sostituire i vari tipi
di gas al tradizionale carbone, e la antichissima corporazione dei carbonari si
è sciolta. Contemporaneamente è scomparsa la malaria e la selva di Terracina,
della quale, il minuscolo Parco Nazionale del Circeo, è una pallida ed addomesticata visione.
Di quando in quando, ora, qualche filo di fumo nei radi boschi di
Monte Pedicino indica che c’è ancora chi non sa staccarsi dalla cottura a legna
e carbone degli alimenti.
I carbonari hanno cambiato mestiere e quartiere od addirittura regione o nazione. Nel borgo di San Leucio regna ora silenzio e abbandono che, né
i pochi abitanti rimasti, né la nuova bella strada panoramica, ombreggiata da
giovani pini italici, costeggiante le mura ciclopiche, riescono a scuotere.
Dall’arcolaio dei pensieri si dipana un filo di speranza, di augurio che,
tra le antiche mura del Borgo, tra gli stipiti in pietra da taglio delle porte e
finestre delle case semiabbandonate, ritorni un soffio di vita sotto forma di
ricostruzione urbanistica di un complesso autenticamente medioevale, di rinascita turistica e folkloristica delle botteghe ed empori artistici ed artigianali,
un tempo vanto della industre città.
GIULIO LAUDISA
3. “La terra mia è anche per te...” Giuseppe Trulli
Estro, n. 11-12, 1968
69
Casa medioevale - particolare del profferlo
Borgo Santa Croce - Veroli
Roseto sulle mura medioevali
Borgo San Leucio - Veroli
Via Aonio Paleario
Borgo San Leucio - Veroli
Tramonto sulla Valle del Sacco visto da una terrazza
Borgo San Leucio - Veroli
CAPITOLO IV
Veroli e Roma
Veroli, città ernica
81
Nello stemma di Veroli i colori di quello di Roma
84
Via Latina o via Casilina?
86
“Camminamento militare segreto” e resti del Tempio di Roma e Augusto
89
I “Fasti Verulani”
91
“A Lucio Alfio”
98
4.1
Veroli, città ernica
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
V
eroli, nel cuore della Ciociaria, fu antichissimo centro ernico
(«Herna», equivalente al latino «saxa», è una parola sabina che
significa sasso, rupe). «Oggi gli studiosi concordano nel ritenere
che gli Ernici siano venuti in Italia, via terra, con il sistema di
bande successive da una imprecisata zona del medio Danubio
intorno al 2500 a.C. nella prima ondata dei popoli italici; essi appartengono
ai proto-italici, i cui nomi etnici indicanti raggruppamenti non vasti (Rutuli, Ernici) denotano il loro iniziale frammentamento politico-sociale, appena
scalfito dalle unioni di leghe sacre: tra di essi era in vigore un assai tenue sistema federativo. Mentre i latini si stanziarono nel triangolo del «Latium vetus»,
alla sinistra del Tevere, (...) gli Ernici occupavano i monti da Preneste a Sora
e i territori alla sinistra del Sacco e lungo le rive del Cosa. Nel secolo IX a.C.
gli Ernici subiscono l’influsso degli Etruschi e nel secolo successivo quello dei
coloni greci della costa tirrenica» (GIUSEPPE SPERDUTI, Saggi di storia locale
ciociara, Veroli 1979).
Virgilio, nel VII libro dell’Eneide così descrive i soldati ernici: «Non
tutti hanno armature sonanti, scudi e cocchi, anzi i più scagliano ghiande di
livido piombo o portano in mano due giavellotti, proteggono il capo con berretti di pelle di lupo, hanno il piede sinistro scalzo e il destro coperto di cuoio
non conciato». Molto acutamente Giovanni Coccia, nel suo interessantissimo
opuscolo dal titolo «Alba di una storia luminosa», osserva che «i guerrieri della
rustica legione calzavano il solo piede destro lasciando nudo il sinistro, non
perché quest’ultimo fosse coperto dallo scudo (...) ma perché questo piede aveva caratteristiche prensili, svolgeva cioè la stessa funzione delle scarpe chiodate
degli atleti moderni (...). La prensilità di questo piede era necessaria soprattutto nei lanci in genere, in particolare delle ghiande di piombo, l’arma principale
di questo popolo, che richiedeva molta precisione, quindi un ultimo appoggio
sul terreno molto sensibile».
Pastori bellicosi, gli Ernici si circondarono di poderose mura. La cinta
muraria di S. Leucio a Veroli è forse la più antica del territorio ernico, serviva
validamente a difendere la parte nord-nord-est della «civitas erecta», cioè la
zona più alta del paese, ed «è costituita da grossi massi calcarei (...) rozzamente
lavorati, sovrapposti fra loro senza combaciamento esatto. Massi più piccoli fra
i grandi non sono affatto rari» (VINCENZO QUATTROCIOCCHI, Gli Ernici ed il
loro territorio, Veroli 1928). Lungo la fascia muraria si aprivano cinque porte
(attualmente ne è rimasta in piedi una soltanto). «Con grande probabilità le
nostre posterle furono fatte in quei punti ove la conformazione del terreno
non permetteva, né rendeva desiderabile una porta, mentre nell’interesse della
81
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
82
difesa, essendo troppo distanti fra loro le porte, era richiesta una comunicazione tra l’interno e l’esterno. In caso di assedio la difesa di queste porte non
presentava grande difficoltà poiché si potevano chiudere con pietre» (VINCENZO QUATTROCIOCCHI, Gli Ernici..., cit.).
«Una leggenda che s’udiva raccontare un tempo a Veroli e Alatri, diceva che i costruttori erano uomini giganteschi provvisti di forza eccezionale;
le loro donne portavano loro i massi raccolti sui monti vicini; su un semplice
cercine, se li mettevano sul capo, per poi fare la strada filando la rocca e chiacchierando. Le leggende sono sempre pittoresche e più attraenti della storia»
(GIULIO ALONZI, Le antiche muraglie raccontano la loro storia, in Historia, gennaio 1964).
«Che l’ernico indossasse un solo calzare o che si coprisse di pelli di
lupo o che cacciasse con lo spiedo e la fionda o che adorasse pelasgici numi,
non importa. Ciò che più conta è lo spirito che animò quel piccolo popolo, il
quale ebbe la sua civiltà, la sua religione e seppe difendere con valore gli “hernica saxa” e le verdeggianti colline sulle quali crebbe le sue greggi in una solitària vita primitiva» (MARIO MEZZACAPO, Gli Ernici e le loro mura pelasgiche,
in Lazio ieri e oggi, marzo 1968).
Gli Ernici, «per provvedere ai pubblici bisogni, tenevano comizi, assemblee (...). Negli affari di maggior rilievo tenevano diete generali nel Circo
Marittimo, ove convenivano i deputati dell’intiera ernica nazione, (...) terminavano liti, toglievano contese, regolavano commercio, trattavano delle guerre
e della pace» (VINCENZO CAPERNA, Storia di Veroli, 1907).
«Dionisio di Alicarnasso riferisce che il nostro popolo ebbe relazioni con l’Urbe sin dal periodo regio. Esso ruppe però il patto all’epoca della
cacciata di Tarquinio (509 a.C.) in quanto la deposizione del re fu ritenuta
dagli Ernici motivo di risoluzione dell’alleanza. Il comportamento degli Ernici
fu giudicato dai Romani offensivo e pertanto, nell’anno 487 a.C, il console C.
Aquilio, dopo una strepitosa vittoria, li punì togliendo loro parte del territorio.
Sotto il terzo consolato di Spurio Cassio, nell’anno 486, fu concluso
con gli Ernici, su un piano di parità, il “foedus” che dal console prese il nome.
La posizione del territorio permetteva agli alleati una costante osservazione
delle ostili manovre dei Volsci e degli Equi ai danni di Roma; quest’ultima,
perciò, fu sempre oltremodo amica e condiscendente nei riguardi della confederazione, la quale, alla superiorità della diplomazia romana, contrappose una
politica che spesso si rivelò se non opportunistica, non sempre coerente. Schiere ausiliarie di “funditores” furono presenti all’espugnazione e al saccheggio di
Veio da parte di F. Camillo nel 396. Dopo il disastro gallico, dal 362 al 358 essi
levarono le armi contro Roma. Una ribellione si ripetè nel 306 quando, tra le
schiere dei Sanniti furono trovati soldati ernici. I consoli P. Cornelio Arvina e
Q. Mercio Tremulo furono perciò incaricati di condurre una indagine presso la
confederazione, la quale, riunitasi urgentemente in Anagni, prese la decisione
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
di opporre resistenza a Roma. Ferentino, Alatri e Veroli si astennero dalla lotta.
Anagni, affiancata da centri minori, dopo un ultimo sforzo bellico, fu costretta
alla resa» (MARIO MEZZACAPO, Gli Ernici..., cit.).
«Alle tre città, Veroli, Alatri, Ferentino, non compromesse nella guerra, dai Romani fu offerto il diritto di cittadinanza; esse però vollero piuttosto
preferire le proprie leggi che godere o accettare l’offerta. Ebbero prerogativa del
connubio coi Romani, e Veroli segnatamente restò libero Municipio, repubblica separata dal popolo romano, “Senatus Populusque Verulanus”. Ebbe ordine
Senatorio detto Decurionato formato dai più cospicui cittadini.
Anagni all’incontro, priva di sua libertà, divenne in tutto soggetta a
Roma. Le fu concessa solo la cittadinanza, fu privata del diritto ai concilii e
suffragi nell’elezione dei Magistrati, all’infuori delle cose religiose. Anche le
fu vietato il connubio coi Romani, in guisa che, tolte le leggi e magistrati, fu
ridotta più a forma di Prefettura che di Municipio o Colonia col nudo titolo di
cittadinanza romana, senza diritto del suffragio.
La distinta condizione in cui trovavasi il Verolano Municipio, le tendenze dei suoi abitanti, tanto influirono a formare delle vicendevoli relazioni
tra Romani e Verolani, che questi, uniformandosi a quelli ne divennero fedeli
imitatori. Come Roma avevasi il Senato, così Veroli godeva ordine Senatorio
da cui eleggevansi i Duumviri come in Roma i Consoli. Ebbe Pretori, Questori, Quinquennali, Edili, Flamini. Quindi i Collegi degli Augustali, Sevirali,
Dendrofori. Il nobile ordine Senatorio Verolano, che soleva chiamarsi Decurionato, formavasi dal Collegio dei Decurioni nominati dalle decurie in cui
erano ascritti. Ecco primo cenno delle dieci curie o scritte o rioni in cui Veroli
era divisa, come vedrassi nei secoli di mezzo. Un reddito di cento mila sesterzi
dovevano avere i Decurioni non altrimenti che i Senatori Romani. I Duumviri
annualmente eletti come i Consoli usavano bastoni legati a mo’ di fasci consolari portati dai littori. I Pretori per i Duumviri presiedevano ai pubblici giuochi
e spettacoli, i Questori all’erario, i Censori Quinquennali al censo, onore, costumi, gli Edili al culto, Città, annona; finalmente i Flamini ai dazi.
Gli effetti della reciproca amicizia tra Romani e Verolani meglio si
conobbero quando i Frusinati, conoscendo il valore degli Ernici, cercarono
staccarli dall’amicizia di Roma (302 a.C). Il Senato Romano, venutone a cognizione, decretò che Frosinone perdesse la terza parte del territorio e i Capi
della congiura fossero battuti con verghe e percossi con la scure» (VINCENZO
CAPERNA, Storia di Veroli, cit.).
«La Lega Ernica veniva così completamente disciolta. Quando Augusto divise
l’Italia in regioni, i territori degli Ernici furono inclusi nella prima regione,
seguendo le sorti di tutto il Lazio» (GIUSEPPE SPERDUTI, Saggi..., cit.).
83
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
4.2
84
Nello stemma di Veroli i colori di quello di Roma
«Ha per arma la Città di Veroli un campo di oro diviso per lungo co’
sbarre di colore rosso. Da alcuni vecchi udii la ragione di detta Arma, ciò è
essendo assaliti nei tempi antichi i Verolani da’ popoli vicini, accorgendosi un
giovane di Veroli che la somma del valore de’ nemici stava nell’ardire e prudenza del capitano; egli con la spada e col scudo si fece strada nel mezzo dell’esercito contrario, et penetrò fino a combattere col capitano, quale ferì e diede a
morte, et col medesimo valore tornato in dietro a i suoi, scortato da altri pochi
che seco da principio si erano congiunti; essendo da alcuni invidiosi della di
lui gloria ripreso da soverchio ardimento; egli abbattendosi con la destra mano
aperta il petto, giurando se di nuovo bisognasse fare simili imprese, non punterebbe punto la moltitudine degli avversari, et perché il petto era coperto di
giubbone di oro tessuto e la sua destra per i molti che in quel conflitto haveva
feriti e morti del tutto insanguinata; restò il giubbone d’oro tinto da i quattro
deti (sic) della mano.
Il popolo che havea gradita la sua impresa et acclamato il suo valore
per haver fatta una segnalata vittoria in quel giorno quando tutto l’esercito nemico si mise in fuga per la morte del loro capitano; alzò per corpo di impresa
in lode di quel giovane un campo d’oro con quattro sbarre (sic) di colore rosso,
spiegando il di lui valore con bellissima et elegantissima sentenza. Et poscia
la Città per decreto di pubblico conseglio la prese per sua Arma» (GIOVANNI
VECCIA, Historia di S. Maria di Giacomo e di Giovanni Evangelista, ms. sec.
XVII, Biblioteca Giovardiana, Veroli).
«È da osservare che nel ms. del Veccia la parola “quattro” (sbarre) si
trova cancellata a capo della pagina, e tale cancellatura, per il comportamento
della penna e del colore tanninoso dell’inchiostro, non lascia dubitare che possa non essere del Vecci stesso, che certo aveva notato poi come realmente nella
Arma vi fossero tre e non quattro sbarre rosse» (ARDUINO SCACCIA SCARAFONI, Stemma della Città di Veroli, Veroli 1929).
«Lo stemma della Città di Veroli consta (dunque) di uno scudo sannitico: d’oro con tre pali di rosso, coronato di chiavi di Città libera, sormontato
da corona marchionale, con attorno alla punta dello scudo una lista recante
il motto: “Verulana Civitas Almae Urbi Confoederata”. Lo scudo sannitico va
rannodato al fatto che tra i prigionieri sanniti catturati dai Romani dopo la
resa di Allifas, non si trovarono Ernici di Veroli, Alatri e Ferentino, perciò a
queste tre città va riconosciuto come trofeo di guerra, la sagoma dello scudo
sannitico. Il colore oro con le strisce rosse è da ricollegare, come si è visto, alla
leggenda del soldato che con le dita insanguinate si macchiò il giubetto tessuto
d’oro. Le chiavi coronanti lo scudo furono concesse da Urbano V, quale distin-
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
tivo alle città libere, e Veroli, come tale, le assunse nel 1637. Il diritto alla corona di marchese venne a Veroli non per graziosa concessione di un diploma,
ma per una fondamentale ed universale disposizione che dall’era carolingia
classificò Marche i feudi di confine. E Veroli, che col suo vasto Distretto aveva
giurisdizione feudale su ben sei Terre e Castelli, essendo politicamente al confine, quale Marca, non poteva avere che corona di marchese. Per la vastità del
feudo si deve aggiungere che il vescovo di Veroli era Barone di Strangolagalli,
Colli, Ripi, Torrice, Pofi, ed aveva feudatari i nobili Conti di Aquino.
Veroli non solo era un feudo importante, ma di frontiera, per la quale
condizione si ebbero Bolle e Brevi che concedevano speciali diritti per l’amministrazione della giustizia e per la difesa del territorio. Il motto «Verulana
Civitas Almae Urbi Confoederata” fu qui sempre non solo una distinzione,
ma quasi il titolo migliore cui la Città tenne fino dall’epoca romana, in ricordo
dell’alleanza ernico-romana e per l’ordinamento e le istituzioni civili che sempre conservò e modificò sull’esempio di Roma» (ARDUINO SCACCIA SCARAFONI, Documentazione storica circa l’antico uso dello stemma dell’illustre Città di
Veroli, Veroli 1929).
85
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
4.3
86
Via Latina o via Casilina?
«L’antica Via Latina da Roma giungeva sino alla Campania attraversando il territorio della Lega latina. Seguiva in un primo tratto la via di Tuscolo, poi, poco oltre Valmontone, entrava nella Labicana; quindi toccava Anagni,
Ferentino, Frosinone, Fregelle e Cassino per congiungersi infine a Capua con
la Via Appia». È quel che si legge sul Dizionario Enciclopedico Italiano della
Treccani e che era condiviso dal nostro concittadino Amedeo Maiuri; ma è anche quello che mandava in bestia il Prof. Arduino Scaccia Scarafoni, verolano
anche lui, che si battè con accanimento, ma anche con argomenti validissimi,
per dimostrare che la Via Latina non passava per Frosinone, ma per Veroli. Se
esigua è la schiera di coloro che hanno dato credito alla tesi del Professor Scaccia Scarafoni, è pure vero che pochissimi sono quelli che si son presi la briga di
leggere, come lui ha fatto, la storia di Roma di Tito Livio. Da alcune sue lettere
indirizzatemi, estraggo qua e là i brani che mi sono sembrati più significativi,
riportando, almeno spero, il succo del suo pensiero.
Da Roma la Via Latina si dirigeva verso i Colli Albani, saliva a Grottaferrata e continuava a settentrione di Artena. Dopo Valmontone e Colleferro,
piegava a nord per accostarsi prima a Paliano, poi ad Anagni. Da Ferentino
(e qui il Prof. Scaccia Scarafoni non è più d’accordo con Maiuri), attraverso la
stretta compresa tra il Monte Ernicino e il Monte Reo, la Via Latina scendeva
a Tecchiena, dirigendosi verso «La Magione».
Breve pausa per ricordare al lettore che il Monte Ernicino deve il suo
nome al fatto che qui si adunavano gli Ernici delle tre città alleate e socie di
Roma, cioè Veroli, Alatri e Ferentino, dopo che da Roma fu interdetta l’adunanza al «Compitum Anagninum», dove, come si sa, confluivano tutti gli Ernici da quando Anagni fu scelta come loro principale centro e guida contro gli
attacchi di altri popoli. Il nome del Monte Reo è forse da mettere in relazione
con il ricordo delle ribellioni di Ferentino nel 296 e 293 a.C.
Da «La Magione», mentre una deviazione saliva ad Alatri, la Via Latina piegava verso il Monte S. Leonardo e, ai piedi di questo, giungeva ad una
mascalcia i cui resti si rinvennero presso Pignano. Dopo aver fiancheggiato
«Le Murelle» e «Brecceto», a «Le Prata», verso «Le Girate», saliva passando
davanti alla chiesetta della Madonna del Pianto e toccava la Torre Santo Spirito, la «Preta Liscia» e la collinetta degli «Osti». (Quest’ultima si chiamò così
perché vi erano costruiti alcuni alloggi per i viaggiatori che vi sostavano; c’era
il cambio dei cavalli di posta ed erano disponibili i buoi per essere in testa, al
timone dei traini, in aiuto dei cavalli da tiro).
Dagli «Osti» la Via Latina raggiungeva la quota più alta, dove sorse poi
la chiesetta della Madonna degli Angeli, e, dopo una diramazione che saliva a
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
Porta Santa Croce, scendeva al Rio di Bagno Folino. Passato il Ponte Nuovo,
nei pressi del quale molti anni addietro era ancora visibile un tratto di via basolata, saliva alla scrima della Vittoria, da dove, per Casamari, andava diretta
ad Atina col nome di «Maria» o Consolare. Il tratto Ponte Nuovo-Casamari fu
percorso fino al tempo della rivoluzione francese, allorché si dovette rinunciare alla processione che da Veroli lo percorreva in forma solenne, recando parte
delle reliquie dei santi custodite nella cattedrale di S. Andrea.
Per finire, è interessante notare che, dopo la scrima della Vittoria, una
diramazione della «Maria» scendeva al quadrivio corrispondente oggi alla frazione di S. Angelo in Villa. Il tratto di via romana trovato distrutto molti anni fa
nel punto in cui sorge l’Hotel Picatti, doveva dirigersi verso «Fregellae», centro
strategicamente importante, alla confluenza del fiume Sacco con il fiume Liri.
La obliterazione di questa strada si deve forse ai Saraceni, che lasciarono su
questa scrima della Vittoria il triste ricordo del loro nome: «Scrima Saracena».
La convinzione del Prof. Scaccia Scarafoni che la Via Latina passasse
per Veroli gli derivava non solo, come si accennava prima, da un’attenta lettura
della Storia di Roma di Tito Livio (particolarmente importante il capitolo 36
del Libro X), ma anche dalla constatazione della esistenza nel territorio verolano di monumenti e reperti archeologici tanto importanti da giustificare il
passaggio per la nostra città di un’altrettanto importante arteria romana.
Ed ecco i due punti-chiave della tesi del Prof. Scaccia:
1) La Via Latina fu prolungata da Ferentino verso Sora nel territorio di
Veroli dalla data della conquista della stessa Sora, da quando cioè, nel 342 a.C,
i Romani la tolsero ai Volsci (Livio, Libro VII, cap. 38) e ne fecero la base logistica per le loro conquiste nella Campania e nel Sannio Irpino. Se si tiene presente che i Romani nel 358 a.C. avevano tolto agli Ernici la città di Ferentino,
nel corso di quei sedici anni avranno predisposto l’avanzata nel territorio di
Veroli.
2) Frosinone fu strappata ai Volsci solo nel 302 a.C. (Livio, Libro X,
cap. I) e i Volsci fino al 302 non lasciarono passare i Romani. Non risulta poi
che i Romani si avvalessero di una via che, transitando per Frosinone e Fregelle, potesse rendere più facile e rapido il passaggio dalla Piana del Sacco alla Piana del Garigliano. Perciò, prima del 302 a.C, prima cioè della «debellatio» di
Frosinone, i Romani, per arrivare al Sannio, ebbero da questa parte la sola Via
Latina nel suo proseguimento da Ferentino per Veroli-Sora. «La Via Casilina è
posteriore, e non ha nulla a che fare con la Via Latina. Si lambicchi chi vuole il
cervello, distorcendo il significato delle parole di Tito Livio e asserendo che la
Via Latina è la Via Casilina». (ARDUINO SCACCIA SCARAFONI, manoscritto).
Noi, con tutto il rispetto per il grande Maiuri, simpatizziamo per la tesi
del Prof. Arduino Scaccia Scarafoni. Forse il famoso pittore di cavalli avrebbe
fatto salti di gioia se avesse letto il brano che Antonio Giannetti, in «Cereatae Marianae», riporta da un articolo di Silvio Panciera in Epigraphica: «Nel
87
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
1951, per la costruzione della sala parrocchiale (di Casamari) si operarono
degli sbancamenti che portarono in luce, tra l’altro, un tratto di pavimentazione a grandi lastroni di una piazza, attraversata, come si potè accertare in
seguito (1958) dalla Via Latina». Non siamo d’accordo, però, con quello che
il Giannetti aggiunge subito dopo il brano riportato: «II Panciera forse voleva
dire il raccordo che unisce la Via Latina con Sora». Siamo convinti che il Prof.
Panciera volesse dire semplicemente... quello che ha detto.
88
“Camminamento militare segreto”
e resti del Tempio di Roma e Augusto
«Un’interessante costruzione è situata nel sottosuolo dell’area compresa tra il palazzo del municipio e la cattedrale di S. Andrea. Si tratta di una
serie di ambienti disposti sullo stesso asse, con orientamento da est ad ovest,
comunicanti fra di loro per mezzo di piccole aperture arcuate; il primo, sotto il
municipio, ha un gradino dinanzi a ciascuno dei lati lunghi. Sembra che proseguano in direzione della torre campanaria. La maniera rozza della costruzione
fa datare il manufatto al II secolo a.C. circa e lo fa mettere in relazione col terrazzamento in opera poligonale esistente sotto lo stesso palazzo municipale e
visibile dal seminterrato della casa Mazzoli, con ingresso dalla piazza del Duomo. Un altro tratto simile di muro si trova nel magazzino verso oriente dello
stesso palazzo, dal lato che guarda il vicolo di Casalunga; appartiene evidentemente allo stesso fabbricato antico che formava una terrazza o un basamento»
(GIUSEPPE LUGLI, Un’antica costruzione sotto la piazza del Duomo di Veroli,
estratto da Studi Romani, gennaio-febbraio 1962).
Secondo il Prof. Arduino Scaccia Scarafoni, che nel 1924 visitò la costruzione sotterranea, si tratta di un camminamento militare segreto che metteva in comunicazione l’antica torre romana, oggi campanile della cattedrale,
con le mura, di un “opus quadratum” molto rozzo, di via Casalunga. Egli stesso
passò carponi sotto i piccoli archi che dividono gli ambienti del camminamento e giunse «fin sotto l’antico cimitero attiguo alla cattedrale, dove era un
cumulo di scheletri».1
«Dal Vecci si apprende che identico muro di sassi come quello di Casalunga esisteva in linea con l’attuale vicolo Paolini (via V. Ellena) ed era il sostegno della terrazza, a quota superiore, oggi piazza Palestrina, dove nel 1921
fu accertato che vi era un tempio dedicato a Roma e Augusto. Dal Vecci si apprende anche che quel muro, che proseguiva dietro l’abside della cattedrale fin
verso l’attuale porticina dell’episcopio, fu demolito per usarne i massi nella costruzione dell’oratorio di Santa Salome» (ARDUINO SCACCIA SCARAFONI, manoscritto). Archi e pilastri romani, in pietra scalpellata, si vedono ancora, sotto
l’episcopio: che sia stata l’antica casa dei Flamini?
Come si diceva, nel 1921, in occasione di alcuni lavori di sistemazione
di piazza Palestrina, furono rinvenuti plinti, rocchi di colonne ed una cornice d’angolo, poi utilizzata nel monumento ai due aviatori verolani del largo
Marconi. «Secondo la tradizione, qui sopra, e presso l’attuale chiesa cattedrale,
1
Non è infondato supporre che il “camminamento” sia stato un Mitreo, del quale
presenta caratteristiche da non sottovalutare.
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
4.4
89
era il luogo del tribunale, come sarebbe confermato dal rinvenimento delle
tombe dei due protomartiri Biagio e Demetrio, che furono (dopo il martirio)
sepolti “in loco tribunali”. Nel diploma di Niccolo IV (1290) è fatto cenno ai
due protomartiri “quorum corpora ibidem requiescunt”, mentre solo nel 1743
se ne rinvennero le tombe, quando, nel ribassare il piano del presbiterio della
cattedrale, fu avvertito un vuoto che sta “in proseguimento della costruzione
sotterranea che va alla torre, oggi campanile”» (GIUSEPPE LUGLI, Un’antica costruzione..., cit.).
Il luogo del tribunale fu poi occupato dalla chiesa di S. Andrea, e proprio vicino al punto ove era la cattedra del vescovo, fu lasciato, fino al 1350, il
basamento della statua di Lucio Alfio, «a ricordo di questo magistrato che sedè
lì, “in loco tribunali”, quasi a confermare la continuità dell’autorità religiosa a
Veroli, secondo quanto scrisse S. Cipriano: “Ubi Flamini, ibi Episcopi”».
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
ARDUINO SCACCIA SCARAFONI
manoscritto
90
I “Fasti Verulani”
Nel 1922, durante alcuni scavi eseguiti negli orti di casa Reali, vennero
alla luce numerose tombe cristiane databili al IV - V secolo. A copertura di una
di esse era posta una lastra marmorea che, ridotta in frantumi, è stata pazientemente ricomposta dal Prof. Camillo Scaccia Scarafoni.
Tale lastra presenta da una parte i primi tre mesi del calendario romano,
dall’altra un’epigrafe risalente al tempo del secondo consolato di Stilicone (405).
L’intero calendario doveva essere collocato, come in altri Municipii,
nel Foro, sulla parete di un edificio pubblico, per poter essere liberamente consultato dai cittadini. Il luogo di rinvenimento del calendario trovasi proprio
nelle immediate vicinanze dell’antico Forum Verularum che, grosso modo,
coincideva con l’attuale centro urbano. Lo confermano i resti di costruzioni
romane situate sotto la piazza principale del paese, oltre ad una importante
epigrafe ed alla base di un monumento equestre, rinvenute, anch’esse, nei pressi della piazza.
I tre mesi, divisi per colonne, sono indicati, in alto, con le abbreviazioni IAN (Ianuarius), FEB (Februarius) e M (Martius), mentre il numero dei
giorni che li compongono sono riportati al termine di ogni colonna: 31 per
gennaio e marzo, 28 per febbraio.
Gennaio prende il nome da Giano (Ianus), il dio dell’inizio e della fine,
vigile custode della soglia e spesso rappresentato bifronte, non perché “doppio”, cioè ipocrita, ma perché vigile custode di ogni entrata e di ogni uscita
della casa.
Febbraio deriva da februa, oggetti magici per purificare, ed è perciò
dedicato alle purificazioni ed alle espiazioni. Chiudeva l’anno religioso che,
anticamente, iniziava a marzo.
Marzo fu il primo mese dell’anno fino al tempo di Numa il quale premise gennaio e febbraio.
Trae il suo nome da Marte, in origine dio della vegetazione primaverile, poi considerato quasi esclusivamente dio della guerra.
Come negli altri calendari romani, ogni mese presenta tre date fisse:
le Calende, le None e le Idi. Le prime sono indicate dalla lettera K (Kalendis),
le altre, rispettivamente, dalle abbreviazioni NON (Nonis) e EID (Idibus). Le
calende coincidevano con il primo di ogni mese, le None e le Idi con il 5 e il
13; fanno eccezione i mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, in cui le None
cadevano il 7 e le Idi il 15. Come si vede, i Romani aborrivano dalle cifre pari.
La lettura del calendario verolano è facilitata dal fatto che, accanto alle
prime otto lettere dell’alfabeto, che si ripetono per tutti e tre i mesi a partire da
gennaio (sono le lettere nundinali e servivano a fissare ogni nono giorno la data
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
4.5
91
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
92
delle fiere e dei mercati), sono incisi i giorni che vanno riferiti alle tre date fisse.
Facciamo qualche esempio: se le None di gennaio cadono il 5, con
l’espressione “il giorno prima”, indicata nel nostro calendario dalle lettere PR
(pridie), si intende il 4, mentre per indicare il 6 dello stesso mese si calcola il
numero dei giorni che precedono quello della successiva data fissa, includendo
nel computo sia il giorno di partenza che quello di arrivo; siccome nel nostro
caso tali giorni sono 8 (prima delle Idi), sotto le None, accanto alla lettera F,
troviamo inciso il numero VIII.
Calende, None e Idi erano determinate in funzione delle fasi lunari. Il
primo di ogni mese, infatti, il pontefice incaricato dell’osservazione della luna,
all’apparire della prima falce nel cielo annunciava (Kalabat) al popolo il giorno
in cui ci sarebbe stato il primo quarto, cioè le None, ed il plenilunio, cioè le Idi.
Mentre le None (così dette perché cadevano nove giorni prima delle
Idi) non erano sacre ad alcuna divinità, le Calende erano dedicate a Giunone
e le Idi a Giove, il quale, essendo la personificazione del Cielo, ben si poteva
manifestare nella fase del plenilunio. Nel nostro calendario, accanto alle Idi dei
tre mesi, sono riportate le parole FERIÆ IOVI
Le lettere F, C, N, NP, EN, poste accanto alla tipica numerazione del
calendario, costituiscono la nota dierum, cioè la natura di ogni giorno. Esaminiamole brevemente:
F, cioè fasti (da fas = è lecito, è concesso). Erano i giorni in cui ognuno
poteva attendere liberamente alle proprie occupazioni. Si potevano adire i tribunali, ma non tenere i Comizi.
C, comiziali, i giorni in cui, oltre ad attendere alle normali occupazioni, si potevano convocare i Comizi.
N, nefasti, quelli a carattere espiatorio e dedicati esclusivamente al culto. Nei dies nefasti non era lecito amministrare la giustizia. Febbraio, proprio
per la sua natura religiosa, ha ben dodici giorni contrassegnati da tale lettera.
NP, (nefasti [feriæ] publicæ), erano i giorni festivi, alla cui gioia tutti
partecipavano.
EN, intercisi, quelli in cui erano sacre la prima e l’ultima parte, mentre
a metà della giornata ci si poteva dedicare agli affari. Tali giorni, che precedono le festività, sono segnati a gennaio il 10 e il 14, prima della Carmentalia, a
febbraio il 16, prima delle Quirinalia, a marzo il 13, prima delle Equirria.
Il 24 marzo presenta le lettere Q. R. C. F. (Quando rex comitiavit fas), e
sta ad indicare il giorno in cui il re adunava i Comizi delle curie per sanzionare
i testamenti.
Le FERIÆ erano le feste consacrate alle divinità in genere, ma anche ai
morti ed agli spiriti dell’oltretomba, i cui riti avevano lo scopo di propiziarsi la
loro benevolenza.
Altre feriae erano solo commemorative, servivano cioè a ricordare avvenimenti importanti; quasi sempre, comunque, erano occasione di gioia e,
fra i ceti più bassi, culminavano spesso in sfrenatezze erotiche. Nel Curculio di
Plauto si legge: “In quei giorni voi potete mangiare quello che volete, andare
dove desiderate e amare chi vi piace, a condizione che vi asteniate dalle donne
sposate, dalle vedove, dalle vergini e dai fanciulli di libera condizione”.
Gennaio
A gennaio incontriamo le AGON(ALIA), il 9, e le CARM(ENTALIA),
l’11 e il 15. Le prime (da agonia, cioè vittime per il sacrifìcio) erano dedicate a
Giano, essendo le prime feste dell’anno.
In suo onore un montone nero veniva sacrificato nella Regia. Le seconde erano feste in onore di Carmenta, profetessa delle nascite e protettrice
delle partorienti. A lei, che aveva un tempio ai piedi del Campidoglio ed un
proprio sacerdote (Flamen Carmentalis), non si potevano fare che sacrifici vegetali; una dea, dunque, di una certa importanza e da non irritare, visto che
era capace di porgere il suo aiuto nelle situazioni più scabrose e nei parti più
difficili.
Febbraio
Lupercalia. Erano le feste consacrate a Fauno Luperco, in onore del
quale venivano immolati davanti al Lupercale (grotta nei pressi del Palatino
ove una lupa avrebbe allattato Romolo e Remo) un capro ed un cane. Dopo riti
iniziatici piuttosto complessi e tenuti dalle due confraternite del Collegio dei
Luperci, i Quinzali e i Fabiani, si assisteva alla corsa che i Luperci stessi facevano attorno al Palatino per cacciare gli spiriti maligni. Quasi completamente
nudi, partivano dal Lupercale e, senza interrompere la corsa, percuotevano
con strisce ritagliate dalla pelle degli animali sacrificati tutte le donne
sterili che si offrivano per essere battute: in tal modo la pelle del capro avrebbe
misteriosamente, ma sicuramente trasmessa loro la sospirata fecondità.
La corsa dei Luperci (da lupum arceo = tengo lontano il lupo) ricordava l’antichissima usanza dei pastori i quali, al fine di allontanare il pericolo
dei lupi, correvano intorno al proprio gregge per formare intorno ad esso una
specie di cintura sacro-magica, di sicurezza.
Poco si conosce circa i riti delle Quirinalia. Erano dedicate al dio Quirino, dapprima associato a Marte e Giove, con i quali costituiva l’antica triade,
poi assimilato a Romolo, figlio di Marte. Aveva un proprio tempio sul Quirinale
e al suo culto erano addetti il Flamen Quirinalis ed il Collegio dei Salii Collini.
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
Nel mese di febbraio sono sacri i giorni 15 (LUPER(CALIA), 17
(QUIR(INALIA), 21 (FERAL(IA), 23 (TERM(INALIA), 24 (REGIF(UGIUM)
e 27 (EQUIR(RIA).
93
Il 21 di questo mese si celebravano le Feralia durante le quali si svolgevano particolari cerimonie funebri per ricordare ai vivi le figure dei defunti.
Sulle loro tombe, riccamente ornate di fiori, venivano posati vasi d’argilla contenenti “grano, sale, pane bagnato nel vino e viole sciolte”.
Il giorno dopo venivano le Charistie o Caracognatio: i parenti dei defunti banchettavano e facevano offerte ai Lari, scambiandosi auguri di ogni
bene. Ringraziavano così gli dei protettori di essere ancora in vita, segretamente sperando di raggiungere i cari scomparsi il più tardi possibile.
Il 21 febbraio era anticamente segnato come giorno di lavoro (F); solo in un
secondo tempo diventò festivo (NP). Il nostro calendario segna il momento
in cui cambia la natura di questo giorno, tanto è vero che, accanto alla parola
FERAL, troviamo due lettere, FP: esse stanno per Fastus principio o parte, e
significano “questo giorno è da considerarsi fasto in parte”.
Al dio Termine era consacrato il giorno 23. Inizialmente si festeggiavano in suo onore le pietre di confine poste fra le proprietà agricole private,
poi la sua importanza crebbe al punto da diventare protettore dei confini dello
Stato. Nel mese di maggio queste pietre terminali venivano ornate di fiori e
spruzzate col sangue degli animali sacrificati; gli addetti al rito erano i Fratres
Arvales che, alla testa di una simpatica processione, rivolgevano canti e preghiere alla Terra perché desse abbondanti raccolti.
Nel giorno del Regifugium veniva praticato uno strano rito: il sacerdote (rex sacrorum), una volta immolata la vittima, doveva fuggire con i Salii.
Alcuni mettono in relazione questo curioso atteggiamento con la cacciata di
Tarquimo il Superbo; sembra invece che il rito abbia avuto carattere magico.
Il 27 si celebravano le Equirria. Erano corse di cavalli (da equus) che
si svolgevano in Campo Marzio, in onore di Marte.
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
Marzo
94
Il 14 marzo incontriamo ancora una volta le Equirria, poi le
LIB(ERALIA), il QUIN(QUATRUS); ed infine il TUBI(LUSTRUM).
Con questo mese iniziava il nuovo anno religioso ed i poveri lo festeggiavano il giorno 15 in modo tutto particolare: innalzate delle tende in Campo
Marzio, imploravano Anna Perenna affinchè desse loro tanti anni di vita per
quanti bicchieri di vino avrebbero bevuto nel corso della festa. Come poteva
finire una festa del genere lo possiamo facilmente immaginare; aggiungiamo
solo che, se la dea avesse veramente dato ascolto alle loro preghiere, tutti, indistintamente, sarebbero vissuti troppo a lungo.
Le Liberalia (17 marzo) erano consacrate a Libero, il dio che presiedeva alla fecondità vegetale, animale e umana. Nel giorno a lui consacrato i
giovani vestivano la toga virile e le famiglie banchettavano all’aperto, mentre
vecchie con il capo ornato di edera vendevano pani impastati con farina, olio
Passiamo ora ad esaminare quei giorni che sono destinati a ricordare
avvenimenti eccezionali o, comunque, di notevole importanza, sia come fatti
storici che come documenti della vita di allora.
Il 14 gennaio è di cattivo auspicio perché ricorda la nascita di Antonio:
D(IES) VITIOSUS EX S(ENATUS) C(ONSULTO) ANT(ONII) NATAL(IS).
Perché Augusto (al suo tempo o pochi anni dopo la sua morte si riferisce il nostro calendario) volle questo marchio infamante per il suo fiero
avversano? Antonio gli aveva giocato un brutto tiro: aveva sposato sua sorella
Ottavia, virtuosa e fedele, ma dopo poco tempo si era stancato di lei e l’aveva
rispedita a Roma. All’onestà della moglie aveva preferito il fascino di Cleopatra. Ottaviano, che non era ancora diventato imperatore col titolo di Augusto,
non subì l’offesa arrecata alla sorella e decise di punire il responsabile.
Visto che suo cognato aveva sposato Cleopatra e le aveva assegnato i tributi
di alcune provincie, dette largo credito alle notizie secondo le quali Antonio
intendeva fare di Alessandria il nuovo centro dell’Impero, assegnando a Roma
un ruolo di secondaria importanza. Fu facile così convincere il Senato a dichiarare guerra ad Antonio, il quale, sconfìtto ad Azio, tornò precipitosamente
in Egitto con Cleopatra, ma, raggiunti da Ottaviano, non restò loro altro da
fare che suicidarsi.
Forse questi avvenimenti avrebbero preso una piega diversa se il futuro Augusto avesse riflettuto un pò, prima di dare sua sorella in moglie ad
Antonio. Questi, infatti, pur essendo famoso per le sue virtù militari, troppo
spesso si lasciava vincere dalle tentazioni di una vita disordinata: il lusso, il
vino, le donne, avevano per lui un’attrattiva cui era impossibile resistere. Pare
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
e miele. Non si sa precisamente in quale mese, ma è certo che a Lavinio, in
onore del dio della fecondità si svolgeva una processione durante la quale un
simbolo fallico faceva il giro della città, accolto allegramente da una folla di
gente devota. Al termine della processione una matrona, prima di riporre tale
simbolo, lo incoronava con una ghirlanda di fiori.
Nel nostro calendario, accanto all’abbreviazione LIB ne troviamo un
altra: AGON. In questo giorno, infatti, oltre a festeggiare Libero, si celebrava il
secondo sacrifìcio agonale in onore di Marte.
Quinquatrus, (19 marzo) era la festa della purificazione delle armi,
prima dell’entrata in guerra. Alla presenza di autorità religiose e militari, i Salii
facevano la loro danza sacra intorno ad un cumulo di armi; si pregava e si sacrificava per allontanare gli influssi maligni e per assicurarsi l’aiuto degli dei.
Questo era giorno di letizia anche per artisti e studenti, i quali celebravano la festa in onore di Minerva, loro protettrice.
Il Tubilustrum (23 marzo) o lustrazione delle trombe di guerra, chiude
la prima parte delle feste del nostro calendario.
95
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
96
che disponesse addirittura di un harem di entrambi i sessi e che una cortigiana
greca lo accompagnasse in lettiga, durante i viaggi di trasferimento.
Oramai il conto con Antonio era saldato e problemi ben più importanti, fra cui un impero da riorganizzare e da difendere, attendevano di essere
risolti.
Il 16 ricorda il giorno della dedicazione del tempio della Concordia
nel Foro. Accanto al segno di festa NP troviamo, infatti l’iscrizione latina:
FER(IAE) EX S(ENATUS) C(ONSULTO) QUOD EO DIE AEDIS CONCORDIAE IN FORO DEDIC(ATA) EST.
Il giorno dopo ricorre l’anniversario delle nozze di Augusto con Livia.
Vi si legge: FERIAE EX S(ENATUS) C(ONSULTO) QUOD EO DIE AUGUSTA NUPSIT DIVO AUGUSTO.
Livia non era stata la sua prima moglie; sebbene Claudia e Scribonia
l’avessero preceduta nelle nozze, soltanto lei aveva lasciato una traccia indelebile nell’animo dell’imperatore.
Semplice ed affettuosa, mite e dolce, bella e assolutamente fedele al
marito, si era sempre dimostrata una sposa d’eccezione. A queste doti univa
sempre un’intelligenza viva e pronta che le consentiva di partecipare attivamente ma discretamente alla vita politica e alla soluzione dei difficili problemi
che tenevano impegnato l’importante marito.
Dione riferisce che quando le domandavano come facesse ad avere
tanta influenza sull’Imperatore, ella rispondeva: “essendo rigidamente casta,
non intromettendomi nei suoi affari e non pretendendo di essere informata né
di interferire negli amori con le sue favorite”.
Prima di morire, Augusto volle abbracciarla per l’ultima volta; nello
stringerla a sé disse: “Ricordati della nostra lunga unione, Livia, addio!”.
L’iscrizione latina esaminata dà all’Imperatore l’appellativo di divus;
nel giorno stesso dei suoi funerali, infatti, era stato deciso da parte del Senato
di annoverarlo fra gli dei. Tuttavia Augusto non dovette aspettare la morte per
essere considerato tale: era ancora vivo ed il suo nome compariva già, insieme
a quello delle divinità, negli inni ufficiali, mentre in alcune iscrizioni veniva
nominato come “salvatore” e “dio, figlio di dio”.
Un piccolo, forse banale, episodio può testimoniare il culto di cui era
oggetto l’Imperatore: alcuni marinai, sbarcati a Pozzuoli, incontrarono Augusto, gli si avvicinarono e gli offrirono incenso, proprio come a un dio. Dissero
di essergli grati “perché avevano fatto un viaggio tranquillo, avevano commerciato con fiducia e vivevano in pace”.
Specialmente nelle provincie il suo culto si era sviluppato così rapidamente che i Municipii più importanti ebbero, vivente Augusto, Collegi di
Augustali. A Veroli la base di un monumento a Lucio Alfio Cornelio Valentino
testimonia l’esistenza degli Augustali nella nostra città (l’iscrizione dedicatoria è riportata a pag. 97).
GIUSEPPE TRULLI
Le feste di Roma antica nel calendario Verolano, Terni 1967
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
Nel nostro calendario il giorno 27 ricorda i Dioscuri, i brillanti artefici
della vittoria romana presso il lago Regillo: CASTORI POLLUCI AD FORUM.
Un’altra data importante viene segnalata il 30 dello stesso mese: quella della dedicazione dell’Ara Pacis (9 a.C.). Leggiamo infatti: FERIAE EX
S(ENATUS) C(ONSULTO) QUOD EO DIE ARA PACIS AUGUSTI IN CAMPO MARTIS DEDICATA EST.
L’Ara fu innalzata in onore di Augusto, reduce dalle vittoriose imprese della Spagna e della Gallia, per celebrare la pax augustea che finalmente si
era stabilizzata nel mondo romano.
Il 22 febbraio ricorda l’anniversario della morte di Caio Cesare, figlio
di Giulia e di Agrippa: INFER(IAE) C. CAESARIS. Tale data viene ricordata
per il fatto che Caio Cesare era il nipote prediletto di Augusto, il quale volentieri avrebbe fatto di lui il successore al trono imperiale. La morte improvvisa
di Caio, avvenuta per le ferite riportate combattendo in Armenia, sconvolse
bruscamente i piani ed il cuore di Augusto al quale non rimase che fissare sul
marmo il triste giorno della sua immatura scomparsa.
Il 27 marzo è l’ultimo giorno festivo del nostro calendario e ricorda
la presa di Alessandria da parte di Cesare: FERIAE QUOD EO DIE CAESAR
ALEXANDRIAM RECEPÌT.
Nel suo soggiorno alessandrino Cesare assaporò fino in fondo le delizie della ospitalità di Cleopatra. Si trattenne con lei nove mesi, ma, “se i suoi
soldati non avessero minacciato di ammutinarsi” (Svetonio: Iulius), ci sarebbe rimasto molto di più. Cleopatra non dovette rammaricarsi a lungo della
partenza di Cesare; di lì a poco un altro valoroso generale romano, Antonio,
avrebbe trovato nel suo amplesso il meritato riposo dopo tante sanguinose battaglie.
Nei confronti degli altri calendari romani giunti fino a noi, i “FASTI
VERULANI” si impongono all’attenzione degli studiosi non solo perche presentano i primi tre mesi dell’anno in maniera abbastanza completa, ma anche
perché riportano date non riscontrate in altri famosi emerolegii; sono quelle
della nascita di Antonio e del matrimonio di Augusto.
Per noi Verolani essi costituiscono, assieme ad altri monumenti della
nostra città, motivo di orgoglio perché testimonianza inconfutabile di un illustre passato.
Se ci scuotessimo un poco dalla nostra apatia e dal nostro torpore,
scopriremmo di possedere un patrimonio artistico non indifferente, ma che ha
bisogno, per sopravvivere, di essere gelosamente custodito e difeso.
97
4.6
“A Lucio Alfio”
Museo Comunale
fronte:
L(ucio) ALFIO L(ucii) F(ilio) COR(nelia tribù)
VALENTINO II
VIR(o) (iterum) Q(uin)Q(uennali) P(atrono)
M(unicipii) V(erulani)
CURAT(ori) REIP(ublicae) COL(oniae)
CASINATIUM ET
PATRONO ORDO
SEVIRALIUM ET
AUGUSTALIUM OB
MERITA EIUS
L(ocus) D(atus) D(ecreto) D(ecurionum)
II Collegio dei Sevirali e degli
Augustali a Lucio Alfio Valentino, figlio di Lucio, della
Tribù Cornelia, Duumviro
per la seconda volta, Patrono per cinque anni del Municipio verolano, Curatore e
Patrono della cosa pubblica
nella Colonia di Cassino, per
i suoi meriti. Questo luogo gli
è stato dato con decreto dei
Decurioni.
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
lato sinistro:
98
DEDICATA KAL(endis) IUN(iis)
LATERANO ET
RUFINO CO(n)S(ulibus)
OB CUIUS DEDICATI
ONE(m) DEDIT DEQUR(ionibus) ET
VI VIR(alibus) ET AUGUS(talibus) * IIII
DENDROPHOR(is) * III ADIEC
TO PANE ET VINO POPU
LO * I CURANTE URGU
LANIO SECUNDO
(Questa statua) è stata dedicata il 1° giugno, essendo
consoli Laterano e Rufino
(anno 197). In tale occasione
Urgulanio II offrì 4 denari ai
Decurioni, ai Sevirali ed agli
Augustali; 3 denari, con l’aggiunta di pane e vino, ai Dendrofori e 1 denaro al popolo.
La statua bronzea di Lucio Alfio è andata perduta, ma la base del monumento è giunta fino a noi in ottime condizioni. Questa rimase molto tempo
ai piedi dell’antica torre romana (poi campanile della chiesa cattedrale) ed era
situata proprio di fronte al tempio di Roma e Augusto, di cui è unico ricordo
la cornice in pietra che fa parte del monumento a due piloti verolani innalzato
al centro di Largo Marconi. Costruita la chiesa in epoca paleocristiana, la base
fu collocata a lato della cattedra del vescovo, ove stette fino al 1350. Dopo altri
probabili spostamenti e un “soggiorno” pluriennale all’ingresso del palazzo co-
4. Veroli e Roma Giuseppe Trulli
munale, è stata recentemente trasportata nel Museo Comunale. Secondo Mario Mezzacapo, l’Urgulanio nominato nella iscrizione fu con ogni probabilità
Tesoriere del municipio verolano e discenderebbe da una nota famiglia etrusca
tarquiniese che ebbe in Urgulania il personaggio più autorevole. Stimata ed apprezzata alla corte di Augusto, Urgulania meritò l’amicizia di Livia, della quale
fu confidente.
99
Stendardo della città di Veroli
Palazzo comunale - Sala Consiliare
Arduino Scaccia Scarafoni
Sostruzioni del Foro Romano
Sotterranei del Palazzo Comunale
Base del Monumento dedicato a Lucio Alfio
Museo Civico Archeologico
CAPITOLO V
S alome
Diffusione del Cristianesimo
109
Sulle epigrafi di Marturio e di Filomena
113
Gracilia e Salome
115
Santa Salome
117
Culto di Santa Salome
121
Una catena a perenne ricordo
123
La chiesina della Madonna degli Angeli
125
Salome, una donna vestita di nero
130
2007: anno della Ricognizione Canonica
132
5.1
Diffusione del Cristianesimo
5. Salome Giuseppe Trulli
A
chi visiti nella Cattedrale di Veroli la cappella detta del Santuario, che custodisce una straordinaria raccolta di insigni reliquie,
adorne di ori, argenti, smalti, avori e pietre dure in una notevole
varietà di ostensori e di opere d’arte, vien fatto di domandarsi
perché si siano conservate proprio in questa remota cittadina
del Lazio tali e tanti documenti dell’antica pietà.
La posizione geografica di Veroli, ben munita dalla natura e quasi isolata, concorse di certo nelle turbinose vicende dei secoli alla conservazione di
tanti cimeli religiosi e storici, ma essi non avrebbero avuto la loro origine se non
fossero sorti dal vivo sentimento religioso dei suoi antichi cittadini e specialmente dalle particolari circostanze che — secondo una viva tradizione — determinarono e accompagnarono gli albori del cristianesimo nella vetusta città.
È tradizione che i primordi della fede cristiana risalgono in questa plaga degli Ernicì fino ai tempi apostolici e che S. Pietro stesso, nel venire da Antiochia, sia sbarcato a Taranto e, per giungere a Roma dopo aver toccato Napoli, Capua, Atina, sia passato per Veroli, Alatri, Ferentino, Anagni e Palestrina
(tradizione questa che se non è facilmente documentabile è geograficamente
verosimile, mentre invece è certamente da relegarsi fra le leggende l’affermazione che qui proprio S. Pietro avesse ordinato il primo Vescovo: il più antico
pastore della diocesi di Veroli compare solo nel 743, benché si abbia ragione
di ritenere che la origine della diocesi stessa risalga a periodo anteriore alla
penetrazione dei Longobardi in Italia e cioè prima del 568.
Una tradizione localmente ben più diffusa, sebbene anch’essa di non
evidente e facile documentazione, afferma che a predicare la buona novella
del Vangelo a Veroli sia giunta Santa Salome, una delle pie donne testimoni
dell’agonia e della resurrezione del Salvatore, madre di San Giovanni Evangelista e di San Giacomo. Ospite dapprima di un contadino, di nome Mauro, in
quella località suburbana denominata ora dalla chiesetta della «Madonna degli
Angeli», ma che durante il medioevo era appunto detta «la cona de santo Mauro», come si rileva ancora da qualche documento dell’Archivio Capitolare della
Cattedrale, Santa Salome sarebbe entrata in città a portare il seme del Vangelo
e dopo qualche tempo essa, carica di anni, vi sarebbe morta, mentre alcuni fra
i suoi compagni, fra cui San Biagio e San Demetrio, vi avrebbero sostenuto il
martirio.
Che qui, come in altri centri non lontani da Roma, la fede cristiana
trovasse non difficile seguito e quindi rapidamente si propagasse è cosa molto
verosimile: fin dal tempo di Tiberio e cioè pochi anni appena dopo la morte
di Cristo, la nuova fede contava già a Roma molti seguaci, se Tacito, parlando
109
di essi, accenna già ad una grande moltitudine «multitudo ingens». La lettera
di San Paolo ai Filippesi ci dice che ai suoi tempi, cioè una trentina di anni
appena dopo la morte del Salvatore, i cristiani erano già penetrati fino nella
casa dell’Imperatore: «salutant vos qui mecum sunt fratres, salutant vos omnes
sancti maxime autem qui de Caesaris domo sunt». Dalla lettera di papa Cornelio riportata da Eusebio; sappiamo che anche quando i cristiani non avevano
ancora in Roma alcun tempio e vi erano anzi perseguitati, la loro gerarchia era
già così numerosa da poter fondare sedi vescovili in quasi tutta Italia.
Nulla quindi di strano che cittadine, come Veroli, vicine a Roma, siano
state fra le prime ad avere seguaci numerosi del nuovo culto. E questo credo
di poter affermare pur riconoscendo fondata l’opinione generale che nei centri rurali la nuova fede incontrò a diffondersi difficoltà maggiori che non nei
grandi complessi urbani tanto che da allora la parola «pagano» (cioè abitante
di un «pagus», di un borgo o villaggio) divenne sinonimo di idolatra e non fa
pertanto meraviglia che S. Benedetto, trasferitosi da Subiaco a Montecassino,
pur incontrando nel suo cammino proprio in questa plaga, fra Veroli e Alatri,
un centro cenobitico che lo ospitò, trovasse invece ancora, al principio del VI
secolo, sulla cima del monte «a cui Cassino è nella costa» un bosco e un’ara
dedicata ad Apollo e fosse il primo a portar lassù, per dirla con Dante,
5. Salome Giuseppe Trulli
lo nome di Colui che in terra addusse
la verità che tanto ci sublima
110
Che nel secolo IV il Vangelo avesse già trovato numerosi seguaci in
questi paesi anzi che essi fossero largamente cristianizzati, se ne ebbe pochi
anni addietro una sicura documentazione, quando in uno scavo compiuto
proprio qui, nei pressi della piazza del Duomo, venne alla luce, nel 1922, una
piccola necropoli o cimitero (rimasto in parte inesplorato) del secolo IV-V, che
conteneva alcune decine di tombe sovrapposte le une alle altre, in una specie di
stratificazione. In esse furono rinvenuti anelli di argento o di bronzo con il monogramma cristiano e vasetti di coccio e lucerne con simboli paleo-cristiani,
suppellettili funebri che il farmacista Luigi Reali, nel cui interesse si compiva
lo scavo, donò alla Civica Biblioteca Giovardiana, ove ancora tali oggetti sono
conservati. La datazione di questa necropoli fu inequivocabilmente fornita da
un’epigrafe anch’essa cristiana, che, collocata in uno degli strati superiori della
piccola necropoli, portava il riferimento al secondo consolato di Stilicone cioè
all’anno 405:
STILICONE VIRO CLARISSIMO SECUNDO CONSULE
(...) È certo quindi che sulla fine del IV secolo, dopo la pace Costantiniana, il
nostro paese doveva essere, come ho detto, assai diffusamente cristianizzato e
che una chiesa ove sorge la Cattedrale poteva già essere eretta — come è tradizione — forse sull’area di un precedente tempio, perché la piazza antistante la
Cattedrale stessa era anche allora il centro cittadino, cioè il «foro» dell’antica
«Verulae», come lo comprovano i ruderi con alcuni archi di un’opera pubblica
sottostante questa piazza, nonché gli avanzi di altre considerevoli costruzioni
a grossi blocchi squadrati sottostanti la vicina Casa Comunale e la attigua casa
Mazzoli, il ritrovamento, avvenuto qui presso, pochi anni addietro, della base
di un monumento equestre in onore di un
C. PAQUIUS C. F. IIII VIR.
e di una lastra del pubblico calendario dei tempi di Tiberio (che è in vista nel
cortile della casa Reali) e infine il basamento di una statua in onore di L. Alfio
che fino al 1356 stette ai piedi del campanile, come ricorda il Vecci nella sua
opera manoscritta.
Questa Cattedrale del resto, pur modificata e rifatta nella successione
dei secoli, conserva infatti tuttora l’orientamento caratteristico delle prime basiliche cristiane, con la fronte cioè esposta a levante e con l’abside a ponente. Il
presbiterio della chiesa era allora sopraelevato sul piano generale lasciando al
disotto dell’altare maggiore una cripta o cappella cemeteriale nella cui penombra erano conservati, come vedremo, i resti di Santi e di Martiri fra i quali quelli stessi dei santi Biagio e Demetrio. Dall’altare di questa cripta proviene una
epigrafe che è il documento epigrafico più antico di questa chiesa: il picicolo
marmo reca le parole:
DEPOSITIO MARTVRI PRAESBITERI IN PACI,
KAL. DECEMBRIS, DIE SOLIS INDICTIONE XII
con dati cronologici tali che ne consentono forse la datazione all’anno 384 o
poco dopo e comprovano, come già alla fine del IV secolo o sui primi del V si
deponesse nella cripta di questa chiesa la salma di qualche pio e santo cristiano.
A questo periodo va attribuito anche un frammento di transenna, da
me recentemente rinvenuto nella cattedrale, a tergo di una lastra usata nel 1559
per ricordare i lavori compiuti dall’allora vescovo Ant. Filonardi. Il frammento
(cm. 70 x 60) rappresenta parte di una specie di «cancellus» con decorazione
ad archetti disposti ad embrice, decorazione non rara nel repertorio dei motivi
ornamentali in plutei di altari, di tombe e di recensioni presbiteriali nel periodo paleo-cristiano. Credo di potermi limitare a rammentare come analoghi
esempi il pluteo che con la «fenestella confessionis» rivestiva la tomba e l’alta-
5. Salome Giuseppe Trulli
e cioè:
DP MARTVRI PB / IN PCI KAL DECEM/BRIS D SOLIS IN XII
111
re di S. Alessandro nella omonima catacomba della Nomentana, attribuito al
sec. V (con archetti lavorati a giorno); quello più analogo al nostro conservato
nell’ambulacro discendente di S. Agnese pure sulla Nomentana attribuito al
357 che recingeva il luogo ove era deposta la Santa, nonché altro simile residuo
di pluteo presso S. Maria Antiqua. Il frammento rinvenuto ha per la Cattedrale
Verolana una importanza notevole perché esso fornisce un altro documento a
conferma della sua remota antichità e sta ad affermare la indubbia presenza di
un culto verso santi e martiri nel periodo paleo-cristiano.
5. Salome Giuseppe Trulli
CAMILLO SCACCIA SCARAFONI
Ricordi medioevali della Cattedrale di Veroli e
vicende storiche del suo Tesoro Sacro
estratto dal Bollettino della Sezione di Anagni
della Società Romana di Storia Patria II, 1953
112
Sulle epigrafi di Marturio e di Filomena
Della epigrafe riguardante Marturio, il Prof. Mario Mezzacapo dà questa variante: † D(e)P(ositio) MARTYRI / P(res)B(yteri) IN PACI KAL(endis)
DECEM/BRIS D(ie) SOLIS IND(ictione) XII. “(Ricordo della) deposizione in
pace del presbitero Martirio il primo di dicembre, giorno di domenica, dodicesima indizione”.
«La menzione della domenica, ancora nella forma pagana, unitamente
alla indicazione della indizione dodicesima, rappresentano la chiave risolutrice del problema della datazione del reperto. Infatti, premesso che il numero
romano della indizione (XII) nel nostro testo sta ad indicare il numero d’ordine di un anno nel proprio ciclo indizionale (tale ciclo durava quindici anni) e
considerato che la datazione costantiniana ha inizio nell’anno 313, è possibile
isolare quella serie di anni appartenenti al IV secolo, i quali, ognuno nel proprio ciclo indizionale, occupano il dodicesimo posto. Ne risulta la seguente
serie: 324, 339, 354, 369, 384, 399. Si rileva poi che nella serie così ottenuta, il
1° dicembre, coincidente con la domenica (“die solis”) cade soltanto nel 384,
anno in cui può collocarsi l’epigrafe verolana.
Nel IV secolo il nome Martirio è uno dei più noti e frequenti tra quelli
che appaiono nell’onomastica cristiana, ispirata, secondo un costume orientale, alla nuova fede. (...) In buona sostanza si può affermare che Martirio, presbitero di Veroli, chiuse la sua vita terrena il 29 novembre dell’anno 384; fu
deposto il 1° dicembre, essendo console Flav. Machomer e sotto il papato di S.
Damaso che, guarda caso, cessava di vivere due giorni dopo la deposizione del
nostro Martirio.
(...) Se si considera che il 384 documenta l’esistenza in seno alla comunità cristiana di Veroli di un Martyrius presbitero, il quale rivestì uno dei
gradi più significativi della gerarchia dell’ “ecclesia docens”, si può ben supporre
anche la presenza dell’ “episcopus”. Il presbitero, primus inter pares, infatti, era
il più vicino collaboratore del vescovo. Per la dignità del suo grado, allo stesso
erano affidati i compiti organizzativi più delicati ed importanti della comunità
cristiana» (MARIO MEZZACAPO, La più antica epigrafe cristiana di Veroli, in
Lazio ieri e oggi, giugno 1982).
Per quel che riguarda invece l’epigrafe dell’anno 405, scrive il Prof.
Heikki Solin:
«Essa è indubbiamente cristiana (...) ma non si può controllare; infatti
la lastra sulla quale essa è incisa, recando sull’altra faccia i Fasti Verulani, è
stata murata in modo da rendere leggibili i soli Fasti. L’iscrizione è gravemente
frammentaria, rotta in più pezzi. Fortunatamente Camillo Scaccia Scarafoni
nelle N. Sc. 1923, p. 194 fornisce il testo in maiuscolo, indicando le lacune,
5. Salome Giuseppe Trulli
5.2
113
con proposito di restituzione senza ulteriore commento. Dalla riproduzione
dell’editore si può ricavare che era l’epitaffio di una donna che forse si chiamava “Philumena” (questo è un nome diffuso ovunque nel mondo romano, ben
documentato anche presso i cristiani), dedicatole dal marito di nome “Victorinus” o simile. Del primo nome, che dunque presupponiamo essere quello
della moglie, è conservata solo la fine ]MENA e del nome del marito l’inizio
BICTORI[. Perciò non sarebbe da escludere la possibilità di vedere nel primo
nome quello del marito, essendo “Mena”, un nome comune presso i cristiani fin dal quarto secolo, ispirato dall’omonimo santo egiziano che godette di
grande popolarità; in tal caso il nome della moglie potrebbe essere “Victoria” o “Victorina”, o simili. Il tenore del testo conservato ci induce però a dare
la preferenza alla prima ipotesi. Il nome del marito è seguito evidentemente
da indicazioni relative all’età della donna, sfortunatamente troppo lacunose
per una sicura restituzione. Poi dep]osita ic [est] in domu s[epulcr]ale; però si
deve notare che «domus sepulcralis» è espressione non usuale, mentre si trova
frequentemente «domus aeternalis». Da ciò che resta della datazione, IX Kal.,
(manca il nome del mese) d]ie Bener(is) F[l. S]tilicone v.c. [s]ecund[-con]s. Si
ricava che la deposizione avvenne di venerdì, per cui il mese deve essere stato
marzo o giugno, e il giorno 24. L’indicazione dell’anno con il solo nome di
Stilicone, senza quello di Flavio Antemio, è molto comune nelle iscrizioni, per
il semplice fatto che il consolato di Antemio fu pubblicato nell’Occidente appena poco prima della fine dell’anno. Si noti ancora «secun-dum» o «secundo
cons.», forma meno comune; così anche ICVR 2813»
HEIKKI SOLIN
Nuove iscrizioni paleocristiane della Ciociaria
in II Paleocristiano in Ciociaria, Roma 1978
5. Salome Giuseppe Trulli
Probabile lettura epigrafe del tempo di Stilicone:
114
D…I AD PA(cem)
MEAE…(D)ulcisum(ae)
(Philo)MENA…MI(hi…i)UGA
(l)IS BICTORI(nus…in) DI(e…)IS
(…) VIII IIIIX (…) A(nnis dep)OSI
TA IC (e)ST IN DOMU S(epulchr)ALE
IX KAL. (d)IE BENER(is) F(l.S)TILIC
ONE V.C. (s)ECUND(o con)S
...Verso la pace (di Dio) della
mia affettuosissima Filomena ... legata a me da vincolo
coniugale, Vittorino nel giorno ... all’età di anni ... É stata
deposta qui nel sepolcro il 24
marzo(?), giorno di venerdì,
durante il secondo consolato
di Stilicone.
Gracilia e Salome
Dopo la morte di Nerone, seguirono lotte sanguinosissime; le legioni
elessero imperatori i propri comandanti e Galba, Ottone e Vitellio regnarono
per poco tempo, finendo tutti uccisi. Vitellio, quando era giunto al potere aveva perseguito una politica di feroci vendette, suscitando in tutti il malcontento.
Quando seppe che le legioni del Danubio e dell’oriente si erano accordate sul
nome di Vespasiano, salutato imperatore in Egitto, e che il generale di Vespasiano, Antonio, stava conducendo un esercito in Italia per detronizzarlo, affidò
la difesa ai suoi subordinati. Non appena Antonio giunse a Roma, Vitellio si
rifugiò nel suo palazzo. A Roma era prefetto del pretorio il fratello maggiore
di Vespasiano, Flavio Sabino, il quale fu assalito da un gruppo di vitelliani e
costretto a porre l’estrema difesa in Campidoglio. Tacito, nel Libro III delle
sue «Historie», ci fa sapere che tra i difensori c’erano delle donne, e, tra queste,
una verolana, Gracilia, la bella moglie di Giulio Aruleno Rustico, la quale si distinse per il suo grande valore: «Subierunt obsidium etiam foeminae inter quas
maxime insignis Verulana Gratilla, neque liberos neque propinquos, sed bellum
secuta» («subirono l’assedio anche alcune donne, fra le quali la nobilissima
verulana Gratilla (dei Pomponi) che non seguì nè figli, nè parenti, ma la sua
fazione»)
«Mentre la battaglia infuriava, molti della plebaglia saccheggiarono
case e negozi e le prostitute esercitarono il loro commercio. I soldati di Antonio vinsero, uccisero senza misericordia e senza freno saccheggiarono; la feccia sempre pronta (come la storia) ad applaudire il vincitore, li aiutò a scovare i
loro nemici. Vitellio, tratto fuori dal suo nascondiglio, fu trascinato seminudo
per la città, con un nodo scorsoio attorno al collo, fu ricoperto di letame, lungamente torturato e infine, in un momento di misericordia, ucciso (dicembre
69). Il suo cadavere fu trascinato per le strade con un uncino e buttato nel
Tevere» (WILL DURANT, Storia della civiltà. Cesare e Cristo, Mondadori 1958).
Anno 70 d.C.. L’imperatore Vespasiano guardava con benevolenza i
seguaci della nuova religione, sia perché erano stati favorevoli alla sua elezione
imperiale, sia perché lo stesso Flavio Sabino, fratello di Vespasiano, era cristiano e la nostra Gracilia (Gratilla Pomponia), cristiana tra i primi verolani che lo
sono stati, era amica di Sabino (...).
La saldatura tra il cristianesimo di Gratilla Verulana ed il cristianesimo di Roma si attua anche nella parentela di due matrone cristiane: Pomponia
Grecina e Pomponia Gratilla Verulana; la prima nobile (“insignis”), la seconda
nobilissima (“maxima insignis”), secondo Tacito al vertice della nobiltà e come
tali legate da parentela.
Entrambe appartenevano alla famiglia “Verulana” della “Gens Pomponia” (...).
5. Salome Giuseppe Trulli
5.3
115
5. Salome Giuseppe Trulli
116
La saldatura tra il cristianesimo di Gracilia e il cristianesimo di Veroli
si ha, oltre che nella sua “verulanitas”, nella persona del primo vescovo verolano, il Rusticano Mauro, che altri non è che il cognato di Gratilla, Maurico (da
non confondere con Rusticano Mauro) Rustico.1
La rettifica del nome di questo personaggio è un’operazione necessaria: Tacito dà, infatti, testimonianza della sua appartenenza al Senato romano
già nel 69 (Hist.IV, 40); dagli autori latini apprendiamo che nel 93 fu esiliato da
Domiziano e che restò esiliato fino al 96, morte dell’imperatore. Plinio (Lettere
ai familiari), nell’informarci dell’amicizia che legava questo personaggio a Nerva, apre spiragli nei quali l’opera di consigliere imperiale, dallo stesso Plinio
attestata, lascia intuire la profonda influenza che Maurico ebbe sulla storia di
quel tempo, è, perciò, un’operazione necessaria per correggere un errore provocato dal logorio dovuto al bimillenario tramandarsi della tradizione di Salome,
in qualche periodo, necessariamente, soltanto orale: e ciò spiega perché dal
cognome “Rustico” fu tratta un’indicazione erronea del ceto “contadino” di un
romano, che contadino non era. Questa deformazione nasconde la vera identità di Maurico Rustico: patrizio romano, ricco proprietario di terre (ascritti,
ì suoi avi, come tali a tribù rustica), senatore, consigliere imperiale, fondatore
della Chiesa verolana, primo Vescovo della nostra Città e promotore del primo
incontro tra un Papa (Clemente) ed un Imperatore (Nerva). Incontro, che, alcuni passi della prima Clementina, lasciano sospettare come avvenuto.
È nell’ambito della storia di quel periodo burrascoso, che contrapponeva in Roma schiere di armati, che va inquadrata la venuta a Veroli di Salome. Questa fu da Gracilia condotta nella nostra città (ove già esisteva una
comunità cristiana che aveva nella stessa Gracilia e nei suoi parenti i massimi
referenti) per sottrarla ai pericoli che i disordini romani potevano far correre
alla preziosa ospite della comunità cristiana dell’Urbe.
Perciò, ribaltando un luogo comune, si può dire che non fu Salome a
convertire Veroli, ma la comunità cristiana di Veroli ad accoglierla per offrirle
un comodo e tranquillo rifugio. Salome morì nelle immediate vicinanze di
Veroli e fu ivi sepolta, in contrada Osti, dal Rusticano Mauro, o meglio da
Maurico Rustico. Successivamente i Suoi resti furono condotti all’interno della
città e sistemati nella chiesa principale. Furono infine nascosti tra il 726 ed il
732 nel luogo dove saranno rinvenuti nel 1209.
CARLO TARQUINI
Riduzione ed adattamento da
Maria Salome, la madre dei figli del tuono e Veroli
1
Il vescovo Maurico Rustico era fratello di Giunio Aruleno Rustico, marito di Gracilia.
5.4
Santa Salome
Madre di Apostoli
La nostra amata Patrona, discendente dalla regale stirpe di David, era
la moglie di Zebedeo e la madre di Giacomo (il Maggiore) e Giovanni (l’Evangelista). Sposo e figli erano dei pescatori che con il loro faticoso lavoro nelle acque del mare di Galilea traevano il quotidiano sostentamento. Un giorno lungo
quella riva passò Gesù, mentre essi accomodavano le reti, e li invitò a seguirlo
promettendo loro di farli «pescatori di uomini» e i due giovani, «lasciata lì la
barca e il padre, lo seguirono» (Mt. IV, 18-22).
La madre sentì tutto il sacrificio del distacco dei suoi figli, che erano
conforto ed aiuto alla famiglia, ma non si oppose alla loro vocazione. Quel
generoso sacrificio fu per lei il motivo della sua grandezza, perché da allora
divenne la madre di due apostoli che con San Pietro furono, come scrive San
Paolo, «le colonne della Chiesa» (Gal. II, 9). Gesù ebbe per loro particolari
attenzioni ed essi soli, insieme al Principe degli apostoli, furono degni di assistere alla risurrezione della figlia di Giairo (Lc. VIII, 51), di godere della gioia
della Trasfigurazione (Mt. XVII, 1-9) e di osservare più da vicino l’agonia del
Getsemani (Mt. XXVI, 37).
È vero che questa madre per un momento si lasciò guidare dalla voce
del sangue e chiese al Divino Maestro di far sedere Giacomo e Giovanni a
destra e a sinistra nel suo Regno (Mt. XX, 21), ma fu anche fiera della risposta
affermativa dei figli alla domanda di Gesù se cioè potevano bere il calice della
sua Passione (Mt. XX, 22) e fu coraggiosa di offrirli a lui decisamente senza
riserve.
Veramente fortunata Santa Salome che ha assistito il Salvatore sul Colle del dolore e ne ha ascoltato le ultime parole d’amore! Le è sobbalzato il cuore
in petto quando ha notato che anche su la Croce Gesù si è interessato del suo
figliuolo Giovanni ed a lui, rappresentante allora dell’umanità intera, ha affidato la sua propria Madre «ecce Mater tua» (Giov. XIX, 27). Ha compiuto il suo
pietoso ufficio, accompagnando Gesù morto alla sepoltura ed asciugando le
lagrime dell’Addolorata.
5. Salome Giuseppe Trulli
Presente sul Calvario
117
Testimone della Risurrezione
Passato il sabato — dopo la morte e il seppellimento di Gesù — Maria
Maddalena, Maria madre di Giacomo (il minore) e Salome comprarono aromi
per recarsi ad imbalsamare quel sacro Corpo. La mattina del primo giorno
della settimana molto per tempo, preoccupate della difficoltà di rimuoverne la
grande pietra, arrivarono al Sepolcro che, con loro meraviglia, videro aperto e
vuoto, ma un bianco Angelo le assicurò: È risorto..., lo vedrete in Galilea (Mr.
XVI, 1-8).
La immagine della nostra Santa Patrona si rappresenta con un vasetto
in mano per ricordare appunto il delicato pensiero che lei ha avuto, insieme
alle altre Marie, di profumare il Corpo esanime del Salvatore.
Questo ci dice quanto ella amasse Gesù e che proprio per questo amore lei, con le altre, meritò di vedere il Risorto, che le inondò l’anima di gioia
ineffabile.
5. Salome Giuseppe Trulli
Apostola del Vangelo
118
Salome si trovò fra le Donne, che gli Atti degli Apostoli ci dicono adunate in preghiera, insieme alla Vergine SS.ma ed agli Undici, in attesa del Paraclito promesso da Gesù. «E giunto il giorno della Pentecoste... apparvero,
distinte l’una dall’altra, delle lingue che parevano di fuoco e se ne posò una su
ciascuno di loro e tutti furono ripieni di Spirito Santo» (Atti II, 1-4).
Quel Fuoco suscitò in quelle Anime la febbre dell’apostolato ed anche
le Donne, come poi attesta San Paolo per i suoi tempi (Fil. IV), si diedero a
lavorare per la diffusione del Vangelo «laboraverunt in Evangelio». Nel numero
di queste donne apostole certamente fu la nostra Santa Patrona, che così da
vicino aveva seguito il Maestro, lo aveva inteso parlare del suo Regno, lo aveva
assistito agonizzante, lo aveva rivisto gloriosamente risorto e salire al Cielo,
mentre raccomandava agli Apostoli di andare nel mondo a predicare il Vangelo a tutte le genti.
Antica ed accreditata tradizione riferisce che lei, nella dispersione
della chiesa di Gerusalemme, effettuata da Erode Agrippa (Atti, VIII, 1), sia
venuta in Italia ed a Veroli abbia terminata la sua vita, consumata dal lavoro e
dall’età (Comm. di Cornelio A. Lapide al Cap. VIII degli Atti; Ughel. Ital. Sac. Ep.
Verul.).
Collaboratori del suo apostolato
II 29 novembre di ogni anno la Chiesa Verolana ricorda il martirio
dei Santi Biagio e Demetrio. Essi furono, secondo la tradizione, i collaboratori
più fedeli della nostra Santa Patrona nel lavoro dell’apostolato; insieme ad altri
ventidue cristiani, subirono il martirio in Veroli per la fede di Gesù Cristo. Il martirologio in pergamena del secolo decimoterzo, conservato nella
chiesa di Sant’Erasmo, registra che Biagio cadde vittima del Preside Onorio
sotto il taglio della spada e Demetrio finì il suo martirio nel fondo di una orrida prigione dopo fiere percosse; i loro corpi furono devotamente composti nel
sepolcro sottostante all’ingresso della vecchia Cappella del Tesoro della Cattedrale.
Ora i resti mortali dei due Santi Martiri si trovano a sinistra e a destra
delle Reliquie di Santa Salome, nella «Confessione» della Basilica omonima,
mentre la pittura su l’altare del Sacramento in Sant’Andrea ce li mostra pellegrini ai lati della Santa.
La Storia verolana registra avvenimenti che dimostrano l’intervento
manifesto della protezione di Santa Salome a vantaggio della nostra Città.
Nell’assedio delle truppe spagnole, capitanate dal Duca di Toledo, nel
1556 Veroli corse pericolo di essere messa a ferro e a fuoco, ma quando il condottiero si accingeva ad entrare dalla Porta Napoletana, il suo cavallo improvvisamente cadde in ginocchio. Rialzato, a stento si giunse nei pressi dell’antica
Chiesa di San Pietro Ap., ai piedi di «Castello», qui il cavallo di nuovo piegò i
ginocchi e, per quanto si facesse, riuscì vano rialzarlo. Un sacerdote spagnolo,
canonico della Cattedrale, fece rilevare al suo connazionale il potere di Santa
Salome, madre di San Giacomo, Patrono della Spagna; ed il Duca allora, desistendo dalla sua minaccia, a piedi si recò devotamente a venerare le Reliquie
della Santa (Crescenzi, Santa Salome). A ricordo del prodigio sul luogo fu posta
una catena di ferro e una lapide.
Nel colera del 1837, importato dall’Asia e penetrato, attraverso il porto
di Napoli, in parecchie città italiane specie dello Stato Pontificio, i Verolani
rivolsero fervide preghiere alla Santa Patrona e furono salvi da tanto flagello
(Crescenzi, Santa Salome).
Nell’anno 1915 la nostra Città, così vicina all’epicentro del terremoto
marsicano, fu risparmiata dalla rovina e dalla morte. Tutti allora mostrarono
gratitudine a Santa Salome e l’annuale triduo di gennaio è in ringraziamento a
Lei per lo scampato pericolo.
5. Salome Giuseppe Trulli
Sua Protezione Materna
119
Ricordiamo con terrore la notte del 1° Giugno 1944 quando, a conclusione dell’aspra e lunga battaglia di Cioceria, nel fronte di Cassino, Veroli fu
violentemente cannonneggiata. La mattina seguente sentimmo spontaneo il
dovere di recarci, e alcuni anche a piedi scalzi, nella Basilica della Santa Patrona a ringraziarla.
5. Salome Giuseppe Trulli
ADOLFO BROCCHI
Santa Salome, Veroli 1958
120
5.5
Culto di Santa Salome
II culto di questa Santa, ricordata nei vangeli ed effigiata nelle catacombe1 poteva da tempo esser vivo nei verolani se essi già prima del rinvenimento delle reliquie, ne usavano il nome nella onomastica familiare2. Una nota
relativa alla sua festa compare nel già ricordato martirologio pergamenaceo
manoscritto del sec. XIII della chiesa di S. Erasmo alla data del 25 maggio. La
piccola chiesa di S. Pietro al «largo della catena», che forse ricordava il passaggio del principe degli Apostoli nella nostra cittadina era, fino a pochi anni
addietro, rammentata dai residui di tre arcate gotiche che purtroppo sono state
demolite per esigenze stradali; ma la personalità di quel Tommaso che scoprì il
luogo della tomba di S. Salome è documentata tuttora da pergamene sincrone
che testimoniano doni, offerte o vendite che fecero i verolani nel 1210 e seguenti in suo favore per la costruzione di una cappella sul luogo ove la tomba,
scavata nella viva roccia, era stata rinvenuta. Le reliquie della Santa furono
allora conservate in un’arca di pietra appositamente scolpita sul cui coperchio
si legge tuttora, in caratteri del sec. XIII, l’iscrizione:
«RELIQUIAE S. MARIAE MATRIS APOSTOLORUM JOHANNIS EV. ET
JACOBI»
2
È importante notare che il nome Salome si trova già in documenti verolani anteriori
all’anno della invenzione delle reliquie della santa e cioè al 1209: la perg. dell’ardi, cap. n. 373
dell’a.1195 ne fornisce una documentazione: «Ego Bona Octabiani et Caritiae filia vendo vobis
fratrimeo Adinulfo et uxori tuae Salome vineam...» («Io Bona, figlia di Ottaviano e di Carizia,
vendo a voi, mio fratello Adinolfo e tua moglie Salome, una vigna...»). Lo stesso rinvenimento
delle ossa dei compagni di S. Salome, Biagio e Demetrio, avvenuto una quindicina di anni prima
sotto il pontificato di Celestino III, doveva aver risvegliato nei verolani il ricordo della Santa prima ancora del rinvenimento delle sue reliquie. Il culto di questa santa doveva esser largamente
diffuso nella Chiesa romana ed una reliquia, non del suo corpo ma di un oggetto appartenutole,
era conservato in uno dei tanti reliquiari e tabernacoli della vecchia basilica Costantiniana di S.
Pietro in Vaticano (cfr.T. Alpharanus: «De basilicae Vat. antiquissima et nova structura» (Roma,
1914), pag. 99: “de scutella ubi Maria Jacobi et Salome comoederunt” («scodella dove mangiarono
Maria di Giacomo e Salome..» ). Due edizioni quattrocentine a stampa, censite dallo Hain coi
n.ri 8746 e 8747, recano fra l’altro anche la vita di S. Salome, ma, non essendo risultati posseduti
questi due incunaboli da nessuna biblioteca pubblica d’Italia, non mi è stato possibile esaminarne il contenuto.
5. Salome Giuseppe Trulli
1
J. WILPERT: Die Katakombengemalde, Friburgo, 1891, tav. XVIII, riporta un disegno
ripreso dal Ciacconio nelle catacombe di S. Valentino in cui una donna è effigiata e identificata
dal nome MR (Maria) SALOMET ma tale figura, già ritenuta per la nostra Santa, pare si riferisca
invece, secondo la più recente critica, ad una strana leggenda riportata da uno pseudo evangelo.
121
Ma il capo della Santa, come oggetto di particolare devozione, fu racchiuso in un busto di argento dorato, lavorato a sbalzo, che nella rigidità della
posa e nella spaventata vivacità degli occhi niellati e tagliati a mandorla rammenta l’arte bizantina. In due cassette di argento con le figure sbalzate della
Santa, dei Figli e dei suoi compagni e con la figura del Vescovo del tempo, Leto o Leo, furono racchiuse alcune reliquie; ma di queste due cassette descritte
dal già citato Necchiaroli nel 1730 non si conserva ora che la riproduzione
xilografica in un volume di incisioni della Biblioteca Giovardiana, perché già
nel 1748 questi reliquiari non figurano più nei minuti atti notarili riguardanti
la ricognizione dei resti della Protettrice e furono forse fusi per formare purtroppo con quel metallo altri ostensori.
CAMILLO SCACCIA SCARAFONI
5. Salome Giuseppe Trulli
Ricordi Medioevali..., cit.
122
5.6
Una catena a perenne ricordo
Largo della Catena
A Dio Ottimo Massimo. O passante, fermati e venera la beata Salome, patrona di Veroli, che, avendo impetrata da Dio la salvezza della città, la salvò da gravissimo pericolo. Infatti, Ferdinando di Toledo, duca d’Alba, comandante dell’esercito nemico,
avendo presa con la forza la città dopo averla assediata, minacciò la strage dei cittadini.
Improvvisamente, messi da parte i sentimenti di vendetta, frenò i soldati pronti alla
distruzione ed alla rapina e trattò umanamente la città. Il Senato e il Popolo Verolano,
l’anno del Signore 1556, nel luogo dove avvenne il fatto, dispose con pubblico decreto
di apporre su questo muro la tipica catena della schiavitù. Sebastiano de’ Sebastiani,
proprietario della casa, ne pose la memoria scolpita nel marmo a documento dei posteri, nell’anno del Signore1742
Filippo II aveva ereditato da Carlo V (1556) il vasto regno e il gran peso della
lotta contro la Francia. Avendo il papa Paolo IV preso le parti della Francia,
Filippo II mosse guerra al papa e mandò Don Fernando Alvarez duca d’Alba
5. Salome Giuseppe Trulli
D.O.M.
SISTE GRADUM VIATOR
AC B. SALOMEN VERULI PATRONAM
VENERARE
QUAE URBIS SALUTEM A DEO DEPRECATA EAM AB MAXIMO PERICULO SERVAVIT
VI ENIM POST OBSEDIONEM CAPTA
FERDINANDUS TOLETANUS ALBAE DUX
HOSTILIS EXERCITUS IMPERATOR
INTERNICIONEM CIVIBUS MINATUS
DEPOSITA REPENTE IRA
MILITES COETIBUS PRAEDAQUE INHIANTES COMPESCUIT
AC CIVITATEM HUMANE TRACTAVIT
S.P.Q.V. AN. DNI MDLVI
IN LOCO UBI RES EVENIT
CATENAM SERVITUTIS NOTAM
AD HUNC MURUM APPENDI
EX PUBLICO DECRETO JUSSIT
SEBASTIANUS DE SEBASTIANI AEDIUM DNUS
FACTI SERIEM AD POSTERORUM DOCUMENTUM
MARMORI SCULPTAM POSUIT
ANNO DNI MDCCXLII
123
5. Salome Giuseppe Trulli
124
e viceré di Napoli nello Stato Pontificio con 12000 uomini e 1500 cavalieri
comandati da generali frementi di vendetta. Conquistate Ceprano, Falvaterra, Castro de’ Volsci, Ripi e Bauco (Boville Ernica), il duca inviò Don Garcia
ad assediare Veroli, allora governata dal luogotenente Marco Aurelio Maffei,
essendo podestà Federico Roscio da Genzano e vescovo Antonio Filonardi. Il
presidio verolano era comandato dai capitani Bargello da Fabriano e Lorenzo
da Perugia con due compagnie di soldati oltre alle milizie cittadine. I difensori
di Veroli cercavano di resistere ad ogni costo, ma poi, vedendo che il cannone
avversario apriva brecce nelle mura, chiesero tre giorni di tregua sperando di
ricevere in quel frattempo aiuti dal papa o da suo nipote, il conte di Montorio,
duca di Paliano. Intanto il nipote del generale, Virgilio Corradino, per spiare i punti più vulnerabili della città, si accostò troppo alle mura e il verolano
Flavio Fiorini con un colpo di spingarda l’uccise. Il generale ordinò allora di
saccheggiare e distruggere Veroli. Ma la città era protetta da Santa Salome. I
verolani mandarono nel campo nemico un canonico della cattedrale chiamato
Giovanni affinchè trattasse la pace con Don Garcia.
Il religioso cercò di persuadere il generale di astenersi dal distruggere
la città perché protetta da Santa Salome, madre di S. Giacomo il Maggiore, a
sua volta protettore della Spagna. Don Garcia promise di non fare alcun male
alla città purché gli venisse consegnato l’uccisore del nipote, che però non fu
potuto ritrovare. Mentre Don Garcia era nei pressi del convento dei Minori
Osservanti di San Martino, gli vennero incontro gli ufficiali con le chiavi della
città. Di nuovo domandò loro di Flavio Fiorini e quelli risposero che avrebbero fatto del tutto per soddisfarlo. Ma il generale, che aveva ormai deciso
di inoltrarsi nella città, non potè farlo perché il cavallo su cui era montato si
inginocchiò e a stento lo si potè rialzare. Giunto davanti alla chiesa di San
Pietro, il cavallo si inginocchiò di nuovo e, per quanto si facesse, non si riuscì
a rimetterlo in piedi. Allora il canonico si presentò al generale dicendogli che
in quel prodigio riconoscesse la mano di Santa Salome per proteggere Veroli.
Don Garcia, turbato da quel prodigio, revocò la sentenza e ordinò ai soldati di
non recare danno alla città; poi, sceso da cavallo, si recò alla cattedrale, dove
fu accolto dal Capitolo. Venerato il sacro corpo della patrona, ne chiese qualche reliquia, ma mentre un canonico ne estraeva un dente, uscì vivo sangue.
Don Garcia di fronte a questo nuovo miracolo, rinunciò al suo desiderio e si
accontentò del poco sangue che aveva raccolto in un pannolino; poi, toltosi
dal dito l’anello, lo donò alla santa. Don Garcia partì da Veroli lasciando due
compagnie di soldati spagnoli e italiani i quali rimasero fino alla pace conclusa
a Cave, nella casa Leoncelli, tra il cardinale Carafa, nipote del papa, e il duca
d’Alba (14 settembre 1557).
GUIDO SPANI
La chiesina della Madonna degli Angeli
La chiesina della Madonna degli Angeli sorge a circa due chilometri
dal centro di Veroli, a pochi metri dalla strada che unisce il quartiere medioevale di Santa Croce con il Giglio, sulla Maria.
È situata al centro di una zona archeologicamente e storicamente interessante, paesaggisticamente suggestiva, dove testimonianze di fede e strane
leggende si intrecciano e, a volte, si confondono.
A «San Giuseppe Le Prata» un bel tratto di mura megalitiche, costituito da massi, alcune volte di forma rettangolare, altre, e più spesso, simili a
poligoni irregolari, sempre perfettamente combacianti, dagli spigoli affilati e
dalle superfici levigatissime, sfida ancora il tempo.
Più a nord, verso la chiesa di Sant’Anna, un altro tratto di mura, più
rozzo e più antico, è di una suggestione immediata.
E non è difficile imbattersi, nella zona, in reperti interessanti che, a
volte prepotentemente, affiorano qua e là, quasi a voler confermare ad ogni
costo la forza e la vitalità di una civiltà ormai in completo dissolvimento.
Su uno sperone roccioso, quale scudo a difesa della chiesetta degli Angeli, è ancora al suo posto, severa ed austera, la medioevale «Torre di Santo
Spirito», muta testimone di combattimenti e scontri che insanguinarono non
solo questa zona, ma anche le contrade vicine, come quella detta della «Vittoria», che porta ancora questo nome per ricordare, appunto, la vittoria del duca
verolano Regnerio su Garferio, principe dei Saraceni.
Testimonianze di lotta, dunque, ma anche testimonianze di fede sopravvivono, spesso faticosamente: piccole tavole dipinte con ingenue immagini di santi, edicole, cappelle, chiesuole sparse un pò dappertutto, anche lungo
gli itinerari di nessuna importanza, erano motivo di edificazione per i viandanti, i quali recitavano una giaculatoria e si segnavano con l’acqua benedetta
la fronte e il petto.
Le ruspe ed i mezzi meccanici moderni, che impietosamente e violentemente tutto divorano, hanno modificato in parte l’aspetto originario del paesaggio, ma, nelle immediate vicinanze della chiesetta degli Angeli, c’è ancora
un angolo di paradiso.
Non è esattamente il caso delle terre comprese tra monte Nero e monte Schiavitto, un tempo sommerso dalle acque del lago Canoce, dove, in occasioni particolari, si svolgevano finte battaglie navali, ad imitazione di quelle,
più famose, che si tenevano a Roma.
È l’«Ondola», a poche centinaia di metri dalla chiesa, il luogo magico,
non ancora offeso dall’egoismo dell’uomo moderno e tanto caro al famoso incisore Dorè, che vi si recava spesso con il suo taccuino al fine di trarre ispira-
5. Salome Giuseppe Trulli
5.7
125
5. Salome Giuseppe Trulli
126
zione per le sue celebri tavole.
Ma leggiamo ciò che dell’Ondola scrive Luigi Alonzi nel suo volume
«Itinerari di Cioceria»:
«A sinistra del ponte che scavalca le acque del Bagno, poco discosto
dal mulino e dalla strada antica, una fenditura rocciosa s’apre tra due colline:
l’una assai scabra, con qualche ulivo qui e là; l’altra ricoperta di elcini e di querce, e in basso di spini e di muschi. Il paesaggio a contrasti è quasi nordico, e la
tentazione di insinuarsi in quella strettoia, irresistibile.
Sul letto del torrente affiorano rocce diseguali, levigate e arrotondate dallo scorrere delle acque, da una parte emergenti, in altro sito inclinate o
depresse; e, ai lati della stretta, due strapiombi che s’aprono e chiudono a ogni
passo. Su, in alto, una lista di cielo appena appena».
Luoghi tanto suggestivi sono la cornice ideale dei racconti, spesso lugubri e sinistri, che i vecchi della contrada trasmettono, da generazioni, a figli
e nipoti.
È il caso dell’«Ara delle streghe», dove, nelle notti di plenilunio, si riunivano spiriti dannati, streghe e diavoli per compiere le loro operazioni malefiche: dopo orge sessuali e parodie blasfeme della messa, andavano in giro
schiamazzando, per terrorizzare i poveri abitanti della contrada.
Ma anche il racconto, piuttosto confuso, di Maria Francesca è terrorizzante.
In una grotta del monte Schavitto i briganti tenevano nascosta, vicino
ad un favoloso tesoro, una fanciulla di nome Maria Francesca, che avevano rapito brutalmente durante un violento temporale in un afoso pomeriggio d’estate.
Per la sua liberazione era stato chiesto un forte riscatto, ma la somma
non fu pagata e Maria Francesca, uccisa col taglio della testa, fu sepolta nella
grotta dei briganti accanto al tesoro maledetto.
Dopo qualche tempo Maria Francesca apparve in sogno ad un contadino, indicandogli la grotta in cui era sepolta, e supplicandolo di liberarla. L’uomo, molto turbato, si presentò all’ingresso della grotta, e vide una
scena raccapricciante: Maria Francesca aveva un bambino in braccio ed era
accanto ad una culla ricolma d’oro. Ma era senza testa, ed aveva gli intestini
completamente fuori. Terrorizzato, il contadino scappò verso la chiesa degli
Angeli, inseguito inutilmente da Francesca che gli scagliò contro il terribile
anatema: «Sii maledetto, tu ed i tuoi figli, fino alla settima generazione!».
Ma, da allora, nessuno ha visto più, né udito la voce di Maria Francesca, e la maledizione, fortunatamente, non ha avuto alcun effetto.
In questi luoghi, dove le leggende si mescolano ancora con le tradizioni e con la storia, giunsero, quasi duemila anni or sono, tre strani personaggi,
una donna e due uomini, dalle idee molto chiare e con un obiettivo preciso:
diffondere la parola di Cristo. Si chiamavano Salome, Biagio e Demetrio.
Salome era la madre di Giacomo il Maggiore e di Giovanni l’Evangelista. Aveva
5. Salome Giuseppe Trulli
assistito fino in fondo alla morte di Gesù ed aveva asciugato sul Colle del dolore le lacrime della Madonna. Giunta a Roma con i suoi infaticabili collaboratori, percorse la via Latina e si fermò a Veroli, ospite di un contadino di nome
Mauro, nel punto esatto in cui sorge ora la chiesina degli Angeli.
Dopo una intensa, feconda collaborazione, i magnifici quattro furono
costretti a separarsi: Biagio fu decapitato e Demetrio finì in carcere. Mauro,
consacrato vescovo da S. Pietro, subì il martirio a Bisceglie, vicino Bari, mentre
Salome, morta vecchissima, ebbe la sua prima sepoltura fra le rocce dell’Ondola. Da allora zampillò in questo punto una sorgente di acqua purissima, la
«Fontana dell’oro», vero e proprio «dono di Santa Salome», come gli abitanti
degli Angeli continuano a ripetere.
Nel medioevo, per ricordare il luogo dove si era fermata la nostra Santa, sorse una edicola conosciuta con il nome di «Cona de Santo Mauro». Dopo
l’edicola, furono costruiti, subito dietro, tre rozzi ed angusti locali, oltre ad una
scala in pietra, malamente scalpellata e di una povertà tutta francescana.
Grosse e preoccupanti crepe si aprono paurosamente nello spessore
della muratura, e la costruzione sembra oggi irrimediabilmente compromessa.
Nel sedicesimo secolo il vescovo Antonio Filonardi concedeva indulgenze a chi avesse cooperato alla costruzione di una chiesa che avrebbe
incluso fra le sue mura la preziosa «cona». I lavori, iniziati sollecitamente, si
protrassero nel tempo, e praticamente si conclusero con la venuta dei certosini,
quando questi, a seguito della soppressione dei luoghi pii voluta da Napoleone,
dovettero abbandonare il loro monastero di Trisulti. Sulla parete di fondo della
chiesa è raffigurato, infatti, S. Bruno, fondatore dei certosini, che spicca con il
candore del suo abito tra le immagini che inquadrano una plastica e cromaticamente ricca «Trinità».
Ma il cuore della chiesina degli Angeli rimane pur sempre l’antica
«cona di Santo Mauro».
Gli affreschi che rivestono splendidamente il suo interno rappresentano, sulle pareti laterali, Salome, Biagio, Demetrio e Mauro, mentre, sul muro
di fondo, è raffigurata la Madonna che allatta il Bambino. In alto, sulla volta,
campeggia la figura dell’Eterno Padre benedicente.
L’autore di tali affreschi sembra essere Antoniazzo Romano, pittore
tra i più fecondi nella Roma del quattrocento. Le caratteristiche della sua arte,
sensibile agli influssi dei pittori contemporanei di lui più famosi, sono qui facilmente individuabili.
Il volto della Madonna, per esempio, se ricorda la cristallina bellezza
delle immagini di Piero della Francesca, è piuttosto lontano dall’astratto ed
impassibile mondo figurativo del Maestro di Borgo S. Sepolcro.
Lo sguardo dolcemente pensoso della Vergine, ed il gesto del Piccolo
che con estrema naturalezza succhia il latte della propria Madre, dimostrano
nell’artista romano una maggiore comprensione per la pittura più umana e
127
5. Salome Giuseppe Trulli
128
«terrena» di Melozzo.
Ma, con il pittore romagnolo, Antoniazzo condivide anche una certa
predilezione per l’ampiezza delle forme e per la monumentalità dell’insieme.
Perfino il trono su cui siede la Madonna, vasto e largo, abilmente disegnato
secondo le regole della prospettiva centrale, sembra sottolineare quel senso di
grandiosità che emana dall’affresco in esame.
Il paesaggio che si sviluppa dietro il trono, merita di essere osservato
attentamente, non solo per la delicatezza dei colori, ma anche e soprattutto per
la freschezza di alcuni particolari ottenuti con poche pennellate, rapidissime,
eppure creatrici di forme.
Le navi, molto lontane, ancorate nel porto di una fantastica città, e le
deliziose figurine che animano il paesaggio, sono schizzate con estrema facilità
e sicurezza.
Non mancano scene gustose, come quella di sinistra, in cui un asinello si è caparbiamente impuntato e ha deciso di non muoversi, sebbene venga
spinto con forza da un gruppetto di volenterosi, accorsi a dare man forte al
padrone del cocciuto animale.
A destra, un altro asino, meno capriccioso del primo, segue docilmente e speditamente un più fortunato padrone. Fa strada un minuscolo, ma vivacissimo cagnolino.
L’Eterno Padre benedicente lascia ammirati per le eccezionali doti plastiche che il pittore dimostra di possedere. Si tratta di una plasticità nutrita di
un chiaroscuro morbidissimo e perfettamente fuso con un colore insolitamente denso e ricco.
Al contrario, i Santi dipinti sulle pareti laterali della «cona», ci stupiscono per la loro fragile consistenza e per la profonda spiritualità dei volti,
permeati di una sottile, indicibile malinconia.
Pur negandogli la stoffa degli innovatori, bisogna riconoscere in Antoniazzo, oltre alla sua capacità di assimilatore profondo, padronanza di mestiere e doti pittoriche notevolissime; insomma un Maestro di qualità.
Oggi nella contrada degli Angeli si parla sempre più spesso delle singolari virtù dei santi affrescati nella «cona», del loro zelo nella diffusione della
fede, del loro grande amore per il Cristo, del loro coraggio nell’affrontare il
supremo sacrificio della vita.
Di Maria Francesca e dei briganti si parla invece sempre meno. La loro
grotta, ormai, non fa più paura.
Anche le streghe sono scomparse, e gli uccelli nidificano festosi fra le
travi della vecchia casa sull’aia.
Gli abitanti attendono sereni alle loro occupazioni millenarie, mentre
«la vita scorre tranquilla e laboriosa, ancorata agli affetti puri e alle gioie semplici e genuine dell’esistenza».
A tenere loro affettuosa compagnia ci sono quattro amici: Salome, Bia-
gio, Demetrio e Mauro. Ma c’è anche una Mamma dolcissima e c’è il Bambino
più bello del mondo: una garanzia per l’Eternità.
GIUSEPPE TRULLI
5. Salome Giuseppe Trulli
Testo dell’audiovisivo La chiesina della Madonna degli Angeli
129
5. Salome Giuseppe Trulli
5.8
130
Salome: una donna vestita di nero
Molto suggestiva la processione che si è svolta oggi pomeriggio, 24
maggio 1990, per le vie di Veroli, con la statua lignea della nostra protettrice, Santa Salome, tornata da pochi giorni nella nostra città, dopo essere stata
splendidamente restaurata e ricoperta di una lamina d’argento. Anche io vi
ho partecipato, percorrendo le nostre strade illuminate a giorno da lampade
e torcie, tra gli scoppi dei fuochi d’artificio ed il suono festoso delle campane.
Mentre seguivo da vicino il simulacro della santa, ho provato una grande emozione: lei davanti, io dietro, ignorando le persone che mi erano accanto, ho
sentito la stessa sicurezza e la stessa gioia che può venire al figlio dalla madre
quando camminano insieme.
Durante il tragitto, il mio pensiero è andato a quel mese di giugno del
1944, quando, subito dopo l’ingresso degli alleati a Veroli, fu fatta una processione a cui parteciparono quasi tutti gli abitanti del centro e delle frazioni, i
quali, a piedi scalzi e con enormi fasci di candele sulle braccia, ringraziavano a
gran voce Santa Salome per averli preservati dalla distruzione della guerra. Ed era vero. Per molto tempo, allora, si parlò dell’intervento miracoloso della nostra protettrice che rinnovò quell’altro del 1556, quando si oppose al
comandante delle truppe spagnole che stava per mettere a sacco la nostra città.
Alla fine del maggio 1944 alcuni carri armati alleati che tentavano di
entrare nel paese, furono improvvisamente fermati alla curva che precede il
ponte del Crocifisso da raffiche di mitragliatrice sparate da un soldato tedesco appostato nei pressi del cimitero. Allarmato per la supposta presenza di
soldati avversari, l’ufficiale comandante la colonna dei carri decise di chiedere
al comando superiore l’immediato intervento delle fortezze volanti per eliminare ogni resistenza, anche a costo di distruggere la città. In quel momento
gli si fece innanzi una donna, non più giovane e vestita di nero, che lo convinse a
desistere dal suo terribile quanto inutile proposito perché a Veroli — ella diceva —
erano rimasti soltanto tre soldati tedeschi, di cui uno era quello che sparava
dal cimitero. Poi scomparve. L’ufficiale, turbato dall’incontro con quella strana
donna, ascoltò il suo consiglio ed entrò a Veroli evitando altro spargimento
di sangue. Il 2 giugno lo stesso ufficiale, scendendo nella cripta della chiesa di
Santa Salome e guardando la statua nera della nostra protettrice (era di questo
colore prima del recente restauro) riconobbe in lei le sembianze della donna
incontrata al ponte del Crocifisso!
Mentre la processione rientrava in chiesa, le campane continuavano
a suonare a distesa, come quarantasei anni fa. Allora erano l’espressione della
voce del popolo che ringraziava la santa protettrice per lo scampato pericolo.
Quella stessa voce, oggi, la ringrazia per essere finalmente tornata, così bella,
tra noi. A me è sembrato di avere fatto una bella passeggiata in compagnia di
una persona cara alla quale ho raccontato tante cose e dalla quale ho avuto
tanto conforto.
5. Salome Giuseppe Trulli
GIUSEPPE TRULLI
131
5.9
2007: anno della Ricognizione Canonica
VIII CENTENARIO DEL RITROVAMENTO DEL CORPO
DI SANTA MARIA SALOME
5. Salome Giuseppe Trulli
1209 – 2009
132
Veroli, dall’anno 2007 all’anno 2011, ha vissuto momenti straordinari
e irrepetibili della sua storia, vissuti tutti nel nome della Madre Santa Maria
Salome nella ricorrenza dell’ottavo centenario del ritrovamento del suo venerato corpo, avvenuto il 25 maggio del 1209. Si! Momenti d’intenso fervore e di
ritrovato orgoglio; momenti in cui ogni figlio di questa terra è stato chiamato a
riappropriarsi della sua tradizione, poiché cosi è stato inteso questo VIII centenario, cioè un viaggio nella memoria, per dare un futuro al passato, una scossa
a destarsi da una sorta d’assopimento spirituale tale da portare questa antica
comunità ad un impoverimento interiore e a una freddezza tale che rischiava
di far dimenticare la grandezza a cui la provvidenza l’aveva vocata: a custodire
gelosamente la tomba di Maria Salome Discepola del Signore, la Madre degli
Apostoli Giacomo e Giovanni.
Allora, ci è apparso giusto far ripartire il nostro futuro, lì dove l’avventura spirituale della nostra gente era iniziata, dove si affonda la radice della nostra civiltà, attorno alla tomba della Madre della Città, il sacello che nei
secoli è diventato il cuore pulsante della verolana gente, il luogo sacro dove si
sono rinverdite le speranze e spente le paure, cioè la confessione della Basilica
a Lei dedicata. È lì che il giorno del Signore 21 del mese di ottobre dell’anno
2007 alla presenza delle autorità religiose e civili, di una moltitudine di popolo
orante, all’ora stabilita dopo un secolo è stato riaperto il Sacro Deposito e mostrato al popolo i resti mortali della Mirrofora Maria Salome. Mai nella vita ho
potuto vedere tante lacrime di gioia; i volti sembravano raggianti mentre dalle
volte della Basilica scendevano piogge di petali di rose bianche che rendevano
tutto irreale e per un attimo davvero ci siamo sentiti “unica famiglia” attorno
alla Madre quasi che il tempo si fermasse…
Da quel momento il Corpo della Patrona è stato portato nel Monastero delle Benedettine perché lo custodissero durante la ricognizione canonica
e affinché la commissione appositamente istituita potesse più comodamente
iniziare lo studio dei reperti.
Con trepidazione ma ancor di più con venerazione è iniziato un cammino a ritroso nel tempo per cercare, aiutati dalle moderne tecniche scientifiche, di ristabilire una verità storica, e traslare la tradizione Verolana di Salome
ad una storia di Salome e Veroli.
5. Salome Giuseppe Trulli
Mi pare giusto, a questo punto, elencare le sorprese che questa ispezione ha portato con sé:
• Come dicevano i documenti antichi, è stata rinvenuta una piccola
pergamena che ha la funzione di attestare l’autenticità di quel corpo; e cioè
“Maria madre di Giovanni Apostolo e Giacomo è qui – Maria di Giacomo”. Questa pergamena è stata fatta analizzare da esperti dell’archivio segreto vaticano
e certamente può essere datata attorno al X secolo, altri esempi di tale scritto
si possono trovare nella biblioteca Nazionale di Palermo e nell’autentica delle
reliquie della compagna di Salome, Maddalena.
• Gli scritti antichi parlavano sempre di un panno o velo, ma la descrizione era piuttosto povera. È stato trovato un velo lungo tre metri e largo
cinquanta, certamente antico; sembra richiamare, per la tessitura e le fasce colorate, un velo orientale. Esso aveva la funzione di chiudere a mo’ di fagotto, in
due punti, frammenti di ossa e calcina della così detta tomba di Salome.
• Come gli antichi documenti dicevano, è stato trovato un frammento
di pietra; probabilmente aveva la funzione di lapide, su cui è incisa ancora una
volta, la frase: Maria madre degli Apostoli Giacomo e Giovanni. La pietra sarà
oggetto, insieme con il velo, di ulteriori prove scientifiche.
• Nei due fagotti che probabilmente non furono aperti nelle ricognizioni del ‘700 e del 1910, fra i calcinacci è stato rinvenuto un piccolo dischetto
in bronzo “moneta o sigillo” di origine templare, dove su una faccia è riprodotta la croce patente dell’ordine cavalleresco e dall’altra il tempio della roccia di
Gerusalemme.
• L’ispezione del cranio: trovato mancante della mandibola già annotato in un piccolo cartiglio, rinvenuto all’interno a metà ‘800. Da un’ispezione
accurata del medico legale, Dott. Stefano Conti, dell’Istituto di Medicina legale
dell’Università di Roma è stato appurato che la Santa, in vita, ha subito violenze
inaudite, tanto da portare ad una deformazione del cranio con notevoli ematomi e a portarla probabilmente ad una sorta di paralisi della parte sinistra. Un
frammento del cranio è stato asportato dal RIS dei Carabinieri per ulteriori
accertamenti che hanno come risultato il ricavare il DNA della Madre.
Il lavoro si è protratto per ben 5 mesi; al termine il corpo è stato ordinatamente composto in nuove urne di plexiglass appositamente create e racchiuso nell’urna bronzea.
Al momento c’è in programma di continuare l’indagine scientifica sul
velo e sulla pietra, ma le cose che sono venute alla luce fino a oggi certamente
ci invitano a credere che davvero il corpo è di Maria Salome Madre di Giacomo
e Giovanni.
Da questa ricognizione è nato un fervore nuovo per la gente di Veroli,
soprattutto nell’approssimarsi dell’anno 2009, tanto che è stata immediatamente ricostituita l’antica e nobile confraternita che si è fatta carico della custodia
della Basilica. Nello stesso tempo il rettore, Don Angelo Maria Canonico Oddi,
133
5. Salome Giuseppe Trulli
134
unitamente al Vescovo S.E. Ambrogio Spreafico, ha cercato di ridare a Salome
il suo giusto posto nel culto dei Santi nella Chiesa, ed è per questo che si è
promessa una pellegrinatio del corpo della Madre nelle città che con Veroli ne
condividono il culto; le città toccate, oltre a tutte le contrade e le parrocchie
di Veroli sono: Castelliri, Monte San Giovanni Campano, Frosinone, Supino,
Anitrella, Pale (Foligno), Alfedena. In tutti quei luoghi è stato suscitato un
rinnovato spirito di adesione al Vangelo. Alcune reliquie sono state donate
alle chiese sorelle nel culto della Madre ed in modo particolare va ricordata
la comunità dei verolani a Toronto (Canada) e per ultima, ma solo cronologicamente, in Spagna la città di Bonares che la venera come patrona, dove quel
buon popolo riserva a Salome una venerazione strepitosa.
Il risveglio spirituale, grazie soprattutto al Vescovo Diocesano, ha fatto
si che a Veroli confluissero numerosi pellegrini ed eventi di straordinaria portata, primo fra tutti la venuta del Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone
che il 18 ottobre 2009 condivise con noi la gioia dell’anno giubilare Salomiano.
Le volte della Basilica hanno potuto contemplare la presenza anche di cerimonie celebrate nella lingua propria di Salome, l’aramaico, con la comunità dei
monaci Maroniti provenienti dal Libano e di altre confessioni cristiane come
quella dei fratelli Ortodossi Rumeni.
La Basilica è stata teatro di eventi diocesani quali il convegno diocesano del 2010 ed il giubileo diocesano delle donne dell’ottobre 2010; infine, uno
degli eventi più significativi si è avuto il 28 di agosto 2011, quando sono convenuti attorno alla tomba della patrona, quindici vescovi provenienti da ogni
continente che insieme al vescovo diocesano, che ne è stato promotore, hanno
celebrato la Divina Eucarestia nel nome di Salome.
Non và dimenticato l’impegno oneroso della civica amministrazione
nel restaurare l’antico tempio per riportarlo al suo primitivo splendore.
Ai verolani che sono i primi custodi di un così grande tesoro il compito di perpetuare nella storia delle nuove generazioni il messaggio grande di
verità e libertà che Salome ha portato in mezzo a noi, annunciando a tutti che
Gesù è la via, la verità e la vita! Allora è bene concludere, come è stato scritto
nel nuovo inno perché davvero tutti storditi dal frastuono della modernità
abbiamo bisogno di ridare ordine alla nostra vita dicendo o Madre Salome,
parlaci ancora di Gesù.
DON ANGELO MARIA CANONICO ODDI
Rettore della Basilica di Santa Maria Salome - Veroli
Basilica di Santa Maria Salome
La facciata
Gracilia
Sala Consiliare del Municipio di Veroli
Santa Maria Salome - particolare
Cavalier D’Arpino - abside della Basilica
Santa Maria Salome
La statua portata in processione
Santa Maria Salome
La statua esposta nella basilica
Basilica di Santa Salome
La confessione
Basilica di Santa Salome
Navata centrale
CAPITOLO VI
Veroli al centro dell’Europa
Veroli nel secolo XII e Alessandro III
145
Alessandro III, Thomas Becket e Veroli
151
La Rocca di San Leucio
154
Le chiese
156
6.1
Veroli nel secolo XII e Alessandro III
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
V
eroli è una delle principali città degli Ernici, popolazione italica stabilitasi nel Lazio intorno al 2500 a.C. e proveniente da
una non precisata zona del medio Danubio. Prese parte con le
altre città erniche alla lega che Roma strinse con i popoli vicini
all’epoca del re Tarquinio il Superbo e si legò nuovamente con
i Romani per opera di Spurio Cassio, che diplomaticamente riuscì a stipulare
con gli Ernici un trattato di alleanza simile a quello concluso con i Latini.
Nel Medioevo Veroli acquistò grandissima importanza, poiché fu tra
le poche città della Campagna (le altre furono: Segni, Anagni, Alatri, Ceccano)
da cui si irradiarono la civiltà e la rinascita dopo il Mille. È noto a tutti che
sotto i Carolingi il «Patrimonium Sancti Petri» o Ducato Romano veniva governato per mezzo di missi dominici, rappresentanti del papa e dell’imperatore. Ma alla scomparsa dell’impero carolingio tutta la giurisdizione sul Ducato
si concentrò nelle mani del pontefice, che eleggeva giudici ed amministratori
nella Campagna e Marittima. Solo a metà del secolo X si ha notizia di un comes
Campaniae quale supremo magistrato, cui veniva affidato il governo della provincia romana. «Il comes — scrive il Falco — è l’ufficiale papale che governa la
Campagna; viene eletto dal papa; la sua carica dura probabilmente a vita; a lui
spetta amministrare la giustizia e fors’anche raccogliere l’esercito e riscuotere
le imposte; in qualità di giudice tiene placiti, ai quali intervengono i vescovi
delle città e i giudici che ciascuna di esse invia come assessori, in maggiore e
minor numero secondo l’importanza della città. A capo delle città egli pone
dei giudici, i quali amministrano la giustizia ed esercitano le varie funzioni del
loro ufficio circondati dall’aristocrazia locale, dai nobiliores homines, che, come
assessori nei processi, prendono il nome di iudices dativi; la riscossione delle
imposte si fa per mezzo di gastaldi; l’esercito ha per base le antiche e salde organizzazioni militari cittadine. Qualunque sia stato il primo comes, l’istituzione
dell’uffico cade in un momento in cui era venuta meno del tutto la difesa dei
Carolingi sullo stato papale e i continui pericoli rendevano più che mai necessaria la vigilanza sulle province soggette...»
Dall’importanza di questa carica si ricava anche l’importanza non solo
della famiglia che la detiene, ma anche della città in cui questa dimora. Infatti, verso la fine del secolo XI e la prima metà del seguente, l’ufficio di comes
Campaniae o Campaninus è ricoperto da Roffredo I, Giovanni, Roffredo II di
Veroli. A Roma, in quel periodo, era molto potente la famiglia dei Crescenzi,
che contrastarono i Verolani, dai quali dovettero difendere il loro predominio nella Campagna. Ma la lotta per le investiture, che ben presto il papato è
costretto ad ingaggiare, spezza l’ordine politico-economico della provincia di
145
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
146
Campagna e per più di un secolo non si ha più notizia di comites Campaniae.
Durante questa lotta le città della Campagna acquistarono una grande indipendenza e subirono, in genere, le vicende alterne del papato e dell’impero,
preparandosi a reggersi in modo autonomo, premessa indispensabile al sorgere degli ordinamenti comunali in Roma e in tutto l’antico Ducato Romano.
Affievolitosi il potere centrale dei papi, il governo cittadino veniva esercitato
da una vasta cerchia di uomini, chiamati duces, comites, iudices, nobiliores homines. «A questo punto non possiamo più parlare esclusivamente di governo
papale e di signorie indipendenti: il lento, oscuro processo trasformatore della
società ci si manifesta nelle forme prime: sono gli albori del comune». Dal
1000 al 1150 circa, quindi, si ha un periodo di dissoluzione degli ordinamenti
politico-sociali ed uno di ricostruzione in tutto il Ducato Romano.
«In un primo momento che comprende pressappoco — scrive il Falco
in una pagina rimasta classica per la storia della regione — la prima metà del
secolo XI, i Tusculani nemici e vincitori dei Crescenzi, s’impadroniscono del
papato e della Città; in un secondo, che giunge quasi alla metà del secolo XII,
i pontefici, sorretti dai marchesi di Toscana, dai Normanni e, probabilmente,
dalla minore nobiltà e dal medio ceto cittadino, avversati per lungo tempo da
gran parte della nobiltà maggiore, per la quale la suprema autorità della Chiesa era stata oggetto di competizioni familiari, compiono la riforma del clero,
conducono la lotta per le investiture e, mentre levano il papato ad autorità
universale, vedono quasi distrutto il potere temporale, in Roma dal comune
arnaldiano, nelle terre circostanti dai Normanni, dagli imperatori, dai capitani
di parte imperiale; in un terzo momento infine, i papi, ormai naturali alleati
di parte dell’alta nobiltà romana, che il comune escludeva dalla Città, naturali
alleati dei comuni minori, che nel papato, debole, non avevano trovato ostacoli
durante la loro costituzione, e nella sua forza vedevano ora una difesa contro
la tendenza espansiva di Roma, lottano fino alla vittoria contro il comune romano e riconquistano militarmente e riorganizzano con regolare amministrazione il Patrimonio».
In tal modo, per tutto il secolo XII la Campagna e la Marittima diventano terra di esilio, di passaggio e di lotte per i papi, nonché di adesione alterna
e scismi religiosi, fomentati dagli imperatori e dalle famiglie nobili romane. La
regione dall’epoca di Giordano di Capua a quella di Enrico VI è soggetta ora ai
principi di Capua, ora ai re di Sicilia, ora agli imperatori, che vi stabiliscono in
modo più o meno stabile ed ampio il loro dominio, mentre i papi lottano per
ristabilirvi il loro potere. All’opera militare attendono Callisto II (che nel 1120
assalta Arnara e Tecchiena), Onorio II (che nel biennio 1125-1126 riconquista
Segni, Trebi, Maenza, incendia Pisterzo, Roccasecca dei Volsci, Giuliano di
Roma, Villa S. Stefano, Prossedi, riducendo i Conti di Ceccano a suoi feudatari), Eugenio II (che recupera Terracina, Sezze, Norma, Fumone). All’opera di
riorganizzazione si rivolgono Eugenio III, Adriano IV ed Alessandro III, che
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
riportano in uso la carica del comes Campaniae. Ma la figura del comes è ora
diversa, perché viene affidata ad un ecclesiastico, che resta un ufficiale della
Chiesa, mentre nel periodo precedente l’ufficio era stato ricoperto dai laici potenti, che lo esercitavano in maniera indipendente dal potere centrale papale.
In questo contesto storico generale si deve inserire la politica di Alessandro III (1159-1181), per comprendere la quale è opportuno riandare brevemente agli eventi romani all’indomani della morte di Innocenzo II, quando
si verifica a Roma un imponente moto rivoluzionario, che culmina nella creazione del Comune (1143). Celestino II si pose allora sotto la protezione dei
Frangipane, mentre il Comune di Roma nominava come suo capo il patrizio
Giordano Pierleoni, fratello dell’antipapa Anacleto II e decretava la decadenza
del potere temporale dei papi. Successo a Celestino, Lucio II assalì il Campidoglio, ma trovò morte nell’assalto. I cardinali, riuniti in conclave, elessero
immediatamente Eugenio III (1144) che, non volendo riconoscere il Comune,
fu costretto a fuggire da Roma e rifugiarsi a Viterbo. Seguirono periodi di pace
e di ostilità tra il Comune romano ed Eugenio III, finché Federico Barbarossa
ascese al soglio imperiale (1152) con l’animo di ridurre a soggezione i comuni
italiani. Adriano IV nel 1154 lo chiamò in aiuto a Roma, ma non riuscì a spingerlo contro Guglielmo I di Sicilia, che infastidiva la Marittima e Campagna.
Contro Guglielmo osò combattere il papa, che cadde prigioniero del re (1156)
e fu costretto a cedergli in feudo il regno di Sicilia.
Alla morte di Adriano IV (1159) scoppia un nuovo scisma nella Chiesa: la maggioranza dei cardinali elegge Alessandro III, mentre la minoranza,
ligia agli ordini dell’imperatore, elegge l’antipapa Vittore IV. Non essendo sicuri in Roma, Alessandro III si rifugia ad Anagni, mentre l’antipapa si arrocca a Segni. Il concilio di Pavia, riunito dall’imperatore, riconosce come papa
Vittore; Alessandro III ad Anagni scaglia la scomunica contro l’imperatore ed
invita i Lombardi alla resistenza e prende sotto la sua protezione la lega lombarda (1167). L’imperatore, sceso in Italia, si trova a Roma nel 1167, donde
Alessandro è costretto a fuggire e a riparare successivamente ad Anagni, Segni
e Benevento. Ma una terribile peste costringe l’imperatore ad allontanarsi da
Roma e a ritirarsi nell’Italia settentrionale.
«Nuvole oscure, — scrive il Gregorovius — gonfie di pioggia, calarono il 2 agosto sulla città scatenando il diluvio; ad esso successe una calura
soffocante e la malaria che in agosto in questi luoghi è mortale, si tramutò in
febbre pestifera. Il fior fiore di quell’esercito invitto fu falciato da quella morte ingloriosa; cavalieri, fanti e scudieri morirono, chi dopo una lunga agonia,
chi all’improvviso, a cavallo o camminando per la strada; ben presto non si
poterono più seppellire i morti. In sette giorni Federico vide morire i suoi più
fulgidi eroi: Rainaldo di Colonia, Goffredo di Speyer, Eberardo di Regensburg,
i conti di Nassau e di Lippe, Federico di Rotenburg, vescovi e signori e innumerevoli eroi e soldati comuni furono portati via dalla peste. Roma stessa fu
147
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
148
devastata orribilmente dalla epidemia: migliaia di persone morirono e i loro
corpi furono gettati nel fiume. Da secoli la città non era stata colpita da due
sventure tanto tremende: prima la battaglia di Monteporzio poi, subito dopo,
questa febbre pestifera. Un terrore superstizioso si impadronì dei Tedeschi... Il
6 agosto l’imperatore tolse le tende e s’incamminò sgomento col resto dell’esercito che si trascinava a stento, come una schiera di ombre... Questa fu la raccapricciante conclusione della guerra condotta da Federico intorno a Roma,
presso le cui mura sin dal tempo dei Goti tutti i popoli di Germania caddero in
tombe senza nome...».
L’imperatore Federico da questo momento si accorge di non poter
combattere contemporaneamente con lega lombarda e con il papato e cerca di
spezzare l’alleanza dei suoi avversari. Profittando della morte dell’antipapa Callisto III, Federico cercò di riconciliarsi con il papa e gli inviò come messaggero
Everardo, vescovo di Bamberga, il quale, non potendo entrare nelle terre del re
di Sicilia, nemico dell’Imperatore, inviò una lettera ad Alessandro III, allora a
Benevento, perché indicasse una città della Campagna, dove potersi riunire a
convegno. Il papa indicò Veroli, sede del cardinal legato «comes Campaniae» e
per l’occasione diresse un breve al vescovo, al clero e al popolo verolano.
Contemporaneamente Alessandro III scrisse alle città lombarde, perché inviassero a Veroli i loro rappresentanti con pieni poteri per trattare con il
messo imperiale. E così il 18 marzo 1170 Alessandro III da Benevento si trasferisce a Veroli per ricevere Everardo, inviato dall’imperatore Federico, e prende
dimora presso i canonici di S. Erasmo. «Sedendo adunque in pieno concistoro,
nella primitiva Chiesa edificata da S. Benedetto, e rispondente sotto l’attuale
crociera dell’altare maggiore, il Pontefice ricevè il Vescovo che l’adorò e disse: Federico Imperatore mio Signore mandandomi, strettamente ha ingiunto
che parli a Voi separatamente, e riveli a Voi solo quanto mi ha commesso»
(V. CAPERNA, Storia di Veroli... cit.). Il papa non volle allora ascoltarlo, perché
desiderava trattare apertamente con il libero intervento dei plenipotenziari dei
comuni lombardi, ma poi si venne al compromesso dietro suggerimento degli
stessi rappresentanti dei comuni lombardi.
Il papa ascoltò Everardo separatamente e poi riferì agli alleati lombardi. Non fu possibile concludere patti, perché Alessandro III poneva come premessa l’accordo con i comuni della lega Lombarda. In tal modo il tentativo di
Federico diretto a spezzare l’alleanza tra i comuni ed il papa fallì miseramente
e si rivelò come un rozzo espediente politico.
Il papa si intrattenne a Veroli e vi ordinò molti vescovi, vi fece costruire a proprie spese la chiesa di S. Maria Maddalena fuori le mura annessa ad
un ospizio per lebbrosi e ricevè ambasciatori dell’imperatore greco Emanuele
Comneno, che inviò la nipote Eudochia in moglie a Oddone Frangipane, che
vi celebrò solennemente le nozze con l’assistenza del pontefice. L’imperatore greco cercava in tal modo di spingere il papa ad un’alleanza contro il re
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
Guglielmo di Sicilia, ma non riuscì a persuadere Alessandro III, che invece
vedeva nel regno meridionale un ottimo alleato contro il Barbarossa. Comunque, la città di Veroli, in questa circostanza assiste all’intreccio di tanti tentativi
diplomatici importanti ed Alessandro, che è al centro di questa vasta rete di
diplomazia politica, rende celebre Veroli in tutta l’Europa civile di allora. Alessandro respinge, qui, diplomaticamente, le subdole arti del Barbarossa, che mirava semplicemente a dividere i suoi nemici; assicura gli alleati lombardi della
persistenza e lealtà nella lotta contro l’imperatore di Germania; respinge l’abile
diplomazia orientale, che in quel momento avrebbe potuto creargli un nemico
vicino (il regno di Sicilia) senza un aiuto valido e necessario da parte di un impero lontano; disbriga gli affari ordinari della Chiesa e rintuzza le pretese del
re d’Inghilterra contro l’arcivescovo Tommaso di Canterbury. L’importanza di
questo momento è decisiva per il futuro sviluppo storico del papato e della nostra penisola. Basti pensare alla piega che avrebbero potuto prendere gli eventi,
qualora Alessandro III avesse deciso, per esempio, di tradire i comuni lombardi e cedere alle lusinghe del Barbarossa.
Veroli, quindi, può vantarsi giustamente di essere stato il luogo di dimora di un papa, che potè decidere in essa i destini dell’Italia.
Lo stesso Gregorovius racchiude questi eventi storici in poche ma significative parole: «Nello stesso periodo Alessandro III, che risiedeva a Veroli,
si trovava in violento disaccordo con il re d’Inghilterra a causa dell’arcivescovo
Tommaso di Canterbury; invano il re spese il suo denaro per corrompere i
magnati romani, nella speranza che costoro piegassero il papa ai suoi desideri, e non meno inutilmente offrì a lui tesori ed aiuti per sottomettere Roma. Alessandro accoglieva intanto gli inviati dell’imperatore desideroso di
pace, e quelli delle città lombarde da lui stesso chiamati. Giunsero anche messaggeri greci per rinnovare le loro proposte e Manuele Comneno spinse la sua
benevolenza fino al punto di concedere la mano di sua nipote al più potente
vassallo del papa, Oddone Frangipane. La festa nuziale fu celebrata a Veroli,
ma Alessandro III non accettò le proposte dei Greci. Anche le sue trattive con
Federico andarono a monte, ma ormai egli sperava di trovare a Roma buona
accoglienza».
Le ostilità tra Federico Barbarossa da una parte e il papa con i comuni
lombardi dall’altra continuarono fino allo scontro finale di Legnano (1176), la
cui lieta notizia fu accolta da Alessandro III, mentre dimorava in Anagni. Poco
dopo «giungevano a Tivoli Vigmaro arcivescovo di Magdebourg, Corrado vescovo di Worms, Cristiano arcivescovo di Magonza, Arduino protonotario
imperiale, con pieni poteri di intavolare trattative di pace richieste dall’imperatore. Colà fecero sapere al papa la cagione di loro venuta. D’ordine del pontefice due cardinali, co’ maggiorenti di Campagna mossero al loro incontro, e li
condussero con onore in Anagni, ove l’indomani furono ricevuti dal papa nel
duomo. Ivi quei legati domandarono la pace a nome dell’imperatore. Ritirossi
149
il papa allora nella canonica, nominò una commissione di cardinali, che con
i legati imperiali desse principio al trattato preliminare di pace da servire di
base alle trattative ulteriori. Quindici giorni durarono le trattative che condussero al pactum Anagninum, che era la promessa di pace proposta fra il papa e
l’imperatore, e siccome alla conclusione definitiva della pace era necessaria la
presenza dei collegati Lombardi, così si convenne che il papa e l’imperatore
con i detti legati Lombardi si trovassero insieme a Venezia o altrove. Questo
pactum Anagninum constava di 30 articoli» (P. ZAPPASODI, Anagni attraverso i
secoli, Veroli, 1907).
E così tutte le forze belligeranti si avviavano alla pace di Venezia (1177).
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
GIUSEPPE SPERDUTI
Veroli nel sec. XII e Alessandro III
in Fatti e figure del Lazio Medioevale
Lunario Romano, Palombi Editori, 1979
150
Alessandro III, Thomas Becket e Veroli
Originario della Normandia, Thomas Becket nacque a Londra il 21
dicembre 1118. Compì i primi studi a Londra, quindi entrò al servizio di Teobaldo, Arcivescovo di Canterbury che lo mandò a perfezionarsi nel diritto
a Bologna e nel 1151 lo fece arcidiacono. L’anno dopo re Enrico II lo nominò suo cancelliere. Resosi vacante l’arcivescovado di Canterbury per la morte
di Teobaldo, Enrico II offrì l’alta carica ecclesiastica al suo cancelliere e fedele amico Thomas Becket, il quale esitò ad accettare pensando che il re avesse
qualche scopo nascosto. Ma il sovrano negò qualsiasi addebito di natura politica ed il 3 giugno 1162 Becket accettò. Da cortigiano condiscendente, amante
dello sfarzo e fautore dell’assolutismo, dopo la sua elezione a vescovo, Becket si
trasformò in un severo asceta e fervido sostenitore dei diritti della chiesa. Nel
1163 ebbero inizio le discordie tra Becket ed Enrico II, discordie che avevano la
loro base nelle leggi giurisdizionali vigenti. La disputa riguardava la comparatività della giurisdizione secolare con quella ecclesiastica, compresa la immunità
clericale. Il re non intendeva modificare le leggi, ma neanche Becket nella sua
veste di Arcivescovo primate intendeva rinunciare alle sue prerogative ecclesiastiche; non si poteva e non si doveva confondere lo Stato con la Chiesa.
Anzi, per sottolineare questo suo atteggiamento Becket si dimise da
cancelliere dichiarando la incompatibilità tra le due cariche. Nel 1° Concilio
di Woodstock (luglio 1163), Becket chiese al re di cancellare le tasse sui beni
ecclesiastici. Per questa richiesta il vescovo Gilber Foliot si schierò dalla parte
del re e rifiutò di rinnovare la sua professione di obbedìenza a Canterbury. Nel
Concilio di Westminster (ottobre 1163), la disputa tra il primate ed il re riguardò in particolare la giurisdizione sui «crimini» del clero che doveva essere
trasferita all’arcivescovo. Il re non accolse la richiesta.
Nel gennaio 1164 infine Becket si sottomise all’autorità del Papa Alessandro III. Questo atto offese a tal punto il re, che questi convocò l’arcivescovo
alla Dieta di Clarendon che si riunì pochi giorni dopo l’atto di sottomissione.
Becket minacciò la scomunica. Il re da parte sua gli ricordò che secondo le
leggi emanate da Guglielmo il Conquistatore, leggi con le quali si esautorava il
Papa, la scomunica non aveva alcun effetto. Gli ricordò inoltre che il Papa non
sedeva più sul trono di Roma, ma era fuggitivo, e per il momento risiedeva in
Francia. Infine Enrico lo invitò a sottoscrivere, quale arcivescovo primate, le
costituzioni di Clarendon che ponevano notevoli limiti ai poteri ecclesiastici.
Becket rifiutò e nel frattempo anche Alessandro III respingeva i 16 articoli di
Clarendon. In seguito il re oppresse talmente Becket, che questi dovette rifugiarsi in Francia presso lo stesso Alessandro III. Il suo esilio durò dal novembre 1164 al novembre 1170. Appena Becket tornò in Inghilterra, uno dei primi
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
6.2
151
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
152
atti che compì fu quello di sospendere l’arcivescovo di York, causando così l’ira
di Enrico II. Un’espressione irritata di Enrico II fu di incitamento a 5 cavalieri
normanni, che il 29 dicembre 1170 uccisero l’arcivescovo nella Cattedrale. Dei
5 cavalieri, in un documento dell’epoca ne sono citati solo 4: Reginald Fitzarse,
Ugo de Moreville, William de Tracy, Richard le Pret; il 5° era probabilmente
un certo Steffen, che non è nominato perché si pensa che sia colui che redasse
il documento-cronaca dell’uccisione di Becket. L’assassinio dell’arcivescovo fu
accolto con enorme orrore dal mondo cristiano. Enrico II, che si trovava in
Normandia, apprese la notizia il 1 gennaio 1171. Una descrizione della «costernazione della Corte Reale» è data in una lettera indirizzata al Papa Alessandro
III da un testimone oculare: Arnolfo, vescovo di Lisieux. Le voci della responsabilità maggiore dell’assassinio addebitata al re, giunsero fino ad Alessandro
III che ordinò un’inchiesta. L’inchiesta fu condotta da alcuni cardinali che riferirono al Papa della «assoluta innocenza» del re e quindi della sua estraneità al
crimine. Il Pontefice comunque pretese da Enrico II una revoca delle consuetudini contrarie alla Chiesa introdotte ai suoi tempi nel Regno, la promessa di
non impedire gli appelli alla Santa Sede, e di fare una Crociata. Ottenne inoltre
la promessa che i Sovrani Inglesi non sarebbero stati considerati da allora in
poi veri re, se dal Papa non fossero stati ritenuti «catholici reges». Da parte sua
Enrico II, per compiere l’espiazione finale, il 12 luglio 1174 fece celebrare una
solenne funzione in onore del suo «grande amico e padre Thomas Becket». In
quella occasione il re rimase inginocchiato in preghiera davanti alle reliquie di
Becket per 24 ore di seguito nella Cattedrale affollatissima. Si sottomise inoltre
alla flagellazione da parte dei monaci presenti.
Thomas Becket divenne subito popolare in quanto il suo martirio coronò una
vita di tenace difesa della libertà religiosa in Inghilterra ed il suo sacrificio risolse, almeno per qualche tempo, la grave crisi tra la Chiesa ed i Sovrani Inglesi. Le leggi di Clarendon infatti, e con esse la generale subordinazione della
Chiesa allo Stato rimasero in vigore.
Il pellegrinaggio alla tomba di Thomas Becket, attraverso quella che
ancora oggi è chiamata «via dei pellegrini», divenne popolarissimo nell’Inghilterra medioevale.
Ma ciò che ora ci interessa maggiormente è che il culto per Thomas
Becket si diffuse ampiamente anche nella nostra terra, tanto che nella Cattedrale di Anagni troviamo un oratorio dedicato a Tommaso di Canterbury.
Circa due anni dopo la sua morte, il 21 febbraio 1173, Alessandro III
che allora dimorava a Segni canonizzò Thomas Becket. Gli «Acta» ricordano
che la tradizione voleva che Tommaso passando per Anagni si fosse fermato
a pregare ed a celebrare in questa cripta che in seguito fu a lui dedicata. Ma
la critica storica dimostra che Becket non venne in Italia dal 1152 in poi, da
quando cioè fu nominato cancelliere da Enrico II, e che da arcivescovo, dopo i
dissidi con il re, trascorse i sette anni di esilio sempre in Francia. Non restereb-
GIORGIO MAUTI
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
be quindi che ammettere la venuta di Becket in Italia dal 1145 al 1152 (anni del
Ponficato di Eugenio III) per trattare con la Corte pontificia gli affari dell’arcivescovado presso il quale era diacono; giovanissimo quindi e forse non ancora
sacerdote. D’altra parte Eugenio III passò per Anagni una sola volta nel luglio
del 1150.
In conclusione, la critica storica esclude che Becket sia stato in Anagni. Non c’è dubbio che questa erronea tradizione anagnina abbia avuto origine dall’oratorio della Cattedrale, ma siccome il culto di Thomas Becket ebbe
origine a Segni — vicinissima ad Anagni — dove Alessandro III lo canonizzò,
è probabile che lo stesso Papa abbia consacrato e dedicato in quello stesso periodo l’oratorio al martire inglese.
Da qui il culto del Santo si diffuse presto per tutta la Campagna e nel
1199 un altro oratorio gli fu dedicato a Carpineto. Ecco quindi la ragione storico-religiosa della denominazione dell’oratorio della Cattedrale di Anagni, il
quale a causa della sua stessa ubicazione è contemporaneo alla costruzione
della Cattedrale stessa.
Ma oltre all’oratorio ci sono in Anagni altre cose che ricordano il martirio di Thomas Becket. Nel tesoro della Cattedrale si possono osservare infatti
un paramento ricamato ed una meravigliosa urna di smalto che riproducono
entrambi la medesima composizione: il Santo inginocchiato dinanzi all’altare
dove si compie il suo martirio, il suo diacono che tiene la croce arcivescovile e
due cavalieri che si avanzano per decapitarlo.
L’urna, che è un meraviglioso e prezioso esemplare della oreficeria di
Limoges del XIII secolo, con ogni certezza era destinata ad accogliere le reliquie del martire inglese; ora contiene i resti di altri santi.
Da ricordare infine che anche a Veroli, in un busto d’argento del 1651
custodito nel Tesoro della Cattedrale, si conserva una reliquia di San Tommaso
Becket. Si ritiene che il canonico Vespasiano Giulio intorno alla metà del 1600
ebbe la reliquia del santo dalla famiglia Conti di Segni, imparentata con il Papa
Innocenzo III (1198-1216), nativo di Anagni. Si deve tener presente che Alessandro III, dal 1170 al 1173, prima di trasferirsi a Segni dimorò a Veroli e che
qui ricevette la notizia dell’assassinio dell’Arcivescovo.
153
6.3
La Rocca di San Leucio
Ioannes Papa X, dum sacro altari Lateranensi divina mysieria faciebat,
captus fuit a militibus Guidonis Comitis Verularum et Verulas duchis in Arce
quae in eminentis Civitatis regione extructa est, secus quam extat nunc Parochialis Ecclesia S. Leucii, in durissimum et arctissimum carcerem ubi pane tribulationis et aqua lacrymarum sustentabant - Vid. Stat. Verul. in Praef.
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
Mentre Papa Giovanni X celebrava i divini misteri sul santo altare della Basilica Lateranebse, fu afferrato dai soldati di Guido, Conte di Veroli, e
condotto nella Rocca innalzata sulla parte più alta della città. Sottoposto ad un
durissimo carcere, lo nutrivano con il pane della tribolazione e l’acqua delle
lacrime.
154
Secondo fonti, accreditate dalla migliore storiografia, il papa deposto fu Giovanni XIII, catturato nel 965 da Roffredo «comes Campaniae et dux Verularum». La discordanza tra le due versioni non esclude l’autenticità dell’episodio,
semmai la conferma; anzi, esso è indicativo della notevole influenza acquisita
dal ceto nobiliare di Veroli nell’ambito del Lazio meridionale alla fine del primo millenio, nel secolo, cioè, in cui il papato fu pesantemente condizionato da
potenti e ramificate consorterie nobiliari romane ferocemente in lotta tra loro
per la supremazia politica nella regione. Per allentare la pressione della nobilita
cittadina e per contrapporla ad essa, qualche pontefice favorì il consolidarsi
della nobilita provinciale. In tal modo crebbe in prestigio e in potenza la famiglia, convenzionalmente detta, dei Roffredi di Veroli, che ben presto e senza
scrupoli s’inserì nella lotta tra le varie fazioni, schierandosi a fianco dei Tuscolo
contro la potente casata dei Crescenzi. Di origine franca, probabilmente proveniente dalla contea dei Marsi, i Roffredi di Veroli, appartenenti alla gerarchia
militare pontificia, furono investiti del comitato campano (carica per alcuni
aspetti simile a quella successiva del rettore) che tennero per quasi un secolo e
mezzo, cioè fino a pochi anni prima che la famiglia si estinguesse sullo scorcio
del sec. XI.
Nel 1167 la rocca ospitò di nuovo tra le sue mura, non più in cattività,
un altro papa: Alessandro III. Vi sostò per brevissimo tempo durante la sua
fuga a Benevento, essendo Roma occupata dall’imperatore Federico Barbarossa con il suo esercito. Dalla Chiesa di S. Leucio il pontefice indirizzò un Breve
ai cittadini di Alessandria della Paglia, città fondata in suo onore dai trentasei
comuni della Lega Lombarda posta sotto la sua protezione.
Agli inizi del sec. XV, sotto il pontificato di Bonifacio IX, la rocca passò in proprietà alla Camera Apostolica, che la tenne per un secolo circa. La
sua custodia fu affidata dai vari pontefici ad esponenti militari romani, ma le
notizie al riguardo sono estremamente scarse. Nel 1403 la rocca di Veroli fu
infeudata da Bonifacio IX a Giovanni della Rocca di S. Agata. In seguito fu
tenuta dai Della Rovere, ai quali fu tolta da Innocenzo Vili.
Rimasta indenne alla violenza dei terremoti del 1170 e del 1350, la
rocca di S. Leucio subì una prima parziale rovina nel 1406 sotto i colpi di artiglieria di Ladislao di Durazzo, re di Napoli e Protettore d’Ungheria. Rovinò del
tutto un secolo e mezzo dopo (1556) durante l’assedio dell’esercito spagnolo,
responsabile anche di altre gravissime devastazioni.
Un vecchio maniero
sull’ardua collina
aspetta il vento ululante,
unico compagno
delle monotone notti.
Ed il vento arriva,
come scalpitìo d’arabi cavalli,
animando le pietre cadenti
e narrando lontane storie,
ma gli anni passati rammenta
ed aiuta la rovina del tempo.
GIUSEPPE VIRONE
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
MARCELLO STIRPE
Il rione e la chiesa parrocchiale di S. Leucio in Veroli, Veroli 1980
155
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
6.4
156
Le chiese
Le numerose chiese medioevali di Veroli hanno subito molti rifacimenti nelle epoche successive; alcune sono scomparse e si è persa la memoria
anche del luogo in cui sorgevano; altre, più volte restaurate, si presentano oggi
in una veste totalmente diversa dall’originale. Le chiese esistenti in Veroli nel
Medioevo erano quattordici (TOUBERT, p. 864, nota 2): S. Angelo, S. Barbara,
Ss. Cosma e Damiano, S. Croce, S. Eleuterio, S. Ippolito, S. Leucio, S. Maria dei
Franconi, S. Maria Rotonda, S. Nicola, S. Paolo, S. Pietro, S. Salome, S. Stefano.
Dal numero sono escluse la cattedrale di S. Andrea e le chiese monastiche di
S. Erasmo e di S. Martino, quest’ultima situata subito fuori della cinta di mura.
Solo sette di esse erano parrocchie: S. Andrea, S. Croce, S. Erasmo, S.
Leucio, S. Maria dei Franconi, S. Michele Arcangelo, S. Paolo (Statutum 1657,
Praefatio, p. 2; UGHELLI 1717,1, p. 1386; BATTELLI, 1942, pp. 171-206).
Alle chiese erano annessi altri edifici soggetti alla giurisdizione ecclesiastica: due monasteri, parecchi ospedali ed ospizi per i pellegrini, disseminati
nell’area urbana o nell’immediato fuoriporta.
Veroli era città vescovile e la sua diocesi abbracciava un vasto territorio (DUCHESNE 1892, p. 8 s.; C. SCACCIA SCARAFONI 1930-1932, pp. 255-282);
essa comprendeva i comuni di Monte S. Giovanni, Bauco, Torrice, Arnara,
Pofi, Ripi e Strangolagalli. La giurisdizione del vescovo sulla diocesi non si
fermava alle semplici pertinenze ecclesiastiche, ma aveva anche carattere amministrativo, fino a quando per lo meno non si stabilirono in questi paesi delle
signorie locali che si resero indipendenti.
Cattedrale di S. Andrea — Non se ne conosce la data di fondazione; la
tradizione vuole che si cominciasse a costruirla durante il regno di Costantino.
La sua dedicazione a S. Andrea apostolo, il cui culto si diffonde in Occidente
già dai primi anni del sec. V (Bibliotheca Sanctorum 1967,1, coli. 1907-1908;
C. VIOLANTE — C.D. FONSECA 1964, pp. 337-339), è un elemento che testimonia a favore di una data molto antica. Documento importante è un’iscrizione cristiana, ritrovata nella cripta della chiesa nel 1478 ed ora conservata nel
Museo della Cattedrale, che è variamente datata dagli studiosi tra la fine del IV
e l’inizio del sec. V.
Direttamente collegato al problema della fondazione di S. Andrea è
quello che riguarda l’elevazione di Veroli a sede vescovile. Il pontefice S. Leone
Magno (440-461) verso la metà del sec. V istituì varie diocesi nel Lazio meridionale (Alatri, Anagni, Ferentino); si potrebbe far risalire a quell’epoca la
nomina del primo vescovo di Veroli, per l’importanza di questo centro pari a
quella delle suddette città (QUATTROCIOCCHI, p. 151). Però solo a partire dal
743 si può parlare con certezza dell’esistenza di tale sede episcopale; una carta
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
pontificia di papa Zaccaria nomina Martinus episcopus verulanus (L.P. p. XX).
Il Quattrociocchi avanza l’ipotesi che la primitiva chiesa di S. Andrea dovesse
ricoprire circa l’area della navata sinistra dell’edificio odierno, dato che in questo luogo si conservano le più importanti testimonianze sacre, cioè le tombe
dei vescovi e la cappella del Sacramento.
Probabilmente della prima costruzione doveva far parte anche una
piccola cripta, nella quale fu sepolto il presbitero Marturius tra la fine del IV e
l’inizio del sec. V. In epoca posteriore la chiesa fu ampliata; si costruì un edificio a pianta basilicale con transetto ed abside, corpo a tre navate e copertura
a capriate, con cripta, probabilmente absidata, e presbiterio rialzato. Le navate
erano divise da pilastri e quella centrale era attraversata, in corrispondenza di
essi, da arconi a tutto sesto che sostenevano il tetto; queste strutture sono tuttora esistenti sotto gli intonaci settecenteschi. A tale fase costruttiva appartengono alcuni frammenti marmorei scolpiti (secc. IX-X), resti di un ciborio (sec.
X); una croce cosmatesca, unico avanzo del seggio vescovile confrontabile con
quello di Anagni che, come questo, era posto al centro dell’abside, testimonia
lavori successivi.
L’8 settembre 1350 un forte terremoto provocò gravi danni agli edifici
di Veroli e dei paesi circostanti. Le murature della cattedrale subirono serie
lesioni, cosicché qualche anno dopo, sotto il vescovato di Adiutorio (13311354), si operò un restauro della chiesa, che dette ad essa un’impronta gotica.
Furono aperte in facciata due porte secondarie architravate su mensole, ai lati
del portale principale, più grande e ad arco a tutto sesto. Le aperture laterali
oggi sono visibili solo all’interno; meglio conservata è la porta della navata
destra, di cui si scorgono l’architrave, le mensole e parte dello stipite di sinistra
liberi da intonaco, ma seminascosti da un confessionale. Risale al periodo gotico anche il bel rosone che tuttora decora la facciata di S. Andrea. Durante il
vescovato di Guido (1354-1363) fu costruita la torre campanaria che si appoggia all’esterno del muro terminale della navata sinistra (UGHELLI, p. 1386).
Rifacimenti e restauri furono compiuti dai vescovi G. Asteo (16081626), V. Lanteri (1628-1651), De Zaulis (1690-1708) e Tartagni (1715-1751):
nel 1621 fu abbassato il presbiterio e quindi soppressa la cripta; si chiusero le
porte secondarie in facciata e se ne aprirono altre due sui fianchi della chiesa,
che ancora oggi danno accesso alle navatelle; si costruirono le cappelle delle
navale laterali; si operò infine un restauro ed un’intonacatura sia dell’esterno
che dell’interno dell’edificio, nascondendo tutte le strutture originarie. L’aspetto
odierno di S. Andrea è quello che ci hanno lasciato i rifacimenti settecenteschi.
S. Angelo (S. Michele Arcangelo) — È situata nella parte settentrionale
della città, in una zona non fittamente abitata nel Medioevo; a questa parrocchia era intitolata una delle dieci regioni di Veroli. Non si conosce la data di
fondazione. Il suo aspetto odierno è quello che i restauri settecenteschi le hanno dato, cancellando ogni traccia delle strutture precedenti; forse solo la pianta
157
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
158
è rimasta intatta. S. Angelo è una chiesa di piccole dimensioni (m. 19 x 14),
mononave a croce latina.
Sul fianco destro di essa sorgeva l’ospedale di S. Angelo, la cui costruzione fu iniziata nel 1235 (Statutum, Praefatio, p. 2). In esso venivano curati i
malati di petto, data la salubrità dell’aria in quel luogo (pro infirmis ob aeris salubritatem). Non si può definire la sua pianta, ma probabilmente esso ricopriva
una superficie limitata, tenendo presenti le proporzioni dell’attigua chiesa e la
pendenza del terreno, che non consente la costruzione di grandi edifici.
La prima menzione di S. Angelo si ha in un documento dell’Archivio
della Cattedrale, del sec. X; cfr. C. SCACCIA SCARAFONI, doc. 14 (146). È nominata poi molte altre volte nei documenti pubblicati (SCACCIA SCARAFONI e
MOTTIRONI) ed appare anche nelle decime del 1328 e 1333 (G. BATTELLI, pp.
171-206) e negli Statuti Verolani.
Santa Barbara — Si è persa ogni notizia cronologica e topografica di
questa chiesa e nessun elemento ci permette di ubicarla, neppure approssimativamente1.
La chiesa è citata in quattro documenti che vanno dal 1088 al 1155
(MOTTIRONI, docc. 86-89-159-173), mentre negli Statuti Verolani, che pure
menzionano chiese anche molto antiche, essa non compare.
Ss. Cosma e Damiano — La via Umberto I fino alla fine del secolo
scorso sembra dovesse chiamarsi via Ss. Cosma e Damiano. Si è quindi potuta
ubicare questa chiesa in via Umberto I, al n. catast. 608. Sicuramente fu fondata
in epoca anteriore al Mille. L’interno, adattato a magazzino e poi abbandonato,
è ora impraticabile; la facciata però sembra essere rimasta intatta, salvo una
finestrella che è stata aperta alla sua sommità: è larga m. 6 ed al centro si apre
un portalino ad arco a tutto sesto (luce m. 1.60). Ai lati di esso, a circa m. 2.50
dal piano stradale si trovano due feritoie di pietra ben tagliata, che terminano
in alto con un minuscolo archetto ogivale (m. 0.70 x 0.15) e che probabilmente
furono aperte in epoca posteriore alla costruzione della chiesa.
Gli Statuti Verolani la includono nel numero delle chiese anteriori al
Mille e soggette alla giurisdizione della cattedrale (Statutum, Praefatio, p. 3),
ma nei documenti dell’Archivio Capitolare essa è citata a partire dal 1098; cfr.
C. SCACCIA SCARAFONI, docc. 82 (21), 94 (25), 112 (66).
Santa Croce — Sorge immediatamente fuori della porta omonima, a
sud di Veroli. Dell’antica struttura non rimane che l’impianto di piccola basilica, a tre navate sorrete da pilastri ed abside, ed alcuni frammenti di decorazione marmorea del sec. XI, probabilmente provenienti dalla stessa chiesa ed
1
La chiesa viene nominata nelle carte n. 399 e 435. Cfr. Regesti..., cit.
2
Provengono da altre costruzioni
3
Chiesa di Santa Croce nelle vicinanze della quale esisteva l’ospedale di giurisdizione della cattedrale, i cui vescovi accoglievano i pellegrini, ne lavavano i piedi, li ricevevano a
mensa e umilmente li servivano.
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
oggi inseriti in facciata2 (pilastrini decorati a girali). Non si conosce la data di
fondazione della chiesa, che era una delle sette parrocchie di Veroli e dava il
nome alla contrada più meridionale della città.
Santa Croce compare negli Statuti Verolani (Praef., p. 3), in cui è citato
anche l’ospizio per i pellegrini prospiciente la porta urbana; la chiesa è nominata anche nelle decime del 1328 e 1333 (BATTELLI, op. cit., pp. 171-206) e nei
documenti appare per la prima volta nel 1087; cfr. C. SCACCIA SCARAFONI,
doc. 71 (629).
Accanto alla chiesa, esterno alla cinta e vicino alla porta urbana
(C. SCACCIA SCARAFONI, doc. 113 (552) del 1123) sorgeva l’ospedale di S. Croce, un ospizio per i pellegrini. Non sappiamo quando fu fondato, ma solo che
nel 1235 già esisteva, e si può ubicarlo con approssimazione sul luogo dell’edificio che oggi sorge proprio di fronte alla porta, a circa m. 15 da essa.
Nella prefazione degli Statuti Verolani si legge: ecclesia Sancte Crucis
cui proxime, anno 1235, extebat Hospìtale iurìsdictionis Cathedralis ecclesiae, in
quo Episcopi peregrinos suspiciebant, pedes eorum lavabant, mensa recipiebant,
eidemque humiliter ministrabant3.
Forse gli affreschi della cripta di Anagni con la storia di S. Magno testimoniano, appunto, l’uso dei vescovi verolani, che andavano ad accogliere i
pellegrini illustri a porta S. Croce: in essi si vede il vescovo di Veroli con il suo
seguito, che aspetta sotto l’arco della porta l’arrivo del corpo di S. Magno.
S. Eleuterio — Anche questa, come S. Barbara, è una chiesa di cui si
sono perse le tracce.
Non è menzionata nelle decime e neppure negli Statuti Verolani, mentre ne parlano i documenti degli Archivi della Cattedrale e di S. Erasmo, dei
quali il più antico risale al sec. X (C. SCACCIA SCARAFONI, docc. 23 (G) del sec.
X; 56 framm. B del 1177; 116 (740) del 1125; MOTTIRONI, doc. 74 del 1085).
S. Erasmo. — La data di fondazione di questo importante complesso
di edifici (chiesa, monastero ed ospedale) non si conosce con certezza. La tradizione vuole che nel 529 S. Benedetto, in viaggio da Subiaco a Montecassino,
passasse per vari centri del Lazio meridionale; sostando in ognuno di essi vi
lasciò, come segno tangibile del suo passaggio, chiese e monasteri che seguivano la regola da lui dettata. Ciò accadde forse anche per Veroli, dove avrebbe
fondato l’oratorio di S. Erasmo. I documenti in nostro possesso però non consentono di risalire ad una data così antica. L’unica fonte che parla esplicitamen-
159
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
160
te del viaggio di Benedetto in direzione di Montecassino è gli Acta S. Placidi
(MABILLON 1668, I, pp. 45-50), un testo assai inesatto e di incerta datazione (da
collocarsi tra il sec. IX e il XII).
Riguardo alla data di fondazione, pur non potendo affermare nulla con
certezza, si può ritenere che una chiesa ed un monastero benedettino sono
esistiti in Veroli a partire dal sec. IX. È plausibile l’ipotesi che Benedetto, di passaggio per questo centro, vi fondasse un oratorio dedicato al vescovo S. Erasmo
(MOTTIRONI, prefazione), oratorio che successivamente venne ampliato e a cui
si affiancò il monastero, forse sorto in seguito alla grande ondata di fervore
monastico che pervase l’Italia intorno al sec. VII.
I documenti in cui è citato S. Erasmo non sono più antichi del sec. X «e
il primo in cui si faccia esplicita menzione del monastero e del suo abate è del
1042» (MOTTIRONI, Prefazione, p. 7).
S. Erasmo è una delle chiese meglio conservate di Veroli, almeno nella
parte esterna (l’interno è alterato dai restauri del Cinque e del Settecento e della
costruzione originaria non rimane che la pianta, a tre navate con transetto ed
abside). Il suo aspetto attuale risale al sec. XII, al tempo dei vescovi Agostino
(1104-1111) e Leto (1111-1127) (TRULLI 1968, p. 180), o forse al tempo di papa
Alessandro III, che sostò in Veroli dal 1170 al 1173, proprio nel monastero di
S. Erasmo. Le parti originali di quest’epoca sono le absidi scandite da lesene
e da colonnine su mensole e coronate da archetti pensili di tipo romanicolombardo, parte del campanile, fino al primo piano (mentre la parte superiore
dovrebbe essere dell’inizio del sec. XIII; SERAFINI 1927, pp. 227-228), ed il portico addossato alla facciata. Esso è costruito in pietra bianca ben tagliata e si
apre in tre archi a tutto sesto su pilastri; l’arcata centrale è più ampia e più alta.
Le tre ghiere sono decorate da fregi; quello centrale è cinquecentesco e risale al
rifacimento che in quel secolo alterò un poco le linee del portico. Quelli laterali
invece sono originali e per il rilievo piuttosto schiacciato e per il tipo di decorazione a girali possono essere datati al sec. XI. L’ambiente al di sopra del portico
fu costruito nel Cinquecento ed altera le linee architettoniche della struttura
sottostante. Tuttavia anche in epoca medioevale doveva esistere un ambiente
sovrapposto al portico, forse di minori proporzioni; unica testimonianza di esso
è rimasta una bifora quadrata sul alto destro della struttura cinquecentesca.
S. Erasmo, al cui nome era intitolata una delle dieci contrade, fu chiesa
parrocchiale, oltre che collegiata.
La chiesa è citata in molti documenti del suo archivio (MOTTIRONI) e in due
dell’Archivio della Cattedrale (C. SCACCIA SCARAFONI, docc. 118 (486) del
1128 e 165 (316) del 1166); inoltre è menzionata nella decima del 1328 e nella
prefazione degli Statuti Verolani.
Sul fianco sinistro della chiesa è addossato il monastero di S. Erasmo,
abitato fino a tutto il sec. XI dai benedettini e passato ai canonici regolari all’inizio del sec. XII. Le notevoli dimensioni (m. 55 X 31 circa) denotano l’impor-
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
tanza della costruzione, che per tre anni ospitò la corte papale di Alessandro
III. Dell’impianto originario restano solo i muri perimetrali, in particolare
quello che dà sulla via Garibaldi. Esso è formato da un severo paramento murario in pietre ben squadrate, in cui si aprono tre porte con architravi triangolari su mensole ed un arco a tutto sesto, notevolmente rialzato dal piano
stradale. Questo lascia supporre che verso il Tre-Quattrocento in quel punto si
doveva addossare alla costruzione un grosso profferlo o una scala, di cui non
rimane più traccia. In alto su questo muro, accanto agli spigoli esterni della costruzione, si aprono delle feritoie (sec. XII?) e delle finestre di epoca posteriore.
Questa costruzione assai rimaneggiata, potrebbe risalire alla stessa epoca delle
strutture originali della chiesa, cioè al sec. XII. In quel tempo tutto il complesso
si trovava in posizione isolata (foris civitate) e fu fortificato, divenendo uno dei
nuclei meglio difesi della città.
Forse si può identificare l’area su cui sorgeva l’ospedale di S. Erasmo
con quella segnata da nn. cat. 744 o 746 (cioè a sud del monastero, verso porta
Arenaria), ma non rimane più niente dell’edificio originario.
Appare menzionato la prima volta nel 1089, in una carta dell’Archivio
di S. Erasmo (MOTTIRONI, doc. 96), in cui l’ospedale posito est in civitate verulana subtus ecclesia S. Herasmi.
S. Ippolito — La chiesa è situata all’angolo di via Umberto I con largo
Arenaria. E’ un edificio irregolare (m. 9 e m. 6 sui lati corti; m. 13 e m. 15
sui lati lunghi), restaurato nel Settecento. Forse il solo portale, architravato su
mensole decorate e sormontato da lunetta cieca, è medioevale, ma una datazione più precisa è impossibile. Oggi S. Ippolito, di cui non si conosce la data
di fondazione, è sconsacrata e chiusa al pubblico.
La chiesa è nominata solo negli Statuti Verolani {Praefatio, p. 3).
Santa Maria Rotonda — È scomparsa, ma se ne conosce l’ubicazione approssimativa. Fino alla fine dell’Ottocento la via Lucio Alfio (da via dei
Franconi a via G. Campano, nella zona centrale di Veroli) si chiamava via di S.
Maria Rotonda; gli isolati contrassegnati dai nn. cat. 30, 39 e 24, 26 sono abbastanza recenti, perciò la chiesa doveva essere situata sull’area di uno di essi. È
evidente, come si deduce dal nome, che l’edificio era a pianta centrale.
Gli Statuti Verolani (Praefatio, p. 3) attestano che S. Maria Rotonda fu
costruita prima del Mille, ma nei documenti non è citata prima del 1093; cfr
C. SCACCIA SCARAFONI, doc. 75 (527). Era sottoposta alla giurisdizione della
cattedrale.
S. Martino — La chiesa e l’annesso convento sorgevano immediatamente fuori dalle mura, sotto Castel Briccoli; ora, dopo lo spostamento della
porta urbana più ad est, avvenuto nel Settecento, sono inglobati nell’abitato.
Il monastero fu fondato dal vescovo Leto e da esso consacrato, insieme alla
chiesa, sotto il pontificato di Onorio II, nel 1127, come testimonia una lapide
murata all’interno della chiesa stessa. Tutto il complesso fu rimaneggiato nel
161
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
162
Settecento, ma la chiesa ci si presenta ancora nella pianta originaria, ad un’unica navata, presbiterio ed abside, con cinque cappelle su ogni fianco, dovute
forse ad un’aggiunta posteriore.
In esso abitarono le monache benedettine fino al 1449 (Statutum, Praefatio, p. 3), quando, essendo abitato solo da tre religiose, queste furono fatte
trasferire in città ed il convento fu assegnato all’Ordine dei Frati Minori (CASIMIRO DA ROMA 1764, pp. 445-454). Il monastero è citato nella decima del 1333.
S. Nicola — La chiesa fu distrutta nell’ultima guerra e sulla sua area
passa oggi la via di Traffico. Di essa rimane solo la parte absidale, divisa in due
piani tra una salumeria ed una casa di abitazione4.
Alla chiesa era annesso l’ospedale di S. Nicola, ma i recenti mutamenti subiti
dalla zona ne hanno cancellato le tracce.
S. Nicola è menzionata in un documento dell’Archivio Capitolare (C.
SCACCIA SCARAFONI, doc. 112 (66) del 1122) e nella prefazione degli Statuti
Verolani, che la dicono iuris ecclesie Cathedralis. Anche l’ospedale è citato solo
nella decima del 1333.
S. Paolo — Sorge nella parte meridionale della città. Pur inserendosi in un contesto urbano di aspetto medioevale, le sue linee architettoniche
esterne sono settecentesche e la pianta è a croce greca sormontata da cupola.
Probabilmente la parte originaria è solamente quella occupata dal presbiterio e
dall’abside e la chiesa, in origine più piccola, forse aveva una sola navata. La dedicazione all’apostolo Paolo farebbe pensare ad una grande antichità; tuttavia i
documenti non ne danno conferma.
All’esterno, a destra della porta d’ingresso, sono murati dei frammenti
di scultura; la maggior parte di essi è indatabile, ma due potrebbero risalire
al sec. IX (una testa femminile e parte di un sostegno di plutei o transenne,
decorato ad intrecci). Purtroppo non sappiamo quale sia stata la collocazione
originaria di queste sculture che, se provenissero da questo edificio, potrebbero
testimoniarne l’esistenza già dal sec. IX.
La troviamo citata in una sola carta dell’Archivio Capitolare (C. SCACCIA SCARAFONI, doc. 195) (92) del 1191) e nei due elenchi delle decime.
S. Pietro — La tradizione vuole che essa fosse fondata sul luogo in cui
sostò S. Pietro, di passaggio per Veroli, nel corso del suo viaggio dal sud dell’Italia verso Roma (ovviamente questa notizia non è documentabile). La chiesa
era situata nella zona centrale della città, tra largo della Catena e largo G. Trulli.
Fino alla metà del Novecento si potevano vedere in largo della Catena tre archi
ogivali, ultima testimonianza di questa costruzione (C. SCACCIA SCARAFONI
1953), che doveva costituire un bell’esempio di architettura medioevale.
4
La chiesa di S. Nicola fu demolita nel 1950 e la via oggi si chiama Corso M. Fortunata Viti.
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
Accanto alla chiesa sorgeva l’ospedale di S. Pietro, di cui non rimane
più traccia.
La chiesa e l’ospedale sono nominati nella decima del 1333; solamente
la chiesa compare nella prefazione degli Statuti Verolani.
Santa Salome — È l’unica chiesa di Veroli di cui si conosce l’anno di
fondazione. Nel 1209 fu ritrovato il corpo della santa, lungo la scarpata che
delimita il fianco occidentale della città. In quel tempo l’andamento altimetrico del terreno era diverso da quello odierno: la piazza di S. Salome e parte
dell’area del Seminario vescovile erano occupate da uno sperone roccioso, che
fu tagliato durante i lavori di ricostruzione della chiesa, dopo il terremoto del
1350, per facilitare l’accesso dal centro della città. Appena rinvenuto il corpo
della santa si cominciò ad onorare il luogo della sepoltura erigendovi sopra un
piccolo edificio sacro. Il primitivo oratorio era orientato N-S e vi si accedeva
da sud, la chiesa vera e propria fu compiuta solo nel 1317 e mantenne lo stesso orientamento. Il terremoto del 1350 distrusse quasi completamente questa
costruzione, che negli anni seguenti fu adattata a cripta; sopra ne fu eretta
un’altra ex novo, con orientamento E-O ed ingresso ad est, consacrata nel 1429
dal vescovo Clemente (CAPERNA 1878, pp. 49-54). Il nuovo edificio ebbe pianta a tre navate, con transetto ed abside a picco sulla scarpata. Di questa fase
costruttiva sono visibili solamente gli archi gotici in pietra chiara che segnano
il passaggio dalle navate laterali al transetto e gli affreschi sul lato sinistro di
esso, perché le antiche strutture, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, furono coperte completamente dai restauri commissionati dai vescovi De Zaulis
(1690-1708) e Tartagni (1715-1751). Il tetto, prima sorretto da capriate lignee,
fu ricostruito a volta; le colonne che separavano le navate furono inglobate in
pilastri e si eressero le cappelle laterali che si aprono nelle navatelle.
All’esterno, addossata al fianco sinistro della chiesa, rimane la torre
campanaria, restaurata, che ricorda come tipologia i campanili della cattedrale
e di S. Erasmo. È a pianta quadrata, a tre piani; nei due superiori si aprono gli
archi a tutto sesto della cella campanaria.
S. Salome è ricordata nella decima del 1328 con il nome di S. Maria
Iacobi e con la stessa definizione appare nella Prefazione degli Statuti Verolani.
S. Stefano — Si è già parlato, a proposito della Regio S. Stephani, del
problema dell’ubicazione della chiesa e dell’omonima contrada nella parte meridionale della città. Purtroppo non si hanno più tracce di questo edificio sacro, che gli Statuti Verolani (Praefatio, p. 3) includono nel numero delle chiese
anteriori al Mille.
Nei documenti appare per la prima volta nel 1062 (C. SCACCIA SCARAFONI, docc. 43 (653) del 1062; 80 (747) del 1097; 82 (21) del 1098; 94 (25) del
1108; 112 (66) del 1122) e in carte posteriori, nelle quali il suo nome è sempre
abbinato a quello di S. Vito, come se fossero due edifici molto vicini oppure
un’unica chiesa con due denominazioni.
163
Nel Medioevo fuori della porta Arenaria sorgevano un monastero ed
un ospedale.
Monastero di S. Agostino — L’antico convento di S. Agostino (S. Agostino Vecchio) era situato poco distante dalla porta, in un luogo oggi non identificabile5, in esso si tenne il Capitolo provinciale della provincia romana nel 1296
(CAPERNA 1907, cap. X), il che denota come esso fosse un complesso di grandi
dimensioni, atto ad accogliere i numerosi partecipanti al Capitolo. Il monastero
fu completamente distrutto nella guerra tra lo Stato Pontificio e gli Spagnoli del
Regno di Napoli, durante il pontificato di Paolo IV (1555-1559) e gli Agostiniani furono trasferiti entro le mura di Veroli, presso la chiesa della Ss. Annunziata,
che da allora ricevette il nome collaterale di S. Agostino (S. Agostino Nuovo).
6. Veroli al centro dell’Europa Giuseppe Trulli
M. LETIZIA PUTTI
Veroli, in Lazio meridionale
Multigrafica Editrice, Roma 1980
164
5
Sopra la Fontana del Lago, vicino al Convento dei Frati Cappuccini.
Alessandro III e Federico Barbarossa - particolare
La Rocca di San Leucio dopo il restauro
Ogni problema di carattere strutturale ed estetico
è stato brillantemente risolto dall’architetto Alessandro Tarquini
Recupero della cinta muraria in opera Poligonale di epoca romana e delle strutture difensive
di epoca medievale, località San Leucio
- Progettista e Direttore ai lavori Architetto Alessandro M. Tarquini - Impresa esecutrice: Moliri S.r.l. di M. S. Giovanni Campano (Fr) -
- Versante Ovest delle Mura Poligonali, e Rocca di San Leucio Durante l’esecuzione dell’intervento di restauro.
- Vista interna della Rocca di San Leucio Durante l’esecuzione dell’intervento di restauro.
Martirio e Beatificazione di Thomas Becket - particolare
Museo Archeologico - Abbazia di Casamari
Duomo di S. Andrea
Esterno
Croce Santa - dettaglio
Duomo di S. Andrea - Cappella del Tesoro
Chiesa di San Michele Arcangelo
Esterno
Basilica di S. Erasmo
Assonometria - Da “Dettagli Verolani”- Arch. Massimo Terzini - 1999
Basilica di S. Erasmo
Esterno e scalinata
CAPITOLO VII
Il trionfo delle “humanae litterae”
Veroli e la scuola umanistica
177
Giovanni Sulpicio
179
Giovanni Martello
181
Giovanni Antonio Campano
183
Aonio Paleario
185
Davanti al Tribunale dell’Inquisizione di Roma
188
L’ultimo giorno del Paleario
192
Come il futuro Cardinale croato Veranzio tentò di salvare la vita
al verolano Paleario
195
Campo de’ Fiori: a morte gli eretici
198
7.1
Veroli e la scuola umanistica
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
I
I risveglio dell’amore verso le humanae litterae, che vide in Italia i suoi
centri maggiori in Firenze e Roma, trovò anche in Ciociaria un terreno
fertilissimo. Nelle scuole di grammatica veniva a formarsi una nutrita
schiera di umanisti tra i quali Benedetto da Piglio, Martino Filetico di
Ferentino, Domizio Palladio Sorano, Mario Equicola di Alvito, Bernardino Cacciante di Alatri, Giovanni Antonio Sulpicio e Aonio Paleario di Veroli. Molti di questi, spinti dal bisogno di arricchire le proprie esperienze culturali, si allontanarono dai luoghi nativi, «cosa che d’altra parte permise loro di
offrire un contributo valido allo sviluppo dell’Umanesimo stesso».
In questo ben determinato periodo, la città di Veroli «si trovava nel
suo più grande splendore in fatto di studi, e contava fra i suoi cittadini valenti
maestri nella conoscenza del latino e nel metodo d’insegnamento». Furono
proprio gli eruditi locali e i maestri delle scuole di grammatica a riproporre
agli allievi lo studio dei grandi autori greci e latini. Tra questi insegnanti della
classicità spicca Giovanni Antonio Sulpicio, che ebbe i suoi massimi riconoscimenti di valente docente prima a Perugia, poi a Urbino e infine a Roma. La
notorietà del verolano si deve al testo Opus Grammaticum Sulpitianum che,
seppur destinato all’inizio a scolari ciociari, divenne un’opera adottata in diverse scuole d’Italia e all’estero. L’apprezzamento della grammatica fu così generalizzato da essere edita più volte.
Giovanni Antonio Sulpicio fu uno degli umanisti lodati da Pomponio Leto, il restauratore dell’Accademia Romana, e su consiglio di quest’ultimo
curò l’edizione De Architectura di Vitruvio pubblicata nel 1484 con una lettera
di dedica al cardinale Raffaele Riario. L’opera meritò un’attenzione particolare
da parte degli architetti e degli urbanisti del rinascimento; la conobbero certamente, tra gli altri, Leonardo, Antonio e Francesco da Sangallo, il Bramante e
Michelangelo.
Durante il periodo romano Sulpicio commentò con rigorismo filologico opere classiche riguardanti il De aquaeductu Urbis di Frontino, le opere di
Vegezio, di Eliano e Modestino, le Institutiones di Quintiliano in collaborazione con Lorenzo Valla e Pomponio Leto, la Pharsalia di Lucano, i Paradoxa di
Cicerone, il commento a Virgilio .
L’impegno culturale di Sulpicio non si esauriva nella ricerca, nell’interpretazione e nel commento degli antichi codici: la filologia era solo un
aspetto della sua versatile attività di studioso umanista. Egli era anche portato
per la poesia, la musica e il teatro.
Sempre con la disponibilità del cardinale Riario l’umanista verolano,
unitamente a Pomponio Leto, profuse molto del suo ingegno per la rinascita
177
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
178
del teatro classico introducendo parti musicali nelle rappresentazioni. Mise in
scena alcune commedie di Plauto e Terenzio nel testo originale e una tragedia
di Seneca, Ippolito, con il prologo e la scenografia curati da lui stesso. Quest’opera, nel 1468, fu in scena a Campo de’ Fiori. Si realizzava così l’intento di
Giovanni Sulpicio: le rappresentazioni si svolgevano non più solo nei saloni
degli splendidi palazzi dei principi, dei signori e dei papi, ma anche nei luoghi
aperti, nelle piazze.
Tra i suoi componimenti in metrica, di argomento religioso, il ludicium Dei Supremum de vivis et mortuis, pubblicato a Roma nel 1506, «è senza
dubbio il più impegnativo ed apprezzato» tanto da rappresentare «il testamento di Giovanni Sulpicio ed insieme la sua professione di fede». Il breve poema
passò certamente tra le mani di uno dei suoi alunni più illustri, Alessandro
Farnese, il futuro papa Paolo III e da questi a Michelangelo, che ad esso si ispirò per la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina.
Lo stesso Giovanni Sulpicio potrebbe essere stato un maestro di Aonio Paleario, come scrive Vittorio Giovardi, anche se lo stesso Paleario ricorda
nei suoi scritti, e con animo pieno di riconoscenza, un altro grande umanista,
Giovanni Martello, dotto notaio verolano, che gli impartì i primi rudimenti
di latino e greco dietro richiesta del padre Matteo. «In vita mia — scriverà
più tardi Aonio al Martello — non ho provato un piacere più grande di quello
che mi recò la nuova che tu volevi abitare la mia casa... Credi tu che io non
ricordi quando mio padre mi conduceva bambino in casa tua? Oh! Come egli
era contento d’aver trovato in te un uomo a cui poter affidare i suoi figli! Tu
fosti certamente necessario alla mia fanciullezza, e sono creduli quelli che mal
sopportano che io ti ami! Non ho persona al mondo a cui abbia obbligo maggiore».
Questo era il clima culturale della Veroli ad inizio Cinquecento. Questo il contesto che avvolse il periodo giovanile di Aonio Paleario.
GIUSEPPE D’ONORIO
Lineamenti di vita e di pensiero, in Aonio Paleario tra l’inedito e l’inedito
di Giuseppe D’Onorio e Alfredo Gabriele
Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, Sora 2008
Giovanni Sulpicio
Veroli, nel frusinate, era una delle isole minori del nostro Rinascimento, tanto generose nel raccogliere gli echi della vita di Roma, Firenze e Napoli,
quanto aperte ai loro inviti e al richiamo delle loro seduzioni. Nella cittadina
arroccata in una altura panoramica al centro della Ciociaria, si formarono, e di
lì presero la strada di Roma, Perugia, Urbino, Siena, Milano e Lucca, Giovanni
Sulpicio e Aonio Paleario, trovando fortune diverse e antitetiche: il primo accompagnato sempre da onori, favori e amicizie in alto e popolarità dovunque,
il secondo inseguito dall’Inquisizione e portato sul rogo. Un centro di cultura
nel Lazio, a non molta distanza da Roma, poteva infatti appagare spiriti tranquilli e modesti, ma era troppo poco per un filosofo letterato, ambizioso e intrepido e troppo poco anche per un umanista di versatile talento.
In Roma a Giovanni Sulpicio Verulano, grammatico e poeta didascalico e morale, senza debolezze nella onesta adesione alla fede religiosa tradizionale, non fu difficile entrare presto nel giro dei letterati e dei loro potenti mecenati, tanto che divenne in breve tempo «auditor» e poi intimo del principe di
studi e di sangue, Pomponio Leto.
Fra le varie e numerose iniziative di questo attivissimo maestro e della
sua Accademia, dall’archeologia al teatro, dalla filosofia all’urbanistica, dalla
filologia alla poesia, il Verulano si trovò certamente a suo agio. Intorno all’anno in cui per volontà di Lorenzo De’ Medici si pubblicava postumo il «De re
aedificatoria» di L.B. Alberti, il Verulano dava l’editio principes del «De architectura» di Vitruvio, offrendo quel testo all’esame di architetti ed urbanisti che
non attesero molto per servirsene ampiamente. Ad una cultura che si evolveva,
nella pratica non meno che nella teoria, verso generi specifici e specializzati
fino al tecnicismo, il Verulano faceva dono delle opere di Vegezio, Eliano e
Modestino.
Ruolo rilevante cercò ed ottenne infine nel teatro, il nuovo genere allora riscoperto fra l’entusiasmo di tutti. Nella Roma mondana di Sisto IV a chi
aveva idee nuove per il teatro e vocazione di teatrante non potevano mancare
occasioni e aiuti. Il Cardinale Raffaello Riario Sansoni, fra i nipoti del Pontefice secondo, in fatto di mondanità, soltanto allo zio Pietro di San Sisto, si era
assunto il ruolo di sovrintendente agli spettacoli, sacri o profani che fossero, e
più attento a questi che a quelli. Il personaggio, noto per essere stato il sacerdote celebrante nel tragico 26 aprile, non si sa se ignaro o complice della congiura
contro Lorenzo e Giuliano, organizzava e finanziava tutto ciò che il raffinato
gusto del tempo richiedeva in fatto di teatro. Gli dovettero essere gradite l’amicizia e la collaborazione dell’umanista di Veroli, se fu il primo ad apprezzare
l’idea innovatrice di introdurre la musica nelle rappresentazioni dei classici.
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.2
179
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
In una epistola del Verulano al Cardinale, in mezzo alle usitate lodi e
prima dell’esortazione ad edificare «Theatrum novum» («... quid enim popularius? Quid gloriosius?»), c’è un accenno a questa impresa, non senza orgoglio
di umanista: «Tu nam primus tragoediae, quam nos juventutem excitandi gratia
et agere et cantare primi hoc aevo docuimus (nam eius actionem jam multis saeculis Roma non viderat) in medio foro pulpitum ad quinque pedum altitu-dinem
erectum pulcherrime exornasti».1
Evidentemente il Verulano aveva piena coscienza del valore del suo esperimento, se di fronte all’autorità del «Romanae Ecclesiae dignissimus Camerarius» teneva a rivendicare a sé quel primato che in breve avrebbe avuto grande
seguito nell’opera della Camerata fiorentina. L’inserimento di parti musicali
nella commedia costituiva una gloria che non intendeva dividere con nessuno.
Grande fama non raccolse nei secoli per questa originale innovazione,
e appena gliene toccò per le edizioni di Vitruvio e Vegezio o per i commenti
alla Farsaglia di Lucano o alle opere di Quintiliano; non molta per le poesie
latine di argomento morale, religioso e storico.
Di lui furono letti e molte volte stampati i trattatelli di grammatica, di
metrica e prosodia, compilati per le scuole del tempo, raccomandati e celebrati
dal Platina, il grande protetto di Sisto IV. Fra questi il «Compendium gramaticae», il «De versuum scansione» e l’immancabile opera di retorica, il «De octo
partibus orationis libellus».
180
ANTONIO G. CASANOVA
De moribus in mensa servandis di Giovanni Sulpicio
in Libro di cucina del sec. XIV, a cura di A. Consiglio
Roma, Canesi
1
Tu infatti per primo facesti ornare meravigliosamente un palco dell’altezza di 5 piedi
eretto nel mezzo del foro per la tragedia che noi per primi in questo tempo, al fine di farla rivivere, abbiamo insegnato alla gioventù a rappresentare e a cantare (infatti da molti secoli Roma
non ne aveva più visto la rappresentazione).
Giovanni Martello
Giovanni Martello, nato in Veroli nella seconda metà del secolo XV,
fu notaio e umanista. Fu maestro di Aonio Paleario. Questi gli vendette la casa
paterna, come sappiamo da una lettera che gli scrisse da Siena nel 1531: «Ho
ricevuto la tua lettera cortesissima nella quale mi dici che abbandonerai volentieri la casa paterna per acquistar la mia, purché io approvi le condizioni del
pagamento. Ho scritto spesso al Pavonio e al Bono che sanno il mio amore per
te, pregandoli a dirti che io non ho nulla che non creda più tuo che mio. Approvo dunque le condizioni e ti rimetto la cedola. Corsini, così affabile e così
innamorato di te, disbrigherà ogni cosa con la massima diligenza, e ti auguro
che questa compra torni a tuo sommo vantaggio. In vita mia non ho provato
un piacere più grande di quello che mi recò la nuova che tu volevi abitare la
mia casa... Però mi consolo pensando che tu stii dove a me non è possibile
di stare e dove, se io pure ci stessi, staremmo sempre insieme. Credi che non
ripensi al tempo che mio padre mi conduceva bambino in tua casa? Oh come
egli era contento d’aver trovato in te un uomo a cui poter affidare i suoi figli!
Tu fosti veramente necessario alla fanciullezza mia, e sono crudeli quelli che
mal sopportano che io ti ami. Non ho persona al mondo a cui io abbia obbligo
maggiore: tuttavia operi assai prudentemente se eviti il loro astio a cui non so
assegnare una ragione. Ma via, scuoti da te queste molestie.
Credo a ciò che mi scrivi degli amici, e sento in me accadere lo stesso.
Non posso dirti quanto malvolentieri io mi rassegni alla vostra lontananza.
Non passo giorno che non vi abbracci tutti nella memoria e nel pensiero. Siamo pur divisi e lontani, noi ci ameremo sempre. Sì, né ostacolo né lontananza
né tempo porrà mai fine al nostro amore. Addio».
Nelle cronache locali Giovanni Martello è ricordato come Segretario
di Ferrante Sanseverino, Principe di Salerno (GUIDO SPANI, Veroli..., cit.).
Del Martello, contrassegnato con il n° 384 (P. LII) dell’«Inventario dei
manoscritti della Biblioteca Giovardiana di Veroli», 1925, di Camillo Scaccia
Scarafoni, esiste l’unico documento autografo che ancora si conservi: «Sante
di Giangiacomo di Anagni vende a Francesco Marco Andrea di Nardo Spani
di Veroli una vigna in territorio verolano contrada Plantarelli per il prezzo di
18 ducati in ragione di 10 carlini per ogni ducato. Fatto in Veroli in contrada
Castel Briccoli dal notaio Giovanni Martello. Anno 1526».
«A un discendente della famiglia del Martello apparteneva la casa,
situata nel rione della Civerta, che in vari ambienti ancora conserva quattro
iscrizioni col nome FABRITIUS MARTELLUS, nipote dell’umanista. Secondo Camillo Scaccia Scarafoni, tali iscrizioni risalgono alla fine del sec. XVI. La sua
supposizione è sostanzialmente confermata da un documento dell’archivio di
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.3
181
S. Leucio, dove un “Fabritius Martellus”, abate di S. Angelo, è menzionato nei
primi decenni del sec. XVIII»
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
MARCELLO STIRPE
Il rione e la chiesa parrocchiale di S. Leucio... (cit.)
182
Giovanni Antonio Campano
Lo storico della letteratura potrà occuparsi con maggior profitto di
poeti latini come i due Strozzi di Ferrara, il Poliziano e il Marullo di Firenze, il
Pontano e il Sannazzaro di Napoli, che nulla hanno a che fare con Roma; noi ci
limitiamo qui a parlare di Gian Antonio Campano.
Quest’uomo pieno di talento, nato in Campania da un servo della gleba, da fanciullo pascolava le pecore; ammesso alla scuola di un prete, studiò a
Napoli con il Valla, poi a Perugia, dove nel 1455 divenne professore di eloquenza. Aveva l’aspetto di un Calibano ma il genio di un improvvisatore e scriveva
in uno stile così fiorito, da superare quello dei primi latinisti. Il temperamento
burlesco e il felice senso umoristico facevano di lui una compagnia piacevolissima e gli assicurarono il favore di Pio II, il quale gli conferì il vescovado di
Teramo. Paolo II lo mandò nel 1471 alla dieta di Ratisbona, a propugnarvi la
guerra contro i Turchi; il poeta campano si trovò come Ovidio tra i Geti, e del
suo malumore per il clima, per il modo di vivere e per l’inciviltà dei Tedeschi
non gli si può fare torto. Nell’età dell’umanesimo, che infuse nuovo vigore al
sentimento nazionale degli Italiani, riaffiorò anche l’antico concetto dei «barbari»; ma è un cinico odio nazionale quello che si manifesta negli epigrammi
e nelle lettere scritte dal Campano dalla Germania all’amico Ammannati. Oggi
che le condizioni della nostra patria non sono più tanto nere, leggiamo con
un sorriso quei vituperi. L’allegro poeta cadde in disgrazia presso Sisto IV per
aver difeso con troppa franchezza Città di Castello, di cui era governatore, assediata dalle truppe del papa, e morì esule a Siena nel 1477. Le sue opere sono
una testimonianza eloquente del suo talento. Scrisse una biografia di Pio II,
una vita di Braccio, molti discorsi e trattati, moltissime lettere, che sono fra le
più argute del tempo, e ancora elegie, epigrammi, poesie d’occasione di ogni
specie, pregevoli per senso umoristico e facilità di espressione. Il Campano si
rese benemerito anche con le sue revisioni dei testi di autori antichi.
Molti poeti dell’epoca vivevano alle corti dei principi. Il Beccadelli diede lustro alla corte di Alfonso I, il Pontano a quella di Alfonso II e di Ferdinando II, il celebre Mantovano a quella di Federico Gonzaga, gli Strozzi a quella
di Borso, il Filelfo alla corte di Francesco Sforza; Basinio e Porcellio brillavano
nel palazzo di Sigismondo Malatesta e della sua amante Isotta. Gli umanisti
eternavano in discorsi e biografie le gesta dei loro protettori, i poeti cortigiani
lo facevano con poemi epici. Poeta di corte di Pio II poteva essere considerato
il Campano.
F. GREGOROVIUS
Storia della città di Roma nel medioevo, Einaudi Editore.
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.4
183
Giovanni Antonio Campano visse molti anni a Veroli e ne ottenne la cittadinanza. «Vi acquistò una casa che fino ai primi anni del secolo passato conservava questa iscrizione: “IN HONOREM DULCISSIMAE PATRIAE”. Anche oggi la
via dove abitò è intitolata Via Giovanni Campano»
GUIDO SPANI
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
Veroli... (cit.)
184
Aonio Paleario
Aonio Paleario (Antonio della Pagliara) nacque a Veroli nell’anno
1503. Dotato di una forte sensibilità d’artista e di un raro ingegno, l’umanista,
già da ragazzo — sotto la guida del suo primo maestro Giovanni Martello,
dotto «notario verolano» — dimostrò una spiccata disposizione per l’arte della
poesia e della eloquenza ed una naturale inclinazione per la filosofia.
Il Paleario, dal 1520 al 1527, frequentò a Roma la scuola di letteratura
greca e latina, conseguendo un notevole grado di perfezione nelle classiche
discipline. Le Università di Perugia, Siena, Milano e Lucca non esitarono ad
affidare al dotto umanista la cattedra di letteratura greca e latina e quella d’eloquenza.
La maggiore opera del Paleario, «De Immortaliate animorum» (15321535) — dedicata a Ferdinando d’Austria, re dei Romani — è considerato un
perfetto saggio di elegante latinità. I classici dell’epoca, tra i quali il Vossio e
Jacopo Sadoleto, paragonando il Paleario a Marco Gerolamo Vida e a Jacopo
Sannazzaro, giudicarono «divini» i versi del poeta. Nell’opera maggiore — ricca di intensa spiritualità e notevole per il contenuto filosofico-religioso — l’illustre cittadino verolano, conformandosi al classico gusto letterario dell’epoca,
ricalcò i versi lucreziani spintovi, anche, dalla esigenza di contrapporre all’opera epicurea un poema profondamente spirituale. Il Paleario, con sincera fedeltà, attinse dalla poesia di Lucrezio, ma la perfetta aderenza stilistica al «De
Rerum Natura», privò il poema di quella originalità, la quale avrebbe potuto
derivargli da una forma metrica diversa o nuova.
In questa sede vogliamo però analizzare, sia pure brevemente, non
tanto le opere dello scrittore, quanto il suo pensiero, la sua anima accesa di
entusiasmo, la sua consapevole e coerente contraddizione ad alcuni princìpi
tradizionali religioso-teologici. Non possiamo giudicare l’atteggiamento del
Paleario, in quanto egli non potè sottrarsi all’esame ed alla critica dei problemi
dibattuti da quel movimento umanistico, il quale avvertì la necessità di impegnarsi nel libero esame della scrittura e delle dottrine religiose. Furono quelli,
dunque, problemi di vita intelletuale, i quali fanno parte dell’intera cultura italiana del ‘500.
Ecco perché, ci pare che l’atteggiamento dello studioso verolano devesi
considerare non frutto della caparbietà di un figlio di Belial o della ostinatezza
della persistenza nell’errore — come ebbe a commentare il Laderchi, continuatore degli Annali della Chiesa — ma, piuttosto, derivante da quella necessità
di rinnovamento, avvertita da tutti gli umanisti, posti di fronte ad un sistema
di dottrine, di educazione e di vita morale, che, a motivo della sua decadenza,
imponeva una riforma. La Chiesa, travagliata e scossa da inquietudini, affio-
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.5
185
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
186
rate già nel Concilio Lateranese ed aggravatesi in conseguenza del Sacco di
Roma, anch’essa sentì il bisogno di una «Riforma Cattolica». Quest’ultima ebbe
nel Cardinale Sadoleto — sincero amico e protettore del Paleario — uno dei
maggiori artefici, come si rileva dal documento del 1538, «Concilium de emendanda Ecclesia».
In un periodo così tormentato, quando le menti più fervide gareggiarono in accese dispute, in interpretazioni dottrinali e, finanche, in ispirati annunci profetici, il Paleario prese la sua posizione. Lo scrittore, tra l’altro, era
vissuto in quell’ambiente toscano (a Colle Val d’Elsa, nel 1534, aveva sposato
Maria Guidotti) ove ancora non s’era spenta l’eco delle prediche savonaroliane
e dove era fiorito quel movimento fiorentino di rinnovamento religioso, ch’
ebbe quali sostenitori Marsilio Ficino e Pico della Mirandola.
Entrato in relazione epistolare con Lutero, Calvino e Melantone, il
Paleario si compromise a tal punto che il Granduca di Toscana credette opportuno non riconfermare lo studioso nella cattedra universitaria senese. Inizia, così, per l’umanista verolano un periodo denso di timori e di contrasti. «È
difficile essere cristiano e morire nel proprio letto». Nell’esclamazione dell’umanista è contenuta la consapevole amarezza di un tragico presentimento. Lo
scrittore, inoltre, nella sua opera «Actio in Pontifices Romanos» — composta tra
il 1530 e il 1546 e pubblicata, dopo la sua morte a Basilea, nel 1606 — ed in altri
scritti, metteva chiaramente in luce le sue idee antidogmatiche. A Milano, dove
s’era rifugiato e dove aveva ottenuto una cattedra, il Paleario cadde ben presto
in sospetto al Senato. Prese, dunque, l’umanista, la decisione di rifugiarsi a
Faenza, intimorito anche per l’arresto del Carnasecchi. È l’anno 1566, lo scrittore, indifferente all’invito dell’inquisitore che l’esorta a presentarsi a Roma per
giustificarsi, viene arrestato sotto le accuse di divulgazione della dottrina della
giustificazione per fede, con il ripudio delle opere meritorie; disconoscimento
del primato del Papa, contro il quale rivendica il primato del Concilio; disprezzo e derisione della vita dei monasteri; negazione del Purgatorio; disapprovazione della sepoltura nelle Chiese.
Il sostenitore della riforma luterano-zwingliana, il seguace di Ochino,
il dotto scrittore, ritenuto, finanche, il capo della riforma in Italia, viene rinchiuso nel carcere romano di Tor di Nona, per quattro lunghi anni. Le gravi
accuse, le quali procurarono all’umanista il battesimo di eretico, trascinano
inesorabilmente alla morte il Paleario. La pesante legge dei tempi, cui va aggiunta l’inflessibilità del papa Pio V, allora regnante, severissimo con gli eretici,
prevede una sentenza durissima.
Messer Aonio Paleario da Veroli, infatti, assistito dai religiosi della
Compagnia di S. Giovanni Decollato dei Fiorentini, in Roma, il 3 luglio 1570,
è condotto al supplizio. In Castel S. Angelo, l’eretico viene strangolato ed il suo
corpo dato alle fiamme. Si conclude, dunque, tragicamente l’esistenza dell’umanista verolano, che preferì la morte all’abiura d’eresia.
MARIO MEZZACAPO
Aonio Paleario, umanista verolano
in Lazio ieri e oggi, febbraio 1969
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
I protestanti inglesi, tedeschi e svizzeri non esitarono a proclamare il
Paleario martire e ne onorarono la memoria pubblicando le sue opere. A Colle
Val d’Elsa, nel 1840, un gruppo di Toscani, in onore dell’umanista, riportò alla
luce, presso una fonte, una lapide, sulla quale lo studioso aveva fatto incidere
l’iscrizione: «Aonia Aganippe». A Veroli, un bassorilievo di scadente fattura,
posto sullo spigolo d’una antica casa, in località «La Catena» riproduce le sembianze del Paleario, e reca due date, probabilmente di mano recente, risalenti
al 1846. La qual cosa ci autorizza a pensare che all’epoca risorgimentale, alcuni
cittadini verolani sentissero il bisogno di rivendicare lo spirito di libertà dell’illustre cittadino. Nella città di Roma, una bella immagine del Paleario è visibile
sul basamento di quel severo momumento, che Ettore Ferrari, nel 1887, eresse a Giordano Bruno, in piazza Campo de’ Fiori. Solenne è, invece, la statua
dell’umanista, creata da Ernesto Biondi, nel 1910, per il monumento frusinate
raffigurante i maggiori martiri della regione. È doveroso, inoltre, rammentare
che due canonici, cittadini verolani, sia pure in maniera diversa, onorarono,
in passato, il Paleario. Il primo fece incidere su marmo un’iscrizione ove, esageratamente, si afferma che il cittadino verolano «vel aequavit vel superavit
Ciceronem»; il secondo, in un libro di memorie della Città di Veroli, del 1941,
animato forse da umana pietà, tenta di riabilitare l’eretico.
Veroli, importante sede episcopale, ha vantato sempre una grande fedeltà alla Chiesa cattolica. L’eresia del Paleario, pertanto, sembrò pesare come
una vergogna sulla comunità cristiana verolana, la quale, pur cosciente della
grandezza dello studioso, preferì che il ricordo dello stesso cadesse nell’oblio.
Noi abbiamo voluto tracciare il profilo di Aonio Paleario perché, approssimandosene il IV centenario della morte, vogliamo augurarci che la graziosa cittadina ciociara, non vorrà negare quel doveroso omaggio che spetta al
più illustre dei suoi cittadini.
187
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.6
188
Davanti al Tribunale dell’Inquisizione di Roma
(…) I chiarimenti dati da Aonio Paleario, il 19 aprile 1567, non convinsero l’inquisitore di Milano. Il 9 agosto dello stesso anno il cardinale Scipione Rebiba, per ordine del pontefice Pio V e del S. Uffìzio, fece arrivare a
Milano l’ordine di arresto e l’intimazione al Paleario di presentarsi davanti al
tribunale dell’Inquisizione a Roma. La notifica di tale provvedimento avvenne
il 20 agosto. Aonio tentò di rimandare la partenza. Era consapevole che la sua
comparsa davanti al Sant’Uffizio romano sarebbe coincisa con una condanna
definitiva.
Costretto a ubbidire, alla fine di agosto del 1568 raggiunse la città dei
papi. Fu rinchiuso nel carcere di Tor di Nona, uno dei torrioni della Roma medievale, «posto sulla riva destra del Tevere, a due passi da Ponte Sant’Angelo.
L’Inquisizione vi aveva profonde sotto terra e al mortifero contatto con le acque del fiume, le sue carceri più spaventose, destinate, si direbbe, a far provare
agli eretici le pene anticipate dell’inferno». Vi aveva languito Pier Carnesecchi
e lì verrà rinchiuso, non molto tempo dopo, Giordano Bruno.
Nel processo vennero mosse quattro accuse al Paleario: negare il Purgatorio, sostenere la giustificazione per la sola fede, disprezzare la vita monastica e condannare le sepolture nelle chiese.
Durante il periodo della sua prigionia Aonio Paleario conobbe fra Roberto Novella da Eboli. Ciò significò nuovi guai per il verolano che a questo si
associò nell’accusare di simonia Pio V, per aver elargito trentamila scudi ad un
nipote del predecessore perché inducesse il cardinale Borromeo a farlo papa e
ottomila per la stessa ragione al cardinale Vitelli . A queste accuse Aonio fece
seguire quest’altra dichiarazione: «II cardinale Farnese, fece nozze di una che
confessò pubblicamente sua figliola bastarda, con che si proclamò concubinario con scandalo di tutta Roma» .
Nei colloqui processuali Aonio Paleario delineò una nuova accusa
contro il papa: «Non potest esse vicarius Christi et successor Petri, qui non
habet dilectionem in proximum suum» (“Non può essere vicario di Cristo e
successore di Pietro chi non ama il suo prossimo”).
Certamente non era questo il modo migliore per mettere in salvo la
propria vita.
Invitato a ritrattare, il Verolano non tornò indietro neppure di un millimetro dalle sue posizioni e dichiarò: «Ego iam dixi saepe: abrenuntio omnibus
defensionibus meis et meorum et expecto iudicium, non recognosco errores, quia,
ut dixi, in dilectione proximi et observatione gloriae
Christi non potest errari» .
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
(“Ho già ripetutamente detto: rinuncio a tutte le mie difese (ad ogni mia difesa) e dei miei ed attendo il giudizio. Non riconosco errori perché, come dissi,
circa l’amore del prossimo e la venerazione (riverenza, ossequio) della gloria di
Cristo non si può sbagliare”).
Venne così affidato a due teologi con l’intento di riportalo all’ortodossia, ma Aonio non ritrattò, anzi le sue posizioni divennero più decise.
Allo stremo delle sue forze fìsiche e intellettuali fu affidato al gesuita
padre Giacomo Ledesma. Riuscì a quest’ultimo ciò che sembrava impossibile:
Aonio Paleario fece una ritrattazione in piena regola dettata dallo stesso gesuita e qui di seguito riportata. Era il 10 aprile 1570.
« Credo et confiteor quidquid sacrurn concilium tridentinum definivit et
quiquid Sancta Ecclesia Cattolica romana credit et confiitetur. In super confiteor
haec:
1) Quod potestas saecularis potest licite punire et occidere haereticos.
2) Quod ecclesia potest tradere potestati saeculari licite haereticos occidendos.
3) Quod summus pontifex romanus potest instituere ministros saeculares qui occidant haereticos.
4) Quod ipsemet summus pontifex in casu aliquo potest etiam per se
haereticos occidere, ut legimus de Samuele et Petro.
5) Quod per peccatum mortalem non amittitur potestates, sed summus
pontifex etiam in peccato existens est vere summus pontifex et habet
summi pontificis potestatem.
Ego Aonius Palearius Verulanus fateor quod in his fuimus concordes et ita credo
ut sunt scripta et subscripta mea manu» .
(«Credo e confesso tutto ciò che ha definito il concilio di Trento e tutto
ciò che crede e confessa la santa Chiesa cattolica romana. Inoltre in particolare
confesso:
1. Che la potestà secolare può lecitamente punire e condannare a
morte gli eretici.
2. Che la Chiesa può affidare alla potestà secolare lecitamente gli eretici da condannare a morte.
3. Che il sommo Pontefice romano può istituire ministri secolari che
condannino a morte gli eretici.
4. Che lo stesso sommo Pontefice, in certi casi, può anche uccidere da
sé gli eretici, come leggiamo [nelle Scritture] a proposito di Samuele [I Sam. 15, 33] e di Pietro [Atti 5,1-10].
5. Che egli non perde la sua potestà a causa del peccato mortale. Ma
il sommo Pontefice, pur vivendo in peccato, è veramente sommo
Pontefice e ha il potere del sommo Pontefice.
Io Aonio Paleario verulano confesso che in questo fummo concordi, e così
credo come sono scritte e sottoscritte con la mia mano».)
189
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
190
Molti si sono chiesti come mai Aonio Paleario, dopo tanta fermezza,
sottoscrivesse un atto così remissivo da far stupire gli stessi giudici dell’Inquisizione. Scrive Morpurgo: «Siamo di fronte ad un problema psicologico di natura assai interessante e sottile... ricordiamo prima di tutto che Aonio era gravemente malato, arso dalla febbre, sofferente d’asma, di ernia, col petto spezzato
da terribili accessi di tosse: e ciò stando da mesi e mesi segregato in cella. Dunque quel corpo aveva certo indebolito anche la mente e l’interminabile noia del
carcere aveva steso come un velo opaco di torpore sul lucido entusiasmo col
quale egli si disponeva a morire, come diceva, per Cristo».
Questo gesto di arrendevolezza di Aonio non fu sufficiente per i giudici del tribunale dell’Inquisizione. Il 14 giugno questi gli sentenziarono la ritrattazione formale in pubblico, che «si faceva vestiti dell’abitello, una specie
di tunica gialla, divisa sul petto da una gran croce purpurea, sconfessando le
proprie opinioni dal pulpito d’una chiesa». Indossare il vestiario del penitente
significava esibire un marchio di vergogna.
Aonio, però, a questo atto pubblico oppose un secco no. Era la sua fine.
La condanna ormai era segnata.
«Die veneris 30 iunii 1570, coram Sanctissimo, Aonii Palearii Verulani, in qua
illustrissimi et reverendissimi domini cardinales praefati, attento quod dixit et
protestatus fuit, se nolle ullo modo deferre abitellum, prò ut sibi iniunctum fuit
in sententia, iudicarunt ipsum esse impenitentem et propterea tradendum fore et
esse iudici saeculari puniendum iuxta sacras constitutiones, prò ut tradi mandarunt reverendissimo domino almae urbis gubernatori».1
Un ultimo pensiero di Paleario, prima della esecuzione della condanna, fu per la moglie e i figli. A loro le sue ultime lettere.
«Consorte mia carissima, non vorrei che tu pigliassi dispiacere del mio
piacere et a male il mio bene; è venuta l’ora che io passi di questa vita al mio Signore e padre, e Dio; io vi vo tanto allegramente, quanto alle nozze del figlio del
gran re, del che ho sempre pregato il mio Signore, che per sua bontà e liberalità
infinita mi conceda. Sì che la mia consorte dilettissima, contentatevi della voluntà, de Dio, e del mio contento et attendete alla famigliola sbigottita che resterà,
di allevarla e custodirla col timore di Dio et esserli madre e padre. Io ero già di
70 anni vecchio e disutile. Bisogna che i figli colla virtù, e col sudore, si sforzino a
1
(“Venerdi 30 giugno 1570, alla presenza del Santissimo (Santo Padre) a proposito della
causa di Aonio Paleario di Veroli, nella quale gli illustrissimi e reverendissimi cardinali, sopra
indicati, tenuto presente quanto da lui detto e dichiarato pubblicamente, cioè di non voler assolutamente (in alcun modo) indossare l’abitello, come gli era stato ordinato nella sentenza, lo giudicarono impenitente e, per questo, da consegnare al giudice secolare per essere punito secondo
le sacre costituzioni; per questo lo affidarono al reverendissimo Signor Governatore della città
(di Roma)”.
GIUSEPPE D’ONORIO
op. cit
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
vivere onoratamente. Dio padre et il Signor nostro Giesù Cristo et la communion
dello Spirito Santo sia collo spirito vostro. Di Roma il dì 3 di Luglio 1570. Tuo
marito Aonio Paleari».
«Lampridio e Fedro figliuoli dilettissimi, questi miei signori cortesissimi
insino a l’ultimo non mancano con esso me della loro cortesia e mi permettono
ch’io vi scriva. Piace a Dio di chiamarmi a sé per questo mezo che voi intenderete,
che vi parerà aspro et amaro, che se il considerate bene, essendo con mia somma
contentezza e piacere per conformarmi alla voluntà di Dio, vi avete anche voi
a contentare. La virtù e diligenza vi lascio per patrimonio con quelle poche di
facultà che avete. Non vi lascio debito, molti chiedono alle volte che devono dare.
Voi sete emancipati più di 18 anni fa, non sete tenuti a miei debiti, quando vi
fussero chiesti ricorrete a sua Eccellenza del signor Duca, che non vi lascierà
far torto. Diedi a Lampridio il conto del dare et avere: ci sono la dote di vostra
madre, e de allevare, come Dio vi darà la grazia sua, la vostra sorellina. Salutate
Aspasia e suor Aonilla mie figliuole dilettissime nel Signore.
L’ora mia si avicina. Lo Spirito di Dio vi consoli, e conservi nella sua
grazia. Di Roma il dì 3 di Luglio 1570. Vostro padre Aonio Paleari».
Lunedì 3 luglio 1570 venne prima impiccato e poi bruciato. Il tutto si
consumò sul ponte S. Angelo poco distante dalle carceri di Tor di Nona.
191
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.7
192
L’ultimo giorno del Paleario
La lettura dei «Regolamenti» e delle «Memorie» della Confraternita ci
permette di ricostruire con esattezza l’ultima giornata del Paleario.
Domenica 2 luglio 1570 il «capo notaro del governo» comunica con
biglietto legale al Provveditore dell’Arciconfraternita (Giovanni Manzuoli, che
per la circostanza è sostituito da Monte Zazera) la notizia che l’esecuzione del
Paleario avrà luogo l’indomani mattina. Il Provveditore fa intimare il cappellano Iosia da Fermo, il padre domenicano Alessandro, il reverendo Francesco
Maria Tarusi, e i quattro confortatori Giambattista Perini, Bastiano Caccini,
Bernardo Aldobrandini e Francesco da Carmignano; e inoltre l’intera Confraternita per accompagnare il condannato al luogo dell’esecuzione.
I fratelli sagrestani si recano nella Cappella della Confraternita (conforteria) dentro le carceri per preparare l’occorrente. Nella stanza antistante la
Cappella si prepara quanto necessario per scrivere. In altra stanza non contigua si appronta «tutto ciò che occorre per i confratri, volendo profittare di
caffè, cioccolato ed altro simile conforto».
Nella notte gli incaricati si riuniscono nella Chiesa della Confraternita
e poi pregando si recano alle carceri con i lampioni. Arrivati, i fratelli indossano il sacco, ed il cappellano la cotta e stola. Aspersione dell’ambiente con
l’acqua benedetta.
Il Provveditore si mette alla porta dove deve entrare il Paleario; con lui
vi sono due dei quattro confortatori: uno con la «tavoletta» che porta dipinta
l’immagine della deposizione di Nostro Signore.
Dopo l’intimazione della sentenza fatta dal cursore del Tribunale, si
apre la porta della conforteria, dove i due confortatori ricevono il Paleario, lo
chiamano per nome e gli mostrano la tavoletta «esortandolo» e avvertendolo
«che il suo tempo è breve, e che però l’hore che gli restano si devono consumare fruttuosamente, con fare molte azzioni le quali li Confortatori gli suggeriranno a cosa per cosa». Lo conducono in ginocchio avanti l’altare, facendogli
recitare l’Ave Maria.
Da quanto appresso diremo si potrà pensare che il Paleario si comportò come un condannato ben disposto, con un giuoco raffinato di ultimo doppismo. Lo dispongono alla confessione e il Cappellano lo confessa, restando solo
loro due nella cappella, mentre gli altri si ritirano nella stanza anteriore.
In questa stanza viene poi portato il Paleario, per rispondere alle domande del Provveditore: generalità sue e dei familiari, se desidera far comunicare loro la notizia della sua morte («se volesse scrivere»), se ha qualcosa da
disporre, se ha crediti o debiti («potendo servire questa nota pigliata dal Prov-
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
veditore in luogo di suo testamento») (ecco le due ultime lettere alla moglie e ai
figli!), se deve riparare per alcun prossimo la fama tolta, «se si protesta morire
da buon cristiano rassegnato ai divini voleri con ferma intenzione di perdonare al prossimo qualunque offesa ricevuta nel modo stesso che egli desidera di
ricevere il perdono de’ peccati»: e questo si deve scrivere nei libri della Compagnia «a perpetua memoria et a gloria di Dio». Per consentirgli di scrivere, uno
dei custodi gli leva le manette ma gli resta vicino.
Lo consigliano, se ha qualche danaro, di versarlo per elemosine o per
la celebrazione di Messe per l’anima sua. Se non lo ha, i confortatori fanno loro
l’offerta. Il Paleario viene ricondotto in Cappella. I sacerdoti presenti (sono
tre) dicono la Messa per lui nella medesima Cappella. Sono le ore una o due
del giorno. Una sola Messa o tre Messe? Se fossero tre, il condannato dovrebbe ricevere la Comunione-Viatico durante la seconda. Ma non risulta, come
vedremo, che il Paleario si sia comunicato. Dopo la celebrazione, al Paleario è
offerta «qualche refocellatione», «facendo trovare le cose che esso stesso desidera», «non però spirito o vino in quantità», «in particolare se si vede che sia
estenuato ò infermo» (e il Paleario lo era). Recita della terza parte del Rosario.
Un’ora prima dell’esecuzione, il Provveditore si reca alla chiesa della Confraternita, dove sono riuniti i fratelli che dovranno accompagnare il
condannato al patibolo: lì viene celebrata una Messa e sono recitati i salmi
penitenziali. Esce la processione: «precede il fattore con abito e ferajolo nero
sulle spalle, quindi due fratelli con torce di cera gialla, in mezzo de’ quali altro
fratello portante il crocifisso con gabbia e panno nero, e quindi i fratelli a coppia, in ultimo de’ quali il governatore, il quale per sistema nell’anno del di lui
governo non è mai invitato all’assistenza nelle carceri la notte». I fratelli, giunti
alle carceri, si schierano nell’atrio.
Intanto il cappellano e i confortatori hanno praticato col Paleario l’esercizio della Via Crucis. Il condannato riceve la benedizione in articulo mortis. Se non ha vestiti decenti, la Compagnia gli provvede a proprie spese camicia o abito adeguato, calzette, scarpe e cappello.
Mezz’ora prima dell’esecuzione, il Ministro della Giustizia viene a mettergli il laccio al collo.
Il Paleario esce dalla Cappella «con gl’occhi sopra la tavoletta che si gli
tiene innanzi». Alla porta delle carceri, lo fanno mettere in ginocchio ai piedi
del Crocifisso della Compagnia. Dal carcere di Tor di Nona a ponte S. Angelo il
tragitto è breve: c’è da presumere che si vada a piedi, e non «sopra il carretto»:
il Paleario cammina tra due confortatori. Si cantano «flebilmente» le litanie
dei Santi.
Il confortatore sacerdote gli impartisce l’ultima assoluzione.
Il Ministro di Giustizia lo lega nelle braccia, mentre si susseguono ancora preghiere ed esortazioni, anche quando è «gettato a basso», «sin che verisimilmente si può credere che egli l’ascolti».
193
Il Paleario è morto. Si recitano il Miserere e il De profundis.
ERNESTO GALLINA
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
Aonio Paleario
Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, Sora 1989
194
7.8 Come il futuro Cardinale croato Veranzio
Ardua è indubbiamente l’impresa di ripercorrere l’intero cammino di
una ricerca storico-scientifico-letteraria che fa parte di quegli strani “viaggi nel
passato”, curiosare nelle vite di personaggi e in eventi storici i quali direttamente o indirettamente fanno parte della cultura latina europea, croata e italiana
di quella terra luminosa per sole e per mare che è la Dalmazia, dalla quale
soffiavano fecondissimi i venti dell’Umanesimo e del Rinascimento europeo.
Tale è la più recente e vasta stesura curata da Giacomo Scotti, scrittore
e giornalista fiumano dalla mente erudita e allenato nel gusto dello storico raffinato, presentata nel volume “Famiglie dalmate” dove ci regalò un sostanzioso
capitolo riguardante la relazione fra “Paleario e Veranzio riformatori del ‘500”.
Indubbiamente alcune delle novità storiche tra Paleario e Veranzio sono state
evidenziate grazie alla minuziosa ricerca, e da pochi anni scoperte, dall’illustre
studioso Leo Kosutta, italianista e latinista responsabile della Biblioteca Nazionale di Parigi.
Quasi coetanei: Aonio Paleario, alias Aonius Palearius, nome e cognome
umanisti di Antonio Paliari ovvero Antonio Della Paglia (Veroli, 1503 - Roma,
1570) e Antonio Veranzio, alias Verantius Vrancic (Sebenico, 1504 - Pressov,
odierna Slovacchia, 1573).
Ambedue fedeli al latino, quale mezzo di espressione letteraria, ambedue amanti delle antichità classiche, sono stati accomunati da qualche studioso
anche nella definizione di “Umanisti protestanti”, quali appartenenti alla cerchia di quegli umanisti italiani, spagnoli, dalmati e di altri paesi che battendosi
per il rinnovamento della Chiesa e il suo ritorno all’originaria purezza cristiana, rimasero però dei criptoprotestanti o nicodemidi (termine usato da Calvino); a differenza di altri riformatori essi rimasero a metà strada, spaventati
sia della repressione cattolica che da quella protestante, isolati nei loro paesi
e costretti ad emigrare spostandosi da un capo all’altro dell’Europa. A dirla
con il ricercatore Leo Kosutta che alla “coppia” Paleario-Veranzio dedicò un
breve saggio alcuni anni indietro, essi rimasero nella sfera del cattolicesimo
conservando un pensiero riformista, con la differenza che il dalmata Veranzio,
prelato, diplomatico, archeologo, storico e poeta, riuscì a scalare tutti i gradi
della carriera ecclesiastica fino a quella di cardinale, spegnendosi lontano dalla
patria, è vero, ma nel proprio letto mentre il nostro Paleario finiva impiccato
ed arso per eresia.
Antonio Veranzio-Vrancic aveva illustri e nobili origini: infatti proveniva da un’antica famiglia dalmata. Raggiunse Vesprem, importante sede
vescovile nel regno di Ungheria nella quale risiedeva in quel tempo il glorioso
Vescovo Bano (Duca) Pietro Berislavic, parente per parte materna dei con-
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
tentò di salvare la vita al verolano Paleario
195
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
196
ti Statileo di Traù-Trogir dove Veranzio passò la sua infanzia (nella casa dei
nonni traurini). Dopo la morte tragica di suo zio Pietro ucciso in battaglia, fu
preso sotto la protezione del vescovo di Erdelyi Giovanni Statileo, segretario
personale del re ungherese-croato Ludovico, il quale per le eccezionali qualità
diplomatiche mandava Giovanni Statileo a Venezia, a Roma (da Papa Paolo
III), dal re di Francia, per raccogliere aiuti nella guerra contro i Turchi.
Nel frattempo, finendo gli studi a Padova, Vienna e Cracovia, nel 1530
Veranzio divenne segretario del nuovo re ungaro-croato Janos Szapolyi che
gli affidò, per tradizione familiare, una missione diplomatica presso il Papa
Clemente VII, il re francese Francois I, il doge Gritti, il re polacco Sigismondo,
il sovrano inglese Enrico VIII, non escludendo lunghi viaggi anche presso la
corte del Sultano, e divenendo così Primate di Ungheria.
Con tutto ciò, non esitò di prendere iniziative per la difesa di Aonio
Paleario (accusato per ben due volte dall’Inquisizione) mettendo a rischio la
propria vita e usando tutte le armi presso la corte di Buda e di Vienna trascinando anche altri illustri personaggi dell’Europa di quel tempo nella sua battaglia, nel nome dei sacri ideali dell’Umanesimo, per la difesa di un amico caduto
in disgrazia, come vedremo più avanti.
Tornando al nostro Paleario che nel frattempo ha lasciato gli studi
presso l’Università di Roma nel 1527 per continuarli a Perugia, Siena e Padova,
bisognerebbe dire che Paleario era stimolato a quei tempi da Pietro Bembo
quando scrisse il poema “De immortalitate animorum”, pubblicato a Lione nel
1536, continuando a insegnare la letteratura greca e latina a Milano. Contemporaneamente uscivano le sue epistole “De pace”, orazione per la pace di Chateau-Cambresis; influenzato anche da Erasmo da Rotterdam, Paleario fece sue
molte delle tesi sulla riforma della Chiesa che arrivavano in Italia dall’opposto
versante delle Alpi: e fu la prima volta che a Siena riuscì a malapena ad evitare
la condanna dell’Inquisizione.
In proposito, il già citato L.Kosutta (“V.Mogucnosti”, Split-Spalato 3A
1992) ha scritto: «L’unico legame noto del Paleario con i riformatori istriani
fu quello allacciato con Pier Paolo Vergano» all’epoca vescovo di Capodistria,
tramite il quale nel 1536 egli tentò di ottenere un incarico alla corte di Vienna,
dedicando a Ferdinando d’Austria l’opera già citata “De immortalitate animorum”, ma non ebbe successo come sappiamo; Vergano restò sordo alla preghiera di Paleario al quale rispose con una lettera che non è giunta fino a noi:
ma vi fa un cenno nel suo saggio E. Gallina. Nel 1565, sette anni dopo l’arrivo
dell’epistola del Paleario a Vienna, quel testo capitò nelle mani del giovane
giurista triestino Andrea Rapicio, laureatosi in ambedue i diritti all’Università
di Padova, all’epoca al servizio della corte. Ma non era un semplice scrivano, si
era già affermato come oratore eccellente e autore di un discorso pronunciato
l’anno precedente per la morte di Carlo V e poi dato alle stampe. Un esemplare di questo testo arrivò nelle mani di Antonio Veranzio. Più tardi il Rapicio
NENAD VESELIC
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
rivolgendosi al Veranzio, gli mandò anche l’opera di Paleario per chiedere il
parere dell’alto prelato e scrittore sul pensiero di quel filosofo verolano. Veranzio, dunque, fu generoso di lodi per quanto riguarda lo stile e la bellezza della
lingua latina dell’umanista Paleario, ma rimase perplesso per quanto riguarda
l’espressione “Dii immortales” per “Dio cristiano”, espressione usata anche da
Erasmo da Rotterdam ma ugualmente criticata sia dai Cattolici che dai Luterani. Il contenuto delle lettere scambiate da Veranzio e Rapicio e il positivo
giudizio dei due sull’opera di Paleario erano condivisi a Milano dal medico
della corte viennese Giuseppe Solano, il quale fece da tramite presso quella
corte perche già conosceva Paleario dai tempi dell’Università di Padova. A sua
volta Paleario consegnò a Solano una lettera di ringraziamento per il Rapicio,
e una speciale epistola per il Veranzio insieme a una sua opera dedicata all’imperatore Ferdinando. Si ignora però se e come l’imperatore reagì alle preghiere
e all’opera di Paleario.
Se questi personaggi siano intervenuti a favore dello scrittore italiano presso l’imperatore Massimiliano II il 27 marzo 1568, quando il cardinale
Scipione Rebibbia chiese ufficialmente che Aonio Paleario fosse consegnato
all’Inquisizione di Roma, non lo sappiamo. Lo fecero veramente Rapicio e soprattutto Veranzio? Kosutta scrisse che è possibile. Ma in ogni caso, in quei
tempi terribili, interventi di solidarietà amichevole, umanistica e misericordiosa, senza la clemenza della corte, diventavano semplicemente una parola
pietosa: “Intercessione fallita”. Una volta proclamato imperatore, Massimiliano
aveva cambiato atteggiamento nei confronti dei Protestanti, eppure essendo
circondato a corte da numerosi riformatori che erano stati compagni di studi e
amici del Paleario a Padova e Siena, lasciò che della vita di Paleario decidessero
quegli stessi che avrebbero condannato al rogo e al martirio anche il Giordano
Bruno.
197
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
7.9
198
Campo de’ Fiori: a morte gli eretici
Di sicuro è un’esperienza da fare, soprattutto quando c’è il sole e si
ha voglia di passare una mattinata diversa dal solito: andare a fare la spesa al
mercato di Campo de’ Fiori. Beh, la prima cosa che ti colpisce è il vociare della
gente, tutto quel brulicare di persone ti mette allegria. E poi gli odori che si
rincorrono, dal profumo di pesce fresco (tra l’altro lì vicino c’è un ristorante
che fa uno splendido baccalà, fritto o in umido) a quello delle verdure. E i
colori? La bancarella con i fiori, quella con la frutta, il macellaio; tutto sullo
sfondo di palazzo Farnese che troneggia nell’omonima piazza adiacente. Trovo sempre molto piacevole passare da lì e quando lo faccio non manco mai di
dare un’occhiata al monumento a Giordano Bruno, il filosofo di Noia bruciato
vivo come eretico il 17 febbraio dell’anno 1600. La storia del grande pensatore
la conosciamo tutti e quella figura chiusa nel manto incappucciato dell’ordine
domenicano contrasta con l’allegria che quotidianamente ruota intorno alla
statua scolpita nel 1887 da Ettore Ferrari. Sul basamento, al di sopra dei tre
rilievi che illustrano i fatti della vita del frate, troviamo una serie di medaglioni con i ritratti di filosofi e letterati che, per le loro idee, vennero considerati dall’autorità ecclesiastica eretici. Ci sono nomi famosi, come Erasmo da
Rotterdam; (1467-1536) che scrisse l’Elogio della follia, Tommaso Campanella
(1568-1639), domenicano come Bruno, che trascorse ventisette anni in carcere. C’è il ritratto di Paolo Sarpi (1552-1623), pugnalato da nemici politici
perché difese la Repubblica di Venezia quando Paolo V le lanciò contro l’interdizione. C’è il ritratto dell’inglese John Wycliffe (1320-1384) che promulgò
idee evangelistiche in Boemia e venne condannato da Gregorio XI. C’è l’effigie
di Michele Serveto (1509-1553) addirittura mandato al rogo da Calvino, quella di Giulio Cesare Vanini (1585-1619) filosofo pugliese bruciato a Tolosa e
quella di Jan Hus (1369-1415) da considerarsi come uno dei precursori della
Riforma. Ma fra tutti costoro, nessuno ebbe il medesimo destino di Bruno,
ossia quello di essere bruciato in Campo de’ Fiori. Soltanto Aonio Paleario,
raffigurato sul medaglione di sinistra, dando le spalle a piazza Farnese, venne
arso a Roma dopo essere stato strangolato in Castel Sant’Angelo: era il 3 luglio
1570. La sua vera colpa era che non sopportava l’idea che la Chiesa mescolasse
la parola di Cristo con il potere e con la politica. Le questioni teologiche e le
convinzioni religiose espresse nel De immortalitate animarum non potevano
essere considerate eretiche (anche se lo furono) se ricevettero il plauso del cardinale Bembo.
Era nato a Veroli, in Ciociaria, intorno al 1503 e qui si era formato,
ma poi le proprie inquietudini culturali l’avevano portato in giro per l’Italia, da
un’università all’altra. Prima a Roma, dove era giunto all’età di diciassette anni
e poi a Siena, nel 1529. Di là, a Ferrara, a Padova, a Bologna, annodando rapporti culturali con uomini di chiesa, ma anche con eretici come il senese Bernardino Ochino (1487-1564), generale dei cappuccini che aderì al protestantesimo e si rifugiò a Ginevra. Insomma, Aonio il cui vero nome era Antonio
della Paglia, era uno spirito libero che mal sopportava verità preconfezionate.
Talvolta la lealtà costa la Vita.
MARCO BUSSAGLI
7. Il trionfo delle “humanae litterae” Giuseppe Trulli
Giornale non identificato
199
Monumento a Giordano Bruno - dettaglio
Roma - Piazza Campo de’ Fiori
Monumento a Giordano Bruno - retro
Roma - Piazza Campo de’ Fiori
Aonio Paleario
Roma - Monumento a Giordano Bruno - Piazza Campo de’ Fiori
Giovanni Sulpicio
Veroli - Sala consiliare del Municipio
CAPITOLO VIII
Un grande cardinale
Il cardinale Francisco Quiñones e Veroli
207
Lo Statuto di Veroli
211
Dallo Statuto di Veroli alcuni articoli riguradanti gli Ebrei
221
Il miracolo eucaristico di Veroli
223
8.1
Il cardinale Quiñones e Veroli
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
N
acque nel 1475 a Leon in Spagna. Nobile e ricco, studiò all’università di Salamanca, ma a 16 anni, seguendo l’esempio del
cardinale Ximenes, lasciò le agiatezze della propria famiglia per
entrare nell’Ordine francescano. In un attimo cambiò nome e
vita: dal convento di Santa Maria degli Angeli nella Sierra Morena, volle chiamarsi Francisco de los Angeles e, in occasione di una pestilenza nell’Estremadura, prodigò tutte le sue energie nella cura degli appestati,
nell’amministrazione dei Sacramenti e nel seppellimento dei cadaveri.
Eletto Definitore Generale nel Capitolo di Roma (1517), divenne a
Burgos (1523) Generale dei Minori Osservanti. Si mise subito al lavoro: visitò i
conventi francescani di Spagna, ne riordinò il numero e la disciplina e si preoccupò che la Regola fosse attuata nella maniera più rigorosa. Lui stesso ne dette
l’esempio: «... oltre a fare a piedi scalzi la visita dei suoi conventi, prendeva il suo
riposo, che non oltrepassava lo spazio di un’ora, sopra la nuda terra, occupandosi
nel rimanente della notte nella preghiera e nella contemplazione delle cose celesti.
Alle vigilie aggiungeva l’astinenza e l’inedia, trattando il suo corpo quale odiato
nemico». «In capo de tre anni lo predicto Generale fece adunare lo capitolo generale a S. Maria degli Angeli nel 1526, et fu refermato ne l’offitio del Generalato
per tre anni».
Durante il suo generalato non pochi guai vennero al Quiñones per
l’atteggiamento ostile sempre dimostrato nei confronti dei Cappuccini, di quei
frati cioè che avevano voluto, con incredibile ostinatezza, una riforma in seno
alla Regola francescana. Bisogna premettere che già al tempo di Leone X erano
sorti nel reatino alcuni poveri conventi abitati da monaci dediti ad una rigorosa attuazione degli insegnamenti del Santo di Assisi. Il Quiñones, una volta
eletto Generale, divenne molto amico di questi frati, detti della Stretta Osservanza o Riformati: li sostenne e li incoraggiò, assegnando loro in Spagna ben
cinque case. A Martino di Guzman e a Stefano Molina dette invece l’incarico
di diffondere in Italia il loro modo di vivere: cominciare e finire il giorno con
una lunga meditazione; nutrirsi di solo pane, erbe e frutta; dormire sulla nuda
terra e così via.
Quando perciò il severo Generale vide profilarsi la possibilità di un’altra riforma (quella cappuccina, appunto), temette per l’unità della famiglia
francescana: prima che diventassero un serio pericolo per la comunità serafica, i nuovi «dissidenti» andavano fermati. Ad ogni costo. Il loro capo, poi,
un certo Matteo da Bascio, doveva fare particolarmente rabbia al Quiñones:
fanatico e visionario, andava gridando ai quattro venti il pressante appello che
S. Francesco stesso gli avrebbe rivolto: «Voglio che la regola mia si osservi fino
207
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
208
alla lettera, fino alla lettera, fino alla lettera!». Diceva inoltre che un contadino, timorato di Dio, gli aveva indicato la vera foggia dell’abito indossato da S.
Francesco: un abito rozzissimo con un cappuccio cucito la cui forma però non
era rotonda, ma quadrata e a punta.
Ce n’era abbastanza per mandare su tutte le furie il nostro Generale che ingaggiò una lotta senza quartiere contro i poveri Cappuccini, i quali, secondo lui,
«turbavano la pace nell’Ordine serafico, di cui era protettore».
Per loro fortuna i frati trovarono in Vittoria Colonna una preziosa alleata: in
alcune lettere indirizzate ad importanti personaggi del tempo, la poetessa denunciò a più riprese «la permanente ostilità del cardinale Quiñones, il quale...
aveva rovesciato il suo odio sui Cappuccini per la ragione che essi facevano
troppo apparire i difetti dei suoi confratelli». Il padre Bernardino da Colpetrazzo, nella sua «Cronica dei Cappuccini», ci racconta un gustoso fatterello:
una volta il Quiñones si incontrò, a Roma, con un gruppetto di giovani cappuccini. Saputo da uno di loro che si recavano alla visita delle sette chiese,
«con molta collera gli bravò dicendogli: Voi andate a sette a sette? Non passerà
molto che vi stroncarò i passi e vi assetterò ben io!». Ma le ostilità cessarono
soltanto nell’agosto del 1536, quando una bolla di Paolo III confermò definitivamente l’approvazione dei Cappuccini, pronunciata qualche anno prima da
Clemente VII. Le responsabilità che venivano al Quiñones dalla sua carica di
Generale dei Francescani non gli impedirono di portare a termine i gravosi
incarichi, questa volta di natura politica e diplomatica, affidatigli da Clemente
VII quando questi si trovò coinvolto nella guerra tra Francesco I e Carlo V.
Avendo accordato, sia pure con estrema indecisione ed in maniera discontinua, la sue preferenze al re di Francia, papa Medici si trovò a dover far fronte
da un lato alle truppe tedesche capeggiate dal Frundsberg, che premevano dal
nord, dall’altro alla flotta imperiale che, comandata dal Lannoy, si avvicinava
alla costa italiana. Il Quiñones, incaricato dal papa, si incontrò a Gaeta con il
Lannoy ed ottenne risultati soddisfacenti per entrambe le parti. Di lì a qualche
mese, però, Clemente VII, irresoluto come al solito e non sapendo se dare
più retta ai consigli di Giammatteo Giberti, che parteggiava per la Francia o
piuttosto a quelli dello Schonberg, che era dalla parte dell’impero, si trovò prigioniero a Castel S. Angelo, mentre Roma veniva sottoposta al brutale «Sacco»
del maggio 1527. A tirarlo fuori ci pensò il Quiñones: avuto l’incarico della
nuova missione, il Generale dei Francescani partiva immediatamente per la
Spagna. Incontratosi faccia a faccia con l’imperatore, otteneva, dopo lunghe
ed estenuanti trattative, condotte facendo ricorso a tutte le sue qualità di abile
diplomatico, la liberazione del papa. La nomina a Cardinale con il titolo di
Santa Croce in Gerusalemme, avvenuta nel dicembre del 1527 e pubblicata il
25 settembre dell’anno successivo, era il compenso, graditissimo, che il papa
offriva al Quiñones. Anche in seno al sacro Collegio il novello porporato non
nascose mai le sue preferenze per l’imperatore, opponendosi alla nomina di
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
quei cardinali che parteggiavano per il re di Francia. Si oppose pure, con particolare intransigenza, alla nomina di quei cardinali che lasciavano a desiderare
sotto il profilo morale: la severità ed il rigore francescano, che nel Quinoñes
erano fortemente radicati, gli impedirono, per esempio, di appoggiare la nomina di Pietro Bembo, precedentemente vissuto, «more uxorio», con una tale
Morosina, dalla quale aveva avuto diversi figli. Pur accettando altri importanti
incarichi, affidatigli sia da Clemente VII che da Paolo III, il Quiñones, che dal
1530 era stato eletto vescovo di Coira e dal 1534 cardinale protettore dell’Ordine francescano, ebbe tempo di occuparsi della riforma, voluta da papa Medici,
del breviario romano. Il nuovo «Breviarium Sanctae Crucis», redatto in collaborazione con Diego Meyla e Gaspare De Castro, era pronto nel 1535; «... gli
ecclesiastici con trasporto l’adottarono, e sebbene dai papi non fosse mai con
generale approvazione per tutta la chiesa conceduto, né comandato pure in soli
40 anni fu stampato, oltreché in Roma, 3 volte a Venezia, altrettante a Parigi e
6 a Lione».
Intorno al 1535 fu affidato al Quiñones il governo della città di Veroli.
A tale proposito sarà bene ricordare che già al tempo di Leone X le città più
importanti dello Stato Pontificio venivano rette da un cardinale che, con la
qualifica di Governatore, o Prefetto o Commendatario, doveva provvedere a
risolvere i problemi più rilevanti della sede a lui assegnata. Il periodo del governo verolano fu per l’illustre porporato spagnolo tra i più operosi e fecondi
della sua vita, a giudicare almeno dalle tracce della sua attività lasciate nella
città ernica.
Il Quiñones dovette gradire molto soggiornare a Veroli, se nel borgo
di Santa Croce ritenne opportuno mettersi subito all’opera per adattare a propria abitazione, trasformandola completamente, una costruzione gotica preesistente. Il nuovo palazzo, austero e severo come i castelli di Spagna, solenne
ed imponente nella scala di accesso al piano superiore, appena impreziosito da
una elegante bifora e dalla croce che ricorda il suo titolo cardinalizio, fu abitato
quasi ininterrottamente dal Quiñones dal 1535 circa al 1540, anno della sua
morte. A pochi metri dal palazzo, totalmente rimaneggiata, è l’antica chiesa di
Santa Croce, che il cardinale restaurò ed eresse a parrocchia sopprimendo due
benefici canonicali della chiesa di S. Paolo.
Nello stesso anno della sua venuta a Veroli, per recuperare una preziosa vena d’acqua che altrimenti sarebbe andata perduta, costruì fuori Porta Romana una deliziosa fontanina il cui prospetto è dominato dal complicatissimo
stemma del Quiñones. Sotto lo stemma è l’iscrizione del 1535: FRANCISCUS
QUIGNONIUS / CARD. SANC. CRUCIS VERUL. PRAEF. / AQUAM QUAE
IN USU ESSE DESIERAT / OB PUBLICAM UTILITATEM RESTITUIT / AN.
A CHRISTO NATO MDXXXV KAL. SEPT.
(Francesco Quiñones, cardinale di Santa Croce (in Gerusalemme), Prefetto
di Veroli, ripristinò per utilità pubblica la sorgente che non si era più potuta
209
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
210
usare. Nell’anno dalla nascita di Cristo 1535, primo di settembre).
Ma il grande merito del Quiñones, per quanto riguarda i suoi rapporti
con Veroli, consiste nell’aver riordinato, modificato ed adattato ai suoi tempi
l’antico statuto della citta ernica. Diviso in cinque libri manoscritti (Elezioni e
dovere degli amministratori — Procedura civile — Procedura penale — Danni
arrecati — Altri fatti di giustizia1) fu dato alle stampe nel 1657 per iniziativa di Tommaso Paolini «Capitano della fanteria della città e terra di Bauco
e presentemente Sindaco del Comune di Veroli», affinchè tutti conoscessero
«quanta semper fuerit Verulanorum in moribus disciplina; iuste in decernendis
prudentia; in delictis corrigendis vigilantia, et in culpis plectendis discreta severitas» (quanto grande sia stata la moralità dei costumi verolani, la prudenza
nell’amministrazione della giustizia, la vigilanza nel prevenire i delitti e l’umana severità nel punire le colpe).
Non appena ebbe redatto il nuovo statuto, il card. Quiñones si spense nel suo
palazzo verolano il 27 ottobre 1540. Il suo corpo fu trasportato a Roma nella
chiesa di Santa Croce in Gerusalemme ed ivi sepolto il 4 novembre successivo.
Ma il proprio cuore il cardinale volle lasciarlo a Veroli, come ultima testimonianza di un affetto verso la città che aveva tanto amato: racchiuso dentro una
piccola urna, fu collocato al centro della cattedrale dove una lapide, ora perduta, recava incisa la seguente iscrizione: HIC IACENT VISCERA RMI DMI
CAR SAN CRUC OBIIT ANNO MDXXXX P-T PAS R M PO-SUIT (Qui giacciono le viscere del Rev.mo Signor Cardinale di Santa Croce. Morì nell’anno
1540. Pietro Passeri pose questo ricordo (?). Riferisce l’Ughelli nell’Italia Sacra,
che «la di lui anima da Bernardino Haredo suo compagno e uomo di santa
vita, fu veduta ascendere al cielo nel momento in cui morì». Ma è probabile
che il lungo viaggio del Quiñones verso il paradiso sia stato interrotto da una
breve sosta in purgatorio. Se non altro per i guai che il terribile cardinale fece
passare ai poveri Cappuccini.
GIUSEPPE TRULLI
Lazio ieri e oggi, agosto 1977
1
II manoscritto del XVI secolo contenente lo Statuto di Veroli, è conservato nella Biblioteca Giovardiana. A pag. 198 in cui terminano le più antiche disposizioni si legge: «Ill.mi ac
Colmi Fr. Quignonez B.M. Card. San. Crucis, inclitae urbis verulanae praefecti Jussu, Martinus de
Molina Cordubensis haec civilia jura scripsit et exemplavit reipublicae stipendio anno a partu Virginis et nati Christi LV supra MD, manus imposita pridie Idus novembris. Optate, praecor, salutem
scriptori». (Per ordine dell’Ill.mo e Ven.mo Francesco Quiñones, di felice memoria, Cardinale di
Santa Croce, prefetto della illustre città di Veroli, Martino di Molina di Cordova scrisse e copiò
queste norme di diritto civile a spese della comunità nel 1555 dal parto della Vergine e dalla nascita di Cristo avendovi posto mano il 14 novembre. Augurate, vi prego, la salute allo scrittore).
8.2
Lo Statuto di Veroli
Sconfitto Federico Barbarossa nel 1176 presso Legnano ad opera della
Lega dei Comuni lombardi, venne a cessare il primato imperiale in Italia e
fiorirono le libere istituzioni. Il papa Alessandro III, che nella lunga lotta era
stato strenuo difensore della Lega, conservò a tutte le città dei territori e beni di
S. Pietro le libertà comunali. Questo privilegio toccò anche a Veroli, i cui cittadini avevano sempre preferito darsi proprie leggi (...). Più tardi, nel 1199, dopo
le decisioni del Concilio di Orvieto, la nostra città elesse il suo primo podestà,
di cui però non si hanno notizie. Si sa invece che il 1° marzo 1294 fu eletto
alla carica podestarile Benedetto Caetani, che poi divenne papa con il nome
di Bonifacio VIII. (...) Circa la data di origine dello statuto, c’è da osservare
che nel testo giunto fino a noi (manoscritto e copia a stampa della Biblioteca
Giovardiana) lo stile latino non è sempre il medesimo. In alcune disposizioni,
certamente le più antiche, si ravvisa lo stile latino dei primi secoli dopo il mille,
stile che acquista sapore rinascimentale in norme aggiunte successivamente ad
integrare le prime.
(...) Per il nostro lavoro ci siamo serviti sia del manoscritto che della
copia a stampa del 1657.
A somiglianza dell’antica Roma, gli uomini di governo rimanevano in
carica sei mesi. Erano eletti il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno. Terminato il loro mandato, potevano essere rieletti, dopo trascorso un intero anno.
La città era divisa in 10 Circoscrizioni chiamate «Scritte»: San Leucio,
S. Angelo, S. Erasmo, Valle, Castello, S. Andrea, S. Maria dei Franconi, S. Stefano, S. Paolo, S. Croce.
I cittadini di ogni Circoscrizione eleggevano: un consigliere, un sopraconsigliere, due custodi (guardie comunali), un forestaro (guardia forestale),
un grascero (guardia annonaria), un viario (cantoniere), un contestabile dei
fanti (comandante delle truppe della Circoscrizione), uno scrittario (capocircoscrizione), uno statutario (per eventuali modifiche allo Statuto). Da ciò
derivava che gli uomini eletti per il governo della città erano in totale: 10 consiglieri, 10 sopraconsiglieri, 20 custodi, 10 forestari, 10 grasceri, 10 scrittari, 10
viari, 10 contestabili dei fanti, 10 statutari.
I 10 consiglieri, eletti dalle predette Circoscrizioni, a loro volta eleggevano un contestabile dei Nobili (comandante generale delle truppe). Qualora
una contrada non avesse avuto nobili o nati da nobili, poteva essere eletto contestabile un altro cittadino che perciò veniva considerato nobile. Eleggevano
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Governo democratico della città.
211
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
212
anche un Depositario (cassiere generale), un Camerario (economo), un banditore e tre sindacatori.
Qui c’è da osservare che la città aveva una seconda suddivisione in tre
contrade: Civita, Plagiali, Monti per cui i predetti consiglieri eleggevano i tre
«sindacatori» uno per ogni contrada.
Il Contestabile dei nobili, il Depositario, il Camerario ed il Banditore,
venivano eletti a rotazione, prima dalla contrada Civita, poi dalla contrada Plagiari ed infine dalla contrada Monti. I medesimi consiglieri eleggevano anche
20 «mediani» i quali, a loro volta eleggevano IL PODESTÀ. I mediani erano
eletti due per circoscrizione.
Il Sindaco invece veniva eletto ugualmente ogni sei mesi il 1° marzo ed
il 1° settembre dalle circoscrizioni, a turno, cominciando la quella di S. Leucio
e terminando con quella di S. Croce per poi ricominciare da capo.
I consiglieri eleggevano anche il Notaio del Comune ed i valletti addetti alla persona del Podestà. Il Podestà doveva essere forestiero, amministrava la giustizia ed era il capo supremo della città. Era accompagnato da due valletti, vestiva una toga a giacca nera con galloni di argento. Aveva per copricapo
il tocco, portava un bastone foderato di velluto nero, gallonato d’argento e con
pomo d’argento.
Nell’anno 1767, il Papa Clemente XIII, concesse al Podestà di Veroli
l’insegna dei «fasci», a somiglianza dei Consoli romani a significare la sua intangibile autorità.
Da quanto si è detto ne deriva che la città aveva un Consiglio formato
dal Sindaco, dal Contestabile dei nobili, da 10 consiglieri e dal Podestà che lo
presiedeva, in totale 13 persone che facevano la normale amministrazione. Un
Sopraconsiglio, formato dal Consiglio e da 10 sopraconsiglieri, in totale 23
membri, che trattava gli affari di maggiore rilievo.
Nelle sedute del Consiglio e del Sopraconsiglio, ogni cittadino poteva
fare le sue osservazioni, le sue proposte e perfino accusare pubblicamente le
autorità per i torti ricevuti, al fine di avere immediata giustizia.
Per le decisioni di capitale importanza, veniva convocata l’assemblea
generale del popolo. Al suono della campana della torre civica che chiamava a
raccolta, gli scrittari chiudevano tutte le porte della città, invitavano il popolo
a radunarsi nella piazza antistante al palazzo comunale, dove si teneva il parlamento.
Ogni cittadino, parlando dall’arengario, poteva fare proposte sui fatti
esposti dal Podestà e nessuno poteva allontanarsi se prima non fosse stata presa una decisione.
Gli elettori dovevano aver superato i 25 anni di età, dovevano pagare le
tasse ed essere regolarmente iscritti negli elenchi della propria circoscrizione.
Non potevano pervenire ad alcuna carica i cittadini che erano stati
condannati per un reato di un certo rilievo o per bestemmia, coloro che non si
trovavano sotto la giurisdizione del Podestà di Veroli, non possedevano beni
del valore di 25 libbre d’argento ed avevano una età inferiore ai 25 anni.
Il solo Depositario doveva avere almeno 30 anni e possedere beni valutabili a 1000 libbre d’argento, in altri termini doveva essere persona che potesse dare massima garanzia di serietà e solvibilità finanziaria.
Erano anche esclusi dalla eleggibilità a qualsiasi carica, gli allevatori
di suini, i mugnai, i macellai i quali tutti, per motivi diversi, avevano rapporti
con il Comune, come può rilevarsi leggendo alcuni articoli dello Statuto, e
tutti coloro che avessero interessi, diretti o per interposta persona, con l’amministrazione comunale ed anche chiunque prendeva in affitto o comprava dal
comune o, in altro modo, ne era debitore.
In qualunque decisione da prendere, se ci si trovava davanti a pareri
discordi, si votava a scrutinio segreto deponendo nel bussolo un lupino per
respingere o una fava per approvare. Per la soppressione dell’ufficio del Depositario infatti, che avvenne nella seduta del Sopraconsiglio e con l’intervento di
alcuni cittadini scelti, l’11 marzo 1543, fatte le votazioni, come si legge in un
allegato allo Statuto, e fatti diligentemente i conti, nella bussola dei lupini ne
furono trovati 5 in quella delle fave 95 e così si concluse, a maggioranza, che
fosse soppresso l’ufficio del Depositario.
Al termine del loro mandato di sei mesi, tutti gli ufficiali indistintamente, dovevano presentarsi innanzi ai Sindacatori per rendere conto di tutto
il loro operato.
I Sindacatori oltre a controllare, per almeno otto giorni, l’operato degli
amministratori al termine del loro mandato, potevano infliggere multe, fare
citazioni, procedere di giorno e di notte, di ora in ora, a loro piacere.
Si è anche detto che ogni eletto a cariche comunali dovesse avere i
migliori requisiti morali. Ma se si osserva che in ogni articolo dello Statuto
c’è una penale, a volte pesantissima, per colui che non avesse fatto rispettare
quanto in esso articolo era stabilito, non vi è dubbio che gli amministratori
assolvevano il loro mandato con la massima correttezza e onestà.
Ma vi è di più. Il sentimento religioso dei Verolani fu certamente profondo ed in certi casi addirittura fanatico. Per dimostrarlo non è necessario rifarsi a S. Pietro che, passando per Veroli diretto a Roma, consacrò nella nostra
città il primo Vescovo di nome Mauro, oppure alla Patrona S. Maria Salome,
in onore della quale nel 1340 fu costruita una bellissima chiesa. Basta pensare
invece che, in quell’epoca, vi erano dentro la città 18 chiese e ben 36 nel suo
territorio e notare che, l’ignoto compilatore della prefazione dello Statuto non
esita a scrivere: «quasi metà delle terre verolane erano passate in possesso degli
ecclesiastici in seguito a donazioni».
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Amministrazione scrupolosa.
213
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
214
Del resto, anche nello Statuto, vi sono disposizioni per cui non poteva
essere eletto a cariche pubbliche, chi fosse stato condannato per bestemmia,
reato questo ritenuto gravissimo e punito con forti multe che, se non pagate,
portavano alla fustigazione attraverso la città da porta Arenaria a porta S. Croce. Ed ancora nello Statuto, e qui è vero fanatismo, si proibisce ai cristiani di
acquistare carne macellata dagli Ebrei ai quali era proibito di servirsi di mattatoio usato dai Cristiani, ed ancora: «Poiché la nostra salvezza e di tutta la fede
cristiana, trova consistenza perfetta nel corpo e nel sangue di nostro Signore
Gesù Cristo» era assolutamente proibito «comprare il vino comunque venuto
a contatto con gli Ebrei, anche se l’uva fosse stata da loro soltanto pigiata, perché, per la loro malizia, potrebbe accadere che, nel rito della messa, si consacri
dolosamente e disonestamente il sangue di Dio».
Ma tanto zelo religioso non incideva minimamente nella scrupolosa
amministrazione del pubblico denaro.
Questa affermazione trova conferma in alcune disposizioni statutarie.
Infatti, il sussidio assegnato dal Comune per la manutenzione e riparazione
della chiesa e del convento di S. Agostino, poteva «essere ridotto o tolto completamente, secondo i meriti o i demeriti dei monaci».
Il contributo, i beni mobili, semoventi ed immobili dell’ospedale della
Passione, che si trovava fuori porta Arenaria, venivano controllati continuamente da ispettori regolarmente eletti dal popolo, i quali infliggevano multe
fortissime al Priore, se trovavano irregolarità amministrative.
Ma neppure quando si trattava di reprimere frodi fiscali, si aveva riguardo per gli enti religiosi. Si legge infatti in un articolo dello Statuto che,
per evitare evasioni fiscali, tutte le donazioni fatte dai cittadini a monasteri
e chiese, dovevano essere senza riserve e totali, altrimenti erano da ritenersi
nulle ed i donatori incorrevano in fortissime multe da pagarsi al Comune oltre,
naturalmente, alle tasse dovute.
Chi faceva donazione totale, senza riserva di alcuna parte dei beni, era
obbligato a portare come vestito «una tonaca lunga fino alle calcagna, non aderente ma larga e con una corda legata alla vita, doveva portare la cappa e non
gli era permesso il tabarro; la cappa doveva essere aperta nella parte anteriore
e portare l’insegna del monastero a cui aveva fatto donazione». Quest’ultima
disposizione dava la possibilità a tutti i cittadini di riconoscere i donatori e di
denunciarli se, per loro conoscenza, avessero fatte donazioni con riserva di
beni o addirittura fittizie per evitare il pagamento di tasse.
Pubblica assistenza.
Molto ben curata dall’amministrazione comunale era l’assistenza dei
cittadini. Esisteva nel 1235, presso la chiesa di S. Croce un ostello per i pellegrini.
Nello stesso anno era in avanzata costruzione, presso la chiesa di S.
Michele Arcangelo, data la salubrità dell’aria, un ospedale. Esistevano anche
due ospizi per vecchi, uno gestito dai fratelli di Nostra Signora, l’altro dai fratelli della Passione. Alessandro III infine, durante la sua lunga permanenza a
Veroli, fece costruire, a sue spese, la chiesa della Maddalena, fuori porta Romana, vicino alla quale fece edificare un ospedale per i malati di elefantiasi e lo
dotò di moltissime rendite. Le cause delle vedove, degli orfani, dei pupilli e di
persone miserevoli, venivano fatte gratuitamente.
Anche i privati cittadini contribuivano a creare istituzioni benefiche.
Ad esempio, il Vescovo Asteo, con il concorso pubblico, riordinò il Seminario dove venivano ammessi a studiare anche i laici. Antonio e Pietro Franchi,
nell’anno 1538, istituirono il Ginnasio che doveva mantenersi con le rendite
di una loro donazione. Il conte Domenico Paolini lasciò legato per mantenere
agli studi un Verolano presso la Sapienza di Roma. Silvio dei Cavalieri, con
disposizione testamentaria, lasciò tutto il suo patrimonio per i giovani verolani
poveri onde potessero frequentare la Sapienza di Roma. Per eseguire la volontà
del medesimo Silvio dei Cavalieri, nel 1772 Vittorio Giovardi erede a ciò designato, per amore dei cittadini, per il pubblico bene, per il decoro di Veroli,
donò alla città la sua biblioteca concedendone la custodia al Seminario.
Base fondamentale dell’amministrazione della giustizia era la collaborazione prestata da tutti i cittadini nel prevenire e reprimere i reati. Ogni cittadino, sotto giuramento, aveva l’obbligo morale della denuncia di tutti i delitti di
cui fosse venuto a conoscenza e, per compenso, riceveva dal Comune la terza
parte della penale dovuta, in denaro, all’erario. Per i reati commessi di notte le
pene si raddoppiavano. Per le aggressioni era ammessa la legittima difesa.
Per la bestemmia, oltre ad incorrere in multe pesanti, i blasfemi non
potevano concorrere ad alcuna carica pubblica e qualora non avessero potuto
pagare la penale, si aggiungeva la fustigazione per le vie della città.
Di maggiore gravità erano ritenute le offese ai genitori. I figli infatti
venivano mandati in esilio finché non avessero ottenuto il perdono.
La fustigazione che si applicava in moltissimi reati, come ad esempio il
concubinaggio, si svolgeva attraverso tutta la città, da S. Leucio a porta S. Croce.
Ma la frusta poteva adoperarla impunemente il padre di famiglia per
punire e correggere la moglie e i figli. La madre poteva usarla verso i figli, i
nonni e gli zii verso i nipoti, il maestro verso gli scolari, sempre però, a scopo
punitivo o correttivo.
Dopo l’omicidio e l’avvelenamento seguito da morte, che comportavano il taglio della testa, le pene più gravi erano inflitte per i reati commessi
contro la proprietà.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
I delitti e le pene.
215
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
II ladro che rubava per la seconda volta, doveva stare un giorno in catene sulla pubblica piazza, innanzi al palazzo del Comune e pagava una multa
doppia di quella stabilita per il primo furto.
Per il mancato pagamento, c’era l’esilio finché il ladro non avesse effettuato il pagamento della multa nelle casse del Comune.
Il cittadino che rubava per la terza volta ed il furto era di una certa
entità, veniva condannato all’impiccagione.
Colui che incendiava una casa o un pagliaio, subiva l’amputazione di
una mano e restava in carcere finché non avesse risarcito il danno.
I ladri di messi, oltre al risarcimento del danno ed al pagamento di una
multa a favore del Comune, rimanevano alla gogna incatenati sulla piazza del
Comune, con innanzi ai piedi la merce rubata.
Il furto con scasso, ancorché fosse il primo, portava all’accecamento
di un occhio ed alla amputazione di un piede, se il reo non poteva pagare la
fortissima multa a cui veniva condannato.
L’impiccagione attendeva colui che commetteva furto con scasso per
la seconda volta.
La rapina, comunque commessa, era punita per la prima volta, con
una forte multa e per la seconda volta con l’impiccagione.
Anche pene severessime erano comminate per chi diffamava con scritte o altre offese, fatte sui muri dell’abitazione del diffamato.
Per i reati di offese e percosse tra parenti o amici, oppure tra persone
vicine di casa, la pena pecuniaria veniva dimezzata qualora fosse intervenuta
la pacificazione in pochi giorni.
Durante l’istruttoria dei processi, il Podestà poteva sottoporre l’accusato alla tortura al fine di ottenere la confessione, qualora fossero risultati seri
indizi.
216
Risorse agricole e commerciali.
Il territorio verolano, pur essendo molto esteso, non era eccessivamente produttivo di granaglie, cereali e frutta, sicché, in molti articoli dello Statuto,
si trova la proibizione di esportare vino, legumi, granaglie e frutta.
La proibizione però era rigorosissima in tempo di guerra. Nei periodi
di tranquillità il fabbisogno della popolazione era assicurato dalla produzione
locale.
Più abbondante era la quantità di olio d’oliva, essendo la natura del
luogo collinoso adatto alla coltivazione degli ulivi.
Fin dall’antichità invece, data l’abbondanza dei pascoli montani e dei
boschi, era sviluppatissimo l’allevamento del bestiame, specie dei suini, se si
pensa che sui missili di metallo che gli antichi guerrieri fiondavano in guerra
era effigiato un verro e che gli abitanti primitivi della nostra terra si cibavano
di ghiande. Anche in molti articoli dello Statuto si parla di tale allevamento in
abbondante numero di capi ed in uno, in particolare, si dice: «Ogni Verolano è
tenuto a pagare al Comune tre fiorini di oro per ogni cento porci».
Nella nostra città esistevano anche fabbriche di stoffe ricavate dalla canapa, se si parla nello Statuto della protezione dei canapeti e della abbondante
produzione di zafferano usato come colorante.
Veroli, città di difficile accesso verso occidente, per la natura dirupata
del luogo, aveva provveduto fin dal suo primo sorgere, alla fortificazione della
parte orientale, con le antichissime mura poligonali. Ma col passare degli anni,
e col perfezionamento delle armi da guerra, alle antiche mura si aggiunsero e
si sovrapposero nuove mura e si costruirono diverse torri a difesa, sicché la città rimaneva completamente chiusa, dalla inaccessabile natura del luogo, dalle
mura e, più tardi, dalle fortificazioni e da una grande torre a difesa dell’accesso
dal nord.
Si poteva entrare nella città da diverse porte. A nord da porta San Leucio, verso oriente da porta della Civerta e per porta Napoletana, a sud per
porta S. Croce, ad occidente per porta Piccola e per porta Arenaria.
Ma lungo le mura vi dovevano essere delle piccole porte che lo Statuto
chiama «portelle» le quali, per motivi di sicurezza si dovevano tener chiuse in
tempi sospetti o di pericolo. Se ne vietava l’entrata e l’uscita a chiunque, sotto
pena del taglio di una mano per i trasgressori.
Nel territorio e nella città inoltre, per ordine del Contestabile dei nobili, venivano innalzati degli sbarramenti difensivi e gravi pene si infliggevano
a chi li avesse danneggiati o rimossi.
Tutti i cittadini atti alle armi formavano l’esercito verolano che si divideva in Decurie, ognuna formata dai soldati della rispettiva circoscrizione che
ne eleggeva il comandante, contestabile dei fanti.
Il comandante supremo, Contestabile dei nobili, veniva scelto dal
Consiglio.
La bandiera era di seta gialla e rossa (i colori di Roma) con effigiata
una balista bianca.
Tutti i cittadini, eccetto i nullatenenti, avevano l’obbligo di possedere
una lancia, una partigiana, uno scudo rotondo, una balista munita di frecce.
I lavoratori tutti, in ogni momento dell’anno, su ordine dei contestabili, erano
tenuti a fornire ognuno 2000 aste per frecce e baliste. Le mura della città erano
ispezionate ogni mese accuratamente dai cittadini eletti a tale scopo. Le eventuali riparazioni si facevano con urgenza e ne avevano l’obbligo i cittadini della
circoscrizione.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Difesa della città.
217
Se questi erano i provvedimenti permanenti per mantenere in efficenza la difesa della città, altri provvedimenti venivano adottati per l’approvvigionamento e le scorte annonarie bastevoli non solo per i cittadini, ma anche per
tutti coloro che, in caso di pericolo, vi cercavano rifugio.
Pertanto era proibita l’esportazione di quei generi la cui produzione
era scarsa. Il vino, la frutta, ed in modo particolare il grano e i legumi non
potevano esser venduti fuori di città.
Gli abitanti delle campagne ed in primo luogo gli abitanti di confine, i
«reductani», avevano l’ordine di portare in deposito in città legumi e frumento.
Ad essi, per i bisogni familiari, ogni settimana, venivano assegnate due coppe
di farina e le loro case erano soggette a frequenti controlli.
Era perfino proibito far macinare grano e granturco fuori città e se il
Podestà ne dava il permesso, la farina doveva essere portata in città.
I mugnai che tentavano di portar fuori di città una qualsiasi quantità
di farina, erano tenuti, per un giorno, in catene sulla piazza del comune con la
farina innanzi.
Chiunque, sorpreso a portare fuori qualsiasi genere commestibile, era
punito con forte multa, perdeva la merce e la bestia trasportatrice.
Qualsiasi cittadino o forestiero che procurava guai che potessero danneggiare la città o faceva scorrerie nei campi o prendeva contatti col nemico,
subiva il taglio della testa.
La stessa pena era stabilita, in pace o in guerra, per chiunque tradisse
o si prestasse a far tradire.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Misure di lunghezza, di capacità e sistema monetario.
218
Nella lettura degli articoli dello Statuto, spesso ci si imbatte in nomi di
misure di lunghezza, di capacità e di monete che ritengo necessario chiarire.
Aggiungo perciò brevi cenni al riguardo.
Misure di lunghezza.
Dalle misure di lunghezza dell’antica Roma deriva il passo di centimetri 150 e il braccio di centimetri 75. Più tardi, quando Veroli passò alla Campania, fu introdotto la canna e la mezzacanna, rispettivamente di due metri e di
un metro. Vi era anche il palmo di 25 centimetri.
Misure di capacità per liquidi.
L’orcio di circa 15 litri, il «petitto» di litri 1,25 circa, il mezzo «petitto»
di litri 0,625 circa. Il «petitto» e il «mezzopetitto» sono misure che rivelano
chiaramente l’origine francese e che di certo furono introdotte dalle truppe
francesi al servizio del Papa.
Misure di capacità per legumi e frumento.
La «scutella» di circa due litri di frumento, la «coppa» contenente 12
«scutelle», la «rubitella» contenente sei «coppe» il «rubbio» formato da due
«rubitelle».
Il campione di tutte le precedenti misure si trovava nel palazzo del
Comune e presso ogni circoscrizione, a disposizione di tutti i cittadini.
Sistema monetario.
Il sistema monetario di Veroli era il medesimo di quello degli antichi
Romani cioè il sistema «ponderale». La base era il «denaro». Con dodici «denari» si formava il «sollo». Con dodici «solli» si formava la «libbra» (circa 300
grammi di argento.
La moneta verolana, basata sul peso, come quella romana, dunque era
formata dal «denaro», dal «sollo» e dalla «libbra». «Sollo» è sicuramente la
corruzione della parola latina «solidum» che, in generale, significa peso e che
ai nostri tempi si è mutato in soldo. In alcuni articoli dello Statuto però (uno o
due per la verità) è nominato il ducato, il fiorino ed il carlino d’oro, monete che
furono introdotte negli anni 1289 e 1278, certamente in articoli aggiunti allo
Statuto successivamente.
Negli articoli 37, 67 e 81 del V libro dello Statuto si nomina un laghetto chiamato «Volubro». In essi si legge: «Nessuno vada a pescare nel laghetto,
ovvero nel «Volubro» del Comune in nessun periodo dell’anno, se non con il
solo amo... sotto pena...». «Per nessun motivo il Podestà può concedere permessi di pesca, sotto pena...».
Dove si trovasse questo laghetto non è possibile rilevarlo dallo Statuto.
Si son fatte molte ipotesi, ma la più verosimile è quella che si trovasse nelle
terre che sovrastano, sulla destra, la strada che reca al convento dei Cappuccini
e si estendono per circa 300 metri di lunghezza. Infatti all’un capo, esiste una
fontana fatta costruire dal cardinale Quignonius e che i vecchi contadini chiamavano dello «Colubro», corruzione certa del nome «Volubro». All’altro capo,
vi è la fontana chiamata del Lago. A ciò si può aggiunger che, chi scrive, nel
1916 insieme ad un suo compagno di Ginnasio, divelse tre conchiglie fossili
dagli scogli, ora scomparsi per l’allargamento della strada, proprio di fronte
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Alcune curiosità: II «Volubro» e la «corrida»
219
alla fontana del Lago.
Ma quando scomparve il «Volubro»? E’ pensabile e possibile durante il
cataclisma che si abbattè su Veroli nel 1350, e se gli articoli citati ancora figurano nello Statuto a stampa del 1657 non fa meraviglia, perché anche altri articoli
soppressi figurano, ad esempio quello della soppressione del Depositario che
avvenne nel 1543. Del resto nel citato Statuto a stampa è stato trascritto completamente tutto quello che c’è nel primo Statuto manoscritto e il sottoscritto
che lo ha letto e tradotto ne può far fede.
La «Corrida».
Nell’articolo dello Statuto che riguarda gli obblighi e i doveri dei macellai, tra l’altro si legge: «I macellai non possono uccidere vaccine o bufali se
non dopo averne fatta la “caccia” nella piazza del Comune, sotto pena...». Ed in
un altro articolo: «Nessuno dia la caccia ad una bestia nella piazza di S. Andrea
nelle domeniche e nelle festività, mentre nella chiesa si celebrano i riti delle
messe, affinchè non venga disturbato il rito divino...». «La stessa disposizione
vige quando nel palazzo del Comune c’è seduta del Consiglio».
Secondo noi è la corrida che si sviluppava durante le «Venationes» che
si facevano a Roma nell’anfiteatro, con tori ed anche con rinoceronti sotto l’impero di Diocleziano. I Verolani la ebbero in eredità, come, del resto, la Spagna
che fece parte delle conquiste romane.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
GIUSEPPE DE MATTIA
Cronistoria e breve commento allo Statuto
del sec. XII della città di Veroli (dattiloscritto)
220
8.3
Dallo Statuto di Veroli, alcuni articoli riguardanti gli Ebrei
Libro III, Procedura Penale
Art. 67 Circa la carne manipolata dagli Ebrei.
Poiché è proibito ai cristiani di mangiare insieme ai giudei e di accettarli
alla loro mensa, e poiché gli stessi giudei, per cattivo uso delle Scritture e per il disprezzo dei nostri cibi, maggiormente combattono la nostra fede, noi dobbiamo
disprezzare la ideologia giudaica e i cibi degli ebrei.
Pertanto nessun giudeo macelli o faccia macellare una bestia grossa o minuta, di qualunque genere, nel mattatoio dove si macellano le carni ad uso dei cristiani; né le carni mattate o fatte mattare altrove dagli ebrei, possono essere vendute
in macelli cristiani. Chi contravviene, giudeo o cristiano, incorre nella multa di l00
solli. Si creda... Tuttavia i giudei, nella piazza dove sono i macelli dei cristiani, possono fare o far fare separatamente soltanto la mattazione delle bestie per loro uso
e non di altre, sotto la predetta multa. Prima dell’inizio della vendita, essi debbono
aver pagato la tassa, come la pagano i macellai cristiani, per l’uso del suolo della
macellazione, dei taglieri e dei banchi di vendita.
Libro V, Casi straordinari.
Se uno riconosce qualunque oggetto tenuto in pegno presso i Giudei, questi sono tenuti, se interrogati, a dire il nome di chi lo ha dato in pegno a colui che ha
riconosciuto l’oggetto, che altrimenti è ritenuto come rubato ed il giudeo incorre nel
reato di furto.
Art. 80 I termini per gli Ebrei.
Per togliere l’ingiustizia degli ebrei, i termini a qualunque titolo concessi ai
cristiani, sia in giudizio che fuori, stabiliti o da stabilirsi, per qualsiasi titolo, forma e
modo siano vantati, sia per prestito di denaro che per altri diversi motivi, non valgono se non per soli quattro anni. Trascorsi però i quattro anni, non si deve prestare
alcuna fede ai termini, sia in giudizio che fuori, e sono da ritenersi di nessun valore.
Il giudeo o altri a suo nome, che oltrepassa detti termini, è punito a 40 solli di multa.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Art. 70 Oggetti dati in pegno a Giudei.
221
Art. 87 Vino da Ebrei.
Poiché la nostra salvezza e quella della fede cristiana trovano perfetta consistenza nel corpo e nel sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, bisogna guardarsi
affinchè il loro mistero ed il venerabile Sacramento non si trasformino in turpitudine per la malizia degli ebrei. Poiché i giudei sogliono comprare dai cristiani vino
nuovo e mosto, e sogliono pigiare e spremere uve, parte del cui vino va ai cristiani,
può accadere che dal vino toccato o spremuto dagli ebrei, si consacri dolosamente e disonestamente il sangue di Dio; intendendo ovviare a tali fatti, che possono
sembrare un riprovevole cedimento della fede cristiana, ogni cittadino che vende ai
giudei il vino o l’uva dagli stessi pigiata, non può riporne alcunché, né può venderlo
o scambiarlo con nessun cristiano. Deve invece venderlo tutto agli stessi giudei, i
quali debbono tutto comprarlo. Chi contravviene al disposto del presente articolo,
sia il compratore giudeo, sia il venditore cristiano, incorre in una penale di 10 libbre
di multa. Si creda...
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
Traduzione di GIUSEPPE DE MATTIA
222
Il miracolo eucaristico di Veroli
II 26 marzo 1570 nella chiesa collegiata di Sant’Erasmo in Veroli venne esposto il SS.mo Sacramento per le quaranta ore di pubblica adorazione, in
memoria delle altrettante ore nelle quali il corpo di Cristo stette rinchiuso nel
Sepolcro.
L’esposizione differiva da quella che oggi è in uso: ancora non era molto diffuso l’ostensorio, anche se nel Concilio di Colonia (1452) si era parlato
di questo oggetto che doveva avere una teca di vetro sul davanti, circondata da
raggi e sormontata da una croce.
Nella chiesa di S. Erasmo, l’ostia consacrata, secondo il rito tradizionale, venne chiusa in una teca d’argento di forma cilindrica con coperchio a cerniera e questa posta dentro un grande calice ministeriale, anch’esso d’argento,
coperto con la patena. Il tutto, infine, fu avvolto in un elegante drappo di seta i
cui lembi vennero raccolti e legati all’impugnatura del calice.
Don Angelo de Angelis, canonico della medesima chiesa collegiata,
preparò così il calice e, dopo i Vespri di Pasqua, lo espose sull’altare della cappella dedicata a San Gregorio papa, illuminata per l’occasione da numerosi ceri.
Era costume che ogni confraternita della città andasse ad adorare per un’ora il
SS.mo Sacramento esposto. Così gli iscritti alla confraternita della Misericordia
o della Buona morte, che precedevano quelli del Corpus Domini e quelli della
Madonna, vestiti con i loro sacchi neri, si accinsero al loro ufficio e si posero
tutti in ginocchio per pregare, recitare salmi ed orazioni.
Ad un certo momento il velo, il calice e lo scatolino divennero trasparenti come puro cristallo. I presenti videro nel fondo della coppa del calice una
stella molto splendente, la cui luce annientava quella delle candele della cappella e sopra detta stella poggiava l’Ostia consacrata. A breve distanza di tempo
l’Ostia si convertì in un fanciullo vestito di nero, semicoperto da una nuvoletta,
che si sollevava sopra il calice, per poi ancora trasformarsi repentinamente in
Gesù Cristo morente sulla croce.
Alla vista di tali apparizioni, i presenti, tra lacrime e grida, tra meraviglia e timore, iniziarono ad implorare la misericordia di Dio. La notizia in
breve tempo fece il giro della città. Accorsero immediatamente nella chiesa
di S. Erasmo il vescovo e le autorità cittadine. Numerosi altri devoti e curiosi
affollarono l’ingresso della cappella di San Gregorio: tutti volevano entrare,
rutti desideravano vedere ciò che stava accadendo. Molti poterono constatare
di persona cosa avveniva poiché le visioni soprannaturali, come attesteranno
i testimoni chiamati a deporre, durarono per circa mezz’ora. Poi tutto ritornò
come prima.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
8.4
223
Il giorno seguente, 27 marzo, alla medesima ora, la luce della stella apparve di nuovo in fondo al calice e poi scomparve. Tutti videro distintamente
tre Ostie, di uguale grandezza e tangenti reciprocamente, sollevarsi dal calice.
Queste a loro volta scomparvero lasciando il posto a tre fanciulli, dei quali
quello centrale era più grande degli altri due; successivamente rimasero visibili
una sola Ostia ed un Bambino. Avvennero ancora altre trasformazioni, che
durarono mezz’ora circa, come la sera precedente.
Terminate le quaranta ore di adorazione, il SS.mo Sacramento non fu
riposto nel tabernacolo, in quanto le autorità ecclesiastiche decisero di prolungare l’esposizione fino al 6 aprile. Nel frattempo si verificarono diverse guarigioni miracolose di cittadini verolani e di altre persone provenienti da paesi
limitrofi che, venuti a conoscenza del fatto, erano accorsi a Veroli .
Dopo ben dieci giorni di continua adorazione pubblica, il 6 di aprile si
pose fine all’esposizione del Sacramento. A questo punto la Sacra Ostia non fu
consumata ma lasciata dentro la teca, che una volta chiusa accuratamente con
filo d’ottone e sigillata, venne riposta dentro il tabernacolo.
8. Un grande cardinale Giuseppe Trulli
GIUSEPPE D’ONORIO
Il miracolo eucaristico di Veroli
in Testimoni in un prodigio
Veroli, 2005
224
Monumento funerario al cardinale Francisco Quiñones
Roma - chiesa di Santa Croce in Gerusalemme
Palazzo Quiñones
Veroli - Borgo Santa Croce
Palazzo Quiñones - bifora
Veroli - Borgo Santa Croce
Palazzo Quiñones - cortile
Veroli - Borgo Santa Croce
Fontana Quiñones
Veroli - via Passeggiata San Giuseppe
Fontana Quiñones
Lapide commemorativa e lo stemma di famiglia
Il Miracolo Eucaristico
Basilica di S. Erasmo
CAPITOLO IX
Seicento e settecento
Francesca Antonia Leni
235
Veroli in un manoscritto del settecento
240
Vittorio Giovardi
242
A Silvio de’ Cavalieri
248
Giovanni Trulli senior
250
A Carlo Maratti (o Maratta)
256
9.1
Francesca Antonia Leni
M
i innamorai per la prima volta di una ragazza quando avevo
quindici anni, nel periodo in cui è difficile tenere a freno il
proprio cuore e non si riesce a nascondere i primi rossori e
le prime sconvolgenti emozioni. Quando si vive soltanto di
illusioni e di sogni. Di tanti sogni.
Ricordo che nel primo pomeriggio di un giorno d’estate, un temporale, improvviso e violento, mi costrinse a riparare nella chiesa di Santa Salome a Veroli. In attesa che quel finimondo cessasse, pensai di curiosare un pò nell’interno dell’imponente edificio, ma con un certo timore, tanto si era fatto buio.
In quell’oscurità i pilastri della chiesa mi apparvero presto come giganti minacciosi. Le figure affrescate ai lati dell’abside, fantasmi vaganti. La chiesa stessa mi
sembrò un immenso sepolcro. Ebbi un brivido alla schiena. Attraversai rapidamente il presbiterio, deciso ad uscire comunque, ma lo scoppio improvviso
di un fulmine, che si doveva essere scaricato poco lontano dall’edificio, mi inchiodò dinanzi alla cancellata, altissima, che in quel tempo proteggeva l’ultima
cappella della navata destra. In quello stesso istante, al di là della cancellata,
quasi sotto la cupola, mi apparve un volto bianchissimo di donna. Terrorizzato
e con il cuore in gola, imboccai la porta della chiesa e, in un attimo, mi ritrovai
a casa, sconvolto per la terribile avventura, ma finalmente al sicuro.
Il giorno successivo, dopo una notte piena di incubi e di strane visioni,
certo che nessuna nuvola ingombrasse l’orizzonte, volli tornare a Santa Salome.
Nella cappella, inondata di luce, trovai, sì, un volto bianchissimo di
donna, ma non era quello di un fantasma. Era il busto in marmo di una meravigliosa ragazza, di nome Francesca, che, in compagnia di due paffuti angioletti, mi guardava teneramente dalla sommità del suo monumento sepolcrale.
Tranquillizzato e stupito per tanta bellezza, mi avvicinai a lei il più
possibile e notai che quella incantevole fanciulla poteva avere all’incirca la mia
stessa età. Aveva un seno ancora acerbo, due mani stupende, un collo di cigno
ed un viso purissimo e regolare, incorniciato da folti capelli, divisi sulla fronte
e raccolti a boccoli sulla nuca. Sembrava essere stato copiato da una statua
greca del quinto secolo avanti Cristo. In quell’ovale dalla forma ineccepibile,
spiccavano due grandi occhi, velati appena da una sottile malinconia, e due
labbra morbidissime, dal disegno perfetto. Ne rimasi affascinato.
Immaginai per un istante di accarezzare i suoi capelli. Poi chiusi gli
occhi e la strinsi a lungo sul mio cuore. Le lasciai un bacio ed uscii correndo,
un pò turbato, ma incredibilmente felice.
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Lontani ricordi
235
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Francesca
236
Francesca Leni era nata a Veroli l’11 aprile 1640, giorno di Pasqua,
dal nobile romano Francesco e da Laudazia De Minaldis, di Montegallo nel
Piceno. In quel tempo a Veroli doveva esserci una vera e propria colonia di Piceni, perché è facile trovare in questa città documenti e testimonianze relativi
a famiglie, come i Sabatini, i Testa, i Paolini, i Minaldi, spesso imparentate fra
loro ed originarie, appunto, di detta regione.
Francesca, che non aveva avuto la fortuna di conoscere suo padre, perché morì prima che lei nascesse, trovò nel nobile Tommaso Paolini colui che fu
capace di sostituirsi al padre, circondandola di tanto affetto e di tante premure.
Chissà quante volte avrà narrato alla «propria» piccola le virtù dei suoi antenati, molti dei quali erano stati importanti uomini di chiesa. E nell’elenco non
avrà certamente dimenticato il cardinale Giovan Battista Leni, arciprete della
basilica di S. Giovanni in Laterano, uomo di «specchiati costumi, incomparabile onestà e onoratezza», che lasciò tutti i suoi averi per la costruzione della
facciata di S. Carlo ai Catinari a Roma e per l’abbellimento di questa stessa
chiesa.
E Francesca crebbe onesta, educata al senso del dovere, della religiosità, della carità, procedendo sempre sulla via del bene, con un comportamento
esemplare.
Ma questo delicato fiore di serra appassirà presto. Inaridirà e si dissolverà nel breve arco di quindici anni. Inesorabilmente. Non serviranno, per
tenerla in vita, né gli affannosi tentativi dei dottori, né le preghiere disperate
della madre. L’11 marzo 1655 andrà a confessarla (ma per quali peccati?) il
Rev.mo Can. Vespasiano Giulio; il giorno successivo riceverà la Comunione e
il 15 l’olio degli infermi.
Se ne andò il 28 marzo, giorno di Pasqua, ut prò facibus Christi radios pro ministris angelos haberet... ut virgo mundo coelo foecundaret («affinchè
avesse come fiaccole i raggi di Cristo, come servi gli angeli... affinchè, vergine,
fosse feconda di purezza celeste»). Alla mamma, distrutta dal dolore, non rimase che innalzare alla memoria della figlia un monumento che esaltasse per
l’eternità la grande bellezza e le molteplici virtù della sua Francesca.
Il monumento sepolcrale
II monumento fu eretto in marmo nella cappella di famiglia, in Santa
Salome, addossandolo alla parete di sinistra. In alto, circondato da un ovale
che riecheggia ed amplifica quello del volto, è il busto, nobilissimo ed aristocratico, distaccato ed assorto, di Francesca, fiancheggiato da due plastici puttini che sembrano sostenere a fatica le abbondanti pieghe di un panneggio con-
tenente l’iscrizione dedicatoria. In questa Laudazia De Minaldis esprime tutto
il suo dolore per la scomparsa della figliola omni corporis animique dote omnes
inter mulieres ut in sidera sol («adorna delle più belle doti fisiche e spirituali,
sopra tutte le donne, come il sole tra le stelle»). Poi, dopo aver fatto notare la
coincidenza della morte di Francesca con la resurrezione di Cristo, per cui la
sua anima esulta nella gloria, conclude: «Uti matrem filiae dolor exanimavit
hinc monumentum hoc amoris et doloris est monumentum» («Come il dolore
per la perdita della figlia uccise la madre, così questo monumento sepolcrale è
monumento di amore e di dolore»).
Fra il sarcofago, che contiene i poveri resti di Francesca, e l’iscrizione
dedicatoria, è una fenice tra le fiamme, il favoloso uccello d’Arabia che, dopo
aver vissuto a lungo, bruciava nel suo stesso nido per poi tornare a vivere di
nuovo. Per i cristiani è evidente simbolo d’immortalità e resurrezione.
Sotto il sarcofago, ai lati dello stemma della famiglia Leni, sono scolpite due figure allegoriche alludenti alle virtù di Francesca: la pietà, a sinistra,
con una melagrana nella mano (la pietas latina, intesa come affetto e devozione dei figli verso i genitori e verso Dio), e la giustizia, a destra, con una spada
accanto, intesa come modo di vivere improntato alla rettitudine ed alla bontà,
secondo i precetti della etica religiosa.
Il monumento, che si sviluppa verticalmente occupando l’intera parete, si anima di suggestivi giuochi chiaroscurali al tramonto, quando la luce
entra più copiosa dalla lunetta di fondo della cappella. Allora è facile cogliere
per intero le qualità non comuni dello scultore, sensibile certamente agli echi
del mondo classico, ma dotato di una personalità ancora tutta da scoprire.
In qualunque dizionario di mitologia è facile trovare il patetico racconto del rapimento di Persefone o Kore («la fanciulla»), la giovane figlia di
Demetra, dea dell’agricoltura, delle messi e della fecondità della terra. Mentre
Kore si divertiva a raccogliere fiori e ad intrecciare corone nei prati di Enna, si
aprì improvvisamente la terra ed apparve Ade, il re dell’oltretomba, su un carro
trainato da cavalli neri. Il terribile dio afferrò Kore, la caricò bruscamente sul
cocchio e sparì dentro una voragine.
Demetra, venuta a conoscenza dell’accaduto, cercò disperatamente la
figlia da un luogo all’altro della terra, fin quando, giunta la sera, accese due pini
sulla sommità dell’Etna e, facendosi luce nelle tenebre, continuò le ricerche
per tutta la notte. Per nove giorni e notti consecutive e senza riposarsi, gridò
dappertutto il nome della figlia, mentre la terra, trascurata da Demetra, cominciava a diventare sterile e a non produrre più i suoi frutti.
Zeus, preoccupato per lo sconvolgimento dell’ordine naturale ed im-
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Kore e Demetra
237
pietosito dal dolore di Demetra, acconsentì alla restituzione di Kore, a condizione che la fanciulla, durante il tempo che era rimasta nell’oltretomba, non
avesse assaggiato alcun cibo. Ma Kore aveva gustato sei chicchi di una melagrana dei Campi Elisi. Per di più era diventata la sposa di Ade. Fu necessario
allora venire ad un compromesso: la fanciulla avrebbe passato sei mesi dell’anno, dalla primavera all’autunno, sulla terra, con la madre, e sei li avrebbe trascorsi con il marito nel regno dei morti.
Da quel momento, con il ritorno sulla terra di Kore e con la gioia della
madre che ritrova la figlia si ripete ogni anno l’arrivo festoso della primavera,
con i suoi fiori ed i suoi frutti; mentre, all’avvicinarsi dell’autunno, Kore ridiscende nell’Ade per tornare ad essere Persefone, la regina dei morti.
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Kore e Francesca
238
Kore e Francesca sono due fanciulle innocenti, tenere e delicate, che
si aprono alla vita, con tanti sogni e tante speranze, ma tutte e due vengono
sottratte, improvvisamente e brutalmente, all’affetto delle madri e ai loro dolci
sogni. Anche il motivo della melagrana, presente nel racconto mitologico e
scolpito nella statua della pietà del monumento sepolcrale di Santa Salome,
rafforza l’identità delle due figure.
Ma l’immagine di Kore mi sfugge. Si confonde con i fiori dei prati di
Enna. Si perde tra le rocce della campagna siciliana. Si annulla nel racconto
stesso della mitologia.
Quella di Francesca invece è vera ed esiste realmente. È lì, nella cappella di famiglia, in Santa Salome, con il suo aspetto nobile ed aristocratico,
con il suo seno acerbo, con il suo collo di cigno, con il suo viso pulito, con i
suoi grandi occhi tristi, con le sue labbra morbide.
Ogni anno però, a primavera, e fino all’inizio dell’autunno, anche il
corpo di Francesca lascia il suo sepolcro in Santa Salome e scivola via, leggero,
verso la campagna verolana, per intrecciare danze di gioia tra il verde dei prati
e il profumo dei fiori, nell’azzurro infinito del cielo.
Addio, Francesca, mio primo, dolcissimo, indimenticabile Amore!
L’iscrizione della tomba
D.O.M. / FRANCISCA ANTONIA / FRANCISCII LENI PATRITII ROMANI
/ UNICA ET POSTHUMA FILIA / OMNI / CORPORIS ANIMIQUE DOTE
OMNES INTER MULIERES / UT INTER SIDERA SOL / QUARTO IDUS
APRILIS MDCXL RESURGENTE XPO NATA / SUB AETATIS MERIDIEM
/ CUM PURPURATI PATERNI ET MITRATI MATERNI GENERIS PERPE-
TUA ECLIPSI / UT TOTUM TERRARUM ORBEM SPECTATOREM / QUINTO CALENDAS APRILIS MDCLV RESURGENTE XPO / UT PRO FACIBUS
XPI RADIOS PRO MINISTRIS ANGELOS HABERET / OCCIDIT ERRAVI
CUM XPO RESURREXIT / UT VIRGO MUNDO COELO FOECUNDARET
/ SPIRITUS ERGO EXULTAVIT IN GLORIA PROUT CORPUS REQUIESCIT IN HOC TUMULO / QUEM SACELLIS ERECTIS LAUDATIAE DE
MINALDIS MATRIS / A MONTE GALLO IN PICENO ORIUNDAE AC VERULANAE CIVIS AMOR EREXIT / UTI MATREM FILIAE DOLOR EXANIMAVIT / HINC / MONUMENTUM HOC AMORIS ET DOLORIS EST
MONUMENTUM
GIUSEPPE TRULLI
Francesca Antonia Leni: il primo amore
in Lazio ieri e oggi, ottobre 1978
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
(A Dio Ottimo Massimo. Francesca Antonia, figlia unica di Francesco Leni, patrizio romano, nata dopo la morte del padre, (adorna) delle più belle doti fisiche
e spirituali sopra tutte le donne, come il sole fra le stelle, nata l’11 aprile 1640,
giorno della resurrezione di Cristo; prima di giungere all’età matura, tolta per
sempre alla vista dello zio paterno cardinale e di quello materno vescovo, il 28
marzo 1655, giorno della resurrezione di Cristo, affinchè tutta la terra la ammirasse, affinchè avesse come fiaccole i raggi di Cristo e come servi gli angeli, morì,
ho sbagliato, risorse con Cristo affinchè, vergine, fosse feconda di purezza celeste.
L’anima sua, quindi, esulta nelle gloria, mentre il corpo riposa in questo sepolcro
che le innalzò, dopo aver costruito la cappella, l’amore di sua madre Laudazia
De Minaldis, oriunda di Monte Gallo nel Piceno e cittadina verolana. Come il
dolore per la perdita della figlia uccise la madre (1664), così questo monumento
sepolcrale è monumento di amore e di dolore).
239
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
9.2
240
Veroli in un manoscritto del settecento
Un testo manoscritto, conservato nell’archivio della Casa Generalizia
degli Agostiniani a Roma, descrive con una certa ampiezza di particolari la
città di Veroli intorno alla metà del 1700. Il testo è opera di un Agostiniano genovese, Tommaso Bonasoli, che scelse di far parte della comunità agostiniana
di Anagni, ma che fu poi Superiore Provinciale della Provincia Romana degli
Agostiniani e che aveva quindi una conoscenza diretta della situazione avendo
visitato chissà quante volte il convento di Veroli per incontrarvi i religiosi che
facevano parte della sua Provincia religiosa.
Ecco la trascrizione del testo agostiniano: «Convento di Veroli — Santissima Annunziata. Veroli, detto in latino Verulae e anche Verulum, è Città
antichissima, ed è distante da Ripi Migl. 5 1/2 di strada sassosa. Di questa città
non si sa l’origine, e apparteneva anticamente agli Ernici. Vi si contano presentemente 10 o 11000 abitanti. Contiene sette Parrocchie, e sono: la Cattedrale intitolata S. Andrea; S. Erasmo Collegiata con Abbate mitrato; S. Maria de
Franconi; S. Paolo; S. Leucio; S. Angelo; S. Croce. La Cattedrale fu riedificata
da fondamenti da Riccardo Annibaldense della Molaria creato vescovo di Veroli il 27 Maggio 1675, e morto in Marzo 1689. Vicino al Domo vi è la Chiesa di
S. Maria Salome principale Protettrice della Città, quale fu consacrata dal Vescovo del nostro Ordine F. Clemente di Bartolo-meo Romano eletto Vescovo il
3 dicembre 1427, qual dignità fu dal medesimo spontaneamente rinunziata nel
1457. Il detto Vescovo unì la predetta Chiesa di S. Maria Salome alla Cattedrale, dichiarandola Concattedrale; benché alcuni vogliono che fosse dichiarata
Concattedrale e assegnata ai Canonici del Domo nel 1409. Di detta S. Maria
Salome vi è tradizione che venuta in Italia con S. Marta, S. Maria Maddalena
ecc, si ritirasse in Veroli e quivi morisse dopo pochi giorni; era moglie di Zebedeo. Circa poi la Chiesa Parrocchiale di S. Erasmo, si dice nello Statuto di
Veroli che S. Benedetto venuto a Veroli edificasse la detta Chiesa nel luogo ove
ora pure dicesi l’Arenaria; ma non dicesi che vi fosse il Monastero, come vi era
a S. Cesario che fu poi in appresso abbandonato. Il Primo Vescovo di questa
Città secondo il citato Statuto fu S. Mauro Verolano ordinato da S. Pietro, il
quale fu poi Vescovo di Bisceglie in Puglia, e morì martire nel 118. Per altro,
secondo l’Ughelli, il primo suo Vescovo fu Martino circa il 743. Sino al 1715,
vi furono, sempre secondo il detto Ughelli, Vescovi 55, l’ultimo dei quali fu
Lorenzo Tartagni di Forlì creato il 1 Aprile 1715 e tra questi vi fu uno dei nostri
nominato di sopra.
Dentro la Città vi siamo noi Agostiniani, di cui diremo appresso. Inoltre vi è un Monastero di Monache Benedettine con Chiesa intitolata a S. Maria
de Franconi, le quali furono introdotte da Ortensio Battisti Frosinonese Vesco-
PIER LUIGI SODANI
Gli Agostiniani e la loro presenza a Veroli
in Potenza e carità di Dio, n°4, 1984
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
vo Verolano circa il 1580. Fuori poi di Città pochi passi distante dalle Mura vi
è un Convento de Minori Osservanti con Chiesa dedicata a S. Martino, quivi
introdotti per mezzo di S. Giovanni Capistrano Vicario Generale dell’Ordine
dal Vescovo nostro Agostiniano nel 1449. Prima vi stavano in detto Convento
le Monache Benedettine venute sin dal 1117, le quali ridotte a poche furono
levate in detto anno 1449. Nel 1731 tentarono i Verolani d’introdurvi anche
i Cappuccini, assegnando ad essi una Chiesa Offiziata da un Prete, e vi fu in
Roma a tale effetto una gran lite, come si può vedere nell’Archivio della nostra
Religione nel Lib. A2.20. pag. 25. Dentro la Città vi è pure un buon Seminario, con dentro una buona Libraria eretta da Mons. Giovardi Verolano circa
il 1771, di cui fu Prefetto per varii anni il nostro Lorenzo Papalardi Figlio di
S. Agostino di Napoli quivi morto nel fine di dicembre 1778. Le famiglie principali di Veroli sono: il March. Bisleti, il Marchese Campanari, il Cocchi, il
Trulli, il Mellonj, il Conte Paolini, il Pelegrini, il Franchi, lo Spana, il Noce, il
Capobassi, il Giovardi. Sotto la Diocesi di Veroli vi sono: Frosinone, Torrice,
Ripi, Pofi, l’Arnara, Castro, Falvaterra, Ceprano, Monte S. Giovanni, Strangolagalli, li Colli, e Bauco. In detta Diocesi trovasi pure Casamari, Monastero
antichissimo de Cisterciensi, mentre si nomina nel 1149 da S. Bernardo, che
scriveva a quei monaci. Secondo l’Ughelli era questo luogo dedicato a Marte, e
il detto Monastero vi fu edificato nel 1005. Da varii anni in qua vi stanno quei
della Trappa. Circa la fondazione del nostro Convento non si sa cosa alcuna.
È certo però che vi eravamo prima del 1274 e stavamo mezzo miglio fuori di
Porta Romana in una piccola eminenza sopra la Strada pubblica nel sito che
anche presentemente chiamasi S. Agostino Vecchio; dove il presente Sig. Vicario Generale Campanari vi fabbricò poco fa un picciol Palazzo, non rimanendo di detto Convento che poche vestigia. Dicesi che fossimo trasferiti in Città
circa il 1450, dopo la morte di Martino V, in tempo che era Vescovo il predetto
Fr. Clemente Agostiniano e che nel luogo ove ora stiamo vi fosse lo Spedale.
La nostra Chiesa fu rimodernata nel 1737. Ha un bell’Altare Maggiore
di Marmo e sei Cappelle tutte Padronali. Nel 1744 un certo Guglielmo Zonnini
v’introdusse un’ottimo ordine sì nell’osservanza come nell’economico.
Anche il P. Bac. Gian Battista Benedetti Lucchese e Figlio del Convento rimodernò ed accrebbe la Fabbrica del Convento e vi accrebbe anche
l’entrata, quale morì in Aprile 1780.
Nel 1652 aveva d’entrata in tutto Scudi 425, nel 1717 aveva Scudi 200.
Al presente poi ha d’entrata in fondi Scudi 150, ma poi con la cerca è ben provveduto di ogni cosa».
241
9.3
Vittorio Giovardi
L’atto di battesimo
Fino alla seconda metà del XV secolo la famiglia Giovardi fece parte
della parrocchia di S. Andrea. Quando, nel 1490, Vittorio I acquistò alcune
case nel «Rione delle Piagge», i Giovardi vennero a far parte della parrocchia
di S. Paolo. Qui nacque il nostro Vittorio (IV) l’11 agosto 1699. Fu battezzato
il 12 dello stesso mese dall’Abate di S. Paolo Don Giuseppe Diamanti, il quale
gli impose anche il nome di Ermadoro. Giacomo e Francesca Manchi, della
parrocchia di S. Andrea, gli fecero da padrini. Ecco l’atto di battesimo: «Die
mercurij 12 aug. 1699. Ego Joseph Diamantus Abbas baptizavi infantem externo die natum ex D.D. Agata et Francisco coniugibus de Jovardis de Verulis, ex
parochia S.ti Pauli, eidem infanti impositum fuit nomen Ermadorus Victorius.
Patr. fuerunt D.D. Jacobus Manchus et Francisca filia q.d. Juliani Frase. de Verulis, ex parochia S.ti Andreae». (Mercoledì 12 agosto 1699, io Abate Giuseppe
Diamanti ho battezzato un bambino nato ieri dai Signori Agata e Francesco
coniugi Giovardi di Veroli, della parrocchia di S. Paolo, e allo stesso bambino è
stato dato il nome di Ermadoro Vittorio. Padrini sono stati i Signori Giacomo
Manchi e Francesca, figlia del fu Giuliano Frasca di Veroli, della parrocchia di
S. Andrea).
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Decano delle Segnature di Grazia e di Giustizia
242
Dopo aver trascorso la sua fanciullezza nell’austero ambiente familiare, Vittorio Giovardi venne inviato a Roma. Forse il padre avrebbe voluto fare
di lui un uomo di lettere, ma la madre, che era sicura di poter contare sul potente zio Mons. Silvio de’ Cavalieri, preferì avviarlo alla carriera ecclesiastica.
Però lo zio morì nel 1717 e non potè essere di grande aiuto al giovane Vittorio,
il quale riuscì ad imporsi all’attenzione dei prelati dell’ambiente romano per le
sue non comuni qualità intellettuali e morali.
Dottore in «utroque iure»; Protonotario Apostolico; Uditore del Sacro
Consiglio; Votante di Segnatura. Queste le tappe principali di una splendida
carriera che doveva culminare con la nomina a «Decanus Utriusque Signaturae», titolo che qualifica Mons. Giovardi in un dipinto ad olio conservato nella
Biblioteca da lui fondata.
Ma che significa «Decano di entrambe le Segnature»? Che nella Segnatura Apostolica di Grazia e di Giustizia, cioè nel Supremo Tribunale della
Chiesa, il posto occupato dal Giovardi era quello di Decano, cioè Primo fra
quei Prelati (i Votanti) che avevano potere deliberativo. Questa carica era ritenuta tanto importante che «II Decano de’ Votanti da diversi Papi fu elevato
alla dignità cardinalizia» (GAETANO MORONI, Dizionario di erudizione storicoecclesiastico, 1859).
La Passione per l’antico
L’arcade, ovvero Zetindo Elaita
«Nella prima metà del settecento troviamo il movimento dell’Arcadia,
sorto per reagire al formalismo vacuo e retorico del marinismo, in nome della
natura, della semplicità, della spontaneità. I suoi fondatori scelsero come insegna una siringa a sette canne... chiamarono i soci pastori e pastorelle e Bosco
Parrasio il luogo delle riunioni...».
Anche Giovardi fece parte di questo movimento e, come pastore, ebbe
il suo nome: Zetindo Elaita. Prima di lui, lo zio Silvio de’ Cavalieri aveva fatto
parte dell’Arcadia con l’appellativo di Elmete Alisio e Francesco Giovardi, suo
padre, era stato a Veroli principe di un’altra Accademia, quella degli Elisi. Oltre
agli Elisi di Veroli, gli Immaturi di Pergola, gli Animosi di Recanati e gli Insensati di Perugia si onorarono di avere fra i propri soci il nostro Vittorio.
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Il 22 maggio 1724 Mons. Giovardi acquistava a Roma, presso la libreria di Gaetano Piancastelli, un codice del XII secolo dal titolo: «Acta Passionis
et translationis Sanctorum Martjrum Mercurii ac XII Fratrum». Sei anni dopo
ne pubblicava il testo e il commento in latino, dando una eloquente prova della
sua vasta erudizione storico-letteraria.
Non è nostra intenzione scrivere in questa sede sul contenuto del codice; vogliamo invece sottolineare il rispetto e l’amore per le antichità sacre,
l’ansia e il piacere della scoperta, così come traspaiono dalle parole dello stesso
Giovardi. Dalla «Praefatio generalis» abbiamo tradotto i seguenti brani:
«... facendo passare in secondo ordine ogni estranea occupazione e lo studio di altre discipline, mi proposi di dedicarmi alla ricerca di tali documenti;
quand’ecco che, al di là di ogni speranza, un codice pergamenaceo, scritto in
caratteri longobardici... colpisce la mia vista... Ne feci subito acquisto per poi
studiarlo con maggiore attenzione... cercai senza indugio di interpretarlo..., di
aggiungere brevi note, di arricchirlo di avvertenze, per poi pubblicare per intero e chiariti in ogni loro parte questi preziosi monumenti della veneranda
antichità, più preziosi, senza dubbio, dell’oro e delle gemme».
243
Come scrittore collaborò attivamente alla serie di volumi riguardanti
le «Notizie historiche degli Arcadi morti», occupandosi, in particolare, della figura dello zio. Nel 1727 pubblicò alcune «Notizie del nuovo teatro degli Arcadi
aperto in Roma l’anno 1726». Vale la pena ricordare che quando questo teatro
fu costruito sul Gianicolo, il nome arcadico di Vittorio Giovardi fu inciso, forse
assieme a quello di altri personaggi, su due lastre di marmo, una delle quali
fu posta nelle fondamenta del teatro stesso, l’altra fu collocata nella sede del
Bosco Parrasio.
Nel 1728 Giovanni Carlo Crocchiante, che del Giovardi aveva avuto
modo di apprezzare i «soavi costumi» e la «vasta erudizione», nel pubblicare alcuni «Sonetti d’Arcadi», penserà di dedicare il suo volume al «Gentilissimo Signor Abate Vettorio Giovardi, che della nostra Arcadia è per ogni conto
sommamente benemerito».
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Corilla Olimpica
244
La bellissima Donna Maria Maddalena Morelli Fernandez era entrata
a far parte dell’Arcadia col nome di Corilla Olimpica e più volte aveva dato prova delle sue qualità poetiche improvvisando con estrema facilità su argomenti
di ogni genere: storico, letterario, filosofico, ottenendo sempre entusiastiche
approvazioni.
Ma la grande ambizione di Corilla era di cingere l’alloro in Campidoglio, proprio come era toccato al Petrarca qualche secolo prima. Protetta da
Maria Ludovica, Granduchessa di Toscana, da Caterina II di Russia, dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, dai Cardinali Delci e Torrigiani, dal Principe
Luigi di Castiglione Gonzaga, dall’Abate Pizzi, Custode generale dell’Arcadia,
la Morelli Fernandez mobilitò tutte le sue amicizie, pur di raggiungere il suo
scopo.
Appoggi tanto autorevoli non servirono però ad evitarle di sostenere
un severo esame «di idoneità», e Corilla fu interrogata, per tre giorni, su dodici
argomenti: Storia Sacra, Religione rivelata, Filosofia Morale, Fisica, Metafisica,
Poesia eroica, Legislazione, Eloquenza, Mitologia, Armonia, Belle Arti, Poesia
pastorale. Dodici furono gli esaminatori: Mons. Giovardi, Mons. Assemani,
l’Abate Petroni, Mons. Saliceti, il Principe Luigi Gonzaga, l’Abate Mazzi, l’Abate
Pizzi, l’avvocato Nardini, l’avvocato Cedri, l’avvocato Petrini, l’Abate Testa, l’avvocato Devoti.
L’esame fu un trionfo: Corilla sbalordì gli esaminatori e, tra questi,
Mons. Giovardi che, oltre alla solida preparazione della candidata, sembra che
ne ammirasse anche la smagliante bellezza.
Anche se Mons. Giovardi visse quasi sempre a Roma, immerso continuamente nei molteplici, delicatissimi incarichi che gli derivavano dalla sua
posizione di prelato e di giurista, non dimenticò mai Veroli.
Al di sopra di ogni favoritismo, curò sempre i supremi interessi della
città, intervenendo in ogni circostanza con il suo prestigio e con la sua autorità.
Ma le attenzioni di Mons. Giovardi furono più spesso rivolte, come era naturale, alle chiese di Veroli. Vediamo che cosa fece per esse.
Alla chiesa di S. Paolo, di cui era Beneficiato, donò molte, ricchissime
casule; alla chiesa di Santa Maria Salome, per la quale aveva fatto ristampare
a proprie spese la Messa, regalò altre casule ed un prezioso calice d’argento
dorato. Non dimentichiamo poi che si occupò personalmente della fusione in
argento dello splendido busto di S. Andrea, ora nel Tesoro della Cattedrale, e
che con il suo diretto interessamento dette nuova vita alla «Confraternita della
Morte, Orazione e Carità».
Da Mons. Giovardi fu dettata l’iscrizione che riassume la storia della
nascita della chiesina dell’Olivello:
A.D. MDCCXXIII / VIGILI / LAURENTII TARTAGNI / VERULARUM EPI
/ STUDIO ET ZELO / PIO / VERULANENSIUM CIVIUM / LABORE ET
IMPENSIS / INACCESSA SAXOR CONGERIES / PER SUBTERRANEOS
IGNES EXCISA / STRATUM ITER / APERTA AREA / TEMPLUM EXTRUCTUM / ADDITUM SACRARIUM / POPULOR PIETAS FIRMATA / AUCTA
/ IN V. MREM RELIGIO.
(L’anno 1723, con l’instancabile amore e zelo di Lorenzo Tartagni Vescovo di Veroli, con il pio lavoro e il denaro dei cittadini verolani, tagliata un’enorme
massa di rupi inaccessibili con l’aiuto di mine, fatta la strada e spianata l’area
antistante, fu costruita la chiesa aggiungendovi una cappella. Fu così rafforzata
la pietà del popolo e accresciuta la devozione verso la Vergine Madre).
Per la chiesa di S. Martino, dove si trovano sepolti quasi tutti i Giovardi, dettò l’iscrizione altrove riportata.
Grazie ancora alla sua generosità ed al culto, vivissimo in Mons. Giovardi, delle patrie memorie, rivivono oggi nella chiesa di S. Erasmo due avvenimenti importanti svoltisi, appunto, nella insigne basilica: la consacrazione di
un cardinale e l’incontro dei messi di Federico Barbarossa con il Papa Alessandro III.
Il primo fatto è inciso su una lastra di marmo di cui riportiamo l’iscrizione:
ALEXANDER. III. P.M. / EX APULIA. REDUX / AEDIBUS. HUIUS. BASILICAE. SUCCESSIT / LEONEM HYPODIACONUM. ABB. CASAURIENSEM / IN EADEM. BASILICA / INTER S.R.E. DIACONOS CARDINALES.
COOPTAVIT / AN. MCLXX. SABBATO. ANTE. DOMINICUM DIEM PAS-
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Suo interessamento per la patria verolana
245
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
246
SIONIS / REI GESTAE. MEMORIAM / PRIVATIS TABULIS, SERVATAM /
VICTORIUS GIOVARDUS VERULANUS. UTRIUSQ. SIGNAT. DECAN. /
PUBLICO MONUMENTO INSCRIBI S.P.F. / ANNO MDCCLXXXV.
(Alessandro III, di ritorno dalla Puglia, passò alla residenza di questa
basilica, nella quale annoverò tra i cardinali diaconi di Santa Romana Chiesa il suddiacono Leone, Abate di Casauria, il sabato prima della domenica di
Passione dell’anno 1170. Il ricordo del fatto, conservato in documenti privati, il
verolano Vittorio Giovardi, Decano dell’una e dell’altra Segnatura, fece incidere a
sue spese su questa lapide, l’anno 1785).
Il secondo avvenimento è ricordato da un’enorme tela che rappresenta
il Barbarossa umilmente prostrato ai piedi di Alessandro III e implorante la
pace. In basso una iscrizione rievoca lo storico incontro:
FRIDERICI I. IMPERATORIS CUM S. ROM. ECCLESIA RECONCILIATIONIS ANNO MCLXXVII VENETIIS ABSOLUTAE MONUMENTUM
COLORIBUS EOTUNC IN ABSIDE ANTIQUISSIMI ORATORII SUB ARA
MAXIMA EXPRESSUM UBI SCILICET ANTE ANNOS SEPTEM ALEXANDER PAPA III. EXHIBITA AB EPISCOPO BAMBERGENSI CAESARIS
ABLEGATO FOEDERIS INEUNDI CAPITA LANGOBARDORUM LEGATIS EPISCOPIS PLURIMIS XV. CARDINALIBUS ITALIAEQUE DINASTIS
FERE OMNIBUS PRAESENTIBUS EXPENDIT PROBAVITQUE CUM NUPERA HUIUS TEMPLI MOLITIONE PERIISSET NI ILLMUS. ET RMUS. D.
VICTORIUS GIOVARDI IN UTRAQUE SIGNATURA SUFFRAGANTIUM
DECANUS SACRAE ANTIQUITATIS PATRIAEQUE AMANTISSIMUS EX
ARCHETIIPI SCHEMATE REDIVIVUM HAC IN TABULA EXTARE VOVISSET. ANNO REPARATAE SALUTIS MDCCLXVII1.
(II ricordo della riconciliazione dell’Imperatore Federico I con la Santa
Romana Chiesa, avvenuta a Venezia nel 1177, precedentemente dipinta nell’abside dell’antichissimo oratorio sottostante l’altare maggiore, dove cioè sette anni
prima Alessandro III ricevette e accolse favorevolmente l’ambasceria dei Lombardi presentata dal Vescovo di Bamberga, Legato dell’Imperatore a trattare i
preliminari (della pace), presenti i Vescovi Legati, quindici Cardinali e quasi tutti
i Signori d’Italia, sarebbe andato perduto con la demolizione di questo tempio se
l’Ili.mo e Rev.mo Signore Vittorio Giovardi, Decano di entrambe le Segnature,
amantissimo delle Antichità Sacre e della Patria, non avesse provveduto a farlo rivivere in questa tela secondo lo schema dell’originale. L’anno della salvezza,
1767).
1
La data 1767 va intesa 1747.
«Nel rione Monti alla Suburra, presso il bel convento dei Minimi, nel
1730 fu fondato un monastero di Paolotte da Suor Maria Diomira, e con architettura di Francesco Fiori la contigua chiesa dei SS. Gioacchino e Francesco di
Paola, come si ha nell’Itinerario del Vasi. In questa chiesa nel 1786 fu sepolto
nella cappella del Crocifisso da lui fondata, Monsignor Vittorio Giovardi di
Veroli, decano de’ votanti di Segnatura e deputato vigilantissimo delle religiose» (GAETANO MORONI, Dizionario di erudizione..., cit.).
Dunque Mons. Giovardi volle essere sepolto nella chiesa annessa al
convento di quelle povere monache di clausura che egli stesso, in circostanze
penosissime, aveva più volte aiutato e beneficato.
Ma fin dal 1777 la sua tomba era pronta. L’aveva fatta scavare sotto il
pavimento della cappella che lui stesso, a proprie spese, aveva eretto, e aveva
voluto che un Crocifisso fosse posto sull’altare affinchè lo vegliasse per l’eternità. A sinistra della cappella, una modesta lapide lo avrebbe ricordato ai posteri
con la seguente iscrizione:
IESU CHRISTO HUMANI GENERIS REPARATORI / UBI S.LEO PP. IV
DRAGONE PEREMPTO / CIVIUM INCOLUMITATI CONSULUIT / VICTORIUS GIOVARDI UTRIUSQ. SIGNATURAE DECANUS / ARAM MARMOREAM AERE SUO DEDICAVIT / CINERIBUSQ. SUIS LOCUM CONSTITUIT. / ANNO REPARATAE SALUTIS MDCCLXXVII
(Vittorio Giovardi, Decano di entrambe le Segnature, nel luogo dove il
Papa S. Leone IV salvò i cittadini uccidendo il drago, eresse a proprie spese l’altare marmoreo in onore di Gesù Cristo Redentore del genere umano e costruì la
propria tomba nell’anno della salvezza 1777) XIV.
Il 20 febbraio 1780 l’Arcivescovo di Atene Giuseppe M. Contesini, «solemni
ritu», consacrava la chiesa di S. Gioacchino.
Ancora sei anni e poi, il 27 aprile 1786, la morte. Il rito funebre gli fu
officiato da Gallazio, Vescovo di Cirene, presenti i maggiori esponenti della
Segnatura Apostolica. Qualche tempo dopo, uno scalpellino dalla mano molto
incerta completava l’iscrizione della lapide, segnando la data della morte: OBIIT A.D. MDCCLXXXVI V. KAL. MAII.
GIUSEPPE TRULLI
La Biblioteca Giovardiana di Veroli nel secondo centenario
della sua fondazione, Tip. U. Marrocchi, Terni, 1973
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
S. Gioacchino ai Monti: l’ultima dimora
247
9.4
A Silvio de’ Cavalieri
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Roma, chiesa di Sant’Eustachio - Monumento funerario
248
D.O.M.
SILVIO DE’ CAVALERIIS, PATRITIO VERULANO ET AB URBINI CIVITATE
PRO COLLATIS IN EAM STUDIIS HONORE NOBILITATIS DONATO
CAMERAE APOSTOLICAE COMMISSARIO GENERALI
VATICANAE BASILICAE CANONICO
PRAELATO DOMESTICO ET SIGNATURAE GRATIAE VOTANTI
SUPREMAE URBIS ET ORBIS INQUISITIONIS CONSULTORI
ATHAENARUM ARCHIEPISCOPO AC PONTIFICII SOLII ASSISTENTI
SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE SUPRA DECENNIUM
SOLERTISSIMO AC MERITISSIMO SECRETARIO
INNOCENTIO XII ET CLEMENTI XI
SUMMIS PONTIFICIBUS BENEFACTORIBUS
OB EIUS
DOCTRINAM PROBITATEM FIDEM
AC IN REBUS PERAGENDIS SINGULAREM PRUDENTIAM APPRIME CHARO
IN ANGUSTO HOC COLLEGII PALATII APOSTOLICI PATRONORUM SACELLO
INTER QUOS OLIM ASCITUS NEMINI FUERAT SECUNDUS
LAPIDEM ISTUM
PIETATIS ET BENEVOLENTIAE DURATURUM APUD POSTEROS MONUMENTUM
AGATHA PETROZZIA GIOVARDI NEPOS ET HAERES
AC AUGUSTINUS GALAMINUS RECINETENSIS EX TABULIS EXEQUTOR
EIUSDEMQUE COLLEGII CONSORS
AVUNCULO ET MAGISTRO DILECTISSIMO POSUERE
UT UNDE NOMINIS ET FORTUNARUM DUXIT PRIMORDIA
COLLEGARUM IBI MEMORIAE PERENNITER VIVAT.
OBIIT TERTIO IDUS IANUARII MDCCXVII AETATIS ANNORUM LXXV
AC SEPULTUS EST IN ECCLESIA COLLEGII EIUSDEM SACRAE CONGREGATIONIS
NON PATIENS ILLINC UBI VIVENS TOTUS FUERAT POST MORTEM DIVELLI.
A Dio Ottimo Massimo. A Silvio de’ Cavalieri, patrizio verolano e onorato del titolo di nobile della città di Urbino per le attività svolte in favore di essa,
Commissario Generale della Camera Apostolica, Canonico della Basilica Vaticana, Prelato Domestico, Votante della Segnatura di Grazia, Consultore della
Suprema Inquisizione di Roma e del mondo, Arcivescovo di Atene e Assistente al
Soglio Pontificio, per oltre un decennio solertissimo e apprezzatissimo Segretario
della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, assai caro a Innocenzo III e a
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Clemente XI, sommi pontefici benefattori, per la sua dottrina, per l’onestà, la
lealtà e la singolare scienza nello svolgimento dei suoi compiti, in questa piccola
cappella degli Avvocati del Collegio del Palazzo Apostolico, tra i quali, una volta
ammesso, a nessuno era stato secondo, questi marmi destinati a durare presso i
posteri quale testimonianza della loro pietà e benevolenza, Agata Petrozzi Giovardi, nipote ed erede, e Agostino Galamini di Recanati, esecutore testamentario
e membro del medesimo Collegio, allo zio e dilettissimo maestro eressero, perché
nel luogo donde egli trasse le origini della sua fama e delle sue fortune, viva perennemente il ricordo dei colleghi. Morì l’11 gennaio 1717 all’età di 75 anni ed è
sepolto nella chiesa del Collegio della medesima Sacra Congregazione, non sopportando di essere strappato, dopo la morte, dal luogo dove egli visse pienamente
la sua vita.
249
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
9.5
250
Giovanni Trulli senior
II 20 marzo 1599, allo scadere del nono mese dalla data del suo matrimonio con Leonardo Trulli, Giulia Campanari dava alla luce a Veroli il primo
di una bella nidiata di figli. Fu deciso di chiamarlo Giovanni e fu battezzato il
giorno successivo in S. Erasmo: a versargli l’acqua benedetta sulla testa fu il
canonico Antonio Rossi; a fargli da madrina ci pensò una certa Rilla, moglie di
Pietro Rossi. La creaturina aveva ancora il capo bagnato, e già Leonardo aveva
deciso dell’avvenire del suo primogenito: avrebbe fatto di lui un medico, un
grande medico.
Non appena fu abbastanza grande per intraprendere gli studi consigliatigli dal padre, Giovanni cominciò a divorare le più importanti opere della
chirurgia e, fra queste, i trattati di Giovanni da Vigo di Rapallo, di Giovanni
Andrea della Croce, di Ambrogio Pare e di Gabriele Falloppia. Ma furono i
grandi progressi compiuti da Mariano Santo di Barletta nel campo della cistotomia ad interessare maggiormente il giovane verolano: le operazioni per l’estrazione dei calcoli in genere non erano, per quei tempi, imprese troppo facili.
Spesso si moriva per non aver osato tentare l’intervento: i chirurghi incaricati
della autopsia di Pio V († 1572) «trovarono nelle viscere tre pietre, della stessa
grandezza, forma, colore e durezza»; nel cadavere di Gregorio XIV († 1591) «si
rinvenne una pietra della forma di un grosso uovo»; Alessandro VII morirà nel
1667 perché distrutto «da fieri dolori prodotti da calcoli».
Giovanni decise perciò di recarsi in Francia, dove avevano grande
successo litotomisti come Collot e Frate Giacomo (Beaulieu). In poco tempo
divenne famoso per i suoi prodigi: «ha colà fatto studio particolare nella chirurgia, con tale successo che ha fatto più tosto miracoli che cure in Francia,
in Genova et in Roma, e ne fa del continuo. Ha in manco di due anni qui in
Roma cavata la pietra a ventisei huomini, de’ quali nessuno è morto e tutti ora
godono intiera sanità...» Dalla Francia a Genova, da Genova a Roma, dunque,
tutta una incredibile serie di interventi brillantemente condotti a termine!
Il 1628 è per la medicina una data importante: la dimostrazione inconfutabile
della circolazione del sangue da parte del fisiologo inglese Guglielmo Harvey.
Questi, con la sua «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis» aveva
suscitato un vespaio tra i pur numerosi sostenitori di Galeno. Il celebre medico
Guy Patin arrivò a definire «paradossale, inutile, falsa, impossibile, assurda e
nociva» la tesi di Harvey, mentre Jean Riolon, chirurgo di Maria de’ Medici,
riuscì a dare della rivoluzionaria scoperta questa macchinosa spiegazione: «La
natura, dopo Galeno, ha modificato l’anatomia; la scoperta del meccanismo
della circolazione non fa che comprovare questa modifica; non dimostra affatto che Galeno si sia ingannato». La dottrina di Harvey ebbe dunque, inizial-
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
mente, pochi fautori. «In Italia il primo a difenderla fu Giovanni Trulli, medico
romano, il quale coi suoi esperimenti arrivò a convincere parecchi avversari
della medesima».
Il conclave del 1623, dal quale risultò eletto Urbano VIII, non era stato
dei più tranquilli. Un pò per la gran calura estiva, un pò per la ristrettezza del
locale «poco ventilato e pieno di sagri elettori», si ammalarono e morirono numerosi cardinali. A conclave ultimato si ammalò lo stesso neo pontefice, «per
cui credendosi anzi avvelenato per un mazzo di fiori, fu d’uopo differire ai 29
settembre la sua coronazione».
Evidentemente qualcuno non doveva avere molto a cuore la salute
del papa se, anche in seguito, tenterà di servirsi dell’opera dello speziale Paolo
Carcarasio, che gli medicava un ascesso, per cercare di avvelenarlo. Urbano
VIII pensò dunque di circondarsi di medici bravi e fidati: Domenico Rivarola,
Sebastiano Vannini, Giulio Mancini, Taddeo e Silvestro Collicola, Pietro Servio, Giovanni Giacomo Baldini e Giovanni Trulli, chirurgo dell’infermeria di
palazzo, furono assunti al suo servizio.
Con il chirografo del 3 agosto 1636 Urbano VIII assegna 200 scudi
annui a «Gio. Trulli da Veroli nostro suddito educato in Francia... acciò resti in
Roma a benefizio, e utile pubblico con obbligo di operare colla sua professione
e, impiegarsi gratis per li poveri ogni volta che da quelli ne sarà ricercato, e d’istruire nel luogo che gli sarà assegnato dal Rettore dello Studio chiunque verrà
a fare l’operazioni più difficili della Chirurgia, e specialmente a levar la pietra
dalla vessica...».
Nel 1637 Giovanni Trulli è, infatti, lettore di chirurgia alla Sapienza, la
celebre università romana che ebbe proprio in quel tempo un grande impulso,
non solo per l’ampliamento e abbellimento della costruzione affidata al Borromini, ma anche per la scelta degli insegnanti e l’istituzione di nuove cattedre. Il
Trulli vi rimarrà come insegnante fino al 1643, anno della morte del suo amico
e collega Benedetto Castelli, già lettore di matematica all’università di Pisa e
poi lettore di matematica nella stessa Sapienza.
Nello stesso anno in cui Giovanni Trulli venne assunto come professore presso l’università romana, Galileo diventò cieco: le cateratte gli impedivano ormai di penetrare i misteri dell’universo. Pier Battista Borghi, membro
del collegio dei dottori di Genova, che si interessava della salute del grande
scienziato, ne parlò al Trulli e da Roma fece pervenire a Galileo, allora relegato
in Arcetri, il consulto medico del chirurgo verolano. Questi, infatti, occupatissimo com’era, non poteva lasciare Roma per eseguire altrove l’intervento: «... e
se non fosse quivi impiegato con impiego così assiduo, mi prometteria di farlo
venir costà a far l’operazione...». L’operazione sarebbe andata certamente bene,
considerata l’esperienza del Trulli: «... ed asserisce averne cavate (le cateratte) a
vecchi di 80 et 85 anni». Ma Galileo morirà cieco.
Spetta al dottor Camillo Morganti il merito di aver compreso e reso
251
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
252
nota in una preziosa pubblicazione del 1959 tutta la «profonda preparazione
scientifica di Giovanni Trulli». Il consulto inviato a Galileo «colpisce per la
modernità dei concetti circa la etiologia e la patogenesi della cateratta, nonché per il tono polemico contro le antiche concezioni secondo cui si riteneva
che la cateratta consistesse in un versamento liquido, intieramente od in parte
coagulato, che producesse l’intorbidamento della pupilla... C’è nell’espressione
exsuffusione il significato di spargimento di un velo, in contrasto con il concetto di inondazione di umore humoris influxu che in oculi globum fìeret affluxu».
Da quando aveva deciso di stabilirsi in Roma, Giovanni Trulli abitò
sempre in via dei Cappellari, vicino alla casa dove nacque il Metastasio, a due
passi da Campo de’ Fiori e non lontano dalla Sapienza, dove insegnava. Preso
com’era dai molteplici impegni, non ebbe tempo di sposarsi. Nello stato d’anime di S. Lorenzo in Damaso del 1644 la famiglia Trulli risulta costituita da:
Giovanni, medico; Andrea, Antonio e Bernardino, fratelli; Delia (Sacchi) moglie di Bernardino, con i figli Zaccheo, Margherita, Giulia e Francesca; Marco,
nipote; Palma da Valmontone, serva; Claudio Borgognone, cocchiero.
Nel 1655 il Trulli fu scelto come partecipante al conclave per la morte
di Innocenzo X; erano con lui i medici Matteo Parisi di Benaudi e Antonio
Maria De Rossi. A conclave ultimato risultò eletto il senese Fabio Chigi (Alessandro VII) che volle come medici: Mattia Naldi, senese, Paolo Zacchia, Francesco Moreschini e Matteo Parisi, oltre ai chirurghi Larche e Trulli.
Il nuovo pontefice prese molto a cuore le sorti dell’università romana;
completò la chiesa di S. Ivo, istituì sei nuove cattedre e dotò l’università stessa
di un orto botanico e della biblioteca. Il 16 novembre 1660 Alessandro VII intervenne personalmente all’inaugurazione del nuovo complesso: «Alcune cattedre o pulpiti intersecavano i sedili dei cardinali, su cui immediatamente salirono i professori di ciascuna facoltà più anziani per fare una breve e analoga
prolusione nella facoltà che rispettivamente insegnavano...». Forse era presente
anche il professor Trulli.
Ancora un anno di febbrile attività al servizio del papa e poi la fine.
Il 27 dicembre 1661, «hora noctis secunda circiter», presenti il Padre Girolamo
Bernabeo e il Vicec. Giovanni Femio, accorsi al suo capezzale per recargli il
conforto dei Sacramenti, si spense nella sua casa di via dei Cappellari Giovanni Trulli, «doctor Celebris ac chirurgus, Maximorum Pontificum Urbani VIII et
Alexandri VII».
Mentre il suo corpo veniva mestamente trasportato nella chiesa di
Santa Maria degli Angeli per esservi sepolto, nelle strade di Roma risuonavano
ancora le dolci note della più bella festa della cristianità.
Gli ultimi anni della vita del dottor Trulli furono amareggiati dal triste
destino (un matrimonio sbagliato) a cui era andata incontro la nipote prediletta, Francesca. Questa aveva diciotto anni quando, in famiglia, le fu proposto di sposare un giovane pittore dal sicuro avvenire: Carlo Maratti, nativo di
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
Camerano, nelle Marche. Molto più grande di lei, non era un Adone. Era «di
struttura mediocre, magro del viso e della persona, ma robusto e d’una agilità
somma»; era «bene accostumato e lontano da ogni leggerezza giovanile». Sua
unica passione, la pittura di Raffaello: conosceva a memoria gli affreschi delle
«Stanze», per averli studiati con febbrile impegno.
Francesca accettò la proposta di sposare Carlo, con grande soddisfazione dei genitori e dello zio Giovanni, che decise di pensare alla dote della
nipote. Per la verità fin dal 1652, anno del suo testamento, Giovanni aveva
lasciato a Francesca e a Giulia, sua sorella, «1500 scudi per ciascheduna da
darseli per una sola volta quando si maritaranno o monacaranno, pregandole a
ricevere questo in segno dell’amore et affetto che gli ho sempre portato et anco
a volersi ricordare a pregare Iddio per me et anima mia...».
A sei anni di distanza, nei capitoli matrimoniali sottoscritti il 5 agosto
1658 da Giovanni Trulli e da Carlo Maratti, gli scudi assegnati a Francesca
salivano a 2500. Di questi, 1000 li avrebbe avuti subito e 1500 entro tre anni.
Il 6 ottobre 1658 Carlo, e Francesca si unirono in matrimonio nella
chiesa di S. Lorenzo in Damaso a Roma. Andarono ad abitare, con una serva
di nome Preziosa, in una via che Sisto V aveva aperto una settantina di anni
prima, fra Santa Maria Maggiore e Trinità dei Monti; portava il nome del Papa
ed era di buon auspicio per gli sposi novelli: Strada Felice.
Per un crudele scherzo del destino, fu tutto il contrario perché il matrimonio si rivelò presto un fallimento. Di fronte alle giornate incredibilmente
piene di un marito importante, c’erano quelle assolutamente vuote di una moglie giovane.
Cominciarono le prime discussioni e si crearono i primi «disgusti tra
essa Signora Francesca e detto Signor Carlo». I maltrattamenti di quest’ultimo
diventarono sempre più frequenti e la situazione divenne insostenibile («ex
viri sevitia recrudescentibus in dies animis»). Fu deciso di dividersi e il 24 marzo 1661, «cum interpositione R.P.D. Baranzoni Judicis», Governatore di Roma,
venne stipulato l’atto della restituzione della dote da parte del Maratti.
Francesca non aveva ancora vent’anni e già si sentiva una donna finita.
Distrutta dal dolore, chiese ospitalità nel convento di Santa Croce in Montecitorio a Roma. Qui vivevano in assoluta povertà alcune suore francescane dette
Le Perugine, le quali, anni addietro, avevano accolto un’altra donna in cerca
di pace: Maria Paleologa. «Il Papa ordina che sia licenza a Maria Paleologa di
nazione greca di poter entrare nel monastero di Santa Croce di Monte Citorio,
vestendo con abito di saia beretina conforme all’uso delle monache, mentre
si promette di starci sempre et vivere con quella modestia che si conviene...».
Così nel Decreto a voce di Urbano VIII del 1632.
Forse anche Francesca indossò, come Maria, il misero abito delle monache. Ma per poco, perché si ritirò a Veroli per chiudersi nel palazzo, ora
Franchi de’ Cavalieri, dove avevano stabile dimora i parenti che non si erano
253
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
254
trasferiti a Roma. Nella vecchia casa, l’affetto del padre fu per Francesca l’unico, vero conforto. Negli atti di battesimo degli anni 1663, 1671 e 1672 «D.D.
Bernardinus Trullius et Francisca eius filia» figurano come padrini dei figli di
Gregorio Melloni, Lorenzo De Gasperis e Carlo Abbondanza. Insieme, dunque, fino al 18 agosto 1678, quando anche Bernardino lasciò Francesca. Per
sempre. Prima di morire aveva voluto sistemare le cose in modo che alla figlia
prediletta fosse garantita una esistenza dignitosa. Aveva sollecitato, infatti, i
suoi fratelli Stefano e Andrea, affinchè fosse data completa attuazione alla volontà di Giovanni senior per il pagamento a Francesca dei 1500 scudi, come
residuo della dote promessa. Perciò, oltre a crediti e censi, le furono assegnati:
«una mola da grano nel territorio di Veroli detto Bagno, una possessione arativa vicino a detta mola, una possessione arborata posta alla Madonna degli
Angeli, un oliveto in contrada il Colle del Bagno, un sito circondato da muri
con vasche ad uso di spurgar le pelli».
Francesca, insomma, aveva di che vivere, ma non era tranquilla. Pare
che lo zio Stefano, intollerante con tutti quando erano in gioco i propri interessi, sollevasse nei confronti della nipote una «istanza iuridica avanti il Governatore», a proposito di alcuni beni ereditati con Bernardino da Giovanni senior.
Francesca cercò allora un pò di solidarietà in quei parenti che non avevano
dimostrato l’avidità di Stefano e in quelle famiglie che le erano state vicino nei
momenti difficili.
Di loro si ricorderà così nel proprio testamento: erede universale dei
suoi beni sarà prima di tutti Francesco Placido Fortuniano Passeri; alla sua
morte il fratello Belardino; poi Lucio e Caterina, loro genitori; quindi il nipote
di Francesca, Giovanni Antonio Vipera. Soltanto morendo quest’ultimo senza
figli, l’eredità passerà al nipote Felice Trulli, figlio di Giovanni iunior. Morendo
anche lui senza figli, «chiamo li figlioli del Sig. Nicola Trulli, nepoti del Sig.
Marco Trulli di Veroli, con dichiarazione però, espressa, che nissuno di essi
sostituiti possa dar molestia alcuna a detto Lutio e Caterina e loro figli de’ Passeri sopra beni lasciatili, ...altrimente hora per all’hora l’escludo affatto dalla
mia eredità...».
Dunque, una lezione per il «clan» di Stefano e un invito alla prudenza
per tutti.
Il nome di Francesca apparirà ancora una volta in un atto di battesimo del 1696 quando, con Filippo Franchi, sarà la madrina della nipote Anna. Quattro anni dopo sarà la fine.
«Die 2 decembris 1700. Domina Francisca Trulli, filia bonae memoriae
Bernardini ac respective uxor excellentissimi Domini Caroli Marattae pictoris
primarii in urbe, aetatis suae annorum circiter sexaginta, in infirmitate sua omnibus Sacramentis referta et roborata, in comunione Sanctae Matris Ecclesiae et
comendatione animae obiit in Domino; et in hac Ecclesia in sepultura familiae
GIUSEPPE TRULLI
Giovanni Trulli senior, medico chirurgo del XVII secolo
in Lazio ieri e oggi, gennaio 1977
Francesca Trulli-Maratti, Terni 1975
Le notizie riguardanti Carlo Maratti e sua moglie Francesca Trulli, sono state tratte dalla «Vita
di Carlo Maratti pittore» scritta da Gian Pietro Bellori fino all’anno 1689, continuata e terminata
da altri, Roma 1731; dall’archivio di Casa Franchi de’ Cavalieri e dal «Tabularium Vicariatus
Urbis» di Roma.
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
De Abundantia precibus exorata sepulta fuit, praeterea suae voluntati, exorantis
in languore, indulgendum benigne duxit».
(«2 dicembre 1700. La Signora Francesca Trulli, figlia di Bernardino e
moglie dell’eccellentissimo Signor Carlo Maratti, il più importante dei pittori
in Roma, si addormentò nel Signore all’età di 60 anni, confortata e ristorata
da tutti i Sacramenti, in comunione con la Santa Madre Chiesa e con la raccomandazione dell’anima. Fu sepolta in questa chiesa, nella tomba della famiglia
Abbondanza, per venire incontro al suo desiderio, caldamente espresso durante la malattia»). Così nell’atto di morte, conservato in S. Erasmo, nel libro dei
morti, vol. II pag. 100.
Carlo Maratti, che, pochi giorni dopo la morte della moglie, aveva
sposato Francesca Gommi, dalla quale precedentemente aveva avuto una figlia
di nome Faustina, nel 1705 era pieno di acciacchi: la vista gli si era abbassata di
parecchio e la mano gli tremava. Svenimenti sempre più frequenti lo costrinsero a non abbandonare mai la propria camera ed il proprio letto.
«In questi anni ad altro egli non attese, che a procurare di placare il
Signore con le orazioni, e a detestare i falli della vita passata. Ma aumentandosi
il male, munito de’ Santi Sagramenti, e provveduto alii suoi temporali interessi,
se ne passò placidamente all’altra vita». Era il 15 dicembre 1713 ed aveva 88
anni.
Il suo corpo «con abito solenne di Cavaliere vestito, fu portato a vicenda dalli Accademici di S. Luca alla chiesa della Madonna delli Angeli». Dopo i
solenni funerali, fu collocato nel ricco sepolcro che lui stesso aveva fatto innalzare nel 1704, su suo disegno, di fronte al monumento a Salvator Rosa.
«Così terminò i suoi giorni Carlo Maratti, che viverà perpetuamente
nella memoria di coloro che o attendono alle belle arti o di esse si dilettano.
Essendo egli stato eccellente da non posporsi ad alcuno de più celebri fra gli
antichi, o moderni Pittori, sì per la perfezione del disegno, che per la proprietà
e vaghezza del colorito».
Francesca Trulli, infelice e sfortunata sposa di Carlo Maratti, vivrà
esclusivamente e semplicemente attraverso le poche notizie che di lei sono riuscito ad offrire al lettore.
255
9.6
A Carlo Maratti (o Maratta)
Roma, chiesa di Santa Maria degli Angeli
Monumento funerario a Carlo Maratti
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
CREDO VIDERE
BONA DOMINI
IN TERRA VIVENTIUM
256
D.O.M.
CAROLUS MARATTI PICTOR
NON PROCUL A S. LAURETANA DOMO
CAMERANI NATUS
ROMAE INSTITUTUS ET IN CAPITOLINIS AEDIBUS
APOSTOLICO ADSTANTE SENATU
CLEMENTIS XI P.M.
BONARUM ARTIUM RESTITUTORIS
MUNIFICENTIA
CREATUS EQUES
UT SUAM IN VIRGINEM PIETATEM
AB IPSO NATALI SOLO CUM VITA HAUSTAM
AC INNUMERIS ESPRESSAM TABULIS
QUAE GLORIOSUM EI COGNOMENTUM
COMPARARUNT
MORTALIS QUOQUE SARCINAE DEPOSITO
CONFIRMARET
IN HOC TEMPLO EIDEM ANGELORUM REGlNAE SACRO
MONUMENTUM SIBI VIVENS POSUIT
ANNO D. MDCCIV
Credo che vedrò i doni del Signore nella terra dei viventi.
A Dio Ottimo Massimo. Il pittore Carlo Maratti, nato a Camerano, non lontano
dalla Santa Casa di Loreto, formatosi a Roma e creato Cavaliere dalla munificenza del Sommo Pontefice Clemente XI, mecenate delle belle arti, alla presenza
del senato apostolico in Campidoglio; per dimostrare la sua devozione verso la
Vergine, attinta in vita dalla sua stessa terra natale ed espressa con innumerevoli
tele che gli procacciarono e gli confermarono anche dopo la sua morte una gloriosa notorietà, in questo tempio sacro alla medesima Regina degli Angeli, ancora
vivente, pose per sé questo ricordo. Nell’anno del Signore 1704.
Camerano, chiesa di Santa Faustina
Monumento a Carlo Maratta e Francesca Gommi
A Carlo Maratti, oriundo dell’Illiria, nato a Camerano, uomo celeberrimo in tutto il mondo, che per il di lui straordinario valore il Sommo Pontefice
Clemente XI, mecenate delle belle arti, insignì della Croce di Cavaliere in Campidoglio davanti al sacro senato dei cardinali, e che precedentemente i sommi
pontefici Alessandro VII, Clemente IX, Innocenzo XI e XII, i sovrani Luigi XIV
di Francia e Giovanni III di Polonia e la regina Cristina Alessandra di Svezia più
volte insignirono di moltissime onorificenze e doni. Essendo stato innalzato un
magnifico sepolcro nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma a colui che
aspetta la resurrezione, i cittadini di Camerano all’ottimo ed illustre concittadino
dedicarono questo piccolo ricordo, ma non piccola testimonianza d’amore affinchè a così grande uomo, della cui memoria quasi nessuna comunità d’Europa è
priva, non venisse a mancare un monumento nella sua città natale. Era in vita
nell’anno del Signore 1712.
Derivato dall’accademia bolognese dei Carracci, attraverso il Sacchi
e l’Albani, Carlo Maratti (Camerano, 1625 - Roma, 1713) fu, nella pittura romana del seicento, un caposcuola. Rappresentò infatti quella corrente pittorica
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
CAROLO MARATTI
EX ILLYRIA ORIUNDO, CAMERANI ORTO
VIRO TOTO ORBE CELEBERRIMO
QUEM OB SINGULAREM EIUS VIRTUTEM
CLEMENTIS XI PONT. MAX. BONARUM ARTIUM RESTITUTOR
IN CAPITOLIO ADSTANTE SACRO CARDINALIUM SENATU
EQUESTRI CRUCE INSIGNIVIT
ET ANTEA ALEX. VII, CLEM IX, INNOCEN. XI, ET XII, SUMMI PONTIFICES
LUDOVICUS XIV GALLIARUM, IOANNES III POLONIAE REGES
CHRISTINA ALEXANDRA SVECORUM REGINA
QUAMPLURIMIS HONORIBUS ET MUNERIBUS DECORARUNT
ROMAE IN TEMPLO DIVAE MARIAE ANGELORUM TUMULO
MAGNIFICE EXTRUCTO
RESURRECTIONEM EXPECTATURO
CIVES CAMERANENSES CIVES OPTIMO ET ILLUSTRI
EXIGUUM HOC NON EXIGUI AMORIS DOCUMENTUM
POSUERE
NE TANTO VIRO
CUIUS MEMORIA NULLA FERE EUROPAE CIVITAS CARET
IN NATALI LOCO MONUMENTUM DEESSET.
VIVEBAT ANNO SALUTIS MDCCXII.
257
che contrastò, temperandone l’esuberanza, l’altra, più apertamente barocca,
dei grandi decoratori come Pietro da Cortona, Andrea Pozzo e Giovan Battista
Gaulli, detto il Baciccia. La sua pittura, fatta di misura e di grazia, di equilibrio e di convenienza, di dignità e di nobiltà, anticipò alcuni caratteri tipici
del settecento. “Tutta la pittura del tardo seicento romano, fuori di quella più
schiettamente decorativa, è marattesca, e dappertutto ritroviamo il medesimo
accento”. (V. Golzio) “Uscirono dalla sua scuola molti uomini insigni, Niccolo
Berettoni, Giuseppe Passeri, Pietro de’ Pietri, Michele Semini, Francesco Pavesi, Jacopo fiammingo, Antonio Balestra, Giacinto Calandrucci, e Giuseppe
Chiari, defunti, Andrea Procaccini, che al presente è nella Corte del re Cattolico in molta stima, ed Agostino Masucci, il quale in Roma va felicemente
seguendo i vestigi del Maestro”. (Gian Pietro Bellori e altri 1689, 1731).
Nella Biblioteca Giovardiana di Veroli sono conservate alcune sanguigne che appartengono al periodò giovanile di Carlo Maratta, quando, giunto
da poco a Roma, dove abitava con il fratello Bernabeo, cominciò a farsi conoscere copiando Raffaello nelle celebri Stanze. È probabile che mons. Giovardi,
uno dei “forastieri studiosi della pittura”, abbia ricomprato le sanguigne della
Giovardiana da qualcuno che, anni prima, le aveva acquistate dal poco scrupoloso Bernabeo. Sono da attribuire ad un anonimo marattesco il Battesimo di
Gesù nella chiesa di Sant’Erasmo, e la lunetta con lo stesso soggetto nel fonte
battesimale della cattedrale. Sono da attribuire certamente a Giuseppe Passeri
il Cristo in croce, la Maddalena e S. Giovanni; S. Giacomo Maggiore, S. Giovanni evangelista, nella chiesa di Santa Salome.
9. Seicento e Settecento Giuseppe Trulli
ROBERTO CANNATA
258
Monumento funerario a Francesca Antonia Leni
Basilica di Santa Salome
Monumento funerario a Francesca Antonia Leni - particolare
Basilica di Santa Salome
Mons. Vittorio Giovardi
Dipinto conservato nella Biblioteca Giovardiana
Biblioteca Giovardiana
Sala lettura
Carlo Maratta
Autoritratto
Monumento funerario a Carlo Maratta
Roma - chiesa di Santa Maria degli Angeli
Monumento funerario a Carlo Maratta - particolare
Roma - chiesa di Santa Maria degli Angeli
CAPITOLO X
Titta,
Mastro
Gioacchino Belli ed altri
Veroli nella prima metà dell’ottocento
268
L’ultima esecuzione capitale. Mastro Titta
273
Il ruolo dei “confortatori” nelle prigioni papaline
275
“Er Confortatore”
277
Gioacchino Belli a Veroli
278
Un gioiello di architettura neogotica
284
10.1
Veroli nella prima metà dell’ottocento
L
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Le attività
268
’interno della città contiene ragguardevoli palazzi. Ne’ fabbricati
progredisce la città in rendersi vieppiù decente, ed essendovi esercitate tutte le arti opportune agli usi della vita, trovansi accreditate
botteghe di mercanti. Il ch. ab. d. Alessandro Atti a’ 23 febbraio 1857
pubblicò nell’«Enciclopedia contemporanea di Fano», t. 5, p. 177,
questa lettera: «Fra molte città dello Stato Pontificio che godono bella fama di
attività, di commercio e di opifizi non è da porre certamente per ultima Veroli,
comeché non sia né molto vasta, né di assai numerosa popolazione (ma la
stampa della riferita proposizione del 1857 dice 14000 anime, e deve ritenersi
errata ancorché vi avesse compreso gli abitanti di sue frazioni, che più innanzi
nominerò; e la «Statistica della popolazione dello Stato Pontificio del 1853»,
pubblicata dal governo nel 1857, compreso le territoriali frazioni veracemente
registrò 10848 abitanti). Poiché, vuoi per il destro ingegno degli abitanti, vuoi
per la vicinanza del regno di Napoli, che rende animatissimi i traffici, vuoi per
gli ebdomadari mercati (in ogni martedì, più abbondanti essendo que’, dell’inverno) che attirano di molto concorso e per i pubblici stabilimenti che vi sono,
ha di che fare invidia ad altre più cospicue e rinomate città pontificie.
Tra le varie fabbriche di diversa ragione tiene senza dubbio il primo
luogo quella messa su dal sig.r marchese Campanari di panni ad uso di Francia, di coperte e tappeti finissimi da disgradarne, starei per dire, i più famosi
d’oltremonti ed oltremare, tra per la bontà de’ tessuti, la bellezza del disegno
e la vivacità de’ colori, come ho inteso più volte a Roma da persone di gusto
squisito. Vi è anche una fabbrica di tappeti inferiori del sig.r Bruni (forse in
essa si formeranno ingegnosamente que’ tappeti colle monture de’ soldati, che
riescono solidi, ed io l’uso nella camera di studio in tutto l’anno, così avendo
sempre presente Veroli), due di seterie ordinarie del sig.r Brocchi e del sig.r
Lauri (noterò che in Veroli le sete egregiamente colle filande si filano e si lavorano); una di cappelli del sig.r Luzzi, 12 di cotone, 3 di cappelli ordinari in
campagna a S. Francesca (frazione della città), una di polvere sulfurea e due
di colla cerviona (aggiungerò inoltre io le fabbriche di vasi di terra cotta e terraglie, di sedie, di spiriti, di confetture e molte di paste di perfetta qualità, non
inferiore a’ rinomati maccheroni di Napoli, di cui si fa gran traffico).
In tanta varietà d’arti e mestieri egli è certo che moltissimi trovano
dove impiegare l’opera loro e donde trarre giornalmente l’onorato sostentamento per sé e per la propria famiglia. Se in ogni paese vi fossero proporzionatamente altrettante fonti d’industrie e di guadagno non avremmo a lamentar
sì spesso la miserabile condizione de’ popoli, e vedere tanta robusta gioventù
molte volte per difetto di facil lavoro gittarsi per disperata a misfare con tanto
scandalo e danno della civil società. I ricchi che hanno come riparare a’ sempre
crescenti mali dell’ozio e dell’inopia, dovrebbero accordarsi di gloriosa emulazione e aprire in ogni terra, in ogni villa, in ogni borgata qualche utile stabilimento acconcio all’indole degli abitanti, ove faticar potessero con guadagno e
con onore tante braccia nate ma non accostumate giammai alla fatica (Utinam!
fiat, fiat)».
Nello stesso anno il Giornale di Roma a’ 26 settembre notificò: «Gran
deposito di tappeti di Veroli ad uso inglese e francese. Per le lodevoli cure della
ditta Campanari e Melloni venne eretta una grande fabbrica di tappeti nazionali in Veroli ad uso de’ migliori inglesi e francesi, con il vantaggio che mentre
in oggi questi sono per lo più falsificati e misti di cotone (specialmente quelli
sotto il prezzo di scudi 2,30 circa) e sono tinti di falsi colori, i suddetti di Veroli sono tutti di lana fina e di colori vivaci e durevoli. I verdi e neri, i ponsò, i
neri specialmente si distinguono per la forza e la bellezza delle tinte, e sono di
molto superiori agli esteri».
Acque e laghi
Nell’interno di Veroli, sebbene si usino comunemente le acque di cisterne che si riempiono coll’acqua piovana, pure le potabili abbondano a contatto della città; e veramente minerali, toniche e deostruenti riescono quelle
del fonte di Pedicosa. Di queste fonti, scrive il Marocco, due se ne incontrano
fuori di porta Romana sulla pubblica via, una nominata «Fontana Nuova»,
l’altra del «Lago», denominazione antica comprovante l’esistenza un tempo di
vicino lago. Infatti al di sotto di essa è un terreno quasi tutto da collinette circondato, e così profondo che da a conoscere la preesistenza d’un lago presso al
fiume Cosa ed al piccolo rivo detto «i Bagni», luogo spettante al capitolo della
cattedrale. Da una pergamena di quell’archivio si apprende la certa esistenza
d’un lago in questa parte, ove sono i confini. Il documento consiste, dice Marocco, in una locazione stipulata nel 959 dal vescovo col consenso del capitolo
e intitolata: «Locatio Lacus Manilani1 facta a Rofrido duce et comite Campaniae
1
La località «Maniano», vicino a Frosinone, sui confini del territorio verolano, non
può essere quella che da il nome alla fontana nelle vicinanze della città.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
GAETANO MORONI
Veroli, in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica
1859
269
Romanae anno 1099» (deve dire 959, come già ho notato). Inoltre nella pergamena si dice dell’esistenza d’un altro laghetto chiamato «Canoce»,
vocabolo di contrada esistente sotto il monte Nero, ove trovasi il cratere disseccato, che per altro riempiesi nelle dirotte piogge con notabile quantità d’acqua;
ma per breve tempo lo formano, sgombrando mercé un ampio meato nel masso di viva pietra, anch’esso proprietà del capitolo cattedrale.
Ibidem
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
L’istruzione, la cultura
270
In Veroli sono diversi sodalizi, rinomato è il seminario il cui edifizio
è capace di contenere un centinaio d’alunni e secondo il Marocco se ne contarono fino a circa annui 70. Gli alunni, a ricreazione, vi hanno un grazioso
teatro a tre ordini appositamente fabbricato, e per villeggiatura un grande casino suburbano situato a Foiano a due miglia dalla città. Questo seminario ha
dato alla letteratura ed alla Chiesa più uomini distinti, anche nel nostro secolo, come il cardinal Carlo Vizzardelli e il prelato Stefano suo fratello, l’abbate
Pallocchi di Pofi, ed all’Università Romana i professori Giuseppe Mangiatordi
e il vivente cav. Paolo Volpicelli. Inoltre l’educazione ha in questa città alcune
utili istituzioni, fra le quali, la scuola elementare, le scuole comunali riunite
nel seminario, e quella di diritto civile e canonico, generosamente fondata da’
nobili verolani fratelli Franchi nel 1538 con oltre 300 scudi per stipendio del
professore.
Per recente istituzione del fu can. d. Pietro M.a Mobili, ben presto vi
saranno introdotte le monachelle o conservatorio di suore francesi per la pubblica istruzione delle donzelle. Non mancano altri stabilimenti benefici. Un
ricco, comodo e spazioso spedale, unico nella provincia, serve agl’infermi; un
altro vicino a porta S. Croce, è pe’ poveri pellegrini. Le oneste e bisognose zitelle ricevono dotazione per benefiche disposizioni d’un Filonardi, d’un Bono,
d’un Campanari, e di un can. d. Domenico Trulli in premio alle istruite nella
dottrina cristiana. Finalmente vi è il teatro comunale, che per l’ordinario agisce
in alcune stagioni e particolarmente nella stagione di carnevale, eziandio con
musiche istrumentali e vocali; e vi sono due società, la filodrammatica e la
filarmonica-strumentale col maestro di musica proprio. L’orchestra è diretta
dal maestro pro-tempore e dal professore violinista Luigi Bubali verolano, aggregato per concorso pubblico nel 1837 alla pontificia accademia di S. Cecilia
di Roma nella sezione degli strumentisti. Evvi eziandio il concerto civico approvato dalla superiorità e distinto da militare divisa.
Ibidem
Osservò il Marocco che il linguaggio de’ popolani, più degli altri luoghi della provincia di Campagna, a quello romano si accosta, ma usano moltissimi vocaboli che partecipano dell’antico idioma latino, benché pronunziati da’
plebei e da’ contadini. Il vestire di questi ultimi somiglia in parte a quello de’
romagnoli, però distinguonsi ne’ calzari detti «ciocie», e pel colore degli abiti
per lo più rossi, inclusivamente a’ mantelli: ma i cittadini, massime le persone
distinte, tutti incedono col costume de’ romani.
I dintorni sono sparsi di eleganti casini e ville. In essi si pretende che
alcuni trovarono in varie epoche diverse anticaglie e per sino de’ teschi con
chiodi conficcati anche nelle mani e ne’ piedi, e sino circa al numero di 12;
iscrizioni lapidarie, piccoli idoletti di metallo e d’oro, monete romane di rame,
d’argento e d’oro di Tiberio imperatore, alcuna quantità di denari, avanzi d’acquedotti di piombo, di anfore e di gran vettine impiombate nella bocca e con
entro ceneri e sostanze fluide; pochi avanzi di bei musaici, di lastre di marmo,
di rosso antico, di pitture a fresco ecc.
Nel suburbio esistono le chiese della Maddalena eretta da Alessandro
III, della Madonna de’ Raccomandati e di S. Valentino vescovo e martire, senza
dire di oltre a 20 altre chiese rurali convenientemente ufficiate.
Frazioni e villaggi soggetti alla municipale giurisdizione di Veroli: Scifelli, in cui hanno la bella chiesa di S. Cecilia a 3 navi, e casa o collegio i liguorini o redentoristi. Il luogo prese il nome di Scifelli dalle scifelle di faggio che
facevano i suoi abitanti. Si chiamano le altre frazioni: Colli Berardi, Crocefisso,
Vittoria, Madonna degli Angeli, Giglio, S. Anna, S. Francesca, S. Giuseppe, S.
Domenico, S. Pietro o tenuta di Castel Massimo, S. Vito, S. Angelo. In quest’ultimo luogo ancora si vedono gli avanzi di altissima torre che serviva pe’ segnali
telegrafici, con propinquo vasto fabbricato servito per episcopio sub urbano, e
nella prossima contrada Viari si rinvennero anticaglie.
Ibidem
II territorio di Veroli
II territorio verolano è abbastanza fertile. Narra Marocco che produce
olio in abbondanza e di qualità squisita e dolcissima, essendo le montagne cariche d’olivi: il prodotto non solo compensa l’agricoltore, ma riesce la principale ricchezza del luogo. Il gelso serve d’alimento a’ bachi setiferi che in quantità
e comunemente si allevano. Il vino non è a sufficienza, ma ottimo e puro; e si
sopperisce colle uve acquistate ne’ paesi limitrofi. Altre produzioni sono i grani, i granturchi, le biade, i castagneti, ecc. Oltre la porcina, buone sono le carni,
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Costumi, rinvenimenti, frazioni
271
abbonda il pollame, così la selvaggina, precipuamente volatili, cinghiali, capri,
lepri, ecc. Poiché le estese montagne sono coperte di boschi di frassini, carpini,
querce e faggi, chiamandosi Fragara la più elevata; producono inoltre ottimi
pascoli e nutriscono nell’estate immense mandrie di bestiame, e vi si trovano
piante medicinali.
Il territorio si estende a 6,040 rubbia romane: confina all’est col regno
di Napoli per una linea tutta montuosa; a sud co’ tenitori di S. Giovanni, Bauco, Ripi, ed in parte con Torrice e Frosinone; al sud-est s’incontra il territorio
d’Alatri, che lo cinge per tutto il lato di tramontana, sino a riconfinare col reame napoletano sulla vetta del monte detto il Passaggio, a cui sono sottoposti
molti paesi regnicoli e tutta la deliziosa valle di Roveto. Le terre dominanti
nella periferia verolana sono in gran parte la calcarea e la silicea, con altra
minor parte di alluminosa. Inoltre questo suolo asconde ferro e asfalto, di cui
s’introdussero l’escavazioni.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Ibidem
272
10.2
L’ultima esecuzione capitale. Mastro Titta
Nel medesimo anno in cui era finito il brigantaggio, e cioè nel 1867,
la testa di un reo di omicidio volontario fu esposta nella gabbietta di ferro
sistemata nel muro esterno di Porta Arenaria (Porta Romana) perché fosse di
esempio a tutti i cittadini. Il condannato1 era responsabile dell’uccisione della
moglie che lo tradiva con un vicino di casa. Al Largo della Filippina infatti, il
12 marzo 1867, alle ore 6,15, avvenne l’esecuzione della sentenza di morte con
decapitazione a mezzo ghigliottina. Tutta l’attrezzatura fu portata da Roma e i
il boia fu il famoso Mastro Titta.
GIUSEPPE DE MATTIA
dattiloscritto
Al numero 4 del vicolo del Campanile o, secondo altri, nel vicino
Borgo S. Angelo, al n. 120, abitava il penultimo e più famoso boia di Roma,
Giambattista Bugatti, detto Mastro Titta, che ci ha lasciato un taccuino in cui
sono diligentemente annotati nome, cognome, professione dei giustiziati, la
motivazione delle rispettive condanne, il tipo di pena applicato in ogni singolo
caso. Nel pubblicare queste «Annotazioni», nel 1886, A. Ademollo tracciava di
lui questo profilo: «Carnefice modello e “artista” veramente degno del teatro
nel quale era chiamato ad agire e del suo impresario — lo Stato e il Governo
Pontificio — Giambattista Bugatti (...) sostenne la sua parte per sessantotto
anni, ed in ogni genere di supplizio, mazzola, squarto, forca, ghigliottina, mostrò sempre uguale abilità (...). Ha eseguito “da sé” la bellezza di 514 giustizie».
Il Bugatti — scrive più avanti l’Ademollo — era bassotto, grasso, sbarbato,
sempre pulito e netto nella persona: portava cravatta bianca e scarpe scollate.
Frequentava moltissimo le chiese (...). La sua carriera finì nel 1864, in parte a
causa di un incidente: la testa di un suppliziato, Antonio Aietti, cadde dal palo
sul quale era stata infissa, provocando grande spavento nel pubblico. Questo
episodio e i contrasti con il garzone Ciriaco Pelosi, provocarono il collocamento a riposo del vecchio boia, con una decorosa pensione (pari a una volta
e mezza il salario del suo successore, Vincenzo Balducci).
1
AA. VV.
Guida ai misteri e segreti di Roma, Sugar Editore, 1970
1
Ignazio Bubali, della parrocchia di S. Paolo. Era nato il 5 febbraio 1837 da Ambrogio
e Apollonia Pica; il 27 gennaio 1864 aveva sposato Luisa Rotondo.
1
Ignazio Bubali, della parrocchia di S. Paolo. Era nato il 5 febbraio 1837 da Ambrogio
e Apollonia Pica; il 27 gennaio 1864 aveva sposato Luisa Rotondo.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Mastro Titta
273
Lo spettacolo
Nella Roma dei papi, come in tutti i paesi del mondo, le esecuzioni capitali erano uno spettacolo molto seguito. I padri vi portavano i figli, non però
per divertimento, ma a fini educativi: nel momento culminante del supplizio
i poveri ragazzi si sentivano arrivare uno schiaffone e parole d’ammonimento.
Lasciamolo dire al Belli:
Tutt’a un tempo ar paziente mastro Titta
j’appoggiò un cardo in culo, e tata a mene
un schiaffone alla guancia de mandritta.
«Pija», me disse, e aricordete bene
che sta fine medesma ce sta scritta
per mill’antri che so meglio de tene».
AA. VV.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Guida ai misteri e segreti di Roma, Sugar Editore, 1970
274
Il ruolo dei “confortatori” nelle prigioni papaline
II poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli scrisse il sonetto riportato
appresso, il 13 settembre 1830 (qualche mese prima di venire a Veroli), ispirato
forse dall’esecuzione di un tal Felice Teatini, originario di Frascati, che era stato
ghigliottinato due giorni prima a ponte Sant’Angelo, a Roma, per omicidio. La
scena che egli descriveva con spirito caustico e irriverente si ripeteva, praticamente immutata, da più di tre secoli, da quando cioè l’arciconfraternita di San
Giovanni Decollato esercitava l’ufficio di confortare i condannati a morte: il
condannato riceveva l’annuncio della sentenza capitale nel cuore della notte
che precedeva l’esecuzione, e subito un gruppo di confratelli lo prendeva in
consegna e non lo abbandonava un istante fino al momento in cui saliva sul
patibolo.
In quelle ore i confortatori dovevano non solo ottenere la salvezza spirituale del “paziente”, attraverso la confessione e le altre pratiche religiose, ma
anche disporlo a recitare convenientemente la parte che gli toccava in quel
grande spettacolo che era l’esecuzione capitale (...). Chi moriva impenitente,
maledicendo i giudici o proclamandosi innocente, sarebbe certo stato dannato (...). Chi invece moriva pentito riceveva in premio l’assicurazione della
vita eterna. Per questo i confortatori iniziavano il loro colloquio col condannato annunciandogli l’imminente ingresso in paradiso. E spesso spingevano il
loro zelo persuasivo fino a dire al condannato che doveva ritenersi fortunato,
perché se avesse continuato a vivere normalmente, avrebbe rischiato di morire improvvisamente, per un motivo qualsiasi, in stato di peccato mortale,
perdendo così la sua anima. Il patibolo diventava quindi una garanzia per il
paradiso, che era in fondo l’unica cosa che contava, per un cristiano.
(...) Se il condannato restava sordo alla persuasione, cercavano di
commuoverlo con le suppliche: si inchinavano a baciargli i piedi, pregandolo
di avere pietà della sua anima, o si flagellavano davanti a lui, implorando a
Dio la grazia del suo pentimento. Se il condannato persisteva ancora nella sua
ostinazione, ricorrevano ai metodi duri: gli scottavano la mano con la fiamma
di una candela, per dargli un’idea delle pene dell’inferno, oppure facevano entrare nella cella il boia, che fingeva di portarlo subito al patibolo.
(...) Un esempio significativo dei limiti culturali dei confortatori è il
caso di Francesca Piroli, impiccata per infanticidio il 16 marzo del 1743. La
ragazza, diciottenne, era orfana di entrambi i genitori, ed era venuta quattro
anni prima a Roma dalla natia Viterbo per fare la cameriera. All’annuncio della
condanna a morte non ebbe alcuna reazione; (...) i confortatori la sollecitarono
allora a rendersi conto della gravità del momento, piangendo con lacrime di
compunzione i suoi reati. Al che Francesca rispose «che aveva tanto pianto
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
10.3
275
per il passato che non poteva piangere di più». (...) Anche lungo il tragitto
dalle carceri al patibolo Francesca si mostrò «contrita, ma bensì avvilita, non
avendo fiato di parlare». Fu solo quando il boia le mise il cappio al collo, annotarono poi i confortatori, che esplose «in un dirottissimo pianto, del quale
non aveva dimostrato minima parte in tutta la notte, invocando con veemenza
l’aiuto di Dio, della Madonna e di S. Antonio».
Questa esecuzione non andò secondo le regole, perché per un errore
del boia Francesca stentò molto a morire: «allora con più veemenza raddoppiò le grida e l’invocazioni al Signore, et ai santi... e si è veduta far sangue da
tutte le parti». La folla che assisteva cominciò a rumoreggiare (...). Quanto ai
confortatori, commentarono questo doloroso episodio in un modo che mostra
come un eccesso di zelo nel trovare comunque una soluzione edificante potesse cancellare la naturale pietà per le sofferenze di un povero corpo: «Da questa mancanza del carnefice nel suo offizio, del quale il numerosissimo popolo
ch’era spettatore faceva già sussurro, e potevano nascere de’ gravi sconcerti, è
resultato in vantaggio alla povera paziente, che ha potuto per qualche momento di più raddoppiare, con fede maggiore, le invocazioni suddette».
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
LUIGI CAIANI
Il conforto del patibolo, in Storia e Dossier
Giunti, febbraio 1987
276
“Er confortatore”
Er confortatore
Sta notte a mezza notte er carcerato
sente uprì er chiavistello de le porte
e fasse avanti un zervo de Pilato
a dije: «Er fischio te condanna a morte».
Poi tra du torce de sego incerato
co du’ guardiani e du bracchi de corte,
entra un confortatore ammascherato
coli’ occhi lustri e co le guance storte.
Te l’abbraccia ar collo a l’improvviso
strillanno: «Alegri, fijo mio: riduna
le forze pe volò su in paradiso».
«Che alegri, cazzo; alegri la luna!»
quello arisponne: «Pozziate esse acciso;
pijatela pe voi tanta furtuna».
GIOACCHINO BELLI
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
10.4
277
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
10.5
278
Gioacchino Belli a Veroli
Vicino al Belli «viaggiatore italiano», che trova in Umbria o nelle Marche lo
slancio necessario per arrivare in Toscana, in Emilia, soprattutto in Lombardia, c’è un «viaggiatore laziale», che non si spinge più in là dei Castelli Romani;
o tutt’al più, per guarire dall’esaurimento nervoso, si rifugia in Ciociaria, a Veroli. Viva la faccia! Niente passaporto, niente carrozza di posta, niente locanda
a La Storta, a Baccano, a Monte Rosi e a Nepi...
Il viaggetto a Veroli risale alla primavera del 1831. Gioacchino ha
quarant’anni tondi. Assorbito dai preparativi della partenza, tra il servo che si
scorda una valigia e il vetturino smanioso di partire, trascura di salutare la moglie.1 Non appena giunto a Veroli, il 26 maggio, le esprime il suo rammarico. E
continua:
«Alle 4 uscimmo dalla porta Maggiore, cioè circa alla levata del sole;
ed all’avemaria eravamo già sotto le mura di Veroli: viaggio felicissimo, eseguito con rapidità, interrotto da sole tre ore di rinfresco cioè due a Valmontone,
25 miglia da Roma, ed una all’osteria di Alatri, 5 miglia distante da Veroli:
viaggio, ripeto, felicissimo, in ottimo legno, con eccellente vetturino, pieno di
libertà e comodo, sotto benignissimo cielo, e sopra una lieta strada fra amene
campagne. Qui ho trovato affettuosa ospitalità, casa superba2 e clima eccellente, benché ancora alquanto freschetto. Io arrivai così leggiero come quando
partii: 60 miglia mi parvero una delle trottate fatte da noi insieme per Roma.
Sto bene, ho appetito, e odo dirmi che di ora in ora mostro un viso più chiaro e
più vivo. Miracoli, so bene, l’aria non ne fa; ma pure il buon’animo che accom-
1
«Mariuccia» (Maria Conti, vedova Pichi).
2
È il palazzo Iacoucci, in via Giuseppe Garibaldi, in parte abitato dalla famiglia Todini.
Scrive Salvatore Rebecchini («Belli in Ciociaria» in «Rivista dell’Urbe», nov. 1963): «II Palazzo
Jacoucci in Veroli, tuttora esistente, è costituito da uno dei più cospicui edifici della cittadina.
Costruito nella prima metà del sec. XV, pervenne alla famiglia — secondo quanto afferma lo storico verulano Prof. Camillo Scaccia Scarafoni in un suo studio su Aonio Paleario, nativo anche
esso di Veroli — quale dote della moglie di un Domenico Jacobutii nel 1441. (...) Tale nobiltà
interna di ambienti non riusciva però del tutto a togliere l’impressione che l’edificio, per spessore
di murature e robustezza di chiusure, fosse stato, un tempo, apprestato a difesa, impressione che
era rafforzata e confermata da un particolare dispositivo di cui sono provviste in tutti i piani le
finestre aprentesi sulla via pubblica. Nello spessore dell’imbotto sono praticate trasversalmente
delle feritoie per fucili, chiuse all’interno da sportelli a fil di muro ed orientate in maniera da
«battere» porte e finestre dei fabbricati antistanti e da prendere d’infilata la strada: tipico accorgimento per sostenere eventuali attacchi dall’esterno».
3
Anna Marcucci, di origine romana. Era la vedova di Giuseppe Iacoucci, noto giurista
del suo tempo. Aveva tre figli maschi: Publio, Icilio e Attilio.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
pagna queste assicurazioni de’ miei ospiti mi riempie di gratitudine e di fiducia
nell’avvenire».
Una fiducia mal riposta. Sia nella clemenza del tempo («Allorché arrivai», scrive sempre alla moglie, «trovai freddo; poi il tempo parve rivolgersi al
buono: da qualche giorno però sono tornate acque, venti e stravaganze. Intanto
io sto coperto della mia lana, e non soffro di simili variazioni. L’appetito regge
e le guance pare che si rigonfino alquanto»), sia nel trattamento ricevuto dalla
signora Nanna3, padrona di casa, per la modica spesa di «scudi 12 mensili»:
«La bontà e la premura con cui qui sono trattato sono grandi, e anche somme, e anche diremo eccedenti, trasformandosi assai di sovente in un
assedio da far capitolare la resa senza neppur l’onore delle bandiere spiegate.
Ma che vuoi fare? L’unica che potesse qui avere una giusta idea del mondo
civile e di quanto può fare la vita riposata e paga, sarebbe la Sig.ra Nanna; ma
premettiamo anche in lei un certo tal quale guasto procedente dalla operosità
insistente ed efficace dell’esempio che la circonda; e se poi ci aggiungeremo
in diffalco tutta la parte d’animo che deve ella concedere ai Sagramenti, alle
Chiese, alle preghiere, ai digiuni e a qualche altra praticuccia di religione, le
cure che le restano disponibili nel cervello e nel cuore possono certo bastare
e bastano a farne una eccellente madre di famiglia ed un’ottima economa di
una casa, ma non mai una donna, dai cui consigli, e previdenze e providenze
abbia a nascerne quel bell’ordine di proprietà e di comodo il quale con gli elementi qui in casa esistenti si potrebbe sperare e ottenere. Quindi, per dire più
specialmente di me, una superba stanza piena di tele di ragno: elegantissime
persiane che la furia continua dei venti qui dominanti vuoi sempre in agitazione, e in istrepito, e chiuse, per mancanza de’ necessari fermagli: dodici ampii
cristalli sporchi in modo che non la vista degli oggetti esterni, ma né anche
la luce solare può quasi più avervi passaggio: un moderno camminetto di bel
marmo bianco affumicato dalle esalazioni interne del bucato del pianterreno:
un larghissimo letto dal quale escono i piedi di fuori per la sproporzione delle
misure, soffice in modo che o i detti piedi, o la testa, od i fianchi vi s’ingolfano fino agli abissi: una nobile coperta che scopa la terra da tutte le parti: una
scrivania alla moda colla zella incozzata in più d’un luogo; due ben modellati
comò, con tiratori che vogliono chiudersi da quella parte che loro più piace:
una lucerna ricolma d’olio e ridondante come una fontana: un’altra senza boccaglie e i di cui stoppini all’improvviso ti si nascondono e ti lasciano al buio:
una tovaglia finissima sparsa di frittelle, una camera da pranzo tutta addobbata
di bel prato e di oggetti da cucina: tre gatti che si fanno pagare il loro ufficio
279
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
contro i topi a furia di saltarvi fin ne’ piatti che vi stanno davanti: mille mezzi
per difendersi dalle mosche, e nulladimeno un milione di mosche per ogni
palmo quadrato di spazio: una sostanziosa cioccolata da tagliarsi a fette, una
studiata minestra senza brodo e colma di pepe o garofoni, un pollo ricercato
sparso da un capo all’altro di schiuma: carbone sparso qua e là, caduto dal
canestro a chi stira: un’insalata cotta, ma cotta in tanta estensione del termine
che non vi rimangono più che le fibre: un solo cucchiarino di caffè per tutta
la carovana: neppure uno sgommarello per dar la zuppa, un’acqua calda per la
barba e pei denti piena di fuliggine, o di fondi di caffè, o di grasso di pila, o di
rimasugli d’ovo sbattuto, o finalmente odorosa di fumo. Un collo di camicia
col baffetto, un gilè colla ciancicatura, un fazzoletto col bughetto rispettato.
Etc. etc. etc. Il trattamento poi di cibarie è quale la estrema scarsezza4 di questo
paese può farlo ottenere migliore e non burlo. La mattina cioccolata: a pranzo
minestra, tre cose e talora più: quindi caffè: e la sera si ripeterebbe altrettanto
ma io vado assai piano. Onde procurarsi però il vitto da fornire la tavola, dice
la Sig.ra Nanna (e la credo) che deve quasi metter gl’impegni. Le carni scarse
e non troppo buone; rarissimi polli,5 erbe quasi nessuna: insomma un paese
senza industria e senza cultura!6 Quindi carissime le vettovaglie che conviene
disputarsi in piazza un coll’altro e incettarle anche prima che arrivino. E la Natura pure produce qui come altrove! Or figurati se è ora così che il governatore
attuale vi ha in qualche modo provveduto, cosa sarà stato prima, che il forno
280
4
Oltre che dal distacco tra città e mondo rurale, questa realtà dipendeva, nel 1831, da
una situazione di grave carestia conseguente ad una prolungata siccità.
5
Dagli atti del Comune di Veroli, relativi a quel periodo, sappiamo che fin dal 1828
era stato deliberato il divieto di allevare polli nel centro urbano. Solamente verso il 1847 fu
permesso l’allevamento di capre nel centro urbano, affidate per il pascolo ad un capraio, per la
fornitura del latte alla popolazione; in quell’anno anche l’amministrazione dell’ospedale annotò
per la prima volta nel registro delle spese l’acquisto di una capra per il latte ai ricoverati.
6
In questa Veroli «senza industria e senza cultura», egli certamente trovò un ambiente
culturale non inferiore a quello romano; incontrò nobili e professionisti che si dilettavano di
letteratura riunendosi anche in «Accademie», come a Roma. Di Roma avrà incontrato, per le
strade o nelle loro abitazioni: il Primario Chirurgo Mojani, il Medico Condotto Giuseppe Bosi
(vincitore della condotta medica, dal giugno 1825 curò anche i degenti dell’ospedale e figurò
nella Commissione comunale per la lotta contro il colera: la sua relazione sulla prima morte «sospetta» denota serietà professionale e preparazione); Giovanna de Witten, sposata con
il Marchese Ferdinando Bisleti; Cecilia Colonna, consorte del Marchese Michelangelo Bisleti;
Plautilla Valdambrini, sposata con Valerio Macciocchi. Non può ritenersi perciò che il Belli
soffrisse allora la solitudine per trovarsi in ambiente molto diverso da quello della Capitale, o
lontano dai conoscenti.
7
II bisogno di «cassia» dovette essere impellente per il poeta, per rimediare alla sua
«pigrizia» intestinale forse conseguente al tipo di dieta.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
spesso mancava di pane; non vi era mai mercato, si vendevano con fraude
quasi tutte le carni morticine del territorio, e il pizzicarolo non teneva fuorché
cacio pecorino, merluzzo salato, e salacche tarlate. Pure qui tutti contenti in
questo paese».
Tutti, meno Gioacchino, scontento di natura: e quanti conoscono Veroli possono testimoniare come abbia ecceduto nel giudizio. Forse, lontano da
palazzo Poli e dalle affettuose cure e premure di Mariuccia, s’era accentuata la
solita ipocondria. A onor del vero, però, osserva che la «dozzina», computata
la colazione, il pranzo e la cena, computato l’alloggio, il lume, il consumo di
biancheria, la lavatura e stiratura, e la servitù, non è in vero «eccedente». Gli
basta recuperare la salute e poi «ambulerà»: poiché, dimorando a Veroli, ha
scoperto «un clima di un’incostanza infernale: certe strade che sembrano scale
dell’ultimo piano del Palazzo Poli; e poi certi abitanti... e poi certi speziali... Basti dire che il primo fra questi è un doratore, che di cento medicine
ne tiene in bottega una dozzina al più; e spesso manca di cassia e quando l’ha,
se non gli tenete sempre gli occhi addosso e vi divagate un tantino, traffete vi
ci ficca la mela cotta, o l’acqua, o il diamine che se lo porti: e ciò per aumentare
il peso senza diminuzione del fondo di farmacia. Un medico quindi!... ma che
medico! fa’ dei pessimi sonettacci satirici, ma pure lo credo assai più abile in
quelli che nel conoscer la febbre». (...) Ai primi di luglio, scacciato dalla «stemperatezza» del clima, Gioacchino rientra a Roma, non senza aver sfogato in
un’ultima lettera (30 giugno) l’estremo rigurgito di bile contro Veroli:
«Questo paese è situato sopra una montagna tutta scogli, e tutta scoperta. Ieri cambiò temperatura cinque o sei volte, e sempre da un eccesso all’altro. Me lo avevano dipinto per un paradiso: potrei anche crederlo per l’elevatezza sua, ma pel resto somiglia meglio all’inferno. Non ti dico che l’aria non
sia buona: non può anzi essere che ottima; ma per reggere alle stravaganze
delle montagne è necessaria una costituzione meno scompaginata della mia. Ciò riguarda al fisico. Circa poi al civile non ti dissi nella mia ultima
che la metà. Figurati tre giorni addietro la Sig.ra Nanna non trovò un uovo
per tutta Veroli onde darmelo la sera. Ieri mattina fece girare e battere ad ogni
porta onde trovare un paio di piccioni. Li ebbe finalmente a gran ventura, ma
grossi come due quaglie le costarono due paoli. Ieri sera io aveva necessità di
un poco di cassia.7 Il povero Publio dovè tornare a casa senza averla potuto
portare. Per farmi un poco d’insalata cotta, bisogna ordinare la cicoria un giorno avanti. Purtuttavia questa tavola è molto a sufficienza provvista, ma tutto
gronda sudore di chi lo ha procacciato. La carne di macello si deve comperare
quando c’è, e poi metterla in grotta. In quanto poi all’interno della casa essa
281
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
282
sarebbe anche assai comoda, ma la poca cura manda tutto in deperimento. La
cortesia de’ padroni di casa può dirsi senza uguale, ma è una cortesia campagnola che ti porrebbe la casa in collo senza comprendere che il peso eccederà le
tue forze. Prenda un poco di questo: sono tenerissimi: e saranno cavoli. Senta
com’è delicato e leggiero questo umido: e saranno funghi, la di cui leggerezza
la misurano a peso di stadera, e non a capacità di stomaco. E mangi qui, e riprenda lì, e assaggi di questo, ma lei non mangia niente, ma lei muore di fame,
ma lei fa penitenza: e beva un altro bicchiere: e si sforzi; e faccia un poco di
merenda: ma i suoi dolori provengono da debolezza, etc. Intanto io vado scoprendo certe codiche di porco cotte col lesso, vado sentendo pepe e garofani,
bevo un’acqua che sa di terra, benché a questi signori sembri acqua celeste, e
debbo tutto giorno lottare contro le cordiali insistenze di chi è incapace di essere illuminato quando certe cose non le capisce da sé. Mi dicono: Lei sta sempre
solo, e si annoierà. Come vuoi fare altrimenti? Io ho bisogno di riguardi. Se
scendo all’appartamento della signora, trovo tutto aperto, e spesso per le stanze
fischia la tramontana come in piazza. È vero che qualche volta al mio apparire
si chiude qualche finestra in qui e in là, ma io mi accorgo assai bene che quello
che giova a me nuoce agli altri, e riesce loro un gran sacrificio.
Figurati, la conversazione è composta di tre o quattro persone che giuocano a calabresella in mezzo proprio di una stanzetta con quattro finestre, due
porte e un camminetto, che vale a dire sette buchi tutti spalancati. La Sig.ra
Nanna sta in camera sua a dir le orazioni con le figlie; ed io in camera mia a
sbadigliare, ma almeno a finestre socchiuse».
Gioacchino esagera e distorce ad arte la verità per convincere Mariuccia che non può restare molto a Veroli. Il sospetto è legittimo perché, tornato a
Roma, vi si trattiene giusto il tempo indispensabile per riassettare carte e libri,
e subito rifa la valigia e piglia la carrozza di posta diretto a Morrovalle. State
tranquilli, a Morrovalle, vicino alla «Cencia»8, Gioacchino si troverà benissimo. Aria buona. Temperatura stabile. Venti educati. Vitto e alloggio eccellenti
e neanche un baiocco di «dozzina». A Mariuccia, moglie comprensiva, non
resta che chiudere un occhio.
MARIO DELL’ARCO
Gioacchino Belli a Veroli, in Capitolium
novembre 1963
8
Vincenza Roberti, di Morrovalle (Macerata). La partenza precipitosa nascondeva, infatti, accanto alla recuperata salute, la passione segreta per la bella e giovane contessina che era
ad attenderlo. Fu questa passione a fargli scegliere, per il viaggio verso Roma (prima di recarsi
nelle Marche), un vetturale verolano più veloce degli altri ed in grado di raggiungere la Capitale
senza soste intermedie: una specie di «rapido» di quei tempi. L’anonimo vetturale è anche indicato sui registri dell’ospedale con il soprannome di «Curri-Curri», perché spesso veniva incaricato di trasportare all’Istituto S. Spirito in Roma qualche «proietto» o «esposto» o figlio di madre
ignota.
La decisione da parte del Belli di venire a trascorrere un periodo di
tempo a Veroli, «decisione nella quale intervennero autorevolmente la consorte e i più vicini amici del Poeta, fu, con ogni probabilità, determinata dalla
conoscenza che la famiglia del Poeta aveva con un giovane curiale romano,
Publio Jacoucci, il quale forse aveva frequentato lo studio legale dell’«abate»
Valentino Conti, «curiale di collegio», suocero del Belli.
Publio Jacoucci era nato a Roma nel 1807 da Giuseppe, uno dei più
noti giuristi del suo tempo, uomo, in gioventù, di tendenze repubblicane, che
intervenne quale Rappresentante Italiano nella Commissione per la Riforma
dei Codici, istituita da Napoleone I. I Jacoucci appartengono ad una delle più
antiche famiglie nobili di Veroli, derivando dagli Jacobutii, che compaiono, fin
dal Sec. XIV, nel Consiglio della Città.
A Roma, esercitava la professione forense; aveva sposato Carlotta De
Rossi. In seguito, rimasto vedovo, si ammogliò in seconde nozze con Maria
Antonia, figlia di quel Luigi Pieromaldi, giudice Capitolino, amico del Belli,
dello Spada, del De Romanis e, come loro, Accademico Tiberino.
Da Publio nasceva quell’avv. Virginio Iacoucci, molto noto negli ambienti cattolici della Capitale, Presidente dell’«Unione Romana per le Elezioni
Amministrative», che, dal 1887 al 1905, fece parte del Consiglio Provinciale
e, per cinque volte, di quello Comunale di Roma, ricoprendo anche, per breve tempo, la carica di Assessore con l’Amministrazione Torlonia. Nominato
Promotore di Giustizia della Città del Vaticano subito dopo il Concordato del
1929, moriva in Roma nel 1933.
La famiglia Jacoucci, oggi definitivamente trasferitasi in Roma, è imparentata con le famiglie romane dei Rem-Picei, dei D’Avack, dei Mazzetti di
Pietralata».
SALVATORE REBECCHINI
Belli in Ciociaria..., cit.
N.B. Le note sono state tratte da Il Poeta... e lo Speziale e da Pregi e difetti di vita paesana, di
Alfredo Gabriele, in Lazio ieri e oggi, gennaio e febbraio 1988.
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Perché proprio a Veroli?
283
10.6
Un gioiello di architettura neogotica
HECT. CIOLFI SIBI SUIS ET AMICIS A. MDCCCIC
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
Ettore Ciolfi per sé, per i suoi e per gli amici. L’anno 1899.
284
L’iscrizione che che si legge sulla facciata del delizioso palazzetto neogotico di Piazza Bisleti, informa il passante che il proprietario, l’avvocato Ettore
Ciolfi, lo aveva costruito per sé, per i familiari e per gli amici nel 1899. Gli amici erano per lo più i massoni della zona che si potevano così riunire nei locali
della casa (praticamente un ampio salone decorato con stucchi e un saloncino
con reminiscenze, anch’esse, di tipo gotico) approntati per le necessità organizzative della loggia.
Si sa che le organizzazioni segrete massoniche sono sempre state di
ispirazione laica e liberale, quindi in contrasto con la Chiesa cattolica, specialmente durante il lungo processo che portò all’Unità d’Italia e che era notoriamente avversato dal papato. L’avvocato Ciolfi, sempre preoccupato dei destini
della patria, non aveva dimenticato il sangue versato, qualche decennio prima,
dai martiri di Villa Glori; ed era ancora addolorato per la sorte toccata alla
patriota Giuditta Tavani Arquati, quando, con l’intera famiglia, fu massacrata
in via della Lungaretta dai gendarmi pontifici. Perciò il famoso giurista aveva
collocato sulla facciata dell’edificio adiacente alla loggia, anch’esso dei Ciolfi,
un busto in stucco raffigurante l’ardimentosa patriota romana. Intendeva così
onorare il di lei sacrificio.
Ma quel busto dovette sembrare a qualcuno il segno, fin troppo evidente, della laicità di Ettore Ciolfi (che pure aveva avuto in famiglia un prete di
nome Vincenzo) e dovette suonare come offesa alla cattolicità dei Verolani. Fu
allora che il signor Arci, il quale abitava proprio di fronte alla casa dei Ciolfi,
in antitesi con l’immagine della Tavani, fece scavare sulla facciata della propria
casa una nicchia di forma ovale nella quale sistemò un delicato busto della
Vergine. In tempi recenti l’effige della Tavani è stata rimossa e sostituita da una
statuina della Madonna, sotto la quale una targa dichiara la “libera proprietà
del canonico don Vincenzo Ciolfi”.
Un particolare: i due stemmi che fiancheggiano la finestra sul balcone del palazzetto presentano: a sinistra una spada ed una bilancia, evidenti
simboli della Giustizia; a destra un albero, sottile ed allungato, un leone rampante ed una stella. L’albero forse un cipresso, fa certamente parte dell’arme
della famiglia Ciolfi e si completa in altra parte della casa con il significativo
motto: “Vivit et morietur erecta”. Amo pensare che i due stemmi racchiudano
un programma ed un augurio che l’avvocato Ciolfi avrà potuto esprimere per
GIUSEPPE TRULLI
10. Mastro Titta, Gioacchino Belli ed altri Giuseppe Trulli
sé stesso, ma che ognuno di noi potrebbe fare propri: vivere con rettitudine,
puntando dritti verso la ricerca della Giustizia, e morire in piedi, conservando
intatto il tesoro delle proprie idee e della propria dignità.
Scrive l’ing. Carlo Tarquini: «nel contesto di fine secolo, il palazzetto
rappresenta un prezioso documento storico di una fase nella quale si attua,
nel Lazio, la transizione politico-culturale dallo Stato Pontificio allo Stato postunitario e laico, con possibilità di liberi insediamenti, anche per i massoni
mazziniani, quali erano Ettore Ciolfi ed i suoi amici (...). Architettonicamente
esso è anche la testimonianza di un periodo di transizione nel quale gli ingegneri, disorientati dall’incalzare del nuovo, privi di un comune e generalizzato
linguaggio, daranno forme antiche a materiali nuovi (cemento, ferro, cristallo). Dell’epoca del cemento armato, che sta avvicinandosi a grandi passi, si
hanno nel nostro palazzetto, sommesse ma interessanti manifestazioni... Ma
quanto elegante questo congedo che il cemento, il nuovo materiale, dà al gotico, al vecchio stile. Si guardi il garbo con il quale il cemento si insedia nelle
bifore (...). e i tondini di ferro che armano le colonnine della balaustra del balconcino, (sciaguratamente) frantumate da una raffica di mitragliatrice durante
un’incursione aerea dell’ultima guerra... Progettista dell’edifìcio fu il triestino
architetto Carlo Pìncherle, padre dello scrittore Alberto Pìncherle, a tutti noto
con lo pseudonimo di Alberto Moravia».
285
Salita di S. Erasmo
La casa Iacoucci dove abitò Giuseppe Gioacchino Belli
Monumento a Giuseppe Gioacchino Belli - dettaglio
Roma - piazza Giuseppe Gioacchino Belli
Palazzetto neogotico
Veroli - piazza Bisleti
CAPITOLO XI
La prima Guerra Mondiale
La scintilla
291
L’intervento dell’Italia
293
Strafexpedition (spedizione punitiva)
294
Caporetto
295
La Vittoria
297
Una lettera dal fronte
298
Il Milite Ignoto
300
La Madre di Littoria
301
Testamento spirituale del Duca D’Aosta
305
S. M. il Re tiene rapporto sul campo
11.1
1914
La scintilla
«L’Arciduca Ereditario d’Austria e la moglie uccisi da un giovane studente bosniaco a Sarajevo».
E
(Corriere della Sera, 29 giugno 1914)
Gli italiani si dividono tra:
neutralisti
interventisti
Tra i neutralisti sono:
Giovanni Giolitti e la maggior parte dei socialisti e dei cattolici, i quali
pensano di ottenere dall’Austria importanti concessioni territoriali in cambio,
appunto, della nostra neutralità.
Tra gli interventisti sono:
Il Re e il Capo del Governo, Salandra; Gabriele D’Annunzio; Benito
Mussolini; Leonida Bissolati, socialista riformista; Gaetano Salvemini, storico;
Cesare Battisti, socialista e deputato al parlamento austriaco, i quali considerano la guerra contro l’Austria, per liberare le terre e le città italiane ancora irredente del Trentino e della Venezia Giulia, come l’ultima e conclusiva battaglia
del nostro Risorgimento.
Prevale la corrente interventista e il 24 maggio 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria, mentre il Re Vittorio Emanuele III assume il comando
dell’esercito, forte di 400.000 soldati.
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
sistono, tra le potenze europee, due blocchi contrapposti:
la Triplice Alleanza (Germania, Austria, Italia)
la Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna, Russia)
Nel giugno, a Sarajevo, uno studente serbo uccide l’Arciduca Ferdinando, erede al trono austriaco. L’Austria coglie il pretesto per
dichiarare guerra alla Serbia. All’Austria si unisce la Germania; alla Serbia,
Francia, Gran Bretagna, Russia.
Allo scoppio della guerra, l’Italia, che non è stata interpellata preventivamente dall’Austria e che non è, quindi, obbligata ad intervenire, rimane neutrale.
291
Postazione con mitragliatrice FIAT
11.2
1915
L’intervento dell’Italia
«L’ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata... Soldati, a voi
la gloria di piantare il tricolore d’Italia sui termini sacri che la natura
pose a confine della Patria nostra. A voi la gloria di compiere finalmente
l’opera con tanto eroismo iniziata dai vostri padri...».
Vittorio Emanuele III
24 Maggio: l’Italia dichiara guerra all’Austria
settentrionale o del Trentino
orientale o dell’lsonzo
Primo balzo offensivo
Superato il vecchio confine e occupati alcuni punti strategici nel Trentino, le truppe italiane conquistano la conca di Caporetto, la dorsale tra Isonzo
e Indrio e dilagano nella pianura friulana, occupando Cormons, Cervignano e
Grado. Ai primi di giugno viene occupata Gradisca e, forzato l’Isonzo a Piava,
creata una testa di ponte. Viene poi occupata Monfalcone e il 16 conquistato
Monte Nero.
Prima, seconda, terza, quarta battaglie dell’Isonzo
Obiettivi: le teste di ponte di Tolmino e di Gorizia e il bastione del Carso.
Nonostante lo slancio con cui le nostre truppe si gettano contro le
saldissime difese nemiche, perdendo il fiore dei nostri combattenti, i risultati
sono scarsi.
23 ottobre: muore Filippo Corridoni.
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
II comando delle operazioni è affidato al Generale Luigi Cadorna. Il
teatro della guerra è diviso in due fronti:
293
11.3
1916
Strafexpedition (spedizione punitiva)
«Se la gente sapesse, bacerebbe il suolo dove passa l’ultimo dei nostri
soldati di fanteria».
Emanuele Filiberto di Savoia, Duca D’Aosta
Gli austriaci passano all’offensiva nel Trentino con la cosiddetta «Spedizione punitiva» che, come il nemico disse, avrebbe dovuto punirci del tradimento dell’alleanza che ad essi ci univa.
Il violento attacco costringe le nostre truppe a cedere qualche lembo di
terra nelle zone di Asiago e nella Valsugana.
Sul Monte Corno vengono catturati e poi impiccati, Cesare Battisti e
Fabio Filzi. Stessa sorte per Nazario Sauro, Damiano Chiesa e Francesco Rismondo.
Contenuta l’azione austriaca nel Trentino, il nostro esercito passa alla
offensiva con le battaglie sull’lsonzo, dalla quinta alla nona.
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
Quinta battaglia dell’lsonzo:
294
particolarmente aspra fra il San Michele e il San Martino. Il 29 giugno,
nella zona del San Michele, fa la sua tragica apparizione il gas asfissiante. Sorpresi nel sonno, in pochi minuti perdono la vita 2700 uomini dell’XI Corpo
d’Armata, mentre altri 4000 rimangono gravemente intossicati.
Sesta Battaglia dell’lsonzo:
conquista dei Monti Sabotino, Podgora, S. Michele. Conquista di Gorizia (9 agosto).
6 agosto: muore Enrico Toti
11.4
1917
Caporetto
«Sappia ogni comandante, sappia ogni soldato, quale è il suo sacro dovere: lottare, vincere, non retrocedere di un passo. Noi siamo inflessibilmente decisi: su le nuove posizioni raggiunte, dal Piave allo Stelvio, si
difende l’onore e la vita d’Italia».
Generale Cadorna
II crollo della Russia permette all’Austria di spostare contro di noi
molte divisioni, rinforzate da un ingente numero di contingenti tedeschi.
Decima e undicesima battaglia dell’Isonzo
Maggio-Giugno: conquista del Monte Kuk, Jamiano e Quota 21 di
Monfalcone.
Battaglia dell’Ortigara
Giugno: conquista del Passo dell’Agnella e della Quota 2101. Conquista della vetta dell’Ortigara (Quota 2105). Ritorno sulle posizioni di partenza,
con perdite ingentissime.
Caporetto
24 ottobre: la XIV Armata austro-ungarica attacca tra Plezzo e Tolmino e dilaga nel Veneto. Le linee della II Armata sono sfondate.
27 ottobre: il Comando Supremo ordine la ritirata sul Tagliamento prima e sul Piave poi. Nuova linea di difesa: Monte Grappa-Piave.
9 novembre: il ripiegamento sul Piave è compiuto.
Il Generale Armando Diaz succede al Generale Cadorna.
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
Agosto-settembre: conquista dell’altipiano della Bainsizza, dello Jelenik, del Kobilek, del Monte Santo.
295
Battaglia degli altipiani
La rottura di Caporetto costringe il settore degli Altipiani a far ripiegare l’ala destra, in collegamento con il Grappa, su una nuova linea che viene
attaccata dagli austriaci il 10 novembre.
Altro ripiegamento.
Il 4 dicembre il nemico è bloccato sulla linea Cima Echar-Monte Valbella-Col Del Rosso-Zaibena. Contro questa linea, il 23 dicembre, il nemico
scatena l’ultima offensiva che si protrae fino al giorno di Natale. Alla fine ogni
velleità austriaca è infranta.
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
28maggio: muore Giovanni Randaccio
296
Acquerello di Achille Beltrame - particolare
11.5
1918
La Vittoria
«...I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono
in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa
sicurezza».
Generale Diaz
Battaglia del Piave o del solstizio
15 giugno: l’impero austro-ungarico scatena una grandiosa offensiva
sul Piave, in concomitanza ad un attacco sugli Altipiani e sul Grappa.
22 giugno: la nostra controffensiva ci consente di riprendere tutte le
posizioni perdute, ricacciando definitivamente oltre il Piave tutte le truppe nemiche.
Battaglia di Vittorio Veneto
24 ottobre: il Comando Supremo italiano fa iniziare, dal Grappa al Piave, la grande offensiva per rompere il fronte nemico nel tratto di saldatura tra
il settore montano e la linea del Piave. La manovra riesce brillantemente e le
nostre truppe, marciando in direzione di Vittorio Veneto, tagliano in due tronconi lo schieramento avversario, costringendo il nemico a chiedere l’armistizio.
3 novembre: armistizio a Villa Giusti
«Le nostre truppe hanno occupato Trento e sono sbarcate a Trieste. Il
tricolore sventola sul Castello del Buon Consiglio e su la Torre di San Giusto.
Puntate di cavalleria sono entrate in Udine».
Generale Diaz
Le ostilità per terra, per mare e nell’aria terminano alle ore 15 del 4
novembre.
giornata nella quale viene pubblicato il Bollettino della Vittoria.
19 giugno: muore Francesco Baracca
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
297
11.6
Una lettera dal fronte
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
18 giugno 1917 - ore 24
298
Cari genitori,
scrivo questo foglio nella speranza che non vi sia bisogno di farvelo pervenire.
Non ne posso fare a meno. Il pericolo è grave, imminente. Avrei un rimorso se
non dedicassi a voi questi istanti di libertà, per darvi un ultimo saluto.
Voi sapete che io odio la retorica... No, no, non è retorica quella che sto
facendo. Sento in me la vita che reclama la sua parte di sole; sento le mie ore
contate, presagisco una morte gloriosa ma orrenda.
Fra cinque ore qui sarà un inferno. Fremerà la terra, s’ oscurerà il cielo,
una densa caligine coprirà ogni cosa, e rombi e tuoni e boati risuoneranno fra
questi monti, cupi come le esplosioni che in questo istante medesimo sento in
lontananza. Il cielo si è fatto nuvoloso: piove.
Vorrei dirvi tante cose, tante ma Voi ve l’immaginate. Vi amo, Vi amo
tutti, tutti... Darei un tesoro per potervi rivedere. Ma non posso. Il mio cieco
destino non vuole. Penso in queste ultime ore di calma apparente, a te, Papà,
a te, Mamma, che occupate il primo posto nel mio cuore; a te, Beppe, fanciullo
innocente, a te, Nina... Che vi debbo dire? Mi manca la parola: un cozzar di idee,
una ridda di lieti e tristi fantasmi, un presentimento atroce mi tolgono l’espressione. No, no, non è paura, lo non ho paura. Mi sento ora commosso, pensando
a voi, a quanto lascio; ma so di mostrarmi forte dinanzi ai miei soldati, calmo e
sorridente. Del resto anch’essi hanno un morale elevatissimo.
Quando riceverete questo scritto fattovi recapitare da un’anima buona,
non piangete. Siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto in guerra
non è mai morto. Il mio nome resti scolpito nell’animo dei miei fratelli; il mio
abito militare, la mia fidata pistola (se vi verrà recapitata), gelosamente conservati stiano a testimonianza della mia fine gloriosa. E se per ventura mi sarò
guadagnato una medaglia, resti quella a Giuseppe.
O genitori, parlate, parlate, fra qualche anno, quando saranno in grado
di capirvi, ai miei fratellini, di me, morto a vent’anni per la Patria. Parlate loro di
me; sforzatevi di risvegliare in loro il ricordo di me. Che è doloroso il pensiero di
venire dimenticato da essi. Fra dieci, vent’anni forse non sapranno più d’avermi
avuto fratello.
È la lettera che il tenente degli alpini Adolfo Ferrero, torinese, scrisse a poche ore dalla sua eroica morte nella battaglia dell’Ortigara. La lettera, prezioso documento che testimonia
in maniera incontestabile lo spirito che animò i nostri combattenti in quel difficile momento
Acquerello di Achille Beltrame - particolare
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
della nostra storia, è stata ritrovata dopo 41 anni ed in perfetto stato di conservazione, insieme
ai resti mortali di altro Caduto, che si presume fosse l’attendente a cui l’Ufficiale aveva consegnato la lettera per farla recapitare ai suoi parenti qualora non avesse potuto egli stesso spedirla
per altra via.
299
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
11.7
300
Il Milite Ignoto
Il 4 novembre 1921, tre anni dopo la Vittoria, in Roma su l’altare della
Patria fu tumulato il Milite Ignoto, al quale il 1° novembre S. M. il Re aveva
conferito la medaglia d’oro al valor militare con la seguente motivazione:
«Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette
inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente
battaglie e cadde combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la
grandezza della Patria». 24 maggio 1915 - 4 novembre 1918.
Nella basilica di Aquileia furono trasportate, dai lontani cimiteri di
guerra perduti su le bianche vette delle Alpi o su le aspre sassaie del Carso o su
le rive del Piave, le salme di undici soldati ignoti, sepolti senza che fosse stato
possibile identificarli. Nell’austerità della grandiosa basilica romana, le undici
salme furono deposte presso l’altare maggiore: su una colonnina era un’urna
piena d’acqua del Timavo; nella chiesa, gremita, il silenzio era solenne.
Una madre di Gradisca, che aveva perduto il suo figlio in guerra e che
ne ignorava il luogo di sepoltura, Maria Bergamas, era stata scelta perché, tra
le undici salme gloriose, additasse quella che, dall’austerità della basilica di
Aquileia, doveva essere trasferita alla gloria fulgidissima di Roma immortale.
Alle undici bare ricoperte dal tricolore si avvicinò l’umile madre dolente e santa, avendo viva nel cuore e negli occhi l’immagine del figlio caduto
nell’aspra guerra. Dopo essersi inginocchiata dinanzi all’altare di Dio, la madre
andò verso le undici bare che racchiudevano i corpi di quegli undici ignoti
soldati morti per la Patria e dopo essersi inginocchiata in santo raccoglimento,
scelse la seconda da sinistra.
Chi fu? Non era nessuno ed era tutti: era il Soldato d’Italia caduto
combattendo, che aveva dato alla Patria sua, la sua purissima giovinezza.
Il treno, che ne portò la salma, mosse da Aquileia verso Roma e attraversò la Penisola con il suo carico sacro: passò in un’apoteosi di gloria mentre
le campane delle chiese, quasi raccogliendo le preghiere ed il pianto orgoglioso
di tutte le madri, suonavano a gloria. Di città in città, di paese in paese, di borgata in borgata passò il treno sacro: su i binari, in ginocchio, erano in devota
adorazione, i lavoratori dei campi, accorsi come ad un rito. Sul treno erano
tutti i fiori dell’autunno morente.
A Roma, portata a spalla da decorati da medaglia d’oro, al cospetto
di S. M. il Re, seguita da una gruppo di madri di caduti, la salma dell’Ignoto
fante, che personificava i cinquecentomila soldati morti per la grandezza e la
salvezza d’Italia, fu tumulata nell’altare della Patria, alle falde del Campidoglio.
Su la pietra, che chiude il loculo fu scritto solamente «Ignoto militi» (al soldato
ignoto).
11.8
La madre di Littoria (Latina)
(Racconto)1
Tempo di messi
II sole di giugno incombeva alto sulla piana sterminata di Littoria
trionfante di messi.
I covoni delle spighe si allineavano biondi lungo i solchi, vicino al grano ancora in piedi, immobile sui gambi. Pace grande all’intorno. All’orizzonte,
Roma.
Tre fratelli contadini di gagliardo ceppo veneto, Marco, Nane, Piero,
avevano appena terminato di consumare la colazione frugale e, seduti sulla
buona terra, frangevano spighe sul palmo per osservare la granitura dei chicchi. Parlottavano di raccolti, di lavoro, di stagioni. C’era, nel loro accento, una
fiera e contenuta nostalgia di paese, attenuata dalla gioia che la terra, madre
ovunque, concede sempre a coloro che hanno saputo piegarla a furia di lavoro
e di speranza.
La madre
Alquanto discosta da essi, immobile, col fazzoletto di percalle annodato sotto la gola e portato avanti sulla fronte a riparo del sole, stava la madre
dei tre fratelli: piccola, olivigna, ma ancor salda. Taciturna ed assorta, fissava
ostinata la terra. Piero, il suo minore, biondo ed abbronzato, la chiamò con
voce di letizia invitante:
«Su, mamma; venite vicino a noi! E parlateci. È giorno di gioia per tutti,
questo. Viviamo qui da anni e molto, insieme, abbiamo fatto. No?»
«I giovani con i giovani, figliolo» rispose la donna.«E i vecchi da soli,
quando non abbian compagnia di altri vecchi».
«Ma i ricordi» intervenne Marco «sono l’orgoglio di tutti noi».
«E che ricordi!» osservò Nane, il meno giovane dei tre, membruto, dalle gote cave, dalle braccia scure e secche come cortecce di tronco. «Solamente pochi anni fa, quando venimmo chiamati per i primi lavori di bonifica, non
c’era che fango, qui attorno. Fango e acquitrino e capanne e zanzare. Le bufale
1
Da “Il libro della quinta classe - Letture” - Mondadori 1940
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
301
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
302
sgambavano soffiando fra le canne, e noi si ballava di febbre, nonostante il chinino che ci facevano ingurgitare. E oggi, invece... guardate, mamma! Grano e grano a perdita d’occhio, fieno e acqua pura, aratri e cavalli e buoi, case
linde, bimbi saldi, fiori, piante; la vita, insomma».
«E la lingua del nostro paese» osservò Piero. «Sembra di essere a Vittorio o a Belluno; si parla veneto da per tutto, qui; e se pure mancano le nostre
montagne amiche, c’è vicino a noi il Duce, più grande di tutte le montagne della
terra! Mamma, dico giusto?»
«Giusto dici, figliolo».
«E dunque? Che cosa vi manca per essere lieta almeno in giorni di mietitura? Verrà fra qualche settimana la trebbia... e le bocche di molti sacelli si
chiuderanno su questo grano santo».
Ma il giovine sapeva, come lo sapevano i suoi fratelli, ciò che alla madre mancava... E la madre medesima, cui le parole dei figli lenivano un poco il
dolore e lo scioglievano in parole vogliose di sfogo, parlò.
«Che cosa mi manchi» disse «non è un mistero.
Io non posso e non potrò mai darmi pace. Sì, sì, è vero; tante madri hanno perduto il figlio in guerra; ma non mi è possibile rassegnarmi al pensiero che
la sua tomba debba rimanermi per sempre ignota ed io non possa inginocchiarmi
davanti alla sua croce. Una croce col suo nome l’ho cercata sempre da allora...
Piero, tu eri bambino e non ricordi...»
«Lo ricordo anch’io, mamma; vagamente».
«Era il maggiore, il più bello, il più forte di voi, e buono come la bontà.
Ebbene: sono quasi vent’anni che io ricerco ostinatamente la sua fossa. E il cuore mi dice che la troverò, che potrò vederla almeno una volta prima di morire.
Sapete che il suo nome stampato ho appreso a leggerlo facilmente e lo vedrei di
lontano sopra una pietra o sopra una croce, anche se logorato dal tempo».
«Mamma» la interruppe Nane serio e dolce «volete proprio accorciarvi
la vita in questa ostinazione che vi consuma inutilmente!»
«Perché inutilmente?» Domandò la donna con voce aspra.
«Ma perché, benedetta, è tutto trasformato ormai, lassù; e dov’erano doline, caverne, reticolati, cannoni, vi sono campi come qui e contadini».
«Non da per tutto, e il Carso è grande. Io stessa, vedi, non sono riuscita
in tanti anni a visitarlo bene. Vi sono ancora cimiteri che non conosco. E la Madonna deve farmi la grazia».
La santa pellegrina
II caso era tutt’altro che raro. Si trattava di una forma di dolore e d’amore divenuta a poco a poco ossessione. I figli rispettavano questo stato d’animo della madre e, se pure cercavano di persuaderla, non la contraddicevano
Quote, doline, sentieri, armi frante, croci e fiori purpurei sboccianti attorno a
qualche obice rugginoso. Vagava, la madre, attenta, sola; e quando vide quei
fiori che le parvero tinti dal sangue dei giovani martiri, si inginocchiò, davanti
ad essi pregando: «Santi fiori della Vergine, rispondete ad una mamma: egli
dorme forse in mezzo a voi? Lo ricordate? Era biondo, grande, aveva gli occhi
come questo cielo!»
Dolce e in pace, la terra non rispondeva se non con qualche alito di
vento che sembrava un sospiro d’anima. La madre coraggiosa seguitò il suo
cammino, guardando ovunque, pregando a mani giunte e a fior di labbra, con
gli occhi intenti e l’anima tesa.
Ogni sasso su cui era scolpito un nome dava alla sua anima un tuffo e
una vaga speranza, che si rinnovava ogni momento e subito si cancellava. Elmetti corrosi, simulacri di baionette, schegge color foglia morta, gavette sfondate e croci, innumeri croci ovunque.
Il miracolo
La donna giunse al grande cimitero di Redipuglia.
«Chi di voi, anime benedette, sa dirmi dove sia il mio figliolo? Chi l’ha
visto? Dove è caduto? Sono una mamma! Signore, aiutatemi!»
L’ansia delusa si tramutò in più bruciante dolore, ma non divenne
sconforto. E quando, stanchissima, sul fare di una sera piena di dolcezza, vide
la statua del Duca d’Aosta, del Principe fiero, immobile col vasto mento sul
petto come se stesse per dare alla sua gloriosa III Armata il comando di battaglia, la donna si gettò ai piedi del monumento, singhiozzando ed implorando:
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
mai bruscamente per timore di esasperarla. La adoravano. E facevano quasi
ogni anno il sacrificio di raggranellare un po’ di soldi per mandarla in pio pellegrinaggio nella zona della grande guerra. Tornava sempre delusa; ma il fatto
di essere rimasta qualche giorno a pregare e a cercare nei luoghi dove il figlio
era certamente caduto valeva a darle un po’ di pace. Santa donna! Aveva tanto,
tanto lavorato e penato per le sue creature. Sempre curva sulle zolle come un
uomo, sempre infaticabile e insonne, sempre in moto per la casa e per i campi,
dimentica di sé, abituata a guarire col silenzio i propri malanni, paga di vedere
i figli crescerle rigogliosi d’accanto. Un piatto di minestra, una fetta di polenta,
un pezzo di pane scuro erano tutto il suo nutrimento; e ne aveva d’avanzo.
Anche quell’anno dunque, nell’intervallo tra la fine della mietitura e
il giungere della trebbia, discreta, quasi furtiva, la madre fedele volle tornare...
lassù. Sempre ci sarebbe tornata fin che la terra, la quale sembrava richiamarla
insistente, incurvandola ogni giorno un poco, non la avesse finalmente placata, accogliendola nell’immenso grembo pietoso.
303
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
304
«Grande Capo, tu lo sai dove è sepolto mio figlio, il bersagliere che ti fu compagno
nella lotta e nella gloria; dillo a una mamma! Illumina la mia mente, conforta il
mio dolore e fa ch’io possa finalmente inginocchiarmi sulla terra benedetta che lo
ricopre».
Vinta nelle membra, la povera donna si addormentò ai piedi del Principe. E allora... oh, miracolo! La statua si mosse, il bronzo divenne carne, il
volto del Duca si sollevò e si fece umano, le sue labbra sorrisero a quella madre
e parlarono: «Si, donna: io lo vidi il tuo eroe. Cadde dopo un’aspra giornata
di sangue. Combattè da leone, chiuse gli occhi sorridendo ed implorandoti. Era
sempre stato semplice ed eroico. Iddio gli dette il gran premio, sì che tu lo cerchi
invano da anni fra queste croci. Madre, madre d’Italia, voglio che tu ritorni a
Littoria con la gioia nel cuore. Egli è... a Roma! È presso il Campidoglio! La sua
tomba è circondata di fiori, di gloria eterna, e su quella tomba andrai a pregare
sapendo, tu sola, che ai piedi del gran Re è sepolto il figliol tuo. Questo è il premio
di tante fatiche, della tua fedele purezza, della lotta che per tanti anni hai sostenuto in silenzio, sorretta dalla speranza, santificata dall’amore, accontentandoti
di nulla, dividendo con le altre creature il duro pane e un ristoro di giacigli. Ma...
ricordati: hai sognato... Serba in cuore il segreto e porta il mio bacio all’eroe».
La donna si svegliò con un grido. Tese le braccia al Gran Principe,
volle chiedere ancora. Ma il Principe era ridivenuto statua, bronzo immortale.
Che cosa importava? La felicità e la certezza erano ormai entrate per sempre
nel cuore della madre italiana.
Ora essa poteva tornare felice fra i suoi!
Festa di luci e di messi a Littoria. In piedi sulla trebbia, largo il petto,
gli occhi sfavillanti e il sorriso di fanciullo, il Duce d’Italia compiva a gesti solenni il rito dei contadini e preparava alla Patria nuovi destini.
Canti, grida, sfavillìo di chicchi d’oro sotto il gran sole romano! Saettare di rondini in croce. E la vecchina, piano, unì il suo canto gioioso a quello
dei trebbiatori. Non più misteri per la sua anima pacificata. Il Milite Ignoto era
suo figlio! Lo sapeva. Ne era certa. Glielo aveva rivelato il Condottiero Sabaudo
nella dolce verità di un sogno là, sul Carso rosso, che per tanti anni ella aveva
interrogato con la santa perseveranza del suo infinito amore.
Il testamento spirituale del Duca d’Aosta
«La sera scende sulla mia giornata laboriosa, e mentre le tenebre inondano e sommergono la mia vita terrena e sento avvicinarsi la fine, innalzo a Dio
il mio pensiero riconoscente per avermi concesso nella vita infinite grazie, ma,
sopratutto, quella di servire la Patria ed il mio Re con onore e con umiltà.
Grande ventura è stata per me quella di vedere, prima di chiudere gli
occhi alla vita terrena, avverato il sogno giovanile della completa redenzione d’Italia, e di avere potuto, mercè il valore dei miei soldati, concorrere alla vittoria
che ha coronato di alloro i sacrifici compiuti. Muoio perciò, serenamente, sicuro
che un magnifico avvenire si dischiuderà per la Patria nostra, sotto l’illuminata
guida del Re, e del sapiente governo del Duce.
Al mio augusto sovrano, che ho servito sempre con lealtà, con ardore,
con fede, rivolgo le più care espressioni del mio animo grato, per l’affetto che ha
sempre avuto per me, al carissimo nipote Umberto, promessa e speranza dell’Italia, il mio augurio più affettuoso e più fervido.
A S.M. la Regina, alla mia sposa, Helene, ai miei figli Amedeo ed Aimone, ai miei fratelli Vittorio e Luigi, a tutti i miei congiunti, il mio pensiero
riconoscente per il bene che mi hanno voluto e che ho contraccambiato con pari
tenerezza.
In questa ora della triste dipartita desidero esprimere particolarmente
tutta la mia gratitudine ad Helene per le cure che sempre mi ha prodigato, e pregare i miei due cari figli di continuare nella via che ad essi ho tracciato e che si
compendia nel motto: “Tutto per la Patria e per il Re”.
Il mio estremo saluto va a tutti i miei amici, collaboratori e cari compagni d’arme del Carso e del Piave, cui esprimo ancora tutta la mia riconoscenza
per quanto ai miei ordini hanno fatto per la gloria della Terza Armata e per la
grandezza della Patria.
Desidero che la mia tomba sia, se possibile, nel cimitero di Redipuglia in
mezzo agli eroi della Terza Armata. Sarò, con essi, vigile e sicura scolta alle frontiere dell’Italia, al cospetto di quel Carso che vide epiche gesta ed innumerevoli
sacrifici, vicino a quel mare che accolse le salme dei Marinai d’Italia».
Emanuele Filiberto di Savoia
11. La prima Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
11.9
305
UNO DEI SEICENTOMILA
BIAGIO MARROCCHI 1899 - 1918
«Voi andate verso quella sovrana battaglia, cantando. Eravate ieri fanciulli. La madre vi ravviava i capelli, accendeva la lampada della vostra
sera, rimboccava il lenzuolo dei vostri riposi. Vi ha chiamati la voce a cui
non si può disubbidire: e vi siete levati, e, a un tratto, avete sentito nella
gola un’altro respiro.
Eravate ieri fanciulli: e ci apparite oggi così grandi. Un momento dimentichiamo, i nostri fratelli maggiori, i confitti nella trincea, i veterani
istoriati di cicatrici, per non guardare se non voi, sopraggiunti, salvatori
imberbi»
GABRIELE D’ANNUNZIO
Altare della Patria - tomba del Milite Ignoto
Roma - Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II
Tutti avevano la faccia
del cristo nella livida
aureola dell’elmetto.
Tutti portavano l’insegna
del supplizio nella croce
della baionetta.
E nelle tasche il pane
dell’ultima cena e nella
gola il pianto dell’ultimo
addio.
(Parole di un combattente
ignoto scolpite nella Galleria
del Castelletto Tofane)
Gruppo scultoreo del Cristo
Aquileia (UD) - Cimitero degli Eroi
Vittorio Emanuele III
Gen. Luigi Cadorna
Emanuele Filiberto di Savoia duca d’Aosta
Gen. Armando Diaz
CAPITOLO XII
“O tempora!, o mores”
Il Fascismo e i giovani verolani negli anni trenta
313
Veroli, città ideale per gli studenti
316
Tutti in divisa! (fotografie da un album)
320
Pagelle
325
12.1
Il Fascismo e i giovani verolani negli anni trenta
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
1
935. Siamo nel periodo della guerra in Etiopia. I verolani partecipano
numerosi ed entusiasti alle manifestazioni per le vittorie delle truppe
italiane nella lontana Africa.
Le manifestazioni sono spontanee, e la piazza si gremisce ogni volta
che i bollettini di guerra del Maresciallo Badoglio annunciano la conquista di un piccolo o grande centro dell’Abissinia; ogni volta che uno dei Ras
fugge in disordinata ritirata, inseguito dalle truppe regolari del Regio Esercito,
della Milizia, degli Ascari, degli indigeni alleati. I verolani ascoltano attenti,
inneggiando ai soldati italiani, al Duce e al Re, i discorsi che i camerati di turno
pronunciano dal balcone della sede del Fascio di Combattimento, oggi abitazione della famiglia del sig. Aurelio Tonnina.
Intanto su alcune facciate di case e palazzi verolani appaiono le prime scritte; tra queste, una frase del Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani: «Ho
conosciuto i ciociari in guerra perché hanno combattuto con me. Essi sono soprattutto valorosi», frase che infiamma i verolani nel ricordo dei tanti Caduti
della prima guerra mondiale e del sacrifìcio di altri morti in terra d’Africa. Ma
non è la sola: «II credo del borghese è l’egoismo, quello del fascista è l’eroismo»;
«Credere, obbedire, combattere» ed altre.
È del 1935 l’inaugurazione della palestra comunale, un’opera a quel
tempo ritenuta grandiosa e forse unica nella provincia di Frosinone. Essa servirà l’Istituto Magistrale, il Ginnasio Franchi e il Liceo Scientifico. Primo insegnante di ginnastica in quella palestra sarà il prof. Vincenzo Sirizzotti, uomo
dalle grandi virtù umane, serio e responsabile professionista. Durante l’estate
del ‘35 sarà ancora il prof. Sirizzotti, con il prof. Giuseppe De Mattia e l’Insegnante Giuseppe Cristini, a dirigere il primo campeggio estivo, a livello comunale, organizzato dall’Opera Nazionale Balilla, l’istituzione voluta dal Fascismo
nel 1926, ma indipendente dal Partito Nazionale Fascista. Al campeggio parteciparono circa sessanta giovani tra i 10 e i 18 anni, i quali si accamparono sotto
le tende nella vicina frazione di Santa Francesca.
1936. Il 3 aprile 1936 si inaugura la nuova sede dell’O.N.B. in via
Gracilia, attualmente sede dei vigili urbani. Una massiccia partecipazione di
giovani e meno giovani darà grande risalto alla manifestazione.
La preparazione della gioventù è ora affidata al prof. Rosario Gennaro,
arrivato giovanissimo a Veroli, appena diplomato dall’Accademia del Littorio
quale insegnante di Educazione Fisica. Il prof. Gennaro, con l’entusiasmo della
età e la gran voglia di lavorare (doti che non gli sono venute mai meno), darà
nuova linfa all’organizzazione giovanile. A lui va il merito di aver saputo suscitare nei giovani l’entusiasmo per le attività ginnico sportive: crea con febbrile
313
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
314
impegno squadre di attrezzistica, pallacanestro (fino ad allora sconosciuta a
gran parte dei giovani), pallavolo e si dedica inoltre alle organizzazioni giovanili premilitari. Appaiono per la prima volta a Veroli le formazioni dei Balilla
Moschettieri e dei Balilla Tamburini, mentre si fanno più spettacolari i saggi
ginnici dei giovani, saggi che si svolgeranno ogni anno nel mese di maggio
presso la palestra dove attualmente sorge il campo di pallacanestro.
È di questo periodo il maggiore impulso dato alle cosiddette colonie «solari»,
che si svolgono durante l’estate ed hanno lo scopo di assistere, in turni di trenta
giorni, i bambini delle famiglie bisognose. (È bene ricordare che la istituzione
di tali colonie fu decisa dal Governo anche per cercare di prevenire la preoccupante recrudescenza di malattie a livello polmonare). In un clima di grande
letizia, i partecipanti si ritrovavano ogni mattina insieme; ricevevano la massima assistenza possibile, compresa la distribuzione dei pasti principali, e la sera
rientravano in famiglia dopo aver gioito per l’intera giornata ed essere stati
esposti alle benefiche radiazioni del sole. Da segnalare il magnifico gesto della
Marchesa Isabella Campanari, che mise a disposizione dell’O.N.B. il suo parco
giardino per lo svolgimento di queste attività.
1937. Siamo al periodo immediatamente seguente alla fondazione
dell’Impero. Si intensificano le attività paramilitari con i corsi «premilitari», i
quali si tengono il sabato pomeriggio. I giovani vengono addestrati all’uso delle
armi (sarà poi solo il moschetto), mentre alcuni frequentano corsi per radiotelegrafisti sotto la guida degli insegnanti proff. Sirizzotti e Luigi Marrocchi.
Durante l’estate il prof. Gennaro, sempre instancabile, organizza il primo campeggio mobile al quale partecipano numerosi ballila e avanguardisti.
Il prof. Gennaro accompagnerà la sua «truppa» da Veroli a Veroli, assistendo i
«suoi» ragazzi giorno per giorno, minuto per minuto, inculcando in essi l’amore per l’ambiente e quindi il rispetto dei luoghi attraversati durante le lunghe
marce giornaliere, ma anche il rispetto di se stessi e degli altri e un alto senso
della disciplina.
L’arrivo di quei giovani meravigliò gli abitanti dei centri raggiunti
(Trisulti, Collepardo, Alatri, ecc), dove furono accolti con grande affetto e viva
simpatia.
1938. L’O.N.B. passa alle dirette dipendenze del P.N.F. La sede di Via
Gracilia viene lasciata e consegnata all’organizzazione del Fascio Femminile,
organizzazione che meritò il più grande riconoscimento, non solo per l’opera
svolta fino ad allora, ma anche per quella che svolgerà nel periodo della seconda guerra mondiale in favore delle famiglie bisognose e dei militari inviati al
fronte. Per la gioventù maschile sarà un periodo di grande impegno. Si intensificano infatti i corsi premilitari, mentre dal nord Europa giungono notizie non
tranquillanti.
1939. Siamo alla vigilia dell’intervento dell’Italia nel conflitto della
seconda guerra mondiale. Alle sedi del P.N.F. vengono attribuiti i compiti della
protezione civile, in caso di attacchi aerei, in collaborazione con le amministrazioni comunali. I giovani non soggetti a obblighi militari (avanguardisti
della G.I.L.) sono chiamati ad espletare i servizi inerenti a tali compiti e la organizzazione di cui fanno parte prende il nome di U.N.P.A. (Unione Nazionale
Protezione Antiaerea). Sede dell’U.N.P.A. è il Comando dei vigili urbani che,
ininterrottamente, 24 ore su 24, sarà a disposizione ed in contatto telefonico
con la Prefettura per ricevere preavvisi o avvisi di avvistamento di aerei nemici
in azione di guerra.
Rintocchi a martello della campana della torre civica e del campanone
della cattedrale, saranno avvertimento per la popolazione affinchè trovi protezione nei rifugi predisposti allo scopo.
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
ANTONIO DAL LAGO
315
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
12.2
316
Veroli, città ideale per gli studenti
Veroli, giugno.
Veroli è la fedele di Roma. Centro della Ciociaria (la lode dei Ciociari
in guerra, fatta dal Duce, vi appare appena arrivate da Frosinone, agghindata
sempre più nella sua degna veste di capoluogo di Provincia), pura nella bontà
dell’aria, dell’acqua e del cuore della sua popolazione, profumata di tigli in fiore
e di rose, severa nell’antichità incontaminata delle sue stradette e delle sue case,
ricca di Chiese e di infiniti ricordi storici, essa è l’ideale quale centro di studi
sereni e severi.
In fondo, Veroli ha tutta una tradizione di studio e di patriottismo, che
le due cose sono inscindibili. Dai lontani padri Ernici, federati di Roma, caduti
per la grandezza e la potenza di Roma, ai trecento morti della Grande Guerra,
fino all’eroico capitano Mazzoli, due volte medaglia d’oro in Spagna, Veroli,
con i suoi combattenti e con i Caduti di oggi, fino all’ultimo Caduto, tenente
Fiorilli, a Gondar, essa solleva l’orifiamma della sua grandezza eroica.
E dalla Biblioteca Giovardiana, dove «impera» il bibliotecario attivo e dotto, don Guido, ai suoi Istituti di Cultura (il nuovo Liceo Scientifico,
presieduto dal prof. Di Stefano, l’Istituto Magistrale, presieduto dal professor
Lombardo, l’Istituto di Avviamento diretto dal prof. Tagliaferri, che è anche
Segretario politico di Veroli, il Convitto Franchi dei Figli dei ferrovieri ed il
Seminario Vescovile, dove fu nel 1538 istituita una delle più antiche e rinomate
Scuole di Diritto Civile e Canonico) si alza oggi ancora più possente che mai
la forza della gioventù studiosa, che in questo paese, tranquillo e senza divaghi
inutili, trova il raccoglimento vero per studiare e creare. In modo che, mentre
patriottismo e cultura si fondono insieme in perfetta aderenza, ancor più Veroli offre l’esempio che gli istituti di vera cultura — come già fu nel passato glorioso delle prime università italiane — dovrebbero essere istituiti a preferenza
in piccoli centri tranquilli e raccolti, molto vicini alla serenità della natura,
acciocché nulla possa distrarre le giovani menti dal severo raccoglimento e
dall’assiduo lavoro.
E che questo risultato sia stato raggiunto e sempre più sarà raggiunto da Veroli, lo prova il movimento che in città destano gli studenti, che qui
accorrono da tutte le parti d’Italia. Certo, ora, per gli esami, il movimento è
eccezionale e non fanno difetto gli adulti, i bravi combattenti di tutte le armi,
nelle gloriose uniformi (anche un pò stinte), come non fanno difetto le belle e
floride studentesse (presso Mazzoleni, fra un cono di gelato ed una discussione letteraria o scientifica, molto facilmente, si intessono reti che non saranno
facilmente infrante; cosa che non fa affatto male!) ma quello che più importa è
il movimento ordinario, regolare, durante l’anno scolastico, quando centinaia
1
II monumentino consiste in un cippo su cui sono incise le seguenti parole: «Ad Arnaldo Mussolini». Esso fu innalzato per ricordare le non comuni doti morali di Arnaldo, il quale
collaborò all’attività politica del fratello Benito e diresse il «Popolo d’Italia» dal 1922 fino alla
sua morte (dicembre 1931). Mussolini ricordò il fratello Arnaldo scrivendone la vita: «pagine
di semplicità e di efficacia, pagine di una malinconia senza scampo. (...) La fiducia nel fratello
è profonda, senza limiti» (BRUNO GATTA, Mussolini, Rusconi 1987). Scrive il Duce: «Arnaldo
fu un buono. Questa virtù della bontà era innata in lui. Buono, il che non significa debole, poiché
la bontà può benissimo conciliarsi con la più grande forza d’animo, col più ferreo adempimento
del proprio dovere. La bontà non è soltanto questione di temperamento, ma di educazione. (...) Il
fascismo prendeva con lui un altro aspetto e non soltanto quello, necessariamente duro, della
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
e centinaia di giovani son qui per seguire i corsi nei vari istituti, per prepararsi
in perfezione di spirito ed in sanità di corpo a servire la Patria col braccio e col
sapere.
Né, a parte la Biblioteca Giovardiana (ricca di cose preziose, di libri
rari, di incunaboli, di manoscritti, fra i quali il «Breviario» di San Luigi di Tolosa), manca ai giovani la ispirazione di cose grandi. Non è forse sempre presente
lo spirito del Cardinale Cesare Baronio, che, da Sora, qui venne per raccogliersi negli studi profondi, e fu poi creatore della imponente opera degli «Annuali
della Chiesa»? E non è accanto agli studenti lo spirito eroico dei Gracchi, che
un marmo prezioso, inciso, (nell’atrio del Municipio), ricorda quali Mecenati
di Veroli? E non è accanto al cuore dei giovani fascisti il ricordo del Pontefice
lontano che, quasi presago, dona a Veroli, alleata e fedele di Roma, il simbolo
del Fascio Littorio? E non sono vicini al cuore dei giovani i ricordi di Giovanni
Sulpizio, di Antonio Pagliari (Aonio Paleario), e del Vescovo Antonio Rossi?
Né altri grandi ricordi tacciono. Qua sono i ruderi del Castello dove
fu prigionerio Papa Giovanni X (l’incoronatore di Berengario e la vittima di
Marozia); qui Alessandro III, con i delegati della Lega Lombarda, discusse col
Vescovo di Bamberga, inviato di Federico il Barbarossa, i preliminari del Trattato di Costanza; qui Onorio III, e Federico II, nel 1222, prepararono la Quinta
Crociata (che doveva chiudersi col deprecato armistizio decennale): qui Carlo
Vili, si fortificò per preparare l’invasione del Regno di Napoli, forzando il passo
verso Sora, e qui furono Ludovico II dopo l’assalto a Benevento, e numerosi
pontefici e sovrani e principi ed uomini di scienza e di dottrina.
Né, si può dire, che «tutto ora tace». Anzi è il contrario, perché nella
nuova affermazione di tutte le forze vive ed agenti della Nazione, strette veramente in un Fascio intorno al suo Duce, Veroli, che è città nobilissima da oltre
dodici secoli, offre non solo il suo cuore rurale e sincero a tutta la gioventù,
che qui arriva da ogni parte d’Italia, ma offre anche un insegnamento di parsimonia, di severità di vita, di dedizione e di raccoglimento, come difficilmente
si potrebbe trovare in altri siti.
Dal piccolo spiazzo intitolato a Marconi, e che accoglie un monumentino ricordo ad Arnaldo Mussolini1ed a due eroici aviatori Caduti (fra i quali
317
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
318
il mio indimenticabile Carlo Quattrociocchi), accanto alla Chiesa dedicata a
Maria Salome, le cui ossa, secondo la visione di Tommaso e la tradizione, qui
riposano, salendo dalla piazza della chiesa di Sant’Andrea, che si sta riordinando con grande dignità artistica (è stata ritrovata una lapide che porta la fondazione di essa a quattordici e più secoli fa), lo sguardo contempla la vallata,
immensa, sottostante, che si stende, chiusa intorno da alte montagne, alcune
delle quali conservano ancora vasti ghiacciai candidissimi. Lo sguardo, girando, lentamente, si riposa in una gamma di verde e di azzurro: terra e cielo.
Spiccano le case e le torri di Frosinone, spiccano, abbarbicate quasi alle montagne, piccole borgate rurali e città dai nomi e ricordi gloriosi e il nastro bianco
delle strade serpeggia fra case e campi, come per legar tutto ed avvicinare tutto,
come per un più intimo contatto.
La forte gente ciociara contribuisce oggi, come sempre, con tutti i
mezzi alla resistenza della Patria nella grande lotta. Col braccio armato, col
lavoro dei campi, con la fiera certezza. E noi vogliamo additare anche questi
educatori delle varie istituzioni scolastiche di Veroli, quali contributori particolari, per le cure che essi dedicano ai loro alunni, in un momento eccezionale,
ma momento che incide fortemente nel carattere e nella vita degli studenti.
Essi saranno, in grandissima parte, in un vicinissimo domani, soldati ed, in un
domani vicino, uomini di lavoro e di opere del braccio e dell’intelletto. I giorni
di Veroli, in tal modo, saranno per essi i più cari nel ricordo, i più densi per
l’ammaestramento ricevuto, i più graditi ed utili per i ricordi che resteranno
indelebili nella loro vita.
Ecco come una città antichissima, apparentemente piccola e lontana
dalle grandi riunioni tentacolori urbane, può profondamente ed «ottimamente» assolvere, nella economia materiale e spirituale dell’Italia in armi, un compito meraviglioso.
rivoluzione. Il regime attraverso la sua opera si umanizzava: il calcolo politico cedeva il posto
all’impulso del cuore. (...) Potente Arnaldo non volle essere mai. Egli si sentiva come gregario e
come uomo un umile. Nel suo testamento balza questa parola evangelica. Nel suo ultimo discorso del 20 dicembre, ventiquattr’ore prima che il suo cuore cessasse di battere, non parlava ancora
degli umili verso i quali doveva dirigersi lo sforzo solidale di tutte le organizzazioni del regime?
La folla immensa che si raccolse dietro la bara di Arnaldo, non era essa la prova che l’anima del
popolo rispetta la forza, ma ama la bontà?». Dopo questa riflessione sulla bontà — scrive ancora
Bruno Gatta — Mussolini si congeda da Arnaldo con una dichiarazione in prima persona, che
ha anche un tocco di nascosta religiosità. Non ha fatto né farà testamenti di alcun genere, né spirituali, né politici, né profani. Inutile quindi cercarli. «Non ho che un desiderio: quello di essere
sepolto accanto ai miei, nel cimitero di San Cassiano. Sarei grandemente ingenuo, se chiedessi
di essere lasciato tranquillo dopo morto. Attorno alle tombe dei Capi di quelle grandi trasformazioni che si chiamano rivoluzioni, non ci può essere pace. Ma tutto quello che fu fatto non potrà
essere cancellato, mentre il mio spirito, ormai liberato dalla materia, vivrà, dopo la piccola vita
terrena, la vita immortale e universale di Dio». (BRUNO GATTA, Mussolini, cit.).
Né sarà un compito che cesserà con la guerra, ma sarà, invece, una
forte affermazione per il futuro.
Gli antichi Ernici di Veroli, sciolta la loro lega, rimasero fedeli e federati di Roma. Gli abitanti di oggi e di domani continuano e continueranno
in questa grandiosa fedeltà, che è la maggior gloria ed il migliore palladio di
Veroli città oggi del nostro cuore e sempre del nostro ricordo, in questa estate
così matura di eventi grandissimi e così significativa per le generazioni italiane
di domani.
Che, in parte, se contano alle volte i numeri più dei simboli, qui si
preparano.
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
ANGELO FLAVIO GUIDI
La fedele di Roma, antica Veroli, città ideale per gli studenti
in Il Messaggero, 14 giugno 1941
319
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
11.3 Tutti in divisa! (fotografie da un album)
320
321
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
322
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
323
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
XI Festa dell’Uva a Veroli
324
Anno scolastico 1940/41 - Nell’Istituto Filonardi di Veroli, Figli della Lupa e Piccole Italiane con
le Suore di Carità, loro maestre, posano per il fotografo.
Da qualche anno l’Istituto è stato trasformato dall’architetto Laura Fiorini in uno splendido
“Hotel Relais” che, all’ingresso, sottolinea in tre parole la nobiltà delle proprie origini: “Antico
Palazzo Filonardi”.
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
12.4
Pagelle
325
326
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
327
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
328
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
329
12. “O tempora!, o mores” Giuseppe Trulli
CAPITOLO XIII
La seconda Guerra Mondiale
Cronologia: 1940 - 1945
335
Quell’infausto 8 settembre
341
Cosa avrei fatto io l’8 settembre 1943
344
“È bastata un’ambulanza!”
346
Una rondine
347
Camicia nera
348
13.1
Cronologia: 1940 - 1945
1940
«... Pregare perché Dio benedica la nostra Patria e protegga i
figli d’Italia che valorosamente combattono e insieme operare
con serena fortezza, ciascuno al proprio posto, compiendo il
dovere assegnato dalla pubblica autorità, in ispirito di sacrificio e di perfetta disciplina».
EVASIO COLLI
Direttore Generale dell’Azione Cattolica
L’Italia entra in guerra
Firma dell’armistizio tra Francia e Germania
Firma dell’armistizio tra Francia e Italia
Rodolfo Graziani è Governatore della Libia
Inizio dell’offensiva italiana nell’Africa Settentrionale
Inizio della campagna di Grecia
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
10 giugno
22 giugno
24 giugno
1 luglio
13 settembre
28 ottobre
335
1941
«... In riconoscimento del valore dimostrato dalle truppe italiane, il Comando inglese, oltre all’onore delle armi, concede
che tutti gli ufficiali di qualunque grado o arma o corpo conservino le proprie pistole...».
Amba Alagi, 19 maggio 1941
19-21 gennaio
21 marzo
28-29 marzo
6 aprile
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
18 aprile
23 aprile
17 maggio
22 giugno
336
Offensiva britannica nell’Africa Orientale Italiana
Truppe britanniche e australiane conquistano Giarabub
Battaglia di Capo Matapan
Addis Abeba occupata dalle truppe britanniche
Inizia la campagna dei Balcani
Resa dell’esercito jugoslavo
Armistizio tra la Grecia e l’Asse
All’Amba Alagi resa di Amedeo di Savoia agli inglesi
Le truppe tedesche invadono l’URSS
Italia e Romania dichiarano guerra all’Unione Sovietica
1942
«... Poi crollò la forza di resistere ... La colpa delle disfatte subite dalle unità italiane davanti ad El Alamein non è dei soldati.
Il soldato italiano era volenteroso, generoso, buon camerata ...
Bisogna dire che le prestazioni di tutte le unità italiane, ma
specialmente delle unità motorizzate, superararono di molto
ciò che l’esercito italiano ha fatto negli ultimi decenni. Molti generali e ufficiali suscitarono la nostra ammirazione dal
punto di vista umano come da quello militare...».
ROMMEL
Inizio dell’offensiva di Rommen nell’Africa Orientale
Muore a Nairobi in prigionia Amedeo di Savoia
Le forze dell’Asse occupano Tobruk
Le forze italiane conquistano Giarabub
Vittoria degli inglesi a El Alamein
Sbarco americano in Marocco e Algeria
Offensiva sovietica sul Don
Inizio della ritirata dell’ARMIR
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
21 gennaio
3 marzo
21 giugno
15 luglio
4 novembre
8 novembre
19 novembre
11 dicembre
337
1943
«... Tra l’alba del 9 settembre ed il 13 settembre si compì intera
la tragedia del popolo italiano. Sono gli italiani, lasciati soli
a se stessi, a dover fronteggiare gli eventi... Nella realtà tragica di quella data esiste solo la pietà della Patria dinanzi alla
tragedia dei suoi figli esposti alla violenza e all’insulto dello
straniero, fosse esso l’alleato che non era più tale o il nemico
che non era più tale».
GIUSEPPE CIARRAPICO
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
23 gennaio
31 gennaio
12-13 maggio
11 giugno
10 luglio
19 luglio
25 luglio
338
Le truppe italiane abbandonano Tripoli
Resa di Von Paulus a Stalingrado
Resa delle forze dell’Asse in Tunisia
Resa di Pantelleria
Truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia
Bombardamento di Roma
II Gran Consiglio del Fascismo vota la sfiducia a Mussolini,
che è arrestato e sostituito da Badoglio
3 settembre
A Cassibile firma dell’armistizio tra il governo italiano e gli
alleati
8 settembre
II maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower rendono
noto l’armistizio
9 settembre
I sovrani e il governo italiano abbandonano Roma e riparano a Brindisi
10 settembre
Le truppe tedesche occupano Roma
12 settembre
Mussolini viene liberato a Campo Imperatore dai tedeschi
13-22 settembre Battaglia ed eccidio di Cefalonia
18 settembre
Da Monaco Mussolini anuncia la costituzione della Repubblica Sociale Italiana
1944
«... Il senso della storia chiede per quei giorni la pietà perché
di quella tragedia, che fu la tragedia di tutti gli italiani, non si
voglia dimenticare il sacrificio di quanti lo soffrirono».
GIUSEPPE CIARRAPICO
6 giugno
10 settembre
Processo di Verona
Sbarco ad Anzio della V armata americana
Bombardamento dell’Abbazia di Montecassino
Attentato di via Rasella
Eccidio delle Fosse Ardeatine
Le truppe alleate iniziano l’offensiva contro la linea Gustav
Gli alleati entrano a Roma
Vittorio Emanuele III nomina Umberto II luogotenente generale del regno
Le forze alleate sbarcano in Normandia
Inizio dell’offensiva alleata contro la linea gotica
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
8-10 gennaio
22 gennaio
14-15 febbraio
23 marzo
24 marzo
12 maggio
4 giugno
5 giugno
339
1945
«... In fondo il solco che ancora divide gli italiani non è quello creatosi con la guerra civile, ma quello determinato dalla
“inutile strage” perpetrata a guerra conclusa; quando cioè,
anziché identificare e portare di fronte alla giustizia, militare
o civile non ha importanza dal momento che allora vigeva la
pena di morte, coloro che si erano macchiati di crimini nefandi, si è preferito sfogare l’odio indiscriminatamente, in un’orgia
di sangue, in una vera e propria “strage degli innocenti”».
ALBERTO GIOVANNINI
25 aprile
27 aprile
28 aprile
Inizio dell’insurrezione partigiana a Milano
II CLNAI assume i poteri civili e militari
Mussolini è catturato dai partigiani a Musso (Como)
Mussolini e Claretta Petacci vengono fucilati a Giulino di
Mezzegra
Strage di Rovetta. Muore Bruno Fraja
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
Non gridate più
340
Cessate di uccidere i morti,
non gridate più, non gridate
se li volete ancora udire,
se sperate di non perire.
Hanno l’mpercettibile sussurro,
non fanno più rumore
del crescere dell’erba,
lieta dove non passa l’uomo.
GIUSEPPE UNGARETTI
Quell’infausto 8 settembre
«To Badogliate», «badogliare». Questo verbo, coniato dagli angloamericani nel 1943 dopo l’ignobile voltafaccia italiano dell’8 settembre, starebbe a significare, secondo l’Oxford dictionary, «tradire scioccamente», «tradire
tanto per tradire», con una sorta di voluttà per il tradimento.
«La guerra continua» aveva dichiarato il maresciallo Pietro Badoglio
nel radiomessaggio del 25 luglio, allorché era divenuto capo del governo in
seguito al vergognoso arresto di Mussolini a Villa Savoia; ed il 27 aveva telegrafato ad Hitler confermandogli che l’Italia avrebbe fatto sino in fondo il proprio
dovere «nello spirito dell’alleanza». Queste assicurazioni di fedeltà vennero,
durante i 45 giorni, più volte ripetute ai tedeschi sia da esponenti del governo e
dello Stato Maggiore, sia dallo stesso Badoglio e persino dal re. Proprio poche
ore prima della proclamazione dell’armistizio — riferisce Carlo De Biase nel
suo «l’otto settembre di Badoglio» — Vittorio Emanuele III ricevette al Quirinale il nuovo incaricato d’affari tedesco Rudolph Rahn, al quale rivolse le
seguenti parole: «Dica al Fùhrer che l’Italia non capitolerà, mai, è legata alla
Germania per la vita e per la morte».
Mentre il re faceva questa falsa dichiarazione (ignorando peraltro, perché Badoglio non l’aveva informato, che l’annuncio dell’armistizio era ormai
imminente) le truppe anglo-americane si apprestavano a sbarcare a Salerno.
Era l’epilogo di una trama vile ed oscura che aveva preso le mosse prima ancora della caduta di Mussolini e che aveva avuto per protagonisti personaggi del
mondo industriale, di ambienti vaticani, ed anche della casa regnante, come
la «principessa-socialista» Maria José. Padri spirituali di questa trama, oltre a
Grandi (che rimarrà deluso nelle sue aspettative di successione al duce), Vittorio Emanuele e Badoglio, il ministro della Real Casa Acquarone e il capo di
Stato Maggiore Generale Ambrosio, affiancati successivamente da una serie di
comprimari quali il capo di S. M. dell’Esercito Roatta, il ministro badogliano
degli Esteri Guariglia, quello della Guerra Sorice, diversi ammiragli massoni
di Supermarina, i generali Carboni, Castellano e Zanuzzi. Una trama costellata
di infingimenti, reticenze, menzogne, che costerà lutti e rovine all’Italia trasformata in campo di battaglia per eserciti stranieri e, quel che è più doloroso,
comporterà una sanguinosa guerra civile.
«Se il re e Badoglio si fossero rivolti a me direttamente — ebbe a dire
nell’ottobre ‘43 Hitler a Graziani — ed esponendo i loro motivi mi avessero comunicato l’impossibilità per l’Italia di continuare a combattere al mio fianco, io
l’avrei capito ed apprezzato in ogni momento... Avremmo trovato una via leale
ed utile per permettere agli italiani di ritirarsi dall’alleanza». Sincera o meno,
l’affermazione di Hitler, resta il fatto che il re, Badoglio, Acquarone ed Am-
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
13.2
341
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
342
brosio non vollero neppure tentare questa via leale; piuttosto che chiedere un
armistizio che li avrebbe messi fuori gioco, preferirono trescare con il nemico
sperando di poterne diventare alleati e salvare così le loro posizioni. «Per Badoglio — riassunse ironicamente questi maneggi il maresciallo Alexander — è
giunto il momento di accorrere in aiuto dei vincitori...». E Kesselring, dal canto
suo, rilevò che il tradimento compiuto ai danni delle forze armate germaniche
«rimarrà sempre come una macchia indelebile su coloro che dirigevano allora
i destini d’Italia».
Mentre preparava il tradimento, Badoglio non riusciva a nascondere
la paura folle che aveva di eventuali reazioni tedesche. «Era talmente ossessionato — c’informa lo storico Attilio Tamaro — che diceva e ridiceva ai suoi collaboratori: «Finiremo tutti così». E faceva il segno della gola tagliata». I «piazzisti della resa» (prima i diplomatici Berio e d’Ajeta, poi i generali Castellano
e Zanussi) avevano già da tempo contattato gli «alleati», ma il maresciallo, per
«non allarmare i tedeschi», si guardava bene dal far avvertire i comandi d’armata di ciò che bolliva in pentola, e cinicamente preventivava mezzo milione
di perdite tra le nostre truppe nei Balcani. Nella sua presunzione, s’illudeva che
gli angloamericani avrebbero accolto il suggerimento di effettuare lo sbarco di
«almeno 15 divisioni» tra Civitavecchia e La Spezia, senza rendersi conto, lui
grande stratega, dell’impossibilità di un’operazione del genere a tanta distanza
dalle basi logistiche del Nord Africa, e senza supporre che in tutta l’area del
Mediterraneo gli «alleati» avevano soltanto 14 divisioni, di cui appena 6 pronte
per l’impiego.
Quando Castellano (il quale, a detta degli americani, più che un generale aveva l’aspetto di un proprietario di ristorante di Soho o dell’Est-side di
New York) riferì i «consigli» di Badoglio ed offrì la cobelligeranza italiana, per
poco non gli risero in faccia. «Resa senza condizioni», fu la secca risposta. Il
che non impedì all’emissario badogliano di spiattellare a quelli che erano ancora formalmente nostri nemici tutti i segreti militari che gli vennero richiesti.
Ed altrettanto fece, di lì a poco, il secondo piazzista della resa, generale Zanussi.
L’andirivieni di Castellano tra Roma e l’alto comando alleato si concluse il 3 settembre a Cassibile con la firma d’un documento che — come nota
l’antifascista Brusasca — autorizzava i vincitori perfino a considerare scomparso, ove fosse loro piaciuto, lo Stato italiano. Castellano firmò per delega di
Badoglio; Eisenhower si rifiutò di apporre il suo nome sull’atto conclusivo di
quello che considerava «uno sporco affare» e in sua vece fece firmare il generale Bedell Smith.
Gli avvenimenti seguenti potrebbero costituire il cannovaccio d’una
farsa se non avessero avuto le drammatiche conseguenze che ebbero: il segreto mantenuto fino all’ultimo dagli anglo-americani, per sfiducia verso i «neoalleati», sulla data di proclamazione dell’armistizio e del conseguente sbarco
a Salerno; i patetici tentativi di Badoglio di ottenere una «proroga» di alcuni
ALDO GIORLEO
Quell’infausto 8 settembre
in Secolo d’Italia, 8 settembre 1989
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
giorni; il mancato lancio su Roma dei paracadutisti americani a causa dei tentennamenti e dell’impreparazione dimostrati dagli italiani; l’imposizione alla
flotta di consegnarsi agli inglesi a Malta; l’ingloriosa fuga dei reali e dello Stato
Maggiore da Pescara senza neppure avvertire i membri civili del governo; il
criminale abbandono delle unità dislocate in Italia e al di là dei confini, alle
quali era stato soltanto impartito l’equivoco ordine di «resistere ad eventuali
attacchi da qualsiasi provenienza».
Il risultato non poteva essere che il caos, lo sfacelo più completo del
nostro esercito. E così fu. Ricordo bene quegli infausti giorni. Diciassettenne,
abitavo a Fiume, ed ebbi modo di assistere ad uno spettacolo avvilente: migliaia di soldati della II armata laceri, scalzi, varcavano il ponte sull’Eneo che
divideva la città italiana da Sussak, incalzati da ragazzini jugoslavi di 13-14
anni, con la stella rossa, che li sbeffeggiavano dopo aver loro tolto le armi. Che
umiliazione! Che vergona!
E fu per reagire a tanta umiliazione, a tanta vergogna, per ribellarsi
al tradimento, che parecchi combattenti italiani, sebbene «non fascisti», come
mio padre ufficiale di carriera, decisero di mantenere fede all’alleanza con i
tedeschi. Per lo stesso motivo moltissimi giovani abbandonammo le aule scolastiche, le fabbriche ed i campi e ci arruolammo volontari nelle forze armate
della Rsi.
Pur essendo consapevoli che le sorti della guerra erano ormai irrimediabilmente compromesse, non ci restava altro da fare che combattere. Era
l’unico modo per riscattare l’onore d’Italia.
343
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
13.3
344
Cosa avrei fatto io l’8 settembre 1943
A essere sincero, non so cosa avrei fatto io se, l’8 settembre, mi fossi
trovato al posto di Badoglio. Forse avrei fatto quello che fece Badoglio. Ma
potendo parlarne da storico, cioè col facile e poco meritorio «senno del poi»,
credo di sapere che cosa avrei dovuto, e potuto, fare. La cosa più semplice di
questo mondo. Avrei detto ai tedeschi: «L’Italia non è più in condizione di continuare la guerra. Quindi ho mandato al comando alleato un plenipotenziario
a chiedere l’armistizio. Non vogliamo passare nel loro campo. Vogliamo arrenderci perché non ce la facciamo più. Sappiatelo».
Non credo che queste siano fantasie infantili perché qualcuno lo fece:
un certo Maresciallo Mannerheim che, dopo aver condotto il suo piccolo esercito (finlandese) alla riconquista della terra (la Carelia) strappatagli due anni
prima con la violenza dalla Russia, disse all’alleato tedesco ciò che, secondo il
mio facile e poco meritorio senno del poi, avrebbe dovuto dirgli Badoglio: “Ci
arrendiamo perché non abbiamo di che resistere alla schiacciante forza nemica. Richiamate in patria le truppe che ci avete mandato, a cui forniremo tutti i
mezzi per lasciare il nostro territorio”. E così fu.
È vero che le truppe tedesche non occupavano la Finlandia così massicciamente come quelle che occupavano l’Italia. Però mi chiedo che cosa in
Italia, se si fosse comportata come la Finlandia, sarebbe accaduto di diverso da
ciò che accadde: un Paese trasformato in campo di battaglia fra due eserciti di
occupazione che ci trattavano con lo stesso disprezzo.
Cosa sarebbe avvenuto a Cefalonia se la nostra guarnigione avesse ricevuto, come tutte le altre truppe dislocate sui vari teatri di guerra stranieri,
l’ordine di arrendersi? La resa non disonora; il tradimento, sì. E fu per evitare
di passare per traditori che quei poveri ragazzi si lasciarono massacrare.
Perfino i russi rispettarono, per il suo contegno, la Finlandia, e le fecero un trattamento d’insolito favore. Noi, per il contegno nostro, non perdemmo soltanto la guerra che continuò a passare sul nostro corpo. Perdemmo
anche la faccia. La quale conta. Conta anche per i singoli italiani, che quando
hanno a che fare con gli stranieri, debbono compiere sforzi erculei per rimontare la disistima, la diffidenza, il sospetto da cui siamo, anche, come individui,
circondati.
Italiani brava gente ce lo diciamo tra noi e per noi. Per gli altri e tra
gli altri, noi siamo soltanto degli inaffidabili doppiogiochisti. Mi pare di aver
già raccontato (ma nulla, diceva Missiroli, è più inedito di ciò che è stato già
stampato) che nel 1938, cioè in pieno idillio italo-tedesco, un ufficiale della
Wehrmacht (qualcuno dice che era Brauchitsch, ma questo non è assodato) fu
invitato da un club londinese di reduci della prima guerra mondiale, di cui an-
che Brauchitsch era reduce, a un pranzo di camerateria. Alla fine del quale gli
fu chiesto chi, secondo lui, avrebbe vinto la prossima guerra (la quale scoppiò
l’anno dopo). Risposta: “Io non so chi vincerà la prossima guerra. Ma so con
sicurezza chi la perderà: chi avrà come alleati gli italiani”. Successe un mezzo
putiferio di note diplomatiche, di cui naturalmente la nostra stampa non fece
parola.
Questa è purtroppo la nomea che ci accompagna: frutto di tutti gli 8
settembre di cui la nostra storia è purtroppo lardellata.
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
INDRO MONTANELLI
da Il Giornale, 22 ottobre 1999
345
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
13.4
346
“È bastata un’ambulanza!”
Una giovinezza arrembante a caccia del potere, poi vent’anni di trionfi,
di adulazione, di comando: una vita piena, vissuta senza un attimo di respiro,
da edonista che gusta il potere come un piatto prelibato.
Le folle immense, cariche di passione popolare, in attesa per ore in
Piazza Venezia; il calore collettivo del consenso, la sua voce; un uomo che respira a pieni polmoni la sua potenza, la risposta della gente, come un rombo di
un tuono d’estate, la magia che lentamente si consuma, l’erba voglio che cresce
impudica nel suo giardino, l’esaltazione collettiva, l’Italia che è Mussolini e che
è l’italia.
Rapido, arriva il declino. La stella politica si oscura, il condottiero si
trascina a rimorchio degli avvenimenti e l’ombra della sconfitta diventa un’ombra di rassegnazione.
Il Gran Consiglio del fascismo liquida Mussolini, e il re. Senza pudore,
gli da il colpo di grazia.
Il regime crolla di schianto: uno solo dei fedelissimi, Manlio Morgagni, presidente della Stefani, si spara, ma quel colpo non lo sente nessuno. Un
gesto dignitoso in tanto squallore. Una sola vittima per la disfatta del fascismo,
per un’estate maledetta. Dino Grandi ha scalzato il Duce, il re lo ha silurato, la
piazza lo ha seppellito. Di colpo, gli italiani si scoprono tutti antifascisti.
«A far sparire dalla scena vent’anni di storia d’Italia - scriverà qualcuno - è bastata un’ambulanza: quella che ha portato via Mussolini da Villa
Savoia».
MARCO INNOCENTI
Mussolini a Salò
Mursia Editore 1996
13.5
Una rondine
Questa morte di Mussolini, precipitata con l’incalzare delle ore quasi all’improvviso, senza alcuna formalità rituale, ... questa morte forse attesa e che ora
finalmente è venuta, accanto alla giovane donna che lo ama e muore per lui, è
soffusa dalla storia di un alone di romantica e tragica leggenda. I corpi, caricati
su un camion, insieme con quelli dei gerarchi fucilati un’ora dopo a Dongo, in
riva al lago, sono condotti a Milano, gettati per terra a piazzale Loreto e poi
appesi al gancio del famoso distributore di benzina. Una folla impietosa e crudele, stupida nella sua bestianza, li calpesta, li sfigura, li insulta. E li martirizza.
Anche la sepoltura tarda dodici anni per paura del culto popolare dei morti.
Ora Mussolini riposa nel silenzio e nella pace di Dio, «il Dio che atterra e
suscita, che affanna e che consola». Là, nel cimitero di San Cassiano, accanto
alla tomba di Bruno. Sono passati tanti anni ed anche per lui è venuto il tempo
della Storia.
BRUNO GATTA
Mussolini, Rusconi Editore 1988
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
« ... La morte mi è diventata amica, non mi spaventa più. La morte è una grazia
di Dio per chi ha sofferto troppo. Stamattina nella mia camera si è smarrita una
piccola rondine. Volava, volava disperatamente, finché cadde esaurita sul mio
letto. Allora la presi, cauto, per non spaventarla. La tenevo nelle mie mani, una
piccola creatura tremante. La accarezzai e, pian piano si calmò e osò guardarmi.
Andai alla finestra, aprii la mano. Essa, ancora stordita, non capì subito, guardava intorno; poi aprì le ali, e, con un grido di gioia, volò verso la libertà. Non
dimenticherò mai più questo grido di gioia. Per me non si apriranno le porte se
non per la morte ... ».
347
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
13.4
348
Camicia nera
349
13. La seconda Guerra Mondiale Giuseppe Trulli
Copertina dell’opuscolo “La terra del Duce”
CAPITOLO XIV
Persone speciali
Una marchesa: Isabella Campanari
353
Un vescovo: Mons. Francesco De Filippis
357
Un podestà: Giuseppe Scaccia Scarafoni
361
Uno scrittore: Luigi Alonzi (Luigino)
364
Un professore: Luigi Bisleti
370
Un arcivescovo: Fabio Bernardo D’Onorio
374
14.1
Una marchesa: Isabella Campanari
D
e Valore.
La cappella deve essere stata innalzata, su disegno dello scultore Ernesto Biondi, intorno al 1910, anno in cui la marchesa richiese al comune di
Veroli un’area fabbricabile adatta allo scopo.
L’esterno, se si fa eccezione per lo stemma dei Torti-Nocchiaroli posto
in alto (Rosa Torti-Nocchiaroli era la moglie del marchese Francesco Maria
Campanari, antenato della marchesa Isabella), esclude ogni motivo decorativo
e non si integra nell’ambiente circostante, isolandosi in una dimensione che
va al di là del tempo e dello spazio e suggerendo il senso dell’eternità, mentre i
quattro Geni alati, posti alla base della cupola, immobili ed impenetrabili nella
profondità dei loro pensieri, non si sovrappongono, come sculture, all’architettura della cappella, ma si fondono con questa divenendo un corpo unico, massiccio ed imponente. Il tutto genera nel visitatore uno stato d’animo di grande
tristezza.
Quando si entra, l’atmosfera è diversa: non si avverte il buio della morte, ma si prova una incredibile pace interiore. Si sente evidente il ricordo, e
forse il rimpianto, di una vita passata troppo in fretta, ma traspare anche la
certezza di un’altra vita che non passerà: quella illuminata dalla luce che fuga
le tenebre e che è la vera vita degli uomini. Sono proprio le sculture del Biondi,
poste di fronte e ai lati dell’ingresso a compiere il miracolo. Egli ha lasciato
nella Tomba Campanari forse alcune delle sue opere più belle; certamente le
meno conosciute.
Ernesto Biondi nacque a Morolo, vicino a Frosinone, il 30 gennaio
1855. Appena quindicenne, deciso ad affermarsi nel campo dell’arte, lasciò il
suo paese per conoscere, a Roma, i grandi della scultura contemporanea. Si
iscrisse all’Accademia di San Luca, ma “presto si stancò dell’Accademia e l’Accademia, altrettanto presto, si stancò di lui” (ANTONIO BIONDI). Divenne un
autodidatta e, grazie alle amicizie dello zio paterno Don Pietro, prima cappellano nella chiesa di Sant’Agnese a piazza Navona e poi beneficiato nella basilica
di San Pietro, si impose all’attenzione degli scultori che operavano a Roma.
Nelle sue opere conservò sempre “la genuinità della sua fede religiosa,
sentita e vissuta nell’adolescenza” e predilesse i temi a sfondo sociale (Povero
Cola, Povera gente, Le misere recluse, ...); a tutte egli “era solito assegnare un
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
ue grandi leoni incisi sulla pietra calcarea che si inchinano dinanzi ad una campana, precedono l’ingresso della monumentale cappella funeraria fatta costruire dalla marchesa Isabella
Campanari per sé e per i suoi nel cimitero di Veroli. Sui leoni,
il motto dello stemma dei Campanari: Honor et Virtus, Onore
353
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
354
messaggio per la giustizia, per la dignità, per la redenzione dell’uomo” (ANTONIO BIONDI). Fra quelle più note di esse, il San Francesco d’Assisi e, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma, i famosissimi Saturnali, che vinsero
il Grand Prix (Primo premio) nella Esposizione Universale di Parigi. Dopo
un’agonia durata 28 mesi, si spense a Roma il 5 aprile 1917.
La scultura posta di fronte all’ingresso della cappella, rappresenta la
Deposizione. Un’analoga opera del Biondi si trova a Buenos Aires ed è conosciuta con il titolo “Le Marie al sepolcro”. A me sembra che la scultura di Veroli
sia meglio riuscita per la composizione dell’insieme, più articolata, e per una
maggiore espressività dei volti. Anche una certa plasticità dei piani, taglienti e
sfaldati, può essere il segno di un progressivo abbandono da parte del Biondi
del pittoricismo che caratterizza molte delle sue opere. In basso, sono riportate
alcune parole ispirate al Prologo del Vangelo secondo Giovanni: “... ed Egli
era la luce e la Luce era la Vita degli uomini”. L’altra scultura, a sinistra di chi
entra, rappresenta forse il sonno dei giusti e si riferisce al felice destino di chi
è vissuto rettamente procedendo sulla via del bene e che, dopo la morte, godrà
del riposo eterno nella pace di Dio. La coppia che si tiene teneramente per
mano, adagiata tra il verde delle palme, si identifica con il marchese Giovanni
Campanari e sua moglie Luigia Forti, padre e madre della marchesa Isabella.
Al di sotto di questi è una iscrizione tratta dal Salmo 92 (91), Cantico del Giusto, vv.13,14: “II giusto fiorirà come (la) palma, crescerà come (il) cedro del
Libano”. Anche questa iscrizione è la prova dell’interesse di Ernesto Biondi per
la Bibbia, che lesse fin dalla sua adolescenza.
In questo secondo gruppo la plasticità si fa più morbida e, direi, più
“rotonda”, contribuendo ad accrescere il senso di totale abbandono al Signore,
in una pace senza fine. In particolare, il viso purissimo della marchesa Luigia,
che per alcuni versi ricorda la spiritualità della scultura toscana del ‘400, riflette pienamente la mitezza del suo carattere e la limpidezza di una vita improntata al timor di Dio e dedicata al bene del prossimo.
Il marchese Giovanni Campanari, nato a Veroli nel 1839, “tenne le
sorti del nostro comune per ben quattro volte e per lo spazio complessivo di
venti anni. Deputato al parlamento nazionale nella XII legislatura e due volte
rappresentante del mandamento elettorale verolano alla deputazione provinciale di Roma, fu tra gli uomini rari che hanno lasciato un imperituro ricordo
della loro opera alta e disinteressata. Fu amico di Ruggero Bonghi, di Tommaso Tittoni e di Giovanni Giolitti, che lo ebbero caro e ne lodarono il cuor
fermo, la rettitudine, la magnanimità dell’animo” (ACHILLE REALI).
Proprio di fronte alle figure dei suoi genitori, è la statua della marchesa
Isabella Campanari, capolavoro del Biondi. Nata a Roma il 23 febbraio 1864,
morì a Veroli, nel suo fastoso palazzo, il 25 gennaio 1949.
Dotata di un carattere forte e deciso, non sempre fu in sintonia con le
idee del padre che, come si è visto, era uomo integerrimo e di grande statura
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
morale. Sposò il Sig. Vincenzo Sparagane, di Pontecorvo, ma il matrimonio si
rivelò subito un fallimento e perciò i due si separarono.
Bella e ricca, intelligente ed esuberante, con tanta voglia di conoscere
il mondo, trascorse gli anni migliori della sua vita fuori Veroli, specialmente
a Napoli, dove si fermò a lungo. Qui, in viale Elena, comprò un appartamento
lussuoso e, nel suo magnifico salotto, ricevette la migliore aristocrazia partenopea. Nel giro delle sue conoscenze c’era il principe di Napoli, poi re Vittorio Emanuele III, e Matilde Serao, che divenne sua grande amica. Gli incontri
mondani e culturali, i concerti, l’opera al teatro San Carlo, i bei vestiti (preferibilmente rossi) e i gioielli (specialmente i rubini), fecero parte della vita brillante che la raffinata e seducente marchesa Isabella condusse nella incantevole
città del Vesuvio.
Dopo la morte del padre dimorò più stabilmente a Veroli. Costruì la
propria cappella funeraria e vi collocò, oltre alle due sculture di cui si è parlato,
il suo ritratto a figura intera, completamente nuda e adagiata su un tappeto di
rose.
Dovette fare una certa impressione, allora, la visione di quella statua,
così “sfacciatamente” profana, collocata nel cimitero di un piccolo centro come
Veroli! Si può immaginare anche l’imbarazzo dell’austero vescovo del tempo,
mons. Fantozzi, che invitò la marchesa a provvedere, con qualunque rimedio,
al rivestimento dell’insolito simulacro. La cosa dovette certamente dispiacere
alla nobildonna e creò qualche problema tecnico allo scultore, come talvolta
nel passato era accaduto ad artisti più famosi del Biondi.
Come tutti sanno, anche i nudi dipinti nel Giudizio universale di Michelangelo suscitarono proteste a non finire per la loro palese nudità e il celebre affresco rischiò di essere distrutto. Per fortuna ciò non avvenne, ma toccò
a Daniele da Volterra, già seguace di Michelangelo, l’ingrato compito di coprire
le parti “incriminate” con adeguati panneggi. E lui, il paziente Daniele, passò
alla storia con il soprannome di ... Braghettone. Che dire poi dell’audacia profanatrice del Bernini nel monumento al pontefice Alessandro VII, in San Pietro? Intorno al papa senese, rappresentato in ginocchio, orante, ci sono quattro
figure allegoriche di Virtù, e, tra queste, la Verità, raffigurata nuda dagli artisti
di ogni tempo. Valentino Martinelli, in un suo libro sul Bernini, scrive che
“Innocenzo XI, salito al trono pontificio nel 1676, con un nuovo programma
di austerità e di reazione al lusso dei costumi e alla mondanità della corte,
preoccupato dei “popolari sussurri”, aveva, tra l’altro, ordinato che la nuda Verità fosse comunque rivestita; che, come scriveva un contemporaneo, era una
“Verità che piaceva troppo”. Bernini la coprì con una veste metallica, tinta di
bianco, controvoglia, “a prezzo di inesplicabile pensiero e fatica”.
Nel caso della marchesa Isabella, per esaudire la richiesta di mons.
Fantozzi e per zittire il bofonchiare dei moralisti intransigenti (ma anche il
mormorare di quelli che pensavano esattamente il contrario), bastò aggiunge-
355
re altre rose a quelle del tappeto su cui la marchesa si adagia e collocarle dove
era strettamente necessario. Come nelle sculture precedenti, anche l’iscrizione
posta alla base del monumento alla marchesa, “Fu soave la sua voce, fu bello il
suo aspetto”, deve essere stata ispirata dalla Bibbia ed esattamente dal Cantico
dei Cantici.
Ma lo scultore, a mio avviso innamoratissimo della sua splendida modella, non ha voluto esaltare soltanto la bellezza di un corpo perfetto. Egli ha
voluto fissare nel candore del marmo, e vi è riuscito in pieno, l’eleganza di un
gesto, la nobiltà di un’atteggiamento, la dignità di una persona. E nel viso della
marchesa Isabella Campanari, per chi sa coglierli, ci sono anche la consapevolezza del tempo fuggito, il ricordo delle rose che ebbero tutto il loro profumo,
il dolore delle spine che non mancarono.
A noi, che oggi la guardiamo stupefatti, manca la soavità della sua voce.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
GIUSEPPE TRULLI
356
Un vescovo: Mons. Francesco De Filippis
Mons. Francesco De Filippis, nato il 12 settembre 1875 a Gagliano del
Capo (Lecce) fu eletto Vescovo di Veroli il 19 marzo 1931.
Avventuroso e solenne, per l’accoglienza la sera del 7 agosto, l’ingresso,
che per le note circostanze politiche doveva essere in forma strettamente privata. L’arrivo del nuovo Vescovo era stato tenuto segreto, ma nel pomeriggio
di quel giorno era trapelato che gli Officiali di Curia mons. Giovanni Tarquini
e mons. Pietro Quattrociocchi erano partiti in vettura per Roma a rilevarlo. In
realtà mons. De Filippis partì dalla Capitale nel pomeriggio, ma per l’auto “in
panne”, così si disse, giunse a Veroli intorno alla mezzanotte.
Le cronache locali riportano tra l’altro: “Piazza Palestrina, Piazza Duomo e Piazza Plebiscito con le vie adiacenti rigurgitavano quella sera di tanta
gente in attesa. Per l’occasione la facciata dell’Episcopio presentava una visione
fantasmagorica per l’opera geniale dell’ing. Giuseppe Papetti e del pittore Rodolfo Mauti, che avevano trasformato la linea architettonica cinquecentesca
del palazzo in costruzione gotica con pietre rettangolari scalpellate, eleganti
bifore alle finestre con relative vetrate, archi a sesto acuto, torrione merlato con
pennone, torcieri in ferro battuto sulla facciata ornata dello stemma di Veroli
e delle Città Confederate. Il piazzale antistante si presentava come un giardino
diviso da aiuole fiorite con autentici ruderi arcaici e col tradizionale pozzo... Il
Presule giunse tra noi tacitamente, quasi clandestinamente; guardò sorpreso lo
spettacolo di luci, raccolse l’applauso di una folla in festa e tutti benedì per la
prima volta; poi in breve tutto tornò nel silenzio”.
L’indomani ebbe la visita dei Capitoli della Cattedrale, di S. Erasmo e
di S. Paolo, che gli fecero dono di un calice di argento dorato in stile bizantino,
cesellato a mano, eseguito dalla Ditta Torchio di Roma.
Nel proclama del Podestà Avv. Giuseppe Scaccia Scarafoni ai Concittadini ed ai Conterranei della Diocesi si lesse tra l’altro: “Pieghiamo le bandiere
e i gagliardetti innanzi al Creatore, che per il nuovo Pastore santifica ancora
i nostri pensieri e le opere nostre... Nella comune esultanza, in alto i cuori!
Questa fedelissima terra alza i fasci littori con l’insegna della Croce; ed a Voi,
Vescovo degnissimo, risponde unanime: Presente!”.
Resse la Diocesi per 11 anni. Il 26 novembre 1942 fu promosso Arcivescovo di Brindisi. Per motivi di salute si dimise dall’ufficio e il 1 settembre 1953
fu nominato Arcivescovo titolare di Gangra. È piamente deceduto in età di 89
anni a Gagliano del Capo il 3 gennaio 1964.
Il suo magistero episcopale fu sempre intenso, profondo e affascinante
nei discorsi di circostanza e soprattutto nelle sceltissime Lettere Pastorali di
Quaresima.
FRANCESCO MANCINI
Santa Salome a Veroli, cit.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
14.2
357
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
Il vescovo Francesco De Filippis per i poveri malati di Veroli
358
L’immagine di questo vescovo di Veroli torna spesso nelle immagini
dell’epoca, in occasione delle inaugurazioni di edifici laici o delle manifestazioni religiose legate alla Beata Suor Maria Fortunata Viti.
Negli ultimi anni della sua presenza in Veroli egli fu anche protagonista in ombra durante la ricerca di aiuti economici per l’ospedale civico di
Veroli. Un’ombra che poi ha nascosto per sempre i suoi meriti quando già il
suo intervento presso il Capo dello Stato era stato determinante, ma le nuove
circostanze successive alla caduta del regime fascista indussero i politici locali
ad occultare tutti gli eventi anteriori, anche quelli positivi, di un regime caduto. Cessate queste preoccupazioni, ora, grazie al trascorrere degli anni, è il
caso di riportare alla luce tutto ciò che mons. De Filippis riuscì ad ottenere per
l’edifìcio ospedaliero di Veroli, anche se da quasi un secolo il nosocomio verolano era stato sottratto all’ingerenza dell’amministrazione ecclesiastica, come
nel periodo pre-unitario.
I fatti si collocano nell’anno 1943. Agli inizi di quell’anno il commissario dell’Ospedale della Passione di Veroli, l’avv. Vincenzo Paolini, aveva inoltrato una richiesta di finanziamento per lavori urgenti da eseguire sull’edificio
ospedaliero, essendo le ingenti spese previste non sostenibili con le rendite dei
beni immobili, allora appena sufficienti per le spese correnti. Ma egli non ebbe
alcun riscontro né dal Prefetto né dal Ministro degli Interni a Roma.
Mons. De Filippis, vescovo di Veroli, al corrente di quelle necessità
ed informato del silenzio seguito alla petizione ufficiale del Paolini, decise di
recarsi lui personalmente a Roma chiedendo udienza al Duce, allora capo del
Governo. Per quelle spese urgenti relative ai lavori da eseguire fece sapere che
occorrevano almeno ottantamila lire. Il Segretario del Duce a Roma, che doveva predisporre quell’incontro, informò il Prefetto di Frosinone dell’imminente udienza accordata al De Filippis dal Duce e lo invitò a trasmettere una
relazione ufficiale sulle effettive necessità e sui lavori da eseguire nell’Ospedale
verolano, con un’indicazione precisa del costo. La somma necessaria sembrava
oscillare tra le 80.000 e le 100.000 lire. In particolare il Prefetto di Frosinone
informò che occorreva:
1)
2)
3)
4)
Ricostruire la scala d’accesso al primo piano;
Riparare la scala di servizio;
Sistemare la farmacia e l’attiguo ufficio dell’economato;
Adattare la corsia adibita per le donne, priva di luce e di aria, a sala per raggi
X e Gabinetto per analisi.
UTI MORTALIUM LENIANTUR DOLORES
EORUMQUE CONSULATUR INFIRMITATI
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
Informava poi che nei locali sistemati al secondo piano era necessario
costruirvi la camera operatoria e quella di preparazione “che attualmente si
trovano in condizioni non idonee al primo vecchio piano”.
In data 12 maggio 1943 XXI e.f. il Segretario particolare del Duce, Nicola De Cesare, inviò al Prefetto di Frosinone con assicurata la somma di lire
centomila pregando di assicurare che la somma fosse sufficiente e di vigilare
affinchè i lavori venissero iniziati subito e condotti a termine in tempo breve.
Pochi giorni dopo, il giorno 27 maggio 1943, il Ministero dei Lavori Pubblici invitava l’ingegnere Capo dell’allora Genio Civile di Frosinone a mettersi a
disposizione del Prefetto “per quanto possa occorrere nei riguardi tecnici ai fini
di un oculato impiego della somma concessa”. Intanto per il contributo arrivato
dal Duce mons. De Filippis invitò gli amministratori dell’ospedale di Veroli ad
inviare un telegramma di ringraziamento al Duce; ed ebbe una sollecita risposta di consenso dal Presidente avv. Paolini: “Verolani tutti ringraziano Vostra
Eccellenza interessamento sussidio Ospedale rilevando devoti nuova attestazione
paterna benevolenza questa città”. Tra le carte dell’archivio ospedaliero non si è
trovata però, oltre al testo del predetto telegramma spedito al mons. De Filippis, la copia del Telegramma di ringraziamento che si doveva spedire al Duce,
come suggerito da mons. De Filippis stesso. Intanto il Dr. Gullotta, Prefetto di
Frosinone aveva rimesso l’assegno di centomila lire al Presidente dell’Ospedale
di Veroli indicando anche la procedura per un sollecito inizio dei lavori “in
quanto è necessario che il contributo del Duce consegua senz’altro lo scopo per
il quale è stato erogato” e rimaneva in attesa di ricevere “subito una sintetica
relazione sui criteri eseguiti e sui risultati raggiunti dall’impiego della somma
predetta”.
Le immagini del dopoguerra dell’edificio ospedaliero di Veroli dimostrano che i lavori furono effettivamente realizzati; e la dimostrazione si può
leggere anche su di una lapide affissa nell’atrio, al primo piano dopo l’ingresso,
dell’ospedale stesso. Ma, con sorpresa di chi ora conosce i meriti di colui che si
era mosso da Veroli per andare a Roma a richiedere il finanziamento ed i meriti di chi quella somma volle stanziare, non legge su quella lapide né il nome del
Duce né quello di mons. De Filippis. I primi amministratori del dopoguerra
vollero ricordare ai posteri se stessi come gli unici meritevoli delle opere realizzate. Le circostanze di quegli anni lo permisero: quando già la furia iconoclasta
aveva frantumato altre lapidi che riportavano, comunque sia, il nome “Duce”
non si poteva elevarne una nuova con un riferimento anche fugace a costui. Il
silenzio fu d’obbligo e mons. De Filippis ne fece le spese, finendo dimenticato
anche lui dai verolani e dagli amministratori locali per questo suo intervento a
beneficio dei poveri malati; ecco il testo della lapide:
359
HOC VALETUDINARIUM RESTITUTO AERARIO
FUNDITUS PAENE REFICIENDUM AMPLIFICANDUMQUE
NEC NON MIRIS AETATIS NOSTRAE INSTRUENDUM INVENTIS
HARMANDUS BALDASSARRA ATTILIUS CESTRA RENATUS PAPETTI
VINCENTIUS QUATTROCIOCCHI IOSEPH RONDINARA
PETRUS ROSSI ALOYSIUS VICTORIUS TODINI
PROCURATORES LEONIDAS MIZZONI AB ACTIS
MARIO ANTIGNANI MODERANTE
AB A. MCMXLVI AD A. MCMLVI
LIBERALITER CURAVERUNT.
EX CONS. VAL. ADM. SENT. A. MCMLVII
Per alleviare i dolori dei mortali e per provvedere alla loro infermità, gli amministratori Armando Baldassarra, Attilio Cestra, Renato Papetti, Vincenzo Quattrociocchi, Giuseppe Rondinara, Pietro Rossi, Luigi Vittorio Todini e il segretario
Leonida Mizzoni, sotto la presidenza di Mario Antignani, con liberalità, dall’anno 1946 all’anno 1956, curarono, dopo averne risanata la situazione finanziaria,
la ricostruzione e l’ampliamento di questo ospedale, dotandolo di moderne apparecchiature. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ospedale,
anno 1957.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
ALFREDO GABRIELE
in Potenza e carità di Dio, n°3 2009
360
Un podestà: Giuseppe Scaccia Scarafoni
Nato a Veroli il 23 agosto 1888 da Giuseppe e Laura Ambrosi, compie i suoi studi classici nel collegio di Montecassino. Consegue la laurea in
giurisprudenza presso l’Università di Roma e quindi esercita per vari anni la
professione forense, nonché quella notarile quale sostituto notaio in Roma.
Negli anni Venti ricopre, quale persona di nota rettitudine, l’ufficio di
cassiere della Banca di Veroli, carica che gli viene riconfermata dai liquidatori
della Banca anche dopo il noto crac finanziario dell’istituto. Poi dal 1930 è
direttore dell’agenzia di Veroli della Cassa di Risparmio di Roma, carica che
reggerà fino allo sfollamento da Veroli per le vicende del secondo conflitto
mondiale. Dal 10 maggio 1931 è podestà di Veroli.
La sua opera di amministratore si protrae fino al 1938 ed è particolarmente densa di realizzazioni, segnando per Veroli un’inversione della tendenza negativa manifestatasi negli anni precedenti. Infatti, per sua iniziativa,
sono presto ristabiliti in Veroli l’Ufficio del Registro e la Pretura, che erano stati
soppressi; viene impiantato l’istituto magistrale, per il quale costruisce l’edificio attualmente sede della Scuola Media Mazzini.
L’opera pubblica di maggior rilievo è la costruzione del nuovo acquedotto di Veroli dalle sorgenti alte di Capodacqua (1933-1936 circa). Precorrendo i tempi, incarica l’ing. Giamboni del progetto degli acquedotti rurali, opera
in parte realizzata solo nell’ultimo dopoguerra. Altri lavori pubblici degni di
nota: la ristrutturazione del palazzo municipale; la sistemazione del piazzale
dell’episcopio; la sistemazione della zona del Monumento ai Caduti, dei giardini pubblici e dell’assetto viario circostante; la sistemazione della zona detta
“L’Arnara” con la costruzione della Casa del Balilla (originariamente destinata
a museo) attraverso il riutilizzo di materiali antichi; la realizzazione dell’accesso carrozzabile all’Ospedale civico da via della Civerta; l’allargamento del
piazzale di Santa Salome; la costruzione della palestra e del campo solare presso il Convitto Comunale. Per tali lavori si avvale prevalentemente dell’opera
dell’ing. Giuseppe Romita, che all’epoca è confinato politico in Veroli, e costituisce l’Ufficio Tecnico del Comune, prima inesistente.
Dedica particolari cure a risollevare le sorti del Convitto Comunale, di
cui risana il bilancio, ottenendo nuove convenzioni con la Pubblica Amministrazione (Ministero per l’Interno, etc).
In seguito alla caduta di un aereo di nazionalità francese sulle montagne di Veroli, organizza le squadre di soccorso, prendendo personalmente
parte alle ricerche e al recupero delle salme dei passeggeri. Per tali scrupolosi
ed efficaci interessamenti, spiegati prendendo contatto con le autorità diplomatiche francesi, gli viene conferita la decorazione di Cavaliere della Legione
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
14.3
361
d’Onore. È anche Commendatore della Corona d’Italia.
Appassionato di musica, suona con trasporto pianoforte e violoncello,
prendendo anche parte a pubbliche esecuzioni.
Dopo gli eventi bellici si trasferisce a Frosinone, dove dal 1949 è collaboratore e consulente del Segretario Generale della Provincia.
Muore in Frosinone il 21 gennaio 1957.
PAOLO SCACCIA SCARAFONI
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
Il podestà Giuseppe Scaccia Scarafoni ai cittadini di Veroli
362
Cittadini,
ho l’onore altissimo di assumere l’Ufficio di Primo Magistrato di Veroli
nostra.
Lo assumo come il gregario fedele, che obbedisce all’ordine e che porta
con sé tutta la fede di patriota e di fascista.
Lo assumo con entusiasmo perché sono sicuro che voi, Concittadini, mi
sarete larghi di benevolenza e di preziosa collaborazione.
E così, nell’ora solenne, mentre volgo il pensiero di omaggio riverente al
nostro Sovrano e al nostro Duce, porgo a voi il mio primo fraterno saluto.
Nell’avvenire della nostra Città ho fiducia sicura, perché ascendo sotto
l’egida di un Prefetto, eccelso per bontà e per sapere, e di un Segretario Federale,
forte e deciso nelle conquiste del Regime quanto lo fu nella difesa della grandezza
d’Italia sui cruenti campi della gloria.
A loro, oltre alle Autorità, tutto il mio cuore per l’amore che hanno verso
la cara Città nostra.
Cittadini,
la nostra terra, l’anima nostra escono da prove durissime: non ci sgomentiamo. Io conto che noi sapremo dare il segno di chi ricostruisce mirabilmente, così come il Condottiero della Provvidenza ricostruì una Italia grande e
temuta.
Non formulo programmi; il fascista opera in silenzio e non pone prime
pietre, ma romanamente saluta i successi. Questi non mancheranno: ve lo ha pur
detto un valoroso, il Commissario Prefettizio che mi da consegna di guardia con
forma eletta dell’eroe, del Soldato generoso e gentile che ci lascia il suo indimenticabile amore.
All’On. Comm. Gen. Alberto Turano porgo carissimo il saluto mio ed il
vostro, con sensi della più alta riconoscenza.
Verolani,
assumendo il nobile Ufficio, chiedo a Dio che voglia benedire noi e le
opere nostre, e faccio un solo proposito: compiere tutto il mio dovere ed esigere
che ognuno lo compia. In regime fascista deviazioni ed equivoci non esistono.
Formulo un voto: essere uniti per la prosperità e le fortune di Veroli, per
la grandezza d’Italia.
A questa unica e grande meta, programma del Regime che il mondo ci invidia, giuro di essere ad ogni costo fedele.
AVV. GIUSEPPE SCACCIA SCARAFONI - Podestà
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
Veroli, 10 maggio 1931 - A. IX
363
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
14.4
364
Uno scrittore: Luigi Alonzi (Luigino)
Il cinque maggio del 1970, col riserbo con il quale era vissuto, Luigino
affrontò l’ultimo viaggio venendo a mancare all’affetto dei familiari e di quanti
lo ebbero prezioso amico e maestro di vita.
Credo di essere uno dei pochi sopravvissuti di quella ristretta cerchia
di amici verolani con i quali ebbi il privilegio di vivere, accanto a Luigino, la
stagione più fruttuosa della mia giovinezza.
Conobbi il “professore” durante i quotidiani trasferimenti in pulman
con il quale, negli anni cinquanta, raggiungevamo la nostra scuola in Frosinone
e ove, presso la medesima, egli svolgeva un modesto incarico amministrativo.
Mi colpiva, di quell’uomo, il profilo vagamente dantesco, la sua aria
distaccata, quasi assente dalla realtà, il suo perenne incedere con gli occhi incollati alle letture.
Che fossero libri, manoscritti o giornali egli aveva, infine, la grande
abilità di saperli ridurre tutti in tascabili, sì che potesse tenerli con la mano sinistra per la lettura, nel mentre sprofondava la destra nella tasca dei pantaloni.
E così, assorto nello studio, ogni mattina percorreva il breve tratto di
strada dalla sua abitazione alla fermata del pulman, di tanto in tanto alzando
gli occhi dallo scritto e soffermandosi in riflessioni.
La stessa lettura, immancabilmente, proseguiva durante tutto il tragitto; sia che fosse seduto, sia che in piedi, spesso tra la calca, avvinghiasse, per
tenersi, la mano destra ai correnti del pulman.
A volte accadeva di vederlo far sparire i suoi appunti nella tasca sinistra della giacca e venire a sedersi tra il folto gruppo che eravamo di studenti e
con noi intrattenersi paternamente, tra battute scherzose e non lievi pizzicotti,
non negandoci, di volta in volta, dettagliati resoconti ed espressioni critiche
sulla lettura che aveva appena sospesa.
In una di queste non rare occasioni ebbi modo di confessare a Luigino
la mia passione per la fotografia.
Volle vedere alcune mie immagini e da quel momento iniziò - allora
io giovanissimo - un meraviglioso rapporto di frequentazione e di confidenza
che, ben presto, si tramutò in vera amicizia e successivamente in fattiva collaborazione.
Negli anni Sessanta - grazie all’intuito ed alla intelligenza di Giacinto
Minnocci, allora ai vertici delle Istituzioni Provinciali, il quale ne sapeva il
grande valore di scrittore, di profondo studioso e conoscitore, oltre che della
storia, anche delle composite realtà socio-economiche e politiche della Cioceria - Luigino realizza, alfine, un sogno da lungo tempo accarezzato: quello di
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
poter dare inizio alla creazione di una ponderosa biblioteca provinciale della
quale, ben presto, diviene il responsabile.
In questi anni l’attività di Luigino è improntata ad un dinamismo che
produce risultati rilevantissimi e che impegna anche chi scrive in una assidua e
frenetica, quanto gratificante, collaborazione con lo stesso.
Sono anni in cui si gettano le basi per la creazione del nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco, in cui si ottiene di far attraversare la
Cioceria da una autostrada, altrimenti progettata per le pianure pontine; sono
anni in cui si realizza la rivoluzione dei patti colonici verolani.
Tutto questo promosso e preparato dalle Istituzioni Provinciali e sempre preceduto da interventi programmatori e convegni di studio ai quali, mai,
è estranea l’opera di Luigi Alonzi che, già dal lontano 1951 con il suo “Cioceria,
porta del mezzogiorno”, aveva, con lungimiranza, anticipato un itinerario progettuale di cui ora, lentamente, si cominciano a percepire i concreti riscontri.
Ed è in questo fecondo periodo che Luigino decide di concretizzare,
più che mai, un desiderio che oramai da troppo tempo contiene: dare alle stampe i suoi “Itinerari di Cioceria”.
Una raccolta di scritti sulla sua terra che compendia un lavoro di ricerca decisa e puntigliosa in cui riversa tutta la poesia e l’amore dell’animo suo.
Frutto di lunghi anni di indagini e di preparazione durante i quali venne, man mano, affinandone la stesura attraverso un minuzioso peregrinare nelle terre di Cioceria ricercandone, oltre che la storia e le bellezze, sopratutto, le
radici e l’animo della sua gente.
Nella prefazione all’opera ebbe a scrivere: «Da solo, in compagnia di
qualche amico - a piedi o in motoretta - girai la Cioceria per lungo e per largo....».
Mi piace ancora rivederlo, rannicchiato sul sellino posteriore della mia
Lambretta o di quella del comune amico Gino Venturi, nel nostro avventuroso
peregrinare tra i paesi della Cioceria.
Una terra alla quale ha dedicato tutto l’amore di cui era capace, non
solo nella ricerca e nella esaltazione del bello - che però mai volle folclore cantato in pagine di rara poesia, ma anche nella acuta e ricorrente osservazione
che lontane consuetudini economiche e sociali venivano oramai soppiantate
dal lievitare di una nuova economia locale del benessere generale.
Chi, attento osservatore, si fosse trovato, nelle serate d’estate, a metà
degli anni sessanta, presso il monumento ai Caduti di Veroli, avrebbe potuto
assistere al formarsi di uno strano quartetto.
Primi a giungere chi scrive ed il compianto Gino Venturi; dopo un
rapido saluto con la testa, restavamo in silenzio a porger l’orecchio finchè, dalla
curva Macallè, non giungeva l’ansimare conosciuto di una vecchia giardinetta
dalla quale, dopo qualche minuto e non senza sforzo, scendeva il Sor Armando.
365
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
366
Ci raggiungeva tutte le sere da Santa Francesca il Sor Armando; in
pantaloncini e canottiera e sulle labbra ancora il sapore del buon Cesanese del
Piglio, del quale si professava esperto intenditore; qualche volta, sulla testa, il
largo cappello di paglia da mietitore.
Così assortiti ci spostavamo, allora, presso il monumento; lo sguardo
fisso alla poca luce che filtrava dalle persiane socchiuse a piano terra del palazzone delle case popolari, finchè questa non si spegneva.
Solo allora, in sincronia, esclamavamo: eccolo.
Eccolo: Luigino appariva dalla curva del vecchio distributore e veniva
a raggiungerci, non senza essersi fatto precedere da scherzose quanto pungenti
allocuzioni sull’abbigliamento estivo del Sor Armando.
Dopo tali convenevoli iniziavamo un incessante andirivieni, lungo il
piazzale Vittorio Veneto, che si concludeva solo a notte inoltrata.
Erano, credo, i soli momenti in cui Luigino, tra l’affetto sentito dei suoi
amici, abbandonasse il suo guardingo riserbo ed aprisse a noi i suoi dubbi,
le sue aspettative, i suoi progetti, i suoi studi ed in fondo le sue speranze per
quella Cioceria che amava davvero profondamente e che era percorsa, allora,
dai fremiti di un beneaugurante rinnovamento.
Si vestiva, in quei momenti, di una umanità insospettata ed allora conoscevamo la sua gioventù, il tempo, invero assai breve, passato in Milano, ma
sopratutto il ricordo ricorrente per il fratello Giulio, giornalista già vice direttore del Corriere della Sera, massimo esponente, con Ferruccio Parri, della
resistenza in Milano e che gli sopravvisse di due anni.
Ma, inevitabilmente, in quelle serate, Luigino amava riandare alle pagine dei suoi “Itinerari” e, quale viaggiatore virtuale - dimentico volutamente
che tanti li avevamo percorsi assieme sulla sbuffante giardinetta del Sor Armando - tornava a parlarci del vescovo Pietro e della leggenda del lupo e del
bove; delle dolci ninna nanna udite tra le selve di Acuto e di Porciano; di Peppetta, il guardaboschi della Rotonaria, della Madonna d’Agosto e dell’aia di
Antullo che sprofonda; di Lotario Conti e del sogno dell’eremita nella grotta
delle Cese; di Graziano Iaboni che ricorda il giovane Dorè intento al disegno
delle asprezze dell’Ondola; del commovente marmocchio che, alle porte di
Alatri, sotto la prima pioggia di primavera, con le braghette a mezza gamba, tira disperatamente la corda che lega il somaro di casa, impuntato sull’aia,
quasi temendo che la leggera pioggia possa portarglielo via quel bigio somaro,
“prezioso ed indivisibile come l’anima sua”.
Capivo, allora, nello scrutare il suo volto, pervaso da una gioia che ne
addolciva i decisi lineamenti, quanto egli amasse la sua terra; con l’amore puro
e limpido di un grande, vecchio bambino.
Un grande, vecchio bambino con l’animo pregno di una profonda e
sentita religiosità, sia pure sempre ostinatamente negata, ma che prepotente
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
esplode tra le pagine di poesia dei suoi “Itinerari”: nella leggenda del pruno e
della rosa; della roncola nel lago; di Benedetto da Norcia e di Francesco d’Assisi.
Solo allora, acquietato il suo dire, gli occhi del Sor Armando lucidi
dalla commozione, a notte ormai fonda, con un impreciso arrivederci e tanta
nuova ricchezza nell’animo, ci accomiatavamo da Luigino.
Tra il 1965 ed il 1966, per incarico dell’Ente Provinciale per il Turismo,
tornai a visitare e fotografare trenta tra i più importanti comuni della provincia. Questa volta da solo ma ricco di un dettagliato e puntiglioso “itinerario”
che Luigino aveva doviziosamente impostato.
Iniziavamo così a lavorare alla preparazione di due importantissime
mostre fotografiche: l’una sui monumenti da salvare in provincia di Frosinone,
l’altra sull’arte in Cioceria.
Di ambedue Luigino preparò i commenti, i cataloghi e le pubblicazioni che le accompagnarono e che, per “Arte in Cioceria”, furono un vero e
proprio trattato di storia dell’arte.
Le mostre, l’una inaugurata il 30 luglio 1966, la seconda, più corposa,
nel 1967 dal ministro Romita, ebbero un rimarchevole successo di pubblico e
di critica, anche al di fuori dei confini della provincia e la seconda fu, successivamente, itinerante in diverse, importanti città italiane.
Il non frettoloso lettore potrà, anche in questa occasione, scoprire un
Alonzi - oltre che fine scrittore e sensibile poeta, lucido studioso dei problemi
sociali, economici e politici della sua terra - anche sottile critico e profondo
conoscitore della cultura e dell’arte di Cioceria.
In questo fattivo impegno verso il nuovo che avanzava egli non dimenticò mai la sua Veroli posta, allora, di fronte alla diversa realtà sociale ed
economica che, a cavallo degli anni sessanta, vedeva la piccola borghesia ereditiera, a mano a mano, esautorata dalle istanze e dalla protesta rurale.
Il 30 ottobre 1968, per sua precisa volontà, con un gruppo di amici
sottoscrivemmo l’atto di costituzione della Pro Loco in Veroli.
Una Associazione che egli volle sorgesse, come scriveva: «... per contrastare il diffuso pessimismo che stringe e debilita lo spirito cittadino».
Il primo marzo del 1969, in una sala stracolma del vecchio Cinema
Moderno, fu proiettato il documentario “Veroli Inedita”.
Luigino, che fortemente lo aveva promosso, intervenne alla serata ed al
solito volle parteciparvi, in in un angolo della sala, in piedi, appartato e silente.
Al termine della proiezione, toccato dalle immagini e dal sentito commento, scritto con l’anima dall’amico Giuseppe Trulli, volle gratificarci con un
brevissimo ma intenso: «...Bravi...Veroli è veramente bella...».
Credo che in nessuna altra occasione della mia vita, grazie a Luigino,
abbia potuto cogliere, come in quella serata, tra tutti i presenti, l’orgoglio di
sentirsi verolani.
367
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
368
Nel maggio dello stesso anno vide la luce il numero speciale, edito
dalla pro loco, “Veroli domani”, curato da Luigino, nel cui fondo — presago
forse della non lontana fine — volle lasciare, a mò di testamento, una accorata
esortazione ai verolani nella quale, come appresso, concludeva: “Un concreto
avvio alla comprensione della realtà cittadina verolana — tale l’ostacolo da superare — è quello di ravvivare in essa i lati positivi, poichè le storture valgono
quanto il brodo di zucca. Non edificano e non dicono niente a nessuno. Semmai fanno perdere tempo. Guardiamo piuttosto agli elementi vivi e fattivi della
nostra piccola società, quali essi siano, e, nella comprensione loro, cerchiamo
di utilizzarli. Le Città, Veroli compresa, non sono cose fisiche, ma come i popoli e le nazioni vogliono essere personalità morali, coscienze, volontà operose
e operanti. E volontà e coscienze, ove manchino, bisogna aiutarsi a crearle e
formarle”.
Varrebbe la pena, oggi, soffermarci a riflettere perchè e quanto disattese siano rimaste le esortazioni che Luigino ci rivolse a favore della nostra
Veroli, una città che pure, nell’imperversare del feudalesimo, con le consorelle
erniche, si governava a consoli e podestà, contribuiva validamente alla civiltà
rinascimentale con i suoi numerosi umanisti, apriva il suo pubblico ginnasio
sin dal 1537, gelosa, in ogni tempo, dei suoi Statuti e delle sue libertà e perchè
l’Associazione Pro Loco, l’istituzione che egli caparbiamente volle nascesse per
spronare i verolani ad uscire dal proprio torpore ed avviarsi a prendere coscienza del nuovo che, allora, bussava prepotente alle nostre porte, sia, oggi,
ridotta ad una semplice, sbiadita etichetta; e, ancora, perchè, dopo oltre trentacinque anni dalla sua scomparsa, nel 1998 Veroli abbia ricordato il suo Luigi
Alonzi solo su iniziativa della Amministrazione Provinciale e non già come
omaggio dovuto dai suoi concittadini.
Troveremmo la sola risposta, sia pure tardiva, nella necessità di un rinnovato impegno civico che cancelli la nostra rassegnazione e la nostra apatia e
ci consenta, alfine, in una stagione nuova di solidarietà e di azioni, di ricordare
degnamente, a noi stessi ed alle giovani generazioni, un autentico verolano che
visse, amò e cantò la sua terra, spronando noi tutti verso il rinnovamento che
andava mutando l’ordine delle cose della nostra Città ed auspicando, per essa,
un nuovo avvenire di progresso pur nella certezza, come egli spesso amava
ricordare: «... che la patria di Aonio Paleario...non fu mai terra d’idillio».
La sua morte impedì che portasse alle stampe un ponderoso ed originale studio sulla nascita del Gotico nelle terre del Lazio meridionale e su i molti elementi che, ivi, lo precedettero e poi si fusero nell’opera dei maestri d’arte
cistercensi; studio del quale stava riordinando e battendo gli appunti e per il
quale avevo già fotografato le abbazie di S. Domenico in Sora e di Casamari e le
chiese di S. Maria a Fiume e S. Nicola in Ceccano e di S. Lorenzo in Amaseno
e attendevo al completamento di un copioso elenco che Luigino, già da tempo,
aveva scrupolosamente preparato.
Qualche volta, nel rivedere quelle diapositive, oramai sbiadite dal
tempo, mi è caro immaginare, come entro uno sfuocato paesaggio di nebbie,
uno strano terzetto i cui componenti, a lato di una vecchia giardinetta dalle
portiere spalancate, aspettano che un caro amico li raggiunga per riprendere,
assieme, un nuovo, misterioso, infinito itinerario.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
GIORGIO DI FABIO
369
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
14.5
370
Un professore: il Marchese Luigi Bisleti
Tra i miei maestri ricordo con senso di particolare affetto e ammirazione il Marchese Luigi Bisleti. Una figura singolare, che mi insegnò il greco
nel ginnasio e nel primo anno di liceo nel Seminario di Veroli. Si era in una
scuola assolutamente privata, e il Prof. Luigi Bisleti ci capitò per caso. Venuto
a mancare il professore di greco e non essendoci tra il clero diocesano chi lo
potesse sostituire, non so come il Vescovo ebbe a rivolgersi a questo laico, appartenente alla nobiltà verolana, ma che aveva succhiato in gioventù lo spirito
anticlericale del liberalismo del tempo, pur avendo per fratello il Cardinale
Gaetano Bisleti, che Pio XI definì «gemma del Sacro Collegio».
A un certo punto della sua vita, alla morte della moglie, cui era legato
da fortissimo vincolo di affetto, ebbe una crisi, anzi un profondo sconvolgimento, che lo ricondusse alla fede, senza intaccare l’amore per la libertà. Coltissimo in umane lettere e integerrimo per dirittura morale, era stato Sindaco
della città di Veroli e aveva amministrato così bene, con competenza e disinteresse assoluto, tanto che, risanato un bilancio disastroso, potè dire quando
passò la mano: «Mi avete dato un cadavere, e io vi restituisco un morto risuscitato».
Quando prese a insegnare nel Seminario, viveva appartato, quasi del
tutto emarginato, intento ai suoi studi preferiti. Ricordo la sua prima apparizione in classe. Un bel vecchio, forse vicino ai settant’anni, alto, asciutto, diritto, dalla chioma bianca tagliata a spazzola, ma liscia e incorniciante un volto
scavato, con sguardo vivissimo sprizzante acutezza di intelligenza e fervore
di spirito giovanile, tanto che non si avvertiva quasi che avesse un occhio di
vetro.
I miei compagni ed io ne sentimmo subito il fascino. Anche dal modo
con cui iniziò ad insegnarci le lettere dell’alfabeto, si sentiva come egli gustasse
i suoni stessi di quella lingua, che proveniva dai secoli antichi, precristiani, ed
era stata lo strumento espressivo di una letteratura e di un’arte, che soggiogò lo
stesso mondo romano, che pur aveva piegato la Grecia col ferro: Graecia capta ferum victorem cepit. I romani, infatti, poterono chiamare il Mediterraneo
«Mare nostrum», ma la lingua e la cultura greca continuarono a dominare
il mondo a raggio universale, sicché anche i Vangeli — tranne Matteo che
scrisse in aramaico — furono redatti in greco «coinè».
Venne l’inverno, che a Veroli è particolarmente rigido, e a quei tempi
non si usava riscaldamento di sorta, né a gasolio né a metano. Solo nella famiglia patriarcale, la fiamma viva del camino riuniva tutti i membri nelle lunghe
serate, e la gioia dei bimbi era grande quando si cuocevano le castagne «callarroste», meglio se si facevano scoppiare sotto la cenere infocata.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
II Signor Marchese, in una fredda giornata del novembre avanzato,
venne a scuola, puntuale come sempre, in uno strano equipaggiamento. Era
coperto dal cappotto, e le mani erano infilate in guanti di grossa lana marrone,
frutto del paziente e febbrile sferruzzare della donna, regina della casa; ma con
grande dignità portava un antico ombrello ottocentesco di seta verde, tuttora
ben conservato, che egli appoggiò con cura in un angolo.
Poi, rivolto a noi, rannicchiati dal freddo e con le mani intirizzite, che
per il Natale si sarebbero coperte di “geloni”, disse con la sua voce limpida,
lisciandosi la chioma bianca: «Suvvia, ragazzi, aria! Aprite le finestre! L’aria
è vita». Noi restammo quasi sgomenti più che meravigliati. Un nostro compagno obbedì al comando e spalancò le finestre. Così andammo avanti tutto
l’inverno!...
Quando ci vedeva, nelle giornate più rigide, ravvolti nelle nostre mantelle nere, ravvicinati e aggruppati l’uno all’altro per mutuarci un pò di calore:
«Tapini — diceva — faremo così: chiudere del tutto la finestra, no, che mi sentirei come in una tomba; vuol dire che accosteremo i battenti, in modo che voi
non siate colpiti dall’aria fredda, e io mi metterò contro la fessura in modo che
l’aria — la vita — me la prenda tutta io!...».
E così faceva, con una fortezza spartana, e noi zitti! Ma il fuoco veniva
dalla lezione. Più andavamo avanti, più cresceva l’entusiasmo. Che scoperta il
leggere le prime proposizioni e il tradurle, entrare nel mistero di quella lingua
che si scriveva con lettere assolutamente diverse, penetrare il mistero di quelle
parole, di cui il Signor Marchese — non lo chiamavamo Professore, ma non
perché lui esigesse il titolo nobiliare — ci trasmetteva l’armonia, direi l’incanto, il gusto della bellezza.
Quando, procedendo, fummo in grado di tradurre i primi brani — oh
le indimenticabili favole di Esopo! —, il Signor Marchese ci propose di imparare il Pater noster, l’Ave Maria e il Gloria Patri in greco. E imparammo. Anzi
imparammo anche il segno di Croce, sicché ogni lezione iniziava, tutti in piedi,
con la recita: «En to onòmati tu Patròs...» e così via: «Pàter emòn...», «Chaire,
Maria...», «Dòxa to Patrì...». Lui, assorto, ascoltava il nostro coro, che scandiva
la preghiera, frase per frase, mentre la sua mano guidava il ritmo della recita e
segnava le pause.
Il suo volto si illuminava di un godimento che non so dire. In particolare, durante il «Pater noster». Ci fissava negli occhi come un direttore di
orchestra. Arrivati al «libera nos a malo», che in greco suona «rùsai emàs apò
tu poneru» ci accorgemmo che voleva una particolare accentuazione su quel
«rùsai emàs».
E noi ci stemmo. Tutti insieme erompevamo come in un grido «Rùsai
emàs!...». Quando arrivavamo all’«Amèn», sorrideva, soddisfatto, «Bravi, bravi!» esclamava. Anche noi si rideva un pò sotto i baffi, perché su quel «rùsai»
finimmo per esagerare, dandogli una forza eccessiva, che lui però attribuiva
371
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
372
solo al nostro entusiasmo, in perfetta sintonia con l’esaltazione del suo spirito. Si andò avanti così in un crescendo che non ti faceva sentire il peso di
una lingua difficile, anzi te la faceva amare.
Talora si soffermava in osservazioni filologiche — aveva l’intero vocabolario greco in testa — e si divertiva anche nel trovare l’origine di parole dialettali dal greco. Un giorno, dovendo spiegare la questione dello iotacismo ed
etacismo, cioè della pronuncia dell’ eta (e lunga) rispetto all’epsilon (e breve),
ci fece rilevare che anche a Torrice, un paesino non lungi da Veroli, in molti
casi la e si pronuncia i. Si dice mi, ti invece di me, te. E si divertiva un mondo
nel raccontare la barzelletta del torriciano, che aveva visto la prima volta la sua
immagine nello specchio e si meravigliava nel rimirarla ferma se lui rimaneva
fermo, mentre spariva se anche lui si spostava da un lato. Il Marchese, divertito,
rifaceva le mosse e il parlare dell’ingenuo torriciano: «Si mi (io) rimiri ti, ti (tu)
rimiri mi, si mi ritiri mi, ti ritiri ti».
In quinto ginnasio traducemmo un buon numero dei gustosissimi «Dialoghi di
Luciano» e l’Anabasi di Senofonte. Ricordo ancora il commento del MarcheseProfessore al brano in cui si descrive l’apparizione del mare ai greci in ritirata. La gioia dopo le fatiche di una marcia quasi disperata e il grido «Thalatta! Thalatta!», cioè «II mare! Il Mare» che significava la salvezza. In poche
righe è descritto lo scoppio della vita ritrovata, della mèta tanto agognata e
finalmente raggiunta. Il nostro Professore ci si immedesimava. Dopo la traduzione del testo, lo rilesse per intero declamandolo, e — strano — mi richiamò
alla mente i famosi versi della scoperta dell’America di Pascarella, quando la
ciurma avvilita e riluttante finalmente espolde nel grido: «Terra! Terra!».
In primo liceo, con una buona preparazione grammaticale e sintattica
(come si può apprendere senza le nozioni?), potemmo affrontare testi più impegnativi. Tornò l’inverno. Il Marchese veniva sempre, puntualmente, con i
suoi guanti di grossa lana marrone e l’ombrello di seta verde. Insegnava sempre a finestre aperte in piedi, mai in cattedra.
Un giorno, più freddo del solito, ci accorgemmo che il Marchese aveva
qualcosa di strano. Evidentemente si sentiva male. Le mani gli cominciarono a
tremare. Il libro traballava tra le dita, che caparbiamente lo tenevano aperto. Il
viso si fece prima pallido, poi bluastro.
«Signor Marchese, si sente male?». «No, è cosa da poco! Andiamo
avanti». Ma si vedeva che faceva una fatica disumana. «Signor Marchese, si sieda! Chiudiamo la finestra?». «No! Andiamo avanti». Noi eravamo allibiti. Un
silenzio profondo si era fatto nella scuola. A un certo punto, il Marchese non
salì, ma si appoggiò alla cattedra, lui sempre diritto e forte come una quercia.
Andò ancora avanti, ma non ce la fece ad arrivare al suono della campanella,
che segnava la fine dell’ora, quando era solito inveire contro il bidello «sempre
attaccato a quella maledetta corda». Quel giorno la campanella di fine lezione
non suonò per lui.
Era suonata un’altra campana. A un tratto, chiuse con stizza il libro, indossò il cappotto, si infilò i guanti pesanti di lana, prese l’ombrello ottocentesco
di seta verde, staccò il cappello dall’attaccapanni e si avviò all’uscita. «Signor
Marchese, vuole che l’accompagni a casa?» disse uno di noi, alzatosi in piedi.
«No, le mie gambe ce la faranno». Poi, giunto alla porta, prima di uscire, si voltò e agitando il cappello, esclamò: «Ragazzi, addio! Questa è la mia anabasi!»
Thalatta! Thalatta!...
Dopo tre giorni era morto.
Quando ce lo daranno i Decreti delegati e tutta la contestazione di
questa nostra epoca un educatore come il Marchese Luigi Bisleti? Non lo fui
certamente io, che, conclusi gli studi e consacrato Sacerdote, fui chiamato dal
Vescovo a insegnare greco in Seminario dalla stessa cattedra. Ma lo feci con
un pò di quella passione e di quell’amore, che per quella bellissima lingua mi
aveva trasfuso il vecchio Marchese Luigi Bisleti.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
DON ANDREA SARRA
Il Marchese Luigi Bisleti, in Incontri
Casamari, 1976
373
14.6
Un arcivescovo: Fabio Bernardo D’Onorio
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
L’ABATE DI MONTECASSINO
374
Don Bernardo D’Onorio, ordinato Abate di Montecassino dal Cardinale Casoria, Prefetto della Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino,
il 3 luglio 1983 si è recato a Veroli per incontrarsi con una popolazione in festa
per lui e per riabbracciare parenti, amici e conoscenti che aveva lasciato a soli
13 anni per salire al Sacro Monte di Benedetto.
Ad accoglierlo nella Cattedrale di S. Andrea c’erano il Vescovo di Veroli-Frosinone Angelo Cella, il clero diocesano, i sindaci di Veroli, Cassino,
Atina ed altre autorità ecclesiastiche, politiche e militari.
(…) Nella chiesa si erano radunati numerosi fedeli e perché no, anche
curiosi per vedere il volto di un loro concittadino, conosciuto ma dimenticato,
messo a Capo del più importante monastero dell’occidente.
All’inizio della celebrazione Eucaristica, come Pastore della Diocesi
di Veroli, il Vescovo Angelo Cella ha rivolto un benvenuto al nuovo Abate di
Montecassino, successore di S. Benedetto ed ordinario della Diocesi di Cassino, con queste parole «... lo salutiamo con gioia, lo abbiamo già salutato del resto quando è venuto ed è entrato in chiesa; l’esplosione di gioia che si esprime
con un battimano vale più di qualunque altra parola».
Monsignor Cella ha così continuato «mi permetti di dirti fratello Bernardo, che sarai sempre il benvenuto qui, tra la gente di Veroli che è il tuo
popolo; la tua terra ti vedrà sempre con gioia perché vede esaltata nella tua
persona le fede in cui questo popolo è sempre vissuto. (…) Ti consideriamo in
qualche modo il nostro Abate, perché sei nostro, in quanto sei di Veroli. (…)
Preghiamo per te — ha concluso il Vescovo — perché la tua missione,
che prevedo lunga in quanto tanto giovane sei stato eletto a questa dignità,
possa per tanti e tanti anni risplendere lassù a Montecassino, affinchè il mondo
intero guardi a te e al tuo monastero ispirandosi a quel Santo ma anche a te e
alla tua opera che prolunga la Sua nel tempo.
(…) Nell’Omelia il Padre Abate Don Bernardo D’Onorio si è rivolto ai
suoi concittadini con queste espressioni: «Con il cuore palpitante di commozione mi ritrovo questa sera in questa veneranda chiesa Cattedrale che tanti
anni fa mi vide chierichetto non sempre attento e devoto accanto al parroco D.
Antonio. In questa parrocchia ho ricevuto il Battesimo, qui per la prima volta
mi sono accostato alla Mensa Eucaristica, qui ho ricevuto il Sacramento della
Cresima, qui ho celebrato la mia prima Messa solenne. Qui ora mi ritrovo
insieme a voi, per dire con voi grazie al Signore per tanti e tanti benefici (...)
Carissimi, la vostra Veroli fu per 13 anni anche la mia Veroli. Ne percorsi tutte
le piazze e le strade, ne conosco tutti gli angoli, ricordo immutatamente non
solo il modesto focolare domestico di via dei Franconi, accanto a papà e mamma, ai fratelli e sorelle, ma ricordo anche i miei ambienti di gioco, di scuola, di
chiesa. Ma specialmente ricordo quella piccola a me dilettissima chiesa delle
monache che voi giustamente chiamate le monache buone. Ricordo le mie funzioni di chierichetto presso la Beata Maria Fortunata Viti. Alla Beata, alle preghiere e alle esortazioni delle monache, alla religiosa pietà dei miei genitori che
mi lasciarono, tengo a precisarlo, libero della mia decisione, devo senz’altro la
svolta radicale che ebbe la mia vita, quando ancora tredicenne lasciai Veroli
per Montecassino che stava risorgendo dalle rovine immani della guerra per
opera di un altro grande ciociaro, l’Abate Ildefonso Rea a cui fui vicino». Il neo
eletto ha poi tenuto a precisare: «Essere Abate è segno di benedizione divina
ma è anche responsabilità grandissima che mi fa tremare le vene e i polsi. Fratelli e sorelle vi scongiuro di pregare per me questa sera e in seguito, affinchè il
Signore mi trovi sempre attento e fedele ai miei onerosi impegni per la salvezza
mia e per la santificazione del mio carissimo gregge».
PATRIZIA ARCI
L’incontro del nuovo Abate di Montecassino con la sua città natale
in Lazio Sud, agosto 1983
L’ARCIVESCOVO DI GAETA
Così ne L’Osservatore Romano del 21 settembre 2007
(…) «II Santo Padre, Benedetto XVI, mi ha chiesto la disponibilità a
servire la vicina Chiesa di Gaeta - ha dichiarato il neo arcivescovo Bernardo
con voce visibilmente commossa - e al Papa è impossibile dire di no, anche
se il distacco da Montecassino è immenso... tutta la mia vita è stata qui, sin
da quando tredicenne entrai nell’Abbazia quale alunno monastico, per poi diventare monaco e successivamente salire, il 25 aprile del 1983, alla prestigiosa
cattedra di San Benedetto. Ventiquattro anni di governo abbaziale sono tanti, e
porto dentro di me tutte le conoscenze, gli incontri, le celebrazioni e soprattutto i volti di tantissime persone (…). É vivo in me il periodo della ricostruzione,
la salita sul monte di Paolo VI, Giovanni Paolo II, di vari presidenti della Repubblica.
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo di Gaeta (Italia) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Fabio Bernardo D’Onorio, O.S.B., finora Vescovo titolare
di Minturno ed Abate Ordinario di Montecassino.
375
14. Persone speciali Giuseppe Trulli
Posso fugare qualche timore sorto circa la sussistenza della diocesi.
Nella Chiesa resteranno, come segno della storia e del bene svolto nei secoli, le
due abbazie territoriali: Montecassino e Pannhonalma in Ungheria (…). Montecassino resterà sempre nel mio cuore. Inizierò questo mio nuovo cammino
con un po’ di timore e trepidazione».
Il Padre Abate, che conosce per così dire ogni pietra dell’amata abbazia, ora dovrà conoscere altre pietre, quelle dei fedeli che costituiscono la
chiesa Arcivescovile di Gaeta e sarà nuova dedizione, tra attività e direttive
pastorali perché Cristo sia annunziato e amato. «Monsignor D’Onorio - ha
detto infatti l’arcivescovo Pierluigi Mazzoni che lascia per raggiunti limiti di
età - viene portando le sue apprezzate doti umane e sacerdotali, congiunte ad
una ricca esperienza pastorale, che saranno arricchimento per la nostra Chiesa diocesana». È fuori dubbio. Nella Terra di san Benedetto sono tanti i segni
della sua indefessa opera. Ha avuto carisma e personalità tali da rappresentare
per tanti un sicuro punto di riferimento tra le incertezze e le povertà morali
che sfigurano e indeboliscono la città degli uomini. Guidato e sostenuto dallo
spirito della Regola benedettina, con parole e interventi ha costantemente e
coraggiosamente affrontato i malesseri sociali, promovendo il bene delle persone. Nella “cittadella sul monte”, inoltre, non si è stancato di dare all’arte uno
spazio privilegiato, in un fluire incessante di iniziative, calando così nella realtà
di un mondo sempre più lacerato e distratto appunto la forza creatrice e rigeneratrice della bellezza (…).
L’umile Beata Maria Fortunata, che prossimamente ricorderemo nel
quarantesimo della beatificazione, l’aiuti a trovare la Potenza e la Carità di Dio
in questa disposizione del Santo Padre, unito a quella silenziosa schiera di monaci e monache che, lungo i secoli, lasciarono incompiuto quanto stavano facendo e, con piede prontissimo all’obbedienza, seguirono con i fatti la voce del
Signore che chiamava.
376
ROSA DEL SIGNORE
Da Montecassino all’Archidiocesidi Gaeta
in Potenza e carità di Dio, n°3 2007
Cappella Campanari
Cimitero comunale di Veroli
Ora parla il mio diletto e mi dice:
«Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!
Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna.
Il fico ha messo fuori i primi frutti
e le viti fiorite spandono fragranza.
Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è leggiadro».
Come sei bella, amica mia, come sei bella!
Gli occhi tuoi sono colombe,
dietro il tuo velo.
Le tue chiome sono un gregge di capre,
che scendono dalle pendici del Gàlaad.
I tuoi denti come un gregge di pecore tosate,
che risalgono dal bagno...
Come un nastro di porpora le tue labbra
e la tua bocca è soffusa di grazia...
Come la torre di Davide il tuo collo,
costruita a guisa di fortezza...
I tuoi seni sono come due cerbiatti,
gemelli di una gazzella,
che pascolano fra i gigli...
Tutta bella tu sei, amica mia,
in te nessuna macchia...
Tu mi hai rapito il cuore,
sorella mia, sposa,
tu mi hai rapito il cuore
con un solo tuo sguardo,
con una perla sola della tua collana!
Quanto sono soavi le tue carezze...
Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
c’è miele e latte sotto la tua lingua
e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.
Cantico dei Cantici - 2, 10-14; 4, 1-2,3,4,5,7,9-10,11
Cappella Campanari - particolare
Cimitero comunale di Veroli
Mons. Francesco De Filippis
Vescovo di Veroli dal 1931 al 1942
Giuseppe Scaccia Scarafoni
Podestà di Veroli
Luigi Alonzi detto “Luigino”
Cultore di storia locale
“Questa casa è simile al Sinai
dove fu promulgata la legge
di Dio, e lo dimostra la regola che di qui anticamente fu
pubblicata. Di qui è uscita la
legge che solleva le menti dalle bassure morali e, propagata, ha diffuso la luce per tutti i
luoghi e i tempi”.
(Alfano)
190° Abate di Montecassino
disegno di Pietro Annigoni
Fabio Bernardo D’Onorio
Fabio Bernardo D’Onorio
Arcivescovo di Gaeta
CAPITOLO XV
All’delombra
monastero benedettino
La Beata Suor Maria Fortunata Viti
389
Il monastero benedettino
391
Madre Chiara De Felice
395
Padre Gabriele Locher
401
Il Conte Stanislao De Witten
405
15.1
La Beata Suor Maria Fortunata Viti
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
M
eno di un mese e mezzo fa, l’8 ottobre, in San Pietro, Paolo
VI ha venerato in ginocchio una nuova Beata della Chiesa,
la cui immagine era stata issata sulla «Gloria» del Bernini,
circondata dall’aureola della santità.
La solenne e anche festosa cerimonia potrebbe essere messa efficacemente a contrasto con un’altra, spoglia e disadorna, quasi furtiva,
quando un esiguo frettoloso corteo un giorno di novembre del 1922, accompagnò al cimitero di Veroli il Corpo di una conversa di 95 anni, di cui quasi
non si ricordava il nome, per seppellirlo nella fossa comune delle monache di
clausura.
La santità di Maria Fortunata Viti, questa recentissima recluta degli
altari, non ha nulla di umanamente clamoroso. È una santità fuori del tempo
— soprattutto del nostro tempo — che potrebbe sembrare anacronistica a chi
non ricordi — come scrive il più recente ed esauriente biografo della nuova
Beata, Don Andrea Sarra — la dottrina cristiana del Corpo Mistico, secondo
la quale i meriti dei Santi sono patrimonio attivo, reale e sempre attuale di tutti
i credenti, anzi di tutti gli uomini.
Di eccezionale, nella vita di Maria Fortunata Viti, non sembrerebbe
esserci che la longevità: quasi cent’anni — cent’anni che hanno cambiato il
mondo in ogni suo aspetto, ma che sembrarono scivolare senza traccia sulla
monaca di clausura, «sepolta viva», per ben 72 anni, sempre nella stessa cella,
sempre alle stesse occupazioni, per venticinquemila giorni in apparenza tutti
uguali.
Era nata nel 1827, e l’avevano chiamata Anna Felice. Il padre, un possidente di Veroli, antica e nobile città ernica, in Ciociaria, non lontano da Frosinone, avrebbe potuto mantenere decorosamente, se non agiatamente, nove tra
figli e figlie, se non si fosse lasciato dissipare dal giuoco e dal vino.
Morta la mamma quando aveva 14 anni, Anna Felice fu la premurosa
mammina, tra crescenti ristrettezze, dei fratellini minori. Per loro lavorò senza
mai stancarsi, dimenticando se stessa. Per loro andò a servizio, senza sentirsene umiliata. Soltanto a 24 anni potè pensare a se stessa, e dopo aver rinunziato
a sposare un ottimo partito, prese il velo delle monache benedettine di Santa
Maria de’ Franconi, a Veroli — le cosidette «monache buone».
Illetterata, restò sempre monaca conversa, e non fu mai ammessa tra
le «coriste», le monache cioè che si dedicavano alle funzioni liturgiche. Il suo
compito fu quello del lavoro manuale, nella «panneria» del monastero. Filare e
cucire, cucire e filare senza un attimo di sosta e di distrazione, in una giornata
lavorativa che cominciava alle tre e mezzo di mattina.
389
E quanti piccoli continui eroismi, in quelle giornate apparentemente
tutte uguali! Il lavoro e la preghiera erano il primo dovere della benedettina,
al quale doveva accompagnarsi l’obbedienza e l’umiltà, la penitenza e la mortificazione, la pietà e la meditazione, la carità e la sopportazione, la povertà
più assoluta unita alla proprietà e alla pulizia... E quanti intimi combattimenti
sotto l’apparente serena imperturbabilità! Quante tentazioni sconfitte, quanti
periodi di tormentosa aridità spirituale!
«Voglio farmi santa», aveva detto entrando in monastero. Aveva scelto
la strada più lunga e più difficile, la più nascosta. Il suo desiderio venne esaudito dopo 72 anni, quando la vecchissima conversa si spense, il 20 novembre
1922, dopo penose sofferenze fisiche, cieca, sorda, rattrappita. «Sto bene. Attendo la morte», aveva detto tre giorni prima.
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
PIETRO BARGELLINI
Un santo al giorno, rubrica RAI
390
15.2
Il monastero benedettino
Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, nessuno avrebbe pensato che uno dei tanti fronti di battaglia sarebbe venuto a formarsi in ciociaria
con la linea Gustav, che fece pernio a Cassino, a piè della dorsale preappenninica. L’otto settembre 1943 l’Italia, ormai prostrata, si sganciava dall’alleato
tedesco. Ricordo la sera di quel giorno, quando il popolo ebbe la sensazione
che tutto ormai fosse finito e le campane suonarono a festa. Invece il peggio
non era ancora venuto per l’Italia, che avrebbe conosciuto sul proprio corpo
l’urto tremendo tra l’ostinata resistenza dei tedeschi e le forze preponderanti
degli «alleati».
Gli angloamericani sbarcati a Salerno non fecero quella «passeggiata»
di risalita fino alle Alpi, che tutti si aspettavano. Stabilizzata, dunque, la linea
del fronte di Cassino, la guerra infuriò specialmente dal cielo, dove «le fortezze volanti» americane, precedute da ricognitori per individuare gli obiettivi
con scarsa distinzione tra quelli civili e quelli militari, scaricavano le bombe a
grappoli seminando distruzione e morte. Anche a Roma cominciarono i bombardamenti a tappeto, che si arrestarono solo per il fermo intervento di Papa
Pio XII, accorso in un primo tempo sulle rovine fumanti del quartiere San Lorenzo, dove nell’abbracciare un ferito si macchiò la bianca veste di sangue.
Il 12 settembre, la città di Veroli tremò a causa di tre bombardamenti sulla vicina Frosinone attraversata dalla via Casilina. Il terzo, effettuato al
calar della sera, fu tremendo. Il cielo era illuminato a giorno, mentre la città
capoluogo appariva avvolta da fiamme e nuvole di fumo. Su Veroli passò un
ricognitore, che accese razzi luminosi sulla villa Campanari, sede del locale
comando tedesco sottostante al muro di cinta del monastero. Lo spavento delle
monache fu grande. Rincuorate dal Padre Locher, si rifugiarono in un sotterraneo del monastero, dove rimasero per qualche ora in preghiera. Cessato il
pericolo, il buon Padre celebrò la Santa Messa in Chiesa all’una dopo la mezzanotte, comunicò le religiose ed espose il SS. Sacramento.
Si andò avanti, tra ansie e timori, mentre ogni giorno la Valle del Sacco
rintronava dal fragore dei bombardamenti e il fuoco dell’artiglieria contraerea.
Si sperava che la città di Veroli, posta fuori delle grandi vie di comunicazione,
sarebbe stata risparmiata. Intanto, il primo gennaio al furore degli uomini in
guerra si aggiunse un violento ciclone, che fece crollare gran parte del muraglione dell’orto-giardino e portò via, come fuscelli, le tegole della casa. Si
era in pieno inverno, e fu difficile riparare in qualche modo almeno i tetti. 15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
Tempo di Guerra
391
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
392
Ma il peggio venne la mattina dell’otto febbraio con il primo bombardamento
diretto su Veroli. L’obiettivo era la villa Campanari, che non fu colpita. Dopo
il vicino scoppio di una bomba, un fitto mitragliamento colpì il monastero
con una pioggia di proiettili. Alcuni penetrarono nella cella di una inferma
novantenne, che per miracolo restò illesa, mentre il letto della consorella che
l’assisteva andò in fiamme. Altri proiettili raggiunsero il refettorio, la cucina, la
lavanderia. Nell’orto cadde uno spezzone incendiario, e una sorella conversa
intenta al lavoro fu sbattuta a terra dallo spostamento d’aria e dallo spavento.
Più di una religiosa, quel triste giorno, fu sfiorata dalla morte, ma
grazie a Dio tutte furono salve. Dopo alcuni giorni, il 15 febbraio 1944, in
lontananza, giù verso l’orizzonte si notò un carosello di fortezze volanti, che
venivano a ondate dai monti Aurunci. Si seppe poi che quel giorno l’Abazia di
Montecassino era stata rasa al suolo. Tutto il mondo civile inorridì per la sacrilega quanto inutile distruzione.
Intanto il Padre Locher, che era sofferente di cuore ma più si preoccupava del monastero e delle religiose, aveva pregato il Vescovo Emilio Baroncelli
che una parte delle monache potesse rifugiarsi nei locali del Seminario, meno
esposto ai bombardamenti. La sera stessa dell’otto febbraio, mentre esplodeva
qualche bomba a scoppio ritardato, dodici monache col Padre Locher trovarono ospitalità nel Seminario. Ma era una soluzione provvisoria. La Madre
Abadessa Maria Chiara De Felice, accompagnata da due religiose, si recò in
campagna verso Scifelli, dove trovò alcuni locali in contrada «Case di Fisco».
Nel pomeriggio del 12 febbraio, un gruppo di venticinque monache
partì verso Scifelli, dove trovarono ospitalità, per quella prima notte in un conventino presso la casa dei Padri Redentoristi, che poterono offrire solo del latte
e delle sedie e panche per riposare almeno sedute. Il disagio fisico era grande,
ma molto più forte il dolore per l’abbandono del monastero e lo smembramento della Comunità. Venticinque a Scifelli, dodici in Seminario, mentre diciotto
— le più coraggiose — erano rimaste nel monastero. Il giorno seguente, le
ospiti del conventino di Scifelli si trasferirono nei locali delle «Case di Fisco».
Era un cascinale, con poche camere, senza acqua, senza luce elettrica,
senza letti, senza riscaldamento, senza provviste per il cibo quotidiano. Pur
abituate al sacrificio e alla rinuncia del superfluo, le poverine erano costrette ad
una vita quasi disumana. Le aiutò la carità dei Padri Redentoristi, specialmente
il Padre Rettore Giacomo Vigna per la parte spirituale, e quella dei contadini
del luogo che fornirono un qualche aiuto materiale. Pian piano, tra mille difficoltà, si organizzò una certa vita di comunità. In un angolino di una camera
fu eretto un modesto altare, dove ogni giorno un Padre Redentorista celebrava
la Santa Messa. Durante la giornata si pregava e si lavorava: chi alla cucina,
chi alle pulizie, chi al cucito, chi al catechismo dei bambini, chi alla ricerca di
cicorie nei campi e anche alla coltivazione di un orticello.
Purtroppo la salute del Padre Gabriele Locher andò precipitando. Il
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
suo cuore, già minato dal male, non resse. Fu trasportato dal Seminario nella
contrada di Santa Francesca, dove potè trovare più tranquillità e una generosa
ospitalità in casa della famiglia Carinci. Ma a nulla valsero le cure delle monache che da Veroli lo avevano seguito. Il 27 febbraio rese l’anima a Dio. Grande
fu il dolore non solo delle monache, ma anche di molti verolani, specialmente
i poveri, che da lui erano stati beneficati. Imponente per concorso di gente il
trasporto della salma nel cimitero, dove fu sepolto nella tomba delle benedettine. Lì ancora dorme il sonno dei giusti, all’ombra dei cipressi, accanto alla
Cappella che domina sulla collina con la scritta sul timpano: Resurrecturis. Il
suo nome è legato a un periodo della storia del Monastero di S. Maria de’ Franconi, che egli tanto amò e da cui fu ed è riamato.
Passò l’inverno. Venne la primavera, ma la guerra si faceva sempre più
aspra. Crebbero i disagi e le paure. Finalmente, alla metà di maggio, il fronte di
Cassino cedeva.
Ma come si sarebbe verificato il passaggio dell’esercito tedesco in ritirata e l’arrivo della quinta armata anglo-americana? Furono giorni drammatici. Il 30 maggio, l’Abadessa Donna Maria Chiara De Felice decise di trasferire
la comunità in un locale dei Padri Redentoristi di Scifelli. Qui, tra fitti cannoneggiamenti e bombardamenti, — vi fu anche il saccheggio da parte di un
gruppo delle famigerate S.S. — attesero l’evolversi della guerra di movimento.
Intanto, a Veroli il Monastero fu colpito da cannonate in vari punti dei piani
superiori, ma le monache si salvarono nei sotterranei. Era l’ultimo giorno di
maggio, dedicato alla Madonna. Con quanta nostalgia e trepidazione passò
quella ricorrenza, che in altri tempi era carezzata da canti in onore della Regina
della pace!... Ora si moltiplicavano le preghiere alla Gran Madre di Dio, che
nella Chiesa di Scifelli si venera col titolo di Madonna del Buon Consiglio. Intorno a quella bella immagine, nella Chiesa di Scifelli si riunirono le monache
nelle ore decisive, in cui si trovarono tra la vita e la morte.
La notte tra il 31 di maggio e il primo di giugno, alle ore due, il Rettore
P. Vigna celebrò la Santa Messa e distribuì la Santa Comunione, che scese nei
loro cuori portando conforto e speranza.
Il giorno seguente finalmente arrivarono le prime avanguardie dell’esercito liberatore. Impressionava ora l’imponenza dei mezzi corazzati e il miscuglio di soldati di varie nazionalità e di lingue esotiche.
La Madre Abadessa Donna Maria Chiara De Felice su di un asinello,
che faceva contrasto con lo sferragliare dei carri cingolati e le colonne interminabili di macchine militari, accorse a Veroli, mentre le consorelle si spostavano
a Case di Fisco per riordinare quel poco che rimaneva di masserizie e di oggetti vari e prepararsi al ritorno definitivo in Monastero.
Come dopo un furioso temporale il cielo percorso dalla nuvolaglia
rabbonita pian piano si rasserena, così andò finendo la terribile vicenda. Il 5
giugno tutte le monache erano tornate e riunite nel Monastero di Santa Maria
393
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
de’ Franconi. Molti i danni, ma nessuna mancava all’appello. Dopo la visita del
Vescovo Emilio Baroncelli, fu cantato il Te Deum.
La pagina più terribile della storia del monastero si chiudeva, mentre, purtroppo, gli uomini continuavano la strage fratricida. Per le monache di
clausura, con la ripresa regolare dell’Ora et labora, non restava che pregare per
la pace degli uomini e l’avvento di un’era nuova.
A conclusione di questo capitolo, anche se parrà strano, mi permetto
di ricordare oltre i nomi delle persone che furono vicine alle nostre religiose, il
generale tedesco von Senger und Etterlin, che comandava il settore del fronte
di Cassino e dirigeva le operazioni belliche dal quartiere di Castelmassimo in
territorio di Veroli. Oblato benedettino, fece il possibile per salvare la popolazione dalle angherie delle S.S., che non dipendevano da lui, e fu largo di attenzioni per il nostro Monastero1. Dopo il conflitto gli stessi nemici riconobbero
non solo la grande abilità strategica, ma anche la correttezza di questo generale
costretto a servire in una guerra insana voluta dal despotismo di Hitler. Non
conosciamo il dramma intimo della sua coscienza di cattolico, ma sappiamo
che ogni domenica veniva ad ascoltare la Messa nella Cattedrale di Veroli, e la
sua compostezza edificò il popolo, che seppe distinguere tra la malvagità e la
dirittura morale degli uomini coinvolti in una così immane tragedia.
394
DON ANDREA SARRA
Storia del monastero di Santa Maria dei Franconi
Casamari 1977
1
Quando poteva, Senger accettava l’invito a pranzo della badessa Madre Chiara De Felice. «Il convento si trovava in una tranquilla piazzetta. La porta veniva aperta da una donna del
paese, dato che le suore non potevano abbandonare la clausura. Anche noi dovevamo trattenerci
in una stanza che non faceva parte della clausura. In un angolo, a terra, c’era un braciere con del
carbone acceso. L’unico ornamento dell’ambiente consisteva in un crocifisso sulla parete, ma al
centro si trovava una tavola apparecchiata dall’aspetto invitante. A un certo punto comparivano,
dietro una finestrella sbarrata da una doppia inferriata, i nostri anfitrioni: la badessa e una suora
tedesca. I volti delle due religiose si distinguevano a malapena a causa della penombra e delle
grosse sbarre di ferro, ma rivelavano ciò nondimeno l’attraente gentilezza dovuta alla bontà e
alla serenità che così spesso si riscontrano nelle suore. Durante tutta la nostra permanenza a
tavola, le due suore restavano dietro le sbarre senza pronunciare parola. Le pietanze arrivavano
dalla clausura attraverso la “ruota”, un portello a battenti mobili, e ci venivano servite da una
domestica laica».
Madre Chiara De Felice
Nata a San Giovanni Incarico (Fr) nel 1899 dal barone Antonio De Felice e da Anna dei conti Franchi de’ Cavalieri, entrò nel monastero benedettino
di Santa Maria dei Franconi in Veroli il 7 ottobre 1917. Vestito l’abito religioso
nell’anno successivo, fu eletta abadessa l’11 maggio 1940. Scrive di lei il prof.
Umberto Caperna, ordinario di latino e greco nei licei classici: «Non è facile
fare un’analisi precisa ed esauriente di tutta la sua attività e del suo magistero,
che si svolse sempre all’ombra della discrezione e del silenzio. (...) Guidò la sua
comunità nello spirito strettamente benedettino, cercando di coinvolgerla in
modo totale nella vita consacrata e quindi nel cammino verso il cielo. (...)
Poneva alla base di qualsiasi progetto o iniziativa, la fede e la preghiera
nel solco più autentico della Regola, che stabilisce che nulla si intraprenda senza chiedere l’aiuto di Dio con la preghiera. Tutte le persone, una volta entrate
in contatto con Madre Chiara, diventavano suoi figli nello spirito e lei stessa
costituiva un sicuro punto di riferimento per tutti. (...) Sapeva conquistare tutti
con la sua profonda spiritualità e con la squisita gentilezza che sgorgavano da
un’anima di grande nobiltà. (...) Madre Chiara ti ascoltava volentieri e aveva un
comportamento superiore che ti convinceva e ti conquistava dal di dentro. A
sentirla si provava una grande gioia interiore e desideravi che il suo colloquio
non finisse mai» (UMBERTO CAPERNA in Luci di un’anima, Madre Chiara De
Felice, Monastero di Santa Maria de’ Franconi, 1990).
Madre Chiara aveva una profonda venerazione per il Santo Patriarca
Benedetto e non di rado la manifestava ricorrendo in casi di necessità alla cosiddetta medaglia o croce di S. Benedetto. Riportiamo alcuni brevi episodi in
cui l’aiuto invocato trovò risposta. Per alcune notti consecutive il lamento di
una civetta continuava a disturbare in modo particolare il sonno di una monaca. La poveretta cercava di assopirsi, ma nemmeno con le pastiglie adatte era
riuscita a trovar rimedio contro l’insonnia. Le ore di veglia l’avevano innervosita a tal punto che, stanca e spazientita, esclamò a voce alta: «Possibile che io
debba sentire questa bestia piangere? Lei dorme di giorno, io però devo dormire di notte» e spinta agli estremi dall’insofferenza concluse: «Madonna mia,
falla crepare!». Madre Chiara, che era al corrente della difficoltà, benedicendo
l’animale con la medaglia di S. Benedetto, disse: «Creaturella di Dio, vai in un
altro posto, dove non disturbi nessuno». La mattina seguente, verso le nove, la
molesta inquilina traslocò, volando via con la sua nidiata.
Un’altra volta venne indicata alla Madre una rondinella sul tetto della
cucina. La bestiola aveva l’ala rotta e giaceva immobile tra le tegole, in attesa di
sicura morte perché i gatti l’avevano già adocchiata. Immediatamente la Madre
Abadessa con la medaglia di San Benedetto in mano, pregando e benedicendo
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
15.3
395
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
396
ripetè più volte: «Rondinella vola!». Come per incanto l’uccello spiccò il volo e
la banda di felini rimase senza pranzo.
In un’altra circostanza fu alle prese con i pennuti e usò la sua grande
fiducia nell’intercessione del Santo Padre Benedetto.
La monaca che si prendeva cura del pollaio si lamentò della strage
che due galli stavano spargendo tra le galline. Uno voleva prevalere sull’altro
e così c’era sempre guerra e volavano piume. In tempo di ricreazione, dopo il
pranzo, Madre Chiara scese all’orto e si accostò al pollaio. La custode si mise
i due accaniti rivali appollaiati sull’avambraccio e li presentò stando dietro la
rete metallica del piccolo recinto. L’Abadessa, mostrando la medaglia di S. Benedetto, proferì le testuali parole: «Vi comando, in nome di Dio e di S. Benedetto, di non toccare più una gallina». I galli, prima battaglieri, come storditi
abbassarono la testa ed in seguito non diedero più fastidi.
Forse il fatto più noto, legato alla devozione della medaglia benedettina è la storia di un tiglio tagliato, ripiantato senza radici e ancor oggi rigoglioso. La questione iniziò con il desiderio dell’ortolana di sfruttare un pezzo di
terra per piantarvi l’insalata. Nel mezzo di questo spazio c’era però un giovane
tiglio che con le sue fronde faceva ombra. Approfittando della presenza di alcuni operai la buona monaca, ben intenzionata, pensò di risolvere il problema
tagliando il tronco. Aihmé, senza chiedere il consenso alla Superiora, la quale non appena se ne accorse chiese severamente: «Chi ha detto di recidere
quell’albero?». Sopraggiunta a cose fatte non si fermò all’evidenza di una realtà
irreparabile e seguitò con un comando: «Mettetelo là» indicando un sito vicino
alle scale, che dalla terrazza portano giù all’orto. Nel buco scavato collocò una
medaglia di S. Benedetto e la pianta senza radici, ripiantata per obbedienza,
riprese vigore e anche a noi oggi mostra le sue folte chiome che superano addirittura l’altezza del caseggiato vicino a cui si erge.
Il segno della provvidenza
Un’anima che vive di fede conosce i prodigi della Provvidenza. Tale fu
l’esperienza di Madre Chiara in tutto l’arco del suo abbaziato. Anche quando
l’urgenza di determinate necessità metteva a dura prova lo spirito di abbandono nella bontà del Padre che tutto provvede, lei sapeva mantenere ferma e
serena la fiducia nell’aiuto divino.
Innumerevoli episodi tratteggiano una vita costantemente affidata al
Signore ed immancabilmente benedetta con fatti evidenti, testimonianza di un
Dio presente ed attento alle sue fedeli Spose.
Così nel caso di un inverno inoltrato la cui rigidezza metteva a dura
prova la salute delle monache. La Madre, preoccupata ed impietosita, pensò
che un po’ di carne in più da dare alle monache fosse un buon sostegno, ma alla
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
previdente proposta l’economa fece giustamente notare che con solo quattro
soldi non si poteva comprare alcun pezzo per un buon bollito. Alle obiezioni
della celleraria contrappose la sua fiducia nella Provvidenza e disse: «Prendi
questi quattro soldi e dalli al primo povero che si presenta, con la raccomandazione di recitare una “Ave Maria” secondo le mie intenzioni». Così fu fatto.
Un po’ più tardi la Madre si recò in parlatorio per l’inaspettata visita di
una contessa sua lontana parente. Appena la vide, la signora si mise a raccontare come da tutta la mattina sentisse spinta a recarsi al monastero per dare un
contributo denaro. Venuta a conoscenza del reale bisogno pose termine a quel
particolare incontro con una offerta. Il Signore non si era lasciato vincere in
generosità.
Durante la guerra capitava spesso che persone prive di tessera ricorressero alla carità dell’Abadessa. Rasentavano i limiti della sussistenza e lei era
sempre pronta a tendere una mano, comportandosi come S. Benedetto, che
durante la carestia che afflisse la Campania (537-538) «aveva distribuito a molti poveri tutte le provviste e monastero, sicché in dispensa non rimaneva quasi
più nulla...» (S. Gregorio Magno, Dialoghi, XXVIII). Di volta in volta ordinava
a monaca dispensiera di portarle 1 kg., 2 kg., 3 kg. di farina fino a quel mattino in cui ne chiese addirittura 6 kg. La causa di una richiesta così esosa era
la povertà estrema in cui versava una famiglia: una donna, con il ricovero in
ospedale del marito, era rimasta sola con a carico sei bambini in tenera età. La
dispensiera, attenta a non smaltire di troppo le già magre scorte, prevedendo
la scarsità per le consorelle, si impennò: «Ma Madre Abadessa, si è dimenticata che ha tante bocche da sfamare?». La Madre rispose: «Dia quello che ho
detto, non sento ragioni». Tra un brontolamento e l’altro la farina fu consegnata. Giunse l’ora del pranzo e dopo che la comunità ebbe recitato il Magnificat
l’Abadessa dovette recarsi d’urgenza in portineria. Ufficiali tedeschi avevano
parcheggiato fuori del portone un camion carico di ogni ben di Dio e rassicurando le religiose ripetevano dietro l’uscio ancora chiuso: «Aprire, aprire, portare roba...». La prima merce ad essere scaricata fu la farina, non solo qualche
chilo ma tanti sacchi, sei quintali al posto dei sei chilogrammi “perduti” poco
prima. E poi lupini, cioccolato, caffè ed in ultimo mezza giovenca. La carità
attuata verso i militari e verso la povera gente aveva, ancora una volta, attirato
sul monastero altrettanta abbondante Provvidenza e la dispensiera, capita la
lezione del «Date e vi sarà dato» esclamò vivacemente: «Madre Abadessa, dia
pure tutto il monastero, non me ne importa più!».
Maestra di carità, Madre Chiara si commuoveva di fronte a quella altrui e soleva affermare: «Io sono grata anche a chi mi porta un fagiolo perché
per portarmelo se lo è tolto».
Non fu raro che la Madre nell’esprimere piccoli desideri, venisse appagata dalla Provvidenza per le vie più imprevedibili.
Un giorno, sotto il peso della croce, così pregò il Signore: «Dammi un
397
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
398
segno che le mie sofferenze ti sono accette: mandami un fiore bianco». Il conforto arrivò. Una signora presentandosi in portineria con una rosa bianca, era
inverno, disse: «Questa l’ho portata alla Madre Abadessa. È strano, l’ho trovata
nel mio giardino».
Alla monaca che le chiedeva cosa gradisse per pranzo, Madre Chiara
continuava a replicare il rifiuto di qualsiasi cibo, perché si sentiva male e preferiva il digiuno. Alla fine, per accontentare la sollecita infermiera e nel contempo
non mangiare, espresse con santa furbizia una richiesta impossibile: «Dammi
due asparagi». E l’altra: «Adesso gli asparagi? Ma è inverno e non si trovano!».
La Madre concluse: «E va bene, fa conto che non abbia detto niente». Dopo
alcune ore si avvicinò alla ruota del monastero un anziano fruttivendolo e indescrivibile fu la sorpresa delle monache quando seppero il motivo di quella
comparsa: «Sono andato a Terracina — specificò il vecchietto — ho trovato
questo mazzetto di asparagi e ho pensato di portarlo alla Madre Abadessa».
Chi ha conosciuto Madre Chiara sa che era molto devota di S. Giuseppe. Non perdeva occasione per narrare la grande potenza interceditrice del
prudente Custode della Sacra Famiglia e con ricordini di vario genere, ampliava il messaggio di propaganda. La sua filiale fiducia era sostenuta dall’esperienza di tante grazie, di tanti disagi risolti, ad esempio quando una volta
c’erano le tasse da pagare ma non i soldi per effettuare il versamento. L’economa mostrò tanta apprensione ma l’Abadessa la tranquillizzò, almeno momentaneamente con un: «Stia tranquilla, ci pensa S. Giuseppe». Passarono i giorni
e l’economa pensando ad una dimenticanza ripresentò l’urgente problema:
«Madre, se entro domani non si paga...» ma fu interrotta dal solito ritornello:
«Stia tranquilla, c’è S. Giuseppe». Il giorno seguente, in coincidenza con lo scadere del termine di tempo concesso per pagare, la portinaia, come tante altre
volte, avvisò la Madre che alle grate c’era un signore che desiderava parlarle.
Ella scese immediatamente nel piccolo parlatorio, udì una voce d’uomo che le
disse: «Per i bisogni della casa», ma avvicinandosi alle grate per ringraziare e
vedere lo sconosciuto benefattore non scorse alcuno. Nella ruota trovò una busta con l’offerta necessaria. Chiamò subito Maria, la portinaia-guardiana, che
accudiva alla foresteria, per chiederle informazioni circa la persona che non si
era presentata. La buona donna rispose un po’ seccata per la strana domanda:
«Ma che signore volete che sia entrato a quest’ora se sto aprendo adesso il portone?».
Un anno, alla vigilia di S. Salome (25 maggio) amata Patrona della città di Veroli, la Madre pensò di allietare la solenne ricorrenza acquistando per
il pranzo un po’ di bistecche. Informata l’economa della speciale iniziativa non
trovò parere favorevole: «Eh sì, le bistecche!» — borbottò — «Quelle costano.
Le monache ringrazino Dio se hanno la fettina». La Madre senza replicare
andò in cappella e pregando si rivolse all’Economo, che immancabilmente l’accontentava: « S. Giuseppe pensaci tu». Più tardi un amico del monastero suonò
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
in portineria e consegnando una pesante borsa disse: «Queste le ho portate alla
Madre Abadessa». Il contenuto: quarantadue bistecche!
Un’altra volta occorrevano due milioni per pagare il gasolio, la buona
economa sempre un po’ agitata per le continue spese e le scarse possibilità finanziarie si lamentò e rivolgendosi all’Abadessa esclamò: «Dica a S. Giuseppe
che si muova!». Trascorsero alcune ore. Madre Chiara ricevette la visita di persone care, le quali senza saper nulla dell’accaduto precedente lasciarono come
offerta uno cheque con la bella cifra di... due milioni esatti.
Madre Chiara ricorse a S. Giuseppe anche in altre semplici necessità
della vita quotidiana. Accadde che la mancanza di sale, tutta la zona era rimasta sprovvista, rendesse impossibile la preparazione del pane. Chiamati diversi commercianti più di una volta per procurarsene almeno un po’, la risposta
fu sempre negativa e alla fine molto sgarbata. Il sale non c’era e basta. Alla
tradizionale e sperimentata invocazione: «S. Giuseppe pensaci tu», la Madre
aggiunse un simpatico gesto: mise un po’ di sale in una piccola tazzina ai piedi della statua del Santo, come promemoria. Subito dopo uno dei negozianti,
completamente rabbonito, si adoperò per inviare gratuitamente in monastero,
mezzo quintale di sale.
Così successe per altri generi alimentari, come ad esempio la pasta,
mai mancata da quando Madre Chiara incaricò S. Giuseppe di procurarla.
Anche nel campo della meteorologia preghiere e grazie si intrecciavano. Quando un anno la neve rischiò di sfondare alcuni vecchi tetti pericolanti,
Madre Chiara fece mettere vicino ad una finestra la statua del caro S. Giuseppe.
Con tanto fervore lo pregò di fermare la caduta dei candidi fiocchi, per evitare
pericoli e seri danni. Nulla mutò. Fece allora accendere due candele, ma niente
da fare. Allora pensò di portare processionalmente la statua in coro, con la speranza di ottenere ascolto. Spinta dalla profonda fiducia bussò all’intercessione
ricorrendo a devoti stratagemmi eppure, questa volta tutto pareva inutile. Ferma nelle incrollabili attese e preoccupata più che mai per gli eventuali crolli,
tornò nuovamente alla carica... con una scodella piena di neve. Ne depositò
un pizzico proprio sul piede della statua e grande e generale fu lo stupore nel
constatare il reale miglioramento del tempo.
Se profonda e costante era la fiducia per S. Giuseppe, filiale e tenerissima era la devozione della Madre Chiara verso la Madonna. Bramava onorarla
soprattutto con la quotidiana recita del rosario e la implorava per il sollievo
di tante anime sofferenti. La corona non mancava mai nelle sue mani. Grano
dopo grano, ella penetrava nel mistero della vita di Cristo e di Maria. Quella
dolce catena di “Ave Maria” la fissava ad una intensa e commovente confidenza
nella Madre del Redentore. Spesso si faceva portare in cappella per un saluto
alla Madonna del Divino Amore e sarebbe rimasta lì per delle ore. Tra i tanti
piccoli doni che amava fare alle monache o alle persone che la frequentavano
c’era immancabilmente il rosario, con la raccomandazione di pregare riper-
399
correndo la strada del Signore. «Affidiamoci a Maria e chiediamole una vita
interiore intensa». Lei stessa si definiva «la piccola Maria del “Sì” al servizio di
Gesù».
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
LUCI DI UN’ANIMA
Madre Chiara De Felice, in Potenza e Carità di Dio, 1990
400
Padre Gabriele Locher
Lo vidi, la prima e l’unica volta, entrando a caso nella chiesetta delle
Benedettine. Celebrava la Messa. Non mi colpì tanto l’accento esotico con dure
inflessioni tedesche sul latino liturgico. Né la sua alta persona, la testa rasata
nella più rigida foggia monastica, e la pianeta bizantina — allora una rarità —
che gli scendeva dalle spalle, conferendo maggiore spicco alla imponente figura sacerdotale. Ma la sua devozione, il suo atteggiamento nell’offrire il calice,
il suo modo di guardare l’Ostia consacrata, i suoi occhi e la sua voce nel dare
la Comunione ai fedeli!... Si capiva subito che era l’uomo di Dio. Il MonacoSacerdote colmo di fede e di carità.
Era l’anno 1939. L’anno della mia prima Messa. Tutte le prediche che
mi avevano fatto in Seminario non furono, forse, così efficaci come quell’esempio vivente, per sentire e celebrare degnamente il Sacrificio di Cristo.
La guerra, nei mesi cruciali, mi portò lontano da Veroli. Tornai e, dopo
qualche anno, fui Cappellano delle monache benedettine di clausura.
La Comunità mi apparve ordinata e plasmata da una mano superiore. C’era buono spirito. C’era grande semplicità, umiltà, obbedienza. Ma c’era,
soprattutto, molta preghiera e lavoro, come vuole S. Benedetto. C’era il respiro
di una liturgia senza fronzoli, e il canto gregoriano come non avevo sentito in
nessun altro Monastero femminile d’Italia.
Mi dissero che un monaco tedesco, Padre Gabriele Locher, era passato nella Comunità e aveva fatto delle riforme. Mi dissero che era un “santo”
Che era forte come una roccia e delicato come una madre. (Pensai a S. Paolo,
che bruciava nella rampogna e chiamava “fittoli” quelli che aveva generato a
Cristo). Mi dissero anche che era morto durante la guerra, lontano dalla sua
Abbazia adagiata nella valle di Beuron. Non mi fu difficile comprendere che
Padre Locher era quel monaco, che avevo visto celebrare la Messa in un giorno
qualsiasi del 1939, entrando a caso nella Chiesa delle Benedettine, e che mi
aveva fatto la predica coll’esempio, al modo di S. Francesco.
Era nato il 16 novembre 1884 a Bremelau nel Wurttemberg. A battesimo fu chiamato Agostino. Compiuti gli studi umanistici a Rottemburg (18851899) e a Kottweil (1899-1904), bussava al grande Arcimonastero di Beuron,
che conia duecento monaci. Vi fioriva una scuola teologica di alto livello che
si poteva alimentare ad una ricchissima biblioteca, ed una scuola d’arte sacra,
che ha lasciato anche in Italia una impronta nella cripta di Montecassino e nel
coro del Monastero di Veroli.
Professò i voti solenni il 10 novembre 1905, a ventuno anni. Ma per
altri sei anni fu impegnato negli studi, prima a Maria Laach e poi di nuovo a
Beuron. Maria Laach condivide con Beuron il primato in quella fìtta rete di ab-
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
15.4
401
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
402
bazie benedettine, che sono la più grande gloria civile e religiosa della Germania, Se non erro, neppure Hitler, che pure chiuse tutte le altre, osò toccarle. Il
grande Adeneuer trovò rifugio e approfondì il suo adamantino cristianesimo,
che non si era piegato alla dittatura nazista, nel clima della Abbazia Benedettina di Maria Laach.
L’otto settembre 1910 Agostino Locher, che in religione aveva assunto
il nome di Gabriele, era ordinato Sacerdote.
L’ingegno e la pietà del giovane monaco avevano colpito i Superiori,
che lo inviarono all’Università di Freiburg (in Briscovia). Poi fu chiamato a
Roma, come docente di latino al Collegio Greco di S. Atanasio. Fu professore
di latino e di greco antico anche nel Seminario del Laterano. Di lui molti ex
alunni del Seminario Romano conservano il più grato ricordo.
Con l’entrata in guerra dell’Italia, il Padre Locher fu costretto a lasciare Roma. Lo troviamo a Beuron nel 1916, nominato Segretario dell’Abate
Primate P. Fidelis von Stotzingen. Subito dopo la guerra tornò a Roma, e riprese l’insegnamento al Laterano, mentre occupava la cattedra di greco biblico a
S. Anselmo, dove rimase Segretario del Padre von Stotzingen fino alla morte.
Per oltre venti anni lavorò intensamente per l’Ordine, servitore fedele e intelligente, umile e caritatevole. Pubblicò quattro volte il catalogo dell’Ordine e gli
«Annales O.S.B.» dal vol. VI (1913) al vol. XX (1938). Gli fu affidato, per qualche anno, l’ufficio di Maestro dei Fratelli Conversi e fu nominato Postulatore
della Causa di Fratel Mekirad Engster, Monaco di Einsiedeln.
II 26 maggio 1931 l’Abate Primate Don Fedele von Stotzingen fece visita al Monastero di Veroli. La Comunità, che viveva nel ricordo di una Sorella
Conversa morta, pochi anni prima, in odore di santità, gli fece una buona impressione. Ma l’edificio accusava il peso degli anni, e la spiritualità, alimentata
da ottimi Direttori Spirituali del clero secolare e regolare, richiedeva un indirizzo e una guida più marcatamente e specificamente benedettina. L’Abate
Primate fece una promessa e la mantenne.
Il martedì in Albis del 1932 mandava il suo stesso Segretario, Padre
Gabriele Locher. Si può dire che la sua venuta segnò una svolta nella storia
della Comunità.
Con saggezza e prudenza, con delicatezza e fermezza, ma soprattutto
con l’esempio, iniziò una progressiva riforma. In particolare sostituì il canto
gregoriano al polifonico, facendone comprendere la storia e lo spirito liturgico
in una serie di conferenze. Il primo giugno del 1932 inviò uno specialista, Don
Agostino Baumer, il quale diede un corso di lezioni teorico-pratiche. Il Padre
Locher, quindi, passò a svolgere la sua azione nel campo più vasto nella liturgia. Venne il Maestro dei Novizi di S. Paolo di Roma Padre Ambrogio Wultur,
che tenne un nutrito corso di lezioni sulla vita liturgica, specie in riferimento
all’Opus Dei, che è il cardine della Regola Benedettina.
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
Il 3 dicembre 1933, dopo aver dettato gli Esercizi Spirituali, il Padre
Gabriele Locher assumeva ufficialmente l’alta direzione del Monastero.
È impossibile dire quanto egli fece sul piano spirituale e materiale.
Non solo le monache nella clausura, ma anche quanti lo conobbero a Veroli
restarono edificati del suo esempio. Rigido con sé, aveva modi straordinariamente caritatevoli e gentili senza alcuna punta di affettazione. Aveva e faceva
la carità ai poveri. Non la piccola elemosina, ma il soccorso dato al fratello con
cuore di fratello. Aiutò anche altri monasteri d’Italia. Ma quello di Veroli fu
il prediletto. Tra l’altro, rinnovò con la guida artistica del Conte De Witten la
decorazione della chiesina aperta al pubblico. Fece venire alcuni fratelli laici di
Beuron per rivestire il coro interno di pitture, che sono tipiche di quella scuola
ispirata ai canoni dell’arte egiziana con l’anima cristiana del Beato Angelico.
C’era, tra quelli monacelli, un tal Fra’ Beato, che dipingeva pregando,
con la stessa ingenuità e fede, che io immagino sostenessero il pennello del
Frate Domenicano del Convento fiorentino di S. Marco.
Al Padre Gabriele Locher fu affidato anche l’ufficio di Postulatore della
causa di Suor Maria Fortunata Viti. Se il processo canonico ha fatto passi da
giganti, e dopo quarant’anni si è arrivati al Decreto dell’eroicità delle virtù, si
deve molto alla impostazione e alla previggenza di Padre Locher. Diresse la ricognizione e la traslazione della salma dal cimitero di Veroli alla Cappella delle
monache, in perfetta armonia e con l’incoraggiamento fervoroso del Vescovo
S. E. Mons. Francesco De Filippis. Fu un vero trionfo popolare. Mai vista a
Veroli tanta gente, accorsa anche da tutte le Parrocchie della Diocesi!... C’erano
molti Abati Benedettini e la Schola Cantorum di S. Anselmo. Non basta. Padre Locher scrisse la vita di Suor Maria Fortunata Viti in tedesco, con il titolo
«Aus verborgenheìt ans Licht», cioè «Dall’ombra alla luce», che fu pubblicata in
Germania nel 1937, quindi tradotta in italiano e pubblicata, per i tipi di Reali
di Veroli, nel 1940. Non solo in Germania, ma anche in altre parti del mondo,
specialmente negli Stati Uniti, attraverso la rete di conoscenze e di amicizie
nell’Ordine Benedettino, il Padre Loeher riuscì a far conoscere l’umile figura
della Serva di Dio verolana avviata agli onori degli altari.
Venne la terribile guerra del 1939. Gli eventi drammatici del 25 luglio e 8 settembre 1943, che portarono la guerra sul territorio italiano, con i
tedeschi impegnati al fronte di Cassino, sorpresero Padre Locher a Veroli. La
malattia di cuore, che lo minava da tempo, si fece più grave. Intanto crescevano
le sofferenze della guerra, si inasprivano gli odi e il settore di Cassino diventò
un inferno. La stessa Abbazia di Montecassino fu al centro della tragedia. Ci
furono bombardamenti e mitragliamenti anche su Veroli. Fu colpita un’ala del
Monastero e le monache dovettero sloggiare.
Come poteva reggere il suo cuore?... Prima fu trasportato in una camera del Seminario Vescovile, aperto ad altri gruppi di sfollati. Poi nella frazio-
403
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
404
ne rurale di S. Francesca, dove fu ricoverato nella casa della famiglia Carinci.
Qui passò gli ultimi giorni, offrendo il sacrificio della vita per la pace degli
uomini. Visse ancora per apprendere la distruzione completa di Montecassino.
Il 27 febbraio, a soli 60 anni, morì assistito da alcune monache, che gli furono
vicine fino all’ultimo respiro, pregando con lui, più edificate che sconsolate
dalla santa morte del loro più grande padre, maestro e benefattore. Il Vescovo
S. E. Mons. Baroncelli volle essere presente ai funerali. Quindi con il popolo lo
accompagnò al cimitero, dove fu deposto nella tomba delle benedettine.
Nell’agosto del 1960, passando le vacanze in Germania, fui anche a
Beuron. Visitai l’Abbazia grandissima in ogni settore. Fui condotto a vedere il
piccolo cimitero dei monaci. Tra le umili fosse, segnate dal nome dei monaci
trapassati, notai quella di Fra’ Beato, l’ultimo monacello pittore della scuola
beuronense, che aveva dipinto la Crocifissione e le eteree Sante Vergini dell’Ordine Benedettino nel coro di Veroli. Pensai che era dolce dormire nella pace
di quella valle stupenda, nel silenzio dei boschi, all’ombra della croce che s’innalza sulla più alta delle roccie emergenti tutt’intorno dalla corona di verde. Si
sentiva il mùrmure lieve del Danubio, che, vicino alle sorgenti, non irrompe
ancora maestoso e regale, ma sembra intonarsi alla pace e al silenzio del luogo.
Lì doveva riposare anche il Rev.mo Padre Gabriele Loeher. E avrei trovato la sua fossa e il suo nome accanto a quella di Fra’ Beato, se la sua salma
non dormisse, anonima, sotto la pietra della tomba comune delle “monache
buone”, sulla collina del cimitero di Veroli, avvolto di neri cipressi.
DON ANDREA SARRA
15.5
Il Conte Stanislao De Witten
Quando ero piccolo seminarista di dodici anni, andavo a giocare al
pallone con la Camerata nel prato adiacente la villa del Conte De Witten. Prima e dopo il giuoco entravamo nella Cappellina della villa a dire una breve
preghiera. Come era bella e devota la Cappellina del Conte! Ci dicevano che
era stata dipinta da lui, quel bel Signore alto, con i capelli bianchi, con la bocca
sempre aperta al sorriso, che aveva la bontà e la nobiltà stampate sul volto. Ci
dicevano che il Conte era un grande artista e che perfino il Papa era stato un
bel pezzo fermo, seduto sulla poltrona, a farsi fare il ritratto da lui (a quell’età
non capivo il verbo «posare»).
E poi il Conte era un gran signore, aveva possedimenti all’estero, era
anche un famoso cacciatore. Ne facevano fede i numerosi trofei: corna giganti
di cervi, di daini, una spaventosa testa di cinghiale e qualche testina graziosa
di volpe che eran disposte in bella fila lungo la scala esterna fino alla veranda e
al salottino del primo piano. Sotto la fila dei trofei correvano le targhe di legno
con la data e il luogo dove ciascuna bestia era stata abbattuta. Nomi esotici di
foreste nordiche e di castelli boemi.
Tutto ciò mi faceva una certa impressione. Ma l’impressione crebbe,
quando un giorno che era venuto con noi Monsignor Rettore e dava la Benedizione nella Cappella, notai che il Conte faceva da sagrestano. Avevo quasi
sempre visti sagrestani sghembi, lerci o minus habentes. Non potevo concepire
che quel grande Signore prendesse la canna per accendere e spegnere le candele, servisse al Sacerdote, suonasse il campanello. E poi durante la Benedizione
se ne stava lì in ginocchio guardando l’Ostia con due occhi così lucidi di fede e
di commozione, che pareva proprio un Santo.
Così vidi il Conte Witten, quando avevo dodici anni.
Nascita a Montecitorio
Era opinione comune che il Conte Stanislao De Witten discendesse da
un’antica e nobile famiglia austriaca. Ma egli teneva a dirci che era Romano.
Un giorno mi sciorinò alcuni sonetti del Belli con tanta disinvoltura e con una
pronunzia così schiettamente romanesca, che ci si sentiva il buon sangue di
Roma.
Egli difatti nacque il 3 gennaio 1867 in Roma, a Montecitorio. Proprio
in quel palazzo dove oggi i deputati tra vivaci scambi di parole e di pugni creano le leggi della prima Repubblica italiana. I suoi genitori, Ignazio e la Contes-
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
La prima conoscenza
405
sa Macchi di Cellere, vi abitavano con Monsignor Luigi De Witten, fratello di
Ignazio, che era Ministro dell’Interno del Governo Pontificio. I bersaglieri, tre
anni dopo la sua nascita, entrarono a Porta Pia. Egli, educato a forti sentimenti
religiosi dai genitori piissimi, dopo aver conseguito la licenza liceale nell’Istituto Angelo Mai, si dedicò interamente all’Arte. La squisita sensibilità dell’animo
aristocratico e profondamente cristiano, la ricca cultura acquistata nei numerosi viaggi all’estero (parlava il tedesco, il francese, l’inglese, il boemo), i suoi
maestri d’Arte, rinomatissimi, fecero di lui un grande artista.
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
Al servizio di Dio e dell’Arte
406
La sua vita fu impostata su questi due temi: Dio e Arte. Ma forse si
direbbe meglio che tutta la sua vita fu orientata verso di Dio. Che l’Arte per lui
fu un modo di servire Dio, di scoprire Dio nelle creature.
Fu guardia nobile nella Corte Pontificia per 31 anni e raggiunse il grado di Esente. Ma la nobiltà dei natali e l’altezza dell’ufficio non l’adagiarono
nella neghittosità e nella ricerca del gran mondo. Lavorò sempre, ma dall’Arte
non chiese lucro ed onori. Architetto e pittore di fama internazionale, spese
i suoi talenti, in gran parte, per il decoro della Casa di Dio. Lavorò intorno
a palazzi e castelli in Cecoslovacchia, eresse una Chiesa a Budapest, fu collaboratore del Maccari negli affreschi della cupola della Basilica di Loreto e in
tante altre opere. A Loreto dipinse anche il trittico della Cappella nazionale
degli Slavi. Lavorò con l’Accademico Gaudenzi. Fu ritrattista rinomato. Invitato a partecipare alla Biennale di Venezia, vi espose alcuni ritratti che furono
ammirati e premiati. I Papi Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII,
posarono per lui. Le sue opere si trovano sparse nel mondo. Nelle Americhe,
ritratti di Papi e di Santi. In Italia, Germania, Ungheria, Austria e Romania,
ritratti di parenti, amici e sovrani, ricostruzione e decorazioni di castelli medioevali, di Chiese, di ville antiche e di palazzi.
Francescano
Nei suoi numerosi viaggi all’estero e in Italia il Conte De Witten frequentò tutta la più alta aristocrazia d’Europa, con la quale era legato da vincoli
di amicizia e di parentela.
Sposò nel 1895, a Dresda, la Contessa Fanny Strachwitz, dama di corte
della Regina di Sassonia.
Pur vivendo nel fasto del mondo, egli fu sempre un’anima semplice,
sinceramente cattolico, di costumi illibati, sempre pronto a lenire le sofferenze.
Sapeva stare nella grande società, dove la sua presenza imponeva riguardo, ma
di quella società non divise la frolla, inutile vita. Ai grandi ricevimenti preferiva spesso, in Roma, le lunghe ore della notte passate in adorazione del Santissimo Sacramento. Egli non spezzò mai la integrità della vita cristiana. Tutto d’un
pezzo, fu cattolico apostolico romano in famiglia, a corte, nel divertimento
come nel lavoro.
Appassionatissimo cacciatore e amante della montagna, vedeva nella
natura la presenza di Dio. La vedeva nella delicatezza del fiore come nella terribilità della tempesta. In tal senso ebbe un animo francescano. Apparteneva,
difatti, al Terzo Ordine ed era Oblato di S. Benedetto. Ma non formalmente. Se
portava il cordiglio di S. Francesco, coltivava lo spirito di povertà. Non cercò
mai di accrescere la sua fortuna, perché credeva che i veri tesori fossero quelli
della grazia, che il tarlo non corrode e la tignola non corrompe.
Nel 1915 si trasferì a Veroli con la moglie. Da un cascinale in campagna, appartenente alla famiglia dei Marchesi Bisleti, egli seppe tirar fuori
una graziosa villetta, nido di pace e di amore agli uomini e a Dio. La Contessa
Fanny spendeva le sue giornate a ricamare tovaglie con pizzi finissimi per la
Cappellina o a cucire vestiti e camicette per i bambini poveri della contrada. E
il Conte dipingeva.
Eppure ci fu in quei primi tempi chi osò insultarlo. Alla dichiarazione
di guerra contro l’Austria, un gruppo di esaltati andò, di notte, a tirar sassi e a
«dimostrare» contro i due buoni Signori. Egli uscì dalla villa. Calmo e sereno
disse che non era proprio il caso che italiani se la prendessero con un italiano. E gli scalminati se ne andarono. Non serbò nessun rancore della cosa.
Anzi in Veroli profuse, per tanti anni, i tesori della sua bontà e della sua intelligenza. Resta di lui, come abbiamo detto, la Cappellina tutta affrescata con uno
stile bizantineggiante, ma ingentilito dalla grazia di un credente tenero e forte.
Resta il bel campanile della Cattedrale, la decorazione della medesima, a cui
si prodigò gratuitamente per oltre un anno, vincendo ostacoli e, spesso, integrando le spese con la sua borsa personale. Resta la sistemazione del Santuario
di Maria dell’Olivella. Resta l’indirizzo artistico dato al laboratorio di ricamo
delle sue carissime Monache Benedettine e a un gruppo di artigiani, che si
valsero del suo illuminato consiglio: Rodolfo Mauti e i fratelli Zeppieri.
E poi la decorazione della Cappella del SS. Sacramento in S. Erasmo e
quella del Monastero delle Benedettine. Infine la sistemazione delle Reliquie e
dei cimeli della rinnovata Cappella del Tesoro in Cattedrale, che fu il suo canto
del cigno.
Veroli riparò al gesto insano degli scalmanati del 1915, facendolo suo
cittadino onorario.
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
A Veroli
407
Gli ultimi anni
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
II piccolo seminarista che a 12 anni si meravigliava che il Conte De
Witten accendesse e spegnesse le candele all’altare, divenne suo Cappellano dal
1944 al 1947. Tre anni di contatti intimi, che non potrà mai dimenticare.
Tutte le domeniche che scendevo alla villa, lo trovavo lì con i suoi
contadini. Mi accoglieva con tanta festa e mi baciava le mani con effusione,
mentre Lupo abbaiava e ci saltava intorno. Io sentivo che egli credeva davvero che quelle mani sacerdotali tra poco avrebbero consacrato e gli avrebbero
dato Gesù. E andava a suonare la campanella, esortava i buoni contadini alla
Confessione. Come era contento quando venivano! Me li accompagnava sorridendo. Sebbene io non fossi il suo confessore, spesso mi si inginocchiava
davanti per dire le sue colpe. Ma quali colpe? La mia dottrina teologico-morale
stentava a trovare la materia specifica e il modo di applicare l’assoluzione. Avrà
mai deliberatamente peccato il Conte De Witten?...
Finite le Confessioni, celebravo la Santa Messa. Egli spesso la serviva.
Recitava le preghiere della preparazione e del ringraziamento a voce alta sì che
il popolo le ripetesse. Come erano scelte bene! Spesso un nodo di pianto gli
serrava la gola sicché faceva forza per continuare e arrivare alla fine.
408
L’asceta
No, non è una esagerazione. Egli fu un asceta. Non azzardo di dire
un “Santo”, come diceva e dice la gente della contrada. Ma un asceta si, certamente, se non un mistico. Tutte le mattine faceva la sua meditazione. Gli
erano familiari i manuali liturgici, sopratutto quello del Guéranger. Mi accorsi
una mattina che, prima della celebrazione della Messa, egli già ne aveva letto il
testo e l’aveva meditato. Spessissimo mi diceva: «Che bel Vangelo ci sarà oggi!
È l’Epistola di S. Paolo!». Me ne diceva i punti salienti. Io che dovevo spiegare
il Vangelo e ancora non sapevo di che si trattasse, cercavo di frenare il rossore
che mi saliva sul volto. A colazione mi diceva: «Conosce questo trattato!... E
quest’altro?... E quest’altro?...». Erano libri ascetici della sua biblioteca, che egli
leggeva e meditava profondamente.
Aveva una devozione speciale per il Papa. Lo considerava veramente
come il Successore di Pietro e il Vicario di Cristo. Tutti gli anni, quando poteva, andava all’udienza speciale del Corpo delle Guardie nobili. Ne conservava
gelosamente tutte le immaginette-ricordo.
Aveva una fiducia illimitata nella Provvidenza. Di fronte a tutte le difficoltà egli soleva dire: «Tutto si accomoda». Era diventata la sua frase preferita.
Si commoveva al pensiero che Gesù in Sacramento, per speciale privi-
legio del Papa, abitasse sotto il suo stesso tetto. L’Altare era il centro della sua
giornata. Lì si apriva e lì si chiudeva con la recita del Rosario.
Solo i contadini della contrada potrebbero dire quanto era grande il
cuore del Conte De Witten. Sempre cortese e sorridente con tutti. Conosceva
tutti e a tutti aveva fatto del bene. Con il consiglio o con l’aiuto materiale. Non
c’era casa di malato che egli non visitasse. Se moribondo, anche di notte e con
il cattivo tempo. Si preoccupava che venisse il Sacerdote, andava lui a chiamarlo. Una mattina d’inverno mi aspettava con ansia: «Bisogna andare da un
moribondo!» mi disse. Aveva tutto preparato per il Viatico.
E mi accompagnò, lungo le vie di campagna, traversando una piccola
valle fino a una povera capanna. Aveva allora 80 anni suonati. Mi dissero una
volta che era andato a visitare un contadino che aveva una gamba tutta piagata,
e l’aveva medicata e fasciata con le sue stesse mani per più giorni.
Ma i bambini erano la sua passione. Faceva loro il Catechismo, li preparava alla Prima Comunione, li educava al rispetto della famiglia. Che festa
l’ultima domenica di giugno, quando il Vescovo veniva a dare la Prima Comunione e la Cresima ai suoi cari contadinelli! Dopo la bella cerimonia, i bambini
si schieravano lungo i viali per la colazione. Egli tutto aveva preparato: le medaglie, i rosari, i piccoli libretti di devozione. Passava in mezzo a quei pargoli,
carezzandoli come un padre amoroso. E gli crescevano affezionati. Se partivano militari o tornavano dalla guerra, andavano a salutare il Signor Conte.
Quando sposavano, andavano dal Signor Conte. A tutti regalava l’immagine del S. Cuore, che aveva incorniciato con le sue mani: «Questo lo metterete a capo del letto» diceva e li rimandava felici. Con gli operai o gli artigiani,
che lavoravano alle sue dipendenze, aveva un tratto così garbato che otteneva
più che se avesse comandato. Era meticoloso nelle sue cose. Ma sapeva tutto
ottenere. «Come son boni» diceva, «boni e bravi». Ed essi lo amavano.
Lo rivedo ancora, povero Signor Conte, lo rivedo arrampicarsi giovanilmente sulla scala a pioli, operaio tra gli operai, (aveva ottantadue anni),
durante l’ultimo lavoro della Cappella delle Reliquie, per salire sul ponte della
cupola. Era inverno. Di mattina egli era sempre il primo a trovarsi sul posto
di lavoro. Andava a sollecitare i ritardatari. E dire che egli, prima ancora che
sorgesse il sole, era andato a Messa e alla Comunione nella Chiesa delle Benedettine.
Sorella morte è venuta ad incontrarlo dopo il bel lavoro compiuto. E
Gesù gli ha dato l’ultimo bacio eucaristico proprio nel giorno che egli faceva la
festa della Prima Comunione ai suoi contadinelli. Il morbo lo vinse, togliendo-
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
L’Apostolo
409
gli i sensi e la conoscenza del trapasso. Era l’11 di agosto. Pochi giorni prima
della festa dell’Assunta. Tutta Veroli si è commossa alla morte del gentiluomo
perfetto e del cristiano integrale. Egli rimane esempio, in questo secolo di cupidigia sfrenata e di pervertimento morale, di come un uomo che viva di fede,
possa acquistare la libertà dall’egoismo e dall’orgoglio.
I Canonici della Cattedrale gli hanno fatto i funerali solenni. Gli hanno
tributato l’onore di accogliere la sua salma, in attesa che partisse per il Verano
di Roma, nella stessa Cappella delle Reliquie, che egli con intelletto di amore
aveva restaurato. Ma il più bell’elogio forse sono state le lacrime che la povera
gente della campagna e gli artigiani han versato sulla bara, che essi stessi han
voluto portare sulle spalle. Non è forse un miracolo oggi?... Che operai e contadini e le donne di servizio abbiano pianto per la morte di un aristocratico.
15. All’ombra del monastero benedettino Giuseppe Trulli
DON ANDREA SARRA
Il conte Stanislao De Witten, in La Voce Amica
dicembre 1948
410
Beata Maria Fortunata Viti
Dipinto di Giuseppe Trulli - 1967
Ingresso al Monastero Benedettino
Fra le chiese S.Maria dei Franconi e Sacra Famiglia
Monastero Benedettino
Abside e opus reticulatum della chiesa S.M. dei Franconi
Cripta di Sant’Onofrio
Monastero Benedettino
Madre Chiara De Felice
Il Conte Stanislao De Witten
Cappella De Witten - esterno
Casino Bisleti
Cappella De Witten - interno
Casino Bisleti
CAPITOLO XVI
Tedeschi
I
La leggenda del tedesco invasore
421
Comportamento dei tedeschi a Veroli
425
Io ricordo...
427
16.1
La leggenda del tedesco invasore
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
P
aese di falsi martiri, vergini ricucite, retori incorreggibili e autentici
bugiardi, l’Italia figlia della «Resistenza» inventò, per dirsi vittima
quando credette che le servisse, quella favola del «tedesco invasore»
che doveva farla uscire innocente dal solito «giudizio della storia».
«Collaborazionismo col tedesco invasore» fu il pretesto alla condanna, dalla morte alla galera, all’epurazione, di quanti tentarono, dalle file
della Rsi, di limitare gli immensi danni inferti alla sovranità nazionale dalla
fuga di Badoglio e dai crimini partigiani.
Dimostrare che i tedeschi fossero «invasori» diventa impresa sempre
meno difendibile. Ma anzi, truffaldina e grottescamente disperata, come sa chi
abbia letto, tra mille e mille pagine, quelle di Roma nazista in cui Eugen Dollmann tracciò l’ironica, spiritosa guida alla pretesa invasione. A cominciare
con lui stesso, chiamato eminenza grigia e anima nera di quel momento atroce
che la nazione italiana, spezzata in due, era egualmente disprezzata, odiata e
sfregiata dalle due parti in lotta, gli alleati (tra loro) che stavan vincendo la
guerra, e gli alleati (di ieri) che la stavano perdendo. «L’Otto Settembre è memorabil data», comincia la canzonetta di Malaparte: «Volte le spalle all’infausta
alleata / già col ginocchio a terra, / corremmo a vincer coi nostri nemici / arditamente quella stessa guerra / che avevamo già persa con gli amici». Amici e
amicissimi furono i tedeschi, più tardi padroni dell’Italia a loro abbandonata
dal re e generali suoi, quando scesero tra noi. Dollmann fin dal 1927, fuggendo
la Germania e le sue lotte interne, a studiare col professor Trompeo, Benedetto
Croce e padre Tacchi-Venturi; ebbe un fittizio grado di ufficiale delle SS, allora
corpo più politico che militare, quando il nuovo regime sedente a Berlino dal
1933, desolantemente sprovvisto di uomini esperti delle maniere e delle cose
del mondo, cercò di arruolarli in loco, e profittare di conoscenze ed esperienze. Ai tempi che scesero i Dollmann e poi i Kappler, l’Italia era, di gran lunga,
maestra e modello. L’alleanza attrasse una pioggia di emuli e allievi, di cui
Dollmann descrisse i penosi apprendistati e gl’innumerevoli passi falsi in quella giungla dello Stato e del partito, del Vaticano e della Corte, coi principi e le
principesse, i dami e le dame della nobiltà. «Da quando ci siamo messi con gli
italiani, ci troviamo in una compagnia alquanto mista (in einer sehr gemischte
Gesellschaft)» sospirò affranto il Reichsminister Joseph Goebbels al ritorno da
Roma.
Le amministrazioni, i partiti, i sindacati, le gioventù, le scuole, le giustizie, si scambiavano addetti e rappresentanti. Bocchini e Himmler, «i due
prestigiatori segreti delle due dittature», improvvisarono un clima di cordialità
tra due popoli, dei quali uno ammirava e temeva l’altro senza amarlo, e l’altro
421
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
422
talora ammirava, talaltra addirittura amava, ma di un amore totalmente scevro
di stima. Addetto di polizia, «con privilegi diplomatici», scese, nel 1937, Herbert Kappler, a quei tempi un ispettore Derrick in uniforme.
«Più che dai ministeri degli Esteri e dalle rappresentanze diplomatiche», fu dall’energica immaginazione dei prestigiatori occulti che furono messi
in movimento i «corrieri e inviati speciali» che intenerirono il cuore di Hitler
davanti alle sanzioni, e persuasero Mussolini a non muover dito, nella primavera 1938, per salvare il principe Starhemberg, le Heimwehren, il cancelliere
Schuschnigg e l’indipendenza dell’Austria. E mentre le polizie, la maestra e
l’allieva, manovravano di nascosto, alla luce del sole lanciavano i loro Heil! e
Alalà «i ragazzi in nero e i ragazzi in bruno», coi loro principes juventutis, Renato Ricci e von Schirach. E nel tepore odoroso delle cucine, imparavano gli
apprendisti cuochi delle SS, sotto l’egida dell’ex capocuoco dei Duchi d’Aosta,
nella scuola di polizia a Caserta, come preparare le saporite e spiritose vivande
di quella che un’epoca più tardi sarà vantata «cucina mediterranea», per tener
tonici e leggeri i preziosi stornaci del Führer e dei grandi del Reich millenario.
Venne l’ora delle signore, rappresentate dalla «non coronata imperatrice germanica Gertrud Scholtz-Klinck, presidentessa delle dame del Reich»,
e dalla marchesa Olga Medici del Vascello. La loro intesa, preservata dagli ardori dei mille e mille giovani fascisti del Campo Dux, in mezzo al quale era
stata piantata una tenda castrense quale alloggio per la signora Gertrud, andò
a rotoli a Milano, all’albergo Continental, quando la prima dama del Terzo
Reich allibì all’inchino di corte in cui la Medici del Vascello e le Vestali fasciste
che l’attorniavano si esibirono davanti al Conte di Torino. Da quello schiaffo
cortigiano, i rapporti tra le due dame dei partiti fratelli subirono un colpo irrimediabile, e la signora Gertrud ripartì proprio «mentre le armoniose esibizioni delle splendide allieve di Orvieto accaparravano, in misura quasi offensiva,
l’attenzione della mascolinità italo-germanica».
I più efferati capi dell’esercito «invasore» erano da lungo acquartierati
in Italia, via via cortesemente accolti, cordialmente chiamati e disperatamente
evocati quando le sorti ruzzolarono dai deserti, a Tripoli, alla Tunisia, al fuggi
fuggi di Sicilia: dove, tolte valorose eccezioni, restarono gl’invasori tedeschi a
difendere la patria italiana, mentre gl’italiani si squagliavano, applaudivano il
nemico, e gli consegnavano intatti porti militari prestigiosi e artiglierie intatte,
come ad Augusta.
Tutti conoscono la tragicomica serie di spergiuri in cui si profusero il
Monarca e il suo Badoglio ogni volta che i diplomatici e i generali del Reich, da
molti anni a Roma amici e alleati, sentendo o non sentendo l’odor di bruciato
che trasvolava l’Europa fino alle brughiere e le selve della Prussia Orientale,
chiedevano se fosse vero che l’Italia macchinava di lasciarli con una pace separata. Affrontato con quella lealtà che gl’italiani non ebbero, Hitler accetterà,
un anno più tardi, dal maresciallo Mannerheim, l’uscita della Finlandia dalla
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
guerra, alla condizione che le truppe tedesche potessero ritirarsi senza essere
aggredite.
Una simile ipotesi, retrospettivamente formulata da Ribbentrop a
Farinacci, venne respinta nella «malafede teutonica»: tutt’altro che dimostrata, perché i Badoglio, Ambrosio e compagni, che destituirono e arrestarono
Mussolini che aveva intrapreso la manovra di sganciamento annunciandola
all’ambasciatore del Giappone, la mattina di domenica 25 luglio, per il mercoledì successivo, si mascherarono, quando sarebbe venuta la loro ora per parlar chiaro ai tedeschi, dietro una cortina di menzogne, che fu preludio, per
l’Italia, di eterna infamia. Badoglio e compagni erano convinti di «tenere a
bada» i tedeschi con la menzogna. Ci riuscirono tanto bene, che le divisioni
tedesche raddoppiarono in Italia, in un mese. L’Italia di Badoglio cercava, con
tanta lentezza e goffagine, non solo la pace separata alle spalle dell’alleato, ma
addirittura il passaggio ai nemici. Ed era naturale che i tedeschi si preparassero
a non subire le conseguenze del voltafaccia, ma a farcele scontare. Andarono a
Tarvisio a ingannare l’alleato, e pretendevano che questo venisse a dimostrarci
la sua amicizia, e il piacere di farsi prendere prigioniere le divisioni già arrivate
e in arrivo. Castellano assicurava a inglesi e americani che l’Italia non era un
vinto che abbassava le armi, ma un popolo redento dal male che anelava a
riprenderle contro l’alleato di ieri. Al generale Jodl che, a Bologna, il 15 agosto, gli domandava ironicamente se l’Italia intendesse schierare al Brennero le
forze che voleva ritirare dalla Francia, replicò Roatta non esser noi come i sassoni traditori che in piena guerra passarono al nemico. Pronto, nell’accenno al
voltafaccia con cui la Sassonia abbandonò Napoleone, quanto imprudente, che
stava facendo di peggio. E nessuno l’ha dimenticato. Continuarono a mentire
fino alla giornata inoltrata dell’8 settembre, e poi scapparono. Dalla sera alla
mattina l’Italia si trovò sensza Capo di Stato, senza Stato, né governo, né forze
armate. Tabula rasa. «Le pouvoir était à ramasser», disse il generale De Gaulle.
Lo ramazzarono gli amici e alleati, che quella fuga in massa tramutò,
senza che neppure lo volessero, in occupanti. Avrebbero preferito un’occupazione pacifica, che li lasciasse liberi di accudire al fronte. Alla guerriglia reagirono con quelle rappresaglie, cui ricorrono per disperazione, tutti gli occupanti. Alle stragi risposero con altre stragi. A Biscari, presso Ragusa, gli americani
punirono il ferimento di dodici loro soldati con la fucilazione di ottantun italiani e tre tedeschi (ROBERTO CIUNI, nel «Giornale» del 31 dicembre 1944). In
Germania, presso Paderborn, il 30 marzo 1945, vendicheranno l’uccisione del
generale Maurice Rose con centodieci prigionieri soppressi col colpo alla nuca.
A Roma adottarono l’usuale ragioneria dei dieci contro uno. E così, caddero
nella trappola tesa dal partito comunista, che voleva una strage anche maggiore, e avrebbe supremamente gioito se, cedendo ai primi impulsi del Führer e
del generale Mälzer, gli antichi alleati avessero raso al suolo un intero quartiere
di Roma con dentro i suoi abitanti. Purtroppo, né i supremi reggitori a Berli-
423
no, né i loro generali in Italia, ebbero l’intelligenza e la fantasia, senza parlare
dell’umanità, esclusa del giuoco, necessario a capire il volo dell’immaginazione
di Dollmann, che scrisse nel suo libro, e cento volte descrisse parlando con me,
il grandioso colpo propagandistico e umano della sua proposta: rinunciasse
il Reich al massacro di rappresaglia, in cambio di una immensa processione
di tutto il clero di Roma, vescovi e abati, monsignori parroci e chierichetti
sventolanti i turiboli fumanti d’incenso per impetrare dall’Onnipotente l’eterno riposo per i caduti e il perdono all’orrendo italico misfatto. Il solo che
avrebbe potuto capire e adoperarsi per una simile vittoria dell’intelligenza, il
feldmaresciallo Kesselring, era assente in una ispezione al fronte. Il tedesco,
non invasore ma occupante per forza, realizzò così il sanguinoso disegno che i
liberatori del Pci avevano tracciato.
(P.B.)
“Mi ha fatto sempre piacere venirvi a trovare. (...) Mi attirava nelle vostre linee
il desiderio di vedere la divisione in combattimento. Era il momento in cui tutti
davano l’impressione di essere veterani. Nessuno aspettava ordini. Tutti dimostravano di sapere perfettamente ciò che dovevano fare, come ammaestrati da
una lunga esperienza. (...) Che importavano le fatiche, la strapotenza del nemico,
le perdite? In quei giorni di dura lotta non ho incontrato che espressioni allegre,
traendone nuove energie nell’assolvimento dei miei compiti”
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
GENERALE FRIDOLIN VON SENGER UND ETTERLIN
424
Comportamento dei tedeschi a Veroli
Il comportamento dei Tedeschi durante la loro permanenza a Veroli fu
sempre corretto. Nei riguardi degli abitanti, di cui spesso comprendevano i bisogni e i disagi, si dimostrarono molto umani e generosi. Basterebbe ricordare
che subito dopo l’8 settembre 1943, proprio quando dagli occupanti ci si poteva aspettare qualche reazione inconsulta per lo stato d’animo di chi era stato
tradito, in piazza Bisleti un reparto di sussistenza distribuiva gratuitamente il
caratteristico pane di segale a chiunque lo avesse richiesto. Particolare rispetto
i militari ebbero per le autorità religiose, per il clero in generale e per il Monastero delle suore benedettine. Alcuni esempi:
Nella zona della Civerta, in casa Diamanti, abitava con la sua famiglia
il procuratore delle imposte Sig. Polimeni, mentre in due case poco distanti si
erano installati alcuni soldati tedeschi che vi avevano impiantato delle radio
trasmittenti. Un giorno uno dei militari bussò al portone di casa Diamanti,
quindi, avendo trovato l’uscio socchiuso, entrò e salì fino al primo pianerottolo. Qualcuno di casa, vedendosi di fronte un tedesco, cominciò a strillare richiamando l’attenzione dei vicini. Questi accorsero subito, ma rimasero molto
meravigliati quando il soldato, che era disarmato ed aveva un cartoccio tra le
mani, disse loro con voce tranquillizzante: «Cerco uomo nero (era il Signor
Polimeni, abitualmente vestito di scuro) perché io dare a lui zucchero per il
figlio malato». Il procuratore fu chiamato; il soldato gli consegnò il prezioso
cartoccio e si allontanò salutando, tra lo stupore dei presenti.
Quando Veroli cominciò ad essere presa di mira dalle bombe degli
angloamericani, la famiglia Cacciavillani da via Carlo Alberto andò ad abitare
momentaneamente nella parte alta del paese, in casa del ragioniere Leonida
Mizzoni. Un giorno il prof. Giuseppe Cacciavillani, allora insegnante nel ginnasio verolano, tornava alla casa in cui era ospite con un pacco di biancheria
in mano. Proprio di fronte alla chiesa di S. Erasmo fu bloccato da un soldato
tedesco che, visibilmente ubriaco, gli puntò sul petto la pistola e gli ordinò di
tornare indietro con lui. Insieme (ora il professore aveva la bocca della pistola
attaccata alla schiena) percorsero via Gracilia ed arrivarono presso Porta Napoletana, dentro il giardino della marchesa Isabella Campanari, nella cui villa
aveva sede un comando tedesco. Qui il professore avrebbe dovuto darsi da fare,
con altri, a disseppellire alcune bombe inesplose; fortunatamente un graduato,
che aveva preso visione del lasciapassare dell’insegnante e che doveva avere un
grande rispetto per gli uomini di scuola, disse al malcapitato: «Tu professore;
nicht Arbeit! (non lavorare!)», e, indicandogli la vicina scorciatoia (la cosiddetta Taragnola), gli fece capire di squagliarsela immediatamente. Inutile dire che
il professor Cacciavillani giunse a casa in un tempo incredibilmente breve.
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
16.2
425
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
426
Per i Tedeschi lavorava come sarta nella attuale sede dei Vigili Urbani (ex Opera Ballila) la Signora Ines Terzini che, con altre persone, uomini e
donne, aggiustavano e rinnovavano le divise dei militari occupanti. Ella ricorda bene che il trattamento usato dai soldati nei confronti dei verolani che
lavoravano per loro fu sempre corretto ed educato, qualche volta molto umano e addirittura fraterno; uno dei Tedeschi soleva ripetere alla signora di non
voler essere considerato nemico e di avere solo un grande desiderio: rivedere
la propria madre ed il proprio fratello, lasciati in Germania. Ogni settimana
i lavoranti venivano pagati ciascuno con 18 lire ed avevano un litro di olio,
due pagnotte di pane ed un pò di patate (la signora Ines prendeva perfino
gli assegni familiari per la madre anziana). Una volta soltanto la signora vide
irritatissimi i suoi datori di lavoro: fu quando «sparì un taglio di vestito di un
maggiore»; allora stava per succedere il finimondo. Per fortuna il vestito fu
ritrovato nella casa di un certo Pepetto e la cosa finì li. Per il resto i Tedeschi
«erano soprattutto onesti. Mai avuta una sgarberia!», conferma la signora Ines.
Il comportamento corretto dei Tedeschi a Veroli è evidenziato, infine,
da quanto risulta scritto nella «Cronistoria della parrocchia di S. Erasmo dal
1940 al 1960», di Mons. Gerardo Mizzoni: «Nonostante l’infuriare della guerra
che passava come un rullo compressore distruggendo uomini, città e borgate,
volli restaurare la prima cappella a sinistra di chi entra in chiesa, dedicata alla
Addolorata. Affidai il lavoro al decoratore Mauti Rodolfo e al muratore Manchi Marino. La cappellina era mal ridotta a causa della pioggia che penetrava
dal tetto. Un giorno, durante il lavoro di restauro, soldati tedeschi armati di
mitra, andavano facendo razzia di uomini per condurli al fronte di Cassino.
I pittori Rodolfo Mauti e Armando Fiorini erano usciti dalla chiesa e stavano
fumando tranquillamente una sigaretta, quando intesero voci strane di soldati
che minacciavano quelli che si rifiutavano di seguirli. Impauriti, rientrarono
subito in chiesa e ripresero il lavoro sul ponte. Due soldati entrarono in chiesa
come furie, ma quando videro che si stava decorando la cappella della Madonna, si calmarono, fecero segno di approvazione e andarono via salutando
cortesemente».
16.3
Io ricordo...
Dopo l’8 settembre 1943, anche la contrada di Santa Francesca fu occupata dai Tedeschi.
Una signora, che preferisce mantenere l’anonimato, mi ha detto: «Io
non posso dire che bene dei Tedeschi che erano a Santa Francesca nel periodo
compreso tra l’armistizio e la ritirata dal fronte di Cassino. Essi sono stati molto bravi e si sono comportati sempre da veri signori.
Ricordo che, proprio vicino a casa mia, avevano installato un gabinetto dentistico per i militari, ma anche noi potevamo andarci. Ricordo anche
che una signora di Frosinone, sfollata a Santa Francesca, soffriva molto per un
dente che le faceva male; io stessa avevo un canino ed un molare che mi facevano impazzire per il dolore. Entrambe fummo curate da un militare tedesco
senza che questi prendesse una sola lira. «Niente pagare, niente pagare!», fu la
frase con la quale, a cura finita, ci congedò a tutte è due.
Mio padre era costretto a stare in poltrona perché aveva una gamba
molto malata e niente serviva a farla guarire. Un ufficiale che era venuto a casa
per farsi prestare il cavallo con il carrozzino, avendo saputo della sua malattia,
mi disse: «Io tenente medico, visitare papà!». Dopo averlo visitato, mi dette alcune medicine che, incredibilmente, gli fecero molto bene.
A Santa Francesca, sia la mattina che il pomeriggio, c’era il coprifuoco
ed io non sapevo come uscire per portare il foraggio ai cavalli, però riuscii a
trovare sempre un soldato disponibile che, tutte le sere, mi accompagnava nel
breve tratto di strada che univa la mia casa alla stalla.
Ogni giorno, nella nostra piazzetta, i militari addetti alla cucina, aiutati spesso da qualche donna del posto, confezionavano i pasti dentro enormi
recipienti. Al momento della distribuzione, chiunque voleva, si poteva avvicinare per avere qualcosa da mangiare. Insomma, tra soldati e abitanti del posto
si era stabilito un rapporto di amicizia molto bello.
Di fronte a casa nostra c’era un soldato di nome Hans che, con altri
compagni, veniva spesso a trovarci per intrattenersi con mio padre e mia madre. Il giorno prima di Capodanno (1944), papà mi pregò di preparare un po’
di pasta all’uovo e di portarla, con un pollo, a quegli amici tedeschi. Così feci.
Essi ne furono molto contenti, tanto che, spesso si presentavano a casa e mi
dicevano: «Ci fai altri maccheroni?». Ed io li accontentavo. Un soldato, in particolare, mi faceva molta tenerezza: quando veniva a casa si lamentava sempre
di non avere notizie della sua famiglia. Una volta scoppiò a piangere e disse:
«Mia moglie, giù! Miei bambini, giù! Niente più io trovare in Germania!». Era
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
«Erano veri signori!»
427
continuamente assillato dal pensiero che i suoi potevano essere rimasti vitime
di qualche bombardamento.
Non sempre, però, gli abitanti di Santa Francesca ricambiavano il civile modo di comportarsi dei soldati tedeschi. Alcuni fecero ai militari molti dispetti ed usarono spesso l’arma del sabotaggio, come l’interruzione dell’energia
elettrica, il taglio dei cavi telefonici e così via.
C’era un soldato molto giovane che frequentava assiduamente la casa
di una donna che gli faceva trascorrere qualche ora di “svago”, certamente in
cambio di piccoli favori. Un giorno il povero ragazzo non trovò più la sua divisa e perciò non potè ripresentarsi al comando. Fu ordinato di perquisire tutte le
case di Santa Francesca per ritrovare il militare scomparso. Non ricordo come
andò a finire questa storia.
Un’altra volta alcuni facinorosi, che forse pensavano di potersene vantare con gli Alleati, ormai alle porte di Veroli, sequestrarono un altro giovane
tedesco e lo portarono verso Collegrosso, dove c’è una torre molto antica; lo
legarono ad un albero e, una volta al giorno, gli portavano un po’ di pane e di
acqua. Rimase così fin quando entrarono gli Alleati, i quali... slegarono subito
e liberarono il povero ragazzo.
Voglio concludere riconfermando il mio giudizio sui Tedeschi: furono
sempre corretti ed educati. Quando ci presero un maiale, ce lo pagarono 1000
lire e, quando lasciarono Santa Francesca, incalzati dagli Alleati, si preoccuparono di ricordaci di andare a riprendere in una casa vicina il tavolo che erano
stati costretti a toglierci al loro arrivo. Non fu un comportamento da veri signori?».
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
Con una forca!
428
La signora P.G. ricorda che a Castelmassimo, nel palazzo dei marchesi Campanari, si era insediato il comando tedesco impegnato nelle operazioni del
fronte di Cassino. A dirigerle era il generale von Senger che, a pochi metri
dal palazzo, aveva fatto installare un efficentissimo centralino telefonico. Nelle
immediate vicinanze erano state scavate cinque gallerie che servivano da rifugio in caso di incursione aerea. Tutta la zona intorno, allora ricca di bellissimi
cipressi, era recintata e posta sotto la sorveglianza di alcuni militari. La sera
c’era il coprifuoco e nessuno poteva più uscire da casa. A Castelmassimo, però,
nonostante le restrizioni e gli impedimenti causati dallo stato di guerra, la vita
trascorreva abbastanza tranquillamente.
«Durante tutto il periodo in cui stettero qui — dice la signora — i Tedeschi si dimostrarono sempre dei bravi ragazzi e nessuno ci fece mai del male.
All’inizio del 1944, con l’avvicinarsi dello sfondamento del fronte di Cassino,
ci chiedevano sempre più spesso da mangiare, con garbo, e noi davamo loro
quello che potevamo: patate, quasi sempre. Davamo loro anche del latte, che
portavano ai compagni, ammalati o feriti, ricoverati nella casa di Don Checco
Bragaglia, trasformata in ospedale. Questa casa si trova ancora vicino al ponte
di Castelmassimo.
Una volta — doveva essere Natale — i Tedeschi si arrabbiarono perché
qualcuno aveva rubato da alcuni camion in sosta dei pacchi contenenti cioccolata, sigarette ed altri doni, destinati ai soldati del fronte. Due SS iniziarono
subito, minacciose, il controllo delle case per recuperare quanto era stato rubato, ma tutto fu ritrovato e niente fecero ad una ragazzo che aveva confessato
di aver mangiato un po’ della cioccolata di cui altri, più grandi di lui, si erano
impadroniti.
Un fatto tremendo successe, invece, a poca distanza da Castelmassimo, in località Campello. Un soldato1 aveva bussato alla porta di una casa per
chiedere un pollo. Il padrone, facendo capire al militare che avrebbe soddisfatto la sua richiesta, si allontanò un momento. Quando ritornò, invece di
dargli il pollo, lo infilò con una forca di ferro, quella che normalmente si usa
per rimuovere fieno, letame ed altro. Alle grida strazianti del povero soldato,
accorsero alcuni suoi compagni che, mitra in mano, uccisero l’uomo che aveva
assassinato il loro amico e il figlio che era accorso per vedere quel che stava
succedendo2.
Forse si chiamava Kristen Erwin.
2
Reazioni simili, purtroppo, erano molto frequenti in Italia, perché i Tedeschi erano
costretti a difendersi non solo dagli Alleati, ma da nemici più pericolosi, partigiani o no, che
tendevano loro trappole, agguati e insidie di ogni genere, portandoli all’esasperazione e inducendoli alle rappresaglie più feroci. Ecco tre esempi:
«A Rioveggio i partigiani della «Stella Rossa» uccisero alle spalle due ufficiali tedeschi
che stavano passeggiando in compagnia di alcune ragazze del posto. “Questo attentato — ci
hanno detto a Rioveggio — provocò una feroce rappresaglia tedesca. I soldati nazisti cercarono
i partigiani: diedero loro 24 ore di tempo per presentarsi, poi scelsero undici ostaggi e li fucilarono. E pensare che i partigiani che avevano compiuto l’attentato erano in gran parte nati qui, a
Rioveggio. Eppure lasciarono che, al loro posto, pagassero undici innocenti”».
«In una frazione qui vicino — ricordano a Vado — si erano accampati per un po’
di tempo alcuni soldati tedeschi che dovevano impiantare una teleferica. Erano per lo più dei
buoni figlioli e avevano stretta amicizia con le famiglie del luogo. Alla fine se ne andarono. Un
giorno, però, a metà giugno del 1944, uno di questi tornò nella frazione per salutare i suoi amici
italiani. Ma nella casa dove si recò era presente anche un giovane componente della famiglia,
già da tempo partigiano della «Stella Rossa». Questi simulò grande cordialità nei confronti del
soldato tedesco tanto che, ad un certo punto, lo invitò a seguirlo nei campi a prendere una
boccata d’aria in attesa della cena: ma, fatti pochi passi, e senza valutare il terribile pericolo di
rappresaglia cui esponeva tutta la sua famiglia, uccise il soldato tedesco con un colpo d’accetta.
Poi fuggì. Fortuna volle che il comando germanico non riuscì a saper che fine avesse fatto quel
suo soldato i cui resti, ancora oggi, riposano nella campagna bolognese».
«A Gabbiano di Monzuno, infine, due tedeschi che stavano acquistando uova dai
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
1
429
Con lo sfondamento del fronte, cominciò la ritirata dei Tedeschi. Diretti verso Alatri e Fiuggi, ne passarono tanti; sfiniti e con la barba lunga. Ci
chiedevano qualcosa da mangiare e noi gli davamo un pezzo di pane, un bicchiere di vino e tutto quello che avevamo. Facevano una gran pena!...».
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
Una ciocca dai capelli biondi
430
La signora Elisa Giralico abita nella località “Casino Bisleti”. Ecco quel
che ricorda del periodo dell’occupazione tedesca:
«Dopo l’8 settembre, i Tedeschi occuparono molte delle nostre case.
Alcuni stettero qui da me sette mesi, ma utilizzarono la casa solo per dormire.
La sera, io con i miei due figli, Vincenzo e Carlo (mio marito era in
Grecia) passavamo la notte nella vicina casa di mio padre. Questi soldati erano
molto gentili con noi e, in particolare, uno di essi voleva molto bene a mio figlio Carlo. Facendosi capire anche con i gesti, mi diceva: «Anche io Calò, anche
io!»: voleva dire che anche lui aveva un figlio di nome Carlo, ma era molto lontano. Quando andò via, regalò al mio bambino una sveglia; ora non funziona
più, ma noi la teniamo lo stesso, come ricordo.
Vicino a noi abitava il conte De Witten. Era bravissimo. Voleva bene
a tutti e faceva tante elemosine. Quando io stetti male con il tifo, lui veniva a
casa, mattino e pomeriggio, per vedere se avevo bisogno di qualche cosa. A tutti dava conforto e per tutti aveva una parola di incoraggiamento. Una volta, io
ed altre quattro ragazze stavamo su una pianta per raccogliere le olive, quando
si avvicinò un tedesco ubriaco e cominciò a darci fastidio. Un cugino di mio
marito prese una pertica (di quelle che servono per battere le olive) e gli fu addosso. Stava per succedere il finimondo! Qualcuno chiamò subito il conte che,
recatosi al casino Bisleti, dove era insediato il comando, espose il grave fatto.
Immediatamente il soldato che ci aveva dato fastidio fu trasferito.
Durante l’occupazione tedesca avevamo tutti una gran fame, ma c’era
chi ne aveva più di noi: da Boville Ernica, da Monte S. Giovanni e da altri paesi
vicini venivano fin qui tante persone, solo per raccogliere e mangiare le pelli di
maiale che i Tedeschi scartavano, dopo aver messo da parte i pezzi da cucinare.
contadini, furono sorpresi da una pattuglia partigiana comandata da un certo «Aeroplano».
I Tedeschi capirono subito di non essere in grado di opporre resistenza e alzarono le mani in
segno di resa. Ma i comunisti spararono ugualmente uccidendone uno. L’altro venne trascinato
prigioniero alla base partigiana. Conoscendo di fama la ferocia dei guerriglieri, il soldato germanico tentò inutilmente di impietosirli mostrando anche le fotografie della moglie e dei suoi due
bambini. Lo legarono con i piedi a un paletto e gli inchiodarono le mani al suolo trafiggendole
con due pugnali. Poi lo lasciarono morire così» (GIORGIO PISANO, Storia della Guerra Civile in
Italia, vol. II, 1980).
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
Con la fame che avevano, quei poveracci litigavano spesso: le pelli non bastavano mai e tutti volevano portarsene a casa un pezzo.
Mitragliamenti e bombardamenti, specie verso la fine della guerra,
diventarono molto frequenti. Il 17 marzo 1944, io e mio suocero eravamo andati a Veroli per riscuotere il sussidio mensile di 25 lire, che mi davano per i
miei due figli. Proprio quel giorno aeroplani alleati (dovevano essere inglesi),
mitragliarono e bombardarono il centro del paese e noi, davanti alla chiesa
dell’Addolorata, fummo costretti a buttarci in terra per evitare di essere colpiti
dai proiettili. Per fortuna riuscimmo a tornare a casa sani e salvi.
Un’altra volta, verso le sette di mattina, alcuni soldati tedeschi, tutti
molto giovani, erano andati a lavarsi presso la sorgente del Bagno Coperto.
Improvvisamente si avvicinò un aereo nemico e li mitragliò, uccidendone otto.
I loro poveri corpi furono portati quasi subito nel cimitero di Casamari. Il giorno dopo, io ero andata con la conca a prendere l’acqua alla sorgente
dove era successo il mitragliamento. Passando per un terreno di mio padre,
rimasi molto impressionata nel vedere fra l’erba un pezzo di testa con tanti capelli biondi attaccati. Tremavo tutta e non sapevo che fare. Poi mi feci coraggio:
lo raccolsi con un fazzoletto e lo misi tra i sassi di una maceria. Per qualche
mese non passai più in quel punto.
La sera dello stesso giorno si presentarono a casa altri due soldati. Erano ancora più giovani di quelli morti presso la sorgente. Erano dei ragazzi;
portavano una gavetta in mano ed avevano un pentolino legato al cinturone.
Volevano qualcosa, ma i miei suoceri ed io non riuscivamo a capirli. Li portammo nella stalla dove c’erano le mucche, per vedere se volevano del latte,
ma loro dicevano: «No»; gli facemmo vedere una pagnotta di pane, ma loro
ripetevano: «No»; poi l’acqua, l’olio e non ricordo che cosa altro. Loro rispondevano sempre: «No». Mia suocera, che forse stava pensando ai suoi figli, anche essi lontano da casa, cominciò a singhiozzare; allora uno dei due soldati si
appoggiò ad un palo che era dinanzi alla stalla, e scoppiò a piangere come un
bambino. Poi si allontanarono. Non li abbiamo rivisti più.
Quando gli Alleati sfondarono il fronte di Cassino, i Tedeschi cominciarono a ritirarsi. Un ufficiale, prima di andare via, ci disse di stare in guardia, perché. quelli che arrivavano erano cattivi, perciò ci dovevamo procurare
dei bastoni. Anche un altro ufficiale, questa volta Alleato, ci disse: «Attenti
ai neri: quelli solo del bastone hanno paura!». Un giorno io stavo in cucina
e lessavo le patate. Sentii dire che un gruppo di quei terribili soldati stava già
attraversando un viottolo qui vicino. Presi in braccio mio figlio e scappai verso
la casa dove erano i miei. Quei soldati passarono, ma non successe niente. Di
li a poco, altri tre soldati neri si fermarono in una casa in cui era ospitata una
famiglia di sfollati provenienti da Atina: era formata dal padre, dalla madre
e da tre figlie. I neri furono subito attratti dalla bellezza di quelle ragazze: ne
afferrarono una e, a turno, la violentarono sotto lo sguardo esterrefatto dei
431
genitori. Il padre della ragazza cercò di reagire, ma uno dei tre soldati gli sparò
addosso, fulminandolo».
Intanto in Italia erano già in molti a «gettarsi allegramente ai piedi dei
loro liberatori».
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
La Pasqua del 1944
432
Come aveva annotato mons. Gerardo Mizzoni nel registro della parrocchia di
Sant’Erasmo — non portò sui volti la gioia. Tutti erano preoccupati e la maggior parte dei Verolani, sia per la paura, sia per le privazioni, erano cambiati nel
loro aspetto. Il 16 aprile, domenica in Albis e festa della SS.ma Vergine dell’Olivello, Veroli fu mitragliata e bombardata per la seconda volta. Due bambini
che la mattina erano venuti in chiesa, avevano ascoltato la Messa e fatta la Santa Comunione, con tanta devozione da attirare l’attenzione dei pochi fedeli che
erano in chiesa, in via Castel Briccoli, nel giardino di casa Benedetti, rimasero
vittime della mitraglia. Erano originari di Napoli, ma venivano da Frosinone».
Il signor Arcangelo Botticelli fu testimone di un altro tragico fatto
accaduto nel pomeriggio dello stesso giorno in cui morirono i due bambini
napoletani: tra le 16 e le 17 saliva a Veroli, proveniente dalla casa di campagna
dove si era rifugiata con la famiglia, Giulia Pagliaroli, una bella ragazza verolana da tutti conosciuta per la semplicità e la schiettezza dei suoi modi, per i
suoi atteggiamenti sempre gioviali e per il suo sorriso fresco e luminoso. Era
accompagnata da una donna di nome Nazzarena. Furono soprattutto il tepore
della primavera e i ventun’anni di Giulia, ma anche la devozione di entrambe
verso la Madonna dell’Olivello che spinsero le due ad affrontare i pericoli di
una visita alla chiesina in cui era custodita la venerata immagine. Improvvisamente, al di là della strada che per un tratto circonda la piazzetta del borgo
Santa Croce, Giulia e Nazzarena furono sorprese da alcuni aerei alleati che,
dopo aver effettuato un paio di giri minacciosi sul paese, mitragliarono e bombardarono tutta la parte adiacente al borgo. Fu un attimo. Nazzarena ebbe un
braccio troncato e Giulia, massacrata dai proiettili e dalle schegge che le spezzarono le gambe, cadde tra i sassi, nell’acqua putrida di un fosso. Una ventina
di minuti dopo, richiamato dai lamenti fievoli di Giulia, il Botticelli accorse
per aiutare in qualche modo la povera ragazza. Le sollevò il capo adagiandolo
su una pietra, mentre il sangue, unendosi al fango, formava una poltiglia rossastra. Poi raggiunse la strada, fermò una macchina tedesca e pregò i soldati di
dargli una mano per soccorrere la sventurata. Subito i militari posero il corpo
straziato su una scala di legno che il Botticelli aveva preso da un suo capanno
e lo portarono nella macchina. Il volo verso l’ospedale, l’intervento chirurgico
ed il sangue offerto da uno dei soldati, non salvarono Giulia, che morì all’alba
del 18 aprile. Non ci furono incursioni aeree quel giorno. Sembrò strano. Qualcuno disse poi che gli Alleati avevano voluto fare un regalo a quello squallido
gruppetto di Verolani che, con una radio ricetrasmittente, li tenevano costantemente informati sui movimenti delle truppe tedesche.
Trascorsero altri giorni d’inferno. Poi, fra il 31 maggio e il 1° giugno,
dopo che ebbero tirato le ultime cannonate, sganciato le ultime bombe, causato le ultime vittime, le truppe indiane, neozelandesi e australiane fecero il
loro ingresso trionfale a Veroli. Al loro seguito c’era pane bianchissimo, farina
di piselli, latte in polvere e gomma americana. Fra l’esultanza dei Verolani, la
guerra era finita.
“4 delinquenti”
I soldati tedeschi di stanza a Veroli abbandonarono precipitosamente
la nostra città. Anche il palazzo Franchi, in piazza Bisleti, sede di uno dei comandi dislocati nel territorio di Veroli, fu evacuato; ma, prima di andarsene
un soldato volle lasciare a tutti un messaggio molto significativo, una vera e
propria denuncia nei confronti dei tre grandi della terra, Stalin, Roosvelt e
Churchill, che egli considerava i veri responsabili dei disastri provocati dal secondo conflitto mondiale. I tre personaggi, disegnati con caricature di grande
efficacia, sono inseriti in un profilo che presenta le caratteristiche della razza
semitica. I tre, unitamente alla figura disegnata di profilo, sono definiti “bastardi” e “delinquenti”. Ecco il messaggio per i nuovi arrivati:
These are the bastards who have driven you as well as us into this bloody war. 4
Verbrecher.
Sono passati cinquant’anni. Chi ricorda più? Le case verolane distrutte
dai liberatori sono state ricostruite. I morti ammazzati sono stati portati da
tanto tempo al cimitero e qui riposano in pace. Per chi se ne accorge, nel buio
sottoscala della cappella del camposanto c’è un mucchietto di ossa frantumate
dalla cattiveria umana: è quel che rimane del sorriso di Giulia Pagliaroli.
GIUSEPPE TRULLI
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
Questi sono i bastardi che hanno trascinato voi come noi in questo sanguinoso
conflitto. Quattro delinquenti.
433
Ai suoi soldati
“Voi, soldati della divisione, avete compiuto gesta sovrumane. Per settimane
avete combattuto ininterrottamente, giorno e notte, spesso minacciati a tergo
e contemporaneamente attaccati frontalmente da formazioni corazzate. E nei
brevi trasferimenti da un epicentro della lotta all’altro, non avete avuto mai un
attimo di riposo. La stirpe sveva dalla quale voi provenite, non è abituata a vantarsi di ciò che ha fatto. Tuttavia è giusto che sappiate di aver superato la prova
più dura che si possa concepire. La fama di aver resistito con i vostri battaglioni
decimati a intere divisioni, e con successo, passerà alla storia”
16. Tedeschi I Giuseppe Trulli
434
GENERALE FRIDOLIN VON SENGER UND ETTERLING
Castelmassimo - Veroli
Palazzo Campanari
CAPITOLO XVII
Tedeschi
II
Morire a Veroli
443
Lili Marleen
448
LA MORTE PER LA PATRIA È ETERNA GLORIA
17.1
Morire a Veroli
Morire a Veroli
nel mese delle rose
sulle foglie appena nate
sulle ginestre profumate.
In Veroli fallen
im Rosenmonat
auf frìschem Grün
auf duftendem Ginster.
Bleibach Breslau Essen Bleibach Breslau Essen
Würzburg Wien Mannheim... Würzburg Wien Mannheim...
Morire a Veroli In Veroli fallen
sulle strade assolate auf sonnigen Strassen
giovinezze troncate. vernichtete Jugend.
Fischenich Kattowitz Hundsheim Fischenich Kattowitz Hundsheim
Freinwalde Karlsdorf St. Kolomann... Freinwalde Karlsdorf St. Kolomann...
Morire a Veroli In Veroli fallen
sulle rocce scheggiate auf zersplitterten Felsen
sotto le case crollate. unter zertrümmerten Häusern.
Morire a Veroli In Veroli fallen
e non tornare più. und Kehren nimmermehr wieder
GIUSEPPE TRULLI
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
Gerhard Friedrich Richard Ihr mir lieben: Gerhard Friedrich Richard
Werner Kurt Rudolf Hermann... cari! Werner Kurt Rudolf Hermann..!
443
Riposano nel Cimitero Militare Germanico di Cassino - Caira
Ahlborn Werner, maresciallo.
Nato il 13 giugno 1917 a Ziegelrode/Mansf. Seekr.
Morto il 26 maggio 1944 a 0,5 km nwl. Veroli.
(campo 4 n° 253)
Baier Richard, sottufficiale.
Nato il 13 maggio 1906 a Bleibach.
Morto il 29 maggio 1944 e già sepolto dietro il monumento ai caduti di Veroli.
(campo 4 n° 178)
Eenboom Herbert, soldato del genio.
Nato l’1 aprile 1906 a Mellee.
Morto il 30 maggio 1944 al bivio di Veroli, S. Cristoforo.
(campo 4 n° 171)
Freitag Walter, caporale.
Nato il 5 settembre 1905 a Breslau.
Morto l’8 dicembre 1943 a Sora.
(campo 4 n° 254)
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
Glasbrenner Hermann, maresciallo.
Nato il 4 ottobre 1899 a Gerabon Krs. Crailsheim.
Morto il 29 maggio 1944 al b. di Veroli.
(campo 4 n° 174)
444
Gross Kurt, paracadutista.
Nato il 22 dicembre 1925 a Vienna.
Morto il 3 giugno 1944 a Veroli, La Moietta.
(campo 4 n° 249)
Hagedorn Hermann.
Nato il 5 settembre 1915 a Essen.
Morto il 2 giugno 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 248)
Hammermann Gerhard, cap. magg.
Nato il 13 giugno 1919 a Fischenich.
Morto l’1 giugno 1944 al b. di Veroli, Casalotto.
(campo 4 n° 168)
Heine Richard, granatiere.
Nato il 18 dicembre 1909 a Mannheim.
Morto il 28 novembre 1943 a Civitacastellana.
(campo 4 n° 176)
Kaufmann Otto.
Nato il 12 ottobre 1924.
Morto il 1° giugno 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 172)
Kristen Erwin.
Nato il 16 settembre 1917.
Morto a Veroli, Campello.
(campo 4 n° 166)
Mùller Friedrich, caporale.
Nato il 29 novembre 1906.
Morto il 29 maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 252)
Müller Reinhold.
Nato il 23 maggio 1901 a Würzburg.
Morto il 29 maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 175)
Olsacher Christian, cap. magg.
Nato il 30 novembre 1911 a Karlsdorf.
Morto il 29 maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 170)
Pieper Heinrich.
Nato il 16 ottobre 1915.
Morto il 31 maggio 1944 a 2 km da Frosinone.
(campo 4 n° 167)
Pockl Franz, caporale.
Nato il 29 marzo 1905 a Hundsheim.
Morto il 29 maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 173)
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
Nowatius Eligius, caporale.
Nato il 23 novembre 1924 a Kattowitz.
Morto il 31 maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 247)
445
Rehrl Rupert, caporale.
Nato il 28 febbraio 1923 a St. Kolomann.
Morto il 29 maggio 1944 a Veroli, S. Angelo in Villa, Case Rufa.
(campo 4 n° 245)
Schmidt Max, cap. magg.
Nato il 26 maggio 1906 a Zschorna Loebau.
Morto il 28 maggio 1944 ad Anitrella.
(campo 4 n° 255)
Winicker Rudolf.
Nato il 31 luglio 1924.
Morto nel maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 177)
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
Zache Gustav, tiratore scelto.
Nato il 7 luglio 1906 a Freinwalde.
Morto il 28 maggio 1944 a Veroli.
(campo 4 n° 169)1
446
1
L’elenco dei caduti è stato compilato tenendo conto dei nomi dei soldati (di difficilissima lettura) riportati in una lettera dell’Archivio Storico Comunale di Veroli e di quelli di un altro
elenco, sempre di Veroli, dopo averne fatta collazione e integrazione con i nomi segnati negli
elenchi ufficiali del Cimitero Militare Germanico di Cassino. Nella lettera, datata 24 giugno
1946 e inviata alla Prefettura di Frosinone, il sindaco scrive:
«In riferimento alla nota in oggetto («Cimiteri di guerra»), pregiomi comunicare quanto segue:
a) Cimiteri militari: Contrada Casamari, costruito nel 1943.
Vi sono tumulate 54 salme di soldati tedeschi. Il cimitero è completamente abbandonato e non è
stato mai consegnato, per la sorveglianza, ad alcuno. Si comprende che è un cimitero formato in
un relitto stradale con il solo segno di una grande croce di legno. Le croci che erano sulle salme
sono scomparse. Il cimitero è accessibile a chiunque perché non è stato mai recinto con il filo di
ferro. I nomi delle 54 salme ivi sepolte si ignorano.
b) Al cimitero del capoluogo si trovano sepolti altri cadaveri di militari tedeschi, in totale 18, dei
quali solamente 13 hanno le seguenti notizie ed indicazioni: ... (V. elenco).
Si hanno inoltre due piastrini di riconoscimento e sono i seguenti:
1) Piastrino n° 63125 P 61, con un biglietto indirizzato a Maria Triscler, Wien 40 - Khunngalle 11
2) Piastrino n° 63125 F/65 F
Dei rimanenti nessuna indicazione,
c) Nessuna tomba si trova sparsa nel territorio».
Nel Cimitero Militare Germanico di Cassino
“La maggior parte dei soldati tedeschi che qui riposano è caduta nei
combattimenti per la testa di ponte presso Salerno, nei combattimenti durante la ritirata sulla costa adriatica, in quelli sul territorio antistante Cassino e
nei duri combattimenti per la conquista della città e di Monte Cassino. (...)
Ricordiamo qui i sepolti, in silenzio e con sincerità, apprezzando la forza d’animo e il coraggio che furono loro richiesti in quanto soldati. (...) La grandezza
dell’uomo, la sua capacità di superare se stesso, emergono allorché egli è posto
di fronte a situazioni estreme. Anche la guerra, che riduce morte e sofferenza a
quotidianità, è una di tali situazioni estreme. Non dobbiamo dimenticare che
anche coloro che sono sepolti qui erano uomini, che furono impauriti dalla
granaglia e dalle bombe, che soffrirono quando furono colpiti, avendo sempre
la speranza di superare il peggio e di tornare in seno alla patria e alla famiglia.
Dipende da noi il riconoscerci nei nostri morti, il ricordarli con sincerità e
senza timori, per far si che la loro dignità persista anche nella morte. (...)
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
(Dalla allocuzione del Segretario Generale del Volksbund Deutusche Kriegsgrä-berfürsorge e V.
- Servizio per le Onoranze ai Caduti Germanici - Signor Adolf Barin, tenuta in occasione della
Giornata commemorativa tedesca per i Caduti in guerra, nel Cimitero Militare Germanico di
Cassino, il 17 novembre 1991).
447
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
17.2
448
Lili Marleen
Ha già quarantatrè anni eppure il suo nome vuol dire ancora amore,
tenerezza, speranza: soprattutto per quegli uomini e quelle donne che nel 1940
avevano vent’anni. Lili Marleen, è di lei che stiamo parlando: chi era? (...) È
esistita veramente una signora che rispondesse a questo nome? A molti è piaciuto crederlo. Da quando per la prima volta, dai microfoni di Radio Belgrado
occupata dai tedeschi, si trasmise la canzone, molti pensarono di riconoscerla.
E forse il successo della canzone di Leip e Schultze sta proprio qui, nel
fatto che in fondo, nella vita di ogni uomo, c’era una ragazza che poteva assomigliare a quella del disco. Proviamo comunque a ricostruire la biografia.
Lili Marleen nacque, secondo Renato Besana e Marcello Staglieno, autori di un libro dallo stesso titolo, al Kabarett der Komiker, una notte del 1938.
«...Intorno ai tavoli con sopra le seggiole capovolte, gli inservienti spargevano
segatura sotto la luce dritta e gialla di poche lampade rimaste accese dopo la
fine dell’ultimo spettacolo. Le note si sciolsero e si ricomposero, poi finalmente
cominciarono ad articolarsi ripetendo e arrangiando il tema di una marcia militare di molti anni prima. A mezza voce, più parlando che cantando, Schultze
intonò alla musica le parole che stavano scritte su un foglio di carta a quadretti,
troppo gualcito per restare diritto sul leggio. Lale Andersen, la cantante, portava una vestaglia sopra l’abito di scena. Prese il foglio e insieme a Schultze ripetè
due volte la prima strofa accennando il motivo: “Vor der Kaserme, vor dem
grossen Tor, stand eine Laterne”.
Finì quasi in un fiasco: il pubblico presente in sala non apprezzò particolarmente la novità e del disco si vendettero solo 600 copie. Proprio una di
queste, però, venne ripescata nel 1941 in un magazzino di Vienna e utilizzata
da Radio Belgrado: per mesi e mesi ogni notte, puntuale alle 21 e 57, Lili Marleen andò a tenere compagnia ai soldati nel deserto, tra le isbe russe, sui monti
della Grecia e a tutte le mogli e fidanzate rimaste ad aspettare. Gli estimatori
non solo furono molti, furono anche famosi: John Steinbeck la definì la canzone più bella di tutti i tempi; Churchill, a quanto raccontano, pregò Bing Crosby
di cantargliela; Eisenhower la considerava l’unico momento di dolcezza del
conflitto.
Hans Leip, ex-fuciliere della Guardia tedesca, autore delle parole, dice
che almeno 250 donne hanno creduto di potersi identificare nella sua creazione: ma la realtà, spiega, è diversa. Lui, infatti, buttò giù le parole una notte, in
caserma, ispirandosi a due donne che aveva amato (questo giustificherebbe il
doppio nome, Lili Marleen), con l’intenzione di scrivere l’addio del soldato che
parte per il fronte. Sempre per dovere di storia, Leip ha raccontato che Marleen era figlia di un medico e Lili di un fruttivendolo; la prima, una sera che
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
lui stava lasciandola perché doveva montare la guardia, lo pregò: «Rimani!».
E proprio quella notte sulla sua brandina, il giovane Hans compose quei versi
che poi dovevano assicurargli la tranquillità economica per tutta la vita. «Non
riuscivo a staccare i pensieri dalle immagini delle due ragazze», ha raccontato
Leip, «e i loro nomi si fusero in uno solo, che mi rendeva triste e allegro nello
stesso momento».
Norbert Schultze scoprì i versi di Leip perché glieli propose un tenore che cantava nella sua operetta Der Schwarze Peter (Peter il nero): Schultze
musicò dieci poesie tra cui Lili Marleen, che però al tenore non piacque. La
canzone, allora, venne offerta a Lale Andersen, che all’inizio non ne volle sapere: accettò di inciderla solo quando si accorse che la versione di Schultze era
gradita al pubblico.
Lili Marleen comunque cadde nell’oblio per tre anni: nella Germania di
Hitler, infatti, si preferivano musiche più stimolanti, dai toni più militareschi,
e fu ben accetta da Goebbels solo dopo il lancio da Radio Belgrado. Schultze
ebbe comunque modo di beneficiare del successo della sua composizione: il
suo nome, infatti, fu inserito nella lista degli «artisti creativi», esonerati dal
servizio militare; inoltre, nel ‘41, quando serviva una canzone per la guerra di
Russia gli commissionarono Il Führer lo vuole.
Intanto cresceva la popolarità di Lale Andersen: se ne accorse quando cominciò a ricevere lettere indirizzate a «Lili Marleen - Radio Belgrado, Germania».
«Cominciai a guadagnare parecchio denaro», ha raccontato la Andersen, «ma
c’era la guerra...».
In un intervista rilasciata ad Enzo Biagi molti anni dopo, la Andersen ha detto: «No, per me non è stato tutto bello, tutto semplice. La mia vita
sentimentale, ad esempio: ho alle spalle un altro matrimonio fallito. Ho anche
tentato di uccidermi, col sonnifero. (...) Certo, a molti ho fatto compagnia».
Forse in questa ultima frase c’è il senso di quello che questa canzone ha
rappresentato: perché se è vero che Lili Marleen ha ritmato la lenta, rassegnata
marcia della ritirata tedesca e la fine di un’epoca, ha anche consolato quanti in
quelle notti di guerra, l’aspettavano: quelli dell’Africa Korps di Rommel e quelli
di Montgomery, gli americani ma anche i russi. Era, in qualche modo, la ragazza di tutti, bionda o bruna, alta o bassa, e ogni soldato poteva darle appuntamento nel paesaggio che preferiva. Per noi il paroliere Rastelli aveva tradotto:
«Tutte le sere sotto quel fanal, presso la caserma ti stavo ad aspettar»; gli inglesi
dicevano: «Underneath the lantern by the barrack, Darling, I remember, the
Way you used towait»; i francesi cantavano: «Et dans la nuit sombre nos corps
enlacés», mentre noi, sempre i più sentimentali, canticchiavamo: «Dammi una
rosa da tener sul cuor, legala col filo dei tuoi capelli d’or».
Sono passati più di 40 anni ma, come si vede, siamo ancora qui, ogni
tanto, a parlare di Lili Marleen: con lei ritornano paure di guerra e nostalgie
di vecchi amori. I ragazzi che allora avevano vent’anni sono signori e signore
449
di una “certa età”: ne hanno viste tante, da quei tempi, è passata una guerra,
è cresciuto un altro mondo, è finita un’epoca. Ma, in fondo, sulle note di una
canzone anche certi ricordi tristi possono riempirsi di nostalgia. E magari di
rimpianti.
17. Tedeschi II Giuseppe Trulli
BICE BIAGI
Un fanale sempre acceso, in Oggi, 1983
450
Hanna Schygulla
Nei panni di Willie, l’eroina di “Lili Marleen”
Croce di bronzo Commemorativa
Cimitero Militare Germanico - Caira - Cassino
Tomba di tre soldati tedeschi caduti a Veroli
Cimitero Militare Germanico - Caira - Cassino
Campo 4 - sepolture dei soldati tedeschi caduti a Veroli
Cimitero Militare Germanico - Caira - Cassino
Scultura commemorativa
Cimitero Militare Germanico - Caira - Cassino
CAPITOLO XVIII
Tedeschi
III
Il Generale Frido Von Senger: un uomo esemplare
461
A Montecassino
463
Un piccolo libro per un grande generale
466
Il cimitero di Häg
469
18.1
Il generale Frido Von Senger: un uomo esemplare
Fu l’uomo esemplare che ogni persona onesta, amante del bene, vorrebbe avere
per amico, confidente e guida; un animo generoso che rese ferma testimonianza delle sue virtù, arricchite da una sincera fede cristiana, proponendosi
come modello da imitare a quanti hanno a cuore la costruzione di un mondo
migliore.
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
D
urante la seconda guerra mondiale, Il Generale Fridolin Von
Senger und Etterlin (1891-1963) comandò il XIV Corpo Corazzato e, per molto tempo, tenne inchiodati a Cassino Americani,
Inglesi, Polacchi, Neozelandesi, Indiani, Marocchini ed altre
truppe, ostacolando seriamente quella “passeggiata” per l’Italia
che essi avevano immaginato di poter fare.
Fece quanto gli fu possibile per impedire la distruzione dell’Abbazia di
Montecassino da parte alleata ed ebbe una parte molto importante nel porre in
salvo i tesori artistici e storici del celebre monastero benedettino.
Fu un antihitleriano convinto, ma compì il suo dovere di soldato fino
in fondo. «Sentì e visse il terribile conflitto tra l’ubbidienza al giuramento e la
propria coscienza e bevve il calice amaro della sua professione militare con
dignitosa rassegnazione, con lealtà verso la patria, nel rispetto, per quanto gli
fu possibile, dei supremi diritti umani». Dopo l’8 settembre 1943, si rifiutò di
passare per le armi 200 ufficiali italiani fatti prigionieri in Corsica, contravvenendo ad un preciso ordine di Hitler che ne aveva preteso la fucilazione
immediata.
Scrive Senger: «A questo punto mi resi conto che era venuto per me il momento di rifiutare l’obbedienza. Parlai subito, via radio, con l’apparecchio a
onde ultracorte, con il feldmaresciallo Kesselring e gli comunicai che mi rifiutavo di eseguire l’ordine. Il feldmaresciallo accolse senza commenti la mia
dichiarazione e mi assicurò che l’avrebbe trasmessa al comando supremo della
Wehrmacht. Presi le opportune disposizioni perché gli ufficiali prigionieri venissero trasferiti immediatamente sul continente, dove l’ordine di fucilazione
non poteva essere ancora noto. Devo essere grato al feldmaresciallo Kesselring,
perché accettò, in certo qual modo, il mio rifiuto di obbedienza e non prese
alcun provvedimento a mio carico».
461
Kesselring
Il Feldmaresciallo Albert Kesselring nacque a Markstedt am Mein, in Franconia nel 1885. Nel 1940 era Capo di Stato Maggiore della luftwaffe e nel 1943,
dopo i lusinghieri successi ottenuti sulla linea Gustav contro gli Anglo-Americani, divenne capo di tutte le forze tedesche in Italia, delle cui crudeltà è stato
sempre ingiustamente ritenuto responsabile. Nel 1945 era Comandante Supremo del Fronte Occidentale. Arresosi al nemico il 5 maggio dello stesso anno,
fu processato quale criminale di guerra e condannato a morte da un tribunale
alleato. In seguito la condanna fu commutata in ergastolo e nel 1952 fu amnistiato. Morì nel 1960 ed è sepolto accanto alla moglie Luise Pauline Hanna nel
cimitero di Bad Wiesse.
Di Kesselring, Dollmann disse: «Era duttile ed amabile, non un testardo brutale come Rommel. Aveva simpatia per gli Italiani e continuò ad averla
fino alla fine». Ma l’Italia che forse amò e che fu il teatro delle sue gesta, è piena
di lapidi accusatrici che lo ricorderanno a lungo. Non c’è da meravigliarsi: gli
italiani hanno fatto assai peggio nei riguardi di Mussolini, che ebbe il torto di
amare troppo la nostra patria.
«Apparentemente scorbutico, Kesselring sapeva intrattenere gli ospiti a colazione, era galante con le signore (specie con certe signore italiane), amava la
buona tavola, i musei, le città d’arte e gli va dato atto di averne salvate più di
una nel nostro Paese, contravvenendo agli ordini di Hitler: per esempio Roma
e Siena, Orvieto e Perugia, Urbino e Ravenna.
Cionondimeno in Italia si è conservato un ricordo nefasto di lui e delle
sue truppe, ma io credo che valga la considerazione che fece a me, parlando
di lui, il suo capo di Stato Maggiore Siegfried Westphal: “In guerra la colpa è
sempre di chi perde. Quando si combatte per tanti anni, è facile sbagliare».
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
SILVIO BERTOLDI
462
18.2
A Montecassino
Già durante i combattimenti in Calabria (autunno ‘43) l’Abbazia di
Montecassino era stata interessata dall’arretramento del XIV Corpo Corazzato.
Quando nell’autunno ‘43 von Senger ne assunse il comando, rese omaggio da
buon cattolico qual’era, all’Abate Diamare e gli assicurò la protezione del Comando.
L’Abate si vide presto costretto a far tesoro di tale offerta; infatti soldatesche della Divisione Paracadutisti “Hermann Göring”, milizia personale
dell’ex Maresciallo del Reich, mostravano spiccato interesse per i tesori artistici
dell’Abbazia. Al Comando erano pure giunte voci secondo le quali quella divisione intendeva “mettere al sicuro” nel Nord Italia, oltre alla biblioteca, anche
antichi dipinti e sculture. Poiché la divisione non era soggetta al Comando,
questo non poteva interferire direttamente. Tuttavia l’abate fu autorizzato a
rivolgersi al Comando per qualunque iniziativa intrapresa da qualsiasi gruppo
armato. In quel tempo i contatti con il monastero erano vincolati da misure
cautelative, dato che l’autorità ufficiale dell’OKW intendeva astenersi da qualsiasi contatto con le istituzioni della Chiesa Cattolica. Tali disposizioni giunsero fino al punto di proibire ai soldati tedeschi di fede cattolica l’ascolto della
Messa nelle chiese italiane.
Il Comando fu veramente sorpreso quando venne a sapere, nell’autunno del ‘43, che la Divisione Hermann Göring si era spontaneamente offerta
di trasferire, ancor prima dell’imminente battaglia, i tesori artistici di Montecassino in Vaticano. Il Generale suppose, a ragione, che quella disponibilità
celasse secondi fini. Purtroppo la sincera fiducia nei confronti degli ufficiali
della “Göring”, che lo avevano ampiamente rassicurato, indusse o costrinse (il
Comando non lo ha potuto appurare) l’abate ad acconsentire al trasferimento.
Indagini successive stabilirono che i preziosi incunaboli ed altri oggetti d’arte
non erano affatto destinati al Vaticano, bensì dovessero costituire il bottino
di guerra del Maresciallo del Reich. Il Generale tuttavia intimò alla Divisione
“Hermann Göring”, benché non avesse su di essa alcuna autorità, di trasferire
in Vaticano tutti i preziosi ed informò il capo della X Armata, Generale von
Vietinghoff, dell’intenzionale furto. Dopo estenuanti trattative, nel corso delle
quali la rappresentanza tedesca presso la Santa Sede agì in modo assolutamente conciliativo, si riuscì a stornare quel furto programmato; cosicché quella
gran quantità di oggetti d’arte fu posta sotto la tutela del sovrintendente ai
Musei Vaticani, prelato Dr. Kaas.
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
Nota sul comportamento del Generale del XIV Corpo Corazzato prima e durante la battaglia di Montecassino.
463
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
464
Nell’ottobre-novembre ‘43 il nuovo fronte agli ordini del Comando
Supremo della Wehrmacht nella Valle del Liri-Garigliano fu dislocato in modo
tale che l’Abbazia di Montecassino per forza di cose venne a trovarsi in prima
linea. Proposte e considerazioni presentate dal Generale alle autorità superiori
per spostare considerevolmente più indietro il fronte, per restringerlo e, nel
contempo, per preservare ai monaci di tutto il mondo quel prestigioso monumento culla dell’Ordine Benedettino, non ebbero alcun esito, anzi, furono
bollate come vile clericalismo dal Comando Supremo del Sud. Il Generale si
adoperò per tutelare rigorosamente, durante l’occupazione, la neutralità degli
edifici conventuali. Nonostante motivate considerazioni di ordine militare circa la posizione dominante del monastero, questo fu risparmiato. Il Comando
tuttavia mirava a sostituire la divisione paracadutisti di stanza in quei luoghi,
coraggiosa, ma politicamente intransigente, con un’altra agli ordini di un comandante cattolico convinto. Tra la fine del ‘43 e l’inizio del ‘44 si riuscì ad
installarvi la 90a divisione agli ordini del Generale Baade, sotto il cui corretto
comando si potè assicurare un particolare riguardo al monastero. Soprattutto
si collocò all’ingresso una postazione di guardia con l’incarico di impedire l’accesso agli edifici conventuali.
Il 15 febbraio 1944 l’aviazione anglo-americana bombardò l’Abbazia,
che bruciò quasi completamente. Già settimane prima, fin dall’inizio della 2a
battaglia di Cassino del 1 febbraio, il Generale aveva fatto avvertire l’ottantatreenne abate di porsi sotto la protezione del Comando o di rifugiarsi a Roma.
L’abate dignitosamente aveva rifiutato: si riteneva un soldato di Cristo e rimaneva, come comandante della fortezza di San Benedetto, al suo posto. Solo
dopo la distruzione del monastero, si lasciò convincere ad accettare l’invito
del Generale. Per quattro ore sotto il fuoco dell’artiglieria, col Crocifisso in
mano, si adoperò per mettere al sicuro, insieme ai suoi monaci, parecchi feriti
italiani e tedeschi; infine fu accompagnato alla sede del Comando, il palazzo
del Marchese Campanari a Castelmassimo di Veroli. Qui fu ospite del Comando, espresse un particolare ringraziamento al Generale e confermò ancora una
volta che l’esercito combattente a Montecassino si era comportato in modo
irreprensibile.
La constatazione che i soldati ai suoi ordini non avessero offerto alcun
pretesto per la distruzione del monastero stava particolarmente a cuore al Generale, cattolico e soldato cristiano, perciò pregò l’abate di incidere su nastro
tale conferma, cosa che avvenne. Ogni altro clamore propagandistico e giornalistico fu intenzionalmente evitato per rispetto alla dignità dell’illustre ospite e
per autentico rammarico per il tragico destino dello splendido antico monastero. L’Abate il giorno successivo fu trasferito a Roma con un automobile del
Comando. L’ufficiale che lo accompagnava ebbe l’incarico di condurre al più
presto quell’alta autorità presso la sede dell’Ordine Benedettino a Roma sull’Aventino. Giunto ai margini della città, l’abate, già stremato dall’esperienza del
giorno precedente, nonché dal viaggio spesso interrotto dai bombardamenti,
fu trascinato per ordine militare, dall’uno all’altro centro di propaganda e trattato in modo indegno da giornalisti tedeschi rozzi ed arroganti. L’aver consentito una simile onta, rappresenta una macchia indelebile per l’onore dell’allora comandante in carica dell’unità militare, Maggiore Conte Bossi Fedrigotti,
tanto più grave per un uomo di fede cattolica, oltreché di nobile famiglia.
Il Generale fu sdegnato da tali avvenimenti e, noncurante dell’esser
tacciato di clericalismo, a tale proposito si espresse francamente col Feldmaresciallo Kesselring. Quando, nella primavera del 1944, il fronte arretrò nel Frusinate, il Generale, nonostante l’esplicito divieto di aiuto a conventi cattolici,
soccorse con grande generosità le Benedettine di Veroli, sia mettendo a loro
disposizione automezzi militari perché potessero porre al sicuro le loro cose,
sia rilasciando alle suore, nonché all’ottantenne Capitano della Guardia Nobile e Cameriere di Sua Santità, Conte Stanislao De Witten, che colà risiedeva,
documenti scritti in cui pregava il nemico avanzante di risparmiare arredi e
terreni. Questa diretta presa di contatto con il nemico, sia pure a fini caritativi,
innegabilmente avrebbe potuto, dato il particolare momento, condurre von
Senger dinanzi al tribunale militare o, addirittura, costargli la vita.
Ne sono testimoni il Marchese Campanari e Suor Ildegarda Eppich
delle Benedettine di Veroli.
GEN. A. OSTER
ehem. Erster Generalstabsoffizier des XIV Pz. Korps
Monaco, 33 maggio 1946
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
(traduzione dal tedesco di MIRELLA PAGLIAROLI)
465
18.3
Un piccolo libro per un grande generale
Fridolin von Senger und Etterlin
un uomo, un generale
che cosa scrive chi lo ha letto
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
Adriana Letta
466
Tra le numerose pubblicazioni giunte in libreria per il Cinquantenario
della distruzione bellica, vogliamo segnalarne una che merita un’attenzione
particolare: la biografia di un personaggio che ha avuto una parte determinante nello svolgimento delle battaglie di Cassino nel ‘43/’44, il generale tedesco
Fridolin von Senger und Etterlin. Il prof. Giuseppe Trulli, di Veroli, autore del
libro, intende tracciare un ritratto dell’uomo e del generale, che vale la pena di
conoscere più da vicino.
Infatti studiare la vita e i comportamenti di un alto comandante tedesco come von Senger, e scoprire in lui un militare coraggioso, capace, fedele
al dovere, ma al tempo stesso un uomo retto, profondamente religioso, colto,
amante della musica e del bello, critico verso la dittatura sotto la quale si trovava a militare, significa avere strumenti per articolare meglio il proprio giudizio
storico e in fondo... capire meglio la storia. L’autore, citando le memorie di von
Senger racchiuse nel suo libro “Krieg in Europa”, ricostruisce le tappe della sua
carriera e ne dimostra la linea di condotta sempre irreprensibile, pur vivendo
egli in un “duplice e contrastante imperativo: quello di battersi strenuamente
per la vittoria e quello di desiderare la disfatta per amor di patria!”. È in Corsica l’episodio più luminoso: appena presa Bastia, von Senger riceve da Hitler
l’ordine di fucilare tutti i prigionieri italiani (200), ma coraggiosamente rifiuta
di obbedire e li fa trasferire immediatamente in salvo in continente, rischiando
la sua stessa vita.
Poi è sul fronte di Cassino, dove organizza la resistenza tedesca in una
tenace guerra di posizione che ha dell’incredibile, rispettando sempre l’accordo della neutralità dell’Abbazia; a Spoleto blocca il convoglio che trasporta i tesori di Montecassino al nord, e lo dirotta verso il Vaticano; sulla “linea Gustav”,
come comandante del XIV corpo corazzato, dimostra capacità strategiche notevoli, ma dal suo quartier generale di Roccasecca e poi di Castelmassimo di
Veroli, si preoccupa costantemente delle necessità della popolazione e delle
monache benedettine, prega con fervore, è affabile con la gente comune, soffre
per l’inutile distruzione dell’Abbazia, si prodiga per trasferire a Roma l’abate
Diamare.
Più tardi, trovandosi al nord, tra continui attacchi di partigiani, si adopera per evitare le rappresaglie, “opponendosi a molte disposizioni riguardanti
le fucilazioni senza processo”.
E continua a darsi da fare per aiutare le popolazioni affamate, e ad andare con
passione alla scoperta di bellezze artistiche e naturali. Convinto della imminente fine del regime nazista, e desideroso di questo, continua fino all’ultimo
ad essere leale verso la Patria.
Un vero generale, dunque, un vero uomo, un cristiano convinto.
Un bel libro a cura di Giuseppe Trulli, che traccia la vicenda umana del
generale comandante il XIV Corpo Corazzato tedesco durante la battaglia sul
fronte di Cassino. Proposto in occasione del 50° anniversario della distruzione
dell’Abbazia, unisce ai ricordi desunti da fonti locali, orali e scritte, spunti narrativi tratti dal bel volume “Krieg in Europe” dello stesso von Senger, tradotto
in italiano da Giorgio Cuzzelli e pubblicato nel 1968 da Longanesi, con il titolo
“Combattere senza paura e senza speranza”. Al centro, la storia di un uomo che
ha vissuto intensamente la contraddizione tra l’ubbidienza al giuramento di
soldato e un insopprimibile rispetto per i supremi diritti umani.
Dal conflitto tra dovere e libertà nasce il sofferto e articolato profilo di
un comandante che ha legato il suo nome ai tragici anni della guerra lasciandovi una nota di singolare nobiltà. I tentativi fatti per scongiurare la distruzione di Montecassino, l’opera svolta per portare in salvo i tesori del Monastero
(a Spoleto è von Senger a bloccare il convoglio che stava per dirigersi a Nord),
sono solo alcune tra le azioni grandi e generose di quest’uomo che l’8 settembre del ‘43 aveva già rischiato la vita rifiutandosi di passare per le armi - secondo un preciso ordine di Hitler - 200 ufficiali italiani fatti prigionieri in Corsica.
L’amore per la cultura e per l’arte, il senso profondo della famiglia e
della patria, la sincera fede cristiana di von Senger sono raccontati con una
scrittura piana e ben documentata. L’evocazione è commossa, ma trattenuta
nelle maglie di un discorso sereno; il personaggio è reso con uno spessore che
non si dimentica.
Maria Rita Zanone
(...) È la narrazione straordinaria di un avvenimento straordinario;
comprende quella parte di verità storica e umana che nei libri scolastici difficilmente si trova. (...)
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
Ione Vettese
467
P. Fedele Schnitzler, Benediktinerabtei Gerleve
(...) È un volume molto, molto interessante scritto con criterio e acribia. L’ho letto in un fiato. L’ho fatto vedere anche al mio P. Abate. (...)
Gino Colafranceschi
(...) Ho letto con molto interesse il suo libro “Fridolin von Senger und Etterlin”.
Lavoro accuratamente condotto; disposta in modo sistematico tutta la documentazione raccolta; collegate con serietà e obiettività date, luoghi e avvenimenti. Me ne compiaccio e, ancora una volta, mi rallegro con lei. Per chi come
noi conosce quei posti e ha vissuto i tragici eventi della II guerra mondiale, che
tanto hanno inciso sulla nostra formazione giovanile, la lettura del libro ci rafforza nello spirito e ci impegna ad avere sempre più coraggio nell’affermazione
di quei valori che fanno grandi gli uomini e il loro paese. (...)
Mario Chiabrera
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
(...) Provo ammirazione per lo spessore e la nobiltà della sua opera, per
la sua coraggiosa obiettività. (...) Ma Senger è universale. Egli appartiene alla
aristocrazia di coloro che redimono e suggeriscono, dalle miserie di vicende
spietate, la speranza nella civiltà dell’uomo. Davvero mirabile la Sua sintesi:
«un uomo esemplare che ogni persona onesta amante del bene vorrebbe avere
per amico, confidente e guida».
468
Il cimitero di Häg
Häg: un piccolo centro appollaiato su una collina del Baden meridionale, in
Germania, nell’immensità della Foresta Nera. Il cimitero di Häg: un fazzoletto
di terra dipinto di verde, intenso e ricchissimo nelle sue infinite tonalità; con
alcune manciate, qua e là, di rosso, di giallo, di bianco, e con tante piccole macchie rettangolari, quasi sempre nere o grigie, disposte simmetricamente rispetto ad un punto focale: un grande Crocifisso scolpito, che il tempo ha rivestito
pazientemente di una calda patina dorata.
Entrando nel luogo dove si va a dormire, non si prova tristezza: nel
cimitero di Häg piante e fiori sono motivo di vera gioia per gli occhi e prefigurano, con la loro smagliante bellezza, le meraviglie del paradiso. (...)
Un esile e basso muro descrive intorno alle tombe una dolce curva e
chiude, nello stesso abbraccio, una modesta ma loquace fontanina, unica voce
nel perenne silenzio di questo luogo sacro. Vicinissima, s’innalza, simbolo del
popolo di Dio, una chiesa architettonicamente valida ed elegante nella sua decisa bicromia, stretta vicino ad un campanile asciutto e slanciato, severo nel
suo colore scuro e aguzzo fino a sfondare il cielo. Insieme dominano la valle
solitaria.
In questo cimitero, nel gennaio 1963, fu sepolto un uomo eccezionale
ed un grande generale: Fridolin von Senger und Etterlin. Ma la sua tomba è
simile alle altre: poco più di un metro quadrato di terra, due giovani cipressi ed
una croce. Davanti all’aiuola, una pietra reca inciso il suo nome e quello della
moglie Hilda M. von Kracht, venuta a raggiungerlo nel 1983.
«O Gott, Du Herr der Erbarmungen, gewähre der Seele Deines Dieners
den Ort der Erquickung und die Seligkeit der Ruhe. Laß sie genießen des ewigen
Lichtes Gluckseligkeit».
«O Dio, Signore della misericordia, elargisci all’anima di questo servo
il luogo del riposo e la beatitudine della pace. Concedi che goda della luce e
della felicità eterna».
GIUSEPPE TRULLI
18. Tedeschi III Giuseppe Trulli
18.4
469
L’Abbazia di Montecassino
Nei pressi dell’ingresso dell’Abbazia
Per finire
La processione della Madonna dell’Olivello
479
19.1
La processione della Madonna dell’Olivello
19. Per finire Giuseppe Trulli
É
il pomeriggio di sabato 17 aprile 1982, il giorno prima della domenica “in Albis”, e a Veroli fervono i preparativi per la processione della Madonna dell’Olivello: grossi mucchi di legna vengono
sistemati febbrilmente nelle piazzette del paese per essere accesi nel
momento in cui passerà la statua della Vergine.
Il largo antistante la chiesa, da cui tra poco prenderà il via la processione, è insolitamente animato da gente accorsa a rendere omaggio alla Madonna,
ed è rallegrato dal suono delle trombette dei più piccini.
Ci sono le bandierine di carta e le sedie per sedersi a bere in santa pace
un bicchiere di birra. Ci sono i palloncini colorati e le noccioline americane. Ci
sono le bancarelle stracariche di giocattoli e di dolciumi. C’è la banda. Insomma ci sono tutti gli ingredienti tipici delle feste di paese.
Eppure fino a ieri qui intorno tutto era silenzio e pace. Per l’intero
anno solare qui intorno è silenzio e pace.
Contemplando il paesaggio dal piccolo piazzale che circonda la chiesina, vengono in mente gli «interminati spazi» ed i «sovrumani silenzi» di leopardiana memoria.
E soltanto apparentemente i Monti Lepini riescono ad arginare la vastità del paesaggio.
Perfino Torrice e Ripi, Frosinone, Alatri e Fumone, non ce la fanno a
circoscrivere l’ampiezza della veduta: con il profilo morbido e sfumato delle
loro colline, che si fonde sempre con l’azzurro del cielo, esse finiscono con
l’accentuare il senso dell’infinito che trascende lo spazio e il tempo.
Quando, nel lontano 1722, alla bellezza superba di questo paesaggio si
unì l’incanto di una chiesina delicata e gentile, nacque un connubio così perfetto che ancora oggi continua a stupire.
Prima di tale data, il luogo in cui sorge la chiesa era irto di scogli e di
difficile accesso. C’era soltanto un viottolo sul quale era stata costruita, chissà
quando, una edicola che custodiva una immagine della Madonna col Bambino, dipinta ad affresco.
Siccome il viottolo conduceva al punto in cui nel 1209 era stato ritrovato il corpo di Santa Salome, è probabile che l’edicola sorgesse su quella
direttrice per sollecitare la devozione dei visitatori del sepolcro.
Ma col trascorrere degli anni la piccola costruzione andò in rovina ed
assunse il triste aspetto di altre edicole dimenticate dagli uomini: tetto sfondato, muri sbriciolati, consunzione della sacra immagine.
Improvvisamente un fatto nuovo cambiò il destino dell’affresco, ormai seriamente danneggiato dalle intemperie: nell’angolo superiore destro era
479
19. Per finire Giuseppe Trulli
480
cresciuta una piantina di olivo che sembrò proteggere con le sue foglie e i suoi
rami il volto della Madonna.
Vedendo nella nascita dell’olivo un evento miracoloso che poneva rimedio all’incuria dei verolani, si decise di riparare il torto recato alla sacra immagine, innalzando proprio in quel punto una chiesa in onore della Madonna,
che da quel momento si chiamò dell’Olivello.
Tutti i cittadini, anche i più poveri, concorsero generosamente alle
spese per la costruzione del nuovo edificio. Per fare un esempio, il chierico
Nicola Paniccia offrì «un braccio di panno, una salvietta, una foderetta di cuscino, una cinta di velluto, cerchietti et anelli d’argento n. 34... tre file d’ambra,
fili di corallo n. 18, un agnellino molto piccolo, (...) un pintarello».
Il 4 aprile 1722 il vescovo Tartagni benedisse la prima pietra e l’anno
seguente, con la celebrazione della prima messa, veniva dettata da monsignor
Giovardi l’epigrafe, in latino, collocata nella parete interna, sulla porta d’ingresso. Leggiamola, traducendola dal latino:
«L’anno 1723, con l’instancabile amore e zelo di Lorenzo Tartagni, Vescovo di Veroli, con il pio lavoro e il denaro dei cittadini verolani, tagliata una
enorme massa di rupi inaccessibili con l’aiuto di mine, fatta la strada e spianata
l’area antistante, fu costruita la chiesa, aggiungendovi una cappella. Fu così rafforzata la pietà del popolo e accresciuta la devozione verso la Vergine Madre».
Negli anni seguenti fu costruito il muro che regge il largo intorno alla
chiesa e nel 1740 i lavori erano praticamente conclusi.
Come si legge in un diario dell’epoca, le persone incaricate della raccolta dei fondi furono esonerate dal loro incarico: «... furono ripigliate le patenti
alli cercatori per non sentire più li fiotti delle genti che dicevano essersi la chiesa accomodata, e non haver più bisogno della carità e d’ingrassare più li cercatori che non davano il terzo alla chiesa di quello che havevano per limosine».
Nel 1922, grazie all’opera del conte Stanislao De Witten, che diresse
con rara sensibilità e competenza i lavori, la chiesa fu unita alla roccia retrostante, creando un indovinatissimo ampliamento dell’originale nucleo ottagonale. Oggi si accede alla chiesina dell’Olivello in modo agevole.
Non c’è più Porta Piccola e non c’è più l’antico sentiero che conduceva
al sepolcro di Santa Salome.
Nonostante la discutibile presenza di moderne costruzioni sorte alcuni anni or sono nei pressi della chiesa, la recente sistemazione data ai dintorni
del piccolo santuario è dignitosa ed ineccepibile sotto ogni aspetto.
Sull’architrave della porta laterale, che originariamente costituiva l’ingresso principale, è inciso, fra due rametti d’olivo, l’anno della fondazione della chiesa: 1722. Nell’interno, circondata da una gloria di angeli, è la venerata
immagine in onore della quale fu innalzato il piccolo tempio. Al di sopra è
un grosso ramo di olivo: sta lì a ricordare la pianta che protesse il sacro volto
per moltissimi anni. Sotto l’altare, le reliquie di Sant’Angelica, ivi collocate nel
19. Per finire Giuseppe Trulli
1737. Il marchese Luigi Bisleti, che abitava nel palazzo alle spalle della chiesa,
ricorda in un suo opuscolo, stampato nel 1909, che sua madre, devotissima
della Vergine dell’Olivello, fece ricoprire il fondo della sacra immagine con una
lamina d’argento e con 17 stelle d’oro. Ricorda inoltre che «ogni sera, quando
fanciullo m’acconciava nel letto, mi faceva volgere verso la prossima chiesetta
dell’Olivello a salutar Maria e che alla Vergine ogni mattina, appena levato, mi
faceva ripetere le più gentili salutazioni...».
Anche l’arredo è deliziosamente settecentesco ed in perfetta armonia
con le strutture architettoniche della chiesa: dai due quadri posti in alto, a sinistra e a destra dell’altare, che ripetono, con alcune varianti, il tema della Sacra
Famiglia, alla tela della cappellina dedicata alle Anime del Purgatorio; dal Crocifisso ligneo, a sinistra dell’ingresso, ai due lampioni, in legno dorato, che lo
affiancano; agli stucchi che impreziosiscono il già delicato disegno della chiesa.
Come si diceva prima, di sapore settecentesco è anche la parte posteriore, quella dietro l’altare, aggiunta nel 1922 dal conte De Witten, in occasione
del secondo centenario della fondazione della chiesa.
Sistemata dentro una nicchia ricavata nel prospetto posteriore dell’altare, è la statua della Madonna che ogni anno viene portata in processione per
le vie del paese. Intorno alla statua, reliquiari ed ex voto.
Di fronte, la tomba del cardinale Gaetano Bisleti, anche lui, come il
fratello e come la madre, devotissimo della Vergine dell’Olivello.
Sul sarcofago, a sinistra e a destra, sono riassunte le principali cariche
ricoperte dall’illustre Porporato: Cameriere Segreto Partecipante e Maestro di
Camera di Leone XIII; Maggiordomo di Pio X e Cardinale di S. Agata dei Goti;
Gran Priore del Sovrano Ordine di Malta e Gran Cancelliere della Pontificia
Università Gregoriana; Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle
Università e Presidente della Pontificia Scuola Superiore per la Musica Sacra.
Sul bordo del sarcofago, la frase più bella che Pio XI abbia mai pronunciato per onorare un cardinale: «Gemma del Sacro Collegio».
Morì nel 1937 e volle essere sepolto nella chiesina prediletta.
Il suono argentino della campana avverte che la processione sta per
prendere il via; quindi la statua della Madonna si allontana, accompagnata dal
suono festoso della banda, tra gli scoppi dei fuochi artificiali, seguita da una
moltitudine di fedeli che intonano l’inno a Lei dedicato: «Sii benedetta o Vergine Santa dell’Olivella; vita, dolcezza, bella, nostra speranza e amor».
Mentre la processione si snoda per le strade di Veroli, i fuochi illuminano con suggestivi bagliori la statua della Madonna...
Nel diario già citato, in data 8 aprile 1725, si registra la prima processione della Madonna dell’Olivello: «Festa solenne della Madonna Santissima,
cioè Dedicazione della chiesa; fatta la festa dal Sig. Erminio Melloni con l’haver fatto la processione hier sera colli sacchi bianchi, vestitisi tutti li nobili et
artisti, colla manichina della Madonna Santissima, la prima volta». Un’altra
481
domenica “in Albis” è rimasta memorabile quella del 28 aprile 1737, quando
giunse a Veroli, per essere collocato nell’altare della chiesa dell’Olivello, il corpo di S. Angelica Martire. Trasportato con la mula di Giovanni Domenico Farina, e accompagnato da Gregorio Melloni e da Don Angelo Mazzoli, fece una
sosta nella chiesina degli Angeli; poi giunse nel santuario dell’Olivello, accolto
da una folla immensa.
La processione sta per rientrare. Ancora il suono della banda. Altri
inni. Qualche preghiera. Gli ultimi spari. Poi tutti si allontanano e, piano piano, intorno alla chiesa si diffondono il silenzio e la pace.
Ma il cardinale Bisleti non rimarrà solo: da domani, ogni sera, tornerà
a fargli compagnia un allegro e affiatatissimo coro di passeri e di rondini che
canteranno per lui il «Magnificat», in onore della Vergine dell’Olivello.
Buonanotte, Eminenza!
19. Per finire Giuseppe Trulli
GIUSEPPE TRULLI
Testo dell’audiovisivo La festa della Madonna dell’Olivello
482
Il Santuario
Cronologia
530
Sui Colli Albani alleanza degli Ernici con Tarquinio il Superbo.
509
Cacciata di Tarquinio il Superbo.
496
Gli Ernici, istigati da Tarquinio il Superbo, dichiarano
guerra a Roma, ma vengono sconfitti nella battaglia del
lago Regillo.
493
Foedus Cassianum tra Romani e Latini.
488
Dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, gli Ernici non
ritenendo più valida l’alleanza con i Romani, ne devastano
il territorio, essendo consoli a Roma C. Aquilio e Sicinio.
C. Aquilio sbaraglia gli Ernici.
487
Gli Ernici vengono sconfitti da Spurio Cassio.
486
Foedus Cassianum fra Romani ed Ernici. In virtù di questo
patto, in ogni impresa gli Ernici hanno diritto ad un terzo
del bottino.
389, 386
Ernici e Latini si uniscono ai Volsci contro Roma.
358
I Romani tolgono Ferentino ed altre città agli Ernici. Spenti gli ultimi focolai, i Romani costringono gli Ernici a rientrare nella Lega Romana.
358 - 342
La via Latina da Ferentino, passando per Veroli, è prolungata fino a Sora.
342
I Romani tolgono Sora ai Volsci.
343 - 290
Guerre Sannitiche.
307
Durante la seconda Guerra Sannitica una parte degli Ernici si ribella di nuovo a Roma ed invia segreti aiuti ai Sanniti. Nella battaglia di Alife, 7.000 soci dei Sanniti cadono
prigionieri dei Romani.
306
Anagni convoca gli Ernici al Circo Marittimo per combattere Roma. Veroli, Alatri e Ferentino non aderiscono. Veroli ha un nuovo trattato di alleanza: ha la cittadinanza ro-
Cronologia Giuseppe Trulli
a.C.
489
mana ed il diritto del connubio, ma continua a governarsi
con le proprie leggi, rimanendo libero Municipio. S.P.Q.V.
I Romani tolgono un terzo del territorio ai Frusinati.
302
La Lega Ernica è completamente sciolta.
100
Veroli appoggia Mario contro Silla.
90 - 88
Guerra Sociale. Verulana Civitas Almae Urbi Confoederata.
86
Muore Mario. Silla forma le liste di proscrizione. Veroli diventa colonia militare.
Cronologia Giuseppe Trulli
d.C.
490
14
Muore Augusto.
14 - 41
Fasti Verulani.
69 - 79
Lotte fra Vespasiano e Vitellio. Gracilia.
69 circa
Giunge a Veroli Santa Salome. Muore intorno al 70
96 - 98
Al tempo di Nerva Veroli torna ad essere libero municipio.
194
Per ordine di Settimio Severo, il nome di Veroli viene inciso sul marmo assieme a quelli delle altre città che avevano
inviato soldati in aiuto dell’imperatore il quale combatteva
in Asia contro Pescennio Nigro.
197, 1 giugno
Dedicazione del monumento a Lucio Alfio, duumviro di
Veroli.
384
Deposizione in S. Andrea del presbitero Marturio.
405
Iscrizione sepolcrale nella parte posteriore dei Fasti Verulani.
419 (o 411)
Atina è distrutta dai Goti. I Verolani riscattano i fanciulli di
questa città, i quali vengono ad abitare a Veroli.
529
S. Benedetto a Veroli getta le fondamenta della chiesa di
S. Erasmo.
743
Martino è il primo, documentato, vescovo di Veroli, la
quale da papa Zaccaria riceve il titolo di Città.
Per interessamento di Piatone, tribuno della Campania, le
ossa di S. Magno vengono portate, per maggior sicurezza,
da Fondi a Veroli.
872
Ludovico II, re d’Italia, si incontra a Veroli con il papa
Adriano II.
877
I Saraceni a Veroli.
883
Le ossa di S. Magno sono vendute agli Anagnini.
IX sec.
Scontro alla Vittoria tra Regnerio e Garferio.
928
Papa Giovanni X è prigioniero nella Rocca di S. Leucio.
1036
Quattro chierici verolani fondano il Monastero di Casamari.
1079
Dedicazione della chiesa di S. Leucio.
1106
II papa Pasquale II, nel recarsi a Benevento, si ferma a Veroli e consacra vescovo Agostino, abate di Casamari.
1127
II vescovo Leto consacra la chiesa di S. Martino.
1170
II papa Alessandro III è a Veroli. Vi era già stato nel 1167.
1209
Ritrovamento del corpo di Santa Salome.
1217
II papa Onorio III consacra l’attuale chiesa di Casamari.
1222, 25 aprile
L’imperatore Federico II si incontra a Veroli con il papa
Onorio III.
1294
È podestà di Veroli il cardinale Benedetto Caetani, futuro
papa Bonifacio VIII.
1350, 8 settembre Violento terremoto a Veroli e nel Lazio meridionale.
1350, 17 ottobre
Rinvenimento dell’urna, con il coperchio spezzato, contenente i resti del corpo di Santa Salome.
1351, 25 maggio
Traslazione del corpo di Santa Salome nella cattedrale di
S. Andrea.
1429
Nuova consacrazione della chiesa di Santa Salome.
Cronologia Giuseppe Trulli
846
491
Cronologia Giuseppe Trulli
492
1440 circa
Nasce Giovanni Sulpicio.
1495
Carlo VIII, re di Francia, entra a Veroli.
1503
Nasce Aonio Paleario.
1535
È governatore di Veroli il cardinale Francisco Quiñones.
1540, 27 ottobre
Muore a Veroli, nella sua casa di Santa Croce, il card.
Quiñones.
1538
Fondazione del Ginnasio “Franchi”.
1556
Gli Spagnoli a Veroli. La Catena.
1561
Si delibera l’apertura di un nuovo monastero benedettino.
1570
Muore Aonio Paleario. Miracolo eucaristico in S. Erasmo.
1575
Giubileo. I Verolani a Palestrina.
1594
Pompeo Caetani fa saltare il palazzo comunale.
1599
Nasce Giovanni Trulli.
1611
II vescovo Asteo comincia a costruire il Seminario.
1742, 25 maggio
Traslazione del corpo di Santa Salome nella confessione
della chiesa omonima.
1743
Ritrovamento nella cattedrale dei corpi dei Santi Biagio e
Demetrio.
1744
Carlo III di Borbone è a Veroli.
1760
Veroli è elevata a Governo di Breve.
1767
II Consiglio comunale è formato da 60 membri appartenenti alle famiglie nobili di Veroli.
1773
Fondazione della Biblioteca Giovardiana.
1786
Muore Vittorio Giovardi.
Alcune immagini della Madonna muovono gli occhi.
1798
Massacro della famiglia Franchi.
1802
Carestia.
1809
Editto di Napoleone che unisce gli Stati della Chiesa alla
Francia e soppressione (1810) del monastero benedettino
di Veroli.
1829
Demolizione del Castello di S. Angelo in Villa.
1853
Carestia. È vescovo Mariano Venturi.
1861
I reazionari napoletani recano gravi danni all’Abbazia di
Casamari.
1863
II papa Pio IX è a Veroli.
1866
Scontro a Fontana Fusa tra briganti e guardie pontificie.
1867, 12 marzo
Ultima esecuzione capitale.
1870
Veroli fa parte del Regno d’Italia.
1889
I frati Minori Osservanti lasciano Veroli.
1913, 6 agosto
Scoprimento della lapide che ricorda i Caduti verolani nella Guerra di Libia.
1915
Terremoto.
1921, 17 aprile
Inaugurazione della sezione di Veroli dei Fasci Nazionali
di Combattimento.
1922
Scoperta dei Fasti Verulani.
1922, 20 novembre Muore Suor Maria Fortunata Viti.
1923, 2 giugno
Inaugurazione del monumento ai Caduti della Prima
Guerra Mondiale.
1928, 2 febbraio
Inaugurazione del restaurato campanile della cattedrale.
Cronologia Giuseppe Trulli
1796
493
Cronologia Giuseppe Trulli
494
1933
La pretura, già soppressa, è restituita a Veroli.
1944, 2 giugno
Gli Alleati entrano a Veroli.
1967, 8 ottobre
Suor Maria Fortunata Viti è proclamata Beata.
1988, 22 maggio
Inaugurazione del monumento ai Caduti della Seconda
Guerra Mondiale.
VEROLI pagine di storia, eventi, personaggi
Indice autori
Alonzi Giulio 9, 60, 82
Alonzi Luigi 37, 57, 60
Arci Patrizia 374
Caperna Umberto 395
Caperna Vincenzo 82, 83
Cardarelli Vincenzo 348
Casanova Antonio G. 179
Cestra Attilio 39, 41
B
Ciarrapico Giuseppe 338, 339
Baldini Antonio 26,
Colli Evasio 335
Bargellini Piero 389
Belli Gioacchino 277
Bertoldi Silvio 461
Biagi Bice 448
Brocchi Adolfo 116
Bussagli Marco 198
Bussagli Mario 45
Cochin Henry 23
D
Dal Lago Antonio 313
D’Annunzio Gabriele 306
Dell’Arco Mario 278
Del Signore Rosa 376
De Mattia Giuseppe 211, 221, 273
C
Cadorna Luigi 295
Caiani Luigi 275
Cannata Roberto 256
Diaz Armando 297
Di Fabio Giorgio 364
D’Onorio Giuseppe 177, 188, 223
Durant Will 115
Indice autori Giuseppe Trulli
A
495
E
L
E. Filiberto di Savoia 294, 305
Laudisa Giulio 66, 68
F
Ferrero Adolfo 298
G
Gabriele Alfredo 358
Gallina Ernesto 192
Gatta Bruno 347
Giorleo Aldo 341
Giovannini Alberto 340
Gregorovius Ferdinand 183
Indice autori Giuseppe Trulli
Guidi Angelo Flavio 316
496
I
Innocenti Marco 346
K
Kesselring Albert 460
Luci di un’anima 395
Lugli Giuseppe 89
M
Mancini Francesco 357
Mauti Giorgio 151
Mezzacapo Mario 43, 82, 113,185
Montanelli Indro 344
Moretti Marino 11
Moroni Gaetano 268
O
Oster A. 463
Oddi Don Angelo Maria 132
P
P. B. 421
Panciera Silvio 87
Putti Maria Letizia 156
Q
T
Quattrociocchi Vincenzo 81, 156
Tarquini Alessandro 166, 167
Rebecchini Salvatore 283
Ricca Ornella 55
Rommel Erwin 337
Rosazza Ferraris Patrizia 63
S
Sarra Don Andrea 370, 391, 401, 405
Scaccia Scarafoni Arduino 84, 87, 89
Scaccia Scarafoni Camillo 109, 121
Scaccia Scarafoni Giuseppe 362
Scaccia Scarafoni Paolo 361
Sluyterman V. Langewe Georg 441
Sodani Pierluigi 240
Solin Heikki 113
Spagnoli Pietro 11
Sperduti Giuseppe 81, 83, 145
Spani Guido 123, 184
Stirpe Marcello 154, 181
Terzini Massimo 13
Trulli Giuseppe 11, 39, 43, 86, 91,
125, 130, 207, 235, 242, 250, 284, 353,
427, 443, 469, 479
U
Ungaretti Giuseppe 340
V
Veccia Giovanni 84
Vesilic Nenad 195
Virone Giuseppe 155
Vittorio Emanuele III 293
Von Ranke Leopold 5
Von Senger Fridolin 424, 434
Volpicelli Luigi 24
Indice autori Giuseppe Trulli
R
Tarquini Carlo 115
497
Scaricare