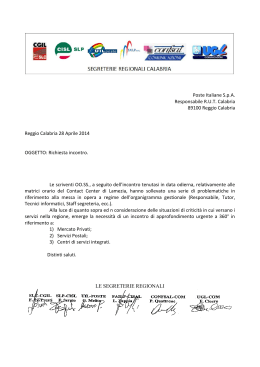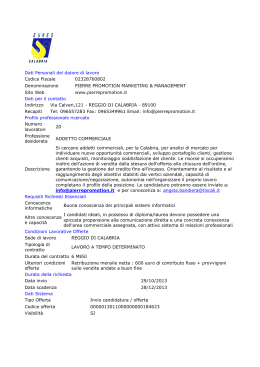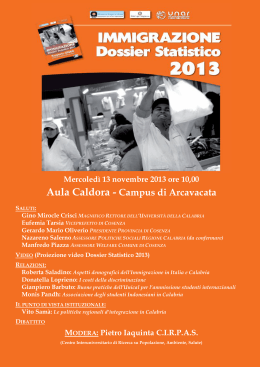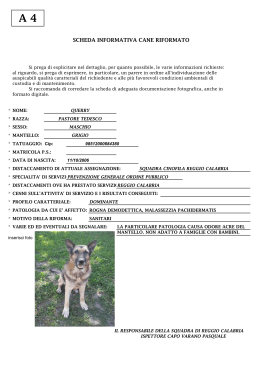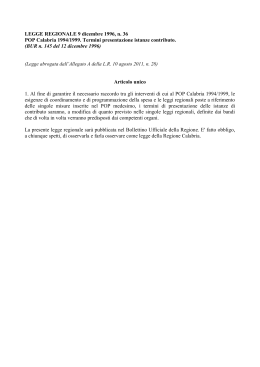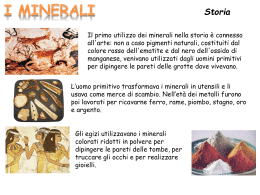LE IDENTICHE MINIERE DI RAME ALLE DUE ESTREMITÀ NORD E SUD DELLA PENISOLA LA GRANDE DISPONIBILITÀ DI GIACIMENTI, ANCHE DI ORO, E LE ANTICHE MINIERE PER LA CRESCITA DEL TURISMO E DELL’OCCUPAZIONE IN CALABRIA --------di Mario Pileggi (*) Il prezioso patrimonio di rocce e minerali della Calabria, poco noto nella regione ma da millenni sfruttato soprattutto dai colonizzatori di ogni epoca, si ripropone all’attenzione con i risultati della seconda fase del Censimento dei Siti Minerari Abbandonati dal 1870 al 2004. Resi noti nei mesi scorsi dal Ministero dell’Ambiente, i dati del censimento riportano 29 miniere a cielo aperto e 31 in sotterraneo. I minerali estratti nei 60 siti rilevati sono: Zolfo 17, Feldspati 16, Caolino 7, Mica 7, Marna da cemento 6, Minerali del Manganese 5, Salgemma 3, Lignite 3, Lignite xiloide 2, Pirite 2, Silicati idrati alluminio 1, Barite (Baritina) 1, Fosforite 1, Limonite 1, Quarzo 1, Molibdenite 1, Grafite 1, Arsenopirite 1, Cinabro 1. Questi sono solo pochi esempi della gran varietà dei giacimenti minerari sfruttati e disponibili nella regione. Varietà documentata storicamente e anche con ricerche recenti. D’altra parte, è significativo il Decreto del Ministero del Ministero delle Attività Produttive del 13 luglio scorso, che ha integrato l’elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa inserendo sia la provincia di Cosenza per i minerali di oro, piombo, zinco e rame sia i comuni di Bivongi e Pazzano della provincia di Reggio Calabria per i minerali di molibdeno. Altri due dati di grande interesse e utili per il recupero della memoria storica sulle risorse minerarie e per individuare le potenzialità della più complessiva specificità geoambientale della Calabria. I due dati, rilevati e documentati dal Responsabile del Corpo Reale delle miniere d’Italia, si riferiscono: 1) alla provenienza della preziosa materia prima delle note porcellane Ginori per come a parte documentato; 2) alle identiche caratteristiche delle miniere di rame localizzate a Sud di Reggio Calabria e nella zona della Vetta d’Italia nel comune di Predoi della regione Trentino Alto Adige. Sulla eccezionale identità delle miniere di rame, (primo metallo estratto e sfruttato dall’uomo primitivo ), esistente alla due estremità Nord e Sud della penisola, la massima autorità dell’epoca in campo minerario, centoventi anni fa, scriveva: “trovate poco a Sud di Reggio, le vestigia di una fonderia di rame; …furono scoperte delle gallerie strettissime, capaci di dar passaggio ad un suolo uomo, scavate a scalpello. In esse si trova del carbonato di rame verde, depositato da acque che vengono dal di sotto dei sovrastanti terrazzi dell’Aspromonte..; il deposito e le gallerie sono identici a quelli trovati a Caserme (Kasern) nella Valle Aurina dell’Alto Adice, che scende dalla Vetta d’Italia, e le gallerie sono, certo, della stessa epoca.” In pratica le due estremità Nord e Sud della penisola sono fatte dalla stessa materia ben diversa per natura ed epoca di formazione delle rocce che formano la Catena appenninica. La grande varietà di minerali della calabria è connessa ai vari ambienti che caratterizzano l’intero Arco Calabro dove, tra l’altro, esistono: mineralizzazioni prealpine con metamorfici a solfuri (pirite, calcopirite, galena blenda, arsenopirite, pirrotina), magnetite ed a grafite; mineralizzazioni alpine (barite, cinabro, galena, calcopirite, torio, manganese zolfo, salgemma, lignite) che interessano le Unità Ofiolitiche, di S. Donato ed i sedimenti dei depositi miocenici. In pratica, i giacimenti minerari più interessanti risultano distribuiti proprio all’interno di particolari tipi di rocce ed assetti geostrutturali come sono quelli che costituiscono l’Arco Calabro-peloritano caratterizzato anche dalla ben nota attività sismica. Meno noti invece e spesso colpevolmente trascurati sono i numerosi ed importanti giacimenti minerari che, come i terremoti, sono connessi alle condizioni geostrutturali ed ai processi geodinamici che caratterizzano il territorio della regione. Alla gran varietà di litotipi esistenti (in Calabria sono stati individuati oltre 200 tipi di rocce) ed ai fenomeni di sollevamento tettonico cui è sottopostala regione, sono, infatti, associati importanti «ambienti geodinamici» che presiedono alla formazione degli accumuli di minerali utili. La Calabria, quindi, oltre ad essere la regione a più alta sismicità, è anche una delle zone d'Italia più ricche di depositi minerari metallici e litoidi. D'altra parte sulla disponibilità ed utilizzazione di giacimenti minerari nella regione, come per gli eventi sismici, non mancano i dati che ne documentano l'attività nel passato remoto e recente della storia calabrese. Basta ricordare, ad esempio, l’intenso e diffuso sfruttamento minerario che seguì alla colonizzazione greca e, partire dal Medio Evo, le secolari attività di sfruttamento delle miniere d’argento di Longobucco e S. Donato nella provincia di Cosenza. L’intesa attività mineraria nella regione ed in particolare nelle ultime due località citate è, tra l’altro, documentata da Vincenzo Padula che scrive: “Al 1701 alcuni ottennero in feudo le miniere di S. Donato, di scavare fino alla circonferenza di 20 miglia. Se ne prese possesso a maggio del 1705. Saggi felici. Da 3 cantaia e 3 rotoli si ottennero 67 libbre e1/2 di rame perfettissimo. L’anno appresso si scopersero 2 grotte, e nel dicembre si aprì la fonderia. Per più anni vi lavorarono 100 forzati sotto la sorveglianza d’Austriaci. Era direttore uno Jusquall. Si ottennero oro, argento, mercurio, rame, cinabro. Si lavorò fino al 1736; e si cessò per rivolgimenti politici, l’infedeltà degli impiegati e l’ingordigia del duca di S. Donato”. E poi “Carlo VI ne tentò le marine e vi trovò argento, piombo, cinabro oltre marino in terra di Umbria. Carlo VI mandò da Boemia il chimico Khez, e si fanno monete col motto: “Ex visceribus meis”, d’argento. Il primo 5 grana di argento fu fatto con quello di Longobucco>”. “Nell’editto di re Roberto del 1333 concernente la Sila è detto che la regia corte riserbava si il diritto su una miniera di ferro, che era aperta.” Nel passato recente, gli anni a cavallo della seconda guerra mondiale rappresentano un periodo di discreta attività estrattiva dei minerali presenti nella regione: oltre due milioni di tonnellate è la produzione di minerali non metallici (grafite, baritina, feldestati, etc.); ancor più significativa è la quantità (50 mila tonnellate) di minerali metallici, come ad esempio ferro, rame, manganese, estratti in soli dieci anni; e la produzione d’idrocarburi, nel solo periodo compreso tra il 1950 ed il 1969, è stata calcolata intorno al milione di metri cubi. Questi dati dimostrano dunque come quello attuale rappresenti uno dei periodi di minore utilizzazione delle risorse minerarie disponibili. Il salgemma del Crotonese, il quarzo di Serra S. Bruno ed i feldespati del Vibonese, costituiscono i pochi e più significativi esempi di giacimenti minerari attualmente utilizzati, e neanche pienamente, nella regione. Mentre si registra il minimo dell'attività estrattiva, paradossalmente, i risultati di ricerche eseguite nel biennio '80-'81 con moderne tecniche d'indagine dalla RIMIM dell'ENI, oltre a confermare l'esistenza dei giacimenti già noti, hanno permesso l'individuazione di nuove aree di grande interesse geominerario su tutto il territorio della regione. Nel settore settentrionale, ad esempio, zone di grande interesse sono risultate quelle di Normanno-Verbicaro-Sangineto per una superficie di 352 km2, dove è stata rilevata la presenza di piombo, bario, rame, tungsteno ed altri minerali utili. Nel settore centrale è stata individuata un’area di 50 km2 (zona Catanzaro-Nocera-Amantea) con accumulo di vari minerali tra cui mercurio, stagno berillio, molibdeno. E, nel settore meridionale sia sull’Aspromonte che nella zona Stilo-Bivongi-Mammola, oltre ai minerali sopracitati per la zona centrale, le ricerche hanno accertato la presenza di altri minerali quali tormalina, ferro arsenico, uranio. Se si considera che quelli sopra citati sono solo alcuni degli accumuli di minerari metallici d'interesse economico ed industriale di individuati e che molto più lungo è l'elenco dei cospicui giacimenti non metallici presenti nella regione, si ha l'idea del grande patrimonio di risorse minerarie disponibili in Calabria. L'utilizzazione e la valorizzazione di questo grande patrimonio, e di tutte le altre georisorse (litominerarie agricole, idriche, energetiche, e geositi), sono stati finora impediti dall'incapacità dei governi nazionali e regionali di attuare una politica di organico approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie. Incapacità e responsabilità che si è tentato di nascondere attribuendo la grave crisi della Calabria all’assenza di risorse naturali. Alla consapevolezza di come non sia la natura, in particolare quella geologica, ad essere sfavorevole e causa dei mali della Calabria, deve accompagnarsi la capacità di porre il territorio e le sue risorse come pietre miliari della politica di sviluppo della società calabrese e, in particolare, del “percorso per uno sviluppo strutturale sostenibile e autopropulsivo”. A tal fine servono programmi e ed interventi anche di nessun costo economico come, ad esempio,:il varo di una legge regionale che disciplini ed incentivi l’attività di ricerca e coltivazione sostenibile delle Cave e Torbiere, per come già da decenni è stato fatto nelle altre regioni d’Italia; la definizione da parte del Governo nazionale di idonei indirizzi della politica nazionale nel settore minerario per come previsto dalla legge 752/1982 (Norme di attuazione della politica Mineraria) .Interventi che non possono ancora essere rinviati anche perché, invece di essere costretti ad andare a scavare nelle miniere del nordeuropa e delle Americhe, i giovani disoccupati calabresi vogliono e devono trovare lavoro nella propria regione non meno ricca di minerali di quei paesi nei quali le passate generazioni sono state costrette ad emigrare. (*) geologo - g e opileggi@ libero.it DALLA CALABRIA LA PREZIOSA MATERIA PRIMA DEI SERVIZI REALI DI PORCELLANA OGGI AL QUIRINALE ---------di M a r i o P i l e g g i ( * ) Negli ultimi decenni del XIX secolo, l’ing. Emilio Cortese, capo del Corpo Reale delle miniere d’Italia, nel documentare le ricche georisorse della Calabria, tra l’altro, scrive: “Nei dintorni di Parghelia, in provincia di Catanzaro, si sviluppano dei grossi filoni di pegmatite, che furono e sono oggetto di una grande industria. La località fu visitata dallo scrivente fin dal 1882, la prima volta, e successivamente egli se ne occupò perché gli pareva assai interessante il materiale nelle sue applicazioni per l’arte vetraria e per la ceramica. Ma pare che questa preziosa materia sia destinata a cader sempre sotto la mano di gente che, o per ignavia, o per cattiva fortuna, non sa trarne tutto il profitto che può dare.” Sul modalità di trasporto e destinazione viene precisato che: “La materia pura è portata a Tropea ed imbarcata su grosse barche a vela. Viene acquistata quasi tutta dal Ginori di Firenze, dopo accurata macinazione. Questa si eseguisce in Toscana per conto di un intercettatore. Ne vidi, con grande meraviglia, macinare ad un mulino di Val Castello sopra Pietrasanta! Sono filoni entro la grande massa granitica di Monte Poro, e si chiamano pegmatiti per antonomasia, perché realmente si dovrebbero chiamare silici o filoni quarzosi, essendo che di essi ben pochi contengono feldespato.” D’interesse risulta anche la variazione dei costi della materia prima nei vari passaggi dal momento dell’estrazione nelle cave fino all’arrivo allo stabilimento dei Ginori. Scrive in proposito l’ing. Cortese:” La materia prima si vende a Troppa al prezzo minimo di 2 lire, al massimo di tre lire al quintale, ma costa al conduttore delle cave da 0,70 a 4 lire al quintale. Il trasporto e la macinazione fanno aumentare il prezzo a 6 lire (?) il quintale; è così, mi si disse, che viene a costare allo stabilimento Ginori, o Doccia presso Firenze.” Riguardo la specificità e potenzialità economica del giacimento, l’ing. Cortese evidenzia :È materia straordinariamente pura, specialmente perché scevra di ferro, ed adattissima per le vernici dure di cui la manifattura Ginori fa una sua pregevole specialità. Scrive sempre l’ing. Cortese: “Riporto dal mio opuscolo, le analisi di alcuni esemplari, eseguite da me (1859 e dal Dott. G. Giorgis..” E sottolinea :“Se questi giacimenti fossero ben coltivati e i materiali ben preparati sarebbe possibile farne oggetto di una industria fiorente” Nella descrizione del capo del Corpo Reale delle miniere d’Italia non mancano i riferimenti ai fallimenti delle iniziative d’insediamento industriale, ben noti e diffusi nella regione negli ultimi decenni,. Infatti l’ing. Cortese annota: “nel 1891, la Società mineraria per il quarzi e silici d’Italia pareva potesse dare qui, come in altre parti della penisola, largo sviluppo alla produzione e utilizzazione di questi materiali. Travolta anch’essa ai primi del 1893, da una catastrofe bancaria che ha trascinato con sé molte altre cose, i suoi lavori, poco ben piantati, sono rimasti senza frutto” Nel stesso periodo in cui la Calabria forniva la migliore qualità della materia prima, nello stabilimento della Ginori, venivano realizzati ”diversi servizi su ordinazione, di non facile reperibilità oggi sul mercato antiquario, abbastanza simili a quello prodotto su richiesta del re Umberto I nel 1880. Si tratta di una realizzazione di grande raffinatezza, decorata pâte sûr pâte illustrante tralci di piante con fiori e frutta in oro, platino e colori. Questo servizio da dessert per il Re è oggi conservato a Roma nel Palazzo del Quirinale.” (*) geologo
Scarica