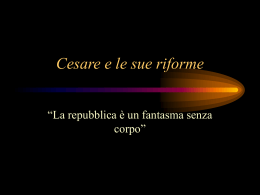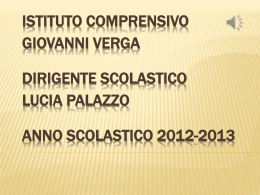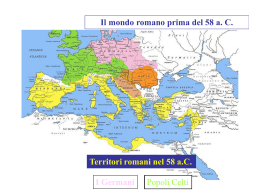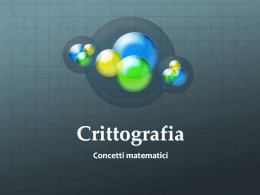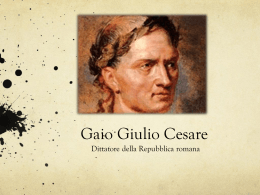Università Ca’ Foscari di Venezia Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali Tesi di Laurea Triennale Il collezionismo librario nella Venezia dell'Ottocento: il libraio Adolfo Cesare Relatore: Laureando: Prof. Mario Infelise Mario Marino Matricola nr. 814153 Anno Accademico 2008 - 2009 1 Sommario 3 Introduzione 6 Una panoramica sul mercato antiquario a Venezia fra Sette e Ottocento 11 La figura di Adolfo Cesare attraverso i Diari di E. A. Cicogna 15 Metodologia di ricerca 18 Trascrizione Diari 47 Lettera autografa di Adolfo Cesare a E. A. Cicogna 49 Conclusioni 53 Tavole 56 Bibliografia 60 Indice dei nomi 2 Introduzione L’etimologia del termine antiquariato vede la sua origine in ambito librario, già nell’editto di Diocleziano De pretiis rerum venalium, del 301 d. C, la parola antiquarius è impiegata come sinonimo di librarius ad indicare il maestro di calligrafia e scrittura e, successivamente, l’amanuense che attendeva alla copia e alla manutenzione dei codici. Con l’invenzione della stampa, gli antiquarii sono gli estimatori e collezionisti di antichità e solo a partire dal secolo XVI la figura dell’antiquario si amplia fino a comprendere la fisionomia del commerciante di antichità tout court1; ma se è nel Settecento che la bottega dell’antiquario si istituzionalizza nella sua funzione di luogo di compravendita di oggetti antichi, è però nell’Ottocento che la professione dell’antiquario si configura nel senso attuale del termine, ovvero di colui che si occupa del “commercio di libri, oggetti antichi e di opere d’arte antica”2. Il piacere di raccogliere, conservare e anche collezionare il libro, inizialmente nella forma manoscritta e qualche secolo dopo anche stampata, non è moda recente ma si perde nei meandri della storia della cultura. Si pensi alle raccolte di papiri avviate in epoca ellenistica, che diedero fama eterna a istituzioni come la Biblioteca di Alessandria, le cui alterne sorti non smettono di appassionare gli studiosi di ogni epoca, o alle collezioni private di epoca romana come quella rinvenuta nella cosiddetta “Villa dei Papiri” ad Ercolano. E in epoca tardo-medievale, non si può non ricordare l’attività di bibliofilo di Francesco Petrarca che a buon diritto può essere considerato l’antesignano di una tendenza che troverà la sua massima espressione nell’Umanesimo3. Cfr. S. RIZZO, Il lessico filologico degli Umanisti, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1973, p. 203; e s.v. «Antiquari» in Enciclopedia Italiana, 3, Roma 1929, p. 526. 2 s.v. «Antiquariato» in Dizionario Enciclopedico Italiano, 1, Roma 1955, p. 507. 3 Per una panoramica attenta e dettagliata sulla questione cfr. R. SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV. Nuove ricerche, Firenze, Sansoni, 1967. 1 3 Dal punto di vista storico e culturale infatti è l’Umanesimo che contribuisce in modo determinante alla rinascita del collezionismo librario, dopo la stasi del Medioevo, in cui la circolazione libraria era legata alla produzione degli scriptoria monastici, quell’antichità, che era stata considerata un’epoca priva di valori etici cui attingere, diventa per gli Umanisti un riferimento e un esempio da seguire e quindi da studiare attraverso i documenti scritti, in primo luogo, ma anche attraverso testimonianze come statue, epigrafi, monete4. In questa fase ad animare l’interesse per i libri antichi è fu soprattutto l’aspetto filologico, in una visione in cui il testo è più importante del supporto che lo reca; con lo sviluppo delle Università, che contribuirono alla laicizzazione del sapere, e con l’ascesa delle oligarchie cittadine (soprattutto in Italia nella forma della Signoria), le famiglie più in vista si misero in evidenza per il loro mecenatismo, organizzando intorno a sé veri e propri circoli culturali, e mostrandosi sempre più sensibili alla fruizione sia passiva che attiva della cultura. Tra il Quattrocento ed il Cinquecento si verifica quel cambiamento di rotta nei gusti e nelle tendenze che si concretizzerà con la bibliofilia Settecentesca, collezionisti di libri, che ricercano e soprattutto ne commissionano la produzione oltre all’interesse per il testo in sé, perché questi oggetti diventano status symbol di un determinato ceto sociale e investimento economico; certamente capolavori come la Bibbia di Borso d’Este o il Breviario Grimani non sono stati prodotti per essere usati come libro di preghiere quotidiane ed i possessori erano perfettamente consapevoli del loro potenziale valore sul mercato. All’interesse per lo studio dei testi, che abbiamo visto animare i collezionisti di libri nel Quattrocento e primi anni del Cinquecento, ovvero la Cfr. anche F. CRISTIANO, L’antiquariato librario in Italia: vicende, protagonisti, cataloghi, Roma, Gela, 1986, pp. 19-20. 4 4 volontà di possedere antichi manoscritti e prime edizioni a stampa esclusivamente in funzione del contenuto testuale, si veniva affiancando una passione puramente antiquaria, che porta a considerare il libro antico come oggetto da collezionare soprattutto per il requisito estrinseco dell’antichità. Nello specifico, è proprio il Settecento il secolo in cui l’antiquario diventa anche “cercatore di libri”, in questo secolo infatti si sviluppa fra i collezionisti di antichità la moda della bibliofilia5 ovvero la passione per i libri considerati in sé come oggetti da collezione alla stregua di opere d’arte o monili preziosi6. È in questo Secolo che la passione dei bibliofili si accende e si sviluppa in tutta la sua intensità, portando alla nascita e all’incremento delle più ricche e importanti biblioteche private, basti pensare all’esempio del senatore veneziano Iacopo Soranzo e alla sua celebre Libreria, preziosa per la raccolta di manoscritti e libri a stampa. Per i bibliofili più estremi, il libro viene spogliato completamente della sua funzione primaria di portatore di un testo scritto e quindi di fondamentale veicolo di cultura, per diventare un puro e semplice oggetto materiale, non da leggere ma da possedere e la sua ricerca viene guidata dagli interessi individuali anche se il requisito che diventerà primario nella selezione di un oggetto-libro piuttosto che di un altro sarà il parametro della Il termine bibliophilia con questa accezione, è attestato per la prima volta nel Seicento utilizzato da SALDENUS nel titolo del suo trattato Christiani Liberii Germani Bibliophilia, Sive De scribendis, legendis et aestimandis Libris Exercitatio Paraenetica, Utrecht, apud Franciscum Halma, 1681; si è diffuso poi nel corso del Settecento mutuato dal francese bibliophilie; una definizione del termine è codificata anche in C. BATTISTI-G.ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze, G. Barbera, 1968 p. 509 e M. CORTELLAZZOP.ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, 1, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 137. 6 Per una panoramica sulla figura del collezionista bibliofilo cfr. G. SCHNEIDER, Handbuch der Bibliographie, Lipsia 1926, 217; M. PRAZ, Collezionisti e Cataloghi di libri, in: Studi in onore di Alfredo Schiaffini, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965, p. 881; F. RIVA, Introduzione a una guida del libro di pregio contemporaneo, «Accademie e Biblioteche d’Italia» 36 (1968), n. 3, p. 139; R. FRATTAROLO, Studi di bibliografia storica ed altri saggi, Roma, Bonacci, 1977, p. 21. 5 5 rarità che spesso, in quest’epoca, si trova a coincidere con quello dell’antichità7. Interessante è la discussione teorica che si sviluppò, nel corso del secolo, intorno al concetto di libro raro. Il concetto di rarità libraria, pressoché sconosciuto al mondo antico ed estraneo alla cultura medioevale, è legato all’introduzione della stampa. La tipografia, trasformando radicalmente il modo di produzione del libro, aveva creato una generica situazione di abbondanza dei prodotti; si verificò di conseguenza quella condizione di rarità determinata dalla scarsità di alcuni esemplari. All’interesse teorico e speculativo per i libri rari, che dava luogo ai vari trattati e alle numerose bibliografie, si affiancava, in un rapporto di reciproca influenza, l’interesse “bibliofilico” che ai più diversi livelli ispirava i collezionisti. In effetti l’aspirazione a possedere un libro integro, possibilmente “intonso”, tipica del bibliofilo fino ai nostri giorni, trae origine proprio da questa “scoperta” del libro-manufatto. L’attenzione alla realtà fisica del libro non era solo circoscritta alla cerchia dei collezionisti e dei bibliofili, ma interessava tutto il mondo del libro Il mercato antiquario a Venezia fra Sette e Ottocento Nel Settecento, il mercato antiquario offerto da Venezia era certamente uno tra i più ricchi, vasti e vivaci a livello mondiale ma è proprio in questo secolo che Librerie e collezioni d’arte di ordini religiosi, di patrizi e di privati cittadini cominciano a mutare fisionomia, destinazione e spesso anche Lo stesso discorso non è applicabile ai nostri giorni, quando i due parametri di antico e raro non sono più sovrapponibili, benchè sia fisiologico che più un libro è antico meno esemplari dovrebbero esserci in giro; a conforto di questa affermazione si pensi alla diffusione di edizioni del Seicento recanti opere di autori classici, ad esempio Cicerone, confrontata con la rarità della prima edizione de’ I Malavoglia di Giovanni Verga edita a Milano nel 1881 dai Fratelli Treves. 7 6 proprietario8. Tre sono gli avvenimenti deleteri per la storia di Venezia che di riflesso sovvertirono completamente l’approccio al collezionismo: la caduta della Repubblica nel 1797, fatto che sconvolgerà l’assetto politico, economico e culturale della città; il passaggio dalla dominazione austriaca prima, francese poi e quindi nuovamente austriaca fino al 1866, anno in cui la città venne annessa al neonato Regno d’Italia e per ultimo, anche se non per ordine cronologico, il famigerato decreto napoleonico per la soppressione degli Ordini religiosi9. Focalizzando l’attenzione sul collezionismo librario, non ci si può esimere dal considerare come esso abbia trovato terreno fertile in una città che, fin dalle sue origini, per la sua natura prettamente commerciale ha sentito l’esigenza di familiarizzare con la scrittura 10 e sia imposta come crocevia di culture, per lunghi anni infatti fu l’unico tramite per i contatti fra Occidente e Oriente. L’importanza di avere una biblioteca sia essa privata e inaccessibile o di pubblica utilità11 e il desiderio di costituirla, trova testimonianze già in epoca medievale, se si pensa che Petrarca, umanista ante litteram, rapito dallo splendore e dalla pace che il governo della Serenissima garantiva ai suoi Per una panoramica generale ma esaustiva e puntuale sulla diffusione del libro e sul collezionismo a Venezia nel Settecento si rimanda a M. INFELISE, L’editoria veneziana nel Settecento, Milano, Franco Angeli, 1989; M. ZORZI, La circolazione del libro. Biblioteche private e pubbliche, in: Storia di Venezia, 6, Roma 1994, pp. 589-613; id., La stampa, la circolazione del libro, ibid., 8, Roma 1998, pp. 801-860 e al nutrito apparato bibliografico. 9 Tra il 1806 e il 1811, sotto il dominio napoleonico si ordinò la soppressione degli ordini religiosi, il decreto riguardava tutti gli Ordini e le Congregazioni eccetto gli Ospitalieri e le Suore di carità, i delegati statali apposero i sigilli e sequestrarono archivi, librerie, casse e appartamenti religiosi, dei beni confiscati quanto vi era di più prezioso o ritenuto tale fu trasportato in Francia, il resto venne messo all’asta; va ricordato che una prima spoliazione ad opera francese avvenne già nel 1797 all’indomani della caduta della Repubblica. 10 Per l’analisi del legame tra attività commerciali e sviluppo e diffusione della scrittura cfr. Zorzi, La circolazione del libro, pp. 589 e sgg. 11 Spesso anche le biblioteche private dei patrizi veneti, avevano ruolo di pubblica utilità e venivano aperte a studiosi e appassionati grazie alla sensibilità culturale dei propri possessori. 8 7 cittadini, aveva in mente di lasciare in eredità alla Repubblica, proprio per evitarne la futura dispersione, la sua preziosissima collezione di codici manoscritti, all’epoca la più importante in Italia, creando così il nucleo per una biblioteca pubblica12. La storia delle librerie a Venezia13 si differenzia a seconda della classe sociale di appartenenza del loro fondatore, di origine più antica, spesso medievale, quelle religiose; cinque-seicentesche quelle patrizie; molto più recenti, soprattutto settecentesche e oltre, quelle dei privati cittadini. Per quanto riguarda gli ordini religiosi, solo per citarne alcune fra le più illustri, si ricorda quella di S. Giorgio Maggiore, per la quale è possibile datare all’anno 1362 il primo catalogo dei manoscritti in essa conservati14. Celeberrima la libreria dei Camaldolesi di S. Michele di Murano 15, si stima che possedesse all’incirca quarantamila volumi tra stampati e manoscritti; essa era la più ricca del territorio ed il suo incremento maggiore lo ebbe nel ‘700 grazie alla brillante direzione del padre Giovanni Benedetto Mittarelli, autore della monumentale opera Annales Camaldulenses16 e del Catalogo17 a stampa dei libri posseduti dalla Biblioteca di San Michele di Sulla questione e sui motivi per i quali il progetto purtroppo non riuscì cfr. ZORZI, La libreria, pp. 9-22. 13 Per un resoconto dettagliato e puntuale sulle vicende delle biblioteche veneziane alla caduta della Repubblica, si veda la compilazione manoscritta di F. S. FAPANNI, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Marc. It. VII, 218 (=9116), Biblioteche di Venezia e delle isole, si veda a riguardo, ancora di FAPANNI, il ms. Cod. Marc. It. VII 2302 (=9131) con alcune varianti rispetto al precedente; per la bibliografia a stampa cfr. M. ZORZI, Le biblioteche a Venezia nel secondo Settecento, in «Miscellanea Marciana», 1 (1986), pp. 253-324; id., La gestione del patrimonio librario, in: Venezia e l’Austria, a cura di G. BENZONI – C. COZZI, Venezia 1999, pp. 265-290. 14 Cfr. ZORZI, Le biblioteche, p. 256; tra i suoi frequentatori vi fu Cosimo de’ Medici nel 1433, durante il suo esilio veneziano, egli visitò spesso la biblioteca facendo dono anche di numerosi codici della sua personale biblioteca. 15 Cfr. ZORZI, Le biblioteche, pp. 260-261. 16 G.B. MITTARELLI, Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, Venetiis, Jo. Baptistam Pasquali, 1755-1773. 17 G.B. MITTARELLI, Bibliotheca codicum manuscriptorum Monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, una cum Appendice librorum impressorum seculi XV, Venetiis, ex typographia Fentiana, 1779; pubblicato postumo, il catalogo contiene la descrizione di 1212 manoscritti più un’appendice con la descrizione di 668 incunaboli, presenti nella Biblioteca all’epoca del Mittarelli; l’organizzazione è data secondo l’ordine 12 8 Murano. Benchè di formazione più recente rispetto alle precedenti, quella dei Chierici Regolari Somaschi a S. Maria della Salute, costruita fra il Sei e Settecento su progetto del padre generale dell’Ordine Girolamo Zanchi, gestita dalle personalità più illustri della cultura veneziana 18, contava alla caduta della Repubblica più di trentamila volumi; fu grazie alla sua dispersione che le quotazioni di Adolfo Cesare come libraio salirono notevolmente. Per quanto riguarda le biblioteche patrizie, va riconosciuto e reso onore al merito che ebbero i patrizi veneti di preservare e custodire la cultura nonché di permetterne la diffusione tramite le proprie raccolte librarie, incrementate con pazienza e cura. Scrive Vittorio Rossi: “il patriziato veneziano, fedele a una nobile tradizione sorta coi primi albori del Rinascimento e ravvaloratasi nei secoli, fu, mediante le sue biblioteche, adunate con sollecitudine sapiente e munificenza principesca, benemeritissimo custode e valido aiutatore di quegli studi eruditi onde al secolo XVIII viene tanta luce di gloria”19. Non vi era dimora nobiliare nella quale una stanza non fosse riservata alla collezione libraria, incrementata spesso durante viaggi all’estero e a scambi o acquisti con altri collezionisti; anche questo patrimonio librario subì la stessa sorte riservata a quello delle biblioteche monastiche, disperso o distrutto dopo la caduta della Repubblica. La motivazione principale fu quella economica, con la mutazione di regime politico infatti il patriziato dovette enormenete ridimensionare il proprio tenore di vita, privato com’era alfabetico dei nomi degli autori, nel caso di opere anonime dei titoli o dei soggetti; per i manoscritti viene data l’indicazione della materia, dell’epoca e la segnatura originale. Nella prefazione alla descrizione dei manoscritti Mittarelli fornisce informazioni sull’origine della Biblioteca, sullo scriptorium in essa attivo, su copisti illustri ed altrettanto illustri possessori e committenti. 18 Per un elenco dei padri bibliotecari che la ressero cfr. ZORZI, Le librerie, p. 292 n. 34. 19 V. ROSSI, La biblioteca manoscritta del senatore veneziano Jacopo Soranzo, in: Scritti di critica letteraria. Dal Rinascimento al Risorgimento, Firenze, Sansoni, 1930, pp. 251271, qui p. 251. 9 delle sue principali fonti di guadagno 20, per monetizzare si era quindi costretti a disfarsi nel vero senso della parola, dei gioielli di famiglia quali collezioni di monili preziosi, raccolte d’arte e librerie. Menzione d’onore merita fra tutte, la biblioteca del senatore Iacopo Soranzo,21 giudicata eccellente e addirittura principesca già dagli eruditi suoi contemporanei che ebbero il privilegio e la fortuna di poter essere ammessi alla sua consultazione; tra questi Apostolo Zeno, possessore anch’egli di una ricca biblioteca che la giudicava addirittura “immenso tesoro di libri più ricercati”. Soranzo ne curò l’incrementò senza badare a spese, arrivando a raccogliere più di quattromila manoscritti, moltissimi dei quali di grande pregio oltre che per il loro valore artistico anche per l’importanza dal punto di vista filologico; alla sua morte nel 1757, la biblioteca passò in eredità a due rami distinti: gli Zorzi a San Severo 22, che vendettero la propria quota di duecentoventi codici a Teodoro Correr23, e i Corner della Ca’ Granda24 a San Maurizio, che ottennero la parte più cospicua e la rivendettero all’abate Matteo Luigi Canonici. Della biblioteca Soranzo esistono tre cataloghi Tratto distintivo del patriziato veneto rispetto a quello di altri Stati europei, fu il trarre le proprie ricchezze dalle attività commerciali, ora del tutto loro impedite. 21 Iacopo Soranzo (1686-1757) cfr. C. FRATI, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sec. XIV al sec. XIX, Firenze, Olsckhi, 1933, p. 521; per una storia della Biblioteca Soranzo cfr. V. ROSSI, La biblioteca manoscritta del senatore veneziano Iacopo Soranzo: appunti, «Il libro e la stampa», 1 (1907), pp. 3-8, 122-133; I. MEROLLE, L’abate Matteo Luigi Canonici e la sua biblioteca: i manoscritti Canonici e CanoniciSoranzo delle biblioteche fiorentine, Roma-Firenze 1958, I-XI. 22 Cfr. ZORZI, La libreria, p. 285. 23 Iniziatore del futuro Museo Civico della città di Venezia; per una resoconto sulla figura di Correr e sulla Biblioteca cfr. G. ROMANELLI, Correr, Teodoro, in DBI, 29, Roma 1983, pp. 509-512; id., Il Museo Correr, Milano, Electa, 1994. 24 Cfr. ZORZI, La libreria, p. 273. 20 10 manoscritti in lingua latina e distinti per formato,25 compilati da Francesco Melchiori, ultimo bibliotecario del senatore. In questa fase storica, gli unici ad incrementare le proprie ricchezze furono i mercanti antiquari e i librai, che spesso coincidevano, emergono così, a cavallo tra i secoli XVIII e XIX, figure come Vincenzo Bianconi; Antonio Canciani e suo figlio Gaetano, titolari di una delle più antiche botteghe di libraio di Venezia, sita presso le Mercerie; i fratelli Coleti e Adolfo Cesare, oggetto della nostra indagine, che susciterà sentimenti contrastanti per il ruolo che ebbe nel commercializzare alcune fra le più illustri librerie della storia veneziana. La figura di Adolfo Cesare attraverso i Diari di Emmanuele Antonio Cicogna Come già accennato, oggetto della presente ricerca è la figura di Adolfo Cesare26 nella sua funzione di libraio, la motivazione principale di tale interesse va ricercata principalmente nel ruolo che egli ebbe nel decretare il destino finale di numerose librerie veneziane che passarono fra le sue mani. Ad oggi non esistono studi sistematici, se non cenni fugaci in pubblicazioni di vario genere, che ripercorrano le fasi della sua attività commerciale, né Due volumi di in folio e uno per gli in quarto, la denominazione esatta dei cataloghi è per i primi Manuscriptorum codicum sexcentorum in folio in Bibliotheca Jacobi Superantii patritii veneti ac senatoris existentium catalogus. Tomus primis e Manuscriptorum codicum DC. in fol. in bibliotheca Jacobi Superantii patricii veneti ac senatoris existentium catalogus. Tomus secundus; per gli in quarto: Manuscriptorum codicum DCCC in 4.to in bibliotheca Jacobi Superantii patricii veneti ac senatoris existentium catalogus. Tomus Primus, era previsto un altro tomo che non è mai stato compilato; i cataloghi manoscritti si trovano conservati sia alla Biblioteca Marciana che presso la Biblioteca Correr, qui con la segnatura mss. Correr 1440-1442. 26 Adolfo Cesare (m. 1847) cfr. E. A. CICOGNA, Saggio di bibliografia veneziana, Venezia 1847, p. 573 n. 4330; FRATI, pp. 157-158; Editori italiani dell’Ottocento, Milano 2004, p. 271. 25 11 che propongano un resoconto puntuale sulle librerie da lui acquistate e rivendute, con esplicito riferimento agli acquirenti. Si ritiene interessante tale approfondimento poiché la sua Bottega divenne sia motore di nuove dinamiche del collezionismo veneziano, sia punto di riferimento e luogo di incontro obbligato per i letterati in città. Infatti, grazie all’abilità commerciale e alla disponibilità economica, Cesare fu tra coloro che beneficiarono del decreto napoleonico sulla soppressione dei conventi, arricchendo il negozio di tali preziosi esemplari da fargli assumere quasi la funzione di libreria di pubblica utilità27. Oltre che da Emmanuele Antonio Cicogna28, impegnato fra l’altro in mansioni organizzative come la stesura del Catalogo, la Libreria fu assiduamente frequentata da studiosi veneziani fra i quali Giovanbattista Licini, Mauro Boni, Giovanni Balbi, Luigi Celotti che qui si intrattenevano su dotti argomenti bibliografici, specie in occasione dell’arrivo da Milano di Gaetano Melzi e del libraio Carlo Salvi. O ancora da Iacopo Morelli e Pietro Bettìo e dall’abate Daniele Francesconi motivati da esigenze professionali, in quanto responsabili di pubbliche biblioteche, o dai collezionisti privati come Mocenigo, Vanzetti, Pinali, Da Ponte, Pisani, per citare alcuni tra i più noti29. Accanto a questo considerevole e movimentato interscambio di erudizione, il Cesare svolgeva anche un’attività editoriale30, seppur modesta e riferibile ad una pubblicistica divulgativa, Cataloghi di librerie private, almanacchi, Cfr. Cicogna, Diario, I, 1 luglio 1810, p. 150: “L’ab. Torres grecista assai buono di nazione Spagnuolo ora si trova diserto perché non ha librerie, da andarsi a studiare. Esse, come si sa, sono bollate. Il perché va egli ogni giorno dal Cesare, e ivi si mette a studiare”. 28 Per la biografia di Emmanuele Antonio Cicogna si rimanda a P. PRETO, Cicogna, Emmanuele Antonio, DBI, 25, Roma 1981, pp. 394-397; L. SPINA, «Sempre a pro degli studiosi». La biblioteca di Emmanuele Antonio Cicogna, in «Studi Veneziani», 39 n.s. (1995); G. BENZONI, La storiografia, in: Storia della Cultura Veneta, 6, Dall’età napoleonica alla prima guerra mondiale, Vicenza 1986, pp. 597-623 qui in pp. 601-602. 29 Per i dati identificativi delle persone citate si rimanda alle note di commento ai Diari. 30 Secondo Cicogna, Cesare aveva intenzione di fondare una Gazzetta Urbana sulla scia di quelle di Gasparo Gozzi e antonio Piazza ma il governo non gli concesse la licenza, cfr. Cicogna, Diario, II, 7 agosto 1816, p. 4193. 27 12 opuscoli di ammaestramenti morali e religiosi, fra i cui autori spesso figuravano gli stessi frequentatori della sua libreria e Cicogna in primis. Strumento indispensabile per delineare a tutto tondo la storia di Adolfo Cesare, sono i racconti che Cicogna fa di lui nei suoi Diari, i due ebbero assidua frequentazione anche se definire il loro rapporto amicale risulterebbe eccessivo31. È invece carente a riguardo l’Epistolario Cicogna, all’interno del quale si registra la presenza di un’unica lettera inviata da Cesare a Cicogna, datata 26 novembre 1811. I Diari32, costituiscono un ricchissimo patrimonio di notizie storiche, artistiche e letterarie, nonché puntuale ed esaustiva cronaca pubblica e privata dell’epoca che va dall’anno 1810 al 1866 33. Inseriti in un filone ampiamente documentato nella storia di Venezia, si pensi ai Diari di Marino Sanudo34, sono un’ulteriore testimonianza di quanto la storia della città stesse a cuore e fosse fra i principali interessi di letterati ed eruditi. Cicogna non ricoprì cariche ufficiali di prestigio, né mai brillò per ingegno personale, caratterizzato da una cultura di tipo erudito fu personalità di notevole importanza ed influenza nel panorama culturale della città; i Diari oltre a costituire intima riflessione sui fatti della propria vita, furono da lui costantemente impiegati come fonte principale per le sue innumerevoli attività di ricerca, ad esempio la monumentale opera Delle inscrizioni veneziane35 sarebbe stata molto più difficoltosa senza l’apporto delle minuziose informazioni raccolte nei Diari. Si vedano più avanti i toni spesso polemici, misti sovente ad una superba alterigia con i quali Cicogna si eprime a proposito del Cesare, benche egli paia non meritare questo trattamento. 32 In tre volumi manoscritti (mss. Cicogna 2844-2846) più uno (ms. Cicogna 2847) denominato Diario veneto politico, conservati presso la Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia, così come l’intero fondo Cicogna 33 I resoconti terminano infatti pochi anni prima della morte dell’autore nel 1868. 34 Marino Sanudo (1466-1536) ABI II 547, 181-185; III 380, 100-101 35 Pubblicate a fascicoli a partire dal 1824 31 13 Redatti in uno stile mai ordinario ma sempre ricercato e attento, i Diari rivelano la piena consapevolezza da parte dell’autore, che il loro carattere solo apparentemente privato, sarebbe stato modificato per renderli strumento di pubblica diffusione e questo dato è confermato dalla compilazione di un nutrito volume di Indici36, sintomo della volontà di farne un’edizione a stampa. In principio la registrazione procede regolare e spesso è occasione di divagazioni letterarie, numerosi gli aneddoti, racconti, fatti di cronaca, storielle a sfondo morale, componimenti letterari, racconti salaci, nulla viene escluso perché ogni avvenimento è considerato un tassello che rivela una sua logica nella totalità del trascorrere del tempo. Si tratta di materiale per lo più ordinato, nonostante l’apparente casualità delle annotazioni, con rimandi che collegano argomenti già trattati, facilitando l’individuazione di tematiche attorno a cui si sono svolti i dibattiti e le polemiche del mondo culturale ottocentesco. Dai Diari emergono soprattutto gli interessi di Cicogna, quasi esclusivamente letterari e bibliografici all’inizio, ma che col tempo rivelano un curioso interesse verso qualsiasi esperienza culturale, sia essa musicale, letteraria o artistica, che sancisce l’immagine di erudito che gli ha riconosciuto la posterità. Notevole è la fitta rete di relazioni che si evince con letterati e bibliografi soprattutto di Venezia e Udine, le due città alle quali fu maggiormente legato, ma anche con personalità di spicco provenienti da Milano ad esempio Melzi e Salvi, o Firenze. Puntuale è il resoconto delle sue acquisizioni37 quantunque ancora limitate, date le sue precarie condizioni economiche e degli scambi, si assiste infatti alla formazione di quella che sarà la Biblioteca Cicogna, lasciata in seguito a nota testamentaria, inter Rimasta incompleto, la stesura degli Indici fu iniziata dal Cicogna nel 1816, in aggiunta al terzo volume dei Diari (ms. Cicogna 2846); l’intenzione dell’autore di farli rilegare trova conferma in ms. Cicogna 2845,; pp. 4281-4282, 8 novembre 1816 “li farò legare a 10 per tomo quinterni di II fogli l’uno”. 37 Di queste si troverà sistematica descrizione nei copiosi cataloghi in sette volumi (mss. Cicogna 4424-4430) in cui descriverà il suo prezioso fondo manoscritti. 36 14 vivos, in dono alla città di Venezia e quindi passata ad incrementare quello che sarebbe divenuto il Museo Civico Correr. Il primo incontro fra Emmanuele Antonio Cicogna e Adolfo Cesare avvenne nel 1805 in occasione di un viaggio a Udine che il Cesare fece per acquistare la libreria del commendatore Carlo Maria Della Pace 38; i rapporti fra i due si intensificarono a partire dal marzo 1808 quando Cicogna, dopo aver lasciato il Collegio dei Nobili ad Udine, si trasferi a Venezia con tutti i suoi libri, per ricoprire l’incarico di commesso alla Corte d’Appello della città “occupando le ore vacue dall’ufficio di alunno alla Corte d’Appello, presso il libraio Adolfo Cesare, egli mi regalava libri in compensamento dell’opera che io gli prestava, unitamente al probo signore Giambattista Licini della Fava, nel porre in ordine e nel catalogare le centinaia di volumi ch’egli aveva, e preziosi assai, razzolati da molte librerie veneziane andate miseramente in vendita, frallequali quella de’ Zeni a’ Gesuiti de’ Gradenigo segretari a Santa Sofia, del Vanzetti, di santa Maria della Salute ecc. ecc. In mezzo a questi libri ho potuto affrancarmi nelle cognizioni bibliografiche e potei mandar fuori la «Dissertazione sul corpo di san Marco» (anno 1811), la quale è tutta lavorata su autori che vidi ed esaminai presso il Cesare: nella quale libreria, ch’era divenuta per l’importanza quasi di utilità pubblica”39. Metodologia di ricerca Lo studio è stato condotto effettuando lo spoglio del Diario, I, Scartabelli I-VIII relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio 1810 e 21 Secolo XIX, cfr. FRATI, pp.194-195; il Catalogo della sua collezione di manoscritti e incunaboli fu stampato presso Adolfo Cesare nel 1807, cfr. CICOGNA, Bibliografia, p. 573 nr. 4330. 39 R. FULIN, Saggio del Catalogo dei codici di Emmanuele A. Cicogna, in Nozze ChiodoBressanin, Venezia 1872, pp. 63-64 38 15 maggio 181140, da questi vengono tratti degli excerpta relativi alla figura di Cesare. I criteri utilizzati per la selezione si basano sulla presenza o meno di riferimenti significativi, sono stati infatti isolati tutti i passi dai quali emerge un ritratto esteso e dettagliato della sua attività di libraio (es. acquisizioni, contatti commerciali etc), mentre sono stati esclusi dalla trascrizione i resoconti in cui del libraio compaia mera citazione, senza che egli abbia parte attiva nei fatti narrati o dai quali non sia possibile desumere alcuna informazione utile all’obiettivo della ricerca. Trattandosi di fonte manoscritta inedita, è stata proposta una trascrizione fedele e rispettosa della grafia dell’autore, mantenute le abbreviazioni laddove presenti e la punteggiatura originale, sono stati invece normalizzati tutti i punti in cui la lettura sarebbe risultata appensantita o che avrebbero potuto essere equivocati come refusi di stampa. Limitati al minimo gli emendamenti al testo, se non in presenza di evidenti errori segnalati col segno (sic!) nel corpo del testo; benchè la scrittura di Cicogna si presenti agevole, spesso l'interpretazione di alcuni nomi o parole pone dubbi significativi sulla lezione da accogliere, in tali casi si darà conto in nota della lettura incerta. 40 Il primo volume dei Diari, ms. Cicogna 2844, raccoglie le annate dal 1810 al 1816. 16 Ritratto di Emmanuele Antonio Cicogna, Morando Morandini, 1810 17 Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. CICOGNA 2844, DIARI DI EMMANUELE ANTONIO CICOGNA (vol. I) DAL 1808 AL MARZO 1816 (tot pagine 4061, mm 293 x 200) “N.B. Questi diari erano in fascicoli sciolti. Furono per ordine della Direzione legati, affinché non andassero dispersi; si mantenne però il N. progressivo dei fascicoli. Noto anche che la numerazione delle pagine è sbagliata, nel fascicolo XXIV il Cicogna dalla pag. 1099 passò al 2060, sorvolando 940 pagine. G. Nicoletti”41 “I Scartabello ossia Diario scritto in fretta e senza alcuno studio da me Emmanuele Antonio Cicogna veneziano, comincia dal 1 gennaio 1810 a tutto 28 marzo 1810” 2 gennaio 1810, p. 2: “ (…) Questa sera ho scorso il Catalogo de’ libri che trovansi vendibili appresso il Pagani42 a Firenze. Ve ne sono a prezzo vilissimo. Exem. gratia il Decamerone del 1573 e le Annotazioni de’Deputati del ’7443 ambedue rari e specialmente il primo, negli altri Cataloghi sono messi del prezzo almeno di lire venete 70, ed ivi lo sono per paoli 30. La Novella antica del grasso Nota autografa dell’abate Giuseppe Nicoletti (m. 1911), che fece parte del pool di catalogatori costituitosi in occasione del trasferimento della Biblioteca Correr alla sede del Fondaco dei Turchi, nel 1898 ne divenne vice-conservatore, si occupò dell’aggiornamento del Libro delle Classi; anch’egli legò in sede testamentaria i suoi libri alla Biblioteca Correr. 42 Si tratta del tipografo e libraio fiorentino Gioacchino Pagani (sec. XVIII), i Cataloghi cui fa riferimento Cicogna e da lui visti presso la Bottega di Cesare potrebbero essere o il Catalogo di una collezione di libri che si vendono presso Giovacchino Pagani librajo in Firenze, Firenze 1802 o il Catalogo di una scelta e copiosa collezione di libri greci, latini, italiani, francesi, inglesi, spagnoli, tedeschi &c. alcuni dei quali di un merito assai distinto che si vendono da Giovacchino Pagani negoziante di libri e stampatore in Firenze, Firenze, aprile 1806. 43 Per le questioni bibliografiche a riguardo cfr. Le annotazioni e i discorsi sul Decameron del 1573 dei deputati fiorentini, a cura di G. CHIECCHI, Padova 2001. 41 18 legnajolo44 del Manni 1744, si è fatta assai rara e fu venduta persino oltre lire 100; e nel Catalogo suddetto si vende per 8. Questo fa credere ragionevolmente che o non esistano presso il Pagani i libri nominati, o se esistono, siano di pessima conservazione, o mancanti, od altro. Il sig.r Cesare libraio di qui, appo il quale vidi il Catalogo, non dovrebbe, a mio credere, farlo vedere a’ suoi amici, perciocché costoro disingannati degli alti prezzi che ritrovansi sui Cataloghi45 di detto sig.r Cesare a paragone di quelli del nominato Catalogo, troverebbero di miglior loro interesse il rivolgerse al Pagani piuttosto che al Cesare, e aperti così gli occhi darebbero la buonanotte a quello che fino ad ora credettero discreto nel fissare il valore a’ propri libri”. 4 gennaio, 1810 p. 5: “(…) L’ab. Celotti46 chiaro raccoglitore di libri rarissimi ha seco un unico ms. e inedito de’ viaggi di certo Bembo Viniziano47 nella China e nella Persia. Esisteva questo codice pregiatissimo nella libreria di Giuseppe Gradenigo48 a S. Sofia di Venezia, con note di uomini illustri e del chiar.mo Domenico Maria Manni (1690-1788; DBI, 69, Roma 2007, 94-97), Novella antica del Grasso legnaiuolo, scritta in pura toscana favella, ed ora ritrovata Istoria ec, illustrata e coll’ ajuto di buoni testi emendata, in Firenze 1744, in-4; per la questione cfr. anche la Novella del grasso legniajuolo, riscontrata col manoscritto e purgata da molti e gravissimi errori, a cura di Pietro Fanfani, Firenze 1856; 45 “Alcuni libri vendibili al negozio di Adolfo Cesare, Venezia, 1808 e 1809, in 8; cfr. Cicogna, Bibliografia, p. 576 nr. 4351, p. 582 nr. 4389. 46 Luigi Celotti (abate, pubblico consultore, 1789 ca.-1846 ca.) per le notizie sulla sua libreria cfr. FRATI, p. 154; CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane, 4, Venezia 1834, p. 380; 6, Venezia 1853, p. 879; ZORZI, La libreria, pp. 275, 525–526 n. 308, 538 n. 83. 47 Ambrogio Bembo (1625-1705; DBI, 8, Roma 1966, pp. 101–102), si tratta dell’opera Viaggio e Giornale per parte dell'Asia, (1671-1675); alla voce curata da Ugo Tucci viene data menzione del manoscritto cui fa riferimento Cicogna; cfr. la recente edizione del testo Viaggio e giornale per parte dell'Asia di quattro anni incirca fatto da me Ambrosio Bembo nobile veneto, a cura di A. Invernizzi, Torino, Ed. Abaco, 2006. 48 Giuseppe Gradenigo (1738–1820; DBI, 58, Roma 2003, pp. 323-328); possessore di una pregiata libreria cfr., ZORZI, La libreria p. 298, della Biblioteca Gradenigo esisteva un indice curato da Jacopo Bravetti e pubblicato nel 1775 cfr. Cicogna Bibliografia, p. 576 nr. 4350, lo stesso Cicogna, nel resoconto del 18 giugno 1810 (ms. Cicogna 2844, p. 140), racconta di essersi occupato del suo trasporto, impresa di notevole impegno dato che la libreria constava di circa seimila volumi. 44 19 cav. Morelli49 che il tenne in sommo pregio non pel contenuto, ma per la rarità e unicità di esso. Passato poi con tutta la libreria in poter del sig.r Cesare questi lo diede all’ab. Celotti (vedi giorno 27 corrente). Non posso che lodare viemmaggiormente l’istituzion del p. Barnaba50 mentre questa sera me ne diede più minuti ragguagli. Gli è poi di grande utilità, e di bell’ornamento l’Enciclopedia di Padova51 che comperò dal sig.r Cesare onde fornire il suo Collegio52 di ogni articolo di scienza ed arte, e servire così al vario genio de’ Convittori e di foristieri che vanno a visitarlo (…)”. 13 gennaio, 1810 pp. 9-10: “(…) Il sig.r Cesare libraio di qui, ha veramente fatto un bell’acquisto nelle Librerie Zen53, Gradenigo, e parte di quella della Salute54; e acquisto tale che, a mio credere, e a credere anche di chi conosceva le dette librerie, non verrà mai pareggiato da qualunque altro che posteriormente si facesse dal Cesare. Iacopo Morelli, (1745-1819; Frati, pp. 379-384) custode della biblioteca Marciana di Venezia dal 1778, per la sua figura cfr. Zorzi, La libreria. 50 Ermanno Barnaba, (sec. XIX; padre somasco), Cicogna, Bibliografia, p. 547 nr. 4165. 51 Allusione all'Encyclopédie Française stampata a Padova. 52 Collegio privato istituito a S. Lucia in Venezia. 53 Fondata dal senatore Sebastiano Zen e incrementata da suo figlio Antonio, nato nel 1773, che ne aveva compilato un dettagliato catalogo, egli inoltre prestava con generosità i libri più rari e preziosi, la biblioteca cominciava a disperdersi nel 1808, cfr. ZORZI, Le biblioteche, p. 284, id., La libreria, p. 345; Catalogo cronologico di edizioni del sec. XV che si trovano vendibili appresso Adolfo Cesare Librajo in Venezia in Cicogna, Bibliografia, p. 585 nr. 4407. 54 La Libreria dei Chierici regolari Somaschi a Santa Maria della Salute, nata fra la fine del ‘600 e i primi del ‘700, fu arricchita costantemente grazie alla volontà dei suoi bibliotecari, spesso fra i più raffinati eruditi dell’ambiente veneziano, nel 1797 arrivò a contare circa trentamila volumi tra stampati e codici manoscritti. Nel 1810 l’ordine fu soppresso e la biblioteca definitivamente dispersa; dei manoscritti Somaschi esiste un Inventario il cui originale è conservato presso la Biblioteca Marciana Per la Libreria dei Chierici Regolari Somaschi a Santa Maria della Salute, cfr., fra gli altri, M. Zorzi, Le biblioteche, pp. 259-260; essa comprendeva, nel 1797, più di trentamila volumi, fu depredata pesantemente dai Francesi; “Fece sensazione l’accordo che i Somaschi conclusero con il libraio Adolfo Cesare, noto mercante di libri, in possesso di rilevanti mezzi liquidi, che in quel momento era fra i pochissimi ad avere. Egli poteva prendersi tremila libri a sua scelta, pagandoli una cifra fissa: un ducato l’uno; (…) Molti altri libri, sia a stampa sia manoscritti, finirono «nelle mani dei pescivendoli e venditori di pepe»” in Zorzi, La libreria, p. 327. 49 20 Perciocché la Biblioteca Zen oltre il Boccaccio del 27 d’edizione originale venduto per 90 zecchini (vedi giorno 13 aprile) al sig.r Vanzetti 55 colto bibliografo ed antiquario, oltre le Bibbie poliglotte, i quattrocentisti più rari, i più scelti Bodoniani, una gran parte degli Aldini, i molti e rari libri d’arti, di figure ec. ridondava (e ancora in parte ridonda) di libri d’ogni genere e francesi e latini, e del 500 e moderni e di poemi antichi ec. libri di più legati ottimamente, e a perfezion conservati. La Biblioteca Gradenigo aveva tutta intera la Crusca. Chi non vede quanti libri perciò e quanti opuscoli rarissimi che racchiudeva? V’erano di pregiati quattrocentisti e il celebre manoscritto Bembo di cui favellai il giorno 4. Pochi, è vero, erano in essa i libri latini e francesi e di poco pregio, ma i poemi e i libri italiani del 500 compensavano questa mancanza. Ciò che in essa mi dispiaceva si era che, a riserva della Crusca, gli altri libri tutti erano o non legati o mal conservati e talora imperfetti. Tratti i più rari libri della Crusca, essa esiste invenduta tuttora, e fra poco per opera nostra e del sig.r Licini56 ne sortirà il Catalogo. Che dirò della libreria della Salute? È già fama ch’essa fosse una delle migliori di Venezia. Per comprendere se è pregevole quella parte di libri che di essa acquistò il sig.r Cesare, basti il dire che da quei religiosi stretti dal bisogno egli ebbe la libertà di scegliersi a piacere 3mila volumi dando un ducato corrente per ogni volume. È ben facile l’immaginare che il Cesare avrà scelti i più buoni, i più rari e firmati. Dice Virgilio: quid non mortalia pectora cogit auri sacra fames: io ometterei l’auri e se vuolsi anche il sacra, e adatterei acconciamente questo detto ai religiosi della Salute che per pura fame furon ridotti a spogliarsi di cose tanto preziose. Dirò di passaggio che fra questi libri scelse il sig.r Cesare il Decor puellarum57, libro tanto noto per LorenzoVanzetti (sec. XVIII-XIX) bibliofilo e antiquario vicentino; per un resoconto sui suoi acquisti cfr. B. GAMBA, Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana, Milano, dalla Stamperia Reale, 1812, loci varii. 56 Giovanbattista Licini Della Fava, amico personale di Cicogna cfr. Fulin, op. cit., p. 63. 57 Il Decor puellarum fu oggetto di una vera e propria disputa bibliografica, a causa di un errore tipografico, il frontespizio recava come data di impressione il 1461 anziché 1471, fu considerato il primo libro stampato a Venezia, a sostenere questa tesi furono Giovanni 55 21 le bibliografiche quistioni che suscitò, e che fu da lui venduto 60 zecchini, una Bibbia del ‘400 impressa in pergamena, le laudi di Feo Belcari, la Bella mano del 147258 e del 1595 rarissime, i Capricci del bottaio 59 ec.ec.ec. Una gran parte di questi sono già venduti. Ho io pure cooperato a farne il Catalogo”. 26 gennaio 1810 p. 21: “(…) Ho veduto un esemplare delle Rime del Coppetta 60 tutto postillato e con aggiunte inedite a penna del p. Caterino Zeno61 Ch. R. S. assai noto per la sua erudizione, e ho veduto anche postillato dallo stesso un esemplare delle Rime del Burchiello62 edizione di Crusca; volli anzi far il confronto dell’uno e dell’altro carattere onde veder se erano della stessa mano, come in fatti lo sono. Esistevano nella libreria dei PP. Della Salute, che nominai più sopra, ed ora il Coppetta è appresso il sig.r Cesare e il Burchiello l’ha acquistato il sig.r Licini che mi pregò di fare il detto confronto (…)”. 2 febbraio 1810 p. 25: Maria Paitoni e l’abate Mauro Boni, entrambi sistematicamente smentiti; sulla controversa questione editoriale cfr. D.M. PELLEGRINI, Della prima origine della stampa in Venezia per opera di Giovanni da Spira del 1469. E risposta alla difesa del Decor Puellarum del signor ab. Mauro Boni, Venezia dalle stampe di Antonio Zatta, 1794; CICOGNA, Bibliografia, p. 570, nrr. 4309-4312. 58 Giusto de’ Conti, Iusti de Comitibus Romani utriusque iuris interpretis ac poetae clarissimi Libellus foeliciter incipit intitulatus La bella mano, [Bologna], per me Scipionem Malpiglium Bononiensem, 1472. 59 Opera di Giovan Battista Gelli, accademico fiorentino, stampati per la prima volta a Firenze nel 1546, qui non è menzionata l’edizione. 60 Francesco Beccuti detto il Coppetta (1509-1553; DBI, 7, Roma 1965, pp. 498-502), il riferimento è alla prima edizione delle Rime stampata postuma a Venezia nel 1580 presso i fratelli Guerra e curata da Ubaldo Bianchi. 61 Pietro Caterino Zeno, al secolo Nicolò (m. 1732; Ferrari, Onomasticon, p. 633); padre somasco, fratello di Apostolo Zeno, collaborò all’organizzazione della Biblioteca della Salute. 62 Domenico Di Giovanni (1404-1449; DBI, 40, Roma 1991, pp. 621-625) detto il Burchiello. 22 “Il sig.r Cesare da ier l’altro ha principiato a fare il Catalogo della famosa libreria Canonici63, ridondante di molte Bibbie stampate, e di molti e molti pregevolissimi codici m.ssi. Mi trattenni per alcune osservazioni di lingua”. 12 febbraio 1810 pp. 30-31: “Il sig.r Giovanni Balbi64 Nobile Veneto con cui spesse volte mi trovo nella Bottega del sig.r Adolfo Cesare (…) ci narrava, come il famoso codice delle leggi di Ferramondo65 esistente già nel tesoro di s. Marco e poi nella Biblioteca di S. Marco sotto la custodia del ch. Cav. Morelli per varie volte ricercato da Luigi XVI, ma che la Repub. non volendosene privare ne fece fare una copia bellissima e mandogliela in dono, e come lo stesso preziosissimo codice, essendo stato descritto dal sullodato Morelli nella sua Biblioteca de’ mss. di S. Marco, fu il primo che i francesi, con tutti gl’altri più ricchi e pregiati monumenti di questa città, portarono con loro in Francia unendolo alla copia già fatta (…)”. 14 febbraio 1810 p. 32: “(…) Si parlò della Libreria Canonici. Non è poi essa tanto pregevole quanto si dice. Egli è vero che ci sono trecento e più codici manoscritti, ma a riserva d’una cinquantina gli altri sono de’ comuni. Vero è che vi è una grandissima serie di Bibbie, ma tradotte una cinquantina, le altre sono di poco valore. (…)” 22 febbraio 1810 p. 34: Matteo Luigi Canonici (1727-1805; DBI, 18, Roma 1975, pp. 167-170); per la storia della sua celebre libreria cfr. C. FRATI, pp. 134-135; I. Merolle, l’abate Matteo Luigi Canonici e la sua biblioteca, Roma 1958; ZORZI , La libreria, pp. 290, 299, 320, 375, 537. 64 Giovanni Balbi (sec. XIX); cfr. Zorzi, Le biblioteche, p. 271; id., La libreria, p. 334. 65 Se la lettura è corretta, si allude al mitico re francese Ferramondo che nel 418 d. C. emanò un codice di leggi, tra cui la Legge Salica, prima di Clodoveo. 63 23 “Feci ieri vedere il Catalogo della libreria Cajmo 66 di Udine al sig.r Cesare. Egli non vi trovò di buono che l’epistole di S. Caterina da Siena 67 1500 di Aldo, e quelle di S. Gerolamo68 in due tomi 1480. Il resto si può vender a peso di carta”. “II Scartabello. Comincia da 29 marzo a tutto 22 maggio 1810” 12 aprile 1810, pp. 87-88: “(….) Nel Catalogo de’ libri che il sig.r Cesare ebbe da’ PP. Della Salute eravi descritta un’edizione originale del Boccaccio 1527 69, ma frammischiata con molte carte dell’edizione contraffatta (vedi 13 Genn.). Iersera l’ab. Celotti portò seco un Decameron originale dello stesso anno cui mancano poche carte, una essendone ristampata due altre avendo un pezzo manoscritto, essendo alcune altre imbrattate. È una fortuna che tra l’uno e l’altro si perfeziona un esemplare originale, quantunque verrà esso troppo smarginato. L’esemplar del Cesare è trattenuto dal Mulazzani70 Com. di Polizia, ma non acquistato. Il Celotti d’altronde non vuol vendere il suo, vedremo dunque chi dei due avrà la forza di perfezionarlo, lo dirò più abbasso”. 21 aprile 1810 p. 93: Nobile famiglia udinese, per la vendita della cui biblioteca Cicogna fece da intermediario. 67 Epistole deuotissime de sancta Catharina da Siena, Venetia, in casa de Aldo Manutio Romano, 1500 a di xv septembrio 68 Hieronymus, Epistolae, quod quidem opus una cum priori volumine in urbe Parmensi diligenter & emendatum & impressum est, 1480 Idibus Maii 69 Il Decamerone di m. Giouanni Boccaccio nuouamente corretto et con diligentia stampato, 1527 impresso in Firenze, per li heredi di Philippo di Giunta nell'anno del Signore 1527, adi XIIII del mese d’aprile. 70 Antonio Mulazzani, barone (1772-1854) collezionista bibliofilo, per una storia della sua collezione cfr. F. ZANOTTO, Descrizioni della città, in: Venezia e le sue lagune, 2/2, Venezia 1847, p. 480, sul suo ruolo pubblico cfr. M. MERIGGI, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848), Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 216-218. 66 24 “(…) Questa sera capitò a Venezia il sig.r Gaetano Melzi 71 famoso bibliografo a Milano. Vi capitò pure l’ab. Profess. Francesconi 72 di Padova e il professor Cigolini73 nella Specola di Bologna, e il Salvi 74 librajo in Milano assai colto e peritissimo di libri antichi e rari. Giunsero in Bottega dal sig.r Cesare e si parlò di varie cose bibliografiche (…)”. 24 aprile 1810 p. 95: “Ippolito Pindemonte75, chiaro poeta (…) il vidi una volta sola nel negozio di Adolfo Cesare”. 5 maggio1810 p. 111: “(...) Ieri giunse nella Bottega del sig.r Cesare il Melzi. Il Cesare gli disse che avrebbe da me ricevuta una Novella76 fatta stampare in 24 esemplari (26 aprile e segg.). Rispose il Melzi che la vedrà volentieri quando gli verrà consegnata a Milano. Io gli dissi d’essere anche l’autore della prima Novella che egli già ricevette; e vi soggiunse che ne credeva autore Tommaso Grapputo77”. 14 maggio 1810 p. 120: Gaetano Melzi, conte (1783-1851), possessore di una biblioteca di circa 30.000 volumi, cfr. notizie in FRATI, pp. 355-356. 72 Daniele Francesconi, (1761-1835) professore e bibliotecario della Biblioteca Universitaria di Padova dal 1805, comperò da Adolfo Cesare parte della biblioteca del nobile veneziano Lorenzo Antonio da Ponte; cfr. notizie in FRATI, p. 236. 73 Lodovico Maria Ciccolini (1767-1854; DBI, 25, Roma 1981, pp. 357-358) professore di Astronomia all'Universita di Bologna, direttore della Specola e commendatore dell'Ordine gerosolomitano. 74 Carlo Salvi, (sec. XIX); per la sua attività di libraio cfr. Catalogo de' libri che trovansi vendibili presso Carlo Salvi, librajo in Milano sul corso di Porta orientale al n. 634, Novembre 1806; il Supplemento al catalogo de' libri del 1807 e un nuovo Catalogo del 1808. 75 Ippolito Pindemonte (1753-1828; ABI I 787, 185-250). 76 Per una bibliografia delle Novelle di Cicogna cfr. G. PAPANTI, Catalogo dei Novellieri italiani in prosa, 1, Livorno 1871, pp. 100-102. 77 Tommaso Grapputo (sec. XIX), censore alla stampa in Venezia; cfr. Cicogna, Diari, I, 14 marzo 1811, p. 367. 71 25 “Si parlò di cose letterarie in bottega Cesare, vi era il sig. Pinali Gaetano 78 Giud. presso questa Corte d’appello, bravo dilettante d’architettura. Vi venne l’ab. Boni79 questi mi disse che dovette costretto da preghi comporre di poca voglia l’Epigrafe pel Predicatore (4 maggio), e che era anche incomodato a letto. Gli parlò di varie edizioni del 400 con figure, di Roma, di Verona etc. e ciò perché Pinali aveva acquistato di fresco un libro figurato che fu il primo con figure impresso in Verona80; di alcune cose di letterati del ‘500 fioriti in Venezia; e come sarebbe utilissimo dalla storia il sapere dove abitavano gli Aldi, i Gioliti ecc. Vi fu pure l’ab. Francesconi che mi promise, tornato da Milano per cui parte domani, di rispondermi sulla novella”. 22 maggio 1810 p. 123: “Ieri il sig. Cesare librajo fece acquisto di vari codici mss. dalla libreria di PP. Della Salute di questa città, vi sono fra gli altri un Dante assai antico, un Burchiello, un Petrarca in pergamena ma imperfetto, i corali di S. Gregorio, la Bella mano in pecora, un Boezio tradotto con note, un altro Petrarca perfetto in pergamena in forma di 4 grande, alcuni libri di cose venete, un’opera di S. Agostino ossia i suoi Sermoni volgarizzati, alcuni versi latini (che paiono indici) di Nicolò Leonici dei Tomei 81 veneziano etc. oggi ha portato alcuni novi mss. ma non li vidi ancora (...)”. 78 Gaetano Pinali (n. 1759) archeologo, giudice ABI I 787,67-70 Mauro Boni (1746-1817; DBI, 12, 81-84), bibliotecario del Collegio dei Gesuiti in Reggio; cfr. in FRATI, pp. 113-114 80 Probabile allusione ad un esemplare dell’editio princeps del De re militari di Roberto Valturio (1405-1475), stampato a Verona nel 1472 da Giovanni di Niccolò da Verona e tradizionalmente indicato come il primo libro illustrato da un incisore italiano, le cui illustrazioni sono variamente attribuite a Giovanni Bettini da Fano e Matteo de Pasti o alla sua scuola romana; per un resoconto sulla questione cfr. fra gli altri F. LOLLINI, Il “De re militari”: qualche considerazione sulle questioni stilistiche, in: Roberto Valturio “De re militari”, Rimini 2006, pp. 107-114. 81 Nicolò Leonico Tomeo (1456-1531), filosofo aristotelico docente presso l’Università di Padova; cfr. in G. TENNEMANN-F. LONGHENA, Manuale di storia della filosofia, 4, Milano 1855, pp. 517-518. 79 26 “III Scartabello. Comincia da 23 maggio a tutto 18 luglio 1810” 24 maggio 1810 p. 128-129: “Al 22 di questo vidi un preziosissimo libro, ed è Antoniana Margarita del Pereira82 libro descritto da m. De Bure83 al numero 1291. L’esemplare che vidi io che era presso il sig. Cesare e che prima apparteneva alla Libreria della Salute corrisponde perfettamente alla descrizione che ne fa De Bure. (...). Ho acquistato dal sig.r Cesare, presso cui era il suddetto manoscritto84, il Decamerone del 157385 per lire 12 venete. Ne vale almeno 30. In cambio gli diedi un Rusconi Architettura in folio. Siccome poi a me non piace d’ingannare alcuno, così avvisai il sig.r Cesare che l’edizione di questo Rusconi è quella del Valvassense 166086, ma che non ha il frontispicio di quella, avendolo invece rimesso dell’edizione Giolito 159087 rarissima. Aggiungesi che in fine vi è anche l’impressa de’ Gioliti rimessa a bella posta. E siccome nella fine dell’ultima pagina era indietro il luogo, lo stampatore e l’anno dell’edizione del Valvasense, così per meglio ingannare il compratore fu con fortissimo inchiostro cassata questa riga (...)”. Di Juan Gomez Pereyra, Antoniana Margarita, opus nempe physicis, medicis, ac theologis non minus vtile, quam necessarium, per Gometium Pereiram, Methymnae Campi, excusum est hoc opus in officina chalcogrphica Guillielmi de Millis, 1554. 83 Guillaume-Francois Debure (sec. XVIII-XIX), libraio e tipografo francesce, autore della Bibliographie instructive, ou Traite de la connoissance des livres rares et singuliers, 1-7, Paris, chez Guillaume-Francois De Bure le jeune, Libraire, quai des Augustins, 17631768. 84 Si tratta di un volgarizzamento della Prima Deca di Tito Livio. 85 Il Decameron di messer Giouanni Boccacci cittadino fiorentino. Ricorretto in Roma, et emendato secondo l'ordine del sacro Conc. di Trento, et riscontrato in Firenze con testi antichi & alla sua vera lezione ridotto da' deputati di loro alt. Ser, nuovamente stampato in Fiorenza, nella stamperia de i Giunti, 1573. 86 Si tratta dell’opera del Rusconi I dieci libri d' architettura di Gio. Antonio Rusconi. Secondo i precetti di Vetruuio, nouamente ristampati, & accresciuti della Prattica degl'horologi solari, in Venetia, per Francesco Valvasense, 1660 adi 25 maggio 87 Della architettura di Gio. Antonio Rusconi, con centosessanta figure dissegnate dal medesimo, secondo i precetti di Vitruuio, e con chiarezza, e breuita dichiarate libri dieci, in Venetia, appresso i Gioliti, 1590. 82 27 29 maggio 1810 p. 132: “Oggi ho inviato a regalo l’esemplare 21 della mia seconda novella al co. Francesco Rizzo88. Signore che possiede di assai buoni libri e rari e che è gentilissimo. Egli me ne ricercò una copia ier sera nella Bottega del sig.r Cesare (...)”. 30-31 maggio 1810 p. 132: “Fui dal sig.r Cesare, e posi in ordine e in Catalogo 89 i libri del quattrocento. Si stamperà questo Catalogo (...)”. 2 giugno 1810 p. 133: “Ier sera fui di nuovo a Catalogare di quattrocentisti assai rari (…)” 12 giugno 1810 p. 138: “(…) L’altro giorno scrissi al Tomitano90 rendendogli conto di un esemplare delle Annotazioni de’ deputati al Decameron 1573, postillato di mano di Alessandro Tassoni91 che esisteva nella Libreria della Salute e ora è in vendita presso il sig.r Cesare. So che è assai amante di questi libri Tomitano, e che anche il Decameron del Salviati 158792 con annotazioni ms. originali di mano dello stesso Tassoni, esemplare che similmente era in libreria alla Salute e che pervenuto al Cesare fu da questi ceduto al Grapputo, e il Grapputo lo diede al Tomitano. In questo esemplare è una nota di mio Francesco Rizzo Patarol (m. 1833), cfr. ZORZI, Le biblioteche, p. 287 e nn. 311-312. cfr. Cicogna, Bibliografia, p. 585 nr. 4407 “Catalogo cronologico di edizioni del secolo XV, che si trovano vendibili appresso Adolfo Cesare Librajo in Venezia, in 12, senza data, ma è del 1810 circa. E’ formato per lo più dall’acquisto che il Cesare fece della squisita Biblioteca già fondata da Sebastiano Zeno dei Gesuiti”. 90 Giulio Bernardino Tomitano (1761-1828) ABI I 953, 409-417; II 624, 240-241. 91 Alessandro Tassoni (1565-1635) Ferrari, 651. 92 Il Decameron di messer Giouanni Boccacci cittadin fiorentino, di nuouo ristampato, e riscontrato in Firenze con testi antichi, & alla sua vera lezione ridotto dal caualier Lionardo Saluiati, Firenze, nella stamperia de' Giunti, del mese di febbraio 1587. 88 89 28 carattere; il perché Tomitano scrivendomi nell’anno scorso credette che l’esemplare fosse stato mio”. 15 giugno 1810 p. 139: “(…) Ho lavorato come un cane nel trasportare in tante casse la libreria Gradenigo. Questo signore affitta quelle stanze a monache, ed ha voluto che il Cesare trasporti in casa sua la libreria”. 18 giugno 1810 p 140: “ Si vede a trasportare una quantità di libri di Biblioteche de’ Conventi Soppressi, e vengono venduti a peso di carta. Se io avessi tempo e luogo vorrei farne scelta e forse mi capiterebbe alle mani qualche libretto raro. Si è terminato di trasportare la libreria Gradenigo. Non fu piccola impresa il trasporto e il metter in altrettanti cassoni una libreria d’oltre 6 mila volumi numerati progressivamente in modo che traendoli fuori per riporli in nuovi colci93 non ne vada più uno fuori dal suo luogo, e facilmente possano trovarsi. Questo è mio merito”. 25 giugno 1810 p. 142: “Oggi il Cav. Lamberti94 è ito a vedere i libri di casa del Cesare, scelse alcuni libri di Crusca, di Aldo e del Quattrocento”. 26 giugno 1810 p. 141: 93 94 Lettura incerta. Anton Maria Lamberti, (1757-1832; DBI, 63, Roma 2004, pp. 165-168). 29 “Ier sera il Cav. Lamberti fu dal sig.r Cesare. Vi fu anche il cons.e Pino, il p. Barnaba, il Balbi ed altri (…)” 29 giugno 1810 p. 145: “Ier sera vidi il Decameron 1527 dell’ab. Celotti di cui parlai altra volta, dissi che allora volea prenderlo il conte di Aolisin 95 egli nol prese e prese invece per 4 zecchini quello che possedea il Cesare mezzo imperfetto di cui parimenti parlai. Non si può dar cosa peggiore. Egli aveva la bella opportunità di perfezionare un esemplare e non volle per la spilorceria di 10 o 12 zecchini che avrebbe costato quello di Celotti in qualche luogo, come dissi altrove, imperfetto, ma in modo che di due se ne poteva trarne uno perfettissimo. Chi sa mai quando succede una più bella occasione, forse mai più! (…)”. 30 giugno 1810 p. 147: “Ieri di mattina fui in casa del sig. Cesare. Vi venne l’ab. Bettio 96 Vice Bibliotecario di S. Marco. Scelse alcuni opuscoletti. Egli testé raccolti, dissemi che l’Ab. Morelli ne ha più di mille volumi di opuscoletti, de’ quali tutti esso ab. Bettìo fece il Catalogo per nome d’autori, e per materie in cui impiegò più di un anno. Eravi anche Licini. Parlammo di cose letterarie e bibliografiche. Li ho mostrati vari libri rari. Egli mi disse, e bene, che molti libri citati dal Vogt97 come rari, tali non sono in Italia ma bensì in Germania. E infatti molti libri rari sono in un luogo che in un altro non lo sono (…)”. 1 luglio 1810 p. 150: La lettura è incerta e non è stata possibile l’identificazione. Pietro Bettìo (1769-1846) DBI, 9, Roma 1967, pp. 757-760; successore di Iacopo Morelli come direttore della Biblioteca Marciana, dal 1819 al 1846; per una trattazione esaustiva cfr. Zorzi , La libreria. 97 Johann Vogt, Johannis Vogt Catalogus historico-criticus librorum rariorum, jam curis quartis recognitus et copiosa accessione ex symbolis et collatione bibliophilorum per Germaniam doctissimorum adauctus, Hamburgi, sumptibus Christiani Heroldi, 1753. 95 96 30 “(…) L’ab. Torres98 grecista assai buono di nazione spagnuolo ora si trova diserto perché non ha librerie, da andarsi a studiare. Esse, come si sa, sono bollate. Il perché va egli ogni giorno dal Cesare, e ivi si mette a studiare”. 3 luglio 1810 p. 151: “Ieri l’altro col Licini e coll’ab. Bettìo fummo dal Cesare e l’ab. scelse alcuni opuscoli, giacché ne fa raccolta. Scelse per la Libreria di S. Marco due libri di lettere manoscritte autografe di Giovanni Poleni 99, e molti libretti di musica del ‘500” (…)”. 8 luglio 1810 p. 156: “(…) Ier sera dal Cesare si parlò di varie cose concernenti medaglie, e veneasi sul discorso dell’immortale Canova (che abita ora in casa dell’architetto Selva100) (…)”. 13 luglio 1810 p. 164: “(…) Lo mostrai ier sera al Cesare. Lodò la bellezza, ma ne biasimò il prezzo dicendo ch’e’ lo venderebbe per 12 zecchini e che per conseguenza lo comprerebbe per 6 (…)” “IV Scartabello comincia da 19 Luglio a tutto 28 Agosto 1810” Antonio Torres di Siviglia, (sec. XVIII-XIX) ex-gesuita, autore fra le altre cose delle Antiquitates Cretenses, incomplete per la sopraggiunta morte dell’autore, lasciò nel 1817 una scelta libreria di argomento biblico e archeologico cfr. Zorzi, La gestione del patrimonio librario, p. 281. 99 Giovanni Poleni (1683-1761; Ferrari, p. 548); matematico e fisico, docente presso l’Università di Padova. 100 Giovanni Antonio Selva (1753-1819; Ferrari, p. 622). 98 31 20 luglio 1810 p. 177: “Ier sera ho parlato al sig.r Cesare di questa libreria non facendo il nome del suo possessore. Egli s’accorse subito ch’era quella del Tomitano, e disse che anche il Salvi di Milano era pronto per farne la compra ma che non si accordò pel prezzo esorbitante (…). Il Cesare ha delle trattative per comprare la libreria Pisani101. Esistono in essa de’ libri assai buoni come apparisce dal Catalogo102 che in tre volumi in 8.vo fecesi stampare, e che ha avuto pochissimo esito (…)”. 21 luglio 1810 p. 178: “(…) Il Cesare non è soltanto libraio; è anche antiquario. Chi vede ora la sua Bottega, vi troverà de’ bronzi non ispregevoli. Egli li comperò da’ Padri della Salute, se non erro (…)”. 22 luglio 1810 p. 179-180: “Ieri ebbi lettera del sig. Gaetano Melzi di Milano. Risponde a due mie con le quali gli mandai la Novella seconda. Mi ringrazia, la loda ecc. disse che ha parimenti scritto al Cesare sul mio libro delle Cento Novelle” 23 luglio 1810 p. 189: “Il sig. Melzi mi ha offerto 20 zecchini veneti del libro delle Novelle antiche. Io gliene avea dimandati per mezzo del Cesare 24 (…)”. 24 luglio 1810 p. 181: Per la Libreria Pisani cfr. Zorzi, Le biblioteche, pp. 280-281. Bibliotheca Pisanorum Veneta annotationibus illustrata, Venetiis, Curti, 1807-1808, volumi tre, in 8; compilatore e curatore fu Antonio Giovanni Bonicelli, futuro vice bibliotecario della Biblioteca Marciana; cfr. anche Cicogna, Bibliografia, p. 581, nr. 4383 101 102 32 “Il Cesare aveva scritto anche al Balbi, che ora si trova a Padova perché parlasse col co. Borromeo103 sul mio libro Delle cento novelle antiche. Ieri il Balbi rispose al Cesare che il co. Borromeo all’annunzio di questo libro e all’udire i 24 zecchini svenne; che era presente il co. Lazara 104 il quale con acque e con odori lo fe ritornare in se (…) Ieri poi similmente il Cesare per far riavere il co. Borromeo dal suo svenimento gli mandò la lettera del Melzi con cui mi offre 20 zecchini (….). Il Foglierini 105 altro librajo di questa città dicesi che possa per opposizione al sig.r Cesare nell’acquisto della Libreria Pisani che va all’asta a’ 29 del corrente” 26 luglio 1810 p. 182: “(…) Ier sera nella Bottega di Adolfo Cesare narraronsi varie storielle (…)”. 2 agosto 1810 p. 191: “(…) Ieri fui a pranzo dal Cesare, con l’ab. Barnaba, il Bada 106 poeta veneziano e anche altri. Si passò la giornata assai allegramente. Il Cesare ha un suo figlioletto nel Coll. del detto Barnaba. Non vi potrei dire quanto sia amato questo figliuolino. Forse egli è anche troppo, il perché è un poco disubbidiente, cattivo, piange quando lascia il papà e la mamma. Cesare vuole un ben di vita a cotesto suo figliuolo. In Collegio lo fa trattare meglio di quanto ve ne pare. Ciò è male. L’invidia è facile che sia suscitata fra gli altri. Gli fé fare un bicchiere d’argento, gran quantità di camicie, di biancheria. Maestri egli vuole di tutta la sorta. Egli ha intenzione che questo suo figliolo diventi un gran frutto. Egli potrà essere. Ma a che ciò se e’ vorrà poi fare il librajo? Bene è vero che è buono ch’egli sappia di tutto, e che fatto Antonio Maria Borromeo conte (1724-1813; DBI, 13, Roma 1971, pp. 27-28), bibliofilo collezionista e novelliere, cfr. anche Frati, p. 117. 104 Nicolò De Lazara (1790-1860; Ferrari, p. 404).). 105 Antonio Foglierini (sec. XVIII-XIX; Editori Italiani dell’Ottocento, p. 456), tipografo e libraio. 106 Giambattista Bada (sec. XVIII-XIX; ABI I 89, 200). 103 33 grande scelga quello che meglio gli piacerà. Non par al presente che questo fanciullo abbia talento, e voglia d’apprendere. Ha 4 anni circa. Non so disapprovare il padre se teneramente e sinceramente l’ama. Fui amato e sono ancora io similmente dal Padre mio che farebbe tutto per me. Sebben non lo meriti a niun punto.” 13 agosto 1810 p. 203: “(…) Venne il giorno 10 in Bottega dal Cesare l’ab. Nalesso 107 di Padova. Si parlò sul legare e lavare, e levare le macchie de’ libri. Pino v’era, ed è assai valente anche in ciò. (…)” 14 agosto 1810 p. 204: “(...) Due Ebrei, come dissi comperarono per otto mila ducati la Libreria e la Galleria di quadri de’ co. Collalto. Il librajo Cesare acquisterà alquanti di questi libri. La Libreria Pisani è già del Cesare – poi fu acquistata dall’Occhi108 librajo” 15 agosto 1810 p. 205: “(…) Il Cesare avea simile intenzione di ristamparlo109. Ne ha una copia colle immagini ed aggiunte etc. Apparteneva alla Libreria Gradenigo, e credo di averne parlato (N.d.A. non fu ristampato – 1866)”. Giambattista Nalesso (sec. XVIII-XIX) abate di Padova, collezionista di libri e di opere d’arte. 108 Simone Occhi (Sec XVIII-XIX), tipografo e libraio di Venezia, cfr. Zorzi, Le biblioteche, p. 270 109 Il riferimento è all’opera di Gasparo Gozzi la “Marfisa bizzarra”, precedentemente citata. 107 34 18 agosto 1810 p. 209: “L’altra sera capitò in bottega Cesare l’ab. Boni. Parlò della Prefazione che fece al Petrarca stampata dal Picotti a spese Foglierini in quest’anno (…)” 20 agosto 1810 p. 212-213: “Il giorno 15 fu venduta all’asta la libreria Pisani, e per 22 mila lire italiane la comperò il sig.r Cesare senza che alcuno vi concorresse. Unitamente alla libreria vanno comprese le scancie che sono di noce assai belle e ben architettate (…) Più bella compera e a sì piccolo prezzo non potea fare il sig.r Cesare. Ma il bisogno è grande; e come si sa, Ca’ Pisani è colma di debiti. L’ab. Bonicelli che n’era il Bibliotecario si doleva assai. Egli è degno di compassione, come lo sarebbe un padre cui venisse tolto suo figlio. Gli doleva forse anche il crederla venduta per così poco prezzo; ma opportunamente Pino e altri gli fecero osservare che se non c’era il Cesare nessuno gli avrebbe date 22 mila lire ma bensì 12 o 16 al più, e forse nemmeno queste; cosicchè la Libreria (che già dovea vendersi, così volendolo i creditori) sarebbe stata invenduta o almen data via per poco o niente. Colpa i tempi, ne’ quali pochi sono quelli che abbian dinaro, e pochi gli amatori de’ libri. Aggiungesi che fu d’uopo all’asta esborsare il danaro sul fatto, o almen un generoso deposito. A respiro certamente è più agevole il vendere qualunque cosa, che a contanti pronti. Il Cesare è un uomo di credito, di fortuna, e di danari; e il più bello è che non ha bisogno d’alcuno che gli dia a prestito la somma occorrente per far quegl’acquisti che vuole. Dice il Foglierini che farebbe concorso all’asta. Egli non si vide. Questo è il solito di chi gracchia e assomigliasi al cane che abbaja ma non morsica (…)” 22 agosto 1810 p. 215-216: 35 “(…) Il Cesare dopo aver acquistato la libreria Pisani la cedette con un guadagno di due mila ducati correnti a un compagno che gliela ricercò. Bel guadagno in poche ore di trattative duemila ducati! L’ab. Bonicelli e un certo Franco fattore di Ca’ Pisani sono le due figure principali che comprarono la libreria di nuovo. Carminati110 a S. Lio esborsò loro il danaro occorrente cioè le 24mila lire italiane per l’asta e i 2000 ducati. Foglierini è il direttore della vendita. Questa libreria che per 24 mila lire italiane era ben comprata e potea render grandissimo utile al Cesare non sarà che di discapito ai nuovi compratori. Essa intanto è aggravata Io. di due mila ducati .IIo. di 30 scudini dati di ricognizione all’inserviente e all’usciere .III o. del mezzo per cento che verrà somministrato al Carminati che esborsò il danaro .IV o. di un tanto al mese che dee ritrarne l’ab. Bonicelli come Bibliotecario .V°. del dato per cento che dee averne il Foglierini venditore; oltre le 24 mila lire italiane. Questi aggravi vanno a peso di compera: e io credo che pochi ce ne saranno. Essi ben comprarono dal Cesare perché non v’erano che le 24 mila lire di aggravio e nient’altro. Da alcuni non posson compare che a caro prezzo e la ragion n’è evidente quando pure voglian i suoi compratori ricavare lo speso, e guadagnarci. Cesare impiegherà meglio il suo dinaro a momenti. Il Balbi non approvò questa cosa per parte del Cesare. Egli parla per passione, mentre non potrà più acquistare que’ pochi libri che aveva già scelti” “V Scartabello. Comincia da 29 agosto a tutto 6 novembre 1810” 7 settembre 1810 p. 229: Famiglia veneziana proprietaria di una ricca biblioteca, cfr. Zorzi, La libreria, p. 335; non si fa menzione del nome di battesimo del titolare. 110 36 “L’altra sera e ier sera capitò in Bottega dal Cesare l’ab. Boni, noi si fu che rideva quand’ei capitò. Ci raccontò d’avere stimato la libreria Rossi di Treviso; ma non volea dire quanto. (…) La libreria Pisani si va vendendo. Pino111 ha comprato il Catullo Tibullo e Properzio in due tomi in 8.vo. cum notis per lire 36 italiane. Mi sembra che l’abbia pagato assai caro. Se il Cesare avesse venduto questa libreria per sé, a quest’ora sarebbe in più di mezzo?”. “VI Scartabello. Comincia da 7 novembre fino al 31 dicembre 1810 inclusive” 16 novembre 1810 p. 277: “(…) Per li 20 del corrente spero di essere a Venezia, e mi metto a comporre qualche cosa di genio e per istampare e per leggere all’accademia. È molto tempo che non ho notizie di essa e che non so niente del mio Cesare e di que’ che praticano nella sua bottega. So bene per altro ch’egli un mese fa fu assalito da tre ladri che lo gittarono a terra. Egli dimenando e mani e piedi si sghermì e gridò in modo che venuta gente i ladri fuggiano senza torgli nulla. Aveva 30 luigi in saccoccia, due orologi d’oro e un anello di brillanti in dito oltre la scatola d’oro (…)” 20 novembre 1810 p. 279: “Finalmente sono giunto in Venezia. Mia prima cura fu l’andare al Negozio Cesare. Egli ha fatto il grande acquisto della libreria Collalto 112, mole immense di libri per lire 52 mila. Egli vendette a peso prima, si scelse il Giuseppe Pino (sec.XIX) giudice della Corte d’Appello di Venezia; cfr. Cicogna, Diari, I, 16 gennaio 1810, p. 43. 111 37 meglio per sé, e del rimanente fece tre porzioni cioè, libri in 12 e in 8.vo una lira veneta, i libri in 4 due lire, libri in folio 4 lire (…)”. 21 novembre 1810 p. 279: “Se il Cesare avesse saputo fare nella libreria Collalto egli potrebbe guadagnare il duplo di quello che si crede. Essa sarà stata composta di 150 mila volumi di ogni genere e doppi e imperfetti. Doveva egli, fatto l’acquisto dagli Ebrei, separare quelli da vendersi a peso, quelli da mandare a casa sua più scelti, quelli da 1, 2, 4 lire etc. e indi riconosciuto quello che ha chiamare i compratori. Egli invece fece cosi: appena comperata lasciò ogni maniera di gente andar dentro per le sale e per le camere a sceglier. Vendé e vende tuttora senza neppur sapere che cosa egli abbia perché la mole immensa di libri non permette in breve tempo una scelta. Libri ammonticchiati per terra, in librerie sciolte, imperfetti. Vendé dei libri per quattro lire che ne valevano 20; moltissimi gli vengono derubati. Al presente non si vedono sui banchetti che libri di Collalto, e si vendono cari, mentre non hanno costato che pochi soldi ai loro venditori. Non vi fu mai un catalogo. E io non so come potesse essere un uomo di gusto quello teneva si male questi libri, e che chiamare si doveva piuttosto Bibliomano che Bibliografo, e raccoglitori di libri113”. “VII Scartabello. Comincia da 1 gennaio a tutto 9 marzo 1811” 3 gennaio 1811 p. 320: Giacomo Collalto di San Stin (sec. XVIII), collezionistia veneziano fra i più noti, cfr. M. Zorzi, Le biblioteche, p. 272; id., La libreria, p. 335. 113 La vendita della Libreria Collalto suscitò pareri discordanti, Giovanni Rossi in Leggi e costumi dei Veneziani (Biblioteca Marciana di Venezia Cod. It. VII, 1399=9220), vol. 14, c. 190 “Tutto vendettesi, facendone strage indescrivibile e non bastevolmente da deplorarsi dal libraio Adolfo Cesare”; 112 38 “Ier sera in Bottega da Cesare si parlò della Libreria Canonici, e come la raccolta delle Bibbie toccò di sua porzione al sig.r Cardina, e il restante cioè la miscellanea, i manoscritti etc. al sig.r Perissinotti ambedue eredi dell’ab. Canonici istituiti, e ciò in vigore di sentenza nota, o per meglio dir di accordo fatto114 (…) 10 gennaio 1811 p. 329: “(…) Dico il vero la cosa che un po’ mi dispiace è quella di dover lasciar de’ libri e delle librerie copiose. Degli amici dotti non parlo, perché poco mi trovo con essi, atteso che la mia vita è assai solitaria. Mi dispiace lasciar il crocchio nella bottega di Adolfo Cesare, di lasciar l’Accademia di belle lettere, la Biblioteca di S. Marco, che qualche volta consultai (…)” 13 gennaio 1811 p. 332: “Il Cesare mi ha fatto proposizione di darmi lire 3 ½ venete al giorno nel tempo che mi fermo ancora in Venezia fino alle feste Pasquali purché gli metta in ordine i libri e ne faccia il Catalogo. Io gli dissi che si, considerando che alla Corte d’Appello non ho alcuna speranza di guadagno, che già da Venezia devo partire, che è meglio ricavar 3 ½ al giorno piuttosto che niente, che le ore di questo mio nuovo impiego sono dalle 9 alle 4 cosicché ho tutte le sere di libertà e tutte le domeniche, che è una cosa di mio genio giacché al Cesare stesso feci degli altri Cataloghi senza alcuna utilità (…)”. “Nella libreria del Canonici, fra l’altro, era confluita buona parte di quella del senatore Giacomo Soranzo. Il Canonici aveva 4.000 Bibbie, in 52 lingue diverse, una raccolta di statuti di tutte le città italiane, diverse centinaia di manoscritti, alcuni straordinariamente preziosi. Morendo, nel 1805, lasciò tutto il suo al fratello Giuseppe, che gli sopravvisse di poco. Nel 1807 ereditarono i nipoti, avv. Gianni Perissinotti e Girolamo Cardina. A quest’ultimo toccò la raccolta delle Bibbie; i manoscritti e la miscellanea andarono al Perissinotti. In quello stesso anno 1807 gli eredi, intenzionati a vendere, trattarono tramite il Morelli, con il governo del Regno Italico senza nulla concludere. Poco dopo – attorno al 1810 – le Bibbie furono comperate da Adolfo Cesare” in Zorzi, La libreria, p. 275. 114 39 15 gennaio 1811 p. 333: “Ieri fui da Cesare e cominciai a por in ordine l’immensa quantità di libri che ha. Capitò l’avvocato Valentinelli115 ferrarese che sta in Padova e mise alcuni libri a parte per sé (…)” 16 gennaio 1811 p. 334: “(…) Non c’è caso, io non mi posso usare a servire un privato. Alla fine de’ conti io non fo che servire il Cesare quantunque sia servo nobile, e sia solamente per acconciare i libri suoi e farne il Catalogo; pure aspetto che domenica vengami la risposta di mio Padre e se mi pare ch’egli non ne sia gran fatto persuaso, io rinuncio volentieri all’utile che mi viene da queste mie librarie fatiche e torno a frequentare l’Appello finché partirò da Venezia; e se mi da l’estro rinuncio anche prima che mi giunga la risposta. D’altra parte io desidero di civanzare qualche dinaro per acquistarmi de’ libri che mi servano di sollievo in campagna e sono di tre classe cioè alcuni Bibliografi, alcuni classici latini, e alcuni classici italiani; e se non istò da Cesare non posso civanzar quattrino perché non ne ho. Ma già io temo che l’amor della libertà sorpasserà quello dell’interesse (…). Mi disgusta poi molto il veder quasi riuscir vane ogni di le mie fatiche mentre non v’è alcun ordine in casa Cesare. E come mai vi può essere se è piena di figli e figli piccini e grandicelli? Se io metto un libro a suo luogo oggi, dimani non trovo più là ma in un altro ove non vi sta. Si getta la fatica e bisogna rifar quel che si ha fatto per non far nulla. C’è un’altra cosa, ed è che ognun che non mi conosce, crede ch’io sia un garzone di bottega di Cesare e dammi del voi, e mi comanda. Cosa che io non posso inghiottire, ben diversa essendo stata la mia educazione da quella di umil servitore”. 19 gennaio 1811 pp. 335-336: 115 Giuseppe Valentinelli (1805-1874; Frati, pp. 555-556). 40 “Ho fatto il gran colpo. Questa sera ho vestita l’aria di malinconico. Sono andato in bottega Cesare, e cominciai col sig.r Licini a lagnarmi di avere ricevuta di mio Padre nella quale significa che non vuole che io lasci l’Appello per attender ad un libraio (lettera che fingo di aver ricevuta) che perciò sono costretto a tornare all’antico mio uffizio, e a rinunciare all’utile che mi veniva essendo presso Cesare (v. 16 gennajo). Al Cesare, cui comunicai le stesse cose, dispiacquero fortemente; ma siccome siamo liberi amendue, così possiamo fare quello che più ci aggrada. Pertanto ritornerò all’Appello per que’ pochi giorni che ancora mi fermo in Venezia. Nonostante voglia aver in libertà qualche ora per poter seguitare a mettere in ordine e in Catalogo alcuni libri di Cesare e di Andrighetti 116. Sono poi obbligato al Cesare il quale mi fece delle agevolezze in alquanti libri che ho comperati (…)”. 21 gennaio 1811 p. 337: “La finzione si è avverata. Imperciocché ricevei una lettera da mio Padre, nella quale, non approva che io m’abbia messo presso il libraio Cesare. Facendo riflesso all’educazione che ebbi e al desiderio suo di vedermi all’Appello infine che partirò da Venezia (v. 19 gennaio)”. 22 gennaio 1811 p. 337 “Domani ritornerò alla Corte d’Appello secondo il volere di mio Padre. Ho posto in ordine da Cesare tutti i libri, e non resta che principiarne il Catalogo. O egli si contenterà di quel brevissimo tempo che posso aver io per farle, o si Ottavio Andrighetti, conte (1777-1857), la sua biblioteca “passò al nobile Andrea Zon, suo erede, che sposò Teresa Carlotti; la figlia Andriani andò sposa ad Alessandro Marcello; e in casa Marcello la biblioteca ancora oggi si trova affidata alle intelligenti cure del conte Girolamo”, in Zorzi, La libreria, p. 347. 116 41 troverà altri, o aspetterà, a me non importa. Per compenso di quello che feci non volli denaro, ma libri, e anche questi li pagai benché a buon mercato (…)”. 24 gennaio 1811 p. 338: “Il sig. ab. De Martiis117 comperò per 9 zecchini circa l’Aetna118 del Bembo stampata da Aldo nel 1495, libricciuolo rarissimo venduto fino 15 zecchini dal Cesare all’ab. Berti119 per Casa Mocenigo120 (…)”. 29 gennaio 1811 p. 341: “(…) Ier sera nella bottega del sig.r Cesare si giuocò a scacchi dall’ab. De Martiis e dal sig.r Marco Cesare. (…)”. 31 gennaio 1811 p. 343: “(…) In poco tempo da Cesare misi in ordine i libri di Crusca e ne feci nota da spedire a Parigi. Ebbi l’Omero tradotto dal Salvini121 e Anacreonte. Quella traduzione se non diletta istruisce appunto perché esprime non i pensieri soltanto ma anche le parole di Omero”. Antonio De Martiis (1772-1850; Ferrari, p. 266), proprietario di una ricca libreria di circa 20.000 esemplari, cfr. Zorzi, Le biblioteche, p. 287. 118 Pietro Bembo, De Aetna ad angelum Chabrielem liber, Venetiis, in aedibus Aldi Romani, mense februario 1495. 119 Pietro Berti abate (sec. XVIII-XIX), precettore e bibliotecario della famiglia Mocenigo di San Stae, cfr. Zorzi, Le biblioteche, p. 308. 120 Il Cesare acquisterà la libreria Mocenigo il 2 luglio dello stesso anno, così come descritto da Cicogna nel suo Diario, I, p. 427: “Il Cesare oggi ha comperata la preziosissima libreria Mocenigo a S. Stae, ma la cosa è secretissima (…). Ella è ridondante di tutti i libri citati a stampa dalla Crusca, di tutti i più belli e rari aldini, di tutti i Santi Padri di Parigi, di tutti i Cominiani ec., di storie ec. Un messale poi, ch’è superbamente miniato, e di cui dal Salvi di Milano all’ab. Berti, maestro di Ca’ Mocenigo, furono offerti zecchini 600; questo è escluso dalla vendita suddetta”. Cesare offrì per l’acquisto era di circa 8000 ducati “eppure si pretendevano dalla famiglia Mocenigo altre volte ducati 20.000”. 121 Opere d'Omero tradotte dall'original greco da Anton Maria Salvini. Divise in tomi due, in Padova, nella Stamperia del Seminario, appresso Giovanni Manfre, 1742 117 42 2 febbraio 1811 p. 344: “Venne a Venezia l’ab. Dalmistro122. Comperò alcuni libri dal Cesare. (…)”. 10 febbraio 1811 p. 349-350: “(…) L’aver in possesso un esemplare delle Metamorfosi d’Ovidio tradotte in prosa da Giovanni de’ Bonsignori123 stampato a Venezia da Zuan Rosso nel 1497 in fol. che fu già appartenente alla diviziosa libreria della Salute di questa città i cui più rari libri furono venduti al Cesare, esemplare stesso veduto e descritto dal p. Paitoni124, mi fece sovvenire di aver tra miei libri un’opera manoscritta del Bonsignori medesimo, che s’aggira sulla vita di S. Macario della Casa Frangipani romana, e mi spinse a ricercare ulteriori notizie di questo Bonsignori, e della Casa Frangipani e di altre (…) Per lo che mi chiamo contento d’aver per poco acquistato fin dall’anno 1805 questo libro che apparteneva alla libreria Pace di Udine 125 comprata dallo steso Cesare (…)” “VIII Scartabello. Comincia da 1° marzo a tutto 21 maggio 1811” 17 marzo 1811 p. 349: Angelo Dalmistro (1754-1839; DBI, 32, Roma 1986, pp.153-157). Giovanni Bonsignori (sec. XIV; DBI, 12, Roma 1970, pp. 407-409) 124 Giovanni Maria Paitoni, protomedico (sec. XVII-XIX) cfr. Zorzi, Le biblioteche, p. 287. 125 Carlo Maria Della Pace (sec. XIX; Frati, pp.194-195); il Catalogo della sua collezione di manoscritti e incunaboli fu stampato presso Adolfo Cesare nel 1807, cfr. Cicogna, Bibliografia, p. 573 nr. 4330. 122 123 43 “(…) Io trovo continuamente fra i libri di Cesare rari opuscoli e libri non indicati nei cataloghi e ignoti affatto. Se ho tempo voglio farne un catalogo. È probabile che mi metta a fare il Catalogo delle Bibbie di Canonici tutte comprate da Cesare. Costui si rende di giorno in giorno formidabile fra i libraj; oltre le dette Bibbie che sappiamo esservene di rarissime, ebbe i due Papiri, le Miscellanee e che so io (…)”. 25 marzo 1811 p. 372: “(…) Ier sera parla coll’ab. Boni dell’acquisto fatto dal Cesare delle Bibbie Canonici. Egli morrebbe di voglia, come anche io, di farne un catalogo che veramente sarebbe necessario per istamparsi a comune utilità e dei Bibliografi specialmente, ma il male si è che quelle Bibbie e que’ codici sono in mano di chi non ha altra cifra che quella di vendere e non di decretare il loro nome col darne ragionato catalogo a stampa. Vi avrebbe voluto un Librajo dotto un Aldo, un Giolito, un Comino, un Fournier, un De Bure, un Ruinart di Parigi etc., un Remondini, e non il Cesare”. 26 marzo 1811 p. 373: “Il Cesare ha per suo agente Giuseppe Scapin126 fu libraio di Padova. La sfortuna di quest’uomo ammogliato con figli il ridusse da padrone a divenir servo con 200 ducati l’anno. Quindi è che l’uomo nelle prosperità non deve mai tenersi sicuro; e de viver in esse come se fosse sepolto nella miseria. L’ab. Celotti che aveva intenzione di comprar tutte le Bibbie acquistate dal Cesare si ridusse a prender la Magontina127, un’altra Bibbia s. a. ut putant del 1462, 40 o 50 pezzi stampati in carta pecora, i due papiri e due rotoli Giuseppe Scapin (fl. 1802-1811), nipote di Carlo, celebre libraio padovano, alla cui morte, nel 1801, eredita assieme ai fratelli l’attività al Leon d'Oro a Padova; cfr. C. Amedei-P. Randi, Cinque secoli di libri: tipografi, editori, librai a Padova dal Quattrocento al Novecento, Padova, Libreria Draghi editrice , 2001, p. 37. 127 Riferimento ad un esemplare della celebre Bibbia stampata da Guttemberg. 126 44 contenenti due Bibbie ebraiche, lunghissimi e rarissimi, e ciò per lire 15 mila venete”. 11 aprile 1811 p. 381: “Scrive Adolfo Cesare da Milano che se mi capitasse qualche impiego qui in Venezia, ho dilazioni di accettarlo mentre egli crede di poter trovarmi un utile stabilimento a Milano”(…). 19 aprile 1811 p. 387: “(…) Ho un esemplare del detto Konz128 che ha in principio un’annotazione di mano di Trifone Wrachien129 giureconsulto della Repubblica di Venezia di cui si fa menzione nel dizionario degli uomini illustri di Bassano. Si trovano utilissimi libri che a lui appartenevano, li quali hanno di queste annotazioni assai erudite, e si trovano i più fra quelli dello Zeno 130 a Gesuiti, ora di Adolfo Cesare librajo. (…)”. 25 aprile 1811 p. 393: “Gamba131 mi scrive da Milano dicendo che opportune e graditissime gli riuscirono le nuove osservazioni. Dice ch’egli si è determinato di farne colà eseguire la edizione e spera che si effettuerà nella Stamperia Reale e in piccola forma poiché così gli ha suggerito l’ottimo amico e sagacissimo negoziante sig.r Adolfo (Cesare) (…)”. Lettura incerta, nome non identificato. Trifone Wrachien nobile di Cattaro (m. 1784), giureconsulto della Repubblica di Venezia, possedeva una fornita libreria di argomento giuridico ceduta nel 1784, ebbe vari possessori cfr. E. A. Cicogna, Bibliografia, p. 585 nr. 4404, che cita un Catalogo dei libri posseduti dal conte Wrachien consultore della Repubblica di Venezia, in 8° senza frontispizio senz’anno, di pag. 395; cfr. anche Zorzi, Le biblioteche, p. 287. 130 Libreria fondata dal senatore Sebastiano Zen e incrementata da suo figlio Antonio (n. 1773), acquistata dal Cesare prima del 1810 cfr. Cicogna, Diario, I, 13 gennaio 1810, p. 41. 131 Bartolomeo Gamba (1776-1841; DBI, 51, Roma 1998, pp. 798-800); ex-direttore della casa Remondini e grande bibliografo. 128 129 45 27 aprile 1811 p. 395: “Cesare è tornato da Milano ha venduto, ma credea di vender di più. Gamba è ivi senza impiego. Egli ha in pensiero di trasferirsi a Padova e piantare un negozio di libri. La sua nuova edizione dei testi di Ciregna si principia a Milano dalla Stamperia Reale in 16mo in due tometti; così il persuase di fare il nostro Cesare, a comodo de’ librajo e de’ dilettanti che se li potranno tenere in saccoccia. (…)”. 9 maggio 1811 p. 400: “In bottega dal Cesare si è tenuto discorso sul signor Antonioli mercante di bisutterie e si è dipinto per un raggiratore, per uomo di poco buon nome, per un ladro, un buffone che so io (…) Queste cose mi furono riferite nella stessa bottega Cesare dal Giudice Pino, Cesare e Balbi. Costui già è noto, e a punto guardo di non cadergli nelle mani” 21 maggio 1811 p. 407: “(…) Gamba aprì un negozio di librajo in Milano. Si servirà di libri da Cesare (…)” ms. Cicogna 2898/281 lettera autografa di Adolfo Cesare ad Emmanuele Antonio Cicogna datata 26/11/1811 (unico esemplare, stranamente nell’epistolario Cicogna non sono conservate altre lettere fra i due….) 46 “Stimat. sig. Emmanuele Due gite una dopo l’altra a Milano la terza a Bassano fu la causa che la sua preg.ma lettera resti senza risposta, ora che mi sono ripatriato nella speranza di non più partire per quest’anno, offro la mia servitù ove mi crede capasse. Alla venuta di questo Religioso che mi accenna sarò a servirlo alla meglio che potrò. Ho consegnato al comune amico Licini la Sua lettera e spero che nel venturo anno, cioè quando le giornate saran lunghe, potrà mettersi all’impresa di darle risposta e di ciò mi consenta di assicurarla. Viene detto ch’Ella era in procinto di abbandonare il suo principale per passare commesso con molto suo vantaggio, tutti godevano di questa metamorfosi ma avendo poi visto non essersi verificato si avrà di dispiacere. Il Padre Stella132, col quale ho pranzato a Milano, ambidue a scroco due volte in casa di altro Stella, non parente però del Padre mi disse di essere in collera seco Lui per non vedersi riscontrato di qualche lettera a lei diretta e che teme ch’ella si dimentichi di lui, io l’ho assicurato che la cosa non sarà così ella dunque le avanzi una lettera. In quanto ai libri ch’ella possede da me provveduti, non sono al caso di sapere il loro valore ma se starò al limite di convenienza diamone pure passata. Ora che fa inverno mi trovo solo alla solita mia collazione di Collalto e mi rincresce di aver perduto un compagno che avevo assai caro, ho fatto l’acquisto di tutti gli Aldini e i Classici del Balbi a lei noto. Non sarà difficile che in breve faccia altro acquisto di una libreria di grandissimo valore, Ella può immaginare quanto abbia bisogno di una assistenza, fui veramente sfortunato l’averla dovuta perdere nel momento che avrei potuto ricompensarla di sue fatiche, se mai non le convenisse a suoi interessi il suo impiego, non si dimentichi che io sarò sempre disposto d’accettarla in mia casa. Spero ch’Ella non si dimenticherà che io sono di lui. Isidoro Stella (sec.XVIII-XIX) padre barnabita, insegnante di Cicogna presso il Convitto dei Nobili diretto dai Padri Barnabiti di Udine, cfr. Fulin, op. cit., p.p. 62-63. 132 47 P.S. Avrei piacere di sapere se quel birbante del Buffeli s’attrova costì e qual vita conduce. [Udine], 26 Novembre 1811 Aff. Amico A.C.” 48 CONCLUSIONI Dopo aver esaminato il materiale estratto dai primi otto Scartabelli dei Diari, emergono due dati essenziali: il primo è il notevole rilievo che il libraio rivestiva nel panorama commerciale della Venezia del primo Ottocento; il secondo è l’opinione, non sempre benevola, che nutrivano nei suoi confronti gli “addetti ai lavori” dell’ambito del collezionismo librario e culturale, un dato che si evince anche dalle parole permeate di sentimenti spesso contrastanti che Cicogna gli riserva. Fin dai primi resoconti è chiaro che a Venezia e non solo, non si verificasse vendita di fondi librari importanti, nella quale Adolfo Cesare non fosse in qualche misura coinvolto o protagonista principale; il 13 gennaio si segnala dell’acquisto delle importanti biblioteche Zen e Gradenigo e in parte di quella della Salute che verrà da tutti considerato il “colpaccio” del Cesare per l’esiguità della somma pagata rispetto al valore dei libri acquistati133. La disponibilità economica del libraio doveva essere davvero imponente 134 dato che, raramente qualcuno era disposto a fargli concorrenza o nutrisse la speranza di spuntarla su di lui135, ma nonostante fosse l’unica persona in grado di acquistare pregiate librerie, non mancavano i suoi detrattori, fra i quali Cicogna, e non solo, che ne lamenta i prezzi troppo alti136. Cicogna, Diario, I, 13 gennaio, pp. 9-19: “Acquisto tale che, a mio credere, e a credere anche di chi conosceva le dette librerie, non verrà mai pareggiato da qualunque altro che posteriormente si facesse dal Cesare” 134 G. Rossi, Leggi e costumi dei Veneziani, vol. XIV, cod. It. VII, 1399 (=9290), c. 136rv “Sarebbe potuto farsi ricchissimo in pochi anni, se fosse stato più giudizioso (…) la sua fortuna, di cui fece uso pessimo, ebbe principio dall’acquisto della libreria dell’abate Munaro”. 135 Cicogna, Diario, II, 5 giugno 1819, p. 4560: “Si sa poi d’altronde che Cesare è un dritto di prima sfera, e che capita male chi s’intrica con esso lui, e ne chiamo in testimonio Zen ai Gesuiti, Gradenigo a S. Sofia e molti altri”; si pensi anche all’asta per la vendita della Libreria Pisani alla quale doveva partecipare il Foglierini che però si ritirò all’ultimo momento, cfr. Diario, I, 20 agosto 1810, pp. 212-213. 136 Cfr. Diario, I, 2 gennaio 1810, p. 2 133 49 Dalle note dei Diari si evince che Cesare era si un ottimo commerciante ma mancava di quella cultura ed erudizione di cui il Cicogna si riteneva impregnato, spesso, infatti, egli scrive contraddicendosi non poco, che anche le vendite del libraio non erano all’altezza del valore dei libri che erano spesso sottostimati, con atteggiamento tipico del commerciante che stabilisce il prezzo di vendita più sul guadagno che intende ricavare da una vendita che dall’effettivo valore di mercato. D’altro canto dalle considerazioni del Cicogna, essendo lui stesso un accanito collezionista, non è esente l’invidia per oggetti che avrebbe voluto possedere ma che la sua precaria condizione economica al momento, gli permetteva solo di esaminare da studioso. Da qui i suoi sentimenti contrastanti verso il libraio che da una parte gli concedeva una relazione economico-lavorativa, spesso retribuita in libri, dall’altra il sentirsi assoggettato ad un datore di lavoro di cultura sicuramente più modesta. Ne è la prova il resoconto del gennaio dell’anno 1811 137, quando, su sollecito del padre, scrive di voler lasciare la corte d’appello perché scarsamente pagato e di voler accettare un incarico nella libreria Cesare meglio remunerato ma dopo pochi giorni, dato il trattamento ai suoi occhi riservatogli, sentendosi un umile “garzone” e trovando disdicevole tale mansione indegna della sua educazione e cultura, si inventa una scusa per poter ritornare alla sua libertà. Interessante è sicuramente la funzione che la Libreria assume quasi di circolo culturale per eruditi, letterati e artisti dell’epoca, si pensi ad Ippolito Pindemonte e ad Antonio Canova, solo per citarne alcuni, segno evidente dell’importanza che la Libreria Cesare, ricopriva nonostante tutto, nel contesto culturale di Venezia. Personalità come Morelli, Celotti ma anche come il milanese Melzi o il libraio Salvi, si ritrovavano presumibilmente per disquisizioni di carattere bibliofilico ma anche per mere trattative commerciali. 137 Cfr. le aspre considerazioni di Cicogna in Diario, I, 13-16 gennaio 1811, pp. 332-334. 50 L’impressione che se ne ricava è che, pur non essendo Adolfo Cesare un erudito nel senso Ottocentesco del termine, fosse una persona che in quel momento possedeva libri importantissimi per gli studiosi che gravitavano intorno alla sua Libreria, di conseguenza il frequentare la sua Bottega diventava cosa obbligata, potendo contare anche sull’immensa generosità del libraio che permetteva la consultazione gratuita dei libri in vendita adattando l’attività commerciale allo scopo di pubblica utilità. Che il Cicogna avesse una dubbia opinione di Cesare, lo si constata anche quando, ricordando un pranzo in casa sua, ne analizza il comportamento nei confronti del figlioletto di quattro anni, affermando che era fuori luogo che Cesare tentasse di educarlo nel migliore dei modi quando da grande non avrebbe fatto che il libraio, dimostrando una vena di disprezzo per la professione e per la persona di chi comunque aveva per lui grande considerazione138. Ancora, si occupò di riordinare la libreria Cesare e di farne il Catalogo, si lamentava del disordine dovuto alla mancanza di controllo sui figli del libraio, lasciati liberi di mettere in disordine laddove non avrebbero dovuto invece avere accesso. Data la quantità degli Scartabelli esaminati, Cesare muore nel maggio del 1847, si hanno solo pochi riscontri di carattere umano per poter definire, in maniera più completa, la personalità del libraio ma i dati emersi sono sufficienti per poter delineare un suo profilo professionale. La sua superficialità nell’approccio bibliografico e la sua apparente mancanza di scrupoli, in realtà, sono sensazioni che emergono nell’animo di soggetti legati ad una diversa concezione del collezionismo librario. Decisamente pragmatiche e realistiche infatti paiono le considerazioni del Cicogna quando a proposito della vendita della Libreria Pisani, a chi lamentava che Cesare l’avesse acquistata ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo valore Si vedano i toni devoti usati da Cesare nei confronti di Cicogna, nella lettera del 26 novembre 1811 138 51 reale, rispondesse “L’ab. Bonicelli che n’era il Bibliotecario si doleva assai. Egli è degno di compassione, come lo sarebbe un padre cui venisse tolto suo figlio. Gli doleva forse anche il crederla venduta per così poco prezzo; ma opportunamente Pino e altri gli fecero osservare che se non c’era il Cesare nessuno gli avrebbe date 22 mila lire ma bensì 12 o 16 al più, e forse nemmeno queste; cosicché la Libreria (che già dovea vendersi, così volendolo i creditori) sarebbe stata invenduta o almen data via per poco o niente. Colpa i tempi, ne’ quali pochi sono quelli che abbian dinaro, e pochi gli amatori de’ libri. Aggiungesi che fu d’uopo all’asta esborsare il danaro sul fatto, o almen un generoso deposito. A respiro certamente è più agevole il vendere qualunque cosa, che a contanti pronti. Il Cesare è un uomo di credito, di fortuna, e di danari; e il più bello è che non ha bisogno d’alcuno che gli dia a prestito la somma occorrente per far quegl’acquisti che vuole”139. 139 Cfr. Diario, I, 20 agosto 1810, p. 213. 52 Fig 2 - Frontespizio del Catalogo di Adolfo Cesare del 1809, cfr. Cicogna, Bibliografia veneziana, p. 582 nr. 4389 53 Fig. 3 - Catalogo di Adolfo Cesare del 1809, p. 3; cfr. Cicogna, Bibliografia veneziana, p. 582 nr. 4389 54 Fig. 4 - ms. Cicogna 2898/281 intestazione della lettera autografa di Adolfo Cesare a Cicogna del 26 novembre 1811 Fig. 5 - ms. Cicogna 2898/281 lettera autografa di Adolfo Cesare a Cicogna del 26 novembre 1811. 55 Bibliografia delle fonti manoscritte E. A. CICOGNA, Catalogo dei codici della Biblioteca di Emmanuele Cicogna, 1841-1867, Venezia, Biblioteca del Museo Correr (già mss. Cicogna 4424-4430). F. S. FAPANNI, Biblioteche di Venezia e delle isole, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Marc. It. VII, 218 (=9116) F. S. FAPANNI, Biblioteche di Venezia e delle isole, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Marc. It. VII 2302 (=9131) G. ROSSI, Leggi e costumi dei Veneziani, vol. XIV, cod. It. VII, 1399 (=9290). Bibliografia Abbreviata ABI = Archivio biografico italiano, a cura di T. Nappo, München, K. G. Saur, 1987Cicogna, Bibliografia = E. A. Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana, Venezia, G. B.Merlo, 1847. DBI = Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960Enciclopedia italiana = Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1929Frati, Dizionario = C. Frati, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sc. XIV al XIX, raccolto e pubblicato da A. Corbelli, Firenze, Olsckhi, 1933. Zorzi, Le biblioteche = M. ZORZI, Le biblioteche a Venezia nel secondo Settecento, in «Miscellanea Marciana», 1 (1986), pp. 253-324. Zorzi, La libreria = M. Zorzi, La libreria di San Marco, Milano, Mondadori, 1987. 56 Bibliografia* C. AMEDEI - P. RANDI, Cinque secoli di libri: tipografi, editori, librai a Padova dal Quattrocento al Novecento, Padova, Libreria Draghi editrice, 2001. Le annotazioni e i discorsi sul Decameron del 1573 dei deputati fiorentini, a cura di G. Chiecchi, RomaPadova, Antenore, 2001. A. BEMBO, Viaggio e giornale per parte dell'Asia di quattro anni incirca fatto da me Ambrosio Bembo nobile veneto, ed. e note di A. Invernizzi, disegni di Joseph Guillaume Grelot, Torino, Ed. Abaco, 2006. G. BENZONI, La storiografia, in: Storia della Cultura Veneta, 6, Dall’età napoleonica alla prima guerra mondiale, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 597-623. E. A. CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna cittadino veneto, 1-6, Venezia, presso Giuseppe Picotti stampatore, 1824-1853. CLIO. Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento (1801-1900), Milano, Ed.Bibliografica, 1991. F. CRISTIANO, L' antiquariato librario in Italia: vicende, protagonisti, cataloghi, Roma, Gela, 1986. Dizionario Enciclopedico Italiano, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1955Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1989 Dizionario etimologico italiano, Firenze, G. Barbera, 1968. R. FRATTAROLO, Studi di bibliografia storica ed altri saggi, Roma, Bonacci, 1977. R. FULIN, Saggio del Catalogo dei codici di Emmanuele A. Cicogna, in: Nozze Chiodo-Bressanin, Venezia, Tipografia del Commercio, 1872. B. GAMBA, Serie dell’edizioni de’ testi di lingua italiana, Milano, dalla Stamperia Reale, 1812. M. INFELISE, L' editoria veneziana nel Settecento, Milano, Franco Angeli, 1989. F. LOLLINI, Il “De re militari”: qualche considerazione sulle questioni stilistiche, in: Roberto Valturio “De re militari”, Rimini 2006, pp. 107-114. * Si da conto della bibliografia corrente escludendo le opere citate nei Diari, per le quali si rimanda alle note a piè pagina. 57 M. MERIGGI, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848), Bologna, Il Mulino, 1983. I. MEROLLE, L’abate Matteo Luigi Canonici e la sua biblioteca: i manoscritti Canonici e CanoniciSoranzo delle biblioteche fiorentine, Roma-Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, 1958, I-XI. G.B. MITTARELLI, Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, Venetiis, Jo. Baptistam Pasquali, 1755-1773. G.B. MITTARELLI, Bibliotheca codicum manuscriptorum Monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, una cum Appendice librorum impressorum seculi XV, Venetiis, ex typographia Fentiana, 1779. G. PAPANTI, Catalogo dei Novellieri italiani in prosa,1-2, Livorno, pei tipi di F. Vigo, 1871. D.M. PELLEGRINI, Della prima origine della stampa in Venezia per opera di Giovanni da Spira del 1469. E risposta alla difesa del Decor Puellarum del signor ab. Mauro Boni, Venezia dalle stampe di Antonio Zatta, 1794. M. PRAZ, Collezionisti e Cataloghi di libri, in: Studi in onore di Alfredo Schiaffini, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965. P. PRETO, Cicogna, Emmanuele Antonio, Dizionario biografico degli italiani, 25, Roma 1981, pp. 394397. F. RIVA, Introduzione a una guida del libro di pregio contemporaneo, «Accademie e Biblioteche d’Italia» 36 (1968), n. 3, p. 139. G. ROMANELLI, Correr, Teodoro, in: Dizionario biografico degli italiani, 29, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1983, pp. 509-512. G. ROMANELLI, Il Museo Correr, Milano, Electa, 1994. S. RIZZO, Il lessico filologico degli Umanisti, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1973. V. ROSSI, La biblioteca manoscritta del senatore veneziano Iacopo Soranzo: appunti, «Il libro e la stampa», 1 (1907), pp. 3-8. V. ROSSI, La biblioteca manoscritta del senatore veneziano Jacopo Soranzo, in: Scritti di critica letteraria. Dal Rinascimento al Risorgimento, Firenze, Sansoni, 1930, pp. 251-271. 58 R. SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV. Nuove ricerche, Firenze, Sansoni, 1967. G. SCHNEIDER, Handbuch der Bibliographie, Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1926. L. SPINA, «Sempre a pro degli studiosi». La biblioteca di Emmanuele Antonio Cicogna, «Studi Veneziani», 39 n.s. (1995). G. TENNEMANN-F. LONGHENA, Manuale di storia della filosofia, 1-4, Milano, G. Silvestri, 1855. F. ZANOTTO, Descrizioni della città, in: Venezia e le sue lagune, 2/2, Venezia 1847. M. ZORZI, La circolazione del libro. Biblioteche private e pubbliche, in: Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 6, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp. 589-613. M. ZORZI, La stampa, la circolazione del libro, in: Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 8, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, pp. 801-860 M. ZORZI, La gestione del patrimonio librario, in: Venezia e l’Austria, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 265-290. 59 Indice dei nomi Andrighetti, Ottavio 41 Balbi, Giovanni 12, 23, 30, 33, 36, 45, 47 Barnaba, Ermanno 20, 30, 33 Becccuti, Francesco il Coppetta 22 Belcari, Feo 22 Bembo, Ambrogio 19 Bembo, Pietro 21, 41 Berti, Pietro 41, 42 Bettìo, Pietro 12, 30, Bianconi, Vincenzo 11 Boni, Mauro 12, 22, 26, 34, 36, 43, Bonicelli, Antonio Giovanni 32, 35, 36, 51 Bonsignori, Giovanni 42 Bravetti, Jacopo 19 Canciani Antonio 11 Canciani, Gaetano 11 Canonici, Matteo Luigi 10, 11, 23, 38, 43 Canova, Antonio 31, 49 Carlotti, Teresa 41 Celotti, Luigi 12, 19, 20, 24, 30, 44, 49 Cesare, Adolfo 9, 11-13, 15-16, 19-54 Cicogna, Emmanuele Antonio 12-26, 28, 32, 36, 42-55 Coleti, Giovanni Antonio 11 Corner, famiglia10 Correr, Teodoro 10-11, 13, 15, 18 Dalmistro, Angelo 42 D’Este, Borso 4 De Martiis, Antonio 41-42 De’ Conti, Giusto 22 De’ Medici, Cosimo 8 Della Pace, Carlo Maria 15, 43 Di Giovanni, Domenico 22 Francesconi, Daniele 12, 25-26 Gamba, Bartolomeo 21, 45-46 Gelli Giovan Battista 22 Gradenigo, Giuseppe 15, 19-21, 29, 34, 48 Grimani, Domenico 4 Licini della Fava, Giovanbattista 12, 15, 21-22, 30-31, 40, 46 Manni, Domenico Maria 19 Marcello, Alessandro 41 Marcello, Girolamo 41 Melchiori, Francesco 11 Melzi, Gaetano 12, 15, 25, 32-33, 49 Mittarelli, Giovanni Benedetto 9 Mocenigo famiglia12, 41-42 Morandini, Morando 17 Morelli, Iacopo 12, 20, 23, 30, 49 Nicoletti, Giuseppe 18 Pagani, Gioacchino 18-19 Paitoni, Giovanni Maria 22, 42 Petrarca, Francesco 3, 8, 26, 34 Pinali, Gaetano 12, 26 Pindemonte, Ippolito 25, 49 Pisani famiglia12, 32-36, 50 Rossi, Vittorio 9-10, 38, 48 Saldenus, Guilielmus 5 Salvi, Carlo 12, 15, 25, 32, 42, 49 Salviati, Lionardo 29 Salvini, Anton Maria 42 Sanudo, Marino 13 Scapin, Carlo 44 Scapin, Giuseppe 44 Schiaffini, Alfredo 5 Soranzo, Iacopo 5, 9-11, 38 60 Stella, Isidoro 47 Superantii, Jacobi 11 Tassoni, Alessandro 29 Tomitano, Giulio Bernardino 28-29, 32 Torres, Antonio 12, 31 Valentinelli, Giuseppe 39-40 Vanzetti, Lorenzo 12, 15, 21 Verga, Giovanni 6 Wrachien, Trifone 44 Zanchi, Girolamo 9 Zeno, Apostolo 10, 22, Zeno, Pietro Caterino 22 Zeno, Sebastiano 28 Zon, Andrea 41 61
Scarica