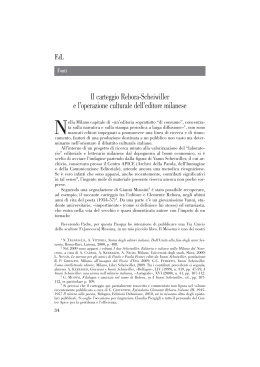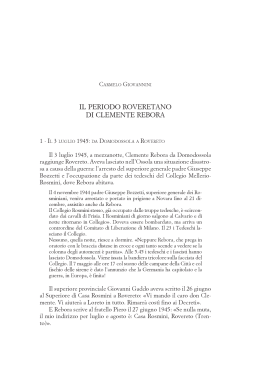INTORNO ALL’ULTIMO REBORA La percezione collettanea dell’ultimo Rebora fissa e significa l’aspetto comune all’interno di uno sguardo plurimo sui Canti dell’ infermità, però dicendo il senso di una prospettiva in cui si tiene conto, analizzando le liriche religiose composte negli ultimi anni, di elementi che ovviamente concorrono a creare un collante tra diversi approcci, prospettiva soprattutto capace d’impostare una focalizzazione che pare voler tornare al presupposto principale: “dai vertici esatti di luce”, per dirla con un verso di Paolo Volponi (Il cuore dei due fiumi, ne Le Porte dell’Appennino), di una visione prospettica rivolta alle cose, dal senso del viaggio che, nel suo isolamento, la lettura reboriana impone, da quella necessaria commistione di mobilità nell’immobilità, di vibrazioni, di movimento continuo, perché bloccato nel suo sviluppo da una strutturazione visiva dentro cui, immobili, cioè eterni, nel movimento, si vedono gli alberi, le emergenze naturali, il saliscendi dei moti percettivi. Questo pare essere alla base di quanto si può cogliere per L’ultimo Rebora 1954-1957 (Venezia, Marsilio 2008), volume a più mani a cura di Giuseppe Colangelo e Gualtiero De Santi. Un ultimo Rebora, quello dei Canti dell’ infermità appunto, che però s’imposta sul primo dei Frammenti lirici e richiama in qualche modo l’analisi già attuata da Pier Vincenzo Mengaldo, per il quale lo stile e il suo peculiare espressionismo, violentemente carico di quella forza deformante con cui il linguaggio viene aggredito, tendono a sollecitare il linguaggio stesso ad attivarsi. Dunque il verbo porta alla rappresentazione dell’azione, invece che alla descrizione. Mengaldo aveva espressamente parlato di “verbi intransitivi fatti transitivi e causativi” (Poeti italiani del Novecento, Mondadori, 2009) e di un conseguente linguaggio sempre “come sovradeterminato per inflazione”. All’interno del suo saggio, L’itinerario mistico di Clemente Rebora, Gualtiero De Santi intende lo spazio del divino laddove, in Rebora, il circostante della naturalità e l’atto metafisico possano fondersi in una sorta d’intersecazione sia esterna a noi, dunque forse collocata nella natura, ma anche insita al nostro interno, nell’animo. E questo, ad esclusione di un luogo esclusivamente metafisico, in uno spazio contemporaneamente dentro e fuori dell’uomo, tanto da impostare una sorta di circuito: per cui nei Canti dell’ infermità è fulminea la soluzione, dentro cioè quel circuito ciclico tra chiarezza interiore e musicalità, soluzione che prevede lo scorciarsi dei finali e il loro sospendersi. Laddove le immagini, benché smaglianti, erano ancora in corso di rifinitura e conclusione, è nei Frammenti lirici che De Santi vede, con Rebora, nel pioppo e nel salice, nello slancio figurale di questi due alberi, il senso, quel senso che dà conclusione alle prime poesie di Rebora e valore religioso all’ultima produzione. La cima del frassino, il vibrìo delle foglie del pioppo, ogni momento del semplice vegetale, si caricano di un valore universale, si assolutizzano di un significato ben preciso, la conciliazione tra immanente e trascendente, e divengono quindi depositari significanti di un significato comune, che è la conciliazione degli opposti. La cima del frassino, che intende “la vicenda del vento”, diviene la rappresentazione della parola che “afferma / il tendere massimo al cielo: / richiama così la vetta dell’anima”. Capovolgendo l’ordine, la parola, dicendo “cima del frassino”, si fa cima del frassino e allora può comunicare (“e in fine sempre afferma”) la necessità di una tensione continua verso il cielo richiamando, così, “le vette dell’anima”: quel picco verso cui s’eleva il commovimento delle ragioni interne, quelle che rispondono al sentimento, all’etica e alla morale. Non troppo dissimilmente il pioppo che, severo, è attraversato dal vento, “Vibra nel vento con tutte le sue foglie”, coinvolge l’anima e però allaccia quanto c’è di più vero, sepolto negli abissi delle nostre fondamenta, “in rami per fronde”, a quant’altro esiste di più vero: al cielo (“tutte al ciel tese con raccolte cime”) – l’altro che sta al lato opposto, noi separati dalla paura terrestre dell’immanentissima vita di un tronco. Il trasporto, ci dice il critico, è verso la leggerezza, detta dalla scrittura dove giace l’imprendibile che diventa quindi “immanente alla scrittura”, rivelando nel visibile alcunché d’invisibile… e questo ha valore fino a che “l’eterno giunga a palesarsi”. In questa attesa avviene l’improvvisa “apertura di senso”: se “la poesia è ascesi, possibilità di elevazione”, ch’essa celebri l’albero è necessario: dal sottosuolo ai vertici ogni albero è dunque metafora di un percorso mistico. Nell’intendimento del significato di percorso si palesa il riaggancio con lo sguardo di Maria Lenti: non già nello spazio aperto di Rebora, quanto in quello chiuso. La poesia si rivela strumento di ricerca della verità, della conquista di un senso del vivere e della vita in generale: “dall’abisso”, con “un sentire” verso sé, nel senso di un ritorno verso l’inizio di un allontanamento verso l’alto, la metaforica luce. Maria Lenti intende “viaggio nel viaggio”: viaggio individuale verso la fine della vita terrena che include quello spirituale verso l’inizio di un’eterna era: vincendo il “non essere”; un viaggio mondocielo che parte da un viaggio (dentro il mondo) – dal “rischio terribile del perdersi, del non essere” - verso la luce di cui è accesa la stanza del poeta… con e verso la poesia che “al ciel sia vita, mentre quaggiù è sol arte” – e a Dio. Il tema d’indagine di De Santi è la metafora dell’albero; quello della Lenti è il viaggio nel viaggio, mentre Donatella Marchi indica la non convenzionalità della punteggiatura reboriana, dal duplice valore: interpunzione come preghiera che non scandisce e non regola, bensì spalanca orizzonti interpretativi e conferisce originalità alla versificazione del nostro. Ora, il punto non divide: collega due versi, mentre la virgola non indica una breve pausa: è posta prima della congiunzione “e” o a fine verso, oppure viene omessa. Non c’è più l’uso ortodosso della punteggiatura, bensì essa è funzionale a “impercettibili e sotterranei mutamenti del sentimento”. Allo stesso modo, i due punti sollevano le barriere del sangue versato ne Il torchio e sono funzionali a vedere la pagina /sindone. Il libro, che si apre con l’ultimo intervento critico di Mario Luzi, si sviluppa intessendosene, là dov’egli definisce la poesia di Rebora una preghiera addolorata, una poesia religiosa che propone un senso della consolazione a sua volta immerso, per usare le parole stesse di Luzi, in quello di Cristo. Dunque, poesia sacra che punta alla conversione del sentimento del dolore e in questo ammette l’incontro tra preghiera, supplica, implorazione e ricerca di consolazione. Luzi indica l’assenza, nella lirica reboriana, di ogni trionfalismo e sottolinea la coincidenza tra conversione del poeta e conseguente vocazione sacerdotale. A naturale seguito di questo, Franco Lanza, nel suo testo su Clemente Rebora e la profezia, pare tenerne conto in primo grado, tanto che, parlando di un percorso alla conversione del 1929, specifica come tale elevata esperienza abbia coinvolto l’intera personalità del poeta. E s’intende ora il senso del messaggio profetico cui fa riferimento Lanza, laddove esso annunci la possibilità di una rigenerazione spirituale per via di un programma d’amore. Se Luzi avvicina la poesia del nostro a cert’altra dei primi decenni del Novecento, è vero che in quel periodo il problema centrale di tanta indagine, soprattutto per via degli influssi metafisici europei, è stata la visione di un mondo in attesa di un evento rigeneratore e Lanza ricorda, della buona novella nuovo testamentaria, com’essa racconti dell’uomo a cui Dio ha donato i mezzi per risorgere dallo sfacelo della propria caduta; però a sua volta intersecandosi, non dimenticandone dunque la magistrale lezione vichiana, con la ciclicità della visione storica di quest’ultimo: per il quale la poesia è il “sentimento religioso che si attua negli istituti civili”. L’immagine vichiana dei giganti osservanti il cielo, i suoi moti satellitari e il volo degli uccelli richiama alla memoria diversi tratti della percezione volponiana del rapporto tra mondo e volta celeste, dove il transitare di meteori desta nell’uomo l’idea di un congegno meccanico alla base della creazione del pianeta terra e della razza umana, delle cui ossature paiono udirsi mille rumori improvvisi. La profezia cui si accennava chiama in causa la crescita in verticale della partecipazione spirituale all’ indagine di una realtà che resta, invece, nell’ orizzontalità della propria immanenza e in questo itinerario ascendente prende corpo l’esperienza della conversione, a cui seguono l’idea, appunto, di profezia di un mondo senza messaggio cristiano e la possibilità di salvezza metaforica dal diluvio tramite la bontà del cuore. Ancora ed infine ad incontrare, qui, la lettura di Attilio Bettinzoli di poesia come riscatto dall’abisso per cui, mettendo a fuoco le due edizioni dei Canti dell’infermità, quella in opuscolo nel 1956 e l’edizione ampliata del 1957, emerge come, nella seconda edizione s’imponga un “nucleo tematico nuovo”, con le immagini simboliche della condizione di infermo e l’idea di poesia che riscatti il dramma della malattia equivalendo il suo patire con il tema di un’ Imitatio Christi. Aggiunge Giuseppe Colangelo che il patimento è dato dalla consapevolezza che la poesia, contrariamente a quanto si sarebbe voluto, non svolge alcuna azione morale sugli altri. Giovanni Terzanelli Pubblicato in “Effigies”, quaderno N.2 2011
Scaricare