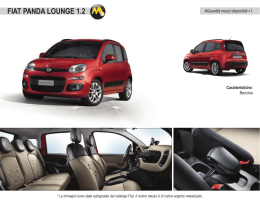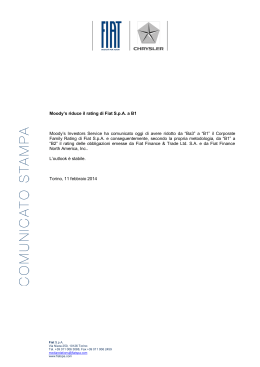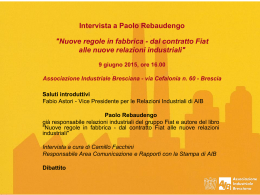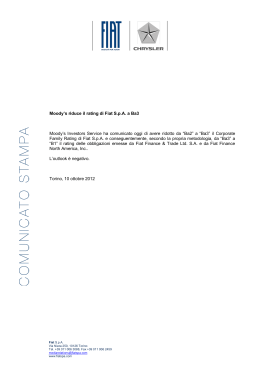La finanziarizzazione dell’impresa e la deriva del lavoro in Italia1 Angelo Salento (Università del Salento) Giovanni Masino (Università di Ferrara) VERSIONE PROVVISORIA / DRAFT 1. Introduzione La tendenza dei soggetti economici a indirizzarsi verso l’accumulazione finanziaria è certamente una delle cause - se non la causa - della bolla speculativa che ha portato alla crisi finanziaria del 2007-2008. L’enorme espansione dei valori finanziari a livello planetario è giunta infine a un esito di conclamata insostenibilità (salvo poi manifestare una straordinaria resilienza, peraltro prevedibile). Ma la finanziarizzazione dell’economia ha anche un rapporto in un certo senso più “profondo” con la crisi: non con la crisi finanziaria in senso stretto, ma con la strisciante tendenza recessiva di lungo termine delle economie occidentali, ossia con la tendenza al calo dei profitti manifestatasi dalla fine degli anni Settanta (e anche prima negli Stati Uniti). Come insegna la letteratura sull’economiamondo (Arrighi 2007), è una sorta di costante del capitalismo quella di assumere una torsione finanziaria quando le attività produttive manifestano una caduta del saggio di profitto. Il processo di finanziarizzazione che oggi presenta conseguenze estreme nasce in effetti alla fine degli anni Settanta. Come ha mostrato la sociologa statunitense Greta Krippner (2011), quando negli Stati Uniti i profitti hanno smesso di crescere, la reazione dei policymakers è stata non la programmazione di un piano di distribuzione sostenibile della ricchezza, ma la liberalizzazione del mercato del credito; una reazione che ha portato non già - come forse qualcuno si aspettava - a un effetto di disciplinamento dei consumi, ma all’esito inverso, cioè a una crescita esponenziale dell’accesso al credito, e quindi a una crescita artificiosa quanto vertiginosa degli asset finanziari. Questa sorta di “keynesismo privato” ha permesso di evitare, o almeno di procrastinare, l’inasprimento di conflitti distributivi; ma ha innescato una divaricazione fra “economia reale” e mercato dei prodotti finanziari. La produzione di profitto attraverso canali propriamente finanziari è diventata quindi, progressivamente, la tendenza dominante; e dominante è divenuta la forza degli attori della finanza internazionale. Il baricentro dell’economia mondiale si è venuto spostando dalla produzione e dal commercio di beni, all’investimento - ben più redditizio - in prodotti finanziari. È su questo sfondo che si colloca il processo solitamente definito finanziarizzazione dell’impresa, ossia la tendenza delle imprese non finanziarie ad assumere canoni di accumulazione finance-oriented. Nei contesti anglosassoni questo fenomeno è indagato ormai da molti anni: intorno al 2000 è diventato uno degli argomenti più dibattuti da economisti e sociologi soprattutto di ispirazione neo-marxista; ma anche in seno alla new economic sociology. Il contributo più citato è probabilmente quello di Neil Fligstein, che sulla questione è tornato più volte [1990; 2001], concettualizzando la finanziarizzazione dell’impresa come una serie di trasformazione delle concezioni di controllo, fra gli anni Cinquanta e il nuovo Questo paper riproduce in parte, nel par. 3, il testo di un articolo pubblicato su Rassegna Italiana di Sociologia (Salento e Masino 2012); e, nei parr. 2 e 4, il testo di un articolo di Angelo Salento attualmente sottoposto a peer review. 1 1 secolo: da una concezione del controllo d’impresa su basi di vendite e marketing, a una finanziaria, a una specificamente orientata alla massimizzazione del valore per l’azionista. In Italia quest’argomento è rimasto invece, per lungo tempo, sostanzialmente trascurato, con la notevole eccezione di Luciano Gallino, che nel 2005 ha indirizzato la questione al pubblico italiano - è proprio il lavoro di Gallino che ce ne ha fatto cogliere il rilievo - senza purtroppo elaborarne una declinazione specificamente italiana. La riflessione che proponiamo si pone proprio quest’ambizioso obiettivo: provare a comprendere se, e perché, un processo di finanziarizzazione delle imprese abbia avuto luogo anche in Italia. E inoltre provare a capire se questa tendenza all’orientamento finanziario dell’accumulazione possa essere assunta come una chiave per la comprensione delle trasformazioni della regolazione e dell’organizzazione del lavoro, che sinora sono state rubricate prevalentemente con l’etichetta di postfordismo (oggi forse caduta un po’ in disuso, e pour cause, ma senza che siano state elaborate concettualizzazioni alternative). In quel che segue, quindi, ci porremo distintamente questi due interrogativi. 2. Il capitalismo italiano e l’impresa finance-oriented La prima questione: si può ammettere che siano penetrate in Italia concezioni del controllo d’impresa di provenienza anglosassone? E come lo si può spiegare? Secondo uno schema esplicativo molto diffuso nella letteratura internazionale sulla finanziarizzazione, la tendenza alla massimizzazione del valore per l’azionista - ossia appunto il pattern di controllo finance-oriented - è connessa alla forza degli investitori istituzionali, che a sua volta si manifesta soprattutto in contesti connotati da assetti proprietari a forte dispersione: è in quei contesti che si può diffondere una tendenza all’accumulazione finanziaria, che si fonda su manovre di breve periodo. È per questo motivo che gli studi sugli assetti proprietari e sulla corporate governance escludono a priori che un sistema imprenditoriale come quello italiano, controllato da nuclei ristretti e tendenzialmente stabili, possa essere coinvolto a pieno titolo nei processi di finanziarizzazione: mantenendo per supposto che le modalità del governo d’impresa siano univocamente connesse alla struttura degli assetti proprietari, si ritiene che le modalità di controllo delle grandi imprese italiane non manifestino segni di trasformazione, concludendo che in Italia si assista a un radicale immobilismo (Culpepper 2007, 791); che non vi sia alcuna sostanziale evoluzione di un capitalismo manageriale (Pagano e Trento 2002); che, in luogo dei problemi di gestione del rapporto di agenzia fra shareholders e management (tipici delle imprese finance-oriented), continui a porsi il problema dei rapporti fra azionisti di controllo e minoranze azionarie (Melis 2000, 354). Al rigido sillogismo alla base di queste analisi si associa talvolta il richiamo alla teorica dei modelli di capitalismo, che amplifica il rischio di sottovalutare, da un lato, il dinamismo endogeno di ciascun contesto e, dall’altro, i processi di isomorfismo. In alternativa a questo schema semplificato - la cui validità, come vedremo, è negata dall’evidenza - proponiamo un’analisi sociologica, costruita su uno schema esplicativo di possibilità oggettiva (Weber 1906), prendendo in considerazione diverse dimensioni della regolazione dell’agire economico: quella istituzionale-normativa, quella culturale-simbolica, quella organizzativa-gestionale. È un approccio analogo a quello utilizzato, in altri contesti, dalla sociologia dell’organizzazione (cfr. Powell e DiMaggio 1983), dalla new economic sociology (cfr. Fligstein 1990; 2001) e dalla sociologia storica (cfr. Krippner 2005; 2011). La nostra proposta, quindi, è di concepire il controllo d’impresa finance-oriented non come un canone meccanicamente associato a una certa configurazione di interessi, ma come una concezione del controllo che mantiene il “baricentro” nel valore finanziario dell’impresa, 2 dispiegandosi attraverso un ventaglio di modalità d’azione vasto e variabile di caso in caso. Ci pare possibile mostrare come questa concezione del controllo in Italia si sia diffusa non in virtù di una ricomposizione degli assetti proprietari, ma attraverso un quadro di trasformazioni che coinvolge sia aspetti di ordine giuridico e politico, sia processi di autorappresentazione e di costruzione di visioni del mondo autoreferenziali (le concezioni del controllo, appunto) elaborate nella cultura manageriale. Proveremo di seguito un’esposizione sintetica di questo quadro analitico. 2.1. La dimensione istituzionale e normativa Dall’inizio del decennio Ottanta, la regolazione giuridica dell’economia italiana si è venuta sintonizzando con uno scenario normativo segnato, su scala transnazionale, dalle «straripanti energie del breve termine» (Ferrarese 2002, 11), dalle istanze di un’accumulazione fondata su transazioni istantanee, integrando il contesto italiano in quella sfera di interazione transnazionale che, con Bourdieu (2000, 275), si può definire il campo economico mondiale. Occorre considerare almeno tre ambiti di questa trasformazione: l’apertura dei mercati finanziari, le privatizzazioni di imprese pubbliche, la deregolazione dei rapporti e del mercato del lavoro. 2.1.1. L’apertura (o “democratizzazione”) dei mercati finanziari Fra il 1980 e il 2000, in Italia si è sviluppato un vasto programma di riforma del mercato dei capitali (v. Ciocca 2000; Costi 2010): un ciclo di interventi pensato come un programma di democratizzazione del mercato dei capitali, che – constatata la “minorità delle minoranze azionarie” e il conseguente immobilismo imprenditoriale – intendeva innescare un processo di rigenerazione degli assetti proprietari delle grandi imprese in Italia. Iniziato con la Legge n. 77 del 1983 - primo ordinamento generale del mercato mobiliare in Italia - il processo ha accelerato negli anni Novanta. Vanno menzionati la “Legge SIM” (n. 1 del 1991), che attiva il processo di centralizzazione del mercato borsistico italiano, con la chiusura dei mercati locali, la concentrazione degli scambi nella Borsa e l’adozione di un sistema telematico di negoziazione; e il D.Lgs. n. 415 del 1996, che recepisce la Direttiva del 1993 sui servizi di investimento (ISD) per l’integrazione del mercato finanziario europeo. I passi fondamentali, però, arrivano dopo Tangentopoli, con il Governo Prodi. Al 1998 risale la privatizzazione della Borsa, con la nascita di Borsa Italiana s.p.a., che acquista anche il mercato dei futures creato nel 1991 (MIF). La “Riforma Draghi” (T.U. n. 58 del 1998) è il pilastro normativo della nuova stagione: porta a compimento un ciclo di trasformazioni normative di scala europea nel segno di una concezione privatistica dei mercati e delle strutture di supporto, incardinata nei principi di «imprenditorialità, concorrenza, apertura internazionale, efficienza, stabilità, trasparenza» (Ciocca 2000, 119 s.). Così come in altri Paesi (v. Cioffi e Höpner 2006), l’integrazione dei mercati dei capitali e di potenziamento del mercato finanziario italiano è stata promossa in particolare da forze politiche di centro-sinistra, interessate a indebolire le elite economiche consolidate (in Italia il cosiddetto salotto buono della finanza) e ad accreditarsi come coalizioni politiche “modernizzatici”. Ma la peculiarità del caso italiano è che l’offensiva contro l’establishment finanziario non ha avuto il successo che i suoi promotori speravano. Probabilmente si sono sottovalutati il livello reale di concentrazione della proprietà azionaria e quindi le doti di resistenza di coalizioni ben consolidate (v. Rossi 2003, 36); e poi, negli anni 2000, è arrivata la stagione del governo di un imprenditore oligopolista. Tuttavia, se il ciclo di riforme degli anni Novanta non ha scalfito il potere delle coalizioni dominanti del capitalismo italiano, non per questo si può affermare che sia rimasto senza 3 effetti. La resilienza dei blockholders e la continuità delle proprietà azionarie familiari (Panunzi et al. 2006) non devono far pensare – come si sostiene invece nella letteratura su corporate governance e assetti proprietari (v., ad es., Aganin e Volpin 2005; Bianchi e Bianco 2008; Culpepper 2007) – che il contesto imprenditorial-finanziario italiano sia rimasto ancorato ai “tradizionali” schemi di controllo e governo dell’impresa. Le trasformazioni normative, in realtà, hanno messo le compagini dominanti del capitalismo italiano – quelle stesse che non sono riuscite a deporre – in condizione di operare in un quadro regolativo accordato a una dimensione transnazionale, largamente assimilato a quello anglosassone, promuovendo una concezione dell’impresa e prassi gestionali orientate alla priorità del valore finanziario. Va aggiunto che, sul piano della percezione sociale, un quadro di riforme presentato come un programma di europeizzazione, modernizzazione, democratizzazione (con i suoi corollari di accessibilità degli investimenti finanziari, di trasparenza, di efficienza dei mercati) ha prodotto in Italia un clima di consenso rispetto alla crescita del rilievo della dimensione finanziaria dell’economia e alla centralità del valore azionario delle imprese (v. Frank 2002, 103). 2.1.2. Le privatizzazioni Giustificate come pilastro della disciplina di bilancio e di stabilità monetaria imposta dalla sottoscrizione del Trattato di Maastricht, le privatizzazioni sono state un tassello essenziale del programma di rafforzamento del mercato finanziario in Italia, pienamente in linea con lo spirito del Testo Unico della Finanza: «le operazioni di privatizzazione che hanno smantellato il sistema delle partecipazioni statali […] – racconta Mario Draghi, allora direttore generale del Tesoro – si proponevano specificamente fra gli obiettivi quello di contribuire a una crescita del mercato azionario che va oltre i meri aspetti dimensionali» (Draghi 2008, 78). «Il fenomeno delle privatizzazioni – aggiunge Paolo Scaroni, amministratore delegato di Eni – ha rivitalizzato la Borsa ed era l’unica possibilità per rilanciarla. […] Banche, autostrade, telecomunicazioni erano pubbliche e rappresentavano gran parte delle imprese italiane con fatturati di un certo rilievo, determinando inevitabilmente una Borsa asfittica. L’unico modo per uscirne erano le privatizzazioni» (Scaroni 2008, 162 s.). La massa di capitali che questo processo ha immesso nel mercato finanziario è enorme. A fine 2006, 41 società quotate su 290 (per un valore pari a circa il 60% della capitalizzazione di Borsa) erano società privatizzate (Barucci e Pierobon, 2007, 607), e il rapporto fra capitalizzazione di Borsa e Prodotto Interno Lordo passa, fra il 1990 e il 2006, dal 13,8% al 52,8% (Borsa Italiana 2008, 3). Non meno rilevante è l’impatto simbolico delle privatizzazioni, che aprono possibilità di alfabetizzazione finanziaria per porzioni ampie della popolazione e generalizzano un habitat finanziario per le attività economiche in Italia. Su queste potenzialità del processo di privatizzazione facevano affidamento i promotori italiani dell’orientamento allo shareholder value, pienamente consapevoli della dimensione eminentemente politica del processo di finanziarizzazione: […] il mercato mobiliare si pone sia come strumento sia come obiettivo delle privatizzazioni. Un efficace programma di privatizzazione può decollare solo disponendo di tale canale di collegamento; e, d’altro lato, il processo di privatizzazione può rendere operative alternative di finanziamento e di investimento per un numero sempre più vasto di operatori economici e di risparmiatori. La diffusione della cultura dell’impresa esplica effetti di tipo anche politico importanti: cade la distinzione netta tra proprietari e dipendenti e si attenua l’atteggiamento “anti enterprise” di numerosi settori sociali (Guatri e Massari 1992, XXV). 4 Aver innescato un legame fra il capitalismo finanziario e il corpo sociale è probabilmente uno degli effetti più rilevanti della stagione delle privatizzazioni. 2.1.3. La liquefazione del lavoro Anche la trasformazione della regolazione giuridica del mercato del lavoro e del rapporto di lavoro è un elemento essenziale del processo di riorientamento del controllo d’impresa. Se l’impresa può ricomporre agevolmente i propri assetti produttivi e la gestione dei costi in vista di obiettivi di ordine finanziario, ciò si deve alla destrutturazione del rapporto di “appartenenza” dei lavoratori all’impresa: un processo iniziato in Italia, come in altri contesti europei, nei primi anni Ottanta. Il superamento della disciplina del lavoro fondata su una logica di status (Streeck 1988) ha proceduto sia attraverso la ricomposizione delle relazioni industriali, sia attraverso la riformulazione della disciplina del rapporto di lavoro. Sul piano delle relazioni industriali, la sconfitta del movimento operaio a Mirafiori, nel 1980, ha segnato non soltanto un abbattimento drastico del contropotere sindacale, ma anche l’inizio di una graduale riacquisizione di egemonia nei confronti del corpo manageriale da parte della coalizione di controllo2. Rafforzata nel corso degli anni Ottanta dall’egemonia del neo-riformismo (Favilli 2009), la ridefinizione degli equilibri negoziali è stata definitivamente consacrata dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993 che ha optato per una politica dei redditi deflattiva e al tempo stesso ha delineato la funzionalizzazione della regolazione del lavoro agli obiettivi di competitività delle imprese. La flessibilità è individuata come criterio fondamentale per la costruzione di nuove regole sulle politiche del lavoro e sui regimi d’orario, nonché come fondamento dell’introduzione del lavoro interinale. Un’attenzione particolare viene dedicata all’apertura delle imprese al mercato finanziario; e anche per la gestione dei servizi pubblici si manifesta «l’esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla redditività del capitale investito e che non limiti lo sviluppo degli investimenti». Da quel momento in poi, la subordinazione delle istanze dei lavoratori alle esigenze di competitività delle imprese si è venuta accentuando; sino all’esplicita e radicale messa in discussione dell’accettabilità di una contrattazione di primo livello su scala nazionale (ratificata di recente dall’art. 8, L. n. 148 del 2011, cosiddetta manovra-bis). Sul piano della regolazione del rapporto di lavoro, sin dalla seconda metà degli anni Ottanta, prima la produzione dottrinale e giurisprudenziale e poi ripetuti interventi legislativi hanno consentito un’inarrestata “fuga dalla subordinazione”, intesa come graduale liberazione dell’impresa dai vincoli e dai costi propri del lavoro subordinato. La concezione stessa dell’impresa adottata nella disciplina giuslavoristica si è allontanata da una concezione di marca sociologica – nella quale l’impresa è un contesto connotato da un’asimmetria nella distribuzione del potere – e si è approssimata a una concezione neocontrattualista, in base alla quale l’impresa è considerata come centro di imputazione di rapporti contrattuali (nexus of contracts). La regolamentazione del lavoro che è venuta emergendo – portata a compimento con l’intervento “riformatore” del 2003 (L. n. 30 e D.Lgs. n. 276) – ha dato corpo ai requisiti essenziali dell’accumulazione finanziaria: la “liquidità” del lavoro (con la frammentazione delle tipologie contrattuali) e la scomponibilità del processo produttivo (con la liberalizzazione degli appalti di manodopera e delle cessioni di ramo d’impresa): elementi «La svolta – racconta Romiti – fu concordata tra la proprietà e il management, ma a farla non poteva essere la proprietà, ossia gli Agnelli come rappresentanti della proprietà» (Romiti 1988, 217): fu quindi l’occasione per ricostruire l’“alleanza” fra proprietà e management nel segno della promozione degli interessi degli azionisti. Se si accetta la tipizzazione elaborata da Gourevitch e Shinn (2005) in relazione ad altri contesti, si può affermare che il “gioco” delle relazioni industriali viene riportato sotto il controllo ferreo della proprietà: la quale riesce, facendo leva su alcuni settori del management, a piegare la resistenza operaia. 2 5 fondamentali, appunto, per una continua aggiustabilità delle risorse (anche umane) agli obiettivi di massimizzazione della redditività degli investimenti (v. Salento e Masino 2012). 2.2. La cultura del valore (per l’azionista) L’aspetto culturale dei processi di finanziarizzazione – sottovalutato nella letteratura sulla corporate governance e il controllo d’impresa in Italia – è pienamente colto da molte analisi di ispirazione neo-marxista e post-strutturalista che, dagli anni Novanta, hanno insistito sulla dimensione simbolica della transizione neo-liberale3 . L’idea basilare di queste letture è che per comprendere le trasformazioni del capitalismo si debbano osservare le trasformazioni delle sue auto-descrizioni. Nulla c’è di più performativo – avverte Bourdieu – della letteratura manageriale: «La teoria del management, letteratura di business school per business school, svolge una funzione del tutto analoga a quella degli scritti dei giuristi europei del XVI e XVII secolo, che contribuisce a fare lo Stato nell’apparenza di descriverlo: concepita a uso dei manager attuali o potenziali, essa oscilla continuamente fra il descrittivo e il normativo» (Bourdieu 2000, 245). Analogamente, il concetto di cultural cirtuit of capital proposto da Thrift esprime «il collegamento di una serie di istituzioni per produrre e diffondere il sapere manageriale [business knowledge]. Questo circuito sorge dalla convergenza di tre istituzioni in particolare – gli enti di consulenza manageriale, i guru del management e specialmente le business schools – il tutto immerso nello sciabordio dei media, che costituisce di per sé una parte significativa del circuito» (2005, 95). In effetti, non si comprende la penetrazione delle pratiche di gestione finance-oriented in Italia se non si considera la diffusione di alcune idee relative al modo di intendere la comunicazione, la contabilità e il controllo di gestione dell’impresa: idee dapprima elaborate e diffuse in ambito consulenziale e accademico; poi promosse da atti di regolamentazione e di autoregolamentazione. In Italia, il processo di standardizzazione contabile iniziato dagli anni Novanta è stato preceduto da una progressiva rielaborazione del concetto di valore nella dottrina aziendalista. Si è venuto istituendo un corpus di nozioni – in larga parte importate dalla dottrina e dalla prassi anglosassoni – che è divenuto il riferimento di un processo di isomorfismo culturale (Powell e DiMaggio 1983, 147-60) per le imprese italiane. Un processo del tutto analogo a quello osservato altrove: come ricorda Fligstein, «in ogni momento dato esiste una saggezza convenzionale che guida l’azione e i manager sono soggetti a pressioni per conformarsi a essa» (1990 [2001, 6]). Con una schietta sintesi manageriale, la saggezza convenzionale corrente si può riassumere nella convinzione che il mercato finanziario sia «l’unico misuratore di valore, stabilito dall’equilibrio tra chi compra e chi vende. Il resto sono cavolate» (Marchionne 2008, 107 s.); ovvero – con le parole dell’amministratore delegato dell’ENI – nella consapevolezza che analisti e investitori finanziari «alla fine, gira e rigira, ti amano se li fai guadagnare. E ti detestano se li fai perdere. Queste sono le regole del gioco. Il resto sono soltanto chiacchiere» (Scaroni 2008, 165). La pressione della concorrenza, naturalmente, va considerata come una componente essenziale dei processi di isomorfismo (Powell e DiMaggio 1983, Fligstein 2001 [2004, 154]): è il “garante di ultima istanza” dell’adesione al tipo di controllo d’impresa dominante. «Il modo migliore per assicurare indipendenza e autonomia all’ENI – avverte ancora Scaroni Per fare soltanto qualche esempio, si possono ricordare i contributi di Boltanski e Chiapello (1999), Bourdieu (2000), Harvey (2005), Thrift (2005). 3 6 – è essere efficienti e creare valore per gli azionisti. Così il titolo sale, la società diventa costosa e acquistarne il controllo è sempre più difficile» (2008, 164). 2.2.1. Declinazioni italiane della teoria del valore per l’azionista Una concezione propriamente finanziaria dell’impresa ha preso piede, in Italia, attraverso il lavoro di una corrente di studi aziendali che ha trasferito, con gli aggiustamenti minimi indispensabili, i capisaldi teorici della dottrina anglosassone. Un ruolo preminente va riconosciuto alla scuola bocconiana che fa capo a Luigi Guatri. Esponente esemplare di una generazione di aziendalisti impegnata nel triplice ruolo di consulenza, studio e divulgazione, Guatri ha iniziato sin dagli anni Ottanta una rivisitazione del concetto di valore in uso presso la dottrina aziendalista italiana, riuscendo negli anni Novanta a consacrare la teoria del valore per l’azionista nell’ambito accademico italiano, tradizionalmente legato a un’impostazione “renana”. Allievo, come molti altri prestigiosi aziendalisti italiani, di Gino Zappa – e quindi anch’egli, in origine, erede di una concezione istituzionalista dell’impresa – Guatri ha compiuto uno straordinario sforzo di importazione di una concezione neo-contrattualista. La transizione dall’una all’altra concezione d’impresa – e quindi del lavoro contabile – è avvenuta attraverso successivi slittamenti semantici del concetto di produzione di valore: concetto che in origine fa riferimento al mandato sociale dell’impresa, ossia alla necessità di combinare i fattori della produzione in maniera economicamente utile; e che viene progressivamente riferito, a partire dagli anni Novanta, al valore per l’azionista, ossia alla produzione di rendita finanziaria. Lo snodo centrale di questo slittamento è l’idea di diffusione del valore, intesa come «il trasferimento, che può essere totale o parziale, degli incrementi di valore del capitale economico […] nei valori di mercato delle azioni. A tale passaggio sono interessate tutte le […] nozioni di valore di mercato: prezzi borsistici o comunque relativi a partite di titoli estranei al controllo; prezzi di quote di controllo sia nella versione dell’impresa unitaria sia in quella dell’impresa smembrata per parti o per “aree”» (Guatri e Massari 1992, 6). L’idea di diffusione del valore pone un’istanza di connessione costante fra l’attività dell’impresa e la platea degli investitori: rendendo la seconda sensibile alle vicende della prima, quindi la prima sensibile alle esigenze della seconda. Nell’ottica dei sostenitori dello shareholder value questa connessione giova non soltanto agli investitori “breveperiodisti”, ma anche agli imprenditori meno impazienti, ai detentori dell’intero capitale, e persino agli stakeholders non azionisti, lavoratori inclusi (ivi, xvii; 9). Come sul piano delle riforme normative, anche nel campo delle teorie dell’impresa l’idea di trasparenza è il fulcro dell’apertura dell’impresa al mercato finanziario. La disclosure nei confronti della comunità finanziaria, con la connessa esigenza di diffusione del valore, è il principio che sorregge l’adozione di strumenti di valutazione, contabilità e controllo fondati sulle variabili-chiave della concezione finanziaria dell’impresa. Inizia da qui – attraverso la ridefinizione degli strumenti di accountability – una complessiva ridefinizione degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (cfr. Ezzamel, Wilmott e Worthington 2008; Salento e Masino 2012). 2.2.2. La trasformazione della contabilità, del controllo di gestione e della valutazione delle imprese Attraverso la ristrutturazione dei canoni contabili, la disclosure nei confronti del “mercato” – promossa come principio di intelligibilità dell’operari delle imprese a beneficio degli investitori – è progressivamente trascolorata in una dinamica di gestione finance oriented: l’ottica dello shareholder è divenuta prospettiva di strutturazione dei processi gestionali e organizzativi dell’impresa. 7 Anche in Italia, soprattutto dalla seconda metà degli anni Novanta, i tradizionali indicatori di redditività, sviluppo, liquidità e solidità, sono stati progressivamente sostituiti da modelli derivati dalla teoria finanziaria, il cui riferimento essenziale è il valore del capitale economico aziendale. Il sistema di valutazione riconosce la preminenza delle attese degli azionisti, e dunque «valuta le prestazioni globali di impresa non in funzione della massimizzazione del reddito […], ma piuttosto della capacità di offrire al capitale proprio un rendimento in linea con quello assicurato dal mercato finanziario per impieghi di pari rischio» (Agliati 1999, 51). Attraverso questa ricomposizione dei canoni contabili, anche le imprese italiane hanno “introiettato” i caratteri fondanti dell’habitat global-finanziario in cui operano: hanno appreso a valutarsi, e quindi a modulare il proprio agire, secondo i parametri che orientano le scelte degli operatori finanziari. «Nel quadro descritto, la funzione dei meccanismi di controllo direzionale è quella di riprodurre la meccanica utilizzata dal mercato per effettuare le sue valutazioni [attraverso] indicatori di prestazione positivamente correlati alla dinamica del valore del capitale economico, in grado di orientare in modo conseguente i processi di gestione operativa e strategica» (ivi, 52)4. Anche in un contesto in cui è debole la penetrazione di investitori istituzionali, il mercato dei titoli è divenuto così un principio di regolazione che si impone a tutti gli attori, garantendo la conformità alle regole del contesto. L’adozione di strumenti contabili market based – fra i quali l’EVA (Economic Value Added) è forse il più sofisticato – permette «di raggiungere un rendimento del capitale investito che sia superiore al suo costo in tutti i punti del sistema, e pertanto in tutti i business e in tutte le aree geografiche che lo compongono» (Parazzini 1999, 66), rendendo così l’intera impresa responsive nei confronti degli andamenti del suo valore finanziario5. A questo proposito bisogna ancora aggiungere che anche in Italia, come nel resto d’Europa, sono stati resi vincolanti gli standard di contabilità detti International Financial Reporting Standards (IFRS), elaborati dall’International Accounting Standards Board (IASB), organismo facente capo a una fondazione privata6. La peculiarità degli standard contabili è quella di offrire una valutazione dell’impresa conforme a quel che gli investitori si aspettano di conoscere, allo scopo di «comparare la performance delle imprese in una dimensione transnazionale ed esercitare pressione sul management» (Deeg 2009, 560). Alla radice c’è l’interesse degli investitori al minor scostamento possibile fra il valore del patrimonio dell’impresa risultante dal bilancio d’esercizio e il valore corrente dell’impresa, ossia il valore del capitale investito. I principi contabili internazionali fanno ampio ricorso, perciò, Un caso esemplare è quello di Pirelli, alla fine degli anni Novanta (v. Parazzini 1999), che rende evidenti sia il nesso fra valorizzazione finanziaria del capitale e riappropriazione del controllo da parte della proprietà e dell’alta dirigenza; sia il rilievo di misure contabili orientate all’incremento del valore del capitale, a loro volta poste a fondamento della remunerazione dei manager. 4 L’EVA associa indici di controllo interno e valori di mercato, indirizzando quindi l’azione manageriale verso la produzione di un profitto inteso non come risultato netto, ma come surplus di valore azionario rispetto a quello attribuito dal mercato alla specifica classe di rischio. L’attività dell’impresa viene valutata sulla base di quel che il mercato (dei titoli) si aspetta. La remunerazione minima esigibile per gli azionisti è il costo del capitale definito dal mercato: si assume che si produca valore soltanto nella misura in cui questa remunerazione minima sia superata. (v. Anthony, Govindarajan, Macrì 2006, 211 s.). 5 La normativa è in continua evoluzione. I testi basilari sono il regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in Italia, il D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38. Nel 2009 lo IASB ha pubblicato anche gli gli International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese. Grossomodo dall’inizio della crisi economica corrente, tuttavia, le istituzioni europee (e quelle degli stati membri) guardano con diffidenza al processo di integrazione contabile, lamentando anche una scarsa indipendenza dello IASB da interessi privati. L’Organismo Italiano di Contabilità starebbe perciò elaborando «su input del mercato e delle imprese» una “exit strategy” per sottrarre alcune tipologie di bilanci dalla cornice Ias/Ifrs (Cavestri 2011). 6 8 all’idea di fair value, ossia un’idea di valore potenziale dell’impresa, stimato non soltanto sulla base del patrimonio, ma anche sulle future prevedibili dinamiche aziendali: il valore, cioè, che si può presumere attribuito all’impresa nel mercato dei titoli. Da ciò deriva peraltro – in forte discontinuità rispetto all’impostazione tradizionale dei metodi contabili italiani – l’apprezzamento dei cosiddetti intangible assets, ossia risorse di cui è possibile stimare soltanto la probabilità di futuri benefici economici 7. 2.2.3. La trasformazione degli stili proprietari Se la letteratura su assetti proprietari e controllo non dà conto dei processi di finanziarizzazione delle imprese è anche perché trascura le trasformazioni degli stili di ownership, dando per scontato che – laddove permangano rilevanti concentrazioni proprietarie (o, a fortiori, coalizioni di controllo familiari) – l’orientamento all’accumulazione finanziaria non penetri i confini dell’impresa. Per comprendere quanto rilevanti possano essere le trasformazioni della concezione d’impresa anche presso nuclei di controllo molto stabili e in principio non impazienti, ci si può riferire in Italia alle vicende di Fiat: un caso che mostra come lo stile proprietario familiare, per quanto consolidato, sia comunque destinato a mutare sulla base di processi di isomorfismo che trascendono di gran lunga la dimensione degli ambiti nazionali. Da almeno un trentennio, la storia di Fiat mostra chiaramente che la composizione familiare delle coalizioni proprietarie non è affatto ostativa alla diffusione di pattern d’azione finance-oriented. La path dependency del controllo d’impresa – o, se si preferisce, la viscosità dello stile proprietario – non può comunque produrre esiti radicalmente dismorfici o anacronistici rispetto alla configurazione del campo organizzativo: per quanto gli eredi delle grandi famiglie capitaliste possano mantenersi affezionati all’idea di essere imprenditori, operare in un campo organizzativo che istituisce l’incremento del valore azionario come mission essenziale – e quindi di fatto attribuisce all’impresa non finanziaria lo status di rentier (Stockhammer 2004) – non può non condurre, in un arco di tempo relativamente breve, a una riconfigurazione della vocazione, orientandola verso l’accumulazione finanziaria8. Innanzitutto, l’impresa torinese ha guidato la svolta degli anni Ottanta in Italia, facendosi teatro della “sfida a tre” (fra proprietà, management e lavoratori) che ha portato a un integrale ripristino della sovranità proprietaria nell’impresa. Fiat è stata, dunque, il più importante laboratorio di una “prima” finanziarizzazione (v. Fligstein 1990; 2001) che ha introdotto una concezione dell’impresa come portafoglio di investimenti, e del processo di produzione come catena del valore. Un’attenzione alle misure di rendimento del capitale e la costruzione di una business intelligence era iniziata già negli anni Settanta. Nel decennio successivo l’analisi economica e finanziaria è stata irrobustita e resa sempre più rilevante per i livelli operativi delle varie unità aziendali, incorporandola nei programmi di breve termine e nel calcolo delle retribuzioni manageriali (Volpato 2004, 358). Fra gli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, la razionalizzazione del portafoglio d’investimenti è stata La sopravvalutazione degli asset intangibili è oggi clamorosamente evidente. Il loro valore complessivo nei bilanci delle società quotate, di 138,8 miliardi nel 2005, è pari a 311 miliardi a fine 2010, rappresentando in media il 38% del patrimonio netto aziendale. Allargatasi la forbice tra la capitalizzazione di Borsa – ridimensionata dalla crisi – e il patrimonio netto (sostenuto anche dagli attivi immateriali), si pone oggi l’esigenza di un drastico abbattimento in conto economico (impairment) degli intangibles (v., per un esempio, Sabbatini 2011). 7 Va aggiunto che il succedersi delle generazioni e la moltiplicazione degli eredi, comporta una frammentazione delle vocazioni e delle aspirazioni. Sebbene possa apparire paradossale, un azionariato familiare può essere nei fatti più “plurale” – e, al limite, “impaziente” – rispetto al controllo esercitato, ad esempio, da attori del sistema bancario. 8 9 l’obiettivo dei principali interventi organizzativi sulla configurazione d’impresa: le ristrutturazioni, il re-engineering e la fabbrica integrata (v. Lipparini e Melloni 1998). Il controllo della coalizione familiare non ha ostacolato poi la transizione a una fase di finanziarizzazione radicale. Se fino ai primi anni Novanta ha prevalso l’interesse al mantenimento del controllo, la profonda crisi del 1993 ha innescato un processo di cambiamento in direzione radicalmente finanziaria. La nomina di Paolo Fresco nel Consiglio di Amministrazione, nel 1996, ha segnato la transizione dell’impresa a una logica di shareholder value, peraltro esplicitamente declinata nella Carta dei valori (Fiat Auto S.p.A. 1997), con l’adozione di una versione “customizzata” dell’EVA, una «profonda trasformazione della cultura gestionale del personale del Gruppo» e «l’utilizzo di un sistema informativo integrato in grado di monitorare i value driver rilevanti e di configurare un tableau de bord orientato alla creazione di valore con modalità tarate su ciascuna area di business» (Volpato 2004, 361 s.). Sul piano dell’azione organizzativa, questa è stata la stagione della “modularizzazione” dell’impresa (v. Salento e Melloni 2001), con una forte tendenza all’esternalizzazione di processi produttivi legata anche a valutazioni di ordine finanziario. Il consolidamento dell’orientamento finanziario è avvenuto con la generazione di John Elkann. Molto meno legato all’industria dell’auto e alle dinamiche socio-politiche italiane, questi ha una chiara propensione alla diversificazione del portafoglio in ottica finanziaria 9; è poco occupato dall’esigenza di mantenere alla famiglia il controllo dell’impresa ed è quindi disponibile a diluizioni del capitale come pure alla ceoizzazione dell’impresa, ossia a un’ampia delega a beneficio dell’alta dirigenza. Elkann, insomma, esprime chiaramente le propensioni delle generazioni più giovani di una famiglia oramai necessariamente frammentata: propensioni legate molto meno ai destini dell’automotive che alle dinamiche di un’economia dominata dalla finanza. Sergio Marchionne, beneficiario della delega dirigenziale, è il co-protagonista (per la prima volta esposto al pubblico più dell’azionista di riferimento) della svolta radical-finanziaria dell’impresa torinese. Uomo di formazione ed esperienza prettamente finanziaria, ha una notorietà legata alla capacità di moltiplicare il valore azionario (v. Ferrante 2011, 71). Da quando si è insediato, nel 2004, ha tenuto la Fiat in una condizione di turnaround permanente, consolidando uno stile comunicativo disinvolto e assertivo, ma ricco di dichiarazioni e ricostruzioni generiche ed evocative. Fiat è in definitiva un esempio chiarissimo di impresa guidata ancora da una coalizione familiare, che mostra nondimeno segni inequivocabili di orientamento finanziario: a) uno straordinario accentramento della gestione in capo a un dirigente estraneo alla famiglia 10; b) la tendenza a trattare i problemi d’indebitamento attraverso operazioni finanziarie11; Si veda in Exor 2011 la composizione che ha assunto il portafoglio della società di investimento controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann: nella quale – pur rimanendo centrale il settore automotive, dove peraltro si è dato luogo alla separazione fra Fiat Auto e Fiat Industrial – si sono venute aggiungendo partecipazioni di controllo in grandi imprese finanziarie (come Vision Investment Management e Banca Leonardo), di servizi immobiliari (Cushman & Wakefield) e di investimento immobiliare (Almacantar). 9 Il quale per la prima volta riunisce su di sé le cariche di amministratore delegato di Fiat Gruppo, amministratore delegato di Fiat Auto, amministratore delegato di Chrysler, Chief Financial Officer di Fiat Gruppo. Sull’azzeramento del management di primo livello, v. Ruggeri 2010. 10 V. ad esempio la brillante e discussa “manovra dell'equity swap” che, tra l'aprile e il settembre 2005, consentì a Ifil-Exor di mantenere il controllo al 30,06% di Fiat anche dopo l'esercizio da parte delle banche creditrici di un “convertendo” da tre miliardi di euro [cfr. Ferrante 2011, 83-6]. 11 10 c) il perseguimento di obiettivi di addomesticamento del contropotere sindacale e di graduale liquefazione del rapporto salariale (conseguiti con la “liberazione” dell’impresa dal contratto nazionale di lavoro di categoria e la sottoscrizione di un contratto aziendale qualificato come “di primo livello”); d) la tendenza al “nomadismo” e al dumping sociale: nel caso di specie, si consideri la dismissione delle attività produttive in Italia e il trasferimento della produzione in contesti in cui è più agevole ottenere riduzioni del costo del lavoro, riduzione della resistenza sindacale, finanziamenti e agevolazioni governativi (v. Berta 2011); e) il mantenimento di una “strategia del galleggiamento”, ossia di una modalità d’azione che non si rivolge alla soluzione “strutturale” di una crisi industriale «che viene da lontano» (Volpato 2004), ma assume un’ottica di breve periodo, preoccupandosi di rinnovare negli investitori una fiducia che sarebbe ingiustificata nel medio e lungo termine. Se Fiat può mostrare i tratti distintivi di un chiaro orientamento finanziario appena velati da una retorica produttivista – ripetiamo – è perché la coalizione di controllo poco o nulla ha conservato del tradizionale “spirito di famiglia”, di quella identità che per decenni ha legato il nome della famiglia Agnelli all’industria dell’automobile e alle sorti economico-sociali e politiche dell’Italia. 3. Finanziarizzazione, organizzazione e regolazione del lavoro La seconda questione che intendiamo discutere - sulla quale possiamo rinviare più estesamente a un articolo pubblicato quest’anno (Salento e Masino 2012) - è se la trasformazione delle concezioni del controllo d’impresa si possa assumere, anche in Italia, come un principio di spiegazione delle trasformazioni della regolazione e dell’organizzazione del lavoro. Non c’è dubbio che gli studi sulle trasformazioni dell’organizzazione e del lavoro nell’impresa abbiano per lungo tempo sottovalutato il ruolo giocato dalla pressione dei mercati finanziari nelle scelte organizzative e strategiche e quindi anche - indirettamente nelle trasformazioni della regolazione del lavoro (in essa includendo, naturalmente, la dinamica delle relazioni industriali). Gli studi di strategia – da Chandler, a Porter, a Prahalad e Hamel, per non riferirsi che alle “pietre miliari” – hanno costruito la questione del posizionamento e del vantaggio competitivo dell’impresa con riferimento al mercato dei prodotti. La letteratura organizzativa si struttura a sua volta a partire dallo stesso presupposto, assumendo che l’obiettivo delle profonde trasformazioni dei contesti di produzione sia stato un guadagno di adeguatezza delle imprese alla crescente complessità del mercato dei prodotti. E nella stessa chiave la sociologia dell’organizzazione e del lavoro ha interpretato le trasformazioni del lavoro, ponendo al vertice dei propri schemi analitici anche se con molti distinguo e accenti critici - l’esigenza di flessibilità delle imprese, ossia appunto la necessità di un continuo riaggiustamento del posizionamento strategico nel mercato dei prodotti. Fuori d’Italia, l’ipotesi che la pressione dei mercati finanziari abbia a che vedere con la deriva del lavoro viene comunque sviluppata almeno dall’inizio del decennio 2000. La letteratura anglosassone (v. ad es. Lazonick e O’Sullivan 2000) - ampiamente riportata in Italia da Luciano Gallino (2005) - suggerisce che la tendenza delle imprese a rispondere alla logica sanzionatoria dei mercati finanziari possa spiegare l’abbandono dei programmi di lungo periodo; la diffusione di espedienti di natura finanziaria per assicurare l’aumento del valore azionario; la tendenza a sostituire manager tecnici con manager finanziari e a destinare cifre ingenti alla copertura di costi di agenzia; la forte diffusione di fusioni e acquisizioni; l’inasprimento della competizione e la progressiva riduzione dei profitti 11 derivanti da produzione e vendita di merci; la riduzione dei costi del lavoro e la sostituzione di costi fissi con costi variabili. Su questo quadro si può sostanzialmente convenire. Tuttavia, per valutare l’ipotesi in maniera più compiuta, abbiamo provato a declinarla sulla base di una partizione analitica più dettagliata, di matrice specificamente teorico-organizzativa. Abbiamo quindi adottato lo schema analitico proposto da Bruno Maggi (2007) che individua tre livelli analitici (dal micro al macro): le situazioni di lavoro, la configurazione dell’impresa, le relazioni fra imprese; e abbiamo provato a valutare se i mutamenti che si osservano in relazione a ciascun piano analitico siano interpretabili come esiti della tendenza delle imprese a istituirsi non più come dispositivi di razionalizzazione produttiva, ma come centri di imputazione di relazioni contrattuali che operano in vista della massimizzazione del valore del capitale investito. Su un’ipotesi così articolata abbiamo dato inizio a un programma di ricerca empirica, facendo ricorso a fonti diverse. L’analisi «di sfondo» sulle trasformazioni organizzative dell’ultimo trentennio è condotta sulla base dei casi aziendali discussi, nello stesso lasso di tempo, nel programma di ricerca L’Officina di Organizzazione: un workshop delle Università di Bologna e di Ferrara che riunisce manager di primo livello di grandi e medie imprese e ricercatori universitari, nel quale sono stati sinora discussi oltre 150 casi di trasformazione organizzativa. Un’analisi diacronica di queste esperienze restituisce i tratti fondamentali del mutamento organizzativo dell’ultimo quarto di secolo: le ristrutturazioni e la riduzione delle dimensioni aziendali, i processi di terziarizzazione, la distribuzione delle responsabilità coniugata all’accentramento del controllo, la destrutturazione del rapporto di appartenenza organica della forza-lavoro all’impresa. L’ipotesi della connessione fra questi mutamenti e le istanze di valorizzazione finanziaria del capitale è indagata poi attraverso un ciclo di interviste in profondità a manager di organizzazione di grandi imprese. Quel che interessa, naturalmente, non è soltanto né soprattutto la trasformazione del lavoro manageriale: se abbiamo scelto di intervistare manager di organizzazione è perché questi attori – operando «all’incrocio» fra le istanze di accumulazione degli shareholders e i dispositivi organizzativi, con l’incarico di costruire compatibilità fra le une e gli altri – sono testimoni essenziali per ricostruire una mappa della finanziarizzazione dell’impresa. L’analisi ha sinora restituito conferme rilevanti, che di seguito riportiamo in estrema sintesi. Tutte le testimonianze confermano, in primo luogo, che esiste una tendenza – o, piuttosto, una pressione regolativa – all’adozione di una concezione finanziaria del controllo. Quest’orientamento si impone infatti, in primo luogo, nelle modalità della comunicazione delle performance dell’impresa verso «il mercato»: la capacità di valorizzazione del capitale nel breve termine è il metro di giudizio adottato dagli analisti. Così, anche in settori nei quali fino agli anni Novanta la logica della comunicazione esterna era tipicamente industriale e intendeva trasmettere l’idea di affidabilità e di potenzialità degli investimenti in ricerca – come quello farmaceutico - si asseconda la pretesa di attivismo manageriale di breve termine, e la dialettica fra la logica industriale e quella finanziaria as- sume spesso connotati schizofrenici. Questa pressione regolativa va considerata, evidentemente, un effetto di campo (Bourdieu 2000). L’ingresso nell’arena del mercato finanziario comporta imme- diatamente un processo isomorfico (DiMaggio e Powell 1983), cioè l’adozione del frame culturale e degli stumenti di rappresenta- zione, misurazione e comparazione che strutturano l’interazione fra gli attori. Uno degli intervistati (un manager del settore petrolifero) racconta a questo proposito: Si diceva: come è possibile che abbiamo indicatori finanziari peggiori (per esempio, gli earnings per share) dei nostri concorrenti? Dobbiamo allinearci agli altri su questi aspetti che determinano il valore di borsa. Dobbiamo ridurre i costi, gli altri lo hanno fatto con fusioni e acquisizioni, noi lo facciamo con integrazioni e sinergie interne. Questo fu il mandato forte dell’AD in quegli anni. 12 La pressione del mercato finanziario esercita poi condizionamenti su tutti i livelli dell’azione organizzativa: 1) Al livello della configurazione d’impresa, la logica finanziaria del controllo sollecita l’accentramento decisionale. La logica che governa queste scelte è, ancora una volta, quella propria del campo di concorrenza entro cui si opera, ossia il «mercato unico» dei titoli: la tendenza all’accentramento – che si associa a una rinnovata centralità della figura del CEO – è il portato dell’esigenza di mantenere (e dimostrare «al mercato») una capacità di controllo utile a governare gli andamenti del valore del capitale nel breve periodo. Come dichiara uno dei manager intervistati: L’accentramento consente di pilotare con l’azienda come con un joystick. Se io la voglio orientare la gestione seguendo la borsa, se è troppo decen- trata non ci riesco. L’accentramento è collegato con la «ceoizzazione», perché il CEO deve apparire sul mercato non come colui che lancia una direttiva generale, ma come colui che agisce e fa, colui che ha in pugno l’azienda. [...] Oggi posso fare cose dal centro che tre anni fa sarebbero state impensabili. (Manager A) L’incremento dell’efficienza, quando è guidato da indicatori finance-oriented, trova nell’accentramento la sua manovra organizzativa di riferimento; alle unità periferiche restano soltanto frazioni insignificanti della discrezionalità guadagnata nel corso del tempo. 2) Il quadro regolativo dell’impresa finance-oriented include mutamenti di rilievo anche sul piano della situazione di lavoro. Innanzitutto, mutamenti macroscopici sono connessi alle opera- zioni di «dimagrimento» che le imprese hanno sostenuto per guadagnarsi «la stima del mercato», ossia una positiva valutazione di redditività degli investimenti. Si tratta chiaramente, anche in questo caso, di un processo di isomorfismo, ossia di una progressiva assimilazione reciproca delle logiche e delle pratiche in uso fra gli attori economici. Come dichiara uno degli intervistati: In questi 15 anni [dall’avvenuta privatizzazione] l’azienda è certamente dimagrita molto in termini di attività manifatturiere e industriali. Basta vedere l’andamento dell’occupazione complessiva, e si nota che il calo è di circa il 30%, in certi paesi in cui la presenza dell’azienda è particolarmente forte il personale è stato più che dimezzato. Il downsizing è robusto anche in periodi di espansione economica: talora si produce in forme «dolci» e concordate con le controparti sindacali, spesso connesso a fusioni e acquisizioni, oppure a dismissioni ed esternalizzazioni, a mutamenti delle politiche del personale, a reingegnerizzazioni dei processi di lavoro e via dicendo. In un approccio strategico orientato alla massimizzazione dell’utile degli azionisti, il rapporto di appartenenza organica della forza-lavoro all’impresa viene drasticamente superato: la vasta platea di stakeholders dell’impresa, compresa la forza- lavoro, assume un valore puramente strumentale e subordinato al perseguimento dell’obiettivo essenziale della massimizzazione del valore del capitale. Come avverte uno degli intervistati: Qualche decennio fa si parlava di persone, di impiegati, di operai. Oggi invece le risorse umane sono fattori della produzione. Oggi l’uomo è ancora ovviamente importante per certi aspetti, ma il termine risorse implica che, date certe caratteristiche, le persone sono comunque sostituibili. Il valore «intangibile» del lavoro (il significato del lavoro, l’identità professionale, il senso di appartenenza) è seriamente pregiudicato. Una complessiva messa in discussione della soggettività del lavoro riguarda sia i livelli operativi, sia le posizioni manageriali. La sottomissione dell’impresa a imperativi di valorizzazione sostanzialmente eteronomi, ossia alle regole del gioco del mercato dei titoli, priva l’impresa stessa e i suoi attori fondamentali della possibilità di essere realmente partecipi. È una condizione, questa, che non riguarda soltanto gli esecutori, ma anche il management: Nella prima fase della mia carriera – racconta uno dei testimoni – ho vissuto il processo di accentramento da manager di una divisione periferica, che diventava sempre meno autonoma. Questo toglieva a noi, manager divisionali, il «gusto» e la capacità di cambiare le cose. Se ai manager togli questo gli togli tutto, li svuoti del loro senso del mestiere. Diventano country manager ben pagati e navigatori del nulla. [...] Le aziende, prese in questo «vortice di governo», spesso orientato a soddisfare l’azionista, hanno quest’ansia del controllo, che però diffonde demotivazione. 13 Nel quadro regolativo che descriviamo, in definitiva, il lavoro diventa variabile dipendente e residuale. La logica della valorizzazione finanziaria si riverbera sull’organizzazione del lavoro, nell’officina, sulle politiche del personale e, in ultima analisi, sul modo di concepire il rapporto tra uomo e impresa; con effetti che, nelle parole dei manager intervistati, non solo non sembrano desiderabili sul piano del benessere individuale, ma neanche paiono razionali sul piano dell’efficacia industriale dell’impresa. 3) Infine, sul piano dei rapporti inter-impresa, si constata che le scelte di esternalizzazione - rappresentate ufficialmente come misure di razionalizzazione produttiva – non sono affatto estranee al processo di finanziarizzazione delle imprese. Alla base della scelta di “terziarizzare” ci sono anche esigenze connesse alla valorizzazione finanziaria del capitale: riduzione dei costi, trasformazione di costi fissi in costi variabili, guadagni di liquidità da destinarsi ad attività finanziarie. Uno dei manager intervistati - con un’esperienza pluridecennale nel settore meccanicoautomobilistico - avverte che i processi di esternalizzazione possono essere interpretati in modi diversi: Un primo modo è quello di leggerli come modi per concentrarsi sul core business, oppure per ridurre la complessità interna. Ma se la vediamo in un altro modo si può pensare che l’outsourcing serva anche per fare cassa al fine di incrementare il valore per l’azionista e per fare investimenti di genere finanziario. Queste sono due letture ben diverse, che si riferiscono alla questione: «a che tipo di azienda stiamo pensando?». Se penso all’azienda industriale che vuole essere più efficiente, flessibile, allora siamo dentro alla prima ipotesi, ma se penso a fare cassa, a fare contenti i miei azionisti eccetera, allora penso a tutt’altro tipo di impresa. 4. Conclusioni Il quadro analitico e le evidenze che abbiamo proposto suggeriscono che anche in Italia, come in altri contesti europeo-continentali, ha preso piede una concezione del controllo d’impresa che la sociologia d’oltreoceano ha rilevato da tempo nei contesti anglosassoni. La diffusione della concezione finanziaria del controllo d’impresa in un contesto come quello italiano, in cui non si è (ancora) verificata una penetrazione massiva di investitori istituzionali né una forte frammentazione della proprietà, aiuta a prendere atto che le trasformazioni del controllo d’impresa sono comprensibili, più che come conseguenze di una ricomposizione delle coalizioni proprietarie, come mutamenti di ordine politicoculturale (v. Fligstein 1990; 2001). A dispetto di ogni inferenza costruita su schemi riferiti alla concentrazione proprietaria, bisogna prendere atto che la scarsità di investitori “impazienti” non ha impedito la penetrazione in Italia di nuovi patterns di accumulazione. Sebbene i processi di riforma degli anni Ottanta e Novanta abbiano mancato l’obiettivo di ridefinire i nuclei di controllo del capitalismo italiano, hanno indotto la transizione a una modalità di gestione finanziaria dell’impresa, con implicazioni sul piano della solidità del sistema industriale e della compatibilità sociale del modo di produzione. Se queste osservazioni sono fondate, si possono proporre alcune tesi sul piano della formulazione teorica. I. La shareholder value maximization non è da considerarsi una strategia pienamente definita, tale da potersi misurare attraverso indici e indicatori (come pure qualcuno ha tentato di fare in altri contesti: ad es. Höpner 2001). Senza aderire all’idea per cui lo shareholder value è una «retorica sociale buona per tutti gli usi» (Froud et al. 2006), lo si può considerare come un orientamento che viene interpretato diversamente di contesto in contesto: come un pattern dotato di forza normativa, presente e cogente nella logica della pratica degli attori economici in quanto oggetto di una massa enorme di messaggi normativi e integrato nella 14 logica di strumenti intrinsecamente performativi, come i dispositivi di valutazione, contabilità e controllo di gestione. II. Va rifiutata l’idea che l’orientamento allo shareholder value introduca una discontinuità rispetto alle trasformazioni dell’impresa in atto sin dagli anni Ottanta (e dagli anni Settanta negli Stati Uniti). L’epoca del valore per l’azionista pare piuttosto la prosecuzione – sotto l’ombrello di un apparato regolativo e culturale rinnovato – di una stagione (la “prima” finanziarizzazione) che ha segnato la presa di distanze delle imprese dalle regole del “compromesso fordista”. È la stagione della rivendicazione – corroborata da nuovi strumenti e da una nuova temperie culturale e ideologica – della sovranità delle prerogative proprietarie. Se nel decennio Ottanta le ragioni della proprietà sono state tenute esenti dalle pretese avanzate dagli stakeholders non azionisti (innanzitutto dai lavoratori e dalla loro rappresentanza); nei due decenni successivi – stagione di conclamata sovrapproduzione – l’obiettivo delle coalizioni proprietarie è stato (ed è) quello di assicurarsi un’immunità dalle stesse congiunture dei mercati dei prodotti nei quali le imprese operano, garantendosi comunque, per via finanziaria, l’acquisizione di profitto (in quanto rendita). Il discorso dello shareholder value, in definitiva, è uno strumento di giustificazione – per dirla con Gallino (2011) – di un’incondizionata pretesa di estrazione di valore. III. Il costrutto analitico di finanziarizzazione dell’impresa non si può ridurre a una ricostruzione schematica secondo la quale la massimizzazione dello shareholder value è il portato della razionalità calcolatrice di investitori istituzionali. Soltanto un’analisi sociologica, in grado di prendere in considerazione la dimensione politica e culturale della regolazione, può dare conto di quei processi di deistituzionalizzazione del mercato che consentono la penetrazione di logiche d’azione orientate all’accumulazione finanziaria. Rifiutando schemi di spiegazione monocausali, è opportuno adottare un concetto di finanziarizzazione dell’impresa in grado di prendere in conto l’imbricazione dei corsi d’azione economica con i processi di trasformazione delle regole e dei saperi che governano o condizionano l’agire imprenditoriale. Per finanziarizzazione, dunque, non va intesa né soltanto una modalità di azione economica, né (più ampiamente) una modalità di accumulazione. Si può proporre, invece, di indicare con questo termine un vasto fascio di mutamenti della regolazione dell’azione economica12 . Nella prospettiva che abbiamo proposto, in definitiva, finanziarizzazione è un termine che individua alcuni connotati basilari di quel generalizzato ritorno al mercato – a un mercato deregolamentato e deistituzionalizzato – che viene definito anche rivoluzione neoliberale (Harvey 2005; Duménil e Lévy 2006), evidenziando – ed è questo il suo pregio – il ruolo delle logiche dell’accumulazione nelle trasformazioni dell’impresa, dell’azione organizzativa e del lavoro. IV. Per questa ragione, il costrutto di finanziarizzazione può aiutare a superare le rappresentazioni dell’ultimo trentennio come stagione di razionalizzazione produttiva. È un obiettivo rilevante, questo, se si considera che l’idea di una continua razionalizzazione produttiva delle imprese ha offerto un quadro giustificativo all’imponente deregolazione e deistituzionalizzazione del mercato che ha reso sostanzialmente ingovernabile il capitalismo contemporaneo: su queste premesse sono stati elaborati – e in Italia continuano a essere elaborati – anche i percorsi di riforma del diritto del lavoro e del mercato del lavoro, la cui missione essenziale è stata, e continua a essere, quella di adeguare la regolamentazione giuridica al quadro delle esigenze di competitività delle imprese, con una progressiva destrutturazione della tutela dei lavoratori. Le scelte fondamentali sul lavoro sono state largamente sottratte alla dimensione politica proprio assumendo che esse debbano rispondere a questa razionalità tecnica. Rendere chiara la pressione dei mercati finanziari Laddove per regolazione si intende «il modo di prodursi e di svilupparsi del processo d’azione» (Maggi 2011, 78), che prende in conto l’intenzionalità dell’azione come anche l’esistenza di norme e indicazioni, ma non si esaurisce mai in esse. 12 15 sulle dinamiche dell’azione economica, e la tendenza alla distruzione di risorse che essa implica, aiuta quindi a riaprire la via di una critica sociologica del capitalismo contemporaneo e di un’interpretazione sociologica della crisi. Bibliografia Aganin A., P. Volpin (2005), The History of Corporate Ownership in Italy, in R.K. Morck (ed.), A History of Corporate Governance around the World: Family Business Groups to Professional Managers, Chicago: University of Chicago Press: 325-66. Agliati M. (1999), Modelli contabili e modelli del valore. Dal Cash Flow all’EVA, Economia&Management, 6: 51-59. Anthony R.N., Govindarajan V., Macrì D.M. (2006), Management Control Systems, Milano: McGraw-Hill. Arrighi, G. (2007), Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-First Century, London-New York, Verso; tr. it.: Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Milano, Feltrinelli 2008. Berta G. (2011), Fiat-Chrisler e la deriva dell’Italia industriale, Bologna: il Mulino. Bianchi M., Bianco M. (2008), The evolution of ownership and control structure in Italy in the last 15 years, in atti della conferenza Corporate governance in Italia: a 10 anni dal Testo Unico della finanza, http://www.bancaditalia.it/studiricerche/convegni/atti/ corp_gov_it/session1. Boltanski L., Chiapello E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard. Bourdieu, P. (2000), Les structures sociales de l’economie, Paris, Seuil (trad. it.: Le strutture sociali dell’economia, Trieste: Asterios 2004). Cavestri L. (2011), Un piano per l’uscita dagli Ias, Il Sole 24 Ore, 25 maggio. Ciocca, P. (2000), La nuova finanza in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Torino: Bollati Boringhieri. Cioffi J.W., Höpner M. (2006), The Political Paradox of Finance Capitalism: Interests, Preferences, and Center-Left Party Politics in Corporate Governance Reform, Politics and Society, 34, 4: 463-502. Costi R. (2010), Il mercato mobiliare, Torino: Giappichelli. Culpepper P. (2007), Eppure, non si muove: Legal change, institutional stability ad Italian corporate governance, West European Politics, 30 (4): 784-802. Deeg R. (2009), The rise of internal capitalist diversity? Changing patterns of finance and corporate governance in Europe, Economy and Society, 38 (4): 552-79. Draghi M. (2008), Privatizzazioni e mercati, in Tamburini F. (2008), Storie di Borsa quotidiana, Milano: Il Sole 24 Ore: 74-101. Duménil G., Lévy D. (2006), Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, in Epstein G. (Ed.), Financialization and the World Economy, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar: 17-45. Exor (2011), Interim Report at September 30, 2011 (in: www.exor.com). Ezzamel M., Wilmott H., Worthington F. (2008), Manufacturing shareholder value: The role of accounting in organizational transformation, Accounting, Organizations and Society, 33: 107-40. Favilli P. (2009), Il riformismo e il suo rovescio, Milano: FrancoAngeli. Ferrante M. (2011), Marchionne. Rivoluzione Fiat, Milano: Mondadori. 16 Ferrarese M.R. (2002), Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna: il Mulino. Fiat Auto S.p.A. (1997), Valori e politiche del gruppo Fiat, opuscolo a diffusione aziendale, s.l. (ma Torino). Fligstein N. (1990), The Transformation of Corporate Control, Cambridge, Mass.: Harvard University Press (trad. it.: La trasformazione del controllo d’impresa, Torino: Edizioni di Comunità 2001). Fligstein N. (2001), The Architecture of Markets, Princeton: Princeton University Press (trad. it.: L’architettura dei mercati, Milano: Egea 2004). Frank T. (2002), One market under god. Extreme capitalism, economic populism and the end of economic democracy, London: Vintage. Froud J., Johal S., Leaver A., Williams K. (2006), Financialization and Strategy. Narrative and numbers, London: Routledge. Gallino, L. (2005), L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino. Gallino L. (2011), Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino: Einaudi. Gourevitch P., Shinn J. (2005), Political Power and Corporale Control: The New Global Politics of Corporate Governance, Princeton: Princeton University Press. Guatri L., Massari M. (1992), La diffusione del valore, Milano: Egea. Harvey D. (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press (trad. it.: Breve storia del neoliberismo, Milano: Il Saggiatore 2007). Höpner M. (2001), Corporate governance in transition: Ten empirical findings on shareholder value and industrial relations in Germany, Max Planck Institute for the Study of Societies Working Paper n. 5. Krippner G. (2005), The financialization of American economy, Socio-Economic Review, 3: 173-208. Krippner G. (2011), Capitalizing on crisis: The political origins of the rise of finance, Oxford: Harvard University Press. Lazonick, W. e M. O’Sullivan (2000), Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance, in «Economy and Society», 29, 1, pp. 13-35. Lipparini A., Melloni A. (1998), La re-ingegnerizzazione dei processi in Fiat Auto, in B. Maggi (a cura di), L’Officina di Organizzazione. Un osservatorio sui cambiamenti nelle imprese, Roma: Carocci: 199-215. Maggi, B. (a cura di) (2007), A mudança organizacional do trabalho e da empresa: uma avaliação do quadro de análise, in L.I. Sznelwar, F.L. Mascia (a cura di), «Cadernos de TTO», 1, p. 15-51. Maggi B. (2011), Théorie de l’agir organisationnel, in Id. (sous la dir.), Interpréter l'agir: un défi théorique. Paris: PUF: 69-96 (tr. it. in Id. [a cura di], Interpretare l’agire: una sfida teorica, Roma: Carocci 2011: 67-88). Marchionne S. (2008), A ciascuno il suo mestiere, in Tamburini F., Storie di Borsa quotidiana, Milano: Il Sole 24 Ore: 105-16. Melis A. (2000), Corporate Governance in Italy, Corporate Governance, 4: 347-55. Pagano U., Trento, U. (2002), Continuity and Change in Italian Corporate Governance: The Institutional Stability of One Variety of Capitalism, Quaderni del Dipartimento di Economia politica dell'Università di Siena, n. 366. Panunzi F., Favero C.A., Giglio S., Honorati M. (2006), The Performance of Italian Family Firms, CEPR Discussion Paper n. 5786 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=918181). Parazzini E. (1999), La misurazione del valore nel gruppo Pirelli. Il ruolo della filosofia value-based nel processo di cambiamento, Economia & Management, 6: 60-68. Powell, W. e P. DiMaggio (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality, American Sociological Review, 48: 147-160. 17 Romiti C. (1988), Questi anni alla Fiat, Milano: Rizzoli. Rossi G. (2003), Il conflitto epidemico, Milano: Adelphi. Ruggeri R. (2010), Parola di Marchionne, Milano: Brioschi. Sabbatini R. (2011), Sui bilanci l’insidia degli avviamenti, Il Sole 24 Ore, 3 dicembre. Salento A., Masino M. (2012), L’impresa della crisi. Finanziarizzazione e trasformazioni organizzative, Rassegna Italiana di Sociologia, 1: 43-65. Salento A., Melloni A., La fabbrica modulare in Fiat Auto, in B. Maggi (a cura di), Le competenze per il cambiamento organizzativo, Milano: Etas: 107-26. Scaroni P. (2008), Capitalisti senza passaporto, in F. Tamburini (2008), Storie di Borsa quotidiana, Milano: Il Sole 24 Ore: 157-69. Stockhammer E. (2004), Financialisation and the slowdown of accumulation, Cambridge Journal of Economics, 28 (5): 719-41. Streeck W. (1988), Status e contratto nella teoria delle relazioni industriali, Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, 673-719. Thrift N. (2005), Knowing Capitalism, London: Sage. Volpato G. (2004), Fiat Auto. Crisi e riorganizzazioni strategiche di un’impresa simbolo, Torino: Isedi. Weber M. (1906), Kritische Studien auf dem Gebiet der kultur-wissenchaftlichen Logik, in Id., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: Mohr (trad. it.: Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino: Einaudi 1958). 18
Scaricare