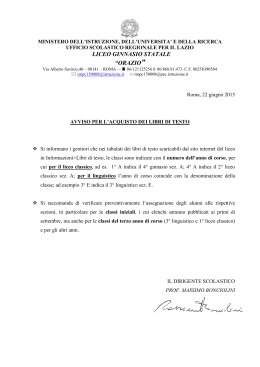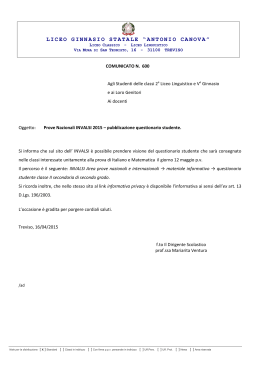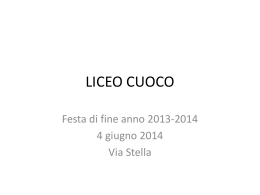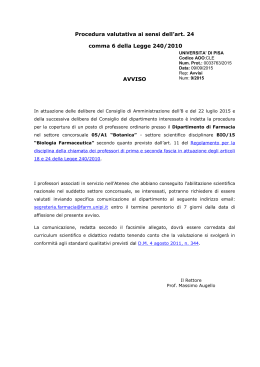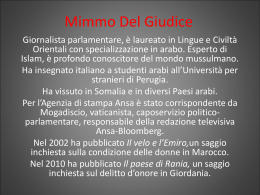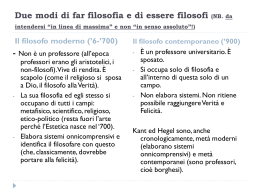PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI D I STATO
FO TI XXI
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
FONTI PER LA STORIA D ELLA SCUOLA
IV
L'inchiesta Scialoja
sulla istruzione secondaria
maschile e femminile (1872-1875)
a cura
di
LUISA MONTEVECCHI e M ARINO R AICICH
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
1995
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
SOMMARIO
DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI
Direttore generale per i beni archivistici ff :
Rosa Aronica
Antonio Dentoni-Litta
Direttore della divisione studi e pubblicazioni:
il direttore generale, presidente, Paola Ca
rucci, Antonio Dentoni-Litta, Cosimo Damiano Fonseca, Romualdo Giuffri
da, Lucio Lume, Enrica Ormanni, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi
Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isidoro Soffietti, Isabella Zanni Rosiello, Lu
cia Fauci Moro, segretaria.
Comitato per le pubblicazioni:
PREMESSA
11
I NTRODUZIONE
13
1.
L 'inchiesta Scialoja e la crisi della politica scolastica della De
stra, di Marino Raicich
15
n.
Le carte dell'inchiesta Scialoja,
INVENTARIO,
a cura di Luisa Montevecchi
N OTA METODOLOGICA,
SEZIONE l.
1 995 Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archivistici
ISBN 88-7 1 25-087-7 .
Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato
Piazza Verdi 1 0 , 00 1 98 Roma
©
Stamparo dalle Arti Grafiche Panetto & Petreiii - Spolero
di Luisa Montevecchi
di Luisa Montevecchi e Marino Raicich
LO SVOLGIMENTO DELL'INCHIESTA
53
67
1 35
1 47
1 . Relazione del ministro Antonio Scialoja al re sul decreto che ordina un'inchiesta sulla istruzione secondaria maschile e femminile,
e r.d. 29 set. 1 872, n . 1 0 1 6 .
1 49
2 . R.d. 29 set. 1 872, n. 1 026, nomina dei membri della Commissione d'inchiesta.
1 58
3 . Ordinanza del ministro Antonio Scialoja in cui si fissano i punti
principali sui quali verterà l' inchiesta ( 1 872).
1 59
4.
Regolamento per l a Commissione d' inchiesta ( 1 872).
1 62
5.
Quesiti sulla istruzione secondaria ( 1 87 2).
1 66
6. Lettera di Antonio Scialoja a Marco Tabarrini del 29 settembre
1 87 2 .
1 99
7 . Appunto di Marco Tabarrini sulla preferenza data agli istituti re
ligiosi dai padri di famiglia.
200
8. Lettera di Antonio Scialoja a Girolamo Cantelli del 25 gennaio
1 87 3 .
20 1
6
9. Lettera di Angelo Bargoni a Girolamo Cantelli del 1 4 febbraio
1 87 3 .
203
1 0. Lettera d i Antonio Scialoja a Girolamo Cantelli del 24 febbraio
1 87 3 .
206
1 1 . Relazione sulle visite fatte dai professori Settembrini e Cremo
na all' Istituto Marciano e all' Istituto della carità di Napoli ( 1 873).
209
1 2 . Lettera di Antonio Scialoja a Girolamo Cantelli del 24 marzo
1 87 3 .
211
1 3 . Lettera d i Girolamo Cantelli a Marco Tabarrini del 1 5 aprile
1 87 3 .
1 4 . Lettera d i Girolamo Cantelli ad Antonio Scialoja del 1 3 mag
gio 1873.
212
2 13
1 5 . Lettera di Girolamo Cantelli ad Antonio Scialoja del 18 mag
gio 1873.
2 14
16. I due decreti conclusivi: r.d. 13 set. 1 874 , n . 2092 , e r.d. 1 3
set. 1 874, n. 2093 .
217
l7.
Lettera di Ruggero Bonghi a Marco Tabarrini ( 1 87 4).
18.
2 19
Il. I VERBALI D E L L E DEPOSIZIONI
22 1
Seduta di Roma, 1 1 febbraio 1 873
Giuseppe Ferreri
Gabriele Luigi Pecile
223
SEZIONE
2 26
1 9 . Seduta di Roma, 1 2 febbraio 1 873
Stanislao Cannizzaro
Antonio Allievi
Michele Coppino
228
20.
Seduta di Roma, 14 febbraio 1 873
M ichele Amari
248
249
Seduta di Roma, 1 5 febbraio 1 873
Michele Coppino
25 6
22.
Seduta d i Napoli, 1 8 febbraio 1 873
Ippolito Amicarelli
27 1
272
23.
Seduta d i Napoli, 1 9 febbraio 1 873
Antonio Labriola
Filippo Capone
275
21.
7
Sommario
Fonti per la storia della scuola
))
230
235
))
))
288
2<!.
Seduta di Caserta, 3 marzo 1 873
Angelo Incagn oli
301
25.
Seduta di Bologna, 26 marzo 1 873
Cesare Bardesono di Rigras
308
26.
Seduta di Bologna, 27 marzo 1 873
Francesco D'Ovidio
313
27.
Seduta di Bologna, 29 marzo 1 873
Antonio Salvoni
Francesco Acri
3 19
28.
Seduta di Ferrara, l aprile 1 873
Enea Cavalieri
335
29 .
Seduta di Forlì, 3 aprile 1 873
Aurelio Saffi
Alessandro Fortis
342
30.
Seduta di Cesena, 4 aprile 1 873
Alfredo Antonio Comandini
35 1
352
31.
Seduta di Torino, 1 6 maggio 1 873
Nicola Marselli
Giuseppe Miiller
354
32.
Seduta d i Firenze, 2 9 ottobre 1 873
Ubaldino Peruzzi
367
33 .
Seduta d i Firenze, 3 1 ottobre 1 87 3
Pasquale Villari
378
34 .
Seduta di Milano, 5 novembre 1 873
Graziadio Isaia Ascoli
Giovanni Rizzi
389
))
))
))
328
))
))
347
))
362
))
))
400
35.
Seduta d i Venezia, 6 gennaio 1 874
Cristoforo Pasqualigo
405
36.
Seduta di Venezia, 7 gennaio 1 874
Laura Veruda Goretti
407
408
37.
Seduta di Venezia, 8 gennaio 1874
Giorgio Politeo
4 12
38.
Seduta di Padova, 1 3 gennaio 1 874
I professori del Seminario filologico-storico di Padova
421
))
))
))
8
Fonti per la storia della scuola
SEZIO E
III.
LE RISPOSTE SCRITTE
Sommario
439
39.
Francesco Antonio Agus
44 1
40.
Flaviano Antonacci
443
41.
Cesare Bay
444
4 2 . Giovanni Bosco
450
43.
Giovanni Calvetti
45 1
44.
Salvatore Calvino
460
45.
Giovanni Cittadella
464
46. «La Civiltà cattolica»
467
4 7 . Consiglio accademico dell'Istituto professionale e industriale
di Chieti
477
48. Angelo De Gioannis
482
49.
Giulio Alessandro De Rolland
486
50.
«L'Educazione»
492
5 1 . Jacopo Facen
500
52.
Giuseppe Gambino
502
53.
Giovanni Gattoni
505
54 .
Salomone Jona
509
55.
Enrico Labriola
511
56.
Francesco Linguiti
514
57.
Federico Napoli
520
58. Vito Pappalardo
534
59. Paolo Pavesio
537
60.
Luigi Rogliano
539
61.
Ernesto Sergent
547
62. Andrea Vergani
550
SEZIONE
IV.
G L I ECHI DELL'INCHIESTA
63 . Il n uovo ministro della pubblica istruzione, in « Il Diritto »
del 5 luglio 1 872.
553
555
9
64 . Il nuovo ministro della pubblica istruzione, in "La Perseve
ranza » del 4 agosto 1 872.
5 56
65. Il nuovo ministro della pubblica istruzione, in "Il Diritt o »
del 9 agosto 1 872.
560
66. Lettera di Antonio Labriola a Ruggero Bonghi del 23 ottobre
1 87 2 .
67 . F. P ETRUCCELLI DELLA GATTINA, L 'inchiesta dello Scialoja , in
« <l Pungolo » del 26 ottobre 1 872.
564
68. L. MORANDI , La disciplina nel corpo insegnante, in "La Liber
tà » del 29 ottobre 1 872.
57 0
69. Inchiesta sull'istruzione secondaria, in "L 'Opinione , del 26
gennaio 1 873.
57 2
70. L 'inchiesta sull'istruzione secondaria, in "La Perseveranza »
del 3 1 gennaio 1 87 3 .
574
7 1 . L 'istruzione secondaria, i n "Il Pungolo » del 1 9 febbraio
1 87 3 .
57 6
7 2 . Inchiesta sull 'istruzione secondaria, i n " L 'Osservatore di
Alessandria>> del 5 marzo 1 87 3 .
579
7 3 . Lettera d i Raffaele Lambruschini a Marco Tabarrini (marzo
1 873].
583
562
74 . Istruzione secondaria. Intorno ad alcuni dei quesiti proposti
dalla Commissione d'inchiesta, in "La Riforma>> del 30 marzo
1 87 3 .
585
7 5 . Due parole all'on. Scialoja, in « Il Pungolo •• del 3 agosto 1 873.
7 6. Inchiesta sull 'istruzione secorip.aria, in « L'Opinione•• del 1 9
ottobre 1 87 3 .
590
593
7 7 . L 'inchiesta sull'istruzione secondaria in Milano, i n « La Per
severanza •• del 1 3 novembre 1 87 3 .
594
7 8 . A. GHIVIZZANI, L'inchiesta sull'istruzione secondaria, i n « La
Riforma •• del 23 dicembre 1 87 3 .
597
Indice dei nomi
603
Indice degli istituti di istruzione
62 1
Indice dei periodici
629
Indice dei luoghi
63 1
,
PREMESSA
Nella non ricca letteratura di storia dell'istruzione manca una qualche
raccolta di fonti documentarie, già scarsamente edite o del tutto inedite, che
costituiscono la base per ogni ricerca che non voglia limitarsi a una rassegna
del dibattito pedagogico ma voglia misurarsi da vicino con i nodi istituzio
nali, sociali e culturali che si riflettono e si intrecciano nella storia della
scuola.
Senza poter avere - per ragioni oggettive relative all'attuale condizione
degli studi oltre che per ragioni di spese - l'ambizione di dar vita a una serie
di volumi che, come un secolo fa i Monumenta germaniae paedagogica,
spaziasse per i secoli, per le diverse tradizioni locali, per gli ordini religiosi
ecc . , abbiamo voluto, per ora, offrire agli studiosi una raccolta di documen
ti, in più volumi, che servissero almeno ad offrire un più modesto sussidio
agli studiosi di storia della scuola nell'Italia unita .
Lieti se in un prossimo futuro altri potrà allargare lo spettro di una siffat
ta ricerca (sia risalendo ai tempi anteriori all'unità nazionale, sia esaminando
le numerose fonti documentarie disperse negli Archivi di Stato periferici,
negli archivi degli enti locali, di istituzioni private, religiose ecc.), per ora ci
siamo limitati alla presentazione di documenti conservati all'Archivio cen
trale dello Stato (con la sola eccezione dei verbali del Consiglio superiore
della pubblica istruzione depositati presso il ministero omonimo) e relativi
alla realtà scolastica e universitaria del Regno d'Italia. I documenti presi in
considerazione, in genere, si collocano tra la legge Casati del 1 859 e le leggi
Gentile del 1 9 2 3 .
I singoli volumi della collana sono curati i n stretta collaborazione da uno
studioso di storia e da un funzionario dell'Archivio centrale dello Stato: essi
hanno, in un comune lavoro, scelto i documenti a loro avviso più significa
tivi da una ampia serie di buste e filze fino ad ora scarsamente esaminate, ne
hanno curato la trascrizione, hanno provveduto a predisporre un sobrio ap
parato di note, ed hanno ad ogni volume premesso una introduzione illu
strativa articolata in una parte storica e in una parte più strettamente archi
vistica.
I volumi, che entreranno a far parte della collana Fonti curata dall 'Uffi
cio centrale per i beni archivistici, saranno raggruppati in due serie distinte:
una prima serie istituzionale che esaminerà i vari ordini di scuola (elementa
re, classica ecc. ) o le varie istituzioni (Consiglio superiore, amministrazione
12
Fonti per la storia della scuola
centrale ecc.); una seconda, monografica, che offrirà i documenti relativi a
questioni e episodi particolari ma significativi (inchieste, libri di testo ecc.).
La documentazione offerta dai singoli volumi è, per ragioni evidenti di
spazi e di costi, antologica: in tal senso, oltre ad offrire una prima base do
cumentaria per gli studiosi, essa intende altresì fornire lo stimolo per più
ampie e dettagliate ricerche e per la predisposizione di inventari più detta
gliati dei fondi disponibili. Va infine richiamata l'attenzione dei lettori sul
fatto che la documentazione versata presso l'Archivio centrale dello Stato,
per la non regolarità dei versamenti o in seguito a dispersioni, per lo più
causate da eventi bellici, presenta vuoti e lacune che non possono non ri
specchiarsi nella scelta dei documenti per i singoli volumi.
Ma il significato di questa iniziativa ci sembra vada al di là della stessa
utilità che potranno trarne gli studi sulla storia della scuola in Italia per co
stituire un esempio della necessaria collaborazione fra il mondo degli studi e
della ricerca e le istituzioni archivistiche, nel rispetto dei diversi ruoli e nel
la consapevolezza di un possibile lavoro comune.
La direzione scientifica
l
INTRODUZIONE
l.
L'INCHIESTA SCIALOJA E LA CRISI DELLA POLITICA SCOLASTICA DELLA
DESTRA
Origine e svolgimento dell 'inchiesta
L'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria maschile e femminile
( 1 872- 1 875), fino ad ora scarsamente considerata dagli studiosi 1, costituisce
con le sue carte, conservate all'Archivio centrale dello Stato, per l 'ampio
ventaglio di pareri che offre sulla realtà scolastica del paese a poco più che
un decennio dalla costituzione del Regno d 'Italia, per il quadro che propone
di più generali stati d'animo dell'opinione pubblica all 'indomani del trionfo
prussiano, della fine del potere temporale, della Comune di Parigi, un docu
mento di grande interesse, e non solo per gli storici della scuola in senso
stretto. Anzi paradossalmente quanto furono allora, negli anni del tramonto
della Destra, irrilevanti gli esiti concreti dell' inchiesta sul piano dell'innova
zione legislativa nel settore della scuola secondaria, altrettanto i suoi testi
sono rilevanti per noi, offrono uno spaccato, difficilmente riscontrabile in
altre fonti, degli umori e delle ideologie correnti nei primi anni Settanta.
Giacché il tema della scuola secondaria, per la sua stessa natura, nell'Ita
lia del secondo Ottocento, al di là delle questioni più tecniche, di legislazio
ne scolastica, di metodologia didattica, di normativa regolamentare, stimo
lava la discussione su alcuni grandi temi: la libertà di insegnamento e il con
nesso problema dei rapporti dello Stato con la Chiesa e il mondo cattolico;
la questione dell'unità del giovane regno nato da poco e da realtà culturali
diverse, e dunque la querelle del centralismo e delle autonomie; i modi di
formazione e selezione della classe dirigente (e dunque il sempre difficile
rapporto, in questo quadro, del ruolo della cultura generale e disinteressata
' Sulle inchieste scolastiche e in questo quadro anche sulla Scialoja vedi P . M A CRY, La que
stione scolastica: controllo, conoscenza, consenso, in « Quaderni storici », XV ( 1 980), 4 5 , pp.
867-893 e più in particolare M. RAtCICII, L 'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria (18721874), in l/ Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica dell'Italia (186 1 - 1 988),
Milano, Nuova C EI , 1 989, III, pp. 237 - 262 e ID., Un piemontese in Sicilia, in P. CERR I , Le tri
bolazioni di un insegnante di ginnasio, con prefazione di A . D'ANCONA, Firenze, Passigli,
1 988, pp. 5-34. Su alcuni aspetti parziali dell' inchiesta vedi M. R A I CI CH, Le polemiche sugli stu
di classici intorno al l 870 e l 'inchiesta Scialoja (1 872- '74), in Scuola cultum e politica da De
Sanctis a Gentile, Pisa, Nistri-Lischi, 1 98 l , pp. 285 - 3 2 5 e S. FRAN CHI 1, Le origini dell'istru
zione secondaria femmin ile in ftalia e l 'inchiesta Scialoja (1872- 1873), in « Quaderni di sto
ria delle donne comuniste » 1 987, l, pp. 35-46.
...
16
17
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
e della cultura speciale e professionale), la funzione della donna nella vita
sociale, etc .
Nel presentare una selezione d i documenti dell'inchiesta, vale l a pena ricostruirne la vicenda, toccare i problemi che Scialoja e i suoi collaboratori si
erano proposti di affrontare, capire le ragioni dei suoi esiti deludenti.
Antonio Scialoja era stato chiamato a far parte del governo Lanza, come
ministro della pubblica istruzione, il 5 agosto 1 87 2 : il presidente del Consi
glio e i vari gruppi della Destra avevano faticato più di due mesi per dare un
successore a Cesare Correnti, dimessosi dal suo incarico il 1 7 maggio, sepa
randosi dalla maggioranza, renitente a seguirlo nelle sue scelte politiche, co
me in quel momento la soppressione dei direttori spirituali nei licei e ancor
prima la chiusura delle facoltà di teologia, giudicate dai moderati inopportu
na causa di non necessarie tensioni con il mondo cattolico. Tutta la vicenda
conferma come fosse ormai logora la compagine governativa di Lanza e co
me la questione scolastica si facesse sempre più spinosa per la Destra, coll'a
cuirsi dei contrasti con la Chiesa, più che mai gelosa nel difendere la sua tra
dizionale missione educativa.
Scialoja era del tutto nuovo ai problemi della politica scolastica: patrio
ta, esule in Piemonte, cattedratico, senatore dal 1 862, segretario generale e
ministro, era stato tra i protagonisti della politica finanziaria, doganale e in
dustriale della Destra 1• La sua nomina al ministero dell' istruzione, dovuta
probabilmente anche al fatto che altri, più esperti di lui, avevano rifiutato di
farsi carico della pesante eredità di Correnti (come dimostra il lungo inte
rim di Sella) fu commentata dalla stampa con non poche riserve: l'uomo era
intellettualmente stimabile, ma del tutto inesperto, anche se poi taluno sco
priva in questa inesperienza un lato positivo, l'estraneità del nuovo ministro
alle camarille dominanti al ministero di piazza Colonna, che avevano condi
zionato in modo assai negativo l'opera dei suoi predecessori. Si criticava an
che il fatto che un lombardo come Correnti fosse sostituito da un napoleta
no e che si alterasse così l'equilibrio geografico del gabinetto, ove sedevano
già due napoletani. La stampa della sinistra infine giudicava inopportuna la
scelta per quel ministero di un senatore: per la Sinistra il Senato era il ramo
del parlamento tradizionalmente orientato in senso conservatore, oltre a es
sere quello meno politicamente caratterizzato 2.
eanche u n mese dopo la sua nomina, raccolte le idee e esaminate le
carte ministeriali lasciate da Correnti in grande disordine 1, Scialoja fece la
prima uscita pubblica presentando le linee generali della sua politica scola
stica il 29 agosto in un banchetto a Pavia. Espose il suo programma muoven
dosi con cautela, condizionato sia dalla sua inesperienza, sia dal fatto che
era entrato in un governo già costituito . Perciò dichiarò di far propri, ma
coll'esplicita intenzione di emendarli, i due più significativi disegni di legge
predisposti da Correnti, quello sull'istruzione obbligatoria, presentato alla
Camera il 17 aprile 1 872, quello sul nuovo ordinamento dell'università, pre
sentato al Senato il 1 3 maggio dello stesso anno . Erano così coperti i settori
dell' istruzione primaria e dell' istruzione superiore. Restava il buco dell 'i
struzione secondaria, per la quale né Correnti né i suoi predecessori aveva
no presentato proposte organiche e complessive di riforma: si era sempre
preferita una politica di ritocchi agli orari e ai programmi attraverso decreti
ministeriali, circolari, etc . In questa situazione Scialoja comprese che la mi
glior cosa era prendere tempo: perciò a Pavia riconobbe che la condizione
della scuola secondaria era « assai difettosa e abbisognava di pronti ed effica
ci ripari,, ; fece capire che egli aveva qualche idea ma non intendeva renderla
pubblica prima di averla discussa nei consigli della Corona. Probabilmente
aveva già in mente l'idea di una inchiesta sull' istruzione secondaria , cui
avrebbe dato corpo di lì a qualche settimana col r.d. 29 set . 1 872, n. 1 0 1 6.
Negli Stati moderni dell'Ottocento lo strumento dell'inchiesta a volte go
vernativa, a volte parlamentare, era molto diffuso: la Francia e l'Inghilterra
offrivano molti esempi di inchieste, anche sui temi della pubblica istruzio
ne 2 . Né mancavano esempi in Italia di inchieste sugli ordinamenti scolastici
ai quali Scialoja in qualche modo poteva rifarsi: basti pensare all'ampia inda
gine sullo stato dell'istruzione primaria, coordinata da Girolamo Buonazia
alla fine degli anni Sessanta, o ai quesiti che il ministro Correnti sottopose ai
collegi degli insegnanti dei licei nel 1 87 1 , vertenti sui programmi e sui me
todi di insegnamento (la questione dell' Euclide, del Curtius, i limiti dell' in
segnamento della filosofia, ecc .), problemi che si ritroveranno proposti nel
questionario dell'inchiesta Scialoja : le risposte dei vari licei dovevano poi
essere vagliate da una commissione autorevole formata dai presidi dei mag
giori licei del regno e tradotte in proposte per il ministro�- Nello stesso pe-
Scialoja, che superi i limiti della or
1 M anca tuttora una documentat a biografi a di Antonio
tip.
m ai d at at a opera di C. DE CESARE, La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja , Rom a,
N a
li,
d'Italia,
regno
del
ministri
I
OSCATI,
M
A.
vedi
recenti
più
studi
gli
per
879;
1
del Senato,
cit.,
.
italiano
Parlamento
Il
in
,
Scialoja
Antonio
poli, 1 957, pp. 1 64- 1 93. e M. CANAVALE,
lV, pp. 385 - 402 . Per un approfondim ento sulla sua vita vedi però soprattutto Primo inventa
, c attedra di
rio dell'archivio Scialoja , Università di Firenze, Facoltà di economia e commercio
storia delle dottrine economiche , Firenze, 1 976, e A. SCIAL OJA , Lettere inedite di Antonio Scia
4 6 1 -528,
e di altri a lui, a cura di P. ALATRI, in • Movimento operaio • , 1 9 5 6 , pp. 1 08-200,
1 Per il disordine di Cesare Correnti nel tenere le carte di ufficio, vedi la gustosa rievoc azio
ne di C. Dossi, Note azzurre, Milano, Adelphi, 1 989, p. 609, n. 478-t.
' Per la Destra italiana era soprattutto presente il modello inglese di inchiesta. In-quella che
è probabilmente Ja prima proposta di una inchiest a sull'istruzione (nel ca;o specifico l 'istruzio
ne superiore) nel Regno d'Italia, avanzat a da Bonghi all a Camera nella tornata del 13 m arzo
1 863, il proponente sottolineava che « l' I nghilterra, che è la principale delle potenze costituzio
nali dell'Europa, ha seguito sempre questo sistema . . . " e più avanti present ava le caratteristiche
e le procedure delle inchieste inglesi come esemplari: vedi R. B ONG HI , Discorsi e saggi sulla
pubblica istruzione, l , Discorsi, Firenze. Sansoni, 1 876, pp. 8 1 , 84 , 87-88.
' I quesiti formulati da Correnti vennero diffusi con la circolare n . 303 del 9 m aggio 1 87 1 ;
le conclusioni che ne trasse il ministro, scavalcando il parere del Consiglio superiore che si ri-
. .
loja
687-767.
" Dello scarso pre�tigio del Senato è testimonianza significativa l 'articolo di un giornale
non certo di sinistra, « La Perseveranza del 4 agosto 1 87 2 (vedi doc. 64, p. 5 5 6).
•
18
riodo, più o meno sugli stessi temi, in Austria il ministro Stremayr promuo
veva una Gymnasialenquete 1• E gli esempi di simili procedimenti nell' Euro
pa e nell'Italia potrebbero moltiplicarsi. Ma la suggestione più immediata a
Scialoja veniva probabilmente da un episodio recente della vita parlamenta
re; agli inizi del maggio del 1 872, dopo una faticosa discussione alla Came
ra, era approdata al Senato la proposta di legge sull'adeguamento degli ordi
namenti delle università di Padova e di Roma a quelli delle altre università
del Regno . In apertura del dibattito il senatore Menabrea, rendendosi inter
prete di un largo disagio diffuso nel Senato sulla politica scolastica, aveva
proposto di sospendere la discussione su quel disegno di legge (e su ogni al
tro disegno di legge di politica scolastica) per dar luogo ad un'inchiesta del
Senato sulla pubblica istruzione. La proposta di Menabrea suscitò una di
scussione complessa anche formalmente, poiché non esistevano precedenti
in Senato di inchieste monocamerali . Ma soprattutto irritò il ministro Cor
renti per due motivi: essa avrebbe, se accolta, bloccato ogni discussione non
solo sulla legge all'ordine del giorno ma anche sulle due proposte che Cor
renti voleva far discutere rapidamente, quella sull 'obbligo, già depositata, e
quella sulla riforma universitaria che avrebbe presentato pochi giorni dopo.
Correnti si sentiva poi offeso soprattutto perché Menabrea aveva sottolinea
to la necessità di indagare sui comportamenti, spesso scorretti e parziali,
dell'amministrazione centrale; e, nonostante che Menabrea negasse che quei
sospetti avessero qualcosa di personale contro il ministro in carica, in quan
to egli si riferiva ad una prassi decennale del ministero e di tutto il governo,
Correnti era risentito . La proposta comunque non ebbe seguito nell'imme
diato ma probabilmente lasciò una traccia, una suggestione nell'animo del
senatore Scialoja; del resto Menabrea aveva insistito in modo particolare sul
la crisi della scuola secondaria 2 •
Da tutti questi precedenti e in particolare dall' ultimo, Scialoja, che non
era in grado di proporre subito una sua linea elaborata di riforma dell'istru
zione secondaria, trasse spunto per proporre una inchiesta sul tema, anche
tenne di conseguenza offeso, sono esposte nella circolare del Ministero della pubblica istruzio
ne ai prefetti del 20 aprile 1 8 7 2 . I documenti relativi, con le opinioni espresse dai collegi degli
insegnanti e la loro sintesi, opera della commissione di presidi insediata ad hoc dal ministro in
AR CHIVI O CENTRALE DELLO STATO, M I , ISTER O DELLA PUBBLICA ISTR UZI ONE (d'ora in poi ACS, MPI),
Div. scuole medie (1 860- 1896), b. 2. La relazione della commissione è ora pubblicata in A R CHI
VIO CENTRALE DELLO STATO, Fonti per la storia della scuola, III, L 'istruzione classica (1 8601 9 1 0), a cura di G. B ONETTA e G. FI ORAVANTI, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali,
Ufficio centrale per i beni archivistici, 1 995, pp. 209-22 2 .
' Vedi Verhandlungen der Gymnasial Enquete Commission i m Herbste 1 870 ver6ffentli
cht von k.k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht, Wien, Verlag der k.k. Ministeriums, 1 87 1 .
La proposta Menabrea e la successiva discussione in Atti parlamentari [d'ora in poi AP],
Senato del regno, legislatura Xl, Il sessione ( 1 87 1 - 1 872), Discussioni, Il, tornata del l o maggio
1 87 2 , pp . 539 sgg.; e 2 luglio 1 87 2 , p. 4; è significativo che Camillo De Meis scrivendo a Vitto
rio lmbriani il l o set. 1 873 sulle sedute bolognesi dell'inchiesta, ne consideri ispiratore Mena
brea, in Carteggi di Vittorio lmbrani. Gli hegeliani di Napoli, a cura di N. C OPPOLA, Roma,
ISRl, 1 96'!, p. 1 22 .
2
19
Introduzion e
Fonti per la storia della scuola
za diffusa t �a. uomin �
se probabilmente era ben consap evole che nella coscien
a con scetttc tsmo. St
accolt
stata
e
olitici e pubbli cisti la sua proposta sarebb
ies � e non risolvo no
�
nc
�
l�
che
e
comun
�apeva bene - era anzi già un luogo
a, spesso non
ttahan
a
pohttc
one
situazi
nessun proble ma e che specie nella
icato nel non
giustif
è
così
che
ro
minist
il
per
sono altro che un nobile alibi
.
ti
urgen
più
mi
proble
i
.
fare nulla, nel rinviare anche
�el
Meglio di ogni altro dava espres sione a tale stato d'animo P�truc celh
�
pu�bhca ha o: ma
la Gattin a, annun ciando che: « il minist ro dell' istruzi one
subtto la prevts tone
to un'inc hiesta sull'ist ruzion e second aria » e formu lando
che " il risulta to sarà nullo » . E aggiun geva:
inchieste; e tutte si sono ri
"Da dodici anni il bilanci o italiano si spossa a pagare
un : apporto fors , e poi
ati,
erano incaric
solte in partite di piacere dei signor i che ne
e scaltro , ordma una
ma
fare,
di
voglia
ha
zero più zero, zero! Un ministr o che non
ebbe dison ? rato
creder
si
regola
per
che
sore,
succes
suo
Il
.
inchies ta, vegeta e muore
_ a que1 rap
confm
,
e cavarn e l meglio
di raccog liere l'eredi tà del suo predecessore
sumus!» .
porti nel limbo degli archiv i, e pulvis et umbra
�
�
a, di ma
E analog hi nella sostan za erano i giudiz i di altri organi di stamp
, come
lucano
lista
giorna
del
quella
da
a
remot
trice ideolo gica anche molto
cri
olte
a di �
per esemp io "La Civiltà cattol ica ,, dei padri gesuit i 2• La somm
nel
o
a
susctt �
�
tiche e di qualch e speranza che l'annu ncio dell' inchie sta aveva
ah
•
q
(d
ornale
�
g
di
li
artico
negli
sa
espres
era
�
si
�
che
e
.
l'opin ione pubbl ica
trovo mfme
la quarta parte della nostra silloge offre uno specimen parzta le),
d �scussi on� col
una eco nel genna io del 1 873 alla Came ra, quand o venne_ in
t deput ati che
tra
nuovo minist ro il bilanc io della pubbl ica istruzi one. Moltt
sta� i i�
erano
quale
intervennero parlar ono dell'in chiest a avviat a e della
. gmdt
to
esemp
per
era
quei giorni resi noti i quesit i . L' iniziat iva del minist ro
erso le re
cata da Salvat ore Morel li una perdit a di tempo : il minist ero, attrav
ispezi oni
le
erso
attrav
i,
presid
lazion i dei prefet ti, dei provv editor i e dei
dovev a
na),
lon
o
�
piazza
di
contin ue (tutte carte che riemp ivano le stanze
_ t_ � rop st
optnt
cere
conos
?� � � �
essere in posse sso di tutti i dati, dovev a ben
tntztat � ve �� n
e dunqu e essere in grado di fare una politic a e di assum e_re le_
teana , dt n
m
,
pnv
non
ne
erazio
�
forma . Si aggiungeva anche una consid
_ terra; ma �m
_
Inghtl
l
era
tiche
scolas
ste
inchie
suo fonda mento : la patria delle
L'articolo di Petruccelli della Gattina in " Il Pungol o , di Napoli del 26 ottobre 1 87 2 (vedi
doc. p. 564 ).
VIII, serie VIU , p. 348: dopo aver sotto l'1Vedi " La Civiltà cattolica ,, XXIII ( 1 87 2 ) , vol.
ionarie », la rivista p�r ncono
«leggi
le
neato lo stato deplorabile dell'istruzione dopoe il caratterrivoluz
to della sua relaziOne, con
«medita
e
Scialoja
di
ni
intenzio
delle
à
scendo la sincerit
esta riesca a qualcosa
d'inchi
ssione
Commi
una
"che
clude negando che si possa ancora sperare
approd�rono molte
cu1
a
vuote,
e le chiacchiere
di più salutare che non siano le ingenti spese
hi giudiZI e pre
Analog
».
nulla
nel
sfumate
e
o
apparat
grande
con
_ CI scolasti
altre cotali faccende, a\'viate
CI antigo
penodi
alcuni
davano
Scialoja
visioni sul fatale fallimento dell'iniziativadedili 'istruzio
tecnica
e
classica
aria
second
ne
critica
La
"
e
Baretti.
vernativi, come " Il
1
1
67,
•
•.
20
quel paese c'era la libertà di insegnamento più piena: non c'erano program
mi uniformi, regolamenti pignoli, occhiute ispezioni. E dunque se il gover
no e il parlamento volevano conoscere le condizioni della scuola, l' unico
strumento di cui potevano disporre era l'inchiesta, che in Italia, nella condi
zione centralistica e statalistica del suo ordinamento scolastico, era del tutto
pleonastica. Ma coglieva nel segno, a difesa dell'inchiesta promossa da Scia
loja, Morpurgo, il futuro segretario generale del Ministero dell'agricoltura,
industria e commercio: faceva notare che nella pubblica amministrazione il
settore in cui era più scarseggiante la documentazione era la pubblica istru
zione, che se nei primi anni del regno aveva prodotto documenti « abbon
danti, copiosi di cifre e di notizie» , poi si era afflosciata in una certa inerzia.
Probabilmente questa decadenza della capacità di indagine del ministero era
incominciata col trasferimento della capitale a Firenze, quando perse terre
no la pignoleria burocratica dei subalpini e incominciò a prevalere una certa
indolenza tipicamente toscana. È significativo in questo quadro che, ad
adempimento di quanto previsto dalla legge Casati (art. 1 5), la presentazio
ne ogni cinque anni da parte del Consiglio superiore di una relazione gene
rale sullo stato dell' istruzione, mentre era stata puntualmente realizzata nel
1 865 sotto la guida di Matteucci e con la presenza in prima persona, come
relatori per due delle tre parti in cui la relazione si articolava, di intellettuali
subalpini, esponenti di quella pedagogia che a Torino aveva avuto sviluppo
nel decennio di preparazione (Rayneri e Bertini), nel 1 870 l'impegno del
Consiglio superiore venne meno e la relazione non fu presentata, come non
sarà mai più presentata nel futuro. I consiglieri giustificarono l' inadempien
za proprio col fatto che dal ministero non veniva fornita la documentazione
richiesta. E se Morpurgo aveva richiamato l'attenzione sulla ormai scarsa ca
pacità documentaria del ministro, Bonghi, sempre a sostegno della opportu
nità dell'inchiesta, rilevava come l'altro canale informativo del ministero le
ispezioni, fosse inaffidabile, giacché le relazioni degli ispettori non erdno
« né efficaci né utili,, 1 •
E che lo scetticismo, le critiche e riserve nei confronti dell'inchiesta non
fossero solo opposizione preconcetta ma avessero un fondamento reale lo
dimostra un fatto : Carlo Tenca, commissario dell'inchiesta, buon conosc i to
re della situazione scolastica del paese e certamente non schierato né con la
sinistra né con i clericali, scriveva privatamente a Clara Maffei rammarican
dosi del proprio arruolamento forzato nei ranghi della Commissione d' in
chiesta e manifestava anch 'egli il suo scetticismo sulla iniziativa di Scialoja:
<d' impresa sarebbe in realtà vasta e faticosa. Ma di solito queste inchieste
fanno un po' di chiasso sulle prime, e poi tutto s' arresta; né questa sarà di
versa » 2 •
1 AP, Camera dei deputati, legislatura X I , I I sessione ( 187 1-1872), Discussioni, v , tornata
del l febbraio 1 873, pp. 4564-4565 .
Vedi Carteggio Tenca-Ma.ffei, I I , 1872- 1875, a cura di L. }AN N UZZI, Milano, Ceschina,
1973, p. 53 (lettera del 7 ottobre 1872).
2
Introduzione
Fonti per la storia della scuola
21
Certo le parole di Tenca erano scritte per tranquillizzare la Maffei, per
farle capire che gli impegni dell'inchiesta non sarebbero stati poi tanto as
sorbenti e non avrebbero impedito a lui, già oberato dagli impegni del parla
mento e del Consiglio superiore, di ritornare ogni tanto a Milano a riposarsi
e confortarsi nell'affetto dell'amica. E tuttavia quello di Tenca era anche un
giudizio che nasceva dalla sua esperienza, u n giudizio di cui egli era persua
so. Nel caso specifico poi la scarsa opportunità dell' inchiesta e la probabilità
che si risolvesse in un fallimento era resa ancor più probabile dal suo tema:
un tema su cui l'opinione pubblica era troppo divisa, per poter suggerire al
governo un indirizzo preciso e prevalente di politica scolastica. Ant? nio La
briola, scrivendo a Bonghi il 23 ottobre 1 87 2 , sulla base della relaz10ne del
ministro al decreto istitutivo della commissione e del primo questionario ge
nerale predisposto da Scialoja, notava - e non sarà il solo a fare una tale os
servazione - che in Italia, per difetto di cultura politica e pedagogica, non
esisteva una chiara opinione maggioritaria sulle questioni della scuola e in
particolare su quel nodo centrale, intorno al quale ruota la ratio dell'inchie
sta, senza mai centrarlo direttamente, cioè cosa è nella presente situazione
storica, la « cultura generale » 1•
Tutto dunque sembrava convalidare la diffusa persuasione che il lancio
dell' inchiesta fosse anche per Scialoja solo un comodo espediente per non
scegliere o almeno per rinviare le scelte. E probabilmente in parte era così. E
tuttavia c'era nel ministro una sincera convinzione che l ' inchiesta sarebbe
stata utile e chiarificatrice. Essa derivava dall'esperienza che Scialoja aveva
fatto in prima persona - ed era una esperienza in corso, ma assai ben avviata
- con l' inchiesta industriale 2• Giacché, al di là delle suggestioni delle grandi
inchieste straniere, dei quesiti Correnti e della proposta Menabrea, quello
che contò nello spingerlo all' inchiesta fu l 'esperienza positiva che aveva fat
to come presidente della Commissione d'inchiesta industriale, che aveva
promosso insieme a Luzzatti, e con la quale aveva girato l' Italia conducendo
interrogatori serrati cui avevano dato risposte puntuali industriali e com
mercianti. Perciò nel discorso di insediamento della Commissione d'inchie
sta sulla scuola del 20 ottobre 1 87 2 Scialoja esorterà i commissari a prende
re a modello i metodi dell'inchiesta industriale e a privilegiare gli interroga
tori orali sui questionari scritti . E insisterà su questi richiami anche successi
vamente nella corrispondenza tenuta nel corso dell' inchiesta con il presi
dente Cantelli. Ma in tali lettere veniva anche alla luce quanto l'ipotesi di ri
petere l'esperienza dell'inchiesta industriale si manifestasse sempre più illu1 Per la lettera di Labriola vedi in questo volume il doc. 66 , p. 56 2. Sulla mancanza di una
opinione prevalente e maggioritaria sugli indirizzi della riforma della scuola secondaria, insist�
anche" L'Unità nazionale» di Napoli del 5 settembre 1872 nel commentare il discorso pavese dt
Scialoja.
Sulla inchiesta industriale, vedi ora L. C A FA GNA, L 'inchiesta industriale, in Il Parlamento ita
liano, III, Nuova CE!, Milano, 1989, pp. 195-225; per una bibliografia sull'inchiesta ibid. , p. 5 1 1 .
2
22
sofia. Giacché se dagli industriali e dagli operatori economici, uommt con
precisi interessi, era stato possibile ottenere dati concreti, dagli uomini di
scuola, in genere letterati, i cormnissari ricavavano solo parole, auspici, pe
rorazioni, spesso anche gravate da scoperti ideologismi e retori declama
toria.
Nel definire le modalità e le procedure dell'inchiesta, Scialoja si distaccò
dalla proposta Menabrea su un punto essenziale: volle che l'inchiesta fosse
promossa e guidata dal governo e non dalle camere o da una di esse . Non sa
rà un caso che nel 1 87 5 , quando ormai divenne a tutti manifesto che l'in
chiesta era fallita, Menabrea farà responsabile di quel fallimento proprio
quella scelta: per il senatore savoiardo il male era lì, nell'amministrazione
centrale, negli alti funzionari, nei ministri, nelle loro scorrettezze, nei loro
clientelismi: non si poteva dunque pretendere che il governo si facesse ac
cusatore e giudice di se stesso Non aveva torto: ed è significativo che né
nell'ampio ventaglio di problemi delineati da Scialoja nel decreto ministeria
le dell' l ottobre, né nell'articolatissimo questionario predisposto poi dai
commissari non viene quasi mai toccato direttamente il tema dell'ammini
strazione centrale. Nonostante ciò parecchi tra quanti risposero a voce e per
iscritto non mancarono di indicare le sue gravi responsabilità nella crisi del
la scuola . E più decisamente ancora la stampa di opposizione richiamava
l'attenzione sulla questione: "Strano dottor mi sembra la commission d'in
chiesta che vuoi curar le membra l se il mal sta nella testa»; così per esem
pio suonava un epigramma di un periodico scolastico torinese, particolar
mente ostile alla politica scolastica governativa anche se poi Scialoja tenne
conto in qualche modo di questi sospetti e riprese dalla proposta Menabrea
il criterio di escludere dal novero dei commissari gli ex ministri dell'istru
zione, per togliere all'inchiesta il sospetto di parzialità; anzi escluse anche
gli ex segretari generali (i Brioschi, i Villari, ecc.) cui Menabrea non aveva
pensato.
Scialoja fu assai attento nella scelta dei commissari; seguì innanzi tutto il
criterio di assicurare una calibrata rappresentanza alle varie aree culturali
del paese. Se l'equilibrio geografico contava, come abbiamo visto sopra, per
la composizione del governo, tanto più contava in una commissione di in
chiesta per la scuola, poiché nei modelli di cultura da trasmettere sussisteva
no (e non dovevano essere offese) le tradizioni regionali (il paolottismo to
scano, il purismo napoletano, il classicismo romagnolo, il pedantismo sub1•
l
l
2,
1
Vedi
AP, Senato del Regno,
legislatura XII, I sessione ( 1 87 4 - 1 875),
del 16 febbraio 1 8 7 5 , pp. 1 36- 1 37 .
2
Discussioni, 1, tornata
" I l Baretti " , organo scolastico torinese, legato agli ambienti classicheggianti e antiliberali
di Vallauri, pubblica l ' epigramma sul n . 3 2 del 7 agosto 1 8 7 3 . Ma già nel n . 4 2 del 24 ottobre
1 87 2 così dava notizia del l ' inchiesta: • Intanto si crea una Giunta d 'inchiesta perché vada giran
dolando per le nostre scuole, al fine di scoprirvi i mali che v i sono e correggerli. Là, al Ministe
ro si faccia l ' inchiesta, severa, inesorabile contro questi factotum orgogliosi, che sono i l disdo
ro e la ruina di quelle scuole e di quegli studi di cui dovrebbero essere i moderatori, e come tali
percepiscono lauti stipendi
•.
23
Introduzio n e
Fonti per la storia della scuola
Stati preunit�ri e dell59a
o le tenaci memorietreddegicili ann
). e. si avvertivan
alpt. no, ecc.nstz
i trascorst dal 1 8
i
non .per Ila in tutt i que
fase di traassi tone;
za alla omologaziooli e a Firenze� la resistenfuro
era stata �rte �isp;����do���onto
scelti i nove
quest esigenza no
pou.r
ne alla. leg��. c::�o�e era un funzionadi rio
on�e
isteriale piem seall(�amm
t
commtssar stesura del uestionario sarà opemin
uva
rela
e
ra sua la part
�o
c�use e
grup
al
to
lega
an�
arrini era un tosc tto la pubbhca
astic. a p;ovinciale), eTab
mstraz�to�: scol
.
bruschini aveva dtre d , Ita ta; cornLam
lfi
t
R'do
a
d. et mo. deratin ellae assfasetemdie passaggio dal Gra
cato al Regno
tstruzwne que a questa pecul'tan't'a 'l comndu
nella ste' to che egli si assunseame
spondeva d ionario di curare la parte relapttiva
nt� t�tipic
a
tem
un
ad
sura de� u��itti e gli educandati . Bonghi e Settembrini erano napolet am, Ft
�nv
sidente Can telli era parmense, Cremona e Tenca
������ �omagnolo, il preven
y era eto.
erano lombardi 'dLio
.
he perehesione era necessariatanc
veneto nella Commisnon
un
La presenza
evan
pochi problem sttrapon
nessione
hi anni do o l'anven
anc a par��en
a
r
nte: . lt�o la
all'o rdinamento vige
to delle �uole ete
e �� d
iato un ricordo eh� alned� l!a'::ll� ���s����Jr:�
fe:isl:zi��� austriacadelavetuttvaolasc
ativo, per ese�pw tare era !:'mv�ce il bilantriottiche non eragnanti dove neg
più fortemente falht men n
ento de li inse
o
e
i z
od e
���lt� ��
i
; ��\�e �n��:�T� ght,
�� r�;���� �t=���;eran
�che �!�. p���;� �� :i�t�a:��:lCan
Bon
,
telli e Tabarrini o senaton e Lwy e
i era calibrat
��:���:��0 deputat i, Fina li era stato deputat�� s��e��:���t�:s� �u����v���
a se
s
le nor�:l�!��
uS:�:rsitarie e le scuo
e�����ie�:��;t;scie
��p
��
�
i
o��
:;�
;e
���
a: qu.e
m�n
Cre
da
. egnan ti erano rapp
lle ntifiche aveva mfm
resentat e,. que
. L'am
. Sett
ms
e m Carboe
zion
ministra
nistiche da Bonghti e ic emb nm .
ne un espo:���� �o: l���o dosaggio di competenze e di prove�enze sarà
q
nell estate del
sco!����o pochi mesfdopo, mentre l'inchiesta era in corso:
·
r
·
1
1
.
.
0
1
.
testi mon ianza di Luig i
M
ustri aco è signi ficat iva la
S ul rimpi anto per le scuole del penodo a .
scuola in Italia , idella
·
e la decadenza
.
.
si della sc1enza
ogres
r
p
l
·
111
11
ora,
a
nte
tamo
stude
.
poss
non
Luzzattl,
.
. g·' ova dirlo da noi ' che
.
o s1gn on,
.
.
· " Ma gwva d1rlo
, d1
lano, Treves, 19 09 , PP · 5 7 - 5 8 · .
.
. pe r ordi ne d i stud i, per giust a seve nta
.
'
lana,
'
l
!ta
a
patn
alla
e
devozwn
del
e
o
latin
essere sosp ettat i di poca
del
e non solo filologica
.
.
' cogmz10ne l etter ana
l a s 1·cura
frequenza e d1 esam 1, per
quel li della mate . .
t'1 lette rari e filosofici con
en
nam
.
mseg
i
degl
equo
t°
e il liceo augreco , pel conte mper amen
asio
del· professori ' il ginn
.
. .
1 • per la cura ne 11a sce lta
l'
ra
natu
ze
SCien
delle
e
mati ca
o istitu ti p i ù perfe tti d1
vene te e 1o mba rde eran
incie
prov
e
r
t
nos
e
11
ne
.
stria co, la scuo la reale
arde e vene te,
.
hiest a specie in quel le lomb
. . . " · Nelle nspos�e a11, ��c .
'
quel li che l i sosti tuiro no
e e di reclu tame nto dei
azion
form
di
a
tem
�ls
.
sa nost algia non so o per
c, è una abbastanza diffu
iaco che cons entiv a.
p1u d ue del ginnasio austr
.
'
1a 5cansione d1 se1 anru
.
prof esso n, ma anch e per
e di cinq ue anm
sion
nam ento della scan
ione delle ma te ne d.' . �· nseg
ibuz
distr
ta
libra
equi
una più
ti .
dispo sta dalla legge Casa
ginn asial i p i ù tre licea li,
l
'
24
25
Introduzione
Fonti per la storia della scuola
1 87 3 con le dimissioni del governo Lanza e la formazion� del governo Mio
ghetti abbandonarono la Commissione il presidente Cantelli, :�ssunto al Mi
nistero degli interni, e Finali, chiamato a reggere il Ministero dell'agricoltu
ra, industria e commercio. Poco mancò che anche Cremona non lasciasse la
Commissione, dato che Finali avrebbe voluto portarlo con sé al ministero,
come segretario generale Ma Scialoja pose il veto: non poteva lasciar svuo
tare del tutto la commissione, tanto più che Cremona era l ' unico che si in
tendesse delle discipline scientifiche. Agli effetti negativi della crisi ministe
riale si aggiunsero poco dopo le del resto prevedibili ed inevitabili dimissio
ni di Lioy, che fin dall'inizio delle sedute pubbliche della commissione ave
va disertato sistematicamente i lavori. Ormai aveva anche pubblicamente
esplicitato le ragioni del suo comportamento e del dissenso che lo divideva
dai colleghi, che a suo avviso davano poco spazio al parere e alle risposte
dei padri di famiglia. I tre dimissionari furono sostituiti con difficoltà e sen
za più alcuna considerazione di quei criteri di equilibrio geografico che Scia
loja aveva seguito nelle prime nomine. Comunque il ministro riuscì a desi
gnare tre nuovi commissari in complesso idonei e competenti. Solo Lo Mo
naco, nominato al posto di Lioy, non sembra che si fosse mai particolarmen
te interessato di questioni di politica scolastica. Gli altri due nuovi commis
sari, Ciccone, senatore e amico di Scialoja e nuovo presidente della commis
sione, e il giovane deputato di Savona, Boselli, erano due competenti. Anto
nio Ciccone, che aveva avuto una interessante e bizzarra evoluzione cultura
le che lo aveva portato dalla cattedra di medicina a quella di economia poli
tica, già nel 1 849 aveva presentato al parlamento di Napoli una proposta di
riforma della scuola Nel 1 860 poi aveva ricoperto a Napoli la carica di di
rettore della pubblica istruzione e nello stesso anno su «Rivista contempora
nea>> aveva pubblicato un parere attento sulle legge Casati, da poco promul
gata: in un giudizio, globalmente positivo sulla nuova legge, accanto a qual
che riserva sul carattere d'urgenza del provvedimento, criticava un punto
non secondario, cioè la soverchia timidità del legislatore a proposito della
libertà di insegnamento, un tema cioè che sarà ancora centrale nei dibattiti
dell'inchiesta Scialoja
Paolo Boselli era ancora più attento ai problemi della scuola: legato a
Scialoja dal comune interesse per la politica finanziaria, era stato fatto il suo
nome nell'agosto del 1 87 2 per l'incarico di segretario generale che doveva
affiancare Scialoja al ministero . Ma già nel 1 865 il giovanissimo Boselli, scri
vendo su «La Civiltà italiana», aveva perorato la causa dell'istruzione tecni-
ca da sviluppare nel futuro di fronte alla pesante tradizione della scuola clas
sica. Al congresso pedagogico di Torino nel 1 869, relatore applauditissimo,
aveva ancora trattato il tema dell'istruzione tecnica e professionale Questi
interessi di Boselli per la scuola troveranno altre conferme nella sua succes
siva lunga carriera, quando per due volte sarà chiamato a reggere il Ministe
ro della pubblica istruzione e quando dal 1 906 al 1 909 sarà chiamato a pre
siedere la commissione Bianchi sull'istruzione secondaria.
Ma le competenze dei nuovi commissari non valsero a risollevare le sorti
dell'inchiesta che, dopo una lunga pausa, riprese con stanchezza i propri la
vori nell'ottobre a Firenze per passare a Milano e chiuderli poi a gennaio a
Venezia e a Padova .
Non fu neanche facile per Scialoja persuadere i commissari designati ad
accettare un incarico che comportava fatiche e spostamenti per tutto il pae
se; diversamente da quanto aveva scritto nell'articolo sopracitato Petruccelli
della Gattina, era tutt'altro che una «partita di piacere»; era un continuo an
dare in giro per l'Italia come «Zingari», un «rizzare bottega di chiacchiere
con poco o nessun costrutto» Viaggiare continuamente era stancante; e lo
era soprattutto nel sud dove le ferrovie erano scarse e funzionavano in mo
do assai precario. Anche per queste difficoltà la commissione non riuscì mai
a spostarsi sotto Salerno; le intenzioni di visitare il profondo sud non man
cavano, anzi venivano continuamente ribadite. Già nella prima fase dell'in
chiesta c'era il progetto dopo le deposizioni campane di proseguire il lavoro
spingendosi fino alla Sicilia; così dopo le audizioni romagnole si era pensato
di proseguire verso le isole. Persino nell'autunno del 1 87 4 , quando ormai
da molti mesi la Commissione non dava alcun segno di attività, Bonghi pro
pose ai colleghi di riprendere le audizioni dalla Sicilia e dalla Sardegna. Ma
nessuna di queste intenzioni si realizzò; oltre alle difficoltà dei trasporti al
cuni commissari temevano i brutti incontri con i briganti. All'amico Alfonso
de Guzzis che gli chiedeva quando la Commissione sarebbe giunta a Catan
zaro, Settembrini scriveva il 6 marzo 1 87 3 :
1 Vedi G. FINALI , Memorie, con introduzione e note di G. MAIOLI, Faenza, F.lli Lega editori,
1 9 5 5 . p. 38 1 .
' Vedi Il Parlamento napoletano del 1848-49. Storia dell'istituto e inventario dell'archi
vio, a cura di C. LODOLINT TUPPUTI, Roma, Camera dei depurati, 1 99 2 , pp. 2 t 7-2 1 8 .
' Vedi A . CICCONF., L e nuove leggi. I l . L a legge sulla pubblica istruzione, in " Rivista con
temporanea • , gen. 1 860, pp. 3 1 -5 1 .
zione tecnica è la vera istruzione dell 'avvenire e dei popoli operosi e liberi » e polemizza contro
« le abitudini e i pregiudizi della istruzione classica » ; e i noltre A tti del VI Congresso pedagogico
italiano, Torino, 1 870, pp. 263-27 1 .
' Vedi Carteggio Tenca-Maffei . cit . , p . 1 30 (lettera del 2 1 ottobre 1 873).
; L . SETTEMBRINI, Lettere edite e d inedite 1 860- 1 8 76, a cura di A . PESSINA, Napoli, Società
editrice napoletana, 1 983, p. 1 85 .
1•
2.
5
1•
2.
« Non so se l a commissione d i inchiesta potrà venire o mandare qualcuno dei
suoi membri . . . la mancanza di ferrovie, e una certa idea dei briganti che negli uomi
ni del l ' Italia superiore è una brutta e una grossa idea, forse non farà venire la com.
.
3
mtsswne
. . . »
.
Questa rinuncia ad effettuare audizioni nell ' estremo sud costituisce, per
1 Vedi la recensione di Paolo Boselli a R. Scuola tecn ica di Porto Maurizio, Relazione sul
corso 1 863- '64 , in • La Civ;Ità italiana • , 1 ( 1 865), 1 2 , p. 1 9 2 , dove Boselli sostiene che < d' istru
..
26
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
un'analisi dei risultati dell'inchiesta, forse la lacuna più grave; solo in parte
offrono testimonianza surrogatoria
le risposte scritte giunte dalle isole e dal
le province meridionali . Il Mezzogiorno infatti era l'area in cui in forma par
ticolarmente acuta erano presenti nel sistema scolastico i guasti e i problemi
più gravi: una invadente iniziativa privata di carattere speculativo e di basso
livello didattico, sostenuta dal rimpianto per le tradizioni puotiane, forti re
sidui di una ideologia nostalgica e reazionaria diffusa dal clero nelle sue
scuole e anche nelle scuole governative ove molti sacerdoti insegnavano, la
qualità scadente del corpo insegnante reclutato spesso con criteri più clien
telari che culturali . Conferma questa situazione in modo esemplare la testi
monianza di Cerri in uno scritto pubblicato in occasione dell'inchiesta
La disponibilità a un serio impegno di lavoro da parte dei commissari de
signati dal ministro era piuttosto scarsa, tant'è che persino nell'atto di nomi
narli, Scialoja in qualche caso acconsentì che il loro impegno fosse più di
facciata che di sostanza: questo almeno risulta da una lettera di Tenca alla
Maffei; anche se poi Tenca, da quel cittadino zelante e da quel cireneo che
era, approfittò assai poco della licenza di disimpegno e anzi uno dei com
missari più assidui e più presenti alle sedute pubbliche dell'inchiesta
Molti dei commissari avevano impegni pubblici cui non potevano rinun
ciare. Proprio Tenca per esempio era segretario dell'assemblea alla Camera e
difficilmente poteva concedersi delle assenze dalle sedute e dalle votazioni .
Ancor più era impegnato nel Consiglio superiore della pubblica istruzione i
cui verbali attestano quante pratiche, e spesso le più delicate, venissero affi
date per l'istruttoria a lui. Anche Bonghi, con le sue molte creature, era oc
cupato alla Camera, spesso come protagonista e portavoce di una parte della
Destra nelle discussioni sul bilancio e sui più rilevanti problemi politici.
Prendeva parte ai lavori del Consiglio superiore, nonché era impegnato in
una multiforme attività giornalistica nella «Nuova Antologia» e ne «La Perse
veranza». Nel 1 87 3 , inoltre, era stato designato dal governo a commissario
per la partecipazione italiana alla grande esposizione di Vienna compito
che assolse con impegno, e in parte gli impedì di partecipare ai lavori del
l'inchiesta nella sua ultima fase. Infine Cremona e Settembrini non intende
vano rinunciare del tutto ai loro doveri accademici: anche questi rendevano
precaria la loro presenza alle audizioni pubbliche Scialoja comunque riuscì
in qualche modo a impegnare i designati anche se poi dai carteggi interni
della Commissione e da qualche notizia di stampa risulta che la Commissio
ne spesso lavorava a ranghi incompleti fino al caso limite di Torino in cui
l'interrogatorio era condotto dal presidente e da un solo commissario An
che perciò saltarono quasi tutte le ispezioni nelle scuole che secondo il de
creto istitutivo dovevano costituire uno dei punti qualificanti dell'inchiesta,
alle quali anzi Scialoja tanto più teneva quanto più, leggendo i resoconti del
le sedute pubbliche, si rendeva conto che le deposizioni erano inconcluden
ti e retoriche.
Anche la vacuità di molte risposte e quel dovere ascoltare tante volte gli
stessi ragionamenti stancava i commissari: Settembrini avvertì subito questa
noia dell'inchiesta e i suoi colleghi, col proseguire dei lavori, sempre più
condivisero questa sensazione. Tabarrini nei foglietti su cui annotava le im
pressioni delle sedute cui partecipava, con brevi giudizi sui deponenti, giu
dicava inconcludente la maggior parte degli interventi �. E persino il presi
dente della Commissione, Cantelli, viene descritto sonnecchiante durante le
sedute da Camillo De Meis e da qualche giornalista
Se l'idea dell'inchiesta era stata accolta senza entusiasmo ed era giudicata
1•
fu
2•
3:
1 P. CERRI, Tribolazioni di un insegnante di ginnasio . . . cit . , Firenze, Passigli , 1 989; le
memorie di Cerri, laureato a Torino e sanscritista, mandato dal ministero in u na piccola cittadi·
na siciliana, Bivona, e poi deceduto forse in seguito a una malattia contratta nell'inospitale luo
go di lavoro, erano state pubblicate, come contributo all'inchiesta, da Alessandro D 'Ancona su
« La Nazione • , nn. 1 07- 1 1 1 del l 87 3 ( 1 7 , 1 8 , 1 9, 20, 2 1 aprile).
2 Carteggio Tenca-Maf
fei . . . cit., pp. 5 2-53 (lettera del 7 ottobre 1 872); ma già in una lette
ra di poco successiva, dell'8 dicembre ' 7 2 , scrive alla Maffei che il lavoro preparatorio della
commissione d'inchiesta fu rovesciato sulle mie spalle ed io dovetti assumerlo per i l meno ma
le. Non ho mai tanto lavorato quanto in questi giorni • . E anche nei mesi seguenti Tenca, nono
stante i suoi molti impegni, e nonostante la sua assai scarsa fiducia nei risultati dell' inchiesta, fu
uno dei commissari più presenti a i lavori.
3 Bonghi fu nominato giurato italiano per l'istruzione alla esposizione universale di Vienna
con decreto 8 aprile 1 87 3 ; nella carte dell' inchiesta c'è qualche accenno a questo suo impegno
che gli impedì di essere presente a diverse sedute. Su questa sua esperienza, che fra l 'altro gli
suggerì l'idea del Museo d 'istruzione, vedi la sua relazione in R. BON GHI , Discorsi e saggi sulla
pubblica istruzione, I l , Firenze, Sansoni, 1 876, pp. 447-523.
•
27
1•
2•
3;
5.
1 Vedi ad esempio in L . SETTEMBRI N I , Lettere edite ed inedite . . . cit . , p. 1 89, la lettera a Raf
faele Masi del 1 7 maggio 1 873 in cui Settembrini, oltre ad esprimere con forza il suo desiderio
di far lezione, manifesta la sua uggia per le audizioni della Commissione, la quale non fa altro
che udire, e gli stenografi scrivono. Ebbene leggerò quello che avranno scritto gli stenografi e
sarà lo stesso • .
2 Oltre alle d u e lettere torinesi d i Cantelli al ministro, da n o i pubblicate (docc. 1 4 e 1 5) , ve
di in proposito la maligna sottolineatura della Critica dell'istruzione secondaria classica e tec
nica • che così ammonisce il ministro nel numero del 28 maggio 1 87 3 : " Scialoja, siate più ener
gico. Voi nominaste nove componenti la commissione d 'inchiesta. Ve ne ricordate? Ebbene di
questi noue non lavorano che tre o quattro ed anche tavolta solo due • . Toni non diversi si ri
trovano ne l i Baretti • che ironizza sulla Commissione, scomparsa di scena dopo il fiasco tori
nese. Anche la • Rivista di filologia e d 'istruzione classica • , nel resoconto delle sedute d i Torino
deplora l'assenteismo dei commissari.
l L. SETTEMBRINI, Lettere edite e inedite
. cit . , p. 1 83 . Il 1 2 feb. 1873, Settembrini scrive
alla moglie: Ieri incominciammo l ' inchiesta. Stetti seduto cinque ore ad ascoltare discorsi: e
dissi ai miei colleghi che lodavano quei discorsi: questa minestra che ora vi pare saporita l'avre
mo a mangiare ogni giorno per un sei mesi, e ve ne verrà la nausea . . .
' ARCHIVIO D I STATO D I FIRENZE, (d'ora in poi A S F l ) , A rchivio Marco Tabarrini, b . 1 2, ins.
2.
5 I n Carteggi di Vitto1·io lrnbriani. Gli hegeliani di Napoli, ... cit., p. 1 22 , vedi la lettera
di Camillo De Meis del l o set. 1 873 dove è descritto Cantelli con la commissione a Bologna: « e
non ha fatto che sonnecchiare e ripetere meccanicamente l e stesse domande . . . • . Anche l a Cri
tica dell'istruzione secondaria classica e tecnica • del 9 luglio 1 87 3 descrive Cantelli mentre di
rigeva a Torino le sedute pomeridiane • dormigliando e chilificando, egli dalla cui bocca non
uscì mai domanda onde si potesse arguire che sapeva in che consistesse il suo dovere di presi
dente della Commissione .
•
•
•
. .
•
•.
•
'
29
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
dai più un diversivo, una perdita di tempo (di fronte a çui veniva indicata
come assai più efficace la via delle circolari, e si citava ad esempio la nota
circolare , quasi contemporanea all 'annuncio dell' inchiesta, del ministro
francese Jules Simon 1 ) , anche la scelta dei commissari, che era costata tanta
fatica al ministro, scontentò non pochi . La stampa di sinistra e in genere i
rinnovatori e quanti giudicavano obsoleto e antiquato il sistema scolastico
italiano sottolineavano che l ' inchiesta era affidata a uomini della Destra,
certo poco coraggiosi e poco portati alla critica dell 'esistente. Le critiche
non risparmiavano lo stesso presidente Cantelli: non s ' era mai occupato di
scuola; era un politico, che con la sua carriera p refett izia era semmai più
adatto a compiti di ordine pubblico, di polizia. Non era una critica campata
in aria se di lì a pochi mesi Cantelli sarà chiamato a reggere il M inistero del
l ' interno nel governo Minghetti. La stampa cattolica criticava la presenza tra
i commissari di noti anticlericali come Settembrini e Tenca e l 'assenza di di
fensori della libertà di insegnamento 2 . Si notava infine che la commissione
era partigiana: alcuni, i più attivi dei suoi membri , Tenca, Cremona, Bonghi
e Carbone erano giudici e parte nello stesso temp o : giacché per i loro prece
denti e le loro funzioni erano legati ad interessi e a politiche ministeriali . Gli
altri commissari erano magari galantuomini, ma contavano assai poco.
Eppure nel l ' impianto dell' inchiesta c 'era una grande novità da cui pote
vano venire non pochi frutti : i temi della grande inchiesta sull' istruzione
elementare della fine degli anni Sessanta, i quesiti proposti dal ministro Cor
renti nel 1 87 1 , erano tutti diretti o ad autorità politiche e scolastiche o a uo
mini di scuola; si rivolgevano ai competenti, agli addetti ai lavori . E la stessa
caratteristica avevano le molte i nchieste straniere sui temi scolastic i : l ' ulti
ma di esse, probabilmente nota al ministero italiano, la viennese Gymnasial
enquète del 1 87 1 , aveva riunito intorno a un tavolo una trentina tra profes-
sori universitari, professori ginnasiali, amministratori scolastici della C islei
tania, per dibattere e rispondere ad una serie di quesiti.
Con Scialoja per la prima volta viene rotta la barriera dei competent i . So
no chiamati a rispondere anche i padri di famiglia 1 • Potevano altresì essere
ascoltati dalla Commissione tutti coloro che richiedevano di essere intesi . La
platea delle persone investite dall' inchiesta diventava così amplissima, in u n
certo senso illimitata, data l a latitudine dei concetti d i " padri d i famiglia " o
di « persone note per esperienza acquistata nell'insegnamento e nell ' educa
zione della gioventù " · Anche i sindaci che fecero da tramite (accanto ai pre
fetti) per la distribuzione dei questionari sia nelle lettere al ministero con cui
chiedevano un gran numero di questionari , sia nei pubblici avvisi con cui in
coraggiavano i cittadini a presentarsi alle sedute della Commissione, tende
vano a mobilitare un gran numero di persone . In effetti nessuna inchiesta di
quei decenni ebbe forse una così vasta eco d i risposte, anche se quasi certa
mente sono poco attendibili ed esagerati i dati che Scialoja presentò alla Ca
mera alla fine del 1 87 3 ; secondo il ministro sarebbero stati distribuiti
2 4 . 000 questionari, sarebbero giunte 8 . 000 risposte 2• Specie quest ' ultimo
dato, delle risposte giunte al questionario, sembra del tutto inverosimile:
non è improbabile che il ministro, assediato dalle critiche relative all' inchie
sta, abbia gonfiato notevolmente le cifre per simulare una risonanza pubbli
ca dell ' inchiesta che non c ' era stata e andava sempre più decrescendo .
Che l e cifre esibite d a Scialoja nel dicembre 1 873 alla Camera n o n siano
attendibili è dimostrato non tanto dal fatto che oggi nel fondo sono reperi
bili solo circa 500 risposte scritte; in più di un secolo di vicende complicate,
di scarti e dispersioni, si potrebbe anche ipotizzare in astratto la perdita di
28
1
Vedi J. StMON, Le réforme de l 'enseignement secondaire, Paris, Hachette 1 87 4 , pp. 399-
l Sul carattere di parte della Commissione, oltre a qualche accenno nella deposizione tori
nese di Luigi D 'Ancona, vedi per esempio • La Riforma • del 4 nov. 1 87 2 che così scrive: « <
componenti l a Commissione, considerati individualmente, possono essere persone rispettabili
e rispettate: ma, considerati invece collettivamente, ha1mo la sorte (ad eccezione di qualche
semplice sfumatura) hanno la sorte, dico di appartener tutti a quel medesimo partito che ha go
vernato finora • . La stampa clericale spesso in quei mesi parla di Settembrini e di Tenca come di
" cacodemoni • dell'istruzione privata: anche i cattolici liberali erano rimasti perplessi di fronte
al giudizio assai limitativo su Manzoni, espresso da Settembrini nella storia della letteratura ita·
liana. Avevano fatto scalpore infine le sue dichiarazioni, essere cioè preferibile un liberale non
onesto a un clericale onesto. Sollevano obiezioni contro la designazione alla presidenza di Can
telli per esempio il deputato Salvatore Morelli nella seduta della Camera del 30 gennaio 1 87 3 e
la " Critica deli' istruzione secondaria classica e tecnica » dell' 8 ottobre 1 87 3 (quando ormai
Cantelli era ministro dell'interno); in ambo gli esempi si sottolinea che i suoi precedenti prefet
tizi e l 'essere egli digiuno di questioni scolastiche lo rendevano non idoneo a quella funzione. È
in sostanza la stessa obiezione che da più parti nell'inchiesta viene sollevata contro l 'affidamen
to al prefetto della presidenza dei Consigli scolastici provinciali, simbolo, per i clericali, di una
visione accentratrice e nemica della libertà d'insegnamento, per i democratici di una visione re
pressiva e poliziesca della vita scolastica.
1 La questione della partecipazione (mancata) dei padri di famiglia, già avvertita come cen
trale fin dalle sedute napoletane, diventerà la bandiera degli oppositori con le dimissioni, nel
l'autunno del 1 87 3 , di Lioy. Questa impressione negativa rimarrà nella memoria dei commissa
ri; Tabarrini, relatore al Senato sulla proposta Coppino sull'obbligo, nella seduta del l giu.
1 877, dando parere contrario alla proposta del senatore Pepoli di una inchiesta sull'istruzione
elementare, esprimeva l'avviso che le inchieste in Italia • non possono dare nessun risultato » e
portava a prova di ciò la sua esperienza con l'inchiesta Scialoja. Succo e simbolo di questa espe
rienza negativa era stata, per Tabarrini, la mancata risposta all'appello dei padri di famiglia:
" . . . Ebbene, noi cercavamo i padri d i famiglia; noi volevamo che le persone interessate nell' i
struzione secondaria ci dicessero le sue mancanze e i loro lamenti, ci dicessero francamente le
cose in cui credevano che il suo ordinamento peccasse. Noi non avevamo mai, o quasi mai i pa
dri di famiglia che ci rispondessero: avevamo degli ispettori, dei provveditori, dei professori, i
quali sapevamo già quello che ci avrebbero detto, dai loro pareri, e dalle loro rimostranze di
cui son pieni gli archivi del Ministero . . . Per questo, quando fummo per stringere le nostre con
clusioni, ci accorgemmo che erano poca cosa, e non valevano certo le spese che si era fatte per
procurarcele . . . •. Sintomaticamente diverso il punto di vista di Bonghi, che ostentava indiffe
renza rispetto all'assenza dei padri di famiglia, giacché per lui le questioni della scuola sono so
Io questioni tecniche, che solo gli esperti possono trattare e non certo le famiglie: a questo mo
do di considerare le cose corrisponderà del resto tutta la sua condotta ministeriale.
4
l AP, Camera dei deputati, legislatura X l , Ili sessione ( 1 87 3- 1 87 ), Discussioni, l, tornata
del l dicembre 1 87 3 , p. 220.
30
Fonti per la storia della scuola
molti documenti 1 • Ma il censimento delle risposte scritt.e fatto da Casetti e
Folli nella primavera del 1 87 5 , cioè poco dopo la conclusione dell 'inchie
sta, presenta una somma di document i assai vicina alla consistenza attuale
del fondo e remotissima dalle cifre di Scialoja: è certo i n poco più di un an
no è impensabile che ci sia stata una così vistosa scomparsa di carte. È bensì
ipotizzabile che in quei mesi qualcosa, ma assai poco, abbiano scartato Folli
o Casetti (risposte anonime, risposte insignificanti), che qualcosa si sia per
so, per la maniera su cui i due redattori furono costretti a compiere il loro
lavoro di montaggio di estratti , nonché per il fatto che in quel periodo il mi
nistero avviò il trasloco da piazza Colonna a piazza della Minerva: e nei tra
slochi è facile che qualcosa vada perduto o venga gettato via 2 .
Resta comunque chiaro che alla fine del 1 87 3 lo svolgimento dell 'inchie
sta era in crisi: i commissari erano stanchi e sempre meno disponibili a fati
cosi spostamenti; i primi fondi stanziati per l ' inchiesta si erano già esauriti e
non era facile per il ministro reperirne altri , tanto più che dal mondo della
scuola veniva sempre più forte (come confermano anche molte deposizioni
e risposte scritte) la domanda di aumenti di stipendio: se c 'erano dei fondi
disponibili non si sprecassero nel l ' i nutile inchiesta ma servissero piuttosto a
rendere più dignitose le condizioni di vita degli insegnanti . I lavori della
commissione trovavano anche sulla stampa e nell'opinione pubblica, sem
pre più sfiduciata, una eco sempre minore. È del resto caratteristico il com
mento conclusivo de « La Perseveranza >> alle sedute milanesi (4- 1 0 novembre
1 87 3) 3: c 'era stato sì un notevole concorso di uomini di scuola e di cittadini
1 Le cause del possibile smarrimento di carte possono essere le più varie; la più facilmente
ipotizzabile è quella del prelievo da parte di funzionari per uso di ufficio di documenti che poi
non sarebbero stati ricollocati. Per esempio i n margine al documento 29 settembre 1 873 del
Consiglio superiore (ACS, M P I , Div. scuole medie, 1860-1896, b. 4, fase. l ) c'è la seguente no
tazione: « a marzo 1 878 le proposte della Commissione d ' inchiesta e la Relazione a S . M . ritirate
dal commendator Gabelli che le ha perdute. 30 marzo 1 880 • . • L'Osservatore scolastico • ,
1 8 8 1 -'82, del 2 nov. 1 88 1 , p. 77, nella s u a • Cronaca dell' istruzione • riporta: • Acquista sempre
più credito la grave notizia della sparizione dei documenti concernenti l ' inchiesta nell'istruzio
ne secondaria del 1 87 5 Nella sezione delle deposizioni orali i due smarrimenti più vistosi so
no quelli della deposizione romana dell'ex ministro Domenico Berti e quelli della deposizione
veneziana del deputato Paulo Fambri. Di quest ' ultimo forse offre una spiegazione un appunto
di Antonio Casetti in margine sulla busta delle deposizioni veneziane " Il discorso del Fambri
stampato è presso di me •. Non va dimenticato che Casetti morì in corso d 'opera: è facile che si
siano smarrite le carte in suo possesso al momento del trapasso. Poteva infine capitare che i
due collettori del materiale, Folli e Casetti, per la necessità del loro lavoro trattenessero e ma
gari smarrissero qualche carta. Per esempio tra le risposte scritte manca proprio quella di Folli,
presente nell'inventario da lui curato nella prima dispensa degli atti dell ' inchiesta. Si può co.n
getturare che l'abbia trattenuta e conservata per sé?
2 Per esempio da una lettera di F. Fiorentino a Tallarigo del 1 87 1 , che gli chiedeva alcune
verifiche su alcuni quotidiani napoletani da fare alla biblioteca della Camera, risulterebbe che
nel trasporto della capitale da Firenze a Roma la biblioteca avrebbe venduto gran parte della
sua emeroteca (ACS, MI'!, Personale, 1 860-1 880, b. 1 1 58, fase. " Tallarigo Carlo Maria »).
' Coincide con la valutazione de • La Perseveranza• del 13 nov. 1 873 (doc. 77, p. 594) quanto
scrive nella sua risposta serina, redatta dopo le audizioni milanesi, Giovanni Gattoni: • lo ammiro,
».
Introduzione
31
che erano venuti ad esporre i loro punti di vista; non erano mancate deposi
zioni di alto livello (Ascoli, H ajech); eppure, notava il giornale, dall' inchie
sta ormai, dopo più di quaranta sedute , vicina alle conclusioni , non era
emersa una chiara linea di riforma, che il ministro potesse assumere; l ' unico
frutto di tutta quella fatica poteva essere una lezione di reciproca tolleranza
per i diversi progetti educativi: risultato assai magro per una inchiesta che
nelle intenzioni di chi l ' aveva promossa, doveva orientare l' opera del gover
no; anzi , secondo quanto aveva detto nel gennaio alla Camera il ministro
Scialoja, d ifendendosi dalle prime critiche, il fine più vero della iniziativa
era quella di dar forza al ministro attraverso un sostegno dell' opinione pub
blica.
Anche i l provveditore agli studi di Vicenza, Cesare Cavara, in una delle
ultime deposizioni rese ai commissari a Venezia, osservava che, dopo tanti
interrogatori, la conclusione da trarre forse era quella che non ci fossero da
introdurre mutamenti sostanziali nell' ordinamento delle scuole secondarie 1 •
Ma allora che senso aveva avuto quel girovagare dei commissari in cerca di
pareri?
Ma il colpo di grazia definitivo venne dal voto con cui la Camera alla fi
ne del gennaio 1 874 bocciò, grazie a non pochi franchi tiratori, il progetto
Scialoja sull ' obbligo scolastico. Il ministro aveva ormai registrato solo scon
fitte : l ' inchiesta sull' istruzione secondaria era impantanata, nulla s i era rea
lizzato per l ' università (e tra l' altro la nuova università di Roma, che doveva
essere il s imbolo della nuova cultura da promuovere sulle rovine della vec
chia superstizione, della retorica e dell' antiquaria, stentava a decollare) 2 ;
ora infine veniva bocciata l a legge sull' obbligo scolastico. S e già nell' estate
del 1 87 3 , al momento della costituzione del governo Minghetti, Scialoja, già
deluso, era rimasto al suo posto, solo per poter portare a compimento i due
più rilevanti impegni assunti, la legge sull'obbligo scolastico e l' inchiesta
sulla secondaria, ora che i suoi obiettivi l ' uno dopo l ' altro, erano manifesta
mente falliti, non gli restava altra via che quella di presentare le sue irrevo
cabili dimissioni .
Si ripeteva dunque, in forma anche più grave, la vicenda del maggio
1 872 quando si era dimesso Correnti, il predecessore di Scialoja . Ora però l a
Destra al potere era i n difficoltà anche maggiori n e l fare chiarezza n e i propri
orientamenti di politica scolastica e nello scegliere un ministro idoneo a tradavvero, la pazienza degli onorevoli commissari, messa a così dura prova, ed affermo che non
sarà da imputarsi a colpa loro se, dopo che saranno stati tradotti, raccolti, confrontati i proces
si verbali degli stenografi, si troverà impresa difficile, anzi impossibile, il prendere provvedi
menti, che accontentano gusti così vari, aspirazioni così opposte • (ACS, MPI, Div. scuole me
die, 1860-1896 , b. I O, fase. 7 2 ) .
1 !bid. , b . 6 bis, fase. 5 I .
1 Sulle molte difficoltà incontrate nella creazione della nuova università di Roma prima da
Correnti e poi da Scialoja, vedi ora S . POLENGH I , La politica universitaria italiana nell 'età del
la Destra storica 1 848- 1 8 76, Brescia, La Scuola, 1 99 3 , pp. 382-397, 4 1 1 -4 1 7 nonché alcune
delle lettere di Scialoja pubblicate da Paolo Alatri (cfr. n. l , p . 1 6).
32
33
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
durli in atti di governo, vincendo le insidie parlamentar.i e superando le di
visioni interne alla maggioranza. Se allora, nel 1 87 2 , erano· stati necessari
due mesi di interim affidato a Sella, per scegliere il nuovo ministro, ora l ' in
terim, affidato al ministro degli interni , Cantelli, durò più di sette mesi. Solo
il 2 7 settembre 1 874 fu insediato al Ministero della pubblica istruzione il
nuovo ministro, Ruggero Bonghi. Era senza dubbio l ' uomo più preparato sui
temi della scuola, dell'università, della cult ura, che la Destra potesse mette
re in campo . Innumerevoli, eloquenti ed argomentati erano stati i suoi inter
venti sugli argomenti della pubblica istruzione alla Camera, al Consiglio su
periore, nella stampa. Ora, tra le speranze di molt i , veniva messo alla prova,
lui che non aveva risparmiato critiche ai suoi predecessori, da Matteucci e
Correnti . Ci si attendeva che dopo tante circolari , tanti regolamenti , dopo
l ' inchiesta, egli fosse in grado di fare una politica, di dare un nuovo ordina
mento alla scuola. Senonché egli dichiarò subito la s ua diffidenza per le
grandi riforme, e soprattutto per la via legislativa alle riforme; anche così fi
niva per vanificarsi la somma di pareri e di esperienze raccolte durante l ' in
chiesta Scialoja. Tutta quella mobilitazione del mondo della scuola e più in
generale dell ' opinione pubblica avrebbe prodotto solo i l frutto modesto di
alcuni ritocchi di poco conto nelle procedure di esame e in altri aspetti se
condari della vita dei ginnasi, dei licei, e delle scuole tecniche e normali.
Aveva avuto ragione Petruccelli dalla Gattina nella previsione formulata al
l ' apertura dell' inchiesta: « il resultato sarà nullo » .
delle conclusioni parziali , trascegliendo d a l materiale raccolto alcune que
stioni di secondo ordine , sulle quali si fosse manifestata una più ampia con
vergenza di pareri e che per la loro dimensione strettamente tecnica non
sollevassero polemiche ideologiche. Ma anche in questa vicenda il trascorre
re del tempo portò a un progressivo attenuarsi delle ambizioni di riforma .
Giacché, s e l a commissione d'inchiesta nella fase conclusiva dei suoi lavori,
nella primavera del 1 87 4 , aveva elaborato u n pacchetto di proposte che pre
vedeva quasi una trentina di interventi di modifica della legislazione vigen
te, i passaggi successivi di queste proposte attraverso il parere del Consiglio
superiore e degli uffici ministeriali portarono a u na drastica riduzione del
numero degli interventi che finirono poi per accorparsi in due brevi decreti
reali, miscellanei nella loro composizione e che Cantelli portò alla firma del
sovrano poco prima di lasciare l ' interim ; sicché a Bonghi non restò altro
compito che quello di emanare nei mesi successivi alcune circolari esplica
tive.
Ma ancora più rivelatrice è la vicenda della mancata pubblicazione degli
atti d eli' inchiesta. Il decreto istitutivo del 29 se t. 1 87 2 aveva previsto al
l ' art . 5 che « gli atti dell ' inchiesta saranno p ubblicate nei modi e nelle forme
che dalla commissione verranno stabiliti " · Salta agli occhi il fatto, che men
tre per l ' inchiesta industriale , promossa pur essa da Scialoja nel 1 87 1 , per la
pubblicazione completa degli atti (relazioni delle Camere di commercio, de
posizioni , ecc . ) si provvide sollecitamente e tra il 1 87 3 e il 1 874 uscirono
molti volumi per migliaia di pagine (che di recente sono stati ristampati in
tegralmente) 1 , la stampa degli atti dell ' i nchiesta scolastica dopo una fat ico
sa gestazione si arenò subito dopo che ne era uscita una prima esigua di
spensa nell 'estate del 1 87 5 . Molti sono i motivi di questo diverso destino
delle due inchieste . I nnanzitutto la prima offriva nelle deposizioni u n mate
riale vivo : erano industriali e commercianti che si facevano portavoce dei
loro concreti interessi; la seconda si disperdeva in molte chiacchiere, era ri
petitiva: erano professori col vizio tutto letterario della retorica e le loro
proposte non erano quasi mai concrete; in alcuni pochi casi erano costru
zioni utopistiche, più spesso erano prpposte di ritocchi particolarissimi; per
la verità erano a ciò stimolati anche dalla minuziosità dei quesiti, come sin
dalla loro divulgazione non pochi critici e fra essi, con garbo lo stesso mini
stro, non mancarono di rilevare 2 . I noltre, specie nelle risposte scritte, ove
L 'affondamento dell 'inchiesta
Poi, come succede a certi fiumi africani, l ' inchiesta si perse del tutto tra le
sabbie dell'inerzia ministeriale. Se, quando Scialoja si dimise, essa era già sulla
via di un tramonto in tono minore, successivamente, da un lato l' inefficenza
strutturale nel funzionamento degli apparati della pubblica istruzione, dall' al
tro le vicende private di coloro che avrebbero dovuto perpetuarne la memo
ria e soprattutto la mutata situazione politica fecero sì che su t utta l ' inchiesta
scendesse il più profondo oblio: pulvis et umbra, per usare ancora la profeti
ca espressione di Petruccelli della Gattina dell'autunno del 1 87 2 .
I l ministro ad interim succeduto a Scialoja, Cantelli , che per nove mesi
era stato presidente della commissione d ' inchiesta e aveva fatto esperienza
sufficente dello scarso frutto dei suoi lavori (e le sue lettere al ministro da
Torino, ultima città ove esercitò la presidenza, lo confermano), assunse i n
pratica i l ruolo d i commissario liquidatore dell ' inchiesta, ponendo fine alla
sua lenta agonia e facendone concludere i lavori in fretta e in sordina. Sparì
così dal programma l ' idea di una relazione finale complessiva, che secondo
qualche notizia di stampa, doveva essere affidata a Bonghi 1 ; si scelse la via
4 4 agosto 1 87 4 , p . 6 38, che infor
1 Vedi per esempio • L'Osservatore scolastico • , 1 873-'7 ,
ma che la commissione ha altresì incaricato l 'onorevole Bonghi di stendere una relazione ge•
nerale sull'inchiesta, da presentarsi al Parlamento
Accanto alle ragioni politiche generali
che fecero rinunciare alla relazione generale, probabilmente intervenne una difficoltà formale:
non era possibile, divenuto ministro Bonghi il 27 settembre, che egli, come relatore della com
missione, presentasse a se stesso, come ministro, la relazione conclusiva.
1 A lti del Comitato dell'inchiesta industriale (1870- 1 8 ...,4). San G iovanni Persiceto, Analisi
Trend, 1 98+ 1 987 , voli . 9 .
' C ' è una evidente contraddizione tra i l carattere politico generale che Scialoja voleva dare
all' inchiesta. appellandosi ai padri di famiglia, e il carattere più tecnico che era nelle intenzioni
di alcuni commissari e soprattutto di Bonghi (cfr. n. l , p. 29). Nella lettera indirizzata da
.
. "·
34
Fonti per la storia della scuola
cadeva il muro di pudore dato dal parlare in pubblico, erano frequenti le
eterne lamentele per il misero trattamento economico e per il- mancato rico
noscimento della dignità sociale del professore. I ministri e i funzionari, cui
spettava il compito di promuovere la pubblicazione degli atti dell 'inchiesta,
non erano certo invogliati a farlo dalla deludente monotonia di gran parte
dei testi. In secondo luogo dietro l ' i nchiesta industriale stava un ministero,
quello di agricoltura, industria e commercio, molto attivo, portato all ' inda
gine sociale, alle statistiche, che andava costruendo una ricca e fornita bi
blioteca, che produceva « piramidi di carta » , cui allude con qualche ironia
Pasquale Villari nella sua polemica del novembre 1 87 2 con Luzzatti 1 • Basti
ancora ricordare per sottolineare la sua prontezza nel dar fuori i risultati
delle proprie inchieste che, proprio in quegli anni, il nuovo m inistro Finali
commissionò al segretario generale Morpurgo una ricerca sugli istituti tecni
ci; Morpurgo in pochi mesi provvide a raccogliere i pareri dei competenti e
già nel 1 87 5 vedeva la luce a sua cura un ricco volume ministeriale che co
stituisce un quadro assai attento della situazione 2 . Tutt ' altra cosa era il Mini
stero della pubblica istruzione; aveva perso mordente dopo i primi anni di
efficente attivismo e anzi perdeva sempre più le penne 5 . Era un infaticabile
Scialoja a Cantelli il 25 gen. 1 873 (vedi doc. 8 ) dopo la lettura dei quesiti predisposti dalla
Commissione il ministro esprime il timore che le persone non addette ai lavori di fronte ai
• dotti quesiti ne sarebbero come sgomentate e soprafatte • . Come esempio di minuziosità si ve
dano i quesiti sugli esami (2 3-30) con la loro casistica sulla formazione delle commissioni, i
tempi delle prove, il rapporto tra la valutazione scolastica e quella dell'esame ecc. Vero è che
dietro gli aspetti tecnici della questioni si intravedono problemi politici-culturali: la questione
del carattere di cultura generale o professionale del liceo ecc . , la questione poli t ica del control
lo attraverso gli esami sulla istruzione non governativa. Si noti infine che la bozza di questiona
rio predisposta da Settembrini (cfr. n. l , p. 1 66) ha un carattere assai meno tecnico, un taglio
assai più puntato sull'educazione che sull'istruzione.
1 Sulla polemica Villari-Luzzatti vedi P . VILLAR!, La scuola e la quistione sociale in Italia ,
in • Nuova Antologi a • , 1 87 2 , vol . 2 1 , fase. XII, pp. 477-5 1 2 , (in particolare p. 483) e L . LUZZAT·
TI, Sull 'ordinamento degli istituti tecnici, ibid. , vol. 2 l , fase. X I I , pp. 9 5 1 -957.
2 Vedi E . MORPURGO, L 'istruzione tecnica i n Italia. Relazione a l Ministero d i agricoltura
industria e commercio, Roma, Barbera, 1 87 5 .
1 Nonostante la s u a vocazione per la statistica, Correnti nulla aveva fatto per attrezzare il
·
ministero a questi studi. L ' unico che in qualche modo, durante il suo incarico, tentò di risolle
vare il prestigio del ministero e di dargli una qualche capacità di analisi e di ricerca fu Bonghi,
soprattutto attraverso tre strumenti: a) il " Bollettino ufficiale •, di cui promosse la pubblicazio
ne dalla fine del 1 874 e che nei suoi primi anni, oltre agli atti dell 'amministrazione, riportava
anche statistiche, relazioni, estratti degli atti del parlamento e del consiglio superiore, studi, al
cuni dei quali anche tradotti da riviste straniere, specie tedesche; b) il Museo pedagogico aperto
nel 1 87 5 con materiale didattico vario che Bonghi aveva acquisito a Vienna, alla chiusura del
l ' Esposizione universale; c) la collana di " Studi di legislazione scolastica comparata " che il mi
nistro affidò ad un nuovo editore, nato da poco, Sansoni , e della quale uscirono quattro volumi
tra il 1 87 5 e il 1 877 (di cui due di scritti di Bonghi); quest'ultima iniziativa fu abbandonata dai
ministri della Sinistra. Sulla situazione di crisi della capacità operativa e documentaria del Mini
stero della pubblica istruzione all'inizio degli anni Settanta, si veda soprattutto R. BONGHI, Di
scorsi e saggi . . . cit . , p. XXII: • Povero Ministero d 'istruzione pubblica! In tutti questi anni gli
Introduzion e
35
produttore di circolari, un parco produttore di studi; non aveva neanche
una sua biblioteca e a lungo non l ' avrà, come noterà nel 1 894 un suo alto
funzionario, Giuseppe Chiarini, che lo definiva il ministero più digiuno di
cultura fra tutti i ministeri 1• Il personale che lavorava alle scrivanie di Piazza
Colonna era di letterati; talvolta vi si trovavano ancora gli ultimi stanchi re
sidui del vecchio metodismo; non mancavano fra esso parecchi sacerdoti o
ex sacerdoti . Per molti aspetti era insomma una roccaforte del vecchio mon
do . Era tra quel personale una rara avis un uomo come Aristide Gabelli,
studios o di scienze sociali, o come Gerolamo Buonazia, laureato in fisica e
matematica, e curatore di quei Documenti sull 'istruzione p rimaria, usciti
tra il 1 868 e il 1 873, che costituiscono una preziosissima fonte per la nostra
storia sociale di quegli anni . Non per nulla Bodio che sovrintendeva nel Mi
nistero di agricoltura, industria e commercio ai servizi statistici, volle l ' uno
e poi l'altro nella Giunta per la statistica, ben sapendo che, per esempio, un
uomo come Buonazia, che aveva la direzione della scuola elementare e per
ciò governava 40 . 000 maestri, era preziosissimo per i censimenti e le stati
stiche che allora, sopratt utto nelle campagne, avevano nei maestri un soste
gno indispensabile. Ma, a parte queste e poche altre sporadiche eccezioni, la
baracca della pubblica istruzione era pochissimo attrezzata all' indagine so
ciale e all' elaborazione dei dati di una inchiesta.
Per la pubblicazione degli atti dell ' inchiesta Scialoja si scelse non la for
ma integrale, sconsigliabile per il volume e i costi che avrebbe richiesto; si
volle anche evitare la monotonia delle troppe ripetizioni che avrebbero
aduggiato l' opera. Si optò per una pubblicazione parziale dei risultati del l ' in
chiesta in forma riassuntiva. I curatori avrebbero dovuto scegliere, su ogni
questione posta dai quesiti, i pareri più significativi traendoli dalle deposi
zioni orali e dalle risposte scritte, riportando in calce ai singoli excerpta, ol
tre al nome dell 'autore, anche i nomi di quanti nel corso dell' inchiesta ave
vano prospettato pareri o soluzioni analoghe, in modo da avere, almeno ap
prossimativamente, anche un censimento quantitativo delle diverse propo
ste. Per questo complesso lavoro di montaggio, del quale si possono vedere
le tracce nelle carte dell' inchiesta, furono incaricati due valenti p rofessori,
più misero uccello di
sono state strappate le penne di qua c di là. e non si può immagina re un
o il Ministero ,
sottopost
stato
è
cui
i
spoliazion
le
lui • ; e nelle pagine successive Bonghi enuncia
Bari Gennaro Mo
di
tecnica
Scuola
della
direttore
Il
III).
XXV
(p.
Archivi
degli
all'ultima
fino
e commercio co
scaielli, nella sua risposta >Critta, descrive il Ministero di agricoltur a industria
Div. scuole rned1e,
me " talvolta lussureggiante a spese della miseria dell'altro , (ACS, MPI,
delle due amminist ra
186 0- 1896 , b. I l . fase. 77). Ma l ' analisi del tipo di cultura del personale
a industria e
zioni conferma soprattutt o la superiorit à documen taria del Ministero di agricoltur
del ministero
generali
segretari
Maestri,
che
Luzzatti
sia
che
ruolo
al
pensare
basta
io:
commerc
.
in quegli anni, ebbero nel promuov ere la pubblicaz ione di studi e statistiche
uova Antologia • ,
1 G. CHIARINI, La scuola classica in Italia dal /860 ai nostri giorni, in "
.
7
S
-J33--J
.
p
p
XV.
fase.
,
ibid.
e
250-270
.
p
p
1 89 -J , vol . S 2 , fase. XIV,
36
37
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
Antonio Casetti 1 e Riccardo Folli 2 , leccese il primo, lombardo il secondo,
con l ' incarico dello spoglio, il primo delle deposizioni orali, il secondo delle
risposte scritte. Ambedue erano stati trasferiti a Roma nell'ottobre del 1 872
per insegnare al Visconti, il nuovo ginnasio liceo governativo , ove il mini
stero cercava di chiamare da altre sedi i migliori i nsegnanti , per combattere
la concorrenza di gesuiti e scolopi . Senonché ambedue, proprio mentre si
accingevano al lavoro, incontrarono difficoltà sempre maggiori. Casetti era
di salute cagionevole e perciò nell ' inverno del 1 874-'75 fu sollevato dai do
veri dell' i nsegnamento e comandato prima al neonato Museo d' istruzione,
poi al ministero (probabilmente per il lavoro sull ' i nchiesta); aggravatesi ulte
riormente le sue condizioni di salute, chiese di tornare nella natale Lecce, di
cui fu nominato provveditore degli studi, carica che ricoprì per brevissimo
tempo, perché a Lecce morì 1 ' 8 luglio del 1 87 5 ; perciò la sua collaborazione
all ' apprestamento dell'edizione degli atti fu assai scarsa. In pratica il lavoro
di montaggio venne a ricadere quasi tutto sulle spalle di Folli, che però, no
stalgico anche lui dell'aria natia, ottenne di ritornare a Milano al Beccaria
nel settembre del 1 87 5 . Fu questa una ulteriore complicazione perché biso
gnava far viaggiare continuamente le carte dell' inchiesta tra Roma e Milano;
il che non solo rallentava il lavoro ma comportava anche i l rischio di qual
che smarrimento di carte.
Nonostante che da Roma giungessero a Folli frequenti sollecitazione per
ché concludesse l ' opera, dopo l' uscita della prima dispensa nell'agosto del
1 87 5 , il lavoro si arrestò; Folli stesso era probabilmente poco disponibile,
anche perché il suo ritorno all' ambiente milanese lo aveva stimolato a un la
voro più gratificante. Si stava dedicando a Manzoni e nel 1 877 farà uscire un
grosso volume, prefato in modo lusinghiero da Bonghi, cioè l ' edizione dei
Promessi Sposi, con il confronto interlineare delle diverse redazion i : u n ' im
presa che certo gli sarà costata più fatica ma meno noia che non le cure re-
dazio nali sulla Scialoja e che segnò una svolta importante negli studi manzo
niani .
Ma ancor più che dagli indugi e dai ritardi di Folli il destino fallimentare
della pubblicazione degli atti dell ' i nchiesta fu determinato dalla rivoluzione
parlamentare del marzo 1 876. Giacché se Bonghi, pur scettico e poco entu
siasta, durante il suo ministero non poteva esplicitamente abbandonare l' im
presa della pubblicazione, non foss ' altro per avere egli stesso partecipato ai
lavori dell' inchiesta come commissario, C oppino, il suo successore, non era
trattenuto da alcun vincolo. La Sinistra ora al potere non aveva mai mostra
sto simpatia per l ' inchiesta di Scialoja: aveva anche criticato la composizio
ne della commissione, t utta di parte moderata; e perciò ora poteva lasciar fi
nire nel nulla la sempre più stanca fat ica di Folli, tanto più che nell' ottica
del nuovo ministro l'annosa disputa sulla scuola secondaria della quale pro
prio l ' inchiesta aveva mostrato la complessità, cedeva il passo di fronte a
una scelta prioritaria e caratterizzante , cioè la legge sull' obbligo scolastico
che Coppino, dopo il fallimento di Scialoja nel 1 874 , portò in porto in po
chi mesi .
Caduta ogni velleità di pubblicazione degli atti dell' inchiesta, questa ben
presto uscì dalla memoria storica degli stessi addetti ai lavori . Pochi anni
dopo, Chiarini, nel 1 894 , nell'articolo già c itato di storia della scuola classica,
la ricorderà con un cenno fugacissimo e sbagliandone anche la collocazione
cronologica, nonostante che egli stesso nel 1 87 3 , preside a Livorno, avesse
risposto con i suoi colleghi del liceo ai quesiti dell ' inchiesta 1 • Ancor più si
gnificativo è il fatto che Paolo Boselli, commissario dell ' i nchiesta tra i l 1 87 3
e i l 1 874, quando agli inizi del nuovo secolo fu chiamato a presiedere i lavo
ri di una nuova e più fortunata commissione d ' inchiesta sulla scuola media ,
fece accompagnare la relazione conclusiva dei lavori da una ampia storia
delle vicende istituzionali della scuola secondaria, in cui sono ricordati con
molta minuzia tutti i ministri con le loro iniziative legislative, i loro decreti
e le loro circolari : ma c ' è un vuoto tra l ' uscita di scena di Correnti e l ' arrivo
al ministero di Bonghi . Non c ' è una parola su Scialoja e sulla sua sfortunata
inchiesta, sulla quale quasi sembra pesasse una vera damnatio memoriae 2 •
1 Antonio Casetti (Lecce 30 marzo 1 840 - ivi 8 luglio 1 875), diplomato all'Università di Na
poli nel 1 867 . Insegnò giovanissimo all'Accademia scientifico-letteraria di Milano con l'incari
co di tenere lezioni propedeutiche all'insegnamento dell'italiano, per essere trasferito nell'otto
bre 1 872 al Visconti di Roma, e passare infine nel novembre 1 874 alta direzione del neo costi
tuito Museo d'istruzione e nel maggio 1 87 5 al Provveditorato di Lecce. Letterato, collaborò
con Vittorio Imbriani nella raccolta di canti popolari dell 'Italia meridionale.
2 Riccardo Folli (Castelnuovo Bocca d 'Adda 1 844 - Porto Maurizio 1 7 dicembre 1 889), di
plomato all'Accademia scientifico-letteraria di Milano, vinse il concorso al ginnasio Beccaria
nel 1 865: i verbali di questo concorso, che lo videro gareggiare con un insegna.nte anziano di
tipo tradizionale, il Cossi, conservati in MPI, Consiglio superiore della pubblica istruzione
(d'ora in poi CSPI), Processi verbali, 1 868, pp. 2945-3022, costituiscono uno dei documenti più
significativi della lotta in corso nel giovane regno tra tradizione e innovazione. Chiamato al Vi
sconti di Roma nel 1 872, tornò a Milano al Beccaria nel 1 875; pubblicò nel 1 877 l'edizione delle
diverse versioni dei Promessi sposi, che ebbe notevole diffusione nette scuole; autore di uno stu
dio sull'istruzione all'estero (Le scuole secondarie classiche italiane e straniere: confronti, note e
proposte, parte I, Milano, Briola, 1 882) fu attivo nella vita associativa degli impiegati e degli inse
gnanti a Milano; finì la sua carriera come provveditore dal 1 887 a Porto Maurizio.
1 G. Chiarini, nel suo articolo La scuola classica in Italia . cit . . p . 259, fa nominare la
Commissione d'inchiesta nel I 87'! .
' L'unico o quasi, nella copiosa pubblicistica di politica scolastica di fine Ottocento, che
mostri un qualche apprezzamento per il lavoro dell'inchiesta Scialoja è Aristide Gabelli che in
un saggio del 1 888, ora in L 'istruzione in Italia , Bologna, Zanichelli, 1 903, pp. 2 2 1 -2 5 7 , sot
tolinea, a proposito delle riforme da introdurre, come " sotto questo aspetto l'ir1chiesta del
1 872 ha ancora una grande importanza " (p. 254), oltre, naturalmente, a R. FOLU, Le scuole se
condarie classiche
cit . , pp. 22-23: " una sola pubblicazione forse poteva dare e i l caos e l 'or
dine in questa selva di questioni appartenenti all'istruzione secondaria. Quella, appena inco
minciata delle risposte orali e scritte fatte alla Commissione d' inchiesta nel 1 873 . . Ma l'ardore
con cui l'inchiesta fu principiata e compiuta, trovò uguale più tardi lo scoramento e la freddez
za; nel governo forse perché troppi i consiglieri e troppo diversi i consigli, nel pubblico perché
egli non vide di essa che qualche fiore e nessun frutto .
. .
. . .
.
.
"·
38
Font i per la storici della scuola
Introduzion e
La crisi della scuola secondaria negli anni Settanta
All 'indomani del 1 8 59-'60 , la Destra al potere aveva valut ò per la scuola
secondaria mirare in alto 1 ; pareva necessario dare per questa via unità cul
turale ai ceti medi del nuovo Stato, individuati, anche nella relazione di
Scialoja al re, come lo strumento più delicato e decisivo per la costruzione
dello Stato. Ma non era facile, per ragioni oggettive e per soggettive inade
guatezze della classe dirigente, mirare in alto. B isognava innanzitutto pagare
lo scotto alle necessarie improvvisazioni, tanto più i nevitabili nel convulso
succedersi degli eventi, per esempio nel reclutamento e nelle nomine dei
nuovi i nsegnanti. Inoltre la politica scolastica degli Stati pre-unitari , se aveva
ali � spalle � n � �ualche non spregevole elaborazione per le scuole primarie
(dat metodtsti piemontesi a Lambruschini), non forniva (se non forse nelle
regioni governate dall' Austria) un plausibile modello di riforma della scuola
secondaria; l ' Ottocento scolastico italiano, detto in altre parole, non poteva
vantare né un H umboldt né un Cousin . Ben presto perciò nel corso degli an
ni Sessanta, nell' assenza di un progetto nazionale, e con crescente impulso
dopo Sadowa e Sédan, questo rinnovamento finì con l' assumere il modello
formativo prussiano; l ' obiettivo era quello di imitare la prestigiosa scuola di
cultura tedesca, il Gymnasium e quanto contornava il Gymnasium, cioè la
Realschule e il Realgymnasium. Nel 1 870 il ministro Correnti i n parlamento
a chi gli rinfacciava la grave colpa di voler germanizzare la scuola, i nterrom
pendo l ' obiettore, rispondeva che anzi egli avrebbe vol uto germanizzarla
ancora di più 2 . Senonché questo obiet tivo doveva fare i conti con una tena
ce tradizione culturale di vecchio tipo che aveva i suoi quarti di nobiltà nel
la scuola del marchese Puoti, nella retorica dei collegi gesuiti, nel paolotti
sm o dei moderati toscani e dei loro modesti eredi . Non era facile per i mini
stn_ d �lla Destra e per i funzionari del ministero, per gli ispettori, per i pro
fesson, per tanta parte formatisi nel recinto angusto di quella vecchia cultu
r � , dar corpo concretamente ad un nuovo principio educativo importato
d oltralpe, facendo perno per esempio non più sulla retorica ma sulla filolo
gia e perciò imponendo, quasi come una prova del fuoco per la futura classe
dirigente, l ' indigesto greco, tanto più indigesto in quanto affrontato attra
verso il Curtius e le novità della linguistica comparata: le carte dell ' inchiesta
offrono mol � i documenti di una generale insofferenza verso questo obbligo
del greco, dtffusa non solo fra gli studenti - col loro " abbasso Senofonte ,
ma tra i genitori e tra gli stessi professori che poco lo masticavano 5 . Ancora
_
1 Vedi M. CorPINO, Michele Coppino, 1882- 1 901. Scritti e discorsi.
A lle radici dello Stato
laico, a cura di A . A . MOLA, Alba, Famija Albeisa, 1 978, p. <-� 2 5 .
' AP, Camera dei deputati, legislatura X , I l sessione ( 1 869- 1 870), Discussio
ni, l , tornata
del 1 2 aprile 1 870, p. 1 0 10 .
' Testimoni a in proposito G . FINA LI , Memorie . . . cit . , p . 330: • Mi rimase però
l 'impressio
ne condtvtsa con Cantelli e Cremona, che di greco tutti poco o nulla sapessero
, a cominciare
:
dat professon E lo �tesso Finali, tutt 'altro che digiuno di cultura classica ed
elegante tradutto"·
39
più difficile era poi dare corpo a questo principio educativo nella filosofia,
abbandonando l ' approdo risorgimentale di un vaporoso giobertismo, nell 'i
potesi migliore, per confrontarsi con l 'eredità di Hegel o con le nuove scien
ze positive; anzi in questo campo i tabù ideologici e il timore di impaurire la
borghesia moderata finivano per imporre - e anche ciò emerge con chiarez
za dall 'inchiesta - prudenze e silenzi e tagli a tutte le parti « pericolose » del
programma di insegnamento della filosofia 1 • Di fronte a questo ambizioso
tentativo la vecchia cultura trovava rifugio nei numerosissimi istituti non
governativi di istruzione secondaria, fossero a Napoli e dintorni gli stinti
eredi della scuola del marchese Puoti, fossero tanti istituti o sopravvissuti al
passato o messi su ex nova, di carattere speculativo, che promettevano di
plomi facili e corsi abbreviati in concorrenza con le esagerate pretese delle
scuole governative, fossero i tanti piccoli ginnasi provinciali e comunali ,
aperti più per soddisfare le ambizioni del piccolo notabilato locale che per
una reale esigenza di cultura, fosse soprattutto la fitta rete delle scuole, dei
seminari e dei collegi retti dal clero che godevano di una solida fama per la
loro tradizione pedagogica secolare, e che , nell'esempio più illustre, gli sco
lopi di Firenze, aveva conquistato la simpatia e il sostegno dei liberali tascare di Plauto, confessa che lui • a malapena sapeva soltanto leggere " la lingua greca. Quanto egli
afferma, che ci fosse una " larga maggioranza favorevole al mantenimento dello studio della lin
gua greca non corrisponde al dato che si ricava dalla lettura delle deposizioni e delle risposte
scritte, dove i difensori del greco sono nettamente minoritari e del t utto isolato è il parere di
Francesco D ' Ovidio (vedi doc. 26) che nella sua deposizione bolognese sottolinea con compia
cimento i notevoli progressi compiuti nel greco in un decennio. Prevalgono nettamente i radi
cali abolizionisti, che sviluppano un argomento di opposizione alla paleofilia sulla scia dell'arri
colo di commento all ' inchiesta di Petruccelli della Gattina (vedi doc. 67) e tra essi, ad esempio,
Branzolfo Toia (ACS, MPl, Div. scuole medie, 1 860- 1 896, b. 8, fase. 67), che giudica inutile e
dannoso l'insegnamento del greco (ai greci, corruttori della civiltà italiana nell'umanesimo egli
rimprovera di averci fatto dimenticare • la grandezza del Trecento, la robusta poesia di Dante »)
e quanti - e tra essi uno studioso come Amari (vedi doc. 20) - propongono una attenuazione
dello studio del greco, da ridurre a livello elementare, e soprattutto quanti vorrebbero renderlo
opzionale, e dunque non più elemento fondamentale della cultura generale dei ceti medi, ma
strumento professionale solo per i futuri studenti di lettere e medicina.
1 l programmi per l'insegnamento della filosofia, vigenti nel 1 87 2 , erano ancora quelli del
I O ottobre 1 867 (anche se qualche modifica era stata introdotta da Correnti con la circolare del
l nov. 1 870, n. 287); nonostante fossero stati redatti da un filosofo toscano di ispirazione cat
tolica e devota, Augusto Conti, (e per tale loro caratteristica saranno criticati duramente per
esempio da Francesco Fiorentino in Scritti l 'ari di letteratura, filosofia e critica, Napoli, Mo
rano, 1 876, pp. 294-3 1 6) per la loro indeterminatezza consentivano facilmente, secondo molte
denunce della pubblicistica moderata di quegli anni, confermate nell'inchiesta Scialoja, a pro
fessori idealisti e posi ti visti una libertà " pericolosa che generava un sapere " vano e ambizio
so " · Anche Terenzio Mamiani aveva perciò suggerito a Cesare Correnti, allora ministro, con un
parere del 1 9 settembre 1 870 (ACS, MPI, Div. swo/e medie, 1 860-1 896, b . 2 ) di adottare per la
filosofia programmi più elementari e determinati per evitare « disordini e stordimento dei tene
ri ingegn i » . Sul problema, oltre alla deposizione di Antonio Labriola (vedi doc. 2 3 ) si vedano
tra le altre le deposizioni di Francesco Acri (vedi doc. 27) e A ndreasi (ibid. , b. 6 bis, fase. 47).
l'na siffatta preoccupazione emerge nella stessa formulazione del quesito n. 39, che sarà perciò
giudicata severamente da « < l Pungolo " di Napoli del 2 1 febbraio 1 87 3 (vedi doc. 7 1 , nota 1 ).
"•
"•
40
41
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
ni da Ricasoli a Peruzzi. Molto spesso la bandiera della libertà di insegna
mento veniva alzata, ma più che segnacolo di fruttuosa co ncorrenza tra pub
blico e privato e dunque di innovativa sperimentazione era solo un nobile
paravento per la difesa della vecchia cultura.
Alla svolta del Settanta si registrava da varie parti una duplice sconfitta
degli sforzi del governo sul terreno delle scuole secondarie: la scuola non
governativa, di livello cult urale più basso di quella governativa, come con
fermano a grande maggioranza le deposizioni dell' inchiesta Scialoja, riusciva
per ragioni politiche a conquistare sempre maggiori simpatie, seduceva sem
pre di più le famiglie, sottraeva studenti alle scuole del governo; tant 'è che
era forte la tentazione (quesito 34) di ridurre la presenza dello Stato nel for
tilizio di pochi licei-ginnasi, altamente qualificati ed esemplari, lasciando al
le province , ai comuni, ai religiosi il compito di gestire la scuola secondaria
per la gran parte della popolazione: una proposta, questa, che incontrerà
molte opposizioni nelle risposte dell ' inchiesta, per il significato che assume
va di varco aperto alla più larga influenza del clero nella formazione della
futura classe dirigente. Nello stesso tempo la scuola del governo falliva il
suo progetto di educazione rigorosa : D 'Ancona, scrivendo a proposito del
l ' inchiesta, parlava di un progressivo rincretimento della nazione, a guarda
re le prove degli esami; le diagnosi di Labriola nel 1 87 1 , di Villari nel 1 87 2
erano altrettanto negative 1 •
Quali l e ragioni e gli aspetti di questa d uplice crisi? I n primo luogo l a
nuova organizzazione dello Stato unitario richiedeva funzionari e professio
nisti con una cultura speciale sempre più profilata, per il medico, l ' i ngegne
re, l ' avvocato, il servitore dello Stato; l ' ipotesi formativa della Destra, pro
prio perché mirava in alto, richiedeva che questa cultura speciale avesse il
suo fondamento in u na larga cultura disinteressata, quella dei ginnasi l icei,
acquisita i n tempi Tunghi, paziente, basata essenzialmente sul latino e il gre
co. Era proprio il contrario di quanto avrebbe voluto la borghesia per i pro
pri figli . Scriverà Gabelli in una chiara analisi della crisi della scuola classica,
proprio riferendosi ai ceti dei nuovi arricchiti, a pizzicagnoli, calzolai e fale
gnami e alle loro aspettative per i figli :
geod etici in mano ai ragazzi di dodici anni. Che consolazione per loro vedere in toga
l 'avvocatino, come un tempo vedevano in tricorno il pretino» 1.
"Se stesse i n loro metterebbero il codice d i procedura, l o stetoscopio, gli strumenti
1 Il giudizio di D 'Ancona nella già citata lettera a Celestino Bianchi di presentazione delle
Tribolazioni di Placido Cerri, pubblicata la prima volta su « La Nazione " del 1 9 aprile 1 87 3 (ve
di nota l , p. 26); di Antonio Labriola si veda l ' articolo L 'istruzione secondaria in Italia e in
Francia, pubblicato su « Il Piccolo del 9 ottobre 1 87 1 , ora in A. LABRIOLA, Scritti pedagogici,
•
a cura di N . Siciliani de Cumis, Torino, UTET, 1 98 1 , pp. 1 33 - 1 38; di Pasquale Villari il già ri
cordato saggio del novembre 1 87 2 , La scuola e la questione sociale, composto sotto la duplice
spinta di una polemica con Luzzatti per le sue riforme degli istituti tecnici e di una chiarifica
zione nella discussione in corso suscitata dalla proposta, prima di Menabrea, poi di Scialoja, di
una inchiesta.
Non era facile resistere a questa larga domanda di spiccia concretezza,
tanto più che un problema diverso e più serio si poneva allora anche in I ta
lia e in forma particolarmente acuta agli inizi degli anni Settanta. I l fonda
mento umanistico-classico era ancora l ' u ni co viatico per la formazione della
classe dirigente o lo svolgimento della cultura (lo sviluppo delle conoscenze
scient ifico-tecnologiche, la nuova attenzione alle lingue e alle letterature
moderne) prospettava un diverso indirizzo per la cultura generale? Il conflit
to tra l' istruzione classica e l ' istruzione tecnica poteva essere visto ancora
come il rapporto tra la cultura generale e una cultura speciale o , come soste
neva Luzzatti, l 'istruzione tecnica (ove seguisse il modello delle Realschu len
tedesche) era anch ' essa, e con pari d ignità, cultura generale? Le opposte ri
sposte a questo problema trovarono espressione esemplare in uno scambio
epistolare tra Sella e Luzzatti del settembre 1 87 1 . Al lavoro di riforma dell 'i
struzione tecnica, intrapresa da Luzzatti, Sella opponeva la sua fede incon
cussa nel modello classico: « Se volete uomini forti e profondi non mandate
li per carità a queste scuole tecniche o professionali inferiori, mandateli in
vece alle scuole classiche e più tardi chiamateli agli studi tecnici , . A v eva un
bell' obiettare Luzzatti che le lingue e le letterature moderne potevano bene
adempiere alla funzione del greco e del latino e essere anch 'esse cultura ge
nerale; e aggiungeva una profezia: fra qualche tempo gli alunni dei tecnici
avrebbero pensato e perciò scritto meglio di quelli dd classici . Ma Sella an
cora insisteva a ribadire: «a fare un uomo un uomo davvero giova qualcosa
più della ragioneria >> . Il contrasto fra i due era veramente, nei suoi toni alti,
una « musica dell ' avvenire » , come , con allusione a Wagner, scriveva Sella 2
Ma nel presente il contrasto era nella realtà effettuale ad un livello più bas
so : la scuola classica era ben lontana dai modelli cui pensava Sella , non era
né Schulpforta né Oxford; la scuola tecnica era ben lontana dal costituirsi,
come una Realschule di Sassonia, quale scuola di cultura generale. I l duello
fra le due scuole assai spesso era solo un duello tra una retorica qua e là
spruzzata da qualche dilettantesca velleità filologica e dall 'altro lato la ragio
neria più piatta più un po' di francese.
La sensazione largamente diffusa era perciò che agli sforzi e alla mira alta
del ministero corrispondessero risultati modesti : valeva dunque la pena
quello sfoggio nei programmi di aspettative culturali se poi i temi conclusivi
del corso liceale rivelavano - come scriveva D 'Ancona, allineando in alcune
1
Vedi il già ricordato saggio del 1 888 in A. GABELLI, L 'istmzione in Italia . . cit . , p . 227.
Vedi Q. SELLA, Epistolario, a cura di G . e M . Q AZZA, Roma, Istituto per la storia del Ri
sorgimento, 111, 1 99 1 , pp. 5 39-5-J l, 5 5 -J - 5 5 5 e ora anche G . Q UAZZA, L 'utopia di Quintino Sel
la. La politica della scienza, Torino, Comitato di Torino dell' Istituto per la storia del Risorgi
mento italiano, 1 992, pp. 437-44 3.
2
.
42
Fonti per la storia della scuola
pagine un abbondante museo degli orrori - che dal liceo uscivano sempre di
più giovani incolti ed analfabeti? Valeva la pena tenere i ragazzi per tanti an
ni sui banchi della scuola, allontanando il loro ingresso nella vita lavorativa,
rovinando la loro salute fisica, se poi, a parte i limiti culturali, soprattutto
non si educava, e dallo scontro irrisolto tra i valori civili e i valori cattolici,
usciva dalla scuola una generazione di scettici, che volentieri, evadendo dal
Curtius, si dilettavano a leggere la stampa oscena muricciolaia o cedevano
alle lusinghe dell'Internazionale e nell'ambigua presenza dell'educazione re
ligiosa riuscivano o bigotti o miscredenti '? Su una tale questione, al di là
dell'opinione dei dotti e dei professori, era importante sentire il polso dei
diretti interessati, dei ceti medi e più direttamente dei padri di famiglia, cui
Scialoja aveva indirizzato i suoi quesiti. E se spesso la stampa dell'epoca la
mentava che all'appello dell'inchiesta avessero risposto scarsamente i padri
di famiglia (ed era fondato il lamento) va pure osservato che non pochi tra i
padri che si presentavano a deporre non erano padri qualunque. Avevano
un peso rilevante nella vita sociale. Erano alti funzionari, prefetti, segretari
generali di un ministero, alti ufficiali dell'esercito, erano senatori, deputati,
professionisti affermati. Vale perciò la pena, a conclusione di queste consi
derazioni, sul nodo della cultura generale e disinteressata, richiamare la de
posizione orale e l'opuscolo che presentò all'inchiesta un senatore toscano
della Destra, padre di famiglia, Enrico Poggi, già ministro nel governo prov
visorio toscano del ' 5 9 e che in senso codino aveva avuto una sua parte nel
varo della legge Ridolfi sulla pubblica istruzione, appoggiando le prudenti
concessioni fatte al clero da Lambruschini contro il più intransigente laici
smo di Salvagnoli e Ricasoli. Era un caratteristico portavoce del toscano
Morfeo; era perciò assai poco disposto a condividere gli entusiasmi per la
" musica wagneriana, di Sella . Scriveva Poggi che ai suoi tempi si andava a
collegio senza tante pretese, un giovane aveva una professione a venti anni e
non gravava sulla famiglia con studi lunghi e non utili, non doveva sostene
re «l'esame spietato di licenza liceale»; ora invece se veniva bocciato, ri
schiava di finire male, magari «tra coloro che degradano con vergognose
1 Sulla caduta degli ideali nei giovani studenti (un tema che va ben al di là delle specifiche
responsabilità che in ciò può avere il sistema scolastico con le sue lungaggini e le sue frustrazio
ni) e sull'esigenza di recuperare il momento dell'educazione morale contro l'ambizioso e sterile
enciclopedismo del momento dell'istruzione, nell'inchiesta, come del resto nella varia pubblici
stica pedagogica di quegli anni, sono numerosissimi gli interventi. l più accaniti avversari del
l'inchiesta anzi (cfr. la • Critica dell' istruzione secondaria classica e tecnica » , 18 giugno 1 873)
informano - ma la notizia non ha riscontri documentari - che Cantelli i n una relazione a Scialoja
lo informava, dopo la visita a Torino, che col progresso dell'istruzione, diminuiva « l'affetto e
la fiducia nella monarchia e nelle istituzioni » . È comunque significativo che in quanti deplora
no l'assenza di ideali nei giovani sono pochi quanti si rifanno agli ideali civili, patriottici, risor
gimentali; assai più numerosi sono quanti hanno nostalgia di un comportamento morigerato,
religioso, più vicino ai modelli di padre Bresciani che a quelli di Settembrini : una conferma di
più che dalle carte dell' i nchiesta viene fuori il quadro di una società civile i n complesso assai
più retriva della classe politica.
43
Introduzione
manifestazioni il nobile ufficio della stampa periodica»; e concludeva:
« uno degli errori fondame ntali che informa no il nostro sistema d'istruzi
one che
�ar compilat o da chi non è stato, non è padre di famiglia, ma da chi vive sospes
tra
_
Il ctelo e la t � r: a t n una certa atmosfera mediana che non respirano gli esseri di
que
sto mondo, s t e dt_ aver s � orda! o eh� le moltitud ini in ogni classe sociale si compon
_
_ medtocn
gono dt medtocn
ta;
ta neglt scolari , mediocr ità negli esercent i le arti libera
li. medio crità negli impiegat i alti e bassi; e che queste mediocri tà, le quali si consu
mano e st_ nproducon o ogni giorno, devono pur compiere il loro corso , 1 •
�
Questa rivendicazione, pragmatica e moralistica a un tempo, dei diritti
della mediocrità era un epitafio, probabilmente condiviso da molti, non so
lo per la auspicata serietà della politica scolastica di quegli anni o per la con
cezione rigorosa in astratto della cultura generale che le era sottesa, ma an
�he �er i. sogni delusi di chi credeva che l'unità nazionale avesse significato
_
l avv1o dt una nforma
morale e intellettuale.
Ma su tutta la politica scolastica e sul dibattito sulla secondaria in parti
colare pesava in secondo luogo l'ipoteca del dissidio con la Chiesa fattosi
più aspro dopo la breccia di Porta Pia . Già le ultime fasi dell'attività �iniste
riale di Correnti, con la soppressione delle facoltà di teologia e la ventilata
abolizione dei d�rettori spirituali nei licei, e infine le sue dimissioni nel giu
gno del 1 87 2 dunostravano quanto la questione clericale condizionasse la
politica s last_ica. E di ciò le carte dell'inchiesta Scialoja offrono una prova
Fra tutti i quesiti sottoposti alla pubblica opinione
anco�a pm�? evidente.
quelh _dal 1 3 al _ 1 7 �icevono infatti il maggior numero di risposte, complesse
e assat spesso dtvancate, sui terni della libertà di insegnamento, sulle ragioni
della crescente preferenza data dalle famiglie alle scuole rette dal clero, sulla
presenza o meno dell'insegnamento religioso; senza dire poi che anche nelle
ris �oste ad al �ri quesiti (per esempio sulla filosofia, sui convitti e gli educan
dati) la quest10ne cattolica ha uno spazio rilevantissimo. Si succedono in
queste risposte le esplicite posizioni contrapposte dei clericali e dei laici in
coraggi_ati ques_ti �ltit� d_al modello del Kulturkampf Erano in camp� gli
opposti estremtsml, dt cht da un lato vedeva negli orientamenti materialisti
ci presenti nelle scuole del governo, nell'arruolamento tra gli insegnanti di
queste scuole di preti apostati e magari concubini un pericolo per l'ordine
morale e sociale, un incitamento ai giovani allo scetticismo e alla dissolutez
za, se non un compiacere al «vicino petrolio come ricordavano a Cantelli i
padri de « La Civiltà cattolica» (e allora, come osservava maliziosamente
"•
2
.
1 E . POGGI, Pensieri di un padre di famiglia in replica de ' quesiti sopra l 'istruzione
se
conrtana, F1renze, t1p. della Gazzetta d'Italia, 1 87 :1 . p. 1 2 (ACS, MP!, Diu.
scuole medie' 1 8601 896, b . 1 1 , fase. 80).
,. 2 Vedi la r isposta della redazione de • La Civiltà
cattolica » (doc. 46, p. 467). Ma la critica al
l unp1ego nell . msegname nto di ex sacerdoti, specie se di dubbia condotta morale,
è assai diffu
sa, specie nel Mezzogiorn o, anche da parte eli uomini non legati alla Chiesa,
per il timore che la
44
Introduzione
Fonti per la storia della scuola
Celestino Bianchi 1 , anche molti « Spiriti forti » che in parlamento tuonavano
contro il clero , collocavano poi i loro figli e sopratt utto le lorò figlie nei più
sicuri collegi gestiti da religiosi), e di chi dall 'altro lato denunciava l ' incon
ciliabilità dei valori civili e istituzionali del nuovo Stato con la religione del
Sillaba e degli infallibilisti e magari calcava la mano sui casi di pedofilia che
di tanto in tanto gettavano un' ombra sui collegi ecclesiastici e avrebbero
dovuto alienare da essi le simpatie dei padri di famiglia 2. Ma specie nelle de
posizioni dei notabili, prevalevano anche tentativi di conciliazione tra le op
poste esigenze dello Stato liberale e della Chiesa romana; così da molti si au
spicava, con le più varie sfumature che vanno da un vago deismo, non privo
di suggestioni mazziniane, a un più dichiarato cattolicesimo liberale, la pre
senza necessaria dei valori religiosi nella scuola, come strumento necessario
dell' ordine morale, purché essi fossero presentati in una versione non bigot
ta e rispettosa della libertà di coscienza e della nuova realtà istituzionale del
paese. E poiché non era facile trovare nel presente un punto di accordo tra
Stato e Chiesa su lla scuola, in molte deposizioni affiorava una linea di con
dotta segnata dalla provvisorietà: parecchi per esempio si pronunciavano in
linea di principio a favore della libertà di insegnamento; aggiungevano però
che a questa nella presente congiuntura politica bisognava porre dei limiti a
difesa dell ' ordine liberale 3. Analogamente altri affermavano essere sì necespresenza nella scuola di apostati induca i padri di famiglia a scegliere le scuole private religiose.
Caratteristica da tal punto di vista la deposizione casertana di Francesco Saverio Labriola (padre
di Antonio), non certo clericale, tanto che propone di chiudere i seminari " semenzai di infalli
bilisti durissimo contro " gli arcinfallibilisti scellerati ed empi » e tuttavia più ostile ancora a
" quelli che rinunziano il loro ufficio, perché sono immorali e pravi e che perciò esercitano
una " triste influenza » nelle scuole (ACS, MPI, Div. scuole medie, 1860-1 896, b. 5, fase. 1 8).
1 fbid., b. 6 bis, fase. 3 5 . L 'osservazione di Celestino Bianchi coglie bene la contraddizione
dei liberali moderati , specie a Firenze, dove viene sottolineato anche da Peruzzi e da padre Zini
(ibid. , b. 6 bis, fase. 3 6 ), che nel 1 87 3 dirigeva l'istituto fiorentino degli scolopi, il fatto che
molte famiglie liberali , anche di religione ebraica, preferiscono per i loro figli le scuole pie.
el corso dell'inchiesta nel maggio 1 87 3 il collegio barnabatico di Monza fu chiuso in se
2
guito a un caso di pedofilia di cui si era reso colpevole il barnabita padre Stanislao Ceresa, di
rettore di quel collegio e presente con una sua risposta nell'inchiesta: specie i giornali della Si
nistra, « La Riforma » e " Il Pungolo » , sfruttano sia questo che altri simili casi per screditare i col
legi ecclesistici. Scriveva per esempio « Il Pungolo del 6 settembre 1 87 3 : " È dunque sui padri
di famiglia che pesa la resposabilità delle colpe nefande, per cui un tempo furono Sodoma e
Gomorra e sono celebri oggi i collegi affidati ai religiosi » . Del resto già nel 1 86 3 il ministro
Amari con la stessa imputazione aveva trascinato in tribunale le frère Théoger, degli ignorantel
li, e non nascondeva perciò una certa soddisfazione scrivendone a Rénan nella stessa lettera del
28 giugno 1 8 63 con cui lo ringraziava per la Vie dejesus, in A. D ' ANCONA, Carteggio di Michele
Amari, Torino, Roux Frassati , 1 89 6 , I l , p. 1 6 5 . Per il processo torinese a padre Théoger, vedi
ora G. BONETTA - G. FIORAVANTI, L 'istruzione classica (1860- 1 9 1 0) . . . Cit. , pp. 379-382.
.l Specie nelle sedute romane, ove depongono alcuni notabili (deputati, alti funzionari, ecc . )
è presente questo doppio binario d i una riaffermazione dei principi liberali e di u n a riserva
provvisoria o di un loro contingente temperamento per esigenze politiche: si vedano ad esem
pio le deposizioni del deputato Piolti de' Bianchi (ACS, MPI, Div. scuole medie, 1860- 1 896, b.
4, fase. 4) che così si esprime: « <n teoria io sono partigiano della libertà d'insegnamento; ma in
»,
»
•
45
saria e opportuna l ' istruzione religiosa, ma che per ora non si poteva impar
tire perché il direttore spirituale se era d ' accordo col suo vescovo avrebbe
insidiato le basi del consenso allo Stato costituzionale e, ancora peggio, se
era un prete liberale, avrebbe provocato l'ostilità nei suoi confronti del ve
scovo e di conseguenza la fuga da quella scuola delle famiglie cattoliche. In
somma il punto di equilibrio politico non era facile da trovare e variava da
città a città, a seconda della maggiore o minore rigidità del vescovo, degli
umori prevalenti nel Consiglio provinciale scolastico e in chi lo presiedeva,
il prefetto. Questa speranza in un arrangiamento del dissidio tra Cesare e
Pietro veniva infine espressa con un adeguato paragone da un cattolico con
ciliatorista, l' umbro Paolano Manassei, che paragonava i rapporti tra Stato e
Chiesa sul terreno della scuola a quelli tra due coniugi, che pur avendo pro
fondi motivi di rancore tra di loro, decidessero di continuare a vivere insie
me per riguardo alla prole 1• Bisognava però , per rendere possibile questa
convivenza, che dalle due parti si tagliassero le punte di estremismo . Più
volte perciò nelle deposizioni veniva avanzata la proposta di allontanare
dalla cattedra i filosofi materialisti (il caso Angiulli era recente) 2 e soprattut
to i preti spretati, la cui presenza a scuola era un vulnus grave per la co
scienza dei genitori cattolici , sperando che in pari tempo l' autorità ecclesia
stica imponesse al clero un atteggiamento meno ostile verso lo Stato unita
rio (ed è significativo che anche i padri de « La Civiltà cattolica » , così intran
sigenti sulla loro rivista nei confronti dello Stato usurpatore, nella risposta a
Cantelli facciano avances di non belligeranza nei confronti delle nuove isti
tuzioni , purché ovviamente sia concessa al clero libertà d ' insegnamento, e
analoga è la presa di posizione di Manassei) e non continuasse a lasciar per
esempio circolare nelle sue scuole e nei seminari le carte geografiche che
raffiguravano la penisola nell' assetto mett ernichiano. Ed è degno di nota il
pratica, stante le attuali condizioni , le cose cambiano d'aspetto; credo che la libertà d'insegna
�ento nocci a » e, a proposito dell'insegnamento religioso, così conclude: « Ma quando un paese
e ndotto alle condizioni in cui siamo, al conflitto attuale di opinioni, che può fare la società ci
vile? Quando veramente la religione, come essi la intendono, ha cessato di essere nel cuore de'
cittadini, ha cessato di essere nel campo delle tendenze dell'animo, ma è venuta nel campo mi
litante, e tutto giorno viene a darci battaglia, ad impegnar lotta contro tutti i principi accettati
dalla società civile, che deve fare lo Stato' Non può che stare sulla difensiva . . . » .
1 Vedi ACS, M P ! , Div. scuole medie (1860- 1 896), b. 1 1 , fase. 7 7 ; l a risposta
d i Manassei,
presente nel fondo in più copie, è un estratto da « La Rivista universale » (settembre 1 873), che
pruna de « La Rassegna nazionale » fu organo dei cattolici conciliatoristi. Non stupisce che nella
sua risposta Manassei faccia il più caldo elogio al Municipio fiorentino (e si veda i n proposito la
deposizione di Peruzzi) ove " le amiche leggi sull'istruzione vennero in parte conservate , e " do
ve i principi di temperata libertà meglio si intendono » .
' Andrea Angiulli, professore d i filosofia a l liceo Vittorio Emanuele d i Napoli, era stato ri
mosso dalla cattedra (ma poi promosso per intervento di Correnti all'università) in seguito alle
sue lezioni troppo positiviste e alla pubblicazione nel 1 86 8 del volume La filosofia e la ricerca
positiva. Sul caso e sugli echi che esso ebbe anche nell'inchiesta Scialoja, vedi M. RAICICH, Iti
nerari della scuola classica dell'Ottocento, in Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia
contemporanea, a cura di S. SOLDANI e G . TURI, Bologna, Il Mulino, 1 99 3 , I , p. 1 4 5 .
46
Fonti per la storia della scuola
fatto che a questa politica di mutua prudenza non si sottraesse in quegli anni
del tutto neanche l'università, considerata di norma come area-di una com
pleta libertà di pensiero
Ma a rendere difficile la costruzione di una scuola di cultura seria e seve
ra era soprattutto, in terzo luogo, la questione degli insegnanti. Aveva colto
nel segno Antonio Labriola nel 1 87 1 quando aveva ammonito gli uomini del
governo a lasciar perdere "la vecchia polifarmacia ,, dei ritocchi ai program
mi, delle questioni meschine, a non lasciarsi «lusingare dalla speranza della
gloria nel ritentare nuove riforme•• , a saper attendere, e aveva concluso la
sua diagnosi scrivendo: "ma innanzi tutto rivolgete tutte le cure sopra un so
lo punto, cercate di formare la nuova generazione di professori. Questa è
la vera cura radicale,,
Ancora una volta le carte dell'inchiesta danno una conferma significativa
e articolata della centralità della questione; i quesiti dall' l al 9 (presidi, di
rettori, insegnanti) trovano una eco di moltissime risposte, e non solo fra gli
insegnanti; di questi ovviamente i più fermavano la loro attenzione innanzi
tutto sulla questione degli stipendi, sul fatto che con gli stipendi assegnati a
un insegnante una famiglia non campava; e dunque erano necessari lavori
supplementari: da ciò la piaga delle lezioni private se non addirittura degli
incarichi aggiuntivi di insegnamento in qualche istituto privato, con la con
seguenza non solo di una disponibilità oraria strozzata di ogni singolo inse
gnante per la sua cattedra governativa, ma anche di un rischio abbastanza
frequente di compiacenze illecite negli esami per gli alunni delle scuole pri
vate E ne soffriva non solo l'efficacia didattica di un insegnante così stres1•
2•
3.
1 Le cautele della Destra nei rapporti con la Chiesa e le sue esigenze dottrinali, nonostante
che sia Mamiani che Bonghi sostenessero che l ' u niversità, a differenza dell' istruzione seconda
ria, doveva consentire la più audace libertà di pensiero, nei momenti politicamente più caldi,
riguardavano anche la vita accademica. Così, quando al Consiglio superiore venne in discussio
ne la nomina di Trezza a ordinario, il relatore Prati deplorò che nel recente volume su Lucrezio
« sono svolti principi di un sistema che quantunque in voga egli non crede che possano essere
approvati né desiderati in un professore » : a conclusione della discussione, persino Amari, « allié
de Satan • reputò « non prudente il mettere in questo momento in troppa evidenza l 'autore di
esso (se. libro) col provocarne la nomina a ordinario » e la deliberazione venne sospesa per
quattro mesi. MPl, CSPl , Processi uerbali, 1 87 1 , I l , pp. 833-848.
z Vedi A. LABRIOLA, L 'istruzione secondaria in Italia e in Francia . . cit. , in Scritti peda
gogici . cir . , p . l 37 .
1 Pasqualigo, per esempio, nella risposta scritta (ACS, MPl, Div. scuole medie, 1860- 1 896,
b. 1 1 , fase. 80) denuncia esplicitamente la irrazionalità degli orari scolastici, dovuta al fatto che
bisognava concentrare le lezioni di certi insegnanti in uno o due giorni per consentire loro di
dedicarsi a u n secondo lavoro, generalmente un insegnamento in un istituto privato o le lezioni
domestiche. Si veda anche • La Riforma • del 30 marzo 1 873, che denuncia con forza la piaga
delle lezioni private: i professori di uno stesso istituto • sono sempre divisi in due campi oppo
sti: da una parte quegli onesti che, vivendo di privazioni, si accontentano del troppo l imitato
stipendio ed adempiono al proprio dovere, dall'altra i mestieranti che fanno, quanto più posso
no, lezioni private, che accettano presenti e che, agli esami di ammissione e di promozione,
danno a tutti e sempre una media sufficente » .
.
. .
47
Introduzion e
sato e distratto dalla preoccupazione per il pane, ma anche la sua riputazio
ne sociale. Ne soffriva infine la prospettiva per il futuro: se così pochi erano
i giovani che si iscrivevano alle facoltà e alle scuole normali con sbocco nel
l'insegnamento, la ragione principale non era nel rifiuto degli studi letterari
era piuttosto nell'avvenire di fame, nella nessuna prospettiva di vita dignito�
sa e di considerazione sociale che esse schiudevano. Lo sottolineavano non
solo, come era ovvio, le vittime di questa situazione, i professori in servizio,
ma anche non pochi notabili (prefetti, senatori, deputati).
Al di là delle tante questioni minute che affollano i quesiti sui professori
(sulle diverse forme di assunzioni, sul rapporto tra titolo universitario e pro
fessionalità didattica, sul tirocinio, sui trasferimenti arbitrari, ecc.) alcune
questioni principali emergono dall'insieme delle risposte. Una di politica
contingente innanzitutto: in maggioranza i professori in servizio (i più dei
quali erano confinati nella fascia subalterna degli incaricati e dei reggenti)
erano privi del titolo di studio previsto dalla legge Casati. Erano stati reclu
tati in fretta al momento della istituzione dei singoli istituti in condizioni di
fortlll�a, sec� ndo le disponibilità non molto larghe che offrivano i singoli
luoglu e le Circostanze e pagando assai spesso lo scotto politico di compia
cenze verso i patrioti, i reduci dalle patrie battaglie, i preti disponibili al
nuovo or�ine, gli intellettuali locali meno compromessi con l'antico regime;
non poch1, che erano già in servizio sotto i governi precedenti all'unità era
no stati confermati al loro posto, a volte erano stati promossi, nonos� ante
non avessero i requisiti richiesti dalla legge Casati (non richiesti però dalla
legge Imbriani, a lungo vigente nel Mezzogiorno).
Le qualità di questi professori era scadente; inoltre la loro cultura era as
sai poco omogenea nelle varie regioni del paese, difficilmente riconducibile
a un comune progetto educativo; certo è comunque che, qualunque fossero
�e l o ?a �i cul u ali, quasi tutti erano poco disponibili a misurarsi con gli
m? l?��tzzt . ft. �olog1� ��� e germanizzanti proposti sempre di più dai programmi
mmtstenah; da cw la loro polemica, sia nell'inchiesta Correnti che in quella
Scialoja, contro il Curtius e l'Euclide, contro le nebbie d'oltralpe, da ciò la
loro frequente rivendicazione del metodo < esteticO>> contro l'aridità dei me
todi tedeschi; anzi così facendo ostentavano il loro patriottismo contro chi,
dopo che l'Italia si era liberata dalle milizie di Radetzky, si consegnava ver
gognosamente a una occupazione culturale straniera.
Con una serie di provvedimenti, dal ministro Amari in poi, il governo si
era proposto di porre, almeno formalmente, rimedio a questa situazione of
frendo agli insegnanti non in regola una possibilità di sanatoria: veni�ano
istituite presso alcune università sessioni speciali di esame, cui pote�ano ac
cedere gli insegnanti privi di titolo che avessero determinati requisiti di an
zianità (differenziati se il loro servizio era stato in scuole governative, delle
provincie e dei comuni, o dei privati). L'ultima di queste sanatorie era stata
proposta, con durata triennale da Bargoni nel 1 869 e giungeva dunque a
1
1
R.d. 8 ago. 1 869, n. 5202.
48
49
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
scadenza durante l ' inchiesta Scialoja. Era naturale che se ne discutesse, tanto
più che il bilancio della sanatoria era deludente perché ass<l i pochi erano gli
insegnanti in servizio che si erano presentati alle sessioni speciali di esame
per ottenere l'abilitazione. Erano piuttosto anziani e sentivano quasi come
una offesa il doversi sottoporre alle " forche caudine degli esami che, an
che se facilitati, non erano affatto sicuri di superare (specie in una sede co
me Torino, dove pare che Giuseppe Miiller non perdonasse l ' ignoranza ge
nerale della linguistica comparata) 1 • Li confortava infine in questa renitenza
la consapevolezza che comunque , anche se privi di t itolo, non avrebbero
certo perso il loro lavoro, dato che non c ' era chi potesse sostitu irli, essendo
assai esiguo il gettito di nuovi laureati usciti dalle università; e di fronte a
quei pochi ed imberbi dottori potevano sventolare la bandiera del loro lun
go tirocinio 2 Frequentemente poi essi preferivano alla prova degli esami,
come è attestato dai loro fascicoli personali, farsi raccomandare da qualche
notabile (un parlamentare, un alto funzionario) presso il ministro in carica o
il commendator Barberis, per ottenere fuori sacco una equipollenza del loro
titolo o del loro servizio alla laurea; e perciò allegavano alla loro domanda
copia della loro produzione letteraria e più spesso poetica, se non addirittu
ra di poesia latina, e non mancavano di esibire qualche carme patriottico e
qualche poesia di circostanza, per esempio per il centenario di Dante o per
uno scampato attentato al sovrano. Il ministro, anche per liberarsi da questo
soffocante assedio, condizionava il proprio assenso al parere del Consiglio
superiore; qui Villari, Tenca e Cremona, che in genere istruivano queste pra
tiche, che per le patenti per maestri e le equipollenze per professori assorbi
vano circa la metà delle pratiche sbrigate dal Consiglio superiore, furono in
complesso severi, ma ancora u na volta senza frutto, lasciando cioè i postu
lanti a insegnare dov ' erano, perché non c ' era la possibilità di sostituirli.
Ma se dava così scarsi frutti una politica di riqualificazione e di aggiorna
mento del personale in servizio (che oltre alle sessioni speciali d'esame, pre
vedeva l ' ipotesi di conferenze pedagogiche autunnali e la creazione di un
autorevole periodico di pedagogia, sul modello dei tedeschi «Jahrbiicher fiir
Philologie und Padagogik »), non dava più ricchi risultati almeno dal p u nto
di vista quantitativo neanche l' altro aspetto della politica del personale,
quello suggerito da Labriola, di lavorare per il futuro . D i questa politica di
trasformazione della università e specie della facoltà letteraria in una fabbri
ca di nuovi professori qualificati fu momento caratteristico per esempio la
creazione delle cattedre di linguistica comparata e di sanscrito promossa in
particolare da Mamiani e De Sanctis e proseguita con i loro successori : se si
volevano germanizzare i licei ginnasi, bisognava che i n uovi insegnanti pa
droneggiassero la nuova scienza linguistica che era il fondamento metodolo
gico del nuovo modello di insegnamento 1 • Ma il tentativo più organico - an
che se realizzato fra varie resistenze e non poche difficoltà - di mettere l ' uni
versità in grado di assolvere al meglio alla funzione di fornire insegnanti col
ti e didatticamente agguerriti fu quello della istit uzione delle scuole normali
superiori, a cominciare da quella di Pisa, richiamata a questa funzione da De
Sanctis e Matteucci e in questa ottica affidata alla direzione di Villari e più
tardi di D'Ancona, per giungere alle altre scuole normali superiori istituite
presso varie università negli ultimi anni Sessanta e all ' inizio degli anni Set
tanta 2 : a queste infine si era aggiunto, dopo la liberazione del Veneto, il Se-
"•
1
Oltre alla deposizione dello stesso Mli ller (vedi doc. 3 1 } si veda ad esempio lo sfogo ama
ro del professor Michele Ferrero di Genova (ACS, M P I , Div. scuole medie, 1860- 1 896, b . l O , fa
se. 7 1 } che lamentando l'eccezionale rigore degli esami aggiunge: « lo scoglio insormontabile lo
incontrarono nel prof. di lingua greca, il signor cavalier Mi.iller, il quale esigeva una cognizione
in quella lingua assai superiore a quanto si possa aspettare da coloro che devono, bensì con le
altre materie scolastiche, i nsegnare il greco, ma, secondo i regolamenti vigemi. nel ginnasio
non hanno che da impartirne una cognizione elementare; ed oltre al pretendere più del dovuto,
si scorgeva che s'avessero studiato grammatiche composte da autori italiani, non si contentava
in nessun modo
' Le risposte sulla questione del tirocinio sono generalmente favorevoli; vanno però esami
nate con attenzione. Nelle intenzioni di chi aveva formulato il quesito si era pensato al modello
per esempio della legislazione austriaca nel Lombardo Veneto, cioè, per l ' insegnante già in pos
sesso del titolo di studio richiesto, un periodo di prova da trascorrere sotto la guida di un inse
gnante provetto o di un preside in un ginnasio, assistendo alle lezioni dell'insegnante titolare,
aiutandolo nella correzione dei compiti, ecc. prima di essere confermato: nelle nuove scuole
normali superiori si stava studiando del resto qualcosa di simile, se non anche la presenza ac
canto alla scuola di un ginnasio liceo apposito dove i normalisti facessero il loro apprendistato.
Senonché la maggior parte delle risposte favorevoli al tirocinio viene da anziani insegnanti che,
con un certo distorcimento del senso del quesito, per tirocinio intendono la pura pratica, cioè
in altre parole il servizio da loro stessi già prestato, che anzi contrappongono al " pezzo di car
ta al titolo di studio.
.
"•
. "·
1 Sulla creazione di tali cattedre nei primi anni dello Stato unitario e in particolare sulla no
mina di Ascoli a M ilano vedi M. RAICIC I I , Scuola politica cultura . . cit . , pp. 204-28 1 ; sull'im
portanza, per la formazione degli i nsegnanti, della presenza nelle università delle cattedre di
linguistica comparata, vedi la deposizione torinese di Giovanni Flechia (ACS, MPI, Div. scuole
medie, 1860-1 896, b . 6, fase. 32). Che poi tali studi degenerassero in sanscriromania presun
mosa e dilettantesca è noto; e con una certa ironia guardava al sanscrito, come conoscenza in
dispensabile del professore ginnasiale, Niccolò Tommaseo nel ritratto poetico che ne disegnò
in quegli anni Vincenzo Riccardi di Lanrosca.
' Sulla Scuola normale di Pisa e la sua nuova funzione nei primi anni del l ' U nità vedi ora T.
TOMM>I - N. SISTOI.I PAOLI, La scuola normale di Pisa. Cronache di un 'istituzione, Pisa , ETS,
1 990, pp. 87- 108 e soprattutto M. BERENGO, La rifondazione della scuola normale nell'età
della Destra, in « Annuario della Scuola normale superiore di Pisa », Vl, a. ace. 1 987-'88, pp.
37-5 7 . Sulla faticosa nascita delle scuole normali presso altre università, da Napoli a Torino a
Roma, tra il 1 865 e i primi anni Settanta varrebbe la pena, ma non è questa la sede, approfondi
re il discon,o sulla base della documentazione, per altro lacunosa, offerta dalle carte dell ' Afchi
vio centrale dello Stato e dai verbali del Consiglio superiore. Uno degli aspetti più rilevanti di
quei dibattiti è la questione se le facoltà letterarie hanno la funzione di fornire una cultura ge
nerale letteraria elevata, propedeutica alle altre professioni o devono essere finalizzate esclusi
vamente o quasi alla formazione professionale degli insegnanti secondari: Settembrini, per
esempio, nel parere steso per il ministro Berti a nome della facoltà napoletana, respinge le pro
poste ministeriali e così scrive: « se l ' università dovesse avere per unico e principale suo scopo
la formazione dei maestri dei ginnasi e dei licei perderebbe il suo avvenire, la sua natura e l 'es.
50
51
Fonti per la storia della scuola
Introduzion e
minario filologico storico di Padova, diretto da un uomo di formazione
transalpina, De Leva, e del cui funzionamento offre un quadro interessante
l ' ultima deposizione orale dell' inchiesta Scialoja, riportata in questo vo
lume.
Ma i " normalisti , erano pochi e di quei pochi, specie tra i pisani, parecchi
abbandonarono ben presto le cattedre ginnasiali e liceali per una più gratifi
cante carriera accademica. Ma, pur pochi, erano visti dai vecchi insegnanti
come una minaccia alla loro carriera, tanto più che spesso la raccomandazio
ne di un Villari, di un D'Ancona, di un Ascoli, faceva assegnare loro le catte
dre e le sedi migliori, cui magari da tempo qualche vecchio insegnante aspira
va invano . Questo spiega un certo malumore diffuso nelle deposizioni e so
prattutto nelle risposte scritte dei professori contro i normalisti giudicati pre
suntuosi e incapaci di spiegare con elementare chiarezza ai loro scolari le de
clinazioni e le coniugazioni e non già le leggi fonetiche o la storia antica se
condo Mommsen. Un uomo di scuola, Giuseppe Vallo , preside del liceo Pari
ni di Milano e presente con la sua deposizione nelle sedute milanesi dell 'in
chiesta Scialoja, aveva forse meglio di ogni altro saputo dar voce a questo
malcontento in un lettera del 1 87 1 al segretario generale di Correnti , Canto
ni . D 'Ancona da Pisa aveva suggerito il nome di un normalista per una sup
plenza milanese. Vallo così esprimeva le sue perplessità sulla proposta:
Per questi tre motivi di fondo, l ' incapacità di elaborare e concretare una
concezione della cultura medio-alta, che fosse largamente condivisa, serban
do la nobiltà del suo carattere disinteressato, l ' impossibilità di sfuggire ai
condizionamenti del conflitto con la Chiesa, l'inadeguatezza dei mezzi im
piegati (i professori), che non erano in grado di dar corpo ad un progetto
educativo, sia pure incerto , quale quello proposto da Casati e dai suoi suc
cessori, la scuola secondaria degli anni Settanta era in profonda crisi . E u na
inchiesta, anche vasta e ambiziosa, come quella promossa da Scialoja, non
era certo in grado di farla superare. Essa mostrava chiaramente però quale
parto difficile fosse la costruzione dello Stato, il passaggio dagli entusiasmi
progettuali alla paziente fatica di dar regole a una nazione che dietro l'appa
rente unanimità dei plebisciti serbava nel suo corpo i segni di non risarcite
divisioni e qualche nostalgia per l ' ordine dei vecchi regimi, una nostalgia
che pericolosamente trovava risonanza nella voce del pontefice, nelle paure
sociali , nella boria culturale .
Forse anche il risorgere della questione della lingua - un tema che per
corre diverse deposizioni e risposte nel corso dell ' inchiesta - , il fatto che l ' I
talia turrita, appena u nita, si accorgesse, per dichiarazione del suo maggiore
intellettuale, Alessandro Manzoni , di non avere la lingua, era pur esso u na
spia significativa di questa fatica, di questa difficoltà del nuovo Stato a darsi
i suoi istituti. Giacché nella stagione della vigilia risorgimentale era stato un
facile luogo comune (per lo stesso Manzoni) suffragare le aspirazioni patriot
tiche con la prova dell ' unità della lingua (una d ' arme, di lingua, d ' altare . . . )
e della sua purezza non contaminata . Ma ora quando u na maestra o un pro
fessore subalpino andavano a insegnare i n Sicilia, un magistrato pugliese
rendeva giustizia in Friuli, un tenente toscano presidiava un borgo della Ca
labria , quel mito era infranto . Emergevano con prepotenza le distanze tra
lingua scritta e lingua parlata , tra l 'a ureo Trecento e i rozzi dialetti, tra la bo
ria puristica e il degrado gallicizzante della lingua della burocrazia, dei gior
nali, del commercio . Lo stesso scarso successo dell' iniziativa manzoniana
del 1 868 era la riprova delle difficoltà da superare per dare una lingua co
mune ai cittadini. Tuttavia anche in questo caso l ' esame delle carte del l 'in
chiesta rivela come lentamente il problema maturasse. Accanto agli imper
territi e coriacei puristi (presenti in forze sopratt utto nelle provincie meri
dionali e in Romagna) altri interlocutori manifestano una maggiore attenzio
ne (anche sul piano della didattica) ai dialetti 1, al parlare dei moderni, sug-
" . . . Ma fin d'ora mi permetta manifestarle un mio avviso sugli scolari normalisti,
che è l'andazzo di improvvisare professori. Qui , come dappertu tto, trovai nei vecchi
insegnanti una mala contentezza per queste nomine a detrimento e disdoro della lo
ro anzianità. Poi non Le dissimulo avermi l'esperienza convinto che ottimi alunni
delle scuole normali hanno difetto delle qualità personali didattiche e segnatamente
quelli delle tre letterature, i quali (fin nei ginnasi!) delle loro lezioni fanno laghi di
erudizione, di archeologia, di mitologia, di filologia indo-germanica, trascurando lo
studio soprattutto estetico degli autori e inaridendo le menti dei giovan i . Miiller e
Mommsen sono le lenti dei loro occhiali, e niente altro. Ginnasi e licei si lastricano
di normalisti, i quali sono un vero esercito ormai d'una consorteria di scuole norma
li, di accademie, d'istituti superiori, d'università, che sarà presto un m inistero fuori
del ministero 1 " .
sere d ' università . . . perché l a filosofia e l a letteratura sono l a sostanza e l a forma d i tutto l o sci
bile " (Parere della Facoltà di lettere e filosofia dell 'Università di Napoli sul progetto di rego
lamento del min istro Berti, Napoli, Ghio, l 867 , p . .f); si vedano anche le lettere di Settembrini
a Villari del 2 febbraio 1 867 e del 14 d icembre 1 868 pubblicate in L. SETTEMBRINI, Lettere e
scritti familiari, a cura di A . PESSINA, Napoli, L'officina tipografica, 1993, pp.207-208, 2 1 8222.
1 Vedi ACS, MPl, Personale, 1 860-1 880, fase. « Vollo Giuseppe » , b. 1 362; non sono poche,
nel l ' inchiesta, le proteste dei vecchi insegnanti contro i privilegi dei normalisti e contro il loro
esibi�ionismo scientifico, specie quando calavano nel Mezzogiorno dove più forte era il peso
della tradizione. « La Riforma » del 30 marzo 1 87 3 (doc. 74, p. 585) difende i normalisti: « sono
i migliori per buon volere, per zelo, per amor della scuola e, quello che più importa, per digni
tà di carattere " ma aggiunge: " vanno subito a insegnare al liceo, sorpassando i loro maestri che
restano reggemi al ginnasio per tutta la vita. Sono i favoriti del ministro » e passando poi alle ri-
valità tra le varie scuole osserva che la ruota della fortuna " presentemente . . . ha il suo domici
lio a Pisa » . Pasqualigo nella sua risposta orale (ACS, M P I , Div. scuole medie, 1 860- 1 896, b . 7 ,
fase. -t7) disegna i l quadro d i u n a iniziale specializzazione delle varie scuole normali, per c u i da
Napoli uscirebbero i migliori professori di italiano (Settembrini e De Sanctis), da Pisa quelli di
greco (Comparetti), da Padova quelli di latino e storia (Canal, De Leva).
1 I n diverse risposte ricompare ovYiamente il tabù per i dialetti. Ma specie nel Veneto il dia
letto, per la sua tradizione nobile, aveva maggiore forza di resistenze anche nei ceti medi e non
solo nel popolo. Si veda ad esempio la deposizione di Luigia Widmayer, direttrice del convitto
52
Fonti per la storia della scuola
geriscono che al dodicenne si propongano come modelli di espressione non
più le fole del Trecento, ma qualche lettura che sia più vicina -al parlare del
babbo e della mamma. Ed è significativo che proprio Coppino, che nei pro
grammi del 1 867 aveva proposto per gli alwmi del ginnasio inferiore un cano
ne di letn1re rigorosamente puristico, ora, nella sua deposizione romana, rico
nosca che « noi non possiamo cambiare i nostri piccini a dieci o dodici anni in
tanti antiquari » e che Ascoli nella sua deposizione milanese ribadisca e appro
fondisca sul piano educativo il ragionamento del Proemio ed esorti il mondo
della scuola a capire che la conquista di una lingua comune e non bécera non
può non venire che da uno sforzo intellettuale da fare tutto in salita, dalla con
sapevolezza che il parlare dei colti ha bisogno di un attrito da superare, per
non adagiarsi, come accadeva con la ricetta manzoniana, in una piatta e leziosa
spontaneità. Ma questo, della questione della lingua, è solo un esempio di co
me le carte dell'inchiesta Scialoja possano aiutarci a capire quanto è stata lunga
e tortuosa, in quei primi decenni di vita dello Stato italiano, al di là della for
mula dazegliana, la strada da percorrere per fare gli italiani.
MARINO RAICICH
annesso alla scuola normale femminile di Venezia (ACS, MPI Div. scuole rnedie, 1860- 1896, b.
..., . fa�c. 50), che dichiara che le sue alunne non solo parlano in dialetto ma • hanno per esso
qua� i una specie di idolatria •. Sul piano della didattica non mancano riferimenti alla questione
nelle risposte sulla scuola normale e taluno conclude (e tale sarà la conclusione anche di Ascoli
al Congresso Pedagogico di Bologna del 1 87..j) che per insegnare l' italiano in prima elementare
a bambini unicamente dialettofoni, il maestro deve partire dal dialetto. Su un piano più consa
pevolmente teorico, si veda la deposizione torinese di Liveriero (ibid. , b. 6, fase. 28) direttore
del ginnasio Gioberti: dopo aver rilevato i guasti provocati dai retori, per cui i giovani • sono
impacciati sempre quando abbiano da scrivere una lettera con pratico intendimento, saranno
capaci di far parlare Annibale e Scipione ma non saranno capaci di parlare essi aggiunge: " Vi
è anche il disprezzo di coloro che meno conoscono la lingua italiana pei dialetti: non vogliono
mai che nella scuola risuoni un vocabolo che appartenga al dialetto: una frase di questo dialetto
dà sui nervi. Allora il giovane si avvezza ad un linguaggio impersonale, scontornatO, dove tutto
ruota nel generico; non vi è nulla di preciso, bisogna sempre intendere per sottintesi . . . Biso
gnerebbe che i professori tenessero conto dei dialetti particolari dei giovani che hanno nella
propria classe e facessero continuamente raffronti . . . •. Dopo aver osservatO che i dialetti sono
• un materiale per cui giovarsi nell'insegnamento • , Liveriero conclude osservando che alla sua
proposta aderiscono • le persone più colte che fecero gli studi più profondi in fatto di filolo
gia • . Allude probabilmente a Giovanni Flechia, professore all' università di Torino (presente al
l'inchiesta con una sua deposizione), che in quegli anni sulle pagine dell'• Archivio glottologico
italiano • dava rigore a una nuova scienza, la dialettologia italiana. Anche Vollo, preside del li
ceo Parini di Milano, notando u n miglioramento nella condizione linguistica dei giovani, osser
va: • La lingua italiana, che è in statO di formazione ora, e che era altra a Firenze, altra a Torino,
altra a Roma, questa lingua italiana comincia ad essere u n bisogno, e i giovani cominciano a
sentire che bisogna esprimersi come si parla e non cercare la parola nel Novellino o nel Gala
teo senza capirla, ma che bisogna cercarla nella vita • (ibid. , b. 6 bis, fase. 40): una tesi questa
sullo • statO di formazione • della lingua italiana non lontana da quanto sostenutO qualche anno
prima da Sella in polemica con Manzoni a Brusuglio e ricordato da Giorgini nella sua nota lette
ra a Quintino Sella del 1 869: vedi ora in proposito G. QUAZZA, L 'utopia di Quintino Sella . .
cit . , pp. 5 1 1 -5 1 2 .
.
•,
I I . L E CARTE DELL 'INCHIESTA SCIALOJA
Le carte prodotte dalla Commissione d ' inchiesta per l' istruzione secon
daria maschile e femminile, più comunemente nota come inchiesta Scialoja,
dal nome del ministro che la promosse, sono state versate dal Ministero del
la pubblica istruzione all'Archivio centrale dello Stato insieme alla docu
mentazione della Direzione generale per l ' istruzione media (Archivio gene
rale) della quale fanno parte. Questa serie archivistica comprende documen
tazione riguardante regolamenti, progett i di legge, programmi scolastici , li
bri di testo, personale, licei, convitti ed educandati, ispezioni e inchieste .
L e carte dell' inchiesta Scialoja sono contenute i n undici buste e , malgra
do le evidenti lacune delle quali si dirà in seguito, costituiscono la fonte pri
maria per la ricostruzione della storia e delle vicende dell' inchiesta e del suo
funzionamento .
L ' inchiesta doveva compiersi, come previsto dal r . d . 29 set . 1 87 2 , n .
1 O 1 6 , per mezzo di « interrogatori scritti diretti alle autorità scolastiche, ai
corpi scientifici, a presidi e direttori di istituti, a insegnanti, padri di fami
glia, a persone note per i loro studi o per la loro esperienza. Inoltre per
mezzo di interrogazioni orali alle persone invitate dalla commissione o che
ne facciano richiesta, per mezzo di lettere circolari inviate alle autorità sco
lastiche per richiedere notizie statistiche ed infine per mezzo di visite ed
ispezioni a particolari istituti , 1 •
La tipologia della documentazione è quindi piuttosto omogenea e s i ca
ratterizza per due principali gruppi di document i : i verbali degli interrogato
ri compiuti nelle città visitate dalla Commissione e la raccolta delle risposte
che pervennero per scritto; a questi due gruppi si devono aggiungere una se
rie di documenti comprendenti gl i atti preparatori , i resoconti delle prime
riunioni tenute dai membri della Commissione per la stesura del regolamen
to dell' inchiesta e dei quesiti, corrispondenza fra il Ministero e i membri del
la Commissione, fra il Ministero e le autorità locali per l ' organizzazione del
le sedute nelle varie città e la convocazione delle persone invitate a rispon
dere . Un fascicolo contiene inoltre numeri di diversi giornali con articoli ri
guardanti l' inchiesta.
L ' elenco delle carte della D irezione generale per l ' istruzione media, coe
vo al versamento, dà l' indicazione sommaria delle buste contenenti la docu
mentazione relativa all' inchiesta Scialoja.
L ' esigenza di redigerne un inventario analitico è nata contestualmente al-
.
1 Vedi doc. 1 , p. 1 49.
54
Fonti per la storia della scuola
l' idea del presente volume, ponendosi come condizione necessaria per poter
effettuare la scelta dei documenti da pubblicare e fornendo al tempo stesso
uno strumento di ricerca a quanti altri vorranno studiare l'inchiesta Scialoja.
Si tratta infatti di un complesso documentario le cui potenzialità di ricer
ca sono da cogliere, oltre che nell' insieme, anche nei singoli documenti . Da
ognuno di essi si possono ricavare le risposte date ai quesiti dell ' i nchiesta,
ma anche notizie biografiche relative al personaggio che parla o che scrive,
al la sua f? rma�ione culturale e politica, alla sua provenienza geografica, al
. .
l , tstttuto m c m eventualmente aveva insegnat o : tutti dati questi che consen
tono di ridisegnare in modo più dettagliato e articolato il panorama storico
e culturale che fa da sfondo all' inchiesta.
�a particolarità della documentazione conservata e la pluralità delle pos
. .
stbth letture hanno suggerito la scelta dei criteri da seguire nell ' inventaria
zione e nella descrizione dei documenti, criteri che sono stati improntati al
la massima analiticità. All' indicazione del nome della persona che aveva ri
sposto oralmente o per iscritto si è aggiunto quindi il dato della professione
che svolgeva o della carica che rivestiva. Diverso, infatti, se pur ugualmente
interessante, è l ' intervento di u n prefetto o di u n provveditore, da quello di
u n padre di famiglia, di un maestro o di un privato cittadino. Tali dati, ove
non ricavabili dai documenti stessi, sono stati desunti da bollettini e annuari .
_
E sembrato interessante inoltre rilevare a quali particolari problemi lega
ti all' istruzione essi fossero più sensibili, pertanto vengono di seguito elen
cati i numeri dei quesiti ai quali le varie persone hanno risposto. Come si
espone ampiamente più oltre, il questionario predisposto dalla Commissio
n � co�prendeva 79 domande tra le quali le persone interrogate sceglievano
dt quah trattare . Quasi sempre l ' indicazione dei numeri dei quesiti è riporta
ta � ul frontespizio del verbale o evidenziata in qualche modo nelle risposte
scrttte. Quando questa non era presente sul documento la si è desunta dal
testo e segnalata con un asterisco . I quesiti vengono riportati nell' ordine
con il quale le persone risposero. Talvolta queste tornarono sullo stesso ar
gomento e quindi alcuni numeri di quesiti vengono segnalati due volte. Non
sono stati invece indicati argomenti non riferentisi a precise domande del
questionario: ad esempio l'esposizione della situazione generale della istru
zione in una provincia, argomento sempre trattato dai provveditori e dai
prefetti, o il funzionamento di un istituto privato illustrato dal suo direttore.
Per l � �isp?ste giunte per scritto alla Commissione, tipologicamente più va
.
.
ne, st e mdtcato: per le risposte autografe cognome, nome, professione, nu
mer? dei qu�si � i , eventuali allegati . Le risposte giunte sotto forma di opu
.
.
scoh , arttcoh dt gwrnale, estratti sono state descritte secondo le regole bi
bliografiche.
Le risposte scritte furono all 'epoca archiviate in u n unico ordine alfabeti
co comprensivo di nomi di persona, di città, di associazioni: si è rispettato
quindi tale criterio nel presente ordinamento .
Poiché i nfine le carte relative all' inchiesta fanno parte di una serie archi
vistica si è mantenuta la numerazione originaria delle buste .
Introduzione
55
Prima di passare all' esame oggettivo della documentazione e tornare
quindi sulla tipologia della stessa è opportuno soffermarsi sul modo in cui la
Commissione fu costituita e ne furono organizzati i lavori, anche per valuta
re come la documentazione è stata prodotta, raccolta e utilizzata.
La relazione presentata dal ministro della pubblica istruzione Antonio
Scialoja il 29 settembre 1 872 sul decreto che ordinava l ' i nchiesta su lla istru
zione secondaria maschile e femminile illustra chiaramente lo spirito che
animò l ' iniziativa . I n special modo esprime la convinzione che il ceto medio
svolgeva u n ruolo fondamentale nella società civile e da ciò deriva l ' impor
tanza attribuita all' istruzione secondaria dalla quale quel ceto « attinge la sua
coltura e la sua educazione >> 1 . Sarà effettivamente il ceto medio, nelle sue
molteplici sfumature e differenze, quello che risponderà, in misura più mas
siccia, agli interrogatori proposti dalla Commissione .
L ' inchiesta prese avvio in tempi sostanzialmente brevi: lo stesso 29 set
tembre 1 872 venne firmato il decreto di nomina dei nove membri della
Commissione : Girolamo Cantelli, Marco Tabarrini, Paolo Lioy, Carlo Tenca,
Ruggero Bonghi, G aspare Finali, Luigi Settembrini, Luigi Cremona, Domeni
co Carbone; Pasquale T uriello avrebbe svolto le funzioni di segretario insie
me ad un impiegato del Provveditorato centrale per l ' istruzione seconda
ria 2 La Commissione così composta subì nei mesi successivi diversi cambia
menti e sostituzioni. Il presidente Cantelli, nominato ministro dell' interno
nel luglio 1 87 3 nel governo Minghetti venne sostituito da Antonio Ciccone.
Paolo Lioy, dimissionario, fu sostituito da Francesco Lo Monaco, Paolo Bo
selli prese il posto di Gaspare Finali quando questi, nel luglio 1 873, divenne
ministro dell ' agricoltura, industria e commercio . Il ruolo di segretario, dopo
la rinuncia di Turiello, fu svolto da Cesare Donati e poi da Paolo Mantovani
e da Salvatore Delogu . Il l ottobre il ministro Scialoja firmò l' ordinanza che
illustrava i punti intorno ai quali si sarebbe compiuta l ' i nchiesta ' e nominò,
con suo decreto, Girolamo Cantelli presidente della Commissione: l ' ordi
nanza del ministro venne pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Regno d ' I ta
lia del 1 2 ott . 1 87 2 , n . 2 8 2 . Con il r . d 3 ott . 1 87 2 , n. l 039 venivano stanziate
L. 2 5 . 000 per coprire le spese dell ' inchiesta.
Il 20 ottobre 1 87 2 la commissione si riunì per la prima volta i n una sala
del Ministero della pubblica istruzione. Vennero formate due sottocommis
sioni , la prima cui partecipavano Cantelli, Carbone, Finali e Tabarrini per la
stesura del regolamento, la seconda, con B onghi, Cremona, Lioy, Settembri
ni e Tenca per la stesura dei quesiti. Antonio Scialoja, che aprì i lavori, ri
cordò in quella occasione la recente inchiesta industriale ed i metodi del suo
1 Vedi doc. l , p. 1 49.
' Vedi doc. 2, p. 1 58.
al ministero furono sti
1 Vedi doc. 3 , p. 1 59 . Alcune delle prime risposte scritte pervenute
late sulla base di tale ordinanza, come si rileva dai quesiti indicati con lettere alfabetiche e non
con il numero, come nell'opuscolo stampato in seguito; vedi, per esempio la risposta inviata da
Enrico Labriola (doc. 55, p. 5 1 L ).
56
57
Fonti per la storia della scuola
Introduzione
svolgimento. La sottocommissione incaricata della stesura
. dei quesiti si sud
divise le varie parti da trattare. Lioy e Carbone curarono la parte relativa al
l'amministrazione scolastica provinciale, Tabarrini quella sui convitti, Set
tembrini e Cremona si occuparono dei ginnasi e dei licei, Bonghi degli esa
mi, Tenca della parte relativa ai quesiti generali per tutte le scuole e a quelli
per le normali, magistrali e tecniche 1 •
Il 25 novembre, in una successiva riunione, ebbe inizio la discussione sul
regolamento. Emerse subito una notevole divergenza di opinioni tra coloro
che ritenevano sarebbero state più fruttuose le risposte orali (Settembrini e
Cremona) e coloro che si attendevano maggior ricchezza di contributi dalle
risposte scritte (Tenca, Lioy, Tabarrini). Si discusse anche sull ' opportunità
di prendere o meno in considerazione eventuali risposte anonime e se si do
vesse investire i sindaci della scelta delle persone da interrogare . Si stabilì di
estendere al massimo le categorie di persone cui mandare l ' elenco dei quesi
ti, aggiungendo tutte le facoltà universitarie, i corpi scientifici e le accade
mie. Fu respinta la proposta avanzata da Paolo Lioy di ammettere commissa
ri aggiuntivi che potessero recarsi, con delega, a visitare i posti più lontani
nei quali la Commissione non potesse recarsi. I diversi problemi che insorse
ro dopo alcuni mesi giustificheranno la proposta di Lioy. Fu, infatti, anche
l ' impossibilità di raggiungere le provincie più remote u no dei tanti motivi
che inficiarono in misura non trascurabile i risultati dell'iniziativa.
Dopo alcune altre riunioni tenute nei primi giorni di dicembre, durante
le quali si cominciò la discussione dei quesiti stesi preventivamente dai vari
commissari, il 9 dicembre 1 87 2 la Commissione giunse alla firma del regola
mento definitivo 2 .
Emersero, nella seduta d i quel giorno, nuove divergenze sul modo d i av
viare l 'inchiesta e il ministro ricordò analoghe difficoltà incontrate nell 'av
vio del l ' inchiesta industriale. Affermò di essere convinto che si dovessero
aspettare maggiori contributi dalle risposte orali poiché gli italiani « parlano
delle cose meglio che non ne scrivano •• . Si discusse inoltre dopo quanto
tempo iniziare gli interrogatori e se fosse o meno conveniente iniziare da
Roma.
Nel frattempo era stata fatta una prima edizione di un opuscolo conte
nente l ' elenco dei quesiti 3 . In esso era riprodotto anche i l decreto istitutivo
dell' inchiesta, quello relativo alla composizione della Commissione e il de
creto ministeriale di nomina di Cantelli a presidente della Commissione. I 79
quesiti erano articolati secondo argoment i : presidi, direttori, insegnanti ( 1 9), amministrazione scolastica ( 1 0- 1 1 ), insegnamento pubblico e privato ( 1 21 7) , libri di testo e letture ( 1 8- 1 9), orari, premi e pene, tasse scolastiche (2022), ginnastica e igiene (23-2 2bis), esami (2 3bis- 30), licei e ginnasi (3 1 -4 2 ) ,
scuole tecniche (4 3-5 1 ), scuole normali e magistrali e convitti annessi ( 5 2 6 1 ), scuole superiori femminili (62-63), convitti maschili (64 -72), educatori
femminili (7 3 -77). Ciascun quesito era poi suddiviso in diversi punti. I que
siti contrassegnati con un asterisco erano diretti specialmente ai privati e a
quanti non avevano parte nell' insegnamento . Nell 'opuscolo erano alternate
pagi ne a stampa ad altre lasciate appositamente in bianco per annotarvi le ri
spost e .
Complessivamente era dunque stata prodotta una fittissima, incalzante
griglia di domande che avevano lo scopo di offrire molti punti di partenza
per una discussione e la possibilità di esaminare i molteplici problemi legati
all' istruzione secondaria, sotto diverse angolazioni. Lo stesso ministro della
pubblica istruzione, però, sembrò rimanere quanto meno scettico di fronte
al numero e alla complessità dei quesiti stessi ed in una lettera a Cantelli del
25 gennaio 1 87 3 espresse in forma non del tutto velata i propri dubbi sulla
possibilità che si riuscisse a trarre risposte utili da quel lungo elenco, specie
se sottoposto a persone prive di una specifica competenza in materia « le
quali ne sarebbero come sgomentate e non si periterebbero a rispondere né
a voce né per iscritto » 1. Il ministro suggeriva piuttosto di sollecitare rispo
ste con domande mirate e adeguate all' esperienza delle singole persone in
terrogate, come era stato fat to anche per l ' inchiesta industriale. D i fatto
questo comunque avvenne e quasi nessuno rispose a tutti i quesiti proposti.
Nel corso degli interrogatori la commissione chiese sempre alle persone
convocate quali fossero gli argomenti più rispondenti alla propria esperien
za personale . Nelle risposte scritte giunte al ministero molti si dichiararono
incapaci a dare adeguate risposte a tutti i quesiti e preferirono soffermarsi
solo su alcuni di essi.
Non si ha un quadro complessivo del n u mero di opuscoli stampati e spe
diti . Il ministro Scialoja, alla Camera dei deputati, nella seduta del l dicem
bre 1 873 parlò di 24 . 000 opuscoli spediti e di 8 . 000 risposte 1 , ma il dato
sembra essere assolutamente eccessivo se confrontato con le 492 risposte
conservate, anche ammesso che alcune siano andate disperse.
Gli interrogatori scritti venivano inviati per mezzo del ministero ai presi
denti dei consigli scolastici provinciali, ai provveditori , ai presidi e direttori
di istituti pubblici , ai rettori di convitti, alle direttrici di educandati, agli
ispettori di circondario e ai delegati scolastici. I l consiglio scolastico avreb
be provveduto a distribuirli ai direttori di istituti privati o di corpi moral i ,
1 Vedi ACS. MPI, Diu. scuole medie, /860-1896, b. 4, fase. l , s. fase. 3. Interessante è il rap
porto tra i quesiti proposti dall' inchiesta Scialoja, quelli predisposti da Correnti nel 1 87 1 e le ste
sure dei quesiti fatti da Settembrini in L. SETTEMBRJNI, Lettere edite e inedite . . . cit. , pp. 267-27'!.
1 Vedi do� '! , p. 1 6 2 .
1 Da segnalare che, in questa prima edizione, sulla base della quale furono inviate l a mag
gior parte delle risposte, e che servì da guida anche per le deposizioni orali, compaiono due
domande segnalate con numero bis e precisamente quella relativa all'igiene (22 bis) e quella re
lativa agli esami (23 bis).
1
Vedi doc. 8, p. 2 0 1 .
AP, Camera dei deputati, legislatura Xl, I I I sessione ( 1 87 3 - 1 87<� ). Discussioni, l , tornata
del l dicembre 1 87 3 , p. 220.
1
58
lntmduzione
Fonti per la storia della scuola
agli insegnanti e agli istitutori privati . I sindaci li avrebbero distribuiti ai pa
dri di famiglia con figli che frequentavano o avevano frequentato le scuole
del comune e a quanti avessero ritenuto in grado di dare u n qualche contri
buito con proprie risposte.
Diversi documenti conservati fra le carte dell' inchiesta testimoniano un
notevole fervore da parte delle autorità locali, nel sollecitare l ' invio di opu
scoli da distribuire. Il sindaco di Ancona, che già ne aveva ricevuti quaranta
nove, ne sollecitò altri con la motivazione di aver individuato novantasei
padri di famiglia in grado di rispondere; il presidente della Commissione gli
rispose che poteva inviarne solo 10 poiché l 'edizione fatta era quasi termi
nata; al prefetto di Belluno vennero inviate 1 26 copie, alla prefettura di Cal
tanissetta 29 copie, a quella di Abruzzo Citeriore 1 36, al preside dell ' istituto
tecnico di Cremona 3, al sindaco di Chiavari 20, al prefetto di Padova altri
1 20 oltre quelli inviati in u n primo tempo, al sindaco di Torino 1 00, all ' u ni
versità di Sassari 1 1 1 •
La maggior parte delle risposte scritte pervennero tra marzo e aprile
1 87 3 ; precedentemente ne erano giunte altre probabilmente stilate sulla ba
se dell' ordinanza ministeriale. Può essere interessante sottolineare che nel
corso delle sedute nessuno dei commissari accennò mai alla documentazio
ne che stava affluendo al ministero, i n risposta all' inchiesta, dalle varie parti
d ' I talia .
La prima seduta pubblica della Commissione si tenne a Roma l ' 1 1 feb
braio 1 87 3 , a questa seguirono altre quattro sedute il 1 2 , il 1 3 , il 1 4 e il 1 5
dello stesso mese. Da Roma la Commissione si spostò a Napoli dal 1 8 al 26
febbraio, tenendo le sue riunioni nella sala del Consiglio provinciale a S. Ma
ria la Nova, quindi a Salerno dal 27 al 28 febbraio. I l 3 e 4 marzo è a Caser
ta, dal 26 al 29 marzo a Bologna, il 3 1 marzo e il l aprile a Ferrara, poi il 3 a
Forlì, il 4 a Cesena, il 7 a Ravenna. I lavori subirono una pausa per le feste
pasquali dopo le quali si era progettato di visitare la Sicilia e la Sardegna, co
me scriveva Cantelli a Tabarrini i n una lettera del 1 5 aprile 1 87 3 1. La com
missione si spostò invece a Torino dove rimase dal 1 0 al 17 maggio. Dopo
la pausa estiva, resa più lunga dalla crisi del governo Lanza, i lavori della
Commissione ripresero a Firenze dal 28 ottobre al l novembre, poi a Milano
dal 4 al 1 0 novembre, per concludersi quindi a Venezia e a Padova nel gen
naio 1 874 . Complessivamente furono tenute cinquantadu e sedute nelle qua
li furono ascoltate 4 38 persone.
La commissione percorse quindi l ' Italia per quasi 1 1 mesi, visitando pe
rò solo 14 città e compiendo nel corso del tempo numerosi cambiamenti di
programma: non giunse mai a visitare né la Sicilia, né la Sardegna, mete an
n unciate anche in un articolo de « Il Corriere di Milano ,, del 1 7 marzo 1 873
1
ACS, M P I , Diz•. scuole medie, 1 860- 1 896, b. 7, fase. 58.
Vedi doc. 1 3 , p. 2 1 2 .
59
e altre rinuncie furono compiute anche per alcune città della Lombardia e
del Piemonte . Del resto già in maggio Cantelli aveva fatto presente al mini
stro le difficoltà insorte in seno alla Commissione per la frequente assenza
di alcuni commissari 1 •
Ali 'inizio del 1 874 , quando la Commissione si recò a Venezia e a Padova
la volontà di proseguire l ' inchiesta era ormai praticamente nulla e quelle pa�
dovane furono le ultime sedute .
L a storia della Commissione s i conclude c o n l e proposte inviate al Consi
glio superiore e con la pubblicazione dei decreti del settembre del 1 874 2 •
L ' attività della Commissione era seguita con molta attenzione dalla stam
pa, sia da quella nazionale, che fornisce il quadro delle reazioni dell'opinio
ne pubblica di fronte all' inchiesta , ne dichiara le aspettative e le speranze
denunciando le carenze e le lacune dell' ordinamento scolastico, che da
quella locale, la quale riferisce spesso i resoconti delle varie sedute, dà noti
zia dell' arrivo e della partenza dei membri della Commissione e delle acco
glienze da parte delle autorità locali.
Quando la Commissione giungeva in una città era stata in genere prece
duta da u na comunicazione del ministro al prefetto 3 , da u na serie di avvisi
pubblici disposti dalla Prefettura o dal Municipio " , avvisi nei quali si invita
vano tutti gli interessati a dare la propria disponibilità ad un interrogatorio:
notevole, ad esempio, è il numero dei cittadini milanesi che chiesero di es
sere ascoltati " . Successivamente venivano preparate le liste delle persone
scelte, alle quali veniva data comunicazione del giorno e dell 'ora in cui pre
sentarsi davanti alla Commissione. Tra le carte relative alla Commissione
1
Vedi doc. ! 5 , p. 2 1 4.
Vedi in proposito l'introduzione di Marino Raicich, p. 3 3 , e doc. 1 6 , p. 2 1 7 .
Tra l e carte dell'inchiesta è conservata la seguente lettera circolare del ministro della pub
blica istruzione ai prefetti, presidenti dei consigli provinciali scolastici, del maggio 1 873: " La
Commissione per l 'inchiesta sopra l ' istruzione secondaria si adunerà fra breve in cotesta città
per chiamare innanzi a sé le persone più autorevoli a rispondere ai vari quesiti da essa proposti.
Son certo che la S.V. non lascierà di cooperare da parte sua perché l 'inchiesta si compia con
frutto, ad ogni modo non \'Oglio astenermi di raccomandarle le egregie persone che compon
gono la �ammissione le quali con raro zelo e devozione portano un carico non lieve né agevo
le. Io saro tenuto a V.S. se potrà far di maniera che l'opera loro per una parte riesca più compi
ta, e per l'altra torni ai Commissari il men che sarà possibile faticosa » : ACS, MPI, Div. scuole
medie, 186 0- 1896, b. 7. fase. 63.
' A Cesena per esempio il Municipio predispose il seguente manifesto: « Avviso. La Commis
sione d'inchiesta sull 'istruzione secondaria maschile e femminile presieduta dal signor conte se
natore Cantelli, terrà una seduta pubblica in questa città venerdì 4 corrente alle ore 1 2 meridia
ne nella sala del Liceo per sentire le dichiarazioni che le potranno esser fatte sull'a�gomento
dell'inchiesta. Tutti quelli pertanto, che desiderano di esser i nterrogati, e siano in grado di
esporre fatti e giudizi riguardanti le scuole secondarie sono pregati di farsi inscrivere entro do
mani alla segreteria del Comune. Lo scopo grandemente utile e commende,•ole che ha in mira
la Commissione troverà certo in ogni ordine di cittadini quell'efficace concorso che essa si at
tende. Cesena. 2 aprile 1 87 3 . 1 1 sindaco Mami » : ACS, M P I , Diu. swole medie, 1860- 1896, b. 7,
fase. 60.
' Gli elenchi sono conservati ibid. , b. 7, fase. 6-J.
60
61
Fonti per la sto1·ia della scuola
Introduzione
d ' inchiesta è conservata traccia di questa attività preparatoria solo per alcu
ne città.
Alla Commissione, durante la sua permanenza in una città, venivano in
dirizzate non solo le lettere delle persone che per diversi motivi non poteva
no recarsi a deporre, ma anche risposte scritte .ai quesiti, che secondo il re
golamento avrebbero dovuto essere inviate al ministero . In un fascicolo di
corrispondenza relativo alla permanenza della Commissione a Torino, è ad
esempio conservata una lettera di G . Melotti, professore del r. ginnasio G io
berti, il quale scrive di aver già inviato un suo libro intitolato Il progetto
Correnti e il pubbUco insegnamento in Italia, che peraltro non è conserva
to fra le carte dell ' inchiesta. Mentre una lettera del preside del liceo Cavour,
Pietro Baricco, annuncia di aver spedito, secondo la prassi regolare, cioè al
ministero, le risposte del consiglio dei professori che sono infatti regolar
mente conservate fra le risposte scritte. Un breve appu nto su cui è scritto
" deputato G. B. Ruggeri - opuscolo intito lato Osservazioni relative alla
istruzione secondaria e superiore in Italia >> lascia supporre l ' invio di que
sta p ubblicazione della quale però non vi è traccia 1 •
Questo indirizzare alla Commissione e non al ministero le risposte fu
probabilmente la prima causa della evidente dispersione di parte della docu
mentazione. Una seconda causa fu certamente lo spostamento continuo del
le carte che seguivano la Commissione da una città all 'altra e i frequenti ri
torni a Roma dei vari membri della Commissione chiamati nella capitale dai
rispettivi impegni, lasciando così la Commissione nella quasi impossibilità di
proseguire i lavori , come faceva presente Cantelli al ministro nella lettera
del 1 8 maggio già citata.
I verbali delle audizioni compiute dalla Commissione sono conservati
suddivisi in fascicoli con l ' indicazione del luogo, della data e con l ' elenco
delle persone ascoltate. All' interno, i n ordine di presentazione delle perso
ne, i diversi verbali .
Il regolamento p e r la Commissione d ' i nchiesta prevedeva c h e le deposi
zioni orali fossero raccolte dai segretari nominati dal decreto reale . La Com
missione, e le eventuali sotto-commissioni, avrebbero potuto decidere quan
do far raccogliere le risposte stenograficamente. Probabilmente la Commis
sione viaggiava con i propri stenografi che successivamente trascrivevano i
testi. Questa ipotesi è avvalorata da un breve appunto dal titolo « Stenogra
fia » ave si riferisce che durante la deposizione del prof. Colombetti, nella
seduta torinese del 1 4 maggio 1 87 3 , nella quale si parlò dell ' i nsegnamento
della stenografia in I talia, Cantelli, che presiedeva la seduta, i nterrompendo
l 'oratore disse « gentili parole che tornano in lode degli stenografi i quali se
guono la Commissione ed adoperano il metodo Gabelsberger » 2• Il 1 8 maggio
1 87 3 Cantelli scrive al ministro della fine dei lavori torinesi annunciando
anche di aver disposto il ritorno a casa degli stenografi.
Lo stato dei documenti conservati è alquanto vario: ci sono testi che ri
velano un'attenta operazione di controllo, altri che mostrano tracce di nu
merose correzioni. È probabile che i testi trascritti venissero spesso sottopo
sti per una revisione alle persone stesse che si erano presentate alla Commis
sione d' inchiesta. Siamo indotti a pensar!o da alcune notazioni sui verbali
nelle quali è scritto " revisionato dali 'autore " ed anche da una lettera del sin
daco di Ravenna Rasponi che il 2 maggio 1 87 3 restituì alla Commissione la
traduzione dallo stenogramma del suo intervento 1 •
Alcuni verbali presentano evidenti errori, specie nella grafia dei nomi
stranieri o meno noti e nelle citazioni in altre lingue anche a causa, talvolta,
della cattiva acustica della sala dove si svolgeranno i lavori . Nel verbale del
la deposizione milanese di Jung, ad esempio, ad un certo punto è scritto: " la
voce dell' oratore non giunge al banco degli stenografi '' . Si può affermare
comunque che il lavoro degli stenografi era molto attento anche nel riporta
re le eventuali reazioni di ilarità, approvazione, dissenso da parte del pubbli
co. Nel verbale della seduta del 1 0 novembre 1 873 a Milano è riportato il te
sto che il prof. Gaetano Galante lesse davanti alla Commissione e vi è ag
giunto un appunto dello stenografo : " In terrompe qualche volta la lettura
per spiegare meglio i concetti scritti, ma senza aggiungere nulla d i nuovo .
C . Gallini sten . " 1 .
Su alcuni verbali sono presenti sottolineature di alcuni brani e all' inizio,
sul frontespizio, sono quasi sempre elencati i quesiti sui quali la persona in
terveniva, quesiti che spesso sono riportati anche in margine al testo stesso.
Sono segni questi che testimoniano forse i l lavoro condotto in vista della
pubblicazione dei risultati dell' inchiesta.
La Commissione compì, secondo quanto previsto nel decreto istitutivo,
alcune ispezioni delle quali sono conservate le relazioni. Queste furono mol
to poche, malgrado le sollecitazioni del min istro . Siamo certi, dalla docu
mentazione conservata, di u na ispezione a Napoli presso due istituti privati,
di una a Santa Maria Capua Vetere, di due a Ferrara alla scuola tecnica e al
ginnasio comunale.
Le sedute della Commissione erano pubbliche, tranne nei casi nei quali si
doveva parlare di fatti o situazioni strettamente personali o riservate, come
la seduta segreta di Firenze dedicata ai problemi relativi al collegio Cicogni
ni di Prato: la rivista fiorentina " La Scuola » , diretta da Alfani, aveva denun
ciato nei mesi precedenti le sedute fiorentine, irregolarità e scandali nella
gestione del C icognini, attribuendone la responsabilità al suo direttore, il
deputato Merzario.
Le risposte scritte presentano, come è naturale, una tipologia molto va-
1
ACS, MPI, Div. swole medie, 1 860-1 896, b. 7, fase. 64 .
L'appunto è conservato nel fascicolo contenente la documentazione prodotta dalla Commissione durante la sua permanenza a Torino, ibid. , b. 7, fase. 6 3 .
2
·
1
Ibidem.
ACS, MPI, Div. scuole medie, 1 860- 1896, b. 7, fase. -1 5 , s. fase. 8 .
62
Fonti per la storia della scuola
ria e differenziata. Molti risposero direttamente sull' opuscolo dei questtt ,
utilizzando l e pagine lasciate libere all 'uopo; molti spedii-ono. invece mano
scritti, aventi talora la forma di vere e proprie lettere indirizzate alla com
missione, numerosi furono anche coloro che inviarono propri lavori a stam
pa, opuscoli e piccole pubblicazioni sia prodotti i n occasione dell' inchiesta
per rispondere ai quesiti, sia pubblicati negli anni precedenti su problemi ed
aspetti particolari dell' istruzione 1 •
I ndipendentemente comunque dalla tipologia t utte l e risposte ricevute
furono conservate in fascicoli contraddistinti dalle lettere dell ' alfabeto e ar
chiviate secondo il nome di chi le aveva spedite. I pochi fascicoli originali
conservati recano sulla copertina l ' elenco dei documenti contenuti , indicati
col nome del mittente. Questo elenco è però parziale, sembra cioè che il la
voro di archiviazione non sia stato condotto a termine.
È da segnalare come non sempre siano stati seguiti analoghi criteri nella
suddivisione alfabetica delle risposte nei fascicoli : i documenti inviati da
consigli scolastici e presidi di istituti sono generalmente conservati secondo
l ' ordine alfabetico della città di provenienza, analogamente per alcuni prov
veditori, mentre altri figurano nel fascicolo secondo la lettera iniziale del lo
ro cognome .
Sull' angolo superiore sinistro di quasi tutti i documenti è segnata la data
di arrivo, spesso il nome del mittente, talora il numero di protocollo. Quasi
sempre c'è anche un numero vergato a matita blu , forse secondo l ' ordine
d ' arrivo.
Il decreto istitutivo della inchiesta prevedeva, all ' art . 5 , la successiva
pubblicazione degli atti " nei modi e nelle forme che dalla commissione ver
ranno stabiliti » . Era però esclusa la pubblicazione di fatti attinenti a situazio
ni strettamente personali . Esempio dell ' obbedienza a questo dettato è ri
scontrabile nel confronto tra la risposta inviata da Giovanni Calvetti, e ri
prodotta in questo volume 2, e quanto poi pubblicato . Nel 1 875 infatti fu
pubblicata, a cura di Riccardo Folli e Antonio Casetti, una prima dispensa
che comprendeva gli atti normativi coi quali venne ordinata l 'inchiesta, il
1 Si vedano per esempio A. CATERINI, La libertà dell 'insegnamento. Considerazioni di An
gioia Caterini, Livorno, 1 86 1 ; I D . , Della non onorevole causa dell 'insegnamento privato de
gl 'insegnanti pubblici sostenuta dall'onorevole deputato sig. Luciano Scarabelli. Confuta
zione di A ngiolo Catet·ini, Livorno, tip. Fabbresehi , 1 864 (ACS, MPl, Div. scuole medie, 1 8601896, b. 9. fase. 68); T. GHIRON, fl metodo, le scritture e l 'insegnamento del calligrafo Giaco
mo Castelli esposti al pubblico giudizio da Teodoro Ghiron, maestro di calligrafia, Torino,
ti p. Moretti, 1 869 (ibid. , b. l O, fase. 73); L. GRANDI, Definizioni e regole di aritmetica di Luigi
Grandi, prof titolare di matematica elementare, Bergamo, tip. Fratelli Bolis, 1 869, ( ibidem) ;
L. G RAND I , Sull 'insegnamento dell'aritmetica. Ossen•azioni d i Luigi Grandi, pubblico inse
gnante di matematica, Bologna, ti p. Fava e Gavagnara, 1 865 (ibidem); E . MARENESI, Sul riordi
namento della istruzione nazionale in Italia: abbozzo di legge ideato da un antico maestro
di scuola, Bergamo, Pagnoncelli, 1 86 1 (ibid. , b. I l , fase. 77).
1
Vedi doe. �3 . p. � 5 1 .
63
Introduzione
regolamento della stessa, l ' elenco delle persone che risposero oralmente e
per iscritto ai quesiti proposti dalla Commissione ed infine un sunto delle
più interessanti risposte orali e scritte limitato soltanto ai primi cinque que
siti 1 • A questa prima dispensa non ne seguirono però altre probabilmente a
causa delle vicende finali dell ' i nchiesta che, più che concludersi, andò lenta
mente morendo, anche per il mutamento del clima politico, senza aver esau
rito tutti i lavori programmati . Ma certamente, nella mancata pubblicazione
ebbero un loro peso anche le personali vicende dei due professori che erano
stati incaricati di redigere il lavoro . Antonio Casetti, divenuto provveditore
agli studi per la provincia di Lecce, morì 1 ' 8 luglio 1 87 5 ; Riccardo Folli fu
trasferito dal ginnasio Visconti di Roma a Milano. Dal suo fascicolo persona
le 2 si ricava la notizia che egli, successivamente, continuò il lavoro : il 2 2
ottobre 1 87 5 i l ministero scriveva a l provveditore d i Milano , ave Folli inse
gnava, perché questi rimandasse a Roma le risposte orali e scritte relative al
le scuole normali , l ' 1 1 novembre un' altra lettera parla della restituzione a
Folli delle carte dell' inchiesta, il 3 febbraio dell'anno successivo lo stesso ca
po di gabinetto Donati inviava un telegramma a Folli in cui scriveva: " Urge
ult imare pubblicazione atti inchiesta. Pregola rimandare subito bozze corret
te » . Sono queste le ultime tracce dei lavori per la pubblicazione. Tracce che
comunque sono anche evidenti nelle carte stesse dell' inchiesta, spesso re
canti sottolineature, chiosature e commenti in margine certamente opera di
Folli e di Casetti .
Anche i trasferimenti che le carte subirono in questa fase sono quasi si
curamente tra le cause di alcune lacune e dispersioni nella documentazione.
Si può affermare comunque che lo stato con cui le carte sono giunte fino
a noi testimonia, nelle annotazioni apposte su di esse , nelle sottolineature di
alcuni brani particolarmente significativi, il lavoro di razionalizzazione che
Folli e Casetti cominciarono a compiere per « tirare le somme » . L'evidente
provvisorietà dell' ordinamento delle carte stesse testimonia inoltre il venir
meno dell' interesse per l ' inchiesta e i suoi risultati .
In una valutazione complessiva delle carte dell ' inchiesta s i può afferma
re, ai fini del panorama storico che esse delineano, che mentre l ' insieme
delle risposte orali rappresenta, per lo più, l ' Italia dei notabili, degli alti fun
zionari, in genere delle personalità di rilievo, il complesso delle risposte
scritte fa emergere l ' Italia minore, il ceto medio e vi trovano voce l ' inse
gnante di provincia, il padre di famiglia, direttori e presidi di quelle località
ave la Commissione non giunse . Questo è confermato anche da un « panora
ma , in cifre, che può essere dato come indicazione di massima, comunque
significativa. Si deve infatti tener presente che molte persone risposero da
1 L'avviso di questa pubblicazione comparve in " Bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione », 1 87 5 , l, e in " L' Ossen•atore scolastico 1 874-'75, p. 62 1 (n. 39 del l o
agosto 1 875).
1 ACS, MPI, Personale, 1 86 0 - 1 880, b. 7 2 4 , fase. « Folli Riceardo •.
"•
65
Fonti per la storia della scuola
Introduzion e
più punti di vista, come facenti parte, per esempio, dell'amministrazione scola
stica, ma anche come padri di famiglia, come presidi o direttori: di un istituto
scolastico, e come singoli insegnanti. Si riportano i dati solo per alcune catego
rie di persone: furono ascoltati, nel corso dell'inchiesta, 1 5 provveditori , 80
presidi, 23 direttori di istituti privati, 5 prefetti, 23 persone tra consiglieri per
le scuole, ispettori, facenti parte delle giunte di vigilanza, 57 professori univer
sitari, 6 sindaci, 1 32 insegnanti, 28 padri di famiglia, 4 delegati mandamentali .
Tra le risposte scritte si notano, oltre agli undici provveditori, un solo prefetto,
ma un numero molto maggiore, ad esempio, di delegati rnandamentali (22), di
professori e insegnanti ( 1 96), e poi 40 risposte collettive di consigli di profes
sori e 7 di collegi di professori universitari. Si tenga presente che in molte loca
lità per iniziativa di autorità scolastiche o di notabili o di società culturali ven
nero formate apposite commissioni per discutere sui quesiti ed elaborare le ri
sposte. Si ricorda, a titolo di esempio, il caso del corpo insegnante di Piacenza
che si riunì in diverse commissioni e sotto commissioni, per più giornate, per
compilare le risposte da inviare alla Commissione.
Esaminando poi il complesso delle risposte ricevute in base alla loro pro
venienza geografica balza agli occhi la grande disparità numerica delle rispo
ste provenienti dalle diverse province. È in testa il Piemonte (con 54 risposte
da Torino, 9 da Cuneo, 3 da Novara, 5 da Alessandria) seguito dalla Lombar
dia (52). Numerose risposte giunsero dalla Liguria, dal Veneto, dall'Emilia,
dalla Toscana, dalle Marche. L'Umbria è presente con 10 risposte, notevole è
il numero delle risposte del Lazio e della Campania, mentre per l'Abruzzo, le
Puglie, la Calabria e la Basilicata il numero diventa molto esiguo. Da segnala
re invece le numerose risposte provenienti sia dalla Sicilia che dalla Sardegna.
Spesso, prendendo spunto dalle domande formulate nei quesiti predi
sposti, molte persone espongono una situazione talora minoritaria, a volte
di forti delusioni personali, di difficoltà economiche, d i problemi derivati
dalla sovrapposizione del nuovo regime ai precedent i .
Emergono realtà scolastiche profondamente diverse fra loro, in c u i s i in
contrano, e si scontrano, ceti sociali con aspirazioni spesso contrastanti e
opinioni divergenti sui programmi, sugli esami, sull' insegnamento della- reli
gione e della filosofia, sugli stessi libri di testo, opinioni che avevano evi
denti radici nel substrato culturale preunitario.
Si deve sottolineare inoltre come questo complesso documentario rap
presenti, oltre ad una fonte primaria per la storia dell' istruzione della secon
da metà dell 'Ottocento, un possibile terreno per ricerche di altro tipo.
Emergono ad esempio notizie sulle usanze delle varie regioni, sui periodi
preferit i per le vacanze, in relazione al clima del posto, ma anche alla preva
lente attività agricola o non dei padri di famiglia, alla maggiore o minore vi
cinanza al mare che poteva consentire i bagni nella stagione estiva '. Si pos-
sono ricavare diverse considerazioni sulla presenza femminile nel mondo
scolastico: significativo è, mentre il decreto istitutivo della Commissione di
inchiesta è la prima norma legislativa in cui esplicitamente si parla di istru
zione secondaria femminile, sia l 'esiguo n umero di donne che rispondono
alle domande formulate dalla Commissione, sia il fatto che esse si sofferma
no quasi sempre solo su alcuni specifici temi 1 • Emerge inoltre quale fosse la
considerazione del ruolo delle donne nella società e nella scuola 2, su come
si riteneva dovesse esser configurata la loro istruzione, su quali lavori « don
nesch i » esse dovessero essere maggiormente esercitate. Dalle testimonianze
raccolte dall' inchiesta si ricava inoltre u n panorama delle condizioni socio
economiche delle diverse zone d ' Italia 3 .
Dalle notazioni diverse apposte sui documenti traspare la vita e il lavoro
del travet ottocentesco e spunti di ricerca sui « tempi ,, della burocrazia (la ri
sposta spedita da De G ioannis da Alghero il 3 1 maggio 1 87 3 è protocollata
64
1 Pasquale Turiello, ad esempio, nella sua deposizione napoletana del 20 febbraio 1 87 3 , si
sofferma sul clima, sugli orari dei pasti e sui riflessi di questi aspetti nell'organizzazione scola
stica (ACS, MPI, Diii. scuole medie, 1860- 1 896, b. 4, fase. 9).
1 Solo 1 2 donne si presentarono per rispondere alla Commissione d 'inchiesta: Luigia Oliva,
ispettrice delle scuole femminili a Napoli, Annetta Fantini, ispettrice a Bologna, Clelia Marini,
direttrice delle scuole normali femminili di Ravenna, Giuseppina Carapia, direttrice dell'orfa
notrofio di Ravenna, Savina Fabbricius, maestra di storia nelle scuole normali di Firenze, Albina
Perletti Soprani , madre di famiglia, Luisa Casari Piana di Firenze, Teresa De Gubernatis Man
nucci, di Firenze. Carolina Nencioni (della quale manca però la deposizione), la direttrice del
Collegio materno di Bergamo Barbetta, Laura Veruda Goretti, ispettrice delle scuole femminili
di Venezia. Luigia Widmayer, direttrice del Convitto normale femminile di Venezia. Tra le ri
sposte giunte per iscritto solo nove sono di donne: la direttrice del Conservatorio di S.Chiara
in San Miniato, Amalia Alfieri Cattaneo; Angiolina Bulgarini, insegnante nella Scuola superiore
femminile di Roma. Augusta Civra, direttrice del Pio Istituto della Ss. Annunziata di Torino, Te
resa De Gubernatis Mannucci, che aveva anche risposto alla Commissione a Firenze, Maria De
Vincentis Rubino di Trani, Emilia Prampolini ispettrice scolastica a Roma, Sara Salom Jona, di
rettrice di un Istituto convitto femminile di Venezia, Albina Soprani Perletti di Firenze, Teresa
Surlera, direttrice dell' Istituto delle dame inglesi di Vicenza.
1 Giacomo Filippo Airoli. direttore della Scuola normale femminile di Firenze, ad esempio,
nella seduta del l novembre 1 87 3 , riflettendo sulla domanda se fossero preferibili maestre o
maestri nelle scuole normali femminili , dichiarò di preferire i maestri, poiché le donne « con
quella leggerezza che è propria di esse, sono più inclini a dar corpo alle ombre • . Suggerì inoltre
che i consigli comunali sranziassero fondi per la preparazione delle proprie maestre, in modo
che queste non dovessero essere chiamate da altri luoghi, poiché riteneva " sconveniente , che
ragazze di soli diciassette anni andassero, per esempio, da sole, fino in Sicilia. Nella stessa sedu
ta, Antonio Roiti, sempre insistendo sul tema di una diversa indole ed educazione delle donne,
dichiarò che, se era bene educare i ragazzi a parlare i n pubblico, non era bene fare altrettanto
per le ragazze, alle quali si doveva insegnare riservatezza e modestia di modi : ACS, MPI, Div.
scuole medie, 1860- 1 896, b. 6 bis, fase. 39. Un 'altra voce fortemente critica sulle capacità delle
donne fu quella di Enrico Labriola che, alla domanda relativa a chi fosse da preferire alla dire
zione e all'insegnamento nelle scuole normali e nelle scuole superiori femminili, rispose: « Non
v ' ha dubbio cl1e sarebbe cosa molto buona affidare a femmine anziché a uomini la direzione e
l' insegnamento nelle scuole normali femminili. Ma se si rende tanto difficile trovare uomini vera
mente atti a dirigere e insegnare . . . dove e come trovare altrettante donne' , (doc. 55 . p. S I I ) .
.l Vedi per esempio la descrizione delle condizioni socio-culturali della zona di Arpino, co
me emerge dalle deposizioni di Giambattista Panico e di Di Napoli, alle quali si fa riferimento
nella nota l , p. 302; ed anche la deposizione di Laura Veruda Goretti, che contiene un attento
esame della situazione dell'artigianato veneto (doc. 36, p. 407).
66
Fonti per la storia della scuola
in arrivo al ministero a Roma il 3 giugno ! ) ; dal modo di conservazione delle
carte, che sembra iniziata secondo precisi criteri e non più portata avanti,
dalla mancata pubblicazione degli atti dell' inchiesta si traggono spunti an
che sull'organizzazione della memoria storica dell' ammi nistrazione. Dal te
nore delle risposte emerge la psicologia di coloro che si presentarono da
vanti alla Commissione, oltre alla maggiore o minore attenzione dei membri
della stessa, che a volte interloquiscono con frequenza, a volte sembrano su
bire veri e propri fiumi di parole. L e risposte scritte offrono spunti infiniti
per uno studio sul modo di scrivere, sulle formule retoriche usate, sui riferi
ment i più frequenti ad autori classici o moderni, sui numerosi influssi dialet
tali, sul livello culturale di quel « Ceto medio » al quale aveva in particolare
pensato il ministro Scialoja nel dare avvio alla sua inchiesta sull' istruzione
secondaria.
LUISA MONTEVECCHI
A rchivio centrale dello Stato
INVENTARIO
ACS, MPI, Div. scuole medie (1 860- 1 896), Commissione d 'inchiesta sulla
istruzione secondaria maschile e femmin ile (1 8 72- '75), bb. 4 - 1 3 .
busta 4
Commissione d ' inchiesta sulle scuole secondarie 1 872- 1 87 5 (fase . l )
1 . Relazione a l re d i Antonio Scialoja nella udienza del 2 9 settembre 1 872
sul decreto che ordina un' inchiesta sulla istruzione secondaria maschile e
femminile (e testo dei due decreti relativi) , e regolamento della Commissio
ne d'inchiesta sulla istruzione secondaria discusso e approvato nelle tornate
del 25 novembre e 9 dicembre 1 872 (a stampa); « G azzetta ufficiale del Re
gno d ' Italia >> , l ott. 1 87 4 , n. 234 .
2 . « Verbali della Commissione (sedute private) >> : 20 ottobre 1872 - 9 di
cembre 1 87 2 .
3 . « I nterrogatori scritti >> : testi dei quesiti elaborati d a Lioy, Carbone, T en
ea, Tabarrini, Settembrini, Cremona, Bonghi .
4 . Atti conclusivi : minuta della relazione al re sulle proposte fatte dalla
Commissione d ' inchiesta; lettera di Carlo Tenca al ministro della pubblica
istruzione con allegata proposta della Commissione da sottoporre al Consi
glio superiore; relazione del Consiglio superiore , l luglio - l settembre
1 874 .
Verbali della seduta di Roma dell ' I l febbraio 1 87 3 (fase . 2)
GIUSEPPE F ERRERI , segretario generale del M inistero di grazia, giustizia e dei
culti ( 1 2- 1 4 , 1 7 , 1 9 , 20, 2 3-30).
GABRIELE L UIGI PECILE, deputato al Parlamento ( 1 0 , 1 4 , 36, 5, 1 8) .
A LESSANDRO C ASAUNI , deputato a l Parlamento ( 1 0 , 1 1 ).
L 'elaborazione del programma di stampa dell'inventario è stata curata da Alberto Ro
bustelli. L' immissione dei dati è stata curata da Salvatore Griffo.
P IER F ELICE B ALDL'ZZI , preside del r. liceo E nnio Quirino Visconti di Roma ( 1 ,
2 , 3 , 5 , 8 , 1 0- 1 3 , 1 8 , 20, 2 2 - 2 7 , 1 4 , 64 , 66, 68, 7 1 , 7 2 ) .
70
Inventario
Fonti per la storia della scuola
professore di eloquenza latina nella
studi di Roma (5, 1 7 , 36, 2).
O ORATO OCCIONI ,
r.
71
u niversità degli
Verbali della seduta di Roma del 1 4 febbraio 1 873 (fase . 5 )
Verbali della seduta di Roma, 1 2 febbraio 1 87 3 (fase. 3)
STANISLAO CANNIZZARO, senatore del regno, professore di chimica organica e
inorganica nella r. università degli studi di Roma ( 1 , 5 , 1 0, 1 3 , 24).
MAURO MACCHI ,
deputato al Parlamento, professore (23, 7 , 9, 1 1 , 1 2 , 1 6, 1 7 ,
2 3 , 1 3 , 20, 69).
capo dell 'Ufficio di statistica presso i l M unicipio di Roma
(6, 1 3 , 1 4 , 1 7 , 20, 23, 27, 4 5 , 47, 62, 64, 68, 69, 7 3 ) .
DAVIDE SILVAGNI ,
GIUSEPPE ALASIA,
consigliere di Stato ( 1 , 4 , 5 , 7 , 1 0, 1 2 , 1 4 , 2 2 , 2 3 , 3 1 , 6 5 ,
73).
MICHELE AMARI, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
professore nel r . istituto di studi superiori in Firenze , senatore del regno (5 7, 1 1 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 2 3 , 36) 1 •
GIUSEPPE GADDA,
CARLO BELVIGLIERI , professore di storia nel r . liceo e nella r. università degli
studi di Roma ( 1 , 25-27, 40, 1 8 , 3 1 , 1 3) .
CARLO LEARDI,
avvocato, professore di agronomia, deputato al Parlamento
(44-48, 43).
EUGENIO BERTIN I , professore nel r . ginnasio E. Q. Visconti e nella r. universi
tà degli studi di Roma ( 1 2 , 4 1 , 1 4 , 2 3 bis, 4 1 , 28).
BIAGIO PLACIDI,
ANTONIO ALLIEVI,
direttore della Banca generale in Roma ( 1 0 , 1 4 , 2 3 , 1 8 , 3 8 ,
senatore del regno, r . prefetto di Roma ( 1 0 , 1 1 ).
consigliere per le scuole della provincia di Roma (3 1 , 4 3 ,
1 3 , 1 7) .
39, 73).
o, professore di letteratura italiana nella r . u niversità degli
studi di Torino, deputato al Parlamento ( 1 - 1 2 , 1 8-20, 22-26).
M I C HELE COPPI
Verbali della seduta di Roma d e l 1 5 febbraio 1 873 (fase . 6 )
professore nella r . università degli studi di Torino, depu
tato al Parlamento (3 2 , 5 2 , 3 3 , 4 1 , 44, 4 5 , 3 5 , 36, 24 , 37, 38, 40-4 2 , 4 2 , 44,
4 5 , 48, 5 5 , 57, 58).
MICHELE COPPINO,
Verbali della seduta di Roma del 1 3 febbraio 1 87 3 (fase . 4)
avvocato, professore di diritto, segretario generale al Ministero
dell' interno, deputato al Parlamento (4 , 5 , 1 4 , 8, 1 0- 1 2 , 1 7 , 1 8 , 2 3 , 23 bis,
1 3) .
L U I G I GERRA,
FRANCESCO ZAMBALDI, professore di lettere latine e greche n e l r . liceo Ennio
Quirino Visconti e nella r. università degli studi di Roma ( 1 -9 , 1 1 , 1 4 , 1 8 ,
1 9, 2 3 bis, 3 2 , 37, 24).
GIUSEPPE PIOLTI D E ' BIANC H I ,
GALEAZZO CALCIATI,
PIETRO BLASERNA,
deputato al Parlamento (6, 7 , 1 2- 1 4 , 1 7 , 2 3 , 2 3 bis, 56,
deputato a l Parlamento, consigliere d i Stato ( 1 8 , 2 7 , 26,
36, 1 4 , 3 2) .
consigliere per le scuole della provincia di Roma (27, l ,
3 1 , 34, 4 3 , 38, 3 5 , 1 0 , 36, 38, 1 7) .
consigliere provinciale (3 1 , 36, 38, 39, 4 9 , 1 7) .
rettore della r . università degli studi d i Roma ( 1 1 , 1 2 , 4 2 ) .
ALIPRANDO MORIGGIA, professore di istologia nella r . università degli studi di
Roma (23, 2 3 bis, 1 7 , 36).
GIUSEPPE SIGLINO
deputato al Parlamento ( 1 0- 1 2 , 5 2 ) .
57, 7 1 ) .
DOMENICO CARUTTI,
FRANCESCO RAMELLI,
( 1 - 5 , 7 , 1 0- 1 2 , 23, 2 3 bis, 26, 3 1 , 44).
Verbali della seduta di Napoli del 1 8 febbraio 1 873 (fase . 7)
r . provveditore agli studi per la provincia di Napoli
(4 , 8,
10, 1 2 , 2 3 , 2 2 bis , 2 .3 bis , 5 2 ) .
GIROLAMO NISIO ,
IPPOLITO AMICARELLI,
preside del r. liceo Vittorio Emanuele (20, 1 8, 1 9 , 2 2 ,
2 3 bis, 2 4 , 30).
ETTORE NOVE L L I ,
1
Unita al verbale lettera d i Michele Amari al presidente della Commissione (Roma, 15 feb.
1 873).
72
Inventario
Fonti per la storia della scuola
EDOARDO Fusco, professore di antropologia e pedagogi;J nella r. università
degli studi di Napoli * ( 1 , 2 , 52, 56, 57).
·
PIETRO Rossi, direttore della r. scuola normale maschile di Napoli * (5 2 , 2 ,
54-59. 6 1 ) .
ANTONIO MIRABELLI, professore di letteratura latina nella r. u niversità degli
studi di Napoli * (2 3 bis, 30, 1 2 , 1 3 , 1 8) .
73
DI MAlO, direttore del proprio istituto di educazione e istruzione ( l , 36).
MARTI ELLI, direttore di istituto privato .
MARCIANO, direttore del proprio istituto di educazione e d' istruzione, asses
sore municipale * ( 1 2 , 1 3 , 23 bis, 6, 28, 1 7 , 2 3 , 38).
CELESTINI, d irettore dell' istituto degli scolop i .
LEOPOLDO RODINÒ, professore e consigliere municipale d i Napoli * ( 2 3 bis,
43, 44, 36, 38, 30).
Verbali della seduta di Napoli d e l 1 9 febbraio 1 87 3 (fase. 8 )
LUIGI pALMIERI, professore di fisica terrestre nella r. università degli studi d i
Napoli.
FILIPPO CAPONE, consigliere alla Corte d'appello, deputato al Parlamento (4 ,
6, 7 , 23 e seguenti).
FELICE BERNABEI, professore di letteratura latina e greca nel r . liceo Vittorio
Emanuele di Napoli (30, 29, 1 8).
ACHILLE COSTA, professore d i zoologia nella r . università degli studi di Napo
li * (3 2 , 30, 39).
ANTONIO LABRIOLA, professore di filosofia nel r. liceo Principe Umberto
* (39, 1 8 , 3 1 , 38, 1 2 , 1 7 , 30, 28).
GIAN VI C ENZO BELSANI, professore nel r. g innasio Principe Umberto * ( 4, 3 1 ,
3 2 , 36, 2 3 bis).
Verbali della seduta di Napoli del 22 febbraio 1 873 (fase. 1 1 )
FILIPPO CAPONE , consigliere alla Corte d' appello, deputato al Parlamento (2,
4-7, 1 2- 1 4 , 1 6, 1 7) .
FILIPPO PATELLA, preside del r . liceo Principe Umberto d i Napoli (3 1 , 4 0 , 4 1 ,
2 3 bis).
CAMILLO RICCIO, bibliotecario nella Biblioteca S. Giacomo di Napoli (* 1 4 ,
* 1 8 , 2 3 , 20, 2 7 , 2 6 , 3 1 ) .
Verbali della seduta di Napoli del 20 febbraio 1 87 3 (fase. 9)
PASQUALE TURIELLO, professore nel r . liceo Vittorio Emanuele di Napoli (6 ,
1 3 , 1 7 , 52).
GIUSEPPE DE LUCA, professore di geografia antica e moderna e statistica nella
r. università degli studi di Napoli ( 1 , 2, 5, 1 1 , 1 8 , 40, 4 3) .
DOMENICO FAILLA, direttore della r. scuola normale femminile di Napoli ( 5 2 , 54).
MAURO VALENTE, professore di lingua e lettere italiana nella r. scuola norma
le maschile di Napoli (9, 1 0).
Verbali della seduta di Napoli del 2 4 febbraio 1 873 (fase. 1 2)
LUIGI RAGUSEO, professore
1•
DEL VECCHIO, professore privato di filosofia e storia, direttore di istituto pri
vato * (30).
PAOLO EMILIO IMBRIANI, senatore del regno, rettore della r. università degli
studi di Napoli (30, 1 1 , 3 1 , 20, 5 2 , 3 3 , 73).
GIOVAN 1 PAGANO, professore di materia medica e tossicologia nella r. uni
versltà degli studi di Napoli ( * 1 , 39, 1 3 , 5 2 , 1 2 , 1 6, 1 7) 2 .
Verbali della seduta di Napoli del 2 1 febbraio 1 873 (fase. 1 0)
ANTONIO GALASSI, bibliotecario della Biblioteca nazionale di Napoli ( 1 -9 , 38,
39, 2 3 bis).
BARTOLOMEO D E RINALDIS, delegato scolastico mandamentale di Napoli * (4 ,
1 0, 1 1 , 1 4 , 2 3 , 7 3 ) l
CAMILLO RICCIO , bibliotecario della Biblioteca S. Giacomo ( * 4 3 ) .
1 A l verbale è unita Jenera di B. De Rinaldis al presidente della Commissione d'inchiesta,
serina dopo la deposizione orale, nella quale prega di far aggiungere al resoconto alcune sue
osservazioni sugli studi tecnici (quesito 4 3).
1 A l verbale della deposizione è unita lettera di L . Raguseo alla Commissione del 20 feb.
1 87 3 nella quale richiama quanto scritto nella • Memoria sugli esami liceali " dell' ottobre 1 869.
2 Alla deposizione è unito appunto • proposte d'urgenza " ·
74
Inventario
Fonti per la storia della scuola
75
Verbali della seduta di Salerno del 27 febbraio 1 87 3 (fase . 1 5 )
GIOVANNI SCRIVANTE, r. provveditore agli studi per la provincia di Salerno
(4 3 , 5 2 , 3 2 , 23 bis, 1 2 , 57).
busta 5
Verbali della seduta di Napoli del 2 5 febbraio 1 87 3 (fase . 1 3)
TOMMASO SORRENTINO,
deputato al Parlamento * ( 1 3 , 3 3 , 2 3 bis, 39).
senatore del regno, rettore della r. università degli
studi di Napoli * (39, 1 7 , 1 2 , 5 2 ) .
PAOLO EMILIO IMBRIANI,
LVIGIA OLIVA ,
OLIVA ,
ispettrice delle scuole femminili * (5 2 , 59, 5 7 , 60 , 7 3 , 54).
padre di famiglia * (38, 2 3 bis, 1 7 , 39, 1 2) .
LANDOLFI ,
padre di famiglia * ( 1 2 , 1 7) .
libero insegnante di economia sociale nella r . u niversità degli
studi di Napoli * ( 1 2 , 1 7 , 26, 37) 1 •
D I ODATO LIOY,
PASQUALE CICCARELLI ,
consigliere per le scuole della provincia di Napoli
* ( 1 3 , 1 0 , 3 3 , 20, 1 3).
Verbali della seduta di Napoli del 26 febbraio 1 87 3 (fase . 1 4 )
JUDICONE ,
professore * (2 , 1 2) .
LUIGI CONFORTI
FRANCESCO ALARlO,
avvocato ( 1 2 , 3 3 , 2 3 bis, 1 3 , 20).
LUIGI BONOPANE ,
preside del r . liceo ginnasiale T . Tasso di Salerno (20,
1 7 , 67, 6, 2 3 , 38, 26, 28, 2 3 bis).
PIER LUIGI APOLLONI,
ALFONSO
VIscovo, direttore del proprio istituto di educazione e di istruzione
a Salerno (6, 3 3) .
FRANCESCO NAPOLI,
PIER EMILIO
direttore della scuola tecnica provinciale di Salerno (4 3).
GoGGIA, professore nel r . l iceo ginnasiale T . Tasso di Salerno ( l ,
1 7 , 1 8 , 3 , 37, 43).
CLEMENTE CLARIZIA ,
professore (20).
FRANCESCO LINGUITI, professore di letteratura italiana nel r . liceo ginnasiale
T. Tasso di Salerno ( l , 1 1 , 1 3 , 1 8 , 20, 2 1 , 2 3 bis , 3 2 , 28, 29, 3 1 , 3 5 -38).
professore di filosofia nel r. liceo ginnasiale T . Tasso di
Salerno ( I l , 28, 35, 39, 29, 2 5) .
ALFONSO D E CARLO,
* ( 1 2 , 26, 1 8, 20).
D'A vossA, professore, segretario dell'Associazione nazionale di
mutuo soccorso degli scienziati , letterati e artisti ( * 1 0 , * 36 , * 4 2 , * 1 8 , 2 2 ,
1 7 , 2 3 , 3 9 , 5).
Verbali delle sedute di Salerno del 28 febbraio 1 87 3 (fase. 1 6)
GIUSEPPE
maestro elementare ( 1 , 5 , 6, *9, 1 0- 1 4 , 1 7 , 1 8, 20- 2 2 , 2 2 bis, 23
bis, 35, 36, 73).
CASSELLA,
GIUSEPPE MA.STRIANI,
professore * (2 3 bis, 5 , 1 0 , 1 8 , 38, 22, 52, 37, 60, 1 7 ,
7 3) .
professore nella scuola superiore di medici na veterinaria
di Napoli * ( 1 , 66, 1 0, 1 9, 2 3 , 22 bis, 3 1 , 37, 73).
VINCENZO TENOR E ,
consigliere comunale e professore nella r. u niversità degli
studi di Napoli * ( 1 2 , 1 8 , 23 bis, 2 3 , 39, 1 7) .
FEDERICO PERSICO,
1
consigliere per le scuole della provincia di Salerno ( 1 2 ,
67, 1 7 , 1 0).
Allegata a l verbale relazione sugli argomenti svolti d a Diodato Lioy .
SALVATORE COLONNA,
GAETANO D E FALCO,
professore (55).
direttore del proprio istituto d'educazione e d ' istruzio
ne ( ! , 1 7 , 1 0 , 5 2 ) .
STANISLAO BASSI,
consigliere p e r le scuole della provincia di Salerno ( 3 6 , 4 1 ,
28, l , 2 1 , 6 , 1 0) .
ALFONSO MALANIMA,
professore n e l r . liceo-ginnasiale di Salerno ( l , 3 1 , 36,
37, 1 7) .
GUGLIELMO SANFELICE,
direttore del ginnasio della Badia di Cava d e i Tirreni
( l , 66, 1 7 , 36, 2 3 , 72).
FERDINANDO D E FILIPPIS, direttore del proprio istituto di educazione e di
istruzione di Cava dei Tirreni (2 3 bis, 6 5 ) .
76
Fonti per la storia della scuola
FILI PPO CAPOZZI , direttore del ginnasio G ianbattista Vico di Nocera Inferiore
( 5 3 , 1 1 , 1 0 , 1 2 , 3 1 , 39, 64 ) .
VITO L A FRANCESCA,
direttore del ginnasio di Eboli ( 1 8 , 3 1 , 2 3 bis).
Jnuenta1·io
GIOVA NI MARIA CAROLI ,
di Maddaloni
•
( 1 7 , 39).
FEDERICO QUERCIA,
r. provveditore agli studi per la provincia di Caserta ( 1 7 ,
2 3 bis, 3 1 , 1 0) .
ANGELO INCAGNOLI,
consigliere provinciale ( 1 3 , 1 2) .
preside d e l r. liceo ginnasiale G iordano Bruno di Madda
loni (23 bis, 39, 1 8 , 1 7 , 7 2 ) .
GABRIELE SANTIL L I ,
SALVATORE PIZZI,
consigliere per l e scuole della provincia di C aserta ( 10 , 3 6 ,
39, 2 3 bis).
professore nel liceo ginnasiale municipale di Capua (3, 30, 33, 5,
17, 32, 1 3 , 42).
G u iD O RANALLI,
direttore della scuola normale maschile di Caserta (52).
professore nel r. liceo di Maddaloni ( 1 8 , 19, 2 3 bis, 4 1 ) .
GIOVANNI VERDE ,
direttore del conv itto d i Caserta ( 1 7 , 66, 20).
F I L I P P O BARBATI , professore nel r. liceo ginnasiale Giordano Bruno di Mad
daloni (32, 2 3 bis, 3 1 , 20, 4).
FRA CESCO SAVERIO LABRIOLA, professore nel r. liceo ginnasiale Giordano
Bruno di Maddaloni ( 3 3 , 1 6 , 3 1 , 59, 1 3 , 5, 3 5 ) .
ALFONSO DE CARLO ,
professore nel r . liceo ginnasiale Torquato Tasso di Sa
lerno (40, 4 ) .
BRUTO FABBRICATORE,
professore nel liceo di Caserta (3 3 , 38, 36, 3 1 , 5, 2).
GIAN BATTISTA PANICO,
CARLO GuERDILE,
D I NAPOLI,
professore nel r. liceo ginnasiale Giordano Bruno
GIULIANI,
GI USEPPE C HIA.JA,
Verbali della seduta di Caserta del 3 marzo 1 87 3 (fase . 1 7)
77
rettore del Collegio tulliano di Arpino ( 1 7 , 4 5 ) .
preside del liceo comunale di Sessa Aurunca ( 2 3 bis, 3 3 ) .
professore n e l Collegio t ulliano di Arpino (4 1 ) .
IGNAZIO LUCIGNANO,
professore nel r . liceo ginnasiale Giordano Bruno d i
Maddaloni (36, 27).
LUIGI ORLANDI ,
MASSIMO DAGNA,
CoNTINI NICOLA,
professore nel liceo ginnasiale di Santa Maria Capua Vetere
(23 bis, 4 1 ).
FRANCESCO G JANGUITTO,
ANTONIO PASQUALE,
professore nel liceo ginnasiale di Santa Maria Capua Vetere
Caserta
SOLARI , direttore del ginnasio di Teano e professore nel liceo ginnasiale di
Santa Maria Capua Vetere (64 , 39, 1 7 , 9).
delegato scolastico mandamentale di Aversa (77).
professore nel r. liceo ginnasiale Giordano Bruno di
Maddaloni (38).
(38).
CARLO D E FERRARIS,
professore nel r. liceo ginnasiale Giordano Bruno di Mad
daloni (36).
professore nella scuola normale maschile pareggiata di
1•
Verbali della seduta di Bologna del 26 marzo 1873 (fase. 1 9)
CESARE BARDESONO DI RJGRAS ,
r. prefetto della provincia di Bologna ( 1 0- 1 2 ,
1 8, 1 7 , 43).
professore di diritto costituzionale nella r. università degli
studi di Bologna (2 , 36, 3 3 , 26, 30, 1 2 , 39, 4 3 ) .
CESARE ALBICINI,
Verbali della seduta di Caserta del 4 marzo 1 87 3 (fase . 1 8)
professore di fisica e chimica nel r . liceo ginnasiale Gior
dano Bruno di Maddaloni (4 2 , 4 1 , 30).
PASQUALE FORNARI,
A L FONSO CUTILLO,
consigliere per l e scuole della provincia di Bologna ( 1 0 ,
1 2).
preside del liceo di Caserta (23 bis, 39, 40, 2 3 ) .
direttore della scuola normale femminile pareggiata di
Capua (59, 23, 1 7 , 5 7 , 1 0 , 59).
A LBERTO B E L L ENTA
AUGUSTO AGLEBERT,
1,
1 Manca la deposizione: c'è un appunto: " il sig. Pasquale deve mandare in iscritto i suoi
pensieri sui quesiti alcuni dei quali furono stenoscritti ma non tradotti ». Vedi ACS, MPI, Div.
scuole medie (1 860- 1 896), b. I l , fase. 80.
78
79
Fonti per la storia della scuola
Inventario
G . BATTISTA GAND! o, professore di letteratura latina nella r. università degli
studi di Bologna ( 1 , 5 3 , 3 2 , 27, 36, 30) .
A TONI O QUIRICO, direttore della r. scuola normale femminile di Bologna ( 1 ,
4 , 5 2 , 58, 59, 2 3 bis, 29, 1 7) .
MEDARDO BURZI , dottore (28, 4 3 , 30, 1 2) .
RAFFAELLO NOTAR!, professore nel collegio barnabitico di Bologna * (36, 1 7) .
FRANCESCO BERTOLINI, professore di storia moderna nella r. u niversità degli
studi di Bologna (30, 52).
LUIGI FRATI, professore nella r . università degli studi di Bologna (36, 1 7 , 20) .
TIMOLEONE BELLENGHI, assistente al r. gabinetto di agraria di Bologna (2, 9 ,
1 7 , 28, 1 8, 64).
LUIGI MARTINATI, professore nella r. scuola normale femminile di Bologna
(5 2 , 3 3) .
LUIGI UNGARELLI , direttore del proprio istituto d' educazione e istruzione
* ( 3 3 , 39, 1 3 , 36, 2 3 bis).
FELICE GALLIAN, preside del r. istituto i ndustriale e professionale di Bologna
* (4 3 , 4 1 ) .
MATTEO PEDRINI, consigliere per le scuole della provincia di Bologna * ( 1 0,
1 7) .
ADOLFO GRosso, direttore della scuola normale maschile provinciale pareg
giata di Bologna * (5 2 , 56).
Verbali della seduta d i Bologna del 27 marzo 1 87 3 (fase . 20)
ANGELO MARESCOTTI, professore nella r. università degli studi di Bologna
* ( 1 0 , 3 1 , 1 4 , 1 7 , 2 3 bis, 1 7) .
LUIGI BOMBICC I , professore di mineralogia nella r. università degli studi di
Bologna * (4 1 , 4 2 ) .
FERDINANDO BERTI, assessore del municipio di Bologna * ( 1 0, 39).
ENRICO SASSOLI, consigliere p e r le scuole della provincia di Bologna * (5 2 ,
54, 5 5 , 3 1 , 1 4 , 1 7 , 1 0 , 1 1 ).
GASPERO GHILLI I , padre di famiglia * ( 1 5 , 17, 2 3 bis, 3 2 , 1 6) .
Verbali della seduta di Bologna del 29 marzo 1 873 (fase. 2 2 )
ANGELO DucATI, professore di diritto commerciale nella r . u niversità degli
studi di Bologna * (28, 1 3 , 36, 1 2 , 39, 23 bis, 4 2) .
G . BATTISTA ERCOLANI , professore di patologia veterinaria nella r. università
degli studi di Bologna • (3 1 , 1 2 , 39, 2 3 bis).
CARLO ZANOLINI, direttore della scuola tecnica pareggiata di Bologna * (4 3 ,
4 8 , 4 7 , 4 9 , 2 3 , 2 2 bis, 7 , 44 , 1 7 , 39).
ALFONSO COLOGNESI, professore nel r . liceo Galvani di Bologna * ( 1 2 , 4, 2 2 ,
3 7 , 3 0 , 4 1 ).
FRANCESCO D ' OVIDIO, professore di letteratura greca e latina nel r. liceo Gal
vani di Bologna * (36, 37, 2 3 bis).
Verbali della seduta di Bologna del 28 marzo 1 87 3
ETTORE MASCIOLI , professore * ( 1 2) .
LUIGI ASCHIERI , dottore * (3 3 , 1 7, 2 2) .
LUIGI SAVORINI, professore nella scuola normale maschile provinciale pareg
giata di Bologna * (59, 4 3 , 3 1 , 56, 30, 39, 1 7).
ANNETTA FANTINI, ispettrice della r . scuola normale femminile d i Bologna
(52).
CUBONI , padre d i famiglia * ( 1 2 , 1 7 , 2 3 bis, 6, 23, 18, 20).
1•
' A llegato al verbale ritaglio di giornale: Progetto di una scuola normale di ginnastica per
Emilio Baurnann.
GIOVANNI LUINO, professore di fisica chimica n e l r . liceo Galvani di Bologna
* (4 1 , 4 2 , 1 8 , 23 bis).
GABRIELE ROSSI , professore * (34, 38, 36, 39).
VINCENZO RAVA, professore * ( 1 3 , 1 0 , 44 , 4 3 , 36, 5 2 ) .
EMILIO BAUMANN, maestro di ginnastica negli istituti di Bologna * (2 3 )
PROCOLO BENETTINI , professore della r . scuola normale femminile di Bolo
gna (22 bis, 58, 2, 23, 5 3 , 1 8 , 1 1 ) .
GIUSEPPE B IGNAMI, ispettore delle scuole * (3 5 , 44, 1 7) .
ANTONIO SALVONI, r . provveditore agli studi della provincia di Bologna * ( 1 2 ,
1 6, 1 0, 20, 38).
......
80
Inventario
Fonti per la storia della scuola
81
FRA CESCO SA VERI O DE DOMINICIS, professore di filosofia nel r. liceo Galvani
di Bologna * (39).
A TO IO BOTTONI, professore nell' istituto industriale professionale provin
ciale pareggiato di Ferrara * (4 3 , 1 6, 20, 2 3 ) .
LUDOVICO BERTI, deputato al Parlamento * (39, 3 3 , 23 bis).
GHERARDO PROSPERI, ex deputato a l Parlamento * (2 3 bis).
IGNAZIO TOSATI , professore nel ginnasio comunale pareggiato di Bologna
* ( 3 3 ).
ABRAM PESARO, assessore municipale di Ferrara * (2 3 bis).
ENRICO PANZACCHI, segretario e professore della r. accademia di belle arti di
Bologna * (3 3 , 39).
FELICE MAGNANI , e x direttore del ginnasio comunale e della scuola tecnica
pareggiata di Ferrara * (4 3 , 36, 26, 27).
FRA CESCO ACRI , professore di storia della filosofia nella r. u niversità degli
studi di Bologna * ( 1 , 3 1 , 38, 36, 39, 1 7) .
CARLO FELISI, direttore della scuola tecnica pareggiata di Ferrara * (4 3 , 1 7 ,
4 7 , 48).
.
Verbali della seduta di Ferrara del 3 1 marzo 1 87 3 (fase . 2 3 )
LUCCI , direttore del seminario di Ferrara * (2 3 bis, 1 7) .
GIUSEP PE TABANI , preside del r. liceo Ariosto di Ferrara * (30, 38, 36, 2 , 64,
1 7 , 33).
FELICE GIORDANO, preside dell' istituto industriale professionale provinciale
pareggiato di Ferrara * (3, 20, 4 , 4 3 ) .
SAMUELE BIANCHINI, padre di famiglia ( * 3 3 , 20, 37, 1 7).
scuole e dell' istitu
TOBIA ZAMOR ANI , membro della G iunta di vigilan za delle
a * (4 3 , 3 1 , 1 6,
Ferrar
di
iato
paregg
ciale
provin
to indust riale profes sionale
64).
di Ferrar a * (2 , 3, 5 , 9 ,
CARLO GRILLE NZONI , professore nella univer sità libera
.
3)
2
,
9
I O , 1 2 , 1 7 , 1 8 , 20, 2 3 bis, 3 1 , 38, 4 0 , 4 1 , 3
G IOVANN I MANFR EDINI, sindac o di Ferrar a * ( 1 7 , 39, 20).
Ferrar a * (26, 3 3 , 30,
EFISIO CUGUS I-PERSI , rettore della univer sità libera di
43, 42).
di Ferrar a * ( 1 0 , 32, 23
G IUSEPP E COTTA -R.AMU SINO, r. prefet to della provin cia
bis, 1 4 , 1 7 , 39, 43, 7, 64 ) .
di Ferrar a * ( 1 7) .
LUIGI BARBA RO, r . provv editor e agli studi della provin cia
Verbali della seduta di Forlì del 3 aprile 1 87 3 (fase . 25)
FILIPPO GAFFODIO, r . provveditore agli studi per la provincia di Forlì.
AURELIO SAFFI, assessore al municipio di Forli * (3 3 , 39, 2 3 bis , 5 2 , 43, 1 0) .
ALESSANDRO FORTIS, assessore al municipio di Forlì * ( 1 0 , 1 7 , 2).
ROMUALDO CANNONERO, direttore della scuola tecnica di Forlì * (4 3 , 6, 2 4 ,
47).
DOMENICO BONGIOVANNI , preside del liceo comunale Morgagni e direttore
del ginnasio comunale di Forlì * (30, 26).
COSTANZO MALACARNE, direttore della r. scuola normale maschile di Forlì
* (5 2 , 1 7 , 5 4 , 58, 59).
VITALIA
o VITALI, professore nelle scuole secondarie * (4 1 , 23 bis, 1 0) .
DOMENICO BONGIOVA Nl 1 , preside del liceo comunale Morgagni e direttore
del ginnasio comunale di Forlì.
FILIPPO MARINELLI, direttore delle scuole elementari di Forlì * (2 5 , 53, 1 7) .
LICURGO CAPPELLETTI, professore nella r. scuola normale d i Forlì *_(52 , 5 3 ,
58).
busta 6
Verbali della seduta di Ferrara del
l o aprile 1 873 (fase . 24)
COSTANZO MALACARNE, direttore della r. scuola normale maschile di Forlì.
ENEA CAVALIERI, dottore in legge * (3 1 ).
CARLO BALBO I , segretario municipale di Ferrara * ( 1 6, 38, 1 7 , 23 bis).
1 Chiede nuovamente d i intervenire per u n a precisazione s u quanto già esposto .
82
Fonti per la storia della scuola
DO PRATESI ,
FERDINA
professore nella r. scuola normale maschile di Forlì
* (36, 24).
professore nelle scuole liceali e ginnasiali di Rimini
* (30).
ANDREA RUSCONI,
VINCENZO TESTI,
professore nel ginnasio comunale di Forlì * (2 4 , 1 8) .
ORLAN D I ,
PIETRO NOTO- BADGE,
•
GIOVACHINO RAsPO I ,
professore n e l r . istituto industriale e professionale d i
( 1 7 , 2 3 bis) .
Verbali della seduta di Cesena del 4 aprile 1 87 3 (fase . 26)
FORTUNATO TROMBONE,
preside del r . liceo Monti di Cesena * (30, 36, 3 3 , 2 5 ,
7 0 , 38).
PIO TEODORANI,
consigliere d 'Appello * (3 3 , 36, 38, 1 7) .
DAVIDE ANGELI,
delegato scolastico mandamentale di Cesena * (36, 2 3 bis).
SOCRATE
PAGGI, delegato scolastico mandamentale di Cesena * (4 3 , 20, 1 0).
ANTONIO ALFREDO COMANDINI,
LUIGI CARDINA L I ,
studente liceale * ( 1 7) .
professore * (3 1 , 1 7 , 3 2 , 40).
PIETRO PACCHIONI,
professore nel r. liceo Monti di Cesena * (4 0 , 32, 30, 1 8).
ALFONSO CERQUETTI ,
professore nel liceo comunale Morgagni di Forlì * ( 1 0 ,
38).
PIETRO MORELLI ,
professore nel r. liceo Monti di Cesena * (39) .
GIOVAN BATTISTA DAL LAGO ,
deputato al Parlamento, sindaco di Ravenna * (3 3 , 44,
sindaco di Bagnacavallo * (4 3 , 44).
direttore delle scuole secondarie di Lugo.
FRANCESCO HOMODEI,
direttrice della scuola normale femminile pareggiata di Ra
venna * (57, 59).
GIUSEPPINA CARAPIA ,
direttrice dell' orfanotrofio femminile di Ravenna.
CELESTINO DRUETTI ,
direttore della scuola normale femminile pareggiata di
Ravenna * (52).
GIULIANO BERTI,
COSIMO
parroco e direttore di convitto a Ravenna • (23 bis).
FAB BR I , consigliere comunale di Ravenna * (2 3 bis, 1 0).
AUGUSTO RUGGERI, direttore della scuola tecnica di Ravenna * (4 3 , 39, 33, 2 3
bis, 28).
FRANCESCO CAREGA D I
MURICCE, professore nel r. istituto tecnico di Ravenna
* (3 3 , 4 3 , 42).
GIUSEPPE BRAVI,
professore nel liceo comunale Morgagni di Faenza * (39).
AuGUSTO FARINI , professore nel r. istituto tecnico e nel liceo pareggiato Dan
te Alighieri di Ravenna • (4 1 , 46).
GIOVAN BATTISTA SAMMARITANI ,
PIETRO
DE
direttore del convitto comunale di Ravenna.
MICHELIS, preside del r. istituto tecnico di Ravenna * (43).
professore nel ginnasio comunale di Cesena
Verbali della seduta di Torino del 1 0 maggio 1 87 3 (fase. 2 8)
VINCENZO GARELLJ ,
Verbali della seduta di Ravenna del 7 aprile 1 87 3 (fase. 2 7)
FILIPPO GAFFODIO,
r. provveditore agli studi delle provincie d i Forlì e Raven
na * (7 3 , 56).
GIUSEPPE BOTERO,
PAOLO PAVESIO,
prefetto di Ravenna * ( 1 0) .
CLELIA MARINI,
* (3 1 , 34).
32).
83
64 , 17, 7 3).
GOFFREDO FRANCESC H I ,
Forlì
Inventario
preside del liceo Torricelli d i Faenza * (30, 1 6 , 64 , 65).
professore nel liceo Torricelli d i Faenza * (36, 33, 30, 2 8 ,
r. provveditore agli studi della provincia di Torino ( 1 2 ,
1 7 , 1 0 , 1 8 , 1 1 ).
GI USTO EMANUELE GARELLI, professore di diritto istituzionale nella r. -universi
tà degli studi di Torino ( 1 , 3 1 , 3 3 , 36, 2 3 bis, 1 2 , 39, 1 0) .
CAMILLO FERRATI , professore di geodesia teoretica nella r. università degli
studi di Torino ( 1 0 , 1 2 , 23 bis, 4 1 , 4 2 , 38, 20, 2).
PIETRO BARICCO,
1 9, 23).
preside del r. liceo Cavour di Torino (33, 26, 8, 20, 39, 6,
84
FRANCESCO CAVALLERl ,
preside del r. liceo G ioberti di Torino ( 1 2 , 3 3 , 4 1 , 36,
30, 29, 26, 6 , 3 1 ) .
EMILIO LIVERIERO,
85
Inventario
Fonti per la storia della scuola
dottore aggregato alla r. università degli studi di Torino
1 0 , 1 8 , 3 3 , 3 4 , 36).
DOMENICO PEZZI ,
(l,
direttore d e l r. ginnasio Gioberti di Torino (3 1 , 3 3 , 3 6 ,
3 5 , 23 b i s , 6 , 38).
G I USEPPE PARATO,
rettore del convitto nazionale di Torino (66 , 6 , 23, 64 , 68 ,
Verbali della seduta di Torino del 1 4 maggio 1 873 (fase . 3 1 )
7 1 , 72).
PAOLO COLOMBETTI,
RAFFAELE
Verbali della seduta di Torino del 12 maggio 1873 (fase. 29)
direttore del proprio istituto privato di Torino (64 , 2 2 , 1 - 1 0 , 36,
1 2 , 66, 38, 4 1 , 39).
FORNARIS,
CARLO RODELLA,
direttore del proprio istituto di istruzione ed educazione in
Torino ( 1 2).
ANTONINO PARATO,
direttore della r . scuola tecnica di Monviso a Torino (4 3-
45).
direttore della r . scuola tecnica di Dora a Tori
no (4 3 , 46, 1 7 , 48, 44, 6, 1 1 , 1 8) .
CARLO EMANUELE RICCHETT I ,
GIUSEPPE CAMILLO VIGNA
1,
direttore della r. scuola tecnica di P o a Torino.
calligrafo e Stenografo .
V ALABREGA , maestro di calligrafia.
padre di famiglia e professore di disegno nella Accademia alberti
na di belle arti (48).
ORGAGN I ,
GIOVANNI LANZA, direttore dell' istituto paterno di educazione e istruzione a
Torino ( 1 2 , 64 , 1 7, 39).
AVALLE, professore di storia e geografia nel r. liceo G ioberti di Torino
( 1 , 6, 40).
CARLO
CARLO BARUFFI ,
professore nella r. università degli studi di Torino (33, 22
bis, 4 1 ).
professore nel r. ginnasio Monviso di Torino (37, 2 5 , 1 2 ,
33, 3 5 , 4 4 , 3 2 , 20, 2 3).
PIETRO SIGNETT I ,
GIUSEPPE ROTA,
ispettore scolastico di Torino (5 2 , 54, 62, 57, 59).
Verbali della seduta di Torino del 13 maggio 1873 (fase . 30)
professore di diritto e procedura penale nella r. univer
sità degli studi di Torino (36, 4 1 ) .
TANCREDI CANON ICO,
LUIGI BRIATTA,
direttore della scuola normale maschile d i Pinerolo ( 5 2 , 5 4 ,
56).
SCIPIONE BOTTA ,
professore nella r. scuola tecnica di Dora di Torino (20, 4 3 ,
3 7 , 2 3 bis).
professore nel r . ginnasio di
no (4 , 1 1 , 1 8 , 40, 47) .
EuGENIO COMBA ,
S.
Francesco da Paola di Tori
MICHELE LESSONA, professore di zoologia e anatomia comparata nella r. u ni
versità degli studi di Torino (4 2 , l , 33, 37, 2 3 bis).
professore di storia della filosofia nella r. universi
tà degli studi di Torino (9, 2, 1 8 , 20, 23 bis).
G I OVANNI MARIA BERTIN I ,
1
I l nome
è segnalato sulla cartella del verbale, ma la deposizione manca .
Verbali della seduta di Torino del 1 5 maggio 1 87 3 (fase. 3 2 )
VINCENZO PAPA , professore n e l r . ginnasio d i
(5 2 , 2 3 , 59, 6 1 , 58).
S.
Francesco d a Paola di Torino
CAPIRONE, direttore della r . scuola tecnica di Moncenisio di Tori
no (4 3 , 4, 1 1 , 1 0) .
AGOSTINO
professore di storia e geografia n e l r . liceo Cavour e
nella r. università degli studi di Torino ( 1 , 2 3 bis, 1 0 , 1 7 , 20, 40, 2 2 ) .
CELESTINO PEROGL I O ,
professore di lingua e letterature comparate nella r . u ni
versità degli studi di Torino (36).
GIOVANNI FLEC H IA ,
BENEDETTO N E G R I , direttore spirituale della r . scuola tecnica di Monviso di
Torino ( 1 7 , 43, 38) .
CARLO
FERRARIS,
insegnante privato nell ' is t it uto Rossi di Torino ( 1 2 , 5 2 , 5 3 ) .
86
Fonti per la storia della scuola
Inventario
87
DIRETTORE DEL CONVITTO VALSALICE
CASIMIRO DA NA, dottore aggregato della r. università degli studi di Torino 1 •
Verbali della seduta di Torino del 1 6 maggio 1 87 3 (fase . 3 3 )
NICOLA MARSELLI , maggiore di stato maggiore, professore alla scuola superio
re di guerra di Torino (6 , 1 2 , 36, 28, 1 8 , 23 bis , 1 7 , 40).
CASIMIRO DANNA, professore aggregato della r. università degli studi di Tori
no ( 1 0 , 3 3 , 6, 1 8 , l , 57, 36).
busta 6 bis
RUOTA, professore di Torino (4 , 4 1 ) .
ARJODANTE FABRETTI, professore di archeologia nella r. u niversità degli studi
di Torino (26, 3 1 , 36, 40, 1 8 , 44).
GIOVANNI BATTISTA PANIZZARDI, preside onorario dell ' istituto industriale e
professionale di Torino (59).
PIER LUIGI DONNINI, professore nella r . scuola tecnica di Moncenisio di Tori
Verbali della seduta di Firenze, 28 ottobre 1 87 3 (fase . 3 5 )
MASSIMO CORDERO DI MONTEZEMOLO, r . prefetto di Firenze, senatore del re
gno * ( 1 0 , 5, 7 3 , 64).
GAETANO CAMMAROTA, r . provveditore agli studi della provincia di Firenze
* (5 2 , 1 2 , 3 , 7 3 , 1 0) .
no (44 , 40, 47).
ENRICO POGGI, senatore * (3 1 , 2 6 , 2 2 , 2 7 , 2 5 , 1 2 , 1 7) .
ERNESTO RJCARDI Dr NETRO, consigliere per le scuole della provincia di Tori
TOMMASO DEL BECCARO, preside del r . ginnasio-liceo Dante * ( 1 0 , 6 , 2 3 bis,
no (2 3 , 59).
26, 33, 32, 1 8 , 39, 40, 38, 36).
LUIGI D 'ANCONA, professore nel r . istituto industriale e professionale di To
rino (30, 1 0).
CELESTINO BIANCHI, membro del consiglio direttivo del r. istituto di studi su
periori di Firenze, deputato al Parlamento * ( 1 2 , 6 , 1 9 , 30, 2 5 , 4 3) .
ALFEO Pozzr, professore nel r. istituto industriale e professionale di Torino
FLORIDO ZAMPONI, direttore della scuola tecnica comunale L. B . Alberti * (4 3 ,
(44 , 47).
2 3 bis, 4 8 , 46, 44).
GIUSEPPE Mi.iLLER, professore di letteratura greca nella r . università degli stu
di di Torino (36).
Verbali della seduta di Firenze del 29 ottobre 1 87 3 (fase . 36)
Verbali della seduta di Torino del 17 maggio 1 87 3 (fase . 34)
A TONIO FASSINI, professore di letteratura italiana nel r. liceo G ioberti di To
rino (30, 38) .
GIOACHINO PONZIO, professore nel r. ginnasio Monviso d i Torino (7, 6, 1 2 ,
1 8 , 36, 3 8 , 3 1 , 4 3).
GIOVANNI PRADIS, professore nel r. ginnasio Gioberti di Torino (33, 2, 64 , 5).
VINCENZO
PAPA,
professore nel r. ginnasio di S . Francesco da Paola di Torino
(36, 44, 1 8) .
UBALDINO PERUZZI, sindaco di Firenze, deputato al Parlamento * (3 , 43, 4, 5,
1 1 , 1 3 , 22, 1 3 , 1 4 , 1 7-20, 2 3 , 3 1 , 3 3 , 3 4 , 4 8 , 5 2 , 5 4 , 57).
GIOVANNI
PASINI, padre di famiglia * (36, 4 1 , 23 bis).
CELESTINO ZINI, direttore del l ' istituto fiorentino degli scolopi * ( 1 7 , 20, 3 1 ,
3 3 , 2 5 , 2 4 , 28, 26, 2 9) .
MARCO TREVES, padre di famiglia * (4 3 ) .
ANGELO FRASGANI, padre d i famiglia * (6 5 , 1 9 , 7 2 ) .
SAVINA FABBRJCIUS,
maestra di storia nella r . scuola normale femminile * (5 2) .
LUIGI RoccA, segretario dell'Accademia albertina di belle arti di Torino (36,
20, 64 , 17).
MARIOTTI, maestro di canto (59).
' Allegata lettera di ringraziamento a l presidente della Commissione, Torino, 1 7 rnag.
1 873.
88
Fonti per la storia della scuola
Inventario
89
ALBI A PERLETTI-SOPRANI, madre di famiglia * (4 2 ) .
fia e filologia nel r. istituto di studi superiori in Firenze * ( 1 , 3 , 5, 3 2 , 9 , 1 3 ,
AGENORE GEL LI, professore di storia e geografia nel r. liceo Dante • ( 1 2 , 1 8 ,
40, 3 3 , 2 3 bis, 5 2 ) .
1 8 , 20, 3 5 , 38, 4 3 , 64).
AURELIO GoTTI, direttore delle rr. gallerie di Firenze * ( 2 5 , 26, 3 3 , 36, 64).
ANGELO FRASCANI, padre di famiglia * (2 5 ) .
FRANCESCO GAETA, padre di famiglia * ( 1 7 , 7 , 14, 20, 23, 20, 23 bis, 36).
PIETRO STEFA ELLI, professore nella scuola tecnica comunale Dante di Firen
ze * (4 5 , 48, 44, 4 7 , 52).
TERESA DE GUBERNATIS MA NUCCI * (4 3 , 44).
DANTE COEN, padre di famiglia * ( 1 3 , 17, 18, 20, 28).
Verbali della seduta di Firenze del 30 ottobre 1 87 3 (fase. 37)
GrLSEPPE MEINI, professore onorario della r. università degli studi di Siena
* (3 1 , 2 5 , 30, 38).
ANSELMO VITTA, padre di famiglia * (2 3 bis, 36).
DESIDERIO CHILOVI, primo vice-bibliotecario della Biblioteca nazionale di Fi
renze * ( 1 8, 1 9).
Cl TOLESI FILIPPO, professore * (4 2 , l , 46, 1 4 , 2 2) .
CACCIAR! , direttore del proprio istituto d'istruzione ed educazione in Firenze
• (30,
3 1 68, 20, 66).
'
FRANCESCO WIECHMANN, direttore del proprio istituto d'istruzione ed educa
zione in Firenze.
LUISA CASARI PIANA * ( 3 5 , 52).
ANTONIO MARTINATI, padre di famiglia e professore (36, 40, 2 , 1 7 , 20, 2 3 bis,
26, 38, 40, 44 , 2 3 , 64 , 73).
LUIGI RIDOLFI * (6, 33, 2 3 bis, 1 8 , 4 1 ) .
Verbali della seduta di Firenze del l novembre 1 87 3 (fase. 39)
GAETANO CAMMAROTA, r. provveditore agli studi per la provincia di Firenze
(seduta segreta).
LEONE TEDESCO, direttore di istituto privato (seduta segreta).
PIETRO CATELLA, direttore del proprio istituto di educazione e istruzione di
Firenze * (2 3 bis, 1 7, 1 2) .
GIACOMO FILIPPO AIROLI, direttore della r. scuola normale femminile di Fi
renze * (4 , 5, 7, 8 , 1 0 , 20, 5 2 , 56, 2).
GIUSEPPE RIGUTINI, professore nel r. liceo D ante di Firenze • (3 1 , 3 3 , 38, 36,
30).
Verbali della seduta di Firenze del 3 1 ottobre 1 87 3 (fase. 3 8 )
FRANCESCO BERLAN, preside del r. liceo Forteguerri di Pistoia * (4 , 1 2 , 1 8 , 3 1 ,
2 3 bis).
MASSIMILIANO GIARRÈ, professore nella scuola tecnica comunale Dante di Fi
renze * ( 1 2 , 23 bis, 4 3 , 4 7 , 48, 44).
GIUSEPPE MERZARIO, deputato, rettore del collegio Cicognini di Prato * (4 ,
3 2 , 36, 20, 2 3 bis, 66, 68).
ANTONIO Rorn, professore di fisica nell'istituto provinciale industriale e
professionale di Firenze ( 5 , 3 3 , 4 1 , 38, 2 5 , 2 6 , 20, 64 , 1 7) .
SILVIO P ACINI , professore di lettere nell' istituto provinciale industriale e pro
fessionale di Firenze * (5 , 6 , 1 7 , 3 3 , 1 2 , 47).
ACHILLE GENNARELLI, professore nel r. istituto di studi superiori di Firenze
* ( 1 , 3, 23 bis, 1 2 , 1 7 , 3 3 , 1 8 , 36, 38).
LUIGI SAMMJNIATELLI , padre di famiglia, deputato al Parlamento * (4 , 1 7 , 3 3 ) .
AUGUSTO CONTI , professore nel r. istituto di studi superiori di Firenze * (2 , 5 ,
7-9, 1 1 , 1 4 , 2 3 , 2 2 bis, 26, 28, 3 5 , 3 4 , 3 8 , 3 9 , 1 7) .
AUGUSTO FRANCHETTI , avvocato * ( 1 0 , 5 , 3 1 , 3 8 , 4 3 ) .
CAROLINA NENCIONI 1
ARTURO ZANNETTI, professore nella scuola tecnica comunale Dante e aiuto
nel Museo di antropologia di Firenze, * (4 , 1 8, 2 5 , 4 1 , 38, 64).
S!L VESTRO BINI 1
PASQUALE VILLAR! , deputato al Parlamento, presidente della Sezione di filoso-
' Il nome
è segnalato sulla copertina del verbale, ma la deposizione manca.
90
Fonti per la storia della scuola
91
Inventario
GIOVAN I RIZZI, direttore della scuola superiore femminile di Milano * (62,
63).
Verbali della seduta di Milano del 4 novembre 1 87 3 (fase. 4 0)
GIULIO BELLINZAGHI, senatore del regno, sindaco di Milano • (62, 22).
CARLO GIODA, r. provveditore agli studi della provincia di Milano * (3 3 , 4 1 ,
39, 1 0 , 3) l .
CARLO BELGIOIOSO, presidente della r . accademia di belle arti di Milano * (3).
BARTOLOMEO MALFATTI, professore di geografia e etnografia nella r. accade
mia scientifico-letteraria di Milano * (4 0 , 1 8, 4 2).
GIOVANNI FIGAROLLI, padre di famiglia * (44 , 3 3 , 26).
Verbali della seduta di Milano del 6 novembre 1 873 (fase. 4 2)
PIETRO ROTONDI, preside del r. liceo Cesare Beccaria di Milano * (30, 33, 4 0,
38, 52, 3 1 , 6).
BARBETTA, direttrice del Collegio materno di Bergamo * (7 3 , 76, 77).
GIUSEPPE VOLLO, preside del r. liceo Parini di Milano * (6, 44 , 3 3 , 28, 3 5 , 3 2 ,
38).
AMATO AMATI, preside del r. liceo Sarpi di Bergamo * (20, 1 2 , 1 9, 1 7 , 4 0 ,
22).
GAETANO NEGRI, assessore del municipio di Milano.
FORMENTINI, ingegnere, padre di famiglia * (38, 4 3 , 23 bis).
GIUSEPPE SACCHI, r. bibliotecario della Biblioteca nazionale di Milano • (5 2,
58, 59, 57, 5 4 ).
CAMILLO HAJECK, professore nel r. liceo Beccaria di Milano • (2 ' 4 -6 1 0, 1 1 ,
20-2 2 , 2 4 -30, 3 3 , 3 5 , 4 2 , 58, 4 1 ) .
GIUSEPPE SOMASCA, vice presidente della Società pedagogica di Milano • (3 1 ,
3 3 , 3 6 , 44 ).
G . BATTISTA VILLANI, avvocato di Bergamo * (5 2 , 59).
CESARE FENINI, professore nel r. ginnasio Parini di Milano * (3 1 , 23 bis, 30,
33, 36).
Verbali della seduta di Milano del 5 novembre 1 873 (fase. 4 1 )
'
LAMBERTO LAMBERTI, direttore della r. scuola normale femminile di Milano
* (5 2 , 6 1 ).
SANTE POLLI, direttore della scuola magistrale maschile pareggiata di M ilano
* ( 1 2 , 1 3 , 5 2 , 56-59, 23).
DELL'UoMo, direttore del proprio istituto di educazione e di istruzione a M i
lano * (28, 26, 44 ).
GRAZIADIO ISAIA ASCOLI, preside della r. accademia scientifico-letteraria di
Milano * (36, 38, l , 5 2 , 3, 58, 44 ).
PAOLO BELGIOIOSO, consigliere municipale di Milano * (3 6 , 32, 2, 4 , 5 , 9, 1 0 ,
1 8 , 2 0 , 22, 2 4 , 3 5 , 37, 4 1 , 44 , 4 9, 5 2 , 65, 7 2).
VITTORE RICCI, direttore della r. scuola tecnica in via Cappuccio a Milano
* (4 3, 4 5 , 4 7).
CARLO MARIANI, tenente colonnello in riposo • (3 1 , 44 , 1 7 , 6, 1 2 , 20, 29,
3 4 ).
VINCENZO STRAMBIO, padre di famiglia * (62).
ACHILLE ROUGER, padre di famiglia * (3 1 , 1 7 , 26).
1
Allegato: « Stato numerico degli studenti iscritti nell'anno scolastico 1 87 2 - ' 7 3 " ·
Verbali della seduta di Milano del 7 novembre 1 87 3 (fase. 4 3 )
ALBERTO DE GIOVANNIS, r. provveditore agli studi per l a provincia d i Pavia
* ( 1 0 , 57, 2 3 bis).
ALESSANDRO FARUFFINI, direttore della r. scuola tecnica a Porta Romana di
Milano * ( 1 , 5, 3 1 , 4 5 , 4 3 , 1 7, 1 8 , 2 3 , 20, 2 2 , 2 1 , 23 bis, 44 , 46- 4 8).
LUIGI BALBI, direttore del proprio istituto liceale e ginnasiale in Milano * (2 2 ,
26).
GIULIO CARCANO, consigliere per le scuole della provincia di Milano * ( 1 0,
66 , 68, 67).
Pro RAJNA, professore di letteratura greca e latina nel r. liceo Parini di M ila
no * (2 1 , 2 4 , 2 6, 3 1 , 3 2 , 3 6, 1 7 , 39, 4 , 2).
92
lnventan·o
Fonti per la sto1·ia della scuola
CESARE CANTU', direttore degli archivi di Lombardia * ( 1 2-, 1 7 , 3 3 , 44).
LUIGI BORDINI, notaio * (40, 36, 1 7 , 23 bis, 4, 5).
GIUSEPPE ]UNG, professore di matematica nel r. liceo Parini di Milano * (23
bis, 24, 26-28, 4 1 ).
93
CAR LO CANTO I, professore nella r. accademia scientifico letteraria di Milano
* ( 1 , 39, 1 7 , 1 3 , 5 2 , 4, 6, 9, 1 8 , 20, 2 5 , 22 bis).
EZIO CASTOLDI, professore nella r. scuola tecnica di via Bassano Perrone a
Milano * ( 1 , 5 , 4 , 1 2 , 1 4 , 1 8 , 20, 4 3 , 46).
GIOVANNI UBOLDO DE' CAPE! * (3 3 , 26, 1 4 , 1 7 , 44).
ANTONIO PELIZZARI-VIGO, direttore della r. scuola tecnica in via Bassano Per
rone di Milano * (4 3 , 1 7).
IGNAZIO MUZIO VILLA * ( 1 7 , 40, 26, 62, 38).
VI CENZO DE CASTRO, professore * ( 1 0, 9).
BALDASSARRE LABANCA, professore nel r. liceo Parini di Milano * ( 1 8).
GIOVA NI BROCCA, medico primario all 'Ospedale maggiore e console di Spa
gna a Milano, padre di famiglia * (44, 2 5 , 3 3 , 20).
GAETANO GALANTE, professore di agronomia nel r. istituto professionale e in
dustriale di M ilano * (3 1 , 4 1 , 40, 36, 1 8 , 38, 36, 1 7).
Verbali della seduta di Milano del 8 novembre 1 87 3 (fase. 44)
PIETRO RAVASIO, r. ispettore scolastico per i circondari di M ilano e Monza
* (5 2 , 57, 44, 59, 54).
MICHELE TOMATIS, rettore del r. convitto nazionale Longone di Milano . * (67 ,
65 , 66, 20).
GIUSEPPE PIOLA, dottore, membro del consiglio di vigilanza del Collegio rea
le delle fanciulle di Milano • (73 , 20, 1 7).
PASQUALE ERCOLE, professore nella r. università degli studi di Pavia * (36 , 9,
39) .
POMPEO CORBELLA, direttore spirituale del r. convitto nazionale Longone di
Milano * ( 1 7).
POMPEO CASTELFRANCO, professore * (44, 37, 20).
PASQUALE FORNARI, insegnante nel r. istituto dei sordomuti di Milano * ( 1 7).
CARLO GIODA, r. provveditore agli studi della provincia di Milano ' .
ANDREA VERGANI , preside del r. liceo Verri di Lodi * (2, 5 , 10, 1 1 , 1 8 , 2 3 bis,
28, 30).
GIUSEPPE RICCARDI , professore nel r. liceo Verri di Lodi * ( 1 , 2, 6 , 1 2 , 1 7 , 1 8,
26, 4 1 , 40).
VINCENZO NOLLI * (5 2 , 54, 59, 20).
busta 7
Verbali della seduta di Venezia del 5 gennaio 1 874 (fase . 46)
GIOVAN BATTISTA MARTI I, direttore della r. scuola tecnica di Lodi * (4 3 , 4 7 ,
48).
ANTO 1 0 CIMA, r. provveditore agli studi della provincia di Venezia * ( 1 5 ,
1 3 ", 1 4 , 5 2 , 56, 1 0, 1 8, 1 1 , 44, 26).
CARLO TEDESCHI, professore * (5 2 , 3 1 ) .
PIETRO ENRICO SCALETTARIS, preside del r. liceo Marco Foscarini di Venezia
* ( 1 , 5, 2, 3 1 , 3 3 , 38, 36, 1 7 , 39).
FRANCEsc o MAZZI, preside del ginnasio -liceo Marco Polo • ( 1 8, 38, 40, 26,
17, 4 1 , 30, 24, 28).
UBALDINO SERVI ERI * (26, 27, 4 1 , 1 8 , 3 6 , 40).
ANGELO D ELL'ACQUA, ragioniere * ( 1 8 , 5 , 40, 1 1 ).
Verbali della seduta di Milano del 10 novembre 1 873 (fase. 45)
MICHELE MoscA, rettore del convitto nazionale di Venezia * (64 , 62 , 65 , 67,
68).
GEROLAMO PADULLI, padre di famiglia * ( 1 2 , 1 7 , 28, 65).
LUIGI SAILER, direttore del collegio Calchi-Taeggi di Milano * (38).
1 Interviene a chiusura delle sedute milanesi per. salutare la Commissione.
94
Fonti per la storia della scuola
Inventario
95
ANTONIO MATSCHEG, professore di storia e geografia nel r. liceo Marco Fosca
rini di Venezia * (3 5 , 5, 3 1 , 3 2 , 38, 4 1 , 39).
RAvÀ,
direttore di un istituto privato * (35, 44 , 4 5 , 4 7, 4 8, 46 , 1 4 ) .
DANIELE RICCOBONI, professore d i letteratura greca e latina nel r. liceo Marco
Polo di Venezia * (36).
ALVISE MINIO, direttore della r. scuola tecnica di San Felice di Venezia * (44 ,
4 5 , 4 7, 4 8).
Verbali della seduta di Venezia del 6 gennaio 1 87 4 (fase. 4 7)
CARLO MAYR, prefetto della provincia di Venezia * (5, 1 0, 1 1 , 23, 22, 1 4 ).
WALDIMIRO MIRCOVICH, direttore della r. scuola tecnica di S . Stin a Venezia
* (3 1 , 4 0, 4 3, 4 5 , 44 , 4 7).
ACHILLE ANDREASI, professore di filosofia nel r. liceo Marco Polo di Venezia
* (39, 28).
ANTONIO BERTI, consigliere per le scuole della provincia di Venezia * (5 4 , 2 3 ,
2 4 , 1 0 , 1 3, 1 7 , 22, 25, 2 8 , 2 9 , 32, 2 6 , 3 8 , 3 1 , 35, 37, 4 0, 4 1 , 4 5, 44 , 5 6 ,
52).
CRISTOFORO P ASQUALIGO, professore di letteratura italiana nel r . liceo Marco
Polo di Venezia * ( 1 3 , 9, 22, 23 bis, 38).
FERDINANDO GALANTI, professore di letteratura italiana nel r . liceo Marco Fo
scarini di Venezia * (5 , 1 0, 3 4 , 6, 33, 37, 30).
DARIO BERTOLINI, padre di famiglia * (44 , 3 6, 20).
MARCO D IENA, padre di famiglia * (5, 3 4 , 38, 36, 37, 20).
Verbali della seduta di Venezia del 7 gennaio 1 87 4 (fase. 4 8)
MARCO D IENA * (4 0, 6, 1 4 , 1 7 , 1 9, 23 bis).
GIUSEPPE ABELLI, direttore della r. scuola normale femminile di Venezia * (5 2 ,
58-6 1 , 5 4 , 57).
ADOLFO PICK, direttore del giardino infantile * (9, 55).
LAURA VERUDA GORETTI, ispettrice delle scuole femminili di Venezia • (63,
6 1 ).
Verbali della seduta di Venezia dell'8 gennaio 1 87 4 (fase. 4 9)
GIORGIO POLITEO, professore di filosofia nel r. liceo Marco Foscarini di Ve
nezia * ( 1 , 2, 3 1 , 3 3 , 3 6, 38, 39).
CALZA, medico * (3 5 , 3 3 , 38, 37, 2 6 , 20, 1 7) .
ANTONIO MIKELLI , professore nel r. liceo Marco Polo di Venezia * (4 2 , 4 1 ).
GIOVANNI TAMBURLINI, professore nel r. ginnasio Marco Foscarini di Venezia
*(3 4 , 3 1 , 3 3 , 1 7 , 2 3 , 4 0, 3 5 , 32).
GUGLIELMO BERCHET, r. ispettore scolastico per il circondario di Venezia
* ( 1 0 , I l , 5 2 , 57, 5 5 , 58).
NICOLÒ ANTONIO CARRARO, sostituto procuratore del re a Venezia * (4 , 1 7 ,
64, 33, 66 , 58, 2 3 bis, 20).
Verbali della seduta di Venezia del 9 gennaio 1 87 4 (fase . 50)
LUIGIA W IDMA YER, direttrice del convitto normale femminile di Venezia
* (59, 6 1 , 56, 55, 57).
AURELIANO FAIFOFER, professore di matematica nel r. liceo Marco Foscarini
di Venezia * (6, 1 7 , 2 5 , 4 1 , 3 6 , 39).
FEDERICO BIANCHI, professore nel r. ginnasio Marco Polo di Venezia * (4 , 5 ,
1 7 , 2 4 , 3 1 , 26, 38, 4 0).
GIOVANNI CALZAVARA, ingegnere * ( 1 , 1 8 , 1 7 , 2 3 , 64 , 6, 39, 3 3 , 37).
MOISÈ ]ONA, padre di famiglia * ( 1 7 , 59, 73, 2 3 , 1 3) .
SAVORGNAN, marchese d i * (4 , 38, 1 8, 2 0 , 23).
Verbali della seduta di Venezia del 1 0 gennaio 1 87 4 (fase. 5 1 )
CESARE CAVARA, r. provveditore agli studi della provincia di Vicenza * ( 38,
1 0, 1 1 , 1 3, l , 1 7 , 4 ) .
CARLO TOSI, professore nel r. ginnasio Marco Foscarini d i Venezia * (5 , 4 1 ) .
LUIGI DAMIN, avvocato, padre di famiglia * (4 , 5 , 6 , 1 0 , 1 2 , 1 7, 1 8, 20-2 4 ,
3 4 , 38, 1 8, 4 0, 37, 4 1 , 4 5 , 64 , 66, 68, 6 2 , 1 7).
SARDAGNA, barone di * ( 1 7 , 3 3 , 2 3 bis, 44 , 20, 1 8, 23).
96
Fonti per la storia della scuola
Inventario
Verbali della seduta di Venezia dell' 1 1 gennaio 1 87 4 (fase . 52)
Verbali della seduta antimeridiana di Padova del 1 3 gennaio 1 87 4 (fase. 5 4 )
PIETRO GALLO, direttore della scuola di ginnastica di Venezia • (23, 2 4 ) .
LUIGI BAlLO, professore di letteratura greca e latina nel r. liceo Canova di
Treviso * (3 , 6, 1 9 , 9, 2 1 , 3 5 , 26, 32).
CASANOVA , colonnello, padre di famiglia * ( 1 3 , 1 5 , 18, 1 7, 2 1 , 1 4 , 20, 3 1 ) .
NovELLO, direttore della r. scuola tecnica di Treviso * (4 3 , 4 5 , 4 7 , 46 , 4 8,
44 , 36, 4 1 ' 59).
97
PIETRO MOLI ELLI, preside del r. liceo Tito Livio e professore nell' università
degli studi di Padova * (44 , 2, 52, 1 0, 1 1 , 1 3, 1 8, 3 3 , 2 1 , 26, 30, 37).
CIRILLO RONZONI, professore di fisica e chimica nel r. liceo Tito Livio di Pa
dova * (3 3 , 4 1 ).
CESARE SORGATO, professore di letteratura italiana nel r. liceo Tito Livio eli
Padova * (33, 28).
SERAFINO CALDAGNI, censore del convitto nazionale di Venezia * (64 -72).
LUIGI PADRIN, professore nel r. ginnasio Tito Livio di Padova * (5 , 1 1 , 26, 36,
38, 4 0, 37).
GIOVANNI BINDONI, professore nella r. scuola tecnica di Treviso * (4 3 , 4 8, 4 7 ,
53, 4 5 , 1 7).
PIETRO ZANIBONI, professore nella r. scuola normale maschile di Padova
*(55, 58, 59, 4 5 , 60).
GIUSEPPE PUGLIESE, professore nella r. scuola tecnica di S . Felice a Venezia
* (4 , 5, 4 7 , 4 5 , 4 7 , 4 8, 2 5 , 6, 1 7 , 1 8 , 4 9, 1 3 , 1 4 ).
LUIGI GAMBA, preside del r. istituto tecnico e direttore della r. scuola tecnica
di Padova * (4 3, 47, 23 bis, 22, 5, 3).
BARTOLOMEO BRESSAN, preside del r. liceo Pigafetta di Vicenza * ( 1 7 , 6, 20,
2 1 , 26, 30, 4 , 36, 3 3 , 4 0, 4 1 ) .
Verbali della seduta eli Padova del 12 gennaio 1 874 (fase. 53)
CARLO BARONI, professore nella r. scuola tecnica di Padova * (4 7 , 58, 4 5).
ANTONIO TOLOMEI , consigliere scolastico delegato * ( 1 2 , 1 0).
SARDINELLA, studente in medicina * (3 3 , 20, 2 1 , 1 8 , 26, 4 3).
PIETRO LEPORA, r. provveditore agli studi per la provincia di Padova • (3 1 , 5,
26, 30, 28, 1 3 , 5 2 , 58, 5 4 , 1 0, 1 1 , 2 3 , 1 7).
A TONIO FAVARO, professore di statica grafica nella r. università degli studi
di Padova *(36, 4 2, 4 1).
GIUSTO GRIO , preside nel r. liceo Scipione Maffei di Verona * (3 1 , 20, 23
b�. 30, 22, 36, 38, 1 3 , 3 3 , 4 0, 4 1 ).
FRANCESCO PICCOLI, sindaco di Padova * (26, 36, 33, 2 3 , 1 3 , 17, 4 , 6 4 , 1 0).
CLEMENGIG, avvocato, padre di famiglia * (62).
MICHELE COLOMIATTI, direttore della r. scuola normale femminile di Padova
* (5 2 , 58, 5 4 , 57, 59).
GIOVAN I BATTISTA MALESA I, ispettore scolastico per il circondario di Le
gnago * (52).
ALVARO BONINA, r. ispettore scolastico per il circondario di Rovigo * (5 5 , 23
bis).
G IUSEPPE DALLA VEDOVA, professore di geografia nella r. università degli stu
di di Padova * (60, 6 2, 6 3 , 55).
FERDI ANDO GNESOTTO, professore di filologia latina nel r. liceo Tito Livio e
nella r. università degli studi di Padova * (3 , 26, 3 6 , 44 , 36).
Verbali della seduta pomeridiana di Padova del 1 3 gennaio 1 87 4 (fase. 5 5)
GIUSEPPE DE LEVA, EUGENIO FERRAI, FRANCESCO BONATELLI , PIETRO CANAL,
GIAN PAOLO TOLOMEI, professori del Seminario storico filologico di Padova.
busta 7
" Corrispondenza della commissione col ministero e viceversa , (fase. 56)
l . « Considerazioni sul libro dei quesiti » ( 1 873 gen. 25).
2. « Maddaloni » ( 1 87 3 mar. 28).
98
Fonti per la storia della scuola
Inventario
99
<< Ispezioni , (fase . 59)
« Ricorsi alla Commissione >> (fase. 57, vuoto)
" Lettere delle autorità provinciali , (fase . 58)
l . « Ancona »
2 . << Arezzo »
3 . << Ascoli Piceno »
4 . << Avellino »
5 . << Belluno »
6. << Brescia »
7 . << Caltanissetta»
8 . << Caserta »
9. << Catania »
1 0 . << Chieti »
1 1 . << Cremona »
1 2 . << Firenze »
1 3 . << Foggia »
1 4 . << Forlì »
1 5 . << Genova »
1 6 . '' Grosseto »
1 7 . << Lecce »
1 8. << Mantova »
1 9. << M ilano »
20. << Modena »
2 1 . << Napoli »
2 2 . << Novara »
2 3 . << Padova »
2 4 . << Pavia »
2 5 . << P iacenza ,
26. << Potenza »
27. << Reggio Emilia »
28. << Roma »
29. << Sassari ,
30. << Siracusa »
3 1 . << Teramo »
3 2 . << Torino »
3 3 . << Trapani »
( 1 873 feb. 22 - mar. 20).
( 1 873 feb. 1 -2 1 ).
( 1 87 3 feb. 1 2).
( 1 873 feb. 23).
( 1 87 3 feb. 4 - mar. 22).
( 1 87 3 mar. 1 0- 1 9).
( 1 87 3 feb. 1 1 - 1 2).
( 1 87 3 mar. 7- 1 0).
( 1 873 mar. 4 ) .
( 1 87 3 feb . l mar. 8).
( 1 87 3 mar. 4 ).
( 1 87 3 feb . 1 0 - apr. 2).
( 1 87 3 feb. 23 - mar. 20).
( 1 87 3 mar. 26).
( 1 873 mar. 1 2- 1 4 ).
( 1 87 3 feb. 1 2) .
( 1 87 3 mar. 29).
( 1 87 3 feb. 1 2 - mar. 2 1 ).
( 1 87 3 feb. 20 - mar. 20).
( 1 87 3 feb. 10).
( 1 87 3 feb. 1 2 - mar. 1 0) .
( 1 87 3 mar. 25).
( 1 873 feb. 1 2) .
( 1 87 3 feb. 1 8 - mar. 28).
( 1 87 3 mar. 25).
( 1 87 3 feb. 1 4 ) .
( 1 87 3 mar. 28).
( 1 87 3 feb. 8 - mar. 3 1 ).
( 1 87 3 feb. 1 8 - mar. 1 3).
( 1 87 3 feb. 1 7) .
( 1 87 3 feb. 7).
( 1 87 3 feb. 4- 1 4 ).
( 1 87 3 feb. 1 8 - mar. 20).
1 . << Ispezioni agli istituti privati di Napoli, Santa Maria Capua Vetere e Caser
ta; Istituto asiatico in Napoli » ( 1 87 3 feb . 2 4 - mar. 1 9).
2 . « <spezioni. Bologna: ginnasio comunale pareggiato. Istituto Ungarelli n,
scuola tecnica comunale ( 1 87 3 mar. 28-30).
3 . << Relazione sulla visita fatta dai commissarj Finali e Cremona alla scuola
tecnica comunale pareggiata di Ferrara » ( 1 87 3 apr. 2).
4 . << Relazione sulla visita fatta dai commissarj Finali e Cremona alla scuola
tecnica di Cesena n ( 1 87 3 apr. 4 ).
5 . << Relazione sulla visita fatta dai commissari Carbone e Cremona al ginna
sio comunale pareggiato di Ferrara » ( 1 87 3 apr. 1 2) .
<< Inchiesta verbale-Forlì » , 1 87 3 apr. 2 - 3 (fase. 60)
-
<< Inchiesta verbale-Bologna », 1 873 mar. 2 3-30 (fase . 6 1 )
<< Inchiesta verbale-Ferrara », 1 87 3 mar . 2 4 -30 (fase. 62)
<< Inchiesta verbale-Torino », 1 873 apr. 28 - mag. 20 e s.d. (fase . 63)
<< Milano - Inchiesta a voce », 1 873 ott. 3 1 - nov. 10 (fase. 64 )
busta 8
<< Giornali che contengono sunti delle sedute e che parlano dell' inchiesta »
(fase. 65)
l . « Giornale di Napoli » ( 1 87 3 feb . 1 9 - mar. 3 , nn. 50-5 3 , 58, 59, 62).
2. << Il Messaggiere italiano » ( 1 87 3 feb. 6 - apr. 1 9, nn. 5 4 , 57, 7 2 , 73, 87,
88, 1 06 - 1 08).
1 00
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24 .
25.
Fonti per la stm·ia della scuola
Inventario
« Il Pungolo >• ( 1 87 3 feb. 1 9-26, nn. 50, 5 5 , 57).
« L'Opinione » ( 1 87 3 gen . 26, n. 26, copie due).
« Corriere di Milano » ( 1 873 mar. 1 7 , n. 7 5 , copie tre).
« <l Piccolo » ( 1 87 3 feb. 1 7- 1 9, nn. 48, 50).
« Corriere cremonese » ( 1 873 mar. 1 2 , n. 2 1 ).
« L'Unità nazionale» ( 1 87 3 feb. 1 8-23, nn. 48-50, 5 3).
« Monitore di Bologna » ( 1 87 3 feb. 1 9) .
« L 'Osservatore d i Alessandria » ( 1 872 nov . 1 3 - 1 873 mar. 8 , a. VIII, n.
88, a.IX, nn. 1 6, 1 7).
« <l Diritto » ( 1 872 dic. 1 5 - 1 87 3 feb. 9, a. XIX, n. 350, a. XX, n. 40).
« Giornale di Salerno » ( 1 873 gen. 9, n. 3).
« <l Genovesi » ( 1 872 gen. 1 1 - 1 87 3 feb. 10, a. I , nn. 1 -3 6 , a. Il, nn. 1 -4).
« Gazzetta di Sassari » ( 1 873 feb . 1 -2 , nn. 26, 27).
« <l nuovo Sannio » ( 1 87 2 ott. 24, a. X , n. 30).
« <l Commercio savonese » ( 1 87 3 feb. 6, a. l , n. 23).
" Giornale di Udine » (manca).
« La Perseveranza , ( 1 87 3 gen. 3 1 , a. XV, n.4763).
« La Libertà » ( 1 87 2 ott. 29 - 1 873 feb. 1 6, a. III, nn . 3 , 3 1 1 , a. IV, n. 47).
« La Riforma » ( 1 873 feb. l , a. VII, n. 32).
« Scuola e officina » ( 1 87 2 ott . 27 - nov. 7 , a. I , nn. 44, 45).
« L' Educatore italiano » ( 1 87 3 gen. 30, a. XVII, n. 5).
« Lo annunciatore » ( 1 868 mag. 3 1 , a. V, n.47).
« L' Educazione » ( 1 87 3 gen. 1 5 , a. I , n. 1 ) .
« <l Conte Cavour » ( 1 873 apr. 8, a . I X , n.98).
101
direttore del ginnasio comunale di Tirano ( 1 , 2 , 9 , 1 4 , 1 7 20 , 2 2-29, 3 9 , 4 3 , 4 8 , 64 , 65).
A LBO ICO LUIGI,
i professori del r. ginnasio ( 1 , 2, 4-6, 8- 1 1 , 1 7-2 1 , 23, 2 2 , 2 3-28,
40,
4 1 ).
30-38,
A L CAMO:
ALFIERI C ATTANEO A MALIA,
direttrice del r. conservatorio di S. Chiara di San
Miniato (a-u).
A MATO G AETA o,
delegato scolastico mandamentale di Augusta ( 1 , 1 2 , 25-
27).
A FOSSI CELESTINO, professore nel r. ginnasio di Pinerolo ( 1 , 3-2 4 , 2 6 , 27,
29, 3 1 -38, 40, 4 3 , 44, 47, 48, 50, 5 2 , 53, 55, 57-63).
A NTONACCI F LAVIA o,
delegato scolastico mandamentale di Barisciano, pa
dre di famiglia ( 1 4).
preside rettore del liceo ginnasiale e convitto T. Tasso
di Salerno (33, 20, 32, 37, 1 7 , 38, 3 6, 3 3 , 1 8, 27, 26, 2 1 ).
A POLLONI P IERLUIGI,
A RGAN CARLO, Programmi per l'istituto commerciale diretto dal dr. Carlo
Argan,
Torino, tip . Vincenzo Bona, 1 87 2 .
direttore della r. scuola tecnica di Velletri ( 1 , 4 , 5 , 1 0,
1 1 , 1 7, 1 8, 20-24, 28, 4 4 , 46, 48).
ARMINI A LESSANDRO,
A RNAUDO
G.
G IACOMO, Istruzione, spettacoli e feste e di alcune cause di
scadimento delle nazioni. Studi del prof G. Giacomo A rnaudon, consi
gliere comunale di Torino, Forlì, Febo Gherardi ed. prop. , 1 872 (Biblioteca
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria:
( 1 867 - 1 87 3 lug. 2 1 e s.d.)
A
(fase . 66)
professore incaricato per l'aritmetica nel ginnasio di Co
senza, " Piano di riforma scolastica del prof. Gaetano Adami » , ms.
A DAMI G AETANO,
A DRIA :
Collegio Carlo Bacchi ( 1 -5, 7-9, 1 2- 1 4 , 1 6-34, 36-4 2).
direttore del r. ginnasio di Cefalù ( 1 , 4, 1 1 , 1 2 , 1 7-2 1 , 2 3 ,
2 5 , 26, 2 8 , 3 1 , 3 5 , 3 6 , 38, 40, 44).
A GNELLI L ORENZO,
professore nel r. ginnasio di Barcellona Pozzo di Gotto
( 1 , 2, 4-6, 8- 1 1 , 1 7-3 1 , 2 3 , 22 bis, 23 bis, 24-28, 30-38, 40, 4 1) .
A GNOLETTI CARLO ,
professore nel r. ginnasio Dettori d i Cagliari ( 1 -3 ,
5 , 1 0 , 1 2 , 1 7 , 1 8 , 20-2 3 , 25-27, 30, 3 1 , 36-38, 4 3 , 44, 4 6 , 47, 64-66, 72).
A Gus F RANCESCO A NTONIO,
i professori della scuola tecnica pareggiata (3, 4, 1 2 , 1 4 , 23, 2 4 , 35,
4 3-47, 50, 5 2 , 5 5 , 58).
A LBA :
scientifica agricola industriale).
i professori delle scuole secondarie (4 3-5 1 , 1 9- 2 3 , 22 bis, 30,
39, 38, 4 1 , 28, 4 3-5 1 , 59, 52-54, 56, 58, 1 7, 59).
Ascou P ICENO:
ASSOCIAZIONE COSTITUZIO ALE DI MILANO
( 1 2- 1 4 , 1 7, 20, 2 2 , 22 bis, 24 , 26,
30, 28, 4 3-4 5 , 64 , 73, 62).
A SSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO D E G L I SCIENZIATI, LETTE
RATI E ARTISTI, Osservazioni dell 'Associazione nazionale italiana di mutuo
soccorso degli scienziati, letterati e artisti sopra il rinnovamento degli stu
di in Italia in occasione di quesiti proposti dalla Commissione di pubblica istruzione, s . n . t .
direttore del ginnasio comunale pareggiato di Bologna (ali . il
testo che avrebbe letto nella seduta di Bologna del 26 mar. cui non parte
cipò).
A TTI G AETANO,
A ZZI LUIGI , Economie e riforme nell'istruzione pubblica. Opuscolo del pro
fessore Luigi Azzi, Torino, Paravia, 1 867.
1 02
Inventario
Fonti per la storia della scuota
103
BERGAMO: Società industriale ( 1 , 1 7 , 2 7 , 1 2 , 2 3 bis, 2 3).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: B (fase . 67)
( 1 869 - 1 873 set . 29 e s.d.)
BALBI VALIER MARCO GIULIO, consigliere della provincia di Treviso (2, 4-7,
1 2- 1 4 , 1 6, 1 7 , 20, 27, 29, 32, 34 , 3 5 , 40, 57, 59, 65-69, 7 1 , 72).
BALDUZZI CARLO, professore di matematica nel r. liceo Torricelli di Faenza
(4 2).
BERLA FRANCESCO, preside del r. liceo Forteguerri di Pistoia ( 1 3- 1 7, 2 2 , 4 ,
5 6).
BERNARDI GAETANO, professore nel ginnasio dei monaci cassinesi di Monte
Cassino, sacerdote (a, b, c, e, f, g, h, n, o, s, t).
BERTAGNONI LUIGI, professore di pedagogia nella r. scuola normale femmini
le di Parma (52).
BARATELLI FRANCESCO, professore nel r. ginnasio di Mortara (64 , l , 18, 1 7,
2 1 , 64).
BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA, professore di filosofia, già rettore del convit
to civile di Ivrea, preside del liceo ginnasiale Dettori di Cagliari ( l , 4, 5, 1 01 3, 1 7 , 1 8 , 20, 2 2-29, 34-3 6 , 38-40, 64).
BARCELLONA Pozzo DI GOTTO: i professori del r. ginnasio ( 1 , 4-6, 8, 1 1 - 1 3 ,
1 7-32, 34, 3 5 , 37, 38, 40-42).
BIAGGI VINCENZO, delegato scolastico mandamentale nell'isola della Madda
lena ( 1 -69).
BARI: r. provveditore agli studi della provincia di Terra di Bari (Giuseppe
Laudisi) { 1 -5, 8, 9, 1 8 , 2 3-26, 28, 3 1 , 3 2 , 34-3 6 , 38, 39, 5 3-58).
BIANCHI EMIDIO, direttore delle scuole tecniche e ginnasiali di Filottrano, Or
dinamento degli studi secondari del professar Em idio Bianchi direttore
delle scuole ginnasiali e tecniche di Filottrano, Cingoli, tip. A. Ercolani,
BARI: i professori del liceo ginnasiale Salvator Rosa di Bari { l , 2 , 4-6, 8- 1 1 ,
1 8 , 2 3-26, 28, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 36, 38-4 2).
1 873.
BARTOLI ERACLIDE, Cingoli (3, 5, 1 4 , 1 6- 1 9 , 27, 38, 40, 4 5 , 47, 48, 65).
BIANCHI FELICE, avvocato di Tortona.
BAUMANN EMILIO, All 'onorevole commissione d 'inchiesta sull 'istruzione se
condaria maschile e femminile. Risposta e proposte al quesito 23 Ginna
stica, in « La Ginnastica », VII ( 1 873), n. 8, pp. 9 1 -93.
BIANCHINI ALESSA DRO, professore di francese nella scuola tecnica comunale
di Lucca (3, 4, 7, 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 7-20, 2 2 , 2 3 , 2 2 * , 2 3 * , 24 , 2 5 , 27, 28, 3 5 , 4 349).
BAY CESARE, direttore del ginnasio di Pescina dei Marsi ( 1 , 2 , 4-6, 8, 14, 1 7 ,
1 8 , 24 , 26-28, 3 1 , 3 5 , 4 1 , 3 4 , 65 , 3 6 , 40).
BoccARDO GIOVAN BATTISTA, direttore della r. scuola tecnica centrale di Ge
nova (3, 4, 1 1 , 1 8, 2 3 , 2 4 , 47).
BECCARIA MARCO, professore di filosofia nel r. liceo Giambattista Beccaria di
Mondovì, sacerdote (39). Allegati temi degli alunni.
Bocci TITo, padre di famiglia, delegato scolastico del mandamento di Fau
glia (6, 7, 1 2- 1 7 , 1 9-24, 27, 30, 3 3 , 34, 37, 43-46, 48, 5 4 , 57, 59, 6 0).
BELGIOIOSO CARLO, presidente della r. accademia di belle arti di Milano.
BOLDORI I VITTORIO, delegato scolastico mandamentale, professore nel r.
ginnasio di Tortona (4 1 , 4, 5, 7).
BELLUNO: gli insegnanti della r. scuola tecnica { l , 3, 5 , 6, I O , I l , 1 7-20, 2 32 5 , 28, 4 3-47, 49, 5 5).
BELLUNO: il Consiglio scolastico provinciale (4 , 5, 9, I O , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 1 8, 20,
22, 23, 2 2 * , 36-39, 43-4 5 , 5 2 , 57, 60).
BENEDICTI G . BATTISTA, professore di grammatica nel r. ginnasio di Ventimi
glia (3, 5).
BOLOGNA: i professori del ginnasio comunale pareggiato ( 1 , 4- 1 0, 1 2-23, 2 2
bis, 2 3 bis, 24-3 2 , 34-3 6 , 38-50).
BOLOGNINI GIANMARIA, professore di religione nella r. scuola normale femmi
nile di Mantova, « Indice delle tesi di religione » , ms .
BERGAMO: i professori dell' istituto professionale e industriale (43-5 1 ).
BOLZAN ANTONIO, professore reggente nel r . ginnasio di Reggio Emilia ( 1 , 5 ,
8 , 9, 1 4, 2 3 , 2 4 , 27, 2 8 , 3 1 , 3 2 , 3 6 , 38-4 1 ) .
BERGAMO: la direzione della r. scuola tecnica ( 1 -5 , 8- 1 2, 1 7-22, 2 2 bis, 2 3
b�, 24, 2 5 , 27, 2 8 , 30).
Bo ELLI A TO
24, 28, 47).
10,
professore della r. scuola tecnica d i Ascoli Piceno (2-5 ,
1 04
Fonti per la storia della scuola
Bo !VENTO PIETRO 1 •
BORDERI CORRADO, professore reggente nel r . ginnasio d i Noto (4).
BORGIALLI DOMIZIANO, dottore in medicina, Castellamonte ( 1 -77).
BORSANI MICHELE, professore in varie scuole di Bari ( * 4 3 , l , 3 3 , 23 bis, 24).
Bosco GIOVANNI, rettore dell'oratorio di S. Francesco di Sales di Torino ( 1 ,
1 3 , 1 7 , 26, 29).
Bosio SALVATORE, professore di storia e filosofia nel r. liceo Pontano di Spo
leto ( 1 -8, 1 0- 1 8 , 20, 22, 2 3 , 23 bis, 24-36, 38-40).
BOTERO GIUSEPPE, preside del r. liceo Torricelli di Faenza (4 , 1 2- 1 4 , 20, 2 2 ,
24-27, 29-33, 3 5 , 37).
BOTTA SCJPIONE, professore titolare di lingua francese nella r. scuola tecnica
di Dora di Torino (7, 1 0 , 1 2-22, 2 2bis, 2 4 , 2 3bis, 2 5-27 , 43-48).
Inventario
1 05
membro effettivo del r. istituto lombardo letta nell'adunanza del 23 di
cembre 1 869, Milano, tip . Bernardoni, 1 869.
BUFFONELLI VI CENZO, Conegliano ( 1 2- 1 4 , 1 8-20, 23, 2 5 , 28, 3 1 , 40, 42, 4 3 ,
46, 47, 54, 64 , 66, 67, 69, 74).
BUG GIANI FRANCESCO, professore del r. ginnasio Dettori di Cagliari (5, 1 8-20,
22-25).
BUG LICA G. BATTISTA, direttore dell'orfanotrofio maschile di Perugia ( 1 -5 , 7,
1 3- 1 8, 20, 2 1 , 2 3 , 27, 28, 4 3 , 46, 47, 55, 6 1 , 64-68, 72).
BULGARINI ANGIOLINA, maestra nella scuola superiore femminile di Roma,
Pensieri intorno all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole nor
mali di Angiolina Bulgarini, Torino, tip. subalpina di Marino e Gantin,
1 87 3 .
BoTTONI ANTONIO, professore della scuola tecnica pareggiata di Ferrara ( 1 -5 ,
8, 1 3 , 1 4 , 1 8 , 1 9, 2 1 , 2 3 , 2 8 , 4 0 , 44, 4 7 , 4 9 , 64 , 65).
BRANZOLFO-TOIA BERNARDINO, direttore della scuola tecnico-ginnasiale pa
reggiata di Chiari ( * l , 1 0 , 44, 4 3 , 36, 38, 1 8, 1 7 , 1 2).
busta 9
BRE O: i professori della scuola tecnica pareggiata ( 1 -5 , 1 0, 1 1 , 18, 2 4 , 26,
28, 35 , 47-50).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: C (fase. 68)
( 1 86 1 - 1 874 gen . 1 5 e s.d.)
BRESCIA: istituto sociale di educazione e d' istruzione ( l -5 , 9, 1 1 , 1 2 , 1 7-29).
CABRINI ALESSANDRO, istitutore nel convitto di Lucca ( 1 -5, 7- 1 1 , 1 3-48, 5 2 ,
5 3 , 5 3 , 5 5 , 56, 60).
BRESSOLIN LUIGI, Asolo ( 1 8, 20, 3 1 , 32, 36, 38).
BRINDISI, OSTUNI e CAMPI SALENTINO: i professori dei ginnasi 2 •
BRIZIO FRANCESCO, preside del r. liceo Leopardi di Macerata ( l , 2 , 4-6, 8- 1 1 ,
1 8, 2 3-26, 28, 3 1 -4 5 , 55).
BROGIALDI ADOLFO, professore di filosofia nel r. liceo Torricelli di Faenza
(3 1 , 36, 44, 4 5 , 6, 1 0, 1 1 , 39, 1 8).
BRUNI ORESTE, direttore della r. scuola normale femminile di Chieti ( 1 , 4, 5 ,
1 0, 1 2 , 1 4 , 1 6-20, 2 3 , 2 2bis, 2 4 , 27, 30, 5 2 , 5 3 , 5 5 -6 1 ) .
BRUSONI LUIGI, professore nella r. scuola tecnica d i Viterbo ( 1 8, 2 4 , 4 3 , 47).
BucCELLATI ANTONIO, professore di diritto e procedura penale nella r. uni
versità degli studi di Pavia, Cenno critico intorno alle norme che ressero fi
nora gli esami di licenza liceale. Memoria del prof A n tonio Bucce/lati
' Fascicolo dei quesiti senza alcuna risposta.
una petizione alla Commissione sul problema dei professori reggent i .
z
È
CABURLOTTO LUIGI, direttore onorario dell' istituto privato Manin di Venezia,
direttore del collegio delle figlie di S. Giuseppe di Vittorio ( 1 -6, 1 0, 1 2- 1 5 ,
1 7-20, 2 2 , 2 3 , 28, 39, 40, 5 2 , 5 5 , 57-63, 65-68, 7 2 , 73, 76, 77).
CAGLIARI: i professori del ginnasio comunitativo di S. Giuseppe ( 1 , 4, 5, 1 0,
1 1 1 8 , 20-26, 28, 3 1 ' 34 ' 36).
'
CAGNASSI MICHELE, professore di fisica e storia naturale nel r. liceo ginnasiale
Broggia di Lucera (4, 5, 1 1 , 1 2, 1 8 , 2 4 , 27, 3 2 , 4 1 , 42).
CALCABALE G . BATTISTA, delegato scolastico mandamentale di Arienzo ( 1 - 3 ,
5-8, 1 0, 1 8, 1 9, 2 3 , 26-30, 4 3 , 5 2 , 5 5).
CALVETTI GIOVANNI, professore nel r. ginnasio Verri di Lodi ( 1 4 , 27, 3 3 , 36).
CALVINO SALVATORE, r. provveditore agli studi per la provincia di Palermo
( 1 -77).
CAMOZZI GIOVAN BATTISTA, professore nel r. ginnasio Manin di Cremona (2,
4, 5 , 8, 9, 1 1 , 1 3 , 1 6, 1 8 , 2 3-26, 28, 3 1 , 3 5 , 36, 38, 40, 4 1 ).
1 06
1 07
Fonti per la storia della scuola
Inventario
CAMPACCI CESARE, professore di fisica e chimica nel r. liceo Pellegrino Rossi
di Massa (2 , 4- 1 2 , 1 7, 1 8 , 20, 2 1 , 2 3-28, 3 1 , 3 2 , 34, 4 1 , 4 2 ):
CARUSI GI SEPPE MARIA, professore di storia naturale nel r. liceo ginnasiale
Tasso di Salerno 1 •
CAMPORI GIUSEPPE, presidente della Accademia di scienze, lettere ed arti di
Modena (2, 5-7, 1 0 , 1 2 - 1 4 , 1 7 , 18, 20-24, 26, 3 3 , 38, 44, 64 , 72).
CAS ATI GIOVAN 1 , sindaco d i Casnate, consigliere provinciale d i Como ( 1 0,
1 1 , 20, 2 2 , 2 3 , 29, 3 1 , 36, 38, 44, 45, 55, 59, 64 , 7 1 ).
CANDIANI FRANCESCO, direttore delle scuole ginnasiali e tecniche di Cesena
(a, b, c, d, f, g, i, n, o, p, q, r, s, t, u).
CASSOLA EusTACHIO, direttore della r. scuola tecnica di Siracusa (3, 1 1 , 23,
24 , 4 3 , 4 5-47).
CANEDELLI G. ATTILIO, professore nel r. istituto industriale e professionale di
Brescia (6, 20, 1 2 , 1 4 , 1 7 , 18, 22).
CASTELLANI AUGUSTO, consigliere comunale di Roma (6, 1 2- 1 4 , 1 7, 1 9 , 20,
2 2 , 27, 30, 37, 44, 46, 64 , 65).
CANNEVACCI CAMILLO, professore nella r. scuola normale femminile di Mes
sina.
CASTELLANI CARLO E ROSI ARCANGELO, professori nel r. liceo Galilei di Pisa,
CAPUA: direzione dell' Educandato.
Intorno alla riforma dell 'insegnamento secondario classico. Lettera ai si
gnori componenti la commissione d 'inchiesta sopra l 'istruzione seconda
ria, Pisa, tip . Nistri, 1873.
CARATI GIULIO, insegnante di scienze naturali nella scuola tecnica pareggiata
di Medecina (2, 4 , 5, 9, 1 7-20, 22, 23, 2 5 , 28, 30, 4 3-47, 49-5 1 , 55).
CASTELLANI GIOVAN BATTISTA, commissario distrettuale di Castelfranco Vene
to ( 1 -20, 2 2 , 24-27, 29-3 1 , 3 3 , 35-37, 39, 40) .
CARAVELLA VENTURI NO, professore di ginnastica nella r. scuola normale fem
minile di Catania, Su la ginnastica educativa e il canto corale nelle scuole
italiane. A S.E. il ministro della pubblica istruzione Scialoja, Siracusa, tip.
Pulejo, 1 87 2 .
CASTELLETTI SAVERIO, direttore del r. ginnasio d i Modica ( 1 , 2 , 4 , 5 , 8- 1 1 , 1 7,
1 8, 20-2 3 , 25-30, 3 2-43).
CARBONATI DOMENICO, r . provveditore agli studi della provincia d i Siena { 1 0 ,
1 1 , 1 3- 1 7, 20-26, 28, 30, 3 1 , 3 5 , 4 0 , 4 3 , 47, 5 2 - 5 5 , 57, 59, 60, 7 3 , 74).
CAREGA DI MURICCE FRANCESCO, L 'agronomia negli istituti tecnici. Nota CO
mun icata al secondo congresso dei Comizi agrari figuri tenuti in Genova
nel 1 8 73 da F. C. M. , tip. Cappelli Rocca, 1 873 (2 copie).
CASTELLI GAETANO, professore di calligrafia nella r. scuola tecnica di Monvi
so e di Po di Torino, Brevi nozioni preparative allo studio della calligra
fia per G. Castelli, Torino, tip . Camilla e Bertolero, 1 872 2 •
CASTELLI GIUSEPPE, professore nel ginnasio comunale di Ascoli Piceno 3 .
CASTELLINI NAPOLEONE, maestro elementare privato d i Siena ( 1 2 , 1 3 , 1 8) .
CATALIOTTI GAETA GIUSEPPE, professore nel r. ginnasio d i Cefalù ( 1 -5 , 9- 1 1 ,
1 8, 2 5-28, 30, 3 3 , 34 , 37, 38, 40-42).
CARLONI FRANCESCO FORTUNATO, soprintendente delle scuole elementari di
Fabriano (4-6, 8- 1 4 , 1 7 , 1 8, 20-28, 30, 3 1 , 38, 4 4 , 46-48, 5 2 , 59, 60, 64 , 7 1 ,
72, 77).
CATERI
CAROLI GIOVANNI MARIA, professore di filosofia nel r. liceo ginnasiale Gior
dano Bruno di Maddaloni.
CATERINI A GIOLO, professore, Della non onorevole causa dell 'insegnamen
to privato degl 'insegnanti pubblici sostenuta dall 'onorevole dep u tato sig.
Luciano Scarabelli - confutazione di A ngiolo Caterini, Livorno, tip. Fab
CARRA CESARE, professore nel ginnasio comunale di Tirano ( 1 , 1 8, 2 3 , 24,
38) .
breschi, 1 864 .
CARRARA: i professori della scuola tecnica pareggiata e del ginnasio comuna
le ( 1 -5, 9- 1 2, 1 4 , 1 5, 1 8-2 1 , 2 3-28, 3 1 , 3 2 , 35-38, 40, 43-4 5 , 47-50).
CARROCCIO ANTONIO, professore della r. università degli studi di Modena, Ri
sposta a più quesiti della commissione d 'inchiesta sull 'istruzione seconda
ria. Relazione letta al corpo accademico della r. università di Modena e
per suo voto unanime pubblicata, Modena, tip. Vincenzi, 1 87 3 .
1
ANGIOLO, professore, L a libertà dell 'insegnamento. Considerazio
Livorno, tip . Fabbreschi, 1 86 1 .
ni di Angiolo Caterini,
CATTABENI GUGLIELMO e FALCOCCHIO PIO GIUSEPPE, Pensieri di Guglie/mo
_
' Lettera del 28 febbraio 1 87 3 con la quale invia alla Commissione il periodico " La Scuola
salernitana • (che manca) e riassume le idee iv i espresse.
2 All'opuscolo è unita copia di lettera di
Castelli al ministro della Pubblica istruzione
Castelli a C. Donati, caposezione del Ministero della pubbli :
Torino, 4 ago. 1 87 1 , e lettera di
ca Istruzione, Torino, 7 giu. 1 87 3 .
G.
j
G.
Con annotazione: « non risponde ai quesiti, fa u n a dissertazione c h e n o n c'entra • .
1 08
!Jwentario
Fonti per la storia della scuola
Cattabeni e Pio Giuseppe Falcocchio a proposito dell 'inchiesta sull 'istru
zione secondaria, Napoli, tip. San Pietro a Maiella, 1 87 2 .
CAVALASCA GIUSEPPE, studente del l o anno di medicina nell' università degli
studi di Torino.
CAVALLERO AGOSTINO, preside del r. istituto industriale e professionale di
Torino (4 3 , 5 1 ).
CEI GERONTE, professore di greco nel liceo pareggiato Raffaello e nel ginna
sio comunale pareggiato di Urbino (2, I l , 1 4 , 1 8 , 24-27, 30- 3 2 , 36).
CERESA STA ISLAO, rettore del collegio barnabitico di Monza ( 1 3, 1 7 , 1 8 , 2 2 ,
2 5-28, 3 9 , 42).
CITTADELLA GIOVA
1,
1 09
senatore del regno, Padova ( 1 3- 1 7).
CIVILTÀ CATTOLICA: la direzione { 1 6- 1 8 , 20, 1 4 , 29, 3 1 , 36, 39-4 2 , 5 5 , 57,
60, 62, 64-66, 72, 77).
CIVRA A UGUSTA, direttrice del Pio istituto della Ss. Annunziata eli Torino (52,
5 3 , 55-59, 62 , 63).
C LEMENTE
Ll!IGI, professore nel r. ginnasio di Cefalù (2 2 , 2 3-28).
CLEME TE LUIGI, professore nel r. ginnasio di Cefalù ( 1 -20, 2 2 , 23, 3 1 -44).
CoCCIIETTI CARLO, direttore della r. scuola normale femminile di Brescia (2 ,
8, 1 0, 1 1 , 1 7 , 1 8, 20, 24, 3 5 , 40, 44, 47, 5 2-58, 60).
CERRUTI FRANCESCO, preside e direttore del collegio convitto di Alassio ( 1 8,
26, 36, 38, 39, 4 1 , 65, 66, 68).
COLOMBERI MICHELE, professore del r. liceo ginnasiale Cirillo eli Bari, Poche
parole di Michele Colomberi intorno all'inchiesta sull 'istruzione seconda
ria, Bari , tip. Gissi e Compagno, 1 87 3 .
CERVI ALESSANDRO, direttore della r. scuola tecnica di Messina ( 1 -29, 43-6 1 ).
COLOMBETTI
CESENA: consiglio direttivo del convitto comunale, Cesena (64).
CHIAPPORI AGOS TINO, professore di scienze naturali nella r . scuola tecnica
occidentale di Genova, Considerazioni sui quesiti governativi 43, 45, 46,
4 7, concernenti le scuole tecniche, Genova, tip . r. istituto sordomuti, 1 87 3 .
CHIARLA GIUSEPPE, direttore della scuola tecnica pareggiata d i Alba ( 1 , 7, 1 0,
1 2- 1 4 , 1 6, 1 7 , 1 9-2 1 , 2 3 bis, 4 3 , 50, 79).
CHIESA LUCIANO, delegato scolastico mandamentale di Vignale, ( 1 , 2, 5-7, 1 0,
1 2 , 1 4 , 20, 2 2 , 2 3 bis, 26, 27, 3 2 , 34, 36, 38, 39, 44, 4 5 , 5 5 , 6 1 , 62).
CHIETI: i professori dell 'istituto industriale e professionale ( 1 - 5 , 9, 1 0 , 1 2 ,
1 4 , 1 5 , 1 8 , 20, 2 2-27, 29, 3 1 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 37, 39, 43-5 5 , 59, 5 4 , 65-73).
PAOLO F . , professore di stenografia e calligrafia, Torino.
COLOMBO DONATO, professore di matematica nel r. ginnasio Ximenes e nella
r. scuola tecnica di Trapani ( 1 -5 , 9, 1 8 , 20, 24-28, 3 1 , 3 3 , 37, 4 1 , 4 3 , 44,
46-48).
COMBA EUGENIO, reggente di aritmetica e geometria nel r. ginnasio di S.
Francesco da Paola di Torino, I reggenti e gli incaricati, in « L' Istitutore ••,
XXI ( 1 873), 1 3 , pp . 1 93- 1 94 .
E SONDRIO: il r . provveditore agli studi Carlo Enrico Rossari (4 , 1 3 , 1 7,
1 8, 20, 2 3 , 27, 3 1 - 3 3 , 39-4 1 , 4 3 , 5 2 , 5 3 , 56).
CoMo
CONTI-VECCHI VINCENZO, professore eli matematica nel r. liceo Pellegrino
Rossi di Massa (4 1 ).
CHIMINELLO PATRIZIO, professore d' italiano nella scuola tecnica comunale di
Lendinara ( 1 - 1 0, 1 8 , 20, 2 3-26, 28, 3 1 , 3 2 , 34, 3 5 , 38, 40, 4 4 , 47, 5 5 , 58).
COPPOLA ANTONIO, professore eli fisica e chimica nel r. liceo ginnasiale Mario
Pagani di Campobasso ( 1 , 2, 4-6, 1 0- 1 4 , 20, 2 4 , 26-28, 3 2 , 3 5 , 39, 4 1 , 58,
66, 67).
CI-liPARI VINCENZO, professore di storia e geografia nella r. scuola tecnica di
Modica ( 1- 1 1 , 43-4 5 , 47).
CORLEO E: il sindaco (4- 1 4 , 1 7-26, 28-30, 3 3-38, 40, 4 2 , 4 3).
CHRIST ToMASINO, sacerdote di Remanzacco ( 1 , 1 2 , 1 7 , 23, 27).
ClARAMPONI LUIGI, direttore della scuola tecnica comunale di Treia, delegato
scolastico mandamentale ( 1 -3 , 1 4 , 1 7, 44, 46-48).
CORLEONE: i professori del r. ginnasio {4 , 5 , 8, 1 2 , 18, 1 9 , 24-26, 35).
CORNAGLJA ALBERTO, professore di lettere del r. ginnasio Botta eli Ivrea (2, 5,
6, 1 5- 1 7 , 20, 2 3-28, 3 1 -38, 40, 4 3-47).
ClGLIUTTI VALENTINO, preside del r. liceo Vittorio Emanuele e rettore del
convitto nazionale di Palermo ( 1 , 5, 7, 8, 1 0- 1 5 , 1 7-32, 34-4 2 , 64-72).
CORNAGLlA ALBERTO, professore nel r. ginnasio Botta d'Ivrea, Progetto di ri
forma degli istituti d'istruzione secondaria in Italia di Alberto Cornaglia
dottore in lettere, Torino, tip. del giornale « <l Conte di Cavour », 1 87 3 .
ClPELLI BERNARDI o, professore nella r . università degli studi di Parma e con
sigliere scolastico provinciale ( 1 2- 1 3 ).
CossETTI GIUSEPPE, professore nel r. ginnasio d i Pinerolo ( 1 -6, 8- 1 9, 2 2 , 2 2
bis, 2 3 , 2 4 , 26-40).
1 10
Inventario
Fonti per la storia della scuola
COSTA SAVA ANTO 10, professore di fisica sperimentale nella r. università degli studi di Messina.
·
Covi o ANDREA, professore libero di geografia nella r. università degli studi
di Torino (40).
CozzA GIOVANNI, delegato scolastico mandamentale di Orvieto ( 1 - 2 2 , 2449).
Cozzi LORENZO, professore, Sulla pubblica istruzione. Osservazioni e pro
poste per Lorenzo Cozzi in risposta ai quesiti della commissione d 'inchie
sta sulla istruzione secondaria maschile e femminile, Spezia, ti p. Montico
ni, 1 874 (2 copie).
CRAVOSIO LUIGI VITTORIO, impiegato nella segreteria della r. università degli
studi di Torino (20-3 7).
CREMONA: i professori del r. ginnasio Manin (5, 8 , 1 1 , 1 7-20, 22-2 5 , 27, 3 1 ,
3 2 , 36, 38, 40).
CREMONA: i professori della r. scuola tecnica (2, 1 2 , 1 8, 47, 38, 4, 19, 20-22,
24, 26, 30, 4 3-4 5 , 47, 5-6- 1 4- 1 6-24).
CREMONA: i professori del r. liceo Manin (5, 8, 1 1 , 1 7-20, 22).
CRISTINI MICHELE, direttore del ginnasio comunale di Umbertide (5, 6, 1 0,
1 2 , 1 8, 1 9, 2 3 , 2 6 -28, 3 5 , 36, 38, 40).
CUFFIA GIACOMO, professore nel collegio municipale di Alassio ( 1 , 2, 4, 9 ,
1 4 , 1 6, 2 6 , 33, 3 5-37, 4 1 , 4 2 , 44, 4 6 , 6 5).
111
D'ANCONA LUIGI, professore nel r. istituto industriale e professionale di To
rino, Sulla istruzione e sull 'istituto tecnico di Torino, Cenni, Torino, tip.
Favale, 1 872.
DANELLI GIOVANNI, professore di letteratura italiana nel r. liceo ginnasiale
Melchiorre Delfico di Teramo ( 1 , 2 , 4, 6-29, 3 1 -40, 44, 64 , 65 , 67-70, 72).
D'A vossA GIUSEPPE, segretario dell'Associazione nazionale italiana degli
scienziati letterati ed artisti in Napoli, Appendice II alle osservazioni sopra
il riordinamento degli studi nella Italia compilate dalla Giunta dell'Asso
ciazione nazionale italiana degli scienziati, letterati ed artisti in Napoli,
Napoli, tip. R. Tortora, 1 87 3 .
D E ANGELI CLEMENTE, professore d i matematica e scienze naturali nella scuo
la tecnica comunale di Pisogne, Sull'abrogazione del r. decreto n. 1 3 09 6
giugno 1 863 che può servire di risposta al l 0dei 77 quesiti proposti, foglio
a stampa.
DE ANGELIS PIO, professore reggente di lingua francese nella r. scuola tecnica
di Viterbo (43 , 48).
DE CASTRO VINCENZO, Relazione delle conferenze magistrali ten ute nel cir
condario d'Ivrea nell 'anno scolastico 1 861 aggiuntivi alcuni discorsi edu
cativi del professore Vincenzo De Castro, r. ispettore delle scuole primarie
nella provincia di Torino, Ivrea, tip. F . L . Curbis, 1 862.
DE DONATO GIANNINI PIETRO, professore nella r. scuola tecnica di Padova,
Sull'inchiesta per l 'istruzione secondaria. Lettere del professore De Dona
to Giannini al commendatore Francesco Piccoli deputato al Parlamento,
CULTRERA GRIMALDI ALFONSO, r. delegato scolastico mandamentale di Chiara
monte ( 1 -5 , 9, 1 0 , 1 2- 1 5 , 1 7-20, 22-42, 4 5-47, 50, 5 3 , 56, 58-6 0, 63 , 64 ,
7 1 ).
D E DONNO ACHILLE, Maglie Terra d'Otranto ( 1 - 1 0).
CUNIBERTI ANGELO, direttore della scuola tecnica pareggiata di Savigliano (5,
2 3 , 24, 2 6 , 28, 4 3-47, 49, 50).
DE FALCO GAETANO, Seguito delle risposte a ' quesiti della commtsstone
d 'inchiesta su l 'istruzione secondaria , in « Il Genovesi >>, II ( 1 873), 9 e 1 0 ,
Padova, tip. F . Sacchetto, 1 87 3 .
pp. 75-77.
Risposte ai quesiti sull'istruzione secondaria: D (fase . 69)
( 1 862 - 1 873 mag. 1 0 e s.d.)
DALLA VALLE GIUSEPPE ROLANDO, senatore del regno, padre di famiglia, Tori
no ( 1 2 , 1 4- 1 7, 20, 2 3 , 27, 30, 33, 37, 57, 6 1 , 64 , 65, 68, 69, 72).
DE GIOANNIS ANGELO, incaricato dell' insegnamento dell'aritmetica nel r. gin
nasio di Alghero (5 , 4 1 ).
DE GUBERNATIS MANNUCCI TERESA, Firenze (6 , 1 4 , 1 7, 1 9-2 1 , 2 3 , 37, 38, 40,
4 1 , 43-46, 48, 50, 60-63, 7 3 , 74).
DALMAZZO FRANCESCO, professore nel collegio Valsalice di Torino ( 1 , 1 3 ,
27).
DEI MEDICI D ILOTTI SPIRIDIONE, socio onorario dell'Accademia Peloritana,
Messina (36).
D 'ALTEMPS ALBERTO, padre di famiglia, Cesena (9 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 20, 2 3 , 27, 3 1 ,
3 2 , 36, 37, 39, 40, 63 , 68, 69, 72).
DE LAURE TJJS CARLO, maestro normale per l' insegnamento superiore a Val
lecorsa ( 1 , 4, 8, 1 7 , 20, 2 3- 2 5 , 27, 28, 3 5 , 4 0, 5 2 , 53).
1 12
Inventario
Fonti per la storia della scuola
DE MARIA VI CE zo, direttore spirituale della scuola femminile privata delle
Terzine domenicane di Modena ( 1 7).
1 13
FALORSI GUIDO, Ginnasi, licei e con vitti - osservazioni del prof Guido Fa
estr. da « La Rivista universale » , Firenze, tip . Cenniniana, feb. 1 87 3 .
torsi,
DE MICHELIS ANGELO, dottore in teologia, direttore del Pio istituto della Ss.
Annunziata di Torino ( 1 , 3-6, 9, 1 0, 1 2-20, 22-24, 27, 28, 34, 36, 5 2 , 5 3 ,
5 5-62 , 64, 68, 70, 72, 76, 77).
FENAROLI GIULIANO - GALLOTTA FRANCESCO, professori del r. liceo-ginnasio
Tiziano di Belluno (4, 5 , 9- 1 1 , 1 8-28, 30-36, 39-4 1 ,).
DENICOTTI DoMENICO, r. provveditore agli studi per la provincia di Messina.
All . : Calendario scolastico per le scuole tecniche classiche normali e pri
marie, anno scolastico 1 8 72- ' 73, Messina, tip. del commercio.
FERRACINA G . BATTISTA, direttore del ginnasio comunale di Bassano Veneto
( 1 , 2, 4, 5, 8- 1 0 , 1 3 , 1 8 , 20, 2 3-26, 28, 3 1 , 35 , 36, 38, 40, 4 1 , 47).
DE ROLLAND G . ALESSA DRO, prefetto di Livorno ( 5 , 6, 1 0, 1 2- 1 4 , 1 8, 20, 2 1 ,
3 3 , 3 4 , 37, 64 , 65 , 68).
FERRARIO ERCOLE, direttore della scuola tecnica comunale di Gallarate ( l , 2 ,
4 , 5 , 8, 1 0- 1 2 , 1 4 , 1 7-2 5 , 27, 2 8 , 3 0 , 4 3-4 5 , 47-50).
DE VINCENTIIS RUBINO MARIA, Trani (65 , 75 , 77, 79).
FERRARJS CARLO, professore privato nell'istituto Rossi di Torino ( 1 3 , 52-55).
All . : « L'Osservatore scolastico », a. VIII, nn. 17 e 19 con suoi articoli sull'in
chiesta.
DI CASTAGNETTO CESARE, senatore del regno, Torino ( 1 7) .
DI MARTINO ANDREA, Napoli ( 1 , 2 , 4 , 1 1 , 1 3- 1 5 , 1 7 , 1 8, 2 0 , 2 2-28, 30, 324 1 ).
DI PAOLA VINCENZO, professore di lettere italiane nel r. liceo ginnasiale Ma
rio Pagano di Campobasso ( 1 8, 24-26, 28, 3 1 , 3 2 , 38).
FERMO: i professori del ginnasio comunale (a, b, c, f, g, n, o, t , r, u).
FERRERI LUIGI, ingegnere, Torino (2-7, 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 7-30, 35, 38, 4 3 , 46-49,
62, 63).
FERRERO MICHELE, professore, Genova ( 1 ).
FERRONI NATALE, professore nel r. ginnasio V irgilio di Mantova (5, 1 4 , 1 7-20,
24 , 30, 32, 35, 38, 40).
DONÀ GIACOMO, professore di francese nel ginnasio tecnico comunale Gior
gione di Castelfranco Veneto ( 1 - 1 1 , 1 8 , 2 3 , 2 4 , 34, 37 , 38, 4 3 , 4 5-48, 50,
59, 65, 67-69, 7 1 ).
FICHERA ALFIO, professore privato di matematica, Acireale (3 1 , 3 5-37).
DURANDO CELESTINO, direttore degli studi nell 'oratorio di San Francesco di
Sales di Torino ( l , 1 8, 26).
FONTANA GUGLIELMO, colonnello, Modena ( 1 -8, 1 1 - 1 8, 20, 2 2 , 23, 26, 28,
30-4 1 ).
FORNACIARJ MARCO, ingegnere, Reggio Emilia (6, 7, 20, 23).
FORNARI PASQUALE, insegnante in istituti pubblici e privati, padre di famiglia,
Milano (62 , 63, 65, 67, 68, 72).
busta 1 0
FRANCHI MAURO, Mantova (23, 3 3).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: E (fase . 70)
( 1 873 mar. 1 5)
FRANCIOSJ GIOVANNI , professore di letteratura italiana nel r. liceo Muratori di
Modena (2, 5 , 8, 1 2 , 1 8, 2 3 , 26, 28, 3 2 , 36, 38).
L' EDUCAZIONE: la redazione, Risposte ai quesiti della commissione d 'inchie
sta sulla istruzione secondaria maschile e fem m inile, Firenze, tip. Bencini,
FRANCIOSJ PIETRO, professore nella r. scuola tecnica bis di Palermo, Pubblica
in « Gazzetta di Palermo » , 1 87 3 , V,
nn. 1 24 , 1 4 1 , 1 50 .
1873.
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: F (fase . 7 1 )
( 1 873 feb. s.g. - 1 873 ott . 8 e s.d.)
FACEN ]ACOPO, delegato scolastico mandamentale di Fonzaso ( 1 -77).
istruzione nella provincia di Palermo,
FRASSI PROBO, già docente nel Seminario diocesano, poi reggente nel r. gin
nasio di Reggio Calabria (4-7 , 9, 1 4 , 1 8 , 20, 2 1 , 2 3 , 24 , 26, 27, 3 1 , 3 3 , 3 5 40).
FRIGERI A TO IO, direttore della r. scuola tecnica di Noto ( 1 -5, 8- 1 1 , 1 8 , 2 32 5 , 28, 47, 49).
1 14
Fonti per la storia della scuola
Inventario
FRIZZI ENRICO, maestro, Siliqua.
1 15
GATTONI GIOVAN 1, professore nel r. ginnasio Beccaria di Milano, Riforma
delle scuole medie classiche proposta da G. Gattoni professore titolare nel
r. ginnasio C. Beccaria, Milano, ti p. degli i ngegneri, 1 87 5 .
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: G (fase . 72)
{ 1 865 - 1 875 e s.d.)
GABRIELI ANDREA, professore di storia e geografia nell'istituto tecnico pro
vinciale di Bari, Brevi risposte ad alcun i fra i quesiti proposti dalla com m .
d 'inchiesta sulla istruzione secondaria del prof Andrea Gabrieli, estr. da
« Piccolo Corriere di Bari >>, Bari, tip. Cannone, 1 873 (tre copie).
GALASSI LUIGI, professore di patologia medica nella r. università degli studi
di Roma (4 , 5 , 8, 1 4 , 1 8 , 1 9 , 2 4 , 26-28, 30, 36, 37, 40-42) 1 •
GALLI GIUDICI ODOARDO, giudice conciliatore nel comune di Lucca (6, 7 , 1 21 7, 2 1 -2 3 , 44).
GALLO GIUSEPPE, dottore aggregato alla r. università degli studi di Torino { 1 4 , 9 , 1 1 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 2 6 , 3 3 , 34, 37, 39, 40, 4 2 , 44).
GAMARINO CIPRIANO, censore della disciplina del convitto nazionale di Ca
gliari (64-72).
GAMBETTI PIETRO, direttore del ginnasio comunale e della scuola tecnica pa
reggiata di Loreto { 1 , 2 , 1 0 , 1 8 , 3 1 , 3 2 , 38, 39, 4 3-47, 64).
GAMBINO GIUSEPPE, Sugli studi geografici - Osservazioni e note didattiche
del prof G. Gambino, insegnante di geografia in vari istituti. Risposte
quesiti 40 e 4 7 della commissione d 'inchiesta sugli studi secondari, Paler
mo, tip. Giliberti, 1 87 3 .
GATTONI GIOVANNI, professore nel r. ginnasio Beccaria di Milano, Risposte
del prof G. Gattoni ad alcuni quesiti della Commissione d 'inchiesta sulla
istruzione secondaria, Milano, tip. del Patronato, 1 874.
GAVOTTI GEROLAMO, Nella distribuzione dei premi agli alunni ed alle alun
ne delle scuole elementari del comune di A lbissola superiore. Allocuzione
del sindaco M.se Gerolamo Gavotti, Genova, tip. r. istituto sordomuti,
1 87 3 .
GENOVA - i professori della r . scuola normale femminile (5 2-6 1 ).
GENOVA - i professori della r. scuola tecnica occidentale { 1 -6, 8- 1 1 , 1 3, 1 4 ,
1 7-20, 2 2-24, 27-30).
Ali. : Risposte ai quesiti della commissione d 'inchiesta intorno alle scuole
tecniche, Genova, tip. Sebenone, 1 873.
GENTILI DI ROVELLONE TARQUINIO, avvocato, Sanseverino Marche { 1 0- 1 4 , 1 7,
3 1 , 34, 39, 43).
GERA LUIGI ANTONIO, direttore della r. scuola tecnica a S . Stin di Venezia { 1 77).
GEROLA ANDREA, direttore delle scuole tecniche a Crema (4 3, 49).
GHERZI STEFANO, professore di fisica e storia naturale nel liceo di Chiavari
{ 1 8, 24-26, 28, 3 2 , 39, 4 1 ) '.
GHIRON TEODORO,
GARNERI AGOSTINO, direttore capo divisione alla ragioneria del M inistero del
l ' interno { 1 2).
GARNIER GIOVANNI GIUSEPPE, professore di computisteria nelle r. scuole tec
niche di Monviso e di Po in Torino (4 3).
GATTI CARLO, preside del r. liceo Forteguerri di Pistoia (4-6, 1 8-20, 23, 2 4 ,
27, 2 8 , 3 1 , 3 2 , 36-38, 40).
.
GATTI G IOVANNI, Ceva { 1 -4 , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 20, 2 1 , 2 3 , 24, 28, 29, 43-4 5 ,
4 7 , 50).
GATTINARA LUIGI SEVERINO, professore di fisica e chimica nel r. liceo Torri
celli di Faenza { 1 , 2 , 4, 5 , 1 0 , 1 1 ).
1 Con lettera di accompagnamento delle risposte, nella quale chiede di essere dispensato
dall' interrogatorio orale.
Il metodo le scritture e l 'insegnamento del calligrafo
Giacomo Castelli esposti al pubblico giudizio da Teodoro Ghiron, maestro
di calligrafia, Torino, tip. Moretti, 1 869.
GHISI L . A. , professore di fisica nel collegio convitto di Lodi.
Ali. : Prospetto di un nuovo corso di fisica dettato dal professore cavaliere
Ghisi, Milano, tip. Guglielmini, 1 87 2 .
GIAMBELLI CARLO, professore nel r. ginnasio d i Pinerolo { 1 -7, 9- 1 1 , 1 4 , 1 8,
2 2-38).
GIANGUITTO FRANCESCO, professore di letteratura italiana nel r. liceo ginna
siale Giordano Bruno di Maddaloni (38).
V
1
i è unita una prima risposta di
l 0 0tt. 1 87 2 .
S.
Gherzi stilata sulla base dell'ordinanza ministeriale del
1 16
1 17
Fonti per la storia della scuola
In ventario
GIA NI ANTONIO, professore di fisica e chimica nel r. liceo Forteguerri di Pi
stoia (32).
GUASTALLA: i professori del ginnasio municipale ( 1 , 5 , 8- 1 5 , 1 7- 2 1 , 25-30,
33, 34, 37, 38, 40, 4 2 , 43).
GIAN INI VINCENZO, rettore del collegio di Viareggio (66, 67, 70, 74,) COMU
ITÀ DI VIAREGGIO, Pensieri sopra i collegi con vitti di Vincenzo Giannini,
Lucca, tip. Racchi, 1 873 .
GUASTALLA: il sottoprefetto ( 1 , 3-5, 9, 1 2, 14, 1 3 , 1 7, 1 8, 2 2 bis, 2 3 , 2 3 bis,
24-28, 3 2-34, 37, 40, 43, 4 5 , 47, 50, 5 2 , 5 5, 56, 77).
GIGLIO TORQUATO, professore di lingua francese nella scuola tecnica di San
sepolcro.
GIROTTI GIOVANNI, delegato scolastico mandamentale di Amelia (3, 4 , 6-8,
1 4 , 1 6-2 1 , 2 3-26, 28, 30, 3 5 , 37, 38, 40, 4 3 , 44, 46, 50, 5 1 , 65-68).
GIULIANI PIETRO, La istruzione secondaria tecnica e classica in Italia. Os
servazione del cav. Pietro Giuliani prof di diritto commerciale e di politi
ca economica nell 'università di Macerata e preside dell 'istituto tecnico
provinciale, est r. da " L ' Economista delle Marche », Macerata, tip . Mancini,
1 87 3 .
GUERDILE CARLO, preside del liceo comunale di Sessa Aurunca (35-38, 55).
GUERRA FILIPPO, professore nel ginnasio comunale di Cesena ( 1 -5, 8- 1 1 , 1 4 ,
1 8 , 20, 2 3-26, 28, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 38, 40).
GUERRIERO ANTONIO, preside del r. ginnasio di Caltagirone e delegato scola
stico mandamentale ( 1 , 2).
GUIDETTI GIOVANNI, capo sezione della Corte dei conti ( 1 8, 26, 28).
GuzzoNI PIETRO, delegato scolastico mandamentale di Borgotaro ( 1 , 3 , 5, 6,
9, 1 0 , 1 3, 1 5- 1 8, 20-28, 30-47, 52-63-65, 72 , 75).
GIUSTI PIETRO, professore d i ornato nell'istituto industriale e professionale
di Torino ( 1 -7, 1 1 , 1 7, 1 8, 2 2 , 22 bis, 24, 26, 28, 3 2 , 3 5 , 37, 43-48).
GORETTI LUIGI, professore di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole
tecniche di Portoferraio (2-4 , 4 3 , 4 4 , 47).
GRANDI LUIGI , Sull 'insegnamento della aritmetica. Osservazioni di Luigi
Grandi pubblico insegnante di matematica , Bologna, tip. Fava e Gavagna
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: H (fase. 73, s.d.)
HAJECH CAMILLO, professore di fisica nel r. liceo Beccaria di Milano (2, 4-6,
10, 1 1 , 1 4 , 20- 2 2 , 24-3 1 , 3 3 , 3 5 , 4 2 , 44, 58).
ri, 1 865 .
GRANDI LUIGI, Definizione e regole di aritmetica di L u igi Grandi, prof ti
tolare di matematica elementare, Bergamo, tip. dei fratelli Bolis, 1 869 .
GRANDI LUIGI ,
Il
primo lavoro di Euclide e introduzione alla geometria ad
uso dei ginnasi dei licei e delle scuole tecniche per Luigi Grandi prof di
matematiche elementari pure e miste, Bergamo, tip. dei fratelli Bolis, 1 87 1 .
GRECO DOMENICO ANTONIO, Napoli (39, 40).
GRION GIUSTO, preside del r. liceo Scipione Maffei di Verona ( 1 , 2, 5, 9- 1 1 ,
1 8, 24 , 3 1 , 32).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: I (fase. 74 , s.d.)
IGLESIAS : i professori della r. scuola tecnica (43-49).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: ] (fase. 75)
( 1 87 3 giu. 1 9)
]ONA SALOMONE, rabbino maggiore della università israelita di Modena ( 1 7).
GR!SANTI CRISTOFARO, professore reggente nel r. ginnasio di Cefalù ( 1 -5 , 91 2 , 1 7-26, 28, 3 1 , 3 5 , 38, 40, 44).
GRONDONA PASQUALE, intendente militare, Ispra (23, 2 2 bis).
GUADAGNI GIUSEPPE, direttore delle scuole pie di Napoli (5- 1 7).
GUAITA GIUSEPPE, delegato scolastico mandamentale di Erba ( 1 0).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: L (fase. 76)
( 1 87 1 - 1 874 gen. 16 e s . d. )
LABRIOLA ENRICO, Brevi risposte ai quesiti dell 'inchiesta su l 'istruzione se
condaria dedicate a S. E. il signor m inistro della pubblica istruzione del
1 18
1 19
Fonti per la storia della scuola
Inventario
Regno d 'Italia da Enrico Labriola professore nella quinta classe del r. gin
nasio di Modica, stamperia di Mario La Porta, 1 872 (4 copie).
LUMELLO GIUSEPPE, professore nel r. liceo ginnasiale Colletta di Avellino ( 1 ,
2 , 4 , 5 , 1 0 , 1 1 , 1 3, 1 4 , 1 7 , 1 8, 20-28, 30-40, 60, 64).
LABRIOLA ENRICO, professore nel r. ginnasio di Modica ( 1 -5 1 ) ' .
LABRIOLA GAETANO, direttore della r. scuola tecnica di Modica ( 1 - 1 1 , 1 8 , 202 5 , 27-30, 4 3-4 5 , 49).
LAGANÀ PIETRO, professore nel r. ginnasio di Caltagirone (4-6, 8- 1 2 , 1 7- 2 3 ,
26-28, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 38-40).
busta 1 1
LANZA GIOVAN I, direttore del proprio istituto d'educazione e d'istruzione a
Torino, Sull 'insegnamento pubblico e privato. Brevi parole del prof Gio
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: M (fase. 77)
( 1 86 1 - 1 874 gen. 3 1 e s.d.)
vanni Lanza alla comm issione d 'inchiesta per l 'istruzione secondaria,
MAFFEI G. PIETRO, segretario del comizio agrario di Reggio Emilia (6, 7, 1 21 5 , 1 7 , 20, 22, 27, 37).
Torino, tip. e lit. Camilla e Bertolero editori, 1 87 3 .
LAVAGGI FRANCESCO, Roma ( 1 -4 , 1 4 , 1 7, 20, 2 2 , 2 3 , 28, 30- 3 3 , 37, 4 1 ).
LEO FRANCESCO, Francavilla Fontana ( 1 , 4, 9- 1 1 , 1 3 , 1 8, 1 9, 2 3 , 24, 27, 3 1 ,
36, 39, 40, 44, 46, 47).
LEPORA PIETRO, r. provveditore agli studi per la provincia di Padova.
LINGUITI FRANCESCO, professore di lettere italiane nel r. liceo Tasso di Saler
no, Sull 'insegnamento delle scienze e particolarmente della filosofia ne/ li
ceo - Considerazion i di Francesco L inguiti. S . n . t .
LINGUITI FRANCESCO, Intorno a l riordinamento degli studi classici proposto
nella lettera circolare del ministro della p. istruzione del 9 maggio 1 8 71 .
Considerazioni di Francesco Linguiti prof di lettere italiane nel r. liceo
Tasso di Salerno, Salerno, tip. Migliaccio, 1 87 1 .
LIVORNO: i professori del r. liceo Niccolini di Livorno (5, 9 , 1 0 , 1 2 , 20-2 2 ,
2 4 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 28-34 , 38-4 2).
LONGO SALVATORE, professore nel ginnasio di Sessa Aurunca ( 1 , 4 , 5 , 1 8, 2 4 ,
2 6 , 28, 40).
LORENZONI A TONIO PIETRO, professore di calligrafia nella r . scuola tecnica
di Mantova (3-5 , 8, 9, 1 8, 2 1 , 2 2 , 2 4 , 4 3 , 4 5 , 47).
LuccA: i professori della scuola tecnica comunale di Lucca ( 1 , 2, 4, 5 , 7- 1 1 ,
1 7 , 1 8 , 2 3- 2 5 , 28, 3 1 , 3 2 , 34-36, 38-40, 4 3-46, 64).
LUCiANO PIETRO, professore di filosofia nel r. liceo Lagrangia di Vercelli (2,
4, 9, 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 1 8, 20, 2 3 , 24, 27, 29, 3 1 , 32, 34, 38, 39, 53, 65).
MAGELLI LISIMACO, avvocato, Modena (6, 1 2, 1 3 , 1 5- 1 7, 20, 22, 27, 30, 33,
34, 37, 38).
MAGLIULO NICOLA, Bona (Tunisi ) .
MAGRINI ALESSANDRO, direttore della r. scuola tecnica di Bergamo ( 1 - 1 3, 1 730, 3 2-37, 39-50, 5 2 , 5 5 , 57, 58, 60, 6 1 , 63-68).
MAIOTTI FORTUNATO, professore reggente nel r. ginnasio di Saluzzo (2, 5, 6,
9, 1 2 , 1 8, 20, 3 1 , 3 5 , 36, 38, 40).
MAJER GIOVANNI, professore nel r. istituto tecnico di Sassari, Risposta alla
commissione d'inchiesta sull 'istruzione secondaria circa l 'insegnamento
del disegno nelle scuole tecniche, Sassari, tip. Azuni, 1 873.
MALACARNE CosTANZO, direttore della r. scuola normale maschile di Forlì
(52-6 1 ) .
MANASSEI PAOLANO, consigliere municipale di Terni, Risposte ad alcuni que
estr. da « La Rivista universale », Firenze,
set. 1 873 (4 copie).
siti sulla istruzione secondaria,
MANCINI ALESSANDRO, professore e preside della r. scuola nautica di Chioggia
( 1 -8, 1 0, 1 1 , 1 8 , 24-26, 28, 40, 4 3-45).
MANCINI LUIGI, professore di storia nel liceo pareggiato Nolfi di Fano.
MANGIAMELI DOMENICO, Corleone ( l , 1 3, 1 8 , 2 2 , 28).
MANTOVA: i professori del r. liceo e del r. ginnasio Virgilio, ( 1 -5 , 9- 1 1 , 1 8 ,
2 3-26, 3 2 , 35 , 36, 38, 39-4 2 , 47, 5 2 , 5 3 , 5 5 , 5 6 , 5 8 , 59).
1
V i è unita lettera di E. Labriola del 27 m a r .
1 873 a l ministro della pubblica istruzione nella
quale riassume le risposte già inviate alla Commissione.
MANZI A . , professore nel liceo barnabitico di Lodi, Studio psicologico sul!�
vita umana. Dissertazione del P. M. A. Manzi letta in occasione della dt-
1 20
Fonti per la storia della scuola
fnventario
MAUTI
121
AMBROGIO, professore di storia naturale nel r. liceo Pellegrino Ros
5, 1 8 , 2 5 , 3 2 , 4 2 , 49).
stribuzione dei premi nel collegio San Francesco in Lodi, Lodi, tip. E . Wilmant , 1 87 2 .
si di Massa (4,
MARCHIANÒ, vice preside collegio italo-greco di S. Adriano ( 1 , 2 , 4 , 5 , 8, 9,
1 8, 23-28, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 36, 38, 40, 4 1 ).
MELODIA GIUSEPPE, r . provveditore agli studi per la provincia di Siracusa, Su
le scuole secondarie. Lettere due di Giuseppe Melodia, Siracusa 1 87 2 .
MARENESI ERCOLE, preside del r . liceo Canova di Treviso, Sul riordinamento
dell 'istruzione nazionale in Italia , Bergamo, Pagnoncelli, 1 86 1 .
MELODIA GIUSEPPE, r. provveditore agli studi della provincia di Siracusa ( 1 6).
·
MARIANI MARIANO, professore di matematica nella scuola tecnica pareggiata
di Fano ( 1 -3, 5 , 2 2 , 2 3 , 4 5 , 46, 49, 50).
MARINELLI FILIPPO, direttore della scuola elementare d i Forlì, " Ordinamento
della pubblica istruzione. Proposta discussa e approvata dal Congresso degli
insegnanti tenuto a Forlì sullo scorcio del mese di settembre dell'anno
1 864 », ms.
MARINI ANTONIO, professore nel ginnasio comunale di Bassano Veneto (2 , 3 ,
5 , 9, 1 2 , 1 6, 1 8, 20, 2 3 , 2 4 , 26-28, 3 1 , 3 3 , 34, 3 6 , 39-4 1 , 4 3 , 4 5 , 46, 5 5 , 64 ,
6 5 , 68, 7 2 , 74, 75, 77).
MARINI GIOVANNI , professore di matematica e docente particolare di scienze
naturali nella r. scuola tecnica di S. Felice a Venezia.
MARINO SALVATORE, professore nel r. ginnasio di Modica ( l , 5, 1 4 , 1 8, 2 3 ,
2 4 , 2 6 , 2 7 , 3 5 , 36, 38, 40).
MARTINATI ALESSANDRO, direttore della r. scuola normale maschile di Padova
(2-6, 1 0, 1 4 , 1 7 , 1 8, 20, 2 3 , 24, 3 1 , 4 4 , 36, 5 2-56, 58, 60-62).
MARTINENGO GUGLIELMO, professore di lettere, Scarnafigi ( 1 -3 , 5, 6, 1 0, 1 3 ,
1 4 , 1 7, 1 8, 20, 2 2 , 2 5-30, 3 2-36, 38, 40, 4 2 , 59, 66, 67, 69, 70, 74).
MARTIN! DOMENICO, professore di scienze fisiche nel r. liceo Tiziano di Bellu
no ( 1 8, 20, 2 4 , 27, 28, 4 2).
MASSA GIOVANNI, professore d i matematica e computisteria nella scuola tec
nica comunale di Cortemilia, Risposte ad alcuni quesiti proposti dalla
commissione d 'inchiesta, in « Istruzione e dilett o " , opuscolo didattico-lette
rario pubblicato da una società d 'insegnanti sotto la direzione del prof. Gio
vanni Massa, pp. 5 3-68 (3 copie).
MASSABÒ MICHELE, professore di matematica e computisteria alla scuola tec
nica pareggiata di Susa (4 , 5, 1 8, 28, 46, 47).
MASUCCI LUIGI, professore, Santa Maria Capua Vetere (29).
o
MERIZZI GIACOMO, deputato, Tirano.
MEROLLA NICOLA, professore nel ginnasio comu nale di C ivitavecchia (9, 1 4 ,
1 7).
MESSINA: i professori della facoltà di lettere e filosofia della r. università de
( 1 , 2, 4-7, 9- 1 3, 1 5- 1 9, 2 1 -28, 37-40).
gli studi
MIANI LUIGI, professore della scuola nautica di Chioggia ( 1 -5, 8, 9, 1 4, 1 5 ,
1 8, 1 9 , 23, 2 5 , 27, 28, 32, 4 1 , 43-47).
MICHIEL LUIGI, senatore del regno, Roma ( 1 , 2, 4, 5, 18, 2 3 , 24, 28, 3 1 , 3 3 ,
36, 3 8 , 4 0 , 47).
MINONZIO CARLO, Osservazioni sulla dissertazione del dott. Carminati
prof Temistocle. Del rigorismo considerato per se stesso e come sistema di
sciplinare nelle scuole e nei collegi. Lettura fatta nella seduta 18 dicembre
1 8 73 all 'A ccademia fisico-medico statistica dal membro effettivo Minon
zio dr. Carlo segretario della Deputazione provinciale di Milano, s . n . t .
MODENA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, Risposta a p iù quesiti della Commissione
d 'inchiesta sull 'istruzione secondaria. Relazione letta al Corpo accademi
co della r. università di Modena e per suo voto unanime pubblicata, Mo
dena, tip. C. Vincenzi, 1 873 (3 copie) .
MOLA GIUSEPPE, professore di storia e geografia nel r. liceo Romagnosi di
(5, 8- 1 0, 1 2, 18, 2 3-26, 28, 3 1 , 32, 3 5 , 40).
Parma
MOLLAME VINCENZO, professore di matematica nel r. liceo ginnasiale Filangie
ri di Monteleone (4 1 ) .
MONATERI GIUSEPPE, professore nel r . ginnasio d i Ventimiglia (4 , 5, 8- 1 1 , 1 8 ,
2 3 , 24 , 26, 28, 3 1 , 3 5 , 40).
MONIGATTI DOMENICO, docente provvisorio nel ginnasio comu nale Marinon i
di Tirano ( 1 ).
MONTANARI GIUSEPPE, Ravenna ( 1 4 , 1 7, 20, 2 3 , 2 2 bis).
MORELLI CARLO, direttore della scuola tecnica pareggiata di Lecco (4, 1 7 , 1 8 ,
20- 2 3 , 2 3 bis, 2 4 , 2 7 , 4 3 , 4 5-47, 50).
1 22
1 23
In. uentario
Fonti per la storia della scuola
MORIGGIA ALIPRANDO, professore incaricato di istologia nella r. università de
gli studi di Roma, socio della r. accademia dei lincei 1 •
MORSOLINI GIUSEPPE, professore nel r. ginnasio Ximenes di Trapani (4 , 5 , 2 4 ,
3 1 ).
MOSCA LUIGI , padre di famiglia, Torino ( 1 7).
MosCATELLI GENNARO, Risposta sommaria ai quesiti formulati dalla com
missione d'inchiesta su l 'istruzione secondaria maschile e femminile per
G. Moscatelli, direttore delle scuole tecn iche di Bari, lì 2 aprile 1 8 73, Bari,
tip. G issi e Compagno, s . d .
MussA TALENTINO ANTONIO, delegato scolastico mandamentale di Castella
monte, Ivrea ( 1 2 , 20, 28, 29, 3 2-34 , 36, 38-4 1 , 44).
MUZJO CARLO, rettore del r. convitto nazionale di Genova (64-72).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: P (fase .
( 1 873 geo. 2 1 - 1 87 5 e s . d . )
80)
PACCERE ERMENEGILDO, direttore spirituale del convitto collegio di Chivasso
( 1 7).
PAGLIA o GIUSEPPE, professore di lettere nella scuola tecnica pareggiata d i
Dogliani, « Relazione a S . E . il M inistro della pubblica istruzione sulla riforma
degli studi secondari », ms .
PALERMO: i professori della r. università degli studi di Palermo, Risposte ai
quesiti sulla istruzione secondaria e progetto della Commissione della re
gia università di Palermo composta dai prof Cacopardo, Garajo, Gemel
laro, Sampolo, Mucciarelli, Guarneri e Corteo relatore, s . o . t .
PALMIERI GIOVANNI, professore d i fisica nel r . liceo ginnasiale Tasso d i Saler
(2, 20, 2 2 , 27-29, 4 1 , 42).
no
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria :
( 1 873 feb. 1 0 - 1 873 lug. 1 7)
N (fase . 78)
NAPOLI FEDERICO, già segretario generale del Ministero della pubblica istru
zione ( 1 - 1 7, 3 1 -39, 4 3-49, 64 , 73).
PANIZZONI LUIGI, insegnante elementare superiore, Verona .
PAPPALARDO VITO, consigliere scolastico provinciale, professore nel r. liceo
Ximenes di Trapani ( 1-4, 6, 8- 1 1 , 1 6- 1 8, 18 bis, 20, 2 2-28, 3 1 -36, 38-40, 4 4 ,
4 6, 5 2 - 5 5 , 59, 74).
NARDI A. , direttore del proprio istituto privato di Firenze ( 1 -5 , 7, 9 , 1 1 , 1 2 ,
1 4-23, 2 2 bis, 24-26, 29, 30, 77).
PARATO GIUSEPPE, rettore del convitto nazionale di Torino (64).
NARDUCCI ENRICO, bibliotecario della biblioteca alessandrina di Roma ( 1 2 ,
1 7 , 1 8 , 20, 2 2 , 24, 2 6, 27, 29, 30, 35-38, 40, 4 1 ).
no
NociTo GAETANO, r . provveditore agli studi della provincia di Girgenti.
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria:
( 1 873 nov. 2 3 e s . d . )
O (fase . 79)
OPERTI FRANCESCO, reggente nel r. ginnasio di Pinerolo ( 1 - 5 , 8- 1 1 , 1 8 , 2 2 ,
2 4 , 2 5 , 2 8 , 3 1 , 32, 3 5 , 3 8 , 40).
OSELLA BARTOLOMEO, professore di lettere nel r. ginnasio di Susa ( 1 , 2, 4, 5 ,
1 8, 2 0 , 2 3 , 2 4 , 26-28, 30- 3 2 , 38-40).
1 Lettera del 1 4 feb. 1 873 con la quale chiede di essere interrogato nelle sedute romane.
PARA VICINI TITO VESPASIANO, pro fessore di disegno nell ' istituto Dolci di Mila
(39).
PARDI CARMELO, Ad alcuni quesiti della comm issione d 'inchiesta per l 'i
struzione secondaria. Brevi risposte del prof Carmelo Pardi direttore del
r. ginnasio S. A n na, Palermo, tip. Francesco Giliberti, 1 87 5 .
PARENTI LUIGI, dottore, Modena ( 1 2- 1 4 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 7 , 3 0 , 3 3 , 36,
65, 7 2 , 77).
PARMA: i professori della facoltà di scienze, fisica, matematica della r. univer
sità degli studi ( 1 , 2, 9, 1 8 , 20, 22-28, 30, 3 1 , 3 3 , 34 , 36, 37, 39-45).
PASQUALE ANTONIO, professore di pedagogia e morale nella scuola normale
maschile pareggiata di Caserta ( 1 8, 1 9 , 2 2 - 2 5 , 28, 29, 5 2-6 1 ).
PASQUALIGO CRISTOFORO, professore nel r. liceo Marco Polo di Venezia (4 , 7 ,
8, 1 7 , 1 8 , 2 3-24 , 2 5 , 28).
PASSERI LUIGI, professore nel r. ginnasio di M istretta ( 1 -5 , 8- 1 1 , 1 8, 23-3 1 ,
3 5 , 36, 38, 40).
1 24
1 25
Fonti per la storia della scuola
PA VES! O PAOLO, professore di letteratura latina e greq nel r . liceo Torri celi i
di Faenza (2, 4 , 6, 1 0- 1 -t , 1 6 , 1 9 , 20, 2 3 , 24, 26, 2 7 , 29, 30: 3 2 , 36, 38-40).
PIAZZI
Pon te
PEGORARI LUIGI, professore di matematica e computisteria nelle scuola tecni
ca comunale di Gemona ( 1 1 , 1 7 , 1 9, 20, 24, 2 5 , 28, 30, 44, 46, 68).
36 , 38, -t O).
PEPE SALVATORE, economo segretario del r. liceo convitto T. Tasso di Saler
no, Idee dettate da non breve pratica su convitti nazionali delle province
napoletane, Salerno, tip. Migliaccio, 1 87 3 .
PEPOLI CARLO, senatore, Bologna
( 1 -77).
PERDOMI G IOVACCI I INO, provveditore onorario agli studi e rettore del convit
to nazionale di Sondrio (64-72).
Ali . : relazione sulla gestione del Convitto nazionale di Sondrio.
PEROGLIO CELESTINO, professore nel r. liceo Cavour e nella r . u niversità degli
studi di Tori no, Riproposta della fondazione di un istituto di compiuto in
segnamento geografico in Italia, estr . dalle Pubblicazioni del Circolo geo
grafico italiano, 3 o bimestre 1 87 2 (2 copie).
PEROGLIO CELESTINO, Dei meriti civili letterari ed artistici di Massimo D 'A
zeglio. Discorso letto alla presenza di S. A . R. il Principe di Carignano in
occasione della festa scolastica del 1 869 dal Cavaliere Celestino Peroglio
professore nel r. liceo Cavour e di geografia nella r. università, Torino,
tip . Bona, 1 869 .
PEROZZO G IOVAN NI, Torino
(2 1 ) .
ICOLA , professore ginnasiale e delegato scolastico mandamentale di
( 1 -3, 1 0, 1 4 , 17, 1 8, 20, 22, 2 5-30, 32, 35, 38, 40).
PICCO E ONORATO, professore nel r. ginnasio di San Remo
(5, 2 3-2 5 , 3 1 , 3 5 ,
PILI BoNIFACIO, professore di lettere nel r. ginnasio di Mistretta
1 8-20, 2 3 , 2 2 , 2 3 bis, 24-28, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 36, 38, 40).
PIROTTA FRANCESCO, maestro elementare i n una scuola femminile privata e
correttore tipografico di Milano ( 1 5 , 1 7 , 20, 2 2 , 2 2 bis, 2'l, 27, -t 1 , 4 3 , 46).
PISA : i professori della facoltà di lettere e filosofia della r. università degli
studi di Pisa ( 1 , 3 , 26, 3 2 , 36).
PISANI EMANLTELE, l probabili risultati di una inchiesta sugli esami liceali.
Studi pratici e voti all'innalzamento dell 'istruzione secondaria in Italia
per Emanuele Pisani professore di matematica nel r. ginnasio e nella r.
scuola tecnica di Modica (in occasione del VII Congresso pedagogico di Na
poli) , Modica, Mario La Porta, 1 870 1 •
PISANI EMANUELE, Le riforme nell 'istruzione primaria e secondaria subordi
nate all 'inchiesta ed al bilancio. Studi didattico-finanziari del professore
Emanuele Pisani, Modica, tip. Lutri e Secagno, 1 87 5 .
PoGGI ENRICO, senatore del regno, Pensieri di un padre di famiglia in re
plica dei quesiti sopra l 'istruzione secondaria , Firenze, tip. della Gazzetta
d ' Italia, 1 873 (2 copie).
POLESE PASQUALE, delegato scolastico mandamentale di Venosa
PERRAN DO GIOVAN BATTISTA, delegato scolastico del mandamento d i Sassello
(6, 9, 1 0 , 1 2 ,
26, 27, 36, 38).
( 1 4 ).
PONTREMOLI ANTONIO, direttore della r. scuola tecnica di Spezia
PERUGI A : i professori dell ' u niversità libera, Perugia, Risposte ai quesiti sul
l 'istruzione secondaria del regno fatte dalla commissione della libera uni
versità di Perugia e pubblicata per cura del mun icip io , Perugia, tip . V.
Santucci , 1 87 3 .
63, 68).
PESSINA LUIGI GABRIELE, professore della r . scuola normale maschile d i Messi
na ( 1 8) .
PETTENATI G . , professore del ginnasio comunale di Borgotaro
( 1 , 3 , 9, 1 0 ,
1 3-28, 30-4 1 , 4 3 , 44, 4 6 , 4 7 , 5 2-65 , 7 2 , 75).
PIACENZA: i professori delle scuole secondarie
(1-12, 14,
1 5 , 1 7-77).
PRAMPOLINI MARCHESI EMILIA, ispettrice scolastica di Roma
PROBJ ANTONIO
( 1 8-20, 2 2 , 59,
(23).
PROTO GIUSEPPE, direttore del r. ginnasio di Nuoro
( 1 , 2 , 4 , 5, 8- 1 1 , 18, 23-
26, 28, 35, 38, 40).
PucCJ SERAFINO, professore di letteratura italiana nel r. liceo Pellegrino Rossi
di Massa (2, 4 , 5 , 1 0- 1 2 , 1 4 , 1 7 , 1 8, 20, 2 1 , 2 3-28, 30, 3 2 , 37, 38, 40).
( 1 -77).
P IAZZA ARMERI A : i professori della r. scuola tecnica
2 4 , 25, 27 , 44, 46, 47, 49).
( 1 -5 , 8- 1 3 ,
(6-8, 1 0- 1 2 , 1 8, 20-22,
1 All ' interno dell'opuscolo foglio ms. : « Pensieri di un vecchio insegnant e » , e « L 'Av1•enire
economico » Il ( 1 875), 3 1 ott . , n. 30, 1 2 nov . , n. 3 1 .
1 26
Fonti per la storia della scuola
1 27
Inventario
RECCAGNI G. BATTISTA, preside del r. istituto tecnico professionale di Vicen
za ( 1 -6, 8- 1 1 , 1 8-28).
RENZETTI CAJO, Rimini (3 1 , 33).
busta
RICARDI DI NETRO ERNESTO, consigliere per le scuole della provincia di Tori
no (23).
12
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria:
( 1 873 lug . 29)
Q (fase . 8 1 )
QUADRI GAETANO, Mantova (38).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: R (fase .
( 1 873 mar. l - 1 873 lug. 1 6)
RICCA ALFONSO, professore nel ginnasio comunale pareggiato di Fano ( 1 , 3 7, 1 0 , 1 2- 1 4 , 1 7, 1 8 , 2 2 , 28-30, 3 2-34, 3 7 , 38, 4 0 , 64).
82)
RABBENO ARONNE, avvocato, Reggio Emilia (6, 7, 1 2-20, 2 1 -2 3 , 2 2 bis, 2427, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 40-42).
RAFFINO GIUSEPPE, direttore della r . scuola normale maschile di Urbino (5254, 56, 58-6 1 ) .
RAGAZZONI PIETRO, commissario distrettuale di Asolo ( 1 -6, 1 0- 1 2 , 1 5 , 1 7 ,
1 8 , 2 3-36, 38-40, 44, 47, 5 2 , 5 3 , 58-6 1 ).
RAMorNo
Ali . : Relazione fatta dal cavaliere Ernesto R icardi di Netro a l VI congresso
pedagogico italiano sui veri confini della ginnastica e del canto nelle
scuole popolari, estr. da « La Palestra » , V ( 1 869), 1 1 6, pp. 1 6.
G . BATTISTA, direttore della r. scuola normale femminile di Lucca.
RASPONI GIOACCHINO, facente funzioni di sindaco di Ravenna, La scuola nel
contado ravennate, Ravenna, tip. Nazionale, 1 87 3 .
RAULLI LUIGI, professore, Forlimpopoli ( 1 -5, 8- 1 1 , 1 8, 2 0 , 2 5-28, 3 0 , 3 3 , 3 4 ,
3 7 , 3 8 , 40-4 4 , 4 9 , 5 1 -5 5 , 57, 58, 60, 77).
RAVANO FRANCESCO, maestro di ginnastica nelle civiche scuole e nella r.
scuola normale femminile, direttore dell' istituto ginnastico medico, Rispo
sta al quesito 23 , in « La Ginnastica » , giornale della federazione ginnast ica
italiana, Genova, VII ( 1 873), 9, 1 5 maggio.
RAVIOLA GIUSEPPE, canonico, Torino ( 1 4 , 1 8).
REALE ANTONIO, Risposte di un padre di fam iglia a d alcuni tra i quesiti
della onorevole Commissione di inchiesta sulla istruzione secondaria, in
« Il Convegno », I ( 1 873), fase. V, pp. 409-424 , fase. VI, pp . 505-529.
REBECCHINI ALESSANDRO, direttore della r. scuola tecnica di Viterbo ( 1 8, 1 9,
2 3 , 44, 4 5 , 47 , 48).
RICCI VITTORE, direttore della r. scuola tecnica i n via Cappuccio di Milano
(2-4 , 6, 7, 1 0, I l , 1 3- 1 7 , 20, 4 3 -46, 50, 55).
RICHETTI CARLO EMANUELE, direttore r . scuola tecnica di Dora di Torino (2,
4 , 6, 9, 1 1 , 1 7 , 1 9, 2 1 , 24-28, 3 1 -3 4 , 38, 40, 4 3 , 44, 46-48, 5 2 , 55-57, 62,
64 , 67 , 7 1 , 73).
RIDOLA PIER ANTONIO, delegato scolastico mandamentale di Matera (29, 30).
RIEPPI A
Siracusa
TONIO, professore di lettere latine e greche nel r. liceo Gargallo di
(20, 3 2 , 36).
RODINI GIUSEPPE, professore, Napoli ( 1 8, 40).
RODINO' LEOPOLDO, professore e consigliere municipale in Napoli (2, 5 , 6, 9,
10, 1 2- 1 4, 1 8-20, 22, 24-32, 34-36, 38-4 1 , 4 3 , 47, 59, 64 , 65 , 67, 68, 7 1 ,
73, 76).
ROGLIANO LUIGI, direttore dell ' istituto convitto comunitativo d' istruzione
tecnica ginnasiale di Rende.
Ali . : Programma dell 'Istituto, a stampa.
o LUIGI, Poche cose in occasione degli esami pubblicamente dati
dagli alunni dell 'istituto con vitto in Rogliano diretto dal sacerdote Ro
gliano Luigi da Aprigliano anno scolastico 1 868- '69, Cosenza, tip . M unici
pale [ 1 869].
ROGLIA
ROGLIANO LUIGI , Profusione e risultati degli esami pubblicamente dati da
gli alunni dell 'istituto convitto Rogliano diretto in Rogliano dal saGerdote
Rogliano Luigi da Aprigliano anno scolastico 1 869- ' 70, Cosenza, t ip . Mu
nicipale, 1 870.
ROMA : i professori della facoltà medico-chirurgica dell 'università degli studi
di Roma (2, 5, 7 , 9, 23, 2 2 , 26, 30, 3 3 , 63, 69, 76, 77) ' .
1
Trasmessa con lettera del rertore dell' universirà degli srudi di Roma del
5 mag. 1 87 3 .
1 28
ROMA ELLI GIUSEPPE AGOSTINO, soprintendente alle scuole di
mino
( 1 , 2, 1 4 , 1 7 , 32, 34, 35, 37, 39).
1 29
In ventario
Fonti per la storia della scuola
Soriano del Ci
obbligatoria - lettera al deputato Zanardelli del professore A ntonio Salvo
ni regio provveditore agli studi in Bologna, Bologna, tip. G . Monti, 1 87 3 .
SANNA-PIGA GIOVANNI AGOSTINO, r . provveditore agli studi della provincia di
RONCALLI FRANCESCO, senatore del regno, Bergamo ( 1 , 3-8, 10, 1 1 , 1 3- 1 8,
20-28, 30-34, 36, 37, 39, 4 1 -44, 46-48, 52, 55, 60 , 64-69, 7 1 -73, 77).
Salerno
RosA FRANCESCO ANSELMO, direttore del ginnasio convitto privato G iambatti
SANTANGELO PAOLO,
RosELLI ERCOLE, Ancona, « Principi d i disegno axonometrici riferito ad un so
SAPORITI RINALDO,
professore di disegno nella scuola tecnica comunale di
SARTI 1 RAFFAELLO,
professore di disegno nella scuola tecnica comunale di
sta Vico di Vallata
( 1 -77).
lo asse. Studio di Ercole Roselli prof. di meccanica industriale nel l ' istituto
tecnico di Ancona >> , ms .
Rossi,
direttore di istituto privato di Torino
( 1 -9, 1 1 - 1 3 , 1 5 , 1 6, 1 8 , 1 9, 24,
lia
scuola normale maschile di Reggio Emi
( 1 , 4, 5, 1 0, 24, 52, 43, 54-56, 58, 59).
RosTEGHIN CARLO,
professore nel r. ginnasio di Modica
chimico e farmacista, Treviso
( 1 2- 1 4 , 1 6, 1 7 , 20, 2 2 , 2 3 ,
2 7 , 2 8 , 3 0 , 3 3 , 3 4 , 44-46, 4 8 , 59).
RoviGO: i professori del r. liceo ginnasiale Celio ( 1 - 1 1 , 1 3-37, 39-4 2).
RUINI GIUSEPPE, professore nel ginnasio comunale di Sassuolo ( 1 8).
( 1 -3, 5 , 8, 1 0 , 1 4 ,
18, 20, 2 3-2 5 , 3 2 , 3 5 , 36, 38, 40).
Lendinara
Terracina
(48).
( 1 , 3).
SARTINI VINCENZO, professore di fi losofia n e l r .
26, 45).
Rossi CoSTANTINO, direttore della r.
( 1-5, 8- 1 1 , 1 8, 1 9, 2 2-36, 38-42 , 47, 49-56, 58, 6 1 , 64, 66, 69, 75).
liceo Galilei di Pisa
(4 , 5 , 1 0,
1 4 , 1 7-20, 27, 3 2 , 34, 39).
SASSARI:
i professori della r. università degli studi ( l ,
2 0 , 2 2-2 6 , 2 8 , 30-44, 5 2 , 5 5 , 56 , 59).
SBROCCO NICOLA,
2, 4 , 5, 9, l O , 1 7 , 1 8 ,
direttore della scuola tecnica comunale di Isernia
(2, 3, 9,
1 2- 1 5 , 1 8, 23, 24, 26-29, 32, 35, 40, 4 1 , 4 3 -47).
SCAETTA VALERIO, dottore in diritto, Verona (40).
SCAFFI 1 GIUSEPPE, professore nel r. liceo Plana di Alessandria ( 1 -5, 7- 1 4, 1 729, 3 1 -48).
Risposte a i quesiti sulla istruzione secondaria: S (fase .
( 1 872 - 1 874 feb . 1 4)
83)
SACHERO CELESTINO, maggiore generale, comandante la scuola d ' applicazione
di artiglieria e genio in Torino
(24-30, 3 1 , 36, 38, 4 1 ) .
SALERNO: alunni della prima e seconda classe liceale, Salerno ( 1 8, 42).
SALERNO GIUSEPPE, delegato scolastico mandamentale di Santa Severina.
SALESI CANOBBIO FRANCESCO, rettore del r. collegio Carlo Alberto di Monca
lieri ( 1 ,
1 3 , 1 7 , 1 8, 2 6 , 29-3 1 , 36).
SALLIER FILOMENO, Torino (4 3 , 45, 46, 48).
SALOM )ONA SARA, direttrice e proprietaria di
di Venezia
un istituto convitto femminile
(79).
SALVATICO PIETRO, senatore del regno, Piacenza ( 1 -5 , 6 , 9, 1 0, 1 2- 2 5 , 27, 28,
30, 3 2 , 34 , 35, 37-48, 57, 60, 63-65, 68 , 7 1 , 72, 74, 76, 77).
SALVONI ANTONIO,
Sul progetto di legge Correnti-Scialoja per l 'istruzione
All . : « Piano d ' insegnamento nelle scuole secondarie proposto dal prof. Giu
seppe Scaffini ,, , foglio a stampa (2 copie).
SCALERO GIUSEPPE, professore del r. ginnasio di Chieri ( 1 7).
SCARDIGLI RAFFAELLO, professore di disegno nella r . scuola tecnica di Viterbo
(47).
SCARPELLINI FABBRI ERASMO, sopraintendente scolastiCO di Roma.
SCHIAVO ANGELO, professore, Vicenza ( 1 , 2, 1 2- 1 4 , 1 6- 1 8 , 27, 3 1 , 39, 5 2 , 5 3 ,
5 6 , 64 , 65 , 72).
SELVATICO ESTENSE PIETRO, Padova (48).
SERGENT ERNESTO, professore di aritmetica, geometria e scienze naturali nella
r. scuola normale femminile di Bari
SERGI GIUSEPPE,
(4).
professore di filosofia nel r. liceo Maurolico di Messina
(9,
3 6 , 40, 37, 17, 2 2 , 39, 1 8 , 32).
SERPIERI ALESSANDRO,
professore delle scuole pie , direttore del collegio Raf
faello di Urbino, Relazione sulle scuole del collegio Raffaello di Urbino
1 30
nell'anno accademico 1 8 70- ' 71 e studi e voti sulla buona istituzione dei
giovinetti con proposte di alcune riforme nell 'ordina mento dei licei. Di
scorso del prof Serpieri, Urbino, tip. del Metauro , 1 87 2 .
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: T (fase .
( 1 869 - 1 873 lug . s.g. )
SGARONJ EDOARDO, Delle difficoltà di salire a gradi superiori massime ne '
ginnasi, in « L ' Istitutore » , foglio ebdomadario d ' istruzione e degli atti uffi
ciali di essa, XXII, n. 6, 7 feb. ( 1 874), pp. 82-84 , n. 7 , 1 4 feb . ( 1 874), pp.
97- 1 00 .
SILVAGNI DAVID,
capo dell ' ufficio statistica presso i l Municipio d i Roma
(6,
1 3, 1 4 , 1 7, 20, 2 3 , 22, 27, 4 5 , 47, 62-64 , 66-68, 7 1 , 73-77).
SIOLA GIUSEPPE,
professore nel r . ginnasio di Novara
[ SIOTTO-PINTOR
GIOVANNI ] , La vita n uova ossia del rinnovamento delle isti
(2, 4-6, 1 0- 1 2 , 1 4 , 1 8,
2 2-26, 28, 29, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 40, 44).
tuzion i e degli ordinamenti dello Stato. VI. Rinnovamento della pubblica
istruzione, Tori no, L. Benf, 1 873.
SIRINGO BERNARDO,
1 0 , 1 2-4 1 ).
professore nel r . ginnasio-liceo Gargallo d i Siracusa
SISSA LUCIANO, professore di lettere latine e greche
di
Fermo (3 1 , 3 2 , 36).
(1-
nel r . liceo Annibal Caro
SOCIETA' PEDAGOGICA ITALIANA (2, 4, 5 , 1 3 , 1 4 , 1 7, 2 3 , 24-3 1 , 54, 56, 64 , 66,
72).
Ali . : « Patria e famiglia » , giornale dei congressi pedagogici compilato e diret
to da Giuseppe Sacchi a nome della Società pedagogica italiana, XIII ( 1 87 3),
fase . II, pp. 1 06- 1 2 3 .
SOCIETA' TREVIGIANA ( 1 -5 1 , 54-77).
SOLITRO VINCENZO, direttore della r . scuola normale femminile di Bari.
SOPRANI PERLETTI ALBINA, Firenze ( 1 8, 76).
SPALLICCI GIUSEPPE, r . ispettore scolastico di Palermo (5 2-58, 60, 6 1 ).
SPINEDI DOMENICO, professore di matematica nella r. scuola tecnica di Viter
bo
131
Inventario
Fonti per la storia della scuola
(47).
STEVANO LUIGI, procuratore capo di Casale (3 1 , 3 2).
STRUCCHJ GHERARDO, preside del r . liceo Spallanzani di Reggio Emilia ( 1 - 5 5 ,
62, 64 , 65, 68, 69, 76, 77).
SURLERA TERESA, direttrice dell' istituto delle dame inglesi di Vicenza (62 , 77,
75, 76, 72, 38, 52, 1 8, 38, 37, 40, 4 2 , 59, 23, 28, 49, 2 1 , 2 2 , 48, 68, 76, 77,
1 5 , 4 , 75).
T ACCANI L U I GI , professore nel collegio privato Ubicini di Pavia
TAJANI DOMENICO,
84)
(36).
delegato scolastico mandamentale di Vietri sul mare
( 1 0,
1 1 , 1 3 , 20, 26, 27, 34, 36, 4 4 , 62, 69, 72).
TAMBURI 1 STANISLAO, professore d i disegno nella r. scuola normale femmini
le di Roma (48).
TEDESCHI CARLO, professore, Milano.
TEDESCHI - RIZZONE MICHELE, deputato al Parlamento , Roma.
TERRENO GIOVANNI ANTONIO, professore del r. ginnasio Monviso di Torino,
Discorso del professore Giovanni A nton io Terreno nella solenne distribu
zione dei prem i agli allievi delle scuole liceali, ginnasiali e tecniche di To
rino, Torino, tip . Subalpina Marino e Gautin, 1 87 3 .
TESTA FELICE,
delegato scolastico mandamentale d i Torchiara
( 1 2, 1 4 , 2 7 ,
36, 4 0 , 68).
TESTA MICHELANGELO, Delle scuole tecniche e de/ loro necessario compimen
to per Michelangelo Testa , Salerno
1 87 3 .
TODI : i professori della scuola tecnica comunale, Todi
TOMATIS MICHELE,
( 1 0, 1 1 , 47).
rettore del r. convitto nazionale Longone di Milano
(64 ,
65 , 67-69, 72).
TOMMASINI ORESTE,
direttore della scuola tecnica di Pietrasanta ( 1 -4 ,
8- 1 O ,
1 9 , 20, 24, 28, 4 3 , 47).
TOMMASSONI ALCIDE, delegato scolastico mandamentale di Predappio.
ToNELLI MOSE', professore di disegno, Treviso (648, 757).
TORINO: i professori del r . liceo e ginnasio Cavour ( 1 7-4 2).
TORINO: L 'istruzione femminile i n Torino dall 'anno 1 848 all'anno
Monografia pubblicata per cura del municipio, Torino, tip. Botta,
TORINO:
1 8 73.
1 87 3 .
Istruzioni per il governo della scuola femminile superiore della
città di Torino e programmi d 'insegnamento approvati dalla Commissio
ne permanente d 'istruzione pubblica mun icipale nella seduta del 20 otto
bre 1 869, Torino, tip. Botta, 1 869 .
1 32
1 33
Fonti per la storia della scuola
Inventario
1 , direttore del ginnasio pareggiato di Sarzana ( 1 , 2 , 4 , 7 , 8 ,
1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8, 20, 2 3 - 3 1 , 3 4 , 3 5 , 3 9 , 4 1 , 4 4 , 64 , 65).
VECCHIO ANGELO, professore di matematica presso la r. scuola tecnica di Pa
via ( 1 -5 , 8, 30, 3 2-38, 40, 4 1 , 4 3-4 6, 48-50, 5 2 - 5 4 , 5 6-59, 6 2 , 64 , 6 5 , 7 1 ) .
TORRE GIOVAN
TRABOCCHI GIUSEPPE,
presidente del r . tribunale civile e correzionale di Ve
rona ( 1 , 4-8, 1 0 , I l , 1 4-24 , 26-3 1 , 3 3 , 3 5 -40) .
TRIGONA FILIPPO,
professore incaricato di fisica nella r. scuola tecnica di
Piazza Armerina (24, 44, 46).
TRIZZINO FRANCESCO, direttore del r. ginnasio di Bivona ( 1 ,
2, 4, 8 , 9 , 1 8 , 24 ,
3 5 , 3 7 , 38).
TROMBACCO RAFFAELE, professore, Candela ( 1 ).
TROMBONE FORTUNATO, ( 1 , 2 , 4 , 5 , 8- 1 0, 1 8, 24 ,
26, 3 1 , 3 2 , 38).
Al l . : Question i letterarie per Fortunato Trombone dott. in lettere inse
gnante preside nel r. liceo Monti, Cesena, tip. Nazionale 1 87 2 , e « Il Nuovo
istituto re » , IV ( 1 872), nn. 9 e 1 0, con l ' articolo La questione proposta dal
Rodinò.
VEGEZZI MARCO,
professore di calligrafia e stenografia, padre di famiglia,
Bergamo .
VELLETRI :
i professori della scuola normale e magistrale, Velletri ( 1 -5 , 7- 1 5 ,
1 8- 2 3 , 22 bis , 2 3 bis, 3 1 , 3 5 -4 1 , 4 3 , 4 4 , 54-63, 64-66, 75-79).
VENEZIA: i professori della r . scuola tecnica di S. Stin .
VENEZIA: professori delle r. scuole tecniche (2-5 , 9,
1 0 , 1 8 , 2 2 , 24-27, 29,
30, 36, 37, 45, 48-5 1 ) .
VENIALJ FRANCESCO, direttore generale municipale di
Mantova, Richiesta sul
l 'istruzione secondaria, in « Nuovo educatore » , II ( 1 872), 2 1 , pp. 3 3 5 - 3 3 8 .
VENTURELLJ CARLO, direttore del proprio istituto d ' educazione e d' istruzione
a Firenze ( 1 , 3-6, 8 1 3 , 1 5 - 3 2 , 3 5 , 3 7 , 4 5 , 4 7 , 5 2 , 5 3 , 59-6 1 , 6 3 , 77).
All . : « Ai padri primi educatori ed alle madri prime educatrici » , ms.
busta 1 3
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria:
( 1 87 3 g i u . 1 8)
U (fase . 8 5 )
UDINE: i professori del r. liceo e r. ginnasio ( 1 , 2 , 4 - 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8- 2 3 , 2 2
bis, 2 3 bis, 24-4 2 , 44).
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: V (fase . 86)
( 1 873 gen . 1 5 - 1 874 ott. 2 3 )
VALDARNINI ANGELO, professore nel r. liceo Leopardi di Macerata (2, 4 , 5 ) .
Al l . : L 'insegnamento della filosofia negli istituti secondari classici e scien
tifici, estr. da « La Scuola » , II [ 1 87 3 ] , fase. V, sem . I .
VETTORUZZO ARTEMIO, vice-presidente del comizio agrario di Asolo ( 1 2) .
VIADANA: i professori della scuola tecnica pareggiata, Viadana (45-48).
VICENTJNJ APOLLO, segretario del comitato provinciale di Treviso della Asso
ciazione medica italiana, Studi e considerazion i sull 'insegnamento dell 'i
giene pratica popolare nelle scuole, in « Associazione medica italiana, Co
mitato provinciale di Treviso •• , bollettino n . 2 , pp. 1 6-29 ' .
VICENZA: il Consiglio provinciale scolastico.
VICENZA: i professori della r. scuola tecnica (43-55).
VINCENTI GIULIANO, direttore della scuola tecnica commerciale comunale di
Pescia ( 1 -4 , 8- 1 0 , 1 2 , 1 8 , 2 3 , 27, 28, 4 3-50).
VISENTINI ISAIA, professore reggente nel ginnasio Virgilio di Mantova ( l ,
VALSECCHJ GIACOMO, direttore spirituale della r . scuola tecnica d i Alessandria
VITALI VITALIANO,
VANZO LUIGI,
VOLPE ANGELO, rettore del convitto comunale Canova di Treviso .
( 1 7) .
direttore del ginnasio tecnico comu nale G iorgione di Castel
franco Veneto ( 1 , 3-9, 1 1 - 1 4 , 1 6- 2 3 , 26- 3 2 , 34-44 , 46-4 9 , 64-66, 68).
VATTA ANTONIO,
26, 4 0 , 4 4 , 47).
professore nella r . scuola nautica di Chioggia ( 1 2 , 1 8 , 24,
2, 4,
5 , 8 , 1 0 , 1 1 , 1 4 , 1 7-24, 28, 3 1 -3 4 , 38).
professore nella scuola secondaria di Forlì ( 1 , 2 ,_ 1 0 , 1 2 1 4 , 1 7 , 1 8 , 2 1 , 24-3 3 , 3 5 , 4 1 ) .
' Vi è unito opuscolo con recensione del libro
A.
VICENTINI, Igiene popolare e medicina
igienica alimentare. Studi di Apollo Vicentini, Treviso 1 87 1 .
1 34
Fonti per la storia detlc1 scuola
Risposte ai quesiti sulla istruzione secondaria: Z (fase. 87)
( 1 87 3 mar. 1 - 1 87 3 giu. s.g. e s . d .)
ZACCARIA ANTONIO,
professore nel r. ginnasio di Vercelli (4- 1 3 , 1 7-20, 24,
26-29, 3 1 , 3 2 , 3 5 , 36, 3 9 , 40, 4 7 , 55, 59, 60).
ZANETTI PIETRO,
Ivrea ( 1 , 6-8, 1 0 , 1 2- 1 4 , 1 7 , 1 8 , 20- 2 2 , 24-26, 29, 30, 3 5 38, 4 1 , 4 2 , 4 5 -47, 5 5 , 59, 6 1 -6 3 , 6 6 , 67 , 69-7 1 , 7 3 ) .
ZANI PAOLO,
professore di francese e contabilità nella scuola tecnica com
merciale di Salò ( 1 8, 20, 2 3 - 2 5 , 4 3 , 4 4 , 5 5 ).
ZANNETTI ARTURO,
professore di scienze naturali nella scuola tecnica comu
nale Dante e aiuto nel m useo di antropologia di Firenze (4 , 5, 9 , 1 1 , 1 4 , 1 8 ,
2 3 , 24 , 2 7 , 28, 3 2 , 3 4 , 36, 39, 40, 4 2 , 4 7 , 49, 5 2 , 5 5 , 60, 64).
ZANOLINI CARLO,
direttore della scuola tecnica pareggiata di Bologna ( 1 - 1 5 ,
1 8- 3 0 , 4 3-49) .
ZICHICHI ANTONIO, maestro elementare privato di Trapani ( 1 -3 , 5 , 1 7-2 1 , 2 2
b � , 2 3 b�, 2 4 , 26, 28, 3 0 , 3 3 , 3 5 , 36, 4 3 , 44, 4 7 , 5 2 , 5 3 , 5 5) .
ZOLA BARTOLOMEO,
Brescia ( 1 -4 3 , 46-48, 5 2 , 5 3 , 5 5 , 57-6 1 , 6 3 , 64 , 7 2 , 7 4 ,
78) .
Anonimo: « Risposte ai quesiti della Commissione d ' i nchiesta sull ' istruzione
secondaria maschile e femminile n .
NOTA METODOLOGICA
La scelta dei testi
La raccolta di documenti che si è predisposta si sviluppa in quattro sezio
ni. Nella prima sezione sono pubblicati i più significativi testi legislativi e
normativi che stanno a fondamento dell 'attività della commissione , alcune
testimonianze della sua vita interna (per esempio il carteggio tra il ministro
e il presidente Cantelli), che mostrano anche le difficoltà cui essa è andata
incontro nel suo operare, e la breve relazione di una ispezione compiuta i n
Campania i n alcu ne scuole da Cremona e Settembrini. Questo momento
ispettivo era previsto esplicitamente dalla legge istitutiva (art . 2/d) e sarà più
volte ma invano sollecitato da Scialoja che, deluso dallo scarso frutto delle
deposizioni orali, tentava di convincere la commissione a rendersi conto de
visu della condizioni degli istituti 1 • I n realtà la commissione lasciò ben pre
sto cadere nel nulla l' invito: lavorava per lo più a ranghi ridotti e non era
perciò possibile che si dividesse i n due parti, l ' una impegnata ad ascoltare le
deposizioni, l 'altra ad ispezionare. Anche le scarse risorse finanziarie (lo
stanziamento previsto per i lavori della commissione si era già esaurito nel
maggio del 1 873 e non era facile reperire nuovi fondi) non consentivano di
prolungare, a fin i ispettivi, le soste nelle varie città. I nfine non era molto
congruo con i sentimenti che emergevano dalle audizioni, di forte critica al
le ispezioni dei notabili mandati dal ministero, andare in giro a visitare le
scuole . I n sostanza si decise di adagiarsi nella routine delle sole audizioni ,
lasciando aperto a l mondo della scuola l o sfogo delle risposte scritte che di
norma erano inviate al ministero e che probabilmente gran parte dei com
missari non lesse mai. Questa linea di impegno molto relativo trova infine
conferma nel fatto che fu anche completamente disatteso il compito di rac
cogliere con lettere circolari dati statistici (art . 2/c). Era un impegno che non
aveva molto senso : la Commissione non aveva i supporti necessari a ciò e
avrebbe potuto fornire dati parziali, mentre ogni anno i prefetti presidenti
dei Consigli scolastici provinciali mettevano a disposizione del ministero
tutti i dati in questione. Si spiega dunque la rinuncia a operare in questa di
rezione e il fatto che nelle buste dell' inchiesta non c ' è alcun documento sta
tistico ma solo, saltuariamente, nelle deposizioni d i prefetti a provveditori,
qualche indicazione sul numero degli studenti nelle scuole della provincia.
1 La pressione di Scialoja sulla Commissione perché nei suoi viaggi si dedicasse a ispezioni
era tanto più forte in quanto la spesa per le normali ispezioni era stata ridotta nel bilancio della
pubblica istruzione in previsione del fatto che nel corso dell'inchiesta i commissari avrebbero
soddisfatto questa esigenza e ispezionato molte scuole.
1 38
Maggiori problemi sono sorti per l ' organizzazione della seconda (deposi
zioni orali) e della terza sezione (risposte scritte), dato il numero e l'ampiez
za dei testi da selezionare , che costituiscono il cuore dell ' i nchiesta. Qui la
scelta non è stata semplice , poiché le esigenze editoriali hanno consentito
di riprodurre non più del cinque per cento del materiale conservato nelle
bust e . Si sono dovuti sacrificare pertanto personaggi anche illustri , come
per esempio Cesare Cantù, Giulio Carcano , Paolo Emilio Imbriani, Enrico
Panzacchi, Pio Rajna . Per le già citate esigenze di spazio alcune deposizioni
e risposte sono state pubblicate solo parzialmente, segnalando ad locum le
lacune. I n altri casi si è dovuto rinunciare ai testi di personaggi minori o
anche oscu ri, le cui proposte però , per la loro originalità a volte stravagan
te, si staccano dal consueto e spesso monotono cliché della maggior parte
dei testi. Si pensa, per fare qualche esempio, al caso di Nicola Magliulo ,
che tramite le autorità consolari invia da Bona in Tunisia (è l ' u nico testo di
u n italiano all' estero) u n manoscritto piuttosto lungo e verboso con cui
propone un progetto di scuola del tutto lontano dai modelli correnti, u n
collegio residenziale u n i c o con u na gamma molteplice di libere opzioni
culturali e professionali . L ' elemento caratterizzante è dato dalla carica u to
pistica e ideologica che lo connota, costituendolo a l aboratorio del futuro,
col suo internazionalismo pacifista, con un anticleralismo quasi mistico e
con la forte rivendicazione dei diritti civili e culturali della donna; e que
st' ultimo elemento fa premio su tutto il resto se bizzarramente Magliulo, co
sì ostile alla Chiesa romana, propone che nella scuola sia solennemente cele
brata l ' Immacolata Concezione, simbolo che esalta il principio femminile.
Altrettanto particolare la deposizione di Alfonso Cerquetti, professore a For
lì, in quell' isola di tenace purismo che era la Romagna, che non d'altro si
preoccupa che di denunciare i barbarismi e i francesismi intollerabili che co
stellano la prosa dei quesiti proposti dalla Commissione: testimonianza pate
tica della resistenza che la vecchia cultura opponeva alla riforma manzonia
na 1 • Si ricorda infine la risposta di don Tomasino Christ , sacerdote e precet
tore nel Friuli, tutt ' altro che incolto dal momento che era vissuto per diver
si anni a Vienna come insegnante nel prestigioso Collegio orientale, ma so
prattutto testimone di un piccolo mondo ant ico in via di estinzione che
stentava a misurarsi con la complessa organizzazione scolastica dell ' I talia
unita.
Per le stesse ragioni è stata sacrificata tutta una serie di temi relativamen
te secondari e che tuttavia hanno trovato nel corso dell ' i nchiesta una viva
eco in molte risposte e in polemiche anche accese. Ci si riferisce, per esem
pio, a quella parte del quesito 20 ove si propone l ' alternativa tra le vacanze
1 La deposizione di Cerquetti è sostanzialmente riprodotta nella fan.faniana « Unità della lin
gua », IV ( 1 87 3 ) , 9, pp. 1 29- 1 3 5 .
1 39
Nota metodologica
Fonti per la storia della scuola
estive e quelle autunnali; queste ultime erano la tradizione ancora vigente:
l ' an no scolastico si apriva ai primi di novembre per chiudersi ad agosto.
L' inchiesta Scialoja ci presenta nella varietà delle risposte su questo tema
u na tendenza conservatrice e una innovativa. La prima t iene conto della
consuetudine di molte famiglie benestanti di trascorrere l ' autunno in villa,
donde, secondo la risposta scritta di Pasqualigo, non si ritornava in città pri
ma dell'estate di San Martino . Altre famiglie avevano fuori della città u na vi
gna e perciò soggiornavano in campagna per tutto il tempo della vendem
mia, che per i figli era insieme occasione d i lavoro e di festa. G li innovatori
che proponevano di anticipare le vacanze nei mesi più caldi avevano l 'ap
poggio di medici ed igienisti, preoccupati per gli alunni, costretti a studiare
e a sostenere gli esami nella canicola con pregiudizio della loro salute. A co
storo si affiancavano quanti propugnavano la recente moda dei bagni mari
ni. Tra le due tesi opposte finisce per prevalere numericamente una ipotesi
conciliativa. In considerazione delle diversità di clima e di consuetudini so
ciali nella lunga penisola si propone di delegare le scelte di calendario ai
Consigli scolastici provinciali : una via difficilmente praticabile in u n ordina
mento molto accentrato come quello della scuola italiana. Bisognerà atten
dere gli anni Ottanta e u n ministro medico come Guido Baccelli perché le
ragioni dell'igiene prevalessero sulle tradizioni, non senza che ancor oggi re
sti un loro residuo, più di un secolo dopo Baccelli, nel modo di definire l ' a
lunno che ripara come « rimandato a ottobre » . In casi come questo l ' esame
delle varie risposte consente di seguire il lento evolversi dei costumi sociali
e anche la loro trama geografica con le differenze tra Nord e Sud, tra grandi
città, piccoli centri e campagna.
Analoghe considerazioni si possono fare per u n altro tema che si è dovu
to quasi del tutto sacrificare, quello della ginnastica (quesito 23) 1 Non pochi
1 L ' ostilità dei padri di famiglia nei confronti di essa doveva essere forte specie nelle scuole
femminili, se, come informa Baumann in « La Ginnastica • , VII ( 1 873), 8 (ACS,
Div. scuole
medie, 1860-1 896, b. 9, fase. 67), una circolare ministeriale, anche per « l ' avversione delle si
gnore ispettric i » , ne a\·eva sospeso l' insegnamento, trovandola disadatta e sconveniente per le
future maestre. La polemica sul tema è presente soprattutto a Venezia in riferimento sia alla
scuola normale femminile che agli educandati, per esempio nella deposizione di Jona (ibid. , b.
7, fase. 50), che giudica tutta l ' infatuazione per l'educazione fisica negativamente, quasi • un ri
!Orno presso i tempi barbari » e in particolare giudica sconcia quella femminile « COi salti, colle
gambe portate ad angolo retto » , e innaturale la donna atletica colle « braccia eccessivamente lO
rose e le polpe sviluppate » .
sempre a Venezia, il professar Tamburlini (ibid. , b. 9 , fase. 4 9)
del liceo Foscarini confessa di non poter soffrire « questo saltare, questo mettere a basso i l velo
del pudore » . Di fronte a un così vasto coro di oppositori veneziani offre un quadro diverso il
torinese Ricardi di Netro, che nella sua relazione al congresso pedagogico di Torino aveva regi
strato t u tti i consensi ottenuti dalla ginnastica femminile " persino nelle istituzioni monacali .
(ibid. , b . 1 2 , fase. 82), e a Venezia il marchese di Savorgnan (ibid. , b. 9 , fase. 50) che contro le
bigotte paure osserva cbe • il pudore sta ben più addentro che nell ' alzare una gamba . e conclu
de dicendo che del resto le allieve potrebbero benissimo mettersi i pantaloni. La questione del
la ginnastica maschile s i inscrive invece a pieno titolo , per la grande maggioranza delle rispo
�te, in un programma di rigenerazione morale (come afferma Beni « Cont ribuisce ad impedire
MPI,
E,
hO
141
Fonti per la storia clelia scuola
Nota metoc/ologica
mettono in guardia dalla moderna infatuazione per la ginnastica, ponendo
l'accento sui pericoli che ne vengono per l ' i ncolumità fisica degli allievi, su
gli aspetti talora funamboleschi e indecorosi degli esercizi proposti e soprat
tutto sui rischi che la diffusione della ginnastica anche nelle scuole femmini
li comportava attentando al contegno e al pudore delle a llieve. Sull'altro
fronte sono schierati quanti (come Allievi o Marselli, dei quali si riportano le
deposizioni, nella parte relativa alla ginnastica) vedevano nelle pratiche gin
nastiche u n salutare antidoto alla pigrizia e alla fiacchezza nazionale, un ele
mento decisivo per la formazione del carattere; costoro erano confortati
nella loro polemica apologia della ginnastica non solo dal modello suggerito
dalle pratiche sportive dei colleges inglesi, ma anche e soprattutto dai per
duranti echi delle vittorie militari prussiane, fatte dipendere per tanta parte
dal Turn vater )ahn e dal patriottismo paramilitare delle diffusissime società
ginnastiche. E ciò spiega come oltre che sugli aspetti igienici delle attività di
palestra si insistesse molto sulle esigenze pre - e paramilitari (tiro al bersa
glio, scherma, equitazione). Senonché tutti questi auspici si scontravano con
l'assenza quasi totale di palestre e di campi da gioco, su cui non poche ri
sposte all' inchiesta insistono e che neanche più tardi la battaglia desanctisia
na del 1 878 varrà a superare.
Per dare un senso alla scelta operata si sono seguiti , senza schematismi
rigidi, alcuni criteri di massima. In primo luogo, si è cercato di rappresenta
re la variegata geografia scolastica del paese: abbiamo già notato come più
di dieci anni dopo l ' Unità fossero ancora evidenti le tracce del diverso co
stume educativo delle varie regioni e le risposte all' inchiesta lo confermano.
Poiché le sedute pubbliche per le deposizioni orali non si sono spinte sotto
Salerno, per dare una qualche idea dei pareri del più profondo Mezzogior
no, si è compensata questa lacuna con alcune risposte scritte.
I n secondo luogo si è tentato di rispecchiare la varia tipologia sociale e
funzionale degli interlocutori della commissione: autorità e notabili del
mondo politico (deputati, senatori, prefetti) e del mondo accademico, diri
genti scolastici (provveditori, presidi) e poi i professori medi nella loro
grande varietà fatta di insegnanti pubblici e privati , di vecchi retori e di nor
malisti, di preti liberali e di preti infallibilisti , d i preti spretati ; infine c'è la
presenza, inferiore alle aspettative ma pur sempre significativa, dei padri di
famiglia. A questo proposito u na costante che emerge dalle carte del l ' inchie
sta è la conflittualità fra le famiglie e i professori. Giacché spesso nei loro in
terventi (soprattutto nelle risposte scritte ove le timidità sono minori) i pa
dri criticano duramente gli insegnanti, accusandoli di essere esosi nelle loro
pretese e spesso anche di essere immorali e materialisti. I professori veçlono
perciò sempre più nell' inchiesta quasi un processo alla loro categoria, già
così umiliata nel trattamento economico e nella considerazione sociale.
Quasi passando alla controffensiva si lamentano delle famiglie, le accusano
di disinteressarsi del tutto dell'educazione dei figli, di puntare solo al titolo
di studio, da ottenere con qualsiasi mezzo; e a questa gretta aspettativa di ra
pida sistemazione per i propri figli fanno anche risalire la crescente prefe
renza per le scuole private e clericali che promettevano (specie a Napoli)
studi più facili e corsi abbreviati. Di fronte all' accusa dei padri di famiglia
che i professori non sanno educare, quando non siano esplicitamente dise
ducatoci, questi ribattono individuando proprio nella famiglia il punto più
debole per la formazione civile e intellettuale dei giovani .
Sono scarsamente presenti nell'inchiesta donne e studenti, ed è naturale,
ove si consideri quale barriera di timidità e di pudore sconsigliasse allora un
giovane e una donna di rivolgersi a u na così autorevole commissione anche
per iscritto e soprattutto di parlare in pubblico 1• Proprio perciò, per l ' ecce
zionalità significativa di questi casi, si sono riportate le deposizioni di Laura
Veruda Goretti, tra le prime promotrici dell' istruzione professionale femmi
nile, e quella dello studente Antonio Alfredo Comandini, che si fa interprete
dell ' anticlericalismo deista, tutto romagnolo, dei suoi compagni di classe:
un documento rivelatore di una vocazione precoce, se si pensa che Coman
dini un anno dopo sarà tra gli arrestati di Villa Ruffo e avrà poi un ruolo non
secondario nella politica e nel giornalismo dei decenni successivi.
Si sarebbe infine desiderato rispondere a u na u ltima esigenza essenziale,
quella di offrire attraverso la scelta dei testi un quadro esauriente delle que
stioni di politica scolastica emerse nel corso dell' inchiesta. Si è mostrato più
sopra come abbiamo dovuto rinunciare a rappresentare alcune questioni re
lativamente secondarie (le vacanze, la ginnastica). Purtroppo sono stati ne
cessari sacrifici anche più gravi: si pensa a tutta la tematica sulla scuola tec
nica e ai suoi rapporti da un lato con gli istituti tecnici (con il nodo connes
so della conflittualità tra il Ministero della pubblica istruzione e quello del
l'agricoltura industria e commercio 2, che proprio in quel periodo si mani
festa non solo nel corso dell' inchiesta, ma anche per esempio nella pole-
che vadano a sciupare loro denari cacciandosi in qualche taverna ibid., b. 9 fase. 47) e so
prattutto in un programma di educazione patriottica e militare. Su tutto il tema della ginnasti
ca, vedi ora il ricco lavoro di G. BONETTA, Corpo e nazione, Milano, Angeli, 1 992, ove però mi
sembrano non adeguatamente considerati i problemi della ginnastica femminile, e P. FERRARA,
L 'Italia in palestra, Roma, La Meridiana Editori, 1 992.
•:
Si noti per esempio che al Congresso pedagogico di Torino del 1 869 una delle più stimate
donne subalpine, Giulia Molino Colombini, relatrice su uno dei temi proposti, faceva, per pu
dore, leggere da altri la sua relazione giudicando sconveniente che una donna parlasse in pub
blico.
Tale conflittualità era vissuta non solo nelle sedi ministeriali ma anche nella periferia. Ri
corda G. FINAU, Memorie . . cit., p. 330, che nelle sue peregrinazioni la Commissione in una lo
calità ove il ginnasio liceo e l'istituto tecnico convivevano in uno stesso edificio, divisi solo da
una porta, trovò davanti a quella porta le guardie, chiamate dal direttore dell'istituto tecnico,
per impedire che i commissari del ministero nemico accampassero pretese ispettive fuori delle
loro competenze.
1
2
.
142
1 43
Fonti per la storia della scuola
Nota metodologica
mica tra Villari e Luzzatti sulla « Nuova Antologia »), dall' altro con i ginnasi
inferiori (con la proposta, ancora maggioritaria nell' inchiesta, di una fusione
tra le due scuole e di un ritardo nella biforcazione) 1 • Ci si riferisce ancora al
la scuola normale (e al difficile problema del reclutamento dei maestri e del
le maestre soprattutto per le campagne, ancora tenacemente analfabete,
scarsamente « nazionali >> quando non nostalgiche degli antichi regimi e co
munque dipendenti dagli orientamenti parrocchiali) 2 , o alle scuole superiori
femminili o ai convitti ed educandati, istituzioni in quegli anni ancora assai
importanti: esse tra l ' altro costituivano uno dei principali terreni di scontro
tra la tradizione dei seminari e dei collegi ecclesiastici e l ' ambizione del gio
vane Stato nazionale di offrire alle famiglie una alternativa moderna a quella
tradizione: una ambizione che alla lettura delle deposizioni e delle risposte
rivela un bilancio fallimentare 1• Questo elenco impietoso, anche se parziale,
delle manchevolezze del presente lavoro vuole essere non tanto una richie
sta di indulgenza ai lettori, quanto piuttosto u na segnalazione e u no stimolo
per gli studiosi perché, anche con l' aiuto dell' inventario analitico delle carte
dell ' inchiesta che viene offerto, affrontino queste questioni, nei loro aspetti
politici, culturali e sociali.
Certo un metodo c ' era per coprire tutta la tematica del l ' i nchiesta, quello
di andare sulle orme di Folli e Casetti che avevano impostato il loro lavoro
seguendo passo passo ogni quesito con gli excerpta delle risposte più signifi
cative e dei pareri emersi. Questo metodo rispondeva bene allora alle esi
genze dell ' amministrazione che in tal modo, per i propri progetti di riforma,
veniva a disporre di un inventario e di una quantificazione delle idee cor
renti, ma non risponde oggi alle esigenze di una ricerca storica. Seguire le
orme di Folli e Casetti avrebbe poi significato cancellare i volti e gli umori
degli uomini in carne ed ossa che, protagonisti o comparse che fossero, dan
no vita nelle carte dell' inchiesta a u n dibattito concreto e non a u na astratta
elencazione di terapie per il grande malato che era la scuola secondaria.
' La questione della unificazione del corso triennale inferiore del ginnasio e della scuola
tecnica era stata avanzata nella pubblicistica torinese già prima della legge Casati, in particolare
da Giovanni Maria Bertini, che la ribadirà con particolare vigore nella relazione del 1 864 del
Consiglio superiore sull'istruzione secondaria (cfr. G. TALAMO, La scuola dalla legge Casati al
la inchiesta del 1864, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 290-325 e in particolare pp. 301-304). Si noti
che Bertini in occasione della inchiesta Scialoja manifesterà viceversa una forte riserva nei con
fronti di ogni proposta di ritardo della biforcazione tra scuola tecnica e gmnasio inferiore,
preoccupato dei guasti che avrebbe prodotto un ritardo negli inizi dello studio del latino. La
proposta di unificare i corsi inferiori delle due scuole aveva innanzitutto una motivazione poli
tico-pedagogica, quella cioè di consentire una più ponderata scelta di indirizzo ai giovani e alle
famiglie (a 14 anziché a 1 1 anni); ma giocavano altresì altri fattori: la coscienza della insuffi
cienza e inadeguatezza del corso elementare e la conseguente opportunità di rendere più ampi i
fondamenti di cultura generale, prima di avviarsi a studi classici o tecnici; la situazione dei pic
coli centri che avevano difficoltà soprattutto d'ordine finanziario a istituire due scuole distinte
soddisfacendo sia le esigenze dei notabili col ginnasio, sia quelle delle minores gentes con la
scuola tecnica. Per tutti questi motivi più volte negli anni Sessanta furono avanzate da Coppino
e da altri proposte (che mai però giunsero a uno sbocco legislativo) per l'unificazione delle due
scuole; ed è significativo che nell'inchiesta Scialoja consentano con essa anche esponenti con
servatori se non reazionari, come Cesare Cantù (ACS, MPI, Div. scuole medie, 1860-1 896, b. 6
bis, fase. 43) e " La Civiltà cattolica » (ibid., b. 9, fase. 68), anche se poi la realizzazione della
scuola unificata vede i suoi sostenitori assai divisi sui modi culturali dell'intervento legislativo:
p.es. col latino o senza latino? Ed è da ricordare che il dibattito su questa questione si ripeterà
un secolo dopo (p.es. tra Marchesini e Banfi) e in tutta la discussione che dalla bottaiana Carta
della scuola porterà alla creazione nel 1959 della scuola media unica e al successivo dibattito
del 1977. Non sarebbe infine privo di interesse cercare di capire le ragioni per cui in questa
lunga vicenda, negli ultimi decenni dell'Ottocento, si assiste a un ripiegamento verso una posi
zione di strenua difesa della peculiarità irrinunciabile della scuola classica: valga ad esempio il
confronto tra la posizione assunta dal Consiglio superiore con la relazione Bertini nel 1 864-'65
e quella, rigidamente classicista, assunta nel febbraio 1898 dallo stesso organo. Vedi in proposi
to ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fonti per la storia della scuola, Il, Il Consiglio superiore
della pubblica istruzione 1847- 1 928, a cura di G. CIAMPI e C. SANTANGELI, Roma, Ministero per
i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1 994, pp. 1 54-1 77.
Nelle risposte ai quesiti sulle scuole normali e magistrali (quesiti 52 - 61) ha notevole spa
zio la questione della formazione dei maestri e soprattutto delle maestre per le scuole della
campagna: non solo perché nelle campagne era più tenace la resistenza dell'analfabetismo ma
anche perché la popolazione delle campagne era la più sorda al sentimento nazionale, la più
sensibile all'influenza dei parroci. Il sindaco di Ravenna e deputato Gioacchino Rasponi riporta
(ACS, MPl, Dill. scuole medie, 1860- 1 896, b. 1 2, fase. 82) con plauso l'osservazione di un mae
stro romagnolo, Tito Miserocchi, secondo il quale il campagnolo "si può dir che non ha vita ci
vile. Poco a lui importa di essere suddito di uno piuttosto che di un altro governo: esso gli è
sempre avverso, non per concezioni politiche ma per erronee questioni economiche ... ed una
prova di ciò l'abbiamo nel non avere la campagna che molto debolmente prestato volontario il
suo braccio nelle nostre guerre d'indipendenza" · Da questa profonda lontananza del mondo ru
rale dalla nuova realtà istituzionale e dai progetti formativi delle classi dirigenti, ben visibile an2
che nei Documenti sull'istruzione primaria pubblicati dal ministero tra il 1868 e il 1872, deri
vano per esempio sia la renitenza dei diplomati maestri di estrazione cittadina di accettare una
destinazione in campagna, sia la grande preoccupazione presente in molte deposizioni (si veda
per esempio quella di Filippo Airoli a Firenze, ibid. , b. 6, fase. 39) di individuare il più pruden
te itinerario formativo per la maestra rurale, tale che e nella sua cultura e nel suo modo di ve
stire e eli atteggiarsi non offendesse le tradizioni del mondo contadino educandolo sia a un pur
modesto traguardo culturale e a un sia pur passivo consenso alle istituzioni. La questione della
maestra di campagna, presente oltre che nell'inchiesta anche nei congressi pedagogici degli an
ni Settanta, non ha ancora trovato anche nei più recenti studi una adeguata considerazione.
1 Dalle molte risposte, quasi tutte insoddisfatte, sui convitti del governo viene fuori un qua
dro assai negativo: in genere questi convitti o avevano una natura quasi militare, riscontrabile
nelle divise dei convittori e nel personale spesso proveniente dall'esercito, o ripetevano i mo
delli controriformistici dei collegi religiosi. Si spiega la preferenza dei padri di famiglia per i
convitti stranieri e per quelli ecclesiastici, spesso meno costosi e sostenuti da una consolidata
esperienza educativa. Proprio perciò, per impedire e ostacolare il successo dei clericali, nono
stante la riconosciuta incapacità del governo, da più parti viene invocata l'istituzione di un
convitto nazionale dovunque ci sia da contrastare un seminario o un collegio ecclesiastico: si
veda per esempio il caso di Ferrara dove il prefetto e altri intervenuti chiedono a gran voce il
convitto governativo. Si consideri infine che l'assenza di scuole secondarie adeguate nei piccoli
centri, la renitenza di molte famiglie benestanti di confondere i loro figli con i figli delle classi
inferiori, i frequenti trasferimenti dei funzionari, un insieme di motivi insomma rendeva assai
frequente e desiderato l'affidamento dei figli ai convitti. Né nelle abitudini sociali italiane riu
sciva a penetrare l'istituto, pur consigliato dal questionario e assai diffuso in Germania, delle
pensioni domestiche.
1 44
145
Fonti per la storia della scuola
Nota metodologica
La quarta sezione ricava la sua origine da un gruppo di giornali quotidia
ni, conservato nella busta 8 , contenenti giudizi e notizie de;ll 'inchiesta: essi
costitu iscono forse un tentativo, peraltro assai monco e incompleto, di ser
vizio stampa del ministero ove si voleva rendersi conto degli echi che l ' im
presa aveva nell ' opinione pubblica. Si sono scelti da questo nucleo i testi
più significativi e attraverso u n esame di altre testate di quotidiani lo si è
ampliato, anche qui con i necessari sacrifici di non pochi pezzi e di tutta la
stampa non quotidiana (riviste di politica, di cultura, di pedagogia) 1 •
Sono infine comprese in questa sezione due lettere , u na di Labriola a
Bongh i, già edita da Berti con qualche inesattezza quaranta anni fa, e una di
Lambruschini a Tabarrini, inedita e dettata a Figline dal pedagogista genove
se pochi giorni prima della sua morte: ambedue sono significativa espressio
ne delle aspettative e delle delusioni suscitate dall' iniziativa di Scialoja i n
d u e intellettuali così diversi fra loro e che b e n rappresentano le n uove ten
denze pedagogiche nell' Italia u nita l ' uno, e l 'eredità della pedagogia risorgi
mentale l'altro .
nistici - , attenua certe espressioni troppo forti o addirittura riformula il
suo ragionamento tenendo conto di interventi nel dibattito successivi al
suo .
Nelle deposizioni orali dell' inchiesta Scialoja gli stenografi lavoravano in
condizioni più disagiate. Talora l ' acustica dei luoghi in cui si svolgevano le
audizioni (per esempio a Milano) non era felice; bisogna poi tener conto del
le inflessioni dialettali o della voce troppo fioca di alcuni oratori, del chiac
chiericcio di fondo degli spettatori presenti, a volte, come in una seduta na
poletana, tumultuanti. Non sempre infine, per i continui spostamenti della
Commissione, era possibile sottoporre a chi era intervenuto , per la revisio
ne, la prima trascrizione dello stenogramma di base. Sicché i testi delle de
posizioni orali si presentano, secondo le circostanze, in tre stadi diversi : a)
la prima trascrizione fatta dallo stenografo s tesso , che è il caso più frequente
e che conserva evidenti le tracce delle incertezze e dei malintesi propri della
trasmissione orale; b) la stessa prima trascrizione . però con nelle i nterlinee e
ai margini le correzioni di un revisore che è spesso ma non sempre chi ha
deposto; c) la bella copia definitiva .
Soprattutto nei testi a noi giunti nello stadio a), ma a volte anche in quel
li giunti negli altri livelli, l'enu nciato orale presenta dei problemi di i nt er
pretazione. Poiché solo di rado chi veniva a deporre aveva un testo già pre
parato, e più spesso improvvisava a braccio e perdeva il filo del discorso (si
veda ad esempio la deposizione di Enea Cavalieri) non essendo certamente
consumato oratore (come in genere sono i parlamentari nei loro interventi),
sono frequenti anacol uti e periodi contorti che non hanno un senso chiaro .
In questi casi si è rispettata la forma del testo, eventualmente con qualche
chiarimento in nota; altri errori possono avere origine, oltre che negli sban
damenti espressivi di chi depone, anche in incomprensioni dello stenografo.
Queste si possono verificare inoltre nelle singole parole : una tipica lectio fa
cilior ex au.ditu è, per esempio, « sezione » per « sessione » . Sono più facil
mente vittime d ' errore le parole rare e difficili e ovviamente i nomi propri:
per es. Canale per Canal, M icarelli per Amicarelli, Limana per I nama ecc . ;
l ' interpretazione diviene più difficile con i nomi stranieri stenografati i n ma
niera imprecisa (per es . Bonis per Bonitz) fin o ad essere a volte irricostruibi
li. Infine i segni di interpunzione, di norma assai labile nel secondo Ottocen
to (e si vedano in proposito le osservazioni fatte nella sua deposizione da un
fine letterato come Acri) specie nelle scritture redatte in fretta, come per
esempio nei quotidiani, sono nelle trascrizioni delle deposizioni orali di col
locazione molto arbitraria; in molti casi sembrano riflettere più il desiderio
di riposo della mano dello stenografo scrivano che la pausa della voce di chi
parla.
In questa situazione, in cui tra le parole realmente pronunciate e il letto
re c'è la mediazione alterante dello stenografo (della quale si è offerta solo
una parziale esemplificazione), ci si è attenuti a u na linea di cauta norma-
Alcune question i di critica testuale
Per la trascrizione e la stampa dei documenti ci si è ovviamente attenuti
alle norme e alle consuetudini di questa collana; ma per la seconda sezione
si sono poste alcune questioni di critica del testo : le deposizioni orali sono
state raccolte da stenografi e poi da loro stessi trascritte. C ' è nel procedi
mento una qualche analogia con la serie Discussioni degli A tti parlamenta
ri, con la differenza però che di norma gli stenografi parlamentari sono pro
fessionalmente più capaci di quelli dell 'inchiesta, lavorano in condizioni
ambientali migliori, il loro lavoro prima di essere affidato al tipografo è sot
toposto a più di u na revisione, compresa i n genere quella dell'oratore . In
complesso dunque gli A tti parlamentari forniscono un testo attendibile e
fedele, salvo qualche errore che può insinuarsi nella mediazione stenografi
ca (come per esempio, una ventina di anni fa, quando, per malinteso da
omofonia, il musicista Luigi Nono è diventato, a stampa , Luigi IX) e salvo il
caso più frequente per cui, per ragioni di opportunità, u n oratore nel rive
dere il testo ne sopprime alcune parti - specie nei dibattiti ostruzio-
Non solo le riviste più esclusivamente pedagogiche, come per esempio le più volte citate
" La critica dell'istruzione secondaria classica e tecnica " Il Baretti "· Il Nuovo istitutore La
Scuola " Il Progresso educativo dedicano tra il 1872 e il 187-1 notevole spazio ai resoconti e
alle questioni sollevate dall'inchiesta, ma anche altre riviste di studio e di cultura, come la " Ri
vista di filologia e d'istruzione classica " La Rivista universale " ecc. prendono parte ai dibattiti
sui quesiti. Si veda per esempio la lettera dello scolopio Tommaso Pendola a Niccolò Tomma
seo pubblicata col titolo l quesiti sull 'istruzione secondaria, in La Rivista universale», 1873,
pp.368-373. Assai di rado gli autori di questi contributi si preoccupavano poi di spedirli aJ mi
nistero, sicché non figurano tra le carte conservate all'Archivio centrale, come pure non vi fi
gura quello che è forse il più significativo scritto provocato dall'inchiesta, le già ricordate Tri
bolazioni di Placido Cerri, con le considerazioni in proposito di Alessandro D'Ancona.
1
•.
•.
•
"•
"•
•
•,
•
1 46
Fonti per la storia della scuota
lizzazione del testo, correggendolo direttamente senza alcuna segnalazione
nei casi di estrema evidenza, segnalando invece il problema in nota nei casi
più caratteristici o in quelli ove persiste una ragionevole ombra di dubbio,
ma si è proposta una soluzione congetturale, arrendendosi di fronte alle ma
lae cruces.
LUISA MONTEVECCHI
MARINO RAICICH
SEZIONE I
LO SVOLGIMENTO DELL' I NCHIESTA
Relazione del ministro Antonio Scialoja al re sul decreto che or·dina un 'in
chiesta sulla istruzione secondaria maschile e femmin ile, e r. d. 29 set.
1 8 72, n. 1 01 6.
ACS, M P I , Div. scuole medie (J860- 1896) , b. 4 ,
fase . l , s. fase. l .
Si re,
Il ceto medio attinge dalla istruzione secondaria la sua coltura e la sua
educazione.
Ad essa parimenti ricorrono tutti coloro che intendono addirsi a più ele
vati studi o a speciali professioni.
Dalle scuole secondarie quindi esce tutta quella gente che chiamasi civi
le, e che merita d' esser tenuta per colta e bene educata, quando sa compren
dere quel che deve volere, e quando ha appreso a volere con fermo e persi
stente proposito tutto ciò che mena al conseguimento di fini non solo utili,
ma anche nobili e virtuosi. Il che non si consegue altrimenti che temperan
do l ' animo di buon' ora al sentimento del dovere ed a quello della responsa
bilità de'propri atti, ed acquistando fin dall'età giovanile la coscienza della
dignità e della indipendenza personale, congiunta alla rispettosa osservanza
di quanto è imposto per legge ed alla riverenza per chi è chiamato a curarne
l' applicazione .
Coteste scuole sono destinate ad essere come il vivaio di quella somma
di cittadini intelligenti, volenterosi , attiv i , che costituiscono il nerbo della
società civile, e che sono chiamati a compiere , or gli uni or gli altri secondo
le mutevoli vicende della fortuna, l ' arduo ufficio del comandare e quello
non men difficile dell' obbedire, senza protervia e senza viltà.
La quale classe di cittadini ha inoltre con coloro che non ebbero né tem
po né modo di acquistare coltura e educazione pari alla sua, tutte quelle re
lazioni frequenti e molteplici che ne ' campi, nelle officine , nella casa e nella
città sorgono tra la intelligenza, il capitale, la proprietà, l ' agiatezza,_ i pubbli
ci uffici e le braccia, il lavoro, il bisogno , l 'ignoranza e i mali che l ' accompa
gnano. O nd ' è che ad essa corre moralmente e socialmente l ' obbligo di ser
vir loro d 'esempio e di aiuto, e nel tempo stesso di apprestare, con cure in
defesse e amorevoli, t utte quelle istituzioni e que' modi che facilitano a' mi
gliori tra loro la via di riuscire a provare col fatto, che dove i l ceto medio
non ha linùti di privilegio, il lavoro, la sobrietà ed il risparmio bastano a mi-
1 50
gli orare e � anch � a � uta�e la condizione del proletario 1 • Il che quanto sia
_
unle,
non e mestJert_ sta dtmostrato, oggi soprattutto che vi ha da temere che
la poca vir� ù della classe media, e le abitudini molli e l ' egoismo de ' più, non
_
dteno
credtto a quelle stravaganti dottrine le quali, sostituendo un'astratta e
brutale eguaglianza di fat to . a quella santissima del dritto seducono le sem
plici menti, eccitano gli animi meno gentili all' odio contr� tutto ciò che vi è
di grande, di elevato e di nobi le, e mettono in sospetto la moderna civiltà.
Le scuole debbono altresì attendere, con non minore sollecitudine non
tant ? ad info�mare la mente delle giovani donne con discipline che abil itino
a sptegare utilmente così nel seno della famiglia come fuori di essa la parte
non lieve d ' i ntelligente attività che loro spetta, quanto a predisporre l ' ani
mo loro in guisa che quello ascendente morale che saranno chiamate ad
esercitare più tardi come spose, come madri , come prime maestre e come
r� odell � di d� li �ato sentire e di bontà, possa valere ad ingentil ire la rude vir
t � degli uommt se nza infiacchirla né corromperla, anzi facendola loro appa
_ anche quando non sarà fortunata.
nre bella ed amabtle
Ma �� istruzione secondaria maschile e femminile risponde presso di noi
a questt Importantissimi fini?
Vi �ispondono per lo meno alcune specie degl ' istituti ne' quali la volontà
e tstrmta o educata?
�e�1Za ammetter� �eruna delle opinioni estreme che per preoccupazioni
_
parttgtane, per nvaltta
o per mala prevenzione e per sospetto possono esse
re accreditate e diffuse contro questa o quella specie d ' istituti, io reputo, e
_
con �e cred o c � e pen�mo
la gente più calma e i padri di famiglia più intelli
,
_
gentt , che �e ali u na ne ali altra domanda si possa con pieno convincimento
_
nspondere
m modo affermativo, senza molte riserve.
Né ciò deve arrecar meraviglia.
Il temp? in c � i compiansi l e grandi mutazioni di Stato non è sempre op
_
_ � quelle nforme
portun � ne � ro� tzto
che richiedono calma e ponderazione;
esso net suot pnmordt non suoi riuscire favorevole a quegli studi severi che
preparano i buoni insegnanti, né lascia sempre sereno e tranquillo l ' ambien
te della scuola. Anche il soperchio desiderio del bene converte ne ' tempi di
generale eccitazione l ' impazienza in precipitanza, e talvolta arreca danno
_
Sezione I - Lo stJolgimento dell 'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
.
l'importanza dell'istruzione secondaria per la formazione civile dei ceti medi, per i com
. . ' poltttct
e professwn �li che essi devon? assumere nel nuovo Stato nazionale e per la funzio
ne dt g_mda n_et con:rontt det cett sfavonu, viene sottolineata più volte nel dibattito di politica
scol:sttca det pnm� decenni dell'unità. Si veda ad esempio l'articolo di Pasquale Villari del
1 86:> (ora Nuou1 studi pedagogici, Firenze, Sansoni, 1 89 1 , p. l41) ove si parla della scuola
secondana come scuola dt quella gran classe sociale che rimane tra il popolo e coloro che
sran�10 alla testa del paese ,, attraverso la quale " le idee filtrano, per così dire, continuamente
tlagh ordmi. supenon agh mftmt " e dunque il ginnasio viene ad essere « il cemento che dà unità
e manuene msteme tl corpo della nazione ». Simili considerazioni sull'importanza politica in Ira
ha della scuola secondana erano svolte in quegli anni anche da un acuto osservatore straniero'
Karl Htllebrand.
P':'
111
•
151
più di quel che non
con lo spingere a far troppo presto e poco bene molto
.
re
dispor
consen tano i mezzi di cui si può
che hanno da ri
Oltre di che gravis simi sono per loro natura i proble mi
della istruzi one se
solver si da chi vuoi proced ere ad un buon ordina mento
civili per prepararne la
condaria . Larghi gli studi fatti presso tutte le nazion i
sono sempr e conco rdi
soluzi one; e coloro medes imi che più ne sanno non
sopra alcuni modi del risolv erli .
arduo argom enAd aggravare p o i le diffico ltà c h e s ' i ncontrano in questo
contra rietà, ed è che
to , si aggiun geva in Italia un' altra deplor abiliss ima
meno , ma da per
dove
più
dove
è
quale
la
o
quella gara nello insegn ament
il laicato civile,
e
clero
il
tra
enza,
confid
oca
tutto agitata con poca recipr
sa poco men
conte
di
dir
non
per
lotta
di
forma
prend eva nel nostro Stato
che politica.
e difetti nella parte
Né si può dubita re che l ' istruzi one secon daria, sebben
parte che riguar da
nella
a
ancor
evole
manch
che conce rne la coltur a, sia più
la educa zione .
ament i, di tutte
Quest a è un risultamento compl essivo di tutti gli insegn
i, del modo
esemp
degli
i,
tazion
eserci
delle
le pratic he, di tutte le discip line;
dirò pure ,
e,
eco
estrins
mento
ordina
di spend ere il tempo , e dello stesso
della fa
ni
relazio
e
l
parte
gran
pure
sono
e
ammin istrati vo d i una scuola . N
fuori di
o
tti
convi
nei
e
i
giovan
i
loro
tra
miglia c quelle stesse che hanno
essi.
una suffiI mezzi pratic i più diretta mente atti ad impar tire ai giovan etti
quind i per una parte in
ciente coltur a ed u na sana educa zione consis tono
minut e e specia li disci
di
e
i
iment
accorg
una serie numer osissim a di sottili
perso ne pratic he , per
da
rite
sugge
e
te
pline, che posso no essere bene estima
o più facilm ente
note
lmente
genera
più
à
un'altr a parte consis tono in qualit
ai due princi pali
iano
ademp
che
ordini
di
appre zzabil i di perso ne, di cose e
mezzi non so
altri
gli
come
uni
gli
così
intent i della istruzi one. Nullad imeno
ali e certe
gener
eri
caratt
certi
hanno
o
no soltan to buoni ed efficac i quand
econo mi
ze
esigen
alle
dono
rispon
astratt e propo rzion i , ma quand o meglio
.
o
popol
dato
n
u
di
e
che, politic he e sociali di un dato luogo
inoltre essere agevo
La ricerc a e l ' applic azione di cotest i mezzi posso no
te della istruzi one,
presen
stato
lo
za
late verific ando e mette ndo in eviden
e dalle person e
ordini
dagli
,
modi
dai
ti
cioè i risulta menti che si sono ottenu
i e dal Go
razion
corpo
dalle
,
i
privat
che furono adope rati nelle scuole dai
di quelle o
cause
le
ndo
indaga
ed
,
vizi
i
verno ; svelan done le imper fezion i o
dello Sta
e
razion
minist
dell'am
così
ione
di questi : chiam ando infine I 'attenz
ne da
magag
le
re,
colma
da
lacune
le
to, come di tutta la cittad inanza sopra
correggere e i mali da curare .
che le perso ne stuE per vero nei paesi ordina ti a libertà non solo è utile
no sugger ire ac
sappia
e
fatti
dei
a
diose d ' una certa mater ia abbian o notizi
rendu ti notor i,
sieno
fatti
i
che
ile
conci provv edime nti; ma è indisp ensab
1 52
1 53
Fonti per la storia della scuola
Sezione / - Lo svolgimento dell 'inchiesta
che la necessità di certi provvedimenti sia universalmente avvertita, e che
coloro i quali hanno maggiore affetto ed interesse a certe buone ed utili ri
forme (come nella specie presente sarebbero i padri di famiglia) spingano il
Governo a farle, o per lo meno si predispongano ad accettarle volentieri,
ovvero anche ne aiutino l ' attuazione, sia giovandosi delle relazioni econo
miche e educative che le famiglie hanno con la scuola e sia pure per mezzo
delle amministrazioni locali, dove i padri di famiglia sono chiamati dalla ele
zione o dove eleggendo mandano i loro pari .
A tutti questi fini soddisferà la inchiesta pubblica sulla istruzione secon
daria che io propongo a V. M. di ordinare col decreto che sottometto alla
rea l sanzione.
I o son ceno che la stessa agitazione prodotta dalla inchiesta volgendo le
menti e sollevando la discussione intorno ad argomenti troppo negletti dal
maggior numero , sarà per riuscire salutare: molt i dubbi e molti p reconcetti
saranno chiariti vani, erronei o esagerati , molte opinioni raddrizzate, molti
mali occulti svelati e qualche pregio poco apparente sarà posto in luce; nuo
ve esigenze saranno avvertite . La classe stessa degli insegnanti e di coloro
che prendono parte alla educazione è dalla inchiesta scossa utilmente, sti
molata a far bene, e svincolata dai ritegni che potrebbero trattenerla dal dire
come si può far meglio.
Solo coloro a cui giova il mistero o che preferiscono alla sanità ed alla
robustezza della educazione e della coltura la dissimulazione delle infermità
morali che le travagliano e della fiacca loro cost ituzione, possono aver so
spetto della inchiesta.
Anzi, per questa parte, e sotto questo rispetto la inchiesta medesima sarà
buono e lodevole esempio di cittadina educazione. Per essa il Governo mo
stra all ' u ni versale come ne ' p ubblici negozi, non meno che ne' privati , il
proposito di migliorare non deve essere arrestato da un falso pudore che
consiste nel nascondere i propri difetti, né sgomentato della responsabilità
che deriva dal porre a nudo le proprie miserie. Esso anzi deve trarre dagli
uni e dalle altre nuovo argomento di vigore.
E ne tornerà onore a tutta la nazione; perocché se è grande il merito di
chi sa conservare le utili ed eccellenti istituzioni che possiede, maggiore è
quello di chi si volge ad indagare in che peccano quelle che si hanno, e ri
cercar con ogni maggior cura i mezzi per migliorarle, mostrando animo deli
berato di adoperarli efficacemente al conseguimento del fine.
E questo è per lo appunto l ' indole che avrà l ' inchiesta che V. M. sarà per
ordinare .
Non informata da spirito di parte, non macchiata da occulto vizio di ri
sentimenti o di gare appassionate, non mossa da sospetti, non diretta a glo
rificare o ad abbattere riputazioni individuali né a giustificare o condannare
atti o fatti ne' quali si trov ino avvolti nomi avversati o favoriti, l ' i nchiesta di
cui si tratta si aggirerà in u na sfera superiore a quella dove si agitano le pas
sioni e gli interessi mutevoli e stizzosi della politica miUtante.
Migliorare la coltura e la educazione di un popolo è scopo così elevato
che non può essere posto altrove che in una regione calma e serena .
E perché questo carattere sia in modo solenne impresso alla inchiesta, il
decreto che la ordina formalmente dichiara eh' essa non avrà nulla di perso
nale; e che quando anche fossero denunziati o provati fatti o atti personali
non degni di lode , di quest i non si abbia altrimenti a tener ragione se non
per quel che possono avere d ' importanza generica rispetto ai fini dell ' in
chiesta, e tacendo però sempre i nomi delle persone.
E per vero un' inchiesta, come la presente, non è un processo, e molto
meno un atto d ' accusa; è un' indagine franca e leale, fatta in pubblico, e col
concorso di tutti coloro che sanno e che possono favorirne la riuscita, col
fine altissimo di trovare i modi di render migliore l ' insegnamento e sopra
tutto la educazione de' nostri figliuoli.
E questa indagine cadrà su ciò che v i è d i bene come su ciò che vi è di
male, sui fatti e sulle opinioni e i giudizi concernenti codesti fatti . A misura
che si estenderà, essa andrà di mano in mano acquistando luce a se medesi
ma, dal molteplice confronto de' fatt i , ddle opinioni e de' giudizi che andrà
raccogliendo . La stessa varietà de' mezzi che saranno adoperati - le interro
gazioni scritte, le orali, le informazioni, le visite - gioverà col riscontro de'
relativi risultamenti allo scoprimento del vero : e conferirà pure efficace
mente ad utilissime induzioni, il diverso i ndirizzo degli istituti sottoposti al
la inchiesta, la varia indole loro, e lo accertamento de' pregi e de' difetti de
gli uni paragonati a quelli degli altri , secondo ciò che hanno di vero e secon
do la opinione che se ne ha da' più ed il giudizio che ne fanno le parti tal
volta opposte.
Una inchiesta di tal natura risponderà, ne confido, alla universale espet
tazione. Essa soddisfa un desiderio già più d ' u na volta autorevolmente
espresso in Parlamento 1 , ed un sentimento che, se mal non mi appongo, era
già nell' animo del più gran numero de' padri di famiglia.
Avrei forse potuto comprendere nella inchiesta anche la istruzione pri
maria e la superiore. Ma me ne sono astenuto, sì perché la indole di queste
due altre parti essendo per opposte ragioni diversa da quella della istruzione
secondaria, avrebbe recato confusione congiungerle insieme, sì perché gli
studi fatti intorno a quelle due parti , hanno già meglio chiariti alcuni de'
punti su' quali è da richiamare l ' attenzione del legislatore, e sì perché infine
questa ch'è detta secondaria merita essere di preferenza studiata e discussa
pubblicamente, come quella che per sua natura è più complessa, che ha
maggiori punti di contatto con gl ' interessi della classe intelligente che ne
reclami il riordinamento, e confina con le altre due parti in guisa che alcune
delle ricerche che la concernono possono anche gettar di lato sprazzi di l uce
sovra di esse .
' Allude alla richiesta di un'inchiesta sulla pubblica istruzione presentata dal senatore Mena
brea al Senato nel maggio 1872: su cui vedi introduzione di Marino Raicich, p. 18.
1 54
1 55
Fonti per la sto1·ia della scuola
Sezione I - Lo suolgimento dell'inchiesta
Anzi dacché nell ' ordine pratico per arrivare a conchiusioni certe è pur
mestieri saper circoscrivere per quanto è possibile la mater-ia, ho pensato
che ordinando una inchiesta sulla istruzione secondaria non bastasse accen
nare al fine ultimo e generico del suo miglioramento, ma fosse conveniente
aggiungervi la indicazione di punti principali .ai quali deve essere più deter
minatamente rivolta l 'attenzione di chi compie la inchiesta, per raccogliere
fatti, opinioni e giudizi che meglio valgano a metterli in chiaro, e più aiutino
a risolvere i problemi che vi si riferiscono 1 •
Questa piuttosto che u n a vera e d assoluta limitazione del campo della in
chiesta è uno schizzo, a larghi tratti, di quei gruppi di questioni in cui si sud
di vide l ' argomento.
I valentuomini che saranno chiamati da Vostra Maestà a fare la inchiesta
formoleranno i quesiti speciali che giudicheranno meglio convenienti alla
esplicazione più o meno larga delle principali questioni accennate, e faranno
a lor talento le relative ricerche. Per loro al certo, se non interamente super
flua, non sarà gran fatto utile, e per fermo non sarebbe stata indispensabile,
la traccia di quei principali punti . Ma ho creduto che q uesta giovi a far me
glio intendere a tutti il vero scopo della inchiesta, l' indole sua e i suoi con
fini. Molti tra coloro che avranno per avventura notati alcuni fatti o avverti
ti alcuni inconvenienti in modo, dirò, sperimentale, - siccome ha potuto
avvenire a molti padri di famiglia che hanno ovvero hanno avuti figliuoli a
scuola, - potranno più facilmente comprenderne l ' importanza, quando
avranno delle categorie speciali sotto cui ridurli assai più facilmente che
non potrebbero, se avessero a riferirsi soltanto a ' fini poco ben determinati
dell' educazione e dell' insegnamento. A molti altri anche più intendenti della
materia servirà quella traccia per raccogliere l ' attenzione e meglio preordi
nare le idee, col fine di fornire nel modo più acconcio e più proficuo alla
Commissione di inchiesta le proprie informazioni e i propri giudizi . E giove
rà pure a tutti per giudicar della inchiesta e della sua utilità pratica, mentre
si va compiendo; perché segna i punti ai quali potrà chiunque facilmente ri
ferire le informazioni dei fatti o le opinioni e i giudizi che quella raccoglierà;
e che prima ancora del tempo, nel quale verranno ordinatamente pubblicati,
perverranno, siccome suole accadere, a notizia del pubblico, i n modo in
completo, a brani e senza logica successione .
Oltre di che, codesta traccia, accennando ad una serie di quesiti, prova
che infin de' conti il Governo, ordinando un' inchiesta, non è mosso da una
curiosità vana, né da u n concetto indeterminato, e, sarei quasi per dire, pri
vo di contenuto . Esso per lo contrario, traendo frutto ed esempio da quanto
è stato praticato e praticasi presso tutte le nazioni civili e dagli studi e di
scussioni fatte in Italia da uomini sapienti, da assemblee legislative e da cor
p i amministrativi intorno alla grave materia, ha già presenti alla mente i
punti culminanti dell' argomento ; ma reputa necessario che una pubblica e
generale inchiesta riesca a renderli popolari , ed a chiarire nel tempo stesso
lo stato vero delle condizioni intrinseche della istruzione secondaria e di
quelle estrinseche che debbono essere rispettate o raddrizzate, se non si
vuole che una riforma giudicata utile in astratto, venga meno in pratica per
ignoranza de' fatti o per difetto di buona preparazione.
Non ostante questi utili accorgimenti, non dissimulo alla M. V . , che io
sono convinto che la buona riuscita della inchiesta in massima parte dipen
derà dall'abilità e dalla solerzia di coloro a cui sarà affidata.
Per questa parte io confido interamente nelle eminenti qualità e nella
meritata riputazione de ' personaggi che propongo alla Maestà Vostra di
chiamare a comporre la Commissione d'inchiesta.
Non ho compreso nel loro numero alcuno di coloro che nella qualità di
ministri o di segretari generali governarono le cose della pubblica istruzione
nel Regno sia per la parte che spetta a questo Ministero , sia per la parte tec
nica che è fuori delle sue competenze . Quantunque questo proponimento
mi riuscisse doloroso e restringesse il numero delle egregie persone tra cui
scegliere nomi chiari e provati, pure l ' ho creduto utile , per rimuovere anche
da' più sospettosi la possibilità del dubbio che la presente inch iesta possa es
sere offuscata da preconcetti o da affezioni di sorta.
Per meglio conseguire questo intento ho pure procurato che tra gli egre
gi componenti la Commissione s ieno ed uomini notissimi per ispeciali studi
o cure concernenti l ' istruzione, ed altri per coltura e per fama degnissimi ,
ma non chiamati precedentemente per ragion d ' ufficio o d i professione ad
attendere alle particolari discipline della istruzione. E tra' più speciali ho
pensato che fosse opportuno badare a mantenere una discreta varietà d ' opi
nioni intorno a qualche alta controversia, che dirò d ' ordine sociale o politi
co, la quale abbia relazione più o meno diretta con alcuno de' punti princi
pali dell ' inchiesta. La lealtà di tutti e l ' incontro delle opinioni varie rimuo
vono ogni possibilità di pericolo che si incorra nell ' inconveniente delle per
suasioni anticipate.
La scienza e la esperienza di t utti gli uomini speciali, e massime di coloro
che, per le ragioni sopra esposte, ho schivato di veder rappresentati nella
Commissione, potranno essere di grande aiuto sia fornendo informazioni e
giudizi all ' inchiesta, sia dimostrandone e criticandone i risultati per indurne
utili suggerimenti, sia concorrendo con le parole o col suffragio ne' consigli
e nelle assemblee deliberanti, a far trionfare q uelle vantaggiose e pratiche ri
forme , alle quali l ' inchiesta avrà data occasione.
E questo sarà più specialmente il compito del Consiglio superiore della
pubblica istruzione. Esso potrà inoltre trarre profitto da tutti gli studi prece
denti e vivificarli con la notizia recente de' fatti riscontrata con quelle infor
mazioni che ufficialmente pervengono al Governo per mezzo de' suoi uffi
ciali e delle ispezioni straordinarie .
1
Si riferisce alla successiva ordinanza ministeriale del l ottobre 1872 (vedi doc.
3, p. 1 5 9).
1 56
1 57
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1 - Lo svolgimento dell 'inchiesta
Ma sia che il Consiglio proponga, sia che esamini le proposizioni che a
suo tempo, dopo terminata l'inchiesta, il Ministero potrà sottoporre al suo
avviso, è pur facile a prevedersi che nel corso dell 'inchiesta medesima si pos
sa chiarire urgente qualche provvedimento o qualche riforma. Perché atten
dere che l' inchiesta sia condotta a termine per soddisfare ad una necessità
evidente? Il decreto con l' ultimo suo articolo prevede il caso, e lo risolve.
ti, a padri di famiglia, e a persone note per studi speciali intorno all' istruzio
ne, o per esperienza acquistata nell 'insegnamento e nella educazione della
gioventù;
b) Per mezzo d ' interrogazioni orali alle persone che saranno invitate dal
la Commissione, o che richiedendo di essere intese, riceveranno la notifica
zione del giorno e dell' ora per presentarsi a dare le informazioni che credo
no o a fare le loro deposizioni;
Sire,
Il lavoro efficace e persistente è la fonte della ricchezza d ' una nazione: le
buone leggi e le buone armi sono l ' appoggio e la tutela della sua grandezza.
Ma il lavoro senza coltura non frutta, e la ricchezza senza virtù corrompe: le
leggi non valgono senza i costumi, e le armi cadono dalle mani di chi non
unisce alla vigoria del corpo quella dell' animo.
La scuola soltanto con la coltura della mente, e sopra tutto con la educa
zione fisica e morale de' cittadini è l ' arbitra vera dell ' avvenire d ' un popolo.
Tutti gli atti che tendono a renderla più efficace e migliore, massime nella
parte che maggiormente ne abbisogna, sono atti di alta e previdente politi
ca. Tale è quello che oggi, col consentimento del Consiglio della Corona, io
sottometto alla Vostra reale approvazione.
c) Per mezzo di lettere circolari che la Commissione potrà mandare alle
autorità scolastiche ed agli istituti governativi , perché forniscano le notizie
statistiche che potranno essere desiderate;
R. d. 29 set. 1 8 72, n. 1 0 1 6. Inchiesta intorno alla istruzione secondaria
maschile e femm inile.
Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volonta' della nazione re d ' Italia
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica
istruzione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art . l . Sarà fatta un' inchiesta intorno alla istruzione secondaria maschile
e femminile, sotto il duplice aspetto dell' insegnamento e dell'educazione.
Saranno sottoposti all' inchiesta gl ' istituti e le scuole che attendono nello
stato all' istruzione secondaria, sia che appartengono al governo, a corpi mo
rali, o a privati, sia che costituiscano fondazioni speciali destinate all' inse
gnamento ed ali' educazione.
Art . 2 . Una Commissione composta di nove membri, nominata da noi e
presieduta da uno dei suoi componenti a ciò delegato dal nostro ministro
per la pubblica istruzione, o presieduta dal ministro medesimo quando vor
rà intervenirvi, farà l' inchiesta:
a) Per mezzo di interrogatori scritti, o siano elenchi di domande, formu
late dalla Commissione, i quali saranno diretti non solo alle autorità scolasti
che, ma anche a corpi scientifici, a presidi e direttori di istituti, ad insegnan-
d) Per mezzo di visite ad ist ituti, deliberate dalla Commissione medesima
secondo le norme da lei tracciate.
Art . 3 . Quando la Commissione delega uno o più dei suoi componenti a
recarsi in alcun luogo per visit are istituti, fare interrogazioni, o prendere in
formazioni, i delegati hanno facoltà di aggregarsi una o più persone del luo
go per essere coadiuvati nell ' esecuzione del loro mandato.
Art . 4. Contemporaneamente a questo decreto il nostro ministro per la
pubblica istruzione, con sua ordinanza, traccerà i principali punti intorno ai
quali si aggireranno gli interrogatori , le informazioni e gli altri atti dell ' in
chiesta.
Art . 5. Gli atti dell ' inchiesta saranno pubblicati nei modi e nelle forme
che dalla Commissione verranno stabiliti.
L' inchiesta non essendo personale, saranno esclusi dalla pubblicazione i
fatti e le censure individuabili che possano essere comprese in risposte ad
interrogazioni o in riservate informazioni . Q uando i fatti, le note, o le cen
sure concernendo individui hanno u n ' importanza generale, o quando si ri
scontrano in considerevole numero di casi, saranno menzionati per ciò che
possono contenere di utile ai fini dell' inchiesta in modo generico, e prescin
dendo sempre dai nomi delle persone.
Art . 6. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà consultato sui ri
sultamenti dell' inchiesta, e avendo presenti anche le notizie che saranno de
sunte dalle relazioni delle ispezioni centrali sin ora fatte, e dai rapporti an
nuali delle autorità scolastiche, delibererà intorno a quanto crederà u tile per
migliorare gli ordini e le condizioni della istruzione secondaria, sia avvisan
do sulle proposte che gli potranno essere presentate dal ministero, sia: pro
ponendo i provvedimenti amministrativi o legislativi che giudicherà oppor
tuni.
Durante il corso della inchiesta quando per essa fosse posta in luce il bi
sogno di prendere qualche utile provvedimento, il ministro sentirà l ' avviso
del Consiglio superiore sul merito di esso , e sulla opportunità di farlo senza
pregiudicare il risultamento finale dell' inchiesta.
1 58
Fonti per la storia della scuola
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1 87 2 .
A. Scialoja
Vittorio Emanuele
1 59
Sezione 1 - Lo svolgimento dell 'inchiesta
2
Cremona cav . prof. Luigi .
Carbone cav . D omenico, provveditore agli studi .
Art . 2 . Sono destinati a tenere le funzioni di segretario Turiello Pasqua
le 1 ed uno degli impiegati addetti al Provveditorato centrale per l ' istruzione
secondaria, che sarà designato dal nostro ministro .
Il nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione è incari
cato dell 'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei
conti 2 .
Dato a Roma, addì 29 settembre 1 87 2 .
Vittorio Emanuele
A. Scialoja
R. d. 29 set. 1 8 72, n. 1 026, nomina dei membri della Commissione d 'in
chiesta.
Vittorio Emanuele IJ per grazia di D io e volontà della nazione re d ' Italia .
Visto il nostro decreto di questo giorno con cui è ordinata un'inchiesta
sull' istruzione secondaria maschile e femminile del regno;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato della pubblica
istruzione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art . l . Sono chiamati a far parte della Commissione d ' inchiesta ordinata
dal sopracitato nostro decreto i signori :
Cantelli conte Girolamo, senatore del Regno 1 •
Tabarrini comm. Marco, senatore del Regno .
Lioy comm . Paolo, deputato al Parlamento 2 .
Tenca cav . Carlo, deputato al Parlamento, membro del Consiglio supe
riore di pubblica istruzione.
Bonghi comm . Ruggero, deputato al Parlamento, membro del Consiglio
superiore di pubblica istruzione .
Finali comm. Gaspare, consigliere alla Corte dei conti 3 .
Settembrini comm . prof. Luigi .
Girolamo Cantelli fu nominato presidente della Commissione d'inchiesta con d.m. del l o
ottobre 1872. ominato ministro per l'interno nel ministero Minghetti, il l O luglio 1873 fu so�tituito da Antonio Ciccone.
Paolo Lioy, dimissionario per dissensi, fu sostituito da Francesco lo Monaco.
Gaspare Finali, nominato ministro per l'agricoltura industria e commercio nel ministero
Minghetti il l O luglio 1873, fu sostituito da Paolo Boselli.
1
2
j
3
Ordinanza del min istro A ntonio Scialoja in cui si fissano i punti princi
pali sui quali verterà l 'inchiesta.
Roma, l ottobre 1 87 2
I l ministro della pubblica istruzione
Visto il r. decreto del 29 settembre 1 87 2 , n. 1 0 1 6 , con cui fu deliberata
un'inchiesta intorno all' istruzione secondaria, maschile e femminile del
Regno;
Visto l'articolo 4 dello stesso r. decreto in cui si dice : contemporanea
mente a questo decreto il nostro ministro per la pubblica istruzione con
sua ordinanza traccerà i principali punti intorno ai quali si aggireranno
gli interrogatorii, le informazioni e gli atti dell 'inchiesta,
ordina:
Art . l . L' inchiesta raccoglierà principalmente tutti quei fatti, quelle opi
nioni e que' giudizi che potranno dare argomento per rispondere ai seguenti
quesiti:
Pasquale Turiello rinunciò all'incarico per motivi di famiglia; verrà quindi nominato Ce
sare Donati, affiancato in seguito da Paolo Mantovani e da Salvatore Delogu.
Il 3 ottobre 1872 venil•a portato alla firma reale il r.d. n. 1039, che autorizzava la spesa di
L. 25.000 per i lavori della commissione; secondo varie voci di stampa tale primo stanziamento
era già stato già speso nella primavera del 1873.
1
2
1 60
161
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1- Lo suolgimento dell 'inchiesta
a) Il numero , la distribuzione e l ' ordinamento degl'insegnamenti che si
danno negli istituti di istruzione secondaria corrispondono alla capacità dei
giovani e al grado d ' istruzione che loro si vuoi dare?
n ) Quali sono gli effetti del presente sistema i n quanto ai libri di testo? È
utile, che questi libri siano determinati per t utte le materie o per alcune di
esse, ovvero che ne sia libera la scelta? Mutare i libri di t esto nei successivi
corsi d ' insegnamento della stessa materia arreca inconvenienti? Come rime
diarvi?
b) Converrebbe affidare ad un solo alcuni insegnamenti ora divisi tra più
professori, o separare altri che ora sono affidati ad un solo?
c) Quale effetti derivano dal non essere generalmente negli istituti classi
ci alcun insegnamento di lingua moderna, né esercitazioni di disegno e di
calligrafia?
d) Quali sono le condizioni dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbli
che e private, e quali conseguenze derivano tanto rispetto all' educazione
morale, quanto rispetto al concorso dei giovani ne' vari istituti? Quali sono
le opinioni prevalenti circa l ' opportu nità di sopprimere o conservare questo
insegnamento nelle scuole governative che sono aperte a tutte le confessio
ni, o circa la possibilità di ordinario in modo che non offenda la libertà di
coscienza?
e) Quali sono le condizioni dell ' insegnamento filosofico , e quali effetti
intellettuali, morali e educativi derivano dalla misura e dal modo con cui fi
nora venne impartito ai giovani ne' licei?
f) Quali sono le condizioni dell 'insegnamento delle lettere italiane; quali
le cause per cui non se ne ottenne finora tutto il frutto che se ne attendeva,
e come rimoverle? Quali sono le condizioni dell ' i nsegnament o della storia e
della geografia rispetto al modo come oggi è dato negli istituti d ' istruzione
secondaria? Quale influenza gli insegnamenti delle lettere e della storia eser
citano, non solo sulla colt ura della mente, ma anche sulla educazione del
cuore della gioventù?
g) Se la d urata e la distribuzione dello studio del greco son le cause prin
cipali del poco frutto finora dato da questo i nsegnamento, e come rime
diarvi?
h) Dall'ordine e dal modo dello insegnamento delle scienze naturali e
matematiche negl ' istituti classici traggono sufficiente profitto teorico e pra
tico cosi coloro che sono destinati all ' U niversità come quelli che restano
contenti del solo insegnamento secondario?
i) Qual è il risultato degli studi fatti secondo gli ordinamenti presenti del
le scuole tecniche rispetto al fine che esse debbonsi proporre? Quali sono le
cause che rendono meno proficui i detti studi e come porvi rimedio?
o) Quali sono i risultamenti che si ottennero dagli esami ne' varii istituti
e specialmente da quelli di licenza liceale in questi ultimi anni? È utile in u n
buon sistema d 'esami dare eguale importanza a ciascuna materia d ' i nsegna
mento in modo assoluto; massime se agli insegnamenti attuali se ne aggiun
gessero altri? È utile continuare nel sistema presente di dare gli esami di li
cenza ginnasiale e di licenza liceale in u na sola volta e su tutte le materie?
p) Converrebbe che così il Governo come le amministrazioni locali re
stringessere il numero dei presenti istituti, e specialmente quelli di ordine
più elevato per migliorarne le condizioni con discipline più accurate e con
insegnanti dei più eletti e meglio retribuiti, cercando d ' altra parte di agevo
lare l ' accesso a queste scuole con sussidi e borse o con altri simili modi?
q) Come complemento di questo sistema non sarebbe utile lasciare alle
amministrazioni locali la facoltà di istituire scuole in cui gli insegnamenti
per numero, qualità e combinazione fossero più vari e meglio corrisponden
ti alle condizioni sociali ed economiche dei d iversi luoghi con o senza sussi
di? Sarebbe utile che queste scuole avessero facoltà di rilasciare attestazioni
dietro esami sugli studi fatti?
r) L ' educazione che si dà negli istituti d ' istruzione secondaria è ben di
retta a infondere ne' giovani il sent imento del dovere, a svolgere l ' e nergia
del carattere e a formare la coscienza della propria responsabilità? Provve
dono sufficientemente a questo intento gli istituti governativi, i privati e
quelli tenuti da corpi morali? In che peccano sotto il rispetto educativo e di
che difettano tutti questi istituti, ovvero gli uni piuttosto degli altri?
s) La ginnastica, le altre esercitazioni di simil genere e le abitudini igieni
che negli istituti d ' istruzione secondaria sono ben dirette a svolgere le forze
fisiche e a coadiuvare la buona educazione morale della gioventù?
t ) Il sistema dei premi e delle pene, che è i n vigore secondo i presenti re
golamenti, e il modo come suol essere app licato , giova al buon indirizzo
educativo degli istituti? Se non giova, come rimediarvi?
l) Quali sono le condizioni delle scuole normali maschili e femminili e
quali effetti se ne ottennero rispetto al numero ed al valore dei maestri e
delle maestre che ne uscirono, e come si potrebbe estendere la utilità ed ac
crescere l ' efficacia dell 'insegnamento normale?
u) Il modo come sono applicate le tasse scolastiche produce disugua
glianza di carico tra gli istitu t i governativi e quelli tenuti da corporazioni e
da privati? E questa disuguaglianza perturba le condizioni della libera con
correnza tra i vari ordini di istituti, favorendo gli uni con danno degli altri?
m) È utile che alla direzione e al l ' insegnamento nelle scuole normali e
nelle scuole superiori femminili attendano piuttosto uomini che donne, o
non sarebbe più utile il contrario?
Art . 2. La indicazione dei precedenti quesiti, ai quali dovranno più spe
cialmente mirare gli atti dell ' inchiesta, non toglie alla Commissione la facol
tà di raccogliere tutte quelle altre notizie, che essa giudicherà acconce a
1 62
1 63
Fonti per la storia della scuola
Sezione / - Lo suolgimento dell 'inchiesta
chiarire le condizioni presenti dell' istruzione secondaria collo scopo di mi
gliorarle.
giorno in una tornata successiva; respinta a nche in questa, può essere ripro
dotta soltanto per istanza scritta fattane da c inque commissarii .
ministro
A . Scialoja
I1
Art . 6. Le votazioni saranno palesi, tranne nei casi in cui trattisi di perso
na da delegare, scegliere, ammettere, od escludere.
4
Regolamento per la Commissione d 'inchiesta.
1
Roma, 9 dicembre 1 87 2
Art . l . L a Commissione è convocata dal s u o presidente.
Il ministro della pubblica istruzione ne proroga ed aggiorna le tornate.
Art . 2 . Insieme coll' avviso di convocazione, sarà mandata a ciascun commissario la indicazione degli argomenti che dovranno essere discussi, e dei
lavori da compiere.
Quando tutti i commissarii siano presenti alla tornata, si potrà discutere
e deliberare anche sopra argomenti non indicati nell ' ordine del giorno.
Art . 3. L' ordine della discussione è regolato dal presidente; potrà tutta
via ognuno dei commissarii presenti proporne la modificazione.
La facoltà di parlare sarà concessa nell' ordine delle dimande fattene; ma nel
caso che taluno chiegga di fare avvertenze per ricondurre all' ordine della di
scussione, avrà la precedenza.
Se il ministro non sia intervenuto alla tornata , nell' assenza del presiden
te, sarà presieduta dal commissario maggiore d ' anni .
Art . 4 . Per deliberare è necessaria la presenza di cinque commissarii ; ma
nei casi d ' u rgenza basteranno tre, quando non trattisi di stabilir norme al
procedimento dell' inchiesta.
Basteranno pure tre, quando la seduta cominciò colla presenza di cin
que, o più commissari.
Chiusa la discussione , il presidente mette a voti la proposta, la quale vie
ne approvata a maggioranza assoluta.
La seduta è chiusa e sospesa per dichiarazione del presidente; ed è chiusa
di diritto, quando restano presenti meno di tre .
Una proposta respinta u n a volta, potrà fare argomento dell' ordine del
1 Il regolamento fu discusso e approvato nelle riunioni della commissione del 25 novembre
Sulla sua elaborazione vedi int roduzione di Luisa Montevecchi, pp. 5 5-56.
e 9 dicembre
1 872.
Art . 5 . Ad u no solo, od a più commissarii può essere conferito l ' incarico
d ' un progetto, d ' u n lavoro, d ' una visita, o d ' u n esame speciale ; colla facoltà
a ciascuno degli altri di fare osservazioni per iscritto, e salva la definitiva de
liberazione dell' intera Commissione.
Art . 7. L ' interrogatorio scritto sarà comune a tutte le persone che vo
glionsi interrogare; vi saranno però notate con segno particolare le dimande
più specialmente indirizzate a privati cittadini, i quali non hanno parte uffi
ciale nell 'insegnamento .
Art . 8. G l ' interrogatorii scritti saranno dalla Commissione , per mezzo
del Ministero della istruzione pubblica, mandati personalmente ai presidenti
dei consigli scolastici, ai provveditori , ai presidi e direttori d ' istituti pubblici
maschili e femminili, ai rettori di convitti, alle direttrici di educatorii, agli
ispettori di circondario, ai delegati scolastici di mandamento.
Alle persone che dirigono istituti privati o pertinenti a corpi morali, sa
ranno gl ' interrogatorii mandati per mezzo del rispettivo consiglio scola
stico.
I col legi delle u niversità, i corpi scientifici ed accademici, le direzioni
degli istituti tecnici, e le persone note per istudii speciali i ntorno alla istru
zione, o per esperienza acquistata nell'insegnamento e nella educazione del
la gioventù saranno richieste, oltre la risposta agli interrogatorii, del loro av
viso ed informazioni intorno allo stato dell 'educazione e dell' istruzione se
condaria, intorno ai metodi educativi , ed ai mezzi di migliorare l ' istruzione
e l ' educazione nazionale. Eguale dimanda sarà fatta ai senatori del regno ed
ai deputati al parlamento, a ciascuno dei quali sarà personalmente mandato
l ' interrogatorio .
Art . 9. In ciascun comune dove esista u n istituto educativo, od una scuo
la d ' insegnamento secondario , gl'interrogatorii scritti saranno mandati
agl ' i nsegnanti pubblici o privati ed agli istitutori per mezzo del rispettivo
consiglio scolastico, ai padri di famiglia per mezzo del sindaco del comune .
I sindaci di que' comuni manderanno gl' interrogatorii personalmente a
quei padri ed a quelle madri di famiglia, che ebbero, od hanno figli nelle
scuole e negli istituti d' istruzione secondaria, esistenti nel comune; sarà loro
commesso di trasmettere gl' interrogatorii anche ad altri cittadini, da cui cre
deranno potersi avere più compiute risposte; vi sarà però in ciascuna segre
teria comunale un deposito di formule d ' interrogatorii, a disposizione di
qualunque cittadino voglia ad essi rispondere.
Art . 1 0 . Le risposte agl 'interrogatorii ed alle domande di cui all'art . 8 e 9
1 64
1 65
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo suolgimento dell 'inchiesta
saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione in Roma (Commissione
d ' i nchiesta scolastica).
Ciascuno potrà rivolgere direttamente al Ministero della pubblica istru
zione l e s u e risposte scritte ancorché abbia ricevuto g l ' interrogatorii, o l e
domande per mezzo del consiglio scolastico, o del sindaco.
Le risposte dovranno avere la data del luogo e del giorno ed essere fir
mate; e non si terrà alcun conto delle anonime.
quali soltanto intende dare risposta; e può sempre non rispondere ad u na
domanda, anche senza dar ragione del silenzio .
Art . 1 1 . All' inchiesta orale saranno, dalla Commissione sedente in Roma,
invitate le persone che a ciò stimerà meglio idonee, nel giorno o nei giorni
che verranno dalla medesima fissati.
Qualunque persona, abbia o non abbia ricevuto gl' interrogatorii per ri
spondere per iscritto, può domandare di essere ammessa a deporre oral
mente.
, La Commissione, ammessa che abbia la dimanda, fisserà il giorno od i
giorni dell ' udienza; e nessuno potrà presentarsi se non ne abbia ricevuto in
vito .
Art . 1 2 . La Commissione si trasferirà temporaneamente in altre città, per
raccogliere informazioni e deposizioni orali sui luoghi ; e quando ciò stimi
più espediente potrà formare a tal uopo una o più sottocommissioni, che
potranno agire contemporaneamente in diversi luoghi, per mezzo di uno o
più dei suoi componenti.
I commissarii delegati potranno aggregare a sé qualche persona del luo
go, purché nella sot tocommissione non siano mai più di cinque in numero .
Potrà la sottocommissione incaricare il sindaco, od altra persona notabi
le d ' u n luogo nel quale non stimi opportuno trasferirsi, di raccogliere qual
che determinata informazione e notizia orale.
Gl' interrogandi saranno invitati od ammessi all' udienza i nnanzi ai com
missarii delegati ed alle sottocommissioni, od innanzi ai loro speciali i ncari
cati nei modi stabiliti all 'art . 1 1 .
Il commissario delegato, o fra più delegati l ' anziano, presiederà la sotto
commissione, che è convocata da lui, e non può sedere né deliberare senza
il suo i ntervento.
Il ministro della pubblica istruzione potrà sempre intervenire alle sedute
d ' u na sottocommissione e n ' avrà la presidenza.
Anche il presidente della commissione p uò i ntervenire acl una sottocom
missione, e quando non siavi il ministro presiederà egli la seduta.
Art . 1 3 . Le udienze della Commissione e delle sottocommissioni sono
p ubbliche; possono essere private se l ' invitato o ammesso a deporre, ne fac
cia domanda .
La Commissione, o sottocommissione, potrà sempre deliberare che la
udienza sia privata; e sarà sempre privata quando riguardi persone .
L ' interrogato può preventivamente dichiarare quali siano le dimande alle
Art . 1 'f . Le interrogazioni del presidente saranno il più che sia possibile
conformi a quelle degl 'interrogatorii scritti, che potranno però essere am
pliate e particolareggiate.
Ognuno dei commissarii o sottocommissarii, può, col permesso del pre
sidente, fare u na climanda non compresa nell ' interrogatorio scritto; quando
però questi non la creda opportuna, o perché non pertinente all' inchiesta o
per altro motivo, ne avvertirà il proponente; e se questi persista, la Commis
sione, o sottocommissione, delibera sul proposito.
Art . 1 5 . Previa deliberazione della Commissione o sottocommissione,
uno o più delegati dell ' una o dell 'altra potranno recarsi in istituti e scuole
pubbliche o private o pertinenti a corpi morali per raccogliere deposizioni
ed informazioni nel modo che più stimeranno opportuno : questi delegati
potranno a sé aggregare uffciali del pubblico insegnamento, od altre per
sone.
Art . 1 6 . Le deposizioni orali innanzi alla commissione saranno raccolte
da' segretarii nominati nel decreto reale; potrà la commissione aggregare
l' uno o l' altro di quei segretarii acl una sottocommissione .
I prefetti presidenti dei consigli scolastici provvederanno alle sottocom
missioni quei segretarii , eli cui queste abbiano bisogno.
La Commissione e la sottocommissione delibereranno quando vogliano
che le risposte siano raccolte stenograficamente, e provvederanno le perso
ne che accorrano.
Art . 1 7 . G l ' interrogatorii saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale del
Regno, e nei giornali provinciali destinati agli atti amministrat ivi , affinché
ogni cittadino conosca i fini del l' inchiesta, e sappia che interrogato o no, ha
facoltà eli concorrervi colle proprie informazioni, e col proprio giudizio .
Sarà pure pubblicato nella Gazzetta ufficiale di mano in mano che si vada
compiendo l ' inchiesta, un sommario del suo andamento.
Art . 1 8 . La Commissione, durante l ' inchiesta, farà al ministro della pub
blica istruzione le proposte di quei provvedimenti, che reputasse urgent i .
Determinerà p o i il modo eli ordinare ed esaminare l e deposizioni, le in
formazioni e gli altri element i che avrà raccolti; e, t erminata l' inchiesta, de
terminerà il modo di riassumerne i risultati e di far le sue generali dedu
zioni.
La Commissione d' inchiesta: Bonghi Ruggero, Cantelli G irolamo, Carbo
ne Domenico, Cremona Luigi, Finali Gaspare, Lioy Paolo, Settembrini Luigi,
Tabarrini Marco, Tenca Carlo .
Il segretario
Cesare Donati
V. o Il presidente
G. Cantelli
1 66
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo svolgimento dell 'inchiesta
7 . L'interrogato potrà, se vuole, mandare soltanto
serbando gli stampati .
1 67
fogli manoscritti ,
QUESITI
5
Presidi, direttori ed insegnanti
Quesiti sulla istruzione secondaria 1 •
Roma, dicembre 1 87 2
AVVERTENZE
l . I quesiti che seguono sono comuni a tutte le persone che voglionsi in
terrogare ; ma quelli segnati con * ) s' indirizzano più specialmente ai privati
cittadini, i quali non hanno parte nell ' i nsegnamento .
2 . Le risposte saranno inviate senza affrancazione al Ministero della pub
blica istruzione in Roma (Commissione d 'inchiesta scolastica).
3. Ciascuno potrà mandare direttamente al ministero suddetto le sue ri
sposte scritte, tuttoché abbia ricevuto i quesiti per mezzo del consiglio sco
lastico o del sindaco.
4. Le risposte dovranno portare il nome e il cognome del proprio autore
e l ' i ndicazione del luogo, donde sono mandate; delle anonime la Commis
sione non terrà alcun conto.
5. Ciascuno è libero di rispondere i n tutto o i n parte ai quesiti contenuti
nel presente fascicolo.
6 . Le risposte si potranno scrivere in foglio a parte, o pure sui fogli bian
chi intercalati fra gli stampati; ma ad ogni modo esse porteranno a lato il nu
mero del quesito a cui si riferiscono.
1 La redazione delle varie parti del questionario era stata affidata secondo un criterio di
competenz.< ai vari commissari; successivamente la commissione approvò in seduta plenaria il
testo definitivo dei quesiti, la cui edizione con le pagine bianche per le risposte fu spedita a sin
daci, prefetti ecc., e, esauritasi, sarà ristampata. Esiste, tra le carte del fondo, una redazione
complessiva, dovuta a Paolo Lioy, ove sono accentuate le esigenze educative e la necessità di
sconfiggere lo scetticismo dei giovani; una redazione, anch'essa complessiva, di Luigi Settem
brini, datata 27 ottobre 1 872, è ora pubblicata in L. SETTEMBRINI, Lettere edite e inedite . cit.,
pp. 267-274. Ci sono evidenti coincidenze redazionali tra il testo di Lioy e di Settembrini, tamo
che si può supporre che uno dipenda dall'altro: si veda per esempio il comune auspicio per l'u
so scritto e parlato del latino nelle facoltà giuridiche e mediche dell'università e la comune insi
stenza, espressa quasi con le stesse parole, sulla parte quasi esclusiva dell'Italia nei programmi
di storia.
. .
l . Basta, oppure è insufficiente al bisogno delle scuole secondarie il nu
mero dei professori che fanno i loro studi e conseguono il diploma nelle
scuole normali superiori e nelle facoltà u niversitarie? Se non basta, come ac
crescerne il numero ? Con quali altri provvedimenti si può ottenere che alle
scuole secondarie non manchino i professori regolarmente abilitati?
Gioverebbe ristabilire le sessioni annuali d ' esame presso alcune u niversi
tà per abilitare all ' insegnamento secondario anche quelli che non hanno fat
to studi universitari? Può aversi nel solo esame una prova sufficiente della
capacità dei professori , ovvero l' esperienza ha dimostrato il contrario 1?
Le commissioni permanenti d ' esame altra volta esistenti presso le uni
versità di Padova e di Pavia 2 hanno prodotto buoni effetti? Si potrebbe
prender norma da quelle per una istituzione che agevoli ai professori il con
seguimento del diploma?
2 . Quali prove fanno nell' insegnamento i professori usciti dalle scuole
normali superiori e dalle facoltà u niversitarie? Il grado e più specialmente
l'indirizzo dell' istruzione che vi ricevono sono bene adatti a farne abili inse
gnanti nei diversi ordini di scuole secondarie? Vi apprendono i metodi ap
propriati all' insegnamento mezzano, a cui si dirigono? Si fanno in ogni scuo
la gli esercizi e le conferenze?
Non è avvertito negli allievi delle scuole normali il difetto d'un opportu
no tirocinio scolastico? G ioverebbe a questo fine coordinare u n istituto se
condario alle scuole normali e alle facoltà universitarie per servire alle eser
citazioni pratiche?
Può tenersi sufficiente il solo diploma di laurea per abilitare all ' insegna
mento ? Non dovrebbe richiedersi anche l ' attestato di un lodevole tirocinio
fatto in una scuola?
Per regolarizzare la situazione degli insegnanti privi di titolo reclutati nei primi anni dello
Stato unitario furono stabilite sessioni straordinarie d'esame. Le norme per l'esame di abilita
zione degli insegn4nti del liceo e del ginnasio erano state stabilite con d.m . 8 apr. 1 870 in se
guito al r. d. 1 2 lug . 1 869 " Sessioni straordinarie d'esame per conferimento dei diplomi di abili
tazione agli insegnanti dei licei e ginnasi governativi sprovvisti di titoli legali d'idoneità». Que
sto decreto abrogava i precedenti r.d. 1 4 giu. 1863, n. 1 329, e r.d. 16 lug. 1 865, n. 24 19.
' Come mostra l'espressione sfumata « altra volta », il riferimento è all'ordinamento austria
co che nel 1 855, con l'istituzione dei seminari filologici a Padova e a Pavia, aveva previsto che
le due università, attraverso le prove di esame, potessero rilasciare certificazioni di abilitazione
per gli insegnanti nelle scuole dei territori italiani dell'impero.
1
1 68
1 69
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1 - Lo svolgimento dell 'inchiesta
giovani, che escono dal liceo, sono bastantemente istruiti per essere
2mmessi ai corsi normali superiori? Il difetto di preparazione non è spesso
d ' ostacolo a un conveniente svolgimento di quei corsi? C onverrebbe istitui
re pei giovani che si dedicano all ' insegnamento corsi preparatorii presso le
facoltà e le scuole normali?
segnare? Trovano nelle famiglie e nella �ocietà l ' appoggio e la considerazio
ne, a cui hanno diritto, non sono offese qualche volta dalla disparità di gra
do dirimpetto ai loro colleghi? Da quali altre cause, oltre la scarsità degli sti
pendi, possono essere condotte a trattare con negligenza l' insegnamento?
3. Quali frutti diedero i corsi speciali istituiti presso alcune facoltà uni
versitarie per abilitare i professori delle scuole tecniche e magistrali? Se po
chi sono gli alunni inscritti, da che deriva questa scarsità? Da poco zelo del
le facoltà, dalla noncuranza dei giovani , dalla gravezza degli studi, dalla po
ca lusinga che offre la carriera dell' insegnamento? Con quali eccitamenti si
potrebbe attirarvi un maggior numero di alunni? Con quale altro mezzo si
potrebbero procacciare buoni insegnanti a queste scuole?
I professori delle scuole tecniche e magistrali, ai quali non si chiede un
corso preparatorio di studi, ma che si abilitano mediante l' esame agli inse
gnamenti della contabilità, del disegno, della calligrafia, o delle lingue stra
niere, danno saggio sufficiente di attitudine e di sapere? Bastano le prove
stabilite per l ' esame ad accertare della loro idoneità? Le commissioni esami
natrici intendono tutta l ' importanza di queste prove, e portano negli esami
un criterio elevato e costante ' ?
Del metodo p i ù adatto per l ' insegnamento del disegno nelle scuole tec
niche sono in grado di giudicare convenientemente tutte le accademie di
belle arti oggi incaricate di dare esami di abilitazione? Per conoscere l 'abi lità
d ' u n professore di lingue straniere può credersi bastante la sola pubblicazio
ne d ' un libro , quantunque lodevole, in quelle lingue, giusta quel ch'è am
messo dal regolamento? Quali modificazioni si stimano necessarie nei rego
lamenti a rendere più sicure le prove d ' idoneità per quest' ordine di profes
sori ? Non si dovrebbe chiedere anche a questi un tirocinio scolastico prima
di concedere il diploma d'abilitazione?
4. Le persone incaricate della direzione e dell ' insegnamento nelle scuole
secondarie dello Stato vi si dedicano generalmente con zelo, con alacrità,
col sentimento del dovere e della disciplina, con amore vero degli studi e
della gioventù?
La condizione fatta a queste persone può concorrere in molti casi a ren
derle svogliate e poco curanti del loro uffizio? Vedono esse sempre apprez
zate le loro fatiche? Si sentono sicure del loro posto e non soggette troppo
all 'arbitrio ammi:1istrativo? Non incontrano soverchio impedimento a salire
a gradi superiori? Non sono troppo rigidamente vincolate nei modi dell ' in-
Vedi r. d. 3 apr. 1870, n. 5620, Regolamento per l'istituzione dei corsi d'istruzione desti
nati a preparare i maestri di scuole tecniche normali e magistrali e pel conferimento dei diplo
mi di abilitazione negli insegnamenti delle dette scuole"· Gli artt. 1 5-20 trattano in particolare
della calligrafia. A questo decreto fa riferimento la circolare ministeriale n. 280 del 14 ago.
1870 relativa all'insegnamento della calligrafia.
1
•
5. Le nomine e le promozioni, come oggi avvengono, soddisfano sempre
alle esigenze della scuola e alle giuste aspettative degl ' i nsegnanti? L'attuale
sistema dei concorsi è atto a dare criterii sufficienti per la scelta di buoni
professori? Gioverebbe togliere la differenza di grado tra gli istituti della
stessa specie per rendere possibile la promozione dei professori senza trasfe
rirli di l uogo? Quale prova ha fatto questo sistema nelle provincie napolita
ne, dov 'è stabilito per legge 1 ?
L a frequenza dei trasferimenti ha nociuto a l buon andamento delle scuo
le? Non dovrebbe il trasferimento esser fatto i n ogni caso per motivi gravi e
col consenso del Consiglio scolastico provinciale? Si può approvare che un
professore sia mandato per punizione da u na scuola ad un' altra?
È u tile mantenere la distinzione che oggi si fa tra professore di liceo e di
ginnasio; e nel ginnasio tra professori delle classi superiori e delle classi in
feriori? La condizione dei reggenti non dovrebb ' essere resa stabile dopo u n
triennio d ' esperimento? Non converrebbe, dopo u n tempo d i tirocinio, con
fermare a vita anche gl ' i ncaricati? V ' è qualche modificazione a portare nel
sistema degli aumenti che la legge stabilisce per gli stipendi a determinati
periodi d'anni? Gioverebbe dare ricompense straordinarie, anche d ' indole
morale, ai professori più distinti e benemeriti ?
C o n quali altri provvedimenti oltre l ' aumento dello stipendio, si potreb
be rilevar l'animo e migliorare la sorte degli insegnanti?
6. * I presidi, i direttori e i professori delle scuole secondarie pubbliche
inspirano tutti pel loro carattere, pei loro modi , per la loro condotta la fidu
cia necessaria, perché i padri di famiglia abbandonino alle loro cure i propri
figli? Insieme coll 'istruzione si danno essi pensiero dell' educazione degli
alunni? Cooperano a quest 'educazione colla costante urbanità degli atti e col
decoro e coll' esemplarità della vita? Invigilano i giovani e si occupano di
questi anche fuori della scuola? Tengono informati i genitori del profitto e
della condotta dei figli? E i genitori hanno con essi continua corrisponden
za, li interrogano e li richiedono di consiglio? Oppure la scuola è affatto dis
sociata dalla famiglia?
7 . * A scemar credito al pubblico insegnamento concorre il fatto che al-
Il d.lgt . IO feb. 186 1 , n.2 1 8, all'arr. l7 prescriveva: [ professori titolari verranno distinti
in tre classi, e secondo la classe in cui sono annoverati riceveranno lo stipendio. Il passaggio da
una classe all'altra avrà luogo o per anzianità o per merito indipendentemente dalle materie che
insegnano e dall'istituto al quale sono addetti. l professori di prima classe non possono oltre
passare il terzo del numero totale dei professori titolari nelle provincie napoletane ,.
1
•
1 70
Sezione 1 - Lo suolgimento dell'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
cuni professori facciano dell' opera loro u n ' industria poco decorosa? Vi so
no professori che danno ripetizioni ai propri alunni, che preparano candida
ti ad esami ch'essi sono chiamati a dare, che partecipano al privato insegna
mento in modo non approvabile o in iscuole non conformi alla legge?
È eseguita la disposizione che vieta ai professori delle scuole governative
d ' i nsegnare in istitut i privati senza il permesso del Consiglio scolastico pro
vinciale? Quali effetti, anche rispetto all ' i nsegnamento p rivato, ha prodotto
il permesso dato, ovvero l ' abuso di cumulare uffici che si fanno concorren
za tra loro 1 ?
8 . Tra i professori d'un medesimo istituto s i stabilisce quell'accordo in
telligente ed operoso che agevola le fatiche di ciascuno, unifica i metodi e
cresce efficacia alla disciplina? l presidi e i direttori vedono ben accolta dai
professori la loro autorità e la esercitano generalmente con profitto? Visita
no con frequenza le classi , assistono alle lezioni, consigliano i professori e li
sorreggono nel mantenere la disciplina? Si tengono in ogni istituto le confe
renze mensili, e si discutono in queste le proposte relative al buon andamen
to della scuola? Si concordano soprattutto i programmi e si combinano op
portunamente gli orari? Si tengono i verbali di queste conferenze? Si crede
necessaria qualche modificazione per rendere più utili queste conferenze?
9. l professori sogliono dare importanza agli studi pedagogici? Si pubbli
ca in Italia, come si fa altrove , qualche giornale pedagogico, che sia partico
larmente alimentato da professori delle scuole secondarie? Quali mezzi han
no i professori per seguire i progressi degli studi e le discussioni sui metodi
che si fanno presso le altre nazioni? D ifetta nelle nostre scuole la conoscen
za dei buoni metodi d' insegnamento ? Gioverebbero conferenze autunnali da
tenersi nelle principali città fra professori ginnasiali, liceali, e universitari?
Si potrebbe con tal mezzo sperare di ottenere la conciliazione delle di
verse opinioni sui metodi, le quali ora rimangono solitarie ed infeconde 2 ?
Amministrazione scolastica
1 0 . L' amministrazione scolastica provinciale è ordinata nel modo ptu
adatto a promuovere, invigilare e ben governare le scuole secondarie? Non
sono troppo limitate le attribuzioni tanto del provveditore quanto del consi
glio scolastico, e non gioverebbe allargarle t rasferendo in questi alcune delle
attribuzioni dell' autorità centrale? È utile che il prefetto sia il presidente del
consiglio scolastico, e quali effetti sono derivati dall' aver tolto il provvedi
tore e il consiglio scolastico dalla immediata dipendenza del ministero 1 ? I
consigli scolastici, come oggi sono composti, hanno sufficiente autorità e
rappresentano nel miglior modo gl'interessi dell' istruzione ? Vi è fatta una
parte conveniente al corpo insegnante della provincia? Come si potrebbe af
forzarne l'autorità e renderla più operosa ed efficace sulle scuole seconda
rie ? Si riterrebbe utile di restringere il numero dei consigli scolastici, esten
dendo l ' autorità di ciascuno a più provincie?
L' istituzione dei delegati di mandamento è stata di qualche vantaggio ri
spetto alle scuole secondarie? Come potrebbe il consiglio scolastico giovarsi
delle forze locali per esercitare con profitto la sua autorità 2?
1 1 . Una parte dei difetti che si lamentano nelle scuole secondarie può
derivare dal modo in cui è ordinata e opera l ' amministrazione centrale della
pubblica istruzione '? L' esperienza ha dimostrato intorno a ciò la necessità
di qualche riforma tanto nei çongegni amministrativi, quanto nelle autorità
consultive e tutrici del pubblico insegnamento?
Le ispezioni scolastiche hanno dato tutto il frutto desiderabile? Sono esse
ben ordinate e dirette al fine di riconoscere la condizione delle scuole e la
capacità degli insegnanti? Sono sempre ascoltati i consigli degli ispettori così
dai presidi e dai professori, come dall 'amministrazione centrale? Non acca
de talora che l' operato d ' un ispettore sia disfatto da un altro? A eseguirle
Il regolamento intorno all'amministrazione scolastica provinciale fu approvato dal r.d. 2 1
nO\'. 1 867, n. '-1050. Innovativo rispetto ai regolamenti successivi alla Casati estese a tutto il re
gno l'affidamento ai prefetti della presidenza del Consiglio scolastico e costituì l'amministrazio
ne scolastica provinciale con l'esclusione di fatto del corpo insegnante. Per tutte queste vicen
de relati\'e ali 'amministrazione scolastica provinciale si veda soprattutto la ricostruzione che ne
offre nella sua risposta scritta Federico Napoli (doc. 57, p. 520).
Per le attribuzioni dei delegati mandamentali per le scuole primarie e secondarie vedi
eire. 3 ago. 1 867, n. 209, e r.d. 2 1 nov. 1867, n. 4050, sul regolamento per l'amministrazione
scolastica provinciale. La funzione dei delegati fu oggetto eli notevoli discussioni nel corso del
l'inchiesta, e da più parti ne venne contestata l'utilità, soprattutto per le scuole secondarie. So
no comunque da ricordare anche voci favorevoli e in particolare la testimonianza di alcuni de
legati mandamentali riportati in questo volume (docc. 40 e 5 1 , p. '-1'13 e p. 500).
; Vedi r. d. 22 set. 1 867, n. 3956, « Ordinamento dell'amministrazione centrale della pubbli
ca istruzione », e r.d. 20 ott. 1 86"', n. '-!008, « Regolamento dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione "· Anche per questi temi si veda la sopra citata risposta scritta di Federico
a poli.
1
Il divieto agli insegnanti di impartire lezioni private ai propri allievi fu reiteratamente ri·
pelllto nel tempo. La circolare n. l '"i l, div. 3°, del l o ott. 1 863 firmata dal ministro Amari ri·
chiama sia il regolamento emanato a Torino il 1 2 dic. 185 1 , sia la circolare ministeriale del mi
nistro De Sanctis clell"8 nov. 186 1 . Rispetto ai precedenti la circolare Amari si sofferma molto
più diffusamente sui motivi del divieto. Si veda a questo proposito la risposta di Pasqualigo
(ACS. MPl, Dit•. scuole medie 1860-1896, b. 1 1, fase. 80), soprattutto per la consuetudine di
consentire agli insegnanti di scuole governative l'insegnamento negli istituti privati, con grave
pregiudizio anche per l'organizzazione degli orari.
Da più parti fu lamentato nel corso dell'inchiesta l'assenza di un giornale pedagogico nel
quale il ministero raccogliesse le idee degli insegnanti e proponesse delle direttive, sul modello
in particolare dei giornali pedagogici tedeschi. A questa lacuna intese in parte ovviare, quando
divenne ministro, Ruggero Bonghi promuovendo la pubblicazione del « Bollettino ufficiale del
Mini;tero della pubblica istruzione che nei suoi primi anni pubblicava anche saggi pedagogici
spe;so tradotti dal tedesco.
1
l
•,
171
!
1 72
1 73
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1 - Lo suo/gimento dell 'inchiesta
dovrebbero essere chiamati ispettori mutabili e straordinari, ovvero fissi e
scelti fra gli insegnanti secondari o u niversitari?
altri? Se dall' ordinamento della scuola, che cosa ha questa di particolare o di
più accetto? Se dal desiderio d ' una istruzione più conforme al sentimento
religioso, in che si crede che questo sentimento sia offeso o dalle persone o
dagli insegnamenti nelle altre scuole? V'hanno altre cause di questa prefe
renza? Può essere in qualche luogo effetto soltanto dell ' abitudine? Non c'en
tra mai la passione politica, e quella prevenzione che fa supporre cattivo tut
to ciò ch'è opera del governo?
Avviene che tra le persone stesse appartenenti agli istituti dello Stato vi
sia chi ne scemi il credito sparlando di quello che vi si fa, prendendo a
scherno autorità ed ordinamenti scolast ici, e dando esempio di polemiche
poco convenienti?
Insegnamento pubblico e privato
1 2 . • I padri di famiglia inculcano ai figli il rispetto che si deve alla scuola
e ai professori, ovvero mostrano essi stessi in molti casi di tenere in poca
considerazione lo studio e la disciplina? Sogliano alcuni dolersi , come d ' u n
peso soverchio, dell ' istruzione richiesta per dare ai giovani uno stato, e non
cercano e non abituano i giovani a pigliarne il meno che possono? Più che al
profitto e all'educazione i nt ellettuale dei figli non mirano sovente al conse
guimento del diploma o del certificato scolastico, e non scelgono, in luogo
della migliore, la via più breve per attenerli? S ' è dato qualche tentativo di
riuscire a questo scopo anche con mezzi non leciti?
I giovani trovano nell ' ambiente domestico e sociale quell ' impulso al rac
coglimento ed al lavoro, quel sentimento di riverenza all'autorità, quella
consapevolezza del dovere, che valgano a nobilitare ai loro occhi lo studio e
a rendere proficua la scuola?
1 3 . • Quale concorrenza si fa dagli istituti privati ai governativi, e in qua
le misura, e in qual ordine di scuole? Questa concorrenza si palesa con utile
o con danno dell ' istruzione? Come regolarla e renderla p roficua? Giovereb
be esigere maggiori guarentigie per l ' i nsegnamento privato o basterebbe ap
plicare ad esso più rigorosamente la legge, ovvero si dovrebbe concedere
piena libertà d ' i nsegnare senza guarentigie di sorta?
V ' è in qualche parte d ' Italia un regime di libertà quasi assoluto per l ' inse
gnamento secondario privato? Quali prove questo vi ha fatto, e quali effetti
ha prodotto anche sull' insegnamento p ubblico ' ?
1 4 . * Da che proviene che alcuni istituti tenuti da religiosi o da corpi mo
rali hanno maggior numero di alunni che gl'istituti governativi? Se dalla
maggior fiducia che inspirano i professori, in che questi sono superiori agli
La l. 1 7 ott. 1 860, n. 263, emanata sotto la prodittatura di Mordini all'art . 1 1 dettava:
" l'insegnamento privato è libero, ma non avrà lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico,
se non è dato secondo le norme prescritte dalla legge •. Il decreto lmbriani 10 feb. 1 86 1 , n.2 18
(cap. VI Degli istituti appartenenti a corpi morali e degli istituti privati» artt. 57-6-t), è più re
strittivo, pur non prevedendo alcun controllo sul titolo di studio del direttore dell'istituto pri
vato. Pur dando facoltà a tutti i cittadini superiori ai 25 anni di aprire scuole private poneva
una serie di condizioni: che i programmi eli studio fossero approvati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione, che l'insegnamento fosse dato in conformità al programma, che l'isti
tuto fosse aperto ali 'autorità per le ispezioni. La legge Casati invece (art. 247) prevedeva una
comunicazione al provveditore con annesso programma degli insegnamenti. Inoltre gli inse
gnanti e il direttore dovevano avere gli stessi requisiti richiesti agli insegnanti pubblici. Per la
situazione di licenza determinatasi a Napoli in seguito alle legge lmbriani, vedi, tra gli altri do
cumenti, la deposizione eli Antonio Labriola (doc. 23).
1
•
1 5 . • Le scuole private sono generalmente modellate su quelle dello Stato,
o ve n 'ha di libere? In che modo sono ordinate quest ' ultime, a quali scopi
soddisfanno, e come ottengono la fiducia dei genitori? Nelle scuole private
v'è ordinariamente sufficienza di insegnanti e di suppellettile scientifica?
V'hanno scuole private che con promesse illusorie e con vani apparati di stu
dio ingannano le famigl ie? Quale profitto si ottiene da quei corsi accelerati,
coi quali alcuni istituti privati assicurano di preparare i giovani sui programmi
governativi in un tempo minore di quello consentito per le scuole pubbliche?
1 6. • I professori delle scuole private vanno a paro di quelli delle scuole go
vernative così per l' istruzione come pel costume e per le qualità personali? Cu
rano più o meno di questi l'educazione degli alunni? Sono più trascurati, o re
golano meglio la disciplina nelle loro scuole? Quelli che appartengono al clero
o che insegnano nelle scuole ecclesiastiche intendono generalmente i bisogni
della civiltà moderna? V'ha di quelli che portano nella scuola la controversia
religiosa e che tendono a deprimere nei giovani il sentimento nazionale e a di
stoglierli dal rispetto dovuto alle leggi e alle istituzioni dello Stato? Questo ri
spetto è inspirato e mantenuto in tutte le scuole private dirette da laici?
1 7 . • L' istruzione religiosa è data in tutte le scuole secondarie dello Stato
nelle forme e colle discipline prescritte dalla legge? I n che modo è accolta
dai giovani? Quali frutti produce? Coopera alla loro educazione morale? È
accaduto che in qualche scuola sia stata causa d ' indisciplina e di disordini?
Negli istituti privati tenuti da laici è meglio provveduto a quest' istruzione?
Ne sono soddisfatti o se ne lagnano i padri di famiglia?
Può attribuirsi al modo con cui è data quest' istruzione la sfiducia che al
cuni genitori mostrano per le scuole dello Stato? Là dove questa istcruzione
non c ' è stata o fu smessa, v ' ebbero rimostranze per parte dei genitori? C 'è
stato alcuno, il quale abbia chiesto che questa istruzione non sia data al pro
prio figlio? Deve lo Stato sopprimerla o conservarla 1 ?
La legge Casati ali 'art. l 9 3 del tit . lli " Dell'istruzione secondaria classica prevedeva:
L'istruzione religiosa sarà clata da un Direttore spirituale nominato dal ministro della pubblica
1
•
•
1 74
Sezione I - Lo svolgimento dell 'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
L ibri di testo, letture
1 8 . Quali sono gli effetti del presente sistema rispetto ai libri di testo? È
utile ch'essi siano determinati per tutte le materie, o soltanto per alcuna di
esse? Ovvero che ne sia libera la scelta? I professori si attengono ai libri ap
provati dai consigli scolastici, e i consigli provvedono opportunamente ai
bisogni delle scuole?
Non produce inconveniente il mutare libro di testo per la medesima ma
teria nel passaggio da classe a classe? S ' impone con troppa leggerezza e fre
quenza l ' acquisto di libri , dei quali poi i giovani fanno scarsissimo uso? Vi è
qualche inconveniente a notare che sappia di monopolio o di traffico ille
cito?
V'è in alcuni istituti la pratica di far mandare a memoria i libri di testo e
di trascurare le dimostrazioni sulle carte, sugli oggetti naturali ecc . ? V ' è la
pratica contraria di non usare libri di testo per quelle materie in cui sono ne
cessari , e di costringere i giovani a scrivere note in iscuola per poi stendere
da sé il sunto delle lezioni?
È da approvarsi l ' uso delle antologie in generale? Quando siano raccolte
di scritti interi e compiuti e di pochi autori, potrebbero essere adoperate,
specialmente nelle classi inferiori?
D ica ciascun professore quali libri di testo adopera, qual ' è l ' uso che ne
fa, e che cosa l' esperienza gli ha fatto scorgere in essi di buono o di cattivo.
1 9 . * O ltre le letture che si fan no nella scuola, i professori consigliano e
dirigono le letture che i giovani fanno a casa? Si curano di distoglierli dai
cattivi libri e d ' inspirar loro l ' amore dei buoni, fanno concorrere queste let
ture a uno scopo d ' istruzione? Cercano alcuna volta ai giovani, in luogo del
le solite composizioni sopra un tema dato, qualche sunto o relazione o im
pressione delle letture fatte a casa? I genitori cooperano coi professori a
questo fine, o fanno da sé quando il professore non se ne cura?
Quali sono i libri non scolastici più comunemente letti e preferiti dai gio-
istruzione per ciascuno stabilimento secondo le norme da determinarsi con un regolamenLO ».
L'art. 222 che parla dell'obbligatorietà della frequenza dei corsi ginnasiali e liceali, aggiungeva:
" Gli alunni acattolici, quelli il cui padre o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di prov
vedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi, saranno dispensati dal frequentare
l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono. Tale dichiarazione
dovrà essere fatto per iscritto e con firma autenticata ai direttori od ai presidi di questi stabili
menti"· A tale articoli si rinvia per l'insegnamento religioso nelle scuole ed istituti tecnici. Da
alcune deposizioni come da altre fonti sembra però che l'insegnamento religioso fosse ignorato
spesso negli istituti tecnici che erano visti come scuole di ateismo o di indifferentismo religio
so; oltre a varie testimonianze nell'inchiesta, si possono ricordare alcuni versi del poemetto La
nuova educazione pubblicato dallo scolopio Mauro Ricci nel 1 867: "appena del francese sia sa
tollo l schiaffalo in qualche tecnico istituto l ove alla fede in Dio si tira il collo ». Nel periodo in
cui si svolse l'inchiesta il dibattiLO sull'istruzione religiosa era stato reso più acuto dalla propo
sta di Correnti di abolire la figura del direttore spirituale nei ginnasi-licei.
1 75
van i? Gl' istituti d ' istruzione secondaria possiedono piccole biblioteche cir
colanti atte a fornire ai giovani letture amene ed istruttive? on sarebbe uti
le provvederne ogni scuola?
Orari, premj e pene, tasse scolastiche
20. • Gli orari delle lezioni sono bene ripartiti nel loro complesso in mo
do che il lavoro eli ciascun giorno non riesca né troppo leggiero, né troppo
gravoso? Le lezioni sono opportunamente alternate fra le varie materie? Sta
bene che le lezioni si succedano nella giornata senza interruzione, o è me
glio dividerle con qualche ora eli riposo? Si potrebbe occupare quest 'inter
vallo eli riposo con esercizi od insegnamenti più geniali, quali la ginnastica
ed il canto? Qual è il sistema seguito nelle diverse scuole?
Le vacanze sono ben distribuite? Si pensa o no che siano troppo frequen
ti e soverchie al bisogno ? Giova che sia lasciato libero il giovedì o conver
rebbe impiegarlo almeno in piccola parte ? La vacanza principale deve aver
luogo, e per tutti, nell'autunno, o è meglio anticiparla nella stagione più cal
da? Sarebbe utile restringerla, oppure dividerla in due periodi? Sarebbe pos
sibile un sistema che, tenendone fissa la durata, variasse da luogo a luogo il
tempo di questa vacanza?
Che cosa pensano gli insegnanti delle vacanze per gli effetti ch'esse pro
ducono nell' insegnamento? Che cosa pensano le famiglie rispetto ai bisogni
ed alle abitudini domestiche?
2 1 . * I premj e le pene stabilite dalla legge giovano tutti al buon indirizzo
educativo della scuola? Sono proporzionati ai meriti e alle mancanze degli
alunni? Valgono a destare e tenere vivo in questi il sentimento del dovere e
un'emulazione che non trasmocli e non diventi nociva? V'è sempre accordo
colle famiglie affinché l ' efficacia dei premj e delle pene si estenda oltre la
scuola?
Le feste scolastiche sono ben dirette ad eccitare l ' amore degli studi, a far
onorare le glorie dell 'ingegno e a crescere importanza e nobiltà alla scuola?
Profittano nel modo e nel tempo in cui sono fatte? Si potrebbe attenerne
migliore risultato 1 ?
2 2 . * Che cosa si pensa dell'attuale sistema di tasse scolastiche? Devono
Il r.d. -t mar. 1 865. n. 2229, aveva istituito una festa annuale letteraria da tenersi nei licei
il 17 marzo eli ogni anno. Il Consiglio scolastico provinciale indicava ogni anno eli quale pensa
tore o scrittore si dovesse fare la commemorazione e quali insegnanti (e alunni) dovessero svol
gerla. Nel corso dell'inchiesta fu varie volte discusso sull'opportunità eli tale festa, che secondo
i più distoglieva eccessivamente professori e studenti dal normale svolgimenLO degli studi. In
seguito alla relazione presentata dalla Commissione d'inchiesta il l o luglio 1 87-t, il r.d. 1 3 set.
187-t, 2092, tra le altre cose, stabilì che la festa scolastica dovesse essere celebrata in forme
più semplici all'inizio di novembre, in coincidenza con l'apertura dell'anno scolastico.
1
n.
1 76
1 77
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1 - Lo svolgimento dell 'inchiesta
essere mantenute nella misura in cui sono stabil ite per le diverse scuole e se
condo la loro distinzione in tasse d' ammissione, d ' iscrizione _o d ' esame ' ?
Sono le une e le altre troppo gravi, o sono tollerabili? È bene che la tassa
d ' esame sia uguale per tutti i giovani, provengano essi da scuole private o da
scuole governat ive? Gioverebbe al contrario ripristinare l' obbligo della dop
pia tassa per gli studenti privati 2?
Si crede compenso sufficiente pei professori che fanno da esaminatori la
parte ad essi assegnata sulle tasse d' esame? Non sarebbe più conveniente che
tutte le tasse scolastiche fossero in maggior misura od anche interamente
adoperate a retribuire i professori delle scuole secondarie proporzionalmen
te all' opera che prestano?
varie parti d ' Italia? Oltre quella di Torino, vi sono in Italia società ginnasti
che , le quali pot rebbero coadiuvare in ciò il governo 1 ?
I giovani sono addestrati bastantemente anche negli esercizi militari? Do
ve si offre l ' opport unità, sono i più adulti esercitati anche al bersaglio, alla
scherma, all' equitazione, al nuoto? Si suoi dare nelle scuole la debita impor
tanza a tutti gli esercizi che invigoriscono l ' u omo e giovano a formarne il
carattere 2 ?
Ginnastica, Igiene
2 3 . • G li esercizi ginnastici si fanno in tutte le scuole e colla dovuta rego
larità? Furono introdotti anche nelle scuole e nei convitti femminili? E per
questi non incontrarono opposizione in qualche luogo?
L'insegnamento di questa disciplina è dato in ogni scuola coi riguardi
dovuti all' igiene ed ha assunto veramente un carattere pedagogico? V' hanno
in numero sufficiente i maestri che intendono la ginnastica non come un di
sordinato esercizio, ma come una razionale ed armonica educazione del cor
po? Nelle scuole e nei convitti femminili vi sono maestri o maestre di ginna
stica?
Come si abilitano i maestri di ginnastica, e quali guarentigie di attitudine
si chiedono a chi assume quest' ufficio? on dovrebbero questi maestri avere
sufficienti nozioni d ' igiene e una conoscenza almeno elementare della peda
gogia? Sarebbe utile che il governo provvedesse a istituire corsi normali in
La 1 . 1 1 ago. 1870. n. 5""8-J, aveva stabilito che per i licei e gli istituti tecnici, per i ginnasi,
per le scuole tecniche vi fosse una tassa di ammissione, una tassa di iscrizione annua e una per
l'esame di licen�a. Per i primi tre anni del ginnasio e delle scuole tecniche era stata stabilita la
stessa quota per la tassa di ammissione e di iscrizione, pari risperrivamente a L. 5 e L. l O. Prece
dentemente (come stabilito dal r.d. 28 giu. 1866, n. 302 1 ), le tasse erano diversificate per le va
rie scuole. La tassa di ammissione alle scuole tecniche era di L. 5, esarramente la metà di quella
per il ginnasio che era fissata in L. IO . La parificazione di tasse fra i tre primi anni del ginnasio e
della scuola tecnica verrà criticata nel corso dell'inchiesta. Si veda in proposito, per esempio, la
risposta inviata da Enrico Labriola (doc. 55, p. 5 1 1 ), che sostenne che tale sistema era da con
dannare perché aveva fatto aumemare il numero degli iscritti al ginnasio e diminuire quello de
gli iscrirri alle scuole tecniche, con grave danno per lo sviluppo economico del paese, che ave
va assai più bisogno, secondo Enrico Labriola, di lavoratori dell'industria, del commercio e del
l'agricoltura, che di la\'Orarori intellettuali.
' li r.d. 1 3 ser. I 87'f, n. 2092, frutto delle valutazioni emerse su questO pumo durante l'in
chiesta, all'art. 6 stabilì che gli studenri privati avrebbero potuto presemarsi in qualunque scuo
la governativa a sostenere gli esami di passaggio dall'una all'altra classe alla fine dell'anno insie
me agli altri alunni della scuola e pagando la tassa prescritta per gli esami di ammissione.
1
2 2bis . • È abbastanza provveduto a i bisogni dell ' igiene i n t utte l e scuole?
Le aule sono generalmente adatte e convenientemente arredate, hanno aria
e luce a sufficienza, e presentano quell ' aspetto di comodità e pulitezza che
giova a dare ai giovani l ' abitudine dell ' ordine e della decenza? Non si hanno
a lamentare in alcune scuole servizi mal disposti e indecorosi, che mettono
in pericolo il buon costume e la salute ?
In quali scuole e dentro quali limiti si dà l ' insegnamento dell ' igiene? Non
dovrebbe quest ' insegnamento essere reso più generale?
Esami
2 3bis. • Posto che i due mezzi per accertare il profit to degli studenti so
no il giudizio quotidiano del professore sulla loro diligenza ed attitudine, e
l ' esame di passaggio dall' una all' altra classe e dall ' uno all' altro grado d ' inse
gnamento, è data nel nostro sistema l ' influenza dovuta a ciascuno di questi
mezzi? Se no, quale dei due ne ha meno? E come si potrebbe a quello che ne
ha meno restituire l ' influenza che gli spetta?
Il dare poca importanza nell' accertamento del profitto del giovine al giu
dizio quotidiano e registrato dal professor scema l ' autorità di questo sugli
studenti?
24. Se da ll'esame di promozione fossero dispensati gli studenti che du
rante l ' anno avessero dato prova di essere dil igenti e studiosi e meritarono
costantemente punti di approvazione nelle ripetizioni e negli esercizi scola
stici, non si gioverebbe all' autorità del professore e non si promoverebbe la
diligenza e lo studio continuo?
Gli esami di passaggio da classe a classe debbono essere fatti dal profes-
La �ocietà ginnastica di Torino, fondata c diretta da Rudolf Obcrmann, era stata abilitata a
formare maestri di ginnastica: cfr. eire. 20 mag. 1 867, n.205, che annuncia l'apertura della
scuola magistrale tecnico-pratica di ginnastica di Torino, e eire. 9 lug. 1869, n. 253. relativa al
la disciplina per l'ammissione di allievi maestri alla scuola ginnastica di Torino. In proposito si
veda anche la deposizione di Ernesto Ricardi di Netro a Torino (ACS, MPI, Div. scuole medie
1860-1896, b. 6, fase. 33). Da diverse parti si levarono proteste per l'esclusiva concessa dal go
verno alla scuola di Torino, in particolare da parte della analoga scuola esistente a Venezia,
fondata nel 1866 da Pietro Gallo e Costantino Rcycr. Vedi anche pp. 1 39- lo.� O, in particolare
nota l .
Si vedano le deposizioni di Antonio Allievi (doc. 1 9, p. 230) e di Nicola M arse Ili (doc. 3 1 ,
p. 354).
1
1
1 78
1 79
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo st•olgimento dell 'inchiesta
sore della classe che lo studente lascia, o di quella in cui entra? Ed in genere,
sono necessari ed utili?
Può approvarsi che si ammettano come uditori nelle classi i giovani che
non abbiano superato l'esame di ammissione o di promozione? È conciliabi
le questa concessione col buon andamento delle classi?
Si potrebbero ammettere uditori a lezioni speciali, e in quali scuole?
2 7 . • Quando il profitto dei giovani si giudichi soltanto dalla riuscita de
gli esami, il giudizio può essere turbato dall ' influenza che può avere sulla
riuscita l' indole più o meno procace, più o meno timida dell ' esaminato, o il
caso della domanda che gli è diretta? Si crede che per queste due cause sie
no molti i giovani non meritevoli i quali sono approvati, mentre altri più
meritevoli sono respinti? Vi è un modo d ' impedire l ' i nfluenza di queste due
cause o di temperarla?
È utile negli esami attribuire eguale importanza a ciascuna materia d 'in
segnamento in modo assoluto ? Ovvero si dovrebbe assegnare a ciascuna ma
teria u na diversa importanza, avendo riguardo alla professione alla quale il
giovane dichiara di volersi dedicare? O con questo si rischierebbe di dimi
nuire la colt ura generale, ch'è il fine principale a cui è diretta la scuola?
Gioverebbe dividere le materie d ' insegnamento in diversi gruppi, e chie
dere al giovane a sua scelta o un' uguale profitto in tutte, o uno maggiore
dell ' ordinario in alcuna di esse?
Il numero delle materie d ' esame sembra soverchio, o si crede che, pur
ammettendo che tutte siano necessarie, gioverebbe distribuirle meglio e non
esigere l'esame sopra t utte una volta sola? I n quanti esami complessivi, in
questo caso, si dovrebbe dividere l' esame liceale e ginnasiale?
2 5 . Gli esami di passaggio da u n grado all' altro di insegnamento devono
essere fatti da una giunta di professori sia dell' istituto in cui lo studente ha
compiuto i corsi, sia di quello a cui è per ascriversi, ovvero da persone
estranee all ' i nsegnamento, o piuttosto da una giunta mista? Potrebbe lo Sta
to dare l ' esame ai giovani che escono dagli istituti governativi con una giun
ta di professori ufficiali, e ai giovani che vengono da istituti privati con una
giunta mista di professori ufficiali e di professori privati, ovvero di questi e
di persone estranee all' insegnamento e di professori ufficiali insieme?
Non è invece garantita meglio la imparzialità degli esami, quando siano
fatti da giunte comuni così ai giovani che escono da istituti governativi, co
me a quelli che escono da istituti privati?
26. È necessario che l'esame di licenza ginnasiale preceda quello di licen
za liceale, o basterebbe quest ' ultimo? Dovrebbero esser fatti amendue da
giunte composte nella stessa maniera, o diversamente composte?
on gioverebbe anziché sopprimere una di queste licenze, aumentarne il
numero e obbligare gli studenti ad ottenere una licenza ginnasiale inferiore
dopo i primi tre anni di ginnasio , una licenza ginnasiale superiore dopo altri
due, e la licenza liceale dopo altri tre?
È u tile aggiungere all' esame di licenza ginnasiale quello di ammissione al
liceo , e all' esame di licenza liceale quello d ' ammissione all ' università? O
uno dei due è soverchio e quale? O , soverchio uno, per i giovani che escono
da istituto governativo e vanno ad altro, governativo del pari, sono amen
due necessari per i giovani che venissero da istitut i privati e volessero entra
re in istituto governat ivo?
G iova che l ' intervallo fra l ' esame ginnasiale e il liceale sia prescritto per
legge, ovvero è meglio lasciare libertà al giovane di determinarlo secondo le
sue forze? Quando gli si lasciasse questa libertà, non bisognerebbero altre
garanzie ' ?
1 I l r.d. 2 9 set. 1 87"1, n. 10 16, all'art. 2 , su propof>ta della Commissione d'inchiesta abolirà
l'esame di ammissione al liceo. L'intervallo di tre anni tra l'esame ginnasiale e liceale era stato
reso obbligatorio con il r.d. 3 mag. 187 2, n. 807, relativo all'approvazione del regolamento per
gli esami liceali. L'art. 2 prescriveva che tra gli altri documenti che il candidato doveva presen
tare per essere ammesso dovesse esserci l'attestato di licenza ginnasiale conseguita non meno di
tre anni avanti l'epoca dell'esame di licenza liceale. Il fine evidente di questo provvedimento
era quello di colpire l'istruzione privata speculativa che, specie nel Mezzogiorno, proponeva corsi
abbreviati per il conseguimento della licenza liceale: nelle deposizioni e nelle risposte scritte
meridionali sono numerose le proteste contro il decreto del 1872; anche osservatori disinteres-
28. Il sistema d ' esprimere il giudizio coi punti è buono? Se no, quali so
no i suoi difetti? Non è meglio esprimerlo con parole indicanti il merito gra
duale, dal passaggio semplice fino al passaggio con plauso? Oltre l ' espressio
ne del giudizio sopra ciascuna materia, è necessario l ' esprimerlo sopra il
complesso dell'esame, e indicando l 'effetto d i questo sul progresso del gio
vine nell ' insegnamento?
Giova prescrivere programmi ai corsi dei professori d'insegnamento se
condario? Se sì, devono essere molto particolareggiati ed esprimere a parte a
parte i punti dello insegnamento , od indicarne solo l ' i ndirizzo e lo spirito, e
l'effetto che se ne aspetta: piuttosto, insomma , istruzioni che programmi?
Gli esami vanno fatti sopra tutte le materie dell ' insegnamento, così come
è descritto ne' programmi, o piuttosto sopra tesi formulate in conformità di
questi? Se sopra tesi, giova che queste sieno pubblicate in principio dell'in
segnamento del quale è termine l ' esame, oppure poco prima innanzi gli esa
mi? Potrebbero essere comuni agli esami in tutti gl ' istituti, se i programmi
d'insegnamento non fossero molto particolareggiati?
29. • È comune nel paese il sentimento che le giunte locali, nominate dalla
giunta centrale, procedono nei loro giudizi con imparzialità, o il contrafio?
Si avverte che gli studenti degli istituti privati sieno a condizioni pari
trattati con più rigore di quelli degli istituti governativi ,_ o no?
sati rilevavano però che gli studi secondari regolari erano troppo lunghi (cfr. per esempio la de
posizione di Marselli, doc. 3 1 , p. 35"1).
1 80
181
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo st•olgimento dell'inchiesta
G iova un magistrato inteso a dare unità d'indirizzo agli esami in tutto il
regno , sia proponendo temi comuni per gli esami scritti, sia nominando le
giunte locali d' esami, sindacandone i giudizi e raccogliendone e comparan
done i risultati?
Se giova , in quali termini dovrebbero restringersi le attribuzioni di que
sto magistrato ?
Gioverebbe che la legge si limitasse a determinare per ciascun istituto il
numero dei professori, e li lasciasse liberi d i distribuirsi fra loro in ciascun
anno le materie e le classi? Potrebbero in tal caso gli studi delle scuole nor
mali superiori ordinarsi in modo da abilitare tutti i professori all ' insegna
mento di più materie?
Si crederebbe opportuno di lasciare in facoltà dei professori di stabilire
le norme didattiche e disciplinari per le scuole, di fare programmi, di sce
gliere i libri di testo, ecc . ? Si avrebbe u na sufficiente guarentigia, qualora
questa facoltà fosse esercitata col mezzo di un consiglio generale d ' inse
gnanti eletti fra essi e convocato nelle ferie autunnali per discutere sui risul
tati ottenuti e sulle riforme da farsi?
3 0 . • L ' esame liceale è tenuto in ogni materia a quella maggiore altezza
dell ' esame ginnasiale, che l'intervallo dei tre anni dall ' uno all ' altro richiede
rebbe?
Sono soverchie e per numero e per ampiezza le prove scritte che si esi
go no per gli es�mi di licenza ginnasiale, anco a fronte di quelle che poi si
.
estgono per la ltcenza liceale?
È giusto e ragionevole l ' esame di riparazione? Dopo quanto tempo do
vrebbe concedersi? E, chi è approvato in alcune materia soltanto, dovrà nel
l ' anno seguente rifare l' intero esame?
Coloro che per legittimi motivi non possono presentarsi alla sessione
estiva di esami, non si trovano in una condizione più onerosa riguardo all'e
same di riparazione, presentandosi alla sessione d ' autunno? Come rimediare
a ciò?
Licei e ginnasi
3 1 . �a divisione della scuola classica in ginnasio e liceo è naturale o arti
ficiale? E utile mantenerla? O gioverebbe toglierla? Se è da togliere come do
vrebbero o �? inarsi gli studi in u n istituto unico? Gioverebbe i n ogni caso
c � lle?are ptu strettamente il ginnasio col liceo? Gioverebbe togliere la di
stmztOne tra ginnasio inferiore e superiore? Può essere utile che alcune ma
terie sieno insegnate dal medesimo professore tanto nel ginnasio quanto nel
liceo; e così pure pei due gradi del ginnasio? Converrebbe almeno togliere o
diminuire la differenza di stipendio che oggi v ' è tra i professori di liceo e
quelli di ginnasio superiore e pel ginnasio tra i professori delle classi i nferio
ri e quelli delle superiori?
Data la separazione del liceo, è bene mantenerlo qual è ora, di tre anni
ovvero ridurlo a due aggiungendo u n sesto anno al ginnasio? Ha giovato o
ha nociuto l ' aver tolto quest ' u lt imo anno dal ginnasio per aumentare il cor
so del liceo?
3 2 . Conviene nel liceo affidare due insegnamenti a un solo professore?
Qu�st ' accoppiamento di materie quale prova ha fatto pel latino e pel greco?
.
Se tl nsultato non fu del tutto soddisfacente, si può sperarne uno migliore
dall' unione d ' altre materie, per esempio del latino coll ' italiano , della fisica
colla storia naturale? Non si potrebbero anche fondere in uno due insegna
menti? O è più utile che ogni materia sia distinta e insegnata da un profes
sore?
33. • Gli alunni che escono dai licei sono sufficientemente e acconcia
mente preparati per entrare nelle un iversità? E se non passano alle universi
tà, hanno acquistato dagli studi liceali una coltura generale sufficiente?
Il numero e la distribuzione delle materie nelle varie classi tanto del li
ceo quanto del ginnasio corrispondono alla capacità dei giovani e ai fini del
l ' istruzione secondaria? I metodi d ' insegnamento danno il profitto che si de
sidera?
Quando il numero e la distribuzione delle materie fossero stimate supe
riori o alla capacità dei giovani o al grado d ' istruzione che ad essi si vuoi da
re, quale materia potrebbe senza danno essere tolta, quale ristretta? O sareb
be piuttosto da riformare il metodo dell ' insegnamento?
34 . • Converrebbe diminuire il numero degli istituti classici (ginnasi e li
cei) per poter fornire di più larghi mezzi e di professori tutti valenti quegl' i
stituti che verrebbero conservati?
Gli altri istituti classici potrebbero essere trasformati in licei scientifici
somiglianti alle scuole o ginnasi reali di Germania dove delle lingue classi
che s ' insegnerebbe il solo latino? In quest i licei scientifici non avrebbe il suo
posto naturale l' insegnamento delle lingue straniere viventi? Da quale di
queste lingue si dovrebbe cominciare? A quali giovani e per quali carriere
potrebbe servire il liceo scientifico, per quali il liceo classico? I due istituti
non potrebbero avere u n primo stadio comune, per esempio di tre anni?
3 5 . È sufficiente la preparazione degli alunni che sono ammessi nella pri
ma classe del ginnasio? Non ha recato danno la disposizione del regolamen
t o , la quale limita l'esame d' ammissione a prove troppo facili eli grammatica
italiana e eli aritmetica? Non converrebbe tener fermo alla disposizione della
legge, la quale prescrive che l ' esame d ' ammissione abbia luogo su tutte le
materie che s' insegnano nella quarta classe elementare 1? N o n gioverebbe
La l. 18 nov. 1859, n. 7 2 5 , all'art. 1 9 prescriveva che per l'ammissione al ginnasio l'alun
no dovesse sostenere l'esame su tmte le materie della quarta elementare. Fu probabilmente di
sattesa, come risulta da diverse deposizioni nel corso dell'inchiesta.
1
182
Sezione l - Lo SL'olgimento dell 'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
anzi richiedere per l ' ammissione al ginnasio, come alla scuola tecnica, che
gli alunni abbiano compito l ' intero corso elementare?
Sarebbe utile che la legge, come ha fatto per le scuole elementari , stabi
lisse anche pel ginnasio un minimo di età, per esempio i dieci anni, per esse
re ammessi?
·
36. I giovani che escono dal liceo hanno fatto nelle lingue classiche un
profitto corrispondente al lungo studio in esse speso? Se questo profitto è
scarso, quale ne è la cagione? Dei metodi non buoni, ovvero dei professori
poco abili? Sanno questi rendere accetto lo studio delle lingue classiche e
farne comprendere l ' utilità nella vita civile dei nostri tempi? Si fa la giusta
parte alla lettura dei classici, ovvero si eccede di troppo nell 'insegnamento
grammaticale? Questa lettura è diretta ad educare l 'intelletto ed il cuore ?
Quali effetti hanno prodotto nell 'insegnamento delle lingue antiche le re
centi grammatiche del Curtius, dello Schultz, dello Schenkl, ecc. 1 ?
Son<? ragionevoli i lamenti che s' odono intorno all' insegnamento del
greco? E utile conservare quest'insegnamento e ritenerlo obbligatorio per
tutti? Qualora si aprissero i licei scientifici 2, si soddisfarrebbe al desiderio di
tutti mantenendo l ' obbligo del greco solamente nel liceo classico?
Come ottenere che i giovani usciti dai licei e avviati alle università non
dimentichino gli studi fatti, principalmente quelli del latino e del greco? In
che modo questi studi potrebbero essere continuati nelle u niversità, quale
mezzo di più perfetta coltura, e qual sussidio agli studi professionali?
1 La grammatica scolastica del greco di Georg Curtius. pubblicata a Praga nel 1852, fu la
prima a introdurre nello studio del greco i risultati profondamente innovativi della linguistica
comparata. Si affermò in Austria Ungheria, anche grazie all'appoggio del ministro Bonitz; pro
gressivamente nella seconda metà del secolo sostituì in tutta Europa le precedenti grammatiche
tradizionali ed empiriche, quale quella del Burnouf; introdotta dall'Austria nel Lombardo-Vene
to nella traduzione italiana di Emilio Teza, edita a Vienna nel 1855, si diffuse in tutto il regno
nella seconda metà degli anni Sessanta nella traduzione loescheriana eli Giuseppe Mliller; ne fu
raccomandato l'uso agli insegnanti nelle istruzioni annesse ai programmi Coppi no del 1 O otto
bre 1 867. Nonostame la forte resistenza che incontrava presso gli insegnanti di tipo tradiziona
le (della quale sono numerose le testimonianze nell'inchiesta Scialoja) riuscì lentamente a im
porsi e anzi venne indicata come modello metodologico per lo studio della grammatica latina e
di quella italiana dal ministro Correnti con la circolare n.303 del 9 mag. 1 87 1 . La grammatica
latina dello Schultz e quella greca dello Schenkl, come messo in rilievo dalla deposizione tori
nese di Pezzi {ACS, MPl, Dit'. scuole medie 1860-1 896, b. 6, fase. 30) erano assai meno rigorose
e meno soddisfacemi dal punto di vista filologico; probabilmente perciò incontrarono minore
ostilità nel corpo insegnante. Ma anche nei loro confronti c'era un forte pregiudizio nazionali
stico come in genere contro i manuali importati dalla Germania.
' I licei scientifici, per i quali si veda anche il quesito 3-J, considerati con favore, per esem
pio, nella deposizione fiorentina di Villari (doc. 33, p. 378), rispondono soprattutto alle criti
che, diffusamente testimoniate nell'inchiesta, contro l'obbligo generalizzato del greco; si preve
deva un liceo adeguatamente umanistico ma liberato dal sovraccarico, difficilmente digeribile
per la maggior parte degli studenti, del greco. il loro modello era il Realgymnasium prussiano,
nato nel 1859, e presto diffusosi negli Stati tedeschi. Si trattava di una Realschule di prima cla;
se. che aveva il suo cardine nelle discipline scientifiche, ma prescriveva anche in tutto il corso
di nove anni, una presenza forte del latino.
1 83
3 7 . • egli istituti classici, nei quali gli studi versano principalmente sulle
lingue antiche, sarebbe opportuno l ' i nsegnare anche qualche lingua moder
na? Quale sarebbe la lingua da preferire, e in che anni di corso e con qual
metodo dovrebb ' essere insegnata? Converrebbe rendere obbligatorio questo
studio, ovvero lasciar liberi gli scolari di seg uirlo, contentandosi di incorag
giarlo con qualche distinzione? Quale prova ha fatto nei ginnasi delle pro
vincie napoletane l ' insegnamento della lingua francese ' ? Se i frutti sono sta
ti scarsi è da incolparne la negligenza degli alunni o la poca attitudine dei
maestri, o il non buono ordinamento dei corsi?
Sarebbe u tile l 'estendere a tutti gli istituti classici gli esercizi di disegno e
calligrafia che sono in alcuni? Gioverebbe unire lo studio del disegno geo�
metrico con quello della geometria in modo da aprire con esso un campo dt
esercizi pratici per questa scienza?
38. L'insegnamento della lingua italiana quali frutti ha dat<? ? È buono il
metodo seguito? e si credono i più adatti gli autori adoperati? E utile che } o
studio della lingua s' incominci nelle prime classi sugli scrittori del Trecento - ?
Quali composizioni si fan no dai giovani? Sono abituati a scrivere con na
t uralezza e con semplicità? Sono addestrati a ben ordinare i propri pensieri e
a concepire e svolgere convenientemente i soggetti che trattano? Nel liceo
continuano gli esercizi di composizione? Si credono utili per questi esercizi i
temi portanti descrizioni di cose non vedute o conosciute dai giovani, ch'es
si devono creare coll' immaginazione?
L ' insegnamento della letteratura è opportunamente sussidiato colla spie
gazione degli autori? I giovani sono preparati a profittarne con una suffi
ciente coltura nello scrivere? l professori sono essi stessi buoni e corretti
provinci a napoletana era stato in
L'insegnamento del francese negli istituti classici della
feb. 1 861, n. 2 18, art. 5. St pre
10
lgt.
cl.
il
con
alunni
gli
tuni
per
trodorro obbligatoriamente
apprendere la lingua tedesca a
di
e
ariament
vedeva inoltre la possibilità di permettere straordin
la letteratura e la filosofia.
dire
approfon
di
volontà
e
e
attitudin
ero
mostra>;
che
quei giovani
nelle Romagne e nel Vene
o,
apoletan
nel
forte
rmenre
' La tradizione puristica , particola
contro l'ondata di francesismi v�nuti eli
to, pri\·ilegia,·a gli scrittori del Trecento, per polemica
ne, negli anm dt Napo
moda nel Settecento e dilaganti , anche nel linguaggio dell'ammoinistrazio
nella scuola la scelta puristica
leone Ili; i programmi Coppino del 10 ottobre 1867ti,ribadivan
o co
trecenris sul fatto che " quelli come parlavanescl
insistendo sulla schienezza e vivacità » dei prime
�
letture
di
canone
un
ginnasio
del
classi
nelle
sì scrivevano,. e propone,·ano perciò
nel 1868 in favore della lingua de1 vtvl,
sivamente rrecentistiche. Sulla Relazione di Manzoni
la scelta puristica e sulle successive fa
sulla tenacia con cui nel 1870 il ministro Correnti ribadì
e scuola ( 1 860- 1 900), in Scuola, cul
lingua
si del dibattito, vedi M. RAIC!Cll, Questio11e della
1 98 1 , pp.85- 1 69, 433-444 . Nell'in
chi.
Nistri-Lis
Pisa,
Gentile,
a
Sanctis
De
da
tura e politica
e e di inviti acl adottare un
puristich
i
posizion
di
scontro
chiesta Scialoja si assiste a un continuo
lo stesso Coppi no (duce. 19 e 2 1 ,
canone eli lettura più moderno; nella sua deposizione romana
orientamento e privilegiare la _lettura dei moder
pp. 235 e sgg., 256 e sgg.) sembra aver mutato
389) si stacca dagli opposti schemausmt e n
ni. La deposizione milanese di Ascoli (doc. 3-t,luip. s\·olte
nel Proemio, pubblicato agli inizi del
eta
già
tesi
le
vigore
re
particola
prende con
in chiave scolastica.
ndole
;viluppa
,
JH73 sull' « Archivio glottologico italiano»
1
•
1 84
1 85
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo svolgimento dell 'inchiesta
scritt ori? La misura, in cui quest ' insegnamento è dato, corrisponde sempre
al grado della scuola e alla capacità dei giovani? on si eccede- talora in quel
le generalità della critica che gonfiano, in luogo di ammaestrare, la mente
dei giovani?
Si ritiene che basti per la coltura letteraria dei giovani la sola conoscenza
degli autori italiani? Devono essi uscire dal liceo digiuni d ' ogni notizia intor
no ai grandi autori stranieri moderni? Si potrebbe aggiungere al corso di let
tere italiane qualche lettura e spiegazione dei più insignì fra questi autori?
gradatamente all ' Italia, e da questa all' Europa, alla terra, agli astri? La geo
grafia astronomica non dovrebb ' essere insegnata dal professore di fisica?
Le scuole ginnasiali sono tutte fornite delle principali carte geografiche,
cosicché sia dato a ciascun professore, anche nell 'insegnare altre materie, di
additare sulla carta la regione o il luogo che gli accade di nominare? Gli
alunni sono provveduti degli atlanti prescritti , e vengono esercitati a trac
ciare carte geografiche e a risolvere quesiti di geografia?
39. Lo studio della filosofia profitta nei licei? Si deve mantenerlo nel cor
so secondario, ovvero riservarlo per l ' u niversità? Se si stima u tile di mante
nerlo, dentro quali limiti dovrebbe essere fatto? Bastano la logica e la psico
logia che ora s ' insegnano? Data l ' istituzione dei licei scientifici, può in que
sti ritenersi necessario l ' insegnamento di qualche parte della filosofia, e di
quale parte?
I professori , che insegnano filosofia nei licei, seguono tutti i l programma
e le istruzioni governative? Accade che alcuni se ne scostino o nei limiti o
nell ' indirizzo, o anche nella sostanza dell ' i nsegnamento? Si fondano tutti
sulle dottrine più comunemente ricevute, o v'è chi porta anche nella scuola
gli ardimenti e le singolarità della scienza 1 ? Sanno contenere quest' insegna
mento nella parte elementare , o tendono qualche volta ad elevare il corso e
a trascendere nelle dottrine speculative? Così com ' è dato quest ' i nsegnamen
to , si coordina e coopera utilmente cogli altri ad afforzare e disciplinare l ' in
telletto dei giovani, o non accade qualche volta che vi porti la confusione, e
lo riempia di un sapere vano e ambizioso 2 ?
4 0 . L ' insegnamento della storia deve succedere a quello della geografia,
o entrambi devono essere dati simultaneamen te? Quale profitto si ricava og
gi da questi studi nei ginnasi e nei licei?
Si crede ben fatto che lo scolaro, al quale s'è cominciato a dare qualche
nozione di storia nel corso elementare superiore, rimanga privo di tale inse
gnamento nelle prime tre classi del ginnasio? È utile che la storia si incomin
ci ad insegnare nel ginnasio nella parte più antica? Non sarebbe miglior con
siglio quello di incominciare dalla storia nazionale e compier questa nel gin
nasio svolgendone i punti principali , per poi riprenderla più ampiamente
nel liceo scendendo ai particolari e allargandosi via via alla storia delle altre
nazioni antiche e moderne? Non gioverebbe far procedere insieme e collo
stesso disegno lo studio della geografia?
È buono il metodo usato d ' insegnare la geografia incominciando dal si
stema degli astri , e scendendo al mappamondo e alle carte d ' Europa e d ' Ita
lia; o non è più utile incominciare dal comune dov ' è la scuola per risalire
' l'na forte critica a questa domanda fu svolta dal " Pungolo nell'ambito di una serie di ri
tle,,ioni svolte dal giornale 'ui quesiti proposti dalla Commissione (doc. 7 1 , p. 5 7 6) .
' Sull'insegnamento della filosofia vedi introduzione di M. Raicich, in particolare nota l ,
p . 39
"•
4 1 . Gli elementi della matematica, della fisica e della storia naturale sono
insegnati in tale misura e con tale metodo da bastare e per coltura generale e
per la preparazione agli studi speciali superiori?
In quale classe e a quale età degli alunni è opportuno incominciare l ' i n
segnamento dell' aritmetica ragionata , come prima parte dell'insegnamento
rigoroso della matematica elementare? Qualora nelle classi precedenti si ri
putassero necessari soltanto alcuni esercizi d i aritmetica pratica in continua
zione dello st udio che si fa nelle scuole elementari, potrebbero questi eserci
zi essere affidati al professore che in quelle classi insegna le materie lette
rarie?
In qual modo dev ' essere ripartito nelle varie classi l ' insegnamento della
matematica? Deve incominciare dall'aritmetica o dalla geometria, ovvero da
entrambe simultaneamente?
Quali effetti ha prodotto nelle scuole il metodo di Euclide prescritto dai
programmi del 1 867 1 ?
-! 2 . Dato che l a fisica e la storia naturale debbano essere non solamente
un campo d'esercitazioni per l' intelletto, qual è la matematica, ma anche
una somma di cognizioni positive indispensabili ad ogni colta persona, con
quale estensione si crede che convenga insegnarlo? A quali parti di esse sa
rebbe da dare maggiore svolgimento? Quali potrebbero essere omesse? O li
mitate senza danno? Sarebbe conveniente restringere in più modesto campo
queste materie lasciando che i giovani compiano poi la loro istruzione o nel
le scuole superiori o nei corsi liberi?
' R.d. 10 ott. 1 867 , n. 1 9-12, che approva le i'truzioni e i programmi per l'insegnamento
nelle pubbliche 'cuole del regno. Nel paragrafo " Istruzioni e programmi per l'insegnamento
della matematica nei ginnasi e nei licei era in particolare raccomandata l 'adozione del metodo
euclideo: " Nella geometria per dare all'insegnamento la massima efficienza educativa e per ri
durre a un tempo la materia entro modesti confini, basta applicare alle nostre l'esempio delle
scuole inglesi, facendo ritorno agli Elementi di Euclide, che per consem,o universale sono il più
perfeuo modello di rigore geometrico "· Questo metodo fu duramente contestato da molti inse
gnanti, ramo che il ministro Correnti con la eire. 9 mag. 1 87 1 , n. 303 , tornò a chiedere il pare
re degli insegnanti sul metodo euclideo: dalle carte (ACS, MPl, Diu. scuole medie, 1 860- 1 896,
h. 2) relative all'inchiesta Correnti ri,ulta una grande quantità di risposte negative, come in se
guito anche nell'inchiesta Scialoja. La pubblicazione degli Elementi di Euclide, curata da Enrico
Betti e Francesco Brioschi, era stata tempestivamente lanciata nello stes;o 1 8 67 dalla casa edi
trice Le Monnier, che si assicurò in tal modo il monopolio delle vendite, ;uscitando però molte
critiche per gli aspetti speculativi della vicenda.
•
1 86
1 87
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo svolgimento dell 'inchiesta
L ' insegnamento della storia naturale si fonda princip;llmente sulla flora,
sulla fauna e sulla geologia del luogo dov'è la scuola, ovvero si · danno nozioni
di cose lontane e senza vivificarle col paragone delle vicine? Le collezioni di
storia naturale nei licei, oltre a possedere i tipi necessari per le classificazioni
fondamentali, sono più specialmente ordinate ad illustrare la geologia, la fau
na e la flora del luogo anche in relazione all ' agricoltura ed alle industrie?
mento proprio della scuola tecnica in quella misura e con quella diligenza
che valgono a dar guarentigia di un vero profitto? V'è qualche scuola tecni
ca , in cui il corso è distribuito in quattro anni, e quale prova ha fatto così
pel profitto negli studi, come per la frequenza degli alunni?
Gioverebbe ordinare questo corso di quattro anni in modo, che nei pri
mi tre fossero dati con maggiore larghezza gl ' insegnamenti letterari, e all' ul
timo si riservassero gl'insegnamenti più strettamente tecnici e scientifici?
Quale fru tto ha dato l ' istituzione di un q uarto anno, fatta con questo
concetto in alcune scuole tecniche? Sarebbe utile che, conservato nei primi
tre anni un tipo comune di scuola generale, si lasciasse in facoltà dei comuni
e delle provincie di aggiungere il quarto anno con quei corsi complementa
ri, che sembrassero più propri ai bisogni speciali del luogo 1 ?
Scuole tecniche
4 3 . * La scuola tecnica, qual' è attualmente ordinata, provvede a una suf
ficiente istruzione pei giovani, che abbandonandola, si danno alle arti e ai
negozi, o cercano i più modesti impieghi ? Prepara inoltre convenientemente
i giovani, che prosieguono i loro studi negli istituti tecnici? I n che difetta o
in che eccede sotto l ' uno e l ' altro aspetto?
Gioverebbe dare alla scuola tecnica un indirizzo più determinato verso
alcune professioni, o si crede più utile mantenere ed allargare in essa i soli
insegnamenti destinati a fornire una coltura generale superiore all 'elementa
re? È possibile raggiungere tutti e due questi scopi in un' u nica scuola riparti
ta in gradi o sezioni diverse? Come potrebbe essere ordinata questa scuola?
E se non è possibile, converrebbe stabilire due ordini diversi di scuole?
4 4 . * Quali effetti ha prodotto per le scuole tecniche l ' aver tolto gl' istitu
ti tecnici dalla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione 1 ?
Non è utile che i due gradi dell' insegnamento tecnico secondario siano
retti dalla medesima amministrazione?
Non è di danno a un gran numero di giovani il non poter passare dalle
classi della scuola tecnica a quelle del ginnasio e viceversa? Non gioverebbe
coordinare la scuola tecnica al ginnasio inferiore in modo da render possibi
le questo passaggio? O non converrebbe piuttosto fondere insieme scuola
tecnica e ginnasio inferiore, e istituire un solo corso triennale da servire per
l ' istruzione dei giovani, che non si avviano a studi superiori, e di prepara
zione comune così per l ' istituto tecnico, come pel ginnasio superiore?
Come dovrebb' essere ordinato questo corso?
4 5 . * È sufficiente il corso di tre anni per isvolgere le materie d'insegna-
Gli istituti tecnici erano stati trasferiti dalle attribuzioni del Ministero della pubblica istru
zione a quello dell'agricoltura, industria e commercio con r.d. 28 nov. 1 86 1 , n. 34 7 . Lo iato
che si determinò di conseguenza tra scuole tecniche istituti tecnici, che ebbe riflessi nello
scollegamento tra i programmi delle due scuole e nella rivalità fra i due ministeri (che si cercò
di temperare insediando commissioni miste per trovare un accordo), creò molti scontenti; le
deposizioni e le risposte dell'inchiesta ne offrono ampia testimonianza con una decisa preva
lenza di pareri favorevoli al ritorno degli istituti tecnici alle dipendenze della pubblica istru
zione.
1
e
'!6. * Quale prova ha fatto nelle scuole tecniche l ' insegnamento delle ma
terie scientifiche? È appropriato all'età ed all ' intelligenza degli alunni? È op
portunamente coordinato colle altre materie di studio? È mantenuto entro
giusti limiti? Vi sono libri di testo adatti a q uesta prima istruzione scientifi
ca? I professori possiedono generalmente non solo le cognizioni necessarie,
ma anche il metodo per insegnare elementarmente la scienza?
L ' estensione data all ' insegnamento della matematica nelle scuole tecni
che è in relazione coli ' età e coi bisogni dei giovani, specialmente di quelli
che non proseguono oltre negli studi? Non occupa parte del tempo e delle
forze, che gioverebbe spendere in altre discipline? Basterebbe insegnare
compiutamente l ' aritmetica, e dare un conveniente svolgimento alla parte
elementare della geometria? Ovvero si ritiene necessario anche qualche inse
gnamento di algebra?
4 7 . Da che deriva, che l' insegnamento della lingua italiana dà troppo
scarsi frutti nelle scuole tecniche? Dall' insufficiente preparazione degli alun
ni nelle scuole elementari? Dali ' ordinamento difettoso della scuola tecnica?
Dal tempo non bastante che vi s ' impiega? Dai professori poco abili? Dal me
todo non buono? Da quali altre cause?
L ' insegnamento della storia è dato nei giusti confini, e con opportuno
indirizzo educativo? Procede unitamente a quello della geografia, e si sussi
diano l ' un l'altro? Sta bene che questi i nsegnamenti siano affidati al medesi
mo professore che insegna la lingua italiana? È necessario che tutte queste
materie siano insegnate da un professore nel secondo e terzo anno di corso,
e da un incaricato nel primo? Non può bastare un solo insegnante per rutti e
tre gli anni? E se non basta, gioverebbe dividere fra due insegnanti non già
1 Con eire. n. 3 1 5 del 30 ser. 1 87 1 il ministro Correnti introdusse alcune variazioni nei pro
grammi d'insegnamento delle scuole tecniche raddoppiando ad esempio le ore d'italiano. Al fi
ne però di completare l'istruzione profes>ionale di quanti dopo la scuola volessero dedicarsi ad
una professione si propose di aggiungere al triennio un quarto anno complementare in quei
municipi che fossero disposti ad assumersi metà della spesa.
1 88
1 89
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo suolgimentu de/l 'inchiesta
gli anni di corso, ma le materie d' insegnamento, e incaricare l ' uno della lingua
italiana, l'altro della storia e geografia? Come procedono questi insegnamenti,
dove questa riforma fu fatta? Della geografia non converrebbe affidare la parte
fisica ed astronomica al professore di matematica o di scienze naturali?
elementari le cognizioni a loro necessarie, e di formare al tempo stesso buo
ni educatori e buone educatrici?
Se la parte educativa vi è negletta, come riparare a questa mancanza?
Suppliscono i convitti, dove questi sono annessi alle scuole, o sono istituiti
soltanto per un fine economico? Come sono amministrati quei convitti, in
che relazione stanno colla scuola, e quale frutto hanno dato riguardo alla di
sciplina? La difficoltà incont rata così nell 'aprire come nel mantenere i con
vitti maschili }.Jroviene dal non essere questi coordinati alla scuola e dal non
avere alcun carattere educativo oppure da altre cause int rinseche ai convitti
stessi? È possibile di vincere questa difficoltà? Può la scuola normale femmi
nile far senza del convitto?
Converrebbe fare un' istituzione sola del convitto e della scuola, affinché
i maestri e le maestre vi trovassero non sola la colt ura della mente ma il
buon indirizzo dell'animo e la conveniente d isciplina del costume? È possi
bile ottenere ciò mantenendo la scuola a spese del governo e il convitto a
spese del comune o della provincia? Come si potrebbe dare a questa scuola
convitto unità eli direzione e d'amministrazione?
48. • Quali frutti si hanno nelle scuole tecniche dall' insegnamento della
lingua francese? I professori sono generalmente capaci, e possiedono, oltre la
cognizione di questa lingua, il metodo per ben insegnarla, e l ' uso perfetto
della pronuncia? Quest ' insegnamento raggiunge lo scopo di servire non solo
quale strumento di coltura generale, ma anche quale sussidio nella carriera
professionale dei giovani?
L ' insegnamento del disegno è dato in tutte le scuole con indirizzo pratico
e con metodo opportuno? I professori che vi attendono , sono in grado d'in
segnare il disegno geometrico o si limitano generalmente al disegno d'ornato?
E in questo fanno buona scelta di modelli, prendendoli dalle migliori età del
l ' arte? Avvezzano i giovani a copiare dal vero?
I programmi scolastici rispondono in tutte le materie dell' insegnamento
tecnico al migliore indirizzo degli studi? In che si crede che pecchino, e quali
correzioni vi sembrano richieste?
49. La suppellettile scientifica soddisfa in ogni scuola alle esigenze dell 'in
segnamento? È fornita colla larghezza sufficiente dai comuni, ai quali spetta
provvedervi? on s' incontra per questa e per le altre spese, che sono poste a
carico dei comuni, una renitenza che incaglia il buon andamento della scuola?
V ' hanno scuole tecniche in cui il concorso degli alunni è così grande che
alcune classi n ' abbiano molto al di là di quaranta? Dove questo accade, i mu
nicipi si sono prestati ad aggiungere altre aule alla scuola e a raddoppiare i
corsi? S'è ordinato in tal caso l ' insegnamento in modo da non diminuire per
alcun corso le ore di studio?
50. Il pareggiamento concesso alle scuole tecniche istituite dai comuni e
dai corpi morali ha concorso a moltiplicare queste scuole e a migliorarne la
condizione? Le scuole, che furono pareggiate, hanno tutti i requisiti voluti
dalla legge? Il pareggiamento è tolto subito che venga a mancare alcuno di
questi requisiti? Le autorità scolastiche pongono la debita diligenza nel rico
noscere quando avviene questa mancanza? Sono sempre in grado di avver
tirla?
5 l . Vi sono scuole tecniche non compiute sia pel n umero degli insegna
menti, sia per la durata dei corsi, state istituite da' comuni e da corpi morali
giusta la facoltà concessa coll'articolo 1 39 del Regolamento 1 9 settembre
1 860? Come sono ordinate queste scuole, e quali risultati danno?
Scuole normali e magistrali e convitti annessi
5 2 . La scuola normale, così com 'è oggi ordinata, raggiunge il doppio
scopo, a cui deve intendere , quello cioè di fornire ai maestri e alle maestre
5 3 . Quali prove hanno fatto, al paragone d i quelle dello Stato, le scuole
normali e magistrali aperte dai comuni e dalle provincie? Son tutte ordinate
regolarmente? H a giovato il pareggiarle e il costituirle sedi d ' esame per gli
aspiranti alle patenti?
Vi sono scuole private o di corpi morali istituite per preparare gli alunni
a sostenere l ' esame di abilitazione? Ve n'è alcuna presso i conservatorii e i
ricoveri di beneficenza? Come sono ordinate queste scuole? A qual grado
d ' insegnamento provvedono? Quali frutti danno?
L ' esame di abilitazione basta da sé solo a dare la guarentigia necessaria
della capacità dei maestri? Sono sufficienti le prove richieste in questo esa
me ai candidati? Ai candidati che sostengono l ' esame senz' aver fatto il corso
normale non si dovrebbero chiedere almeno le stesse prove che sono impo
ste agli alunni della scuola normale? Le commissioni d ' esame sono bene
scelte e mettono un giusto rigore nei loro giudizi? Si crede necessaria qual
che modificazione, sia nella composizione delle commissioni sia nella esten
sione e nella forma degli esami?
5'+ . • I sussidi stabiliti dal governo e dalle provincie per gli allievi e le al
lieve delle scuole normali sono sufficienti al bisogno così pel numero com
plessivo, come per la somma assegnata a ciascuno ? Ne hanno tutte le parti
dello Stato, e in qual proporzione? Varia questa proporzione secondo la
maggiore o minor mancanza di scuole e eli maestri ?
l sussidi sono sempre distribuiti opportunamente, e giovano ad attirare
buoni allievi alle scuole normali ? Accade che molti degli allievi sussidiati,
dopo d ' aver compito il corso normale , si dirigano ad altre carriere? Come
provvedere a che i l sussidio non vada perduto per l ' i nsegnamento elementa
re ? Come ottenere ch'esso chiami alle scuole gli allievi più capaci?
1 90
191
Fonti per fa storia della scuola
Sezione I - Lo S!'ofgimenlo dell'inchiesta
In che proporzione stanno i maestri che escono dalle scuole normali con
quelli che conseguono la patente sostenendo soltanto l ' �same?
5 7 . • L' accomunare in u no stesso convitto e in una stessa scuola le allieve
maestre di città e quelle di campagna non reca inconvenienti? ei convttu,
specialmente se sono nelle grandi città, si segue quella parsimonia nel vivere
e quella semplicit à nel vestire, per le quali le alunne destinate a diventare
maestre di campagna possono abituarsi alla vita povera e stentata, a cui sono
chiamate? Non accade che tutte le alunne vi prendano abitudini e desiderj
superiori alla loro condizione? Come rimediare a ciò? Togliendo i convitti e
le scuole normali femminili dalle città, ovvero distinguendoli in due ordini
diversi secondo la diversa condizione delle alunne?
Vista la difficoltà e il pericolo che s ' incontra nello staccare le maestre i n
giovine età dalle loro famiglie, non dovrebbe cercarsi il modo d i rendere
abili all ' i nsegnamento le allieve che potessero esser nominate maestre nel
loro comune? Come raggiungere questo scopo?
5 5 . È necessario che la scuola normale sia divisa dalla scuola tecnica nel
mentre ha comuni con questa il grado e le materie d ' insegnamento ? Non si
potrebbe restringere la scuola normale ad un quarto anno di studi da farsi
dopo terminato il corso tecnico? Basterebbe un solo anno complementare a
istruire i maestri nella pedagogia e nel metodo, a perfezionarne la coltura e a
esercitarli nella pratica della scuola? Gioverebbe questo provvedimento a ri
mediare a quell 'interruzione di studi, che ora è inevitabile, tra la scuola ele
mentare e la normale per l ' età richiesta all' ammissione degli allievi maestri ?
Come riparare altrimenti a questa interruzione?
Si potrebbe estendere questo provvedimento anche alle allieve maestre
aggiungendo alla scuola superiore femminile un quarto anno destinato agli
insegnamenti speciali per la loro carriera? Non sarebbero in tal caso da con
vertire in scuole superiori femminili tutte le scuole normali attualmente esi
stenti?
Quali altre istituzioni od espedienti possono essere suggeriti per crescere
i mezzi di preparare buoni maestri e maestre?
'
56. Sono molti o pochi gli alunni provenienti da scuole rurali che chie
dono d 'entrare nelle scuole normali? Sono bastantemente preparati per so
stenere l ' esame d ' ammissione? Sono ammessi talora, benché non i n grado di
seguire il corso? Quest 'agevolezza non ha fatto abbassare gli studi in alcune
scuole normali?
In quale proporzione stanno nelle scuole normali gli alunni provenienti
dalla campagna e quelli appartenenti alle città? Se i primi sono in picco! nu
mero , concorre a ciò l'insufficiente istruzione ricevuta nella scuola elemen
tare, la quale rende loro insuperabile l ' esame d ' ammissione? Come rimedia
re a quest ' inconveniente? Gioverebbe aprire in ogni scuola normale un cor
so preparatorio, o sarebbe più utile convertire in scuole preparatorie le mi
gliori fra le scuole elementari superiori di campagna? Questi due modi di
preparazione al corso normale sono in atto in qualche parte d ' Italia? Le di
sposizioni date a questo fine con le circolari ministeriali 1 8 marzo e 23 lu
glio 1 870 hanno avuto esecuzione, e quali effetti ottennero? Non sarebbe
necessario estendere anche a questo anno preparatorio i sussidi concessi agli
alunni pel corso normale 1 ?
1 L ' ipotesi di un corso preparatorio nacque in seguito alla esigenza d i poter scegliere quali
maestre le stesse alunne provenienti dalle scuole di campagna. Vedi eire. 1 8 mar. 1 870, n. 2 69 ,
del Ministero della pubblica btruzione (Provveditorato centrale per l'istruzione primaria e po
polare). << Istituzione di scuole femminili preparatorie ai corsi magistrali •, e eire. 23 lug. 1 870, n .
del Mini;tero della pubblica btruzione (Pronediwrato centrale per l'istruzione primaria e
popolare), « Convenienza di btituire scuole preparatorie e magistrali per allieve maestre desti
nate all'insegnamento nei piccoli comuni rurali •. Inoltre una successiva circolare n. 296 del 30
2,5.
5 8 . Le materie che s ' insegnano nelle scuole normali sono ben coordinate
fra loro ed atte a dare la coltura necessaria a i maestri e alle maestre elemen
tari ? V'è sovrabbondanza negli studi che vi si fanno? Col metodo seguito si
ottiene di nutrire efficacemente l ' intelletto degli alunni e di avviarli alla pra
tica più conveniente per la scuola? Non si esercita t roppo la memoria a sca
pito della buona educazione della mente? Sarebbe da dare minore estensione
e più profondità all ' i nsegnamento, o da impiegarvi un tempo maggiore allar
gando il corso a quattro in luogo di t re anni? V ' hanno osservazioni a fare sui
programmi e sulle istruzioni che li riguardano? Gli orari assegnati per le le
zioni sono opportunamente distribuit i ? Quali effetti si ottennero dalle modi
ficazioni portate agli orari colla circolare ministeriale 2 dicembre 1 87 0 1 ?
S ' è provveduto a raddoppiare i corsi in quelle scuole dove il numero de
gli alunni va oltre i quaranta per classe?
59. • All ' insegnamento della lingua italiana è data nelle scuole normali
un ' importanza corrispondente l ' indole speciale della scuola? Vi è considera
ta come il fondamento dell ' istruzione? È speso intorno ad essa un tempo
sufficiente? Si abituano gli alunni e le alunne a parlare correttamente? Si ha
cura che tutti apprendano a legger bene?
I lavori femminili sono insegnati con sufficiente larghezza? Sono partico
larmente indirizzati ai bisogni della vita domestica? S' insegna in qualche
clic. 1 87 0 , « Riforma degli istituti femminili di educazione diretti da suore e oblate e f!On stati
colpiti dalla legge di soppressione 7 luglio 1 8 66 • , prevedeva tra l'altro la possibilità di istituire
tali scuole presso questi istituti. Secondo la legge Casati alla scuola normale ci si poteva iscrive
re a l -1 anni, quindi con un intervallo di circa tre anni dalla fine del primo corso di studio. La
necessità di eliminare questa pausa e preparare soprattutto le ragazze uscite dalle scuole rurali,
portò ;tll'ipotesi di un corso preparatorio.
1 La eire. 2 clic. 1 870, n. 2 9 2 , aveva modificato la distribuzione delle materie nei vari anni.
l criteri e le motivazioni furono illustrate dal ministro Correnti con successiva circolare del 2 6
marzo 1 87 1 , n . 299, che dava istruzioni s u l nuovo orario.
1 92
1 93
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo svolgimento del/ 'inchiesta
scuola il cucire a macchina 1 ? Non si dovrebbe estendere a t utte quest' inse
gnamento? V'è in qualche scuola un insegnamento di musica 'diretto a un fi
ne professionale? Come si dà, e qual frutto se ne ottiene? In quali scuole si
dà l' insegnamento del canto come semplice disciplina educativa? Entro qua
li limiti e con qual metodo è dato ? Q uali frutti se ne ebbero ? Gioverebbe
rendere obbligatorio quest' insegnamento in tutte le scuole?
S ' i nsegnano in qualche scuola normale maschile i principj dell' agricoltu
ra? Non si dovrebbe promuovere quest'insegnamento in tutte le scuole?
Le ispettrici chiamate a vegliare all 'andamento della scuola e a curare l ' i
struzione nei lavori femminili adempiono con zelo a quest' incarico e porta
no un efficace concorso alla scuola? I consigli direttivi che governano le
scuole e i convitti , attendono con premura al loro ufficio, si adunano nei
tempi stabiliti, visitano la scuola e il convitto, e vi esercitano con profitto la
loro autorità? Se l' opera loro è scarsa, proviene ciò dall' istituzione, o dalle
insufficienti attribuzioni, ovvero dalla composizione del consiglio?
60. * Le persone che insegnano nelle scuole normali offrono tutte una
sufficiente guarentigia di sapere e di attitudine didattica? Non ha nociuto al
l ' importanza di queste scuole che la legge non chiedesse agli insegnanti i ti
toli d ' idoneità prescritti per tutti i professori delle scuole secondarie e non
sottoponesse ad alcuna condizione la loro nomina? Non dovrebbero que
st' insegnanti essere parificati agli altri così nei diritti, come negli obblighi?
Alla direzione ed all ' i nsegnamento nelle scuole normali femminili come
nelle scuole superiori femminili, sarebbero da chiamare di prefer�nza le
donne, o si credono più atti gli uomini ? Se la donna sembra preferibile, co
me metterla in grado di adempiere a quest ' u fficio? In quali scuole e con qua
le preparazione di studi si possono formare le maestre per l ' insegnamento
secondario? In quali materie si crede che la donna può raggiungere più facil
me nte e più sicuramente il grado di sapere necessario per quest'insegnamen
to -, ?
Scuole superiori femminili
6 2 . * Le scuole superiori femminili istituite secondo la circolare ministe
riale 9 luglio 1 869, rispondono al bisogno di una giusta e soda coltura mez
zana per la donna? Appare richiesto qualche miglioramento o modificazione
sia nell' ordine, sia nella qualità e durata degli studi che vi si fanno 1 ?
A quali ceti appartengono l e alunne che frequentano queste scuole? L ' i
struzione che vi ricevono è in armonia con la condizione delle alunne e con
gli uffici a cui esse sono destinate nella società e nella famiglia? Questa istru
zione è sussidiata e sorretta da un' appropriata e salda educazione dell 'ani
mo? Giova ad afforzare nelle alunne il senso p ratico della vita?
Da che nasce che pochi municipi finora hanno risposto agli eccitamenti
del governo? È per negligenza, o perché non credono necessario questo ge
nere di scuole? Li trattiene forse la precarietà del sussidio che il governo
promette solo d ' anno in anno? Quali cause impediscono il rapido propagarsi
di quest' istituzione?
6 1 . * Le persone che dirigono i convitti e le scuole normali e in genere
quelle che insegnano e che assistono gli alunni e le alunne intendono l ' indo
le speciale del l ' ufficio loro affidato, e vi mettono le cure necessarie per ben
adempirlo? Fanno convergere a un fine educativo l ' istruzione e la disciplina
e vi cooperano coll' esempio e coi modi? È abbastanza raccomandata e fatt�
osservare nei convitti e nelle scuole normali l ' abitudine dell ' ordine della
compostezza e dell ' urbanità? Le direttrici dei convitti femminili hann ; gene
ralmente la capacità e l' autorità necessarie a ben governare giovani già adul
te e restie al vivere in comune? Fanno buona prova le direttrici che sono al
tempo stesso assistenti maestre nella scuola? È compatibile il cumulo di que
sti due uffici? Può una sola maestra assistente vegliare, come si conviene, al
la disciplina in tutte le classi? Può al tempo stesso questa maestra insegnare i
lavori femminili alle alunne di tutte le classi, specialmente se la scolaresca è
molto numerosa? Non sarebbe utile avere più d ' u na assistente per questi uf
fici? S'è fatto ciò in qualche scuola'
6 3 . • Sta bene che le scuole superiori femminili si limitino a fornire la
coltura generale necessaria a qualunque donna di civile condizione, o sareb
be utile coordinare ai corsi che vi si danno qualche i nsegnamento professio
nale o da tenersi distinto o da unirsi alla scuola stessa?
Là dove non è possibile d ' istituire una scuola superiore femminile e tut
tavia può essere desiderata una istruzione più elevata dell' elementare, giove
rebbe aggiungere corsi complementari alla scuola elementare stessa? Entro
quali limiti e con qual durata dovrebbero essere ordinati questi corsi? Sareb
be utile dare ad essi un indirizzo professionale?
Come sono accolti e quale importanza hanno i tentativi fatti da privati
per istituire scuole professionali femminili ? Qual è l ' ordine degli studi che vi
si fanno, quali le professioni a cui indirizzano ? Dovrebbe il governo pro
muovere questo genere di scuole concedendo sussidi sotto date condizioni,
1 Vedi in proposito, per esempio, la deposizione veneziana di Laura Veruda Goretti (doc.
36. p. -108).
' Questa esigenza dettata da ragioni di prudente pudicizia, di sostituire nelle scuole normali
femminili, profeswre•se a professori, costituirà in quegli anni il primo varco per gli studi uni
versitari delle signorine.
1 La eire. 9 lug. 1869 di Bargoni ai prefetti proponeva ai municipi di aprire scuole superiori
femminili sull'esempio di quella già istituita di Milano; poiché la risposta dei municipi, soprat
tutto per ragioni finanziarie, non fu corrispondente alle attese del ministero, il ministro Cor
renti con eire. 16 ago. 1 8""' 1 . n. 3 1 3. ribadiva la convenienza di aumentare il numero delle
scuole superiori femminili.
1 94
come fa per le scuole superiori femmi nili, o è da abbandonarle interamente
ali ' iniziat iva dei cittadini 1 ?
Con vitti maschili
64 . • Deve avere il governo convitti propri, o si crede più conveniente
che esso lasci questo modo di educazione agli istituti privati?
È nella natura degli istituti educativi qualche cosa di così particolare da
renderne malagevole la direzione non solo al governo, ma ancora ad ogni
pubblica amministrazione , sia questa di province o di comuni?
Nel caso affermativo, si crede che convenga meglio rendere più indipen
dente la direzione dei convitti nazionali costituendo consigli direttivi con
larghe attribuzioni, o affidandone la responsabilità a privati cittadini?
Sarebbe utile che il governo incoraggiasse l ' istituzione di pensioni dome
stiche poco numerose, dirette da cittadini specchiati per educazione e per
carattere, nelle quali i giovani potessero essere accolti ed educati frequen
tando in pari tempo le pubbliche scuole?
Dovrebbe in tal caso il governo concentrare i suoi sforzi i n un piccolo
numero di convitti bene ordinati e provveduti d ' ogni mezzo d ' educazione?
Gioverebbe unirvi anche le scuole, scegliendo per queste i migliori inse
gnanti e curando che gli studi vi siano fatti in modo esemplare?
65 . • I genitori, che collocano i loro figli nei convitti nazional i , lo fanno
perché credono che vi saranno bene educati, o perché non vogliono o non
possono educarli in famiglia ? Da che proviene che alcuni preferiscono man
dare i figli in convitti stranieri? Stimano questi istituti migliori dei nazionali,
o vi cercano un particolare i ndirizzo d ' istruzione o il mezzo più facile d ' im
parare la lingua del paese? Da quali altri motivi possono essere indotti a que
sta preferenza?
Per quali motivi i convitti tenuti da ecclesiastici sono in generale più fre
quentati di quelli diretti da laici? Si crede che in essi l 'educazione sia miglio
re, o che vi si facciano meglio gli studi? È forse la tenuità della spesa che at
tira il maggior numero degli alunni? Se ciò è, come potrebbero i convitti sia
dello Stato, sia dei comuni e delle provincie, mettersi a paro con quelli? Può
essere causa della maggiore frequenza degli alunni l' esservi nei convitti te
nuti da religiosi le scuole interne sotto la vigilanza di chi regge i l convitto?
Si lagnano i genitori dell' obbligo fatto agli alunni dei convitti nazionali di se
guire le scuole pubbliche?
In che differiscono dai governativi gl ' istituti di educazione privati o di
retti da associazioni religiose? È nell ' ordinamento degli studi, nelle discipli
ne educative, nei modi d ' amministrazione, nel trattamento fatto agli alunni?
Hanno essi più frequenti e più immediate relazioni colle famiglie? Le scuole
vi danno maggior frut to che non nei ginnasi e nei licei pubblici?
1
Sezione l - Lo suo/ 'imento de/l 'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
Anche su questo tema si veda la deposizione di Laura Veruda Goretti (doc. 3 6 , p. 4 08).
195
66. • È ben provveduto alla direzione e d alla vigilanza degli studi nei
conYitti nazionali ? I ret tori sono generalmente atti ad adempiere anche a
questa parte del loro ufficio? Hanno sapere e coltura sufficienti , e basta loro
il tempo di attendervi efficacemente? G l ' istitutori o prefetti sono in grado di
assistere e aj utare nei loro studi gli alunni delle scuole secondarie? Se manca
in essi ques t ' attitudine, non ne viene di conseguenza scemata anche la loro
autorità come educatori, e non ne scapita la disciplina del collegio? Non av
viene questo in alcuni convitti anche per i rettori? Come e con quali mezzi si
può ch iedere dalle persone preposte alla direzione e alla disciplina dei con
vitti un tirocinio di studi e di prove che le renda idonee a ben educare e al
tempo stesso a ben dirigere gli studi degli alunni?
La misura dello stipendio, con cui sono rimunerati gli uffici educativi, e
particolarmente quelli degli istitutori, è cagione che non vi attendano perso
ne di buon ingegno e di compita educazione? V ' è nell' indole di questi uffici
qualche cosa che li rende gravi e poco comportabili , specialmente agli istitu
tori? Come si potrebbe rendere più accetta la loro condizione a queste per
sone? Non gioverebbe ordinare i convitti in modo che gl ' istitutori avessero
parte nell' insegnamento, e potessero trovare in questo una carriera più libe
ra e lucrosa?
67 . • Produsse buoni effetti la legge del 1 8 59, laddove separò la direzio
ne dei convitti da quella delle scuole, o si crede più utile che la direzione del
convitto sia affidata a chi dirige le scuole esterne a questo annesse 1 ? È possi
bile l ' unione di questi due uffici dove le scuole esterne hanno un gran nu
mero di alunni ? Fatta astrazione dal valore personale, si crede che alla dire
zione di un convitto riesca meglio quel ret tore che ha famiglia o quello che
è celibe?
La sorveglianza, quale è ora esercitata nei convitt i, basta acl impedire che
alcuno si faccia maestro eli mal costume ai compagni? Il numero degli istitu
tori è sufficiente i n tutti i convitti, affinché i giovani siano del continuo assi
stiti ? Le compagnie affidate a ciascun istit utore sono abbastanza limitate nel
numero degli alunni perché si possa mantenere su di esse un'efficace vigi
lanza? Sono opportunamente distribuite secondo l'et à degli alunni?
68 . • Quali effetti produce nei giovani l 'educazione che si dà nei convitti
riguardo all ' amore della famiglia e al rispetto pei genitori? V'è relazione
continua tra il convitto e le famiglie degli alunni? I rettori si fanno sostegno
del! 'autorità domestica, e i genitori cooperano col rettore alla buona riuscita
dei giovani? Avviene talora che dai genitori non s ' inspiri ai giovani if rispet
to dovuto alla disciplina , e non si continui, nel tempo che passano in fami
glia, il buon indirizzo dato ad essi nel convitto? È bene che si conceda ai
convittori di passare in famiglia le ferie autunnali, o devono questi essere
La l. U no\'. 1 8 59, n. 3 � 2 5 , al capo VII, art. 238 prevede,·a che il direttore dei com·itti
fos;c figura distima da quelle del direttore del ginnasio e del preside del liceo.
1
1 96
1 97
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo suolgimento dell 'inchiesta
trattenuti m convit to, o condotti a villeggiare, oppure a viaggiare per istru
zione? Questi viaggi autunnali hanno fatto buona prova? Perché non si rin
novano più di frequente?
I trattenimenti che si concedono agli alunni nel carnevale sono sempre
in armonia col buon regime educativo del convitto? Portano qualche volta
soverchia distrazione, e tolgono troppo tempo agli studi? V'è nulla a dire
sull' uso di far rappresentare agli alunni commedie e operette musicali dinan
zi a un numeroso uditorio di persone estranee al convitto? Come andrebbe
ro regolati questi trattenimenti?
cacemente pratica, ed è fondamento all' educazione morale degli alunni?
Soddisfa ai desideri delle famiglie? Quale pratiche religiose si fanno dai con
vittori? Sono poche o troppe? Sono fatte soltanto in ossequio al regolamen
to? Tra i libri dati in lettura ai giovani vi sono anche libri d ' argomento reli
gioso, e quali?
Come è provvisto per l' educazione religiosa dei giovani non cattolici?
Pensa la famiglia a procurare ad essi l ' istruzione necessaria? Come si conci
liano le pratiche richieste dai diversi riti colla disciplina e col buon anda
mento del collegio? Giova la convivenza di giovani di religione diversa a in
spirare il rispetto per la libertà di coscienza e la tolleranza reciproca? Quanti
sono nei vari convitti nazionali gli alunni non cattolici?
Quale differenza passa, riguardo ali ' educazione religiosa, tra i convitti
nazionali e quelli diretti da persone appartenenti a società religiose? Quale
differenza passa anche riguardo all' educazione civile e al sent imento patrio
degli alunni? Si crede utile che il direttore spirituale abbia nei convitti nazio
nali un'ingerenza nella disciplina?
69 . • Quali sono le relazioni che ai giovani si concedono al di fuori del
convitto? Sono troppe, o troppo scarse? Sono a vantaggio o a danno della
loro educazione? Sarebbe possibile un ordinamento di convitti più libero
dell ' attuale e che segregasse meno dalla famiglia e dalla società? Sta bene
che questa segregazione appaia anche nella foggia del vestire? Non basta in
questa l ' u niformità, ma si crede necessaria u na certa singolarità? È approva
bile l ' uso dell' assisa militare, e quello di far portare le armi?
70. • In che proporzione sono i giovani i quali cominciano e compiono
la loro istruzione nei convitti nazionali, con quelli che ne escono a studi e
ad educazione incompiuti? Di questi u ltimi quanti escono dal convitto per
volontà delle famiglie, quanti per proprio capriccio o per ripulsione alla vita
del collegio, quanti sono espulsi? V'hanno genitori che considerano il colle
gio soltanto come utile sussidio dell ' educazione domestica, come un compi
mento di disciplina, e pensatamente vi collocano i loro figli per poco
tempo ?
Chi ha compito l ' intero corso di studi stando in un convitto nazionale, e
ora è uomo, che giudizio può fare dell' educazione in esso ricevuta e degli
studi ai quali diede opera? È possibile raccogliere qualche informazione sul
frutto che danno nelle università i giovani educati nei convitti a paragone di
quelli educati nelle famiglie?
7 1 . • Produce buoni effetti il modo col quale si conferiscono dal governo
i posti gratuiti nei convitti? Si fa per essi una parte sufficiente al merito degli
alunni , o si concede troppo alle ragioni economiche? Giova che vi siano po
sti gratuiti o sarebbe più conveniente averne soltanto di semigratuiti? Il con
seguimento del posto gratuito non sposta qualche giovane dalla sua carriera
naturale e non lo conduce per una via che all' uscire dal collegio gli viene
impedita dalla sua povertà? Si potrebbe conservare qualche posto gratuito ,
libero anzi d ' ogni spesa accessoria, per casi eccezionali di giovani non favo
riti dalla fort una, ma segnalati per ingegno? Come si potrebbe regolare il
conferimento di tutti questi posti, affinché ne venga un' efficace impulso agli
studi secondari?
7 2 . • Come è data nei convitti nazionali l ' istruzione religiosa? Riesce effi-
Educatorj fem m inili
7 3 . • Gli educatori femminili tenuti dal governo sono ben ordinati tanto
per l' educazione quanto per l ' andamento economico ed amministrativo? Gli
studi che vi si fanno sono sufficienti a dare la coltura generale necessaria ad
una donna di civil condizione , e in pari tempo abbastanza pratici per servire
di utile preparazione a u na madre per istruire i propri figli? Di qual grado è
l ' insegnamento secondario che si dà negli educatori ? Si modella su quello
delle scuole superiori femminili, o è altrimenti ordinato? Si dà troppa o po
ca parte ai lavori donneschi, e si mira in essi piuttosto al geniale che all' uti
le? In tutti gli educatori s' istruiscono le alunne nell' economia e nella conta
bili tà domestica, si dà loro qualche nozione d ' igiene, si rendono esperte in
tutte le arti minute che occorrono a ben condurre una casa?
In qual numero d'anni si fanno nei vari educatori gli studi superiori al
corso elementare? Come si conciliano gli anni destinati all ' istruzione con
quelli ritenuti necessari a u na soda educazione e quindi alla permanenza del
le alunne nell'educatorio? È provvedu to in questi educatori a una intelligen
te vigilanza sull' indirizzo e sulla riuscita degli studi? Dov' essa manchi, come
si potrebbe riparare?
74 . * L'educazione che si dà negli educatori dello Stato è ben diretta a
formare il carattere della donna, o mira piuttosto all' ornamento dello spiri
to ? La prepara con fem1e convinzioni a vincere le difficoltà della vita, o fo
menta sotto certi aspetti la frivolezza e la vanità? Quello che si fa negli edu
catori per destare nelle alunne l ' amore verso la patria è troppo o poco ? Rag
giunge il fine d ' i nspirare il sentimento del dovere che hanno tutti i cittadini
di sopportare i sacrifici ch'essa richiede ?
1 98
1 99
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo SNilgimento dell 'inchiesta
Le letture che si fanno dalle alunne fuori della scuola sono ben dirette e
invigilate? Quali sono i libri forniti? Si permette ai genitori ·di darne, o v ' è
nell ' educatorio una piccola biblioteca a ciò destinata? Quali sono i libri ado
perati nella scuola? Sono quelli stessi approvati per le scuole maschili, o ve
n ' ha di speciali?
la visita di qualche monumento o di qualche istituzione utile? Se debbono
uscire , è bene che le alunne vadano tutte insieme in un giorno determinato,
o siano divise in piccole schiere, anche alternando i giorni? Sarebbe ciò
compatibile colle buone discipline interne?
7 5 . Gl' insegnamenti d ' ornamento, come la musica, la danza ecc . , sono
dati indistintamente a tutte le alunne? Come conferiscono alla loro educa
zione? Lo studio elementare del disegno è obbligatorio per tutte ed è dato
con particolare riguardo all 'esecuzione dei lavori femminili? È lasciato in fa
coltà delle alunne di applicarvisi anche più estesamente? Le lingue straniere
sono bene insegnate, e le alunne sono esercitate a parlarle fra loro e colle
istitutrici? Basta una sola di queste lingue, o conviene rendere obbligatorio
lo studio di due? Le alunne che escono dagli educatori possiedono perfetta
mente così nello scrivere, come nel parlare, le lingue straniere loro inse
gnate?
Si crede che negli educatori sieno da preferire le maestre ai maestri an
che per gl' insegnamenti perfettivi e d'ornamento? Se in tutti non è possibile,
in quale degl ' insegnamenti si crede utile questa preferenza?
Potrebbero alcune maestre perfezionarsi negli educatori stessi ? Escono
ora da alcuni di essi abili istitutrici, le quali per solida istruzione e per com
pita educazione possano tenere luogo di quelle che molte famiglie ricche
fanno venire dall'estero ? Ci sono alunne avviate a prepararsi a quest'ufficio
negli educatori dello Stato ? Converrebbe promuoverne l ' educazione anche
per provvedere ai bisogni dell ' insegnamento negli stessi educatori? Conver
rebbe destinare a questo fine alcuni dei posti gratuiti che il governo assegna?
76. • A quale età si debbono accogliere le alunne negli educatorj ? Fino a
quale età si stima u tile che vi rimangano? Si crede che non abbia inconve
nienti l' ammetterle fino a dodici anni? Non dovrebbero le alunne essere re
stituite alla famiglia, compita che sia la loro educazione, senza stabilire un li
mite invariato d'età?
Come si regolano gli educatori riguardo alle uscite concesse alle alunne?
Quante sono le uscite giornaliere nell 'anno e come distribuite? È permesso
alle alunne di passare alcuni giorni dell 'anno in famiglia, o anche di passarvi
il tempo delle ferie aut u nnali? Si credono utili o dannose alla disciplina e al
la buona educazione delle alunne queste ferie prolungate fuori del l ' educato
rio? Vi sono educatori che conducono le alunne a villeggiare?
Quali sono i trattenimenti che si danno nell ' interno dell 'educatorio? Si
danno in alcuni rappresentazioni sceniche, o giuochi , o danze in comune o
con intervento delle madri e delle sorelle delle alunne? Come si potrebbero
meglio dirigere e regolare questi trattenimenti? Escono le alunne a passeg
giare , e quante volte nella settimana? Si credono preferibili le passeggiate
nelle vie, o si ritiene che basti alle alunne il passeggiare nel giardino? Si po
trebbe rivolgere alcuna delle passeggiate esterne a un fine educativo, come
7 7 . • Sono molti o pochi gli educatori privati o di corpi morali laici, nei
quali si dà un' istruzione superiore all' elementare, e che pel grado dell'edu
cazione e per le discipline che li governano si accostano agli educatori dello
Stato? Ve n'è alcuno direttamente promosso e invigilato da madri di fami
glia? Come sono ordinati questi educatorj ? Come vi sono distribuiti e quale
estensione vi hanno gli studi? Sono generalmente in edifizi adatti ed hanno
arredi e suppellettile conveniente? Accolgono nella scuola anche alunne
esterne, e come questo si concilia con un ben regolato andamento del con
vitto? Questa mescolanza delle alunne esterne colle interne non produce in
convenienti ? È approvata dai genitori? È causa di poco concorso al con
vitto?
Gli educatori tenuti da religiose in concorrenza con quelli dello Stato sod
disfano i bisogni di una compita educazione? Vi si fanno veramente studi su
periori agli elementari, e in quale misura e con quale indirizzo? È provveduto
in essi, e come, agli studi d ' ornamento? L'educazione religiosa vi è data seria
mente e giova ad elevare e a fortificare l 'animo, o è solo rivolta all 'ascetismo
e alle pratiche divote? V' imparano le giovinette a diventare buone madri di
famiglia? Da che proviene che molti genitori benché non amino l ' indirizzo
educativo di questi istituti, vi collocano di preferenza le loro figlie?
Le persone che dirigono e che insegnano negli educatori, così laici come
religiosi, sono regolarmente autorizzate? Si fanno in questi istituti le ispezio
ni necessarie?
Sarebbe utile che lo Stato incoraggiasse e sussidiasse quegli educatori pri
vati che offrono serie guarentigie di una buona educazione? Dovrebbe il go
verno promuovere a questo fine associazioni di madri di famiglia?
Per la commissione d' inchiesta
I l presidente
G. Cantelli
6
Lettera di A n tonio Scialoja a Marco Tabarrini.
AS F l , A rcbi/liO Marco Tabarrini, b. 1 2 , ins . 2 .
Roma, 29 settembre 1 87 2
Molto s ' è detto e pubblicato in questi ultimi anni sulle condizioni dell ' in
segnamento secondario, che dai più si dipingono come deplorabilissime.
200
Fonti per La storia della scuola
Sezione l - Lo suolgimento dell'inchiesta
Della generalità e persistenza di queste voci non poteva io non prendermi
pensiero, ché l ' insegnamento secondario, ove si modella, �er cos� dir� , tutt �
quella parte eli popolazione che sa pensare e volere da se, e_ clet varJ � raclt
.
dell' istruzione il più importante . Laoncle, fin da quando ho accettato l mca
rico eli reggere questo Ministero , ho volto il pensiero ad u na inchiesta sugli
istituti eli insegnamento secondario maschile e femminile. Tale inchiesta, da
me proposta al Consiglio dei ministri, fu da questo approvata, ed è già fir
mato da S . M . il decreto che l' autorizza.
È manifesto quanto importi che le operazioni dell'inchiesta, la quale do
vrà servire di fondamento a provvedimenti legislativi, siano affidate a perso
ne autorevoli e condotte con prontezza e prudenza: e questo appunto m ' ha
indotto a chiamare la S. V . Ill .ma a parte della Commissione a ciò delegata.
Certo che Ella non vorrà rifiutare il suo concorso ad un'opera che io spe
ro feconda eli molto bene, La prego di farmi subito avere un cenno di rispo
sta, e mi pregio eli profferirmele
20 1
Perché abbiamo fra noi da due secoli l ' educazione morale fatta unica
mente dal prete . Il padre eli famiglia cattolico non esercita alcuna specie eli
sacerdozio; non parla mai eli cose che trascendono gli interessi domestici e
la politica. Non c'è un giorno in cui egli aduni la famiglia e parli loro delle
verità eterne, che faccia una preghiera in comune. Egli sente peraltro che
avrebbe il dovere eli dare ai figli questa alta educazione morale, e per sclebi
tarsene manda i figli a quelle scuole e a quei convitti dove spera che bene o
male a questo si provveda. Se nella famiglia il padre fosse egli stesso creden
te, e sentisse il bisogno eli trasfondere la sua fede nei suoi figlioli, il prete ri
marrebbe per gli atti eli culto che hanno bisogno del ministero ecclesiastico,
e non assorbirebbe, come ora fa, tutta l ' educazione morale della gioventù
cattolica . [ . . . ]
Il ministro
A. Scialoja
8
Lettera di Antonio Scialoja a Girolamo Cantelli.
7
Appunto di Marco Tabarrini
ACS, M P l , Dii'. scuole medie (1860-1896), b . 7, fase. 5 6 .
i .
AS F I , A rchivio Marco Tabarrini, b . 1 2 , ins. 2 .
[ . . ] Perché i padri mandano eli preferenza i loro figliuoli alla scuola e ai col
legi diretti da ecclesiastici?
.
' Marco Tabarrini, nell'ambito della stesura dei quesiti, aveva curato la parte relativa ai
convitti. L'appunto qui riportato è una sua (ma, come vedremo, non �olo sua) riflessione � ul �e
que�tioni affrontate nei quesiti 12- l-t, un tentativo di �piegare la preferenza di molte faimghe
per gli istituti religiosi. Lo stesso richiamo alle conseguenze sulla Vita rehgmsa_ delle famiglie del
cattolicesimo post-tridentino è esplicito nel laico Correnti, nel corso dt un dibatttto
parlamen
tare: Correnti infatti che così risponde alla stessa questione: « Il nostro non è il caso di una so
cietà profondamente religiosa, dove il capo di famiglia, per abitudine, e si può dire per tradi
zione secolare, legge la Bibbia e il Vangelo, come fonte d'ispirazione quotidiana, e ne trae mse
gnamento per sé e per i suoi figlioli ... e anzi deve credersi naturalissimo, se i padri di famiglia
cerchino nella Chiesa e negli uomini di Chiesa un aiuto e un soccorso per mfondere senumentt
religiosi e morali nella propria prole " (AP, Senato del Regno, legislatura X l , l i sessione 1 87 1 1872, Discussioni, Il, tornata del l o maggio 1872, pp. 5-t8-5-t9). �i tratta di un aspetto non �e
conciario del dibattito allora acceso sugli aspetti negativi della mancata riforma religiosa in Ita
lia. Lo stesso concetto di Tabarrini e di Correnti sarà espresso anche da Antonio Allievi nella
sua deposizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta a Roma il 12 feb. 1873 (doc. 1 9 , p. 230).
Roma, 25 gennaio 1 87 3
Oggetto : considerazioni sul libro dei quesiti .
Il libro dei quesiti sull ' istruzione secondaria maschile e femminile che la
Commissione d' inchiesta da V . S . I ll . ma degnamente presieduta mandò fuori
in questi giorni mi venne a confermare come i componenti della medesima,
uomini dottissimi nella materia, siansi reso conto a se stessi del vasto argo
mento ch 'era sottoposto al loro studio. Nessuna parte infat ti dell'ampio te
ma venne dimenticata, e eli ciascuna furono svolte le più minute attinenze e
studiate le più singolari e molteplici forme .
Quest' analisi profonda e d accurata del vasto argomento condusse la
Commissione a scioglierlo in quella ammirabile serie eli quesiti che il '"'_Olume
contiene. E però veramente essi sono, come la Commissione li chiama, veri
quesiti , cioè peculiari problemi che essa pone a se medesima e dalla cui riso
luzione dipende quella del gran problema che tutti gli inchiucle, del modo eli
migliorare l ' insegnamento e l' educazione, che fan parte dell' istruzione se
condaria.
I n torno a cotesti quesiti possono con profitto essere consultati coloro
che per istucli e per pratica abbiano cognizione abbastanza estesa della mate-
202
Fonti per la storia della scuola
ria. E perciò il libro dei quesiti mi pare che abbia una grande utilità . Ma a?
punto perché questi sono quesiti, come egregiamente li chiama fa Commts
sione e non pure interrogazioni intorno a fatti o giudizi semplici e peculiari
opini � ni, io dubito che l' inchiesta per mezzo di essi , non riesca a raccogliere
risposte egualmente utili dalle persone (e sono il maggior numero) che senza
avere una conoscenza speciale della materia giudicano però per l 'esperienza
propria e della loro famiglia; le quali persone leggendo quei dotti � uesiti ne
sarebbero come sgomentate e soprafatte e non si periterebbero a nspondere
né a voce né per iscritto.
Questi fatti e queste opinioni, appunto perché non hanno quel co lore
.
che dà loro chi ha nella mente un sistema preconcetto, sono a parer mto la
parte su cui più specialmente pare che debba versare l ' inchie� ta, perché n ? n
si commuti in un lavoro dottrinale fatto da persone esperte 111 una matena ,
le quali mettono i nsieme il tesoro delle loro cognizioni per elaborare un di
segno di riordinamento al di fuori di quella salutare agitazi ? ne che l ' Inch ie
_
sta deve diffondere non solo fra coloro che possono ordmare la pubblica
istruzione, ma eziandio fra quelli che, per servirmi di u na metafora, direi
quasi i consumatori che debbono giovarsene.
.
Non osando noverar me medesimo fra le dott issime persone a cm sopra
accennai e che si trovano nel seno della Commissione e meglio di me po
tranno gi udicare dell' importanza di questo mio dubbio, io mi prendo la l i
_
cenza di formulare più nettamente questo dubbio , ricorrendo per analogta
allo esempio di un argomento che ho dovuto io medesimo in altra occasio
ne trattare praticamente, alludo all' inchiesta indust riale e commerciale .
Certo l' inchiesta industriale non ha che fare colla presente; il soggetto è
ben diverso e poi la nostra sull' istruzione secondaria è di un ordine superio
re e più complicato. Ma certe forme generali del pensiero di chi si volge ad
una indagine sono pur comuni a diversi soggetti.
.
Nell ' inchiesta industriale adunque, sebbene il governo si proponesse dt
indagare se il sistema della libertà e della protezione avessero fatti ed opi
nioni favorevoli o contrari; e se i trattati conclusi per avviare il paese verso
la libertà del commercio avessero provato bene e fossero accetti, pure non
formolò a questi due intenti principali una serie di quesiti , poniamo questi:
1 o . È utile che u n paese commerci e traffichi liberamente con u n altro?
203
Sezione l - Lo sr>olgimento del/ 'inchiesta
nerale, se elevasse il prezzo in modo da non poterli far reggere la concor
renza col ferro fuso ali' estero ecc . . . ecc . . .
on si potrebbe far qualche cosa di simile anche nel caso nostro, e d ag
giungere ai bellissimi e dotti quesiti già pubblicat i una modesta serie di inter
rogazioni che dicessero per esempio:
Nella vostra città vi sono istituti governati vi, vi sono istituti provincia li o
municipal i? Vi sono istituti privat i? Sapete quale di queste scuole è più fre
quentata? Avete voi figliuoli o parenti che vanno a scuola? A quali di questi
istituti li mandate? Quale è la cagione per cui voi ed altri date la preferenza
ali' istituto dove dite che più volentieri mandano i figliuoli? Sapete se la città
è contenta dei professori governati vi? Qual ' è la parte d ' insegnam ento che in
uno o nell' altro di quest i Istituti, secondo l 'opinione del luogo , è data me
glio? Sono più educati i giovani che escono dall' istituto governativ o o dal
provincia le, se ve ne ha? Sono avvenuti fatti in qualchedu no di questi istituti
che Ella creda di nota; e che il governo potrebbe correggere per indurre i
parenti a mandare i loro figl iuoli?
Ma io m' accorgo che io entro in particolar i che non sono di mia compe
tenza e che sapranno meglio trovare gli uomini eminent i che compong ono
la Commissi one ed ai quali mi rimetto interamen te anche nel caso che abbia
no a giudicare ch'io m' inganni.
Voglia, onor. le signor president e, convocar e la Commissi one e con quel
la sagacia che le è propria esporle assai meglio ch ' io non abbia saputo fare a
lei queste consideraz ioni , le quali io fo u nicamente perché mi sembrano ido
nee a conformare sempre più gli atti della C ommissio ne al concetto che eb
be il governo quando propose a S . M . di ordinare l ' inchiesta.
Il ministro
A. Scialoja
9
Lettera di A ngelo Bargoni 1 a Gi·rolamo Can telli.
2 o . È utile che le materie prime siano esenti o paghino dazio ?
3 o . È utile che si protegga con qualche dazio la produzione manufatturiera?
4 o . È in I talia qualche materia prima o qualche industria che possano richie
dere la protezione mediante dazio sull' uscita o sull'entrata? ecc . . . ecc . . .
ACS, M P l , Div. scuole medie (1860-1896), b. 7, fase. 5 8 .
Ma per risolvere questi quesiti fece interrogazioni particolari a ci� scun
industriale sui fatti e sull ' esperienza propria, cioè domandando quale mdu
stria esercitava: e se questa fosse, per esempio, la fonderia del ferro , si do
mandava donde mai traesse ed il ferro ed il carbone e per quanto sul prezzo
di produzione entrasse il dazio; se questo impediva di acquistar fuori il mi-
' Angelo Bargoni (Cremona 2 6 maggio 1 8 2 9 - Roma 2 ; giugno 1 90 l ), uomo politico e depu
tato, nel 1 869 ministro della pubblica istruzione; in questa veste emanò il decreto relativo alle
sessioni speciali di esami per l'abilitazione all'insegnamento, di cui spesso si discute nel corso del
l'inchiesta (cfr. quesito n. 2 ) e promosse l'istituzione di scuole superiori femminili; su queste si
vedano i quesiti 62 e 63, sui quali l'inchieMa offre non poche risposte, che tracciano un primo bi·
lancio, in complesso non troppo positivo, dell'iniziativa; dal 1 87 1 al 1 876 era prefetto di Pavia.
Pavia, 1 4 febbraio 1 87 3
204
Il giorno 1 1 del corrente mese ho avuto l' onore di ricevere la riv . a Cir
colare 20 gennaio u . s . colla quale mi è stato trasmesso un esemplare dei
quesiti a stampa, proposti dall'on . le Commissione d ' i nchiesta, di cui la S . V
Ill.ma è i l degnissimo presidente, più altri 2 1 2 esemplari d e i quesiti stessi,
da distribuire a norma delle indicazioni contenute nell'elenco annesso alla
circolare .
Ho disposto immediatamente perché entro domani la distribuzione abbia
luogo ed ho cercato di secondare il desiderio della prelodata S . V . col farla
eseguire accompagnata dalla circolare, di cui, a dimostrazione del buon vo
lere che assiste il mio operato , rassegno due esemplari .
on mi è facile ottenere senza spesa la riproduzione dei quesiti nel gior
nale ufficiale della provincia; perché il contratto non mi assiste nel preten
derla , e la condiscendenza è nell'editore contrastata dalle difficoltà econo
miche . Tuttavia se dovrò assolutamente rinunciare alla pubblicazione inte
grale e contemporanea di tutti i quesiti in apposito supplemento, procurerò
ch'essa abbia luogo meno interrottamente che sia possibile .
Mi riservo di sottoporre alla S . V. Ill . ma un elenco di persone che dietro
anche l ' autorevole avviso del r. provveditore agli studi mi parrà doversi in
terrogare.
Ma fin d ' ora io non posso astenermi dal pregare l ' o n . le Commissione
d ' inchiesta di farmi pervenire gli esemplari occorrenti per provocare le ri
sposte dai signori professori di questa r . università ' .
S ' io grandemente non m' inganno, nessuno meglio dei professori u niver
sitarii, i quali ricevono ogni anno il contingente di nuovi alunni che proven
gono dalle scuole secondarie, è in grado di poter essersi formato, con dovi
zia di dati e col frutto di un' osservazione costante, un esatto criterio intorno
a ciò che in codeste scuole è o deficente o mancante o soverchio . Oltre di
che alla ragione di competenza parmi si possa aggiungere anche un'elevata
ragione di convenienza, avuto riguardo appunto agli effetti che da riforme
nelle scuole secondarie può sentire l ' i nsegnamento superiore .
Che se importasse ant icipatamente conoscere quali e quanti sarebbero i
professori della università disposti a studiare i quesiti ed a scrivere le loro ri
sposte, anche a ciò si potrebbe provvedere al momento della distribuzione,
previe le opportune intelligenze coll' il l . mo sig . r rettore.
Sicuro di vedermi quanto prima onorato di categorica risposta, ho intan
to il pregio di esprimere i sensi del mio sincero ossequio.
il prefetto
A. Bargoni
' Il presidente della Commissione d'inchiesta risponde al prefetto di Pavia con lettera del
mar. 1 8 ' 3 , nella quale comunica che una prima spedizione dei quesiti destinati ai professori
universitari è già stata fatta direttamente all'Università degli studi di Pavia (ACS, MPI, Diu.
scuole medie l 860- 1896, b. 7, fase. 58).
28
205
Sezione 1- Lo st•olgimento del/ 'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
Allegato :
R. prefett ura della Provincia di Pavia
Gabinetto
Circolare n. 1 1 2-2
Pavia,
1 5 febbraio 1 87 3
Oggetto: Inchiesta sulla istruzione secondaria maschile e femminile.
Illustrissimo signore,
Ella conosce senza dubbio i saggi avvedimenti e le ragioni autorevolissi
me che condussero l' illustre uomo, il quale oggi presiede al dicastero della
pubblica istruzione in Italia, a proporre a Sua Maestà di ordinare un' inchie
sta su quella parte della istruzione, che, posta fra la primaria e la superiore,
ha la influenza più vasta e più efficace e più diretta su lla coltura generale
della nazione.
Quegli avvedimenti e quelle ragioni ebbero degno svolgimento nella re
lazione che precede il r . decreto 29 settembre 1 87 2 , mercé cui fu appunto
determinata la i nchiesta intorno alla istruzione secondaria maschile e fem
minile, sotto il duplice aspetto dello insegnamento e della educazione.
Ed a Lei, onorevolissimo signore, è pur noto che a quel decreto, un altro
fece seguito che designava le persone chiamate a far parte della commissio
ne cui l' inchiesta è stata affidata; come Le è noto che questa Commissione,
presieduta per decreto ministeriale dall 'onorevole senatore, conte Gerola
mo Cantelli, ha formulato i quesiti , la cui soluzione deve costituire il fonda
mento principale della inchiesta.
La importanza dei quesiti, sia nel loro complesso, sia considerati singo
larmente, è tale e tanta che ben si comprende come la Commissione d ' in
chiesta abbia voluto far consistere il primo suo atto nella accurata distribu
zione dei quesiti medesimi, procurando che u n esemplare di essi pervenga
nelle mani e diventi oggetto delle ponderate riflessioni di t utte quelle perso
ne, le quali, pel loro sapere, per la molta loro esperienza e per l ' am ore che
nutrono pei buoni studi, sono le meglio adatte a far presagire che la Com
missione ritrarrà un abbondante frutto dalle risposte eh' elleno saranno per
dare .
Fra queste persone l ' onorevole signor presidente della Commissione
d ' i nchiesta, in un elenco annesso ad una sua circolare del 20 gennaio 1 87 3 ,
testé a m e pervenuta, h a meritamente compreso anche Lei, I llustrissimo Si
gnor . . . , nella sua qualità di . . .
Ond ' io mi affretto a trasmetterle, insieme colla presente, l ' esemplare dei
quesiti a Lei dovuto, fra le pagine del quale Ella troverà i foglietti in bianco
destinati a ricevere le risposte eh ' Ella vorrà dare a tutti o a parte di essi, sen
za che ciò Le impedisca di scrivere separatamente quelle tra le sue risposte
207
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo st•olgimento dell'inchiesta
che esigessero pel loro sviluppo u no spazio più ampio di quello ivi con
cesso.
Dalle A vvertenze che precedono i quesiti Ella vedrà che le sue risposte
possono essere da lei spedite direttamente al Ministero della pubblica istru
zione in Roma (Commissione d 'inchiesta scolastica).
Tuttavia, ove non Le piaccia profittare di siffatta facoltà, a me sarà ben
caro di essere intermediario fra Lei ed il ministero e di avere in pari tempo il
mezzo di constatare il premuroso interessamento con cui le egregie persone,
in questa occasione richieste dell' autorevole concorso dei loro lumi e della
loro esperienza, avranno, in questa provincia voluto corrispondere all'a
spettazione del governo e del paese.
In u n ' epoca come la nostra, nella quale, così nei rapporti sociali, come
nei rapporti internazionali, ogni valore non si misura che alla stregua della
coltura intellett uale e del perfezionamento morale, un' inchiesta sulla istru
zione secondaria non può non destare u na gara efficace e feconda fra tutti
coloro che agl ' inconvenienti, i quali possono esistere att ualmente, amano
contrapporre, non la sterilità di facili rimpianti o l ' acrimonia di più facili
censure, ma quell ' operoso sussidio di studi e di consigl i, che può preparare
in modo più saldo e più ammirando il credito e la forza della nuova genera
zione .
C o n questa convinzione, ch'io spero sia nutrita anche d a Lei, amatissi
mo signore, ho il piacere di professarle i sensi del più sincero ossequio .
ciale di Napoli 1, che ella m' inviava erano meno importanti per me, di quel
che sarebbero stati gli apprezzamenti personali della S . V . , inoltre quel gior
nale dà conto dei lavori della Commissione con un ritardo che par sover
chio a me che vorrei paterne seguire di giorno in giorno e quasi d' ora in ora
l ' andamento; così il giornale di ieri riferisce la seduta di venerdì, e soltanto
domani mi sarà dato conoscere quel che fu fatto nella seduta di sabato .
Avrei desiderato che quelle sedute fossero più ricche d ' informazioni e di
fatti, che non di esposizioni dottrinali e di discussioni ; tuttavia parmi che
anche in quella parte siasi raccolto qualche frutto dall' inchiesta e confido se
ne otterrà maggiore quando la S . V. resa esperta dell 'i ndole e del facile abito
che travasi in coloro che costà furono chiamati a deporre, trovi opportuno
eli costringerli colle dimande a precise e categoriche risposte, anziché lasciar
loro balia di diffondersi in più o meno pregevoli dissertazioni . Certo è desi
derabile che rispondano agli inviti della Commissione, in più gran numero
che non avvenne fin qui , persone che non abbiano parte nell 'insegnamento;
ma forse dagli insegnanti si può cavar miglior costrutto costà che altrove, at
tesa la emulazione fra gli insegnanti ufficiali ed i privati. In quanto a quelli
poi che furono interrogati, la Commissione avrà potuto formare un giusto
concetto del loro sapere, e delle loro attitudini.
Né dal giornale di Napoli però, né dalla lettera della S . V . ho avuto alcun
cenno di ispezioni fatte ; le quali reputo non meno importanti eli qualsivoglia
altro modo d ' i nchiesta. Non credo le ispezioni inutili negli stessi istituti go
vernativi, necessarie poi le reputo negli istituti privati , che costà sono in nu
mero prevalente ai governativi tenuti da laici e da ecclesiastici; ed opportu
ne sembranmi non meno negli istituti comunali, il cui avviamento non cre
do sia in tutto conforme a quello dei governativi . Soltanto colla copia delle
informazioni e delle indagini, coi confronti molteplici la Commissione potrà
colla desiderabile sicurezza fare le sue conclusioni. Di queste ispezioni pre
go la S . V . darmi ragguaglio.
Amerei altresì conoscere quali altri centri oltre Napoli, la Commissione
visiterà, e in quali giorni: Salerno e Caserta parmi sarebbero con utilità visi
tate . In ogni modo la grande vicinanza a Napoli non dovrebbe far trascurare
la provincia di Caserta, che e nel capoluogo ed a S . Maria 2 con esempio imi
tabile aperse e mantiene a spese provinciali istituti d ' i nsegnamento seconda
rio, e ciò non astante mi si fa premura di non insistere in provvedimenti che
escludano da seminari giovani non destinati alla carriera ecclesiastica, per-
206
Il prefetto
A. Bargoni
10
Lettera di A n tonio Scialoja a Girolamo Cantelli.
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860- 1896), b. 7, fase. 59.
Roma,
24 febbraio 1 873
Oggetto: ispezioni ad istituti.
I resoconti delle sedute della Commissione pubblicati n e l Giornale uffi-
1 Allude al « Giornale eli Napoli quotidiano politico riconosciuto come organo ufficiale
per l'inserimento degli atti amministrativi e giudiziari della provincia. Alcuni numeri, con i re
socomi delle sedme napoletane, sono comervati tra le cane dell'Inchiesta (ACS, MPI, Dil•.
scuole medie 1 860- 1 896, b. 8, fase. 65).
' Santa Maria Capua Vetere, grosso comune del Casertano di circa 1 8 .000 abitanti, dove, in
ossequio al desiderio del ministro, la commissione effettuò una delle sue poche ispezioni.
( ibid. , b. 7, fase. 59, s. fase. l ).
"•
208
Sezione 1 - Lo svolgimento dell'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
ché si lamenta la penuria di istituti laici . Premure che mi si fanno anche per
seminari di altri luoghi , come per esempio per quello di Sarno ' . .
Forse in coteste provincie la Commissione ha, per esaminare l' insegna
mento privato, un campo più vasto di quel che potrebbe trovare in qualsi
voglia altra parte; e raccogliendo, interrogando, indagando, confrontando
senza preconcette conclusioni la Commissione in questo suo secondo stadio
potrà ottenere importanti risultamenti, che saranno poi base a' suoi avvedi
menti ed alle sue proposte.
el senno e nello zelo di lei e della intera Commissione confido grande
mente.
Suo devotissimo
A. Scialoja
Scialoja
1 Sui seminari che spesso servivano all' istruzione liceale dei giO\'ani non chiamati al sacer
dozio e che perciò facevano una remibile concorrenza agli istituti di istruzione governativa,
assai acceso il comrasto con la Chiesa in tutta l 'età della Destra: nel corso dell'inchiesta molti
interventi si oppongono all'orientamento espresso dal ministro di ridurre il numero dei licei
governativi ( e anzi talora si chiede di istituirne degli altri) perché temono che un tale indirizzo
possa favorire il successo dei seminari. Sulla questione il ministro Scialoja era intervenuto con
circolare del 18 dic. 1 87 2 che suscitò critiche sia dai clericali intransigenti che dagli anticlerica
li; per questi ultimi vedi nell 'inchiesta le critiche di Pecile alla circolare troppo indulgente ver
so il clero e l 'intervento di Francesco Fiorentino e la risposta di Scialoja in AP, Camera dei de
putati, legislatura X l , Il sessione ( 1 87 1 - 1 872), Discussioni, tornata del ) l gennaio 1 87 :3 , pp.
-t 520 sgg. e 4 5 3 2 e seguenti. I l contrasto tra seminari e scuole classiche governative era del re
sto proprio di tutti i paesi cattolici. Per la Francia vedi per esempio M . M . CoMPÉRE, Du collège
au Lycée (1500- 1 8 50), Paris, Gallimard, 1 985, pp. 250- 2 5 3 e, per gli inizi della Terza repubbli
ca J. SiMON, La reforme de l 'enseignemenl seconda ire . citata.
1 1 1 2 5 febbraio Antonio Scialoja scrive un'altra lettera a Cantelli relativa all' Istituto asiatico.
In essa, dopo aver spiegato che l ' istituto dipende dalla Divisione degli studi superiori e profes
sionali, pur rientrando, per l'insegnamento impartitovi, nella sfera dell 'insegnamento seconda
rio e che corpo morale che vive di rendite proprie, suggerisce di far capo al senatore Gallotti,
pre,idente della commissione che amministra l' istituto stesso, per poter ottenere di farvi visita
(ACS, M P I , Dill. swo/e medie, b. 7. fase. 59. s. fase. l ). Il r.d. 16 apr. 1 87 4 , n. 1 888, istituì una
appo,ita conm1issione per il riordinamento del Collegio a'iatico a v' iando la sua progressiva
trasformazione in quello che poi sarà l ' Istituto di studi orientali. In proposito vedi C. M. FIO·
è
.
è
Cesare Corre11ti, il Collegio asiatico di Napoli e Propaganda Fide intorno al 1 8 70,
in " Rassegna storica del Risorgimento "· LXXIX ( 1 992), "' , pp. 4 58-"18 2 .
ll
Relazione sulle visite fatte dai professori Settembrini e Cremona all 'Istitu
to Marciano e all 'Istituto della carità di Napoli 1 •
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860-1896), b . 7 , fase. 5 9 .
2 marzo 1 873
Istituto Marciano 2, al Largo di S . Gaetano (28 febbrajo 1 873).
P . S . Ella conosce l ' Istituto asiatico, stabilito in Napoli al fine di mantenere
relazioni coll'Oriente indipendenti da Propaganda Fide. Alcuni miei prede
cessori se ne occuparono; io penso che siano necessarie riforme in quell ' Isti
tuto per migliorarne l'amministrazione e renderlo meglio rispondente a'
suoi fini. Sarei quindi assai lieto che la Commissione vi facesse una ispezio
ne larga e minuta, abbracciante l'insegnamento e l'amministrazione, l'azione
dell'istituto ed i suoi rapporti 2 •
llENTJNO,
209
Questo istituto che comprende convitto e scuole elementari, ginnasiali e
liceali, è tenuto dai signori B . Marciano e G . Maglione, ex preti e liberali, ac
coglie giovanetti la più parte provinciali.
Le scuole sono molto sudicie, anzi indecenti . Il convitto, situato in un
piano più elevato, è meglio illuminato ed ha aspetto mediocremente pulito.
Non giardino, non ginnastica; panche e seggiole senz'altro. Abbiamo esami
nato un po' una terza classe elementare. Vi sono alcuni che non vi dovreb
bero stare perché ignoranti , accolti per non perderli. Hanno letto alcuni
componimenti italiani, ne' quali si affetta lo stile arcaico del Trecento. Il
professore ha dichiarato ch'egli non dà argomento, né traccia, non consiglia
imitazione, li fa scrivere quello che vogliono . I fanciulli non sanno che scri
vere, si sforzano, si spremono, dicono sciempiaggini . Non quaderni, ma car1 La situazione dell'istruzione secondaria privata nelle provincie napoletane era caratteriz
zata dal gran numero di istituti privati e della quasi totale libertà sia per quanto concerneva la
loro apertura, sia per gli insegnamenti che vi erano impartiti. A questa situazione fecero ripetu
ti accenni le persone che deposero davanti alla Commis,ione d'inchiesta nelle sedute di Napoli,
Caserta e Salerno. Il documento pubblicato, che quasi la risposta alla lettera che il ministro
Scialoja aveva indirizzato il 2-J febbraio 1 87 3 al presidente della Commbsione sollecitando l 'av
vio delle ispezioni, conclude auspicando una speciale e organica ispezione sulle scuole di Napo
li. Questa sarà effettivamente svolta per le scuole private dal provveditore Carlo Giuda nel
1 87 5 . Dalla Relaziolle (pubblicata nel " Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzio
ne », 1 876, pp. 2 2 6-237) emerge una situazione complessa e variegata ma nell'insieme non
completamente negativa. Furono censiti 58 ginnasi privat i , 2 -J licei, I l scuole tecniche. Questi
istituti vengono classificati in tre gruppi: quelli che costituiscono il seguito di antichi e gloriosi
istituti d ' istruzione, quelli nati secondo le regole dettate dalla legge Imbriani, quelli 1enuti da
religiosi o da corporazioni religiose. Rimangono poi secondo la relazione del provveditore, al
tre scuole di numero considerevole che vivono al margine della legalità per ordine di studi e se
rietà dei direttori. In risposta alla relazione di Gioda i gestori delle scuole private diffusero una
controrelazione stesa dal prof. Tallarigo dove si difende\'a la autonomia degli istituti privat i , e
la qualità del servizio che essi offrivano.
1 Il direttore dell'Istituto Marciano, che
anche assessore municipale, depone a Napoli nel
la seduta del 2 1 febbraio 1 87) (ACS, MPI, Diu. swole medie 1 860-1 896, b. 'l , fase. l O) .
è
è
210
Fonti pe1· /a storia della scuola
Sezione l - Lo suolgimento dell'inchiesta
te poche e sporche. A dimande di geografia hanno risposto male, male a di
mande di aritmetica. Cominciano ora la storia greca. Manca la disciplina e
l 'ordine dell'insegnamento.
Delle classi elementari, non abbiamo veduto che pochi fanciulli scrivere
sotto dettatura.
Delle liceali niente: l'ora era tarda. In una sala poche e vecchie macchine
di fisica.
Visitando il convitto, abbiamo interrogato alcuni giovani del liceo : an
ch'essi mancano di quaderni per la matematica; l'insegnamento che loro
viene impartito consiste nullo nell'esplicazione di un testo, senza esercizi ,
senz' applicazioni .
Ecco ciò che abbiamo osservato intorno alle scuole private della città di
Napoli. Troppo poco a dir vero. In Napoli s ' è fatto il tirocinio de' procedi
menti dell' inchiesta; e soltanto negli ultimissimi giorni fu compresa da tutti
l'opportunità di aggiungere le ispezioni agli interrogatori orali. Negli stadj
ulteriorj dell'inchiesta si potrà tener conto di quest'esperimento, e, purché i
membri della Commissione non siano troppo scarsi di numero, far procede
re di pari passo l 'una e l'altra forma dell'inchiesta. Ma resterà una grave la
cuna rispetto a Napoli, dove l ' istruzione privata ha sf smisurate ramificazio
ni, che ad essa non è lecito applicare i criterj desunti dalle visite di altre città
o provincie. Crediamo perciò necessario che l 'illustre nostro presidente pre
ghi S . E . il ministro a volere ordinare una speciale ispezione delle scuole se
condarie priYate e pubbliche della città di Napoli; della quale ispezione sia
stesa una diligente relazione da unirsi agli att i dell'inchiesta.
Istituto della carità ( 1 marzo 1 873) (A questa visita prese parte anche il col
lega cav . Carbone) .
Scuole elementari, ginnasiali, e soltanto l a prima ginnasiale - Convitto.
Direttore sac . Errico Attanasio . Istituto per nobili e ricchi giovanetti. Si
pagano al mese l O lire nelle scuole elementari, 1 5 nelle ginnasiali, 20 nel li
ceo, 70 nel convitto.
Casa bellissima, ampia, tutta piena d'aria e di luce; alcune parti ancora in
costruzione. Convitto pulitissimo, anzi elegante. Nel cortile attrezzi di gin
nastica.
Abbiamo visitata la prima classe liceale. I giovanetti sono mediocremen
te istruiti: molta grammatica latina e greca, poca pratica di scrittori. Si è let
to un componimento italiano, l' incendio di Roma, fatto da Nerone: Roma
doveva cadere, per risorgere cristiana. Recitarono versi di Dante; taluno ha
recitato versi suoi . Di latino non imparano niente a memoria. Manca ancora
qui l' ordine della disciplina e dell 'insegnamento. I giovanetti non sapendo
rispondere ad alcune dimande, dicevano: a questa lezione io mancai. Di
geometria sanno poco e male; nessuno svolgimento di raziocinio. Si doman
da ad uno: quando due linee rette si dicono parallele? Risposta: non fui alla
lezione, quando si spiegò questo . Dunque i signorini vanno a scuola quando
e come vogliono.
Tra i loro libri hanno alcuni libri di divozione . L'oratorio è un luogo bel
lissimo della casa.
Ci si insegna, per accogliere tutti, anche qualche materia di diritto.
Il direttore è contentissimo che si è stabilito l'esame dopo la s a ginnasia
le, e l' intervallo di tre anni tra la licenza ginnasiale e la liceale: vorrebbe
un 'altro esame dopo il terzo anno ginnasiale, e la licenza ginnasiale dopo un
intervallo prescritto di due anni.
Del resto si sente in generale negl'istituti privati della città di Napoli, al
meno ne' più accreditati , il bisogno di un provvedimento governativo, che
impedisca ai giovani di entrare in quelle classi dove non possano stare e di
fare gli studi a salti.
211
Luigi Cremona
12
Lettera di Antonio Scialoja a Girolamo Cantelli.
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860-1896), b . 7, fase . 6 1 .
Roma, 24 marzo 1 873
Le visite agl'istituti d'istruzione secondaria.
Ho ricevute le relazioni delle visite fatte agli Istituti Marciano e della ca
rità in Napoli, ed alle scuole di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta, delle
quali vivamente la ringrazio. E nel significarle la mia piena approvazione a
ciò che fu fatto debbo aggiungere che mi fu grato altresì il leggervi come la
Commissione concorra finalmente nella mia sentenza della necessità dell ' i
spezione alle scuole secondarie da farsi contemporaneamente all ' inchiesta.
Quella di Napoli certo voleva esser condotta con più larga misura e eonver
rà pure che vi si ritorni . Solo è da avvertire, che a risparmio di tempo, fareb
be d' uopo, come io ne la prego, che la S.V. Ill. ma disponesse le cose in mo
do, che le dette visite si potessero eseguire da alcuno dei componenti la
Commissione, allorquando essa nuovamente si condurrà nelle provincie del
Mezzogiorno. Così per l'altre parti del regno, man mano che la Commissio
ne le percorre, V.S. potrà delegare a ciò alcuni dei commissarii, che racco-
212
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1 - Lo SL •olgimento dell 'inchiesta
gliendo da sé abbondante copia di fatti, e recandoli in seno alla Commissio
ne vanno con maggior frutto posti a riscontro dei giudizii, che d4gli interro
gatori v � rbali e dalle risposte scritte si saranno accumulati . E con ciò augu
randomi, che le incominciate investigazioni menino a quello scopo, ch'è nel
comune desiderio, con perfetta osservanza me Le raffermo
f. t o Scialoja
213
l '!
Lettera di Girolamo Cantelli ad A ntonio Scialoja.
ACS, M P I , Diu. scuole medie (1 860- 1896), b. 7, fase. 6 3 .
13
Lettera di Girolamo Cantelli a Marco Tabarrini.
AS F l , A rchivio Marco Tabarrini, b. 1 2 , ins. 2 .
Roma, 1 5 aprile 1 87 3
La Commissione fece i n alcune provincie dell' Emilia i l giro ch'era stato
convenuto nell'ultima adunanza; solo che per lo scarso numero dei commis
sarj e la imminente ricorrenza delle feste pasquali dovette interromperlo a
Ravenna, lasciando indietro Pesaro, Macerata ed Ancona. Secondo la delibe
razione presa si dovrebbe dopo le feste imprendere quello della Sicilia e del
la Sa :ctegna, ma prima d'i ncominciarlo io desidererei conoscere quali dei si
gnor� eh � compongono la Commissione siano disposti a farne parte in que
sto vtaggw 1 •
Pr�go qui � di la �.V. Ill.ma acl essere cortese di farmi sapere s'Ella possa
parteetpare at lavon della Commissione in quelle due isole, e nel caso affer
mativo, s'Ella sia in grado di partire da Roma verso Napoli eli conserva con
gli altri colleghi, tra il 20 e il 30 del presente mese.
�� sarò .grato .assai s' Ella si compiacerà farmi conoscere senza indugio i
suot mtendtmentt su questo particolare; intanto me Le profferisco con pie
nezza di stima.
Il presidente
G. Cantelli
Torino, 1 3 maggio 1 87 3
Eccellenza,
l' inchiesta scolastica dura ormai da tre giorni in questa città, onde mi pa
re debito rendere informata l'E.V. del suo procedere 1 • Ho avvisatamente in
dugiato a scriverle su tale argomento , per potermi fare chiaro concetto del
l'ambiente nel quale la Commissione si trova e deve operare. Torino, non
occorre dirlo, è da noverare tra le città più benemerite d' Italia in fatto di
studi , vuoi pel numero e l 'importanza degli istituti governativi, comunali e
provinciali, vuoi per l' estensione e il credito che qui ha raggiunto l ' insegna
mento privato. Ma Torino ha forse in sé come uno strascico di quella vita
politica della quale per quasi quattro lustri fu il focolare, strascico che per
isventura non pare sempre effetto di elevate aspirazioni ma piuttosto di uno
scontento, di una diffidenza per tutto ciò che le viene di fuori, e in partico
lar modo dal governo. In questa opinione mi sono indotto dal considerare
come qui la Commissione d' inchiesta non abbia trovato dalla cittadinanza
quell'accoglimento cordiale e fiducioso che non le è mancato mai ne' luoghi
sinora percorsi. Non parlo del prefetto 2, tutto premura e cortesia per la
Commissione, non del provveditore ·' la cui trascuranza invero potrebb'esse
re censurabile senza la grave sventura domestica onde fu colpito, ma sibbe
ne della parte eletta dei cittadini e delle persone più autorevoli in fatto di
studi , le quali o mostrano manifestamente di non credere nei buoni effetti
dell'inchiesta o accolgono questa con un'indifferenza molto prossima all'a
patia, tuttoché la sala delle udienze sia sempre gremita ' .
Sino a qui si sono uditi i capi degli istitut i governativi, e alcuno dei pri-
' La Commissione tenne la prima �eduta il l O maggio e rimase a Torino fino al 17. Furono
ascoltate complessivamente cinquantuno persone.
' Vittorio Zoppi.
' Vincenzo Garelli.
' Nelle carte allegate :1i verbali delle �edute torinesi (ACS, MPl, Div. scuole medie 1 860- 1896,
b. 7, fase. 63) c'è la documentazione di parecchie rinuncie a deporre da parte di notabili� politici
e accademici torinesi; a queste rinuncie, dovute alla sfiducia nella commissione e all'ostilità al go
verno e al ministro, fa più volte cenno anche « La Critica dell'istruzione secondaria classica e tec
nica settimanale pedagogico torinese di ispirazione clericale. Anche Tommaso Vallauri, profes
sore di letteratura latina all'università di Torino, non si presenta a deporre e nelle sue Acroases
più volte si esprime negativamente sui quaesitores de scholis ordinis secundi e sul valore delle
deposizioni. Su queste e altre assenze. vedi anche la lettera di Cantelli del 18 maggio 1873 (doc.
15, p. 2 14).
•,
La Commissione non visitò invece la Sicilia e la Sardegna né allora né in seguito, malgrado
l mv1to retterato m segu1to anche da Ruggero Bonghi (vedi doc. 17, p. 219).
,.
1
•
2 1 '-l
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo st•olgimento del/ 'inchiesta
vati; qualche notevo le professore dell' univers ità, come il 8ertini 1 , il Cano
nico 2, il Lesson a \ ma non per anco, ed è spiacev ole assai, lia potuto
la
Commi ssione raccogliere dichiar azioni da'padri e dalle madri di famigli a, su
cui qui più che altrove aveva fatto assegna mento. È da sperare tuttavia che
nei giorni che verrann o questo stato di cose si possa alquant o mutare in me
glio . Dopo il telegramma che ebbi l'onore d'indiri zzarle sabato, non occorre
che io m'intra ttenga maggio rmente sulle condizi oni partico lari della Com
mission e. Solo mi pare debito fare compro vare ali'E.V. come il rimedio re
cato dell 'art . 3 del r. decreto 29 settemb re 1 872 non possa usarsi per le
cose espress e, in questa città. Ond'è che si rende più che mai necessa rio che
i commis sari assenti possan fra breve raggiungere la Commi ssione a volere
che questa prosegu a con frutto l'opera sua .
G. Cantelli
1 ,
15
Lettera di Girolamo Cantelli ad A n tonio Scialoja.
ACS, M P I , Div. scuole medie (/860- 1 896), b . 7 , fase. 6 3 .
Torino, 18 maggio 1 873
Eccellenza,
Ieri ebbe termine l' inchies ta a Torino , dopo sette tornate consec utive,
1 Giovann i Maria Bertini ( Pancalier i, Torino
3 agosto 1 8 1 8 - Torino 1 3 ottobre 1 876). Dal
l !:l·J7 resse la cattedra di storia della filosofia dell ' università di Torino;
nominato nel 1 8 5 1
membro straordin ario, e dal 1 858 ordinario , del Consiglio superiore della
pubblica istruzion e;
nel 1 85 2 membro del Consiglio generale delle scuole elementa ri; nel 1 865
redasse per il Consi
glio superiore , nell'amb ito dell' inchiesta promossa dal ministro Natali,
la relazione sullo stato
generale dell' istruzione >econdar ia, proponendo l 'istituzion e di un corso
unico per l 'istruzion e
media. Bertini intervenn e alla seduta torinese del 1 3 maggio 1 87 3 (ACS,
MP1, Div. scuole me
die 1 860-1 896, b. 6, fase. 3 ? ) e più volte scrisse sull'inchi esta
Scialoja sulla « Rivista di filologia
e 1struztone class1ca » e su « l Istitutore » del l 874 e 1 87 5 .
' Tancredi Canonico (Torino 1 -t maggio 1 828 - Sarteano , Siena 1 5 settembr
e 1 908). Laurea
.
to 111 legge, dal 1 86 1 resse la cattedra di filosofia del diritto, poi di diritto
penale all'univer sità
di Torino. Nominato senatore nel I 88 1 .
·' Michele Lessona (Venaria Reale, Torino
20 settembre 1 82 3 - Torino 20 luglio 1 894). Lau
reato in medicina esercitò la professio ne in Egitto. Dal 1 849 insegnò storia
naturale ad Asti, poi
a Tonno; nel 1854 gli fu conferita la cattedra di mineralo gia e zoologia
all ' università di Geno
va, poi a Bologna e Torino. Senatore dal 1 89 2 ; autore di numeros i libri
di testo di storia natura
le ad uso delle scuole e del fortunati ssimo Vole,-e è pote1·e, Firenze, Barbera,
1 869.
' Si riferisce alla possibilit à prevista nel decreto istitutivo della Commiss
ione (vedi doc. 1 ,
p . 1 -t9) che i commiss ari potessero giovarsi di persone del luogo per
fare ispezioni o visite a
istituti.
215
nelle quali fu copiosa la materia raccolta se non tutta del pari pregevole.
Mancò anco qui quasi interamente il concorso dei cittadini, e in alcune giun
te quello pure delle persone più ragguardevoli per dottrina e per grado, il
che veramente non era da aspettarsi. on tennero l' invito icomede Bian
chi 1 , Ercole Ricotti 2, Tommaso Vallauri ·' , Gaspare Gorresio 1 , il pro f. Pey
retti ", il presidente delle Assise 6 , alcuni consiglieri di Cassazione e via di
cendo ché troppo lungo sarebbe noverarli tutti. Il ché panni doversi attri
buire in parte alla sfiducia con cui in generale fu accolta qui l' inchiesta sco
lastica in parte a quel non so che di ostile per tutto che sa di governativo,
che invano qui si studiano nascondere sotto le forme più squisite di civiltà.
Cionondimeno non può dirsi che l'opera nostra sia rimasta senza frutto:
giacché in mezzo alle opinioni discordi e alle allusioni circospette, si raccol
sero giudizi e avvedimenti degnissimi di ponderazione i quali andranno ad
accrescere utilmente il patrimonio che la commissione si va formando nelle
sue peregrinazioni.
Intorno alle quali mi giova dichiarare all ' E . V . che sarebbersi continuate
nelle principali provincie subalpine, com'crasi in origine divisato, se com1 N icomede Bianchi (Reggio Emilia 19 settembre 1 8 1 8 - Torino 6 febbraio 1 886). Laureato
in medicina all'uni\·ersità di Parma nel 1 8 18 gli fu assegnata la cattedra di storia e geografia nel
collegio nazionale di Nizza, dopo che in seguito ai fatti politici si era rifugiato in Piemonte. De
dito in special modo agli studi di .,toria contemporanea pubblicò numerosi lavori. Nel 1 860 fe
ce parte della commissione incaricata di redigere i programmi per le scuole e gli istituti tecnici
del regno s:1rdo; fu preside del liceo Carmine di Torino, nel 1 86-t segretario generale della pub
blica htruzione. Nel 1 870 preside del liceo ginnasio E . Quirino Visconti di Roma, dal 1 8 dicem
bre l!l70 diresse l 'Archivio eli Stato di Torino. Fu nominato senatore nel 1 88 1 .
' Ercole Ricotti (Voghera 1 2 ottobre 1 8 1 6 - Torino 2-t febbraio 1 883). Nel 1 8-t6 gli fu affi
data presso l ' università eli Torino la cattedra di storia militare d ' I talia, che successivamente si
chiamò di storia moderna. Fu autore di uno dci più diffusi manuali di storia per le scuole; sena
tore dal 1 86 2 .
' Tommaso \'allauri (Chiusa Pesio. Cuneo 23 gennaio 1 80'5 - 2 settembre 1 897). Professore
di eloquenza latina e italiana all' uni\·ersità di Torino. Deputato nel 1 8 '5 7 , senatore dal 1 88 2 .
Osteggiò l a politica liberale d i Cl\ our e dei suoi successori. Specie nelle Nol'elle e nelle Acroa
ses pre.,e posi/Jone durameme contro le tendenze filologiche di origine tedesca che stavano pe
netrando nelle scuole secondarie: difese perciò la vecchia tradizione retorica. gli e;ercizi di ver
sificazione latina. le antiche grammatiche esemplare sul Donato.
Gaspare Gorresio (Bagnasco, Cuneo 20 giugno 1 808 - Torino 2 l maggio 1 89 1 ). Abate, in
dianlsta, fu direttore della Biblioteca nazionale di Torino. Laureato in filowfia nel 1 8 30, studiò
in seguito a Vienna. Dal 1 83-t aggregato alla facoltà di lettere di Torino. A Parigi studiò sanscri
to con Burnouf; corrispondente della Crusca, dal 1 8 '5 2 incaricato per l ' insegnamento del san
scrito a Torino.
Giovan Battista Peyretti, professore ordinario di filosofia teoretica alla facoltà drfilosofia
e lettere dell'università di Torino.
" Probabilmente Giovanni Prato. Il l 'i maggio 1873 Prato scrive al presidente della Com
mis;ione d' inchiesta per comunicare la propria impossibilità a presentarsi di fronte ad essa per
una comemporanea udienza cui deve presentarsi come re latore. Aggiunge: « e se fosse lecito
esprimerei ancora il desiderio di essere in avvenire dispensato, poiché uomo esclusivamente eli
leggi e magistrato ben poco potrò gioYare con le mie risposte all'inchiesta sull' istruzione secon
daria » (ACS. MPI, Dit•. scuole medie 1860-1 896, b. 7, fase. 6 1 ).
•
<
216
Sezione I- Lo svolgimento dell 'inchiesta
Fonti per la storia della scuola
piuto l'ufficio nostro qui, io non mi fossi trovato solo, o quasi solo all'impre
sa. Perocché il numero sempre scarso dei commissarii, si andò man mano as
sottigliando, fino a ridursi al solo cav. Carbone. Il comm. Tenca come sa
l' E.V. , dovette condursi in fretta costà per la discussione parlamentare; il pro
fessore Cremona chiamato per telegrafo all'adunanza del Consiglio scolastico
di Milano, dichiarò doversi trattenere alquanto colà ai servizii dell'Istituto
lombardo, privato dell'altro segretario Carcano; il senatore Finali, mal dispo
sto in salute, dovette correre precipitosamente al capezzale del morente fra
tello, lasciando poca o punto speranza di ritornare fra breve in seno della
Commissione 1 • Tuttavia non mi scoraggii; e nel vivo desiderio di accertare il
compimento dell'opera dall'E.V. affidatami , feci premure telegraficamente ai
commissari Settembrini e Tabarrini, coi quali avremmo potuto domani, o
martedì riprendere i lavori in Alessandria, e di là d'istenderci a Piacenza, e a
Novara, per modo di impiegare utilmente il tempo che resta al 1 o di giugno
in che mi riprometto di potere aprir l'inchiesta a Milano con parecchi de'
commissari presenti. Ma l' uno e l'altro furono impediti per varie cagioni dal
l 'aderire alle mie preghiere, ond'io dovetti di necessità sospendere l'inchie
sta, salvo a riprenderla tosto, se nel frattanto piccola parte almeno dei com
missari sarà disposta a coadiuvarmi. Al quale effetto gioverà non poco l'intro
missione autorevole dell'E.V., così presso i commissari che sono costà, come
per gli assenti. Intanto ho disposto che gli stenografi tornino pel momento al
le case loro e i segretarii rimangano qui; giacché ho considerato maggiore il
dispendio del doppio viaggio a breve intervallo che della permanenza. Qualo
ra per altro all'E. V. paresse altrimenti, non avrà che a significarmelo a Parma,
dov'io starò attendendo i suoi ordini, e l'esito delle premure che farà perso
nalmente costà il cav. Cremona, dal quale l'E.V. avrà notizie più particolareg
giate, e di quanto si fece e di quanto si potrebbe ancor fare da qui al 1 o di
giugno solo che due dei commissari anticipassero la loro venuta.
Con perfetta osservanza.
Suo G. Cantelli
P.S. Avevo divisato che la Commissione visitasse alcuni dei tanti istituti e
pubblici e privati, che si trovano in questa città, e specialmente il Convitto
nazionale. Ma poiché la maggioranza dei commissari presenti portava con
trario avviso dovetti rinunziarvi. Ciò le dico, e per non tacerle nulla di quel
lo che importa, e per provarle sempre più come l'inchiesta non possa riusci
re compiuta se i più di coloro a cui fu commessa non si trovino al loro
posto .
1 Luigi Settembrini, in una leuera a Cantelli del 7 maggio 1 87 3 , scrive: • Non posso venire a
Div. scuole me
Torino per varie ragioni, e non ultima un ritorno della podagra » (ACS,
die 1860- 1 896, b. 7 , fase . 63). Di una scarsa presenza dei commissari nelle sedute di Torino
La inchiesta sull 'istruzione secondaria, in " Rivista di filologia e d'istru
parla anche D.
zione eia;> i ca », ( 1 87-!), pp. 2 '>-39.
è
PEZZI,
II
MPI,
217
16
I due decreti conclusivi.
R.
d. 1 3 set . 1 874, n. 2092
1•
Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione re d' Italia.
Visto il decreto 29 settembre 1 87 2 , n. 1 0 1 6;
Osservata la relazione particolare presentata il dì l o luglio 1 874 dalla
commissione d'inchiesta sulle scuole secondarie;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari del
l' interno, reggente il dicastero della pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art . l Negli esami di licenza ginnasiale le prove saranno le seguenti:
Prove scritte: componimento italiano - versione dal latino in italiano versione dall' italiano in latino - versione dal greco in italiano - quesito di
aritmetica.
Prove orali : italiano, latino, greco - storia e geografia - aritmetica - pro
sodia e metrica latina ed italiana - lingua francese, o v'è prescritta.
1 La Commissione, alla fine dei suoi lavori, presentò circa 30 proposte al Consiglio superio
re. l due decreti qui pubblicati furono il frutto di un lungo travaglio deci;ionale e oggetto di
numerose critiche, a cominciare da quelle dello stesso R uggero Bonghi. Sul decreto n. 2092 i l
Ministero dell' istruzione pubblica invierà a i prefetti la eire. 2<; ott. 1 87"1 , n . "10 1 , relativa all 'ap
plicazione delle norme previste dal decreto relativamente alle prove per gli esami di licenza li
ceale, mentre una precedente circolare del 1 5 ottobre (n. 399) comunicava il nuovo orario per
i licei. Ma la questione degli esami liceali, del le materie e dei mocli sui quali condurla, dell'am
missione ecc. continuarono a essere successivamente riproposti . Nella seduta della Camera dei
deputati del l O febbraio 1 87 5 il deputato Merzario, nel corso del dibattito sul bilancio del Mini
stero della pubblica istruzione, ripropose la questione, insieme a quella del! 'abolizione della fe
sta scolastica e della soppressione dell'Annuario del ministero. Bonghi, che con r.d. 7 gen.
1 87 5 , n . 2337, aveva dettato nuove norme relative alla giunta per gli esami di licenza liceale e
sugli esami stessi e con regolamento del 22 febbraio 1 87 5 ne indicava l 'applicazione, rispose a
Merzario ricordando da un lato come i due decreti del settembre 1 87"1 fossero stati il fru tto del
le risposte raccolte dalla Commissione d ' inchiesta e dall'altro spiegando come una buona am
ministrazione significasse anche fare riforme continue e successivi aggiornamenti. AP, Camera
l sessione ( 1 87"1- 1 87 5 ) , Discussioni, l , tornata del L O febbraio 1 87 5 ,
dei deputati, legislatura
pp. l l <t 3 e seguenti.
II,
218
219
Fonti per la storia della scuola
Sezione l - Lo suolgime11to de/l 'h1chiesta
La prova orale di latino e di greco comprenderà la doppia versione dal
l' una all 'altra lingua.
Nelle materie in cui è richiesta la doppia prova avrà luogo la compensa
zione allorquando ai cinque punti ottenuti nell ' una si possono contrapporre
otto punti ottenuti nel! 'altra.
Osservata la relazione particolare presentata il dì 1 o eli luglio 1874 dalla
Commissione d' inchiesta sulle scuole secondarie ·
udito il Consiglio superiore di pubblica istruzt one;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l' interno, reg
gente il Ministero della pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art . 2. La licenza ginnasiale darà diritto d' iscriversi come studente nel
primo corso liceale senza obbligo di speciale esame d'ammissione.
Art . 3. Lo studio della storia e geografia, delle lettere italiane e della ma
tematica avrà luogo in tutti e tre i corsi liceali.
All'ordinamento delle relative lezioni con quelle degli altri studi sarà
provveduto con nuovo orario.
Art . - L Nelle scuole tecniche, previo il parere del consiglio scolastico e
l'assenso del ministero, l' insegnamento delle materie letterarie sarà così eli
viso che in tutti e tre gli anni del corso il professore del secondo e terzo an
no insegni lingua italiana, e l' incaricato del primo anno insegni storia e geo
grafia.
Art . 5. La festa scolastica stabilita ne' licei col decreto del 4 di marzo
1 865 , n. 2229, sarà celebrata al ripigliare degli studi nel mese di novembre .
Il preside l'aprirà esponendo l'andamento delle scuole nell'anno preceden
te, un professore leggerà un discorso su tema da lui scelto, e, senza più , la
festa terminerà con la proclamazione dei premiati e la distribuzione degli at
testati eli licenza.
Art . 6 . Gli studenti privati potranno presentarsi in qualunque scuola go
vernativa a sostenere gli esami eli passaggio dall'una all'altra classe alla fine
dell'anno scolastico insieme agli alunni della scuola, con egual diritto ai pre
mi e alle menzioni onorevoli, e pagando la tassa prescritta per gli esami
d'ammissione. Le commissioni esaminatrici avranno le propine stabilite per
tali esami.
Art . 7. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d' Italia, man
dando a chiunque spetti eli osservarlo e eli farlo osservare.
Dato a Valsavaranche addì 1 3 settembre 1 874.
Vittorio Emanuele
G. Cantelli
R. d. 1 3 set. 1 874 , n. 2093.
Vittorio Emanuele I I per grazia eli Dio e volontà della nazione re d' Italia
Visto il decreto del 29 settembre 1 87 2 , n. 1 0 1 6;
Art . l . Salvo la facoltà che ha il ministro di aprire sessioni straordinarie
eli esami là dove ne occorre il bisogno, gli aspiranti all'abilitazione e all' inse
gnamento elementare, eli grado inferiore e superiore, che non abbiano fatto
i lo �o st �1di in l�na scuola normale o magistrale pareggiata dovranno presen
.
tarsi aglt esam1 111 una scuola regia.
Art . 2 . Gli aspiranti all'abilitazione dell'insegnamento elementare, per es
sere ammessi allo esame, dovranno provare di aver già fatto l'anno di tiroci
nio, di cui è parola all'art .42 del regolamento 9 novembre 1 86 1 , presentan
do, per ciò l' attestato dell' ispettore del circondario.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in
serto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d ' Italia, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Valsavaranche, il 1 3 settembre 1874 .
Vittorio Emanuele
G. Cantelli
17
Lettera di Ruggero Bonghi a Marco Tabarrini
1•
AS F l , A rchiz•io Marco Tabarrini, b . 1 2 , i n s . 2 .
(s . I . , dicembre 1 874]
Pregiat .mo Signore
Mi parrebbe non soltanto utile, ma opportuno che la Commissione d'In
chiesta per le scuole secondarie, prima eli por termine ai suoi lavori, visitasse le scuole della Sicilia e della Sardegna.
1 Il tentati\·o, condotto �enza molla convinzione. di riavviare l'inchieMa, dopo che da quasi
un anno erano ;tale so�pe;e le audizioni e riprendendo l ' antico progetto di visitare le scuole
delle bole, non ebbe alcun effetto, anche perché nessuno dei commissari era disposto a questo
viaggio natalizio. Si ,·eda a que;ro proposito Carteggio Tenca-Maffei . cit . . p. 1 8 2 (lettera
dell'8 ottobre 1 8-,-J).
. .
220
Fonti per la storia della scuola
Io comunico questa idea alla S . V . Ill.ma acciò nel caso ch'Ella l'approvi
mi faccia noto se nulla La impedisca d'intraprendere questo viaggio, che do
vrebbe effettuarsi non più tardi del 20 di questo mese.
Le sarò grato di un pronto riscontro per mia norma, mentre con perfetta
stima me Le profferisco.
devt .mo
Bonghi
SEZIONE II
I VERBALI DELLE DEPOSIZIONI
18
Seduta di Roma, 1 1 febbraio 1 8 73
'.
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860- 1 896), b . 4 , fase . 2 .
G I L'SEPPE FERRERI
2
Presidente. Il signor comm . Ferreri ha desiderato d'essere interrogato
verbalmente sopra quesiti che riguardano i padri di famiglia, rapporto ai
confronti dell' istruzione pubblica e privata, e sui resultati dell' una e dell'al
tra. Ora io lo pregherei a dire intorno al profitto che crede che si possa otte
nere nei ginnasii e licei governativi, e intorno a quello che si possa ottenere
invece negli istituti privati, dicendo a quali secondo lei sia da darsi la prefe
renza, se agli uni o agli altri .
Ferreri. Io come padre di famiglia darò alla Commissione quelle poche in
formazioni cui l'esperienza mel concede, e risponderò a domande speciali,
se mi verranno dirette, e a qualche nozione generale se io loro dovrò espor
re. lo sono padre di famiglia ed ho quattro figli. Due di questi corrono il se
condo anno degli studi liceali; il terzo fa il terzo anno delle scuole tecniche,
ed il quarto è alla terza classe elementare. Mi permetto di avvertire che fino
a due anni addietro i miei figli hanno frequentato in Firenze l' Istituto fioren
tino diretto dai padri scolopi ·\ che, venuto in Roma colla mia famiglia e i
' La seduta dell ' l ! febbraio 1 873 è presieduta da G irolamo Cantelli.
' Giuseppe Ferreri (Cuneo 5 novembre 1 825 - ivi 29 maggio 1 885), magistrato; nella sua
carriera ricoprì vari incarichi in diven,e sedi e fu sostituto procuratore generale presso la Corte
d'appello di Firenze nella seconda metà degli anni Sessanta; e a questa esperienza fiorentina si
riferisce in gran parte la sua deposizione; dal 9 agosto 1 869 al 1 5 giugno 1 87 3 fu, prima a Fi
renze e poi a Roma, segretario generale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; nel 1 87 5
relatore della Giunta per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Risponde anche sugli esami, i li
bri di testo, l ' istruzione religiosa, le vacanze.
1 L' Istituto fiorentino degli scolopi era, anche dopo l ' Unità, la scuola secondaria principale
e più frequentata di Firenze; il maggior successo degli istituti religiosi rispetto ai goyernativi,
spesso lamentato nell'inchiesta, aveva forse nell' Istituto fiorentino, che sottraeva molti scolari
al liceo Dante governativo, l 'esempio più clamoroso, verificandosi nell 'Atene d'Italia, per cin
que anni capitale. Il successo della scuola era dovuto a una consolidata tradizione per cui gran
pane della classe dirigente fiorentina aveva studiato presso gli scolopi, alle qualità educative
del corpo insegnante, al fatto che gli scolopi, noti come avversari dei gesuiti, avevano fama di
liberali e di patrioti, godevano perciò del favore della borghesia fiorentina e di un contributo fi
nanziario del comune di Firenze. Il ministero tentò più volte di sminuirne il credito ordinando
alcune severe ispezioni: p.s. Masi-Brioschi nel 1 868 , Settembrini-Cremona nel l 87 1 (ACS, M P I ,
225
Fonti per la storia della scuola
Sezione 11 - l verbali delle deposizioni
miei figli , affidai al Collegio romano 1 i due maggiori e il terzo ; i due maggio
ri pei corsi liceali , e il terzo pel corso delle scuole tecniche; l'ultimo poi l ' ho
affidato alle scuole elementari municipali , e precisamente egli frequenta il
Collegio Capranica. Se io dovessi parlare dell ' istruzione e educazione che i
miei figli hanno ricevuto a Firenze, e specialmente ì tre primi, nell ' istituto
fiorentino, non potrei che rendere a quei padri i maggiori elogi, perché in
verità io non potrei essere abbastanza grato sia del modo di educazione sia
del modo di istruzione, con cui furono per ben sei anni portati al punto da
potersi presentare a Roma a ottenere la loro promozione seppur ai corsi li
ceali o nelle scuole tecniche, stando pure a tutte le regole prescritte dal re
golamento governativo.
Dirò che l' istruzione fiorentina 2 secondo me, in Firenze attrae a sé la
maggioranza dei giovani appartenenti anche alle famiglie più ragguardevoli
di quella stessa città non già per la nobile e antica tradizione non solo ma
anche pel concorso di circostanze che difficilmente in altri istituti si posso
no trovare e riunire. Là c'è un locale non pure vasto, adatto, decente, ma
decoroso in modo che attrae la simpatia dei giovani, a cui serve anche ad
ispirare il sentimento del rispetto verso l ' istituto e gl'istitutori . I giovani, là,
credo poi che approfittino forse più che negli altri istituti , perché oltre ad
avere un' istruzione lodevole, hanno anche tale l'educazione ; e dal momento
in cui il mattino mettono piede nell ' istituto fino al momento in cui ne esco
no sono guardati, sorvegliati , non abbandonati mai . Non hanno solo il mae
stro, che invigila durante la lezione, ma hanno anche il prefetto che sorve
glia nel momento che entrano in scuola alla disciplina, e non li abbandona
mai . Quindi non è possibile che siano dimenticati, che trascorrano. Ed è poi
importante a notarsi che i giovani anche più svelti, e dirò anche sfrenati,
che fuori dalla scuola non si possono in nessuna maniera contenere , una
volta che entrano nell' istituto o che veggano i loro maestri o il prefetto, non
è più possibile che manchino, per modo che è un piacere il vederli. Dunque
io credo che uno dei maggiori pregi di quell' istituto tanto nell ' istruzione
quanto nell 'educazione sia quella solidarietà che riunisce i membri di quel
sodalizio. Quanto poi all'insegnamento, bisogna pure che io dica, per quan
to consta a me, non essendo io naturalmente competente a parlare e giudi
care delle materie speciali , che io sono rimasto soddisfatto in ispecie perché
ho veduto che si occupavano con particolare amore della lingua italiana e
latina per la parte classica; e il profitto che ne hanno fatto in verità ha corri
sposto ampiamente; e non credo di andare errato , perché in fatto gli esami a
cui sono stati esposti prima in Firenze per la licenza ginnasiale, quindi a Ro
ma per essere ammessi alla licenza, hanno giustificato pienamente quanto
me ne avevano detto i professori . Non devo egualmente tacere però che se
la parte degli studi [dei] classici della lingua italiana, latina e anche greca
(perché anche questa lingua è coltivata con amore particolare) 1 , non potrà
dirsi la stessa cosa per le matematiche 2 , perché a dire la verità nell ' u ltimo
anno i n cui per disposizione governativa si è coltivata questa scienza dai
giovani che frequentavano l ' ultimo anno eli ginnasio, non si fu abbastanza
rigorosi per le matematiche, forse perché questa parte d ' insegnamento non
si era costituita per l' innanzi, e non abbia perciò per allora potuto corri
spondere alle vedute del governo; quindi da questa parte io ebbi a trovare
un lieve difetto, a cui dovetti poi riparare con studi particolari. Quanto poi
all ' istituto di Firenze dirò che per queste ragioni attira a sé la maggioranza
dei giovani, e che la vince sugli istituti privati i quali non hanno mezzi corri
spondenti da poter sostenere la concorrenza di ques t ' istituto, perché appun
to in esso si trovano riuniti tutti i mezzi, che ho poc 'anzi accennati , poten
tissimi e speciali, che difficilmente i n altri istituti si troverebbero riuniti; ed
è per questo che le stesse scuole del governo , per quanto si faccia, non sono
riuscite ad ottenere ciò. Le scuole normali governative 3 per quanto si faccia,
sinora non sono riuscite a poter vincere la concorrenza; e ciò lo dirò di vo
lo, perché nell ' istituto governativo, nei collegi , per quanto vi siano profes-
Dii'. scuole medie, 1860- 1 896, b. 59). Dopo l 'avvento della Sinistra al potere, nel 1 878 il mini
stro De Sanctis, il prefetto Bardesono e il barone Reichlin, commissario del Comune di Firenze,
con un colpo di mano soppressero il contributo comunale e costrinsero gli scolopi ad abbando
·
nare la sede di S. Giovannino in via Martelli ove poche settimane dopo istituirono il ginnasio
Galileo. L'atto governativo suscitò molte proteste tra i moderati fiorentini. La polemica, tra le
più significative delle scontro tra i laici e i paolotti, si protrasse tutto l ' autunno del 1 878 sulla
stampa nazionale e trovò anche echi all'estero. La questione scolopia torna spesso nell 'inchie
sta (p.es . le deposizioni di Amari a Roma, di Peruzzi e Zini a Firenze).
1 Nel Collegio romano, già sede delle scuole dei gesuiti, il governo nazionale aveva aperto
il primo ginnasio liceo governativo, il Visconti, curando che vi fossero trasferiti alcuni dei mi
gliori insegnanti disponibili in altre sedi.
1 Deve intendersi invece " istituto fiorentino » : si parla della scuola degli scol opi normal
mente denominata così.
1 La frase non risulta compiuta. Lo stenografo ha probabilmente omesso qualche parola.
' Offre a ciò riscontro il diario dell' ispezione eli Luigi Cremona alle scuole pie fiorentine del
9 luglio 1 87 1 (quinto ginnasio) in ACS, MPJ, Dil'. scuole medie (1860- 1 896), b. 59: « Comincio
io dal chiamare e interrogare due giovanetti, figli eli un eminente magistrato (avvocato Ferreri);
domando all'uno come si trova il minimo mutiplo di più numeri, all'altro come si trovi il mas
simo comune divisore; non esigo dimostrazioni o ragionamenti, ma mi limito a chiedere l'ese
cuzione materiale del conteggio; li ajuto con amorevole dolcezza, li guido quasi per mano. Tut
to indarno; i meschini non sanno nemmanco l 'abaco! Oh avrei voluto presente lor padre, che
pochi giorni innanzi mi diceva d 'essere contentissimo dell'istruzione impartita ai suoi figliuo
li! " · Nella relazione acclusa Cremona mostra di non accettare la spiegazione che gli scolopi gli
adducono per giustificare gli scarsi risultati del loro insegnamento di matematica: la eire. l o
nov. 1 870, giungendo a loro conoscenza con molto ritardo, avrebbe sconvolto il piano didatti
co precedentemente fissato. Nella sua deposizione Ferreri invece sembra accogliere la giustifi
cazione degli scolopi.
1 Il riferimento è alle scuole normali universitarie che, secondo Ferreri (e l ' opinione
lar
gamente condivisa anche in altre risposte e deposizioni), non erano in grado di formare inse
gnanti in grado di competere con gli insegnanti religiosi, e specie gli scolopi, soprattutto sotto
il profilo educativo.
è
-
227
Fonti per la storia della scuola
Sezione /1 - I L •erbati delle deposizioni
sori valenti, siccome i professori non attendono che u nicamente, esclusiva
mente alla vigilanza dei giovani che solo nelle ore di lezione, la disciplina
essendo meno curata che presso gli scolopi , i padri di famiglia si consigliano
di far frequentare questo istituto a preferenza degli altri dai propri figli . [ . . . ]
istruzione secondaria non vi fossero professori che non fossero in grado alla
loro volta di superare gli esami di licenza liceale . Io mi limiterei a questo;
pur troppo credo che si trovi un certo numero di professori, che messi al
posto degli allievi, non so se potrebbero superare l'esame. oi ct stamo tro
vati in circostanze difficili; dopo la guerra del ' 59, c ' era un gran numero di
giovani spostati, i quali si sono collocati spesso nella istruzione . Ora possia
mo rimediare gradatamente all ' inconveniente, senza offendere riguardi che
pur si debbono rispettare . Io credo che quando il ministro abbia u na mano
di ferro , si possa sbarazzare degli elementi inutili. [ . . . ]
Ma al punto in cui siamo oggi per ovviare la diserzione bisogna da u na
parte cercare di migliorare i nostri istituti 1 , dall ' altra chiudere quelli che
apertamente congiurano contro di noi. Noi vediamo come lo Stato scioglie
le riunioni repubblicane, per lo stesso motivo deve chiudere gli stabilimenti
educativi dove appunto si congiura contro le nostre istituzioni, e si ispirano
sentimenti ostili e si dà del ladro al re, al parlamento fino all'ultimo applica
to del governo . I o trovo incomprensibile come si possa lasciar sussistere tali
istituti e qui parlo anche degli istituti femminil i .
Ecco un esempio dell' istruzione c h e si dà in questi. U n a ragazza uscita da
un istituto femminile scrive alla sua amica di pregare perché Iddio ispiri la
Francia a rimettere il potere temporale del papa. Quando un fatto simile sia
constatato non sarebbe questo uno stabilimento che si dovrebbe chiudere ? È
proprio vera corruzione (esco con una sola parola dal tema che ho trattato)
quella che si fa nell'educandato femminile. Per me non mi spavento dell ' in
fluenza degli istituti religiosi nei maschi i quali forse diventeranno atei con
questo modo d ' educazione. Le donne si corrompono, diventano bigotte, si
pregiudicano . [ . . . ]
Un 'altra innovazione importante che io ho chiesto ai ministro ed ora rin
novo alla Commissione d ' i nchiesta sarebbe quella della riunione delle prime
due classi del ginnasio alle scuole tecniche perché sono tanti i vantaggi che
derivano da ciò che mi meraviglio che questo sistema già propugnato da uo
mini distinti che si sono occupati della p ubblica istruzione non abbia avuto
una fase di esperimento . Io credo che questo sia il mezzo di attirare alle
scuole dello Stato molti studenti . È un gran vantaggio che u na scuola condu
ca piuttosto a due carriere che ad una sola.
Un po' di latino insegnato praticamente potrebbe essere utile a chi deve
percorrere u na carriera tecnica. Credo che sovrapponendo i programmi del
ginnasio a quelli delle scuole tecniche, l' orario delle une con le altre materie
226
GABRIELE L UIGI PECILE 1
[. . .]
Negli studi secondari l ' uomo vive nell'antichità: io crederei che per tem
perare quest ' insegnamento, che è pure vantaggioso, sarebbe bene che nel
l' insegnamento secondario si insegnasse un po' di doveri e di diritti dei cit
tadini, un po' di economia sociale, un po' di morale, che oggi mancano del
tutto 2• Non v ' è bisogno di dire che la istruzione pubblica è una funzione es
senziale dello Stato, come le imposte, come le leve militari . La scuola secon
daria è per così dire il corpo di mezzo più importante della istruzione. Ora
pare che l 'amministrazione dell ' istruzione pubblica pecchi di essere u n po'
debole e intralciata . Io credo che a ciò si rimedierebbe col discentrament o .
Prima di tutto, perché l ' amministrazione proceda bene, i l ministro deve far
si uomo di ferro, e deve appoggiarsi ai più forti della sua amministrazione .
Bisogna bandire la beneficenza dal Ministero dell ' istruzione pubblica; essa è
di competenza del Ministero dell' interno.
Bisogna escludere le raccomandazioni dei deputati , che sono nocevolis
sime alla scelta dei professori. Finché si mette a posto un impiegato un po'
scadente, meno male; ma quando mettiamo a posto un professore che non
vale, questo guasta tutta la scuola, e tante volte guasta tutta l ' istruzione. Le
commissioni d ' esame dovrebbero essere serie, sempre serie, e giudicare sen
za riguardo, altrimenti la istruzione rimane defraudata. Io vorrei che nella
1 Gabriele Luigi Pecile (Fagagna, Udine 1 1 novembre 1 826 - 27 novembre 1 902). Avvocato,
nel 1 866 alla liberazione della provincia di Udine sovrintese provvisoriamente all'amministra
zione della pubblica istruzione c successivamente fece a lungo pane del Consiglio scolastico
provinciale c della Giunt a di vigilanza per l ' istruzione tecnica. Deputato nella IX, X, Xl legisla
t ura dal novembre 1 865 al settembre 1 87'1, fu nominato senatore nel 1 880. Nella sua deposi
zione parla anche della legislazione scolastica, dell' istruzione religiosa, del l ' istruzione non go
vernativa, della condizione dei professori (reclutamento, promozioni, trasferimenti), delle tasse
scolastiche, gli esami, le biblioteche (per l'aggiornamento degli insegnanti), le scuole superiori
femminili da professionalizzare; si pronuncia altresì contro il greco obbligatorio c contro l ' uso
cieli' Euclide.
' Nella parte immediatamente precedente dopo aver notato che rispetto ai licei • nell' istitu
to tecnico c'è più volontà, minor vincolo di pregiudizi, minor auaccamento alle vacanze, agli
scioperi, alla volontà di non far niente » , sostiene che attraverso la scuola bisogna « far guerra al
vizio di noi italiani . . . vale a dire all' ozio e alla superbi a » ; da ciò l'esigenza di avvicinare la
scuola alla vita pratica e la polemica contro il classicismo.
1 Nelle parole precedenti deplora che gli istituti religiosi non diano quell 'educazione « che
rende l ' uomo buon cittadino » . Per le stesse ragioni più avanti critica la circolare Scialoja del 1 8
dicembre 1 872 perché troppo generosa verso i seminari e conclude: " Lo stato civile abdica cd
il clero esterno avanza )) .
228
229
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
ci starebbe perfettamente. M i pare che questa innovazione non avrebbe osta
colo di legge in quanto che la legge non definisce ciò che si deve fare nei
singoli anni. Quindi non vi è bisogno di nuova legge. Io dalla mia parte ri
cordo alla Commissione d ' inchiesta che sarebbe gran vantaggio ai paesi che
non hanno ginnasio e liceo di provvedere in tanti casi a questa mancanza.
Così io credo che ciò gioverebbe all' istruzione pubblica anche in quei paesi
che hanno scuole. A questo riguardo prego vivamente la Commissione di
farsi interprete presso il ministero di tale desiderio che non è mio ma che ho
letto e mi persuade. Fossi ministro lo attuerei in tutta la linea, tanta è la mia
persuasione. Io credo che il ministero non si rifiuterà di permettere se non
altro che si tenti questo mezzo una volta almeno .
[. . .]
Il fatto è che negl ' istituti femminili si dà una educazione con cui si gua
sta il carattere delle fut ure madri di famiglia. Se il ministero udrà i rapporti
delle ispettrici forse vedrà i dati ed indicazioni che conducono a questo
scopo .
Ho veduto libri diretti dal ministero da cui si rileva che in Italia andiamo
soggetti ad u n invasione di monache francesi che predicano le idee del pao
lottismo e del gesuitismo e per la demolizione dello stato civile . [ . . . ]
per esperienza personale da me fatta in Sicilia perocché in Sicilia la libertà
d ' insegnamento è completa per effetto delle modificazioni introdotte dalla
Prodittatura alla legge Casati 1 che lasciò piena libertà d ' insegnamento, tal
ché l' autorità scolastica non può intervenire se non per quest ioni d ' igiene o
per attacchi violent i e manifesti contro le istituzioni civili dello Stato o per
violazione delle leggi da richiedere l ' autorità giudiziaria: all'infuori di q uesti
casi non si può intervenire. Avvenne che in Palermo prendesse molta esten
sione un' ist ituto privato, detto del S. Salvatore e condotto da un padre ge
suita (certo padre Agalbato 2 ) il quale aveva raccolto u na quantità di alunni e
l ' adesione di molti padri di famiglia; il Consiglio scolastico fu avvertito del
l ' i ndirizzo pessimo che vi si dava e ordinò u n ' inchiesta, ma il Consiglio do
vette addurre ragioni d ' igiene per giustifi care la visita, e avendola fatta per
sorpresa si trovò nei loro libri la vera imagine di ciò che era l 'educazione
morale impartita là dentro: là si leggevano giornali dei partiti estremi giac
ché a fianco dei giornali più avventati v'erano i giornali clericali , come, ad
esempio, il << Gazzettino rosa ,, � insieme coi giornali più neri : nessun giornale
del partito moderato . E questo ci dava causa d ' agire, ma non ci fu permesso
di seguitare, quindi si andò ad esaminare alcuni giovani di quarta ginnasiale
insieme al provveditore che fece un esame rigorosissimo. Questi giovani tra
ducevano stupendamente Tito Livio, ma quando poi si domandò a quali pa
role italiane corrispondevano le latine, allora la magia fu sciolta: avevano
imparato tutto a memoria. Ora per mezzo di questi artifizi l ' istituto aveva
prodotto un effetto magico, ma vi erano pessimi insegnanti, e anche la parte
materiale del latino s ' insegnava malissimo. Una sola cosa v'era, ed era la
grande apparente cura che quei maestri si prendevano dei ragazzi in presen
za dei genitori: la verità poi venne a galla e si seppe che tutta questa cura
non c' era quando erano assenti i genitori. Ora questa specie di disciplina an
che fuori della porta dell' istituto era fatta in modo che i giovani non stesse
ro molto in compagnia, non andassero pei vicoli, ed era questa la cagione
principale della grand' influenza che aveva acquistata su molti padri di fami
glia. I particolari di questo fat to si possono trovare presso il Consiglio scola
stico provinciale di Palermo .
[. . .]
19
Seduta di Roma, 1 2 febbraio 1 8 73
1•
A CS , M P I , Div. scuole medie (1860-1896), b. 4 , fase. 3 .
STANISLAO C A NNIZZARO 2
[ . . .]
Presidente. (Libertà d 'insegnamento 1 3). Avrebbe nulla a dire sull 'art .
130?
Cannizzaro. Su quest 'articolo non mi trovo d'aver a dire che qualche cosa
1 Presiede Girolamo Cantelli.
' Stanislao Cannizzaro (Palermo 1 3 luglio 1 826 - Roma 10 maggio 1 9 1 0) . Professore di chi
mica all'università. Nel 1 87 3 insegnava a Roma; senatore dal 1 87 1 . Membro del Consiglio supe
riore dal 1 860 al 1 906.
' La l. 1 7 ott. 1 860, n. 263, promulgata dalla prodittatura, limitava fortemente la possibilità
di controllo sulla scuola privata.
2 L 'istitutO del S. Salvata re (ex « Stesi coro » ) era uno dei numerosissimi istituti privati di Pa
lermo retti prevalentemente da sacerdoti. In quegli anni ne era direttore il sacerdote Francesco
Paolo Agalbato che, nonostante l 'appoggio del principe Gaetano di Belmonte, non riuscì ad ot
tenere dal ministro Bonghi il pareggiamento (ACS, MPI, Personale 1860-1 880, b. 9, fase . • Agal
bato Francesco Paolo »).
3 Giornale democratico di opposizione.
230
A NTONIO A LLIEVI
Sezione 1! - l t•erbali delle deposizioni
Fonti per la sto,.ia della scuola
1
[. . .]
Allievi. Ho notato alcuni quesiti sui quali posso rispondere per l'espe
rienza che ho come padre di famiglia e che acquistai come capo di provin
cia: mi fermerò quindi ad essi .
Amministrazione scolastica e provinciale. Il quesito numero 1 0 dice (lo
legge). Non credo che questo quesito voglia che si formuli un ordinamento
ideale assai difficile a discutere e a raggiungere; io intendo che esso doman
di un giudizio su questo ordinamento pratico che oggi è in funzione . Io cre
do in massima che quest'ordinamento sia relativamente buono e che rispon
da allo spirito di tutta la nostra amministrazione, la quale vuole consociare
l ' azione locale provinciale coll 'azione centrale e governativa. Io credo che
se si escludesse l' elemento locale dei consigli provinciali scolastici si perde
rebbe molto di quell'impulso ed assistenza utile che le persone del luogo
prestano alle scuole. E credo altresì che l ' azione centralizzata del governo
arriverebbe, o assai tarda, o assai disuguale . In massima, ripeto l 'ordinamen
to d ' oggi è abbastanza buono.
Io credo anche utile che il prefetto sia preside del Consiglio scolastico
provinciale, e ciò non per ossequio onorifico alla carica del prefetto, ma per
ché un medesimo concetto io vorrei applicato a tutti i servizi pubblici: vorrei
come principio che il prefetto fosse nella provincia il capo di tutti i servizi
pubblici. Un prefetto che si limiti a trattare gli affari di sicurezza pubblica col
questore o coll ' ispettore, m'è sempre parso ridotto a funzioni troppo meschi
ne per avere fiducia che possa esercitare una influenza seria sullo spirito pub
blico . Per avere una forza morale bisogna addentrarsi negli interessi morali
della popolazione, e perciò occuparsi e principalmente delle scuole 2 •
Forse ci sono d e i prefetti a c u i riesce grave di presiedere il Consiglio sco
lastico provinciale, e che infatti non lo presiedono. Questo non toglie il me
rito dell' ordinamento; è un difetto od un accidente dell'applicazione.
1 Antonio Allievi (Segrano, Greco Milanese, 28 febbraio 1 82'-1 Roma 29 maggio 1 876).
Economista, patriota, negli anni Cinquanta si acco;tò progressivamente alle posizioni moderate
e ;c risse ne « <l Crepuscolo " sui problemi economici e amministrativi della Lombardia, fece par
te della Commissione per l'organizzazione amministrativa della Lombardia. Direttore de « La
Perseveranza , per alcuni anni, fu deputato dal 1 860 al 1 866. Nominato con la liberazione del
Veneto commissario regio a Rovigo, fu prefetto di Verona fino al 1 87 1 . Tornò alla Camera nel
1 877 e fu nomjnato senatore nel 1 88 1 . Nel 1 87 3 era direttore a Roma della Banca generale e
conservò tale incarico fino al 1 884 quando la Banca fu posta in liquidazione in seguito alla crisi
bancaria. Risponde anche ai quesiti sugli educatori femminili.
' Fin dai primi anni dell' U nità i prefetti presiedevano i Consigli scolastici provinciali in
Toscana, in Emilia e nell'ex Regno di Napoli; Coppino estese tale funzione a tutto il regno con
la riforma dell 'amministrazione scolastica del 1 867. Nel corso del l ' i nchiesta la questione è
largamente discussa. anche perché i provveditori nel nuovo ordinamento si sentivano emargin
ati . In genere sostengono la presidenza dei prefetti quanti sottolineano la rilevanza politica del
problema scolastico e di riflesso la nece;sità di una autorità forte contro le inerzie localistiche e
le minacce dell'Internazionale rossa e nera. La contestano quanti temono le insidie che le pres
sioni politiche dei prefetti possono recare alla libertà della scuola.
-
23 1
Del resto io penso che i provvedimenti emanando dai consigli scolastici
presieduti dal prefetto acquistano maggiore autorità e quasi indiscutabilità
per il personale abbastanza indocile delle scuole; quei provvedimenti sono
meglio accettati e rispet tati. Per questa ragione io non so concepire la costitu
zione di un consiglio scolastico, il quale abbracci la periferia di più provincie,
né l 'elemento elettivo provinciale, né l'elemento governativo del prefetto po
trebbe avere alcuna reale influenza sul consiglio scolastico; così praticamente
in questo consiglio scolastico costituito di più provincie, entrandovi i rappre
sentanti di tutte le provincie a cui si estende la sua giurisdizione, può affer
marsi che nessuno di essi vi prenderebbe attiva parte, nessuno essendo dispo
sto a spostarsi dal suo centro naturale per intervenire alle riunioni. È già diffi
cile a raccogliere i consiglieri ora che si trovano in luogo; che potrebbe aspet
tarsi quando dovessero andare in altro capoluogo di provincia 1 ?
Eliminato l ' elemento provinciale, si andrebbe all ' accentramento assolu
to. E siccome io credo che bisogni praticamente contemperare l'elemento
locale coll' elemento centrale, così il sistema dei nuovi consigli scolastici mi
parrebbe dannoso .
[ . . .]
Della preferenza alle scuole religiose. Passando più avanti anch ' io ho volu
to occuparmi della quistione posta dall'art . l 4 . Perché le famiglie preferisco
no di mandare i loro figli a scuole ed istituti diretti da religiosi, piuttosto
che alle scuole laiche e del governo? Io credo che sieno vere , ma solo fino
ad un certo punto, le ragioni addotte, cioè, la maggiore economia o le pas
sioni politiche. Io vedo mandarsi i giovani agli stabilimenti religiosi che fan
no spendere più dei laici, e vedo padri liberali che mandano i loro figli alle
scuole dei barnabiti .
I l male , io credo, ha radici molto profonde.
Io non vorrei essere accusato di divagazioni, ma mi bisogna dipartirmi
da un concetto più generale per trovare il motivo della lamentata preferen
za. Essa ha sue radici , nel carattere morale costitut ivo della famiglia nel pae
se cattolico.
In esso la autorità del padre è stata moralmente diminuita; il sacerdote si è
arrogato molte funzioni morali della paternità; in tempi di vanagloria e di ac
cidia a poco a poco i genitori si sono rimessi per la coltura morale e religiosa
dei figli alla cura degli ecclesiastici. Noi abbiamo due secoli di generazioni al
levate dai frati. Da due secoli e più poco o punto si curarono i genitori nei
paesi cattolici della educazione dei figl i. I genitori erano ridotti, oserei dire,
ad amare solo sensualmente e carnalmente i figli, ma quanto a formarne il
sentimento morale, la fede, il carattere, è tutta quistione del sacerdote 2•
1 1 1 ruolo organico dei provveditori era inferiore al numero delle provincie; perciò spesso
un provveditore aveva competenza su due provincie (p. es. Belluno e Udine, Forlì e Ravenna
ecc.). In molte deposizioni e risposte si sottolineano i gravi inconvenienti di questa situazione.
' Sull'incapacità del padre cattolico italiano di occuparsi personalmente dell'educazione
morale c religiosa dei figli (diversamente da quanto avviene nel mondo protestante) e sulla con-
232
Fonti per la storia della scuola
Il padre semi-sacerdote nella famiglia che almeno u na volta la settimana
raduna intorno a sé i suoi figli e parla loro solennemente dei dovere, della
giust izia di Dio, non vi è conosciuto . Il frate ha preso per sé col nome anche
l'ufficio morale di padre . La Chiesa è dessa la madre!
Il laico ha la coscienza di non occuparsi della educazione morale de' suoi
figli; e crede che tutti gli altri laici si trovino nelle stesse attitudini e disposi
zion i . Esiste una coscienza vaga e confusa nelle famiglie che si dovrebbe
adempiere ad un compito che né si vuole né si sa adempiere, e che intanto
si affida per il minor male , a quelli che l'hanno compiuto con noi. Non si
conosce ancora altro educatore che quello della passata generazione. Questa
virt ù , delle reminiscenze, u nita alla coscienza confusa di un dovere che non
si adempie e che pure si sente, fa ricadere molti a dar la cura del l 'educazio
ne dei propri figli agli istituti religiosi. Si pensa che presso di questi un fon
do morale ci ha pure da essere: e che il soprappiù del bigotto e dell 'illiberale
si corregge poi da sé nell 'attrito sociale. Io credo queste mie idee vere ; esse
mi mostrano che il male non viene da cause occasionali , ma ha radici più va
ste e profonde . È una specie di accomodamento colla coscienza, un discari
co che i padri trovano di dare a se stessi, un residuo di accidia e di indiffe
renza morale: è la persuasione che il maestro laico non possa educare come
non sappiamo noi .
Se sia vera la diagnosi del male troveremo anche i rimedi i .
Prima d i tutto bisogna rialzare l a parte morale delle nostre scuole, infon
dere loro il carattere e l ' aspetto di istituti morali che ora non hanno. Biso
gna che anche nella forma esterna esse conservino quel prestigio che fa na
scere la fiducia d ' una educazione severa; bisogna oltracciò che non sia
esclusa la istruzione religiosa. Io la credo indispensabile, e sono perciò d ' ac
cordo con chi ha parlato prima di me ' . Non si sono ancora visti popoli sen
za religione, e le religioni essenzialmente influiscono sulla moralità. Vorrei
però che nelle scuole non si insistesse nel campo meramente dogmatico del
cattolicismo; l ' istruzione dogmatica p uò essere rinvigorita colla l ibera fre
quenza delle chiese: vorrei che primeggiassero le considerazioni della mora
le e la educazione del sentimento .
L ' insegnamento della morale deve avere nelle nostre scuole uno svilup
po che ora non ha. È doloroso il dire che, meno quel l ' embrione di lezioni
sui doveri e sui diritti dei cittadini che si imparte nelle scuole tecniche, e
meno quello dell'etica puramente speculativa che s ' imparte nelle scuole di
filosofia, noi abbiamo assenza assoluta d'insegnamento morale. Non solo nel
campo e nel corso della filosofia, ma anche nelle altre classi, nel successivo
svolgersi dell'educazione dei giovanetti, importa che vi sia chi parli loro dei
seguente delega al clero di " molte funzioni morali della paternità , si veda anche l ' appunto di
Tabarrini (doc. 7 , p. 200).
1 Si riferisce probabilmente alla deposizione di Davide Silvagni, nella stessa seduta, che so
stiene la necessità dell' insegnamemo religioso in forme non bigotte e non antinazionali.
Sezione Il - / verbali delle deposizioni
233
doveri individuali e sociali , della virtù, del sacrificio : chi ne affini i senti
ment i , ne commuova i cuori, faccia amare il bene, e crei infine una coscien
za morale.
on vogliamo la morale ascetica ed egoista che non lascia pensare altro
che al proprio vantaggio ; vogliamo insegnare la morale cristiana, umana e
insegnarla facendola amare. Questo che ci manca è parte essenziale , abolita
nel fatto come nei programmi .
Ginnastica. Passo all'art . 2 3 che tratta della ginnastica. Io credo che in
quanto alla ginnastica noi facciamo cosa incompleta non solo ma indegna
nella sua meschinità d'un popolo civile. Incominciamo dai locali; è u na vera
miseria: guardate ai gesuiti: quelli sì rispettano ed apprezzano l'educazione;
sgraziatamente gli unici locali ampi , grandiosi, belli sono quelli che abbiamo
tolto ai gesuiti. In u na provincia che conosco dopo cinque anni di ammini
strazione non ho potuto sapere a chi rivolgermi per le riparazioni di u n lo
cale pel ginnasio-liceo che cadeva in completa rovina. Io non dimando che
questo dal lato materiale delle scuole agli italiani : fate per le scuole almeno
quel che fate per i teatri, che pur sono un ramo eli spesa abbastanza notevole
per i nostri bilanci . Abbiamo è vero delle cosiddette palestre ginnastiche con
quattro corde e pochi pali in una qualche sconnessa baracca, per fare eserci
zio da funamboli, dirette da maestri di ginnastica a cui conferisce u nicamen
te autorità l ' esser meno colti e più violenti degli altri. E gli altri maestri si
terrebbero per disonorati se dovessero appena prendere una qualche parte
alle lezioni di ginnastica, ond ' è che la metà dell'educazione dell'uomo, quel
la del corpo, eguale in necessità se non in dignità a quella dello spirito, è af
fidata a questi poverissimi mezzi . E quando s i hanno è ancora fortuna: quan
do si ha una palestra quale la descrissi si possiede l ' ottimo massimo .
Bisogna pretendere ben altro: bisogna che i giovani imparino la scherma,
l ' equitazione, il ballo: esso è una forma della ginnastica, la più estetica ed
aggraziata. Ho assistito nelle scuole normali femminili a degli esercizi di sola
ginnastica . Quei moti violenti e sgraziati mi offendevano: avrei preferito
b allassero. Il ballo può essere un esercizio di forza e una ispirazione di gra
_ senza punto degenerare in effeminatezza. Bisogna dunque accampare
zta,
esigenze radicali in materia eli educazione ginnastica: noi dobbiamo fare uo
mini robusti, forti, capaci tutti quanti di dominare la materia di cui sono cir
condati .
Ogni giovane che attenda a l liceo, a l ginnasio, all ' istituto professionale
deve imparare a nuotare, a stare a cavallo, a maneggiare un'arma . O rganiz
zate gli studenti in compagnie di bersaglio ; esercitateli; io ne ho fatto esperi
mento e fel ice; i giovani prezzano l ' arma, quando non è un giocattolo; non
temono più il ridicolo delle legioni accademiche, se ponno dar prova di loro
perizia . Accanto ad ogni ginnasio e liceo ci deve essere la ginnastica, la
scherma, la cavallerizza, la vasca di n uoto, il bersaglio. Ciò si dovrebbe im
porre per legge . Le spese di questo genere dovrebbero stare principalmente
234
Fonti per fa storia deffa scuola
a carico del comune e della provincia. La legge dovrebbe determinare un li
mite obbligatorio; ma un minimo a larghe proporzioni; almeno quanto si fa ,
lo ripeto , per i teatri. Così solo avrete delle generazioni robuste, sane, mora
li. È una lacuna immensa nella nostra educazione . I governi passati temeva
no l ' intelligenza ma più che l'intelligenza temevano il coraggio, il carattere
indipendente, insomma la indole dell' uomo libero . La ginnastica infatti nelle
sue molteplici manifestazioni, è la caratteristica dei popoli liberi.
Libri di testo. Quanto ai libri di testo devo dichiarare come padre di fami
glia, che il modo con cui si insegna nei principi la lingua italiana ha sempre
offeso il mio criterio. Ora si mettono alle mani dei giovanetti di dieci o do
dici anni gli scrittori del Trecento, credendo di inspirar loro con quei mo
delli l ' amore del semplice, del naturale, del popolare; lo credo un errore. I l
critico n e l s u o buon gusto scopre e intende in quelle scritture spontanee tut
to il vero, i l bello di una natura ingenua ed inesperta; così il pittore studia, e
sente in una tela del secolo X I I , nella semplicità delle linee, nella ingenuità
delle figure , nell' infantilità della composizione come il soffio di una inspira
zione superiore e divina, ma è questo il sommo del gusto artistico; il giovi
netto non ci trova a primo tratto che l ' antico, il grezzo, il disadatto . Il mez
zo migliore e più semplice per far apprendere ai giovanetti la lingua è quello
di farli parlare e scrivere come oggi si parla e scrive. Questo è per me assio
ma: bisogna proprio abbandonare il gusto dell ' arcaico sopra tutto nella parte dei libri di testo 1 .
Insegnamento dell 'italiano . Quanto alla coltura dei professori nelle lettere
italiane sgraziatamente è varia e discorde . Non manca una certa vernice di
erudizione, ma in rarissimi casi conobbi insegnanti che non scrivessero in
una maniera strana e violenta: e lo strano e l ' astruso lo cercano sopratutto i
professori d ' ingegno : quelli che non ne hanno scrivono come possono.
Filosofia nei licei. Dirò una parola della filosofia nei licei .
Prima di tutto devo dichiarare che ho veduto dei libri di testo impossibi
li, i quali per l'assenza completa di ogni ordine didattico, di ogni prepara
zione elementare, per la vaporosità indistinta delle formole e delle frasi, so
no specialmente disadatti ad esser guida nell ' insegnamento. Incominciano
con Galileo, con Cartesio, con Vico; parlano della grande rivoluzione negli
studi che introdusse il metodo sperimentale in surroga della scolastica e del
l' aristotelismo. Queste sono le prime nozioni che si impartono a dei giovani
i quali probabilmente vorrebbero sapere a un dipresso che cosa è filosofia.
Tutto cammina poi sul medesimo metro . I giovani più intelligenti non ne ca
piscono nulla, gli altri in proporzione. A questa scuola si fanno gli ingegni
1 Nel 1 867 i programmi Coppino avevano ribadiro per le prime classi del ginnasio la neces
sità di una esclusiva lettura di autori del Trecento (Novellino, Fatti di Enea, Cavalca); nel 1 868
la relazione di Manzoni a Broglio implicitamente suggeriva una scelta diversa, più moderna,
non legata alla tradizione puristica. Perciò in quegli anni era vivace la discussione sul canone
delle prime letture scolastiche.
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
235
petul anti che racco zzano le paro le, indo vinan
done più che comp rend endo il
_
senso , scambtand
o le frasi per le idee.
on dirò che si debb a venir e al sistem a dell
' inseg name nto uffic iale della
filosofia �ome l' abbia mo visto in Franc ia
ai temp i della scuo la eclet tica e
sotto la ditta tura di Cous in 1 • Però bisog na
conv enire che molt i libri didat tici
stam pati a quell 'epoc a per le scuo le franc
esi sono assai buon i . Io vorre i che
l ' Itali � � vess� de! libri per la fi losofia in
cui non ci fosse prete sa di crear e
nuov i ststem t. D tffido dei prof essor i che
ambi scon o crear e essi stess i un si
stem a, e più spess o fram mezz ano e frain tendo
no le vecc hie form ole con ac
cozza ment i indec ifrabi li.
I o pa �lo dietr o u na certa esper ienza . La prete
sa di origi nalità nel più di
cast_ non e che stravagan za , non ha altri risult
ati che di alterare tutti i criter i
e di cond urre alla confu sione , al nulla .
Impo rta in quest a mate ria sopra tutto di
forni re all' inseg name nto delle
scuo le seco� dari� alcun e basi comu ni in buon
i libri di testo . Non vogli amo
cr�ar e det ftloso f1 ; poch i posso no prete nder
e a diven ire grand i filosofi ; vo
glt a�no da �e �elle no �me diret tive al giudi
zio, al criter io, al gusto . Io preg he
r� I_ tl � ons1�ho supen ore della pubb lica istruz
ione di occu parsi più di prop o
Sito dt testt per quest o ramo d ' i nsegn amen
ti; un certo freno alla sconf inata
libert à è assol utam ente indis pens abile .
[...J
M ICHELE COPPINO 2
Presidi, direttori, insegnanti (l o e segg.). Io premetto che sottoscrivo
.
ptenamente alle dichiarazioni del comm . Allievi. Quanto al primo quesito, se
1 Vietar Cousin ( 1 792- 1 867). filosofo e
uomo politic o francese, eserci tò una notev ole
in
fluenz a sulla politic a scolas tica nel period o orlean
ista; fu minist ro dell'is truzio ne nel 1 84 0 e a
lungo membro del Conse il royal de l ' instru ction
publiq ue. Ebbe partic olare rilievo la sua azione
per ti rmnov ament o dell 'inse.gnamento filosof
ico nei licei in Franci a ove in quegli anni furono
bbltca tJ buont manua li dt fllosofta per le scuole
. Non fu indifferente l 'influenza di Cousin sul
l tmptanto dell 'insegnamento della filosofia in
Italia, anche per i molti rappo rti che allora ebbe
con gli esuli italian i in Franc ia.
2 Miche le Coppi no (Alba, Cuneo
l aprile 1 82 2 - Torino 25 agosto 1 90 1 ), lettera
_
to e uomo
polt uco,
deput to dal 1 860, rofcssore e rettor e dell' univer
sità di Torino , fu più volte minist ro
della_ pubbl tca tStruzw ne. Mtmst ro per la prima
volta nel gabine tto Rattaz zi nel 1 867 , varò
t
nuovt programmi per le scuole con r.d. 22 set.
1 867, n. 3956, e il nuovo ordina mento dell'am
mtntst razt�ne scolas tica con r.d 20 ott . 1 867,
n. 4008; sul merito di questi provv edime nti (da
u n lato ti canon e trecemesco delle letture nel
ginnas io inferio re, la scelta dell'Eu clide e del Cur
_
tJu>, t p�ogrammi i filosofia, dall'al tro la design
azione del prefet to a presidente del Consi glio
scolas uco provm ctale, I poten_ e la comp osizio
ne di questo organo) si sviluppa un ampia discus
SIOne nelle depos tzJOnt e nelle risposte all'
inchie sta Scialo ja; nel periodo dell'in chiest a, Coppi
no era anche memb ro straor dman o del Consi
glio super iore della pubbl ica istruzi one.
��
·
�
�
·
�
·
236
Fonti per la storia della scuola
cioè basti o sia insufficiente al bisogno delle scuole secondarie il numero dei
professori che fanno i loro studi e conseguono il diploma nelle scuole nor
mali superiori e nelle facoltà u niversitarie, la risposta si è facile ad essere da
ta. Le nostre scuole normali non danno sufficiente personale; ora come si
fa? Sono questioni dominanti, ed io l ' ho visto per esperienza in Piemonte
nel Collegio delle provincie dove avevamo posti speciali per i maestri . Suc
cesse che quei giovani i quali avevano vinto questi posti cercavano di otte
nere che fossero cambiati, che cioè si potesse studiare legge o medicina.
Questo si ottenne da prima per concessione e si fece poscia per legge . Ora
dunque la ragione principale di questo scarso numero di professori sta in
ciò che il giovane nella carriera del professore per quanto ingegno abbia
non può far nulla. Egli non ha che un mezzo per riuscire ed è quello di ab
bandonare l ' insegnamento ufficiale per entrare nell ' insegnamento privato .
Per rialzare la dignità dei giovani insegnanti l ' unico mezzo è quello di mi
gliorarne le condizioni . È u na necessità universalmente sentita, ma siamo
tuttavia molto lontani prima che venga il tempo in cui i giovani lascino la
professione dell' avvocatura, della medicina, ecc . per dedicarsi all'insegna
mento . Però qualche cosa si fa, ma intanto bisogna studiare il modo per ri
mettere queste sessioni annuali d ' esame .
Queste sessioni annuali sono molto necessarie, perché noi abbiamo gen
te che professa, ma con difetto di diplomi e con difetto di studii: e io non
condanno questo, giudico dietro l' esperienza. Sono molti anni che mi trovo
a presiedere agli esami autunnali di licenza; e mi è avvenuto di vedere gente
che aveva u na certa coltura, ma con tutto questo ne venne decisa l' insuffi
cienza. E la ragione è chiara; hanno studiato piuttosto bene il latino, l ' italia
no e il greco, o qualche altra scienza . Ma tutto ciò non basta, è insufficiente;
perché nell ' i nsegnamento bisogna conoscere i metodi, e inoltre il professore
deve avere u na certa piccola enciclopedia. In molti casi può avvenire che
per ispiegare una parola latina o italiana il professore sia costretto di ricorre
re a cognizioni di archeologia; quindi non si tratta di dare al giovane una co
noscenza materiale della lingua, ma si tratta di fargli apprendere lo spirito
antico di essa . C iò non si può fare che nell ' ambiente più largo delle universi
tà. Queste commissioni autunnali sono dunque necessarie per organizzare
l' istruzione secondaria; e in ciò il governo deve essere severo, direi quasi ,
feroce. D ietro queste considerazioni, credo conveniente d i mantenere le
sessioni autunnali di esame come ci sono state finora. Forse sarebbe necessa
ria qualche modificazione, stante i caratteri dell ' i nsegnamento secondario.
Il difetto più grave è che si fa la scuola come qualunque altro ufficio; essa si
fa male, malissimo, senza amore alla scuola; e questo è un gran male, perché
bisognerebbe che il professore sentisse la forza del suo apostolato, bisogne
rebbe si capacitasse che la sua ntissione ha qualche cosa del sacerdozio. Bi
sognerebbe amare i giovani quando piacciano e quando disturbino.
Gli insegnanti privi di diploma i n che condizione sono? Essi per lo più
Sezione Il - I uerbali delle deposizioni
2 37
sono uomini, in massime preti entrati per caso nell ' i nsegnamento , o perché
il governo se ne è servito , o perché si erano messi a fare il pedagogo, e non
sapendo che altro fare si sono accontentati di stare anche negli ultimi gradi
ni dell' insegnamento. Se noi teniamo le sessioni d ' esame, abbiamo aperta
una carriera dell ' insegnamento , in cui i nostri professori delle scuole secon
darie possono acquistare dipl onti maggiori e stimoli continui ; e di questo so
no sicuro, ma non sono sicuro delle scuole normali . Ma di tutti questi giova
ni, che vivono a spese dello Stato e della provincia, che avrebbero contratto
un obbligo per chi li ha sussidiari , quando trovano un altro impiego pianta
no la scuola elementare . Col mio sistema invece si otterrebbero buoni pro
fessori che darebbero argomento di amare la scuola.
Passo ora al secondo quesito. Abbiamo in Italia varietà di scuole normali
abbiamo la scuola normale di Pisa, il seminario di Padova, l'accademia dt
Milano; anche a Napoli v ' è una scuola simile a quella di Pisa. E in queste
scuole vi sono varietà di preparazione; in complesso credo che siano buone;
ma quando si debba rispondere se vi si apprendono i veri metodi d ' insegna
re , rispondo di no. Il nostro alunno delle scuole normali esce con cognizio
ni di buon professore, solo dopo un tirocinio di tre o quattro anni, tirocinio
fatto a sue spese; e io lo so per esperienza, perché l ' h o verificato nelle mie
ispezioni : così i giovani perdono il loro tempo migliore e questo è un gran
danno, perché io credo che i migliori professori siano i giovani . Noi cono
sciamo i programmi dell' insegnamento delle facoltà; non solo vorrei che
nelle scuole normali si facessero conferenze; questo è poco; vorrei che ac
canto ad ogni scuola normale vi fosse una scuola pratica in cui gli allievi del
l' ultimo anno potrebbero insegnar molto bene se non altro in materie ele
mentari : vi potrebbero inoltre essere anche allievi che abbiano compiuto il
corso i quali avrebbero un compenso. Q uando manca un maestro si dovreb
be ricorrere alla scuola normale perché mandasse professori. Io insisto mol
to su questo concetto , perché sarebbe una riforma che non costerebbe mol
to e che potrebbe dare de' buoni resultat i . Qui chiamo l ' attenzione della
Commissione sopra una lacuna, che mi pare di aver notata. Se la Commis
sione si domandasse conto del come va l' insegnamento letterario scientifico
nelle scuole normali, io risponderei che vi è una grande mancanza nella par
te scientifica. In nessuna università v ' è un piccolo teatrino di fisica a dispo
sizione degli allievi, in cui essi , imparando ad adoperare gli strumenti da sé,
possono formare la base dei futuri professori di fisica, di chimica e di storia
naturale . Metterei per esempio a loro disposizione parecchi fornell i -d ' un ga
binetto di fisica, chimica, o storia naturale. Ora il nostro insegnamento è
tutto teorico e non pratico. Se questo ora non si può fare in tutte le univer
sità, si faccia in alcune. In ogni modo bisogna farlo assolutamente per i gio
vani che si dedicano all ' i nsegnamento scientifico. Essendo ora l ' insegna
mento che si dà agli allievi insegnanti tutto teorico non mi fa specie che non
dia buoni risultati .
238
Fonti per la sto1·ia della scuola
Nell 'ultimo alinea si domanda se i giovani che escono dal liceo siano ba
stantemente istruiti per essere ammessi ai corsi normali superiori, e se il di
fetto di preparazione non è spesso di ostacolo al conveniente svolgimento
di quei corsi. Qui si fa una domanda particolare, se cioè nei nostri licei si
impari abbastanza per potere con frutto continuare la carriera professionale
nelle università. Io voglio fare la quistione generale e dico che se noi avessi
mo il concetto che l ' istruzione secondaria dovesse preparare gli alunni a
questa o ad altra professione, andremmo contro allo scopo dell 'insegnamen
to secondario, che deve essere generale. I nsomma nell ' insegnamento secon
dario si acquista quella certa umanità, che non consiste nella letteratura e
nella filosofia ma in tutto il mondo reale: si deve addestrare la mente con
una continua ginnastica, finché i giovani divenuti uomini abbiano facoltà di
scegliere e di rivolgere la propria mente a scopi determinat i . Io non credo
che siano ben preparati per veruna scienza, giacché se credessi questo, na
scerebbe il bisogno di specializzare gli studi, senza bisogno d 'altra cultura.
Tirocinio. on so se sia qui che si discorre del tirocinio: io credo alla neces
sità del tirocinio: perché mi pare che avendo indicato come conveniente la
scuola pratica, ne venga come conseguenza la necessità d ' u n vero t irocinio .
Qui c'è una domanda transitoria, in cui avendo il governo stabilito che
certi uomini che insegnavano senza diploma, dopo un certo numero di anni
si inscriverebbero alla facoltà per riuscire professori. Io ero rettore a Torino
e ne venne uno solo: ma questo difetto di accorrenti non fu per gravezza de
gli studi : quest 'uno che è venuto e parecchi che dovevano venire mi disse
ro: io debbo lasciare la scuola. Era uno studio che si doveva fare contempo
raneamente all' obbligo di insegnare . Non adempiendo a quest 'obbligo per
devano lo stipendio: è stata più la quistione finanziaria che altro. C ' è stato
un comune che dava un sussidio ad un tale, e pagava un supplente; ma il
sussidio non era tale che bastasse per vivere, e d ' altra parte il comune non
poteva fare maggiore spesa: ma il povero sussidiato non poté neppure man
tenersi a Torino, cosicché anche con questo sistema non si è riusciti. Una
delle ragioni più gravi secondo me, per la esperienza che ho avuta, è stata
questa : essi avevano bisogno di studiare e di guadagnare : ma t ra vita morale
e materiale hanno naturalmente scelto questa. Qui avrei a dire sulla parte
dell' articolo quarto se i professori non siano troppo rigidamente vincolati
nei modi di insegnare. Io metterei un altro punto di interrogazione; se cioè
non siano troppo poco vincolati: mi pare che sia nata una specie di equivo
co su tale quistione: giacché credo che nessuno sia più libero del professore
non solo nella cerchia dell' università, ma anche nelle scuole secondarie .
Diffatti, in c h e sono vincolati? Nei libri di testo? n o ; hanno ogni libertà: nei
programmi? Sono piuttosto istruzioni, che possono rifiutare : d ' altronde so
no specie di indici di tutte le cose sostanziali. I verbali dei consigli degli isti
tuti, dove si discutono i programmi speciali dei professori, provano che li
bertà ce n'è molta: questa è una dichiarazione che io voleva fare.
Sezione Il - l 1 1erba/i delle deposizion i
2 39
Concorsi. Sono due gravi quistioni che io non tratterò per disteso : quello
che penso si è che l' attuale sistema di concorso non sia adatto per avere de'
buoni professori . Abbiamo concorsi per titoli o per esami . Che si ha con
questi concorsi? Si esamina una parte sola del professore, la sua dottrina, ma
la sua attitudine sfugge . Quando nell ' insegnamento secondario c'è un uomo
di discreto ingegno e di buona volontà, lo si converte facilmente in un buon
professore, sebbene non abbia fatto scuola e non abbia stampato volum i . Il
sistema de' concorsi, come è ora, io lo credo pericoloso : bisogna quindi mo
dificarlo in modo che la vera qualità didattica e la disciplina non isfuggano
nel concorso.
Differenza di grado (5). Rispetto alla parte del quesito quinto, che dice :
« Gioverebbe togliere la differenza di grado fra gli istituti della stessa specie,
per rendere possibile la promozione de'professori senza trasferirli di luo
go? " io rispondo subito che sì: bisogna proprio intendere a togliere questa
differenza. Si vede che distendendo questo quesito il problema della mutabi
lità de' professori s'è presentato alla Commissione. Io sono di avviso, che
nulla vi ha eli peggio dei trasferimenti, coi quali si arrecano gravi danni. Il
professore diventa efficace a misura della sua immobilità in un paese: se si
trasferisce, non ha tempo eli acquistare l' autorità e di acquistare le necessa
rie aderenze. Così abbiamo sempre un personale quasi nuovo e così si perde
la solidarietà nell'istituto. Come si fa a creare lo spirito di corpo , quando co
loro che sono l ' anima dell'istituto oggi ci sono, domani no? Assolutamente
non dovrebbe essere ciò permesso, tranne che nei casi in cui il traslocamen
to sia vantaggioso. La frequenza dei trasferimenti è dunque dannosa. Qui
torna una idea accennata dall'Allievi , che cioè sarebbe bene, che le autorità
locali sapessero quando si porta via un qualche professore.
A rt o . 7. « A scemar credito >> ecc . Qui si parla dell' insegnamento privato dato
dai professori ufficiali : io sono contrario e credo che tutti siano contrari .
Questa è cosa più tollerata che voluta: perché non si può impedire a un uo
mo, che sia in istrettezze, di migliorare la propria posizione. Ma, lasciando
gli altri danni, vi sono questi che provengono dalla natura umana; e questa
corruzione ha viziato l ' i nsegnamento privato . Che interesse ha lo Stato di fa
vorire coloro, che sono tanti doppioni dell' opera sua? Lo Stato non può fare
tutte le esperienze, anzi, non le deve fare: io fo esperienza sopra un metodo:
se non mi riesce ne adopro un altro.
C ' è un individuo che con istrumenti perfetti ottiene certi effetti, che un
altro non ottiene : e poi le esperienze si fanno bene da coloro che anendono
veramente a ciò. Ora quando noi lasciamo che un insegnante ufficiale faccia
scuola privata egli la fa alla sua maniera : anzi fa con più zelo la scuola priva
ta che la scuola pubblica. Sostanzialmente essi non hanno fatto che raddop
piare i metodi governativi; e se hanno potuto fare qualche cosa è stato di re
stringere il tempo e la materia dell' insegnamento, il che è dannoso.
Accordo di programmi (8). Passo al quesito n.8. Io non posso rispondere
240
24 1
Fonti per la storia della scuola
Sezione II - l verbali delle deposizioni
adeguatamente, credo che sarebbe importantissima la concordia dei pro
grammi. Vorrei lasciata agl ' istituti la distribuzione degli orarj", corp'è ora per
molti. Questo è un discorso che si dovrebbe fare in ogni Consiglio scolastico
provinciale che può dar lume per vedere il grave punto di molte osservazio
ni e critiche che si fanno . Io credo poi che le conferenze, lasciando le forme
determinate , giovino molto e sieno necessarie quando c ' è l ' i ntroduzione
d ' un nuovo sistema. Finora quanto al greco mentre si preparano i giovani
per studiarlo vi si preparano anche i professori . Non c ' è personale adatto
negli studj linguistici. I risultati di queste conferenze sarebbero la bontà dei
metodi . Bisognerebbe mettere insieme questi maestri, e che le conferenze
fossero dirette da uomini capaci che introdurrebbero utili modificazioni e
riforme. Per la pronunzia del greco ci sono a modo d'esempio grandi que
stioni, che vale la pena di fare 1 ; egualmente si possono fare gran questioni
al latino il cui insegnamento si può combinare con quello del greco. Gli in
segnanti s i trovino insieme e tengano un linguaggio diverso in una classe
dall 'altra. Io dunque sono favorevolissimo al concetto delle conferenze.
Conferenze annuali. Richiamo anzi tutto un fatto; che queste conferenze
furono consigliate dal governo ma sventuratamente avvenne che non si po
tessero radunare insieme i professori . Per lo più si sceglie il tempo dell' au
tunno . Qui si pone una questione di una certa gravità, se cioè i professori
non volessero riposare . Io credo che no, perché un buon studio fatto bene
non stanca; così si immaginerebbero di esser tornati giovani . Difficoltà reali
contro queste conferenze sono gli affari particolari o le spese che si debbo
no fare; quindi il governo deve far le cose a poco a poco. Se vuoi fare tutto
non farà nulla . Metta per ora alcune sedi di conferenze per questo o per
quell'altro insegnamento e dovrebbe guardare dove ce n'è più bisogno. Co
minciando dal principio, guarderei il latino e greco. Dovrebbe il governo
determinare alcune sedi : una sola non converrebbe pel nostro paese; ma
conviene scegliere questi uomini da una università e da un'al tra, secondo le
circostanze: e devono questi professori che ci vanno e non possono spende
re , avere una specie di indennità ed una dichiarazione di ciò che facciano .
Queste conferenze non devono essere inefficaci . Una legge sull' istruzione
secondaria deve farsi , una riforma deve avvenire, e sarà la conseguenza del
l ' inchiesta che va ad intraprendersi. Nel fare questa riforma bisogna partire
dal concetto che se non abbiamo a lagnarci della volontà del personale inse
gnante ne' licei , tuttav ia questo non risponde al suo ideale, perché non c'è
mai stata occasione di studiare i buoni metodi . Ma ci sono ginnasi dove non
si parla neppure di quistioni filologiche. B isogna adunque cominciare dal
principio, bisogna stabilire alcune sedi, fissare alcune indennità a chi ci an
drà e quindi farne vedere i testi.
Evidentemente in quelle conferenze bisognerebbe definire la quistione
dei testi ; e determinare i libri opportuni che si debbono ispiegare e quel
qualche cosa che è stato accennato in un quesito sui membri del corpo inse
gnante, in fatto di programmi ecc . : sarebbero tutte cose da farsi da loro .
A mministrazione provinciale. Ques. l O. Venendo al quesito dieci ho notato
una cosa sola là dove dice : « Vi è fatta una parte conveniente al corpo inse
gnante della provincia ? , Io sottoscrivo alle parole del com m . Allievi : amo
notare che alla domanda presente bisogna rispondere con un altra domanda.
Quell' ordinamento era fatto in previsione d ' una legge già assoggettata al Se
nato, colla quale una parte degl' istituti secondari passavano alle provincie e
il governo si tenea trenta o quaranta istituti; e ciò spiega come gli altri rego
lamenti abbiano diminuita l ' autorità del provveditore . Tutto il Consiglio
scolastico provinciale non ha diretta ingerenza, ma potere morale , quando
avviene qualche cosa di gravoso. Quando il governo si riduce ad avere tren
ta o quaranta istituti, che bisogno c ' è di mettere framezzo qualche altra co
sa? Un'anuninistrazione che non sappia governare sì poca cosa non merita il
nome di amministrazione.
Accennerò ora ad un concetto, che mi ritornerà nelle note fatte: si consi
derava che con gli istituti interi non c'era che una scuola di latino, che s i po
teva dividere in due sezioni, governate così, un professore titolare ed un
aiuto che sotto il suo indirizzo insegnasse con lo stesso spirito di autonomia.
Adunque l'azione del Consiglio scolastico provinciale era piuttosto u n ' azio
ne morale, allo scopo che non si andasse contro la legge. Questo Consiglio
scolastico provinciale, quanto più vere e serie attribuzioni egli ha, le ha per
agire sopra il personale insegnante . Non mi suona bene, che coloro che
stanno sotto la sorveglianza diventino al tempo stesso sorvegliatori. C ' è sta
to un momento in cui entravano nel Consiglio scolastico provinciale i presi
di o direttori, i direttori spirituali, di guisa che il personale insegnante era di
gran lunga superiore al non insegnante. Su che cosa s i giudica, se è una que
stione di convitto? I l preside va inteso perché spieghi, non perché giudich i .
Io credo c h e i n una secondaria amministrazione, il Consiglio scolastico pro
vinciale debba rispondere a due cose, deve avere le parti scolast iche, cioè la
garanzia che i suoi membri abbiano conoscenza delle disposizioni scolasti
che. La ragione per cui io credo ed ho sempre creduto che il corpo inse-
1 Per il greco si discuteva molto, e non solo in Italia, se conservare la tradizionale pronun
cia reuchliniana (o iotacistica e moderna) o adottare la pronuncia erasmiana (o etacistica e sup
posta antica). A favore della prima erano gli insegnanti di vecchio stampo, prevalenti soprattut
to nell' Italia meridionale, e quanti volevano, grazie alla pronuncia moderna, instaurare rapporti
culturali e commerciali con la Grecia indipendendente e col Levante: così per esempio Antonio
Racheli nella sua relazione del 1 86 1 a De Sanctis sull'insegnamento del greco (ACS, MPI, Perso
nale, 1860 - 1 880, b. 842 , fase. " Racheli Antonio »); erano invece erasmiani gli insegnanti più
giovani, quelli che avevano studiato nel Lombardo-Veneto e soprattutto i collaboratori della to
rinese " RiYista di filologia e d 'istruzione classica "· La pronuncia erasmiana prevalse grazie alla
crescente diffusione dell a grammatica del Curtius ed ebbe l 'appoggio delle autorità ministeriali.
Tuttavia la vittoria degli erasmiani non fu rapidissima se ancora nei programmi del l 884 Coppi
no dovrà insistere nel prescrivere l 'adozione della pronuncia erasmiana « come quella che sem
bra meglio rispondere ai bisogni della scuola » .
242
243
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
g11ante non debba penetrare nel consiglio è appunto perché sia libero dinan
zi a questo corpo che gli è affatto straniero . Quanto al restringere i consigli
scolastici credo che finché restano le provincie ci è troppa difficoltà di far
viaggiare i provveditori . Abolire molte provincie è grande difficoltà, è qui
stione finanziaria: certo si potrebbe st udiare un altro ordinamento; si po
trebbe andare a grandi regioni, ma allora la quistione si m uterebbe; io vedrei
volentieri questo ordinamento più largo.
Ispezioni scolastiche. Relativamente alle ispezioni c ' è una quistione grave:
se ad eseguirle debbano essere chiamati ispettori mutabili e straordinari ov
vero fissi e scelti fra gli insegnanti secondari od universitari .
Quando si tratta di ispezioni, io le credo indispensabili, anche quando
siano sopra il provveditore . Tutte queste ispezioni sulle ispezioni del prov
veditore io le credo necessarie : ma quanto alle ispezioni fisse, io credo che
l' ispettore fisso diventi un burocratico : è impossibile, che quando c'è questo
ispettore alla lunga non traduca il suo giudizio in un semplice giudizio meto
dico dell' obbedienza ai programm i . Io credo che accada lo stesso in tutte le
scuole.
L ' ispettore fisso mi pare che abbia questo pericolo in tutte le amministra
zioni: dopo un poco che egli è stato nel suo ufficio sorge un cumulo di sim
patie e di antipatie che lo paralizza e gli toglie efficacia: egli non mantiene
che il terrore quando arriva: ma la efficacia grande sull' insegnamento secon
dario non l'ha. Se invece ha l ' autorità che nasce intorno a lui dalla sua ripu
tazione allora questo è un buono ispettore . Un serio ispettore di liceo non è
facile a trovarsi: per esempio che parli di quistioni linguistiche, in greco tra
la grammatica di C urtius e di un altro; che possa parlare sul greco, o sull' ita
liano, sulla filosofia, sulle lettere, sulla storia , sulla fisica. Di questi ispettori
bisognerebbe averne mol ti. Che nasce? Nasce che dove abbiamo una capaci
tà didattica, ne facciamo una capacità amministrativa.
Se invece agli ispettori fissi noi sostituiamo, come ispettori temporanei, i
professori delle facoltà universitarie e normali, forse creeremo una relazione
maggiore tra l ' ispettore e gli insegnanti, perché l' uno è causa, gli altri sono
effetto. L ' ispettore va e trova qualcuno de' suoi scolari in cattedra, vede se
il suo insegnamento dà buoni risultati , la necessità de ' metodi: e quindi può
modificare talvolta l'indirizzo della scuola normale superiore . Quindi per
me se in qualche caso sono risoluto è su questa quistione. Bisogna lasciare
questa ispezione mobile . Capisco che spesso un ispettore disfa quello che ha
fatto un altro : ma prima di tutto se quell 'operato è cosa seria il disfarlo è
molto difficile. La cosa del resto, sebbene vera, è molto rara .
Ques. o 12. Riguardo al quesito dodici ho notato se i padri di famiglia più
che al profitto ed alla educazione intellettuale de' figli non mirino sovente
al conseguimento del diploma e del certificato scolastico, e non scelgano in
luogo della migliore la via più breve per attenerlo; mi pare purtroppo che la
cosa sia così . I nostri padri di famiglia hanno una fretta che il savio interesse
de' loro figli , dovrebbe sconsigliare; hanno una fretta enorme di vedere lau
reati i loro ragazzi . E questa appunto è la ragione del rifiorire di alcuni istitu
ti d ' insegnamento privato, perché in essi le famiglie viziano l' insegnamento
a loro modo. Sventuratamente la famiglia è ancora in questa condizione di
cose: vi sono poi anche le condizioni finanziarie . C ' è un fatto generale alme
no in alcune parti d ' Italia : costa la educazione de ' ragazzi ai tempi nostri più
di una volta per molti fatti e per uno specialmente . Una volta, se io guardo il
mio paese, in qualunque terra un po' riguardevole c ' era un istituto di educa
zione completo. Io credo che in Piemonte ci fossero più di ottanta collegi:
venuta la riforma questi ottanta collegi si sono ridotti a otto o dieci, quando
arrivano a sedici è il numero maggiore. La libertà ha prodotto quest'effetto
dappertutto : nelle leggi di pubblica istruzione si vede che colla unificazione
d' Italia la legislazione scolastica sente il bisogno di allargare la sua base e
sollevare la sua cima, e in questo doppio lavoro deve assumere personale
maggiore e spendere di più ; e quindi si è dovuto necessariamente restringe
re il numero degli istituti che servivano all' istruzione secondaria. Chi faces
se confronto degli istituti, che una volta preparavano, o bene o male, i gio
vani alle università, trova una diminuzione enorme a confronto di quelli
d ' oggi . Questa diminuzione indica la cura delle famiglie di spendere poco e
fare presto, e la necessità anche finanziaria di tenere i figli fuori di casa due
anni invece di tre.
Istituti religiosi. Sulla quistione dell' insegnamento religioso consento col
comm. Al lievi . Il cattolicismo vuole che si vada alla messa alla domenica, al
la spiegazione del Vangelo; ha levato l' insegnamento religioso dalle fami
glie, la sua funzione la fa fuori di casa, ha creato il sistema di sollevare dalla
sua responsabilità il padre di famiglia; e si seguita di questo tenore . Inoltre
quanto al costare più o meno credo poi che la differenza non sia molta per
ché se si guarda alle spese di uniforme nei convitti nazionali il divario non è
molto, sebbene si paghi qualche cosa di più . Ma c ' è di più : quando in Pie
monte cominciò il Boncompagni ad introdurre un insegnamento più largo
colla sua legge, si sentì qualche cosa, che cercava di scemare la fiducia. D un
que molte famiglie mandano i loro figli in istituti privati o tenuti da corpo
razioni religiose, perocché realmente si spende meno: perciò si vedono certi
seminari con trecento, quattrocento giovani, che vi stanno bene, perché pa
gano meno e perché c ' è lusinga che siano più morali e meglio guardati . Nei
nostri convitti nazionali c ' è un gran difetto negli istitutori. Vi sono bravi
giovani istitutori, che stanno aspettando il momento di poter uscire. Invece
negli istituti religiosi l'istit utore è un frate, che ha l ' obbedienza e lo spirito
di corpo e che fa, contento, quest ' ufficio. Invece nel nostro convitto nazio
nale l' istitu tore cerca di andare nella capitale o in altra città importante per
potere attendere ad altri ufficii e provvedersi da vivere.
Inoltre i rapporti fra questi istitutori e i professori sono di superiore a in
feriore : non pranzano insieme a tavola: gli istitutori vivono separatamente e
245
Font i per la storia della scuola
Sezione li - I uerbali delle deposizioni
continuamente coll 'alunno . Ma poi credo che c'è una grande azione di pro
paganda. C ' è ancora qualche cosa che tende a vuotare que·s ti is_tituti nazio
nali : i convitti nazionali sono guardati con sospetto e perciò hanno bisogno
di camminare molto più direttamente.
I convitti nazionali non sono molto popolati, ma delle domande ce ne
sono . Mi sono trovato tre o quattro volte ad insegnare in istituti con convit
ti nazionali. Si cerca di prendere i ragazzi d ' una certa età quindi se ne rifiu
tano parecchi; il bisogno vero delle famiglie sarebbe quello di trovare con
vitti che accettassero i giovani finito il ginnasio, perché i ginnasi sono molti
ed i licei sono pochi . La ragione sta in ciò , che i padri vogliono essere sicuri
che i loro figli saranno educati bene e moralmente.
Libri di testo. Quanto ai libri di testo, io sono dell' avviso che bisognerebbe
avere il coraggio (ed è molto facile l ' averlo) di prescriverli . Sarebbe necessa
rio che il corpo insegnante determinasse esso i suoi libri di testo : le occasio
ni nelle conferenze ci sono sempre, e ogni decisione che non parta da loro
contiene difficoltà enormi. Il governo dovrebbe proporre molti testi fra i
quali il corpo insegnante dovrebbe scegliere. Io credo che si potrebbe fare
molto di più , perché oltre ai libri permessi dal Consiglio superiore , ci sono
quelli permessi dal Consiglio scolastico provinciale: il quale dovrebbe, come
corpo amministrativo, domandare un parere. Ci dovrebbe essere insomma
una collazione di pareri. Quando il professore domanda la introduzione di
un libro dovrebbe fare un giudizio critico; se ciò avesse fatto, la commissio
ne troverebbe un argomento ottimo per respingere o adottare con cognizio
ne di causa un libro . Libri di testo sono necessari : l ' insegnamento seconda
rio non è il terreno della libertà, specialmente per ciò che riguarda la filoso
fia e la morale. La scienza dell 'insegnamento secondario non è punto creata,
ma essa è la parte positiva di tutte le cognizioni e dovrebbero perciò essere
idee nette e determinate: quindi i libri di testo sono opportuni; e sono poi
assolutamente necessari in tutto il nostro insegnamento elementare .
Pare che sia molto gravosa la spesa dei libri di testo, ma in generale i gio
vani sono assuefatti ad una spesa, la quale sarebbe maggiore nel caso contra
rio, perché il professore, quando non c'è il libro di testo , varierà spesso, e
tante volte dirà al giovane di prendere un libro , ch'egli stesso forse non
legge .
Vacanze. « Le vacanze sono bene distribuite? » . Io vorrei abolite le vacanze
del giovedì, perché ho sempre visto che dopo un giorno di vacanza i giovan i
sono sempre p i ù distratti. E poi succede c h e mentre n o n si mandano i figli
alla scuola tutto il resto della famiglia deve lavorare, e questi giovani non
hanno altro che il lavoro scolastico. La idea di bene usare del tempo non è
abbastanza inculcata nella istruzione. Qui non si parla della istruzione ele
mentare; ma però si deve capire nella gioventù che questo studio prepara
uno scopo di utilità. Quanto alle vacanze autunnali auguro che la inchiesta
possa riuscire a qualche cosa: ma i tentativi fatti non danno speranza di po-
tere indurre l e famiglie a lasciar presto l a campagna p e r recarsi i n città, ma
colle nostre abitudine non è molto facile riuscire; poiché c'è l ' idea che gli
uomini rinverginino alla campagna. Che la scuola si apra al 1 5 ottobre, io la
credo u na finzione più che altro: perché ha l ' aria d ' insegnare in un tempo in
cui in realtà non s ' insegna.
Feste scolastiche. Riguardo alle feste scolastiche non saprei che cosa dire . La
commemorazione d ' un uomo illustre è bene, perché i giovani sentano l ' e
mulazione e si formino nella mente dei grandi tipi . Ma mi pare che in queste
feste si sono applicate cose poco utili, come i saggi , i quali molte volte sono
stati la occupazione di due o tre mesi: è una brutta imitazione del passato . Io
credo che non si faccia che spostare la mente del giovane.
Obbligo della doppia tassa. Quanto alla domanda se si debba ripristinare
l' obbligo della doppia tassa per gli studenti privati, io credo che sia utile . La
scuola dovrebbe essere gratuita, solo per chi non può pagare . Quando si
può pagare la gratuità mi commove poco. Non è quistione di principii, ma
quistione di mezzi . Per i privati è un aggravi o . I professori si lagnano e molti
chiedono di sottrarsi alla commissione di esame . Ciò non è bello per l ' istru
zione . Adunque se c'è qualche cosa per attirare i professori, parrebbe questa
di accordare loro queste tasse .
Ginnastica. Quanto alla ginnastica io sto col comm. Allievi. Ciò che si fa
per la ginnastica è simile a ciò che si fa per la solenne distribuzione dei pre
m i : quel po' che si fa è povera cosa, mentre è un insegnamento che deve es
sere fatto seriamente: tanto più oggi coll' ordinamento che deve prendere il
nostro Stato: quelli che vanno alle scuole secondarie dovrebbero sapere ma
neggiare le armi. La composizione dell ' uomo italiano richiede questo adde
stramento alle armi: dobbiamo studiare l ' orario che permetta il passaggio da
questi esercizi fisici agli esercizi intellettuali e che così si coltivi l ' una e l ' al
tra parte dell ' uomo. Io dunque appoggio le teorie del comm. Allievi.
Esami. C ' è una quistione grave, quella degl i esami: vi sono due modi di fare
la promozione e di assicurarci del progresso degli allievi: qual è il migliore?
L ' attestazione del professore o gli esami? Io credo che parlandosi di alunni
regolarmente iscritti i due metodi dovrebbero essere contemperati . Darei la
preferenza all' attestato, ma voglio anche l' esame. I nsomma preferisco uno,
ma adotto t utti e due . I n queste scuole bisogna che i giovani possano dire:
io sono il primo, io sono il secondo; bisogna che vi sia emulazione : è tanto
ciò vero che spesso si ode un giovane dire con dispiacere: è u n mese che il
maestro non ha fatto i posti . I nsomma se noi vogliamo fare u na classificazio
ne che persuada, bisogna ricorrere al sistema degli esami, ma oltre a dare va
lore alla prova scritta e verbale, bisogna anche attenersi al giudizio de'pro
fessori, che deve essere preferito. I giovani degni d 'essere promossi negli ul
timi anni sono in un epoca in cui la loro natura fisica subisce alterazione; il
loro organismo, che si compie, non permette certi sforzi : questi giovani in-
Fonti per la storia della scuola
vece, sebbene questo mutamen to influisca sul loro sistema, cercano però
d'essere sempre i primi. È del pari immorale ed assurdo c h e un- giovane che
non ha fatto nulla debba passare: il maggior numero degli esami si fa colla
memoria : e succede spesso che un giovane che ha buona memoria possa
passare, mentre un altro che ha più ingegno e meno memoria sembri miglio
re . È un abuso, che si vede anche nelle universit à, ma la coscienza di colui
che vede questo spettacol o si rivolta. Il giovane che ha fatto quello che po
teva fare non deve andare all 'esame triste e pauroso, come se da esso dipen
desse il frutto dell'anno . Ci si apporti dunque una correzion e od un tempe
ramento .
Uditori. Può approvar si che si ammetta no come uditori nelle classi i giovani
che non abbiano superato l' esame di ammissio ne e di promozio ne? È conci
liabile questa promozio ne col buon andamen to delle classi ?
lo risponde rei che no: la disciplina nelle scuole secondar ie è condizio ne
di successo . Ora i giovani, che non sono stati ammessi potrebbero essere
consider ati come coloro che più sono impegnat i a far bene; ma sventurat a
mente non è così. Perché si è uditori? Perché non si è studiato mai . L ' udito
re non è mai sicuro di sé, e poi egli è irrequieto di natura per la brutta posi
zione; e perché farlo restare nella scuola? Faccia il suo corso di lezioni, ripe
ta l'anno, oppure faccia il suo corso altrove . La perdita di un anno non è
tanto dannosa nell 'insegnam ento secondar io come nell'inseg namento supe
riore: ma a quell ' età non vi sono che le famiglie, che si infastidis cono. In
somma gli uditori non li ammetto in nessun ordine di studi.
E per gli uditori a scuole speciali? È la stessa cosa. Del resto le ragioni
stesse per cui non li accetto altrove sono anche quelle per cui non li accetto
qui.
Giunte esaminatrici. Quanto agli esami che si devono dare ai giovani, che
hanno compito un corso di studi, io preferisco una giunta mista: e ciò per
dare una maggior guarentig ia, specialme nte per gli alunni privati, perché es
si sommano la maggior parte negli esami. Ma vorrei eleggere entrambi per
adottare una misura giusta. E lo farei anche per un' altra causa; perché l ' inse
gnament o governat ivo non divenga una cosa privata in cui niuno abbia a ve
dere ; giacché, quando in una giunta d ' esami vi sono uomini capaci che non
dipendon o dal governo possano anche influire abbastan za sulla commiss io
ne stessa: giacché se chi interroga ha a fianco un collega che non conosce
tiene un miglior sistema di giudicare e di interroga re.
Per avere una cosa seria, le prove dovrebbe ro esser date nella maniera
che diciamo, che cioè si debba dare un prevalen te peso al giudizio del pro
fessore, e un corrispet tivo perché l ' alunno governat ivo sia giudicato bene e
severame nte e l' alunno privato si trovi nella circostan za di vincere la batta
glia in pochi momenti . Ma tale quistione si deve congiung ere coll'esam e di
ammissio ne alla universit à: che io qui non tratto.
24 7
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
Esami di licenza. Quanto agli esami di licenza ginnasiale e liceale si chiede
se questo debba precedere quello. Qui si concatenano diversi qu�siti. L' esa
_
me di licenza ginnasiale deve precedere di tre anni , oppure dt mmor tempo
quello di licenza ticeale? Mi pare che debba _r�ecedere di tre an ni. �el con:
_
_
_
cetto di istituto governativo non ammetto ne ltcenza gmnastal � t�enore, n�
superiore : ciò perché io non credo alla separazione del nostro tstttuto classico in ginnasio e liceo.
.
In ogni istituto ogni materia ha il suo professore: se questi non basta per
seguitare l 'alunno in tutte le classi, avrà un altro lui che inseg� i co � lo st�sso
metodo . Come facciamo adesso abbiamo questo risultato , al gmnas1o e ltceo
abbiamo ottenuto questo effetto : ma il liceo deve insegnare qualche cosa di
più.
11 concetto del liceo è diventato una retorica , portata un po ' pm su:
quindi c'è stato una specie di abbassamento , il guaio è stato per ciò nell' insegnamento del liceo.
Sono cascati nel vizio di cui si devono purgare le umverstta: fanno lezio
ni di tutta storia letteraria. Il professore che ha dinanzi Omero e Virgilio
sente t ' amor proprio di fare una bella lezione: parla per un' ora ; i � iovani re
stano ammirat i . Ma hanno conosci uto Omero e Virgilio? I giovam non han
no imparato nulla . Di qui nascono grandi guai, che cioè il liceo si � alzato , il
_
ginnasio s'è abbassato, mentre la solidità dei due istituti si con�bac1a e 1 1 p r?
_
_
fessor ginnasiale deve sentire. che egli non è cosa straruera al ltc�o; qumd1 10
leverei la licenza, perché sono le colonnette, che mi fanno sentire la separa
zione . Io credo che un buon esame contemperato al giudizio del professore
possa ricongi ungere i due istituti, ginnasio e liceo .
. .
Io leverei l ' esame di licenza liceale : vorrei gli istituti governatiVI forte
mente composti nel senso della responsabilità: vorrei �he non vi ���ass � un
corpo forestiero : lo Stato però deve sapere quando SI esce dagl 1st1tutt se
condari per entrare alla università. Adunque io ritengo l ' esame d ' ammissio
ne all 'università; ma la forza, il peso che si dà all' esame di licenza deve essere dato a quello d ' ammissione all ' universit à .
.
.
L 'esame d'ammissione non dovrebbe ricercare quale attttudme particola
re abbia quel giovane presentemente, invece pare che si ris � o �da a q��sto
concetto: si fa per vedere, se, ad esempio, il tale, che si destmt a med1cma,
matematica ecc . , abbia le cognizioni che possano iniziar!o ; ma l ' esame attua
le prova pochissimo; perché o l' esame è identico, e allora lo sapeva fino da
_
jeri; o v ' è qualche cosa di più e allora non s ' ha r�gione di pretende�lo .. Qum
_
di l ' esame d ' ammissione dovrebbe essere una d1mostrazwne che t1 gwvane
che è andato all' università ha ricevuto una cultura generale in modo che tut
te te facoltà sono abbastanza addestrate; e quindi t ' esan1e d 'ammissione lo
ammetterei, ma lo farei più serio , in guisa che mi potesse assicurare della
bontà dell' insegnamento secondario. Una delle ragioni poi è che nell ' at t� ale
_
legge v'è una gravosa difficoltà per la molteplicità delle sedi , per cu1 not ab"
.
.
_
.
.
248
Sezione 11 - I verbali delle deposizioni
Fonti per la storia della scuola
biamo tante sedi, i cui giudizi sono veramente disparati , i criteri troppo di
versi: e i giudizi sulla capacità de'giovani sarebbero più impOt:tanti. Però il
corpo insegnante dell'università per compiere quest' ufficio dovrebbe pren
dere professori dell' insegnamento secondario.
La licenza serve forse a qualche carriera? Io non so a che carriera serva:
non serve ad andare all' università, perché ci vuole l'esame d ' ammissione:
non per entrare nei concorsi nelle amministrazioni, perché ci vogliono gli
esam i : alle quali (secondo me) si dovrebbe poter andare senza laurea. Con
cludo che l ' esame di licenza lo vorrei trasformato in esame d ' ammissione al
l ' università.
(La seduta è levata).
20
Seduta di Roma, 1 4 febbraio 1 8 73
1•
ACS, MPI, Div. scuole medie (1860-1896), b . 4 , fase. S .
1 La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli. A l verbale è allegata una lettera d i Michele
Amari al presidente della Commissione d'inchiesta:
Roma, 1 5 febbraio 1 87 3
Onorevole signor collega
La prego di far nota alla Commissione d 'inchiesta, meritamente presieduta da Lei, una dichiara
zione che voglio aggiungere a quelle fatte nella tornata di ieri intorno le cagioni della poco fre
quenza di studenti negli istituti governativi di insegnamento secondario. Nel rassegnare quelle
che a me sembrano cagioni di cotesto deplorabile fatto io dimenticai un'altra che non è lieve. A
me pare che gli istituti privati, quelli in ispecie tenuti da religiosi, cercano tutti i modi di abbre
viare i corsi; e che i padri di famiglia più solleciti di far compiere presto il corso a' loro figliuoli
che di far loro acquistare una soda e profonda istruzjone preferiscono quelle tali scuole spediti
\'e alle scuole governative regolarmente e forse pesantemente ordinate. Vari i rimedi potrebbero
adoperarsi contro questa nociva impazienza de' giovani e delle loro famiglie. Tra gli altri io ho
designato la soppressione della lingua greca ne' ginnasii e la riduzione dello insegnamento di
quella ne' licei, riduzione dico ai rudimenti. Nessuno più di me ammira quello squisitissimo
strumento del pensiero umano, quella lingua che si può chiamare la più bella della famiglia
ariana e forse di ogni umana favella. Ma l'esperienza di tutti i paesi europei ci prova che il gre
co presto si dimentica da chi non coltivi specialmente le lettere classiche; che serve poco a tutti
gli altri uomini di scienza di lettere e d'arte, non che ai meno culti; che preoccupa nelle scuole
secondarie il posto di studii assai più utili; e che infine gli eletti ingegni destinati a giovarsene
potranno benissimo continuare il greco nelle università e presso privati professori, dopo essere
usciti da' licei in grado di tradurre una facile prosa greca. Prego la Commissione di riflettere su
questo voto di un che ha sentito ne' suoi lavori il bisogno della aurea lingua d 'Omero e di Ero
doto e colgo questa occasione per attestare a Lei, egregio signor Presidente, i sensi della mia
profonda osservanza.
suo devotiss.
M. Amari
M ICHELE AMARI
249
1
Tenca (Promozioni, 5). Giacché Ella ha indicati i quesiti sui quali inten
de fornire notizie alla Commissione, se crede principieremo dal quinto, che
riguarda le nomine, le promozioni dei professori, i concors i ( . . . ) .
A mari. Ecco nel quesito c'è quella domanda, << Se gioverebbe togliere l a dif
ferenza di grado fra gli istituti della stessa specie per rendere possibile la
promozione dei professori senza trasferirli di luogo » . Io credo che sì. Spesso
si presenta il bisogno di promuovere un professore, di premiarlo e si incon
tra l' ostacolo della residenza: quindi io credo che sarebbe perciò necessario
rendere personale il grado, perché l ' amministrazione sarebbe così più libera
di soddisfare anche a questa parte.
Presidente. A lla domanda cui Ella ha risposto segue l' altra �< quale prova ha
fatto questo sistema nelle provincie dov ' è in vigore » . Potrebbe Ella colla sua
esperienza indicare se un tale sistema ha presentato qualche inconveniente ?
Amari. A questa domanda rispondo che l a esperienza per questa parte si ri
duce a quella acquistata nei due anni che tenni il M inistero perché essendo
poi entrato nel Consiglio superiore di pubblica istruzione, lei sa che non vi
si trattano queste questioni: perciò non potrei dire se non che in generale
questo sistema di rendere personale il grado, non ha presentato i nconve
nienti.
Io vorrei poi osservare sul secondo paragrafo di questo quesito , cioè a
dire sulla frequenza dei trasferimenti , che si sogliano fare ogni anno. Credo
che questi portano cattivi frutti: i trasferimenti si sogliano fare ogni anno e
piuttosto frettolosamente: ci sono tante considerazioni e forse in parte qual
che volta estranee all' insegnamento , che rendono necessarii, o almeno fan
no parere necessarii, e opportuni questi traslocamenti; qualche volta questi
trasferimenti è necessario che siano fatti, non per passare uno da un luogo
ad un altro, ma perché resti vuoto il posto per un altro professore; di modo
che si è trovato qualche volta sbalzato da un luogo ad un altro senza sua col
pa senza aver meritato alcuna punizione ma unicamente per fare posto per
collocare un altro. Io vorrei quindi che i trasferimenti avvenissero meno fre
quentemente. Un professore che ha fatto cattiva prova in un luogo, non può
certamente farla buona i n un altro ; i trasferimenti a mio credere dovrebbero
essere limitati ai casi di scandali che rendano veramente incompatibile la
presenza del professore in quel certo luogo .
Inamovibilità (5) . E nello stesso ordine di idee incontriamo quell'altra gran
1 Michele Amari (Palermo 7 luglio 1 806 - Firenze 1 6 luglio 1 889). Fin da giovane partecipò
alla lona politica in Sicilia. Esule a Parigi vi studiò l'arabo. Rientrato in Italia nel 1 860 fu chia
mato ad insegnare arabo all'Istituto di studi superiori di Firenze dove rimase fino al 1 87 3 ; sem
pre nel '60 fu nominato senatore del regno. Oall'8 dicembre 1 862 al 27 settembre 1 864 fu mi
nistro della pubblica istruzione. Fu infine a lungo membro del Consiglio superiore della pubbli
ca istruzione.
2';0
25 1
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
questione della inamovibilità: io su questo particolare devo dire che la ina
movibilità mi pare un provvedimento che non si debba ad otta:re se non nel
l'interesse pubblico; come ad esempio pei membri della magistratura giudi
cante .
Tenca. Scusi sa, nel quesito non si parla già di inamovibilità, ma di stabilità
del posto, dell'impiego, pei reggenti.
Amari. Un momento : ma per l ' inamovibilità dall'ufficio mi pare che prov
vedano bastantemente le leggi, e quella del 1 859 in specie mi pare che vi
provveda.
Tenca. Il quesito perciò domanda se non sarebbe conveniente rendere stabi
le la condizione dei reggenti dopo un triennio di esercizio, e di confermare
a vita anche gli incaricati; si parla quindi di questi professori che stanno in
certi della loro posizione per un lungo periodo di anni , di toglierli da questa
condizione precaria, con danno dell ' insegnamento, di porli nella condizione
dei professori ordinari dopo un determinato numero di anni di esercizio.
Amari. Se si trattasse di estendere ai reggenti quei tali privilegi di cui godo
no i professori stabili dopo un certo numero d ' anni, qui io non troverei dif
ficoltà. Ho approfittato di questa occasione per esprimere le mie idee sulla
inamovibilità in generale dei professori e perciò io diceva che il principio
della inamovibilità deve essere adottato nel solo interesse pubblico; mi pare
che c i sia troppa tendenza di estendere questo principio all ' i nteresse pri
vato.
Presidente. Ella ha pure indicato il quesito sesto .
A mari (Quesito sesto). Su questo quesito devo dire che ho sentito, in gene
rale, in t utti i tempi delle lagnanze sul personale delle scuole secondarie; e
queste lagnanze mi sembrano fino a un certo punto fondate : non dico per
tutte ma almeno per la maggior parte. I n una materia così delicata com ' è l'i
struzione secondaria, l' opinione pubblica dovrebbe essere favorevole a tutti
non solamente al maggior numero; e perciò devo dire che su questa parte
l' opinione pubblica non sia favorevole a quel grado che sarebbe necessario
in questa materia . E sanno bene l 'origine di questo stato di cose, dovendosi
creare in Italia l ' i nsegnamento secondario laicale, mentre quasi dappertutto
era ecclesiastico, ed avendo avuta la disgrazia di stabilire un grande numero
d ' istituti, si fece una specie di leva di professori, e si accettarono tutte le sol
lecitazioni che si presentavano, e perciò la scelta, devo dirlo, che non fu fe
lice, né dalla parte dell' i nsegnamento, né dalla parte dell' istruzione, né dal
la parte del carattere. E io credo anzi che una delle ragioni principali che ha
condotto l ' istruzione secondaria, non dico al grado di inferiorità in cui è,
ma al grado di poca riputazione (perché credo che essa sia migliore della sua
fama, più forte e più morale di quel che si crede generalmente) e questo si
deve alla sventura delle prime elezioni; e dico sventura perché gran parte fu
una necessità di fare delle elezioni così frettolose. Una volta che per un cor
po si stabilisce u na opinione sfavorevole è poi difficile assai lo sradicarla;
ma ripeto se questo inconveniente esiste, lo credo d ' assai inferiore di quello
che lo fa la pubblica opinione, in I talia.
Quesito 7 ° . E di qui passo naturalmente all 'art o 7° (legge il quesito). Devo
dire che per quanto ne so, non solo come privato ma anche per gli uffizi
pubblici sostenuti, che questo inconveniente esiste; che fino ad un certo
punto si è dovuto tollerare , e che il ministero ha fatto delle circolari per re
stringere questo abuso. Mentre io avevo l ' onore di sedere nei consigli della
Corona, ho dovuto occuparmene , ma come accade sempre nell'esecuzione
delle leggi, ci si fa entrare la pietà: noi non sappiamo esser crudeli. Bisogne
rebbe usare a questo riguardo una grande severità, e non cedere tanto alle
considerazioni personali: io credo che per questa parte c'è stata troppa rilas
satezza, troppa tolleranza verso tanti pubblici insegnanti che danno lezioni
private: si sono fatte delle distinzioni; ma io non voglio entrare nei partico
lari dei provvedimenti in questo momento . Io credo che su questo punto bi
sogna ristaurare l ' autorità della legge. Si potrebbe adottare un espediente:
vedo fra gli altri quesiti che è posto quello dei diritti d' esame che si potreb
bero attribuire ai professori; ma poiché ci sono ancora delle tasse scolasti
che vorrei , o almeno crederei opport uno, che si trovasse il modo di far frui
re gli insegnanti d ' una parte di esse, che potrebbe in certo modo servire co
me un 'aumento di stipendio, che è necessario per rilevare la condizione del
l ' insegnamento secondario. Io raccomando perciò alla Commissione di non
perdere d' occhio questa idea.
Io dovrei rispondere ancora alle domande contenute nel quesito 1 0 ° , ma
ho già esposto il mio avviso quando mi presi la libertà di domandare la pa
rola allorché parlava l'on. Cannizzaro che trattava egregiamente questo ar
gomento. Dissi allora che ero perfettamente d 'accordo con lui, e perciò ora
non mi resta che confermare tutto quello che dissi allora, e cioè che vera
mente senza l ' intervento del prefetto il Consiglio provinciale non avrebbe
che pochissima autorità 1 •
Ispezioni ( 1 1 ° ) . I o avevo pure accennato l 'articolo 1 1 o (lo legge). S u questo
punto io credo che forse c'è da adottare u n provvedimento; mi ricordo che
quando io ero al ministero, non avendo trovato costituitO un corpo a questo
oggetto io lo creai, sentiva varie persone di autorità, perché certamente per
quanta fiducia possa meritare un alto impiegato del ministero il quale è pra' Cannizzaro. nella parte non riprodotta della �ua deposizione (doc. 19, p. 228), difende la
necessità che il prefetto sia presidente del Consiglio scolastico provinciale come era cStato di
sposto da Coppino con provvedimento del 20 ottobre 1 867 nell'ambito della riforma dell'am
ministrazione scolastica. Mentre nel corso dell'inchiesta non mancava chi denunciava nell'auto
rità del prefetto un rischio di condizionamento poliziesco con soffocamento della libertà e del
l 'autonomia della 'cuoia, Cannizzaro sottolinea che il prefetto « non solo delegato del mini
stro dell'interno, ma di tutto il gO\ erno e perciò anche del ministro della pubblica istruzione » e
che con la 'ua autorità morale " è l ' unico che può imporre lo sviluppo dell ' i>truzione elemen
tare e vigibre sulla scuola non governativa. Amari interrompendo la deposizione eli Cannizzaro
si dice in tutto d ' accordo con lui. anche in base alla sua esperienza di ministro.
è
•
252
253
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - I l 'erba/i delle deposizioni
tico negli affari, conosce tutti gli antecedenti di un profe�sore, ma certe vol
te il giudizio di un solo può sbagliare, vi possono essere delle -simpatie e del
le antipatie . . . Perciò io credo, siccome anche gli uomini più giusti si posso
no sbagliare, che le promozioni e tutto quello che riguarda la sorte degli in
segnanti secondari passi piuttosto per le mani di un consiglio ad hoc ristret
to che fosse incaricato di questo oggetto e che la sorte degli i nsegnanti anzi
ché essere ristretta nelle mani di uno solo, dipendesse e fosse esaminata da
parecch i : perché è vero che c'è il ministro ed il segretario generale, ma essi
non hanno di certo il tempo di mettere nella bilancia tutti i meriti, occuparsi
dei dettagli : perciò sarebbe miglior consiglio che questi siano esaminati da
varie persone probe e pratiche, ognuna delle quali avrebbe da esprimere il
proprio giudizio.
Quesito ( 1 4 ° ) . Sull'art icolo 1 4 ° , che è così concepito (lo legge) . Questi mi
pare il gran nodo della questione, quello che ha fatto sorgere l ' idea di cerca
re d ' approfondire la condizione del nostro insegnamento pubblico, che si
crede in una condizione inferiore, in una reputazione i nferiore di quella di
alcuni privati . Io ripeto ora quello che dissi poco fa ' , cioè che questo giudi
zio non sia troppo fondato. Ma noi sappiamo benissimo quali sono le altre
ragioni che producono questo d isfavore dell' opinione pubblica; io credo
che la prima sia lo spirito di ostilità delle corporazioni le quali un tempo
avevano in mano l ' insegnamento secondario: è da aspettarsi che per l ' attua
le condizione di cose, esse combattano il governo specialmente che lo av
versino nel suo lato più debole, i n quel punto che loro sembra il più vulne
rabile . E mi pare che in gran parte questo d isfavore dipenda da che il partito
clericale sventuratamente in alcune provincie si trova accanto a quelli che
rimpiangono l ' antico ordine di cose, e siccome gli uomini ordinariamente
sogliano credere che quello che s i faceva ai tempi della loro gioventù sia il
meglio che si possa fare , così chi fu istruito dalle corporazioni religiose, in
generale, è difficile che si persuada che un insegnamento migliore sia possi
bile, e crede perciò preferibile quello all ' insegnamento pubblico. E se non
possono dire che gli insegnanti sono ignoranti dicono che sono immorali , o
che non curano abbastanza i giovanetti, e quindi nasce i l discredito. Io non
cito né persone né luoghi, ma è certo che i n parecchie città d ' Italia certi isti
tuti religiosi son preferiti ai governativi, i quali in quelle medesime città, e
pei costumi e per l ' insegnamento, si trovano forse superiori agli altri, e frat
tanto i governativi non sono i più frequentati .
Tenca . Potrebbe Ella precisare qualche punto d ' I talia dove questo squilibrio
esiste?
A mari (Sco/opi di Firenze). Sì, signore; io non soglio usare tanti riguardi;
perciò dirò che in primo luogo questo si verifica per l ' Istituto degli scolopi
d i Firenze 1 ; e l o dico ancora perché io ho tante ragioni particolari, oltre
quelle che ha ogni italiano per amare Firenze ; alla quale l ' I talia deve molta
riconoscenza, e perciò mi duole di vedere in quella città quest ' ordine di co
se. E senza nominare la persona, dirò anzi che l 'anno scorso, discorrendo di
questo precisamente con un uomo di molto valore, esprimevo la mia mera
viglia pel gran favore che si mostrava per l ' Istituto degli scolopi ed il poco
conto che si faceva del liceo regio, egli mi rispose : " Non può concorrere,
non insegnano bene, non è affatto per gli scolopi e per i frat i che lo favoria
mo; rendete i vostri insegnanti pari agli altri e noi cacceremo i frati » . Questa
però era una maniera di giustificare la pubblica opinione del suo paese od
un concetto puramente personale di quel bravo uomo .
Vengo ora ali 'articolo 1 7 , che mi pare anche importante : e su questo de
vo fare preliminarmente una dichiarazione, che cioè il pensier mio su questa
parte dell' insegnamento non dipende da alcuna particolare tendenza filoso
fica ma dipende dalla natura stessa delle cose che mi inducono in questo
pensiero, e dirò finalmente che un uomo che ami il suo paese, il progresso
dell ' istruzione pubblica, dovrebbe desiderare che fosse bandito l ' i nsegna
mento religioso dalle scuole pubbliche. Certamente la religione ha molta in
fluenza sulla civiltà della nazione, ma io credo però che essa sia minore di
quella che le si attribuisce, ma un' influenza non si può negare: orbene que
sta religione segue un ordine diverso da quello dell 'insegnamento , perché
essa non guarda che le cose dell' altro mondo; e poi in uno Stato in cui ci sia
una religione, non dico dello Stato, ma una religione seguita da tutto il po
polo, allora sì, si potrebbe dire che è una parte cieli 'insegnamento, ma ciò
non accade in una società moderna, e non vediamo nessuno Stato i n cui gli
abitatori professano tutti questa sola e unica religione, in cui tutti i cittadini
siano iscritti sui registri dello stato civile come appartenenti a quella data re
ligione. Di certo ogni padre di famiglia ha il diritto di indirizzare i suoi figli
in quella credenza che a lui pare la più sana, e allora non vedo come lo Stato
possa intervenire nel dare un' istruzione religiosa pi uttosto che u n ' altra: or
bene se da queste generalità noi 2 veniamo allo stato nostro, noi vediamo co
me la Chiesa sia in una accanita lotta collo Stato: come si fa a dare vera
istruzione cattolica mentre il cattolicismo ci è contrario? A chi affidare que
sta istruzione religiosa? Non potete affidarla ad altri che ai ministri di questa
religione, perché altrin1enti sarebbe un controsenso . Se lo Stato oggi pren
desse il prete più onesto , il migliore , e gli affidasse l ' istruzione religiosa, per
questo solo fatto il prete sarebbe ripudiato, scomunicato e messo al bando
dai suoi superiori: per questo io credo che non si debba dare questo i nse1 Cfr. la n. 3, p. 2 2 3 , alla deposizione Ferreri. Da M P l , CSPl, Processi verbali, 1 867- '68, I,
p. 200, risulta che Amari, nel dare parere contrario alla concessione della patente agli scolopi
di Firenze. raccomandava particolare rigore soprattutto per gli scol opi toscani perché qui più
che altrove cercano di persuadere la popolazione che cattivi sono gl'i>tituti d' istruzione governativa
! Nel m s : ({ non » .
•
1
n.
Cfr. supra la risposta al quesito sesto.
254
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l t•erbali delle deposizioni
gnamento nelle scuole pubbliche, ma !asciarne la cura ai . genitori. La Chiesa
cattolica in questi ultimi tempi ha proclamato nuovi dogmi, che non incon
trarono p unto il favore dell' opinione pubblica, che va innanzi: resterebbe
quindi il gran dubbio [di] come si dovrebbe dare questa istruzione: questo
dogma, il Sillaba, lo dovete ammettere od escludere? Se sì, andate contro i
principi vostri, ciò è evidente, se li ammettete sconfessate il principio che
dovete sostenere, se pel contrario li bandite, andate contro i principii della
Chiesa, non trovate più la religione cattolica. Quindi io conchiudo col dire
che sia mille volte meglio che non si dia u n ' istruzione religiosa anziché cor
rere il pericolo di darla contraria alle credenze dei parenti : e credo anzi che
un buon credente debbe preferire mille volte che non si dia. Questo è il mio
povero avviso .
Presidente (Insegnamento della morale). La Commissione desidererebbe
sentire da Lei se indipendentemente dall' istruzione religiosa sia dato nelle
scuole secondarie un insegnamento morale; se sia fatto in modo da diventa
re contrario alla religione.
A mari. Io rispondo precisamente alla teoria che Ella mi ha messo innanzi:
credo che l ' insegnamento morale si debba dare senza dubbio. Si presenta
qui una questione molto delicata: [se] nell'insegnamento della filosofia e so
pratutto nella fi losofia basata sulle scienze fisiche e naturali si debba porre
un limite o no.
Non c'è dubbio che queste scienze si toccano colla filosofia e colle cre
denze religiose: ora io non credo che sia necessario nell'insegnamento se
condario di urtare di fronte le credenze religiose: si deve riserbare al padre
di famiglia l ' indirizzare i suoi figli nell' istruzione religiosa come meglio cre
de, di scegliere quella strada che meglio gli aggrada; tanto più poi quando
l'individuo è giunto ad u na certa età io credo che un giusto riserbo nell'i
struzione secondaria sia giusto; né è necessario di darlo alle teorie filosofi
che che tendono a un punto, piuttostoché ad un altro; quanto alle scienze fi
siche e naturali, insegnano quel che è vero ; perciò la continuazione di que
sta linea se la farà da sé il giovane.
Presidente. E Ella crede che i n fatto nel modo con cui si insegna nelle nostre
scuole si vada contro queste credenze religiose come ha accennato?
Amari. Su questo non posso dare molte informazioni, perché questi sono
fatti che la Commissione , credo, potrà raccertare e raccogliere più facilmen
te interrogando le persone che sono lontane dai grandi centri dell' insegna
mento : io non saprei rispondere precisamente a questo.
L ibri di testo ( 1 8) . Veniamo ora al quesito 18 che riguarda i libri di testo, ri
guardo ai quali devo dire che vorrei vedere esclusi i libri di testo scelti da un
areopago, senza un principio determinato e prescritto a tutte le scuole:
quando si è seguito questo principio non si è fatto altro che dare delle ri
compense pecuniarie a quelli che han saputo fare dei libri di testo più pron
tamente che gli altri . Io su questo dico che non vorrei prescrivere i libri di
testo : non h o una quantità d i fatti tanto grande per poter dare u n giudizio .
Non vorrei ammettere la illimitata autorità dei professori nella scelta dei li
bri di testo, perché questo sistema avrebbe l ' inconveniente che ciascun pro
fessore vorrebbe mettere avanti un libro suo o quello d ' un amico suo, e per
ciò io questo sistema non lo vorrei ammesso, e perciò io escludo questa illi
mitata libertà ai maestri . Anzi io credo che la Commissione farà benissimo a
prendere una lista dei libri di testo, ammessi in t utte le nostre provincie , di
farla esaminare, per farsi poi un criterio e poter dare il suo giudizio sul pun
to intermedio a cui conviene arrestarsi. Questa parte io la credo u na delle
più delicate e delle più meritorie dell ' inchiesta affidata alle Signorie loro .
Sull'art . 2 2 ho già risposto.
Presidente. Allora potrà favorirci qualche informazione su li 'art . 2 3 che ri
guarda la ginnastica e l ' igiene .
A mari (Ginnastica ed igiene 23) 1 • Io veramente non avevo domandato la
parola sul quesito che riguarda gli esami perché non avevo trovato nessun
punto su cui avessi potuto fermarmi ; ora però se mi permettono parlerò
d' uno solo, vale a dire del greco. Su questo punto mi permetterà la Commis
sione di fare una confessione: io, quando uscito d ' Italia andai in Francia, mi
sentiva una gran vergogna che in Italia non s'insegnasse il greco come si in
segna in Francia, ed altrove; ma poi io cominciai a pentirmi di quella prima
opinione: io non credo affatto che l ' insegnamento del greco vada bandito
dal nostro i nsegnamento secondario.
La lingua è la figlia maggiore del genere umano, è l 'orgoglio della schiatta
ariana . Nessuna letteratura è giunta a tanta altezza, ed è perciò che il greco
si deve studiare . Perciò si deve aprire ai giovani la strada di studiare questa
lingua dei nostri maestri; ma d ' altro lato io vedo che l ' i nsegnamento del gre
co occupa troppo tempo nell'insegnamento secondario: che esso è quello
che presto si abbandona, eccettuate quelle persone che si danno esclusiva
mente alla letteratura. I o credo che calcolando i vantaggi cogli svantaggi , sa
rebbe meglio di togliere assolutamente il greco dal ginnasio e limitare al li
ceo i principii del greco, come insegnamento elementare abbastanza sod o : i
giovani potrebbero poi continuarne lo studio nelle università non come so
no attualmente u niversitarie, perché come lor signori sanno non c'è catte
dra eli lingua greca e di letteratura greca. Io vorrei che l'insegnamento avan
zato del greco non fosse obbligatorio nel liceo, ma solamente fossero obbli
gatorii i rudimenti, tanto per arrivare a tradurre con abbastanza facilità u n
passo el i prosatori n o n z dei p i ù facili : m a questo n e l liceo e non g i à nel gin-
255
1 L'equivoco tra la domanda del presidente (basata sulla richiesta di Amari di parlare sul
quesito 23) e l 'argomento segnato in margine alla risposta di Amari dipende da un errore di
;rampa sul fascicolo dei quesiti dove i numeri 2 2 e 2 3 sono ripetuti due volte, e il 23 riguarda
prima la ginnastica, poi gli esami; senonché poi Amari rinuncia a parlare anche degli esami.
' Se si confronta la parte finale della lettera alh:gata, il " non " sarebbe da espungere dal
testo.
256
2 57
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
nasio. Questa è l ' opinione mia e non solo la credo la migliore ma mi pare
abbastanza il caso per doverla ponderare e rifletterei sopra . lo vedo che ne
gli esami di licenza liceale , è in questa parte che vanno precisamente a ca
scare una gran parte dei giovani .
Studio del greco . lo non so se sia anche quest ' insegnamento obbligatorio
del greco, che allontana i nostri giovani dalle scuole secondarie: insomma io
vorrei che si esaminasse profondamente questo punto, per poter poi delibe
rare se convenga di togliere l ' insegnamento del greco dal ginnasio, e limitar
lo al liceo, in modo che al giovane che dà l ' esame di licenza non si [ richieda]
tutto quel grado di conoscenza che oggi si richiede .
Presidente. La Commissione la ringrazia.
c i inclino per quello c h e h o g i à detto prima perché cioè i professori faccia
no quello che è possibile per l ' i nsegnamento loro.
Mi sembra pure adottabile la idea del professore principale e degli ajuti
assistenti, che si attengano allo stesso programma. Una riforma di questa na
tura si deve conciliare con molti riguardi. Per un certo tempo non possiamo
inventare i professori, quando abbiamo bisogno che un professore lavori
per due. Questo è un difetto. La condizione generale è questa, ma vi sono le
condizioni transitorie di finanza e la scarsità di personale che ci obligano a
cw. d i ' i nsegnamento vi sono talora cose non tanto straniere l ' una all' altra
che qualche volta non convenga metterle insieme. Bisogna distinguere bene,
per l ' i nsegnamento secondario non occorre potenza d' i ngegno . Il professo
re non deve tanto far progredire, ma la prima cosa che deve sapere si è di
porre limiti certi alla sua scienza e adattarla agli scolari e condurre i giovani
fino a un certo punto lontano della sommità del sapere. Ne nasce allora u n
grave inconveniente circa alla distribuzione delle materie e s u l come i l pro
fessore chiuso e circoscritto in dati limiti possa non escirne. Quando avessi
mo un professore per ogni materia la direzione dovrebbe essere fortissima
per continua vigilanza e vera utilità didattica per contenere ciascun inse
gnante nei suoi limit i . Alcune materie però, per esempio il latino e il greco li
metterei insieme. Sarebbe utile se ciò si potesse fare perché la conoscenza
d ' una lingua giova molto alla cognizione dell ' altra. Non possiamo studiare
una lingua senza saperne u n ' altra. Tali richiami sono facilissimi nella lettura
e nella traduzione. Non si può insegnare bene il latino e il greco senza sape
re un po' d' italiano. Ciò si dovrebbe fare anche nel ginnasio. Gli esercizj di
versione si devono fare in qualunque lingua, perché chiunque parla u na lin
gua, che non ha imparato da bambino, fa esercizio di traduzione . Il mio pen
siero si manifesta nella mia lingua. Prima di pensare in latino, in greco, in
francese bisogna avere molto esercitata la facoltà di pensare, ci vuole molto
tempo . Quindi il mio concetto generale è che ciascun professore insegni una
sola materia, ma non bisogna spingere questo principio all'eccesso. I l latino
e il greco potrebbero benissimo stare uniti. Un uomo che sa il fat to suo può
insegnare il latino e il greco . La questione è che il professore sappia. Nel
tempo che si impiega a imparare il latino, il ragazzo potrebbe imparare an
che il greco. Una grammatica può essere comparativa. È impossibile dare un
precetto di sintassi senza comparazione. Le differenze della sintassi, la diver
sità di forme tra le due lingue così si trovano . Questo insegnamento indiret
to lascia più tracce nel l ' animo dei giovani .
Quanto al secondo allinea in cui si domanda se gioverebbe che la legge si
limitasse a determinare, nel l ' u topia di u n perfetto istituto secondario am
metterei questo principio ma non facendo questa utopia non posso am
metterlo. Sappiamo, ed è un fat to sopra cui la Commissione può giudicare
se osserva la discussione che si fa nei consigli scolastici , negli istituti d ' istru
zione secondaria, nelle facoltà universitarie, sui programmi dei professori di
21
Seduta di Roma, 1 5 febbraio 1 8 73 1 •
A C S , M P I , Diz•. scuole medie (1860- 1 896), b . ... fase. 6 .
.
M ICHELE COPPINO 2
Tenca . Ella, signor Coppino, aveva interrotto le sue risposte ai quesiti, e
mi pare che non avesse esaurito il capo delle scuole secondarie.
Coppino (Quesito 32). M i pare di esser rimasto a quel capo lì e precisamente
al quesito 3 2 dove si chiede se convenga affidare due insegnamenti a u n
professore solo.
Veramente su questa allinea non avrei molto a dire perché o è questione
di principj e allora è sciolta essendo meglio naturalmente che ogni materia
abbia il suo professore . E dico che è meglio perché importa notare che le
scuole normali 3 , mentre devono avere un punto di educazione generale,
hanno però anche il fine di dedicare il giovane a un particolare insegnamen
t o . È necessario che l'insegnamento normale mentre in un punto deve esse
re comune a tutti, venga poi a specializzarsi. Nel concetto assoluto è bene
che ciascuna materia sia rappresentata dall' uomo che vi si è dedicato. Dun
que la risposta è che a ciascun professore bisogna dare una sola materia. Io
1 La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
' Michele Coppino aveva già svolto parte della sua deposizione nella seduta del 12 febbraio
(vedi doc. 1 9 , p. 2 3 '> ) .
' Si riferisce alle scuole normali universitarie.
258
259
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - f t,erbali delle deposizioni
rado si presentano serie questioni che ammettano vera controversia. C ' è un
biglietto di visita che un professore passa all'altro, quind i regna sempre l'ar
monia in questa parte ed è ben difficile che si faccia ritirare un programma.
Se un professore insegna una materia non di suo genio ha u n ' immobilità,
un' incertezza che nuoce al buon andamento dell 'insegnamento; se si crede
che ogni professore debba rappresentare una materia sola, questi non deve
pensare a insegnare altro .
I l guaio è indicato dopo: " Potrebbero in tal caso gli studj della scuola
normale superiore ecc » . Questo è un impossibile. A fare un buon professore
di grammatica bisogna farlo stare due o tre anni all ' università perché impari
una grammatica generale, una filosofia della grammatica. Questi sono gli
studj filologici di cui il professore non deve parlare nel liceo . Ora si fa trop
pa linguistica. Come si può alla scuola normale preparare un professore om
n ibus che sappia dare oggi lezione di filosofia, domani d i letteratura e così
via? Se facciamo passare nell ' i nsegnamento questi professori enciclopedici
rinunziamo all ' insegnamento. Avremmo così insegnant i versati in troppe
materie per potere insegnar bene. Volendo contemperare lo studio della fra
se con quello delle cose si cercò di unire l ' insegnamento del greco o del lati
no a quello della fi losofia, quando il greco aveva meno uso, ma i risultati
non sono stati buon i . Chi è buon latinista o grecista non vuol dire perciò
che sia buon filosofo. Se non è tale come può insegnare filosofia? Io credo
che l 'idea di indirizzare in modo la scuola normale che uscendo i giovani
possano prendere qualunque cattedra sia dannosa. Bisognerebbe proprio de
terminare, e ora c ' è una determinazione abbastanza larga. Uno stesso diplo
ma ora abilita ad insegnare le tre letterature e la storia. La esperienza dimo
stra che queste quattro materie non si possono fare egualmente bene. Nei
programmi d ' insegnamento tutta la storia passa dinanzi al professore, e que
sto non è piccola cosa. Molte volte i migliori libri, le migliori lezioni dei
professori non sono che splendide monografie, che illustrano la storia, non
già ricerche di fatti storici . I noltre il professore deve sapere più storia di
quella che insegna. In due o tre anni di corso normale non si può sentire tut
ta la storia. Dunque è troppo vasta la materia . La fabbricazione di un buon
professore non si può ottenere che col concentrarlo in uno o pochi studj , è
certo che non si devono del tutto trascurare le altre parti dello scibile di gui
sa che siena date le precipue cognizioni matematiche, filosofiche, storiche.
È indubitata la necessità di queste cognizioni generali . La scuola normale pe
rò deve serbare il suo carattere e non se ne deve forzare la composizione.
Cremona. Vorrei conoscere il suo avviso su tale questione, quando la cosa
fosse limitata nei termini in cui era nell ' ultimo periodo sotto l' Austria nella
Lombardia e Venezia. L'Austria aveva introdotto il sistema germanico secon
do cui i professori che entravano nel ginnasio (allora si chiamava ginnasio il
ginnasio e liceo) dovevano essere abilitati a due materie . Gli studj si face
vano presso le u niversità e i seminarj che erano istituiti a Pavia, a Padova, a
Vienna 1 • L e due materie n o n erano arbitrarie, erano stabilite dalla legge dei
gruppi che si dicevano naturali . Gli esami si facevano presso commissioni
istituite appositamente e dovevano aggirarsi principalmente sopra le due
materie, in cui il candidato voleva essere abilitato. Chi superava quest' esame
aveva il diploma per le due materie. Veniva nominato professore e poteva
indifferentemente insegnare l ' una o l ' altra materia o ambedue in diverse
classi . Al principio di ciascun anno il consiglio dei professori determinava in
quali classe e quale materia doveva insegnare il professore. Si desidererebbe
sapere il suo avviso su questo ordinamento, se lei è favorevole o contrario .
Coppino . Ci sono due punti. Quanto al primo sono favorevole. oi abbia
mo che la laurea di letteratura abilita a troppi insegnamenti, cioè al latino, al
greco, all 'italiano, alla storia e geografia, e credo anzi che la cattedra di geo
grafia non ci sia. Un poco più ristrett i sono gli altri di fisica, di matematica.
Per lo più d'un farmacista ne fanno u n chimico, d'un medico si fa u n fisico e
questo è un male . Un diploma per due insegnamenti può stare. Così il pro
fessore di italiano potrebbe essere anche professore di latino e di greco.
Quello di greco potrebbe forse avere la patente in filosofia. Io sarei favore
vole anche all'introduzione allo st udio di qualche lingua moderna che oggi è
indispensabile. Credo che sia un danno il fare altrimenti; qualche occhiata
nel campo del vicino va portata . Io reputo che non si possa concedere il di
ploma per più di due insegnament i . Non si può però essere buon professore
d ' italiano, se non si sa bene il latino qu indi per questa parte mi parrebbe ben
fatto il congiungere i due insegnamenti. I l nostro professore di letteratura
può tenere quattro posti nel liceo .
Quanto alle scuole io non ho dati . Vorrei vedere bene l ' esperienza; che il
capo di un istituto adotti questo od un altro sistema è quistione di fatto in
cui io non ho autorità di parlare. Ma se sorge qualche inconveniente credo
che la giunta debba pensarvi. Il principio d' autorità nel Lombardo-Veneto
era allora tanto potente quanto lo è ora nel Regno d ' Italia colla libertà . Il
professore aveva il sentimento della propria indipendenza come può averlo
oggi . Docilità e disciplina, questa riverenza all ' ordine superiore era nel gra
do in cui è ora. Il capo dell' istituto veniva allora ad imporsi agli altri inse
gnanti, e li faceva viaggiare dall' uno all' altro insegnamento . Solamente io
avrei voluto che fosse giudicato perché io diffiderei sempre di un insegnan
te non abilitato; di quelli che davano questa prova sarei contento. Io ho ve
duto ed ho sentito questo perché insegnai molto tempo nei confini della
Lombardia, anzi l ' i nsegnamento secondario l ' ho passato là 2 . Quel sistema
non andava a sangue a molti, e mi pareva che dovesse scemare la energia del
professore; quindi la mia impressione non sarebbe molto favorevole.
' \'edi doc. ) , in particolare n . 2 , p . 1 6""' .
Coppino insegnò dal ! Ho.J '; a l ' c� ""' a Pallanza e nel 1 8ct8 a Novara.
260
Fonti per la storia della scuola
Quesito 33. Sul quesito che vien dopo non ho nulla a dire se non richiamare
qualche cosa sull'allinea secondo « Se non passano all ' u n iversità hanno ac
quistato ecc . » Ci sono due domande : se gli alunni sono sufficientemente
preparati per ent rare nell ' università, e se altrimenti sono preparati per la
coltura generale . Mi pare che qui sia vago il concetto, e che occorre che in
questa materia non ci sia vaghezza, indeterminatezza di concetto. La scuola
secondaria deve dare la colt ura generale oppure essere di preparazione?
Non vuoi dire che facendo una cosa non possa fare l ' altra. I o quando vado
al sole per riscaldarmi resto anche illuminato , e ot tengo un' altro vantaggio
indirettamente. La coltura generale sta bene, è necessaria ed u tile, ma biso
gna averne un concetto netto perché veggo dopo escire i licei scientifici
(34). Se si vuole ottenere lo scopo dell' istruzione secondaria si deve dare
quel grado di istruzione che deve avere ogni cittadino: lo Stato ha come suo
compito la scuola elementare che deve educare il popolo, e qui lo Stato de
ve avere un concetto chiaro e determinato ma deve dare anche la coltura ge
nerale superiore principalmente alla classe borghese che è la vita della na
zione. Tutta questa gente che opera e che ha dato il nome alla civiltà presen
te deve arrivare a questo grado. La istruzione secondaria deve essere genera
le, se non lo fosse allora sarebbe una istruzione insufficiente. Il difetto della
interrogazione sta nel rimedio che si suggerisce subito. Allora si distinguono
nella istruzione secondaria quelli che fanno il medico, l ' i ngegnere, l ' avvoca
to. Chi fa l' avvocato avrà bisogno d' insistere di più sopra alcune discipline .
Il legislatore dovrà dire quello che dicono le famiglie? Quando un ragazzo è
forte nel complesso dell' esame di licenza, ma è fallito nella matematica, il
padre dice: « santo Iddio! mio figlio non vuoi mica fare il matematicO >> ; così
se fallisce nell' esame di storia naturale può dire : « mio figlio non voleva fare
il medico >> . Le famiglie ci vanno a questa separazione, ma il governo non
può perché altrimenti l ' istituto secondario diventerebbe u na scuola profes
sionale. A molti così non basterebbe la scuola secondaria mentre io vorrei
poter dire che la nostra istruzione secondaria dà a tutti una vera e soda col
t ura generale. Allora comincia la vocazione in un giovine che nasce 1 dalle
tradizioni della famiglia, dalle condizioni sue. E allora esso si specializza e
noi abbiamo le università che oltre ad essere grandi istituti di scienza sono
essenzialmente istituti professionali dove ciascuno studia una cosa speciale .
C ' è qualche cosa di incompleto nello sviluppo delle facoltà mentali del gio
vane e io non credo tutte bene sviluppate, quale lo spirito di osservazione e
il sentimento che non sono bene sviluppati nella istruzione secondaria. Io
ne farei tesoro non per provvedere a quelle facoltà ma per ripararvi nell ' or
dinamento dell'istruzione secondaria.
Viene dopo un ' altra domanda . Si richiede se i metodi attuali diano il
profitto che si desidera. Qui c'è un gran guaio. Dei metodi non c ' è ne sono
1
rei m s . : (< nascono ».
Sezione I l - l t'erbati delle deposizioni
26 1
e per quello che ho veduto il difetto principale è nel metodo. Vi sono pro
fessori che ne applicano ora un metodo ora l ' altro . Questo è un disarmoniz
zare il giovine che è costretto a vedersi rappresentato sotto forme diverse di
una stessa materia; diversità di metodi che ha ragione nei libri di testo e nel
silenzio curioso che serbano questi. Un buon libro di testo solleva più recri
minazioni che uno cat tivo. La introduzione di grammatiche che si possono
dire più o meno opportune, ma il cui valore dottrinale è certo ma non può
essere messo in contestazione, ha sollevato delle tempeste. La produzione in
Italia non è stata scarsa di grammatiche greche . Se la produzione non fu
scarsa la dottrina greca però non fu numerosa. Non ho mai sentito sopra le
grammatiche d ' I talia tanti strapazzi quanti se ne fanno contro le grammati
che tedesche.
Quanto alla matematica c'è qui un reo presente 1 • La geometria di E ucli
de tutto il corpo insegnante l ' ha fatta a bersaglio delle sue ire . Nelle scuole
nostre non c ' era altra geometria al disotto di Euclide ma la ragione è chiara .
Quando non c'è il libro di testo il professore è libero di seguire quella teoria
che vuole e non trova impaccio nel libro che ha dato da studiare agli alunni.
Io ho accetmato questo fatto per non mettermi nella discussione del metodo
d'i nsegnamento che io reputo causa principale dei difetti dell' istruzione se
condaria . Per quello che ho detto io ci tengo molto a quelle conferenze per
ché portano la conoscenza di questi metodi. Vi sono metodi che i professori
non amano perché a primo aspetto pare che debbono assoggettare i giovani
a grandi fatiche. Si può far vedere che questi metodi non sono p unto fatico
si. Quando si dà un istrumento in mano al maestro perché lo adoperi io so
no sicuro di averlo convertito alla pratica di esso .
Quesito 34. Al quesito 34 si domanda se si debba diminuire il numero degli
istituti classici (legge. ) Qui c ' è una quistione gravissima. Ci sono alcuni che
vogliono pochi istituti del governo in questo senso perché l'insegnamento
privato si possa sviluppare; e la ragione per cui altri difendono questa dimi
nuzione, e vorrebbero per esempio che l' insegnamento elementare fosse pa
gato, si è perché evidentemente se lo Stato ha il suo insegnamento gratuito
la concorrenza non si fa . Questo quesito può essere considerato rispetto allo
svolgimento più largo della istruzione privata. È evidente che il mercante
apre la bottega dove c'è la domanda, e la bottega si chiude quando mancano
gli avventori. Io non do importanza a questa ragione; io non mi commove
rei . Il governo deve fare l ' obbligo suo e deve aprire tanti istituti quanti sono
bastevoli . Non deve dire : io educo metà della popolazione, l' altra metà la
educano i privati . Il governo non dà niente per niente, sono i cittadini che
pagano. Tale ragione non mi commuove anche perché l ' istituto privato non
' Probabilmente allude a se stt:>SO che nei programmi del 1 867 aveva imposto l ' Euclide;
può però anche darsi che alluda a Cremona che assieme a Brioschi aveva suggerito al ministro
quella decisione. Sia le risposte ai quesiti correnti del 1 87 1 sia quelle all'inchiesta Scialoja con
fermano una quasi plebiscitaria ostilità del corpo insegnante all'Euclide.
262
Fonti per la storia della scuola
mi interessa giacché non fiorisce, e perché non l' ho veduto sgorgare dal bi
sogno che abbia qualche anima eletta di imprimere una pàrticolare nota alla
educazione. Se v ' è si perde. Educatori solitarj ce ne sono, ma sono dispersi.
Se qualcuno ha creato un istituto non v i è riescito. Questo quesito si può an
che fare per la ragione qui indicata cioè per concentrare il meglio dei p ro
fessore e dotarli meglio. Questa evidentemente non è una ragione assoluta
ma di necessità prodotta purtroppo dal mezzo sociale, in cui viviamo . Lo
Stato deve tenere tanti istituti quanti crede di tenerne bene. Il cavallo, che
non può trottare, si contenta di andare di passo, ma il governo deve far be
ne o non fare . Per fare mediocremente vi ha altri . Questo però è uno stato
transitorio . Il governo dice : oggi ne ho dieci perché non posso provvedere
che per dieci, ma domani, se posso , provvederò per dodici . Presentemente
gli istitut i secondarj sono numerosi più forse della possibilità del governo di
renderli stimabili e stimat i . E allora il governo per non far danno a sé e per
ché la mediocrità di alcuni istituti non getti il marchio sugli altri è meglio ne
abbia pochi , ma buoni . Non si ha il vantaggio di vivere della riputazione di
chi fa più bene.
Qua vengono queste trasformazioni . « Gli altri istituti classici potrebbero
essere trasformati ecc . '' · Io qui faccio u na domanda che ho fatto innanzi sul
concetto della istruzione secondaria: se si suddivide un po' la coltura gene
rale allora si avrà una coltura generale diversa. E tutti sapremo qualche cosa,
ma non la stessa . Il problema della istruzione secondaria sarebbe facilissimo
ma invece è in tutti gli Stati il problema più difficile, e in tutti non è ordi na�
ta bene . L ' ordinamento del l ' oggi non è quello del dimani. Una scienza nuo
va obbliga ad allargare ed a restringere i programmi. Ma se entrassimo in
questa via farei osservare che bisogna modificare oltre gli istituti classici an
che i tecnici . Troviamo questi nostri giovani messi innanzi a una terribile
anticipazione della deliberazione della mente loro per la carriera futura.
Questo è u n bivio che spaventa . Molti tentativi, molte riforme sono intese a
non dividere troppo l'attitudine dei giovani per non fargli perdere tempo .
Quesiti 44 e 45 . Questo bisogno qui è sentito perché si domanda se fosse
possibile di evitare che i giovani troppo immaturamente si dedichino a una
carriera (44). C ' è una domanda (45) se torni utile portare a quattro anni il
corso delle scuole tecniche, e un' altra come da una scuola tecnica si potreb
be passare al ginnasio . (44) Sono domande che contano, si vede, sopra i
pentimenti delle famiglie o studenti di esser andati in un istituto piuttosto
che in un altro. Io non sono di questo avviso. Gli istituti scientifici si capisce
come devono essere ordinati alla coltura generale. Non sminuzziamoli, non
facciamo che col troppo variare di questa coltura generale si corra il perico
lo che nella manifestazione della vocazione uno si dedichi a studj non suoi .
Credo che si debba dar la prevalenza agli istituti classici pel bisogno che v ' è
d i educare i giovani a principj elevati perché i l greco e latino n o n si studia
no per sé, ma pel vantaggio di vedere a u na certa distanza una società, che
Sezione Il - l uerba/i delle deposizioni
263
ha fatto grandi cose. oi di tutta questa manifestazione del mondo antico
non vediamo che il grande, tutto il resto ci scompare. Tutti quegli scrittori
che risvegliano questi sentimenti nell' animo dei giovani sono abbondanti.
Noi vediamo una società che ci arresta st upefatti a distanza di secoli per le
cose grandissime operate. Tutto questo m i solleva il morale del giovane .
C ' è una seconda cosa. C ' è l'elemento sociale, che fa la grandezza del
paese; non sorge l ' individualismo. Io credo che non abbiamo ragione di cor
reggere il tempo nostro . Il sentimento della patria è u na gran devozione,
non è troppo largo perché non si divide troppo nel sent imento dell' umani
tà. II mondo antico ha due cose, la sua grandezza e l ' elemento, per cui è sta
to forte, lo stato religioso cioè di tutti i cittadini specialmente a Roma. Io
credo che far passare il giovane per queste grandezze e fargli sentire la reli
gione del dovere, sia bene. Così si escirà dall 'utilitarismo, che è uno dei
principali nostri difetti. Uscire da quest ' u t ilitarismo vuoi dire capire che c'è
qualcosa fuori di noi, la patria. Vorrei la prevalenza del sentimento della co
scienza. Per coloro che sven turatamente non possono perdere molto tempo
noi abbiamo l ' insegnamento secondario professionale nelle scuole tecniche
e negli istituti tecnici; ma trattandosi di coloro che debbono andare alla uni
versità, a me pare che non basti un' unità di concetto, che ci farebbe appari
re come uomini che vagano solo in un lato della questione, e non sono an
cora decisi. Io inoltre non biasimerei tanto la preparazione all'università
benché non abbastanza buona e speciale. Io ho fatto questa domanda alla fa
coltà matematica . Se i giovani non sanno tutti quello che si vorrebbe ci vor
rebbe molto tempo per rifarlo? Mi si rispose che no . Tanto si ha a ripigliare
un poco. Ci dovrebbero essere corsi semestrali che compiano e rifacciano in
modo vero questa istruzione secondaria, i quali servissero di anello all ' uni
versità. Abbiamo tanti modi di prepararli, che a me basta avergli dato l ' istru
mento adatto.
Quesito 35. H o fatto solo un'avvertenza dove si parla della preparazio ne al
ginnasio, e del l ' esame d ' ammissione al ginnasio e riguardo alle prove di arit
metica e grammatica, che sono troppo semp lici . Io non sono d ' avviso che
sia troppo richiedere tutte le cognizioni delle scuole elementari. Quando il
ginnasio desse esami serj su tutte le materie dell'insegnamento elementare
pochi passerebbero . L'insegnamento elementare va guardato con molta se
rietà. Non bisogna credere che vi sia molto. La grammatica italiana è il so
stanziale . Certamente credo che non si debba dar l' esame su quelle gramma
tichette microscopiche che per molti sono le migliori . Un esame di gramma
t ica prova che un ragazzo sa esprimere i propri pensieri, sa fare una compo
sizione. Bisognerebbe dare gli esami bene, e allora credo che si avrebbero al
tri risultati .
Tenca . Crederebbe che fosse necessario di obbligare l ' alunno ad avere percorso l' intero corso elementare?
Copp ino. Sinceramente, perché il solo esame non basta, io credo che ora
264
Fonti per la storia della scuola
facciano quattro anni per le scuole tecniche, mentre pel ginnasio bastano tre
di elementari. Quando voi avete quattro anni di studj , il professore del terzo
anno si riserva una parte del quarto. Se vi sono quattro anni di elementari e
poi si restringono oltre per andare al ginnasio è mal fatto perché si va trop
po giovani al ginnasio . In paesi che danno gran risultati non si hanno gli
scolaretti che abbiamo noi; si studia di più, e più lungamente. Noi dobbiamo
creare t utto all ' improvviso, le famiglie fanno pressura. Bisogna avere il co
raggio di dirlo; in paesi dove si studia più seriamente che da noi si ha gio
ventù più stagionata che studia. Quindi sono di avviso che per istudiare bi
sogna impiegare tutto il tempo necessario .
Quesito 36. È gravissimo il quesito 36, ma io vi h o g i à risposto, h o detto che
il poco profitto è colpa principalmente dei metodi non buoni, e credo che
nel liceo sia così, quantunque a paragone il difetto sia più nel ginnasio che
nel liceo . C ' è lo sconcio che il professore di liceo sta qualche volta troppo
su e qualche volta troppo abbasso. Questo è difetto di ordinamento. C ' è una
domanda, cui se si potesse dare, e più che dare proprio s i potesse attuare,
tal risposta sarebbe fecondissima.
« Come ottenere che i giovani usciti dai licei >> ecc. Il rimedio è facile. Per
non dimenticare questi studj bisogna seguitarli . Per seguitarli vi sono due
vie, lo studio solitario e la scuola. Se lo studio solitario fosse bastato non vi
sarebbe questo quesito, dunque bisogna metter la scuola. Penso che non sa
rebbe impossibile in un ordinamento degli studj superiori che certi studenti
attendano ad alcuni studj d ' altre facoltà . on ci trovo opposizione. Bisogne
rebbe studiare un poco le diverse facoltà se hanno attinenza con questi studj
qui o con quelli là. Una certa promiscuità è desiderata; per esempio alla fa
coltà di legge si dovrebbe dire vi dovete studiare il latino. Io lo metterei li
bero quanto a scelta, obbligatorio quanto a frequentazione, per esempio chi
della legislazione vuole studiare certe parti, specialmente le parti erudite, ha
bisogno del latino. La parte economica ha bisogno di frequentare il corso di
storia. Io credo che ciò tornerebbe a vantaggio della coltura generale, per
ché spesso si ha bisogno di spigolare nel campo del vicino . L ' avvocato, il
medico che conoscono la letteratura, il letterato che conosce le scienze na
turali, imparano a rispettare le altre scienze, e a non credere il t utto la loro
materia e le altre nulla. Credo che a ciò si possa provvedere e non sia diffici
le, e avverto che nell'esame di ammissione abbiamo già la prova di queste
materie.
Abbiamo il sistema degli uditori ; se uno fallisce nell'esame di ammissio
ne, viene accettato come uditore , ma coll 'obbligo di dar l ' esame di nuovo .
Se si dicesse che uno può essere uditore all ' università, e dopo i l primo non
ha bisogno di dare alcun saggio i n quelle materie, ove frequenti le scuole e
profitti sarebbe un attirare i giovani dalla scuola secondaria a sentire date da
un professore d ' università certe lezioni che ha sentite al liceo in maniera di
versa, dove quelle materie non lo avevano abbastanza eccitato, e per le quali
gli si desta un amore che prima non aveva.
Sezione Il - l verbali delle deposizioni
265
Quesito 3 7. Quanto al quesito 3 7 si domanda se negli istituti classici sarebbe
opportuno introdurre lo studio di qualche lingua moderna. Abbiamo gli isti
tuti delle provincie meridionali nei quali è introdotto questo studio 1 • I o ne
ho veduti pochi di questi istituti da paterne dire qualche cosa per esperienza
ma idealmente credo utile insegnare qualche lingua moderna. Dovrebbe es
sere insegnata tanto quanto basta per poter dare al giovane la sicurezza
grammaticale perché possa conti nuare da sé. Non bisogna andare tanto in là
per una ragione che dirò quando parlerò della formazione dei professori di
queste lingue. Quanto all ' introduzione del disegno e della calligrafia io ho la
stessa opinione già espressa per la ginnastica e per gli esercizii militari. Io
credo che nei nostri istituti si debba dare larga parte [a discipline] che tor
nando utili all' uomo ne impiegano la mente sua. Dopo la fatica di una com
posizione, di u na lezione di matematica o di filosofia giova passare al d ise
gno, lo studio delle arti belle giova alla coltura generale. Inoltre bisogna
procurare in questi studi di non contentarsi del volgare ma di cercare ciò
che posssa allettare la mente dei giovani, o che possa avere relazione cogli 2
altri studi che essi fanno.
Quesito 38. Al quesito 38 c'è una guistione gravissima. Bisognerebbe distin
guere che intendiamo per gli scrittori del Trecento, i tre grandi oppure tutti
gli altri . Sopra ai tre non c'è nulla da dire . Ma è uno studio che allega i denti
ed è certo però che non sono difficili. Abbiamo avuto il torto di credere che
Dante sia molto difficile, mentre invece per chi conosca la lingua italiana ha
delle parti facili. Parrebbe certo singolare darlo nelle scuole elementari.
Quando si discorre degli altri il mio avviso è diverso . Il greco e il latino han
no dato dei nomi imperituri che non furono dimenticati giammai , e quando
si viene al paragone si vede che dei Platani, dei Senofonti, degli Omeri l 'u
manità ne ha dati pochi. La educazione di una lingua deve essere fatta bene
e non è data dai vocaboli né dalla grammatica ma da tutt'altra cosa, da un
nonsoché che si attiene all ' anima. Quelle letterature hanno dei grandissimi
rappresentanti che sono tutti potenti intelletti. Nella nostra lingua invece ci
sono molti scrittori ma sono ben diversi. Vi sono coloro che tenendo la no
ta dei loro fondachi sono diventati maestri di lingua. Erano tanto rozzi che
non conoscevano la rettorica . Quando sono colti sdrucciolano nella cattiva
arte di essere diversi dal volgare, e non parlano bene. Quasi tutti gli scrittori
del Trecento non sono veri scrittori, veri pensatori, anzi oserei dire quasi
l ' opposto. Forse alcuni saranno stati pensatori allora , ma il corso della civil
tà ha fatto sì che le cose che ci si imparano ora sono ben poche. Io credo
poi che sarebbe cosa veramente utile bandire gli scrittori ascetici -' . Là ci
porta il volgarizzamento di una favola non un miracolo . Siccome la scuola
' Vedi doc. 5, in particolare n . l , p . l 83.
' Nel ms: « degl i • .
' Sulla componente laica, d i polemica contro " le grullerie dei santi • , nell'opposizione alle
letture trecentiste devote (Cavalca, Passavanti ecc. ) cfr. M. RAICICII, Scuola cultura politica . . .
cit . , pp. I O't- 1 05 .
266
Fonti per la storia della scuola
non deve né credere, né deridere queste fandonie, così io vorrei si bandisse
ro . C'è un precetto sostanziale nella educazione letteraria. B is ogna prima di
tutto trovare scritture che invogliano i giovanetti a leggere. Il difetto si è
che si leggono poco i nostri classici. I giovani leggono poco e sappiamo
quando hanno acquistato il maneggio della lingua che libri leggono. Si intro
duca i Thouar 1, i Parravicini 2 e si farà bene. I o credo che il Trecento men
tre ha tutti i pregi di lingua che noi riconosciamo non può essere amato dai
giovanetti, e, quindi difficilmente lascia buoni frutti nel lettore. Farò consi
derare una cosa . Bisogna cercare qualche cosa che ci metta in relazione colla
letteratura moderna. I nostri classici sono letti molto? Ho già detto che cre
do di no. C ' è u na separazione. È la letteratura moderna che si legge assai.
Noi non possiamo cambiare i nostri piccini a dieci o dodici anni in tanti an
tiquari. I o credo che bisognerebbe cercare certamente che la proprietà della
lingua fosse nei libri che si mettono nelle mani dei giovanetti. D' altronde le
biblioteche di queste piccole classi non potrebbero avere molti volumi. Bi
sognerebbe mantenere nei giovani il senso letterario, il senso architettonico
della composizione. Gioverebbe anche introdurre qualche d ' u no dei roman
zi fatti appositamente per i giovanetti, i quali sono rari. Dunque bisogna da
re questo piccolo tutto nella mente del ragazzo perché si faccia un quadro
completo e metta ora il naso, ora la bocca, ora la mano, ed ora il braccio.
Quindi credo che si debbono sostituire alcuni scrittori moderni che per af
fetto, pensieri , sentimenti, civiltà sono vicinissimi al nostro tempo, anzi so
no il nostro tempo e possono facilmente esser sentiti dal bambino, e che si
trovano all' un isono coi sentimenti del bambino e delle famiglie. C ' è una co
sa utilissima che chiede il quesito 38 quando si domanda se la sola cono
scenza degli autori italiani basti e non bisogni aggiungere anche quella degli
stranieri. Ecco, si dice subito che sì . Ma quali e quanti sono gli scrittori ita
liani noti nelle nostre scuole, e quanti dei buoni? I principali autori italiani
dovrebbero essere letti. Se ciò è conciliabile con la lettura degli autori stra
nieri si faccia pure, ma bisogna vedere se c'è il tempo. Uno deve sapere an
zitutto la storia del proprio paese. Dopo che io ho messo in mezzo al mon
do i giovani, se io non ho creato loro la curiosità scientifica non ho raggiun
to lo scopo . Il giovane ricevuta la coltura generale può ricercare quest i auto
ri da sé, quindi non converrei in questo concetto perché mi impedisce di fa
re veramente il mio uomo italiano, e col mettere tanta carne al fuoco non si
sarà tutto cotto egualmente.
Quesito 40. Qui c'è una domanda sull ' i nsegnamento della storia su cui dirò
complessivamente sebbene si pongano diversi quesiti seguitando ciò che ho
1 86 1 ), scrittore toscano, autore di nu
1 Pietro Thouar (Firenze 23 ottobre 1 809 - l giugno
premio nelle
merosi libri per l 'infanzia, che ebbero larga diffusione come libri di testo e di
4 agosto
Venezia
800
1
(Como
i
Parravicin
Alessandro
Luigi
secolo.
del
fine
alla
scuole fino
riedito fino
1 880), pedagogis ta lombardo, autore del Giannetta pubblicato nel 1 836 e più volte
alla fine del secolo, spesso adottato come manuale nelle scuole elementar i.
z Nel ms. : « Pallavicini n.
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
267
detto prima. L ' insegnamento della storia è una grande difficoltà e mi pare
che lasci a desiderare qualche cosa . Ma non veggo un migliore ordinamento
stando dinnanzi a un fatto grave. Questo fatto grave è la ricchezza della sto
ria d' Italia. Se la mia nazione cominciasse nelle tenebre del Medioevo e tut
to consistesse nella lotta con l ' impero romano, io non troverei grandi diffi
coltà, ma io non devo solo trovare questo periodo, debbo risalire alle origi
ni di Roma, Romolo e Remo ecc . Ma c ' è una civiltà dietro a questo, io deb
bo andare più in là sette od otto secoli prima di Roma. Fatto questo la ne
cessità mi porta alla storia greca. Bisogna riconoscere che una parte della
nostra Italia è greca. Poi viene nientemeno che la storia dei periodi più ope
rosi dell'umanità. La spiegazione della civiltà presente che ha tanta parte
della civiltà greco-romana. Come si fa a studiare tutto questo? Si distenda
pure questo programma. Nel ginnasio si comincia dalle prime nozioni, ma
che cosa è ? Quella non è storia; quando si dice di volere insegnare la storia
vale più un ristretto periodo storico saputo bene , perché dà esperienza, che
un lungo periodo saputo male. Giova assai che la storia sia un tantino parti
colareggiata anche ai giovan i . La storia p erò non s ' i nsegna per curiosità o
come una novella. Non è la curiosità che io voglio alimentare . Io non mi
propongo di fare uomo un ragazzo prima di quel tempo che naturalmente
diverrebbe. Così si acquista l ' esperienza a spese degli altri quindi la storia
deve avere un tempo in cui deve cominciare se si vuole che giovi . Non cre
do opportuno che nella distribuzione presente del ginnasio si metta la sto
ria. Sono menti di dieci o undici anni che devono apprendere anche altre
materie. Siete sicuri che tutto ciò non ingeneri confusione? Quindi io non
anticiperei di molto questo insegnamento . Io veggo che generalmente i pro
fessori hanno accennato che bisognerebbe allargare l ' insegnamento della
storia e della geografia. Io dico che è tanto difficile compiere una buona sto
ria italiana che io sarei contento che sapessero un po' della greca e dopo
fosse la storia italiana . La storia dei paesi che furono in contatto col nostro
paese si dovrà far dopo . Io direi con quell'arabo che si deve studiare prima
di tutto la storia del proprio paese . Io in fatto di storia sarei restrittivo e mi
contenterei che ognuno sapesse la storia del proprio paese.
Quesito 4 1 . Quanto all' insegnamento della fisica e della storia naturale non
discorro che per dire una cosa sola. Accetto tutto questo ma vorrei che que
ste scienze qui tendessero a sviluppare lo spirito di osservazione . Dovrebbe
quindi essere cambiato il metodo. I nvece dei trattati di fisica vorrei dei gabi
netti, invece dei trattati di storia naturale vorrei delle collezioni di s toria na
turale .
Quesito 42. Noto un fatto avvertito alla domanda : « L' insegnamento della
storia naturale » ecc. Credo che qui bisogna i nsistere con prescrizioni nette.
Dunque i professori di storia naturale, di fisica, di chimica dovrebbero senti
re che è loro debito di raccogliere tutto quello che di proprio e di speciale
v'è nel paese dove insegna. Io nelle mie ispezioni ho veduto che queste col-
268
Fontiper la storia della scuola
lezioni sono poche. Bisogna ridurre queste scuole, in modo che capitando
un dotto il quale voglia vedere i prodotti naturali del paese trovi nella scuo
la la flora, la fau na, i minerali . Il governo può ottenere ciò con prescrizione
e i vantaggi sarebbero enormi. Qualche professore ha avuto il comodo di fa
re queste collezioni; c'è per esempio qualche parroco che è amico dei pro
gressi del sapere che si diletta di conoscere le piante e le manda al professo
re. Un altro ha preso delle farfalle e le manda p ure al professore. Di questi
amatori ce ne sono sempre e così si forma a poco a poco u n gabinetto di
storia naturale.
Quesito 44 - Scuole tecniche. Passo al quesito 44, il quale dice: " Quali effetti
ha prodott o » ecc . Io credo di non essere in grado di potere rispondere sugli
effetti prodotti. Ma credo che la scuola tecnica vada ordinata con l ' istituto
tecnico . I o sono poi anche d' avviso che la direzione degli studj debba essere
affidata ad una stessa autorità. L'istituto tecnico non è tanto speciale che chi
soprassiede alla coltura generale non li possa governare. Tutte le professioni
universitarie hanno del tecnicismo poiché tendono a specializzare . Io credo
che questo contatto sarebbe economico di danaro e di personale, e che que
sta armonia sarebbe molto feconda. Quindi gioverebbe unire tutto insieme .
Quesito 45. Qui c'è una domanda se gioverebbe coordinare la scuola tecnica
al ginnasio inferiore in modo da rendere possibile questo passaggio. Io sono
compromesso in questo . Questo è stato il mio avviso e lo aveva proposto .
Io trovo insufficiente l ' i nsegnamento elementare popolare ed io intendeva
che la scuola tecnica dovesse essere il seguito dell' istruzione elementare e
dovesse raccogliere tutti gli alunni che di là passerebbero alla scuola classica
o all' istituto tecnico.
Quesito 48. Dico una sola parola sul quesito 48. Non parlo della lingua fran
cese. Io credo che la giu nta deve considerare i titoli con cui si diventa pro
fessore di lingua straniera e quando questi passano nell' insegnamento uffi
ciale non posso seguitare a considerare le cose come oggi. F inora è profes
sore di lingua straniera chi la sa, ma faremo noi professore di italiano chi lo
sa? No. Ci vuole anche la coltura letteraria. Si provi se questi professori di
lingue straniere sono anche letterati . Io credo che questi adesso difettino,
ma qui bisogna studiare il modo d i avere questi buoni e veri professori di
lingua e letteratura. Per conto mio non mi contento di formare professore
uno cui la fortuna ha fatto uscire dal proprio paese, perché ciò mi sembra
assurdo e non credo che basti conoscere superficialmente u na lingua stra
niera per poterla insegnare con profitto.
Scuole normali - Quesito 55. Vengo ora al quesito 5 5 che riguarda le scuole
normali. Io guardo la questione i n astratto e vedo che non si può dire che
sia necessaria la distinzione dei due ordinamenti. Qui o altrove si accenna a
quello che è la scuola normale presentemente. Essa non è congiunta diretta
mente con nessun ordine d ' istruzione inferiore. Si tratterebbe di regolare la
istruzione tecnica di tre anni e la ginnasiale di cinque i n ordine alla scuola
Sezione 11 - l l 'erba/i delle deposizioni
269
normale . Si vorrebbero mettere insieme queste due preparazioni molto di
verse. Io credo che l ' i nsegnamento della scuola normale possa essere consi
derato sotto diversi aspetti, pel congiungimento cogli altri insegnamenti che
hanno preceduto ed anche rispetto agli insegnamenti medesimi. Finora la
pratica se non la legge hanno avuto un diverso concetto e contrario del pro
fessore normale . Io credo che il professore normale dovrebbe essere uno dei
migliori professori di liceo. Mi pare che nel fatto non si abbia questo e che
ciò è un gran guaio. Insegna molto bene le cose più minute chi ne sa di più.
Il professore di liceo infine dei conti non ha il metodo didattico che convie
ne ali ' università, ma se si addice a questi s tudi pedagogici egli avrà metodo
conveniente all' età stessa degli studiosi. D unque credo quanto alle scuole
normali che si debba guardare se i professori sono degni e capaci . Bisogne
rebbe trovar modo che questi studi si congiungano coi precedenti perché
come sono fatti oggi non sono campo speciale di vocazione, ma vi regna il
dubbio e l ' incertezza perché molte volte si mandano i giovani alle scuole
normali perché non sanno cosa fare . Se tutti questi studi si unissero insieme
sarebbe una cosa naturale e si potrebbe restringere il corso normale a u n
quarto anno di studio dopo terminato un corso tecnico. Bisogna p o i guarda
re nel l ' ordinamento di queste scuole che gli allievi non escano troppo gio
vani per insegnare perché allora non si avrebbero buoni effetti. Un tale cor
so potrebbe convenientemente sostituire la scuola normale presente. Quan
to alla trasformazione delle scuole normali superiori femminili ci sarebbe il
pro ed il contro; per me dico che sì, perché anche la scuola superiore fem
minile è diretta all 'educazione della donna che io considero destinata a que
sto nobile ufficio . Le cognizioni che si danno alle donne non possono, non
debbono variare, forse sarà il metodo che varierà ma io non sono in grado
di pronunziare su questo argomento . Io ho capito la scuola superiore fem
minile come è costituita a Verona di cui parlò con tanta competenza l ' altro
giorno l'Allievi 1 Io ho capito il suo concetto ed anch ' io l' avrei adottato
poiché debbo guardare alla qualità delle famiglie e ai diversi elementi che
vengo a mettere insieme. Vi è più difficoltà di trovare buoni istituti per le
ragazze di quello che non ci sia per i maschi , i quali vanno bene per tutto. Ci
sono certi istituti femminili in cui vanno particolari ordini di persone . Io
non biasimo chi va con i suoi pari , ma alla scuola pubblica amo l ' accomu
narsi di tutti; nella scuola privata ognuno è padrone di fare quello che v uo
le . Ora nelle scuole superiori femminili vi concorrono degli stati diversi di
persone, dalla donzella civile a quella che va per fare la carriera. Questo
1 Nella sua deposizione del 12 febbraio 1 87 3 , riportata in questo volume solo in parte (doc.
1 9 , p. 230), Antonio Allievi si era soffermato, parlando degli educatorii, sulle recenti riforme
introdotte nella scuola superiore femminile di Verona. Ricordò come l'educazione impartita in
quell'istituto non mirasse solo a formare le ragazze • a vita meramente di vanità e di fioritura
esterna •, ma fosse " intesa a fare delle fanciulle che escono di là buone madri di famigli a '' · A
Verona era stato inoltre introdotto lo studio della pedagogia per la preparazione necessaria a
divenire maestre nelle scuole superiori.
270
27 1
Fonti per fa storia deffa scuola
Sezione 11 · l L •e1·bafi delle deposizioni
contatto mi piace e quindi io preferisco l ' accomunamento. Vi sono molte
cose da fare. E quindi propongo un' idea che mi pare buona .per rispondere
così alla provvista ordinaria della maestra . La scuola superiore femminile
può essere impiantata anche dal municipio. Noi così facciamo una cosa mol
to nuova e quindi bisogna andare adagio poiché è cosa prudente accrescere
le scuole poco per volta . È un' interesse della società che queste scuole siano
il semenzaio delle maestre: bisogna però diminuire la facilità di ottenere le
patenti di grado inferiore perché questa facilità è dannosa al progresso degli
studi. I noltre io proporrei che alle maestre di grado inferiore si desse la pa
tente di grado superiore dopo aver mostrato la propria abilità in conferenze
autunnali.
Quesito 5 7. Quanto al quesito 57 io piglio l ' occasione per u na cosa che for
se sembrerà strana. Nell ' opinione dei più è questo, che la preparazione delle
maestre destinate a stare in città o in campagna deve essere diversa. Il prin
cipio è vero e vi concordo anch 'io, ma lo noto per avere questa occasione
di dire che bisogna prendersi guardia da questo . Si dice che le maestre in
campagna portano le loro aspirazioni e si trovano in una atmosfera che non
va bene ad esse che diventano povere vittime. Dicendo questo diciamo u na
cosa giusta poiché è un fatto vero , ma entra il sospetto che queste maestre
non si trovano tanto agiate nemmeno in città . Questo spostamento non cre
do che muti molto la loro condizione. È un punto dubbioso. È vero che que
ste maestre di città non si sappiano adattare in campagna? Mi avvenne di co
noscerne molte perché ho insegnato in due grandi istituti i quali hanno pre
parato un enorme numero di maestre che si sparsero in tutte le parti d ' I talia.
Ho fatto esperienza che questo fatto del trovarsi bene o male in campagna
dipende dal carattere particolare di ciascuna maestra. Ci sono maestre di cit
t à che hanno fatto benissimo in campagna o nel loro paesetto o viceversa
delle contadine che stanno in città le quali per lo più accrescono le loro pre
tenzioni . Questo mettere insieme allieve di città e di campagna credo che
non sia una questione matura. I o veggo adesso che si predica un po' gene
ralmente. Forse questo può darmi torto, ma siccome non vedo che tutti i
problemi che vi si aggiungono siano sciolt i , così credo che bisognerebbe
aspettare dalla esperienza lumi maggiori . In ogni modo io non farei distin
zione tra la preparazione. Nei piccoli paesi nulla c'è che soddisfi la vita mo
rale del paese, nelle piccole borgate c'è bisogno d'abbattere i l pregiudizio
dove la civiltà è minore e quindi c ' è bisogno di lumi ov ' è più buia.
Quesito 58. Discorrendo di convit t i , al quesito 5 8 si dice: « Non si esercita
troppo la memoria a scapito della buona educazione della mente? >> . Credo
che sì; queste scuole peccano tutte di tale difetto. Non solo ci vuole il libro
di testo, ma si debbono fare i commenti. Le fat iche materiali portano via
molto tempo , poiché le fanciulle sono costrette a prendere norma di tutte le
lezioni . Così io sono favorevole, là dove discorre di estendere a tutte le
scuole il cucito a macchina. Nella scuola femminile si deve dare u na grande
importanza al lavoro e Yi dev 'essere una scuola a parte. « S ' insegnano in al
cune scuole normali i principii dell'agricoltura? ,, Io credo che sì. Credo an
che che sarebbe utile nella formazione delle scuole normali avere un ordina
mento un po' più elastico, per cui in certe scuole si curasse una cosa, in al
tre un'altra. Sarebbe utile che vi fosse qualche scuola normale che avesse
l' insegnamento dell'agricoltura, che andasse un po' più in là di quello che
va attualmente; dove vi sono maestri che andranno in campagna, vi porte
ranno del vantaggio. Sarebbe u tile che alcu ne di queste scuole normali bene
stabilite nel paese si potessero atteggiare in modo da rispondere a questo
aspetto di studi e ali 'attit udine del paese stesso.
Dei convitti non dico che u na cosa sola. Io credo che il governo non
possa avere convit t i . I convitti del governo è difficile che possano risponde
re a tutte le esigenze delle famigl ie, per questo capo principale che non c'è
quasi niente di vocazione negli impiegati che il governo mette alla testa dei
convitti. Vi sono in questi uomini cognizioni generali , larghe, ma non cono
scenza particolare. Il governo tratta questo suo funzionario come tutti gli al
tri . Molte volte il direttore del convitto arriva in un paese nuovo, ed ha ' au
torità solo in quanto si dice in quel paese: tutto ciò che fa il governo, lo fa
bene ma se non v ' è quest 'autorità nel governo, allora egli non gode più la fi
ducia. I convitti dovrebbero essere una cosa locale , u na produzione sponta
nea . Si dee trovare un individuo che ispiri la fiducia di tutte le famiglie.
Quindi i convitti si devono lasciare al comune, ai privati, regolandoli bene.
Solo in un caso però il governo dovrebbe procurare di avere dei convitti, se
alla scuola normale superiore ed inferiore si unissero istituti congeneri . Allo
ra si avrebbero grandissimi istituti sui quali lo scuola normale superiore
eserciterebbe u na influenza scientifica, e quindi questi istituti diventerebbe
ro il modello degli altri , sarebbero il luogo dove si fa il tirocinio di tutti gli
insegnant i . Si saprebbe in questo modo che in fatto di studi non si può far
meglio. Questi istituti dovrebbero stare nelle grandi citt à : in quel caso i l go
verno farebbe molto bene a tenerli .
Presidente. La Commissione la ringrazia della compiacenza avuta.
22
Seduta di Napoli, 1 8 febbraio 1 8 73 2 •
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860-1896) , b. 4 , fas e . 7 .
1 Nel ms: " e d à errore d i legamento caratteristico della trasmissione orale del testo.
La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
"•
272
Fonti per la storia della scuola
I PPOLITO A MICARELLI 1
Presidente. Sopra quale parte desidera essere interrogato?
Risposta . Sull' insegnamento pubblico e privato (legge il quesito).
Veramente non si può dire che gl' istituti privati facciano concorrenza
agli istituti governativi perché i nostri istituti hanno tale numero di giovani
che sono soverchi e né si possono accettare tutti. Un po' di concorrenza
l ' hanno fatta solamente però alle scuole liceali e ne dico la ragione, ma alle
scuole ginnasiali per vedere che concorrenza si abbia, siccome Napoli è città
così grande, bisognerebbe avere una ventina di istit uti governativi, e allora
si vedrebbe se questi hanno tale numero di giovani quanto gli istituti privat i .
In Napoli l ' i nsegnamento privato è molto esteso, quello governativo è poca
cosa. Le ragioni perché questo insegnamento privato sia così esteso possono
essere le opinioni politiche, le opinioni religiose e altre abitudini del paese
dove non c'è stato mai l ' insegnamento governativo nel tempo passato, era
tutta istruzione privata, e quel bene che si è avuto è nato dall' istruzione pri
vata; quindi è la tradizione che fa correre i giovani all' insegnamento priva
to. Vi può essere anche maggior fiducia in un maestro che non si ha in un al
tro, ma questa è una ragione piuttosto speciale. Certo che l ' insegnamento
privato in Napoli è molto esteso , in ogni canto di via si vedono tabelle di
scuole private, di scuole tecniche, di ginnasi , licei eccetera .
« E il frutto che dà l'insegnamento privato è egli buono ? •• dice il quesito,
è regolato bene e vigilato bene? Qui è la questione ed è seria . Noi abbiamo
visto i nostri giovani uscire dalla quinta ginnasiale nell'anno passato e lascia
re il corso liceale e questo era la voglia di far presto, perché non c 'era allora
l ' obbligo di presentarsi all'esame liceale con una licenza ricevuta tre anni
prima 2 Se non potevano dare l ' esame di licenza liceale a Napoli andavano
fuori . In questi istituti perciò trovavano i giovani il modo di far presto, di
abbreviare i cors i . E questa è la ragione principalissima per cui le scuole pri
vate erano molto affollate. In quest 'anno si è visto un po ' il contrario; e dac
ché si è visto obbligare i giovani a presentarsi all 'esame di licenza ginnasiale
1 lppolito Amicarelli (Agnone I O agosto 1 82 3 - Napoli 2-t novembre 1 889). Sacerdote, aprì
scuola i n patria con orientamento puristico; pubblicò nel 1 858 le Lezioni sopra la lingua e lo
stile italiano, che avranno notevole diffusione nella scuola classica dell 'Italia unita· arrestato
dalla polizia borbonica, evaso e latitante negli ultimi anni del dominio borbonico, n � l 1 860 fu
eletto deputato di Agnone nel primo parlamento nazionale. Dal 1 865 fino alla morte fu preside
e rettore del liceo-convitto Vittorio Emanuele II a Napoli. Un suo affezionato allievo, Francesco
D 'Ovidio, traccerà un suo profilo in Rimpianti, Palermo, Sandron, 1 903, pp. 2 0 1 -226. Rispon
de altresì ai quesiti relativi ai libri di testo, le letture domestiche degli allievi, le vacanze, le tas
se scolastiche, gli esami, gli uditori e l ' insegnamento dell 'italiano.
' I l regolamento per gli esami di licenza liceale, approvato con r.d. 3 mag. 1 872, n . 807,
prevedeva all'art. 2 l ' intervallo di almeno tre anni fra l 'esame di licenza ginnasiale e quello di
licenza liceale: il provvedimento era mirato ad impedire la tendenza ad abbreviare gli studi su
cui prosperavano le scuole private di Napoli: fu perciò assai osteggiato dagli insegnanti privati
e determinò un assai maggiore afflusso di studenti nei licei governativi.
Sezione 11 l z>erbali delle deposizioni
-
273
o licenza liceale le nostre scuole cominciarono ad essere affollate. E di fatto
nella prima liceale in quest' anno se ne sono presentati tanti che non si sono
potuti ricevere. Le classi si molt iplicarono, si divisero in tre, quattro, cinque
e sei sezioni 1 e non furono ancora bastanti. Giunte ad un certo numero, a
sessanta, dovettero chiudere l ' ammissione . Ed è anche troppo questo nume
ro se si considera che c'è tanto da fare che è impossibile che il maestro pos
sa bastare a tutto. Venendo dunque a quello che si fa nell ' istituto privato ri
spetto all' istituto governativo , io farò notare che le nostre leggi non bastano
a regolare l ' istruzione privata in Napoli; qualunque persona può aprire un
istituto . Per Napoli è un mestiere come u n altro 1 . Si presenta uno al Consi
glio scolastico con fede di buona condotta ottenuta dall'autorità municipale
e dice : voglio aprire un istituto; presenta i professori che insegneranno in
quell ' istituto. I professori sono sempre indicati tra quelli che possono essere
autorizzati dal Consiglio scolastico . Il Consiglio scolastico concede la facoltà
di aprire un corso per certe classi a seconda dei casi; il fatto si è che ottenu
ta questa facoltà viene aperta la seconda classe quando fu chiesto di aprire la
prima; venne chiesto di aprire le classi ginnasiali e si trovano aperte anche
quelle del liceo . Si dice di osservare i programmi governativi e poi non ven
gono osservati . l o so di qualche ist ituto dove i l corso liceale si fa in u n solo
anno. Che si cominciano le scuole alle sette del mattino e durano sei ore e
in ciascuna ora prende posto una materia, sicché i giovani dopo aver fatto
un' ora di latino passano a fare un ' ora di greco, poi di matematica e così via
via tutte le materie ginnasiali che si fanno in tre anni. Domandai a alcuno di
questi professori che sono brava gente, " ma che ottenete voi ? » . Mi risposero
che i giovani escono come pecore istupiditi dalla scuola. " E voi gente onesta
fate questo? , diceva io a loro , " ma se non facciamo così dovremmo chiude
re le scuole ». Non è che in Napoli mancano professori privati onesti, ce ne
sono; ma v ' è un numero grande eli quelli che fanno scuola per mestiere e gli
onesti sono costretti a fare quello che fanno gli altri , perché hanno bisogno
di vivere. Da tutto questo vengo a conchiudere che i nostri regolamenti e le
nostre leggi sono insufficienti per regolare gl ' istituti privati . B isognerebbe
che il regio provveditore avesse obbligo e facoltà o per sé o per altri di i nvi
gilare continuamente gli istituti privati; vedere se ciascuno di questi che
hanno chiesto di aprire una scuola privata eseguisce quello che ha ottenuto
di fare ; cioè se ha quelle sole classi per le quali è stato autorizzato di fare; se
i professori siano quelli che ha presentato al Consiglio; se le classi sono così
divise come voglino i programmi governativi; se il frutto sia tale che possa
accertare insomma il governo o l' autorità provinciale o il regio pwvvedito
re che quell' insegnamento può continuare. In questo modo si avrebbe nelle
1 Nel ms. : « sessioni » .
' S i riferisce alla legge I O febbraio 1 86 1 sul l 'istruzione secondaria, nota anche come legge
lmbriani. Su questo aspetto imistono anche molte altre deposizioni in Campania, e particolar
mente quella di Antonio Labriola (doc. 2 3 , p. 275).
274
275
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - I verbali delle deposizioni
scuole private dei professori onesti, e l ' istruzione privata riporterebbe quel
frutto che è da desiderarsi.
Presidente. Si esige da questi insegnanti privati la prova dell 'insegnamento
che esercitano onde constatare se sono abili o no?
Risposta . Il regio provveditore potrebbe dare schiarimenti più certi su que
sto. Dirò che non tutti sono veramente autorizzati ad i nsegnare. C ' è stata
una legge dove si diceva che tutti gl ' insegnanti dovevano essere autorizzati
ad insegnare altrimenti non potevano insegnare. Io credo che molti di quelli
che insegnano sono autorizzati provvisoriamente e così seguitano di anno in
anno.
Bonghi. Esiste una statistica delle scuole private di Napoli?
Risposta . Si, credo che esista come non credo che vi sia una statistica esatta.
Il provveditore tiene un apposito registro nel quale vengono registrate tutte
le domande di chi intende aprire una scuola privata. Ma chi le conosce tutte
queste scuole private? Ce ne sono tante in Napoli che chi gira lo sguardo in
ogni canto delle strade vede delle tabelline di queste scuole.
Presidente. Il signor provveditore potrebbe dare qualche spiegazione su
questo proposito, se si esige una prova rigorosa di abilitazione.
Provveditore 1• In quanto alla statistica l' anno passato se n'è compiuta una
esatta e nell ' ufficio sono depositate tutte le relazioni dell' ispettore che fu in
caricato dal ministero per tale oggetto che è i l cav . Turiello 2.
Quanto poi alla ragione detta dal signor preside è pur vera. Degli i nse
gnanti privati vi sono di quelli che hanno l'autorizzazione sopra t itolo effi
cace e giudicato dal Consiglio superiore. Vi sono di quelli i quali hanno tito
li che furono dati dal governo passato e che furono riconosciu t i dal governo
presente, e il Consiglio scolastico ha dovuto usare della benignità verso i
vecchi insegnant i , specialmente di quelli che avevano un lungo esercizio an
teriore . Per gli altri fin dall 'anno passato il Consiglio scolastico ha usato una
grande severità per non concedere sopra semplice titolo, per quelli cioè i
quali non avessero dieci anni d ' i nsegnamento. Sicché fino all'anno passato
si è usata una certa larghezza per i vecchi insegnanti permettendo loro di
continuare l 'insegnamento, e pei giovani si dovessero presentare i t itoli che
poi sarebbero mandati al Consiglio superiore. Ma comprendano bene, qui
c'è una grande questione, che un provveditore non ha nessun modo di invi-
gilare l' istruzione privata. Vengono a chiedere il permesso. A molti si è ne
gato, come si è negata la facoltà a professori di insegnare a più di tre istituti.
Si è domandato il programma ma chi va a vedere se si fa lezione? Ripeto è
questa una questione gravissima ed io credo che colle misure coercitive a
Napoli non si può raggiungere lo scopo, non si può andare avanti.
Amicarelli (continua). I n ogni modo è un male questo al quale bisogna
provvedere. Ogni anno vengono dagli istituti privati degli alunni che voglio
no essere messi al ginnasio o al liceo; si domanda loro: « Che studi avet e fat
to ? » . « H o fatto gli studi di quarta e quinta ginnasiale >> ; ognuno dicé gli studi
che ha fatto. Ebbene si fa domanda di essere ammessi ad aspirare alla quinta
ginnasiale, si va agli esami e si trova che quel tale e tal altro non è buono per
la prima ginnasiale. E potrei dire i nomi. Due anni addietro, per esempio,
venne un giovane di sedici o diciassette anni; il padre me lo presenta e d ice :
« Ha fat to gli studi in un ist ituto speciale e vorrebbe essere ammesso alla pri
ma liceale >> . Domandai che studi ha fatto; e mi parlò di lat ino, di greco, di
Cicerone; si venne all' esame e si trovò che non sapeva leggere né scrivere il
latino né l'italiano tampoco e non sapeva che cosa fosse il greco. Si doman
da: « Voi avete detto di essere passato in t utte le classi ginnasial i ? >> . « Si , egli
risponde, ma non ho mai capito nulla >> . Il padre piangeva perché aveva spe
so molti denari; bisognava cominciare da capo, e di questi fatti ce ne sono
molt i , se ne hanno le prove negli esami di licenza ginnasiale e liceale.
Credo che la Commissione avrà letto gli scritt i che si mandano a Roma
di licenza liceale, e avrà visto che miseria. Giovani svegliati d' ingegno che
proprio lo dimostrano nelle parole, negli atti, ebbene vengono agli esami di
licenza ginnasiale che non sono buoni per una classe qualunque. I nsomma la
Commissione sappia che c'è del male e che a questo male bisogna provvede
re. [ . . . ]
23
Seduta di Napoli, 19 febbraio 1 8 73 ' .
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860-1 896), b. 4, fase . 8.
' I l provveditore agli studi della provincia di Napoli è Girolamo Nisio che aveva già depo
sto nella stessa seduta del 1 8 febbraio 1 87 3 .
' N e l m s . : u Turelli ». Pasquale Turiello (già nominato d a Scialoja segretario della Commis
sione d 'inchiesta, incarico cui rinunciò, e che deporrà nella seduta del 20 febbraio 1 87 3 : ACS,
M P ! , Diu. scuole medie, 1860-1 896, b. 4, fase. 9) aveva svoltO una indagine sull'istruzione pri
vata a Napoli. In seguito ai rilievi sull'insegnamemo privato emersi diffusamente nel corso del
l' inchiesta, il ministro Bonghi commissionerà al provveditore Carlo Gioda una ispezione per la
quale vedi relazione, pubblicata in « Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione » ,
1 876, p p . 226-237, inoltre vedi doc. I l , n . 1 .
A NTONIO LABRIOLA 2
Presidente. Ella ha indicato di voler parlare sul quesito 39.
1 La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
' Antonio Labriola (Cassino 2 luglio 1 8-t3 - Roma 2 febbraio 1 90-!). el 1 87 3 è professore
di filosofia al liceo Principe Umberto, dopo aver insegnatO nel ginnasio inferiore dal 1 866. Dal
276
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l t•erba/i delle deposizioni
Labriola . � ui trovo una interrogazione: << Bastano la logica e la psicologia
.
.
che ? ra SI � � segnano _i' , . M t pare che qui la Commissione· supponga che si in
s �gnt la logtca e l� psic?logia, e che tutto quello che i precedenti regolamen
ti avevano prescntto, fosse andato in esecuzione. Diffatti pei licei sebbene
le ultime istru�� oni limitino l'insegnamento della filosofia, i profess� ri conti
nuano a fare l mtero corso filosofico. Basta guardare i libri d i testo ' che si
ad � ttano nei licei per persuadersi che iv i si fa I' intera filosofia. Sarà u na filo
.
so �ta vana secondo le opinioni, ma si fa un intero corso di filosofia. Ora nel
l� mte �r?gazione si domanda appunto la opinione su questi corsi completi
.
ftlosoftct e se ess1 possa � o mettere disordine nelle menti de' giovani. A me
pare eh � SI, per la es�enenza mia nei pochi anni che sono stato insegnante
ed es� mmatore � o vtsto questo, che nella opinione di molti professori il li
ceo s1 convene 111 arena di discussione filosofica, come l ' università mentre
la �ente dei � iovani non è preparata ancora ad intendere quello eh� voglio
no msegnare 1 professori .
Qui naturalmente comincia una quistione più generale. Se quello è un
. .
tst Ltuto non solo scient ifico, ma di educazione, deve rappresentare la tutela
� ello Stato. � d i ' indirizzo della educazione . E qui pare venga ad assumere
l o?�hgo dt msegt�are una dottrina ufficiale, e questa poi fa nascere un'altra
.
opmwne, che c10e quando vanno all 'esame, siano approvati 0 no secondo
la opinione filosofica dell'esaminatore. È vero che si è detto che 'in alcune
quistioni bisogna limi tare l ' i nsegnamento di queste materie che deve far par
te della � ul tura ? enera l� . Allora bisogna prendere una dottrina generale ac
.
colta e nconoscmta. CIO vuoi dire che tutti gl' insegnant i si debbono mettere
d ' accordo in quello che pensano in complesso e fare una detrazione di ciò
che per� s ano particolarmente in alcune questioni per trovare u n punto co
.
mune eh msegnamento, il che ora non accade.
� ' i �1segn�mento filosofico come è dato ora produce effetti cattivi perché
q �1e1 �10v�ru che non hanno abbastanza colt ura d ' i ngegno e sono scarsi d ' or
dmano d1 letteratura ne escono boriosi e ben superficiali .
E tutti credono che la gran questione sia quella di decidere se la materia
.
sta o no eterna e se l ' anima sia o no immortale . Ora dunque parrebbe che il
conc � t to al quale si dovesse strettamente informare questo i nsegnamento fi
losofiCo dovesse esser questo, cioè di pigliare il giovane al punto dove si
trova. L' insegnamento fi losofico deve cominciare col secondo e terzo anno
e deve far parte della coltura generale in quanto si mette nella mente del
.
gLOvane un �ltro elemento d' intelligenza cioè a dire che questo insegnamen
t � della logiCa debba essere fatto in modo da combacciare colla coltura del
gwvane la quale non deve avere spostamento nella sua mente. Mi pare che
1 87-! è professore di filosofia all'università di Roma. Dal 1 877 al 1 89 1 dirige il Museo d ' tS
' t ru
·
ztone e d't ed ucaz10ne
del Ministero della pubblica istruzione, fondato da Ruggero Bonghi nel
_
-
1 87 <! .
277
are i limiti di questo inse
per ottener e ciò bisognerebbe stret tament e formul
che l ' eccesso individ uale di
gnam ento, formul arli rigoro samen te e imped ire
mi parrebbe insuffi ciente
chi insegn a possa uscire da questo limite che allora
ce logica e psicolo gia. egli
che questo insegn amento si limitas se alla sempli
fare entrare l ' i nsegna
istitu ti second ari non si pensa punto al modo come
logica. Quand o si dice
mento della morale e parte dell'in segnam ento della
che lo fan no impara re a
morale s i ricorre subito ai morali st i , ai precet tisti
questio ne rispett o alle
mente come un catech ismo. E allora nasce u n ' altra
religio so. Bisogn a ri
relazio n i tra l ' insegn amento morale e l ' i nsegna mento
connes so con tutti gli altri
destare la riflessi one morale del giovan e e ciò va
questo che i profes
insegn amenti che si danno a questo giovan e. Ora accade
delle materie che si inse
sori di filosofia si trovin o estran ei a tutto il resto
ad insegn are la logica non
gnano nel liceo. Come se essi quand o comin ciano
atica, il quale non può fa
avessero niente a che fare col professore di matem
la logica , col profes
re il suo proces so dimos trativo se i giovan i non sanno
dramm atica, col professo
sore di lettere quand o presen ta qualch e posizi one
quale si può desum ere
re di storia quando espon e un certo fatto storico dal
cose mi pare che non ci
una qualch e osserv azione moral e. In questo stato di
a dell'insegnan te della filo
sia altro mezzo di quello che riunire nella person
cie merid ionali pri
sofia qualch e altro insegn ament o concre to. Nelle provin
liceo; ma questo insegn a
ma del 1 860 non c ' era profes sore di filosofia nel
vi è stato gran diver
mento era ordina riamen te unito alla matematica . In ciò
quello delle lettere o
bio se l ' i nsegna mento della filosofia vada unito con
più stretta mente pe
(delle] matem atiche . I o credo che chi dal punto di vista
della filosofia vada u ni
dagogico consid eri il liceo creda che l ' insegn ament o
primo eleme nto di ri
to con quello delle lettere , giacch é è natura le che il
e della storia. Non
flessio ne filosofica nasce dalla coltura reale delle lettere
che sia uno sconc io la
saprei come formu lare questo mio pensie ro ; ma trovo
serve ad altro, come
presen za di questo professore di filosof ia perché non
questi oni che non
serve ora , che a risveg liare nella mente del giovan e molte
insegn ament o si faccia
è in grado di risolve re; e non osserv andos i se questo
o in u n mezzo di parti
in un modo piutto sto che in u n altro esso s i conve rte
eccitam enti di affet
ti o in eccitam ento di affetti , e si sa che in pedag ogia gli
che se si riduce l ' in
ti produ cono cattive conse guenz e. Io non credo quindi
e ne venga del danno .
segnam ento della filosofia alla psicol ogia ed alla moral
psicol ogia e a qual
Ma l ' i nsegna mento filosofico, limitat o alla logica ed alla
contem perato col
che conce tto filosofico moral e, può qualch e poco essere
giovin e senza cogni
l ' i nsegna mento pedag ogico che può dare la coltura del
nella person a del
zioni sistem atiche . La quale cosa non si può ottene re se
d ' i nsegn ament o in gui
professore di filosofia non si dà alcun ramo specia le
sia profes sore di
sa che il professore di lettere italian e o di greco o di lat ino
ndo o i Memorabili
filosofia. Io non credo che il professore di lettere spiega
di lingua italian a
testo
e
qualch
o
ne
Cicero
di
di Senofo nte o qualch e opera
278
Fon ti per la storia della scuo
la
non tro vi del le ver ità filosofiche
com e sul con cet to del la definiz
ion e, sul
modo con cui si arriva e via via .
Il professore non avendo risp etto
a tutt a la
col tura del gio van e si pia nta lì per
fare un que stio ne gen era le com inc
ian do
ab ovo . Que sta è una cos a
che non va, biso gna trov are mo do
di por vi rim e
dio . In cias cun lice o c'è un inse gna
nte di gre co, di lati no, di stor ia . .
. Ma ciò
rich iam a tutt 'alt ra questio ne.
Si trat ta di trovare que l tal num ero
di professori che sian o necessari
la com ple ta edu caz ion e del gio van
per
e; opp ure se tutt a la ma teri a debba
esse re
ripa rtit a fra que lli che ci son o attu
alm ent e.
Il con cet to mio è che non vi fosse
ne' lice i un pro fess ore di filo sof ia,
ma
ci fosse un sem plic e inse gna me
nto filosofico elem ent are . E con
verrebbe
qui ndi stud iare un modo pra tico
per riun ire l 'ins egn ame nto della filo
sofi a e
del le lett ere in una sola per son a; e
qua ndo ciò non sia pos sibi le biso gna
abo
lire affa tto questo insegname nto .
Non è nuo vo un ese mp io di que sta
fatt a, per ché anc he in Ger ma nia,
che
citi am o sem pre com e mo del lo, da
un sec olo a que sta par te, si pre se
il par ti
to di abo lire que sto insegname nto
, per ché i gin nas i era no div ent ati
are na di
disc uss ion i filosofiche. E poi dop
o qua ran ta ann i fu rim essa la filo
sof ia,
qua ndo si fu trov ato uno che fec e
un libr o, me tten do insiem e alcu ne
ide e di
Ari stot ile.
Se la filosofia non si può ridu rre
a que l pun to è un elem ent o per ico
loso
del l 'ord inam ent o sco last ico . Io ho
trov ato questo , che i gio vani di
que sto
pae se (do ve non so se giu stam ent
e o ing iust ame nte , faci lme nte si filo
sofa , e
si ha que sta fama) nei loro com pon
ime
zep pi di erro ri, e qua lch e vol ta priv nti ital ian i di lice nza lice ale, che son o
i di sen so com une , a qua ndo a qua
ndo
me tton o frasi cos ì det te trascenden
tali; e difficil me nte si trov
a un gio van e
cap ace di esp rim ere con chi are zza
e sem plic ità un con cett o com une
del la vi
ta: opp ure trov ate una ripi enezza
di ide e, che pro vien e dai catt ivi libr
i di fi
losofia che si stud ian o, e i qua li inv
ece di ord ine me tton o con fus ion
e nel la
test a del giov ane .
E cos ì la filosofia inv ece di esse re
il prin cip io fondament ale di tutt
a la
cul tura , rim ane sem plic em ent e un'
arm a ant irel igio sa e un me zzo di
chia c
chie rare per l'ap pun to com e fan no
i gio rna listi .
Bonghi . Ho inte so il suo con
cett o. Ella dice che per ren der e più
con cre to
l 'ins egn ame nto dell a filo sofi a, non
si dev e dare ad un professore dist
into ,
ma aggiungerlo ad un professore
di lettere o mat ema tica , per ché tro
vi un
fon dam ent o alla oss erv azio ne filo
sofi ca, a intr odu rre il gio van e in
alcu ne
con side raz ion i più spe cial men te app
arte
sarebbe ben e det erm ina rlo. È cer tam nen ti alla filo sofi a. Que sto con cett o
ent e util e, che cer ti inse gna me nti
sian o
fatt i in ma nie ra da risv egli are la rifl
essi one filo sofi ca del gio van e, e che
fatta in mo do da ren der e que sto inse
sia
gna me nto più edu cati vo .
Ma il sign ore inte nde che dovrebbe
pur e darsi dallo stes so professore
un
cor so ord inat o di con cett i mer ame
nte filosof ici, app arte nen ti alla log
ica ed
279
Sezione 11 - l verbali delle deposizioni
.
alla psicologia mo rale , ovvero S I co ? t�� ���bb d' quel po' di filosofia, che
eb�e � no un co rso dis ti nto ? E
il profes sar fa ins egna nd o la mate r��_
testo speoa le dovr be da rsi a tut ti i profess ori de llo Sta to
crede lei che un
. . . . .
·
na mento'.
per designare t hmltl dt que� to mseg
.
'
do che mt pare c l1e ne 11e condizioni attuali di disordine
Labnola. R tspon
.
.
.
che c'è in qu esto msegna �1 �.nt � e �� l �:a umero dei libri di testo medtocn
�
�
'
r all ind i riz zo general e di qu esta
nel senso pedagogico, mt tm t t e r p
.
.
_
soenza per eco· tamento all a n fl esswne ft' losofica e per concorrere alla. col. bbe alla riproduzione degli inconveruentt che
tura generale; e cast, st. ovvtere
ora si verifica no.
.
Ciò poi non sarebbe tl caso d't d'tre, che lo Stato ha una dottrina ufficiale,
.
. cché il modo sarebbe affatto pedagogico: e perche, s , mten
d e ch e col pro_ o
�mma siano fissati i li�� ti della filo
�� ��� è stato segu ito nei gin nasi
l
Questo concetto dell msegnamen
.
.
.f
austriaci per cm urano dettate norme speoa l'1 da due uomini eminenti ' Bo.ttz ' e E xner 2 . E questo stesso concetto s 'e' venuto mano mano accoglienn
.
do e s'è accettato dallo Zunmermann .\ . C'è stata una corrente tutta pedago'
gica inspirata dai princi � ii di Her?ar�
Questi uomini dotati dt_ un cnten� : e ramente pedagogico hanno fatto li.
. dt. testo pedagogicamente concepltt:
ma not. stamo nel caso che lo Stato
bn
.
,
.
questo movtmento f'l
1 osof'co
t , se esso non nasce spantac·
pu
���. Q�a��� t�::�
Jdio della filosofia sia così a� anzato, � he avveng����r ���
.
. .
.
sazioni non esphctte, ma tm p l"tct'te.' allora gh msegnanu sapranno
_
vano arrivare e nasceranno t b uo �ll libri di testo . Intendo che lo Stato abbia
. . elu
dir itto eli regolare qu ello sforzo m ? tv
a che non è scientifico, ma dal
�
quale nasce naturalmente que� to �� tteno p dagogic o che si lascia mo lto de'
sielerare nei libri eli matene soenttfiChe.
•
.
:
st�fi� ��
l
.
�
181 1
1888).
( 1 8 ' 1 1 836)
8 ... 8
.
l 1 1erm a rm Bon
" - Berlino
Filologo , seguace del filone di studi
nz (Langensalza
,
.
· Fu dire ttore dell ' i stru zione seconda' aristotelici che segui aIl' ed IZl· one del Bekker
.
.
e la riformò profondamente.
ria in Austna, dopo la nvoluziOne del 1
.
.
·
' li manoscntto nporta
" Lesmes , e soprascntto dalla stessa calligrafia " Eaner »; e evidente
. .
.
nella dubbiosità del segno mterrogat'vo
t
e nella d up1 tcna, d e Ila proposta (e nessuna delle d ue
.
IJ!'O(JOste trova nscontro posst'b 1' l e c 11 e lo stenografo n on Ila C''t(Jt'to Si congettura pertanto Ex.
fu con Bon.itz autore de1
ner· Franz E xner (
'
l 5 - fl
1 0sofo dt onentamento 1l e rbartiano·
. . .
.
. .
a' ustnact d opo 1a n'for ma fissando per la filosofta il enprogrammi di insegnamento det gt·nnast
'
.. .
terio di escludere dall ' i nsegnamento metaflstca
e fl
t oso f·la morale , [imitandolo alla filologta e alla logica.
Vienna settembre
Filosofo di
; Robert vou Zimmerman (I'raga novemb re
.
.
orientamento herbartiano insegnò ftlosofta ali . umverslta- d'l Olmlitz ' I'raga, Vienna; si dedicò
soprattutto allo studio dell'estetica.
joh ann Frie drich Her bart (Old e nbu rgo q maggiO
Gottinga H agosto 1 84 1 ). Filoso.
fo e pedagogtsta. I l suo program ma pedagogiCo eb be grande seguito nell e scuole elem e ntar i e
.
.
.
fondò l'Associazione di pedagogta sctensecondarie insieme con quello dt Pestalozzt. el
.
tifica che ebbe larga influenza sulla pedagogta ted esca. Labriola negli anni giovanili fu profon
damente influenzato dalla filosofia herbaruana.
_
.
·
1 802- 8 ">)
)
·
•
·
. ·
'
·
·
'
2
1824
l
.
1808
_
1776 -
·
•
.
1
1898f
280
Sezione Il - f verbali delle deposizioni
Fonti per la storia della scuota
Poniamo il caso che lo Stato, come fece a Firenze un privato , intimasse
un gran concorso di libri di testo, esso si troverebbe in un immenso vespaio
di libri , senza forse trovarne uno di buono.
Quindi si va ad un'altra quistione, la quistione delle scuole normali supe
riori dove si formano i professori di liceo. Quando avrete queste scuole,
quando presso di esse il professore avrà potuto studiare e gustare Cicerone,
Quintiliano ecc . , allora il governo potrà facilmente trovare il professore che,
oltre allo studio delle lettere, possa insegnare la filosofia. E allora si genere
rà il criterio pedagogico implicito, e ne nascerà per conseguenza il buon li
bro di testo, senza andare incontro agli inconvenienti ora deplorati, che av
verrebbero di certo, quando questo libro fosse prodotto artificialmente. È
dunque la scuola normale, che deve fare il buon professore . Io non com
prendo un professore di filosofia, che non sappia bene la filosofia ed il gre
co. Ora come si può pretendere che un giovane sappia dodici materie, men
tre il professore ne sa appena due o tre?
Un giovane domandò una volta al professore di lettere che cosa fosse la
notte di S. Bartolomeo, e il professore di lettere rispose: « badate, non è mia
competenza, domandatelo al professore di storia , . Il professore di liceo de
ve avere tutto il liceo in corpo potenzialmente . Finora sono s tati fatti ginna
si e licei come si poteva , e specialmente nelle provincie meridionali. Ma co
me si può fare, in uno Stato, che esce da una rivoluzione, e che raccoglie
quello che trova? Vi era una immensa divisione, vi erano le abitudini native
del paese, che hanno contribuito alla cattiva scelta de ' professori , ma noi
dobbiamo guardare al l ' avvenire. Io non ammetto che vi possa essere un pro
fessore di ginnasio che sia inferiore rispetto allo scolaro; perché egli sa il
greco ed il professore non lo sa, e quindi genera l 'opinione che lo scolaro
ne sappia più del professore . Che impressione può fare un professore di filo
sofia che non sa dare la spiegazione dei termini greci, che si trovano nella
sua logica?
Riguardo alla quistione dell 'insegnamento filosofico, osservo, che la let
teratura tedesca è zeppa di filosofia: e anche prescindendo da ciò, il profes
sore che spiega il Critone è in debito di sapere la filosofia . . .
Bonghi. Per ora la sopprimerebbe affatto?
Labriola . Precisamente. Io aveva chiesto di dire qualche cosa sull ' ordina
mento delle scuole liceali e ginnasiali: il mio concetto è questo . Bisogna pro
curare col tempo di cambiare questo concetto del professore: bisogna cam
biarlo . Io non ammetto punto separazione fissa: un professore che nasce e
rimane sempre professore ginnasiale, per tutta la vita. Io trovo fittizia questa
distinzione fra ginnasio e liceo: essa avrebbe ragione di essere, quando per
certi studi e certe professioni si richiedesse la licenza ginnasiale: ma oggi an
che pei farmacisti ci vuole la licenza liceale. Questa differenza non ha scopo
pratico nella educazione. La differenza sta che nel ginnasio si i nsegna per
classi, e nel l iceo per materie: l 'i nsegnamento invece deve essere tutto per
28 1
le
mate ria: il che non contradd ice, che il professor e debba conoscere tutte
alla
prima
dalla
sia
ci
che
bisogna
materie, e non sia colto in una sola. Ma
Io non
terza ginnasial e un professore che accompa gni nel latino i giovani.
que� t �
�
t
t
�
t
o
c
�
Capi
.
uità
discontin
questa
trov o nessuna ragione che ci sia
.
.
�asst e
c
��
�
10
�
dtspost
queste
tutte
ma
co;
distinzioni nel riguardo burocrati
nel
pnvtlegto
dt
concetto
questo
di
ragione
la
tut to falso: e non capisco
liceo .
Io vorrei che la classazio ne de ' professori fosse interame nte personal e a
e che
seconda del merito individu ale, e non ad arbitrio del potere esecutivo ,
:e .
titola
se
diventas
reggente
da
anni
di
numero
dato
un
dopo
il p rofessore
gmna
e
liceo
fra
zioni
�
ti
�
i
?
più
n
o
n
materia:
per
ento
nsegnam
i
ndi
�
Qui
.
; e c �e eh �
ne
�
emulazt
sta
et
n
professo
i
fra
che
ottenere
ente
possibilm
e
sio,
.
ramt
mette piede nel ginnasio e nel liceo sia capace di prendere .su se ?tverst
fare
dover
dt
di insegnam ento. Quindi non ci deve essere un concet.to ftsso
trovare
possa
non
sempre la stessa cosa. Quindi io non credo che un p.restde
�
un paio d 'ore per fare nella settiman a un corso specta e . .
dt �ar� : �m. vero mt�
po
un
Bisogna ridestare nell' animo del professo re
st ptgha Il suo uffi
re
professo
resse scientifi co e pedagog ico: mentre ora il
a rip�tere sempre,
ati
condann
è
si
cio, come un impiega to. A questo modo
.
o dt tornare
avanti
re
anda
di
desidera
ad esempio , la gramma tica: nessuno
. _
della
indietro e tutto questo dipende da una sola cosa, cwe dal concetto
.
di
ero
vorrebb
ci
Quindi
.
re
professo
del
ne
scuola 1� ormale , della formazio
.
�n
sposizio ni e provved imenti del ministero per andare a ? oco a po� o . togh �
prestdt
at
facolta
lasctare
e
,
inferiore
ed
e
superior
do le differen ze tra classe
di fare esperim enti nei singoli licei per distribui re le singole .� at �rie .
,
Potrei parlare pel greco e pel latino, ma m interessa pm dt fare alcune
osservaz ioni sulla materia del fare compon imento italiano .
parte
Cremon a. Scusi; prima di andare inanzi : lei ha già risposto alla terza .
propet
del n . 3 2 . Crederebbe lei di lasciare questa libertà pei libri di testo,
grammi?
.
. . . .
tere:
Labriola . Fino a un certo punt o , per certt bbn dt testo : non lo permet.
e
per la filosofia e per la storia. Quanto ai libri di testo ?e.r l� gram.� attca
gna
�
ms
l
ma
hbn;
�
una tirannia quella che si esercita di fare accettar e certi
St
mento della filosofia deve essere determi nato. Così accade per la stona.
o
dice : la storia dà i fatti; ma c'è sempre u na valutazio ne de' fatt i : che devon
valu
Questa
.
giudizio
suo
l
i
rre
essere valutati innanzi a l giovane e predispo
.
tazione non dovrebbe essere lasciata assoluta mente in balia del prof� ssore
.
i
insegnat
d'essere
degni
legali
libri
di
Ci dovrebbe essere una somma
Io
Poi vorrei c h e i giovani avessero p i ù libertà nel disporre . l e materie .
o
guardat
o
h
10
:
loro
fra
amento
l'insegn
ero
dividess
si
ri
vorrei che i professo
:
e
ran
�
s
molto
cose
�
n
succedo
quali
ne'
,
tedeschi
ginnasi
'
de
i programmi
_ s t sup
perche
altro,
l
fa
o
l
ora
uno
'
l
fa
o
l
ora
filosofia
della
l ' insegnamento
pone tanto buon senso da non andare nelle nuvole; e non c'è un professo re
.
speciale.
282
283
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
Cremona. Ma il programma vorrebbe che fosse fatto dallo Stato, o dal con
·
siglio de' professori, o da un consiglio generale di tutti i professori?
Labrio/a. Quanto a questo non rispondo; non saprei proprio dare un avviso
che fosse maturo; potrei dire una opinione accidentale.
Presidente. Continui pure nel suo ordine di idee.
Labriola . Devo fare una osservazione sul componimento italiano. È una co
sa spaventevole a dirsi: i nostri giovani scrivono peggio di quello che si scri
veva quaranta anni fa. La causa è questa che i professori di lettere italiane,
buoni, come c ' erano u na volta, che mettevano molta cura nella lettura de'
classici, sono andati diminuendo: ed è andato invece crescendo il capriccio
della teoria nelle nostre scuole ginnasiali e liceali . Bisogna trovare un serio
provvedimento a ciò. I nostri giovani cominciano a riflettere troppo, e quin
di scrivono malissimo perché non trovano il bandolo per iscrivere. Io ho
trovato pochi professori che si sieno formati questo concetto: non s ' è mai
detto loro che al giovane bisogna far dire quello che è capace di dire: e co
me volete che un giovane di dieci anni vi descriva Attilio Regolo? Come tro
vare le parole? Se non ha i pensieri? Quindi bisognerebbe rimettere rigorosa
mente nelle scuole l ' esercizio del leggere molto, e che il professore desti
l ' at tenzione minuta di chi legge . Gli uomini tanto sanno in quanto mandano
a memoria: si faccia scrivere a scuola, e che il professore porti con sé a casa
i componimenti e li corregga : e invece di far fare un lavoro astratto, spesso
si dà una sentenza morale, da cui un giovane di quind ici anni deve cavare
u na narrazione. Quindi i nostri giovani, oltre che non sanno scrivere, porta
no cattivi concetti, storti e stravagant i : e posta la cattiva filosofia del liceo,
ne nasce un pervert imento . La disgrazia è che questo lavoro sarebbe troppo ;
perché quando io ho letto a casa i trenta temi de' miei scolari, resto stupidi
to per una settimana. Ma io non so capire come nella testa de' giovani si ac
cozzino tante parole vuote di senso, e si faccia vedere che sieno egregiamen
t e preparati , e ciò per mezzo di frasi prese dal mercato, e con allusione alla
politica. Non c ' è nulla di vero in tutto questo .
Io non posso esporre una serie di concet t i , ma dico, che bisogna rimette
re verità non astratte nelle teste dei fanciulli , perché così solamente si abi
tuano poi a diventare uomini . Non bisogna ad essi insinuare dei sistemi filo
sofici prima del tempo . È un errore madornale del tempo e dell ' i nsegnamen
to nostro.
Credo che ci sia qualche cosa di speciale sull ' i nsegnamento religioso.
Presidente. Vorrebbe dire qualche cosa sulle scuole private di Napoli e sul
l ' insegnamento religioso?
Labriola. Sulle scuole private altri ha già parlato : le scuole private di Napoli
sono pessime , non già perché i professori sieno pessimi, ma perché sono in
mano a chi ne fa speculazione. Io stesso sono stato professore privato, e
non voglio qui fare la mia apologia: molti de' professori delle scuole private
sono od erano professori delle scuole governative. Qui c'è una quistione se-
ria . Le scuole private sono in mano ad una speculazione che è fat ta con cat
t iva intenzione. Prima del ' 60 le scuole private erano in buona opinione,
perché il governo insegnava malissimo. Questa opinione è rimasta, perché
molti credono, che al governo bisogni far sempre opposizione . Ora che cosa
è avvenuto dal ' 60 in qua? Si sono accumulati tutti questi esami. La legge è
molto larga: essa permette l ' insegnamento purché si abbiano t itoli equipol
lenti ; i quali si sono tanto dilatati, che tutto vale per ti tolo equipollente. Il
numero di quelli , che possono insegnare confina col numero degli abitanti
della città! Il tale o tal altro domanda al principio dell ' anno il permesso di
aprire una scuola, a cui dà l ' apparenza di ginnasio o di liceo. Si cerca che un
galantuomo dia il nome a queste scuole: e quest' uomo che era buono finisce
per divenire cattivo, oppure se ne va via. Questa speculazione privata sarà
frenata dal fatto dell'intervallo dei tre anni 1 : perché allora questi giovani
non volendo sciupare il tempo forzeranno il direttore degl' istituti privati a
fare dei miglioramenti : quindi nasce che gli insegnanti privati e gli specula
tori dovranno riformare la scuola.
C'è un inconveniente alla Università di Napoli, quello cioè che i giovani
non sono obbligati a prendere iscrizioni, e possono andare quando voglio
no. E così molti giovani invece di venire al liceo vanno alle scuole della uni
versità: uno interrogato disse : " io sono stato alle lezioni del professar Set
tembrini » ; u n altro disse : <do sono stato dal professar Mirabelli » : insomma il
giovane, non dovendo presentare nessuna garanzia, il giovane va dove vuo
le; e perciò l ' intervallo de' tre anni riesce di poco effetto. Il provvedimento
de' tre anni non riesce a frenare le scuole private. Quindi le guarentigie del
le scuole private, e qui principalmente, devono essere più rigorose nel senso
che i titoli, che si devono richiedere per l ' insegnante privato, devono essere
quelli della legge, e che si deve mettere freno ai titoli di equipollenza, am
messi dai consigli scolastici. Io mi ricordo di u n regolamento , il quale pre
scriveva come si dovessero sottoporre gli insegnanti ad un esame di idonei
tà. Abbiamo un cumulo di vecchi insegnanti, abbiamo un cumulo di profes
sori che hanno un permesso temporaneo . Questo si è convertito in una con
dizione di titolo anticipato, che non si può più discutere . Per questo ci vuo
le la statistica. Bisogna fare una inchiesta speciale: e regolare i dati per sco
prire chi sono quegli individui: bisogna domandare il registro di iscrizione e
sapere in che modo l 'individuo ha studiato, e in che modo insegna. Qui s i
entra i n una questione complicata di diritto pubblico: m a finché n o n si arri
va a quel punto lo Stato deve trovare mezzo come accertare la capacità del
l' insegnante. Nella pratica io toglierei l ' abuso che dipende dall 'indulgenza
del provveditore o del consiglio scolastico. Ma certe guarentigie forse non
bastano, perché la frode si sottrae a tutte le sorveglianze. Le scuole privat e ,
salvo alcune eccezioni, siano o non siano clericali, hanno effetto n e ' giovani
1
Vedi doc.
22, p. 272,
n.
2.
28'!
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - t t•erbali delle deposizio11i
di eccitare l ' odio all' istruzione del governo sotto il profilo degli esam i . I gio
·
vani vengono agli esami non solo svogliati per la loro insufficienza, ma per
ché credono di fare quello che a Napoli si dice una guapponata, che cioè
hanno opinione anticipata che si deve fare resistenza ai professori, per cui si
vogliono prendere una soddisfazione cont ro di essi.
Non credo che vi siano uomini così cattivi e credo che gli uomini siano
educati piuttosto al bene che al male. La industria privata, che si mantiene
da molto tempo, predicando che le scuole governative sono cattive; come si
possono tenere in piedi questi magazzini, queste botteghe di scolari? Esse
non si mantengono che così: il giovane ha sfiducia in quella scuola che pos
sa intendere il concetto dello Stato . Ora egl i è abituato a considerare la
scuola, come un mezzo di eludere la legge dello Stato. E quindi che nasce
nell ' animo de' giovani? Non voglio fare il filosofo. Ci si trova quello che ci
si mette. Se questi giovani fossero stati educati bene, e fosse stata loro incul
cata la santità della scuola ciò non avverrebbe. Qui non è questione di liber
tà o non libertà: se la cosa procede di questo passo in meno di venti anni la
nostra città sarà imbarbarita.
Tutti mettono opera a screditare la istruzione, e i giovani vengono alla
università storpi e moralmente guasti: e posti i giovani i n queste condizioni,
la università trova dinanzi a sé difficoltà, che è inerente non solo all'inse
gnamento, ma anche al giovane, che è stato così educato. Tiene in pochissi
mo conto l ' autorità del professore, e ciò pel cattivo ambiente in cui è vis
suto.
Presidente. E sull ' insegnamento religioso?
Labriola. Dirò due sole parole. Si domanda se produca buoni effetti. Io per
me ritengo che il come stanno ora i licei quanto a insegnamento religioso è
cosa storpia che fa male perché anzi tutto si tiene un prete che un giorno o
due clelia settimana riunisce i giovani dai quattro, cinque, sei anni fino ai di
ciotto in una gran sala e fa u n discorso. Io non so se si possa fare un discor
so , che si faccia comprendere da tutti. Capisco che vi sono pratiche religio
se che si compiano da tutti, per esempio nei convitti; ma io qui parlo della
istruzione religiosa . Qual è quel discorso che può esser fatto per essere inte
so da tutti? Io non lo comprendo. La conseguenza pratica è questa: io so di
licei, in cui i presidi sono severissimi e la disciplina è ben conservata in tutte
le lezioni tranne che nella lezione religiosa, l ' ora della quale è un'ora di
scandalo. Questo è un fatto. Lo Stato intende d i mantenere l ' insegnamento
religioso per la educazione, lo vuole tenere per la influenza che esercita sui
genitori, e per un'indulgenza verso i medesimi. Bisognerebbe chiarirsi sopra
questo concetto, che sarebbe molto discutibile. Spesso accade che questo
prete dica delle cose che non deve dire, o in un senso o in un altro . Che av
viene? I ragazzi portano in iscuola la discussione . Io mi ricordo che un inse
gnante governativo di religione mi ha detto che alla scuola di religione do
veva calmare i giovani, che venivano indiavolati alla cappella dopo essere
stat i alla ginnastica. E poi dove si piglia il p rete? Si piglia il prete liberale se
parato dalla Chiesa e non si soddisfa la famiglia. Se si porta un prete che ser
ve la Chiesa allora si porta un principio di dissidio. Ora c'è la questione di
versa sul convitto, e sul ginnasio e liceo senza convitto. el liceo e ginnasio
senza convitto si deve abolire . Dove c ' è convitto bisogna trovare un tempe
ramento perché oltre alle semplici pratiche religiose l' insegnamento religio
so sia dato in modo da corrispondere alla diversa età dei giovani, che natu
ralmente i genitori intendano ben affidato alla tutela dello Stato, e far sì che
il prete spieghi il Vangelo e tragga da esso conclusioni morali senza predica
re . Se questo insegnamento non si coordina agli altri insegnamenti, che si
fanno nel liceo, è più dannoso che ut ile. Q uesto si intende in un paese pro
testante diverso dali ' Italia, cioè nei ginnasj prussiani. Nei paesi protestanti
tutto è basato sulla discussione della Bibbia. Si fa esercizio di greco e insie
me di morale e religione . L'insegnamento religioso si intende che corrispon
da alla maggioranza dei cittadini.
Si intende che lo Stato non possa produrre nel seno del liceo stesso un
elemento di perturbazione . Quindi se non si potesse trovar modo di rendere
educativo l' insegnamento religioso, che cosa fa che questo prete porti gli
scolari in chiesa alla messa e alla predica? Quando c'è questo indirizzo edu
cativo, serve allora l' insegnamento religioso a gettar polvere negli occhi?
No, perché tutti sono convinti che la cosa va da sé. Io non so a che serva un
insegnamento eguale dato a diverse età e diverse classi. Io non credo che i
genitori tengano in fondo molto alla istruzione religiosa; finora v'è stato u n
pregiudizio, m a questo svanirà, quando si vedrà in effetto c h e l e scuole go
vernative sono migliori delle altre. Tutto sta che non si dica che la scuola
abbia uno scopo antireligioso. Non si corre questo pericolo, quando l ' i nse
gnamento di religione sia tolto e quello della filosofia sia ridotto , e si faccia
più serio invece di fare tante chiacchiere . Allora si avrà un punto in cui tutti
concordano. Questo insegnamento religioso , se si vuoi dare , si conduca al
punto, che, senza cessare di essere strettamente cattolico, sia benanche edu
cativo; e per coordinarlo cogli altri insegnamenti, sarebbe utile che i l profes
sore di religione prendesse parte al consiglio dei professori nel discutere sul
le varie parti de ' diversi insegnamenti. Se s i vuole la predica tanto fa che si
dica ai genitori: « Conducetevi i bambini » . Farebbe lo s tesso . Quindi questa
condizione di cose si deve studiare . La quistione si deve guardare nello Stato
in cui è vedendo i diversi licei e interrogando il preside che vi dirà t u t to
quello che gli è occorso per l ' insegnamento religioso. Io posso assicurare
che questo insegnamento religioso è causa di perturbazione . Il fatto potrà
avere spiegazioni diverse ma il vero è che l ' i nsegnamento religioso come si
fa ora è tempo perduto. Si potrà proporre anche u n diverso rimedio. Natu
ralmente in quello che ho detto ho inteso distinguere la mia opinione dalla
semplice osservazione dei fatti . La Commissione d ' inchiesta come ho detto,
potrà avere maggiori schiarimenti dai presidi degli istituti.
285
2 86
287
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l t•erbali delle deposizioni
Presidente. Per la cognizione che ha dei licei di questa provincia crede che i
maestri usino tutta la cura a che l'insegnamento non sia dato con indirizzo
antireligioso in modo da far diffidare le famiglie?
Labriola. Mi pare che questo indirizzo religioso non manchi , perché difficil
mente è accaduto che vi siano individui così strani con la proposta di gene
rare nella mente dei giovani queste opinioni ant ireligiose. Anche nelle no
stre provincie dal 1 860 in qua la fiducia nei licei governativi è andata cre
scendo anche dove c ' è maggiore superstizione . Se ne ha esempio nel liceo di
Maddaloni; esso è posto in un ex-convento e ha sofferto molto nei primi an
ni. Si diceva che era stato messo nel convento di S . Antonio e che non vi si
doveva perciò andare. Ora è così zeppo di giovani, che non è più possibile
accoglierne dei nuovi, e nessuno ci p uò più andare, e Maddaloni è una città
pretesca. Si deve vedere se dal modo con cui i professori si atteggiano , se
dal complesso dell' insegnamento stesso può nascere il sospetto di un indi
rizzo antireligioso, e questo può darsi secondo gl' individui e i luoghi, e
quindi si veda se realmente questo insegnamento non è antireligioso. Sebbe
ne ora non si conducesse l'insegnamento a questo modo, molti credevano
che gli si desse quest'i ndirizzo antireligioso. A ciò spinge anche la opinione
più o meno favorevole al nuovo ordine di cose. Questo inconveniente cessa
di prodursi ora che gli animi sono raffreddati . Ci saranno dei casi speciali in
cont rario, ma in general ità vale quello che ho detto, che cioè dall 'insegna
mento della filosofia nasce un esquilibrio e un'incertezza nella mente dei
giovani .
Tenca. Dica qualcosa intorno agli esami di licenza liceale. Crede troppe le
materie, e crede utile dividere l ' esame in due o tre stadj con l ' intervallo
d ' u n anno o di parecchi mesi ?
Labriola. Non credo che le materie siena soverchie purché si convenga nel
concetto di togliere la filosofia come ramo speciale di insegnamento. Potrei
ragionare di questo mio convincimento. Il liceo ha il doppio ufficio di crea
re la coltura generale di chi non attende agli studj professionali e per prepa
rare alla università. Di quelle materie nessuna è superflua. Il naturalista dirà
che è soverchia la filosofia, l ' avvocato che è soverchia la matematica e così
via. Io vorrei forse che si desse meno matematica e piuttosto sarebbe utile
farne meno ma meglio. Credo però utili queste scienze perché servono ad
educare l ' intelletto . Appunto io non ammetto questione su ciò perché non
saprei che materia togliere perché sento dire in senso opposto dall ' uno e
dall ' altro . Il latino niuno mette in dubbio che non ci debba essere perché,
lasciando stare se ve ne sia troppo o poco, la sua utilità è dimostrata dalla
esperienza. Dal punto di vista pedagogico siccome la lingua greca ha una
grande efficacia pedagogica alcuni vorrebbero cominciare dal greco. Si dice
che il latino è più utile, perché se ne fa più uso, ma il liceo non ha solo l ' uf
ficio di preparare degli avvocati a studiare il Digesto. Non si può togliere
nessuna materia , se si vuol dare la coltura generale; e non credo più ragione-
vole togliere una materia invece di un 'altra . on si deve togliere nulla dal
concetto della coltura generale, ma si deve trovare un mezzo che stimoli poi
i giovani a far da sé. Trovo questo, che quando il liceo fosse ordinato come
dico io, si dovrebbe togliere il concetto della perfezione assoluta, perché al
lora nasce naturalmente la indulgenza. Si capisce come si dà la licenza; si dia
a un giovane bravissimo nel greco e insufficiente nella matematica. Si com
prende che non ogni giovane può essere un Vico . Vi potranno essere casi
eccezionali; ma non ci si deve applicare a questi per essere estremamente ri
gorosi. Quindi bisogna che si modifichi il concetto del professore e che le
materie non sieno dislegate l ' una dall 'altra, ma che per esempio la storia ser
va a completare la letteratura. Anzi il liceo come [e] ora mi pare imperfetto
perché mentre prepara alla conoscenza delle matematiche non prepara alle
discipline morali e sociali . E perciò dico che l ' i nsegnamento morale deve es
sere congiunto alla filosofia. Quanto alla divisione delle materie dell' esame
io credo che quello si potrebbe così accomodare che ora stabilito l ' interval
lo dei tre anni si potrebbe dividere l'esame di licenza liceale in due sezioni
d' esame una di lettere, e l' altra di scienze perché quella è u na condizione
triste di dover fare in un determinato giorno tanti esami. Io però lascierei
sempre sussistere l ' intervallo dei tre anni, tra l ' una e l ' altra parte degli esami
dovrebbe correre un anno. Così si ovvia all' inconveniente che il governo
debba sempre concedere quelle benedette riparazioni, che a nulla giovano,
poiché in capo a un anno i giovani sono più asini di prima.
Presidente. M i sembra che abbia accennato al sistema di misurare la capacità
dell ' esaminando dai punti. È contrario a questo sistema e quale vi sostitui
rebbe ?
Labriola . Io sono contrario partendo dalla supposizione che l ' insegnamento
governativo al sistema dei punti senza tener conto del profitto del giovane ' .
Io comprendo un attestato di maturità basato sul profitto del giovane a Tori
no, dove tutti vanno alle scuole pubbliche . Ma qui noi abbiamo scuole p ub
bliche poco frequentate pel passato, e quindi non comprendo questo con
cetto di maturità a Napoli, dove vi sarà u n migliaio di scuole private. Questo
concetto comincia per l ' insegnante da un complesso di circostanze. Ora io
non saprei intendere come questo criterio si possa formare a Napoli. Esso
non si può trovare in un semplice esame . Il professore così nel momento
dell' esame si muove a compassione ovvero fa l ' opposto non avendo dinanzi
a sé i giudizj antecedenti sul giovane. Bisognerebbe seguire il giovane nelle
scuole private. Se lo Stato lasciasse libertà alle scuole private, ma però le
sorvegliasse, st potrebbe attuare il mio sistema.
Presidente. Io intendo benissimo la difficoltà di tener conto del profitto de
gli scolari che vengono dalle scuole private. Ma ora vi sono due sistemi di
dare i punti, uno dei numeri, la somma dei quali costituisce la media. C ' è
' L a frase non
è compiuta o è riportata lacunosamente.
288
289
Fonti per la storia della scuola
Sezione !l - l uerbali delle deposizioni
l ' altro sistema, pw semplice, di dire : questo giovane è da approvare o no.
Raccolti i voti delle persone che compongono la commissio·ne d'esame ecco
che il giovane riesce approvato o no. Crederebbe utile questo sistema o
l ' altro?
Labriola . Io credo che questo sistema dell 'attestato di mat urità sia sempre
preferibile; nella pratica è lo stesso perché quando i professori si mettono
d ' accordo nel fare i punti è perché partono dal concetto di dare la maturità .
Quelli che sono approvati non l o sono perché è avvenuto, perché per caso i
professori si sono accordati . I professori si accordano nel dare i punti per
ché i professori hanno anticipatamente determinato il concetto di maturità.
Nei licei governativi io vorrei che nel dare la maturità i professori tenessero
conto del profitto . Vorrei che pei giovani dei licei governativi rimanessero
due esami nelle due ultime classi, perché solo così dei licei governativi si
potrebbero fare dei licei modello dell ' i nsegnamento . È una cosa brutta che il
giovane sia presentato alla ventura e si trovi dinanzi a commissioni nuove,
quindi deve essere esaminato dai professori del liceo. Nell 'altro modo spes
so accade che il merito sparisca per accidente. Qui cade la quistione se i li
cei si debbano aumentare o diminuire. Io credo che bisogni ora diminuirli
perché non vi sono insegnant i . Bisogna creare u na guarentigia per le scuole
private; lo Stato non può far tutto, e quindi deve trovar modo che gli altri
facciano tutto quello che possono e vogliono secondo i regolamenti.
Presidente. La Commissione la ringrazia.
famiglia, e intorno all 'ordinamento degli esami; poiché trovandomi da sette
od otto anni esaminatore in questa università, e avendo fatto parte di diverse
commissioni d' inchiesta governative, mi sono formato alcuni criteri d'apprez
zamento, ed un certo modo di vedere che sarei fortunato di poter esporre .
Presidente. Anzi questi sono i punti che più interessa alla Commissione di
chiarire, e la Commissione sarebbe molto grata, se volesse su ciò dare schia
rimenti. Se vuole cominciare dal primo quesito che tratta de' rapporti fra gli
insegnanti e le famiglie, e che dice : « l presidi, i direttori e i professori delle
scuole secondarie pubbliche » ecc. (vedi quesito 6) .
Capone. Dico francamente, e non esito a dichiarare, che, secondo me, non
meritano, in massima parte, la fiducia delle famiglie. Quello che dico mi ri
sulta dal fatto che, quando s ' è trattato di mandare i miei figli a scuola, non
trovai quasi negl ' istituti governativi persone che mi inspirassero fiducia; ed
in quel periodo, difficilissimo della mia vita, preferii incontrare qualunque
più grave spesa, piuttostoché affidare i miei figli all ' i nsegnamento ufficiale .
La ragione precipua ne fu (ed essa ragione dura tuttora) che l ' insegna
mento secondario in Italia, piaccia o non piaccia, era già caduto, e vi si man
tiene ancora, in mano di persone le quali non inspirano fiducia appartenen
do esse, in gran numero, ad u no stato sociale che ripudiavano . Certo ho de
bito di rispettare le loro opinioni; e le rispetto, ma chi comincia dal presen
tarsi con una abjura non mi inspira grande fiducia né parmi che sia il miglior
modello da proporre a giovinetti. A ciò si aggiunga, che siccome conosco
direttamente alcune di tali persone, non si peritarono, e non si peritano, di
professare massime immorali e di vivere immoralmente; era quindi possibile
ch' affidassi i miei figli a tale classe di gente? Ed è da desiderare che genitori
onesti lo facessero oggi? Quanto a me preferisco l ' ateo al cinico: e purtrop
po i cinici non mancano tra gl' insegnanti governativi. Io ne conosco perso
nalmente e voglio a questo proposito citare un fatto particolare.
Una mia sorella ha molti figli, (dodici) : tra questi ve n ' era uno, che, a
mio consiglio, era stato mandato al liceo della città dove mia sorella vive.
Era un bambino intorno ai nove o dieci anni il quale in casa non mostrava
volontà alcuna di studiare e d ' applicarsi. Noto questo, perché prima d ' anda
re al liceo, era tutt' altra cosa. Malgrado che il padre e la madre gli tenessero
un ripetitore, persona capace e di fiducia, p ure non si concludeva nulla. Una
mattina il bambino tornò a casa ad ora insolita. La madre ne cercò la ragione
ed il bambino confuso balbettò varii pretesti e finalmente rispose: « questa
mattina non c'è stata lezione '' . La madre non soddisfatta tempestavalo di
domande alle quali finalmente il bambino replicò : « il maestro ci ha congeda
to, dicendo che andassimo a passeggiare, perché non aveva volontà di far le
zione. Io non sapeva dove andare e son venuto a casa » . La madre non gli
credette e volle verificare la cosa. Ma la sua meraviglia fu grande, avendo sa
puto che cotesto era un uso non raro di quel maestro e che ben altre volte il
bambino, più ubbidiente, erasene andato a zonzo invece di tornare a casa. Si
FILIPPO CAPONE
1
Capone. Ho dimenticato in Roma i questtt, e siccome non sono inse
gnante , prego la Commissione di rivolgermi delle domande, o di permettere
ch ' io dica il mio modo di vedere sull'attinenza della scuola secondaria colla
1 Filippo Capone (Montella, Avellino, 2 5 maggio 1 82 1 - Nocera 1 2 giugno 1895). Laureato
in giurisprudenza a Napoli vi frequentò gli ambienti liberali entrando in contatto con Francesco
De Sanctis e Luigi Settembrini. Partecipò alle cospirazioni politiche del 1 848 aderendo alla so
cietà segreta " Unità d ' Italia ». La sua attività fu scoperta e Capone fu costretto all'esilio a Geno
va e poi a Torino dove nell'ambiente degli esuli meridionali maturò le sue posizioni politiche
aderendo sempre più alle idee dei liberali moderati. Tornò a Napoli nel 1 860 e rivestì diverse
cariche. Prima intendente della provincia di Avellino, poi sostituto procuratore generale presso
la Gran Corte criminale di Chieti, quindi di Napoli. Professore onorario dell 'Università di Na
poli, deputato del collegio di Sant'Angelo dei Lombardi per cinque legislature fino alla caduta
della Destra. Senatore del regno dal 1 889, proseguì la carriera di magistrato fino al collocamen
to a riposo nel 1 89 3 . Le due deposizioni che Capone rese alla Commissione d'inchiesta si sof
fermano in particolare sull'esame dello stato dell 'istruzione nelle provincie napoletane, con
forti accenni di denuncia per il proliferare degli istituti privati sui quali il governo non riesce ad
esercitare un effettivo controllo, ma al tempo stesso per le poche garanzie offerte dagli istituti
governativi specie sotto l'aspetto della serietà e moralità degli insegnanti, specie di quelli che
a,·e,·ano svestito l'abito di religiosi. Infine Capone descrive vari episodi di truffe e di guappona
te agli esami a Napoli.
. .
290
Sezione II - l l 'erbali delle deposizioni
Fonti per la sto1·ia della scuola
fecero, per via indiretta, giungere lagnanze al professore, avvertendolo, che
quando non gli tornasse commodo di far lezione, ne avvertisse le famiglie,
anziché mandar vagando i bambini per la città. Il signor professore il giorno
dopo non si peritò di maltrattare il bambino in iscuola, ed in grande ira apo
strofollo dicendogl i : « lo vi mandai a spasso : perché andaste a casa? Potevate
andare . . . , Scusate . . . la parola è troppo indecente, perché io la ripeta. Que
sto è il fatto: e quel professore insegna ancora nello stesso liceo governati
vo, ma mia sorella pose suo figlio in seminario. Ebbe torto?
Il mio amicissimo collega Settembrini fece nell'altro anno parte, con me,
di una commissione d'inchiesta nominata dal Ministero della pubblica istru
zione 1 • Nostro malgrado dovemmo entrare in fatti che non erano nel nostro
mandato; ma siccome erano lamentanze, che ci venivano da tutte le parti,
non potemmo non raccoglierle . Q uindi sapemmo che il reverendo preside
di un liceo governativo conduceva vita assai scandalosa e pubblicamente sa
pevasi che, con tutta la sua riverenza, due volte la settimana, abbandonava il
liceo e andavasene da u na sua amica, in un paesello vicino. Riferimmo, fra
l ' altro, questo fatto ben accertato. Quel signor preside, non per questo, ma
a cagione di aver reso possibile ad un inserviente di sottrargli i temi per gli
esami liceali di quell 'anno si ebbe sei mesi di sospensione, e dopo fu tramu
tato , con la stessa carica, in u na città più nobile ed assai più importante di
quella in cui era prima!
Ora allorché i padri di famiglia conoscono cose di tal sorta, e le sanno
indubbiamente note al governo e non corrette, come è possibile che abbia
no fiducia negl ' istituti governativi ? Se a questo proposito s'entra nel campo
officiale vi avremo a notare cose ben gravi circa la prevalenza di raccoman
dazioni e d'influenze personali . Né i tristi casi vi son rari. In vero , basta do
mandare gli antecedenti d ' u n gran numero d ' i nsegnanti governativi e si
avranno esempii innumerevoli di un lassismo eccessivo di una tolleranza
che non esito a qualificarla colposa, e per la quale, sove�t i volte, accusati d l
fatti immorali indubitabili, si è stimato punirli abbastanza col tramutarli da
u na provincia all ' altra! Domando, è in questo modo, che si fa il bene dell ' in
segnamento? È così che si mantiene morale ed esemplare? Né è tutto; cono
sco io professori che, anche in alcune delle più cospicue città d ' Italia tengo-
1 I n seguito a una fuga di temi agli esami di licenza l iceale a Napoli nel 187 1 (i temi di latino
e greco, sottratti a Salerno erano stati venduti a Napoli e a Maddaloni), fu nominata una com
missione d 'inchiesta della quale facevano parre Settembrini e Capone. La relativa relazione, che
non presente tra le carte dell'Archivio centrale dello Stato, è conservata a Napoli nell'archivio
privato Pe:_ssina: vedi in proposito L. SETTHtBRIN t , Lettere edite e inedite 1 860- 1 876 . . cit . , pp.
1 50- 1 5 1 . E probabile che Settembrini, impressionato da questo e da altri consimili episodi, fre
quenti nel Napoletano, scrivesse nella sua proposta di quesiti per l'inchiesta (ibid. , p. 273):
Per qual cagione, per quale grande interesse parecchi di essi (se. padri di famiglia) danno da
naro ai loro figliuoli che fanno esame di licenza liceale per comperar le risposte alle tesi, cor
rompere serventi per introclurle, e fare altre cose simili che l'onestà riprova' ».
è
.
•
29 1
no un linguaggio in iscuola il più villano e volgare ed improntato di un cini
smo ributtante. Non avrei difficoltà di declinar nomi , ove ne fossi richiesto,
dacché codeste cose mi constano per fatti e per nomi ben precisi . Sono essi
fatti appunto che mi confermarono, sempre più, nel convincimento di non
poter far mettere ai miei figli piede nelle sc uole ufficiali.
Dal fin qui esposto emerge un 'altra conseguenza, la ragione cioè, per cui
gli istituti religiosi sono più frequentati, e per cui molti padri di famiglia,
notissimi e saldissimi liberali , hanno più fiducia di affidare i loro figli ai fra
ti, anziché agl ' i nsegnanti e agl ' istituti governativi. A questo proposito potrei
qui aggiungere assai istruttivi esempii, ma trattandosi di cose notissime, li
tralascio . Il mio concetto, se debbo esprimerlo tutto, è che l ' insegnamento
officiale domanda serissime riforme; ma non ho gran fatto fiducia che il go
verno le possa compiere.
Presidente. Ella ha accennato a fatti speciali dolorosi e dispiacenti; ma per la
cognizione che ella ha delle varie parti d ' Italia, e per la cognizione che ha di
questa materia, crede lei, che questo stato di cose si possa generalizzare a
tutta la istruzione secondaria, o che non sia p iuttosto stata una infelice scel
ta di personale che sarà stata o può essere corretta? Crede lei, che questo sia
il concetto che si deve formare dello stato generale dell' istruzione?
Capone. Ella sa, che le vicende della mia v ita politica (giacché fummo insie
me in condizioni ben diverse dalle attuali), mi portarono a conoscere molte
parti d ' Italia, e le quali pruovai a studiare il meglio che potei . Indi le dirò
aperta la mia opinione. In generale credo , che più o meno quella da me la
mentata è una infezione, che può patire eccezioni di località e di individui,
ma affetta sventuratamente, tutto lo insegnamento governativo ed in tutto il
regno. Mi spiego. Quando vedonsi promossi e mandati in u niversità profes
sori, che insegnano apertamente idee con trarie ad ogni sentimento di reli
gione, professori le cui dottrine materialistich e debbono logicamente negare
ogni legge morale, dovrei concludere che il governo vuole appunto negata
la religione e la morale 1 • Debbo concludere che vuole che cotesto diventi i l
sistema generale. I n verità n o n s o capire p erché nella università debba i nse
gnare ufficialmente chi si rimove dall ' insegnamento secondario per aver of
feso colle dottrine professate nelle scuole secondarie il sentimento generale.
In ogni modo è certo che un professore, conosciuto da quanti siamo in Na
poli come degnissimo insegnante, fu rimosso da una cattedra liceale sola
mente perché deferendo alle idee del G ioberti, non insegnava secondo He-
1 Si riferisce al caso di Andrea Angiulli, professore di filosofia al liceo Vittorio Emanuele II
di Napoli, accusato eli diffondere dottrine atee dal direttore spirituale e da parecchi genitori e
rimosso dalla sua cattedra; il ministro Correnti, per risolvere la questione, lo allontanò dall'in
segnamento secondario e lo nominò incaricato di antropologia e pedagogia all' università, susci
tando le proteste dei clericali che giudicarono scandaloso che l'ateismo fosse viatico per una
carriera universitaria.
292
293
Fonti pe,· fa storia della scuola
Sezione Il - / uerbali delle deposizioni
gel o secondo non so chi 1 ; egli fu sostituito da un altro , che propugnò in un
libro stampato le conclusioni le più materialistiche a cui si possa mai venire;
rispetto, lo ripeto, le opinioni di tutti; ma sono padre di famiglia e non man
do i miei figli a coteste scuole e da tal sorta di professori. E poiché guardan
do più innanzi scorgo essere u na condizione imprescindibile dei paesi e dei
governi liberi che si professi e s' insegni nelle scuole governative qualunque
opinione e qualunque dottrina (non ci è cosa a questo mondo che non abbia
un lato buono e un lato cattivo), così mentre ripeto che non spero gran fatto
nelle riforme su questo capo dello insegnamento, accenno qui a conclusioni
forse eccedenti il tema della presente inchiesta. Mi spiego . Gli uomini che
son chiamati ad assumere nei paesi liberi il governo della somma della cosa
dello Stato sono additati dalle parti polit iche e dalle condizioni parlamenta
ri ; quindi lo indirizzo ch'essi vi portano, soventi può non trovarsi di accor
do colle opinioni della maggioranza del paese. Certo discorderà sempre da
un gran numero di opinioni, non meno rispettabili che la sua . Comunque
sia, nessuno di sicuro potrà pretendere, che un ministro di pubblica istruzio
ne governi questa secondo i concetti e i modi di vedere di Tizio e di Caio,
piuttosto che secondo i suoi proprii e personali convincimenti. Anzi quanto
questi sono più profondi e pieni, tanto più debbe adoperarsi per farli preva
lere . I ndi è che s ' egli per esempio credesse pregiudizio vano una data cre
denza religiosa, che meraviglia sarebbe il vedergliela combattere? Poniamo
che pensasse sola dottrina vera la materialistica, potrebbesi pretendere che
favorisse le dottrine etiche di un platonico o del catechismo tridentino? Chi
di noi non incontrò nomi, anche i n altissimi posti, i quali ridevano e crede
vano di poter impunemente scherzare con certe idee e certe opinioni? Se ciò
è nella stessa intrinseca natura delle istituzioni politiche dello Stato, che fa
re? Se un min istro la intende in u n modo, ed un altro diversamente, quale
sarà (non dico la riforma) ma l ' indirizzo nel quale si possa u niversalmente
consentire? Stando ciò domando io, come può il governo pretendere d ' im
porsi? La moda oggi è di dare del clericale a chi intende l a morale più stret
tamente. Molti han paura di questo nome, altri invece è gente che tira dirit
to come gli detta la sua coscienza. D i conseguenza la giustizia e la reciproca
libertà dicono che il miglior rimedio è di lasciar ad ogniuno la possibilità di
educare i figli come vuole. Il governo vada per la via sua, e lasci le famiglie
andare per la via loro. Ma quello di volere monopolizzare la istruzione sotto
pretesto che i giovani non divengano clericali, l ' esperienza c ' insegna già
ch'è u n tentativo impossibile, facile ad immaginare ma in fatto vano, del tut
to. Violentasi l ' altrui coscienza e non si approda a n ulla.
Quindi smettiamo di pretendere di sostituire lo Stato alla coscienza del
padre di famigl ia, e rispettiamo in tutti la libertà di educare e d ' i nsegnare.
Tenca. Ella ha detto, che alcuni fatti di immoralità nel personale insegnante
avrebbero gettato discredito sulla totalità delle scuole per modo che i padri
di famiglia allontanino i figli dalle scuole governative, e preferiscano di
mandarli alle scuole tenute da religiosi . Crede sia questo il vero motivo, dal
momento che pure vediamo anche nei convitti retti da corporazioni religio
se, disordini e scandali non meno gravi, e forse qualche volta più gravi di
quelli che ella accennava per le scuole governative?
Capone. Per me sta che il principale motivo sia quello che ho indicato. Vi è
però anche un' altra ragione, quella del minor costo, e su questo ritornerò a
proposito degli esami .
V'è ancora una terza ragione, oltre quelle più gravi della moralità e del
minor costo, quella cioè, che il governo pretenda monopolizzare la istruzio
ne, senza provvedere ai bisogni delle minori località . Nel mio collegio elet
torale, che è di circa 5 4 . 000 abitanti , non v ' è u na sola scuola secondaria go
vernativa 1 • S'è riaperto un seminario e t u t t i corrono là. Ho la fortuna di par
lare a persone che mi conoscono da molti anni, quindi non ho bisogno di fa
re professioni di fede; ed intanto non esiterò a dichiarare che allorquando
fu chiuso l' ultimo seminario che ancora avanzava in detto mio collegio , a
meno di !asciarlo affatto privo di scuole secondarie, mi dovetti rivoigere al
ministro di pubblica istruzione con questo dilemma: «O aprite scuola voi, o
lasciate che ne aprano chi può e vuole » . I ndubitabile è che tanta parte di po
polazione non può restare senza alcuna scuola secondaria. Così quel semina
rio fu riaperto ed è oggi frequentatissimo e fa molto bene. A me sembra che
il governo prima di chiudere un istituto deve pensare ad aprirne u n altro mi
gliore. Dal fin qui detto si raccoglie che a dare la preferenza agli istituti ed
alle scuole tenuti da religiosi concorrono la ragione del minor costo, quella
della scarsezza e lontananza relativa degli istituti secondarii governativi e fi
nalmente quella della moralità, la quale ultima v ' entra massimamente per la
classe agiata, compresa, di questa, pure la parte più liberale di essa . Né di
ciò si meraviglii l ' onorevole mio collega Tenca, ché non le son cose nuove
coteste e gliene addurrò un esempio accorsomi nel Belgio 2. lvi, conobbi as
sai da vicino, uno dei capi del partito liberale , acerrimo nemico del partito
così detto cattolico: fu egli cortesissimo con me e fra l ' altro mi fece visitare
varie scuole ed asili d' infanzia mantenuti a tutte spese del partito liberale,
che avevale fondate per combattere la istruzione e l ' educazione cattolica ed
oltremontana , come la dicevano. In quelle visite non mi rammento di aver
mai scorta la immagine del Cristo nelle scuole, ma ricordo benissimo che in
tesi perenni e vivissimi attacchi contro i gesuiti ed i loro numerosissimi ade-
1 Si riferisce all'abate Felice Toscano, giobertiano, insegnante di filosofia al Vittorio Ema
nuele II dal 1 86 1 al 1 867 e allontanato dalla cattedra, pare per volontà dell'hegeliano provvedi
tore agli studi, Bertrando Spaventa, « lo Spaventa spaventoso » , come lo chiamava monsignor
Mirabelli. Toscano fu sostituito da Angiulli.
1 Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Principato Ulteriore.
' Filippo C1pone compì un viaggio di !>tudi nel 1 8 '5 l in Francia e successivamente visitò an
che il Belgio, la Svizzera e la Germania.
294
Fonti per la storia della scuola
renti. Alcuni giorni dopo mi recai da me nel collegio, tanto rinomato nel
Belgio, di Saint Miche! tenuto e diretto, come tutti sanno, dai . padri gesui t i .
Or quale n o n fu l a mia sorpresa allorché fra i giovanetti c h e mi s' indicarono
e presentarono, e coi quali ebbi ad intrattenermi, vi riconobbi due figliuoli
di quel capo liberale? Il caso portò che quel giorno istesso fossi a pranzo da
questo signore, e non potei fare a meno di chiedergli la spiegazione di quel
lo che mi appariva sì contraddit torio. Ma quel signore con la maggior natu
ralezza del mondo, per tutta spiegazione mi disse: " Puisque il y a la de la
morale, monsieur ! ! ». Così si pensa e si dice anche oggi in I talia, e potrei qui
declinarne assai esempii .
In conclusione, ricapitolandomi, ripeto: per me la primaria ragione della
preferenza che si dà, fra noi, agl ' istituti e scuole dirette da ecclesiastici, è la
morale, a questa vi aggi ungo le altre due del minor costo e della lontananza
relativa e della scarsezza degl ' istituti governativi di insegnamento seconda
rio. Come volete che fosse altrimenti, quando per esempio tutta la mia pro
vincia nativa la quale conta da 360. 000 abitanti, non ha che il solo liceo di
Avellino?
Bonghi (della Commissione). Voleva fare una osservazione. Ella ha fatto
due ordini di deduzioni : u na derivante dalla quali tà delle persone e l ' altra
dalla qualità dell ' i nsegnamento.
Quella derivante dalla qualità delle persone l ' ha creduto connessa; ma
quando poi ha parlato dell ' organizzazione dell ' i nsegnamento, secondo il
principio liberale del governo, non ha distinto, se creda connesso il primo
rispetto al secondo. Niente impedirebbe a un governo liberale che le perso
ne fossero eccellenti , quantunque possa essere difficile ad un governo libe
rale di regolare alcuni insegnamenti in maniera da contenersi in quei limiti
accettabili alla maggioranza delle famiglie. È vero che ella non crede neces
sario , indispensabile che il governo libero non guardi alla qualità delle per
sone e non procuri che quelle persone per la condotta della loro vita non
siano accettabili; è solamente la seconda cosa che le pare difficile?
Quanto alla prima cosa la impressione, che fa parlare l ' onorevole Capo
ne, l ' ha raccolta dalla provincia in cui suole vivere, perché egli ha detto le
sue osservazioni circa ad una classe di persone, la quale sarebbe esclusa dal
l' utile ministero dell ' i nsegnamento per la natura della sua professione ante
riore e della vita presente, per conto della vita anteriore . Qui viene la do
manda: come si spiega, che in questa città parecchi istituti tenuti da persone
della stessa qualità, che paiono così atti a respingere i padri di famiglia ed i
giovani, pure sono affollati. Come è possibile , che questa ragione sia di tan
to valore, se non ha efficacia rispetto agli istituti privati : giacché ho saputo
jeri dal provveditore che alcuni istituti, tenuti da queste persone sono più
affollati di quelli tenuti da persone sulla cui vita anteriore non c'è alcuna oh
biezione da fare?
Capone. L' onorevole Bonghi, napoletano, come me, già sa la risposta, ed è
Sezione Il - / uerbali delle deposizioni
295
impossibile che non la sappia. In parte almeno, credo avergli det to in pro
posito la mia opinione, rispondendo all' onorevole Tenca. Infatti ho detto or
ora: la ragione principale secondo il mio modo di vedere, è la morale, ma a
questo ho aggiunto la ragione economica, e la difficoltà nascente dalle loca
lità . Queste due ultime cause sciolgono la domanda dell 'onorevole Bonghi .
Per fermo, l a mancanza, o l a troppa distanza relativa degli istituti secondari
governativi nelle singole provincie, fa sì che molti, seguendo l'antica tradi
zione ed inveterata abitudine, mandino i loro figli in Napoli. Quanti sono i
padri di famiglia, che possono tener dietro ai loro figli per vedere i n quale
istituto vanno? Volesse Iddio, che i padri lo potessero vedere e potessero
giudicare. Or i giovani lasciati a se stessi e lusingati da promesse e da speran
ze esagerate corrono facilmente e numerosi alle scuole ed istituti dei quali
accenna l 'onorevole Bonghi. I ndi è facile rilevare come di tale concorso d ue
sono le cagioni precipue: una la gran massa di giovani gettati in Napoli, sen
za direzione, né sorveglianza. L' altra la impostura promossa e resa facile del
vigente sistema di esami liceali. Chi non sa come si debba a cotesto sist �ma
appunto la origine di quella classe d ' impostori che chiamansi preparaton ed
i quali pretendono insegnare in sei mesi o dieci al più tutta la enciclopedia?
Tali cose avemmo coll 'amico e collega l ' onorevole Settembrini occasio
ne di constatare, quando ci si dové occupare della inchiesta per l ' i nvola
mento dei temi di esami liceali avvenuto nel liceo di Salerno. Gli atti di
quella inchiesta chiarirono tutto il danno che apporta l ' attuale sistema di
esami, l ' eccessivo agglomeramento di giovani studenti e la quasi nessuna ga
rentia richiesta da u na certa classe d ' i nsegnanti privati, molti dei quali sono
pretti impostori.
Certo se gli istituti governativi di istruzione secondaria fossero più diffu
si nelle provincie; se ci fosse nel governo meno tendenza al monopolio; se si
esigessero esami più ragionevol i, tutto quanto lamentiamo oggi non avver
rebbe . Breve, debbesi sopprimere l ' impostura, impedire il soverchio agglo
meramento dei giovani, ed in terzo luogo occorre tenere miglior conto degli
interessi veri delle famiglie e dei giovani .
Bonghi. Lei h a parlato della parte avuta nell ' i nchiesta sugli esami l ' anno
scorso e del disordine osservato nella preparazion�r. Può dire in quale quali
tà di istituti questi disordini sieno stati osservati maggiori? Lei ha diviso gli
ist ituti in diverse categorie di indirizzo : in quali istituti è stato osservato il
maggior numero di inconvenienti?
Capone. L' apprezzamento mio è individuale. I o non li ho visti tutti; e posso
parlare soltanto di quelli che ho conosciut i da vicino; così in generale dirò
che mi rammento bene precipuamente di tre, tenuti da ex preti i quali fanno
pompa di aver ripudiato il loro antico stat o . Quegl ' istituti erano tutto quello
che poteano essere.
Bonghi. Intende diretti da privati ?
Capone. S i , da privati.
296
297
Fontiper la storia della scuola
Sezione Il - l verbali delle deposizioni
Presidente. Vuole passare al quesito degli esami ?
Capone. I n questo proposito ripeterò in gran parte quelio che scrivemmo
coll ' amico Settembrini, e a cui mi riporto come a documento importantissi
mo ed ufficiale .
D irò in breve il mio concetto. In fatto di esami sembrami che siamo ca
duti in una grande esagerazione , e questa la ravviso anche nella università,
moltiplicando dapertutto gli esami e gli i nsegnamenti obbligatori . Da ciò na
sce che i giovani imparano poco seriamente; e soltanto acquistano una certa
infarinatura delle molte cose, che sono forzati a studiare . Or cotesto per me
è un difetto grandissimo dell ' odierno insegnamento secondario ed u niversi
tario. Lo ripeto, ho l'onore di far parte della commissione di esami della fa
coltà legale di questa università di Napoli ed ho il dovere di confessare che
andiamo sempre più in basso. Non ho difficoltà di dichiarare che di quelli
approvati dalla commissione forse il 9 5 % avrebbe meritato d ' essere riman
dato . In verità non posso affermare se sopra ogni cento ne trovai cinque,
che mi convinsero di aver fatto u n corso regolare sulla materia in cui li in
terrogai .
Quando si pensa al gran numero di studenti ai quali debbesi soddisfare
nel breve periodo destinato agli esami speciali ed alla moltiplicità di questi
ultimi, non si resterà sorpresi di certo dei risultati da me accennati.
Nell' insegnamento secondario v'è lo stesso difetto. Il pretendere oltre
otto materie, studiate tutte di pari passo , e tutte in una data maniera e pre
tendendo dare a tutte otto la stessa importanza, qualunque sia la diversità
dello indirizzo a cui aspirano i giovani, è cosa pressoché impossibile atte
nerla , ed è nella maggioranza dei casi dannosissima.
Difatti oggi si pretende dare la medesima importanza alla cognizione in
dispensabile delle tre letterature, ed alla matematica, alla storia naturale, alla
geografia eccetera . Tutte coteste sono certamente cognizioni bellissime : e si
fa bene assai a promuoverne lo studio; ma non si debbe perdere di vista, che
tutto cotesto complesso di cognizioni non può avere pari valore per tutti e
per tutte le professioni indistintamente. Certo tutto quel complesso non ser
ve al maggior numero ed impedisce di approfondire la parte più importante.
Vorrei che si trovasse modo di distinguere le materie di generale impor
tanza dalle materie d ' importanza minore e relativa. Penso io pure che sia be
ne che si lascino s tudiare coteste materie relativamente secondarie; ma pre
tendere che siano apprese da tutti come le principali e le necessarie da vero
è troppo .
Vengo agli esempii, dacché mi piace stare nel concreto, partendo la mia
osservazione dal fatto che l' ordinamento attuale porta che mancando il gio
vane, per esempio nella risoluzione di qualche equazione algebrica, viene
inesorabilmente respinto negandoglisi la licenza liceale, non astante fosse
ottimamente riuscito nel latino e nel greco ecc . eccetera . Or io domando, è
razionale quel sistema che porta a dichiarare asino, ignorante, di greco e di
latino colui che provatosi ottimo in ambe queste letterature, non riuscì ad
essere mediocre in matematica? Che volete, la coscienza dell'universale si ri
bella a tale conclusione e la dichiara assurda . Sarà infermità della mente mia,
ma debbo confessare che, malgrado sia costretto da sette od otto anni ad as
sistere allo spettacolo tristissimo che offrono in questa città gli esami per la
licenza liceale, non arrivai mai a capire come sia possibile che uno che fece
bene il latino , greco, ecc . debba perdere tutto il frutto delle sue fatiche e del
suo sapere, solo perché non seppe sciogliere un problemuccio di algebra e
viceversa, solo perché non seppe rammentare quella tal tesi di storia o di
geografia, costui diventa un imbecille per tutto il resto. La mia coscienza si
rivolta contro tali conclusioni , e vi si ribella con tanta maggior ragione,
quanto debbo confessare apertamente che se io avessi dovuto soddisfare a
tutto il complesso di esami quale oggi si pretende, avrei dovuto essere ine
sorabilmente respinto. Che volete, il fatto è così: ebbi sempre una certa anti
patia per le matematiche, che non riuscii mai a vincere, non astante mi vi
fossi più volte premurosamente provato a studiarle. La mente umana è fatta
in sì diverse maniere : qual meraviglia? Pure la vita già trascorsa, l'alta posi
zione sociale ove mi portò esclusivamente l 'opera mia, i difficilissimi offici
pubblici per anni ed anni sostenuti, pare che possano dare il diritto di non
tenermi del tutto per l' ultimo fra gli ultim i . Or quando penso al tormento
che sarebbe stato per me quella specie di sconfitta irreparabile, vi assicuro
che non so trovare parole abbastanza efficaci per significarvi tutto il dolore,
tutto il sentimento che destasi in me a tal pensiero. Certo sarei stato un uo
mo perduto per la mia famiglia e per me. D itemi, sarebbe stato giusto? M a il
male che deploro si aggrava di molto col vigente sistema di esami, dacché
non solo si domanda dai giovani anche quello che non è strettamente neces
sario pel loro i ndirizzo, ma li si obbliga a fare simultaneamente gli esami su
tutte le otto materie , sulle quali debbono provarsi. Or bene a chi nuocereb
be se alcun giovane preferisse dare un solo esame per anno? a chi incommo
derebbe? qual danno ne verrebbe alla coltura, al paese e che so io?
Quel che nasce di certo dal sistema odierno di esami liceali (e ciò osser
vo in tutti gli anni) è che questi non son punto serii. Come può essere altri
menti ? Come sia possibile che un professore, a cui si presenta u n giovane
approvato in sette materie, possa, con indifferenza, riprovarlo? Quando si
considera che il fallire in qualche esame porta il rimando del giovane e la
perdita di tutti i denari pagati, è cosa sempre assai grave. Come no? Pel mag
gior numero de' padri di famiglia le tasse di esame che oggi domandansi so
no gravi e diventano esorbitatamente gravi, quando si mettano in relazione
colla vita dispendiosa delle città grandi, e colla deficenza di insegnamento
nelle località minori . Riflettasi che rimandare un giovane vuoi dire imporre
alla sua famiglia un altro anno di più di stipendio e vuoi dire imporre ai ge
nitori un altro anno di abbandono del loro figliuolo in mezzo al vivere
298
Fonti per la storia della scuola
burrascoso delle grandi città. Di qui potrete intendere d ' onde avviene che
nel momento degli esami liceali nasce come u na cospirazione tacita in cui
ognuno mette la mano. Che vi sono gli individui, che potendo agevolare in
qualche maniera, non lo facciano. I n tale occasione producesi una compas
sione ed una dispiacenza universale. Pensare che la indebita moltiplicità de
gli esami può produrre conseguenze funestissime per un gran numero eli fa
miglie muove ad indulgenza tutti. Quel pensiero e quel timore mena i padri
medesimi a cospirare coi figli a fornir loro tutti i modi possibili leciti ed ille
citi per aiutarli a vincere le prove. Né restano soli; quasi ogni ceto di perso
ne, imp iegati, professori, bidelli adoperansi in tutte le maniere possibili per
facilitare, e tutti pigliano interesse ad ajutare quei poveri disgraziati sub ju
dice. Di conseguenza pare quasi che il paese stesso schierasi contro le auto
rità scolas tiche . I ndi segue che gli esami non vanno come dovrebbero anda
re; perché, lo ripeto, il sistema attuale offende l'interesse delle famiglie ed
urta il convincimento universale di queste provincie; certamente qui fra noi
nessuno crede che possano darsi bene simultaneamente gli esami su otto
materie disparate e richieste con eguale misura.
Se poi a queste si aggiungono altre difficoltà, per esempio di opinioni e
dottrine particolarmente favorite da qualche professore, di antipatia contro
questo o quell'altro istituto e si abbia la sventura di andare a scuola da chi o
dove si pensa differentemente dall'esaminatore, allora si va incontro ad
u n 'altra serie di inconvenienti, i quali non fanno che sempre più aggravare
quelli già rilevati. Per me sta che bisogna ridurre il numero delle materie ob
bligatorie. Mi affretto a dichiarare che riconosco utili tutte le altre, ma non
le credo necessarie per tutti. Quindi vorrei lasciato un po' più di lassitudine
ai giovani di scegliere quelle parti dello scibile più necessarie all ' avviamento
a cui si vogliono dare. E nello stesso tempo reclamo con tutta la forza che
sia data facoltà ai giovani di fare gli esami in uno od in più per anno come e
quando stimano meglio.
Persuadiamoci; il padre di famiglia non ha interesse di tenere il figlio per
otto anni in una grande città e più altri anni alla un iversità. Se lo fa è segno
che gli è necessario. Ora che importa ed a chi nuoce se il giovane, invece di
tre anni, ne impieghi otto negli esami? Più volte mi si disse che quel com
plesso di esami simultanei richiedevasi per avere un concetto della cultura
generale acquistata dal giovane. I n verit à non so se gli esami come si fanno
ora diano cotesto concetto. Io credo di no. Un tale concetto del sapere pos
sono darlo soltanto un insegnamento serio e pochi e serissimi esami. Il mo
do che si tiene oggi è cattivo ed è precisamente il contrario di quello che
dovrebbe essere. Su cotesta materia le facoltà universitarie di Napoli ebbero
già occasione di manifestare la loro opinione ed io qui testimonio ch'è ap
punto quella di tutto il paese. Su questo capo so di certo di aver io ripetuto
ciò che pensano i nove milioni d i abitanti dell ' Italia meridionale. Si desidera
ardentissimamente (credo che sia lo stesso anche nelle altri parti d ' Italia)
Sezione I l - f t•erbali delle deposizioni
299
che sia lasciata libertà ai giov:mi di far l ' esame quando vogliono. Tutti desi
deriamo che gli esami siano seri, e perciò domandiamo che sia permesso di
viderli. Quando l'esaminatore sa che il giovane non si rovina la carriera, se
non passa quel dato esame, avrà animo d i dirgli : « Amico mio, voi avete il
debito di studiare ancora .. . Così avremo l ' esame certamente più rigoroso e
quale deve essere. Col metodo attuale gli esaminatori, si mandino pure da
una provincia ad un' altra, siano del luogo , siano estranei, è quistione di più
o di meno, ma in faccia a migliaia di studenti , del cui destino debbono deci
dere, la compassione che pur è un sentimento della nostra natura , non può
non vincerli ed anche sovrastarli . Per me, ripeto, stimo indispensabile la di
visione degli esami , e la diminuzione delle materie obbligatorie, ma nel tem
po istesso reclamo con tutta la forza mia che si trovi modo di rendere gli
esami seri i . Sono almeno otto anni, da quando vedo i giovani negli esami
universitari. Credetemi : andiamo di male in peggio : più giù non si può scen
dere . Sono imposture, non sono né esami , né insegnamenti quelli che vedo
ogni anno .
Bonghi. lo volevo che queste cose fossero chiarite bene: e parmi fossero
queste tre. Vorrei sapere se le vuole tutte e tre o se una basti a compensare
le altre. Ella ha chiesto prima che le materie obbligatorie sieno diminuite;
che l' esame si faccia in più volte e che i giovani abbiano facoltà di fare l' esa
me quando loro piace. I ntende questa terza domanda nel significato che lo
Stato abbandoni qualunque garanzia, che dipenda dalla durata dell' insegna
mento; oppure crede che lo Stato debba prescrivere tra l ' una e l ' altra prova
un certo intervallo? Non riconosce che anche sciogliendo l' esame liceale i n
p i ù prove s i h a questo danno, c h e l e prove in l uogo di essere complessive, e
di abbracciare il saggio della mente del giovane, quando lascia l ' i nsegnamen
to secondario, diventino prove eli ciascuna parte della mente, e invece di
forzare il giovane a compiere tutte le part i , lo abitua in u na strada affatto
opposta e diversa, quella cioè di isolare ciascuna attitudine, di perfezionarlo
in quella materia, finché sia bisogno di dare l ' esame, per dimenticarlo poi
un'a ltra vol ta e così si metta in grado di subire la prova?
Ora se ella riconosce questo danno, non le parrebbe che alla seconda do
manda si potrebbe rinunziare? Una volta ottenuta la diminuzione delle pro
ve, ovvero che queste siano alternate in modo che un giovane possa sceglie
re il gruppo delle materie che vuole, come in Germania, credesi possa man
tenere intatta la u nità dell' esame liceale?
Capone. Prego l ' onorevole mio collega Bonghi di ripetermi la prima do
manda a ciò io sia brevissimo nella risposta.
Bonghi. La prima domanda è se, abolite alcu ne prove obbligatorie , si debba
mantenere intatta la u nità dell ' esame; e se basti questo ad ottenere lo scopo
che ella dice.
Capone. Alla domanda del mio amico Bonghi rispondo senza esitare che io
sono partigiano di pochissimi esami; ma son persuaso che debbano essere
300
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l t'erbati delle deposizioni
serissimi, specialmente i primi, anche perché diano modo di tornar indietro
a tempo e prendere altra carriera. Breve, vorrei trovar modo · di ridurre gli
esami a pochi: ma però sarei per u na forma più severa e più grave che mai .
Bonghi. Tutti quanti i n una volta sola?
Capone. Cotesta sarebbe una modalità la quale può dipendere dalla maniera
secondo la quale si ripartisce l' insegnamento . Certo è che un esame finale
nel quale si possa fare un giudizio più compito , credo sia pel giovane utilis
simo ed importantissimo : ma da questo non segue che gli esami speciali deb
bano essere fatti tutti contemporaneamente, giacché il giovane non può es
sere ben preparato in tutto.
Del resto, per avere idea della cultura acquistata dal giovane, basta anche
un solo esame; nessuno lo può saper meglio del mio amico Bonghi, dacché
dal modo di scrivere, di esporre, di pensare, da quello che dice il giovane, è
facile capire lo stato della sua cultura. L ' unico esame certo potrebbe parere
una mia esagerazione, né in verità saprei acconciarmi ad un solo, ma d 'altra
parte, diminuire le materia d ' esame , è cosa utilissima. Però non mi stanco di
ripetere che nello stesso tempo desidero esami serii, dichiarando che in nes
sun modo, per quanto a me consta, quelli di oggidì son tal i . E quindi invece
di promovere la coltura, provochiamo ed autorizziamo la ignoranza.
Bonghi. Mi pare che lei vorrebbe certo diminuire le materie; le parrebbe pe
rò che gli esami si dovessero fare insieme.
Capone. No, li preferisco sempre separatamente: non vorrei coartare i gio
vani, perché penso che non ci si guadagna nulla.
Bonghi. L ' altra domanda era questa: se tra queste prove separate deve esserci un intervallo .
Capone. I n generale un certo intervallo giova ai più; ma lo vorrei tra classe
e classe di esami. Vorrei per esempio che si distinguesse l ' esame di licenza
ginnasiale da quello di licenza liceale . Scorso il tempo d ' inters tizio prescrit
to, non mi curerei se gli esami si facessero tutti insieme ovvero u no alla
volta.
Non voglio intanto omettere di notare che, siccome sono nemico di ogni
inutile coazione, così vorrei che in quanto a quel l ' i nterstizio, si trovasse mo
do di rimettere ad una autorità scolastica di poterlo dispensare con certe
cautele per colui che si sentisse pronto, e non credesse di dover essere co
stretto a stare i nchiodato tre anni per esempio senza pro . Certo che se l ' o
norevole Bonghi fosse stato obbligato di stare tre anni nel ginnasio prima di
passare al liceo, gli si sarebbero fatti perdere anni preziosi. Rammento con
piacere che egli avea tredici anni e mezzo e fece un esame stupendo di logi
ca e metafisica, esame che si rammenta ancora . Or sembrami i ngiusto e dan
noso obbligare giovani di sicuro e precoce ingegno a dimorare coatti intor
no a cose che già sann o . In regola generale la esperienza chiarisce utile la
prescrizione di u n interstizio fra classe e classe di esami, massime per impe
dire gli impostori . Ma occorre pure lasciare tanta latitudine al ministro od
alle autorità locali, da rendere possibile a chi non ha bisogno di quel l ' in ter
vallo, di farne a meno.
Finali. Sono rimasto incerto sopra u na sola risposta. Io ho capito che le ma
terie speciali d eli ' insegnamento secondario debbano essere diminuite ' ma
non ho capito se crede buono l'esame complessivo, che dia saggio della cul
tura generale .
Capone. Io non credo agli enciclopedisti sia in folio sia in trentaduesimo.
Non sono amico degli esami complessivi, perché per me non dicono nulla.
Chi sa da vero mostra facilmente di sapere, non ha bisogno di esser tortura
t ? con esperimenti troppo gravi, sol perché troppo complessi . Un tale espe
nmento serve soltanto per affliggere i giovani senza alcun profitto. Se ci de
ve essere un esame di tal genere, sia questo l ' esame di laurea. Ma o comples
so o sciolto, facciamo sempre serio lo esame; a ciò ottenere importa sopra
tutto ridurre le materie obbligatorie, non potendo pretendere che tutti stu
dino tutto, ed anche quello eh' è indubbiamente di minore importanza ed af
fatto secondario per il loro indirizzo professionale. No, non voglio abbassa
re il livello della coltura generale, voglio invece vederlo di molto rialzato.
Per ottenere ciò fa mestieri guardarsi dalle esagerazioni, ed il sistema di esa
mi oggi in vigore fra noi lo stimo una grande esagerazione dannosissima a
tutto il paese. Ecco la mia opinione .
Presidente. La Commissione la ringrazia vivamente. 1
30 1
24
Seduta di Caserta, 3 marzo 1 8 73 2 .
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860- 1896), b. 5, fase. 1 7 .
A NGELO I NCAGNOLI 3
Presidente. Lei ha figli nell ' istruzione secondaria?
' Filippo Capone tornò dinanzi alla Commissione d'inchiesta nella seduta del 22 febbraio.
Tra i temi da lui trattati in quella giornata prevale il giudizio piuttosto negativo sugli esami di
laurea, ntenuti insufficienti ad abilitare all'insegnamento; la convinzione che sia necessario mi
gliorare la condizione degli insegnanti, che egli giudica " miserrima » ; il problema delle scuole
pnvate, sulle quali chiede un controllo governativo, delle quali però difende la libertà anche ri
chiamandosi alle antiche tradizioni dell' insegnamento libero napoletano. Sul tema degli illeciti
m fatt � di esami espone alla commissione divertenti aneddoti di truffe e guapponate di cui egli
stesso e stato testunone.
2 La seduta è presieduta da Luigi Settembrini.
·1 Angelo Incagnoli (Arpino, Frosinone, 1 8 1 9 - Napoli 1 5 maggio 1 884). Letterato, filosofo,
avvocato, deputato nelle legislature XIII, X I V e XV. Prese parte ai moti del 1 848-'49, in seguito
302
Fonti pe1· la storia della scuola
Incagnoli. e ho avuti.
Presidente. E come è stato contento dell' istruzione ricevuta . nella scuola?
Scusi, li ha tenuti in istituti privati o governativi?
Jncagnoli. Li ho tenuti nella loro prima educazione nel liceo ginnasio di Ar
pino in questa provincia e poi dopo quando erano più adulti li ho mandati a
Napoli dove hanno compito i loro studi e poi li ho perdut i . Se lei vuole che
dica quello che ho rilevato dal modo di studiare lo dirò brevemente.
L' educazione dei miei figli io la ho avuta quando eravamo nei primi tem
pi del nostro risorgimento cioè nel '60, nel ' 6 1 , in cui noi non avevamo che
i vecchi ordinamenti e cominciavano a sorgere i nuovi; anzi non v ' era stata
ancora promulgata la provvida legge Imbriani del '6 1 , fatta sotto la luogote
nenza dal capo della pubblica istruzione. Si era quindi in istato di formazio
ne dei nuovi ordinamenti scolastici. Io in verità essendo nativo di Arpino,
benché di Napoli per elezione, allora mi studiai di dar opera per quanto in
me era possibile essendo amico di persone rispettabili che governavano il
paese, di far sì che l ' antico collegio di Arpino 1 fosse riordinato per il primo .
Istituto di A rpino. Si potrebbe su ciò sentire il De Sanctis nostro amico, al
lora al Ministero provvisorio della pubblica istruzione. Allora io gli dissi che
infi ne in Arpino c ' era u n collegio reale abolito da pochi anni e pigliato dai
gesuiti a cui era stato dato dai Borboni e che io proponeva di riaprirlo pre
sto, salvo ordinario in miglior forma: ma che in centro così importante di
questa provincia non era bene che i padri di famiglia non avessero alcun
ai quali subì le persecuzioni della polizia borbonica. Nel 1 860 fu tra i promotori dell'insurrezio·
ne in Terra di lavoro. Si dedicò a imprese industriali, particolarmente a quelle del Liri, parteci·
pò all'inchiesta industriale promo>sa da Antonio Scialoja. Fu membro e presidente del Consi
glio provinciale di Caserta. Coprì cariche pubbliche anche a Napoli.
' Sul Collegio tulliano di Arpino parlarono, nella stessa seduta, anche il preside del l ' istitu
to, Giambattista Panico, e il professore di matematica Di Napoli. Il primo, alla direzione del
collegio dal 1 860, fece presente che ai corsi ginnasiale e l iceali furono sostituite le scuole tecni
che contro il parere del consiglio dei professori, che sarebbe stato anche disposto a fare gratui
tamente il corso tecnico purché la provincia autorizzasse il mantenimento di quello classico. La
deposizione di G. Panico e quella di Di Napoli sono di un certo interesse anche per il riferimen10 alle condizioni sociali della zona di Arpino, ricca di industrie, nelle quali i ragazzi venivano
collocati a lavorare assai presto. D i apoli in particolare dichiarò: « Abbiamo una scuola tecnica
unita al ginnasio da due anni . Però queste scuole sono poco frequentate e questo dipende an
che dalle condizioni speciali di Arpino. Essa ha una popolazione importante; però questa popo
lazione fino dall 'età di sette od otto anni si trova già impiegata nell'industria del paese. Quindi
essa non va che alle scuole elementari e quindi non può neanche venire alle altre scuole. Nel
paese si cerca di istituire scuole operaie; ma il difetto c'è. Ragazzi di sette od otto anni già lavo·
rano, fanno i cannellini, preparano le spole, cose queste per cui non pensano più alla propria
istruzione " · E alla domanda, posta da Luigi Settembrini, se nessuno industriale avesse pensato
di creare scuole per gli operai rispose: « No, solo è venuto questo pensiero una volta ai profes
sori del collegio che si proposero di dare agli operai lezioni gratuite. I professori si erano diviso
questo fra loro, ma il loro progetto fu osteggiato dalla maggior parte degl'industriali di Arpino.
La istruzione non è gran che desiderata dagli industriali di questa città; non c'è cassa di rispar
mio, né si può sperare che la condizione del paese migliori così in un tratto ». Sullo status giuri
dico del Collegio tulliano vedi ACS, MPI, Div. scuole medie ( 1 860- 1 89 6), b. 4 4 .
Sezione 11 · / uerbali delle deposizioni
303
mezzo per educare i loro figli. Il De Sanctis mi domandò di essere insieme
per questo e così l ' antico collegio reale di Arpino si ordinò nella forma anti
ca salvo che si mutarono gli uomini . A me questo centro d' istruzione era ca
rissimo perché ivi era stato educato io stesso nel tempo che non era dei ge
suiti, quando era secolare, quando aveva idee di progresso per cui fu odiato
e rimesso dai gesuiti. Io per incoraggiare vi mandai i miei figli . Avrei potuto
tenerli in Napoli, ma vidi che là la istruzione tanto privata quanto pubblica
mi pareva poco ordinata; così altri padri di famiglia mandarono i loro . Que
sta istruzione secondaria sebbene provvisoria seguiva quello che più tardi si
fece. In questo caso sono gli uomini che danno la istruzione anziché le for
me regolari . In quel collegio si ebbe ottima istruzione secondaria in breve
tempo e fu ripieno di tutti giovanetti che provenivano dalla parte superiore
della nostra provincia. Fui però pentito di quello che feci, perché inconsa
pevolmente, quand' io non mi occupava più delle cose pubbliche, vidi uscire
u na legge nuova che ordinò l' istruzione in quella forma che si chiamò ginna
sio-liceo o liceo-ginnasio, e furono formati dei centri d ' istruzione nelle pro
vincie meridionali, ma fu dimenticato il C ollegio tulliano . Io ne fui dolentis
simo . Si disse che quella era una dimenticanza che non si poteva fare per
legge, perché il collegio era reale. Ma questo collegio reale ciò nonostante
restò disfatto. Non ci fu altro mezzo che ricorrere alla provincia. Si fece il
meglio possibile e si riordinò la istruzione secondaria a spese della provin
cia. Ho spesso reclamato quanto vi sarebbe bisogno che una provincia così
vasta avesse un istituto in una parte lontana e superiore: ma vi sono s tati
ostacoli burocratici. Non credo che provenissero dalla legge. Abbiamo prov
veduto alla meglio coi mezzi della provincia.
Parlerò dell' andamento dell' istituto . Il Col legio tulliano ordinò l ' istru
zione secondaria che fu mezzana tra quella, che poi fu introdotta nelle n uo
ve leggi dell' istruzione, e l ' antica, cioè in quella istruzione l ' insegnamento
ginnasiale e liceale, sempre distinto, ma in certo modo raccolto insieme . Co
sicché invece di avere tredici o quattordici classi , invece di avere tredici o
quattordici insegnanti, quanti se ne hanno ora nell'istruzione secondaria,
non ve ne furono che sette od otto. Si rese possibile che coloro i quali ap
prendevano nel Collegio tulliano non si trovassero digiuni di quella parte
dell' insegnamento che si dice tecnica.
Questo parve un peccato gravissimo in quel tempo, perché si diceva es
sere impossibile che l' insegnamento tecnico andasse unito all' insegnamento
classico. Ma gli effetti non furono così perché i giovani alunni di quest ' isti
tuto quando , giunti al compimento della loro educazione, si presentarono
agli esami di licenza liceale furono tutti approvati, e questa credo che sia
stata una riprova bastante.
Oggi però ques t ' istituto va in certo modo a decadere perché venuti i
nuovi regolament i che impongono il modo degli esami all' alunno, non si
possono adempire più tutte le gradazioni tra ginnasio e liceo e via discorren-
304
305
Fon.ti per la sto,-ia della scuola
Sezion.e II - l uerbali delle deposizioni
do. Vi è stata u n ' altra difficoltà circa le patenti dei professori. Alcuni profes
sori la ottennero dando le prove all ' u niversità. Altri produsser9 i loro titoli
che furono approvati dal Consiglio scolastico provinciale e dal Consiglio su
periore. Ad altri che presentarono i titoli degli esami dati all ' università pri
ma del nuovo governo furono ritenuti per invalidi. C ' è un imbarazzo perché
questi professori dovrebbero ritornare a far l'esame, ma ciò si potrà acco
modare . Io vengo a fare un'osservazione più importante ed è che questo
ginnasio e liceo cui abbiamo dato vita se non ufficiale almeno semi-ufficiale
perché lo ha sostenuto la provincia, da qualche tempo in qua ha u na certa
diserzione. I professori sono i medesimi, le rette sono più lievi, perché non
c'è aggiunto a quello che una volta era, sebbene oggi tutti gli altri istituti
l ' abbiano cresciuta. Anzi sarebbe necessario che questa retta si accrescesse
per far fronte alle spese maggiori, il che non si è fatto.
Concorrenza degli istituti religiosi. Quale è la cagione d i questa diserzione :
abbiamo veduto sorgere l ' istituto di Monte Cassino ad una certa distanza,
abbiamo veduto sorgere istituti tenuti da preti cioè quest i rimpastamenti di
seminari che oggi permessi o no danno l ' insegnamento. Ecco che alcuni si
allontanano e chi sono questi ? Sono gente poco agiata su cui valgono gli in
flussi clericali che ricorrono a quelli istituti che rappresen tano u na bandiera
alzata contro lo Stato. Questa gente presso di noi è più credente alle forme
esterne del culto anziché alla sostanza delle cose cui i nemici dello Stato
vorrebbero condurre, quindi questi badano a spendere poco e dicono: pur
ché mio figlio impari a leggere e scrivere e poi diventi dottore od avvocato,
vada dove si spende poco . Nei seminari si spende poco, dunque mandarlo
nei seminari . Ecco che le scuole si disertano nelle classi non agiate, v'è poi
la gente agiata, benestante la quale forma lo strato superiore della nostra so
ciet à . E non possiamo dissimularlo e io non sono d ' accordo col provvedito
re che sia la ragione del risparmio 1 , che non faccia frequentare le scuole go
vernative alle classi agiate : nella gente agiata, nelle classi benestanti, non
possiamo negarlo, il principio della superstizione domina e sono in quella
specie di dubbio, incertezza, dove stia il bene e quale sia l ' avvenire e per le
suggestioni che ricevono specialmente dal clero e si sviano sentendo dire : in
quel luogo s ' insegna il materialismo, in quel luogo non si diviene religiosi,
in quel luogo non si va a messa tutti i giorni ma solo la domenica, non si
fanno i digiuni il sabato e via dicendo . Queste sono cause bastanti per pro
durre questa diserzione . Ora dunque vediamo che magistrati i quali siedono
nei tribunali , che militari che sono generali d 'esercito ed i primi del regno
d ' I talia, mandano i loro figli dai preti e consigliano i loro amici a mandarli.
Ecco perché gli istituti tenuti da monaci e da preti sono popolati. Non è già
perché ivi vi sia miglior coltura, che anzi sono più ignoranti; infatti guardia-
mo l ' istituto di Monte Cassino . Questo una volta aveva una specie di colle
gio, oltre il seminario prima del '6o. Che avveniva? Che non entrata la gran
quistione religiosa, non sol levate le due bandiere l ' una contro l ' altra, questo
faceva sì che l ' istruzione si teneva per bene e che molti correvano là per
sfuggire alle persecuzioni del governo borbonico contro le lettere e quindi
quell ' istituto era popolato siccome luogo di rifugio e valenti professori vi
accorrevano. Io so che Bertrando Spaventa è stato educato a Monte Cassino.
Là vi era un centro di civiltà, la quistione politica non era sorta. L'abate Pa
palettere, uomo distintissimo, prima del '48 insegnava filosofia ed è quello
che fece intendere le grandi dottrine del Cousin e specialmente l 'Hegel fu
fatto conoscere dal Papalettere. Allora in quel tempo da quell' istituto sorse
ro giovani colti, ma dopo il '60 in quell'istituto non ci possono andare che
giovanetti di quei luoghi , perché u na persona valente non va a rinchiudersi
in quel deserto . Dunque non si possono avere quei professori bravi e quella
istruzione spregiudicata. Eppure oggi è più popolato di allora . E la ragione?
La ragione è perché oggi dove c'è la cocolla ed il collare si alza una bandiera
che combatte il regno nostro e voi altri . Ci resta di guardarci in viso e di ve
dere i provvedimenti che si devono adottare. Quali sarebbero non tocca a
me il giudicarlo. Ma se noi facessimo le istruzioni secondarie bene ordinate
quando se ne vedranno gli effetti nel profitto della gioventù, e presto o tardi
molti padri pregiudicati li vedranno, diranno: mio figlio non potrà essere in
gegnere, avvocato, e verrà il disinganno. Con più rigore noi dobbiamo anda
re nella istruzione e sorvegliare quelli istituti che ora crediamo di potere la
sciar liberi fuori delle nostre man i . Io sono nemico delle patenti perché cre
do che il vero sapere si faccia la strada indipendentemente da esse, ma oggi
devono essere un'arma dello Stato, perché credo che questo sia un modo
per contenere i nostri nemici. Quanto ai seminari io li vorrei del tutto pro
scritti perché gli insegnanti per la maggior parte non sono muniti della pa
tente e perché insegnano cose contrarie al nostro stato di cose. Queste dun
que sono le ragioni per cui l ' istituto d'Arpino da alcuni anni in qua, a misura
che sono sorti intorno istituti clericali , si vede i n certo modo venir meno,
decadere alquanto . In conseguenza per mia parte io farei dei voti perché
questi centri della civiltà, della istruzione, che sono in dipendenza dello Sta
to, seguano la nostra bandiera e siano animati e protetti con mezzi sufficien
ti e con un numero d' insegnanti che possano rispondere al bisogn o . La pro
vincia di Terra di lavoro è vasta. Qui vi ha il centro d ' istruzione rappresen
tato dal liceo e ginnasio di Maddaloni. E poi vi sono intorno molti altri licei
comunali e dei ginnasi abbastanza bene ordinati. La nostra provincia ha qui
un istituto agrario che è un 'altra forma con cui si prende la coltura e l ' istru
zione. Vi è una scuola normale dove un certo numero di persone si va ad
istruire e questo è un semenzaio che ci darà frutti. Questo è nella parte pros
sima a Napoli. Nella parte superiore non c'è che un deserto , non c ' è che l ' i
stituto del Collegio tulliano che solo si può contrapporre agli istituti clericali
1 Si riferisce alla deposizione del provveditore di Caserta, Federico Quercia, che era inter
venuto nella stessa seduta del 3 marzo.
306
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - f t,erba/i delle deposizioni
sorti intorno. Questo centro non solo sarà utile alla nostra provincia, ma an
che alla provincia vicina che è l'aquilana, perché il circondar!o per esempio
di Avezzano invece di portare i figli ad Aquila soleva ant icamente portarli al
Collegio tulliano perché gli era più vicino, quindi lo Stato farebbe opera uti
le se volesse un centro di istruzione del Collegio tulliano dandogli la forma
di un liceo ginnasiale . Questa sarebbe un' utilità per una parte importante
della provincia napoletana e romana perché il circondario di Frosinone è vi
cino. Inoltre vi sarebbe u n contro altare al partito clericale. Questo è quello
che io voleva dire alla Commissione; ora se vogliono interrogarmi io potrò
rispondere.
Presidente. Le famiglie dei giovani , che sono dati in educazione in questi
istituti religiosi o seminarj perché mettono i loro figli in questi collegi e non
preferiscono tenerli presso di sé o mandarli ai licei governativi? È perché te
mono di una cattiva educazione religiosa?
Incagnoli. Insegnamento pubblico e privato. L' istruzione in casa propria è
molto difficile perché oggi la qualità degli studi e degl' insegnamenti diversi
per educare i giovani alla scienza e alle lettere è tale che se il padre di fami
glia dovesse procacciare l ' istruzione in casa propria avrebbe bisogno di un
numero grande di insegnanti e professori e le spese sarebbero di gran lunga
superiori a quelle che si hanno in un luogo dove gl'insegnanti sono riuniti.
Supponga che u n padre di famiglia come me avesse dovuto cominciare a da
re l ' istruzione in casa propria ai figli , avrei dovuto cominciare a procurarmi
il professore di latino, italiano, greco, storia e via dicendo, e così per tutte
le altre branche d ' insegnamento . Avrei dovuto con spesa grande raccogliere
tutti questi professori in casa mia. Ma questo poi non si può fare che in una
grande città, difatti vi sono in Napoli famiglie che impartiscono tal istruzio
ne privata ai loro figli. M a in provincia anche che il padre di famiglia volesse
non potrebbe farlo . Abbiamo tante mediocri città in cui come si può trovare
un professore che sappia il latino, il greco, la matematica, che dia l ' insegna
mento delle scienze naturali? È impossibile; si ha quindi necessità di racco
gliere i figli in quella parte, dove pei mezzi combinati si è reso possibile che
molti insegnanti si trovino insieme . Ecco la difficoltà di trovare insegnanti
privati in casa propria. In quanto all 'altra domanda perché si dia preferenza
a questi istituti clericali, io vi ho già risposto. Ho detto che gli istituti cleri
cali oggi si sono costituiti non solo come istituti che insegnano ma come
istituti che hanno u na bandiera levata contro il governo. Quindi bisogna
contrapporvi istituti che abbiano un' educazione l ibera e anti-clericale. Quin
di le famiglie clericali cercheranno di andare da chi ha la bandiera nera . Così
ci conteremo quanti siamo di qua e di là. Se noi ci numeriamo ci troviamo
i n pochi, non dico se ci pesiamo . Se ci pesiamo per valore e fermezza di
propositi saremo più potenti e nella lotta vinceremo . M a quando andiamo
alla numerazione aritmetica siamo pochi e molto poch i . Nella città di Arpi
no abbiamo un istituto con principj liberali, con professori venuti dalle uni-
versità. Ebben molti padri di famiglia del paese stesso non mandano figli lo
ro a questa scuola, perché dicono ci sono questi professori secolari; tutta
gente che chi sa se hanno principj religiosi ; essi sovvertiranno i nostri figli e
ne faranno uomini diversi dal nostro pensiero . Ecco la ragione richiesta. In
una città piccola, come la nostra di provincia, dove gli uomini hanno siffatti
principj religiosi che conducono alla superstizione, viene il dubbio e il timo
re, e questo li allontana. Quindi ci resta a fare che i nostri istituti colla pru
denza dei direttori, la eccellenza degli insegnanti, coll 'effetto dell ' ottima
istruzione presto o tardi vengano alla pugna; e quando risulterà che i nostri
giovanetti raggiungono i gradi dottorali e possono prendere professioni no
bili, e gli altri rimangano in basso allora forse vinceremo questa prova.
Quanto al mio proprio convincimento io siccome in politica professo prin
cipj u n po' diversi perché vorrei che l ' azione dello Stato fosse più energica,
così inferisco diversamente. Queste sono le mie conclusioni. Ho spiegato
perché un gran numero di giovani ci si svii; cioè per la divisione degli animi,
per le due parti , pei due grandi principj che lottano, il liberale e il clericale,
il quale è un principio politico combattente che è diverso dal principio reli
gioso , che si può rispettare in ogni uomo; si rispetterà anche il sentimento
dei protestanti ; ma la nostra società non è entrata ancora in questo rispet to ,
in questa sfera d i libertà. Noi siamo due principj combattenti . C iascun o è
forte; noi siamo forti d ' una vittoria, essi sono forti di quella forza della di
sfatta, per cui possono riprender potenza, e se non vincerei, possono incep
parci d ' assai nella via del progresso . Essi vogliono ristabilire le cose col par
tito di Fabio Massimo, cunctando. Sono dolente che negli uomini che go
vernano il nostro paese ci sia molta spensieratezza.
Carbone. Da chi è mantenuto il collegio di Arpino?
Incagnoli. Dall'antico patrimonio dato dallo Stato quando lo stabilì e man
tenne, adesso da un sussidio che dà la provincia in sostit uzione di quello
che dava lo Stato.
Carbone. Che cosa dà la provincia?
Incagnoli. Quindicimila lire annue, e circa altre quindicimila si ricavano dal
patrimonio.
Carbone. E il comune non concorre?
lncagnoli. I l comune concorre perché dette una parte della rendita d ' u n al
tro istituto e poi dà un cinquemila lire annue. Per poterlo costituire in for
ma compita ci vorrebbe qualche altra cosa perché trentamila lire non sono
sufficienti a mantenere u n centro di istruzione tanto più che i n un luogo co
sì remoto della provincia non è possibile avere professori che possano veni
re a dare insegnamento e non occuparsi di altro . Quindi bisogna avere pro
fessori rimunerati in modo da soddisfare alle loro giuste esigenze. Ecco per
ché a voler avere insegnanti come si converrebbe bisognerebbe che i com
pensi fossero più larghi . I nfatti in questo modo si vide escire da Arpino u n
distinto professore romano, il Santini, chiamato dal municipio di Roma. Egli
307
308
Fonti per la storia della scuola
era venuto ad Arpino per isfuggire alle persecuzioni del papa. Chiamato egli
a Roma non fu ancora possibile rimpiazzarlo. Per quanro si .s ia domandato
di avere professori buoni non se ne è potuto rinvenire perché lo stipendio
di 1 . 600 lire non può chiamare persone valenti e convenienti. Ecco perché i
voti della provincia sono di poter avere un centro d ' istruzione a fine di dare
sviluppo a questa.
Presidente. La Commissione la ringrazia.
25
Seduta di Bologna, 26 marzo 1 8 73
1•
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860-1 896), b . 5 , fase . 1 9 .
C ESARE BARDESONO D I RIGRAS 2
Presidente. (A mministrazione scolastica provinciale (I O). G iacché la
Commissione ha la fortuna di i nterrogare per primo il signor prefetto, io le
sarò grato se ella vorrà dirci la sua opinione intorno all' ordinamento scola
stico per ciò che riguarda il Consiglio scolastico provinciale; e se ella crede
che le innovazioni portate nel Consiglio scolastico provinciale abbiano gio
vato o nociuto, specialmente sul fatto d ' avere escluso dal Consiglio provin
ciale i direttori dei ginnasi e dei licei degli istituti secondari?
1
La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
Cesare Bardesono di R igras (Torino 27 giugno 1 83 3 - Roma 4 gennaio 1 892), prefetto di
Bologna dall '8 ottobre 1 868 al 26 agosto 1 87 3 . Entrò nel Ministero dell'interno nel 1 85 5 dopo
essersi laureato in giurisprudenza. Risentì fortemente l' influenza di Cavour presso il quale svol
se incarichi straordinari. Particolarmente attivo al momento dell'unificazione nazionale, fece
parte del gabinetto Farini in Emilia, successivamente fu a Milano come consigliere presso l' Uffi
cio di governo e quindi a Napoli dove si occupò delle elezioni amministrative e dell'organizza
zione delle guardie nazionali. Resse nel 1 86 1 il Governatorato di Capitanata. Prefetto dal 1 862
in diverse città, la sua azione fu sempre caratterizzata dalle sue posizioni di moderatismo libera
le. A Bologna condusse nel 1 870 un' inchiesta su Carducci accusato di posizioni antimonarchi
che, mostrandosi indulgente verso il poeta (vedi B. CROCE, Pagine sparse, III, Napoli, Ricciar
di, 1 94 3 , pp. 457-46 1 ) . Resse quindi la prefettura di Mantova, Udine e Milano. Nel 1 876 fu no
minato senatore. Il 29 luglio 1 878 assunse la prefettura di F irenze e nell'autunno dette esecu
zione alla direttiva del ministro De Sanctis per la soppressione del contributo comunale e la
cacciata dalla loro sede dell' Istituto fiorentino degli scolopi a San Giovannino, attirandosi molti
risentimenti da parte dei moderati fiorentini (cfr. doc. 1 8, n. 3, p. 2 2 3) e da • La Nazione » .
z
Sezione II - l t•erbali delle deposizioni
309
Bardesono. Intorno ali' ordinamento amministrativo della pubblica istruzio
ne, credo che le differenze introdotte coll 'ultima legge non abbiano modifi
cato di molto gl ' inconvenienti che io vi scorgo. Ritengo che il diffetto prin
cipale provvenga dai principi su cui si informa la legislazione sulla istruzio
ne pubblica . Credo che la libertà d ' i nsegnamento sia una idea giusta, ma in
concreta, e che non risponda a coloro, che se ne fanno sostenitori . Credo
poi che le nostre leggi non si informino completamente alla libertà d ' inse
gnamento; né siano conformi alla i ngerenza, che secondo i principii deve
avere lo Stato . Quindi credo che da questi difetti, che informano le nostre
leggi, ne vengano poi tutti i difetti che deploriamo.
Quanto al Consiglio scolastico provi nciale, io credo che desso non potrà
mai avere una seria importanza, finché non saranno ben definite le sue attri
buzioni. Ora se la Commissione crede che io dica la mia opinione sull' inse
gnamento, lo dirò francamente .
Presidente. Dica, dica.
Bardesono. Le attribuzioni del Consiglio scolastico provinciale sono t rop
po disparate fra di loro: ed in questo stato d i cose esso non può avere im
portanza sopra tutte le materie nelle quali esercita la sua autorità . I o vorrei
che la legge governasse tutti i rami del l ' insegnamento pubblico: vorrei che
la libertà d' insegnare fosse limitata alla i niziativa dei padri di famiglia; ma
la libertà di fondare stabilimenti di pubblica istruzione non la vorrei : ma
vorrei che tutti gli ist ituti p ubblici fossero soggetti all'au torità scolastica.
Questa autorità scolastica poi vorrei che fosse in condizioni necessarie per
esercitare tutte le sue attribuzio n i . L ' a u torità amminist rat iva, dove c i vo
glia competenza scient ifica, non è più al suo posto. E, venendo al caso pra
tico, nella istruzione secondaria, dove si tratta di cose tecniche, l ' azione
del prefetto e dei consiglieri provinciali non è più al suo posto . Noi abbia
mo corpi morali , che rappresentano l ' is truzione pubblica e queste sono au
torità; quindi per la parte della istruzione la loro competenza è superiore
ad ogni altra.
Quanto all' istruzione elementare non occorre u n corredo di dottrina
scientifica . Quando il governo ha dato u n i ndirizzo, ha segnate le norme
generali , l ' amministrazione è quella che è più competente. E questa vorrei
affidata al prefetto, ai sindaci, alla gerarchia amministrativa. Quindi am
met terei l ' autorità del C onsiglio scolastico provinciale sul la istruzione ele
mentare, e farei coadiuvare i l prefetto da u n buon numero di ispettori .
Presidente. (Ispezioni scolastiche). Riguardo alle ispezioni , neL modo in
cui si fanno attualmente hanno dato buoni frut t i ? Ora sono scelti volta per
volta.
Bardesono. I l numero degli stabilimenti non è tale da giustificare ispet tori
stabil i , ma si dovrebbero mandare volta per volta. Nella nostra provi ncia
le ispezioni sono pochissime e sempre per oggetti speciali, non mai gene
ral i .
310
Fonti per la storia della scuola
Presidente. (Ispettori manda mentali) 1 • E i delega ti manda
mental i hanno
fatto buona prova?
Bardesono. In qualch e luogo si ha la fortuna di t rovare person
a che abbia
voglia di occupa rsene, ademp ia a questo compito come ad
una mission e;
ma anche qui ci si sente la diffico ltà che dissi poco fa : del
l ' essere cioè le
attribuz ioni molto indeter minate.
Presidente. (Insegn amento pubblico e privato). E intorno
alle condiz ioni
genera li del l ' istruzio ne in questa provin cia vorrebbe dirci
il suo parere ;
che cosa pensa dell' istruzio ne govern ativa e del l ' istruzio ne
privata ? Sa ella
che la istruzio ne privata in questa provin cia sia data come
si convie ne , e
che sia miglior e del l ' istruzio ne govern ativa?
Bardes ono. Vi ho già in parte accenn ato; e quindi senza offe
ndere person e
rispetta bilissim e, che si occupa no di istruzio ne i n questa provin
cia, dirò,
che la istruzio ne second aria, che danno i privati , è deplore vole.
Credo che
gli istituti di istruzio ne p rivata, oltre a tutto il danno morale
e politico , che
portan o con sé, hanno anche l ' inconv eniente di i nganna re le
famigli e, per
ché offrono agevole zze nel prezzo , e fanno raggiri , perché i padri
mandin o
i loro figli in quegli istituti a prefere nza degli istituti govern
ativi, dove al
meno si può ottener e lo svil uppo necessa rio.
(Ginna sio di Bologna). Quanto al confro nto fra il ginnasi
o comun ale di
Bologn a e le scuola private , io credo di non fare torto a nessun
o se dico
che il confro nto non è possibi le. Non c ' è parago ne e per la
capa�ità e pel
numero degli insegna nti e pel corred o scienti fico, e per tutto
ciò che è ne
cessari o per fare u n buono stabilim ento per la istruzio ne second
aria.
Nel paese i n genera le , come in t u t ta I talia , la istruzio ne second
aria data
dal govern o è giudica ta male perché ferisce i pregiud izi di
tutti. E d è poi
natural e . Una person a, che è stata istruita bene , è natural e
che veda di ma
locchio questo sistema essersi riform ato o mutato , e che ai
suoi figli i nse
gni mal volenti eri con metodi diversi . Io per me credo che
questa genera le
opinion e non sia giusta. Il maggio r argome nto d i critica è
l a moltep licità
delle materi e nell ' i nsegna mento second ario. Ora questo non
può parere
un difett o : nessun o può discon oscere la necess ità di conosc
ere le scienze
fisiche , natural i ecc . , anzi io credo che piuttos to ci sia un
difetto , e stia
special mente nella manca nza di u n libro di testo unico.
(Libri di testo). I o credo che chi ha ispirato le n uove idee
sull' istruzio ne
second aria abbia esagera to un princip io vero , l ' abolizi one del
libro di testo
nelle u niversi tà. Ma a parer mio c ' è una differe nza immen sa
fra le materi e
d ' insegna mento univer sitario e quel le di insegna mento second
ari o . Credo
che alla u niversi tà si possa e si debba lasciare la più ampia facoltà
nelle ma
terie del loro i nsegna mento: altretta nto credo, che per l ' istruzio
ne secon
daria sia necessa rio un testo u niform e.
·
1
La domand a si riferbce in realtà ai delegati scolastic i.
311
Sezione I l - / verbali delle deposizioni
.
Di più credo che la uniformità del libro di testo avrebbe il vantaggio di
supplire alla deficienza degli insegnant i . Il regno italiano ha dovu t o in fret
ta provvedere tutti gli stabiliment i , per rimpiazzare i preti , che avevano il
monopolio dell ' istruzione: quindi ora non tutti gli insegnanti sono bene al
loro posto, ed il libro di testo supplirebbe alla loro deficenza.
Vi hanno poi altre ragioni troppo ovvie, perché io le debba esporre,
come sarebbe la facilità per i giovani che alla metà dell ' anno dovessero
passare da una scuola ad u n ' altra per traslochi od altro ; poi c ' è la ragione
economica, quella cioè della minore spesa .
V ' è finalmente u n altro argomento, direi di debolezza per l ' istruzione
governativa secondaria, e questo è speciale alla provi ncia di Bologna, vale
a dire la mancanza d ' u n convitto, dove mettere i giovani che frequentano
le scuole secondarie . Purtroppo le abitudini e i costumi del nostro paese
hanno dato molta importanza alla istituzione di convit t i ; e molte famiglie
nella città stessa vorrebbero mettere i loro figli in collegi o : per la provin
cia poi è una necessità, perché i padri in provincia se vogliono che i loro
figli prendano i gradi accademici bisogna che li portino a Bologna, che
manca d ' un collegio-convitto; e di questo si sono valsi i p reti: giacché v ' è
i l collegio d e ' barnabiti 1 • D i u n collegio-convitto s i pot rebbe provvedere
Bologna : anzi molti cittadini ed il Consiglio provinciale se ne occupano.
Bologna ha tre o quattro istituti privati , che hanno questo scopo, e che
hanno il nome di collegio; ed i loro fondi consistono nelle pensioni dei
giovani , che stanno là dentro . Una volta che si unissero tutti questi patri
mon i , si potrebbe formare un buon collegio, perché si avrebbe una rendita
di oltre 4 0 mila lire .
A questo la legge permetterebbe di venire; si sono però sempre trovati
degli scrupoli di legalità; scrupoli, che non dovrebbero avere ragione di
nanzi alla necessità della pubblica istruzione . Panni che questo sarebbe il
caso di richiamare l ' attenzione del governo, e anche del parlamen t o , se oc
corresse u na legge spec iale .
Tenuto conto di tutte queste ragion i , sotto tutti gli altri aspetti l ' i nse
gnamento governat ivo e municipale non lascia nulla a desiderare .
Presidente. (Insegnamento religioso). Ella ha accennato alle cause per cui
l ' istituto dei barnabiti fa concorrenza all ' istruzione governativa. Non ce ne
sarebbero altre? Per esempio, l ' i nsegnamento religioso non crede che pos
sa essere una delle cause principali?
Bardesono. Bisogna distinguere fra collegio e scuola : quando ho parlato
del col legio, non ho pregiudicata la quist ione della religi one nel conv i t t o .
S.
' L' istituto retto dalla congregazione di S . Paolo, detta anche dei chierici minori di Paolo
e nota col nome di barnabiti dalla chiesa di S . Barnaba a M ilano. La congregazione, fondata a
Milano nella prima metà del ' 500, si dedicò dal XVII secolo all 'educazione e alla istruzione sco
lastica. 1 barnabiti sono presenti a Bologna dal 1 77 3 , anno della soppressione dell'ordine dei
gesuiti . Nell'età della Restaurazione acquistarono palazzo Montalto come sede dell'istituto.
312
313
Fonti per la storia della scuola
Sezione 11 - 1 uerbali delle deposizioni
Ora non si può fare un confronto fra il collegio de' barnabiti e quello che
dovrebbe sorgere; ma certo lo si p uò fare colla istruzione pubblica. Presso
quell' istituto l ' insegnamento religioso è u na affermazione, è un fat t o : e
quindi non andranno che i figli di coloro, che vogliono espressamente un
i nsegnamento religi oso; mentre negli istituti governativi, dove l ' insegna
mento religioso di fatto non si dà, possono andare tanto quelli che lo vo
gliono, quanto quelli che non lo vogliono. Quindi non c'è ragione in ciò di
concorrenza.
Presidente. È s ta to notato (prescindendo ora dagl ' insegnamenti particolari
positivi) che, fra gli insegnanti governativi, c'è spesso una t endenza irreli
giosa, o contraria alla tendenza religiosa: non pare a lei, che questa sia una
causa di preferenza per convitti tenuti da corporazioni religiose?
Bardesono. Ciò è verissimo, e specialment e per le famiglie clerical i . Credo
anzi , che se si abolissero quei convitti, molte famiglie manderebbero i loro
giovani all ' estero : di questo ne sono persuaso.
Presidente. (Scuole tecniche). E sulla istruzione tecnica?
Bardesono di R igras. Le scuole tecniche sono , a parer mio, una istituzione
sbagl iata . Credo che la separazione dell ' i nsegnamento classico dal tecnico
sia u n errore di metodo , e, direi anche, polit ico . C redo che la origine delle
scuole tecniche dati dalla restaurazione del ' 1 5 in Francia. Ci fu un movi
mento antirivoluzionario, il quale partiva da questo principio, che la rivo
luzione francese fosse da attribuirsi all' insegnamento classico. D icevano : i
nostri rivoluzionari hanno imparato dai Bruti, dagli eroi dell'antichità; e
quindi s ' è cercato e spiegata la mancanza dell ' insegnamento cristiano, e
per ciò reagire contro l ' insegnamento classico : e s ' è detto !asciamolo a
quell i , che possono fare applicazione sensata di queste massime de ' classici
antichi; e quindi una scuola, che pretese di allontanare interamente l ' i nse
gnamento classico dalle scuole secondarie. Quest o da alcuni fu creduto li
beralismo; e credo sia stato un grande errore pieno di conseguenze funeste
e dal punto di vista dell ' istruzione e dal punto di vista politico 1 •
I o per esempio , credo, che l ' insegnamento della lingua latina sia uno
de' mezzi migliori per apprendere la grammatica italian a . E vedo oggi nelle
scuole tecniche la conferma delle mie opinioni. E mi confermo che il mi-
glior mezzo per apprendere bene l ' i taliano è di capire il latino. E credo che
se anche oggi si facesse un esame complessivo, u n confronto fra uno scola
ro che esce dal ginnasio e uno che esce dall'istituto, sarebbe più valente il
primo, perché ha il fondamento della lingua latina. Credo che la separazio
ne dell' insegnamento classico dal t ec nico si potrebbe fare con maggiore
utilità dopo un certo numero di anni.
Presidente. Per cui ella crede ut ile che nel ginnasio si preparasse tanto al
l ' insegnamento scientifico che al tecnico .
Bardesono. Si, e mi confermo in ciò anche per u n ' a ltra ragione e cioè per
ché le famiglie potrebbero farsi un criterio più sicuro della tendenza dei
loro figli ; giacché se si abbandona il latino è pregiudicato l ' avvenire di
questi ragazzi.
Presidente. E crede lei sia stato un danno l ' avere passato gli istituti tecnici
sotto la dipendenza di u n ' altro ministero ?
Bardesono. Non molto.
Presidente. Ma nel passaggio fra scuole tecniche ed istituti tecnici crede
non vi sia qualche lacuna, che bisognerebbe colmare?
Bardesono. Ne' programmi non la vedo. Non trovo deboli, programmi,
ma trovo piuttosto debole l ' insegnamento.
Presidente. H a nessun' altra parte su cui desidera parlare?
Bardesono. Non saprei. . .
Presidente. La Commissione la ringrazia.
1 For�e il rilievo dato da Barclesono alla polemica antirivoluzionaria come spinta all'istitu
zione delle scuole tecniche, nate soprattutto per rispondere alle esigenze eli sviluppo agricolo,
industriale e commerciale, esagerato. Mentre in Francia (Bastiat, Monsignor Gaume, Ventura)
e in Germania i tenebriones, particolarmente attivi dopo la tempesta del 1 848, spinsero a fon
do l 'attacco contro l'insegnamento classico e il modello eli Bruto, causa dei sussulti rivoluzio
nari e della diffusione di una morale edonistica e paganeggiante, in Italia gli echi di questa pole
mica furono assai più scarsi, perché sia la curia romana che i gesuiti e gli scolopi, a lungo ege
moni nel campo scolastico, erano fermi difensori della scuola classica, e attribuivano tutti i
gua•ti piuttosto all'istruzione moderna, all " il luminismo e poi al romanzo francese. Appaiono
isolatamente vicini alle posizioni di Gaume e dei tenebriones negli anni Settantal la rivista « La
Scuola cattolica , e l'arciprete G . A . Miotti.
è
26
Seduta di Bologna, 2 7 marzo 18 73 1•
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860-1 896), b. 5, fase. 20.
FRANCESCO D ' O VIDIO 2
Presidente. Vuole i ndicare il quesito su cui vorrebbe parlare ?
D 'Ovidio. Sul quesito 38 3, ove si parla degli studi classici. Vorrei dire che
è
1 L a seduta presieduta da Girolamo Cantelli.
' Francesco D 'Ovidio (Campobasso 5 dicembre 1 84 9 - Napoli 24 novembre 1 92 5 ). Filologo
e letterato, insegnò dal 1 870 al 1 87 5 lettere latine e greche nei licei di Bologna e eli Milano. Al
l 'università di Napoli dal 1 876 re>se la cattedra eli storia comparata della lingua e letteratura
neolatina. Senatore del regno dal 3 dicembre 1 905.
' D ' Ovidio e\'identemente si riferisce a un elenco dei quesiti ove non compaiono le nume
razioni bis di due quesiti, presenti nella maggior parte dei questionari nei quali il quesito relati
vo agli studi classici invece contrassegnato col numero 36.
è
3 14
315
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l t•er!Jali delle deposizioni
il concetto che si ha fuori è un concetto troppo sfavorevole di quello che
si ricava da chi vede le cose molto da vicin o . Il gi udizio che- si dà è u n giu
dizio che si fonda su dati non attendibili. La ripugnanza che trovo nel! ' i n
segnamento del greco era molto più rilevante nei primi anni che venne in
trodot t o , e se si tien conto di quanto si è fatto in questi ultimi anni si ve
drà essere molto diminuita. Io sono stato scolaro quando il greco s ' intro
duceva per la prima volta e fui il solo fra t renta che lo studiasse con u n po'
d ' amore. Negli anni posteriori il n umero è aumentat o ; e veramente io non
trovo nessuna differenza nella mia scuola fra il greco e il lati n o . I miei gio
vani studiano indifferentemen te l ' uno e l ' altro . E se dovessero scegliere
parte prenderebbe il greco parte il latino, e questo osservo perché si sente
dire che sia desiderio universale del paese eli abolirlo. È la parte peggiore
della scolaresca che non vorrebbe s tudiare né l ' u n o né l ' altro e per questo
si lamentano e in iscuola e coi parenti, il quale eco trova appoggio perché
nella istruzione prima d ' ora non c ' era; ma io ripeto non veggo questa dif
ferenza ed antipatia tranne da quelli che provengono dalle scuole del Se
minario, e dai barnabiti i quali sanno bene il latino. I n quelli che vengono
dall' Istituto Ungarelli o dal ginnasio non trovo nessuna differenza 1 • E se si
dovesse fare un suffragio non so se la preferenza si dovesse dare al latino.
Non dico adunque che i n alcune città i lamenti contro i l greco non siano
veri e spontanei, che delle difficoltà non vi siano da superare, credo però
che queste difficoltà dipendano da professori e dall ' epoca in cui si comin
cia a studiare e dal modo con cui si studia, per cui temerei che si prendes
sero deliberazioni troppo premature se si levasse l ' i nsegnamento del gre
co. Vorrei che si lasciasse t empo al tempo . È incredibile il miglioramento
eli questo studio se si confronta con quello eli dodici anni i ndietro ; intorno
al metodo vi è il sospetto che molti professori diano importanza eccessiva
agli studi grammaticali , che molti vogliono spingerlo anche più in là eli
quello che in un liceo è permesso; sarà forse possibile che q ualche giovane
professore voglia nella scuola fare dei suoi scolari altrettanti piccoli filolo
gi e elia u no sviluppo eccessivo a questa parte n uova. So che questi difetti
ci sono, so che ho amici e colleghi in altre città che hanno questo v izio ,
ma non credo che sia la generalità neppure eli quelli che adottano i metodi
modern i , che elia questa eccessiva importanza alla parte grammaticale . Sic
come ora si cominciano queste riforme bisogna lasciar freddare questo pri
mo calore; e il t empo correggerà questi abusi tanto più che si vede che la
riprovazione eli questi vari abusi parte da persone autorevoli come il pro
fessore Ascoli che ha dato solenne lezione ai giovani professori che comin
ciano a parlare eli sanscrito agli scolari del liceo . Una reazione v'è ma non
vorrei che questa si portasse troppo oltre perocché lo studio del greco e
del latino non è possibile senza portare un metodo più razionale eli quello che
si è fatto pel passato . La grammatica del Curtius è un po' troppo analitica e
scientifica ma nel fatto non è poi trovata [ . . . ] dai professori e dagli scolari che
la studiano. Quando si è spiegata bene gli scolari non hanno difficoltà a capir
la. È vero che essendo imposta questa grammatica, e siccome fra i professori
ve ne erano molti che avevano dato gli studi con altri metodi e non vi erano
preparati, questi hanno impreso acl insegnare la grammatica con malumore e
questo ha fatto più male che bene, ma quando questa grammatica sia insegna
ta bene non dà scapito della parte pedagogica perché questo libro è fatto per
unire la parte pratica alla parte scientifica; questa è una delle cose che il C ur
tius elice in tutte le edizioni della sua grammatica: egli elice che nel ginnasio e
nel liceo non è possibile apportare la vera scienza, ce ne vuoi tanta eli questa
che basti a portare l ' insegnamento razionale e non empirico, come si è fatto
sinora; dunque il Curtius nulla ha eli esagerato. Il professar Inama 1 eli Milano
ha pubblicato una grammatica che per scienza va molto più in là. Capisco che
la lingua si possa imparare praticamente, ma sopratutto la lingua greca pre
senti fenomeni così complessi e eli tale natura che non s ' imparano bene se
non sono ordinati da un concetto scientifico; il giovane non può imparare
empiricamente. Vi sono state molte delle generazioni passate che hanno im
parato volontariamente il greco, ma questo quanta fatica non ha costato loro?
Questa fatica rimane nascosta. Adesso il giovane col Curtius impara in un an
no ciò che prima richiedeva molto più tempo. Io stesso non ho trovato che il
Curtius e con questo sono stato sicuro della forma greca 1. Ciò successe a me
e così credo succede a tutti i giovani quando si sostituisce ad una grammatica,
col Curtius per esempio, una delle tante che corrono in Italia che non hanno
nessun valore né scientifico né pedagogico. Non basta eliminare la scienza
per avere il valore pedagogico e quello che non è scientifico non è neppure
pedagogico. Libri che non sono fatti secondo la scienza non sono fatti neppu
re secondo la sana pedagogia. Per cui non saprei che cosa si potesse sostituire
a questi libri che insegnati bene fanno prosperare lo studio della lingua greca.
Presidente. Quanto alla distribuzione dello studio va bene ?
D 'Oz•idio. Va benissimo, per rispetto poi al greco v a meglio c h e nella lingua
latina perché nel latino i giovani non lo cominciano perfettamente bene, se
ne svogliano più presto che del greco ed ora vi è forse più favore presso il
greco che presso il latino.
Presidente. Farebbe bene l ' i nsegnamento di qualche lingua moderna?
D 'Ovidio. Crederei necessario il francese e il tedesco : ma finché il l_a tino è
1 Nel m;. : erroneamente « Limala»; D'Ovidio si riferisce a Vigilio lnama, ordinario di lingua
e letteratura greca all'Accademia scienti fico-letteraria di Milano, autore della Grammatica gre
ca per le scuole, Milano, Valentiner e Mies, 1 870, voli . 2 .
' Come riferisce M . NOR,A, La memoria di Girolamo Vitelli, Firenze, Le Monnier, 1 936, p
.B. il professore ginnasiale del Vittorio Emanuele Il di Napoli , Domenico Denicotti, aveva fatto
arrivare da Vienna alcune copie del Curtius. allora. nei primi anni Se;santa, sconosciuto in Ita
lia, per i suoi migliori allievi.
.
1 Sull ' istituto diretto dai barnabiti e sull ' istituto privato Ungarelli si soffermerà il provvedi
tore Antonio Salvoni (vedi doc. 27, p. 3 1 9).
3 16
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l 1•erbali delle deposizioni
come ora, avrei paura di int rodurre n uovi studi e li riserberei a un avveni
re migliore. Voleva dire ancora rispetto alla moltiplici tà delle materie di
cui tutti si lamentano , che anche in questo io dubito molto della verità di
queste voci che corrono . In generale i lamenti partono dalla parte peggio
re della scolaresca, sono raccolti dai genitori , sono per la stampa e per al
tre vie p ubblicat i , se ne fa u n continuo scalpore, e pure benché questi sia
no anche in parte lamentat i dai giovani, pure la cosa vista da vicino dimo
stra che i lament i sono molto meno reali di quello che si crede . I migliori
giovani attendono a tutte le materie e vi attendono molto volentieri. Più
volte ho preso i n mano l ' elenco dei giovani e ho chiesto ai professori miei
colleghi sia di fisica che di matematica quali erano i più distinti: mi han
sempre risposto quei nomi che da me figuravano migliori nel greco e nel
latino. Sicché si veda che l ' avversione, che non nego d ' altronde possa es
servi, è pi utto sto una rilassatezza di cert uno ma non di tutti i g iovan i . D ' al
tra parte l ' istruzione moderna ha bisogno d ' essere completa ; io non conce
pisco oggi una persona colta, se non ha una certa cult ura di fisica, matema
tica, scienza naturale ecc. Dunque il problema consisterà nel vedere di tro
vare il punto fino al quale questi studi debbano esser fatti tutti, e trovare il
modo di poterli i nsegnare . H o sentito dire qui, e altrove tante volte, che
non si p uò pretendere di fare dei giovani tanti encicloped ic i : ma questa è
pure una esagerazione; si pretende forse per richiedere a u n giovane la ri
soluzione d ' u n problema, d ' un ' equazione che sia matematico? E pretende
re che uno sia grecista per richiedergli la traduzione d ' u n brano d ' Omero?
E così d ' u n fatto storico sia uno storico? Dunque al liceo non si pretende
né si potrebbe pretendere di fare degli enciclopedici, dei Pichi della M iran
dola . Ma che cosa ci vuole poi ad imparare un po' di matematica e di fisica
e via v ia quando se ne abbia buona volontà! Io le ho studiate queste mate
rie, non dirò con molto profitto, ma con molto amore, con molto affetto e
la mia coscienza non gonfia per la pretesa d ' essere e nciclopedico né u n
matematico o u n fisico. Questa parola adunque di enciclopedica è una pa
rola di cui si abusa. Si pretende che i l giovane si abbia quella cultura che ai
tempi nostri è divenuta importante ; si pretende che quando egli si vede
davanti al telegrafo sappia come è che s i muove, che non creda come i
contadin i , che vi entra il diavolo a farlo muovere; si p retende che quando
si trova s u u n vapore 1 che lo trasporta sappia come la locomotiva abbia la
forza movente e via via. Ecco adunque che si pretende . I o ripeto non pos
so farmi l ' idea d ' un giovane colto oggi se è privo d i quelle nozion i , di
quelle parti che si insegnano nei licei, il male è solo nella distribuzione di
queste materie. Adesso abbiamo una brutta partizione delle materie perché
invece di farle procedere gradatamente si tende a riunirle disordinatamen
te. Nei primi tre anni di ginnasio noi non abbiamo storia, l ' abbiamo nel
primo e second 'anno e non più nel terz'anno nel quale v i è l ' esame. Le
scienze fisiche sono tutte n eli' ultimo anno di liceo. Per sette anni interi il
giovane non deve capire niente del mondo esterno, non gli si i nsegna la
storia nat urale. Eppure se tutti ci ricordassimo le impressioni da fanciulli,
l e prime curiosità sono state del mondo esterno . Noi tante volte da bambi
ni avemmo intensissima la curiosità di sapere mille perché, le cause di tan
te cose . Ebbene quanto sentimento che fin da quella tenera età si sviluppa
in noi e ci trasporta verso il mondo esteriore invece d ' esser appagato è
adesso rintuzzat o , attutito. G li si dice: mettetelo da parte per ora e vi si in
segnerà quando avrete diciotto anni ora non dovete capire neppure come
l ' acqua bolle. Quando sarete in terz ' anno di liceo vi si insegnerà tutto quel
ben di Dio che là è concentrato. Ora è naturale che quando si trascurano
fin dai primi anni questi studi, è naturale dico che i giovani si annoino poi
se dovranno studiarli più tardi .
Presidente. Lei che ha fatto gli studi classici sotto l ' ordinamento t rova che
i giovani finiti questi studi, se non si danno la scienza, ent rando nella vita
per attendere alle proprie cose, conservino u na cultura generale sufficien
te pei colti cittadini ?
D 'Ovidio. Questo dipende non tanto dalla scuola e dal l ' insegnamento
quanto purtroppo dal carattere nazi onale . In I talia è u na cosa rarissima co
me in I nghi lterra trovare a mo' d ' esempio u n medico che segu iti a studiare
Omero, si citano come rarissimi Lord Gladstone che studiò il greco, Gra
te 1 banchiere, la storia. Loro si ricorderanno che mesi sono nei giornali
era pubblicata una lettera del ministro Sella diretta al i ' niversità d i T horn
che lo aveva nominato dottore: ebbene questa cosa ha fatto un impressio
ne così strana che se il ministro Sella fosse andato in piazza a ballare non
avrebbe fatto una impressione così nuova e st ravagante . E quando s ' è sa
puto che tutti i giorni traduce un pezzo di Lucrezio e d 'Orazio è parso una
cosa dell'altro mondo. Eppure questa è u n a noncuranza comune purtrop
po al nostro paese.
Dagli impiegati che cosa si legge? Niente: fuori del giornale o anche so
lo l 'appendice, o qualche romanzo fran cese che avrà fatto più chiasso.
Dunque il problema è un po' complessivo, c ' è del pedagogico in quanto
ché se l ' istruzione si potesse perpetuare come sonvi gli studi, allora sareb
be possibile che si segu itasse a studiare con piacere fino alla tarda età; ma
questa, ripeto è [più] una quistione di pedagogia nazionale e anche di psi
cologia , di quello che quistione del ginnasio o del liceo .
Presidente. E quanto agli esami crede che siano dati in modo soddisfa
cente?
D 'Ovidio. D irò : gli esami hanno difficoltà i ntrinseche come ci sono i n t u t
te le cose umane ; e siccome adesso si porta u n riflesso speciale su questi ,
così dirò che s i h a l ' illusione che siano queste speciali agli esami, e invece
el ms . : • sapore »; evidente errore di percezione fonetica.
3 17
1 Nel ms.: « Grm » . si traua di George Grote ( 1 79<!- 1 87 1 ), appartenente ad una famiglia di
hanchieri inglesi, che si divise fra l 'attività economica e gli studi classici e storici.
3 18
Fonti per la storia della scuola
Sezione fJ - l uerbali delle deposizioni
è tutt ' altra cosa. Per esempio ho sentito qui da un mio egregio col lega par
lare degli esami scritti che si fanno con l ' i nganno; fatta la legge, trovato
l 'inganno; tutte le gabelle banno per correlativo il con trabbando. Questi
sono proverbi noti. Ma non bisogna poi credere che gli esami siano poi giù
giù come si dice. Gli esami scritti da soli non bastano per formarsi un crite
rio del giovane ma non basterebbero neppure gli orali, uniti allora hanno
più importanza e si può dare un giudizio più esatto del giovane; non è un
giudizio perentorio, non è un giudizio che non possa essere errato. Se fos
sero fatti a ltrimenti sarebbe sempre la stessa faccenda. Ma questa non è
colpa degli esami , è colpa di tutti i princip i . Quanto agli esami troverei di
nuovo a lamentare la manca della partizione della materia e che parmi sia
una delle ragioni della poca riuscita degli studi, e della poca riuscita agli
esami. Agli esami di licenza i giovani debbono dare degli esami di italiano
e di storia dopo che da un anno hanno interrotti questi studi. C osì dicasi
della matematica: dunque questo aumenta la difficoltà; se tutti gli anni vi
fossero le stesse materie solo ampliate di mano i n mano, credo s ' avrebbero
fru tti migliori . Adesso noi portiamo i giovani a prendere t roppo tardi co
gnizione di st oria naturale e fisica; se si cominciasse prima sarebbe molto
meglio. Insomma il difetto che trovo nell' ordinamento attuale è la man
canza di equa distribuzione nelle materie. Ho sentito da alcuni proporre il
rimedio di spezzare gli esami i n due gruppi scientifico e letterario : questo
crescerebbe il male, ci farebbe lamentare più il danno che si lamenta ades
so d' una istruzione troppo isolata. Che la varie scienze fossero partite tutte
equamente e regolarmente e le difficoltà sparirebbero .
Presidente. Crede che nell'esame di passaggio fosse u n bene tener conto
del profitto durante l ' anno e i più distinti dispensarli anche dall 'esame?
D 'Ovidio. Certi giovani riceverebbero forse volentieri questa dispensa, al
tri l ' avrebbero anche per pena. B isogna riflettere che non siamo ancora al
l ' un iversità; i giovani del liceo tengono molto per la loro età all' amor pro
prio , alcuni hanno l ' ambizione di far bene gli esami, vogliono i punti, e se
si prendessero gli esami questi ne avrebbero dispiacere . Questo metodo so
che s i pratica in alcuni istituti pubblici e con successo, ma non nei lice i .
Presidente. E negli esami d i liceo è m a i avvenuto che giovani capaci siano
stati rimandati?
D 'Ovidio . Quantunque in astratto sembri che giovani bravi in certe mate
rie e deboli in altre, dovessero restare indietro , questo però non avviene in
pratica; si arriva in un modo o nell ' altro ad approvarlo; non si sta mai al
vero rigore . Non credo dunque in realtà che giovani meritevoli d ' andare
a l l ' università perché deboli in una materia siano stati arrestat i . Lagnanze si
sono fatte anche sui giornali ma le credo infondate .
Presidente. S e fossero dunque state fatte sarebbero partite da coloro che
erano veramente inetti?
D 'Ovidio . Forse ci può essere qualche caso eccezional e . Una delle difficol-
tà grandi che trovo per la buona riuscita del l ' istruzione è anche la poca di
ligenza dei genitori a curarsi del profitto dei loro figli . I o sono da tre anni
professore a Bologna, ho avuto circa duecento scolari , e sei solo parenti si
presentarono a chiedermi conto dei loro figli. Sono d' essi quattro padri,
una madre e un nonno; e si ché al caffè e altrove ci siamo trovati per mesi
continui con alcuni padri dei miei scolari . Quelli che sono venuti o a casa
o dal preside non sono che sei e li ho scritti nel taccuino perché mi pare
un fenomeno . Loro sanno anche come l ' istruzione della donna sia giù da
noi , quindi i giovani in casa non imparan niente e vengono a scuola privi
di quella educazione che sarebbe indispensabile venisse data dalla famiglia;
a casa perdono quel tanto che han imparato alla scuola e allora i l profitto
non può essere che poc o . Du nque bisogna persuadersi che gli insegnanti
non trovano nessuna cooperazione dove la dovrebbero trovare . I padri do
vrebbero assumersi la responsabilità dei figl i ; o non sanno, o non vogliono
occuparsene menomamente.
Presidente. La ringrazio anche a nome della Commissione.
La sed uta è levata alle ore 5, l 5 .
3 19
27
Seduta di Bologna, 29 marzo 1 8 73 1 •
A C S , M P I , Div. scuole medie (1860- 1 896), b. 5 , fase. 2 2 .
A NTONIO SAL VONI
1
Presidente. Signor provveditore, lei vorrebbe dire lo stato della istru-
è
1 La seduta presieduta da Girolamo Cantelli.
' Antonio Salvoni, r. provveditore agli studi della provincia di Bologna, ex sacerdote. Inse
gnante in tutti i gradi dell' istruzione entrò in urto con le autorità ecclesiastiche per un suo "Ap
pello al clero" contro il potere temporale nel 1 859 e ancor più nel 1 86 1 in seguito ad un invito
da lui rivolto al clero bresciano per la formazione di una Associazione cattolico-liberale che gli
costò la minaccia della sospensione a divinis da parte del vescovo di Brescia. Dopo aver rinun
ciato alle funzioni di parroco a favore dell'insegnamento liceale, fu nominato provveditore a
Ravenna, quindi a Cremona, Padova, Firenze, Treviso, Pavia, Milano e Bologna. Dal 1 88 1 ispet
tore centrale al Ministero della pubblica istruzione, cavaliere dell 'Ordine di SS. Maurizio e Laz
zaro e della Corona d'Italia. Contrario al progetto di introdurre l'obbligo dell'istruzione ele
mentare, espresse le sue posizioni i n un opuscolo inviato alla Commissione d'inchiesta: Sul
progetto di legge Correnti - Scialoja per l 'istmzione obbligatoria - Lettera al deputato Za
nardelli del professore A n tonio Sall•oni regio provueditore agli studi in Bologna, Bologna,
tip. G. Monti, 1 87 3 (l'opuscolo è conservato tra le carte dell ' inchiesta nella b. 1 2, fase. 83). Sal-
320
321
Fonti per la storia della scuola
Sezione ll - l verbali delle deposizioni
zione secondaria, e degli istituti principali, che sono in questa provincia;
ed oltre agli istituti governativi, dirci la condizione degli istituti privati?
Salvon i. Per quanto riguarda la istruzione governativa abbiamo il liceo re
gio Galvani 1 , il ginnasio comunale, la scuola tecnica, sussidiata in parte
dal govern o , la scuola normale maschile provinciale e la scuola superiore
femminile sostenuta dal comune col concorso governativo .
Presidente. Q uesti istituti sono molto frequentati?
Salvoni. La frequenza credo anzi che sia soverchia: il liceo relativamente
non si può dire scarso, ed ogni anno dà un aument o . I l ginnasio, quant un
que abbia il concorso dell ' istituto Ungarelli e dell ' istituto barnabitico ha
u n aumento in u n anno d ' una diecina.
Presidente. Oltre all ' istituto Ungarelli 2 ed al barnabitico 3 v i sono altri isti
tuti?
Salvon i . Vi sono gli istituti elementari che propongono di compiere l ' i nse
gnamento tecnico : ginnasi non ci sono.
Presidente. E gli istituti privati sono frequentati, quanto i governativ i ?
Salvon i. Si, specialmente l ' istituto U ngarelli: ma per confessione dello
stesso direttore, quanto in questi ultimi anni è venuto progredendo il nu
mero e la frequenza degli istituti pubblic i , altrettanto è s � emata quella de
gli istituti privat i .
Presidente. Per c u i questa preferenza n o n è venuta d a u n bisogno della po
polazione, ma piuttosto dal preferire u n istituto all'altro .
Salvoni. Il concetto della superiorità di valore degli istituti governativi in
confronto dei privati oramai s ' è fatto largo tanto da potersi dire u n con
cetto u niversale .
Presidente. I due istituti privati, che ha accennato, hanno adottato i pro
grammi governativi, e gli insegnanti sono governativi ?
Salvoni. L ' istituto Ungarelli ha l ' assenso del Consiglio scolastico provin
ciale e si giova di qualche professore governativo.
Presidente. I giovani dell'istituto Ungarelli si presentano poi all ' esame di
licenza ginnasiale , fanno eccel lenti prove?
Salz,on i. Hanno fat to eccellente p rova, massime due anni fa , ed anche lo
scorso anno appunto perché ebbero questo rinforzo degli istruttori ufficia
li; ma in complesso non è un collegio, pel quale l ' esito degli esami pubblici
abbia portato detrimento, anche minimo alla buona opinione che godeva.
Presidente. Gode dunque buona reputazione?
Salvoni. Sì.
Presidente. A che attribuisce, se nelle prove d ' esame i giovani di quell ' isti
tuti sono superiori , la preferenza, che le famiglie danno all ' istituto Unga
rel li?
Salvon i . P iucché ad altro, io credo , al bisogno che molte famiglie hanno di
avere il proprio figlio appoggiato interamente alla custodia di persona fi
data .
Presiden te. È dunque i l convitto . . .
Salvoni. Molto; ma il convitto si alimenta i n gran parte più di quelli che
stanno fuori della città , che di cittadini.
Presidente. E l ' istituto de' barnabiti è pure ordinato secondo i programmi
governativi?
Salvoni. Certamente.
Presidente. E i p rofessori ?
Salvoni. Sono tutti barnabit i .
Presidente. E i risultat i ?
Salvoni. I risultati non avrebbero dato t u t t i questi saggi molto confortanti:
per esempio per la parte ginnasiale pare che ultimamente si siano sforzati
di rialzare l ' insegnamento : ma per l ' addietro si è trascurato u n poco l ' i nse
gnamento della l ingua greca.
Presidente. E presentano i loro scolari all' esame di licenza ginnasiale i bar
nabiti?
Salvoni. Sì .
Presidente. I barnabiti non hanno liceo?
Sa/vani. No : e lo accennò anche il superiore dell' ist ituto, il quale superio
re invitato confidenzialmente dal provveditore a dire se aveva avuto qual
che indizio che i suoi convittori frequentanti i l liceo, dal conto dei liceali ,
dalle lezioni che ricevevano, avessero patito , secondo i loro propositi, u n
minimo danno, e d ebbe l a risposta che n o n ebbero a deplorare u n minimo
indizio di una nocevole distrazione , che avesse fatto né l ' opera degl ' inse
gnant i , né quella degli scolari .
Presidente. Le prove fatte negli esami di l icenza ginnasiale a confronto di
quelle del l ' istituto Ungarelli sono state buone?
Salvoni. Furono al di sott o .
voni sosteneva che i n Italia non esistevano scuole « vere educatrici della mente e del cuore » , e
riteneva inoltre che il progetto dell'obbligatorietà della istruzione elementare era carente per
!"inadeguatezza dei mezzi di coazione suggeriti e che avrebbe comunque dovuto essere prece
duto dalla riforma della scuola elementare; gli stessi temi furono ripresi nella Lettera seconda
del provveditore A ntonio Salvoni al deputato Zanardelli sull 'istruzione obbligatoria, Bolo
gna, tip. G. Monti, 1 87"1 (ACS, MPI, Personale, 1860-1 880, b. 995 , fasc.« Salvoni Antonio »).
1 Fondato con decreto Farini il 1 2 febbraio 1 860, ricevette il nome di r. liceo Galvani con il
r. d . "� mar. 1 86 5 , n. 2229. Nel 1 87 3 ne era preside Prospero Viani e vi insegnava, in qualità di
reggente di letteratura greca e latina, Francesco D ' Ovidio.
1 L ' istituto era diretto da Luigi Ungarelli che si presentò alla Commissione nella seduta di
Bologna del 28 marzo 1 87 3 . Nell ' istituto, che aveva sede nel palazzo Martinetti, si svolgevano i
corsi elementari, delle scuole tecniche, del ginnasio, il corso liceale e di filosofia, il corso di lin
gue straniere e contabilità commerciale. Sull'organizzazione dell'istituto, i programmi, le nor
me per gli alunni ecc. vedi: Istituto - Con vitto Ungarelli in Bologna - Notizie, programma e
regolamento, Bologna, Tip. Cenerelli, 1 870. L ' istituto fu oggetto di una delle ispezioni com
piute dalla Commissione d 'inchiesta (ACS, M P I , Div. scuole medie, 1 860- 189 6, b. 7, fase. 59, s.
fase. 3 )
� Vedi doc. 2 5 , n. I , p. 3 1 1 .
.
322
323
Fonti per la storia della scuola
Sezione 11 - I l'erbati delle deposizioni
Presidente. E gli uni e gli altri al di sotto degli istituti pubblici?
Sa/vani. Sì; ma pei barnabiti farei entrare, oltre a ciò che . ho detto per
l ' U ngarelli, anche la istruzione religiosa, per cui è frequentato.
Presidente. E della disciplina nel ginnasio comunale e nelle altre scuole ha
buone notizie?
Sa/vani. Io l ' ho trovata i nalterata sempre: la scuola tecnica comunale pre
senta il pericolo di qualche rischio di indisciplinatezza 1 , perché vi si in
contra una gioventù estremamente viva e decaduta nella via di orbe abitu
dine depravate ma la vigi lanza e la solidarietà dei professori coi direttori
ha qui prevenuto alcun grave dann o . Ma non cessa il direttore di pregare,
e di avvertire certi indirizzi morali , che potrebbero poi temere un qualche
disordine.
Presidente. I professori sono rispettati?
Sa/van i . Sì.
Presidente. E nel ginnasio comunale?
Sa/vani. La disciplina è rispettata .
Presidente. Ella ha sentito che un cittadino 2 ha accennato ad un abuso dei
libri di testo, perché ha dovuto cambiarlo per quattro volte nel ginnasio .
Mi saprebbe dire che cosa sia questo abuso?
Salvoni. L'abuso potrà essere avvenuto i n parte nel ginnasio, e fu già av
vertito il direttore, e vogl io credere che ciò non avvenga più . Invece d ' es
sere d ' accordo cogli altri ogni professore sceglieva un l ibro di testo per la
propria materia, e quindi ecco il bisogno di mutare : ma il direttore fu già
formalmente avvisato, perché per l ' anno venturo cessi questo inconve
niente .
Presidente. E in provincia?
Salvoni. Abbiamo ginnasio e scuola tecnica ad Imola, scuola tecnica a Me
dicina, scuola tecnica a San Giovanni i n Persiceto . È inutile i l tenere parola
della scuola di Imola, perché l ' organico è fondato su quello delle vecchie
scuole pontificie . Ora però quel sindaco ha indicato una radicale riforma
nell' ordinamento di tutte le sue scuole, cosicché si possa avere parificazio
ne e p el ginnasio e pel liceo.
Presidente. E relativamente agli allievi ed alle allieve della scuola normale ,
una volta usciti dalla scuola, tien conto lei del modo, con cui disimpegna
no i loro uffici?
Salvoni. Qualche cosa: chi ne tiene più conto è l ' ispettore Armandi.
Presidente. E l ' ispettore Armandi ha trovato che adempiono bene ?
A rmandi 1 (alzandosi dal pubblico). In quanto alle maestre lasciano qual
che cosa a desiderare: ma poi non possiamo aver esempi che ne ' luoghi
molti popolat i , perché in certe località è impossibile, che u n maestro di
stinto vada. Ma a questo proposito io vorrei fare alcune osservazioni: e se
domani . . .
Presiden te. lo spero anzi che oggi stesso la commissione potrà ascoltarlo .
In generale (rivolgendosi al provveditore Sa/vani) lei non ha altri appunti
da fare sull 'andamento d eli ' istruzione secondaria i n questa provincia?
Salvon i. Circa alle scuole normali ho inteso ieri (con compiacenza, perché
ho visto confermata u n ' opinione che da tempo mi sta sull ' animo) ho i nte
so, che il direttore della scuola normale dopo avere messo in rilievo i titoli
di benemerenza della sua scuola, ha confessato che dopo tre anni di scuola
normale non presume di dare buoni educatori .
Questa è una sventura c h ' io deploro in I talia , non per le singole p ro
vincie, perché giudicando di singoli insegnan t i in correlazioni agli i nsegna
menti, non ne abbiamo alcuno degli inetti; ve ne sono de' buoni ed anche
degli ot timi : ma perché quello eh' io professo dover essere maestro ele
mentare, dichiaro di non trovarlo buon educatore .
Presidente. Nella scuola normale femminile sono tutti maestri , che danno
la istruzione, o vi sono anche delle maestre?
Salvoni. Tutti maestri, tranne la direttrice, che assiste per la buona disci
plina .
Carbone. Nella provincia ci sono ginnasi seminari li?
Salvoni. Ci è i l ginnasio seminario d' Imola e quello di Bologna .
Carbone. Sono regolari questi ist ituti?
Salvoni. Nel seminario di Bologna le cose procedono regolarmente, tran
ne che per il greco, appunto per la irregolarità degl i studi, con quello degli
istituti pubblici .
Carbone. Sono tutti intern i , semi naristi?
Sa/van i . Abbiamo seminari che ricevono anche giovani esterni e noi prov
vedemmo già, secondo la circolare ministeriale 2 •
Carbone. C ' è anche i l corso del ginnasio e liceo?
Salvoni. Sì.
Carbone. I professori sono forniti di titoli legali per l ' insegnamen to ? .
Salvoni. A m e consta che n o n sono in conformità cogli istitut i pubblici:
per la parte poi del greco, manca affatto; per cui quando venissero agli
isti tuti pubblici, non ci sarebbe quel l ' i ngranaggio, che occorre per entrare
negli istituti pubblici .
Carbone. E l 'istituto d ' I mola?
Salvoni. Non riceve che chierici .
1 In parecchie deposizioni (vedi per esempio quella di Pecile a Roma) è presente un giudizio
che individua negli studenti della istruzione tecnica una maggiore vivacità rispetto agli studenti
del classico, e che a volte si connota positivamente, più spesso negativamente come irrequie
tezza e indisciplina. in alcuni casi (a Ferrara per esempio) come sediziosità politica.
1 È l'a\·vocato Cuboni che aveva risposto alla Commissione d 'inchiesta nella stessa gior
nata.
' Gaspare Armandi, ispettore scolastico del circondario di Bologna, Imola e Vergato; non
sarà ascoltato dalla commissione che con la seduta del 29 marzo chiuse le audizioni a Bologna.
' Vedi la circolare 18 dic. 1 872, di cui alla n. I , p. 208.
.3 2 4
325
Fonti per la stor·ia della scuola
Sezione Il - / uerbali delle deposizioni
Carbone. Lei ha trovato bene organizzata la segreteria del C onsiglio pro
vinciale scolastico ; mi dica ciò che ne pensa, e come le ha tro.vate al trove ,
se soddisfano ai bisogni della istruzione.
Salvon i . Dacché fu cost ituito il provveditorato colla vigente norma ho
sempre considerato una lacuna grave per l ' ufficio del provvedito re la scel
ta del segretari o : perché bisogna prendere un ufficiale della prefettura, e vi
è pericolo che venga con poca buona voglia, giacché considera l ' u fficio
del provvedito rato come una aggregazione esterna e posticcia. Vengono
persone, che sono estranee affatto agli affari scolastici, e che non hanno
nessu n stimolo a familiarizzare coi regolamenti: e considerano come prov
visoria i n quell ' u fficio la loro posizione. Io ho sempre trovato dissociata la
mia posizione davanti ad un ufficiale di prefettura. Per cui deploro che lo
stesso segretario venga a trovarsi i n una condizione che lo avvi lisce .
Non è raro il caso in cui una ordinanza ministeriale porta il bisogno che
nello stesso giorno si siano diramate otto o dieci lettere ; ora per un prov
veditore t roverei questo più opport uno, più necessaria l ' esperienza d ' u n
pratico copista, d i quello c h e di u n segretario, quando il segretario debba
essere mutabile. Per cui desidererei anche preferito un segretario fisso no
minato dal provveditore, che potrebbe compatire se nei casi di bisogno
dovesse fare anche la parte di copista: oppure che piuttosto che u n segre
tario si abbia a dare ad un copista quest ' ufficio, perché vi sia q uella solleci
t udine che abbisogna .
Carbone. E i delegati mandamentali c h e utilità hanno recat o : c h e n e
pensa?
Sa/vani. Per me è un tasto un po' delicato perché io debbo qui far prece
dere che ho delegati scolastici che esercitano il loro ufficio in modo vera
mente benemerito ; ma mi pare difficile il t rovare persona che compendia
in sé proprio quelle particolari qualità che si richiederebbero a ben eserci
tare quell' ufficio . Per me il delegato scolastico dovrebbe avere più che al
tro gran zelo d' istruzione, ma anche gran prestigio d'au torità nel suo man
damento. D ' altronde ci vorrebbero persone molto agiate perché possono
percorrere spesso per tutti le parti del mandamento senza farne gravitare
la spesa, stante che non è provveduto al viaggio.
Carbone. Adesso si hanno le indennità di viaggio .
Sa/van i . I nvece è molto difficile trovare una persona autorevole molto e
che abbia gran zelo per l ' istruzione. Abbiamo avuto fin qui la disgrazia ,
c h e difficilmente i delegati mandamentali 1 si sono trovati alla portata par
ticolare che ha davvero il loro ufficio. Molti persistono a guardare e a con
siderare il loro ufficio più sotto l ' aspet to didat tico, che per quella influen
za che i nvece devono portare nella scuola, vanno e vogliono fare dei giu
dizi sulla parte didattica anziché concorrere coll ' au torità provinciale a fare
pressione efficace sui comuni per dilat are e far progredire i provvedimenti
dell' istruzione .
Crernona. Vorrei pregarlo a dire come sono distribuiti gli orari nell ' istru
zione secondaria.
Sctll'On i. Quello delle scuole tecniche è consecutivo: nel ginnasio è riparti
to in due lezioni una al mattino e l ' altra dopo mezzogiorno; quella del
mezzogiorno è fatta soltanto per l ' aritmetica .
Cremona . E par bene che si facciano queste lezioni tutte di seguito, all' au
torità scolastica di qui?
Salvoni. Il Consiglio provinciale fu u nanime nell 'esprimere il desiderio
che da qui innanzi si tengano due lezioni con notevole dist anza l ' una dal
l ' altra . Conviene col municipio che la distanza a poco intervallo non sia
bene. Il Consiglio provinciale la vorrebbe tale che lasciasse tutto l ' agio agli
scolari anche più lontani di recarsi alle case loro e di potere anzi i nterpor
re qualche mezz ' ora di studio .
Cremona . Può dunque sperarsi che questo nuovo metodo venga intro
dotto?
Sa/vani. Io voglio sperare che nel prossimo anno scolastico, e anche n el
l ' estate prossima si mettesse in pratica questo orario. Avremmo certo un
migliorament o . Io non mancai di far sentire il bisogno di introdurre questa
modificazione nell 'orario e non ho mancato di far osservare che è già in
applicazione in altra città .
Cremona . Sì: fatte poche eccezioni questo sistema nelle altre città è già in
trodotto.
Presidente. Ha qualche altra cosa da dire?
Sa/vani. Direi sulla ragione del poco profitto che in generale si vuole av
vertire nell ' istruzione secondaria. È i nnegabile che in questa istruzione
non abbiamo veduto una floridezza di risultati : le cause però io le ridurrei
a due specialmente, una esterna ed una interna. L ' esterna io la troverei
nelle scuole elementari. lo dico: la malatt ia da cui sono t ravagliati gli isti
tuti secondari è vera etisia : è u n ' etisia perocché ha principio nella scuola
elementare . Oggi i risultati della scuola elementare sono in generale tali in
tellet tualmente e moralmente che I ' opera della scuola secondaria trova un
terreno già guasto e guasto sì da riuscire troppo difficile a curarla. Io ho la
franchezza di dire che avrei preferito che il ministero anziché procedere
con u n ' inchiesta sull' istruzione secondaria avesse i ncominciato con una
inchiesta sull' istruzione primaria, da cui credo che rampollino le c o nse
guenze dei vizi che deploriamo nell ' istruzione secondaria. La scuola ele
mentare, come hanno sentito, non educa, non istruisce ordinariamente; in
generale i frutti della scuola elementare sono chiari: non educat i , mente
disordinata, anche la poca istruzione che si riceve nelle scuole elementari
è u n ' istruzione sbagliata : molto lavoro di memoria ma quel l ' educazione,
non dirò solo intellettuale , ma anche quella che consiste proprio nel gra
duato ed armonico sviluppo delle facoltà i ntellettuali noi non le riscontria-
1
Nel ms. : " parlamentari •. per evidente lapsus dello scrivano.
326
Fonti per la storia della scuola
mo. Quanto poi alle cagioni esterne il compito morale delle scuole secon
darie io lo considero occasione di demoralizzazione, se n·on fosse altro per
il pericolo del con tatto di tanta fanciu llezza non sorvegliata nel ri trovo
della scuola . Io quando ho voluto di frequente interrogare ogni anno i capi
direttori delle scuole tecniche ed elementari e li ho pregati a dirmi quale è
lo stato intellettuale e morale degli alunni, e anche oggi ebbi questa con
fessione da quattro o cinque persone au torevoli: si è riscontrato u n regres
so del lato morale. Ora le scuole secondarie che devono lavorare sulle basi
di intelletti già guast i , perché istruiti disordinatamente, e su cuori già gua
sti, che profitto ne ricaveremo 1? D u nque guasto morale, e d isordine intel
lettuale; ecco la base per cui l' edificio non può rialzarsi , e lavorando oggi
sulla istruzione secondaria, senza veder bene se la base stasse, temerei che
lavorassimo attorno alle screpolature esterne di u n palazzo il di cui interno
e le fondamenta sono già guaste e corrose . I vizi i nterni della scuola secon
daria poi, li ridurrei ad uno capitale. Non è curato abbastanza lo studio
della lingua, non fatto quale dovrebbe essere; e la mancanza di questo stu
dio della l i ngua io lo credo la causa precipua per cui il profitto è scarso.
Per me valuto con maggior importanza lo studio della lingua per il suo uf
ficio, direi quasi ginnastico, che ha negli studi e perché svolge l ' i ntelletto
dei fanciulli meglio di quello che lo facciano le scienze.
Io, per la lu nga esperienza acquistata nei ginnasi e nei lice i , ho sempre
notato questo fatto, e credo di non sbagliarmi , che i giovani usciti dalla
rettorica e che sono andati al liceo riuscivano male nella parte scientifica
se non erano ben fondati negli studi della lingua, e invece riuscivano bene
quelli che avevano proprio versato nei classici, che avevano già guadagna
to u n punto di progresso nella cultura letteraria e dei quali si poteva dire :
questi hanno gusto di lingua, questi possiedono proprio il metodo della
lingua. Ora gli istituti, nei quali sia per scarsezza di mezzi, di orari , o di
metodi, sia perché male insegnata la lingua, soffrono u n deperimento della
parte scientifica . I o veggo che fu forse la forza dei tempi che ci ha trascina
ti a questo abbandono dello studio della l ingua nelle scuole secondarie .
oi dopo aver avuto una quasi idolatria per lo studio della l ingua al punto
di dimenticarci perfino ciò che v ' era di più serio abbiamo poi avuto la
scuola della reazione: si è dett o : abbandonate lo studio della frase e della
parola: ci vuoi altro che frasi e parole per far progredire la società : scien
za ! scienza! scienza! Fu un vero delirio che invase la società e la scuola.
Oggi io cerco invano il giovane venuto al termine di questo t irocinio che
mi dia il min imo indizio di sapore di l ingua; di avere dimestichezza coi
classici, di scrivere in modo di dare un lucente specchio d ' essere in posses
so dei pregi p rincipali della lingua e che ci s ia nei suoi scritti proprietà e
purezza . Fra le altre cose citerò a prova di questa trascuranza il non aver
' La frase appare incompleta.
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
327
mai trovato che si facciano quegli esercizi di lingua per cui i maestri d ' Ita
lia G iordani e Leopardi riusc irono grand i . Io non veggo mai attuate i n nes
suna scuola quelle regole per le quali il giovinetto, dopo che si è di già get
tato nello studio della letteratura e nell' amore dei classici, siasi addestrato
per farsi proprie quelle bellezze di frasi e di concetto, voglio dire nelle t ra
duzioni dal latino. Noi vediamo questi sommi, Leopardi , G iordani , Monti,
riuscire specialmente perché si esercitarono nelle trad uzioni dal latino:
perché appunto essi comprendevano che questo esercizio serve al doppio
compito di coltivare il pensiero e la forma di esso e proponevano perciò ai
loro alunni gli esercizi di traduzione, in quanto che vi trovavano la parte
invent iva e non occorreva che la dettatura . Nelle nostre scuole, parlo in
generale, non ho trovato che sia dato un i ndizio di traduzione che si faccia
per questi due scop i , direi anzi che la traduzione dal latino in italiano do
vrebbe essere p i ù coltivata a preferenza della traduzione dell' italiano in la
tino per i maggiori rapporti di derivazione che vi sono fra queste due lin
gue. Non s i potrebbe veramente separare un interesse dall ' altro, perché
quando fosse adoperata questa traduzione per impratichire il giovane a
scegliere i vocaboli più propri , questa necessità lo porterebbe a sceverare
il vocabolo latino e quindi questo sforzo delle traduzioni sarebbe un p ro
gresso per la lingua. In genere si traduce purché ci sia il senso , il periodo
con sufficiente regolarità; ma mai un indizio d ' u n i nsegnante che v i dica:
vestitemi questo periodo dell ' autore latino della più studiata ed elegante
forma, scegliendo quello che il vostro criterio vi detta e prendendo occa
s ione dal tempo e dal luogo in cui siete . Io concludo però che tra i due vizi
che secondo la mia convizione mi portano a considerare le cause del deca
dimento dell' istruzione secondaria, trovo più meritevole di studio quello
che si riferisce all ' istruzione elementare in confronto di quello che si rife
risce alla istruzione secondaria . E dico francamente che noi non avremo
mai ottenuto una riforma sostanziale in queste scuole se non avremo pri
mo portato una radicale riforma nell' istruzione elementare. Ma deve esse
re radicale veramente fino al punto di esigere una legge nuova, giacché
quella del 1 8 5 9 non serve più allo scopo; e la prima riforma deve riguarda
re lo stipendio degli insegnanti; perocché senza di questo le scuole ele
mentari non educano . E ci conviene tutto giorno sentirsi a dire: perché le
vostre scuole normali non danno buoni educatori? Coi vantaggi e cogli uti
li che offre oggi la carriera dell ' insegnamento è impossibile che la scuola
normale possa dare dei buoni educatori . Le p overe scuole no n:t� ali sono
costrette ad abbassarsi talmente che è impossibile che esse possano adem
piere al compito di preparare educatori. Veggo che questi maestri sul con
to dello stipendio prendono continuamente anticipi, causa le angustie in
cui s i trovano . Ma io vado più in là e non deploro la scarsezza dello stipen
dio per la miseria del maestro , ma dico: qual gente volete presumere che
venga a questa carriera coli ' attrattiva d i questo stipendio che riduce il
maestro al disotto del l ' infimo grado degli altri uffici? Da questo lato però
329
Fonti per la storia della scuola
Sezione II - l verbali delle deposizioni
che cosa vediamo noi se vi u niamo anche l ' età così tenera richiesta dalla
legge per ricevere gli allievi al tirocinio per diventare maestri; fuori di
qualche eccezione, in generale sono quasi giovinetti. I giovani che vanno
alle scuole normali sui quindici anni, sono giovani spostat i cui forse pesa il
conti nuare nella carriera laboriosa ed umile del padre e che cercano nell ' i
d e a d e l patrocinio elementare di sfuggire a d u n a posizione troppo grave:
Sono giovani che hanno tentato per altre vie, pel ginnasio e pel liceo e
vanno alle scuole normali credendole più facili : sono giovani sui quindici
anni affatto inconsapevoli , ignari e non comprendono nemmeno l ' altezza
dell 'ufficio cui stanno per consacrars i . Vengono lì prima che l ' anima abbia
provato la sua forza morale, a fare questi t re anni di scuola; come è presu
mibile che l ' istruzione elementare possa ricevere da questa gente quella le
va che il paese domanda dali ' istruzione elementare? La moralità del popo
lo non la possiamo avere che dalle scuole elementari . I o ho voluto in que
sta occasione dire la mia convizione in questo senso, credo che sarà vera
mente preziosa l'opera che scaturisce dai loro studi nel volere avvertire
tutti i difetti dell' istruzione secondaria ; ma i risultati della inchiesta saran
no tanto più efficaci e profondi quanto più essi porteranno la loro inchie
sta nell' istruzione elemen tare.
Carbone. Crederebbero utile all' intento che Ella si propone, procurare
con un programma rivolto a quelle scuole, che il ginnasio avesse con sé la
c lasse terza e quarta elementare coordinate agli studi classi c i ?
Salvoni. Io n o n crederei che ne potesse venire gran fatto di vantaggio da
questa innovazione, tanto più che non mi pare che possa venire sulla linea
dei provvedimenti ossia dei ripari ai disordini che abbiamo; manca alle scuole
elementari tutto il lievito educativo e dunque neanche coll 'instaurare le due
classi superiori elementari in precedenza al ginnasio ovviate al male. Il rime
dio bisogna cercarlo in un campo puro e radicale di provvedimenti e di leggi
e portare più innanzi l' età; non vorrei che il maestro potesse essere messo
nell 'esercizio dell ' ufficio, prima dei ventitre o dei ventiquattro anni e aspetta
re quell 'età giovanile in cui si può avere la guarentigia che il morale di chi si
dedica a questa carriera abbia già provato e sostenuto se stesso, ciò che non si
può dire del ragazzo di quindici o sedici anni .
Presidente. La Commissione lo ringrazia.
A cri . Sì, di filosofia; io ho raccolte parecchie osservazioni facendo ispezio
ni nelle scuole secondarie: il male che t ravaglia queste scuole è che i mezzi
non sono sempl ificati per l ' ottenimento del fine; e anche il fine a cui sono
indirizzati è ancora incerto nella coscienza dei professori stessi . Si ritiene
da molti che le scuole secondarie abbiano per fine d i formare l ' uomo e
non il professionista. Quali debbono essere gli i nsegnamenti da dare per il
perfezionamento di quest ' uomo? Chi dice che le materie sono troppe e chi
dice che sono poche. Ora quello che a me pare, per ottenere questa sem
plificazione di mezzi si è primieramente questo: che a ciascun professore si
affidi l ' i nsegnamento della stessa materi a , sia nel ginnasio, sia nel liceo;
vorrei che u n professore solo insegnasse latino in t utte le classi del ginna
sio e del liceo : uno l ' italiano , uno il greco eccetera. Vediamo quali sono le
difficoltà che si potrebbero fare a questa mia proposta e come queste diffi
coltà si possono facilmente togliere . La d ifficoltà è che un professore solo
non ha il tempo, ed io rispondo cos ì : ordinariamente da una esperienza
che ho, la più parte dai professori, dopo fatta la lezione officiale, fa lezioni
private perché lo stipendio del governo é piccolo ed ha bisogno di com
pensarvi con guadagni straordinari. Il governo potrebbe dire : voglio che vi
occupiate tutto per me; vi aumenterò lo stipendio . Così i professori non
darebbero lezioni private, avrebbero lo stipendio aumentato , la responsa
bilità sarebbe sostanziale e non apparente. Se ora si va in una scuola di li
ceo e si dice al professore: « < vostri scolari non sanno di latino » risponde:
" Mi sono venuti male preparati dalle scuole ginnasiali , : e così l ' uno incol
pa l ' altro , in modo che non si sa più a chi addebi tare il profitto degli scola
ri e il poco profitto degli scolari stess i . I no ltre affidando l ' i nsegnamento
della stessa materia a uno stesso professore vi sarebbe molta più facilità a
mettervi professori buon i ; migliori di quelli che abbiamo presentemente
perché ora abbiamo bisogno di sei professori che i nsegnino il latino; di sei
professori che i nsegnino l ' italiano . Che c osa è più facile: trovare u n solo
professore valente o trovarne sei ? Poi aggiungo che diffici lmente i profes
sori sono concordi fra loro : in ogni liceo e ginnasio vi sono dissidii fra
professori e presidi, e fra professori scambievolmente : diminuito il n ume
ro forse la concordia v i sarebbe. Vorrei che i l preside fosse un professore
eletto a maggioranza di voti fra i suoi collegh i : al presente si osserva che il
FRANCESCO A CRI 1
la » un saggio, Considerazioni su ' licei e ginnasi d 'Italia, o ve sono svolti ragionamenti analo
ghi a quelli della deposizione soprattutto relativamente all'insegnamento filosofico. Assieme ad
Augusto Conti , Vincenzo Sartini e Vito Fornari, fu capofila della polemica dei cattolici contro
le tendenze hegeliane e materialiste dei professori di filosofia nei licei, giudicate pericolose per
la fede religiosa e la morale dei giovani. A queste argomentazioni, la cui sostanza appare nell'in
chiesta condivisa da molti padri di famiglia, anche liberali, risposero Bertrando Spaventa e
Francesco Fiorentino (già compagno di studi di Acri i n Calabria). Vedi di quest'ultimo La filo
328
Presidente. Lei è professore all' Università?
1 Francesco Acri (Catanzaro 19 marzo 1 834 - Bologna 2 1 novembre 1 9 1 3) . Frequentò gli
studi a Catanzaro. Laureato in giurisprudenza nel 1 857, vinse a Napoli un concorso per una cat
tedra di filosofia nel 1 86 1 . Si recò quindi in Germania dove frequentò le lezioni di F. A. Tren
delenburg e di K.L. Michelet. Dal 1 866 al 1 87 1 insegnò filosofia teoretica all'università di Pa
lermo, poi storia della filosofia all 'università di Bologna. Nel 1 87 3 pubblicò sulla « Rivista sicu-
sofia contemporanea in Italia. Risposta di Francesco Fiorentino al professar Francesco Acri,
Napoli, Morano, 1 876, e Scritti vari di letteratura, filosofia e critica, Napoli, Morano, 1 876,
pp . 3 3 1 -347.
330
33 1
Fonti per la storia della scuola
Sezione li - l verbali delle deposizioni
preside ordinariamente non insegna. Rappresenta solo il mantenitore della
disciplina: i professori che insegnano credono di rappresentare la scienza e
quindi nasce un conflitto fra loro per l ' autorità reciproca i ndiv iduale . Il
preside non facendo scuola i nvece di progredire va indiet ro : e i professori
che se ne accorgono non potranno più avere quel rispetto che avrebbero
ad un i nsegnante eletto fra loro. Vorrei insomma che al liceo si facesse
quello che si fa alla università: si avrebbe anche il vantaggio che il ginnasio
ed il liceo sarebbero fra loro conness i ; i professori nel l ' assegnare l ' orario
non baderebbero più alla comodità loro : presentemente i giovani non han
no tempo di riposarsi e quando vengono all ' ultima lezione sono così stan
chi che non capiscono più nulla. Quando i professori non avessero altre
occupazioni che quella della scuola governativa, nel distribuire l ' orario ba
derebbero più all ' ut ilità dei giovani che alla propria. Vorrei anche che ai
professori fosse levata quella parecchia libertà che hanno nello scegliere i
libri di testo, perché ve ne sono molti che danno l ibri di testo fatti da loro
stessi : vorrei che il libro di testo avesse una certa autorità come ha in ma
tematica l ' Euclide, ed in letteratura Dante : così vorrei che in filosofia si
desse un libro la cui autorità fosse storica, perocché molt i per aumentare i
guadagni vi abborracciano libri di testo in un anno, i quali i giovani biso
gna li comprin o .
Venendo ora a dire degli insegnamenti faccio osservazioni sull' italiano.
I giovani che escono dal liceo sono pochi quelli che sanno fare l ' interpun
zione . Noi stessi che ci lagniamo della insufficienza dei giovani, parlando,
mostriamo d ' averla st udiata poco . D onde la cagio ne di questo? È che non
hanno scopi ben chiari e i mezzi non sono coordinati a questo fine; abbia
mo un fine incerto e questo stesso male io lo trovo replicato in ciascun in
segnamento speciale . I l fine che si deve proporre il professore d ' italiano
non si sa: molte sono le opinioni e d iverse. Bisognerebbe che il fine fosse
modestissim o : vorrei che l ' insegnamento fosse indirizzato allo scopo di far
sì che il giovane potesse, uscito dalle scuole, scrivere quattro o c inque pe
riodi che fossero adorni di una certa eleganza. Per ciò fare b isognerebbe
dar libri di precetti scritti in buona lingua, ciò che ora non avviene spesso.
Secondo: vorrei che fosse fatto con molta regolatezza e che invece di esami
nare più testi di lingua in un anno se ne tenesse uno solo: per es. il Vasari, il
G iambullari, il Firenzuola, il Cavalca e via, via 1 • C osì i giovani acquistando
famigliarità con u no solo è più facile che acquistino una certa purezza di lin
gua nel notare le bellezze eli quello scrittore; così l' analisi che si fa sullo
scrittore classico dovrebbe essere ordinata, perché il giovane stesso seri-
vesse in buona lingua . Vorrei che l ' analisi logica fosse fatta con qualche in
terpunzione del periodo. Ora si ha un' analisi logica che apparisce come un
mezzo senza sapere il fine cui tende . Poi v orrei che non si desse da impara
re a mente una filza di sinonimi, ma solo quando cade in acconcio allora
ne tenessero nota : vorrei che si facesse quello che costumava secondo la
scuola del Puoti, cioè si facesse tener conto del bel modo di dire e in tutto
questo si tenesse sempre un metodo pratico. Invece di dettare regole sulle
parole, io detterei un periodo di un autore classico, lo farei scrivere sulla
lavagna disordinato e vorrei vedere se i l giovane sapesse notare i difetti
musica l i eli periodo: poi vorrei che lo confrontasse al periodo del class ico,
e vorrei che tutte le cose procedessero con questo metodo pratico, così
che le scuole assomigliassero ad un laboratorio 1 • Pel latino e pel greco
vorrei applicare la stessa regola che ho d etto per l' italiano, e vorrei che i
giovani fossero esercitati a parlare in latino. Quanto al greco è da fare la
questione se la grammatica del Curtius sia o no buona: ogni regola assoluta
che si voglia stabilire sempre mena ad errori ; certo il Curtius considerato
in sé è libro utilissimo perché vi dà le regole della l ingua in modo scientifi
co; però per quei professori che sanno valersi di questo metodo scientifico
del libro come un mezzo per l ' apprendimento delle regole è utile. Al con
trario per quei professori che si trovano impacciati a maneggiare queste re
gole io lo credo dannoso . In una ispezione che ho fatto ho trovato d ue
professori uno dei quali era i nnamorato d el C urtius e un altro non lo vole
va trattare e i nsegnava una grammat ica fatta da lui medesimo. I giovani,
che studiavano col professore che era un vecchio prete stato in Atene e
che insegnava con u na grammatica fatta da l u i , sapevano spiegare qualche
periodo eli classico greco e gli altri no. D u nque bisogna disputare sull'abili
tà di colui che si vale del mezzo della grammatica: la grammatica del Cur
tius è eccellente; nelle mani di chi sa usarla è u ti lissima, nelle mani di chi
non la sa adoperare è dannosa. Però tornando al proposito dell ' i nsegna
mento io dire i : voglio da voi professore l ' ot tenimento del fine e vi lascio
libertà dei mezzi . Così direi al professore di italiano : voglio che il giovane
mi sappia fare u n periodo eli italiano e via via, ma i mezzi li lascio a voi. Io
bado più al fine anziché alla determinazione dei mezzi. Venendo ora all ' in
segnamento di storia e geografia ho notato che le lezioni di storia sono un
po' rettoriche. Io vorrei un metodo più svelto in cui maestri e giovani fos
sero collaboratori i ns ieme, vorrei sbandita ogni rettorica, vorrei che i gio
vani dicessero un luogo, me lo mostrassero nella carta geografica e così
nella storia il giovane mi dicesse bene il tempo e il luogo del fat t o avvenu-
1 La polemica contro l'uso scolastico delle antologie è diffusa nelle risposte all'inchiesta
Scialoja: vedi per esempio la risposta di Cristofaro Grisanti (ACS, M P I , Div. scuole medie,
1860- 189 6, b. 1 0, fase. 72). Essa è dovuta a una concezione dell'apprendimento dell'arte dello
scrivere, basato sull'imitazione, che ha bisogno di un unico modello. Vedi in proposito M. RAI·
CICH, Scuola politica e cuttm·a da De Sanctis a Gentile
ci t . , pp. 1 30 e 1 3 1 .
.
.
1 Nell'articolo di F. DE SANCTIS, La scuola, in « Nuova Antologia », 1872, vol. 20, fase. VIli,
pp. 757-770, c'è la stessa concezione della scuola come laboratorio. Sia in De Sanctis, con un ta
glio più moderno, sia in Acri con una maggiore fedeltà al modello puristico, c'è una mediata me
moria della scuola di Basilio Puoti. egli stessi anni, in chiave diversa, la concezione della scuola
come laboratorio ritorna a livello universitario, sul modello dei seminari tedeschi, nei filologi.
332
333
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - I L•erbali delle deposizioni
to . C osì vorrei che i giovani si esercitassero a disegnare le carte stesse sulla
lavagna. Non dico n ulla della matematica e delle scienze naturali perché
questa non è part ita che mi spetti ; dirò soltanto qualche cosa della filoso
fia . Nell ' i nsegnamento della fi losofia come è dato oggi si trovano grandi
difetti. Primo difetto è quello dei diversi sistemi che si insegnano : questo è
un male, questa diversità di opinioni che si professano nelle scuole, perché
contraddice al fine dell' insegnamento della filosofia che deve essere la for
mazione del l ' uomo, e non bisogna istru irlo solo nel l ' i nt elletto ma educar
lo ancora nella volontà. Ora ogni opinione che può nuocere all' educazione
del giovane bisogna sbandirla ed io in u n liceo non tollererei un professore
ateo o materialista perché vedo che non sarebbero utili pel fine cui sono
ind irizzate le scuole secondarie . Altri dicon o : sbandite dai licei la filosofia
perché è inutile: questo è contrario al buon senso ed io vi discorro qui da
positivista. I l genere umano riconosce che P latone, Aristotile, Hegel, sono
grandi e poi dicono che dicevano corbellerie . Perché il genere umano
chiama grandi questi uomini che dicevano corbellerie? Se sono grandi co
me elice il genere u mano bisogna pure che la filosofia sia grande, dunque la
filosofia vi deve essere per la tradizione delle nostre scuole e perché un
giovane non potrebbe uscire dal liceo senza saperci dire che cosa è intel
letto, anima, corpo ecc . Però bisogna che non contraddica all'educazione
morale e che non offenda il fine delle scuole secondarie . Alcuno qui vi
propone un programma ufficiale che costringa il professore; questo non va
perché i programmi ufficiali sono inutili colla filosofia (ilarità); e i profes
sori che ci dicono di essere liberi e di osservare i programmi lo fanno i n
apparenza. M i ricordo quando era a Verona ispettore mi trovai con u n pro
fessore materialista, il quale credendo che io fossi spiritualista , mi fece una
lezione da spiritualista; ed io che conobbi questa contraddizione, osservai
i quaderni dei giovani e trovai che il giorno prima aveva fatta la stessa le
zione da materialista (ilarità) . I programmi officiali sono affatto inutili: al
cuni dicono : distinguete filosofia elementare dall 'alta, la prima al liceo la
seconda all' università. Qui però vi è grande difficoltà ed è che che non si
può con notizia s icura segnare il limite che divide la filosofia elementare
dalla filosofia alta.
Vengo ad esempi : il professar Dominicis 1 diceva: occupatevi delle fa-
coltà cieli ' uomo riguardo alla scienza, dell' antropologia: l ' i nt elletto, b iso
gna dire, nella scuola , è una facoltà indirizzata al vero . E allora che cosa è
questo vero? Perché al lora la definizione di intelletto sarebbe incognita
ove non si spiegasse per cosa è questo vero. I o definirei u n ' i ncognita me
diante un' altra incognita. (Bene, braz>o dal pubblico). La distinzione d i fi
losofia elementare da filosofia alta, è inat tuabile, è inconcepibile . Bisogne
rebbe secondo me porre questo rimedio: cioè restringere la filosofia den
tro certi confini, stando entro i quali, il professore non vedrebbe offeso il
suo amor proprio se non fosse tenuto a manifestare opinioni inopportune,
cioè elementi eli logica fondata sopra passi di Aristotile . Secondo. Esami eli
qualche dialogo ed anche u n compendio di morale cavato da Aristotile.
Quale utilità se ne ricaverebbe? Primieramente l ' insegnamento della filoso
fia si conterrebbe coll ' insegnamento fi losofico: i nfatti ciancio le regole del
la logica aristotelica sui passi di Aristotele s i esercitano i giovani nel greco;
insomma io spiegherei il valore filologico dalla lingua filosofica . Voi dan
do ad insegnare u n dialogo eli Plato ne date ad imparare u n sistema forma
to: ma bisogna notare che quando fo studiare a ' miei giovani u n pezzo di
Platone, faccio studiare un monumento cl ' arte senza andare a vedere se è
vero o no; io noto solo le bellezze inarrivabili di quel dialogo. Per esempio
il Pedone che tutti riconoscono essere un monumento del l ' arte e lavoro
classico. Io darei a studiare Platone, come lavoro artistico: se noi cerchia
mo in tutti gli altri insegnamenti di avere un testo classico in mano, perché
in filosofia non ricorrere a un testo classico come Platone e Aristotile? Per
esempio dando ad insegnare Francesco Maria Zanotti 1 io col lego insieme
la filosofia colla lingua italiana. Però questo mio rimedio parrebbe anch ' es
so i nefficace .
Come Panzacchi 2 diceva, è impossibile che il pensatore stia costretto
nel testo. Se non s i fa in iscuola questa conversazione, s i fa fra maestro e
scolaro per via: se egli vuole mi manifesta la sua opinione materialistica o
nella scuola mentre commenta Platone o fuori per via. Il solo rimedio pos
sibile è che il governo bisogna badi non t anto a guardarsi dai professori e
1 Francesco Saverio De Dominicis (Buonalbergo, Benevento, 2 2 marzo 1 84 5 - Pavia 1 6 no
vembre 1 930). Laureato in filosofia all ' università di Pisa nel 1 868, insegnò per oltre un decen
nio nei licei di Cremona, Venezia e Bologna, ove era in servizio nel 1 87 3 . Nel 1 88 1 fu nomina
to professore straordinario di pedagogia nella facoltà di lettere e filosofia di Pavia. Fu collocato
a riposo nel 1920. Aveva deposto il 29 marzo 1 87 3 , trattando soprattutto dell'insegnamento
della filosofia. Attento osservatore e studioso dei problemi connessi all'organizzazione scolasti
ca dell' Italia unita, della quale segnalò con vigore numerose carenze dal livello dell'istruzione
elementare a quello universitario, diede vita alla fine del secolo a un movimento di opinione
che prese il nome di Partito nazionale della scuola. Dal 1 906 al 1 9 1 0 diresse la « Rivista di peda
gogia » .
1 Francesco Maria Zanotti, letterato e filosofo (Bologna 6 gennaio 1 692 - ivi 25 dicembre
1 777). Professore di filosofia insegnò all'università di Bologna dal 1 7 18. Segretario e poi presi
dente dell' Istituto di scienze. La sua posizione filosofica è caratterizzata dal tentativo di conci
liare il superstite aristotelismo con le dottrine cartesiane e newtoniane. Autore di numerose
opere poi raccolte dal discepolo Palcani (Opere, Bologna, 1 779- 1 802, voli . 9) e scrittore di lin
gua e stile purissimi.
2 Enrico Panzacchi (Ozzano, Bologna, 1 6 dicembre 1 8'f0 - Bologna 5 ottobre 1 904). Laurea
to in lettere all'università di Pisa, allievo di P. Villari e di A . D 'Ancona, insegnò in numerosi li
cei. Rispose alla commissione nella seduta di Bologna del 2 9 marzo 1 87 3 come segretario e
professore della R. Accademia di belle arti. el congresso pedagogico di Bologna del settembre
1 87'f sarà relatore sull'istruzione religiosa sostenendone l'abolizione i n nome della laicità della
scuola, e scontrandosi nel dibattito successivo con Francesco Acri, docente di storia dell 'arte
all ' università di Bologna, fu deputato e sottosegretario alla pubblica istruzione nel ministero Sa
racco (24 giugno 1 900 - 1 5 febbraio 1 90 l ).
335
Fonti per la storia della scuola
Sezione 11 - 1 verbali delle deposizioni
dai programmi, ma a scegliere gli stessi professori, scelti professori che
non trasmodino essi, e all ora tutto sarà accomodato.
Quanto all' insegnamento religioso, vi deve essere o no? Se guardo la
questione prat icamente dico: è difficile che v i sia perché l ' ambiente ora è
contrario , non è favorevole: bisogna essere positivi e riconoscerlo . Se
guardo la stessa questione teoreticamente : vi deve essere, e come vi deve
essere? Certo non come era pel passato, che invece di rendere la religione
veneranda, la faceva contennenda; perché si riduceva a poche pratiche.
Ora questo insegnamento religioso gesuitico, spigolistico, non poteva
bilanciare gli insegnament i che v i dà un professore di fi losofia . D ' altronde
se un professore fosse materialista, la sua opinione non potrà mai essere
soffocata dalla predica del padre prefetto o dalla recita del rosari o : dunque
se l ' insegnamento religioso vi deve essere, deve essere diverso da quello di
prima . Vi deve essere? Vi deve essere, perché le scuole secondarie hanno
per fine di educare. Se hanno per fine di educare bisogna dire: l ' insegna
men to religioso, può essere mezzo educat ivo? Secondo me è un mezzo
educativo dei più efficaci; perché bisogna distinguere l ' uomo a seconda
della sua età. Quando si è giovani , avere u na morale indipendente è diffi ci
le. Ogni verità bisogna che fonda i n una credenza; è impossibile dire ai
giovani : dovete credere alla vi rtù , per la virtù stessa. Osservo poi una diffi
col tà: come mezzo educativo difficilmente vi può essere nelle scuole se
condarie; perché solo allora vi potrebbe essere quando fosse pietoso. Per
ché basta ogni forma burocratica, i nevitabile del resto , a togliere ogni ef
fetto a questo insegnamento. Questa u nzione che dovrebbe accompagnare
l ' insegnamento religioso è tutta cosa spontanea. L ' insegnamento religioso
dovrebbe darsi come istruttivo, lasciando ai padri di famiglia il darlo come
educativo . Perché nelle scuole di greco e latino va insegnata un poco di
mitologia, giacché senza questa nozione, non si possono cap i re i classici.
Non solo il professore dà questa nozione, ma l ' approfondisce ; non vuole
solamente una nozione superficiale, ma cerca d i approfondirla. Per la stes
sa ragione b isogna che ai giovani che studiano Dante si dia una nozione di
religione: perché il poema di Dante che è tutto religioso , per essere spiega
to ha b isogno di una nozione religiosa. E poi perché mi pare i nconvenien
te che un giovane non conosca la religione dei suoi padri, la religione del
luogo ove è nato . Poi io dico una cosa che a noi italiani farà meraviglia, ed
è che i protestanti dell ' i nsegnamento religioso fanno gran conto. Nei gin
nasi di Berlino pel passato (ora non so) l ' i nsegnamento religioso è dato
con molta cura, perché v i si insegna la Bibbia, i quattro Evangeli, la storia
della Chiesa, in tutte le c lassi delle scuole. D unque vi dovrebbe essere, ma
come?
Vorrei che nelle scuole si leggesse un po' la Bibbia, u n po' gli Evangeli,
si desse qualche nozione della Chiesa e collegherei così l ' insegnamento re
ligioso alle altre istruzioni . Perché se veggo una bella traduzio ne della B ib-
b i a , come quella d e l Tommaseo, leggo ai giovani lavori d ' arte . N o i siamo
pieni di pregi udizi i . Oggi la lotta della C hiesa e dello Stato ha fatto s ì che
l ' una e l 'altro sono andati agli estrem i . I mmaginiamo il caso di Pio IX nel
1 84 8 ; se non avesse osteggiato l ' I talia, c redo che non si sarebbe neppure
all'insegnamento religioso : se non vi fosse stata questa lotta, l ' i nsegnamen
to vi sarebbe; ora ad ammettere questo i nsegnamento religioso vi è diffi
coltà. Se tutti i giornali parlano male del chiericat o, ed hanno ragione per
ché questi si oppone sempre alla nostra unità, il giovane che legge questi
giornal i , va alla scuola e non ascolta volentieri questo insegnamento reli
gioso : ecco perché diceva che l ' ambiente non è proprizio .
Da ult imo dico qualche cosa sulla ginnastica: mi pare che questa sia
pi uttosto di nome che di fatto. Secondo me vorrei che si usasse indulgenza
a un giovane che trascurasse una lezione di fisica o di matemat ica : nessuna
indulgenza a un giovane che trascurasse la ginnastica; perché come ben
disse Platone, la più grande armonia si è un bell'an imo in un corpo gagliar
do . Ora dico io noi non solamente dobbiamo indirizzare le nostre scuole
secondarie a educare lo spirito , ma anche a ingagliardire il corpo . Noi bi
sogna che facciamo ben mente acl addestrare i nostri giovani , perché po
tessero a un bisogno farla da soldati e d ifendere quella indipendenza che
hanno il diritto di possedere e mantenere quella unità che non è anche del
tutto sicura. Tutti i provvedimenti che si ottennero sono inutili in fatto di
scuole secondarie . A due cose bisogna badare: l o affidare l'insegnamento
delle scuole secondarie a u n piccolo consorzio di professori , ciascuno dei
quali risponda del fatto suo e si promettano dei premi a questo consorzio.
2 ° Badare alla ginnastica : facendo in questo modo , semmai avvenga che
uno squarcio si faccia nel cielo di questa Italia n uova, al lora avverrà che
non apparirà la nudità come avviene dei n ostri francesi vicini! (Bravo)
334
28
Seduta di Ferrara,
l
aprile 1 8 73 1
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860- 1 896), b. 6 , fas e . 2 - L
ENEA C A VALI ERI 2
Presidente. Lei è insegnante?
è
' La >eduta presieduta da Girolamo Cantelli.
' Enea Cavalieri è una delle poche voci di giovani che compaiono nell'inchiesta. H a appena
terminato il corso di studi giuridici a Pisa e il suo intervento è incentrato sulla critica ad un
-
336
Fonti per la storia della scuola
Cavalieri. o : sono studente uscito appena dalla scuola e appunto i n que
sto senso voleva parlare più dal punto d i vista degli scolari,- anziché da
quello degli i nsegnant i .
Presiden te. Benissim o, parli pure : qual ' è il corso degli studi che egli ha
compiuto?
Cavalieri. I l corso legale . È positivo che da molte parti s'è fatto accusa
della troppa varietà e gravezza degli studi nei licei e nei ginnasi; i nvece a
me è sembrato che questa fosse u na comoda scusa per gli scolari meno di
ligenti, i quali ammetto no questi studi troppo variati e pesan t i pel poco
amore con cui li coltivano ; invece quelli che portavan o amore agli studi fi
n ivano per dire che erano necessar i, perché s ' accorgev ano degli stretti
rapporti che passano fra gli u ni e gli altri : perché non si potevano coltivare
gli studi letterari senza la conoscen za degli scientific i e viceversa . E vera
mente parlando ad esempio degli studi letterari si diceva anche da taluno
degli scolar i : ci insegnan o troppo latin o ; a me i nvece pareva il contrario :
sembrav ami che il professo re, quando faceva lezione , venissesi u n brano
di classici, ne faceva l ' interpret azione, mai pretende va che nulla fosse fat
to a casa, o tutt ' al più erano compiti che sapevano di l illipuzian o, t radu
zioni , ma p iccole cose. Sentivam o dire al liceo dagli studenti, voi ci inse
gnate troppo latino e noi non avremo bisogno di vedere che t ut t ' al più il
Corpus ju.ris o qualche libro dimentic ato; tutti i buoni libri sono tradot t i ,
non pensando c h e vi era u n legame fra i l latino e l ' italiano p e r g l i intendi
menti pratici e scientific i della scienza . Non ci facevano gustare gli autori,
e adesso trovo che quegli studi non erano abbastan za profond i. La lettura
che si faceva degli autori era, direi quasi provviso ria, per scarico d ' obbli
go . Non si faceva la filosofia . Lo studio di V irgilio, d i Tacito , d i Tito Livio,
d ' Orazio o d ' altri autori latini consistev a in una semplice traduzion e, come
ho detto, mai che il maestro dicesse dopo aver i nsegnato i dieci versi del
Virgilio "a casa andate più avan t i , vi i nsegnerò io la traduzione , leggete da
voi tutta l ' Eneide » . Così quando si sapeva che il padre E nea s' era alzato dal
suo seggio eccetera, quando si erano sputat i pochi versi e soffiato i l naso
se n ' era fatto abbastanz a . I nsomma non si faceva l ' esam e , non si gustava il
bello dell' autore : questo, si diceva dal maestro, spetta alla storia letteraria ,
e in questa man iera scaricava no uno dosso all' altro il compito; si finiva per
render sterile l ' i nsegnamento.
Quindi s i toglievan o i punti di collegam ento alla vista dei giovani . Si di
ceva: che cosa importa di sapere dove era Troia, basta sapere che essa ha
esist ito. Non si approfon diva mai il soggetto , ed in questo senso dico che
certo tipo di insegnamento superficiale alquanto diffuso. Emerge, nello stesso tempo, il ricordo
di alcuni insegnanti che seppero instaurare un legame particolare con gli studenti e le cui lezio
ni divenivano uno scambio fecondo di idee. Ma viene anche sottolineato, a proposito dell'inse
gnamento della filosofia, come spesso gli studenti si trovino di fronte professori di scuole e di
pensiero molto diverse che usano, ciascuno, un metodo diverso.
Sezione Il - I uerbali delle deposizioni
337
la varietà degli studi non nuoce, anzi è u n a bellissima cosa che può portare
ai giovani buonissimi risultat i . Lo studente quando va a scuola si trova in
questa posizion e : molte materie fra le quali alcune noiose perché non arri
va a comprenderne l ' importanza : cinque o sei ore che deve passare sui
banchi della scuola e via via. Correggete d u nque queste antipatie , allettate
i giovani all' occupazione non colle burlette ma colla severità dell ' am ico
non del maestro . Così eravamo anche in fatto di greco; e quindi la quistio
ne se sia o non utile: si è detto che se s i c ava l ' etimologia il greco diviene
inutile perché la radice etimologica è piu ttosto una dote d ' erudizione ma
non un giovamento alla reciproca e comune intelligenza, ma all'infuori di
questo non potrete far balenare ai giovani qualche altra utilità. Ma quando
per esempio vi trovate dinanzi ad una statua non saprete darne la spiega
zione, mentre vi sarebbe facile se i giovani fossero stati alimentati in q ue
sto studio. Nella let teratura italiana per esempio io non ho mai v isto o se
non che di rado e ad esempio dal p rofessor Zendrini 1 , non ho mai sentito
dire : leggete i l tal libro od il tal altro . D i questo professore mi ricordo che,
se uno di noi fosse andato alla scuola e gli avesse anche ricordato un brano
del Tasso o d ' un romanzo o non saprei di un libro di pedagogia, a quello
scolaro egli sapeva subito improvvisare una connessione intima fra l ' auto
re che illust rava i n iscuola e le diverse letture fatte a casa : ci mostrava il
nesso così necessario, così logico che rendeva desiderosi tutti gli studenti
di fare quelle letture. Sotto questo aspett o io non posso lasciare di dire,
che , per quanto sia riverente a tutti i miei professori, l ' amore per la scuola
qualche volta cede in loro per l ' amore allo studio proprio . Difficilmente
ho veduto che u n maestro prendesse sotto braccio i suoi scolari : " e bene
che ne dite di quel che si è fatto in iscuola ? •• . Forse si crederà da t aluno un
atto umiliante, ma non lo è; questo sarebbe u n buon modo per far entrare
nei giovani le idee ed i concetti del professore. Il professore si arresta dal far
si l'amico e il consigliero dei suoi scolari: difficilmente si saranno visti dei
giovani andare a passeggio coi loro professori; diventa una casta separata, di
rei quasi come lo è quella della scolaresca. Si crede che la gioventù ed i capel
li bianchi non possono andare d'accordo. Ci sono degli ostacoli materiali spe
cialmente pel pettegolezzo che si introduce dappertutto; e tanto più facilmen
te quanto più sono piccole le città. Si direbbe che lo studente A va in compa
gnia del professar B per guadagnarsi dei punti favorevoli all'esame. Il profes
sore C va in compagnia dello studente B perché è amico del padre, il quale
per la sua alta posizione potrà accordargli favori. Ma siccome ogni compito
ha delle croci, così io trovo che i professori dovrebbero farsi superio_ri a que
ste dicerie che dal solo buon senso sono condannate .
1 Nel ms.: " Zandrini " si tratta di Bernardino Zendrini (Bergamo 1 839 - Palermo 7 agosto
1 879), professore titolare di letteratura italiana nel r. liceo Ariosto di Ferrara nel 1 865 - '66, in
segnò quindi lingua e letteratura tedesca all' università di Padova, morì a "!0 anni, quando era
professore di letteratura italiana all'università di Palermo. Studioso e traduttore di Heine criti
co letterario e poeta (ACS, MPI, Personale, /860 - 1 880, b. 1 397, fase. • Zendrini Bernard:no).
-
338
Fonti per la storia della scuola
Questo è quanto io mi proponeva di dire .
.
Presidente. Lei du nque ha svolto il suo concetto intorno alr insegnamento
che si dà agli scolari , ha mai osservato che questo insegnamento fosse
troppo soverchio?
Cavalieri. No, mai . M i parve poco sviluppato : per esempio quando u n
professore insegna u n ' i nfinità di forme algebriche e trigonometriche e no �
dà il modo di poterle svolgere che cosa ha i nsegnato ? Il professar Fatton
ni 1 , mio maestro, cercava sempre di dare a sciogliere molti problemi , ma
nella scuola ci i nsegnava il modo di risolverli , c i mostrava tutte le teorie
sui numeri primi e che so io senza fermarsi di soverchio per dimostrarci
1 ' i mportanza di quegli studi: i nsomma conduceva lo scolaro più che sul
campo della teorica in quello della prat ica; i nsegnando pure l ' aritmetica
col s istema del Bertrand 2 , non ci svolgeva tutti i teoremi bellissimi che vi
sono anness i . Trovo oggi specialmente questo d ifetto, di non dimostrare
abbastanza l ' utilità pratica che può ritrarre il giovine in avvenire dagli stu
di: se mostrate u n palazzo ad una persona che v i passa davanti egli l ' ammi
rerà , ma ditegli che questo un giorno sarà suo, che u n giorno potrà forma
re la sua felicità e allora lo guarderà con amore e con maggiore attenzione.
Presidente. Vuoi parlare degli esami ? Si è detto che si fanno sotterfugi , ne
sarebbe a cognizione lei?
Cavalieri: Sì, vi sono stati sottorfugi ed io ne ho approfittato, non lo ne
gherò. Ci davano dei problemi e se in tutte le scuole ci avessero avezzat i a
risolverli, se ne sarebbe arrivati allo scioglimento senza l ' aiuto di terze per
sone . Si pretendeva che i giovani mettessero insieme qualche cosa di ele
gante nella composizione ital iana o latina . Per esempio non sono molti an �
n i si ch iedeva la preferenza della p rofessione; il giovane doveva parlare d 1
sè senza aiuto degli autori , doveva dire : m i piace questo e quest ' altro e per
quale ragione, che poi nella sua poca esperienza non pot�va es � ere in gra:
do di tutte saperle. Taluno avrebbe dett o : voglio fare li med1co perche
amo sollevare l ' umanità e che so io tante altre belle parole: ma non più la
descrizione di un giardino, a mo ' d ' esempi o , appunto perché l ' esame era
portato sul campo pratico; e la Commissione ministeriale non ha fatt � os
servazione a questo distacco delle materie d ' esame che spaventava t u t t i .
Presidente. V u o i parlare anche sulle vacanze e sugli orari?
Cavalieri. Sì , in generale i giovani vann o a scuola senza entusiasmo, ma
non dirò che restino a casa con eguale entusiasmo ; e quindi poi vanno a
zonzo colla vedovanza di studi i n cui si trovano, non vanno nemmeno a
?).
1 Vespasiano Fattorini (Mantova 1 3 settembre 1 836 Dal 1 862 al 1 867 professore di ma
tematica al r. liceo AriostO di Ferrara.
2 joseph Francois Bertrand, matematico (Parigi 1 1 marzo 1 82 2 - 3 aprile 1 900). I nsigne ma
tematico e insegnante universitario, membro dell'Académie des sciences. Il suo testo dt mate
matica elementare per le scuole, uscitO in Francia in prima edizione nel 1 85 0 , fu introdotto nel
l'editoria scolastica italiana da E. Betti ( 1 823- 1 892) matematico, professore e poi direttore alla
Scuola normale superiore di Pisa.
Sezione Il - l verbali delle deposizioni
3 39
spasso con entusiasmo, e quindi sono poco da spaventare le difficoltà op
poste da taluno per queste vacanze . Qualche volta si chiedono ai professo
ri , adducendo scuse e anch ' io ne ho domandate per un motivo particolare
che veniva poi sotto il pretesto si sollevarsi dalle troppe fatiche, il che non
era vero, o per assistere ad un divertimento che non c ' era e specialmente
per una brutta consuetudine invalsa . Non dirò che oggi giorno non vi sia
progresso in questo: che i giovani non mostrino più spiegata la loro indi
pendenza e che nelle adunanze che si tengono per deliberare sulle vacanze
(e adesso le adunanze sono indispensabili) non si trovi chi dica: volete far
vacanza, io ci vado: non volete studiare a scuola, state a casa; tutte queste
questioni di procedura sono in lotta per le vacanze; e queste questioni vi
sono perché il parlamentarismo è in voga anche nelle adunanze . S i vuole le
vacanze per picca; buone ragioni non v i sono, perché torno a ripetere
troppa fatica della mente non vi è , poco amore sì, e poco amore per la ari
dità della materia e del metodo. P er esempio ho visto portarsi anche un
progresso da quelle tendenze d' allora nei vari giudizi che si facevano s ugli
esami . . . penso, non mi ricordo di che cosa precisamente parlassi .
Finali. Degli esami.
Ca valieri. Ah ! sì degli esam i . Si diceva, abbiamo u n dato punto da studia
re; abbiamo la nostra esposizione storica che non deve oltrepassare più in
là dal fisso per gli esam i ; non vogliamo approfondire di più, ci basta passa
re : mancava la gara . E questo non dirò per i nerzia, ma perché forse i p ro
fessori non erano abbastanza animati e non ci eccitavano a quella gara che
è sempre feconda di buoni frutti; o perché si sgomentavano alle prime dif
ficoltà e perché si ammetteva troppa distanza fra la cattedra e la scuola . A
Pisa per esempio il professar Gabba 1 e il professar Carrara 2 non fanno co
sì: io li ho visti a far questo: a prendere dopo la lezione i giovani a brac
cietto e ventilare di nuovo le questioni discusse in i scuola: e li ho veduti
1 Carlo Francesco Gabba (Lodi 1 4 aprile 1 835 - Torino 1 9 febbraio 1 920). Compì g l i studi
legali nell'università di Pavia tra il 1 8 5 2 e il 1 856. Nel 1 858 fu premiato dalla r. accademia del
le scienze di Bruxelles per la sua opera Philosophie du droit de succession. el 1 859 il governo
austriaco gli conferì la patente di professore privatO di diritto, riconosciutagli poi dal governo
italiano. Nel corso del 1 8 6 1 il municipio eli M ilano lo incaricò di tenere un corso di lezioni sul
diritto costituzionale nell'ambito di un corso straordinario di perfezionamento per maestri co
munali. Fu quindi nominato professore di diritto commerciale e pubblica economia nel r. istitu
to tecnico di Milano. Con r.d. 20 ottobre 1 8 6 1 fu nominato professore supplente di diritto na
turale e delle genti nella università di Pisa, in seguito divenne professore ordinario di filosofia
del diritto. Nel 1 900 fu nominato senatore.
2 Francesco Carrara (Lucca 1 8 settembre 1 805 - 1 5 gennaio 1 888), criminalista. Insegnò do
dici anni diritto criminale nel liceo. Nel 1 859 ottenne la cattedra di diritto all 'università di Pisa.
Autore di un Programma del corso di diritto criminale, si distinse per una vasta produzione
scientifica e fu considerato tra i maggiori criminalisti . DeputatO per il collegio di Capannori
nella VIII, IX e X legislatura fino al 1 870. Nel 1 87 5 fu nominato socio della r. Accademia luc
chese di scienze, lettere e arti e socio della r. Accademia dei lincei. 1 1 1 5 maggio 1 876 fu nomi
nato senatore.
340
34 1
Fonti per la storia della scuola
Sezione 11 - l t•erba/i delle deposizioni
anche spesso non rifiutarsi di metters i in discussione cogli scolari durante
la lezione. A Ferrara questo non si fa. Per esempio un giorno cadde la di
scussione sul mormonismo e il professar Gabba propose questa questione:
poteva o no il Senato portare l a guerra ai mormoni per la bigamia? E poi si
discutevano con calma . Ed il professore specialmente cercava di mett ere
in grado gli alunni di fare da sé: i l ibri erano come la guida, il corredo. Io
ho sentito dire da certi insegn anti che non davano molta importanza all ' i n
gegno , m o l t a a l l o studio : c h e importa a me, dicevano, che u n o abbia i nge
gno? Voglio che ami lo studio, perché altrimenti cosa vale l ' i ngegno se è
disgiunto dallo studio?
Q uanto all ' insegnamento della filosofia abbiamo avuto diversi profes
sori e non è stato del tutto ragionevole il giud izio portato su di essi dagli
scolari . Abbiamo avuto un professore che era rosminiano , padre Caroli 1 ,
u n professore che era giobert iano , era u n napoletano d i cui non h o presen
te il nome: ma quasi tutti i napoletani sono giobertian i : un altro che era
eclettico e limitava il suo insegnamento alla logica e alla psicologia. È stato
rilevato da un altro professore che ricorse subito alla metafisica parendogli
che lo studio logico e psicologico non fosse sufficiente. E il professar Gia
da 1 ha i nsegnato filosofia anch ' esso con metodo diverso. Così cinque pro
fessori di filosofia hanno sempre cambiato metodo perché non credevano
buono l ' antecedente. E quanto a me giacché siamo i n discorso voglio per
mettermi d'esprimere la mia opinione in proposito. Io ritengo che se tutti i
professori si fossero limitati alla parte logica si avrebbe avuto un insegna
mento più completo , più vantaggioso, si avrebbe avuto il mezzo di creare
un buon raziocinio nei giovani e si sarebbe fatto sì che le discrepanze di
opinioni non si sarebbero mostrate. È vero che anche nella logi ca si mani
festa la libertà del pensiero , ma si potrebbe evitare quel contrasto cui s i va
incontro col voler estendere quest ' i nsegnamento. Abbiamo dei buoni testi
di l ogica, quello del Mill 1, quello del Lusig 1 il quale ha fatto u n trattato
molto importante che può eguagliare u n ' enciclopedia ; ma abbiamo anche
dei libretti piccini che valgono poco e questo disqui librio deve essere av
vertito dai professori ai giovan i, perché possano avere una norma negli
studi che volessero fare o fuori di scuola o dopo, perché possa anche ve
dere che cosa ne pensano gli autori in proposito delle idee svolte dai p ro
fessori, e qual criterio portano in tutto questo lavorio . Tutto questo si può
fare dai professori finita la lezione, quando scorgono chi ne mostri il desi
derio, e con quelli che ne hanno molto potranno dire « guardate d ieci auto
ri sulla tale questione » , e con altri che se ne interessano meno citarne solo
qualcuno.
Finali. Le piacciono le tesi nell ' i nsegnamento secondario?
Cavalieri. Certamente .
Finali. Note fino dal principio del corso?
Cavalieri. No, perché al lora nasce che s i svolgono precedentemente, pas
sano per le tasche eli tutti e si finisce col copiarle .
Finali. Parlava delle tesi per gli esami orali .
Ca valieri. Anche queste sono u n localizzare l ' istruzione; bisogna che il
giovane, si trovi piuttosto al caso el i poter rispondere su cose che non ha
mai stud iato col proprio intendimento , el i quello che ven iva a far pompa,
eli quello che potrebbe aver imparato a pappagallo ; la discussione divente
rebbe molto utile e giovevole . Ho sentito nominare la grammatica del Cur
tius; ebbene questa da noi non fa più buona p rova, perché questa gramma
tica comi ncia collo scheletrizzare i pensieri. Questo fatto oggi non è trop
po apprezzato; si elice , studiatela perché è molto buona; e così si dice eli
quella del Corticelli ·1 , senza pensare che la grammatica è la più indispensa
bile per imparare una l ingua, e perché possa servire occorre che sia molto
chiara e intellegibile a tutti . Ausonio Franch i ' ne è convint o perché sta
1 Giovanni Maria Caroli (Modena 23 ottobre 182 l - Napoli 25 dicembre 1 899). Sacerdote,
scrisse, sorto l ' incoraggiamento di Rosmini del quale fu amico, diverse opere filosofiche volte a
combattere le teorie giobertiane, con lo pseudonimo di T. Zarelli. Nel 1 860 fu nominato pro
fessore di filosofia nel r. liceo di Ferrara. Dal 1 864 insegnò come titolare nel r. liceo di Madda
loni, occupando il posto del prof. Fiorentino quando questo fu traslocato all'università di Bolo
gna. Il Caroli inviò alla Commissione d ' inchiesta una sua risposta relativa al quesito 39 (ACS,
MPI, Div. scuole medie, 1860- 1 896, b. 9, fase. 68).
z Carlo Gioda (Ceresole, Cuneo, 16 maggio 1 839 - ? ). Enea Cavalieri lo ricorda quando Car
lo Gioda era preside, nel 1 865-'66, nel liceo Ariosto di Ferrara. Laureato in filosofia all'univer
sità di Torino nel 1 85 5 iniziò subito la carriera dell'insegnamento. Nel 1 86 1 fu nominato presi
de del liceo-ginnasio di Macerata, successivamente ricoprì la stessa carica a Ferrara, Catania e
infine dal 1 867 a Milano, al liceo Parini. Quando corse voce di un suo trasferimento al liceo di
Padova, motivato anche da una sua presunta debolezza manifestata nel dirimere una questione
relativa ad un professore del liceo, Carlo Tenca intervenne presso il ministro, illustrando l ' azio
ne svolta dal Gioda come preside del liceo, trasformato, sorto la sua direzione, in un istituto
che potrebbe servire di modello ad altri licei e lo definì uomo serio e di polso • (cfr. ACS, M P I ,
Personale, 1 860 - 1880, fase. • Gioda Carlo•). Dopo u n a breve permanenza a Padova tornò a
Milano come provveditore agli studi e in tale veste rispose alla Commissione d 'inchiesta nella
seduta m ilanese del 4 novembre 1 87 3 . Alla fine del 1 874 fu chiamato a svolgere servizio a Ro
ma presso il ministero e gli venne affidata l ' i nchiesta sulle scuole secondarie private di Napoli
(cfr. Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione •, 1 87 5 , pp. 226 - 2 36).
•
•
•
1 James Mill (Northwater Bridge 6 aprile 1 773 - Londra 23 giugno 1 8 36), filosofo, storico
ed economista inglese.
z
on è chiaro chi si volesse indicare, probabilmente lo stenografo non ha capito il nome.
' S. CORTICELLI, Regole e osservazioni della lingua toscana, ridotta a metodo, edita la pri
ma volta nel 1 74 5 , continuò ad avere una certa fortuna nelle scuole dell 'Ottocento; Giosuè
Carducci in una relazione del 1 880 (cfr. M. RAICICH, Scuola politica e cultura . . . cit., p. 1 5 2) la
giudicava del tutto superata.
" Ausonio Franchi, pseudonimo di Cristoforo Bonavino (Pegli 27 febbraio 1 8 2 1 - Genova
1 2 settembre 1 895), seguace di Vincenzo Troya e di Domenico Berti, si era occupato di gram
matiche italiane. Nel 1 849 abbandonò l'abito talare dopo cinque anni di sacerdozio e assunse il
nuovo nome eli Ausonio Franchi. Dal 1 860 insegnò storia di filosofia all'università di Pavia,
ove ottenne la cattedra per i nteressamento di Terenzio Mamiani, quindi passò all'Accademia
scientifico letteraria di Milano dove rimase fino al 1 888. Autore di numerosi scritti a carattere
34 2
Fonti per la storia della scuola
stampa ndo una gramm atica la quale compre nde in sé i reqU Jsltl
necessa ri
per servire al bisogno . Perché appunt o una volta cominc iato · a
sapere la ra
gione logica del ! ' esistenza delle cose nel linguag gio e delle diverse
varia
zioni del nome, una volta imparat o in italiano , non vi è più bisogno
d ' im
pararlo in latino, e questo è l ' addente llato che riunisce uno
st udio al
l ' altro.
Presidente. La Commissione la ringrazia.
29
Seduta di Forli, 3 aprile 1 8 73 ' .
ACS, M P I , Div. scuole medie (1860- 1 896), b. 6, fase. 2 5 .
A URELIO SAFFI 2
Preside nte. Lei in municip io ha l ' ufficio di assesso re prepos to
all' istru
zione p ubblica ?
Saffi. Si.
Presiden te. Vorreb be dirmi come proced e l ' istruzio ne second aria?
[Saffij. Dà soddisfacen ti risultat i per la capacit à e la moralit à
dei profess ori
i nsegnan ti, e per l ' amore dei giovani e per l ' i n teresse che le famiglie
pon
gono a questa istruzio ne . Dà sufficie nti risu ltati , quelli che posson
o aversi
filosofico tendenti a sostenere la supremaz ia della ragione sulla fede. Negli
ultimi anni della sua
vita riabbracciò la religione e fu riammesso al sacerdoz io.
' la seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
z Aurelio Saffi (Forlì 13 ottobre
1 8 1 9 - San Varano, Forlì, I O aprile 1 890). Ministro dell'in
terno e triumviro con Mazzini e Armellini nella Repubblic a romana, alla
caduta di questa andò
in esilio. Si dedicò agli studi storici, continuan do nel frattempo a intrattene
re rapporti con altri
patrioti emigrati. primo fra tutti Mazzini. Rientrò in Italia nel 1 860, fu eletto
deputato nel colle
gio di Acerenza e si dimise dopo i fatti d 'Aspromo nte. Di nuovo a Londra,
vi rimase fino al
1 867 quando, rientrato in Italia, si stabilì in Romagna , dedicand osi dal 1
872 alla pubblicaz ione
degli scritti di Mazzini. Fu incaricato presso l'uni versità di Bologna dove
dal 1 877 tenne una se
rie eli lezioni. G. FINALI , Memorie . . cit., p. 3 3 1 , offre una ricostruz ione
della seduta di Forlì e
della discussio ne sull' insegnam ento religioso, eli cui i verbali conserva ti
danno solo una pallida
idea. Secondo Finali nella discussio ne sarebbe i ntervenu to anche Antonio
Fratti combatte ndo
acrement e il deismo mazzinian o di Saffi: nei verbali non c'è traccia della
presenza in sala di
Fratti. Neanche nella deposizione di Saffi si parla del tema. Si può supporre
che nell'inter vallo
della seduta dopo la deposizio ne di Saffi e perciò fuori verbale, ci sia stato
uno scambio di idee
sul tema tra i commissa ri, Saffi e Fratti? E che questa discussio ne abbia poi
avuto un seguito vi
sibile nei verbali nell ' intervento eli Fortis?
.
Sezione 1/ - l uerba/i delle deposizioni
343
compatibi lmente coll'ordine dei programmi e col metodo adottato negli
ist itut i secondari ginnasiali e l iceali . Certamente questo metodo lascia mol
to a desiderare . Io sono a dir vero profano all ' i nsegnamento, e quindi dò
sotto riserva le mie impressioni in proposito . Sarò breve più che s ia possi
bile per lasciare il campo agli insegnanti e ad altri più competenti di me.
Ma è un fat to che generalmente si sente e dagli allievi e dagli i nsegnanti e
da chi s ' interessa della pubblica istruzione che i programmi attuali non ri
spondono al bisogno dell ' i nsegnamento . E per notare quali siano le mie
impressioni i n proposito , comincierò dalla parte superiore , dalla parte li
ceale. I programmi dell ' insegnamento liceale spaziano per sì vasto campo
che per poco non abbracciano tutti gli studi che si devono poi svolgere
nel l ' i nsegnamento u niversitario. Nei tre anni del l iceo i giovani oltre agli
studi classici di latino, italiano e greco che richiedono assidua esercitazio
ne per parte degli allievi e assidua spiegazione da parte dei maestri e che
quindi per sé soli assorbirebbero t utto il tempo dei giovanett i , sono invece
ch iamati agli studi di matematica, fisica, storia naturale, ch imica e storia
molto largamente svol t i . E per venire ad u n esempio concreto i programmi
del l ' insegnamento della storia chiamano dopo il corso della storia greca e
romana nel primo e second' anno liceale , chiamano i professori a svolgere
un corso completo di studi storici del medio evo d ' Europa per prepararli
poi alle grandi diramazioni storiche nazio nali successive e non si limitano
ad esigere u n quadro s intetico, generico alla grande classificazione che de
ve poi svolgersi successivamente negli studi più profond i . Per concretare il
pensiero : le lezioni di G u izot , sarebbero per così dire u n epilogo del p ro
gramma quando fosse svolto bene pei due primi anni del liceo; ora questo
è troppo . I programmi di storia nat urale o ltre la fisica che si insegna molto
e che sarebbe bene lasciare agli studi relativi, la storia naturale comincia
dalla geologia del globo molto sviluppat a , passa ai d iversi regni minerale
ed animale infine s i t ratta di un caos completo di scienze di storia naturale:
e anche questo realmente va oltre non solo allo stadio di sviluppo del gio
vane i n quella età ma è incompatibile cogli studi diversi che deve fare. O ra
credo che l ' effetto naturale che da ciò deriva è che i giovani attingono una
coltura generale e superficiale delle materie che devono prendere, ma non
possono formarsi nozioni esatte, positive e d urevoli delle materie che stu
diano e questo naturalmente n uoce allo sviluppo delle facoltà intellett u ali
e alla vera e soda scienza del giovanetto . I o credo che in questa parte sa
rebbe molto opportuno modificare i programmi del l ' insegnamento secon
dario e lasciare il completamento dei medesimi agli studi u niversitar i . S ta
bene che al giovinetto si dia una nozione degli studi che si devono poi fare
all ' università ; non scendere mai troppo giù nella manifestazione dei feno
meni del mondo morale e materiale, lasciare questo perfezionament o a
studi più alt i . Credo che il compito degli studi secondari fosse quello di
mostrare per così dire dall' alto di monte i l paese cui si dovrà poi arrivare .
344
Fonti per la storia della scuola
at uralmente la moltiplicità delle materie e lo sviluppo che gli si dà n uoce
alla maturità degli studi classic i : è sentito da tutti che questi vanno deca
dendo; che le antiche erudizioni di gusto letterario vengono meno e que
sto, secondo me, dipende dal non esservi tempo sufficiente, per t utte quel
le esercitazioni che si richiedono ad una matura erudizione delle lettere e
ant iche e moderne, delle quali sarebbe bene che i nostri giovani avessero
cognizione. E le antiche poi soprat tutto che avrebbero bisogno d 'essere
rinnovate ; ma col sistema attuale è difficile che i giovani possano penetra
re addentro in questi studi e farli v ivificare: ripeto è difficile che i giovani
possano gustare il buono di questi studi sotto l ' aspetto filologico, estetico
e sotto l ' aspetto storico . Questo si sente generalmente nei nostri istituti
classici nei quali siamo molto inferiori ad altri paesi d ' Europa. Siccome io
conosco più che gli altri l ' I nghilterra , citerò ad esempio il metodo che si
adopera negli istituti classici inglesi o nelle università applicate special
mente a questo ramo di studi; come nel collegio di Eton, poi nelle due uni
versità classiche di Roebert 1 ed Oxford . È esperienza assicurata in I nghil
terra che il gran profitto che i giovani fanno nelle lettere latine e greche si
deve all' insegnamento cattedratico da un lato ed all' ordine 2 generale del
la materia, ma sovrattutto alle esercitazioni quotidiane costanti di cui i gio
vanetti possono giovarsi ove vivo no ed ove hanno dei ripetitori chiamati
tutors, che li fanno studiare sopra i classici e ne fanno penetrare tutte le
part i . Naturalmente questa esercitazione comincia dal periodo che si inizia
la scuola, e si continua fino ai più alti stadi del l ' istruzione universitaria, fa
sì che il giovane sia maturo, profondo, provetto , dotto nelle lettere classi
che antiche; se i n Italia si potesse, per avventura, unire l ' insegnamento
cattedratico agli esercizi, io credo che con questo metodo s i giungerebbe
ro ad avere quei buoni risultati che si desiderano e che altrimenti non si
avran no. Questo è il mio modo di vedere, ma realmente credo che una
gran parte del profitto in I nghilterra dipenda da questo, che la teoria sia
soggetta alla parte pratica del tutors: questi studi assumono in I nghilterra
ed in Germania molto sviluppo perché tutti si col legano e quello del latino
e del greco , alla loro vera origine storica e filologica mediante l ' insegna
mento del sanscri to . E tutto questo insieme del l ' influenza educativa ed
istrutti va continuata produce effetti che da noi non si hanno.
Presiden te. Ella non crede perciò siano eccessive le materie del liceo?
Saffi. Credo che più che le materie sia difettoso il metodo.
Presidente. E crede che lo sviluppo dato dai professori alle medesime sia
t roppo esteso?
Saffi. Vedo che i poveri professori sono in qualche modo legati al pro
gramma da dipendere da esso : alcuni ne fanno forse troppo economia, al-
1
2
Probabile errore dello stenografo. 1 on è chiaro di quale università si parla.
Nel ms. : « e dall' • .
Sezione 11 - l uerba/i delle deposizioni
345
tri li estendono soverchiamen te. Ma quest ' inconveniente sarebbe certo m i
nore quando l ' economia dell' insegnamento fosse meglio determinata e
conformata al grado dello sviluppo intellettuale dei giovanetti e dei pro
grammi medesimi. Io non sono per escludere la variazione delle materie
che sono adottate dal nostro programma : credo sia necessaria u na nozione
generale di tutto il campo, dirò così, preparatorio della scienza sia sotto
l'aspetto morale, storico ed intellettuale e materiale; ma sarebbe necessa
rio formare il programma sotto un punto di v ista più positivo del grado di
sviluppo che possano avere i giovani nell'età che devono attendere a que
sti studi; riservando le indagini speciali e lo sviluppo particolareggiato del
le grandi leggi ad u n insegnamento u niversitario. Se no succede che il gio
vane è costretto a rifare nelle università quello che ha di volo veduto nelle
scuole secondarie. Quando nelle scuole secondarie ha una nozione esatta
dei grandi delineamenti che deve coltivare nell ' università mi pare bas t i . E
questo gioverebbe al maggiore sviluppo che si potrebbe dare all' insegna
mento classico, il quale è per me la fonte di tutto ciò [ che] v ' ha di grande,
di nobile, di generoso i n u n popolo.
.
Presidente. L ' insegnamento della filosofia nei licei crede che si dovesse
cont inuare nel limite che si dà ora o con maggiore sviluppo ?
Saffi. Credo che non sia male inteso il concetto del programma di filoso
fia, di ! imitarlo cioè alla spiegazione dei fenomeni psicologici , alla parte
dell' analisi, alla logica , lasciando in disparte le grandi questioni di metafi
sica che escono dal campo della capacità dei giova n i .
Presidente. N o n crede u t i l e fare anche l ' etica?
Saffi. No, tutt'al più si potrebbero accennare le quistioni.
Presidente. Quanto all'esame trova il metodo b uono o crede sia tale da
chiamare l ' attenzione del giovane e far sì che s i p reoccupi troppo del risul
tato del suo esame e manchi poi della applicazione più soda che dovrebbe
dare all'ins egnamento?
Saffi. Facendo dipendere il concetto del merito del giovine nel risultato
dell' esame finale soltanto, nat uralmente incontriamo diversi inconvenien
ti. Anzi tutto il giovane non sente d urante l ' anno la necessità di mantenere
una fervida attenzione e diligenza nello studio suo. Molti dei più intelli
genti sono negligenti durante l'anno; poi negli ultimi giorni fanno una pre
parazione improvvisa e figurano bene agli esami; ma questo è un i nconve
niente che nuoce molto agli studi del giovane. D ' altro canto poi u n sem
plice esame finale non credo possa dare saggio della bravura o me110 d ' u n
giovane perché vi sono tanti motivi, a d esempio l e mutate condizioni mo
rali e via via che possono far sfigurare il giovane e non riescire a dar prova
di quella bravura di cui diede saggio durante l ' anno. Per cui non sarebbe
bene escludere del tutto l ' esame ma anche tener conto della condotta du
rante l 'anno per avere u n criterio fondato delle qualità del giovane; e si
stasse o colle note dei professori, o se si temesse la parzialità di questi , fare
347
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
un esame graduato di tanto in tanto ai giovanetti . Credo che associando i
due metodi si arriverebbe ad un giudizio più equo, più retto e più sicuro.
Presidente. E venendo ai casi pratici ha osservato che quelli che escono
dal ginnasio e dal liceo siano educati in modo che abbiano quella coltura
che è necessaria a tutti i cittadini?
Saffi. Mi duole il dire che n o , perché anche i più bravi a meno che non si
dedichino ad un ramo speciale pel sistema attuale d i insegnamento non
possono che avere delle nozioni superficiali. Questo è il mio convincimen
to, ma d ' altronde vi sono casi eccezionali . E si hanno, senza andar fuori
[di] qui; anche a Forlì abbiamo avuto giovani molto disti nti e che insegna
no e qui e a Milano .
Presidente. I giovani che escono dalle scuole normali s uperiori danno buo
ni risultati?
Saffi. I o conosco poco l ' ordine degli studi delle scuole normali superiori,
e non vorrei entrare in un campo del quale non ho esatte notizie, ma cre
do che anche là in gran parte possono applicarsi le mie osservazioni.
Presidente. Da quello che si può osservare da tutti non crede insomma suf
ficiente quel l ' istruzione?
Saffi. Non la credo sufficiente.
Presidente. E crede che in generale siano migliori i giovani che vengono
fuori dalle scuole classiche nell ' i nsegnamento letterario o scientifico?
Saffi. Forse meglio nel scientifico e nel naturale perché a questo danno più
attenzione perché deve servire loro negli ulteriori stadi della vita. L ' inse
gnamento classico non si può rialzare che modificando i programmi e pro
mettendo anche un buon avvenire al giovane; oggi giorno v i è poca attrat
tiva a ques t i studi a mio credere anche per questo , che al giovane che ha
percorso seri studi non è aperta una posizione che lo ricompensi degli
stenti e delle fatiche cui deve sobbarcarsi se vuole iniziarsi in questa via.
Presiden te. Sui ginnasi e licei della provincia non ha niente a dire ?
Saffi. Del ginnasio e liceo di Forlì non possiamo che lodarcene e credo da
rà sempre buoni fru tti perché è sulla via del miglioramento.
Presidente. E le scuole tecniche crede siano utili e che fosse bene comple
tarle : o crede sarebbe meglio riunire la scuola tecnica al ginnasio?
Saffi. Forse sarebbe bene unirle, lasciando però la scelta a i giovani. E qui
u n ' altra cosa deve osservars i : ammesso che si debba dare coll' istruzione
secondaria u n insegnamento completo classico e scientifico, ammesso que
sto, sarebbe poi opportuno non esigere in tutte le materie un merito egua
le, facendo una differenza a seconda della carriera che vorrà percorrere il
giovane. Non vi ha ragione per non fare questa distinzione; non vi ha ra
gione che un giovane molto ben istruito negli studi classici perché deside
ra darsi o alla carriera dell ' insegnante o dell' oratore, o di rappresentante
del paese eccetera, debba essere chiamato con eguale esigenza e severità a
dare gli esami di storia naturale, fisica e matematica od altra materia, le
quali non gli serviranno piucché tanto nella sua carriera . Per cui vorrei che
ci fosse discrezione nelle esigenze degli esami : lasciare libera la facoltà co
me si fa in I nghilterra ove non si chiamano i giovani a dar l ' esame su t utte
le materie con egual rigore : il giovane sceglie u na facoltà e su quella deve
dare l'esame.
Presidente. Avrebbe altro a dire?
Saffi. Fra le domande stampate c ' è qualche cosa sull' amministrazio ne degli
studi, ma non vorrei abusare del tempo scarso che ha la Commissione.
Presidente. Anzi, dica pure.
Saffi . Sull'ordinamento del Consiglio provinciale scolast ico parlerò fran
camente del decreto 2 2 settembre 1 870 1 • Io credo che il Consiglio scola
stico ordinato come è da quel decreto sia male costituito; viene dopo un
semplice rescritto regio ma non so come un rescritto possa modificare u na
legge . La legge Casati costit uiva i C onsigli scolastici provinciali tenendo
gran conto del corpo insegnante e metteva a farne parte il provveditore
degli studi come presidente, i direttori e p residi dei ginnasi e licei, poi la
rappresentanza del comune poi un segretario del provveditore e del Consi
glio scolastico . La legge quindi a quel che sembra evidentemente ha avuto
di mira criteri che mostrano che era in animo di comporre il Consiglio del
la parte più competente a giudicare degli studi, e che voleva dargli impor
tatlZa e decoro . I nvece il decreto di Coppino dà la pres idenza [al prefetto] ,
chiama a segretario del Consiglio scolastico un impiegato di prefettura; in
fine quel decreto fa del Consiglio scolastico u n ' appendice dell ' ufficio di
prefettura e sottopone l ' elemento degli studi all'elemento burocratico e
questo mette in una falsa posizione e i prefetti e chi fa parte attualmente
del Consiglio provinciale scolastico . È necessario al decoro degli studi che
il prefetto non v i entri, egli ha già troppo da fare: voler incaricare la p re
fet tura della parte che concerne la direzione dell ' insegnamento mi pare u n
p o ' troppo: m i sembra che sia u n caricare l e spalle a l d i l à del peso che
possono sopportare; una riforma quindi m i sembra indispensabile, ed u na
riforma che rialzasse nello stesso tempo i l decoro degli studi . Questo è il
mio modo di vedere .
Presidente. La Commissione la ringrazia .
346
A LESSANDRO FORTIS
1
Presidente. Lei è assessore municipale e non presiede alcun istituto?
1 È un evidente errore di Saffi o del copista. I l riferimento ovviamente è al r.d. 22 set.
1 867, n . 3956, relativo all 'ordinamemo della pubblica istruzione.
" Alessandro Fortis (Forlì 1 8-1 2 - Roma -l dicembre 1 909). Patriota, partecipò alla guerra del
1 866 e alla campagna di Mentana del 1 867. Fu tra i principali esponenti del movimento repub
blicano. Eletto deputato nel 1 880 nel collegio di Forlì, fu sottosegretario agli interni nel mini
stero Crispi, ministro dell 'agricoltura nel primo ministero Pelloux, presidente del Consiglio dei
ministri dal 28 marzo 1 905 all'8 febbraio 1906.
348
349
Fonti per la sto1·ia della scuola
Sezione 11 - l t•erbali delle deposizioni
Fortis. Sono assessore e solo faccio parte della Commissione degli stud i :
p e r quelle poche osservazioni che ho potuto fare ai quesitj propost i dirò
alcuna cosa . Prima d i tutto io mi associo di gran cuore a quello che ha det
to il mio amico Saffi , che ha più di me studiato la materia e conosciuto
molti dei difetti che rendono poco proficuo il nostro i nsegnamento comu
nale e tecnico . Specialmente pel Consiglio scolastico provinciale io divido
le sue idee e credo che l ' incompetenza e l ' eccessiva ingerenza governativa
in questa materia rendono non buona la influenza di quest ' au torità supe
riore alla provincia sugli studi.
Dopo questo dirò alcune poche osservazioni da me fatte. Credo che (la
Commissione stessa nel suo mandato ebbe da osservarlo) la scuola com
prenda necessariamente oltre all ' insegnamento la educazione del giovane.
I n gran parte le nostre scuole difettano della parte educativa. La scuola
non deve solo formare l ' i ntelletto ma anche il carattere e l ' indole del gio
vane . La educazione morale deve completare l ' istruzione i ntellettuale. A
me pare che l ' educazione morale e la formazione del carattere mancano
nei nostri istituti educativ i . Non so comprendere come questa parte princi
pale della educazione abbia così poca parte nei programmi e nei metod i :
non s o c h e cosa si educh i , so che s i istru isce e c h e vi sono buoni maestr i :
m a c h e vi siano buoni educatori e che anche essendovene s e ne occupino
non l ' ho mai saputo. Questo è uno dei primi difetti della nostra istruzione .
A questa questione del l ' educazione morale e del carattere dei giovani si
collega la questione dell ' insegnamento religioso : bisogna partire secondo
me dalla massima che la religione non è la morale e che si può essere mo
rali ed educare alla morale senza educare alla religione : questo è indiscuti
bile: posto ciò, io credo, che s i debba educare il giovane alla morale nei
nostri istituti ma credo che la funzione civile dello Stato sorpassi i limiti
che gli sono imposti dalla propria natura estendendo l ' educazione a lla par
te religiosa che deve essere riservata alla famiglia e a chi sia a capo della re
ligi one. " Andate ed insegnate >> questo è il motto dei sacerdot i ; ma essi deb
bono insegnare il Vangelo : l ' insegnamento religioso nelle scuole non ha
ragione di essere . Si viola il principio di l ibertà di coscienza poiché si im
pone alle giovani generazioni una determinata credenza e si chiude ai gio
vani la via di scegliere quello che essi u n giorno dovrebbero preferire.
Il provveditore 1 disse bene che le prime idee che si mettono nel l ' ani
mo dei giovani sono quelle che sono più difficile a sradicare d i poi . Q uan
do voi avete i nculcato nei giovani i l pregiudizio colla educazione religiosa,
sentimento che molto si fa strada nel loro animo, sarà difficile che posso
no vincere il pregiudizio a loro inculcato. I o credo che sia molto diffi cile
che questo i nsegnamento religioso possa essere dato seriamente nelle
scuole e quelli stessi che sono teneri del l ' insegnamento religioso dovreb
bero desiderare che non fosse dato. Non è difficile il caso in cui molti che
non credono siano chiamati ad imparti re un i nsegnamento religioso che
essi per primi st imano bugiardo: allora avrete il fatto immorale che istitu
tori si fanno a dare un insegnamento e a sostenere convinzioni che essi per
primi non hanno . O v i sono istitutori ecclesiastici ed in t al caso lo Stato
non vorrà accingersi all' ufficio eli fabbricare dei cattolici . Altrimenti tutti i
maestri dovranno avere questo insegnamento e tutti i maestri non sono
cattolici . Ora voi vedete quale assurdo sia quello di affidare l ' insegnamen
to religioso a gente che nella maggior parte non crede a ciò che i nsegna.
Posto questo , una riforma essenziale è necessaria e dovrebbe tendere a da
re maggior sviluppo alla educazione morale e ad escludere assolutamente
l ' insegnamento religioso dalle scuole. Quanto a t ut to ciò che concerne i
difetti dei programmi e dei metodi. . .
Presidente. Vorrebbe più concretare il suo pensiero sull' insegnamento mo
rale, in che dovesse consistere ?
Fortis . Secondo me l ' insegnamento morale che lo Stato deve dare ai giova
ni è compendiato nei doveri che il giovine e il cittadino p i ù tardi hanno
verso se medesimi, verso la patria, verso l ' umanità, lo Stato e la società.
Tutti questi doveri possono dipendere supremamente da u n ' idea superiore
religiosa, ma non sono in alcun rapporto né dipendenti da alcuna religione
positiva o religione rivelata . Quindi secondo me vi deve essere il codice
del dovere e della morale differente dal codice religioso. Tutte le religioni
hanno più o meno impartiti i precetti della morale e i doveri dell ' uomo,
ma nessuno vorrà sostenermi che questi doveri siano da quella data reli
gione dipendenti . Ora non intendo di dire che lo Stato debba fare un van
gelo che debba avere u n testo dei doveri morali del cittadino. Ve ne sono
molti dei testi, v i sono I doveri dell 'uomo di u n illustre italiano, libro che
potrebbe sostituire i l Vangelo , quantunque i n questo io riconosca un insie
me di verità che per me è utilissimo 1 •
Saffi (interrompendo dice dal pubblico alcune parole che non giungono
agli stenografi).
Fortis. Io ammetto come questi doveri possano avere fondamento i n u n ' i
dea suprema religiosa e della divinità, ma non possono dipendere da alcu
na religione positiva rivelata .
D ' altronde se poniamo per esempio che dovesse essere affidata a gente
conv i nta del cattolicismo la istruzione religiosa dei giovani , questo i nse
gnamento riuscirebbe probabilmente a danno della costituzione politica
dello Stato . Voi vedete che se lo Stato e la religione si troverebbero i n con
traddizione è da conveni re che il dovere, la moralità siano i ndipende n t i
1 Filippo Gaffodio, che aveva deposto dinanzi alla Commissione d'inchiesta nello stesso
giorno.
1 Allude all'opera di Giuseppe Mazzin.i . che negli ultimi decenni dell'Ottocento verrà pro
posta da alcuni laici come libro per le scuole in contrapposizione ai catechismi religiosi.
350
35 1
Fonti per la storia della scuola
Sezione 1/ - f t •erbali delle deposizioni
dal fatto di una religione posit iva e rivelata. Tutte le religioni sono eguali
in faccia allo Stato che prescinde da qualsiasi religione, ma. non può essere
subordinato ali 'insegnamento e alle rivelazioni che predicano quelli che a
una religione rivelata credono. Del resto io forse sarò uscito dal mio ragio
namento, appunto perché il m io amico Saffi forse ha creduto che io avessi
voluto cont rariare la sua idea nobile, ché per me è tale.
A Bologna per esempio si è abolito l ' istruzione religiosa dalle scuole
eppure non si è escluso l ' insegnamento della morale. Al catechismo che
non è un libro sapiente si è sostituito u n libro assai bell o : dunque per me
non pretendo di risolvere tutte le difficoltà di questa situazione : non vo
glio qui fare u n programma ; accenno solo alla necessità che veggo, non
voglio però risolvere le difficoltà che s i presentano qui. H o citato solo
ques t ' esempio: quanto alle tendenze del paese in questa quistione si sono
già manifestate : il consiglio comunale ha già votato che debba essere ban
dita l ' istruzione religiosa dalle nostre scuole e questo con voto unanime di
tutti noi e del l ' egregio Saffi che è pienamente d ' accordo con me.
Saffi . Si, certamente .
Fortis. A noi fece molta meraviglia di vedere annullata una deliberazione a
Forlì : ché aveva già avuta esecuzione a Bologna la stessa deliberazione. Si è
fatta questione d eli 'applicazione della legge C asat i : ma questa legge da noi
non fu mai promulgata. Il fatto è che a Bologna fu abolita l ' istruzione reli
giosa e da noi no. Solo il ministero rispose che l ' istruzione religiosa non
fosse impartita a tutti quei figli pei quali i padri avessero reclamato che
non la volevan o .
Io accennerò ad alcune altre poche cose c h e mi sono corse alla mente
leggendo quei quesiti . Io non sono molto pratico del l ' andamento delle
scuole e non sono molto addentro nella questione dei programmi, metodi
ed altro . So però che v i sono due o tre questioni importantissime nelle
quali si può essere competenti a giudicare senza essere nell ' insegnamento.
Primieramente la questione delle tasse che bisognerebbe fossero minime:
bisogna attenuare le tasse più che sia possibile. L ' egregio provvedit ore de
gli studi ha fatto questione di pareggiamento nei nostri istituti comunal i :
credo c h e u n a delle difficoltà dinanzi alla quale finora il m unicipio si è ar
restato, sia quella delle tasse, poiché quando noi avessimo pareggiato i no
stri isti t u t i , quei giovani che ora non pagano t asse sarebbero colpiti dalle
medesime: non è però difficoltà insormontabile e si spera che il municipio
si interessi molto della questione : vi è una commissione apposita che
quanto prima sarà in grado di riferire . Altra questione si riferisce al meto
do degli esami; giudicando del merito di un giovane dal solo esame è un
assurdo . I l criterio è l ' esperimento del profitto che tutti i giorni l ' inse
gnante può fare di lui; bisogna che quest i due elementi concorrano i nsie
me. E s iccome quest ' ultimo è preponderante, così questo si deve antepor
re a quello dell ' esame. È poi assurdo il metodo di giudicare per punti : non
so come s i possa stabilire una gradazione di merito senza ricorrere ai pun
ti. Quel s istema può condurre a grandi i ngiustizie; quando i o studiava, sa-
peva che agli esam i si passava appena appena a scappellotto poi si aveva
un grado di plauso, poi un pieno plauso. Questo mi piacerebbe di vedere
rinnovato . Del resto negl i esami è da notare che dovendo concorrere in
sieme questi due elementi d eli ' esame e del merito, secondo me è necessa
rio e vorrei che negli esami di passaggio di classe in classe intervenissero
sempre i professori che hanno insegnato, ma vorrei che assistessero anche
quelli della classe cui deve passare il giovane . Non si dovrebbe mai p re
scindere da un esame d ' ammissione all ' u ni versità e quegli esami d ' ammis
sione sono la stregua alla quale si può giudicare se gli studi liceali portano
i giovani a quella altezza di coltura che è necessaria per entrare ali ' u niver
sità. Quel dichiarare atti ad entrare i giovani all' università senza bisogno
del l ' ammissione può far sì che gli studi degradi no e che molti giovani en
trino all' università senza quel grado di cognizioni che è loro necessario.
Presidente. E della condizione pratica della istruzione secondaria della
provincia? Quale prova fanno i giovani?
Fortis. I giovani usciti dal nostro liceo e ginnasio non pareggiato hanno
fatto buonissima p rova .
Presidente. Per cui i difetti non sarebbero molto gravi?
Fortis. Localmente dico che non sono grav i , potrebbero però essere e di
venire più gravi di quel che son o . Tutto quello che l ' egregio Saffi ha ac
cennato sulle molte materie e sulla estensione delle medesime sono tutte
verità. È impossibile che un giovane a quell'età possa diventare dotto in
tutte quelle materie . Egli deve avere u na coltura generale ed essere profon
do in quelle materie in cui si vuole dedicare ma nulla p i ù .
Presidente. Veramente l o scopo dell ' istruzione secondaria è questo.
Fortis . Si, di dare u na coltura generale ma l a colt ura è quella che è l ' erudi
zione, ma non è la scienza . Il giovane deve essere erudito in t utte le mate
rie senza essere dotto e profondo in quelle materie che non hanno relazio
ne alla carriera cui egli si vuole dedicare. Io però vorrei che g l ' insegnanti
col loro arbitrio limitassero le pretese su quei giovani i n quelle materie che
non hanno attinenza colla carriera cui si vogliono dedicare. Io ho poi sen
tito dire molto bene degli istituti secondari di questa città e provincia e
non posso d irne che bene.
Presidente. La Commissione la ringrazia.
:30
Seduta di Cesena, 4 aprile 1 8 73
1•
A C S , M P I , Diu. scuole medie (1 860- 1 896), b . 6, fas e . 2 6 .
1 La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
352
Fonti per la storia della scuola
A LFREDO A NTONIO COMANDINI 1
Comandini. Io mi sono fatto inscrivere per parlare sul quesito che trat
ta dell' istruzione religiosa in genere, giacché è da lu nga pezza che io desi
dero di far conoscere la mia opinione relativamente . . .
Presidente. Lei pare giovane molto . . . (ilarità).
Comandini. Opinione che è la mia e quella dei miei compagni di studio.
(Legge) ( Vedi lo scritto consegnato).
« lo mi sono fatto inscrivere per parlare sul quesito 1 7 o dell' istruzione
religiosa in genere, giacché è da lunga pezza che io desidero esprimere ciò
che mi sento nella mente, sicuro di farmi interprete dei miei colleghi di
studio . Non potrò esporre delle profonde considerazioni , ma dei fatti li
esporrò e sarà su di essi che io opinerò per l ' abolimento dell' istruzione re
ligiosa nelle scuole.
E ciò opinando non fo soggett o del mio p roposto il non essere la istru
zione religiosa impart ita a norma di legge i n tutte le scuole, ma bensì la
legge stessa la quale non raggiunge ne' suoi effetti l ' intendimento di padri
e di figli; di padri che non vorrebbero l' istruzione menomamente, di quelli
che la vorrebbero ampliata e diffusa.
Voi domandate in che modo è accolta dai giovani l ' istruzione religiosa? Io
vi risponderò in nome dei giovani: da molti è accolta male dai più con indif
ferenza; e voi converrete con me che se si può tollerare che uno non voglia
saperne di religione non si può ammettere che ne sappia per trascurarla.
Io sono giovane e sento in me Dio come lo devono sentire tutti quelli
della mia età, tutti quelli che coll' anima vergine anche in mezzo alle lotte
della passione si piegano riverenti innanzi a questo Dio che si rivela in tutto
l ' u niverso, a questo Dio di cui ci parla la legge universalmente regolatrice
per la quale viviamo. Ed è precisamente per questa mia credenza in Dio, per
questa mia fede religiosa che io grido contro la istruzione religiosa impartita
nelle scuole. Se la mia fede non fosse incrollabile io mi sentirei scorato
1 Alfredo Antonio Comandini (Faenza 4 dicembre 1 8 5 3 Milano 9 luglio 1 923). Cresciuto
in un clima di profondo mazzinianesimo fu a contatto coi circoli repubblicani animati da Aure
lio Saffi . Arrestato in seguito alle sommosse repubblicane di Villa Ruffi nell'agosto del 1 87 4 ,
poco p i ù che ventenne, fu scarcerato nel gennaio 1 875; sull'arresto d i Alfredo A . Comandini
cfr. G. FINAI.I, Memorie
cit . , p. 398. Si laureò in giurisprudenza a Roma nel 1 879. Negli anni
dell 'università iniziò le prime esperienze nel giornalismo, abbandonando progressivamente le
giovanili posizioni rivoluzionarie per un'accettazione sostanziale della idea monarchica avvici
nandosi ai settori più moderati . Direttore del « Corriere della Sera » dal 1 89 1 al 1 892, fu eletto
deputato nel collegio di Cesena nel 1 892. Nel 1 894 fondò il « Corriere del mattino », filocrispi
no, di cui fu direttore fino al 1 895 quando il giornale cessò la pubblicazione. Difficoltà di ordi
ne politico lo allontanarono sia dal giornalismo che dalla politica attiva; si dedicò sempre più a
studi storici pubblicando numerose opere. Sul verbale è scritto " Comendini ». La notizia che si
tratti per certo di Alfredo Antonio Comandini è confermata dall'elenco delle persone invitate
alla seduta di Cesena, conservato fra le carte dell' inchiesta: ACS, MPI, Div. scuole medie (1860-
. . .
1896), b. 7, fase. 60.
Sezione II - l verbali delle deposizioni
353
a l vedere giovani che vanno a d assistere all ' istruzione religiosa, perché
chiamati da la legge, e che poi escono dalla scuola e parlano di Dio come
non si parlerebbe certamente d ' un ode profana di Catullo . E perché que
sto? Perché forse nella gioventù non vi è principio religioso ? Oh ! ben tut
t ' al tro - ma perché noi tutti sentiamo in noi stessi che non ci si può parlare
di un Dio che sia quello dei preti, non ci si p uò parlare di una religione
che va mano perdendo da Wyc leff 1 ad oggi , perché basata sul falso, di una
religione che mentre inspira nei c redenti un sentimento religioso che li
rende persino incuranti della propria esist enza in quanto materiali, li ren
de appassionati cultori del l ' io morale non per altra ragione dell'egoismo
del paradiso .
Se innanzi alla religione che io e giovani della mia patria sentiamo nel
petto, tutto ciò che riguarda quella di cui ho discorso, non è profano, non
è scettico - io vi domando , o signori , che cosa vi può essere di più riprove
vole a guastare lo spirito immacolato di questa sacra primavera della vita.
Con la istruzione religiosa che si impartisce nelle scuole si i nsegna ad
adorare Dio, a reggersi secondo la sua legge non per amore del bene o per
timore del male - ma bensì perché ci si promette nella vita avvenire un
prezzo d ' usura che ci lusinga che ci commuove. I o invece e con me la gio
ventù del mio paese - e so di poterlo dire altamente - la gioventù del mio
paese vuole un' istruzione religiosa ma un ' istruzione religiosa che insegni
ad amare il bene perché bene a sprezzare il male perché male, e non già
un' istruzione come quella che oggi si amministra per legge.
Noi vogliamo adorare I ddio per sottrarci all ' arbitrio e alla prepotenza
degli uomini - noi vogliamo adorare quel Dio che vive nella nostra co
scienza, quel Dio che vive nella coscienza del genere umano, nel l ' universo
che ci circonda - quel Dio che noi ci raffiguriamo nel dovere e nel diritto
immortale.
E perché questo Dio possiamo col tivarlo degnamente, perché possiamo
amarlo ed onorario , noi abbiamo mestieri di conoscere i nostri doveri e
non sono i nostri doveri che ci insegna la ist ruzione religiosa dalla legge
stabilita.
Piuttosto che imparare meccanicamente a conoscere un Dio che non è
il vero, che non è il gran Dio che domini su tutti, sui padroni e su gli schia
vi - pi uttosto che imparare di una religione che è quella di una casta, di
una religione che non coopera alla nostra educazione morale, ma sibbene
ed ecc itare nei più sent imenti di discordia a promuovere disordini;- noi do
mandiamo, noi vogliamo che si insegnino nelle scuole i doveri dell' uomo,
i doveri coi quali possiamo vivere a seconda della legge di Dio, i doveri
coi quali possiamo corrispondere agli obbl ighi che ognuno abbiamo verso
1
Nel ms. : « Wicleff » .
3 54
355
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerba/i delle deposizioni
la grande famiglia umana, verso la patria, verso la famiglia, verso noi
stess i .
I tempi c h e corrono e l a civiltà c h e ravvolge sotto i s u o i piedi i ministri
della religione che è accettata dalla legge, della religione per la quale
H uss 1 fu bruciato e Galileo fu torturato , esiggono assolutamente per noi
giovani destinati all' avvenire, per noi primavera d ' I talia, questa riforma sa
l utare .
E voi incaricati oggi a sentire i bisogni di chi educa e di chi è educato ,
ricevete queste mie espressioni come sincere, accordate a questi miei desi
derii la loro attuazione e allora potrete dire altamente di avere contribuito
voi pure alla patria italiana dell'avvenire ! >> .
Comandin i. Questo è quanto voleva esprimere io; ed i miei colleghi sono
della medesima opinione .
Presidente. Lei è allievo qui?
Comandini. Si, fui allievo del liceo Mont i . H o fatto gli studi ginnasiali par
te a Faenza parte a Fano : il resto lo feci qui a Cesena.
Presiden te. Ha fi nito il corso l iceale?
Comandin i. No, per motivi di famiglia; ora sto completando lo studio li
ceale presso professori privati, per presentarmi poi alla u niversit à .
Presidente. Ha altro a dire?
Comandini. No.
Presidente. La ringrazio .
Marselli. Sì; m e lo permetta, dopo averlo ringraziato della cortesia e del
l' onore che mi ha fatt o . Farò qualche osservazione come padre di famiglia
e manifesterò qualche voto come cittadino , perché come insegnante di
scuola militare ho potuto meditare sopra alcune questioni del l ' insegna
mento . Ma, in questioni pratiche, l ' esperienza stimo possa molto e mi
asterrò dal manifestare qualunque opinione che io possa avere . Avrei ama
to come padre di famiglia fare osservazioni, perché i padri di famiglia, pa
re non facciano troppo bella figura dinanzi alla C ommissione d ' i nchiesta.
Cooperazione delle famiglie. Sento lamenti contro i padri di famiglia e
credo che questi lamenti avranno accompagnato la Commissione i n t utte
le sue escursioni; perciò dovranno forse avere u n fondamento, ed io non
verrò qui a scolpare i padri perché credo che avranno la loro parte di t or
to , ma vorrei dare a Cesare ciò che è di Cesare . Tra i quesiti che pone la
Commissione, ai quali s i è risposto accusando i padri di famiglia, vi sareb
be il 1 2 o che domanda . . .
Insegnamento pubblico e privato. lo credo che questo sia vero , cioè che
si desidera di scegliere la via più breve anziché la migliore: ma vorrei do
mandare se, per avventura, la via non fosse u n po' troppo lunga, in guisa
che i padri desiderano che i figli sentano u n po' più il peso. E gli i nsegnan
ti medesimi sostengono che gli studi classi ci si fanno un po' adagio , che vi
è qualche classe ginnas iale che si potrebbe facilmente sormontare a condi
zione che i figli studiassero mediocremente, senza molto affaticarsi . I l m io
animo si è aperto alla speranza dopo che la mia mente era stata aperta alla
malizia, ed ho dovuto sentire di qua e là che la via era un po' lunga. D i fatti
quindici o sedici anni perché un giovane possa conseguire una posizione
sociale è un termine abbastanza alto, ma se è necessario rimanga. Solamen
te prendo atto di questa osservazione assai generale, come il rimprovero
che si fa dai padri , cioè che si potrebbe accorciare il tempo: ne prendo at
to come indizio che vi è margine anche a studiare nei corsi classici qualche
lingua moderna .
Una seconda osservazione è quella che i padri di famiglia non si curano
del profitto dei figli. C redo che gli insegnanti abbiano molta ragione di in
colpare u na parte dei genitori . Le esigenze della vita moderna sono dive
nute tali che non si ha molto tempo in famiglia di occuparsi dei proprii fi
gli ; non dirò che sia bene, ma è un fatto. Vorrei però che la scuola contri
buisse da parte sua, cioè che stimolasse questi padri un po' pigri e che so
no distratti da tante occupazioni e dall ' attendere ai propri affari : i nsomma
che la scuola venisse in aiuto del padre . Non voglio istit uire paragoni fra
gli istituti privati e gli istituti governativ i : io dimoro a Torino da molti an
ni e questa è diventata come la mia città natale, e tanto nelle scuole prima
rie pubbliche quanto nelle private ed anche nel ginnasio G ioberti ove è il
mio figlio presentemente, ho trovato professori solert i , p ieni di zelo, i ntel
ligenti, e questa città da questo lato nulla ha da invidiare alle più colte cit
tà d ' Italia. Gli sconci sono persuaso v i siano piuttosto dipendenti dal s iste
ma , e negli istituti governat ivi si i ncontrano più di frequente, e questo di-
31
Seduta di Torino, 1 6 maggio 1 8 73 2 •
A C S , M P I , Div. scuole medie ( l 860-1 896) , b . 6 , fase. 3 3 .
N ICOLA MARSELLI ·1
Presidente. Lei desidera parlare su qualche parte speciale dei quesiti?
1
Nel ms. : « Kuss ».
La seduta è presieduta da Girolamo Cantelli.
1 Nicola Marselli (Napoli 5 novembre 1832 - Roma 26 aprile 1 899). Fu allievo di Francesco
De Sanctis al Collegio militare della Nunziatella. Dal 1 866 insegnò storia militare alla scuola su
periore di guerra di Torino, deputato, senatore dal 1 892. Sostenne la necessità di riformare gli
insegnamenti della scuola di guerra in modo da portare la cultura degli ufficiali al livello corri
spondente ai progressi della società e delle scienze; autore di alcune opere storiche tra le quali
Gli avvenimenti del 1 8 70- '7 l; La scienza della storia; La rivoluzione parlamentare del 1 8 76.
356
Fonti per la storia della scuola
pende principalmente dalla natura delle cose, cioè che il privato ha due sti
moli: il sentimento del dovere come ha L ' i nsegnante pubblico, ·ed ha un senti
mento proprio quasi morale. In generale questo è fatto naturale del cuore
umano, quindi non accuso nessuno: trovo che dall' una parte e dall 'altra vi
sono insegnanti pieni di zelo, ai quali io debbo moltissimo, vedendo quanto
sentimento del dovere hanno e sono rimasto per ciò meravigliato. Ma dei di
fetti ve ne sono ed è facile correggere il sistema. Nel liceo Gioberti io ricevo
ogni mese i punti del profitto del fanciullo, p.es. nell 'istituto Rodella, ogni
giorno vi era un giornaletto, dove erano segnati i punti di merito eccetera: e
così era più facile tener dietro al progresso del ragazzo. Capisco che in un
istituto pubblico è difficile che ogni giorno il professore interroghi tutti e dia
i punti; ma ogni settimana si potrebbe avere il profitto del giovane e venendo
La sacramentale domenica si potrebbe premiare o punire il giovanotto. I padri
ancora non sorvegliano lo studio camerale, studio che si fa in famiglia e i figli
stanno a casa più dei padri, perché vi è quest' orario dalle 8 alle 1 0 1 12 e dalle 3
alle 4 1 h: io esco prima del figlio, mi ritiro dopo e sono i n casa meno di lui. I
nostri antichi non lavoravano come noi, non avevano occupazioni come noi,
potevano quindi attendere allo studio camerale del figlio; anche qui la scuola
dovrebbe soccorrerei e fare come in qualche istituto privato nelle scuole go
vernative, cioè , istituire lo studio camerale sotto la direzione del censore in
caricato di sorvegliare i giovanetti . Si studia male a casa perché il padre non
vi è , e la mamma si occupa delle faccende di casa se buona massaia, non ha
tutto il tempo di sorvegliare questo giovane: quindi la scuola e la famiglia
debbono concorrere all' istruzione e alla educazione, ma soprattutto la scuola
si deve occupare dell' istruzione, come la famiglia dell 'educazione, e la scuola
deve in gran parte bastare a se stessa per la educazione: noi siamo troppo uo
mini d 'affari , sono troppe nuove condizioni, la vita pubblica tiene luogo della
vita famigliare, dunque bisogna che la scuola cooperi e molto .
Veggo che si domanda se gli i nsegnanti sorvegl iano i giovani fuori della
scuola : ma io non so come lo potrebbero fare, escono dalla scuola e sono
liberi i giovani di seguire La loro via: mi pare che alcune passeggiate fatte
i n campagna al giovedì per esempio, ché di vacanze ve ne sono t roppe ed
è lamento generale, il giovedì, per esempio pot rebbe essere uno d i questi
giorni per fare queste passeggiate sotto la direzione d i u n professore per
esempio quello di geografia e di storia . A ciò rammento quella circolare
del ministro della pubblica istruzione di Francia, Jules Simon, emanata il
l o ot tobre 1 87 2 ' : la Commissione la conosce certamente e da alcu1 Jules Simon, uomo politico francese, ministro dell ' istruzione nel 1 87 2 , aveva promosso
una serie di modifiche ai piani di studio (abolizione della versificazione latina, studio delle lin
gue moderne e della geografia, sviluppo delle conoscenze sperimentali e, tra l'altro, anche le
passeggiate scolastiche con fini educativi, ecc.) con la circolare del 27 settembre 1 87 2 : assieme
all'opera di Michel Bréal già citata, la circolare Sin1on costituiva un tentativo di liberare la scuo
la francese dalla tradizione retorica e gesuitica, accostandola al modello dei vincitori prussiani.
La circolare Simon è anche ricordata da Petruccelli della Gattina in un suo articolo polemico
sull'inchiesta (doc. 67, p. 56-1 ) .
Sezione Il - l t•erbali delle deposizioni
357
ni 1 quesiti veggo che ne ha preso att o . In questa ci rcolare si raccomanda
di fare q ueste passeggiate in comune, e per noi sono più necessarie che pei
francesi, perché noi non conosciamo la nostra Lingua e i nomi di tanti ogget
ti che ci circondano immediatamente. Probabilmente li conosceranno i to
scani , ma gli altri si troveranno in imbarazzo a rispondere come feci io da
vanti a mia moglie che è tedesca e che sa t utti i nomi possibili. In queste pas
seggiate si può fare un esercizio piacevole ed u tile, e questo entrerebbe an
che nel sistema tedesco che si chiama A nschaungsunterricht e questo con
tribuisce allo sviluppo dell 'intelligenza. È chiaro che per pretendere dagli in
segnanti tutto questo, bisogna pagarli, e qui non aggiungerò una goccia d ' ac
qua all' oceano dei lamenti fatti intorno a questo argomento. Dopo queste
poche osservazioni part icolari, vorrei farne un' altra d 'ordine più generale.
Classicismo e tecnicismo. Un padre di famiglia si trova in grande imbarazzo
quando deve scegliere la via da far seguire ad un suo figlio, se la via classica
o tecnica. A dieci o dodici anni è difficile che le tendenze di questo giovane
si siano spiegate, designate in guisa che il padre possa dire con certezza:
« Questa è la tua strada ,, . Ordinariamente i padri impongono ai loro figli le
proprie disposizioni, gli studi che loro p iacciono maggiormente e dicono :
« Segui gli studi classici, io consiglio questi perché sono un avvocato , e via
via . Vi sarebbe modo di riparare a questo sconcio, perché io credo che lo
studio sia come un reagente, fa conoscere cioè esso stesso ad un giovane
quale sia la sua tendenza spiccata. Ho con molto piacere letto un processo
verbale in cui i l cav . Parato 1 ha proposto di accomunare gli studi tecnici e
classici nelle prime classi che chiamerei elementari dell ' i nsegnamento se
condario . Io sono della stessa opinione, solo nell'attuazione pratica di que
sto concetto mi differenzio da lui , perché il principio che mi muove è quel
lo enunciato di sopra e come tale m i conduce ad u na perfetta fusione di stu
di o identità dei medesimi, né mi pare la conseguenza così cattiva da dover
mettere in un canto il principio, giacché dalla mala conseguenza non si può
sempre argomentare la falsità dei principi . Per cui credo non sia cattiva la
conseguenza di sovraccaricare i giovani del corso tecnico dello studio del la
tino in tre anni. Molti potrebbero gridare, ma questo mi consola, perché tro
vo che a tutti gli italiani in generale è indispensabile il latino, anche a coloro
che vogliano fare gli ingegneri e gli industriali. Sono tempi nei quali il senti
mento religioso è fiacco, noi tutti sentiamo la necessità di [ . . . ] 5 qualche cosa
che tenga l' animo su e non faccia precipitare con alcune credenze benanco
la moralità. Non si può negare che lo studio dei classici latini e della lingua
latina (giacché per me il contenuto e il contenente sono la medesima cosa)
1 Nel ms. : « ed alcuni ».
si
' Antonino Parato, direttore della scuola tecnica di Monviso, nella seduta del 12 maggio
studi.
degli
e
biforcazion
la
era soffermato sulla necessità di posticipare
el m s. la parola non leggibile: si può congetturare " sostenere " o " sostituire • .
è
358
Sezione Il - l verbali delle deposizioni
Fonti per la storia della scuola
contribuisce molto ad allargare lo spirito ed a formare il nostro carattere na
zionale. Tacito è scrittore nazionale quanto Dante e Machi avelli. Non debbo
riconoscere la nostra ignoranza in ciò: sono tante piccole cause che contri
buiscono a formare il carattere nazionale; e questo non è piccolo, è grande.
Capisco che in tre anni di studio non si potrebbe fare troppo latino, ma so
no persuaso che non si debba pretendere di più, perché come avvisa benissi
mo Jules Simon, questo lavoro pei giovani sarebbe un tour de force; ma im
paravano a leggere e a comprendere secondo quel principio che le lingue
antiche sono fatte per essere comprese, le moderne per essere parlate. I no
stri nipoti saranno migliori forse di noi, che diventeremo come i popoli di
razza germanica che anche che facciano gli industriali leggono il loro classi
co, e se non ne sapranno molto ne sapranno però quanto basta. Questa con
seguenza non mi spaventa anche per un'altra ragione che dirò di poi . Ma ve
n'è un'altra, cioè che nelle tre prime classi che ora sono ginnasiali non si
trascurerebbe lo studio della aritmetica e della matematica elementare. Un
giovane delle classi elementari ginnasiali sa d'aritmetica meno di un giovane
delle classi tecniche: ma l ' aritmetica deve saperla ogni uomo, e non è possi
bile che io dica al mio fanciullo : vi è brenta di vino a 3 2 , dimmi quanto fa il
litro, sapendo che la brenta è di 50 litri ; non sapeva fare la divisione, men
tre prima sapeva farla . Ciò bisogna distruggerlo; veggo che nel ginnasio G io
berti non si tralascia del tutto: mentre nelle prime tre classi non vi è lezione
d ' aritmetica, come l'esprime la circolare del ministro: ma se vi è, se ne fa un
poco tanto che non basta. Accomunando gli studi, come diceva Parato, ma
in modo più radicale, come io dico, si potrebbe rimediare dopo tre anni la
biforcazione e avremo cinque anni di s tudi classici e cinque di studi tecnici;
cinque anni, dunque uno di più. Debbono essere uguali tanto i corsi classici
come i tecnici perché tanti che seguano gli studi tecnici a preferenza dei
classici lo fanno forse per la diminuzione degli anni . Ed è da deplorare che i
corsi classici non siano frequentati come i tecnici, i quali lo diventeranno
sempre più perché lo spirito industriale va sempre crescendo: se vi è poi un
anno di meno avremo agevolata una conseguenza deplorevole . Aggiungen
do questo anno vi è il margine da poter studiare il latino.
Latino e greco . Riguardo allo studio del latino aggiu ngerò una ultima osser
vazione circa la quale mi rimetto interamente a ciò che è stato detto nella
circolare di Jules Simon, cioè che fa mestieri cambiare il metodo d ' insegna
mento per trovare il tempo da introdurre qualche lingua moderna, cosa in
dispensabile, giacché non è possibile seguire i corsi classici e arrivare all 'uni
versità senza avere imparato lingue moderne . Si dirà, il tempo dove si trova?
Per ciò alcuni propongono di rendere il greco facoltativo. Capisco che è uti
lissimo a sapersi, anche più utile del sanscrito, capisco che leggere la lingua
originale dei Veda, i libri di Zoroastro eccetera è bello, ma non è indispensa
bile: così il greco è utile il saperlo ma come diceva il prof. Canonico 1 (e qui
metto la mia falce sotto la protezione della sua toga) basta che s i conosca il
greco per poter capire certe parole. Certo che chi va per filologia e sceglie il
greco deve seguire questo fino al termine dei suoi studi. Ma dobbiamo per
gli altri trovare un margine a questo studio che fu introdotto, quando non si
credeva necessario sviluppare le scienze naturali e le lingue moderne; ed ha
ragione Simon di dire che la giornata del 1 87 2 è di 24 ore, come quella del
1 80 2 ; dunque se vogliamo aggiungere q ualche anno questo non va perché
otto anni sono troppi anche per questo.
In quanto alle osservazioni particolari dirò che fu bene osservato dal dr.
Pezzi 1 che l ' istruzione superiore si coordina alla secondaria e che quindi
questa è la base della superiore; io debbo aggiungere che la secondaria si
coordina colla primaria, e che anche sia qualche cosa che oltrepassi il man
dato della Commissione, è bene volgere gli sguardi a quest ' istruzione. Io so
no rimasto preso da gran pietà nel vedere i miei poveri figli condannati a
dovere mandare a memoria pagine intere di grammatica, (si ride) sistema
brutto perché non dirò che non si debba mandare a memoria, è bene che si
mandi a memoria la regola; ma prima bisogna insegnare a questi giovani co
me si parla e come si scrive eppoi venire alle regole ed alle formule. I nvece
cominciano dalla età più tenera a mandare a memoria questa grammatica in
modo scellerato. Questo giovane viene perciò alle scuole secondarie di già
annoiato, seccato, odiando lo studio e allora andate a raccapezzare u n gio
vanetto: vi vuole la fortuna di imbattersi in qualche insegnante rigoroso co
me è capitato a mio figlio: perché vi sono insegnanti bravi ma ve n ' è uno
per esempio che, dovendo attendere al latino ed all' italiano e geografia, per
ché la divisione del lavoro pare non siasi applicata all'insegnamento, è seve
rissimo. Io confesso che quando la mamma è venuta più volte a chiedere il
soccorso dell' autorità paterna non sempre ho avuto il coraggio di affermare
questa autorità, ma mi sono messe le mani nei capelli e qualche volta me ne
sono uscito fuori perché non ho dimenticato di essere anch ' i o stato ragazzo.
Programmi. Si domanda ancora se i programmi debbono essere generali o
particolareggiati, e qui dirò la mia opinione sopra alcuni quesiti, così per
non rendermi importuno. Il programma secondo me deve essere generale,
dare piuttosto l ' i ndirizzo all' insegnante: così mi pare siano fatti in generale
quelli dell ' istruzione secondaria, che sono bene intesi.
Libri di testo . Quanto ai libri di testo, a mio avviso, dopo che il professore è
scelto ed è degno del suo posto, bisogna lasciare libertà a lui. Ma nelle classi
dove si insegnano le stesse materie è necessario che il linguaggio sia lo stes
so. Quindi sarebbe bene che si istituissero quei consigli di professori, una
volta al mese, e che fra loro venissero a discutere sopra ciò che riguarda
l'insegnamento e le sue diverse parti, e con questi consigli sotto la direzione
della « Rivista
Domenico Pezzi, dottore aggregato alla università di Torino, collaboratore
sull'inchiesta
articoli
diversi
873-'7-!
1
nel
pubblicò
ove
,
»
classica
istruzione
di
e
di filologia
3 maggio.
1
del
torinese
seduta
nella
one
Commissi
della
Scialoja, aveva risposto alle domande
1
1 Tancredi Canonico aveva risposto alla Commissione nella seduta del 1 3 maggio 1873, sof
fermandosi in particolare sull'insegnamento delle lingue classiche.
359
36 1
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l verbali delle deposizioni
del preside credo che si possa venire sovente a qualche decisione matura ri
guardo all ' i nsegnamento e scegliere così in buona armon ia qualche libro di
testo .
Esami. on abolirei come è stato proposto in modo troppo radicale gli esa
mi di passaggio o finali . Solo io abolirei la ripetizione di un esame già supe
rato . Ma perché l ' esame non è davvero un mezzo interamente acconcio a
dare giudizio esatto del merito di un giovane, sommerei i punti di esame
con quelli che si darebbero nell ' anno scolastico, facendo conferenze eccete
ra, e la media totale mi rappresenterebbe il merito e quel dado che si chiama
fortuna riuscirebbe a fare la media cogli altri dadi provenienti da queste
conferenze trimestrali .
Insegnamento religioso . Quanto all 'insegnamento religioso che è questione
grave, che brucia, e che non voglio toccare non perché non ne abbia il co
raggio, ma perché voglio parlare come padre e come cittadino, dirò che mi
basta che mi si sia lasciato provvedere da me alla educazione morale di mio
figlio. Se l ' insegnamento religioso fosse inteso per bene, e fatto acconcia
mente, se si spiegasse la Bibbia e la storia sacra semplicemente come storia,
infine se rimanesse nei limiti suoi, non sarei alieno, non ostante la libertà
delle mie credenze, dal permettere che mio figlio lo frequentasse, perché
amo la libertà fino all' u lt ima conseguenza, e non vorrei violentare la co
scienza di mio figlio: voglio che si getti nel grande acquaio e quando è in ca
so di scegliere, scelga. Ma vorrei essere sicuro che questo insegnamento fos
se fatto ragionevolmente, che si mantenesse nei suoi limiti e di questo non
era sicuro: sarà fatto così probabilmente; ma siccome attraversiamo un pe
riodo in cui regna un conflitto fra lo Stato e la Chiesa così ho creduto di fare
opera di buon cittadino pregando i l direttore del ginnasio a dispensare mio
figlio. Non credo però che non sia buon cittadino chi non fa così : ognuno
segue il suo sistema; ciò dipende da criteri proprii : io non era sicuro e ho
avuto paura che sotto la bandiera della religione si insinuasse qualche mer
canzia che avesse potuto viziare il sentimento del mio ragazzo : questo era
un mio dubbio. Anche un uomo come me, assai libero nelle sue credenze, si
rassegnerebbe a fare frequentare al figlio un insegnamento religioso fatto
per bene . La Bibbia è un gran libro , e se ha una parte caduca, ha u na parte
eterna ove sono principi che ogni uomo accetta. Questa è questione che si
deve risolvere molto cautamente, massime se la soppressione dell ' insegna
mento religioso nei ginnasi e nei licei dovesse far diminuire il concorso; bi
sogna risolvere allora la questione piuttosto che toglierla: risolvere facendo
che l ' insegnamento stia nei limiti e lasciando la libertà nei padri di famiglia.
Dirò che ho letto che sarebbe bene di collegare l ' i nsegnamento scientifico
nei licei al religioso: questo sarebbe orribile perché accresceremmo le diffi
coltà. Nei programmi ho letto, con molta soddisfazione, che si raccomanda
di tenersi nei limiti d ' una filosofia elementare: ma guai! se nei licei ol trepas
siamo questo limite, noi ventiliamo le grandi questioni e facciamo i sistem i .
È difficile fare astrazione dal sistema: anche la logica si fa secondo un siste
ma generale: viene un hegheliano e dice che la logica è la metafisica, quindi
si insegnerà la metafisica, e così via via. Sarebbe bene che si inculcasse all ' in
segnante di tenersi in certi limiti e non trattare certe questioni che toccano
più alla università. Io direi di conservare quest 'insegnamento filosofico co
me dai programmi risulta che è al presente, elementare.
Storia. E quanto all' insegnamento storico mi assoderò alle raccomanda
zioni che sono state fatte riguardo ai libri di testo, perché veggo certi som
marii che sono stati scritti o quando l ' Italia non vi era, o se vi era , non an
cora si era cominciato a comprendere che la nostra storia doveva venire
considerata in altro modo: giunt i nel porto noi dovevamo contemplare il
pelago con occhio più tranquillo . Quando non si comprendeva che t u tto
questo caos camminasse direttamente verso l ' unità, la storia italiana non
era stata compresa: ora vi si vede un ordine in questa storia ed un cammi
nare continuo verso questa unità. È chiaro che sommari i e libri di testo
debbono essere fatti oggi con altro intendimen to, e non sarebbe male apri
re concorsi : perché la s to ria è mezzo potente per innalzare l ' animo ed al
largare l ' i ntelligenza .
Da ult imo farò un'osservazione che riguarda il nesso fra l ' istruzione mili
tare e quella che io non vorrei chiamare civile dirimpetto alla militare, per
ché credo che anche noi siamo civili, ma che chiamerei pubblica. Vi sono
molte quest ioni da toccare, ma non ne toccherò quasi nessuna perché la
Commissione potrebbe dirmi che si sconfina dal mandato che essa ha quan
do ci occupiamo coi nessi d ' una altra istruzione, sebbene questi nessi non si
sa a chi appartengono perché quando si avvicinano alla guerra ci si dice che
appartengano alla pubblica istruzione ed alle volte i nessi appartengono a
tutti e due . Vengo solamente ad un' ultima questione e sarebbe strano che io
uscissi da questa sala senza aver fatto sentire che sono soldato.
Collegi militari. La questione è questa: noi oggi abbiamo un collegio m ilita
re ; questo però è in uno stato anormale: probabilmente noi dovremo fare
una grossa guerra, dopo della quale è sperabile che rientriamo nel periodo
di una lunga pace e ci persuadiamo che noi dobbiamo essere nazione marit
tima, industriale e commerciale. Allora la ragione d ' essere di un esercito nu
meroso non vi sarà più, e noi ci avvieremo lentamente a una condizione di
armamento nella quale il numero dell 'esercito permanente scemerà. I o spe
ro che riusciremo vittoriosi da questa possibile grande guerra perché allora
solo noi possiamo dormire tranquilli i sonni della pace, e dedicarcì allo svi
luppo morale ed economico del paese. Allora i collegi perderanno la loro ra
gione di essere : ma le guerre non finiranno così facilmente, e nel paese biso
gna vi sia da riparare all' assenza di certe scuole militari: quindi le scuole se
condarie dovranno essere militarizzate, e con ciò si intende quello che ha
voluto dire Simon, cioè che si provveda più di quello che si suol fare all 'e
sercizio militare, al tiro a segno, alle passeggiate militari eccetera. Questo è
360
362
Sezione Il - I L•erbali delle deposizioni
Fonti per la storia della scuola
necessario a farsi oggi perché l ' esercito ed il paese non sono due cose diver
se : noi siamo cittadini che difendiamo cittadini, e questa è la nostra missio
ne; dunque l ' esercito è tale e quale lo fa il paese: quando il pae�e vi dà una
.
gioventù abile a trattare le armi, istruita i n geografia, anche piu faCilmente
gli eserciti si reclutano e possono far senza d' istruzi? ne, g��cché essi l ' han
_
_ al � tbass
no. I collegi sono necessari ancora perché ora la carnera �ulttare e
�
e sovente è svanito l'entusiasmo che la rendeva accetta; st sono aperti moltt
sbocchi all'attività. È al ribasso, e noi abbiamo mestieri di adescare i giovi:
netti· quindi dei collegi si dice che vogliamo fare collegi di giannizzeri. E
u na �spressione inconsulta, perché noi inculchiamo nell' esercito i sentimen
t i della patria e della libertà. I l nostro esercito è inferiore forse dal lato te�
_
nico all'esercito tedesco, ma non è inferiore a nessuno dal lato del patnottt
smo; (bene, bravo) dunque è indispensabile che la gioventù sappia gli eserci
zi militari, il tiro a segno ecc . non fosse altro che a fare il cacciatore, e al
l 'occasione farà il cacciatore dei nemici (bravo).
Presidente. La Commissione la ringrazia.
G IUSEPPE MULLER 1
Presidente. Lei vuol far parlare su qualche parte dei quesiti?
Muller. (Greco) . Giacché sono stato chiamato dinanzi a questa Commis� io
_
ne, mi pare naturale che io dica alcunché sul greco e n ? n ho btsogn
� � an
dare molto innanzi , per far questo, nei quesiti proposti dalla Commtsswne
d ' inchiesta, perché nei primi numeri si trova la materia. Tanto più che que
sto greco ogni anno è soggetto alle lagnanze dei professori e dei padri di �a
miglia che lo dicono perfettamente inutile. Ora a me pure pare un � uestto
inutile, quello che sto per trattare, dacché è stato dimostrato che ogm coltu
ra per essere ben svolta ha bisogna della cognizione del greco; che pare su�
perfluo tornare su questo quesito. Se confrontiamo chi so�o � p rop�? nator�
del greco e chi i contrari, parmi dovessero andare un p� pm rn.n tl� quelh
che ne parlano contro . D unque, ammesso per intimo m10 convmCimento
che il greco e il latino per quella classe della società chiamata � occupare l a
_
posizione più elevata nella società moderna che sia necessano , vor �e �_ n
_
_
spandere intorno alla domanda che è proposta dalla Comrmsswne, c10e se
studiato a Vienna, inse
' G iuseppe Miiller (Brunn 1 82 5 - Torino 1 895). Grecista, dopo aver
�� Padova; nmosso �a
quell
a
860
1
al
e
gnò dal 1 854 al seminari o storico filologico di Pavia
_
a
filoaus
l
t
senumen
suo1
1
per
866
1
nel
italiano
ario
_tnacl � SI stab1lt
commiss
_
dal
questo incarico
e
IStruziOn
�
e
filolog1a
d1
Rivista
«
la
diresse
r,
Lòesche
Torino dove fu consigliere dell'editore
la Grammattca greca del
classica . e ricoprì la cattedra di gramma tica greca. Nel 1 867 tradusse
IStruziOr n a1 nuov1 pro
nelle
Coppino
ministro
dal
anno
stesso
quello
Cunius, raccoma ndata in
namento del gre
all'inseg
ne
abilitazio
alla
i
grammi. Nell'inch iesta viene presenta to dai candidat
severo.
amente
co come eccessiv
?
�
�
363
quelli che vengono per la facoltà di lettere per prepararsi all ' i nsegnamento
liceale e ginnasiale, sono sufficientemente preparati e se il numero di quelli
che vengono alla u niversità eccetera.
Alla prima domanda dichiaro che la loro preparazione è affatto insuffi
ciente. Vengono all 'esame di ammissione (nella più parte, perché vi sono
sempre eccezioni) con pochissime cognizioni di grammatica greca e con
quasi nessuna lettura. Quando in tutto i l liceo sono state lette venti o trenta
pagine di Senofonte e dieci o dodici di Omero, da una scuola u niversitaria
possono trarre ben poco profitto. Mi si domanderà quale è la ragione per cui
sono così poco preparati? In parte questo dipende dall'ordinamento attuale
del liceo e del ginnasio: alle lingue classiche e specialmente al greco si dedi
ca troppo poco tempo . Negli anni di liceo l ' insegnamento del greco si ridu
ce a due e mezzo od al più tre ore; non si può fare la necessaria lettura che
ribadisca la grammatica che debbono avere studiato nella quarta e q uinta
ginnasiale e per conseguenza quando vengono all 'università il professore si
trova in u na difficoltà immensa in quanto che non sa come combinare la uti
lità dei giovani colla necessità della cattedra u niversitaria. Se entrano poco
preparati, all ' altro quesito : « se possano coll'at tuale ordinamento della facol
tà di lettere e filosofia uscire preparati in modo da essere valenti professori ,
rispondo che l ' attuale ordinamento della facoltà di lettere costringe tutti i
giovani a tale molteplicità di studii che non possono dedicare il necessario
tempo allo studio del greco e del latino. È indispensabile che pei giovani che
accorrono alla facoltà di lettere si debba fare una distinzione di materie se
condo il ramo che vogliono poi professare nelle pubbliche e private scuole;
se vogliono praticare l ' i nsegnamento della filologia, della storia, del greco,
ovvero della filosofia affinché possano dedicarsi a questi studii con maggior
tempo . Sarà sempre da raccomandare a loro di approfittare degli anni u ni
versitari per assistere a tutti i corsi che coadiuveranno a istruire la loro men
te. Ma il mio quesito si riferisce a quelli che nell ' ultimo esame siano special
mente interrogati ed esaminati quanto più severamente si può in quel ramo
in cui vogliono veramente professare l ' i nsegnamento. Come ora stanno le
cose, ché notoriamente escono dal liceo con troppo poche cognizioni di
greco, per assistere alla lezione che per titolo ufficiale porta letteratura gre
ca, mi pare che debba essere ristabilito per la u niversità di Torino quello che
una volta esisteva cioè una cattedra di grammatica greca per quelli che dai
licei vengono all 'università: se non si fa un simile corso preparatorio, fra le
altre difficoltà evvi anche quella che il professore non sa come regolarsi do
vendo parlare per quelli del primo anno e per quelli che hanno lavorato con
lui per due e anche per tre anni. Vi è un altro argomento per dimostrare la
necessità della restituzione della cattedra di grammatica greca ed è che oltre
la guerra generale che si fa alla lingua greca come inutile, vi è poi un caso
speciale ed è contro il metodo grammaticale che nella più parte dalle catte
dre di greco si propugna ed è la grammatica comparata come base.
.3 64
Fonti per la storia della scuola
Qui sto quasi per ripetere quello che uno ieri ha detto 1 , cioè che la lin
guistica ci ha rivelato un tale numero di fatti certi di grainmatièhe greche,
che ha mutato profondamente il metodo che va tenuto specialmente nell' in
segnamento del greco. Noi colla grammatica comparata della lingua indo
europea possiamo a molte regole dare una forma così razionale e scientifica
e intellegibile, quello che importa, anche alla intelligenza del giovane, che
dopo il latino e italiano è condotto a studiare il greco, che non abbiamo più
diritto di continuare con quell' empirismo che fino a [ non] molto tempo in
dietro era invalso anche nell ' insegnamento del greco e questo manca ai pro
pugnatori, in tutti: se non lo posso asserire propriamente di tutti perché non
li conosco tutti, almeno di otto che siamo che insegnamo il greco in Italia
nelle università, siamo tutti di questo pensare. Succede che ogni volta che
questo quesito viene pubblicamente trattato si dice sempre: " Non è adattato
ai giovani italiani, non si confà al genio italiano » , il che però non vuoi dire:
« Non sono capaci di intendere le verit à » . Devono meccanicamente imparare
le cose: se a loro date una ragione, non la intendono più. Questo è ragionare
che nessuno può ammettere; se si può col dovuto riguardo pedagogico do
vuto alla età dei giovani, si deve sostituire una legge generale che faccia ca
pire quali sono le ragioni che guidano a certi fatti, dobbiamo dare queste
formule generali, tanto più quando questa dia una vera luce dove prima non
si vedeva che il caos; e non cito che l ' elenco alfabetico dei verbi irregolari
della lingua greca che nessuno ha mai potuto intendere senza u na lunga let
tura nei classici. Non si dice che non si può arrivare alla cognizione del gre
co che col sussidio della grammatica greca comparata, ma si deve solo cer
care di introdurre un metodo razionale colla necessità di dar tempo anche ad
altre scienze che sono necessarie ai giorni nostri e di cercare qualunque mez
zo per agevolare e rendere più razionale lo studio: noi ciò dobbiamo volere.
Eppure succede che si propongono certe grammatiche e certi ristretti ed
estratti di libri francesi 2 che erano eccellenti cinquanta anni sono, ma non
rappresentano più lo stato della scienza, proposti come modello altri libri
che, rappresentando il vero stato della scienza, introducano quella parte che
è proficua per l' insegnamento escludendo tutto quello che è rarità scientifi
ca, si servono di leggi che la moderna scienza ci offre onde rendere più pro
ficua questa scienza e invece di gridare contro questi libri che autorità chia
mano tedesch i : giacché chi non vuole il Curtius prenda l ' I nama; il principio
è lo stesso. Il principio è giusto e questo si applich i ; quale sia poi l ' autore di
1 Si riferisce alla deposizione di Giovanni Flechia che aveva insistito sull'importanza della
grammatica comparata nella preparazione degli insegnanti del ginnasio-liceo (ACS, MPI, Div.
scuole medie, 1 860- 1 896, b. 6, fase. 32).
2 Allude alla grammatica greca di )ean Louis Burnouf, edita la prima volta in Francia nel
1 8 1 3, molte volte ristampata, tradotta anche in Italia dove, prima dell'adozione del Curtius, fu
molto diffusa, prevalentemente in forma compendiata e che nel 1 873 era ancora adottata in di
versi ginnasi, specialmente in quelli non governativi.
Sezione 11 - f 1•erbali delle deposizioni
365
questo libro, non è che questione secondaria. Come è questione secondaria,
se i principi sono giusti, il vedere se sono pubblicati in tal modo da essere
utili nel pratico insegnamento: quando gli studii siano in tal modo organiz
zati che colui che entra nella facoltà di lettere e filosofia debba rispondere al
quesito a quale dei molteplici rami che si insegnano nella facoltà voglia ap
plicarsi, e quando si sia risposto: « Voglio fare il filologo classico » , allora è
necessario gli sia dato insegnamento grammaticale greco e latino compara
to , non che quegli esercizi pratici di traduzione dall ' italiano in greco perché
quando non si scrive una lingua non la si conosce : cogli esercizii pratici da
adoperare nelle scuole sono certo che alla fine dei quattro anni prescritti
dall 'odierna legge saranno tali i giovani da poter loro affidare qualsiasi i nse
gnamento di greco ed anche di latino. G iacché il mondo greco e latino è co
sì unico e solo che non si può separare. Quando si faccia così sono certo che
i quattro anni bene impiegati nello studio del greco e del latino e corredati
di quei corsi sussidiarii che sono necessari per comprendere lo spirito dei
greci e dei latini, avremo professori che saranno tali da non trovarsi migliori
negli altri paesi civili . Anche ora non bisogna però dire peggio di quello che .
è; si ha un certo numero di giovani che con tale ardore si danno a questo
studio, che malgrado ne abbiano tanti altri, danno un bellissimo risultato e
non è neanche scarso il numero di quelli che annualmente sono a disposi
zione del governo per essere impiegat i : una trent ina; almeno la metà dei
quali esce dalla università con tali punti che fanno vedere che sanno vera
mente di greco . Moltiplicando questo numero pei diversi anni, fra non mol
to si avrà il numero sufficiente per sopperire ai bisogni che si vengono ad
avere. Ma la carriera che a loro è fatta, alletta poco.
È un punto questo già toccato da molti : la posizione che il professore del
ginnasio specialmente ha qui è tale che non può allettare : ci vuole un'amore
grande per l ' insegnamento per dedicarvisi. Pure si ha bisogno di un maggior
numero che venga alla facoltà di lettere e ciò dipende da che venga miglio
rata la condizione economica degli insegnanti dedicati alle scuole seconda
rie . Ma non basta : manca anche il pane intellettuale se noi escludiamo i
grandi centri. I l povero giovane che è imbevuto della vita letteraria della
università, è scelto e viene mandato lontano dalla provincia. Pei primi anni
tenterà di vivere con 30 o 3 7 lire al mese e lo farà se ama la scienza. Ma una
cosa che pesa è la mancanza dei mezzi per continuare lo studio. Una cosa in
dispensabile è che dove per le biblioteche governative non si è provveduto
ai bisogni letterari del professore, si trovi modo di istituire una biblioteca li
ceale che almeno le cose più indispensabili metta a disposizione del profes
sore e gli renda possibile di sfamare il suo intelletto, perché la sete del sape
re è molto più ardente che la materiale 1• Ora di quest i istituti non sono po1 La stessa esigenza di fornire le biblioteche scolastiche dei piccoli centri di opere scientifi
che, per consentire ai giovani professori, usciti da studi universitari rigorosi, di proseguire le
loro ricerche e di non cadere nella prostrazione intellettuale, ritorna più volte nell'inchiesta: se
366
367
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l uerbali delle deposizioni
chi che mancano affatto di biblioteca. Dallo stipendio non può senza impor
si un sacrifizio che non può sostenere, procurarsi i mezzi, tan!o più che in
tante parti d ' I talia non vi sono nemmeno questi librai che gli procurino i li
bri . Ne ho visti parecchi di questi stabilimenti e hanno fatto tali lamenti i
miei scolari che mi facevano veramente compassione a vederli condannati a
non continuare i loro studi in quell' epoca nella quale avevano maggiore ne
cessità di continuare quegli studi cominciati alla università.
Se i giovani vengano ora così poco preparati quanto al greco dai licei bi
sognerebbe ancora fare u na domanda: non è possibile che a poco a poco si
ottenga maggiore risultato anche come si dà ora nei licei? È possibile, pur
ché si divida il greco dall ' i nsegnamento del latino e si affidi il greco e il lati
no a due professori distinti, e di più scegliere per il greco quelli che ogni an
no escono con migliori qualificazioni dalle migliori università del regno; ed
assegnare un maggior numero d'ore: non cito la G ermania perché si cita un
po' troppo oggi . Ho percorsi i programmi della Svizzera pel ginnasio e liceo
e non esiste questa divisione che non credo molto opportuna, quando due
stabilimenti hanno il medesimo i ntendimento e non vedo che esista diffe
renza fra liceo e ginnasio.
Il greco ha sei od otto ore la settimana in quelle classi che corrispondono
agli anni del liceo nel regno d ' I talia. Se qui si crede necessario per ottenere
un risultato in greco sei o sette ore di studio, non capisco come da sette si
possa andare a meno della metà. Vogliamo pure ammettere che l ' i ngegno sia
più pronto ma non sono questi gli studi in cui la prontezza dell 'ingegno ba
sti: sono studi di pazienza, vi vuole l ' occupazione seria giornaliera. Quanto
al greco si deve aumentare di molto l ' orario e costringere i giovani ad antici
pare d ' un anno l ' i nsegnamento del greco, e se è possibile dare l ' insegnamen
to del greco nella terza e quarta grammaticale, compresa la sintassi della
quale non ne vogliono mai sapere. Giacché anche questa va insegnata cogli
esercizi, indispensabili per imparare il greco . Nella quinta la lettura si può
incominciare lentamente e nei primi anni bisognerebbe sempre ricorrere alla
grammatica: ma nei licei bisogna fare ampia lettura dei classici, perché senza
questo succoso nutrimento che ci danno i classici per quell 'età giovanile, al
lora tanto farebbe di eliminare questo studio del greco e sostituire qualche
altra cosa o lingua moderna, la quale quell ' ufficio di ginnastica intellettuale
potrebbe fare. È gran ginnastica intellettuale il greco ed il latino, ma anche
u n ' altra lingua purché sia differente dalla lingua nazionale , fa il medesimo
uffizio; è la lettura dei classici che si deve aggiungere e fare nel più largo
modo possibile, affinché vi sia anche l ' influsso sul cuore, ciò che si vuole
ottenere con la lettura classica. Tutto questo si può ottenere purché si asse-
gni il greco ora negletto ad un professore separato, il quale non abbia da
pensare ad altro che all ' i nsegnamento del greco, e per far ciò credo che il
numero degli insegnanti sia anche sufficiente, e le università danno un certo
numero di giovani i quali sono tutti educati alla medesima maniera, almeno
fino dove arriva la mia conoscenza personale dei colleghi . Questa omoge
neità che si desidera, allora si vedrà che nasce da sé. Non vi sarà nemmeno
bisogno di prescrivere la tale o tale altra grammatica: non importa che sia la
medesima grammatica, importa che il metodo sia lo stesso e gli stessi i prin
cipi fondamentali , purché ognuno di noi porti quello che ha della scienza
propria. Non importa che l 'uguaglianza nei principi fondamentali e credo
che da tutte le università ora escano giovani informati alle medesime idee e
ci facciano la guerra: ci difenderemo volta per volta, e quando il nostro
esercito sarà ingrossato abbastanza per vincere allora si vincerà e tutti tace
ranno.
Presidente. La Commissione lo ringrazia.
ne fece portavoce soprattutto Alessandro D 'A ncona nella lettera a Celestino Bianchi, di presen
tazione alle Memorie di Placido Cerri, pubblicata su La Nazione » del 1 9 aprile 1 87 3 come con
tributo all'inchiesta (ora in P. CERRI, Tribolazioni di un insegnante di ginnasio, prefazione di
A. D 'ANCONA con una nota di M. RAICICH, Firenze, Passigli , 1 988).
•
32
Seduta di Firenze, 29 ottobre 1 8 73
1•
ACS, M P I , Dù•. scuole medie (1860-1896), b . 6 bis, fase. 36.
UBALDlNO PERUZZl 2
Presidente. L ' onorevole signor sindaco ci potrà favorire delle informa
zioni intorno all ' i nsegnamento secondario e sopra quegli argomenti che
crede .
Peruzzi. Se permettono dirò che quando ebbi questi quesiti della Commis
sione mi feci un dovere di studiarli coll' animo di fare una risposta in iscrit
to. Il tempo mi è mancato ; per altro in alcune parti mi hanno giovato per
studiare un progetto di riforma dell ' ordinamento delle scuole del comune di
' La seduta è presieduta da Antonio Ciccone.
Ubaldino Peruzzi (Firenze 2 aprile 1 8 2 2 - Amelia, Firenze, 9 settembre 1 89 1). Capo del
governo provvisorio formatosi dopo i moti del 27 aprile 1 8 59. Deputato dal 1 860 al 1 890, in
seguito senatore del regno, ministro dei lavori pubblici nei ministeri Cavour e Ricasoli e dell'in
terno nel ministero Farini, poi Minghetti, sindaco d i Firenze nel periodo i n cui la città fu capita
le promosse una serie di opere pubbliche che gli costarono l ' accusa di aver condotto il comune
al disastro economico; protesse come sindaco l' Istituto fiorentino degli scolopi ed ebbe una
parte di rilievo nel regolare i non facili rapporti del l ' Istituto superiore di studi pratici e di per
fezionamento con il ministero.
2
368
369
Fonti per la storia della scuola
Sezione Il - l verbali delle deposizioni
Firenze, tanto per le scuole primarie che per le secondarie e principalmente
collo scopo di servire a mettere una remora agli aumenti ogni anno crescen
ti di spese che si fanno qui per l ' istruzione pubblica. Siamo gi à a 700 mila li
re e abbiamo sempre novemila ragazzi fra i sei e gli otto anni che non sanno
né leggere né scrivere. Ogni anno siamo obbligati a rifiutare 200, 300, 400
alunni nelle scuole elementari, quantunque dal '65 in qua si sono aperte
ogni anno due scuole n uove, e siamo già a 280 1 classi .
L o stesso è per l e scuole tecniche, nelle quali siamo sempre obbligati a ri
fiutare degli alunni . Dunque questo mi ha indotto a studiare la questione e
in ciò mi sono giovato dei quesiti della Commissione d ' i nchiesta. Ho fatto
una relazione d ' un progetto che in questo momento si sta studiando dalla
Commissione direttiva delle scuole. Aveva preso degli appunti per fare que
sta relazione scritta e se la Commissione lo permette me ne gioverei . Se poi
la Commissione vorrà interrogarmi sopra altri punti, ove posso risponderò;
tutta la parte pedagogica, ciò che riguarda gli esami eccetera, sono partite
delle quali non m ' intendo: dunque chiederò il permesso di non rispondere
su questi punti .
Sul quesito n . 3 « Quali frutti ecc. ,, non sono in grado di rispondere al
quesito come è formulato perché non so quali frutti abbiano dato questi cor
si. Solamente credo utile la Commissione conosca un fatto ch ' è successo qui
a Firenze relativamente a questa formazione di maestri per le scuole tecni
che. Rammenteranno che pel Regolamento 3 giugno 1 863 2, i maestri delle
scuole per essere ammessi all'insegnamento nelle scuole tecniche bisognava
subissero un esame secondo le diverse materie dell 'insegnamento letterario,
matematico e sia delle scienze naturali. Siccome non si sapeva troppo come
i giovani si potessero preparare a questi esami perché il Regolamento del '63
non lo definiva, fu istituita qui una società privata promossa principalmente
dal deputato comm. Domenico Berti di cui facevo parte io pure; e vari inse
gnanti del liceo Dante e d ' altri istituti si prestarono gratuitamente a fare dei
corsi per preparare i giovani ad essere maestri delle scuole tecniche. Questa
scuola durò tre anni fino a che venne il Regolamento del 3 aprile 1 870 \ il
quale come lor signori sanno, stabiliva che questi giovani per essere ammes
si quali maestri delle scuole tecniche dovessero aver seguito per due anni i
corsi dell ' università, sia della facoltà di lettere e filosofia, sia della facoltà di
scienze fisiche e naturali , e di più disponeva che nelle università dovessero
essere fatte delle conferenze per degl'insegnamenti speciali e per esercizi
pratici e metodici . È stata poi ammessa una disposizione transitoria, che cre
do finisca quest 'altro anno, per la quale sono ammessi anche quei giovani
che hanno insegnato per tre anni in una scuola governativa o comunale, o
sei anni in una scuola privata. Ora è accaduto che questa scuola fondata qui
chiese che i corsi fatti in essa che avevano dato buoni fru tti potessero valere
come quelli delle facoltà universitarie, ma il ministero ebbe un parere con
trario dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e disse che non pote
va ammetterlo sicché i giovani rimasero frustrati nelle loro speranze. La So
cietà sospese allora la sua scuola e si è riunita per fare una petizione al parla
mento sopra quest' argomento. È venuto a risultare (dico questo perché ne
fo parte ed è utile che la Commissione lo conosca), si è venuti a sapere che
in fatti nelle università queste conferenze non sono mai state istituite, e dal
le indagini che si sono fatte è risultato che seguendo per due anni i corsi
d ' una facoltà che abbracciano tante materie le quali non solamente sono in
parti superiori a quello che occorre che i maestri delle scuole tecniche sap
piano, ma ove si danno degli insegnament i con un fine diverso e con un or
dine d ' idee e con metodi affatto diversi, perché il fine che si propongono è
diverso, accade che i giovani che seguono questi corsi oltre che non hanno
le conferenze che dovevano esservi secondo il decreto 3 aprile 1 870, rice
vono un' istruzione che non li abilita al corso da farsi nelle scuole tecniche.
Ma che cosa accadrà quando saranno finiti questi due anni di tolleranza per
questi maestri che hanno già insegnato nelle scuole private governative o
comunali? Ora dico che mi pare questa sia u na partita della quale conviene
che il ministero si preoccupi in quanto che effettivamente l ' i nsegnamento
nelle scuole tecniche pare a me, e qui pare generalmente a tutti quelli che se
occupano, che dovrebbe avere u n ' i ndirizzo, anche astrazione fatta dall' ordi
namento delle scuole tecniche di cui parlerò a proposito d ' un altro quesito,
anche prendendo le scuole tecniche come sono , dovrebbe essere fatto piut
tosto che secondo i principii generali delle diverse scienze che si professano
nelle università con uno di questi due fini o di dare quelle cognizioni prati
che le quali servono a tutti gli usi della vita e che negli usi ordinarii della vi
ta hanno delle applicazioni frequenti oppure dev' essere preordinato a quei
fini speciali che la scuola tecnica deve avere rispetto all' applicazione di que
ste scienze professionali, industriali od altro. A questo ufficio pare che l ' in
segnamento che si dà nelle facoltà u niversitarie non possa rispondere mini
mamente. Rispetto al metodo più adattato all ' insegnamento del disegno nel
le scuole tecniche si domanda se siena capaci di giudicarlo tutte le accade
mie di belle arti che oggi ne sono incaricate. Dico di no e credo che nelle
scuole tecniche, l ' insegnamento del disegno da noi lascia a desiderare; e giu
dico con tanta maggiore libertà in quanto che sono veramente lodevoli gli
sforzi che si fanno nelle nostre scuole tecniche e specialmente nella scuola
tecnica Dante per spingere l ' i nsegnamento del disegno che è arrivato a dare
risultati mol to soddisfacenti. Ma diceva, astrattamente, non soddisfa in rela-
1 A l aro è stato segnato, successivamente alla stesura del verbale " 1 83 ?
Peruzzi dice erroneamente " 3 giugno » , m a si riferisce al r. d. 6 giu. 1 8 6 3 , n . 1 309, " Ap
provazione del regolamento per gli esami di abilitazione all'ufficio di maestro nelle scuole tec
niche di primo grado ».
' R.d. 3 apr. 1 870, n. 5 6 20, che approva il regolamento per l'istituzione di corsi d 'istruzio
ne destinati a preparare maestri di scuole tecniche, normali e magistrali e per il conferimento
dei diplomi di abilitazione ad alcuni insegnanti nelle dette scuole.
!
•.
370
Fonl i per la storia della scuola
Sezione fJ - I verbali delle deposizioni
zione col fine che debbono avere le scuole tecniche; credo domini troppo
l ' elemento artistico e del disegno veramente industriale credo abbiano gran
dissimo difetto. Rispetto ai giudizi, so che anche i professori di accademie di
belle arti cercano di allontanarsi dai canoni secondo i quali giudicano nelle
accademie di belle arti stesse quando pronunciano i loro giudizi sui disegni
delle nostre scuole tecniche; ma siccome non c'è una classe che insegni que
sto disegno, non ci può essere una classe che ne giudichi . A nche in questo
momento ci sono in Palazzo vecchio il direttore della scuola di disegno in
dustriale di Nlirnberg e un professore di Colonia i quali copiano i soffitti del
palazzo di Leone X; e mi dicevano: " Dal secolo sedicesimo in poi anco un
poco nel diciassettesimo questo genere che ha qualche cosa che partecipa
dell 'artista e del tappezziere non c'è più, o c'è un tappezziere senza gusto
antico, o è un decoratore di stanze , o è un artista che farà un bellissimo la
voro, ma non vi orna una stanza » . Ora tenteremo di mettere nel Museo na
zionale una scuola di disegno artistico industriale come quella di Nlirnberg
che ha dato bellissimi risultati . Oggi credo non ci sia una classe giudicante
perché non c'è una classe insegnante a questo disegno .
Al numero 4 : « Le persone incaricate dell ' i nsegnamento ecc ». Su questo
dirò che io credo che generalmente, almeno qui a Firenze, gl' insegnanti
esercitano il loro ufficio molto lodevolmente e con moltissimo zelo, ma in
generale elevo dire che effettivamente credo che queste condizioni fatte loro
dagli ordinamenti attuali non sieno tali da dare buon frutto. Quindi mi pare
che il dubbio della Commissione sia fondato, e sia fondato principalmente
pei modi che si usano troppo spesso rispetto a quest 'insegnanti . Prima eli
tutto quest' insegnanti sono poco retribuiti in confronto dell ' i mportanza del
l ' ufficio che esercitano, ma il peggio si è la minaccia eli traslocazione che
hanno sempre davanti agli occhi . Quando hanno preso i n una città delle
consuetudini eli famiglia, eli altri guadagni, eli studi eccetera, un bel giorno
non si sa perché, né come, si vedono traslocati altrove, e qualche volta sono
messi in aspettativa per riduzione eli ruolo. È accaduto qui, non è gran tem
po, anzi in questo momento stesso che alcuni insegnanti rispettabilissimi
che stavano qui assai volentieri, ed esercitavano bene l ' ufficio loro sono sta
ti traslocati a Roma con loro grandissimo dolore e danno ' , senza che quello
li abbia minimamente vantaggiati , e senza che con la loro condotta avessero
dato mot ivo a questa misura che è stata presa per vantaggio degl ' istituti eli
Roma. Ma questo ha nociuto in due modi perché ha privato gl ' istituti che fa
cevano bene eli un' opera certamente utile , mentre chi sa se faranno egual
mente bene per quell 'armonia che ci dev 'essere fra gl' insegnanti . Il secondo
è che questo ha avvicinato sempre più al capo degli altri insegnanti questa
spada eli Damocle che ne ha colpiti alcuni veramente. Gli altri insegnanti si
trovano quindi in uno stato eli timore, vorrebbero assumere altri impegni
che servono loro eli paracadute pel caso avessero acl essere traslocati , per
chiedere la loro aspettativa.
L' art . 5 « Le nomine e le promozioni come oggi avvengono, ecc » . Su que
sto non esito a rispondere affermativamente, ed anzi mi permetterei di allar
gare un poco la mia risposta esponendo la mia opinione che mi è venuta in
seguito allo studio accurato che ho fatto eli questa materia dovendomene oc
cupare sempre da un punto eli vista pratico, ed è che a me pare che grandis
simi inconvenienti ci siano che costituiscono una grandissima inferiorità de
gli istituti governativi provinciali e comunali in confronto a quelli retti dalle
corporazioni religiose. Sono questi due : prima eli tutto che generalmente io
credo che i nostri maestri tanto eli scuole primarie come eli scuole seconda
rie si considerano come eli passaggio, ma arrivano più alto. Questa differen
za che torna a danno delle nostre scuole c ' è non solo fra i nostri maestri e
gl'insegnanti delle corporazioni religiose , ma anche colle maestre, colle
femmine ed è uno dei motivi per cui tutti quelli che si occupano d ' insegna
mento pubblico tendono acl aumentare il numero delle classi rette da mae
stre. Per le maestre generalmente come per gl' incliviclui addetti alle corpora
zioni religiose, la carriera dell' insegnamento primario o secondario è una
carriera intiera, lì si comincia, lì si finisce. Tutta la loro ambizione è eli di
ventare ottimi insegnanti eli scuole primarie e secondarie. La maestra il più
che possa aspirare è eli diventare direttrice eli una scuola elementare comple
ta, ma sa che in quel cerchio lì si compierà tutta la sua carriera. Così il mae
stro eli un istituto secondario retto da corporazioni religiose sa che general
mente finirà lì . Abbiamo avuto uomini sommi cui non è mai passato per la
testa eli diventare professori d ' università, e se avessero offerto loro un tal
posto non avrebbero probabilmente accet tato. Tutta la loro ambizione era
eli diventare maestri eccellenti in un istituto secondario. Ma i nostri maestri,
meno quelli che sono legati da relazione eli famiglia nel luogo ove sono, cre
do che la loro speranza e il loro desiderio non sia eli rimanere sempre nello
insegnamento secondario, ma aspirino a finire all ' università. Ora io credo
che questo passaggio all ' università possa essere eccezionalmente una ricom
pensa a meriti veramente trascendenti e singolari , e seguitando sempre l'e
sempio delle corporazioni religiose ci sono stati alcuni che, dopo avere inse
gnato nelle scuole secondarie, sono passati all ' università, ma sono casi ecce
zionali . Io credo dunque molto utile il s istema degli aumenti per servigi
straordinari; ma soprattutto credo si dovrebbe cercare eli circondare l ' i nse
gnante d ' ogni sicurezza e più eli tutto eli quella eli rimanere al suo posto fin
che fa il suo dovere. Tutto questo i nsieme credo dovrebbe essere ordinato
per modo da indurre l ' insegnante della scuola secondaria a restringere la sua
ambizione al desiderio eli diventare un eccellente insegnante di scuola se
condaria. Oggi credo nuoccia moltissimo questo desiderio che hanno i mae
stri eli farsi eli questo uno sgabello per salire più alto, e non solo nella carrie
ra dell'insegnamento , ma anche per anelare in altre carriere come purtroppo
1
Nel ms. « ed hanno».
37 1
Font i per la storia della scuola
s i sono veduti molti esemp i; quindi coloro che abbracciano la carrier
a del
.
l . msegna
�1 ento . second ario l 'abbrac ciano come un pis· alter per non aver
tr_ovato ?' meglto . A questo molto gioverebbe il fare quello cui accenn a
uno
dt questi quesiti « Non dovrebbe il trasferi mento essere fatto in ogni caso
ecc . (n. 5 c .v. ) >> . � ��ognerebbe appunto che il ministe ro desse maggiore im
portanza at_ constgh scolasti ci provinc iali. Io credo che il Consig lio scolasti
co provin ciale il quale potrebbe essere rafforz ato metten doci un numero
di
padri di �amiglia ed altri dovrebb avere un' import anza che pur troppo oggi
non ha . E accadu to a me pure dt� vedere arrivare un bel giorno un decreto
_ .
del mtmste
�o che �rasloca un profess ore, che mette in aspetta tiva un altro,
senza eh � SI� stato � nt erpella to il Consiglio. Questo io credo equival ga ad an
.
nullare � ta Il Constgho
delle scuole sia il Consig lio scolast ico provin ciale,
_
mentre LO cre � o bisognerebbe questi fossero rafforz ati princip alment e te
nen� o fermo l uso da parte del ministe ro di non prendere mai misure, e in
p�rtlco l �re r� l � tivamen te al personale della provinc ia vigilato da un consi
g ho dt cmadm t che hanno a preside nte il provve ditore, senza sentire il Con
_ provinc iale . Pe r 1 1 odo che rafforz
s �_ glw
are l'autori tà del Consig lio 1 provin
_ �
C. iale credo essenz �. ahsstmo
oggetto
perché
gl'istitu ti vadano bene. Bisogna
.
fare m
modo che ti personale addetto a quest' istituti abbia tutto da temere
da parte del Consig lio provinciale. Oggi non è così, perché il ministe ro
pren�e le st� e misure al di fuori sia dei consigl i scolast ici provin ciali sia
di
_ IIanza delle diverse scuole govern
quelh dt_ vtg
ative e parlo special mente del
l� magistr ali_ ! ! « Co quali altri provve diment i oltre l'aumen to dello stipen
�
diO >> ecc . (n. 5 ulttmo c . v .). Qui, aveva l' onore di dirlo, credo che sia da
pre � dere quel comple sso di provve diment i che ho indicat o, e princip almen
t � �� dare l � r? dell� g�ra�zie qual' è questa import anza maggiore data ai con
stglt scolastt ct provmc talt che sono più in grado di vedere quello che merita
no gl' insegna nti, e di sentire le loro ragioni e discolp e nel caso di qualche
� ancanz a._ _Al � e domande che seguon o circa l 'autorit à del consigl io provin
Ciale, ho gta
nsposto implicit amente .
N. l l: ' Un� arte dei difetti che si lament ano ecc
,, . Ho già rispost o anche
�
�
a questo tmphcttam ente dicendo che per me credo bisogne rebbe che per
_ r� presa sugl' istituti delle provinc
qual� n�ue nus
ie dovreb be essere prima
�
� entito il Consig lio scolasti co provinc iale; e gli si dovrebbe dare moltiss ima
Import anza, anche per vedere che la politica s'infiltr i meno nelle cose relati
ve alla pu �? li<:= a i � truzion e. � on dico che in un paese libero non ci sia il peri
colo che � mfiltrt anche qm, ma nel Consig lio scolasti co provinc iale si met
t � no degh elemen ti tratti dall 'insegn amento e dai padri di famigli a, che ab
btano verame nte un interess e morale avendo dei figli in età d'andare alla
scuo� a. Si sfuggirà così più facilme nte a questo pericol o che è uno dei più
gravi, e che reca molto danno all'and amento della pubblic a istruzio ne. C ' era
anche una domand a che ora non ritrovo che parlava delle punizio ni e parti1
Nel
ms.
« !or figlio
•.
Sezione I l - l t•erbali delle deposizioni
37 3
colarmente del trasferimento dato per punizione ai professori . Questo pare
sia uno dei grandissimi inconvenienti. È accaduto varie volte che degl'inse
gnanti sono stati traslocati da un istituto ad un altro per punizione . Quando
la misura di traslocamento sia presa per incompatibilità d' umore, di caratte
re con altri, o perché è un professore d'un indole un po' viva, e il presiden
te di quel luogo, ottimo sotto ogni rapporto, non ha le qualità necessarie
per mantenere una disciplina rigorosa, e il professore si manda in un altro
istituto ove ci sia un preside adatto, lo intendo, ma quando si tratta di man
darlo in altra provincia su punizione di vere e proprie colpe, o di atti pei
quali si mostri disadatto al pubblico insegnamento, credo questo rechi pessi
mo effetto, e contribuisca molto all'opinione d' inferiorità degl ' istituti governativi cui ho accennato.
Al n. 1 3
Scarica