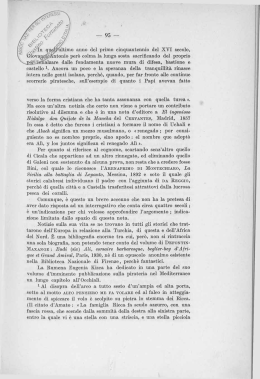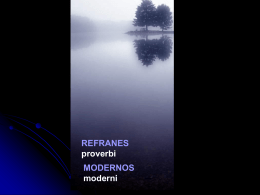Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Per le vie del mondo a cura di Piero de Gennaro 2009 Università degli Studi di Torino Trauben 1 In copertina,“Universale marina” di Francesco Rosselli (Firenze, 1508 circa), incisione su pergamena (cm. 18 x 33,5) conservata al Greenwich National Maritime Museum. © 2009 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Trauben editrice, via Plana 1 – 10123 Torino ISBN 9 78-88-89909-553 2 Indice Paolo BERTINETTI Sull’inutilità degli studi letterari in generale. E di quelli di Anglistica in particolare. 7 Orietta ABBATI Tracimar di sensazioni e idee. Il Natale nella poesia ortoniana di Pessoa. 13 Elena DE PAZ DE CASTRO La traducción italiana del episodio galdosiano Trafalgar. 21 Giancarlo DEPRETIS Lorca amanecido de poesía en su epistolario. 29 Vittoria MARTINETTO Autobiografia de grupo: Las genealogías de Margo Glantz. 41 Maria Isabella MININNI Appunti in margine a un’intervista di Pablo Suero a Juam Ramón Jimènez. 51 Elisabetta PALTRINIERI Más vale salto de mata, que ruego de (hombres) Buenos. 61 Laura RAMELLO Il Libro de la caza de las aves di Pero López de Ayala e i suoi epigoni: tradizione manoscritta e problemi. 73 Gabriella BOSCO La finzione euristica. 87 Maria Margherita MATTIODA Strategie di comunicazione pubblicitaria e traduzione. 95 G.Matteo ROCCATI Un art de gouverner de la fin du XVe siècle: le Dialogue entre un Chevalier er Crestienté (ms. Paris, b.n.F., fr. 148). 103 Marie-Berthe VITTOZ Les dimensions interculturelles du management d’entreprise à l’université : une experience CLIL-EMILE en Français 115 3 Nadia CAPRIOGLIO Teffi. L’emigrazione come forma di sopravvivenza letteraria. 127 Luca ANSELMA, Davide CAVAGNINO, Laura SEROGLIA, Joanna SPENDEL Traslitterazione e trascrizione automatiche mediante l’uso di un foglio elettronico: il caso della lingua russa trascritta in lingua italiana. 139 Mario ENRIETTI Linguistica contro filologia:: l’epentesi di l’ in slavo. 155 Ktystyna JAWORSKA Tradizione e prospettive degli studi polonistici. 159 Donatella ABBATE BADIN Famine in Modern Irish Poetry, an Endring Scar. 171 Melita CATALDI Versioni dell’aldilà. Dal testo altomedievale Echtra Nerai a In the Land of Youth di James Stephens. 179 Andrea CAROSSO “Così non è mai stato”: i Living History Museums e la disneyzzazione del passato in America. 189 Gerhard FRIEDRICH Erdachte Nähe und wirkliche Ferne. Fiktion und Dokument im neuen deutschen Familienroman. 199 Silvia ULRICH Dalla casa all’hotel. Riflessioni sullo spazio abitato in Joseph Roth e Franz Kafka. 211 Matteo CESTARI Introduzione a La metodologia del sapere di Nishida Kitarō. 223 Alessandra CONSOLARO Narrare la trama: la letteratura e la spartizione dell’India britannica. 233 Stefania STAFUTTI Le ‘taxi dancers’ di Shanghai: una miseria sfolgorante. 243 Mario SQUARTINI Metalinguaggio traduzione e il ‘raffreddamento’ della terminologia. 253 4 Paolo LUPARIA Un sonetto eucaristico del Tasso (‘Rime’ 1659). 263 Patrizia PELLIZZARI Alessandro de’ Medici fra Doni e Bandello. 273 Antonio ERBETTA Educazione e cultura in Antonio Banfi. 283 Elena MADRUSSAN L’attualità pedagogica del relazionismo di Enzo Paci. 289 Ada LONNI Tradurre parole o tradurre culture? Identità nazionale e percezione di sé nella figura del dragomanno gerosolimitano del XIX secolo. 295 Francesco PANERO Note sulla “servitù della gleba” medievale. Fra mito storiografico e nuova esegesi delle fonti. 305 Gianni PERONA Note e documenti in margine al carteggio tra Gianfranco Contini ed Emilio Cecchi. 315 Laura BONATO Dietro alla curva. Alcune (poche) considerazioni sul calcio e i suoi tifosi. 329 Filippo MONGE Cultura d’impresa a Lingue. 339 Maria Luisa STURANI Cartography and territorial change in the building of the Italian nation: some reflections on the production and use of small scale maps during the 19th century. 343 5 6 SULL’INUTILITÀ DEGLI STUDI LETTERARI IN GENERALE. E DI QUELLI DI ANGLISTICA IN PARTICOLARE Paolo Bertinetti La ricerca, come tutti sanno, sta alla base dello sviluppo. E come tutti sanno l’Italia è agli ultimi posti, tra i paesi avanzati, per finanziamenti alla ricerca. Una quota percentuale bassissima rispetto al Pil: la metà della Gran Bretagna, un terzo degli Stati Uniti. Si direbbe che l’attuale governo, tagliando ulteriormente i già modesti finanziamenti alla ricerca, voglia farci finalmente ottenere un primato nel settore: quello di diventare gli ultimi tra i Paesi avanzati. Probabilmente ci riuscirà. Tuttavia, a parziale soluzione del problema, mi permetto di avanzare una modesta proposta. Basterebbe destinare tutte le risorse ai settori scientifici e non dare neanche un centesimo a quelli umanistici: a parità di investimenti, la ricerca che conta, quella delle “scienze esatte”, riceverebbe quasi il doppio. Ovviamente bisognerebbe fare qualche eccezione: degli studi giuridici, economici e sociologici, infatti, data la loro evidente ricaduta “pratica” in settori di decisiva importanza per il funzionamento della società, si può tutto sommato riconoscere l’utilità. Mentre invece non è affatto chiaro a cosa servano quei reggimenti di professori universitari di latino e di filosofia medievale, di storia moderna e di letteratura tedesca, di pedagogia e di filologia. I più pensano che le loro chiacchiere in un mondo che vuole vedere risultati concreti, cioè la ricchezza e il successo (che deve sempre essere anche economico) non servano a nulla. Per la verità, forse a qualcosa servono. Servono per intanto a preparare delle persone che faranno l’insegnante, delle persone, cioè, che andranno a fare un lavoro di importanza cruciale, anche se pagato poco e deprivato (dalle leggi, dalle riforme, dai genitori degli studenti, soprattutto se asini) del prestigio sociale di un tempo. Già questa è una funzione di decisivo rilievo: quegli insegnanti sono coloro che si assumono una parte non piccola della formazione dei nostri figli, dei futuri cittadini adulti di questo paese. Parte non piccola, ma poco “utile”: letteratura italiana, storia e altre amenità. Sono molti a pensarla così. Perché sono ciechi; o almeno perché, se 7 posso citare un inutile poeta latino (inutile in quanto poeta e ancor più inutile in quanto latino), pochi sono coloro che sanno capire che cosa davvero è nel loro interesse. Naturalmente questo non vuol dire che, anche nel settore dell’insegnamento, l’importanza degli studi scientifici non sia di assoluta rilievo. E non solo per la loro utilità, ma per il loro fascino e la loro bellezza: come diceva Leibniz, “Quando Dio cantò, cantò l’algebra”. Nessuno sposerebbe ancora le affermazioni del matematico e filosofo Bertrand Russell, il quale, quasi un secolo fa, scriveva che “la formazione letteraria è superiore a quella basata sulla scienza”. Russell diceva che gli stessi scienziati, fermo restando il fatto che grandissimi erano i servizi che la scienza aveva reso all’umanità, riconoscevano tale superiorità, anche perché molti aspetti della ricerca scientifica tendevano “ad essere sacrificati a ciò che è meramente utile”. Il dibattito sulle “due culture” ha fatto giustizia delle incomprensioni e dei sospetti che le contrapponevano. I saperi scientifici non hanno nessun bisogno di essere difesi. Temo invece che ne abbiano bisogno quelli letterari. Innanzitutto c’è da dire, con forza, che l’utilità degli studi umanistici in generale sta nel fatto che essi servono a sviluppare quelle facoltà intellettuali che sono indispensabili per essere dei cittadini a pieno titolo. Facoltà preziose, come la capacità di affrontare criticamente un argomento (valutarne gli elementi oggettivi distinguendoli da quelli soggettivi, cercare e individuare i dati di fatto, i documenti, le prove). Facoltà preziose, come l’interesse a conoscere e a capire società e sistemi di valori diversi dai nostri (che è poi il grande insegnamento dell’umanesimo, che vedeva nelle diversità non una minaccia ma una possibile fonte di arricchimento). In altre parole, gli studi umanistici servono a creare la base culturale che consente di far sì che gli uomini e le donne della nostra società siano in grado di capire meglio e a fondo quali sono e cosa comportano i problemi e le scelte che il mondo in cui vivono deve affrontare, a fare in modo che siano “formati” a valutarne le soluzioni offerte, a soppesarne le premesse e le conseguenze, a separare la retorica, gli abbellimenti, le sollecitazioni viscerali, dalla sostanza e dalla ragione. (Se in Italia non va così, forse è proprio perché gli studi umanistici non sono patrimonio di tutti). Lo spirito critico, il cui sviluppo è uno scopo centrale degli studi umanistici, è una risorsa preziosa sia per capire cosa è meglio per la propria società e che cosa ne rappresenta i valori, sia per capire come rapportarsi ai valori di altre società. A questo serve lo studio della storia, della letteratura, delle arti: a preparare dei cittadini che sappiano capire meglio come “salvare” la società e la civiltà in cui vivono. 8 Nel 1997 fu pubblicata in Inghilterra la relazione del National Committee of Enquiry incaricato di fare il punto sugli studi universitari: un opuscolo molto “tecnico”, intitolato Higher Education in the Learning Society. In esso si legge (capitolo V, paragrafo 5) che la ricerca in campo umanistico serve a sviluppare la consapevolezza “di avere le proprie radici in un preciso contesto, storico e culturale”, che serve a capire “le origini e la natura morale”delle istituzioni su cui si regge una società civile. Una società civile che si caratterizza proprio per il fatto di perseguire “la conoscenza ai suoi più alti livelli a fini altruistici e non solo commerciali”. Tradotto in italiano, il tecnico linguaggio dell’originale inglese suona subito retorico. Peggio ancora, può suonare come la voce delle istituzioni, che difendono se stesse. E invece è quanto diceva anche Edward Said, un intellettuale non certo vicino all’ufficialità. Nel suo ultimo saggio Said spiega che gli studi umanistici, per quanto snobbati dalla “logica del mercato”, sono di importanza fondamentale per vivere in un mondo che allo scontro e alla guerra preferisca il confronto: poiché essi insegnano a usare il proprio pensiero “storicamente e razionalmente” allo scopo di capire se stessi e di aprirsi agli altri. Da qualche tempo, ormai, assistiamo alle gesta e agli spropositi di chi proclama di difendere la propria civiltà dichiarando guerra alle culture “nemiche”. Credo che, seguendo il ragionamento di Said (e dei “saggi” inglesi), non sia azzardato pensare che una più diffusa consapevolezza umanistica, se forse non avrebbe potuto evitare tutto questo, sicuramente avrebbe potuto limitarne i disastri. Può darsi che ci sia un’illusione illuministica alla base di queste considerazioni. E tuttavia, se vogliamo scendere su un terreno più circoscritto, non è difficile capire come gli studi umanistici svolgano un ruolo essenziale per il buon funzionamento della nostra società. Per quanto riguarda l’importanza degli studi storici, mi accontento di citare Cicerone. Conoscere solo il presente significa restare per sempre un bambino; diventare adulto significa conoscere anche il passato. Per quanto riguarda gli studi letterari, i più inutili di tutti, si tenga presente che per decenni il Ministero degli Esteri britannico ha reclutato i suoi dirigenti tra i laureati in lettere classiche; e che il controspionaggio reclutava molti dei suoi funzionari tra i laureati in lettere moderne (addirittura scrittori di romanzi, come Graham Greene). Tuttavia si potrebbe pensare che queste non siano altro che datate bizzarrie inglesi; e che da noi serva soltanto la preparazione specialistica. Forse è opportuno tenere presente quanto, un paio d’anni fa, ha dichiarato Celli, il presidente della Luiss, l’Università della Confindustria. I manager, gli ingegneri, gli specialisti dei più diversi settori hanno tremendamente bisogno di saper comunicare in modo chiaro e convincente i contenuti della 9 loro specialità; e spesso sono invece un disastro. Per rimediare, diceva Celli, bisogna che nella loro formazione occupi un posto di rilievo la lettura “di cose che nulla hanno a che fare con la formazione professionale: letteratura, romanzi”. Forse i docenti di letteratura non saranno il veicolo ideale per comunicare il piacere della lettura. Ma certamente (proprio perché forti del loro lavoro di ricerca) possono insegnare a scegliere, a distinguere tra uno scrittore originale e uno dozzinale, a individuare l’abisso tra un bel verso e l’imitazione di un’imitazione. È anche in questo che consiste il senso e l’utilità dei loro studi. Sull’utilità della letteratura naturalmente non hanno dubbi i romanzieri. Diceva Ian McEwan che Anna Karenina, Emma Bovary, David Copperfield, ci guidano nell’analisi della coscienza umana, e nell’impresa di capire la nostra coscienza, di capire chi siamo, di comprendere noi stessi. Ma anche il comune lettore, a questo proposito, ha un’osservazione cruciale da fare. Ci sono dei libri, come a volte si dice nei servizi giornalistici, che hanno cambiato la nostra vita. O almeno che hanno cambiato il modo con cui guardare a certi aspetti della vita. Uno magari fa il biologo, l’attore, l’avvocato, l’architetto, ma il modo di fare il suo mestiere, il rapporto che vede tra il suo lavoro e la società di cui fa parte, non sarebbe forse lo stesso se non avesse letto questo o quel libro. Mi piace pensare, solo per restare in ambito italiano, che chi da giovane ha letto I Malavoglia, o Una questione privata, o le Poesie scelte di Leopardi, o Marcovaldo, abbia un’idea della proprietà, della miseria, del rapporto con la Storia, della vanità delle cose umane, del rapporto tra “modernità” e natura, che senza quella lettura non sarebbe stata la stessa. Sarebbe stata più povera, più superficiale, più inconsistente. Avremmo avuto dei biologi, degli attori, degli avvocati, degli architetti, magari altrettanto bravi nella loro professione, ma certamente meno capaci di capire il mondo in cui vivono. Sarebbe stato peggio per loro; e peggio per tutti noi. Volutamente ho citato autori e libri italiani. Ma, proprio per quel che si diceva prima, ricordando il grande insegnamento dell’umanesimo, che vedeva la differenza come arricchimento, questo discorso a maggior ragione vale per le letterature degli altri paesi. Perché lo studio letterario ci dà la possibilità di avvicinarci ad altre realtà, ad altre culture, ad altri mondi attraverso le cose più belle che nel tempo essi hanno saputo produrre, perché ci consente di imparare a conoscerli grazie alle visioni e alla riflessione dei suoi letterati, sia quando ne comunicano la bellezza, sia quando ne indagano i limiti e le colpe. Credo che questo discorso, nel nostro Paese, valga in misura ancora maggiore per quanto riguarda la letteratura inglese. Per due ragioni. Primo, 10 perché tuttora resta fortissimo in Italia il pregiudizio anti-inglese (la perfida Albione), che il fascismo, con le grandi capacità di comunicazione tipiche di un regime, seppe imporre alla popolazione italiana cancellando un secolo di “rapporti speciali” tra gli intellettuali e la classe dirigente inglese con il mondo italiano. È un pregiudizio duro a morire, diffuso tanto tra i tifosi di calcio quanto tra i giornalisti, che la conoscenza della cultura inglese può servire a contrastare. Secondo, perché l’insegnamento della letteratura inglese (anche se alcuni dei nostri colleghi non se ne vogliono rendere conto) non può non accompagnarsi a quello delle letterature in inglese, delle letterature delle excolonie dell’Impero. Anche in questo caso, in particolare se pensiamo agli scrittori dell’India, dell’Africa, dei Caraibi, grandissimo è il valore “civile” che discende dal fare conoscere quegli scrittori e le diverse realtà da cui provengono. Il valore civile: la possibilità, attraverso la letteratura, di combattere il pregiudizio, il razzismo, l’inciviltà. Questo lo possiamo fare noi, non i chimici, non i medici, e neppure i linguisti o i giuristi. Il nostro motto, se è consentito fare ricorso a uno slogan, potrebbe essere “Meno corsi e lezioni di letteratura inglese = meno civiltà”. Mi auguro che nessuno consideri questo fatto una diminutio: il nostro è anzi un ruolo importantissimo, di cui dobbiamo andare fieri (e che non colloca affatto la letteratura in una posizione di sussidiarietà). D’altronde, come ben sappiamo, la letteratura è comunicazione dell’esperienza. Insegnando letteratura, insegnando a leggere ciò che forse resterebbe ignorato, noi aiutiamo la letteratura ad esercitare questo suo senso profondo. Naturalmente non svolgiamo soltanto un’opera di valore civile, o di valore culturale genericamente inteso (che comunque non è poca cosa). È evidente che svolgiamo anche un ruolo culturale in senso stretto, di promozione di valori letterari, di diffusione della conoscenza di un patrimonio letterario di grandissimo valore: se i pilastri della cultura occidentale sono Dante e Shakespeare, ebbene noi ci occupiamo del secondo pilastro. E di ciò che gli sta intorno. Ai nostri studenti parliamo di Milton e di Donne, di Fielding e di Sterne, di Shelley e di Dickens, di Joyce e di Yeats, di Lawrence e di Conrad, di Beckett e di Woolf, di Pinter e di Greene. Parlando delle loro opere parliamo di alcuni dei contributi più alti che lo spirito umano abbia espresso negli ultimi cinque secoli. Insegnare a conoscere questi scrittori è altrettanto importante (e questo non dobbiamo mai stancarci di dirlo ai nostri colleghi) che insegnare sociologia della conoscenza, o analisi matematica, o economia politica. Altrettanto importante che insegnare linguistica. E forse anche un po’ più interessante per i nostri studenti. 11 12 TRACIMAR DI SENSAZIONI E IDEE. IL NATALE NELLA POESIA ORTONIMA DI PESSOA. Orietta Abbati In uno dei suoi innumerevoli e illuminanti studi su Fernando Pessoa, scrive Eduardo Lourenço: O estátuto próprio do espírito moderno, incapaz de fazer a síntese entre a sua Ciência e a sua Ética e, ainda menos, o de fundar uma sobre a outra, é o da consciência explodida. Dela nos ofereceu Fernando Pessoa uma das mais trágicas e geniais visões1. Sappiamo come il poeta di Lisbona abbia lucidamente assunto su di sé questa consapevolezza e di essa abbia fatto il ritratto più impietoso, ponendosi egli stesso come suo detonatore e come suo risultato, ossia frantumandosi negli infiniti frammenti di una coscienza irriducibilmente esplosa. Allora, d’accordo con quanto osservato da Eduardo Lourenço, i poeti eteronimi, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, ma anche Fernando Pessoa – che dopo l’apparizione del maestro di loro tutti, Alberto Caeiro, in una delle sue tante notti insonni, quella dell’8 marzo 1914, suggestivamente riferita dal poeta stesso nella celebre lettera a Adolfo Casais Monteriro, del 1935, si costituisce anch’egli – in quanto ortonimo – come perturbante eteronimo – non devono essere interpretati quali frammenti di una totalità, ma piuttosto come “totalidade fragmentada”, quella della poesia di F. Pessoa prima dell’apparizione degli eteronimi2. Ciò chiarisce due aspetti importanti del percorso di conoscenza pessoano: da un lato, la consapevolezza della crisi dell’unità del soggetto e del suo rapporto con l’ oggetto che evolve verso la frantumazione della coscienza, si trasforma in necessità irrinunciabile di “essere altri”, per consustanziarsi in forma letteraria. Ossia, definendosi proprio come processo di creazione, assolve al ruolo di causa e strumento stesso di elaborazione estetica; dall’altro, 1 E. LOURENÇO, Fernando Pessoa ou o estrangeiro absoluto, in ID., Poesia e Matafisica - Camões, Antero, Pessoa, Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, p. 157. 2 E. LOURENÇO, Fernando Pessoa revisitado –Leitura estruturante do drama em gente,2ª ed., Lisboa, Moraes, 1981, pp. 30-31. 13 indirizza e colloca nella giusta prospettiva la lettura del complesso, immenso e frammentario macrotesto, favorendo l’individuazione di una evidente permeabilità tra i diversi attori della coterie inexitente in scena. Del resto, soprattutto alla luce della sempre più puntuale e ampia esegesi dell’opera pessoana, resa possibile dalla progressiva pubblicazione delle edizioni critiche, risulterebbe insufficiente e fuorviante il mantenimento rigido di una separazione estetico-letteraria e quindi di pratiche di scrittura che implichino soltanto un movimento divergente fra i vari eteronimi, ognuno completo e autosufficiente nella sua specifica e differente opera e (in)scritto all’interno di una propria biografia seppure immaginaria. Constatazione che trova una conferma sorprendente anche in un altro straordinario attore del drama em gente pessoano, Bernardo Soares, il semieteronimo, per definizione di Pessoa stesso, autore del Livro do Desassossego. Il libro – che in verità ha costituito per Pessoa un impegno costante, soprattutto a partire dalla fine degli anni ‘20, ma che mai è stato terminato ed è rimasto chiuso nel mitico baule in forma del tutto scomposta, nonostante il sottotitolo recitasse “composto por Beranrdo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa” – si è rivelato come prezioso e ineffabile lascito intellettuale per il nostro secolo. Questo testo invero si configura, in un arduo esercizio classificatorio, come una sorta di “autobiografia senza fatti”, o meglio, “un diario dell’anima”3 dell’autore che più di tutti ha avuto l’ardimento e l’umiltà di porsi di fronte al mondo e all’esistenza, intuendone e imbevendosi allo stesso tempo del loro mistero e della loro inanità. Tra questi due poli, Pessoa ha esplorato ogni percorso facendo propri tutti gli strumenti della conoscenza, ma senza mai giungere ad una fine; il suo percorso ad infinitum, allora, diviene per ciò stesso la rappresentazione più profonda, inquieta e disarmante della condizione esistenziale dell’uomo del Novecento. Rappresentazione che mantiene letteralmente l’etimo della parola, allorché il poeta di Lisbona, istituendosi come grande alchimista delle sensazioni, fa di queste il nucleo generativo della sua opera estetica attraverso la loro elaborazione intellettuale finalizzata alla drammatizzazione, al loro muoversi ed evolvere attraverso i diversi eteronimi che si rivelano, quindi, necessari e imprescindibili per il grandioso progetto estetico/letterario del loro creatore4. Il “senzazionsimo” costituisce, dunque, il dispositivo ma anche la sostanza dell’incessante ricerca di senso del tutto, inscenata “nel teatro della 3 Cfr. P. CECCUCCI, “L’acqua e la spugna. Per una poetica delle sensazioni”, introd. a PESSOA, Il libro dell’inquietudine, Roma, Newton & Compton, 2006, p. VII e segg. 4 Su questo aspetto centrale nell’opera di F. Pessoa si veda J.GIL, Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações, Lisboa, Relógio d’Água, s./d. 14 mente” e racchiusa negli oltre 27.000 documenti che ci ha lasciato. Proprio nel Livro do Desassossego è possibile sentire le voci di tutti gli eteronimi e osservare l’arte dell’elaborazione delle sensazioni, coltivata sul terreno del sogno di cui Bernardo Soares si fa sperimentatore ipersensibile e instancabile. Ma Bernardo Soares è anche, e più degli altri, Fernando Pessoa “ele mesmo”, costituendone, quasi come alter ego, lo specchio più veritiero, senza dimenticare che l’insincerità è condizione fondante di ogni attività poetica ed estetica, come esemplarmente mostra la poesia Autopsicografia. Tali rapporti rivelano, in una dialettica complessa, talora contraddittoria, e anche molto chiassosa tra i membri della “famiglia pessoana”, una incessante circolazione di ipotesi e prese di posizione teoriche sulle quali e con le quali Pessoa scrive la sua prosa e crea la poesia, al punto da poter intravedere un disegno armonico ed una certa omogeneità a cui si arriva anche partendo dalle forme più eccentriche della sua immensa opera. Soprattutto la poesia dell’ortonimo si staglia con nitore, svelandosi come quella dove sia più marcatamente percepibile ed evidenziato il ruolo demiurgico del poeta che vi condensa tutti i suoi percorsi epistemologici tradotti in verso. Allo stesso tempo essa appare come un diario, dove è possibile rintracciare il cammino quotidiano del poeta, che accompagna il lettore, illudendolo forse, ma anche mostrandogli squarci di irriducibili verità da cui si vorrebbe distogliere lo sguardo e che prima erano percepite come opache ed incomprensibili, mascherate o occulte. Del resto, sono conosciuti per quanti e “tantos e tão ásperos caminhos” si sia inoltrato Fernando Pessoa, per cercare una risposta alla “questão primordial: a da identidade perdida”5. Nella poesia ortonima, in effetti, intraprende essenzialmente tre tipi di percorsi articolati in forme più sottili e complesse: quello “religioso”, dove affiorano reminiscenze neoplatoniche; quello verso la desistenza, la rinuncia, l’abdicazione; e quello, infine, che consiste nel desiderio, nell’aspirazione ad essere diverso, totalmente altro da quello che è, e che potrebbe essere raffigurato nella poesia “Ela canta pobre ceifeira”. Ma questi, tutti, sono solo un tentativo, destinato al fallimento, perché su ogni cosa predomina il sentimento lucido del vuoto assoluto, “À beira do precipício/brincamos a dançar”, recita in una poesia; pesa l’impalpabile forza del tedio, che il soggetto poetico coltiva, ma di fronte al quale sa opporre in uno sforzo titanico “sovrumani pensieri, inerpicandosi su irte, altissime vette o precipitare in profondi, terrificanti abissi speculativi”6. I. PASCOAL, (a cura di) Poemas de Fernando Pessoa, Lisboa, Editorial Comunicação, 1986, p. 21. P. CECCUCCI, “Esta febre de Além que me consome” . Viaggio nell’universo poetico di Fernando Pessoa, in Quaderni del Premio Letterario Giuseppi Acerbi. Letteratura del Portogallo, Verona, Ed. Fiorini, 2007, p. 75. 5 6 15 Tra le migliaia di poesie dell’ortonimo che di ciò si pongono come straordinario paradigma, ve ne sono alcune che sembrano coagulare ancor più in un pregnante e suasivo discorso poetico l’intera parabola del pensiero e della vicenda pessoani, laddove quei sentieri instancabilmente e inutilmente calcati si illuminano di una luce speciale, concedendoci, inaspettatamente, di scrutare il pozzo fondo e perturbante della sua stessa anima. Mi riferisco a quelle poesie scritte nel giorno di Natale e/o il cui tema è il Natale stesso. La prima, Natal7, così recita: Nasce um deus. Outros morrem. A verdade Nem veio, nem se foi: o Erro mudou. Temos agora uma outra Eternidade, E era sempre melhor o que passou. Cega, a Ciência a inútil gleba lavra. Louca, a Fé vive o sonho do seu culto. Um novo deus é só uma palavra. Não procures nem creias: tudo é oculto. Sono due quartine, dal titolo piuttosto prevedibile in una sezione della rivista dedicata alla ricorrenza natalizia del 1922. Sappiamo come Pessoa ami sorprendere e disorientare, non per puro gioco, ma in forza della sua sempre inappagata ansia di conoscenza, di comprensione, che gli fa da guida, conscio, egli, come i suoi eteronimi, del “profundo conceito da vida”della “importância misteriosa de existir”8. E il mistero nel testo riportato affiora dal concetto stesso del Natale. Il titolo può trarre in inganno nella sua apparente ovvietà. Esso, in effetti, costituisce un pretesto con cui l’autore propone in forma versificata una sintesi efficace della sua visone religiosa, ancorché complessa e contraddittoria9. Si ritrovano qui, insieme all’ortonimo, il maestro Alberto Caeiro, poeta cui è demandata la ricostruzione della sensibilità pagana, il poeta delle odi Ricardo Reis, definito come “un Orazio greco che scrive in portoghese”, colui che deve ricostruire l’estetica pagana, e il filosofo, Antonio Mora, l’eteronimo o personalità letteraria, autore, fra molte altre, dell’incompiuta opera O Regresso dos Deuses10, cui viene affidata la teorizzazione del pensiero neopagano. “Natal”, apparsa su Contemporânea, 6, 1922. Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, Intr. e Notas de Joel Serrão, Lisboa, Ed. Confluência, 2ª ed., 1960, pp. 75-76. 9 Natal, sembra ricoprire sul versante del pensiero religioso, lo stessa funzione paradigmatica di Autopsicografia, quale straordinaria metapoesia del processo di costruzione poetica che ha nel fingimento il suo asse portante. 10 Per una visione completa degli scritti di António Mora, si rinvia a Obras de António Mora, Edição crítica de Fernando Pessoa,, vol. VI, Edição e estudo de L. Filipe B. Teixeira, Lisboa, IN-CM, 2002. 7 8 16 Il Natale cattolico coagula un’idea fondamentale di Antonio Mora sul cristianesimo che, egli afferma, è “semplicemente l’estrema degenerazione del paganesimo greco-romano”. Questa emerge già nel I verso con l’affermazione che la verità non compete a nessun dio, nemmeno a questo appena nato: “A verdade nem veio, nem se foi”. L’errore si mantiene anche trasformato in nuova verità, “uma outra Eternidade”. Questi due versi accostano e intrecciano neopaganesimo e esoterismo, laddove non viene concesso a questo dio di secondo grado di rivelare il mistero, che rimane al di sopra di lui, affidato ad un irraggiungibile dio Superiore. D’altronde, bisogna tenere in debito conto che già da qualche anno Pessoa si era avvicinato al pensiero esoterico, iscritto nel rosacrocianesimo e nel cristianesimo gnostico, in cui dichiarava di riconoscersi. Nella seconda quartina, il poeta passa a considerare la credibilità della Scienza e della Fede, entrambi relegati al ruolo di inutili strumenti di conoscenza. La prima perché è cieca e, non riuscendo a vedere e comprendere la natura e la realtà al di là della loro apparenza, continua ad esercitare il suo illusorio compito. La seconda è folle e vive all’interno del proprio culto che è solo un sogno. Impossibile non sentire qui, in antitesi ai versi precedenti, la voce antimetafisica di Caeiro. Ma anche un nuovo dio alla fine è solo illusione, poiché la sua verità esiste solo come parola, è solo vuoto nome e non si sostantiva ontologicamente come dato. La conclusione dell’ultimo verso: “Não procures nem creias: tudo è oculto”, già preannunciata dallo stile aforistico predominante in tutto il breve componimento, rivela il sentimento di mistero che, nella voce di Fernando Pessoa, coincidendo ora anche con quella di Antonio Mora, assume i toni dell’ espressione occultista11. Il Natale non rivela nessuna verità, ma rinnova soltanto un inganno, perché il mistero esiste e persiste al di sopra di ogni divinità. Qui Pessoa, lascia intuire il superamento anche dell’illusione neopagana, per continuare il viaggio che lo condurrà sempre più verso la desistenza, la rinuncia allo sforzo di comprendere, o meglio, a sentire il limite di ogni tipo di speculazione. Così, il Natale in altre poesie appare sotto una luce diversa, in un’ atmosfera che, circoscrivendo questa rassegnata consapevolezza nello spazio 11 António Mora arriva a questa conclusione: “Riconoscere che non sappiamo nulla, salvo che c’è una legge in tutto, legge che si manifesta come estranea ai nostri dolori e ai nostri piaceri, e al di là del bene e del male; che siamo sottoposti a questa legge, giocattoli in mano a forze superiori (…): in questo consiste la religione pagana, o, se si vuole, la filosofia del paganesimo”. A. CRESPO, La vida plural de Fernando Pessoa, 1988, [ La vita plurale di Fernando Pessoa], a cura di B. De Cusatis, Roma, Antonio Pellicani Editore, 1997, pp.164-165. Pur mancando qui lo spazio per ulteriori riflessioni, vale la pena far notare la commistione fra il pensiero di Nietzsche e provvidenzialismo, nel complesso sistema progettato da A. Mora. 17 della malinconia, proprio in quel giorno trova la sua casa ideale. Una poesia su tutte, anch’essa intitolata Natal, scritta nel dicembre del 1928 ne è impareggiabile e supremo emblema: Natal. Na província neva, Nos lares aconchegados Um sentimento conserva Os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo, Como a família é verdade! Meu pensamento é profundo, Estou só, e sonho saudade. E como é branca de graça A paisagem que não sei, Vista de trás da vidraça Do lar que nunca terei! Il Natale delle fredde voci neopagane e della sfingica intuizione occultista appare ormai distante. Questa poesia, invero, costruita sull’opposizione tra mondo esteriore e mondo interiore, rinvia, nel nome stesso Natal, nella morbidezza suggerita dalle allitterazioni delle nasali del primo verso, ad uno spazio e ad un tempo ovattati e distanti, ma che nella loro assenza o negazione per il poeta si fanno sentire come lacerante nostalgia, seppure, come vedremo, si tratti di una nostalgia, per così dire di secondo grado. L’associazione del Natale alla neve, in effetti non richiama un’esperienza reale del poeta, ma convoca un’immagine codificata in uno spazio ideale, quello della provincia del Nord, che per Pessoa ha sempre costituito un elemento opposto alla sua sensibilità urbana. Non a caso Lisbona si è sempre configurata come palco eletto di gran parte dell’opera pessona e soprattutto del Livro do Desassossego. Dunque non sarà fuorviante leggere questo testo come particolarmente elucidativo della tecnica di elaborazione intellettuale delle sensazioni e non per raffreddare l’emozione, ma al contrario per farci sentire più autentica quella stessa emozione da cui Pessoa sembra volersi tenere a distanza o che vuole dissimulare. In particolare emerge in modo rotondo e eloquente quel processo, complesso e articolato, sintetizzabile con un movimento di attrazione e di aggregazione del- 18 l’idea con l’emozione, o sensazione, orientate dal ritmo poetico, con il quale si percepisce “a onda” della poesia stessa12. Nel testo riportato, la neve mostra il suo candore proprio nella provincia e, dire provincia significa evocare il caldo focolare domestico, che nel Natale incontra il suo momento simbolicamente più alto. L’evocazione, inoltre, produce nella seconda quartina una prima opposizione, quella tra la propria intimità, o “coração” e l’esteriorità, diventata il mondo intero. Il contrasto appare in forma amplificata attraverso la verità della famiglia, che lo conduce ad una più acuta e dolorosa constatazione: la sua solitudine di fronte alla quale anche solo il sogno della nostalgia diviene un privilegio. Ma a lui, che del sogno ha fatto la propria dimora, questo dono viene concesso; e allora perché non fingersi immerso in quel paesaggio soave, protetti dalla finestra di quel focolare? Il poeta, non ha fatto altro che immaginare, fingere dunque, uno spazio e un tempo, l’occasione del Natale, che in realtà non gli appartengono, e le sensazioni che più verosimilmente da essi potrebbero ingenerarsi. La nostalgia che lui sente, la malinconia che avvolge ogni cosa, sono dunque, indirette, o “di secondo grado”, perché da esse “só a ideia de sonho de um mundo-outro, soterrado, mas presente pela sua própria ausência, nos pode curar”13. Sono quindi le sensazioni di un tempo fittizio, di un tempo non esperito e di uno spazio solo visto dalla finestra dell’immaginazione. Tuttavia la sensazione percepita di questo Natale, nitida, pungente come il freddo del paesaggio innevato, è di una sconfinata, desolata solitudine, di un esilio irriducibile dal mondo e dalla vita; la si sente fin quasi a provare dolore. Come questa, molte altre poesie scritte nei giorni del Natale, producono lo stesso effetto, acuito da una forza poetica, da quella onda che induce quasi ad identificarsi con la malinconia, la solitudine, il tedio, “tradotti” in versi. In queste poesie Pessoa dimostra l’impareggiabile efficacia della sua tecnica poetica, quasi da laboratorio, nella elaborazione intellettuale delle sensazioni, perché è proprio dall’arte del fingimento che nasce l’emozione più autentica e profonda. Ma se fosse solo questo, perché tanta solitudine, tanta nostalgia, tanta malinconia, sgorgano a profusione nel periodo di Natale? Soprattutto in un anno, il 1930, ma anche negli ultimi della sua esi12 Sul processo profondo di creazione poetica in Pessoa si veda J. GIL, O espaço interior, Lisboa, Editorial Presença, 1994. In particolare su questo punto vale la pena citare il seguente brano:“Todo o mistério do esquematismo [poético] resume-se neste facto: a ideia agrega-se a um ritmo, e o ritmo devolve a emoção embutida no verso; os versos ritmados levaram as palavras a adquirir uma camada não verbal de sentido que constitui a sua onda, a qual, “no início”, tinha dado origem à ideia poética”.J. GIL, A onda, o ritmo, o contágio, in ID., O espaço interior, cit, p. 93. 13 E. LOURENÇO, Pessoa e o Tempo, in ID., O lugar do Anjo. Ensaios Pessoanos, Lisboa, Gradiva, 2004, p.117. 19 stenza terrena, il 25 dicembre, l’autore compone diverse poesie, fatto certo non strano per lui e tuttavia impressionante, per un giorno normalmente trascorso “nos lares aconchegados” della famiglia. Viene allora da pensare che anche a lui, che ha fatto della vita poetica un’esistenza più vera della vita, nel giorno di Natale piaccia stare nella sua casa, circondato dalla sua “grande famiglia”, dalla sua coterie inexitente, dunque davvero solo, nella casa della poesia, unico luogo dove, come Bernardo Soares nella sua modesta stanza in Rua dos Douradores, può sognare non per fuggire dalla realtà e dalla vita, ma per sentirle in tutta la loro inesorabile vacuità, fino ad intravederne l’abisso, abisso che a lui ma soprattutto al lettore, si spalanca proprio il giorno di Natale o nell’atmosfera di quei giorni. Del resto, in un passo del Livro do Desassossego scrive Bernardo Soares: A vida seria insuportável se tomássemos conciência dela. Felizmente o não fazemos. Vivemos com a mesma inconscência que os animais, do mesmo modo fútil e inútil (...) Feliz, pois, o que não pensa (...)14 Di fronte a questo coraggioso disvelamento, il Natale non può che essere la condensazione di un vivere incosciente e tuttavia “felice” per chi non lo sa. Pessoa che tutto questo ha lucidamente presente, sente con la consapevolezza dell’intelletto la distanza tra lui e quel mondo, tra quel tempo e quello spazio. Tuttavia, proprio nell’atmosfera del Natale, le sensazioni sembrano tracimare dal recinto dell’idea che, nello schema poetico pessoano, “contorna a emoção”15 per disciplinarla. Si ha, così, l’effetto di un diluvio nel quale siamo trascinati, ma in cui la vista invece di offuscarsi si acuisce, la sensibilità si affina fino a farci sentire quello che Pessoa ha finto di sentire. Del resto, come afferma E. Lourenço: No nosso século, poucos poetas terão deslizado sobre “essas águas eternas”, de que o Tempo e o Espaço são puro exílio, com tanta melancolia e esplendor como Fernando Pessoa 16 . B. SOARES, Livro do Desassossego, edição de R. Zenith, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 363. J. GIL, A onda..., cit, p. 86. 16 E. LOURENÇO, Pessoa e o Tempo, cit., p. 125. 14 15 20 LA TRADUCCIÓN ITALIANA DEL EPISODIO GALDOSIANO TRAFALGAR Elena de Paz de Castro La obra de Benito Pérez Galdós es uno de los más ilustrativos ejemplos de la irregular y por lo común insuficiente difusión que la moderna literatura española ha tenido en Italia. De su abundante producción novelesca, apenas una docena de títulos dispone de versión italiana1. Peor fortuna aún ha correspondido a sus Episodios Nacionales: únicamente Trafalgar y Gerona, pertenecientes ambos a la primera serie, la que ha gozado de mayor aceptación de público y crítica, han sido traducidos2. Y sólo Trafalgar lo fue en vida del novelista español, en 1907. No será hasta muchos años después, en 1936, cuando la editorial Angelo Signorelli proponga una nueva traducción, y más adelante, en los sesenta, lo harán otras casas (con sucesivas reimpresiones): Editori Riuniti, Edizioni Paoline y Gremese. Recientemente se ha sumado a este poco nutrido elenco la editorial romana La Nuova Frontiera, que en 2008 sacó al mercado una nueva versión de Trafalgar a cargo de Giuseppe Gentile. Por lo que concierne a Gerona, en 1944 A. R. Ferrarin dio a la estampa su versión del Episodio3, en cuyo prefacio, además de presentar al escritor y la obra, aducía las razones de la elección del texto: I romanzi della terza, della quarta serie e quelli della chiamata serie finale sono stilisticamente superiori a quelli della prima ventina. Il Pérez Galdós ha cominciato la sua epopea scrivendo francamente male, secondo il significato che questa espressione ha in Ispagna e in Italia. Ma gli scrupoli stilistici gli sono venuti troppo tardi, quando ormai la sua formula del romanzo storico aveva perso grande parte del vigore iniziale. Un uomo solo può fare 46 romanzi ma non può fare 46 poemi. Cosí don Benito ha scritto una decina di Son las novelas La Fontana de Oro, La sombra, Doña Perfecta, Gloria, Marianela, Tormento, La de Bringas, Fortuna y Jacinta, Tristana, Nazarín, Misericordia y El abuelo. 2 Acerca de las traducciones galdosianas, cf. M. I. GARCÍA BOLTA, Pérez Galdós fuera de España, en Actas del Cuarto Congreso Internacional de Estudios Galdosianos (1990), Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993, t. II, pp. 45-56. 3 B. PÉREZ GALDÓS, Gerona, Milano, Valentino Bompiani (Colección de “Grandi Ritorni”), 1944, 240 pp. 1 21 grandi poemi incrinati di stonature, e una trentina di romanzi armoniosamente narrati ma quasi del tutto negati al ritmo della poesia. Gerona, il romanzo che intendiamo presentare al lettore italiano curioso di emozioni retrospettive, è il settimo tra quelli della prima decina del ciclo: è collocato tra Saragozza, il canto classico della follia patriottica, e Cadice, il capriccio romantico in margine al prepararsi della tragedia di un popolo, e ha per conto suo tutti i pregi e tutti i difetti degli Episodi Nazionali migliori; si potrebbe anzi affermare come, dal momento che un buon numero di critici autorevoli concordano nel dichiarare Gerona il migliore addirittura di tutti gli Episodi, in questo romanzo don Benito mostri piena la sua potenza di poeta e piú netti che mai i suoi limiti come romanziere4. Ferrarin ofrece agudas e interesantes observaciones, aunque su traducción incurre en la peculiaridad de no verter al italiano la totalidad de la novela, sino solamente el extenso relato que del sitio de Gerona hace Andresillo Marijuán, amigo del protagonista de la primera serie, Gabriel Araceli. Destaca, pues, en este parco panorama, la mencionada edición milanesa del año 1907 por el hecho de ser la única de los Episodios Nacionales que Galdós pudo ver. Su portada presenta la siguiente disposición5: MARIANELA || E || TRAFALGAR || RACCONTI DI || B. PEREZ GALDÓS || [emblema] || MILANO || FRATELLI TREVES, EDITORI || 1907. 19 x 12’5 cms. — 367 pp. + 3 hojas de publicidad sin numerar. En el vuelto: PROPRIETÀ LETTERARIA || [pleca] || [raya horizontal] || Tip. Fratelli Treves. — Hoja en blanco. — Portada. — Vuelto en blanco. — Texto de Marianela (con portadilla), pp. 1-167. — Vuelto en blanco. — Texto de Trafalgar (con portadilla), pp. 169-364. — Anuncios editoriales. Esta edición conjunta de la novela Marianela y el Episodio Trafalgar constituye el volumen 720 de la colección “Biblioteca Amena”, cuyo catálogo ya incluía, con el número 507, Donna Perfetta. Racconto, aparecido en 1897 y del que don Benito conservaba en su biblioteca dos ejemplares6. Bajo el subtítulo de “Racconti di B. Pérez Galdós”, el volumen ofrece sólo Ivi, p. 16. En la descripción seguimos el modelo establecido por la Bibliografía de Galdós de Manuel Hernández Suárez (Las Palmas, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1972), obra todavía hoy de referencia inexcusable. El ejemplar consultado de Trafalgar se encuentra en la Biblioteca Civica Nicolo’ e Paola Francone de la localidad turinesa de Chieri, bajo la signatura F.1554 del Fondo Francone. 6 Según indica H. Chonon Berkowitz en La biblioteca de Benito Pérez Galdós. Catálogo razonado, precedido de un estudio (Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones El Museo Canario-CSIC, 1951, p. 147), con los números de registro 1984 y 1985. De Trafalgar sólo constata Berkowitz una versión alemana del año 1896 (núm. 2148) y dos copias de la traducción publicada en Nueva York, en 1884 (núms. 2149 y 2156). 4 5 22 el texto traducido de ambas obras, sin prefacio alguno ni indicación de quién es el autor de las versiones7. Desconocemos los motivos que llevaron a escoger tales novelas y a reunirlas en un único tomo. Trafalgar sale en 1873, Marianela cinco años después; ambas son obras de un joven Galdós. Trafalgar tiene en su favor una gran popularidad y el ser la primera entrega del relato histórico novelado que conforman los Episodios Nacionales. Más sorprende la elección de Marianela, sobre todo si se tiene en cuenta que ya la colección disponía de un título galdosiano también perteneciente a las denominadas “novelas de la primera época” y, además, en 1907 el escritor canario gozaba de celebridad, con muchas de sus mejores obras publicadas. En la portada de la versión italiana no se establece ninguna diferencia entre las dos novelas; tampoco se especifica que Trafalgar sea un Episodio Nacional, dato de no escasa importancia, ya que en 1907 Galdós había completado la penúltima serie de los Episodios con el tomo de La de los tristes destinos. Trafalgar ocupa las páginas 169 a 364 y mantiene los diecisiete capítulos del texto original. Se omite la fecha de escritura (“Madrid, EneroFebrero 1873”), indicándose la conclusión con un escueto “FINE”. Las notas a pie de página son ocho, mientras que en el original sólo hay tres. De estas, la primera (II.22)8, suprimida en la traducción, consiste en una aclaración a lo que en el texto se denomina “derrota del 14”: “Así se llamaba al combate del cabo San Vicente”. Las otras dos (XVI.247, en que se reproducen palabras literales de Nelson, y XVII.263, observación de carácter histórico sobre la muerte de Gravina) permanecen también en la versión italiana. Son, pues, seis las nuevas notas que se introducen con el fin de precisar aspectos concernientes a la traducción o al sentido del texto. La primera de ellas aparece en el capítulo I a propósito del término “varas”, que no se traduce: ‘Varas, misura spagnuola, equivalente a 82 centimetri’ (174). Al capítulo segundo (182) corresponden otras dos: ‘Paquita, vezzeggiativo di Francesca in Andalusia più che in altre regioni spagnuole’ y ‘L’ammiraglio Churruca, morto gloriosamente a Trafalgar’. Igualmente requieren explicación, en el capítulo IV, la voz “Señorito” como apelativo de Nelson: ‘Signorino – così chiamavano Nelson quasi tutti i marinari spagnuoli” (192) y el vocablo “farol” (traducido por ‘lanterna’) en boca del personaje de Marcial: ‘Occhio, nel linguaggio di Marziale’ (196). La última nota hace referencia a la expresión coloquial “vengan esos cinco”. Galdós 7 En los anuncios editoriales que aparecen al final de las ediciones de Trafalgar a principios de siglo, sí se indica el nombre del traductor de Doña Perfecta: Cunes. Puede que fuera él mismo quien se encargara de la versión del Episodio. 8 Las referencias al original siguen la edición de 1904 (Madrid, Obras de Pérez Galdós), con la indicación de capítulo y página, respectivamente. 23 la emplea junto con otro dicho popular: “pero nunca pudo aprender más que otro toro y vengan esos cinco, frase con que me saludaba todos los días” (VII.86). En el texto italiano, el traductor opta por dejar ambas expresiones en lengua original, en cursiva, y entre paréntesis da la traducción literal: ‘non seppe però apprendere che due frasi: otro toro (un altro toro) e vengan eso [sic] cinco (vengano questi cinque) con la quale mi salutava tutti i giorni’ (232-233), y en nota se especifica ‘Frase andalusa, per dire: datemi la mano!’ (233), dejando sin aclaración el dicho “otro toro”, utilizado para indicar ‘que se debe cambiar de asunto en una conversación’ (Diccionario de la lengua española de la Real Academia, 22ª ed., de 2001). Tanto en esta última nota como en la del hipocorístico Paquita, el traductor considera erróneamente como andalucismos tales modos comunes en el español peninsular. Hasta 1907 se habían publicado en España varias ediciones de Trafalgar: la primera es de 1873 (Madrid, Imp. de J. Noguera, a cargo de M. Martínez); y a esta siguió una segunda en 1874 también de Noguera y, cinco años después, una tercera, impresa por La Guirnalda. En 1882 comienza a publicarse la edición ilustrada de los Episodios Nacionales por los hermanos Enrique y Arturo Mélida (Trafalgar aparece en el primer volumen junto con La Corte de Carlos IV: Madrid, Administración de La Guirnalda y Episodios Nacionales, t. I, pp. 3-157). Posteriormente la casa editorial que fundó el propio don Benito, Obras de Pérez Galdós, sacó tres nuevas impresiones: en la primera no consta la fecha9; las sucesivas son de 1901 y 1904. La siguiente, del año 1907, lleva ya el sello de Sucesores de Hernando. Como en otras obras de la primera época, Galdós trabajó en el texto de Trafalgar, revisándolo y modificándolo aun después de su publicación. Así, son diferentes las versiones que iba dando a la estampa; en ellas pueden registrarse enmiendas, supresiones y adiciones: variantes que afectan sobre todo al estilo, aunque también las hay relacionadas con el contenido. Del cotejo entre la traducción y las ediciones antes mencionadas se infiere que con mucha probabilidad la fuente del texto italiano no fue la princeps, sino la publicada en 1901 por Obras de Pérez Galdós, en cuya portada se lee “esmeradamente corregida”. Maestro en el manejo de la lengua, Galdós siempre mostró preocupación por que el lenguaje literario asimilara los matices del habla corriente, popular. Es en el registro coloquial que adoptan muchos de sus personajes, y concretamente en el idiolecto de uno de ellos, donde radican las En su edición crítica del Episodio, Dolores Troncoso calcula la fecha alrededor de 1897 (cf. B. PÉREZ GALDÓS, Trafalgar. La Corte de Carlos IV, edición, prólogo y notas de Dolores Troncoso; con un estudio preliminar de Geoffrey Ribbans, Barcelona, Crítica, 1995, p. LXII). 9 24 mayores dificultades que presenta la traducción de Trafalgar. Muy a menudo, la lengua caracteriza a los personajes galdosianos y refuerza su retrato. En este Episodio es claro ejemplo de ello la figura de Marcial, el “mareante viejo” y leal compañero del capitán de navío don Alonso Gutiérrez de Cisniega, a quien el escritor presenta así: Marcial, como digo, convertía los nombres en verbos, y éstos en nombres, sin consultar con la Academia. Asimismo aplicaba el vocabulario de la navegación á todos los actos de la vida, asimilando el navío con el hombre, en virtud de una forzada analogía entre las partes de aquél y los miembros de éste (IV.34). A lo que debería añadirse también una desbordante “inventiva filológica”. Locuaz hiperbólico, en él se aúna la gracia del habla coloquial con los desatinos propios de quien no posee una mediana cultura y sí una imaginación desbordante10. Es aquí donde se advierten ciertas deficiencias de la traducción, puesto que en la versión italiana se aprecia en seguida que se ha perdido gran parte de la idiosincrasia lingüística del personaje. Tomemos en consideración algunos ejemplos de vulgarismos que no se reproducen: “y mucho jumo de pólvora” (IV.33): ‘e molto fumo di polvere’ (192). “porque ni de perros herejes moros se teme la traición, cuantimás de un inglés que es civil y al modo de cristiano” (IV.37): ‘poichè se da quei cani eretici, che sono i mori, non si teme un tradimento, tanto meno dagl’Inglesi che sono civili, ed educati come i cristiani’ (195). “Pusque lo que menos creíamos” (IV.38): ‘Quel che meno pensavamo’ (196). “y anque la noche” (IV.38): ‘sebbene la notte’ (196). “pero dende esa noche… Si están ellos en el Cielo, no quiero ir al Cielo, manque me condene para toda la enternidad” (IV.41): ‘ma da quella notte in poi… se essi si trovassero in cielo, io non vorrei andarvi, anche condannatovi per tutta l’eternità’ (199). “Anque era tiempo de paz” (IV.43): ‘Malgrado fossimo in tempo di pace’ (200). “no por falta de valor, sino por aquello que dicen… en la moral… pues… denque el mismo momento nos vimos perdidos” (IV.45): ‘non per difetto di coraggio… ma perchè fu allora che ci sentimmo perduti’ (201). 10 La naturalidad y destreza que demuestra don Benito en la caracterización lingüística de Marcial hace pensar que quizá este sea trasunto de uno de los supervivientes del combate, a quien el escritor conoció en el verano de 1872, en Santander (cf. B. PÉREZ GALDÓS, Memorias de un desmemoriado, seguido de Crónica de Madrid, prólogo de Juan Van-Halen, Madrid, Comunidad de Madrid / Visor Libros, 2004, p. 34). El que fuera grumete del Santísima Trinidad, apellidado Galán, pudo ofrecerle en su conversación un material precioso. 25 “aunque entavía no se me ha puesto delante la popa de ningún inglés para probarla” (IV.46): ‘benchè non mi si sia presentata occasione di provarla addosso a qualche Inglese’ (202). “Bien haiga quien te puso Rayo” (IX.126): ‘Ben s’avvisò chi ti diede il nome di Fulmine!’ (262). No aparecen, por tanto, en la traducción rasgos del lenguaje vulgar como la simplificación de diptongos, la aspiración de la h, contracciones, epéntesis, alteraciones de vocales acentuadas, prótesis, síncopas o deformaciones. Incluso se llega, en alguna ocasión, a la eliminación íntegra: “Pos pá eso… (Grandes muestras de asentimiento)” (IX.128): ‘(Vivi segni d’approvazione!)’ (263). En el plano léxico se encuentran también, dadas las intrínsecas dificultades del texto español, soluciones de traducción poco afinadas. Por ejemplo, dice Galdós acerca de determinadas palabras que emplea Marcial: “¿Quién podría comprender lo que significaban patigurbiar, chingurria y otros feroces nombres del mismo jaez?” (IV.35), lo que se convierte en: ‘Chi mai poteva intendere che cosa volessero dire le parole: patiojarbiar, chingurria, ed altre moltissime del medessimo stampo?’ (193). En la versión italiana se ha cambiado, pues, de manera arbitraria una de ellas. Tampoco se refleja el uso que hace Marcial de ciertos arcaísmos (“pantasmas” (IV.39): ‘fantasmi’, 197) o de voces de nuevo cuño: en ninguna de las ediciones del Diccionario académico se registra el término “musiqueo” (IV.39), que aparece en cursiva como propio del vocabulario del veterano marinero11; en la traducción se resuelve con un simple ‘musica’ (197). Se pierde asimismo el sentido irónico figurado de la voz “cuchipanda”, en cursiva en el original, “seguíamos la cuchipanda con el inglés” (IV.45): ‘continuavamo a batterci cogl’Inglesi’ (201). Este término no se recoge tampoco en el DRAE hasta su edición de 1884 con el significado de ‘comida que toman juntas y regocijadamente varias personas’. Por su parte, el verbo “esparranclarse” (“Ya se esparrancló la línea de batalla”, X.131) no figura en el repertorio de la Academia y se documenta sólo en esta obra de Galdós: la traducción recurre a la voz de uso común ‘dislocata’ (265). Caso parecido es el del inventado “finiquelear”: “Tú no tienes pecados, y vas á andar finiqueleando con los ángeles divinos” (XV.240); se traduce en este ca11 Aunque esta misma palabra la utilizará Galdós en un Episodio posterior, Memorias de un cortesano de 1815, ya sin cursiva y dentro del parlamento del narrador: “movía volublemente los dedos sobre ella, como quien toca el piano, modulando al par entre dientes un sordo musiqueo” (Memorias…, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1948, p. 151). El CORDE documenta también el término sólo en otro escritor, Tomás Carrasquilla, concretamente en su obra La marquesa de Yolombó, de 1928. 26 so como: ‘Tu non hai peccati, e filerai direttamente verso gli angeli del cielo’ (345). El vocablo “candilear”, creación de Marcial, desaparece en la traducción: “esos señores de popa se candilean (se equivocan) más fácilmente” (XV.217) pasa a ‘questi signori di poppa pigliano delle cantonate più facilmente’ (328). Sí se mantienen, por el contrario, las incorrecciones léxicas de Marcial, señaladas entre paréntesis por el narrador: la confusión por paronomasia “unas endiabladas materias comestibles (combustibles quería decir)” (IV.39) se conserva en italiano, ‘delle maledettissime materie commestibili (voleva dire combustibili)’ (197). Por supuesto, también los vocablos de ámbito marítimo aplicados a lo cotidiano: “tiene poco farol (inteligencia)” (IX.127): ‘ha poca lanterna (voleva dire intelligenza)’ (263); “se me sube la pólvora a la toldilla (la cabeza) (XI.156): ‘la polvere mi sale alla tolda (il capo)’ (284). Otras veces, mientras que en el original simplemente se deja la palabra o la expresión en cursiva, en la traducción se cree necesario dilucidar el significado: “tratados de sursillos” (IX.127), ‘trattati di sursidio (sussidio)’ (263); “Dos mil hombres apagaron fuegos aquel día” (IV.41), ‘Duemila uomini spensero i fuochi (voleva dire, morirono), in quel giorno’ (p. 198). También la traducción sigue al original cuando se trata de reiteraciones propias de la lengua hablada en un registro bajo: “Veremos á ver si vemos lo que espera el francés…” (IX.127): ‘Vedremo… sta a vedere se lo vedremo… che cosa aspetta il francese.’ (263); y en algún dicho popular sorprende la versión: “Hemos salido de Guatemala para entrar en Guatepeor” (XV.217) se convierte en ‘Siamo usciti di Guatemala per entrare in Guatepeggio’ (327), que refleja una tentativa de literalidad con insólito resultado. Deficiencias, pues, de esta primera versión italiana de Trafalgar en aspectos que requerirían un gran esmero, ya que en ellos se pone de relieve el arte de Galdós. Pero no hay que olvidar que los problemas que plantea el texto galdosiano no son de escasa envergadura; conciernen a introducción de neologismos y a las variedades diastráticas y diafásicas de la lengua, las cuales, como es bien sabido, suelen carecer de correspondencias precisas en la traducción y con mucha frecuencia dan lugar a discutibles soluciones. No puede considerarse que la versión de Trafalgar resulte particularmente fallida si se tiene en cuenta el nivel general de las traducciones de la época, y debe reconocérsele, además, el mérito de haber contribuido a la temprana difusión en Italia de la obra del principal escritor español decimonónico. 27 28 LORCA AMANECIDO DE POESÍA EN SU EPISTOLARIO Giancarlo Depretis A Rafael, peregrino con bastón y cantimplora Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Miguel Hernández Empezaré citando un breve pasaje, un apunte que vetea fugazmente una de las cartas escritas por Antonio Machado a su amiga madrileña Pilar de Valderrama: “Lo mejor de la historia se pierde en el secreto de nuestras vidas”. Si por un lado hay que atribuir esta frase a la intensidad del sentimiento que el poeta sevillano profesaba por su amiga escritora, con quien de forma secreta mantenía relaciones con el entusiasmo de quien ha encontrado una segunda juventud (estamos en los años que van del 1928 al 1932), por otro lado, dicha frase contiene la conciencia de la dimensión del acto comunicativo, íntimo y secreto, a veces, para nosotros no destinatarios de aquel mensaje, cifrado, típico de los epistolarios. Escritos que cuando ven la luz más tarde al salir de su secreto, se hacen sumamente enriquecedores no sólo por la capacidad de satisfacer la curiosidad, posible placer deducible por la acción que revela un secreto personal, sino también por la capacidad de reconstituir fragmentos de vida y lo que resulta más valioso a nuestros intereses también de pensamiento, creencias, persuasiones, deducciones y juicios, frecuentemente inéditos también porque a menudo no se manifiestan con facilidad en los escritos o labores oficiales. Episodios, por lo tanto, mínimos que se enfrentan y se integran con los grandes acontecimientos. Fragmentos de una vivencia, momentos y lugares de la memoria, constelaciones de voces y de testimonios cuya investigación los lleva a desembocar en la masa de agua que constituye la ola de la historia y que modifica a menudo su superficie. “El mar / quiere levantar / su tapa // Gigantes de coral / empujan / con sus espaldas” (“Il mare / ha voglia di scoprirsi // Giganti di corallo / 29 muovono con la schiena”)1, se lee en la composición “El mar” sacada de las Suites inéditas. Una imagen que como ejemplificación bien se adapta a la percepción temporal lorquiana diseminada a lo largo de su rico léxico simbólico cuyos signos van de la muerte a la extinción, de la esterilidad a un Eros distinto, de la represión al abandono y con los cuales el poeta compone los anuncios, como más adelante veremos, asimilables en muchos casos al estatuto comunicativo de una misiva donde el tú, como ya ha sido subrayado por Mario Socrate en el estudio de los Sonetos del amor oscuro2, está “sottoposto a una coinvolgente soggettivazione, angolato dolorosamente in una dimensione del sentimento quasi appena rivelata, interrogativa, protagonista e antagonista d’un conflitto disperato, ma vissuto in un solidale destino di oppressi che liberatoriamente si riconoscono nella natura, nella sua superiore norma cosmica”. En los textos autobiográficos o en los diarios, así como en los epistolarios, el pensamiento de quien los escribe tiende a ocupar el centro del espacio vital, a dar a su imagen un cierto relieve gracias a un yo asumido como testimonio, como punto de observación de todo lo que ocurre dentro o alrededor de sí mismo y que acaba por afirmar su propia existencia enriquecida y potenciada por los impulsos vitales de toda la colectividad. Habría todavía bastante de que hablar sobre este propósito y mucho se podría reflexionar sobre las más de 600 comunicaciones epistolares (cartas, postales, telegramas) de Lorca que hasta hoy conocemos. En este número de hecho se cifran en la última edición a cargo de Andrew A. Anderson y Christopher Maurer3 aparecida en 1997. Me limitaré a considerar dos aspectos. Uno concerniente a la documentación biográfica pero que a su vez transpira cierto aire de época presente en las cartas lorquianas que podría constituir un boceto de viajes en la historia literaria, además del contexto histórico y social de aquellos años donde la voz, al faltar la de los destinarios, se limita a la del remitente. El otro aspecto brinda minuciosa Debido a la capital importancia de dichos fragmentos epistolares, cuando incluyen textos poéticos en sus primeras redacciones, advertimos la necesidad de traducirlos. 2 “Studio critico” incluido en su traducción, M. SOCRATE, Sonetti dell’amore oscuro e altre poesie inedite, Milano, Garzanti, 1985. 3 La edición más reciente es F. GARCÍA LORCA, Epistolario Completo, edición de A. A. Anderson y C. Maurer, Madrid, Cátedra, 1997, que venía a ampliar y mejorar la edición anterior muy parcial, pues sólo contenía 277 cartas, F. GARCÍA LORCA, Epistolario, Madrid, edición de C. Maura, Alianza, 1983. si bien la correspondencia entre los dos amigos ha sido objeto de estudio aparte y merecedora de libros recopilatorios: F. GARCÍA LORCA, Cartas, postales, poemas y dibujos, edición de A. Gallego Morell, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1968, aunque el único libro que recoge realmente toda la correspondencia entre ambos amigos es F. GARCÍA LORCA y M. ALMAGRO, Crónica de una amistad. Epistolario de Federico García Lorca y Melchor Fernández Almagro, edición de R. Lozano, Granada, Fundación Federico García Lorca, 2006. 1 30 atención a la poética lorquiana en su dimensión extraliteraria. Es decir, la poética de lo cotidiano de la que nos podemos servir para penetrar en las nervaduras estilísticas de su conversación poética, su estructura ideológica y apreciar en su totalidad aquella vital rebelión y trasgresión que caracteriza el mensaje literario y humano de Lorca retratado por Umbral, a mi juicio de manera no del todo convincente, a el de los poetas maudits, o malditos4. Pero que subraya también una estrecha correspondencia entre los distintos géneros literarios donde poco espacio se concede a una diferenciación entre texto poético y texto teatral y en el que las diversas manifestaciones artísticas se traen a cuento de la música por él mismo compuesta, a la pintura por él mismo pintada. Y también diría una estrecha correspondencia entre pre-texto y texto como su ejecución final. Escribe correctamente Christopher Maurer en su introducción al volumen de los Epistolarios: “Las cartas constituyen el medio más directo de conocer el trabajo creador de Lorca de día en día y de año en año”. En ellas, de hecho, se registran, de manera indeleble, proyectos editoriales como Sur y Gallo, títulos de poesías y comedias desconocidas, composiciones poéticas acabadas o en el momento de su creación, fragmentos teatrales y mucho más, pudiendo establecer, y no es cosa de poca monta, la duración de su redacción. Tómense como ejemplo las cartas enviadas entre el 1921 y el 1934 a Melchor Fernández Almagro. Es sin duda, entre todas, la correspondencia más densa, de ahí “el papel central que este epistolario, constituido por un total de 103 documentos, asume en el estudio de la vida y obra del poeta”5, y que se conserva en el Archivo de la Casa de los Tiros de Granada. Escribe Federico en agosto de 1921 desde Asquerosa (hoy en día Valderrubio), en la llanura granadina, una carta a Melchorito, como de costumbre, con mucho brío, ironía y amistosa impertinencia. Interesando del todo al destinatario hace partícipe al amigo de sus proyectos futuros como la creación de una revista pero, sobre todo, del entusiasmo con el cual planea su propio camino poético. No debe olvidarse que para entonces ya contaba en su haber con una intensa vida social y alternaba con escritores y artistas (a partir de 1915 aparece inscrito en el Centro Artístico de Granada donde con tan sólo 17 años conoce a los intelectuales granadinos Melchor F. UMBRAL, Lorca, poeta maldito, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968. F. GARCÍA LORCA y M. F. ALMAGRO, Crónica de una amistad, cit., p. 7. Si bien la correspondencia entre los dos amigos ha sido objeto de estudio aparte y merecedora de libros recopilatorios: F. GARCÍA LORCA, Cartas, postales, poemas y dibujos, edición de A. Gallego Morell, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1968, aunque el único libro que recoge realmente toda la correspondencia entre ambos amigos es F. GARCÍA LORCA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Crónica de una amistad. Epistolario de Federico García Lorca y Melchor Fernández Almagro, edición de R. Lozano Miralles , Granada, Fundación Federico García Lorca, 2006. 4 5 31 Fernández Almagro, Antonio Gallego Burín, José Montesinos, Ismael de la Serna, Ángel Barrios;6 este círculo de amigos está destinado a ampliarse, tras haber llegado a la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1919, con figuras como José Moreno Villa, Pepín Bello, Luis Buñuel, Eduardo Marquina, Juan Ramón Jiménez y Gregorio Martínez Sierra). Ya había editado, además de artículos y poemas en varias revistas de prestigio, como La Pluma dirigida por Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif y un primer libro de prosas, Impresiones y paisajes, escrita cuando contaba con tan sólo 16 años, su primera recopilación poética significativa Libro de poemas además de haber asistido ya a su primera obra teatral El maleficio de la mariposa escrita en 1920 y estrenada en el mismo año en el Teatro Eslava de Madrid bajo la dirección de Gregorio Martínez Sierra. A pesar de esto la insatisfacción tras su primera experiencia lírica que ya siente lejana, lo lleva a escribir una carta el 2 de agosto de 1921 a Adolfo Salazar que acababa de entregarle su reseña en un artículo aparecido en “El Sol” del 30 julio. En la misiva se lee: Tu artículo me parece el colmo del elogio y del buen gusto. ¡Muchas gracias, Adolfo! ¡Muchas gracias! No me merezco yo tanto, y por esto te lo agradezco doblemente. La única manera de pagarte es decirte que ya sabes tú que mi cariño es verdadero y que siempre te será siempre fiel, mi corazón. Estoy en absoluto conforme contigo en las cosas que me echas en cara de mi libro. ¡Hay mucho más!... pero eso lo vi yo antes... lo que es malo salta a la vista... pero, querido Adolfo, cuando las poesías estaban en la imprenta me parecían (y me parecen) todas lo mismo de malas. Manolo te puede decir los malos ratos que pasé... ¡pero no había más remedio! ¡Si tú supieras! En mi libro yo no me encuentro, estoy perdido por los campos terribles del ensayo, llevando mi corazón lleno de ternura y de sencillez por la vereda declamatoria, por la vereda humorística, por la vereda indecisa, hasta que al fin creo haber encontrado un caminito inefable lleno de margaritas y de pequeñas lagartijas multicol[o]res7. 6 Fue contertulio de “El Rinconcillo” en el Café Alameda, que agrupaba a la joven intelectualidad granadina: “En el fondo del café Alameda, detrás del tabladillo en donde actuaba un permanente quinteto de piano e instrumentos de cuerda, había un amplio rincón donde cabían dos o tres mesas con confortables divanes contra la pared, y en aquel rincón [...] plantaron su sede nocturna”: en J. MORA GUARNIDO, Federico García Lorca y su mundo, Granada, Ed. Fundación Caja Granada, 1998, p. 50. 7 “Il tuo articolo mi sembra il massimo dell’elogio e del buon gusto. Grazie e ancora tante grazie Adolfo! Non merito tanto, quindi ti ringrazio doppiamente. L’unico modo di ripagarti è reiterarti il mio affetto che come sai è sincero e dirti che il mio cuore sempre ti sarà fedele. Sono pienamente d’accordo con te quanto tu mi dici a denti stretti del mio libro. Vi è ben di più...già me ne ero reso conto anch’io.. quello che non va salta subito agli occhi... però, caro Adolfo, quando le poesie erano in stampa mi sembravano (e mi sembrano) tutte brutte. Manolo ti può raccontare i brutti momenti senza porvi riparo che ho passato... Se tu sapessi! Non mi ritrovo più in questo libro, mi sento smarrito nello spaventoso terreno delle prove, dirigendo il mio cuore pieno di tenerezza e di semplicità per i sentieri declamatori, per i sentieri umoristici, per 32 Precisamente es en este período cuando el poeta empieza una actividad febril procediendo hacia nuevos registros expresivos, que ya se encontraban en fase de experimentación. Es suficiente pensar en la redacción aún en vía de experimentación , entre pausas y abandonos, del libro Suites y en la comedia ya escribiría El maleficio de la mariposa. Además, un año después editaría El cante jondo y en 1923 se representaría Los dos habladores de Cervantes con la música de L’Histoire du soldat de Strawinsky. El nuevo contenido visual que va poco a poco formándose en la escritura lorquiana, unido a una íntima y perenne insatisfacción, constituirá la base de la nueva y muy personal arquitectura estilística y expresiva de Federico García Lorca. Tras el abandono de los modelos del simbolismo francés y con especial intensidad emerge aquí la figura de Valéry del que admira la geometricidad de sus versos pero en los que advierte la ausencia de una comunicación espontánea, el poeta opta por otras fuentes: el acercamiento a los cancioneros antiguos y las diferencias del Siglo de Oro, en que se ejercitaba en aquellos años con los cantarcillos de las comedias de Lope en particular, ya musicalizados por Cabezón. Significativos, a este propósito son las numerosas inserciones de breves composiciones, aún no recopilados en su totalidad, que se encuentran diseminadas entre el caudal epistolar a guisa de regalo, verdaderas primicias que subrayan el entusiasmo con el cual Federico afrontaba el trabajo de búsqueda de nuevas formas expresivas, de un nuevo lenguaje poético y organizaba el contenido metafórico, eco de un temperamento propenso a la comunicación oral, a la inmediatez y a la visión armónica de todo arte, en particular de la pintura y de la música. Así, en la carta que fue enviada en agosto de 1922 a Melchor Almagro se lee: Yo empiezo a trabajar y estoy haciendo unas prosas mal escritas, pero llenas de esperanza. En verso estoy escribiendo también unas “historias del viento”... ¡Ya veremos! Pero, ¡qué admirable y qué lleno de perspectivas está el viento! Ahí van dos regalitos (dos buñuelos de viento): ROSA ¡Rosa de los vientos! (Metamorfosis del punto negro.) ¡Rosa de los vientos! un sentiero incerto, finché alla fine credo di aver trovato un piccolo cammino straordinario colmo di margherite e di lucertoline variopinte”: F. GARCÍA LORCA, Epistolario Completo, cit., p. 121. 33 (Punto florecido. Punto abierto.) Y este otro: ESCUELA Maestro ¿Qué doncella se casa con el viento? Niño La doncella de todos los deseos. Maestro ¿Qué le regala el viento? Niño Remolinos de oro y mapas superpuestos. Maestro ¿Ella ofrece algo? Niño Su corazón abierto. Maestro Decid cómo se llama. Niño Su nombre es un secreto. (La ventana del colegio tiene una cortina de luceros.) 34 ¿Qué te parece?... Pues hay muchas cosas más, y si tú no eres un pérfido y suave como la onda y me contestas a vuelta de correo, yo te enviaré muchísimos versos que tienen lo bonito de estar inéditos para todo el mundo menos para ti...8 Pero a través de las cartas de Lorca se transparenta también la presencia de un lenguaje metafórico que incluso en el registro comunicativo epistolar ya se fijan como tejido de imágenes adornadas con aliteraciones, sinestesias, sinécdoques, epítetos incoherentes que no resulta, en cualquier caso, distante del uso creativo que se pueda encontrar en la comunicación diaria: Creo que mi sitio está entre estos chopos musicales y estos ríos líricos que son un remanso continuado, porque mi corazón descansa de una manera definitiva y me burlo de mis pasiones que en la torre de la ciudad me acosan como un rebaño de pantera9, se lee en una carta sucesiva enviada al amigo Melchorito. Y también en otra: El Otoño convierte a la vega en una bahía sumergida. En el cubo de la Alhambra ¿no has sentido ganas de embarcarte? ¿No has visto las barcas ideales que cabecean dormidas a los pies de las torres? Hoy me doy cuenta en el medio de este crepúsculo gris y nácar, de que vivo en una Atlántida maravillosa10, donde las referencias toponímicas, estáticas, dan forma a un viaje liberatorio y conducen a los límites de lo fantástico. Evasión de todo lo que no es auténtico, creativo, por decirlo en una palabra, anticonformismo. Lo imaginario es por tanto la única realidad salvadora igual que el amor para “Mi sono messo a lavorare. Sto scrivendo alcune pagine in prosa che, anche se scritte male, sono colme di speranza. In versi sto anche scrivendo alcune piccole storie del vento... Vedremo! Però, che stupendo è il vento e quanto è pieno di prospettive. Eccoti un paio di regalucci (due frittelle di vento): ROSA // Rosa dei venti! // (Metamorfosi / del punto nero.) // Rosa dei venti! // (Punto fiorito. / Punto aperto.) E quest’altro: SCUOLA // Maestro / Quale fanciulla si sposa / con il vento? // Bambino / La fanciulla di ogni / desiderio. // Maestro / Che le regala / il vento? // Bambino / Mulinelli di oro / e mappe sovrapposte. //Maestro / E lei che cosa offre? // Bambino / Il suo cuore aperto. // Maestro / Dite come si chiama. // Bambino / Il suo nome è un segreto. // (La finestra / del collegio / ha una cortina / di stelle del mattino.) Che te ne pare?... Guarda che ce ne sono altri e se non sarai perfido e leggero come l’onda e mi risponderai a giro di posta, ti manderò moltissimi versi che hanno il pregio di essere inediti per tutti gli altri tranne che per te”: F. GARCÍA LORCA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Crónica de una amistad, pp. 58-60. 9 “Credo che il mio luogo sia tra questi pioppi musicali e questi lirici fiumi che altro non sono che una tranquillità perenne in quanto il mio cuore riposa in modo definitivo tanto da farmi beffe delle mie passioni che sulla torrre della città, come un gregge di pantere, mi inseguono”: ivi, p. 41. 10 “L’autunno trasforma la piana in una baia sommersa. Dal belvedere dell’Alhambra non hai provato la voglia di imbarcarti? Non hai visto le barche ideali che beccheggiano addormentate ai piedi delle torri? Oggi mi accorgo, nel mezzo di questo crepuscolo grigio e madreperlaceo, di vivere in un’Atlantide meravigliosa”: ivi, p. 47. 8 35 todo ser elemental y, también como aquella parte de infancia que el hombre aun sabe conservar en su corazón11. Un viaje hacia ningún lugar o hacia un país que sólo tiene cabida en su realidad imaginaria. Ahora ya transmutada la ciudad por esa dulce ensoñación que conduce el poeta a la hora de representar la ciudad de su infancia queda como reflejo de lo huidizo y perenne: “Eterna en el tiempo y fugitiva en estas pobres manos del más pequeño de sus hijos”12. Pero el camino se puede recorrer también al revés: en la transposición temporal y espacial Lorca planea realidades de ensueño que transfiere a la realidad logrando impregnarla de alegorías e imágenes simbólicas, así como ocurre en la metaforización de la palabra acogida en el lenguaje diario, hasta que encuentre al final del viaje ese país inexistente pero reconocido y hallado gracias a la voz primordial más profunda, a las raíces más lejanas de la propia cultura. La idea que esta noche se expondrá a la consideración de todos en el banquete (yo no me puedo resistir) es la siguiente [...] Se trata, queridísimo Melchor, de hacer en terrenos que ofrece Soriano en su finca de la Zubia un morabito en honor a Abentofail y dos o tres personajes más de la cultura arábiga granadina. Dentro se pondría una biblioteca de cosas árabes granadinas y fuera se plantarían, alrededor del monumento, sauces, palmeras, cipreses. ¡Qué alegría Melchorito, ver desde Puerta Real la blanca cúpula del morabito y la torrecilla acompañándola! Además sería el primer recuerdo que se tuviera en España para estos sublimes hombres granadinos de pura cepa, que hoy llenan el mundo del Islam13. Asistimos en este epistolario, pues, no sólo a una suerte de trastienda del poeta en la que abundan confesiones de proyectos iniciados, queren11 Cercano se encuentra a los planteamientos desarrollados por Pascoli en su tratado teórico: G. PASCOLI, Il fanciullino, Milano, Feltrinelli, 1992. Los primeros capítulos de Il fanciullino, en un primer momento titulado Pensieri sull’arte poetica, se anticiparon en la revista florentina Il Marzocco entre los meses de enero y abril de 1897. En España la temprana acogida de dichas ideas por Juan Ramón Jiménez resulta palpable ya en sus primeros poemarios. 12 F. GARCÍA LORCA, Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, 26 de Octubre 1933 en ID., Obras Completas, tomo III, Barcelona, Círculo de Lectores - Galaxia Gutenberg, 1997, p. 149. 13 “L’idea che questa notte verrà esposta a tutti durante il banchetto (non ne vedo l’ora) è questa [...] Si tratta, carissimo Melchor, di costruire sul terreno che ci ha offerto Soriano nella sua tenuta della Zubia un eremo musulmano, un morabito, in onore a Abentofail e di due o tre altri personaggi della cultura araba granadina. All’interno si allestirebbe una biblioteca di cose arabe granadine e, all’esterno, si pianterebbero, tutt’attorno al monumento, salici, palme e cipressi. Che gioia Melchorito si proverà al vedere da Puerta Real la bianca cupola dell’eremo e unita ad essa la torretta! Sarebbe, inoltre, il primo ricordo che si avrebbe in Spagna di questi grandi uomini di antica stirpe granadina che oggi popolano il mondo dell’Islam”: F. GARCÍA LORCA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Crónica de una amistad, cit., pp. 55-56. 36 cias poéticas, temores, plausibles o no, incertezas artísticas y deseos varios sino también a una vía abierta de experimentación del lenguaje lorquiano que se desparrama por todo aquello que toca. Pero la intimidad epistolar también transparenta el turbador desasimiento que padece Federico García Lorca cuando encauza dicho proceso creativo. Así en carta de primeros de agosto de 1922 leemos: He compuesto unos poemas del cuco (admirable y simbólico pajarito) y los ensueños del río, poemitas patéticos que siento dentro, en lo más hondo de mi corazón infeliz. No tienes idea qué sufrimiento tan grande paso cuando me veo retratado en los poemas; yo me figuro que soy un inmenso cínife color violeta sobre el remansillo de la emoción [...] He visto un libro admirable que está por hacer y que quisiera hacerlo yo. Son Las Meditaciones y alegorías del Agua. ¡Qué maravillas hondas y vivas se pueden decir del agua! El poema del agua que mi libro tiene se ha abierto dentro de mi alma. [...] Creo que, si yo atacase de firme esto, podría hacer algo, y si yo fuese un gran poeta, lo que se llama un gran poeta, quizá me hallase ante mi gran poema. En fin, Melchorcito, ya sabes que eres tú quizá una de las tres personas a quien cuento esto14. Noticia de primerísima mano tenemos de lo que más adelante se convertirá en la suite “Cúco. Cuco. Cucó” y la suite “Meditaciones y alegorías del agua”; por otra parte Maurer reconstruye aquellos poemas a los que alude Lorca15. La obsesión temática que el propio poeta reconoce en la misiva se corona con el obsequio final a su amigo Melchor del avance de un “poemita, una piedra del pórtico de lo que yo pienso” y que más tarde se integrará en la suite de “Ensueños del río”: “Ho composto alcune poesie sul cuculo (ammirabile e simbolico uccelletto) e gli ensueños del río, poesiuole patetiche che mi sento dentro, nel più profondo del mio cuore infelice. Non hai idea di quale grande sofferenza provi quando mi vedo rappresentato nelle poesie; mi sento di essere un enorme insetto di color viola posato sulle acque tranquille dell’emozione [...] Ho adocchiato un libro meraviglioso da fare e che io vorrei mettere in opera. Sono Las Meditaciones y alegorías del agua. Quali meraviglie vive e profonde si possono dire dell’acqua! La poesia dell’acqua che il mio libro ha si è schiusa dentro la mia anima [...] Sono convinto che se l’affrontassi seriamente, ne potrei ricavare qualcosa, e se io fossi un grande poeta, ciò che si chiama un grande poeta, forse incontrerei il mio grande poema. Infine, Melchorito, come già sai, tu sei una delle tre possibili persone a cui lo dico”: F. GARCÍA LORCA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Crónica de una amistad, cit., pp. 64-65. 15 F. GARCÍA LORCA, Collected Poems, edición de C. Maurer, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1991. 14 37 CORRIENTE LENTA Por el río se van mis ojos, por el río... Por el río se va mi amor, por el río... (Mi corazón va contando las horas que está dormido.) El río trae hojas secas, el río... El río es claro y profundo, el río... (Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio16.) Disponemos, un año antes de su publicación definitiva, aunque sólo sea de la parte inicial del poema “Recodo”, perteneciente a la suite del “Regreso”, pues se ha perdido el tercer folio de la carta donde se incluía, como bien señala Rafael Lozano. Es importante registrar el buen juicio crítico que realiza su autor que lo enmarca como la parte más fina de toda la suite: La suite del Regreso es larga, pero te mando los espejillos más delicados que tiene Yo vuelvo por mis alas. ¡Dejadme volver! Quiero morirme siendo amanecer. ¡Quiero morirme siendo ayer! Yo vuelvo Por mis alas ¡Dejadme retornar! Quiero morirme siendo “CORRENTE LENTA // Lungo il fiume si perde il mio sguardo, / lungo il fiume... / Lungo il fiume scompare il mio amore, / lungo il fiume... / (Conta le ore il mio cuore / mentre è rimasto assopito.) / Il fiume trascina secche le foglie, / il fiume... / Il fiume è chiaro e profondo, / il fiume... / (Il mio cuore mi domanda / se può mutarsi di luogo.)” 16 38 manantial. Quiero morirme fuera de la mar. Quiero volver a la infancia y de la infancia a la sombra. ¿Te vas, ruiseñor? Vete. Quiero volver a la sombra y de la sombra a la flor. ¿Te vas, aroma? Vete. Quiero volver a la flor y de la flor a mi corazón17. A medida que el carteo avanza, el relieve que adquiere la propia conciencia de su talla artística comienza a manifestarse de forma leve y desde la inseguridad al principio. He hecho un libro de diálogos y otro de poesías. [...] Y hago ahora una obra de teatro grotesca [...] Pero luego estas cosas son malas. ¿Pero es que no lo sabes? Si yo tuviera fe en ellas... otro gallo me cantaría...[...] Oculto muchos proyectos que ya te diré. Quiero publicar. Porque si ahora no lo hago, no lo hago ya nunca, y esto está mal. Pero quiero publicar bien. He trabajado en el arreglo de mis libros. Son tres. Depuradísimos. Las cosas que van en ellos son las que deben ir. El libro que me ha salido de canciones cortas es interesante. [...] Estoy seguro que ahora empieza una nueva época para mí. Pero con rapidez esa conciencia crítica se amplía a una realidad más profunda que aporta el claro discernimiento de cuán cargadas van las alforjas de su escritura para el viaje literario que apenas había comenzado: Empiezo a ver claro. Una alta conciencia de mi obra futura se apodera de mí, y un sentimiento casi dramático de mi responsabilidad me embarga... no sé... me parece que voy naciendo a unas formas y un equilibrio absolutamente definidos. 17 “La suite del Regreso è lunga, in ogni modo ti mando le schegge più delicate che possiede: Con le mie ali / ritorno. // Lasciatemi tornare! / Voglio lasciarmi morire / essendo albore. // Voglio lasciarmi morire / essendo ieri! // Con le mie ali / ritorno // Lasciatemi tornare! / Voglio lasciarmi morire / essendo sorgente. // Voglio lasciarmi morire / fuori dal mare. // Voglio tornare all’infanzia / e dall’infanzia all’ombra. // Vattene pure usignolo. / All’ombra voglio tornare / e, poi, dall’ombra al fiore. // Aroma, vattene pure. / Al fiore voglio tornare / e dal fiore al mio cuore.” F. GARCÍA LORCA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Cronica de una amistad, cit., pp. 88-89. 39 Al asumir la eclosión de una realidad que alimentaba ya tiempo atrás su fuero interno y con la fuerza que aporta el conocimiento, escribe a su amigo Melchor Fernández Almagro una declaración, íntima y por entonces secreta, pero no por ello menos lapidaria, que se presenta, por decirlo con Ortega y Gasset, con la gentileza de la claridad: “Quiero ser un Poeta por los cuatro costados, amanecido de poesía y muerto de poesía”18. Reyes Magos del 6 de enero de 2009 Santa Fe de los Boliches, Málaga Bibliografìa F. GARCÍA LORCA, Cartas, postales, poemas y dibujos, edición de A. Gallego Morell, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1968. F. GARCÍA LORCA, Epistolario, edición de C. Maurer, Madrid, Alianza, 1983. F. GARCÍA LORCA, Collected Poems, edición de C. Maurer, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1991. F. GARCÍA LORCA, Obras Completas, edición de M. García-Posada, Círculo de Lectores - Galaxia Gutenberg, 1996-1997. F. GARCÍA LORCA, Epistolario Completo, edición de Andrew A. Anderson y Cristopher Maurer, Madrid, Cátedra, 1997. F. GARCÍA LORCA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Crónica de una amistad. Epistolario de Federico García Lorca y Melchor Fernández Almagro, edición de Rafael Lozano Miralles, Granada, Fundación Federico García Lorca, 2006. J. MORA GUARNIDO, Federico García Lorca y su mundo, Granada, Fundación Caja Granada, 1998. R. LOZANO MIRALLES, “Lorca y Fernández Almagro: Análisis del epistolario”, en Federico García Lorca e il suo tempo, edición de Laura Dolfi, Roma, Bulzoni, 1999. J. A. MUÑOZ ROJAS, “Melchor y Federico en su correspondencia”, en El Ideal, 29 de mayo de 1986. G. PASCOLI, Il fanciullino, Milano, Feltrinelli, 1992. M. SOCRATE, Sonetti dell’ amore oscuro e altre poesie inedite, Milan, Garzanti, 1985. F. UMBRAL, Lorca, poeta maldito, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968. 18 F. GARCÍA LORCA y M. F. ALMAGRO, Crónica de una amistad, cit., pp. 55-57. 40 AUTOBIOGRAFÍA DE GRUPO: LAS GENEALOGÍAS DE MARGO GLANTZ Vittoria Martinetto En un famoso ensayo sobre la escritura autobiográfica en la América española Sylvia Molloy pone de relieve como la tradición del relato autobiográfico en primera persona puede remontarse hasta los fundamentos mismos de la historia literaria del subcontinente incluyendo textos heterogéneos como los Comentarios reales de Garcilaso de la Vega, los Naufragios de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca y la Respuesta de Juana Inés de la Cruz. Es fascinante la idea de repensar la historia de la literatura hispanoamericana como un gran homenaje a la reminiscencia, para constatar, junto con Molloy, que también a través de los personajes ficticios más conocidos de su narrativa – Funes, Artemio Cruz, Dolores Preciado, Díaz Grey… – “Spanish American literature remembers”19. Obviamente, yo no voy a partir de tan lejos para hablar de Las genealogías de Margo Glantz20. Ni siquiera voy a leer este texto dentro del marco de la “Jewish Latin American Literature”, donde, gracias al empeño de Ilan Stavans y Marjorie Agosín, las reflexiones y los ensayos en torno al tema de la memoria autobiográfica judía se han multiplicado en los últimos años: los recursos bibliográficos disponibles en Italia lo han hecho imposible. Entonces, he optado por un método tan previsible como experimentado, que es seguir rigurosamente el texto. Así me he preguntado: ¿qué género de libro es éste? Y puesto que por algún lado tenía que empezar, he empezado por el título. “Genealogía”. Finjamos por el momento no habernos fijado en la declinación plural y consultemos el diccionario: “Disciplina que se ocupa del orígen y de la descendencia de familias y linajes”21. Sin embargo, por la 19 S.MOLLOY, At face value. Autobiographical writing in Spanish America, New York, Cambridge University Press, 1991, p. 139. 20 Todas las citas de Las genealogías remitirán a la edición México, Alfaguara, 1996. 21 Traduzco la definición ofrecida por G.DEVOTO-G.C.OLI, Vocabolario illustrato della lingua italiana, vol. I, p. 1143. Lo mismo apunta el Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, 1992: “Disciplina que estudia la serie de progenitores y ascendientes de las personas”. 41 vivacidad del yo narrador que acoge cálidamente al lector desde el primer párrafo, resulta evidente que el texto de Margo Glantz es de lo más ajeno a ese espíritu impersonal de coleccionista de mariposas o de filatélico con el que ciertos genealogistas emprenden la busca de sus antepasados. Al mismo tiempo es también indudable que el libro se remonta a dos generaciones para relatar la historia de una familia en su trayecto migratorio desde el shtetl de la Ucrania originaria al México de los años ‘20. Acudo, entonces, a Bachtín para establecer un puente de siglos entre genealogía y autobiografía, recordando como la autobiografía, en sus remotos orígenes, arranca justamente de la saga, de manera que halla su forma primitiva en ciertas manifestaciones de autoconciencia greco-romana destinadas a guardar memoria concreta de la estirpe y de las tradiciones ancestrales, en un proceso que de acta pública se ha hecho cada vez más íntimo y privado hasta las Confessiones de Agustín22. ¿Podemos leer Las genealogías como una autobiografía? Mi conclusión es, obviamente, afirmativa, aunque se hace necesario dar un paso atrás para ilustrar qué criterios han guiado tal aserción y en qué medida la autora aprovecha también otros géneros contiguos como las memorias, la biografía, el autorretrato y el diario para construir – en la forma y en la sustancia – este insólito ejemplo de autobiografía que lleva el título de Las genealogías. Para entenderlo no tenía más remedio que recurrir a Philippe Lejeune, autoridad indiscutible en los estudios sobre el género desde 1975, año de la publicación de Le pacte autobiographique, donde el crítico francés se medía con la casi imposible empresa de definir las fronteras de la autobiografía brindando una formulación que él mismo, en ensayos sucesivos, no dudó en definir “sectaire et dogmatique”23. Se trata sin duda de una autocrítica oportuna si se aísla la definición de autobiografía de su contexto y se cita como un absoluto: “Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, cuando pone el acento sobre su vida individual y particularmente sobre la historia de su personalidad”24. Sin embargo, como puntualiza el mismo Lejeune, esta definición de carácter casi lexicográfico era entendida como simple “punto de partida para lanzar una deconstrucción analítica de los factores que entran en la percepción del género”25. Por eso, en mi modesta 22 Cfr. M.BACHTIN, “La biografia e l’autobiografía antica”, en ID., Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pp.277-293. Véase también G. MISCH, A History of Autobiography in Antiquity, London, Routledge & Kegan, 1950. Por lo que atañe al establecerse de una tradición ‘autenticamente literaria’ de la autobiografía, véase A.BATTISTINI, Lo specchio di Dedalo. Autobiografía e biografia, Bologna, Il Mulino, 1990. 23 P.LEJEUNE, Moi aussi, Paris, Seuil, 1986, p. 15. 24 P.LEJEUNE, Il patto autobiográfico, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 12. 25 P.LEJEUNE, Moi aussi, cit. p. 15. La traducción es nuestra. 42 opinión, esta fórmula sigue vigente, al ofrecerse como horizonte de espera sobre el que medir diferencias y variaciones. Ahora, retomando el texto de Glantz, salta a la vista de inmediato como en él se respeta una condición imprescindible del “pacto autobiográfico” indicado por Lejeune, es decir la aseveración de una identidad dentro del libro que remite al nombre de la autora en la cubierta del mismo. En definitiva, frente a la naturaleza proteiforme del corpus de los escritos autobiográficos y a la distinta recepción de la que fueron objeto a lo largo de su camino de extra-literarios a literarios, los estudios en materia han logrado individuar en la identidad autor/narrador/personaje y en el carácter averiguable de las noticias contenidas en el texto, los únicos elementos no susceptibles de variación, como oportunamente ha destacado Elizabeth W. Bruss26. Por lo tanto, Las genealogías es, tan sólo en base a estos criterios, una autobiografía. La “Margo” del título es la misma primera persona que estipula el pacto en el Prólogo, así como la “Margo” o “Marguito” a la que se dirigen el padre y la madre, los dos otros principales protagonistas a cuya voz se entrega la narración. Pero, ¿en qué consiste el pacto de Margo con el lector? Ante todo en el propósito de satisfacer dos requisitos que, siempre según Lejeune, son implícitos en el texto autobiográfico, o sea brindar al lector “un discurso sobre sí mismo, pero una realización particular de ese discurso, donde se responde a la pregunta quién soy mediante un relato que explica cómo me he vuelto así 27. La primera tarea que Margo Glantz se plantea a sí misma es precisamente la de investigar su identidad híbrida judío-mexicana, como declara al final del Prólogo: “parezco judía y no lo parezco y por eso escribo – éstas – mis genealogías” (p. 21). Por lo que atañe a la segunda, el texto presenta un elemento de novedad: el “cómo”, es decir la historia de una personalidad del pacto de Léjeune, se vuelve aquí un “¿de dónde vengo?” que se propone relatar hechos de alguna forma extraños a la narradora, rescatando episodios del pasado de sus padres. No solamente. Para satisfacer este propósito la autora escoje un camino insólito para la autobiografía entregando una parte de la narración a otras voces, las de sus padres, con el auxilio de una grabadora. Siendo una transcripción de esta “grabación histórica”(p. 22), como la define Glantz, el texto captura una serie de recuerdos de otro modo destinados a desaparecer junto con sus protagonistas, y adquiere por un lado la fisionomía de las “Memorias”, por 26 E.W.BRUSS “L’autobiographie considérée comme acte littéraire”, en « Poétique », n°17, pp. 14-26 y desarrollado en ID., Autobiographical acts. The changing situation of a literary genre, Baltimore, John Hopkins University Press, 1976. 27 P.LEJEUNE, Moi aussi, cit. p. 19. El corsivo y la traducción son nuestros. 43 otro de la “Biografía” (donde ofrece un retrato bastante completo de la figura del padre, Jacobo)28. La diferencia, aquí, reside en el hecho de que estos géneros de escritura suelen sacar noticias de la burocrática frialdad de documentos y archivos, mientras que el lector de Las genealogías está invitado en la ‘sala de las visitas’ de los Glantz para presenciar a sus vivaces conversaciones y debates sobre las peripecias familiares. Hay, en fin, un aspecto que desde las primeras páginas del libro sugiere al lector que no se encuentra frente a un mero conjunto de anécdotas de familia, y es ese afán hermenéutico que, conscientemente o no, preside toda autobiografía. Se trata de no limitarse a contar, sino de conferir una unidad global a la serie inconexa de las experiencias aisladas. En la imposibilidad de mantenerse fiel, como el diario, a la cronología de los acontecimientos, y teniendo que confiar en la intermitencia del recuerdo que los retrata en plano largo, la autobiografía acaba por soldar la vivencia interior a la exterior traduciendo la pura objetualidad en experiencia personal29. En definitiva, tanto si recoge las voces de sus padres, como si habla directamente por sí, la narradora-recopiladora de estas memorias no hace de ellas una restauración petrificada, sino que las vivifica revelando no sólo su trama existencial sino también, como se verá, una insospechada proyección futura. En definitiva, el hilo conductor de esta “concienzuda y también desmelenada búsqueda de raíces” (p. 219), como la define Glantz, parece resumirse en la pregunta que la autora le plantea a su madre – y por extensión a sí misma – en el Post Scriptum que cierra el libro, pero a la que, sin embargo, el libro mismo ya respondió: “Qué significaría ser judío en la nueva diáspora de elección?” (p. 236). Ajena al narcisismo que informa muchos escritos autobiográficos y de manera indirectamente proporcional al progresivo asomarse de recuerdos guardados en primera persona, Margo Glantz extiende la interrogante sobre su identidad a la de un entero pueblo migrante, reconociéndose en el afán compartido por los hijos de la diáspora, de mantener vivas memoria y tradición junto a la necesidad de seguir enraizándose en la realidad en que se vive. Incapaz “de hablar de la memoria judía, así en bloque” (p. 234), como confiesa al hacer Las genealogías reserva un relieve particular a la biografía del padre, el poeta yidish Jacobo Glantz, fundador de la diáspora familiar, gracias al cual los Glantz entrarán en estrecho contacto con las vanguardias artísticas de México. Marjorie Agosín pone de relieve este aspecto biográfico – y por extensión histórico - del texto de Margo Glantz: véase I.D, “Introduction”, in AA.VV., Passion, Memory and Identity, Albuquerque, University of New Mexico Press. 29 Con respecto a la propensión que tiene la autobiografía a introducir un orden, una unidad, una dirección, un sentido en el relato de una vida, véase A.PIZZORUSSO, Ai margini dell’autobiografía, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 187-88 y R.PASCAL, Design and Truth in Autobiography, Cambridge, Harvard University Press, 1960. 28 44 balance de su libro, Glantz dice de haberlo hecho aferrándose a la “vivencia parásita” de sus padres, pero también – añadimos nosotros – a la suya propia de mujer y de escritora que, reconociendo a través de la memoria la riqueza de su matriz cultural híbrida, reafirma asimismo el deseo de pertenecer al presente con el contributo de su escritura30. A fin de cuentas nadie puede definirse autobiógrafo de profesión, y si alguien decide hablar de sí mismo es porque ya se afirmó en otra actividad. En Las genealogías hay clara conciencia de este privilegio. Por eso su enfoque autobiográfico nunca pierde de vista el hecho de que, aún relatando las memorias de una familia por más de un aspecto excepcional, se ofrece también como testimonio de una vivencia compartida por muchos “hermanos de barco” que, como los Glantz, se trasladaron al Nuevo Mundo pero sin dejar huella de su historia. Creo que este libro fue escrito también en su nombre… No se entendería la originalidad de la fórmula autobiográfica de Las genealogías sin mencionar los aspectos formales del texto, sabiamente escogidos para acompañar su doble esencia: la de ser el relato de una identidad individual y al mismo tiempo el vehículo de una memoria coral. De hecho el texto empieza, como empiezan muchas autobiografías, evocando el tema del nacimiento. Para eso, la autora elige dos verbos, “desciendo” y “nací”, que rubrican el doble registro en el que se va a desarrollar el hilo de la narración. El primero inaugura una clase de tiempo bíblico, que remite literalmente a los orígenes judíos de la familia Glantz, pero que sugiere también ese pasado remoto del que la narradora es testigo indirecta a través del relato de sus padres. El segundo tiempo, por así decir más prosaico, del “nací”, es un pasado próximo que contiene las vivencias autobiográficas de la narradora – infancia y juventud – y que con el avanzar de las páginas, acabará por coincidir con el presente de la escritura. Glantz habla del “yo desciendo…” cuando piensa en la lejana “Ucrania judía” lugar de nacimiento de sus padres y del “yo nací” con referencia a “este México” donde ella misma vio la luz. Dos coordenadas geográficas – Rusia y México – tan distantes como indisolublemente convocadas en estas memorias, y dos tiempos – pasado y presente – que, según Marjorie Agosín, son asimismo y por definición las coordenadas vir30 “What is the Jewish writer in Latin America? – se pregunta Marjorie Agosín - Is she one more inmigrant within a multicultural hybrid society, or is she always the writer who is torn between his desire to be faithful to the past and his ancestors and his desire to incorporate his feelings about the new world?”, in AA.VV. Passion, Memory and Identity, cit. p.XVII. En otro lugar Agosín atribuye a Las genealogías el mérito de haber abierto el camino a una larga serie de textos que de alguna forma tratan de responder a esa pregunta., cfr. ID., “Introduction”, in AA.VV., Memory, Oblivion, and Jewish Culture in Latin America, Austin, University of Texas Press, 2005. 45 tuales del judío: “The Jew is a being who resides in two worlds: the world of the past, which he recuperates through memories, and the world of the present, a very difficult world that contains dangerous and contradictory elements and in which there is a great tension arising from being and not being, for being the same yet different”31. El presente de Margo Glantz, quizás también gracias a la toma de conciencia que este mismo texto representa, no parece tan conflictivo. Sin embargo es indudable que Las genealogías está construido sobre un principio tradicionalmente distintivo del pensamiento judío, es decir que, como sugiere Ilan Stavans “Jewish life is approached as a debate, a clash of opinions, an encounter”32. El principio dialógico es, en efecto, uno de los ejes de este texto heterogloso: por un lado el lector presencia verdaderas discusiones que los padres de Margo, acechados por las preguntas de la hija, emprenden entre ellos con motivo de la fragmentaria discontinuidad de los recuerdos; por otro es testigo de un debate interior a la narradora que recurre en estas páginas como un leit motiv. Se trata de la fascinación de Margo Glantz por la esencia profundamente sincrética de su identidad que discute con un sutil sentido de culpabilidad por una adhesión quizá demasiado heterodoxa a la tradición judía. A la fascinación pertenecen afirmaciones como: “yo judía y mexicana y rusa, sobre todo mexicana de la calle de Jesús María (…) católica subrepticia” (p. 204) o la presencia, en su casa, de la menorah o del shofar junto a objetos de culto cristiano y precolombiano (p. 20). Al sentido de culpabilidad, aunque más retórico que real, remiten los repetidos ejemplos de ajenidad de la autora con respecto a los cánones de la cultura de los antepasados: “no estudié ni la Biblia ni el Talmud”(ivi), “los mandamientos, el Levitico y el Talmud y las ordenanzas de esas fiestas y celebraciones que me son, muchas veces, ajenas…” (p. 18), “yo no entiendo yidish, apenas el coloquial, el que se refiere a la comida y a los regaños”, (p. 174); por no mencionar el curioso paréntesis católico (cap. LVII) y el haber contraído “matrimonio/s fuera de la especie” (p. 36). Esta presentación de sí misma como goi que recurre a lo largo del texto, resulta compensada por el hecho de que precisamente la investigación de su pasado y presente judío, o sea de esa “parte aletargada” de sí que le “toca de cercanía” con su padre (p. 18), es uno de los resortes del libro. Por eso Margo Glantz prende la grabadora cediendo la palabra a su padre, para inaugurar un recorrido que la ayudará a entender algo de sus contradicciones, “por aquello del alma rusa encimada al alma mexicana”(p. 25). Ivi, p. XVIII. I. STAVANS, “Introduction”, en A.M. SHUA, The book of memories, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1998, p. XII. 31 32 46 Hasta el capítulo LIV, que es cuando el testigo pasa directamente a las manos de la narradora, el relato corre a cargo de un diálogo: las voces son, salvo raras excepciones, las de los padres, y “los recuerdos son colectivos, de dos…”(p. 52). Margo interviene como una entrevistadora que, arrebatada por la magia de lo que escucha, olvida de inmediato los imperativos de un hipotético guión, para limitarse a apuntar la belleza fragmentaria, ambigüa y lagunosa del proceso mnemónico de dos ancianos. De hecho su padre “confunde muchas cosas, trastrueca fechas y cambia imágenes” (p. 25) y “los datos varían cada vez que se le da cuerda al recuerdo” (p. 26). Sin embargo la narradora deja espacio libre al alternarse de las voces de padre y madre, que rivalizan por contar anécdotas familiares, hasta el punto de que a veces ella misma las baraja y las sobrepone: “eran de mi madre, o de mi padre? (…) aquí de nuevo los recuerdos y las discusiones se confunden”, (pp. 51-52). La escritura no interviene para deshacer nudos: sólo se encarga, algunas veces, de enlazar el discurso intermitente de la memoria genitorial, imaginando escenas o resumiendo largas descripciones. Es así como a la natural alteración del recuerdo se va añadiendo la elaboración de la recopiladora: “Aquí entra mi recuerdo, es un recuerdo falso, es de Bábel. Muchas veces tengo que acudir a ciertos autores para imaginarme los que mis padres recuerdan” (p. 38). Un respaldo se lo ofrece, por ejemplo, un paso de Bashevis Singer, donde el escritor habla de la falta de sentido cronológico de los judíos como si institintivamente supieran que espacio y tiempo son mera ilusión, y Margo comenta: «Esa sensación de un tiempo largo, gelatinoso, contraído y dispuesto a resumirse en un tema con múltiples variaciones y cadenze, coincide con la vida de mis padres y con las conversaciones repetitivas…» (p. 40). Al eludir voluntariamente las rutas de la genealogía, la autora no trata de encontrar una salida a los laberintos de la memoria, sino que simplemente intenta acceder a ellos sin que le importe volver a recorrer algunos trechos una y otra vez mientras ignora otros. Al fin y al cabo las lagunas no colmadas por sus padres, añaden un aura mitológica al pasado ruso de su ‘génesis’. La voz de Margo Glantz se inserta, como la de un dramaturgo, para fotografiar lo que el diálogo no puede detener: gestos, expresiones, la atmósfera convivial de un té mientras ella estimula la narración de los padres con su curiosidad: “la nostalgia ahora es muy fuerte: lamento no poder grabar las miradas…”(p. 77); “grandes risas emocionales, algunos tragos apresurados de té, ruidos de cucharitas contra el cristal…” (p. 78). 47 Es en pequeñas dosis y de forma muy discreta como el discurso de Margo Glantz se ha ido insinuando en el relato33 de los progenitores de manera que, cuando en el capítulo LIV las voces de padre y madre se aflojan para ceder el paso a la autobiografía de la hija, la narración pasa del diálogo al monólogo sin solución de continuidad. Sin embargo, tampoco aquí el lector halla la concatenación lineal del iter vitae autobiográfico tradicional. La revisitación que Margo hace de sus propios recuerdos es a su vez fragmentaria, con una cadencia que remite por un lado a la del journal intime – sin tener su exactitud cronológica – y por otro al dibujo temático del autorretrato. El lector podría divertirse en titular cada fragmento empezando con la fórmula “Margo y…: “Margo y Argentina”, “Margo y Colón”, “Margo y el catolicismo”, “Margo y la escuela”, “Margo y la biblioteca paterna”, “Margo y los matrimonios”, “Margo y los viajes”, “Margo y México que cambia”, “Margo y el Sionismo”, y el cine, y las lágrimas, y las casas, y la sangre, y Europa del Este, y las fotos… Lo mismo que por el fascinante relato de los padres, donde desfilaban delante de los ojos del lector la Rusia de los zares, de los pogrom y de la Revolución, las peripecias de la inmigración y de la adaptación a la nueva realidad, la odisea de los oficios, la fascinante galeria de personajes frecuentados por Jacobo Glantz…, una vez más el relato de vida que emerge de Las genealogías no es el de un solemne mural, sino el de un mosaico hecho con piezas de esa petite histoire que sóla puede devolver una imágen antirretórica de la historia de una personalidad. Es precisamente el carácter híbrido, heterogloso y fragmentario de este texto nacido de la contaminación de géneros contigüos, lo que hace de Las genealogías un inédito ejemplo de autobiografía coral34. Por otro lado, recorriendo la historia misma del género, se observa cómo, de crónica severa, puntual y planificada de una vida, como se presentaba todavía en su forma clásica, la autobiografía se ha deslizado progresivamente hacia el gusto desestabilizante de la aventura fabuladora acabando por entregarse a la fascinación novelesca. En su fase más madura, la que, para entendernos, remite a Proust, el éxtasis de las reminiscencias fragmentarias y aparentemente desordenadas, inauguraba una temporada que tenía ya tanta familiaridad con las convenciones de este género literario que se permitía 33 Nos referimos a la famosa distinción entre relato y discurso de Emile Benveniste en la acepción ilustrada por G. GENETTE, Figures II, Paris, Editions du Seuil, 1969. 34 Remitiendo a las teorías de Blanchot, Nora Pasternac apunta cómo la fragmentariedad del discurso es un carácter distintivo de toda la obra, incluso ensayística, de Margo Glantz, Cfr. ID., “El caso Glantz”, en AA. VV., Mujeres latinoamericanas del siglo XX. Historia y Cultura, tomo I, Cuba, Fondo Editorial Casa de las Américas, 1998, pp. 215-216. 48 hasta violarlas35. En definitiva, la verdad poética de Las genealogías, cuya declinación plural está ahora totalmente justificada, transgrede de propósito muchos cánones insinuando el principio, quizá simplista y paradójico para el estudioso, pero fascinante para el lector – expresado por Schlegel – según el cual toda obra aspira a ser el género de sí misma…36 Hay un solo punto en Las genealogías donde las dos memorias – individual y plural – y los dos niveles temporales – pasado y presente – puestos a debatir a lo largo del texto aparecen, por primera vez, separados. Se trata del momento en que el discurso de la memoria/biografía y el de la autobiografía han de tomar direcciones distintas para encaminarse a la conclusión. Es notorio que mientras las memorias y las biografías se concluyen naturalmente con la muerte, la autobiografía no tiene un punto final donde estancar la narración. Así en Las genealogías: si el relato de la memoria de los padres se detiene necesariamente en la muerte de sus protagonistas37, el discurso autobiográfico de la narradora llega tan cerca del período de su propia redacción que acaba por registrar el ruido de las teclas de la máquina de escribir, por describir el amontonarse de las páginas sobre la mesa y por imaginar el editor que está esperando recibirlas. La narradora decide ponerles punto final – “ahora sí” (p. 240) – a las memorias genitoriales con un conmovedor homenaje a la madre, fechado en el año de su muerte que rubrica también la última revisión del texto. En cambio, la autobiografía puede solamente cerrarse bajo el signo de la interrupción: “rehago mis genealogías – razona Margo –, recapitulo, es hora de darles un punto, si no aparte, al menos suspensivo…” (p. 232). La suspensión que cierra la autobiografía es entregada por la autora a una especie de ‘viaje a la semilla’, con la imágen sugestiva de la nave de los inmigrantes que, “paréntesis perfecto” entre dos Mundos, ha decidido con un coup de dés la identidad judío-mexicana de Margo y de sus hermanas. Ese “territorio flotante” donde las diferencias se allanan y las experiencias se integran, es símbolo y preludio de una rearticulación de la idea de exilio posibilitada por esas “tierras de realismo mágico”(p. 205), como Margo define México, que no sólo han propiciado una fecunda hibridación, la suya, sino que han permitido armonizar en “un nuevo nosotros” las divergencias – y el antisemitismo – existentes dentro de la misma comunidad rusa expatriada. A ese “territorio propio, fundamental para el Cfr.A.BATTISTINI, Lo specchio di Dedalo, cit., pp. 13-14. Ivi, p. 98. 37 El texto registra lacónicamente las fechas de muerte de los padres: “Mi padre murió el 2 de enero de 1982. Mi madre, el 13 de mayo de 1997” (p. 240). 35 36 49 judío y para cualquier emigrante” representado por las tradiciones, la comida, la lengua, la memoria, Margo Glantz parece decidida a añadir, al término de su exploración, un territorio hecho más de cosas concretas que de abstracciones. Sin faltar al imperativo del shemá que, según Ilan Stavans, convierte a los judíos en eternos “retellers”, la escritora encuentra su “patria” no en la memoria sino a partir de la memoria38. Se trata de la tierra de México que contempla, en el último capítulo, desde el romántico marco de Acapulco, de la tierra de Rusia visitada en 1981 que le brindó el empuje a la redacción definitiva del libro y del libro mismo como cofre de “vivencias” listas para colonizar el futuro de otras generaciones. Bibliografia AA. VV., Mujeres latinoamericanas del siglo XX. Historia y Cultura, vol.I, Cuba, Fondo Editorial Casa de las Américas, 1998 AA. VV., Passion, Memory and Identity, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1999 AA.VV., Memory, oblivion and Jewish culture in Latin America, Austin, University of Texas Press, 2005 M. BACHTIN, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979 A. BATTISTINI, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, Bologna, Il Mulino, 1990 E.W. BRUSS, Autobiographical acts. The changing situation of a literary genre, Baltimore, John Hopkins University Press, 1976 G. GENETTE, Figures II, Paris, Editions du Seuil, 1969 M. GLANTZ, Las genealogías, México, Alfaguara, 1996 P. LEJEUNE, Moi aussi, Paris, Editions du Seuil, 1986 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino,1986 G. MISCH, A History of Autobiography in Antiquity, London, Routledge & Kegan, 1950 S. MOLLOY, At face value. Autobiographical writing in Spanish America, New York Cambridge University Press, 1991 R. PASCAL, Design and Truth in Autobiography, Cambridge, Harvard University Press, 1960 A. PIZZORUSSO, Ai margini dell’autobiografía, Bologna, Il Mulino, 1986 A.M. SHUA, The book of memories, Albuquerque University of New Mexico Press, 1998. 38 Me refiero a las sugerentes reflexiones de Ilan Stavans sobre la memoria como “invención” judía: ”Jews are by nature retellers: their existence is testified by the act of remembrance of events protagonized by God, and that act links them to the generations that come before and after”, in A.M. SHUA, The book, cit., pp. IX-X. 50 APPUNTI IN MARGINE A UN’INTERVISTA DI PABLO SUERO A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Maria Isabella Mininni Nel dicembre del 1935, a bordo della nave Cabo San Antonio proveniente da Buenos Aires, giungeva a Las Palmas de Gran Canarias il giornalista e drammaturgo argentino Pablo Suero, caporedattore delle pagine teatrali della testata “Noticias Gráficas”. Di origine spagnola – era nato nelle Asturie, a Gijón, nel marzo del 1898 – Suero tornava allora alla sua terra natia con il compito di documentare per il quotidiano della capitale argentina la tumultuosa situazione politica spagnola alla vigilia delle elezioni del 16 febbraio 1936; il giornalista intendeva affiancare alle interviste rese dai protagonisti politici di quell’evento epocale le testimonianze di alcuni artisti e letterati spagnoli noti e apprezzati sull’altra sponda dell’Atlantico. Tra la fine del dicembre ‘35 e la seconda metà del febbraio ‘36, Suero portò a compimento la sua missione, e poco più tardi raccolse il prezioso lavoro informativo – successivamente rimaneggiato e integrato da commenti ulteriori1 – in un volume di notevole interesse documentario dal titolo España levanta el puño, pubblicato a Buenos Aires presumibilmente alla fine del 19362, quando la Spagna già piangeva la morte di Lorca e subiva gli orrori della Guerra Civile. Nel Prólogo al libro l’argentino Enrique González Tuñon (sic) – anch’egli giornalista e scrittore iconoclasta permeato di anarchismo romantico – dichiara: Aquí tenéis a España a través de sus hombres. Jóvenes y viejos. Habla España por boca de ellos – políticos, escritores, poetas, artistas – en la inminencia del estallido. Pensad dónde estarán ahora. […] Muchos de ellos Cfr. I. GIBSON, Cuatro poetas en guerra, Barcelona, Planeta, 2008, p. 334. P. SUERO, España levanta el puño, s.l. [ma Buenos Aires], s.d.; d’ora in poi citato come ELP. Il testo non riporta alcuna indicazione relativa all’editore né alla data di pubblicazione. Si può supporre sia stato pubblicato alla fine del 1936 o agli inizi del 1937 affidandosi unicamente alla data posta al fondo del prologo di E. González Tuñon (sic), ovvero “diciembre 30 de 1936” (E. GONZÁLEZ TUÑON, Prólogo, in ELP, pp. IIIVII: p. VII). 1 2 51 están en la pelea o muertos. Muchos de ellos levantando el puño frente a la muerte; levantando el puño más allá de la muerte. […] Abrid este libro. Ahí está Federico García Lorca, que ha levantado el puño con España y ha sido fusilado contra un muro3. Il tono enfatico delle parole di Tuñon lascia trapelare i contenuti espressi dal giornalismo militante di Suero, ne riverbera lo slancio emotivo delle note che invia dalla burrascosa Spagna alla redazione di “Noticias Gráficas” in quei giorni di grande fermento e connota altresì in modo inequivocabile la posizione da lui assunta nel contesto storico-politico che aveva inteso descrivere ai lettori del quotidiano “porteño”: Él [Suero] está con la España de Federico García Lorca, contra la España de Cascajo y de Millán Astray. Él está con la España de Don Quijote, contra la España del barbero y del cura; con la España de Menéndez Pidal, de Ossorio y Gallardo, de Machado, de Alberti, de los bravos poetas milicianos, contra la España del contrabandista March, de los señoritos, de la “dictadura inmoral y analfabeta”, de la mandíbula borbónica y de la hemofilia. Pablo Suero está con su España, con la España de la madre, la España de todos sus antepasados, y contra la España negra, la anti-España4. Di fatto, sebbene apertamente schierato dalla parte della Spagna democratica, nella sua inchiesta Suero seppe narrare anche la “anti-España”, la Spagna del conservatorismo ottuso e bigotto, costruendo in modo esaustivo la cornice entro la quale si collocavano le convulse giornate preelettorali del febbraio ‘36. L’abbondante materiale riunito in España levanta el puño venne organizzato dal notista argentino in tre estese sezioni – Estampas españolas, España levanta el puño e Servidumbre y miseria de los escritores españoles – precedute da una dedica alle figure di maggior rilievo della Spagna democratica ormai irrimediabilmente lacerata dal conflitto civile: “cerebros y corazones […] unidos en el fervor antifascista, con el pueblo heroico que lucha contra la caterva de generales traidores a la república y que asesinan a sus hermanos en nombre de Cristo”. Il volume si apre con la sezione intitolata Estampas españolas in cui Suero propone il suo diario di viaggio, dall’approdo a Las Palmas nel dicembre 1935 fino all’acclamato arrivo nella capitale – documentato dall’“Heraldo de Madrid” il 9 gennaio del 19365 –, dopo le soste a Cadice e Malaga, BarIvi, pp. V-VI. Ivi, p. VII. 5 “Otros invitados había, muy gratos, como […] el jefe de las páginas teatrales del diario bonaerense, ‘Noticias Gráficas’ Pablo Suero, que se encuentra ya en su casa, puesto que está entre compañeros 3 4 52 cellona e Toledo; le Estampas si concludono con un curioso ritratto della “mujer española”. La sezione che dà il titolo al libro, España levanta el puño, costituisce la seconda parte della raccolta di articoli e prende avvio con un brano intitolato El 16 de febrero consacrato ai fatti accaduti in quella giornata cruciale che vide la netta affermazione delle forze di sinistra; seguono poi numerose interviste accompagnate da alcuni efficaci ritratti di uomini politici appartenenti ai due opposti schieramenti, quasi sempre colti nella loro quotidianità domestica, lontani dalla rigida ufficialità del proprio ruolo: tra i repubblicani e i socialisti compaiono Azaña, Largo Caballero, Prieto, Jiménez de Asúa e Dolores Ibarruri “La Pasionaria” – intervistata in carcere dopo l’arresto seguito alla repressione dei moti delle Asturie nell’ottobre 1935; tra gli esponenti della destra, Gil Robles, Calvo Sotelo e José Antonio Primo de Rivera, fondatore della Falange e figlio del dittatore Miguel Primo de Rivera scomparso qualche anno prima, nel 1930. La terza ed ultima sezione del volume, la più cospicua, reca come titolo Servidumbre y miseria de los escritores españoles: in essa Suero commenta la condizione in cui allora versava la cultura spagnola attraverso la testimonianza di illustri poeti e letterati tra i quali i lirici della “España nueva” Federico García Lorca e Rafael Alberti, i fratelli Manuel e Antonio Machado, Pío Baroja, e lo schivo Juan Ramón Jiménez, “iceberg solitario entre esta cadena de cráteres en función a cuyo lado estoy viviendo”6. Il colloquio dell’argentino con l’“Andaluz Universal” avvenne nell’appartamento della calle Padilla 38, nella stessa dimora che Juan Ramón avrebbe lasciato qualche mese dopo nell’agosto ‘36 per raggiungere l’America, terra del suo esilio definitivo. L’intervista, dapprima pubblicata su “Noticias Gráficas” di Buenos Aires e poi raccolta in España levanta el puño7, venne riportata alla luce nel 1985 da Ángel Crespo nel volume da lui curato Guerra en España8, raccolta di materiali vari – lettere, interviste, conferenze, note e documenti ufficiali – radunati da Juan Ramón negli anni di esilio che vanno dal 1936 al 1953. In quest’opera imprescindibile per la ricostruzione della biografia del poeta sorprende tuttavia il riferimento bibliografico attribuito al documenmadrileños. Hubo brindis, anecdotario, abrazos, hasta su poquito de ‘straperlo’, del bueno e inocente, como entretenimiento de moda…”: Paulina Singerman, en Madrid, in “Heraldo de Madrid”, Año XLVI, 9 de enero de 1935, p. 13. 6 P. SUERO, Con Juan Ramón Jiménez, poeta, nada más que poeta, in ELP, pp. 120-126: p. 121. 7 Cfr. nota precedente. 8 J. R. JIMÉNEZ, Guerra en España (1936-1939), introducción, organización y notas de A. Crespo, Barcelona, Seix Barral, 1985, pp. 98-105. 53 to dell’intervista con Pablo Suero, riferimento secondo il quale essa sarebbe stata pubblicata sul quotidiano “Noticias Gráficas” il 23 maggio del 19359 e, secondo quanto segnalato in nota da Crespo, riprodotta in seguito “en el libro de Pablo Suero, Figuras contemporáneas, Sociedad Impresora Americana, Buenos Aires, 1943”10. Il primo dei rinvii indicati è un evidente errore di datazione giacché Suero, come già si è detto, si trovava a Madrid per assolvere al suo impegno giornalistico nei primi mesi del 1936 al fine di documentare il clima febbrile che precedeva le elezioni di febbraio; la seconda citazione è altrettanto errata poiché in Figuras contemporáneas – altra raccolta di articoli curata da Suero qualche anno dopo España levanta el puño – non appare affatto l’intervista in questione. Ciononostante anche nella più completa e recente biografia del poeta curata da Rafael Alarcón Sierra11 si replica l’equivoco nell’accenno all’incontro tra Pablo Suero e Juan Ramón, mantenendo come fonte attendibile il materiale contenuto in Guerra en España e i relativi riferimenti: La opinión negativa sobre Residencia en la tierra, que en la entrevista que en mayo [1935] mantiene con Pablo Suero hizo pública, arremetiendo contra “Este señor Neruda que no sabe ni escribir una carta”, anuncia otro de los polémicos enfrentamientos literarios del poeta12. In questo passaggio il rimando all’opinione negativa su Residencia en la tierra13 di Neruda espressa in occasione del colloquio con Suero permette di situare con più agio l’evento in questione, poiché la raccolta poetica del cileno venne pubblicata in Spagna verso la fine del 1935, quando Juan Ramón ancora lavorava con impegno all’organizzazione editoriale della sua opera maggiore, Canción, uscita tardivamente nel maggio del ‘36; il poeta stesso, informando sui propri progetti futuri l’amico Guerrero Ruiz nell’agosto del 1935, offre indizi attendibili al riguardo: El pliego 13 del libro [Canción] ya lo tiene revisado, pero aún quiere depurar dos páginas, y como en la imprenta se han portado tan mal, no tiene prisa en devolverlo. Por otra parte, como están en prensa los libros de Jorge Guillén y Pablo Neruda, a los cuales sus amigos de Cruz y Raya han de procurar un Ivi, p. 105. Ivi, p. 98. 11 R. ALARCÓN SIERRA, Pasión perfecta, Madrid, Espasa, 2003. 12 Ivi, p. 167. 13 P. NERUDA, Residencia en la tierra, Madrid, Cruz y Raya, 1935. 9 10 54 éxito, dice que le gusta dejar pasar todo ese bullicio para que su libro no salga al mismo tiempo14. Dunque da quanto riferisce Guerrero Ruiz Residencia en la tierra era in corso di stampa nell’estate del ‘35 – di fatto uscì qualche tempo dopo, nel tardo autunno –, la qual cosa avrebbe impedito a Juan Ramón di formularne un giudizio a maggio, molti mesi prima della pubblicazione del libro. Al di là delle inesattezze diffuse in tempi recenti sulla datazione dell’intervista, si ravvisano altresì incongruenze nell’ambito del testo stesso redatto da Suero e nella relazione che esso stabilisce con gli altri testi raccolti in España levanta el puño. Pare quasi che al momento di organizzare il materiale disperso il giornalista abbia trascurato – scientemente o meno – la disposizione cronologica dei contributi al volume: non soltanto infatti manca la data di edizione dell’intera opera, ma sono totalmente assenti anche le date di pubblicazione degli articoli in essa contenuti e risultano assai labili e isolati gli ancoraggi temporali rintracciabili nei singoli testi. Tuttavia in tal senso il caso dell’intervista a Jiménez sembra rappresentare un’eccezione nello scenario caotico di accadimenti e questo grazie alle informazioni reperibili nell’articolo che ha come protagonista il capo della Falange, José Antonio Primo de Rivera. Nella presentazione di quell’incontro infatti Suero così esordisce: En el mismo día, he visto a dos hombres de naturaleza bien distinta. Uno de ellos es el poeta Juan Ramón Jiménez, uno de los más puros poetas hispanos. El otro, un hombre de acción: José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador fallecido15. e poco oltre precisa: “estábamos a tres días de las elecciones”16: se ci si avvale delle indicazioni fornite è pertanto possibile supporre con buona approssimazione che la data presunta della visita al poeta risalga al 13 febbraio 1936. Questo dato cronologico recuperato da una attenta lettura pare garantito dalle magmatiche informazioni trasmesse dallo stesso Suero il quale però, al momento di introdurre la figura di Juan Ramón “poeta, nada más que poeta”, afferma di sapere già “cómo vive y piensa el pueblo español de este agudo momento crítico y cómo piensa el ex ministro y dirigente mo14 J. GUERRERO RUIZ, Juan Ramón de viva voz (1932-1936), Valencia, Pre-Textos, 1999, vol. II, pp. 318-319: 30 de agosto 1935, viernes. 15 P. SUERO, Con el Jefe de la Falange, José A. Primo de Rivera, in ELP, pp. 84-90: p. 84. 16 Ivi, p. 85. 55 nárquico señor Calvo Sotelo”17, e aggiunge inoltre che “después de entrevistar a novelistas y dramaturgos y a poetas jóvenes y viejos, advertí que había uno que escapara a mi atención demasiado tensa para lo actual en mis cuarenta y cinco días de Madrid”18; quell’“uno” sfuggito allo zelante cronista era Jiménez, apparentemente trascurato in quei momenti di elevata tensione sociale e politica. In realtà fin dall’inizio del soggiorno in Spagna Suero cita più volte nei suoi articoli Juan Ramón dimostrando di avere la ferma intenzione di incontrarlo: “Fué una de mis preocupaciones esenciales al llegar a Madrid, conocer y hacer conocer a mis lectores a los dos poetas españoles tan leídos en los países de América: Antonio y Manuel [Machado], lo mismo que Juan Ramón Jiménez”19. Quindi non soltanto appare poco credibile la distrazione di Suero – che palesa invece stima e ammirazione nei confronti dell’andaluso – ma desta qualche perplessità anche la successione dei fatti se è vero, come egli stesso afferma, che l’incontro con Calvo Sotelo avvenne alla vigilia delle elezioni, il 15 febbraio20. Come poteva Suero aver visto Calvo Sotelo prima di Juan Ramón, se aveva incontrato il dirigente monarchico due giorni dopo il poeta? Inoltre, come segnala l’“Heraldo de Madrid”21, Suero era giunto nella capitale l’8 gennaio del ’36 insieme all’attrice Paulina Singerman e alla sua compagnia teatrale, quindi se quarantacinque giorni dopo il suo arrivo a Madrid non avesse ancora visto Juan Ramón, così come riferisce, la visita di Calle Padilla sarebbe avvenuta di fatto intorno al 22 febbraio, dopo le elezioni e non alla vigilia delle stesse. Per quanto concerne poi la conoscenza che Suero fece con i fratelli Machado, è ancora Alarcón Sierra a fornire nuovi dati nella già confusa cronologia affermando che “en abril de 1936, es Manuel quien se queja a Pablo Suero de que nadie estrena su drama [El hombre que murió en la guerra], que es obra de aliento y de actualidad”22. L’episodio menzionato dallo studioso è tratto anch’esso da España levanta el puño23 come indicato in nota al suo testo, ma il riferimento al mese di aprile risulta inspiegabile non solo perché assente dalla narrazione di Suero P. SUERO, Con Juan Ramón Jiménez, cit., p. 120. Ibid. 19 P. SUERO, Antonio, Manuel y José Machado y Ricardo Baroja, in ELP, pp. 139-143: p. 139. 20 P. SUERO, Con Calvo Sotelo, Monárquico-Fascista, in ELP, pp. 74-79: p. 76. La data del 15 febbraio è confermata anche da quanto si legge in P. SUERO, Con Gil Robles, el agitador, in ELP, pp. 66-73: p. 70, considerato che l’incontro con i due esponenti della destra avviene lo stesso giorno a poche ore di distanza. 21 Cfr. nota 5. 22 R. Alarcón Sierra, “El hombre que murió en la guerra”, “El hombre que yo maté” de Rostand y Lubitsch y los intertextos de Manuel Machado, in “Revista de Literatura”, LXVIII (2006), pp. 569-593: p. 574. 23 P. SUERO, Antonio, Manuel y José Machado, cit., p. 142. 17 18 56 bensì perché smentisce gli intenti del giornalista più volte ribaditi e sempre riconducibili ai turbolenti inizi d’anno: “por momentos – dichiara Suero – este agitado y sombrío panorama de la vida social española me ha excitado tanto que he buscado el remanso de los poetas como Juan Ramón y los Machado”24, i poeti “padres […] de la actual poesía hispana”25 e sempre tra loro affratellati nei commenti alle giornate trascorse a Madrid nell’inverno ‘36. Stando a quanto riferisce Suero l’incontro con Jiménez è successivo a quello con i Machado e i Baroja26, Ricardo e Pío27, pertanto se avesse ragione Alarcón Sierra nel situare le lagnanze di Antonio e Manuel ad aprile, anche l’intervista di Jiménez dovrebbe aver avuto luogo nello stesso mese poco più tardi, ma sappiamo che l’argentino lasciò la Spagna poco dopo le elezioni di metà febbraio. Lo stesso Juan Ramón al termine dell’intervista gli chiede: “¿Y cuándo se va usted a Buenos Aires?”, domanda alla quale l’argentino risponde “dentro de cuatro días”, ovvero il giorno dopo le elezioni, il 17 febbraio se è vero che l’incontro con il poeta coincide con quello della visita a Primo de Rivera precedentemente citato, avvenuta il 13 febbraio. Ma Suero partì non senza essersi congedato dai giovani poeti – Lorca, Alberti, Altolaguirre e Aleixandre tra gli altri – che lo festeggiarono prima della partenza quando “ya habían triunfado las izquierdas. Ya Azaña había asumido el poder”28, e sappiamo che Azaña formò il suo governo il 19 febbraio. L’ambiguità sulla datazione permane ma risulta comunque poco probabile ritenere che Suero, rientrato a Buenos Aires dopo un lungo viaggio in nave verso la fine di febbraio, abbia programmato una nuova traversata oceanica per il mese successivo e, di conseguenza, è improbabile che i Machado abbiano lamentato con lui la situazione del teatro spagnolo nell’aprile del ‘36. D’altra parte è indubbio che nel testo riferito all’incontro con Jiménez vi siano indizi che, se da un lato non consentono di determinarne con precisione la data, dall’altro permettono almeno di situare con certezza l’accaduto nel 1936, escludendo la possibilità che l’articolo fosse stato pubblicato da “Noticias Gráficas” nel mese di maggio dell’anno precedente, come indicato invece in Guerra en España. P. SUERO, Horas con Ramón Gómez de la Serna y en la sagrada cripta de Pombo, in ELP, pp. 133-138: p. 133. P. SUERO, Antonio, Manuel y José Machado, cit., p. 140. 26 “Va a ser este un soliloquio, como el de Baroja”: P. SUERO, Con Juan Ramón Jiménez, cit., p. 123. 27 “Le digo [a Ricardo Baroja] que lo entreví hace unas tardes en el ‘hall’ de su casa mientras esperaba a Don Pío y me dice que éste le había hablado de mi entrevista”: Antonio, Manuel y José Machado, cit. p. 143; cfr. anche Con Pío Baroja, el hombre que no cree en nada, in ELP, pp. 144-150. 28 Cfr. P. SUERO, Los jóvenes poetas están con la España nueva, in ELP, pp. 171-176: p. 173. 24 25 57 “¿Es usted comunista, Juan Ramón?”, gli domanda Suero durante l’intervista e il poeta risponde “Sí. Yo creo que el comunismo vendrá, como todo. Yo soy comunista individualista...”29. Come giustamente ha fatto notare Gibson, il concetto di “comunismo individualista” venne sviluppato da Juan Ramón “unos meses después en una hermosa conferencia”30 ovvero nella nota dissertazione dal titolo Política poética, letta a Madrid il 15 giugno del ‘3631; a questa allusione degna di nota vanno aggiunte le considerazioni sulla situazione politica in Spagna formulate dal poeta al giornalista, riflessioni che confermano il contesto nel quale Suero inserisce la sua galleria di brevi profili. Le circostanze critiche di quel momento culminante per il Paese inducono infatti Juan Ramón a confessare il proprio profondo pessimismo e la delusione provata nei confronti della Repubblica: “reconozco la probidad de Azaña – dice – pero no son éstos los hombres que salvarán a España… Algún día habrá que educar a ciertos hombres exclusivamente para la política”, quegli uomini che, se mai ci saranno, potranno condurre la Spagna a una nuova vita così come si augura il poeta. Durante il colloquio poi, Juan Ramón mostra con orgoglio a Pablo Suero il primo volume in corso di stampa delle sue opere complete: Vuelve con su volumen… Lo acaricia con su mano fina y pálida. – Serán 21 volúmenes como éste (gran tamaño). Contendrán 15.000 poemas… Trabajo siempre en esto… Quiero dejar definitivamente depurada mi obra… Rompo mucho de lo publicado… Si usted tiene volúmenes míos de antes, le agradeceré mucho me los mande…32. Né Jiménez, né tantomeno Suero in quella conversazione fanno esplicito riferimento al libro, ma non vi sono dubbi che si tratti di Canción, la raccolta alla quale il poeta lavorava con dedizione fin dagli inizi del ‘35. Il suo progetto complessivo concepito negli anni Trenta con il titolo generale di Unidad: Obra poética prevedeva di fatto i ventuno volumi a cui accenna nel dialogo con l’argentino; di quei ventuno libri “gran tamaño” sette avrebbero raccolto le opere in versi, sette gli scritti in prosa e gli altri sette scritti vari; i volumi di poesia li avrebbe intitolati secondo la forma metrica di volta in volta adottata: Romance, Canción, Estancia, Arte menor, Silva, Miscelánea e Verso desnudo. Lo scoppio della Guerra Civile e le difficili condizioni di esiliato impedirono a Juan Ramón la realizzazione di tale ambizioso progetto e soltanto P. SUERO, Con Juan Ramón Jiménez, cit., p. 125. I. GIBSON, Cuatro poetas en guerra, cit., p. 33. 31 J. R. JIMÉNEZ, Política poética (El trabajo gustoso), in ID., Guerra en España, cit., pp. 105-116. 32 P. SUERO, Con Juan Ramón Jiménez, cit., p. 126. 29 30 58 la raccolta Canción33 venne data alle stampe e pubblicata nella tarda primavera del ‘36. La complessa gestazione di questa antologia, protrattasi a lungo nel tempo, è stata documentata in tutte le sue fasi dalla testimonianza resa quasi quotidianamente da Juan Guerrero Ruiz, il quale mantenne con l’andaluso un contatto costante per più di vent’anni, dal 1913 al 193634. Il 20 gennaio 1935 Guerrero riferisce che il poeta lavora di buona lena “dispuesto a dar el primero de sus libros grandes en verso para abril o mayo. Comenzará por el titulado Canción, donde recoge todas sus canciones”35; fin da allora tutto sembrava preludere alla imminente pubblicazione prevista per la tarda primavera di quello stesso anno, tuttavia alla fine di luglio è ancora Guerrero a riferire che “el libro está justamente en la mitad, y el pliego 13 es el que ha quedado compuesto sin haber podido revisar la prueba; un supersticioso achacaría a este número ‘fatídico’ la causa del retraso. Juan Ramón, no”36; i problemi attribuiti all’editore e derivati dalla continua maniacale revisione del poeta ai suoi testi conducono alla fine dell’anno ‘35, lasciando ancora incompiuta l’edizione di Canción. Ai primi di febbraio del ‘36 Juan Ramón annuncia all’amico e confidente “el envío de dos pliegos nuevos del libro Canción. Él quisiera ir más deprisa – dice Guerrero – pero en la imprenta están agobiados de trabajo y no pueden; para fin de febrero espera haber adelantado bastante”37. Dunque, agli inizi di febbraio Canción non è affatto ultimato e il 17 febbraio la moglie del poeta, Zenobia, riferisce a Guerrero che Juan Ramón “está contento porque el libro va ahora más de prisa y pronto estará terminado”, poi l’amico aggiunge: “Madrid está tranquilo después de la jornada electoral de ayer, en que las izquierdas obtuvieron una gran mayoría”38. Nei giorni immediatamente precedenti a quel 17 febbraio ‘36 Juan Ramón deve aver incontrato Pablo Suero, ma il diario di Guerrero non ne serba traccia. Per la fine del mese spera unicamente che il lavoro di Canción avanzi, nulla di più. In quel periodo la ponderosa raccolta di canzoni è ancora in corso di stampa e soltanto tre mesi dopo, precisamente il 18 maggio, il poeta dichiarerà ultimata l’edizione del libro39. In conclusione, viene da chiedersi come sia stato possibile che Juan Ramón avesse mostrato a Pablo Suero il J. R. JIMÉNEZ, Canción, Madrid, Editorial Signo, 1936. J. GUERRERO RUIZ, Juan Ramón de viva voz, cit. 35 Ivi, vol. II, p. 281. 36 Ivi, p. 306. 37 Ivi, p. 362. 38 Ibid. 39 “Hablamos de la edición de su libro Canción, ya terminada y que podré tener antes de mi regreso”: ivi, p. 367. 33 34 59 volume a febbraio quando disponeva allora soltanto di pliegos sparsi, in attesa di essere rilegati. Qualora Suero avesse visto davvero il volume completo l’incontro sarebbe avvenuto nella tarda primavera, ipotesi questa in contraddizione con le informazioni di cui disponiamo e delle quali fin qui ci si è valsi; se invece, più verosimilmente, avesse fatto visita al poeta a febbraio, non avrebbe avuto l’opportunità di vedere il libro “gran tamaño” ma soltanto i pliegos fino ad allora radunati. Tenendo in considerazione le conoscenze finora acquisite, non si può che lasciare la questione aperta. Gli aspetti incerti e contraddittori di questo episodio isolato nella biografia juanramoniana e la farragine dei dati spesso discordanti alimentano dubbi e interrogativi che si estendono alla sua intera opera, “una de las peor tratadas por la crítica textual”40, una costruzione imponente quanto lungamente negletta. Pablo Suero nel suo España levanta el puño – fonte copiosa di informazioni salienti sul paese “en vísperas del alumbramiento extraordinario”41– conferma una volta ancora la difficile individuazione della personalità di Jiménez che in quelle note giornalistiche appare tra i suoi contemporanei come una figura irreale, quasi un intruso, uno “de los pocos españoles que no levantan el puño. Y si lo levanta es para volverlo a dejar caer sobre su gran corazón lacerado de poeta”42. R. ALIER, La crítica textual juanramoniana, in “Anthropos”, n. 7, febrero 1989, p. XVI. F. GONZÁLEZ TUÑON, Prólogo, cit., p. V. 42 P. SUERO, Con Juan Ramón Jiménez, cit., p. 126. 40 41 60 MÁS VALE SALTO DE MATA, QUE RUEGO DE (HOMBRES) BUENOS Elisabetta Paltrinieri Questo contributo si propone come prima fase di uno studio paremiologico comparato del proverbio “Más vale salto de mata que ruego de buenos” nelle diverse traduzioni italiane delle seguenti opere narrative del “Siglo de Oro”: la Historia de mi vida di Alonso de Contreras, il Quijote di Cervantes e il Guzmán de Alfarache di Mateo Alemán. Non esistendo in italiano un suo equivalente, in questa sede mi limiterò a tracciarne una breve storia – a mio avviso indispensabile per stabilire la sua traduzione più appropriata – esaminando la forma che riveste nelle opere letterarie spagnole che lo riportano – a dire il vero, assai limitate -, le eventuali trasformazioni che ha subito, le sue collocazioni nei “Diccionarios Académicos” e nei maggiori dizionari monolingui spagnoli e, infine, il suo aspetto contenutistico nelle glosse delle opere paremiologiche in cui viene raccolto. I Se fin dal Medioevo la Spagna ha dato mostra di un interesse particolare per la paremiologia con la compilazione di vari refraneros, è nel Rinascimento che questa disciplina raggiunge il suo auge. Ne sono esempio gli Adagia di Erasmo (1500), il Diálogo de la lengua di Juan de Valdés, in cui si raccolgono numerosi proverbi e modi di dire, il Libro de refranes compilado por el orden del ABC di Mosén Pedro de Vallés, i Refranes glosados – verso il 1550 – da Sebastián de Horozco, i Refranes o proverbios en romance di Hernán Núñez – pubblicati postumi nel 1555 – e la Filosofía vulgar (1568) di Juan de Mal Lara. Considerati come dei “piccoli vangeli”1, delle manifestazioni di 1 Cfr. I. ARELLANO, Notas sobre el refrán y la fórmula coloquial en la poesía burlesca de Quevedo, in “La Perinola: revista de investigación quevediana”, 1, 1997, p. 15. 61 una sapienza naturale, quasi infusa, nel secolo successivo subiscono la “reacción antipopularista que se polariza en la repulsa de la frase hecha y de toda otra entidad idiomática fija de tono coloquial”2, rifiuto che “engloba tanto a los refranes propiamente dichos como a las locuciones y modismos coloquiales, es decir, todo tipo de frases hechas o fórmulas comunes, en términos de Correas, caracterizadas por su rigidez formal y su oralidad”3. In realtà, anche se frequentemente smembrati e rielaborati, essi appaiono sovente nelle pagine letterarie del XVII secolo, com’è dimostrato dalla loro fecondità nello stesso Quijote e dalla pubblicazione di due opere monumentali a testimonianza dell’interesse che continuano a rivestire: il Tesoro de la lengua castellana o española di Covarrubias (1611) e, soprattutto, il monumentale Vocabulario de refranes y frases proverbiales di Gonzalo Correas, la cui prima edizione risale al 1627. “Más vale salto de mata que ruego de (hombres) buenos” costituisce, per l’appunto, un esempio di refrán4 sopravvissuto nel XVII secolo, a dispetto del discredito gettato su queste forme popolari nel periodo in questione. Stabilire la sua prima origine, essendo i refranes universali e lontani dall’essere patrimonio esclusivo di una civiltà, è molto difficile. Il Covarrubias, applicandolo alla fuga della lepre scoperta dal cacciatore, sembra ritenere che fu coniato nell’ambito della caccia5, ma la sua prima attestazione scritta è quella che compare in due raccolte del XV secolo: il Seniloquium – della prima metà del secolo e considerato il primo “refranero formal”6 – e i Refranes que dicen las viejas tras el fuego, attribuiti al Marqués de Santillana, la cui prima edizione – postuma – è quella di Sevilla del 1508. In entrambe, il refrán compare sotto la stessa forma, la più antica e “castiza” secondo Coll y Vehí7: “Más vale salto de mata que ruego de homes buenos”. Differenti sono invece le glosse perché, alla breve spiegazione del Marqués de Santillana – “En los principios el mejor medio es huyr del ynjuriado, y apartarse F. YNDURÁIN, Refranes y frases hechas en la estimativa literaria del siglo XVII, in “Archivo de Filología Aragonesa”, VII, 1955, p. 130. 3 I. ARELLANO, art. cit., p. 16 4 In questa sede non distinguerò tra refrán - formulazione popolare – e proverbio – di origine colta, non esistendo in italiano una simile differenziazione, per la quale, tra le altre opere, Cfr.: J. M. SBARBI, El refranero general español, T.I, Madrid, Imprenta de A. Gómez Fuentenebro, 1874, pp. 1-2; e E. S. O’ KANE, Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media, “Anejos de la Real Academia Española”, II, Madrid, 1959, p. 15, dove si afferma anche che il termine refrán appare per la prima volta con il suo significato attuale ne La Gran Conquista de Ultramar. 5 S. DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Barcelona, S. A. Horta, 1943. Cfr. Tabella 2, lemma ROGAR. 6 Cfr. E. S. O’ KANE, op. cit., p.16. 7 J. COLL Y VEHÍ, Los refranes del Quijote, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1874, n. 58, p. 43. 2 62 de la justicia”8 -, il Seniloquium oppone un esteso commento non privo di riferimenti biblici9. Nel secolo XVI, il refrán compare sia nel Viaje de Turquía, dove viene citato nella forma che riveste nella contemporanea raccolta di Zaragoza10, ossia, con l’inversione della sequenza sostantivo/aggettivo, prima sua variante: “[...] valiendo más salto de mata que ruego de buenos hombres;”11; sia nel canto decimonono del poema storico La Argentina o La conquista del Río de la Plata del chierico-poeta Martín del Barco Centenera: “[…] que al fin bien vale más salto de mata/ que no de los amigos buenos ruego,/ según el común dicho dice y trata”12. Sotto quest’ultima forma che, nel primo emistichio, inverte l’ordine di avverbio e verbo e, nel secondo, sostituisce al lessema “hombres” il sostantivo “amigos”, il proverbio incomincia a modificarsi sostanzialmente, tanto che l’autore ritiene opportuno un rimando allo stesso tramite le parole “según el común dicho dice y trata”. Con il Guzmán de Alfarache – appartenente già alla picaresca barocca – il refrán, pur mantenendo la sua struttura bimembre, rompe quella concisione espressiva tipica del genere: “Mas viéndose a peligro, pareciole mejor dar con ello salto de mata que después rogar a buenos”13. Trasformando l’avverbio “más” nel comparativo di maggioranza mejor e il sostantivo “ruego” nell’infinito rogar e, inserendo l’infinito dar, ma, soprattutto, l’avverbio di tempo después – che aggiunge un sema di posteriorità non presente nella sua forma originale -, Alemán ci presenta un proverbio ancora ben riconoscibile, ma ormai molto lontano dal suo primitivo modello. Ciò nonostante, questa sua formulazione priva del sostantivo “hombres” è quella che in seguito adottano le opere barocche esaminate, ad eccezione del Quijote, dove, invece, riveste ancora la sua forma più antica: “Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos” 14. L’epoca di transizione tra una forma e l’altra del proverbio è avvalorata dal fatto che lo stesso Cervantes, ne La gran sultana, pubblicata nel 1615 come la seconda parte del Quijote, lo usa privo del sostantivo citato, sebbeI. LÓPEZ DE MENDOZA, MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranes que dizen las viejas tras el fuego, (a cura di H.O. Bizzarri), Kassel, Reichenberger, 1995, p. 96 (refr. 412), dove appare con la piccola variante grafica: “[...] de ombres [...]”. 9 DR. CASTRO, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos, (ed., trad. y notas de F. Cantalapiedra y J. Moreno), in “Anexos de la Revista Lemir”, Valencia, 2004. Per la glossa, cfr. nota 34. 10 Cfr. M. P. DE VALLÉS, Libro de refranes compilado por el orden del ABC..., Zaragoza, J. Millán, 1549 . 11 C. DE VILLALÓN, Viaje de Turquía, ed. di A.. G. Solalinde, Madrid, Espasa-Calpe, 1965, cap. “La fuga”. 12 M. DEL BARCO CENTENERA (sec. XVI), La Argentina o La conquista del Río de la Plata, in “Historia de Argentina: desde el descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata hasta nuestros días”, T.III, Buenos Aires, Imprenta de la “Revista”, 1854, f. 1512, p. 249, vv. 7026-7027 . 13 M. ALEMÁN, Guzmán de Alfarache, Madrid, Várez de Castro, 1599, libro I, cap. II, p. 95. 14 M. DE CERVANTES, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, I, 21, pp. 118119 e II, 67, p. 646 . 8 63 ne determini con l’articolo i sostantivi “ruegos” – qui al plurale –, “salto” e “mata” nonché modifichi la sua struttura interna invertendo i due emistichi: “más vale que los ruegos de los buenos/ el salto de la mata”15. Il refrán – con la piccola variante “matas” nella prima delle sue due formulazioni – riacquista la sua forma originale, ma ormai priva del sostantivo “hombres”, in Alonso de Contreras: “Más vale salto de mata(s) que ruego de buenos”16; e, con la stessa omissione, compare anche nel teatro barocco, sia – inframezzato da un’esclamazione – ne Del enemigo, el primer consejo di Tirso de Molina: “[…] más vale salto de mata,/ pardiós, que ruego de buenos”17; sia nel titolo di una commedia attribuita a Lope de Vega: Más vale salto de mata que ruego de buenos18; sia in una delle prime opere di Calderón de la Barca, Luis Pérez el Gallego, dove l’avverbio di tempo “antes”, premesso al primo emistichio, sostituisce il contrario “después” che Mateo Alemán aveva anteposto alla seconda parte per evidenziare la successione delle azioni nel refrán: “[pretendí que me valiese] antes el salto de mata/que ruego de buenos” 19. Infine, nel primo atto de El tejedor de Segovia di Ruiz de Alarcón, tramite la sostituzione dei termini che compaiono nel detto popolare con altri antitetici, esso assume un controsenso ironico di grande effetto. Alarcón, infatti, pur mantenendo il sema di “ruego” tramite l’infinito “rogar”, trasforma il secondo emistichio in maniera radicale: con un gioco di specchi deformante, tipico del Barocco, egli oppone agli “hombres” i “ministros”, e all’aggettivo “buenos” l’ossimoro “del infierno”: “Mas vale salto de mata/ que rogar a estos ministros/ del infierno”20. Appare quindi evidente che nel salto dal XVI al XVII secolo, rispetto alla sua forma primitiva, il proverbio subisce numerose trasformazioni, delle quali la più ricorrente è l’omissione del lessema “hombres” 21: M DE CERVANTES, Comedia famosa intitulada La gran sultana doña Catalina de Oviedo, (ed. di F. Sevilla Arroyo), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001, fol. 137 r, vv. 1022-1023. 16 A. DE CONTRERAS, Discurso de mi vida, Madrid, Langre, 2006, pp. 39 e 130. 17 FRAY G. TÉLLEZ, “TIRSO DE MOLINA”, Del enemigo, el primer consejo, in “El pretendiente al revés. Del enemigo el primer consejo (dos comedias palatinas)”, Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2005, atto terzo, scena IV, vv. 2709-2710. 18 C. A. DE LA BARRERA Y LEIRADO la inserisce nel suo Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, London, Boydell & Brewer, 1968. 19 P. CALDERÓN DE LA BARCA, Luis Pérez el Gallego (1628), ed. J. J. Keil, Leipzig, 1830, t. IV. 20 J. RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, El tejedor de Segovia, in “Obras completas”, T. II, Valencia, Albatros Hispanofila, 1990, atto I, v. 427-428. 21 La ricerca condotta non ha pretese di esaustività, ma si offre come primo passo per il reperimento del citato proverbio in tutte le opere letterarie spagnole. 15 64 Tabella 1 Dr. Castro, Seniloquium. Refranes que dizen los viejos (sec. XV) Marqués de Santillana, Refranes que dizen las viejas tras el fuego (sec. XV) Cristóbal de Villalón, Viaje de Turquía (sec. XVI) G. Fernández de Oviedo, Quincuagenas (sec. XVI)22 M. del Barco Centenera, La Argentina o La conquista del Río de la Plata (sec. XVI) Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache I (1599) M. de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605: I, 21; e 1615: II, 67) M. de Cervantes, La gran sultana doña Catalina de Oviedo (1615) Lope de Vega Carpio, Más vale salto de mata que ruego de buenos (sec. XVII) Calderón de la Barca, Luis Pérez el Gallego (1628) A. de Contreras, Historia de mi vida (1633) Ruiz de Alarcón, El tejedor de Segovia (1634) Tirso de Molina, Del enemigo, el primer consejo (1636) Mas vale salto de mata que ruego de homes buenos Mas vale salto de mata que ruego d’ames buenos [Valiendo] más salto de mata que ruego de buenos hombres Vale más salto de mata/ que no de los amigos buenos ruego [Pareciole] mejor dar con ello salto de mata que después rogar a buenos Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos Más vale que los ruegos de los buenos/ el salto de la mata [pretendí que me valiese]/ antes el salto de mata/ que ruego de buenos Más vale salto de matas que ruego de buenos (I parte); Más vale salto de mata que ruego de buenos (II parte) Mas vale salto de mata/ que rogar [a estos ministros/ del infierno] Más vale salto de mata,/ [pardiós,] que ruego de buenos II Sembrano ribadire quest’ipotesi il Covarrubias – che raccoglie il proverbio, sotto i lemmi “rogar” e “mata”, privo del termine “hombres” – e i dizionari della Real Academia Española, che sopprimono lo stesso sostantivo già nel “Diccionario de Autoridades”23 del 1726, per poi reinserirlo soltanto a partire dal “Diccionario Usual”24 del 1899, ma come seconda accezione introdotta dalla disgiuntiva “o”: Cfr. P. CELDRÁN GOMARIZ, Diccionario de frases y dichos populares, Madrid, Alderabán, 2004, p. 410. D’ora innanzi A.A. Questa è l’unica edizione a registrare il proverbio sotto il lemma BUENO. 24 D’ora innanzi A.U.. 22 23 65 Tabella 2 Dizionario Lemma Proverbio Definizione Covarrubias MATA Más vale salto de mata que ruego de buenos ID. ROGAR Más vale salto de mata que ruego de buenos ID. SALTAR Más vale salto de mata que ruego de buenos hombres A.A. 1726 BUENO (con rinvio al proverbio sotto SALTO, ma non sotto MATA) Más vale salto de mata que ruego de buenos A.U. 1780 MATA e SALTO idem A.U. 1783 e 1791 idem A.U. 1803 SALTO (con rimando al proverbio sotto MATA) SALTO Y seguir a uno hasta la mata, seguirle hasta no poder más, por avérsele escapado, como haze la liebre a quien el galgo ha corrido en lo raso y se entra en el monte. Está tomado de la liebre quando la ha descubierto el caçador. Rogativa, la plegaria y letanía pública de la Iglesia por alguna necesidad. [...] saltar una cosa, moverse con violencia de una parte a otra, como salta de la lumbre la centella, o del hierro ardiendo quando le hieren sobre el yunque. Refr. que enseña, que al que ha cometido algun excesso por donde tema ser castigado, mas le aprovecha el ponerse en salvo y escaparse, que no el que pidan por él personas de suposición y autoridad. Lat. “Fuga sibi qui possit, ipse consulat: Potentium sat ipsa precibus tutior […]”. idem, con le varianti exceso e Lat. “Plus fuga profuerit cuivis properata nocenti, Quàm veniam orantum turba patrona virum” idem A.U. 1817 A.U. 1822 SALTO SALTO idem idem 25 idem idem, con la traduzione latina dell’ A.A. 1726 idem, senza traduzione latina idem, con la variante latina: “Cum liceat fugere, ne quaeras liteim”25 Cfr. anche J. DE LAMA, Florilegium latinum […], Madrid, R. Ruiz, 17936, p. 221: “ Mas vale salto de mata, que ruego de Buenos. Cum fugere licet: ne quæras litem. Erasm.”. 66 A.U. 1832, 1837, 1843 e 1852 A.U. 1869 A.U. 1884 A.U. 1899 e 1914 SALTO idem SALTO (sotto MATA rimando a SALTO per “salto de mata”) SALTO (senza rimando sotto MATA) SALTO (idem) idem A.U. 1925, 1936, 1939 e 194726 SALTO (idem) A.U. 1956 SALTO A.U. 1970, 1984 e 1992 / idem Más vale salto de mata que ruego de buenos ó de hombres buenos idem Más vale salto de mata que ruego de buenos ò de hombres buenos / idem, con variante latina: “Fuga patrono melior” idem, senza corrispondente latino idem idem “Refr. que enseña, que al que ha cometido algún exceso por donde tema ser castigado, más le aprovecha el ponerse en salvo y escaparse, que no el que pidan por él personas de valimiento” (variante di: de suposición y autoridad), senza traduzione latina “Refr. que enseña, que al que ha cometido un exceso por el cual teme que se le ha de castigar, más le aprovecha escaparse, que no el que pidan por él personas de valimiento” / Da questa tabella si evince inoltre che, a partire dal 1970, il proverbio non viene più registrato dai “Diccionarios Académicos”, segno questo, della sua caduta in disuso. D’altronde, è noto che i proverbi hanno valore o senso paremiologico solo se si basano su situazioni concrete o su realtà storiche, ossia “quando una comunità li riconosce come tali e attribuisce loro forza espressiva e comunicativa”27. Allo stesso tempo, però, essendo in costante flusso28, sovente si deformano, alcune volte accrescendo il loro testo quasi per sedimentazione, altre sintetizzandosi e potandosi, come limati dall’uso. È questo, per l’appunto, il caso del nostro refrán, del quale è Il proverbio non è registrato negli “Academia Manual” (1927, 1950, 1985 e 1989). http://digilander.libero.it/dichos 28 Cfr. R. RIDOUT-C. WITTING, English Proverbs Explained, London & Sidney, Pan Books, 1969, p. 14. 26 27 67 sopravvissuta soltanto una parte del primo emistichio, ossia “salto de mata”, la cui definizione dell’ A.U. 1803 – “fam. La huida o escape por temor al castigo, como lo prueba el refrán Más vale salto de mata &c.” – è ripresa in seguito tale e quale da tutti i Diccionarios Académicos fino all’ultima edizione del 1992 e all’articolo emendato della 23a edizione29. Ancora molto produttiva oggigiorno è inoltre la locuzione avverbiale “a salto de mata”, registrata per la prima volta sempre nell’A.U. del 1803 – “mod. adv. Huyendo por temor ò recelo del castigo” –, ma poi scomparsa dai “Dizionari Accademici” fino all’A.U. del 1884, la cui definizione – “loc. adv. fig. Huyendo y recatándose” – rimane invariata fino all’edizione del 1984. A partire da quest’ultima, viene aggiunta una seconda accezione: “Aprovechando las ocasiones que depara la casualidad”, raccolta – sempre sotto il lemma SALTO – anche nel Diccionario de Uso del Español di María Moliner30, nel Clave31 e nel Diccionario del español actual di M. Seco32, nei quali la locuzione “a salto de mata” è l’unica parte del proverbio ad essere sopravvissuta. J. Casares, invece, riprende entrambe le locuzioni fornendo, per quest’ultima, la prima accezione dei Diccionarios Académicos – “loc. adv. Huyendo y recatándose” – e sintetizzando in “huida o escape” quella offerta dagli stessi per “salto de mata”33. Quanto alla letteratura, le due locuzioni citate hanno un’alta frequenza fino ai nostri giorni: per citare soltanto alcuni esempi di secoli passati, esse si ritrovano nell’Aquilana di Bartolomé de Torres Naharro, nella Jácara de la venta di Quevedo, ne El carbonero alcalde delle Historietas nacionales di Alarcón, ne El fin de la fiesta di Larra, ne La Quimera e Los Pazos de Ulloa di Emilia Pardo Bazán e nell’ Estilicón di Leopoldo Alas Clarín. 29 Senza il rinvio al proverbio e, in alcune, con la piccola variante “[…] por temor del castigo”. Dall’ A.A. del 1726, sotto il lemma MATA, viene anche registrato: “saltar de la mata”: “f. met. Que significa descubrirse y darse a conocer el que estaba oculto y encubierto” (Cfr. anche S. DE COVARRUBIAS, op cit., lemma MATA: “descubrirse el que estava secreto; término de caçadores quando van a ojeo de liebres o conejos”). M. MOLINER, Diccionario del Uso del Español, Madrid, Gredos, 19831 e 19982. Clave. Diccionario de uso del español actual, Madrid, SM, 1996. 32 M. SECO, Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar 20053. 33 J. CASARES, Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde lapalabra a la idea, Barcelona, Gustavo Gili, 19972. 30 31 68 III Vediamo ora, con l’aiuto di un’altra tabella, quali opere paremiologiche raccolgono e glossano il proverbio, considerando anche alcuni studi che si incentrano sui refranes contenuti nel Quijote34: Tabella 3 AUTORE [Dr. Castro] TITOLO Seniloquium PROVERBIO Mas vale salto de mata que ruego de homes buenos Don Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana M. P. De Vallés Refranes que dizen las viejas tras el fuego (sec. XV) Mas vale salto de mata que rruego d’omes buenos Libro de refranes y sentencias de [...], Zaragoza, 1549 H. Núñez Refranes o proverbios en romance, que coligió Más vale salto de mata que ruego de buenos hombres Mas vale salto de mata, que GLOSSA “Por ello no debe nadie estar o comparecer en donde no deba subir o estar sin peligro de muerte y, aunque tenga un salvaconducto, no debe someterse a sus enemigos mortales [...]; ni resguardarse en el cobijo de los enemigos, no ofrecerse voluntariamente para acarrearse la muerte [...]. Y así, si un cautivo con su juramento se alivia de la pena o peligro de muerte, o se libra de volver a la cárcel en una fecha determinada, [76r], si la muerte era injusta, no tiene obligación de volver [...]”35 “En los principios el mejor medio es huyr del ynjuriado, y apartarse de la justicia” I testi relativi ai refranes del Quijote sono stati inseriti alla fine. La lunga glossa prosegue in questo modo (Cfr. DR. CASTRO, Seniloquium [...] cit., p. 132): “Quien busca en particular huir debe hacerlo según el ejemplo de Cristo, quien huyó a Egipto de la presencia de Herodes. Y además el de Pablo, quien fue descolgado por los hermanos por la muralla en una espuerta. El Señor dijo a los discípulos: “Si os persiguiesen en una ciudad, huid a otra,” etc. Él mismo se escondió y salió del templo, cuando los judíos cogieron piedras para arrojarlas contra él [...]./ En verdad, el Señor, cuando era buscado por Herodes para matarlo, no se buscó una defensa, sino que huyendo a Egipto, se ocultó durante siete años y enseñó a no oponerse a las armas con las armas, sino la huída [sic] ante los perseguidores [...]/ David en un salmo dijo: “He aquí que me alejaré huyendo”[...] Pues la huída es una ayuda para los hostigados [...]. Lo cita Gregorio en la Carta a Juan, obispo de Siracusa”. 34 35 69 G. Correas G. M. Caro y Cejudo J. M. Sbarbi y Osuna Id. Id. L. Martínez Kleiser E. S. O’ Kane 70 [...], Lérida, L. Manescal Mercader de Libros, 1621, p. 67 v. Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), Madrid, Castalia, 2000, p. 507, n.13927 Refranes y modos de hablar castellanos con los latinos que les corresponden [...], Madrid, Imprenta Real, 1792, p. 210 Florilegio o Ramillete alfabético de refranes y modismos comparativos y ponderativos de la lengua castellana, Madrid, Imprenta de A. Gómez Fuentenebro, 1873 El refranero general español, T. I, Madrid, Imprenta de A. Gómez Fuentenebro, 1874 Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos y las obras o fragmentos que expresamente tratan de ellos en nuestra lengua, Madrid, Imprenta y Litografía de los Huérfanos, 1891, Parte II: “Catálogo paremiológico castellano” Refranero general ideológico español, Madrid, RAE, 1953, n. 31-772 Refranes y frases ruego de hombres buenos Más vale salto de mata que ruego de buenos; [o] de hombres buenos Mas vale salto de mata que ruego de buenos Más vale salto de mata, que ruego de buenos Mas vale salto de mata que ruego de hombres buenos Más vale salto de mata que ruego de buenos hombres Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos Más vale salto “Cum licet fugere ne quere litem. Erasmus ex Apohphtegmate Alcibiadis [...] “Ref. que enseña que al que ha cometido algún exceso, por el cual teme se le ha de castigar, más lo aprovecha el ponerse en salvo y escaparse, que no el que pidan por él personas de suposición y autoridad” “En los principios el mejor medio es huyr del ynjuriado, y apartarse de la justicia” / Sotto: “Huida>Conveniencia de huir"; salto de mata, huida Sotto: “SALTO”: > II. SALTO proverbiales españolas de la Edad Media, “Anejos del Boletín de la RAE”, II, Madrid, 1959, p. 209 de mata que rruego de ombres (homes) buenos. Santillana, Refranes 415; Seniloquium 247 Salto de mata que ruego de buenos: más vale P. Celdrán Gomariz Diccionario de frases y dichos populares [...], Madrid, Alderabán, 2004, p. 410 L. Junceda Diccionario de refranes, dichos y proverbios, Madrid, Espasa-Calpe, 2006, p. 347 Los refranes del “Quijote”. Ordenados por materias y glosados, Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1874, p. 44, n. 58 Más vale salto de mata que ruego de buenos36 E. Olmos Canalda Los refranes del ‘Quijote’, Valencia, Imprenta J. Nacher, 1940, n. 196 Mas vale salto de mata que ruegos de hombres buenos M. C. Colombi Los refranes en ‘Don Quijote’, UMI, 1988, pp. 182 e 208, n.111 Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos J. Coll y Vehí Más vale salto de mata, que ruego de hombres buenos DE MATA Llamose antaño “salto de mata” a la fuga o huida, y ruego de buenos a la intercesión que otros hacen en favor de uno. Esta comparación enseña que a quien comete un delito acaso le sea de mayor provecho escapar cuando puede y no confiar demasiado en los buenos oficios de familiares y amigos [...]” Aconseja tomar con determinación aquello a que se aspira, en lugar de solicitarlo con extremos de humildad. [...] Enseña este adagio, en opinión de la Academia, que al que ha cometido algún exceso por el cual teme que se le ha de castigar, más le aprovecha ponerse en salvo y escaparse, que no el que pidan por él personas de suposición y autoridad [...] Aconseja a la mujer que huya ante los ruegos del hombre, si ellos la colocan en peligro. Es lo más eficaz a su honor. Quien ama el peligro en él perece. 36 L’autore rimanda al proverbio anche sotto la locuzione “a salto de mata” della quale dà la definizione alla p. 27. 71 A.Gómez Bernal Una aproximación al refranero popular en el ‘Quijote’, Madrid, Prisma, 1989, p. 91 Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos Escludendo sia i lavori relativi al Quijote che, com’ è logico, riportano il proverbio nella forma che riveste nel romanzo, sia quello di E. S. O’Kane, dove esso viene ripreso dal Seniloquium e dal Marqués de Santillana, i testi paremiologici citati in tabella offrono tutte e tre le varianti proposte nelle opere letterarie esaminate: il Seniloquium, il Marqués de Santillana, H. Núñez e I. Martínez Kleiser accolgono la versione estesa che include il sostantivo “hombres”; al contrario, G. M. Caro y Cejudo e i lavori più attuali di P. Celdrán Gomariz e I. Junceda riportano quella in cui viene omesso; a sua volta, M. P de Vallés, lo presenta nella forma che vede l’inversione dell’aggettivo “buenos” e del sostantivo “hombres”; infine, J. M. Sbarbi y Osuna distribuisce le tre forme, una per ogni sua opera. Quanto alle glosse, G. M. Caro y Cejudo introduce l’equivalente latino e J. M. Sbarbi y Osuna ne El refranero general español rende quella del Marqués de Santillana. L. Juncedo, invece, sembra glossare il refrán che precede il nostro nel Quijote: “No pidas de grado lo que puedas tomar por fuerza”. Gli altri autori concordano sul significato del proverbio “Más vale salto de mata que ruego de buenos” registrato dai “Diccionarios Académicos”, ad eccezione di E. Olmos Canalda il quale, curiosamente, lo considera un monito diretto alle donne per sfuggire alle pretese degli uomini e conclude il suo commento con quest’altra massima perentoria: “Quien ama el peligro en él perece”. Nessuna glossa, infine, accenna all’ambito in cui il refrán potè configurarsi, ossia alla caccia e a quella lepre che, come afferma il Covarrubias37, fuggendo dal cacciatore e dal levriere, sembra effettivamente costituire l’origine della sua formazione. 37 S. DE COVARRUBIAS, op.cit., lemma: ROGAR 72 IL LIBRO DE LA CAZA DE LAS AVES DI PERO LÓPEZ DE AYALA E I SUOI EPIGONI: TRADIZIONE MANOSCRITTA E PROBLEMI Laura Ramello L’indiscussa supremazia della tradizione siculo-normanna nel campo della trattatistica sulla caccia al volo, alimentata dalla fama del suo più illustre autore1, non può oscurare il fatto che la letteratura cinegetica ibero-romanza vanti una produzione assai ragguardevole e tale da collocarla, nel panorama neolatino, in prima posizione sia sul piano numerico delle testimonianze conservate che a livello di specifiche peculiarità2. Al numero relativamente ridotto di trattati di provenienza lusitana3 e catalana4, che va comunque arricchendosi di nuove e promettenti acquisizioni5, fa riscontro, ancora in terra di Spagna, una produzione più cospicua che, dopo una fase di esordio caratterizzata, come in altre regioni d’Europa, da volgarizzamenti di trattati latini6, vede, a partire dal XIV secolo con il Libro de la caza di Juan Manuel7, la comparsa delle prime opere “origiFEDERICO II DI SVEVIA, De arte venandi cum avibus, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Roma-Bari, Laterza, 2007. Mi riferisco ad esempio al primato cronologico delle traduzioni di testi arabi come il Libro de los animales que cazan o Libro de Moamín per cui cfr. Moamyn et Ghatrif, Traités de fauconnerie et des chiens de chasse, a cura di H. Tjerneld, Stoccolma-Parigi, Studia Romanica Holmesiana, 1945, Libro de los animales que cazan (Kitab alyawarih), a cura di J. M. Fradejas Rueda, Madrid, Casariego, 1987 e The Text and Concordance of Biblioteca Nacional Manuscript RES. 270-217: "Libro que es fecho de las animalias que caçan", the "Book of Moamin", a cura di A. J. Cárdenas, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1987. 3 Ricordiamo una traduzione del Dancus Rex (cfr. G. TILANDER, Uma tradução portuguesa desconhecida do tratado de cetraria do rei Dancus, in “Boletim de Filologia”, 6 (1939), pp. 438-457) e il Livro da falcoaria di Pero Menino per cui cfr. M. RODRIGUES LAPA, Livro de Falcoaria de Pero Menino, Coimbra, Universidade, 1931. 4 Oltre alle traduzioni del Dancus rex e del Guillelmus falconarius (per cui cfr. l’Archivo Iberoamericano de Cetrería dell’Universidad de Valladolid, diretto da J. M. Fradejas Rueda, all’indirizzo: http://www.aic.uva.es) si veda ad esempio il Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertayen ha cassa altrimenti detto Pístola a Tolomeu per cui cfr., fra i più recenti, lo studio di M. PICCAT, La Pístola a Tolomeu emperador d’Egipte: un nuovo testimone, in Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997, pp. 341-353. 5 Per l’ambito catalano Marco Piccat ha in preparazione l’edizione di un trattato in versi sugli astori e delle traduzioni del Dancus Rex e del Guillelmus falconarius dal codice da lui recuperato per cui cfr. la nota precedente. 6 Si pensi ad esempio al Dancus rex o al Guillelmus falconarius per cui cfr. Traducción española de Dancus rex et Guillelmus falconarius, a cura di G. Tilander, Karlshamn, Johanssons, 1966 e J. M. FRADEJAS RUEDA, Antiguos tratados de cetrería castellanos, Madrid, Caïrel Ediciones, 1985. 7 La prima edizione, curata da J. Gutiérrez de la Vega (Libro de la caza, in Libros de cetrería del Príncipe y el Canciller, Madrid, M. Tello, 1879) ha inaugurato una serie di pubblicazioni susseguitesi fino ai giorni nostri; fra 1 2 73 nali”, la cui lista, annovera, nell’arco di tre secoli, il Libro de la caza de las aves di Pero López de Ayala, il Libro de cetrería di Juan de Sahagún8, il Libro de cetrería di Evangelista9, il Libro de acetrería y montería di Juan Vallés10 e il Libro de cetrería di Luis de Zapata11. La citazione, a titolo esemplificativo, di questi testi non è affatto casuale, così come non lo è la loro definizione virgolettata che rimanda ad una delle problematiche più spinose della letteratura accipitrina, e cioè la questione della sua originalità12: nel caso specifico, l’opera di Pero López de Ayala costituì la fonte a cui attinsero in vario modo gli autori successivi, taluni in forte debito nei confronti del Cancelliere come Juan de Sahagún, accusato addirittura di plagio13. Al di là del suo enorme successo, lo stesso trattato di Pero López de Ayala non è propriamente originale: agli inizi del ‘900 Carolina Michaëlis de Vasconcelos14 dimostrò il debito del Cancelliere nei confronti di Pero Menino di cui aveva tradotto, sia pure con inserzioni proprie, il Livro de Falcoaria15. Il problema dell’originalità delle opere letterarie in un’epoca quale quella medievale, in cui i concetti di proprietà intellettuale e di plagio erano assai labili, se non inconsistenti, diviene ancor più delicato in ambiti come quelle più recenti si segnala quella a cura di J. M. Fradejas Rueda e F. Calero, Libro de la caza, Madrid, Guillermo Blázquez, 1998. 8 Cfr. J. GUTIÉRREZ DE LA VEGA, Libro de Johan de Sant Fagún, in “La Ilustración Venatoria”, 8 (1885), pp. 9-10, 17-19, 25-27, 33-35, 41-43, 49-51, 57-59, 65-67, 73-75, 81-83, 89-91, 97-99, 105-106, 113-115, 121-123 e F. DE UHAGÓN, Los Libros de cetrería del Canciller Pero López de Ayala, de Juan de Sahagún y de D. Fadrique de Zúñiga y Sotomayor, Madrid, Ricardo Fe, 1889, oltre a numerosi studi per cui si rinvia all’Archivo Iberoamericano de Cetrería, cit. 9 Cfr. J. M. FRADEJAS RUEDA, Manuscritos y ediciones del Libro de cetrería de Evangelista, in Varia bibliografica: homenaje a José Simón Díaz, Kassel, Edition Reichenberger, 1988, pp. 283-288. 10 J. VALLÉS, Libro de acetrería, Madrid, Caïrel Ediciones, 1993 (ed. dei primi due libri). 11 Libro de cetrería. Facsímil del manuscrito 4.219 de la Biblioteca Nacional de Madrid, a cura di M. Terrón Albarrán, Badajoz, Institución Pedro de Valencia, 1979 e Edición paleográfica del Libro de cetrería de Luis de Zapata según el manuscrito 7844 de la Biblioteca Nacional de Madrid, a cura di I. Olmos Martín, Memoria de Licenciatura, Madrid, UNED, 1992. 12 In proposito si veda il contributo di J. M. FRADEJAS RUEDA, La originalidad en la literatura cinegética, in “Epos”, 2 (1986), pp. 75-88, in cui si sottolinea la totale autonomia di una sola opera: “Don Juan Manuel es una isla en medio del océano de la literatura venatoria castellana. No copia de nadie y nadie le copia” (p. 88). 13 In merito a ciò già a fine ‘800 Francisco de Uhagón così si espresse: “ no se trataba ya de una paráfrasis, sino de un verdadero plagio” (F. R. DE UHAGÓN, Los libros de cetrería, cit., p. 8). Sostanzialmente concorde è, ancora oggi, il giudizio di José Manuel Fradejas Rueda: “La verdad es que se limita a copiar, por diferente estilo, es decir, trastrocando ligeramente el orden de las palabras, gran parte de la obra de Ayala, como con gran alarde y durísimas palabras destacó Uhagón” (cfr. l’Archivo Iberoamericano, cit. all’indirizzo: http://www.aic.uva.es/clasicos/ayala/ayala-intro.html). 14 C. MICHAËLIS DE VASCONCELOS, Mestre Giraldo e os seus tratados de alveitaria e cetraria, in “Revista Lusitana”, 13 (1910), pp. 149-432. 15 Cfr. nota 3. L’incidenza dell’opera del Menino sul trattato di Pero López de Ayala è ben percepibile nell’edizione curata da J. FRADEJAS LEBRERO, Libro de la caza de las aves, Madrid, Editorial Castalia, 1965 in cui le parti tradotte sono riportate in corsivo. 74 lo tecnico-scientifico in cui la pratica, empiricamente descritta e divulgata, rappresenta la matrice fondamentale dell’accrescersi e del raffinarsi delle conoscenze presso i cultori di una determinata disciplina. La peculiarità è particolarmente evidente nella trattatistica medico-secretistica: la possibilità di ritrovare in opere, appartenenti a tradizioni testuali e linguistiche diverse, corrispondenze nelle descrizioni di patologie e di rimedi tali da complicare significativamente la ricerca degli ascendenti e la ricostruzione della tradizione manoscritta è altissima16; il più delle volte si tratta di testi tràditi da un solo testimone che mostrano analogie con una pluralità di trattati, in una situazione in cui ad esempio per la stessa affezione vengono talora proposti medicamenti dagli ingredienti o dalla confezione parzialmente diversa, o prescritti rimedi altrove indicati per malattie differenti. Nell’affrontare la questione della tradizione testuale in questo ambito, è necessario tenere presenti i seguenti aspetti che necessariamente ne influenzano l’evoluzione: il carattere empirico delle discipline, associato alla scarsa consapevolezza circa il problema della proprietà intellettuale, che in questo settore diviene pressoché irrilevante, determinano situazioni in cui gli autori, che sono spesso “tecnici”, utilizzano liberamente trattati preesistenti, rielaborandoli sulla base delle proprie esperienze e determinando così una stratificazione di saperi difficilmente districabile. Questa situazione ha ovviamente ripercussioni sulla ricostruzione filologico-testuale: il recupero delle fonti può talvolta risultare assai arduo, e qualora esse appaiano individuabili, la valutazione del loro utilizzo deve spesso fare i conti con apporti personali più o meno cospicui, insieme all’incrocio con tradizioni allogene. A ciò si aggiunga il problema dell’alto tasso di anonimato di questi autori, tecnici-letterati che hanno come principale obiettivo la realizzazione di un’opera a proprio uso e consumo, prima ancora che a carattere divulgativo. Se questa è la situazione di tante discipline a carattere empirico, certamente essa ha dei riflessi anche nel settore dell’arte cinegetica: in questo campo paiono concentrarsi e infittirsi tutte le problematiche suesposte, a cui si aggiunge l’ulteriore variabile rappresentata dall’elevato numero di praticanti di una disciplina che ebbe una fortissima incidenza sul piano socio-culturale, elementi tutti di cui si dovrà necessariamente tener conto nel momento in cui si affronta lo studio delle opere pervenute. 16 Ho in passato riscontrato la sussistenza di queste problematiche sia in una raccolta di ricette mediche in lingua catalana (L. RAMELLO, Una raccolta di ricette in antica lingua catalana (codice palatino 1052 della Biblioteca Nazionale di Firenze) in “Quaderni di Filologia Romanza”, XI (1994), pp. 99-136) che in un trattato di cosmetica di area veneta (EAD., La “cosmetica” del ms. W 478 della Walters Art Gallery di Baltimora e la tradizione secretistica: edizione e indagine lessicale, in “Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano”, III Serie, 21 (1997), pp. 185246) dei quali ho allestito l’edizione. 75 Talune di esse mostrano una tradizione manoscritta assai nutrita e in continuo arricchimento; è appunto il caso del Libro de la caça de las aves che Pero López de Ayala, personaggio di spicco sul piano politico e letterario, scrisse fra il 1385 e il 1386 durante la prigionia nel castello di Óvidos; di esso si contano ad oggi trentadue testimoni, databili fra il XV e il XIX secolo, ripetutamente e ancor recentemente censiti da José Manuel Fradejas Rueda17; fra le ultime acquisizioni viene segnalato un codice custodito presso la Biblioteca Nazionale di Napoli con la segnatura I. E. 6018; esso appare sconosciuto a tutti i curatori delle numerose edizioni che si sono susseguite nel corso del tempo19, di cui solo le ultime hanno assunto la veste di edizione critica20. Pur se collocato nel filone di tradizione dell’opera del Cancelliere, il teL’ultimo aggiornamento è consultabile in J. M. FRADEJAS RUEDA, De nuevo sobre los manuscritos del Libro de la caça de las aves de Pero López de Ayala*, in Lengua viva. Estudios ofrecidos a César Hernández Alonso, a cura di A. Álvarez Tejedor, A. Bueno García, S. Hurtado González, N. Mendizábal de la Cruz, Valladolid, Universidad de Valladolid – Diputación de Valladolid, 2008, pp. 1099-1117: “Por lo tanto, el Libro de la caça de las aves del Canciller Pero López de Ayala se erige en una de las obras medievales castellanas con mayor difusión manuscrita con 32 manuscritos que comprenden 33 copias” (p. 1014). Lo studio rappresenta l’ultimo di una serie di interventi sulla questione per i quali rinvio alla bibliografia in esso riportata. Ringrazio José Manuel Fradejas Rueda per questa ed altre preziose indicazioni bibliografiche fornitemi. 18 Il testo contenuto nel manoscritto è stato oggetto di trascrizione integrale e studio nell’ambito della tesi di laurea condotta sotto la mia guida da C. LIPRANDI, La lingua del Libro de la caza de las aves di Pero López de Ayala (ms. I. E. 60 della Biblioteca Nazionale di Napoli), Università degli Studi di Torino, a.a. 2006-07. Per la descrizione del codice si rinvia al catalogo di A. MIOLA, Notizie di manoscritti neolatini. Parte prima. Mss. francesi, provenzali, spagnuoli, catalani e portoghesi della Biblioteca Nazionale di Napoli, Napoli, Federigo Furchheim, 1895, pp. 80-81 nonché al contributo di J. M. FRADEJAS RUEDA, De nuevo sobre los manuscritos, cit., pp. 1106-1108. 19 La prima edizione (El libro de las aves de caça del canciller Pero López de Ayala con las glosas del Duque de Alburquerque, a cura di E. Lafuente Alcántara e P. de Gayangos, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1869) mostra una genesi alquanto complicata: “La Sociedad de Bibliófilos Españoles encargó a Emilio Lafuente Alcántara que preparara una edición de dicha obra, pero la muerte le sobrevino cuando ya se habían compuestos e impresos los primeros cuadernillos y hubo de concluirla Pascual de Gayangos, según el parecer de algunos no muy elegantemente. El primer defecto que se le achaca es que no está claro qué manuscrito emplearon. Hablan de uno propiedad del conde de Altamira, pero nadie sabe cuál fue, tan sólo que fue vendido en Francia, y ninguno de los dos manuscritos que hay o ha habido en ese país (París, BNF, ms. esp. 292, Musée de la Chasse et de la Nature, ms. 63.100.2 y el de colección Krahe, olim Jeanson) se asemeja al texto publicado” (J. M. FRADEJAS RUEDA, Archivo Iberoamericano, cit., http://www.aic.uva.es/clasicos/ayala/ayala-intro.html); a questa seguirono il Libro de la caza de las aves, et de sus plumages, et dolencias, et melecinamientos, del canciller Pero López de Ayala, a cura di J. Gutiérrez de la Vega in Libros de cetrería, cit., pp. 136-344 e il Libro de la caza, cit., a cura di J. Fradejas Lebrero. 20 P. LOPEZ DE AYALA, Libro de la caça de las aves. El MS 16.392 (British Library, Londres), editado con Introducción, Notas y Apéndices, a cura di J. G. Cummins, London, Tamesis Books Limited, 1986; Cummins basa il suo studio su 22 manoscritti, offrendo una prima sistemazione stemmatica. Il trattato di López de Ayala è stato in ultimo oggetto di una tesi di dottorato a cura di M. Delgado Montoto (Edición crítica del Libro de la caça de las aves de Pero López de Ayala, tesis doctoral, Madrid, UNED, 1998); la tesi, basata su 26 testimoni, non è più consultabile a causa della scomparsa del suo autore, ma è stata recentemente edita (Edición crítica del Libro de la caza de las aves de Pero López de Ayala, Madrid, Ediciones Calasancias, 2006). Non avendo avuto al momento la possibilità di consultare quest’ultima, le riflessioni che seguono saranno basate sull’edizione Cummins e sulle integrazioni di Fradejas Rueda (De nuevo sobre los manuscritos, cit.), riservandomi la verifica di queste prime ipotesi sulla base dei dati bibliografici più recenti. 17 76 sto tràdito in questo manoscritto del XV secolo presenta alcune particolarità su cui è bene soffermarsi, malgrado la titolazione e la successione dei capitoli sia pressoché la stessa; infatti un’analisi del loro contenuto svela immediatamente notevoli differenze che mostrano come esso presenti una versione in più luoghi compendiata. Il primo elemento che si evidenzia dal confronto delle varie sezioni è il forte ridimensionamento che subisce una delle componenti essenziali dell’opera di Ayala che “sin embargo se individualiza y embellece gracias a las anécdotas con las que ilustra sus afirmaciones”21 e che in genere caratterizza la letteratura cinegetica spagnola e cioè l’aneddotica: su di un totale di una trentina di aneddoti, ben i due terzi vengono tralasciati. Esemplare sotto questo aspetto risulta essere il capitolo dedicato al paso de las aves: dei cinque aneddoti in esso riportati, ben tre vengono omessi nel manoscritto di Napoli con una riorganizzazione dell’enunciato di cui ci si può rendere conto esaminando il seguente passo: Libro de la caza de las aves22: …e assy dizen que lo fazen las codornizes, car muchas veces falla hombre con un viento muchas dellas, e luego que otro viento viene parten de ally e vansse e esto vieron muchos. Otrosy, yendo el Rey Don Pedro por la mar, aviendo guerra con el Rey d’Aragon, e atravesando de Martin a Yviça, que es traviessa de doze leguas, e vy que en la galea de un cavallero que llaman Orejon, bien a seys leguas de tierra, decayo una codorniz, non se sy yvan otras, pero dizen que passan la mar. Otrosy, vi en el camino dela traviessa dela mar que se faze entre Vermeo, Bilbao de Vizcaya, y la Rochela, que pueden ser ochenta leguas poco mas, ya yendo en una galea a media via de mar, que podien ser .xl. leguas de tierra de cada parte, falle garças que llevavan aquella via mesma. E asy andan buscando su via e su passo las aves por sua naturaleza. E assy los neblis siguen estas aves e atraviessan todo el mundo. E yo ove un falcon nebly que era muy buen altanero, e llamavalo Poca Ropa, e fue tomado en Plazençia, e dixome el redero que lo tomara que le cayera en la red con unas palomas torcazas en pos que el venia e dezia que las palomas trayan los papos llenos dela fruta dela haya que llaman ho, e aquella mañana la avian comido, e non fallamos que oviesse aya fasta Vila Franca de Montes d’Oca, que avia bien sesenta leguas de ally, e por tanto puedes entender la traviessa que las aves fazen. Nel codice napoletano23 (c. 56v.) leggiamo: 21 J. M. FRADEJAS RUEDA, Archivo Iberoamericano, cit., http://www.aic.uva.es/clasicos/ayala/ayalaintro.html. 22 P. LÓPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., pp. 193-194; corsivo mio. 23 D’ora in avanti esso verrà identificato con la sigla Ff adottata da Fradejas Rueda (J. M. FRADEJAS RUEDA De nuevo sobre los manuscritos, cit., p. 1106). 77 Y lo mismo dicen que hazen las codornizes porque muchas vezes con viento halla ombre muchas d’ellas de la otra parte de la mar y con otro viento parten de allí y vanse, y esto muchos lo vieron. Otrosí se van las aves por naturaleza, commo son neblíes y otras aves, y atraviesan todo el mundo, y podéys entender de la travesía que hazen las aves. In altri casi le omissioni riguardano il riferimento alle auctoritates; all’inizio del già citato capitolo sulle migrazioni degli uccelli si chiarisce24: Muchas vezes avemos dicho en este libro como los falcones neblis e otros vienen con el passo delas aves en esta tierra, e agora queremos dezir que passo es este delas aves de que fazemos mençion. E deveys saber que a todas las cosas que Dios Nuestro Señor crio dio su governamiento e por hordenamiento dela natura an su industria para bevir. E por ende dize el propheta David en el psalmo alabando a Dios e a las sus obras, dize asy: el Señyor que da a las bestias su mantenimiento a ellas pertenesçiente, e esso mesmo a los pollos fijos delos cuervos clamantes a el. E dizen los filosofos naturales que el cuervo, quando vee los fijos sallidos delos huevos cubiertos de pelo blanco, que los non conosçe por sus fijos, porque los vee blancos e que non son de su color e aborresçelos, e non los quiere çevar nin dar de comer. E en aquel tienpo que ellos assy estan desenparados delos padres abren las bocas, dando bozes con la fanbre, e ally pegansele mosquitos e formigas de que se mantienen. Otrosi se mantienen del rozio del çielo, abriendo las bocas, fasta que van cobrando el su pelo prieto que han de su naturaleza, e los van conosçiendo el padre e la madre por sus fijos, e los tornan a governar. E assy provehe Dios a homes e animalias e aves, segun que en muchos logares se podra poner en enxenplo. Ff (c. 56r.) riporta: Muchas vezes he dicho en este libro commo los falcones, ansý neblís commo otros, vienen en el paso de las aves en esta tierra que tenemos. Pues es razón que sepáys qual es el paso de las aves que Dios Nuestro Señor provee a los ombres, y animales, y aves, según que de muchos lugares se podría provar por enxemplo. Il particolare appare ancor più evidente nel prologo, assai più sintetico di quello che si legge nel Libro de la caza de las aves; in quest’ultimo sono individuabili tre sezioni, rappresentate dal richiamo alle auctoritates, da un discorso dedicatorio e autobiografico circa le ragioni che hanno spinto l’autore a comporre il trattato e dalle riflessioni sull’utilità dell’esercizio della falconeria; in Ff vengono omesse del tutto le prime due parti, mentre la 24 P. LOPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., p. 192. 78 terza appare fortemente compendiata, come risulta dal prologo qui riportato integralmente: Ff (c. 1r.): Nuestro Señor quando crió el mundo hizo el ombre, crió todas las aves para su mantenimiento y ansý mesmo que unas aves tomasen a otras y para que los ombres toviesen su exerçiçio, porque todavía no estoviesen ociosos. Porque la oçiosidat causa muchas vezes el pecado y el ombre que tal pasa tiempo siempre toviere, bivirá muy sano y quito de pecado y de otros malos vicios. Y por esto los reyes y grandes señores han plazer de lo usar y de tener consigo ombres que sepan bien exerçitar esta arte, porque mejor sean servidos d’ella. Pero los tales ombres han de ser bien contentos de las cosas que han menester porque el oficio es muy trabajoso porque lo puedan bien hazer. Y por los que gana tienen de hazer esta arte no la saben commo el que mucho la ha usado quise aquí poner de lo que se me entiende, porque en alguna manera se avisen lo25 que dicho tengo. Ansý de gavilanes commo de açores, falcones, esmerejones y alcotanes. Il passo ora evidenziato induce una riflessione: il fatto che l’anonimo redattore ometta gran parte del prologo e in particolare proprio i brani in cui l’autore si cita26, pare mostrare una precisa volontà di appropriazione, attraverso il rimaneggiamento, del testo. Tale impressione sembra trovare conferma nell’analisi dell’ottavo capitolo, dedicato all’addestramento dei rapaci; nel Libro de la caza de las aves ad una parte introduttiva concernente il nibbio segue una lunga serie di reglas per il mantenimento di questo e altri uccelli da preda27; in Ff invece la sezione si arresta prima dell’elencazione delle regole, che tuttavia non vengono omesse, ma trasferite al capitolo successivo e intersecate ai contenuti di quest’ultimo, in gran parte tralasciati; accade così che il nono capitolo, pur mantenendo lo stesso titolo (commo se deve alinpiar el falcón del piojo, c. 12v.), sia in realtà costituito da ampie porzioni dell’ottavo, peraltro spesso riassunte, parafrasate o trasposte, a cui si alternano brevi brani del nono, anch’essi tuttavia variati. Il passo che segue potrà rendere l’idea: Ms.: los. “Al muy honrado padre e señyor don Gonçalo de Miena, por la graçia de Dios Obispo de Burgos, Pero Lopez de Ayala, vuestro humil pariente e servidor, me encomiendo en la vuestra merçed” (P. LOPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., p. 49). 27 Ivi, pp. 82-102. 25 26 79 Ff cap. .ix. (cc. 13r.-13v.) Libro de la caza de las aves28 E quando lo lavares busca ombre que te ayude y que sepa bien cogello, y hazle vañar en esta manera: toma agua tivia, y échala en catino o artesa, y echa dentro una onza de pimienta bien molida y çernida, y allí lo vaña bien, de manera que no quede nada d’él por vañar. Este vaño le darás antes que le comiençes a hazer porque, si después de començado de ha hazer se lo dieses, reconoçería rostro y mano, y avría grand enojo d’ello, de manera que lo que en él ovieses hecho, no aprovecharía nada. Este vaño le asegura mucho y no se deve dexar de hazer si el falcón tiene buena carne para lo sofrir, commo dicho tengo. E después que fuere vañado, enbuelvelo en unas tonajas o paño que sea linpio y déxale la cabeça y los pies de fuera y ponlo al sol, hasta que esté medio enxuto, porque allí reçiba muy bien el vaño. Y después quítale el paño y tenlo en la mano, las espaldas al sol porque luego sale el piojo, y toma una cañuela y quítaselos todos. Otrosí, desque fuere vañado, guarnéçele de buenas piuelas, y cascaveles, y de buen capirote. (cap. 8) Otrosy es bueno que este bañio le sea luego fecho antes que comiençe en el fazer ninguna cosa, ca sy lo [començasses] a amansar e fazer conosçer la mano e el señuelo e el rostro del hombre, todo lo perderias e desto nasçeria quando lo cogiesses para lo bañiar e le fiziesses algun sinsabor, e por tanto es bien lo primero que passe aquella malenconia e trabajo, e dende adelante fazerle bien e non le enojar. …sy piojo ovieren es mejor bañio del agua e pimienta, segun adelante diremos. (cap. 9) …e tomaras para un falcon una onça de pimienta bien molida e çernida, e un quarto de onça de fabarraz molido, e atalo en un trapo, e pon en un bacin o en una gamella pequeña del agua tibia e algun vino blanco quanto el quarto, e faz sallir toda la fuerça delos polvos de la pimienta e fabarraz que tienes en el trapo en el agua… E desque bien lo ovieres assy bañado e requerydo, enbuelvelo en un paño de lino blanco e linpio, e este asy encamisado una pieça ençima de un hazeruelo, e despues desenbuelvelo e tomalo en la mano, e tenlo al sol fasta que se vaya enxugando e veas sallir el piojo, e tiragelo con una caña asy como fuere saliendo. (cap. 8) Otrosy, despues que tu falcon fuera bañiado del piojo, guarneçelo de buenas piuelas e cascaveles e capirote. Il raffronto fra i due brani mostra chiaramente come in Ff l’originario passo del cap. 8 venga variamente organizzato, parafrasato e ad un certo punto interrotto dall’inserzione di porzioni del cap. 9 concernenti metodi di cura – peraltro con una semplificazione nelle componenti della ricetta – per poi essere ripreso con l’ultima frase. Sintomatica appare l’omissione 28 Ivi, pp. 84; 103-104. 80 dell’espressione segun adelante diremos che nel Libro de la caza de las aves rimanda al capitolo successivo e che in Ff viene congruamente tralasciata, avendo operato la fusione di cui sopra; alla luce di ciò, il fatto che dell’originario titolo del cap. 8 (Como se deve governar e regir el falcon nebly, e çiertas reglas de platica para ello) venga omessa la seconda parte (e çiertas reglas de platica para ello) non può essere casuale, ma lascia intravedere una precisa intenzione di dislocare diversamente questa porzione di testo. Oltre a colpire aneddoti e riferimenti alle auctoritates, la tendenza al compendio si manifesta anche a livello delle descrizioni etologiche e dei sistemi di cura; nel primo capitolo nei due testi si legge: Libro de la caza de las aves29: Otrosy a otras aves que su mantenimiento solo es de carniças, e non toman aves bivas, asi como son bueitres, avantos, quebranta huessos. Otrossy ha otras aves que su mantenimiento es carniças, gusanos dela tierra e frutas, asi como son cornejas, picaças e otras. Otrosi ha otras aves, que su mantenimiento es de simientes, assi como sson abutardas, gruas, perdizes, palomas, tortolas, paxaros. Otrosy ha otras aves que su mantenimiento es de pescados, asy como aguila pescadora e alcatrazes e otras aves de mar. Otrosi ha otras aves que andan ribera delas aguas, e su mantenimiento es peçes menudos e gusanos de los que se crian en el agua, e paçen fuera en las yervas, asi como son anades, cisnes, ansares bravas, e otras. E asy ha aves de muchas maneras e diversas, e de diverssos governamientos. Pero de todas las aves las mas linpias son aquellas que solamente se mantienen de aves bivas… mentre in Ff (c. 3r.): Otrosý ay otras aves que sus mantenimientos no son de carne y no matan aves vivas, ansí commo son buytres, y avancos y quebrantahuesos. Pero de todas las aves de rapiña son estimadas aquellas que solamente se mantienen de aves bivas… o ancora nel cap. 46 (De como se deven enxerir las péñolas quebradas): Libro de la caza de las aves30: Otrosi, si la peñola o pluma es quebrada por lo maçiço, por qual quiere logar que sea quebrada, o por lo mas delgado o por lo mas grueso, tajagelo lo que estoviere marrotado e toma la otra peñola que traes e conçierta las peñolas, en guisa que venga nin mas nin menos de la que ha menester e taja las dos peñolas tan bien del ave como la que traes estraña por esta guisa [disegno] car 29 30 Ivi, p. 58. Ivi, pp. 199-200. 81 se juntan meior en guisa que les non corten las plumas menudas de qual quier delas peñolas çerca del logar donde deven ser juntadas, que parescerian feas e non se encubrirya bien la enxeridura. E faz aquella cortadura delas peñolas con ganivete bien agudo, e moja las dos peñollas en el logar do se han de enxeryr con agua tibia por que enternescan, e desy toma el aguja de enxerir que es fecha assy: [disegno] E estas agujas an de ser bien delgadas, las unas mas gruesas que otras, e otras delas pequeñas, cada una segunt la peñola que se deve enxeryr. E sean todas de tres esquinas de cabo a cabo... Ff (c. 58v.) Otrosí, si la peñola fuere quebrada por lo mazizzo, por qualquier lugar que sea, o por lo más delgado, o por lo más grueso, corta lo que está malrotado, y toma la peñola que quisieres, y enxiérela, y conçiértala con ella que venga ni más ni menos que han menester, y tanbién corta las dos peñolas, la de la ave commo la que traes, de manera que venga ygual de cada cuchillo su compañero. Y toma una aguja de tress esquinas aguda de cada vanda y enxiérela allí… La tendenza al compendio non esclude tuttavia la possibilità di aggiunte anche assai estese: alcune di esse risultano percepibili sin dal confronto fra le tavole dei capitoli, che sono 47 nel Libro de la caza e 49 in Ff; lo scarto è dovuto alla presenza di due sezioni (Capítulo .xvij°.: Del falcón que tiene el papo roto; Capítulo .xxxiij°:: Del falcón que tiene güérfago) che non compaiono in nessun altro dei testimoni conosciuti, ad eccezione del ms. BN de España, 1032131. In altri casi si tratta dell’inserimento di ricette collocate non solo al termine del testo, come accade in altri codici32, ma intercalate nel corpo dei capitoli, come si riscontra nel cap. 933 o ancora nel cap. 15 in cui per la cu- 31 “Este manuscrito [Ff] se relaciona estrechamente con el ms. 10321 de la BN de España (sigla Q). Ambos presentan dos capítulos que no aparecen en ninguna otra copia de la obra” (J. M. FRADEJAS RUEDA De nuevo sobre los manuscritos, cit., pp. 1107-1108). Il codice, pur se noto sia a Cummins (Libro de la caça, cit., p. 29) che a Delgado Montoto, non appare collocato a livello stemmatico (J. G. CUMMINS, Libro de la caça, cit., p. 36; J. M. FRADEJAS RUEDA De nuevo sobre los manuscritos, cit., p. 1115, in cui viene riprodotto, con alcuni aggiustamenti, lo stemma messo a punto da Delgado Montoto). 32 In parte della tradizione manoscritta del Libro de la caza de las aves in coda al testo compaiono delle recetas varias; si vedano le descrizioni codicologiche di J. G. CUMMINS, Libro de la caça, cit., pp. 23-32 e di J. M. FRADEJAS RUEDA De nuevo sobre los manuscritos, cit., pp. 1101-1113. 33 Ff (c. 15v.): “Si no hiziese dalle otra, que reçibiría gran daño, salvo dale una píldora que sea tamaña commo una avellana, la qual harás en esta manera: toma una poca de oruga que sea muy molida, y amásala con un poco de miel, y coje tu falcón, y ábrele la boca, y échasela, y dende a poco la regitará con todo lo que en el vientre toviere o en el buche abueltas d’ella, y por esto no dexará de caçar a la tarde. Y si esto no hizieres hazer e el falcón guarda la pluma commo dicho tengo, dale a la noche una pluma hecha de un poco de lienço delgado o de sedeña con un poco de carne, porque la lleve de mejor gana al buche”. 82 ra del falcón que tiene güérmezes vengono proposti rimedi diversi34; possono essere aggiunti degli aneddoti, come nel caso del cap. 735; esistono inoltre sezioni come la decima in cui, a dispetto del titolo uguale, il contenuto del capitolo nei due testi appare in gran parte sostanzialmente diverso. Ancora in tema di aggiunte si deve segnalare la presenza alla fine del testo (c. 62r.) di una Tabla de las diferencias de los nombres de las medeçinas d’este libro che pare non semplice appendice, ma complemento indispensabile del trattato36. Il confronto fra i passi sopra riportati mostra come anche là dove Ff è paragonabile con il Libro de la caza de las aves esso presenti molte varianti; rinviando ad altra sede l’esame puntuale delle lectiones singulares, si riportano qui di seguito alcuni esempi che mostrano l’affinità di Ff con alcuni testimoni della tradizione manoscritta del Libro de la caza de las aves. Nel terzo capitolo dell’opera del Cancelliere si legge37 que aya deribadas las espaldas, e gran mano mentre Ff (c. 9r.) riporta que tenga derribadas las espaldas, y gran carne, lezione condivisa dai mss. siglati F e T38. In altri casi le corrispondenze di lezioni delineano una situazione più complessa sul piano stemmatico,39 come nel caso della variante y úntale las manos con meollo de carrillada de puerco (c. 39r.), a fronte di e untale los pies con el tuetano dela carrellada del tocino40, Nel Libro de la caza de las aves (P. LÓPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., p. 120) si dice “ponle dela miel en aquellas llagas e luego guarescera” mentre in Ff (c. 26r.-26v.) il consiglio è “lava bien aquel lugar con vino puro y, después de bien enxuto, échale un poco de zumo de limón e si limón no oviere, échale un poco de tinta”. 35 Ff (c. 11v.): “Y de todas las aves después de los neblís esta es la mejor suerte de falcones que sea en el mundo y más amigables al ombre porque comúnmente no ay ninguno d’ellos malo, avisándote que yo tuve un alfaneque que era el mijor del mundo y llámase Pero Díaz, por respecto de un alconero que lo traya y mudava suelto por casa, salvo que traya un cascavel porque fuese sentido por donde andava”. 36 Fradejas Rueda nota che “Esta tabla parece que está construida a partir del texto de Ayala ya que al final de ella se dice “Otra suelda compuesta hallaras aqui en este libro en el capitulo ultimo”( J. M. FRADEJAS RUEDA De nuevo sobre los manuscritos, cit., p. 1107). 37 P. LOPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., p. 70. 38 Si tratta dei mss. BN de España, 3350 (XVII sec.) e University of Yale, Beinecke Library, 138 (XV sec.). 39 J. M. FRADEJAS RUEDA De nuevo sobre los manuscritos, cit., p. 1115. 40 P. LOPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., p. 149. 34 83 in cui Ff condivide il tipo meollo non solo con F, T ma anche, con lievi varianti, con i mss. H, I, L, M, O, X, appartenenti a rami diversi, o ancora: Ff (c. 46r.): si quisieres que lo logre (FHIST: logra: M: lograr; X: lograre) invece di sy vieres que la come41; Ff (c. 48v.): y tórnaselas en su lugar, y cósele aquel lugar por do salieron (FITX: e tornale las tripas en su lugar, y cose aquel lugar…) a fronte di e tornale las tripas en su lugar por do salieron42, caso analogo a Ff (cc. 51v.-52r.) tórnalo a la muda, y atápale bien la muda, de manera que sea bien escura (FIOTX: tórnalo a la muda, y atápale bien la muda, que sea…) invece di tornalo a la muda que sya bien escura43. Ff non è immune da errori: nel primo capitolo del Libro de la caza de las aves44 si legge otrosi avia gran diferençia de saber fazer una ave a la saber guareçer e ser buen açetrero; in luogo di açetrero Ff riporta secreto, banale errore in fase di copiatura dalla genesi facilmente comprensibile; nel cap. 28 (29 in Ff) leggiamo: e la simiente dela yerva menudilla que llaman suelda menor, e simiente de mastuerço, e suelda raca, e dela momia sea la mayor parte e suelda menudilla la quarta parte45; Ff (c. 40r.) reca: y la simiente que llaman yerva menudilla, que es suelda menor, la quarta parte y simiente de mastuerço y fiel de vaca, y de la momia sea la mayor parte y de la suelda menor la quarta parte; nella frase si individuano due errori, l’uno dovuto al fraintendimento in fase di lettura di suelda raca, alterato in fiel de vaca, e l’altro nell’indebito inserimento di la quarta parte, poi annullato da sottolineatura, dopo il primo suelda menor dovuto all’attrazione dell’espressione suelda menor la quarta parte che ricorre poco dopo; tali errori denuciano chiaramente il carattere di copia di Ff46. Molti sono inoltre i sauts du même au même rilevabili nel testo, come nel Ivi, p. 165. Ivi, p. 172. 43 Ivi, p. 179. 44 Ivi, p. 59. 45 Ivi, p. 152. 46 Su questo punto non deve indurre a conclusioni affrettate quanto si legge in corrispondenza del cap. 46 (c. 56r.), mancante, in cui dopo il titolo De los alcotanes si legge este capítulo no le allé en el original y por tanto no le puse aquí; come osservato da Cummins (Ivi, p. 191), “Este capítulo falta en todos los manuscritos. H (fol 61r) hace alusión a él (capitulos alcotanes y no esta escryto nada de ellos); I pone el título, pero el resto del folio 62r queda en blanco”. 41 42 84 secondo capitolo in cui nel Libro de la caza de las aves47 leggiamo E los falcones neblis en todas tierras son llamados gentiles, que quiere dezir fijos dalgo, e en Castilla e en Portugal son llamados neblis; pero al comienço fueron llamados nobles, e por tienpo corrompiosse este vocablo e dizenlos neblis mentre Ff (c. 5r.) riporta Y los falcones neblís o pelegrinos en todas las partes los llaman nobles e por tienpo corrompióse este vocablo y llámanlos neblís. Gli esempi ora riportati, piccolo campionario delle particolarità degne di nota, consentono di formulare alcune prime ipotesi circa il trattato contenuto nel codice di Napoli: se un testimone va relazionato con la volontà creativa dell’autore dell’opera che trasmette, è evidente che il manoscritto in oggetto non pare più riflettere la volontà di Pero López de Ayala bensì un’intenzione successiva, quella di un rimaneggiatore che, partendo da un codice dell’opera del Cancelliere, ha inteso abbreviarne e modificarne il contenuto facendolo in qualche modo proprio; la stessa costante sostituzione, negli aneddoti conservati, dell’appellativo Rey Don Pedro con Rey Don Johán non può essere casuale, ma deve far riferimento ad una mutata situazione storica, familiare all’anonimo redattore. L’analisi complessiva delle varianti, nella corrispondenza fra alcune delle quali si è rilevato il ricorrere di certe sigle, nella fattispecie F e T, nonché la stima degli eventuali rapporti con il ms. Q, potrà forse gettare maggior luce sul codice, probabilmente vicino al ramo di tradizione β, su cui è stato modellato Ff, ma non potrà oscurare il fatto che le sue peculiarità lo pongono in una posizione eccentrica nel contesto della tradizione manoscritta del Libro de la caza de las aves. La sistematica eliminazione degli aneddoti, dei riferimenti alle auctoritates e di qualunque rivendicazione di paternità che renda il testo riconducibile alla biografia del Cancelliere, la tendenza alla sintesi nelle descrizioni etologiche e dei sistemi di cura cui fa da contraltare l’aggiunta di interi capitoli, di singole ricette, di altri aneddoti o di porzioni di frasi qua e là, la propensione alla parafrasi raggiungono una portata tale da allontanare Ff dal semplice status di copia del Libro de la caza de las aves, facendone qualcosa di diverso rispetto ad altri manoscritti48, come quelli caratterizzati dell’appendice costituita dalle recetas varias; se queste ultime hanno indotto Fradejas Rueda a concludere che “algunos de los antiguos propietarios de varios manuscritos de la obra de Pero López de Ayala eran cetreros que se preocuparon por anotar en sus manuales de cetrería otros remedios distintos de los propugnados por el Canciller, lo cual demuestra la naturaleza abierta Ivi, p. 62. Si veda ad esempio il ms. O (Madrid, Real Biblioteca, II/1366) che a partire dal cap. 29 “empieza a omitir palabras no esenciales y a parafrasear” (P. LOPEZ DE AYALA, Libro de la caça, cit., p. 29). 47 48 85 de estas obras”49, le particolari condizioni del trattato in oggetto, in cui gli interventi appaiono qualitativamente e quantitativamente più massicci, inducono a ritenere non solo che il suo redattore fosse un falconiere ma che egli, come altri prima e dopo di lui o come lo stesso López de Ayala, intendesse “tomar prestado de obras anteriores y de gran prestigio lo que interesaba y reelaborarlo con mayor o menor habilidad”50. Riconoscere l’indipendenza delle altre opere sopra citate, il cui debito nei confronti del trattato del Cancelliere è ben noto, comporterà la necessità di riflettere sulla collocazione da attribuire al trattato in oggetto; la questione appare delicata e apre una serie di interrogativi che solo una valutazione della tradizione manoscritta che tenga conto delle modalità tutte particolari di trasmissione del sapere scientifico, e cinegetico in particolare, potrà aiutare a chiarire51. Archivo Iberoamericano, cit., http://www.aic.uva.es/clasicos/recetas/recetas-intro.html J. M. FRADEJAS RUEDA, La originalidad, cit., p. 88. 51 In fase di correzione di bozze ho avuto modo di consultare l’edizione di M. Delgado Montoto (Edición crítica del Libro de la caza de las aves de Pero López de Ayala, Madrid, Ediciones Calasancias, 2006). Dati i lievi scarti nei passi citati, ho preferito comunque in questa sede mantenere i riferimenti all’ed. Cummins per il testo, mentre ho privilegiato il saggio di Fradejas Rueda (De nuevo sobre los manuscritos, cit.) per lo stemma e le relative sigle che offrono caratteri di maggiore sistematicità. Dai dati ricavabili dall’ed. Delgado Montoto pare comunque di poter confermare le affinità del codice di Napoli con i testimoni qui evidenziati, reperendo elementi che rafforzano inoltre la parentela con Q. 49 50 86 LA FINZIONE EURISTICA Gabriella Bosco Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi (Sophocle, Œdipe Roi, v. 1149, nella traduzione manipolata di A. Robbe-Grillet) C’è un legame che collega il progetto epico secentesco e una certa parte della narrativa contemporanea, quella che stabilisce un rapporto nuovo tra il soggetto e il reale a partire dalla constatazione dell’impossibile di quest’ultimo. Vale a dire, esiste un legame piuttosto stretto tra i miei interessi di ieri e quelli di oggi. Lo scopro adesso che ne costruisco il racconto. Alain Robbe-Grillet avrebbe detto che è il lavoro testuale a produrre la diegesi. Più prosaicamente, io dico che si capisce dopo la direzione che si è presa prima. Quando pensai che il più interessante, tra i discorsi proposti dalla francesistica torinese, fosse per me quello di Daniela Dalla Valle, su Manierismo e Barocco, limiti di genere, superamento degli stessi, fratture e alterità, mi parve che le ragioni della mia adesione stessero essenzialmente in una caratteristica comune a tutte le nozioni e i testi indagati dalla studiosa: il loro mettere in campo, in maniere sia pure varie e diverse, una trasgressione. Mi parve che si individuasse un ambito di creatività letteraria all’interno del quale il punto saliente potesse essere considerato la volontà di mettere in discussione, attraverso la pratica, la regola letteraria – per come era venuta progressivamente a costituirsi e poi fissarsi in canone sotto forma di auctoritas. Trasferitami a Parigi per svolgere le ricerche necessarie all’elaborazione della mia tesi di dottorato alla Bibliothèque Nationale della rue de Richelieu – la vieille dame con i suoi straordinari trompe-l’œil di cui già all’epoca mi affascinava il carattere di ambiguità – mi organizzai per dividere la mia giornata in due tranches: dalle nove del mattino alle tre del pomeriggio lavoravo alla B.N., dalle tre del pomeriggio alle nove di sera per il giornale. Con un colpo di fortuna fortemente favorito, devo riconoscerlo, da alcune persone cui rendo qui il dovuto grazie – essenzialmente Giorgio Calcagno e Lionello Sozzi – avevo potuto realizzare un virtuoso emploi du temps che mi permetteva di guadagnare con il lavoro pomeridiano il necessario per 87 poter vivere a Parigi e proseguire lì le ricerche mattutine. Dalle nove alle tre, insomma, al posto 302 della sala di consultazione della Nationale, e molto spesso a uno dei tavoli dell’Hémicycle, lessi e annotai per vari anni la maggior parte dei poemi epici scritti in Francia tra fine Cinquecento e fine Seicento. Gli amici dell’epoca scherzando dicevano che con tutta probabilità ero l’unica persona al mondo ad aver letto quei testi, la cui sola dignità letteraria riconosciuta stava in un luogo comune molto diffuso, di origine volterriana: quello secondo cui “les français n’ont pas la tête épique”. Perché proprio quel genere? Da un lato per l’incoraggiamento di Daniela Dalla Valle – si trattava di un ambito poco studiato, andava sondato ed era più facile trovare qualcosa da dire che non fosse già stato detto – dall’altro, cosa non meno interessante, per la fama d’illeggibilità di quei poemi, ciò nonostante così numerosi, pieni di storie e dotati tutti di prefazioni che per lo più assumevano i tratti dell’arte poetica. In poche parole, quegli autori – eretici rispetto ai sostenitori dell’imitazione come principio principe dell’arte – spostavano l’inventio nel campo della dispositio ribaltando così, in qualche modo, i dati della questione. Per loro, che essendo cristiani accettavano l’intoccabilità dei soggetti religiosi quanto ai fatti, l’invenzione stava in una disposizione nuova di quei fatti. Se Dio aveva creato il mondo, loro lo ricreavano attraverso la scrittura ed era grazie a questa disposizione inventata – questa finzione – che il reale dischiudeva nuovi significati. Veniva così a cadere il criterio della coerenza, ovvero della corrispondenza necessaria rispetto alla realtà, già allora a partire da una relativizzazione del concetto di mimesi. L’essenziale – l’utile e il dolce – del testo, stava infatti non nella sua maggiore o minore capacità di riprodurre il creato, bensì all’opposto nella sua potenzialità di creare altro, un oggetto letterario capace, attraverso il suo linguaggio specifico, di dire – e dire in molti svariati modi – ciò che il reale può solo mostrare e in una forma data. Per i sostenitori del canone secentesco, che sarebbe stato codificato a posteriori da Nicolas Boileau nel suo Art poétique (1674), un atteggiamento di quel genere comportava contemporaneamente due infrazioni grandiose: in primo luogo, era assolutamente vietato far poesia a partire da soggetti religiosi – intoccabili in quanto tali – mentre si poteva pescare nel grande repertorio della favola pagana; in secondo luogo, se il soggetto poteva essere inventato, trattandosi per l’appunto di fabula, la sua disposizione invece non doveva essere toccata, e doveva essere mimetica quanto più possibile rispetto al reale. Un progetto poetico tanto eversivo, che nel corso del secolo – messo in pratica – avrebbe potuto portare all’elaborazione dell’auspicata epopea 88 moderna – era stato enunciato sin dal 1610, da Guillaume de Saluste Seigneur du Bartas1 (autore, tra l’altro, di un poema cosmologico – La Semaine – una fantasmagorica Genesi barocca, pubblicata nel 1578, la cui continuazione – La seconde Semaine ou Enfance du Monde – rimase incompiuta per la sua morte sopravvenuta nel combattere contro la Lega a Condom) e avrebbe trovato il suo più entusiasta e pieno esecutore in Jean Desmarets de Saint Sorlin2. Quest’ultimo, in quello che può essere considerato il suo personale Art poétique in versi, L’excellence et les plaintes de la poésie héroïque3, afferma che “l’héroïque vers seul peut faire un héros”, ed anche che “ce que produit l’esprit rend l’eprit satisfait”4. Il ragionamento di Desmarets era questo: nella storia ci sono stati tanti grandi personaggi – i buoni, gli abili, i giusti, i saggi, i valenti, i pii... – ma le azioni eroiche da essi compiute, perché esistano realmente, necessitano di qualcuno che le crei linguisticamente, perché possano essere lette, possano piacere e possano di conseguenza diventare esemplari. Tutti gli elementi della natura che ci circondano, scriveva Desmarets, testimoniano dell’onnipotenza di Dio, ma poiché la mente si compiace solo della propria creazione, perché il senso di tutto ciò che è creato possa giungere alla mente umana è necessario che l’uomo – il poeta – lo ricrei con le parole. Diventi insomma il Dio della propria Creazione. È grazie infatti a questa ricreazione che viene svelato anche ciò che la semplice osservazione del reale non permette di cogliere. L’atto poetico così concepito: Perce les veritez, et les choses obscures, Dans les pressants besoins d’un destin rigoureux Fait descendre du Ciel les Anges bienheureux, Fait parler les Demons, et dans les creux abysmes Va chercher aux Enfers la source des grandes crimes5. Quanto al poeta che così intende la sua opera: ... produisant au jour ce qui ne fut jamais Nell’Advertissement au Lecteur per l’edizione delle sue Œuvres complètes (Rouen, éd. Ovyn), testo in cui du Bartas risponde alle eventuali critiche che qualcuno potrebbe rivolgere alle sue Semaines. Questa edizione del 1610 essendo in realtà postuma, l’Advertissement è dell’editore, che lo scrisse però – afferma - citando parole dell’autore. 2 Noto soprattutto per la commedia Les Visionnaires, il suo testo di maggior successo, Desmarets è autore di numerosi poemi epici e di ancor più numerosi testi di teoria poetica che, nel loro insieme, fanno di lui il maggior artefice – a più largo raggio – dell’epopea moderna in Francia. 3 Testo pubblicato come prefazione a Esther, poème héroïque composé et dédié au Roy par le Sieur de Boisval (Jean Desmarets), Paris, 1670. 4 Ibid. 5 Ibid. 1 89 Imite du grand Dieu les admirables faits6. A monte c’era la teorizzazione tassiana, avendo gli epici francesi secenteschi potuto leggere in traduzione la Gerusalemme e i Discorsi dell’arte poetica e in particolare sopra il Poema eroico. Era stato Tasso in effetti a dire: “Tolgasi l’argomento dell’epopeia da istorie di vera religione, ma non di tanta autorità che siano inalterabili”7. Per lui, la limitazione di campo nasceva dal tentativo di realizzare un compromesso tra la modernità del suo progetto poetico e l’interpretazione acquisita dei precetti aristotelici. In Francia, da parte di autori che per lo più erano esecutori di un progetto formulato da altri, essa diventava soprattutto il riflesso della volontà di non incorrere nella censura, pur nell’accettazione di un percorso innovativo. Ma Desmarets, quanto a lui, non sentiva l’imperativo della prudenza. Era del resto consapevole del carattere artificioso di una differenziazione del genere. C’erano in effetti autori che ammettevano solo soggetti tratti dalla storia cristiana, altri che arrivavano a includere il Vecchio Testamento ma non il Nuovo, altri ancora che consideravano troppo elevati, come soggetti, solo Cristo e la Vergine. Egli allora liberava il progetto epico da qualunque riserva, lo teorizzava fino in fondo e soprattutto ne realizzava il paradigma completo scegliendo i suoi argomenti tanto nella storia del popolo cristiano, quanto nella Bibbia e nei Vangeli. E nel suo discorso Pour prouver que les sujets chrétiens sont les seuls propres à la poésie héroïques8, accusava d’incapacità coloro che proponevano l’esclusione delle verità troppo alte e anche, a più forte ragione, d’ipocrisia coloro che volevano limitare l’impiego del meraviglioso all’ambito delle azioni secondarie, cioè degli episodi. Per Desmarets, un’azione eroica imitata tale e quale dalla realtà, senza svelamento di ciò che si nasconde dietro di essa superandola, produceva solo della storiografia. Egli non poteva credere che si trattasse di rispetto per la religione: “L’Amour que l’on a pour une chose n’impose point le silence, mais il fait que l’on en parle avec autant d’estime & de respect que son excellence le merite”9. L’esempio più incontestabile per Desmarets era quello prodotto da Dio stesso: ... le verbe Eternel s’estant incarné pour nous enseigner ses plus hautes veritez, les a couvertes & insinuées sous des divines paraboles. La fiction ne répugne point à la vérité mais lui est une compagne très agréable, & comme Ibid. Il testo era del 1587. Cito da T. TASSO, Scritti sull’Arte poetica, Torino, Einaudi, 1977, tomo primo, p. 11. 8 Pubblicato come prefazione al Clovis ou la France chrestienne, poëme revu exactement, & agmenté d’invention, & des actions merveilleuses du Roy, par J. Desmarets de Saint-Sorlin, Paris, 1673. 9 Ibid. 6 7 90 son introductrice pour la faire bien recevoir; et jamais il n’a esté dit qu’un excellent tableau representant un miracle de l’ancien ou du nouveau testament, fust une chose contraire à la verité; bien que le Peintre y eust feint diverses choses que le saint texte ne particularise pas, mais qui sont convenables au sujet10. Varie cose che il testo sacro non specifica: qui sta l’essenza del nuovo progetto epico. Il soggetto è preso tale e quale; l’invenzione concerne ciò che il testo non specifica, cioè il modo di organizzare in racconto poetico il soggetto scelto, in una forma che sia degna della sua divinità. Questa creazione deve essere soddisfacente per lo spirito umano tanto quanto la creazione divina lo è stata per Dio. La specificità della poesia epica moderna consisteva insomma nel principio che autorizzava in essa qualunque invenzione. Se Dio, per un cristiano, coincideva con l’impossibile realizzato, e se la poesia epica era l’azione di Dio resa in versi da parte di colui che si faceva Dio tramite la scrittura, non c’era nulla che non potesse essere immaginato. La scrittura poteva e doveva essere l’impossibile detto. Nel ragionamento di Desmarets storiografia e racconto di finzione non differivano dal punto di vista della struttura: entrambe essendo trasposizione scritta di esperienze temporali, concatenamento di sequenze narrative in successione causale. Ma l’epopea, applicando i modi della finzione a soggetti reali, si faceva grazie a questo rivelatrice di verità. Inventando i nessi li svelava, ed ecco che la finzione si faceva euristica: quella cioè che elabora i fatti disponendoli in modo tale da permetter loro di mostrare il senso nascosto. Dire un dominio non dominabile – il reale – utilizzando il modello che organizza le relazioni di un mondo molto più dominabile – la finzione –, trasgredendo due categorie in una volta portava a (permetteva) un’interpretazione diversa del reale stesso. Il discorso, in tutta evidenza, era critico nei confronti delle rappresentazioni tradizionali. Determinava una relazione nuova tra il soggetto e il mondo degli oggetti rappresentati in cui, se la verifica non era più possibile, questo non corrispondeva alla rappresentazione di un reale inesistente, ma a quella di un reale considerato come principio di apertura e di innovazione continue11. Di tutto questo, dicevo prima, mi occupavo dalle nove alle tre. Poi dalle tre alle nove andavo per la città alla ricerca di argomenti per i miei articoli da mandare alla Stampa. Uscite di libri, spettacoli, mostre, eventi culturali in 10 11 Ibid. Cfr. G. BOSCO, Tra mito e storia, ed. dell’Orso, Alessandria, 1991. 91 genere. Ma fin da molto presto rivolsi la mia attenzione a un genere particolare, anche in questa tranche della giornata: la mappatura dei grandi vecchi ancora in vita, da andare a snidare e far parlare. La condizione era che, pur essendo vecchi negli anni Novanta del Novecento, avessero avuto un’ambizione grande (se non, per citare ancora Robbe-Grillet, “smisurata”), fossero stati cioè protagonisti nel XX secolo di innovazioni rilevanti – le loro personali trasgressioni – in fatto di scritture varie. Ce n’erano ancora parecchi e mi misi al lavoro. Ne ho incontrati un certo numero. “Così lei si introduce nelle nostre case e ci fa dire cose che a un francese non diremmo”, mi apostrofò un giorno sorridendo Julien Green, mentre parlavamo seduti sul divano del suo salotto12. Aveva ragione: in qualche modo, con domande da straniera ma non da giornalista13, inducevo quei grandi vecchi a raccontare certe avventure del Novecento in termini inediti. Fingevano? Non so, penso anche di aver sperato che lo facessero. Perché, così, davano un senso nuovo – che nasceva dal racconto lì per lì costruito – a vicende in precedenza troppo dibattute per apparire con chiarezza. Sono entrata in tante case. Mi piace ricordare soprattutto Eugène Ionesco, drammaturgo dell’insolito, che ho frequentato con particolare assiduità grazie alla benevolenza della figlia Marie-France14. Ma anche Robert Pinget, a lui molto vicino. E di quella generazione, ma di altra tendenza creativa, Nathalie Sarraute. Nell’ambito del Nouveau Roman, ho incontrato più e più volte Alain Robbe-Grillet, nelle sue due case, quella normanna e quella di Neuilly, cogliendo del suo percorso evolutivo la fase di svolta: la ripresa, in accezione kierkegaardiana, del lavoro sperimentale degli anni Cinquanta e Sessanta, volta allo svelamento di una scrittura che fin dagli inizi era stata autobiografica ma a partire da una concezione totalmente nuova di scrittura dell’io, che faceva sua attraverso Sartre la lezione husserliana: per dirla in sintesi, quella che – estroflessa la coscienza – determina il reale invece di venirne determinata (usando una formula di Barthes, che parla il mondo invece di parlare del mondo)15. E poi ho conosciuto alcuni rappresentanti dell’Oulipo di Perec e Calvino, meno vecchi rispetto ai precedenti, ma sempre convintamente oulipiani: Jacques Cfr. G. BOSCO, A casa loro, ed. dell’Orso, Alessandria, 2000, p. VII. Devo dir grazie, in questo caso, a Jean-Louis Courtault (allievo del grande comparatista Pierre Brunel e specialista di Claudel) che, dopo esser stato mio professore a Torino – lettore di francese all’Università – era diventato un caro amico, troppo presto scomparso. Finché la malattia glielo permise, accompagnò e incoraggiò il mio lavoro, consigliandomi l’approccio più giusto per i miei incontri. A lui devo, certamente, il fatto di aver perseverato nell’affiancare i due tipi di impegno lavorativo, quello di biblioteca e quello sul campo, anche quando certe circostanze sembravano scoraggiarlo. 14 cfr. G. BOSCO, Eugène Ionesco. Al di là del quotidiano, Ed. dell’Accademia, Torino, 2007. 15 cfr. L’Almanacco 2003. Il romanzo dell’io, a cura di G. BOSCO e G. CERRUTI, Portofranco, L’Aquila, 2004, pp. 54-59. 12 13 92 Roubaud e Harry Mathews. Persino un surrealista, forse l’unico in vita: Alain Jouffroy. Protagonisti di correnti di pensiero molto lontane da queste, come Jean Guitton, il filosofo, unico laico ad aver preso parte al Concilio Vaticano II, ma anche amico e confidente di Louis Althusser. Molti altri. Un solo rimpianto: non avercela fatta a incontrare Samuel Beckett. Sempre più mi interessava riflettere sul rapporto ormai definitivamente rivoluzionato, attraverso il lavoro delle avanguardie prima e delle neoavanguardie poi, tra scrittura e reale. Recensendo a tappeto i romanzi che uscivano in Francia, mi accorgevo di come diventasse predominante, nella pratica narrativa, il genere trasversale (o misto, o ambiguo) dell’autofiction, battezzato nel 1977 da Serge Doubrovsky16 – anche in questo caso largamente a posteriori rispetto alla messa in atto – e sempre più selvaggiamente strapazzato da autori che contaminavano l’autobiografia con la finzione o viceversa alla ricerca di una forma di romanzo che si caratterizzasse come alterità rispetto ai dogmi ormai desueti della rappresentazione e dell’espressione. Entravo in relazione allora, da questo indotta, con chi – parallelamente ai nouveaux romanciers e a mio parere solo pretestuosamente spesso in conflitto con loro – aveva, negli anni Sessanta e Settanta, lavorato sperimentalmente alla rivoluzione del linguaggio poetico, sulla scia di Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont e anche, in parte, di Breton: i telqueliens. Philippe Sollers in particolare, ma anche Julia Kristeva e Jacques Henric. Sollers che, passando da Tel quel a L’Infini, rivista nata dalle ceneri della prima, aveva condotto a conseguenze estreme la sperimentazione di un tempo, riportando sulla pagina narrativa un soggetto, un je, il cui statuto – dopo la morte dell’autore sancita da Barthes – non poteva più essere quello di una volta. Un io prodotto, in altri termini, dal lavoro testuale. Siamo all’oggi, alle ricerche narratologiche che da qualche tempo conduco intorno all’ultima invenzione teorica francese, non ancora dotata di un nome – se non da qualcuno come réélisme (ogni nuova teoria comporta i suoi neologismi), definizione che non mi convince – e che io per ora chiamerei teoria del roman vrai. Generato da Auschwitz e dalla bomba H, dall’osceno insomma, romanzo del dopo-storia, è quello che – riflettendo sull’impossibile e il negativo alla maniera di Lacan (le réel est l’impossible, le réel est ce contre quoi je bute) e di Bataille (la part maudite, le coupable), si sforza di rispondere all’appello che questo reale impossibile rivolge a ciascuno di noi, ma contemporaneamente cerca di rispondere del reale. Il principale rappresentante ne è Philippe Forest, erede di Tel quel per certi versi, ma incamminato su una strada ormai sua, teorico e narratore insieme, alla ri16 S. DOUBROVSKY, Fils, Galilée, Paris, 1977. 93 cerca di un romanzo per così dire testimoniale. Una forma di letteratura cioè, consapevole del carattere inevitabile di finzione che comporta la mise en récit dell’esperienza, che vuol mettere a punto un linguaggio romanzesco capace di ricreare sulla pagina quell’esperienza e, qualora da qualche parte esista, di svelarne se non tutto il senso, almeno una parte di esso. 94 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E TRADUZIONE Maria Margherita Mattioda In questo lavoro intendiamo presentare alcune riflessioni scaturite dalla nostra esperienza nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Traduzione francese relativa al campo della traduzione pubblicitaria1. Nel corso degli anni ci siamo interessati alla comunicazione aziendale nella sua forma specifica di comunicazione esterna mirata alla promozione commerciale e imperniata sulla pubblicità quale attività diretta a “favoriser la transmission d’une information commerciale motivante sur l’offre proposée afin de convaincre le client que cette offre répond exactemement à ses besoins”2. Benché non si possa ridurre quest’ultima ad una sola definizione, in quanto le tecniche da essa utilizzate sono multidisciplinari, è evidente che si tratta di uno degli strumenti della politica di comunicazione di maggior efficacia per sostenere il successo commerciale delle offerte dell’organismo emittente. In tal senso è strettamente vincolata alle strategie di mercato adottate dalle imprese e concorre, unitamente alle altre componenti del marketing, a stabilire e mantenere il contatto con il target prescelto per un determinato tipo di prodotto. Se agli albori e per i decenni successivi l’approccio alla pubblicità è stato soprattutto di natura persuasiva e suggestiva, attualmente gli studiosi tendono a considerarla come uno “strumento che funziona (…) stimolando il crearsi di un ambiente mentale, un contesto culturale e una disposizione d’animo favorevoli che potranno successivamente tramutarsi nell’azione desiderata”3. Tale differente paradigma interpretativo, che colloca il messaggio pubblicitario in un contesto culturale strutturato, implica il riconoscimento dell’interazione di almeno tre componenti dinamiche (cognitiva, affettiva, comportamentale) a cui si 1 L’oggetto della ricerca è stata l’analisi contrastiva della pubblicità stampa di aziende italiane e francesi. Ringraziamo gli studenti che hanno collaborato alla raccolta del corpus mediante Dossiers, alcuni dei quali sono stati ampliati in tesi di laurea (B. Rivero, Stratégies d’adaptation culturelle dans le marketing international, a.a. 2007/2008). 2 D. CAUMONT, La publicité, Paris, Dunod, 2001, p. 12. 3 Cfr. V. CODELUPPI, La pubblicità, Milano, Angeli, 1997, p. 17 e D.A. AAKER, J.G. MYERS, Management della pubblicità, Milano, Angeli, 1991, p. 142. 95 deve apporre una quarta dimensione culturale/contestuale. Inoltre, influenza in una certa misura il comportamento delle aziende che, se intenzionate a presentarsi su mercati internazionali, devono sempre più tenere nella giusta considerazione la formula ‘Think global, act local’. Ne consegue una gestione della comunicazione esterna più consapevole e professionale che comporta non solo il coinvolgimento di specialisti nel settore pubblicitario, ma anche nell’ambito della traduzione specializzata. In effetti, le sfide della comunicazione globale richiedono una più attenta valutazione delle problematiche di una diffusione standardizzata a livello mondiale e una virata verso creazioni che tengano conto delle specificità nazionali, mediante l’adattamento di asset comuni secondo peculiarità e forme adeguate al paese target. Un posizionamento globale può essere così declinato in realizzazioni che rispettano le particolarità regionali e l’impresa emittente può orientarsi in tre diverse direzioni: una standardizzazione del messaggio pubblicitario, un adattamento per i singoli paesi oppure un adattamento globale-locale per zone socioculturali omogenee. Dal punto di vista della traduzione, tali scelte strategiche implicano o escludono il coinvolgimento del traduttore e delle agenzie pubblicitarie del paese di diffusione, a seconda che si adotti il principio dell’invariabilità del testo oppure della variazione, richiedendo quest’ultimo modifiche più o meno importanti che vanno dalla semplice trasposizione del codice verbale a vere e proprie forme di adattamento verbo-iconico riconducibili sia a parametri fissi (identità del prodotto e della marca, concept, impaginazione), sia a variabili collegate al contesto ricettivo4. Trascrizione e standardizzazione La comunicazione globale e il posizionamento universale del prodotto consentono alle aziende di mettere in gioco la notorietà della marca attraverso testi pubblicitari identici sui vari mercati ottenendo delle economie di scala, ma al contempo producendo un effetto ‘straniante’ poiché non integrano dimensioni socio-culturali specifiche. In tale politica comunicativa, la pratica traduttiva non ha alcun ruolo, se non quella eventualmente sollecitata nella mente del fruitore straniero, dato che il linguaggio universale dell’immagine acquista maggior rilievo rispetto al codice verbale. Si tratta, inoltre, di pubblicità che riducono all’essenziale slogan e bodycopy, 4 Cfr. M. BONHOMME, M. RINN, Peut-on traduire la publicité ? L’exemple des annonces romandes et alémaniques, in Communication et pragmatique interculturelles, "Bulletin suisse de linguistique comparée", n° 65, Université de Neuchâtel, 1997. 96 se non eliminandoli del tutto, per concentrarsi sul marchio e sulla sua identità. È questa la direzione percorsa dal settore del lusso, moda e cosmetici innanzitutto, dove si preferisce ancorare il prodotto al paese di origine anche ricorrendo a cliché ben presenti, attuando una sorta di trascrizione che viene a coincidere con il principio di conservazione. Così, la moda e i profumi veicolano immaginari che si servono degli stessi elementi iconici e verbali, sia per il mercato francese, sia per quello italiano, e si esprimono attraverso la lingua di partenza, non senza connivenze con l’inglese: DIOR Escale à Portofino Une essence. Un voyage ARMANI Acqua di Giò – GIVENCHY Givenchy pour homme The gentlemen is back Le nouveau parfum Modulazione funzionale e adattamento global-local Adottiamo qui il concetto di modulazione funzionale5 per indicare quella serie di procedimenti traduttivi messi in atto per meglio rispondere ad una strategia di comunicazione pubblicitaria intesa a unire i vantaggi della standardizzazione ad una più efficace “localisation communicationnelle”6 presso il pubblico target. I testi pubblicitari, mantenendo la stessa trama di fondo, introducono delle varianti per avvicinarsi almeno sul piano della lingua ai propri destinatari, sia mediante l’applicazione della traduzione diretta sia mediante operazioni di traduzione obliqua (trasposizione, modulazione, parafrasi)7. Generalmente, le campagne stampa ispirate a tale filosofia di marketing sfruttano lo stesso apparato iconografico, in qualche caso appena ritoccato con aggiunta o soppressione di elementi, sul quale innestano la versione letterale dell’headline o della baseline ottenendo l’equivalenza formale, ma rischiando di neutralizzare le possibili sfumature argomentative soggiacenti. Interessante, in proposito, è il messaggio pubblicitario del caffè LAVAZZA che, utilizzando lo slogan in inglese “Lavazza. What else?” quale funzione di relais, inserisce a margine per i due diversi Cfr. C. TATILON, Le texte publicitaire: traduction ou adaptation?, "Meta", vol. 35, n° 1, 1990, p. 243-246 e M. BONHOMME, M. RINN, Peut-on traduire la publicité ?, cit. 6 M. GUIDERE, G. LUGRIN, La traduction publicitaire et ses perspectives d’avenir, http://www.tradulex.org/Hieronymus/Guidere.pdf; M. Guidere, Publicité et traduction, Paris, L’Harmattan, 2000. 7 J. PODEUR, La pratica della traduzione, Napoli, Liguori, 1993. 5 97 mercati la traduzione francese (“Quoi d’autre?”) e quella italiana (“Che altro?”) adducendo una funzione supplementare metalinguistica. L’argomentazione per il nuovo rossetto Chanel AQUALUMIÈRE elimina nella versione italiana il segmento “Confort et éclat ultimes” per lasciare spazio, attraverso un piccolo accorgimento grafico, al nome del prodotto e alla trasposizione della baseline che non esita a inglobare una certa tendenza anglofila dell’italiano: Le nouveau rouge brillant multi protection Il nuovo rossetto gloss multi protettivo di de Chanel Chanel. Altra scelta traduttiva appare, invece, nel manifesto Chanel per il profumo CHANCE il cui slogan è proposto attraverso una modulazione metaforica che recupera in italiano la polisemia del termine chance e gioca la carta del prestito lessicalizzato: Une nouvelle fraîcheur d’esprit Una nuova e fresca chance. Più complessa e variegata risulta l’operazione traduttiva alla base della campagna VENUS Gillette in cui, a fronte di una stessa impostazione formale dell’annuncio e di una stessa retorica visuale, si attuano trasformazioni morfo-sintattiche (sostituzione vous/tu), modulazioni (focus sull’azione anziché sulla temporalità) e adeguamenti stilistici (eliminazione del verbo onde evitare ripetizioni), provocando un effetto di maggiore familiarità attraverso una comunicazione più diretta con le donne italiane: Révélez la déesse qui est en vous Jamais le rose ne vous a fait autant d’effet ! Découvrez Venus Rose Passion de Gillette. Une peau d’une infinie douceur, en un clin d’œil. Scopri la dea che c’è in te Il ROSA che ti farà impazzire Passion Venus rosa. Da Gillette. Una pelle morbidissima in una sola passata. Anche il linguaggio del bodycopy, come sottolinea Celotti8, viene trattato secondo le procedure della modulazione funzionale con particolare attenzione al tipo di linguaggio utilizzato per la descrizione del prodotto reclamizzato in funzione della sua appartenenza ad una determinata categoria merceologica e, quindi, ad un ambito specifico. In tal caso la traduzione tende a procedere secondo le modalità della specializzazione riguardante i 8 N. CELOTTI, La publicité: une affaire de traduction? Toutes premières réflexions, in AA.VV., Traduzione. Dalla letteratura alla macchina, a cura di S. Zoppi, Roma, Bulzoni, 1996, p. 74. 98 linguaggi settoriali9, tenendo presente che spesso si tratta di espressioni e termini pseudo-scientifici o tecnici in cui trovano spazio le formazioni neologiche (Figura 1 e 1bis). Adattamento e cultura locale Considerato una delle operazioni ai limiti della traduzione, in quanto pone in relazione strutture linguistiche e fattori socio-culturali e psicologici, l’adattamento costituisce lo strumento proprio alla traduzione pubblicitaria in quanto permette di risolvere problemi pragmatici o culturali attraverso una parafrasi che implica modifiche del contenuto cognitivo del testo di partenza10. Le aziende che scelgono una comunicazione commerciale specifica a seconda dei vari mercati, al fine di differenziare il più possibile i propri prodotti, investono in creazioni pubblicitarie originali per i diversi tipi di pubblico locale, affinché esse rispondano ai particolarismi culturali e permettano la corretta appropriazione del testo di arrivo che altrimenti risulterebbe poco comprensibile. Il posizionamento avviene, quindi, su tratti culturali specifici selezionati a seconda del tipo di destinatario, imponendo cambiamenti formali e sostanziali sia a livello iconico, sia a livello verbale, e l’adattamento del messaggio sfocia spesso in una vera e propria rielaborazione dell’annuncio ad opera di creativi in loco che procedono per negoziazione interculturale allo scopo di ottenere un’equivalenza d’effetto. I casi di adattamento più frequenti in pubblicità riguardano quei prodotti riconducibili ad ambiti della cultura materiale e sociale fortemente connotati dalla francesità o italianità (made in) quali l’alimentazione, le produzioni tipiche appartenenti alla tradizione, eventuali eccellenze in ambito tecnico-scientifico. Se in generale si riscontra una tendenza nel ramo delle bevande alla standardizzazione, numerose risultano essere le eccezioni a partire dai vini e dagli alcolici che, pur conservando una certa tipicità, puntano su schemi facilmente percepibili dalla comunità di arrivo. La pubblicità MARTINI, ad esempio, utilizza per il pubblico francese stereotipi iconici e slogan che enfatizzano l’unicità e l’origine del prodotto, ma al contempo le suggestioni simboliche condivise della moda, dell’arte, del viaggio (Figura 2 e 2 bis). Altrettanto interessante è la campagna CITROEN C·Crosser nella quale l’adattamento avviene mediante la scelta di un riferimento culturale proprio del paese destinatario nell’accroche (Ore 17.07. Milano, piazza Duomo). Il caso FIAT Panda, invece, mette in risalto un tipo di 9 Cfr. F. SCARPA, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2001. 10 ID., p. 118. 99 adattamento legato ai problemi derivanti dalle divergenze della cultura linguistica che, generalmente, si rivelano nei giochi di parola, negli idiomatismi, nell’uso di dialetti o espressioni vernacolari. Lo slogan per la Nuova Panda 100 HP (Figura 3) punta nella campagna stampa italiana sulla funzione ludica e sulla polisemia del termine “pandemonio” che risultano di difficile trasferimento nella lingua francese; di conseguenza, l’opzione proposta al pubblico d’oltralpe prevede l’equivalenza dell’effetto umoristico attraverso uno slogan che si serve della parodia di un riferimento culturale per veicolare l’idea di “demonio” e mantenere all’interno dell’enunciato i due termini: Ha cento cavalli, corre come una lepre, ma che razza di Panda è? È un Pandemonio Le Diable s’habille en Panda Come si evince da questa campionatura di campagne stampa, la traduzione pubblicitaria è strettamente collegata a precisi indirizzi di marketing aziendale e obbliga ad un’attenzione del tutto particolare per il tipo di testo da trattare. Sebbene interposta fra la traduzione generalista e quella specializzata da Scarpa11, essa richiede al traduttore una formazione adeguata poiché si tratta di intervenire non solo a livello interlinguistico, ma anche interculturale e intersemiotico ai fini di osservare una certa fedeltà sia al concetto commerciale soggiacente, sia alla comunità discorsiva ricevente, cercando soluzioni per risolvere i numerosi problemi linguistici e culturali che possono presentarsi. Trattandosi di un processo culturale, è dalla qualità della risposta del traduttore, così come dalla sensibilità delle aziende, che può dipendere il successo del messaggio transnazionale. 11 F. SCARPA, cit., p. 98. 100 Fig.1 Fig.1 bis 101 Fig. 2 Fig. 2 bis Fig. 3 102 UN ART DE GOUVERNER DE LA FIN DU XV SIÈCLE: LE DIALOGUE ENTRE UN CHEVALIER ET CRESTIENTÉ E (ms. Paris, B.n.F., fr. 148) G. Matteo Roccati Le Dialogue entre un Chevalier et Crestienté est un texte anonyme, sans doute inachevé, datable des années 1488-14901. Il s’agit d’un appel à la croisade relevant d’une thématique qui traverse le XVe siècle en particulier à la cour de Bourgogne2; dans la période qui précède la descente de Charles VIII en Italie, elle a connu une faveur particulière, l’entreprise italienne ayant été présentée comme la première étape d’un dessein beaucoup plus ambitieux: la reconquête de Constantinople et la libération de la Terre sainte. En témoigne notamment La ressource de la Chrestienté par André de La Vigne3. Cependant, au-delà de l’appel pour promouvoir la croisade et d’un projet assez détaillé pour l’organisation de celle-ci, l’œuvre devient un véritable “art de gouvernement” dans sa deuxième partie. Si elle se rattache indéniablement au genre des “miroirs au prince”4 elle en représente une forme particulière car elle s’adresse en fait à un gouverneur, non à un souverain: un personnage appelé à assumer des responsabilités au plus haut niveau dans le gouvernement d’une cité, d’une région ou d’une armée, mais dans une position subalterne par rapport au souverain. Elle reflète d’ailleurs se- 1 Cf. G.M. ROCCATI, “Dialogue entre un Chevalier et Crestienté”, un appel à la croisade de l’époque de Charles VIII (ms. Paris, B.n.F., fr. 148), dans “Studi francesi”, LII, n° 155 (2008), pp. 371-382. Je reprends ici la brève présentation du texte que j’ai donnée dans Une description inédite des peines infernales infligées aux menteurs (vers 1490), à paraître dans ”Miscellanea Cecchetti”, 2 Cf. J. PAVIOT, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle-XVe siècle), Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003. 3 ANDRE DE LA VIGNE, La Ressource de la Chrestienté, éd. crit. par C. J. BROWN, Montréal, CERES, 1989. 4 Sur ce genre, voir notamment J. KRYNEN, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-XVe siècle, Paris, Gallimard, 1993, en particulier pp. 167-239 ; J.-Ph. GENET, L’évolution du genre des Miroirs des princes en Occident au Moyen Age, dans Religion et mentalités au Moyen Age. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, sous la dir. de S. CASSAGNES-BROUQUET, A. CHAUOU, D. PICHOT et L. ROUSSELOT, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 531-541 ; et en dernier lieu: Le Prince au miroir de la littérature politique de l’Antiquité aux Lumières, sous la dir. de F. LACHAUD et L. SCORDIA, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007. 103 lon toute vraisemblance l’expérience personnelle de son auteur, “maître d’hôtel” du duc de Lorraine dans les années 14605. Le texte s’ouvre sur la description d’un vieux chevalier, fatigué et tourmenté, qui s’assoupit et a une vision. Une dame, qui se révèle être Crestienté, majestueuse et en même temps portant les signes du malheur, l’apostrophe et se plaint auprès de lui sur son état présent. En naît un dialogue à la suite duquel le chevalier présente de manière détaillée un projet de croisade pour lui porter secours. Pour répondre à la requête du chevalier qui lui demande instamment comment mieux la servir, Crestienté le conduit alors dans le jardin, allégorique, où se trouvent les arbres des vertus. La suite du texte est constituée par la revue des arbres qui portent chacun, accrochés au tronc et aux branches, des morceaux de parchemin, sortes de phylactères, où sont écrits de brefs textes en vers illustrant la vertu dont l’arbre est la représentation: ce sont les fruits dont les hommes de valeur doivent se nourrir. Il s’agit des arbres de Prudence, Justice, Force, Temperance, Liberalité, Amitié, Noblesse, Paix, Diligence, Humilité, Verité6. A ces arbres fait suite l’arbre du Foul, non arbre d’une vertu, mais somme à refuser d’attitudes et pratiques négatives; ne subsistent de cet arbre que le dessin et les vers, et le texte s’interrompt brutalement après. A chaque arbre – sauf donc à ce dernier – est associé un commentaire de longueur variable dans lequel Crestienté donne des conseils et traite de la vertu en question. Toute cette partie – où le propos de départ, la guerre contre les Turcs, ne revient qu’épisodiquement – est constituée d’un mélange de considérations d’ordre général formant l’ossature du discours et de consignes en revanche très pratiques: chaque fois les conseils se proposent de guider celui qui doit assumer des responsabilités politiques et militaires et, au-delà du cadre du discours, lequel est simplement moral, les indications sont précises et concrètes, fruit d’une observation lucide de la réalité et de la volonté de l’affronter efficacement. Sur ce que nous savons de l’auteur, cf. G.M. ROCCATI, “Dialogue entre, cit. pp. 373-376. Les listes de vertus sont courantes à l’époque (pour leur mise en place, et leur transcription en images, cf. J.-C. SCHMITT, Les images classificatrices, in “Bibliothèque de l’école des chartes”, CXLVII (1989), pp. 311341, en particulier pp. 313-318), mais je n’ai pu identifier un modèle précis (cf. G.M. ROCCATI, “Dialogue entre, cit. p. 381). On peut rappeler que, en faisant référence à Aristote, Gilles de Rome énumère douze vertus morales: “quatuor virtutes cardinales ; videlicet, Prudentia, Iustitia, Fortitudo et Temperantia” (AEGIDII COLUMNAE ROMANI De Regimine Principum Lib. III, per fr. H. SAMARITANIUM (…) editi, Romae, 1607, I, 2, 2 ; p. 50), auxquelles il ajoute: “honoris amativam, magnanimitatem, largitatem, magnificentiam, mansuetudinem, veritatem, affabilitatem et eutrapeliam, quam bene vertibilitatem, vel societatem appellare possumus ...” (I, 2, 3 ; p. 51). 5 6 104 Le commentaire du premier arbre, celui de Prudence7, est représentatif de cette partie de l’œuvre; une brève analyse permettra d’en rendre compte. Le commentaire s’ouvre par une apostrophe à teneur morale où Chrétienté commence par affirmer que Prudence8 est la mère de toutes les vertus et qu’on ne peut en pratiquer aucune sans elle: elle est la vertu qui permet de “s’accorder” au temps: garder la mémoire du passé, faire face promptement au présent, prévoir l’avenir. Prudence est indispensable à l’étude, à la guerre, au gouvernement9. Elle passe ensuite à des consignes assez concrètes adressées à un gouverneur10 qui doit prendre possession d’une province ou d’une armée (“exercite”11). Celui-ci doit être accompagné de “saiges gens”, beaucoup plus importants qu’une suite composée de pages, archers, orfèvres, etc., c’est-à-dire tout ce qui traditionnellement constituait une cour aristocratique. Il lui convient de s’informer sur l’état du pays, comment il a été gouverné par le passé, et de s’enquérir de quelles gens viennent au-devant de lui. Après la grande assemblée, le gouverneur rencontrera séparément les différents corps sociaux: il ira voir “messeigneurs de l’Eglise”, c’est-à-dire le haut clergé, dans tel monastère; il doit charger “comtes et barons” d’assembler le reste de la noblesse qu’il recevra dans sa chambre; il doit faire appeler les “bourgeois et marchans (…) des bonnes villes et gros bourgs” dans une petite salle. Prudence donne ensuite la teneur des propos qu’il aura à tenir à chaque “estat”. Aux nobles il doit parler des “hauts faits de noblesse”, s’assurer qu’ils entretiennent leur armement, qu’aucune dissension ne mine leur fi7 Le Dialogue a fait l’objet d’une tesi di laurea (E. PARISE, Ricerche sul ms. Paris, B.N.F. fr. 148, soutenue à la Facoltà di lettere de l’Università di Torino le 23 octobre 2000). Je l’ai repris dans mon cours de Letteratura francese medievale (Facoltà di lingue) pendant l’année 2006-2007 (auquel les étudiants, en particulier Silvia Gardino et Elisa Reinaud, ont collaboré activement). Dans le cadre du tirocinio de Pratica codicologica Clara Ghiurca a établi une première transcription des feuillets dont il est question ici. 8 Prudence a ici son sens aristotélicien, c’est la première vertu de l’homme et tout spécialement du roi d’après le De regimine principum de Gilles de Rome (liber I, pars 1, cap. 2, 3, 4, etc., notamment 12 ; p. 6, 9, 12, 3739 ; les chapitres I, 2, 6-9, pp. 60-70, lui sont consacrés). Cet ouvrage nous servira de référence pour repérer les principaux thèmes où notre auteur se fait l’écho de la tradition, soit qu’il ait lu directement ce texte très connu, soit qu’il ait repris des idées de toute façon très répandues en raison de la diffusion de cette œuvre (à ce propos, cf. S. J. WILLIAMS, Giving Advice and Taking It: The Reception by Rulers of the PseudoAristotelian Secretum Secretorum as a Speculum Principis, in “Consilium”. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, a cura di C. CASAGRANDE, C. CRISCIANI, S. VECCHIO, Firenze, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 139-180). Sur les images allégoriques de cette vertu à l’époque, cf. J. KEM, Allegorical Images of the Cardinal Virtue Prudence in the Works of the Rhétoriqueurs, in “Romance Notes”, XXVIII (1987-1988), pp. 177-185. 9 Cf. De reg. princ., I, 2, 8 ; pp. 66-67. 10 Prudence souligne que le livre entier est destiné à un gouverneur: “Et premier dict: gouverneur qui prudentement veult faire son debvoir, quant vient a prendre possession du regime d’aucune province ou d’ung excercite, tel comme est celuy pour qui ce fructueux livre est faict …” (f. 18ra). 11 Cf. DMF: Dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf, ATILF / CNRS / Nancy Université. 105 délité, et il doit affirmer son rôle d’arbitre si jamais il y a conflit; il doit les congédier avec familiarité. Après vêpres il s’adressera aux “seigneurs d’Eglise” en les assurant qu’il est le garant des “libertez, beaulz droitz, honneurs et franchises de noustre mere saincte Eglise”; en cas de prévarication de la part d’officiers ou de commissaires trop zélés, c’est à lui qu’ils devront s’en référer. Il les exhortera à assurer liturgie, prédication et encadrement religieux du peuple, et à se préoccuper que les curés soient “honnestes” et soucieux de la paix de leurs ouailles. En les congédiant il manifestera douceur et bienveillance. Le gouverneur retournera ensuite “en sa maison” et convoquera “ceulx du tiers estat”; il doit se montrer conscient des grandes charges que ceux-ci ont eu à supporter dans le passé et de la loyauté qu’ils ont cependant gardée; il doit les assurer que les charges seront dorénavant moins lourdes et les exhorter à travailler dans la bonne entente, la division étant la première cause de la ruine des cités. Il doit les congédier en les assurant qu’il les considère comme ses propres enfants. De cette manière il assoira sa réputation auprès des états, ce qui est indispensable pour bien gouverner, mais il doit veiller à ne pas être hypocrite car sinon il se perdra. Prudence passe ensuite à des instructions sur comment gouverner: la chambre de conseil12 ne doit pas être ouverte vers l’extérieur, il ne doit pas y avoir de bruit, la présence d’animaux et de femmes (s’il ne s’agit pas de princesses de la province) n’est pas tolérée et les conseillers doivent être sobres. Le gouverneur doit donner l’exemple “de honneur et de toute bonne vie”, car la vertu est plus prisée que la haute naissance. Les anciens chez lesquels réside la sagesse et toute vertu née de l’expérience seront honorés13; toute décision doit être longuement débattue avec eux de manière à prévoir l’avenir le mieux possible. Mais si des anciens ne sont pas vertueux, il n’hésitera pas à les écarter14. Il convient en outre que le gouverneur se garde d’introduire des nouvelles coutumes, et il doit respecter les anciennes15. Il ne doit pas gouverner seul, mais écouter l’opinion de plusieurs sages, et prendre exemple sur ses ancêtres. Il doit veiller à ce que les vivres ne renchérissent ni manquent. Le discours glisse alors sans que ce soit explicité et s’adresse plus particulièrement au gouverneur militaire16: il doit craindre la “mortalité qui dedans se frappe” qu’on peut limiter mais Sur le conseil et les conseillers, cf. De reg. princ., III, 2, 17-19 ; pp. 497-506. Plusieurs de ces consignes se trouvent dans le De reg. princ., III, 2, 15 ; pp. 490-493. 14 A propos des vices des vieux, cf. De reg. princ., I, 4, 3 ; pp. 195-199. 15 Cf. De reg. princ., III, 2, 31 ; pp. 537-541. 16 Pour l’arrière-plan de ce passage, sur la situation du campement et la manière de le construire, cf. De reg. princ., III, 3, 8 ; pp. 574-577. 12 13 106 non écarter; à cette fin il veillera à éviter les emplacements marécageux et il devra faire en sorte que les lieux soient gardés propres. S’il n’y a pas de fleuve avec de l’eau courante, les “immundicitez” doivent être portées au loin et enfouies, et si quelqu’un est frappé d’“espidemye”, il faut le mettre à l’écart dans un village, s’assurer qu’il ne manque de rien et lui interdire de revenir avant “que troys lunes” ne soient passées. Poissonniers et bouchers œuvreront loin du camp et apporteront “leurs chars couvertes et le plus nectement que faire le pouront”. Il convient que le camp ne soit pas serré mais large. Le gouverneur doit se faire obéir et, s’il est obligé de s’absenter, il doit nommer un homme vertueux, ni jeune ni vindicatif. Les derniers conseils de Prudence sont plus généraux: elle revient sur la nécessité d’obtenir l’avis de plusieurs personnes expérimentées dans la gestion des grandes affaires, sur les vertus dont le gouverneur doit faire preuve. En conclusion, on voit bien comment le discours, s’il est fondamentalement moral et religieux, contient toute une partie très concrète: les conseils s’inscrivent dans une conception “moderne” de gouvernement, s’opposant sans moyen terme à certaines habitudes féodales17, et sont empreints d’un “bon sens” pratique assez savoureux, qui fait l’intérêt du texte. Dès son installation, les soucis politiques du gouverneur sont de parer aux conflits dans la noblesse, à la fronde des gens d’Eglise et aux émotions populaires. La conception d’une société strictement hiérarchisée, doublée de la conscience qu’à chaque “estat” il faut s’adresser de manière différente, font apparaître un tableau vivant des procédés, rusés et manipulateurs, dont le gouverneur doit savoir jouer. A côté d’idées qui sont loin d’être neuves, le ton et les consignes d’ordre pratique qu’il donne font de ce texte un témoignage à travers lequel pointe la réalité de la société de la fin du XVe siècle: malgré le cadre moral dans lequel le discours s’inscrit, nous sommes tout près de la lucidité d’un Commynes18, et on perçoit bien que Machiavel n’est plus très loin. 17 18 A ce propos, cf. aussi G.M. ROCCATI,”Dialogue entre, cit., p. 382. Cf. J. BLANCHARD, Commynes l’européen: l’invention du politique, Genève, Droz, 1996, notamment pp. 19-22. 107 Ms. Paris, B.n.F., fr. 148, ff. 18r-19r 19 Filz, Prudence dit a ses filles, qui en ce clos sont denommees, et a leurs descendances, que pour riens sans elles ne se efforsent d’entreprendre grant faict a conduyre; veu qu’elle est l’adresse, monjoye et mere de toute vertu et que sans son moyen on ne peult d’elles user. Car, comme en a5bregé dict aucun sien verset au commencement de son bel arbre: “O le temps, qui est le vray astrologue, se fault accorder: rememorer le passé, avecques promptitude besongner au present; et bien pourveoir a l’advenir”. Prudence a faict la realle maisonnete ou que toutes vertuz sont logees. Et convient croire que, qui par la droite porte y peut entrer, n’aura deffault de chose que par raison requiere. Prudence est le chemin par ou le homme va aux bournes de perfection, c’est l’util et enclume ou que se forgent et font toutes oeuvres louables. Et sy sans elle l’on veult auchune chose entreprendre, soit certain que sotement sera commencee, mal moiennee, et pis achevee. Et quant l’on s’est laissé tumber en quelque deffault, et dedans les fangeux foussez plains de vices, sans Prudence ne s’en peut relever; et qui veult estudier, sans elle acquerir ne peult bonne science, ne sçavoir mestier quy vaille. Sans prudence on ne pourroit bien guerroyer, appointement faire, republique gouverner, ne nulle chose a son deu mectre. Prudence a ung grant avantaige sur toutes aultres dames: c’est qu’elle congnoist la fin de toutes oeuvres divines et humaines, les sciences des justes et faultes des injustes, le bien d’avecques le mal, la verité de la mensonge; et quelque chose que ce soit, ou prudence ne precede, croire convient que ce n’est vertu, mais vice partant d’arrogance, qui guarde et empesche l’œuvre de venir a parfaicte fin, et bonne congnoissance de raison. Prudence ne se conseille a qui ne sçait son faict conduire, ne a maintes gens sy bien ne les congnoist. Car pluseurs sçauroient son secret, et aussi, des doze, les dix conseillent voulentiers ce qu’ilz congnoissent qui plaist, par quoy prent advis des anciens bien experimentez, executant leurs saiges oppinions, avecques sa fille Dilligence et Prompte Solicitude par quoy riens ne pert, anczois tousjours avance, mectant le sien a seurs et bon prouffit. Prudence a mesure en sa puissance, plus20 grant de soy ne courosse, le maindre ne desprise. Le mal deffend, et se guarde de le faire. Et ne luy suffist sy son faict va bien et scelon ses devis, mais enseigne de bon 19 Le commentaire de l’arbre de Prudence occupe les ff. 18r-20r ; je donne ici, à titre d’exemple, l’édition du début. Dans le manuscrit certaines articulations sont marquées par un interligne vide: je les ai respectées. Le reste est copié à la suite, plusieurs majuscules l’organisent, mais les phrases souvent très longues rendent la lecture difficile: pour la faciliter, j’ai introduit les alinéas et enrichi la ponctuation. 20 Plus et tres sont systématiquement agglutinés au terme qui suit, je les sépare. 108 cueur ses amys, especialement ceulx qui tirent en grandes, pesantes et haultes entreprises, congnoissant en eulx magnanimité. Et premier dict: gouverneur qui prudentement veult faire son debvoir, quant vient a prendre possession du regime d’aucune province ou d’ung excercite, tel comme est celuy pour qui ce fructueux livre est faict, doit estre le mieulx acompaigné de saiges gens que possible luy est. Car paiges et archers, orfavriers, jeunes gens saultans, decoppez, enchaignez, tres court ou trop long vestuz, mulletz a cinquantaines, richement couvers et armoiez, menestreux, tabourins, baings, bancquetz, dances, chantres, faulconniers et venneurs n’y sont le principal. Et entre autre chose il luy convient estre informé de la maniere du pays, et par quelle faczon il s’est conduyt21, maintenu et gouverné par le passé; entendre a son arivee quelles gens viennent au davant de luy, et quelx sont touz ceulx qu’il a a gouverner, conduyre et regir, espiciallement par ledict hault excercite, scelon qu’ilz sont et qu’ilz vallent les honnourer. A touz faire bonne chere et joyeuse, sans effray ne trop de langaige, tenant contenance aseuree, monstrant a gens de touz estatz, en bien les recuillant et parllant avecques eulx, amour, et qu’il est homme. Et finy son parlement faict en la grant assemblee, doibt faire dire a messeigneurs de l’Eglise qu’il veult apprés vespres ou refectouer de tel monastere leur parler. Les contes et barons doibt adviser que avecques eulx assemblent le reste de la noblesse pour ouir ce qu’il leur vieult dire en sa chambre apprés son disner. Les // [f. 18rb] bourgeois et marchans doibt appeller et dire: “trouvez vous a mon retour de vespres en telle sallette, ensemble touz ceulx des bonnes villes et gros bourgs, pour entendre le devis que vous vouldray faire, car bien que vous aye veuz avecques les estatz, il ne me suffist. Lesquelx ce jour vueil depescher, congnoissant que de plus vous tenir ne seroit que despense et ennuy vous faire, a quoy de mon pouair vueil remedier”. Et sy aulchun demandoit pour quoy est ceste faczon conseillee de parler a part a chacun des estaz, c’est que nonobstant que les trois tirent a bonne fin, touz different en vie et gouvernement, et aussy chacun sainct veult seul son offerende22. Les nobles venuz, entre aultres choses leur doibt parler des haults faictz de noblesse, ainsi que en l’article d’elle sera plus amplement touché, comme au vray est acertené que par leurs grandes loyaultez, constances, dilligences et hardemens, a esté la province gouvernee, guardee, soustennee, et deffendue, tellement que a suffisance on n’en pourroit deviser; leur priant que continuellement de bons chevaulx et compaignons soient tousjours 21 22 Manuscrit: et érasé. Cf. TPMA, VI, s.v. “Heilig”, 4. 109 garniz, le harnoys net, et que au reste l’on peult legierement pourveoir. Et apprés le devis faict avecques toute doulceur, dira: “il n’est pas que entre vous autres messeigneurs les nobles ne ayez aucuns differans, questions et procés. Venez vers moy quant bon vous semblera, avecques voz plus prouchains parens et amys qui entendent voz affaires, et sans plaidoyer me efforceray vous appointer. Et sy par voye d’amitié, qui tousjours devant se doibt mectre, faire ne le puys, gardant les termes de justice promptement vous feray expedier”. Puis les doibt ambrasser et toucher la main en leur disant adieu, collation faicte scelon la saison, “et quant viendrez en ceste cité, venez moy veoir, tousjours vous feray bonne chere”. Apprés vespres ausdictz seigneurs d’Eglise doibt user de amyables, haults et substancieulx langaiges, disant entre autres devis, quant aux libertez, beaulx droitz, honneurs et franchises de noustre mere saincte Eglise, “dont23 vous estez les suppostz: je suys celuy quy de mon pouair veulx ayder a les garder, deffendre et augmenter, bien congnoissant que qui rudement vous touche en personne et en biens, il poingt, desobeist et robe noustre sauveur. Et pour ce que aucuns officiers et commissaires mainteffoiz excedent commissions, si sur nulz de vous autres advenoit, envoyez vers moy aucun de vos servans qui seullement me sçaiche voz lectres presenter, semees de toutes vertuz, non enjambant plus que le debvoir, et je y pourvoiray, sans grans cousts vous laisser faire, par maniere que a chascun donneray a congnoistre que je suys et vueil estre en tout droit et raison, pillier, soubstien et potence de noustre dicte mere saincte Eglise”. Et prier leur doibt avecques toute gracieuseté que en leur memento le vueillent tenir, et telle grace luy pourchasser que le pays puisse gouverner au plaisir de Dieu, que touz les estaz en vaillent mieulx, que honneur et salut24 de ame y puisse acquerir. D’autre part les doibt adviser tres estroictement, prier et encharger que souvent preschent et facent prescher, tant es citez comme villes, gros bourgs, moyens et petiz, pour la paix de la mort, qui brief et en pluseurs faczons vient a la personne, des joyes de paradis et peines d’enfer, du redoubtable jour du jugement, des expositions d’euvangilles, et, entre autres choses, des vices qui plus regnent ou pays, remonstrant au peuple que par non faire ouir la messe a leurs enffans le dimenche, prendre l’eauue benoiste, apprendre leur foy et creance, et faire le signe de la croix, l’ennemy les faict en ses laz trebuscher, car tout premier ilz n’ont force ne sens pour contre luy resister ne faire // [f. 18va] oeuvre de bien, par quoy 23 Le propos passe sans transition au discours direct, tel un “discours direct libre”. Comme auparavant, j’introduis des guillemets, mais sans marquer de rupture par une majuscule. 24 Ms.: da biffé. 110 du tout pouvres chetifs et grans pecheurs deviennent. Oultreplus les convient adviser d’ung point, que nostre mere saincte Eglise ayme entre touz aultres, le plus et grant part de leurs supposts le contraire. C’est que sur tout, les curez, qui ont le gouvernement des pouvres ames, soient honnestes, non portant lignaige contre autre, mais se empescher de accord faire, sans parcialité y monstrer, appellant avecques eulx les moins langars25 et plus paisibles. Et si de honnesteté deprisent la tres louable vertu, qu’ilz en facent par maniere que les entrens en leur lieu y prennent l’exemple que fist le filz du juge, qui escorché fut par faulce sentence, et sa peau mise sur le siege et chaire de justice, ou qu’il fut assis portant l’office de son pere apprés sa mort martireuse et bien desservie26. Ouye leur responce, leur replicque doibt estre doulce, meslee de offres et de tant plus si d’aucunes choses se douloient, qui griefves leur fussent a supporter; leur disant comme27 davant que vers luy mandent, et leur faict sera le premier depesché. Et sur ce point, avecques tout honneur et benivolence, leur dire adieu faisant replicques recommandations. Ce faict, retourner doibt en sa maison, et mander querir ceulx du tiers estat, leur disant, avecques autres bons motz, que assez est advisé des grandes charges qu’ilz ont par cy devant supportees, dont moult se esmerveille comme leur a esté possible les soubstenir; et bien congnoist, s’ilz n’eussent esté plus loyaulx, fermes, et amans leur prince et honneur, que nulz autres, dessoubz sy tres griefs et pesans fais, fussent flechiz, tumbez et recreuz. “Or est ainsi, mes tres chers et bons amys, que tout ce que dy, est bien congneu. Par quoy serez doresenavant supportez et allegez, car les charges et affaires ne seront sy grandes que par le passé ont esté; sy vous vueillez resjoir, entendre a Dieu servir, loyaument marchander, faire voz mestiers et labours avecques toute dilligence, et de bon cueur vous entreamer, prenant exemple a telles provinces et citez, qui tres mal se sont gouvernees pour tendre aux parciallitez, lever bandes, nourrir haynes, mouvoir guerres, et aux vices inmundes prendre plaisir. Et vous souviengne comme telles citez et grosses villes haultement et richement se maintiennent, par voulentiers ouir les bons prescheurs, obeir aux commandemens de Dieu, de leurs princes et gouverneurs, faire les oeuvres de misericorde, desirer paix, l’achater, et eulx gouverner par meur conseil, bonne vision et police”. Et ouye leur responce, ainsi qu’ilz veullent prendre congé Langard: bavard (DMF). Cf. VAL.-MAX., Facta et dicta mem., VI, 3, ext. 3. 27 Ms.: deu biffé. 25 26 111 de luy, acertener les doit que par son moyen n’auvront nulle charge, et de tant plus si enclins les veoit a vertuz; mais les aymera, conseillera et soubstiendra, comme si ses propres enffans fussent. Ce qu’est tenu tout bon gouverneur de ainsi faire, ou aultrement peche; et ne suffist de bien dire, soy offrir et donner bons enseignemens, si le faict n’est de mesmes; car a Bellutel28 resembleroit, qui fleur et farine hors de luy gecte pour le bran reserver. Disant le gouverneur a touz les susdictz estatz bonnes parolles, tenant maniere de mesmes, de luy se partiront plus que contens, et tres grans biens en diront, qui est bon et hault commencement pour son entree et pres que son office faict sans grant travail. Car le plus des affaires mondains se gouvernent par renommee et reputation. A cil qui mauvaise l’a, bien que grande chevance ayt, il se consumme. Par quoy doibt tout bon gouverneur se penner a bonne l’avoir, et plus pour ceulx dont il a charge que pour nulz autres, salut de ame reservé. Lequel par ce moyen acquiert, car honnourablement et en perpetuité vit. Et qui faintement et par ypocrisie monstre d’estre bon, puys soubz le faulx manteau et escappouchin, duquel est toust congneu droit ou envers, mal manye, traicte et gouverne chascun des trois estatz, peu durera, et ains qu’il fine sera confondu, // [f. 18vb] mesprisé de Dieu et de toutes gens diffamé. Il est de coustume que a l’entree des gouverneurs criz et commandemens se font. Soit le premier qui les observe, puys les face tenir aux plus grans, especiallement a touz ceulx de sa maison, car faisant le contraire tenuz ne seroient, ne luy en riens estimé. Prudence, en ses notables enseignemens et beaux devis, dict que saige gouverneur ne doibt deviser en sa chambre de conseil, fenestres basses; ne la situer sur rue, court, jeuz de paulmes, ne lieu de bruyt. Et commander doit au premier huissier qu’il n’y seuffre oyseaux sur poing, en caige ne autrement, chiens, cinges, fouls, enffans, tappisserie en parsonnaiges, ne femmes, sy don29 n’estoit qu’elle fust princesse de la province, ne riens, pour abreger, qui puysse empescher d’entendre ce pour quoy on est assemblé. Et garder se doibvent les conseilliers, et sur tout le gouverneur, d’entrer en ladicte 28 La source de l’image se trouve dans les Dits moraux des philosophes de Guillaume de Tignonville: “Et dist: ne soies pas comme le bellutel qui met hors la farine et retien le bran” (R. EDER, Tignonvillana inedita, in “Romanische Forschungen”, XXXIII (1915), pp. 851-1022, à p. 973), mais dans le texte de Tignonville il s’agit en fait d’un tamis, alors que pour notre auteur Bellutel est le nom d’un personnage. 29 “Si dont (d’elles) …”: “si ce n’était que”, “à moins que” ; le sens est clair, mais, sauf erreur, l’expression n’a pas été relevée dans les dictionnaires. 112 chambre estoumach remply de pluseurs sors vins et viandes sophistiquees, car faire ne pouroient plaisantes oeuvres ne de bon fruict. Bon gouverneur, ce dit dame Prudence, doibt estre exemple de honneur et de toute bonne vie, conduyre son gouvernement par bonté, amytié et benivolence, expediant touz ses affaires avecques sain advis, vray, bon et experimenté conseil, car vertu en homme, especiallement a cil qui a grant charge, est d’assez plus louee entre les entenduz, que la haulte noblesse dont pourroit estre party. Et si estranges et mauvaises coustumes sont ou pays, comme de blaphemer le nom de Dieu, premier que nulles autres, la doibt lever et en luy tout son cueur mectre, puys a son aise et sans fureur au surplus remedier. Car prudent gouverneur, se aydant des bons, peult legierement mauvaises coustumes lever. Et ne se fault esmerveiller si pays a vil vice endurcy, seuffre desaise et aigre pugnition, ce par ce qu’ilz ne croyent de vertueuse noblesse les bons vrays et seurs ensaignemens, ou que les chefs et gouverneurs ne sont en la grace de Dieu, par exemple de mal qu’ilz donnent au peuple, comme par trop excessivement les tiranniser, sans nulle allegeance luy donner, pitié en avoir, amour porter, ne justice faire. Par quoy vivent lesdictes choses que ainsi sont a nonchallance de nul bien, et ne sçavent prendre remede de bon conseil, dont perdent, comme gens yvrez du vin de vigne, de celuy de ire, de follie, de faulse amour et de vaine gloire, sans conduyte et vertu de toute haulte et honnourable oeuvre. Oultreplus dit dame Prudence que saige gouverneur doibt priser, amer et croire les anciens, car ce sont bibles, cronicques et registres, adresses de sentiers, seures planches de bons guez et fermez ponts. En eulx se treuve sens, humilité, courtoisie, advis, grans aydes et enseignemens, honneur, memoire, bon conseil, proudommye, hardy parler, et les vertuz dont les onze arbres parleront. Et tout, par les experiences et temps qu’ilz ont veu muer. Par quoy a eulx se doibt on enquerir des anciennes manieres de faire, bien noter et ouir a grant plaisir leurs haults raisonnemens et recordances des choses passees, disposer par leur bonne oppinion, et non autrement, du present besoing, pourveoir a l’estat de sy loing que possible est, tant pour obvier aux contrarietez, comme pour mieulx soubstenir les adversitez et senestres adventures; tout debatre par grant laisir et souvent mectant pluseurs doubtes en avant, qui a l’estat pourroient sourdre, car tellement est fondé que a sy claires lunetes nul n’y peult regarder, que aucune n’en sourviegne, dont garde on ne se prent. 113 Par lesdictz anciens se doibvent suspendre les matieres doubteuses, non les eventiller, ne pour riens en determiner // [f. 19ra] que par temps ne soit et de leur uny advis. Mais en ce n’est entendu que l’on doibve honnourer qui en viellesse aux vices se assert, estant aussy prest de follier et mal faire comme quant en jeunesse se trouvoit. Ne que appeler faille les orgueilleux, envieux, obstinez en leurs perversitez, honteux reprouches et vilz deffaulx; lesquelz maintiennent que hommes de poix les convient monstrer, se faire craindre, et sur touz estimer, et de si hault tumbent que du ressourdre n’y a remede. Et croire ne fault ceulx qui soubstiennent que luxurieux convient qu’ilz soient, affin que joyeusement se puissent maintenir, et les dolans se affeblissent et meurdrissent. Autres soubstiennent que avaricieux leur convient estre, allegant non pouair plus gaingner, et ilz se ahontissent et apouvrissent semblablement ceulx qui, sur leur viellesse, acquierent possessions pour leurs corps aiser, sans fonder messes, prieres, ne aumosnes, qui est oublier Dieu, son ame ne congnoistre, et sa ville charoigne trop amer. Autres dient que frians, glotz et grandement peuz convient qu’ilz soient, car debilité leur court sur, et c’est alors qu’ilz foullent nature, par quoy en brief leur deffault. De telz sont qui veullent sejour pour l’aise et repos du corps et ilz se appesantissent, goutes nourrissent, non faisant bien a eulx ne aultres. Moult sont qui soubstiennent que verité convient celer, autrement n’auroient de court les avantaiges, honneurs et graces, et ilz sçavent bien que aujourd’hui est dame Court en ung propos, demain en autre, et que qui par flaterie y gouverne, par ce mesmes a le bout avecques renommee d’estre menteur… 114 LES DIMENSIONS INTERCULTURELLES DU MANAGEMENT D’ENTREPRISE A L’UNIVERSITE: UNE EXPERIENCE CLIL-EMILE EN FRANÇAIS Marie-Berthe Vittoz Introduction La Faculté de Langues et Littérature étrangères de l’Université de Turin a mis en place depuis 2004 une filière Master 1 et 2 appelée Corso di Laurea specialistica in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale1 à visée professionnelle, très attrayante pour les étudiants, qui exigerait une ouverture sur la mondialisation par le biais de réflexions sur la culture et les différences culturelles dans le monde du travail. D’autant plus que la création d’un parcours d’études binational, réalisé en collaboration avec l’Université de Lyon 3 Jean Moulin, et bâti sur la répartition équilibrée de trois axes requiert la prise en compte de l’interculturalité, présente potentiellement dans l’hétérogénéité du public. Celui-ci se compose d’étudiants français et italiens et, parmi ces derniers, un bon nombre issu d’autres régions d’Italie auxquels s’ajoutent un nombre significatif d’étudiants provenant d’autres pays. C’est pour tenter de répondre à des exigences ponctuelles que l’expérience pionnière du CLIL2 en Management Interculturel, tout en français, a été conduite à partir des années 2005-2006 et constamment évaluée par rapport aux recherches académiques en cours dans ce domaine. 1 La formation dont il est question ici [Master 1 - Master 2 en Langues et Affaires, équivalente à la Laurea specialistica in lingue straniere per la comunicazione internazionale] comprend des enseignements spécifiques de deux langues étrangères (français-anglais), des enseignements économiques et juridiques, des enseignements historiques et culturels auxquels s’ajoutent un enseignement d’informatique appliquée à la communication et un stage professionnel obligatoire. 2 L’acronyme EMILE (Enseignement d’una Matière Intégré à une Langue Étrangère) ou CLIL (Content and language integrated learning) véhicule une approche méthodologique innovante qui va bien au-delà de l’enseignement des langues. En effet, ses promoteurs mettent l’accent sur le fait qui la langue et la matière non linguistique son toutes deux objet d’enseignement, sans qu’il ait de préséance de l’une par rapport à l’autre. Par ailleurs, la réalization de ce double objectif exige la mise en place d’une approche particulière de l’enseignement. (extrait du site www. emilanguages. education.fr) 115 Pourquoi un parcours CLIL dans une Faculté de Langues et Littératures étrangères? La modalité d’enseignement CLIL3 est une innovation de qualité, à élaborer d’un point de vue méthodologique pour obtenir des résultats positifs aussi bien sur le versant linguistique que sur celui des contenus disciplinaires. Parmi les langues du CLIL figure souvent l’anglais auquel s’ajoute une autre langue communautaire comme le français, l’allemand, l’espagnol ou l’italien et même des langues dites minoritaires. Dans le cas précis d’une Faculté de Langues et Littératures étrangères, les contenus des enseignements de langues étrangères correspondant au niveau C1-C 2 du CECR sont choisis en fonction des objectifs, avec les aménagements nécessaires, selon les filières. Par ailleurs, pour l’enseignement de FLE, le développement d’outils pour les niveaux avancés s’oriente autant dans le secteur du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) avec des perspectives professionnelles (parmi lesquelles figurent la compétence traductive terminologique vs littéraire), que dans le domaine de la linguistique appliquée qui se nourrit d’expériences d’analyse de discours. Or, dans le cadre d’un parcours binational comme le nôtre, la question des contenus linguistiques et culturels des deux langues de référence en présence, le français et l’italien, est en relation étroite avec celle des modalités d’apprentissage: dans un contexte interculturel complexe, et en vue d’une qualité d’excellence professionnelle, ces modalités devront être innovantes et motivantes. En fait l’expérience CLIL a été mise en place pour une double exigence. D’abord répondre aux attentes d’un public d’étudiants italiens et français, linguistiquement compétent et désireux de développer de façon interactive de nouveaux savoirs, savoirs-faire et savoir-être et ensuite participer au réseau de recherches sur les enseignements CLIL dans les universités, avec une typologie d’apprenants tout à fait particulière. Pourquoi un contenu de Management Interculturel en Langue Française ? La notion d’interculturel nait dans les années quatre-vingts, à la croisée En Italie, le CLIL est connu d’abord dans l’éducation, dite bilingue, des Régions à statut spécial et se répand à titre expérimental dans d’autres Régions comme la Lombardie, la Vénétie et le Piémont: la communauté scientifique s’y intéresse de près, en particulier les universités Ca’ Foscari de Venise avec Carmel Mary COONAN, CLIL: un nuovo ambiente di apprendimento, Università Ca’ Foscari Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, l’université de Trento avec Federica RICCI GAROTTI, Il Futuro si chiama CLIL: una ricerca interregionle sull’insegnamento veicolare, Editore Provincia autonoma di Trento, 2006, l’université de Turin avec Teresina BARBERO. Comunicare le discipline nelle lingue straniere, CLIL e formazione degli insegnanti: Il progetto europeo LICI, Atti del convegno, Torino, 17 maggio 2007, ELi. 3 116 de la didactique du FLE, avec la prise en compte de la culture dans l’enseignement des langues étrangères. Le succès de ce concept s’est accru au point de s’étendre aux autres disciplines et de devenir un des axes essentiels de toute pédagogie. C’est R. Galisson 4qui aborde la lexiculture ou culture qui se dépose dans les mots, dits à charge culturelle partagée [CCP] accessibles aux natifs seulement. Il importe de ne pas séparer l’enseignement de la langue de celui de la culture et de mettre en œuvre des stratégies mixtes comme le repérage de stéréotypes culturels qui renforcent la cohésion du groupe qui les expriment et créent un consensus aux dépens du non natif, et encore la découverte du lexique idiomatique qui inclut les représentations de l’autre. C’est ainsi que se consolide une attitude globale de prévention contre les malentendus, issus d’une incompréhension d’implicites linguistiques, discursifs, et non linguistiques, gestuels et proxémiques. Du moment que nous sommes aujourd’hui de plus en plus amenés à découvrir d’autres cultures, d’autres identités dans un paysage de marchés mondialisés en pleine évolution, comment ne pas s’interroger sur les différences culturelles et l’interaction entre les cultures – qui se manifestent par et à travers la langue – tant pour satisfaire la diversité de la demande que pour intégrer des équipes de travail multiculturelles. Le Management Interculturel comme matière d’enseignement universitaire figure en France aussi bien dans les cursus de Sciences de l’Education que dans les cursus d’Economie ou encore de Sciences de la communication, tout autant que dans le cursus de Sciences Politiques dès qu’il est question d’ouverture à l’international. Dans le cursus binational italo-français de Langues étrangères appliquées, cet enseignement figure à l’Université de Lyon 3, sous la forme d’un module pratique de 15 heures. A l’Université de Turin l’enseignement de Management Interculturel, ancré dans l’interdisciplinarité (sociologie, anthropologie, ethnologie de la communication, management en entreprise, linguistique appliquée au lexique) a été élaboré par nos soins, selon un canevas rigoureux et respectueux de la modalité CLIL, à savoir le lien inéluctable entre la langue et la matière non linguistique, de façon telle que l’apprentissage (les apprentissages) disciplinaire (s) soi(en)t intégré(s) au développement des compétences linguistiques. Les applications de l’interculturel au management passent par l’étude «en coup de phares» de textes issus de la littérature internationale5 qui s’affirme depuis quelques années (le management interculturel étant une R. GALISSON, De la langue à la culture par les mots, Paris, Clé International, 1991. Parmi les auteurs de référence nous citerons E.T. HALL, Le langage silencieux, Paris, Seuil, 1984 ; G. HOFSTEDE, Cultures and organizations: software of the mind, McGra-Hill, New York, 1991 ; F. TROMPENAARS, L’entreprise multiculturelle, Maxima, 1994. 4 5 117 discipline encore jeune). C’est d’abord par le regard de didacticiens de l’interculturel que nous découvrirons nos représentations et nos stéréotypes (ceux qui appartiennent à notre culture) pour entrer ensuite dans le champ de la gestion du management que nous déclinerons par le biais de la culture et de l’identité/altérité aussi bien par l’enseignement de la langue que par l’enseignement de la gestion des hommes et des entreprises. Quelles conditions pour la mise en place d’un parcours CLIL ? L’activation d’un parcours CLIL par un enseignant, à quelque niveau que l’on intervienne (éducation primaire, secondaire ou universitaire) exige deux conditions préalables: posséder des connaissances en didactique des langues étrangères et des connaissances en didactique de la matière à enseigner, ici le Management Interculturel ou cross-cultural management. Dans de nombreux modules CLIL, ce sont souvent deux enseignants experts de ces secteurs qui montent ensemble le parcours didactique et s’alternent en cours. Nous empruntons à H. Boyer, M. Butzbach et M. Pendanx6 (1990: 7) leur conception développée dans la Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère: Pour notre part nous désignerons comme didactique du FLE l’articulation (plus ou moins idéale, plus ou moins effective) de plusieurs types d’interventions théoriques, méthodologiques et pratiques, qui, en interrelation, vont de la sollicitation de diverses disciplines (des Sciences humaines et sociales tout particulièrement) au seuil de la classe concrète. En fait, le schéma d’articulation du cours répond à cette multiplicité d’interventions sur la base d’éléments constitutifs tels que l’identification des prérequis, des objectifs linguistiques et culturels, du profil des apprenants par rapport au CECR de référence, du chronoprogramme détaillé avec les contenus et les pratiques.. Pour ce qui concerne la didactique de la matière, nous nous sommes inspirés des travaux universitaires de M. Bosche7, auteur d’un didacticiel 6 H. BOYER, M. BUTZBACH et M. BENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Paris, Clé International, 1990, p. 7. 7 « On se propose ici d’esquisser une démarche intégrée de diagnostic interculturel. On évoque une méthodologie qui part du niveau le plus large, les cultures en présence, jusqu’au plus particulier, les individus en situation dans l’espace et le temps. Pour chacun de ces niveaux, des outils sont présentés. Ce type d’approche « en entonnoir » rend compte de la globalité des processus interculturels. Il peut éviter de tomber dans la dichotomie des différen- 118 d’apprentissage interculturel en ligne, grâce auquel notre module CLIL a pu être monté de façon expérimentale à partir des années 2005-2006. Le modèle de compétence communicative interculturelle proposé par P. Balboni constitue également une aide pour notre public, dans la phase initiale de sensibilisation à la réflexion interculturelle. Les outils à disposition permettront de comprendre ce qu’est communiquer, (communiquer en langues étrangères aussi et surtout), pratiquer l’échange social et donc travailler avec des hommes et des femmes d’entreprises et d’organisations d’une autre culture (nationale) que la sienne. En quoi les caractéristiques du CLIL ont-elles été adaptées aux exigences de l’université ? La dimension interculturelle, inhérente à toute pratique CLIL, a constitué l’élément pivot de cette expérience turinoise en Management Interculturel, autour de laquelle se sont développées d’une part des expériences avec des professionnels experts et d’autre part des contacts avec des entreprises8. D’un point de vue des contenus linguistiques, il a fallu revoir le niveau C2 du CECR qui pose l’approche communicative actionnelle comme modèle de référence en excluant la dimension cognitive très présente, au contraire, dans l’approche CLIL. La compétence en langue étrangère, ici le français, a été développée d’abord à partir d’une d’évaluation initiale ciblée sur un certain nombre d’objectifs.9 Ce travail, élaboré au cours de la semaine propédeutique10, a permis à l’équipe d’enseignants de langue française de construire un parcours annuel sur mesure, compte tenu des objectifs institutionnels. L’évaluation ne se base plus exclusivement sur la ces, dans l’analyse déductive au risque de l’ethnocentrisme et des préjugés». Site http://pagesperso-orange.fr/marc-bosches/menu8_page7.html, p. 16. 8 Les étudiants de la LS43, au cours de l’année 2007-2008, ont mené un projet de recherche avec un réseau de 600 entreprises françaises installées en Italie pour essayer de constituer un sorte d’échantillon de leur sensibilité interculturelle. Les résultats de ce travail Interculturalité et Entreprises ont été illustrés par des étudiants italiens et français par une présentation Power Point, à l’occasion de la journée d’étude organisée par les linguistes francisants de l’Université de Turin, dans le cadre de la Semaine de la langue française sur Les mots de la rencontre. 9 Parmi lesquels: la connaissance de l’API, la maitrise de la syntaxe complexe, la connaissance du lexique des affaires et du droit, l’identification du lexique idiomatique, les connaissances socioéconomiques de la France et de Italie. 10 Cette semaine de formation /information, organisée la première semaine d’octobre, permet aux étudiants inscrits dans ce cursus et provenant de toutes les universités italiennes et européennes de connaître et comprendre les objectifs de chaque cours: une prise de contact particulièrement appréciée par les étudiants et les professeurs, si l’on en croit l’évaluation positive de cette modalité, mise en place depuis 2005. 119 connaissance de l’objet langue mais sur l’aptitude de l’apprenant à utiliser la langue en situation, dans un contexte de contacts interculturels. Dans le cadre de ce cours CLIL (réalisé en partie in praesentia et en partie en autonomie et à distance) nous avons privilégié le développement de nombreuses stratégies correspondant à des compétences requises pour le niveau C2, complétées par des savoirs et des pratiques universitaires. Citons par exemple: une approche contrastive du lexique interculturel/idiomatique, des repérages d’éléments d’interculturalité dans des textes de spécialité, des stratégies de lectures de textes issus de la littérature du Management Interculturel mais aussi l’aménagement d’un espace de dialogue, à l’intérieur du cours, pour permettre alternativement aux étudiants français et italiens des prises de paroles dans l’une des deux langues d’étude autour des réflexions proposées au début de chaque cours. Parmi les activités à distance, il faut mentionner les dossiers personnels à réaliser en document Word, les fiches culturelles et socioéconomiques à élaborer à partir d’écoutes individuelles de documents en ligne, les quiz culturels proposés par des sites de langue française. Pour les contenus de Management Interculturel, les adaptations nécessaires à notre enseignement ont été plus complexes même si les problèmes de compréhension linguistique pouvaient apparaître mineurs: le lexique spécifique des disciplines nouvelles a créé des difficultés auxquelles chaque étudiant a pu remédier avec l’élaboration d’un mini dictionnaire individuel de décodage pour développer ses compétences lexicales. Quant aux difficultés d’ordre culturel surgissant lors de la lecture de textes d’illustration des notions de référence, elles ont été résolues alternativement par les étudiants italiens ou français, selon les cas. Quoi qu’il en soit le travail le plus délicat a consisté en une sélection des notions et connaissances essentielles, à proposer progressivement aux étudiants. Selon C. Camilleri11 un triple apport d’informations se rendent nécessaires pour former un acteur interculturel: premièrement lui donner des informations anthropologiques (qu’est-ce qu’une culture, les cultures en présence) pour éviter les tensions dues aux malentendus d’une part et les jugements de valeurs hiérarchisantes d’autre part, afin de lui faire admettre l’égale légitimité des systèmes différents. Deuxièmement lui fournir des informations en provenance des sciences humaines éclairant les mécanismes de l’hétérophobie qui lui serviront de propédeutique à cette prise de conscience des acteurs impliqués dans la gestion de l’interculturel, à quelque niveau que ce soit. Troisièmement donner des informations pratiques et exactes sur les contextes dans 11 C. CAMILLERI, Cultures et stratégies ou les mille manières de s’adapter in Identité(s):L’individu, le groupe, la société, coordonné par Halpern C., Ruano-Borbalan J.C., Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2004, p. 88. 120 lesquels l’acteur est amené à travailler (participation à des équipes de travail internationale en entreprise, conduite de projets européens, contacts professionnels et négociations, etc.). Toutes ces informations constituent une trame de savoirs pertinents en mesure d’assurer la professionnalité de cet acteur en formation qui deviendra expert de communication internationale dans des entreprises ou des organismes internationaux. Comment favoriser le dialogue des cultures dans le management des entreprises internationales ? Quelles modalités et quelle organisation pour cet enseignement ? Il n’est pas possible de parler de management sans parler de communication interculturelle, d’anthropologie et de sociologie, à plus forte raison si l’on s’adresse à un public de linguistes ayant opté pour « une formation à l’international ». L’approche transdisciplinaire permet une dynamique entre information et disciplines. Les connaissances transmises en langue française sont pertinentes dans la mesure où elles sont contextualisées. En fait le parcours choisi débute avec une recherche lexicale et conceptuelle de la notion de communication pour s’orienter vers la communication dans le champ de la mondialisation (Wolton, 2004). La contextualisation passe par l’Université de tous les savoirs12 qui permet aux étudiants une consultation finalisée des éléments de communications culturelles langagières et non langagières, appliqués à la gestion des entreprises et des organisations13. De là une réflexion incontournable sur la notion de culture à l’aide du sociologue Gilles Verbunt (La société interculturelle) qui reprend les notions d’identité individuelle / collective de tout individu et celle d’altérité pour aller vers la sensibilisation au réflexe interculturel. Notre parcours de découverte se poursuit avec un survol de la littérature des anthropologues comme l’ouvrage essentiel de Kluckhohn et Strodbeck (1961: p. 4) qui propose des valeurs étalon, indispensables pour aborder avec M. Bosches sa réflexion sur la management, ancré dans la dimension stratégique d’une entreprise. Il affirme que le sujet apprenant de Cf. www.utls.fr; www.francparler.org. La communication en gestion des entreprises et des organisations ne prend pas nécessairement en compte la dimension interculturelle, comme on le voit dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication de B. Lamizet et A Silem, Paris, Ellipses ( 1997). On y relève cette définition de la communication: “elle désigne l’ensemble des actions entreprises en vue de donner la meilleure image de cette entreprise ou de cette organisation, d’accéder à une certaine notoriété, faire connaître les produits et les activités de l’organisation pour développer éventuellement les parts de marché, de motiver les hommes. Ces actions reposent sur différentes techniques dites de communication: relations publiques, internes et externes, relation presse, publicité, publicité directe (courrier, téléphone) logo de l’entreprise, emballage des produits, charte graphique, parrainage, mécénat”. 12 13 121 l’interculturel est acteur privilégié. On ne peut le traiter comme un récepteur de connaissances objectives et lui permettre de garder une distance illusoire avec l’objet d’étude. Car cette distance même est un problème essentiel qui doit être traité par la formation à l’interculturel. Des méthodes tout à la fois réflexives et actives sont donc requises, avec sans doute une réelle dimension ludique pour exorciser l’anxiété de telles mises en perspectives (cf. note 7. Diagnostic interculturel). L’ouvrage de O. Meier14 (2006) offre des exemples de pratiques du Management Interculturel relatif aux actions organisationnelles et relationnelles que l’entreprise doit intégrer pour améliorer sa performance économique et sociale. Ce que notre module CLIL tente de réaliser dans le projet Interculturalité et entreprises dont il a été question plus haut (note 8) représente aussi une forme de collaboration avec certaines entreprises pilotes en Piémont, comme Ferrero, Michelin, par exemple. Parmi les pratiques proposées se situent le repérage de la culture d’entreprise grâce à des rencontres-séminaires avec des dirigeants de ces deux entreprises internationales15. La politique de communication et de recrutement (en particulier les modalités de recherches de cadres formés à l’international dans des entreprises des deux pays) révèle la distance culturelle existante et le travail à faire pour répondre aux défis lancés par le management interculturel eurostratégique, comme l’affirment Hans Merkens et Jacques Demorgon 16. D’un point de vue de l’organisation chrono-didactique (c’est-à-dire la gestion du temps par rapport aux contenus de l’enseignement), chaque cours d’une durée de 90 minutes est divisé en trois moments successifs de 30 minutes, le premier relatif aux concepts (savoirs) explicités par l’enseignant, le second constitué de lectures de textes significatifs par rapport aux concepts et notions présentés précédemment; à ce point les étudiants commentent et explicitent pour personnaliser leur champ de réflexion, mettre à profit leurs connaissances et les croiser, culturellement parlant. Ce moment d’échanges, et parfois de débats en groupe de discussion, permet autant le renforcement linguistique spontané de chacun que l’approfondissement de savoirs dans une atmosphère d’échanges tout à fait favorable au partage des cultures en présence, à l’intérieur du groupe classe. Le troiO. MEIER, Management interculturel: Stratégie, organisation, performance, Paris, Dunod, 2006. Nos étudiants participent également à quelques séminaires organisés par l’Université de Turin sur la culture d’entreprise: incontro formativo sull’autoimprenditoria nell’ambito della START CUP 2009. Argomento del seminario: “Le caratteristiche dell’impresa”. 16 Les cultures d’entreprise et le management interculturel, téléchargé de http://www.ofaj.org/paed/texte2/intmanagfr/intmanagfr21.html p. 14 14 15 122 sième moment correspond à la mise en pratique ou actualisation des principaux savoir-faire du communicateur d’entreprise qui connaît, par exemple, le rôle du corps dans la communication orale, les modalités de la négociation, les différents écrits de l’entreprise et leurs fonctions etc. Par ailleurs des études de cas relatifs au personnel d’entreprises internationales mettent en évidence les aptitudes essentielles au développement d’une compétence interculturelle et soulignent les tâches à accomplir pour tirer le meilleur parti possible de la diversité culturelle en terme de réussite d’actions, de conquête de marchés etc. Le bref survol de cette mission CLIL, orientée vers le Management Interculturel tout en langue française, a montré l’équilibre et la flexibilité de ce processus d’enseignement. Loin d’être un dispositif méthodologiquement improvisé, il s’est nourri de réflexions sur les modalités didactiques les plus appropriées pour un public universitaire, en partie international. Les enjeux du CLIL dans le monde actuel sont aussi bien pédagogiques que culturels et économiques17. Or, l’intégration de contenus non disciplinaires stimule les compétences linguistiques grâce aux mises en situations multiples, et dans ce cas précis, développe les compétences interculturelles à partir de pratiques intégrées au monde du travail, mais “à la manière humaniste”. Ce parcours universitaire, dont les visées professionnelles se précisent au fur et à mesure que les divers enseignements se complètent, s’adresse à des linguistes de formation: il débouche sur le stage obligatoire, lieu d’application et d’évaluation des savoirs et savoirs-faire, construits à partir de concepts puis d’applications réflexives et pratiques. Même si l’enseignement de Management Interculturel ne représente qu’une partie minime de la formation, il introduit l’essentiel des compétences de terrain, indispensables au seuil de l’entrée dans la vie professionnelle. En effet, notre public binational, titulaire d’un double diplôme, a été évalué de manière élogieuse par les responsables de stages français et italiens qui les ont suivis pendant plus de six mois: ces derniers ont relevé différents facteurs de réussite: outre les compétences linguistiques et interculturelles, la vivacité de 17 La Commission Européenne joue un rôle fondamental dans la vision d’une Europe multiculturelle et plurilingue: elle demande à chaque état membre de protéger ses langues minoritaires et de promouvoir l’apprentissage des langues communautaires. Parmi les publications: AA.VV, L’enseignement d’une matières intégré à une langue étrangère (EMILE) à L’Ecole en Europe, EURYDICE, 2006; AA.VV, Document de travail de la Commission: Rapport sur la mise en œuvre du plan d’action Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique, Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, 2003. Elle soutient financièrement les projets en cours (dont le projet LICI dont nous sommes responsable scientifique pour la période 20062009) et les grands congrès consacrés récemment à la diffusion du CLIL: au Luxembourg en 2005: The changing european classroom-Potential plurilingual Education, 09-11\mars ; à Helsinki en 2006 : Competence-building for globalization Quality in Teaching through a Foreign Language, 15-16 juin ; à Tallin en 2008 : CLIL Fusion Multilingual Mindsets in a Multicultural World, 24-25 octobre. 123 leurs qualités intellectuelles, leur pleine maturité et leur autonomie dynamique. C’est ce qui a fait dire à certains responsables de stage qu’ils ont appris grâce à leur stagiaire. Pour notre part, les résultats obtenus grâce à la mise en place d’un mudule CLIL ont été évalués de façon positive: sur le versant disciplinaires, compte tenu de l’étendue de la matière et de sa fragmentation didactique, il faut noter une certaine superfficialité qui a engendré toutefois une réelle aptitude à l’international. Sur le versant linguistique une nette progression des compétences communicatives langagières a été relevé par l’équipe des enseignants (des compétences linguistiques aux compétences sociolinguistiques et pragmatiques). Quant à l’évaluation de la part des apprenants, si l’on s’en tien à leiìur présence active et assidue au module comme une forme d’appréciation implicite, nous pouvons conclure que cette modalité innovative a remporté leur adhésion et vaut la peine d’être expérimentée à l’université.. Bibliographie P.E. BALBONI, Le sfide di Babele, Torino, UTET, 2003. P.E. BALBONI, Parole La compétence communicative interculturelle: un modèle [trad.MChristine Jamet] in Cahiers ITALS Département des Sciences du langage, Università Ca’Foscari Venezia, Guerra Edizioni, 2006. H. BOYER, M. BUTZBACH ET M. BENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère, Paris, Clé International, 1990. C. BOURGUIGNON, Evaluation et perspective actionnelle CECR: du contrôle des connaissances à l’évaluation des compétences in Le Français dans le monde, 353, 2007. J.P. BRONCKART et alii, Agir et discours en situation de travail In Cahiers de la section des Sciences de l’éducation n°103, Université de Genève, 2004. C. CAMILLERI, Cultures et stratégies ou les mille manières de s’adapter » in Identité(s):l’individu, le groupe, la société, coordonné par Halpern C., Ruano-Borbalan JC, Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2004, p. 85-92. S. CHENVRIER, Le management des équipes culturelles, Paris, PUF, 2000. C.M. COONAN, La lingua straniera veicolare, Torino, UTET, 2002. C.M. COONAN, CLIL:un nuovo ambiente di apprendimento, Università Ca’ Foscari Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2006. D. COYLE, Supporting students in content and language integrated contexts:planning for effective classroom in Masih (sous la direction de) Learning through a Foreign Language, Londres, Cilt, 1999, p.43-62. G. FERREOL, G. JUCQUOIS, Dictionnaire de l’altérité et des relations culturelles (sous la direction de), Paris, Colin, 2003. E. GOFFMAN, Les cadres de l’expérience, Paris, Editions de Minuit, 1991. E.T. HALL. Le langage silencieux, Paris, Seuil, 1984. 124 B. LAMIZET, A. SILEM, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication, Paris, Ellipses, 1997. J. LE ROUX, « Effective educators culturally competent communicators » Intercutural education, 2002, vol. 13, 1, p. 37-48. O. MEIER, Management interculturel: stratégie, organisation, performance, Paris, Dunod, 2006. G. VERBUNT, La société interculturelle: vivre la diversité humaine, Paris, Seuil, 2001. 125 126 ТEFFI. L’EMIGRAZIONE COME FORMA DI SOPRAVVIVENZA LETTERARIA Nadia Caprioglio “Il sottile fiotto di sangue che la mattina vidi attraversare il marciapiede davanti al portone del Commissariato mi tagliò per sempre la strada della vita. Scavalcarlo non potevo, proseguire oltre, neppure. Non mi restava che tornare indietro di corsa”. Il sottile fiotto di sangue che scorre davanti al Commissariato di Odessa, ricordato da Teffi in uno dei suoi ultimi scritti pubblicati in patria1, determinò la sua sorte di emigrante, rappresentando la linea di demarcazione fra le due parti della sua esistenza: quella pietroburghese e quella parigina. Sul finire del 1918, insieme con lo scrittore Arkadij Averčenko, Teffi partì da Pietroburgo per una touneé a Kiev: non sarebbe mai più ritornata nella sua città natale. Il suo percorso di emigrazione è tipico dei russi che non hanno voluto lasciare la patria fino all’ultimo momento: l’Ucraina, la Crimea, Costantinopoli, infine Parigi. Nell’abbandonare la Russia Teffi si lascia alle spalle una grande popolarità, conquistata grazie al successo dei suoi racconti che venivano ristampati2 in continuazione, alle sue commedie che erano sempre in scena, alla collaborazione a numerosi giornali e riviste che dovevano la propria fama al suo nome. Come affermerà anche lo scrittore Mark Aldanov in una recensione del 19233, nessun altro scrittore ebbe mai in Russia una così ampia cerchia di lettori: nonostante i suoi scritti fossero pubblicati soprattutto dalla stampa liberale, la leggevano volentieri “entrambe le Russie”, tanto che uno dei suoi più affezionati ammiratori era l’Imperatore Nicola II. TEFFI, Na skale Gergesinskoj, in “Grjaduščij den’ ”, 1 (1919), pp. 32-34. Le principali raccolte di Teffi pubblicate in Russia prima dell’emigrazione sono: Sem’ ognej, S. Peterburg, 1910; Jumorističeskie rasskazy, S. Peterburg, 1910; Jumorističeskie rasskazy II. Čelovekoobraznye, S.Peterburg, 1911; I stalo tak..., S. Peterburb, 1912; Karusel’, S.Peterburgb, 1913; Dym bez ognja, S. Peterburb, 1914; Ničego podobnogo, Praha, 1915; Neživoj zver’, Praha, 1916; Včera, Praha, 1918. 3 Ved. М. АALDANOV, Teffi. Passiflora, in “Sovremennye zapiski”, 18 (1923), p. 485. 1 2 127 Nella Russia pre-rivoluzionaria erano di moda il profumo “Тeffi” e i cioccolatini “Тeffi”; molti davano il suo nome ai proprî fox-terrier e levrieri4. Тeffi, in realtà, era lo pseudonimo con cui Nadežda Aleksandrovna Lochvickaja firmava le proprie opere5. Era nata il 9 maggio 1872 a Pietroburgo in una nota famiglia nobiliare in cui “scrivevano tutti”6, dal nonno alle sorelle; ella stessa definisce “atavico”7 il proprio dono letterario e negli scritti autobiografici ricorda che le sue prime letture furono Infanzia e Adolescenza di Tolstoj e la prosa di Puškin8; in seguito prese a interessarsi alla poesia russa e tentò di scrivere alcune poesie satiriche. I suoi primi versi apparvero nel settembre del 1901 sulla rivista “Sever”; il suo primo racconto, Den’ prošel [Il giorno è passato], nello stesso anno sulla rivista “Niva”. Ben presto i suoi feuilletton in versi cominciarono a essere pubblicati sulla rivista “Zvezda” e sul numero domenicale del quotidiano “Birževye vedomosti”. Le sue poesie e i suoi racconti brevi appariranno in vari periodici russi, fra cui “Novosti”, “Rus’”, “Teatr i iskusstvo”, “Beseda”, “Rodnaja niva” e molti altri in cui Teffi continuò a pubblicare fino alla rivoluzione del 1905. I suoi scritti di questi anni presentano una forte connotazione politica anti-zarista e molti uscirono sulla prima rivista legale dei Bolscevichi, “Novaja Žizn’ ”, cui collaboravano alcune figure di spicco del mondo letterario, fra cui Zinaida Gippius e Maksim Gor’kij. Le opere più significative, tuttavia, furono scritte per la rivista satirica di San Pietroburgo “Satirikon” (piu tardi “Novyj satirikon”) e per il quotidiano moscovita “Russkoe Slovo”, ai quali Teffi collaborò regolarmente fino alla loro chiusura. Il volume intitolato Jumorističeskie rasskazy [Racconti umoristici], cui deve la sua notorietà, apparve nel 1910. La raccolta rivela acutezza, forte spirito di osservazione e, al tempo stesso, un senso dell’umorismo gentile, quasi elegiaco. A interessarla non è tanto la personalità umana, quanto la vita di ogni giorno, monotona, grigia, ripetitiva e, nonostante tutto, drammatica nella sua staticità. L’uomo che vive su questo sfondo è un 4 Ved. М. CETLIN, N. A. Teffi, in “Novyj žurnal” 6 (1943), p. 384; I. ODOEVCA, V streči s N. A. Teffi, in “Russkaja Mysl’ ”, 21-11-1968, p. 8. 5 In un feuilleton pubblicato a Parigi durante l’emigrazione Teffi spiega che l’adozione di questo pseudonimo è legata al suo primo successo teatrale (Ženskij vopros). Di solito si pensa che il nome Teffi derivi dalla giovane eroina di una fiaba di Kipling (Taffy nell’originale): in realtà l’autrice spiega che non è così. Il nome (leggermente distorto “per delicatezza”) deriverebbe da un “scemo” soprannominato Steffi che viveva nei suoi poderi, basandosi sul fatto che “questi scemi hanno sempre avuto fortuna”. Quando in seguito un giornalista le domandò se l’origine dello pseudonimo fosse Kipling, ella acconsentì di buon grado, in quanto era imbarazzata a rivelare l’autentica origine di quel nome (TEFFI, Psevdonim, in “Vozroždenie”, 20-12-1930, p. 2). 6 V. AGENOSOV, Teffi, in Literatura russkogo zarubež’ja, Moskva, Terra Sport, 1998, p. 370. 7 Ved. AA. VV., Pervye literaturnye šagi. Avtobiografii russkich pisatelej, a cura di F. Fidler, S. Peterburg, 1911, pp. 203-205. 8 Ved. D. NIKOLAEV, Edinstvennaja, original’naja, čudesnaja, intr. a TEFFI, Sobranie sočinenij, Moskva, Lokom, 1997, vol. 1, p. 7. 128 essere ridicolo, intimidito, debole e immancabilmente infelice. La critica accolse con favore gli scritti di Teffi e arrivò a paragonare i suoi piccoli bozzetti dai toni elegiaci e profondamente umanitari ai migliori racconti di Čechov9, apprezzandone anche la lingua e mettendo in rilievo il senso di “unità organica”10 che fa sì che ogni racconto rappresenti un capitolo della “generale commedia umana”. Per il delicato humor dei suoi brevi racconti Teffi viene considerata superiore ad autori di fama mondiale quali Jerome Jerome e Mark Twain11. Seguendo la tradizione čechoviana12, Teffi nei suoi racconti rappresenta un’ampia gallleria di personaggi, migliaia di piccoli uomini con il loro mondo interiore. L’attenzione della scrittrice non si rivolge agli eventi internazionali, bensì all’“esistenza quotidiana degli uomini normali che sacrificano invano l’energia del cuore e della mente alle piccole sfide e ai piccoli insuccessi della vita”13. Fra il 1911 e il 1918 Teffi pubblicò sei raccolte di racconti umoristici e un volume di racconti seri, Neživoj zver’ [La bestia morta]14, grazie ai quali “tutti l’amavano senza eccezione”15 e apprezzavano il suo raro talento. La Rivoluzione d’Ottobre pose fine all’opera creativa di Teffi in Russia. Nonostante avesse salutato la Rivoluzione di Febbraio con entusiasmo, al pari di altri intellettuali russi di ispirazione liberale, di fronte all’insurrezione bolscevica si sentì smarrita, non riuscì a trovare il proprio posto nella nuova vita che si andava affermando in Russia. In alcuni racconti pubblicati più tardi nell’emigrazione Teffi rammenta quei tempi, l’inizio del bolscevismo, descrive Pietroburgo come una città “nuda, lacera, sudicia”16, dove le sembrava che tutti fossero uniti solo dalla malvagità. Nel racconto V streči [Incontri] Teffi descrive una scena di violenza gratuita cui aveva assistito per le vie di Pietroburgo: una povera rozza, che sembra uscita dalle pagine di Dostoevskij17, caduta a terra per la fatica e picchiata a morte tra Ved. A. ČEBOTAREVSKAJA, Teffi. I stalo tak… Jumorističeskie rasskazy, in “Novaja žizn’”, 7 (1912), p. 255; N. LERNER, Teffi. Dym bez ognja, in “Literaturnoe i populjarno-naučnoe priloženie ‘Nivy’ ”, 2 (1914), p. 459. 10 V. KR. [V. KRANICHFEL’D ], Teffi. Jumorističeskie rasskazy, in “Sovremennyj mir”, 9 (1910), p. 255. 11 Ved. V. NEMOIROVIĊ-DAMIĊENKO, Na Kladbiščach. Vospominanija, Revel, Bibliofil, 1921, p. 140. 12 La scrittrice stessa afferma che “le prime opere pubblicate furono scritte sotto l’influenza di Čechov” (AA. VV., Pervye, cit., p. 104). 13 G. ADAMOVIĊ, Teffi, in Odinočestvo i svoboda, New York, Izd. Im. Čechova, 1952 (reprint: Moskva, Respublika, 1996, p. 86). 14 Nell’emigrazione questa raccolta sarà ristampata con il titolo Tichaja zavod’ (Paris, 1921). 15 Secondo le parole di A. Kuprin (cit. in I. VALIL’EV, intr. a: N. A. TEFFI, Žit’e-byt’e. Rasskazy. Vospominanija, Moskva, Izd. Političeskoj literatury, 1991, p. 4). 16 TEFFI, V streči, in O nežnosti, Paris, 1938, ora in: N. A. Teffi, Sobranie sočinenij, Moskva, Lakom, 2000, vol. 4, p. 223. 17 Un’amica parigina di Teffi, Valentina Vasjutinskaja Carcadé, parla del suo amore per Dostoevskij: “Nadežda Aleksandrovna leggeva senza sosta passi da I fratelli Karamazov, La moglie altrui e il marito sotto il letto, Il villaggio di Stepančikovo… benché il suo romanzo preferito rimanesse sempre L’idiota” (V. VASJUTINSKAJA, Nadežda Aleksandrovna Teffi. Iz ličnych vospominanij, in “Vozroždenie”, 131 (1962), pp. 91-92). 9 129 l’indifferenza dei passanti, diventa per Teffi il simbolo di quella Russia sempre più disumana che la scrittrice, presa dal panico, decise di abbandonare. Parafrasando Georgij Adamovič, potremmo dire che Teffi abbandonò la Russia per restare russa nella propria “tonalità” interiore, per non dover dividere la propria vita in pre-rivoluzionaria e post-rivoluzionaria. E così, agli inizi del 1920, dopo un periglioso viaggio per mare e per terra18, Teffi si ritrovò nella Parigi emigré. Cominciò subito a partecipare alla vita letteraria dell’emigrazione pubblicando due poesie sul numero di febbraio della rivista “Grjaduščaja Rossija”19, la prima rivista dell’emigrazione russa in Francia. L’opera che produsse maggior impatto, tuttavia, fu pubblicata poche settimane più tardi sul primo numero del quotidiano russo dell’emigrazione “Poslednie novosti”. Si tratta del feuilletton Ke fer?, senza dubbio il racconto più popolare di Teffi. Comincia con un aneddoto basato su un gioco linguistico fra francese e russo: un generale russo arriva a Parigi, si ferma ai piedi dell’obelisco di Place de la Concorde, guarda con attenzione tutt’intorno, sospira, apre le braccia e, smarrito, dice: “È tutto bello… bellissimo, anzi… ma que faire? Fer-to ke!”20 È tutto bello in questa magnifica città, ma che fare, come vivere in mezzo a tanta bellezza senza lavoro, senza soldi, senza speranza nel futuro? In effetti, le parole del generale, al tempo stesso comiche e tragiche nel loro incongruo tentativo di combinare francese e russo, colgono l’essenza della condizione dell’emigrato russo, il suo tentativo, ugualmente incongruo e assurdo, di fondere la propria personalità russa con un contesto estraneo. Racconta Don Aminado, altro famoso scrittore satirico emigrato, che le parole del vecchio generale del feuilleton di Teffi diventarono un proverbio, “un ritornello costante della vita nell’emigrazione”21. Se “Que faire? ” trasmette una sorta di dileggio nei confronti del risoluto “Che fare?” di Černyševskij, in “Fer-to ke! ” si percepisce tutto lo smarrimento degli emigranti che sperano nel ritorno e vivono solo nell’attesa di quel momento. Nella maggior parte dei casi il ritorno rimane un’illusione e i loro Teffi descrive dettagliatamente il suo congedo dalla patria nel volume Vospominanija (Paris, 1932). Korabl’ e Proklat’e, in “Grjaduščaja Rossija”, 2 (1920), p.71 (entrambe ristampate nella raccolta Passiflora, Berlin, 1923). 20 Ке фер?, in “Poslednie novosti”, 27-12-1920, p. 2 (ristampato nella raccolta Rys’, Berlin, 1923). L’equivoco si basa sulla traslitterazione in cirillico dell’espressione francese “Que faire?” che il generale ripete invertendo l’ordine delle parole e aggiungendo la particella enclitica “-to” la quale nella lingua russa conferisce alla frase un’accezione esclamativa. Dopo la sua pubblicazione sul quotidiano parigino il racconto uscì anche in Russia su “Pravda” e “da quel giorno primaverile del 1920 cominciò a diffondersi nella Mosca sovietica l’equivoco del generale: “Ке fer? Fer-tо kе?..” – e qualcuno cominciò a scherzarci sopra dicendo che i compagni si suddividevano in kefery e fertoki ...” (S. VINOGRADSKAJA, Esli pojdet ..., in “Ogonëk”, 18 (1962). 21 D. AMINADO, Poezd na tret’em puti, New York, Izdatel’stvo im. Chekhova, 1954, p. 258. 18 19 130 “diari non scritti”22 segnano i cambiamenti di umore e la loro graduale disillusione. All’arrivo a Parigi tutti si rifiutano di cercare una sistemazione stabile, alloggiano in albergo e pranzano al ristorante, consolandosi delle parole di “un certo ingegnere”, appena giunto dalla Russia, il quale sostiene che “i bolscevichi non arriveranno alla primavera”23; dopo un anno decidono che “nei dintorni di Parigi si respira un’aria molto migliore”24, si trasferiscono in una camera ammobiliata di periferia e scoprono che “ad aspettare la chiusura del negozio ‘Félix Potin’, si può trovare dell’ottima verdura con cui preparare il minestrone”25. All’epoca Teffi non si faceva illusioni: non condivideva le speranze dei suoi personaggi circa un imminente ritorno in Russia, per quanto siamo sicuri che anche lei, nel cielo stellato sopra alla torre Eiffel, “indicando col dito la costellazione di Orione”, come tutti i russi meditasse sulla solitudine e pensasse alla Russia26. Nell’ambiente dell’emigrazione russa degli anni Venti Teffi trova subito il proprio posto: Don Aminado ricorda che era arrivata un mese prima degli altri e per questo si sentiva una vecchia parigina, tanto che la sua piccola camera d’albergo, non lontana dalla Chiesa della Madeleine, diventò un vero e proprio centro letterario27. Teffi non era soltanto uno degli scrittori più amati dell’emigrazione russa, ma anche la rappresentante della colonia russa a Parigi. Era assidua frequentatrice del salone letterario di Zinaida Gippius e Dmitrij Merežkovskij, “La lampada verde”, membro di varie associazioni, una della più attive organizzatrici dei “Giorni della Cultura russa”, gli incontri franco-russi sull’ “anima russa”. Dal 1920 al 1940 nessuno scrittore ebbe tanta popolarità nell’ambiente dell’emigrazione quanto Teffi. In esilio conosce un periodo di intensa attività creativa: tutte le case editrici, i giornali e le riviste dell’emigrazione pubblicavano i suoi scritti, che ottenevano immancabilmente un grande successo di pubblico e di critica. Oltre a collaborare settimanalmente con vari periodici, Teffi ristampò tutte le opere pubblicate precedentemente in Russia e pubblicò otto nuovi volumi di racconti, la sua principale raccolta di poesie, Passiflora, una novella, Ved. Il racconto Iz dnevnikov nenapisannych, in TEFFI, Žit’e-byt’e, cit., pp. 154-157. Ivi, p.155. 24 Ivi, p.156. 25 Ibidem. 26 Ved. Il racconto Bašnja, ora in: EAD., Nostal’gija. Rasskazy. Vospominanija, a cura di B. Averin, Leningrad, Chodožestvennaja literatura, 1989, pp. 150-154. Anche Ivan Bunin nel 1921 pubblicava il saggio letterario Ob Ejfelovoj bašne [La torre Eiffel, “Obščee delo”, 21-07-1921, p. 2]: entrambi gli autori soffermano la loro attenzione sui radioripetitori della torre Eiffel che danno la possibilità di entrare in comunicazione con le persone amate che vivono in Russia. 27 D. AMINADO, Poezd, cit., p. 257. 22 23 131 Avantjurnyj roman [Romanzo d’avventure], un volume di memorie e una serie di opere teatrali28 L’abbandono della Russia può essere visto come uno spartiacque nell’opera di Teffi: nonostante si sforzasse di sottolineare che ella stessa, il mondo, l’uomo non fossero cambiati, tuttavia i personaggi e le tematiche dei racconti dimostrano che la sua opera è entrata in una nuova fase. Da questo momento Teffi sceglie come tema la vita degli emigrati russi, interessandosi alla problematica dell’esilio. Capisce che la letteratura russa può continuare a esistere anche nell’emigrazione, a patto che abbia coscienza della propria condizione. L’esilio acuisce la sensibilità al tema della Russia e previlegia il ruolo della memoria. Non c’è nessuna rottura con la Russia eterna verso cui sono costantemente rivolti i suoi pensieri, anzi nei racconti dell’emigrazione Teffi sente la necessità di ricordare e far ricordare il passato, nel timore che il passato possa essere dimenticato. In russo (come per la lingua greca classica29) si confrontano due accezioni diverse del verbo “ricordare” (pomnit’): una espressa dal verbo napominat’ si riferisce al “menzionare” (in greco mimnésko), l’altra, espressa dal verbo vspominat’, si riferisce propriamente al “ricordare” e al “rammentarsi” (in greco mnáomai). Proprio da qui si può risalire alle due direzioni metaforiche della memoria indicate da Harald Weinrich30, anch’esse di ascendenza greca: l’una relativa all’immagine della tavoletta di cera su cui si imprimono i dati della memoria mettendoli in luce31 (Platone, Teeteto, 191d32), l’altra connessa all’idea della memoria funzionale al ricordo, come un magazzino che li contiene (Platone, Filebo, 34)33. A ben guardare, esse costituiscono i due aspetti complementari, consequenziali, della memoria: il “ricordarsi”, 28 Volumi composti interamente o quasi di opere pubblicate in Russia prima dell’emigrazione: Tichaja zavod’ (Paris, 1921); Černyj iris (Stockholm, 1921); Vostok i drugie rasskazy (Shangaj, 1921); Sokrovišče zemli (Berlin, 1921); Stambul i solnce (Berlin, 1921); Tak žili (Stockholm, 1922). Raccolte di racconti dell’emigrazione pubblicati da Teffi negli anni Venti e Trenta: Rys’ (Berlin, 1923); Večernyj den’ (Praha, 1924); Gorodok (Paris, 1927); Vsë o ljubvi (Paris, s. a.); Kniga jun’ (Beograd, 1931); Ved’ma (Berlin, 1936); О nežnosti (Paris, 1938); Zigzag (Paris, 1939). Altre pubblicazioni di rilievo: Passiflora (Berlin, 1923); Аvantjurnyj roman (Paris, 1932); Vospominanija (Paris, 1932); P’esy (Paris, 1934). Inoltre, il volume di poesie Šarman (Berlin, s. a.) e la piccola raccolta di fiabe popolari russe per bambini Baba-Jaga: narodnaja skazka (Paris, 1932). 29 Ved E. BENVISTE, Formes et sens de “mnaomai”, in ID., Festschrift A. Debrunner, Berne, 1954, citato in M. DETIENNE, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Maspero, 1967, cap. I. 30 H. WEINRICH, Typen der Gedächtnismetaphorik, in “Archiv für Begriffgeschichte”, 4 (1964), pp. 23-26 [trad. it.: Metafora e menzogna: la serenità dell’arte, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 49-53]. 31 Ricordiamo a questo proposito la famosa poesia di O. Mandel’štam Grifel’naja Oda [Ode d’ardesia, 1923], costruita sull’opposizione fra gli elementi distruttori del tempo e quelli che, al contrario, possono resistergli e che, dunque, costituiscono il luogo in cui si trova l’arte autentica. 32 Ved. PLATONE, Teeteto, in Dialoghi filosofici, a cura di G. Cambiano, Torino, Utet, 1981, vol. 2, p. 296. 33 Ved. G. CAMBIANO, Problemi della memoria in Platone, in ID., Tracce nella mente. Teorie della memoria da Platone ai moderni, a cura di M. M. Sassi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006. 132 lo scegliere dal magazzino, precede normalmente il “menzionare”, ossia la procedura con cui rendiamo conto, nel caso della letteratura mediante la scrittura, di questa azione di trasferimento. È quanto possiamo osservare nei racconti dell’emigrazione di Teffi, dove prevale la riminiscenza, intesa nel suo modello dinamico, che non si limita a duplicare, ma che ricostruisce i fatti e le situazioni modificandoli in base alle nuove esperienze provenienti dall’esterno34. La rievocazione assume, dunque, un carattere interpretativo: nel ricordare qualcosa risalente alla propria vita in Russia, i personaggi dei racconti di Teffi non muovono mai da un’informazione importante, ma da un particolare, o un dettaglio che viene associato a un’esperienza precedente. Osservando che a Parigi mancano le stagioni intermedie, che “le parigine a febbraio portano il cappellino di paglia e a luglio di velluto”35, affiora il ricordo dei preparativi della partenza estiva per la dacia; il Natale parigino mite e senza neve riporta alla mente il ricordo struggente del Natale in Russia, quando “la neve arrivava alla cintura e la cornacchia congelava in volo”36. Non a caso fra le opere di Teffi troviamo una quantità consistente di scritti autobiografici37 e, non a caso, fra i suoi temi più ricorrenti c’è la memoria di un’infanzia felice, vista attraverso il filtro della nostalgia che nasce dal trovarsi in terra straniera. Uno dei personaggi più amati da Teffi è la vecchia balia, di puškiniana memoria: si tratta di una figura senza tempo, che approda dalla Russia con i suoi “collettini ricamati”, dolce e mite come Katerina Petrovna in uno dei suoi racconti più lirici38, oppure severa e scura in volto, come nel racconto Nostal’gija [Nostalgia]. In entrambi i casi è depositaria di tutti i beni perduti che rappresentano la Russia e rischiano di cadere nell’oblio: “Racconta a lungo dei boschi, dei campi, delle monache, dei lattari in salamoia, degli scuri scarafaggi, della processione con la benedizione dell’acqua per favorire il raccolto”39. Non ama il nuovo ordinamento, sa fare ottime ciambelline alla ricotta e ogni sera, dopo essersene stata un po’ triste in solitudine “va nella camera dei bambini e si abbandona ai suoi pensieri notturni, ai suoi sogni di vecchietta, sempre sullo stesso tema”40. 34A proposito della natura dinamica della memoria si veda il celebre studio di F. BARTLETT, Remembering, Cambridge, Cambridge University Press, 1962 [trad. it.: La memoria, Milano, Angeli, 1972] e il saggio di JU. APRESJAN, Eksperimental’noe issledovanie semantiki russkogo glagola, Moskva, Nauka, 1967, pp. 5-35. 35 Dačnyj sezon, in TEFFI, Nostal’gija, cit., pp. 164-167. 36 Sladkie vospominanija, in EAD., Žit’e-byt’e, cit., pp. 184-187. 37 Ved., tra gli altri, il racconto I vremeni ne stalo, in EAD., Sobranie sočinenij, Moskva, Lakom, 2001, vol. 7, pp. 237-249. 38 Katerina Petrovna, Ivi, vol. 4, p. 47. 39 Nostal’gija, in: EAD., Nostal’gija, cit., p. 163. 40 Ibidem 133 Attraverso la nostalgia viene sublimata la ferita dell’esilio, che è al tempo stesso lontananza dalla patria, dalla casa e da ogni cosa cara, ma anche esilio dalla vita vera, amore per la vita che nasce dalla sua privazione. “Arriva un nostro profugo, sfinito, provato dalla fame e dalla paura. Si tranquillizza, si guarda intorno per capire come organizzare la sua nuova vita e di colpo si spegne, – scrive Teffi nel racconto Nostal’gija. – Gli occhi si offuscano, le braccia smunte perdono forza, appassisce l’anima rivolta a oriente. Non crediamo in nulla, non ci aspettiamo nulla, non vogliamo nulla. Siamo morti. Avevamo paura della morte bolscevica e abbiamo trovato la morte qui”41. La coscienza della mancanza di una vita vera, il Ke fer del povero generale smarrito, si inserisce nel flusso delle più grandi contraddizioni della modernità, che tende a cogliere la vita solo attraverso l’anelito per la vita, per poi scoprire che la vita non basta. I personaggi teffiani sono incapaci di vivere, sembrano immersi in un vuoto metafisico apertosi all’improvviso nella loro esistenza, un vuoto che ha sconvolto l’ordine delle cose e dei sentimenti. Teffi con il suo umorismo dolce-amaro bersaglia i compatrioti smarriti, un po’ decadenti, assolutamente inetti nella grande Parigi d’anteguerra: Grigorij Petrovič, ex-capitano dell’armata russa, che perde più di un lavoro a causa del proprio eccesso di zelo e della propria ingenuità42, o i coniugi Ugarovy, che avendo conservato la loro ingenua anima russa, la loro fiducia negli uomini, vengono derubati di tutti i risparmi43, fanno parte di una comunità dai contorni indefiniti che vive alla giornata, al di fuori del tempo e dello spazio, in una condizione di perenne provvisorietà. Teffi si immagina questa società come una cittadina sulle rive della Senna e la descrive nella sua raccolta più famosa, oltre che più riuscita, Gorodok [La cittadina], pubblicata nel 1927. Sulla copertina della prima edizione è raffigurato un samovar sullo sfondo della torre Eiffel e si capisce subito che questa “cronaca”, come recita il sottotitolo, si riferisce alla “Parigi russa dell’emigrazione, uno stato nello stato, una piccola ‘enclave’ nella capitale del mondo”44. Gorodok è anche il titolo del racconto che apre la raccolta, in cui è descritta la colonia russa a Parigi, un mondo strano, spesso povero: “Era una piccola città. Quarantamila abitanti, una chiesa e una innumerevole quantità di trattorie [...]. La popolazione conduceva una vita noiosa [...]. I giovani per lo più facevano gli autisti. Le persone più attempate gestivano le trattorie o vi lavoravano come camerieri [...]”45. Ivi, pp. 161-162. Grigorij Petrovič, in EAD., Žit’e-byt’e, cit., pp. 174-178. 43 L’âme slave, Ivi, pp. 163-168. 44 G. STRUVE, Russkaja literatura v izgnanii, Paris, YMKA-Press, 1984, p. 112. 45 Gorodok. Chronika, in TEFFI, Gorodok. Novye rasskazy, Paris, N. P. Karbašnikov, 1927, pp. 152-153. 41 42 134 La raccolta contiene racconti esili, miniature che rappresentano con delicata ironia altrettanti spaccati di vita di molti personaggi sradicati, tutti contraddistinti dalla ricerca di una “patria”, non tanto materiale quanto spirituale. Queste singole miniature si uniscono a formare “i capitoletti di un grande tutto”46, una vera e propria cronaca, in base alla quale, secondo Don Aminado, “è possibile ricostruire dettagliatamente l’epopea dell’emigrazione”47. Teffi rappresenta la nuova esistenza russo-francese degli emigranti, misera e prosaica, i loro sforzi per raggiungere uno stile di vita europeo: se inizialmente i personaggi di Teffi nutrivano la speranza di far presto ritorno in patria, ora cercano un posto nel nuovo mondo. In realtà sprecano la loro esistenza bighellonando per la città e ripetendosi: “Bisogna lavorare. Costruire una giovane Russia”48 come Andrej Nikolaevič Kormjatov, le tendre André del racconto Dve vstreči [Due incontri], oppure bruciano la loro giovinezza nel gesto estremo del suicidio, come Kostja, protagonista di Majskij žuk [Il maggiolino]49. Chi sono gli abitanti di Gorodok? Esseri perennemente affamati e in cerca di un prestito, poco pratici, ma molto loquaci; amano la ricotta e le lunghe conversazioni telefoniche, non ridono mai e sanno essere anche molto cattivi. Conoscono l’arte di arrangiarsi e di accontentarsi, come il giovane protagonista di Čudesnaja žizn’ [Una vita meravigliosa], che ha messo sulla porta una targa con la scritta: “André d’Ivanoff, artiste de musique”50, o la minuta Daisy che ricama maglioni impossibili nella vana speranza di venderli ai francesi51. La società di Gorodok è divisa in donne e uomini: mentre gli uomini trascorrono il loro tempo a contrarre debiti l’uno con l’altro, “le donne si cuciono vestiti e si confezionano cappellini”52. Nei racconti dell’emigrazione Teffi ritorna a uno dei suoi temi preferiti già in Russia: le donne. Le eroine della Parigi russa di Teffi apparterngono tutte ad un’unica categoria: non nutrono grandi passioni, sono superficiali e chiacchierone. Molte di loro lavorano come sarte, le altre si fanno fare abiti dalle prime. Quando si incontrano parlano per lo più di svendite in qualche famoso negozio di guanti o di come si mangia male nei ristoranti piccoli53. In realtà, hanno perduto, coB. ZAJCEV, in “Sovremennye zapiski”, 34 (1928), p. 498. Cit. in N. NIKOLAEV, Koncepcija ‘knigi’ v tvorčestve N. A. Teffi, in: ID., Tvorčestvo N. A. Teffi i russkij literaturnyj process pervoj poloviny XX veka, Moskva, Nasledie, 1999, p. 34. 47 D. AMINADO, Poezd, cit., p. 257. 48 Dve vstreči, in TEFFI, Nostal’gija, cit., p. 154. 49 Ved. Majskij žuk, in EAD.., Gorodok, cit., pp. 212-217. 50 Čudesnaja žizn’, in TEFFI, Nostal’gija, cit., p. 203. 51 Ved. Desi i ja, in EAD., Gorodok, cit., pp. 221-223. 52 Ivi, p. 153. 53 Ved. Associacii, in EAD., Delo 2, San Francisco, 1951, vol. 1, pp. 68-75. 46 135 me tutti, la loro identità: a chi può servire che Anna Stepanova in patria facesse la levatrice, se a Gorodok “anche i professori hanno trovato lavoro nel coro zigano”54? Soffrono di una profonda nostalgia, ma in pubblico non lo danno a vedere: in pubblico il passato si dimentica55. Les rjussi – come li chiamano i francesi56 – hanno smesso di parlare di arte russa, di letteratura russa, “persino Tolstoj e Dostoevskij si citano sempre più raramente”57. “Oltre che di uomini e donne la popolazione della cittadina è composta di ministri e generali”58 che si dedicano soprattutto alla scrittura di memorie. La solitudine è una dominante della loro esistenza: trascorrono la giornata soli nelle loro camere d’affitto, in attesa della posta, anche se non hanno mai ricevuto una lettera59, quasi dimentichi che “qui è la Francia”60. Tutti i russi che vivono sulle rive della Senna “sono stanchi, soli, invecchiano pian piano”61. Domina tra loro una stanchezza esistenziale che si riflette anche nello stile dell’autrice: sincopato, asciutto, senza periodi lunghi. Тeffi trasmette un quadro spietato: da una parte ricorda Storia di una città di Saltykov-Ščedrin, anche se Teffi sostituisce il sarcasmo con l’ironia, a volte amara, a volte triste; dall’altra suscita un parallelo con la caratterizzazione che, negli stessi anni, Zoščenko fa degli “uomini nuovi” affermatisi nel frattempo in Unione Sovietica: troviamo la stessa incapacità di vivere in armonia con l’ambiente circostante, nuovo ed estraneo. La visione del mondo che emerge dalle centinaia di personaggi descritti nei racconti di Teffi, in fondo, non si allontana molto da quella che prevaleva negli anni della sua formazione in Russia, ai tempi del Simbolismo: è una visione del mondo dualistica, secondo cui l’esistenza terrena appare vuota, senza significato, morta, mentre la “realtà vera” è sempre altrove. È da questo sentimento che nasce la “Grande tristezza” (con l’iniziale maiuscola), descritta nel racconto Syr’ë [Materia prima]: “Tutto è vecchio, tutto è come prima. Soltanto Lei è nuova”62. È un ospite subdolo, che si avvicina quando meno te l’aspetti e all’improvviso “ti spegne lo sguardo e ti piega verso il basso gli angoli delle labbra”63. Anche Teffi, nonostante la fama di scrittrice Anna Stepanova, in EAD., Gorodok, cit., p. 210. Syr’e, in EAD.., Nostal’gija, cit., p. 168. 56 Ved. Ke fer, cit. 57 Syr’e, cit., p. 167. 58 Gorodok, cit., p. 153. 59 Den’, Ivi, pp. 217-220. 60 Ivi, p. 220. 61 A. SEDYCH, cit. in O. MICHAJLOV, Ot Merežkovskogo do Brodskogo: literatura russkogo zarubež’ja, Moskva, Prosviščenie, 2001, p.167. 62 Syr’e, cit., p. 167. 63 Ibidem 54 55 136 umoristica di cui gode, non sfugge ai suoi assalti: Irina Odoevceva riferisce che durante una conversazione Teffi le confessò quanto la propria anima fosse imbevuta delle lacrime “non versate”: “Fuori ho il sorriso, la ‘grande siccità’, come scrivevano sui vecchi barometri, ma dentro una palude sconfinata, non l’anima, solo una palude”64. Durante gli ultimi anni della sua esistenza Teffi è malata, soffre per la solitudine e l’indigenza. Sopravvive alla guerra, ma ne esce vecchia, impoverita e seriamente provata65. Tuttavia, anche in questi momenti difficili il suo umorismo amaro non l’abbandona, come rivela una delle sue ultime lettere: “I miei coetanei se ne stanno andando tutti e io continuo a vivere. Come se fossi nella sala d’aspetto del dentista, gli altri pazienti mi passano davanti e io non oso dir nulla. Resto seduta lì, stanca, incattivita...”66 La sua attesa terminò il 6 ottobre 1952. Poco prima di morire aveva detto: “Appartengo alla scuola čechoviana, il mio ideale è Montpassant. Amo Pietroburgo, ho molto amato Gumilëv, era un bravo poeta e una brava persona. Il periodo migliore della mia attività resta comunque quello russo67. I. ODOEVCEVA, O Teffi, in EAD., Dal’nye berega, a cura di V. Krejd, Moskva, Respublika, 1994, p. 323. La migliore testimonianza sull’ultimo periodo della vita di Teffi è rappresentata dalle sue lettere inviate all’amico Andrej Sedych. Ved. A. SEDYCH, N. A. Teffi v pis’mach, in “Vozdušnye puti. Almanach”, 3 (1963), pp. 191-213. 66 Ivi, p. 212. 67 Е. ТRUBILOVa, Teffi N. A., in EAD., Russkoe zarubež’e. Zolotaja kniga emigracii, Moskva, Rosspen, 1997, p. 639. 64 65 137 138 TRASLITTERAZIONE E TRASCRIZIONE AUTOMATICHE MEDIANTE L’USO DI UN FOGLIO ELETTRONICO: IL CASO DELLA LINGUA RUSSA TRASCRITTA IN LINGUA ITALIANA Luca Anselma, Davide Cavagnino, Laura Seroglia, Joanna Spendel Premessa In questo articolo viene presentata un’applicazione informatica che esegue automaticamente la trascrizione e traslitterazione di un testo in lingua russa. La traslitterazione trasforma il testo scritto in alfabeto cirillico in alfabeto latino, mentre la trascrizione è volta a rispettare il più possibile la pronuncia originaria e indica a un parlante italiano come pronunciare il testo russo. La peculiarità della soluzione proposta risiede nell’uso di un foglio elettronico e delle relative funzioni disponibili, per fornire uno strumento (i) multipiattaforma e (ii) didatticamente valido, in quanto (i) le regole di traslitterazione e trascrizione possono essere adattate ad altre architetture e applicativi e (ii) sono facilmente modificabili da utenti non esperti di informatica. Автоматическая транслитерация и транскрипция употребляя случай русского языка в транскрипции на итальянский язык В статье рассматривается компьютерное применение, которое осуществляет автоматически транскрипцию и транслитерацию любого текста на русском языке. Транслитерация перевращает текст написанный кириллицей в текст написанный латинским алфавитом, между тем как транскрипция придерживается произношения, как можно ближе, и указывает говорящему на итальянском языке, как произносится русский текст. Особенность данного решения предлагает употребление электронного листа /spreadsheet/ и соответствующих основных его функций для создания средств (i) и (ii), которые можно одновременно использовать в изучении русского языка. С одной стороны, правила (i) транслитерации и транскрипции могут быть приспособлены к разным компьютерным системам и иметь также другие применения, с другой, средства (ii) изменяются легко, даже не опытными пользователями. 139 Automatic transliteration and transcription using a spreadsheet: the case of Russian language into Italian language In this paper we describe a computer application aimed at automatically transliterate and transcribe a text in Russian language. On the one hand, the transliteration converts a text written in Cyrillic alphabet into a text written in Latin alphabet. On the other hand, the transcription aims at matching as close as possible the original pronunciation and suggesting to a native speaker of a different language (in this case, an Italian speaker) how to pronounce the Russian text. Our solution uses a spreadsheet and its features in order to provide a tool which proves to be both (i) portable over different computing environments and (ii) didactically useful; in fact, (i) the rules of transliteration and transcription can be adapted to different computer systems and applications, and (ii) they can be easily modified by non-expert computer users. 1 Introduzione Una difficoltà che può incontrare un turista occidentale in paesi slavi orientali (ad esempio Russia, Ucraina, Bulgaria, Serbia) consiste nella lettura di scritte in un alfabeto a lui sconosciuto, l’alfabeto cirillico. Analoghe difficoltà si possono incontrare in situazioni diverse da quelle turistiche, come nella predisposizione di carte geografiche o nella trascrizione di nomi propri di persone, fenomeno ricorrente nel campo letterario e giornalistico. In questo contesto, un applicativo informatico in grado di rendere “leggibile” un testo scritto in un alfabeto diverso da quello latino (leggibile e, quindi, comunicabile), riveste sicuramente interesse sia pratico che didattico. In questo lavoro presentiamo un riassunto della tesi di un coautore del lavoro, consistente in un’applicazione informatica di un foglio elettronico volto alla trascrizione e alla traslitterazione di testi russi. L’applicazione permette di risalire automaticamente alla traslitterazione di un testo cirillico (e quindi una rappresentazione in alfabeto latino) e alla trascrizione di un testo russo (e quindi una rappresentazione in alfabeto latino che suggerisca a un parlante italiano l’effettiva pronuncia del testo in lingua russa). Naturalmente, non tutti i fonemi della lingua russa trovano una corrispondenza tra i fonemi dell’italiano; nel lavoro si è resa necessaria l’adozione di convenzioni internazionali e lo studio di soluzioni atte a mitigare tale problema. L’applicativo è progettato per essere facilmente modificabile per l’adozione di diverse scelte e l’adattamento a lingue diverse da quelle appartenenti alla famiglia delle lingue slave. 140 1.1 Traslitterazione e Trascrizione 1.1.1 Traslitterazione La traslitterazione è il metodo impiegato per rendere leggibile in un determinato alfabeto (ad esempio, l’alfabeto latino) una parola straniera appartenente a lingue che utilizzano un sistema alfabetico diverso (come ad esempio il cirillico, l’arabo, il greco, ecc…). Tale metodo segue uno specifico schema di conversione che fa corrispondere a ciascuna lettera (o a particolari gruppi di lettere) dell’alfabeto di origine una o più lettere dell’alfabeto di destinazione. Per esempio, il nome proprio femminile russo Гульчара viene solitamente traslitterata come Gul’čara. Purtroppo gran parte delle traslitterazioni usano segni diacritici che da un lato non sempre sono facilmente disponibili nei programmi di videoscrittura, nelle pagine Internet o in tipografia, e dall’altro possono costituire anche un serio limite per la comprensione del vocabolo da parte di chi non conosce il corretto significato di tali segni. I principali sistemi a carattere utilizzati per la traslitterazione sono quelli proposti dallo International Organization for Standardization (in breve, ISO). Gli standard ISO sono redatti da commissioni composte da esperti internazionali e sono documenti contenenti specifiche tecniche o altri criteri precisi come regole, linee guida, definizioni per promuovere il coordinamento e la diffusione di norme che facilitino gli scambi internazionali di beni e servizi e sviluppino la collaborazione in ambito intellettuale, scientifico, tecnico ed economico. Tra le varie commissioni ISO, una specifica si occupa dettagliatamente dell’ambito linguistico: è la ISO/TC 46/SC 2 (Technical Committee 46: Information and documentation – Subcommittee 2: Conversion of written languages). Attraverso diverse norme essa definisce regole comuni per eseguire la traslitterazione da un sistema alfabetico all’altro: ad esempio, la norma ISO 9 [ISO 9] (in seguito adottata dalla Federazione Russa come norma GOST 7.79 [GOST 7.79]) stabilisce un metodo per la traslitterazione in caratteri latini dei caratteri cirillici che costituiscono l’alfabeto delle lingue slave meridionali e di alcune lingue non slave. Il principale vantaggio di ISO 9 sugli altri sistemi di traslitterazione dal cirillico è la scelta di far corrispondere (usando i segni diacritici) un solo carattere latino per ciascun carattere cirillico e viceversa, il che permette di rappresentare univocamente il testo originale trascritto, dal quale sarà sempre possibile ottenere, applicando le stesse regole in senso opposto, una precisa traslitterazione inversa, anche se il testo originale non è noto. 141 Tuttavia, esistono anche altri sistemi di traslitterazione, che spesso hanno maggiore diffusione: ad esempio, per l’alfabeto cirillico il sistema più diffuso è il GOST 16876-71 [GOST 16876-71], standard originariamente promosso dall’URSS e successivamente adottato, nella versione del 1983, in sede ONU, dove è maggiormente conosciuto come UN 1987 [UN 1987]. 1.1.2 Trascrizione La trascrizione, a differenza della traslitterazione, mira a rappresentare (in modo più o meno approssimativo) la pronuncia effettiva delle parole. La metodologia di trascrizione più completa è quella seguita dall’International Phonetic Alphabet (in breve, IPA), che fa corrispondere a ogni suono una sua rappresentazione grafica indipendente dalla lingua di origine e di destinazione. In sostanza, l’IPA è un alfabeto fonetico usato dai linguisti per rappresentare in maniera univoca e convenzionale ciascuno degli svariati suoni (tecnicamente detti foni) che l’apparato vocale umano è in grado di produrre, così come le unità distintive del linguaggio chiamate fonemi, di tutte le lingue del mondo. I segni utilizzati dall’IPA sono per lo più caratteri dell’alfabeto latino, con alcuni grafemi greci ed altre lettere non appartenenti a nessun alfabeto. La ricchezza dell’IPA rende tale sistema di difficile utilizzo per chi non ha delle conoscenze pregresse di linguistica. Nell’esempio precedente, la trascrizione IPA di Гульчара è [gul’ʃɑ-rɑ]. Un altro metodo molto più semplice, ma purtroppo meno preciso e dipendente sia dalla lingua di origine che da quella di destinazione, è invece quello che associa al solo inventario fonetico1 della lingua di origine i foni corrispondenti di una specifica lingua di destinazione, e quindi rappresenta graficamente questi ultimi secondo l’alfabeto e le convenzioni di scrittura della lingua di destinazione. Per riprodurre un medesimo suono, infatti, diverse lingue possono possedere rappresentazioni grafiche diverse, formate da una o più lettere: ad esempio, per trascrivere la lettera russa ш un italiano renderà il suono tramite il digramma sc o il trigramma sci, mentre un anglofono sceglierà sh, un tedesco sch, un francofono ch e un polacco sz. Per esempio, una possibile trascrizione di шесть per parlanti italiano è scests, mentre una trascrizione per parlanti inglese è shests. Per utilizzare questo metodo di trascrizione di testi da una lingua a un’altra (soprattutto se esse utilizzano grafemi di alfabeti diversi) è dunque indispensabile definire preliminarmente una serie di regole basate sull’osservazione delle similitudini e delle differenze fonetiche esistenti tra le due 1 Inventario fonetico: insieme dei suoni caratteristici di una data lingua. 142 lingue. Si noti ad esempio che la lingua russa utilizza 43 fonemi diversi (38 consonanti e 5 vocali) più 5 vocali allofone aventi funzioni indicative delle caratteristiche delle consonanti che li precedono [Hamilton, 1980; Skoromochova e Macagno, 2007]; per trascrivere un testo russo secondo la grafia italiana si dovranno dunque individuare altrettanti fonemi italiani corrispondenti o, in loro assenza, ampliare la gamma di questi ultimi ricorrendo ai fonemi (e corrispondenti grafemi) di altre lingue latine prossime all’italiano, della cui presenza dovrà ovviamente essere adeguatamente avvertito l’utilizzatore. Più avanti alcuni paragrafi sono dedicati a questa osservazione ed alla conseguente definizione delle regole di trascrizione. 1.2 Gli strumenti informatici 1.2.1 Il foglio elettronico Un foglio elettronico (spreadsheet) è un programma applicativo che si presenta all’utente come una griglia di celle, in cui le righe sono identificate dai numeri naturali a partire da 1 e le colonne dalle lettere dell’alfabeto inglese A, …, Z, AA, …, AZ, BA, BB, … Ogni cella è identificata mediante le proprie coordinate, che ne specificano la colonna e la riga. Pertanto, ad esempio, D1 identifica la cella all’incrocio tra la quarta colonna e la prima riga. Una delle caratteristiche fondamentali del foglio elettronico è che il contenuto di una cella, oltre a un numero o un insieme di caratteri, può anche essere un valore calcolato a partire da valori presenti in altre celle del foglio. Un’altra importante caratteristica è che il foglio elettronico è “attivo”, nel senso che la modifica del valore in una cella provoca automaticamente il ricalcolo dei valori nelle celle che da essa dipendono. Nella soluzione proposta, è possibile utilizzare qualsiasi foglio elettronico, a patto che dia supporto a un insieme di funzioni tipicamente presenti in tutti i programmi moderni di questo tipo, quali le funzioni di sostituzione di testo (si veda oltre). 1.2.2 La codifica Unicode® Poiché i computer lavorano esclusivamente con numeri rappresentati come sequenze di bit, il trattamento informatico dei testi avviene attraverso una codifica numerica dei caratteri. Affinché le tabelle di codifica rimangano valide indipendentemente dal particolare elaboratore e sistema opera143 tivo utilizzati, è stato definito lo standard Unicode2, che codifica in modo univoco i caratteri speciali e le lettere di tutte le lingue del mondo. È da notare che, anche se una lettera cirillica e una latina hanno lo stesso glifo, devono essere, e sono, codificate da Unicode con sequenze di bit diverse. 2 Dal russo all’italiano 2.1 Convenzioni adottate e soluzioni proposte Come si è prima accennato, esistono diversi sistemi alfabetici atti ad operare la traslitterazione dall’alfabeto cirillico a quello latino. Per la realizzazione del sistema di traslitterazione si è scelto di utilizzare lo standard GOST (1983) / UN (1987) [UN 1987], poiché è il metodo ufficialmente utilizzato nella Federazione Russa, oltre che in modo crescente nella cartografia e nell’editoria internazionale, e in secondo luogo perché non utilizza molti segni diacritici, risultando così sufficientemente comprensibile, anche se pur sempre insoddisfacente sotto l’aspetto della pronuncia, anche per i lettori italiani. La Tabella 1 illustra la corrispondenza tra le lettere maiuscole e minuscole dell’alfabeto cirillico e le corrispondenti lettere dell’alfabeto latino secondo la regola stabilita dal sistema GOST (1983) / UN (1987) [UN 1987]. Si noti come la tabella comprenda 33 righe, quante sono le lettere dell’alfabeto cirillico moderno. La traslitterazione avviene utilizzando lettere singole dell’alfabeto latino per quanto possibile, e per le lettere cirilliche eccedenti si ricorre a segni diacritici e digrammi latini. Lo Unicode Consortium [Unicode] è un consorzio senza fini di lucro, istituito per sviluppare, estendere e promuovere l’uso dello standard Unicode. I membri del consorzio rappresentano un’ampia gamma di aziende e di organizzazioni attive nell’Information Technology. 2 144 Tabella 1 – Tavola di traslitterazione Cirillico-Latino secondo GOST(1983)/UN(1987). Cirillico Cirillico Latino Latino maiuscolo minuscolo maiuscolo minuscolo А а A a Б б B b В в V v Г г G g Д д D d Е е E e Ё ё Ë ë Ж ж Ž ž З з Z z И и I i Й й J j К к K k Л л L l М м M m Н н N n О о O o П п P p Р р R r С с S s Т т T t У у U u Ф ф F f Х х H h Ц ц C c Ч ч Č č ш Š š Ш Щ щ Šč šč Ъ ъ " " Ы ы Y y Ь ь ‘ ‘ Э э È è Ю ю Ju ju Я я Ja ja Per colmare la distanza tra la reale pronuncia del testo russo e la lingua italiana (o almeno per avvicinarsi il più possibile), nell’applicativo sviluppato viene affiancata alla traslitterazione convenzionale la trascrizione, per rendere totalmente comprensibile la pronuncia delle parole o frasi russe e per permettere a chiunque non sappia il russo di leggere il nome di una via, o di capire parole che, se rese nel nostro alfabeto, ci risultano immediatamente molto più comprensibili. Ad esempio, “администрация” si trascrive come “administraziia”. 145 La Tabella 2 illustra le corrispondenze generiche da noi utilizzate per eseguire la trascrizione fonetica del russo in italiano. Anche in questo caso la tabella comprende 33 righe, per due delle quali (i cosiddetti “suoni deboli”, cioè la ъ e la ь) tuttavia non è stata definita alcuna corrispondenza, essendo in pratica le differenze di pronuncia da esse indotte sostanzialmente inavvertibili (e quindi irriproducibili) nel parlato italiano. Tabella 2 – Corrispondenze generiche di trascrizione dal russo in italiano. Cirillico colo А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 146 Maius- Cirillico Minuscolo а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я Latino colo A B V G D IE IO J Ś I I K L M N O P R S T U F KH Z C’ SC’ SC’ Maius- Latino Minuscolo a b v g d ie io j ś i i k l m n o p r s t u f kh z c’ sc’ sc’ Ü ü E IU IA e iu ia 2.2 Problematiche di trascrizione dal russo all’italiano con esempi Può capitare che un dato suono appartenente alla lingua di partenza non sia rappresentabile nella lingua di arrivo poiché inesistente, oppure può verificarsi il caso di eccezioni di pronuncia legate alla posizione del fonema all’interno della parola o alla vicinanza con altre lettere che ne mutano il suono: il russo, avendo a disposizione 33 lettere dell’alfabeto, ha la possibilità di assegnare ad ogni suono un solo grafema, rendendo più complessa la trascrizione in italiano. Si possono evidenziare quattro gruppi principali di problematiche: i fonemi russi che non hanno alcuna corrispondenza fonetica in italiano; i fonemi russi riproducibili foneticamente con gruppi di lettere italiane; ed infine le eccezioni di pronuncia legate alla posizione del grafema all’interno della parola, sia nella lingua russa che in quella italiana. L’elenco completo delle problematiche considerate e le soluzioni corrispondentemente proposte sono schematizzate in Tabella 3; si noti che per il grafema russo K non è stata proposta una trascrizione specifica, in quanto tale lettera, seppure non facente parte dell’alfabeto italiano, grazie alla pronuncia univoca nelle varie lingue che la utilizzano, è ormai diventata di uso comune anche da noi. 147 Tabella 3 – Principali problematiche di trascrizione dal russo all’italiano. Problema Fonemi russi senza corrispondenza in italiano Fonemi russi riconducibili a gruppi di lettere italiane Eccezioni di pronuncia nella lingua russa Eccezioni di pronuncia nella lingua italiana Ж Soluzione proposta J Х kh Ы ü я ia е ie й i ё io ю iu ш sc’ variante allofona vocale a variante allofona vocale e variante allofona vocale i variante allofona vocale o variante allofona vocale u suono sc dolce щ sc’ suono sc dolce щедрый scedrüi в f Булгаков Bulgakof Г v русского russkovo ть ts делать dielats ч sc’ v che in finale di parola diventa f g che in certe posizioni diventa v t e segno debole in finale di parola diventa ts c in certe posizioni diventa sc’ конечно koniesc’no ч ci davanti alle vocali a, o, u чай ciai г gh davanti alle vocali e, i геолог ghieolog ч c’ c da leggere morbida davanti alle consonanti мечтать miec’tats Grafem a russo Note Esempio Trascrizione corrisponde al fonema j francese corrisponde al fonema ch tedesco suono intermedio tra u e i желать jielats похороны улыбка pokhoronü ulübka della приятель priiatiel della первый piervüi della свой svoi della компьютер kompiutier della люди liudi кашмар kasc’mar 2.3 Soluzione proposta 2.3.1 La metodologia La metodologia di trascrizione e traslitterazione si basa su un insieme di regole ognuna delle quali definisce come uno o più caratteri cirillici debbano essere sostituiti con uno o più caratteri latini. 148 Le regole vengono applicate sequenzialmente alla frase in lingua russa; ognuna delle regole riceve come input la frase risultante dall’applicazione della regola precedente e produce come output una nuova frase avente la sostituzione prevista applicata al (ai) carattere(i) specificato(i) dalla regola stessa. La sostituzione prevista da ogni regola può coinvolgere: - un carattere cirillico che deve essere sostituito da un carattere latino (sostituzione 1:1); - un carattere cirillico che deve essere sostituito da una sequenza di due o più caratteri latini (sostituzione 1:n); - una sequenza di due o più caratteri cirillici che deve essere sostituita da due o più caratteri latini (sostituzione n:m). Non si avranno regole che definiscano la sostituzione di n caratteri cirillici con un carattere latino. Queste regole trovano una naturale implementazione nelle funzioni di sostituzione previste da molti tipi di fogli elettronici moderni ampiamente diffusi (ad esempio Openoffice.org Calc e Microsoft® Office Excel). La funzione dei fogli elettronici che costituisce la base dell’algoritmo descritto è SOSTITUISCI. La sintassi della funzione è: SOSTITUISCI(T; V; N; r) dove T è la stringa di caratteri contenente il testo a cui deve essere applicata la regola, V è la stringa di caratteri cirillici, che se presente in T dovrà essere sostituita con la stringa di caratteri in N, ed r specifica, se presente, a quale occorrenza di V in T dovrà essere applicata la sostituzione. Dato che la trascrizione/traslitterazione dovrà essere applicata a ogni occorrenza, non si è utilizzato l’ultimo parametro della funzione. Per esempio, SOSTITUISCI (“mara”; “a”; “o”) restituisce la stringa “moro”. La struttura della riga generica che specifica una delle regole di sostituzione è esemplificata nella Figura 1. 1 … i-1 i A Testo precedente – … Ai-1 Ai B Testo da sostituire – … Bi-1 Bi C Frase con sostituzione applicata Testo iniziale … =SOSTITUISCI(Ci-2; Ai-1; Bi-1) =SOSTITUISCI(Ci-1; Ai; Bi) regola (i-1)-esima Figura 1: porzione di foglio elettronico che illustra la struttura generica di una regola. 149 La cella C1 contiene il testo in caratteri cirillici. La generica cella alla riga i-esima nella colonna C conterrà la frase in C1 con applicate le sostituzioni delle i-1 regole presenti nelle righe 2, 3, …, i. Con la tecnica fin qui esposta si effettua quindi una traslitterazione basata su regole in cui ogni regola viene scritta in una riga del foglio elettronico. Da ciò derivano la comprensibilità e la semplicità con cui le regole di traslitterazione possono essere inserite. In Figura 2 sono evidenziate le righe del foglio elettronico che trascrivono le lettere russe р, с e я; la cella C1 contiene il testo russo originale, mentre la cella C33 indica l’effetto complessivo di tutte le sostituzioni previste, cioè la trascrizione. 1 … 17 18 19 … 33 A Testo precedente – … … р с … я B Testo da sostituire – … … r s … ja C Frase con sostituzione applicata русского (testo iniziale) … руссkovo rуссkovo rуsskovo … russkovo Figura 2: porzione di foglio elettronico che illustra le regole per la trascrizione delle lettere russe р, с e я. Per completezza rimane da gestire il caso in cui una lettera maiuscola debba essere trascritta/traslitterata con due o più lettere (sostituzione 1:n). Nel caso in cui la lettera successiva sia maiuscola, allora tutte le lettere trascritte dovranno essere maiuscole; in caso invece sia minuscola, solo la prima delle lettere trascritte dovrà essere maiuscola mentre le successive minuscole. Si avrà, ad esempio, che: - Если sarà trascritta come Iesli; - ЕСЛИ sarà trascritta come IESLI. L’algoritmo che si è seguito per distinguere i due casi è rappresentato in Figura 3. 150 N La lettera maiuscola da sostituire 1:n è presente nel testo? N Usa la trascrizione con la sola prima lettera maiuscola S La lettera successiva è maiuscola? S Usa la trascrizione con tutte le lettere maiuscole Figura 3: diagramma di flusso per determinare la modalità di trascrizione 1:n di una lettera maiuscola in cirillico. Questo algoritmo può essere implementato con una serie di formule che coinvolgono le funzioni di scelta binaria (SE), le funzioni di ricerca (TROVA) e sostituzione (SOSTITUISCI), scritte nelle celle della riga del foglio che implementa la regola. Purtroppo la funzione SOSTITUISCI di Excel non è “case sensitive”, cioè non distingue tra lettere maiuscole e minuscole. Questa limitazione costringe a un espediente tecnico3, che in sporadici casi potrebbe essere non soddisfacente oppure all’adozione di una soluzione in parte legata al linguaggio di programmazione Visual Basic for Applications, che, d’altro canto, limiterebbe la portabilità della soluzione. Il sistema funziona correttamente in quanto, come precedentemente accennato a proposito della codifica UNICODE, le lettere con lo stesso glifo appartenenti ad alfabeti diversi hanno codifica diversa. Se così non fosse, una lettera cirillica potrebbe essere trascritta con una lettera latina Dato che la ricerca viene effettuata per una singola occorrenza della lettera cirillica (per poi analizzare se il resto della parola è maiuscolo o minuscolo), tale regola andrebbe replicata almeno tante volte quante sono le occorrenze della lettera cirillica in questione. Essendo ciò dipendente dalla frase, la regola è stata replicata un numero arbitrario di volte (10), su più righe, aggiungendo una regola standard (cioè come quelle in Figura 1) in coda che quindi non opera la distinzione maiuscole/minuscole e che traslittera/trascrive tutte le eventuali occorrenze rimanenti. 3 151 che, se uguale (stesso glifo) a una lettera cirillica la cui regola deve ancora essere applicata, porterebbe a una ulteriore errata sostituzione. 3 Lavori correlati Esiste una grande quantità di lavori riguardanti la traslitterazione di lingue slave e del russo in particolare esistono sia sotto forma di programmi applicativi (per esempio, il software shareware RusFon [RusFon]) che di applicazioni web (per esempio, [Translit.cc] e [translit.ru]). Si può consultare anche la bibliografia sulla traslitterazione delle lingue slave su [transbib]. I lavori riguardanti la trascrizione automatica delle lingue slave sono invece più rari. Un motivo possibile consiste nell’uso di dizionari che contengono la trascrizione fonetica IPA o (più rari) la trascrizione fonetica in una lingua di arrivo. Un limite di questo approccio consiste nell’assenza dai dizionari delle forme declinate e coniugate. Lavori di respiro decisamente più ampio sono legati al riconoscimento automatico del linguaggio parlato e conseguente trascrizione automatica, quali i lavori legati al progetto Multilingual Access to Large Spoken Archives [Malach; Psutka et al., 2005]. 4 Conclusioni In questo lavoro abbiamo presentato un’applicazione di un foglio elettronico per la trascrizione e la traslitterazione di testi russi. Il vantaggio nell’utilizzo di un applicativo di foglio elettronico consiste nella portabilità della soluzione, immediatamente utilizzabile o facilmente adattabile agli elaboratori e sistemi operativi che danno supporto a fogli elettronici con le funzioni di base. Inoltre, l’applicativo è didatticamente valido: poiché le regole di traslitterazione e trascrizione sono rappresentate in maniera dichiarativa (specificamente, in forma tabellare), tali regole sono facilmente modificabili anche da utenti non esperti di informatica. La soluzione proposta è quindi facilmente applicabile a: - traslitterazioni alternative (ad esempio, ISO 9); - trascrizioni dal russo all’italiano con scelte fonetiche diverse; - trascrizioni a lingue di arrivo diverse; - trascrizione in IPA; - trascrizione da lingue di partenza basate su alfabeti diversi dal cirillico, quali l’arabo, il greco, i sistemi di scrittura giapponesi hiragana e katakana. 152 Possibili sviluppi futuri consistono nell’accoppiamento con programmi di word processing quali Microsoft® Word, in modo da rendere lo strumento facilmente accessibile durante la redazione di testi, nell’implementazione in linguaggio javascript, in modo da aumentare la portabilità e rendere fruibile l’applicativo tramite il World Wide Web e, infine, l’adattamento per computer palmari e telefoni cellulari. Bibliografia [GOST 16876-71] GOST 16876-71 – Pravila transliteratsii bukv kirillovskogo alfavita bukvami latinskogo alfavita. [GOST 7.79] http://gsntinorms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/stands/7_79.htm [Hamilton, 1980] W. S. HAMILTON, Introduction to Russian Phonology and Word Structure, Slavica Publishers, 1980. [ISO 9] Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages (http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?c snumber=3589) [Malach] http://malach.umiacs.umd.edu/ [Psutka et al., 2005] J. PSUTKA, P. IRCING, J.V. PSUTKA, J. HAJIC, W. BYRNE, J. MIROVSKI, Automatic transcription of Czech, Russian, and Slovak spontaneous speech in the MALACH project, in Proceedings of EUROSPEECH, 2005. [RusFon] http://kudaschov.de/eng/RusFon/rusfon.htm [Skoromochova e Macagno, 2007] L. SKOMOROCHOVA, C. MACAGNO, Grammatica descrittiva della lingua russa, Pisa, Edizioni ETS, 2007. [transbib] http://intranet.library.arizona.edu/users/brewerm/sil/lib/transbib.html [Translit.cc] http://translit.cc/ [translit.ru] http://www.translit.ru/ [UN 1987] Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Montreal, 18-31 agosto 1987, vol. I. Report of the Conference, 1987, pp. 40-41. [Unicode] http://www.unicode.org/standard/standard.html 153 154 LINGUISTICA CONTRO FILOLOGIA II: L’EPENTESI DI L’ IN SLAVO. Mario Enrietti Le sequenze protoslave di consonanti labiali (p, b, m, v) + j sono rappresentate nello slavo orientale, in sloveno e in serbo-croato da pl’, bl’, ml’, vl’ con l’introduzione tra le consonanti e le vocali seguenti di un l’ “molle”, detto epentetico, sostituto di j, mentre nello slavo occidentale, negli odierni bulgaro, macedonico e nella toponomastica slava della Grecia sono conservati pj, bj, mj, vj (con la trasformazione in p’, b’, m’, v’ nelle lingue che hanno la correlazione di timbro delle consonanti)1. Nei manoscritti paleoslavi piú antichi la presenza di l’ è quasi costante, mentre in quelli piú recenti (Suprasliensis, Evangeliarium Savae) l’ è rappresentato soltanto sporadicamente. Al protosl. *zemja “terra” corrispondono: paleosl. zeml’a (ma zemьja nel Suprasliensis), r. zemljá, slov. zémlja, serbo-cr. zèmlja, ma bulg. zemjá, maced. zemja, slavo di Grecia Ζεμιανή ~ *zemjane, pol. ziemia, ceco. země. Al protosl. *kupja “commercio, mercato” corrispondono: paleosl. kupl’a russo kúplja, serbo-cr. kûplja, ma bulg. kúpja, pol. kupia, ceco koupě. Nei toponimi slavi della Grecia: Σερβιανά ~ *Sьrbjane, Δούπιανη ~ *Dupjane . La maggioranza degli studiosi: Vondrák2, van Wijk3, Meillet-Vaillant4, Vaillant5, Bräuer6, Klemensiewicz et alii7, Mareš8, Stieber9, Mirčev10, Kone1 In alcune lingue e dialetti slavi j si è trasformato in x’ (dopo consonante sorda) o in γ’ (dopo sonora) e in altri suoni. Un’abbondante messe di questi casi, anche con paralleli in lingue non slave, è data da L. BEDNARCZUK, Słowiańskie l’ epentetyczne w perspektywie porównawczej, in “Studia linguistica ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie jego urodzin”, Katowice 1999, pp. 247-255. 2 W. VONDRÁK, Vergleichende slavische Grammatik2, I, Lautlehre und Stammbildungslehre, Gottinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1924, p. 377. 3 N. VAN WIJK, Palaeoslovenica. II. O zaniku l epentheticum w cerkiewnosłowiańskim języku, in “Rocznik Slawistyczny”, 9 (1930), pp. 14-18. 4 A. MEILLET - A. VAILLANT, Le slave commun2, Parigi, Champion, 1934, p. 96. 5 A. VAILLANT, Grammaire comparée des langues slaves, I, Phonétique, Parigi, IAC, 1950, p. 69; ID., Manuel du vieux slave2, I, Parigi, Institut d’études slaves, 1964, p. 64. 6 H. BRÄUER, Slavische Sprachwissenschaft, I, Einleitung und Lautlehre, Berlino, W. de Gruyter & Co., 1961, p. 198. 7 Z. KLEMENSIEWICZ et alii, Gramatyka historyczna języka polskiego, Varsavia, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1965, p. 130. 8 F. V. MAREŠ, Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen, Monaco di B., O. Sagner, 1969, p. 79 155 ski11, Schaeken12 e altri, ha affermato che l’ epentetico sia stato un giorno comune a tutte le lingue slave, ma che si sia piú tardi perso nelle lingue slave occidentali, nel bulgaro e nel macedonico. È però anche stata messa in dubbio, da altri studiosi, la diffusione panslava di l’ epentetico (Mladenov13, Lamprecht14, Moszyński15 e altri). L’idea, maggiormente condivisa, che l’ epentetico fosse un giorno comune a tutto lo slavo riposa su fragili basi. Innanzi tutto sulla suggestione che ha esercitato, a causa della sua antichità e del suo prestigio, il paleoslavo: poiché in quest’ultimo i manoscritti piú antichi mostrano l’ epentetico, mentre la sua frequenza diminuisce in quelli piú recenti, se ne è concluso, estendendo meccanicamente questo modello a tutto lo slavo, che l’ fosse originariamente panslavo e che si sia in séguito perso. Si veda ciò che scrive il van Wijk16: “Was das Bulgarische anbetrifft, so weist die abg. Textüberlieferung auf ein ausnahmsloses Vorhandensein des l epenteth. im allerältesten Aksl. hin, – wodurch die Wahrscheinlichkeit, daß es einmal auf dem ganzen slavischen Gebiet vorhanden war, größer wird”17. Sempre nell’àmbito dei manoscritti paleoslavi, poi, una tesi diversa da quella corrente è stata proposta dal Moszyński18; egli ha sostenuto che l’ non esistesse originariamente nella lingua di Cirillo e Metodio ma che sia stato introdotto in Bulgaria nei manoscritti dai chierici di Kocel, componente numerosa degli allievi dei due fratelli (circa 50, secondo il cap. XV della Vita Constantini), che riproducevano il loro dialetto pannonico del quale l’ epentetico era una caratteristica comune con i dialetti serbo-croati e sloveni. Esso infatti è attestato senza eccezioni nel Messale di Kiev19. Ma a mano a mano che, con lo scorrere del tempo, l’influenza dei chierici pannonici diminuiva, gli scribi bulgari e macedoni lo avrebbero eliminato perché estraneo alla loro lingua. Z. STIEBER, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, I, Fonologia, Varsavia, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1969, p. 76. 10 K. MIRČEV, Istoričeska gramatika na bălgarskija ezik3, Sofia, Nauka i izkustvo, 1978, p. 152. 11 B. KONESKI, A Historical Phonology of the Macedonian Language, Aidelberga, C. Winter, 1983, p. 49. 12 J. SCHAEKEN, Die Kiever Blätter, Amsterdam, Rodopi, 1987, p. 99. 13 ST. MLADENOV, Geschichte der bulgarischen Sprache, Berlino-Lipsia, W. de Gruyter & Co., 1929, p.149. 14 A. LAMPRECHT, Praslovanština, Bruna, Univerzita J. E. Purkyně, 1987, pp. 53 sg. 15 L. MOSZYŃSKI, Staro-cerkiewno-słowiańskie l’ epentetyczne, in “Slavia Orientalis”, 27 (1978), pp. 159-164. 16 N. VAN WIJK, Geschichte der altkirchenslavischen Sprache, I, Laut- und Formenlehre, Berlino-Lipsia, W. de Gruyter & Co., 1931, p. 71. 17 Similmente il MAREŠ, Diachronische, cit., p. 79: “Der westslavische Zustand ohne l’ ist das Ergebnis einer weiteren Entwicklung, ähnlich ist es auch im Makedonischen und Bulgarischen, wo wir diesen Prozeß auch historisch [corsivo mio, M. E] verfolgen können”. 18 L. MOSZYŃSKI, Staro-cerkiewno-słowiańskie, cit., pp. 159 sgg. 19 Z. STIEBER, O jazyke Kievskogo missala, in “Issledovanija po slavjanskomu jazykoznaniju”, Mosca 1971, pp. 106-109; ristampato in Świat językowy Słowian, Varsavia, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1974, pp. 130-133. 9 156 Comunque stiano le cose nei manoscritti paleoslavi, la geografia linguistica dà un chiaro responso: poiché le aree laterali (slavo occidentale e bulgaro-macedonico) sono prive di l’ epentetico, esso si rivela come un’innovazione centrale avvenuta in sloveno e in serbo-croato, che ha raggiunto lo slavo orientale, ma che ha lasciato, ai margini settentrionale e meridionale del resto dello slavo, regioni che ne sono prive. Gli strumenti della linguistica ci permettono di giungere là dove non arriva la filologia intesa come mero studio dei manoscritti, che, per loro natura, spesso dànno una visione parziale dei fenomeni linguistici. In questo modo la tesi del Moszyński viene confermata. La nascita di l’ epentetico è connessa con il formarsi della sillaba aperta: l’ possiede una sonorità maggiore di j; in altri termini ubbidisce maggiormente alla tendenza verso la sonorità crescente della sillaba20; la differenza tra j e l’ consiste semplicemente in un rafforzamento dell’articolazione: si confronti l’oscillazione tra j e l’ in romanzo; al lat. folia corrispondono l’ital. foglia, da un lato e il franc. feuille, il piemont. feuja (föja), il rom. foaie dall’altro. Resta da chiarire, cosa che non mi pare che sinora sia stata fatta, perché l’ sia sorto soltanto in alcune lingue slave e non in tutte. La mia risposta è che esso imita la diffusione della sillaba aperta. Come ho sostenuto in altri lavori21, la sillaba aperta, lungi dall’essere uniformemente diffusa in slavo, come in genere si ritiene, si rivela come un’innovazione centrale, che ha raggiunto le Russie, ma che ha lasciato alla periferia settentrionale dello slavo occidentale e alla periferia meridionale del bulgaro e del macedonico (aree laterali) un certo numero di sillabe chiuse, quali la mancata metatesi delle liquide e la conservazione di vocali nasali. L’epentesi di l’ ha una estensione simile a quella della sillaba aperta, anche se geograficamente piú ristretta di quest’ultima: è attestata nell’area centrale, ma limitata allo sloveno e al serbo-croato (e si è propagata, cosí come la sillaba aperta, allo slavo orientale)22: questa diversità di estensione si spiega col fatto che l’ non è un G. Y. SHEVELOV, A Prehistory of Slavic, Aidelberga, C. Winter, 1964, p. 220. M. ENRIETTI, Considerazioni sul costituirsi dell’unità linguistica slava. La legge delle sillaba aperta, in “Atti del Sodalizio Glottologico Milanese”, 23 (1982) pp. 60-98. ID., La linguistica areale e il protoslavo in “ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ, Ricordando Ennio S. Burioni”, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, pp. 93-97. 22 Data la facilità di passaggio tra j e l’ sopra menzionata, forme con l’ sono sporadicamente attestate anche nello slavo occidentale, senza che questo alteri il quadro sopra delineato. Per es. il polacco ha oggi kropla “goccia”, grobla “argine”, przerębla “buco nel ghiaccio”, ma il polacco antico aveva kropia, grobia, przerębia. Si afferma solitamente che l’ epentetico è panslavo in posizione iniziale: pol. pluć, pluję (paleosl. pl’ьvati, pl’ujǫ) “sputare” se confrontato col lit. spiáuju, spiáuti, gr. πτύω, lat. spuō, ma l’ è probabilmente dovuto all’analogia con *bl’ьvati (pol. bluć, bluję) “vomitare”, nel quale l’ è originario, come mostrano i confronti col lit. bliáuju, bliáuti; l’analogia è stata favorita dall’affinità di significato dei due verbi (LAMPRECHT, Praslovanština, cit., p. 53). Il verbo bljusti “salvaguardare” (cfr. il gr. πεύθομαι) è attestato solo in paleoslavo, serbo-croato e russo, lingue nelle quali l’ epentetico è regolare; bljudo “piatto” è un prestito dal got. biuþs e come tale è entrato 20 21 157 fenomeno direttamente collegato con la sillaba aperta, ma è soltanto un riflesso di quest’ultima. Va tenuto in conto anche il diffondersi imprevedibile e capriccioso delle isoglosse, come mostra per esempio, in àmbito germanico, il “ventaglio renano”. Per quel che concerne la toponomastica slava della Grecia, la mancanza di l’ epentetico, comune col bulgaro e col macedonico (e con lo slavo occidentale), non può essere addotta, come affermava il Vasmer23 e affermano studiosi bulgari, come argomento a favore del carattere “bulgaro” di questa toponomastica, perché si tratta di un arcaismo periferico di conservazione, non di innovazione comune24. dapprima nello slavo orientale donde si è poi diffuso in altre lingue, ma non ha raggiunto il ceco, lo slovacco, lo sloveno e il polacco bluda è un russismo, cioè la parola non ha raggiunto le lingue piú occidentali (cfr. M. ENRIETTI, Slavi bljudo e misa ‘piatto, scodella’, in “Scritti in onore di Giuliano Bonfante”, I, Brescia 1976, pp. 225-236. 23 M. VASMER, Die Slaven in Griechenland, in “Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse”, Nr. 12, Berlino 1941, p. 324. 24 Anche in altri lavori ho sostenuto che la toponomastica slava della Grecia non ha un carattere bulgaro, bensí protoslavo: M. ENRIETTI, Il protoslavo *ě in Grecia, in “Europa Orientalis”, 11 (1992), pp. 157-170. ID., La toponomastica slava della Grecia è bulgara?, in “Gli studi slavistici in Italia”, Udine, Forum, 2007, pp. 363-372. 158 TRADIZIONE E PROSPETTIVE DEGLI STUDI POLONISTICI Krystyna Jaworska Il polacco, assieme al russo e al serbo e croato, è una delle tre lingue slave insegnate alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino, Facoltà che al suo interno dispone, accanto a insegnamenti di recente istituzione, discipline che vantano una lunga tradizione di studi all’ateneo torinese, come il romeno o l’ungherese per restare nell’ambito dell’Europa Centro-Orientale. Gli studi polonistici a Torino ebbero formalmente inizio nel 1930, con la fondazione dell’Istituto di Cultura Polacca “Attilio Begey”, ente morale presso l’Università di Torino, ma la loro origine risale all’Ottocento ed è connessa alle affinità di aspirazioni politiche di italiani e polacchi nell’epoca del Risorgimento. Com’è noto, molti esuli polacchi presero parte alle guerre d’indipendenza italiane, combattendo nelle file dell’Esercito Sardo o con Mazzini e Garibaldi. Nel 1848 il massimo poeta polacco Adam Mickiewicz formò a Roma una piccola Legione che prese parte ai moti di Milano; pochi mesi dopo Camillo Benso di Cavour in un discorso al Parlamento subalpino lo definì “uno di quei geni sublimi come Omero, Dante, Shakespeare”1. Fu in quel clima che nella capitale del Piemonte si era formato un gruppo di polonofili attorno all’avvocato Attilio Begey, acceso mazziniano e fautore dell’indipendenza della Polonia, seguace del mistico Andrzej Towiański, che aveva a Torino una cerchia creata da Giovanni Scovazzi e Tancredi Canonico, professore di diritto penale all’ateneo torinese e presi- 1 C. BENSO DI CAVOUR, Discorso alla Camera dei Deputati, Torino, 28.10.1848, in Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1848, vol. II: dall’8 maggio al 30 dicembre 1848, p. 542. Alla fama del poeta in Italia non era seguita una diffusione delle sue opere (di fatto gli italiani colti lo leggevano nelle traduzioni francesi) fatto salvo Il libro dei pellegrini, tradotto pochi mesi dopo la sua uscita a Parigi nel 1830 e primo testo della letteratura polacca che ha influenzato la cultura italiana secondo G. Maver, Le rayonnement de Mickiewicz en Italie, in Adam Mickiewicz 1798-1855, Hommage de l’UNESCO, Paris 1955, p.120 e il Konrad Wallenrod dopo la rappresentazione nel 1874 alla Scala dei Lituani di Ponchielli su libretto di Ghislanzoni, basata sul poema mickiewicziano. 159 dente del Senato del Regno d’Italia2. A Torino si era trasferito dalle Marche nel 1887 Aglauro Ungherini, anch’egli un mazziniano, che imparò il polacco per poterne tradurre i poeti. A lui si devono la prima e tutt’ora unica versione del capolavoro di Mickiewicz Dziady (da George Sand posto a fianco del Faust di Goethe quale massima espressione di dramma metafisico), ed egli cercò di avvicinare ai lettori italiani il romanticismo di Seweryn Goszczyński e Juliusz Słowacki3. Begey aveva saputo trasmettere l’interesse per la Polonia alla sua famiglia e agli amici. Alla storia polacca avevano dedicato diversi studi la figlia Maria e il genero Arturo Bersano, mentre Umberto Zanotti Bianco (noto soprattutto per la sua attività a favore del Mezzogiorno) pubblicò un importante volume sulla questione polacca, sotto lo pseudonimo Giorgio d’Acandia4. Con lo scoppio della prima guerra mondiale venne fondato a Torino, al pari che in altre città, un Comitato Pro Polonia, che raccolse esponenti di spicco della società subalpina e che al termine del conflitto si prodigò per migliorare le condizioni del campo di addestramento per il nascente esercito polacco formato alla Mandria di Chivasso, dove furono ospitati complessivamente circa ventimila soldati, ex prigionieri di guerra austroungarici5. Tra i soci del Comitato, due sorelle, Clotilde Garosci e Cristina Agosti Garosci, come già aveva fatto Ungherini, da sole impararono il polacco per poterne conoscere la letteratura. Nel 1924 si deve a loro la prima traduzione svolta direttamente dall’originale del poema epico di Mickiewicz Pan Tadeusz (tradotto dal francese negli anni Settanta si presume da Arrigo Boito su “Il pungolo”). La casa di Attilio Begey era punto di riferimento importante per quanti si interessavano alla Polonia e con la riconquista dell’indipendenza egli fu Sui towianisti italiani v. A. ZUSSINI, Andrzej Towiański. Un riformatore polacco in Italia, Bologna, 1970; L’Archivio Begey. Documenti towianisti a Torino 1841-1915, catalogo della mostra alla Biblioteca Reale a cura di K. Jaworska, Torino, Celid, 1994. Influssi di Towiański si possono trovare nell’opera di Fogazzaro, ma anche di Rebora e Montale, come indicano gli studi di Carlo Porrati sulla “Rivista di storia e letteratura religiosa” e su “Levia Gravia” e indirettamente persino sulla filosofia di Luigi Pareyson e di Gianni Vattimo, secondo gli studi di M. SOKOŁOWSKI, Wątki towianistyczne we współczesnej filozofii włoskiej (wybrane zagadnienia), in Mit jedności słowiańsko-romańskiej w życiu i twórczości Adama Mickiewicza, pod red. M. Sokołowskiego, Warszawa Fundacja AH, IBL PAN, 2005, pp. 197-215. 3 V. C. ZANCO, Le traduzioni ungheriniane dei romantici polacchi sullo sfondo del carteggio con Władysław Mickiewicz, in La Polonia, il Piemonte e l’Italia. Omaggio a Marina Bersano Begey, a cura di K. Jaworska, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1998, pp. 179-192. 4 V. AA.VV., Umberto Zanotti Bianco (1899-1967), Roma 1980; U. ZANOTTI BIANCO, Carteggio, 2 voll., Bari 1987-1989. 5 Da prigionieri a uomini liberi. La formazione dell’Armata polacca al campo della Mandria di Chivasso 1918-1989, catalogo della mostra a cura di K. Jaworska, F. Spegis, A. Turinetti di Priero, Città di Chivasso, L’Artistica di Savigliano, 2008. 2 160 nominato console onorario. Alla sua morte, occorsa nel 1928, sorse l’idea di creare un istituto di cultura polacca recante il suo nome. Fautore dell’iniziativa era il prof. Roman Pollak dell’Università di Poznań, dal 1924 a Roma quale professore di lingua e di letteratura polacca all’Università della Sapienza in base ad un accordo con il governo italiano. La rinascita dello stato polacco nel 1918 e l’allacciamento delle relazioni diplomatiche, commerciali e culturali con gli altri stati europei aumentava l’interesse per la cultura del paese e facilitava l’istituzione di insegnamenti universitari di lingua e di letteratura polacca. Ma come mai proprio Torino fu scelta per l’apertura di un Istituto di cultura polacca e come mai vi venne acceso il primo corso di lingua, dopo quello attivato nella capitale? Altrove, come a Milano, si poteva contare su singole personalità o sulla presenza di una forte comunità polacca, o ci si poteva richiamare a notevoli tradizioni storiche, come a Bologna (dove era stata fondata nel 1886 l’Accademia polono-slava Adamo Mickiewicz e dove per un certo periodo era stato attivo un insegnamento di letteratura polacca tenuto dal poeta Teofil Lenartowicz, esule a Firenze), e diversi motivi potevano essere addotti a favore di altre città. Il motivo principale della scelta era dovuto indubbiamente alla presenza nella capitale subalpina del più attivo gruppo di polonisti e traduttori della letteratura polacca in Italia. “Da questa cerchia si dovrebbe infatti iniziare parlando della diffusione della nostra cultura in Italia, in quanto essa per noi ha fatto più di tutti gli istituti,delle cattedre e delle lezioni universitarie” scriveva nel 1924 su un periodico polacco6. Nello stesso anno accademico in cui fu inaugurato l’Istituto Begey a Torino, alla Sapienza di Roma sorse la cattedra di lingua e letteratura polacca con titolare Giovanni Maver. Si tratta dei due più antichi insegnamenti della materia in Italia, che nel periodo interbellico venne anche insegnato a vario titolo a Napoli e Firenze7. Il primo passo fu la creazione di un lettorato, che fu attivato nel 1928 presso la Pro Cultura Femminile, di cui erano socie Cristina Agosti e Maria Bersano Begey, e affidato alla nota filologa romanza dell’Università di Cracovia Zofia Gąsiorowska, la quale venne a Torino su incarico del ministero dell’istruzione polacco. Il secondo fu la creazione dell’Istituto. La formula elaborata dagli eredi di Attilio Begey d’intesa con Pollak fu quella di creare un ente morale presso l’Università, al fine di garantire prestigio accademico ma al contempo autonomia di funzionamento all’Istituto stesso. I fondi necessari all’istituzione dell’ente furono offerti dalla famiglia BersaR. POLLAK, Obcy o Polsce, “Przegląd Współczesny”, 1924 n.29, p. 446 (trad. K.J.). E. DAMIANI, Gli studi polonistici in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale, Roma, Istituto per l’Europa Orientale, 1941. 6 7 161 no Begey, un contributo fu concesso dalla Banca Commerciale Italiana, il grosso venne dal ministero dell’Istruzione polacco, mente i locali furono garantiti dall’Università. Lo statuto prevedeva che presidente dell’ente fosse il Rettore e che nel consiglio avrebbero fatto parte, accanto a due professori dell’ateneo torinese, due membri della famiglia Bersano Begey e due o più soci cooptati8. L’istituto fu inaugurato il 12 marzo 1930. Il nucleo della biblioteca fu offerto dal ministero dell’Istruzione polacco e la famiglia Begey dono parte della preziosa raccolta di Attilio Begey, che contiene rari opuscoli e pubblicazioni riguardanti l’attività polonofila in Italia e in Francia nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi del Novecento. L’attività dell’Istituto comprendeva conferenze, concerti, mostre, lettorati, borse di studio per gli studenti migliori. Quale lettrice giunse allora dalla Polonia la scrittrice Zofia Kozaryn. Aglauro Ungherini, cui il governo polacco aveva offerto un sussidio, in segno di riconoscenza per la sua lunga opera a favore della Polonia, volle devolverlo all’Istituto, che ne istituì un premio annuale per il miglior studente di lingua. Dal 1933 il lettorato di polacco divenne parte integrale dei lettorati ufficialmente tenuti all’Università. Tra quanti frequentavano allora i corsi vi erano non solo studenti di Lettere, come Alma Borello o Maria de Petri,che tradusse poi Maria Konopnicka, ma anche studenti di altri Facoltà, tra cui Alessandro Tassoni Estense di Castelvecchio, che nel dopoguerra fu Ambasciatore d’Italia in Polonia. Cicli di conferenze di letteratura polacca erano tenute dal Giovani Maver e da altri studiosi. Nel 1933 si laureavano con tesi di argomento polonistico Giorgio Agosti e Marina Bersano Begey. Quest’ultima dopo gli studi vinse un concorso alla Biblioteca Nazionale, pubblicò studi di Staszic, Krasiński e Miłkowski e nel 1935 ottenne la libera docenza di polacco, sicché dal 1936 accanto ai lettorati si potevano seguire anche i corsi di lingua e di letteratura polacca. In questo periodo intensa è la produzione scientifica dei soci dell’Istituto, come pure l’attività di traduzione: Maria Bersano Begey traduce opere della Iłłakowicz e una scelta di canti natalizi e con la figlia cura un’antologia di poesia contemporanea. Le sorelle Garosci traducono opere di Krasiński, Konopnicka, Żeromski e Słowacki. Nel 1938 esce la prima grammatica polacca in Italia curata da Zofia Kozaryn, che si era avvalsa della consulenza del prof. Matteo Bartoli.9 Il primo Consiglio risultò essere composta dal rettore Silvio Pivano, da Arturo Bersano e da Rosina Begey, dai prof. Arturo Farinelli e Matteo Bartoli, dal prof. Ferdinando Neri, da Cristina Agosti e da Lea Mei (presidente della Pro Cultura). 9 Z. KOZARYN, La lingua polacca. Grammatica – esercizi - letture, Pubblicazioni dell’Istituto di Cultura Polacca Attilio Begey, R. Università di Torino, n. 1, Torino, SEI, 1938. La scrittrice ricorda i suoi anni torinesi in 8 162 “Da nessuna parte in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Germania non si fa tanto, da nessuna parte il lavoro è così intenso, così cordiale,come nella cerchia dei polonofili torinesi” scrisse nel 1933 Roman Pollak10. Il ruolo svolto dall’Istituto nel periodo interbellico fu indubbiamente notevole, inoltre esso offriva l’unica biblioteca pubblica polonistica in Italia Settentrionale ed era punto di riferimento per le ricerche bibliografiche degli studiosi polacchi che spesso scrivevano per avere informazioni. L’entrata in guerra dell’Italia interruppe l’attività pubblica dell’Istituto. I libri furono ricoverati nelle cantine della Biblioteca Nazionale per proteggersi dai bombardamenti. Continuò l’attività di ricerca, incentrata su argomenti che mostrassero i nessi tra le due nazioni. Maria Bersano scrisse su Francesco Nullo, garibaldino che partecipò all’insurrezione polacca del 1863, e su Franciszka Krasińska, ava di Carlo Alberto, Marina Bersano Begey lavorò su una storia della Polonia poi bloccata dalla censura e andata persa, entrambe continuavano la schedatura che avrebbe portato alla pubblicazione nel 1949 della importante bibliografia La Polonia in Italia. Saggio bibliografico 1799-1948 dall’editore Rosenberg e Sellier, quale secondo (e ultimo) numero delle pubblicazioni dell’Istituto. Terminata la guerra, la biblioteca fu inizialmente ospitata a Palazzo Carignano in stanze del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano prima di tornare nel 1949 in locali appositamente predisposti dall’Università accanto alla Biblioteca Nazionale11. Il mutato assetto europeo postbellico sancito a Yalta incise anche sul funzionamento dell’Istituto. Le azioni che costituivano il capitale finanziario avevano perduto valore a causa della guerra, e non pareva opportuno cercare contributi dalla nuova rappresentanza diplomatica espressione del regime filosovietico12. I membri dell’istituto decisero di voler mantenere l’autonomia e un profilo esclusivamente culturale. All’Università EAD., Sto lat (Gawęda o kulturze środowiska), London, PFK, 1982. Per una descrizione più dettagliata dell’attività dell’Istituto Begey v. K. JAWORSKA, La tradizione polonistici in Piemonte e l’Istituto di Cultura polacca “Attilio Begey”, in La Polonia, il Piemonte e l’Italia, cit,. pp. 249-278. 10 Lettera di R. POLLAK a Maria Bersano Begey, Poznań 21.11.1933, Archivio dell’Istituto di Cultura Polacca Attilio Begey. 11 Per offrire all’Istituto una sede adeguata furono effettuate opere murarie, anche se le condizioni erano spartane: leggiamo ad esempio nel verbale della riunione del Consiglio di Istituto del 22.10.1948 dell’autorizzazione a utilizzare la legna dell’Economato per accendere la stufa in terracotta posta nel locale più grande. 12 Nel periodo interbellico numerosi erano i contatti con l’Ambasciata polacca a Roma e direttamente con l’Ambasciatore Alfred Wysocki (cfr. A. WYSOCKI, Tajemnice dyplomatycznego sejfu, Warszawa, Książka i Wiedza, 1974, passim). Nel 1949 venne ancora ricevuto l’ambasciatore Stanisław Kot a cui era legato di amicizia Giorgio Agosti, esponente di Giustizia e Libertà e primo questore di Torino dopo la Liberazione, ma con la svolta stalinista non furono inviate altre personalità governative (Kot stesso chiese asilo politico in Francia nel 1949). Sulla visita di Kot a Torino v. J. OKOŃ, Turyńskie przemówienie ambasadora Stanisława Kota w roku 1947, “Ruch Literacki”, XLIII (2002), f. 6, pp. 623-628. 163 di Torino non fu più concesso il lettorato di scambio e all’Istituto diminuirono le conferenze, rimase però attiva la biblioteca. I pochi fondi rimasti, assieme ai finanziamenti dell’Università, consentivano di acquistare i libri più significati edite in Polonia e all’emigrazione, a Londra e a Parigi. Nel lavoro di biblioteca, prima della guerra svolto da Cristina Agosti, si affiancano ora Maria Schoenaich Oitana e Maria Saganowska. Intanto a Torino si era formata una piccola Comunità polacca composta da un gruppo di ex militari, che avevano combattuto nell’esercito del generale Anders a fianco degli alleati per la liberazione d’Italia e che, terminata guerra, erano stati comandati a Torino per studiare al Politecnico. Nel 1947 con la smobilitazione furono trasferiti in Inghilterra, ma alcuni rimasero a Torino avendo sposato delle piemontesi (che cominciarono a frequentare l’Istituto Begey per imparare il polacco). La Comunità promosse nel 1966 le celebrazioni per il millennio della cristianizzazione della Polonia e in segno di riconoscenza per l’ospitalità avuto in Italia offrì all’Istituto una borsa di studio per il miglior studente di polacco13. Sono questi gli anni in cui Marina Bersano Begey è nominata Direttore della Biblioteca Reale e poi Sovrintendente ai beni librari per il Piemonte. Nonostante gli impegni professionali continua gli studi polonistici e lavora alle sue opere fondamentali: La letteratura polacca (prima storia letteraria di questa nazione slava scritta non da uno slavo), l’edizione degli Scritti politici di Adam Mickiewicz, l’antologia Le più belle pagine della letteratura polacca14. Cristina Agosti Garosci traduce L’avamposto di Prus e il Quo vadis di Sienkiewicz (prima versione italiana dall’originale polacco), otre che a romanzi di Sieroszewski, Wierzyński, Konarski, Morcinek15. Con la costruzione del palazzo delle Facoltà Umanistiche viene offerto all’Istituto un locale nel nuovo edificio, Marina Bersano Begey accetta anche se gli spazi risultano essere molto minori e obbligano a depositare parte delle riviste alla Biblioteca Civica, grazie alla gentilezza dell’allora direttore Carlo Revelli. Nel 1965 il polacco viene riattivato come corso regolare, tra i suoi primi studenti abbiamo Mario Enrietti, ora professore di filologia slava presso la nostra Facoltà, tra gli ultimi che hanno seguito il suo insegnamento, Valeria Rossella poeta e traduttrice di poesia polacca. 13 Cfr. Ognisko Polskie w Turynie. Comunità Polacca di Torino. Pięćdziesiąt lat historii. Cinquant’anni di storia, a cura di M. Rasiej, Pessano, Mimep-Docete, 2002, pp.71-74. 14 Per la bibliografia delle opere di Marina Bersano Begey si veda: M. R. MANUNTA, Bibliografia degli scritti di Marina Bersano Begey, in La Polonia, il Piemonte e l’Italia, cit., pp. XXI – XXXI e Bibliografia degli scritti polonistici di Marina Bersano Begey, a cura di P. Marchesani, in La letteratura polacca contemporanea in Italia. Itinerari di una presenza. Studi in memoria di Marina Bersano Begey, a cura di Id., Roma, La Fenice Edizioni, 1994. 15 Per una bibliografia degli scritti di Cristina Agosti v. M. BERSANO BEGEY, Cristina Agosti, “Ricerche Slavistiche”, XIV (1966), pp.308-310. 164 Nel terminare l’insegnamento nel 1975, Marina Bersano Begey segnalò alla Facoltà di Lettere di chiamare al suo posto Pietro Marchesani, noto in seguito per le magistrali traduzioni di Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, che restò a Torino fino a quando vinse la cattedra a Roma nel 1977. Questi a sua volta propose Jan Prokop dell’Istituto di Studi Letterati dell’Accademia delle Scienze polacca, che insegno nell’ateneo torinese fino al 1986, anno in cui le autorità polacche per l’ennesima volta agli negarono il passaporto in quanto intellettuale non allineato16. Per alcuni anni l’insegnamento fu affidato a colleghi della sezione di slavistica: Maria Luisa Dodero, Marina Rossi Varese, Mario Enrietti, dal 1990 è tenuto dalla scrivente. Pur in pensione, la prof. Bersano Begey ha continuato a offrire il suo prezioso contributo venendo una volta la settimana, il mercoledì mattina, alla Biblioteca Begey e ciò ha permesso agli studenti e agli studiosi di poter usufruire dei suoi consigli e delle sue indicazioni. Nel 1984 fu attivato il lettorato a contratto e agli inizi degli anni Novanta a Torino fu concesso nuovamente, dopo oltre quarant’anni, il lettore di scambio (grazie ad un’ardua battaglia per una ricollocazione dei lettori di scambio inviati in Italia basata sulle reali esigenze delle varie sedi universitarie condotta da Pietro Marchesani, allora professore a Genova, che motivò la richiesta del suo ateneo con l’alto numero di studenti, circa settanta, a quel punto si fece presente che a Torino erano iscritti complessivamente 114 studenti a polacco e quindi entrambi le sedi ottennero per trasferimento una lettrice). Nel dopoguerra il quadro della polonistica italiana era mutato. Restava stabile la situazione di Roma, dove a Maver era subentrato Sante Graciotti, a Firenze grazie a Carlo Verdiani si era creato un importante centro di studi e l’insegnamento si era anche rafforzato a Napoli con Enrico Damiani e Stanisław Piekut. Con la liberalizzazione degli studi universitari negli anni Settanta e la possibilità di poter istituire nuovi insegnamenti si ebbe un notevole incremento delle sedi. Il polacco risultava insegnato da una quindicina di docenti in tredici atenei: Torino, Milano (Statale e Cattolica), Venezia, Udine, Genova, Padova, Pisa, Firenze, Perugia, Roma La Sapienza, Napoli Istituto Orientale, Bari17. Attualmente è insegnato anche a Bologna, Frutto dell’insegnamneto torinese è il volume J. PROKOP, K. JAWORSKA, Letteratura e nazione. Studi sull’immaginario collettivo nell’Ottocento Polacco, Torino, Tirrenia Stampatori, 1990: su J. Prokop v. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, opr. J. Czachowskiej i A. Szałagan, Warszawa WSiP, 1999, t. 6, pp.464-467. 17 S. GRACIOTTI, K. ŻABOKLICKI, La polonistica in Italia e l’italianistica in Polonia 1945-1979, Wrocław, Ossolineum, 1983, p. 5. Si veda anche P. MARCHESANI, Cinquant’anni di studi polonistici in Italia (1940-1990), in La slavistica in Italia. Cinquant’anni di studi (1940-1990), a cura di G. Brogi Bercoff, G. Dell’Agata, P. Marchesani, R. Picchio, Roma, Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, 1994, pp. 271-338. 16 165 Roma Tor Vergata e a Lecce, ma non più a Perugia. Se da un lato questo crea una certa dispersione delle forze, dall’altro ciò ha permesso una maggiore diffusione della materia e la formazione di un buon numero di giovani studiosi. Grazie a questo l’Italia si può ora vantare di avere una delle polonistiche estere più prestigiose, come spesso viene rilevato ai congressi internazionali della disciplina. La formazione spesso classica, filologica, slavistica degli studiosi italiani ha permesso loro dare contributi importanti per la stessa disciplina in Polonia, e frutto della collaborazione della generazione intermedia e di quella giovane dei polonisti italiani è la Storia della letteratura polacca curata da Luigi Marinelli per i tipi di Einaudi. L’Istituto Begey fu sciolto come ente morale su proposta di Marina Bersano Begey nel 1987 in quanto, come ebbe a dire, aveva ormai svolto il suo compito e il polacco a Torino era divenuto a pieno titolo una disciplina d’insegnamento universitario. La preziosa biblioteca contenente in alcuni casi l’unica copia nota di pubblicazioni e opuscoli ottocenteschi, fu donata all’Ateneo e incardinata nella Biblioteca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne e Comparate, mantenendo la denominazione. A proposito di essa aveva scritto nel 1983 Sante Graciotti: Le biblioteche dei seminari di polonistica sono variamente fornite: tra di esse, le più ricche sono senz’altro quelle: dell’Istituto di Cultura Polacca dell’Università di Torino, che deve la sua lontana origine e l’importanza dei suoi fondi all’attività delle famiglie Begey e Bersano, e quella dell’Istituto di Filologia slava dell’Università di Roma, iniziata da Giovanni Maver18. Grazie all’impegno del responsabile della Biblioteca, dott. Valerio Barello, essa è ottimamente seguita, molti volumi sono stati restaurati e rilegati e i periodici depositati a suo tempo i nella Biblioteca Civica sono rientratati nella collezione. La polonistica a Torino ora si avvale di un professore associato che svolge le sue ricerche principalmente nell’ambito della letteratura otto- e novecentesca, di un lettore a contratto la dott. Irena Putka, glottodidatta formatasi all’Università di Varsavia e succeduta nell’incarico al dott. Wojciech Jekiel della stessa Università, che ha al suo attivo diverse pubblicazioni di linguistica e di grammatica contrastiva, e di un lettore di scambio, la dott. Urszula Marzec dell’Università Jagellonica di Cracovia, succeduta 18 S . GRACIOTTI, K. ŻABOKLICKI, ibidem. 166 nell’incarico alle dott. Kwiryna Ziemba del’Università di Danzica, Magdalena Pastuch e Agnieszka Szol dell’Università della Slesia19. Per permettere agli studenti di perfezionare la loro preparazione linguistica e culturale sono stati stipulati accordi di mobilità internazionale Erasmus con sette Università polacche: Varsavia, Cracovia, Poznań, Katowice, Białystok, Wrocław, Łódź, e ogni anno accogliamo nei nostri corsi gli studenti provenienti da questi e altri atenei, come pure ospitiamo le lezioni dei docenti in mobilità Erasmus dalla Polonia. Questo permette uno scambio fecondo di metodologie scientifiche e didattiche. Per le ricerche pre e post laurea sono inoltre disponibili le borse di studio offerte dal Ministero degli Esteri. Infine l’accordo di cooperazione firmato nel 2006 dalla nostra Facoltà con l’Istituto di Studi Letterati dell’Accademia delle Scienze polacca (il più prestigioso centro di ricerca letteraria in Polonia) permette ai nostri dottorandi e dottori di ricerca di partecipare a seminari e convegni organizzati dall’Accademia e l’attuazione di progetti di ricerche comuni. La riforma universitaria e la differenziazione dell’insegnamento delle lauree biennali rispetto a quello delle lauree magistrali richiede l’attivazione di un numero maggiore di corsi. Per garantire adeguate prospettive di sviluppo sarebbe necessario per questa materia, come per gli altri insegnamenti linguistici che dispongono attualmente di un solo docente di ruolo, avere almeno un ricercatore, in modo da ricoprire le esigenze didattiche con due corsi per docente, permettere la ricerca e in prospettiva un bilanciato ricambio generazionale, ma nel titolo del nostro annuario si parla di sopravvivenza dell’umanistica, e per sopravvivere si deve sopperire come si può in tempi difficili, ma è evidente che si tratta di una situazione che richiede un impegno difficilmente sostenibile nel tempo. Nel 2010 ricorrerà il sessantesimo anniversario degli studi polonistici a Torino, sarebbe bello pensare che questo potrebbe essere l’occasione per un rilancio generale della slavistica nel nostro ateneo. Fino ad alcuni anni fa solo due sedi avevano dottorati di slavistica: Roma e Milano; ora anche Torino dispone di posti riservati alla slavistica all’interno della scuola di dottorato in lingue. Ciò da un ulteriore incremento al settore e permette la formazione di giovani studiosi. Nei primi due cicli hanno conseguito il dottorato tre polonisti, e altri tre attualmente sono iscritti nei cicli in corso. Numerosi sono gli ambiti di ricerca in cui si può proficuamente operare in quanto polonisti italiani: dalla comparatistica letteraria agli studi di grammatica contrastiva, dalla storia e dalla teoria della traduzione alla sua prassi, dallo studio delle relazioni culturali a quello 19 Per le pubblicazioni di K. Jaworska, I. Putka e A. Szol si veda il sito: http://hal9000.cisi.unito.it/lingua_polacca e i volumi della Bibliografia della slavistica italiana editi dall’Associazione Italiana degli Slavisti. 167 della letteratura odeporica, dai linguaggi settoriali ai glossari bilingue, dalla ricerche d’archivio ai lavori di ermeneutica letteraria e agli studi a carattere interdisciplinare. Essendo l’insegnamento del polacco a Torino e in Piemonte attivo solo presso la nostra Facoltà, oltre agli studenti di Lingue hanno seguito e seguono i corsi studenti di corsi di Laurea di altre Facoltà, quali Scienze della Formazione, Lettere, Giurisprudenza, Scienze Politiche, ma anche Architettura, e persino Medicina e Scienze. Spesso a spingerli sono interessi specifici, e talvolta diventano studiosi affermati nel loro settori. Operano in campi diversi, ma che in comune hanno l’interesse per l’area polacca, interesse che a suo tempo poterono sviluppare frequentando i corsi di polacco e anche questa è indubbiamente una delle funzioni in un’ottica interdisciplinare che deve assolvere la polonistica alla Facoltà di Lingue. Una formazione umanistica con una specializzazione in lingua e letteratura polacca risulta rispondente alle esigenze che nascono da istituzioni culturali sul territorio ogni qualvolta esse intendono affrontare temi legati alla Polonia. Si sono avuti fruttuosi esempi di collaborazione di polonisti con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano per l’allestimento della sala della Primavera dei Popoli e della mostra sul Contributo dell’esercito polacco alla Liberazione d’Italia, con la Biblioteca Reale per il riordino dell’Archivio Begey, con il Museo Diffuso della Resistenza per la mostra sull’insurrezione di Varsavia, con la Comunità Polacca di Torino20. Alcuni anni fa la ricerca Polonia tra Passato e Futuro promossa dall’Istituto Gaetano Salvemini ha visto coinvolto un bel gruppo di studiosi formatisi all’ateneo torinese che in tre anni hanno organizzato diversi seminari storico-letterari, tre rassegne cinematografiche (Kawalerowicz, Wajda e film di animazione) al Museo del Cinema, due mostre tra cui una di grande spessore sul costruttivismo polacco, un volume di studi sulla cultura del Novecento polacco21. Ultimamente il festival Il luogo delle parole con paese ospite la Polonia, organizzato dai Comuni di Chivasso, Settimo e limitrofi, ha visto impegnati come responsabili per la parte letteraria un nostro dottore di ricerca e una dottoranda, Alessandro Ajres e Barbara Delfino, che hanno organizzato e seguito gli incontri con alcuni tra i più noti autori polacchi contemporanei, mentre una laureanda ha curato una bellissima mostra sul ma- 20 Cfr. Un’Armata in Esilio, catalogo della mostra a cura di C.Vernizzi, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, 1995. Warszawa 1944: i 63 giorni dell’insurrezione, Città di Torino, Comunità Polacca di Torino, Blù Edizioni, Torino 2004. 21 Andrzej Wajda: il cinema, il teatro, l’arte, a cura di S. Parlagreco, Torino, Lindau, 2004; Costtruttivismo in Polonia, a cura di Ead., Torino, Bollati Boringhieri, 2005; Polonia tra passato e futuro. Percorsi di cultura contemporanea, a cura di K. Jaworska, Milano, FrancoAngeli, 2008. 168 nifesto teatrale polacco22. Per il secondo anno la polonistica della nostra Facoltà collabora con la Biblioteca Civica di Torino e la Comunità Polacca nell’organizzazione di cicli di film in lingua intitolati Radość oglądania. La gioia di guardare, presso varie sedi della Biblioteca stessa e in quest’apertura alla collaborazione con enti e istituti culturali si continua la tradizione dell’Istituto Begey. Ovviamente rispetto alle prospettive in ambito culturale, limitate per lo più a singoli eventi, sono più numerose quelle nell’industria, soprattutto dopo l’ingresso della Polonia nell’Unione Europea. Essendo i laureati in polacco un numero esiguo, è più facile mantenere i contatti (anche in occasione dall’incontro annuale che organizziamo in prossimità delle feste natalizie) e, da quanto ci riferiscono, risulta che la maggioranza lavora utilizzando in varia misura la lingua, per lo più in imprese italiane che hanno interessi in Polonia, talvolta con incarichi di responsabilità che li portano a viaggiare tra Italia e Polonia. Alcuni si trasferiscono in Polonia (come già capitava nel Rinascimento23), alcuni lavorano come traduttori liberi professionisti, altri come insegnanti di italiano, due dottori di ricerca come lettori presso università polacche. Tra quanti non lavorano con il polacco più volte ci è stato riferito che avere in curriculum la conoscenza di una lingua meno nota è stato elemento che ha facilitato l’assunzione. Un fenomeno curioso a questo proposito, è che negli ultimi anni, sono aumentati gli studenti che presentano in piano di studi accanto al polacco una lingua orientale: giapponese, arabo o cinese o hindi, motivando la loro scelta spesso con il fatto di voler imparare lingue diverse, aprirsi a culture nuove rispetto a quelle già studiate la liceo. Ed è proprio questo aprirsi a realtà diverse, esigenza sempre più importante in un mondo in cui i nessi tra varie aree si fanno sempre più stretti, che costituisce una delle ragioni per cui l’insegnamento di lingue, letterature e culture di paesi diversi con i quali, come nel caso della Polonia, ci uniscono legami storici, culturali e ultimamente economici e commerciali, acquisisce sempre maggiore significato all’interno delle discipline umanistiche. 22 I luoghi delle parole. festiva internazionale di letteratura. V edizione. 3-10 ottobre 2008, Chivasso, Settimo Torinese, Brandizzo, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Gassnio Torinese, San Maurizio Canadese. Volpiano, s.d., s.l. [programma]; Il manifesto polacco e il gran teatro del mondo, catalogo della mostra a cura di G. Randone e A. Buonaiuto, s.d. s.l. 23 Come curiosità si può ricordare che i primi nessi tra il Piemonte e la Polonia si possono far risalire al XVI secolo ed erano di carattere imprenditoriale. Era l’epoca in cui artisti, artigiani, commercianti italiani emigravano in Polonia per lavorare presso la corte reale e le corti aristocratiche. Tra questi si annovera un Provana al quale fu affidata la gestione del primo servizio postale tra la Polonia e l’Italia, Cracovia e Venezia e tutt’oggi a Cracovia si può ammirare il palazzo che porta il suo nome. 169 170 FAMINE IN MODERN IRISH POETRY, AN ENDURING SCAR Donatella Abbate Badin Of all the famines Ireland has experienced, and which are recorded, directly and indirectly, in legend as well as in history, one only, the 1845-49 famine, is seen, as a historian wrote, as “a major dividing-line in the history of modern Ireland”1. The Great Famine, as it came to be called, owes its historical importance to its “incontrovertible physical consequences”, namely the decline in population and consequent loss of language and national heritage, as well as the transfer of property and the changes in agriculture. An even more important effect, however, was the attitude it helped create: an enhanced sense of nationality and a widespread mistrust and resentment against the British government and the ruling class2. For all these reasons it has left an indelible mark inscribed in folk memory and in the arts even after a century and a half has gone by and Ireland is in the Celtic tiger era. “Every Irish generation since the 1840s has had to deal with the idea of the Famine and its effects on Irish history and Irish identity” writes George Cusack in his introduction to the critical anthology, Hungry Words.3 As for modern poetry, and it is still haunted with its hallucinatory presence. As Chris Morash maintains in The Hungry Voice, Famine literature is “a part of a culturally specific semiotic web”, a web made up of key words and set images, and ruled by a certain number of metanarratives. Indeed, in the absence of an empirically controllable historical reality, “the representation has become the reality” 4. J.C. BECKETT, The Making of Modern Ireland 1603-1623, London, Faber and Faber, 1966, p. 335. Declan Kiberd points out that while historical arguments about British culpability are still rampant, the popular perception is that “God sent the potato-blight, but the English caused the Famine” as a popular saying goes. See D. KIBERD, Inventing Ireland, .London, Vintage, 1996, p. 21. 3 G. CUSACK amd S. GOSS, eds. Hungry Words, Dublin, Irish Academic Press, 2006, p. 2. 4 C. MORASH,. The Hungry Voice, Dublin, Irish Academic Press, 1989, pp 3-.5. 1 2 171 Quite in contrast with the restraint, indeed the revisionism, characterising the work of Irish historians writing about the famine, the work of the poets evoking the past tragedy in its many manifestations is marked by emotion and outrage but the depiction of the actual event and its enduring consequences on modern society is also compounded with the use of famine as a metonymy, a metaphor or even as an explanatory myth. Famine imagery is used “to productively explore some of the most troublesome aspects of Irish identity” writes Cusack,5 while Morash in his afterword to that same anthology, asserts that “keeping the Famine alive through renewing its metaphorical language performs an ethical function in the present, creating a communal conscience”.6 The elusive and pervasive metaphor of famine may be recognized in the rhetoric about Irish identity. While in the case of most nations identity means rootedness, discourses about modern Irish identity focus instead on the wrenching away from such roots as language, tradition, territory. Thomas Kinsella, for instance, talks of Irish identity as being characterized by a “divided mind”, by “dislocation and loss” and represents his literary self as if it were “coming, so to speak, from a broken and uprooted family”7. This is where the pervasive metaphor of famine comes in, for “dislocation and loss” are seen as connected to the destruction of such an essential but also symbolic root as the potato was –a root giving nourishment and therefore allowing the population to remain rooted in the land and its traditions. The blighted potato, thus, represents metonymically the destroyed roots of Irish identity and famine as a metaphor plays an important role in the shaping of nationalism. Even independently from nationalistic concerns, however, the horror of the shared experience of the famine constitutes for many Irish people a kernel of identity as the Northern Irish Protestant John Hewitt indicates in his poem, "The Scar". Hewitt attributes his Irishness to a dying man contaminating his grandmother with “the famine fever”: and that chance meeting, that brief confrontation, conscribed me of the Irishry for ever. Though much I cherish lies outside their vision, and much they prize I have no claim to share, yet in that woman’s death I found my nation; G. CUSACK, Hungry Words, p. 4. C. MORASH,.Afterword in Hungry Words, cit., p. 300. 7 T. KINSELLA, The Divided Mind, in Irish Poets in English: The Thomas Davis Lectures on Anglo-Irish Poetry, ed. S. Lucy, Dublin and Cork, Mercier, 1972, p. 209. 5 6 172 the old wound aches and shews its fellow scar8. Thomas Kinsella, who uses hunger as a central metaphor in his poetry9, makes more specific references to the Great Famine in order to explain his personal malaise. When, in “Ritual of Departure”, his poetic persona at the moment of leaving Ireland, looks back at his country, he sees the landscape that most symbolises an Irish identity because it bears at its heart the causes of loss, dispossession, and therefore of exile: The ground opens. Pale wet potatoes Fall into light. The black soil falls from their flesh, From the hands that tear them up and spread them out Perishable roots to eat.10 The well-to-do and educated speaker of the poem has identified with the primordial Irish exile, the victim of the famine. In the ease of his house with grey floorboard and plush, he becomes one with his less fortunate forebears: “I scoop at the earth, and sense famine, / A sourness in the clay. The roots tear softly”11. Whether the roots fail to give physical or spiritual nourishment, the result is the same – exile. For several other poets, too, the present is famine-tainted and modern landscapes are cursed or bewitched places where the old damage is felt as a haunting presence rather than seen, as in MacDonagh’s “terror of the hungry grass”12 or John Montague’s “shape easily rising from the ground / And easily settling back”13. Seamus Heaney’s potato fields in “At a Potato Digging” appear as a sort of miracle threatened by the curse of the past: the healthy potatoes, ready “to be piled in pits”, raise ghosts of the fearful past when spectral creatures walked the land: Live skulls, blind-eyed, balanced on wild higgledy skeletons, scoured the land in ‘forty-five, J. HEWITT, Collected Poems, Belfast, Blackstaff Press,1991, p. 77. See for instance “Phoenix Park” where the final revelation is that “life is hunger, hunger is for order / And hunger satisfied brings on new hunger / Till there’s nothing to come” (T. KINSELLA, Collected Poems. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 90). 10 T. KINSELLA, Collected Poems, cit., p. 85. 11 op. cit. p. 86. 12 D. MACDONAGH, “The Hungry Grass” in The Penguin Book of Irish Verse, ed. B. Kennelly, London, Penguin 1970. 13 J. MONTAGUE, “Famine Cottage”, Collected Poems, Dublin; Gallery Books, 1995, p. 267. 8 9 173 wolfed the blighted root and died14. For this reason the labourers “exorcise” the curse by pouring “libations” of cold tea on “the faithless ground”: the post-Famine land is a “black Mother” inspiring “fear and homage to the famine god”. No matter how good the harvest, “where potato diggers are, / you still smell the running sore”15. The most notable recent poetic account of the immense burden of human suffering which weighed on past and present is Desmond Egan’s sequence of elegies, Famine, published in 1997 – a grim anniversary piece. Rather than a collection of poems on the theme, Famine is a long lamentation, a form of keening inspired as much by pity as by anger. Structured in ten elegies plus one epilogue, the sequence flows obsessively with no pauses, no punctuation. The language is simple, essential, employing, however, a wide range of registers such as rage, sarcasm, pity and sentimentalism. Egan alternates pieces evoking the past tragedy – both famine poems and emigration poems – and other more meditative compositions reflecting the consciousness of a mutilated present or transcending time and Irish circumstances to introduce a cosmic vision of suffering. Thus the famine is lyrically depicted both as it occurred in the past and in its consequences for the present but also in the perspective of the cyclical genocides and massacres that have marked the history of Ireland and of humanity, paralleling another event that is painfully inscribed in the collective consciousness: the Holocaust16. In the poems that compose Famine, the speaking voice is not lyrical or subjective but rather a collective voice using the first person plural pronoun. It is the voice of the dead or of the emigrants/ exiles of last century and of the wounded community of the present, as in the following excerpt: S. HEANEY, Death of a Naturalist. London: Faber and Faber,1966, p. 32. Ibid. 16 The following table shows the pattern in which the poems are arranged in the sequence. By F, I have indicated famine poems and by E emigration poems. L indicates the lyrical and meditative outbursts. Some poems deal with the times of the famine and emigration and some with the consequences in present times. I F present; II F past; III L general; IV E past--double poem; V L present--double poem VI. E past --double poem VII L present (cf. I) VIII F present- (cf. I)-- double poem IX F past X E past XI L present (cf. I and VIII) 14 15 174 There is famine in our music famine behind our faces it is only a field away has made us all immigrants guilty for having survived has separated us from our language cut us from our culture built blocks around belief left us on our own17 Through this collective we, which is an ancestral voice as well, Egan attempts to sound the nation’s unconscious and bring back fragments of memory and fragments of language. Like “the drivers of motorway diggers / unearthing bones by accident / under disappearing hills”,18 (I, 16,) the poet digs up bits of lore and rhetoric, set images and phrases and makes them part of his linguistic and imaginative fabric. Throughout the sequence he tries to make his voice merge with the voice of tradition—both the tradition of famine literature and the much more ancient tradition of bardic poetry. Many of the set rhetorical topoi of popular famine literature (my emphasis in the text) are present in the following excerpts, conferring to the pieces a sort of traditional tone – a recording of the vox populi – which redeems them from charges of sentimental stereotyping. even the towns were abandoned to knots of unspeaking labourers no one wanting to say famine not even to the hinged coffin at the workhouse and the destitutes went home to the hovels of whimpering so much grief cannot be buried down the fields or under tumbled cabins 19 The graphically powerful synecdoches, as for instance that of the reusable 17 D. EGAN, Famine, Newbridge, The Goldsmith Press, 1997 (trad. italiana Carestia, a cura di D. Badin, Torino, Trauben, 2000), p.15. 18 op. cit. p. 16. 19 op. cit. p.17-18. 175 “hinged coffins”, convey the impossibility to cope with the large numbers of victims. Hinged coffin, the euphemistic workhouse, tumbled cabins and other examples taken from other poems, such as eating grass, coffin ships etc. are all keywords of the rhetoric of famine literature, as detailed by Morash20. To evoke the great tragedy and express the inexpressible, Egan attempts to go beyond language, tending towards the incantation and obsessive repetitions of litanies, magic formulas or primitive ritual music and recurring to devices borrowed from traditional Irish poetry such as triads (e.g. “our wool our linen our glass”)21 or enumerations and repetitions reinforced by anaphorae. While these arrangements of words helped the ancient bards to memorise, add and transform a series of data, in Egan they help underline the horror. The long lists are the poetic equivalent of historians’ statistics of death and destruction. The technique of accumulation and repetition conveys the hopelessness of trying to grasp a catastrophe too large to be comprehended in its entirety one thousand years of murder one thousand years of plunder one thousand years of rape the curse of Raleigh on you the curse of Cromwell too one thousand years in cells one thousand years climbing the gallows the gibbet the wooden triangle22 (V 25) To counteract the sentimentalism of many of the poems, Egan recurs to cutting sarcasm and grim humour, for instance in the many puns where, by the change of one letter or of one word, many realities are stripped of their linguistic pieties and revealed in their essence. Thus laisse-faire economics shows the real intentions of politicians: “their motto laissez mourir if such / were the holy will of trade”23. The sad consequence of absenteeism is “absentee tenants” with the difference that the landlords are absent because they are in their London clubs and the tenants in their graves, like their children who are not only "forced to miss school" but "to miss life" as well.24 C. MORASH, Writing the Irish Famine, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 5 . In the critic’s opinion, there is a sort of “intertextual archive” of “identifiable discursive formation[s]” such as walking shadows, eating grass, dying in the ditches etc 21 op. cit .p. 25. 22 Ibid. 23 op. cit. p. 17. 24 Ibid. 20 176 Irony is also apparent in yet another device adopted in several of the poems. Often the collective lamenting voice is counterpointed by another impersonal and official sounding voice. This happens in what Egan calls “double poems” – a peculiar feature of this sequence and of his poetry in general. Printed side by side with the lyrical poems (and recited simultaneously by two readers) are other poems – mostly made of excerpts from government reports and newspaper records. The synchronicity of the two voices and their tonal discordance very effectively convey the gap between the physical and moral suffering of the Irish and the callousness of those who observe it. Government reports and the press, but also historiography and present day revisionist debates on the question, speak a different language which is heard in the background of the intensely lyrical sequence. took away our great forests took our cattle away took away our farming our wool our linen our glass grabbed the very plots from under our hungry eyes starved our language tried our religion too a nation’s destiny drove us into the ditches of Europe and onto the sad tides the greatest blessing ask the natives children should be taught pride in their imperial heritage its transformation of the tumbled world for the lasting benefit of literally millions (V, 25) In contrast to the many commemorative or revisionist pieces of recent years in which scholars and historians have tried to separate facts from legend, to attribute responsibilities or exonerate from them, Egan probes the famine from within trying to convey the feel of hunger and the suffering of emigration which official histories, even the sympathetic ones, cannot seize. Through the devices I have briefly illustrated, Egan paints his large fresco of the famine in its many implications. The amplitude of the project, in spite of the rhetoric and sentimentalism that at times mar it, make Egan’s attempt one of the most complete in turning history into a national myth in opposition to the uses of the famine as a personal myth which we recognise in Kinsella, Kavanagh, Hewitt, or Heaney. Both approaches, however, emphasise the impossibility to map and comprehend the great ordeal of the famine. Poetry, like the science of cartography (to quote yet 177 another poet, Eavan Boland)25, is limited, when faced with a theme like the famine. With all their achievements, the poets we have examined prove it. 25 E. BOLAND, Collected Poems, Manchester, Carcanet. 1995, p. 175. My reference is to the poem “That the Science of Cartography is Limited” using the metaphor of the failure of maps to represent “the famine roads” built by the starving for the Relief Committee, for “Where they died, there the road ended / and ends still”. 178 179 VERSIONI DELL’ALDILÀ. DAL TESTO ALTOMEDIEVALE ECHTRA NERAI A IN THE LAND OF YOUTH DI JAMES STEPHENS Melita Cataldi Antiche trame sanno reggere sulle loro spalle il peso della storia, essere, di epoca in epoca, portatrici di rinnovati messaggi. Se ne ha conferma considerando l’appassionato impegno dell’Irish Literary Revival nella ripresa e reinterpretazione delle storie irlandesi medievali, impresa in cui si cimentarono scrittori del primo Novecento come W.B. Yeats, Lady Gregory, Austin Clarke e James Stephens. Di quella varietà di significati abbiamo un esempio nella riscrittura che, al crepuscolo di quella “renaissance” letteraria, James Stephens diede di un testo dell’altomedioevo irlandese. Il suo In the Land of Youth, pubblicato nel 19241, è diviso in due sezioni intitolate ai momenti cruciali del ciclo stagionale nella tradizione gaelica: Samain e Lugnasad. La prima sezione – The Feast of Samhain – rinarra tre antiche storie che Stephens abilmente collega e incastra una nell’altra ‘a scatole cinesi’.2 Come trama introduttiva e principale egli riprende opportunamente un racconto scritto in medio-irlandese attorno al X secolo, testo giunto a noi con il titolo Echtra Nerai3, edito e tradotto in inglese da Kuno Mayer nel 1889 con il titolo The Adventures of Nera.4 Stephens sceglie quella storia perché è tutta incentrata su Samain, il momento dell’anno, al passaggio tra ottobre e novembre, in cui, secondo la tradizione, tra questo mondo e l’aldilà – il síd – sono possibili contatti, interferenze, scambi, patteggiamenti e conflitti. Ma la scelta dipende soMacmillan & Co., London 1924. Il libro non è mai stato riedito né ristampato. È prossima la pubblicazione della traduzione italiana a mia cura. 2 Gli altri testi gaelici utilizzati nella prima sezione sono Aislinge Oenguso (Il sogno di Oengus) e De chophur in da muccida (La rigenerazione dei due porcari). La seconda sezione rinarra Tochmarc Étaine (Il corteggiamento di Étain). 3 Manoscritto Egerton 1782 del XVI secolo. 4 “Revue Celtique”, X, 1889, pp. 214-227. 1 180 prattutto dall’aver egli colto – al di là dell’apparente disorganicità del testo altomedievale – quanto radicale fosse quel tentativo di raffigurare la totale diversità di una dimensione alternativa al nostro mondo reale. Echtra Nerai è un semplice canovaccio, molto laconico e a volte poco chiaro nei nessi narrativi. Quanto ci rinarra Stephens è, al contrario, un gradevole racconto, attento a definire dettagli, a descrivere sensazioni e stati d’animo. Eppure ad una lettura attenta Echtra Nerai si rivela più articolato e complesso di quanto sia la sua ampia riscrittura moderna. Lo è soprattutto perché contiene già in sé una duplicità di strati, una reinterpretazione di una trama originaria che doveva avere altra ispirazione: vi si coglie infatti un orientamento ideologico che, nell’ambiente monastico in cui la storia era stata messo per iscritto, si era sovrapposto ad un fondo mitologico preesistente. Per parte sua Strephens tralascia l’uno e l’altro aspetto sostituendovi una sua personale interpretazione in chiave psicologica e tendenzialmente metafisica. Pur rimanendo in superficie fedele alla trama antica, egli in realtà la altera e fraintende. Tuttavia il moderno riscrittore sa mettere in giusto rilievo alcuni aspetti della figura del protagonista – come la sua liminarità e il suo carattere antieroico – e, soprattutto, sa cogliere il vero nucleo tematico del racconto: la relazione tra il nostro mondo e un altro mondo, tanto prossimo quanto profondamente differente e non-parallelo. La degenerazione del síd in Echtra Nerai La vicenda del protagonista5 è in Echtra Nerai seguita dalla giovanile prova di iniziazione fino all’assunzione di un suo ruolo definitivo. L’“avventura” (echtra) di Nera – o più propriamente la sua “uscita” dal mondo, il suo andare al di là e fuori e oltre (l’irlandese echtra ha la stessa radice del latino extra) – contiene alcuni spunti narrativi tipici delle antiche “biografie eroiche” irlandesi: la giovanile prova di coraggio del guerriero, premiata con la consegna da parte del re di un’arma prestigiosa; l’impresa solitaria e rischiosa di un campione che garantisce la sicurezza della propria gente; la scelta di abbandonare questo mondo per seguire una fanciulla del síd e diventare principe in quell’altro mondo di eterna giovinezza. In realtà Nera non è un guerriero, né un campione, né un principe: non combatte, non si scontra con nessuno, non usa mai la spada tanto ambìta. 5 Si veda qui in appendice la sintesi dell’intera vicenda narrata. 181 La sua avventura inizia con uno sconfinamento del tutto involontario da questo mondo; la sua prova di coraggio è superata solo grazie all’aiuto di un fuorilegge; e non sembra propriamente coraggiosa la scelta di accodarsi all’armata nemica dopo che essa ha travolto i suoi compagni, né sembra dignitoso il lavoro servile che in un primo tempo accetta di svolgere nel síd. Grazie a Nera il re Ailill potrà prevenire un attacco nemico, ma la realizzazione ultima di Nera sarà di essere un proprietario di mandrie dell’Oltremondo. Il suo ritorno finale in un síd ormai saccheggiato sembra attribuirgli un ruolo di colonizzatore piuttosto che di comando. Nera è quindi una figura vagamente picaresca: è uno che sbaglia (non sa legare il giunco, si addormenta quando deve badare alla mandria…), che subisce umiliazioni (fa il taglialegna), che accetta decisioni altrui, si adatta alle situazioni, sfrutta le occasioni, e solo casualmente, piuttosto che per sua virtù, svolge anche un’azione preziosa alla comunità cui appartiene: per caso esce dal nostro mondo, per caso scopre dove sono nascosti i tesori del re del síd, per caso viene a sapere di un pericolo imminente per i suoi. Nera si trova senza volerlo ad essere strumento di un destino più grande di lui: il destino dei rapporti di forza tra il suo mondo e un altro mondo. Il soggetto centrale del racconto non è dunque la personalità di Nera ma proprio la relazione tra quei due ambiti, un tema centrale nella letteratura medievale irlandese. Quando Nera passa da un mondo all’altro e, in lui, quelle due dimensioni vengono in contatto, le nostre categorie di spazio, tempo e causalità non hanno più corso. Nel síd si entra attraverso una caverna, eppure nell’aldilà non si è sottoterra. Nera vi arriva camminando per pochi minuti eppure ha lasciato alle spalle una natura invernale e trova i fiori dell’estate. Il tempo scorre non solo con velocità molto diversa ma anche e soprattutto con modalità che risultano incomprensibili alla nostra mente. A ben considerare ci si rende conto che le apparenti incoerenze del racconto non sono che espressione dell’incoerenza e dell’inconfrontabilità tra i due mondi. Quando inizialmente Nera, che ha lasciato la reggia di Cruachan nella notte di Samain, vi fa ritorno per la prima volta dopo la strana avventura notturna con l’impiccato, è come se tornasse al Samain dell’anno successivo, in un futuro che però è un futuro possibile, eventuale, virtuale. Quando poi egli, dopo aver svolto per qualche tempo la corvée di taglialegna, essersi unito alla donna del síd e aver concepito un figlio, ritorna per la seconda volta a Cruachan, è come se viaggiasse nel passato, perché vi trova tutti ancora in attesa di banchettare come quando se ne era allontanato la prima volta. Poi, dopo un anno vissuto a Cruachan, pochi giorni 182 prima della seconda Samain, prima cioè che si riaprano i confini tra i due regni e tra essi possa avvenire lo scontro militare, Nera torna nel síd, conosce il figlioletto nato nel frattempo, una vacca viene ingravidata, partorisce un vitellino e questo diventa un fortissimo torello. Non è detto in quanto tempo tutto ciò avvenga in quell’aldilà, ma sappiamo che quando Nera ritorna per la terza volta a Cruachan, Samain (ancora la seconda Samain) non solo non è passata ma non è nemmeno imminente e c’è tempo perché quel torello del síd si confronti con il campione tra i tori del Connacht – e la vittoria di questo appaia come preannuncio della vittoria di Medb sul re del síd. Mentre dunque nel mondo degli uomini tutta la vicenda narrata è racchiusa nell’arco di un anno – da una festa di Samain a quella successiva, nell’altro mondo c’è il tempo perché un bambino sia concepito e nasca e poi un torello sia concepito e, con portentosa rapidità, nasca, cresca e sia in grado di combattere. Questo è possibile perché l’Oltremondo pagano era concepito come ambito in cui il tempo tende ad annullarsi, e passato e futuro possono sovrapporsi in un eterno presente. Se non si considera che il racconto intende mostrare l’incongruenza tra i due mondi, pare incongruo il racconto stesso e frutto di una maldestra compilazione: così infatti il testo fu giudicato a fine Ottocento dai suoi primi studiosi. Tutto questa complessa e sorprendente vicenda apre a varie possibili speculazioni, una delle quali verte sull’esistenza di un mondo di idee, archetipi, prototipi, di necessità, al quale si contrappone un mondo, il nostro, in cui invece si realizzano possibilità, in cui sono in gioco eventi possibili, forse casuali, comunque non predestinati. Nera può avere avuto in sorte di intercettare un futuro possibile ma non reale proprio perché egli è un essere umano. La sua compagna ride quando vede Nera spaventato per la strage cui ha assistito a Cruachan: “is sluag siabra dotainicc” gli spiega: “un’armata fantasma è venuta per te”, soltanto per te. Come altri testi tramandati dal medioevo irlandese, anche Echtra Nerai mostra di essere risultato di successive elaborazioni e integrazioni. Non è allora strano che anche la raffigurazione del síd si colori di tratti ideologici e politici contingenti, storicamente determinati. In questo scontro tra la sovranità del síd della mitologia pagana e quella del Connacht ci viene qui raccontato anche un momento di un progressivo “crepuscolo degli dèi”, qualcosa sul passaggio di poteri tra il mondo delle 183 antiche divinità – degradate in fantasmi, spiriti, demòni – e l’Irlanda di un’età ormai cristianizzata.6 La vicenda di Nera racconta come un potere nemico e ostile sia sconfitto dalle forze del Connacht, e offre spunti per capire perché quel regno straniero sia ormai indegno di conservare gli emblemi della legittimità regale, e sia dunque giusto che essi ritornino tra gli uomini d’Irlanda. Il síd è diventato un regno disarmonico, governato da un re che non ha più un buon rapporto con i sudditi, che non si fida di nessuno di loro, per cui tiene nascosti gli emblemi della sovranità – corona, mantello e tunica – nel fondo di un pozzo al di fuori delle fortezza e li fa quotidianamente controllare da due persone sfruttandone non le doti ma i difetti (essi sono senza occhi l’uno e senza gambe l’altro). La casa in cui Nera conduce l’impiccato a dissetarsi – quella che non ha protezione dai rischi della notte, in cui (trascurando una riconosciuta regola igienica) sul pavimento vengono tenuti anche di notte secchi l’acqua sporca e maleodorante e i cui abitanti infine muoiono avvelenati in conseguenza della loro sprovvedutezza – è uno specchio di quello stesso síd mal governato. Nel confronto tra il re del síd e il re del Connacht, quest’ultimo appare nettamente più affidabile e avveduto e dunque più legittimato. Nell’antica ideologia gaelica la legittimità del potere sovrano aveva fondamento nella specularità con quel modello di società armoniosa che era la sede degli dèi, quel luogo di pace che era il síd7 (non a caso questa parola ha la stessa radice del sostantivo latino sedes ma, prima ancora, del verbo latino sedare, ‘pacificare’)8. In Echtra Nerai – il cui testo, come tanti altri testi irlandesi antichi, si è salvato grazie al lavoro di trascrizione dei monaci – i tre simboli della sovranità sono sottratti al pagano síd per essere acquisiti dagli uomini d’Irlanda e spartiti dal Connacht con il Munster e il Leinster. In questi due regni, ci viene precisato, quei simboli sono conservati rispettivamente nel luogo monastico di Kildare (fondato da Santa Brigida) e nella sede vescovile principale d’Irlanda, quella di Armagh (fondata da San Patrizio): vessilli ormai sotto protezione cristiana, perché è la nuova religione, non più quella antica, a garantire legittimità e pace. L’aldilà è un mondo irredento, “in cui compaiono regolarmente demòni” (demna in irlandese), in cui sul colle Il merito di aver fatto notare questi elementi di cristianizzazione del testo va a JOHN CAREY, Sequence and causation in Echtra Nerai, in “Eriu”, XXXIX, 1988, pp. 67-74, e a KIM MCCONE, Pagan Past and Christian Present, An Sagart, Maynooth, 1990, pp.151-152. 7 Per questo aspetto del sídh cfr. JOHN CAREY, Time, space, and the Otherworld, in “Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium”, 7 (1987), pp. 1-27. 8 Cfr. TOMAS O’ CATHASAIGH, The semantic of ‘síd’, “Eigse”, XVII (1977-79), p.137-155. 6 184 tra due malviventi “crocifissi” (in irlandese il verbo crochaid – da croch, calco dal latino crux – indicava indifferentemente l’impiccare e il crocifiggere) non c’è un Redentore.9 La interpretatio christiana dell’antica credenza in un altromondo abitato da esseri sovrumani veicola l’idea che quello sia un mondo demoniaco, caotico, minaccioso, che deve essere soggiogato e – come sembra fare Nera alla fine – in qualche modo colonizzato. Quel giunco che, all’inizio del racconto, Nera riesce a stringere attorno al piede dell’impiccato – come la pastoia messa ai piedi degli animali selvatici per tenerli a bada – è un segnale di dominio dell’uomo su qualcosa di oscuro, sfuggente: un aldilà fantasmatico e inquietante. La reinterpretazione del síd in In the Land of Youth Questa sottile sovrapposizione ideologica e religiosa che accentua la negatività del síd, in Stephens sembra scomparire. Quanto dell’aldilà in Echtra Nerai è negativo viene da Stephens volto in positivo o abolito: il re del shí è bonario; il lavoro che Nera fa nel bosco gli si addice perché era stato capo di una truppa di portatori d’ascia; persino i due guardiani menomati svolgono volentieri il loro compito quotidiano perché così hanno l’impressione di possedere quei tesori. Da Stephens viene ignorata l’intera seconda parte del testo antico, quella – dalla nascita del figlio di Nera allo scontro tra i due tori – in cui il conflitto tra questo e l’altro mondo si mostra insanabile. Persino l’episodio di Nera che porta l’impiccato a bere è trasformato in una scena comica: alla prima casa che incontrano, bussano, chi apre scappa per lo spavento perché quell’energumeno sembra il diavolo, e costui si beve tre secchi d’acqua (pulita) e se ne va finalmente soddisfatto a farsi impiccare. – “Do you feel any better now, my darling?” – “ I feel splendid “ said the outlaw. “ I’ll be dead in a jiffey”.10 In queste pagine Stephens conferma la sua propensione ad alternare registri diversi, come il grottesco (il dialogo tra Nera e l’impiccato) e il comico (il dialogo tra cieco e storpio), la descrizione realistica (la scena iniziale e finale alla corte di Medb), l’introspezione psicologica (gli stati d’animo di Che un “crocifisso” morente chieda da bere è, presumibilmente, un motivo anch’esso ispirato dal racconto evangelico della Passione. 10 In the Land of Youth, pag 18. 9 185 Nera) e la speculazione filosofico-teosofica con risvolti sapienziali (le spiegazioni che la fanciulla del síd fornisce al forestiero. Nel rinarrare l’avventura di Nera, Stephens dà soprattutto spazio a emozioni e riflessioni: elementi che in Echtra Nerai sono del tutto assenti. Sono pagine raffinate quelle in cui descrive le contrastanti sensazioni di Nera mentre si dirige nel buio verso la collina, o quelle in cui descrive il tenero idillio con la fanciulla del síd . Ciò che Stephens sa bene raccogliere dal testo antico à l’aspetto antieroico – e per questo tanto più umano – del protagonista11. Il suo Nera è un giovane di buon cuore e ben determinato, ma ingenuo e un po’ infantile nel suo desiderio di ricevere un premio di prestigio, sempre molto perplesso quando gli vengono svelati i misteri del síd. Egli è, per Stephens, soprattutto un uomo in between, sballottato tra due dimensioni, che sente di non aver più radici nel vecchio mondo ma di non appartenere davvero a quello nuovo, disorientato e destinato alla liminarità. È diviso, anche, tra voglia di godersi serenamente il suo nuovo amore e la forte nostalgia di quel che ha visto distrutto. Quanto alle speculazioni sulla discrepanza tra questo e l’alto mondo, Stephens mette tutto il suo impegno nel reinterpretare gli spunti antichi nel quadro delle proprie speculazioni teosofiche, dando loro una prospettiva nettamente psicologica. L’inconfrontabilità dello scorrere del tempo nei due mondi diventa un preciso rapporto tra due velocità confrontabili: un giorno corrisponde ad un solo minuto nel mondo dei viventi, perché là il tempo è più lento, tende verso un annullamento. Quando Nera vede la fortezza di Cruachan messa a ferro e fuoco, non fa – secondo Stephens – esperienza di un futuro virtuale ma, in un quadro parapsicologico, intercetta, nel presente, la mente del re del síd. “A thing – said she – can be conceived and exercised in the mind, but when it has been so exercised in the mind that it really becomes real there, it then becomes real in every part of nature and in all the worlds where life is living”.12 11 Come ci è confermato anche da altri suoi libri, l’elemento antieroico è a Stephens congeniale, e questo ci offre forse uno spiraglio di luce per capire perché Stephens non abbia mai realizzato il progetto di rinarrare l’epopea dell’eroe Cu Chulainn, e, d’altra parte, per intuire che cosa mai spingerà nel 1927 James Joyce – al di là della futilissime ragioni da lui addotte – a considerare Stephens un possibile suo sostituto per portare a termine Finnegans Wake. 12 In the Land of Youth, p. 52. 186 Gli andirivieni del Nera antico tra i due mondi sono per il nuovo Nera ridotti ad una sola iniziale andata al di là e un solo finale ritorno di qua: questo perché ciò che a Stephens preme evidenziare non è la inconciliabilità tra quelle due dimensioni ma la loro compresenza. Ciò che gli importa è, in fondo, reinterpretare le parole della giovane del síd – a ghost army came to you – come affermazione del primato della dimensione interiore, mentale, onirica su quella esteriore, materiale, fenomenica. L’aldilà – ci suggerisce fuggevolmente lo scrittore – è un mondo magico, un Fairy, per la stessa ragione per cui i maghi sanno con la forza della volontà determinare gli eventi, e i poeti sanno con la forza dell’immaginazione evocare sogni, passioni, desideri. Di qui l’insistenza nel dipingere la vita di quegli spiriti come quella in cui solo i desideri intensi si concretizzano: “Nothing is real here, for everything is wished”. “It is by this wishing and willing that the worlds are made, and that everything is made”.13 Confluiscono in queste speculazioni di Stephens eterogenee suggestioni culturali: la concezione gaelica di una perfetta società di esseri soprannaturali cui la società dei viventi vorrebbe corrispondere specularmente; le convinzioni gnostiche e teosofiche sulla metempsicosi; l’idea shopenhaueriana della volontà come sostanza del mondo (rispetto a cui la “realtà” è mera rappresentazione e apparenza); la concezione freudiana di un inconscio in cui sono in gioco soprattutto Wünchen, wishes; la contrapposizione bergsoniana tra il tempo cronologico e il tempo soggettivo, e forse certi assilli degli scrittori modernisti sul tempo interiore. L’aldilà che Stephens abbozza e che la donna del síd cerca – invero senza molto successo – di far capire alla mente poco speculativa di Nera, è una dimensione più evanescente di quanto sia la realtà materiale: “ …as a wish is formed in the mind, so it must be satisfied in the mind; and as this is the first world of the mind, and as you strayed into it, you have seen something happening which happened in the mind, and did not happen anywhere else”.14 Alla ricerca di schemi ciclici, Stephens ci racconta che quel “primo mondo della mente” – la nuova versione del síd – è Tir na n-Óg, la Terra della Giovinezza, entro cui sta un mondo più rarefatto e lento, la Terra 13 14 Ivi, p. 40 e p. 53. Ivi, p. 51. 187 delle Meraviglie, che a sua volta cela un nucleo remoto e senza tempo, la Terra della Promessa: e le anime trasmigrano fra quei mondi concentrici per tornare poi da capo nel primo mondo, quello frenetico, convulso, delle ambizioni e dei tormenti che sta in superficie, il nostro. L’Oltremondo beato, pacifico e speculare del mito antico, cui si era sostituito nell’ideologia cristiana un Oltremondo degradato, demoniaco e minaccioso, ha potuto così rinnovarsi in Stephens come dimensione della mente, articolata in varie stratificazioni sempre più profonde che interferiscono con i nostri stati di coscienza e al di là della coscienza stessa: “… we may be interfered with beyond our knowledge”.15 Appendice Diamo qui una sintesi di Echtra Nerai. In una cupa sera di Samain, quando i confini con il síd sono aperti e possono comparire demoni, mentre alla fortezza di Cruachan si sta preparando il banchetto regale, Ailill re del Connacht promette una ricompensa a chi avrà il coraggio di raggiungere sulla collina i due malfattori impiccati il giorno prima e, a testimonianza, lasciare un cerchio di giunco attorno alla caviglia di uno di loro. Si fa vanti un giovane, Nera, e a lui Ailill promette la propria spada. Nera riesce a raggiungere nelle tenebre i due giustiziati e tenta invano tre volte di chiudere ad anello il giunco al piede di un impiccato, finché la voce di quell’energumeno gli suggerisce opportunamente di usare un fermaglio. In cambio di quell’aiuto, quello gli chiede di tirarlo giù, caricarselo sulla schiena e portalo fino ad una casa dove possa placare la sua tremenda sete. Nera accetta. Nella notte i due incontrano una casa protetta dal fuoco, un’altra protetta da un lago. Solo in una terza casa, non protetta, possono entrare. L’assetato trova tre secchi pieni d’acqua sporca, beve tutto e sputa l’ultimo sorso in faccia agli abitanti della casa, che subito ne muoiono. Riportato il condannato alla sua forca, Nera ritorna – o crede di tornare – alla fortezza di Cruachan, ma la trova messa a ferro e fuoco da guerrieri nemici e vede le teste mozzate dei suoi sovrani e dei suoi compagni. Allora si accoda a quei guerrieri che rientrano vittoriosi nel síd. Allo straniero il re del síd impone un lavoro di fatica – portargli ogni giorno dal bosco ceppi di le- 15 Ivi, p. 8. 188 gna da ardere – e lo manda a vivere in una casa dove è accudito da una giovane donna. Quando trasportava la legna dal bosco alla fortezza, Nera incontrava a volte sul sentiero un cieco che reggeva sulla schiena un uomo senza gambe. Seguendoli di nascosto vedeva che raggiungevano la bocca di un pozzo e ogni volta il cieco chiedeva “C’è?”, ricevendo dall’altro conferma. La giovane donna con cui Nera vive gli spiega poi che quei due sono incaricati dal re di controllare ogni giorno se la sua corona reale è sempre là nascosta. Nera rivela alla donna di essere venuto nel síd perché aveva visto distrutta Cruachan e uccisa la sua gente, ma essa gli spiega: “Non è vero! Hai incontrato solo un’armata di fantasmi. E non sarà vero nemmeno in futuro, se avviserai i tuoi, il che puoi ancora fare perché Samain non è passata ed essi sono là come li avevi lasciati: nel tuo mondo sono trascorsi pochi minuti”. Po gli rivela anche che è profetizzato che saranno Ailill e la ragina Medb a razziare il síd e ad impossessarsi dei tesori regali: la corona di Brian, il mantello di Loegan, la tunica di Dunlaing. Infine, quando Nera la sta lasciando, gli annuncia che gli darà un figlio. Perché possano credere che è stato nel síd, Nera ritornando nel suo mondo d’inizio inverno porterà con sé le erbe e i fiori di inizio estate. Nera giunge a Cruachan e trova ancora tutti riuniti attorno al calderone per il festino di Samain. Racconta la sua avventura e ha in dono la spada del re. Trascorso un anno Nera è invitato da Ailill a tornare nel síd per portare in salvo i suoi beni prima della razzia. Là, la donna gli presenta il piccolo Aingen, nato nel frattempo, cui essa ha dedicato, come dono augurale, una portentosa vacca da latte. Nera conduce al pascolo la mandria ma si addormenta e la dea Morrigan può sottrargli quella giovenca, portarla nella penisola di Cuailnge e farla ingravidare da Donn, lo straordinario toro bruno. Poi Morrigan è però costretta da Cu Chulainn, difensore del Cuailnge, a restituire la vacca alla sua mandria. Poco prima di Samain, Nera conduce i bovini nel mondo dei viventi ma, appena passato il confine, il torello nato dalla vacca di Aingen fecondata dal toro Donn manda tre forti muggiti in segno della sua volontà di predominio sul territorio. Nella piana di Cruachan avviene un scontro tra quel precocissimo torello del síd e Finbennach, il meraviglioso toro di Medb. Questi prevale ma il torello sopraffatto con i suoi muggiti dice che Finbennach sarebbe sconfitto se osasse confrontarsi direttamente con Donn. Medb raccoglie la sfida e giura 189 che al più presto assisterà a quello scontro per confermare la propria supremazia. [Quello scontro sarà argomento del testo epico Táin bó Cúailnge]. Giunta Samain, gli uomini di Fergus, alleato di Medb, entrano nel síd e fanno razzia portando via anche i tre emblemi della sovranità che vengono divisi fra tre province d’Irlanda e verranno protetti a Cruachan, Kildare e Armagh. Poi Nera rimane per sempre nel síd . 190 “COSÌ NON È MAI STATO”: I LIVING HISTORY MUSEUMS E LA DISNEYZZAZIONE DEL PASSATO IN AMERICA Andrea Carosso L’11 novembre 1993 la Walt Disney Corporation annunciava il progetto di un grande parco a tema da costruire a ridosso della cittadina di Haymarket, in Virginia, a poche decine di miglia dalla capitale Washington, DC. Il nome del nuovo parco, Disney’s America, prefigurava senza ombra di equivoco una nuova pagina di quella che lo storico dell’urbanistica Joel Findlay ha definito la “disneyzzazione” del paesaggio americano1, quella tendenza sempre più diffusa al di là dell’Atlantico a creare luoghi “simulati” in cui centralizzazione del controllo e privatizzazione dello spazio profondamente trasformano lo statuto del concetto di “luogo” (shopping malls, i parchi a tema e addirittura le nuove megachurches rientrano in un modo o nell’altro in questa tendenza). Nel caso specifico, la Disney Corporation aveva in mente la realizzazione di una fantasia che avrebbe mischiato celebrazione patriottica, ricostruzione storica e intrattenimento di massa in un resort molto vasto, grande quanto dieci Disneyland messe insieme, e in cui l’immaginario disneyano avrebbe ancora una volta confezionato – insieme a parchi acquatici, campi da golf, alberghi e abbondanti spazi commerciali – una interpretazione idilliaca ed eccezionalista della storia americana. Per la cittadina di Haymarket, l’annuncio valeva una vera e propria sentenza capitale: non solo orde di turisti avrebbero di lì a pochi anni (la Disney aveva annunciato l’apertura del parco nel 1998) sconvolto la quiete di numerose comunità suburbane alle porte della capitale, ma uno dei luoghi storicamente più significativi dell’intero paese, il sito della storica battaglia di Manassas (lo scontro che, nel 1861, segnò l’inizio della guerra J. M. FINDLAY, Magic lands: western cityscapes and American culture after 1940, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 52. 1 191 civile americana) che sorgeva a meno di 5 miglia dal sito, sarebbe stato letteralmente fagocitato dal costruendo parco2. Nei comunicati stampa, la Disney descriveva il futuro parco a tema come “un luogo unico e storicamente fedele in cui celebrare la ricchezza e la diversità, lo spirito e l’innovazione […] cioè quelle speciali qualità americane che sono state la forza del nostro paese e che lo hanno reso un faro di speranza per la gente di ogni dove.” Disney’s America avrebbe visto sorgere villaggi in miniatura ben ordinati, una Hall of Presidents per celebrare i molti capi di stato nati in Virginia e un ottovolante denominato The Industrial Revolution; i visitatori avrebbero potuto provare l’ebbrezza di un lancio con il paracadute o di manovrare un carro armato pronto per il combattimento; ci sarebbe stata una ruota panoramica, una replica perfetta di una fattoria stile ottocento e un edificio che sarebbe “assomigliato a Ellis Island”3. Rispetto ai parchi a tema già esistenti, industria della quale la Disney è pioniere e leader mondiale, Disney’s America segnava chiaramente uno scarto in avanti: non più la realizzazione di fantasie provenienti da libri o cartoni animati (questo è, detta in breve, il modello delle tante Disneyland sparse per il mondo), né l’invenzione di un improbabile, sempre anacronistico futuro di eclettici mezzi di trasporto collettivo e altre fantasie futuriste (come avviene a Epcot Center)4, il nuovo parco avrebbe affrontato vis-à-vis la problematica memoria collettiva statunitense dalla nuova prospettiva di strategie interpretative che avrebbero posto il visitatore non come mero spettatore (come cioè normalmente avviene in un museo), ma come partecipante attivo (questo è sempre il succo della filosofia Disney) di una “esperienza”. Disney’s America, insomma, si sarebbe cimentata con la cosiddetta “living history”, o “storia vivente”, una branca della museologia iniziata ben prima della Disney e che ha assunto particolare importanza a partire dal secondo dopoguerra proprio sulla scia del grande successo dell’impero turistico disneyano. Disney’s America si preparava a collocarsi primo nella classifica dei molti Living History Museum (LHM) d’America. Il National Register of Historic Places degli Stati Uniti censisce oltre 79.000 siti storici nel paese, 2.400 dei quali sono catalogati come National Historic Landmark5. Di questi, circa mille operano commercialmente6 e 2 La vicenda della progettazione del parco è bene riassunta in C. W. BAILEY, “How Washington insiders ambushed Mickey Mouse”, in The Washington Monthly, 1994, p. 10-14 3 “Step Up, Folks! Check It Out! Nationhood!”, New York Times, 29.05.1994. 4 Sull’anacronismo del futuro in versione Disney, si veda S. BUKATMAN, “There’s Always Tomorrowland: Disney and the Hypercinematic Experience”, October (57) 1991, pp. 55-78. 5 http://en.wikipedia.org/wiki/National_historic_site 192 numerosi di essi costituiscono nell’America odierna importanti destinazioni turistiche, luoghi in cui ricerca storica ed esigenze della cultura di massa si incontrano, spesso con risultati inattesi: luoghi come Mount Vernon, poco a sud di Washington, DC (noto come “la prima casa d’America” – America’s First Home – perché fu la residenza del suo primo presidente, George Washington), Monticello in Virginia (la casa che Thomas Jefferson, terzo presidente, si costruì pezzo per pezzo nel corso di buona parte della sua vita), Ellis Island (il porto d’arrivo degli immigrati a cavallo tra otto e novecento) e il Tenement Musuem nella Lower East Side di New York (in cui continua a vivere il ricordo delle durissime condizioni di vita dei nuovi arrivati nel nuovo mondo ad inizio novecento). Un numero cospicuo di questi National Historic Landmarks poi si sono specializzati ulteriormente nel senso di Musei di Storia Vivente (LHM)7, luoghi cioè che oltre a ricostruire e preservare architetture e oggetti di luoghi di particolare importanza storica (edifici, piani urbanistici, decorazioni interne, oggetti d’epoca e così via), innestano in quei luoghi una dimensione che potremmo definire “teatrale”, in cui cioè si fa ricorso a specifiche strategie di rievocazione del passato – tanto nel modo di arrangiare gli oggetti in mostra quanto nel ricorso ad attori e comparse che rievocano arti, mestieri, abitudini e saperi delle persone che in quei luoghi vivevano – per creare una ricostruzione iconica e tangibile dei luoghi come erano, come si ritiene siano stati o semplicemente come si vorrebbe poterli pensare.8 In breve, i LHM sembrano la perfetta incarnazione di quella che Umberto Eco ha definito la “ossessione” con l’Iperreale di un paese per il quale “se la ricostruzione deve essere credibile, deve essere assolutamente iconica, perfettamente somigliante, una copia ‘vera’ della realtà rappresentata”9. Benché originariamente concepiti in Europa, è infatti nel Nuovo Mondo che i musei di storia vivente sono diventati una vera e propria industria, incentrata sulla complessa commistione di recupero architettonico, ricostruzione storica e rappresentazione teatrale. Secondo la definizione ufficiale della ALHFAM (l’associazione che nel Nord America raggruppa questo tipo di organizzazioni), i musei di storia vivente sono luoghi dedica6 United States 2002 Economic Census, Agosto 2005, U.S. Census Bureau (http://www.census.gov/prod/ec02/ec0271a1us.pdf), p. 1 7 Uno studio del 1989 riporta l’esistenza di circa 60 Living History Museums in Nord-America (W. LEON e R. ROSENZWEIG, History museums in the United States: a critical assessment, Urbana, University of Illinois Press, 1989, p. 69). La Association for Living History, Farm and Agricultural Museums elenca attualmente più di duecento parchi associati. 8 Sull’ambiguo trattamento del passato nei LHM, si veda la parte conclusiva di questo saggio. 9 U. ECO, Travels in Hyperreality, New York, Harcourt, Brace and Co, 1990, p. 4. 193 ti a preservare “la cultura materiale, e specialmente gli edifici, dell’era preindustriale in un mondo in rapida industrializzazione,” focalizzati nel “collocare edifici e cose nel loro contesto appropriato ed a utilizzarli quali risorse educative attraverso programmi pubblici mirati a catturare l’immaginazione dei visitatori”10. I LHM sono dunque organizzazioni deputate tanto a preservare luoghi significativi del passato quanto a consentirne la rielaborazione nell’immaginario del visitatore: si pongono cioè come “esperienza”, in cui la partecipazione attiva del visitatore prende la precedenza sull’esperienza “passiva” tipica del museo tradizionale. L’idea originaria risale a uno svedese, tale Arthur Hazelius, che nel 1891 propose un parco vicino al centro di Stoccolma in cui ricostruire la vita quotidiana e il lavoro della gente di quei luoghi in epoche passate. L’intuizione divenne talmente popolare che a soli vent’anni di distanza, nel 1912, l’antiquario del new England George F. Dow importò l’idea in America intervenendo su una storica dimora di Salem, in Massachusetts, la John Ward House, che divenne il primo LHM del nuovo mondo. Posando, come scrisse lo stesso Dow, “casualmente su un tavolo di fronte al camino un quotidiano di Salem datato 1800 e su di esso un paio di occhialini antichi, come se il lettore ve li avesse appena appoggiati sopra”11, si tentava di offrire una ricostruzione della vita in una casa del New England nel XVII secolo, con lo scopo di presentarne un quadro realistico ed iconico attraverso il mix di oggetti d’epoca e riproduzioni di oggetti non più disponibili. A ben guardare, si potrebbe argomentare che la tradizione della storia vivente in America precede addirittura l’antenato europeo. La si potrebbe far risalire addirittura agli anni ‘70 dell’ottocento, quando William Frederick Cody, meglio noto con lo pseudonimo di Buffalo Bill, venne convinto da uno scrittore di romanzi popolari, Ned Buntline, a salire su un palcoscenico e rappresentare se stesso quale ideale modello dell’uomo della frontiera. Nacque così il primo grande spettacolo d’America, denominato Buffalo Bill’s Wild West, che girò per anni in lungo e largo il nuovo e il vecchio continente e in cui Cody sciorinava una versione romanticizzata del west americano, con tanto di cowboy, assalti alla diligenza e comparsate di nativi americani – tra cui per un certo periodo vi fu addirittura il capo indiano Toro Seduto. In un’epoca in cui i trasporti erano alla portata di pochi, Buffalo Bill portava il suo spettacolo viaggiante in giro per il http://www.alhfam.org/ G. DOW, “Museums and The Preservation of Early Houses” (1922), cit. in Dianne H. PILGRIM, “Inherited from the Past: The American Period Room”, American Art Journal, 10.1, 1978, p. 8. 10 11 194 mondo, concepito come “una mostra su grande scala con intenti educativi e dal divertimento assicurato”12. Anticipando il museo storico vivente, il Buffalo Bill’s Wild West già conteneva tutti gli elementi di una storiografia opinabile – e che puntualmente ritroviamo, come vedremo, nei LHM – innestata nel formidabile connubio tra libera rievocazione del passato e intrattenimento di massa, da cui puntualmente risulta una rielaborazione storica al servizio di un progetto ideologico. Nel Wild West Show, l’asservimento all’ideologia dominante era evidente, come ha bene mostrato Bruno Cartosio nel libro Da New York a Santa Fe (1999), nell’invenzione e romanticizzazione del figura del cowboy, una “mistificante mitopoiesi opportunistica”, che faceva assurgere questi vaqueros angloamericani “al ruolo di depositari e interpreti di una romantica ‘americanità’: protagonisti improbabili per uno ruolo mai neppure da essi sognato, assegnato ai loro fantasmi da un’industria culturale consensualmente impegnata a costruire la mitologia nazionale.”13 Analogamente, il LHM “inventa” ciò che non esiste più sulla scorta della semplice ipotesi che esso avrebbe potuto esistere. A ben vedere, è la stessa logica che regola anche il restauro pittorico: ridare a un quadro ciò che quel quadro non contiene più ma che si ritiene essere esistito in precedenza. Analogamente al restauro pittorico, il LHM restituisce quello che il tempo ha sbiadito o rimosso – questa volta sotto forma di cose, persone, animali, cibi, discorsi e abitudini di un’epoca passata. È un miscuglio di falso e autentico che se da un lato si configura come vero e proprio pastiche postmoderno, dall’altro rende altamente problematico lo statuto della ricostruzione storica, sintomo che secondo la critica d’arte Ada Louise Huxtable segnala la perdita di contatto tra l’America e la realtà: “I do not know just when we lost our sense of reality or interest in it, but at some point it was decided that reality was not the only option; that it was possible, permissible, and even desirable to improve on it”14. Il primo grande museo all’aria aperta (così venivano – e vengono talvolta tuttora – anche chiamati i LHM) d’America fu inaugurato nel 1929: era il Greenfield Village di Dearborn, Michigan, opportunamente finanziato dal grande magnate di quella zona, Henry Ford (vari studiosi hanno fatto rilevare come i musei di storia vivente siamo fortemente Bruno CARTOSIO, Da New York a Santa Fe: terra, culture native, artisti e scrittori nel Sudovest (1846-1930), Firenze, Giunti, 1999. 13 Ibid., p. 87 14 A. HUXTABLE, The Unreal America. Architecture and Illusion, New York, The New York Press, 1997, p. 15 12 195 radicati nella sponsorizzazione di grandi conglomerati industriali)15. Fu un successo immediato: inaugurato all’apice della Grande Depressione, registrò 240.000 visitatori nel 1934 e 633.000 nel 1940. Il principio guida del Greenfield Village era semplice: narrare la storia prescindendo dai grandi eventi politici e bellici, per concentrarsi invece sulla “vita di ogni giorno della gente comune”. Autodefinitosi “la maggiore attrazione storica d’America”, il Greenfield Village è ora parte integrante dello Henry Ford Museum, un grande complesso museale che raccoglie rarità della storia industriale e politica d’America16. Secondo l’ALFHAM, educazione, intrattenimento e preservazione sono i cardini della missione dei LHM odierni. E mentre il Buffalo Bill’s Wild West inventava il mio della frontiera proprio nel momento in cui questa scompariva, mettendo in scena vecchi frontiersmen che rappresentavano se stessi, i Living History Museums presentano la storia in quanto spettacolo di ricostruzione pura di un passato concluso, in cui la messa in scena dell’originale cede il passo alla ricostruzione e alla finzione teatrale, in un “prodotto” venduto come viaggio in una immaginaria macchina del tempo e attraverso il quale il visitatore viene catapultato in medias res, in una dimensione spazio-temporale parallela. La creazione di questa dimensione parallela si fonda tanto sulla ricostruzione architettonico-decorativa (di cui ho già parlato e su cui ritornerò nella trattazione di Colonial Williamsburg più avanti) quanto sulla cosiddetta “interpretazione” – il vero sale di un LHM, che nella sua organizzazione conta decine, o addirittura centinaia, di attori e comparse a cui è delegato il compito di creare la “magia” della ricreazione del passato. Ed è proprio l’interpretazione al centro del dibattito e delle polemiche nella letteratura specializzata – una letteratura a metà tra la museologia e i drama studies, in cui costantemente si dibatte se sia preferibile la cosiddetta interpretazione “in prima persona” (in cui gli attori si calano a 360 gradi nel personaggio che interpretano e colloquiano con i visitatori alla prospettiva di costui o costei senza mai uscire, e con esiti talvolta surreali, dal personaggio interpretato), o quella “in terza persona” (in cui gli attori funzionano come delle guide turistiche che, in una narrazione al passato, raccontano episodi di vita dell’epoca che il museo ricostruisce) o addirittura, ultima frontiera dei LHM, l’interpretazione “in seconda persona” (in cui i W. LEON e R. ROSENZWEIG, History museums in the United States, cit., p. 66-67. Lo Henry Ford Museum possiede, tra le molte cose, l’autobus su cui la disobbedienza di Rosa Parks segnò uno dei momenti più significativi la lotta per i diritti civili, una provetta proveniente dalla camera da letto di Edison e quel Corliss Engine che nell’esposizione universale di Philadelphia del 1876 aveva annunciato i futuri fasti dell’industria americana. 15 16 196 visitatori vengono coinvolti direttamente in attività d’epoca quali cucinare, tessere, maneggiare le armi). Il maggior museo storico vivente oggi funzionante in Nord America è certamente Colonial Williamsburg, cittadina della Virginia originariamente fondata nel 1633 e trasformata in LHM nel 1934 grazie a un finanziamento di John D. Rockefeller che, come Henry Ford, aveva entusiasticamente investito nel progetto vedendovi la potenzialità di creare, nel bel mezzo della Depressione, “uno spazio completamente libero da elementi alieni e disarmonici”17 – sostanzialmente un’utopia in cui la ricostruzione di un passato idealizzato intendeva compensare il decadimento del presente. Il modello di Williamsburg divenne la bibbia per i LHM che sarebbero seguiti. A Williamsburg, la ricostruzione si basava sull’arbitraria individuazione di una “data cerniera” (cut-off date) – poiché si era scelto di celebrare la rivoluzione americana, la data stabilita fu il 1790 – in cui il tempo sarebbe stato congelato per creare il già descritto effetto “macchina del tempo”. Ciò significò la distruzione di 720 edifici storici che avevano avuto la sventura di essere costruiti dopo quella data, ma non impedì invece di mantenere numerosi alberi di grossa taglia, inesistenti nel 1790, per rendere più confortevole l’esperienza dei visitatori, specialmente in estate. Vennero restaurati ottantadue edifici e ne vennero ricostruiti trecento, sulla scorta di specifiche informazioni ripescate negli archivi municipali. Tra gli edifici ricostruiti c’era anche il municipio, che anacronisticamente riproduceva il progetto di quello originale seicentesco, ritenuto architettonicamente più gradevole rispetto a quello effettivamente esistente nel 179018. Addirittura la ferrovia venne deviata. E quando il museo aprì, i visitatori venivano accolti da un nuovo genere di guide turistiche, dette interpreti (interpreters), sorte di attori vestiti con i costumi d’epoca, che parlavano un inglese arcaico e specificamente addestrati a coinvolgere gli ospiti in attività ludico-interattive che avrebbero insegnato loro alcune delle peculiarità della vita della prima Repubblica. Il principio guida di Williamsburg era l’idea di J.D. Rockefeller che per raccontare il passato nell’era della comunicazione di massa era necessario ricostruire un contesto autentico, in tre dimensioni, quello che l’industria dei musei di storia vivente oggi definisce “riportare al momento storico” 17 “an opportunity to restore a compete area and free from alien and inharmonious surroundings”, cit. in T. PARRISH, Restoring Shakertown: the struggle to save the historic Shaker village of Pleasant Hill, Lexington, University Press of Kentucky, 2005, p. 29. 18 Ibid., p. 77. 197 (restoring-back) e che di quell’industria è oggi imperativo imprescindibile, legge fondante e pratica che, secondo la nota critica d’arte Ada-Louise Huxtable, è oggi completamente accettata e ritenuta degna degli Stati Uniti: la ricreazione di un luogo “come qualcuno crede che esso fosse – o vorrebbe che fosse stato”, sotto l’egida di una ricerca storica che “se analizzata da vicino, si è spesso dimostrata fallace, o perlomeno opinabile”19. Al centro del concetto di LHM c’è il delicato rapporto tra entertainment, turismo di massa e ricerca documentaria, che molti studiosi vedono fallace dal punto di vista storiografico, come ad esempio Kate Stover: “Although those involved with the development of Colonial Williamsburg considered historic authenticity a major objective, interpretation tended to be nostalgic and incomplete”20. La miscela di elementi storici e scelte interpretative, vecchio e nuovo, costituisce anche secondo Huxtable un problema che in ultima analisi impone una perdita di realtà: “The blend of old and new, real and fake, original and copy, even in the best of these restorations, defies separation and analysis; they are all, in the beginning and the end, an artificial invention that is supposed to tell us, truly, what our art and history were like. But at the same time that they supposedly teach something to those who might otherwise remain innocent of history, they devalue what they teach; the intrinsic qualities of the real are falsified by an experience that is itself the ultimate unreality.”21 Ma rimane un dato di fatto che, negli ultimi decenni, la storia vivente è diventata la versione più frequentata di storia per il grande pubblico in Nord America. Il sito Web di Colonial Williamsburg, il cui indirizzo è – appropriatamente – nientemeno che history.org, capitalizza metonimicamente questa pretesa: “noi siamo la storia”, “noi rappresentiamo la storia americana”. Quando Umberto Eco, in Travels in Hyperreality, sostiene che l’America è un paese “ossessionato dal realismo, nel quale, per essere credibile, una ricostruzione essere assolutamente iconica, perfettamente somigliante, una copia “vera” della realtà rappresentata”22, certamente fornisce un interessante quadro per comprendere ciò che accade nei LHM. Secondo Eco, “l’immaginario americano richiede la cosa vera e per ottenerla deve fabbricare il falso assoluto,” in cui “l’irreale assoluto viene offerto quale vera A. HUXTABLE, The Unreal America, cit. p. 16. K. STOVER, “Is it Real History Yet? An Update on Living History Museums”, Journal of American Culture, 12:2, 1989, p. 13. 21 Ibid., p. 17. 22 U. ECO, Travels in Hyperreality, cit., p. 4. 19 20 198 presenza”23: a Williamsburg quelle “riproduzioni autentiche” fanno sì che ogni elemento sgradevole – tanto materiale (disordine, cattivi odori, mancanza di comfort) quanto ideologico (l’esistenza della schiavitù, i conflitti pubblici e privati, le guerre) – venga rimosso. La “esperienza” storica che ne deriva è una rischiosa confusione tra fantasia e realtà, frutto non tanto di ricerca vigorosa quanto piuttosto di un fenomeno che Huxtable ha definito “memoria selettiva”, una commistione di vecchio e nuovo, reale e fasullo, originale e copia, che si risolve in una creazione artificiale in cui “ le qualità intrinseche del reale vengono falsificate da una esperienza di per sé in fin dei conti irreale”24. Ed è proprio questo elemento di irrealtà che disegna i tratti salienti di una crescente “disneyzzazione” del paesaggio americano. Perché quell’utilizzo selettivo del passato con lo scopo di intrattenere ed evocare memorie di un “altro” romanticizzato fu proprio la trovata cruciale di Walt Disney nel creare il suo primo parco a tema a Los Angeles nel 1955. Imponendo ai suoi visitatori una volontaria sospensione dell’incredulità, Disneyland proponeva di rendere iconica e materiale la fantasia, trasfigurandola in una realtà che utopicamente si contrapponeva al decadimento del mondo esterno (la modernità industrializzata e suburbanizzata). “Reality is here”, la realtà è qui, proclamava Walt Disney nel discorso dell’inaugurazione di Disneyland. E da quel momento, milioni di visitatori ogni anno si riversano nei suoi parchi a tema alla ricerca di quella realtà altra. Lo stesso probabilmente sarebbe avvenuto con Disney’s America, in cui il progetto di ricostruzione storica non sarebbe più stato, come negli altri parchi a tema, mediato dall’immaginario delle favole-trademark della Disney, ma al contrario avrebbe affrontato faccia a faccia il passato della nazione. Il progetto di Disney’s America venne ritirato poco dopo quel trionfale annuncio del 1993, sulla scia di una straordinaria polemica che mischiò raffinate accuse di incompetenza storica con più prosaici interessi immobiliari di potenti gruppi di interesse della Washington che conta25. Ma anche se Disney’s America rimane da costruire, irrisolto resta il modo in cui l’America affronta la narrazione del proprio passato e le “autentiche riproduzioni”26 di cui si nutrono i visitatori dei LHM ne costituiscono una problematica, inquietante testimonianza. Ivi. A. HUXTABLE, The Unreal America, cit., p. 17. 25 Vd. “Step Up, Folks! Check It Out! Nationhood!”, cit. e C. W. Bailey, “How Washington insiders ambushed Mickey Mouse”, cit. 26 Vd. A. HUXTABLE, The Unreal America, cit., p. 25 23 24 199 200 ERDACHTE NÄHE UND WIRKLICHE FERNE. FIKTION UND DOKUMENT IM NEUEN DEUTSCHEN FAMILIENROMAN. Gerhard Friedrich Der neue deutsche Familienroman, verstanden als Genrebezeichnung für die zahlreichen im letzten Jahrzehnt in Deutschland geschriebenen Familien-und Generationenromane, Familiengeschichten und in Familiengeschichte integrierte Autobiographien nimmt als literarisches Genre teil am Prozess eines umfassenden Perspektivwechsels auf die deutsche Vergangenheit von Nationalsozialismus und Weltkrieg, der vor allem gekennzeichnet ist durch die Aufmerksamkeit, die nun der Veröffentlichung persönlicher und privater Erinnerung an diese Zeit gewidmet wird. Harald Welzer äußerte dazu, Ich vermute, daß diese Publikationen (Familienromane, autobiographische Texte und Dokumentationen, G.F.) gerade deshalb so auflagenstark sind, weil sie der gefühlten Geschichte der Bundesbürger viel näher stehen als die autoritative Erzählung über die Vernichtung der europäischen Juden und die anderen Verbrechen des „Dritten Reiches“1. Welzer benutzt den in sich spannungsreichen Begriff der „gefühlten Geschichte“, der er eine andere, „autoritative Erzählung“ gegenüberstellt. „Gefühlte Geschichte“ und Geschichtswissen gehören wohl generell und überall unterschiedlichen Wahrnehmungsregistern an. Dass sie allerdings in Gestalt der sich einander ausschließenden Täter-Opfer Perspektiven in ein antagonistisches Verhältnis treten können und Geschichtswissen die Form einer das Gefühlte disziplinierenden „autoritativen Erzählung“ annehmen kann, ist eher ein spezifisches Problem der jüngsten deutschen Geschichte. 1 H.WELZER, Schön unscharf. Über die Konjunktur der Familien- und Generationenromane, in Literatur. Beilage zu Mittelweg 36, Hamburger Institut für Sozialforschung, Nr.1 Januar/Februar 2004, p. 53. Beilage zum Mitte 201 Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach der Authentizität der Subjekte und ihrer Gefühle im Familienroman rasch zu einer auch geschichtspolitischen Frage. Denn wo sie nicht gewährleistet ist, kann schnell der Verdacht auf manipulative Absichten im Sinne einer Modifikation der „autoritativen Erzählung“ von der Gefühlsfront her aufkommen. Aber auch im Falle authentischer Subjektivität gibt diese noch keine Garantie für die Wahrhaftigkeit des Erinnerten, denn – wie die Gedächtnisund Erinnerungsforschung vielfach nachgewiesen hat – das Erinnerte wird häufig unbewusst organisiert nach den sich aus der Gegenwart ergebenden Anforderungen und Bedürfnissen. Von daher ist die authentische Subjektivität autobiographischer Erinnerung in keinem Fall als Wahrheitskriterium im Sinne geschichtlicher Wahrheit zu verstehen. Sie ist ein Tatbestand und ihr wesentlicher Unterschied zur „erfundenen“ Subjektivität ist der, dass ihre eventuelle „Falschheit“ nicht bewusst ist. Sie wäre im umgangssprachlichen Sinne „naiv“, während „erdachte Subjektivität“ als solche konstruiert ist nach Zeitgeist, Moden, Theoremen, politisch-ideologischen Absichten, Erzählmustern, narrativen Techniken – ihrer Konstruiertheit wegen jedoch nicht „falsch“ sein muss. Im Folgenden soll versucht werden, Funktion und Beschaffenheit des subjektiven Moments als Autorenintention und Organisationsprinzip der Texte in seinem Verhältnis zum historischen Dokument in zwei – gemeinhin dem Genre Familienroman zugerechneten – Texten zu analysieren. Es handelt sich um Uwe Timm, Am Beispiel meines Bruders und Ulla Hahn, Unscharfe Bilder. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchungen soll sofort vorweggenommen werden: in beiden Texten erweist sich die individuelle Perspektive und Schreibintention des jeweiligen Autors als dominant gegenüber dem verarbeiteten historischen Material, gegenüber den eventuell integrierten Dokumenten, wobei sich eine relative Autonomie des Dokuments noch am ehesten in Timms autobiographischem Text finden lässt. Uwe Timm, Am Beispiel meines Bruders Uwe Timm schreibt die Recherche zu seinem freiwillig der SS beigetretenen und 1943 an der Ostfront gefallenen Bruder Karl Heinz fast sechzig Jahre nach Kriegsende. Er lässt sie beginnen mit der einzigen ihm verbliebenen frühkindlichen Erinnerung an diesen Bruder. Er wird von den Eltern in die Küche geführt und aufgefordert sich umzuschauen: 202 Dort, das hat sich mir als Bild genau eingeprägt, über dem Schrank, sind Haare zu sehen, blonde Haare. Dahinter hat sich jemand versteckt – und dann kommt er hervor, der Bruder, und hebt mich hoch2. Mehr als ein Jahrzehnt vorher taucht die gleiche Erinnerung in Timms autobiographischen Text über seinen Romaufenthalt, Vogel friss die Feige nicht, auf. Träumte von meinem Bruder, der – meine einzige Erinnerung an ihn – sich hinter einem Besenschrank versteckt hält. Er will mich, seinen kleinen Bruder, überraschen. Aber ich sehe seinen Kopf, sein blondes Haar3. Der Nachweis dieser Erinnerung in einem anderen Text Timms lange vor dem Projekt vertiefter Nachforschungen zum Bruder muss zunächst als Indiz ihrer Authentizität wie auch ihrer Intensität gelten. Der Bruder tritt nicht erst nach dem Jahr 2000, als die veröffentlichte Erinnerung deutscher Kriegsopfer literarische Mode wurde, in das von Timm erinnerte Leben ein. Allerdings wird ihr im späteren Text eine Bedeutung beigemessen, die dem früheren nicht abzulesen ist. Erhoben werden – Lachen, Jubel, eine unbändige Freude – diese Empfindung begleitet die Erinnerung an ein Erlebnis, ein Bild, das erste, das sich mir eingeprägt hat, und mit ihm beginnt für mich das Wissen von mir selbst, das Gedächtnis (…)4 Es folgt die Erinnerung vom Bruder hinter dem Besenschrank. Mit dieser einzigen frühkindlichen Erinnerung an den Bruder lässt Timm sein Selbstbewusstsein, seine Ich-Identität beginnen. Bruder-Erinnerung und Ich-Identität erscheinen untrennbar miteinander verknüpft. Und ein weiteres bedeutendes Detail gegenüber dem früheren Text: der Bruder geht auf ihn zu und es kommt zum Körperkontakt. (…) – und dann kommt er hervor, der Bruder, und hebt mich hoch. (…) und dann dieses Gefühl, ich werde hochgehoben – ich schwebe5. U. TIMM, Am Beispiel meines Bruders, Köln, Kiepenheuer&Witsch, 2003, p. 9 U. TIMM, Vogel friss die Feige nicht, Köln, Kiepenheuer&Witsch, 1989, p. 17 4 Ivi., p. 9 5 Ibid. 2 3 203 Hier steigert Timm die gefühlte Nähe des Bruders zum Entgrenzungserlebnis – „ich schwebe“. Die Konstitution von Ich-Identität und deren ekstatische Verflüssigung in dem einen Moment des einzigen erinnerten Körperkontaktes mit dem Bruder – authentische frühkindliche Erinnerung erfährt eine so große psychodynamische Aufladung, dass ihre Konstruiertheit wahrscheinlich wird, zumal als Eröffnungstableau des Textes. So wird, sozusagen als Initialzündung, die psychische Energie freigesetzt, die den Gang der folgenden Ermittlungen und Reflexionen Timms vorantreibt, ihnen ihren erlebten und emotional involvierenden Charakter verleiht. Der eingangs freigesetzte psychoenergetische Schub kann den Schreibprozess allerdings nicht widerstandslos vorantreiben. Im Gegenteil. Der Text entwickelt sich kontrapunktisch. Timm äußerte dazu in einem persönlichen Gespräch, er habe ihn nach dem Prinzip der musikalischen Fuge strukturiert. Die Kontrapunkte zum erinnerten Erlebnis des Eins-Seins mit dem Bruder sind seine Träume. Hin und wieder träumte ich vom Bruder. (…) Ein Traum hat sich mir recht genau eingeprägt. Jemand will in die Wohnung eindringen. Eine Gestalt steht draußen, dunkel, verdreckt, verschlammt. Ich will die Tür zudrücken. Die Gestalt, die kein Gesicht hat versucht sich hereinzuzwängen. Mit aller Kraft stemme ich mich gegen die Tür, dränge diesen gesichtslosen Mann, von dem ich aber bestimmt weiß, dass es der Bruder ist, zurück. Endlich kann ich die Tür ins Schloss drücken und verriegeln. Halte aber zu meinem Entsetzen eine raue, zerfetzte Jacke in den Händen6. Der Bruder, Teil der Ich-Identität des Autors, wird als gesichtslose Bedrohung nach außen abgedrängt. Die ihm als Existenzbeweis des Bruders zurückbleibende „raue zerfetzte Jacke“ verweist auf dessen Herkunft aus einer gefährlichen, unheimlichen Gegenwelt – eine Dimension, die auch eine Seite vorher aufgerufen wird im Märchen von Blaubart mit seiner verschlossenen Tür, hinter der ein Strom von Blut wartet. Was aber führt Timm zur Abwehr, Abspaltung dieses Teils seines Selbst, das von seinem Bruder besetzt ist, als grauenvolle Bedrohung? Zunächst scheint Timm hier das Modell der traumatischen Erfahrung und ihrer Verarbeitungsform der Abspaltung, Ausgrenzung der vom Ich nicht beherrschbaren existenziellen Bedrohung oder Verletzung – hier der Verlust des Bruders – abzurufen. Die Vermutung wird bestätigt durch eine später beschriebene, mit dem Verlust des Bruders verbundene und dem Modell der Verletzung 6 Ivi, S. 12 204 durch Traumata folgende flash back Erfahrung. Darauf wird im Folgenden noch eingegangen. Außerdem wissen wir, dass in einem Großteil der um Kriegserinnerungen kreisenden Familienromane und autobiographischen Texte der Rekurs auf das Modell der traumatischen Erfahrung und deren spezifischer Verdrängungsweise, wie auch deren Übertragung auf nachfolgende Generationen nachzuweisen ist. Eine genauere Lektüre allerdings zeigt, dass der Autor einerseits vom Verlusttrauma affiziert ist, es andererseits aber – nicht in seinen Träumen, sondern in der Wirklichkeit – letztlich sein Geschichtswissen ist, das zur Abwehr des Bruders führt. Auf der Bewusstseinsebene ist es Timms Wissen um die Kriegsverbrechen der Wehrmacht an der Ostfront und generell sein Wissen um den verbrecherischen Charakter des Nazi-Regimes, das ihn die Wirkung der traumatischen Beschädigung seiner Ich-Identität als moralische Entscheidung wahrnehmen und die Anonymisierung des Bruders akzeptieren lässt. Die scheinbare Identität von tiefenpsychologischer Verletzung und moralischer Stellungnahme löst sich auf und es eröffnet sich ein neuer Zugang zum Bruder, als Timm in ihm ein abgespaltenes Moment seiner IchIdentität erkennt – ohne sein moralisch-politisches Urteil zu modifizieren. Den unheimlichen Eindringling als abgespaltenen Teil seines Selbst akzeptierend, ist er dazu in der Lage sich in selbstanalytischer Absicht auf den Bruder einzulassen und gleichzeitig dessen moralische Verurteilung, als von der Abwehr des Traumas getrennter Schicht, einer erneuten Überprüfung zu unterziehen. Beim Lesen des Kriegstagebuchs des Bruders stößt Timm auf Folgende Stelle: „(…) Brückenkopf über den Donez. 75 m raucht Iwan Zigaretten, ein Fressen für mein MG“ 7. Der Autor kommentiert: Das war die Stelle, bei der ich, stieß ich früher darauf (…) nicht weiterlas, sondern das Heft wegschloss. Und erst mit dem Entschluss, über den Bruder, also auch über mich,(Herv., G.F.) zu schreiben, das Erinnern zuzulassen, war ich befreit, dem dort Festgeschriebenen nachzugehen8. Die moralische und kulturelle Distanzierung vom Bruder, die das „Fressen für mein MG“ auslöst, bleibt auf dieser Ebene bestehen, doch sie 7 8 Ivi, S. 19 Ibid. 205 wird überprüfbar, wird einem kritischen Verfahren zugänglich und muß nicht mehr zwanghaft geschehen, nachdem der traumatisch abgespaltene Bruder als Teil der eigenen Ich-Identität akzeptiert wurde. Der moralische Schock wird vom Trauma dissoziiert und kann so über den Gestus der Abwehr hinaus zugleich in intimen Annäherungsversuch und in einen kultur-ideologie- und mentalitätskritischen Diskurs überführt werden, der die ganze Familie und vor allem den Vater mit einbezieht. Matteo Galli hat dazu bemerkt: Selten wird jedoch auf eine so offene, brutale und insistierende Weise (…) das kommunikative und soziale Gedächtnis der Vätergeneration geschildert9. Die beiden Ebenen bleiben für den ganzen Text miteinander verschränkt und ihre Verschränktheit reflektiert sich direkt im gleichzeitig Nähe und Distanz, Intimität und Verallgemeinerung ausdrückenden Titel: Am Beispiel meines Bruders. In der minutiösen Analyse seines Tagebuchs wird der Bruder einerseits zum statuierten Exempel der Kritik der Traditionen preußischen Kadavergehorsams und eines über den Vater von den Freicorps herkommenden rechtskonservativen Nationalismus, der Moral und Humanität nur als Bewertungskriterien fremder – aber niemals der eigenen Gewaltanwendung kennt. Der Bruder erscheint als Repräsentant einer spezifischen Prägung, als Individuum wird er kaum greifbar und seine Notizen ermöglichen nicht die Rekonstruktion authentischen Erlebens eines deutschen Soldaten an der Ostfront – dessen gefühlte Subjektinnenseite. Stattdessen bekannte Stereotype. Bestimmend bleibt die kritische Perspektive eines heute Schreibenden auf deutsche Weltkriegsvergangenheit, die Bindung zum Bruder kann keine verstehende Empathie erzeugen. Helmut Schmitz äußerte zusammenfassend: Throughout his narrative, Timm thematises the act of memory and the ‘Gefahr, glättend zu erzählen’. His narrative reflects on itself as a selfconscious public act of creating meaning through narration. As an a 9 M. GALLI, Vom Denkmal zum Mahnmal: Kommunikatives Gedächtnis bei Uwe Timm, in AA.VV. „(Un)erfüllte Wirklichkeit“. Neue Studien zu Uwe Timms Werk, a cura di F. FINLEY e I. CORNILS, Würzburg, Königshausen&Neumann, 2006, p. 169. 206 posteriori explanation it documents the essential unavailability of a ‘naïve’ perspective together with the necessity to narrate10. Andererseits aber hören die Träume vom Bruder nicht auf. Es sind Träume von wiederholten und letztlich immer scheiternden Annäherungsversuchen, von nicht gelingender Kommunikation. Der Bruder steht da, das Gesicht schwarz, der Anzug – oder eine Uniform? – hell. (…) Plötzlich wirft er mir eine Birne zu, die ich nicht fangen kann. Mein Schreck, als sie zu Boden fällt. Und dann sagt seine Stimme: Doldenhilfe11. „Doldenhilfe“ ist nach einer schriftlichen Mitteilung des Autors ein „Traumwort“ von unbestimmter Bedeutung. Verständigung kann nicht stattfinden, aber das unerfüllbare Bedürfnis nach ihr – materialisiert im Paradoxon des bedeutungslosen Wortes – ist stark, denn es geht Timm dabei um nichts weniger, als die Integrität der eigenen Persönlichkeit. Gefühlte Nähe ergibt sich nicht aus der akribischen Recherche in Dokumenten aus dem Leben des Bruders – in ihr wird der Bruder vor allem zum Beispiel einer kritisierten Mentalität. Gefühlte Nähe teilt Timm aber mit als Trauma des Bruderverlustes indem er uns seine Träume zugänglich macht. Auf dieser Ebene geht es allerdings um das Leiden an der Verletzung der Integrität seines heutigen Ichs – nicht um das Leiden des Anderen in der Vergangenheit. Diese Trennung ist die erste Voraussetzung zur Überwindung des Traumas. Hier geht es nicht um Partizipation oder Empathie, nicht einmal um Erinnerung. Timm leidet als unmittelbar Betroffener an seiner seelischen Verletzung in seiner Gegenwart. Er berichtet von einem Erlebnis in einem Kiewer Hotel: Am Tag meiner Ankunft, es war zufällig die Zeit, in der der Bruder verwundet worden war, wurde ich morgens im Hotel durch Telefonschrillen geweckt. Ein Traum, ein dunkler, ein im plötzlichen Erwachen nur noch undeutlicher Traum, in dem er auch schattenhaft vorgekommen war. Im Schreckzustand versuchte ich aufzustehen,. Ich konnte nicht. In beiden Beinen war ein unerträglicher Schmerz. (…) In der Kaffeepause ging ich zur Toilette. Ich blickte in den Spiegel und sah ei10 H. SCHMITZ, Historicism, Sentimentality and the Problem of Empathy: Uwe Timm’s Am Beispiel meines Bruders in the Context of recent Representations of German Suffering, in ID, A Nation of Victims? German Monitor No. 67, Amsterdam-New York 2007, p. 215. 11 U. TIMM, Am Beispiel, cit., p. 141. 207 nen anderen. Das Gesicht bleich, fast weiß, die Augenhöhlen tief verschattet, violett, wie die eines Sterbenden12. Diese Schmerzen, die aus der Vergangenheit kommen, aber heute erlitten werden, ihre das Trauma charakterisierende Zeitlosigkeit, die Vergangenheit als ewige Gegenwart erscheinen lässt, sind durch kein empathisches Verhalten gegenüber wirklich vergangenem Leid zu lindern, denn als solche gehören sie nur der Gegenwart an. Ihre Empfindung ist authentisch und das sie mitteilende Subjekt ist „naiv“ bei sich – oder hat Timm sich eingehend mit der neueren Traumaforschung befasst und einige von deren Ergebnissen und Theoremen – z.B. Lyotards Definition vom Trauma „als ein(em) Zustand des Todes inmitten des Lebens“13 erzählerisch assimiliert? Hier – wie in allen Träumen – wäre ein schmaler Raum für eine fiktionale Ausarbeitung seines Stoffes zu lokalisieren. Unabhängig von der Beantwortung dieser Frage – die nur spekulativ sein kann – besteht die wahre Besonderheit im Buch Timms nach meiner Auffassung in der klaren Trennung in den am Bruder und an der Familiengeschichte entwickelten geschichtlichen ideologie- und kulturkritischen Diskurs auf der einen und den ihn selbst betreffenden therapeutischanalytischen Diskurs auf der anderen Seite. Er trennt rigoros sein seelisches Leid vom Problem Deutschlands mit seiner Geschichte. Die eingangs zitierte „gefühlte Geschichte“ kommt in Timms Recherche nur vor als Gegenstand kritischer Analyse. Dass sein seelisches Leid ursächlich mit deutscher Geschichte verknüpft ist führt nicht zur Vermengung der in betracht gezogenen Heilungsverfahren. Einerseits das selbstanalytische Eingehen auf das Bedürfnis nach Reintegration des an den Bruder gebundenen und traumatisch abgespaltenen Teil seines Ichs, andererseits die entschiedene, anonymisierende Distanzierung vom Bruder als Beispiel einer verbrecherisch gescheiterten politischen Unkultur und individuellen Mentalität. Im Grunde plädiert Timm, selbst diszipliniert, für die Trennung der Disziplinen. Die große Synthese als fiktionaler Zugriff auf das Thema bleibt aus. Vielleicht wird von daher erklärbar, dass das auch hochpersönliche Buch Timms in der Spiegel-Bestsellerliste in der Rubrik „Sachbücher“ geführt wurde. 12 13 Ivi, p. 125 f. J.-F. LYOTARD, Heidegger und ‚Die Juden’, Wien, Edition Passagen, 1988, p. 38. 208 Ulla Hahn, Unscharfe Bilder Die „Bilder“ im Titel des Romans von Ulla Hahn sind Bilder von Menschen, die mit mehr oder weniger Sicherheit die Identifikation von Individuen gestatten. Unschärfe ergibt sich – im physikalisch-optischen Sinne – aus großer Nähe, Schärfe aus der adäquaten Distanz. In dem als Motto vorangestellten Zitat von Ludwig Wittgenstein fragt sich dieser: „Ist das unscharfe nicht oft gerade das, was wir brauchen?“ Wittgensteins metaphorisches Plädoyer für die „Unschärfe“ von Bildern in seinen Philosophischen Untersuchungen steht im Kontext seiner Kritik einer formalistischstatischen Regelkonzeption in der Sprachwissenschaft. Er geht dagegen aus vom Standpunkt der Pragmatik, der Sprache als dynamisch-lebendiges System begreift. Die relative Unschärfe von Regeln – und um diese geht es ihm – wäre Ausdruck der Anerkennung des dynamischen Charakters von Sprache seitens des sie beschreibenden Wissenschaftlers. Hier ist „Schärfe“ bildhafter Ausdruck der Schwäche von vorgefassten Konzepten gegenüber einer „Unschärfe“, die eine Perspektive der Nähe und Unmittelbarkeit auf den lebendigen Sprachorganismus gestattet. Eine derart gefasste Unschärfe kann in der Sprachwissenschaft tatsächlich – nur scheinbar paradoxerweise – Erkenntnisgewinn bedeuten. Ulla Hahn allerdings geht es nicht – wie Wittgenstein – um Sprache, sondern um die deutsche Wehrmacht und deren Soldaten an der Ostfront. Was gewinnt sie aus der Nähe und Unmittelbarkeit bedeutenden „Unschärfe“, aus der Schwäche von Vorkonzepten – diachronisch gesprochen aus der Abwertung der „a posteriori“- Perspektive – für ihr Thema? Im Kern geht es Hahn in ihrem Roman um die Diskussion und letztlich Diskreditierung des Werts von Bildern als Dokumenten einer präzisen und individualisierenden Rekonstruktion von Vergangenheit. Sie diskutiert dabei die komplexen Relationen von Geschichtswissen und einfühlendem Miterleben von Vergangenheit, von dokumentierter und erlebter Geschichte, von Außen- und von Innenansicht. Der Roman ist insgesamt fiktionalen Charakters. Er enthält keine erkennbaren autobiographischen Elemente noch integriert er Dokumente zur Rekonstruktion von Vergangenheit. Im Gegenteil. Das Bild als Dokument nimmt einen zentralen Platz ein in ihrem Diskurs – aber es geht um dessen Desintegration, um die Anzweiflung von dessen Aussagewert. An die Stelle der vom Bild gelieferten Außenansicht setzt sie die Emotionen mobilisierende Erzählung, die Einfühlung und Innenansicht vergangener Ereignisse und Erfahrungen etabliert und dabei den Schein der Authentizität des erlebten Dabeigewesen-Seins erzeugt. Die anfangs skepti209 sche Tochter Katja des ehemaligen Wehrmachtssoldaten an der Ostfront und jetzigen pensionierten und altersweisen Studienrats Musbach reflektiert nach den ersten Kriegserzählungen des Vaters: Sie hatte geglaubt zu wissen, Vergangenes zu wissen. Nun wurde aus dem Vergangenen, dem Vorbeisein ein Mit-Dabeisein14. Helmut Schmitz kommentiert dieses Zitat in seinem schon erwähnten Aufsatz: In the course of Hahn’s novel, for example, the daughter ultimately ends up sharing in the father’s trauma, relinquishing her post-war perspective15. Das „Wissen“ ist der vermittelten Außenansicht und damit auch eher dem Bild zugeordnet, als dem unmittelbar gefühlten, erzähl- aber nicht direkt abbildbaren Miterleben. Der Erzählbarkeit in diesem Sinne wird von Hahn ein prinzipiell höherer Aussagewert zugemessen als der Abbildbarkeit. Nun stellt sich allerdings die Frage, ob die beiden Darstellungsweisen notwendigerweise als einander ausschließend zu behandeln sind und warum Hahn dahin tendiert dies zu tun. Ihr Text will letztlich das Verschwinden des Bildes in der Erzählung erzeugen, alles auf subjektive Authentizität setzen, die ganz ohne Außenansicht auskommt. Auf der letzten Seite kommt es als Klimax des ganzen Romans zum Geständnis des Vaters gegen das schon vorher narrativ diskreditierte Bild seines Kriegsverbrechens und gegen die aus dieser Diskreditierung entstandene Unschuldsvermutung der Tochter. Die Nichtigkeit des Bildes angesichts der väterlichen Erzählung wird gerade durch sein Geständnis demonstriert. ‚Aber’, stammelte Katja, ‚du bist nicht der Mann auf dem Foto! Du kannst es gar nicht sein. Du bist es nicht gewesen! Das Foto ist von dreiundvierzig. Winter. Da warst du doch schon bei den Partisanen! Du warst es nicht. Du hast nicht geschossen!’ ‚Doch! Ich hätte nein sagen können, hörst du: nein! Ich habe geschossen. Das Foto ist von dreiundvierzig im Winter? Was tut das zur Sache? Ich bin es nicht auf diesem Foto? Spielt das denn eine Rolle? Ich weiß doch, was war. Dieses Foto oder nicht. Ein Foto oder keins. Verzeih mir – wenn du kannst’16. U. HAHN, Unscharfe Bilder, München, DVA, 2003, p. 121 H. SCHMITZ,Historicism, cit., p. 209 16 U. HAHN, Unscharfe, cit., p. 275 14 15 210 Der Frage „Ein Foto oder keins“ kommt keine Bedeutung zu vor der gefühlten Authentizität der erzählten Erinnerung. Da ist schon besser: keins Hahns Zweifel am Bild ist aber weniger erkenntniskritischer Natur, sondern speist sich vor allem aus einem aktuellen Anlass, auf den sie im Roman selbst hinweist. Es handelt sich um die 1995 vom Hamburger Institut für Sozialforschung präsentierte Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944“. Im Roman erscheint sie unter dem Namen „Verbrechen im Osten“. Die historische erste Ausstellung (sie wurde nach vier Jahren wegen einiger unkorrekter Bildunterschriften eingezogen und 2001 durch eine modifizierte Fassung ersetzt) bestand zum Großteil aus von Wehrmachtssoldaten angefertigten Privatfotos, die in fast naiver Unverstelltheit Gräueltaten „einfacher“ deutscher Soldaten dokumentierten. Ein großer Teil dieser Fotos stammte aus Archivbeständen osteuropäischer Staaten. Diese Ausstellung hat heftige Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit hervorgerufen – sowohl Zustimmung wie auch höchst emotionale Abwehr – und Hahns Buch ist außerhalb dieser aktuellen Kontroverse kaum zu verstehen. Um ihren Schreibanlass der Diskreditierung des Bildes aus diesem Kontext genauer zu verstehen, ist kurz zu überlegen, welche spezifische Funktion das private Foto im gegebenen erinnerungspolitischen Zusammenhang haben konnte. Vor allem: es wirkte entmystifizierend. Die Mitscherlichs haben schon in den 60-er Jahren darauf hingewiesen17, wie in Deutschland durch die Abspaltung einer anonymen und mystifizierten Entität mit dem Namen „Nazis“, der „anständige Deutsche“ sich von Verantwortung frei fühlen konnte. Die Formel von den „Untaten im Namen des deutschen Volkes“ ist beredter Ausdruck dieser Mystifikation. Die Veröffentlichung gerade von Privatfotos, die zeigen, wie „normale“ Individuen diese „Untaten“ verrichten, bringt Großgeschichtserzählung und individuelle Aktion zur Deckung und hebt die Mystifikation auf. Von Bedeutung ist dabei gerade die Schärfe dieser Bilder, denn nur sie gestattet die zweifelsfreie Identifikation der Individuen, und gerade Individualisierung ist die Voraussetzung für die Aufhebung der anonymisierenden Abspaltung des „Bösen“. Hierin bestand die Sprengkraft der Wehrmachtsausstellung wie auch die der im gleichen Zeitraum erschienenen Arbeiten von Goldhagen und Browning.18 A. und M. MITSCHERLICH, Die Unfähigkeit zu trauern, München, Piper Verlag, 1967 Ch. R. BROWNING, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die ‚Endlösung’ in Polen, Hamburg, Rowohlt, 1993; D. J. GOLDHAGEN, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin, Siedler Verlag, 1996 17 18 211 Klaus Theweleit hat in seiner Beobachtung zu den Fotos der Ausstellung beschrieben, wie „das Böse“ von den Individuen Besitz ergreifen konnte: als seine nicht-Wahrnehmung, als schon damaliges Unschuldsbewusstsein, entstanden aus Übereinstimmung mit der herrschenden politischen Unkultur, die zivilisatorische moralisch-ethische Normen suspendiert hatte und Straffreiheit garantierte. Der Mord wird nicht als ‚Mord’ wahrgenommen, weil er genehmigt ist, er kann als Urlaubsfoto nach Hause gehen oder neben die Familienbilder ins Portemonnaie geraten, weil er das eigene Leben im Zustand krimineller paradiesischer Freiheit zeigt, das sich dabei gefällt, die Erde von Ungeziefer zu befreien. ‚Strafe?’ Keine zu erwarten. Wir werden gesiegt haben. Dieses Bewusstsein, diesen Blick zeigen die Fotos der fotografierenden Soldaten in Russland, in Polen oder auf dem Balkan in aller Klarheit; in aller unschuldigen Klarheit19. Wie diese gefühlte „Unschuld“ sich in der Erinnerung erhält, indem sie nach 1945 nach den Normen des nun geltenden ethisch-moralischen Kodexes umgerahmt wird, wie im narrativen Prozess der Familienerinnerung nach den nun geltenden Normen aus getöteten „gerettete“ Kinder werden können, haben Harald Welzer u.a. in ihrer Studie Opa war kein Nazi20 gezeigt. Voraussetzung für das Gelingen dieser Operation der Umrahmung von Erinnerungsfragmenten ist allerdings das Fehlen der wirklichen Bilder. Diese passen in keinen andern Rahmen. „Unscharfe Bilder“ allerdings passen in viele. Was bei Hahn als Erzählung der einfühlend Bemühung der Tochter um die Rekonstruktion der subjektiven Verfassung des Vaters an der Ostfront erscheint – die Vaterbindung ist bedeutend um glaubwürdig Affekt mobilisieren zu können – erweist sich als Projektion gegenwärtiger ethisch-moralischer Subjektkonstitution in die Kriegsvergangenheit und als Modifikation des Verhaltens des Vaters nach deren Maßgaben. Dabei bewegt sie sich auf der Schiene der oben erwähnten Kontinuität gefühlter Unschuld sozusagen in der Gegenrichtung ihrer Genese. Das Gelingen dieser Operation setzt freilich die Anzweiflung der Beweiskraft präziser Bilder voraus. Wie heißt es am Ende des Romans?: „Ich bin es nicht auf diesem Foto? Spielt das denn eine Rolle? (…) Ein Foto oder keins.“ Die extreme Unvereinbarkeit dieser Art fiktionaler Prosa mit der Integration von authentischen Bildern und, generell gesprochen, von dokumentariK. THEWELEIT, Schulddiskussion und Wehrmachtsausstellung, Badische Zeitung, 11. 11. 2000 H. WELZER, S. MOLLER, K. TSCHUGNALL, Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002 19 20 212 schem Material, reflektiert den Entstehungszusammenhang des Romans in der Kontroverse um die Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“, in der er – auf selten explizite Weise – die Einfühlung produzierende Macht der Fiktion gegen die Glaubwürdigkeit von Dokumenten mobilisiert. Während Ulla Hahn das historische Dokument gegenüber der fiktional erzeugten subjektiv-empathischen Annäherung an Vergangenheit gezielt entwertet, bietet bei Uwe Timm das fiktionale Moment keinen Interpretationsschlüssel der Vergangenheit oder des Verhältnisses zu ihr. Wo es eventuell zu lokalisieren ist – vor allem in den Traumsequenzen – überschreitet es nicht den Raum seiner äußerst zurückgenommenen Subjektivität. Vergangenheit wird über Dokumente, autobiographische Erinnerung und – vor allem – deren kritische Reflexion erschlossen. Die bei Timm gefühlte Ferne zur Vergangenheit setzt diese zweifellos in ein produktiveres Verhältnis zur Gegenwart, als fiktional erzeugte emphatische Nähe bei Ulla Hahn, die aus der Vergangenheit nur den persönlichen Affekt rettet. 213 DALLA CASA ALL’HOTEL. RIFLESSIONI SULLO SPAZIO ABITATO IN JOSEPH ROTH E FRANZ KAFKA Silvia Ulrich Prima che la globalizzazione li mutasse in catene anonime e indistinte, gli alberghi sono stati ben più che semplici luoghi di pernottamento. Molti di essi appaiono oggi come monumenti di epoche ormai remote, di cui testimoniano ancora austeri edifici riportati agli antichi splendori; un esempio è l’Hotel Adlon di Berlino, fondato nel 1907, distrutto dai bombardamenti e reinaugurato nel 1997. Luoghi di memoria storica dunque, dove era di casa l’Europa; ma anche indici di una tradizione culturale sotto la cui egida il costume e l’arte si sono più volte stretti la mano. Esiste una certa affinità tra l’hotel – che assicura al contempo solitudine e vita sociale – e il mestiere di scrivere. Joseph Roth, che non ebbe mai una vera e propria casa, trascorse la maggior parte della sua vita in molti, talvolta anche modesti alberghi, come l’Hotel Foyot o l’Hotel de Tournon a Parigi. Ma l’esperienza dell’hotel sta in stretta relazione anche con la Weltanschauung di Franz Kafka, come si evince in particolare dai diari1. Più in generale, gli scrittori che solevano soggiornare in albergo l’hanno inteso come luogo d’elezione per chi, prigioniero del proprio solipsismo, anela alla socialità; un paradosso che la letteratura, in particolare nel Novecento, ha elevato a testimonianza imperitura, lasciando ampio spazio a riflessioni di natura storico-culturale e filosofico-sociologica. Grand Hotel Libertà Nella letteratura del primo Novecento l’albergo assume un valore alternativo rispetto alla ‘casa’: è un luogo ontologicamente disabitato o, per dirla con Marc Augé, un “non-luogo”2. In quanto approdo sicuro per un ver1 2 Cfr. in particolare l’annotazione del 28.2.1913. M AUGÉ, Nonluohi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1996, in part. p. 74sgg. 214 so e tuttavia sufficientemente indeterminato per l’altro, esso consente a chi vi si insedia di abbandonarlo in qualunque momento. Rappresenta perciò l’irruzione del provvisorio e del mutevole nello stile di vita di chi vi alloggia. Letterati e intellettuali, in particolare, ne hanno fornito con la propria esperienza un diagramma letterario ampio e articolato. Negli anni Quaranta, in alcune riflessioni sull’interieur borghese, Walter Benjamin afferma che “il XIX secolo è stato come nessun altro legato alla casa”, sottolineando parallelamente la risolutezza con cui il Novecento “la fa finita con l’abitare nel vecchio senso della parola”3. Lo spazio abitato è dunque destinato a evolversi: Benjamin lo vede restringersi entro le camere d’albergo, Adorno mette addirittura in discussione la nozione stessa dell’abitare (“ ‘Abitare’ non è più praticamente possibile”)4. Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, tuttavia, l’idea che alla casa si sostituisse l’albergo ha suscitato in genere maggiore ottimismo.“Oggidì la maggior parte della gente abita in hotel – scriveva negli anni Venti il feuilletonista franco-tedesco Victor Auburtin (1870-1928) – ed è bello stare in hotel, perché è un’altra cosa, non è come a casa”5. In questa formula trova riscontro la tanto diffusa “Hotel Culture”6 che ha caratterizzato Germania e Austria nel primo Novecento. L’hotel cela infatti la promessa di uno spazio ‘altro’ che solo per il suo essere diverso dal domicilio abituale accende un interesse avvertito dai più come irresistibile. In albergo ci si può sentire a casa e al contempo lontani da casa: il calore domestico, venuto meno abbandonando la dimora, viene riprodotto artificialmente negli spazi dell’hotel e si coniuga al fascino seducente del nuovo, privo tuttavia del peso della responsabilità che la ‘casa’ tradizionalmente possiede: “Così come altri uomini ritornano a casa, al focolare, da moglie e figli, io ritorno alla luce, alla hall, dalla cameriera ai piani e dal portiere”7. Così Joseph Roth descrive il proprio singolare rapporto con l’istituzione ‘hotel’, cui dedica una serie di scritti raccolti sotto il titolo di Panoptikum. Celebrato come summa della libertà individuale, l’albergo rappresenta il rifiuto della tradizione borghese che aveva fatto della casa un ‘altare sacrificale’ connesso al matrimonio e a una concezione dell’esistenza sedentaria e monotona. L’editore Gustav Kiepenheuer avrebbe ricordato lo scrittore galiziano, sistemato per breve tempo in un appartamento in affitto, “andare su e giù, W. BENIAMIN, I "Passages" di Parigi, Torino, Einaudi, 2002, p. 290sg. [tr. it. di E. Ganni] T. W. ADORNO, Minima Moralia, Torino, Einaudi, 19792, § 18, p. 34. [tr. it. R. Solmi] 5 V. AUBURTIN, Erlebt etwas!, in ID., Einer bläst die Hirtenflöte, Berlin, v. Hugo, 1940, p. 171. 6 Cfr. B. MATTHIAS, The hotel as setting in early twentieth-century in German and Austrian Literature: checking into tell a story, New York, Camden House, 2006, in part. pp. 27-52. 7 J. ROTH, Panoptikum, in ID., Werke, Amsterdam, Kiepenheuer & Witsch, 1976, vol. 3, p. 566. Ove non diversamente indicato le traduzioni sono mie. 3 4 215 con le mani nelle tasche del cappotto, come in una sala d’aspetto, quasi fosse in attesa dell’annuncio della partenza del suo treno”8. All’amico Stefan Zweig Roth stesso scriverà alcuni anni dopo in un’occasione analoga: “io non sono fatto per stare in appartamento.[…] Solo l’hotel m’ha liberato un po’”. In realtà, più che all’’albergo’, egli deve la libertà alla mobilità cui lo obbligano i frequenti viaggi in Europa, compiuti come corrispondente culturale per le principali testate giornalistiche tedesche; e dal 1933, alla condizione di esule. Sarà proprio quest’ultima che nel 1944 indurrà Adorno a giustificare il proliferare del fenomeno alberghiero: “Chi cerca di sfuggire alla responsabilità dell’abitazione andando a stabilirsi in un hôtel […] fa per così dire virtù delle necessità imposte dall’emigrazione”9. Anche per Kafka l’albergo è una potenziale occasione di divincolamento dalle coercizioni dell’istituto della famiglia. Ma il nucleo familiare finisce per esercitare forti pressioni anche nella fantasia, al punto da rendere vano qualsiasi tentativo emancipatorio: Durante un viaggio d’affari, la mattina di una piovosa giornata d’autunno, Ernst Liman arrivò a Costantinopoli e secondo la consuetudine – era ormai la decima volta che faceva quel viaggio – senza curarsi d’altro, andò per le strade, che del resto erano deserte, all’albergo nel quale soleva alloggiare con sua soddisfazione. […] Al termine della scarrozzata lo aspettava una sgradevole sorpresa. Durante l’ultimo incendio a Stambul, del quale Liman aveva certo avuto notizia durante il viaggio, l’Hotel Kingston, dove soleva alloggiare, era bruciato quasi per intero […]. Così venne a sapere – e involontariamente dovette sorridere della pretesa – che per gli ex clienti dell’albergo, e soltanto per loro, si erano preparate ottime camere in abitazioni private. […] “Grazie” disse Liman montando in carrozza. “Resto a Costantinopoli solo cinque giorni e non intendo certo accomodarmi per questo tempo in una casa privata. No, no, vado in un albergo. […]”. [Ma] una ragazza con le mani ancora sui capelli appena ravviati in fretta uscì dalla casa a testa un po’ bassa e corse verso la carrozza […] e incrociando le braccia sul petto esclamò: “Ma perché non vuole farsi indicare da me un appartamento?”. Stanco delle molestie che già aveva sopportate, Liman sporgendosi rispose: “Fatemi il piacere di non trattenermi in domande inutili. Me ne vado all’albergo e tanto basta. Levate il piede dal predellino […]”. “Alt!” gridò invece la ragazza che […] s’infilò davvero nella carrozza, tirò lo sportello [e] disse come tra sé: “Oh dunque!” e si aggiustò alla lesta la camicetta e poi più attentamente la pettinatura. “È inaudito” disse Liman, ricaduto sul sedile, alla ragazza che gli sedeva di fronte10. Cit. in D. BRONSEN, Joseph Roth. Eine Biographie, Amsterdam, Kiepenheuer & Witsch, 1974, p. 222sg. T. W. ADORNO, Minima, p. 34. 10 F. KAFKA, Diari 1910-1923, Milano, Mondadori, 1954, vol. 1, p. 278sgg. [tr. it. E. Pocar] 8 9 216 La camera privata risulta intollerabile non solo allo scrittore; lo stesso Adorno, nel saggio citato, ammette come nell’abitazione tradizionale “ogni traccia di intimità [sia pagata] con la muffosa comunione d’interessi della famiglia”11. In tali interessi Kafka riconosce la presenza femminile. Ritratta nella ‘casa’ come potenza subdola, essa esercita la seduzione volgendola però subito in atto violento. In America, all’hotel egli contrappone la casa in una triplice forma: quella paterna, dove il protagonista Karl Rossmann viene miseramente sedotto dalla domestica, atto che gli costa il rinnegamento dei genitori; il Landhaus di Pollunder, dove la figlia Clara riverserà il proprio ego aggressivo contro l’inerme ospite alla vana ricerca di protezione nei meandri dell’edificio oscuro e labirintico; infine la squallida dimora di Brunelda, angusta e sudicia, nella quale egli si scopre prigioniero. Niente a che vedere con l’immenso Hotel Occidental, ove pur regna un rigido ordine capitalistico di chiaro stampo borghese, ma all’interno del quale la donna incarna il principio materno (la capocuoca) e sororale (Therese), venuto per Karl incomprensibilmente meno. L’albergo tuttavia è un simbolo di tormentata libertà non solo per l’artista, anche per l’uomo Kafka. Poco rappresentato nell’opera letteraria, esso ricorre invece frequentemente negli scritti privati, talvolta in maniera quasi ossessiva. A Felice Bauer, ad esempio, racconterà un sogno in cui camminano insieme verso la porta di un hotel12. Un sogno premonitore, e non perché l’albergo era spesso il luogo in cui si festeggiavano fidanzamenti e nozze, bensì perché in Kafka rappresenta la rottura di ogni legame. Egli prenderà infatti congedo da Felice la prima volta, nel settembre del 1913, con una lettera scritta dall’Hotel Sandwirth di Venezia13; poi nel 1914, all’Askanischer Hof di Berlino. L’albergo della capitale si trasfigura come una corte di giustizia, la rottura del fidanzamento come un processo a suo carico: “Il tribunale dell’albergo. Il viaggio in carrozza. Il viso di F. che si mette le mani nei capelli e sbadiglia. A un tratto si alza e dice cose ben ponderate, tenute in serbo da un pezzo, ostili.”14 Agli occhi dello scrittore la libertà diventa a tutti gli effetti liberazione, ma proprio nel momento in cui egli descrive il congedo dalla ragazza e dalla famiglia, essa assume i tratti di una partenza senza ritorno: “Perché i miei genitori e mia zia mi hanno fatto tanti cenni di saluto mentre mi allontanavo? Perché F. rimase all’albergo e non si mosse, benché T. W. ADORNO, Minima, p. 34. Cit. in N. de SAINT-PHALLE, Hôtels Litteraires. Voyage autour de la terre, Paris, Denöel, 2005, p. 364. 13 Lettera del 16.9.1913. F. KAFKA, Briefe 1913-1914, Frankfurt a. M., Fischer, 1999, p. 281sg. 14 F. KAFKA, Diari, vol. 2, p. 65. L’annotazione è del 23 luglio 1914, ma si riferisce al 12 dello stesso mese. Cfr. N. de SAINT-PHALLE, Hôtels Litteraires, p. 57. 11 12 217 tutto fosse ormai chiaro?”15. Sono domande prive di risposta, esattamente come la sua meta, priva di nome, che finisce per coincidere con la dispersione. Un’immagine che ritorna, nel momento del licenziamento di Karl dall’Hotel Occidental, anche in America, non a caso intitolato da Kafka Il disperso. Il congedo dall’albergo trova riscontro anche in Roth, benché in forma diversa e con una valenza molteplice. Nel Panoptikum viene descritto come momento necessario a dare un senso alla circolarità del ritorno: “Potrei degradare questo hotel a focolare domestico se non lo abbandonassi senza necessità”16. L’urgenza di cui parla risiede infatti nel fascino dell’ “andare e venire”, poiché Roth amava essere “di casa, ma non a casa”17. Non con la stessa levità egli vivrà invece l’abbattimento dell’Hotel Foyot nel 1937, nel quale aveva trascorso “sedici anni, ad eccezione dei miei viaggi”18. L’abbandono dell’albergo parigino segna una tappa dolorosa nell’esistenza dello scrittore, poiché viene a coincidere con il suo ormai inarrestabile decadimento fisico dovuto all’abuso di alcol. Un tragico presentimento, che trova espressione nel breve scritto Rast angesichts der Zerstörung19. Roth sapeva che nel suo hotel erano scesi Rilke (1920 e 1925) e Raymond Radiguet (1923), un giovane, promettente scrittore francese che vi aveva addirittura presagito la propria prematura dipartita. Egli nutriva il presentimento di dover essere il terzo letterato, il cui nome iniziava per R, a dover terminare i suoi giorni al Foyot. Ecco perché non volle abbandonare la sua camera nemmeno quando furono portati via i mobili, accanendosi a dormire con il materasso sul pavimento20. Grand Hotel Eterotopia L’hotel del primo Novecento non è un alloggio per turisti in viaggio alla scoperta del mondo; esso ha un compito ben più arduo, giacché porta il mondo al suo interno: “Quando apro la finestra il mondo mi viene a trovare” 21, scrive Roth. A destarne la meraviglia non è solo il fascino del viaF. KAFKA, Diari, vol. 2, p. 66. J. ROTH, Panoptikum, p. 591. 17 Ibid. [corsivo mio]. 18 J. ROTH, Rast angesichts der Zerstörung, in ID., Werke, vol. 4, p. 884. 19 Ibid. 20 Cfr. V. LUNZER-TALOS, H. LUNZER, Joseph Roth – „Alles was ich besitze sind 3 Koffer”, in C. SEGER, (a cura di), Grand Hotel. Bühne der Literatur, München und Hamburg, Dölling und Galitz Verlag, 2007, p. 134; L. KÜNZLI, Hotels. Ein literarischer Führer, Frankfurt a. M., Gatza bei Eichborn, 19962, p. 97. 21 J. ROTH, Panoptikum, p. 567. 15 16 218 vai urbano che il moderno albergo assicura ai suoi clienti, ma il contesto internazionale che offre, che accende il suo entusiasmo: Il postino [...] è un italiano. Il cameriere un austriaco. Il portiere un francese dalla Provence. Il receptionist un uomo dalla Normandia. Il capocameriere un bavarese. La ragazza che rifà le stanze è svizzera. Il servitore salariato olandese. Il direttore levantino; e da anni nutro il sospetto che il cuoco sia ceco. I clienti provengono dal resto del mondo22. A partire dal momento in cui l’albergo non assolve più alla mera funzione di offrire una sistemazione per la notte ma diventa luogo di interazione umana, esso si configura come ‘spazio sociale’, ossia un universo di tipo relazionale e culturale dove avviene l’incontro tra gruppi sociali diversi. Già Kant nella Dottrina trascendentale degli elementi (1781) definiva lo spazio possibilità dell’essere “l’uno accanto all’altro”23, una formulazione che sarà ripresa dapprima da Georg Simmel, interessato a capire come le relazioni umane siano in grado di dare significato allo spazio che, per definizione, è invece vuoto e nullo; poi da Michel Foucault, il quale afferma che il Novecento va considerato come l’era dello spazio tout court: “viviamo nell’epoca del simultaneo, della giustapposizione, del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso”24. Se in Europa tra Otto e Novecento fiorisce una cultura alberghiera che si sostituisce progressivamente all’abitare tradizionale, è perché la società si adegua ai mutamenti di un’età in rapida evoluzione assai più lentamente di quanto si creda. L’albergo si delinea perciò come eterotopia; esso funge da spazio intermedio dove la memoria del passato e l’inquietudine per il futuro si compenetrano. Osservando lo spazio vuoto su cui sorgeva l’Hotel Foyot, Roth afferma: “probabilmente quei sedici anni, ora che sono andati, mi appaiono tanto preziosi, anzi colmi di preziosità, da non riuscire a comprendere come potessero svolgersi in uno spazio tanto misero. E poiché l’hotel ora è distrutto, esattamente come si sono dileguati gli anni che vi ho trascorso, nella memoria esso mi appare di gran lunga più grande di quanto potesse essere”25. In quanto eterotopia, l’albergo è un luogo dove sono racchiuse le incongruenze e le devianze sociali mal tollerate nella vita quotidiana. Nel romanzo Hotel Savoy (1924) si ritrovano infatti reduci, artisti, ebrei, personaggi stravaganti, tutti consapevoli del proprio destino di reietti: “nessuno di loro stava di propria volontà 22Ivi, p. 568. I. KANT, Critica della ragion pura, Bari, Laterza, 2000, §2, p. 59 [tr. it. G. Gentile] M. FOUCAULT, Spazi altri, Milano, Mimesis, 2001, pp. 19-32 (qui p. 19). 25 J. ROTH, Rast, p. 884. 23 24 219 all’Hotel Savoy. Tutti erano trattenuti da qualche sfortuna. […] ‘L’Hotel Savoy’ diceva Zvonimir ai reduci ‘è un palazzo splendido e una prigione’ ”26. Se tuttavia la funzione del luogo eterotopico è restituire l’equilibrio interiore a chi vi risiede, l’hotel più spesso porta alla luce un disagio esistenziale occulto. All’Hotel Savoy ricorre con grande frequenza l’immagine della morte: “Era come il mondo, quell’Hotel Savoy, […] chi era più in alto abitava in basso, sepolto in tombe ariose, e le tombe erano disposte a strati sopra le comode camere dei sazi, i quali stavano sotto in tutta tranquillità e benessere, e non sentivano il peso dei feretri leggeri”27. Nella contrapposizione tra la dimora usuale e l’abitazione precaria destinata al soggiorno temporaneo ha origine una dialettica complessa dalla chiara valenza poetologica. Se lo spazio in sé suscita la riflessione filosofico-sociologica, uno spazio abitato incoraggia la ricerca sul significato della funzione prima dell’ “abitare”. Gaston Bachelard, nella sua Poetica dello spazio, insiste sull’importanza che assume lo “scrivere” una casa, o il “leggere” una camera28. Camera e casa sono infatti diagrammi psicologici che guidano scrittori e poeti nell’analisi dell’intimità. Per Bachelard i valori dell’intimità possiedono una natura archetipica, cosicché il lettore non legge più della stanza di chi scrive ma rivive la propria. Gli individui sono dunque il diagramma delle possibili funzioni di abitare una determinata dimora e ogni altro domicilio non è che una variazione di un tema fondamentale. Per effetto di una tale suggestione si può ‘leggere’ la stanza d’albergo che Roth descrive nel Panoptikum: In questa camera, per fortuna, non vi è nulla, non un singolo orpello sul quale l’occhio potrebbe posarsi con strazio! Nessuna vecchia zuccheriera, niente scrittoio dello zio, nessun ritratto del nonno materno, niente lavandino con fiorellini rosso cinabro e in mezzo una crepa, niente palchetto che scricchiola, come a casa […] niente olezzo di carne grigliata proveniente dalla cucina, o mortaio tirato fuori dal guardaroba dell’anticamera; nulla! Quando le mie valigie non ci saranno più, ce ne saranno altre; quando il mio sapone sarà stato ritirato, un altro poserà accanto al lavandino; quando io non sarò più a questa finestra, ci sarà un altro al mio posto. Questa camera non crea illusioni né a me, né a te, né ad alcuno. Quando la lascio e vi getto un ultimo sguardo, non è più la mia camera29. J. ROTH, Hotel Savoy, in ID., Opere 1916-1930, Milano, Bompiani, 1987, p. 217 e 226. [tr. it. E. Pocar] Ivi, p. 148. 28 G. BACHELARD, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 19842, p. 33. [tr. it. E. Catalano] 29 J. ROTH, Panoptikum, p. 593. 26 27 220 Non il commiato da un ambiente intimo, bensì il congedo dell’uomo moderno dal privato è quanto egli celebra con la partenza dall’albergo. Tutt’altro che congedata appare invece la vita privata in Kafka, che invade anche le zone “franche” dell’hotel. Quanto non esplicitato nei diari trova compiuta espressione in America, dove l’immagine del “tribunale dell’albergo” assume le proporzioni di un’istruttoria spietata e inappellabile. L’irruzione del privato nella professione è infatti la causa, assurda e inconcepibile, del licenziamento di Karl Rossmann dall’Hotel Occidental: “Questo ragazzo garbato, che lei [la capocuoca] considera un modello di morigeratezza, non lascia passar notte fuori servizio che non corra in città per tornare solo alla mattina. […] Me lo dice lei dove prende i soldi per questi spassi? Come fa a conservare l’applicazione necessaria per il servizio? O vuole che mi metta anche a descriverle quello che fa in città?”30. L’esperienza di Kafka, che si sentiva particolarmente vicino al personale alberghiero tanto da intrattenere, nei suoi brevi soggiorni, più rapporti umani con esso che con altri ospiti (“Qui sono solo, non parlo con nessuno, eccetto che con il personale dell’albergo”)31, dimostra in fondo che la separazione tra gli ambiti ‘pubblico’ e ‘privato’, tra la clientela e il personale non corrisponde a criteri intrinseci, ma è piuttosto frutto di una convenzione. Non a caso, nel romanzo, è in veste di cliente che Karl, approdato al grande hotel affamato e in cerca di cibo, verrà in contatto con la capocuoca, che solo successivamente gli procurerà il posto di liftboy. Il tramonto della ‘casa’ coincide perciò con il declino della sfera privata, evento che Adorno – affermando: “A che punto siamo con la vita privata si vede dal luogo in cui dovrebbe svolgersi”32 – interpreta come una minaccia effettiva per l’uomo moderno. Ma il rapporto pubblico-privato, cui la modernità assegna confini ben delineati, nell’albergo subisce declinazioni nuove, in particolare per quanto riguarda il secondo. L’hotel rappresenta infatti una evoluzione delle nozioni di pubblico e privato, poiché – come può avvenire solo nel luogo eterotopico – esso offre spazi che in realtà sono semi-pubblici (hall, ristorante, scale) e semi-privati (camere). Non solo perché essi, pur essendo riservati a pochi eletti, sono contrassegnati dalla provvisorietà della permanenza, ma perché non vi è una netta demarcazione tra l’uno e l’altro. Se una siffatta realtà genera talvolta inquietudine, più spesso si rivela una occasione per vivere nuove esperienze. L’aristocrazia ad esempio, da sempre impegnata nell’ostentazione della ricchezza, soggiornava lungaF. KAFKA, America, Milano, Fabbri, 1996, p. 172. [tr. it. E. Franchetti] F. KAFKA, Briefe, p. 281. 32 T. W. ADORNO, Minima, p. 34. 30 31 221 mente nei grandi alberghi d’Europa perché, come diagnosticava l’economista nordamericano Thorstein Veblen nel 1899, “non tutta la vita del nobil uomo appartenente alla classe agiata trascorre sotto gli occhi dello spettatore che si vuole impressionare con quello spettacolo di agio onorifico […]. Per qualche frazione di tempo questa vita è per forza sottratta agli occhi del pubblico, e di questa parte trascorsa in privato il nobil uomo deve, per salvaguardare il suo buon nome, saper dare un convincente resoconto”33. Anche i momenti più personali della vita privata, spogliata dell’intimità del rifugio domestico, vengono perciò messi letteralmente in scena negli spazi dell’albergo, spesso ridondanti e artificiosi. L’hotel permette ai suoi ospiti, per mezzo del lusso che offre, di atteggiarsi a gran signori. Specchi, luci, marmi, tessuti pregiati, eleganza creano l’illusione di poter stazionare fuori dai meccanismi opprimenti della quotidianità, in una dimensione parallela fortemente irreale, quasi fiabesca. In quest’ottica, l’albergo assume un significato simbolico molto forte, poiché appare come un palcoscenico sul quale vanno in scena l’estraneo, l’insolito, il diverso. Una siffatta simbologia di tipo drammaturgico trova espressione nella stessa architettura dell’hotel, strutturato – al pari di un teatro – in proscenio (hall, scale) e quinte (camere degli ospiti, spazi riservati al personale). In particolare queste ultime costituiscono quell’ambito privato che tuttavia cessa di essere di pertinenza del singolo e sul quale altri avanzano diritti. Contrariamente a quanto affermerà Kracauer alcuni anni più tardi (“coloro che vagano per la hall accettano senza difficoltà l’incognito dell’albergatore”34), Gabriel Dan, insieme agli altri ospiti dell’Hotel Savoy, indaga sull’identità del misterioso albergatore Kaleguropulos, di cui si scoprirà la vera natura solo alla fine, quando l’albergo sarà distrutto da un incendio appiccato dai lavoratori in sciopero: “Lo sai che Ignatz era in realtà Kaleguropulos?”35. Venendo a coincidere con Ignatz, “il lift, un uomo maturo”36, egli rappresenta, nella molteplicità della sua simbologia, la vita e la morte (“guardai Ignatz: era la morte o era soltanto un vecchio lift?”37), l’alfa e l’omega, l’essenza stessa della realtà. La simbologia dell’hotel si fa dunque allegoria. Non solo è metafora dell’esistenza, contrassegnata da provvisorietà e indeterminatezza, dall’anonimato e dalla solitudine; esso assurge a emblema della patria che, soprattutto nel caso di Roth e Kafka, assume le forme di un dissidio interiore T. VEBLEN, Teoria della classe agiata, Torino, Einaudi, 1971, p. 37sg. [tr. it. F. Ferrarotti] S. KRACAUER, Hall d’albergo, in ID., Il romanzo poliziesco, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 42sg. [tr. it. A. Gargano] 35 J. ROTH, Hotel Savoy, p. 233. 36 Ivi, p. 227. 37 Ivi, p. 157. 33 34 222 dalle tinte nostalgiche e malinconiche. La parentela linguistica che inoltre accomuna la patria (Heimat) alla casa (Heim) richiama ancora una volta il problematico legame con la dimora, che per entrambi gli scrittori sta agli antipodi dell’albergo, il quale in definitiva la nega. Rinunciando al focolare domestico, Roth si dichiara cittadino del mondo, e per farlo pronuncia la formula: “Sono un cittadino d’albergo, un patriota d’hotel”38. Amava l’albergo come una patria, qualunque esso fosse e dovunque si trovasse: il Beauveau di Marsiglia (“L’albergo che amo come la madrepatria sorge in una delle più grandi città portuali europee”39), il Foyot di Parigi, l’Hôtel del la Poste (poi Hotel de Tournon), sito nella strada che avrebbe poi definito “Republik Tournon”40. In particolare con l’esilio, l’albergo diventa un punto di riferimento sicuro per lui che aveva perso, con la patria, anche il proprio passato. Ma l’hotel è molto di più che un surrogato della propria terra, la Galizia dello scomparso impero austroungarico, poiché schiude allo scrittore nuove possibilità. Esse si affacciano nella mente dell’autore già nei primi anni Venti, quando soggiorna nel prestigioso Hotel am Zoo di Berlino e nel quale scrive Hotel Savoy. Di quest’albergo, situato nella città polacca di Łodž, aveva avuto notizia da un amico di gioventù che vi aveva abitato, ammirandone il carattere cosmopolita41. Un aspetto in particolare traspare nel romanzo, la sua vicinanza con l’occidente: “Il più europeo di tutti gli alberghi dell’est mi sembra l’Hotel Savoy, coi suoi sette piani, lo stemma dorato e il portiere in livrea”42. È il miraggio del capitalismo, che attrae il reduce offrendogli la speranza in un fortunato cambio di vita: “All’Hotel Savoy io potevo arrivare con una sola camicia e lasciarlo possedendo venti valigie – rimanendo ancora lo stesso Gabriel Dan. Quest’idea mi ha forse reso così sicuro di me, così superbo e altero che il portiere mi saluta, me, il povero viandante in blusa russa, e un boy servizievole mi aspetta benché io non abbia bagaglio”43. La fortuna che Dan cerca al Savoy pare corrispondere al clima che permea l’intera città, e di cui Roth nel 1928 si esprimerà in un reportage per la “Frankfurter Zeitung”: “Faccio queste esperienze a Lodz, la ‘Manchester polacca’. Abito in un grande hotel, il cui comfort avveniristico sta in netto contrasto con il rigore religioso della maggior parte dei suoi ospiti. ‘La colazione è obbligatoria’ recita una disposizione appesa alla pa- J. ROTH, Panoptikum, p. 567. Ivi, p. 566. 40 Cit. in L. KÜNZLI, Hotels, p. 121. 41 Cfr. V. LUNZER-TALOS, H. LUNZER, Joseph Roth, p. 126. 42 J. ROTH, Hotel Savoy, p. 125. 43 Ivi, p, 126sg. 38 39 223 rete. Non la quiete. Infatti il guadagnar denaro a Lodz è un’occupazione diffusa e l’intero albergo sembra esserne dedito”44. Quanto rielaborato nel romanzo anticipa e trova successiva conferma nella realtà esperita dallo stesso autore: all’Hotel Savoy si lavora, si guadagna, si tenta la fortuna al gioco, si vince come si perde, si ama e si muore. L’epilogo, frutto della sua fantasia, tuttavia non sorprende: l’albergo viene incendiato dagli scioperanti in rivolta, ma è chiaro che il Savoy, simbolo di una patria scomparsa nel nulla, che ha avvinto a sé i suoi “figli” finché ha potuto, abbandonandoli poi al triste destino di esuli, sarà rimpiazzato da un’analoga fonte di guadagno che ripristinerà l’ordine. Al viandante privato della patria non resta che mettersi nuovamente in gioco, e se dapprima aveva bussato alle porte dell’Europa, ora l’imperativo categorico suona “America”: “Viaggiamo in un treno carico di reduci, tutti slavi del Sud. Cantano i reduci e Glanz comincia: ‘Quando arrivo da mio zio a New York…’ ”45. Pare esserci un filo diretto che lega l’epilogo di Hotel Savoy al capitolo iniziale di America, in cui il giovane reietto Karl Rossmann, in viaggio verso New York dallo zio disposto ad accoglierlo, potrebbe ben essere il destinatario dello speranzoso messaggio dei personaggi di Roth. Ma America non è che un susseguirsi di fallimenti, o meglio, è il medesimo fallimento – l’esistenza stessa – che ad ogni occasione si reitera. Anche l’Hotel Occidental perciò, che all’inizio rappresenta un frammento di patria ritrovata – la capocuoca, immagine dell’intera struttura, si rivela sua compatriota – rappresenta in definitiva uno scacco per il protagonista, con la differenza che l’albergo americano, un organismo mastodontico e imperscrutabile, non solo sopravvive al ragazzo, ma lo annienta, spogliandolo dell’identità e votandolo alla dispersione. Forse perché per Kafka, che anelava all’ortodossia ebraico-orientale, un’esistenza all’insegna dell’abnegazione borghese-protestante doveva apparire un’eresia, punibile con la cacciata. Se per Roth l’hotel rappresenta un istanza positiva destinata a svanire, è perché esso gli trasmette il senso di patria attraverso il personale, soprattutto il portiere d’albergo, che fa le veci di un padre benevolo (“Lo sguardo con cui il portiere mi saluta vale più di un abbraccio paterno”)46; mentre per Kafka, che dal capoportiere – figura ugualmente “paterna” e perciò nociva – verrà umiliato, aggredito e punito47, l’hotel si trasforma in una morsa fatale che attira l’individuo con una promessa di libertà e prosperità destinata a rivelarsi vana. J. ROTH, Rüssische Überreste – Die Textilindustrie in Lodz, in ID., Werke, vol. 3, p. 1076sg. J. ROTH, Hotel Savoy, p. 233. 46 J. ROTH, Panoptikum, p. 566. 47 Cfr. F. KAFKA, America, p. 192. 44 45 224 225 226 INTRODUZIONE A LA METODOLOGIA DEL SAPERE DI NISHIDA KITARŌ Matteo Cestari L’autore Nishida Kitarō (1870-1945) è generalmente considerato il più importante filosofo del Giappone anteguerra. Insegnò filosofia all’Università di Kyoto dal 1912 al 1928, ma continuò la sua attività fino alla morte, producendo una notevole quantità di scritti, ora raccolti in un’Opera omnia in diciannove volumi1. Attorno a lui si formò presto un circolo di studiosi, poi conosciuto come “Scuola di Kyoto” (Kyōto gakuha), che costituisce ancora oggi una delle più attive e originali scuole filosofiche giapponesi. La vicenda filosofica di Nishida è caratterizzata da una costante e inesausta ricerca di filosofare in una lingua e in una cultura fino ad allora totalmente estranee all’Occidente. Questa ricerca lo porta a partire dagli anni ‘30 all’elaborazione di un pensiero che incrocia i temi della metafisica occidentale con le esigenze e l’orientamento generale della tradizione buddhista estremo-orientale. Il testo in traduzione Il saggio qui tradotto, “La metodologia del sapere accademico” (Gakumonteki hōhō), è il testo di una conferenza tenuta da Nishida nel 1937 presso la Sala Pubblica di Hibiya (Tokyo) nell’ambito di un convegno patrocinato dalla Sezione Pedagogia del Ministero dell’Istruzione2. Il livello del discorso del testo è introduttivo, adatto a un pubblico non accademico. Sullo sfondo, emerge il tema del mondo storico (rekishiteki sekai), nella sua 1 Cfr. NISHIDA Kitarō, Nishida Kitarō Zenshū (Opere complete di Nishida Kitarō), Tokyo, Iwanami shoten, 1979, voll. 19, d’ora in poi, abbreviata con NKZ, seguita dal numero romano del volume e dal numero arabo delle pagine. 2 L’intervento fu poi raccolto assieme al testo della conferenza Nippon bunka no mondai (Problemi di cultura giapponese, 1938) e pubblicato nel 1940 nella collana Shinsho dall’editore Iwanami. Il testo su cui è stata condotta la traduzione si trova in NKZ XII: 385-394. 227 struttura esistenziale, logica e temporale, che costituisce per Nishida il mondo della Realtà (jitsuzai), in cui trovano fondamento tutti gli opposti. A differenza del mondo privo di vita del meccanicismo causalistico e di quello teleologico della biologia, il mondo storico è il mondo pienamente umano della poìesis, o creazione: “Questo mondo della realtà storica non è solo il mondo da cui nasciamo e verso cui andiamo morendo, ma deve essere il mondo in cui noi creiamo le cose e creandole ne siamo creati”3. La creatività (tsukuru koto), caratteristica principale del mondo storico, porta l’uomo a fare uso di strumenti indipendenti dal loro creatore4. L’uomo come creatore d’oggetti dà vita a un mondo indipendente da sé. Il mondo storico si forma pertanto nell’interazione dialettica fra l’uomo nella sua produttività e creatività e l’insieme degli elementi oggettivati. Ciò implica che il rapporto dell’uomo con il mondo è circolare: da un lato l’uomo crea il mondo, e dall’altro ne è creato, perché questo mondo trasforma l’uomo stesso, anche a distanza di secoli. Così ad esempio le cose costruite dagli antichi continuano a influenzare la vita dell’uomo attuale5. L’uomo stesso è peraltro già da sempre inserito in un circolo di azione e reazione, di attività e passività che Nishida chiama movimento “dal creato al creante” (tsukurareta mono kara tsukuru mono e). La struttura logica di tale mondo obbedisce alla cosiddetta “autoidentità assolutamente contraddittoria” (zettai mujunteki jikodōitsu), principio che sottolinea la coappartenenza e non-ultimità di identità e contraddizione6. Il mondo storico costituisce l’unità e il fondamento (autoidentità) di tutti gli opposti inconciliabili (contraddizione). La natura di tale relazione non può essere ridotta a una semplice identità, ma deve essere “un’identità radicalmente contraddittoria”. Anche il tempo è compreso a partire da tale struttura logica. Infatti, nel mondo della realtà si autodetermina il Presente Assoluto (zettai genzai no jikogentei), che è fondamento tanto del mondo meccanicistico –che per Nishida procede in senso temporale dal passato al futuro, secondo l’ordine di causalità efficiente – quanto il mondo finalistico – che va dal futuro al passato, secondo l’ordine di causalità finale7 –. Nel Presente, passato e futuro si negano reciprocamente e sono uniti pur esNKZ XII: 296. Cfr. NODA Matao, East-West Synthesis in Kitarō Nishida, in “Philosophy East and West”, IV:4 (1955), pp. 355-356. 5 Ibidem. La circolarità del rapporto fra uomo e mondo è presente anche nella concezione della conoscenza-come-azione, che si esplicita nel concetto di intuizione attiva (kōiteki chokkan). Cfr. M. CESTARI, The Knowing Body. Nishida’s Philosophy of Active Intuition (Kōiteki chokkan), in “The Eastern Buddhist”, XXXI: 2, 1998, pp. 179-208 6 Cfr. M. CESTARI, Il concetto di autoidentità contraddittoria (mujunteki jikodōitsu) nel pensiero di Nishida Kitarō (1870-1945), in “Atti del XVIII Convegno di Studi sul Giappone”, Venezia, AISTUGIA, 1995, pp. 65-84. 7 NKZ IX: 148 e sgg. 3 4 228 sendo opposti. Solo attraverso la propria autonegazione, il Presente negando se stesso di istante in istante, garantisce l’unicità dei singoli istanti, procedendo “da presente a presente” e dando vita al movimento del tempo8. Accanto a questi temi, nel saggio Gakumonteki hōhō Nishida avvia un confronto sulla natura del sapere accademico e sulla necessità di sganciare tale dibattito dalle posizioni del nazionalismo, al punto che il brano è spesso considerato una riprova della resistenza passiva del filosofo all’irrazionalismo dilagante dell’epoca in cui il Giappone aveva imboccato la pericolosa deriva militaristica che lo avrebbe portato alla Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, come ho argomentato altrove9, la posizione di Nishida rispetto a questi temi risente di una irrisolta ambiguità: da un lato, egli fa spesso propri gli slogan dei nazionalisti, dall’altro cerca di nobilitarne il significato, nella speranza di illuminare le frange più estreme del governo. Tuttavia, molto di frequente le sue parole si differenziano troppo poco dalla ideologia nazionalista oppure risultano troppo complesse per essere capite da tutti. È stato pertanto inevitabile che il suo discorso sia stato risucchiato, sia pure contro la volontà del filosofo, nei meccanismi della propaganda di regime. Tuttavia, anche se fallimentare dal punto di vista politico, Nishida si esprime al meglio laddove crea una nuova filosofia che riflette sulle più spinose questioni metafisiche, a partire da un approccio veramente mondiale. Nishida Kitarō La metodologia del sapere La cultura occidentale è stata importata in Giappone fin dal periodo Meiji [1868-1911] e noi in Oriente abbiamo compiuto grandi progressi grazie al suo apprendimento. E anche d’ora innanzi, abbiamo molte cose da imparare e dobbiamo continuare ad assorbire [la cultura occidentale], sviluppando fino in fondo una cultura mondiale. Ma è superfluo dire che non dobbiamo esclusivamente assorbire e assimilare la cultura occidentale, ma dobbiamo indirizzarci a creare una nuova cultura mondiale che abbia come fondamento quella cultura orientale che è venuta nutrendoci per migliaia di anni. È inevitabile che il Giappone, che per lungo tempo fu un paese chiuso, abbia dovuto affrettarsi ad apprendere e assorbire la cultura del mondo moderno, quando all’inizio del Meiji entrò in contatto con esIbidem. M. CESTARI, The Individual and Individualism in Nishida and Tanabe, in C. S. GOTO-JONES (ed.), Re-Politicising the Kyoto School as Philosophy, London and New York, Routledge, 2007, pp. 49-74. 8 9 229 sa10. Ultimamente si sente molto spesso dire di rigettare l’epoca Meiji; [ora,] ci saranno state certo cose negative [in quel periodo], ma noi dobbiamo ripensarne profondamente il significato. Coloro che oggi sconsideratamente alzano la voce e rigettano il Meiji hanno la stessa insensatezza di coloro che all’inizio del Meiji alzarono avventatamente la voce per demolire la cultura che il nostro paese aveva fin dai tempi antichi. Com’è possibile una nuova cultura mondiale che abbia a fondamento la cultura della nostra storia? Il tempo non si muove semplicemente in linea retta dal passato al futuro. Se si afferma soltanto ciò, non si ha l’autoidentità del tempo. Il tempo deve essere lineare e insieme circolare. Dietro il tempo ci dev’essere una spazialità. Il tempo si forma dall’autodeterminazione del presente. Questa autodeterminazione unisce nel presente passato e futuro e va muovendosi dal Creato al Creante come autoidentità contraddittoria (e ciò è conseguenza dell’entrare in relazione di ciò che non ha assolutamente relazione). Qui si ha ciò che si chiama tempo. In un certo senso, tale autoidentità contraddittoria che muta e non muta può essere pensata prima di tutto come lo spirito della storia11. Sviluppatosi per millenni nell’isolamento, lontano dalla scena della storia mondiale, anche il Giappone è giunto a una vivace crescita come tale autoidentità contraddittoria. Nel frattempo non si può negare che siano avvenuti molti contrasti e contraddizioni e neppure che da epoca ad epoca siano avvenuti molti cambiamenti. Tuttavia, il Giappone ha continuato a mantenere la propria autoidentità, incentrandosi sulla Famiglia Imperiale (kōshitsu). Qui si trovava lo spirito giapponese. Tuttavia, il Giappone di oggi non è più un paese isolato. Noi ci troviamo sulla scena della storia mondiale. Il nostro presente è il presente della storia mondiale. Per così dire, fino a questo momento lo spirito giapponese è stato lineare. Ma d’ora in avanti deve essere interamente spaziale. Dalle profondità del nostro spirito storico (dal profondo della nostra mente) noi dobbiamo produrre un principio di portata mondiale. La Via dell’Imperatore (kōdō) deve diventare mondiale12. Oggi molti sostengono che la maggior parte dei mali proviene soltanto dall’introduzione del pensiero straniero. Tuttavia, per In epoca Meiji (1868-1911), il Giappone diede avvio a un rapido processo di modernizzazione in ogni settore sociale, civile, politico, economico e culturale, dopo il lungo isolamento internazionale (sakoku o “paese chiuso”) imposto nel periodo Tokugawa (1602-1867). Cfr. M. J. JANSEN (ed.), The Making of Modern Japan, Cambridge & London, The Belknap Press of Harvard UP, 2000. 11 Per un approfondimento dei concetti di “autoidentità contraddittoria” (mujunteki jikodōitsu) e di “autodeterminazione del presente assoluto” (zettai genzai no jikogentei), cfr. l’introduzione alla presente traduzione. 12 Per il rapporto fra Nishida e la politica, cfr. J. W. HEISIG, J. C. MARALDO, (eds.), Rude Awakenings. Zen, the Kyōto School & the Question of Nationalism, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1995; e inoltre: C. S. GOTO-JONES (ed.), Re-Politicising, cit. 10 230 difenderci dal pensiero straniero, non possiamo opporci con successo a un universale con un particolare, ma dobbiamo creare un principio mondiale a partire dalle profondità della nostra mente. Che cosa significa per lo spirito giapponese diventare interamente spaziale, diventare mondiale e spaziale? Significa che è necessario che diventi un sapere nel senso più pieno, che diventi razionale. Non deve assolutamente essere qualche cosa che rifiuta la ragione per il sentimento, né deve essere dogmatico. Deve formarsi concettualmente attraverso un rigoroso metodo di conoscenza e avere un impianto teorico. Il metodo del sapere tenta di riflettere nello specchio spaziale il sé temporale (è la vita dopo la morte). Su questo punto è necessaria una radicale autocritica. Che lo spirito diventi sapere significa che molte persone devono riconoscerlo come oggettivo, ma non significa diventare cosmopolitan13. Molti fraintendono questo punto. Di recente si fa una distinzione fra cultura orientale e cultura occidentale, nel senso che la prima sarebbe insegnamento (kyō) mentre la seconda erudizione (gaku). Non si può dire che la cultura occidentale sia mera erudizione. Tuttavia, la cultura orientale, in particolare quella cinese, era insegnamento; non era ciò che va chiamato sapere (gaku) in senso attuale. Io non negligo assolutamente l’insegnamento. Tuttavia ritengo che se al fondamento della cultura orientale c’è qualche cosa di prezioso che non ha nulla da invidiare alla cultura occidentale, ciò che costituisce il suo punto debole è che non si sia sviluppata come sapere. Il fatto che oggi tendiamo ad essere oppressi dalla cultura occidentale dipende da questo. Di conseguenza, anche se in questo periodo molti sopravvalutano la formazione intellettuale e la usano come uno slogan, io penso che d’ora in poi si debba rispettare sempre di più la vera formazione intellettuale. Che fino ad ora non è davvero esistita [in Giappone]. Per la maggior parte si è trattato di uno studio mnemonico. Pur parlando di “educazione alla storia”, la recita di fatti storici è solo uno studiomnemonico. Assorbire e assimilare la cultura occidentale e creare una specifica cultura giapponese attraverso lo spirito giapponese è una concezione che oggi molti sostengono. E forse molti non avrebbero obiezioni da sollevare all’idea che la cultura giapponese debba costituire un sapere. Tuttavia, viene da pensare che anche tra gli studiosi vi siano coloro che non comprendono cosa sia veramente il sapere. Talvolta si pensa che lo spirito sia come un uomo che utilizza qualcosa e che la conoscenza sia uno strumento. Viene da pensare che anche espressioni come “Spirito giapponese e sapere 13 Per la posizione di Nishida sul tema dell’individuo, cfr. M. CESTARI, The Individual, cit. 231 cinese” (wakon kansai) esprimano tale pensiero14. Tuttavia il sapere ha esso stesso uno spirito. È così anche per le scienze della natura. Con il sapere, il nostro spirito vive nelle cose. In tal modo, diventa possibile per la prima volta un sapere giapponese. Anche il fatto che la matematica sia inglese francese o tedesca è sempre [da considerare] entro tale significato. Se non è così, pur parlando di “spirito”, si tratta solo di un concetto astratto. Fra le scienze dello spirito, emergono delle diversità, ma anche queste differenze devono formarsi grazie al fatto che noi viviamo fra cose storicooggettive. Ciò deve costituire un metodo nel senso detto prima. Per esempio, fin dal periodo Meiji è stato adottato il diritto occidentale. Tuttavia, anche il diritto occidentale, in quanto elaborato da un certo sostrato storico, mostra elementi incompatibili con lo spirito giapponese, che ha uno sviluppo storico diverso. A causa di ciò, emergono diversi problemi. Con quale atteggiamento dobbiamo affrontare la questione? Si può anche pensare di tornare alla situazione che precedeva l’importazione del pensiero giuridico occidentale. Ma se ciò non fosse possibile, non si potrebbe fare altro che introdurre le usanze giapponesi nel sistema giuridico occidentale (anche se questo ha un fondamento nella storia dell’occidente) che ha un sistema logico unificato; un po’ come legare del bambù al legno. Oppure si può negare trascendentalmente la cosa dall’esterno. Noi per organizzare un diritto veramente giapponese dobbiamo entrare in profondità fino alle radici della filosofia della storia e da qui produrre uno specifico concetto di legge. Ciò non è possibile né solo affermando una particolarità, né solo sostenendo una certa idea di passato. Su questo punto, si deve avere un confronto teorico. Lo spirito vivente deve avere un impianto teorico. Come anche nei miti, ciò che ha una vita eterna deve avere un contenuto teorico. Una semplice particolarità non è niente. Cercare di far fronte a una nuova epoca considerando lo spirito con la forma che [questo] aveva nel passato, all’opposto uccide uno spirito di vivace sviluppo. Un particolare non fa altro che opporsi a un altro particolare. Un semplice particolare non può 14 Fra gli slogan che polarizzarono il dibattito sulla modernizzazione Meiji, quello che si impose fu wakon yōsai (spirito giapponese, sapere occidentale), che rimpiazzò il vecchio wakon kansai (spirito giapponese, sapere cinese). Queste due parole d’ordine sottolineavano la distinzione fra un sapere meramente tecnico (considerato come inessenziale) proveniente dall’estero, e una modalità di utilizzo (ritenuta sostanziale) che si credeva restasse saldamente giapponese. Questo dualismo sulla tecnica aveva soprattutto lo scopo di cementare il consenso della neonata nazione moderna giapponese, mantenendo una parvenza di indipendenza culturale dall’estero. Opponendosi a questa prospettiva, Nishida mostra di avere piena coscienza dell’importanza della tecnica per lo spirito. Va ricordato inoltre che, contrariamente ad Heidegger, Nishida non critica la tecnica, ma la accetta, integrandola a tutti gli effetti nella realtà ontologica del mondo. Per una discussione sul problema della tecnica in Nishida, cfr. ŌHASHI Ryōsuke, Nishida tetsugaku no ‘gijutsuron’ (La ‘teoria della tecnica’ nella filosofia di Nishida), in “Gendai shisō”, XXI: 1, (1993), pp. 138-145. 232 essere pensato se non come particolare in un universale. Ciò che è creativo deve avere una universalità concreta. Limitandosi ad affermare una pura particolarità, se poi si teorizza sulla base di un’altra [particolarità], ciò si riduce solamente a un altro semplice particolare15. Che cosa significa che noi a partire dalla radice più profonda della cultura orientale scopriamo un nuovo modo di vedere e pensare le cose e illuminiamo la storia mondiale? Che cosa vuol dire da parte nostra porsi di fronte al mondo in modo teoretico? Dato che in questa sede è per me difficile esprimere ciò filosoficamente, e poiché penso che non sia di facile comprensione per tutti i presenti, proverò a parlarne facendo un esempio tratto dall’arte. Fin dall’antichità, nell’estetica occidentale il bello è stato pensato sulla base dell’arte greca. Ossia, la cosiddetta arte classica è divenuta il criterio del bello. Quest’arte è incentrata sull’umano. L’empatia di Lipps spiega quest’arte in modo assai efficace16. Tuttavia, uno studioso come Riegl (1858-1905) a partire dagli studi di storia dell’arte ha pensato per esempio che con questa visione artistica non si possa spiegare l’arte geometrica egiziana. Di qui, Riegl ha concepito a fondamento dell’arte una volontà artistica assoluta. Essa deve anche chiamarsi volontà formativa. E in essa, in opposizione a un impulso empatico, c’è un impulso astratto-attivo; da un lato, [nell’arte classica,] si ha la gioia di scorgere l’umano nella natura; dall’altro, [nell’arte egizia] si va in direzione di una negazione dell’umano; per così dire, è la direzione della liberazione dagli attaccamenti mondani (gedatsu)17. In questa sede non ho tempo per spiegare in dettaglio la teoria 15 La frase è un po’ oscura. La si potrebbe interpretare nel senso che si cade nel particolarismo sia a partire dall’affermazione della cultura giapponese (la “pura particolarità”), sia a partire dall’affermazione della cultura occidentale (“l’altra” particolarità su cui si teorizza). 16 Il filosofo Theodor Lipps (1851-1914), seguace dello psicologismo di Brentano, puntò alla riduzione della filosofia a psicologia, senza cadere nel relativismo. Le sue ricerche di estetica miravano a dimostrare come l’esperienza del Bello fosse basata sull’empatia (Einfühlung). Un’ampia discussione sull’estetica viene condotta in un saggio risalente al periodo storicista dal titolo: Rekishiteki keisei sayō toshite no geijutsuteki sōsaku (L’opera artistica come attività formativa della storia, 1941), ora in: NKZ X: 177-264. Cfr. anche: M. CESTARI, The Problem of Aesthetics in Nishida Kitarō, in Proceedings of the Association for Japanese Literary Studies, V, 2004, pp. 175-191. 17 Corrispondente al sansrito vimokśa, vimukti, è un termine buddhista che indica la liberazione dagli affanni e dalle passioni. Talvolta è usato come sinonimo di nehan (sanscr. nirvāṇa). Alois Riegl (1858-1905) sviluppò il concetto di Kunstwollen o “volontà artistica”, ossia, una sorta di orientamento interiore della creazione artistica, che si realizza opponendosi a tre “fattori di frizione” (ossia: lo scopo pratico, i materiali e le tecniche). Poiché l’arte non è considerata mimetica, ma è generata da un impulso, Riegl è in grado di spiegare le forme geometriche nell’arte antica. Anche secondo Wilhelm Worringer (1881-1965), l’arte è prodotta dalla volontà artistica (Kunstwollen), che si condensa in forme in grado di diventare veri e propri strumenti di salvezza, che permettono di superare l’ansia di vivere. Mentre l’empatia non riesce a spiegare le forme astratte, come le piramidi egiziane, attraverso “l’impulso ad astrarre” (Abstraktionsdrang), Worringer è in grado di chiarire il senso di timore per la natura di molte civiltà primitive e orientali. Cfr. M. CESTARI, The Problem of Aesthetics, cit. 233 estetica di Riegl (spero che si vorranno leggere Riegl e Worringer). Tuttavia, ciò che mi preme puntualizzare è che il cammino dell’arte non è proceduto in linea retta come la cosiddetta arte classica. Sostengo che alle radici dello sviluppo artistico ci sono stati anche cammini contrapposti. Gli occidentali hanno la tendenza fin dall’antichità a considerare la propria cultura come la più elevata e la più avanzata in senso assoluto. Hanno la tendenza a pensare che anche gli altri popoli, se si evolvono, devono diventare eguali a loro. Ma io penso che ciò sia l’autocelebrazione di una mente ristretta. Il modello di una cultura storica deve essere durevole e complesso. Riegl ha chiarito un concetto d’arte più profondo e ampio attraverso lo studio di un’arte diversa. Allo stesso modo, penso che noi possiamo afferrare bene tale concetto entrando profondamente fino alle radici della cultura occidentale e contemporaneamente arrivare alle radici della cultura orientale, comprendendo che al fondamento di tale cultura si trova un orientamento culturale diverso da quello della civiltà occidentale. Grazie a ciò, possiamo chiarire ampiamente la profonda essenza della cultura umana in sé. Ciò non significa negare la cultura orientale attraverso la cultura occidentale, e neppure negare la cultura occidentale attraverso la cultura orientale. Inoltre, non si tratta neppure di inglobare in qualche modo l’una all’interno dell’altra. Piuttosto, si tratta di scoprire un fondamento più profondo e grande di quello della tradizione e attraverso ciò illuminare di luce nuova entrambe le culture insieme. Io non ho la competenza necessaria per discutere di arte, ma non si può dire forse che al fondamento dell’arte orientale, che bisogna dire esprima la forma che non è forma, c’è qualche cosa di più profondo dell’arte egizia o dell’arte gotica? Per essere compreso dalla gente comune, ho esposto ciò che volevo dire con un esempio tratto dall’arte, ma vorrei dire la stessa cosa anche nel campo della filosofia e della religione. Noi dobbiamo avere una nuova logica. Come esempio di ciò, cerchiamo di spendere qualche parola sull’idea di relazione fra realtà e assoluto. Nelle concezioni del Buddhismo Mahāyāna in Oriente, l’assoluto non è pensato né come una semplice trascendenza, né come un limite estremo verso cui camminiamo senza fine. Si parla di “realtà-eppure-assoluto”18. In realtà, questa espressione può essere facilmente male interpretata. Si cade in un grave errore a considerare l’assoluto come la realtà così com’è (sono mama) senza alcuno sforzo, come 18 La costruzione olofrastica genjitsu soku zettai collega i due elementi con l’avverbio soku che indica la dialettica di paradossale compresenza di elementi contrapposti. Lungi dal risolvere l’opposizione, soku la mantiene. Per questo motivo, è stato tradotto con l’avverbio italiano “eppure”, dal valore avversativo, ma anche rafforzativo (recuperando il significato originario di “e pure”). 234 si pensa comunemente19. Inoltre, pensare in tal modo implica la semplice negazione della ragione. Tuttavia, come ho detto all’inizio, se si pensa il tempo come autoidentità assolutamente contraddittoria, se ne potrebbe ricavare un profondo significato filosofico e religioso. Recentemente, mi giunge all’orecchio la parola chūkin (questa parola che si trova negli editti imperiali pare che significhi semplicemente “ora”); se si caratterizza lo spirito giapponese con questa parola, ciò non deve forse dipendere da questo modo di pensare il tempo? Come mi è capitato di accennare in un mio scritto (Problemi fondamentali di filosofia, parte II)20, penso che le varie culture possano forse essere caratterizzate anche a partire dall’aspetto del tempo. Penso che nella struttura del tempo le varie culture possano forse essere stabilite, collegate e unificate. Il fatto che il tempo sia un’autoidentità delle assolute contraddizioni significa che, come ho detto all’inizio, il tempo è lineare e insieme circolare, irrazionale ma anche spaziale. La cultura occidentale, che è perlopiù una cultura del sapere, è spaziale. La cultura cinese non è una cultura del sapere, ma è spaziale in un significato diverso (è una cultura dei riti). Tuttavia, la cultura giapponese può dirsi lineare. Ecco perché la chiamo rhythmical. L’essenza della Nazione (kokutai) del Giappone emozionale, che fa capo alla Famiglia Imperiale, ricorda un’unificazione ritmica. Se la storia ad ogni modo è temporale e si suppone di pensare il modello del mondo storico sulla base della struttura del tempo, all’interno di questa struttura si possono concepire varie culture che hanno il loro centro di gravità nelle diverse direzioni, e si può dire che costituiscano la cultura mondiale attraverso la loro reciproca complementarità. Ciò che ho portato come esempio per chiarire il punto che voglio qui evidenziare è una mia opinione personale e a ciò si potrebbe muovere più di qualche obiezione. Tuttavia, dico che contribuire a una cultura mondiale illuminandola di luce nuova a partire dalla posizione della cultura orientale deve avere il significato riportato prima. Ed è anche per questo motivo che questa posizione costituisce una protezione contro il pensiero straniero, cosa di cui oggi si parla molto. Naturalmente, per poter chiarire la nostra cultura, dobbiamo studiare la nostra cultura nella storia, la storia del nostro paese e dobbiamo farlo in tutto e per tutto dal punto di vista del sapere. È 19 Questa affermazione allontana Nishida da tutte quelle posizioni religiose e filosofiche che in Giappone tendono a identificare realtà e assoluto, fra cui il pensiero del Risveglio Originario (hongaku shisō), spesso alla base di superficiali sincretismi e giustificazioni dello status quo, come è stato stigmatizzato, non sempre senza eccessi, da parte del movimento chiamato “Buddhismo critico” (hihan bukkyō) dei filologi buddhisti Hakamaya Noriaki e Matsumoto Shirō. Cfr. R. SWANSON (ed.), Pruning the Bodhi Tree. The Storm over Critical Buddhism, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1997. 20 Ora in NKZ VII, pp. 217-454. Dell’opera Tetsugaku no konpon mondai, uscita in due volumi fra il 1933 e il 1934, esiste una traduzione parziale inglese, ad opera di D. Dilworth: NISHIDA Kitarō, Fundamental Problems of Philosophy. The World of Action and the Dialectical World, Tokyo, Sophia UP, 1970, pp. 258. 235 inutile dire che ciò diventerebbe il fondamento del nostro pensiero. Tuttavia, se attraverso lo studio chiariamo soltanto una pura particolarità, non raggiungiamo lo spirito vivo che opera nella scena storica del mondo d’oggi. Noi dobbiamo avere una teoria. In ciò si deve trovare uno spirito che guidi l’educazione del nostro paese oggi. Se ci si concentra d’ora in poi sulla cultura orientale solo perché a partire del periodo Meiji si è caduti nell’errore di importare cultura straniera, ciò è soltanto una reazione. A parole si dice di assimilare la cultura mondiale attraverso lo spirito giapponese, non rifiutando la cultura straniera, ma non si riflette a fondo su come ciò sia possibile. Penso che nel nostro paese una più profonda ricerca teorica fondamentale mostri segni di debolezza in ogni campo. La filosofia non è distinta dalla politica. Come neppure la politica è distaccata dalla filosofia. L’educazione è un compito lungo; non si può pensare solo a partire dalla politica. Penso che un grande e profondo spirito guida debba sempre costituirne la base. Oggi, si ha spesso la tendenza a rifiutare come individualismo e libertarismo il pensiero teoretico, senza comprenderne nulla. Naturalmente si deve rifiutare l’idea di pensare la società della Nazione (kokka shakai) sulla base della semplice libertà dell’individuo. Tuttavia, negare semplicemente l’individuo, la libertà e via dicendo non è altro che tirannia. Anche il razionalismo viene rifiutato con leggerezza. Chi rifiuta semplicemente il razionalismo non è altro che un semplice irrazionalista. Se scompare la libertà dell’individuo, non c’è creazione. Un principio concreto di vivace sviluppo deve contenere il momento individuale (si deve riconoscere libertà alla ricerca; fissare fin dall’inizio una certa tesi implica il venir meno della ricerca). Nel mondo intellettuale d’oggi, saranno pochi coloro che sostengono idee come il razionalismo, l’individualismo, il libertarismo di fine XVIII secolo. Ancor più il Marxismo rifiuta tali idee in maniera radicale. Infine, un’ultima cosa; penso che si ritenga che studiare le cose del Giappone rappresenti per ciò stesso lo spirito giapponese e si dimentica che questo [spirito] si trova piuttosto nel modo di vedere e pensare tali cose. Non bisogna dimenticare che lo spirito giapponese si manifesta anche laddove si studiano le cose straniere. E questo spirito al contrario opera nelle cose giapponesi. Non si deve restare abbagliati da una semplice etichetta. (Traduzione e curatela di Matteo Cestari) 236 NARRARE IL TRAUMA: LA LETTERATURA E LA SPARTIZIONE DELL’INDIA BRITANNICA. Alessandra Consolar o La spartizione dell’India britannica del 1947 rappresenta un momento di svolta del mondo moderno non solo perché provocò la nascita di stati nazionali in Asia meridionale, ma anche perché fu un evento politico con una portata ben più ampia di ciò che fedeli e capi religiosi da una parte e leader politici dall’altra avevano immaginato. La realtà della divisione fu un duro colpo per tutti e l’impronta del suo trauma colpì anche gli scrittori indiani. La spartizione del subcontinente provocò una delle maggiori migrazioni umane mai documentate nella storia: si stima che 12 milioni e mezzo di persone (circa il 3% della popolazione dell’India indivisa) furono sradicate dalla propria terra. Per esempio, in Punjab (pr. Panjab), la provincia più toccata da quegli avvenimenti insieme con il Bengala, violenze e omicidi coinvolsero hindu, sikh e musulmani e nell’arco di poche settimane ebbe inizio lo spostamento di oltre 9 milioni di profughi in un’area grande come il Piemonte1. Oltre al trauma della divisione vera e propria, rimangono le ferite psicologiche: gran parte delle persone nate e vissute nel subcontinente indiano percepiscono ancora la ferita profonda di quell’epoca, anche perché i nodi psicologici legati a quegli eventi del passato Per gli eventi fondamentali che portarono alla spartizione dell’India britannica si veda: M. TORRI, Storia dell’India, Roma-Bari, Laterza 2000, capp. XII- XIV e XV, pp. 442-626; H. KULKE e D. ROTHERMUND, A history of India, London-New York, Routledge 1986 pp. 276-312; F. ROBINSON, Separatism among Indian Muslims. The politics of the United Provinces’s Muslims 1860-1923, Cambridge 1974; C. JAFFRELOT, Les nationalistes hindous. Idéologie, implantation et mobilisation des années 1920 aux années 1990, Paris, Presses de la fondation nationale des Sciences Politiques 1993; M. TORRI, Nazionalismo indiano e nazionalismo musulmano in India nell’era coloniale, in Dietro la bandiera. Emancipazioni coloniali, identità nazionali, nazionalismi nell’età contemporanea, a cura di M. MANNINI, Pisa, Pacini 1996, pp. 139-199; M. HASAN, Partition: the human cost, in “History Today” XLVIII, 9 (1997); S. KAVIRAJ, The imaginary istitution of India, in Subaltern Studies n. 7, a cura di P. CHATTERJEE e G. PANDEY, Delhi, OUP 1992, pp. 1-39; G. PANDEY, The construction of communalism in colonial North India, Delhi, OUP 1990; D.A. LOW e H. BRASTED, a cura di, Freedom, trauma, continuities: Northern India and independence, Delhi, Vedams 1998; P. R. BRASS, The partition of India and retributive genocide in the Punjab, 1946–47: means, methods, and purposes in “Journal of Genocide Research” V, 1 (2003), pp. 71–101; G. PANDEY, Remembering partition: Violence, nationalism, and history in India, Cambridge, Cambridge UP 2001. Per una bibliografia sulla spartizione v. anche: http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/Independent/partition_bibliography.html. 1 237 non sono diventati oggetto di riflessione esplicita, né quei fatti storici sono stati sottoposti a un’aperta riconsiderazione nell’opinione pubblica2. Dall’esperienza della spartizione si sviluppò un corpus letterario in numerose lingue indiane, anche se va sottolineato che il trauma è più marcato nel nord dell’India, poiché le regioni meridionali non furono direttamente toccate da questo evento: perciò anche il riflesso letterario è più forte in lingue come hindi, urdu, panjabi, gujarati o bengali. Si discute spesso se nello studio delle letterature moderne in queste lingue sia opportuno dedicare un capitolo alla cosiddetta “letteratura della spartizione”. In primo luogo questa stessa denominazione è problematica e sarebbe forse più opportuno parlare di “letteratura sulla spartizione”. Non sembra corretto trattare come fossero un genere ben definito opere prodotte da autori di formazione e orientamento artistico molto diversi. Inoltre, la maggior parte delle opere riguardanti la spartizione non fu prodotta durante o immediatamente dopo quegli eventi: sembra esistere un momento di assordante silenzio legato al trauma e solo dopo alcuni anni molti autori riuscirono a guardare al passato, raccontarlo e riflettere su di esso, con il risultato che la letteratura sulla spartizione si estende su un lungo lasso di tempo, che va dal 1947 ai giorni nostri. Si tende, infine, a dimenticare che l’India britannica era stata già in precedenza divisa dagli inglesi, per la precisione quando nel 1905 il Bengala fu separato in due. D’altra parte, la categoria “letteratura della spartizione” negli ultimi anni è comparsa come oggetto di studio non solo riferito alle letterature dell’India: ci si interroga se sia possibile studiare le rappresentazioni letterarie della spartizione anche da un punto di vista comparato, prendendo in considerazione, per esempio, opere di scrittori provenienti non solo da India e Pakistan, ma anche da Israele/Palestina e Irlanda/Irlanda del nord.3 Ci si propone di analizzare e interpretare questa produzione artistica per definirne forme e contenuti e per scoprire come la dialettica forma/contenuto, testo/contesto si sia evoluta col passare del tempo. La memoria (con la capacità di catturarla e fissarla in forma letteraria) è importante perché afferma la negatività del silenzio. La letteratura e le narrazioni orali hanno una ricchezza che è capace di sfidare il silenzio dell’animo umano e che è assente nella storiografia mainstream, incentrata solo sulla realtà empirica. Ma a volte è difficile anche per la narrativa affrontare traumi troppo grossi: basti pensare, per esempio, 2 V. S. KAMRA, Narratives of pain: fiction and autobiography as ‘psychotestimonies’ to the partition, in EAD., Bearing witness. Partition, independence, end of the raj, Calgary, University of Calgary Press 2002, http://libaccess.mcmaster.ca/login?url=http://site.ebrary.com/lib/oculmcmaster/Doc?id=10132545, pp. 165-200. 3 J. CLEARY, Literature partition and the nation-state: culture and conflict in Ireland, Israel and Palestine, Cambridge, Cambridge University Press 2002. 238 all’assenza di accenni alla spartizione nel folklore panjabi, che al contrario ha registrato eventi come la seconda guerra mondiale o la lotta gandhiana. Dal punto di vista tematico, in un certo senso le opere sulla spartizione segnano l’apogeo del discorso comunitarista del periodo coloniale. Ma questa letteratura rappresenta un campo alternativo di memoria collettiva. La sua cartografia immaginaria resiste alla logica che oltre sessant’anni fa portò a imporre frontiere artificiali tracciando una mappa non solo geografica, ma anche sulla psiche e sulle politiche del corpo4. In questo senso è possibile trattare queste opere letterarie come un genere a sé stante: esse presentano da una parte una risposta immediata al massacro, all’esperienza di sofferenza e di degradazione dei valori umani, ma allo stesso tempo sono una rilettura della storia contemporanea o recente a qualche decennio di distanza. È come se la letteratura narrativa avesse eclissato i resoconti ufficiali prodotti dall’ingranaggio statale, come gran parte della storiografia, che fino a pochi anni fa si concentravano esclusivamente sul dominio della politica alta5. Il modo in cui la storiografia descrive la spartizione non è univoco: nell’interpretazione nazionalista indiana essa è il risultato logico del divide et impera in versione britannica. Per gli storici del Pakistan è il momento fondante della patria, il glorioso risultato della lotta dei musulmani per conquistare un’identità riconosciuta sia dai britannici, sia dal movimento nazionalista indiano. Per i britannici, ormai privi del potere di imporre la propria volontà sull’intero subcontinente indiano e già esperti di divisioni (si pensi all’Africa, a Cipro, all’Irlanda, alla Palestina), era l’unico modo per ritirarsi da un impegno che non potevano più permettersi, un utile stratagemma che consentiva di andarsene velocemente da una colonia diventata un peso. Ma tutte queste narrazioni storiche perlopiù ignorano la natura dell’esperienza individuale e non registrano il dolore di chi ha perduto parenti e amici, la nostalgia per luoghi in cui si è vissuti per generazioni, l’angoscia dei fedeli costretti ad abbandonare i propri luoghi di culto, le privazioni della moltitudine che si imbarcò su treni dei desideri che spesso non raggiunsero la meta, ma si trasformarono in cimiteri viaggianti. In letteratura avviene un fenomeno interessante: la spartizione e l’indipendenza sono spesso usate come uno sfondo contro il quale si pongono in rilievo altre problematiche sociali, politiche ed economiche, di cui questi eventi furono precursori. La politica dell’identità che tanto peso ebbe al4 Sul dibattito in corso rispetto all’identità sudasiatica sovra- e trans-nazionale v. il numero monografico di “Himal Southasian” XXI, 8 (agosto 2008): http://www.himalmag.com. 5 V. G. PANDEY, The Prose of Otherness, in Subaltern Studies n. 8, a cura di D. ARNOLD e D. HARDIMAN, New Delhi, OUP 1994, pp. 188-221; v. anche A. NANDY, The invisible Holocaust, and the journey as an exodus: The poisoned Village and the Stranger City, in “Postcolonial Studies” II, 3(1999), pp. 305-329. 239 l’epoca della lotta nazionalista si costruì attraverso la manipolazione di concetti che sono di per sé complessi e connotati in maniera molto fluida: modernità, tradizione, religione e cultura. Essa rimane critica ancora nel mondo di oggi, dove permangono le stesse problematiche, che generano però nuove contraddizioni e nuove soluzioni. La spartizione non è perciò un evento passato, ma un fenomeno contemporaneo che continua a influenzare le politiche dell’identità in Asia meridionale, riflettendosi sulle posizioni individuali e collettive riguardo ad aspetti della religione e della cultura e intrecciandosi anche con la relazione fra tradizione e modernità. Infatti, la spartizione non comportò solo la creazione di nuove frontiere nazionali, ma richiese anche una riconfigurazione delle strutture e del significato di concetti come famiglia, nazionalità, cittadinanza, appartenenza a comunità definite in senso etnico o religioso, sessualità, politica internazionale. Si può affermare che la spartizione e la letteratura che la descrivono sono un tentativo di riconciliare costruzioni problematiche di modernità e tradizione, specialmente quando la modernità è definita come un campo che esclude la fede religiosa. Il postcolonialismo ci ha insegnato che questa interpretazione della modernità non si può applicare tout court a realtà non occidentali: rimuovere la cultura consolidata e la religione dalla struttura sociale significa fare a pezzi caratteristiche ideologiche che sono strettamente legate alle usanze e al sistema ideologico degli individui. Ciò vale anche nell’Asia meridionale degli stati nazionali, dove la modernizzazione e la globalizzazione sono ormai dilaganti e le multinazionali sono fortemente presenti nella scena sociale. Definire chiaramente le complessità storiche, politiche ed economiche associate alla spartizione è un compito arduo. La storiografia tradizionale si è rivelata uno strumento inadeguato per esaminare appieno il trauma della spartizione; la scrittura creativa, al contrario, risulta utile, quasi necessaria: lo scrittore non è legato a un presunto senso di obiettività storica e la forma narrativa permette di comprendere i sentimenti dei diversi agenti e delle parti contrapposte. La narrativa (in particolare il romanzo) crea un discorso che pone in luce problematiche passate e presenti: l’indipendenza e la spartizione sono il risultato della frammentazione della cultura composita che ha fatto sì che religione e cultura siano diventati sinonimi. La letteratura sulla spartizione suggerisce che ciò fu disastroso in Asia meridionale, specialmente perché unito a un incontro ambiguo con la modernità. In questo tipo di scrittura attraverso i diversi personaggi si mettono in luce i pregiudizi razziali, religiosi, socio-economici e politici e il resoconto è onesto nella misura in cui fornisce uno strumento per riferire esperienze personali senza la maschera dell’obiettività. Può darsi che il narratore e/o i 240 personaggi stessi siano prevenuti, ma riescono tuttavia a offrire un punto di vista più ampio, che permetta di comprendere le ramificazioni psicologiche e personali di cui si compone il tessuto sociale. La disumanizzazione dell’Altro, ridotto a qualcosa da distruggere prima di essere distrutti, lascia spazio solo a sentimenti di odio, indifferenza e disgusto. Il problema non è identificare colpevoli, poiché da tutte le parti vi fu violenza fisica e psicologica. Piuttosto, è necessario trovare un modo in cui i diversi gruppi possano imparare a riconciliarsi. In questo senso si può considerare la letteratura sulla spartizione come una serie di passi per trovare una soluzione al conflitto. Non è questa la sede per analizzare in dettaglio le opere della letteratura sulla spartizione in India, perciò ci si limiterà a delineare alcune delle sue caratteristiche, facendo riferimento a opere della letteratura hindi-urdu6. Soprattutto la letteratura dell’epoca immediatamente successiva alla spartizione correva il rischio di essere usata come propaganda dall’una o dall’altra comunità: si banalizzava l’esperienza della spartizione cercando capri espiatori e riproducendo gli stereotipi della comunità avversaria. Anche quando non erano direttamente strumentali al discorso comunitarista, molti di questi testi diventavano un prodotto collaterale del tentativo dell’immaginario collettivo di fare i conti con il trauma della spartizione: attribuendo la responsabilità dell’accaduto ai politici o a una sola comunità essi costruivano una realtà più facile da accettare, che permettesse ai lettori di scaricarsi la coscienza annullando la colpa stessa. Fu un’epoca in cui la profusione di resoconti delle violenze e di opere di carattere splatter – come diremmo oggi – finì per saturare la sensibilità dei lettori, ma vi è anche chi mette a nudo proprio la futilità e la pateticità di quei tentativi di riabilitazione, per esempio presentando gli stereotipi attraverso l’ironia e il rovesciamento dei ruoli. La promessa di libertà e di progresso non si realizzò né in India né in Pakistan: il decennio successivo all’indipendenza vide una grande delusione, che fu colta con particolare amarezza dagli ambienti intellettuali. Nella letteratura hindi e urdu la narrativa della spartizione divenne un modo per smascherare la retorica ufficiale: da entrambi i lati delCon questa espressione si intende che nella presente trattazione si includono anche le opere di autori come Maṇṭo che, pur scrivendo in urdu, usano una lingua “media” e sono stati pubblicati ampiamente in devanāgarī e antologizzati nelle raccolte hindi di opere riferite alla spartizione. Alcune delle antologie più note di letteratura sulla spartizione sono: A. BHALLA, Stories about the Partition of India, 3 voll., Delhi, IndusHarper Collins 1994; S. COWASJEE e K.S. DUGGAL, a cura di, Orphans of the Storm: Stories on the Partition of India, New Delhi, UBSPD 1995; M. Hasan, India Partitioned: The Other Face of Freedom, 2 voll., New Delhi, Roli Books 1995; RAVIKANT e T. K. SAINT, a cura di, Translating Partition, Delhi, Katha 2001; A. BENIWAL, Representing Partition: History, Violence and Narration, Delhi, Shakti 2005; J. JAIN, a cura di, Reading Partition/Living Partition, Jaipur Rawat 2007; F. STEWART, a cura di, Crossing over: partition literature from India, Pakistan, and Bangladesh, Honolulu, University of Hawaii Press 2007. 6 241 la frontiera molti scrittori che lamentavano la perdita di un mondo non lo facevano solo per romantica nostalgia, bensì come una modalità per cogliere appieno il senso di questa disillusione. La spartizione rimase nell’immaginario collettivo come una brusca scissione dal proprio passato, uno spartiacque da cui non si poteva comunque prescindere. Per gli scrittori che avevano lasciato il proprio territorio era necessario abituarsi a un ambiente nuovo e farlo diventare proprio, ma anche per chi restava c’era una soluzione di continuità fra il vecchio paesaggio familiare e il nuovo paesaggio, improvvisamente demarcato da segni di riconoscimento delle nuove identità, con insegne riscritte o toponimi nuovi. Nell’immaginario universale sono rimaste le lunghe file di persone in marcia con carri trainati da buoi e con i loro miseri averi, metafora di una delle più lunghe migrazioni della storia umana7. Ma il senso di sradicamento è espresso in narrativa principalmente attraverso la metafora del treno, emblema del vissuto dei profughi: si pensi al famoso racconto di Bhīṣmā Sahnī Amritsar ā gayā [Siamo arrivati ad Amritsar], nel quale il treno è il luogo che articola la fragilità della vita e l’incertezza di riuscire a raggiungere la propria destinazione8. Il treno diventa il reporter, il testimone della violenza lungo tutto il suo cammino. Lo scomparto del treno è il luogo in cui ci si confronta con il senso di insicurezza e l’impossibilità di avere fiducia nell’altro. La mancanza d’acqua, di cibo, di igiene, di spazio indicano per metonimia la miseria dell’esistenza del profugo. Nel caos generale rapimenti, stupri e altre forme di violenza, soprattutto sulle donne, finivano per perdere la loro drammaticità e si riducevano a meri argomenti di conversazione e a numeri statistici, in una sorta di pornografia della violenza, dove proliferavano immagini di smembramento e di mutilazione9. Allo stesso tempo si venne a creare una condizione di insensibilità, una sorta di anestesia nella quale lo stesso linguaggio fu violentato10. Un racconto come Khol Do [Apri!]11 dimostra l’eleganza dello stile di Maṇṭo (lo scrittore più importante della prima generazione) e il suo conV. per es. il racconto Śaraṇdātā di Ajñeya, in AJÑEYA, Saṃpūrṇ kahāniyāṁ, Dillī, Rājpāl eṇḍ Sanz 1989, pp. 481489 [trad. it. di P. CARACCHI, Il protettore in EAD., Racconti hindi del Novecento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, p. 198-208]. 8 V. Svātantryottar Hindī kahānī-koś, a cura di M. DARPAṆ, Nayī Dilli, Sacin Prakāśan 1988. pp. 812-823. Per uno studio del racconto in italiano v. A. CONSOLARO, La paura nella letteratura hindī contemporanea in Bhaya-abhaya. Paura e liberazione dalla paura. Atti del Convegno, Santo Stefano al mare (sic!) (IM) 28/30 settembre 2001, Quaderni di Villaregia n. 1 (2004), S. Stefano al Mare, pp 93-106. 9 A. RAI, The Trauma of Independence: Some Aspects of Progressive Hindi Literature in “Journal of Arts and Ideas” VI (1984). 10 V. DAS e A. NANDY, Violence, Victimood and the Language of Silence, in “Contribution to Indian Sociology” XIX, 1 (1985), pp. 177-195. 11 MAṆṬO, Khol do, in Maṇṭo kī tīs kahāniyāṁ, a cura di NĪLĀBH, Ilāhābād, Nīlābh Prakāśan 1974, pp. 81-84. 7 242 trollo espressivo nell’esprimere, attraverso metafora sessuale, proprio questa condizione di insensibilità12. Un’altra metafora ricorrente è quella della pazzia13. Essa può essere usata come una convenzione per comunicare un senso di incomprensione, ma a un livello più profondo esprime anche il rifiuto di capire, che permetteva al parlante/scrivente di attribuire solo a sé il dominio del razionale e di rifiutare la spartizione come un’ aberrazione, scaricando la responsabilità di ammettere qualunque coinvolgimento con la sua ripugnante realtà. Nel romanzo Tamas di Bhīṣmā Sāhnī (1976)14 il personaggio di un nazionalista gandhiano dimostra un entusiasmo per la causa che rasenta l’ossessione e finisce tragicamente. In Topī Śuklā di Rāhī Māsūm Razā15 la pazzia diventa il marcatore del rifiuto di ogni polarizzazione: il protagonista, un hindu amante della lingua e della letteratura urdu e amico di musulmani, finisce per suicidarsi perché incapace di vivere intrappolato in un ambiente dominato da un’ortodossia che diventa fanatismo, da entrambe le parti. Nel racconto più famoso di Maṇṭo, Ṭobā Ṭek Siṃh16, il protagonista è l’emblema dello stato intermedio e della resistenza a identità predefinite. La pazzia è utilizzata in modo sovversivo e nel racconto si scardina la razionalità convenzionale e con essa la comoda ipocrisia per la quale ci si assolve troppo facilmente dalla responsabilità della spartizione: si mette a nudo la fredda “razionalità” all’opera nel processo di formazione dello stato nazionale, con la sua logica del taglia e cuci. La nostalgia è un altro tratto spesso presente nella letteratura sulla spartizione. In generale, la letteratura prodotta nelle regioni più direttamente toccate dalla spartizione (Bengala e Punjab) presenta una sfumatura più marcata di nostalgia per la terra perduta. Nei decenni successivi uno degli esiti della nostalgia come motivo letterario è la romanticizzazione dell’esperienza precedente all’indipendenza, che si presenta con sfumature più o meno evidenti in molte opere. Ciò non necessariamente comporta la perdita della loro validità e specialmente nelle opere più tarde la nostalgia non sempre coincide con un romantico desiderio del tempo perduto. Spesso vi è una chiara consapevolezza delle V. AA.VV. Sa’adat Hasan Manto: Seminar Papers, in “Annual of Urdu Studies” XI (1996). Nel discorso sulla spartizione il termine ‘follia’ compare spesso anche nel discorso ufficiale. I leader nazionalisti spesso dichiaravano che il popolo era impazzito, Gandhi esortava a non rispondere alla pazzia con la pazzia, i giornali usavano profusamente il termine e anche nel discorso comune la spartizione è spesso definita come un periodo di follia collettiva. 14 BH. SĀHNĪ, Tamas, Nayī Dillī, Rājakamal 1986 [trad. ingl. dell’autore: Tamas, New Delhi, Penguin 2001]. 15 R. M. RAZĀ, Topī Śuklā, Dillī, Rājkamal Prakāśan 1969 [tr. it. e cura di C. COSSIO: R. M. RAZA, Topi Shukla, Milano, Cesviet 1992]. 16 S. H. MAṆṪO, Ṭobāteksiṃh, in Maṇṭo kī, cit., pp. 319-325 [trad. inglese di F. W. PRITCHETT disponibile su http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00urdu/tobateksingh/index.html]. 12 13 243 tensioni presenti nella società precedente alla spartizione: per esempio, nei romanzi Aṁdhere band kamre (1961) di Mohan Rākeś17 e Jhūṭā sach (1958-60) di Yaśpāl18 si riesaminano le relazioni hindū-musulmane sullo sfondo della spartizione. Anche Zindagīnāmā (1979) di Kṛṣṇā Sobtī19 è un affresco della realtà antecedente alla spartizione, nel quale la nostalgia serve a illustrare l’irrevocabile frattura con i valori tradizionali provocata dalla spartizione. La tematica di un modo di vivere irrimediabilmente perduto, del passato che non può mai diventare futuro, ricorre anche in molti racconti: si pensi, solo per citarne uno, a Malbe kā mālik di Mohan Rakeś20. Altri autori analizzarono le conseguenze della spartizione attraverso la vita dei profughi, l’esperienza dell’esilio, l’impossibilità di ritornare alle proprie radici: l’esperienza della migrazione e la lotta per rifarsi una vita divennero un nuovo fulcro di interesse letterario. Per esempio, il degrado urbano e le condizioni di vita deprimenti delle baraccopoli di Lahore o della regione di Jalandhar devastata dalla povertà furono rappresentate in Girtī divāreṃ (1947-1996) di Upendranāth Aśk21. Per altri scrittori la spartizione divenne una metafora della divisione comunitarista successiva all’indipendenza (es: Tamas). Smentendo le ottimistiche previsioni dei politici che decisero a favore della spartizione, gli scontri comunitaristi divennero una caratteristica ricorrente dei decenni successivi all’indipendenza: la letteratura sulla spartizione sottolineava come non si fosse imparato nulla dalla lezione della spartizione, come l’incubo fosse ancora presente. La tacita proibizione di fare espliciti riferimenti alle violenze della spartizione cercava di scoraggiare ogni tentativo di fare connessioni fra gli eventi del passato e il presente: ne sono testimonianza le controversie che accompagnarono la realizzazione dello sceneggiato televisivo Tamas di G. Nihalani, tratto dall’omonimo romanzo (1988). Tuttavia, in alcune opere si cerca di sottolineare il contrasto fra la cultura composita del passato e l’epoca presente nella quale si è spezzata la fiducia fra diverse comunità. In Adhā gāṃv di Rāhī Māsūm Razā22 la vita armoniosa di un villaggio 17 M. RĀKEŚ, Aṁdhere band kamre, Naī Dillī, Rājkamal 1961. YAŚPĀL, Jhūṭhā sac. vol I Vatan aur deśa; vol II Deś kā bhaviṣya, Ilāhābād, Lokbhar̄atī prakāśan 1992. Per una presentazione in italiano v. M. OFFREDI, Il romanzo hindī contemporaneo, Roma, Cesviet 1974, pp. 144-164. La Sahitya Akademi ha in preparazione la traduzione inglese col titolo The Colour of Truth. 19 KṛṣṇĀ SOBTĪ, Zindagīnāmā - Zindā rukh, Nayī Dillī, Rājkamal 2003. Per uno studio v. K. ABBI, Discourse of Zindaginama: a semio-anthropological critique, New Delhi, Harman Pub. House, 2002. 20 M. RAKEŚ, Malbe kā mālik, in BH. SĀHNĪ, a cura di, Hindī kahānī saṃgrah, Naī Dillī, Sāhitya Akādemī 1994, pp. 34-43 [trad. it. in M. RAKESH, Il signore delle rovine e altre novelle, a cura di C. COSSIO, Milano, Cesviet 1990; v. anche M. KUNZE MAGRINI, Il padrone delle macerie in “A Oriente!” X (2004), pp. 38-51]. 21 V. A. D. ROCKWELL, Upendranath Ashk: a critical biography, New Delhi, Katha 2004. In italiano: M. OFFREDI, Il romanzo, cit., pp. 100-106. 22 R. M. RAZĀ, Ādhā gāṃv, Dillī, Akṣar Prakāśan 1966 [tr. inglese di G. WRIGHT, The feuding families of village Gangauli, New Delhi, Penguin 1994]. 18 244 prima della spartizione diventa un topos letterario, un regno simbolico contro il quale misurare la frammentazione e la perdita successive. In questo romanzo la nostalgia è innestata nel processo politico che ha privato la gente comune di ogni capacità di azione: le sofferenze degli abitanti del villaggio, infatti, sono effetto di una decisione che non è stata presa da loro. La partenza di un’intera comunità per il Pakistan lascia dietro di sé il vuoto e i pochi musulmani che scelgono di rimanere devono confrontarsi con i nuovi equilibri di potere che emergono nell’India indipendente. Attraverso la descrizione dell’esistenza distrutta di una intera comunità si intensificano lo sconvolgimento e l’angoscia, ma si mettono in luce anche le nuove dinamiche di quei gruppi che cercano di conquistare la fiducia dei musulmani che hanno scelto di rimanere in India per sfruttarla a scopi elettorali o di egemonia localizzata. Infine, un tema rilevante che emerge dalla letteratura sulla spartizione è la condizione dell’esilio. Lo si vede declinato magistralmente nel racconto di Kamleśvar Kitne Pakistān? (1966-67)23. Incentrato sul tema di un amore impossibile tra una ragazza musulmana e un ragazzo hindu, il racconto si snoda come una riflessione sullo sradicamento, l’esilio e l’insorgere della rinnovata violenza comunitarista. La vivisezione del subcontinente diventa una metafora che intreccia abilmente l’evocazione di una ferita psichica con immagini di mutilazione fisica. La metafora della spartizione si ripresenta in continuazione, come una smagliatura nel tessuto del tempo, destabilizzando la presa del narratore sul presente e negando ogni possibilità di riscatto per i protagonisti persi nei meandri della propria psiche. La letteratura sulla spartizione si presenta come una categoria che comprende atteggiamenti e voci molto diversificate: il raggio tematico spazia dagli omicidi e dai rapimenti di massa fino al ritrovamento della memoria e all’esperienza dell’esilio coatto, per arrivare alla considerazione del comunitarismo come un problema che rifiuta di scomparire. E nell’ultimo romanzo di Kamleśvar, che si intitola ancora Kitne Pakistān? (2000, premio Sahitya Akademi 2003)24, la metafora della spartizione si dilata nel cronospazio: il romanzo è strutturato come un processo nel quale uno scrittore, coadiuvato dal Tempo, interroga personaggi-cardine della storia mondiale (da Gilgamesh a Gengis Khan, da Hitler a Mountbatten) che devono rispondere dell’accusa di aver praticato la politica dell’odio e del terrore. La spartizione è metafora della crisi di civiltà, che si manifesta tanto in India quanto in Bosnia. Ma nel romanzo diventa anche metafora delle sperequazioni 23 24 KAMLEŚVAR, Kitne Pākistān?, in Kamleśvar kī śreṣṭh kahāniyāṁ, Dillī, Parāg Prakāśan 1976, pp. 21-37. KAMLEŚVAR, Kitne Pākistān?, Dillī, Rājpāl 2000 [trad. inglese di A. K. ANSARI, Partitions, New Delhi, Penguin Books 2006]. 245 sociali: lo smembramento del corpo dell’uomo primigenio nella tradizione brahmanica è infatti la spartizione che nasce dal sistema castale, strumento di emarginazione e sopraffazione sui dalit tanto dannoso quanto il comunitarismo. Un ultimo tipo di produzione testuale che rientra nella letteratura sulla spartizione, infatti, è rappresentato dalle testimonianze dei sopravvissuti e dei subalterni. Si tratta di un ambito a cavallo tra la letteratura e la storiografia, che cerca di esplorare campi generalmente trascurati dalla prospettiva elitaria dei resoconti sulla spartizione e che negli ultimi decenni ha interessato soprattutto la ricerca sulla sorte toccata a coloro che non si definivano in base a identità connotate per etnia o religione: dalit, donne e bambini.25 25 U. BUTALIA, The other side of silence: Voices from the partition of India, New Delhi, Penguin 1998; S. KAUL, a cura di, The partitions of memory: The afterlife of the division of India, Permanent Black, New Delhi 2001; J. BAGCHI e S. DASGUPTA, a cura di, The trauma and the triumph: Gender and partition in Eastern India, Kolkata, Stree 2003; D. MOOKERJEA-LEONARD, Quarantined: Woman and the Partition, in “Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East”, XXIV, 1 (2004); R. MENON, a cura di, No woman’s land: Women from Pakistan, India and Bangladesh write on the partition of India, New Delhi, Women Unlimited 2004; A.J. KABIR, Gender, memory, trauma: Women’s novels on the partition of India in “Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East” XXV,1 (2005), pp. 177-190; K. PATEL, Torn from the roots: A partition memoir, Kali for Women, Delhi 2006; R. KAUR, Since 1947: Partition narratives among Punjabi migrants of Delhi, OUP, Delhi 2007. 246 LE ‘TAXI DANCERS’ DI SHANGHAI: UNA MISERIA SFOLGORANTE Stefania Stafutti Come un paradiso che affonda nell’inferno1 la Shanghai delle concessioni al calare delle tenebre si veste di “fiammeggiante elettricità”2: la luce pare discrimini tra i vincitori e i vinti, tra le creature delle tenebre e le regine della notte, tra il riso e il pianto, tra il dolore e la gioia, tra la folla e l’individuo, tra la confusione e il silenzio; pare doni splendore a sciami di fanciulle senza nome, per un attimo sotto il fascio dell’occhio di bue: lavorano nei locali notturni della città, non sono prostitute ma che siano “gentili” coi clienti non è certo cosa sgradita ai loro datori di lavoro; le più fortunate, più di mille, offrono la loro perizia nei balli alla moda ai patiti delle danze, nelle dieci sale più alla moda della città: “…russe, cinesi, giapponesi, coreane, euro-asiatiche, occasionalmente di altra nazionalità: sanno ballare e reggono l’alcool. Il grido di battaglia di questo fronte della bottiglia è: “Vun small bottle of wine?” […]”Hey, kid; why don’t you marry the girl?” 3 Una sgraziata espressione inglese le chiama taxi dancers; non c’è di che scandalizzarsi, esistono anche in America! ricorda Emily Hahn, giornalista free-lance e, per qualche tempo, cronista del North China Daily News di Shanghai. La bella amante americana del bellissimo Shao Xunmei (邵郇美), poeta 1 MU SHIYING, Shanghai de hubuwu. Yi ge duanpian (上海的狐步舞。一个断片, Fox-trot di Shanghai. Un frammento, 1933), in ID., Mu Shiying xiaoshuo quanbian (穆时英小说全编, Mu Shiying. Opere complete), Shanghai, Shulin chubanshe, 1977. Questa definizione della città è posta in apertura e in chiusura del racconto e ben si accorda con la celebre definizione di un missionario, secondo il quale, Iddio,. avendo creato Shanghai, Iddio avrebbe dovuto mostrare indulgenza verso Sodoma e Gomorra. Cfr. PAN LING, In Search of Old Shanghai, Hong Kong, Joint Publishing Co., 1982, p. 1. 2 All About Shanghai A Standard Guidebook With An Introduction By H.J. Lethbridge, Hong Kong, Oxford, New York, Oxford University Press, ristampa anastatica del volume pubblicato dalla University Press, Shanghai, 1934-1935, senza data, comparsa a Hong Kong per i tipi della Oxford University Press (China); la ristampa riporta anche alcune indicazioni presenti sulla stampa “ufficiale” del volume (Oxford University Press, New York, 1983), dove si afferma tra l’altro che non è stato possibile rintracciare gli originari depositari dei diritti. 3 Ivi., p. 3. 247 ricco di talento e di quattrini, non si interessa troppo delle miserie nascoste dietro ai sorrisi di ordinanza delle ragazze, ma almeno offre un quadro di prima mano, vivo e credibile, di come funzionano le cose: “Uno degli aspetti più pubblicizzati della vita notturna di Shanghai erano i ‘balli-taxi’. Abbiamo anche noi in America la stessa cosa, a Broadway, ma con una sostanziale differenza. A Shanghai le sale da ballo sono enormi e nelle migliori, prima o poi, finiscono per capitarci tutti. Non è obbligatorio per i clienti richiedere le ballerine, ma costoro costituiscono una attrazione molto importante. I Cinesi guardano alle ragazze migliori con lo stesso atteggiamento riservato alle cantanti assoldate come intrattenitrici per i banchetti; è lo stesso atteggiamento che abbiamo noi nei confronti delle stelle delle nostre commedie musicali. Ogni sala da ballo ha la sua Ragazza Numero Uno e solo a un principiante assoluto potrebbe venire in mente di corrisponderle un unico biglietto per un giro di ballo. Il comportamento corretto prevede che le vengano offerti carnet e carnet di biglietti o che si paghino profumatamente i gestori per ottenere il privilegio della sua compagnia al proprio tavolo per una mezz’oretta. Così si diventa popolari, tanto agli occhi della ragazza che presso i proprietari. I giornalisti dei fogli scandalistici osservano famelici il mercato e ne danno conto quotidianamente: “ “Chi ha regalato un anello di giada a Bellezza Hongkonghese? La risposta non è lontana dall’Hotel Majestic4”5. La vita delle dancing girls è probabilmente meno divertente di quanto immagini la ardita Emily; i cinesi le chiamano le ragazze “molleggiate”, danxing nühai (弹性女孩),6 secondo un geniale calco fonetico-semantico operato sull’inglese da qualche spirito fantasioso. Tra il popolino sono “quelle che valgono meno dei granchi”: nei locali meno eleganti, un carnet di inviti per dieci o undici giri di danza costa uno yuan e le brave massaie sanno che, con quella cifra, al mercato, si spuntano al massimo 7 o 8 granchi7. La 4 L’hotel è costruito nel 1911 e già demolito nel 1933, per fare posto a un’altra costruzione con la stessa destinazione d’uso. La sala del "Vienna” troverà spazio proprio sul terreno lasciato libero dal primo edificio dell’Hotel Grande Cina”; cfr. ZHENG SHILING, Shanghai jindai jianzhu fengge/ The Evolution of Shanghai Architecture in Modern Times (上海金代建筑风格, L’architettura moderna a Shanghai/The Evolution….), Shanghai, Shanghai jiaoyu chubanshe, 1999 p.354, e GAO FUJING (高福进), “Yang yule”de liuru. Jindai Shanghai de wenhua yule ye (「洋娱乐」的流入.近代上海的文化娱乐业). L’arrivo dei “divertimenti stranieri”. L’industria del divertimento nella Shanghai moderna), Shanghai, Shanghai Renmin chubanshe, 2003, p. 83. 5 E. HAHN, China to Me, Doubleday, Doran et Co., Garden City, New York, 1944, pp.74-75. 6 CHENG NAISHANG, Danxing nühai, (弹性女孩), in “Shanghai wenxue”, n.7, 2002. Il saggio sarà ripreso in Shanghai Lady (上海 Lady / Le lady di Shanghai), Shanghai, Wenhui chubanshe, 2003. 7 DAI YUNYUN (戴云云), Shanghai xiaojie (上海小姐, Le signorine di Shanghai), Shanghai, Shanghai Huabao chubanshe, 1999, p. 93. 248 lingua tagliente non sempre impedisce loro di coltivare il sogno di quel lusso posticcio anche per le proprie figliole. Così nella pellicola Shanghai vecchia e nuova (Xin jiu Shanghai, 新旧上海, 1936), una madre un poco inetta si lamenta che la sua bimba dodicenne sia troppo giovane per intraprendere quel mestiere, e i circostanti, che pure ci tengono ad essere considerati persone per bene, non si scandalizzano affatto del suo rincrescimento. Una sola osservazione: sono tempi di magra e forse non riuscirebbe a rimediare neanche uno yuan al giorno. Ragazze di città in cerca di facile fortuna, dunque, ma anche giovani arrivate di fresco dalla campagna, fuggite dalla fame e dalla incertezza politica delle regioni più settentrionali, o vendute come persone di fatica a qualche ricco cittadino e speranzose di migliorare il proprio destino, attricette in attesa di tempi migliori, ma anche commesse, impiegate e studentesse. Sono sottile e graziose, sinuose e sensuali nei loro qipao (旗袍) attillati, dal collo rigido e gli ampi spacchi laterali; nessuno ha più voglia di ricordare che le profonde aperture sui fianchi di questi abiti erano nate al volgere del secolo come segno di indipendenza delle prime studentesse e a imitazione delle lunghe palandrane maschili, indossate sopra un calzone. Gli anni Venti ne sanciranno il trionfo, facendone ua sorta di divisa del fascino e della seduzione. I sarti di grido li accostano alle proprie rivisitazioni della moda occidentale e volentieri fanno delle regine delle sale da ballo le loro effimere modelle; in cambio ne ricevono sicura pubblicità8. Loro paiono sempre impeccabili: hanno trucco accurato e “sopraccigli di falena” artatamente sottili, unghie dipinte con l’Onglex, come suggeriscono le riviste alla moda, acconciatura perfetta, qualche volta un poco azzardata, lunghi pendenti che oscillano al ritmo delle danze; le più fortunate si permettono “Acqua di Florida” al sentore di talco, Soir de Paris9 dalla elegante confezione e saponi alla moda dai profumi raffinati. Fumano molto e non hanno che l’imbarazzo della scelta: ragazze belle come loro, talvolta succintamente abbigliate,10 occhieggiano dai calendari pubblicitari realizzati Una funzione fondamentale nel lancio delle grandi sartorie era esercitata naturalmente dal cinema e dalle sue dive. L’abito indossato da Hu Die (胡蝶) nel corso della cerimonia che, nel 1933, la incoronava “regina dello schermo”, fu copiato e riadattato da migliaia di “signorine di Shanghai”. Era stato realizzato nella prima sartoria di “stile occidentale” della città, aperta nel 1917 da Hong Xiang (鸿翔), che aveva studiato taglio a Harbin, dove più forte era la influenza della moda occidentale, proveniente dalla vicina Russia. La “Sartoria Hong Xiang”, i cui primi laboratori erano situati in uno shikumen (石库门) su Nanjing lu, serviva tutte le signore più in vista della città; tra di loro, le bellissime sorelle Song Qinling (宋庆龄) e Song Meiling (宋美岭) rispettivamente mogli di Sun Yat-sen (Sun Zhongshan, 孙中山) e di Chiang-kai-shek (Jiang Jieshi, 蒋介石). Cfr. QIU CHUJI (邱处机), Modeng suiyue/Reminscences (sic!) of Shanghai (摩登岁月, Tempi Moderni/ Reminiscences of Shanghai), Shanghai, Shanghai huabao chubanshe, 1999, p.231-236. 9 Questo ultimo, con il nome cinese di Ye Bali (夜巴黎), compare sul mercato all’inizio degli anni Quaranta. 10 ZHANG YANFENG (張燕風), Lao yuefenpai guanggao shu (老月份牌廣告書, Vecchi calendari pubblicitari), Taibei, Hansheng, 1994, p.84-85. 8 249 negli studi di grafici di successo, colorati e accattivanti, una vera mania di quegli anni, e suggeriscono le marche più diverse: Shillings, Hatamen, White Horse, Golf, Foot Ball, Liberty, Gold Crane, Victory, Pirate o forse Ruby Queen, Belle of China, My Dear11. Un esercito calzato di scarpe dai tacchi arditi, ineludibile tributo a una moda di importazione, attraversa lievemente impettito la linea che separa le abitazioni dalla città dei ricchi e degli stranieri, dove i cinesi non danarosi potevano lavorare ma non risiedere, e si lascia alle spalle tuguri maleodoranti senza acqua corrente né servizi igienici, vicoli malsicuri nelle zone a ovest della metropoli, che gli stranieri hanno ribattezzato badlands, soffitte fredde e anguste come qulle impresse nella nostra memoria grazie a classici ella cinematografia cinese come Angeli della strada12 (Malu tianshi, 马路天使, 1937). Facilmente possiamo immaginare che, a ranghi sciolti, l’esercito proceda, forse stanco, forse triste, forse ticchettando sul selciato il tempo di un motivo alla moda: In tutto il mondo le ragazze canticchiano, con lo struggimento di chi ritrova nella strofa di una canzonetta un poco della propria storia: “Shanghai notturna, Shanghai notturna, città che non conosce la notte, le luci si accendono, la musica risuona, ovunque danze e canzoni., non è il vino che inebria, ciascuno è comunque ubriaco. …. E lei sorride affabile, nessuno conosce 11 Il nome cinese di questa marca di sigarette è un esempio felice di “gioco di parole”, applicato alla pubblicità. Il “My” inglese è reso foneticamente con mei, che significa “bello”; la traduzione cinese sfrutta poi l’assonanza tra dear e deer, per cui il nome in cinese diventerà “Il bel cerbiatto” (Mei lu, 美鹿). Proprio le My Dear affidano alla rivista di satira e fumetti Manhua shenghuo (漫画生活) una campagna pubblicitaria a colori di grande effetto e di notevole qualità grafica, che bene si presta a qualche considerazione sulla contradditorietà dei messaggi pubblicitari affidati all’immagine femminile. Accanto a compagnie che promuovono campagne pubblicitarie basate sulla immagine di di “bellezze cinesi” che di cinese hanno ben poco, poiché il loro aspetto richiama piuttosto la prorompente fisicità delle pin-up americane, in altri casi, come accade per le My Dear, una sorta di ambiguo puritanesimo in chiave di “difesa della morale nazionale” non rinuncia all’utilizzo del corpo della donna in chiave seduttiva, ma affida l’effetto di “rottura” del proprio messaggio promozionale direttamente a una prosperosa bellezza occidentale, dall’aspetto “peccaminoso”, modellata sul prototipo fisico della attrici americane, mollemente sdraiata, corpo nudo e tornito e seni al vento. Queste immagini “forti” e di sicuro impatto si alternano, con cadenza settimanale pressoché regolare, con immagini muliebri rassicuranti, mutuate dalla tradizione iconografica della Cina classica, in una sorta di meditata operazione di “riequilirio” del messaggio, nel quale male si inseriscono, peraltro, le sigarette occidentali. 12 Il film, scritto e girato da Yuan Muzhi (袁牧之, 1909-1978), ha per protagonisti Zhao Dan (赵丹, 19151980) e Zhou Xuan (周璇, 1918 o 1920-1957). 250 le pene del suo cuore…..”13 La cinematografia e la letteratura dell’epoca ci ricordano come queste giovani donne sognassero spesso un matrimonio di convenienza che le sottraesse per sempre alla miseria, mentre bruciavano la propria esistenza in una vita sregolata e ineluttabilmente senza speranza, comparse di un mondo di lusso che non era il loro, stremate dal consumo di alcool cui erano costrette, per fare lievitare il conto dei loro clienti e trarne eventualmente una percentuale di guadagno. Ancora una volta, le canzonette dell’epoca testimoniano come per queste donne bere fosse un lavoro, non un piacere e come l’alcool bruciasse in uno stomaco troppo vuoto: “dopo questo bicchiere, fai portare qualche piccola cosa da mangiare, è dura passare la vita a ubriacarsi…”14 Dalle manchette pubblicitarie, dalle riviste, sotto il lampo del fulmicotone, le “signorine di Shanghai” (Shanghai xiaojie, 上海小姐) offrono reiteratamente il loro sorriso. Anche la rappresentazione fotografica di queste ragazze sulla stampa popolare e sulle riviste alla moda segue una regola costante: la tristezza, la miseria, l’imbruttimento sono ricacciati dove la luce non arriva, “di notte, sono tutte belle ed eleganti le ragazze di Shanghai, di notte hanno tutte la grazia degli angeli.”15 Mu Shiying (穆时英, 1912-1940) le conosce bene: tra gli scrittori di quegli anni, meglio di altri ha catturato l’avvicendarsi sincopato del buio e della luce nella città, nel destino e nell’anima dei suoi abitanti. Ama Shanghai di una passione senza riserve, si perde nella vertigine del suo abbraccio, ma avverte il pericolo e il prezzo di quella malìa, e il fulgore delle sue serate danzanti è attraversato da strette repentine di dolore cupo, il buio dei suoi vicoli è lacerato da bagliori di morte. Descrive “frammenti” di vite, come recita il titolo di uno dei suoi racconti più famosi, che, cuciti insieme, nelle notti di Sono le parole di Ye Shanghai (夜上海, Shanghai notturna, 1947), come altre canzoni di quegli anni portata al successo dalla acclamatissima Zhou Xuan, “ugola d’oro” (jin sanzi, 金嗓子); la partitura è di Chen Geqin (陈歌辛, 1914-1961, pseudonimo Lin Mei, 林枚), l’autore di musica “leggera” più significativo degli anni Trenta-Quaranta. Cfr. CHENG GANG (陈钢), Shanghai laoge ming dian, (上海老歌名典, Dizionario delle canzoni famose della vecchia Shanghai), Shanghai, Shanghai Cishu chubanshe, 2002. 14 Un decennio prima di Ye Shanghai, Zhou Xuan ha lanciato un’altra canzone di tema analogo e di grande efficacia espressiva; il titolo porta tracce di eleganza letteraria: “Quando tornerà il mio signore?” (He ri jun zai lai, 何日君再来): una giovane donna si intrattiene con l’ avventore, ma pensa all’amato lontano e tenta di schermirsi da troppo abbondanti libagioni; una voce maschile, in una sorta di efficace “fuoricampo”, la esorta con modi spicci: “Forza, forza, ancora un brindisi!”. Come spesso accadeva, la canzone nasce come parte della colonna sonora di un film, Sanxing ban yue (三星伴月, “Tre stelle e mezza luna”), del quale la stessa Zhou Xuan è protagonista. Ivi., p. 28. 15 YANG JIANHUA (杨剑华), “Shanghai zhi ye” (上海之夜, Le notti di Shanghai), in Shanhu (珊瑚, Corallo), n.17, 1933. 13 251 Shanghai, al ritmo di balli alla moda, fissano sulla pagina destini individuali spesso sorpresi nella stanchezza di una consunta e faticosa quotidianità: Aveva una ciocca di fiori bianchi appuntati alle tempie. Quando si è girata, mi è apparso un volto affilato, con un naso ben disegnato, occhi grandi e sopracciglia arcuate che scomparivano sotto ciocche di fiori. Lunghe ciglia e labbra morbide, quasi burrose. Due pendenti in forma di torri di giada le sfioravano le spalle: era acconciata alla spagnola! Ma non era questo che mi attraeva: mi piacevano il modo in cui stava seduta, l’aria stanca con cui si poggiava al tavolino, reggendosi il mento, e le crocchie di fiori alle tempie, pallenti e sciupate. Perché anch’io giaccio abbandonato, col fiato corto, dentro il torrente in piena della vita.”16 Il fiato corto: è come se anche la città avvertisse di avere le ore contate. Più di tre milioni e mezzo di individui, pochi i privilegiati, concentrati nelle aree delle concessioni straniere17, dove sembra concentrarsi anche lo sforzo di tenere lontano il mondo, con le inquietudini emerse dopo la fine della Grande Guerra18. Tra il 1925 e il 1927 la città è scossa da scioperi imponenti; i numeri della protesta sono impressionanti, ci sono morti, feriti, arrestati. I 40.000 operai tessili della giapponese Naigai Waita Kaisha, incro- 16 MU SHIYING (穆时英), Hei mudan (黑牡丹, Peonia nera), in ID., Mu Shiying xiaoshuo quanbian (穆时英小说全编, Mu Shiying. Opere complete), Shanghai, Shulin chubanshe, 1977, p.281. Il racconto è scritto nel 1933 e riecheggia nel titolo un film assai famoso, Genü Hong mudan (歌女红牡丹, La cantante Peonia rossa), interpretato dalla celeberrima Hu Die (胡蝶). È la prima pellicola sonora, prodotta in Cina dalla compagnia Ming Xing (明星影片公司), in collaborazione con la Pathé (百代) cinese (per l’occasione le due compagnie fondano una nuova società, la Bai ming feng 百明风), e viene proiettato per la prima volta a Shanghai, nel Nuovo Lux (新光大戏院), il 15 marzo 1931. È probabile che Mu Shiying, grande appassionato di cinema, mentre scriveva il racconto non avesse dimenticato il film. 17 Shanghai conosce il suo momento di massimo splendore dalla metà degli anni Venti alla fine degli anni Trenta. Nel 1936 è una città vivacissima e molto popolosa. Per quanto attiene al numero degli abitanti, le fonti forniscono cifre talvolta discordanti; uno studio cinese piuttosto affidabile descrive una metropoli abitata nel 1936 da oltre tre milioni e mezzo di individui; nelle due concessioni più estese e popolose, quella internazionale e quella francese, tra il 1935 e il 1936 abitano rispettivamente 38.915 e 23.398 stranieri, il cui numero è destinato ad aumentare fino ai primi anni Quaranta (sono 150.931 nel 1942); essi sono divisi secondo 23 principali nazioni di appartenenza. La presenza italiana è di 199 unità nella concessione francese (1936) e di 212 unità in quella internazionale (1935). Cfr. ZOU YIREN (邹依仁), Jiu Shanghai renkou bianqian de yanjiu (旧上海人口变迁的研究, Studi sulle trasformazioni demografiche nella vecchia Shanghai), Shanghai, Shanghai Renmin chubanshe, 1980. Informazioni molto attendibili sulla situazione demografica all’interno delle concessioni sono desumibili dalla Shanghai Municipal Gazzette, organo ufficiale del Shanghai Municipal Council, che riporta regolarmente i risultati dei censimenti all’interno delle concessioni. 18 Secondo alcuni studiosi la Grande Guerra ha un impatto positivo sulla economia della città, le cui industrie producono i beni che in Europa, particolarmente in Francia e in Inghilterra, la contingenza bellica impediva di produrre. 252 ciano le braccia per la prima volta nel 1925. I rapporti della polizia dell’International Settlement sono lividi e rabbiosi: “L’estensione dello sciopero è stata condizionata dalla propaganda, dall’intimidazione, dal furto e dal ricatto. La propaganda è stata onnipervasiva, capillare e priva di scrupoli. Una volta presa la decisione di scendere in sciopero, materiale dal contenuto oltraggioso, in cui gli stranieri erano dipinti come “desperados”19, assassini e mostri, e i Cinesi che lavorano per loro erano trattati da schiavi, cornuti [!] e rettili sono state affissi su ogni sorta di tabellone improvvisato, su porte e serrande dei negozi chiusi. Spesso sono stati anche distribuiti volantini scritti in tutto o in parte in inglese: in uno di essi si denunciavano le forze di polizia come “prostitute spregevoli e creature degenerate, disoneste e senza scrupoli della peggiore specie”. […] Resta comunque assai dubbio che la propaganda avrebbe potuto sortire qualche effetto, se non fosse stata accompagnata dall’intimidazione. Subito dopo l’inizio degli scioperi, gli agitatori hanno aperto una decina di uffici sul territorio cinese […] Da questi rifugi sicuri gli agitatori anti-stranieri hanno intimidito decine di migliaia di persone, che avrebbero voluto vivere in buona armonia con i loro datori di lavoro, e li hanno costretti a partecipare agli scioperi… Essi avevano assunto le seguenti risoluzioni: 1) che tutte le banconote di emissione straniera siano boicottate; 2) che i Cinesi ritirino i loro depositi dalle banche straniere; 3)che il controllo della Polizia Municipale passi nelle mani dei Cinesi; 4) che le navi da guerra straniere lascino lo Huangpu; 5) che siano immediatamente liberati gli studenti e i lavoratori trattenuti dalla Polizia; 6) che i colpevoli dell’assassinio degli studenti e degli operai siano assicurati alla giustizia e che sia fissato un indennizzo; 7) che sia riconosciuto il diritto di sciopero; 8) che nelle fabbriche siano vietati i maltrattamenti ai lavoratori; 9) che siano migliorate le condizioni igieniche degli stabilimenti; 10) che sia proibita ogni forma di crudeltà contro i lavoratori minori e le donne; 11) che sia abolito il controllo nelle fabbriche da parte della polizia straniera (indiana?); 12) che vengano rifiutate le proposte di legge delle Autorità del Settlement relative alla libertà di stampa, all’ aumento dei diritti sulle banchine portuali, e alle autorizzazioni per gli scambi azionari.”20 Con buona pace della Ppolizia delle concessioni straniere, i manifestanti diventeranno 600-800.000 nel grande sciopero generale del 1927. Andrè Malraux, affacciandosi sul mare di dimostranti che pare ricongiungersi col 19 20 Si è mantenuta la espressione usata nel testo originale. Annual Report of the Shanghai Municipality Council, 1925, pp.66-67. 253 fiume, alle 11 del mattino di un memorabile 22 marzo, li descrive raggruppati a migliaia, in piedi o accovacciati sui marciapiedi, in un disordine fitto e teso nel quale si mescolano altre migliaia di marinai, con le loro divise blu, i loro striscioni e le loro bandiere21. 115 giorni consecutivi di sciopero, alla fine dello stesso anno, per 7000 lavoratori della British American Tabacco, che, non a caso, impiegava moltissime donne. Con l’inizio del 1932 i Giapponesi incomberanno appena oltre i fragili confini delle concessioni; nel 1937 assumeranno il controllo di tutta la città. Ma, al calare della notte, Shanghai, balla. Per consolarsi, per stordirsi, per dimenticare, per non vedere. E tanto basta. Gli occhi che si schiudono sulla città nella notte, abbasseranno le palpebre al primo annuncio di luce: “…demoniaci,, innumerevoli […]: occhi sensuali e concupiscenti dalle sale da ballo, occhi di mosca, come mascheroni bestiali di taotie, dai grandi magazzini, occhi ebbri e scanzonati dalla “Birreria”, occhi consumati e ingannatori dai saloni di bellezza, occhi mobili, intimi e caldi dalle case di lusso, occhi ipocriti di dottrina dalle chiese, occhi triangolari, traditori e menzogneri dai cinematografi, occhi annebbiati e sonnolenti dai ristoranti. Occhi di pesca, occhi di lago, occhi azzurri,, pupille su cui scorre il panorama della città: ritta in un angolo scuro della via, la prostituta scruta con occhi di topo […] un giovane poliziotto indiano della pattuglia di ronda…”22 Con le viscere esposte alla cecità delle tenebre, mescolando culture, lingue, costumi, bisogni, interessi, Shanghai pulsa in una pantagruelica e un poco immonda digestione, per ricomporsi livida all’alba. Il buio occulta ciò che sarebbe indecente vedere. Al di sopra e lontano dai miasmi, i vincenti o le loro controfigure sono bene esposti alla luce. Insieme con le belle donne e spesso ad esse direttamente o indirettamente associata, la luce, l’elettricità, è uno dei paradigmi simbolici della modernità. Essa ricama i contorni di una città lontana e ostile per gli esclusi, come nella scena del memorabile di Shennü (神女, La divina, 1934): la madre (Ruan Lingyu, 阮玲玉, 1910-1935), prostituta per miseria e disperazione, stringe alle spalle il figlioletto ignaro. Dall’angusto abbaino guardano alla città punteggiata di insegne e di festoni luminosi: “Non fa per noi, qui non ci vogliono, partiamo, andiamo dove nessuno ci conosce”; di giorno la città perbenista stigmatizza la sua condotta “immorale” e costringe suo figlio a lasciare la scuola. Ma di notte, una folla gaudente si sottrae al buio per offrirsi alla 21 A. MALRAUX, La conditione humaine; ed. it. La condizione umana, Milano, Mondadori, 2002, p. 87 (prima edizione, Bompiani, 1934) 22 MU SHIYING (穆时英), Pierrot, in ID., Mu Shiying xiaoshuo quanbian, cit. p. 412. 254 apparente spensieratezza delle ragazze più o meno in vendita nelle sale da ballo, cedendo al sortilegio dell’elettricità: dita guantate di neon si allungano a tracciare i caratteri di mille insegne contro il cielo color dell’inchiostro.23 Le insegne luminose irrompono nel nero della notte come nei racconti, con passaggi narrativi rapidi come fotogrammi, che molto debbono al cinema e alle suggestioni della letteratura straniera. In Mu Shiying, un gentiluomo in frac rosso si materializza inatteso. Parrebbe un personaggio del suo racconto: brandendo il bastone da passeggio, interrompe deciso la traiettoria di un’ automobile confusa da un bacio galeotto: ai suoi piedi, la scritta luminosa “Johnny Walker: Still Going Strong”24. Una donna elegante ma irrimediabilmente subalterna dentro alla vettura di moda, un wiskey straniero evocato lungo la via. In questo come in molti altri racconti pare che le insegne chiamino a distogliere gli sguardi dalle cose quotidiane e a puntarli verso il cielo. Mu Shiying, pur lontano da ogni sentimento religioso, nella sua sofferta fascinazione per la propria città e le sue donne, alle insegne sfolgoranti contrapporrà qui le sagome delle chiese inginocchiate e nascoste nel buio. Gli paiono ingombranti creature in preghiera, ripiegate sul baratro dell’inferno a chiedere perdono di quel collettivo peccato25. Ma i luoghi di culto sono parte di un panorama “esotico”, in fondo estraneo, e probabilmente per questo la loro forza simbolica non è sufficiente a sollecitare le coscienze. In qualche misura, anche le “belle” di Shanghai, apparentemente disinvolte e agghindate all’occidentale, partecipano dello stesso “esotismo”, partecipano di un paradigma di modernità di sapore occidentale di cui adottano solo le forme esteriori. Nella città parata a festa si consuma uno dei riti più feroci della modernità: essa offre in prestito travestimenti ingannevoli, e per un attimo concede a fragili comparse i panni dei protagonisti. Ma quei panni li esige subito indietro; incurante e inesorabile, macina il destino individuale dei più deboli, protetta dalla folla e dal rumore. I personaggi della finzione letteraria sono la esemplificazione di individui reali: gli amanti alla moda di Mu Shiying, gli imprenditori di Mao Dun, le dark ladies di Liu Na’ou (刘呐鸥, 1900-1939), le ragazzine torbide di Ye Lingfeng (叶灵风, 1905-1975), nei loro incontri al ristorante, durante le feste danzanti, lungo i viali dei parchi o ai tavoli del night-club, sfiorano corpi e destini simili a quello di Shu Meili (殳美丽), giovane donna protagonista per un attimo della cronaca di quei giorni, di grazia gentile, quasi dimessa. Ballava a pagamento al Gran Palais (Wei gong, 伟宫), ma la foto che ne acMU SHIYING (穆时英), Shanghai de hubuwu. Yi ge duanpian (上海的狐步舞。一个断片, Fox-trot di Shanghai. Un frammento), in ID., Mu Shiying xiaoshuo quanbian, cit. p.237. 24 Ibid. 25 Ibid. 23 255 compagna il necrologio, sulle pagine della rivista Dedicata alle piste da ballo26, ricorda piuttosto una studentessa: la scriminatura laterale, i capelli ravviati all’indietro, lo sguardo quieto, il sorriso accennato. Shu Meili si è uccisa per amore, né la riporterà in vita la retorica accorata e rabbiosa dell’amica: “erano tutte in lacrime e con discrezione ho domandato che cosa fosse successo. Shu Meili, che tutti conoscevamo per il suo carattere franco e coraggioso, non era più tra di noi… .Mi hanno detto che è stato per amore, e perché ultimamente non guadagnava più molto: i litigi con la madre, a casa, la opprimevano. E poi per colpa di quel cliente, Xu Hanzhan, che l’aveva presa in giro. Dovevano sposarsi ma, alla fine, a lui era stata presentata una del suo ambiente, e aveva fissato le nozze con lei. La signorina Shu era venuta in qualche modo a saperlo. Quel matrimonio mancato l’aveva profondamente prostrata e delusa: non le rimaneva che farla finita. Anche se a nessuno è dato di sfuggire alla morte, credo che la fine della signorina Shu non sia degna di lei. Non sapete quanti ne girano di uomini come Xu Hanzhan, nel mondo delle sale da ballo, che usano la lusinga dei quattrini e le parole dolci per aggirare la fragile volontà delle ragazze! Sorelle! Dobbiamo essere unite e combattere questi demoni malvagi, spuntare ad una ad una le loro subdole armi…”27 Oggi, le fotografie sbiadite di queste protagoniste della Shanghai notturna riempiono decine di pubblicazioni: per molti anni, dopo il 1949, la città aveva dovuto vergognarsi di quelle notti rutilanti di luci e di eventi, le sue canzoni avevano perso ogni innocenza per diventare capi d’accusa inoppugnabili contro una classe dirigente frettolosamente identificata in toto con la “borghesia compradora” compromessa con il capitalismo straniero, segnata dalla stigmate del tradimento della nazione, cui non si riconosceva alcun merito. Per contro, a partire dai primi anni Novanta del XX secolo, nella sua rinnovata corsa verso la “modernità” la città ricerca la propria, peculiare identità proprio riandando a quei giorni: ne conosce i lati oscuri, ma ne celebra soprattutto i fasti e le luminarie. Con una rivisiazione della storia segnata da nuove ambiguità e storture ideologiche, di segno diametralmente opposto a quelle della “Cina comunista”, molte pubblicazioni cinesi più o meno scientificamente fondate guardano alle esili danzatrici a pagamento con un sorriso troppo indulgente. È una nostalgia malandrina, che 26 Wei gong wunü Shi Meili zi sha (伟公舞女殳美丽自杀, Si suicida Shi Meili, danzatrice del Grand Palais), in “Wuchang texie” (舞场特写), n.2, 1939 (10 luglio). 27 L’articolo è firmato dalla “signora Xiaoman” (Xiaoman xiaojie, 小曼女士), della quale non è indicato il cognome; segnalo la coincidenza con il nome personale della bellissima, mondana e chiacchierata Lu Xiaoman, 陆小曼, seconda moglie del grande poeta Xu Zhimo, 徐志摩, 1897-1932), all’epoca già scomparso in un incidente aereo. 256 suscita disagio e sfiora i fenomeni senza avere il coraggio di aguzzare lo sguardo; è una fascinazione troppo acritica nei confronti della modernità che, nella Cina di oggi, non si limita alla ricostruzione della memoria recente di Shanghai. 257 METALINGUAGGIO, TRADUZIONE E IL ‘RAFFREDDAMENTO’ DELLA TERMINOLOGIA* Mario Squartini Sylvain Auroux in un’appendice al primo volume della ricchissima Histoire des idées linguistiques1 propone di distinguere tra terminologia metalinguistica ‘fredda’ (terminologie froide, figée) e ‘calda’ (terminologie chaude), ipotizzando che la prima possa derivare diacronicamente da una specializzazione tecnicistica della seconda. Qui Auroux si riferisce alla fase aurorale della riflessione metalinguistica (il volume si intitola infatti La naissance des métalangages. En Orient et en Occident) lasciando intendere che la primissima terminologia sumero-accadica o quella sanscrita possano essere fatte verosimilmente derivare dalla specializzazione di termini ancora connessi con i processi connotativi del linguaggio ordinario. Dovetto2 ha già applicato la proposta di Auroux all’evoluzione diacronica della terminologia fonetica italiana in epoca ‘prescientifica’ (dal XVI secolo agli inizi dell’Ottocento) confermandone la pregnanza esplicativa nell’ambito della storia della linguistica. In questo mio contributo intendo mostrare come la distinzione proposta da Auroux possa essere applicata anche a fasi storiche più avanzate, in particolare alla seconda metà del XIX secolo, un periodo che nella storia della linguistica rappresenta il momento più intenso di specializzazione accademica attraverso l’istituzione di cattedre universitarie in molti atenei europei3. Alla fine del secolo il riconoscimento accademico della disciplina vieDesidero ringraziare quelle studentesse e quegli studenti della Facoltà di Lingue e Letterature straniere di Torino che con la loro attenta partecipazione al corso monografico Terminologia tecnica e traduzione nella linguistica tra Ottocento e Novecento (laurea specialistica in Traduzione, a.a. 2005/06) mi hanno spinto ad approfondire le ricerche sulla storia della terminologia tempo-aspettuale. 1 S. AUROUX, Les terminologies métalinguistiques, in ID. (a cura di), Histoire des idées linguistiques. 1. La naissance des métalangages. En Orient et en Occident, Liège / Bruxelles, Mardaga, 1989, p. 465. 2 F. M. DOVETTO, Terminologia ‘calda’ e terminologia ‘fredda’: alcune caratteristiche della costituzione del lessico italiano della fonetica, in C. VALLINI (a cura di), Le parole per le parole. I logonimi nelle lingue e nel metalinguaggio. Roma, Il Calamo, 2000. 3 Il nesso tra riconoscimento accademico e ‘scientificizzazione’ della disciplina è stato soprattutto messo in evidenza da A. MORPURGO DAVIES, La linguistica dell’Ottocento, in G.C. LEPSCHY (a cura di), Storia della linguistica, Bologna, il Mulino, III, 1994, pp. 11-22. * 258 ne segnalato dalla compilazione di opere enciclopediche di grande respiro (i Grundrisse dei Neogrammatici), che rappresentano dei punti di riferimento importanti anche come sistematizzazione terminologica. Ed è proprio in questa fase di canonizzazione della terminologia che mi pare si possa osservare un moderno esempio di competizione tra termini ‘caldi’ e ‘freddi’. Per sostanziare questa ipotesi mi occuperò di un ambito terminologico molto ristretto, quello connesso alla descrizione semantica dei tempi verbali e alla ‘scoperta’ della nozione di aspetto del verbo4, il cui carattere paradigmatico in questa fase della storia della terminologia è stato già messo in evidenza da Samain5. La competizione terminologica che intendo mettere in luce si concluderà con una sostanziale sconfitta della terminologia calda a favore di una terminologia più tecnica. Il prestigio della sistematizzazione operata dai Neogrammatici rappresenta sicuramente il fattore decisivo in questa partita, ma ciò che vorrei soprattutto mettere in evidenza è l’influenza delle pratiche traduttive in questo processo di tecnicizzazione della terminologia6. 1. La terminologia ‘calda’ di Curtius Come nota Berrettoni7, la nozione di aspetto verbale viene percepita dai linguisti della seconda metà dell’Ottocento come il frutto di una vera e propria ‘scoperta scientifica’ (in senso kuhniano), che in quanto tale assurgerà a sistematizzazione paradigmatica per l’intervento degli Junggrammatiker nei Grundrisse di fine secolo e in diversi articoli usciti a partire dal 1896 sulla rivista Indogermanische Forschungen. I Neogrammatici attribuiscono la ‘scoperta’ alla pubblicazione della Griechische Schulgrammatik di Georg Curtius8, uno dei loro maestri poi polemicamente rinnegato. Del resto è Curtius stesso a notare come la distinzione tra Zeitstufe e Zeitart abbia prodotto 4 P. BERRETTONI, Alcuni presupposti epistemologici della scoperta dell’aspetto verbale, in “Quaderni dell’Istituto di Glottologia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti”, II (1990), pp. 5-34 [ripubblicato in ID., Atene e Lipsia. Saggi di storiografia del pensiero grammaticale, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997, pp. 205-232]. 5 D. SAMAIN, La construction du métalangage dans le premier tiers du XXe siècle, in S. AUROUX (a cura di), History of Linguistics 1999, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2003, pp. 349-362. 6 In ciò che segue mi dedicherò soprattutto alla traduzione di terminologia tecnica dal tedesco all’inglese, mentre altrove ho già analizzato le traduzioni italiane e spagnole degli stessi termini (M. SQUARTINI, Durativo o imperfettivo? Per una storia della terminologia aspettuale in Italia, in E. Soletti (a cura di), Pensieri e parole del Novecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, in stampa; ID., ¿Zeitart, Aktionsart o matiz de la acción? Cuestiones terminológicas del siglo diecinueve, relazione presentata al seminario Sobre Tiempo y Aspecto III, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 6.11.2008). 7 P. BERRETTONI, Alcuni presupposti, cit. 8 G. CURTIUS, Griechische Schulgrammatik, Prag, Tempsky, 1852, cap. XX [citazioni dalla seconda edizione, Prag, Tempsky, 1855]. 259 una “sostanziale revisione” (erhebliche Umgestaltung)9 dell’allora tradizionale teoria dei tempi. Per Zeitstufe Curtius intende quello che modernamente potremmo chiamare ‘riferimento temporale’, cioè la collocazione deittica sull’asse del tempo (passato, presente o futuro), mentre Zeitart, letteralmente “qualità del tempo”, corrisponde a ciò che oggigiorno chiameremmo ‘aspetto’10. Come Curtius aveva ben compreso, la Zeitart non dipende dal rapporto deittico con il momento dell’enunciazione ma dalle caratteristiche della struttura interna (innere Eigentümlichkeiten)11 della situazione rappresentata dalla forma verbale. Per definire il sistema verbale del greco Curtius12 distingue tre Zeitarten, che propone di denominare con le seguenti etichette: dauernd per il tema morfologico del presente (in realtà quello di tutti i tempi imperfettivi), vollendet per il perfetto e eintretend per l’aoristo. Le prime due etichette, dauernd e vollendet, hanno bisogno di pochi commenti perché secondo Curtius13 è come se “si fossero offerte di per se stesse” (ergaben sich von selbst), mentre eintretend si presenta fin dall’inizio come la più problematica e richiede una lunga giustificazione. In sostanza Curtius ci dice che, riprendendolo da Rost e Krüger14, ha adottato il termine eintretend proprio perché esso appartiene al linguaggio ordinario, nel quale per altro gode di una certa ambiguità. Come osserva Curtius15, in tedesco il verbo eintreten può indicare l’inizio di un processo e in questo senso si oppone alla sua prosecuzione (der Eintritt des Winters “l’inizio dell’inverno”), ma d’altra parte denota anche la semplice realizzazione di un avvenimento, “il sopraggiungere di un evento” (das Eintreten eines Ereignisses) opponendosi in questo senso alle fasi preparatorie (Vorbereitungen) che precedono il compimento dell’evento stesso. Ciò che accomuna i diversi significati di eintreten è comunque la capacità di denotare azioni delle quali non possono essere “messi in evidenza singoli istanti” perché l’evento si realizza tutto insieme (auf einen Schlag “in un colpo”). Curtius stesso ci ricorda come il termine eintretend sia stato definito dai suoi detrattori “polisemico” (mehrdeutig) e “ambiguo” (unbestimmt), ma in effetti è l’aoristo greco 9 ID., Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik, Prag, Tempsky, 1863, p. 171. 10 Il termine aspect, che nell’Ottocento ricorre nelle traduzioni francesi di grammatiche slave, verrà esteso ad altre famiglie linguistiche solo nel corso del XX secolo. G. CURTIUS, Erläuterungen, cit., p. 172. 12 ID., Griechische Schulgrammatik, cit., p. 217. 13 ID., Erläuterungen, cit., p. 172. 14 Si noti comunque che nella Griechische Grammatik di Valentin Christian Friedrich ROST (Göttingen 1821, pp. 410-411) eintretend ricorre come etichetta definitoria del futuro, mentre l’aoristo viene etichettato come momentan. Karl Wilhelm KRÜGER nel secondo volume (Syntax) della sua Griechische Sprachlehre für Schulen usa invece das Eintreten in die Wirklichkeit come definizione semantica generale dell’aoristo (p. 172, cito dalla quinta edizione, Leipzig, Krüger 1875). 15 G. CURTIUS, Erläuterungen, cit., p. 173. 11 260 ad essere intrinsecamente polisemico ed è quindi ragionevole che ci si possa riferire alle sue proprietà aspettuali con un’etichetta anch’essa polisemica. Contrariamente all’aspirazione ad una presunta univocità referenziale che tenderemmo ad associare alla terminologia tecnica16, Curtius difende quindi l’ambiguità del metalinguaggio perché la lingua oggetto è essa stessa costitutivamente ambigua ed è bene che tale ambiguità traspaia anche nel metalinguaggio. Secondo Curtius eintretend sarebbe dunque un termine sufficientemente ‘caldo’ da rispondere ai requisiti di un metalinguaggio che si vuole così vividamente descrittivo. Se deve essere ‘caldo’ è anche bene che il metalinguaggio rifugga dai forestierismi e non a caso questo è uno dei motivi per cui Curtius17 preferisce il germanico eintretend rispetto a momentan, che ha lo svantaggio di essere un Fremdwort. D’altra parte, come vedremo nel prossimo paragrafo, sarà proprio questa autoctonia germanica a dare filo da torcere ai traduttori. 2. L’intraducibilità di eintretend when that distinguished scholar adopted such terms as dauernd and eintretend […] he placed in the way of the study of the Greek tenses a barrier that has not been entirely removed even at the present day A parlare qui è il grecista americano C.W.E. Miller in una recensione del 1895 ad una monografia sui tempi verbali narrativi in Polibio18; il distinguished scholar è ovviamente Georg Curtius, al quale per altro Miller non lesina elogi quando gli riconosce il merito di aver profondamente innovato la visione tradizionale della grammaticografia: Now Curtius, it must be admitted, rendered a signal service to the cause of Greek grammar […] by instituting the distinction between the sphere of time and what he called the kind of time (Zeitstufe and Zeitart) 19 16 Per una problematizzazione dei concetti tradizionali di monosemia e mononimia si veda R. TEMMERMAN, Towards new ways of terminological description. The sociocognitive approach, Amsterdam / Philadelphia, Benjamins, 2000. 17 G. CURTIUS, Erläuterungen, cit., p. 173. 18 C.W.E. MILLER, The imperfect and the aorist in Greek, in “American Journal of Philology”, XVI (1895) [review article di F. Hultsch, Die erzhählenden Zeitformen bei Polybios. Ein Beitrag zur Syntax der gemeingriechischen Sprache, Abhandl. d. K. S. Gesellsch. d. Wissensch, XIII-XIV, Leipzig 1891-1893], pp. 143-144. 19 Ivi p 143. Questa citazione conferma tra l’altro l’ipotesi di Berrettoni sulla percezione ottocentesca della teoria di Curtius come una significativa novità nell’ambito degli studi sulla semantica dei tempi verbali. 261 Nonostante questi suoi meriti, che ne fanno un distinguished scholar, Curtius rimane comunque molto criticabile per le sue scelte terminologiche. Per capire questa reazione bisogna tener conto che Miller tendeva naturalmente a tradurre il tedesco di Curtius in inglese e che in questa operazione avrà avuto le stesse difficoltà già effettivamente incontrate dai traduttori inglesi della Griechische Schulgrammatik e delle Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik di Curtius. I turbamenti dei traduttori inglesi risultano evidenti confrontando proprio una traduzione della grammatica con la pubblicazione inglese delle Elucidations. Mentre William Smith nella sua versione ridotta della grammatica20, aveva proposto momentary come traduzione di eintretend, Evelyn Abbott21 denuncia apertamente la propria inadeguatezza rinunciando a proporre un unico traducente inglese. A proposito di eintretend Abbott osserva: The epithet is difficult of translation, and cannot be represented in all its bearings by any single English word. Il termine tedesco viene così proposto da Abbott come prestito non adattato, salvo poi fornire alcune glosse che dovrebbero facilitarne l’interpretazione: initial, culminating, instantaneous. Le glosse rendono evidente la polisemia intrinseca del termine, che può indicare indifferentemente sia il momento iniziale (initial) ma anche il punto culminante (culminating), e quindi implicitamente il punto finale di un evento (‘culminating’ as opposed to ‘preparatory’, traduce Abbott). Da un altro punto di vista, eintretend viene anche interpretato in riferimento alla durata dell’evento, o meglio all’assenza di una durata misurabile (instantaneous). La non duratività era anche, come abbiamo visto, il tratto semantico privilegiato dall’altro traduttore, William Smith, che aveva proposto l’etichetta momentary. Le osservazioni di Abbott mostrano però che etichette come momentary o instantaneous riducono drasticamente il ricco ventaglio polisemico di eintretend. Probabilmente proprio questo inevitabile riduzionismo traduttivo è ciò che nel complesso rende poco convincenti le scelte terminologiche di Curtius, soprattutto nella prospettiva interlinguistica dei colleghi stranieri22. Di fronte a termini come 20 A smaller grammar of the Greek language abridged from the larger grammar of Dr George Curtius, London, John Murray, 1863, p. 151. 21 Elucidations of the student’s Greek grammar by Prof. Curtius, London, John Murray, 1870, pp. 204-205. 22 Simili difficoltà si ritrovano anche per il termine dauernd, che, come dimostra di nuovo il confronto tra Smith e Abbott, può essere inteso sia ‘aspettualmente’ come focalizzazione imperfettiva di un processo in corso (on going traduce Smith), ma anche come caratterizzazione della duratività intrinseca di un’azione che perdura nel tempo (continuous in Abbott). Ma, come ho già mostrato altrove (M. SQUARTINI, Durativo o imperfettivo? cit.), l’ambiguità connessa con l’uso del participio tedesco del verbo dauern creava particolari problemi soprattutto a coloro che traducevano Curtius in lingue romanze. 262 momentary e instantaneous, Miller ha infatti buon gioco a criticare la terminologia di Curtius23, ma in realtà sono le traduzioni a produrre un’interpretazione tutta appiattita sulla misurabilità dell’evento. Sappiamo che Curtius stesso era ben consapevole di questa trappola interpretativa: osservando che esistono anche aoristi denotanti azioni durative Curtius segnala infatti esplicitamente che la non duratività non può essere una caratteristica definitoria dell’aoristo greco24. Per Curtius eintretend poteva essere salvato in virtù del fatto che in tedesco la non duratività è solo uno dei possibili tratti semantici di un termine intrinsecamente polisemico. Per i traduttori invece la polisemia rappresenta un ostacolo nel momento in cui impedisce di trovare un traducente adeguato25. A questo punto eintretend poteva essere destinato ad entrare nella nomenclatura tecnica di altre lingue europee come prestito non adattato26 e in un certo senso questa sembra essere la sorte prefigurata da Abbott quando propone il termine tedesco senza tradurlo. Che non si tratti di una possibilità solo teorica è del resto dimostrato dalle vicende storiche di un altro termine, Aktionsart. Quello che Curtius aveva proposto di chiamare Zeitart, dopo essere passato attraverso l’allotropo polirematico (Art der Handlung) proposto da Delbrück27, verrà infatti ribattezzato da Brugmann Aktionsart28. A differenza di Zeitart e Zeitstufe, definitivamente scomparsi dalla terminologia metalinguistica del nostro tempo, Aktionsart esiste ancora come prestito dal tedesco nel lessico tecnico di molte lingue d’Europa, in cui si è specializzato in riferimento alla semantica azionale dei predicati (si può parlare ad esempio di predicati ‘di Aktionsart stativa, telica o durativa’). 29 La sorte di eintretend è stata però meno fortunata di quella di Aktionsart, che è anche riuscito a sopravvivere al sommovimento terminologico connesso con la fortuna novecentesca del concorrente termine ‘aspetto’. Del C.W.E. MILLER, The imperfect, cit., p 143-144. Tra l’altro, G. CURTIUS, Erläuterungen, cit., p. 173, dice esplicitamente che la differenza tra aoristo e imperfetto non è da ‘misurarsi con l’orologio’ (nach der Uhr zu messen). 25 Anche per i numerosi traduttori ottocenteschi italiani di Curtius (su cui si veda M. SQUARTINI, Durativo o imperfettivo?, cit.), il termine eintretend rappresenterà un problema. Le soluzioni proposte (‘incipiente’ ma anche ‘sopravveniente’ e ‘momentaneo’) tendono anch’esse a ridurre l’intrinseca polisemia del tedesco. Incipiente verrà utilizzato anche dall’unico traduttore ottocentesco spagnolo in J. CURTIUS, Gramática griega elemental, traducida de la 15a edición por Enrique Soms y Castelín con un prólogo de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid: Ricardo Fé, 1887, pp. 204-205. 26 Come del resto propone C.W.E. MILLER, The imperfect, cit., p 144 a proposito del tedesco durativ, che si stava diffondendo in sostituzione dell’oscuro dauernd: “The term durativ in ‘durative Formen’ will do little, if any, harm, provided only be understood that it is a convenient name, and nothing else”. 27 B. DELBRÜCK, Das altindische Verbum, Halle, 1874, p.19. 28 Il termine si trova in K. BRUGMANN, Griechische Grammatik, in I. Müller et al. (a cura di), Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. II. Griechische und lateinische Sprachwissenschaft, Nördlingen, Beck, 1885, par. 154. 29 Per le accezioni moderne di Aktionsart si veda Ö. DAHL, Aspect: Basic Principles, in K. Brown e J. Miller, Concise Encyclopedia of grammatical categories, Amsterdam etc., Elsevier, 1999, pp. 30-37. 23 24 263 resto, eintretend è stato anche meno fortunato di dauernd, che rimane in alcune tradizioni terminologiche, almeno come morfo lessicale e con tutta la sua intrinseca ambiguità traduttiva30. Come vedremo nel prossimo paragrafo, eintretend era probabilmente un termine troppo intraducibilmente caldo per non essere soppiantato da un complessivo raffreddamento della terminologia. 3. Il raffreddamento della terminologia Le perplessità dei linguisti non tedeschi e le difficoltà dei traduttori trovano un riscontro in quello che, seguendo ancora la metafora di Auroux, potremmo definire come un improvviso ‘raffreddamento’ della terminologia. I Neogrammatici riconoscono infatti a Georg Curtius il merito di avere innovato la concezione tradizionale della semantica dei tempi verbali, ma nello stesso tempo ne stravolgono completamente la terminologia31. Ho già menzionato il passaggio da Zeitart a Aktionsart nella Griechische Grammatik di Brugmann, che d’altra parte ancora mantiene inalterati i due termini dauernd e eintretend. Non dovranno tuttavia passare molti anni perché si assista ad un completo dissolvimento della terminologia originaria di Curtius nelle opere uscite dall’ambiente dei Neogrammatici. Nei Grundrisse enciclopedici, in cui anche Brugmann è direttamente coinvolto32, le calde ambiguità connotative di dauernd e eintretend dovranno lasciare il posto a imperfektiv e perfektiv, che sono poi i due termini ancora oggi usati nella descrizione tipologica dei sistemi tempo-aspettuali delle lingue del mondo. Alla base di perfektiv e del suo derivato antonimico imperfektiv c’è ovviamente la tradizione terminologica latina (la coppia oppositiva perfectum/imperfectum)33, che rappresenta una lunga e sedimentata cristallizzazione grammaticografica capace di decretare la più assoluta freddezza denotativa dei termini utilizzati. M. SQUARTINI, Durativo o imperfettivo?, cit. Come ho mostrato in M. SQUARTINI, Durativo o imperfettivo?, cit., la terminologia proposta dai Neogrammatici ebbe una tale influenza da portare a modifiche terminologiche nelle edizioni postume della stessa Griechische Schulgrammatik di Curtius, in cui si finisce ad esempio per adottare il termine Aktionsart al posto dell’originario Zeitart. 32 Si veda in particolare la terminologia usata in K. BRUGMANN, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Strassburg, Trübner,1902-1904, II, 1903, pp.491-494 e in K. BRUGMANN / B. DELBRÜCK, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung der Geschichte des Altindischen […], Strassburg, Trübner,1897-1916, II/3, 1916, p. 79. 33 Si osservi che A. SCHLEICHER, Das Futurum im Deutschen und Slawischen, in “Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung”, IV (1855), p. 191, riferendosi alle lingue slave, parlava di verba perfecta per quei verbi che nell’ambiente dei Neogrammtici si preferirà denominare come perfektive Verben. 30 31 264 Questo rinnovamento terminologico, che era stato già formalizzato in due lavori usciti nei primi anni ’90 dell’Ottocento, uno di Streitberg del 189134 e uno di Herbig del 189635, incontra subito il favore degli specialisti del settore. Significativamente sono soprattutto gli studiosi stranieri, i più esposti alle difficoltà traduttive, ad esprimere soddisfazione, come ci testimonia Eleanor Purdie36 in uno dei tanti articoli sull’aspetto verbale usciti in quegli anni su Indogermanische Forschungen: the question of terminology happily needs but little comment after the lucid treatment of Herbig in IF. 6, a treatment which contrasts very brightly with the negative criticism of Hultsch’s terminology offered by Miller in A. J. Phil. 16 Non a caso sono proprio coloro che sperimentavano le potenzialità dell’inglese come lingua di comunicazione scientifica in un ambito fino ad allora tradizionalmente tedescofono ad apprezzare la nuova terminologia dei Neogrammatici. Ciò significa però che il raffreddamento della terminologia non era solo un vessillo scientistico dei Neogrammatici, ma anche una necessità pratica in un momento in cui si doveva stabilire un metalinguaggio che fosse condiviso e facilmente trasponibile da una lingua di cultura all’altra, evitando così le trappole traduttive della ‘calda’ terminologia di Curtius. Le parole di Purdie, attraverso un’insistente metaforizzazione luministica (lucid, brightly), sembrano quasi mitizzare il cristallino scientismo terminologico di Herbig e dei Neogrammatici. Nello stesso tempo Purdie, citando proprio la recensione di C.W.E. Miller sul numero XVI dell’American Journal of Philology37, ci ricorda quanto le difficoltà terminologiche fossero anche connesse con la necessità di trasporre la terminologia tedesca in una lingua come l’inglese, che alla fine dell’Ottocento cominciava a mettersi in concorrenza con il tedesco sul mercato accademico della linguistica. W. STREITBERG, Perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen, “Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur”, XV (1891), pp. 70-71. 35 G. HERBIG, Aktionsart und Zeitstufe. Beiträge zur Funktionslehre des indogermanischen Verbums, “Indogermanische Forschungen”, VI (1896), pp. 157-269, il cui carattere fondativo in questo settore della ricerca sull’aspetto è stato segnalato da P. BERRETTONI, Quando i verbi non avevano l’aspetto, in “Messana”, XVIII (1993) [ripubblicato in ID., Atene e Lipsia cit., pp. pp. 247-250]. 36 E. PURDIE, The perfective ‘Aktionsart’ in Polybius, “Indogermanische Forschungen”, IX (1898), pp. 64-65. 37 C.W.E. MILLER, The imperfect, cit., p 143-144. 34 265 4. Conclusioni Nel loro complesso i dati presentati in questo lavoro hanno mostrato quanto una terminologia metalinguistica ‘calda’, per sua natura troppo radicata nel sistema della lingua in cui nasce, possa correre il rischio di essere costitutivamente intraducibile. Le reazioni dei linguisti del tempo mostrano come nella seconda metà dell’Ottocento le necessità dei traduttori si intreccino poi con la più generale tendenza della linguistica a profilarsi come disciplina accademica autonoma. Non si può dimenticare però che, volendo approfondire la complessa vicenda terminologica del comparto tempoaspettuale, si dovrà anche tener conto della diversa impostazione tra gli interessi applicativi insiti in una grammatica pedagogica come la Griechische Schulgrammatik e la prospettiva più generalizzante e teorica dei Neogrammatici. È facile proiettare acriticamente su questo contrasto la moderna distinzione tra linguistica generale e linguistica applicata, ma, come ho già suggerito altrove38, anche questo contrasto tra diverse correnti della riflessione metalinguistica diventa un fattore significativo soprattutto quando si voglia ricostruire la più tarda evoluzione novecentesca della terminologia grammaticale. 38 M. SQUARTINI, Durativo o imperfettivo?, cit. 266 267 UN SONETTO EUCARISTICO DEL TASSO (‘RIME’ 1659) Paolo Luparia Tra il maggio e il giugno del 1586 il Tasso, ancora per poco detenuto in Sant’Anna1, intravedendo prossima la liberazione sospirata da sette lunghi anni, moltiplica gli sforzi per propiziarsi influenti protettori. Uno di questi è don Cesare d’Este2, fresco sposo di Virginia de’ Medici. E proprio in quel delicatissimo periodo, Torquato, già celebratore in versi profani dell’imeneo principesco, manda con lettere al giovane rampollo estense (che si trovava allora a Roma) tre sonetti spirituali sul tema eucaristico. Al primo componimento si fa cenno nella lettera del 27 maggio 1586. Mentre è in attesa che l’amico Antonio Costantini, “secretario del signor ambasciatore di Toscana, venga a trarlo di prigione” per una breve uscita (e subito, lasciando libero corso alla speranza, il prigioniero fantastica: “e s’andrò a desinar seco, com’io credo, spero che non sarà difficile che mi sia data licenza di venirmene a Roma, o che in alcun altro modo mi sia fatto favore di poterci arrivare”), il poeta annuncia l’invio a don Cesare di “un sonetto spirituale3, c’ho fatto ultimamente nella mia communione, perché i concetIl Tasso verrà affidato al duca di Mantova in libertà vigilata nel luglio del 1586. Cesare d’Este era il secondogenito di don Alfonso d’Este, marchese di Montecchio (1527-1587). Nella complicata genealogia dinastica estense, don Alfonso era lo zio del duca regnante (e carceriere del Tasso) Alfonso II (1533-1597). Veniva però trattato con un certo disprezzo dai nipoti – che lo appellavano “il nostro illustrissimo bastardo” – perché figlio illegittimo (ma legittimato nel 1532) del duca Alfonso I (14761534) e della bellissima popolana Laura Dianti, la “berrettara”. Tuttavia, poiché Alfonso II non aveva eredi, i discendenti del ramo illegittimo divennero ben presto l’unica speranza per la conservazione dei territori ferraresi del ducato. E alla morte del duca, con il ritorno del feudo imperiale ferrarese sotto il dominio ecclesiastico e la fine della splendida corte estense, proprio don Cesare era destinato a raccoglierne la residua eredità dinastica divenendo duca di Modena (1598). Perciò dopo la morte del fratello maggiore Alfonsino (1578), Cesare – in un primo tempo destinato alla carriera ecclesiastica – gli successe in qualità di erede designato: di qui le fastose nozze (febbraio 1586) con Virginia de’ Medici. Tutto questo è necessario tenere presente per comprendere quanto verremo dicendo. 3 Già fui tronco infelice in queste sponde: Rime 1662. Cito i testi da T. TASSO, Le rime a cura di B. Basile, Roma, Salerno, 1994. Non mi dilungo qui per ragioni di spazio sulle questioni testuali. Sull’argomento si vedano G. SANTARELLI, Studi sulle “Rime sacre” del Tasso, Bergamo, Centro Tassiano, 1974; A. DANIELE, Le “Rime” sacre, in ID., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 240-269. 1 2 268 ti, i quali sono di san Tomaso, mi sono molto piaciuti: e s’io non fossi così buono come mi dipingo, gioverà l’esempio, perché non è fatto con intenzione d’ippocrita” 4. Escusazioni di tale sorta rischiano di alimentare se non proprio il sospetto che Torquato intende fugare, almeno quello di un calcolo opportunistico. Tra i corrispondenti abituali del poeta in quei mesi ci si attenderebbe infatti che il destinatario di rime sacre fosse piuttosto il benedettino Angelo Grillo, fortunato autore dei Pietosi affetti, una interminabile raccolta di sonetti e madrigali e canzonette-salmi di ispirazione devota. Ma la vera intenzione del Tasso pare emergere tra le righe della stessa missiva: Mando adunque, incontra a Vostra Eccellenza questa lettera, la quale non è ragionevole che mi porti alcuno impedimento al seguirla. Io so che in lei è somma cortesia, e che sin ora si sarebbe mostrata, se quella stessa cagione che m’è stata freno ne l’onorarla, non avesse ritardato Vostra Eccellenza nel favorirmi: ma ormai è tempo che cessin questi rispetti da l’una parte e da l’altra, e che la sua amorevolezza cominci a discoprirsi insieme con la mia divozione5. Impaziente di recuperare la libertà, Torquato progetta dunque di seguire la via della propria lettera, lasciando la pagana ed ereticale Ferrara per la Roma di Sisto V (proprio il potente vicino che costituiva una minaccia per l’integrità territoriale del ducato). Quanto al cenno enigmatico alla cagione o all’ostacolo che avrebbe fino a quel momento frenato il suo zelo encomiastico nei confronti del giovane don Cesare e il corrispondente favore di questi, vi scorgerei un’allusione al cardinale Luigi d’Este, fratello del duca Alfonso. È noto infatti che già al tempo della crisi religiosa e spirituale che gli farà perdere il favore del duca, culminando nella malaugurata scelta di confessarsi all’Inquisitore, il Tasso aveva rivolto al cardinale di Ferrara – suo primo padrone – velate accuse di libertinismo. E sospettava che due cortigiani estensi, Luca Scalabrino, molto vicino a Luigi d’Este, e l’ebreo convertito Ascanio Giraldini, incaricato d’affari del duca, avessero a loro volta accusato lui, Torquato, “come luterano e come ebreo”6, gettando un’ombra sulla sua ortodossia. Nel momento in cui don Cesare aveva abbandonato la carriera ecclesiastica per tornare nel mondo e sposarsi, si era anche affrancato dalla tutela e dall’autorità declinante del cardinale di Ferrara (Luigi sarebbe morto proprio nel dicembre di quell’anno 1586): vale a dire di colui che il prigioniero di Sant’Anna reputava, a torto o a ragione, il T. TASSO, Le lettere a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, 5 voll.; vol. II, n. 504, pp. 534535. 5 Ibid. 6 Ivi, II, n. 133, p. 85. 4 269 principale responsabile della propria carcerazione. In Cesare, successore in pectore del duca, imparentato con la casata medicea, bene introdotto negli ambienti di curia, il Tasso doveva scorgere un prezioso alleato per la propria causa7. Che l’invio del primo sonetto mirasse a trovare udienza nelle sacre stanze vaticane e prefigurasse l’intenzione di trovarvi riparo, pare confermato dalla successiva lettera del 15 giugno 1586 che accompagna l’invio degli altri due componimenti eucaristici (probabilmente occasionati dalla festività del Corpus Domini), così da formare un trittico: Non ho perduta la speranza di veder Vostra eccellenza o in Roma o per viaggio, perchè s’ella fosse così incerta come sono instabili i voleri de gli uomini, non sarebbe vera speranza. Piaccia a Dio che in quel modo istesso sian vere le promesse de la mia libertà, e tutte l’altre. A me sarebbe caro di poterle baciar la mano in ogni luogo, ed in questo ancora dove sto così mal volentieri, come può imaginare: ma verrò per quella strada per la quale sarò condotto. Ora le mando due sonetti spirituali, l’uno del tabernacolo de’ padri del Gesù, l’altro ne la processione del Corpo di Cristo: e perché in questo accenno alcuna cosa de le pompe d’Alessandria, la prego che ‘l faccia vedere al suo patriarca; e mi faccia tanto favore con Nostro Signore, ch’io sia più certo del mio venir costà, ch’io non sono. E le bacio le mani8. Raffreddatisi durante la detenzione i rapporti con l’amico di un tempo Scipione Gonzaga, Patriarca di Gerusalemme, don Cesare poteva costituire il tramite ideale con il mondo curiale e addirittura con “Nostro Signore”, Sisto V. Esplicito e quanto mai significativo l’invito a far circolare i testi mostrandoli al Patriarca di Alessandria, il cardinale Giovan Girolamo Albani, altro antico protettore del Tasso che lo aveva deluso. La singolare concentrazione e vicinanza temporale riscontrabile nella composizione dei sonetti eucaristici (il tema non ha in effetti altre successive occorrenze tra le Rime sacre del Tasso) non è dunque casuale. Attraverso i tre componimenti il poeta si propone di inviare a Roma un messaggio preciso. Non bisogna infatti dimenticare che nella fondamentale lettera al marchese Giacomo Buoncompagni (figlio del Papa allora regnante Gregorio XIII) del 17 maggio 1580, egli, incarcerato ormai da quattordici mesi, lamentava il disfavore che fino a quel momento aveva ricevuto dalla Chiesa “la quale a Si vedano i due sonetti che il Tasso gli indirizzò nella sua andata a Roma (Rime 1290 e 1291): nel secondo il poeta prega direttamente Sisto V di accogliere Cesare. 8 Ivi, II, 513, p. 514. I sonetti cominciano Eterno Re, che ‘l tuo lucente albergo e Qual gente mai sì grande e ‘nvitta in guerra (Rime 1659 e 1692). 7 270 me s’è mostra non madre ma madrigna, negandomi quel nutrimento che da le madri ad alcuno non suol essere negato (né parlo meno de gli spirituali che de’ corporali cibi [...])”. E denunciava che a lui, infermo nello Spedale di Sant’Anna (oppresso com’era da malinconia o, diremmo noi, da una crisi depressiva: ma i suoi carcerieri la spacciavano invece per pazzia furiosa), “le medicine de l’animo” non furono negate meno di quelle del corpo: e il cappellano dell’ospedale “non è mai ne la mia infirmità venuto a visitarmi, o ad usar meco alcun atto di misericordia: e se pur io l’ho pregato, non ha voluto mai o confessarmi o comunicarmi: e se pur egli mi giudicava indegno di sedere alla mensa de gli angeli e di cibarmi del corpo di Cristo, doveva almeno meco procedere in convertendo, ma non m’avrebbe peraventura trovato ostinato. Ma non l’avendo fatto, che posso credere io altro, se non che il cardinale [Luigi d’Este] non mi voglia cattolico?”. Non sono queste le querule recriminazioni di un forsennato. Era proprio allo scopo di avvalorarne la pazzia che Torquato veniva privato del sacramento eucaristico, “di quei tesori spirituali i quali s’appartiene di dispensare al papa”. La riammissione al sacramento equivaleva a un autorevole referto di sanità mentale. Perciò il poeta, sottoposto alla più odiosa delle violenze psicologiche, si sforza di accreditare l’immagine della propria sincera devozione con ogni mezzo, rievocando addirittura il ricordo della prima comunione insolitamente ricevuta a nove anni (“E quand’io mi comunicai non aveva ancora inteso che ne l’ostia fosse realmente il corpo di Cristo: nondimeno, mosso da non so qual segreta divozione, che la gravità e la riverenza del luogo e l’abito e ‘l mormorare e ‘l battersi di petto de’ circostanti avevano in me generata, andai con grandissima divozione a ricevere il corpo di Cristo, e sentii dentro non so qual nuova insolita contentezza”). Erano stati i padri Gesuiti ad ammetterlo così precocemente al sacramento eucaristico. Eppure l’emozione provata dal fanciullo inconsapevole ancora distilla la sua dolcezza e, nella sventura, si sovrappone con la sua evidenza sensibile ai successivi dubbi dell’uomo e del filosofo: E come ch’io non voglia lodare o biasimare la poca diligenza o l’uso di quei padri, che m’ammettessero al sacramento quand’io non sapea ancora che fosse sacramento; non tanto perché io non potessi alcuna cosa intenderne, quanto perché non m’era stato detto; questo nondimeno ardisco d’affermare, ch’io, come da gli effetti le ragioni s’argomentano, ricordandomi ora quale allora mi sentissi, chiaramente conosco ch’io ne l’albergo di queste mie membra terrene aveva dato ricetto al Figliuol di Dio; il quale allora si degnò di mostrare in me le meraviglie de gli effetti suoi più vivamente, perché in luogo ancora incontaminato e semplice e puro le vidde raccogliere. E di tanta efficacia 271 è ne l’animo mio ora questo argomento, che niuna filosofica ragione può a la parte contraria persuaderlo; ed è argomento tratto dal senso del quale io faccio tanta stima, quanta coloro far debbono che ne le scuole peripatetiche hanno bevuto il latte della dottrina. [...] E certo, come ch’io non nieghi d’essere stato dubbio se ne l’ostia fosse realmente il corpo di Cristo, niuna autorità di Scrittura, che da gli scrittori eretici sia addotta (i quali io non lessi mai), me ne faceva star dubbio; ma quelle medesime cagioni per le quali io de la creazion del mondo, de l’immortalità de l’anima, e de la onnipotenza assoluta di Dio alcuna volta dubitava. Così, attraverso la “concordia de le sue parole discordi”, il Tasso delinea il percorso di un sofferto ritorno ai “principii di pietà” della fede, in cui il mistero dell’ostia diventa il simbolo stesso di una possibile transustanziazione spirituale: [...] ma non prima io cominciai a credere l’assoluta onnipotenza d’Iddio [...], ch’io cominciai parimente a credere che ‘l corpo di Cristo fosse ne l’ostia: percioché l’infinito non ha gradi, né termini, né misure di più o di meno; e chi può tutto, può con la medesima facilità le cose in sé facili, e le possibili, e le impossibili a noi o in sua natura. [...] Oltre di ciò, niuna transustanziazione crediamo sì mirabile per fede, de la quale non si veda alcun vestigio ne l’anima nostra; che essendo prima di sua natura semplice potenza, si tramuta poi ne la natura de le cose intese, e diviene tutto ciò ch’ella intende, e Dio quasi, intendendo Iddio; onde se a l’anima nostra quasi è possibile di deificarsi, e se a Dio fu possibile d’umanarsi, e se può gli uomini transumanare, non si può dubitare che per beneficio de gli uomini non possa transustanziare la sostanza del pane9. In questa disarmata (e purtroppo inefficace) confessione non riesco a scorgere traccia di insincerità o di calcolo. Si tratta piuttosto di un documento insieme commovente e terribile della spietata costrizione esercitata su una coscienza fragile e tormentata dalla opprimente alleanza del potere politico e religioso. Il Santarelli vi ricollega opportunamente il sonetto Carlo che pasci in sì felice mensa (Rime 1640), scritto nel febbraio 1580 per celebrare il passaggio del cardinal Borromeo da Ferrara e la Comunione generale che vi ebbe luogo. Non per il recluso, che, inascoltato, invoca: ‘l digiuno mio cor ... / riempi, e sazia la mia fame immensa. 9 Ivi II, n. 133, pp. 90-92. 272 A chi non perdesse di vista questo necessario antefatto, collocato proprio all’inizio dell’esperienza di Sant’Anna, non sarebbe forse difficile giustificare il “pio conformismo”, il linguaggio “oratoriamente generico e senza intima partecipazione”, l’ispirazione “tutta esteriore, di stanca ripetizione” che il Getto10 imputa ai sonetti eucaristici. Mi propongo invece di dimostrare che la sentenza dell’illustre critico va almeno in parte corretta. Componimenti certamente d’occasione, i tre sonetti non si possono tuttavia ridurre alla stregua di ingegnose perorazioni retoriche volte al conseguimento di un scopo pratico: una sorta di viatico per Roma. Per quanto essi, composti rapidamente in prossimità della liberazione e allo scopo di agevolarla, costituiscano senza dubbio una professione di fede ortodossa volta ad attestare pubblicamente che il farnetico non solo è tornato in sé, ma che ormai è stato riammesso pienamente nel grembo della Chiesa, di cui si professa figlio devoto animato dal pio zelo di servirla anche con i carmi, vedremo che il loro significato non si esaurisce in un mero atto d’ossequio formale. Tenterò qui un’interpretazione del secondo dei tre componimenti, senza dubbio il più arduo dal punto di vista dell’esegesi, tanto che mi pare non sia stato finora rettamente inteso. Eterno Re, che ‘l tuo lucente albergo nel sol ponesti e ‘n tenebre l’ascondi, oh che alti misteri, oh com’ profondi son quelli ov’or m’innalzo, or mi sommergo! E ‘n questo è lume ed ombra, ed io l’aspergo di pianto, e l’alme tu di sangue inondi: cedagli quel che figurò tre mondi, che ‘l divoto pensier si lascia a tergo. E i sette lumi suoi de l’auree stelle segni qua giù, che son là suso erranti, e le move il tuo cenno e regge il ciglio. Perch’altre luci io veggio, altre facelle, Padre dei lumi; e tra sospiri e pianti dono è lo Spirto e sacrificio il Figlio. 5 10 Nell’edizione postuma delle Rime spirituali tassiane, pubblicata a Bergamo per Comin Ventura nel 1597 ed esemplata su un ms. appartenuto al bergamasco Giuseppe Ravelli (Rv), il sonetto reca l’argomento Sopra il taG. GETTO, Malinconia di T. Tasso, Napoli, Liguori, 1979, pp. 300 e 302. Il giudizio è sostanzialmente confermato dal SANTARELLI, Studi, cit., pp. 238-240. 10 273 bernacolo, dove si custodisce il santissimo Sacramento. Nelle lettera a Cesare d’Este il Tasso fa riferimento al “tabernacolo de’ padri del Gesù”: forse proprio il tabernacolo della chiesa dello Spedale di Sant’Anna, dove Torquato era di nuovo e finalmente ammesso a partecipare al banchetto eucaristico. La prima quartina, aperta dal vocativo Eterno Re, è tutta imperniata sulle antitesi. Con un violento effetto chiaroscurale i vv. 1-2 riecheggiano due opposti versetti dei Salmi: in sole posuit tabernaculum suum (18, 6: iuxta LXX) e et posuit tenebras latibulum suum / in circuitu eius tabernaculum eius (17, 12). Ma l’opposizione luce-tenebre si estende alle antitetiche azioni divine dell’aver piantato la propria tenda nel barbaglio dell’astro diurno – nel sol ponesti 2 – e del nascondimento metafisico (e ‘n tenebre l’ascondi), così che i due effetti finiscono con il coincidere nell’immagine misteriosa e veterotestamentaria di un Eterno Re che era prima della creazione, nella quale Egli si manifesta (Caeli enarrant gloriam Dei / et opera manuum eius adnuntiat firmamentum è appunto il celebre avvio di Ps. 18) e insieme si nasconde: il suo tabernaculum, il luogo dove l’Altissimo pose la sua dimora, simbolo della sua presenza, è nello stesso tempo un impenetrabile latibulum. Luce accecante e tenebra proteggono ugualmente la sua inconoscibilità. Né sfugga la contrapposizione temporale tra l’attimo puntuale espresso dal perfetto ponesti e l’attualità del presente l’ascondi. L’antitesi, a ben vedere, è dunque già condensata nel sintagma ‘l tuo lucente albergo – il tabernacolo cosmico e sopraceleste – che, fungendo da complemento oggetto in forte prolessi, esprime subito con paradossale ossimoro la assoluta trascendenza della dimora divina. È il motivo apofatico – caro all’ultimo Tasso – della tenebra luminosa, di un Dio che in suo splendor s’involve (Gerusalemme Conquistata X, 59, 5-6; XX, 4; Mondo creato I, 88-89) e, in sé raccolto, si fa lucente velo (G.C. I, 9, 8; XII, 44, 1-4; XIX, 131-132; Rime 1388, 121-136). Proprio il riconoscimento della dimensione misteriosa e inafferrabile del sacro emerge dall’esclamazione dei v. 3-4. Una dimensione al divino che ancora una volta trova espressione nella verticalità di un’antitesi spaziale (oh che alti misteri, oh com’ profondi), e coinvolge nella vertiginosa ricerca, divaricata tra gli estremi, l’io del poeta (son quelli ov’or m’innalzo, or mi sommergo!), creatura vivente nel tempo. La seconda quartina è incentrata nel tabernacolo della liturgia cristiana: E ‘n questo è lume ed ombra 5 vale “Anche in questo tabernacolo terreno ecc.” (il Maier e il Basile ritengono nei loro commenti superflua una chiosa che invece a me pare indispensabile): il pronome deittico si contrappone infatti al lucente albergo, al latibulum in cui Iddio pose in fulgide tenebre / E ‘n profondo silenzio alte latebre (G.C. XIX, 131). Nel tabernacolo dei Padri del Gesù, vera aula dei che rinnova il significato simbolico adombrato nell’arca santa dell’antico testamento, trova compimento la parola di Geremia (Ha274 bitabo vobiscum in loco isto in terra. 7,7). Nella luce e nell’ombra del mistero cristiano (la luce del Verbo fatta carne: il motivo compare già nel primo sonetto: or che’l tuo corpo è l’ombra e ‘l lume un sole [Rime 1662, 10]), il tabernacolo – corporis Christi novum sepulchrum – rende possibile l’incontro e la comunione altrimenti impossibile (cfr. vv. 1-4) tra uomo e Dio, tra l’individuale dolore umano (ed io l’aspergo / di pianto) e l’universale redenzione operata dal sacrificio divino (e l’alme tu di sangue inondi: dove quel fiotto inesauribile di sangue ha quasi un valore lustrale e celebra l’eterna attualità del sacrificio11). L’oscurità del testo si concentra però soprattutto nella esortazione dei vv. 7-8: cedagli quel che figurò tre mondi, / che ‘l divoto pensier si lascia a tergo. I commentatori chiosano: “Dante Alighieri nella Divina Commedia”. Ma la spiegazione banalizza la profondità esoterica dell’allusione. Il pronome quel va ancora una volta riferito al tabernacolo: non però a quello cristiano, bensì a quello della antica alleanza costruito da Mosè. Torquato presuppone l’esistenza di un lettore capace di ricollegare i suoi versi all’Heptaplus, il grande commentario cabalistico sulla Genesi di Pico della Mirandola. Nell’interpretazione del geniale esegeta neoplatonico il tabernacolo mosaico simboleggia appunto i tre mondi terrestre, celeste e sovraceleste. Il passo va citato per intero nel suo bel latino umanistico: Hoc non praetermiserim, figuratos hos mundos tres [ultramundanus, caelestis, sublunaris] a Mose evidentissime, in admirabilis illius tabernaculi sui constructione. Partitus est enim tabernaculum in partes tres, quarum singulae singulos diximus mundos repraesentare expressius nullo modo possent. Etenim prima pars, nullo defensa tecto vel umbraculo, imbribus, nivi, solibus, calori frigorique obvia erat et opportuna et, quod est nostri, idest sublunaris mundi evidentius simulacrum, inhabitabant eam non modo homines mundi et immundi, sacri et profani, sed et omnifarii generis animalia eratque in ea vel ob sacrificia iugesque immolationes vitae et mortis perpetua vicissitudo. Reliquae duae partes ambae obtectae et undique ab omni peregrina iniuria liberae, quemadmodum et uterque mundus, tam caelestis quam supercaelestis, nec iniuriae capax nec contumeliae. Ambae item sanctitatis nomine honestatae, ita tamen ut quae erat secretior sancti sanctorum, reliqua sancti tantum titulo decoraretur, sicuti quamvis et caelestis et angelicus mundus uterque sanctus, quondam supra lunam post Luciferi casum nec macula nec peccatum aut est aut esse potest, angelicus tamen 11 Impeccabilmente il Tasso allude a TOMMASO, Summa Theologiae III, q. 74, a. 1 “caro Christi sub specie panis pro salute corporis, sanguis vero sub specie vini pro salute animae offertur, sicut dicitur Levit. 17, [14], quod animalis anima in sanguine est” (è citazione da AMBROSIASTER, In I Cor., super XI [PL 17, 256]). 275 caelesti longe sanctior et divinior habetur. Sed quid remotiores has similitudines prosequimur? Nam si postrema pars tabernaculi erat hominibus et brutis communis, secundam, quae tota auri splendore fulgebat, candelabrum illuminabat septem lucernis distinctum, quae ut dicunt omnes interpretes Latini, Graeci et Hebraei, septem planetas significant. In parte tertia, omnium sacratissima, alata Cherubin erant. Nonne nostris tres mundos oculis subiciunt? Et hunc, quem et bruta et homines incolunt; et caelestem, in quo planetae corruscant, et supercaelestem habitaculum angelorum12. Quanto conformistico sia un simile riferimento, potrà valutare chi rammenti come il pensiero del comes concordiae (perseguitato dalla Chiesa che aveva posto all’indice le sue Conclusiones, proiettate alla ricerca di un incontro tra le grandi religioni e il pensiero filosofico classico) fosse agli antipodi dello spirito che animava la controriforma. Al v. 8 testo e punteggiatura richiedono un ritocco. Non danno senso né il che relativo (pesante ripetizione di che 7), né soprattutto il punto fermo in fine di verso. Occorrerà invece leggere ché ‘l divoto pensier si lascia a tergo / e i sette lumi suoi, de l’auree stelle ecc. Infatti ‘l divoto pensier è soggetto (non oggetto): ‘giacché il devoto pensiero si lascia alle spalle anche i suoi (del tabernacolo) sette lumi ecc.’. Non v’è dubbio che i sette lumi suoi richiamino il candelabrum ductile de auro mundissimo, a sette bracci, di cui è Dio stesso a mostrare sul Sinai a Mosè il modello, spiegandone i dettagli (Ex. 25, 31-40; 37, 16-17). Il sacro candelabro (in ebraico menorah) era collocato nella tenda del convegno (ohel moedh) o tenda dell’alleanza (ohel haedhuth), il sancta sanctorum (qodesh ‘santo’; miqdash ‘santuario’, beth-Yahweh ‘casa di Yahvè’), sul lato meridionale e di fronte alla tavola aurea con il pane della presentazione. I suoi lumi ardevano dalla sera alla mattina (Lv. 24, 3). Secondo l’interpretazione simbolica di Pico (che riprende Filone, De vita Mosis II, 102-105 e Flavio Giuseppe, Antiquitates Iudaicae III, 182) esso rappresentava il cielo e i sette pianeti. Diventano così chiari i vv. 9-10: i sette lumi suoi (con l’in12 Cfr. G. PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate. Heptaplus. De ente et uno e scritti vari, a cura di E. Garin, Firenze, Vallecchi, 1942, pp. 184-188 (si tratta del secondo proemio, Aliud prooemium totius operis). Aggiungo che la conoscenza di questo luogo da parte del Tasso è un fatto certo. Guido Baldassarri ha pubblicato le postille autografe del poeta ad un esemplare degli Opera omnia del Pico (Parisiis, Ioannis parui [lo stampatore Jean Petit] impensa, 1517) che al Tasso appartenne e che fino agli anni Ottanta del secolo scorso si conservava – prima di andare disperso – nel Fondo tassiano della Biblioteca Barberiniana a Roma. Il citato passo dell’ Heptaplus vi recava sottolineature, segni di attenzione e nel margine destro la postilla di mano del Tasso “Moseos / taberna- / culum” ( insieme con molte altre che costellano il secondo proemio: cfr. G. BALDASSARRI, Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille inedite al Pico e allo pseudoCipriano, in “Studi Tassiani”, XXXV (1988), pp.141-167; la postilla è a p. 157). Torquato riprende inoltre lo stesso motivo nella splendida apertura del Giorno Secondo del Mondo creato (vv. 1- 24). 276 dispensabile aggiunta di virgola dopo suoi) non sono che segni qua giù, ‘simboli nel basso mondo terrestre’, de l’auree stelle… / che son là suso erranti, cioè dei pianeti (il gr. planetes vale appunto ‘erranti’). Ma il Dio nascosto trascende le auree stelle e il sole stesso, che sono sue creature e ubbidiscono alle leggi e all’ordine cosmico imposto dal Creatore (e le move il tuo cenno e regge il ciglio 11: un verso dalla risonanza omerica). Perciò ‘l divoto pensier si lascia a tergo, nella sua tensione verso il vero, il culto mosaico del Dio artefice del creato, colui che nomina e nasconde se stesso nella tautologia ego sum qui sum, per accedere al mondo superceleste, a quell’ “angelorum consortium” al quale “reserata est via per Christi crucem et sanguinem”13. La terzina finale si ricollega alla precedente nel tema della luce. Perch’ altre luci io veggio, altre facelle 12 rende esplicita la ragione che porta a un superamento dell’antica alleanza (cedagli quel… 7-11) in nome della nuova. Rivolgendosi con un secondo vocativo non più all’Eterno Re, all’Antico dei giorni, al Dio unico della tradizione ebraica, bensì al cristiano Padre dei lumi (Iac. I, 17 “omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a patre luminum apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio”; e cfr. Tasso, Rime 1156, 9; 1505, 123; M.c. I, 570), il Tasso – già accusato “di aver ebraizzato”– intende ora proclamare che il Cristo, sacrificandosi, ha lacerato il velo del tempio e rivelato qualcosa di ulteriore e decisivo intorno alla natura dell’ Eterno Re, del creatore onnipotente che si nasconde nell’abisso e nella tenebra dell’inconoscibilità. Le altre luci, le altre facelle – al di là di quelle splendenti nel cielo – che il poeta dopo il lungo tormento patito dalla sua anima ormai distintamente scorge e riconosce (io veggio, con forte rilievo dell’io), e che guidano e illuminano, tra sospiri e pianti, la sua umana e dolorosa navigazione come le stelle del polo, sono quelle del cristiano Deus Trinitas: il Padre ritrovato da cui discende ogni illuminazione, lo Spirito suo dono vivente (dono è una precisa appropriazione dello Spirito nella teologia trinitaria) e il Figlio oscuratosi nell’ombra della carne e della morte, l’Agnello disceso tra gli uomini per redimerli con il suo sacrificio. 13 Ancora secondo l’interpretazione del Pico (Heptaplus, cit., p.188). 277 ALESSANDRO DE’ MEDICI FRA DONI E BANDELLO Patrizia Pellizzari Anton Francesco Doni, giunto da Firenze a Venezia e ivi stabilitosi nel 1548, strinse pochi anni dopo un proficuo sodalizio con l’editore Francesco Marcolini, presso il quale pubblicò le più importanti e innovative opere. Il trasferimento dalla città natale, dove era rientrato nel 1545 dopo un soggiorno a Piacenza durato alcuni anni, non era stato indolore. Le ambizioni di acquisire uno stabile ruolo di spicco nel mondo intellettuale e letterario e di impiantare una tipografia sotto gli auspici del duca Cosimo I erano state frustrate1; fra le altre non lievi difficoltà, l’iniziale appoggio del principe era venuto meno, questi preferendogli, infine, Lorenzo Torrentino, divenuto a pieno titolo stampatore ducale. Nonostante il risentimento verso il duca, però, Doni continuò a tentare di mantenere rapporti con la madrepatria e di ingraziarsi Cosimo, nella speranza di ottenere almeno qualche riconoscimento. Così, se nel 1552 non esitò a intitolare i Mondi a vari membri della famiglia Strozzi, nemica dei Medici, nello stesso anno dedicò a Cosimo i Trattati diversi, inviandogliene anche una copia, che ricevette, in verità, una piuttosto tiepida accoglienza2. E ancora, nel 1552-1553, nei Marmi, non soltanto il nome del principe occorre più volte in termini elogiativi, ma essi accolgono pure un vero e proprio piccolo ciclo encomiastico del predecessore Alessandro, primo duca di Firenze, ucciso dal cugino Lorenzino nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 1537. Alla controversa figura di Alessandro lo scrittore aveva già alluso in una lettera-novella pubblicata nelle Lettere del 1544, una nera vicenda di persecuzione e torture inflitte alla moglie da un cortigiano e dalla sua amante, poi salvata dal- Eletto segretario dell’Accademia Fiorentina nel 1546, avviò una tipografia che produsse una ventina di edizioni, intendendo però diventare stampatore ufficiale dell’Accademia; ma la cosa non gli riuscì. 2 Per la biografia del Doni mi permetto di rinviare all’ed. da me curata della Moral filosofia e dei Trattati (A.F. DONI, Le novelle, tomo I, Roma, Salerno Editrice, 2002) e al contributo In margine all’edizione della ‘Moral filosofia’ e dei ‘Trattati’ di Anton Francesco Doni, in “Filologia e Critica”, XXVII (2002), 2, pp. 161-205. 1 278 l’intervento della corte ducale3. Il racconto, ripreso da Giuseppe Betussi nel Raverta del medesimo anno, costituisce una precoce testimonianza letteraria degli aneddoti circolanti oralmente intorno al duca assassinato, di cui Cosimo sarà implacabile vendicatore4. A questo si aggiungono, appunto, le res gestae elogiative nei Marmi, anch’esse anticipatrici della successiva fioritura di una letteratura celebrativa (se ne trovano tracce anche nella Historia di detti e fatti notabili di Lodovico Domenichi; 1557 e poi 1564) culminante nella raccolta Delle azioni e sentenze di Alessandro de’ Medici di Alessandro Ceccherelli (pubblicate nel 1564 e ristampate, con accrescimenti, nel’ 70)5. Nei Marmi sono riportati tre episodi, che propongono il principe nel suo ruolo di garante della giustizia e difensore dei deboli; si narra di come egli intervenne contro le manovre speculative dei venditori di grano fiorentini in tempi di carestia, contro due cortigiani che insidiarono, con l’inganno, una povera fanciulla, e, infine, contro un cittadino che aveva ingiustamente accusato un villano di avergli sottratto dieci ducati d’oro6. Nella struttura narrativa dei Marmi – “ragionamenti” di vari interlocutori che si avvicendano davanti a Santa Maria del Fiore – questi racconti sono racchiusi nel dialogo fra il Fiegiovanni e Giovanni Norchiati7, di cui il primo si dice autore di un’opera in cui sono esposte le imprese dei “duchi [...] che sono stati della casa de’ Medici [...] dall’antico Cosimo [...] a questo Cosimo, come dire da un mondo all’altro”. La presenza del Norchiati, morto nel 1541, retrodata il colloquio di almeno una dozzina d’anni rispetto all’uscita dei Marmi, ma comunque lo si immagina avvenire dopo la morte di Alessandro. Il secondo episodio è di particolare interesse, perché di lì a poco riapparirà in un altro libro scritto da un autore non fiorentino, con il quale Doni condivide alcuni temi narrativi8. Si tratta di Matteo Bandello e delle sue Novelle, le cui prime tre parti uscirono nel 1554 (Lucca, Busdrago) e nelle quali, più esattamente nella Seconda parte, compare un dittico, composto dai pezzi 15 e 16, incentrato sulla giustizia del duca, riconosciuta come la sua principale virtù9. La II 15, in causa qui (la II 16 tratta della diCfr. l’Appendice di lettere in coda all’ed. testé cit. (pp. 378-383). Vd. anche P. PELLIZZARI, Un’eroina di Anton Francesco Doni fra Griselda e Ghismonda, in “Levia Gravia”, VI (2004), pp. 243-261. 4 Lorenzino sarà assassinato a Venezia da sicari di Cosimo nel 1548. 5 Cfr. V. BRAMANTI, Il «cartolaio» Ceccherelli e la fortuna del duca Alessandro de’ Medici, in “Lettere Italiane”, XLIV (1992), 2, pp. 269-288. Si veda l’edizione a cura di G. Romagnoli, Bologna, Romagnoli 1865. 6 A.F. DONI, I Marmi, a cura di E. Chiorboli, Bari, Laterza, 1928, I, pp. 76-81. 7 Fu membro dell’Accademia degli Umidi e pubblicò, nel 1539, un trattato sui dittonghi toscani, dedicato a Pierfrancesco Giambullari. 8 Cfr. P. PELLIZZARI, Bandello e Doni: tangenze, in “Matteo Bandello. Studi di letteratura rinascimentale”, II (2007), pp. 249-278. 9 M. BANDELLO, La seconda parte de le novelle, a cura di D. Maestri, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1993, pp. 126-133. 3 279 fesa, da parte di Alessandro, di un avversario politico, Andrea Marsupini), in ottemperanza alla peculiare struttura del novelliere bandelliano, è preceduta da una lettera, diretta a Luigi Gonzaga10, nella quale Bandello espone le circostanze in cui ha ascoltato il racconto. Egli è a Pinerolo, nello schieramento francese guidato da Guido Rangone, cognato del dedicatario e luogotenente generale in Italia del re di Francia11. Rangone condanna a morte un giovane e valente soldato, colpevole di avere violentato una fanciulla. Non serve a salvarlo il perdono della giovane e dei parenti di lei: il luogotenente è irremovibile perché è “necessario che la giustizia abbia luogo”, soprattutto negli eserciti. Tra i molti gentiluomini che commentano l’accaduto, interviene Vincenzo Strozzi, membro di una famiglia e figlio di un padre, Filippo, fieramente avversi ai Medici e da loro perseguitati12. Il nemico dei signori di Firenze approva la condotta del capitano generale (se non si esercitasse la giustizia negli eserciti, essi si ridurrebbero a essere “spelonche di ladroni”) e individua nella giustizia la virtù somma di un principe, in grado di coprire, come “un manto” tutte le altre sue mende; infine, riconosce ad Alessandro, nonostante la famiglia Strozzi non abbia alcuna “cagione di lodarsi” di lui, di governare “con gran giustizia”. E al riguardo prende a raccontare il fatto, oggetto, appunto, della novella bandelliana. Vale la pena soffermarsi sulle versioni del racconto offerte da Doni e da Bandello, sia per la contiguità cronologica delle edizioni delle opere in cui esse compaiono, sia per l’opportunità di aggiungere un tassello alle interessanti “tangenze” riscontrate fra i due narratori. Nell’aneddoto riportato da Doni, dunque, due cortigiani convincono una giovane povera e sempliciotta a cedere alle loro lusinghe e a fuggire con loro, dandole ad intendere che uno dei due l’avrebbe sposata; ma, naturalmente, dopo essersi “cavati i ghiribizzi amorosi del capo”, la riportano a casa. Ne nasce un certo scandalo, e la madre si risolve a chiedere l’intervento del duca, il quale, certo che i cortigiani torneranno alla carica, consiglia di lasciare fare, raccomandando soltanto di assicurarsi di sapere con precisione dove la fanciulla verrà condotta. E così accade. Avvisato Alessandro, questi si reca nella casa in cui si trova la giovane, pretendendo di visitare tutte le stanze; infine, scovatala impaurita e in lacrime, dopo averla rimproverata paternamente della sua imprudenza e avere redarguito i colpevoli, si cava un 10 Uomo d’armi, negli anni in cui Bandello asserisce di avere udito questi aneddoti, ovvero durante la guerra di Piemonte (1536-1539), era maestro di campo con Carlo V contro i francesi. Morì nel 1548. 11 Bandello partecipò alla guerra al seguito di Cesare Fregoso, che, nell’agosto del ‘36, era passato da Venezia alla Francia. 12 Entrambi appoggiarono Alessandro nel 1530; Filippo poi cadde in disgrazia, fu esiliato (1534) e si suicidò dopo la sconfitta di Montemurlo (1537). Il figlio lasciò Firenze e divenne capitano dell’esercito francese durante la Guerra di Piemonte. Morì pazzo nel 1537. 280 prezioso anello dal dito e la unisce in matrimonio con colui che le aveva promesso di prenderla in moglie, obbligando il compare a versare cinquecento scudi di dote. La narrazione del Doni è divisibile in due parti. Nella prima è Fiegiovanni, ovvero il narratore, a esporre in estrema sintesi i fatti, dall’infatuazione del cortigiano alla “restituzione” della ragazza. Il racconto, povero di particolari, privilegia modalità espositive “orali” (ad es.: “la rimenarono una notte a casa, promettendola di tosto tôrla, fare e dire”). La seconda parte, assai più lunga, è, invece, interamente drammatizzata (ovvero riferita o attraverso il monologo di Alessandro alla madre, nel quale illustra il proprio piano, o tramite le serrate battute di dialogo fra il duca, i cortigiani e la fanciulla). Doni intende così porre in risalto la pronta e decisa reazione del duca all’ingiustizia; egli amministra saggiamente il proprio potere e rivela pure un notevole spirito nella risoluzione della vicenda, essendo bonario e ironico con la fanciulla e severo con i cortigiani. Tuttavia la forma narrativa, introdotta nel dialogo fra Norchiati e Fiegiovanni, rimane quella dell’aneddoto, dove al narratore e all’ascoltatore viene riservata soltanto la scarna opportunità di brevi commenti di contorno (Norchiati si limita ad esprimere il proprio stupore e ad invitare Fiegiovanni a esporre ancora la vicenda “della borsa” di ducati, cioè la terza della serie). La sostanza del racconto proposto da Bandello è simile, ma le divergenze nei modi della narrazione sono cospicue. Il cortigiano Pietro, “favorito” del principe, invaghitosi della figlia di un mugnaio, dopo avere cercato di attirarla a sé con doni e promesse, ottenuto sempre un risoluto rifiuto, organizza un vero e proprio sequestro, aiutato da due suoi amici. La giovane, di notte, viene strappata dalla propria casa sotto la minaccia della armi, davanti allo sguardo impotente del padre, e condotta a forza nel palazzo di campagna di Pietro, dove questi la violenta. L’indifeso mugnaio si rivolge al duca, che, fingendo di andare a caccia, si reca alla sontuosa dimora di Pietro. Mostrando di volerla visitare, si fa aprire tutte le camere; giunto davanti alla porta di quella in cui è rinchiusa la fanciulla, Pietro esita, cercando di accattivarsi la complicità maschile del duca e dicendogli che lì “aveva una garzona con cui era dormito la notte”. Il duca la vuole vedere, e così il misfatto viene svelato. Allora Alessandro, “con un viso di matrigna”, impone le proprie condizioni: i colpevoli, meritevoli di morte, saranno perdonati solo se Pietro sposerà la ragazza, alla quale lui e i suoi compari dovranno versare quattromila ducati di dote. Per evitare future ritorsioni, ella viene data in moglie a Pietro come se fosse “sorella carnale” del duca, sicché ad ogni sospetto di maltrattamenti egli “ne farà quella dimostrazione che d’una sua propria sorella farebbe”. 281 Bandello produce una narrazione più lunga e complessa; se limita, pure lui, le battute di dialogo ai momenti cruciali (il breve colloquio fra il duca e il mugnaio e la visita della casa di Pietro), l’esecuzione del crimine è esposta in maniera circostanziata, nell’intento di accrescerne l’enormità e colorando di fosche tinte il racconto. Inoltre, nelle parti affidate al narratore, Vincenzo Strozzi, diventano possibili inserzioni di commenti fuori campo, come, ad esempio, quelli relativi ai sentimenti suscitati in un amante respinto (“il più de le volte avviene che quanto più un amante si vede interdetta la cosa amata egli più se n’accende e più desidera venir a la conclusione, e molte volte ciò che da scherzo si faceva si fa poi da dovero”). Una differenza notevole, rispetto alla versione doniana, per le ricadute ideologiche ad essa collegate, è la totale resistenza della fanciulla alle lusinghe del seduttore. In Doni, invece, è l’ingenuità della protagonista a perderla: ella cede alle dongiovannesche promesse dei cortigiani, presto deluse. Non è che il diverso modo di giungere a possedere la sventurata (in Bandello con la brutalità, in Doni con l’inganno) costituisca agli occhi di Alessandro de’ Medici un elemento di maggiore o minore colpevolezza, anche se nei Marmi il duca ne rimprovera la leggerezza (“[…] le buone fanciulle si stanno a casa loro e non vanno con i cortigiani: che bell’onore voi fate alla vostra casata!”). Ma è inevitabile che tale differenza abbia un peso nell’adozione del registro stilistico delle due novelle: più “giocoso” nei Marmi, drammatico nel novelliere bandelliano. Sicché, in quest’ultimo, Alessandro è un giudice temibile e inappellabile, anche se clemente (“Io non so chi mi tenga che a tutti tre or ora non faccia mozzar il capo. Ma io vi perdono tanta sceleratezza,”ecc.). Questa volta, e contrariamente ad altre novelle, Bandello si arresta sull’orlo del baratro, senza pervenire a uno dei non rari esiti violenti della raccolta: benché la tragica sopraffazione sia consumata, l’intervento della razionalità (l’esercizio della giustizia da parte di un principe, prudente e di temperato giudizio, benché egli stesso “assai dedito ai piaceri venerei”) conduce ad un insperato “lieto fine”13. La gravità della novella bandelliana, appena scalfita dall’uso di alcuni modi di dire, relegati nel racconto del narratore e mai apparenti nei dialoghi fra i personaggi (ad es.: l’innamorato “cominciò a far la ruota del pavone a torno a costei”), si distanzia dal registro fra il serio e il faceto del racconto dei Marmi, culminante nel dialogo fra il duca e la fanciulla: “E quivi, dopo alcune gran minaccie e riprensioni, adoprò le buone parole, che la voleva maritare e dargli parecchi centinaia di ducati di dote; e gli disse, mostrandogli uno de’ suoi 13 La differente decisione di Alessandro rispetto a quella adottata dal Rangone, che offre spunto al racconto, non è una indiretta censura dell’operato del luogotenente; come ha premesso lo stesso Vincenzo Strozzi, infatti, il comando di un esercito impone di essere più inflessibili. 282 bravi e gentilissimi capitani: – Questo vi piace egli per isposo e per marito? –, ecc.”. Non manca, poi, nell’opera doniana, una sottile vena scherzosamente misogina, che ricade sia sulla ingenua ragazza sia sulla madre di lei, alla quale Alessandro, assicurando il proprio appoggio, raccomanda di non “andare cicalando” in giro, “come è il solito di tutte le donne”. Come si è accennato all’inizio, l’interesse di questi racconti risiede principalmente nella precocità della loro proposta letteraria rispetto ad altri dedicati alle imprese del principe. Doni, soprattutto, che aveva sempre proclamato Alessandro suo patrono e lo aveva più volte rimpianto, si fa portabandiera della sua rivalutazione14. Per parte sua, Bandello, militante nelle file francesi, esalta un principe dalla dubbia reputazione, appartenente per di più a una famiglia legata all’Impero e alla Spagna. L’avere, poi, collocato l’ascolto del racconto durante la guerra di Piemonte, più esattamente fra il 16 agosto 1536 e il 6 gennaio 1537, quando il duca, quindi, era ancora vivo15, e l’averne attribuito l’esposizione a un fuoriuscito pongono degli interrogativi sia in relazione alla primogenitura letteraria di questa vicenda (spettante a Doni o a Bandello?)16, a prescindere dalla data di pubblicazione delle rispettive opere, sia in merito alla ragione e al significato da attribuirsi all’inaspettato elogio bandelliano. Questi problemi, soltanto per essere affrontati, richiederebbero di essere esaminati nell’ambito del pensiero politico di Bandello e del suo atteggiamento nei riguardi della politica spagnola e imperiale in Italia, vincenti a metà Cinquecento. Ma la questione abbisognerebbe di lunghi discorsi, non proponibili in questa circostanza17. Comunque stiano le cose, la letteratura encomiastica su Alessandro, posteriore alla prima sporadica testimonianza offerta da Doni nel 1544 – e consistente sia negli ulteriori contributi doniani dei Marmi sia negli aneddoti riferiti da Bandello, da Domenichi e dalle raccolte cui prima si è accennato –, tende soprattutto a metterne in luce le virtù di moderazione e sobrietà (contrastanti con la fama acquistatasi di uomo tendente agli eccessi sensuali), nonché di liberalità e giustizia, tratteggiando il ritratto di “sovrano Cfr. M. PLAISANCE, Le retour à Florence de Doni: d’Alexandre à Côme, in ID., L’Académie et le Prince. Culture et politique à Florence au temps de Côme Ier et de François de Medicis, Manziana, Vecchiarelli, 2004, pp. 405-417. 15 Sia in questa novella che nella II 16, Bandello discorre del principe usando sempre i verbi al tempo presente e parlando di lui come allora regnante in Firenze. 16 BRAMANTI (pp. 279-280) sembra propendere per l’anteriorità della storia bandelliana, tenuto conto anche dell’ipotesi, espressa da Adelin Fiorato, che essa sia stata scritta come “contre-nouvelle” rispetto alla dodicesima dell’Heptaméron di Margherita di Navarra, nella quale si racconta l’assassinio di Alessandro e il duca è dipinto in maniera del tutto negativa, facendo risaltare, invece, la figura di Lorenzino. Benché l’opera di Margherita sia uscita postuma solo nel 1558 (e poi nel 1559), Bandello ne era di certo al corrente ben prima (cfr. A.C. FIORATO, Bandello et le règne du père, in AA. VV., Les écrivains et le pouvoir en Italie à l’époque de la Renaissance, Paris, Sorbonne Nouvelle, 1973, pp. 77-154). 17 Si rinvia al contributo di Fiorato appena cit., pp. 117 e ss. 14 283 ideale”, secondo i dettami suggeriti dalla tradizionale letteratura de principe, escluso, va da sé, Machiavelli18. La figura del duca è rappresentata nell’esercizio quotidiano del potere; di lui, pertanto, non si riportano le tappe ufficiali del suo governo, ma nobili atti e sagge parole eseguiti e pronunciate in circostanze comuni, suggerendo come la statura di un principe sia meglio misurabile nelle vicende meno vistose, lontano dalla scena della “grande storia”. Inoltre, molti degli avvenimenti riportati vedono Alessandro intervenire a favore di personaggi umili, da lui protetti dalla prepotenza di nobili e cittadini avidi. Le collezioni di memorabilia ducali sono costituite da come egli risolve le controversie fra forti e deboli, ponendo in evidenza uno degli aspetti della politica del duca assassinato, ovvero il tentativo di arginare la superbia e il potere degli Ottimati fiorentini e di ricercare il consenso dei ceti più bassi. Nell’ambito di questa letteratura, attestata in specie da quattro testimoni – tre manoscritti e uno a stampa –19 può essere interessante vedere come sia presentato l’aneddoto della fanciulla e dei cortigiani. Nel primo manoscritto, il Palatino 699 (cc. 6v-11v), la versione è piuttosto diversa da quella doniana, mentre è più prossima, pur con varie e notevoli divergenze, a quella di Bandello. La giovane è, come nel novelliere settentrionale, la figlia di un mugnaio; il fatto, però, avviene a Pisa (non a Firenze o nel contado) e, come in Doni, sono da subito coinvolti due cortigiani, entrambi innamorati di lei. Per vincere le sue resistenze, l’anonimo autore ricorre all’intervento di una ruffiana, che la attrae con l’inganno nel palazzo di uno di loro, dove si consuma lo stupro. Se manca la violenta esecuzione bandelliana del rapimento, manca pure l’atmosfera più lieve dei Marmi, giocata sulla dabbenaggine della fanciulla, facilmente persuasa dalle lusinghe degli spasimanti. Alcune circostanze minori sono da rilevare, perché permettono di stabilire rapporti di parentela fra le varie versioni. Nel ms. Palatino, dopo un primo tentativo fallito della ruffiana (una vecchia “molto devota del cordiglio dei frati di san Francesco, la quale pareva la Beata da Signa”) di convincere la giovane a cedere, la fortuna offre l’occasione di attuare il tranello: la ragazza deve recarsi da una zia e, non potendo essere accompagnata dalla madre, viene affidata alla custodia della donna. Il padre, piutto18 Tuttavia Bandello, nella novella II 16, giustifica gli atteggiamenti “machiavellici” di Alessandro, primo fra tutti la necessità di spegnere o esiliare i nemici (M. BANDELLO, La seconda, cit., p. 131; vd. A.C. FIORATO, Bandello, cit., p. 124). 19 Sono nell’ordine: I Detti et i Fatti degni di Memoria, del Signor Alessandro de’ Medici Duca di Fiorenza, ms. Palatino 699 (anonimo, conservato, come i seguenti, nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), databile fra il 1554 e il 1559 (= P); le Sentenze del Duca Alessandro de’ Medici Duca di Firenze, ms. Magliabechiano XXI 144, anonimo e miscellaneo (= M); le Sententie dello Illmo Duca Alessandro de’ Medici di ser Sforzo da San Giovanni, ms. 10523, risalente agli anni Settanta del Cinquecento (= S); e la già cit. opera del Ceccherelli (= C); cfr. V. BRAMANTI, Il «cartolaio», cit., e P. PELLIZZARI, Un’eroina, cit., pp. 245-246. 284 sto inspiegabilmente sotto il profilo narrativo, le segue per un certo tratto e può vedere la figlia entrare nel palazzo del cortigiano e sentirne le grida. Saputo che il duca è a caccia da quelle parti, si reca da lui, chiedendo giustizia. Alessandro si introduce nel palazzo, finge di volerlo visitare e trova la fanciulla rinchiusa in una latrina. È poi lui stesso a sposare, togliendosi un anello dal dito (come nei Marmi) la giovane con colui “che ella amasse più, o per dir meglio odiasse meno”, obbligando l’altro a versare cinquemila scudi di dote. Le ultime parole di Alessandro (“sposala, et fa che sia non altramente trattata, che tu facessi se fusse mia figliuola”) riecheggiano quelle bandelliane. Nella “morale” conclusiva si ribadisce il tratto caratteristico di queste “azioni” del duca: “a coloro insegnò come non si debbano oltraggiare i Poveri”. La versione del Magliabechiano (cc. 5v-9r), è quasi uguale, e se ne può sostenere la diretta derivazione dal Palatino20. A quella di tale manoscritto è anche del tutto contigua la novella esposta nell’opera del Ceccherelli, dove questo e gli altri numerosi aneddoti relativi ad Alessandro (quarantadue nell’ed. 1564, quarantacinque in quella del ‘70) sono incorniciati in un dialogo fra il Domenichi e altri cinque interlocutori, che si immagina svolgersi in una giornata estiva, trascorrendo in piacevole novellare le ore più calde, alla maniera della brigata decameroniana21. Che il Palatino sia la fonte principale del Ceccherelli è sicuro22: lo attestano non soltanto lo svolgimento uguale della storia, inclusi i particolari più minuti, ma anche le riprese letterali del dettato manoscritto, con una propensione a smorzare certe espressioni23. La fanciulla, infine, viene raccomandata al futuro sposo di trattarla come se ella fosse “la prima gentil’ donna di Pisa” (gli scudi di dote questa volta sono tremila). Al Ceccherelli dovette apparire troppo temerario elevarla al rango di sorella o figlia del duca, giacché l’intero dialogo si svolge sotto gli auspici della figlia vera di Alessandro, Giulia de’ Medici24. Anche il commento conclusivo, che in P rivendicava a chiare lettere il ruolo di Alessandro difensore dei poveri, preferisce riportare il duca alla più neutra funzione di chi ha “soddisfatto con degno e onorevol gastigo alla giustizia”. Il tardo manoscritto di Sforzo da San Giovanni dà una versione piutto20 Anche nei particolari, con una tendenza, però, all’amplificazione; ad es.: la ruffiana è “molto divota del cordiglio dei frati di santo Francesco, la quale pareva più devota che la beata da Signa, sempre masticando Ave Marie”. La natura calligrafica di M lo fa supporre una bella copia di P (interrotta a metà della c. 48), seppure non passiva, ma parzialmente rielaborata. 21 Cfr. A. CECCHERELLI, Delle azioni, cit., p. 14. 22 Ciò vale non solo per l’aneddoto qui esaminato ma per l’intera opera: cfr. V. BRAMANTI, Il «cartolaio», cit., p. 282. 23 Ad es.: la latrina, dove è stata rinchiusa la fanciulla, per nasconderla agli occhi del duca, esplicitamente definita in P “stanzino, dove si suol ire a por giù il soverchio peso del corpo”, in C diventa eufemisticamente: “stanzino che per commodo necessario era ordinato”. 24 Cfr. A. CECCHERELLI, Delle azioni, cit., p. 23. 285 sto edulcorata della storia25: la figlia di un mugnaio pisano si lascia blandire dalle chiacchiere di una ruffiana che la distrae, dando modo ai seduttori di introdursi nella casa di lei e di portarla, senza usare la forza, nel palazzo di uno di loro. Il mugnaio chiede l’intervento del duca, casualmente a caccia in quella zona. Qui è il duca a fingere una certa complicità maschile con il cortigiano; scoperta la fanciulla nel “privale”, dice: “tu hai qui una bella preda et la volevi per te?”; e sempre con tono giocoso, si rivolge a lei: “Et perché piagni? Hai tu forse paura che io non ti tolga i tua innamorati?”. Ella viene salvata da Alessandro prima che le sia usata violenza (“Signore, conservatemi l’onore, quale ancora son vergine”); a lei spetta la scelta, di certo meno traumatica che nelle altre versioni, del giovane cui “vuole meglio”, al quale il duca impone di trattarla “da sposa” (la dote è di trecento ducati). Lasciando da parte la molto differenziata qualità letteraria di tutti questi racconti, resta da sottolineare il diverso timbro e la diversa valenza degli aneddoti nei vari contesti. Il passaggio del loro inserimento da un’opera di magmatica configurazione, come i Marmi, e dal libro di novelle bandelliano alle collezioni di detti e fatti memorabili non è privo di conseguenze. L’intento celebrativo, pur ben visibile in Doni e Bandello, che forniscono le prime testimonianze scritte della vicenda, è surclassato dall’impianto nettamente agiografico delle raccolte seriori. Muovendo da un patrimonio narrativo orale, Doni produce un racconto il cui svolgimento è destinato a rimanere isolato nella tradizione letteraria. Non si può dire che Bandello lo conoscesse, nonostante la cronologia delle stampe dei Marmi e delle Novelle possa tentare a supporlo (la sua versione non ne reca traccia, se non nella trama, intesa nel senso più lato, e nell’ambientazione fiorentina). Per quanto concerne le altre versioni, alcune delle quali assai imparentate fra loro, esse mostrano alcune consistenti differenze con quelle dei due scrittori, pur essendo per certi particolari più simili a quella di Bandello. È difficile dire se attingessero a un ramo diverso della tradizione, o se, nel caso soprattutto del novelliere settentrionale, abbia contato di più, per marcare la differenza, la ben altra mano dello scrittore, sapiente nell’eliminare particolari inverosimili (ad es. il “pedinamento” del mugnaio; l’arrivo accidentale del duca, che proprio allora si trova a caccia da quelle parti) o personaggi superflui (la ruffiana), e nel tratteggiare una narrazione che travalica di gran lunga i propositi meramente encomiastici. Resta, comunque, che né la levità e la sintesi doniane né la bandelliana atmosfera cupa e notturna troveranno eguali. Il ms. è stato pubblicato alquanto scorrettamente da Giuseppe Baccini (Mugello, Mazzocchi, 1903). Ho perciò confrontato questa ed. (dove l’aneddoto, datato 23 agosto 1534, è alle pp. 13-17) con l’originale (cc. 277r-280r). 25 286 287 EDUCAZIONE E CULTURA IN ANTONIO BANFI Antonio Erbetta Scovare nell’opera di Antonio Banfi la questione pedagogica per metterne in luce i molteplici risvolti culturali non è di certo un atto storicointerpretativo inedito. E non lo è per almeno tre determinanti ordini di fattori. In primo luogo – forse il più ovvio – perché Banfi, notoriamente, ha molto scritto di pedagogia, sia per quanto riguarda la comprensione teoretica della sua forma culturale (penso in particolare ai molti saggi poi raccolti nel postumo La problematicità dell’educazione e il pensiero pedagogico del 1961); sia per la dimensione storica della pedagogia medesima, ove al Sommario di Storia della pedagogia del 1931 – che tentava la strada di una sua restituzione in chiave di storia della civiltà – s’erano accompagnati gli studi che avevano condotto al decisivo Pestalozzi, forse il più sorprendente, insieme a Galilei e Spinoza, degli eroi che popolano la sua drammaturgia filosofica. Sia, in ultimo, per la straordinaria attenzione alla vita della scuola, da lui afferrata – da intellettuale che nel secondo dopoguerra siede tra i banchi del Senato – come il precipitato materiale dell’idealità che la fa tramite primario di emancipazione collettiva, così come, per altro, si conveniva ad ogni vero grande filosofo e/o intellettuale del secolo scorso. E così come è documentato nel volume, ancora una volta postumo, Scuola e società1. In secondo luogo una lettura di Banfi in chiave pedagogica non è un atto particolarmente originale se non altro perché, tra gli scolari della prima Scelti e ordinati da G.M. Bertin, i principali scritti teorici e storici di Banfi sul problema pedagogico (La problematicità dell’educazione e il pensiero pedagogico, Firenze, La Nuova Italia, 1961) sono poi rifluiti nel vol. VI delle Opere (Pedagogia e filosofia dell’educazione, a cura di G.M. Bertin e L. Sichirollo, Reggio Emilia, Istituto Antonio Banfi, 1983). Il Sommario è stato riproposto dall’editore Argalia di Urbino nel 1964. Il Pestalozzi, del 1929, è stato ripubblicato a Firenze, presso la Nuova Italia, nel 1961. Infine Scuola e società, uscito dapprima nel 1958 per Editori Riuniti, è stato rieditato in forma ampliata, con la curatela di Alberto Burgio, nel vol. XIII delle Opere (Scritti e discorsi politici. I. Scuola e Società, Reggio Emilia, Istituto Antonio Banfi, 1987). Per l’insieme dell’opera di Banfi, cfr. R. SALEMI, Bibliografia banfiana, Parma, Pratiche, 1982, ora integrata e aggiornata da R. CEGLIA, Bibliografia banfiana, in AA.VV., Ad Antonio Banfi cinquant’anni dopo, a cura di S. Chiodo e G. Scaramuzza, Milano, Unicopli, 2007. È in questo contesto di celebrazioni banfiane – nel quale chi scrive è presente con il suo L’eredità pedagogica di Antonio Banfi – che vivono, d’altra parte, le presenti pagine, le quali riproducono sostanzialmente la relazione tenuta alla Casa della Cultura di Milano nella giornata dedicata, il 19 Ottobre 2007, alla figura e all’opera di Antonio Banfi. Più in generale ci sia consentito rinviare al nostro L’umanesimo critico di Antonio Banfi (Roma, Anicia, 2008, n.e.). 1 288 generazione – quelli, per capirci, che, da Paci a Cantoni, da Formaggio a Sereni, da Preti ad Anceschi, avevano frequentato le celeberrime sue lezioni milanesi del ‘33-’34 su Nietzsche, c’è anche, ultimo ma non ultimo, Giovanni Maria Bertin2. E proprio a Bertin si deve una fedele trascrizione del razionalismo critico banfiano esattamente in termini di problematicismo pedagogico. Una trascrizione che risale alla prima metà degli anni cinquanta e che si compie nel 1968 con Educazione alla ragione: una trascrizione per taluni aspetti così minuziosa e puntuale da assorbire in sé la sistematica di Banfi nei termini di una rigorosa filosofia dell’educazione (forse la più rigorosa, o meglio la più diversamente rigorosa, dopo quella di Gentile)3. In ultimo luogo perché, giusto a proposito di Bertin, vi è una famosa lettera – tra l’altro frequentemente rievocata da Sichirollo – nella quale Banfi confidava a Bertin stesso il fatto che i medesimi Principi di una teoria della ragione dovevano essere, nelle sue intenzioni, un lavoro preparatorio in vista di una Teoria generale dell’educazione alla quale sicuramente Banfi si metterà a lavorare, ma che non venne mai stesa4. Dunque sono davvero molte le ragioni che, per la notorietà di quel che si è detto, non fanno del “Banfi in quanto teorico dell’educazione” un capitolo inedito della ricerca attorno alla sua figura e alla sua opera. Così come, se si fa mente locale al suo periodo di giovane professore di liceo – quel lungo periodo che dalle colline di Jesi e di Urbino lo costringe, negli anni Venti, alle pozzanghere di Alessandria – non si può ignorare il peso di una esperienza che molto graverà – almeno io credo – sulle vicende politico-culturali del secondo dopoguerra, dagli straordinari interventi in Senato, a quel celebre dibattito sul latino che, contrapponendolo a Concetto Marchesi, fa di Banfi uno dei veri padri nobili della Riforma della scuola media unica del 1962, a cinque anni dalla sua morte5. Eppure proprio in quel dettaglio – in quella confidenza inusuale – consegnato alla lettera indirizzata a Bertin nel giugno del 1942, sembra risiedere la chiave simbolica grazie alla quale si può parlare in Banfi del rapporto tra educazione e cultura. Di parlarne, si badi, non già, e comunque non solo, come di uno degli orizzonti specifici compresi nella sua sistematica teoretica, bensì come possibilità d’intercettare tutta la personalità di Banfi – A. BANFI, Introduzione a Nietzsche, a cura di D. Formaggio, Milano, Isedi, 1974. È da quella fosforescente nidiata di allievi che nascerà la cosiddetta Scuola di Milano, in seguito raccolta nella Redazione di “Studi filosofici”, la celebre rivista (1940-1949) fondata e diretta da Banfi. Sulla vita, le articolazioni intellettuali e i diversi destini di quel mondo, cfr. F. PAPI, Vita e filosofia. La scuola di Milano. Banfi, Cantoni, Paci, Preti, Milano, Guerini e Associati, 1990. 3 G.M. BERTIN, Educazione e ragione, Roma, Armando, 1968. 4 ID., L’idea pedagogica e il principio di ragione in Antonio Banfi, Roma, Armando, 1961. 5 Sulla questione si vedano, ad esempio, le pagine che gli dedica Livio Sichirollo nel suo Attualità di Banfi, Urbino, Quattro Venti, 1986. 2 289 dunque il senso di tutta la sua presenza culturale – a partire dalla peculiarità di questo punto di vista. Ovvero di vedere in questa questione i due tempi in uno che, in mezzo alle tante polemiche, tengono insieme il giovane Banfi, in particolare il Banfi scolaro di Simmel6, e l’ultimo Banfi, quello dell’uomo copernicano e dell’umanesimo marxista come orizzonte di verità del pensiero contemporaneo7. Infatti: che cos’è per Banfi l’educazione? Aveva scritto il Nostro nel 1931: L’educazione, considerata universalmente nella sua idea, può definirsi come il processo di formazione e di sviluppo della personalità spirituale, che si compie nel rapporto tra l’anima individuale e il mondo dell’esperienza e della cultura. L’anima, aprendosi alla realtà e alla vita, va sciogliendosi dai contenuti e dalle forme del suo particolare essere immediato e, senza distruggere la propria essenziale originalità, assimila i nuovi contenuti che l’esperienza le offre, elaborata e organizzata dalla cerchia di cultura a cui l’individuo appartiene. Questi diviene così partecipe dei valori e delle leggi ideali che sostengono tale cultura e ne esprimono le linee di sviluppo, trova in essi il principio superiore della sua vita e delle sue azioni, acquista in tal modo dignità e libertà di persona spirituale e comunione attiva con gli altri uomini: mentre a lor volta i valori culturali trovano in lui nuove forme e nuove energie d’attuazione8. Qui, ad agire in profondità, vi è – a ben vedere – l’idealtipo goethiano del “soggetto perfetto”. Vale a dire il medesimo orizzonte etico-formativo al quale proprio Simmel – in particolare l’ultimo Simmel, quello direttamente conosciuto da Banfi a Berlino – affidava il significato più intimo della nozione di “azione reciproca”9. Ciò per cui l’educazione è esattamenA Georg Simmel, “il più grande filosofo della crisi della sua epoca”, secondo le parole di Lukács, Banfi si legherà da subito con radicalità spirituale quando, dopo la laurea, frequenterà a Berlino le brillanti lezioni di questo straordinario interprete della modernità. Sicché Banfi, che in Italia sarà per lungo tempo l’unico promotore delle traduzioni simmeliane (le quali solo negli ultimi trent’anni, decretando il suo effettivo valore, lo hanno fatto conoscere nel dettaglio dei suoi molteplici risvolti culturali) a Simmel dedicherà l’importante saggio Il pensiero filosofico e pedagogico di Georg Simmel, in “Rivista Pedagogica”, 1931, n. 4, poi ripresentato, con il titolo Georg Simmel e la filosofia della vita, nel volume postumo Filosofi contemporanei, a cura di R. Cantoni, Firenze, Parenti, 1961. 7 A. BANFI, L’uomo copernicano (1950), Milano, Il Saggiatore, 1965. 8 ID., Sommario di storia della pedagogia, cit., p. 9. 9 La nozione di azione reciproca (Wechselvirkung) sta al centro di tutta l’opera di Simmel, sia in relazione al suo sforzo sociologico di rispondere alla domanda-chiave di Soziologie del 1908 (trad. it. Sociologia, Milano, Comunità, 1989): “com’è possibile la società?”, sia in ordine al dinamismo che inside a tutta la sua filosofia della vita, da lui consegnata, nel 1918, a mo’ di testamento spirituale, a Lebensanschauung (trad. it. Intuizione della vita, Napoli, ESI, 1997. Per la sua risonanza in chiave pedagogica si rinvia al nostro L’azione reciproca come forma dell’esperienza educativa, relazione tenuta a Roma il 6 giugno 2008, in occasione del Convegno internazionale organizzato dalla Società Italiana di Sociologia su “Sociologia cent’anni dopo”, i cui Atti sono in corso di pubblicazione. 6 290 te luogo e processo di formazione della “legge individuale” (das individuelle Gesetz). Quella legge secondo la quale – con un movimento, giustappunto di azione reciproca – “i contenuti della cultura che tendono all’ideale, divengono insieme anche contenuti della vita soggettiva, e i valori soggettivi si obiettivano in valori di cultura”10. Ma quella pagina di Banfi non registra solo un dispositivo teoretico, in quanto essa si misura, sul piano storico-culturale, con la nozione di crisi che giusto in quel momento trova la sua sistemazione nei due blocs che daranno vita all’omonimo volumetto postumo11. Laddove nella nozione banfiana di crisi al centro sta proprio il rapporto educazione/cultura, secondo una prospettiva per la quale, al tema metodologico e regolativo che presiede all’azione reciproca tra ragione e vita – così per come esso veniva drammaticamente registrato dai giovani intellettuali di allora12 –, si sovrappone quello più generale tra persona e società, in maniera tale da annunciare il senso etico-politico di quel medesimo rapporto per come esso maturerà, infine, nel secondo dopoguerra. Cos’era, infatti, la crisi per Banfi se non – almeno in prima battuta – il manifestarsi concreto della sconnessione di valori, significati ideali e stili di vita che ricorsivamente investe una società quando essa viva l’esperienza di un mutamento profondo? E come non intercettarla immediatamente, seppur tramite le infinite forme della vita di cultura, proprio come la messa in questione della mediazione educativa, tanto quanto la si strappi dall’usualità pedantesca di un sapere retorico ed esortativo? A dire, e con Banfi: quando una società esprime una sua intima coerenza strutturale, sicché in lei la concretezza dei rapporti materiali e ideali si rispecchia felicemente nelle forme della rappresentazione individuale e collettiva, lì saranno esattamente le sue istituzioni formative a farsi, insieme, segno e senso della sua stessa vita quotidiana, in quanto avamposti sistemici che in sé riflettono, giustappunto, la sintesi effettiva del mondo che le produce. Ma quando quella stessa società esperisce la disarticolazione degli infiniti legami che la sostengono, tale da vivere senza più centri di riferimento in grado di assumere la dialettica del conflitto al fine di ricondurla al punto di vista di una condivisibile esigenza di trasformazione culturale e sociale, in quell’istante è proprio la sua funzione formativa – ciò che tradizionalmente chiamiamo scuola – a rispecchiare per prima, e forse più 10 Cfr. G. SIMMEL, Ethik und Probleme der modernen Kultur (1913), trad. it. L’etica e i problemi della cultura moderna, Napoli, Guida, 1968, p. 43. 11 Cfr. A. BANFI, La crisi, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1967. 12 Esemplare in tal senso la vicenda umana e intellettuale di Carlo Michelstaedter, non a caso pensato da molti interpreti banfiani (chi scrive compreso) come alter ego profondamente presente – così come, con intensa ed intima relazione amicale, Clemente Rebora – al giovane Banfi. 291 drammaticamente, la crisi della società. Tanto da divenire, essa, il sismografo più sensibile – e tra i più sovraesposti – di ogni età che si ritrovi a fare i conti col sentimento drammatico di un perduto orizzonte culturale e morale. Insomma: gli anni trenta-quaranta, quelli entro cui convergono, in Banfi, l’illimpidirsi della nozione di crisi, da una parte, e il tema della persona dall’altra, sono gli anni dai quali il problema del rapporto educazione/cultura si trasferisce, per lui, sul piano della responsabilità politica, secondo una prospettiva sempre più orientata in senso morale. Tanto che nel 1943 – ovverosia nel momento più tragico ed esaltante a un tempo della sua storia intellettuale13 – nel saggio La mia prospettiva filosofica Banfi pone al centro della sua riflessione esattamente il nesso educazione/morale/politica14. Se l’educazione, dice Banfi in questa decisiva occasione, è “l’immanente formarsi in sé della persona” – ciò che appunto sembra rispecchiarsi nell’antica lezione di Simmel –, è la politica ciò che, viceversa, coglie l’obiettività sociale nel suo valore di autonomia culturale. Per cui, aggiunge in quell’occasione il Maestro milanese, il processo educativo e il processo politico pongono dunque l’una dinanzi all’altra la personalità e la società alla ricerca della propria concreta autonomia spirituale. Da un punto di vista trascendentale le due direzioni sono indipendenti, anzi, antinomiche, ché ciascuna tende a ridurre a sé e a risolvere in sé l’altro polo: la persona a costituirsi come assoluto centro di coscienza e di vita, risolvente in sé ogni alterità; la società come assoluta struttura di diritto, riconducente alla sua esigenza di progressività, alla sua libertà formale ogni persona15. Di qui la moralità come soluzione immanente di tale conflitto, giacché, conclude Banfi, se è vero che “nella moralità la persona sembra attingere la sua ideale libertà solo nel seno della comunità, e la comunità raggiungere la sua universalità progressiva come regno delle libere personalità spirituali”, va da sé come “il momento morale medii sempre in pratica educazione e politica”16. Il tutto ad una condizione. Quella condizione che, contro le ricorsive tentazioni dell’anima bella, ci costringono, tuttavia, a riconoscere come per moralità Banfi oramai non potesse intendere nulla che non fosse 13 È il momento in cui il filosofo entra direttamente nella lotta di Liberazione. Un momento che drammaticamente inaugura il destino etico dell’ultimo Banfi, il cui stile socratico bene traluce dalle poche ma intense battute che – a prescindere dalle innumerevoli ricostruzioni storico-critiche – gli dedica Rossana Rossanda, allora sua giovanissima allieva all’Università e in seguito sua prima segretaria all’atto di fondazione della Casa della Cultura – nel suo autobiografico Una ragazza del secolo scorso, Torino, Einaudi, 2005, pp. 73 e sgg. 14 Cfr. A. BANFI, La mia prospettiva filosofica, in AA.VV., Filosofi italiani contemporanei, a cura di M.F. Sciacca, Como, Marzorati, 1943, poi in ID., La ricerca della realtà, Firenze, Sansoni, 1959. Qui ci serviamo di quest’ultima edizione. 15 Ivi, pp. 86-87. 16 Ibid. 292 la moralità dell’agire concreto. Ciò che in termini di storicismo integrale oramai s’intreccia, nel medesimo torno di tempo, con la questione storicoculturale dell’uomo copernicano e con quella etico-politica del comunismo da lui letto in chiave di umanesimo marxista17. A legittimare, tutto questo, l’idea secondo cui quella dell’uomo copernicano non è altro che declinazione novecentesca di una vera e propria paideia. In altri termini: se in Banfi – che resta pur sempre il filosofo più europeo del nostro Novecento – educazione e cultura rappresentano, sul piano teoretico, i termini di coimplicanza secondo cui la personalità spirituale e l’obiettività delle forme sociali vivono nella e della loro tensione reciproca, là dove irrompe la crisi tale dialettica ci restituisce il problema del rapporto tra personalità individuale e autonomia sociale nei termini di una tensione radicale. Quella tensione tra educazione e politica che solo la responsabilità concreta di un’etica dell’azione può sciogliere in vista del mondo-degli-uomini. Certo: non si potranno ignorare, poi, i grandi problemi che, retrospettivamente, ci è dato scorgere nell’opera dell’ultimo Banfi, così come non si potranno sottacere polemiche, incomprensioni e riserve che, per lo più in forma di silenzi tanto dolorosi quanto esemplari, ne hanno accompagnato il tramonto. Ciò che urge allo sguardo critico è semmai la possibilità, sine ira et studio, di rintracciare in Antonio Banfi la fondamentale attitudine a decifrare il significato dell’impegno filosofico sul versante di una coscienza pedagogica interpretata, non già come deduzione didascalica di un ordine teoretico, quanto piuttosto come trascrizione sistematica della vita educativa destinata a farsi esperienza vissuta dell’uomo in quanto cultura. Ovvero, alla maniera del giovane Nietzsche in lotta contro la formazione degli “uomini di mestiere”, come “benigno scroscio di pioggia notturna”18. Quanto basta, allora, per evocare con ciò la portata europea di Banfi. Ma, più ancora, l’estrema dignità che compete, oggi più che mai, al termine educazione quando, sottratto alle formule del pedagogismo corrente, esso ci dica del mondo e delle sue infinite forme di rappresentazione culturale. 17 Decisive, nel novero delle riflessioni critiche, quelle che Fulvio Papi – che di Banfi è stato ultimo scolaro e suo diretto assistente di cattedra nei suoi ultimi anni vita, nonché giovane protagonista a fianco di Riccardo Lombardi, di una rilevante stagione etico-politica del socialismo italiano – ha dedicato al Maestro nei suoi rapporti con il marxismo. A partire dal suo decisivo Il pensiero di Antonio Banfi, Firenze-Milano, Parenti, 1961, per giungere al suo recente Antonio Banfi. Dal pacifismo alla questione comunista, Como-Pavia, Ibis, 2007. Senza scordare le pagine rievocative contenute in La memoria ostinata Milano, viennepierre, 2005. 18 La celebre espressione di Nietzsche sta nella III delle Unzeitgemäße Betrachtungen, ovverosia in Schopenhauer als Erzieher. Ed essa non a caso riecheggia nelle sopra ricordate lezioni di Banfi del 1933/34. Al punto che da esse prende avvio un percorso carsico di lettura che, in hoc signo, porterà Bertin a scrivere Nietzsche. L’inattuale, idea pedagogica, Firenze, La Nuova Italia, 1977. E da ultimo Nietzsche e l’idea di educazione, Torino, Il Segnalibro, 1995. A sancire, così, un debito culturale che, per altri aspetti, aveva tanto impegnato anche Enzo Paci. 293 L’ATTUALITÀ PEDAGOGICA DEL RELAZIONISMO DI ENZO PACI Elena Madrussan Fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, e poi per tutti gli anni Sessanta, il relazionismo di Enzo Paci si proponeva come una prospettiva priva di quegli appigli tradizionali che hanno consentito – e che talvolta ancora consentono – all’educativo di coincidere con riferimenti aprioristici o con modelli ideali, siano essi morali, culturali, ideologici, prassici. Proprio per questo il fulcro concettuale ed esistenziale del relazionismo è stata l’individuazione della relazione come nucleo problematico dove si amplificano tutte le declinazioni del relazionare quali luoghi immanenti specifici non separati. In altri termini, ciò che premeva a Paci era di ricollocare le forme dell’esistenza all’interno di un plesso problematico nel quale gli intrecci tra i diversi ambiti esperienziali e culturali potessero sottrarsi al rischio di restare imbrigliati in particolarismi del tutto indipendenti dalla contingenza del reale. Tanto sul piano culturale, minacciato da uno specialismo disciplinare teso a frammentare astrattamente l’esperienza soggettiva del mondo e del sapere, quanto sul piano etico, dove l’educazione risultava contesa tra normatività e ideologia. Secondo il filosofo di Monterado, infatti, “educare è richiamare all’esistenza”1 e, in quanto tale, l’educazione è un esercizio2. Nell’ambito del quadro storico-culturale di cui Paci è erede e nel quale il suo relazionismo si inscrive pienamente, indicare l’esercizio all’esistenza come parametro principe dell’educazione è stato un modo incisivo per porre la questione nei termini della irrisolvibilità del percorso formativo del soggetto3. Percorso E. PACI, Il nulla e il problema dell’uomo (1950), Milano, Bompiani, 1988, p. 14. L’esercizio del fare relazioni è, secondo Paci, “paideutico ed etico”. E. PACI, Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl, Bari, Laterza, 1961, p. 162. 3 Se l’interesse di Paci per l’orizzonte pedagogico del relazionismo è documentato in numerose delle sue opere, esso è altresì testimoniato sia dagli esiti del suo magistero filosofico sia dalla ricorsività con cui quell’orizzonte traluce dalle pagine dei diari privati. Non a caso tra i suoi migliori allievi la significativa presenza di Piero Bertolini, fondatore della Pedagogia fenomenologica in Italia, ha dato modo a chi scrive di documentare non solo i tratti meno noti di una importante genealogia culturale, quanto, soprattutto, l’intreccio tra riflessione ed esperienza che li ha visti protagonisti proprio in quelle pagine inedite. A questo proposito ci sia consentito di rinviare a E. MADRUSSAN, Il relazionismo come paideia. L’orizzonte pedagogico del 1 2 294 nel quale proprio al soggetto spetta il compito di stabilire legami, prossimità, rotture tra ciò che accade e il suo vissuto, attraverso un movimento costante, nel tempo e nello spazio, della sua intelligenza critica. In tal senso, l’idea di esercizio lascia permanentemente aperta la dinamicità della relazione con l’altro e con il mondo e, nel contempo, evidenzia la necessità soggettiva di ripensarsi costantemente, rinunciando a permanere nel mito illusorio (e antieducativo) dell’identico. Esercizio è, allora, tutto ciò che mette alla prova, che richiede discussione, che attiva riflessività e che implica scelta di orizzonti. In tal modo l’esistenza si fa luogo di infinite e irriducibili forme del mutamento, gravate soltanto dall’incedere temporale, e il relazionismo, di conseguenza, non può che far propri quei mutamenti come sconnessioni e prospettive dei suoi propri paradigmi. In particolare l’elemento per il quale, fra le differenti forme dell’esercizio relazionistico, la relazione intersoggettiva continua ad avere uno spazio privilegiato di attenzione, sembra essere di grande interesse per l’orizzonte pedagogico. Sia perché all’ovvia centralità della relazione educativa Paci accompagna analisi assai lontane da qualsiasi semplificazione edificante, insistendo, per esempio, tanto sull’idea radicale di alterità quanto sulla perdita come esperienza esistenziale cardine. Sia perché, ciò facendo, ha richiamato e richiama l’educazione ad uno sguardo di più ampio respiro su ciò che è l’attività relazionistica del soggetto in virtù del rischio di ridurre l’educazione stessa esclusivamente entro i confini codificati – e ideologicamente e storicamente compromessi – delle sue istituzioni. Con ciò è forse possibile intendere quel ‘fare relazioni’ come zona esistenziale e culturale nella quale praticare la situazione contingente secondo modalità che precedono – e dunque superano – qualsiasi semplificazione oggettivante del problema formativo. Senza dubbio il relazionismo di Enzo Paci ha percorso questa strada. Un relazionismo fenomenologico che ha tentato di far emergere ‘il problema della relazione’ alla luce delle infinite e variabili forme del ‘costruire relazioni’ quali luoghi emergenti d’intelligenza critica ed esplorativa, di tensione verso il superamento di qualsiasi cristallizzazione inerte del fare e del pensare soggettivi. In quest’ottica Paci si è confrontato con la filosofia analitica, con quella americana (deweyana in particolare), con la cibernetica, la fisica, la letteratura, l’urbanistica, la musica, l’economia, mostrando sempre le connessioni relazionismo di Enzo Paci, Trento, Erickson, 2005. Per quanto riguarda Bertolini, invece, si rinvia a: P. BERTOLINI, Fenomenologia e pedagogia, Bologna, Malipiero, 1958; ID., L’esistere pedagogico, Firenze, La Nuova Italia, 1988; ID., Pedagogia fenomenologica, Milano-Firenze, La Nuova Italia-RCS, 2001. 295 tra i diversi ambiti culturali e la dimensione quotidiana del vissuto4. Così facendo, le diverse figure di senso che venivano componendosi arrivavano ad investire la più ampia dimensione sociale e la più complessa dimensione politica, fino a restituire un’idea di cultura non solo antielitaria, ma soprattutto pedagogicamente capace di intercettare, interpretare e fornire occasioni di impegno concreto all’uomo del suo tempo. L’educazione in senso relazionistico, dunque, invita a ripensare in termini più radicali i dinamismi che producono, inducono e liberano l’intenzionalità soggettiva del mettere in relazione. Dove, secondo Paci, i suoi strumenti sono costituiti innanzitutto dalla costante veglia autocritica sul proprio posizionarsi nel mondo (“reimparare a vedere e sentire”5) e, in seconda battuta, dalla riappropriazione della sterminata messe culturale come occasione progettuale di ricerca di senso6. È quest’ultimo, forse, il luogo pedagogicamente più fecondo, tanto quanto esso venga accolto quale rinnovata occasione di analisi, comprensione e rielaborazione della propria esperienza esistenziale in quanto esperienza culturale, e non quale articolata manifestazione di differenti approcci al reale da acquisire e archiviare7. Oggi l’eco relazionistica sembra ancora in grado di mettere in guardia da irrigidimenti di forma e da scivolamenti concettuali, soprattutto se si pensa alla modalità con la quale, nella sua opera, Paci ha dato corso a quanto proponeva sul piano teoretico. Eppure, l’elemento che pare dirimente è il fatto che la centralità della relazione abbia, in qualche modo, anticipato i problemi che oggi occupano il dibattito educativo – e non solo – rispetto alla impossibilità di pensare il soggetto – e quindi anche la sua intenzionalità – se non nell’orizzonte della frammentarietà, dell’incertezza e della ambiguità. Tutte curvature, queste, che il relazionismo paciano assumeva già, proprio decentrando il primato dall’idea di ‘soggetto pieno’, e, allo stesso tempo, rispondendo alla ormai comune critica al presunto soggettivismo della fenomenologia. Per Paci, infatti, esso non risultava affatto come la falla dell’incedere husserliano, ma il punto d’avvio programmaticamente necessario della presa di coscienza della relatività soggettiva. Certo, il relazionismo va oltre. Non tanto per i problematici approdi marxisti dell’ultimo Paci, quanto per l’attribuzione di una rinnovata dire- Tutta la produzione paciana va in questa direzione, ma forse la testimonianza più ricca è rintracciabile nella fervida attività culturale documentata nella lunga esperienza (venticinque anni) di “aut aut”. 5 E. PACI, Il nulla, cit., p. 132. 6 Tempo, verità e relazione sono i tre paradigmi di un relazionismo che si fa carico della condizione negativa originaria del soggetto per tentare di dare direzione e forma al percorso esistenziale. E. PACI, Dall’esistenzialismo al relazionismo, Messina, D’Anna, 1957. 7 A tal proposito si rinvia all’opera forse più nota di Paci: Diario fenomenologico, Milano, Il Saggiatore, 1961. 4 296 zione che, nei suoi ultimissimi scritti, assume nuovamente il negativo come luogo decisivo della relazione. Nella celebre rubrica di “aut aut” intitolata “Il senso delle parole”, in cui egli testimoniava la straordinaria portata pedagogica delle sue riflessioni, poco prima di morire aveva restituito un’immagine della ‘crisi’ sorprendentemente congrua all’interrogativo in questione. Aveva scritto: “Pur immersi nella crisi non riusciamo a cogliere fino in fondo il suo acme attuale; il suo ripresentarsi in forme che la denunciano ma che poi sempre di nuovo la ricoprono”8. E ancora, “Si ha l’impressione che l’astuzia della ragione cerchi, divenendo più sottile furbizia, di trovare vie simili alle reali e alle vere – non solo simili. Come spesso accade, la realtà costa troppo e il mondano dà troppi segni di vittoria sul negativo”9. Quale forma, assume, allora, il relazionismo fenomenologico di Paci nel tempo della piena affermazione dell’astuzia della ragione? Vale a dire: quale idea di relazione è sottesa all’esigenza storico-culturale del presente pedagogico? Se volessimo ascoltare anche l’ultimissimo Paci e la sua urgenza di tornare al negativo per far emergere i volti inediti della crisi, probabilmente dovremmo rinunciare a ricercare l’armonico congiungersi dei nodi relazionali, ma dovremmo, invece, soffermarci sull’analisi decostruttiva di quei nodi, sulle modalità del loro darsi all’esperienza e del loro stesso predisporre l’esperienza. Potremmo, forse, anche ridiscutere il senso fenomenologico del termine ‘verità’ per imparare a vederne la probabile feticizzazione e il suo occultamento dentro a forme opache di mascheramento ideologico. Potremmo, forse, ripensare all’educazione come luogo di crisi nel quale ad essere positivo, per così dire, cioè demistificante e antiretorico, è proprio il negativo che insidia l’esperienza, e non la sua frettolosa bonifica. Così da avere a mente non un ideale di soggettività – l’uomo astrattamente disincarnato e astorico – ma, appunto, un soggetto situato dentro una congerie di relazioni – per lo più difficilmente riconoscibili – che lo fanno ciò che è e ciò che dovrà essere. In ciò, un sostanziale ribaltamento dell’idea stessa di progettualità formativa, dove a rendere fattiva e concreta la propria attesa esistenziale non è l’immediato perseguimento di qualcosa, ma una più problematica messa in discussione delle modalità stesse del vedere e del desiderare soggettivi. Un impegno pedagogico, questo, che non ha alcuna certezza definitiva da 8 E. PACI, Il senso delle parole 1963-1974, a cura di P.A. Rovatti, Milano, Bompiani, 1987, p. 292. 9 Ivi, p. 293. 297 proporre, ma un andamento metodologico-decostruttivo da tentare come una via possibile per comprendere. Non un soggetto sovrano, dunque, ma un soggetto responsabilmente alle prese con le sue dislocazioni relazionistiche, con ciò che non vede e che lo fa, piuttosto che con l’evidenza; con ciò che non sa o non può essere piuttosto che con ciò che lo rassicura e lo garantisce; con ciò a cui la relazione con l’altro lo induce piuttosto che a ciò che lo gratifica. E, in ultimo, su ciò che può decostruire piuttosto che su ciò che lo mimetizza. Con ciò certificando, allora, non già la debolezza del relazionismo, ma la forma, forse inattesa, della sua infinita apertura critica. 298 299 TRADURRE PAROLE O TRADURRE CULTURE? IDENTITÀ NAZIONALE E PERCEZIONE DI SÉ NELLA FIGURA DEL DRAGOMANNO GEROSOLIMITANO DEL XIX SECOLO Ada Lonni Jacques Panayotti, ovvero dell’identità. “Eccellenza, è con grande umiltà e fiducia nella vostra generosità che una persona a voi totalmente estranea si rivolge all’esaltante personaggio che ora dirige gli affari degli Stati Uniti d’America…”1. Si era nell’autunno del 1877, e a pronunciare, o meglio a scrivere queste parole, in una lettera che partiva da Gerusalemme diretta a Washington, non era né un’autorità, né un personaggio di prestigio, ma un semplice dragomanno, un interprete che aveva lavorato per cinque anni presso il consolato americano, tal Jacques Panayotti. La vicenda di cui fu protagonista è di per sé una vicenda ordinaria, come tante ne capitavano all’epoca, e non lasciò alcun segno nella locale gestione diplomatica, né tracce significative nella complessa storia gerosolimitana: non modificò il corso degli eventi e non diede origine a nuove prassi o a nuove condotte. Il suo interesse deriva invece dal fatto di riflettere appieno i cambiamenti di atteggiamento e di mentalità che si andavano operando in quella regione a seguito di un ormai avanzato processo di colonizzazione delle menti, un processo che in quella parte di mondo aveva preceduto di parecchi decenni la colonizzazione dei luoghi. Nativo di Gerusalemme, ma di origine greca, figlio di “uno dei più vecchi e rispettabili cittadini di Palestina che aveva servito la Turchia per oltre vent’anni”2, Jacques Panayotti vantava la conoscenza del turco, dell’arabo, del greco, dell’inglese e del francese, nonché un buon livello di istruzione. Aveva lavorato come dragomanno presso il consolato “con devozione e diligenza”: da quel 5 ottobre del 1871, quando era arrivata la sua nomina Lettera di Jacques Panayotti al Presidente degli Stati Uniti d’America, 27 luglio 1877, in Despatches from United States’ Consuls in Jerusalem, 1856-1906. Institute for Palestine Studies, Beirut: Microfilm copy of the original in the National Archives, Washington. 2 Nomina di Jacques Panayotti a dragomanno presso il Consolato degli Stati Uniti a Gerusalemme, 5 settembre 1871, ivi 1 300 ufficiale fino all’estate del 1876, quando fu licenziato, a suo dire “senza una giusta causa”, ma semplicemente “caduto in disgrazia” agli occhi del Console Mr. Frank S. deHass, e del suo agente Mr. Hardegg3. Considerando ingiusto questo suo allontanamento, aveva messo in atto tutti gli strumenti e tutte le strategie che conosceva per essere reintegrato nella suo ufficio: non ultimo appunto il ricorso alla suprema autorità americana, all’allora presidente degli Stati Uniti, Rutherford Birchard Hayes. Che fosse stato davvero “ingiustamente denigrato e crudelmente oppresso” ha per noi poca importanza, così come per noi secondarie sono le accuse incrociate tra lui e il console deHass, cui Panayotti attribuiva assenteismo, varie forme di corruzione, ma soprattutto l’uso a fini personali della carica diplomatica4. Anche l’esito della vertenza – peraltro scontato – ha poco rilievo: la pratica venne ovviamente archiviata e la sorte del povero interprete rimane sconosciuta. Quello che invece rende questa vicenda interessante è il percorso di avvicinamento all’Occidente compiuto da questo personaggio, e soprattutto l’intensità della sua adesione ai principi delle società europea e americana, ai diritti da esse proclamate ed ai valori proposti come universali. Non si trattava – è d’uopo sottolinearlo – di semplice ammirazione, bensì di qualcosa di più profondo, di introiettato, di fatto proprio, un qualche cosa diventato patrimonio personale e parte integrante della sua concezione di vita. Non dimentichiamo che Panayotti era diventato un protegé5, sottratto cioè alla giurisdizione ottomana e accolto nella apparentemente più garantista potestà occidentale. E proprio in questo suo cambio di status e in un momento in cui l’idea di nazionalità si diffondeva e radicava in una sempre più estesa comunità è la contraddizione di cui Panayotti e, con lui, gli altri dragomanni diventano protagonisti e vittime insieme; ma soprattutto proprio in questa contraddizione è in qualche modo in nuce il complesso rapporto tra le culture, il doloroso imporsi di una sull’altra, ancor più in momenti nevralgici come quello che Gerusalemme stava attraversando. Significativamente Panayotti scriveva: “… ho fiducia nel mio governo americano”; e, richiamandone la normativa, parlava di “leggi del nostro governo americano”6. Come considerava allora se stesso: turco, greco o staLettera del Jacques Panayotti al Presidente…, cit. Era proprietario di un albergo in quel di Jaffa. Cfr. Lettera di Jacques Panayotti a W Hunter, assistente del Segretario di Stato a Washington, 25 novembre 1876, ivi. 5 Sotto l’impero ottomano, i cittadini degli stati occidentali che avevano siglato appositi accordi con la Porta, non erano soggetti alla normativa locale ma a quella del proprio stato di appartenenza. Gli stessi privilegi erano attribuiti anche ai cosiddetti protegé, a quei sudditi ottomani cioè con cui avevano stretto rapporti particolari, speciali: dipendenti consolari, loro familiari, esponenti del clero, e tra essi i dragomanni. 6 Lettera di Jacques Panayotti al console deHass, 24 aprile 1877, in Despatches from United States’ Consuls in Jerusalem, cit. 3 4 301 tunitense? Come si configurava nella sua mente quel senso di appartenenza: era una convinzione o una aspirazione? Un privilegio o una conquista in quel mondo che, dopo secoli di immobilismo apparente, stava precipitosamente trasformandosi? Ma soprattutto quali informazioni, quali esperienze o quale propaganda avevano generato la speranza, a dir poco assurda e priva di ogni ragionevole fondamento, di avere udienza presso il presidente degli Stati Uniti? E ancora, come si collocava la vicenda nel contesto dell’epoca: un gesto isolato di un personaggio ‘particolare’, o l’espressione di un sentire e di un pensare che si andava diffondendo? E, in questo caso, quali cambiamenti nella mentalità, nella percezione identitaria e nel senso di appartenenza si erano operati per pensare che al di là del Mediterraneo, che al di là dell’oceano fosse la sede della giustizia, o, come diremmo oggi, della tutela dei diritti della persona? Non era più Istanbul, non era più la sublime Porta la massima autorità cui rivolgersi in caso di bisogno? Quel sultano così potente e così vicino a dio stava dunque per essere surclassato dalle nuove espressioni del potere occidentale, considerate più raggiungibili e forse proprio per questo più efficaci? Così forte e così profonda era stata la penetrazione orientalista7? Non solo l’Occidente aveva costruito la sua filosofia e la sua prospettiva per dominare l’Oriente, ma era riuscito addirittura a impossessarsi delle menti dei colonizzati, coinvolgendole, occupandole, sottomettendole: così tanto i savants di Napoleone avevano saputo fare scuola? e così in fretta i risultati? L’età delle riforme . Si era negli anni Settanta del XIX secolo, in un periodo di grandi entusiasmi sulle sorti di quel lembo di terra. Entusiasmi che per motivi diversi e soprattutto con obiettivi diversi coinvolgevano tutti gli attori che là si confrontavano. Gli occidentali, politici o diplomatici che fossero, che vedevano segnali concreti della loro sempre più cogente influenza: l’editto sulla tolleranza, l’editto sulle nazionalità, la riforma agraria e tutto il complesso dei tanzimat non erano forse il frutto diretto ed evidente della guerra di Crimea, e soprattutto di una sempre più forte capacità di indirizzare le scelte della Sublime Porta? Inglesi, francesi, tedeschi, americani compravano terre a Gerusalemme, costruivano case, ampliavano i commerci, si inserivano pesantemente in quel rinnovamento delle infrastrutture che accompagnava le trasformazioni economiche e sociali in corso. Le sedi diplomatiche si moltiplicavano e si rafforzavano, imponendo in modo talvolta 7 E.W. SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2001. 302 sfacciato la loro autorità, sfruttando l’elemento religioso come cavallo di Troia in un gioco ben più ampio. E di lì a poco – quatto o cinque anni, non di più – gruppi sempre più numerosi di ebrei in fuga dai pogrom russi e dall’antisemitismo europeo si sarebbero riversati ovunque in Palestina, a dissodare terreni e a creare strutture agricole. Ma le speranze e i motivi di soddisfazione non erano appannaggio esclusivo dell’Occidente, coinvolgevano anche il tessuto sociale locale: non i gruppi più svantaggiati che avrebbero visto la loro situazione peggiorare in breve tempo, ma il notabilato, ormai solido nelle sue posizioni. Stava per essere istituito un parlamento, là a Istanbul, che avrebbe raggruppato le varie rappresentanze ivi inclusa Gerusalemme. Una maggior liberalità, soprattutto dal punto di vista fiscale, stava migliorando la vita delle comunità non musulmane, religiose o laiche che fossero. La città si stava ampliando fuori le mura e molti erano i miglioramenti dell’assetto urbano. Le strade erano diventate più sicure e la stanzialità dei beduini un obiettivo quasi raggiunto. Istanbul dal canto suo, nonostante il fatto che una parte del suo immenso impero stesse sgretolandosi sotto l’incalzare del colonialismo nelle sue varie, molteplici forme, propendeva a dare dei fatti di Crimea una lettura in chiave di rivitalizzazione del proprio potere: non sedeva ormai alla pari al tavolo delle grandi potenze occidentali? Il fatto era però che gli obiettivi degli uni e degli altri erano spesso in contrasto o addirittura incompatibili fra loro: il potere crescente degli occidentali mal si saldava con le esigenze della popolazione locale, che sempre più si sentiva sotto ricatto, o meglio in balia di scelte e interessi appartenenti ad un altrove. Ma era anche vero che questo altrove aveva un suo fascino, un fascino potente, il fascino del potere, ma anche il fascino della giustizia e della libertà. E a questo fascino i dragomanni erano molto, molto sensibili. Il dragomanno. Il mestiere di interprete è, per dirla con Jan Assman, “uno dei più antichi fra quelli documentati nella storia della divisione del lavoro”. Il termine dragoman – continua lo stesso Assman – “conserva ancora il ricordo del’antico ragamu, ‘chiamare, parlare ad alta voce’, e dell’aramaico targum, traduzione, da esso derivato”8. E tradurre, come ben sappiamo, significa costruire ponti, creare trasparenza e comprensione reciproca, tra le persone e tra le culture. Ma è altrettanto vero che per creare collegamenti tra realtà e pensieri diversi bisogna entrare un po’ in quelle realtà e in quei pensieri: 8 J. ASSMAN, Non avrai altro dio, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 8. 303 non si può conoscere rimanendo estranei, asettici, immuni; non si può in altre parole evitare il contagio. E forse nessuna realtà, come la Gerusalemme ottomana, può mostrare con evidenza il progressivo processo di meticciato tra persone e culture; e nessuna realtà, come la Gerusalemme ottomana, dispone di una figura tanto emblematica come quella del dragomanno per illustrare questo processo. In realtà i dragomanni in Palestina calcavano da sempre la scena politica e sociale. Che si trattasse del dragomanno capo alla corte del pascià, o della più umile guida turistica che accompagnava i pellegrini mostrando, tra realtà e fantasia, i luoghi sacri della cristianità, la città pullulava di interpreti, spesso vistosamente abbigliati per il piacere degli stranieri o per evidenziare la propria carica9. Non erano musulmani – per i quali il servizio era declassante e solo il commercio onorevole10 – spesso non erano nemmeno originari della città; alcuni avevano studiato in Europa, anche se pochi erano quelli che avevano avuto accesso alla prestigiosa scuola francese Jeunes de langues11. Ma è anche vero che la maggior parte di loro non necessitava di particolari competenze, avendo a che fare soprattutto con il mondo dei pellegrini e dei viaggiatori, o tutt’al più con archeologi, esploratori e orientalisti vari. Certo un Robinson poteva vantare un battesimo d’eccezione nella conoscenza della città grazie alla guida del rabbino David Beth Hillel12. E così Melville – o meglio il giovane Clarel – che ebbe la fortuna, nel suo anti – pellegrinaggio in Terrasanta, di avvalersi di un druso libanese, figlio di un emiro “progenie di un nobile in rovina dei tempi d’Ibrahim”, che cercava “di restare un capo, foss’anche solo esser la guida di pellegrini”13. Altrettanto fortunata Matilde Serao, la cui guida aveva alle spalle quarant’anni di viaggi: era stato “otto volte in tutta l’Asia, due volte in Africa con Gordon Pascià, ventisette volte a Damasco, venti volte a Bagdad, e aveva girato tutta l’Arabia, da quella Petrea a quella moabitica, dalla Samaria alla Galilea, da Ascalona a Beyrouth, da Rosetta all’antica Fenicia”14. La maggioranza lasciava però a desiderare: improvvisazioni si alternavano a più o meno sofisticati raggiri, ed era proprio il sentirsi pupazzi nelle mani di questi personaggi che angustiava o semplicemente irritava i viaggiatori: fungevano an9 N. MICKLEWRIGHT, Costume in Ottoman Jerusalem, in AA. VV., Ottoman Jerusalem. The living City: 1517-1917, a cura di S. Auld & R. Hillenbrand, London, Altajir World of Islam Trust, 2000, p. 294. 10 E. BLYTH, When we lived in Jerusalem, London, John Murray Publisher, 1930, p. 185. 11 M. DE TESTA-A. GAUTIER, Drogmans et diplomates européens auprès de la porte ottomane, Istanbul, Editions Isis, 2003, pp. 41. 12 Unknown Jewish in Unknown Land. The Travel of Rabbi D. D’Beth Hillel (1824-1832), a cura di W. Fischel, USA, 1973, p. 14. 13 H. MELVILLE, Clarel. Poema e pellegrinaggio in Terrasanta, Torino, Einaudi, 1999, p. 160. 14 M. SERAO, Nel Paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, Tipografia Aurelio Tocco, Napoli 1898, p. 177. 304 che da ciceroni, ci racconta ad esempio il diplomatico inglese Robert Curzon all’inizio degli anni Trenta, “e garantivano di conoscere tutto sulle antichità e qualsiasi altra cosa; erano lì per comprare qualsiasi cosa volessimo; per spendere il nostro denaro, e di non permettere a nessuno di imbrogliarci a parte loro stessi”15. Ma per i dragomanni erano gli impieghi presso le autorità diplomatiche gli obiettivi più ambiti: lì davvero si assaporava il successo e la possibilità di carriera. Certo Gerusalemme non era Istanbul che forniva molte più possibilità di occasioni e molti più esempi di scalate sociali: a Istanbul presso il califfo, il rumeno Bogoridi, proprio in quel XIX secolo, aveva alternato il ruolo di dragomanno con quello di governatore e di consulente dello stesso Mahmud II, per essere poi nominato bey e diventare membro nientemeno che del consiglio del tanzimat16. Sempre in quel di Istanbul e sempre nello stesso periodo, Alexander Hangerli era passato da dragomanno a principe di Moldavia, proprio come nel secolo precedente aveva fatto il greco Ioan Teodor Callimachi 17, e così via. A Gerusalemme e in Palestina i percorsi e le ascese sociali si misuravano su scala più ridotta, ma non per questo erano meno appetibili. Basti pensare al ruolo svolto da Johanna Carlo Gellat, l’intraprendente mediatore nelle compravendite gerosolimitane a favore del governo francese, cui venne significativamente conferita una medaglia d’argento quale ricompensa per i servigi resi “all’occasione delle ultime epidemie di colera”18. O Boutros Raull, figlio d’arte, protetto e apprezzato tanto da Ferdinand de Lesseps quanto dal console Bentivoglio, accorto mediatore nei ricorrenti tumulti di metà secolo tra Alessandria d’Egitto e Beirut19. Lavorare per i consolati non era comunque cosa da poco, e certamente non era facile capire, tra i vantaggi e i rischi che dalle responsabilità derivavano, dove pendeva l’ago della bilancia20. Non era solo un’opera di traduzione e interpretariato quella che veniva loro richiesta, né esattamente un’attività di mediazione; era piuttosto un’azione a favore degli interessi di una parte, laddove la conoscenza e la partecipazione alla cultura locale si rivoltava a boomerang contro la stessa. Nelle cause civili e penali, nell’acquisto di beni immobili, nelle controversie R. CURZON, Visits to the Monasteries of the Levant, London, John Murrat, 1850, p. 14. M. DE TESTA-A. GAUTIER, Drogmans et diplomates européens, cit., p. 149. 17 Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Tome 23, Paris, Firmin Didot, 1858, p. 290. 18 Lettera del console generale di Francia a Gerusalemme, Mr. de Barrère, 15 ottobre 1867, in Archives Diplomatiques. Série: Archives des Postes. Jerusalem 1840-1914, B3 1867. 19 Lettera all’ambasciatore di Francia a Costantinopoli, 17 luglio 1891, ivi, B3 1891. 20 R. KARK, American Consuls in the Holy Land, 1832-1914, Jerusalem, The Hebrew University Magnes Press, 1994, pp. 176. 15 16 305 commerciali il sapere e l’esperienza del dragomanno erano infatti totalmente al servizio dell’autorità diplomatica che lo aveva assunto. E se la cosa era per lo più motivo di orgoglio, nonché prima e più importante conferma del senso di appartenenza, si rivelava spesso causa ineludibile di disorientamento e di malessere. Erano gli stessi consoli a sottolinearlo, quando riconoscevano che “i dragomanni che servono con fedeltà erano obbligati a rompere i rapporti col loro governo e per questo non c’era alcuna ricompensa, anche dopo molti anni di servizio mal pagato”21. Non era prevista pensione alcuna “né statuto particolare conferito”: così un dragomanno “dopo aver servito durante i migliori anni della sua vita, ed essere incorso in ostilità tanto maggiori quanto più grande era la sua fedeltà e zelo nel servizio, era soggetto ad essere lasciato alla deriva, a ricominciare da zero ed essere esposto alla malevolenza in cui non sarebbe mai incorso se non avesse subordinato i propri personali interessi a quelli della nazione presso cui era stato temporaneamente impiegato”22. Il prezzo da pagare era alto, e il salario percepito non era certamente tale da giustificare scelte pressochè definitive, che spesso – proprio come nel caso Panayotti – influivano profondamente anche sulla lettura stessa della realtà, dei rapporti di potere, della filosofia di vita, ma soprattutto del senso di appartenenza e della propria percezione identitaria. Come si è visto, Jacques Panayotti parlava del governo americano come del “suo” governo, e con esso si identificava pienamente; e quale altro significato, se non questo, poteva avere la famosa lettera al Presidente degli Stati Uniti, un presidente nella sua visione certamente più potente della stessa Porta, ma soprattutto riconosciuto nella sua autorevolezza e per il suo senso di giustizia. “Ho grandi speranze nella giustizia e nella equità del governo americano”, scriveva infatti in una delle sue tante, fluenti missive. Una giustizia che immaginava “per tutti senza distinzione di persone”, proprio in quanto “uno dei grandi principi delle leggi e delle libertà degli Stati Uniti d’America”. Nei tanti anni di servizio e di contatto, le idee occidentali avevano fatto presa sulla sua mentalità, tanto da provare dolore nel vedere la bandiera americana usata “come copriletto” da quello stesso console che lo aveva licenziato: il fatto era non soltanto disdicevole, ma soprattutto oltraggioso. E non si trattava di osservazioni formulate per convenienza: per anni il dragomanno Panayotti aveva oscillato tra due mondi, tra due culture, tra Oriente e Occidente, e poi quel nuovo che era entrato nella sua vita aveva avuto la meglio. A forza di tradurre, a forza di interpretare, a forza di metJ. FINN, Stirring Times, or Records from Jerusalem Consular Chronicles 1853 to 1856, London, C. Kegan Paul & Co., 1878, p. 93. 22 Ibid. 21 306 tere in contatto, in comunicazione, si era trovato irretito, coinvolto ben oltre le aspettative. Ma la realtà purtroppo non coincideva con il percorso che più o meno consapevolmente lui aveva compiuto: l’Occidente non era pronto, o meglio non era disposto a riceverlo come un pari. E non importava che egli si sentisse ormai estraneo a quello che era stato il suo mondo, ai suoi stessi compatrioti, alle logiche di una società sempre più complessa e contraddittoria: non c’era spazio per lui a occidente! Tutte le sue richieste furono respinte, nonostante il fatto che in più di un caso la motivazione del rifiuto fosse debole, e rivelasse una sorta di fastidio per quella che si considerava più una seccatura che un diritto. “Ci sono state evidentemente alcune irregolarità nella conduzione del consolato, e c’è un’accumulazione di cose trascurate o di affari differiti, ma non potrebbe essere diversamente”, scriveva il console Wilson all’assistente al Segretario di Stato a Washington nell’ottobre del 1877, e concludeva: “Suggerisco che qualche volta è meglio lasciar perdere, piuttosto che avere una lunga e noiosa inchiesta”23. La fine di un’epoca. Panayotti non ebbe dunque la fortuna di veder prese seriamente in considerazione le sue proteste, e quel cambiamento che lui sentiva non era in realtà nulla più di un sogno. Per un momento, è vero, il dragomanno era stato l’anello di connessione tra Oriente e Occidente, operando – al di là forse delle intenzioni – una sintesi dei due mondi; ma se c’era stata qualche illusione di un sincretismo reale e soprattutto di un sincretismo accettato da entrambe le parti in causa, ebbene, si era trattato solo di un malinteso che si sarebbe chiarito subito. Nuove figure di interprete si stavano infatti velocemente delineando, tanto negli uffici diplomatici, quanto nel variegato mondo dell’accoglienza al turismo e al pellegrinaggio; nuove figure di interprete in grado proprio di ovviare ai rischi in cui era incorso Panayotti e il suo mal riposto senso di appartenenza. Nei consolati, ad esempio, gradualmente si preferì far ricorso a traduttori nazionali, la cui appartenenza identitaria non sollevava dubbi di sorta. Apprese nel paese d’origine le necessarie conoscenze diplomatiche e normative, completavano la loro preparazione con soggiorni mirati nei potenziali luoghi di destinazione: erano esploratori, linguisti, alcuni anche musicisti; pubblicavano grammatiche e dizionari delle lingue orientali; sapevano 23 Lettera del console J.G Wilson a I.A. Campbel, assistente al Segretario di Stato a Washington, 15 ottobre 1877, in Despatches from United States’ Consuls in Jerusalem, cit. 307 di letteratura e traducevano opere insigni. Esemplare il caso di Clermont – Ganneau24, l’orientalista francese formatosi presso il prestigioso Institut national des langues et civilisations orientales, scultore e archeologo, che iniziò a Gerusalemme una brillante carriera che lo portò, sempre in qualità di dragomanno, a Costantinopoli, e che lo vide a fine secolo console generale in quel di Giaffa. E come lui gli interpreti degli altri consolati: per coprire le proprie necessità e per garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, la comunità diplomatica si attrezzava per attingere risorse il più possibile al suo interno In trasformazione era anche l’altra figura di dragomanno, quella che nel mondo del turismo si procurava la clientela e insieme ad essa la propria ragione d’essere. In questo caso il vero responsabile del cambiamento era stato il moderno viaggio di gruppo, così come lo aveva concepito e diffuso Thomas Cook; in assonanza coi tempi gli antichi pellegrinaggi avevano infatti cambiato stile: miravano agli stessi luoghi ma con uno spirito e un approccio profondamente mutati. Certo ora tutto era più facile: il viaggiatore, turista, pellegrino o studioso che fosse, era sotto tutela, senza rischi, senza inconvenienti. Ma anche senza la possibilità di cogliere appieno le atmosfere e le peculiarità locali: “insieme agli accompagnatori ufficiali – annotava ad esempio acuta e pungente Matilde Serao – bisogna andare al New Grand Hotel, svestirsi e rivestirsi, aspettando la campana della table d’hôte, pranzare con una minuta inglese, prendere il the, come se si fosse sulla Maloia, in Engadina o a Montecarlo, e dormire dieci ore, nella prima giornata, a Gerusalemme!”25 Anche per il dragomanno, Cook aveva segnato la svolta: c’era un prima e un dopo, un prima di Cook e un dopo Cook, “prima della compagnia Cook, il dragomanno era un signore ed era una potenza: egli aveva cavalcature, palanchini, tende, letti, attrezzi da cucina e servizi da tavola, in modo che si contrattava con lui un cottimo di tanti giorni, per tante persone ed egli vi conduceva, vi forniva di tutto, vi dava il pranzo, il tetto, la scorta… tutto infine” 26. E naturalmente il dopo; e per il dragomanno era la disfatta. Era l’agenzia Cook a occuparsi di tutto e il dragomanno riduceva la sua attività a quella di guida turistica, e senza autonomia alcuna27. La rabbia 24 W. BESANT, Our Work in Palestine being an Account of the Different Expeditions Sent out to the Holy Land by the Committee of the Palestine Exploration Fund, London, Bentley & Son, 1877. Tra gli scritti di Ganneau, Etudes d’archéologie orientale (1880), Les fraudes archéologiques (1885), Palestine inconnue (1886), Album d’antiquités orientales (1897), etc. 25 M. SERAO, Nel Paese di Gesù, cit., p. 87. 26 La definizione è di una delle guide di Matilde Serao. Cfr. M. SERAO, Nel Paese di Gesù, cit., p. 355. 27 C. LUMBY, Cook’s Traveller’s Handbook to Palestine, Syria & Iraq, London, Simpkin Marshall, 1934, p. 56. 308 verso questo “nemico”, verso “il carnefice di tutti i dragomanni di Palestina”28, era grande, ma altrettanto grande era il senso di impotenza. Poco valeva però prendersela con Cook. In fondo non era che lo scaltro e intelligente interprete della sua epoca, l’antesignano di quel percorso di colonizzazione turistica che sarebbe esploso in tutto il mondo durante il XX secolo. Come i diplomatici formavano i loro dragomanni, così Cook ne riduceva infatti competenze e prestigio, perfettamente in linea con quell’Occidente intenzionato a non delegare nulla a nella costruzione e nella gestione dei nuovi rapporti con la realtà sociale, economica e politica dei paesi che stava colonizzando. E inevitabilmente quegli strumenti di mediazione che avevano facilitato l’approccio, quelli che in passato erano stati ponti preziosi, ora venivano disinvoltamente sostituiti. Non c’era spazio per identità plurime, per identità meticcie. Ciascuno doveva restare al suo posto: l’ordine naturale delle cose in un secolo che aveva inventato il razzismo non poteva venir modificato, e quello dei dragomanni non era che uno dei tanti sogni sacrificato sull’altare della colonizzazione e dell’orientalismo. 28 M. SERAO, Nel Paese di Gesù, cit., p. 355. 309 NOTE SULLA ‘SERVITÙ DELLA GLEBA’ MEDIEVALE. FRA MITO STORIOGRAFICO E NUOVA ESEGESI DELLE FONTI Francesco Panero 1. Le premesse per una discussione Negli ultimi trent’anni diversi studi hanno consentito di riprendere e affrontare su basi euristiche rinnovate un tema – quello della servitù medievale – che nella prima metà del Novecento aveva impegnato i maggiori storici della società, dell’economia e del diritto in un vasto dibattito, che talvolta aveva assunto toni molto aspri, come per esempio avvenne in Francia nel serrato confronto fra Marc Bloch e Léo Verriest1. La discussione sembrava chiusa dopo la scomparsa di Bloch, fiero combattente nella sua intensa militanza storiografica sulle questioni della servitù e della libertà, ma anche coraggioso difensore della Libertà, fino alla morte, di fronte all’occupazione nazista del proprio Paese2. Grazie agli studi di Georges Duby, Pierre Bonnassie, Dominique Barthélemy e altri studiosi, nell’ultimo quarto del Novecento, il tema della servitù medievale in Francia è tornato a essere di attualità, anche se l’aspetto giuridico dei legami alla terra è rimasto ai margini delle indagini più recenti3. M. BLOCH, Blanche de Castille et les serfs du Chapitre de Paris, in Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ilede-France, XXXVIII (1911), pp. 224-272, ora anche in ID., La servitù nella società medievale, trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1975 (nuova ediz. a cura di G. Cherubini, Firenze, La Nuova Italia, 1993); ID., Servo della gleba. Storia di un modo di dire, in ID., La servitù cit., pp. 153-179 (I ediz. in “Revue Historique”, 136, 1921, pp. 220242); ID., ‘Servus glebae’, Ivi, pp. 179-187 (I ediz. in “Revue des Etudes Anciennes”, 4, 1926, pp. 352-358); ID., I colliberti. Studio sulla formazione della classe servile, Ivi, pp. 189-295 (I ediz. in “Revue Historique”, 157, 1928, pp. 1-48 e 225-263); L. VERRIEST, Institutions médiévales. Introduction au Corpus des records de coutumes et des lois des chefs-lieux de l’ancien comté de Hainaut, Mons-Frameries, s.n., 1946, p. 125 sgg. 2 Cfr. M. BLOCH, L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Paris, Gallimard, 2006. 3 La bibliografia francese è vastissima: ci si limita a citare alcuni studi di P. BONNASSIE, La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société, Toulouse, Presses Universitaires Mirail, 1975, pp. 576 sgg., 824 sgg.; ID., Survie et extinction du régime exclavagiste dans l’Occident du haut moyen-âge (IVe-XIe siècles), in “Cahiers de civilisation médiévale”, XXVIII (1985), pp. 307-343; D. BARTHELEMY, La société dans le comté de Vendôme de l’an Mil au XIVe siècle, Paris, Fayard, 1993, pp. 40 sgg., 474-505; ID., Qu’est-ce que le servage, en France, au XIe siècle?, in “Revue Historique”, 582 (1992), pp. 233-284; G. DUBY, Servage, in Encyclopaedia Universalis, Paris, E. U. ed., 1996, 20, p. 934 sgg. (con rinvio a diversi studi precedenti). 1 310 In Inghilterra e in Spagna, invece, data la presenza rispettivamente del villainage e della condizione dei remensas, si è spesso liquidata la questione della “servitù della gleba” medievale – che Marc Bloch riteneva giustamente essere una realtà del mondo antico, profondamente mutata e sostanzialmente superata con la caduta dell’Impero romano d’Occidente4 – richiamando le specificità regionali, come in particolare fecero Paul Vinogradoff e Jaume Vicens Vives5. Quanto all’Italia e alla Germania, poi, gli storici del diritto, senza prendere in considerazione gli studi francesi, sin dai primi decenni del secolo XX indagarono la servitù medievale in una prospettiva di continuità con il mondo antico, postulando un allentarsi dei vincoli schiavili nell’alto medioevo e ipotizzando contemporaneamente un “livellamento” delle varie condizioni di dipendenza rurale nella direzione del “servaggio”6, condizione che intorno all’anno Mille, secondo il loro modo di vedere le cose, non sarebbe stata troppo diversa da quella del “colonato” tardoantico, che una legge teodosiana definiva “servitù della terra” (servi terrae), per via dei vincoli ereditari alla terra coltivata per i coloni personalmente liberi – diffusisi a partire dai tempi di Diocleziano e di Costantino – in contrapposizione con lo status degli schiavi o servi (de persona)7. L’errore dell’appiattimento cronologico – nel quale sono spesso incorsi gli storici italiani e tedeschi, in particolare – e, insieme, la sovrapposizione di concetti profondamente diversi fra loro (quelli della schiavitù e del colonato tardoantichi, da un lato, e quelli della servitù altomedievale e del nuovo servaggio bassomedievale) hanno per lo più generato situazioni di confusione e perplessità, nelle quali ci si può districare soltanto definendo un rigoroso metodo di analisi storica, che anche grazie all’edizione di nuovi Cfr. nota 1. P. VINOGRADOFF, Villainage in England. Essays in English Medieval History, Oxford, Clarendon Press, 1968, pp. 223 sgg., 313 sgg.; J. VICENS VIVES, Historia de los remensas (en el siglo XV), Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1945. 6 Nella vasta bibliografia cfr. soltanto G. VON BELOW, Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters in ihren Grundzügen, Stuttgart, Fischer, 19662 (I ediz. 1937), p. 103 sgg.; K. BOSL, Modelli di società medievale, con introduz. di O. Capitani, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 84 sgg., 142 sgg.; G. LUZZATTO, I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X, ora in ID., Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, Bari, Laterza, 1966 (I ediz. 1909); P. VACCARI, L’affrancazione dei servi della gleba nell’Emilia e nella Toscana, Bologna, Zanichelli, 1926. 7 Cfr. J.-M. CARRIÉ, Un roman des origines: les généalogies du “colonat du bas-Empire”, in Opus, II (1983), pp. 205251, alle pp. 217 sgg., 233 sgg.; F. DE MARTINO, Il colonato fra economia e diritto, in Storia di Roma, 3, L’età tardoantica, I, Crisi e trasformazioni, Torino, Einaudi, 1993, p. 789 sgg.; G. GILIBERTI, Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 47 sgg., 107 sgg.; A. MARCONE, Il colonato tardoantico nella storiografia moderna (da Fustel de Coulanges ai nostri giorni), Como, New Press, 1988, pp. 81-100; F. PANERO, La cosiddetta ‘servitù della gleba’: un problema aperto, in ID., Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII), Bologna, Cappelli, 1984, pp. 207-276. 4 5 311 documenti va riproponendo un’esegesi rinnovata delle fonti già analizzate nella prima metà del Novecento. Così, in occasione di due tavole rotonde, organizzate rispettivamente dall’Université de Paris X-Nanterre nel 1997 e dall’École Française de Rome nel 1999, le forme diversificate di schiavitù, servitù e servaggio (diversificate dal punto di vista socio-economico delle condizioni di vita e degli oneri imposti), sono state tutte ricondotte alla “dipendenza ereditaria”, l’unica condizione giuridica che consenta di operare una corretta distinzione con le forme di “dipendenza libera” (sempre temporanea, anche quando i patti di lavoro siano di lunga durata) e quindi, sul piano del metodo storico, di procedere nella direzione di un’esegesi corretta della documentazione disponibile8. È proprio grazie a questa nuova impostazione dell’esame critico delle fonti – e segnatamente di quelle relative alla contrattualistica agraria – che negli ultimi anni si sta progressivamente definendo un quadro ben diverso da quello tradizionale, anche se la discussione è ancora molto vivace su alcuni aspetti del servaggio bassomedievale: per esempio, sulla realtà del villainage inglese, dopo le recenti considerazioni di Gianfranco Pasquali, che partono proprio dalla contrattualistica agraria9, si attendono nuovi risultati interpretativi grazie ad alcune ricerche in corso, che affrontano contemporaneamente il tema dal punto di vista dell’analisi socio-economica e da quello dell’analisi storico-giuridica, due percorsi d’indagine storica che non si devono confondere, ma piuttosto integrare, avendo entrambi la finalità di definire natura e caratteri della dipendenza libera e servile10. Les formes de la servitude: esclavages et servages de la fin de l’Antiquité au monde moderne. Actes de la table ronde de Nanterre (12-13 décembre 1997), in Mélanges de l’École Française de Rome – Moyen Âge, 112 (2000), pp. 493-631; La servitude dans les pays de la Méditerranée chrétienne au XIIe siècle et au-delà: declinante ou renouvelée? Actes de la table ronde de Rome, 8-9 octobre 1999, Ivi, pp. 633-1055. Considerati i collegamenti diretti con queste Note, mi permetto di rinviare ai miei contributi presentati alle due tavole rotonde: F. PANERO, Le nouveau servage et l’attache à la glèbe aux XIIe et XIIIe siècles: l’interprétation de Marc Bloch et la documentation italienne, in Les formes de la servitude, cit., pp. 551-561; ID., Persistenze della servitù altomedievale e forme di nuovo ‘servaggio’ nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV), in La servitude, cit., pp. 761-773. Cfr. anche il recente volume miscellaneo Forms of Servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance and Expansion, ed. by P. Freedman and M. Bourin, Tourhout, Brepols, 2005. 9 G. PASQUALI, Rapporti e patti di lavoro nelle campagne inglesi nei secoli X-XII, in Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale, a cura di A. Cortonesi, M. Montanari, A. NELLI, Bologna, CLUEB, 2006, pp. 65-86. 10 Mi limito a segnalare, a questo proposito, gli studi di Alberto Sciascia, che nell’ambito di una tesi di laurea magistrale in Metodologia della ricerca storica presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino sta affrontando il complesso problema del villainage inglese in una prospettiva di lungo periodo attraverso l’analisi di fonti di natura economica e giuridica. 8 312 2. La servitù nell’Europa occidentale durante l’età carolingia e postcarolingia: alcuni risultati della ricerca La ricerca più aggiornata sui temi della servitù e del servaggio ci consente di fare il punto su alcuni aspetti essenziali che possiamo così sintetizzare: a) Il termine servus viene utilizzato nelle leggi germaniche per indicare la condizione dello “schiavo” – un dipendente “ereditario” privo di personalità giuridica, spesso prigioniero di guerra, escluso dalla vita della comunità e talvolta ancora equiparato agli animali da lavoro, come avveniva nell’antichità – e, in Italia, conserva tale significato fino all’età longobarda avanzata. Un avvicinamento del servus allo stato giuridico dei liberi poteva tuttavia avvenire attraverso la manumissione condizionata, una forma di liberazione che però consentiva al padrone di conservare il patronato perpetuo sui liberti, che dunque continuavano a essere considerati dei dipendenti non-liberi11. Infatti lo status dei liti o laeti (presso i Franchi e gli Alemanni), dei lazzi (presso i Sassoni), degli aldi (presso i Longobardi) e dei colliberti, secondo la legge romana, pur consentendo un avvicinamento giuridico e sociale ai dipendenti liberi, continuava a imporre la condizione di dipendenza ereditaria12. b) La diminuzione progressiva, a partire dall’età carolingia, delle attestazioni di manumissioni condizionate è però un segno concreto dell’inserimento degli stessi servi non manumessi nella “comunità cristiana”, sicuramente favorito dalla legislazione dei secoli VIII e IX che, pur non pervenendo a una abolizione completa delle forme più rigide di schiavitù e della “servitù rurale ereditaria”, sotto l’influenza della predicazione di vescovi, monaci e missionari, riconosceva ai liberti condizionati e ai servi propriamente detti la piena dignità umana. A partire dall’età carolingia divenne pertanto superfluo subordinare la partecipazione dei servi alla vita della comunità contadina a un atto di liberazione condizionata perché ormai il servus non era più considerato uno “schiavo”, ossia uno strumento di lavoro, sradicato dalla comunità, come accadeva in età tardoantica (a parte vanno tuttavia sempre considerati i servi nella fase di tratta, che è opportuno continuare a definire “schiavi”, vocabolo che comincia a diffondersi intorno all’anno Mille e, come è noto, si deve alla loro provenienza prevalente, ancora nel tardo medioevo, dal mondo slavo: servi sclavi)13. F. PANERO, Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale, Vercelli, Società Storica Vercellese, 1990, pp. 15-64. 12 K. MODZELEWSKI, L’Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 173 sgg. 13 P. BONNASSIE, Survie et extinction du régime esclavagiste, cit., pp. 307-343; G. ROSSETTI, I ceti proprietari e professionali: status sociale, funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X, I, L’età longobarda, in Atti del X Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM, 1986, p. 192 sgg. 11 313 c) Nell’Italia centrosettentrionale il numero di servi di origine altomedievale diminuisce progressivamente fra X e XI secolo e in alcune aree la servitù scompare nel secolo XII, con alcune eccezioni; scompare in concomitanza con la scomparsa della curtis bipartita e con l’affermazione delle signorie territoriali di banno14. Nel Lazio, per esempio, Pierre Toubert ha rilevato una sostanziale scomparsa dalla documentazione dei vocaboli servi, ancillae, mancipia fin dall’inizio del secolo XI15. Vi sono nondimeno alcune eccezioni a questo processo, verificabile un po’ in tutta l’Europa occidentale. Fa eccezione il territorio di Bologna dove la servitù – assolutamente marginale nel secolo XII – rinacque all’inizio del XIII in seguito all’approvazione di uno statuto comunale, che consentiva ai liberi che avessero sposato un’ancilla di essere esonerati dal pagamento dei tributi al comune. Di conseguenza, nel corso di cinquant’anni, il numero dei servi crebbe in modo eccezionale, infatti per il diritto romano i figli di un libero e di una ancilla erano servi. Così, a Bologna, la popolazione servile alla metà del secolo XIII contava circa seimila persone, vale a dire il 7/8% della popolazione complessiva della città e del contado bolognese, che si può stimare per quell’epoca intorno agli 80.000 abitanti16. d) Queste trasformazioni della servitù, nella direzione della libera dipendenza, fra IX e XI secolo, spiccano in un’indagine condotta ultimamente su circa cinquemila atti scritti del regno di Francia da Michel Parisse: “L’évolution des hommes s’est accompagnée d’un changement des mots en usage, mancipium, servus, homo (proprius), ce changement s’opérant lentement sans coupure ni mutation brusque. Il me parait, pour finir, que le non libre carolingien est devenu un serf, dont on relève les charges juridiques, puis un paysan, qui n’est plus que dépendant supportant des charges à caractère économique. En tous cas il convient de nuancer ou de corriger les définitions abruptes données du serf de la pleine période féodale”17. e) Accanto agli schiavi di tratta, ai servi radicati nelle comunità rurali e ai liberti/aldii, nell’alto e nel basso medioevo sono documentati, oltre a piccoli proprietari terrieri (allodieri), contadini dipendenti liberi, che la documentazione europea induce a ritenere fossero la maggioranza della popolazione, F. PANERO, Schiavi, servi e villani nell’Italia medievale, Torino, Paravia, 1999, p. 27 sgg. P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle, Rome, École française, 1973, p. 475 sgg. 16 F. PANERO, Manumissioni collettive di servi in Francia e in Italia nel secolo XIII: riflessioni per una comparazione storica, in Il ‘Liber Paradisus’ e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008), a cura di A. Antonelli, M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 351-368. 17 M. PARISSE, Histoire et sémantique: de ‘servus’ à ‘homo’, in Forms of servitude, cit., pp. 19-56, a p. 46. 14 15 314 quantunque, per la natura della documentazione, non sia possibile pervenire a un calcolo di tipo statistico nemmeno su base regionale o subregionale18. 3. Libera dipendenza e forme di nuovo servaggio in Italia nei secoli XII-XIII In Italia, con l’affermazione delle signorie territoriali di banno fra X e XI secolo, emerge un ceto di contadini subordinati, di condizione giuridica libera, denominati homines, rustici, libellarii, massarii. Qualche volta sono anche chiamati villani, vale a dire habitatores villae. La libertà dei rustici italiani è denunciata dalla loro possibilità di disporre di un patrimonio mobiliare e immobiliare, di sposarsi liberamente, di testimoniare in tribunale, di abbandonare la terra ottenuta in locazione alla scadenza del contratto, o anche prima della scadenza, pagando una penale. La mobilità di questi contadini nell’Italia centrale e settentrionale è ben documentata fin dai secoli X-XI, quando li vediamo spostarsi con estrema frequenza verso le città, verso nuovi villaggi, verso castelli da poco costruiti nelle campagne: essi si spostavano con molta frequenza da un luogo all’altro anche perché avevano acquisito il diritto di vendere il “dominio utile” sulla terra detenuta in locazione perpetua. La loro dipendenza dal signore locale, dunque, si interrompeva con l’emigrazione dal luogo in cui abitavano. Nel corso del secolo XI non si poneva, quindi, il problema dei legami alla terra per i contadini dipendenti, perché da un lato i servi propriamente detti erano un gruppo minoritario e dall’altro i libellarii, che attraverso un patto scritto s’impegnavano ad abitare sul resedium avuto in locazione, per tutta la durata del contratto, potevano in realtà emigrare quando volevano. La stessa condizione è riscontrabile per i massarii liberi, che regolavano i loro patti di lavoro attraverso la consuetudine locale. Nonostante sia questa la situazione che generalmente è documentata per i secoli X-XI, la storiografia giuridica italiana all’inizio del Novecento ha orientato diversamente gli studi. Infatti negli stessi anni in cui Marc Bloch combatteva contro l’idea che vedeva la dipendenza dei non-liberi del medioevo caratterizzata dai legami alla terra – e dimostrava che la locuzione “servus glebae”, per definire il colonus-adscripticius, era stata coniata, tra la fine del secolo XI e l’inizio del XII, dal giurista bolognese Irnerio nel commentare il Corpus Iuris Civilis giustinianeo, dunque con riferimento R. FOSSIER, L’infanzia dell’Europa. Economia e società dal X al XII secolo, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 484491; F. PANERO, Schiavi, servi e “homines alterius” nelle città e nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale (secoli IXXII), in Città e campagna, LVI Settimana di Studio del CISAM (Spoleto, 27 marzo-1 aprile 2008), paragrafo 2, in corso di stampa. 18 315 all’età tardoantica e non al secolo XI19 – uno storico del diritto italiano, Pietro Vaccari, sviluppava una teoria esattamente opposta. Questa teoria era già stata enunciata da un altro storico del diritto della fine dell’Ottocento, Antonio Pertile, che a sua volta si accostava al pensiero giuridico tedesco e all’interpretazione del revisionismo marxista, che in Italia si sarebbe espresso attraverso la scuola economico-giuridica20. Per Vaccari i “servi della gleba” non erano i servi et ancillae carolingi (da lui definiti “schiavi”), ma sarebbero stati i contadini dipendenti privi di un contratto scritto. Quantunque non sia mai stata apertamente criticata la posizione interpretativa di Marc Bloch, l’interpretazione di Pietro Vaccari ha fatto scuola sino a oggi. Quali sono i documenti che hanno dato forza a questa teoria, accolta anche da alcuni storici tedeschi (come Karl Bosl, per esempio) e da alcuni storici del diritto francesi (Pierre Collinet, Jean Balon)21, oltre che da quelli italiani? I documenti presi in considerazione da Vaccari erano atti dei secoli XII e XIII relativi alla Toscana e all’Emilia Romagna, in cui alcuni contadini s’impegnavano in forma scritta a diventare adscripticii o coloni conditionales, come gli antichi coloni del tardo Impero romano. Egli citava inoltre alcuni atti di liberazione dei coloni dalla condizione di servaggio, della stessa epoca. Per Vaccari in sostanza tutto ciò avrebbe costituito una prova della continuità della condizione dei coloni-adscripticii fra tarda antichità e basso medioevo. Lo storico del diritto trascurava però il fatto che il termine colonus nell’alto medioevo poteva indicare sia discendenti di adscripticii della tarda antichità, sia contadini dipendenti provvisti di contratto scritto e liberi di spostarsi. Aveva invece ragione per quanto riguarda la diffusione in alcune regioni di contratti di adscriptio, che tuttavia, per l’età medievale (sostanzialmente dopo la Prammatica sanzione di Giustiniano e dopo lo stanziamento dei Longobardi in Italia), sono solo documentati a partire dal secolo XII. Lo spoglio di migliaia di documenti editi e inediti, condotto negli ultimi venticinque anni da chi scrive, consente di confermare che – come già rilevava Marc Bloch – fu il giurista bolognese Irnerio a coniare in forma di glossa la locuzione “servitù della gleba” per indicare i coloni tardoantichi. Se però Irnerio si limitò a commentare il Codex Iustinianus, ben presto, nel seM. BLOCH, Servo della gleba, cit., p. 164 sgg. Karl Marx riteneva che la condizione dei villani inglesi si potesse estendere a tutti i coltivatori dipendenti che prestavano corvées, come del resto avveniva sul continente per la realtà altomedievale del servo casato (self-sustaining serf); tale ipotizzato livellamento gli permetteva quindi di parlare di “servi della gleba”: K. MARX, Il Capitale, Torino, Einaudi (PBE), 1978, libro I, cap. 24, pp. 883 sgg., 912 sgg.; libro III, cap. 47, pp. 1062-1079. 21 P. COLLINET, Le colonat dans l’empire romain, in Le servage, Bruxelles, Recueils de la Société Jean Bodin, II, 1959, p. 91 sgg.; J. BALON, “Ius Medii Aevi”, I, La structure et la gestion du domain de l’Église au Moyen Âge dans l’Europe des Francs, Namur, Godenne, 1963, I, p. 171 sg. 19 20 316 colo XII, altri giuristi offrirono la possibilità ai notai di applicare ai rapporti quotidiani, ossia in forma contrattuale, questa antica condizione di dipendenza, riesumando i vincoli dell’adscriptio. Dunque la “rinascita” del diritto romano nello Studium di Bologna non si risolveva solamente nel commento delle antiche leggi sul colonato (dopo Irnerio, basti citare Azzone, Accursio o Roffredo), ma diventava uno strumento operativo per i giuristi pratici (come, ad esempio, Rolando da Lucca) che ogni giorno si confrontavano con l’esigenza di dirimere vertenze fra dipendenti e signori. Sia dai formulari notarili, sia dai contratti agrari risulta dunque che questa nuova forma di subordinazione traeva forza da un patto, per lo più scritto: soltanto in questo modo nell’Italia centrosettentrionale si potevano legittimamente vincolare alla terra dei contadini originariamente liberi. Molti affittuari perciò, per salvaguardare la loro libertà, spesso chiedevano ai proprietari di assicurarli espressamente che non li avrebbero mai considerati manentes perpetui, ciò che non facevano invece nel secolo XI, prima della nuova diffusione delle norme dell’antico diritto romano sul colonato (ullo modo non agemus neque molestabimus vos seu liberos vestros ... de manentia et omni colonaria seu ascripticia vel non ascripticia conditione). La chiarezza non era mai eccessiva visto che solo la condizione di “manenza colonaria” permetteva ai signori fondiari di esercitare la giurisdizione sui contadini e di sottrarli al banno delle signorie territoriali. A questi tentativi dei signori si opponevano con forza anche i comuni urbani, che alla fine del secolo XII stavano estendendo la loro giurisdizione al contado. Tanto per citare un paio di casi, se la consuetudine pisana dei secoli XI e XII permetteva la libera emigrazione dei rustici verso la città, la reazione signorile fu quella di farli impegnare, quando era possibile, a rimanere sul fondo coltivato in qualità di adscripticii, proprio attraverso clausole iugulatorie inserite nei contratti del secolo XII; quando però fu chiaro il tentativo signorile di considerare tutti i coltivatori dipendenti come coloni-ascrittizi, il comune intervenne per ripristinare il precedente diritto consuetudinario. A Firenze la permanenza in città per dieci anni di coloni, villani, homines alterius (cioè di quelle categorie specifiche di contadini che si erano impegnati a rimanere sulla terra signorile in perpetuum e che poi erano fuggiti) cancellava ogni impegno assunto in precedenza con i domini: in questo caso va ripetuto che non si trattava di semplici affittuari, di massari o di mezzadri – per i quali la libertà di movimento era esplicitamente riconosciuta –, ma di coloro che erano formalmente classificati come “servi della gleba” per via dell’accettazione dei nuovi patti di colonato22. 22 F. PANERO, Schiavi, servi e “homines alterius”, cit., paragrafo 3. 317 Anche nella Sicilia e in alcune aree del Meridione d’Italia nei secoli XII e XIII con il vocabolo villani si indicavano contadini legati alla terra, ma qui, per ragioni etniche, a creare questa nuova condizione intervenivano non soltanto i contratti agrari post-irneriani bensì anche le leggi della monarchia normanna, che consentivano di inquadrare tra i villani soprattutto la popolazione musulmana ribelle23. In questo quadro è interessante rilevare che invece non è stato finora possibile trovare contratti relativi alla Valle padana (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli) nei quali i contadini s’impegnino a vincolare se stessi e i propri eredi in perpetuum al fondo coltivato. La ragione sta probabilmente nel fatto che qui il diritto longobardo continuava ad essere applicato anche quando in Emilia Romagna, in Toscana e in tutta l’Italia centrale e meridionale prevaleva ormai nettamente il diritto romano. Nel diritto longobardo la condizione dei coloni non è contemplata, infatti presso i Longobardi erano gli aldii a rappresentare la categoria dei liberi con libertà condizionata, ma questa era una categoria in via di estinzione fin dal secolo X. Comunque, anche nelle regioni in cui il nuovo colonato risulta maggiormente diffuso, come la Toscana, la Romagna, l’Umbria, la Campania (Sicilia a parte), è evidente che coinvolgeva soltanto la minoranza dei coltivatori: infatti piccoli proprietari terrieri e contadini dipendenti continuavano a mantenere la loro libertà giuridica ed effettiva – per lo meno quando non vi fossero state violenze e soprusi signorili – e continuavano a spostarsi da un luogo all’altro con crescente intensità, come del resto dimostrano le migliaia di nuovi insediamenti fondati in tutta la penisola e nell’Europa occidentale durante i secoli XII e XIII24. All’inizio del secolo XIV le categorie di dipendenti che i giuristi medievali definivano servi glebae scompaiono, in seguito all’intervento politico dei comuni urbani nel contado e grazie all’organizzazione delle comunità rurali e alla grande diffusione, al Centro e al Nord della penisola, di contratti agrari a breve termine. Anche al Sud la legislazione sveva e quella angioina tendevano progressivamente a limitare il potere dei vassalli e degli enti ecclesiastici verso i villani, per potenziare l’autorità della monarchia. In conclusione, il mito storiografico della “servitù della gleba” medievale si spiega con il fatto che la “rinascita” del diritto romano consentì in alcune regioni la diffusione di contratti agrari che applicavano clausole tratte dal diritto giustinianeo sugli antichi coloni-adscripticii, consentendo ai proS. CAROCCI, Le libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio meridionale, in “Storica”, XIII (2007), pp. 51-94. Nella vasta bibliografia sull’argomento basti citare Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV), a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo, CISIM, 2002; Le terre nuove, a cura di D. Friedman, P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2004. 23 24 318 prietari terrieri di frenare l’intensa mobilità contadina a partire dal secolo XII. Ma tali contratti non consentirono alla “servitù della gleba” di diventare espressione di un nuovo servaggio nella penisola perché né la giurisprudenza dell’epoca, né i comuni urbani (protesi a imporre la loro giurisdizione su tutti gli abitanti del contado) e neppure la monarchia normanno-sveva tollerarono che leggi antiche, ispiratrici di patti consensuali, potessero diventare una consuetudine generale. La “servitù della gleba” in Italia restò pertanto circoscritta soltanto ad alcune regioni, dove peraltro, come abbiamo detto, non giunse mai a coinvolgere la maggioranza dei dipendenti rurali nei secoli XII e XIII. La stessa situazione si riscontra nella maggior parte delle regioni dell’Europa occidentale25, fatta eccezione per l’Inghilterra e la Vecchia Catalogna, dove il villainage26 e la condizione dei remensas27 ebbero nel corso del secolo XIII un posto importante (quantunque non precisamente definibile sul piano statistico) nel quadro dei rapporti di dipendenza. Le ricerche in corso dovranno pertanto appurare, senza preconcetti interpretativi, se l’affermazione di tali rapporti si possa mettere in relazione con la ripresa degli studi giuridici romanistici e della contrattualistica agraria conseguente – come avvenne in Italia – oppure se l’origine del servaggio glebale sia diversa. Cfr. M. BOURIN, Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d’une sociabilité (Xe-XIVe siècle), Paris, L’Harmattan, 1987, p. 213 sgg.; EAD., Les ‘homines de mansata’ en Bas-Languedoc (milieu du XIIe siècle-milieu du XIVe siècle): théorie, pratiques et résistances, in La servitude, cit., pp. 883-917; P. FREEDMAN, Servitude in Roussillon, in La servitude, cit., pp. 867-882. 26 Cfr. nota 10. 27 I primi risultati esposti nel recente studio di L. TO FIGUERAS, Servitude et mobilité paysanne: les origines de la “remença” catalane (XIIe-XIIIe siècle), in La servitude, cit., pp. 827-865, sembrano orientati nella direzione delle conclusioni formulate dalle ricerche sulle regioni italiane. 25 319 NOTE E DOCUMENTI IN MARGINE AL CARTEGGIO TRA GIANFRANCO CONTINI ED EMILIO CECCHI Gianni Perona La pubblicazione, qualche anno fa, del carteggio tra Gianfranco Contini ed Emilio Cecchi1 ha reso nota una documentazione certamente importante per la ricostruzione di una biografia intellettuale del critico ossolano. Deludente forse, se vi si cercassero informazioni su eventi o dati inediti o nuovi di carattere biografico. Né probabilmente la situazione sarebbe modificata se fossero sopravvissute le lettere di Cecchi degli anni Trenta e dei primi anni di guerra, andate distrutte nella devastazione di casa Contini al ritorno di Tedeschi e fascisti repubblicani nella Domodossola dell’ottobre 1944, dopo che Gianfranco, compromesso dalla partecipazione al governo della piccola “repubblica” partigiana, si era rifugiato in Svizzera nell’amica Friburgo, dove sarebbe proseguita, anche oltre la fine della guerra, la breve stagione del suo impegno politico. Così gravemente amputato nella sua prima parte, lo scambio tra i due rimase comunque costantemente ineguale, come lo stesso curatore ha dovuto ammettere, non dandosi una situazione di effettiva parità, sicché più è quello che noi apprendiamo dalle lettere di Contini, di quanto risulta dalle risposte del suo corrispondente. “Cecchi appare motivato da un certo spirito pratico” e adotta un linguaggio “che si colloca per lo più su un piano meramente funzionale” 2, mentre Contini, sullo sfondo costante di un “atteggiamento di proiezione mitica e ammirazione incondizionata” si abbandona 3 a una comunicazione «autentica e radicale»4. In realtà è vero che, accanto a dichiarazioni esplicite significative, indizi non meno interessanti devono essere colti indirettamente, dietro il sorvegliato affidarsi del giovaL’ onestà sperimentale, Carteggio (d’ora in poi L’onestà) di E. CECCHI e G. CONTINI, a cura di P. Leoncini, La collana dei casi, 46, Milano, Adelphi Edizioni, 2000. 2 L’onestà, pp. XIV, XV. 3 Se mai per la scrittura e in genere per la parola continiana si possa usare questo verbo. Chi scrive non può certo atteggiarsi a discepolo, ma ebbe, per la breve stagione di un seminario pisano all’inizio degli anni ‘60 del Novecento, esperienza diretta e memoranda della retorica didattica di Contini, praticata senza apparente sforzo, ma prossima alla sua scrittura tanto per finezza, precisione e dottrina quanto per preziosità lessicale, civetteria e snobismo. 4 L’onestà, p. XIII. 1 320 ne critico – ma anche, più tardi, del meno giovane, e perfino del maturo ed illustre – “a un genere che non è un ‘genere’, disinteressato, caritatevole e a corpo perduto, la lettera”5. Lo storico non dedito agli studi letterari cede perciò facilmente alla tentazione di cercare qualche spia, e magari, a partire da questa, qualche tratto permanente della personalità di Contini. Qui si farà un tentativo, nei limiti di una scorribanda tutta interna a pagine da lui scritte in un lungo arco di tempo, di usare a questo scopo delle tracce verbali, o delle ricorrenze di parole chiave, incrociando i dati presenti nel carteggio con la più sorvegliata opera critica, che ci sembra tuttavia rivelarsi, a questa verifica, più autobiografica di quanto non sembri. Prendiamo ad esempio un paio di riferimenti indiretti, allusivi, al carattere del rapporto tra il corrispondente più giovane e il più anziano. Nel momento stesso in cui il primo, dopo la lettura delle Corse al trotto, afferma la propria autonomia di giudizio e avanza qualche critica, difendendosi dal sospetto di essere “succubo delle conversazioni del corso d’Italia”6, si affretta però a dire che egli sta “auscultando leggeramente”, cioè “inadeguatamente” un ossimoro questo, come vedremo, nella terminologia continiana, nel quale più importa il secondo termine, che già definì la voluta inadeguatezza della parola di Dante nella Vita nuova rispetto al merito di Beatrice7. Più tardi, il 20 dicembre 1945, Contini chiede all’amico se può rimandargli qualcuna delle sue opere andate perdute per l’incursione fascista. “Sai pure che tutte le tue righe avea ricolte, e perdonami se uso un verbo che fu rivolto a Dante, ma è il più cordiale e veritiero”8. Con il che egli riprende i termini dell’amicizia ammirante che Guido Cavalcanti aveva coltivato per il giovane Alighieri, dove dunque Cecchi sta per Dante. Insomma, anche nelle allusioni, il segno dell’umiltà, del riconoscersi inferiore, permea dall’inizio la corrispondenza. 5 Così Contini stesso nel Progetto per un ritratto di Niccolò Tommaseo, del 1942, uscito nella “Fiera Letteraria” nel 1947, ora in G. CONTINI, Altri esercizî (1942 –1971), Torino, Giulio Einaudi editore, 1972, p. 5. 6 Cioè la casa di Cecchi a Roma. 7 Lettera del 29 dicembre [1936]. Questa citazione e la precedente in L’onestà, p. 35. Il curatore Leoncini coglie il dantismo “leggeramente” ed erroneamente lo collega a Inferno, XVIII, 70, intendendo “con movimento agile e veloce” (Ibidem, p. 137). Il riferimento è invece di certo a Vita nuova, cap. XIX, nella canzone Donne ch’avete intelletto d’amore. È sufficiente ricordare i versi 9 – 12: “E io non vo’ parlar sì altamente,/ ch’io divenisse per temenza vile;/ ma tratterò del suo stato gentile/ a rispetto di lei leggeramente”. 8 L’onestà, p. 57. Il curatore non annota la citazione, esplicita ma approssimata. Lievemente diverso il testo, tratto dal sonetto cavalcantiano I’ vegno il giorno a te ‘nfinite volte, che Contini accoglierà in Poeti del Duecento, tomo II, a cura di G. Contini, Milano – Napoli, Riccardo Ricciardi editore, [s. i. d., ma 1960], p. 548: “di me parlavi sì coralemente,/ che tutte le tue rime avie ricolte.” Nel contesto del nostro discorso, è interessante, se si volesse retroattivamente applicarla all’amicizia per Cecchi, l’esegesi continiana del primo verso: “Eri interprete così schietto del mio stesso sentimento” (Ibidem). 321 E poiché di sfuggita abbiamo toccato Guido, divaghiamo brevemente per notare che la sincerità epistolare di Contini ci dà un indizio raro e prezioso dell’incidenza del giudizio estetico di valore sull’attenzione per così dire tecnica agli autori da parte del filologo. Il cenno al poeta, l’unico, è nella lettera del 12 novembre [1932]: “E appunto mi sono dimenticato di chiederLe – dice continuando la memoranda conversazione del primo incontro personale tra i due, avvenuto poco prima – se Cavalcanti Le sembri ancor oggi un grande poeta. Le confesso che, nonostante l’invasatura odierna per lo stil nuovo, m’interessano molto di più i Provenzali”9. Una confessione interessante, perché fornisce l’unica spiegazione plausibile alla successiva, non sempre soddisfacente attenzione del critico al rapporto tra Guido Guinizzelli e Dante, che sarà esaminato con cura crescente10 ma non mai compiutamente partecipe11, e soprattutto a quella tra l’Alighieri e L’onestà, p. 5. Qui, come nella nota successiva, ci limitiamo a brevissimi esempi, non per addurre prove conclusive, ma per dare plausibilità alla temeraria invasione di campo per opera di un non specialista. Dell’attenzione crescente si trova indizio nell’esame comparato della canzone dantesca Così nel mio parlar e della guinizzelliana Tegno de folle ‘mpres[a]. Nessun rapporto tra le due è infatti ravvisato da Contini nelle due edizioni del suo commento alle Rime dantesche (cfr Dante ALIGHIERI, Rime, a cura di G. Contini, seconda edizione riveduta e accresciuta, Torino, Giulio Einaudi editore, 1946, pp. 162-167) che, significativamente, egli non volle mai modificare per accogliervi i suoi stessi acquisti. Commentando Tegno de folle ‘mpres’, a lo ver dire, nel 1960, egli rileverà invece, commentando il verso 15 (e poi li rendé pace), che la corrispondenza puntuale fra i versi 6 e 15 di Guido e rispettivamente 26 e 78 di Dante in Così nel mio parlar "permette di misurare la fortuna dantesca della presente canzone". (cfr. Poeti del Duecento, tomo II, cit., pp. 451, e 450, nota 1). Ma resta al di fuori dei riscontri continiani il parallelo tra i danteschi versi 34-38 e il sonetto guinizzelliano Dolente lasso, già non m’asecuro, vv. 1-4, che puntualmente riscontrerà, ad esempio, Luciano Rossi (cfr. G. GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. Rossi, Torino, Giulio Einaudi editore, 2002, p. 47, ad locum.) 11 Contini non rileverà mai puntualmente la portata dell’influenza guinizzelliana sulla canzone Doglia mi reca, della quale, come egli stesso dice, “riesce ben probabile che essa fosse la quattordicesima destinata a essere commentata” nel Convivio (cfr. Rime, cit., p. 178). Nessun riscontro si trova infatti nelle Rime einaudiane, ma anche quando, nel saggio Dante come personaggio-poeta della “Commedia” (1957), il critico riprenderà in esame la canzone, minimizzerà questa influenza e insisterà invece, sulla base di un riscontro verbale al verso 14 (“di due potere un fare”), sull’influenza di Guittone, una “posizione […] che idealmente rimanda di là del Guinizzelli” (Cfr. G. CONTINI, Varianti e altra linguistica, Una raccolta di saggi (1938 -1968), Einaudi Paperbacks 96, Torino, Einaudi, 1979 [ma prima ed. 1970], pp. 346-347, ma si vedano anche in generale le pp. 355-359, e specialmente 357, sul canto XXVI del Purgatorio sul “superamento” del Guinizzelli o la sua riduzione a “fonte singola”). Gli sfuggono così non solo la generale corrispondenza tra la guinizzelliana Al cor gentil e la dantesca Doglia mi reca sul piano concettuale, cioè che solo vero amore è quello che unisce una donna a un uomo reso nobile, “gentile”, dalla virtù, ma i puntuali richiami che l’Alighieri fa della cruciale quarta stanza di Al cor gentil, prima riprendendo il senso del verso 38 di quella (se da vertute non à gentil core) nel verso 41 (tu sola – cioè la virtù – fai segnore), poi inserendo al verso 105 (e voi tenete vil fango vestito) un’inequivocabile eco dei guinizzelliani versi 31-34: Fere lo sol lo fango tutto ‘l giorno:/ vile reman, né ‘l sol perde calore;/ dis’omo alter: ‘Gentil per sclatta torno’;/ lui sembro al fango, al sol gentil valore. In sostanza sembra che ci sia una vera resistenza del critico ossolano ad accettare l’evidenza che Doglia mi reca completi la riflessione dantesca sulla nobiltà che, muovendo dall’esposizione guinizzelliana nella grande canzone, aveva occupato, con Le dolci rime d’amor e il relativo commento, il quarto libro del Convivio; una riluttanza cioè ad accettare che anche per la parte non realizzata il progetto del Convivio si ponesse ampiamente sotto quel magistero di Guido che Contini solo lentamente tenderà a riconoscere. 9 10 322 Cavalcanti, per una riluttanza ancora più accentuata a considerare quest’ultimo nella sua piena autonomia, “sulla misura dantesca anziché a sua autonoma norma”, come Contini ammetterà nei Poeti del Duecento12, che lo spingerà a intitolare il suo maggiore saggio cavalcantiano, a introduzione dell’edizione veronese del 1968, Cavalcanti in Dante13, ancora una volta sottraendosi, in un certo senso, a un confronto diretto con la personalità poetica di Guido. In queste prime citazioni abbiamo trovato altre due parole sulle quali conviene ritornare. Una è “conversazione”, riferita al primo incontro con Cecchi. Di questo evento Contini tende presto a fare una trasfigurazione. A due anni di distanza, nel giugno 1934, scriverà: “l’incontro con Emilio Cecchi torna ogni volta a riapparirmi una cosa importante, e da segnare epoca, nella mia vita, quanto l’incontro con un Montaigne, un Alain”14. A caldo, appena avvenuto, se n’era scusato, per essere stato “un po’ troppo passivo: o, come dice il mio sottile distinguitore Rosmini, «recettivo»”15. Sembrano tutte forme di cortesia esagerate e affettazioni dell’umiltà già sottolineata sopra, eppure i termini di queste prime lettere non solo saranno ribaditi nell’epistolario, ma attraverseranno la vita intera di Contini. Così, il 22 aprile 1941, da Domodossola, si duole per non essere potuto andare a Roma per ragioni di salute, e aggiunge: “Mi dà molta noia esser privato della conversazione forse unica che si possa oggi avere in Europa”16. Un climax che culmina il 31 luglio 1942, con un passo che è stato molto notato: “Come in musica da una parte c’è Bach e dall’altra tutto il resto, così da una parte ci sei tu e dall’altra tutto il resto”17. Vediamo, a distanza di anni, qualche altro riscontro. Nel 1955, scrivendo su Longhi prosatore, Contini conclude: “Ma talvolta mi sorprendo a pensare se quello che di loro [gli scrittori e gl’intellettuali più giovani], cioè di noi, diranno i posteri, non sarà soprattutto che essi potevano, solo che avessero fatto un uso giudizioso del telefono, fruire della conversazione quotidiana di Longhi, di Cecchi, di Bacchelli. 18” E nel 1968, in coda al Cavalcanti in Dante, inopinatamente vediamo riaffiorare un ricordo autobiografico: “Rammento la prima volta che incontrai Emilio Cecchi, ed egli mi diCfr Poeti del Duecento, tomo II, cit., p. 489. Poi in G. CONTINI, Varianti, cit., pp. 433-445. 14 L’onestà, p. 11. 15 L’onestà, p. 4. 16 L’onestà, p. 40. 17 L’onestà, p. 47. 18 G. CONTINI, Longhi prosatore, (1955), poi in ID., Altri esercizî (1942 -1971), Torino, Giulio Einaudi editore, 1972, p. 122. 12 13 323 scorse di quei libri (per lui erano la Scienza Nuova e L’action) che «salano il sangue». Diciamo dunque, a sua imitazione, che Cavalcanti aveva salato il sangue a Dante, quod erat demonstrandum.19” Il cerchio si chiude, non imprevedibilmente, nell’intervista del 1988 a Ludovica Ripa di Meana. “Noi siamo vissuti in un’epoca che appare insigne. Dobbiamo congratularci con la Provvidenza che ci ha fatto nascere nell’epoca in cui, intanto, viveva Croce: l’epoca dei Longhi, dei Cecchi, dei Debenedetti, dei Bacchelli...[…] io, sedendo tra l’uno e l’altro di questi amici, mi sentivo promosso […] A me piace ammirare. Io voglio dire che la mia amicizia si nutre sempre anche di ammirazione”20. E qui ritroviamo anche la teoria della recezione, che aveva segnato il primo incontro con Cecchi. Parlando di Longhi, Contini amplia il tema: “Io, per la verità, ne sentivo la grandezza, e mi sentivo in situazione di recettore […] Con gli uomini grandi che ho conosciuto, io mi sentivo piuttosto recettore”21. Tuttavia, nel riferimento all’amicizia di Longhi, Contini fa anche l’ammissione di aver praticato un’amicizia voluta e calcolatamente coltivata: “Quando avvertivo che le sue opinioni divergevano dalle mie […] rallentavo la frequentazione, poi ritornavo… […] riuscii ad amministrare questa amicizia alla quale tenevo moltissimo”22. Qualcosa di molto simile si coglie del resto nelle cautele verso Cecchi, nel silenzio sulla distanza politica, specie dal 1944 in poi, dall’amico, nella reticenza sull’evoluzione per cui in questi “si assiste a un progressivo illimpidimento e raffinamento formale, a detrimento della tensione problematica”23. Calcolato amministratore di un’amicizia pur sincera sembra essere stato, Contini, anche verso Pier Paolo Pasolini: “Quello che preservò la nostra amicizia, un po’ dormiente durante i decennî romani, fu proprio l’essere de lonh. […] e questo […] ricacciava nel non essere una sua proclamazione di stacco”24. Per questo sospetto di una non totale schiettezza, ci piace ricordare qui una frase che sembra invece ispirata a diversa sincerità. Ricordando RafIn G. CONTINI, Varianti, cit., p. 445. Cfr Diligenza e voluttà, Ludovica Ripa di Meana interroga Gianfranco Contini, Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1989, pp. 170-171. Significativamente, Contini era stato colpito da un tratto opposto di Benedetto Croce: “Ma sarà proprio un caso che l’antisnobistico Croce, sottratto alle mode e alle società letterarie, non abbia incontrato nessuno dei grandi più anziani di lui (e i giovani andaron loro a cercarlo)? […] Croce […] ebbe la singolare pietas di costituirsi precursori ideali dei quali indagare affettuosamente la storia […] se li trovò tutti nella cultura locale: De Sanctis […] Vico […] Hegel”. Cfr. G. CONTINI, Croce e De Sanctis (1953), in ID., Altri esercizî, cit., p. 72. 21 Ivi, p. 99. 22 Ibidem. 23 Il passo, in mezzo a una pur entusiasta sintesi sul Cecchi stilista, in G. CONTINI, Letteratura dell’Italia unita, 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1971 (prima ed. 1968), p. 741. 24 Cfr. G. CONTINI, Testimonianza per Pier Paolo Pasolini (1980), in ID., Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-1987), Torino, Einaudi, 1989, pp. 393-394. 19 20 324 faele Mattioli, Contini commenta: “dirò che l’amicizia è più vasta del comportamento. I miei migliori amici, il socialista Ettore Tibaldi come il nazionalista Carlo Emilio Gadda, assunsero una parte che, nella storia fatta coi se, avrei profondamente avversata, quella dell’interventista.25” Ettore Tibaldi, clinico insigne, l’unico che non fa parte degli “spiriti magni”26 soprattutto “vociani” continuamente ricorrenti sotto la penna del filologo concittadino, aveva presieduto la Giunta dell’Ossola libera, della quale quest’ultimo divenne segretario. E questa amicizia, lontana dalle luci e dalla pubblicità della vita culturale, durò fino alla morte, sicché ci piace darne qui, in appendice, documento in due lettere scritte alla sorella del vecchio antifascista che certo aveva avuto un ruolo importante nell’introdurre il giovane amico all’impegno nella Resistenza. Socialista interventista Tibaldi, “azionista” Contini, influenzato dal pacifismo di Capitini27: questa amicizia in qualche modo rappresentava il conflitto presente nell’animo del filologo e critico tra l’anima “interventista” del Partito d’azione di Parri, di Galante Garrone, di Lussu, e il rifiuto della guerra, che nel suo più tardo ricordo egli renderà esplicito. Tutte le considerazioni psicologiche svolte finora costruiscono una sorta di paradigma indiziario preliminare per inquadrare il senso profondo del rapporto tra Cecchi e Contini. Più vicina al cuore della questione ci sembra però un’altra parola chiave, anch’essa già fuggevolmente evocata: “auscultare”. Giustamente il curatore coglie le due occorrenze del verbo: “si vedano l’«auscultare puntualmente» della lettera del 26 giugno 1934 e l’«auscultando leggeramente» della lettera del 29 dicembre 1936”28, e le usa, mentre riconosce le influenze di Santorre Debenedetti e dei rosminiani, per una definizione della critica continiana. Ma pare utile, ai fini di questa nostra esplorazione per spie verbali, cercare altre occorrenze. La prima delle quali, in ordine cronologico, si colloca in una sede particolarmente significativa. Era stato Giovanni Boine, infatti, nelle righe conclusive del suo G. CONTINI, Ricordo di Raffaele Mattioli (1986), in ID., Ultimi esercizî, cit., p. 385. Evidenziazione nostra. Ci pare rivelatore il fatto che un sentimento di amicizia personale profonda Contini, nel 1988, dichiarerà soprattutto per Armando Mastrangelo, uno svizzero scomparso misteriosamente a Radda in Chianti. Ma il suo nome, neppure ai margini dell’opera critica, non compare virtualmente mai. V. Diligenza e voluttà, cit., pp. 87-88. 27 All’osservazione della Ripa: “Nel 1944 lei si è chiesto: «La civilisation italienne va-t-elle être une civilisation d’amour, un monde où l’amour primera sur la liberté? C’est pour lui en tout cas que nous nous battrons».” Contini risponderà: “Io ero allora violentemente nemico della guerra e avevo debiti mentali con Aldo Capitini nel suo periodo più luminoso.” E subito dopo ribadirà: “l’esperienza più decisiva è quella che feci con Aldo Capitini, che stava a Perugia e che era nel momento del suo fulgore.” Cfr. Diligenza e voluttà, cit., p. 81. 28 L’onestà, p. XVII. 25 26 325 intervento sui Frammenti lirici di Clemente Rèbora, quello che aveva detto: “per parecchia di codesta poesia un anno durante inosservata (per ciò che è e ciò che dentro, quasi per echi, vi posso auscultare, traudire, intuire), mi vien voglia di segnar commosso qui la parola GRANDE”29. Un passo che certamente Contini ha presente, intento com’è alla lettura di Rèbora, che stava allora facendosi sacerdote e rosminiano, il primo fra i Due poeti degli anni vociani (l’altro è Campana) le cui analisi saranno pubblicate nel 193730. La principale e forse unica altra occorrenza, significativa e iterata, si trova nel saggio del 1948 su Serra e l’irrazionale, che è necessario citare con una certa ampiezza: “In quanto Serra sia un critico, fornito di caratteristiche imitabili, atte a lasciare la loro traccia nel lettore come metodicamente ben rilevate, bisogna cercarlo in quel primo quaderno della «Voce», nei saggi su Pascoli e Beltramelli […]. Ora, la differenza specifica del Pascoli e del Beltramelli è nell’auscultazione impregiudicata del testo e nella chiamata delle citazioni entro la struttura stessa del ragionamento. […] Ma ciò per cui Serra è Serra, e per cui è ancora Serra una parte dell’atteggiamento della critica moderna, è la gerarchizzazione, la messa in prospettiva e il rilievo come stereoscopico […] del testo letto, anteriormente a ogni giudizio preordinato; lo sforzo, anzi, di ricavare un giudizio ricco e adeguatamente sfumato tutto da questi materiali stereoscopici, da questi excerpta privilegiati e colpiti di necessità nei quali soffia intero lo spirito poetico, una volta che l’orecchio attento ha saputo differenziare quella liscia superficie. Un’immanenza talmente assoluta del critico nella sua lettura postula un certo eroismo ascetico”. E più avanti Contini ribadisce: “Ora, di questi e degli altri iati irrazionali la ragione è nel bisogno di totalità della critica di Serra, che sorge dal fatto stesso di proporsi il testo puro, vicinissimo; la sua irriducibile, inesauribile oggettività induce il critico a più e più tentativi di tangenza, fino a portarlo a un composito risultato provvisorio […] nel quale la componente essenziale, l’auscultazione dell’opera, finisce per diventare uno degli ingredienti”31. Passeranno quarant’anni prima che l’auscultazione ritorni, e con quale evidenza, nella definizione che Contini darà della prima stagione della sua propria attività critica. Citiamo l’essenziale della complessa autodefinizione fornita a Ludovica Ripa: “Quanto alla definizione, direi che la prima mia Nella sua rubrica Plausi e botte, su “La Riviera Ligure”. Il passo citato in G. BOINE, Il peccato e le altre Opere, “Ritratto di Boine” di Giancarlo Vigorelli, Parma, Guanda, 1970, p. 240. Il corsivo è nostro. 30 In una rubrica intitolata significativamente Dalla “Voce” alla “Ronda”. Ora in G. CONTINI, Esercizî di lettura sopra autori contemporanei con un’appendice su testi non contemporanei. Edizione aumentata di “Un anno di letteratura”, Torino, Giulio Einaudi editore, Einaudi Paperbacks 137, 1982 (1ª ed. 1974). Su Rèbora, pp. 3-12. pp. 387388. 31 Cfr G. CONTINI, Serra e l’irrazionale, (1948), poi in ID., Altri esercizî, cit., pp. 83 e 92. Le evidenziazioni sono ovviamente nostre. 29 326 critica è dipesa da una auscultazione molto attenta della superficie del testo […]. Questa è stata la mia intenzione: segnare le curve di livello di un testo auscultato attentamente e, devo dire, con una grande intensità, con grande tensione – che forse ora non potrei più avere.” Curiosamente, il critico rimuove poi ogni riferimento a Serra, e aggiunge non meno curiosamente una riflessione che lo accosta a Boine32: “Non mi pare che abbia dei precedenti cogenti e, in sostanza, data questa auscultazione qualche volta al limite del penoso, debbo dire che si tratta di un fatto autobiografico – portato, però, su testi oggettivi. […] Poiché si tratta di ricavare, mediante questa operazione, l’essenziale da testi oggettivi, in sostanza si delinea una linea autobiografica; cioè una linea oggettiva dei testi e, in corrispondenza, specularmene, una linea autobiografica dell’auscultatore.33” Parlando poi della ricezione della sua critica, ribadisce: “Certo, era una critica non facile da assorbire perché nasceva da un travaglio profondo, almeno nella mia giovinezza, da una auscultazione a cui mi dedicavo interamente”34. Così l’amicizia, la conversazione, l’auscultazione, in questa nostra lettura temeraria e tutta interna, finiscono con il rimandare coerentemente a una piccola area della storia della cultura italiana, quella che si definì all’inizio del Novecento in riferimento alla “Voce”. Qui ritroviamo gli “auscultanti” Boine e Serra, qui gli “amici” Longhi e Cecchi. E le spie verbali fornite dal carteggio con quest’ultimo sembrano rientrare nel percorso di un letterato che, elettivamente, in quel manipolo d’intellettuali si è riconosciuto e con ammirazione identificato. Prendiamo ora in considerazione, avviandoci alla conclusione, il collegamento stretto che Contini stabilisce tra “La Voce” e Cecchi. “Troppo spesso si cita «La Voce» senz’aver bene in mente la rivista di questo nome, e perciò con una certa inesattezza documentaria. «La Voce» era, almeno alla sua nascita, una sede civile e nient’affatto letteraria, molto esplicitamente preoccupata della moralità della cultura e della vita pubblica, d’un’opera di censura etica e ideologica, a non meno espresso e proclamato detrimento d’ogni eventuale collaborazione creativa. Anche chi doveva poi affermare notevoli o dominanti interessi espressivi, come Soffici, Slataper o Jahier, vi compariva militante e secolare. E si vede con lieto stupore, seguendo le pagine della «Voce», nascere la passione alla «cosa» lettera32 Perentorio sull’autobiografismo del critico, ad esempio, parlando del Giornale di bordo di Soffici: “Quel che dico (e me ne glorio) è niente più della mia momentanea e personale impressione, e non parlo infine che di me. In confidenza anzi non so proprio di che altro si possa parlare che di se stessi.” Cfr. G. BOINE, Il peccato e le altre Opere, cit., p. 305. 33 Diligenza e voluttà, cit., pp. 48-49. 34 Ivi, p. 182. 327 ria per opera esclusiva di Cecchi, in quel suo selvoso e tumultuoso romanticismo di allora così ingrato a Serra, e restare per un pezzo in monopolio alle sue mani”35. Centrale la figura di Cecchi nella storia della “Voce”, per Contini, ma centrale anche “La Voce” nella storia del ventesimo secolo. In un intervento del 1941, pubblicato su “Primato”, egli riflette sulla “questione dei rapporti fra vita universitaria ed extrauniversitaria […] quella dialettica di filologia e di presenza che fa la vita della cultura.” E insiste sulla necessità di una distinzione, anzi separazione del fare artistico dall’accademia, sulla “necessaria solitudine del poeta”. “All’università, in senso largo, il «fare» giunge naturalmente in soli termini di cultura. Se l’adequazione fosse veramente perfetta, sarebbe segno che il movimento iniziatosi, press’a poco, con la «Voce» avrebbe esaurito la sua vitalità; e in quanto controllata e approvata senza riposo da una cultura universitaria, la produzione si deriverebbe in un accademismo di piccole perfezioni. Poiché indubbiamente le istanze creative sono ancora da porre, nel nostro momento, in termini romantici, oportet haereses esse”36. Passata la guerra, in una larga ricognizione retrospettiva della letteratura italiana del Novecento, Contini insisterà ancora sulla centralità della “Voce” e dei vociani. “Fondée en 1908, “La Voce” naît à la confluence de la diffusion idéaliste [...], du goût absolu de la poésie [...] et de l’instance religieuse [...]. Soulever la culture italienne sur un plan européen, telle fut l’intention de M. Croce et, sur une base esthétiquement plus libre, des «vociani»”37. Aggiungiamo che, al di là dei due più organici contributi critici su Cecchi, l’ammirazione continiana è pervasiva e diffusa in tutti i suoi scritti. Essa si estende ad esempio al di là del prosatore anche al poeta, sicché si può immaginare che il più anziano dei due corrispondenti fosse compiaciuto nel leggere un giudizio come questo, enunziato dal giovane nella sua recensione a Conclave dei sogni, di Giorgio Vigolo: “sono pur chiari i legami più sottili che lo ricollegano almeno all’esigenza presentata dalla poesia di Vincenzo Cardarelli e di Emilio Cecchi. […] il fato non ha un significato trascurabile; né è meno atto, per conto nostro, a procurarci una privata soddisfazione. Abbiamo sempre ritenuto che l’esigenza Cecchi – Cardarelli Cfr G. CONTINI, Serra e l’irrazionale, (1948), poi in ID., Altri esercizî, cit., p. 78. Cfr G. CONTINI, Risposta a un’inchiesta sull’università, (da “Primato”, 15 maggio 1941), poi in ID., Esercizî di lettura sopra autori contemporanei con un’appendice su testi non contemporanei. Edizione aumentata di “Un anno di letteratura”, Torino, Giulio Einaudi editore, Einaudi Paperbacks 137, 1982 (1ª ed. 1974), pp. 387-388. 37 Cfr G. CONTINI, Introduction à l’étude de la littérature italienne contemporaine, (Ginevra 1944) in ID., Altri esercizî, cit., pp. 248-249. 35 36 328 sia naturalmente la più feconda e in qualche modo paradigmatica tra le esperienze contemporanee”38. Il culmine di questa esaltazione è, forse, nel profilo che Contini traccia nel 1944: “Ayant renoncé de bonne heure aux ambitions macroscopiques, cantonné d’abord dans le genre indirect qu’est la critique littéraire (critique par sympathie et syntonie plutôt que par concepts), l’ayant aussi quitté pour une forme encore plus discrète, c’est entre les marges de sa colonne de journal que M. Emilio Cecchi parvient à condenser un peu de sa vérité cachée. Styliste à l’armure sans défaut, car il faut un cristal impeccable pour saisir et renfermer l’enfer quotidien, il semble réaliser par moments ce que dut être le rêve du dernier D’Annunzio, et que les entraves d’un narcissisme s’agitant dans le vide dériva [sic] chez celui-ci dans un piteux radotage. Dans ses quelques recueils d’essais et de proses de voyage, le secret de M. Cecchi, le meilleur prosateur et l’esprit le plus riche de l’Italie contemporaine, se dévoile toujours plus cruellement: à la thèse d’une sensibilité portant sur l’élément démoniaque et destructeur du monde s’oppose l’antithèse d’une défense de plus en plus angoissée et acharnée. Il n’est pas étonnant qu’en vertu de ce qu’il nomme quelque part la « dialectique de la peur » cet homme prodigieusement lucide, et qui se croit désabusé, en vienne à chercher un abri dans les structures du bon sens, ou même du réalisme pratique. Le cas de Sainte-Beuve, ce libéral qui a renoncé, est-il tellement différent? C’est son antibourgeoisisme de base, qu’il éprouve très intensément sans oser le vivre jusqu’au bout, et contre lequel il soulève d’ailleurs à la fois la terreur du superstitieux et l’objection éternelle du classique, qui induit M. Cecchi aux gestes extérieurs du conformisme. Et c’est sans doute M. Croce qui a éduqué culturellement chez M. Cecchi le sens de la réalité, en même temps qu’il en stimulait la curiosité indomptable”39. Insomma, nella ricostruzione continiana, “La Voce” è al centro di mezzo secolo di storia culturale, e Cecchi è al centro del rinnovamento culturale che “La Voce” promuove ben oltre gli anni della sua pubblicazione. E dell’ultima fase di questa lunga stagione Contini è, ovviamente, partecipe ammirante. Ma si possono cancellare così dalla prospettiva gli altri protagonisti della stagione vociana, che sembrano così vicini a tutta la vicenda del Contini critico e, suggeriremmo, dell’uomo Contini? È lecito pensare di no, ma dobbiamo produrre qualche indizio, se non prova a sostegno. Prendiamo Cfr. G. CONTINI, Giorgio Vigolo, II. Versi, (aprile 1937), in ID., Esercizî di lettura, cit., p. 136. G. CONTINI, Altri esercizî, cit., pp. 246-247. ID., Introduction à l’étude de la littérature italienne contemporaine, “uscito nel 1944, sul fascicolo 4 della rivista ginevrina «Lettres»”. 38 39 329 ad esempio ancora Boine. Mentre critica duramente Le Lettere pubblicate da Serra egli osserva: “I drammi, le impalcature e gli schemi di Emilio Cecchi, io li discuterò ad uno ad uno e mi parranno quasi sempre inutili o non veri (non così per la sostanza intuitiva che è viceversa quasi sempre sicura e rovente) ma mi piacciono e li ammiro perché li sento proiezione esteriore di una faticosa lotta interna, di un vivo ribollimento che non s’accontenta di nessun raggelo, di una disperata ricerca di euritmia anche più morale che intellettuale”40. Sembra dunque avere radice in Boine quell’attenzione alla “moralità essenziale”, all’“onestà sperimentale” che Contini rileva in Cecchi già mentre riflette sul fatidico primo incontro del 1932 a Roma41. E spigoliamo poi due note di Contini stesso. La prima è nascosta nella postilla ai Frammenti di un bilancio Quarantadue, pubblicati nell’estate 1943, “esigue reliquie d’un libro […] nel quale, sotto il mirino dell’attualità, si sarebbe voluta far sfilare più o meno tutta l’Italia letteraria contemporanea.” Contro le critiche, Contini definisce se stesso e il suo compito, poi improvvisamente s’identifica parzialmente ma inequivocabilmente con Boine: “Per noi, hic et nunc, il lavoro immaginato persiste comunque a vivere nei termini della presenza – azione, sul quale gli storicismi divulgativi non hanno presa, come sa il letterato che ebbe la pazienza di districare le obiezioni dai facondi, albuminosi malumori antivociani di Boine, e al sillogismo spicciolo potremmo sempre opporre sperimentalmente la nostra coscienza di non gratuità”42. Conclusione nella quale si sente più che un’eco dell’“onestà sperimentale” attribuita a Cecchi. L’altro passo si trova alla fine del breve saggio Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine. Ma resta, per me almeno, enigmatico: “Importa la posizione storica generale di Boine tra razionalismo e razionalità: nemico del primo, sacrificatore alla seconda; la sua situazione in rapporto all’impulso verso la visione. In ciò sta l’attualità di Boine negli anni presenti: in questo ricorso dal 1915 al 1940”43. Sorprende lo storico la data 1915: di che Boine si parla? Di quello dei Discorsi militari, appunto del 1915? E l’accostamento al 1940 non è meno ambiguo, quasi angoscioso per uno scritto prodotto nel contesto dell’incipiente nuova guerra europea. Passano otto anni, e troviamo un passo analogo, ma illuminato dalla scienza del poi. Se nel 1939 si parlava dell’“attualità” di Boine, ora si analizza l’ “attualità” di Serra, dopo avere ricordato la sua morte nella Grande guerra. “Lo spirito di verità che emana dalla persona di Serra ci vieta ogni G. BOINE, Il peccato e le altre Opere, cit., p. 290. L’onestà, p. 4. 42 G. CONTINI, Frammenti di un bilancio Quarantadue (1943), in ID., Altri esercizî, cit., p. 219. Evidenziazioni nostre. 43 G. CONTINI, Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine (1939), in ID., Varianti, cit., pp. 257-258. 40 41 330 reticenza: l’attualità di Serra che è nell’essere dei tempi – l’impulso irrazionale e religioso senza religione, l’obbedienza alla storia, il gusto pur beneducato del momento eccezionale da vivere, l’opzione per un rischio non imposto – non possiamo concederla al loro dover essere se quell’impulso non si coniughi e componga con un oggetto di validità universale. In tutto questo secolo forse, nella storia esterna diciamo, una simile probabilità d’incontro non fu valida al massimo se non nel fatto della Resistenza. Quel minuto eroico è passato, e solo un senso acuto della presenza, dell’infinità che si attua qui e ora, può dar cuore a proseguire non irreligiosamente nel grigio quotidiano”44. Così, quando la storia si affaccia nello studio di Contini, non sembra essere Cecchi la figura con cui confrontarsi, ma sono proprio i “vociani” più compromessi nell’interventismo, quelli che non sopravvivranno alla guerra. E quegli altri, non necessariamente “vociani”, che, superstiti, gl’insegneranno la via della Resistenza. Anche per questa via, certo non letteraria, il critico avrebbe finito con l’unirsi all’ “interventista” Tibaldi. Appendice: due lettere di Gianfranco Contini a Maria Tibaldi Diamo qui la trascrizione, rispettosa anche della divisione delle righe, di due messaggi – una lettera e una cartolina – di Gianfranco Contini a Maria Tibaldi, sorella del professor Ettore, dopo la morte del fratello. Entrambi i documenti si trovano a Milano, nell’archivio dell’Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia, nel Fondo Ettore Tibaldi, busta 12, fascicolo 61, “Condoglianze e commemorazioni”, sottofascicolo “Contini”. 1. Lettera manoscritta autografa, in una busta con indirizzo dattiloscritto Gent.ma Signorina Maria TIBALDI Certosa di PAVIA Firenze, 5 dicembre 1968 Gentile signorina Maria, Cfr. G. CONTINI, Serra e l’irrazionale, in «L’Immagine», fasc. 6-7, 1948, e ora in ID., Altri esercizî, cit.; il passo citato a p. 100. 44 331 Le mando con qualche anticipo gli auguri per le prossime Feste, perché tra qualche giorno mia moglie e io faremo un salto negli Stati Uniti, tornando solo alla fine del mese. Le sono gratissimo – e ne sono commosso – di avermi voluto mandare il giornale, con quei documenti fotografici tristissimi, ma atti anche a ispirare un certo conforto nel lutto che è Suo ed è di tanti, è certamente nostro. La presenza del Professore non è diminuita, e mi piace avere DI LÀ, con altri cari, anche questo amico, e quale amico. Durante l’anno verrò a farle visita. Ho parlato con Bensi (Bill) d’una strada di Domo da intitolare al Professore. Il Comune ci aveva già pensato, e anche di farne a suo tempo occasione per una cerimonia. Forse ero tenuto al segreto (non mi scopra), ma ho voluto che non restasse all’oscuro proprio Lei dell’iniziativa. Un affettuoso e deferente ricordo, anche per i miei, dal Suo Gianfranco Contini [sul margine verticale a sinistra] Mi saluti per favore la Teresina. 2. Cartolina dattiloscritta, con firma autografa, su carta intestata ACCADEMIA DELLA CRUSCA FIRENZE PIAZZA DEI GIUDICI, 1 Firenze, Pasqua 1969 Gentile Signorina Maria, ci ricordiamo a Lei con devozione e affetto (e mi scuso di usare la macchina, ma esclusivamente per renederLe leggibile la mia micrografia). Ci auguriamo, in particolare, che della Sua salute possiamo avere notizie migliori di quelle che trovai nella Sua lettera tornando da New York; dove, in cambio, l’annuncio che Domo avrebbe scelto il suo meglio per perpetuare il nome del nostro Professore per coloro che non avranno avuto la fortuna di conoscerLo mi ha dato della mia città un’idea più lusinghiera dello sperato. 332 Mi auguro di poterLe far visita durante l’anno, e inTanto Le porgo (pregandoLa di salutarci la Teresina e Piergiacomo) i deferenti ossequi di tutti noi. Il Suo Gianfranco Contini 333 334 DIETRO ALLA CURVA. ALCUNE (POCHE) CONSIDERAZIONI SUL CALCIO E I SUOI TIFOSI Laura Bonato Ricordo che per qualche tempo – più o meno dai 12 ai 18 anni – la mia grande aspirazione è stata diventare una cronista televisiva di calcio: in un periodo in cui poche ancora erano le donne che lo seguivano, amavo quello sport, ne discutevo con adulti (uomini), frequentavo gli stadi. Allora – più di vent’anni fa – era insolito vedere una donna allo stadio a tifare per la propria squadra: le donne spesso accompagnavano mariti e fidanzati ma erano per lo più estranee – e inconsapevoli – a quanto succedeva loro intorno. Ora molte donne hanno fatto del calcio la loro passione e, secondo una ricerca compiuta nel 2005 da alcuni sociologi dell’Università “La Sapienza” di Roma, le tifose amano lo spettacolo del calcio ma sanno anche giudicare il gioco e per loro la squadra è più importante dei singoli giocatori. Esistono diversi gruppi organizzati femminili: cito, ad esempio, “Ladies and Angels” per la Juventus e “Granata Girls” per il Torino1. L’allontanamento dagli stadi per motivi di salute mi ha obbligato ad abbandonare il mio sogno – ero convinta che di questo sport capisse solo chi lo vedeva giocare – ma da tempo desidero scrivere di calcio, soprattutto dopo aver coordinato lo scorso anno un seminario sull’argomento, di supporto al corso di Antropologia culturale, al quale ha partecipato un gruppo di studenti della nostra Facoltà2 interessato a ‘dare voce’ ai tifosi. Attraverso rilevazioni sul campo e numerose interviste, abbiamo avuto conferma che il calcio, linguaggio comprensibile in tutto il mondo, è lo sport che muove tanti sentimenti e che l’amore per una squadra è qualcosa di esclusivo e totalizzante. È inoltre emerso che il calcio e la cultura calcistica sono un intreccio di atteggiamenti trasgressivi e rituali, di interessi economici e 1 AA.VV., L’ultra faccia del calcio, relazione per il seminario di Antropologia culturale, Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 2007. 2 I membri del gruppo di lavoro erano: Silva Bacaj; Andrea Bisceglia; Serena Caldera; Fabio Carando; Greta Cimmino; Rajae Elghazzali; Luca Ercole; Loris Formica; Alberto Frea; Mirko Giolito; Mattias Guidugli; Ensela Koci; Giulia Lauzzana; Gloria Lisa; Serena Maragon; Matteo Mosso; Gabriele Pellegrino; Ilaria Roma; Ermal Shimaj; Ornella Steca; Cecilia Sumin; Rezarta Trushi; Alessandro Ugonia; Megli Xhani. 335 simbolici, di fatti, miti, stereotipi3. In altre parole il calcio condensa i valori fondamentali della nostra società4: in effetti allo stadio si incontrano le stesse persone che si possono incontrare in qualunque altro posto e in uno stadio non accadono più ‘episodi spiacevoli’ che nella nostra società5. Non c’è da stupirsi quindi se il calcio finisce per assumere, a livello individuale e collettivo, significati che travalicano l’ambito sportivo per sconfinare in campo etnico, religioso, politico. Ad esempio in Spagna il Barcellona incarna l’autonomismo catalano, contrapposto al centralismo castigliano del Real Madrid; in Italia e in Francia rispettivamente Napoli e Olympique Marsiglia rappresentano la voglia di riscatto del sud arretrato; a Glasgow, in Scozia, si sfidano i protestanti Rangers e il Celtic, squadra dei cattolici e degli immigrati di origine irlandese. Dobbiamo inoltre ricordare che i gravi incidenti avvenuti in occasione di una partita tra i croati della Dinamo Zabagria e i serbi della Stella Rossa Belgrado furono la prima palese avvisaglia della tragedia che stava per sconvolgere la Jugoslavia6. Pochi argomenti occupano più spazio del calcio nei mass media. Nel nostro paese la televisione, a pagamento o in chiaro, oltre alle partite propone quotidianamente diverse trasmissioni di commento; la stampa offre tre quotidiani specificamente sportivi e tutti gli altri dedicano al calcio diverse pagine. Malgrado ciò sono ancora pochi gli studi in Italia che trattano del fenomeno calcio dal punto di vista sociale e culturale; la letteratura esistente insiste soprattutto sull’aspetto drammatico della violenza, tralasciando di indagare i motivi per cui migliaia di persone frequentano gli stadi; oppure ha cercato “di esprimere sui giovani tifosi delle frange estreme, gli ultras, un giudizio meno stereotipato della rituale condanna”7. Finora hanno trattato di calcio soprattutto i sociologi e gli psicologi; una prospettiva antropologica è proposta dalla rivista “Ossimori”8 – non più attiva – e dalla recente pubblicazione di Bruno Barba (2007), Un antropologo nel pallone. Il calcio è senza dubbio “buono per pensare la modernità, i suoi processi, il nascere di simboli, di miti, di pratiche che si collettivizzano”9, ma qui non tratterò dell’industria del calcio che mercifica tutto, del ruolo dei mass media, e della televisione in particolare, nella creazione di un calciospettacolo, e dell’uso politico del calcio; né farò della retorica affermando A. ZAMPERINI, Prigioni della mente: relazioni di oppressione e resistenza, Torino, Einaudi, 2004. C. BROMBERGER, Le match de football: etnologie d’une passion, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1995. 5 F. BENFANTE, Tifosi, in “Altrochemestre”, 5 (1997), pp. 43-46. 6 A. ZAMPERINI, Prigioni della mente, cit. 7 AA.VV., L’ultra faccia, cit., p. 15. 8 Nel n. 1 (1992) trovano spazio un interessante contributo di Fabio Dei e alcuni brevi interventi di Paolo Apolito, Gianni Dore, Paola de Sanctis, Vincenzo Cannada-Bartoli, Vincenzo Esposito e Pietro Clemente. 9 P. CLEMENTE, Note conclusive, in “Ossimori, 1(1992), p. 24. 3 4 336 che il calcio è lo specchio delle profonde esigenze simboliche dell’attuale società. Più semplicemente desidero esternare quello che penso su ciò che più mi piace – e mi è sempre piaciuto – del calcio: il tifo. Innanzitutto che cosa vuol dire essere tifoso? Le risposte di alcuni tifosi di differente sesso, età e fede calcistica sono state: “tutto tranne la partita! Tutto quello che ci sta intorno e crea atmosfera, carica, adrenalina, per eccitare gli altri tifosi e la squadra”; “significa riconoscermi in una storia, in una tradizione, in uno stile di vita, molto più che seguire semplicemente una squadra”; “amare i propri colori senza mai abbandonarli e rispettare gli altri”; “essere tifoso significa riuscire a provare sentimenti veri che vanno dall’euforia alla disperazione per uno sport e per persone che non sanno neanche della tua esistenza”10. Il tifo sembra possedere un carattere estremamente soggettivo e mutevole, determinato a mio parere dalla frequentazione o meno dello stadio. Infatti non tutti i sostenitori di una squadra seguono le partite allo stadio: un luogo molto frequentato, soprattutto dopo l’avvento delle partite a gestione delle tv a pagamento, è il bar, che molti giovani scelgono come alternativa più tranquilla e meno dispendiosa dello stadio. Poi ci sono i tifosi che preferiscono seguire la partita a casa per vari motivi, quali il costo troppo elevato di biglietti e abbonamenti, il tempo necessario per raggiungere lo stadio e tornare a casa e, non ultimo, il timore di essere coinvolti in risse e tafferugli. Sicuramente né a casa né al bar si può godere del pathos che pervade lo stadio: i tamburi che battono all’unisono con il tuo cuore, le voci e le urla che ti riempiono la testa, l’emozione che ti travolge quando l’altoparlante scandisce la formazione della tua squadra. Per contro le paytv garantiscono una visione della partita accompagnata da commenti, replay, moviole, interviste post-partita non fruibili allo stadio; e poi le ore trascorse con amici e conoscenti al bar o a casa per vedere la partita sono un’occasione per discutere non solo di calcio ma anche di altri aspetti della vita. Ma per quanto la tecnologia sia sofisticata, l’home-theatre non potrà mai trasmettere al cuore l’urlo della curva al momento di un goal! I tifosi ‘da bar’ e ‘da poltrona’ non sono considerati veri tifosi da chi frequenta lo stadio poiché non partecipano attivamente al sostegno della squadra; inoltre hanno una percezione diversa della partita rispetto a coloro che la vedono dal vivo; in questo senso la televisione costruisce una sua immagine dell’evento, che si dilata nei giorni a seguire con i commenti, i processi, i controappelli ecc. Un tifoso ‘da stadio’ intervistato ha affermato che la tv rovina il calcio, “sembra che lo renda più vero perché lo fa vedere meglio, ma in realtà lo rende falso perché non da l’idea di tutto quello che 10 Brani di interviste contenute in AA.VV., L’ultra faccia, cit. 337 c’è attorno, l’aria che si respira in una partita, la tele non può dartela”; un altro afferma di sentirsi “un corpo unico con la mia squadra del cuore ed ho perso tutto l’interesse per le partite viste in tv. Il prato verde, l’abbraccio di chi ti sta vicino, il boato della folla hanno un altro sapore. Vedere la partita è partecipare in prima persona alle imprese della propria squadra”11. Lo stadio è suddiviso in vari settori, ognuno dei quali individua diversi tipi di tifosi: le tribune centrali, la tribuna d’onore e i ‘distinti’, dove generalmente trovano posto gli spettatori – nel vero senso della parola – che seguono la partita come se fossero comodamente seduti in poltrona a casa, e la cui partecipazione attiva all’evento è limita ad applausi e grida isolate; e poi le curve, quella di casa e quella riservata ai tifosi ospiti, i cui membri si riconoscono fra loro attraverso le bandiere, i cappellini, le sciarpe e vari altri gadget che ostentano i colori della propria squadra. La curva è il cuore della tifoseria: i suoi frequentatori incitano incessantemente la propria squadra per tutta la durata della partita, cantando, saltando e rivolgendo cori ironici, non di rado apertamente dispregiativi, alla tifoseria avversaria. È questa la zona del tifo organizzato, distinto in due tipi di aggregazioni, i club e gli ultras (o ultrà), tra le quali esistono alcune differenze circa le modalità di partecipazione al tifo e l’organizzazione del coordinamento del gruppo. I club, al contrario degli ultras, sono direttamente riconosciuti dalle società calcistiche e la loro distribuzione sul territorio spesso si trova anche al di fuori della città o della regione di appartenenza della squadra12. L’aspetto formale è codificato e curato: gli organi del direttivo costituiscono una rete coordinata sul territorio e l’associazione è dotata di un marchio deposto presso la società che, in questo modo, può concedere la denominazione di ‘club’13. Gli ultras, pur mantenendo rapporti con le società, non sono ufficialmente da queste riconosciuti e raramente si estendono oltre i confini territoriali della propria squadra14. Tra ultras e club c’è sostanzialmente un dialogo ma i rapporti non sono propriamente amichevoli, come sottolinea un ultras granata: “loro pensano che mangiamo soldi e che siamo violenti e basta, non capiscono cosa c’è dietro. Sono due modi troppo diversi di vivere lo stadio”15. Brani di interviste contenute ivi. A. DAL LAGO-R. MOSCATI, Regalateci un sogno, Milano, Bompiani, 1992. 13 N. CAIVANO, Dietro alla curva: tifo, tifosi, ultras, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 2008. 14 Fanno eccezione alcuni gruppi affiliati a Milan e Juventus i cui sostenitori provengono da città diverse da quella in cui ha sede la squadra: ad esempio i “Commandos Tigre” del Milan sono di Torino; i “Drughi” juventini, con sede a Torino, sono divisi in sezioni localizzate in varie città d’Italia: una sezione si trova in Svizzera (www.drughi.com). 15 Intervista riportata in N. CAIVANO, Dietro alla curva, cit., p. 39. 11 12 338 Gli ultras sono gi ideatori di cori e coreografie e si posizionano proprio al centro della curva, nella balconata; incitano tutti gli altri tifosi a sostenere la squadra e lo fanno in maniera spettacolare e aggressiva, sia a livello sonoro sia visivo, distinguendosi dal tifo più pacato e meno codificato dei club. In curva sono rappresentati molti gruppi organizzati tra i quali esiste una precisa gerarchia: lo striscione che domina dalla balconata tutta la curva appartiene al gruppo più potente, spesso il gruppo storico, mentre ai suoi lati sono posizionati via via gli striscioni di tutti gli altri gruppi, in ordine di importanza. Da notare che nelle zone laterali della curva si trovano tifosi più tranquilli e interessati alla partita in sé. Una gerarchia vige anche tra i tifosi: non è scritta né codificata ma è accettata all’unanimità; ognuno occupa un posto preciso in curva definito dal ruolo rivestito all’interno del gruppo e dalla fedeltà a questo dimostrata; i capi ultras sono riconoscibili perché rivolgono le spalle al campo e guidano i cori. È importante tener presente che esiste un codice – non scritto – che implica l’osservanza della territorialità da parte dei tifosi anche all’esterno dello stadio: se l’avversario sconfina è un chiaro segno di provocazione che può provocare degli scontri. Per essere ammessi alla zona ‘calda’ della curva è obbligatorio seguire alcune regole sulle modalità di tifo quali cantare e incitare ininterrottamente la squadra, osservare le disposizioni coreografiche e la collocazione di coloro che dirigono i cori e, soprattutto, seguire la partita in piedi: questa particolarità è propria degli ultras. Anche se il Decreto Legge n. 28 del 24 febbraio 2003 ha introdotto l’obbligo dei biglietti nominali che vincola i tifosi a stare seduti al posto assegnato16, in curva questa regola non viene seguita e, anzi, chi non sta in piedi viene ripreso e a volte invitato a lasciare la curva. Il tifo degli ultras comporta un grande lavoro preparatorio per allestire coreografie spettacolari che coinvolgono l’intera curva e richiedono un forte impegno economico, di lavoro e di coordinamento17. Come già accennato, in curva c’è innanzitutto lo striscione del gruppo, che è la sua icona e rappresenta la sua stessa identità, tanto che la sua eventuale appropriazione da parte dei tifosi rivali, sulla base di un codice non scritto degli ultras, obbliga il gruppo allo scioglimento18: colui che si fa rubare lo striscione “viene cacciato, dipende poi da come se lo fa rubare: se lotti per mantenerlo non ti succede niente, altrimenti te la vedi brutta”; per contro, conquistare lo striscione avversario “è come prendergli l’anima, come in www.giustizia.it/cassazione/leggi/dl28_03.html. C. BALESTRI-A. ROVERSI, I gruppi ultras oggi: cambiamento o declino?, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 13 (1999), 3, pp. 453-468. 18 I “Ragazzi della Maratona”, gruppo ultras del Torino, dovettero sciogliersi nel 2003 in seguito al furto del loro striscione ad opera della tifoseria juventina. 16 17 339 guerra quando rubi un’insegna di un reggimento, il reggimento rimane disonorato”19. Accanto allo striscione del gruppo ne vengono posizionati altri che possono esprimere incoraggiamento verso la tifoseria amica in caso di gemellaggio20, oppure insulti e offese trasmessi anche attraverso giochi di parole. “Lo striscione è anche un mezzo di comunicazione per esprimere la propria opinione su avvenimenti di cronaca che riguardano il mondo del calcio, ricordare i tifosi scomparsi (molte sono le tifoserie che li espongono in tutte le partite di campionato) o esprimere solidarietà ai compagni in carcere o in difficoltà”21. Anche l’espressione canora riveste una funzione importante, perché attraverso i cori avviene una vera e propria sfida tra tifoserie con l’obiettivo di dominare la curva avversaria e, non a caso, è guidata dal capo degli ultras. Le basi musicali dei cori appartengono a canzoni note sulle quali si innestano, grazie ad una inesauribile inventiva, sfottò, riferimenti ironici, talvolta discriminatori e razziali. Non è questa la sede per esaminare la complessa fenomenologia dei comportamenti delle tifoserie ultras: mi limiterò ad annotare che si tratta di gruppi di individui organizzati che esprimono e manifestano ciò che li uniforma all’interno e li differenzia dall’esterno; il tifo diventa così un forte elemento di identificazione22. Chi diventa un ultras trova un’identità già predisposta con il suo corredo di norme, valori, sanzioni, credenze, ragioni e modelli d’azione; acquisisce nuovi valori e nuovi obiettivi, e assumono nuovo significato concetti come lealtà, impegno, fedeltà, gerarchia; è un codice non scritto, informale, pieno di eccezioni, ma nella sua struttura di base, rigido23. L’ultras, che deve mostrare doti di affidabilità, coraggio e solidarietà, dirige il proprio comportamento in vista di un fine e secondo le aspettative del gruppo. Quando la propria squadra gioca fuori casa i tifosi, e in particolare gli ultras, si organizzano per seguirla in trasferta, spesso verso destinazioni raggiungibili con viaggi lunghi e faticosi. I mezzi più comunemente impiegati sono il treno, l’automobile e il pullman e, per gli itinerari che lo richiedono, il viaggio viene compiuto anche in aereo. Andare in trasferta è importante – anzi, fondamentale – soprattutto per i più giovani, perché consente loro l’acquisizione di un preciso status all’interno del gruppo: infatti è proprio atBrani di interviste contenute in AA.VV., L’ultra faccia, cit. Il gemellaggio è un rapporto di amicizia e solidarietà che lega gruppi ultras sostenitori di squadre diverse. Durante la partita fra due squadre con tifoserie gemellate le manifestazioni in curva sono amichevoli e spesso si vedono i colori della squadra gemellata nelle due curve. 21 N. CAIVANO, Dietro alla curva, cit., p. 46. 22 C. BROMBERGER, Le match de football, cit. 23 A. ZAMPERINI, Prigioni della mente, cit. 19 20 340 traverso un certo numero di trasferte effettuate che si dimostra la propria fedeltà e l’attaccamento ai valori del gruppo e ai colori della squadra. Molti tifosi sono semplici escursionisti: vanno a vedere la partita fuori casa e, una volta terminata, rientrano subito. Altri invece ne approfittano per visitare la città, prima o dopo l’incontro di calcio. Se la partita si gioca la domenica sera, ad esempio, i sostenitori possono arrivare in città al mattino e, dopo un pranzo con i piatti tipici locali, possono approfittare del pomeriggio per compiere un giro turistico. Lo stesso si può fare nel caso la partita sia prevista il sabato sera: dopo l’incontro si può pernottare una notte e visitare la città il giorno dopo. Si può allora affermare che molti tifosi, quando seguono la propria squadra in trasferta, fanno del turismo, il quale, secondo la definizione dell’OMT, consiste nel recarsi in località diverse da quella di residenza e soggiornarvi almeno una notte senza compiere attività remunerative. Senza dubbio il turismo legato al calcio è più manifesto nelle partite della Nazionale, non tanto nelle gare amichevoli o nei gironi di qualificazione, quanto nei grandi tornei internazionali come gli Europei e i Mondiali che prevedono soggiorni di più giorni, perlomeno tanti quanti quelli della Nazionale: la durata dipende dalla permanenza, più o meno lunga, della squadra nel torneo. Che la trasferta al seguito della squadra sia breve o meno comporta comunque un’organizzazione, esattamente come succede per una qualsiasi altra forma di turismo: deve essere programmata con anticipo per prenotare la struttura in cui pernottare, il mezzo di trasporto (a meno che non si decida di viaggiare in auto), il biglietto per lo stadio. Da segnalare che anche per il calcio esistono dei pacchetti turistici che comprendono il viaggio in pullman, una visita alla città, il biglietto per la partita e, in alcuni casi, il pernottamento in hotel; ancora non sono molto diffusi e riguardano più che altro le partite internazionali o grandi trasferte in Italia e sono rivolti soprattutto a tifosi con maggiore disponibilità economica. Un intervistato afferma però: “una volta ho preso un pacchetto ed è stato un ‘pacco’: poco tempo a disposizione per visitare la città e siamo entrati allo stadio pure in ritardo; non lo farò più”; un altro commenta che questi pacchetti “costano esageratamente”24. Navigando in internet alla ricerca di tali opportunità turistiche, ho consultato il sito – già segnalatomi da alcuni studenti/tifosi – di “Blufreccia” (www.blufreccia.com), che si definisce il più importante portale italiano per i viaggi e gli eventi di sport: per le partite di Brani di interviste riportati in F. CARANDO, Calcio e turismo, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 2008. 24 341 coppa, ad esempio, lancia sul web i pacchetti express, che prevedono il rientro in nottata, e special, con pernottamento dopo l’incontro. Un’altra forma di turismo calcistico riguarda la visita a monumenti sportivi, vecchi stadi abbandonati, musei dello sport e reliquie calcistiche. Sono molti gli impianti sportivi che offrono quest’ultima opportunità: ad esempio il Santiago Bernabeu (stadio del Real Madrid), Camp Nou (del Barcellona), San Siro (di Milan e Inter), Stamford Bridge (Chelsea), la Bombonera (Boca Juniors), presentano tutti al loro interno un museo dove è possibile ammirare i trofei della storia dei club e particolari gadget e magliette storiche. Ad esempio a San Siro è possibile compiere una visita dello stadio (12,50 Euro), scendendo proprio in campo, con una guida che racconta la storia dell’impianto, mostra gli spogliatoi, le tribune e accompagna gli avventori al San Siro Store, dove sono disponibili tutti i gadget ufficiali delle due squadre milanesi. È possibile inoltre visitare il museo (7 Euro) che espone maglie storiche, oggetti d’arte e tutti i trofei di Inter e Milan. “Golden moments” (www.goldenmoments.it) offre a 75 Euro un pacchetto che comprende il tour di San Siro, la visita al museo e un buono acquisto di 25 Euro al San Siro Store. L’offerta calcistica di “Incoming Partners” riguarda gli stadi di Torino, Milano e Roma ed è rivolta ai turisti stranieri che desiderano assistere alle partite delle squadre italiane, accompagnandole a visite turistiche delle città e ad appuntamenti culturali, enogastronomici e di shopping. È significativo che il calcio, intimamente legato negli ultimi anni ad episodi sgradevoli – atti di vandalismo, aggressioni, tafferugli e morti –, promuova il turismo, quello culturale… Riferimenti bibliografici AA.VV., L’ultra faccia del calcio, relazione per il seminario di Antropologia culturale, Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 2007. C. BALESTRI-A. ROVERSI, I gruppi ultras oggi: cambiamento o declino?, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 13, (1999), 3, pp. 453-468. B. BARBA, Un antropologo nel pallone, Roma, Meltemi, 2007. F. BENFANTE, Tifosi, in “Altrochemestre”, 5 (1997), pp. 43-46. C. BROMBERGER, Le match de football: etnologie d’une passion, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1995 [trad. it. La partita di calcio: etnologia di una passione, Roma, Editori Riuniti, 1999]. N. CAIVANO, Dietro alla curva: tifo, tifosi, ultras, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 2008. 342 F. CARANDO, Calcio e turismo, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 2008. P. CLEMENTE, Note conclusive, in “Ossimori, 1 (1992), pp. 23-26. A. DAL LAGO, Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio, Bologna, Il Mulino, 1990. A. DAL LAGO-R. MOSCATI, Regalateci un sogno, Milano, Bompiani, 1992. N. HORNBY, Febbre a 90’, Parma, Guanda, 1997. E. MINARDI-M. LUSETTI (a cura di), Luoghi e professioni del loisir, Milano, FrancoAngeli, 1997. C. PENDANT, Congratulazioni, hai appena incontrato la I. C. F. (West Ham United), Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2006. A. ROVERSI, Calcio, tifo e violenza: il teppismo calcistico in Italia, Bologna, Il Mulino, 1992. A. SALVINI, Ultrà. Psicologia del tifoso violento, Firenze, Giunti, 2004. A. ZAMPERINI, Prigioni della mente: relazioni di oppressione e resistenza, Torino, Einaudi, 2004. www.drughi.com www.giustizia.it www.lega-calcio.it 343 344 CULTURA D’IMPRESA A LINGUE Filippo Monge Pozzuoli, luglio 2000. Caldo pomeriggio di estate. Ho appena terminato una riunione con gli addetti allo Sportello unico per le attività produttive del Comune. Suona il mio telefono cellulare... la linea è subito un po’ disturbata. “Pronto?… .pronto?, pronto!!… Sono Paolo Bertinetti, preside della Facoltà di Lingue dell’Università di Torino, parlo con il dottor Filippo Monge?”… “Sono io…” Inizia così il mio lungo quanto straordinario rapporto con questa nuova facoltà dell’Ateneo torinese. Iniziò proprio in quel luglio di quasi 10 anni fa, in una afosa giornata di mezza estate. La mia carriera accademica era incominciata due anni prima a Siena. Appena rientrato dalla London School of Economics di Londra, avevo ottenuto un modulo “a contratto” presso il locale Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. Un corso di laurea attivato dall’allora Rettore Luigi Berlinguer (che divenne poi anche Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) dopo, mi dissero, un accordo con il comitato “Università” di Confindustria (comitato di cui, ironia della sorte, mi trovo, oggi a far parte). Dopo Siena, una tappa a Genova (a Scienze Politiche sento per la prima volta parlare di Francesco Panero) e poi Venezia, Ca’ Foscari, sede decentrata di Treviso, “chiamato” dal futuro Preside della Facoltà di Lingue Paolo Balboni. Ed è proprio a Venezia, durante un caffè a casa Balboni, che mi viene consigliato di provare a cercare un bando alla facoltà di Lingue a Torino. Balboni sapeva che era in corso in Italia, un processo di “contaminazione culturale” dell’Economia (e degli economisti) in molte facoltà italiane. E che in alcuni casi la domanda non sarebbe stata immediatamente soddisfatta. Io provai a candidarmi,e, subito,ottenni il mio primo incarico a Torino. Mi resi poi conto di esser approdato in una facoltà giovane, dinamica, che nella sua offerta formativa guardava con attenzione (paradossalmente più di altre) al cosiddetto mercato del lavoro. 345 Il curriculum manageriale, che vi trovai, fu una formidabile intuizione che ancora oggi evoco spesso e di cui sento richiamare la modernità didattica, neointerdisciplinare, in molti convegni. Molti allievi del vecchio ordinamento, ora laureati, ancora mi scrivono, raccontandomi di aver trovato impiego nell’ incommensurabile universo delle PMI (piccole e medie imprese) piemontesi (e non solo) grazie, proprio, alla trasversalità di discipline e competenze con cui fu organizzato questo indirizzo. Alcuni dei nostri ex-studenti lavorano in grandi multinazionali ma anche in piccole aziende di lunga e consolidata governance familiare. Altri sono diventati imprenditori, chi avviando una piccola impresa in proprio, chi come naturale tradizione di famiglia; altri ancora, invece, stanno compiendo una eccellente carriera in enti pubblici oppure nel settore del non-profit e delle ONG. Qualcuno ha addirittura intrapreso la strada delle grandi organizzazioni internazionali (FAO). E fu cosi che con l’introduzione del nuovo ordinamento il curriculum manageriale fu archiviato lasciando il posto a nuovi corsi di laurea triennali,specialistici, master; non mi fu difficile trovare “ospitalità” a Scienze del Turismo, favorendo nuove opportunità. La prima fu quella di far sì che la nostra facoltà potesse diventare un attraente interlocutore, ma anche partner di molti soggetti pubblici esterni. Gli enti locali iniziavano a guardare con attenzione alla nostra offerta formativa. Nel 2002, infatti, il dr. Fortunato Asprea, dirigente del Servizio Attività Produttive dell’amministrazione provinciale di Torino, incuriosito delle nuove competenze generate e generabili in questo corso di laurea mi chiese di incontrare il preside Bertinetti per attivare la prima convenzione di studio e ricerca in materia di marketing territoriale (una delle mie specializzazioni) nell’ambito di un accordo territoriale di programmazione negoziata che prese il nome di Patto Territoriale della Stura (territorio di Ciriè). Ne nacque una collaborazione proficua di studio, didattica e ricerca che esportò il nome della nostra facoltà in tutta Italia e, grazie, al primo “Salone Internazionale dello Sviluppo Locale” (novembre 2003), organizzato dalla Provincia di Torino in tutto il mondo. Per la prima volta veniva sdoganato un archetipo esclusivamente letterario della facoltà a favore di un ben più moderno ruolo di player territoriale, in grado di interpretare le diverse esigenze glocal1, alla luce delle innovazioni e identità linguistiche e culturali. Basti pensare che anche il nome della facoltà avrebbe trovato maggior appeal, mutando in Lingue e Letterature Moderne. 1 Global & local. 346 Questo fu propedeutico alla creazione, su idea e suggerimento del prof. Franco Panero, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze del Turismo, del primo laboratorio di ricerca-didattica “Il Piemonte, una regione d’Europa”, in cui tutte le discipline della facoltà potevano concorrere, in sinergia, a rispondere ad una nuova domanda conoscenza, (ancora) interdisciplinare. Si attivò cosi la prima edizione del master in Organizzazione e Promozione Turistico-Culturale del Territorio. In questo caso si diede vita ad un’azione promozionale che, attraverso esperienze come la partecipazione – con tanto di stand – a ben 2 edizioni del Salone “Io lavoro nel settore turistico”, riscosse, nel 2007, addirittura l’attenzione dell’allora Ministro del Lavoro on. Cesare Damiano. Per farlo conoscere, promuoverlo e lanciarlo fu pianificata una vera e propria strategia di impresa. Come nella grandi business school americane. Una campagna di stampa mirata all’informazione locale e nazionale, gestita direttamente, con tanto di follow-up e recalling su ogni manifestazione di interesse, ci portò a conservare i primati di iscrizione, anche quando l’offerta dei master era quasi decuplicata, nel giro di neanche cinque anni, in tutta Italia. Ma era sicuramente l’aspetto innovativo dell’offerta ad incuriosire di più il “mercato”. Studenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero trovavano (e trovano) interesse nell’innovativa offerta trasversale che, oltre alle lingue, proponeva (e propone) un mix formativo completo per le nuove attese professionali. Un mix che attirò l’attenzione prima dei dirigenti dell’Osservatorio Turistico dell’ex Agenzia Turistica Regionale (del Piemonte), poi dello stesso assessorato al Turismo della Regione Piemonte e infine di Sviluppo Piemonte Turismo, la società in house2 che la Regione ha creato per scoprire e potenziare ogni asset promozionale del/in Piemonte. In virtù di questo accordo partecipai ai lavori del comitato scientifico che si occupò di redigere il Piano Strategico Regionale Turistico 20052010. Dal piano strategico si passò poi a studiare, indagare, misurare la customer satisfaction del turista congressuale in Piemonte, accertando come il cosiddetto turismo MICE3 in genere, ma soprattutto quello culturale, siano percorsi innovativi in grado di attrarre studenti ma anche sostegni e finanziamenti a progetti specifici. L’idea di avvicinare i nostri studenti al territorio fu vincente. In questo ci aiutarono anche l’associazione culturale “Antonella Salvatico” di La Morra (Cn), ente non-profit, creato in memoria di un nostra cara collega di Storia medievale, scomparsa prematuramente, e il “Centro Internazionale 2 3 Società strumentali di scopo. Meeting, Incentive, Congress and Events. 347 di Ricerca sui Beni Culturali”, del cui comitato scientifico sono parte insieme ad altri giovani colleghi di facoltà, dando vita ad un modello di collaborazione da case-history, importabile in aula. Dal 2007 abbiamo, quindi, iniziato a sperimentare alcune lezioni-testimonianza con un ciclo di seminari in cui Daniel Winteler, amministratore delegato del gruppo Alpitour, ma anche banchieri, manager, professionisti e Valentino Castellani, già sindaco della “Torino Olimpica”, presidente di “Unimanagement Center” (centro di formazione del gruppo Unicredit) hanno ottenuto un consenso di pubblico inatteso, riuscendo a veicolare, più che mai, l’importanza di appartenenza e il senso di squadra. In virtù di ciò, infatti, oggi molti nostri studenti hanno trovato impiego nella direzione marketing o commerciale di aziende come Fiat, Ferrero, Alpitour, Michelin, Antinori, tanto per citarne alcune. Altri in importanti strutture alberghiere italiane e non (es. Hotel San Rocco, sul Lago d’Orta, Turin Hotel International, Jolly Hotel); altri ancora hanno addirittura intrapreso la strada di importanti scuole di management internazionale come la prestigiosa EAP-ESC che oggi ha anche una sede a Torino (superandone la difficilissima selezione). Un nuovo vivaio di giovani si è appassionato alla cultura d’impresa e ai rapporti con il territorio. Una rete di giovani professionisti guidati da un mio ex allievo, e ora mio collaboratore, Daniele Cattaneo ha condotto, insieme a me, importanti progetti di ricerca e didattica che lentamente ci stanno portando verso la formazione di un brand di qualità. Recentemente, durante la prima riunione del comitato “Education” (Università) di Confindustria ho sentito Luca di Montezemolo tracciare un profilo del nuovo account commerciale di cui ci sarebbe necessità in Ferrari e in Fiat. Molte skill sono le nostre (mediazione, comunicazione internazionale, economia, diritto, ecc). “Il futuro – scrive Giorgio Pellicelli nell’introduzione al suo volume Strategie d’impresa –4 appartiene alle imprese (enti? Atenei?) che sanno interpretare il cambiamento, che sanno scegliere e adattare continuamente le proprie strategie”. Siamo sulla strada giusta. E la nostra facoltà sarà uno dei nuovi “agenti del cambiamento”. Giorgo Pellicelli, già direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale, è ordinario di Strategie d’Impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino. Il riferimento è alla seconda ed. del libro (Milano, Università Bocconi, 20022). 4 348 CARTOGRAPHY AND TERRITORIAL CHANGE IN THE BUILDING OF THE ITALIAN NATION: SOME REFLECTIONS ON THE PRODUCTION AND USE OF SMALL SCALE MAPS DURING THE 19 TH 1 CENTURY Maria Luisa Sturani 1. The contexts of the production, diffusion and use of small scale maps This paper discusses the role that small scale maps of Italy produced during the nineteenth century played in the construction of the “imagined community” of the Italian nation and of a unitary political space within the peninsula. Referring to the results of previous researches into the history of Italian cartography2, this question will be dealt with reference to two different analytical dimensions. First the contexts of the production, diffusion and use of small scale maps in nineteenth century Italy will be analysed. Then, the attention will be focused on the figurative content of the maps and its rhetorical implications with respect to the building of a national Italian space, with particular reference to the way in which cartography dealt with territorial changes. Since 1991, when the tenth chapter dedicated to “Census, Map and Museum” was added to the second edition of the well-known volume by Benedict Anderson3, studies on nationalism have shown increasing awareness of the role that maps – together with other forms of representation – could play in the processes of nation building. This suggestion has raised mounting interest amongst historians working on cartographic sources and their ideological use, and at the same time has met with important A first version of this paper has been presented at the International Workshop Sciences and the Production of Space. Cartography in the Long 19th Century (Firenze, Robert Schuman Centre for advanced studies-European University Institute, March 30th, 2007) 2 See G. PECOUT, La carta d’Italia nella pedagogia politica del Risorgimento, in Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, edited by A.M. Banti-R. Bizzocchi, Roma, Carocci, 2002, pp. 69-87 and M.L. STURANI, La rappresentazione dell’Italia nella cartografia a piccola scala, in Guida all’Italia contemporanea, edited by M. Firpo-N. Tranfaglia-P.G. Zunino, Milano, Garzanti, 1998, vol. II, pp.561-568; EAD., “I giusti confini dell’Italia”. La rappresentazione cartografica della nazione, in “Contemporanea”, I (1998), pp. 447-472; EAD., Unità e divisione nella rappresentazione cartografica dell’Italia tra Risorgimento e fine Ottocento, in “Geographia Antiqua”, VII (1998), pp. 123-142. 3 B. ANDERSON, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London-New York, Verso, 19912. 1 349 conceptual support in the theoretical renewal that struck historical-cartographic studies in the eighties. Beginning with the work of John Brian Harley4, the history of cartography has in fact ceased to be interpreted from a positivist and evolutionary point of view. Maps, traditionally seen as a mirror of reality, whose accuracy is guaranteed by technical-scientific progress, are now seen as texts. A text whose meanings are dictated, apart from the technical rules of its composition, by the limits posed by the cultural context and the power relations within which they are produced and to which they, in turn, contribute to shape. This new trend has clearly highlighted the power of cartographic language to “produce” rather than to simply mirror its territorial reference. Harley also emphasised the inextricable link between cartography as elite technical knowledge and power, above all State power, which systematically used both its practical potential as an instrument of conquest and territorial government and its persuasive capability for the transmission of ideological messages. According to the second profile, the map, which unites the technical authority of its geometric basis with the aesthetic charm of visual language, is a powerful means through which to objectify ideals and political plans. The image of space proposed by a map, although inevitably moulded according to the rules of a certain political-social order, in fact becomes naturalised and presented as a neutral and exact reproduction of reality. For Harley this ideological use of cartographic language was constantly applied in society in only one direction, top-down5. These theoretical references became dominant in the history of cartography in the nineteen-nineties, although they have since been the object of ample discussion and critical revision6. However a rigid adoption of the theoretical principles derived from Harley risks leading to a unilateral consideration of the role of maps as a means of persuasion at the service of power, concentrating attention on the hidden content of the messages they transmit and taking for granted their pervasive influence on a social See for instance J.B. HARLEY, The Map and the Development of the History of Cartography, in The History of Cartography, edited by J.B. Harley-D. Woodward, Chicago-London, The University of Chicago Press, vol. I, 1987, pp. 1-42; ID., Maps, knowledge and power, in The iconography of landscape. Essays on the symbolic representation, design and use of past environments, edited by D. Cosgrove-S. Daniels, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 277-312; ID., Deconstructing the Map, in “Cartographica”, 26 (1989), pp. 1-20. On Harley’s work see M.H. EDNEY, The Origins and Development of J.B. Harley’s Cartographic Theories, in “Cartographica”, 40 (2005), pp. iii-x and 1-145. 5 J.B. HARLEY, Maps, cit., pp. 300-301. 6 See C.D.K. YEE, A reaction to the reaction against scientism: on the power and limits of the textual analogy for maps, in Plantejaments i objectius d’una història universal de la cartographia, edited by D. Woodward et al., Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2001, pp. 203-222 and M. EDNEY, The Origins, cit. 4 350 plane. The debate that arose from Harley’s positions highlighted the need to go beyond the institution of immediate causal links between the content of cartographic images and the plane of social and political action. This debate has instead developed a complex project of cultural and social history of cartography7 aimed to a careful reconstruction of the specific and variable relations that link the institutions, authors, commissioners and users of the maps. As will be seen in the analysis of the content, it is evident that small scale cartography was used in support of the concept of nation and the plans for political unification of Italy, both during the Risorgimento and in the post-unification period. Nonetheless, the aim of the first part of this paper is not so much to emphasise the role of the map as a rhetorical device and an instrument of power as to explore the concrete circumstances and possible limits within which this cartographic power was exercised. It is therefore essential to bring forward three crucial aspects for verifying whether and how maps acted on the spatial structures of an Italian society under construction: - the authors and the commissioners of maps and their relationship with power; - the diffusion of cartographic images and the problem of identification of their public; - the reception of cartographic images, which also raise the almost unexplored question of ‘cartoliteracy’. The reconstruction of these aspects seems particularly difficult, due to the limited degree of advancement of research into the history of Italian cartography in the last two centuries. Not only are the studies that document this period less numerous than those of the previous phases, they were also generally conducted within rather traditional approaches. We will therefore present some interpretative hypotheses, formulated on the basis of an initial and limited sample of maps, and which will be studied in-depth as the research continues. The sample examined comprises about one hundred physical-political small scale maps of Italy produced between the eighteen-twenties and the end of the century, distributed as single maps or included in school-texts, geographical-statistical works and – more rarely – tourist guides8. Their educational purpose particularly amplifies the rhetorical and persuasive C. JACOB, Toward a Cultural History of Cartography, in “Imago Mundi”, 48 (1996), pp. 191-198. The maps and texts examined are mainly comprised in the collections of the Civica Raccolta Bertarelli in Milan, of the Società Geografica Italiana in Rome, of the Touring Club Italiano in Milan, of the Archivio Storico del Comune di Torino and of the Biblioteca Nazionale di Torino (fondo Cora). 7 8 351 function and makes them a privileged research area for the analysis of the role played by maps in the building of the Italian nation. Unlike large scale maps, whose production was constantly the prerogative of the State, small scale maps were almost never commissioned and produced by the public institutions9. They were, instead, produced by private publishers, who throughout the nineteenth century were very variegated in nature and importance; ranging from the printer, to the book and print seller, or the author/publisher and the publisher in the true sense of the word. These operators were spread over numerous production centres (Milano and Torino were particularly important) and only in a few cases were capable of reaching more than local markets. It was only towards the end of the century and more steadily during the early years of the twentieth century, that the first specialised map-publishers began to operate in Italy, on the model of the German workshops. So, during the period we examined, small scale maps are mainly published by non-specialised private publishers who were also active in the wider sphere of scholastic and popular publications. It is extremely difficult to identify the authors commissioned by these publishers, first because numerous figures were involved in the various preparation stages (geographer-cartographer, illustrator, engraver) and secondly due to the practice of reusing and retouching the same material both within the publishing house itself and at other publishing houses, which makes the maps produced anonymous and collective more than precisely attributable. With regard to the authors in the narrowest sense of the word – that is those who were responsible for the planning of the geographical content of the map – during the early nineteenth century relations between the cartographic production and geographical-statistical works appear to have been very close. But after Unification, with the process of academic institutionalisation of geography and its spread in scholastic teaching, the involvement of authors from the world of school and university increased. Both before 1861 and in the following period, it is not therefore possible to see small scale maps as an ideological instrument, issuing directly from state power. On the contrary, the more or less dissimulated presence of patriotic motives in some maps produced prior to Unification rather makes them a means which, together with other types of text and image10, On the contexts of production of small scale maps in Italy see M.L. STURANI, Unità, cit., pp. 126-129 and EAD.,“I giusti confini, cit., pp. 432-434. 10 See A.M. BANTI, La nazione del risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, Einaudi, 2000 and Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, edited by A.M. Banti-R. Bizzochi, Roma, Carocci, 2002. 9 352 was consciously used in support of subversive plots against the political order of the pre-unification states. It is possible in this sense to extend to this type of cartography the thesis presented by Silvana Patriarca11 on the role that “patriotic statistics” produced during the eighteen-thirties by intellectuals of liberal inspiration played in constructing, more than describing the Italian nation. This similarity of intent is also supported by the extremely close links existing at the time between geography, statistics and cartography, with the frequent involvement of the same authors in the production of both maps and geographic-statistical works tending to foreshadow Italian unification. The political figures of the Italian Risorgimento also seem to have been aware of the subversive role that cartography can play, both through the use of topographical maps in support of the planning of clandestine expeditions and uprisings, and in the proposition of using small scale maps as an educational instrument for spreading understanding and love of the homeland12. Also during the post-unification period, the use of small scale maps as means of a patriotic education seems more explicit in the private production sector, rather than in the few cases in which they were published by the national mapping agency. During this phase the rhetorical potential of cartographic language loses its subversive tone to be placed at the service of the new Kingdom of Italy and of its plans for political consolidation and territorial expansion. Nonetheless, this does not occur thanks to the direct efforts of the official cartographic agencies or on the basis of explicit government directives, but rather through the strategies with which the authors and the editors compete for control of a constantly expanding editorial market, between subservience to power and attention for the tastes of the public. National unification also marked important changes in the social dimension and structure of this public13. Geography was only sporadically present in the educational systems of the various pre-unification states and in any case was restricted to higher education, confining the control of the skills necessary for reading cartographic images to a rather limited public, as well as those who handled maps for practical purposes of a professional nature. Small scale maps were therefore mainly destined for an elite of persons with higher education, largely from the middle class background of technical and intellectual professions; the same type of people to whom, during 11 S. PATRIARCA, Numbers and Nationhood. Writing Statistics in Nineteenth-Century Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 12 As it has been shown for Mazzini by M. DA CAPRILE, Mazzini e la cartografia, in “Bollettino della Domus mazziniana”, XLIII (1997), pp. 176-191. 13 See M.L. STURANI, Unità, cit., pp. 129-130 and EAD.,“I giusti confini, cit., pp. 434-438. 353 the Risorgimento, the efforts of the “patriotic statistics” spoke, in order to create favourable public opinion for national independence. When the Casati Reform, on which the educational system of the new national state was modelled, introduced the teaching of geography at elementary schools and when compulsory schooling was progressively extended the conditions were created for the use of geographical maps, constantly considered a fundamental teaching aid for this subject, to a potentially vast public. The use of small scale maps in the institutional contexts of Italian schools not only exposed an increasing number of individuals to the display of maps of the nation, but at the same time generalised the skills needed for reading them. It was this progressive popularisation of the geographic maps as elementary teaching aids that gave them a persuasive force and an unprecedented capacity for social penetration, much greater than that exercised by forms of representation destined for a more specialised public, such as statistics. However, many clues from the history of education in Italy14 lead us to think that this rhetorical force was only fully expressed during the twentieth century. 2. The content of the maps In the framework defined by the reconstruction of the context, we can now proceed with an analysis of the content of the maps, which we intend to develop with reference to the sole topic of the borders, fundamental in defining the concept of nation. In fact, it has recently been shown15 that reference to a coherent geographical collocation, guaranteed by reasonable territorial spread and marked by natural borders, has constituted an important foundation for the idea of the Italian nation as an entity with a natural basis, which was affirmed during the Risorgimento. As a representation that makes it possible to take in at a glance portions of space normally outside the direct experience and to confer graphic evidence to immaterial elements such as borders, cartography is a powerful instrument in giving a territorial form to nations, making them visible and conceivable as bounded spatial unities. So cartographical representations – together with geographic or artistic and literary descriptions – can give solidity to the concept of nation, literally offering a soil in which sentiments 14 See, for instance, G. VIGO, Gli italiani alla conquista dell’alfabeto, in Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, edited by S. Soldani and G. Turi, Bologna, Il Mulino, 1993, vol. I, pp. 37-66. 15 A.M. BANTI, La nazione, cit. 354 of identity and belonging can root. In this sense, the small scale cartography of Italy fulfilled a fundamental task in rendering imaginable the geographical body of the nation, first to a restricted group of intellectuals and patriots and later, in a sort of national pedagogy, to the citizens of the unified Kingdom. What we now intend to verify are the diverse and variable solutions that this cartography adopted to give form to this body of the nation and above all to meet the many transformations that it saw once it was transformed into the territorial body of the Italian Kingdom. For a means of representation based more on synchrony than on diachronic narration, such as cartography, the fundamental problem is to capture and at the same time guide, foreshadowing the developments, an unstable politicalterritorial situation. In small scale cartography produced during the pre-unification phase we find two opposing figurative models, conceived to face up to these problems. A first solution emerged from a long cartographic tradition, which had been established in the early modern period, consisting of the registration of political-administrative borders of the pre-unification states. This neutral registration comes together with an appeal to Italy of purely erudite and antiquarian value through the use of the corresponding geographic name in the title and with the map centred on the peninsula. These illustrations, which cannot be classified as explicitly patriotic appear frequently in our sample. On the contrary, in some maps of clearly patriotic inspiration, issued by Italian publishers, but also printed abroad, as in France16, the contraposition of the existing political divisions and a unified Italy is suggested in a more or less explicit manner. The latter is not presented as an ancient remnant but is explicitly presented as a territorial projection of the nation, defining the borders created by Nature beyond historical contingencies. In these maps we can see the beginning of the visual pattern of the “double frontier”, destined to last in Italian cartography until the mid-nineteenth century. It is interesting to note that in a stage in which initially the political unitary policy is based on federalist hypotheses, the territories of the pre-unification states are never denied when drawing maps. But they are rather used as pieces in a sort of geographical jigsaw puzzle to compose the body of the nation, experimentally and according to solutions of various sizes. The second phase, following unification, is marked by the emergence of a number of strategies for illustrating Italian territory and its borders. Strategies that can be defined above all by the differing relationship be16 See the French maps analysed by G. PECOUT, La carta, cit. 355 tween the representation and the territorial changes. The neutral registration of the political borders of the new state, as they are articulated by the chronology of international treaties, appears mainly in cases of official maps produced by government agencies and in popular and school-atlases of German production which were widely available on the Italian market. In certain maps produced by Italian publishers, on the other hand, we find new and old political borders marked on the same drawing, the result of inept updating of old cartographic materials that the rapid advance of the political-military events of unification had rendered obsolete. Then there were the fruits of deliberate ideological manipulations, figurative models that showed a sort of “wishful geography”, anticipating the territorial changes through two types of strategy. For instance, the use of cartographic silence17 finds ample application in small scale cartography of Italy produced before 1870 with reference to the Roman question (in these maps the borders that separate the Kingdom of Italy from the Lazio territories still under pontifical control are omitted). One can also find the recovery of the pattern of the “double boundary”, applied above all to the north-eastern section of the Alps, along which many maps continue to mark the non-coincidence between the political border of the Kingdom and the “natural” border which, according to the authors, could include more or less extensive portions of Trentino, Istria and Dalmatia. The attempt to establish a relationship between the space of the nation and the historical time which acts backwards, rather than anticipating the future, instituting a parallel between cartography and historical narration is also very interesting. This occurs in certain maps in which drawings or decorative elements are included and in the texts of keys containing historical references in celebration of military grandeur and the heroes of the Risorgimento or which connect the space of the nation to more or less ancient unitary precedents, in a sort of historical teleology. 3. Conclusion Recalling the critical warnings emerging from the analysis of the contexts, the fact that in school-texts and atlases printed after unification we find, in increasing numbers, images intended to legitimate the new national state and its plans for territorial expansion cannot be immediately and un17 On this subject, magisterially explored by Harley, see: J.B. HARLEY, Maps, cit., pp. 290-292; ID., Silence and Secrecy: the Hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe, in “Imago Mundi”, 40 (1988), pp. 57-76. 356 critically assumed to be evidence of a generalised acceptance of these political messages. In fact we cannot ignore the slowness and the partiality with which compulsory elementary schooling spread, in spite of legislation (2/3 of the population at the end of the nineteenth century) and the poverty of the schools and the families leaves more than one doubt about the effective presence of geographical maps of Italy in the elementary school classrooms of the late nineteenth century. Moreover, the totally fragmentary state of our knowledge of the dimensions and the changes in the consumption of small scale geographical maps in the nineteenth century makes it extremely difficult to understand the effect that individual maps could have had on the public. The result is the considerable risk of concentrating attention on images which were preserved due to their exceptional nature – both on an aesthetic-formal plane and in the content – over-estimating their social role18. In order to fully understand the social weight of the cartographic images we have examined, wholly avoiding this risk, it is therefore necessary to await the results of the research into the spread of cartoliteracy and geographical-cartographical publishing, which the history of Italian cartography between the nineteenth and twentieth century has only just begun to study. 18 See C. DELANO SMITH, Maps and Map literacy I: different users, different maps, in Plantejaments, cit., pp. 223-239 and spec. p. 224. 357 Stampato presso EST - Torino 358
Scarica