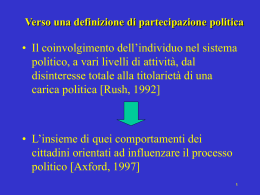la proposta politica di Essere Comunisti* unità, sinistra e governo Prodi C LAUDIO G RASSI ** Le crepe dell’impero americano erano evidenti ben prima del crollo dei mutui che ha provocato sulle Borse mondiali una tempesta paragonabile all’11 settembre e forse peggiore. Gli Stati Uniti producono il 10% delle merci circolanti nel pianeta, meno della Germania, e ne consumano il 30%, più dell’Europa intera. Questo significa che i cittadini dell’impero, dall’ultimo impiegato della middle class fino al primo manager di Manhattan, vivono molto al di sopra dei loro mezzi. […] La grande bolla Usa sta per esplodere. Con quali conseguenze nessuno può dirlo. Prima o poi qualcuno dovrà incaricarsi di spiegare agli americani la scomoda verità. A meno di non ipotizzare un’apocalittica guerra alla Cina»1. Non si tratta delle riflessioni di un pericoloso comunista, ma di un giornalista onesto: Curzio Maltese. In queste parole sono contenute le motivazioni di quanto accaduto nel mondo in questi anni. « Il quadro internazionale: dalla crisi statunitense al Venezuela di Chavez Il sistema economico statunitense è in grado di reggere soltanto attraverso le guerre, la produzione di armamenti, il dominio militare globale, la manipolazione internazionale dell’informazione. Solo governi subalterni hanno potuto sostenere e giustificare le tesi ufficiali con cui il governo Usa ha motivato le guerre intraprese negli ultimi anni. La lotta al terrorismo, la ricerca delle armi di distruzione di massa, l’esportazione della democrazia non c’entravano assolutamente nulla. Tutti sanno che i motivi veri degli interventi militari sono stati altri. L’Iraq è stato invaso per la grande quantità di petrolio di cui dispone e per la decisione di Saddam di venderlo in euro. L’Afghanistan è stato occupato per la sua collocazione strategica a ridosso di Cina e Russia. La politica di guerra e di dominio perseguita da Bush, classicamente imperialista, si trova oggi in una profonda crisi. Crisi militare: le guerre in Iraq e in Afghanistan non si concludono e le perdite sono sempre più significative. Crisi di egemonia: la credibilità della politica estera statunitense è in netto calo rispetto all’11 settembre 2001, quando venne lanciata la dottrina della guerra preventiva e permanente. Inoltre negli Usa esistono contraddizioni economiche immense che, come ha dimostrato la recente vicenda dei mutui subprime, possono scatenarsi da un momento all’altro con conseguenze imprevedibili. Purtroppo a questa situazione di oggettiva debolezza di prospettiva dell’imperialismo americano non corrisponde, già pronta, un’alternativa. Un tempo si sarebbe detto che vi sono le condizioni oggettive ma mancano quelle soggettive. Infatti, alla crisi del sistema economico dell’occidente capitalistico, fanno da contraltare la crisi e la sconfitta del tentativo di costruire un sistema socialista avviato nel secolo scorso con la Rivoluzione d’Ottobre del 1917. Se il capitalismo, quindi, mostra come non mai le sue contraddizioni in tutto il pianeta, rendendo necessario un suo superamento per evitare che si producano guerre, migrazioni e devastazioni ambientali, oggi chi come noi lo propone è indebolito dal fatto che quel tentativo di trasformazione, nei paesi più significativi in cui è stato tentato, non è riuscito ad affermarsi. È in questi grandi processi storici che noi dobbiamo inserire il nostro ragionamento. Altrimenti, oltre a non riusci- ** COORDINATORE NAZIONALE ESSERE COMUNISTI, PRC-SE 1 2 re a comprendere quanto sta avvenendo, non riusciamo ad apprezzare e a valorizzare quanto stiamo facendo. Le difficoltà di Rifondazione comunista, lo scarso consenso elettorale, sono certamente dovuti a scelte sbagliate e a errori soggettivi, ma in larga parte trovano le loro cause in questa pesante sconfitta storica nella quale ci troviamo a operare. Infatti anche in Spagna, in Francia e in Germania, seppure con differenze, i partiti comunisti e di sinistra alternativa sono attraversati da profonde divisioni al proprio interno e il loro consenso elettorale è più o meno analogo al nostro. Tuttavia la partita è aperta e noi dobbiamo lavorare con la consapevolezza che le contraddizioni di questo sistema capitalista possono anche precipitare in crisi accelerate e produrre scenari di vasti sommovimenti e trasformazioni. Inoltre la situazione internazionale non è priva di contraddizioni e di scenari che vanno valutati con grande attenzione. Nella competizione globale il tratto dominante – che va di pari passo con la crisi e l’indebolimento degli Stati Uniti – è l’emergere di nuove potenze economiche: la Cina, la Russia e l’India. L’impetuoso sviluppo economico di questi paesi, in cui risiede quasi la metà della popolazione terrestre, produrrà, nel giro di qualche decennio e forse meno, cambiamenti enormi negli assetti mondiali. Gli Stati Uniti stanno operando per contrastare tale sbocco cercando alleati tra questi paesi. Quando ci riescono, come nel caso dell’India, non esitano ad armarli e a sostenerli; e quando non ci riescono, come sta avvenendo nel caso della Russia di Putin, non esitano a riaprire nei loro confronti una stagione di guerra fredda attraverso lo scudo stellare, l’appoggio ai governi e alle forze più reazionarie dei paesi confinanti e attraverso progetti di destabilizzazione (vedi le rivoluzioni «arancioni»). Oppure, come sta avvenendo nei confronti della Cina, attraverso un sotterraneo e pesante attacco economico. È evidente che oggi vi è un contrasto e uno scontro tra gli Usa da un lato e la Cina e la Russia dall’altro, mentre l’Europa, che attraverso la costituzione dell’euro ha introdotto un elemento oggettivamente antagonistico al dollaro, è divisa al suo interno e allo stato attuale è incapace di rendersi autonoma dall’egemonia statunitense. In questo contesto l’obiettivo prioritario è indebolire la politica di guerra degli Stati Uniti. Non è una scelta di «campo», come quella che si poteva realizzare negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso quando, pur con tutti i limiti, al campo capitalista si contrapponeva un campo socialista. Oggi non c’è un campo socialista. Tuttavia ci sono paesi che non condividono e in alcuni casi contra- stano ciò che di più pericoloso si muove contro la pace nel mondo e cioè la politica estera degli Stati Uniti. Inoltre nella competizione globale, oltre a Usa, Europa, Cina e Russia, vi sono altre realtà degne di attenzione. Ne segnalo una in particolare, quella che mi sembra più significativa: l’America Latina. Qui sta prendendo forma un processo che ha due elementi peculiari. Da un lato un numero crescente di paesi non accetta più la sottomissione ai diktat nordamericani: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Nicaragua solo per citare i principali. Nel Brasile la situazione è più incerta, tuttavia sarebbe un errore non vederne il processo contraddittorio e le potenzialità positive. Dall’altro lato Chavez sta costruendo un progetto di trasformazione del Venezuela in senso antimperialista e di democrazia sostanziale. Ciò ha una straordinaria importanza per il messaggio che lancia a tutto il mondo. Non a caso si è stabilito un asse forte con Cuba e l’esperimento venezuelano è oggi il punto più avanzato per la sinistra, poiché ha come obiettivo il cambiamento rivoluzionario e la trasformazione socialista della società. Il fatto è importante poiché si lotta non solo per una alternanza, come avviene in tutti i paesi europei, ma per una alternativa di società. Ciò che manca oggi in questo panorama internazionale così complesso è la ripresa del conflitto di classe nei paesi a capitalismo avanzato. Sarebbe interessante capire se, viste le trasformazioni EDITORIALE che sono intervenute dagli anni Settanta a oggi, i punti alti dello sviluppo capitalistico, dove si può ipotizzare riparta il conflitto di classe, siano ancora da considerarsi le metropoli europee, e non invece le grandi città di Cina, India, Brasile e Sudafrica dove sono stati trasferiti i più importanti insediamenti industriali e dove più alta è diventata e diventerà la concentrazione operaia. Sono approfondimenti da fare, importanti. Rifondazione comunista e governo Prodi: unità e conflitto, per l’unità programmatica della sinistra d’alternativa Abbiamo il compito, qui e ora nel nostro paese, di costruire l’iniziativa politica più efficace possibile per dare una risposta ai bisogni dei lavoratori, dei ceti sociali più deboli e per tenere aperta una prospettiva di trasformazione, di alternativa di società. La prima cosa da fare è analizzare bene la realtà e compiere una corretta analisi della fase altrimenti, come purtroppo ha fatto il nostro partito (a Venezia e prima di Venezia), si commettono errori e ci si trova in difficoltà. La nostra analisi della fase, e il nostro giudizio su come bisognasse costruire l’unità della sinistra di alternativa e un’eventuale intesa di governo, oggi si rivela valida e confermata dai fatti, mentre quella della maggioranza non ha retto2. Vorrei ricordare, infatti, che si era teorizzato che: 1) la nostra presenza al governo avrebbe impresso alla sua azione una svolta riformatrice, mentre ha prodotto, al contrario, una grave difficoltà per Rifondazione, come hanno dimostrato i dati negativi delle elezioni amministrative e il fallimento del sit in del 9 giugno; 2) a differenza degli anni Novanta, si sarebbe potuta trovare una intesa di governo con questo centro-sinistra poiché esso si era spostato a sinistra; ci troviamo, al contrario, a fare i conti con la costruzione del Partito democratico che si colloca al centro e si distanzia sempre più dai bisogni dei lavoratori e dai valori della sinistra; 3) la forza dei movimenti, in ogni caso, ci avrebbe aiutato e supportato nei passaggi più difficili, e invece ci siamo trovati a operare nel governo in una fase di riflusso dei movimenti. Inoltre, venne duramente attaccata la nostra proposta di unità d’azione e programmatica con le altre forze della sinistra di alternativa poiché – si diceva – era necessario trattare direttamente con Prodi. Oggi, con grave ritardo, e quando ormai molti passaggi sono compromessi, si propone l’unità della sinistra di alternativa esattamente come la proponevamo noi. Infine, venne ridicolizzata la nostra proposta di concordare un programma breve e vincolante di pochi punti (i paletti). Oggi viene avanzata con articoli e interviste (penso, per esempio, ai recenti interventi di Giuliano Pisapia e Cesare Salvi su «il manifesto») come unica possibilità per uscire dalle difficoltà in cui ci troviamo. Insomma: oggi paghiamo per intero non solo le difficoltà oggettive, che ci sono, ma anche il modo sbagliato con cui Rifondazione comunista è entrata prima nell’Unione (anzi nella Gad) e poi nella maggioranza e nel governo. A questo c’è da aggiungere un fatto: il partito non ha gestito adeguatamente il primo anno di presenza nella coalizione di governo. Solo nell’ultima fase si è cominciato a riconoscere che il bilancio di questi primi 15 mesi non è positivo. Per tutto il primo anno non solo si è teso a rimuovere le difficoltà, ma si sono sbandierati risultati positivi anche quando non c’erano. Tutti ricordano, a proposito di una Finanziaria assolutamente negativa, il manifesto «anche i ricchi piangano»; oppure il giudizio positivo sui 12 punti di Prodi dopo la crisi di governo quando positivi non erano; oppure ancora la tesi, rivelatasi poi fasulla, che il voto favorevole al rifinanziamento della missione in Afghanistan si sarebbe potuto dare perché si era ottenuto una prima volta il comitato di monitoraggio, una seconda volta la conferenza di pace: risultati che, come è noto, non si sono mai concretizzati. Ritengo che fin da subito il partito avrebbe dovuto avere un atteggiamento più onesto dicendo apertamente ciò che andava e ciò che non andava. Ciò non è stato fatto e questi errori li abbiamo pagati duramente, come si è visto con il risultato elettorale delle amministrative. Da alcuni mesi, in particolare dalla conferenza di Carrara in poi, l’atteggiamento è cambiato, seppure in modo ancora insufficiente. Detto questo, cosa proponiamo di fare noi nei confronti del governo Prodi? La situazione è molto complessa e l’errore più grave è la semplificazione. Essa porta a due errori opposti che dobbiamo evitare. Il primo, che è quello che ha contraddistinto la maggioranza del partito nel primo anno di governo e che è ancora presente in una parte della maggioranza, è un atteggiamento di subalternità che porta a giustificare e ad accettare tutto quanto il governo propone. Il secondo, che è quello che contraddistingue Sinistra Critica e alcuni dei compagni che sono usciti dall’area, è incentrato sull’idea che si debba uscire dal governo. Sono due atteggiamenti che rifuggono dalla realtà: il primo perché la nasconde, il secondo perché con la sua azione non affronta la difficoltà, ma di fronte a essa scappa, producendo nei fatti uno scenario ancora più arretrato. Nel contesto nel quale ci troviamo a operare giocano molti fattori e noi dobbiamo considerarli tutti. 3 4 Questo governo, che noi giustamente critichiamo e al quale proponiamo un forte cambiamento, soprattutto sulle questioni economiche e sociali, è anche sotto attacco e sotto pressione da parte dei poteri forti. Dai tecnocrati europei alla Confindustria, dal «Corriere della Sera» alla Chiesa e agli Usa. L’ambasciatore statunitense in Italia è intervenuto pubblicamente tre volte per criticare le scelte del governo italiano. Si tratta di una ingerenza inaudita, come non si vedeva dall’immediato dopoguerra. Abbiamo visto inoltre, mentre si avvia a conclusione l’iter di costituzione del Partito democratico, le proposte di riassetto istituzionale di Veltroni e Rutelli che con una legge elettorale alla francese puntano a rendere ininfluente la sinistra dell’Unione, in primo luogo Rifondazione comunista. Tutto ciò avviene, come dice strumentalmente la componente moderata dell’Unione, perché Rifondazione comunista e la sinistra hanno condizionato il quadro politico? Purtroppo no. Le cose ottenute, che pure ci sono state (come per esempio il ritiro dei militari italiani dall’Iraq, una lotta all’evasione fiscale che comincia a dare frutti, le misure ottenute a proposito di sicurezza nei luoghi di lavoro, il contenimento delle privatizzazioni nel primo disegno di legge Lanzillotta), non modificano sostanzialmente il senso di marcia del governo. Il fatto è che nemmeno il timido programma dell’Unione viene rispettato e quelle poche cose che potevano dare ai nostri referenti sociali il senso di una inversione di tendenza – dall’abolizione dello scalone alla restituzione del fiscal drag, dai Dico al superamento della legge 30 e della Bossi-Fini – non vengono attuati. Tutto ciò avviene poiché – dobbiamo riconoscerlo – non siamo ancora usciti dalla sconfitta iniziata alla fine degli anni Settanta. Stiamo vivendo una pesantissima offensiva dei padroni che non ha precedenti e a cui non si contrappone quasi nessuno. Il fatto che dopo un editoriale come quello di Giavazzi sul «Corriere»3, nel quale si propone di rendere precari tutti i lavoratori, vi sia stato il silenzio generale degli intellettuali e del mondo della cultura conferma questa valutazione. Anche la reazione dei sindacati, della Cgil in particolare, è da tempo insufficiente e ciò ha pesato e pesa nei rapporti di forza tra le classi e anche tra le forze politiche e nel governo. Noi dobbiamo operare in questo groviglio di contraddizioni sapendo che ciò che ci chiede la nostra gente, soprattutto i lavoratori, non è far cadere il governo ma lottare per cambiare le sue scelte politiche. Questo è il punto e questo deve essere il nostro impegno per i prossimi mesi sui temi già all’ordine del giorno come pensioni e mercato del lavoro. Il percorso che abbiamo di fronte non è facile, ma ci sono anche le opportunità per fare questa battaglia fino in fondo, come dimostra l’importantissima presa di posizione del comitato centrale della Fiom. I protocolli sottoscritti da governo e sindacati devono essere modificati e per cercare di ottenerlo occorre la lotta e la mobilitazione, in Parlamento e nel paese. Questo deve essere il modo con cui noi ci rapportiamo al governo. Un approccio unitario ma anche, quando occorre, di conflitto teso alla realizzazione del programma con l’unità delle altre forze della sinistra disponibili. Anche sulla base Dal Molin di Vicenza e sul rifinanziamento della missione in Afghanistan che ci sarà in gennaio, noi dobbiamo lavorare perché tutta la sinistra dell’Unione si mobiliti. Tra l’altro a favore di una ipotesi di exit strategy concorre il fatto che né il comitato di monitoraggio né la conferenza di pace sono state fatte e in Afghanistan, come ci ha confermato il rapporto Onu dei giorni scorsi, la produzione di droga ha toccato livelli mai raggiunti in passato. Lo stato del partito e il ruolo dell’area Essere comunisti Il partito vive da tempo una situazione di grave crisi tanto politica quanto organizzativa. Le cause risalgono indietro nel tempo e sono il prodotto di vari fattori di cui più volte abbiamo discusso e che hanno subìto una accelerazione alla fine degli anni Novanta. È stata attuata un’opera di rimozione della nostra storia. Non una riflessione sul nostro passato, quanto mai necessaria, la messa a tema di quella Rifondazione comunista mai fatta dal nostro partito e di cui abbiamo grande bisogno, ma – al contrario – una opera di azzeramento, che ha mortificato molti nostri compagni e ne ha allontanati altri. D’altra parte il ragionamento è molto semplice: se tutto quello che ha a che fare con il comunismo è una sequela di errori e orrori, perché iscriversi a un partito comunista e militare per esso? Noi abbiamo cercato di contrastare questa deriva, prima con un emendamento al V congresso, poi con una mozione alternativa al VI a cui abbiamo dato un nome – Essere Comunisti – che ha voluto replicare anche simbolicamente a quell’attacco. Possiamo dirlo con orgoglio: se tanti compagni e compagne non se ne sono andati dal partito è perché hanno incontrato noi e hanno visto in noi una reazione efficace a quella offensiva. Questo lavoro dobbiamo continuarlo perché non siamo affatto disposti a rinunciare al nome e al simbolo di Rifondazione comunista, ma soprattutto riteniamo inaccettabile che la storia comunista – che in questo paese è storia gloriosa – venga sommersa da falsità e revisioni- EDITORIALE smi. Il nostro impegno deve essere quello di una riflessione vera per capire dove si è sbagliato, per andare avanti senza rinunciare alla prospettiva di costruire una società socialista. Dall’altro lato, accanto a questo sistematico attacco alla nostra storia, si è spinto il partito non a stare nei movimenti, cosa ovviamente giusta, ma a identificarsi con una parte di esso, quella considerata più innovativa e interessante e cioè quella dei Disobbedienti di Luca Casarini. In quel periodo il gruppo dirigente di Rifondazione parlò di «nuova situazione rivoluzionaria», dell’esaurimento dei margini di riformismo, iniziò a considerare la Cgil un sindacato ormai privo di qualsiasi importanza e a lanciare la parola d’ordine della rottura della gabbia dell’Ulivo. Ed entrò non casualmente in sintonia con le tesi negriane dell’Impero e con quelle revelliane delle due destre. Contro chi, come noi, propose l’unità della sinistra di alternativa fioccarono le accuse di frontismo e moderatismo. E quando sostenemmo che il movimento era importante ma bisognava prestare attenzione anche al partito perché – come è naturale – i movimenti rifluiscono, ci accusarono né più né meno di essere contro i movimenti. Come sia finita lo sappiamo tutti. Nel volgere di una estate la politica di Rifondazione cambiò di 180 gradi. Si abbandonarono i Disobbedienti e si decise di entrare nell’Unione e nel governo ancor prima di aver discusso il programma. Si passò, in sostanza, da un estremo all’altro. Queste sono le ragioni delle difficoltà di Rifondazione comunista. Qualsiasi partito politico che contemporaneamente subisce una costante rimozione del proprio profilo identitario e un cambiamento di linea e di collocazione politica di 180 gradi non può che creare disorientamento, soprattutto nella propria base. Il dato nuovo, e dal nostro punto di vista positivo e interessante, è che si sta facendo largo anche nell’attuale gruppo dirigente nazionale la consapevolezza della necessità di modificare questa situazione cercando di instaurare un clima diverso nel partito. Ciò avviene prevalentemente per due motivi. Perché il fallimento di quella modalità di gestione è sotto gli occhi di tutti e perché noi siamo stati tenaci nel non abbandonare mai il campo nonostante nei nostri confronti – al centro e in periferia – siano state attuate pesantissime azioni di emarginazione e discriminazione. Questa nuova situazione – che va ancora verificata e consolidata – è frutto anche del nostro lavoro e della tenuta delle nostre posizioni politiche: dobbiamo considerarla frutto della nostra iniziativa politica. Essa sta alla base della scelta di fare una conferenza di or- ganizzazione come è stata fatta a Carrara, quando, lungi dal ripercorrere lo schema di Venezia, quello dei documenti contrapposti, si è lavorato per un serio confronto, a partire dalla possibilità di presentare emendamenti. È in questo passaggio che si è prodotto il contrasto al nostro interno con alcuni compagni che poi hanno lasciato l’area Essere comunisti. Abbiamo cercato di evitare in tutti i modi questo esito, ma, d’altra parte, non potevamo nemmeno non contrastare tesi che ci avrebbero portati in un vicolo cieco, senza sbocchi politici per la nostra iniziativa. Secondo questi compagni a Carrara avremmo dovuto presentare un documento alternativo. Ritengo che sarebbe stato un grave errore politico. In contrasto con la storia della nostra area, che non è mai stata quella di stare all’opposizione a prescindere e di costruire un partito nel partito, ma che, al contrario, ha sempre operato per cercare di intervenire sulle posizioni sbagliate per cambiarle. Questo obiettivo con la conferenza d’organizzazione, grazie anche al nostro contributo, è stato conseguito. Basta leggere il documento conclusivo per rendersene conto4. In esso si apre finalmente un discorso critico sul Governo, si propone di aprire una offensiva tesa a ottenere il risarcimento sociale e, sul partito, si afferma con chiarezza che non è in discussione la sua identità politica, culturale e organizzativa. Se noi a Carrara avessimo presentato un documento alternativo ci saremmo isolati collocandoci al fianco di chi (come Sinistra Critica) alla Conferenza non ha nemmeno partecipato e quindi condannandoci a una logica di impotenza e marginalità. La nostra è una linea che opera per intervenire nelle contraddizioni presenti nella maggioranza cercando l’unità con la parte a noi più vicina. L’obiettivo è quello di trovare significativi punti di convergenza, come già è avvenuto in altri periodi della storia di Rifondazione comunista, sulla gestione del partito e sulla sua proposta politica. Il punto è se si ritiene Rifondazione comunista il partito nel quale si opera per cercare di migliorarlo o se si è con- 5 6 vinti che ormai non ci sia più nulla da fare e si pensa ad altro. Noi riteniamo che la battaglia sia aperta, l’esito non scontato e quindi l’iniziativa si deve sviluppare dentro Rifondazione comunista. Il Prc è il luogo nel quale lavorare per cercare di costruire una forza politica con basi di massa e che si batte per una alternativa al capitalismo. Un corpo – quello del Prc – in trasformazione e trasformabile su cui abbiamo influito in passato e possiamo influire oggi. Rifondazione comunista mantiene delle ambiguità feconde. In primo luogo perché tra i suoi obiettivi resta quello del superamento del capitalismo e in secondo luogo perché non ha rinunciato all’autonomia dai governi, anche se l’attuale esperienza con Prodi sta mettendo questa sua peculiarità a dura prova. Cosa manca al Prc? Tante cose, ma se dovessi fare una scala di priorità ne metterei una davanti a tutte. La presenza nella classe, il radicamento nel mondo del lavoro, l’assunzione dei problemi dei lavoratori come la bussola principale su cui orientare l’azione del partito. Dobbiamo ricostruire una presenza nel sindacato e nelle fabbriche. Perché il sindacato e le fabbriche ci sono ancora: siamo noi che non ce ne occupiamo più. Non sappiamo più nemmeno dove siano, salvo poi andarci prima delle elezioni e stupirci del disinteresse e della freddezza con cui veniamo accolti, come è avvenuto alla Fiat. Sapendo che una fabbrica è la Fiat, ma lo è anche un call center o un grande supermercato. Così come dobbiamo tenere presente che i migranti e i precari sono soggetti fondamentali su cui investire la nostra attività poiché su di loro è più intenso lo sfruttamento capitalistico. In questo contesto è strategica la tenuta della Fiom, perché è il sindacato che non ha rinunciato al conflitto e sappiamo che senza conflitto nessun progetto di trasformazione è ipotizzabile. Ed è chiaro che, se sono importanti e vanno mantenuti i rapporti con i sindacati di base, noi dobbiamo lavorare prioritariamente sulla Cgil. Essa resta il sindacato nel quale si riconosce la stragrande maggioranza dei lavoratori e al suo interno è attiva una importante componente di sinistra. Il nostro partito deve avere l’ambizione di diventare il principale riferimento del mondo del lavoro e anche della Cgil. Su questo noi dobbiamo lavorare. Fare politica nella classe, costruirvi punti di riferimento, farli avanzare nell’area e nel partito. Anche altri sono i temi su cui lavorare per cambiare Rifondazione, ma ciò possiamo farlo con credibilità se viviamo il rapporto con il partito come una cosa che ci appartiene, alle cui sorti siamo interessati e al quale diamo il nostro contributo. Io penso che la nostra area debba essere attaccata come un’edera al partito, entrare in tutte le sue pieghe, saper cambiare quando la situazione cambia. C’è il momento del contrasto. Abbiamo dimostrato di non sottrarci quando sono in gioco forti convincimenti e per questo, non per altro, siamo stati cacciati dalla Segreteria nazionale. Ma c’è anche il momento in cui se si apre uno spiraglio devi saperlo cogliere e modificare il tuo atteggiamento. Sì alla confederazione. No al superamento di Rifondazione comunista Ma se è sbagliata la posizione di chi dice che bisogna prepararsi per fare qualcosa a sinistra del Prc, altrettanto sbagliata è la tesi di chi propone di sciogliere Rifondazione comunista in un soggetto unico della sinistra. Sgombriamo subito il campo da una questione: noi siamo per l’unità, l’unità dei lavoratori, l’unità della sinistra, l’unità delle forze democratiche. Noi siamo sempre stati per l’unità, ma ciò che ci propongono – esplicitamente o meno esplicitamente – alcuni compagni di Rifondazione o di Sinistra democratica non è una proposta unitaria, ma lo scioglimento del partito in un soggetto genericamente di sinistra. Noi siamo contrari a questo progetto. Siamo per l’unità della sinistra, ma ci opponiamo al superamento di Rifondazione comunista. Tra l’altro, come si vede in questi giorni, tra noi e questi compagni con cui dovremmo fare un unico partito, emergono giudizi assai diversi su questioni rilevanti come l’accordo sulle pensioni o il protocollo sul welfare. EDITORIALE D’altra parte se in tutti questi anni con il compagno Mussi – dalla Bolognina alla concertazione, dalle leggi maggioritarie alla guerra in Kosovo – ci siamo trovati su posizioni diverse, ciò non è avvenuto per caso. Nonostante ciò lo sforzo unitario va perseguito. Stiamo parlando delle forze politiche a noi più vicine e dobbiamo pazientemente ricercare i contenuti su cui convergere, sapendo che abbiamo tanti punti in comune, ma anche differenze significative che non ci consentono di ipotizzare un unico partito. Le divergenze si addensano in particolare su due questioni, entrambe di carattere strategico. La prima: noi non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare alla Rifondazione comunista e non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare ai nostri riferimenti internazionali. Non è un problema che riguarda il passato ma è un problema che guarda al futuro. Si tratta di capire se continuiamo a lavorare per costruire una forza politica il cui orizzonte è il superamento del capitalismo e la costruzione della società socialista e che quindi opera per una trasformazione rivoluzionaria della società, oppure puntiamo a costruire una forza socialista di sinistra che lotta per correggere le ingiustizie più gravi del sistema in un meccanismo di alternanza. Sono due progetti molto diversi. Infatti – e qui è il secondo punto di divergenza strategica – il rapporto con il governo per questi compagni è un dato che non può essere messo in discussione, per noi non è così. Dipende dai contenuti e dalla misura in cui la nostra presenza è utile o meno a tenere aperta la costruzione dell’alternativa. La nostra proposta quindi è molto semplice: unità a sinistra e rafforzamento del Prc. Lavoriamo per costruire l’unità della sinistra nel Parlamento e nel paese sui contenuti, ma contemporaneamente lavoriamo per rafforzare il partito della Rifondazione comunista. Siamo disponibili a tutte le formule organizzative che aiutino questo tipo di unità, come la confederazione, i coordinamenti dei gruppi istituzionali, le case della sinistra. Ma siamo contrari alla costruzione di gruppi unici, liste uniche alle elezioni politiche, partiti unici. In questi mesi su questo punto si è aperta una dialettica nella maggioranza del partito tra chi, come noi, pur in un processo unitario vuole mantenere l’autonomia di Rifondazione e chi concepisce il processo unitario come un percorso che alla fine prevede la costruzione di un nuovo partito politico che non sarebbe più un partito comunista. Quest’ultima posizione è stata contrastata da noi, dall’esito della Conferenza di Carrara, dal segretario nazionale e della maggioranza del gruppo dirigente. Successivamente, di fronte alla reazione del partito e ai fatti politici che andavano in un’altra direzione, chi nel parti- to aveva proposto un suo superamento ha fatto un passo indietro. Ciò è avvenuto nella riunione della maggioranza a Segni e nel comitato politico nazionale di luglio5. Le questioni però potrebbero riproporsi e noi dobbiamo intervenire in questa dialettica che è una dialettica vera. In questo nuovo contesto dobbiamo continuare il nostro lavoro di area nel partito e impegnarci fin da subito perché si vada a un congresso che sia in continuità con lo spirito di Carrara e non con quello di Venezia. Un congresso che possa essere di confronto vero e non di contrapposizione a priori. * Stralci della relazione di Claudio Grassi all’assemblea nazionale di Essere Comunisti, Gubbio, 2 settembre 2007. La versione integrale è consultabile all’indirizzo: www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=18164. 1. Curzio Maltese, «il Venerdì di Repubblica», 24 agosto 2007 (qui è possibile leggere l’articolo integrale: www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=get_filearticolo&IDArticolo=17798). 2. È interessante rileggere alcuni materiali del congresso scorso, come il documento della prima mozione (www.rifondazione.it/vi/documenti/mozione1.html), il nostro documento (www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=3387) e l’intervento di Claudio Grassi di presentazione della mozione al Centro Congressi Frentani di Roma il 27 novembre 2004 (www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=3401). 3. La delusione dei più deboli, «Corriere della Sera», 26 agosto 2007. 4. A quest’indirizzo è possibile consultare il documento conclusivo della conferenza di Carrara: www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=14869. Qui, invece, è possibile leggere l’intervento di Claudio Grassi a Carrara: www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=14871. 5. Riportiamo per completezza anche il documento conclusivo del Cpn del 14 e 15 luglio (www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=get_filearticolo&IDArticolo=17037) e la dichiarazione di voto di Claudio Grassi (www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArtico- 7 non cerchiamo scorciatoie 8 A URELIO C RIPPA * n un clima di «crisi» della politica e di speculazione della (e sulla) medesima, dove una diffusa egemonia culturale che riduce la politica a pratica di governo, ad amministrazione, ad «affare interno» a oligarchie di partito e il rapporto con i cittadini a intrattenimento mediatico affidato ai talk show televisivi, la storia e le ragioni della sinistra rischiano di essere messi ai margini, il conflitto sociale di esser considerato una patologia da estirpare, il mondo del lavoro di scomparire dalla scena politica. Nella regressione generalizzata dei diritti e delle garanzie di lavoro, il capitalismo torna ad assumere sembianze ottocentesche. Un nuovo proletariato abita l’Italia e l’Europa: le/i precarie/i. La precarietà introdotta per via legislativa include un numero di persone triplo rispetto a quello del resto d’Europa, a cui si aggiunge il lavoro nero (per l’Istat circa 4 milioni di disposizioni lavorative), quello dei collaboratori, dei circa 4 milioni di partite IVA, di cui una gran parte monocommittenti (quindi in una condizione di dipendenza economica). Non semplicemente uno spostamento a destra del quadro politico, ma un oscuramento delle idee-forza della sinistra, indotto dal progressivo smantellamento di un intero impianto concettuale e da un pesante sfondamento ideologico (tramonto delle ideologie, con l’affermazione dell’unica ideologia imperante, quella del cosiddetto «pensiero unico»), dal revisionismo storico, dalla demolizione scientifica e sistematica dei valori: al posto della solidarietà la competizione, al posto dell’uguaglianza la meritocrazia. E le responsabilità non vanno individuate solo a destra. Dietro la formula «semplificare la democrazia» (per semplificare occorre ridurre, dice il vocabolario) una parte significativa di «ceto» politico, intellettuale, mediatico – che ritiene l’eccesso di democrazia e di complessità socia- I le un ostacolo per la governabilità – opera per meccanismi elettorali che riducano la rappresentanza a pochi e si basino sulla personalizzazione (si veda l’euforia per le primarie): come se i cittadini contassero di più, perché possono votare una persona anziché un programma. Così è oggi in atto un «lavorio» (a destra, al centro, a sinistra) sulla ricerca di nuove prospettive e alleanze. Preminente il suo carattere politicista e – ognuno a suo modo – evidente la volontà di seppellire il «partito di massa» e tutto quello che esso rappresenta: rapporto con la gente, partecipazione per far avanzare la politica. Lavorio politicista, manifesto nella ricerca di nuovi interpreti della politica, per esercitare leaderships pervicacemente personalizzate e di vertice. Ma anche, a suo modo, nell’«oltre Rifondazione»: per fare in fretta un nuovo soggetto unico di sinistra, a fronte della formazione del Partito democratico e in seguito a risultati elettorali negativi (una sommatoria per «stato di necessità»). Nella sua precipitazione organizzativistica (chissà perché la fine conclamata di un’esperienza dovrebbe accelerare un processo unitario) sta il suo politicismo, speculare a quello dei fondatori del Pd. Si vuole competere, in una visione che appare tutta governista. Vedo riecheggiare l’«oltre Pci» e ciò che prese avvio allora. Confermo la mia ostilità di sempre all’idea che alle difficoltà si risponda con proposte politiciste. Ma a scanso di equivoci, chiarisco: andare «oltre» fa parte della ricerca di chi vuole migliorare, anche innovando; e quindi dell’essere e dell’agire delle/dei comuniste/i. * PRC-COMITATO POLITICO NAZIONALE EDITORIALE Il problema è non sbagliare meta: questo vedo nell’«oltre Rifondazione». Sarebbe bene che il Prc, la sinistra, prendessero coscienza che il vero problema che abbiamo di fronte è l’esaurimento di un lungo ciclo di cultura e impostazione politica, quello che ha trasformato la politica in pura tecnica di gestione del potere, separata dal sociale, privilegiando decisionismo, verticalizzazione, concertazione, sacrificando ogni sede di rappresentanza e partecipazione. Non c’è bisogno di nessun «oltre» se con ciò si intende scioglimento, né di sommatorie per stato di necessità, né di perdite d’identità. C’è bisogno di un «fare» che recuperi il ruolo della politica rispetto all’economia, riconnetta a essa i temi sociali, riporti il baricentro della sua azione nella società, rioccupandosi dei suoi problemi, a partire dalle contraddizioni capitale-lavoro, all’interno delle quali ritroviamo questioni ambientali e di genere. I temi del lavoro salariato nelle vecchie e nuove forme. Un nuovo ciclo di cultura e impostazione politica che ponga fine alla mercificazione dei beni comuni, alla precarietà, alla privatizzazione delle risorse pubbliche che, nella gran parte dei casi, ha determinato un maggior costo per i cittadini, peggioramento di condizioni di lavoro, della qualità dei servizi e dei prodotti. Un nuovo ciclo che riaffermi il valore delle lotte alle disuguaglianze, all’esclusione sociale, a vecchie e nuove povertà; avvii una redistribuzione del reddito verso il basso (negli ultimi 20 anni, la ricchezza si è spostata in modo massiccio – 10 punti – dal lavoro alla rendita), conduca con forza e sistematicità una lotta agli sprechi, all’evasione fiscale (ci sono tasse da abbassare, a partire da quelle sul lavoro, e tasse da aumentare: quella sulla rendita, con franchigia per tutelare i piccoli risparmiatori). Occorre riconquistare il ruolo programmatorio dello Stato, in un ridisegno della una struttura produttiva che tenga conto del fatto che, per quanto il perno dell’industria si sia ridotto, essa continua a essere il motore delle economie più avanzate (sviluppo delle forze produttive per il soddisfacimento dei bisogni). Vanno riproposte l’idea e la pratica della pace, del disarmo, della cooperazione fra i popoli; della laicità, proteggendola da incursioni di fondamentalismi che usano la religione come clava per veicolare discriminazioni, conflitti, guerre, presunte superiorità culturali. Resistere è d’obbligo, ma non basta. Non è ipotizzabile per noi comuniste/i annullare l’idea e la speranza di cambiamento e trasformazione della società. Dobbiamo avere capacità e forza per riproporre in maniera più vasta l’idea gramsciana di «egemonia», attraverso un’azione politica e sociale che si riproponga come momento di riorganizzazione della democrazia partecipata, coinvol- gendo nella ricerca, con pari dignità, tutte/i coloro che sono disponibili a ridefinire un pensiero critico. Sul «che fare» – ma anche su ciò che siamo, vogliamo e possiamo diventare – è opportuno promuovere una grande campagna di massa, evitando il pericolo (oggi presente), che anche il giusto progetto dell’unità a sinistra si riduca a un fatto verticistico. È indubitabile (sarei meravigliato del contrario) che nel popolo di sinistra vi sia una richiesta di unità, che va ascoltata e accolta. Ma reputo forzata l’interpretazione, la tesi, che questa sia un avallo a un’operazione che cancelli l’identità dei singoli Partiti: e con essa tradizioni, culture politiche ancor oggi differenti. Nella società contemporanea siamo in presenza di una pluralità di soggettività politiche (costituitesi anche su parzialità), che sarebbe un azzardo pensare di voler ridurre «a uno». Un conto è la necessità di un’alleanza, di una coalizione elettorale, un altro voler appiattire l’identità di tutte/i. In questa seconda modalità la politica non appassiona, perché non è azione di trasformazione ma solo raccolta di «consenso»; e, certamente, così non si recupera la spoliticizzazione intervenuta in questi anni, il profondo disagio del popolo di sinistra e del paese. La presente richiesta di unità parte dai contenuti e ci chiede di unire le forze, a livello parlamentare e nel paese, per contrastare, cambiare una politica economica e sociale non corrispondente alle aspettative, dando così vita a un’azione che possa esser guardata come una «forza» in grado di incidere in direzione degli interessi popolari, attraverso concreti processi di cambiamento. Quindi unità d’azione e contestualmente il «fare» per il processo unitario a sinistra: per una soggettività che, per essere unitaria al plurale, deve avere necessariamente connotati confederali. Una soggettività nella quale, oggi, convivono, cooperano e si confrontano esperienze e paradigmi diversi. Il Prc sia motore autentico di questo processo, mettendo, al pari di altri e con pari dignità, a disposizione di esso i propri valori identitari. Avverto oggi come ieri (all’atto della nascita del Prc) la necessità, l’attualità dell’esigenza che permanga e anzi si sviluppi una forza politica organizzata, autonoma, comunista, che leghi alle battaglie politiche dell’immediato un progetto di trasformazione della società capitalistica. Si tratta non soltanto di un’enunciazione ideologica ma di una constatazione politica degli eventi: tanto da riportare nella sinistra, al centro della scena politica, la questione del socialismo. Per questo, va rapidamente sconfitto il tentativo in atto di mettere in soffitta i deliberati della Conferenza d’organizzazione, il progetto del «partito che si fa società», 9 10 l’alter ego del partito altro, di massa, degli anni Novanta. La coraggiosa e giusta autocritica sui fallimenti del V° Congresso – autoriforma – e del VI Congresso – investimento sul governo, come passaggio strategico per l’alternativa di società – ha aperto una fase nuova nella vita interna del partito, favorita anche dalla diffusa consapevolezza che una sommatoria di parti separate (correnti) non forma un’organizzazione. Per affermare questa nuova fase e nel contempo essere protagonisti delle vicende politiche e del processo di unità d’azione a sinistra, occorrono scelte urgenti: in primis, procedere al recupero dell’insediamento e del radicamento del partito, il quale deve essere ancorato saldamente alla società, ai luoghi del conflitto, organizzato nei luoghi di lavoro e di studio, nei territori, presente nelle organizzazioni/associazioni di massa, sindacali, culturali, di categoria, nei movimenti. I Circoli devono essere riconcepiti non come terminali di un apparato burocratico, ma come luoghi dove si esercita il «saper fare», la capacità di entrare in rapporto con tutti i soggetti della società, i movimenti, per realizzare una forma più alta della politica, non separata dai contenuti, dalla partecipazione democratica e non delegata. L’esigenza è più partito, non meno partito. Con un agire che non sia né la pura cancellazione del passato, né il suo culto nostalgico. Nessun rigurgito di atteggiamenti settari, ma l’idea del partito come strumento di identità e di autonomia politico-culturale, così come è nell’elaborazione di Gramsci. A fondamento, i valori della democrazia e del pluralismo, da esplicarsi entro un sistema di norme chiare, trasparenti, condivise: le differenti opinioni sono un arricchimento per tutte/i se non si sclerotizzano in correnti. Poiché, in tal caso, la democrazia pluralista finisce per privilegiare la dialettica e il confronto «di vertice», anziché coinvolgere l’insieme del partito. La vita interna deve essere strutturata in modo da garantire a tutte le differenze piena cittadinanza, agibilità, libertà di esprimersi, possibilità di contare. Deve essere riconosciuta l’esistenza di due soggetti – uomini e donne – e le loro tematiche, il loro pensiero e protagonismo, devono contare realmente. Va ricostruita l’organizzazione dei Giovani comunisti, garantendo loro gli spazi politici che competono alla loro specifica condizione, alle tematiche della loro realtà. La caratteristica di massa sta nel modo di essere e di agire nella politica, oltre che nel numero di iscritte/i, nel saper dare ampio spazio alle relazioni con l’insieme della società. In un’ansia di «modernizzazione» ma anche di nuova legittimazione «occidentale», il marxismo è stato derubricato alla condizione di «dottrina obsoleta», anche da parte dell’intellettualità di sinistra. La realtà parla d’altro: il marxismo di Marx, la sua elaborazione teorico-politica costituisce il punto più alto della critica all’economia capitalistica. Le difficoltà con cui misurarsi sono tante e non dobbiamo nascondercele: con tutto ciò, vale la pena di provarci. Non ci sono scorciatoie, però: e l’esperienza storica (vedi i fallimenti delle varie «nuove sinistre») sta lì a dimostrarlo. PACE E GUERRA guerra permanente e basi militari due facce di una stessa medaglia Il quadro politico internazionale M ASSIMO D E S ANTI * Tutte le basi disseminate sul territorio italiano sono state installate tramite accordi segreti stipulati tra Italia e Usa, con grave limitazione della nostra sovranità territoriale e politica. Su questi temi è cresciuta una sensibilità politica di massa. La manifestazione vicentina del 17 febbraio non è stata solo la classica manifestazione contro la guerra; è stata una manifestazione per la Pace Preventiva Contro la Guerra Infinita di Bush e dei suoi alleati * MEMBRO DEL PATTO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ E MUTUO SOCCORSO C on la fine della «guerra fredda» e l’instaurarsi di un nuovo mondo unipolare a dominio Usa, il quadro politico internazionale è diventato sempre più complesso, minaccioso e insicuro per la maggioranza dell’umanità. Si è imposta, infatti, la nuova filosofia della guerra preventiva che ha moltiplicato i conflitti armati, con la conseguente ripresa di una vertiginosa corsa agli armamenti convenzionali, accompagnata dalla costruzione e sperimentazione di armi sempre più raffinate nella loro tecnologia di morte. Ancora una volta, di fronte alla crisi economica mondiale, l’Occidente risponde su due livelli: militare e mediatico. Prima inventa un presunto conflitto di civiltà e poi attiva tutti i pretesti per promuovere la guerra a livello planetario, in primo luogo contro quei paesi che sono ricchi di materie prime, come il petrolio e il gas naturale, oppure di quel prezioso bene comune che si chiama acqua. Non è affatto azzardato affermare che è in corso la terza guerra mondiale, iniziata nel 1991 con la Prima guerra del Golfo: anche se i politologi di regime non lo hanno mai ammesso. Eppure si erano già levate prestigiose voci che cercavano di aprirci gli occhi sugli scenari mondiali che si stavano profilando. Noam Chomsky ha sin dall’inizio espresso una valutazione lapidaria: la guerra globale di Bush divorerà il pianeta. Lo stesso Ramsey Clark, giurista americano ed ex ministro della Giustizia all’epoca di Carter – oltre che promotore e Presidente del Tribunale Contro i Crimini di Guerra commessi dagli Stati Uniti in Iraq – ebbe a dire nel 1992 che l’imperialismo americano, imponendo gli Usa come unica potenza economico-militare al governo del mondo, aveva inaugurato l’era dell’unipolarismo. Nel 1991, durante la prima fase del mondo unipolare, gli Usa aspiravano ancora a salvarsi la faccia di fronte all’opinione pubblica mondiale e, per legittimare la guerra, fecero entrare in gioco l’Onu, corrompendo vari paesi col ricatto del debito estero. Oggi, invece, in quella che possiamo chiamare la seconda fase dell’unipolarismo americano, l’Onu viene sistematicamente scavalcata e chiamata solo a legittimare a posteriori l’accaduto. Il diritto internazionale, prima violato attraverso l’artifizio di una interpretazione pro domo americana, ora è violato direttamente e a ripetizione col tipico modo sprezzante di chi non teme alcuna ritorsione. E la guerra viene «santificata» grazie al monopolio dei potenti apparati mediatici filo-occidentali. La guerra planetaria in corso, è sfuggita alla gestione delle stesse potenti lobbies internazionali che l’hanno scatenata e che ora hanno difficoltà a contenerla o fermarla. La situazione è fuori controllo: si veda l’Iraq dove gli Usa sono impantanati in un conflitto armato, che di fatto hanno perso sia sul piano politico che su quello militare. La stessa cosa vale per l’Afghanistan: là dove c’era la convinzione euforica della vittoria, la guerra si ripresenta invece su vasta scala sotto la sorprendente direzione dei talebani che erano dati per scomparsi e sconfitti. 11 Tra i primi firmatari del Patto Nazionale di Solidarietà e Mutuo Soccorso si ricordano oltre ai NO TAV, NO MOSE, NO PONTE, le Reti Contro i Rigassificatori e gli Inceneritori, i vari Comitati che lottano Contro le Basi Militari e in particolare il Comitato NO Dal Molin contro l’allargamento della base Usa di Vicenza 12 Ma d’altra parte solo gli arroganti Stati Uniti d’America, accecati dalla megalomania dell’invincibilità, potevano pensare, ancora una volta, che i popoli rimanessero passivi di fronte alla tragedia di una folle guerra di sterminio. La ribellione all’ingiustizia è il risultato di una precisa dinamica di eventi che genera, in chi subisce continue sopraffazioni, un incontenibile desiderio di riscatto della propria identità, in nome del diritto di ognuno a una vita dignitosa. Al livello dei popoli, tale istanza è giustamente sancita e ribadita nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Onu 1948), al terzo comma, e passa sotto il nome di «diritto alla ribellione». Pertanto, in Afghanistan, in Iraq o in qualsiasi altro luogo del pianeta vittima di una oppressione, la presenza di una resistenza organizzata è inevitabile. L’unipolarismo di oggi a guida Usa ha trasformato la guerra in una sorta di normalità giustificata da finalità etiche, essendo utilizzata come il miglior mezzo di prevenzione di tutti i mali dell’umanità. Ne consegue che l’economia, la scienza, la tecnologia, l’informazione e le stesse relazioni internazionali vengono utilizzate per massimizzare la capacità distruttiva di un apparato politico-militare sempre più potente, che vuole governare il pianeta in ogni sua dimensione e in ogni suo spazio territoriale. La Terza guerra mondiale, in corso per fasi, sta subendo ora un’accelerazione inaudita che non solo interessa le aree dei vecchi conflitti, come la regione me- diorientale dilaniata dalla drammatica questione palestinese, ma si estende anche a nuovi territori del pianeta, soprattutto in Africa. È in questo quadro che la Russia di Putin ha recentemente denunciato il sistema antimissile che gli Usa vogliono installare in Polonia e nella Repubblica Ceca, ammonendo che il cosiddetto scudo spaziale è una provocatoria operazione bellica contro la Russia e il mondo intero e rappresenta un pericolo per la pace e la distensione internazionale. La risposta russa allo scudo spaziale consiste nella minaccia di puntare i missili a testata nucleare verso l’Europa, se il progetto Usa dovesse andare avanti. Prima che sia troppo tardi, prima di entrare nella fase del non ritorno, la politica deve intervenire urgentemente per cambiare rotta e bloccare questa logica autodistruttiva. Occorre riprendere il cammino concreto del disarmo nucleare e dell’eliminazione degli arsenali militari nucleari e di qualsiasi altro tipo di armi di distruzione di massa (chimiche, batteriologiche ecc.). Il movimento contro la guerra e il ruolo delle basi militari straniere in Italia In questo quadro, dobbiamo affrontare la questione del ruolo delle basi militari straniere in territorio italiano, che il movimento contro la guerra indica come prioritaria e urgente ma che purtroppo ancora non è entrata come tema centrale nell’agenda politica. Riconvertire le basi militari straniere a usi civili non solo è un obbligo etico verso l’umanità, ma anche un obbligo sociale e economico in una situazione di crisi del nostro paese. Lo stesso discorso vale per la riduzione progressiva delle spese militari dei nostri soldati all’estero: non si può continuare a tagliare le spese sociali, per poi aumentare scandalosamente quelle militari del 13% – 15% come è avvenuto recentemente. L’Italia è il paese europeo che ha il maggior numero di basi: se ne calcolano circa 180. Esse di fatto sono funzionali al ruolo degli Usa come gendarme planetario, soprattutto rispetto ai paesi del Medio Oriente. Ma, da questo punto di vista, dobbiamo includere nel conto i sottomarini nucleari che transitano nei nostri mari senza piani di sicurezza in caso di incidente e il cui computo è fuori da qualsiasi trattato internazionale. La vicenda collegata alla richiesta Usa dell’allargamento-raddoppio della base militare Dal Molin a Vicenza è stata un ulteriore banco di prova della nostra politica. Prodi e il ministro degli Esteri, incapaci di ascoltare le ragioni della grande manifestazione del 17 febbraio 2007, non hanno saputo far tesoro della splendida lezione di democrazia testimoniata dai manifestanti e non hanno voluto tradurre le istanze del popolo pacifista in azioni politiche concrete. A seguito di questa insufficienza politica, il conflitto nel paese è destinato ad allargarsi a tutta la questione delle basi militari straniere, Usa e Nato, presenti in Italia. Si pensi ad Aviano, con le sue PACE E GUERRA 50 testate nucleari; o a Camp Darby (Livorno/Pisa), la base militare logistica Usa più grande d’Europa, con lo stoccaggio non solo di armi convenzionali ma anche di armi di distruzione di massa. Tutte le basi disseminate sul territorio italiano sono state installate tramite accordi segreti stipulati tra Italia e Usa, con grave limitazione della nostra sovranità territoriale e politica. Su questi temi è cresciuta una sensibilità politica di massa. La manifestazione vicentina del 17 febbraio non è stata solo la classica manifestazione contro la guerra; più specificatamente, essa è stata una manifestazione per la «Pace preventiva contro la guerra infinita di Bush e dei suoi alleati». La stessa grande manifestazione del 9 giugno a Roma, che ha visto la partecipazione di 150 mila persone contro la presenza di Bush in Italia, è da considerarsi uno spartiacque tra chi pensa che è ancora utile rimanere sudditi della politica estera Usa e chi, invece, vuole liberarsi delle basi militari straniere Usa e Nato. In queste mobilitazioni un ruolo importante è stato svolto dal Patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso costituitosi il 14 luglio 2006, nella sala della protomoteca del Campidoglio a Roma, a conclusione della carovana NO TAV Venaus-Roma, a cui avevano aderito comitati, reti, movimenti, gruppi che si battono contro la logica delle «grandi opere». È la dimostrazione che la solidarietà paga e che la sovranità del nostro paese deve ritornare nelle mani del popolo. Come ci ricorda la partigiana Teresa Mattei, la più giovane parlamentare che partecipò ai lavori della Costituente, «l’essenza della sovranità è nella partecipazione». Tra i primi firmatari del Patto nazionale di solidarietà e mutuo soccorso si ricordano oltre ai NO TAV, NO MOSE, NO PONTE, le reti contro i rigassificatori e gli inceneritori, i vari comitati che lottano contro le basi militari e in particolare il comitato NO Dal Molin contro l’allargamento della base Usa di Vicenza. L’analisi del Patto di Mutuo Soccorso è chiara: l’Italia, disseminata di basi militari Usa e Nato, è di fatto una grande base logistica funzionale alla guerra preventiva e permanente, dettata dalla logica della globalizzazione economica che attiva il terrore su scala planetaria. Interpreti primi di questa filosofia di morte sono gli Usa, ma 13 anche gli stati europei (e tra loro l’Italia), che affiancandosi a una simile politica di guerra rischiano di diventarne corresponsabili. Nel nostro paese si verifica l’assurdo che, invece di riconvertire le attuali basi straniere a usi civili, come richiesto dal movimento pacifista, si accetta servilmente il progetto Usa di ampliare le proprie basi in territorio italiano, come nel caso di Vicenza, magari per il prossimo annunciato attacco contro l’Iran, colpevole di voler sviluppare l’uso pacifico dell’energia nucleare. Ciò è assurdo e contraddittorio. Si dice che l’Iran potrebbe costruire la bomba atomica. Ma gli Usa, che fanno questa accusa, hanno già arsenali pieni di armi di distruzione di massa, incluse bombe atomiche e al neutrone, capaci di distruggere più volte l’intero pianeta. Il variegato popolo pacifista che ha manifestato a Vicenza contro la base militare Usa e il 9 giugno a Roma contro la presenza di Bush – e che continuerà a manifestare in Italia contro le basi di Camp Darby, di Aviano e di tutte le altre località per la loro riconversione a usi civili – non è fatto di visionari, ma unicamente di uomini e donne coscienti della gravità della posta in gioco per il presente e il futuro dei propri figli e dell’intera umanità. Nell’epoca del neoliberismo globalizzato le guerre sono diventate la norma per risolvere le controversie internazionali, l’industria bellica è il motore centrale dell’economia mondiale nonché la fonte primaria di inquinamento e di rapina delle risorse naturali. La stessa specie umana, così come denunciato a livello internazionale dagli scienziati del Bollettino scienziati atomici (Ong statunitense) è a rischio di estinzione: le lancette dell’orologio della catastrofe si sono spostate in avanti di due minuti e il quadrante simbolico della fine del mondo è passato da sette a cinque minuti prima della mezzanotte. Dal 17 gennaio 2007 gli scienziati sostengono che l’ora zero della fine del mondo è più vicina. E il grande astrofisico Stephen Hawking ha affermato che i cambiamenti cli- 14 matici costituiscono una minaccia molto più grave del terrorismo, tanto enfatizzato dall’occidente. È dunque fondamentale dire un chiaro NO alle grandi opere inutili, dannose e pericolose, a partire dalle basi militari, in quanto strumenti planetari di distruzione e di morte. Primario, per il Patto nazionale di mutuo soccorso, è il diritto alla preventiva informazione e partecipazione attiva dei cittadini alle scelte in merito a ogni intervento si voglia operare sui territori in cui essi vivono, condividendo il principio in base al quale i beni comuni (acqua, terra, aria, energia) devono essere tutelati, sempre e comunque, a partire dalle istituzioni locali. Il Governo in carica dovrebbe dar prova di maggiore saggezza, sospendendo l’autorizzazione agli Usa per l’ampliamento della base militare Dal Molin, aprendo un Tavolo di confronto nazionale e coinvolgendo le associazioni e i movimenti, al fine di affrontare l’urgente questione della presenza delle basi militari straniere nel nostro paese. Sarebbe, questa, una pratica di democrazia vera e auten- tica, che finalmente rinuncerebbe a trincerarsi formalmente dietro trattati internazionali, obsoleti e tenuti illegalmente segreti al nostro Parlamento. Un interrogativo di fondo è infatti sin qui rimasto senza risposta: perché la Nato deve sopravvivere, anche se sono venute a mancare le ragioni storiche e politiche della sua esistenza come alleanza militare difensiva decisa nel 1949? Il muro di Berlino e il Patto di Varsavia non ci sono più. È sotto gli occhi di tutti la trasformazione della Nato da patto difensivo ad alleanza militare «offensiva» secondo un’ottica di prevenzione, finalizzata a garantire all’Occidente la sicurezza delle fonti energetiche e a tutelare i suoi interessi economico-politici nonché il suo modello di democrazia. Tutto questo è stato decretato in un Summit del 1999 e si colloca totalmente al di fuori dell’art. 5 dell’atto costitutivo del Patto Atlantico. Da sempre la Nato è stata pilotata dagli Usa, ma col nuovo ordine internazionale unipolare inaugurato dopo il 1989 ciò si è manifestato in modo eclatante. Non a caso, l’attuale Capo militare della Nato è un generale statunitense. Nei Balcani la Nato ha sostituito l’Onu, in Afghanistan ha scatenato la prima guerra preventiva, effettuando bombardamenti criminali e insediando basi militari che mirano direttamente a minacciare l’Iran. La Nato ha elaborato una nuova visione del concetto di «minaccia», che si è esteso a tal punto da includere i fondamentalismi e l’Aids; per questa via, si è arrivati ad autorizzare strutture di cooperazione umanitaria sotto il controllo militare Nato (PRT). Un tale ampliamento di nuove e arbitrarie sfere di intervento Nato dovrebbe imporre una seria riflessione sulla necessità di mantenere o meno il Patto Atlantico. Occorrerebbe anche interrogarsi sul perché l’Italia debba rimanere suddita della politica bellicista e neoimperiale Usa e sul perché l’Europa non riesca a elaborare in tempi rapidi una sua autonoma politica di difesa rispetto al modello americano. In definitiva, sulla questione delle basi militari straniere è in gioco la sovranità territoriale e politica dell’Italia dettata dalla Costituzione, la nostra stessa dignità nazionale e il nostro ruolo etico di paese di pace nel Mediterraneo e nel mondo. Secondo quanto recita l’articolo 11 della nostra costituzione: «L’Italia ripudia la guerra». PACE E GUERRA base militare a Vicenza la Costituzione è un optional V ALDEMARO B ALDI * Le basi militari americane oggi esistenti in Italia godono del diritto di extraterritorialità, il che significa che il territorio che occupano è sottratto alla giurisdizione italiana, in forza di un trattato di diritto internazionale col quale lo Stato italiano ha rinunciato alla propria sovranità sul territorio medesimo in favore degli Stati Uniti * PRC-COLLEGIO DI GARANZIA NAZIONALE L a dottrina costituzionalistica più recente ha definito il territorio dello Stato come «il luogo della sovranità statale entro il quale lo Stato dispone dello jus excludendi alios» (cfr. Livio Paladin, Diritto Costituzionale, Padova 1998). Secondo questa dottrina l’esercizio del diritto di escludere gli altri viene assunto come criterio per l’individuazione del territorio di uno Stato per cui si può dire che il territorio statuale coincide con quello dove materialmente lo Stato esercita la propria sovranità. Deriva da ciò, per corollario, che il passaggio di sovranità da uno Stato all’altro sopra una porzione di territorio importa una variazione territoriale che può essere definitiva o temporanea a seconda dei casi. Le cause che determinano la variazione di sovranità, e quindi di territorio, sono di varia natura e vanno dall’occupazione violenta all’accordo pattizio. Entro questi estremi si trova una ampia casistica che non è qui il caso di esaminare. Vogliamo invece soffermarci sugli accordi pattizi, che si concretizzano in trattati internazionali, per i quali uno Stato cede a un altro Stato porzioni di territorio su cui lo stato cedente non esercita più la propria sovranità per sempre o per un periodo determinato. Il caso più noto, per le violazioni dei diritti umani che vi si compiono – ma anche perché rappresenta un caso limite per il tipo di accordo internazionale che lì è stato fatto – è la base militare americana di Guantanamo dove la sovranità è stata ceduta dallo Stato di Cuba agli Stati Uniti nel 1903 (trattato rinnovato nel 1934) per un periodo indeterminato il cui termine è lasciato alla decisione degli americani di andarsene. Recentemente la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto che la base di Guantanamo è territorio sul quale gli Stati Uniti esercitano «controllo e giurisdizione esclusiva». In definitiva la rinuncia pattizia all’esercizio di sovranità su di un territorio da parte di uno Stato a favore di un altro concreta una variazione territoriale dello stato cedente. È possibile questo nel nostro ordinamento? È possibile. Le basi militari americane oggi esistenti in Italia godono del diritto di extraterritorialità, il che significa che il territorio che occupano è sottratto alla giurisdizione italiana, in forza di un trattato di diritto internazionale col quale lo Stato italiano ha rinunciato alla propria sovranità sul territorio medesimo in favore degli Stati Uniti. Trattati di questa natura la nostra Costituzione li ammette all’art. 80 che recita: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». La Costituzione consente quindi alle variazioni territoriali (id est della sovranità nazionale) dello Stato italiano: alla condizione che la ratifica del trattato internazionale che le prevede sia autorizzata dal Parlamento «con legge». Nel nostro ordinamento cioè la dismissione di sovranità su una porzione di 15 LETTERA APERTA DALLA REPUBBLICA CECA Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente lettera aperta di Jan Neoral, sindaco del comune di Trokavec, a Tomas Klvaňa, portavoce del governo della Repubblica Ceca e responsabile per la promozione dell’installazione del radar Usa sul territorio ceco. Si tratta di un significativo documento che testimonia del duro confronto in atto nel suddetto paese su un tema che – come nello scorso numero della nostra rivista ha ricordato Giulietto Chiesa – al di là dell’impatto interno costituisce un delicatissimo snodo per l’Europa e, in generale, per le prospettive di pace. Mr. Klvaňa, lei sta mentendo! 16 E territorio nazionale non è lasciata alla decisione del Governo, ma deve essere autorizzata con un provvedimento legislativo primario – la legge – dopo un dibattito parlamentare e un voto di Camera e Senato. Ora, se rapportiamo tutto quanto detto sopra alle vicende della base militare americana di Vicenza, vediamo due cose: la prima è che il raddoppio dell’estensione territoriale della base, determinando una dismissione di sovranità, costituisce una variazione di territorio; la seconda è che a questa variazione territoriale corrisponde un onere finanziario dello stato italiano non fosse altro perché sottrae terreni e costruzioni edilizie all’imposizione fiscale. In ambedue i casi siamo di fronte alla fattispecie prevista dall’art.80 della Costituzione. Ma allora sorge una domanda: con quale legge il Parlamento ha autorizzato il Governo alla ratifica dell’accordo col quale si consente di ampliare territorialmente la base militare americana di Vicenza? La domanda non riguarda solo questo governo, ma anche quelli precedenti e la risposta ha valenze diverse a seconda di chi deve rispondere. Perché, se il governo attuale ha trattato con gli Stati Uniti per ampliare la base, deve presentarsi in Parlamento con una proposta di legge di ratifica dell’accordo; se invece a trattare è stato il governo Berlusconi e lo ha fatto senza presentare il testo dell’accordo alle Camere per ottenerne l’autorizzazione alla ratifica, ha violato la Costituzione e perciò gli accordi presi non hanno alcun valore giuridico e l’attuale governo Prodi non è tenuto a rispettarli. Continuare a insistere, come si è fatto ancora in questi giorni, che la questione della base militare americana di Vicenza è solo un problema urbanistico, non ha senso; si tratta di un problema che prima di essere urbanistico (ed è anche quello) è tanto politico da investire persino la correttezza costituzionale dei governi. Sarebbe bene che si richiedesse una risposta convincente anche su questo versante della questione. gregio Signore, la stampa ha reso noto che lei intende far visita ai sindaci e ai rappresentanti delle municipalità dell’area di Brdy, mirando a superare le loro resistenze all’installazione di un radar Usa. Nello stesso tempo, la stampa ci informa del fatto che pubblico e giornalisti sarebbero esclusi dalle relative trattative; e che lei ha rifiutato di spiegarne la ragione. Si tratta di una manifestazione di arroganza senza precedenti, al pari del diniego della democrazia e del diritto all’informazione. Come sindaco di questa cittadina, ho il dovere di mantenere rapporti di comunicazione con gli organismi statuali della Repubblica Ceca: questi – anche se mentono al popolo, non rispettano le loro stesse promesse e non tengono in alcun conto l’opinione di quasi i tre quarti dei cittadini di questo paese – purtuttavia sono stati eletti in modo democratico. Ma io non sono affatto obbligato ad avere rapporti con lei in quanto direttore della British American Tobacco, con lei che da nessuna parte è stato eletto dai cittadini. Non sono obbligato a interloquire con chi, sulla base del suo contratto ed essendo retribuito con pubblico denaro (dunque con le tasse che noi paghiamo), vuol costringere la popolazione ad accettare un impianto su cui grava il serio sospetto di arrecare danno alla salute delle persone e all’ambiente circostante; nonché di mettere in pericolo, per il suo impatto internazionale, le loro case e la loro sicurezza. Signor portavoce, lei sta mentendo. Lei ripete le bugie dette dal nostro governo e da alcuni politici. E offende noi sindaci: come quando, sul quotidiano on line «Popular Newspaper» lo scorso 10 luglio 2007, ha commentato in termini ingiuriosi sia il passato che la cosiddetta retorica dei sindaci che si oppongono al radar. Per tutto questo, io respingo la sua visita, le chiedo di non far visita alla nostra municipalità. Noi non accettiamo di trattare con lei. Jan NEORAL, Sindaco del comune di Trokavec PACE E GUERRA economia all’uranio impoverito C ARLOTTA N AO * Riceviamo (da Franca Rame e Carlotta Nao) e volentieri pubblichiamo l’articolo seguente È L’uranio impoverito è un metallo pesante, radioattivo, ad alta capacità piroforica: un materiale perfetto per costruire ordigni bellici. Ed ecco come smaltire i rifiuti tossici radioattivi a costo zero: fabbricando ordigni da scaricare lontano dal luogo dove sono prodotti possibile immaginare una differenza tra un soldato ucciso durante una missione all’estero da un colpo d’arma da fuoco o da un attentato, e uno che si consuma lentamente tra le mura domestiche e sotto gli occhi dei suoi familiari a causa dell’uranio impoverito che l’ha contaminato in «Missione di pace»? Il primo torna in patria in un feretro tricolore, con funerali di stato e indennizzi alla famiglia; il secondo invece, spesso rimane senza neppure una lapide, senza risarcimenti, senza onori. Alle volte arriva l’aumento dei gradi, una promozione a titolo onorario, quando il soldato è già deceduto. Anche la morte ha un’economia: i familiari dei carabinieri deceduti a Nassirya ricevono risarcimenti cospicui, che le famiglie con perdite a causa dell’uranio non hanno: in alcuni casi hanno ricevuto indennizzi pari a 258,23 euro al mese. La morte non guarda in faccia nessuno, ma la Difesa sì: si sceglie da sola gli «eroi della patria», è necessario morire con onore. Consumarsi con dolore non basta. Lasciando a margine il tema delle missioni all’estero, del loro carattere sempre più offensivo e belligerante, concentriamo l’attenzione sui militari, i quali poco più che ventenni, per convinzione, e molto più spesso per assenza di valide opportunità di lavoro, si arruolano, partono in missione. Sei mesi, uno, due anni, e al loro ritorno li attende una bella cifra, con la quale pianificare qualche passo di futuro: una casa, una macchina, un matrimonio. Un ventenne ha molte aspirazioni per la testa, ma di certo raramente ha sentito parlare di DU238 Depleted Uranium. È l’uranio impoverito, scarto della lavorazione dell’uranio «U-235», usato per la produzione di energia nucleare a scopi civili. T * COLLABORATRICE PARLAMENTARE utti i paesi che utilizzano centrali atomiche hanno il problema di smaltire le scorie, ma il costo è altissimo e le procedure molto meticolose. L’uranio impoverito è un metallo pesante, radioattivo, ad alta capacità piroforica: un materiale perfetto per costruire ordigni bellici. Ed ecco come smaltire i rifiuti tossici radioattivi a costo zero: fabbricando ordigni da scaricare lontano dal luogo dove sono prodotti. Noi esportiamo democrazia: le vittime civili e i rifiuti nucleari sono un piccolo sovrapprezzo. Ma, si sa, nulla è gratis! Non importa se una risoluzione dell’Onu ne vieta l’utilizzo in campo bellico, non importa se il Pentagono, nel 1978, dopo averli sperimentati nel poligono militare di Heglin dice: «il materiale prelevato ed esaminato post esplosione ha evidenziato la presenza di un particolato talmente sottile che potrebbe provocare seri danni a chi lo respira senza alcuna protezione». Una diagnosi che non lascia scampo e diventa un boccone prelibato per chi con la vita ha un rapporto distaccato e superbo: la nuova frontiera è sperimentare gli effetti sugli uomi- 17 18 ni. La guerra del Golfo è l’occasione giusta. I risultati sono devastanti: cancro, leucemie, gravissime patologie, feti malformati non solo tra i civili che abitano i territori bombardati, ma anche tra gli stessi militari americani. Constatata la grande pericolosità delle munizioni all’uranio impoverito, lo stesso Pentagono produce e distribuisce a tutti gli alleati una videocassetta in cui si illustra come individuare un obiettivo colpito da uranio impoverito, come proteggersi e come procedere alla bonifica del posto in cui si trova l’oggetto. S ono importanti questi indirizzi, soprattutto per gli alleati che si troveranno a operare con gli Stati Uniti che utilizzano queste armi. Scoppia il conflitto in Bosnia Erzegovina, i Balcani diventano un teatro di guerra importante dal punto di vista di «sperimentazione attiva»: 30.000 tonellate di uranio impoverito vengono scaricate sul suolo della ex Repubblica di Jugoslavia. Siamo nel ‘99, in Italia la situazione politica interna è incerta, il governo D’Alema è combattuto tra americanisti e anti-americanisti, ci si arrovella sull’interpretazione dell’articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra? Oppure se si partecipa sotto l’egida della Nato è una guerra giusta? Nel frattempo nelle caserme non si sta a pensare: la partenza è alle porte. Avvengono vaccinazioni di massa, una sull’altra, senza rispettare protocolli e norme, si affastella l’organizzazione della missione e si lasciano a casa le protezioni per l’uranio impoverito (tute, guanti, maschere), non c’è tempo neppure per istruire i soldati a riconoscere i rischi legati all’uranio; nessuno dice loro di non avvicinarsi ai proiettili esplosi e alle cariatidi colpite da proiettili all’uranio, come illustra l’opuscolo distribuito dagli americani agli Stati Maggiori degli alleati. I vertici della difesa erano quindi al corrente, ma l’informazione non è arrivata ai ragazzi in missione. Sono oggi 542 i soldati italiani ammalati, quarantasette quelli già deceduti di cui si ha notizia, è fuori dubbio che vi siano molti altri casi. Nel silenzio assordante delle istituzioni, che non vogliono ammettere di aver inviato truppe allo sbaraglio senza alcuna informazione né protezione. Nessuno intende farsi carico della responsabilità dei danni provocati, e quindi non vengono erogate le pensioni, né sono fornite le cure necessarie. Da una parte c’è l’apparato militare che si nasconde dietro un muro di omertà invocando il segreto militare, dall’altra la politica che lascia cadere l’istanza, chi perché riceve finanziamenti dai costruttori d’armamenti, chi perché era al Governo al tempo in cui si approvarono le missioni. Già, i militari. E i civili? Che dire dei civili residenti nei paesi coinvolti dai bombardamenti all’uranio? Iraq, Kosovo, Bosnia e Afghanistan rimarranno contaminati per milioni di anni. Chi è sopravvissuto ai bombardamenti, dovrà sfidare acque e terreni avvelenati, lotterà per non avere figli malformati, contro leucemie e tumori: accade che da quelle parti non esistano solamente perché spesso non c’è nessuno che possa diagnosticarli. E noi, che abbiamo donato la gioia della «democrazia occidentale», voltiamo le spalle. D a ultimo, vogliamo menzionare una buona notizia. C’è uno Stato che ha deciso di assumersi la responsabilità delle sue azioni: il Belgio, nel marzo di quest’anno, ha messo al bando l’uso dell’uranio impoverito. Speriamo sia capofila di una lunga serie di paesi, tra i primi il nostro. Infine una riflessione. Fare la guerra rimarrà un business fino a quando i conflitti alimenteranno le ricchezze delle lobby degli armamenti e gli Stati non saranno chiamati a farsi carico dei costi di bonifica e decontaminazione dei territori avvelenati con armi di questo tipo, oltre che dei danni inferti alle vittime civili. Se è vero che il mondo politico come lo conosciamo si muove in funzione di capitali, allora è necessario impegnarsi affinché chi inquina, devasta, uccide e bombarda, paghi. È stata aperta una sottoscrizione in aiuto degli ammalati da uranio impoverito e le loro famiglie. A oggi sono stati raccolti oltre 26.000 euro. Ogni contributo, di qualsiasi cifra, sarà prezioso. Grazie. Conto corrente per la sottoscrizione in favore delle vittime dell’Uranio Impoverito: ccp n. 78931730 intestato a Franca Rame e Carlotta Nao ABI 7601 – CAB 3200 Cin U. POLITICA ED ECONOMIA pensioni e welfare implosione sociale e sinistra «in cerca d’autore» D INO G RECO * L’impegno elettorale assunto nei confronti dei tanti giovani (e non solo) che sono costretti ad attraversare le forche caudine del lavoro senza senso umoristico definito «atipico», si è così convertito in una sorta di manutenzione ordinaria della legislazione esistente. Abbiamo presto capito che nulla di sostanziale sarebbe mutato e che avremmo ancora dovuto fare i conti, in Italia, con quel monstrum giuridico che è il lavoratore «parasubordinato», una figura né carne né pesce, sconosciuta nel resto d’Europa * GGIL-DIRETTIVO NAZIONALE 1 Quando, sino a poco meno di due anni fa, governava il centrodestra, la sinistra moderata spiegava che una cosa era il «pacchetto Treu» (la flessibilità «buona») e un’altra la legge«30», foriera di precarietà nel lavoro e, specularmente, nella vita. Il programma dell’Unione tentò in seguito di andare oltre l’una e l’altra, cogliendo la necessità di una più profonda revisione della legislazione in materia di mercato del lavoro, tale da porre qualche argine a un rapporto fra lavoro e capitale platealmente sbilanciato a favore di quest’ultimo. Poi, una volta al governo, l’intento riformatore è andato progressivamente sfocandosi sotto i colpi di freno della Confindustria e di quella parte del sindacato che avendo condiviso il «patto per l’Italia» non se ne era mai pentita. L’impegno elettorale assunto nei confronti dei tanti giovani (e non solo) che sono costretti ad attraversare le forche caudine del lavoro senza senso umoristico definito «atipico», si è così convertito in una sorta di manutenzione ordinaria della legislazione esistente. Abbiamo presto capito che nulla di sostanziale sarebbe mutato e che avremmo ancora dovuto fare i conti, in Italia, con quel monstrum giuridico che è il lavoratore «parasubordinato», una figura né carne né pesce, sconosciuta nel resto d’Europa, un «ircocervo», come ebbe a definirlo, ricorrendo a un’immagine mitologica, il compianto Giorgio Ghezzi. Di più. Si è cominciato a spiegare che non è della flessibilità, in quanto organica e funzionale a un buon funzionamento dell’impresa moderna, che bisogna preoccuparsi, quanto piuttosto del sistema degli ammortizzatori sociali, da noi alquanto povero per qualità ed estensione. E pazienza se, al dunque, come abbiamo visto, anche su questo terreno si è investito ben poco, diciamo una somma pari a quella che il solo finanziere bresciano Chicco Gnutti ha frodato al fisco dimenticando di pagare le tasse sulla vendita di Telecom a Tronchetti Provera. Il cuore del ragionamento sta infatti in questo: lo Stato, la legislazione non debbono irrigidire i rapporti di lavoro, perché ciò che è razionale per l’impresa lo è anche per l’economia e per il paese. Al punto che persino istituti scarsamente o per nulla utilizzati dai datori di lavoro, come il lavoro a chiamata (job on call), o il lavoro somministrato a tempo indeterminato (staff leasing), dei quali il governo aveva data per certa l’abolizione, continuano a sopravvivere, insieme alla vergognosa reiterabilità ad libitum dei rapporti di lavoro a termine, condanna inestinguibile dei forzati della precarietà. Insomma, la nuova linea della politica governativa in materia di mercato del lavoro è che quel che si può fare lo si fa – se lo si fa – a valle del processo produttivo, mai e poi mai con un intervento disturbante dei rapporti di produzione, di potere di cui l’impresa è e deve rimanere il solo soggetto regolatore. Non dovrà sorprendere se, su questa scia, prima o poi tornerà in auge l’attacco allo statuto dei lavoratori e a quell’articolo 18 che solo qualche anno fa la Cgil e i lavoratori hanno difeso con le unghie e con i denti. In conclusione, appare chiaro come la legge del 2003 si muova lungo una linea di sostanziale continuità 19 20 con quella del ’98. Quest’ultima ne ha rappresentato, per così dire, l’archetipo. Poi, la destra, su quelle fondamenta, con metodica ferocia, ha innalzato un edificio di venti piani. Ma le coordinate erano già tracciate. Ecco allora che la politica che sta prevalendo nel governo è quella di un blairismo in sedicesimo: poco welfare e persino poco workfare, molta flex e poca security. 2 Veniamo alla partita delle pensioni. Il confronto fra governo e sindacati ha avuto qualcosa di surreale, perché la realtà, i dati di fatto, i conti dell’Inps, le proiezioni di spesa, depurate da quanto di arbitrario e di palesemente contraffatto era presente nelle posizioni dell’esecutivo, non hanno avuto alcun peso nel negoziato. Da quel tavolo sono scomparsi il merito, l’argomentazione rigorosa. La discussione, destituita di ogni serietà contabile, è stata sin dall’inizio condizionata, anzi, sovradeterminata dall’imperativo che un nuovo intervento strutturale sul sistema pensionistico doveva essere assolutamente realizzato. La perfidia ideologica con cui il Fmi, la Banca centrale, la Banca d’Italia, l’Unione europea e, ovviamente, la Confindustria hanno incessantemente battuto su quel chiodo, ha avuto il sopravvento. Ancora una volta, quel programma dell’Unione che dimostrava – si badi, in un quadro economico ancora stagnante se non addirittura recessivo – come non esistesse un problema di sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico italiano, quanto piuttosto un grave problema di sostenibilità sociale, viene progressivamente rimosso. La riforma «Maroni», il cosiddetto «scalone», non sarà più da abolire, ma, semplice- mente, da «ammorbidire»: non è più in discussione la linea di marcia, ma soltanto il tempo entro il quale diluirla. In realtà, abbiamo visto come sia l’intero impianto dell’accordo del 23 luglio che fa acqua: l’età pensionabile, a regime, nel 2013, sarà comunque di 61 anni, ma comporterà un requisito contributivo di 36 anni, superiore di un anno a quello fissato dalla legge «Maroni»; requisito quest’ultimo che varrà anche per la platea dei cosiddetti lavoratori «usurati», poiché lo sconto di tre anni a essi concesso agisce sull’età anagrafica, ma non su quella contributiva! La stessa possibilità di coniugare in modo variabile età anagrafica ed età pensionabile (le cosiddette «quote»), così da rispondere flessibilmente a diverse esigenze dei pensionandi è stata talmente edulcorata da risultare impalpabile. Ancora: le finestre d’uscita per quanti andranno in pensione con i quarant’anni di contribuzione vengono riportate a quattro, ma l’identico meccanismo varrà anche, d’ora in poi, per le pensioni di vecchiaia, in quanto è scritto, nero su bianco, che l’operazione deve essere compiuta a costo zero e che, dunque, l’una misura deve compensare l’altra. E i giovani, a proposito dei quali sono state somministrate dosi massicce di retorica? Si ricorderà la polemica sui coefficienti di rivalutazione delle pensioni, secondo il governo da ritoccare verso il basso, mentre sarebbe necessario un percorso esattamente inverso, visti gli effetti devastanti sulle rendite pensionistiche future di quanti sconteranno il micidiale «mix» fra sistema di calcolo contributivo e precarizzazione/sottocontribuzione del lavoro. Bene: al riguardo l’accordo prevede l’apertura di un confronto che dovrebbe (il condizionale non è di chi scrive, ma del testo) determinare una protezione delle pensioni più basse, collocandole a una soglia prossima al 60% della retribuzione ma, contemporaneamente, si fa riferimento a un tetto di spesa complessiva ridotto del 68%. Come sarà possibile, allora, elevare la rendita pensionistica con meno risorse? Evidentemente, non si potrà! Insomma, l’invarianza della spesa sociale è a tal punto l’assillo del governo, che in caso di scostamento verso l’alto dei costi si prevede, sin d’ora, l’aumento di un decimale di punto della contribuzione a carico dei lavoratori. Poi, la «chicca» finale, la detassazione delle ore di lavoro straordinario (altro beneficio elargito «a pioggia» alle impre- POLITICA ED ECONOMIA se), ispirata alla geniale trovata secondo la quale è solo lavorando di più che si può racimolare qualche denaro. Ora, a parte il fatto che una simile misura contrasta palesemente con l’esigenza di aumentare i posti di lavoro, il tasso di popolazione attiva e le entrate fiscali e contributive corrispondenti, ricorderà il ministro Damiano, ex sindacalista, che il prolungamento della giornata lavorativa figura come una delle più ricorrenti cause di infortunio? 3 La minaccia, «attenzione che se il governo cade torna Berlusconi», ha funzionato come un potente freno inibitorio che ha nascosto in realtà propensioni politiche reali, ben presenti nel gruppo dirigente della Cgil e potentemente rilanciate dalla gestazione del Pd che proprio nella Cgil ha svolto e sta tuttora svolgendo un’intensa campagna di reclutamento Come è agevole constatare, è sull’intera latitudine del confronto (e non sulle sole misure che hanno implicazioni economiche) che viene in mostra il tratto della politica sociale del governo. In ogni caso, il rovesciamento dei proclami elettorali è di un’evidenza palmare. Basti pensare che le risorse messe a disposizione per l’insieme delle partite sociali aperte rappresenta una modesta quota del surplus fiscale, dell’extragettito. Ed è ragionevole chiedersi come avrebbe potuto concludersi il negoziato di luglio se neppure quelle impreviste risorse fossero state disponibili. Mentre, nello stesso tempo, ben altra dimensione hanno avuto i trasferimenti alle imprese (cuneo fiscale, risarcimento per la quota di Tfr inoptato confluito presso l’Inps ecc.) e mentre nuove e non poco consistenti prebende vengono annunciate, sia pure sotto forma di un discutibilissimo scambio fra incentivi (pur sempre, in qualche misura, mirati e dunque finalizzati a uno scopo) e riduzione delle imposte. Più in generale, è tutta la linea di politica economica del governo a essere sottoposta a un’intensa fibrillazione. Si pensi alla lotta all’evasione fiscale che – sia pure nei suoi ancora iniziali approcci – costituisce l’elemento di più significativa discontinuità rispetto alla criminale istigazione a delinquere del governo di centrodestra: è bastato che quest’ultimo scatenasse un’indecente campagna di sapore eversivo, con un ventaglio di minacce che va dallo sciopero fiscale alla spacconesca entrata in azione delle doppiette padane, perché il governo rinculasse, promettendo un’incomprensibile «tregua fiscale» nella prossima finanziaria e bacchettando severamente quanti, nel governo medesimo, hanno chiesto di procedere all’allineamento della tassazione delle rendite da capitale, in linea con la media europea e in coerenza con un orientamento già assunto e contenuto nel Dpef. Quanto al tema del debito, è noto come la forsennata accelerazione impressa al rientro della esposizione finanziaria dell’Italia abbia condizionato (e contratto) le disponibilità di spesa. Nessuno trascura il fatto che gli interessi sul debito erodano l’avanzo primario e compromettano la capacità di investimento produttivo e sociale del paese e che una linea di risanamento si imponga. Quello che è invece gravemente sbagliato è l’autentica ossessione monetarista che ha impresso un ritmo di rientro a tappe forzate, destinato fatalmente a stressare il paese, a minare il consenso degli strati sociali più deboli che attendono legittimamente una risposta redistributiva ben altrimenti consistente e tale, in ogni caso, da indicare una netta inversione di marcia che invece, fatalmente, non c’è stata. Tutto ciò è francamente paradossale, a maggior ragione se si rammenta che la legge vigente sull’amministrazione straordinaria (che – ironia della sorte – porta proprio il nome dell’attuale Presidente del Consiglio), strumento estremo per trarre le imprese da situazioni di dissesto finanziario, prevede proprio il congelamento del debito, il pagamento dei salari correnti, dei fornitori, così da rimettere in moto un circolo virtuoso che, solo, può consentire a quell’impresa di sopravvivere prima e di soddisfare i propri creditori poi. La linea del governo è apparsa dunque lontana persino dalle buone, collaudate pratiche delle social-democrazie, per cui a una forte e progressiva imposizione fiscale corrisponde un altrettanto robusto sistema di protezione sociale, di servizi (previdenza, assistenza, ammortizzatori sociali, sanità, istruzione ecc.). 21 22 In definitiva, la tensione crescente che si è accumulata dentro la compagine governativa non è il prodotto di chissà quali accelerazioni impresse dalla sua parte mancina, ma da una sostanziale rimozione del patto di governo. 4 Sul fronte sociale, è importante comprendere l’evoluzione politica intervenuta nel più grande sindacato italiano, la Cgil, che grande parte ebbe nel mettere in crisi il governo di centrodestra (ricordate la lotta per la difesa dell’articolo 18, per i diritti nel lavoro, contro il declino industriale?) il quale aveva fatto della crociata contro il lavoro il proprio connotato identitario. Ora, nella relazione d’apertura del XV congresso della Cgil, in piena campagna elettorale, Guglielmo Epifani offrì a Romano Prodi, qualora l’Unione avesse vinto le elezioni, un «patto di legislatura», formula ardita, anche per un sindacato «concertativo», perché fatalmente incline ad attivare meccanismi di collateralismo consociativo, alquanto lesivi di quel bene prezioso che è l’indipendenza del sindacato da qualsiasi governo, anche da quello a sé non ostile o che tale si dichiara. Quell’intemerata fu poi prudentemente corretta dal dibattito e non fu più ripresa da Epifani nelle conclusioni, né – tantomeno – nel documento finale del congresso. E tuttavia essa ha marciato, prima sotto traccia, poi apertamente, quando, a elezioni avvenute, al sindacato è stato chiesto di non tirare troppo la corda nei confronti di un governo che si reggeva su equilibri tanto precari. La minaccia, «attenzione che se il governo cade torna Berlusconi», ha funzionato come un potente freno inibitorio che ha nascosto in realtà propensioni politiche reali, ben presenti nel gruppo dirigente della Cgil e potentemente rilanciate dalla gestazione del Pd che proprio nella Cgil ha svolto e sta tuttora svolgendo un’intensa campagna di reclutamento. Così, il perimetro dell’azione della Cgil è andato via via reiscrivendosi entro precise norme di comportamento che si possono così riassumere: a) l’unità preliminare, come prius, con la Cisl e con la Uil che archivia come impraticabile qualsiasi iniziativa unilaterale della Cgil; b) l’interdizione della mobilitazione e il mantenimento della polemica con il governo entro i canali della pura diplomazia; c) la moderazione delle richieste, inscritte nel quadro di compatibilità fissato dal governo. Va da sé che una trattativa dalle implicazioni sociali e politiche che conosciamo (pensioni, welfare, mercato del lavoro, fisco ecc.) si è svolta in un rapporto a dir poco lasco con i lavoratori, ai quali è stata sostanzialmente recapitata una piattaforma unitaria, a maglie larghe, onnicomprensiva, non soggetta ad approvazione alcuna: le assemblee nei luoghi di lavoro sono state puramente informative e ricognitive di proposte e suggerimenti che, sebbene copiosamente pervenuti, non hanno modificato – come era scontato – neppure la punteggiatura di quel testo. Con queste premesse, con una mobilitazione assente o a bassissima intensità e di pura immagine, l’esito del confronto è stato esposto a sistematiche incursioni, a veti, a mediazioni quasi sempre esterne al contraente sindacale. I contrasti fra le forze politiche, persino le bizze fra ministri a gara nel contraddirsi l’un l’altro, hanno fatto sì che persino le minacce di una Emma Bonino o di un Lamberto Dini pesassero di più rispetto a organizzazioni che trattavano in rappresentanza di milioni di lavoratori e di pensionati. Sicché, alla fine, alla Cgil è toccato fare buon viso a cattivo gioco, ingoiando insieme al rospo anche qualche sonoro e umiliante ceffone quando Epifani ha chiesto – del tutto snobbato – di poter sottoscrivere soltanto i punti condivisi e non l’intero protocollo. Quanto è accaduto è dunque un episodio di pessimo sindacalismo e tale rimarrà quale che sia l’esito di una consultazione che ora si vuole rigidamente blindata da schiere di sindacalisti allineati come un sol uomo a difendere nelle assemblee la POLITICA ED ECONOMIA qualità del rancio, immancabilmente «ottimo e abbondante». Credo che sarà dura. E che non lo sarà di meno la reazione di quanti sanno «far di conto», vale a dire la parte più sindacalizzata del movimento, quella senza la quale sarebbe tutto il sindacalismo italiano a smarrire la propria peculiare identità. Quel che più temo non è la sacrosanta incazzatura di chi deciderà di rendere esplicito il proprio dissenso e di ingaggiarsi in una forte lotta politica interna. Pavento invece lo scoramento, l’abbandono, la deriva verso il disimpegno e il conseguente, ulteriore indebolimento del sindacato, delle ragioni di una battaglia che merita fare per cambiare una rotta foriera di ulteriori delusioni, di ulteriori sconfitte. E ancor più preoccupa il riflesso d’ordine che matura nello stato maggiore della Cgil, la repulsione verso il dissenso, la tentazione di legittimarlo come espressione di pulsioni politiche esterne, prive di sostanza e di motivazioni sindacali; preoccupa il clima da caccia alle streghe che monta dal centro alla periferia e che sta già mettendo in circolo i peggiori istinti repressivi, sempre latenti nelle burocrazie. 23 5 Non credo proprio sia un caso se questo clima di implosione sociale condizioni anche il dibattito dentro una frammentata sinistra in perenne «cerca d’autore». È davvero poco confortante questa discussione sull’opportunità o meno di fare, il prossimo 20 ottobre, una manifestazione a sostegno di una diversa politica economica e sociale e di una vera lotta alla precarietà. Per cui chi chiede al governo di fare qualcosa di somigliante al programma elettorale che ha unito la coalizione è paradossalmente accusato di fellonia (i ministri), oppure di estremismo (partiti, movimenti, singole personalità, semplici cittadini). Non sorprende che lo facciano gli azionisti del Pd, i quali sembrano ormai considerare la sinistra utile solo se si acconcia a starsene quieta al guinzaglio, addomesticata in un ruolo sostanzialmente ornamentale, ma altrimenti trattata come una zavorra di cui liberarsi quanto prima, ove essa pretenda di far valere i patti sottoscritti e con essi la propria ragion d’essere. È invece singolare che il contagio si sparga oltre e intacchi forze impegnate a fondare una diversa progettualità politica e una idea di democrazia incardinata nella partecipazione popolare. Lo snodo è cruciale. Perché il peggio che può accadere non è di essere costretti a uscire dal governo, ma di uscirvi avendo contemporaneamente logorato il rapporto con la propria gente e compromesso una credibilità che invece va difesa con assoluta coerenza. Anche la disfida apparentemente secondaria e per certi versi macchiettistica sui lavavetri, elevati a malattia degenerativa della civile convivenza, è invece rivelatrice di una grave involuzione culturale, è l’apoteosi di quel perbenismo ipocrita che spaccia per virtù legalitaria una spudorata crociata contro la marginalità sociale. E fa riflettere che a brandire la clava sia un uomo, pardon, un ministro come Amato (ancora lui!) che non riesce a va- rare un provvedimento che stabilisca che se un immigrato costretto alla clandestinità da una legislazione persecutoria denuncia il suo sfruttatore possa essere regolarizzato: in un paese dove un terzo del territorio è controllato dalla mafia, dove prospera un’evasione fiscale mastodontica, dove è consueto lo sfruttamento della manodopera clandestina, dove nei santuari della finanza si pratica il riciclaggio di denaro sporco o, ancora, dove una parte cospicua dell’economia legale galleggia su una bolla di economia illegale. È un’autentica falsità, concettuale ed empirica, che colpendo la microcriminalità (e in essa l’anello più debole e miserabile della catena) si risale a quella grande che si annida in essa. Poiché è vero l’esatto opposto: è afferrando per le corna la grande criminalità che inquina e corrompe la politica e l’economia, che asfissia con i propri tentacoli la vita democratica, che travolge ogni senso di giustizia; è facendo questo che si bonifica il terreno e che si affrancano, non che si incarcerano, anche i lavavetri. Queste cose, un secolo e mezzo fa, erano già ampiamente note. A nessuno, neppure nella sinistra più moderata, sarebbe mai venuto in mente di metterle in discussione. Oggi, la «modernità» di un pensiero anchilosato, davvero «unico», sembra averle cancellate. Non per caso, Walter Veltroni ha intitolato il suo manifesto politico con una formula, «contro tutti i conservatorismi», tipica di ogni gattopardismo. Per questo oggi occorre «riscoprire» tutto. Non per camminare con la testa volta all’indietro, ma per scansare il rischio di sapere come andare, senza sapere più dove. le ragioni della nostra opposizione al federalismo 24 « Foedus» presuppone un patto fra diversi: così dalle correnti di pensiero risorgimentali sino al dibattito che si sviluppò all’interno dell’Assemblea Costituente, la quale bocciò l’ipotesi federalista in favore di quella regionalista. Al di là delle disquisizioni semantiche, storiche e teoriche sulla natura del federalismo, non vi è dubbio che il federalismo fiscale, proprio perché fondato sull’«autosufficienza delle risorse» degli enti locali (così l’art.119 della Costituzione), interpreti nel miglior modo possibile le istanze egoistiche delle regioni più ricche del paese. Anche per questa ragione – come noto – il Partito della rifondazione comunista espresse, in occasione del referendum costituzionale sulla legge n. 3/2001 (approvata al termine della legislatura 1996-2001 con cinque voti di maggioranza), una posizione contraria alla riforma del Titolo quinto della Costituzione. Va ricordato, inoltre, che nel programma elettorale dell’Unione il tema dell’attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 della Costituzione è un punto centrale di mediazione condiviso dalle forze politiche che hanno sottoscritto il programma medesimo. A partire dall’inizio degli anni Novanta, infatti, l’Italia ha sperimentato,sia pure nell’alternarsi di accelerazioni e di periodo di stasi, un’intensa stagione di riforme nella direzione di un sempre maggiore decentramento della responsabilità di spesa e di finanziamento. Nuove competenze di spesa, più poteri autonomi di tassazione, trasferimenti meno vincolanti hanno profondamente modificato il quadro della finanza regionale e locale: tanto da far dire a Wallace Oates, uno dei massimi studiosi del federalismo fiscale, che in Italia «il movimento verso la decentralizzazione si è spinto talmente in là da prevedere una vera e propria proposta di separazione della nazione in due stati indipendenti»1. L’introduzione dell’Ici nel 1992 ha riconosciuto ai Comuni un potente strumento di autonomia tributaria mentre, prima ancora, la L.142/90 e adesso il T.U. 267/2000 hanno innovato i fondamenti della finanza comunale. È stata poi la volta delle regioni a statuto ordinario. In una prospettiva di progressivo superamento del modello della finanza derivata, nuove entrate tributarie hanno sostituito i trasferimenti erariali: la tassa automobilistica e i contributi sanitari nel 1992, la compartecipazione sull’accisa sulla benzina nel 1995, e soprattutto l’Irap e l’addizionale sull’imponibile Irpef nel 1998. Parallelamente le leggi Bassanini (59 e 127/97) e i collegati derivati attuativi hanno avviato un significativo processo di decentramento delle competenze pubbliche dallo Stato alle regioni e, a cascata, agli enti locali nell’ambito di rilevanti settori di intervento (industria, energia, opere pubbliche, assetto del territorio, beni culturali, formazione professionale, sicurezza sul lavoro, istruzione), con corrispondente trasferimento di personale e risorse finanziarie. La riforma del Titolo V approvata nel 2001 ha infine dato una cornice costi- M ARCO D AL T OSO * Individuo nell’accelerata attuazione dell’art.116 terzo comma, contenuto nel disegno di legge sul federalismo fiscale proposto dal Governo, un potenziale pericoloso cedimento politico alle istanze del costituendo Partito democratico del Nord e alle sirene «leghiste»: temo, in particolare, l’effetto di trascinamento che ne deriverebbe, soprattutto in assenza di una politica che fornisca risposte al fabbisogno sociale del paese * RESPONSABILE COMMISSIONE GIUSTIZIA E PROBLEMI DELLO S TATO P RC MILANO F EDERAZIONE SOCIETÀ tuzionale a un’ulteriore fase di trasformazione del nostro paese in senso federale. La riforma (per alcuni aspetti, la controriforma) costituzionale del 2001 ha innovato il quadro delle relazioni finanziarie fra stato ed enti territoriali in tema sia di allocazione delle funzioni pubbliche tra le competenze legislative di Stato e regioni (ampliando significativamente i poteri legislativi di queste ultime), sia di disegno generale del sistema di finanziamento dei livelli di governo subnazionali (riconoscendo la maggior autonomia fiscale, escludendo i trasferimenti erariali quale modalità ordinaria di finanziamento, ponendo l’istituzione di un fondo perequativo). Successivamente, la controriforma costituzionale approvata a fine 2005 dal centro-destra e fortunatamente sconfitta a larghissima maggioranza dal popolo italiano (furono 15 milioni i no in opposizione alla «devolution») con il referendum del 25/26 giugno 2006 è intervenuta tentando di trasformare in competenze esclusive regionali due materie cariche di significati perequativi e di identità nazionale come la sanità e la scuola. Una richiesta di maggiore autonomia competitiva e/o differenziata è stata recentemente avanzata ai sensi dell’art. 116 terzo comma della Costituzione da alcune Regioni settentrionali come la Lombardia, il Veneto ma anche il Piemonte (peraltro con intese «bipartisan»), su alcune materie rientranti fra quelle di competenza concorrente: ambiente, beni culturali, giudici di pace, sanità, comunicazione, sicurezza, previdenza integrativa, strade, ricerca, università, cooperazione, risparmio. Tale richiesta ha trovato riscontro nel recente disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (pur fra le critiche del ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio e della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero) nel mese di agosto, facendo leva sulle istanze di giusta responsabilizzazione degli enti locali e di autonomia finanziaria degli stessi. Un primo problema che il prossimo confronto politico dovrà affrontare è quello relativo all’evidente rischio di «sovraimposizione» (segnalato dallo stesso quotidiano di Confindustria dal prof. Enrico De Mita) e cioè a dire di un prevedibile aumento della pressione fiscale locale determinato dalla necessità di finanziare le funzioni devolute alle regioni. Il tanto evocato «modello catalano» dagli apologeti «modernizzatori» del federalismo fiscale, approvato dal Governo Zapatero in Spagna, pur non aumentando il livello generale di pressione fiscale, tiene in giusta considerazione la necessità di garantire «nazionalmente» i livelli essenziali definiti dalle prestazioni dei servizi sociali. Il disegno di legge-delega presentato al Parlamento dal Governo Prodi (con le dichiarazioni di astensione di Ferrero e Pecoraro Scanio) sul federalismo fiscale, invece, non contiene alcuna definizione dei livelli essenziali di assistenza: usando il principio della delega in una materia così complessa, rischia di acuire lo scontro fra i diversi livelli istituzionali e, in particolare, limita fortemente 25 26 la partecipazione di tutti gli organi istituzionali, esautorando le assemblee legislative e lo stesso Parlamento. In secondo luogo, il disegno di legge sul federalismo è subordinato interamente al criterio vincolante del patto di stabilità interna e crescita definito in sede comunitaria dal Trattato di Mastricht (così l’art. 2 del disegno di legge); criterio che, come noto, comprime il livello della spesa sociale che gli enti locali territoriali potrebbero, diversamente, sostenere. In terzo luogo, il disegno di legge sul federalismo fiscale presenta un rischio di incostituzionalità nel meccanismo che affida alle regioni il coordinamento per la distribuzione delle risorse necessarie agli enti locali per finanziare le funzioni amministrative loro attribuite. Il punto 5.9 della relazione introduttiva della legge delega, infatti, stabilisce che alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di coordinamento della finanza comunale corrisponda un assetto duale della finanza comunale basata sulla distinzione dei Comuni secondo l’ampiezza demografica. Saranno inoltre i governatori a istituire (nelle materie non soggette a imposizione statale) tributi locali o regionali e decidere le materie entro cui si potrà esercitare l’autonomia tributaria degli enti locali. Sempre alle regioni, le cui fonti di finanziamento saranno una compartecipazione Iva e Irpef (oltre a tributi propri), sarà garantito il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali dei comuni più piccoli. E in ultimo, ma non meno importante, le regioni avranno il compito di definire gli schemi di perequazione «solidale» delle risorse per i comuni di dimensioni minori. Un nuovo centralismo regionale, dunque, ove il godimento dei diritti civili e sociali dipenderà dalle risorse e dalla capacità di spesa delle regioni, peraltro fortemente differenziata su base territoriale. Sotto il profilo più strettamente legato all’iniziativa politica, devono essere rilanciate alcune posizioni intorno alle quali penso sia possibile ottenere il sostegno ampio non solo del Prc e di tutta la sinistra di alternativa, ma anche di quei movimenti di ispirazione solidale che sanno legare la questione delle riforme istituzionali a quella della difesa e dell’ampliamento dei diritti sociali: 1. Occorre abrogare, con legge costituzionale, il terzo comma dell’art.116 della Costituzione che consente l’attuazione di quel federalismo differenziato che, se attuato, minerebbe l’unità e la coesione sociale del paese. 2. Alcune materie di rilevanza sociale come la sicurezza sul lavoro, la previdenza integrativa, le reti energetiche e i trasporti devono ritornare alla competenza esclusiva dello Stato. 3. Va superata la sussidiarietà orizzontale perché torni la centralità della questione sociale come obbligo nell’erogazione dei servizi da parte del pubblico. 4. Come richiesto già dalla Corte Costituzionale, vanno definiti con legge ordinaria i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti sociali. 5. Con l’approvazione del nuovo codice delle autonomie locali, occorre una più netta e precisa definizione delle funzioni amministrative e delle competenze ripartite fra comuni, province, regioni e città metropolitane. 6. Occorre un equo bilanciamento fra autonomia, responsabilità (dove ‘responsabilità’ non può significare unicamente capacità autonoma di spesa virtuosa e rispetto dei vincoli del patto interno di stabilità per i saldi complessivi di bilancio, ma anche e soprattutto sanzioni rigorose per quelle regioni che assumono competenze rafforzate, senza però garantire livelli essenziali delle prestazioni, si pensi ad esempio al sistema scolastico) e solidarietà intesa come valore costituzionale vincolante. In conclusione, individuo nell’accelerata attuazione dell’art.116 terzo comma, contenuto nel disegno di legge sul federalismo fiscale proposto dal Governo un potenziale pericoloso cedimento politico alle istanze del costituendo Partito democratico del Nord e alle sirene «leghiste»: temo, in particolare, l’effetto trascinamento che ne deriverebbe, soprattutto in assenza di una politica che fornisca risposte al fabbisogno sociale del paese. L’esito inappellabile del voto referendario del 25 e 26 giuno 2006 contro la modifica della seconda parte della costituzione, contro la «devolution» e in difesa della costituzione repubblicana (soprattutto nel Mezzogiorno e nelle regioni più povere del paese), segnala una preoccupazione civile e sociale a cui il Partito della rifondazione comunista non può restare certamente indifferente. 1. Alberto Zanardi (a cura di), Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale, il Mulino, Bologna 2006, p. 11. OPINIONI A CONFRONTO essere comunisti, perché? P IERO D I S IENA * Marx scriveva nella Prefazione alla Critica dell'economia politica che quello che egli cercava nell'economia politica erano i fondamenti di un’anatomia della società civile, intesa come il complesso delle condizioni materiali di vita del genere umano in una determinata epoca. Ebbene, penso che a noi tocchi un compito della stessa portata * SENATORE SINISTRA DEMOCRATICA E VICEPRESIDENTE ARS C ari compagni, la domanda che vi pongo – perché essere comunisti oggi? – fatta da uno che milita in un’altra formazione politica (oggi Sinistra democratica), può apparire brutalmente invasiva, sembrare un’ingerenza priva di ogni legittimo fondamento. Non mi sfugge affatto che, quando come in questo caso si affronta il tema dell’identità altrui, prima che le culture e l’agire politico si tocca il simbolico, le emozioni, la costituzione di senso che si genera nel complesso rapporto tra politica e vita. Per questo affrontare una discussione sul tema dell’identità è questione di grande delicatezza su cui in genere si sorvola quando si intende stringere rapporti unitari a sinistra. Eppure in questa non ingerenza io vedo anche il segno di una sorta di neodoroteismo, una diplomatizzazione delle relazioni, un’implicita ammissione che su di esse i problemi identitari non hanno alcun peso (a meno che non si voglia agitarli strumentalmente come pregiudizi ideologici). Che, insomma, l’identità politica ha un valore puramente autoreferenziale, una funzione di mera rassicurazione per chi la condivide, senza un’influenza effettiva nell’azione politica concreta. Penso che, se si vuole tornare alla grande politica a sinistra, è necessario superare questo sostanziale «riduttivismo» sul tema dell’identità, capire che esso più che di ascolto reciproco e di apertura intellettuale è figlio dell’indifferenza, che l’evoluzione della globalizzazione neoliberista (quella che Bauman ha battezzato «società liquida») ha prodotto per le culture politiche sostituendole con i grandi «feticci» del tempo presente (l’idolatria dei beni di consumo, i fondamentalismi religiosi ecc.). Perciò sarebbe ora che a sinistra il bilancio critico delle culture politiche e delle identità ereditate dal Novecento (affidato alla rinascita di un forte senso della storia in contrasto con l’appiattimento su un presente che cancella passato e futuro, frutto di sociologia e politologia imperanti) venga fatto seriamente, fino in fondo e con spirito aperto da parte di tutti. Insomma, senza realizzare quel necessario passaggio dalla rimozione o dalla riproposizione acritica dell’eredità che le deriva dal proprio passato al bilancio critico della propria storia, la sinistra difficilmente uscirà dalla minorità da cui è afflitta nel tempo presente. Ma voglio porre a voi questa domanda anche per una seconda ragione. Nel corso degli ultimi dieci anni, tra la tendenza che avete rappresentato in Rifondazione comunista e quanti come me si battono per l’unità e il rinnovamento della sinistra, vi sono stati più di un punto di contatto. Abbiamo da entrambe le parti vissuto con sofferenza la rottura della coalizione di centrosinistra nel 1998; abbiamo spinto parallelamente sia pure senza successo affinché nel 2001 si superasse la divisione tra l’Ulivo d’allora e Rifondazione; abbiamo guardato entrambi criticamente all’esaltazione dei movimenti come esclusivo punto di riferimento della sinistra. E anche oggi voglio interpretare la precoce critica da voi avanzata all’esperienza dell’Unione non come un ir- 27 28 rigidimento settario ma come una forma di cautela per l’oscillazione che si sarebbe potuta produrre a sinistra tra movimentismo e politicismo. Ci accomuna poi un rapporto con la storia del Pci che non prevede abiure, anche per gli aspetti relativi ai rapporti internazionali tenuti da quel partito nella sua complessa e articolata esperienza. Anche se probabilmente diversa è la prospettiva con cui guardiamo al peso della sua eredità nella situazione attuale. Dunque: perché essere comunisti oggi? Siamo sicuri, cioè, che nel bagaglio culturale, nell’esperienza politica e nella storia che abbiamo ereditato dal comunismo del Novecento vi sia un patrimonio che possa servire alla riformulazione di una teoria della trasformazione dell’ordine sociale esistente all’altezza delle contraddizioni dell’oggi, in cui il superamento del capitalismo venga concepito come una possibilità piuttosto che come una necessità? Questa è la domanda cruciale a cui rispondere (che a sinistra da tempo non viene nemmeno più posta), e dal cui esito dipende la risposta al primo e fondamentale quesito che vi pongo. Oggi è possibile che ci si dichiari comunisti senza tuttavia avanzare alcuna ipotesi di trasformazione della società, non perché la si neghi in via di principio, come pure avviene per altre correnti della sinistra contemporanea, ma perché implicitamente la si ritiene fuori dall’orizzonte delle eventualità storicamente possibili. Né la critica no-global al capitalismo contemporaneo può costituire il punto di partenza di una nuova pratica della trasformazione, non avendo sostanzialmente rimosso quella scissione tra produzione e consumo che costituisce sul piano generale la principale forma di alienazione attraverso cui passa oggi nella coscienza dei più il dominio del capitale. Per incominciare a interrogarsi su quale possa essere la risposta alle contraddizioni della nostra epoca segnata dalla globalizzazione, ricomincerei da Marx, dal suo metodo più che dai risultati della sua lunga e complessa ricerca, per forza di cose condizionata dai problemi del suo tempo e dal grado di sviluppo storico del secolo in cui è vissuto. Marx scriveva nella Prefazione alla Critica dell’economia politica, testo che costituisce una sorta di dichiarazione programmatica sulle intenzioni che lo avrebbero ispirato nel lavoro di ricerca del Capitale, che quello che egli cercava nell’economia politica erano i fondamenti di un’anatomia della società civile, intesa come il complesso delle condizioni materiali di vita del genere umano in una determinata epoca. Ebbene, penso che a noi – rispetto al capitalismo contemporaneo – tocchi un compito della stessa portata, che anche la critica al neoliberismo che si è sviluppata nel corso di questi decenni se resta fine a se stessa non produrrà mai una nuova teoria della trasformazione sociale che affronti le contraddizioni della nostra epoca, se essa non affida a se stessa il compito di aprire la strada a un’anatomia della società civile del nostro tempo. Ebbene, se solo si muovono i primi passi in questa direzione non è difficile scoprire che l’ormai lunga rivoluzione neoconservatrice apertasi negli anni Settanta ha provocato cambiamenti nell’assetto del capitalismo di una portata ben più profonda e radicale di quelli prodottisi tra l’Ottocento e il Novecento con l’avvento dell’imperialismo, la cui presa d’atto non a caso costituì il principale fondamento della svolta impressa da Lenin all’indirizzo del movimento operaio internazionale nel corso della Prima guerra mondiale. Non si tratta di fare concessioni a quelle teorie, elaborate in particolare in Impero da Michael Hardt e Antonio Negri, che individuano nella contrapposizione tra «impero» e «moltitudini» il tratto costitutivo del nuovo capitalismo dell’età della globalizzazione. Con questa impostazione, smentita dallo sviluppo delle contraddizioni di tipo geopolitico che segnano le odierne vicende internazionali dominate da un rinnovato primato della guerra e del conflitto tra capitalismi, voi avete giustamente polemizzato quando sembrava potesse influenzare gli orientamenti della maggioranza del vostro partito nel congresso di Rifondazione del 2001. E tuttavia se si procede, sia pure per timidi accenni, a trasformare la critica del liberismo in una nuova anatomia dei movimenti profondi delle società contemporanee è facile vedere come ci si trovi di fronte a problemi costitutivi dello stesso modo di produzione capitalistico che risultano del tutto inediti. Il primo fra tutti questi problemi è che, se esaminiamo a fondo le trasformazioni che sono avvenute nel rapporto tra lavoro e produzione capitalistica, ci tocca constatare che lo sfruttamento del lavoro da parte del capitale avviene sempre più nell’ambito del rapporto (nel cuore stesso del processo produtti- OPINIONI A CONFRONTO vo) tra lavoratore-individuo e capitale impersonale. È questione che appare del tutto evidente se ci soffermiamo a esaminare i modelli organizzativi della produzione nella fabbrica contemporanea, le radici strutturali dei processi di precarizzazione del lavoro, il rapporto tra lavoro e non-lavoro sia nelle società sviluppate (vecchie e nuove) che nelle immense aree diseredate del resto del mondo. Ora, non deve sfuggire l’enorme rovesciamento teorico e pratico che una simile condizione impone a un’idea della trasformazione sociale che miri ad aprire un processo storico di superamento del capitalismo. Se nell’Ottocento e nel Novecento il problema della liberazione del lavoro dalla sua condizione di sfruttamento era un processo di emancipazione collettiva da una condizione altrettanto collettiva di subordinazione, e aveva nella realizzazione del principio di uguaglianza il suo compimento, ora tale processo non può che prendere le mosse dall’individuo che lavora, e trova il suo riscatto nella realizzazione della sua libertà. E non è un caso che l’organizzazione capitalistica della società, per, in un certo senso, «esorcizzare» la carica eversiva che potrebbe derivare dalla percezione di sé come individuo da parte del lavoratore, tende a «collettivizzare» la condizione umana nel mercato, rispetto a cui gli uomini e le donne del mondo contemporaneo sono indotti a percepirsi o come consumatori o, appunto, come moltitudini escluse dai consumi delle società opulente e dai loro valori. La scelta di questa prospettiva, lungi dal mettere in discussione quel legame sociale rappresentato dalle classi, restituisce loro una nuova funzione in quanto condizione di una solidarietà interindividuale che nasce dalla comune posizione nei rapporti di produzione e di scambio. Anzi, si potrebbe dire che nell’età della globalizzazione – almeno a certe condizioni di sviluppo delle forze produttive – vi sia una sorta di «ritorno» dalle masse, che hanno costituito il tratto distin- tivo dell’organizzazione della società e dei sistemi politici del Novecento, alle classi. E quindi come per Hannah Arendt l’avvento della società di massa aveva portato al declino delle classi, l’età della globalizzazione ne potrebbe riproporre in termini nuovi la fondamentale funzione. Si può obiettare che tale nozione dell’individuo e della libertà tende a confondersi in modo equivoco con le principali categorie proprie del liberismo. Si potrebbe allora orientare la ricerca teorica a scavare sulla fecondità analitica di approcci culturali al tema dell’individuo estranei alla tradizione liberale, dalla categoria della «singolarità impersonale» avanzata negli anni Trenta del secolo scorso da Simone Weil, nella sua breve eppure intensa esperienza intellettuale, a quella condizione umana evocata dall’esistenzialismo che è propria del singolo e del suo essere-al-mondo. Un tale ripensamento della nozione di individuo, al di fuori della tradizione liberale e dei suoi aggiornamenti operati dal neoliberismo, consentirebbe anche di approfondire il nesso organico che può essere rintracciato tra il peculiare rapporto tra capitale e lavoro impostosi nell’età della globalizzazione e l’altra cruciale questione che riguarda la fondazione di una nuova teoria della trasformazione. Mi riferisco al tema della differenza di genere, che si riferisce a quel fondamentale aspetto della condizione umana che evidentemente prescinde dalla dimensione storica della formazione sociale capitalistica, che insomma la precede e la segue, e che tuttavia diviene storicamente influente al fine della costruzione dell’agire politico proprio in relazione al nuovo processo di individualizzazione che si realizza nell’odierno rapporto tra capitale e lavoro. Assumere questa prospettiva, inoltre, consente di capire come vi sia un rapporto organico, e non una sovrapposizione come è apparso ad alcune correnti del socialismo europeo, tra questione sociale e tematica dei nuovi diritti, quelli derivanti da Se nell'Ottocento e nel Novecento il problema della liberazione del lavoro dalla sua condizione di sfruttamento era un processo di emancipazione collettiva da una condizione altrettanto collettiva di subordinazione, e aveva nella realizzazione del principio di uguaglianza il suo compimento, ora tale processo non può che prendere le mosse dall'individuo che lavora, e trova il suo riscatto nella realizzazione della sua libertà 29 30 una nuova concezione della sessualità e del rapporto tra la vita e la morte, cioè da una condizione umana storicamente in trasformazione nel suo stesso fondamento antropologico. Lo stesso vale per la questione cruciale del rapporto tra uomo e natura e le nozioni di compatibilità e crescita che ne derivano, della necessità di un nuovo modello di sviluppo pena la sopravvivenza stessa del genere umano. Questa relazione tra status sociale e condizione umana, tra economia e politica, tra materialità e simbolico – insomma per dirla con Marx tra struttura e sovrastruttura – rimanda al nesso strettissimo, che più che in Marx è presente nell’analisi del capitalismo di Weber (benché questa sia orientata attraverso il concetto di «razionalizzazione» alla sua conservazione e riproduzione piuttosto che al suo superamento) tra processi di civilizzazione ed evoluzione dei rapporti di produzione. Ciò potrebbe consentire di cominciare a sondare le ragioni che stanno alla base del paradosso che caratterizza l’epoca della globalizzazione, non sufficientemente analizzato a sinistra, in cui al massimo di integrazione e mondializzazione del mercato corrisponde il massimo di incomunicabilità e di contrapposizione tra le culture ridotte a fondamentalismi l’uno contro l’altro armati (ciò che Huntington ha chiamato «scontro di civiltà»). È a ben vedere questa situazione, prodotto diretto del capitalismo dell’età della globalizzazione, che impedisce alla sinistra di riassumere dopo il crollo del «socialismo realizzato» una rinnovata dimensione mondiale, circoscrivendone nella sostanza ruolo e funzione alla sola Europa. È come se, dopo un ciclo storico durato più di un secolo, la sinistra fosse tornata alle origini, al suo luogo di nascita. Si tratta di una questione cruciale. Infatti, se la realistica presa d’atto di questa situazione dovrebbe condurre a considerare il socialismo europeo in tutte le sue componenti l’ambito nel quale iniziare a misurare l’efficacia del rinnovamento di cui ci sarebbe bisogno, d’altra parte la sinistra ben difficilmente potrebbe uscire dalla sua crisi se fosse costretta dal declino dell’universalismo della civilizzazione europea di cui è figlia in una dimensione sostanzialmente eurocentrica. Questo complesso di riflessioni – che ritorna attuale nel momento in cui da più parti si invoca la nascita di un nuovo soggetto della sinistra italiana – ha cercato nel nostro paese, spesso senza successo, di aprirsi un varco nel dibattito a sinistra nel decennio trascorso. Ed è d’obbligo in questo momento riconoscere il debito politico e intellettuale contratto da tale indirizzo di pensiero con due persone che non ci sono più. Una è Bruno Trentin che caratterizzò negli anni Novanta la sua collaborazione alla rivista «Finesecolo» (diretta da me e Adriana Buffardi) proprio lavorando all’approfondimento di una nuova concezione della libertà, che poi sviluppò nel suo libro La libertà viene prima. L’altro è Claudio Sabattini che attraverso il tentativo di dar vita al movimento «Lavoro e Libertà», in stretta collaborazione con Aldo Tortorella, gettò le basi di quella «rivoluzione copernicana» della concezione del rapporto tra individuo e modo di produzione di cui abbiamo parlato. Che questa innovazione sia venuta da due personalità segnate nella loro esperienza politica e intellettuale dal lungo e profondo rapporto con il principale comparto della classe operaia italiana, quello dei metalmeccanici, a me pare segno di non poco significato. Insomma, se questo ragionamento ha un qualche fondamento e si conviene che sia vero l’assunto che una nuova teoria della trasformazione sociale deve misurarsi con questa dimensione dei problemi del tutto nuova prodotta dal capitalismo della globalizzazione, che cosa c’entra con tutto questo la proprietà collettiva dei mezzi di produzione, una certa concezione del rapporto tra partito e masse, una certa idea della funzione e del ruolo dello Stato nella società e nell’economia, in una parola il comunismo, cioè quel movimento che per forza di cose è figlio della società di massa del Novecento e che ha vissuto la sua esperienza politica ambiguamente a cavallo tra totalitarismo e democrazia, che di quella società rappresentano i modelli politici prevalenti non a caso ambedue in crisi? Mi sembra emblematico che dopo il crollo dell’89 chi ha voluto conservare il nome «comunista» sia ricorso a rappresentare il comunismo o come un orizzonte o come una idea regolativa, una sorta di guida per l’azione, in ambedue i casi un kantiano «dover essere». Ma il problema che oggi la sinistra ha di fronte è di tutt’altra natura. Si tratta cioè di ricostruire dalle fondamenta quello che per Marx avrebbe dovuto essere il comunismo, cioè non un orizzonte né un’idea regolativa ma quel «movimento reale che cambia lo stato di cose presente». Qualora si volesse riproporre questo obiettivo, si dovrebbe prendere atto che le esperienze del movimento operaio del secolo scorso sono del tutto inutilizzabili a tal fine. Ricorrere surrettiziamente a esse significa involontariamente non rendere giustizia alla loro grandezza, sebbene storicamente esaurita, e affrontare non adeguatamente i compiti del presente. Vorrei dirvi, insomma, «cerchiamo ancora» come nel cuore degli anni Ottanta ci suggerì Claudio Napoleoni. A me sembra il modo migliore di restare fedeli alle passioni e alle scelte di tutta una vita. OPINIONI A CONFRONTO perché essere comunisti B RUNO S TERI * Intendo riferirmi a quel poderoso dispositivo di rimozione che ha investito quella che chiamavamo «sinistra»(comunista o non) verso la fine del secolo scorso, all’indomani del fatidico ’89: vero e proprio passaggio epocale, che ha condotto – consapevolmente o meno – a una sorta di «introiezione della sconfitta» e, con questa, a un progressivo adattamento a contenuti e valori della controparte già trionfante * DIRETTORE DI «ESSERE COMUNISTI» P iero Di Siena ci sollecita a rispondere a una domanda che è evidentemente per noi cruciale: perché essere comunisti oggi? Si può, beninteso, restare affezionati a un nome, persistere per inerzia nel «chiamarsi» comunisti: ma l’interrogativo sull’«essere» comunisti chiama in causa direttamente e senza diplomazie l’adeguatezza del nome alla cosa. Si va insomma diritti alla sostanza; e lo si fa col tono giusto, riconoscendo cioè nel contempo la problematicità, il peso concettuale ma anche la delicatezza simbolico-emozionale della questione. Di questo ringraziamo il nostro interlocutore: c’è bisogno di riaprire un confronto di lunga lena su temi di fondo, che non dovrebbero esser costretti nei tempi dell’urgenza politica, magari nei termini di svolte sommarie o a colpi di decreti congressuali. Uguaglianza e libertà Un contributo non reticente, che per così dire espone il suo autore, reclama nell’accordo e nel disaccordo un’interlocuzione altrettanto generosa e netta. Dico subito che mi convincono il programma di lavoro e le modalità di ricerca proposte da Di Siena: tornare a porci nella visuale marxiana di un’indagine sui «fondamenti di un’anatomia della società civile», per provare a delineare i punti di forza di una «teoria della trasformazione sociale che affronti le contraddizioni della nostra epoca». L’epoca – appunto – di una «rivoluzione conservatrice» proiettata su dimensioni planetarie dalla globalizzazione capitalistica. Molto meno mi convince il punto di caduta della sua argomentazione, tesa a premiare più «il metodo» che non «i risultati della (…) lunga e complessa ricerca» di Marx. Non mi convince la contrapposizione che vede, da una parte, un obsoleto approccio otto-novecentesco, tutto imperniato sulla connessione stretta tra liberazione del lavoro e «processo di emancipazione collettiva» in vista della realizzazione del principio di uguaglianza e, dall’altra parte, una concezione di tale processo adeguata all’oggi, che in forme del tutto nuove prenda le mosse dall’individuo in vista della realizzazione della sua libertà. Non penso che i connotati dell’odierna condizione umana, indotti dalla possente spinta globalizzatrice del capitale, autorizzino l’inaugurazione di una antropologia postcomunista e un progetto di trasformazione del tutto nuovo, in discontinuità con i caratteri fondamentali dell’analisi marxiana della formazione sociale capitalistica. Beninteso, c’è una parte dell’esigenza che ci viene proposta che va attentamente considerata: che, tra l’altro, non nasce come un fungo e può anzi vantare autorevoli precedenti. Di Siena converrà che la sua esigenza può essere situata dentro una tradizione, un filone del marxismo: quello che è alquanto genericamente individuato come marxismo etico. Un filone particolarmente influente proprio nel nostro paese, se è vero che autorevole è stata la lezione di Antonio Banfi e che, per altro verso, intere generazioni nei decenni passati si sono formate alla scuola di Galvano Della Volpe e, su questa 31 32 scia, hanno seguito l’insegnamento e l’elaborazione del citato Claudio Napoleoni: nomi – questo ultimi – cui, ad esempio, Fausto Bertinotti e Alfonso Gianni si sono richiamati (in Le idee che non muoiono, uno dei loro primi lavori). In riferimento alla lettura di Marx, tali orientamenti hanno anche supportato un intento condivisibile: recuperare una certa unitarietà nella riflessione del grande rivoluzionario di Treviri, ritematizzare l’ispirazione etica del «giovane» Marx evitando di decretarne troppo frettolosamente la caducità in contrapposizione al Marx «maturo» del Capitale (che appunto avrebbe liquidato i giovanili furori umanistici in nome della scienza della società). Per parte mia, non è in questione la portata peculiarmente scientifica («i risultati») della riflessione marxiana: quella che, affinandosi con lo studio approfondito dell’economia classica inglese, ne recupera la forza analitica e – insieme – ne denuncia il limite storico e apologetico, pervenendo a una compiuta teoria del plusvalore capitalistico. Solo, parrebbe anche a me poco convincente spaccare nettamente spaccare in due un percorso di ricerca, quasi a voler separare il grano dalla crusca: soprattutto se la crusca è intesa essere la prospettiva etica di Marx (e dei comunisti). Tutto ciò ha evidentemente a che vedere con la questione della libertà e dell’uguaglianza. In una fase storica in cui i princìpi, i valori, la storia e le prospettive dei comunisti sono state messe all’indice da un capitali- smo trionfante, è fondamentale tornare a porre all’ordine del giorno del dibattito ideale non solo la concreta possibilità ma – oggi, nel vivo di una «catastrofe dell’uguaglianza» – perfino la necessità di un ordine superiore di libertà, di un progetto di liberazione dell’essere umano da catene sociali che, lungi dall’essere «naturali», mostrano il loro carattere storicamente determinato. Una civiltà – quale quella liberale – in cui l’altro è sentito come limite al dispiegamento della propria libertà è una civiltà che, nonostante (e in contraddizione con) le sue potenzialità progressive, non può andare lontano. Una società che, a partire dal luogo della produzione di merci e in concomitanza con l’incremento della ricchezza, potenzia a livello planetario la negazione dei bisogni primari della maggioranza dell’umanità, oltre a impedire ai più l’accesso alla soddisfazione dei bisogni «ricchi» (l’insieme di condizioni spirituali e immateriali che permettono l’esercizio di una «libera attività umana») – questa è una società tarata alla radice. Il contributo analitico offerto da Marx alla rousseauiana ricerca dell’origine della disuguaglianza ha consentito a questa stessa ricerca di uscire dal regno dell’utopia, di connettere indissolubilmente impegno etico e analisi scientifica delle condizioni di superamento di una formazione sociale data, fornendo un concreto senso storico all’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e al superamento dell’assetto capitalistico della produzione medesima. Se si prende sul serio la lezione hegeliana che Marx fa propria liberandola dal suo involucro idealistico – se quindi non si concede nulla alla vulgata semplificatrice che la riduce a visione escatologica – si può ritrovare quel senso profondo del dramma storico, che da Hegel passa in Marx ridefinendosi come storia della lotta di classe: un duro confronto nel seno stesso del mondo umano, a ridosso delle contraddizioni e delle imperfezioni del reale. La vicenda storica prende corpo allora in una dimensione che non è annichilimento dell’individuo, ma che è sua dislocazione in un quadro epocale, all’altezza di un contrasto tra formazioni sociali; e dentro un divenire che non è lineare, ma appunto contraddittorio, che può mettere capo a configurazioni spurie (che poco hanno a che vedere con la levigatezza di un’idea o di un modello). È con tale complessa eredità che un progetto di liberazione umana ha dovuto e deve ancora fare i conti. Classi e persone Ora Piero Di Siena ci richiama alla necessità di ripensare la nozione di individuo, di meditare sull’esigenza di una sua nuova e inedita valorizzazione, alla luce dell’«enorme rovesciamento teorico e pratico» indotto dalla globalizzazione capitalistica: ripensamento che dovrebbe auspicabilmente mettere capo alla «fondazione di una nuova teoria della trasformazione». Non v’è dubbio che sotto i nostri occhi si sia prodotta in questi anni un’accentuazione che ha OPINIONI A CONFRONTO toccato la qualità del vivere associato così come la disposizione delle singole esistenze. L’attuale «rivoluzione conservatrice» ha imposto la precarietà quale cifra dominante del mondo umano: ciò ha effetti sulla concezione del sé, sulla sua costituzione, sul rapporto con i suoi fini. Non a caso filosofi e sociologi non mancano di evidenziare i tratti distintivi dell’individuo contemporaneo, caratterizzato da un «sé atomizzato», spossessato di punti di riferimento e di criteri sostanziali per la conduzione della propria vita (e dunque facile preda di mitologie mediatiche), esposto a una «cultura della sopravvivenza» che lo fa vivere in un presente privo di passato e dall’incerto futuro. A maggior ragione tali caratteri acquistano concretezza e spessore sociale non appena si pensi all’odierna condizione del lavoro e del non lavoro. Certamente, il suddetto individuo è meno «libero» e, come tale, soggetto potenzialmente sensibile alla rivendicazione di una riappropriazione del sé, della propria libertà. In proposito, non parlerei tuttavia di radicale «rovesciamento», quanto piuttosto di potenziamento su scala planetaria di un’attitudine che è intrinseca al modo di produzione capitalistico – la persistente tendenza a piegare esseri umani e cose alle leggi del mercato, a rivoluzionare i rapporti sociali e di comunità, a rompere i nessi che legano gli individui alle proprie radici storico-sociali – e che Marx ha così ben descritto nel suo Manifesto. Non mancherò di accennare a quan- to c’è di effettivamente inedito nell’attuale congiuntura. Ma prima intendo colmare quello che, a mio giudizio, si presenta come un vuoto nell’argomentazione di Di Siena. Intendo riferirmi al poderoso dispositivo di rimozione che ha investito quella che chiamavamo «sinistra» (comunista o non) verso la fine del secolo scorso, all’indomani del fatidico ’89: vero e proprio passaggio epocale, che ha condotto – consapevolmente o meno – a una sorta di «introiezione della sconfitta» e, con questa, a un progressivo adattamento a contenuti e valori della controparte già trionfante. Un recente articolo tratto da «il manifesto» (L. Pregnolato, Le tute blu all’assalto del cielo, del 23 settembre 2007) offre una mirabile descrizione di cosa fosse la «coscienza di classe» in Fiat alla metà degli anni Settanta: «Il Consiglione di Mirafiori in quel periodo era di 800 delegati, e non c’è alcun paragone con le attuali Rsu. Ogni linea aveva il suo delegato, ogni squadra aveva il suo delegato: dove c’era un caposquadra, c’era anche un delegato. Ogni delegato veniva eletto su scheda bianca, e c’era un’appartenenza, una socialità e un legame fra il delegato e la sua squadra, e fra la squadra e il proprio delegato. Il Consiglio di fabbrica era strutturato con delegati di settore, delegati di officina e poi tutti insieme a volte si facevano le riunioni del Consiglione. Nel ’75 lanciammo alla Fiat mille vertenze sulla salute, la professionalità, l’ambiente di lavoro. Facemmo vertenze di officina e di Mi chiedo: quei lavoratori del Consiglione di Mirafiori non erano forse a pieno titolo, essi sì, «persone», individui associati capaci di contendere col conflitto quote di potere reale, di appropriarsi del controllo sul proprio lavoro e, con esso, della propria dignità? 33 34 reparto, si aprì un grande conflitto articolato, una grande vertenzialità articolata che portò a conflitti ma anche ad accordi sulle condizioni di lavoro e sulla gestione della produzione. (…) I delegati avevano la capacità, oltre che di conoscere la loro squadra – perché la squadra era un ambiente sociale, lavorare in fabbrica era una comunità – di conoscere tutto quello che succedeva. (…) I delegati avevano il controllo assoluto di come era organizzato il lavoro: quanti siamo, che problemi abbiamo, quali problemi ambientali, quante categorie chiedere, cosa chiedere alla Direzione, manca organico qui, spostano tre persone in un’altra linea: perché le hanno spostate? (…) La Fiat cominciò a maturare che il potere del Consiglio di fabbrica e del sindacato era a un livello che non poteva né condividere né subire». E la Fiat agì di conseguenza, fece il suo mestiere. Così come, negli anni Ottanta e dopo – per tutti gli anni Novanta – fecero il loro, i poteri forti del capitalismo reale. E noi? Cosa abbiamo fatto noi, o meglio cosa fece una parte di noi? Piero Di Siena ha ricordato la figura di uno dei grandi dirigenti della Cgil: Bruno Trentin, un compagno, un dirigente autorevole e stimato. Il mio ricordo va alla Conferenza di programma che la Cgil tenne a Chianciano nell’aprile del 1989: un «quasi-congresso» fu definita, una svolta che disegnava «la nuova Cgil». In effetti, Trentin aprì allo sguardo, in quella sede, dimensioni generali e tematiche fino ad allora non indagate. Fu posta, per la prima volta in una sede sindacale, la grande questione dei vincoli ambientali e di uno sviluppo fino ad allora inteso senza limiti quantitativi di lungo periodo (è precisamente questa una delle questioni davvero inedite cui prima accennavo). In proposito, Trentin fu lapidario: «Nessuno può fare la lezione ai disoccupati o ai braccianti del Brasile sulla necessità di salvaguardare l’Amazzonia se non dà al tempo stesso le prove di voler lottare, qui in Italia e in Europa, per cambiare il governo dello sviluppo» (Relazione di B. Trentin alla Conferenza di programma Cgil, Chianciano 12-14 aprile 1989). Eppure quella Conferenza passò alla storia del sindacalismo italiano e della sinistra nel suo complesso per tutt’altri motivi: perché, come scrissero benevolmente i giornali dell’epoca, lo «strappo di Trentin» finalmente inaugurava il passaggio dal «sindacato di classe» al sindacato dei diritti e delle persone», un sindacato che – commentò Alfredo Reichlin – sapesse «parlare non solo alle masse ma agli individui, non solo all’operaio ma all’insieme dell’Italia moderna che intraprende, che pensa e che produce» («l’Unità», 16 aprile 1989). Mi chiedo: quei lavoratori del Consiglione di Mirafiori non erano forse a pieno titolo, essi sì, «persone», individui associati capaci di contendere col conflitto quote di potere reale, di appropriarsi del controllo sul proprio lavoro e, con esso, della propria dignità? Viceversa, sarà un caso, ma la fine del «sindacato di classe» – e nonostante l’investimento ufficiale del sindacato sulle «persone» – ha dato l’avvio a uno dei periodi più neri nella storia del movimento operaio italiano. Nella prima metà degli anni Novanta (con Trentin per un certo periodo alla testa della più grande forza sindacale) un micidiale tsunami si è abbattuto sul mondo del lavoro. Nel giro di pochi anni è stata abrogata la scala mobile, perché «toglie spazio alla contrattazione»: col risultato che assieme all’abolizione della parte automatica di salario è andata indietro anche quella contrattata. Sono stati siglati i famigerati accordi del luglio ’92 e ’93, che hanno contrassegnato la mutazione «concertativa» del sindacato. È stata data la prima devastante spallata alla previdenza pubblica: con la «riforma» Dini, viene tagliata del 30% la copertura pensionistica. Nell’insieme, un vero e proprio «colpo di stato» sociale. Come è potuto accadere? Ha certo ragione Felice Roberto Pizzuti a rispondere – per la parte relativa alla previdenza – che la ricaduta degli effetti della controriforma, da lì a un paio di decenni dopo, non fu allora distintamente percepita: così che la resistenza del mondo del lavoro fu fiacca. Ma non basta. Più in generale e più in profondità, era già in atto quella che sopra ho chiamato «l’introiezione della sconfitta», un processo la cui data di nascita nel nostro paese può essere plasticamente compendiata dallo scioglimento del più grande partito comunista d’Europa. L’introiezione della sconfitta Ma da tempo non era più chiaro cosa si dovesse intendere con «sinistra». Non si tratta qui dell’ovvia considerazione che quel termine aveva da sempre avuto un riferimento non univoco a tradizioni, ispirazioni, forze politiche diverse e divise da non lievi contenziosi ideologici. Nonostante questa multiforme estensione, un senso di massima permaneva a tutti chiaro – almeno nell’ambito della storia europea del Novecento: quello di una determinata scelta di campo sociale, di un’appartenenza ideale e politica alla storia, ai valori, alle lotte del movimento operaio. Gli avvenimenti del 1989, oltre a segnare la profonda crisi del cosiddetto socialismo reale, avevano di fatto impresso un’accelerazione senza precedenti a un già avviato processo di sfaldamento delle idee e della progettualità politica della sinistra in generale. Vi sono, a mio parere, due punti sensibili la cui erosione ha originato crepe in un intero edificio teorico e pratico: a) la tesi secondo cui tra i conflitti vecchi e nuovi che attraversano la totalità sociale ce ne sia uno che resta comunque fondamentale, segnando specificamente il modo di produzione dominante in occidente – il conflitto appunto tra Capitale e Lavoro – dal cui esito continua a dipendere la possibilità di instaurare una società diversa e più giusta, oltre che di uno sviluppo delle forze produttive equilibrato e in sintonia con i limiti naturali del pianeta; b) la convinzione che una soluzione di tale conflitto – che è conquista di poteri, decisionali e di controllo, nella società e nei luoghi di lavoro – passi per una modifica dei rapporti di produ- OPINIONI A CONFRONTO zione e proprietari e implichi il primato della sfera pubblica, ovvero la preminenza di un’organizzazione collettiva e consapevole della vita sociale e dello sviluppo produttivo. Se è vero che questi punti hanno direttamente ispirato la tradizione comunista in particolare – o, più in generale, la sinistra «a impianto marxista» – è altresì vero che essi abbiano operato come riferimenti di massima nelle stesse socialdemocrazie europee: non è un caso che, con il tracollo dei paesi del socialismo reale, sia contestualmente sopraggiunta in Occidente la liquidazione di qualsiasi idea di piano, sia pure nella forma addolcita di strumento regolatore a supporto e correzione della spontaneità delle forze economiche. In breve, si è ritenuto che entrambi i punti sopra detti fossero stati confutati dalla storia: ciò ha determinato, accanto alla messa all’indice di qualsiasi prospettiva comunista (comunque declinata), il definitivo logoramento dell’identità e della comune nozione di «sinistra» e l’adozione contestuale di strumentazioni concettuali e ispirazioni politiche già patrimonio dell’ideologia dominante (poi comprensibilmente definita «pensiero unico»). È istruttivo, oggi, tornare a quell’euforica orgia di autodissolvimento che decretò la falsificazione dell’idea di socialismo in quanto tale. Si moltiplicarono gli epitaffi in memoria del caro estinto. Jürgen Habermas, autorevole rappresentante della scuola di Francoforte, trasse da quegli eventi la «lezione inequivoca» secondo cui «le società complesse non possono riprodursi se non lasciano intatta la logica di autoregolazione di un’economia di mercato» (La rivoluzione in corso, Milano 1990). Sulla medesima scia, Richard Rorty, filosofo americano erede della tradizione pragmatista – anch’egli collocato «a sinistra» – non fu meno perentorio. In un saggio dal titolo significativo (Gli intellettuali alla fine del socialismo, in Il Mulino, n°6, 1991), dopo aver notato che «le pubbliche virtù continueranno a essere parassiti dei vizi privati» e che quindi non c’è modo «di assicurare beni e servizi se non incoraggiando imprenditori privati ad arricchirsi», egli invitò a «lasciare i diritti di proprietà al loro posto» e ad abbandonare il vecchio armamentario terminologico. Esortò quindi (la «sinistra») a far fuori dal proprio vocabolario termini come «economia capitalista», «socialismo», o come «borghese» («con il suo tradizionale senso peggiorativo»), in quanto essi avrebbero esaurito la loro forza, tutta contenuta nella strana idea che «esistesse un’alternativa al capitalismo». Invero, le propensioni «pragmatiste» rischiano a volte di scadere nel banale. Ma è proprio questo il messaggio più impegnativo che il suddetto saggio voleva trasmettere: al marxismo veniva infatti imputato non un difetto quanto, per così dire, un eccesso di teoria. L’ossessione dei marxisti è quella di pretendere di avere o di ricercare «una profonda conoscenza del moto della storia», di costruire «larghe vie teoriche», nella convinzione (falsa) che vi sia bisogno di una «“base teo- rica” per l’azione politica»: di qui «la sete di favoleggiamenti sulla storia mondiale e di profonde teorie su profonde cause del mutamento sociale». A tutto ciò, il filosofo contrapponeva i «piccoli passi» di quanti, anziché trastullarsi con forze e tendenze storiche, «si accontentano di essere concreti, banali e pragmatici», nell’intento di «passare dall’istituzione presente a una un po’ migliore». Come si vede, proprio i concetti che danno profondità storica, spessore strategico alla spiegazione dei fenomeni economico-sociali (si pensi alla nozione di «modo di produzione» o a quella di «classe») venivano a essere destituiti di efficacia conoscitiva e rilievo operativo da siffatte forme «indebolite» di riflessione. Da qui occorre ripartire per comprendere le cause profonde che – sul versante delle «concezioni del mondo», dei valori dominanti, degli impianti concettuali – hanno determinato la poderosa involuzione degli ultimi due decenni. In sintonia con la linea argomentativa sopra richiamata, nel nostro paese fu tra gli altri il filosofo Biagio De Giovanni a fornire un supporto ideale e strategico alla «svolta» di Achille Occhetto, salutando gli avvenimenti dell’89 come «una delle più grandi speranze di liberazione umana che mai sia comparsa nella storia» e sanzionando che «il comunismo, come principio di una realtà politica antagonista, di una strategia mondiale destinata a unificare il mondo, ha chiuso la sua esperienza» (Intervista a «il manifesto»,24 dicembre 1989). 35 36 Successivamente, in occasione del convegno su Le idee della sinistra organizzato nel febbraio del 1992 dal Partito democratico della Sinistra (cfr. gli atti pubblicati da Editori Riuniti, Roma 1992), De Giovanni precisava in termini significativi il suo pensiero. In particolare, egli notava che al progetto di una trasformazione è venuta meno «l’idea che la storia ha un senso, che c’è un senso della storia che va verso un compimento». In tale affermazione egli non esprimeva semplicemente una condivisibile concezione antideterministica dello sviluppo storico, bensì l’accettazione di una tesi ben più radicale e restauratrice: la tesi di R. Dahrendorf secondo cui la stessa «idea di un’altra società, di una società alternativa a quella esistente, ha in sé una connotazione che conduce verso il “terrore” e il totale rinnegamento della semplice ed essenziale umanità dei diritti umani». Come si vede, a farsi strada è l’idea che vi sia un’irrimediabile frattura tra la possibilità storica di «rivoluzionare», trasformare in profondità i rapporti sociali e «il carattere universale del principio di libertà». Ognuno può vedere quanto grande sia il prezzo da pagare non appena si pensi la sfera dei diritti dell’individuo così irreparabilmente contrapposta all’ambito storico-sociale: in questione finisce per esser posta niente meno che la possibilità di modificare un assetto sociale dato. È muovendo da un siffatto fatale passo che, nel medesimo convegno, si potè poi affermare una nozione di «democrazia» intesa come «fine in sé», come valore autonomo e preminente, non necessariamente inclusivo dell’azione emancipatrice del conflitto sociale. Nel momento in cui si considera «deperito il fondamento classista della solidarietà» (Achille Oc- chetto), è possibile parimenti sentenziare che «la democrazia è formale o non è nulla» (Claudia Mancina), con buona pace della distinzione tra carattere formale e sostanziale della medesima. Sin da allora, si poteva cogliere il divario abissale tra le proposte di modelli regolativi ideali, privi di aggettivazioni specificanti («democrazia», «mercato» ecc.), predisposti per soggetti altrettanto generici (il «cittadino» con i suoi «diritti»), e la dura realtà del «nuovo ordine» capitalistico. Così, ad esempio, una mente lucida come quella di Luciano Barca poteva polemizzare con una tale «sconvolgente foga di cancellazione della memoria», stigmatizzando con ironia quanti si sono affrettati a liquidare «non solo Ricardo, Marx, Sraffa ma perfino il “mercato oligopolistico” studiato da Sylos Labini» (cfr. L’eresia di Berlinguer, ed. Sisifo). Oggi, dovremmo essere in grado di affrontare con una minore ansia e con maggiore cognizione di causa il tema di che cosa non ha funzionato in quel grandioso (e drammaticamente contraddittorio) disegno di superamento del vigente modo di produzione che è stato il «comunismo reale». Lo possiamo fare, perché abbiamo bene davanti agli occhi cos’è (e a quali violenze, a quali disastri sociali e ambientali sta conducendo) su scala planetaria il dispiegato «capitalismo reale». Accogliamo dunque di buon grado l’invito a «cercare ancora». Pensiamo altresì che di questo «cercare» faccia parte a pieno titolo il lavoro della «Rifondazione comunista». OPINIONI A CONFRONTO Rifondazione comunista e l’unità a sinistra Intervento alla Festa di Liberazione di Bologna, 1 agosto 2007 R AUL M ORDENTI * Domandiamoci, ad esempio: che fine hanno fatto alcuni milioni di ex iscritti al Pci che non sono andati né nei Ds né in Rifondazione né nei Comunisti italiani? * DOCENTE DI STUDI FILOSOFICI, LINGUISTICI E LETTERARI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ROMA-TOR VERGATA 37 1 Ringraziando molto sinceramente dell’invito, debbo precisare che io (al contrario degli altri interlocutori) non rappresento qui nessun altro che me stesso e il ragionamento, come vedrete molto banale e di buon senso, che cercherò di dipanare in 6 punti. Preliminarmente, tento dunque di dare un’interpretazione al mio invito e alla mia presenza, e l’interpretazione potrebbe essere questa: che nel dibattito necessario sulla nuova «unità a sinistra» ci sia, e debba esserci, una sorta di «convitato di pietra», cioè un interlocutore non precisamente identificabile e strutturato e tuttavia indispensabile, un interlocutore magari sgradito e tuttavia inevitabile. Penso che questo interlocutore ineludibile possa essere individuato per ora fra noi nel cosiddetto «popolo della sinistra» o, se preferite, nelle migliaia e decine di migliaia di compagne e compagni che militano nella sinistra di alternativa, nei movimenti, nei micro-conflitti quotidiani, nell’associazionismo, nel volontariato e soprattutto nel sindacato ecc. ma che non si riconoscono nei nostri partiti (o non ci si riconoscono più: il che, naturalmente, è molto peggio). Domandiamoci, ad esempio: che fine hanno fatto alcuni milioni di ex iscritti al Pci che non sono andati né nei Ds né in Rifondazione né nei Comunisti italiani? Oppure pensiamo che, solo per quello che riguarda Rifondazione, il turn over degli iscritti si aggira intorno al 20%, a totali stabili o leggermente in calo, ciò significa che ogni anno circa il 20% degli iscritti non ha rinnovato la tessera; personalmente non so con precisione quanti siano attualmente gli iscritti al Prc (mi sembra che negli ultimi anni questi dati non siano neppure più forniti) ma in ogni modo possiamo calcolare facilmente che dal 1991 a oggi ci siano molte decine di migliaia di compagne e compagni che si sono affacciati nel partito, hanno visto da vicino e direttamente di cosa si trattava e, per motivi che nessuno si è dato la pena di indagare, sono scappati via. Per non dire di altre centinaia di migliaia che hanno riempito le piazze contro la guerra o per difendere l’art. 18 e così via. Si può pensare seriamente un processo di unità a sinistra «a prescindere» (come direbbe Totò) dal problema politico costituito da questi compagni e da queste compagne, i quali (come si diceva una volta) hanno votato la sfiducia ai nostri partiti con i loro piedi, cioè allontandosene e scappandone via? Io penso proprio di no; e questo è il primo snodo del mio ragionamento, e il primo tema che vorrei sottoporre al dibattito. Si potrebbe affermare che, quanti che siano i soggetti che contribuiranno al processo unitario di cui parliamo, cioè sia se essi saranno 4 (Prc-Pdci, Verdi, Sinistra democratica) oppure tre oppure due, oppure, chissà?, cinque o sei, ebbene occorrerà sempre aggiungere a questo numero n un uno in più, e questo uno in più deve essere il«convitato di pietra» del popolo della sinistra alternativa, le compagne e i compagni senza partito di cui parlavo. Come può una compagna o un compagno «normale», per ipotesi una giovane compagna o un giovane compagno, sentire come suo, come degno di impegnare e riempire la sua stessa vita, un partito in cui è necessario iscriversi a una corrente se si vuole godere di diritti civili elementari (come l’elettorato passivo) e in cui, soprattutto, si decide sempre tutto altrove e «in alto», dalle scelte strategiche e teoriche più impegnative fino alla designazione di un assessore di Municipio? 38 2 Se questo primo tema è condiviso, allora ne consegue direttamente un secondo, che enuncerei così: l’unità nuova a sinistra non può essere in rapporto di continuità lineare con l’esistente; in altre parole: credo che nessun soggetto politico o partito possa considerare il processo di unità a sinistra che si avvia come il prolungamento e l’ampliamento della propria esperienza, insomma come la conseguenza del proprio successo politico. Il contrario è vero: questo processo unitario deriva da insufficienze, ritardi, errori di ogni tipo (alcune volte: gravissimi errori) commessi da ciascuno dei soggetti che si accingono al processo unitario, esso è insomma il frutto di una complessiva debolezza (e se volessimo essere spietati dovremmo dire: di una generale sconfitta) e non certo del successo di questo o di quello. Fausto Bertinotti, nel suo articolo Massa critica e nuovo soggetto politico su «Alternative per il socialismo» (a proposito: chissà se l’uso di questa parola «socialismo», e il contemporaneo abbandono della parola «comunismo» significa qualcosa?) scrive: «Tocca correre e, insieme, cercare la strada»; io mi permetterei di dire: «Tocca correre e, insieme, cambiare la strada»; anzi (facendo slittare un po’ il significato della parola «insieme», dal significato di «allo stesso tempo» che ha nel testo bertinottiano, al senso più letterale e proprio) io direi: «Tocca correre insieme e, cambiare strada insieme». Deriva da questo fatto politico (che a me sembra incontestabile: baste- rebbe ricordare che la somma dei voti e degli iscritti di Prc e Pdci non raggiunge nemmeno il livello del 1998, vale a dire prima della scissione cossuttiana; delle cifre dei voti e degli iscritti del Pci meglio non parlare nemmeno, per carità di patria, eppure sono passati quasi vent’anni dalla Bolognina, in pratica un tempo storico, non solo politico!), da questo fatto politico – dicevo – e non da un generico spirito unitario-buonista, deriva dunque la necessità di abbandonare atteggiamenti arroganti e «imperialisti», cioè la tentazione di invitare l’altro, qualsiasi altro, a iscriversi, sia pure sotto mentite spoglie, al proprio partito, o (come si dice nel gioco dei bambini) a «mettere il dito qui sotto». Il processo di unità a sinistra non può consistere nel fatto che uno dei soggetti si ingrandisce accogliendo benevolmente qualcun altro. Questo è dunque il secondo snodo del mio ragionamento. Debbo dire che esso è talmente ovvio che sembra quasi superfluo ribadirlo; eppure voglio farlo perché questo tratto, ad esempio, configura il processo di cui parliamo come il contrario (vorrei sottolinearlo: non solo qualcosa di diverso e meno che mai in rapporto di continuità, ma il contrario) rispetto alla costruzione della «Sinistra europea»; tornerò più avanti, brevemente, su altri aspetti della «Sinistra europea» che mi sembrano da valutare come maestri negativi, come esempi di ciò che occorre non fare. Assumiamo per ora, come secondo punto, che unità a sinistra significa anche discontinuità, necessaria correzione, anzi innovazione (ma sul tema dell’innovazione, che può prestarsi e si presta a pericolosi equivoci, vorrei tornare in conclusione di questo intervento). 3 Il terzo snodo del ragionamento, o tema, è altrettanto ovvio, ma forse non è banale: l’unità si fa su un programma, su un progetto, su delle discriminanti; questo se non si vuole cadere nel tragicomico vissuto in questi giorni dal Partito democratico che, per aver voluto avviare un processo generico e onnicomprensivo (il quale in realtà aveva ed ha come precise discriminanti politiche il liberismo più o meno temperato e l’americanismo), si ritrova poi come candidato alla segreteria…Marco Pannella, il quale, non senza ragioni, rivendica di essere da sempre il più liberista e più atlantico di tutti. Ora, questo terzo punto del programma rappresenta un vero paradosso che si può così enunciare: sul programma non esistono oggi, e non esistono più da tempo, delle rilevanti contraddizioni fra le forze che dovrebbero avviare l’unità della sinistra. A chi avesse dei dubbi basterebbe avere un po’ di buona memoria (la buona memoria: ecco un ingrediente politico preziosissimo che nella sinistra, ahimé!, scarseggia): mi riferisco al convegno «Verso sinistra», promosso da «il manifesto» il 15 gennaio 2005 all’Eur a Roma (e ricordato proprio oggi da Rossanda su «il manifesto»), con la partecipazione di circa 3.000 persone, la relazione di Alberto Asor Rosa e interventi di tutti i leader della sinistra, dai segretari dei due partiti comunisti, ai verdi, agli OPINIONI A CONFRONTO esponenti dell’allora sinistra Ds, a molti cristiani di sinistra, dai massimi responsabili sindacali ad alcuni dei leader più significativi del movimento, fino a singoli, prestigiosi intellettuali e personalità. Tutti, senza eccezione, si dichiararono lì d’accordo con l’impianto di quella relazione e (soprattutto) con quella proposta unitaria di programma, tutti parteciparono poi alla «Camera di consultazione della sinistra» che ne derivò. Avvicinandosi le elezioni del 2006 quel processo, invece di accelerare, fu interrotto, anzi affossato; e bisogna riconoscere che Rifondazione fu il primo partito che si sfilò da quel processo, in verità senza addurre nessun’altra motivazione che non fosse quella malintesa e miope politica di grande potenza di cui parlavo poc’anzi, insomma la motivazione che suonava così: «Sono il partito (relativamente) più grosso e visibile, presentandomi in solitudine potrò avere un po’ più di seggi e di potere». Lo stesso ragionamento, ammesso che si tratti di un ragionamento, ha portato Rifondazione a negare la possibilità di sperimentare una lista unitaria e dal basso nelle successive elezioni per il Comune di Roma. Aggiungo, perché la cosa non è forse priva di significato, che quando la situazione politica (e anzitutto il processo di fondazione del Partito democratico) ha costretto tutti a riaprire quel discorso così insipientemente affossato, a nessuno è venuto in mente di fare una telefonata (come dire? per buona educazione) ai compagni che avevano promosso quell’esperienza del Convegno del 2005. Il riferimento a quel progetto (che, ripeto, era anche un programma politico largamente condiviso da tutti) mi risparmia comunque di rifare qui l’elenco di elementi di programma della sinistra alternativa al capitalismo che è ben presente nella mente di tutti noi, un elenco che parte dalla pace e dunque dal rifiuto di finanziare le guerre imperialiste o di parteciparvi, che fa cardine sulle politiche per il lavoro, per il risarcimento sociale dei lavoratori e dei pensionati, contro il precariato, per la difesa e il rilancio del welfare, della scuola pubblica, della ricerca e dell’Università, dei diritti di cittadinanza (a cominciare da quelli dei lavoratori e delle lavoratrici migranti); è un programma che trova il suo fondamento e il suo coronamento nella Costituzione repubblicana e antifascista. Mi sia consentita a questo proposito una sola sottolineatura del nostro possibile programma: la lotta per la democrazia e la partecipazione, contro il presidenzialismo, il plebiscitarismo populistico, il sistema elettorale maggioritario e, insomma, contro l’americanizzazione della politica; è questo un tema da sempre presentissimo ai nostri avversari (che sono, da sempre, nemici della Costituzione antifascista), dalle leggi truffa al «Piano di rinascita democratica» di Licio Gelli, da Berlusconi alla bicamerale dalemiana fino a Mariotto Segni e ai poteri forti che lo sostengono, ed è un tema che oggi appare centrale nel programma veltroniano, ma è anche un tema su cui il silenzio della sinistra di classe e di alternativa è a dir poco assordante. Ed è un silenzio, a me sembra, che deve preoccuparci tutti, e parecchio. Comunque, se volessi fare un riassunto e contrario dei tratti di quel programma unitario e possibile della sinistra, mi basterebbe oggi ricordare, punto per punto, ciò che siamo stati costretti a ingoiare in questo anno e mezzo di governo del centro-sinistra: dalla nuova base Usa di Vicenza al rifinanziamento della guerra, dal nuovo invio in guerra di soldati italiani alla finanziaria «lacrime e sangue» (per il lavoratori, beninteso), dall’attacco alle pensioni fino alla conferma della legge 30 e al pacchetto welfare, dal rilancio delle «grandi opere» devastanti l’ambiente fino all’affossamento, per ossequio al Vaticano, dei pur minimalissimi Dico ecc.; non scorderei le piccole ma importantissime provocazioni, veri e propri sputi in faccia alla classe operaia e alla sinistra, come l’intenzionale umiliazione della Cgil da parte di Prodi e Padoa Schioppa, la detassazione degli straordinari (cioè il 39 40 finanziamento statale, attraverso il fisco, dei padroni che li usano) o il recente ricorso del Governo di Roma contro la tassa della Regione Sardegna sulle ville dei ricchi. In continuità e coerenza con quanto detto poc’anzi a proposito della democrazia e delle leggi elettorali, aggiungerei all’elenco degli sputi in faccia la partecipazione di ben quattro ministri in carica (Melandri, Parisi Di Pietro e Bindi) alla raccolta di firme per il referendum ultra-maggioritario, che mira esplicitamente a costringere l’elettore, con una legge elettorale assurda, a scegliere fra due soli partiti di centro distruggendo tutti gli altri, una raccolta portata avanti dai ministri di Prodi, e dallo stesso sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Letta, assieme a Segni, Fini, La Russa, Alemanno, al radicale berlusconico Della Vedova, e (soprattutto) a Confindustria e banche, cioè i poteri forti e fortissimi (come il coro mediatico pro-referendum dimostra ampiamente). Credo che sia un caso politico unico nella storia in cui dei ministri (e, tramite Letta, evidentemente lo stesso Prodi) lavorano apertamente ed esplicitamente per conseguire la distruzione di tre o quattro partiti che sostengono il loro Governo, e possono fare ciò senza che tali partiti morituri reagiscano in alcun modo. Io, da vecchio proporzionalista fedele alla Costituzione, avrei voluto sentire dalla voce di uno dei nostri autorevoli compagni ciò che ha detto il ministro Mastella, cioè che il Governo cadrà il giorno stesso in cui quel vergognoso quesito referendario fosse portato al voto. 4 Ma torniamo al filo del nostro ragionamento: se l’unità a sinistra è necessaria (cosa di cui nessuno du- bita) e se essa oggi si può addirittura fondare su una larga condivisione di programma, allora perché mai essa non ha avuto luogo e, a tutt’oggi, non si vede un processo politico credibile e concreto che vi pone mano? Credo che rispondere a questa domanda ci porterebbe a rispondere a una domanda diversa, già comparsa come sottintesa nel nostro ragionamento, cioè quali siano stati i limiti, i ritardi, e i veri e propri errori che hanno segnato, di fatto, la crisi o lo stallo dei tentativi di ricostruire, o costruire, una sinistra di classe nel nostro paese dopo l’89 e lo scioglimento del Pci. Per quanto mi riguarda personalmente, data la tessera che ho in tasca dal 1990, si tratterebbe di cercare di capire come, dove e perché sia sostanzialmente fallito il processo della Rifondazione comunista. Dunque questo discorso ci porterebbe troppo lontano, e certamente fuori dai limiti di questo intervento. Mi limiterò allora a due soli elementi, che mi sembrano essere tutti rivolti al domani (anche se derivano dall’esperienza negativa di questi anni), cioè due elementi che mi paiono tratti di innovazione assolutamente necessari per rendere in qualche modo appetibile e interessante per il grande «popolo della sinistra» il processo di unità, ed evitare che esso si riduca alla semplice sommatoria burocratica di ceti politici più o meno in crisi: questi due elementi si chiamano a) democrazia interna, e b) lotta contro la degenerazione istituzionalista dei nostri partiti. Penso che si illude chi pensa che senza sciogliere questi due nodi sia possibile coinvolgere, o addirittura far partecipare, qualcuno che non faccia parte dei partiti esistenti e delle loro ramificate burocrazie. Per democrazia, intendo riferirmi al fatto che noi (mi riferisco alla sola esperienza che conosco personalmente, quella del partito in cui milito, degli altri non saprei dire) siamo usciti da destra, e non certo da sinistra, dal centralismo democratico della tradizione comunista; cioè abbiamo dato vita a una mostruosa democrazia verticale e correntizia, non priva di elementi personalistici e, ormai, anche di aspetti di vera e propria corruzione della politica. Come può una compagna o un compagno «normale», per ipotesi una giovane compagna o un giovane compagno, sentire come suo, come degno di impegnare e riempire la sua stessa vita, un partito in cui è necessario iscri- OPINIONI A CONFRONTO versi a una corrente se si vuole godere di diritti civili elementari (come l’elettorato passivo) e in cui, soprattutto, si decide sempre tutto altrove e «in alto», dalle scelte strategiche e teoriche più impegnative fino alla designazione di un assessore di municipio? Credetemi compagni, non è possibile che un simile partito attragga nessuno, se non degli ostinati pazzi e vecchi come me e come molti di noi, oppure, ormai sempre più frequentemente, chi vive del partito stesso che, direttamente o indirettamente, gli fornisce lo stipendio. In particolare nessun giovane normale può essere attratto da queste cose, che lo respingeranno cento volte di più se è di orientamento ideale comunista, e mille volte di più se è una lavoratrice o un lavoratore. Si opera in tal modo una selezione, per così dire, inversa, cioè si respingono proprio coloro che dovrebbero interessarci di più (i giovani e i lavoratori) e si attraggono proprio coloro che dovrebbero interessarci di meno (i carrieristi). Mi rendo conto che questi processi degenerativi sono più gravi a Roma, la mia città, che è sede anche della Direzione nazionale, del giornale «Liberazione» (che meriterebbe un discorso a parte), di gruppi di partito al Senato, alla Camera, alla regione, alla provincia, al comune, nei municipi, e ogni volta con i relativi assessori e uffici, senza contare, da un anno e mezzo i ministeri e i sottosegretariati. Tutto ciò significa diverse centinaia di posti di lavoro retribuiti, che si trasformano immediatamente in «pacchetti tessere» congressuali del tutto decisive nel partito romano, ma temo che anche nel resto d’Italia si verifichino processi degenerativi analoghi, anche se in forma meno conclamata. In questo senso l’istituzionalismo è una faccia diversa dello stesso problema della democrazia; intendo per istituzionalismo il fatto che sia la coda (i compagni nelle istituzioni, a tutti i livelli) a muovere il cane (il partito) e non viceversa il cane a muovere la coda. Non aggiungo altro, per spirito di partito, appunto. Dico solo, per mantenere la promessa fatta poc’anzi, che l’esperienza di costituzione della «Sinistra Europea» può bene essere utilizzata come exemplum negativum: io (che, ripeto, sono iscritto al Prc dalla fondazione) non so neppure chi abbia eletto i delegati a quel congresso di fondazione e come essi siano stati eletti (nel mio circolo, di certo, non è stato eletto alcun delegato né si è approvato alcun documento di tesi); non so chi e come e dove abbia deciso le «quote» di ripartizione di posti fra il Prc, «Socialismo del XXI secolo», «Unità a sinistra» e altri, né so a quali forze reali di base queste sigle corrispondano, o se invece, per ipotesi, si tratta solo di ceto politico che ha patteggiato coi vertici del Prc a partire dal conseguimento, o dalla conferma, del proprio ruolo istituzionale; soprattutto non so come e dove e chi abbia deciso i nomi che andavano a ricoprire quelle quote prefissate. So solo che mi ritrovo dentro il mio partito (anzi alla sua testa, nel suo gruppo dirigente) l’on. Folena, un parlamentare non comunista, ma eletto da noi comunisti, il quale rivendica apertamente di essersi battuto, e con successo, per rafforzare l’embargo della Comunità Europea contro Cuba e contro la sua rivoluzione. Non aggiungo altro. 5 Ma il vero problema politico è che questi processi sono dentro il più generale problema della crisi della politica italiana e della sua corruzione, non ne rappresentano una soluzione, e neppure un tentativo di soluzione, ma, appunto, solo un episodio e un aspetto. Ecco allora in che senso l’innovazione appare necessaria anche al processo unitario: un partito, o una federazione di partiti, o un aggregato di partiti e altre forze di sinistra, che si ponesse esplicitamente, seriamente e credibilmente (ripeto questi tre avverbi: esplicitamente, seriamente e credibilmente) come tentativo di soluzione di questi problemi della lotta per la democrazia e contro l’istituzionalismo, credo che incontrerebbe un grande successo; mi sembra che pochi sentimenti siano diffusi nel nostro popolo quanto il risentimento e il vero e proprio disprezzo verso la politica e i politici, che noi possiamo demonizzare quanto vogliamo reiterando l’accusa di qualunquismo mentre ormai tali sentimenti hanno non solo motivazioni sacrosante ma anche un’evidente connotazione di classe. Ora, io credo che ci sia una sola frase che i comunisti non possono sentirsi dire dal loro popolo, mai, in nessuna circostanza, e questa frase è: «Anche voi siete come tutti gli altri». E questa frase, che segna la fine di ogni ipotesi di sinistra politica alternativa, fa oggi parte del diffuso senso comune delle masse. Non so neppure se i nostri dirigenti se ne rendano conto, ma vi assicuro che è così. Per spiegare con un solo esempio cosa intendo dire: oggi penso che sarebbe credibile solo un partito o una federazione di partiti, o un aggregato di partiti e altre forze di sinistra, che esplicitamente, seriamente e credibilmente praticasse cose come la rotazione degli eletti; la loro non rieleggibilità; la collegialità della leadership; anzitutto e specialmente nella rappresentazione mediatica; l’incompatibilità più rigorosa fra cariche istituzionali e cariche di partito; la designazione dal basso dei candidati e delle candidate e la verifica costante in strutture permanenti di democrazia diretta del comportamento degli eletti e delle elette; la riduzione sostanziale degli emolumenti (non solo il ridicolo, e quasi 41 42 provocatorio, taglio dei 3000 euro delle spese per i viaggi all’estero!) ricordando che nella tradizione comunista (fino agli anni Ottanta!, non secoli fa!) l’ammontare degli stipendi degli istituzionali come dei dirigenti corrispondeva al salario degli operai metalmeccanici meglio pagati; la pratica di forme di diritto ineguale, per privilegiare la presenza nelle istituzioni di coloro che la spontaneità capitalistico-borghese esclude ferreamente, a cominciare dalle donne, naturalmente, ma anche dai lavoratori dipendenti, e così via. E, contro ogni alibi, faccio presente che la maggior parte di queste cose si potrebbero fare oggi, o domani stesso, senza aspettare nessuno, con semplici, ma dirompenti!, gesti unilaterali. Analogamente il problema della democrazia nel/nei partiti o nella nuova aggregazione si potrebbe e si dovrebbe riaffrontare dalle fondamenta: idee, esperienze (molte straniere ma molte provenienti dal movimento italiano) e anche proposte assai articolate non mancano, benché io non abbia il tempo di affrontare ora e qui questo problema; ma ci vorrebbe poco perché un’apposita commissione unitaria di «saggi» predisponesse una «pacchetto democrazia» da sottoporre al dibattito unitario. Questo intendo per innovazione (ma altri analoghi esempi si potrebbero fare). 6 Ciò significa che non necessariamente l’innovazione è sinonimo di «svolta a destra», ci può, e ci deve essere un’innovazione che, al contrario, porta a sinistra. Questa identificazione, fra innovazione e svolta a destra è anzi una delle jatture della storia della sinistra da cui occorrerebbe liberarsi una volta per tutte. Se ci pensiamo fu questo uno dei tratti dell’occhettismo, che presentò la liquidazione del Pci e la proposta del Pds appunto come un’«innovazione» a cui si opponevano solo i «conservatori» e i settari. L’esperienza ci ha insegnato, o dovrebbe averci insegnato, dove porta in realtà l’innovazione postmoderna, quando i princìpi, cioè i riferimenti classisti e internazionalisti che ci fanno comunisti, sono sostituiti da fascinose frasi, ultrasinistre per suono e colore ma in sostanza liquidatorie. E ora, quasi vent’anni dopo, e soprattutto dopo che l’esperienza ha dimostrato dove porta quella linea di falso movimento, ci rifacciamo? Se «ci rifacciamo» allora bisognerebbe almeno avere l’onestà di rivalutare Achille Occhetto e di chiedergli scusa. Ma se non si vuol fare questo, allora occorre percorrere tutt’altra strada. Non si tratta, secondo me, di questione di nome: se nel processo della nuova unità a sinistra non tutti saranno comunisti il nome non potrà essere comunista; ma deve essere chiaro che a) l’intero asse della nuova unità sarà e non potrà non essere l’anticapitalismo, e b) che i comunisti rivendicano la possibilità di organizzarsi, o restare organizzati, dentro tale nuovo soggetto, con la loro autonomia e una piena dignità rispetto agli altri soggetti. Guai se il nostro dibattito sull’unità a sinistra fosse fra, da una parte, gli «innovatori», che spingono a destra verso l’abbandono del comunismo e un pastrocchio postmoderno neosocialista, pieno di frasi scarlatte ma sostanzialmente liquidatorio, e dall’altra parte i difensori della natura comunista, di classe e internazionalista della nostra politica, che però si lasciassero intrappolare nella difesa di ciò che è davvero indifendibile, cioè lo status quo dei nostri partiti, la misera cosa (una cosa niente affatto rossa!) che essi sono attualmente. Al contrario, l’unità a sinistra, fra i partiti, i movimenti, le compagne e i compagni del «popolo della sinistra», può essere intesa come un’occasione, forse l’ultima, per rifondare la politica, la nostra politica rivoluzionaria, che non è altro se non un rapporto più intenso e vitale fra formazioni politiche e classe, un nesso fondante fra presenza nella politica e conflitto sociale. IDEE Marx oggi i compiti dei movimenti di liberazione e i loro presupposti teorici E NZO M ODUGNO * V LADIMIRO G IACCHÉ ** a cura di Gianmarco Pisa Centro di Documentazione «Patrizia Gatto», Napoli Negli stessi anni in cui la figura di Lenin è ridotta a una sorta di «tirannello orientale», non si può fare a meno di constatare che i cinque contrassegni dell’«Imperialismo, fase suprema del capitalismo» costituiscono la rappresentazione più corretta di ciò che sta succedendo 43 Q uella che segue è una tavola rotonda con Enzo Modugno e Vladimiro Giacché, svoltasi alla vigilia delle elezioni politiche (aprile 2006), poi rivista a poco più di un anno dall’insediamento del Governo Prodi (giugno 2007). In questa riflessione, situata a cavallo di eventi rilevanti per il futuro della sinistra, dalla sinistra di alternativa al Partito democratico, i temi chiave per l’attualizzazione della lezione di Marx sono venuti subito alla luce: la centralità del conflitto capitale-lavoro, l’esigenza di ri-appropriarsi dei contenuti autonomi del pensiero di classe e le nuove frontiere della trasformazione. Con un occhio anche alle proposte di riforma che è necessario introdurre nel nostro paese, dopo il «deserto sociale» prodotto da cinque anni di governo delle destre e gli effetti devastanti del neoliberismo su scala mondiale, con tutto il portato delle sue contraddizioni, anarchia della produzione e pulsione alla guerra. Le contraddizioni del reale ci consegnano il compito di ripartire da Marx e attualizzarne il messaggio. Da lì parte l’esigenza di questo confronto con due figure rappresentative del panorama intellettuale della sinistra comunista. Per dirla con le parole di Vladimiro Giacché: «In Marx vedo tre “nodi” decisivi: una teoria scientifica dello sfruttamento; il conflitto capitale-lavoro e la centralità del lavoro salariato (tanto più importante oggi, essendo i lavoratori salariati nel mondo ben più che nel passato); e, quindi, una teoria delle contraddizioni della società capitalistica, ineliminabili sul terreno del capitalismo stesso, le quali danno luogo alle crisi e alla caduta tendenziale del saggio di profitto. Marx parlava di “tendenze antagonistiche” a tale caduta, tra cui le più importanti sono la costruzione di nuovi mercati, la tendenza verso il mercato mondiale (mondializzazione) e, infine, la colonizzazione di tutti gli spazi di esistenza sino a oggi sottratti al mercato». Marx, dunque. Da lì si parte. L’INDICAZIONE PER ORIENTARCI POTREBBE OFFRIRCELA GIUSEPPE PRESTIPINO, QUANDO AFFERMA CHE UNA TEORIA «NON PUÒ PROPORSI, SEMPLICEMENTE, DI «TORNARE A MARX»; DEVE FARCI SAPERE SU QUALE MARX CADE LA SCELTA»… MA * SAGGISTA E COLLABORATORE DE «IL MANIFESTO» ** ECONOMISTA QUALE MARX? QUALI IPOTESI PER UNA SUA ATTUALIZZAZIONE? MODUGNO La questione dell’innovazione del marxismo è importante. A essere in ritardo è oggi l’individuazione delle categorie più elementari che Marx ha usato per analizzare il capitalismo. Se di capitalismo si tratta, le categorie marxiane sono ancor oggi all’opera: il lavoro e il mezzo di lavoro, come questi si sono trasformati. Basta dare queste risposte per riempire lo schema teorico marxiano, tanto più che le interpretazioni correnti sono spesso fuorvianti. La più fre- E’ necessario riflettere su cosa significhi produrre e lavorare oggi. Non dimentichiamo che non c’è più la macchina termica ma quella informatica, che richiede un lavoro molto diverso 44 quentata vuole che la classe operaia ci sia ancora ma non nei paesi avanzati: ne segue che i paesi emergenti producono tutta la ricchezza e noi gliela sottraiamo. Ciò è vero solo in parte e perciò è necessario riflettere su cosa significhi produrre e lavorare oggi. Non dimentichiamo che non c’è più la macchina termica ma quella informatica, che richiede un lavoro molto diverso. Marx era stato molto netto a questo proposito. Non questo o quel lavoro, ma lavoro tout court: è lavoro produttivo il lavoro che produce profitti, punto. L’impianto teorico alla base è sempre lo stesso: si tratta di mezzi di produzione gestiti da proprietari capitalistici che assorbono lavoro. Nella società industriale, il capitalista produce ricchezza appropriandosi del lavoro dei nuovi proletari, nucleo storico di classe operaia. Il nuovo lavoratore industriale perde così la sua virtuosità ed è ridotto ad appendice di una macchina che è di proprietà del capitalista. Lo stesso vale per il sapere. Anche qui dopo un lungo processo storico, il capitale conquista un’altra sfera dell’attività umana, l’arte di vendere cognizioni: oggi il capitale «produce e vende cognizioni come qualsiasi mercante che venda cibi e bevande». Queste cognizioni sono oggi la merce più venduta, come mezzo di produzione o di godimento, «valanga di informazioni minute e divertimenti addomesticati». Questo processo va di pari passo con l’alienazione, la separazione del nuovo lavoratore mentale da questa universalità delle conoscenze, divenuta la nuova ricchezza sociale «che cerca di far sua e dalla quale viene ingoiato». Prodotta, scambiata, consumata dalle nuove macchine, la conoscenza ormai gli si contrappone come condizione oggettiva della produzione che appartiene ad altri, dalla quale è stato separato e della quale è ridotto ad appendice quale lavoratore precario. Insomma, sta succedendo alla produzione di conoscenze ciò che successe alla produzione artigianale. Il vecchio proprietario fondiario aveva bisogno dell’aratro ma, per arricchirsi, doveva portarlo sulla terra; allo stesso modo il capitalista industriale aveva bisogno di conoscenze, ma, per arricchirsi, doveva portarle in fabbrica e far lavorare gli operai. Oggi, il capitale, con le nuove macchine informatiche, può realizzare profitti producendo, gestendo e distribuendo conoscenze. Dunque il nuovo lavoratore mentale tende a sostituire da un lato l’operaio e dall’altro il vecchio intellettuale, ridotto a servitore di un complesso di macchine che ne incorporano la virtuosità. Ecco perché non è vero che nella società della conoscenza il cervello umano diventi il nuovo mezzo di produzione, come hanno sostenuto certi ex operaisti. Anzi, il cervello umano ne è escluso: nessuno usa più i calcoli del cervello di un ingegnere per costruire un ponte! Così impostata, la questione della produzione lascia del tutto in piedi le categorie marxiane, indispensabili per capire chi sono i nuovi lavoratori addetti alle macchine informatiche. Non c’è lavoratore oggi che non sia diventato in qualche modo un lavoratore mentale perché in qualunque ramo d’industria ha sempre a che fare con una macchina che manipola segni. GIACCHÉ Il «mio» Marx è vicino a questa interpretazione. In primo luogo, il processo appena descritto è un processo storico. Il momento dell’ideazione c’è sempre stato ed è stato valorizzato già nella teoria economica classica. La novità odierna consiste semmai nella reductio ad unum (dove quest’unità è il mercato capitalistico) di tutto ciò che è riconducibile alla vita e quindi la distruzione sistematica dell’ambiente naturale e della vita sociale. La pericolosità della situazione può essere intesa se si comprende che il capitale, per definizione, ha un orizzonte di breve periodo e non è capace di pensare strategicamente: il suo unico obiettivo è la massimizzazione dei profitti a beneficio dell’accumulazione. Mi riesce difficile prescindere, nel cercare cosa ci serve delle teorie marxiane oggi, dagli sviluppi successivi dati alle sue teorie dai teorici dell’imperialismo. Anche rispetto a questo la realtà attuale è abbastanza stupefacente. Negli stessi anni in cui la figura di Lenin è ridotta a una sorta di «tirannello orientale», non si può fare a meno di constatare che i cinque contrassegni dell’«Imperialismo, fase suprema del capitalismo» costituiscono la rappresentazione più corretta di ciò che sta succedendo. Il primo è la concentrazione tra imprese (monopolio), arrivata a un livello mai conosciuto nella storia del capitalismo: basti ricordare che i profitti della Exxon, 36 miliardi di dollari, sono pari al PIL di 125 paesi. Il secondo è la finanziarizzazione dell’economia: la crescente importanza del capitale IDEE finanziario (cioè la fusione tra capitale industriale e capitale bancario) e la conseguente integrazione tra banca e industria. Il terzo è la crescente importanza dei flussi di capitale rispetto all’esportazione di merci. Vige un autentico «paradosso», in quanto il deficit dei paesi industrializzati è pagato con l’afflusso di capitali dai paesi emergenti con il risultato che, di fatto, i poveri finanziano i ricchi; se il meccanismo saltasse, l’economia Usa crollerebbe. Il quarto è la formazione di cartelli tra imprese che si spartiscono i mercati mondiali. Basta entrare in un’auto per rendersene conto: si è di fronte a tre cartelli, le grandi compagnie petrolifere, assicurative e automobilistiche. Il quinto è la lotta per il controllo delle aree di influenza tra potenze capitalistiche, che contempla la guerra e rappresenta una competizione per l’egemonia delle rispettive aree valutarie. È chiaro che l’unificazione monetaria europea va interpretata come una sfida lanciata al potere di signoraggio monetario del dollaro. Infatti, conquistare potere di signoraggio significa attirare capitali, spostare risorse e partecipare da posizioni di forza alla spartizione internazionale del lavoro. Dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989, dopo la prima guerra in Iraq del 1991, e, pochi mesi dopo, la fine dell’Urss, mentre Fukuyama favoleggia di «fine della storia», a Maastricht nel 1992 si decide di dar vita alla moneta unica europea. Si attiva una sorta di «esempio di scuola» di conflittualità inter-imperialistica, con una attivazione di eventi impressionante. Dopo l’89, il mondo entra in un piano inclinato tutto costellato di guerre: Iraq (1991), Somalia (1992), Bosnia (1993), Kosovo (1999), Afghanistan (2001), oggi ancora Iraq e, forse domani, Iran. Ecco perché per capire queste dinamiche è essenziale rifarsi a Marx e al marxismo. POSSIAMO AFFERMARE DI ESSERE IN CERCA DI UNA PROPOSTA PER L’ATTUALITÀ DEL MARXISMO, TEORIA/PRASSI DELLA LIBERAZIONE E STRUMENTO DI TRASFORMAZIONE DELLA REALTÀ. COME HA SCRITTO MARCELLO MUSTO: «SE SI RITIENE CHE IL PENSIERO DI MARX PARLI ANCORA AL PRESENTE, OCCORRE RILEGGERNE GLI SCRITTI ALLA FONTE. ESSI VANNO DISGIUNTI DAGLI IDEOLOGISMI CHE LI HANNO SPESSO ACCOMPAGNATI». GIACCHÉ L’operazione di lettura filologica è legittima, ma anche velleitaria, perché la lettura del testo è sempre mediata dalla realtà storica e dall’esperienza sociale di chi lo legge. In questo caso, poi, la vitalità di Marx consiste nel fatto che i dati di fondo del modo di produzione che descrive sono gli stessi del modo di produzione in cui viviamo oggi. Il problema non è il «giovane Marx» o il «vecchio Marx», il punto fondamentale per cui Marx serve o non serve è se interpreta in maniera valida la società in cui viviamo. Se ce la fa, bene, altrimenti bisogna trovare una teoria sostitutiva. MODUGNO La lettura filologica è pienamente legittima perché il ciar- pame che avvolge Marx è veramente cospicuo. Quindi, andare a vedere cos’era veramente Marx è operazione necessaria, se non altro per scrostarlo da certi orpelli del Novecento… GIACCHÉ …purché i recuperi non corrispondano a una esorcizzazione! In questo senso la riscoperta dei Grundrisse è stata straordinaria così come il lavoro di ri-edizione della Mega [Marx-Engels Gesamtausgabe], l’opera completa, sta mettendo nuovi materiali a disposizione. In definitiva, possiamo convenire che Marx è il Marx del Capitale: è un pensatore unitario perché consequenziale, dotato di un proprio processo di sviluppo e di una ricca articolazione del ragionamento, il cui approdo è l’opera che ci ha consegnato. MODUGNO Marx è ancora insuperabile proprio perché è andato più avanti nella teoria del capitale. La sua è l’ultima sintesi complessiva: la sua critica dell’economia politica è più che mai attuale e avanzata. TORNIAMO AL TEMA CENTRALE DELLA NOSTRA DISCUSSIONE. NUOVE FRONTIERE DELLA LIBERAZIONE, PERCORSI DI SUPERAMENTO DEL CAPITALISMO E LORO DIALETTICA CON IL PATRIMONIO STORICO DEL SOCIALISMO. QUALI IPOTESI PER UNA COERENTE ATTUALIZZAZIONE, ANCHE ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI ESPERIENZE DI TRASFORMAZIONE E DELLA PROPOSTA ODIERNA, DA PIÙ PARTI EVOCATA, DEL «SOCIALISMO DEL XXI SECOLO«? GIACCHÉ Faccio riferimento all’esperienza dei movimenti, in generale, degli ultimi anni. Credo che quando si usa lo slogan «un altro mondo è possibile» (senza dire quale mondo) automaticamente si afferma che un altro mondo è impossibile. In effetti, uno dei presupposti anche dei movimenti, e non solo dell’ideologia liberale, è quello dell’intangibilità dell’attuale modo di produzione. Questo presupposto condanna il movimento e lo spinge all’indeterminatezza, perché presuppone, nella migliore delle ipotesi, una sfiducia nel fatto che movimenti di liberazione basati sulla abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione possano risultare efficaci. Questo chiude l’orizzonte della trasformazione nei nostri paesi. Viceversa, i paesi dell’America Latina in cui il processo di trasformazione è più consolidato (pensiamo a Cuba, al Venezuela di Chavez e oggi alla Bolivia di Morales), hanno fatto una chiara esperienza di espropriazione che li colloca in una dimensione più avanzata. Il fermento che contraddistingue oggi il subcontinente lo dimostra. MODUGNO Anche in questo caso vale la lezione della storia. Se tanto mi dà tanto, può servire ricordare cosa è stata la guerra del Vietnam: la nazione più potente del mondo – contro 45 MODUGNO Il fatto più rilevante è che gli Stati Uniti, ininterrottamente dalla Seconda guerra mondiale, hanno gestito militarmente il ciclo economico. È interessante notare che le diverse fasi del ciclo economico segnano le diverse ondate delle campagne militari Usa, che sostengono il rilancio economico con l’intervento militare, le spese per commesse di guerra, l’investimento pubblico nel complesso militar-industriale. In definitiva, appare sempre più evidente come la spesa militare e la guerra siano uno strumento fondamentale per la politica economica degli Stati Uniti. Basti considerare che, quando l’economia Usa è in crisi, dopo due o tre trimestri consecutivi di contrazione, ecco che, in genere sei mesi dopo, scoppia una guerra. Questa traccia dei sei mesi è ricorrente: la guerra di Corea comincia sei mesi dopo la crisi del dicembre 1949; le Torri Gemelle crollano sei mesi dopo la crisi del marzo 2001. Anche l’11 settembre sembra rispondere alla medesima logica anti-ciclica. Il problema è come mai tutto ciò non passa nel dibattito pubblico. 46 una nazione di contadini, sia pure eroici – costretta dodici anni nel pantano, per poi finire sconfitta e ritirare le bare avvolte dalla bandiera a stelle e strisce. Quando Sweezy e Magdoff facevano conferenze nelle Università americane in quegli anni, gli studenti erano convinti che lì ci fossero chissà quali riserve di uranio che giustificassero quella carneficina. L’aggressione Usa era stata in realtà militarmente priva di senso, come rivelarono poi i«Vietnam Papers». Lo stesso, mutatis mutandis, avviene oggi in Iraq. Anche quella in Iraq è una guerra «misteriosa», come dice lo storico militare inglese John Keegan, cioè, ancora una volta, militarmente priva di senso: doveva durare cinque anni, erano stabilite «a priori» modalità e durata e, soprattutto, non bisognava far scoprire i retroscena della guerra stessa, le ragioni non propriamente militari della crescita abnorme dell’apparato bellico degli Stati Uniti. Ma questo castello rivela tutta la sua fragilità, come dimostra anche la sconfitta di Bush alle elezioni di medio termine per il Congresso. GIACCHÉ La grande sconfitta del movimento per la pace è venuta quando ha resistito in maniera flebile all’idea dell’«esportazione della democrazia» o ad altre tesi (che continuano a essere riproposte, come testimonia la relazione di Fausto Bertinotti al congresso della Sinistra Europea dello scorso 16 giugno) come la «spirale guerra-terrorismo». Quando si dice che «non si combatte così la guerra al terrore», non ci si accorge che così si accetta il presupposto stesso della «guerra al terrore». Si fanno propri, cioè, alcuni corollari insostenibili: il terrorismo esclude l’attività degli eserciti regolari, come se questi non si rendessero responsabili di episodi di terrorismo (basta vedere la Palestina); si accetta la metafora della «guerra» per combattere il terrorismo e che il terrorismo sia «autonomo», dimenticando che è semplicemente una tattica che può essere al servizio dei fini più disparati. Insomma, accettare la guerra al terrore e la «spirale guerra-terrorismo» significa consegnare la vittoria al Pentagono, nel senso che oggi la grande vittoria degli apparati statunitensi è quella di aver imposto un lessico e una agenda, alle quali non ci si riesce a sottrarre. I MECCANISMI DOMINANTI, DI SOPRAFFAZIONE E AGGRESSIO- NE, CHE CONTENGONO IL NERBO DELLA VIOLENZA, COSTRUISCONO LE LORO ARCHITETTURE IDEOLOGICHE, LE LORO CUL- ALTRO NESSO CHIAVE È QUELLO TRA ECONOMIA E GUERRA. ANCOR OGGI LE CLASSI DOMINANTI SCELGONO L’OPZIONE MILITARE COME VETTORE ANTICICLICO PER L’ACCUMULAZIONE, COMPRIMENDO LE ISTANZE DI EMANCIPAZIONE; LA MEDESIMA AMBIZIONE USA A «MODELLARE IL FUTURO» RISPONDE A UNA LOGICA DI «POTENZA» CHE SEMBRA QUASI ATTINGERE A UN’ISPIRAZIONE «HEGELIANA», NEL SENSO CHE «LO STATO DEVE AVERE DEI NEMICI, PERCHÉ PUÒ NASCERE E DURARE SOLO NEL GIOCO DI UN CONFRONTO MILITARE». TURE ATTE A GIUSTIFICARNE CONDOTTE ED ESITI. IL LIBERALISMO, DUNQUE, COME PRODOTTO IDEO-POLITICO DELLA CLASSE DOMINANTE, CONSUSTANZIALE ALLA GUERRA. MODUGNO Il liberalismo è l’ideologia del denaro: i capitalisti sono condannati a far passare tutte le cose prodotte attraverso il denaro. Anche per appropriarsi del lavoro altrui devono farlo diventare denaro. Questa è la loro condanna: sono IDEE diverse fasi del ciclo economico segnano diverse ondate delle campagne militari Usa, che sostengono il rilancio economico con l’intervento militare, le spese di guerra, l’investimento pubblico nel complesso militarindustriale. E’ sempre più evidente come spesa militare e guerra siano uno strumento fondamentale per la politica economica Usa condannati all’astrazione che è strumento di dominio e al contempo di disfatta. Non a caso, per ovviare alle crisi, uno dei mezzi cui fanno ricorso è il militarismo. È in questa chiave che si inscrive il nesso tra liberalismo e militarismo: il militarismo è prodotto dalla logica di accumulazione legittimata dal liberalismo in quanto ideologia della classe dominante. Oggi, l’unità produttiva è fatta di una macchina diversa da quella del passato, ha bisogno di un lavoro diverso, incorpora i saperi che prima le macchine non possedevano e ciò rende inutile il keynesismo di sinistra (welfare), perché non si ha più necessità di mantenere operai specializzati. Se tutto è fungibile e il lavoro stesso diventa precario, allora si può realizzare l’obiettivo storico del capitale, cioè prendere il lavoro quando serve e mandarlo via quando non serve più. Il welfare dunque era un’esigenza della fabbrica fordista. Rimane, per la gestione del ciclo, la disponibilità dei vettori di accumulazione anti-recessiva, come ad esempio la spesa pubblica per investimenti militari, ovvero il keynesismo di destra (warfare); il capitale non può fare a meno di questo versante e lo giustifica in maniera ideologica, con la «guerra al terrore». Ecco perché neoliberismo e guerra sono, dal punto di vista del capitale, più avanzati dell’alternarsi di keynesismo militare e keynesismo civile. Neoliberismo e guerra sono complementari, perciò il keynesismo ha vinto nella sua forma militare, il warfare. GIACCHÉ L’ideologia per cui democrazia e pace si diffondono grazie al libero mercato è molto vecchia. La ritroviamo già nel Settecento e ancora alla vigilia della Prima guerra mondiale. Recentemente Fukuyama ha ripreso questo tema, addirittura dicendo che non esistono più guerre per le risorse energetiche e che anzi esse appartengono inesorabilmente al passato, perché il binomio democrazia e libero mercato si diffonderà in tutto il mondo. È la celebre tesi della fine della storia, alla quale rispose con qualche sarcasmo perfino la Thatcher: End of history, beginning of nonsense («Fine della storia, inizio del non senso»). Il punto è che il libero mercato è una costruzione ideologica perché, in realtà, non esiste: Alan Freeman ha detto chiaramente che il mercato è, né più né meno, un sistema concretamente esistente da trecento anni, fondato sulla repressione interna e sulla guerra esterna. È un concetto chiave per comprendere la connessione tra capitalismo, liberalismo e guerra. Lo stesso Marx, interrogandosi nel Capitale sull’«accumulazione originaria», spiega che la storia del capitalismo è storia di violenza, dalle enclosures alle leggi contro il vagabondaggio, che promossero la creazione del proletariato industriale in Inghilterra; dalle guerre commerciali alle guerre per le risorse. Insomma, la storia del capitalismo è storia di continue aggressioni. Non è mai esistita una fase irenica, pacifica del capitalismo. ALL’ACQUISIZIONE DI QUESTA CONSAPEVOLEZZA DEVE PERÒ CORRISPONDERE LA PREDISPOSIZIONE DELLE STRADE DEL «SUPERAMENTO». SOTTO QUESTO PROFILO, IL KEYNESISMO È ANCORA UNA SOLUZIONE TRANSITORIA PRATICABILE PER IL MOVIMENTO OPERAIO? IN PARTICOLARE, ANCHE ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE DI «SINISTRE» IN ITALIA EUROPA, IL KEYNESISMO DI SINISTRA, BASATO SUL COMPROMESSO DEL WELFARE, È ANCORA ATTUALE? GOVERNO DELLE ED MODUGNO Non bisogna dimenticare che i capitalisti, sull’onda della crisi, hanno bisogno della guerra per recuperare il ritardo accumulato, sostenendo il settore privato attraverso l’indebitamento dello Stato. Tuttavia, oggi le risposte anticicliche sono più spaventose. In passato, le crisi erano crisi di sovrapproduzione e determinavano l’alternanza del ciclo: crisi, ripresa, crisi; dopo la distruzione della parte maggioritaria di capitale, quello che restava ritrovava il mercato. Già con la Prima guerra mondiale si decise che non conveniva aspettare che la crisi distruggesse i propri capitali, era meglio andare a prendere i mercati altrui, distruggendone i capitali e depredandone le risorse. Fu il primo tentativo compiuto in questa direzione. GIACCHÉ La tendenza alla guerra è la dimostrazione pratica delle conseguenze disastrose delle crisi capitalistiche e non è un caso che tutti i tratti peggiori della storia del Novecento (la mobilitazione delle masse e la coazione del consenso, le dittature reazionarie e i campi di sterminio) siano frutto delle crisi e connesse a questa dinamica e alle sue tragiche conseguenze. MODUGNO È anche vero, però, che non si può fare una guerra mondiale ogni volta che arriva una crisi. Nel ’29, per esempio, non fu possibile e gli Usa dovettero subire una crisi terrificante che durò fino alla Seconda guerra mondiale. In quella circostanza si verificò anche che gli Stati Uniti subirono una depressione contro la quale non poté valere il welfare (quello è il periodo in cui nasce il welfare svedese, e ciò fa capire cosa sia il welfare, 47 Lo stesso Marx spiega che la storia del capitalismo è storia di violenza, dalle enclosures alle leggi contro il vagabondaggio; dalle guerre commerciali alle guerre per le risorse. Insomma, la storia del capitalismo è storia di continue aggressioni. Non è mai esistita una fase pacifica del capitalismo 48 quando e perché nasca). In quel frangente maturò la tesi keynesiana: non aspettiamo che la crisi arrivi; facciamo intervenire lo Stato per mobilitare le risorse necessarie a scongiurare le crisi. Il keynesismo punta esattamente a questo: lo Stato fa debiti nella fase di contrazione per poi recuperarli nelle fasi di crescita. La Seconda Guerra Mondiale rappresentò l’occasione per gli Stati Uniti per uscire dalla crisi. Nella logica del warfare,è la spesa militare che rilancia l’economia statale… GIACCHÉ …ovviamente, a determinate condizioni: che la guerra non arrivi in casa, che la mobilitazione popolare sia irreggimentata e, logicamente, che la guerra alla fine si vinca. Il problema è il costo di questa strategia; e questo costo si chiama «debito pubblico Usa» che rappresenta una mina vagante nel sistema finanziario internazionale. Ad esempio, il valore del dollaro rispetto all’oro sta continuando a scendere; ciò significa che il valore reale del dollaro continua a ridursi, perché gli Usa inondano il mondo di dollari e questo genera dinamiche inflattive. Anche nel confronto con le altre valute dominanti, il dollaro tende a deprezzarsi. Questo è un punto assai delicato. Inoltre, da quando (1971) sono saltati gli accordi di Bretton Woods, venuta meno la convertibilità del dollaro in oro, il dollaro è una sorta di «moneta fiduciaria», nel senso che vale nella misura in cui è «accettata» come strumento di transazione per lo scambio delle materie energetiche. Ecco perché gli Usa devono assolutamente evitare una alternativa al dominio del dollaro; ed ecco spiegate la minaccia di una guerra contro l’Iran e la contrapposizione per «interposta persona» (Polonia, Repubblica Ceca) al rafforzamento dell’unità europea. Rispetto al passato, la differenza sostanziale è che esiste una valuta che può affermarsi in alternativa al dollaro come valuta internazionale di riserva. Non è velleitario oggi contendere al dollaro la capacità di acquisire potere di signoraggio e perciò gli Stati Uniti rafforzano la propria proiezione strategica in Europa. Ad esempio, nel 1999, con la guerra del Kosovo, gli Usa determinano un crollo dell’euro, che, partito da 1.16 sul dollaro, comincia poi a declinare da marzo-aprile, in coincidenza con i bombardamenti della Nato. Il dollaro ha continuato a crescere per qualche anno e poi ha preso a declinare e, in corrispondenza con le spese di guerra in Iraq, è andato sempre più giù salvo riprendersi in parte nel 2005, grazie ai proventi del commercio del petrolio, al rimpatrio dei profitti delle grandi imprese e alla politica dei tassi di interesse, che sono più elevati rispetto a quelli applicati dalla Banca centrale europea. ARRIVIAMO AI COMPITI DI FASE. GO- VERNO DEL PAESE E PROPOSTE PER UNA «CONL’OPZIONE DEL SOCIALISMO DEL XXI SECOLO, A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE IN AMERICA LATINA, IN EUROPA SEMBRA PARTIRE DALSINISTRA DI TRASFORMAZIONE TEMPORANEA». IDEE L’OBLITERAZIONE DEL NESSO CAPITALE-LAVORO. È UN PRE- SUPPOSTO INCONCILIABILE CON UNA OPZIONE POLITICA CHE INTENDA ISPIRARSI AL SOCIALISMO, PER QUANTO INNOVATO… GIACCHÉ Sono convinto che bisogna ricominciare a parlare di classe, fare un ragionamento serio di re-distribuzione e invertire la tendenza di fondo di questi anni, facendo leva anche sullo strumento fiscale. La fiscalità rappresenta uno degli strumenti più classici di «lotta di classe dall’alto». La fiscalità in Italia, oggi, è, di fatto, regressiva ma la tendenza può (e deve) essere invertita. Oggi, registriamo una struttura parassitaria di gran parte del capitale italiano. I super-profitti fatti negli anni Novanta sono serviti a rimpinguare le tasche dei padroni senza fare investimenti nelle imprese. Si è spinto il paese su una frontiera di competitività insostenibile, la competitività di prezzo e non di prodotto, con tutto che non abbiamo più le svalutazioni competitive, l’evasione fiscale non può giungere oltre i livelli attuali e la compressione salariale non può essere spinta ancora oltre. Purtroppo, a fronte di tutto questo, non si riescono a scorgere politiche seriamente riformatrici, perché oramai c’è una «cappa ideologica». L’idea che i costi non debbano essere re-distribuiti su quella classe che ha accumulato in questi ultimi anni profitti enormi, rivela un tabù di fondo. La tesi dominante è che tutto ciò che fa bene al capitale fa bene anche al paese, mentre è provato che semmai è vero il contrario. Anche il «catalogo dei diritti» (i diritti fondamentali, i beni comuni ecc.) è un nonsense, perché non esistono diritti garantiti ab aeterno, esistono bisogni che, se vengono esigiti con la lotta, possono dare luogo a diritti, come il contratto di lavoro. Basta ricordare lo slogan delle mobilitazioni francesi per i diritti sociali e contro il Cpe (il contratto precario di primo impiego): «Cento anni per farlo, un Cpe per toglierlo» (con ovvia allusione al contratto di lavoro). Proprio questa lotta vittoriosa ci indica la strada giusta. Da noi però illustri studiosi di area Partito democratico, come Michele Salvati, non trovano di meglio che dire che «il peso della precarietà non deve gravare sui giovani, ma essere distribuito sull’intera forza-lavoro». Ebbene, è proprio questo l’approccio che va rovesciato. MODUGNO Inoltre il nuovo modo di produzione pone problemi a cui le sinistre non hanno risposto: in particolare quello dell’attualità di una proposta di governo «progressiva». Le sinistre vogliono tornare indietro al keynesismo di sinistra, sono le «vedove del welfare», ma il welfare è legato, come detto, al ciclo fordista, all’operaio specializzato, alla catena di montaggio. Oggi, con le nuove macchine, si producono nuova ricchezza e nuovi lavoratori che prima non c’erano. I lavoratori sono sempre la prima e più importante produzione del capitale che ha dovuto distruggere la vecchia classe operaia con i suoi rappresentanti, in un ci- 49 mento storico durato decenni, per produrre un nuovo lavoratore, che avesse caratteristiche diverse dall’operaio tradizionale: più acculturato e flessibile, legato a una nuova fase del capitalismo, in cui la produttività sarebbe aumentata. Tornare indietro al keynesismo di sinistra è come tornare indietro nella storia. Il modo più avanzato dell’organizzazione del capitalismo è questo «liberismo con l’elmetto». Proprio in questo nuovo contesto, si giocano le possibilità dei nuovi lavoratori, i quali hanno delle chances diverse da quelle che avevano gli operai tradizionali: sono tutti acculturati e, quindi, pur essendo diversi dai vecchi intellettuali, in qualche modo vivono come intellettuali e hanno una capacità produttiva superiore a quella degli operai tradizionali. Proprio per questo, conoscono intimamente il rapporto capitale-lavoro, hanno già dato segno di sé negli ultimi decenni e sono teoricamente pronti ad assumere un protagonismo nelle mobilitazioni di massa. Bisogna, a tal proposito, interpretare le lotte di classe degli ultimi decenni, perché queste nuove forme di lavoro sono tornate molte volte sulla scena, pur se con aspetti diversi. Ma è necessario interpretare le forme che le lotte hanno assunto, perché possono tutte essere ricondotte al nuovo scontro tra capitale e lavoro che si presenta in forme diverse da quelle del passato ma potenzialmente molto più ricche di consapevolezza anticapitalistica. questione meridionale e questione sarda i temi dell’autonomia e l’elaborazione dei comunisti prima parte G IANNI F RESU * 50 Democrazia progressiva e autonomia N ella storia del movimento operaio italiano il Partito comunista ha saputo divenire un grandissimo strumento di partecipazione popolare grazie anche alla sua capacità di leggere le peculiarità storiche, economiche, sociali e culturali del nostro paese, costruendo su esse una prospettiva socialista che non fosse una riproduzione «pappagallesca» della teoria generale marxista. In questo senso la lezione leniniana sulla necessità di concentrarsi nello studio delle specificità di ogni singola «formazione economico-sociale», piuttosto che dedurre deterministicamente dalle leggi generali dell’economia le ragioni del socialismo e l’inevitabilità della rivoluzione, ha lasciato un solco profondo su cui si è innestata una elaborazione assai originale nella sua ricchezza e articolazione. Di questa ricchezza fa parte sicuramente lo sforzo per leggere nelle diversità dei rapporti di sfruttamento delle varie realtà italiane una trama unitaria, in ragione della quale, ad esempio, la questione meridionale andava intesa come grande questione nazionale, come crocevia attorno al quale ruotavano alcuni dei principali snodi degli assetti di dominio della società italiana. All’interno di questa storia si inserisce anche la questione sarda e il tema dell’autonomismo nell’elaborazione dei comunisti. Esso nasce e si sviluppa con una prospettiva storicistica che ha quale dato di partenza due elementi nodali: 1) la condizione di oppressione secolare del popolo sardo nel corso delle diverse dominazioni, oppressione che ha trovato nei molteplici frangenti storici il fattivo sostegno delle stesse classi dirigenti sarde; 2) la marginalizzazione dei movimenti culturali e politici della Sardegna – da parte della letteratura storica e scientifica italiana – la sottovalutazione sistematica, sul piano politico, del diritto all’autodeterminazione culturale e politica, pur nel quadro unitario dello Stato italiano. Il punto di approdo dell’autonomismo comunista si situa in una nuova concezione di sardismo inteso come terreno d’incontro tra gruppi intellettuali e masse sarde nella prospettiva del socialismo. Per affrontare con sufficiente chiarezza questo tema è opportuna una precisazione preliminare sul contesto che gli fa da sfondo, più precisamente sulla situazione che caratterizza il Pci all’indomani della caduta del fascismo. Con la «Svolta di Salerno» il Pci intraprendeva la strada dell’unità di tutte le forze antifasciste, comprese quelle stesse forze che avevano reso possibile e agevolato l’ascesa del fascismo (monarchia, esercito, liberali), rinviando la questione istituzionale su forma di Stato e forma di governo a liberazione avvenuta. Questa svolta, decisiva nel processo di liberazione dal nazifascismo, Se nel confronto tra le esperienze dei comunisti del Nord e quelli del Sud era possibile parlare di dualismo, rispetto alla Sardegna la differenza era ancora maggiore, perché l’isolamento geografico e l’assenza di contatti con la ricostituita direzione nazionale aveva lasciato fuori il Pci sardo dalla dialettica innescata dalla «Svolta di Salerno», che era stata recepita nell’isola come un «abile espediente tattico» * PRC-COMITATO POLITICO NAZIONALE IDEE impegnava i comunisti nella ricostruzione del quadro democratico senza alcuna ambiguità tattica o «doppiezza», si trattava di una scelta strategica destinata a mutare il ruolo dei comunisti nella storia d’Italia. Ma come è stato ampiamente rilevato in sede storiografica, la «Svolta di Salerno», nel Sud e nelle Isole, non si traduce immediatamente in una radicale riorganizzazione del modo di operare dei comunisti. Nel Mezzogiorno permangono limiti enormi sia tra le file dell’antifascismo, sia tra quelle del Partito comunista. Su questi limiti si è soffermato con attenzione Antonello Mattone: «Lo stesso dibattito interno sulle tematiche della svolta registra un dualismo di esperienze opposte tra le organizzazioni comuniste del Nord e quelle meridionali. Mentre nel Nord l’atteggiamento dei quadri è volto ad approfondire i contenuti della formula di democrazia progressiva e l’articolazione della nuova società antifascista attraverso i Cln, nel Mezzogiorno prevale la preoccupazione, frutto di un massimalismo generico e sovente anche messianico, di riaffermare i principi del comunismo e la purezza classista della linea politica. In definitiva il partito nel Meridione si pone al di fuori della linea indicata nella svolta; nel migliore dei casi essa viene interpretata come un espediente tattico necessario per la conquista del potere. Atteggiamenti e orientamenti settari sono assai diffusi nel partito, ne costituiscono quasi una doppia anima»1. Dall’8 settembre in poi si fa largo una realtà frammentata che a stento può essere identificata con una entità nazionale unitaria; non a caso Spriano, in proposito, ha parlato di tante Italie all’interno delle quali si diramano ulteriori sottoframmentazioni addirittura municipali. Tra esse proprio la Sardegna si distingue per il suo totale isolamento. Se nel confronto tra le esperienze dei comunisti del Nord e quelli del Sud era possibile parlare di dualismo, rispetto alla Sardegna la differenza era ancora maggiore, perché l’isolamento geografico e l’assenza di contatti con la ricostituita direzione nazionale aveva lasciato fuori il Pci sardo dalla dialettica innescata dalla «Svolta di Salerno», che era stata recepita nell’isola come un «abile espediente tattico» ancora più che nel resto del Mezzogiorno. In Sardegna il partito, che muove i suoi primi passi, si trova di fronte a un compito immane di ricostruzione delle 51 sue basi. Per andare oltre la condizione di silenzio e isolamento che i lavoratori sardi avevano dovuto subire per un intero ventennio, compito primario era di non ricadere nelle divisioni corporative che avevano limitato la sua forza egemonica nel passato, quando il movimento socialista rimase recintato nei bacini minerari limitandosi alle sole rivendicazioni degli interessi operai. Bisognava cioè unificare, sul piano politico generale, le rivendicazioni parziali della classe operaia, delle masse contadine e agro pastorali, in unico movimento popolare sardo capace di dettare l’agenda delle priorità della ricostruzione e l’orientamento del nuovo modello di sviluppo. I lavoratori dovevano liberarsi per sempre dallo sfruttamento secolare a cui erano stati sottoposti, il che significava liberarsi non solo dal dominio padronale straniero, ma contrastare da posizioni di forza anche quello sardo, per porsi essi stessi come nuova classe dirigente dell’Isola. Ma tra i comunisti sardi si afferma anche una tendenza storicamente radicata, seppur minoritaria, con ispirazione indipendentista. Al primo Congresso regionale del partito, svoltosi a Iglesias il 13 e 14 marzo del 1944, una delegazione di comunisti galluresi si presentò chiedendo di essere accreditati all’assise in qualità di membri e delegati del Partito comunista sardo, del quale esisteva uno statuto e un programma. La richiesta venne respinta all’unanimità e si offrì al gruppo del Pcs di partecipare ai lavori senza diritto di voto. Il gruppo del Pcs si era sviluppato, fondamentalmente nella provincia di Sassari, nel caos organizzativo e politico proprio del periodo che va dal dicembre del 1943 al giugno 442. Il Pcs nel suo manifesto si richiamava all’ideale della Re- 52 pubblica federativa sovietica della metà degli anni Venti e indicava come obiettivo programmatico la costituzione di un’autonoma Repubblica sarda degli operai e dei contadini. Nel solco tracciato dal Krestintern del 1925 il Pcs riproponeva l’alleanza strategica con il PSd’A e intendeva federarsi al Comintern (in realtà già sciolto per l’alleanza contro il nazifascismo) autonomamente dal Pci. Il Pcs, pur ricollegandosi alla linea del Pci, «riteneva che la Sardegna fosse una realtà a sé stante e che male sopportasse l’imposizione di forme istituzionali e di organismi politici propri del continente; individuava nella politica fiscale dello Stato la causa dell’arretratezza dell’isola e criticava l’incapacità del liberalismo, del fascismo, ma anche del socialismo, di dare alla Sardegna un assetto politico e istituzionale consono alle sue peculiarità. Solo al sardismo si riconosceva di aver compiuto uno sforzo in tale direzione, peraltro inadeguato per carenze organizzative e programmatiche»3. L’emergere, ed eventualmente il prevalere, di posizioni isolazioniste, come quelle del Pcs, tra i comunisti sardi avrebbe potuto significare l’autoestromissione della Sardegna dal profondo processo di rinnovamento democratico di cui la Resistenza antifascista era protagonista. Ciò indusse tutto il gruppo dirigente sardo del Pci a combattere con durezza le posizioni separatiste, così come i residui di settarismo che ancora galleggiavano tra i suoi quadri e militanti: il partito doveva operare a stretto contatto con le condizioni materiali di esistenza delle classi subalterne, la sua composizione sociale e la sua direzione politica dovevano sorgere naturalmente da esse. Il «partito nuovo» non poteva più essere l’organizzazione degli avvocati e dei professori, doveva realmente divenire il partito dei lavoratori. Da Lione alla Q ue s tio ne m e rid io nale , l’alleanza operai-contadini Costruire in Sardegna un partito di lavoratori di massa significava affrontare di petto la questione contadina e investire tutte le proprie energie nella costruzione di un movimento avanzato tra le masse dei contadini senza terra e i braccianti per sottrarli all’influenza e alla direzione della Chiesa e dei movimenti più conservatori. In Sardegna favorire la nascita del movimento cooperativo tra contadini e pastori era l’unico modo per superare la dispersione sociale e territoriale di quelle realtà e anche il modo per dare un radicamento di massa al partito. Bisognava lavorare nel movimento contadino fino a svilupparlo e a farne una forza sociale capace di incidere sugli equilibri politico-sociali dell’isola. L’emergere di una questione meridionale, e al suo interno di una specifica questione sarda, era scaturito dal tentativo di tradurre in italiano la teoria politica di Lenin, a partire dal tema dei temi, per quel tempo: l’alleanza operaicontadini, che si era rivelata determinante per la vittoria della Rivoluzione d’Ottobre. Le riflessioni delle Tesi di Lione e la Questione meridionale rispondevano esattamente a questa esigenza nel tentativo di disarticolare il blocco sociale reazionario che dominava l’Italia dall’Unità all’avvento del fascismo. Secondo le Tesi di Lione, l’elemento predominante della società italiana era dato da una particolare forma di capitalismo nel quale convivevano un industrialismo ancora debole e incapace di assorbire la maggioranza della popolazione e un’agricoltura che costituiva la base economica del paese, segnata dalla netta prevalenza in essa di ceti poveri (bracciantato agricolo) molto prossimi alle condizioni del proletariato e perciò sensibili alla sua influenza. Tra le due classi dominanti – industriali e agrari – si poneva quale elemento di raccordo una media e piccola borghesia urbana abbastanza estesa. La debolezza del modo di produzione in Italia – che non poteva disporre di materie prime – spingeva gli industriali a varie forme di compromesso economico con i grandi latifondisti agrari che si basavano su «una solidarietà di interessi» tra ceti di privilegiati a detrimento degli interessi generali della produzione e della maggioranza della popolazione. Anche il processo risorgimentale era espressione di questa debolezza, perché la costruzione dello Stato nazionale era stata possibile grazie allo sfruttamento di particolari fattori di politica internazionale e il suo consolidamento aveva necessitato quel compromesso sociale che ha reso inoperante in Italia la lotta economica tra industriali e agrari, la rotazione di gruppi dirigenti, tipici di altri paesi capitalistici. Secondo Gramsci, questo compromesso a tutela di uno «sfruttamento parassitario» delle «classi dominanti» aveva determinato una polarizzazione tra l’accumulo di immense ricchezze in ristretti gruppi sociali e la povertà estrema del resto della popolazione; aveva comportato il deficit del bilancio, l’arresto dello sviluppo economico in intere aree del paese (come il Mezzogiorno), ostacolando una modernizzazione del sistema economico nazionale armonica e calibrata con le caratteristiche del paese. Il compromesso tra industriali e agrari attribuiva alle masse lavoratrici del Mezzogiorno la stessa posizione delle popolazioni coloniali; per esse il Nord industrializzato diveniva come la metropoli capitalistica per la colonia; le classi dirigenti del sud (grandi proprietari e media borghesia) svolgevano la stessa funzione delle categorie sociali delle colonie che si alleano con i coloni per mantenere la massa del popolo soggetta al proprio sfruttamento. Tuttavia nella prospettiva storica questo sistema di compromesso si è rivelato inefficace perché si è trasformato in un ostacolo allo sviluppo tanto dell’economia industriale, quanto di quella agraria; ciò ha deter- IDEE minato in diverse fasi livelli molto acuti di lotta tra le classi e quindi la pressione sempre più forte e autoritaria dello Stato sulle masse. In Italia il processo d’unificazione nazionale non si è realizzato sulla base di un rapporto d’uguaglianza, ma attraverso una relazione squilibrata all’interno della quale l’arricchimento e l’incremento industriale del Nord dipendono strettamente dal crescente impoverimento del Mezzogiorno. Nella Questione meridionale, premessa fondamentale alle riflessioni sul Risorgimento nei Quaderni, Gramsci definisce il Mezzogiorno come una grande disgregazione sociale, all’interno della quale i contadini non hanno alcuna coesione tra di loro. Le masse contadine, che costituiscono la maggioranza della popolazione meridionale, non riuscendo a dare «espressione centralizzata» alle proprie aspirazioni, materializzano il loro perenne fermento attraverso uno stato di ribellismo endemico privo di prospettive. Al di sopra di queste masse si struttura l’assetto di dominio del blocco agrario che, attraverso le sue «proporzioni definite», riesce a mantenere le masse contadine permanentemente nella loro condizione «amorfa e disgregata» e a evitare qualsiasi forma di centralizzazione a quello stato di perenne fermento. L’esito del Risorgimento entro un equilibrio moderato non ha fatto altro che innestare su questa secolare struttura di potere il dominio del capitalismo settentrionale saldatosi, dopo l’unità, a quello della borghesia agraria del Sud in un nuovo blocco storico la cui chiave di volta risiedeva nella funzione degli intellettuali. Gramsci dunque nel porre la questione contadina come questione meridionale rappresenta quest’ultima come questione nazionale, all’interno della quale si situa con le sue specificità geografiche storiche e culturali, una questione sarda. La dialettica con la Dc alla Costituente e l’emergere della questione autonomistica Tuttavia nel Pci del dopoguerra per giungere nuovamente a questa consapevolezza, e ricomporre il filo interrotto con l’elaborazione della metà degli anni Venti, occorreranno anni e un lungo processo di lotte e riflessioni. Bisogna infatti ricordare che nel dibattito dell’Assemblea costituente la posizione del Pci era più orientata verso il municipalismo, che rivendicava la continuità storica con la tradizione dei comuni e intendeva mettere a valore il patrimonio delle «cento città»; era una posizione che si basava sulla necessità di un forte decentramento amministrativo a comuni e province ma sul rispetto assoluto dell’unità politico territoriale del paese e quindi della potestà legislativa centrale. Il Pci interpretava al tempo la funzione delle regioni ordinarie come enti autarchici e organi di largo decentramento amministrativo. Secondo quella posizione, la creazione di una struttura federale o a forte regionalismo avrebbe invece portato al consolidarsi dei blocchi di potere che dominavano il Mezzogiorno acuendo la frattura tra Nord e Sud, ma soprattutto avrebbe impedito l’attuazione organica e omogenea delle riforme a carattere generale, le cosiddette «riforme di struttura». Dunque solo per Sardegna e Sicilia si prevedeva un ipotesi di specialità nell’attribuzione di competenze, facendo però salva la capacità impositiva e d’intervento dello Stato, che era ritenuto il solo organo capace di reperire le risorse e approntare gli strumenti per le profonde trasformazioni economiche e sociali che le due Isole necessitavano. Sul terreno dell’articolazione dei poteri e della struttura regionale, il Pci alla Costituente esprimeva ancora una posizione molto arretrata seppur imposta da un contesto assai complesso: si riconosceva che l’istituzione delle regioni avrebbe avvicinato il popolo alle amministrazioni attraverso il decentramento, ma si sottolineava altresì che, qualora alle regioni fossero stati attribuiti poteri esorbitanti da quelli della semplice amministrazione, fino a determinare una potestà legislativa esclusiva e anche concorrente, la posizione del Pci sarebbe stata contraria. Una tale accelerazione, più che la democratizzazione di ampi settori e rami della vita politica del paese, avrebbe favorito, secondo i comunisti, il frazionamento del potere legislativo e la disgregazione dell’unità organica del paese. La preoccupazione del Pci era che con la frammentazione politica del paese importanti riforme socioeconomiche, come ad esempio una profonda riforma agraria, o la nazionalizzazione di importanti settori dell’economia (si pensi alla produzione e distribuzione dell’energia elettrica), avrebbero trovato mille ostacoli nell’applicazione. In questo modo si sarebbe stabilito nel corpo della democrazia italiana un sistema per compartimenti-stagno. Sempre secondo questo ordine di ragionamenti il Pci si espresse contro il principio della autonomia della magistratura, palesando il rischio che la magistratura divenisse un corpo a sé stante regolato da modalità di autogoverno proprie. Su questa posizione sicuramente aveva influito il timore che la magistratura (come più in generale la burocrazia e le forze armate) ereditata dal Ventennio potesse divenire un corpo autonomo capace di condizionare negativamente il processo democratico. Le paure espresse in tal senso erano le prime avvisaglie di un clima nuovo che andava mutando nel paese proprio in quei mesi. Il 31 maggio del 1947, con l’estromissione di comunisti e socialisti dal governo, «si archiviava definitivamente la realtà politica uscita dalla resistenza; cominciava una dura stagione della Repubblica»4. Sull’articolazione dei poteri le posizioni dei comunisti mutano profon- 53 54 damente nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta e nell’orientare questo mutamento l’azione e l’elaborazione di alcuni comunisti sardi è determinante. Inizialmente però, all’indomani della caduta del fascismo, sul tema dell’autonomia anche il Pci sardo ha scontato un ritardo notevole e ha commesso diversi errori. Le cause di tale ritardo e dell’iniziale propensione antiautonomista dei comunisti sardi erano molteplici e ramificate. Tra queste bisognava considerare anzitutto l’origine dei dirigenti che ripresero l’attività nel 1943: molti di essi provenivano dall’attività clandestina, erano quadri che avevano oramai metabolizzato una concezione settaria dell’agire politico; altri ancora provenivano dal Partito socialista che tradizionalmente era più attento alle questioni delle zone urbane e industriali piuttosto che alle questioni contadine. Oltre a ciò c’era la contrapposizione alle frange del movimento indipendentista che aveva contribuito a rendere sospettosi, se non proprio ostili, i comunisti sardi verso ogni discorso autonomistico. Per lungo tempo la maggioranza dei comunisti sardi ha considerato fuorviante e interclassista la parola d’ordine dell’unità di tutti i sardi per l’autonomia. Da tutto ciò derivavano l’atteggiamento incerto e attendista e i ritardi nella piattaforma politica, che si palesarono al primo Consiglio Nazionale del Pci tenutosi a Roma nell’aprile del 1945 dove la delegazione sarda era composta da Renzo Laconi, Antonio Dore e quindi Giovanni Lay che in proposito ha scritto: «In quell’occasione io fui aspramente criticato da Togliatti perché feci un intervento che suonava pressappoco così: «i contadini e i pastori sardi non sanno che farsene di un’autonomia regionale guidata dai proprietari terrieri e dai nemici della Sardegna che sono presenti anche nell’Isola. Noi dobbiamo batterci per un’autonomia che sia strumento di progresso sociale ed economico, che liberi il popolo sardo dalla miseria e dallo sfruttamento, che salvi le miniere, che va- lorizzi le risorse umane ed economiche della Sardegna». Nelle conclusioni dei lavori del Consiglio nazionale Togliatti disse: «Se il compagno Gramsci fosse stato qui presente e avesse udito un comunista sardo, per giunta dirigente del partito in Sardegna, sostenere che i contadini sardi e i pastori non sanno che farsene dell’autonomia, certamente ne sarebbe rimasto molto sorpreso». Togliatti criticò i dirigenti del partito in Sardegna non tanto per quello che era stato detto in quella sede, ma per il fatto di non essere stati ancora capaci di impegnare le masse popolari sarde nella battaglia per «togliere la bandiera dell’autonomia» dalle mani di quelli che pensavano di fare dell’autonomia regionale la loro cittadella per la difesa dei loro interessi di classe, e farla passare nelle mani della classe operaia5. Anche se non solo in ragione di questo fatto, la rivendicazione autonomista viene a essere assimilata solo dopo il superamento del «pericolo» rappresentato dalla prospettiva del Pcs. Sul versante istituzionale poi, la Consulta tardò enormemente a elaborare un proprio progetto, mentre già dal maggio del 1946 il Governo aveva promulgato lo Statuto speciale siciliano. Come è noto Lussu, storico leader del sardismo, preoccupato per i ritardi e per l’irrigidimento della Dc sulle questioni autonomistiche, si adoperò presso i rappresentanti della Consulta per ottenere l’estensione dello Statuto siciliano alla Sardegna ottenendone un rifiuto. Anche la delegazione del Pci si unì nel rivendicare alla Consulta il compito di scrivere il proprio Statuto, con il risultato di ritardare fino alla fine del gennaio 1948 la promulgazione di uno Statuto dai contenuti autonomistici decisamente più blandi di quello siciliano. 1. A. Mattone, Velio Spano. Vita di un rivoluzionario di professione, Edizioni della Torre, Cagliari 1978, p. 107. 2. Il Pcs era animato da alcune figure di un certo rilievo nella storia del movimento socialista e comunista sardo, come l’Avvocato Antonio Cassitta che era stato direttore del giornale «Avanguardia», organo dell’organizzazione giovanile comunista. Nella FGCI Cassitta era stato membro della segreteria nazionale e delegato al III Congresso del Comintern. Oltre a lui altre figure importanti erano un altro avvocato, conosciuto per le sue doti di vecchio tribuno socialista, Antioco Mura di Bonorva, e Francesco Anfossi che in Argentina era stato tra i promotori della Lega sarda di Avellaneda. 3. G. Lai (a cura di), La biblioteca di Renzo Laconi, Cuec, Cagliari 2000, p. 59. 4. P. Cucchiarelli, A. Giannulli, Lo Stato parallelo. L’Italia oscura nei documenti e nelle relazioni della Commissione stragi. Gamberetti, Roma 1997. 5. G. Lay, Io comunista, Tema, Cagliari 2006, p. 114. RIVE GAUCHE DUE ANNI DOPO Il 30 settembre del 2005 si tenne a Roma un convegno (Rive Gauche), promosso da «il manifesto» in collaborazione con gli economisti Sergio Cesaratto e Riccardo Realfonzo, il cui obiettivo era quello di riunire a discutere economisti, politici e – in generale – donne e uomini «di sinistra» attorno al tema: “La critica della politica economica e le linee programmatiche delle coalizioni progressiste” (gli atti furono pubblicati nel marzo 2006 per la Manifestolibri a cura degli stessi Cesaratto e Realfonzo). Eravamo alla vigilia delle elezioni politiche del 2006 e viva era l’esigenza di ragionare sui programmi di politica economica che avrebbe dovuto realizzare una coalizione, auspicabilmente vincente, di alternativa alle destre. Sulla scia di quell’esperienza va anche considerata la successiva promozione di un Appello degli economisti (cui abbiamo aderito anche noi di Essere comunisti) rivolto al governo in carica e teso a modificare la linea rigorista di rientro dal debito pubblico ed un’ applicazione stretta dei dettami di Maastricht. A due anni di distanza – e in vista di una seconda tornata di Rive Gauche dedicata a «L’economia della precarietà» che si terrà a Roma martedì 9 ottobre (promotore «il manifesto», con la collaborazione di Paolo Leon e Riccardo Realfonzo) – abbiamo inteso chiedere ad alcuni dei partecipanti (Riccardo Bellofiore, Emiliano Brancaccio, Giorgio Gattei, Giorgio Lunghini, Riccardo Realfonzo) le loro attuali valutazioni sia sulla strada da allora percorsa che sulla generale prospettiva economica. Qui di seguito presentiamo le domande con le relative risposte. Ovviamente, consideriamo questo inserto come il capitolo di una discussione destinata a proseguire. Per questo abbiamo deciso di pubblicare i contributi così come ci sono pervenuti, anche scontando qualche difformità nei toni e nella lunghezza: nella convinzione che non mancherà l’occasione per ulteriori repliche. Che naturalmente consideriamo sin d’ora benvenute. B.S. 55 RICCARDO BELLOFIORE 56 RICCARDO BELLOFIORE – Università di Bergamo EMILIANO BRANCACCIO – Università del Sannio GIORGIO GATTEI – Università di Bologna GIORGIO LUNGHINI – Università di Pavia RICCARDO REALFONZO – Università del Sannio In relazione al nostro paese, si è parlato spesso di «declino» economico e sociale: ci si riferisce in particolare alla fragilità del sistema industriale, alla crisi dei distretti e allo smantellamento dell’impresa pubblica, al basso livello degli investimenti in ricerca e sviluppo, alla caduta dei salari reali (e dunque allo stato asfittico della domanda interna). Poi «The Economist», nel suo rapporto annuale Il mondo in cifre, colloca l’Italia tra le economie più forti, ponendola ai primi posti della classifica per il Pil pro capite, il commercio di beni e servizi, il consumo di beni privati. Per non parlare dei dati degli ultimi anni sui profitti d’impresa, i quali non registrano alcun declino e anzi mostrano che il bicchiere è pieno fino a strabordare. Come stanno dunque le cose? Ci si chiede, in primo luogo: declino per chi? Una risposta vera a questa domanda richiederebbe uno spazio ben maggiore di quello concesso. Si tratta di una questione alla quale gli economisti più attivi della Rive Gauche – di cui in realtà non faccio parte, se con questa sigla ci si riferisce ai firmatari dell’appello per la stabilizzazione del debito pubblico lanciato nell’estate del 2006: e trovo francamente la sigla già un problema, costruita con tutta evidenza con una troppo facile logica di tipo giornalistico – hanno prestato poca attenzione e con grande ritardo, ossessionati come erano da una battaglia male impostata e peggio condotta sulle questioni appunto del debito pubblico. Non mi convince neppure la considerazione, diffusa a sinistra anch’essa, che il «declino» avrebbe a che vedere con l’assenza di una vera classe imprenditoriale. È un po’ la tesi di ambienti Banca d’Italia. Rispettabile, coglie un grano di verità, ma a ben vedere non dice poi granché. Lungo quella linea si finisce poi nella ingenuità – che tenta, mi pare, anche Rifondazione – di una battaglia per separare la rendita e la finanza dall’economia reale sulla base di un intervento sulle banche centrali o di una introduzione isolata della Tobin tax. O all’illusione che una rinascita del «keynesismo» e del «conflittualismo incompatibilista» possa essere la risposta ai problemi che ci troviamo di fronte oggi, dopo i fallimenti delle politiche dell’offerta (illusione spesso nutrita sulle colonne del vecchio «Ernesto», e ora di «Essere Comunisti»). Si dovrebbe mettere in piedi una analisi ben più approfondita e una dimensione programmatica ben più seria di quella che è stata costruita dal 2001 a oggi. In questi anni, infatti, Rifondazione comunista – il più forte partito nella dispersa galassia della sinistra, ma dunque anche il più responsabile dei suoi limiti – ha semplicemente cancellato la riflessione sul programma che pure aveva messo in piedi alla fine degli anni Novanta, anche se innegabilmente con molte carenze. A un certo punto aveva iniziato a corteggiare, in economia almeno, una politica fatta di appelli e presenza mediatici, i cui risultati sono stati nulli se non deleteri. Credendo così di poter parzialmente recuperare rispetto a una scommessa sbagliata: che la spinta del «movimento dei movimenti» avrebbe senz’altro spostato in avanti gli equilibri della coalizione. Oggi si è costretti a pregare che qualcosa succeda sulle piazze, e il movimentismo si trasforma in politicismo. Il declino economico e sociale italiano lo si capisce molto bene con le analisi di De Cecco, o Graziani, o Halevi, o ancora Gallino. Questo autore, in particolare, ha utilizzato una formula più corretta, la «scomparsa dell’Italia RIVE GAUCHE industriale», che è il titolo di un suo bel libro recente. È un fenomeno che va avanti, in realtà, dalla metà degli anni Sessanta. Quando il capitalismo italiano ha risposto in modo regressivo alle lotte nella distribuzione, prima, e nella valorizzazione immediata poi: lotte che avevano messo in evidenza tutti i limiti dello sviluppo dualistico del nostro paese. È di qui che progressivamente inizia la decadenza o l’eliminazione delle grandi imprese private, la mitologia dei distretti, il nanismo, l’insufficienza della ricerca e sviluppo, e così via. Non è stata intrapresa nessuna seria politica di programmazione o di piano del lavoro, dentro una riqualificazione della nostra posizione nella divisione internazionale del lavoro, ormai sempre più a rischio. Salvo rare eccezioni, la sinistra stessa l’ha progressivamente accantonata. Sono spariti il nucleare, l’elettronica, la chimica, l’aeronautica civile, l’acciaio, sono state o sono molto in difficoltà l’automobile e la telefonia. Ovviamente, i settori nascono e muoiono dovunque: il problema è che da noi sono solo morti, non ne sono nati altri sostitutivi e trainanti. I grandi monopoli pubblici sono stati quasi tutti privatizzati, diventando spesso nient’altro che strumenti per la percezione di rendite. La politica industriale praticamente non c’è stata, se non adattiva alla pressione internazionale o alla politica monetaria restrittiva. La politica bancaria ha avuto andamenti alterni ma senza poter mai divenire orientativa dello sviluppo economico. Dentro un quadro di politiche macroeconomiche e microeconomiche quali quelle europee – politiche che un po’ furbescamente non si è voluto neanche nominare in un programma di più di 280 pagine: tanto i movimenti avrebbero «spinto» a sinistra, il che però fa un po’ specie se simultaneamente si impugna la battaglia del rispetto del programma dove fa comodo – l’unico margine di riaggiustamento a una competitività declinante e ai problemi di una produttività sempre più bassa non poteva che essere la pressione sul valore d’uso e sul valore di scambio della forza-lavoro. Forse bisognerebbe tornare all’Abc del marxismo. La sinistra sa solo reagire con il lamento, non vedo nessuna seria riflessione o proposta. Prima si attesta sulla tesi di una globalizzazione che metterebbe fuori gioco lo Stato nazionale (come anche sull’illusione di un rapporto di lavoro salariato in crisi), poi recupera quest’ultimo come risposta solo verbale e subalterna alle politiche social-liberiste che danno il cambio a quelle neoliberiste. È ovvio, peraltro, che in un paese come l’Italia il «declino» non significa una caduta immediata e verticale. Ci sono fattori distributivi, ci sono fattori settoriali, ci sono fattori regionali, che spiegano come alcuni stanno meglio, molto meglio, mentre altri stanno peggio. Di più, si possono mantenere alti tenori di vita pur in una situazione generale che lentamente degrada. Vedi le aree dove il salario unitario può anche essere basso, ma con lo straordinario, o con il fatto che si vive più a lungo e di più insieme dentro la famiglia, o con il capitale familiare accumulato, il tenore di vita può essere da zona ricca, molto ricca. Insegnava poi Marx che non esistono crisi permanenti. Dobbiamo stare molto attenti ai mutamenti portati dalla ristrutturazione, se no si rischia di fare come il vecchio Pci togliattiano ancora contaminato dallo stalinismo, e ancora negli anni Cinquanta e Sessanta si favoleggiava di una stagnazione generale e di una crisi dietro l’angolo. Ci sono voluti i «Quaderni rossi», il gruppo del manifesto, lo stesso Trentin, e pochi altri a ragionare, all’inizio degli anni Sessanta sull’Italia come paese capitalistico non «arretrato». EMILIANO BRANCACCIO Forse su questo tema bisogna uscire da un equivoco: il cosiddetto declino è relativo, non assoluto. Mi spiego. Da decenni in tutti i paesi Ocse registriamo uno schiacciamento della quota dei redditi da lavoro subordinato rispetto al reddito complessivamente prodotto. È una tendenza che registriamo sia in termini lordi che al netto dell’intervento statale. Essa si spiega principalmente col fatto che da tempo in fase di contrattazione i lavoratori subordinati non riescono a conquistare gli incrementi di produttività generati dal cambiamento tecnico, dall’aumento delle ore per unità di lavoro e dall’intensificarsi dei loro stessi sforzi produttivi. Per giunta, in molti casi la compressione salariale non è solo relativa ma anche assoluta: la diffusione dei contratti precari ha determinato vere e proprie cadute del monte salari, sia nel settore privato che in quello pubblico, e soprattutto nelle classi generazionali più giovani. I dati dunque segnalano che il lavoro è sotto attacco in tutti i paesi, anche in quelli più avanzati. Detto questo, però, bisogna pure aggiungere delle specificità che caratterizzano le cosiddette «periferie» dello sviluppo capitalistico, e in particolare l’Italia. Nel nostro paese sussistono problemi anche sul versante dei profitti. I capitali nazionali sono frammentati, polverizzati, il che determina una crescita più bassa della produttività, e quindi alti costi per unità di prodotto e bassa competitività rispetto ai concorrenti esteri. La conseguenza è che, rispetto ai «centri» dello sviluppo capitalistico, in Italia i profitti crescono comunque, ma crescono di meno e oltretutto si perdono in una infinità di transazioni, di rivoli commerciali, e quindi non si concentrano. 57 58 Possiamo dunque tranquillamente parlare di declino «relativo» del capitalismo italiano, senza per questo pensare che i padroni nostrani si siano ridotti in braghe di tela. È bene tuttavia comprendere che pure un declino «relativo» alla lunga può risultare deleterio. Ai tempi del «piccolo è bello» andava di moda farsi vanto della scarsa concentrazione dei capitali nazionali, quasi che questa fosse indice di un capitalismo più diffuso, più democratico, magari persino «dal volto più umano». Oggi sappiamo invece che assecondare una tale frammentazione è stato forse il più grande errore strategico dei decenni passati. Infatti ora il capitale nazionale non regge la concorrenza estera, e rischia ogni giorno che passa di essere eliminato dal mercato o assorbito tramite acquisizioni straniere. Questo è un fenomeno che in Europa caratterizza non solo l’Italia ma anche, per esempio, la Grecia, il Portogallo e la sopravvalutata Spagna. Questi paesi sono caratterizzati da una eccessiva frammentazione dei capitali, da una bassa produttività, da costi eccessivi di produzione, da una competitività sempre più compromessa e da crescenti disavanzi nei conti con l’estero. GIORGIO GATTEI Premesso che l’opinione dell’«Economist» è di parte (non è una rivista ultra-borghese, oppure la collocazione di classe non ha più ragione di essere?), chi ha mai detto che una economa che fa profitti è poi efficiente? Partiamo dall’inizio: in una economia si producono merci per rivenderle. Quindi per fare profitti ci vuole sia la produzione che il realizzo. Ora come si può fare produzione? Migliorando la produttività o aumentando la fatica. E dove si può fare realizzo? Sui mercati esteri o su quello interno. Di fronte a questo crocevia di alternative l’Italia cosa ha scelto? Siamo tutti contenti che dal 2006 sia arrivata una ripresa, ma trascinata dalle esportazioni che sono cresciute del 5,3% in termini reali (le cifre sono tratte dall’ultima relazione del Governatore della Banca d’Italia; qui a p. 78). Così la domanda estera netta (esportazioni – importazioni), che era calata dello 0,3% nel 2005, è risalita dello 0,3% nel 2006 (p. 42). Tuttavia per puntare sulle esportazioni si deve pagare il prezzo della «competitività» e la maniera più semplice per ottenerla è quella di tagliare il costo del lavoro. Ciò che si è fatto: le retribuzioni per unità standard di lavoro dipendente hanno ridotto il loro aumento dal +3,3% del 2005 al +2,8% del 2006 (p. 98) con la conseguenza di continuare a trasferire valore aggiunto dai salari ai profitti (la quota del lavoro, che era pari al 72,5% negli anni 1996-2000, è calata al 71,8% tra 2001 e 2005)(p. 98). Quindi la scelta di puntare sulla domanda estera ha consentito la contrazione dei salari, non essendo il mercato interno il luogo privilegiato di realizzo. Poi c’è la maniera di produrre le merci. E qui si vede che l’occupazione è aumentata, sebbene per più della metà nei lavori «precari» che adesso toccano il 13,5% dell’occupazione dipendente (p. 88). Anche le ore di lavoro per dipendente sono salite: erano diminuite dell’1,1% nel 2005, sono +1,0% nel 2006, mentre la «vita lavorativa» è stata allungata dall’ennesima «controriforma» delle pensioni. Ma l’aumento della produttività? Non c’è stato: il prodotto per unità standard di lavoro, cresciuto dell’1,1% tra 1996 e 2000, è diminuito dello 0,2% tra 2001 e 2005 (per l’industria in senso stretto i valori sono simili: +0,8% tra 1996 e 2000, +0,7% tra 2001 e 2005) (p. 98). Insomma, sembra che i nostri coraggiosi capitani d’industria, che hanno fatto certamente profitti, li hanno fatti più con l’aumento della fatica che con il miglioramento della produttività. Marx avrebbe detto: più con il pluslavoro assoluto che con il pluslavoro relativo. E questa sarebbe una economia efficiente? Lo si vedrà alla lunga, perché alla lunga le scelte regressive si pagano. GIORGIO LUNGHINI Di «declino» si cominciò a parlare a seguito di un saggio del 2003 di Pierluigi Ciocca, L’economia italiana: un problema di crescita. In quel saggio Ciocca non usa mai la parola «declino», semplicemente mostra come nell’economia italiana, soprattutto dopo la crisi valutaria del 1992, sia prevalsa una tendenza al rallentamento di tutti gli indicatori: reddito (assoluto e pro capite, effettivo e potenziale), consumi, produttività, esportazioni. Nel periodo tra il 1992 e i primi anni di questo secolo, le determinanti principali del rallentamento sono la dinamica della produttività del lavoro e la dinamica delle esportazioni. Il rallentamento nella produttività del lavoro, produttività peraltro elevata, è a sua volta determinato dalla minor crescita della produttività totale dei fattori, cioè dalla minor crescita della produttività del sistema economico-sociale nel suo complesso. Dal lato della domanda aggregata, il rallentamento dipende dal minor contributo dei consumi privati e pubblici, un minor contributo non compensato da sufficienti esportazioni nette. Dinamica della produttività e dinamica delle esportazioni, sono tutte e due conferme di «una economia strutturalmente meno capace di impiegare e organizzare il lavoro, innovare, applicare il progresso tecnico, competere». Negli anni recenti il prodotto interno lordo ha ripreso a RIVE GAUCHE crescere, sia pure di poco, e molti ne hanno concluso che il «declino» si è arrestato. Se però il problema economico è un problema di crescita, il problema rimane irrisolto: l’economia italiana è ancora un’economia poco capace, sempre meno capace, di impiegare e organizzare il lavoro. Lo è tanto poco da guardare al lavoro non come al fondo da cui ogni nazione trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita, dunque come alla risorsa da valorizzare; bensì come a un fattore della produzione, il cui impiego dovrebbe essere massimamente flessibile e minimamente costoso. Di qui la ricetta «precarietà e bassi salari» come due condizioni necessarie e sufficienti per una crescita duratura del prodotto interno lordo. Ma se mai la flessibilità ne fosse condizione necessaria (e c’è ragione di dubitarne), certamente non lo sono i bassi salari. C’è infatti il problema di una distribuzione arbitraria e non equa della ricchezza e del reddito; e dunque c’è anche un problema di domanda effettiva: occorre che le merci che si potrebbero produrre, trovino compratori all’interno e all’estero. All’interno dovranno trovare consumatori con sufficiente potere d’acquisto e imprenditori determinati a effettuare nuovi investimenti reali; mentre all’estero dovranno poter contare su paesi importatori in crescita costante e attratti dalla qualità e dai prezzi dei nostri prodotti. Tutte e tre queste componenti della domanda effettiva, consumi investimenti esportazioni, sono importanti; ma una importanza particolare hanno i consumi, poiché qui la questione economica è immediatamente questione sociale. La quota più importante della domanda per consumi è costituita dai consumi dei lavoratori, il cui reddito è dato dai salari. Gli imprenditori vedono nel salario soltanto un costo di produzione, da minimizzare, e si dimenticano che il salario è anche potere d’acquisto. Se i salari sono bassi, e lo sono, bassi saranno i consumi dei lavoratori; né basteranno a sostenere la domanda per consumi complessiva i consumi di lusso, finanziati con rendite e profitti, che invece sono a livelli elevati. Insufficiente è anche la crescita degli investimenti, poiché gli imprenditori spesso preferiscono impiegare gli alti profitti nella speculazione finanziaria anziché in nuovi investimenti reali; e d’altra parte l’andamento delle esportazioni è spiegato piuttosto dalla congiuntura favorevole degli altri paesi, che non dalla qualità dei prodotti nazionali. Se mai si è arrestato il declino economico, negli ultimi decenni si è aggravato il declino sociale, e qui «declino» è la parola giusta. Ce ne sono molti segnali, non soltanto economici ma anche politici e culturali. In campo economico un sintomo secondario, ma assai chiaro, è lessicale: non si parla più di «lavoratori», bensì di «consumatori». La ragione vera è la dissociazione tra prestazione lavorativa e consumo. Il lavoratore fordista acquistava egli stesso ciò che aveva prodotto, oggi non è più così. Questa separazione tra produzione e consumo si dà anche all’interno dei singoli paesi, ma è particolarmente evidente a livello internazione: la si potrebbe chiamare «effetto Nike»: le costose scarpe da ginnastica sono prodotte da ragazzini sottopagati in qualche paese asiatico, e acquistate dai ragazzini benestanti dei paesi più ricchi. RICCARDO REALFONZO Il declino italiano è talmente marcato da non potere sfuggire agli analisti internazionali; e d’altronde fu proprio «The Economist» che, un paio di anni or sono, descrisse l’Italia come «il vero ammalato d’Europa». Nessuno può stupirsi per questa definizione, i dati ufficiali parlano chiaro. Sono ormai oltre quindici anni che l’Italia cresce meno della media dei paesi europei, avvitata, come è, in una stagnazione che è il prodotto al tempo stesso di una bassa domanda aggregata interna e di una pesante arretratezza dell’apparato produttivo, con conseguente progressiva perdita di quote di mercato negli scambi internazionali. Al tempo stesso, l’Italia è il paese d’Europa in cui si assiste alla più intensa crescita degli squilibri distributivi e territoriali. Queste semplici annotazioni sono sufficienti per rispondere alla tua domanda in merito a chi sostenga il peso del declino. È innegabile che il declino stia scaricando gli effetti più nefasti sui lavoratori. I dati relativi alla caduta del potere di acquisto dei salari e alla riduzione della quota del prodotto interno lordo che va ai redditi da lavoro parlano chiaro. D’altronde come potrebbe essere diversamente? L’abolizione della scala mobile, gli accordi di politica dei redditi del luglio ’93 con la relativa introduzione del meccanismo dell’inflazione programmata, il varo del Pacchetto Treu e la famigerata legge 30, hanno progressivamente indebolito il potere contrattuale dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Lungi dal generare effetti positivi sulla occupazione, l’unico risultato tangibile di queste politiche è stato il freno alla crescita dei salari reali, che nel migliore dei casi sono aumentati meno della crescita della produttività del lavoro. Sono questi gli elementi che spiegano, nonostante il declino, l’andamento dei profitti. 59 RICCARDO BELLOFIORE 60 In secondo luogo: a quanto pare la barca dell’economia italiana continua ad andare e a distribuire dividendi, pur in presenza di consistenti squilibri (economici e sociali). Da un lato, il governo sostiene che «la notte è passata» e che non resta che godere i frutti del «risanamento»; sul lato opposto, non si è per nulla ottimisti (e c’è ad esempio chi evoca, dati alla mano, imminenti crisi commerciali). Quale futuro prossimo possiamo prevedere per il nostro paese? Qui bisogna intendersi. Innanzi tutto, scordiamoci che un governo, soprattutto se a predominanza «social-liberista» come questo, dica mai che la notte è passata e che finalmente si può godere il frutto del risanamento. Il risanamento, per loro, non finirà mai. La ragione c’è. Quelli che vengono impropriamente chiamati «moderati», liberisti sì ma un po’ meno, non credono in realtà neanche loro ai parametri di Maastricht o al Patto di stabilità. Gli servono solo come copertura per far passare certe politiche, quasi come necessità naturale, imposte da uno stato di emergenza. I parametri sulla finanza pubblica, o il Patto che prevede a medio termine l’azzeramento dei disavanzi, sono semmai sostenuti per ragioni di reputazione, come norma sociale. Le conseguenze talora recessive sono in fondo benvenute, come frusta alla riorganizzazione produttiva e alla regolazione sociale, alla «modernizzazione». Di più, e qui si misura la cecità della sinistra, quei vincoli in larga misura autoimposti e quella deriva deflazionistica, servono perché si pensa che uno stato più «leggero» aiuti prima o poi a migliorare l’efficienza del settore pubblico. Che uno stato regolatore aiuti a elevare la produttività del sistema. Che la politica industriale si possa ridurre al gioco degli incentivi e disincentivi. Che il tenore di vita possa migliorare, così come le posizioni di rendita possano ridursi, grazie alle politiche di liberalizzazione dentro una riregolamentazione dei mercati. Magari mettendo in piedi una rete sociale di sicurezza che aiuti la precarietà spacciata per flessibilità. Il «social-liberismo» appunto. Tutte cose in cui non credo, ma – vivaddio! – è qualcosa che non sta nel mondo dei sogni, dove si è rifugiata la sinistra. Una sinistra degna di questo nome avrebbe dovuto porre, lei, la questione della «qualità» del sistema produttivo, economico, sociale: con un piano di intervento strutturale a cui si poteva e doveva lavorare da anni. Se no, perché, per cosa, ti candidi a governare? Esiste un nuovo, chiarissimo ciclo economico-politico da molte parti. La destra, o centro-destra, chiamalo come vuoi, va al governo. Sinistra e centro-sinistra (qualcuno mi dice, centrosinistra senza trattino, ma non sono un esperto di queste cose) unite all’opposizione sono spesso in grado di non far passare il lato liberista selvaggio su mercato del lavoro e welfare del neoliberismo. Intanto spende e spande, e i disavanzi addirittura crescono. Se il centro-sinistra va al governo con un pezzo della sinistra, non c’è più niente o poco da ridistribuire, e allora bisogna puntare tutto sulla flessibilità (leggi, precariato) e qualche make-up, e ovviamente «risanare». La stessa sinistra di governo comincia a fare una operazione sulle parole: si RIVE GAUCHE voleva l’abolizione della legge 30? No, «superamento». E gli esempi si potrebbero moltiplicare. E lì a fare barriera sul nuovo confine: gli stessi intellettuali vicini al partito adattano subito la terminologia, non si sa mai. Chi si oppone viene presto bollato come nemico del popolo. Da quelli che voi chiamate «moderati» l’accusa viene mossa alla sinistra al governo, da questa con qualche cautela a chi rompe le scatole. Si decidono espulsioni, che anche rappresentanti della vecchia area dell’Ernesto mi pare abbiano votato. Dall’altro versante, ovviamente, da quella che si vuole sinistra della sinistra si finisce con il vedere come salvifica una opposizione pura e semplice, tanto la sinistra non deve andare mai al governo con i «moderati». Il conflitto e l’incompatibilismo divengono parole che sole garantiscono la salvezza. Non ci si parla più. Ci si spezza in mille anime. È successo anche a voi, mi pare. Si è già visto, lo si sapeva. Idealisticamente, il problema politico diventa l’egemonia «neoliberista» sulla componente «moderata», come ho sentito dire a Burgio in un dibattito a Torino. Uno dei drammi della sinistra radicale è che non capisce che l’asse Stati Uniti-Asia costituitosi negli ultimi anni ha marginalizzato l’Europa, un continente che dipende ancora troppo dal neomercantilismo forte della Germania. Con il paradosso che la Germania ora cresce se cresce la Cina e l’Asia, ma se l’economia degli Stati Uniti va molto male le difficoltà rimbalzano lo stesso in Europa: o per gli effetti della globalizzazione finanziaria, o perché si hanno problemi nell’area asiatica. Tutti appesi, dunque e comunque, a un atterraggio morbido dell’economia americana. Nonostante alcune tesi, che a me paiono fantasiose e che sono circolate all’inizio dell’anno (i dati non basta citarli, bisogna saperli leggere), la ripresa europea è stata trainata dall’export netto e dagli investimenti tedeschi, non certo dai disavanzi del bilancio pubblico o dai consumi salariali. Lo abbiamo sostenuto a più riprese Halevi e io: ma si può leggere De Cecco su «Repubblica», oppure Nardozzi su «Il Sole 24 Ore». È chiaro che dentro l’Europa dell’euro, sotto il cappello delle politiche che conosciamo, va avanti una riarticolazione geografica e settoriale, che penalizza la nostra industria e il nostro manifatturiero: dove conta la posizione debole dell’Italia tra i «grandi» fondatori del Mercato comune europeo. Dobbiamo restare dentro, ed essere posti sotto stress. Siamo doppiamente dipendenti da uno sviluppo europeo che è esso stesso non autocentrato. Se la crisi finanziaria di questa estate – le cui cause e il cui contesto sono ignote alla sinistra, che non l’ha vista arrivare, e che continua a ragionare in una ottica nazionale, ancora all’oscuro delle novità del capitalismo da un quindicennio a questa parte – se quella crisi, dicevo, dovesse dar luogo a un atterraggio duro dell’economia americana, dentro la possibile se non probabile crisi europea ci sarà una rinnovata e certa, drammatica stagnazione del nostro paese. È già successo nei primi cinque anni di questo decennio. Noi non possediamo né il sistema finanziario anglosassone, peraltro oggi in difficoltà, né la manifattura di qualità tedesca. Quello che però è chiaro è che le difficoltà attuali non sono state create dalla moneta unica, che si è limitata a renderle più visibili. Per quel che riguarda l’imminenza di una crisi commerciale tipo 1992, non ne sono affatto convinto. E i «dati alla mano» di cui parla la domanda non si vede dove siano. Si applicano all’Italia dentro la moneta unica argomenti che valgono, quando valgono, fuori dall’unificazione monetaria. In generale, un grave disavanzo commerciale può spingere a un riaggiustamento via modificazione del tasso di cambio nominale. Ma non è detto. Oggi il dollaro si svaluta rispetto a Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda in serio disavanzo commerciale. Il perché è chiaro: gli alti tassi di interesse di questi paesi più che compensano sul piano dei movimenti di capitale, e consentono di rifornire di liquidità la speculazione col c.d. carry trade, indebitarsi in yen e investire dove i rendimenti sono elevati, senza più di norma un rischio di cambio. Non vale neanche sempre nei casi di ipervalutazione «reale». Si pensi al caso del Giappone dal 1985 al 1995, o negli ultimi anni, cioè nei periodi di grande svalutazione del dollaro. O si pensi alla Germania negli anni Settanta, prima del Sistema monetario europeo. Gli stessi cultori più seri dell’equilibrio economico generale hanno smontato la legge della domanda alla base dei meccanismi di riaggiustamento: le variazioni del prezzo agli eccessi di domanda netta non garantisco l’unicità o la stabilità dell’equilibrio, e smontano anche tutti gli esercizi di statica comparata. Dentro l’area dell’euro, proprio i dati fanno dubitare dell’imminenza di una crisi tipo 1992. Secondo le stime Ocse la Spagna avrà nel 2007 un deficit della bilancia corrente rispetto al Pil del 10,1%, l’Italia si limiterebbe al 2,5%. Nel 1992 i valori erano rispettivamente del 3,5% e del 2,3%. Se deve saltare qualcuno, sarebbe la Spagna. E la causa sarebbe lo sgonfiamento della bolla immobiliare e le conseguenze della crisi dei subprime, non la bilancia commerciale. Nell’unione monetaria non c’è proprio il vincolo valutario. C’è evidentemente un problema di finanziamento dei disavanzi commerciale e corrente, e questo ha a che vedere con i trasferimenti nell’area, con le politiche fiscali, con afflussi di capitale, e così via. Rimane il rischio relativo alla qualità del debitore (un 61 62 punto, ahimé, che resuscita in parte gli argomenti di quelli che sono preoccupati dello stato della nostra finanza pubblica). Ma non scommetterei su una crisi a breve. Né il disavanzo commerciale dell’Italia, in gran parte all’interno dell’area (escludendo la bolletta energetica), influenza l’euro più di tanto. L’Italia fa più paura fuori che dentro, e una crisi dell’Italia facilmente significherebbe che salta l’eurozona. Lo ha ricordato sensatamente Alfonso Gianni criticando Emiliano Brancaccio su «Liberazione»: Gianni si appoggiava su alcune email di Joseph Halevi a «Liberazione» che davano ragione a me su un punto criticato affrettatamente e fuori contesto da Brancaccio. Mi fa piacere che, per interposta persona, Alfonso Gianni e io si sia d’accordo almeno su questo. Per quel che riguarda la nostra posizione con l’estero, si tratta di nuovo di un vincolo «pseudo-naturale» che spinge verso le politiche contro il lavoro che conosciamo. Il «riaggiustamento» può procedere per la via di una prolungata spinta alla deflazione dei salari, alla precarizzazione. Per un prolungamento del tempo di lavoro sociale nell’arco vitale. Per il dare alle imprese mano libera sugli orari. Per un attacco al contratto nazionale. Per un aumento dei salari solo su base territoriale e aziendale. Al limite, fallimenti e crisi degli investimenti: in un circolo perverso che aggrava i problemi. Ma scordiamoci che urlare alla crisi cambi la situazione. È chiaro da quel che si è detto che dire questo non significa affatto sottovalutare il nodo della qualità delle nostre esportazioni e importazioni, le carenze dell’industria e del manifatturiero, e così via. Significa anzi l’esatto contrario. D’altronde quel nodo è al centro da sempre della mia riflessione, come di quella di Halevi. EMILIANO BRANCACCIO Il rischio di un allargamento degli squilibri commerciali tra i paesi dell’Unione monetaria, fino all’eventualità di una crisi interna all’assetto europeo, è oggetto di indagini approfondite da parte di studiosi delle più svariate correnti di pensiero (cito ad esempio Roubini tra i neoclassici, e Graziani tra gli economisti critici). I dati di cui disponiamo oggi sembrano avvalorare l’eventualità che nei prossimi anni possa scatenarsi una crisi commerciale con possibili epicentri in Italia e negli altri paesi del Mediterraneo, vale a dire nei paesi in crescente disavanzo estero, soprattutto rispetto alla Germania. L’Unione monetaria soffre insomma di una struttura delle bilance commerciali fortemente squilibrata, che potrebbe improvvisamente entrare in crisi anche a seguito di uno shock esterno, come ad esempio un boom del costo delle materie prime o una crisi bancaria internazionale. Ora, noi sappiamo che i governi dei paesi in deficit commerciale – in primis il nostro – stanno cercando di rimediare a questi squilibri con la solita ricetta dell’ortodossia neoclassica: da un lato comprimere la spesa pubblica, in modo da contenere la domanda e le importazioni; dall’altro comprimere i salari monetari, in modo da compensare il divario di produttività e contrastare quindi l’aumento del costo del lavoro per unità prodotta delle merci esportate. Questa strategia deflazionista però a quanto pare non funziona: basti notare che il deficit nei conti esteri dell’Italia continua ad aumentare. Ora, nel criticarmi, Halevi (18 agosto, «Liberazione») e altri hanno sostenuto in modo forse ardimentoso che la deflazione non funziona perché ormai il nesso tra prezzi relativi e bilancia dei pagamenti non sussiste più. Ora, piacerebbe anche a me che avessero ragione, ma al momento questa idea non trova riscontri attendibili. È più probabile, invece, che il mancato aggiustamento delle bilance sia dovuto al fatto che nell’Unione monetaria la dinamica dei salari monetari risulta abbastanza omogenea tra i paesi, mentre l’andamento delle produttività tende a divergere. In altri termini, la compressione salariale nei paesi cosiddetti «periferici» non riesce a favorire il riequilibrio poiché una compressione analoga si sta verificando anche nei paesi «centrali», nonostante che in questi la produttività cresca molto. Al pari dei lavoratori italiano e greco, anche quello tedesco dunque non riesce più ad accaparrarsi gli incrementi di produttività, sebbene nel suo paese questi siano estremamente cospicui. Ora, se questo fenomeno dovesse trovare conferme anche in futuro, faremmo bene a dedicargli molte attenzioni. Infatti esso rappresenta al contempo un potenziale fattore di crisi, ma anche un sintomo di crescente omogeneità nei rapporti di forza in cui versano i lavoratori europei, che potrebbe magari preludere a una loro maggiore coesione rivendicativa. Se ci pensiamo bene, da un punto di vista marxista è difficile immaginare una contraddizione più feconda di questa, sul piano sociale e politico. Ma per sfruttarla bisognerebbe lavorarci su, e soprattutto iniziare a coordinarsi a livello europeo, sia sul piano sindacale che partitico. GIORGIO GATTEI È troppo presto per dire se l’economia italiana abbia ritrovato il sentiero dello sviluppo (intanto le stime sono state riviste al ribasso). Quello che sembrerebbe invece in ordine è il bilancio dello Stato, così che la prossima finanziaria potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) «a costo zero». I conti andrebbero così bene che l’obiettivo dichiarato può essere l’azzeramento del disavanzo RIVE GAUCHE per il 2011, come imposto dal sempre più nefasto accordo di Maastricht (ma perché non costituire un movimento a dimensione europea per cambiarlo?). Ora azzerare il disavanzo significa che a quella data le spese statali saranno coperte soltanto dalle entrate fiscali, perché il deficit dovrà essere 0,0%. È una regola monetarista, che ormai non trova oppositori, che sancisce il principio che lo Stato spende solo in base a quanto i cittadini si fanno tassare. E se non si vogliono le tasse? Niente spesa pubblica! È questo il veleno delle campagne di stampa contro l’eccessivo peso fiscale che finiscono per essere la copertura della parola d’ordine neoliberista dello «Stato al minimo» così che tutto sarà iniziativa privata e (se va bene) sussidarietà – Stati Uniti docet. Però, messa così, non la si racconta ancora tutta perché tra le spese dello Stato pesano, e non di poco, gli interessi sul debito pubblico che non si prevede affatto di azzerare mediante, che so?, un «annulla il debito» (evidentemente adatto solo ai cantanti e al Terzo mondo) che portasse a quella «eutanasia dei rentiers» preconizzata in altri tempi da Keynes. Ma oggi i rentiers sono «sacrosanti» (e poi ricattano anche), sicché il loro diritto a percepire interessi non si può discutere. Quindi, permanendo la spesa per interessi, il pareggio del bilancio statale necessita di un ammontare di entrate superiore alle «spese pubbliche al netto degli interessi». Per questo servono più tasse e meno servizi per formare quell’avanzo primario che deve pagare gli interessi sul debito. Siamo così tutti molto felici che, dopo 9 anni di riduzione, l’avanzo primario possa riprendere a crescere grazie alla pressione fiscale in aumento (dal 40,6 % del Pil nel 2005 al 42,3% del 2006)(p. 135), mentre la spesa pubblica corrente ha segnato il passo: 44,5% del Pil nel 2005 e 2006 (p. 138). E la spesa per interessi? È aumentata dal 4,5% del Pil nel 2005 al 4,6% nel 2006 (p. 138). Si potrebbe comunque pensare che nel pagare quegli interessi lo Stato trasferisca reddito nazionale dai cittadini che pagano le imposte (che dovrebbero essere tutti) ai 63 cittadini che hanno sottoscritto il debito, che sono soltanto una parte ma comunque cittadini sono. Ciò però non è proprio vero perché buona parte del debito è nelle mani di investitori stranieri (anche fondi d’investimento e fondi pensione americani) che approfittano di quell’avanzo primario per portarsi a casa interessi senza tasse. Messa così non è più soltanto una partita di giro interna, ma una fuoriuscita di capitali che «saccheggia» la ricchezza del paese, un’evenienza ben nota di cui ha scritto Karl Marx nel Capitale: «con i debiti pubblici è sorto un sistema di credito internazionale che spesso nasconde una delle fonti dell’accumulazione originaria di questo o di quel popolo», così che quando il credito pubblico (perché tale andrebbe meglio chiamato) «diventa il credo del capitale, al peccato contro lo spirito santo, che è quello che non trova perdono, subentra il mancar di fede al debito pubblico». Guai dunque a deludere gli interessi del debito, specie se alle viste c’è una nuova stagione di «alti tassi del denaro» simile a quella di reaganiana memoria. A meno che l’imprevista (?) crisi dei mutui subprime non imponga invece di fargliela pagare proprio a «bancocrati, finanzieri, rentiers, mediatori, agenti di cambio e lupi di Borsa» (K. Marx). 64 GIORGIO LUNGHINI In questo momento – ma in verità sempre – è molto difficile fare previsioni: gli economisti possono fare buone diagnosi, ma di rado fanno buone previsioni. Si può però dire che proprio perché l’economia italiana dipende troppo dal contesto internazionale, essa è un’economia strutturalmente fragile; e che le prospettive economiche mondiali, in particolare le prospettive di quella parte del mondo cui siamo più legati, non sono affatto tranquillizzanti. Il vero problema – ormai da quasi un secolo – sono gli Stati Uniti. In uno dei suoi tanti scritti profetici, Keynes scriveva, nel 1932, che: «il capitalista moderno è come un marinaio che naviga soltanto con il vento in poppa, e che non appena si leva la burrasca viene meno alle regole della navigazione o addirittura affonda le navi che potrebbero trarlo in salvo, per la fretta di spingere via il vicino e salvare se stesso. Se gli Stati Uniti risolvessero i loro problemi interni, ciò varrebbe come esempio e stimolo per tutti gli altri paesi e dunque andrebbe a vantaggio del mondo intero. Magari uno sguardo ravvicinato potrebbe attenuare il mio pessimismo, ma guardando da lontano non riesco a immaginare un corso degli eventi che possa risanare l’economia americana nel futuro immediato». RICCARDO REALFONZO Credo che se non assisteremo a una svolta nella politica economica del governo il futuro prossimo del paese sarà sempre più cupo, soprattutto per i lavoratori. In primo luogo, c’è da dire che la politica di «risanamento» non produce alcun frutto. A una Finanziaria di rigore segue un’altra Finanziaria di rigore, a un avanzo primario (l’eccesso delle entrate pubbliche sulle uscite, interessi sul debito a parte) segue un altro avanzo primario, con la conseguente progressiva fuoriuscita dello Stato dall’economia, lo svuotamento dello Stato sociale, la sempre più grave carenza di beni pubblici. Secondo i piani dei «rigoristi» questa politica dovrebbe proseguire, ai ritmi attuali, almeno per 20-25 anni. Solo allora, infatti, una volta che il debito fosse sceso alla tanto fatidica quanto del tutto ingiustificata soglia del 60% del Pil, dichiarerebbero compiuto il «risanamento», metterebbero fine alla successione di avanzi primari e ci lascerebbero godere gli effetti di un bilancio pubblico alleggerito del fardello del debito. Solo che nel frattempo il sistema economico-produttivo italiano risulterebbe tragicamente immiserito, definitivamente smantellato, per non parlare degli inaccettabili costi sociali di una politica di questo genere. Una vera tragedia. In secondo luogo, la crisi commerciale c’è già. In un articolo a firma mia e di Augusto Graziani apparso su «Liberazione» il 10 settembre 2006, significativamente intitolato L’alternativa alla politica di lacrime e sangue, precisammo che il declino ha ormai portato al disavanzo cronico della bilancia commerciale. E chiarimmo che la strategia «moderata» per rispettare il vincolo esterno (l’equilibrio dei conti con l’estero) punta sulle politiche di bilancio restrittive e sul contenimento dei salari. Infatti, le politiche di bilancio restrittive – la manovra di abbattimento del debito – determinano una contrazione della domanda interna e quindi dell’occupazione e delle importazioni, contribuendo per questa via a migliorare il saldo dei conti con l’estero; mentre il contenimento dei salari determina una contrazione dei costi di produzione, aumentando la competitività delle imprese e quindi rilanciando le esportazioni. Si tratta di una strategia che evidentemente scarica il prezzo del riequilibrio della bilancia commerciale sui lavoratori. E questa sembra essere, purtroppo, la strategia sulla quale il governo in carica sta di fatto puntando. L’alternativa che noi proponiamo consiste nello stabilizzare il debito rispetto al Pil (e qui non posso non rimandare al ben noto appello degli economisti che si trova sul sito www.appellodeglieconomisti.com), rilanciare gli investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali, rimettere in piedi una politica industriale degna di questo nome, valorizzare il lavoro. Insomma tentare una «via alta» al rilancio della competitività, giocata su ricerca, innovazioni, lavoro di qualità. RIVE GAUCHE RICCARDO BELLOFIORE Al di là del caso italiano, è ricorrente la domanda sulla tenuta in generale del sistema capitalistico, sulla sua capacità di sopravvivere alle sue crisi e di mostrarsi resistente ai progetti di trasformazione sociale. Al riguardo della recente crisi di solvibilità, indotta dallo scoppio della bolla speculativa e propagatasi dal cuore dell’impero, qualcuno ha evocato la crisi del ’29. In effetti, la finanziarizzazione dell’economia ha accresciuto i punti di vulnerabilità dell’economia capitalistica. Secondo Federico Rampini, con opportune e severe correzioni, il mercato può recuperare un suo fisiologico equilibrio; al contrario, Joseph Halevi ritiene che la dimensione finanziaria e speculativa è insita strutturalmente nel sistema capitalistico. Non sembra una divergenza di poco conto. Joseph Halevi ha assolutamente ragione. Non mi è difficile essere d’accordo con lui. Su questo punto, come su tanti altri, la sintonia con Halevi si è rafforzata negli anni, in un dialogo ormai ininterrotto, a partire almeno da un convegno che organizzai a Bergamo nel 1997 e a cui lo invitai. Lo si è visto nelle due interviste uscite quest’estate su «Liberazione», che sono state entrambe attaccate da economisti di grido e politici di rilievo come affette da «rassegnazione», e da «pessimismo» naturalmente «cosmico». In privato, addirittura, non si sa perché, di «negrismo» (cosa che ha un che di divertente: l’anno scorso, con Giovanna Vertova, Halevi e io abbiamo condotto una polemica proprio con il versante economico di questa ideologia italiana, in cui sono intervenuti filosofi come Tomba e sociologi come Sacchetto, o ancora Ferruccio Gambino e Fabio Raimondi; gli economisti della Rive Gauche, ma non solo, si sono fatti notare per il loro silenzio; e dire che il tema trattato era proprio la precarietà del lavoro). In realtà, però, forse una ragione c’è. Basta criticare i partiti della sinistra così come sono, la loro politica, ricordare che il cambiamento necessario non può che andare insieme a una rinascita dal basso, invitare a smetterla di far finta che lo scontento della «base» sia un mugugno di cui non si è responsabili per le analisi e le scelte sbagliate degli ultimi anni. A questo punto la vecchia tradizione «comunista», nel senso peggiore, si risveglia e vieni accomunato all’anti-politica, o sei neutralizzato con il richiamo vuoto alla psicologia. Sul carattere specifico del capitalismo contemporaneo, e sulla sua connaturata deriva finanziaria e speculativa, proprio con Halevi avevamo già incentrato la nostra critica agli economisti della Rive Gauche nel nostro contributo al convegno di due anni fa, poi raccolto nel volume curato da Cesaratto e Realfonzo. La crisi recente di questa estate la si comprende solo su quello sfondo. Sempre con Halevi, in continuità con quella nostra analisi, ho appena ultimato un articolo per «Alternative per il socialismo» che tratta della crisi dei mutui ad alto rischio. In un paragrafo di quello scritto, la riconduciamo al quadro di insieme delle dinamiche macroeconomiche degli ultimi decenni. Il punto d’inizio non può che essere la svolta neoliberista di Reagan e Volcker. La liberalizzazione dei movimenti di capitale, la restrizione monetaria, lo smantellamento dello stato sociale, la concorrenza aggressiva dei global player, hanno messo in moto negli anni Ottanta una potente tendenza stagnazionistica. La quota dei salari si riduce e gli investimenti non crescono a sufficienza. Unica controtendenza, i disavanzi pubblici eccezionali di Reagan, a furia di 65 66 politiche a favore del complesso militare-industriale e di sgravi fiscali per i ricchi. La congiunzione di politica monetaria restrittiva e di politica fiscale espansiva negli Usa, in contrasto con le altre aree, ha fatto balzare verso l’alto i prezzi delle attività finanziarie, e ha determinato un differenziale positivo dei tassi di interesse che produceva afflussi di capitale e rivalutazione del dollaro in quel paese. Si ingrossava così il disavanzo nel commercio con l’estero americano: ma il «rosso» nei rapporti con l’estero non è evidentemente un vincolo per un paese la cui moneta nazionale è la valuta di riserva mondiale. Queste dinamiche, accompagnate da numerosi scossoni finanziari, non hanno instaurato subito un nuovo modello. È solo alla metà degli anni Novanta – dopo un decennio di politiche coordinate di svalutazione del dollaro, e mentre si sgonfiava l’onda dell’alto costo del denaro – che si assiste a un mutamento qualitativo di rilievo. Quelle novità che con Halevi abbiamo sintetizzato nella terna lavoratore «spaventato» – consumatore «indebitato» – risparmiatore «terrorizzato», e quelle dinamiche che hanno finito con il produrre una «sussunzione reale» del lavoro alla finanza e al debito che retroagisce sulle modalità dello sfruttamento in senso stretto. Per capire queste novità conviene prendere le mosse dalla new economy: non intesa come nuova ondata tecnologica, ma come interazione «virtuosa», per gli Stati Uniti, tra rinnovata politica del dollaro forte e politica monetaria di fiancheggiamento alla nuova finanza da parte della Fed. Le innovazioni finanziarie, accoppiate allo spostamento dei risparmi globali dai mercati obbligazionari del debito statale ai mercati azionari, attivano allora una bolla speculativa nella speranza di profitti dell’economia virtuale del tutto irrealistici. La centralizzazione del capitale finanziario a Wall Street fu favorita dalla prolungata recessione del Giappone e dalla stagnazione dell’Europa, intrappolata tra riunificazione tedesca e unificazione monetaria europea, e venne accelerata dalle varie crisi della globalizzazione finanziaria. Grazie anche alla diffusione dei fondi pensione in giro per il mondo, la moneta è affluita sempre più negli Stati Uniti. L’euforia irrazionale dei mercati diviene parossistica, sino a che il repentino aumento dei tassi di interesse da parte della Fed a fine 1999 porta alla svolta nel marzo 2000. La nuova «economia della borsa» va compresa nel quadro macroeconomico globale e nel suo ruolo di dispositivo di un efficace «keynesismo» finanziario. Fuori dall’area anglosassone vige un eccesso del reddito sulla spesa, in forza di politiche neomercantiliste forti o deboli, all’insegna di deflazioni o svalutazioni competitive. Acuta la necessità di trovare sbocchi alla produzione. Gli Stati Uniti svolgono il ruolo di principale fornitore della domanda globale. Questa domanda non può venire, per definizione, dal canale estero. Nel 1995-2000 neanche dal settore statale, in attivo sotto Clinton. Viene dunque dal settore privato, famiglie e imprese, la cui bilancia finanziaria va in passivo. In parte investimenti privati, in parte più significativa consumi che superano il reddito disponibile. Il meccanismo ebbe come perno la rivalutazione delle attività finanziarie, in particolare le azioni, e diede vita a rapporti prezzi/utili eccessivi. Banche e intermediari trasformarono la ricchezza cartacea in spesa senza fondo. Un effetto ricchezza che aumentò la componente «autonoma» (cioè indipendente dal reddito corrente) della domanda di consumi. Il processo, insostenibile, si sgonfia nel 2000-01, mentre riprende la svalutazione di lungo periodo del dollaro. La crisi si è prolungata sino a metà 2003. Fu tamponata con più moneta, spesa militare e meno tasse per i ricchi (il vecchio «keynesismo» di cui molti hanno nostalgia). Nel triennio, i disavanzi statali bruciarono 7 punti percentuali di Pil. Il disavanzo della bilancia corrente intanto peggiorava, raggiungendo il 7% del Pil nel 2005. Tende ora al 5%: grazie al rallentamento dell’economia americana, che migliora la bilancia commerciale; e alla svalutazione di oltre il 20%, che favorisce l’indebitamento netto, dato che le passività sono denominate in dollari e le attività in valuta estera. Visto che le imprese hanno ripianato i propri bilanci e spendono meno del risparmio d’impresa, come è ripartita la crescita? Grazie a una dose più robusta della stessa droga, per far ripartire i consumi di famiglie ancor più indebitate. Il mercato immobiliare, favorito dal crollo dei tassi di interesse, è venuto in soccorso. Con prezzi che salgono, e rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile, le case sono diventate un bancomat. Il deficit finanziario delle famiglie (misurato come i loro risparmi al netto dell’investimento residenziale) ha raggiunto il 4% del Pil, una novità assoluta nel dopoguerra. Come nel 1995-2000, non sarebbe potuto avvenire senza la compiacenza della banca centrale. La Fed ha favorito la domanda, prima sostenendo i prezzi dell’immobiliare, poi per il tramite dei nuovi strumenti di credito finanziati dalle banche commerciali. Una piramide la cui sostenibilità si regge sulla continua disponibilità degli acquirenti esterni di attività in dollari, in primis la Cina, di finanziare il «buco» americano con l’estero. Dal 2004 i tassi di interesse riprendono a salire, l’immobiliare cede, e il meccanismo di trasmissione della nuova politica monetaria si fa più perverso. Compaiono i subprime, e si ingrossano sino a costituire, nel 2006, ben il RIVE GAUCHE 40% dei nuovi crediti ipotecari, e il 13% del totale. Bisogna far entrare nel gioco le famiglie povere e il lavoro precario, che non sarebbero in condizione di indebitarsi. La sussunzione reale del lavoro al debito promette l’accesso facile alla proprietà. Nessuno si curerà di chi resta sul terreno. Ma quando le cose vanno male per il debitore, il creditore non riesce a disfarsi della casa se non a prezzi inferiori ai suoi impegni. E si avvia la crisi che abbiamo descritto. Non si capisce nulla del capitalismo contemporaneo se non si ragiona dentro questo quadro (in Italia Luciano Gallino è, di nuovo, chi sembra avere più coscienza di questa dinamica). Né si capisce nulla di quel che succede e succederà in Europa o in Italia se non legandolo a questo discorso. Le politiche sul lavoro e sulle pensioni, per esempio, nascono di qui. Il «keynesismo» reale è questo, oscillante tra il bellico e il finanziario. Il capitalismo è questo virus, e lo si affronta solo con politiche che mettano davvero in questione questo meccanismo unico. L’appello al «conflittualismo» incompatibilista, beh, fa sempre bene ma lascia il tempo che trova. Come la discussione governo sìgoverno no. Con Halevi non ci facciamo illusioni su quello che porterà questo governo. La soluzione non sta però in un’opposizione pura e semplice. Una controversia che di nuovo oppone un politicismo a un altro. Sta, semmai, in un’opposizione che sia in grado di avere anche una cultura da classe dirigente, che ambisca a governare i processi. Oppure si dimostri coi fatti e con i risultati, non con le parole o le promesse, di poter ottenere che qualche punto essenziale del proprio programma venga realizzato. E la si smetta con una contrattazione continua e uno scontro ideale esasperato che non porta a niente. EMILIANO BRANCACCIO La semplice dicotomia concettuale tra stabilità e instabilità, tra equilibrio e crisi del capitalismo, non mi ha mai particolarmente convinto. Di solito il concetto di «crisi» viene dalle nostre parti declinato come un sintomo dell’instabilità e quindi della debolezza sistemica del capitale. E invece, soprattutto ai giorni nostri, accade spesso che la crisi agisca paradossalmente da fattore di riequilibrio del sistema. Pensiamo ad esempio alla crisi valutaria italiana del 1992. La vendita in massa di titoli pubblici nazionali mise nell’angolo i sindacati, e li costrinse ad accettare una compressione della spesa e dei salari di tali proporzioni da rimediare al deficit nei conti esteri. La crisi, insomma, può agire sul grado di sfruttamento assoluto e relativo dei lavoratori, può ridurre questi ultimi a variabile residuale del sistema e può consentire, per questa via, di ripristinare l’ordine nelle 67 condizioni di riproduzione del capitale. Si badi bene che questa «crisi disciplinante» può riproporsi, anche in Italia. Se il deficit nei conti esteri continua a crescere, potrebbe diffondersi il timore di un’uscita del nostro paese dall’euro e di una conseguente svalutazione. Il solo diffondersi di un tale sospetto potrebbe attivare una massiccia vendita di titoli pubblici, e di conseguenza anche i sindacati più combattivi potrebbero esser messi alle strette, così da ridurre il deficit estero attraverso una compressione dei salari unitari ancor più violenta di quella del 1992. La prospettiva è funesta, ma se si volesse davvero evitarla bisognerebbe forse cimentarsi nel recupero e nell’aggiornamento di una vecchia lezione di Lenin, a mio avviso non del tutto obsoleta: imparare ad anticipare la crisi, per annunciarne i rischi e per saperla poi sfruttare politicamente. Personalmente ho cercato di approfondire la questione (11 e 22 luglio, «Liberazione»), ma riflessioni di questo tipo mi sembrano ancora poco diffuse. C’è addirittura un certo imbarazzo nell’affrontarle. Eppure la loro attualità è evidente, così come è evidente che fino a quando non ci si attiverà per anticipare le crisi, queste piegheranno sempre in una direzione disciplinante e normalizzatrice. GIORGIO GATTEI La crisi di Borsa che si è aperta in agosto sarà per il capitale appena un «turbamento» oppure il suo «crollo»? Credo nessuna delle due. Certamente la crisi è gravissima e avrà ricadute sull’economia «reale», proprio come è stata la Grande crisi che nel 1929 ai commentatori appariva appena finanziaria e circoscritta (poi s’è visto cos’è suc- 68 cesso). Tuttavia essa potrà mettere alle corde il capitalismo americano, non di certo il capitale nel suo complesso che adesso vede diversi soggetti inediti in competizione come Cina+India. E che ne potrà succedere? Per gli Stati Uniti non mi pare che ne possano uscire senza un’inversione radicale di tendenza che porti all’aumento dell’imposizione fiscale per ripianare il bilancio federale e alla svalutazione del dollaro per raddrizzare la bilancia dei pagamenti. Però le imposte ridimensionerebbero quel mercato interno americano che attualmente funziona da luogo privilegiato della domanda globale, mentre la caduta del dollaro lo spodesterebbe dal ruolo privilegiato di moneta mondiale. Sarebbe un disastro per tutti, che quindi proprio tutti si sforzeranno d’impedire. Ma sarà proprio così? Fino all’altro ieri avrei detto di sì, perché a fronte della crisi americana ci sarebbe stata la vittoria dell’Urss nella «guerra fredda» con l’intero «mondo libero» a farne le spese. Oggi però l’Urss non c’è più e per il «mondo libero» la fedeltà all’America non è più una virtù. Fino a ieri c’era poi anche il fatto che al mercato americano e al dollaro mondiale non si davano alternative. Ma ora potrebbe aprirsi il grande mercato euro-asiatico, se Europa, Russia e Cina+India passassero a uno sviluppo continentale integrato, e poi c’è l’euro che, macinando guadagni sul dollaro, sconsiglia di comprarlo. Insomma, può darsi che stiamo vivendo, più che una crisi del capitale, un trapasso di supremazia capitalistica dagli Stati Uniti all’Eurasia all’incontrario di quello che dopo il 1945 portò alla detronizzazione (pacifica) dell’Inghilterra e della sterlina estenuate dalla «guerra dei trent’anni» contro la Germania. Può così darsi che il XXI secolo non sia più americano e al proposito raccolgo una notizia giornalistica passata in sordina: «La Cina vende T-Bond Usa? È la sua “opzione nucleare”. Un pesante calo nelle ultime cinque settimane del possesso di titoli del tesoro americano (Treasury bonds) ha fatto crescere i timori che Pechino stia silenziosamente ritirando i propri fondi in dollari dai mercati degli Stati Uniti» («Wall Street Italia», 7 settembre 2007). GIORGIO LUNGHINI È vero che il capitalismo è capace di metamorfosi, di trasformazioni che però non ne intaccano il nesso interno, cioè il rapporto tra capitale e lavoro salariato. Metamorfosi che anzi sono intese a salvaguardarlo. L’esempio più chiaro è stato proprio il fordismo, come risposta alla crisi del ’29; e lo è anche questa globalizzazione, come risposta alla crisi del fordismo. Quale sarà la prossima metamorfosi, non lo so; ma credo che non avrà un bell’aspetto. Circa i rischi della finanziarizzazione, cito di nuovo Keynes, il Keynes della Teoria generale: «gli speculatori possono essere innocui se sono delle bolle sopra un flusso regolare di intraprese economiche; ma la situazione è seria se le imprese diventano una bolla sospesa sopra un vortice di speculazioni. Quando l’accumulazione di capitale di un paese diventa il sottoprodotto delle attività di un casinò, è probabile che le cose vadano male. Se alla borsa si guarda come a una istituzione la cui funzione sociale appropriata è orientare i nuovi investimenti verso i canali più profittevoli in termini di rendimenti futuri, il successo conquistato da Wall Street non può proprio essere vantato tra gli straordinari trionfi di un capitalismo del laissez faire. Il che non dovrebbe meravigliare, se ho ragione quando sostengo che i migliori cervelli di Wall Street sono in verità orientati a tutt’altri obiettivi». RICCARDO REALFONZO Su questi temi preferisco continuare ad avere come punti di riferimento i contributi di Marx, Keynes e Schumpeter. Questi autori, insieme con la migliore e più recente letteratura postkeynesiana e sul circuito monetario, ci hanno insegnato che l’economia capitalistica possiede una natura intimamente monetaria, attraversata da incertezza sistemica, e quindi anche da una dimensione speculativa, e non a caso procede lungo sentieri di sviluppo ciclici e non lineari. Ormai sappiamo bene che lungo la fase crescente del ciclo gli atteggiamenti speculativi degli agenti – imprese e famiglie – si moltiplicano, assecondati dagli intermediari finanziari e dalle banche, facendo aumentare la fragilità finanziaria delle singole imprese, anche delle famiglie, e del sistema nel suo insieme. E sappiamo anche che in fondo il capitalismo non è riformabile, ma che lo Stato può ridurre gli scossoni e le crisi cicliche attraverso l’intervento diretto nell’economia e la regolamentazione dei mercati. Le vicende di questi giorni, con la crisi dei mutui subprime, mostra ancora una volta quanto sia fallace il mito liberista della piena libertà dei mercati, con i suoi assunti della perfetta informazione e della perfetta razionalità, con il suo mito dello sviluppo in equilibrio. In realtà i mercati finanziari dovrebbero essere regolamentati più intensamente, anche impedendo l’emissione di strumenti derivati ad alto rischio. I movimenti interni e internazionali di capitale, non associati allo scambio di merci e servizi, dovrebbero essere maggiormente controllati e limitati. E, naturalmente, la politica fiscale e la politica monetaria dovrebbero essere libere dai lacci in cui i modelli neoliberisti tendono a imbrigliarle. RIVE GAUCHE Con il mutamento epocale del 1989, la crisi dei modelli social-democratici ha accompagnato l’eclissi del cosiddetto «socialismo reale». Anche a sinistra il «piano» è caduto in disgrazia, a tutto vantaggio dell’idea di «mercato», seppure regolato. Per chi oggi – nel mondo occidentale – fa riferimento a un impianto analitico marxiano, ciò è nella sostanza espressione di una sconfitta «di classe». Analogamente, quanti non ritengono Keynes una sorta di residuo archeologico sopravvissuto alla globalizzazione capitalistica vedono in tali sviluppi il presupposto di una verticale regressione sociale. È qui in gioco un pezzo essenziale dell’identità di una critica del modo di produzione capitalistico. RICCARDO BELLOFIORE Credo, a questa domanda, di avere già risposto. Keynes è autore di grande utilità per capire gli aspetti monetari e finanziari, l’inadeguatezza della domanda effettiva, il ruolo di aspettative e incertezza, l’insufficienza di domanda effettiva nel capitalismo «puro», la disoccupazione di massa come stato permanente, la povertà in mezzo all’abbondanza, il costitutivo disequilibrio che caratterizza il capitalismo. Ma lui, come le politiche economiche costruite e costruibili dentro il suo quadro, resta in un ambito borghese. Solo una ridefinizione strutturale della domanda, ma anche dell’offerta, può superarne i limiti intrinseci. Lo sapevano molto bene Joan Robinson e Hyman Minsky negli anni Sessanta e Settanta, critici interni del keynesismo realizzato, che non scambiavano certo per l’anticamera del comunismo. Per quel che riguarda Marx, poi, in Italia davvero nessuno se ne preoccupa più, se non come filosofo: e, veramente, a quel punto Marx è ridotto a un classico o a oggetto di studio filologico che non mi interessa. Riprendere la critica dell’economia politica significa peraltro stare dentro la teoria del valore, dentro l’essenzialità del denaro come capitale. Queste cose, per alcuni economisti della Rive Gauche, sono un «pantano» e nulla più. La domanda fa riferimento a un primato del «mercato», pur regolato, nella cultura prevalente nella sinistra cosiddetta moderata (ma è poi ancora sinistra?). È un buon punto di partenza, se si sviluppa sino a criticare il tic tipico di tutti, non ultimi il vecchio «Ernesto» e ora «Essere comunisti» (vedi i contributi di Burgio), che parlano sempre di liberismo o di neoliberismo come se fosse la riedizione del laissez faire. Quel liberismo non è mai esistito davvero. Oggi la retorica liberista dilaga nel centro-sinistra, anche in conseguenza del risultato elettorale risicato, sicché economisti di quell’impronta hanno larga eco. Ma il liberismo non è però più da tempo un’opzione reale, se mai lo è stato davvero. 69 70 Il neoliberismo, vedi Bush e Berlusconi, protegge i monopoli, usa i disavanzi del bilancio dello Stato e fa aumentare il debito pubblico senza problemi. È selvaggiamente liberista sul mercato del lavoro e contro lo stato assistenziale, questo sì. I social-liberisti, dal canto loro, si credono per più mercato e più stato perché vogliono liberalizzare per riregolamentare. In questo sono, per un verso, più liberisti, sul mercato dei beni e dei servizi. Ma sono anche, per l’altro verso, per un welfare universalista, per una qualche redistribuzione, per politiche industriali e del credito basate su incentivi e disincentivi. Cercano di riempire l’ampio spazio che si apre secondo loro tra liberismo e statalismo vecchio stampo. I primi si rifanno al monetarismo e alla nuova macroeconomia classica, ma più ancora agli austriaci Mises e Hayek. I secondi, partono da quell’«imperfezionismo» alla Stiglitz che nega l’utilità dell’equilibrio economico generale walrasiano come guida al come funzionano i mercati nella realtà. Siamo ben lontani dalla social-democrazia, ma anche da Keynes. Però, sia chiaro, tutti usano le politiche keynesiane quando ce n’è bisogno. Di nuovo, la sinistra ha su questo un’arretratezza culturale spaventosa, non sa cosa sia oggi il dibattito vero in economia o in politica economica. Lo dimostrano come meglio non si potrebbe la gran parte degli interventi degli economisti sulle pagine de «il manifesto» e di «Liberazione», un giorno sì e l’altro pure. EMILIANO BRANCACCIO Io non so se la critica del capitale ponga effettivamente un problema di «identità». È chiaro che la pianificazione socialista o anche la socializzazione degli investimenti possono rappresentare delle valide prospettive attorno alle quali riunirsi, soprattutto se si riuscirà nuovamente ad approfondire il nesso tra queste forme di organizzazione delle relazioni economiche e le forme di espressione della democrazia. Contrariamente al mercato capitalistico, infatti, la pianificazione potrebbe costituire un vettore delle più grandi e disattese istanze di emancipazione sociale, dalla tutela dell’ambiente alla lotta al patriarcato. Ma al di là del discorso sugli obiettivi di riferimento, io credo che la critica del capitalismo, almeno da un punto di vista marxista, ponga in primo luogo un problema di metodo. Quel che oggi manca ai movimenti anticapitalisti è un metodo, vale a dire un criterio di analisi e di anticipazione degli avvenimenti concreti. La questione dell’efficacia del metodo di analisi è assolutamente cruciale dal punto di vista politico. Ad esempio, sempre riguardo alle vicende europee, io prima ho sostenuto che la duplice tendenza alla convergenza dei salari e alla divergenza delle produttività potrebbe rappresentare una contraddizione feconda sul piano politico. Tuttavia un buon metodo di analisi potrebbe farci scoprire che la divergenza delle produttività stia avanzando più speditamente della convergenza nelle retribuzioni e nelle condizioni di lavoro. Questo significherebbe che la crisi e la relativa normalizzazione dei sindacati possono sopraggiungere ben prima che si creino le condizioni per un ricompattamento del movimento dei lavoratori a livello europeo. La notizia non sarebbe delle migliori, ma mi pare sia meglio essere a conoscenza di simili evenienze piuttosto che continuare imperterriti a brancolare nel buio. Se non altro, saremmo ancor più consapevoli del fatto che l’ingranaggio dell’euro deve ancora dispiegare i suoi effetti più repressivi, e che forse, per sperare in un rafforzamento della sinistra europea, non ci si può limitare ad attendere che i movimenti dei lavoratori convergano spontaneamente, «dal basso», senza una guida politica capace di anticipare gli eventi. GIORGIO LUNGHINI Di questo esito è responsabile la stessa sinistra, che ha rinunciato senza ragione ai suoi riferimenti teorici classici, Marx e Keynes, e ha aderito frettolosamente alla visione oggi imperante di un capitalismo del laissez faire capace di autoregolarsi: una visione priva di qualsiasi fondamento teorico robusto e foriera di gravi guasti economici, sociali e politici. È anche un segno di provincialismo, poiché in nessuna parte del mondo c’è oggi uno stato liberista. RICCARDO REALFONZO Continuo a pensare che Marx e Keynes siano vivi e quanto mai utili per capire e per agire. Ed è per questo che occorre tornare faticosamente a evidenziare i tanti fallimenti del mercato e la necessità dell’intervento pubblico, della programmazione economica, del piano. RIVE GAUCHE RICCARDO BELLOFIORE In questo quadro – a dispetto degli esiti referendari registrati a suo tempo in Francia e Olanda – il progetto europeo conferma nei fatti l’ispirazione e le politiche neoliberiste. E, al di là della «retorica europeista», va consolidandosi una conduzione comunitaria a misura degli stati più forti (in primo luogo, Germania e Francia). Al punto che Valentino Parlato, già nel convegno di due anni fa, prospettava per una politica delle sinistre la necessità di una scelta netta: o si procede nella democratizzazione del suddetto progetto, in direzione di un’«Europa dei popoli», o è meglio tornare a dare forza e autonomia ai governi nazionali. Una tale alternativa non si pone oggi con maggior radicalità? No, quella proposta da Valentino Parlato è una falsa alternativa. La categoria di «popolo» è tra le più ambigue che conosca. Una sinistra autentica dovrebbe ripartire da una analisi di classe del capitalismo contemporaneo, e delle trasformazioni in Europa, quella cui ho accennato nelle risposte precedenti. Un’esigenza del genere è stata affermata all’inizio di questa estate tanto dallo stesso Parlato quanto da Rossana Rossanda. Bene, non si capisce perché il loro giornale, che non è un giornale qualsiasi, non se ne faccia promotore. Idem per «Liberazione», che sembra procedere sul terreno dell’economia con un approccio di tipo «pluralista» nel senso più deteriore: i tecnici dicano quello che vogliono, tanto la sintesi la tirano altri. Il punto è che una «analisi di classe», una volta fatta, imporrebbe scelte diverse, vincolerebbe le mani. Né si può pretendere che gli intellettuali che vi mettono mano non abbiano una loro politicità, non pongano una sfida cui occorre rispondere. Le politiche «nazionali» in Europa certo che ci sono. Ma dal lato della classe operaia, come dal lato del capitale, non si può non osservare come «centri» e «periferie» divengano trasversali, e così la catena della creazione di valore in senso marxiano. Qualcosa che non si può pensare scorra lungo i confini delle «nazioni». Bisognerebbe allora avere il coraggio di dire che una sinistra autentica esiste davvero solo se ha un progetto di trasformazione radicale, e se è a partire da questo che va a una dialettica con i «social-liberisti». E che dunque, come dice Lafontaine, va al governo se su qualche punto discriminante del suo programma quel governo si impegna. Insomma, non vedo in nessun partito o aggregazione un discorso veramente europeo e di classe, se non a parole. Occorre abituarsi all’idea di una lunga marcia attraverso le contraddizioni reali per tornare a poter incidere davvero, smetterla con i cortocircuiti. Questi errori sono stati condivisi da praticamente tutti a sinistra, inclusa l’area dell’Ernesto. Sulle questioni che stiamo discutendo, si è appiattita, senza distinguo, alle analisi più correnti sul terreno dell’economia, che non hanno con tutta evidenza portato da alcuna parte. Ricordo bene come, quando posi più o meno queste questioni nella discussione al Cpn sulle Tesi del Prc, a fine 2001, la reazione fu una simmetrica sordità, tanto della maggioranza di allora, quanto degli emendatari. Mi votò praticamente solo il compianto compagno Rigacci, uno che sulle questioni dell’economia – come Maitàn – darebbe molti punti agli economisti vicini al partito. Si vede che avevo torto. 71 EMILIANO BRANCACCIO imboccarlo potrebbe aprire in sé nuovi scenari, magari 72 La contrapposizione tra europeismo e neonazionalismo viene presentata troppo spesso in modo semplicistico. Stando all’esperienza passata, credo sia lecito ritenere che la strada verso un’Europa più unita e democratica possa essere imboccata solo attraverso un maggior protagonismo dei paesi periferici. Il problema della maggiore forza e autonomia dei governi di questi paesi dunque si pone, e indubbiamente potrebbe esser fonte di complicazioni e di contrasti. Ma sarebbe ingenuo o strumentale considerare i conflitti interstatuali necessariamente disgreganti. Nulla toglie che essi possano invece rivelarsi il giusto stimolo per la ripresa del processo di unificazione politica europea. A ogni modo, è chiaro che i governi dei paesi periferici potranno acquisire maggiore forza solo se si rendono più autonomi rispetto al vincolo di bilancia dei pagamenti con l’estero (che non si vede più ma esiste eccome). Ciò può esser conseguito tramite una politica protezionistica, della quale mi farebbe senz’altro piacere discutere ma che non mi pare sia all’ordine del giorno. Oppure, si può cercare di allentare il vincolo dei conti esteri attraverso un allentamento del vincolo dei conti pubblici, e un utilizzo delle risorse statali per un programma di politica industriale selettivo, fondato sull’intervento pubblico negli assetti proprietari e orientato all’esportazione (questo, in sostanza, era il progetto insito nell’appello degli economisti contro l’abbattimento del debito). Si noti che, in misura più o meno radicale, tutte le soluzioni menzionate richiedono la violazione di almeno alcune delle regole europee (dal patto di stabilità alle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di stato). Ma il problema chiave non è di ordine politico-istituzionale. Il problema di fondo è di capire se c’è il margine economico per agire in questa direzione. A tale riguardo, dall’esame della reattività dei tassi di interesse si scopre che questi sono scarsamente sensibili alla dinamica dei conti pubblici mentre risultano abbastanza condizionati dalla dinamica dei conti esteri. Dunque, contrariamente a quel che si pensa, se vogliamo capire quanto margine abbiamo, dobbiamo spostare l’attenzione dal deficit pubblico al deficit commerciale. Se l’allentamento del vincolo sul deficit pubblico viene sfruttato nel modo giusto – che è quello di accrescere i parametri di competitività nazionale – allora è possibile che il conseguente ampliamento del deficit commerciale venga assorbito prima di un attacco speculativo sui titoli pubblici nazionali, o comunque in tempo utile per evitare un’eccessiva instabilità finanziaria. Sarebbe un sentiero stretto, non particolarmente agevole. Eppure la ferma volontà dei paesi «periferici» di pure convincendo la Germania e gli altri paesi «centrali» della necessità di costituire un ampio bilancio pubblico europeo per salvare il processo di unificazione. Ma, soprattutto, rinunciare a questa opzione politica alternativa significherebbe proseguire lungo la nefasta e già ampiamente sperimentata via crucis della deflazione, questo vediamo di non dimenticarlo mai. GIORGIO LUNGHINI Penso anch’io che la prospettiva auspicabile sia quella di un’Europa degli Stati-nazione anziché di un mercato dell’Europa, ma non ne vedo le premesse politiche e culturali. RICCARDO REALFONZO Purtroppo temo che la grande speranza in quello straordinario progetto di pace e solidarietà che chiamiamo «Europa dei popoli» rischi di tramontare. Sappiamo sin troppo bene, infatti, che il Trattato istitutivo dell’Unione Europea ha prospettato un modello ben diverso, incentrato sulla moneta e sul mercato. Un modello che ha preteso la progressiva fuoriuscita dello Stato dall’economia, l’indebolimento dello stato sociale, nonché una politica monetaria che guarda con ostilità alla piena occupazione, perché foriera di spinte salariali e conseguenti rischi inflazionistici. Tutto ciò ha determinato una significativa crescita degli squilibri e delle disuguaglianze. Le aree centrali e sviluppate sono diventate più ricche e congestionate, le aree periferiche e sottosviluppate più povere e desertificate; i profitti e le rendite sono aumentati, i salari si sono contratti; l’occupazione non è aumentata e invece si sono intensificati i flussi migratori. Eppure, per quanto tutto ciò abbia del paradossale, la moneta unica e l’abbattimento delle barriere alla circolazione delle merci avrebbero effettivamente potuto costituire il volano per un nuovo modello di sviluppo, per l’«Europa dei popoli». Con l’adesione alla moneta unica l’Italia e gli altri stati d’Europa hanno perso la sovranità monetaria, hanno rinunciato a importanti strumenti di politica economica, hanno accettato una serie di vincoli alle politiche di bilancio. Oggi non solo siamo lontani anni luce dall’«Europa dei popoli», ma abbiamo anche vincolato l’azione dei governi, e abdicato pezzi di democrazia economica a favore delle tecnocrazie della moneta unica. RIVE GAUCHE Il convegno della Rive Gauche aveva provato a fornire indicazioni circa la politica economica che un governo progressista dovrebbe proporsi di attuare. Il fatto che, nella sostanza, nel nostro paese non si sia dato seguito a quelle sollecitazioni dipende da un difetto di ascolto da parte del versante moderato della coalizione di governo oppure esistono impedimenti «strutturali» al concretizzarsi delle suddette politiche? In altri termini, quale spazio c’è oggi – oggettivamente – per politiche progressiste? RICCARDO BELLOFIORE Di nuovo, la domanda mi sembra malposta. È ovvio che esistono impedimenti «strutturali»: si chiamano rapporto di classe e relazioni di potere, ma ci si dovrebbe muovere per cambiare lo stato di cose esistente, no? La domanda non considera neanche la possibilità che le «sollecitazioni» sulla politica economica avanzate dagli economisti della Rive Gauche fossero superficiali e sbagliate. Ed è infatti questa la vera risposta. Non può non colpire che nelle vostre domande la questione su cui più si sono impegnati gli economisti della Rive Gauche più presenti su «il manifesto» e «Liberazione», ma anche sul vecchio «Ernesto» e ora «Essere comunisti», quella della battaglia sul debito pubblico, compaia marginalmente, sullo sfondo. D’altronde, è così nello stesso articolo che annuncia un secondo convegno di economisti promosso da «il manifesto» a Roma, di Leon e Realfonzo, dove non vi si fa praticamente cenno. Peraltro, si parla solo del neoliberismo, come se il social-liberismo non esistesse, e la crisi economica che dagli Usa rischia di tracimare, anzi lo ha già fatto, merita una riga come se non ci riguardasse, e non avesse a che vedere con le questioni della precarietà o delle pensioni. Quella che si è fatta sul debito pubblico è stata per due anni una battaglia «gridata», su un approccio in fondo contabile al pari di quello della controparte: meglio la «stabilizzazione» del «risanamento finanziario». Questo lo sappiamo tutti. Ma è chiaro che la stabilizzazione di per sé non comporta alcun avvio di una diversa politica economica, è all’insegna di un’illusoria riduzione del danno. Un ministro bravissimo di suo, come Paolo Ferrero, si è in qualche misura sganciato. E si è attestato sulla linea del Piave dell’attuazione del programma. Costretto a questo punto a sostenere una tesi altrettanto debole: quella di spalmare il rigorismo su due anni. Illusoria, la pretesa riduzione del danno, perché la parola d’ordine della stabilizzazione è debole, tanto sul terreno dell’analisi, quanto sullo stesso terreno immediatamente politico, di una proposta efficace. Sul terreno dell’analisi, dei contenuti, perché la sinistra dovrebbe, come ho detto, partire lei all’offensiva, non farsi mettere nell’angolo. Pretendere lei di partire dai 73 74 problemi del «declino» economico e sociale da cui è iniziata la nostra conversazione. Denunciare lei l’inaccettabilità del come sono articolate spesa pubblica ed entrate statali, la qualità a rischio della nostra specializzazione produttiva, i limiti seri della nostra posizione verso l’estero, il pericolo del degrado strutturale che ne consegue. Dunque, presentarsi lei con una qualche proposta di dove e come intervenire, in un’ottica meno debole di quella della cosiddetta via alta alla produttività (ne ho scritto con Garibaldo su «il manifesto»). Se no i discorsi sulla programmazione, sulla lotta alla precarietà, la stessa battaglia contro la controriforma delle pensioni e lo scippo del Tfr, su un pieno impiego di qualità, sono tutti fiato sprecato. Muoversi in quest’altra direzione (che va preparata da un lavoro vero: e un lavoro vero prende tempo, sta lontano dai riflettori, non si esaurisce in articoli, convegni e presenza mediatici, che vengono dopo) comporta una politica di maggiore spesa per «investimenti» pubblici in senso lato. È chiaro che con questa struttura dell’imposizione fiscale, si determina un peggioramento, nell’immediato, del rapporto disavanzo/Pil. A medio-lungo termine, però, se le politiche sono ben disegnate, il denominatore aumenta. Ovviamente ciò deve avvenire con una composizione della produzione che segnali l’impronta di sinistra, ed è qui che per esempio divengono essenziali l’ottica ambientalista e anche quella femminista: dovremmo smetterla di vedere queste questioni come separate, si tratta di far vivere la questione di genere e quella della natura dentro il proprio orizzonte di cambiamento dei modi dello sviluppo economico. È il cosiddetto «paradosso della produttività», che risale in fondo a Schumpeter. Per aumentare la produttività, per innovare, prima devi finanziare una politica di investimenti che avrà effetti, darà frutto, solo nel futuro. A questo punto, se ti contrappongono l’esigenza di evitare un aumento del disavanzo, beh, si può replicare che si vadano a cercare delle entrate altrove che nel mondo del lavoro, che una politica di spesa pubblica è produttiva eccome. Graziani ha spesso ricordato che gli stessi parametri di Maastricht non impediscono affatto una politica espansiva, visto che un aumento delle spese finanziato da entrate di pari ammontare accresce reddito e occupazione. Su questa linea si sarebbe evitata la situazione prevedibile, e che si è poi effettivamente verificata, che la battaglia sul debito sarebbe stata etichettata come la solita da parte di una sinistra che difende l’esistente, insensibile ai problemi strutturali. Ammettiamolo, non del tutto a torto. D’altronde quello che chiedono i partiti della sinistra e qualche sindacalista è un po’ di respiro: si può ca- pire, ma è cortoterminismo anche quello. Come ha detto con efficacia, qualche tempo fa, Giorgio Lunghini: nel breve periodo siamo tutti morti, anche e soprattutto a sinistra. La carica distruttiva del capitalismo odierno non è certo frenata dal piccolo cabotaggio. Non è un caso che a Salvati, che ha posto da destra questi problemi, gli economisti della Rive Gauche non hanno saputo replicare praticamente niente. Avevamo in realtà risposto in anticipo due anni fa Halevi e io, nel contributo al convegno e poi volume di Rive Gauche. E su «il manifesto» abbiamo controbattuto Garibaldo e io, in un articolo sui nodi strutturali che ho messo al centro delle risposte in questa intervista. Essere «rassegnati» significa prendere questi ragionamenti sottogamba, come un discorso di utopia. Mi è stato detto a ripetizione, nei vari dibattiti a cui ho partecipato dall’anno scorso: sei, come Halevi, un «esagerato». Gli investimenti pubblici, sì, va bene, ma in realtà non si sa cosa siano. E comunque non ci sono le condizioni politiche. Se la sinistra non sa come dare carne e sangue a un discorso sulle politiche strutturali, è chiaro che perde. Perde per molte ragioni, ma RIVE GAUCHE anche perché non ha veri argomenti, non conosce i processi strutturali, non sa come ragionano gli altri. Claudio Napoleoni nel 1987, in un intervento a un convegno del Cespe, e pur all’interno di una impostazione piena di limiti, in parte subalterna alla sirena del «risanamento», non ha però mai perso di vista un punto essenziale senza del quale non c’è politica economica di sinistra. Che si deve intervenire sulle questioni della spesa pubblica e del debito solo «all’interno di una operazione più complessiva che abbia come suo punto di partenza un punto immediatamente mobilitante: quello della redistribuzione del reddito». E aggiungeva subito che «le operazioni che si intendono fare mediante il bilancio pubblico sono quelle volte allo spostamento in avanti del vincolo interno»: in altre parole, che spazi per una diversa distribuzione del reddito si aprono soltanto se contemporaneamente si rimette in questione, a partire dalle politiche statali di spesa, la struttura economica e produttiva, se dunque con quelle politiche si allenta anche il vincolo «esterno». E questo, se deve avere contenuti di sinistra, richiede una vera e propria rivoluzione culturale. Richiede «di mutare in maniera radicale le prospettive, gli obiettivi e perciò anche gli strumenti, di contrapporre veramente al modello degli altri un altro modello». La sinistra, quest’altro modello, ce l’ha o no? O si tratta di parole da spendere come moneta ormai svalutata senza dar loro un contenuto, prima o poi? Uno come me, che è «pessimista» e «rassegnato», e per qualcuno poco meno o poco più che un traditore perché non convinto dall’economia della Rive Gauche, non capisce come sia possibile che Sarkozy possa dire e fare quello che da noi la sinistra non ha il coraggio nemmeno di bisbigliare a Prodi e Padoa Schioppa. Si tratta in fondo dell’ex Presidente della Commissione Europea e di un ex banchiere centrale della Banca Centrale Europea. Dovrebbero spendere il loro prestigio in Europa per far accettare un serio programma di intervento strutturale, anche se all’inizio finanziato in ulteriore disavanzo. Questo avrebbe almeno potuto, e dovuto, chiedere la sinistra, se fosse giunta all’appuntamento preparata sul piano programmatico. Così, alla resa dei conti, risulta più coraggioso – oggi come nel 1998 – Prodi con il suo discorso sull’utilizzo in Europa, a fini di investimento, dell’eccesso di riserve in oro delle banche centrali. Vola diecimila volte più alto della sinistra. Né ci si può nascondere che la battaglia condotta da alcuni dei promotori dell’appello degli economisti, quelli più presenti sui giornali della sinistra, è stata pressoché integralmente autoriferita in modo imbarazzante, una sorta di grandiosa autopromozione di ceto. Non ci vuole molto a provarlo. Si vada sul sito www.appellodeglieconomisti.com, e si contino, tra i soli suoi firmatari, gli interventi raccolti (articoli, interviste, radio o televisione) dopo il lancio dell’appello sotto la rubrica «il dibattito». I dati sono questi: Emiliano Brancaccio, Università del Sannio, 19 ricorrenze: Riccardo Realfonzo Università del Sannio, 14 ricorrenze; Luigi Cavallaro, editorialista, 4 ricorrenze; Guglielmo Forges Davanzati e Rosario Patalano, 3 ricorrenze ciascuno; Paolo Leon, 2 ricorrenze; Artoni, Bosco, Cesaratto, Graziani (con Realfonzo), Palermo, Romano: 1. Se si tiene conto che Forges Davanzati e Patalano, di altre sedi universitarie, sono però legati da una lunga collaborazione a Realfonzo, gli interventi di quello che il «Corriere della Sera» ha denominato l’Mit del Sannio ammontano a 39 ricorrenze (senza Forges Davanzati e Patalano, sono comunque 33). Gli altri firmatari sono intervenuti, o per lo meno i loro interventi sono stati registrati, per 12 ricorrenze (con Forges Davanzati e Patalano si arriverebbe in ogni caso a 18). Si noti che uno dei quattro primi promotori, Ciccone, non compare tra gli interventi. Né è intervenuto in alcun modo, che non sia la firma dell’appello, Garegnani. Lasciamo perdere dunque il versante «moderato» della coalizione, come lo chiamate, che non è comunque rinchiudibile nella caricatura che se ne dà nella polemica giornalistica su il «il manifesto» e «Liberazione», e neanche nei contributi che ho letto sul vecchio «Ernesto» o su «Essere comunisti». E d’altra parte, se gli economisti della parte «moderata» della coalizione fossero tutti «bocconiani» e «neoliberisti», magari «un po’ meno», davvero non capisco come si possa aver pensato di andarci al governo insieme. Qui il problema sta nella sinistra. Come anche nella debolezza intrinseca, su diversi piani, dell’appello. E sta nel fatto che un certo modo di fare l’economista di sinistra, «consigliere del principe», è ormai giunto al capolinea. EMILIANO BRANCACCIO Non definirei «moderato» il nascituro Partito democratico. Quel partito resta fedele alla deflazione da salari e da domanda per rimediare al deficit commerciale. In esso cova da tempo il desiderio di una resa dei conti con le frange più combattive del sindacato, magari proprio attraverso una «crisi disciplinante». Non mi pare che in questo anno e mezzo di governo le forze della sinistra abbiano avuto la possibilità concreta di scalfire l’egemonia dei cosiddetti «democratici» nel campo prioritario della politica economica. E non credo proprio che un convegno 75 76 e un appello come i nostri, pur lodevoli, pur tempestivi sul piano politico, potessero cambiare lo stato dei rapporti di forza. L’unità degli economisti della Rive gauche, le loro iniziative, nel loro piccolo stanno sicuramente aiutando a fare chiarezza, e stanno mettendo in seria difficoltà gli esponenti dell’ortodossia liberista, i quali vedono finalmente un po’ scalfito il privilegio di poter diffondere il loro verbo senza alcun contraddittorio (a titolo di esempio, mi permetto di segnalare il confronto che ho avuto con Giavazzi e Ichino in tema di precarietà, su «Liberazione» dell’1, 4, 6 e 8 settembre). Questa rinnovata dialettica ci ha permesso anche di dare la sveglia ai numerosi esponenti e opinionisti della sinistra che si erano lasciati condizionare dai falsi dogmi dell’ideologia dominante, e che per questo motivo avevano preso ormai una velleitaria deriva etico-sentimentale (del tipo: le leggi economiche proprio non le conosco, ma le considero brutte e cattive). Ma al di là di questi pur apprezzabili risultati, l’illusione che delle belle teste pensanti si siedano a un tavolo, scrivano un gran programma e grazie a questo arrivino a cambiare il mondo la lascio volentieri all’amico Bellofiore, che si professa «marxiano» ma che spesso cade, curiosamente, in un idealismo alquanto ingenuo. Come ho detto e ripetuto, un’analisi accurata e un programma efficace ci servirebbero senz’altro, ma uno spazio per la politica economica alternativa potrà emergere solo dalla capacità di impiegare le conoscenze acquisite al fine di sfruttare la prossima congiuntura, la prossima emergenza. Pertanto la questione prioritaria è la seguente: se domani all’improvviso ci trovassimo nel bel mezzo di un momento «emergenziale», saremmo noi in grado di sfruttarlo, di piegare la direzione degli eventi secondo i nostri scopi? Io credo proprio di no, credo che risulteremmo ancora una volta impreparati e sguarniti, come nel 1992. È questo il grave problema politico sul quale bisognerebbe concentrarsi e lavorare. A partire forse da un interrogativo: fino a che punto si possono condividere le responsabilità di governo con degli alleati che puntano alla deflazione e che magari passerebbero volentieri per una «crisi disciplinante»? Visto che a sinistra non è ancora maturato un effettivo potenziale egemonico, mi domando molto sommessamente se non sarebbe opportuno assumere una posizione più critica e defilata rispetto a gestioni di cui non abbiamo ancora visto il lato più oscuro, e che al momento non abbiamo la forza di cambiare. GIORGIO GATTEI Scrive Marx che le parole d’ordine economico della Comune di Parigi (1871) furono l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, da sostituirsi con la proprietà collettiva degli stessi, e l’abolizione dell’anarchia del mercato, da sostituirsi con una direzione di piano. La sinistra del Novecento ha portato avanti queste due «bandiere», sicura che l’impresa pubblica fosse più efficiente della privata (il caso italiano dell’Iri si è giustificato a lungo così) e che col piano si potessero meglio governare le grandezze economiche fondamentali (l’esperienza italiana della «programmazione» si è giustificata a lungo così). E va detto che verifiche storiche concrete non sono mancate negli anni del «miracolo economico», poi però il giocattolo si è rotto. L’impresa pubblica è precipitata nell’inefficienza e corruzione, così che l’Iri è stata soppressa con il plauso di tutti e oggi quelle poche imprese pubbliche rimaste, che nel frattempo sono tornate efficienti, rischiano la privatizzazione (o lo «spezzatino» per renderle inefficienti e quindi privatizzabili). La programmazione invece è franata sotto l’urto della supremazia dell’impresa diventata «globale»: come governare un’economia nazionale quando i capitali finanziari e industriali che la compongono possono fuggire da tutte le parti? Per di più con l’Unione Europea si sono trasferite quote consistenti di sovranità economica agli organi comunitari, così che adesso un singolo governo, che fosse deciso a prendere iniziative d’indirizzo, dovrebbe misurarsi con gli inevitabili divieti europei. Per questo, se di politica di piano si vuole tornare a parlare, non può che essere a livello europeo. Ma qui ci si imbatte in un altro ordine di problemi. I centri di decisione economica comunitaria, che non sono di nomina elettiva, sono stranamente (?) imbevuti della peggiore ideologia neoliberista: privilegiano il libero mercato (dei capitali), l’iniziativa privata (delle imprese), le rendite finanziarie (delle borse) a tutto danno di un «mondo del lavoro», peraltro in via di frammentazione, che patisce le conseguenze di una sconfitta storica (nei fatti, prima ancora che nelle idee) di cui non ha ancora preso piena coscienza (altrimenti non voterebbe come vota, anche perché nell’insieme non è affatto minoranza). Con simili rapporti di forza europei diventa difficile immaginare politiche di piano a livello nazionale perché prima ci vorrebbe un cambiamento nell’indirizzo economico della Ue, che lo rendesse almeno «eclettico», se è troppo sperare «di sinistra». D’altra parte la Comune di Parigi aveva potuto alzare quelle sue bandiere sulla base del fatto politico che quella era «il governo della classe operaia», o piuttosto «il dominio politico dei produttori» (K. Marx). Oggi in Europa abbiamo a che fare con il dominio politico dei rentiers e con l’assenza (perfino) di una coscienza di classe lavoratrice, così che «a sinistra» non restano che di- RIVE GAUCHE chiarazioni di principio e capitolazioni di fatto. A meno che la crisi finanziaria in corso non arrivi a produrre conseguenze economico-sociali tali da far paura a Lorpadroni, così che siano proprio loro a tornare a richiedere l’intervento «salvifico» dello Stato nell’economia. È già successo e può darsi che risuccederà. GIORGIO LUNGHINI Oggi i governi nazionali non dispongono più della leva monetaria e sono soggetti a vincoli di bilancio per quanto riguarda la politica fiscale. Tuttavia dispongono ancora di un potentissimo strumento di politica economica e sociale, che è la produzione legislativa. Tutto dipende dunque dal potere politico. Forse per ragioni di età, io continuo a pensare che il miglior programma per un governo di sinistra sia già stato scritto nella Costituzione del 1947. Il problema è che non la legge più nessuno o che semmai la si vorrebbe mandare al macero. Dunque può essere utile, per i più giovani, ricordarne i passi di maggior rilievo economico-politico. «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Ogni 77 78 cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Ecco, mi pare che la sinistra potrebbe trovare qui il proprio programma, un programma semplice e chiaro, dunque comprensibile, convincente, e seducente. Mi viene però in mente l’ultimo editoriale di Luigi Pintor, del 2003: «La sinistra italiana che conosciamo è morta. Non lo ammettiamo perché si apre un vuoto che la vita politica quotidiana non ammette. Possiamo sempre consolarci con elezioni parziali o con una manifestazione rumo- rosa. Ma la sinistra rappresentativa è fuori scena». RICCARDO REALFONZO Dal convegno Rive Gauche era emerso con chiarezza il quadro complessivo delle linee di una politica economica progressista da perseguire nelle condizioni date dell’economia e della società italiana. Al di là delle questioni relative alle politiche sociali, gli economisti convenivano sulla necessità di agire per favorire un vero e proprio «salto strutturale», che consentisse al nostro apparato produttivo di superare le strozzature presenti dal lato della domanda e dal lato dell’offerta e appariva chiaro che la condizione di base per la messa in pratica di una politica economica incisiva – in grado di rilanciare l’economia del paese e spingerla nella direzione di un nuovo modello di sviluppo – era una politica delle finanze pubbliche che sapesse spogliarsi dei dogmi liberisti e «rigoristi» del pareggio del bilancio. In altre parole, si rendeva necessario evitare di intraprendere la strada dell’abbattimento del debito pubblico e puntare viceversa sulla stabilizzazione del debito rispetto al Pil nell’arco temporale della legislatura. Personalmente posi la questione nel dibattito che anticipò il convegno sulle pagine de «il manifesto» raccogliendo subito molte adesioni. E non a caso, quando alcuni mesi dopo proponemmo l’appello per la stabilizzazione del debito, gli economisti di sinistra risposero compatti. L’appello raccolse rapidamente un centinaio di adesioni, tra cui quelle dei più autorevoli rappresentanti dell’economia politica critica italiana. Al di là di rare posizioni minoritarie, di cui non si comprendono né i punti di partenza politici né gli sbocchi, resta ancora oggi evidente per gli economisti di sinistra che la stabilizzazione del debito rappresenti l’unica strada capace di liberare le risorse necessarie per una svolta incisiva nella politica economica; ed è su questo punto che – prima di ogni altra cosa – registriamo l’inadeguatezza del governo Prodi. Va da sé che la stabilizzazione del debito rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per intraprendere la strada del «salto strutturale»; non si può certo ignorare il tema della qualità della spesa, come ci ricorda tutti i giorni la scarsa efficacia della pur ridotta spesa nel Mezzogiorno, improntata come è ai principi della programmazione negoziata. E va anche da sé – come diversi di noi hanno mostrato nel dibattito che ha fatto seguito all’appello – che non esistono ragioni tecnico-istituzionali che impediscano l’attuazione di un programma di politica economica di sinistra. Semplicemente non abbiamo avuto la forza per imporlo. COMUNICAZIONI Siamo comunisti, vogliamo le stelle! he compagni saremmo se non stessimo assieme? La nostra festa a Gubbio l’abbiamo fatta apposta. Per discutere, riflettere, documentarci. Per conoscere altri punti di vista. Per unire la sinistra senza perdere le nostre identità e i nostri orizzonti di comunisti. Per non dimenticare mai la nostra storia di resistenze e di assalti al cielo. Per difendere la dignità del lavoro e reclamare i diritti che ci spettano. Per continuare a urlare «no alla guerra» e «no al fascismo», senza se e senza ma. Lo abbiamo fatto tra un bicchiere di vino e un ballo in pista. Spesso a bocca piena, solo il sorriso a trattenerla. Tutti militanti, perché non c’è altro modo di essere comunisti. A Gubbio abbiamo portato un pezzo di Cuba e un po’ di Venezuela. A Gubbio il Sud C del mondo e il Sud d’Italia hanno ribadito che vogliono tornare al centro. A Gubbio abbiamo fatto incontrare i Quaderni di Gramsci con gli Scritti corsari di Pasolini. A Gubbio Bella Ciao e Bandiera Rossa le fischiettavano pure gli uccellini. A Gubbio c’erano più falci e martello che coltelli e forchette. A Gubbio ci siamo divertiti, perché senza gioia non si fa la rivoluzione. A Gubbio eravamo tanti. A Gubbio, dove i comunisti governano davvero e da soli, ci siamo ripetuti che il governo non è un fine ma un mezzo. A Gubbio abbiamo riaffermato, se qualcuno se lo fosse dimenticato, che noi ci siamo. Nel partito e per il partito. Rifondazione comunista è qui e non vuol smettere di lottare. E noi di continuare a Essere comunisti. Alberto Burgio Per Gramsci. Crisi e potenza del moderno pp. 176 euro 13,0 Tra il 1945 e il 1975 le società occidentali cambiano volto. Aprendosi, integrandosi, evolvendosi non soltanto sul terreno delle libertà civili, ma anche sul piano della partecipazione democratica e nel riconoscimento dei diritti del lavoro. Non stupisce che questa dinamica progressiva susciti una furiosa reazione. Che dura tuttora. A partire dai tardi anni Settanta, la restaurazione capitalistica promossa dalla «rivoluzione conservatrice» di Reagan e Thatcher determina in tutto l’Occidente il sopravvento di poteri oligarchici. È una vera e propria rivoluzione passiva. Che svolge una funzione analoga a quella assolta, a giudizio di Gramsci, da altre «rivoluzioni-restaurazioni» come il fascismo e il New Deal rooseveltiano. Ma la crisi è luogo di ambivalenze. Alleva nascostamente in seno una incoercibile istanza di cambiamento. Di giustizia, di libertà e dignità per tutti: il «sogno di una cosa». È questa la lezione di Gramsci, grazie alla quale ancora oggi, a settant’anni dalla sua morte, leggiamo nei Quaderni la partitura teorica della nostra epoca e della sua crisi. acquisti diretti presso l’editore 1 copia sconto 20% da 2 a 3 copie sconto 30% da 4 a 10 copie sconto 40% oltre 10 copie sconto 50% [email protected] 79 Comitato editoriale Maurizio Acerbo Gianni Alasia Marco Amagliani Pierfranco Arrigoni Jone Bagnoli Imma Barbarossa Giorgio Baratta Katia Bellillo Riccardo Bellofiore Piergiorgio Bergonzi Maria Luisa Boccia Manuele Bonaccorsi Vittorio Bonanni Bianca Bracci Torsi Nori Brambilla Pesce Emiliano Brancaccio Giordano Bruschi Tonino Bucci Alberto Burgio Maria Rosa Calderoni Maria Campese Luigi Cancrini Luciano Canfora Guido Cappelloni Gennaro Carotenuto Bruno Casati Luciana Castellina Giulietto Chiesa Francesco Cirigliano Fausto Co' Cristina Corradi Aurelio Crippa Roberto Croce Marco Dal Toso Walter De Cesaris Peppe De Cristofaro Jose' Luiz Del Roio Tommaso Di Francesco Giuseppe Di Lello Finuoli Piero Di Siena Rolando Dubini Gianni Ferrara Guglielmo Forges Davanzati Gianni Fresu Mercedes Frias Alberto Gabriele Haidi Gaggio Giuliani Francesco Germinario Orfeo Goracci Roberto Gramiccia Claudio Grassi Dino Greco Margherita Hack Alessandro Leoni Lucio Manisco Giovanni Mazzetti Enrico Melchionda Maria Grazia Meriggi Enzo Modugno Sabina Morandi Raul Mordenti Franco Nappo Giorgio Nebbia Saverio Nigretti Alfredo Novarini Simone Oggionni Angelo Orlando Franco Ottaviano Gianni Pagliarini Valentino Parlato Armando Petrini Michele Pistillo Felice Roberto Pizzuti Giuseppe Prestipino Marilde Provera Riccardo Realfonzo Alessandra Riccio Paolo Sabatini Giuseppe Sacchi Luigi Saragnese Marco Sferini Guglielmo Simoneschi Vincenzo Siniscalchi Massimiliano Smeriglio Bruno Steri Antonella Stirati Mario Tiberi Nicola Tranfaglia Fulvio Vassallo Paleologo Mario Vegetti Massimo Villone Luigi Vinci Pasquale Voza Maurizio Zipponi Stefano Zolea Stefano Zuccherini direttore – Bruno Steri direttore editoriale – Mauro Cimaschi direttore responsabile – Bianca Bracci Torsi redazione – Mauro Belisario, Silvia Di Giacomo, Marcello Notarfonso email: [email protected] diffusione e abbonamenti email: [email protected] editore associazione culturale essere comunisti via Buonarroti 25 – 00185 Roma stampa tipografia Jacobelli – Pavona (Roma) chiuso in Tipografia il 15 ottobre 2007 grafica progetto grafico, impaginazione e service editoriale: DeriveApprodi credits immagini p. 2, p. 6, p. 10: Nanni Balestrini; p. 13: da «Docks»; p. 16: da «Troubles»; p. 18: Eugenio Cappuccio; p. 20: teatro romano di Benevento; p. 22: lapide funeraria, Benevento; p. 23: Arcangelo; p. 25, p. 26: Thomas Feuerstein; p. 32, p. 33, p. 36: da Muro scritto; p. 40, p. 42: Michael Grobman; p. 44, p. 46, p. 48, p. 49: da La créativité en noir et blanc; p. 55, p. 60, p. 63, p. 64, p. 65, p. 67, p. 69, p. 71, p. 73, p. 74, p. 77: Henri Michaux; copertina: elaborazione grafica originale da un progetto di Tyler Poniatowski www.esserecomunisti.it a notizia è che il nostro sito sta, giorno dopo giorno, crescendo. Cresce rinnovandosi: una nuova veste grafica, nuove sezioni (a partire da quella multimediale, arricchita ogni giorno con nuovi audiovisivi), un doppio aggiornamento quotidiano e già in mattinata articoli e commenti sui fatti del giorno. E ancora: più attenzione alla cultura, una rassegna stampa più completa e articolata, un maggior numero di interventi, commenti e interviste redazionali. E i risultati si vedono: l’attenzione dei nostri lettori è in costante crescita al punto che, dall’uscita del secondo numero della rivista a oggi, abbiamo guadagnato migliaia di contatti giornalieri. Insomma: ci stiamo ritagliando uno spazio. Come la rivista ha bisogno degli abbonati (e del loro sostegno, dei loro suggerimenti), il sito ha bisogno dei lettori, della loro fiducia e del loro sguardo critico. In questi anni ce l’abbiamo fatta anche e, forse, in primo luogo, grazie al fatto che la fiducia e la critica non sono mai venute meno. E grazie a voi, lettori e abbonati della rivista, a cui chiediamo di moltiplicare per due il vostro già preziosissimo lavoro di suggeritori e critici: ciascuno di voi coinvolga una nuova compagna o un nuovo compagno, diffondendo la rivista e facendo conoscere il sito (consultabile all’indirizzo: www.esserecomunisti.it). Scommettiamo che non rimarranno delusi? L registrazione Tribunale di Roma n. 170/2007 del 08/05/2007 anno I, numero 3, ottobre 2007 bimestrale Poste Italiane s.p.a. – spedizione in A.P. 70% Roma n. 96/2007 Per la realizzazione di questo numero non è stato richiesto alcun compenso. Si ringraziano tutti gli autori e collaboratori.
Scarica