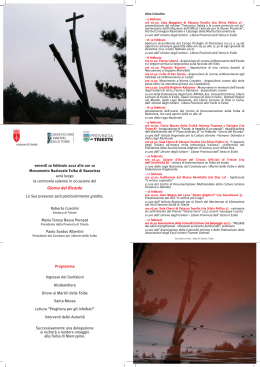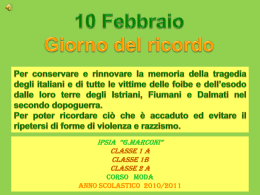sabato | 10 febbraio 2007 pagina 2 I diversi modi di intendere la storia di 350mila infoibati o esuli solo perché volevano essere “Italiani” PRIMO PIANO Î IL REPORTAGE Il Giorno del Ricordo, un argomento tabù Omertà, paura e voglia di cancellare il passato L’emblema della pulizia etnica da oggi è una scultura A Fiume alcuni vecchietti parlano italiano fra loro «Può raccontare la storia di Fiume nel dopoguerra?» Tutti tacciono all’improvviso, poi si alza una voce: «Mi smo u Rijeci», “siamo a Rijeka” La foiba di Basovizza monumento nazionale V dal nostro inviato Gianvito Casarella Una giornata per ricordare. L’edizione del 2007, la seconda dall’entrata in vigore dell’apposita legge-Menia, si colora di significato e suggestione: il 10 febbraio 1947, sessanta anni fa, la Conferenza di Parigi sanciva la cessione dell’Italia, sconfitta, di buona parte del nord est del Belpaese. Di lì partiva la persecuzione del maresciallo comunista Tito, nuovo padrone di quelle terre, nei confronti della popolazione di cultura e lingua italiana. Giorno del Ricordo non è solo foibe. La tragedia delle vittime delle voragini carsiche intorno a Trieste si aggiunge e lega in maniera indissolubile al dramma degli esuli. Istriani, giuliani, dalmati costretti a lasciare le proprie case per raggiungere i nuovi confini italiani. Per rimanere figli di quella Patria a cui erano legati, ma che li aveva traditi senza troppi complimenti, al momento di sedersi, sia pure con il potere contrattuale di chi aveva perso una guerra, al tavolo delle spartizioni nella capitale francese. La fuga verso la democrazia, lontana dalla dittatura titina, fu straziante: senza più una casa, un lavoro, un’identità, se non quella insita nell’italianità. Un’identità indelebile. Come indelebile resta, dopo 60 anni, il dolore, al pari della vergogna, dell’imbarazzo. Spesso dell’omertà. Trieste non accolse bene gli esuli: attentavano alla già fragile convivenza multietnica che è propria della città. Gli istriani, in particolare, erano visti come usurpatori di un lavoro che scarseggiava. Di contro, i profughi vivevano la loro condizione fra mille difficoltà. Nessuno ne parla volentieri. A Basovizza, dove a pochi chilometri dal centro giganteggia la foiba delle foibe, per strada è tutto bilingue: italiano e sloveno. Essere figli della lingua “del sì” è quasi una discriminante. Parlare del tragico dopoguerra diventa un’impresa ardua. Un’anziana signora, davanti ad un bar, deve appartarsi per riferire dei suoi ricordi. «Avevo una compagna di scuola - narra - che visse la tragedia delle foibe in prima persona. Suo padre era direttore della Banca d’Italia a Trieste. Arrivarono i partigiani di Tito e lo trovarono armato. Lo portarono via credendolo un fascista: non se ne seppe più niente». Le ronde della polizia jugoslava erano mirate, col placet della popolazione comunista del luogo. «Entravano nelle vie - racconta la signora, che non vuole rivelare le proprie generalità - e puntavano coi mitra alle finestre. I partigiani italiani segnalavano ai titini L’EVENTO le abitazioni di ex fascisti o presunti tali e gli slavi se li venivano a prendere. Furono 40 giorni di terrore. La guerra era finita il 25 aprile 1945. Ma per noi triestini ne incominciò un’altra, civile, già dal 1 maggio». I ricordi affiorano nella commozione: «Mio padre non era fascista, ma al passaggio dei titini voleva mostrare loro dalla finestra un quadro di Garibaldi, ad orgoglio di italianità. Lo tirai per i pantaloni, implorandolo di non farlo: ero piccola, ma avevo capito che ce l’avevano con noi perché eravamo Italiani». Qualche chilometro più ad est, ad Opicina, le porte si chiudono: nessuno vuol parlare di quei giorni. La situazione si accresce man mano che ci si avvicina al confine. Nel primo comune sloveno, a Cezanna, un anziano barista inizia a parlare italiano, sebbene di chiara estrazione slovena. Quando l’argomento scivola sulle foibe, entra in un portone, scappando, adducendo di non capire la lingua. Le foibe e gli esuli continuano ad essere tabù, una pagina di storia sottaciuta e da sottacere, per quieto vivere e per legami di collaborazionismo infame. Anche Fiume, a 67 chilometri da Trieste, porta i segni di un’italianità che fu. La gente capisce la lingua. La parla. Ma qui, in terra di Croazia, sia pure con una grande percentuale di Italiani di prima o seconda generazione, la città parla slavo dalle vetrine, dalle insegne, dai menu. Come se 60 anni di governi stranieri avessero voluto scientificamente cancellare le tracce. Anche Fiume, terra amata dal poeta Gabriele D’Annunzio, piange i suoi tanti morti infoibati e le vite spezzate degli esuli. Accanto al porto c’è un portone. Dentro, alcuni vecchietti parlano italiano fra loro. «Può raccontare la storia di Fiume nel dopoguerra?». Tutti tacciono all’improvviso. Si alza una voce: «Mi smo u Rijeci», “siamo a Rijeka“, insomma, l’Italia ed i dolori a questa connessi sono una storia da dimenticare. Sopra nella foto la città di Trieste e nella foto in alto a destra la foibe di Basovizza dove lo scultore Livio Schiozzo ha posto una pedana lignea con una croce La Foiba di Basovizza è l’emblema dell’intero capitolo sulla pulizia etnica di Tito Basovizza | Mercoledì scorso l’inaugurazione della mostra sulla foiba di Basovizza. Questa mattina, la cerimonia ufficiale e solenne per il nuovo sacrario, monumento nazionale, commissionato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per ricordare l’eccidio perpetrato a pochi chilometri dalla città giuliana, nell’immediato dopoguerra. All’imboccatura della voragine carsica, tomba di tanti italiani di difficile quantificazione, lo scultore Livio Schiozzi ha posto una pedana lignea con una croce: «È un segno forte e significativo - ha spiegato - progettato tenendo conto anche delle altre foibe istriane, per dedicare un’opera mastodontica alla memoria dei 350mila Italiani, fra infoibati ed esuli, nel giorno del sessantesimo anniversario del Trattato di Parigi». Non ci sarà nessun esponente del Governo attuale. Il presidente del Senato, Franco Marini, ha fatto sapere di essere «impossibilitato per impegni già assunti». Un modo elegante ma non troppo per glissare sull’argomento. La Foiba di Basovizza, emblema dell’intero capitolo sulla pulizia etnica di Tito, è in verità un pozzo minerario, scavato all’inizio del XX secolo per intercettare una vena di carbone e presto abbandonato per la sua improduttività: divenne però nel maggio del 1945 un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da parte dei partigiani co- munisti di Tito, dapprima destinati ai campi d’internamento allestiti in Slovenia e successivamente processati e giustiziati a Basovizza. Le vittime venivano precipitate nella voragine carsica, dopo essere state prelevate nelle case di Trieste, durante alcuni giorni di un rigido coprifuoco, i 40 giorni dal 1 maggio ‘45. Lassù arrivavano gli autocarri della morte con il loro carico di disgraziati. Questi, con le mani straziate dal filo di ferro e spesso avvinti fra loro a catena, venivano sospinti a gruppi verso l’orlo dell’abisso. Una scarica di mitra ai primi faceva precipitare tutti nel baratro. Sul fondo chi non trovava morte istantanea dopo un volo di 200 metri, continuava ad agonizzare tra gli spasmi delle ferite e le lacerazioni riportate nella caduta tra gli spuntoni di roccia. Molte vittime erano prima spogliate e seviziate. Fonti anglo-americane riferiscono di un numero di esecuzioni fra i 4 ed i 5mila, fra civili, militari di tutti i Corpi, anticomunisti. Molti altri furono deportati nei lager slavi, senza mai più tornare a casa. Per questo enumerare i morti diventa arduo quanto impossibile. Dalla capienza della foiba di Basovizza, 500 metri cubi, si calcola che siano stati fatti precipitare almeno 2mila Italiani. Una strage gratuita, nutrita d’odio a guerra finita. Ora un monumento ricorda le vittime, ad imperitura memoria. gvc La mostra allestita nel campo che ospitò gli esuli scuote le coscienze anche dei triestini. Il presidente dell’Unione degli Istriani Del Bello: «Un modo per coinvolgere i giovani che non hanno vissuto gli eventi tragici» Padriciano 60: impossibile dimenticare, necessario far conoscere Trieste | Padriciano compie 60 anni. frontare l’argomento». In questi giorni Non è un compleanno felice se troppi sono tanti i visitatori che salgono fino a ancora non sanno cosa sia stato, perchè Padriciano, animati da sentimenti e così ha voluto la storia dei vinti. La piccoinvolgimenti diversi. «Tutti - osserva cola località alle porte di Trieste fu seMale - finiscono la visita con gli occhi de di un campo profughi dal 1947 per lucidi: non si può restare indifferenti al esuli istriani, fiumani e giulio-dalmati in cospetto della effettiva sofferenza di fuga dalle persecuzioni titine. E quella quegli anni, dal 1947, quando i nostri dell’esodo, che coinvolse oltre 350mila padri sono stati costretti a scappare dalitaliani, è l’altra faccia di una medaglia le proprie terre, verso l’Italia, senza nienscura e seppellita nell’oblio. Neppure te più». Fra i visitatori, anche molti triel’attenzione sulla Giornata del Ricordo stini, rivoluzionando il clichè che vede serve a porre il giusto accento sulla trastoricamente l’ex presidio asburgico mal gedia di popolazioni depauperate di ogni sopportare gli esuli istriani. «Trieste ha bene materiale, unite nella loro italiariscoperto una parte della storia che è nità e tante volte dal conseguente senanche la sua - sottolinea il responsabitimento anti-slavo che le dei Giovani esuli ne è inevitabilmente perché abbiamo allescaturito. stito una mostra realiPer accendere la luce, stica in tutto e per tutMassimiliano Lacota to, compresa l’ambieninaugurò nel 2004 tazione spoglia, triste, una mostra sul campo d’emergenza propria profughi, in occasione di quegli anni». La gedel trentennale dalla nerazione nata negli fondazione dell’UnioAnni 70 ignora la prone degli Istriani. «È miscuità, l’affollamenstato un modo - spieto, il disagio della baga il presidente Silvio raccopoli con unità Del Bello - per coinvol- Il campo profughi di Patriciano abitative di fortuna, in gere i giovani, che non legno, della grandezhanno vissuto sulla propria pelle quei za di 4 metri per 4, in cui vivevano antragici eventi, ma che li sentono nel che 5 o 6 persone per nucleo familiare. sangue, perché discendono da esuli o, «Tutto ciò - osserva con rammarico Masemplicemente, perché sono Italiani. le - solo perché i nostri padri volevano Le nuove generazioni assicureranno il essere istriani, Italiani, per lingua e per ricordo». Mercoledì scorso, la presentacultura. Non slavi». Nel marasma di rizione di una mostra, sulla scia di quelcordi diretti o raccontati, una signora inla del 2004, che si avvia a diventare peterviene dal pubblico, nella saletta di Via renne. Ad assicurarlo, il presidente dei Silvio Pellico, a Trieste, sede dell’UnioGiovani istriani, Alan Male: «Ci siamo ne istriani. Aveva seguito fino a quel resi conto di cosa fosse la vita nei cammomento con gli occhi lucidi, sfoglianpi per profughi, al di là dell’imbarazzo do un opuscolo donato all’entrata, cone della vergogna dei nostri padri nell’aftenente le fotografie del centro per pro- fughi di Padriciano. Si alza. È commossa. Si presenta: si chiama Graziella Vegliach. «La mia baracca era 3x3 - ricorda ai presenti - ce l’ho ancora davanti agli occhi». La memoria di una persona sola si fonde con quella collettiva degli istriani presenti in sala. Alcuni si riconoscono, malgrado i segni del tempo: «Lei era quella della baracca 9 porta 9». Tanti non hanno il coraggio di intervenire, per la solita pudicizia, per la vergogna di venire allo scoperto. «L’inverno faceva freddo - continua la Vegliach - : nel 1956 ci fu un gelo più intenso e non bastavano coperte per vincerlo. Ero ragazza, lo ricordo perfettamente». Dopo l’esodo del 1947, la situazione è, se possibile, peggiorata. Tanti sono morti sognando l’Italia. «Col tricolore nel cuore», irrompe una voce in fondo, senza aggiungere altro, un po’ vinto dall’emozione, un po’, ancora, per la vergogna di essere stato profugo. Nella mostra di Padriciano si ritrovano le schede di identificazione degli ospiti del campo. Un uomo ha rinvenuto quella di sua madre. Due rapidi conti e ha capito che era passata di lì con lui in grembo, ancora in attesa. «Sono spaccati di storia che non lasciano indifferenti aggiunge Alan Male - : molti visitatori dell’esposizione di Padriciano avvertono una sorta di imbarazzo per aver così lungamente ignorato la vicenda». Per troppo tempo l’ha ignorata anche lo Stato italiano, abbandonando al loro destino i profughi nei campi e svendendo alla Jugoslavia, poi, con Moro, l’Istria nel 1975 ad Osimo. «Siamo ancora in attesa di riavere indietro i nostri beni -spiega Male - . Noi non abbiamo dimenticato, altri lo hanno fatto da tempo». gvc LA TESTIMONIANZA Il disorientamento di Annamaria Del Bello, 6 anni nel campo profughi «Io, né triestina né istriana» Trieste | Tanti hanno voluto seppellire quell’esperienza. Essere esule istriano voleva dire emarginazione. I problemi di accoglienza si sovrapponevano beffardi e si aggiungevano a quelli conseguenti allo sradicamento dalla terra d’origine, quella Capodistria che oggi è Kaper, quella Fiume che tutti chiamano Rijeka. Altri ce l’hanno fatta a raccontare, ad uscire allo scoperto. Tardivamente, ma l’hanno fatto. È il caso di Annamaria Del Bello, simpatica psicologa che vive e lavora a Trieste come chiunque altro, ma con un ricordo indelebile di un periodo triste, mai compreso pienamente: quello di essere originaria di Cittanova. Non di Novograd. Era a Padriciano nel 1947… «Sì, avevo 2 anni, ma conservo delle scene ben impresse nella memoria. Sono stata lì fino all’età di 6 anni, con la mia famiglia. O meglio, fra parenti eravamo divisi: io ero con mia sorella, in un angolo della stanza, nel letto a castello. Nello stesso spazio esiguo, in completa promiscuità, c’era anche mia madre. Mio padre era con gli uomini, a parte, separato da noi». Viveva e frequentava le scuole a Annamaria Del Bello Trieste, come era l’integrazione sociale con gli altri bambini? «I triestini ci accusavano di essere arrivati per portar via il lavoro a loro, o nella migliore delle ipotesi di essere fascisti fuggiaschi, quindi è comprensibile pensare che i rapporti non fossero idilliaci. Chiaramente, però, noi piccoli non avevamo piena consapevolezza di ciò che eravamo, se non a causa dei disagi quotidiani che vivevamo». Quando e come ha assunto poi la dimensione di ciò che era successo? «Non subito. A casa, anche dopo la fine di quella esperienza di Padriciano, l’argomento dell’esodo era tabù. I motivi erano tanti, primo fra tutti che si faceva fatica, penso soprattut- to a mio padre, a parlarne, perché farlo avrebbe significato ammettere emozioni, dolore sempre vivo. Per noi bambini, discutere del tema era un’ulteriore sottolineatura del fatto che eravamo bisognosi che necessitavano di un aiuto altrui». In famiglia tutti avevano difficoltà a parlare dell’Istria? «Mio padre in primis. Lui era stato anche in carcere per quella ragione. Non voleva mai parlarne o lo faceva ironizzando. Poi mia madre interveniva nel discorso, spesso a mitigare la durezza di certe riflessioni di papà, forse perché noi piccoli non ne avvertissimo il trauma». Ha ancora vergogna per quella fase della sua vita e del suo essere? «Ora non più. È la prima volta che ne parlo anche pubblicamente, segno che ho superato il trauma, almeno in parte. Certe volte ci penso e rifletto sul fatto che mi manca un’identità definita. Questo mi porta ad avere difficoltà a sentire l’appartenenza ad un qualsiasi gruppo sociale: riviene dall’incertezza e la confusione di essere istriana o triestina. Forse nessuna delle due cose in senso completo e definito». È mai tornata nella casa natale in Istria? «No, neppure dopo la disgregazione dell’ex Jugoslavia. Si fa difficoltà a mettere insieme i pezzi». Di cosa? «Della vita nel suo insieme: quando manca una famiglia unita per motivi simili, manca una cornice. Per questo dopo è difficile venire allo scoperto, anche perché l’educazione impartita in casa ha risentito dell’esodo forzato. Rinnegare coi figli è l’atteggiamento più comune a chi ha vissuto in quel modo quei giorni: è un modo per proteggere, ma poi si cresce e si finisce per non avere radici, perché non sai cosa sei». gvc
Scaricare