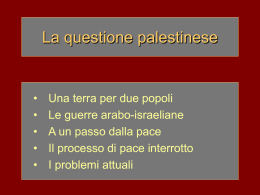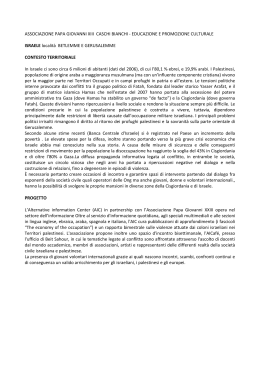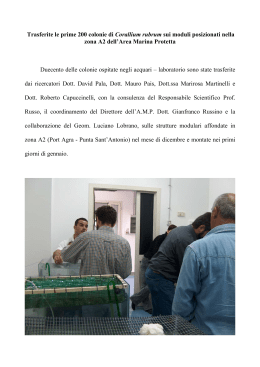Notiziario settimanale n. 571 del 29/01/2016 versione stampa Questa versione stampabile del notiziario settimanale contiene, in forma integrale, gli articoli più significativi pubblicati nella versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace "Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri" don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù" 30/01/2016: Ricordo dell'assassinio di Gandhi avvenuto il 30 gennaio 1948 a Nuova Delhi E’ morto nell’ospedale di Nairobi, Salah Farah, l’insegnante musulmano che fu ferito dai terroristi di Al Shabaab per avere difeso i cristiani sul bus il 24 dicembre scorso. Farah è morto per le ferite riportate. Gli assassini di Al Shabaab avevano tentato di dividere sul bus i musulmani dai cristiani. Farah, padre di cinque figli, si oppose alla divisione e disse: “Uccideteci tutti o andatevene. Siamo fratelli. Io penso che cristiani e musulmani debbano aiutarsi reciprocamente”. Centro Studi Sereno Regis Indice generale Editoriale......................................................... 1 La natura ci educa alla fiducia, la politica rinasca dalla “grotta” (di Antonio Vermigli)...................................................................................... 1 Approfondimenti.............................................2 L’economia delle diseguaglianze (di Andrea Baranes)............................... 2 Il filo della memoria (di Rosaria Gasparro)................................................ 2 Il Coraggio della Memoria (di Laura Tussi)............................................... 5 Lesbo. Il dovere di restare umani (di Giacomo Capriotti – Un ponte per...) ................................................................................................................... 8 Benvenuto 2016! Rinnoviamo l’impegno per la pace e la solidarietà (di La redazione di Unimondo)............................................................................. 9 Nuovi impegni per la pace e il disarmo................9 Fede e cultura per Bergoglio. Conflitto e pace (di Enrico Peyretti) ..........10 Il Vangelo del conflitto (di Alberto Asor Rosa)........................................ 10 Costituzione, la controriforma di Renzi (di Maria Luisa Pesante) ............11 #HeForShe: la parità di genere riguarda anche lui (di Anna Toro)...........12 L’indice di Colonia (di Ida Dominijanni)................................................. 13 Notizie dal mondo......................................... 14 Gabbia Europa (di Stefano Galieni)......................................................... 14 Come le colonie israeliane soffocano l’economia palestinese (di Nur Arafeh, Samia al-Botmeh, Leila Farsakh)................................................ 15 1 Editoriale La natura ci educa alla fiducia, la politica rinasca dalla “grotta” (di Antonio Vermigli) L’angoscia, la paura, la diffidenza, l’incertezza e il sospetto sembrano essere i sentimenti prevalenti in questa nostra epoca in cui molte certezze e sicurezze del passato stanno crollando. Anche la nostra fiducia granitica del passato subisce forti scrolloni. Credere in dei valori forti voleva dire possedere certezze, avere risposte su tutti i problemi, sentirsi dalla parte giusta, fare blocco. Oggi questo credo non è più scontato, tutto è messo seriamente in discussione. Oggi, che questi valori vengono meno, pensiamo più ad aver fiducia nella nostra vita personale e siamo piuttosto critici verso le istituzioni. Questi nostri valori sono messi alla prova in modo particolare in questo momento e sostituiti dalla paura della vita che abbiamo intorno e che ci attende. Perfino la la terra, la madre Terra, è diventata fonte di minaccia incombente, dato gli sconvolgimenti che abbiamo indotto nell’equilibrio ecologico. Non è da ingenui, in questo momento, pretendere di muoversi seminando fiducia. Comunque una fiducia credibile e incisiva non può che venire da una nuova relazione tra noi, tra noi e la natura. Le persone che attorno a noi ci ispirano fiducia sono in genere ben ancorate nella loro umanità, sono persone che sanno ascoltare, che sono in ricerca, che danno valore al nostro stesso cercare, che sono disposte a rischiare, che ci permettono e possono permettersi di sbagliare. Senza rendersi forse conto stanno sostituendo ideologie mal praticate, ideali astratti che piovevano dall’alto, con una nuova partecipazione dal basso, legata alla concretezza del quotidiano. alla pazienza e alla volontà, al se ci impegniamo le cose avvengano, alla fiducia nella forza della vita. Medesimi valori, con applicazioni diverse. Rintracciare ognuno la forza della vita, la forza del bambino trascurato che è in noi, mi sembra il segreto per scoprire nuovamente il vero ancoraggio di una nuova fiducia. La fiducia nella forza della vita ha un radicamento ben più profondo che la sfiducia indotta dagli scombussolamenti di superficie legati al momento storico che stiamo vivendo. Questa fiducia è inscritta nel nostro codice genetico, nel nostro stesso organismo, specie se lo lasciamo interagire correttamente con gli altri e la natura. E’ una compagna di strada che non ci abbandona mai. Penso alla grande moltitudine degli impoveriti, alcuni miliardi, che questa loro fiducia, speranza nella vita la mettono in gioco ogni giorno, camminando migranti da uno stato all’altro, stanchi, trascinandosi, ma lordi di fiducia e del senso profondo dell’essere ancorati alla vita, nonostante le loro immense e devastanti povertà. E’ la natura stessa che ci educa alla fiducia. Già nel ventre materno ci siamo allenati a questo, a godere di questo ambito protetto e rassicurante; fino a prepararci a collaborare con la mamma al travaglio del parto, ossia agli inevitabili rischi che chi scommette sulla vita deve saper affrontare. E’ su questa fiducia fondamentale che continuiamo di fatto a crescere. Senza fiducia non avremmo imparato a succhiare, a parlare, a camminare, a interagire, a sorridere, a protestare... E’ il contatto corporeo che spinge il bambino ad apprendere, a godere, a meravigliarsi, a perlustrare. Il bambino che è in noi ha bisogno però di non perdere l’ancoraggio in se stesso, di non diventare funzionale alle attese angoscianti degli adulti, di non trascurare la propria fiducia di base, la propria autostima. Ecco perché: dalla famiglia alla politica, dalle relazioni affettive a quelle sociali, un affidamento eccessivo a quanti vorrebbero renderlo funzionale alle loro aspettative, finirebbe col rafforzare il loro potere a scapito del proprio potere-autonomia personale. Vorrebbe dire svuotarsi fino a perdere la propria identità, diventando così schiavo. Rinascere continuamente, in semplicità, nella “stalla” della vita con il tepore del bue e l’asinello, il calore dei genitori, ancorato alla terra-natura, questa può essere la sfida per instaurare una nuova politica. Buon Natale Antonio link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2427 Approfondimenti Economia L’economia Baranes) delle diseguaglianze (di Andrea Sessantadue persone sono più ricche di 3,6 miliardi di esseri umani. Sessantadue persone che in cinque anni hanno visto la propria ricchezza crescere del 44%, oltre 500miliardi, mentre la metà più povera del pianeta si impoveriva del 41%. I dati divulgati da Oxfam sono un affronto e una vergogna dal punto di vista della giustizia […] Quando il movimento Occupy Wall Street lanciò lo slogan “siamo il 99%” probabilmente non immaginava che solamente pochi anni dopo quel 99% sarebbe realmente stato la parte più povera del pianeta. Eppure oggi l’1% più ricco della popolazione ha un patrimonio superiore a quello del rimanente 99%. Sono alcuni dati contenuti nell’ultimo rapporto di Oxfam sulle diseguaglianze, presentato in vista del Forum di Davos dei prossimi giorni. Sempre secondo il rapporto “An economy for the 1%”, non solo le diseguaglianze stanno aumentando, ma stanno addirittura accelerando. Nel 2010 bisognava prendere i 388 miliardari più ricchi per arrivare al patrimonio della metà più povera del pianeta. Nel 2014 bastava fermarsi all’ottantesimo. Oggi sono 62. Sessantadue persone sono più ricche di 3,6 miliardi di esseri umani. Sessantadue persone che in cinque anni hanno visto la propria ricchezza crescere del 44%, oltre 500miliardi, mentre la metà più povera del pianeta si impoveriva del 41%. Ancora, dall’inizio del secolo alla metà più povera del mondo è andato l’1% dell’aumento di ricchezza, mentre l’1% più ricco se ne accaparrava la metà. E’ un fenomeno particolarmente drammatico nei Paesi più poveri, ma che accomuna tutto il mondo. Nel Sud, il 10% più povero ha visto il proprio salario aumentare di meno di 3$ l’anno nell’ultimo quarto di secolo. Se le diseguaglianze non fossero cresciute durante questo periodo, 200 milioni di persone sarebbero uscite dalla povertà estrema. Nello stesso arco di tempo, negli USA lo stipendio medio è cresciuto del 10,9%, quello di un amministratore delegato del 997%. In questo quadro, di quale ripresa, di quale crescita, di quale economia parliamo? Tralasciamo l’insostenibilità ambientale e persino l’ingiustizia sociale. Guardiamo unicamente le conseguenze economiche. In uno studio recente l’OCSE ricorda che le diseguaglianze hanno causato una perdita di oltre 8 punti di PIL in vent’anni. Un’enormità. Il motivo è semplice: se famiglie e lavoratori sono sempre più poveri, calano i consumi e quindi la domanda aggregata. Una “soluzione” è indebitare famiglie e imprese per drogare la crescita del PIL. E’ il modello subprime, un’economia del debito che può funzionare per qualche anno, finché inevitabilmente la bolla non scoppia. L’altra soluzione è scaricare il problema sul vicino, puntando tutto sulle esportazioni. Tagliamo stipendi e diritti di lavoratrici e lavoratori, tagliamo le tasse alle imprese e il welfare. Ovviamente aumenteranno le diseguaglianze e crollerà la domanda interna, ma saremo più competitivi e quindi esporteremo di più. E’ l’attuale modello italiano ed europeo, riassunto nel documento “dei cinque presidenti”, promosso da tutte le istituzioni europee per tracciare la linea dei prossimi anni. Nel capitolo dedicato alla “convergenza, prosperità e coesione sociale” si riesce 2 nell’impresa di non menzionare mai parole quali “diritti”, “reddito” o “diseguaglianze”, mentre viene utilizzata per diciassette volte la parola “competitività” (17!). Un modello in cui la crescita delle diseguaglianze non è quindi un fastidioso effetto collaterale, ma la base stessa di un gioco pensato e tagliato su misura per l’1%. Una gara verso il fondo in ambito sociale, ambientale, fiscale, monetario, per vincere la competizione internazionale. La semplice domanda è: se le diseguaglianze aumentano ovunque e la gara è globale, è possibile che tutti esportino più di tutti? In attesa che la NASA scopra che c’è vita su Marte per potere esportare anche li, questa economia dell’1% non sembra particolarmente lungimirante, come mostrano le cronache di questi giorni. A chi deve esportare una UE che nel suo insieme ha già oggi il maggior surplus commerciale del pianeta? Si guarda all’Asia e alle economie emergenti come mercato di sbocco, ma ecco che un calo della Borsa di Shanghai rischia di diventare una tragedia per l’economia italiana. Siamo arrivati al paradosso che pur importando petrolio dobbiamo sperare che il prezzo del greggio non continui a scendere, altrimenti i Paesi esportatori non potranno acquistare il nostro made in Italy. I dati divulgati da Oxfam sono un affronto e una vergogna dal punto di vista della giustizia sociale, ma sono disastrosi anche da quello meramente economico. Una ricetta per una nuova crisi. Il problema è che l’aumento delle diseguaglianze dal 2008 a oggi è anche un segnale fin troppo evidente di chi rimane con il cerino in mano quando questa crisi scoppia. Ed è allora difficile che il messaggio venga recepito a Davos, all’incontro annuale di quell’1% – anzi, di quel zero virgola – che continua a guardare dall’alto, sempre più dall’alto, oltre il 99% dell’umanità. (fonte: Sbilanciamoci Info) link: http://sbilanciamoci.info/leconomia-delle-diseguaglianze/ Fare memoria Il filo della memoria (di Rosaria Gasparro) Non mi piacciono le giornate fine a se stesse. La retorica che le svuota, le irretisce in ritualità statiche che spengono ogni forza di trasformazione. Mi piacciono le giornate che si allungano nel prima e nel dopo, che ti tallonano con la loro ragione e chiedono un esercizio quotidiano di passione e impegno. Perché ognuno può essere ebreo di qualcuno, come diceva Primo Levi. Si tratta di costruire una storia militante, che vale ancora oggi con nomi diversi eppure uguali, a cui partecipare nei luoghi abitati con la fragilità del ricordo – un filo sottile che bisogna continuare a filare e ad annodare, perché ogni passato è a suo modo un presente strappato – l’occupazione del giorno e la tenacia della speranza. Perché il futuro viene da lontano e si lascia inghiottire dall’indifferenza. La storia militante è una storia attiva, si costruisce con tante piccole storie da cercare e ascoltare. Una narrazione composita di biografie e poesie, canti, musiche e danze, lettere e diari, filmati, voci e volti. Un ricondurre al cuore per una memoria emozionale, che se ti tocca col dolore degli altri non si fa dimenticare. Anche quando risulta difficile capire come e perché tutto è potuto accadere. L’idea di memoria di Alberto Savinio: «Piace in ogni modo la forma francese (connaître par coeur), che la cosa che noi conosciamo a memoria, ossia senza bisogno di strumenti o documenti intermedi, la conosciamo “per mezzo del cuore”, ossia l’amiamo; quasi il ricordare sia amare – come infatti è…». La mia didattica della memoria è questo filo che intessiamo insieme. Una storia animata, dotata di anima. L’alfabeto della Memoria Nella ninna nanna ebraica Oyfn pripetshik – la stessa che con tutta probabilità, le madri cantavano ai propri figli mentre li accompagnavano alle camere a gas – il rabbino insegna ai bambini l’alfabeto e dice loro: «Vedete, bambini, pensateci cari a quello che studiate. Dite ancora una volta e ancora una volta “A b c, a b c”. Prenderete forza da queste lettere e guardate ancora in esse». Con i bambini e le bambine della mia classe abbiamo guardato in ogni lettera per capire, conoscere e scolpire dentro di noi il ricordo. E abbiamo scritto il nostro “Alfabeto della Memoria”. A seguire le lettere esplorate col doppio sguardo, storico e poetico. Vocabolarietto e tautogramma per l’unico sguardo che conta, quello umano. A A come aiuto! Ad Auschwitz non voglio andare! Non voglio essere ammazzato non voglio essere annientato. Non avranno la mia anima. ARBEIT MACHT FREI: non è vero, il lavoro non rende liberi gli ebrei ma ci scava l’abisso. B B come basta con questa barbarie, dov’è finita la bontà? Partivano dal binario 21 forse non se n’è salvato nessuno. A Birkenau e a Buchenwald c’erano belve con la faccia da uomo, i bambini nelle baracche di notte avevano le speranze rotte. C C come ciao casa, chissà se ti rivedrò. Né cibo né carezze né calore, nel campo di concentramento si è perso il cuore. I miei capelli tagliati per terra anche questa è la guerra. Lo so non crescerò non arriverò a maggio, mi hanno detto delle camere a gas ed io prego il Dio del coraggio. Passerò davvero in un camino anche se sono un bambino? D D come Dio dov’è? Perché non è qui con me? A Dachau sono deportato e da tutti disprezzato. Qui è tutto disumano dolore e distruzione un’unica disperazione. Nelle docce delle donne sono entrate e non sono più ritornate. Ogni diritto è cancellato e il mio diario è bruciato. Tutto muore ma non il desiderio di essere liberato. 3 E E come eccomi: sono ebreo, mi chiamano anche giudeo. Un essere umano come te come puoi fare gli esperimenti su di me? F F come figlio alla sua famiglia strappato e chiuso dietro ad un filo spinato, nel fango con la fame e il freddo qualcuno viene fucilato. Führer chiamano il loro capo e nel forno crematorio milioni ne hanno bruciato. Nel fumo denso che saliva la gente in silenzio moriva. G G come Giornata della Memoria per ricordare ciò che è accaduto nella seconda guerra mondiale quando grande fu il male. Per ricordare che nessuno va chiuso in un ghetto, nessuno strappato al suo tetto. Che la Gestapo tanta gente arrestava e che un genocidio la Germania preparava. Giudei e gitani ebbero la stessa sorte, alcuni “giusti” li salvarono dalla morte. H H come di Hitler ho paura! Come gli handicappati eliminati per questa rovina della razza pura. Help me! I I come chi ha fatto l’indifferente chi non si interessava di niente, chi ignorava ciò che accadeva l’ingiustizia che si commetteva. Internati e in isolamento io, tu, lei a cento a cento. Un incubo tremendo le nostre identità nel vento. Indicibile. Inverno inferno. L L come le leggi razziali che mi hanno cancellato come le lacrime che ho versato come le lettere che ho scritto. Chiuso nel lager con i lavori forzati e poi la liberazione degli alleati. M M come matricola 34796 ma tu mamma dove sei? Vieni, prendimi per mano chiamami per nome piano piano. Hans, Magdala, Amos, Edna, Daniel… Lot, Marisha, Isaac, Sarah, Rah’el… La Memoria di chi siamo chiamateci e per un po’ viviamo. N N è il mio nome che si presero il numero che mi lasciarono. Avevamo un nascondiglio ci trovarono, non era per gioco. Qui la notte è nera e lunga non vedono i nostri occhi tristi cade la neve e urlano i nazisti. “Numi numi nim” Fai la ninna, fai la nanna canta canta la mia mamma, prendo forza dalle sue parole scivola dentro un goccio di sole. Qualcuno un giorno negherà… O O come orchestra ma qui non c’è festa. In ogni campo ce n’è una copre il suono della sfortuna. Un’orchestra piccolina per placare la paura. Per chi scende dai treni per coprire i suoni della morte dolci e amare sono le note. L’orrore suona più forte il suo concerto d’odio e non è ancora esausto in diretta c’è l’olocausto. P P come prigionieri, come popolo da perseguitare, non solo l’ebraico anche il popolo del vento volevano eliminare. Porrajmos, divoramento, lo diciamo. P come propaganda di un popolo superiore e di un altro inferiore. Q Q come Questo è stato, meditate… «Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore». (Primo Levi) R R come rastrellamento siamo stati catturati in un momento, requisiti gli oggetti e i beni personali si sono scordati di essere umani. La razza è una menzogna ci mette contro ed è una vergogna. R come ricordo di quella violenza 4 a cui si oppose la resistenza. S S come stella a sei punte: la storia di sei milioni di stelle rubate al cielo e spente sul petto di donne, bambini, uomini, anziani. Esclusi dalle scuole catturati dalle SS portati nei campi di sterminio per la selezione e la soluzione finale. Un grande silenzio. Questa è stata la shoah. S come Shalom aleikem. T T come treni merci al posto del bestiame T come Terezin il campo dei bambin T come terrore come tremore come tatuaggio sul braccio T come triangoli colorati per essere distinti e comunque maltrattati: rosso, verde, rosa, marrone, blu, nero… E questo è tutto vero. Quello dei Testimoni di Geova era del colore delle viole e non c’erano più parole. U U come uomini… ma che uomini sono se umiliano i loro fratelli se li considerano nemici se li offendono se li uccidono? Che storia è questa qua che distrugge l’umanità? V V come le valigie che lasciammo come i vagoni su cui viaggiammo come i vestiti tolti come i nostri pallidi volti come le vittime che diventammo. Erano ebrei novanta su cento la loro verità viaggia nel vento. Un violino suona nel tempo della vita il valzer lento. Z Z come zingari, rom e sinti, senza zuppa con la zappa senza una zolletta di zucchero. In cinquecentomila li misero in fila a morire di sicuro con lo Zyklon B, gas a base di cianuro. (fonte: Comune-info - Associazione Persone Comuni) link: http://comune-info.net/2016/01/il-filo-della-memoria/ Il Coraggio della Memoria (di Laura Tussi) All’interno della comunità educante il ruolo dei testimoni e la trasmissione della memoria: scuola e giovani generazioni. I cultori della storia, gli insegnanti, gli educatori, i testimoni degli eventi devono mantenere il rapporto con il concreto relazionarsi delle comunità, con la testimonianza dei singoli, ma anche, in una prospettiva di trasformazione delle memorie, in un tessuto storico e sociale robusto, che confluisca in progetti e consista in una fonte di energia e di riflessione per le nuove generazioni. Questo passaggio dal ricordo, dalla narrazione alla memoria, alla storia, alla riflessione è un processo che deve avvenire tramite il contributo della scuola, non concepita meramente come domicilio, insieme di persone, ma come una comunità di studio, contesto di comunità educante intesa nel senso e significato culturale di progettazione di idee e di confronto; perché l’attenzione e dimensione specifica dell’istituto scolastico consiste nella trasmissione culturale, lavorando, interagendo con le nuove generazioni, attraverso il metodo, lo strumento, la modalità ultima, pedagogica dell’impegno culturale, educativo del confronto, dell’interscambio di progetti e di idee e costruzione, elaborazione collettiva di basi valoriali. Il rapporto “memoria e testimonianza” è l’importante filo rosso educativo come il riferimento all’aspetto di documentazioni di studio e ricerche, elaborate, a diversi livelli, sia come eco di studi e indagini qualitative a livello nazionale (CEDEC, ANED, ANPI), sia di progetti di ricerca, attività di studio e documentazione, intrapresi dalla scuola, da insegnanti e da esperti e tecnici di settore. Dunque veramente la scuola diventa comunità di ricerca, dove gli studiosi sono operatori sociali, insegnanti, impegnati a livello storico non avulso e disancorato dal territorio circostante, dal sistema formativo: per cui i progetti di recupero storico si intraprendono in interazione con i vari enti ed agenzie educative operanti nell’ambito territoriale stesso, dove la comunità scolastica si apre al sistema formativo nella sua complessità ed auspicabile integrazione. Pertanto i ricercatori si trovano ad operare utilizzando ed animando pedagogicamente le agenzie educative, dalle biblioteche, agli oratori, al volontariato associazionistico culturale, pubblico e privato, in prospettive auspicabili e realizzabili positivamente, di senso compiuto, perché prodotto di interazione tra parti, per un passaggio di idee ed un’intermediazione effettiva, efficiente ed efficace. La voce culturale e la memoria che scaturisce e si raccoglie nella scuola, attraverso di essa deve poi avere un suo deposito, un simbolo, una rappresentazione, senza essere lasciata solo al ricordo delle persone intervistate, dei testimoni o dei ricercatori, per cui si approntano i documenti in opuscoli, ingenti annuari, manuali di storia locale ecc…per seminare e diffondere valori, ottenere un seguito di idee, retaggi di memorie significative nel tessuto sociale. I punti cardinali sono il ruolo educativo dei testimoni nella formazione e tradizione di una memoria collettiva di esperienze e documenti recuperati, considerando le figure pedagogiche dei testimoni e le questioni salienti dei processi di partecipazione: come partecipare, rendere partecipi a tali esperienze, tradotte in testimonianze, le giovani generazioni. Come passare e tramandare la memoria è il nodo del rapporto di formazione nella interazione tra memoria e storia, tra testimonianze e fonti di diverso tipo, per chiudere un cerchio ideale per giungere ad una trama di storia da proporre ai nostri giovani. Il rapporto memoria e storia. Ipartigiani italiani ammettono che è importante la memoria, perché aiuta a superare situazioni anche estremamente difficili collegate alle vicende, agli avvenimenti ed eventi inerenti la conquista della democrazia, vissuti in prima persona dagli ormai anziani testimoni. 5 La memoria della resistenza costituisce un ingente patrimonio morale, culturale, etico, da difendere e valorizzare perché, purtroppo, molte volte viene dimenticato, ignorato, in quanto rischia, sottovalutato di importanza, di cadere in oblio, nella società italiana, insieme alla complessa memoria storica di quel periodo caratterizzato dalla lotta, dalla guerriglia, nella resistenza alle leggi, alle regole, ai dettami dell’antifascismo, che ha portato il nostro Paese ai principi cardine della Costituzione ed all’identità di Repubblica: questo non dobbiamo dimenticare…Sono valori sacri che devono essere portati a conoscenza e trasmessi soprattutto alle giovani generazioni per far comprendere il senso del sacrificio, l’impegno, le lotte per rivendicare la libertà, condotte per la democrazia, con la conseguente deportazione di parte del popolo italiano, militante nel movimento antifascista, nei campi di concentramento e sottocampi di sterminio… e centinaia di migliaia di morti conoscenti, amici, compagni, partigiani, donne, bambini senza nome, senza età, senza sesso, senza più identità e dignità, ridotti a larve umane senza volto… Oggi dobbiamo ricordare questo passato di terribile vergogna per impedire che il danno possa rivivere, ripresentificarsi, reiterarsi nella vita morale e politica del nostro Paese. Anche nell’ultima campagna elettorale ANPI ed ANED hanno apportato l’esempio, con la loro fattiva presenza, dell’impegno, nell’importanza del ricordare e tramandare la memoria storica e il significato che rappresenta la militanza del popolo nella società italiana per la conquista della democrazia e della libertà. L’impegno fondamentale contemporaneo di tutte le forze politiche, morali, sindacali, culturali deve consistere nella difesa dei valori della Costituzione, il che significa mantenere fede al sacrificio di più di 60.000 uomini e donne, giovani e anziani, battuti per difendere la libertà, la democrazia a vantaggio delle giovani e future generazioni. Lo spirito dell’antifascismo e l’anelito della resistenza è ancora in gran parte presente nella coscienza della società italiana, del popolo. Occorre tenere presente e far rivivere la memoria storica, ma soprattutto nell’impegno della difesa della Costituzione Repubblicana, che per il popolo italiano assume importante significato di libertà, democrazia, giustizia sociale: la nostra Costituzione è una delle più avanzate in tutta Europa. Per questo motivo le nuove generazioni devono conoscerla e rispettarla in un continuo rapporto dialogico con la memoria storica. La generazione della Resistenza, che è sopravvissuta alla guerra, ha voluto testimoniare, tramandare le vicende, gli avvenimenti, mostrando così una grande attenzione nei confronti dei giovani. Ma le generazioni intermedie dell’Italia Repubblicana hanno sicuramente subito un’interruzione di memoria. Quando l’ex Ministro della Pubblica Istruzione Berlinguer, nel novembre del ’96 ha inserito d’autorità la storia contemporanea nell’ultimo anno delle scuole superiori, improvvisamente ci si è resi conto di quanto fosse difficile coniugare la memoria individuale e collettiva con l’interpretazione e la narrazione storica che ha aperto nuovi problemi agli insegnanti, sfide innovative alla scuola. Secondo Norberto Bobbio, il mestiere dell’insegnante è contemporaneamente terribile ed affascinante: terribile per le responsabilità che comporta; affascinante perché stabilisce il dialogo con le giovani generazioni, con il nuovo, il futuro, tra differenti contesti epocali e diverse identità sociali formatesi nell’evoluzione dei tempi…per questo risulta un mestiere estremamente difficile. Gli insegnanti, tra gli intellettuali, sono coloro che più di tutti esercitano direttamente la funzione dell’autodidatta, perché molto spesso devono adattarsi a cambiamenti decisi altrove e studiare, intervenire ed aggiornarsi o meglio autoaggiornarsi. Scuola e storia contemporanea: laboratori e corsi organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione rivolti agli insegnanti. Per la storia contemporanea è sortito un immenso lavoro del Ministero della Pubblica Istruzione dedito all’aggiornamento degli insegnanti a cui l’Istituto Nazionale della Resistenza ed i distretti decentrati su tutto il territorio italiano hanno collaborato a livello centrale e locale, con grandi esperienze dove si è messo a punto, anche grazie a ispettrici preposte, un modello di corso di aggiornamento che è poi stato utilizzato in altre circostanze, partendo dal presupposto che non è sufficiente l’aggiornamento relativo ai contenuti, appunto di tipo passivo e parziale, ma è risultato necessario facilitare l’intervento di altri elementi nella conoscenza storica: sicuramente la metodologia storica e la didattica della storia, ma, per esempio, anche oltre la storiografia, l’inserimento del tema delle testimonianze e delle memorie di vita. Alcuni corsi erano giocati appunto non sulla tematica della memoria divisa, ma sull’argomento relativo alla pluralità delle memorie, sia per quanto riguarda e concerne la seconda guerra mondiale, la resistenza, i movimenti del ’68, ma per esempio, anche la tragica diatriba tra palestinesi ed israeliani, argomento, oggi, di una sconvolgente e drammatica attualità. Quindi pluralità di memorie, ma anche di interpretazioni storiche a confronto. Sulla base di queste esperienze di iniziative ed attività educative concretizzatesi in corsi di didattica e divulgazione in tutta Italia a livello regionale per l’aggiornamento del corpo insegnanti e di laboratori con giovani studenti di discussioni relative alle condizioni di vita, focalizzate, al centro di situazioni esperienziali in rapporto al loro tempo, sortiva il concetto di deprivazione di memoria nei giovani, deprivati, appunto di storia, depauperati di volontà di memoria e conseguentemente di motivazione ai perché, agli eventi, alle vicende storiche. La responsabilità non è certamente da attribuire ai ragazzi che non ricordano, perché essenzialmente non hanno vissuto gli eventi, “non c’erano”… Il problema sostanzialmente consiste nell’assenza di memoria, di consapevolezza del proprio vissuto che evita, impedisce a ciascun soggetto di recuperare il senso dell’esistere e di esserci nella storia, l’esercizio passivo o attivo del vivere nella storia come primari, principali fattori causanti, attori nel palcoscenico del divenire, nel teatro dell’avvicendarsi inesorabile degli eventi, del susseguirsi incessante degli avvenimenti. Certamente alcuni periodi storici favoriscono la solitudine, l’individualismo, il disimpegno politico, la non partecipazione, l’astensione, nella “solitudine della società globalizzata”, a cui susseguono altri momenti, periodi più alti, elevati di impegno politico, collettivo che favoriscono, aiutano la trasmissione della memoria storica. Era accaduto un dato su cui ci si è molto soffermati nella ricerca da parte del Ministero della Pubblica Istruzione “Memoria ed insegnamento della storia”: proprio la generazione che ha vissuto gli anni ’70 di maggior conflitto ideologico non ha passato, trasmesso, tramandato memoria, non avendo metabolizzato e rivissuto criticamente anche il sentimento, il senso diffuso di un fallimento che alcuni dei partecipanti alle lotte politiche di quel tempo hanno sperimentato e reso proprio, personale, a livello di bagaglio culturale. I corsi ministeriali hanno centrato storicamente questo tema della memoria nei confronti degli insegnanti, attraverso gli anni della formazione individuale e professionale e culturale nel periodo prossimo al dopoguerra (anni 50 e 60) che coincide con la grande trasformazione economica, culturale e sociale del nostro Paese. Sussiste una difficoltà dell’educazione alla memoria per cercare gli strumenti finalizzati alla ricostruzione di memoria a scuola e sul metodo didattico da impiegare, non solo per l’utilizzo (il far tesoro) del testimone durante la spiegazione storica in determinati contesti, ma anche per usare criticamente la propria, personale memoria percettiva in modo che lo studente costruisca, in rapporto reciproco, relazioni interpersonali e possa sperimentare sulla propria persona la situazione che lo psicologo Giuseppe Mantovani sostiene in una conversazione in atto :”i giovani entrano in un flusso e processo di tipo storico e gli adulti devono loro spiegare a che punto si trova la conversazione, attribuendo loro gli strumenti perché intervengano nel processo di trasmissione di memoria”. Nella società precapitalistica tradizionale i cui momenti apicali erano scanditi da feste popolari in comunità, saghe narrate e cantate, rituali stagionali reiterati, ciclici in rapporto al divenire della natura circostante, di memorie povere o grandiose tramandate di padre in figlio, condizioni non più esistenti né in territori di campagna né di città, nell’ambito del nostro Paese d’appartenenza, gli anziani in questo tempo mitico, in illo tempore, svolgevano e praticavano l’importante e vitale funzione di spiegare ai giovani come si viveva, cosa era la vita nel presente, nella quotidianità… la situazione patriarcale chiusa, anche autoritaria, evidentemente, permetteva che sussistesse una rituale trasmissione di memoria anche a livello di quotidiano di piccole esperienze, di personali 6 vissuti. Nella società contemporanea ancora una volta la scuola deve assumersi un compito che forse non le è proprio, appunto, la funzione basilare relazionale tra generazioni di trasmissione della memoria storica, ma in assenza di un sistema formativo efficientemente integrato, di una più ampia ed estesa società educante in contesti di comunità. L’unico luogo educativo molto prezioso a tal fine risulta appunto l’istituzione scolastica, con tutti i suoi problemi irrisolti, le questioni pesanti, le difficoltà evidenti, sia a livello burocratico sia sulla base dei rapporti di incontro ed interscambio dialogico e culturale tra generazioni, di intesa ed accordo comuni nei processi didattici ed educativi. Questo rapporto tra memoria e storia risulta un binomio relazionale tra le singole soggettività. Una frase di Holfam, nell’introduzione del “secolo breve”, che descrive la condizione dello storico nello studiare storia contemporanea, si adegua proprio alla posizione ed al ruolo degli insegnanti. Sostiene Holfam: “parliamo dei nostri ricordi ampliandoli e correggendoli e li rievochiamo come uomini e donne di un tempo e di uno spazio particolari, coinvolti in varie guise, ruoli, aspetti, nella storia, come attori di un dramma, per quanto siano state insignificanti le nostre parti, come osservatori del nostro tempo e, non da ultimo, come persone le cui opinioni sono state formate da ciò che noi siamo giunti a considerare come eventi cruciali: siamo portatori di questo secolo che è parte di noi”. Questo spiega, per esempio, l’attenzione per lo sterminio, per la Shoah, come parte fondante della coscienza successiva alla seconda guerra mondiale. Ma il problema consiste nel fatto che senza memoria diventa molto difficile presentare, prospettare, progettare il futuro. La memoria è una mappa di orientamento del presente in quanto permeabile, muta nel tempo, si trasforma, è proteiforme…per esempio, un problema emerso tra i colleghi del gruppo di progettazione di ricerca consisteva nel quesito: cosa può ricordare una generazione che non ha vissuto situazioni estreme e precarie da ricordare, eventi eroici da raccontare, condizioni traumatiche come la guerra da scongiurare…cosa ha da ricordare? Nei laboratori ministeriali si sono svolti esercizi di memoria considerando e valutando che per la generazione degli anni ’50 e ’60 tra i colleghi non sussisteva tanto una memoria politica quanto di tipo sociale riflessa nei grandi cambiamenti intervenuti nella storia italiana. Siamo partiti dal presupposto, messo in luce dal pedagogista Alessandro Cavalli, nell’ambito della ricerca dal titolo “i giovani ed il tempo”, per cui ha evidenziato la netta cesura di memoria politica come elemento che non ha permesso il passaggio di consegna delle eredità conquistate come monito ed indicazione riguardo alla storia contemporanea trasmessa alle nuove generazioni. Il rapporto tra adulti e giovani consiste nel necessario passaggio di memoria come elemento di costruzione e di confronto della storia. Riflessioni sulle “memorie”… La memoria rappresenta per colui che racconta la ricerca del senso di un fatto accaduto nel passato in base alle indicazioni del presente: questo è di grande stimolo dal punto di vista della didattica della storia. Sono le domande del presente che portano ad evidenziare certe situazioni e condizioni vissute nel passato. Sempre più gli insegnanti sono chiamati alla responsabilità della scelta dei contenuti da sottoporre ai ragazzi, perché più si allarga il campo della storia, più la cernita responsabile, critica, storiograficamente accettabile e pertinente risulta importante ed insostituibile. Quando i giovani si rivolgono ad adulti o ad anziani per sentirsi raccontare dei fatti accaduti in un passato prossimo o remoto della storia del nostro secolo, essi stessi cercano e vogliono attribuire senso alla propria vita ed esistenza trovando radici, matrici di significato in ciò che è stato ed è accaduto, agli eventi della storia individuale e collettiva che li ha causati direttamente, a tutti gli effetti. Questo è il grande dono di colui che ha esperienza consolidata, rispetto a chi si deve costruire da solo un proprio senso dell’esistenza, per ragioni individuali e personali: molto spesso non si consolida tale utilizzo ed impiego proficuo, saggio, della memoria nella società contemporanea occidentale, in quanto si cerca di vivere in un eterno presente e probabilmente si sperimenta la difficoltà di attribuire senso anche alle singole esistenze e di costruire personalità strutturate, il che consiste di conseguenza nel compito precipuo dell’educazione, della pratica pedagogica volta alla formazione della persona ed all’istruzione di cultura. Jedlowskji sottolinea la memoria come esperienza, come saper fare, ed esperienza di sapere. Spesso nella scuola il “saper fare” non è sufficientemente sottolineato nel lavoro generale, nelle mansioni quotidiane, nei compiti propri dell’insegnante. Jedlowskji è un sociologo, ma compie una riflessione sostenendo che la forte accelerazione della nostra vita porta ad una crescente intellettualizzazione dei contesti artistici e culturali e per converso a non valutare, non assorbire e metabolizzare le emozioni su cui la memoria si basa soprattutto, come sugli affetti, sugli aspetti emozionali, nell’ambito dei sentimenti, delle passioni che comportano gli eventi. Quindi può avvenire una divaricazione tra memoria collettiva, sedimentata e memoria individuale, per cui il singolo individuo si manifesta in difficoltà, non riesce ad intrecciare ad interagire la propria esistenza con le altrui esperienze di vita. Se rapportiamo tale riflessione al mondo degli studenti, osserviamo che essi stessi non riescono ad attivare un interesse con la storia insegnata ed a rapportarsi con colui che la tramanda (insegnante, storico, studioso, testimone, operatore culturale). La memoria è la storia commentata dell’esperienza dell’uomo, come sostiene la Yourcenar, che fa dire ad Adriano: “ho ricostruito molto e ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato, coglierne lo spirito e modificarlo, protenderlo quasi verso un più lungo avvenire…significa scoprire sotto le pietre il segreto della sorgente”. La testimonianza a scuola porta l’uomo e la donna in carne ed ossa, come protagonisti esistenti e viventi della storia passata, con i loro sentimenti, passioni e scelte di vita con un impatto emotivo diretto ai ragazzi nei confronti degli eventi storici di elevatissima efficacia didattica, nei cui racconti e narrazioni sottesi all’impercettibile filo rosso del sentimento, del ricordo emotivo, si scopre “la sorgente sotto le rocce” sedimentate del tempo…La testimonianza riconsegna al legittimo attore degli eventi ed all’attento ascoltatore il senso dell’essere nella storia, in sé stessi e per sé stessi, nell’immanenza dell’attualità del momento presente. Le parole testimonianti di Giovanni Pesce, Presidente nazionale dell’ANPI, rese note nelle scuole di ogni ordine e grado, scandiscono le date salienti della storia italiana, coincidenti con le scansioni, gli eventi, gli avvenimenti, le scelte, i cambiamenti della sua vita di militante, narrando i fatti storici collettivi, comuni che lo hanno visto protagonista, senza parlare di sé, in prima persona, risparmiando la testimonianza della ricchezza della personale, unica ed irripetibile esperienza di vita, volendo però ricordare date collettive, ma in cui Pesce stesso c’era, era presente e militante, nella contemporaneità immanente di quegli eventi. Lo psicologo Mantovani considera la memoria una mappa per orientarsi tra passato, presente e futuro. Senza la memoria non esiste scansione storica, non ci si connette al passato ma neanche al futuro, non esiste il prezzo del senso della vita e questo fenomeno accade nelle società in crisi che cambiano radicalmente i parametri della vita collettiva. A proposito del processo di pacificazione del Sud Africa dove si è attuata un’esperienza diversa ed originale rispetto ad altri paesi, perché il governo ha presieduto una commissione dove sono stati chiamati a presenziare vittime e carnefici della guerra civile per raccontare le ingiustizie subite, sofferte o perpetrate. La ragione di tale fatto è che memorie così diverse, conflittuali, di forte contrasto venivano così a creare il variopinto ed astratto mosaico della memoria collettiva di un Paese che doveva uscire da una storia tragica. Questo processo di pacificazione, tramite il filo sublime e nobile della memoria, non è accaduto in molti Paesi europei, anche se la Germania, per quanto riguarda la Shoah ed il nazismo, ha elaborato e praticato forse un lavoro più approfondito e capillare rispetto a quello che è avvenuto in Italia o in altri Paesi successivamente. La memoria è soggetta all’oblio del tempo, a cancellazione e rimozione: è continuamente manipolata. Chi plasma oggi la memoria collettiva? Si oscilla tra l’opinione che non esista memoria o che è partorita dai media. Anche se più che memoria i media generano un senso 7 comune condiviso. La costruzione di memoria richiede necessariamente un intreccio interpersonale, mentre i mezzi di comunicazione di massa compiono un’operazione autoritaria, perché il messaggio risulta univoco e con cui non si può interferire ed interagire: è un contenuto non partecipato dialogicamente, dialetticamente, attraverso l’interazione relazionale e razionale tra soggetti. L’istituzione scolastica, in primis responsabile della trasmissione di memoria storica contemporanea. Per lavorare come insegnanti a scuola in progetti riguardanti la storia contemporanea e la memoria storica occorre affrontare in modo critico l’uso pubblico delle fonti e dei documenti che testimoniano gli eventi storici. La scuola per molto tempo ha trasmesso la storia patria: un processo finito, compiuto. Sicuramente l’istituzione scolastica ha perso una centralità educativa di comunicazione di molte informazioni e conoscenze che attualmente sono retaggio specifico dei mass media, anche perché gli insegnanti usano moltissimo gli strumenti visivi, sapendo che consistono in rielaborazioni anche rispetto ai documenti che citano, perché spesso il commento di un documento storico viene elaborato sulla base delle immagini che si sono trovate a disposizione, e non necessariamente con quelle più convergenti e congruenti rispetto al contenuto specifico da trasmettere. Poiché l’impatto visivo è emotivamente molto più alto rispetto al messaggio verbale, i media hanno compiuto un’operazione che contraddice in parte anche quello che i sociologi ottengono come risultato delle inchieste, perché mai come negli ultimi anni si sono riprese parti, frammenti, momenti della nostra storia con annesse reinterpretazioni, adattando certi aspetti ed estrapolandone altri dal contesto, e si è compiuta così un’immensa operazione di memoria collettiva. Dunque si è passati da una fase in cui la memoria della seconda guerra mondiale, della resistenza, dell’internamento, della deportazione, del complesso fenomeno concentrazionario nella sua globalità, erano rievocati, rammentati, rimembrati dai testimoni in ambiti e contesti collettivi e socioculturali, alla fase in cui è stata elaborata dalla storiografia, come è giusto, fino ad approdare a questo ultimo stadio di ricerca in cui è soprattutto il documento ricostruito con tutte le componenti necessarie della drammatizzazione, a volte persino della fiction, che hanno veicolato una certa memoria. Occorre anche considerare le memorie di vita, le narrazioni autobiografiche, pluralità di memorie del contesto storico che contiene esperienze plurime e diverse, mentre molto spesso si individua in un personaggio, in un evento, in una giustificazione il senso della storia ed in questo uso pubblico e decisamente politico della storia è subentrato un grande coinvolgimento che non ha ottenuto altro che un dibattito di contrapposizioni. Sono legittime le posizioni ed opinioni di storici cosiddetti revisionisti, che contrastano la visione della resistenza connessa strettamente alla nostra democrazia e che attua un vero riferimento ai testimoni ancora in vita, militanti nell’associazionismo storico culturale (ANED e ANPI) ed alle vittime, con reali interpretazioni. Esiste una differenza tra queste due modalità e visioni interpretative di leggere la storia più recente del nostro Paese, che consiste appunto nell’opinione anche di storici relativa al lavoro storiografico: il parere può essere formulato sulla base di ipotesi, di ideologie e convinzioni, mentre la storia si costruisce in base alla fonte dei documenti, per cui si parla di uso pubblico della storiografia, perché il documento viene messo in secondo piano e si preferisce elaborare riproposizioni dell’accaduto sulla base di un’interpretazione che spesso non fa riferimento ai documenti a disposizione, vale a dire le fonti normali, cartacee, testimonianze, memorie raccolte ed elementi visivi che nel lavoro dello storico vanno tenute insieme per essere lette ed interpretate globalmente ed utilizzate criticamente. Perché ci soffermiamo tanto sulla costruzione di memoria storica? Non esiste solo il problema di motivare i ragazzi all’apprendimento della storia, perché questa materia, per sua definizione, è una disciplina nomotetica. Non è un caso che la discussione di una riforma della scuola si sia poi focalizzata sul programma e sul curricolo di storia. La storia è anche educazione alla convivenza civile di un Paese ed allora questo termine della responsabilità della memoria, emerso dalle interviste dei docenti che partecipano alle ricerche di memoria ed insegnamento della storia, è un tema della responsabilità educativa che riemerge attualmente con molta evidenza all’interno del corpo docenti anche con la prova dell’autonomia della scuola, dove il ruolo dell’insegnante diventa necessariamente di scelta, di orientamenti di indirizzi, di contenuti e di organizzazione collettiva della dimensione scolastica, concedendo, trasmettendo ai ragazzi, gli strumenti per costruire, riabilitare la memoria al fine nobile di interagire con essi tra passato, presente e futuro, da interiorizzare come responsabilità educativa primaria, al pari della costruzione di tematiche rigorose della storia. I docenti sono organizzatori di sapere nella loro funzione specifica e nel caso della storia contemporanea e soprattutto nel caso della seconda parte del novecento, diventano attori primari degli eventi trascorsi e testimoni principali degli avvenimenti che raccontano e trasmettono perché vissuti in prima persona in un contesto storico globale. Gli insegnanti prima di affrontare un lavoro congiunto con gli studenti, relativo alla memoria storica, devono compiere un lavoro molto serio sul concetto di memoria. In un momento epocale per cui molti individui si sentono singoli ed isolati, perseguono l’interesse personale e non collettivo, vivono in situazioni estreme di solitudine esistenziale, intellettuale e sociale, avere memoria significa assumersi la responsabilità della propria vita ed anche di un modo di esserci di esistere, di partecipare, nel processo storico che viviamo. Il coraggio della memoria, vale a dire andare alla ricerca della storia non è di per sé un fatto che ci porta a valutare anche il presente. I fatti della storia sono sempre la conseguenza e la continuazione di altri eventi, altri avvenimenti, e quindi non è possibile ignorare una parte del passato se si vuole pensare al presente e proiettarsi nel futuro. Quando si parla di storia contemporanea si dimostra la fortuna della ricerca di atti, di fatti e testimonianze che offrono certamente agli storici la possibilità di valutare e di trasmettere queste esperienze e dati di ricerca ai giovani. Negli incontri dei testimoni della resistenza con i giovani si è maturata negli anni una maggiore consapevolezza e coscienza storica. Sostiene Giovanni Pesce Presidente Nazionale dell’ANPI :”Noi abbiamo vissuto esperienze tali, che rievocate oggi, mi danno l’impressione di essere al di fuori della mia persona. Riconosco i fatti, cito i casi, i dati, i protagonisti, ma talvolta avverto la sensazione di stare seduto in una platea e di vedere questi eventi rappresentati in palcoscenico. Con lo scorrere degli anni non si prova più la passione, l’emozione che cresceva dentro di noi in passato e forse i fatti risultano forse anche più chiari, più luminosi ed il discorso, il dialogo, anche con gli insegnanti difficilmente riporta alle singole esperienze personali”. Gli eventi si considerano in una dimensione diversa ed in qualche caso con cartine geografiche o film si riescono ad approntare dibattiti estremamente vivaci che riportano alla memoria non solo i fatti, gli avvenimenti, ma i motivi, le cause. Gli aspetti ignorati maggiormente sono i documenti che precedentemente, all’inizio della guerra, durante il conflitto, sono stati emessi e che denunciano, in primo luogo come gli eventi bellici si sono verificati per certi obiettivi (l’accordo prima con la Germania, poi con la Germania ed il Giappone). Questo disegno strategico in atto che i partigiani, oggi testimoni, non riuscivano allora a comprendere bene, mentre si viveva l’evoluzione dei momenti bellici, ha portato poi, col tempo, e per le modalità in cui si è svolta la Grande Guerra, ad intuire che la strategia bellica era mortale per l’intero globo. Quando l’esercito tedesco è giunto al Volga e si è bloccato a Stalingrado, in quel momento si è capito che se Hitler avesse vinto quella battaglia e fosse riuscito ad ottenere i petrolio del Caspio, probabilmente la guerra avrebbe assunto una dimensione diversa. Il fatto che i giapponesi abbiano attaccato nell’Indocina e nella Cina, il ricongiungimento di tale disegno strategico degli eserciti fascisti che volevano dominare il mondo, oggi se avesse vinto, avrebbe creato una terribile situazione di regresso per l’umanità. E allora qual è stato poi il motivo, la ragione per cui, battuti il nazismo ed il fascismo, rotto il patto antifascista, si è cercato, in anni che sono diventati terribili, bui, dopo la guerra, di dimenticare o di far dimenticare i risultati ottenuti con la resistenza, con il movimento antifascista. Il disegno era questo: il mondo occidentale era diviso in due ed allora bisognava recuperare la Germania, il popolo tedesco che diventava importante per 8 l’occidente. E allora ecco nascondere i fascicoli che riguardavano le stragi avvenute in Italia, in Francia e nei Balcani, e di cercare di ignorare che la guerriglia partigiana e la lotta antifascista avessero portato questo aspetto alla società moderna, all’Italia di oggi, alla Repubblica. Infatti attualmente quelli che tendono ad ignorare questi aspetti tentano di nascondere i motivi per i quali è scoppiato il conflitto per cui il mondo diviso in due doveva produrre certi effetti. E’ importante ricercare nei documenti (i giornali, le biblioteche, nei ministeri) tutto ciò che può far comprendere come si viveva allora, quali erano le ragioni fondanti per cui si è organizzata la resistenza, si è combattuto contro il fascismo. L’aspetto più qualificante della storiografia è andare alla ricerca delle memorie per la possibilità del pensiero di ricordare, di rielaborare, di parlare, di proferire il passato, l’accaduto… ma questo non basta perché è evidente che poi le memorie vanno inserite in un contesto unitario, storico comune: questa è la funzione primaria della scuola. L’istituzione scolastica è la prima forma sociale che l’individuo incontra nel suo percorso di formazione ed in cui si plasma l’avvenire delle future generazioni. Laura TussidadaPeaceLink.it Relazione riassuntiva dell’incontro di presentazione dell’Annuario “Agorà” del Liceo scientifico G. Ferraris di Varese, Maggio 2001: ”Il coraggio della memoria e la storia europea del ‘900” (fonte: Unimondo newsletter) link: http://www.unimondo.org/Notizie/Il-Coraggio-della-Memoria-154334 Immigrazione Lesbo. Il dovere di restare umani (di Giacomo Capriotti – Un ponte per...) Si è conclusa la nostra missione a Lesbo, dove eravamo arrivati il 2 gennaio per aiutare il lavoro dal basso dei volontari nell’accoglienza dei migranti. Ecco com’è andata. Lesbo: isola greca di fronte alla Turchia, ma soprattutto anticamera di quell’Europa che per chi fugge dalla guerra, dalle persecuzioni e dalla miseria rappresenta spesso l’unica possibilità di salvezza. La prima tappa forzata di un crocevia per centinaia di migliaia di siriani, iracheni, afghani, ma anche nordafricani, pakistani, bengalesi, iraniani, che una volta superato il controllo appaltato ad Erdogan dall’Unione Europea, decidono che vale la pena tentare. Vale la pena avere una seconda chance. Vale la pena fuggire da una guerra che non hanno voluto e che sta devastando milioni di vite. Vale la pena imbarcarsi anche con il mare in tempesta, rischiando la propria vita e quella dei propri cari, perché oltre quella traversata c’è forse l’unica alternativa ad un futuro che non ha più nulla da offrire. Siamo partiti perché volevamo vedere con i nostri occhi quanto grande fosse il portato di questa crisi umanitaria, e per raccontare una storia diversa da quella che viene offerta nel dibattito politico italiano ed europeo. Una storia fatta da uomini e donne che, nonostante tutto, decidono di restare umani. Se da una parte le istituzioni municipali dell’isola, il governo greco e la governance europea cercano di porre un freno a questo flusso umano, mascherandosi dietro problemi di natura securitaria, dall’altra volontari indipendenti e piccole Ong si adoperano quotidianamente per soccorrere, accogliere e in certi casi sostituirsi ai meccanismi istituzionali. Meccanismi che escludono dal sistema di accoglienza migliaia di migranti sulla base di una selezione etnica, o con la pretesa di valutare se le motivazioni che li hanno spinti a fuggire siano valide o no, di decidere se la presenza di un essere umano in questo o quel territorio sia legale o meno. Ci sono volontari che lavorano nei campi, nei magazzini, che si coordinano tra di loro portando da una parte all’altra dell’isola ciò di cui si ha maggior bisogno. C’è tra di loro chi passa giorno e notte aspettando segnalazioni di SOS dai barconi in arrivo per poi correre freneticamente da una parte all’altra della costa con torce, coperte ed acqua per poterli soccorrere. Ad attendere queste persone in fuga non ci sono istituzioni democratiche pronte a dar loro il benvenuto o a preoccuparsi di come un diritto sancito dalle Convenzioni Onu venga rispettato. Non ci sono presidi medici o ambulanze. Non c’è neanche la polizia. Ci sono solo i volontari. Sono loro che si gettano in mare per segnalare il miglior punto di attracco. Loro che si preoccupano di soccorrere uomini e donne stanchi e vulnerabili, bambini terrorizzati, anziani impossibilitati anche a scendere da soli dai gommoni. Tutto sotto lo sguardo vigile dei radar di Frontex, posti sulle alture adiacenti alle spiagge. Loro controllano, come un grande fratello che non si scomoda, chiude un occhio e non muove un dito. Nemmeno in caso di naufragio. Padri e madri che ringraziano dio per avercela fatta, che abbracciano i bambini per rassicurarli, che sperano in cuor loro sia tutto finito. Ma non è così. L’Europa dell’austerity, delle sanzioni economiche, che finanzia guerre ed erge muri in nome di quei valori democratici che dice voler difendere, è più preoccupata ad attivare sistemi di controllo che di accoglienza. A seconda della provenienza ci sono differenti meccanismi di registrazione, e differenti tempi di permanenza nei campi. C’è chi aspetta per giorni, chi per mesi, chi non ha trovato riparo nelle strutture istituzionali organizzate e vive in tenda in quelle autogestite. C’è chi è già stato rimpatriato ed è al suo secondo tentativo; chi non ha voglia di raccontare e non si capacita di non poter proseguire il viaggio. E poi c’è chi ha in mano un foglio di via (scritto in greco) ed è convinto che tra pochi giorni potrà lasciare l’isola e raggiungere la famiglia in Svezia. Nessuno dei pretesti utilizzati dai nostri governi può giustificare il mantenimento di una simile condizione umanitaria. Non c’è crisi economica, mercato del lavoro o rischio infiltrazione terroristica che tenga…come se Daesh, forte dei miliardi di dollari guadagnati a seguito di scambi commerciali con ben più conosciuti partner internazionali, Europa compresa, inviasse tagliagole sui gommoni. L’unico scontro di civiltà in atto a Lesbo è tra chi ritiene la presenza di esseri umani un problema da declinare in termini economici e di pubblica sicurezza, e tra chi invece considera la solidarietà, l’accoglienza e la cooperazione come valori umani imprescindibili in qualsiasi condizione e in qualsiasi momento storico. *La missione di Un ponte per…a Lesbo si è svolta dal 2 al 9 gennaio 2016. Nove i/le volontari/e che hanno partecipato. Clicca qui per leggere il loro diario. Giacomo Capriotti – Un ponte per.. (fonte: Un ponte per... - newsletter) link: http://www.unponteper.it/lesvos-calling/ 9 Nonviolenza Benvenuto 2016! Rinnoviamo l’impegno per la pace e la solidarietà (di La redazione di Unimondo) Anche nel 2015 Unimondo ha continuato ad informare sulle numerose iniziative delle associazioni della società civile per promuovere l’impegno per la pace, lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la salvaguardia dell’ambiente, i beni comuni e il consumo critico, l’accoglienza dei migranti, per citare solo alcune delle voci presenti nelle nostre guide. Sono già quasi 15mila gli articoli pubblicati sul nostro portale in questi 17 anni – tutti accessibili gratuitamente nell'archivio– che costituiscono una miniera preziosa di informazioni e di memoria storica per i lettori. Le informazioni di Unimondo, e tante altre che non siamo riusciti a pubblicare sul sito, hanno trovato spazio anche sulla pagina “Unimondo Face2Facebook” e sono state rilanciate dal nostro profilo Twitter. Il 2015 è stato un anno difficile per molte popolazioni. Vogliamo ricordare in particolare il dramma dei profughi e dei migranti: un dramma spesso nascosto, oppure sbandierato soprattutto per creare tensioni ansiogene. Ma che ha visto anche la solidarietà vera di moltissime associazioni tra cui, proprio in questi giorni, quella di Benvenuti Rifugiati Italia. Vogliamo anche ricordare il conflitto in Yemen, una delle numerose “guerre dimenticate”, soprattutto dai nostri media nazionali. Un conflitto che – come riportano le agenzie dell’Onu – ha già causato più di 5.880 morti di cui più di 2.700tra la popolazione civile(di cui 600 bambini) e milioni di sfollati. Un conflitto che si è esacerbato a seguito dell’intervento militare di una coalizione guidata dall’Arabia Saudita: un intervento svolto senza alcuna legittimazione da parte delle Nazioni Unite che, anzi, hanno ripetutamente stigmatizzato gli “attacchi sproporzionati” da parte delle forze aeree della coalizione saudita. Nonostante il Consiglio europeo si sia dichiarato “estremamente preoccupato per l'impatto delle ostilità in corso in Yemen”, inclusi i bombardamenti e per gli attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili, in particolare le strutture sanitarie e le scuole, l’Italia ha continuato ad inviare bombe alle forze armate dell’Arabia Saudita. Unimondo ha documentato che diversi ordigni inesplosi di provenienza italiana sono stati ritrovati in Yemen nelle zone civili bombardate dall’aeronautica militare saudita. Rete italiana per il Disarmo, Amnesty Itala e l’Osservatorio OPAL di Brescia hanno ripetutamente chiesto al governo italiano di sospendere l’invio di bombe ai sauditi: i ministri degli Esteri e della Difesa non hanno accettato di incontrare gli esponenti delle tre associazioni e anzi si sono spesso giustificati dicendo pubblicamente che sarebbe “tutto regolare”. Tutto questo fa capire come sia assolutamente necessario mettere nell’agenda del nuovo anno un impegno specifico per il controllo delle esportazioni di armamenti. Lo scorso luglio, Rete Disarmo ha promosso alla Camera una conferenza stampa (qui il video) per fare un bilancioa 25 anni dall’entrata in vigore della legge 185 che dopo decenni di mobilitazioni delle associazioni della società civile, nel 1990 ha introdotto nel nostro Paese “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.Come ha evidenziato Unimondo, in questi 25 anni la legge 185 è stata applicata dai vari esecutivi con pochissimo rigore,ma soprattutto è stata fortemente intaccata la trasparenza tanto che dalle Relazioni consegnate al Parlamento negli ultimi anni non è più possibile conoscere i dettagli dei miliardi di euro di sistemi militari esportati dall’Italia nei vari paesi del mondo. Nuovi impegni per la pace e il disarmo I conflitti in varie zone del mondo, le tensioni internazionali e gli annunci di nuovi missioni militari da parte dell'Italia non hanno tolto la voce al popolo della pace che lo scorso anno ha continuato a promuovere numerose iniziative. Ne vogliamo ricordare in particolare una: la Campagna “Un’altra difesa è possibile” ha raccolto e consegnato alla Camera le 50mila firme necessarie per presentare la “Legge di iniziativa popolare per la Difesa civile, non armata e nonviolenta”. Inoltre, il 15 dicembre (Giornata dell’obiezione di coscienza e del servizio civile) è stata annunciata in Parlamento la presentazione di un progetto di Legge sulla Difesa civile non armata e nonviolenta che ripropone lo stesso testo della legge di iniziativa popolare. “Nel 2016 – scrive il comitato promotore – tutti i gruppi territoriali della Campagna sono invitati a interpellare i Parlamentari del proprio collegio per promuoverne la discussione e i contenuti”. E’ questo l’impegno più importante che ci attende nel nuovo anno. E, proprio allo scadere del 2015, è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile il bando per gli enti che vorranno presentare progetti per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace. Un passo importante che pone le basi per la realizzazione di più ampia e strutturata della “difesa civile, non armata e nonviolenta” in situazioni di conflitto e di emergenze ambientale. Pur evidenziando alcune criticità, le associazioni del Tavolo Interventi Civili di Pace “esprimono soddisfazione per l’atteso avvio di questa esperienza, alla quale parteciperanno apportando il proprio contributo in termini di personale, formatori, conoscenza del contesto e partenariati in luoghi di conflitto nella consapevolezza che un nuovo modello di intervento civile e nonviolento nei conflitti può interrompere la spirale di guerra e terrorismo, e consentire al nostro paese di farsi promotore un modello originale, innovativo e sostenibile di azione per la pace e la sicurezza anche a livello internazionale”. In questo contesto vogliamo anche segnalare una notizia che forse è sfuggita ai molti lettori: lo scorso 28 ottobre una stanza della Camera dei Deputati è stata intitolata a Massimo Paolicelli, storico esponente del movimento pacifista morto due anni fa dopo una lunga malattia. “Un riconoscimento importante per un uomo che si è sempre battuto per la pace” – ha commentato Giulio Marcon, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà. Nella sua ultima lettera agli amici Massimo ci ha regalato alcune parole che vogliamo assumere come impegno per il nuovo anno: “Tante gocce possono scalfire la roccia: cerchiamo di scalfire la roccia dell’indifferenza e dell’egoismo e costruiamo, in nome di Dio, un mondo di giustizia, pace e solidarietà”. Buon 2016 a tutti! La redazione di Unimondo (fonte: Unimondo newsletter) link: http://www.unimondo.org/Notizie/Benvenuto-2016!-Rinnoviamo-l-impegnoper-la-pace-e-la-solidarieta-154480 Pace Fede e cultura per Bergoglio. Conflitto e pace (di Enrico Peyretti) Questo testo di Bergoglio, papa Francesco, ripreso oggi, interessa non solo chiesa e cultura laica, come mostra Asor Rosa nel suo articolo "Il vangelo del conflitto". A me sembra interessante per la cultura della pace, nella linea tolstojana-gandhiana, che è la più seria e profonda e realistica, non moralistico-esortativa, ma culturale-politica . In questa peace research, il tema laico del conflitto è centrale. Il conflitto va assunto, tutt'altro che eluso o coperto. Azione di pace giusta, nonviolenta (non è pace se non è nonviolenta nei mezzi, nel fine voluto, nel risultato ottenuto), è smascherare il conflitto occulto, che non può avere giustizia, verità e pace. La vittima del conflitto violento e occulto resta vittima. C'è silenzio, ma non c'è pace. Azione di pace è la trasformazione nonviolenta del conflitto aperto, liberato dagli elementi di violenza con cui appare. Il termine misericordia oggi corrente non è altro che l'amore positivo e attivo a favore delle varie forme di vita, dei suoi bisogni, della sua ripresa, 10 e della stessa terra viva che noi abitiamo. La pace è atto di riconoscimento, rispetto, tutela della realtà, perciò è cura d'amore, occhio e sentimento positivo, di stima, di bene diretto dall'io responsabile a tutta la realtà. Perciò è impegno immediato a non distruggere, non ferire né offendere, a comprendere le ragioni altrui, a cercare la composizione di diritti, interessi, gusti e bisogni. E' un lavoro di intelligenza, di analisi e strategia. Tutte le arti messe in campo dal potere degli uni sugli altri, l'umanità può volgerle all'azione educativa-culturale-politica-storica per lo sviluppo umano degli uni con gli altri e per gli altri, in una linea evolutiva umanizzante che possiamo con umile concreterzza favorire e rpomuovere. Ciò che la spiritualità, l'etica, chiama amore è quella benevolenza, comprensione, perdono, aiuto e stima che compongono una antropologia realistica ma positiva, pensata e praticata per la costruzione della pace, dalle relazioni prossime fino a quelle cosmopolitiche. Voglio solo dire che quel rapporto costruttivo e dialettico che Bergoglio propspettava nel 1985 e che rilancia oggi da papa, tra, da un lato, fede evangelica che è prassi di amore e giustizia, e, dall'altro lato, cultura laica di una società plurale e correttamente conflittuale, è, espresso in termini analoghi, proprio il lavoro che i movimenti pensanti e operanti per la pace nonviolenta gandhiana, o pace giusta, intendono fare col costruire la cultura e la prassi della trasformazione nonviolenta dei conflitti. Le due culture ristrette, o soltanto al religioso o soltanto al laico, raramente (e non nelle loro espressioni più note e di successo) colgono e coltivano questo rapporto fecondo per tutti tra l'amore prevalentemente donativo (l'agape evangelica; la compassione buddhista) e il confrontoconflitto politico genuinamente democratico. Il quale, per potere essere davvero libero e aperto, ha bisogno di essere basato, non su scontri di cieche forze centripete, ma sulla giustizia distributiva, sui diritti umani e sulla dignità umana inviolabile. Personalmente, io tengo a testimoniare che, nei decenni del mio impegno e partecipazione, ho vissuto uno stimolante contatto e appartenenza ad entrambe queste culture, laica e religiosa, e sperimento, dalla mia formazione alla mia vecchiaia, che si fecondano l'una l'altra, senza assimilazione. C'è chi alimenta la guerra tra civiltà e culture. C'è chi sperimenta che è possibile, a livello locale e planetario, la collaborazione dialettica tra le umane visioni e azioni, dirette a custodire e sviluppare la realtà. Questa è la pace. E. P. link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2440 Il Vangelo del conflitto (di Alberto Asor Rosa) Bergoglio lo ha scritto trent’anni fa e ora lo ha rivisto: un testo che riflette sul rapporto tra fede e cultura, tra paura e misericordia. Integrando concetti cristiani e laici. Nelle settimane passate è apparso in Italia un testo di Papa Bergoglio, che a me sembra di grande importanza. Si tratta dell’intervento da lui pronunciato a un Congresso internazionale di teologia (da lui stesso voluto e preparato), svoltosi a San Miguel in Argentina dal 2 al 6 settembre 1985, sul tema “Evangelizzazione della cultura e inculturazione del Vangelo”. L’intervento, nella forma pubblicata da Civiltà cattolica, porta il titolo “Fede in Cristo e Umanesimo”. Ritengo però che il suo vero tema sia più esemplarmente testimoniato da quello del convegno. Andrò per accenni, limitandomi a segnalare quello che, dal mio punto di vista, spicca per novità e intelligenza del discorso. In effetti, trovo, per cominciare dagli inizi, che ipotizzare questa doppia missione – che è anche un doppio movimento di andata e ritorno per ognuno dei due elementi che lo compongono, e cioè: “evangelizzazione della cultura” e “inculturazione del Vangelo”– significa offrire una visione nuova dei rapporti tra la “fede cristiana” e “il mondo”. Bergoglio, infatti, non dice: “questa” o “quella cultura”. Dice: “cultura”. A chiarimento della tesi scrive: «Stiamo rivendicando all’incontro tra fede e cultura, nel suo duplice aspetto di evangelizzazione della cultura e di inculturazione del Vangelo, “un momento sapienziale”, essenzialmente mediatore, che è garanzia sia dell’origine (movimento di creazione) sia della sua pienezza e fine (movimento di rivelazione)». «Un momento sapienziale, essenzialmente mediatore…»: se la traduzione dallo spagnolo in italiano non ha deformato qualche senso, questo vuol dire che tra “fede” e “cultura” si può stabilire un confronto, i cui momenti di reciprocità sono destinati a influenzare sia l’una sia l’altra parte, producendo, attraverso la “mediazione”, un accrescimento di sapere e di conoscenza per tutti. Bergoglio chiama in causa una parola-concetto tipicamente laica o quanto meno mondana: “mediatore”, mediazione. Tale impressione però si accentua, in misura significativa, nella lettura di un brano seguente, che qui riporto per intero, perché lo trovo denso di parole-concetti sorprendenti: «La base di questo sforzo è sapere che nel compito di evangelizzare le culture e di inculturare il Vangelo è necessaria una santità che non teme il conflitto ed è capace di costanza e pazienza. Innanzi tutto, la santità implica che non si abbia paura del conflitto: implica parresia, come dice San Paolo. Affrontare il conflitto non per restarvi impigliati, ma per superarlo senza eluderlo. E questo coraggio ha un enorme nemico: la paura. Paura che, nei confronti degli estremismi di un segno o di un altro, può condurci al peggiore estremismo che si possa toccare: l’“estremismo di centro”». In questo caso, la parola-concetto centrale è: “conflitto”. Si deve ammettere che siamo di fronte a una acquisizione inedita nel campo della cultura cristiano-cattolica. Il termine infatti ricorre nel pensiero e nelle problematiche del pensiero dialettico e sociologico europeo e americano degli ultimi due secoli: da Hegel a Marx, e poi Simmel, von Wiese, Dahrendorf… Nessun equivalente, almeno della stessa portata, nel pensiero cristiano-cattolico dello stesso periodo, e si capisce perché: la predicazione evangelica sembrerebbe escludere una virata di tale natura. Ma la sorpresa è destinata persino ad aumentare se si procede nell’analisi del ragionamento. «Affrontare il conflitto », scrive Bergoglio, «per superarlo », ma «senza eluderlo»; si misura con «un enorme nemico: la paura». Paura di che? Paura dei possibili estremismi, che dal conflitto possono scaturire. Ma tale paura, se incontrollata, è destinata a condurre «al peggiore estremismo che si possa toccare: l’“estremismo di centro”, che vanifica qualsiasi messaggio». L’“estremismo di centro”! In un paese come l’Italia, spesso arrivato a catastrofiche conclusioni proprio a causa di un sistematico e prevaricante “estremismo di centro”, tale messaggio dovrebbe risultare più comprensibile che altrove. Anche il riferimento alla parresia s’inserisce in questo contesto: solo chi parla alto e libero può vincere la paura. Quali considerazioni si possono fare su posizioni, di questa natura? Su Bergoglio sono stati scritti molti articoli (bellissimi quelli di Eugenio Scalfari). Pochi, però, si sono soffermati sulla scaturigine storica delle sue prese di posizione, che è inequivocabilmente gesuitica. I gesuiti, nel corso della loro lunga storia, ne hanno combinate di tutti i colori, nella difesa perinde ac cadaver della Chiesa di Roma. E però… Molti anni or sono ho studiato a lungo la cultura gesuitica del Seicento in Italia. Mi risultò chiaro allora che carattere perspicuo della cultura gesuitica, nei momenti migliori, è sempre stato il tentativo «di operare la saldatura fra cultura laica e cultura ecclesiastica, fra tradizione e rinnovamento… »; e questo su base mondiale. Se le cose stanno così, la domanda (provvisoriamente) finale di questa ricostruzione è: quale rapporto esiste fra la centralità della parola-concetto “conflitto” e la centralità della parola-concetto “misericordia”, alla quale Papa Francesco ha voluto dedicare il Giubileo? La risposta più semplice è: nessuno. “Misericordia” è parola evangelica, pochissimo usata in ambito laico, come pochissimo “conflitto” in ambito ecclesiale. Sono passati trent’anni dalla prima formulazione, padre Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco, ha ripensato radicalmente le sue posizioni, rientrando nell’ambito più tradizionale della cultura ecclesiastica. Come tutte le soluzioni troppo semplici, anche questa però si presta a un’obiezione di fondo. Una noticina al testo pubblicato da Civiltà cattolica informa infatti che il testo è stato ripresentato «in forma rivista dal Santo Padre ». Questo ci rende lecito pensare che nel pensiero di Papa Francesco “conflitto” e “misericordia” possano stare insieme. Cioè: il prodotto di una cultura laica può stare insieme con il prodotto tipico di una cultura evangelico- cristiana. Non può esserci “misericordia” se non c’è stato 11 “conflitto”; il “conflitto” è buono, anzi, addirittura indispensabile, se è necessario per superare la paura, e superare la paura è necessario per arrivare alla “misericordia”. Sarebbe troppo pretendere che Bergoglio, divenuto Pontefice, dopo averci additato come il conflitto sia necessario per attivare la misericordia, ci additi come la misericordia sia necessaria per attivare il conflitto, motivo quest’ultimo inesauribile – e positivo, quando c’è – delle azioni umane. Però la connessione possibile – il prima e il dopo, insomma, che però è anche o può essere anche, un dopo e un prima – almeno a noi laici e non credenti, risulta – credo – ben chiara. link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2441 Politica e democrazia Costituzione, la controriforma di Renzi (di Maria Luisa Pesante) Di fronte all’obiettivo – ampiamente condiviso nel paese – di uscire dal bicameralismo perfetto, Renzi, tra le molte soluzioni tecnicamente possibili, ne ha scelto una così gravemente contestabile. Perché di fronte all’obiettivo – ampiamente condiviso nel paese – di uscire dal bicameralismo perfetto, conferendo la prerogativa dell’investitura governativa a una sola camera, Renzi, tra le molte soluzioni tecnicamente possibili, ne ha scelto una così gravemente contestabile, e contestata? La domanda non riguarda le intenzioni di Renzi, ma la logica dello sconcio costituzionale che sta per essere definitivamente approvato. Esso contiene tre elementi fondamentali, il ritorno a un accentramento del potere politico, la creazione di una seconda Camera con funzioni improprie e distorsive, una soppressione del carattere rappresentativo di un organo politico. Queste tre connesse operazioni vengono compiute nel modo meno lineare possibile, in modo da creare oscurità e confusione, e quindi il massimo di difficoltà a capire il merito della posta in gioco per i cittadini che saranno chiamati a pronunciarsi. In primo luogo, la controriforma renziana riduce in modo molto forte le competenze delle Regioni, soprattutto in tema di politiche economiche e sociali; e non definisce in nessun modo né il baluardo della loro residua autonomia di scelta né lo strumento necessario ai loro compiti, ossia le fonti di finanziamento da attribuire loro in via istituzionale, lasciandole invece interamente all’arbitrio del governo. Al tempo stesso, però, nessuna modifica riguarda i punti cruciali dell’istituzione regionale che in questi anni, in generale, non ha certo brillato per efficienza, onestà, capacità progettuale: la configurazione dei suoi organi, con un assurdo presidenzialismo locale; le leggi elettorali fatte su misura delle contingenti prevalenze partitiche; la mancanza di ogni efficace modalità di controllo della spesa. Questo accentramento è coerente anche con una prassi di governo che avoca in continuazione alla Presidenza del consiglio compiti di decisione di pertinenza di vari ministeri; nomina commissioni ad hoc, con compiti giudiziali o consultivi, sui più diversi problemi; usa i prefetti – funzionari integerrimi, ma dipendenti dal governo – contro le amministrazioni locali elette. In secondo luogo, queste regioni svuotate, ma non riformate, vanno a costituire, attraverso il proprio processo elettorale, il corpo politico del nuovo Senato, a cui sono attribuite funzioni di intervento nelle revisioni costituzionali, e nell’elezione di organi costituzionali di garanzia. In altre parole, la repubblica italiana è assai lontana da uno stato federale, ma attribuisce alla seconda Camera funzioni tipiche di quest’ultimo, in cui i Länder, o i cantoni, o gli stati dell’Unione sono le unità originarie dal cui patto nasce lo stato centrale, e perciò hanno funzioni costituzionali. Perciò gli eletti dei corpi politici federati che costituiscono la seconda Camera rappresentano, secondo diversi processi elettorali, un definito segmento di cittadini, a cui rispondono direttamente, o indirettamente: a uno specifico collegio elettorale, come negli Stati Uniti, o al governo parlamentare del Land, frutto di una legge elettorale proporzionale, come nel Bund tedesco. Da chi sono eletti – in terzo luogo – e a chi rispondono i membri del previsto nuovo Senato italiano? Sono eletti dai cittadini con una scelta in cui si confonde la funzione di consigliere ragionale e quella di presumibile senatore, e poi sono nominati dal potere esecutivo della regione, a cui però non dovranno rispondere, perché non avranno vincoli di mandato. La risibile e penosa battaglia di una parte del PD per ottenere simile risultato, come se questo fosse un decente sostituto di un’elezione pulita, ha contribuito a oscurare il disegno complessivo della controriforma, in sé e nella sua connessione con la legge elettorale per la Camera dei deputati. Essa, a sua volta, magicamente trasforma una minoranza dei suffragi elettorali in sicura maggioranza per un governo, con un disprezzo per la rappresentatività del parlamento che non credo si fosse ancora vista. Se poi il governo così benedetto sarà quello che il governo attuale era sicuro di essere è tutto da scoprire: quando in un sistema oramai saldamente tripolare,e per il momento molto bilanciato, la scelta dei partiti che vanno al ballottaggio non dipende da una ragionevole soglia minima che può lasciare in corsa più di due liste, come in Francia, ma dalla casualità di un voto in più o in meno per tornare in gara al secondo turno, tutto può succedere. Accentramento presso il potere esecutivo centrale, funzioni improprie o finte di organi con competenze costituzionali, svuotamento o distorsione del rapporto tra elettori ed eletti ammontano a uno smantellamento dell’equilibrio tra poteri che è parte integrante di qualsiasi costituzione. E su questo terreno è particolarmente preoccupante quanto le maggioranze previste per la nomina dei giudici costituzionali, pensate per un sistema politico dotato di legge elettorale proporzionale, perdano gran parte del proprio potere di tutela. Ogni costituzione ha infatti come funzione primaria quella di porre limiti precisi al potere legislativo cui il popolo sovrano si affida periodicamente; e i giudici costituzionali hanno il compito di difendere quei limiti. Se a questo si aggiunge che, come si è visto in occasione della controriforma e come si vedrà ancora di più se essa entrerà in vigore, il potere esecutivo controlla il legislativo e non viceversa, è lecito formulare l’ipotesi che ci stiamo avvicinando non già a un qualche peggioramento della Costituzione, bella o brutta che fosse, ma a un limite nei pressi del quale la carta non è più in grado di esercitare la sua funzione di dare forma e limite al monopolio del potere. Si può comprendere attraverso queste considerazioni perché un problema che poteva essere consensualmente risolto sia diventato un tale oggetto di contesa: l’obbiettivo raggiunto, e non interessa se per intenzione, incompetenza tecnica, o semplice iattanza in contese meschine, va molto al di là di quel problema. Bisogna ricordare che questo obiettivo è la cristallizzazione di una lunga serie di attacchi alla Costituzione, cominciati negli anni ’80, proseguiti nella stagione berlusconiana, sostenuti in maniera irridente o felpata da più di un presunto custode della costituzione, approvati da una rilevante parte dei produttori di opinione pubblica nel centrosinistra. Senza che, tra chi a questo indirizzo era contrario, si formasse, oltre all’onorevole opposizione, anche una almeno implicita alternativa in positivo. La debolezza della risposta al progetto neogollista di Quagliariello nella Commissione voluta da Napolitano e Letta era già un segnale preoccupante. Il risultato che Renzi ottiene oggi è molto di più di quel progetto, e un danno è stato prodotto, anche se quel risultato gli fosse sottratto dal referendum. Senza formulare davanti ai cittadini, almeno sommariamente, una chiara alternativa, sarebbe impossibile dissipare la mistificazione che copre, e ancora più coprirà, la situazione costituzionale, o piuttosto a-costituzionale, che si prefigura. (fonte: Sbilanciamoci Info) link: http://sbilanciamoci.info/6797-2/ Prospettiva di genere #HeForShe: la parità di genere riguarda anche lui (di Anna Toro) “Uomini, vorrei cogliere questa opportunità per farvi un invito formale. La parità di genere è anche un problema vostro”. 12 E’ passato più di un anno dal famoso discorso dell’attrice britannica Emma Watson di fronte alle Nazioni Unite, in occasione del lancio della campagna “He for She” (“lui per lei”): una chiamata all’azione rivolta soprattutto agli uomini affinché si attivino anch’essi in prima persona per ridurre le disuguaglianze di genere. Il video ha raggiunto una viralità straordinaria, e mentre le adesioni fioccavano in tutto il mondo – da capi di stato come Barack Obama ad attori e personalità del mondo accademico, sportivo e dello spettacolo – in Italia la campagna ha stentato a decollare. A prendere le redini della situazione ci ha pensato il comitato italiano di UN Women guidato da Simone Ovart, che il 15 dicembre l’ha lanciata anche nel nostro paese, alla presenza del presidente del Senato Pietro Grasso e della Vicepresidente Valeria Fedeli. “La campagna ha come principale obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi, gli uomini, e di renderli più coscienti e consapevoli rispetto agli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità di genere in Italia, in Europa e nel mondo” ha spiegato il presidente Grasso, che ha rimarcato il punto focale della campagna, ovvero come “gli stereotipi costruiti per le donne presentino una doppia faccia della stessa medaglia” e come le pari opportunità e gli uguali diritti che spettano a ciascuno in quanto individuo portino invece a “una società migliore con meno abusi e prevaricazione per tutti”. Sebbene siano tantissimi i progressi fatti dalla Conferenza di Pechino del 1995, molti paesi restano ancora parecchio indietro rispetto all’obiettivo principale di ridurre in modo costante i numerosi gap esistenti tra uomo e donna. Neanche le nazioni che si autoproclamano alfieri dei diritti umani e della parità di genere sono immuni dal problema, anzi: violenze, sessismo, stereotipi e luoghi comuni continuano a condizionare in modo subdolo e sottile scelte e comportamenti in ogni campo della vita della donna, anche nel nostro paese. “La ricerca presentata dal dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall' Istat ci consegna in effetti il ritratto di una nazione dove gli stereotipi sessisti sono tuttora duri a morire – sottolinea il presidente del Senato –. Ci dice che, nonostante per il 40 per cento dei cittadini le donne sul subiscano evidente discriminazione di genere, un italiano su due ritiene che gli uomini siano meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche, e la metà della popolazione trova giusto che, in un tempo di crisi, i datori di lavoro debbano dare la precedenza ai maschi in ambito lavorativo. Ci dice che le donne sono più svantaggiate nel trovare una professione adeguata loro titolo di studio, nel fare carriera, nel conservare il posto di lavoro. Infatti il 44,1 per cento delle donne contro il 19,9 per cento degli uomini ammette di aver rinunciato ad opportunità lavorative per essersi dovuta occupare della famiglia o dei figli”. Il video presentato durante la stessa giornata dal presidente di Pubblicità Progresso, Alberto Contri, non è scelto a caso: nel clip infatti si vede una donna che viene mandata allo stesso colloquio di lavoro prima truccata perfettamente da uomo, e poi come donna, sempre ripresa da una telecamera nascosta. A parità di esperienze e di curriculum, quando si arriva a parlare della retribuzione, ecco che con la donna il datore di lavoro passa improvvisamente al “tu”, per poi dirle: “Ma non ti pare un po’ troppo?” La classica domanda sui figli viene qui risparmiata, ma i recenti casi di cronaca mostrano che anche l’attenzione che i selezionatori destinano alla vita sentimentale delle donne non è la stessa che rivolgono a quella dei maschi. A questo si aggiunga l’odiosa pratica delle dimissioni in bianco in caso di maternità (problema che la legislazione italiana sta cercando di arginare), o la difficoltà di fare carriera appunto perché penalizzate da figli e famiglia (e la carenza di asili e l’inadeguatezza dei permessi parentali per gli uomini non aiuta), o ancora le critiche e i biasimi per le donne che scelgono la strada completamente opposta. E poi c’è la violenza, quella fisica, verbale, psicologica, a dimostrare il lungo lavoro che c’è ancora da fare, a partire soprattutto da un cambio di mentalità. Si pensi al Rapporto sulla violenza contro le donne e gli stereotipi di genere “Rosa shocking 2” curato da WeWorld Onlus insieme a Ipsos, secondo cui in Italia sono 6 milioni 788 mila le donne che hanno subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Ma a sconvolgere sono soprattutto i dati che riguardano i ragazzi e la loro percezione del fenomeno: per un giovane tra i 18 e i 29 anni su cinque, quello che accade in una coppia non deve interessare agli altri; per uno su quattro, la violenza sulle donne è dovuta a "raptus momentanei, giustificati dal troppo amore”; per uno su tre, gli episodi di violenza domestica "vanno affrontati dentro le mura di casa". E se oggi le donne sono sempre più organizzate e consapevoli, sempre meno timorose di definirsi femministe e di reagire e lottare contro abusi e discriminazioni, coinvolgere gli uomini diventa l’imperativo che i promotori di HeForShe vorrebbero portare avanti, al di là di paternalismi e, si spera, vuota retorica. Anche per questo in Italia si è deciso di puntare innanzitutto sul mondo dello sport – di grande impatto per le giovani generazioni – grazie al testimonial Filippo Magnini, due volte campione mondiale di nuoto, così come sul mondo accademico, con 19 delle maggiori università italiane che hanno già risposto positivamente e attivamente all’appello. La Sottosegretaria all’Istruzione Angela D’Onghia ha espresso a questo proposito pieno sostegno da parte del Miur, ricordando che attraverso il comma 16 della Legge 107/2013 l’educazione alla parità di genere sarà promossa in tutte le scuole. Un modo anche questo affinché della campagna HeForShe non rimangano solo parole, quelle stesse sottoscritte per ora da circa 560.000 persone nel mondo, ma che i promotori vorrebbero portare presto a un milione. “C’è ancora molta strada da fare e speriamo si organizzino altre iniziative – ha commentato il presidente de Senato Pietro Grasso – ma i passi avanti si fanno insieme, donne e uomini fianco a fianco, donne e uomini sullo stesso piano. Magari, mano nella mano”. (fonte: Unimondo newsletter) link: http://www.unimondo.org/Notizie/HeForShe-la-parita-di-genere-riguardaanche-lui-154521 Violenza L’indice di Colonia (di Ida Dominijanni) Un branco di maschi è un branco di maschi. A qualunque latitudine e di qualunque colore (anzi: “colore presunto”) essi siano. Con rara onestà intellettuale e morale, l’ha ricordato ieri su Repubblica Gabriele Romagnoli, a partire dalla sua propria esperienza di studente universitario bolognese, nonché di “maschio sessualmente arretrato”, che quarant’anni fa partecipava, o assisteva, ai riti goliardici di carnevale che ogni anno contemplavano caccia, molestie e palpeggiamento delle ragazze. E lo si potrebbe ricordare con svariati altri esempi presi dal mondo occidentale, bianco e libero, dove stupri di gruppo, molestie di varia natura, femminicidi di varia efferatezza non smettono di accadere. Oppure con altri esempi tratti dal circuito militare, occidentale e orientale, settentrionale e meridionale, dato che sempre nelle guerre, e in qualunque guerra, le donne continuano a essere la preda succulenta che gli eserciti di maschi si contendono, o il marchio etnico che cercano di conquistare, o la presunta altrui proprietà che cercano di rapinare. Lo si ricorda per sminuire i fatti di Colonia, Francoforte, Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda? No. I fatti della notte di capodanno non vanno sminuiti: sono fatti brutti, e, se fossero come si sospetta l’effetto di un’azione coordinata di bande di maschi “nordafricani” – ma attenzione, basta interpellare delle amiche che abitano in quelle città per sapere che la notte di capodanno l’aria che tira è sempre la stessa –, sono fatti inquietanti. Segnalano che la provocazione dei maschi islamici contro i maschi occidentali tramite l’aggressione delle “loro” donne entra ufficialmente, dichiaratamente, a far parte delle tattiche della guerra civile globale in corso. E questa è certamente una pessima notizia, che non va derubricata. 13 Ma che non va nemmeno distorta, o piegata ad altri fini, l’altro fine essendo il titillamento dell’ideologia dello “scontro di civiltà” cui si presta egregiamente: che è precisamente quello che gli islamisti radicali cercano di fomentare e dovrebbe essere precisamente la trappola in cui evitare di cadere. Intendiamoci, c’è pochissimo di nuovo sotto il sole. È dall’indomani dell’11 settembre americano che tutto l’occidente suona la grancassa dell’oppressione femminile come marchio d’inferiorità della cultura islamica, e della liberazione delle donne dal patriarcato islamico come legittimazione per le guerre occidentali di “democratizzazione” del Medio Oriente. Non per caso, questa grancassa suona soprattutto nel fronte conservatore americano ed europeo, che è tanto pronto a difendere la libertà femminile delle donne contro l’aggressione degli “altri” maschi quanto è pronto a tacitarla, all’occorrenza, in casa propria: che dire dell’allarme per i fatti di Colonia di un commentatore come Sallusti, che ai tempi del Berlusconi-gate non aveva mezzo dubbio sulla libertà maschile di comprarsi il corpo femminile? Oppure che dire delle certezze del Corriere della Sera, che dagli attentati di Parigi porta avanti una strenua battaglia a difesa dello “stile di vita” occidentale assimilando la libertà femminile alla libertà di andare a teatro o a prendersi un aperitivo al bar? Difese sospette, cui consegue sempre l’ingiunzione alla sinistra, o a ciò che ne resta, a non sacrificare i diritti delle donne alla bandiera del multiculturalismo. Ma qui non è questione di multiculturalismo, se per multiculturalismo si intende il rovescio dello scontro di civiltà, ovvero l’accettazione acritica di una cultura diversa dalla propria e la giustificazione delle sue gerarchie e sopraffazioni interne, a partire dalla gerarchia uomo/donna e dalla sopraffazione delle donne da parte degli uomini. I branchi di maschi che assalgono donne non sono giustificabili in nome di niente, né nella cultura islamica né nella cultura occidentale, né fra gli immigrati di Colonia né nei campus americani o nelle scuole “bianche” italiane. Assumere davvero lo stato dei rapporti fra i sessi e la libertà femminile come indici dello stato di una civiltà – o meglio, della crisi di civiltà in cui il mondo intero si trova – significa affrontare le contraddizioni comuni e trasversali alle civiltà che vengono rappresentate come contrapposte e in lotta fra loro. Significa combattere la brutalità del patriarcato islamico come i residui, o i rigurgiti, patriarcali nelle democrazie occidentali. E viceversa: significa anche e forse oggi soprattutto riconoscere i segni positivi di libertà femminile non solo nelle democrazie occidentali, ma anche nei paesi più patriarcali dei nostri. Solo pochi giorni fa Shirin Neshat, un’artista che in materia di rapporti tra i sessi nel mondo islamico non ha uguali e non teme confronti, in un’intervista sul Manifesto interpretava l’efferatezza contro le donne nel radicalismo islamico come il segno non tanto di una permanente oppressione femminile, quanto di una inquietante arretratezza e reattività della cultura politica di fronte a una libertà femminile sempre più diffusa. È una sindrome che in occidente conosciamo bene: il patriarcato diventa più aggressivo proprio quando scricchiola. Se cominciassimo a leggere il disordine mondiale nei termini di una crisi planetaria del patriarcato, e non nei termini autorassicuranti di un Eden occidentale della libertà femminile in guerra contro l’inferno patriarcale islamico, probabilmente cominceremmo finalmente a fare un po’ d’ordine, a capodanno e tutti i giorni. (fonte: Internazionale) link: http://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2016/01/08/coloniacapodanno-molestie Notizie dal mondo Europa Gabbia Europa (di Stefano Galieni) Avete presente l’Europa che conoscevamo fino ad un anno fa? Scordatevela, non esiste più. Ha gettato la maschera. È diventata ufficialmente quello che in molti capivamo sarebbe diventata. Una moneta, un sistema gerarchico di rapporti sociali fondati sulla ricchezza. La libera circolazione delle merci e dei capitali. Il controllo da Stato totalitario delle persone. Si esagera? Proviamo a guardare da vicino. Sin dalla sua fondazione, dai trattati che hanno definito lo Spazio Schengen. Solo alcuni potevano circolare senza controlli di sorta. E per entrare a far parte di questo spazio privilegiato bisognava di saper controllare le frontiere esterne e saper cacciare chi non aveva diritto (ricchezza sufficiente) a restare nel Continente. Lo Spazio Schengen nasce prima dell’Europa stessa per affermare chiaro e tondo a chi si avvicina: «Noi saremo una fortezza. Faremo entrare chi ci serve, da sfruttare, magari anche da inserire, ma ci terremo il privilegio di cacciare e respingere chiunque. Si per ora rispetteremo qualche Convenzione internazionale». E dopo che era crollato con gioia di molti di noi, il Muro di Berlino, simbolo di un’epoca cupa, di muri, lentamente, se ne alzavano altri. E si creavano spazi interni di reclusione per chi doveva essere identificato ed espulso. Sistemi fallimentari di detenzione, privazione della libertà personale e della dignità, luoghi di violenza sparsi per tutta Europa, oltre 400 ad un certo punto. E chi voleva entrare in UE doveva a sua volta costruirne e contemporaneamente assicurarsi che i paesi limitrofi ne creassero in loco, per esternalizzare le frontiere ed allontanare il pericolo di un’invasione. C’era l’invasione? No. Ma in questa maniera milioni di persone sono entrate in condizioni di irregolarità e precarietà, hanno lavorato, non solo in Italia (in questo leader del settore) al nero e sottopagati, contribuendo ad abbassare anche i salari e le condizioni di vita degli autoctoni e scatenando guerre fra ultimi e penultimi. Il sistema si è per anni gerarchizzato: all’ultimo posto le donne, ovviamente, e poi via via chi riusciva ad imporsi e a riscattarsi, attraverso i mille cavilli con cui ogni singolo Stato ha gestito la questione, in un’ottica di controllo del mercato del lavoro su base “etnica”. Ogni uomo, donna che entrava nel “paradiso” ci entrava a condizioni specifiche, ogni volta scavalcando muri o “bruciando frontiere”, ma ci entrava con una speranza di ascesa sociale. E oggi? Oggi il mercato del lavoro si è ristretto, soprattutto nei paesi del Sud Europa che grazie alle politiche di austerity e di liberismo sfrenato, hanno visto frantumarsi interi settori produttivi. Nel frattempo il mondo davanti a noi continuava ad esplodere, grazie a conflitti provocati anche da interessi Occidentali e alle ritorsioni terroristiche, grazie al frantumarsi di Stati e all’imporsi di nuovi orizzonti reazionari altrettanto catastrofici come quelli che ci governano. Oggi abbiamo un Europa fondamentalista in un contesto esterno ove altri fondamentalismi attecchiscono, anche per reazione. Non è lo “Scontro di civiltà” tanto paventato da una visione perennemente colonialista ed eurocentrica del pianeta, ma quello fra poteri diffusi, ognuno a suo modo nefasto. I risultati sono muri e frontiere. Il risultato è un bilancio da guerra di morti nel Mediterraneo, vera fossa comune, oltre 25 mila vittime in 15 anni. Vittime delle leggi e della guerra, non del fato, del mare cattivo, della nave in panne o dei biechi 14 trafficanti, quelle sono concause. E questa è una frontiera. E poi ci sono quelle frontiere sorte nei Balcani, da quando l’emergenza umanitaria siriana, per tre anni dimenticata, ha bussato alle nostre porte. Mentre i potenti si divertivano col risiko della geopolitica applicato a esseri umani in carne ed ossa: Turchia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, ergevano lentamente muri, reti di filo spinato, inutili quanto crudeli, funzionali ad ottenere risorse dai bilanci UE. E intanto si presidiava il confine fra Ventimiglia e Mentone, fra Francia e Italia, quello del Brennero, fra Italia ed Austria, a breve, molto probabilmente, fra Italia e Slovenia, quello di Calais, fra Regno Unito e Francia. Oggi – se ne parla poco – in quella che chiamano la giungla di Calais, vivono in condizioni disumane 6000 persone, ne sono morte 11 di stenti in pochi giorni a dicembre, nel silenzio assoluto. E poi i vecchi reticolati in Marocco delle enclave spagnole di Ceuta e Mililla, dove si spara a chi esce, il Mar Egeo, dove nel tentativo di scappare dalla Turchia per andare verso la Grecia sono morte nel 2015 oltre 700 persone, molti i bambini. Il 2016 si è inaugurato con altri 36 morti e anche lì molti i minori. La foto di Aylam, il bambino siriano trovato morto sulla spiaggia di Bodrum, Turchia, ha fatto male, come hanno fatto male e commosso i naufragi che sono continuati al largo della Libia, ma si dimentica facilmente. Basta erigere muri e allontanare il problema. Ma questo non basta. L’impossibilità della Grecia a fermare le persone ha portato l’UE a proporre la sospensione per due anni e per tutto il continente, delle misure di libera circolazione nello Spazio Schengen. La minaccia è rientrata dopo che la Grecia, con lo stesso ricatto con cui ha dovuto accettare il memorandum economico, ha dovuto accettare le guardie di frontiera e il personale di Frontex per fermare, controllare, cacciare. Oggi la libera circolazione sta morendo, anche con l’alibi dell’“allarme terrorismo”, e si utilizzano due strumenti a tenaglia. Da una parte le frontiere si chiudono, dal civile Nord Europa, Danimarca, Svezia, Germania, in Belgio e in Francia, dove ormai il controllo al confine riguarda tutti. Si promette di accogliere un numero limitato di richiedenti asilo ma poi prevalgono gli egoismi dei singoli Paesi, prevale il fatto che, al di là di alcuni gesti propagandistici, si vorrebbe fermare ognuno nel paese in cui è scappato. E si accettano come rifugiati solo coloro che provengono dai paesi in cui almeno il 75% dei richiedenti asilo ottiene risposta positiva, attualmente Siria, Iraq, Eritrea, Repubblica Democratica del Congo. Gli altri sono “migranti economici” e debbono tornare nel loro paese che è considerato “sicuro”. Leggiamo di quanto accade in Nigeria, Afghanistan, Pakistan, Turchia, Somalia, solo per citare alcuni esempi, ci indigniamo, ma poi lasciamo che le persone vengano deportate negli stessi luoghi in cui si muore ogni giorno. E nel frattempo ci si rimpalla le persone come fossero pacchi, fra un Paese e l’altro, usando un’altra volgare violenza, il Regolamento di Dublino che obbliga a fermarsi nel paese in cui, spesso a forza, vengono prese le impronte ai profughi. E la seconda tenaglia è quella dei soldi. Soldi da dare ai paesi terzi affinché fermino i profughi, certo per aiutarli, si dice. Il rapporto di Amnesty International sulla Turchia parla di costanti violazioni dei diritti basilari di chi è trattenuto nei centri ma nel frattempo l’UE destina 3 mld di euro alla Turchia per aiuti. Saranno utilizzati per alzare le mura delle gabbie, per riportare in patria chi non è siriano o iracheno, per imprigionare minoranze come quella kurda. La Turchia di Erdogan, quello che cita un certo Hitler come esempio di presidenzialismo, incassa e ricatta: «O ci date i soldi o noi i 2,200 mila profughi non riusciamo a “trattenerli”. E soldi ai regimi africani, in cambio della costruzione di campi per rifugiati per ora in Niger, ma poi chissà magari anche in Sudan e Mali. Il Processo di Khartoum, quello con cui si è ridata legittimità a dittatori atroci come Isaias Afawerke in Eritrea, va avanti, l’incontro che c’è stato a Malta a novembre, fra UE e Stati Africani non ha ancora prodotto i risultati sperati per l’avarizia degli Stati europei ma l’intenzione è quella di far divenire anche paesi a sud della incontrollabile Libia, campi di concentramento pagati dall’UE. argomenti addotti da Israele contro la decisione dell’Unione Europea di etichettare i prodotti delle colonie, dimostrando l’impatto devastante che il sistema delle colonie israeliane ha avuto sull’economia palestinese togliendo ai palestinesi la terra, l’acqua e altre risorse e creando una massiccia disoccupazione. Affrontano anche la condizione di quei lavoratori palestinesi – una minoranza della forza lavoro – che sono stati obbligati a guadagnarsi da vivere proprio nelle colonie che hanno danneggiato in modo così grave l’economia dei palestinesi e più in generale i loro diritti. Proseguono esaminando il passo dell’Unione Europea (UE) e suggeriscono le iniziative successive che l’UE dovrebbe prendere per rispettare pienamente le leggi internazionali ed europee1. Il contesto 1.800 milioni di Euro sono già disponibili, la stessa somma dovrebbe essere messa a disposizione come sommatoria di raccolta dai singoli Stati e quella ancora manca. Intanto si sperimentano collaborazioni con le polizie delle dittature per fermare gli arrivi delle persone. In questo orrido gioco Italia e Grecia dovranno fare una parte consistente del lavoro sporco. Avvalendosi di risorse europee e dell’Agenzia Frontex, dovranno, nel silenzio degli organismi internazionali, provvedere ai rimpatri. Il meccanismo ferruginoso è già pronto: chi arriva finirà negli hotspots, dove difficilmente potrà chiedere asilo. Una parte consistente di coloro che fuggono da Paesi non ritenuti a rischio (la richiesta di asilo dovrebbe avere carattere totalmente individuale) potrebbe essere rimpatriati. Ma dove? Nel proprio paese o in altri di transito? Cosa importa. L’importante è che non tocchino il sacro territorio europeo. Il 2016 si è aperto con la morte per freddo in Turchia, di un bambino siriano di 4 mesi, ma questo non cambia nulla, la macchina deve andare avanti. Inceppiamolo questo meccanismo infernale, con la politica, quella alta che ancora a volte riesce a farsi flebilmente sentire, quella delle città meticce dove ci si aiuta anche in emergenza e in quella sociale, dove invece di far diventare i profughi fonte di profitto per delinquenti si può provare a costruire vera alternativa. Inceppiamola con vera informazione, raccontiamo perché si fugge, da cosa si fugge, per colpa di chi e in quali reali dimensioni, raccontiamo il fallimento di una politica estera europea misera e criminale, facciamo comprendere che il pericolo è in chi ci comanda e non in chi bussa. Altrimenti si resta nel gioco delle mille frontiere, in cui, come nel Gioco dell’Oca che qualcuno forse ricorda, molto spesso tiravi i dadi, tentavi la sorte e una casella beffarda e maligna ti faceva tornare da dove eri partito. L’Europa di oggi somiglia troppo a quel tabellone. A percorrerlo non sono pedine ma persone. E si diffidi di chi dice “non mi riguarda”. In un anno oltre 100 mila cittadini italiani sono andati a cercare fortuna in altri paesi europei. Anche i vostri figli potrebbero diventare simili a quelle pedine. (fonte: Zeroviolenza) link: http://www.zeroviolenza.it/editoriali/item/73680-gabbia-europa Palestina e Israele Come le colonie israeliane soffocano l’economia palestinese (di Nur Arafeh, Samia al-Botmeh, Leila Farsakh) Israele vede le linee giuda recentemente emanate dall’Unione Europea per l’etichettatura di alcuni prodotti delle sue colonie come la punta dell’iceberg. Teme che ciò aprirà la porta a misure più dure contro la sua colonizzazione illegale e sta mettendo in campo le forze filo-israeliane in Europa e negli Stati Uniti. Uno degli argomenti continuamente ripetuti è che l’etichettatura danneggia i lavoratori palestinesi. In questo documento la responsabile politica di Al-Shabaka Nur Arafeh e le consulenti politiche Samia al-Botmeh e Leila Farsakh sfatano gli 15 Ci sono voluti anni all’Unione Europea per sviluppare la sua posizione sull’etichettatura dei prodotti delle colonie che Israele ha costruito sui territori palestinesi e siriani [le Alture del Golan. Ndtr.] fin da quando li ha occupati nel 1967. La Commissione Europea ha emanato una decisione nel 1998 in cui si sospettava che Israele stesse violando l’accordo di associazione con l’UE, firmato nel 1995 e entrato in vigore nel 2000, che esentava i prodotti israeliani dal pagamento di dazi doganali. Nel 2010 la Corte Europea di Giustizia ha confermato che i prodotti provenienti dalla Cisgiordania non beneficiavano del trattamento doganale preferenziale in base all’accordo di associazione dell’UE con Israele e che le affermazioni delle autorità israeliane non erano vincolanti per le autorità doganali dell’UE. Tuttavia è stato solo nel 2015 che l’UE ha preso la decisione a lungo attesa di adeguare le proprie azioni alle sue stesse regole, in parte come risposta alla crescente pressione da parte della società civile perché riconoscesse l’illegalità delle colonie. Il 10 settembre il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che chiede l’etichettatura dei beni delle colonie israeliane in quanto prodotti negli “insediamenti israeliani” piuttosto che in “Israele” e che garantisce che non beneficino del trattamento preferenziale sugli scambi in base al Trattato di Associazione tra l’Ue ed Israele. Due mesi dopo, l’11 novembre, l’UE ha emanato le linee guida attese da molto tempo riguardo all’etichettatura, che ha definito in un linguaggio molto discreto come una “Comunicazione Interpretativa”. Tuttavia i prodotti delle colonie saranno ancora commerciati con l’Unione Europea (EU), lasciando ai consumatori la “decisione informata” se comprare o meno questi prodotti. Israele sostiene che l’iniziativa dell’UE è “discriminatoria” e che è dannosa per l’economia palestinese in generale e per i lavoratori palestinesi in particolare. E’ chiaramente un tentativo da parte di Israele di distogliere l’attenzione internazionale dalla realtà dell’illegale colonizzazione israeliana, dei suoi effetti profondamente negativi per l’economia palestinese e degli obblighi morali e giuridici dell’UE. In effetti, l’intera colonizzazione da parte di Israele è illegale in base al diritto internazionale, come riconfermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel suo “Parere consultivo” del 2004 sul Muro di Separazione costruito da Israele. Il trasferimento da parte di Israele della sua popolazione nei territori occupati è una violazione della Convenzione dell’Aja del 1907 e della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949. Lo sfruttamento economico dei Territori Palestinesi Occupati da parte delle colonie Il presente rapporto riguarda i territori occupati da Israele nel 1967 – la Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, la Striscia di Gaza e le Alture del Golan, e più specificamente le colonie israeliane e gli avamposti costruiti nei Territori Palestinesi Occupati (TPO)2. Non affronta tutte le violazioni delle leggi internazionali e dei diritti dei palestinesi da parte di Israele. Il fatto che la costruzione delle colonie israeliane si sia basata sullo sfruttamento economico dei TPO è stato ampiamente documentato. Ciò ha incluso la confisca di ampie zone di terra palestinese e la distruzione di proprietà palestinesi per utilizzarle a scopi edilizi ed agricoli; la confisca di risorse idriche, al punto che 599.901 coloni utilizzano sei volte più acqua che tutta la popolazione palestinese della Cisgiordania, composta da 2.86 milioni di abitanti; l’appropriazione di luoghi turistici e archeologici; lo sfruttamento di cave, miniere, risorse del Mar Morto e di altre risorse naturali non rinnovabili dei palestinesi, come sarà argomentato in seguito. Le colonie sono anche state agevolate da un sistema infrastrutturale di strade, di checkpoint e dal Muro di Separazione, portando alla creazione di bantustan isolati in Cisgiordania e all’appropriazione di altra terra palestinese. In conseguenza di ciò attualmente le colonie israeliane controllano circa il 42% della terra della Cisgiordania. Questo dato comprende aree edificate così come i confini municipali delle colonie israeliane. Questi confini attualmente comprendono un’area 9,4 volte più ampia di quelle edificate nelle colonie della Cisgiordania e sono proibiti ai palestinesi che non hanno un permesso per accedervi. La maggioranza delle colonie della Cisgiordania sono costruite nell’Area C, che rappresenta il 60% della Cisgiordania e che è molto ricca di risorse naturali3. Secondo uno studio della Banca Mondiale, il 68% dell’Area C è stato destinato alle colonie israeliane, mentre meno dell’1% è stato concesso all’utilizzo da parte dei palestinesi. Gerusalemme creati da Israele dopo l’inizio dell’occupazione, nel 1967. Un’economia palestinese strangolata dalle colonie La colonizzazione illegale da parte di Israele ha avuto decisamente un effetto profondamente negativo sull’economia palestinese. Il controllo israeliano su acqua e terra ha contribuito a ridurre la produttività del lavoro del settore agricolo ed il suo contributo al PIL: l’apporto di agricoltura, settore forestale e della pesca è sceso dal 13,3% del 1994 al 4,7% nel 2012, ai prezzi attuali. Lo sversamento di rifiuti solidi e liquidi dalle zone industriali delle colonie nei TPO ha ulteriormente inquinato l’ambiente, la terra e l’acqua dei palestinesi. L’accesso limitato alle cospicue risorse del Mar Morto ha impedito ai palestinesi di sviluppare il settore dei cosmetici e altre industrie, basate sull’estrazione di minerali. Uno studio della Banca Mondiale stima che se non ci fossero state restrizioni alla disponibilità di queste risorse, la produzione e la vendita di magnesio, potassio e bromo avrebbe comportato un valore annuo di 918 milioni di dollari [circa 844 milioni di euro. Ndtr.] per l’economia palestinese, l’equivalente del 9% del PIL nel 2011. All’interno dell’Area C lo sfruttamento da parte delle colonie israeliane è concentrato nella Valle del Giordano e nella parte settentrionale del Mar Morto. Le colonie israeliane controllano l’85,2% di queste zone, che sono le terre più fertili della Cisgiordania. L’abbondante disponibilità di acqua e il clima favorevole forniscono le migliori condizioni per l’agricoltura. Di conseguenza producono il 40% delle esportazioni di datteri da Israele. Nel contempo i palestinesi hanno il divieto di vivere lì, costruire o persino pascolare il loro bestiame con il pretesto che si tratta di “terre statali”, di ” zona militare” oppure di “riserve naturali”. Le drastiche limitazioni nell’accesso alle miniere e alle cave nell’Area C ha anche ostacolato la possibilità per i palestinesi di estrarre ghiaia e pietre. Il valore lordo annuo stimato come perdita per l’economia palestinese per l’estrazione da cave e miniere è di 575 milioni di dollari [circa 529 milioni di euro. Ndtr.]. In totale, si stima che le limitazioni all’accesso ed alla produzione nell’Area C sono costate all’economia palestinese 3.4 miliardi di dollari [più di 3.1 miliardi di euro Ndtr.]. Come esaminato in un precedente documento di Al-Shabaka, Israele controlla persino l’accesso dei palestinesi al loro stesso campo elettromagnetico – una politica a cui contribuiscono le colonie – creando perdite tra gli 80 ed i 100 milioni di dollari annui [dai 73 ai 92 milioni di euro. Ndtr.] per gli operatori palestinesi delle telecomunicazioni. Israele ricorre anche ad altri metodi per espellere i palestinesi dalle loro terre, distruggendo le case, proibendo la costruzione di scuole e ospedali e negando ai residenti l’accesso a servizi essenziali come l’elettricità, l’acqua e l’escavazione di pozzi. Al contrario, molte colonie sono definite “aree di priorità nazionale”, permettendo loro di ricevere incentivi finanziari dal governo israeliano nei settori dell’educazione, della salute, dell’edilizia, dello sviluppo industriale ed agricolo4. Inoltre l’assenza di contiguità territoriale all’interno della Cisgiordania, unita ad altre restrizioni israeliane al movimento ed all’accesso, ha frammentato la sua economia in piccoli mercati non connessi tra loro. Ciò ha incrementato i tempi ed i costi di trasporto delle merci da una zona della Cisgiordania ad un’altra e dalla Cisgiordania al resto del mondo. In seguito a ciò, la competitività dei prodotti palestinesi sui mercati locali e internazionali è stata indebolita. I proventi israeliani derivanti dallo sfruttamento della terra palestinese e delle risorse della Valle del Giordano e dell’area settentrionale del Mar Morto sono stimati attorno ai 500 milioni di shekel all’anno (circa 118 milioni di euro). Per avere un’idea dell’impatto sull’economia palestinese, vale la pena di notare che i costi indiretti delle restrizioni imposte da Israele all’accesso palestinese all’acqua nella Valle del Giordano – e di conseguenza l’impossibilità di coltivare la loro terra – erano pari a 663 milioni di dollari [circa 616 milioni di euro. Ndtr.], l’equivalente dell’8,2% del prodotto interno lordo palestinese nel 2010. Oltretutto, poiché l’economia in Cisgiordania è stata viziata dall’imprevedibilità e dall’incertezza – il che non è sorprendente, in quanto l’area è sottoposta a un’occupazione militare – il costo ed i rischi di fare impresa sono aumentati. Ciò ha peggiorato il clima per gli investimenti, limitato lo sviluppo economico e aumentato la disoccupazione e la povertà. Nel complesso si stima che il costo diretto ed indiretto dell’occupazione sia stato di circa 7 miliardi di dollari [6,4 miliardi di euro. Ndtr] nel 2010 – circa l’85% del PIL palestinese stimato5. Nel frattempo Israele continua a costruire nuove colonie. Netanyahu, durante il suo discorso all’US Center for American Progress [organizzazione liberal vicina ai Clinton e ad Obama. Ndtr.] in novembre, ha sostenuto che nessuna nuova colonia è stata edificata negli ultimi vent’anni. Di fatto 20 colonie israeliane sono state approvate durante i suoi mandati, tre delle quali erano avamposti illegali che sono state successivamente regolarizzate dal governo. Spossessati: i lavoratori palestinesi nelle colonie israeliane La manifestazione più recente della politica di colonizzazione israeliana è la ripresa della costruzione del Muro di Separazione nei pressi di Beit Jala in Cisgiordania, che di fatto separa gli abitanti del villaggio dalle terre coltivate di loro proprietà nella valle di Cremisan. Il percorso di questo tratto di Muro è stato disegnato per permettere l’annessione della colonia di Har Gilo, a sud di Gerusalemme, mettendola in collegamento con la colonia di Gilo, che si trova all’interno dei confini del Comune di 16 L’economia palestinese è stata quindi colpita da fragilità strutturali e settoriali che sono principalmente dovute all’occupazione israeliana e alla colonizzazione. L’espropriazione di terra, acqua e risorse naturali da parte delle colonie e il controllo restrittivo di Israele sui movimenti, l’accessibilità e altre libertà ha indebolito la base produttiva dell’economia, che non è più in grado di generare occupazione e investimenti sufficienti ed è sempre più dipendente dall’economia israeliana e dagli aiuti dall’estero. Questa dura realtà economica è il fattore principale che porta alcuni palestinesi a lavorare nelle colonie israeliane – si stima che siano state solo il 3,2% del totale degli occupati della Cisgiordania nel terzo quadrimestre del 20156. Invece di essere auto-sufficienti proprietari dei mezzi di produzione, i palestinesi sono stati spossessati delle loro risorse economiche e dei loro diritti dall’occupazione militare e dalle colonie israeliane e sono stati trasformati in manodopera a basso costo. Infatti la maggior parte dei lavoratori palestinesi nelle colonie è impiegata in lavoro di bassa qualifica e retribuzione: almeno la metà di loro è utilizzata nel settore edile. Ciò significa che meno del 2% del totale della popolazione palestinese occupata sarebbe colpita nel caso di chiusura delle industrie israeliane nelle colonie. I lavoratori palestinesi nelle colonie sono sottoposti a condizioni di lavoro difficili e a volte pericolose, e si stima che il 93% di loro non abbia un sindacato che li rappresenti. Di conseguenza sono soggetti a licenziamenti arbitrari ed alla revoca del permesso di lavoro se rivendicano i propri diritti o cercano di sindacalizzarsi. Una ricerca del 2011 ha scoperto che la maggioranza dei lavoratori palestinesi avrebbe lasciato il proprio lavoro nelle colonie se avesse trovato un’alternativa nel mercato del lavoro palestinese. Mentre si sostiene che i lavoratori palestinesi nelle colonie ricevono un salario superiore a quello del mercato del lavoro palestinese, è il caso di notare che sono pagati in media meno della metà del salario minimo israeliano. Ad esempio a Beqa’ot, una colonia israeliana nella Valle del Giordano, i palestinesi sono pagati il 35% del salario minimo legale. E’ da notare che gli impianti di impacchettamento della Mehadrin, il più grande esportatore israeliano di frutta e verdura nell’UE, si trovano in questa colonia. In breve, è proprio il colonialismo di insediamento israeliano che nuoce ai palestinesi, molto più che l’etichettatura da parte dell’UE dei prodotti delle colonie. Quello di cui i palestinesi hanno bisogno non è più lavoro nelle colonie o più dipendenza dall’economia israeliana. Piuttosto quello di cui i palestinesi hanno bisogno è lo smantellamento delle colonie israeliane, la fine dell’occupazione e la piena realizzazione dei loro diritti in base alle leggi internazionali. Solo allora potranno realmente migliorare la base produttiva dell’economia palestinese, generare opportunità di lavoro, garantirsi autonomia e auto-sufficienza e smettere di essere dipendenti dagli aiuti internazionali. La distanza tra la retorica dell’UE e le sue azioni E’ contro questo contesto che il ruolo dell’UE nei riguardi delle colonie israeliane deve essere messo in discussione. L’UE riconosce che le colonie israeliane costruite nei TPO sono illegali. La sua “Comunicazione Interpretativa” stabilisce chiaramente che l’UE, “in linea con le leggi internazionali, non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati da Israele dal giugno 1967.” Tuttavia l’UE continua ad importare beni dalle colonie israeliane (soprattutto frutta e verdura fresche coltivate nella Valle del Giordano) per un valore annuo stimato in 300 milioni di dollari [276 milioni di euro. Ndtr.]. E’ più di 17 volte il valore medio annuale dei prodotti esportati dai TPO nell’UE tra il 2004 e il 2014. Nonostante la “Comunicazione Interpretativa”, rimane una grande discrepanza tra i discorsi dell’UE e le sue azioni, e la “Comunicazione” è insufficiente per adempiere agli obblighi legali dell’UE per varie ragioni. In primo luogo, non tutti i prodotti provenienti dalle colonie israeliane devono essere etichettati. Solo la frutta fresca e le verdure, il pollame, l’olio d’oliva, il miele, l’olio, le uova, il vino, i cosmetici e i prodotti organici sono soggetti all’indicazione obbligatoria dell’origine. Cibi preconfezionati e prodotti industriali che non siano cosmetici sono soggetti solo all’indicazione volontaria dell’origine. In più le imprese israeliane che operano nelle colonie possono facilmente aggirare l’etichettatura dei loro prodotti. Ad esempio, possono mettere insieme beni prodotti nelle colonie con altri prodotti in Israele per evitare che siano etichettati come “prodotti nelle colonie”. Possono utilizzare l’indirizzo di un ufficio all’interno dei confini di Israele internazionalmente riconosciuti come l’indirizzo ufficiale dell’impresa 17 piuttosto che l’effettivo luogo di produzione. L’UE dovrebbe anche rilevare il fatto che le imprese che etichettano i propri prodotti come provenienti dalle colonie possono ricevere delle compensazioni dal governo israeliano per le eventuali perdite. Si stima che il bilancio dello Stato abbia destinato circa 2 milioni di dollari [1,8 milioni di euro. Ndtr.] ogni anno negli ultimi 10 anni per compensare le imprese israeliane delle colonie per le perdite cui devono far fronte a causa della fine del trattamento doganale di favore e di altre agevolazioni. Nel contempo le stesse linee guida per l’etichettatura sono un’arma spuntata, in quanto “l’applicazione delle attuali disposizioni ricade sotto la responsabilità principale degli Stati membri”, come stabilisce la “Comunicazione Interpretativa” dell’UE. Cosa ancora più importante, limitandosi ad etichettare i prodotti provenienti dalle colonie e mantenendo al contempo relazioni commerciali e investimenti con queste ultime, l’UE sta in realtà continuando a finanziare l’espansione degli insediamenti ed a perpetuare l’occupazione israeliana, lo sfruttamento delle risorse naturali e l’appropriazione delle terre palestinesi – una situazione illegale che l’UE sostiene di non “riconoscere”. Inoltre, in chiara opposizione con quanto sostiene, l’UE intraprende progetti con imprese israeliane che sono profondamente coinvolte nelle colonie e nell’occupazione. Per esempio, l’UE ha approvato 205 progetti con la partecipazione israeliana a “Horizon 2020”, il più vasto programma di ricerca e innovazione dell’UE. Le imprese israeliane che vi partecipano comprendono Elbit, che è direttamente coinvolta nella costruzione degli insediamenti e del Muro; le Israel Aerospace Industries [industrie aerospaziali israeliane], che forniscono i macchinari necessari per la costruzione del Muro; l’università Technion, che lavora con il complesso militare israeliano. Banche europee sono anche legate a banche israeliane che forniscono mutui ipotecari ai coloni, finanziano le autorità israeliane nelle colonie e nella costruzione di insediamenti che godono del sostegno da parte dello Stato e altre attività economiche che promuovono la colonizzazione. Pertanto la “Comunicazione Interpretativa” dell’UE sembra essere principalmente un atto simbolico, attraverso il quale [l’UE] risponde solo formalmente alla crescente richiesta della società civile europea, sempre più favorevole al movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) guidato dai palestinesi, che vuole che essa rispetti i propri regolamenti e che Israele sia chiamato a rendere conto delle proprie azioni. In base alle leggi internazionali gli Stati terzi sono obbligati a non riconoscere come lecita una situazione illegale, a non fornire alcun tipo di assistenza per mantenere una situazione illegale e a collaborare per garantire che Israele rispetti le leggi umanitarie internazionali. In altre parole, l’UE e i suoi Stati membri dovrebbero fare quanto possibile per porre fine alla colonizzazione da parte di Israele. Come l’UE potrebbe rispettare meglio la legge L’UE dovrebbe iniziare a trasformare le sue parole in misure concrete per rendere Israele responsabile, istituendo un blocco totale su ogni attività economica, finanziaria, commerciale e di investimenti diretta o indiretta con le colonie israeliane, seguendo le orme di Copenhagen, Reykjavik e recentemente Amsterdam. Come raccomandato poco tempo fa in un rapporto del Consiglio Europeo delle Relazioni Estere [centro studi paneuropeo, i cui membri sono ex-ministri degli esteri, imprenditori, intellettuali ed attivisti, il cui scopo è promuovere il dibattito e favorire una politica estera efficace fondata sui valori europei. Ndtr.], dovrebbe anche sospendere le relazioni finanziarie con le banche israeliane, soprattutto quelle che finanziano l’occupazione e la costruzione delle colonie. In più, da parte loro gli Stati membri dell’UE dovrebbero cessare ogni relazione con le colonie israeliane. Va qui osservato che l’UE è il principale partner commerciale di Israele, con scambi totali attorno ai 30 miliardi di euro nel 2014, che rappresentano circa il 33% del totale delle esportazioni israeliane di beni e servizi nel 20147. Il commercio dell’UE con le colonie israeliane rappresenta meno dell’1% del commercio dell’UE con Israele. Una iniziativa seria da parte dell’UE avrebbe un impatto consistente sulla colonizzazione israeliana e sulla prolungata occupazione militare. Oltre a passare dall’etichettatura dei prodotti delle colonie a porre fine ad ogni relazione con gli insediamenti israeliani, i Paesi europei dovrebbero prendere in considerazione un embargo di tutti i prodotti israeliani. Fin da quando l’UE ha riconosciuto che il controllo di Israele sui TPO è una situazione di occupazione – un’occupazione militare che dura da circa 50 anni – avrebbe dovuto affrontare le cause profonde dell’occupazione, cioè la politica del governo israeliano, piuttosto che solo il suo effetto, ossia le colonie. Per esempio, nel caso dell’apartheid in Sud Africa, un boicottaggio concentrato solo sugli affari che riguardavano le township non avrebbe avuto un grande effetto sul sistema di apartheid. Allo stesso modo, boicottare solo i prodotti degli insediamenti israeliani avrebbe un impatto molto minore che boicottare il sistema concreto che sta organizzando la colonizzazione dei territori per fare pressione su Israele perché ponga fine all’occupazione. Per questo è importante vietare ogni prodotto israeliano e non solo quelli delle colonie. Un simile passo prenderebbe di mira, tra le altre cose, l’inganno israeliano riguardo all’origine dei prodotti e delle materie prime che provengono dagli insediamenti. E’ difficile controllare, a meno che siano realmente boicottate le imprese e non solo i loro beni e servizi. In effetti molte delle imprese che lavorano nelle colonie provengono da Israele piuttosto che dai territori del 1967. Gli appelli per un boicottaggio totale stanno aumentando e trovando adesioni in luoghi imprevisti. Per esempio, due docenti universitari statunitensi hanno recentemente sostenuto in un editoriale sul ” Washington Post” che boicottare solo i prodotti delle colonie “non avrebbe un impatto sufficiente”. Hanno invece proposto “un ritiro dell’aiuto e del supporto diplomatico USA e il boicottaggio e il disinvestimento dall’economia israeliana” per modificare i piani strategici di Israele. Per la Palestina, un simile divieto aiuterebbe a proteggere i prodotti palestinesi, aumenterebbe la loro competitività e aiuterebbe in futuro a rafforzare la capacità dell’economia palestinese di integrarsi con quella internazionale, una volta che la libertà sia garantita. Il boicottaggio di tutti i prodotti ed i servizi israeliani sarebbe un modo efficace per dare la possibilità ai palestinesi di sconfiggere il colonialismo israeliano. Ciò sarebbe molto più efficace che fornire assistenza per lo sviluppo a settori specifici e risponderebbe direttamente alla richiesta del popolo palestinese di libertà e diritti umani. Note: Le autrici ringraziano l’ufficio Palestina/Giordania della fondazione Heinrich-Böll per la cooperazione e la collaborazione con Al-Shabaka in Palestina. Le opinioni espresse in questo articolo sono responsabilità delle autrici e non riflettono necessariamente l’opinione della fondazione Heinrich-Böll. Gli avamposti delle colonie sono costruiti senza l’autorizzazione ufficiale del governo israeliano. Tuttavia ricevono supporto finanziario da ministeri, agenzie governative, fondazioni locali ed internazionali e da privati (soprattutto dagli USA). Spesso Israele dopo un certo lasso di tempo li “legalizza”. In base agli accordi di Oslo, la Cisgiordania è stata divisa provvisoriamente in Area A, che dovrebbe essere sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese ma è sottoposta a frequenti incursioni militari israeliane, Area B, sotto controllo condiviso di israeliani e palestinesi, ed Area C, sotto controllo esclusivo di Israele. Questo periodo provvisorio è scaduto nel maggio 1999. Per maggiori informazioni vedi “Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements.” [“Vendere la pace: come l’Europa 18 aiuta a sostenere le illegali colonie israeliane “] I costi diretti sono i costi supplementari sostenuti dai palestinesi in conseguenza delle restrizioni imposte dagli israeliani all’accesso ed al movimento, compresi i maggiori costi dell’acqua e dell’elettricità. I costi indiretti sono le perdite di entrate provenienti dalla produzione che i palestinesi avrebbero potuto fare se non ci fossero state queste limitazioni da parte israeliana. Un esempio di costi indiretti è rappresentato dal valore aggiunto dell’estrazione delle risorse del Mar Morto. In base all’inchiesta sulla forza lavoro realizzata nel novembre 2015 dal PCBS [Palestinian Central Bureau of Statistics, istituzione ufficiale del governo palestinese. Ndtr.], nel periodo luglio-settembre 2015 il numero di lavoratori palestinesi nelle colonie israeliane in Cisgiordania era di 22.100, su un totale di 674.900 lavoratori in Cisgiordania. Da confrontare con il commercio dell’UE con i TPO, che nel 2014 è stato di circa 154 milioni di euro. Nur Arafeh, Samia al-Botmeh, Leila Farsakh fanno parte di Al-Shabaka, un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro la cui missione è quella di educare e stimolare il dibattito pubblico sui diritti umani palestinesi e l’autodeterminazione nel quadro del diritto internazionale. Originale in Al-Shabaka, 15 dicembre 2015, traduzione di Amedeo Rossi (fonte: Centro Studi Sereno Regis) link: http://serenoregis.org/2015/12/28/come-le-colonie-israeliane-soffocanoleconomia-palestinese/
Scarica