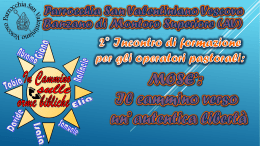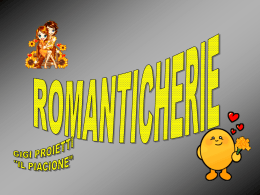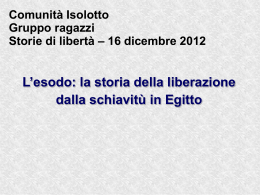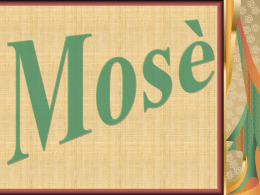Giorgio Tavani SPIGOLARE tra i testi biblici (Dispensa ad uso esclusivo interno per Unitre Sesto Calende) “Molti problemi dell’anima moderna possono essere risolti dalle soluzioni proposte dalle religioni. La saggezza delle fedi religiose appartiene all’umanità, anche ai più razionali di noi e merita di essere assimilata, seppure con giudizio, perfino dai più grandi nemici del sovrannaturale”. (A. de Botton: “Del buon uso della religione”) Francamente non credo che essere credenti sia il requisito necessario per accostarsi ai Testi della Bibbia. Sono invece convinto che anche un non credente possa trovare spunti e ammaestramenti dalla loro lettura. Il valore etico di quei libri va oltre la condizione della fede. g.t. 2 PRESENTAZIONE La mia professione ha impegnato gran parte del mio tempo in questioni avulse dallo studio, dall’interesse, che pure ho sempre nutrito fin dagli anni dell’università, verso argomenti biblici. La lettura e la riflessione sui libri sacri ha quindi avuto carattere di marginalità, è sempre stata qualcosa di cui mi sono occupato, almeno fino alla pensione, necessariamente dopo altri impegni e in qualche modo sulla scia di altre persone, che, a differenza di me, a tali temi hanno dedicato gran parte del loro tempo, delle loro energie, della loro intelligenza e passione, quando non tutta la loro vita. Marginalità e secondarietà fanno così del mio studio qualcosa di simile all’attività dello spigolare, dell’andare qui e là in un campo, da altri prima di me mietuto. Da altri che, davanti a me, hanno raccolto a piene mani. Il mio, invece, è stato un prendere dove ho trovato, uno spostarmi, spesso a caso, da un lato all’altro del terreno, in tempi diversi, per trovare qualche spiga non vista, qualcosa di trascurato, un resto. La Bibbia ci offre un’infinità di significati, così ho cercato, talvolta trovato, l’ennesimo senso, quello forse meno importante, ma, chissà, un po’ più nascosto di altri e che mi sembrava uno spreco lasciare dov’era. Le mie riflessioni sono un “inoltre”, un’aggiunta ad altre. Sono sparse come spighe rimaste sul campo dopo la trebbiatura; sono pensieri balenati nella mente sull’onda di un’emozione suscitata, di un ricordo, un’esperienza di vita, o di una lettura più esperta potuta fare in precedenza. Lo sguardo con cui guardare ad essi non è necessariamente quello del credente: per coloro che hanno già maturato un cammino di fede tutto ciò potrà, così spero, essere solo motivo di riflessione e di arricchimento; chi non ce l'ha, ha ancora dubbi, è 'in cammino’, o semplicemente nutre interesse per tali argomenti, mi auguro possa trovare elementi nuovi di comprensione. In Appendice ho invece riportato un intervento da me fatto in sede universitaria nel corso della cerimonia di Proclamazione del master di secondo livello in Finanza per lo Sviluppo presso l’Università di Parma nell’A.A. 2008-2009, del cui corpo docente ero parte. Voleva essere un modo per far capire come l’insegnamento biblico, trattato laicamente, potesse avere piena cittadinanza anche nel mondo accademico. L’iniziale sgomento che indovinavo nell’espressione del viso del Preside che mi ascoltava si trasformò, alla fine del mio intervento, in sincero apprezzamento e ciò, ricordo, mi fece finalmente tornare a respirare bene…. g.t. 3 SU UNA GAMBA SOLA “.. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore” Lv 19, 18 Si racconta che un giorno al grande rabbino Hillel il Vecchio (vissuto dal 70 AC al 9 DC, quindi più o meno contemporaneo di Gesù,) un suo discepolo si rivolgesse con questa domanda: “Maestro (rabbì), spiegami tutta la Legge ed i Profeti stando su una gamba sola”. Hillel ci pensò un attimo e poi gli rispose: “Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te; tutto il resto è commento. Va’ e studia!” Cosa chiedeva in realtà quel discepolo? Cosa gli ha risposto in realtà il grande maestro? Quel discepolo poteva avere fretta, o non sentirsi all’altezza degli altri, pur volendo seguire le indicazioni del suo maestro. Voleva forse ricevere delle idee forti, delle frasi ad effetto, qualcosa da farsi venire in mente alla bisogna, un qualche slogan – diremmo oggi - da dire a se stesso o ripetere a qualcun altro al momento giusto, una condotta alla quale conformarsi. Per il resto si sarebbe fidato ciecamente del maestro, più o meno come si fa quando si va dal medico, il quale ci prescrive una terapia, dei comportamenti da tenere; cosa ci sia dietro, i trattati di medicina, l’esperienza del medico stesso e tutto quanto d’altro, poco importa, purchè “funzioni”. Ecco perchè “su una gamba sola”. Provate un po’ a fare un discorso reggendo tutto il vostro peso su di una sola gamba… dovrete essere molto sintetici! Hillel cosa risponde, mentre gli risponde in quel modo? Gli dice, intanto, tre cose: 1. Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Per facilitare la comprensione di questa frase basta togliere i “non” e il senso della frase è del tutto simile a quello di Levitico cap. 19, 18 “ama il prossimo tuo come te stesso”. (di quel versetto, occorre precisare che vi sono traduzioni che lo rendono “desidera per il tuo prossimo quello che desideri per te”). Hillel lo mette come sintesi, come essenza di tutti i testi sacri (Gesù farà, poco dopo di lui, la stessa cosa). Ma per evitare che diventi uno sterile e vuoto slogan aggiunge: 2. Tutto il resto è commento. Cos’è “il resto?” E’ nientemeno che tutto il corpo della Torah (che si traduce comunemente come “Legge”, ma in ebraico sta allo stesso modo come “Insegnamento” e corrisponde al Pentateuco) e degli altri libri che compongono quello che noi chiamiamo l’”Antico, o Primo, Testamento”. Quindi, secondo Hillel, le Sacre Scritture sono tutte a commento di quella sola idea forza. Infine aggiunge: 3. Va’ e studia! Studia cosa? Il commento! E cioè tutto quanto, senza tralasciare nulla. Eh sì, perchè i Testi Sacri non sono come un trattato di medicina, riservati a pochi studiosi, agli specialisti del ramo. I Testi sono per tutti, alla portata di tutti, offrono significati per chiunque si voglia approcciare a loro con sincerità di mente e semplicità di cuore. Il Signore dell’Universo è per tutti e non per pochi. Non ci sono scuse per evitarli come quel discepolo forse pigro o forse troppo indaffarato. Ci piace pensare che Hillel abbia voluto anche sottrarsi al ruolo di dispensatore di frasi ad effetto e di leader carismatico, di quelli a cui ci si rivolge per ascoltarli, prendere qualche veloce appunto delle belle frasi che possono dire, fare proprie soltanto quelle, mandarle a memoria lasciando a lui il compito di studiare “il resto” e fidandoci delle sue interpretazioni e delle sintesi che dispensa agli altri in occasione di incontri o attraverso opuscoli, libri, intermediari adoranti e ossequiosi e cose simili. 4 Hillel ha forse voluto proteggere il suo discepolo dal pericolo di farsi guidare passivamente da altri, alla tentazione di delegare ad altri l’uso della sua intelligenza e il suo rapporto personale con il suo Dio. Ha voluto, per quel che poteva, impedire che si facesse di una Fede, di una religione, un’ideologia. Ha voluto salvaguardare la responsabilità personale che ciascuno deve sentire verso se stesso, verso gli altri e verso Dio. Ha voluto essere, lui sì, un vero leader, ma soprattutto ha voluto essere quel che era, cioè un Maestro! Così Gesù, Rabbino, cioè Maestro a sua volta, voleva che i suoi discepoli credessero ed agissero, che aderissero alle Sacre Scritture in forza della libertà delle loro menti e dei loro cuori e non seguendo dottrine o santoni. Che facessero, quindi, quel che andava fatto e non quello che si era sempre fatto. 5 SEGNO DI PACE “…allora l’equità abiterà nel deserto e la giustizia avrà la sua dimora nel frutteto. Il frutto della giustizia sarà la pace e l’effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre…” Isaia 32, 16-18 Cosa ci auguriamo veramente quando durante la Messa ci scambiamo un segno di pace e recitiamo la formula “la pace sia con te”? da cosa deriva quella frase, cosa significa davvero? Ancora oggi l’ebreo cortese saluta chi incontra con uno “Shalom allècha”, che sta per “la pace sia su di te”, dando l’idea di qualcosa che scende dall’Alto e tutto pervade. Usualmente traduciamo Shalom con pace, il più delle volte intendendo con tale termine l’assenza di conflitto, di tribolazione. Shalom però significa qualcosa di molto più impegnativo. Alla radice quella parola sta il concetto di riempimento, completamento, benessere. Il versetto di Isaia sopra citato ne fornisce una sintesi esauriente e vi ricomprende l’equità, la giustizia, la tranquillità e la sicurezza. Possiamo trovare delle condizioni di pace interiore, dove una persona “si sente” in pace, ha già dentro di sé tutto quanto quel concetto di pace comprende. Si sente in pace con se stessa e con gli altri. Tuttavia questo non la mette al riparo dalla necessità di doversi confrontare con l’altro e tale confronto può essere sui fatti, le cose da fare, oppure sui valori, cioè sulle ragioni di fondo per le quali ciascuno si attiva in un senso piuttosto che in un altro. …E talvolta ci si scontra. Ma quando ci si scontra per davvero? Quando si può parlare propriamente di conflitto? Non quando le divergenze siano sui fatti, sulle strade da intraprendere, sul “cosa” fare. In tali casi se tra le parti vi è intelligenza e buona fede, fiducia reciproca e onestà intellettuale, prima o poi una soluzione, una sintesi si trova. Sarà una soluzione di quelle che appagano entrambi, dove a ciascuno viene riconosciuto il proprio apporto. Sarà una soluzione che unisce, cementa, trasforma un rapporto, spesso lo rende più forte. Il prerequisito perchè ciò accada è che il confronto, avvenendo sui fatti, sia sostenuto da un impianto di regole e di valori comuni e condivisi. Invece il conflitto vero, lacerante, quello che, anziché sommare, sottrae, è quello solo apparentemente basato sul da farsi, ma in realtà attraverso ciò maschera la sua vera natura che invece riguarda divergenze non sui fatti, ma sui valori e sulle regole, sui principi di fondo ed anche sul modo di intendere il rapporto con l’altro contendente. Conflitto, questo, non causato dal “cosa” fare, quanto piuttosto dal “perchè” fare o non fare quella cosa, dai principi che stanno alla base della nostra azione. Far emergere la vera natura di tale conflitto è salutare in ogni caso, poiché fa chiarezza, rende evidenti le differenze, mette in condizione di capire l’altro e di farsi capire e, anche se la conseguenza può essere una separazione, un’impossibilità di raggiungere un’intesa, le parti escono entrambe a testa alta, con dignità e riconoscimento reciproci delle rispettive diversità valoriali. Talvolta si teme il conflitto e si cerca in tutti i modi di evitarlo poiché si prevede che provocherà tribolazione, qualche incomprensione; viene alle volte considerato un’espressione di malanimo se non di odio. Shalom, quindi, include idealmente anche l’idea di assenza di controversie, di conflitti, ma, si badi bene, non espressamente anche l’idea di amore, benché quest’ultimo in un contesto di pace ne sia un derivato. L’opposto di guerra, infatti, è pace e non amore; l’opposto di amore, invece, più propriamente è odio. La situazione ideale è quella in cui vi siano tanto la pace quanto 6 l’amore tra gli esseri umani. Parliamo però per lo più di una speranza, molto più che di una realtà constatabile e duratura. Non in questo mondo almeno. Non ora. Invece guerra e amore non sono necessariamente antitetici e così scopriamo di poter essere in guerra senza per questo odiarci, anzi magari amandoci o proprio perchè ci amiamo! Il conflitto tra esseri umani è fisiologico e ricorrente. Patologico è non vederlo o peggio fingere di non riconoscerlo, cercando di affrontarlo, di risolverlo. In tal modo viene sostituito con l’inerzia, con un tirare avanti defatigante, distruttivo, logorante; nelle migliori ipotesi con un “vogliamoci bene” che non risolve nulla e stratifica ambiguità, nella quale il male, avrà prima o poi il sopravvento. Assistiamo, o partecipiamo, a situazioni, nelle famiglie, tra colleghi, tra vicini di casa, nelle quali vi sono “tregue armate”, al più qualche scaramuccia, mai un confronto vero. Il conflitto costruttivo, comunque finisca, chiama e crea energia; l’inerzia, l’inedia, l’evitazione, la disperdono, la consumano. Ricordiamoci anche di questo ogni volta che a Messa stringiamo una mano in segno di pace. 7 L’EFOD “…Farai vesti sacre per tuo fratello Aharon, come splendido ornamento. Tu parlerai a tutti gli artigiani, che ho riempito di spirito di saggezza, e faranno le vesti di Aharon per la sua consacrazione e per l'esercizio del sacerdozio…” Es. 28, 2 – 29 “…Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: questi, all’esterno, sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume...” Mt, 23, 27 La lettura congiunta di questi due brani può disorientare. Vi sono infatti affermazioni che stridono con quanto tutti noi comunemente sappiamo. Sorge subito una perplessità derivante da una nota affermazione di Gesù che successivamente, nel passo di Matteo qui sopra citato, pare essere smentita. Gesù dice infatti al cap. 5, 18 dello stesso Vangelo di Matteo, che “non passerà nemmeno uno iota o un apice dalla Legge” (il Primo Testamento), intendendo che occorre sempre e comunque rimanere fedeli alla Bibbia in ogni sua più piccola parola; però il senso della sua ira contro certi scribi e certi farisei, dovuto al loro apparire come i sepolcri imbiancati “belli a vedersi”, contraddice decisamente quell’attenzione verso gli aspetti esteriori posta invece nel brano del Primo Testamento citato, nel quale viene descritto, con estremo puntiglio e precisione, come debbano essere confezionati ed indossati i paramenti di Aronne e dei sacerdoti. Inoltre viene da chiedersi: ma come, la Bibbia tutta non insegna a far prevalere la sostanza sulla forma? Non pone l’accento sulle qualità interiori, non disapprova ostentazioni esteriori come l’abbigliamento? Leggere l’intero cap. 28 del libro dell’Esodo, completamente dedicato, in apparenza, solo ad un aspetto decisamente estetico, esteriore del sacerdozio, richiede una dose supplementare di pazienza, può generare insofferenza e viene da chiedersi perchè mai tutto quanto lì descritto sia necessario. I due brani citati in apertura sembrano quindi contraddirsi nella sostanza e pare di dover fare una scelta di campo tra l’uno e l’altro. Eppure per un cristiano sono entrambi “parola di Dio” in ogni loro più piccolo dettaglio e validi in ogni tempo, in ogni contesto. Come la mettiamo? Del detto popolare “l’abito non fa il monaco” cosa ce ne facciamo? Se ci soffermiamo anche soltanto su alcuni, tra i tanti dettagli di quel cavilloso descrivere i paramenti sacri che Aronne e i sacerdoti devono indossare e ci concentriamo sulla descrizione dell’Efod (una sorta di grembiule) e sul pettorale, intuiamo che ogni elemento ha una sua finalità. Leggiamo in particolare che il sacerdote doveva avere incisi su due pietre i nomi di tutte le tribù di Israele e portarli “sulle sue spalle” e, più avanti sarà specificato, anche “sul suo cuore”. Ma per farne che? Per presentarli quando andava davanti al Signore, come a ricordare a se stesso che il popolo doveva essere per lui un carico sacro. Possiamo così capire quale poteva essere la funzione di questi speciali indumenti. Proviamo ad immaginare con quanta cura si dovessero prima confezionare, poi indossare e quanto alla fine dovessero pesare, essere d’impaccio per i movimenti tutti quei paramenti. Certamente i sacerdoti dovevano ogni volta fare qualcosa che li impegnava e li affaticava. Peso, scomodità e fatica che dovevano preludere anche ad un 8 significato simbolico più alto, cioè a far loro capire di dover sostenere il peso di una comunità sulle proprie spalle e di tenerla sul cuore. E’ quindi un richiamo alla responsabilità di chi guida il popolo, a far sì che non ci si dimentichi mai chi si rappresenta, per conto di chi si agisce. Ecco quindi perchè “sulle sue spalle” (Es 28, 12): perchè il sacerdote si ricordasse sempre di non essere lui ad esser portato sulle spalle del suo popolo, in quanto a lui e non al popolo toccava di avere cura delle sue necessità nel rispetto della Legge di Dio. Non dimentichiamo che in quei tempi i sacerdoti avevano, di fatto, anche poteri temporali. E oltre che sulle spalle, il sacerdote doveva portare il suo popolo “sul suo cuore” (Es 28, 29), poiché chi guida un popolo deve poterlo fare con passione e compassione, con gioia e non in modo arido o cinico. Ecco allora l‘offerta di senso che ci viene dall’invettiva di Gesù. Egli ci fa capire che a ciò che appare deve corrispondere ciò che sta dentro di noi. Non criticava gli aspetti esteriori in sè, ma l’incoerenza di quegli scribi e di quei farisei che si fermavano al compimento di riti formali (per inciso Gesù non si scaglia contro tutta la categoria, ma contro quelli tra loro che ne tradiscono lo spirito, l’essenza; contro gli ipocriti, appunto), ma che poi non vivevano la loro vita in armonia con la Legge di Dio. Quindi quello di Gesù è un richiamo forte alla coerenza tra il dentro e il fuori, tra ciò che siamo e come questo nostro essere vogliamo comunicare, come vogliamo apparire. L’abito talare del sacerdote, la divisa del carabiniere o quella della crocerossina ci dicono chi sono, cosa rappresentano coloro che li indossano e, soprattutto, ci comunicano cosa possiamo aspettarci da loro. E chi invece non ha un’uniforme, un particolare capo di abbigliamento da indossare? Un abito, in fondo, rappresenta solo chi se lo mette. Il fatto è che, ce ne accorgiamo o no, tutti noi abbiamo comunque anche un altro “abito”, che non è quello di cui ci vestiamo, ma quello rappresentato dal nostro modo di vivere la nostra vita, dalle scelte che compiamo e da come ci poniamo nei confronti dell’altro. E’ responsabilità esclusiva di ciascuno di noi decidere per chi o per cosa vogliamo vivere e agire, per impedire a noi stessi di divenire dei sepolcri imbiancati, degli ipocriti. Oppure se voler dare di noi un’immagine alterata, magari spinti da un “dover apparire” imposto dalle mode del momento, dal potente di turno, o dal nostro cinismo e frodare con le nostre piccole e grandi falsità, certamente l’altro, ma, prima ancora, noi stessi. 9 VOCAZIONI E ATTITUDINI “…Quindi i comandanti così parleranno al popolo: chiunque abbia costruito una nuova casa e non l’abbia ancora inaugurata, vada, torni a casa sua….” Dt 20, 1 - 8 Talvolta sentiamo dire che il Dio del Nuovo Testamento è un Dio d’amore, mentre quello dell’Antico, del Primo Testamento, è un Dio violento, poiché tra i suoi Libri troviamo resoconti di guerre, eccidi, leggi del taglione e cose simili, da Lui volute, comandate. Il Dio del Primo Testamento è anche il “Dio degli Eserciti”; quello del Nuovo è inteso come un Dio Padre misericordioso. Nel Primo, Dio interviene direttamente nella Storia e talvolta lo fa con mano pesante, ne è protagonista, spesso seguendo una logica incomprensibile; peraltro nemmeno oggi noi capiamo i Suoi disegni e con quel “sia fatta la Tua volontà” che pronunciamo nel “Padre Nostro”, talvolta sottintendiamo dire: “non capisco ma mi adeguo”. Il fatto è che il Dio a cui ci riferiamo è uno solo e non due, è l’unico dal primo all’ultimo libro della Bibbia. La Sua “logica” rimane per noi imperscrutabile allora come ora e se usiamo le nostre categorie concettuali o l’etica dei giorni nostri, troviamo troppi disallineamenti, ci confondiamo. La volontà di Dio, i suoi percorsi, non ci sono noti e ancora oggi, davanti al nostro sguardo accadono guerre, terremoti, alluvioni, ingiustizie, stragi, che fanno qualche volta dubitare perfino della Sua esistenza o, quantomeno, fanno pensare ad una Sua latitanza o che chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie, quando non addirittura che sia Lui a non essere giusto, equo. E’ forte la tentazione, che è forse più un bisogno umano, di etichettarlo, desiderarlo a nostra misura, dire cosa Dio debba o non debba essere, fare o non fare per essere considerato Dio per come ciascuno di noi lo vorrebbe. Il brano che qui commentiamo è tutto dentro la logica, a molti tra noi incomprensibile, della guerra di conquista. Dio promette ad Abramo una numerosa discendenza ed il possesso di una terra, ma non di una terra qualsiasi: la Terra di Canaan. Ma, si potrebbe obiettare, con tutto lo spazio libero e fertile che pure doveva senz’altro esserci da qualche altra parte perchè proprio quel territorio già abitato dai Cananei? Perché complicarsi la vita? Canaan era, secondo la Bibbia, il nome del popolo dei discendenti del figlio di Cam, colui che, visto il padre Noè ubriaco e nudo, anziché ricoprirlo e usare la dovuta discrezione, lo derise e andò a dirlo ai fratelli, mancandogli così di rispetto (Gn 9, 22-27). Noè, una volta messo a parte dell’accaduto, maledisse la discendenza di Cam, cioè il figlio Canaan appunto, ad essere schiava sia di Sem, il primogenito, i cui discendenti saranno – per la linea di Abramo – gli ebrei, sia dell’altro fratello Jafeth. Ecco quindi la promessa divina della terra, abbinarsi a quella maledizione. Così le tribù di Israele si accingono a muovere guerra per la conquista di una terra, che quantunque promessa a loro, era già occupata da altri. Il discorso che i comandanti fanno al popolo prima di muovere contro i Cananei è apparentemente incomprensibile. Essi si trovano a dover guidare un piccolo assembramento variegato di nomadi per lo più nati durante i lunghi anni di vagabondaggio nel deserto e fare di essi dei combattenti. Oltre a non essere addestrati per la battaglia, sono anche pochi, mentre i loro nemici sono molti e molto potenti. Stando così le cose qual è l’alzata d’ingegno di quei comandanti? È quella di esonerarne tantissimi dal compito di andare in guerra: chi non ha finito di costruire casa è rimandato indietro, così come chi non ha ancora colto i frutti della sua vigna, chi deve sposarsi e chi ha paura della lotta (Dt. 20, 5-8). Possiamo immaginare quale progressivo e drastico sfoltimento possa essersi causato tra i ranghi dei potenziali combattenti. Dove sta il buon senso logico? Date le circostanze non 10 sarebbe stato meglio gettare in ogni caso nella mischia il maggior numero di individui possibile? Secondo quali criteri allora ragionarono quei comandanti? I più fedeli, coloro che maggiormente si affidavano a Dio, non si preoccupano più di tanto del numero di combattenti disponibili, certi di avere Dio accanto a sostenerli; gli altri, forse più scettici circa la possibilità di un aiuto divino, oppure soltanto più pragmatici, pongono l’enfasi sulla libera scelta per ottenere il medesimo risultato in termini di qualità e motivazione di quei combattenti. Entrambi i punti di vista hanno però un elemento fondamentale in comune, un aspetto sia etico che di grande valore in termini di libertà individuale: fanno in modo da rispettare le diverse “vocazioni” e le attitudini di ciascuno! Anzi fanno di più, invitano espressamente tutti coloro che non si sentono liberi, disponibili, abbastanza forti o determinati, tutti coloro che sono già dediti ad altri progetti, che sono più adatti ad altre attività, a dedicarsi a quelli. In tal modo potranno fare al meglio ciò che stanno già facendo o ciò per cui si sentono più portati e così facendo non abbasseranno il livello di efficacia di coloro che avranno il compito di conquistare la Terra Promessa. Vi è un altro elemento da sottolineare: l’assenza, nel discorso di quei comandanti, di un qualunque cenno di critica o di valutazione purchessia nei confronti di coloro che rinunciano alla battaglia per fare qualcosa d’altro. Gli esonerati, insomma, non vengono in alcun modo etichettati, o emarginati per questo, poiché costoro sono comunque dediti ad un “altro” che serve a loro stessi e al popolo tanto quanto la conquista del territorio. Vi è un riconoscimento reciproco, le loro strade si dividono, ma non c’è rottura; solo la contingenza operativa li separa temporaneamente, mentre i loro destini rimangono accomunati dalla loro appartenenza al medesimo popolo, alla cui vita e continuità provvedono ciascuno secondo le proprie capacità, attitudini, possibilità. Un’ultima considerazione. Quelle tribù israelite non avevano la pretesa di conquistare il mondo, di essere presenti dappertutto, ma solo di impossessarsi di quel pezzetto di terra. In altri termini conoscevano le loro possibilità ed erano consapevoli dei loro limiti. Avevano un obiettivo definito e, per quanto ambizioso, raggiungibile con le loro sole forze. Sapevano cosa dovevano fare e perchè, erano consapevoli delle implicazioni delle loro azioni e sapevano fin dove sarebbero dovuti arrivare. Si affidavano a Dio, consapevoli che se avessero dubitato anche solo per un istante di Lui, avrebbero perso tutto. Ciò tuttavia non li rese mai fatalisti, né fanatici e la loro azione era animata da concreto pragmatismo. Cosa possiamo imparare da questo brano? Che in fondo importa solo relativamente quello che facciamo nella vita, il ruolo, la professione, lo status sociale. Ciascuno ha il diritto di fare quello che gli tocca (e con i tempi che corrono ci sarebbe anche così da star contenti….) con la massima dignità e nel totale rispetto e riconoscimento da parte degli altri. Ma impariamo anche che dobbiamo comunque sforzarci di fare quello per cui meglio siamo dotati, conoscendo di noi sia le potenzialità che i limiti. Dobbiamo farlo con sano ottimismo, con fiducia in noi stessi e… se ci crediamo, soprattutto in Dio. Solo così potremo dare il nostro miglior contributo alla qualità della nostra vita e al bene comune. Infine, noi che viviamo e talvolta “soffriamo” nella nostra società, non possiamo non considerare la lezione in termini di senso di unità nelle differenze, di chiarezza degli obiettivi, del dire ciò che va detto e, soprattutto, del fare ciò che va fatto. 11 IETRO …Il giorno dopo Mosè sedette per rendere giustizia al popolo, e il popolo stette con Mosè dal mattino alla sera. Il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva al popolo e disse: «Che cos'è tutto questo lavoro che vai svolgendo per il popolo? Perché siedi tu solo, e tutto il popolo sta con te dal mattino alla sera?». Es 18, 13 - 15 Questo brano è un rimprovero a Mosè, ma un rimprovero paterno e non è difficile immaginare il vecchio Ietro, suo suocero, rimbrottarlo per il suo bene. Andando avanti nella lettura si scorge anche nella risposta di Mosè alla domanda di Ietro una sorta di lamento, si direbbe quasi come di un bambino che cerca scuse per giustificare un suo comportamento, accusando i compagni: “cosa ci posso fare se…” Ietro glielo dice chiaro, senza giri di parole: “non è bene quello che fai”. Povero Mosè, con tutto il suo daffare se le deve anche sentire dal suocero che imperversa: “ti esaurirai”, aggiunge, “perchè il lavoro è troppo pesante per te e non puoi farlo da solo”! Ietro procede implacabile e nella lettura di tutto il brevissimo capitolo 18 del libro dell’Esodo si viene a conoscere quello che voleva dire. Voleva dire certo molte cose, alcune delle quali proviamo a descrivere qui. La storia di Mosè ci dice che non doveva essere un gran che come trascinatore di folle. Non voleva accettare l’incarico che Dio gli aveva dato di portare gli Israeliti fuori dall’Egitto e obbedì infine con riluttanza. Inoltre era “duro di parola” in altri termini era balbuziente e non poteva parlare al popolo tant’è che per lui parlava suo fratello Aronne, messogli a fianco da Dio stesso purchè la finisse, Mosè, di accampare anche quella scusa per declinare il compito; non doveva nemmeno essere un gran condottiero; di logistica, una volta esaurito lo slancio della fuga oltre il mar Rosso, in tutta evidenza non ci capiva un gran che e in quanto a chiarezza di idee sul da farsi si è certo visto di meglio prima e dopo di lui. Il percorso delle tribù israelite nel Sinai rilevato dagli archeologi e dedotto dalla stessa narrazione biblica, sembrava quello di gente allo sbando, il popolo si lamentava e malediva il momento in cui l’aveva seguito. E adesso lo si ritrova immobile a dare udienza a tutti con tutto il popolo lì attorno a starlo a sentire. Una situazione di stallo che lo metteva in affanno senza che potesse risolvere nulla. Ma un merito il povero Mosè ce l’aveva e non era da poco: sapeva ascoltare ed imparare. Cosa gli dice Ietro? Gli dice che se lui si esaurisce, verrà a mancare la continuità, il popolo rimarrà senza guida. Gli spiega che il suo ruolo doveva essere quello di “informare (il popolo) dei decreti e delle leggi e di far conoscere la via da percorrere e le opere da compiere”. Di essere, quindi, il garante della Legge/Insegnamento di Dio. Gli dice poi di scegliere tra il popolo degli uomini “di virtù”, specifica Ietro e definisce cosa intende dire: non devono necessariamente già conoscere leggi e decreti (altrimenti perché mai doverli istruire in tal senso insieme agli altri?) ma devono essere “integri”, cioè senza interessi o motivi personali fuorvianti, e più avanti sapremo che Mosè li sceglierà tra i “capaci”. Capaci di cosa, se doveva istruirli? Capaci innanzitutto di imparare e poi anche di fare!! Ecco, non doveva prendere chiunque fosse disponibile, forse ne avrebbe trovati a migliaia, ma, tra i disponibili doveva scegliere i capaci di imparare e di fare, purchè fossero integri, ai quali affidare il compito, che in quel 12 momento era quello di dirimere le questioni in base ai criteri che Mosè, su ispirazione divina, aveva spiegato sia a loro che a tutto il popolo. Ietro prosegue ancora e dice a Mosè che deve assegnare a quegli uomini di virtù il governo di altri secondo uno schema gerarchico piramidale. E’ il concetto della delega. Mosè deve poter delegare a chi sa cosa fare, ma deve anche poter controllare l’operato. Ietro precisa: “a te sottoporranno le questioni più importanti”. Niente male il vecchietto! In tal modo Mosè non perderà mai il controllo sulla loro competenza e sulla loro attività. Del resto, se così non fosse non sarebbe più delega, ma abbandono, resa, abdicazione, sarebbe lasciar fare, lasciar andare in una deriva piena di incognite. Vale la pena porre attenzione anche sul come Ietro gli dice tutte queste cose: In modo franco e diretto, senza giri di parole, senza diplomazie, “sui denti” insomma. Mosè doveva imparare ad ottimizzare le proprie risorse e le proprie fatiche, a ripartirle, delegarle, altrimenti “il popolo non arriverà alla sua meta”. Doveva imparare a capire che è solo facendo crescere altri dopo di lui secondo principi e criteri ben precisi, che avrebbe potuto dare una speranza di continuità, senza penalizzare la qualità dei suoi sforzi e di quelli di coloro che lo avrebbero sostituito, sacrificando tutto sull’altare della mera quantità, del fare. Doveva imparare a capire a chi affidare incarichi, a chi assegnare responsabilità educativa e/o organizzativa anche secondo il criterio della capacità e dell’integrità oltre che della volontà. Doveva imparare a capire che talvolta il compito è quello di garantire i principi, i criteri e i metodi e successivamente valutare se applicarli direttamente o delegare in una qualche misura quella parte di compito ad altri. Doveva infine imparare a capire che il suo compito era definito e non doveva prendersi in carico le sorti del mondo intero, ma solo di condurre alla meta quella gente e rassegnarsi serenamente a dare un credito alla Mano di Dio e di fiducia agli altri. Mosè doveva capire cosa poteva essere in grado di fare lui, di farlo bene, come andava fatto. Un’ultima osservazione: Mosè ha fatto quello che ha fatto senza cognizione di causa, ma aveva diverse altre frecce al suo arco: la consapevolezza di dover imparare, la capacità di ascoltare, la voglia e l’umiltà di migliorarsi, la misura dei suoi limiti e del suo obiettivo e, soprattutto, la fede che il suo Dio lo avrebbe sempre accompagnato. 13 GIUDITTA E LE ALTRE Se non siete capaci di scrutare la profondità del cuore dell'uomo né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scandagliare Dio, che ha fatto tutte queste cose e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni?...” Gdt 8, 14 Parlare delle donne della Bibbia è come intraprendere un viaggio in un universo a parte, profondamente radicato nella cultura del tempo e nei luoghi della narrazione biblica, eppure ancora così attuale, talmente valido da sorprendere. Soltanto poche tra loro emergono dallo sfondo della storia. Sono un po’ come le fondamenta di una casa: per lo più non si vedono, ma se non ci fossero, quella casa reggerebbe ben poco. Parleremo brevemente solo di alcune di queste, raccontate in uno spaccato ora sottile ora più ampio delle loro vite. Alcune note, altre meno, quando non del tutto sconosciute ai più; un modo al femminile di insinuarsi inaspettatamente ed improvvisamente nella storia e di portare avanti il disegno divino. Cercheremo di cogliere in un preciso momento della loro vita, come hanno fatto la volontà del loro Dio attraverso la loro capacità di conoscere l’uomo, nelle sue potenzialità come nelle sue debolezze. Accostarsi alle loro storie, conoscere le loro gesta, talvolta lascia perplesso chi non dovesse in ogni momento ricordare che Dio si rivela nella storia umana con tutti i limiti di quest’ultima. Così incontriamo Rahav (Gs. 2, 1-21) cananea, prostituta di Gerico che nasconde, a chi le ricerca, le spie israelite entrate di nascosto in città per capire come meglio conquistarla. Fa subito, si direbbe istintivamente, una scelta di campo, si assume il rischio di essere considerata traditrice del suo popolo e si mette dalla parte di coloro che considera già i vincenti, non perchè più forti, ma in quanto riconosce che a guidarli hanno un Dio potente, un Dio che definisce come “Dio su nel cielo come sulla terra”, quindi un Dio universale. In cambio, lei donna e prostituta, quindi tra gli ultimi posti della scala sociale e perdente per destino, osa chiedere uno scambio di favori. Rahav capisce che di quegli uomini venuti dal deserto si può fidare e le basta un impegno sulla parola, impegno che poi quelle spie manterranno, di risparmiare lei e la sua famiglia dall’imminente saccheggio della città. (Gs 6, 22-25) Troviamo Ruth la moabita (Libro di Ruth) che con disarmante semplicità, non solo non se la sente di lasciare sola sua suocera Naomi, che rimasta vedova, vuole partire da Moab per rientrare a Betlemme dove è nata, e rimanere, Ruth, vedova a sua volta, tra la sua gente; ma così, di slancio (per come viene descritto quel passaggio si dovrebbe dire che si impunta con la suocera), professa la sua adesione ad un mondo non suo, quello ebraico, al quale peraltro con la morte del marito niente più la trattiene e lega la sua vita al popolo e al Dio della famiglia del marito e della suocera “..il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio” (Rt 1,16-17). Sua suocera Naomi farà poi astutamente in modo che Ruth possa incontrare un parente del marito (Rt 3,1-5) e sposarlo. Da Ruth nascerà colui che diverrà il nonno di David, il più amato Re d’Israele. Tra i personaggi, tutti maschili, protagonisti della storia della conquista della Terra di Canaan, compare inaspettata Deborah, una donna definita giudice e profetessa. La si incontra mentre dirime vertenze giudiziarie (Gdc 4, 4-9) e d’improvviso la si ritrova a comandare, su ispirazione divina, l’inizio di una guerra. Ordina ad un titubante Barak, che accetta di obbedire solo se lei gli sarà accanto, di muovere battaglia contro l’esercito di un re cananeo. Deborah lo accompagnerà, ma lo avverte – con una punta di scherno che la gloria per la vittoria sarà allora di una donna e non più sua. Provocato, Barak allora reagisce. L’esercito nemico verrà sconfitto da Dio stesso prima che dalla spada di 14 Barak alla guida delle tribù israelite, a riprova che il coraggio e la fede possono più della forza e dando in tal modo ragione alla donna. E Yael, donna di origine madianita che poteva starsene in disparte e non farsi coinvolgere in quella stessa battaglia e invece, vedendo cosa sta accadendo all’esercito cananeo, coglie la potenza del Dio di Israele, capisce cosa può fare lei in prima persona, individua e asseconda le paure e le esigenze del generale nemico con cui si trova faccia a faccia e agisce risoluta con gli strumenti di cui dispone: l’astuzia, ma anche un picchetto da tenda che, con un martello, gli conficcherà nella tempia… Del resto anche Rebecca (Rivqa: “colei che irretisce”. un nome che segna un destino come spesso accade nella Bibbia) gioca d’astuzia e usa un trucco per far benedire dal marito Isacco il figlio Giacobbe, al posto del gemello Esaù (Gn, 27, 15-16), poiché secondo lei più adatto a raccogliere l’eredità e la missione - già del padre e del nonno Abramo - di fare di quella loro piccola tribù una grande nazione. Nessuno ha detto a Rebecca cosa dovesse fare, ha fatto quello che lei sentiva e noi possiamo poi leggere il disegno divino in quella azione apparentemente eversiva, iniqua. Sembrano passare sottotraccia Shifra e Puah, le due levatrici che disobbediscono nientemeno che a Faraone e non uccidono alla nascita i nati maschi tra gli israeliti. Trovano delle giustificazioni, ma non si nascondono. La Bibbia dice che Dio avrebbe moltiplicato le loro “case”. Troviamo ancora Hadassa, (Libro di Esther). Ebrea andata in sposa all’imperatore persiano nascondendo per prudenza le proprie origini dietro il nome persiano di Esther, mette in gioco la sua vita e, senza starci a pensare, dichiara la sua vera identità all’imperatore suo marito, pur di salvare il suo popolo, minacciato di genocidio. Più avanti nel tempo si incontrerà Maria (Miriam), che, con un semplice “eccomi” detto di slancio, accetta di diventare la madre di Gesù e legherà il suo destino, che altrimenti poteva essere quello di una normale moglie e madre, a quello del figlio. Così un’altra Miriam di Migdal, la Maddalena, che si unisce al gruppo dei seguaci di Gesù per null’altro motivo che “per servirlo” e si troverà poi ad essere lei la prima persona a cui Gesù darà l’incarico di annunciare la cosa apparentemente più folle: la Sua resurrezione, annuncio che farà, con spavento e gioia, insieme ad altre donne. La vicenda di Giuditta ci fornisce una chiara chiave di lettura per le scelte fatte da tutte queste donne. Descritta come ricca e bellissima vedova, molto devota, intelligente e saggia, un’avveduta imprenditrice agricola, Giuditta si espone anch’essa, si gioca la vita. Entra nel campo dell’esercito assediante, riesce a conquistarsi la considerazione del comandante nemico e alla prima occasione utile impugnerà la sua stessa spada con la quale gli reciderà la testa dal collo. Lei, donna senza potere alcuno e come le altre indicata come moglie (nel caso specifico vedova) di qualcuno, avendo le donne di quel tempo una valenza sociale solo in quanto relative ad altri, osa criticare le decisioni prese dagli anziani della sua città e li rimprovera con veemenza e con una domanda rivelatrice: “Se non siete capaci di scrutare la profondità del cuore dell'uomo e di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scandagliare Dio, che ha fatto tutte queste cose e conoscere i Suoi pensieri o comprendere i Suoi disegni?...” (Gdt 8, 14) E’ proprio così, questa è certamente una spiegazione del suo pensiero e della sua azione, che possiamo riconoscere anche in quelli delle altre donne. Da loro impariamo che occorre saper leggere nel cuore e nella mente dell’uomo per comprendere la volontà di Dio, che – non dimentichiamo - l’ha creato a Sua immagine e somiglianza. Nessuna di quelle donne si defila o delega ad altri il da farsi e le loro azioni producono anzi una svolta nei loro destini, in quelli della loro gente e dell’umanità. Usano le uniche armi di cui possono disporre: astuzia, intelligenza, intuito, dedizione, slancio; perfino la disperazione e la paura divengono una risorsa. Dopo il loro gesto rimangono quello che sono sempre state e come sono comparse all’improvviso sulla scena, così tornano nell’ombra. Hanno il coraggio dell’azione individuale e non trovano scuse per 15 giustificare l’inerzia. Da loro impariamo il senso della responsabilità personale per ogni nostro gesto in tempi, questi, dove ripararsi dietro l’illusione che qualche “uomo della provvidenza” pensi a tutto in nostra vece, sembra essere diventato un atteggiamento molto diffuso. Da loro impariamo anche a non aspettare di avere tutti gli strumenti necessari prima di agire poiché potremmo non averli mai e di usare al meglio quelli di cui disponiamo. Se preparazione, strategia, metodo, organizzazione hanno una valenza, possiamo dire, “al maschile”, quelle donne ci indicano un modo “al femminile” di agire, modo che in nessun caso può essere confuso con l’improvvisazione, l’approssimazione; modo altrettanto efficace e che fa leva sulla comprensione del cuore degli uomini. Le donne della Bibbia ci insegnano che strumenti davvero indispensabili sono anche il coraggio, l’istinto, l’audacia e la fiducia in se stessi e, se ci crediamo, in un Dio sia con noi e guidi le nostre azioni. Tutta la predicazione evangelica, del resto, è permeata da questa attenzione verso ogni singola persona, pone enfasi sulla necessità di conoscerne il cuore e il pensiero. Sottolinea in modo radicale l’importanza della responsabilità e dell’azione individuale fino alle loro estreme conseguenze. 16 MASCHIO E FEMMINA “Adam disse: Questa volta è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Pertanto si chiamerà isha essendo tratta da ish” Gn 2, 23 Leggendo la Bibbia si incontrano talvolta diverse affermazioni dal significato oscuro, enigmatico, o semplicemente poco comprensibile, che lasciano nel lettore qualche perplessità. Tra le tante proponiamo qui di porre attenzione su alcune di esse che suscitano, per come vengono formulate, interrogativi sul senso intrinseco che possono avere e che, nonostante le apparenze, sono unite da qualcosa che chiameremo un “dispositivo” comune. In Gn 17, 5-15 leggiamo che Dio rinomina Abramo: “Non ti chiamerai più Avram, il tuo nome sarà Avraham, perchè ti farò padre di moltitudini”. Si fatica a coglierne il senso: perchè per divenire padre di moltitudini gli viene cambiato il nome? Che bisogno c’è e dove sta il nesso? “Padre di moltitudini” è, in ebraico, av-amon (padre di una massa d’uomini) ed ha solo una vaga assonanza verbale con Avraham. Un cambio di nome da Avram ad Avamon, invece, non avrebbe fatto una piega, lo si sarebbe capito immediatamente: il nuovo nome sarebbe così stato coerente con ciò che esso significa ed implica, con la promessa che Dio fa al patriarca. Del cambiamento del nome della moglie di Avraham, Sarai, in Sarah, che viene annunciato poco più avanti nel brano citato, non ci sono poi spiegazioni di sorta e si può solo ipotizzare la cosa più ovvia, cioè che il destino di quella donna sia associato a quello del marito. Ad un altro grande personaggio biblico viene modificato il nome senza spiegazione alcuna. Si tratta di quell’Osea (Oshèa) figlio di Nun a cui Mosè cambia il nome in Giosuè (Yeoshua) (Nm 13, 16). Il compito di Giosuè sarà poi quello altissimo di condurre le tribù di Israele alla conquista della Terra di Canaan in adempimento alla promessa divina. Anche qui si rimane perplessi: che significato ha quella modifica di nome e che relazione ha questo con il destino di chi lo porta? Poche insoddisfacenti spiegazioni se non addirittura nessuna spiegazione. Eppure nella Bibbia tutto ha un senso. In cosa questi nomi vengono modificati? Per capirlo occorre allora fare un’analisi su di un piano differente da quello letterale, semantico o teologico e andare a monte, partire dal modo con il quale quei nomi sono scritti, nei caratteri ebraici, prima e dopo la ri-nominazione. Sappiamo che la parola scritta, in ebraico, ha significato di sostanza. Lo stesso termine “davar” significa indifferentemente parola e cosa, sostanza, per cui la parola scritta pesa, vale quanto un fatto concreto. Da qui la cura estrema con la quale ogni lettera di ogni parola viene scritta e collocata, poiché ciò che con essa si vuole indicare è impegnativo, vincolante, concreto e anche una piccola variazione può talvolta far mutare il significato di un termine. Quindi, esaminando le lettere con le quali i nomi di Avraham e di Sarah vengono modificati, scopriamo che quel cambiamento è dovuto all’aggiunta di una sola lettera, la “h” (la “he” ebraica) in entrambi. Perchè quella lettera e non un’altra? L’unica risposta plausibile, che troviamo nel commento rabbinico, è che quella lettera è una delle lettere sante di cui Tetragramma, il Nome di Dio(*) è composto. Allo stesso modo il nome di Oshea diviene Yeoshua per l’inserimento di un’altra delle lettere sante del Tetragramma: la “i” (la“iod” ebraica e con tale inserimento cambia parzialmente anche la vocalizzazione del nome stesso). Ecco allora la ragione di quella frase, che così capiamo non essere tanto nel cambio di nome in sé o nel tentativo di creare assonanze, quanto nel santificarne il destino di “padre (e madre) di moltitudini” per Avraham e Sarah e di condottiero per Yeoshua. Questi tre personaggi biblici avranno un ruolo decisivo per la storia del 17 popolo di Israele. Ecco quindi il senso: santificare il nome di quelle persone per segnarne, marcarne un destino all’interno del piano Divino.Accade così anche nel nominare il genere umano (“Adàm” deriva da “Adamà” che significa terra e con il termine Adam si intende l’essere umano in generale, il “terrestre”, in quanto tratto dalla terra), che in tal modo viene anch’esso santificato nel modo più solenne. Sì ma come questa volta? Con una particolarità ancor più sorprendente e rivelatrice. Quando Dio crea l’uomo, l’Adam, lo crea indistintamente “maschio e femmina” (letteralmente: al maschile e al femminile) e in quanto tale lo forma a Sua immagine (Gn 1,27). Poi però, più avanti nel testo, afferma: “non è cosa buona che l’uomo (Adam) sia solo”. Così di Adam separa il maschio dalla femmina. Quando Adam vede l’essere generato attraverso una separazione da lui, ha un’esclamazione (Gn 2, 23) che intendiamo come di sorpresa e di gioia, possiamo pure ipotizzare di sollievo, nella quale compaiono per la prima volta i termini Ish, maschio, e Isha, femmina (letteralmente diremmo: maschia). Stavolta non si vedono apparenti stranezze, non vengono domande da fare sul senso o sulla apparente incongruenza tra la parola scritta e ciò che significa. Ma se, anche qui, andiamo a vedere come quei due termini sono scritti, scopriamo che, a differenza di come appaiono usando le lettere latine, nella scrittura ebraica (rispettivamente Alef, Iod, Shin e Alef Shin, He) vengono utilizzate insolitamente lettere parzialmente diverse. Ora se noi togliamo la “iod” e la “he”, lettere che troviamo solo nell’uno o solo nell’altro dei due termini, notiamo che queste due, unite insieme, formano l’inizio della rivelazione del Nome di Dio! Quindi che cosa viene santificato in quei due nomi ed in ciò che rappresentano? Ne viene santificata, esaltata la differenza esistente tra loro! Non è santa l’uguaglianza, l’identità; è invece la differenza, la distinzione fra ciò che è specifico dell’uomo e ciò che lo è della donna ad essere sottolineata, rimarcata e valorizzata nel modo più alto possibile. Questo ci dice anche e soprattutto che insieme e non separatamente, il destino dell’uomo e della donna è quello di rappresentare l’immagine di Dio. Come? Nelle loro diversità e specificità, proprio grazie ad esse e attraverso di esse. Ci dice anche che sono le differenze, non le uguaglianze, ad essere portatrici di valore e di arricchimento reciproco nella vita. La verità della Bibbia risulta chiara se non si confonde l’uguaglianza con l’emulazione, l’identità e la pari dignità con la becera omologazione. Il fatto che l’uomo e la donna siano in grado di fare le stesse cose non significa, per questo soltanto, che le debbano fare allo stesso modo, seguendo lo stesso percorso, con le medesime sensibilità, le stesse motivazioni più profonde, o che debbano avere come prerequisito l’essere “uguali”. Significa invece che ciascuno le fa, e le fa al meglio, solo se è consapevole delle proprie peculiarità e se l’altro, o l’altra, quelle differenze sa riconoscere, rispettare e valorizzare, farne a sua volta tesoro. Questo vale anche in quella specifica relazione che si forma all’interno di una famiglia, comunque la si voglia configurare. Un bambino può certamente crescere, divenire un adulto sano e consapevole, anche con un solo genitore, con nessun genitore, o seguito da figure parentali diverse, ma altrettanto certamente la compresenza di adulti in equilibrio dialettico tra le loro diversità porta un valore aggiunto a quel bambino, che in tal modo viene agevolato nel suo processo di identificazione e di distinzione; può sperimentare meglio, avendone l’esempio, diverse modalità di affrontare la vita, traguardarla, valutarla, farci i conti, prendere le misure per viverla al meglio a sua volta, prendendo come esempio quello di figure adulte che, nelle loro diversità, la vita affrontano giorno dopo giorno. Certo occorre che tra loro, la figura maschile e la femminile, vi sia complementarietà ma non subalternità e che possano esprimersi appieno proprio e soprattutto attraverso le loro differenze. E’ il loro destino al quale sono stati designati fin dal Nome di Dio. ______________________________________ *) Il nome di Dio, traslitterato dall’alfabeto ebraico a quello latino, è IHVH (le lettere ebraiche sono: iod, he, vav, he) ed è impronunciabile. I termini Iahvè, Geova, Iehova sono alcune delle verbalizzazioni possibili che tuttavia non possono essere considerate che degli appellativi. 18 LECH LECHA’ “…Il Signore disse ad Abramo: “Va’” via dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla tua casa paterna al paese che ti indicherò…”. Gn, 12, 1 Parliamo di cammino, chiediamoci se si è davvero disponibili a camminare. Parliamo di quel camminare che è ricerca di sé. Camminare alla ricerca di se stessi è la più grande avventura che un essere umano possa intraprendere. E’ anche la più insidiosa, la più incerta, il cui risultato è tutt’altro che scontato. Andare verso la conoscenza di se stessi significa anche rinunciare alle certezze, ridiscutere tutto. L’ordine che Dio dà ad Abramo è formulato in un modo unico in tutta la Bibbia e nella Bibbia nulla accade per caso. Quello che viene comunemente tradotto come un “va’”, nell’originale ebraico anziché essere scritto “lech” (va’, appunto) è scritto – e lo è solo lì – “lech lechà” che letteralmente vuole dire nientemeno che “vai a te stesso”. Quindi quel “va’” ha un significato del tutto speciale che non si può eludere. Questo dice la Bibbia ad Abramo e a tutti noi: ricerca te stesso. Abramo non scappa da niente, va verso qualcosa. Non si nasconde, ma anzi ricerca innanzitutto se stesso. Quell’ordine significa anche vai via da ciò che ti impedisce di essere quel te stesso che puoi essere. Andare a se stessi è il presupposto per costruire la propria libertà e la propria identità, ma non è una fuga, è la ricerca di un’alternativa, di qualcosa che innanzitutto debba partire da se stessi. Sembra tutto così chiaro, ma non per questo è altrettanto facile. Abramo attraversa terre e deserti. Nella Bibbia compare spesso il deserto, e non solo come metafora, come scenario di ricerca di sè e anche questo non può mai accadere per caso; nel deserto accadono le cose più importanti. Perchè il deserto? Quella del deserto è, può essere, un’esperienza dura, è un mettersi alla prova. Tutto può essere tranne che una fuga da se stessi, poiché il deserto ti mette in ogni momento di fronte a te stesso, soprattutto alle tue debolezze, per poi farti capire quali sono anche le tue forze, su cosa puoi davvero contare. Sto parlando del deserto vero, quello fatto di roccia e sabbia, di sole e di freddo la notte, di niente all’orizzonte d’altro che cielo roccia e sabbia. E non puoi scappare da niente anche, o forse proprio perchè, non hai niente attorno da cui poter scappare. Allora ti devi rassegnare a confrontarti con te stesso, farci i conti. E finchè scappi, temporeggi, eviti, non ne vieni fuori, anzi rischi di morirci dentro. Se sei con qualcuno, ti rendi conto che non puoi isolarti e che il fare i conti con te stesso deve passare con il fare i conti con gli altri con cui vivi, dai quali dipendi, come loro da te. Fare i conti con gli altri significa guardarsi in faccia l’un l’altro, magari anche a muso duro o con l’angoscia di rompere equilibri, provocare rotture per poi cercare di ricucire. Il deserto ti costringe a spogliarti da tutto ciò che è superfluo, dalle ipocrisie, da quel che va fatto perchè si è sempre fatto e da quello che non si deve fare perchè ci hanno detto che così dev’essere. Dai luoghi comuni, dalle regole imposte, dai perbenismi. Ti costringe a metterti in gioco, sperimentarti e ti impedisce di tentare di risolvere i problemi, tuoi o quelli con altri, semplicemente evitandoli, o con la diplomazia, o “aspettando il momento giusto”. Se aspetti di esser più forte per poter affrontare il deserto, quindi te stesso, allora non lo farai mai. E’ una delle cose che vanno fatte quando una voce ti chiama a farle. Cosa significa andare nel deserto quando non si ha un deserto reale dove andare? Significa tentare di raggiungere il “deserto”, creandolo in noi e intorno a noi, vivere come se si fosse là, vederlo come fonte di consapevolezza di sé, come modo di relazionarsi con gli 19 altri, con la stessa franchezza, con la stessa “verità di noi” per quanto cruda, deludente o, semplicemente, normale essa possa essere. Chiunque stia facendo quello che una voce, magari quella Voce, gli chiede di fare, fa un’impresa grande. Quindi in questo cammino occorre cercare di essere accorti, ma non astenersi, non evitare, non nascondere e non nascondersi. Non rinunciare agli slanci che sono la linfa della vita. Il nemico più pericoloso che si incontra è la paura, soprattutto la paura di scoprire chi siamo davvero. Ma per non incontrarlo, questo nemico, si dovrebbe non camminare, non cominciarla nemmeno l’avventura. E allora le cose vanno fatte e se c’è paura, questa va affrontata a viso aperto. L’alternativa è sopravvivere, vegetare. 20 LA PACE E LA SPADA “..Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada..”. Mt. 10,34 Gesù è certamente uomo di pace, ma possiamo dire che sia stato anche un uomo pacifico, accomodante? Che rifuggiva le situazioni conflittuali e per questo preferiva i compromessi? Possiamo dire che la cacciata dei mercanti dal Tempio sia stata un’azione pacifica? Al lettore la frase che segue sembrerà forse strana o inopportuna, ma non sbagliamo molto se affermiamo che alla base della predicazione di Gesù non stia propriamente la pace, ma l’amore, quello assoluto. “Non sono venuto a portare la pace, ma una spada”! Già una spada che separi, distingua, che faccia chiarezza. Nel suo discorso missionario in Matteo 10, 1-42, Gesù richiama in modo risoluto ad una scelta di campo che ciascuno deve fare, definisce delle condizioni chiare, indica ai suoi apostoli, nominati nel testo – si badi bene - uno per uno, regole alle quali attenersi per decidere come comportarsi nei confronti di una serie di situazioni nelle quali essi potranno venirsi a trovare; pone dei confini, dei limiti: per chi si trova all’interno di essi – cioè sia portatore di un impianto valoriale comune e condiviso con gli apostoli stessi mandati a predicare - ci si dovrà comportare secondo taluni criteri; per chi ne è all’esterno secondo altri. Allora ecco la spada che separa e distingue, talvolta anche con lacerazioni (vv. 32-42). Oggi diremmo che quel discorso missionario somiglia tanto ad un briefing prima dell’inizio di un’azione, una “missione”, appunto. Una missione con tanto di regole di ingaggio e di disimpegno, durante la quale bisogna mettere in conto ogni eventualità. Incluso lo scontro, il conflitto. Il discorso missionario di Gesù non prevede altre possibilità. Talvolta il confronto assume i contorni della “correzione fraterna” (Mt. 18, 15-18) che indica, nell’intervenire sul comportamento del fratello, una gradualità, una progressione, ma, ancora, sempre una assoluta franchezza e trasparenza, senza ombra di tatticismi da retrobottega. Ci si riferisce ad una “colpa” che il fratello commette. Colpa rispetto a cosa? Rispetto ai valori ed alle regole a cui tutti ci riferiamo concordemente in una sorta di Patto che unisce e contraddistingue. La correzione fraterna ha come scopo primario il ritorno del fratello dentro la comunità, ma ne prevede anche, come estrema ratio, il rigetto. Ciò che non prevede invece mai è di lasciare le cose come stanno per il dubbio amore del quieto vivere. Anche nella nostra società vengono dichiarati valori e regole che riguardano tutti indistintamente. E anche qui è fisiologico il manifestarsi del conflitto che può essere all’interno di tale sistema di valori, oppure riguardare proprio questi ultimi, quando invece non siano condivisi, sia nelle grandi questioni come in quelle più minute. Non dobbiamo temere quel conflitto, non facciamo il bene di nessuno a girare lo sguardo altrove e talvolta, magari senza nemmeno volerlo, finisce che il nostro agire non è nemmeno animato da amore. La Bibbia e Gesù, in ogni caso, ci insegnano altrimenti. “Vi dò un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,24) Il commento più comune a tale versetto è che Gesù ha amato fino a dare la sua vita per gli altri. Commento assolutamente condivisibile nella sua evidenza. Ma quel versetto, volendo, ci offre un altro significato. Il commento citato risponde di fatto alla domanda “fino a che punto” Gesù abbia amato? e non a “come” ha amato, così come è scritto in quella frase. Allora chiediamocelo noi: come Gesù ha amato? Lo ha fatto con tutti i mezzi, in tutti i modi, inclusi i rimproveri, le tirate d’orecchie, anche arrabbiandosi. Lo ha fatto sempre “con 21 lingua dritta”, con i “sì, sì e no, no” dicendo quel che andava detto, facendo ciò che andava fatto. Tutti i Sacri Testi ci fanno intendere che si deve poter percorrere ogni strada, usare ogni mezzo perché pace e amore possano regnare e che è dovere di ciascuno provarci. Ad una sola condizione: che il motore delle nostre decisioni e delle nostre azioni sia l’amore verso tutto ciò che il mondo contiene fin nel suo più piccolo dettaglio, ogni singolo essere umano incluso. 22 CAMBIARE SENZA TRADIRE “Il capo dell'esercito del Signore rispose a Giosuè: «Togli dai piedi i sandali, perché questo luogo dove stai è santo». Giosuè obbedì prontamente”. Gs 5, 15 E’ impossibile non avere un’impressione di “deja vu” dopo aver letto questo versetto. Dove l’abbiamo già visto? Cambiano i protagonisti, ma la situazione è analoga a quella in cui Dio si rivela a Mosè nel deserto. Qui il protagonista è Giosuè e lo incontriamo in una situazione molto simile a quella raccontata nel libro dell’Esodo; qui troviamo lui al posto di Mosè e “il capo dell’esercito del Signore” anziché Dio stesso. La vicenda di Giosuè, per come è narrata nel Libro intitolato con il suo nome riporta diversi episodi apparentemente simili a quelli riferiti nell’Esodo, dove il protagonista era Mosè. Chiediamoci intanto chi era Giosuè. Si tratta di una figura che appare sulla scena in Esodo, il suo nome era Osea, un giovane sempre fedele a Mosè, che lo segue dovunque, lo sostiene nella sua missione, che lo aiuta, lo difende. Dobbiamo andare nel libro dei numeri (Nm 13,16) per scoprire quando il suo nome cambia da Oshea (Osea) a Joshua, Giosuè, appunto: “Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. Mosè diede ad Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè” Giosuè avrebbe ben presto avuto una missione del tutto particolare da compiere, che non era più quella di partecipare all’esplorazione della terra di Canaan, ma nientemeno quella, successiva, di conquistarla. Possiamo facilmente immaginare la delicatezza di tale compito, non solo per la difficoltà e per i rischi insiti in una simile impresa, ma anche perché doveva da un lato trasformare un popolo di nomadi del deserto in combattenti; doveva però preservare usi, costumi e le sicurezze acquisite dal popolo, preservarne, attraverso di essi, l’identità, lo spirito. Doveva anche assolutamente salvaguardare e rafforzare la sua stessa personale figura, senza d’altro canto mai avere la pretesa di mettersi all’altezza del più grande condottiero Mosè, cosa che gli avrebbe fatto rivoltare contro il popolo stesso. Così, quando succederà a Mosè, Giosuè porterà avanti il suo programma. Ma cosa fece per consolidare la sua leadership? Ripetè alcuni dei gesti significativi del suo predecessore, per ribadire la continuità della sua azione e nel contempo per mandare sempre un messaggio di minorità rispetto al grande condottiero che lo aveva preceduto. Così anche lui manderà degli esploratori, ma non in pompa magna, come già fece Mosè, e con obiettivi limitati e precisi (Gs 2,1). Come Mosè separò le acque del Mar Rosso, così Giosuè separerà quelle del più piccolo e certamente più facile fiume Giordano; non lo farà nemmeno direttamente, ma mandando avanti l’Arca dell’Alleanza contenente le Tavole della Legge. Per un fiume fu sufficiente fermare le acque da un solo lato, a monte, e non entrambi i lati come è necessario fare per un mare (Gs 3,15-16). Giosuè incontrerà, in uno scenario molto simile, non Dio ma il più modesto "capo dell'esercito del Signore" che pure gli farà togliere i sandali, come già Dio a Mosè. (Gs. 5,14 - 15) E ancora: se Mosè scrisse, su ispirazione divina, le Tavole della Legge, Giosuè si limiterà a copiarle (Gs 8, 32). Mosè fece giurare il popolo sulle Tavole della Legge; Giosuè, a Sichem, farà solo rinnovare quel giuramento (Gs 24, 19-25). A cosa potevano servire tutti quei gesti, distribuiti durante tutto l’arco di tempo della conquista della terra, se non per giustificare Giosuè stesso nel suo ruolo, rinforzarlo, ribadirlo? E a cosa, se non a rassicurare il popolo circa la continuità della sua azione con quella di Mosè? Giosuè ricalca, replica, conferma (Gs 8, 35). Ma in realtà ha un compito del tutto diverso da quello di Mosè. Quello di Giosuè era un altro tempo e un 23 altro contesto, non vi era un deserto in cui sopravvivere, compito assolto da Mosè, vi era una terra popolata da conquistare. Il popolo di Israele doveva essere ora all’altezza di nuove sfide, soprattutto verso se stesso: doveva trasformarsi da un insieme di gruppi tribali vaganti nel deserto in una nazione forte, autonoma e responsabile di sé. Doveva riuscire a fare tutto questo senza perdere la propria identità, le proprie origini, le proprie radici fondanti. Questo implicava dover rinnovare senza rinnegare. Un compito arduo in capo prima di tutto a Giosuè. La lingua italiana ci aiuta a capire la portata del compito di quel condottiero. Dal dizionario etimologico (Zingarelli 2009) leggiamo: tradizione, da traditus, tradito: trasmissione nel tempo di memorie, consuetudini; traditore: da traditus (come sopra) ma con significato assunto di tradire. Ciò a dire che nel fare qualcosa “per tradizione”, se ne tradisce il significato. Ecco allora la stupenda operazione riuscita a Giosuè: rinnovare nella tradizione senza tradirne la sostanza, l’essenza. Viviamo in un mondo in cui troppe volte i gesti, i riti tradizionali che ripetiamo, vengono traditi nel loro significato. Cerimonie sempre uguali nei gesti, nella forma, sono svuotate dei loro contenuti, poiché prima ancora di non credere più in essi, spesso non sappiamo nemmeno più quali, quei contenuti, dovevano essere stati, cosa hanno portato a quei riti. Così quelle cerimonie, quei gesti finiscono con l’essere vuoti, spenti, fino a divenire ridicoli, a considerarli superati, al punto che talvolta ci vergognamo di compierli. L’ammaestramento che riceviamo dall’azione di Giosuè sta proprio nel suo essere riuscito a cambiare, adeguandoli al tempo, alla situazione, i gesti che confermano l’identità di un popolo, il suo credo, i suoi convincimenti, senza stravolgerli, tantomeno abolirli. Giosuè ci insegna a badare a che quando facciamo qualcosa per tradizione non ne tradiamo lo spirito, anche se magari le forme possono cambiare nel tempo e nei luoghi. La vera tradizione, quella che vale la pena continuare a far vivere, è quella che non va contro la continuità, l’evoluzione. Se essere fedeli non significa essere ripetitivi, essere ripetitivi può significare divenire infedeli, tradire il significato originale. Fedeltà non è ripetizione acritica che tradisce; la fedeltà non esclude il rinnovamento se rimane dentro un solco già tracciato. Qualunque “cosa” sia quella in cui crediamo, una religione, un partito, un “credo” laico o quant’altro, abbiamo cura di chiederci sempre se e cosa vi sia da innovare e, nel contempo, di chiederci anche di preservarne l’essenza al fine di non perdere l’”anima”. 24 RAZZA UMANA “Ma Ruth rispose: non insistere perché io ti lasci e me ne torni lungi da te; perché dove andrai tu, andrò anch’io; e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio”. (Ruth 1,16) Era l’aprile del 1973 quando visitai per la prima volta i resti di Masada, la fortezza fatta costruire da Erode il Grande nel deserto di Giuda, nei pressi del mar Morto. Vi salii a piedi, con altri miei coetanei, attraverso la rampa, innalzata sul suo lato ovest con pietre e sabbia, dalla X Legione romana che la teneva sotto assedio da circa tre anni. Partimmo quasi all’alba e in pochi minuti fummo dentro, esattamente 1900 anni dopo quei legionari. La suggestione faceva avvertire i suoni, le voci, il clangore delle spade, perfino l’odore della morte, lo stesso che doveva aver impregnato le narici dei soldati romani che, pronti alla battaglia, trovarono invece solo cadaveri. Chi ci guidava ci portò poi sull’altro versante della fortezza. A est, velate dalla foschia mattutina, si scorgevano delle alture oltre il mare, in territorio giordano. Fu ancora la guida a spiegarci che si trattava dei monti dell’antica Moab; fu la sua voce, segnata dalla routine che la rendeva triste e monocorde, a raccontarci la storia di una certa Ruth, una donna moabita che sposò un ebreo di Betlemme e che, rimasta vedova, insistè per rimanere con la suocera Noemi, anziché tornare tra la sua gente. “Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio”, le disse per convincerla a tenerla con sé. Ne parlava, la guida, come se si trattasse di una vicenda ordinaria, di qualcosa accaduto solo pochi giorni prima a qualcuno di noto, di famigliare. Così non era per la maggior parte di noi e davanti alle nostre espressioni perplesse, aggiunse non senza un filo di insofferenza, che quella era una storia di profonda e umile adesione a un disegno di Dio. Ruth, continuò la guida, divenne la bisnonna di David, il primo vero re, il più amato, che unì tutto Israele. E che si fece riconoscere come re pur avendo ascendenze straniere. E questo, concluse, dovrebbe dirvi qualcosa sulla questione della purezza della razza. La discendenza dell’Unto del Signore (David il Mashiàh/Messia) è quindi dovuta a grembi diversi, a sangue misto e questo allontana lo spettro dell’ideologia funesta della purezza del sangue. Fu però il modo, l’ordinarietà dell’esposizione di quella guida, che ne parlava, dicevo, come fosse di qualcosa di normale, di recente, attuale a farmi per un istante azzerare il tempo. I pregiudizi, il razzismo c’è ora come già allora e non è cambiato niente. Solo diversi anni più tardi, spigolando tra i commenti ai testi, trovai le ragioni che portarono alla formazione dei libri che avrebbero composto il canone biblico. Il racconto di Ruth fu inserito tra i libri sacri non senza problematicità. Quando nell’anno 539 a.C. i reduci dall’esilio di Babilonia tornarono in terra di Giuda, liberati da Ciro il Grande re di Persia, avevano modi diversi di intendere se stessi. In particolare una parte di essi riteneva che da quel momento in poi gli ebrei non avrebbero più dovuto accettare tra di loro persone provenienti da altri popoli, non ci sarebbero più dovuti essere matrimoni misti. Quello ebraico sarebbe dovuto divenire una volta per tutte un popolo esclusivo e chiuso, separato dagli altri. Una diversa corrente di pensiero, tuttavia, affermava a sua volta che tale posizione non era giusta nè sostenibile, ritenendo che il popolo avrebbe comunque dovuto rimanere aperto agli altri. Il dibattito portò così ad un compromesso. Il libro di Ruth, infine inserito tra i testi sacri, doveva servire a correggere tale tendenza esclusiva, di chiusura, affermando che perfino il più grande re di Israele aveva avuto sangue misto e con ciò accogliere nel mondo ebraico dell’epoca anche chi proveniva da altri popoli, altre culture e religioni. 25 Già, la razza. Oggi il mondo scientifico, anche quella parte tornata sobria dopo le ubriacature ideologiche del secolo scorso, non ha dubbi nell’affermare che le razze umane non esistono. O meglio, ne sopravvive una sola, quella a cui tutti gli esseri umani fanno parte e le differenze esteriori dipendono solo da adattamenti, da variazioni di una o più caratteristiche morfologiche all'interno di una data area geografica. E, con buona pace per i razzisti di tutti i tempi e di tutti i luoghi, l’attuale razza umana superstite (homo sapiens sapiens) è a sua volta l’esito di ibridazioni tra razze precedenti, poi estinte. Tuttavia, semplicemente osservando quanto è sempre accaduto e accade nel mondo e anche nelle nostre strade e nei nostri cuori, capii che, anche se fossimo tutti meticci, al razzismo, al pregiudizio razziale, probabilmente non vi sarebbe rimedio. Si troverebbero altre modalità, non tanto per distinguersi o per mantenere delle identità – cosa in sé a mio avviso per nulla deprecabile – ma per confrontarsi, rivaleggiare, prevaricare. E’ forse solo con la ragione, con il buon senso e con il guardare in faccia finalmente le nostre paure verso chi non sembra come noi; con la riflessione su ciò che siamo e siamo stati, con la costante vigilanza su noi stessi, sui nostri sentimenti e emozioni che possiamo cercare di evitare di cadere ogni volta nella spirale della paura, della diffidenza o dell’odio verso il diverso. Il senso del racconto di Ruth, uno dei sensi possibili, una “spiga” di senso lasciata magari in terra è, anche, questo. Paure e diffidenze si devono riconoscere e affrontare. La conoscenza, il contatto sono i veri antidoti del razzismo. Solo con l’esperienza della condivisione, del lasciare una porta aperta, si può provare a convivere nel quadro di un sistema di valori condiviso, che includa il rispetto per le rispettive peculiarità e senza farci sopraffare da questo grande male endemico del genere umano. 26 APPENDICE Due parole ai giovani: Progettare il futuro Vivere significa tante cose e non si possono esaminare tutte, ammesso che sia mai possibile portare a termine una simile impresa. Possiamo però ricercare delle chiavi di lettura, dei modelli interpretativi della realtà del vivere. Possiamo attingere, come faremo qui, alla saggezza di scritti e di scrittori, per cercare di mettere a fuoco delle parole chiave, delle frasi significative, capaci di lasciare il segno. Una di queste è posta sotto forma di domanda: un buon vivere è basato sull’avere o sull’essere? Assegnando istintivamente il significato più comune ai due verbi nella loro essenza, la risposta sembra scontata, soprattutto se a darla sono le generazioni più giovani e, se dovessimo fare un rapido sondaggio, dovremmo constatare come la maggioranza dei giovani sia per l’essere, pur magari con qualche distinguo, con qualche dubbio, e questa era anche l’intenzione, l’ipotesi da dimostrare di chi, come Erich Fromm, su tale argomento ha scritto un libro, uno di quelli che l’hanno reso noto al grande pubblico. Però la questione non si pone sempre e solo in termini di alternativa secca: o avere o essere e credo si debba ricercare un qualche legame tra questi due modi di interpretare la vita. Così possiamo dire: io sono quello che ho e definirmi in base al mio possesso dei beni materiali; oppure dire io ho quello che sono, con ciò affermando che il mio vero patrimonio è me stesso. Tutto il resto, che pure può esserci in termini di beni materiali, ne è corollario. Credo che ci rendiamo tutti perfettamente conto che tali discorsi suonerebbero del tutto fuori luogo se giungessero alle orecchie di chi, in ogni angolo della Terra, lotta quotidianamente per mettere insieme il pranzo con la cena; ma da queste parti di mondo una domanda di questo genere bisogna pur farsela e la risposta forse è meno scontata di quanto sembri. Proviamo ora ad addentrarci, senza farci intrappolare in quello che potrebbe diventare un labirinto da cui sia poi quasi impossibile uscire, in ciascuno dei due elementi estremi. Cominciamo pure dall’essere. Seguendo il filo di pensiero espresso, attraverso un suo romanzo, da un grande scrittore contemporaneo Amos Oz, credo si possa in linea di massima essere d’accordo con lui nell’affermare che, in qualunque cosa si faccia, in qualunque compito, incombenza che sia, occorra avere passione, pietà e gioia. Non una o due tra questi sentimenti, ma tutti e tre insieme, poiché se ne mancasse anche uno soltanto, verremmo ad essere privati anche degli altri. Non potremmo provare gioia, infatti, se nel nostro agire non vi fossero né passione né pietà; non proveremmo pietà quando si mancasse di gioia e di passione. E come potremmo mai aver passione in quel che facciamo, se non provassimo gli altri sentimenti della gioia e della pietà? In ogni caso non faremmo quello che siamo chiamati a fare con la pienezza del nostro essere. Quindi: agire in funzione dell’essere, del sentire, dei sentimenti e delle emozioni più profonde e più vere. Scomodiamo, ora, frasi dal valore universale, che le si consideri o meno anche scritte su ispirazione divina. Nel libro del Levitico, al capitolo 19, versetto 18, leggiamo una frase celebre, “forte”: ama il prossimo tuo come te stesso. Si sono fatti commenti di ogni tipo su tale frase, si sono trovati innumerevoli significati, tutti integrativi l’uno dell’altro, nessuno alternativo. Uno di questi è il seguente, formulato in modo lapidario: se non ami te stesso, non potrai amare gli altri, oppure: potrai amare gli altri nella misura in cui 27 saprai amare te stesso. Bene, ma cosa significa amare se stessi? Significa trovare occasioni per coccolarsi? Significa potersi togliere degli sfizi? Avere delle soddisfazioni, prendersi delle rivincite? Avere cura di noi? Avere rispetto del nostro corpo? Della nostra mente? Essere coerenti? Quindi se io mi sento bene, se io mi sento “a posto” con me stesso, se mi voglio bene qualunque sia il significato che al volersi bene si voglia dare, allora potrò rivolgermi validamente verso l’altro. Ecco ancora il richiamo alla pienezza di sé, alla coerenza, al fare ciò che ci fa sentire bene, in armonia con noi stessi. Messa così sembra anche facile. Il fatto è che noi ogni giorno e in ogni momento siamo chiamati a fare delle scelte, prendere delle piccole o grandi decisioni, che ci possono corroborare nel nostro benessere, nella misura in cui tali scelte siano coerenti con il nostro essere ed il nostro sentire, ma che ci chiamano anche a fare delle rinunce. Mi riferisco, quindi, alla capacità/necessità dello scegliere, all’inevitabilità dello scegliere. Spesso non sappiamo bene cosa scegliere tra le opzioni che abbiamo a disposizione. In tali casi, per identificare meglio le cause del dilemma, si tratta forse di riformulare meglio la domanda. Non: non so cosa scegliere, ma: non so a cosa rinunciare. Così forse si mette meglio a fuoco l’origine del disagio che talvolta ci impedisce di compiere una scelta, che è sempre inevitabilmente anche una rinuncia, ed è questo a rendercela difficoltosa. Haim Potok, che oltre ad essere uno scrittore era anche un rabbino, sottolineava che una cosa occorre che sia sempre chiara: quando un uomo ha una scelta da compiere sceglie ciò che è più importante per lui. Non vi devono essere equivoci a questo riguardo e bisogna sgomberare il campo da tentazioni colpevolizzanti del genere egoistico: se faccio una scelta in base a cosa sia o meno importante per me, allora sono un egoista. No! E’ un falso problema! Perfino il missionario che decide di spendere la propria esistenza a favore della gente del più sperduto angolo della terra, fa una scelta basata su cosa sia più importante per se stesso: spendere la propria vita, appunto, per quello scopo anziché per un altro. Quindi ancora una volta il riferimento ultimo è il proprio benessere. E, a tal proposito, non vale nemmeno il dire “su quella questione non avevo scelta”, oppure “era una scelta obbligata, condizionata”. E’ un punto di vista limitato, fondamentalmente sbagliato. In linea di principio noi possiamo sempre scegliere, perfino di fronte ad un fucile puntato. La vera questione è invece la posta in gioco, ciò a cui sono disposto a rinunciare. La domanda allora può essere: “ne vale la pena di fare questa scelta, di prendere questa decisione?” Ancora, non vi sono scelte obbligate, se non quelle che altri fanno per noi e in quel caso non saremo più noi a scegliere, ma, appunto, altri per noi. Possiamo invece dire che non sempre, anzi quasi mai, vi è una possibilità di scelta tra una gamma numericamente soddisfacente di opzioni. Peraltro vi è scelta già quando le opzioni siano soltanto e almeno due…. Ma tra quelle possiamo comunque pur sempre scegliere. Ognuno di voi ha scelto di fare un certo percorso di studi, piuttosto che di cercarsi presto un lavoro. Ha scelto, o sta scegliendo, la persona con cui vivere, alla quale dedicarsi. Chiedetevi, diceva Potok, per cosa è stato importante aver compiuto queste scelte e cosa sarà importante per voi in quelle che farete. Chiedetevi anche a cosa sarete disposti a rinunciare. Infine, che possa interessare o meno soggettivamente, con ogni scelta che compiamo, comunichiamo consapevolmente o meno - al mondo, alla gente che ci percepisce, che ci conosce, quale specie di persone noi siamo. Noi tutti siamo l’esito, la risultante delle nostre scelte, oltre che di quelle che altri hanno compiuto per nostro conto, ed è in base a quelle che ci definiamo agli occhi degli altri. Veniamo ora al primo dei due verbi posti in contrapposizione, l’avere. Talvolta, nella mia professione di valutatore del personale da inserire in azienda o da far crescere in un percorso di carriera, pongo a dei gruppi di ragazzi, un quesito di questo genere, certamente molto provocatorio: se foste soci di una società di pubblicità e pubbliche relazioni che, per sopraggiunte difficoltà economiche, si trova sull’orlo del 28 fallimento, pur di sopravvivere fareste una campagna pubblicitaria per conto di un’associazione razzista che ve la commissionasse? La maggior parte di loro, rispondendo d’impulso e sulla base del loro sistema di valori, solitamente rifiuta tale proposta e lo fa anche adducendo, in aggiunta alle prime che rimangono quelle preponderanti, ragioni pratiche, concrete, tipo “perdere la faccia”, la credibilità, bruciarsi il mercato ecc. In un secondo momento, tuttavia, quando quei ragazzi affrontano la questione andando ad esaminare altri elementi di valutazione, allora emergono considerazioni diverse: chi è il cliente potenziale di una agenzia di pubblicità, stante che non è né il vicino di casa, né il parente o l’amico, ma sono società, le quali “misurano”, valutano secondo parametri economici e di opportunità; come reagirebbe l’opinione pubblica (la valenza di provocazione) ad una simile pubblicità; e, ancora, si valuta la possibilità di acquisire nuova visibilità. Inoltre alcuni tra quei ragazzi cominciano a considerare che in fondo chi fa pubblicità ha un ruolo simile a quello di un avvocato difensore, cui importa poco chi deve difendere, poiché il suo ruolo è appunto difendere chi è accusato di un reato senza dare giudizi di valore e, ancora, la possibilità di negoziare condizioni, di formulare quella disgraziata campagna pubblicitaria in modo da non andare contro la legge; non ultimo la possibilità di guadagno. Alla fine, dopo dibattiti talvolta anche accesi e sofferti, una parte non indifferente di quei ragazzi decide di poter accettare di fare quella pubblicità. Eppure i loro convincimenti di fondo rimangono immutati. Che cosa è successo? Cosa è cambiato? Come si può partire da un no deciso e arrivare entro una mezz’ora ad aderire ad una richiesta che rimane in ogni caso discutibile? In quella mezz’ora quei ragazzi hanno valutato altre opzioni, altre opportunità; hanno esaminato vincoli, opportunità e la conclusione, anche quando sia stata positiva, è quasi sempre gravata da un dubbio al riguardo della correttezza sul piano etico – morale. Quei ragazzi hanno dovuto confrontarsi con due aspetti, con due sistemi che regolano la convivenza civile: il primo è il corpo di leggi, che regolano i rapporti tra i cittadini di uno Stato; il secondo è l’impianto etico valoriale di cui ciascuno di loro, come tutti noi, è portatore e che, tra l’altro, regola un sistema di coerenze personali ed interpersonali. Ciò di cui si rendono più o meno chiaramente conto sono due elementi: il primo è che non sempre il sistema delle leggi è sovrapponibile a quello etico valoriale; il secondo è che loro, negli ipotetici panni di soci di una società, (quindi non sul piano personale, non a livello individuale) non possono decidere a prescindere dalle valenze economiche che le loro decisioni implicano e che la priorità è quella di muoversi nient’altro che all’interno della legalità; ciò a dire che, chi più chi meno, mettono da parte il loro personale sistema di valori, a favore della continuità della società stessa, che significa – non dimentichiamolo - possibilità di benessere per loro e per chi, nella simulazione, con loro lavora. Siamo nella sfera dell’avere, ma già solo per questo possiamo permetterci di storcere il naso? Del resto: come giudicheremmo un nostro amico che accettasse un impiego presso un’industria di armi? Cosa diremmo di quel direttore del personale (professione in sé talvolta ambita) che dovesse eseguire la decisione della proprietà dell’azienda di operare riduzioni collettive di personale, sapendo di poter mettere in difficoltà economica intere famiglie? Le risposte immediate sono troppo facili e trancianti; peraltro rispondere, come facevano tanti tra quelli della mia generazione “ok tanto io non accetterò mai di fare quel mestiere”, oggi è, se non ingenuo, certo insufficiente ed illusorio e del resto molti di loro, quei mestieri poi li hanno pure fatti… In ogni caso, comunque e qualunque cosa si faccia, prima o poi ci si dovrà confrontare con la dimensione dell’avere, con le ragioni “degli altri”, ragioni opposte alle nostre, talvolta a noi aliene e con i “conti” che devono sempre tornare. Certo, possiamo sempre scegliere e decidere che no, quell’impiego non lo si accetta, quell’incarico ci si rifiuta di eseguirlo, quelle condizioni di lavoro non si possono proprio accettare e allora bisognerà 29 considerare l’eventualità dell’impatto che tali scelte avranno sulle nostre condizioni di vita, sulla qualità delle nostre relazioni, dei nostri affetti. Si tratta quindi di ricercare un modo per operare nella dimensione dell’avere salvaguardando quella dell’essere. Per ricercare un equilibrio, quantunque sempre instabile, tra essere e avere, forse allora occorre che ciascuno possa fare per se stesso un progetto di vita. Occorre domandarsi quali possibilità vi siano nel contesto in cui ci si trova ad essere, quali siano le attitudini, quali le proprie istanze e quali quelle della persona con cui quella vita intendiamo condividere; quali i desideri, le priorità. E poi cercare di definire cosa fare e perchè, in quanto tempo, con quale percorso. Mettere correttamente a fuoco le implicazioni, valutare la fattibilità, chiedersi per tempo a quali compromessi si sia disposti a scendere. Più in generale, in questi anni si parla spesso di pace e ancora più spesso non ci si rende conto che non ci può essere pace senza benessere, senza tranquillità, senza equità, senza negoziare condizioni e che benessere e tranquillità si otterranno solo a prezzo di qualche rinuncia, di tralasciare le particolarità, le posizioni individuali e assolute, a favore di quelle generali e relative, opinabili; di favorire, alle certezze, le possibilità. Questo vale per le grosse questioni internazionali come per quelle interpersonali. Il progredire nelle nostre vite sarà anche frutto della capacità che avremo di ricercare ciò che è possibile e di preferirlo a ciò che in linea di principio sarebbe giusto per ciascuno di noi; dipenderà dalla capacità che avremo di riconoscere cittadinanza alle istanze dell’altro e di lasciare all’altro un suo spazio vitale, chiedendo in cambio di averne per noi, in una logica di scambio, di fiducia e di comprensione tra pari, senza cedimenti ma con la necessaria flessibilità. E, mi si perdoni se uso un termine spesso strapazzato, con amore. I conflitti, i problemi, sia quelli tra persone che quelli tra popoli, sono provocati dai valori e non fai fatti, non dalle cose in sé, ma dal peso che ad esse si dà. Un proverbio attribuito a Mao Tse tung dice: “non importa che il gatto sia bianco o sia nero; ciò che conta è che prenda i topi”. Quando, diversi anni fa, mi occupavo di salute mentale in un’industria metalmeccanica, ero, nei primi tempi, costantemente in conflitto con il mio capo ufficio. La causa era il peso diverso che ciascuno di noi dava ad un dato problema da risolvere. Quando si smise di chiederci perché fare una certa cosa e sostituimmo a quella domanda quell’altra, decisamente più pragmatica: “cosa facciamo di fronte a questo problema”? semplicemente smettemmo di litigare, poiché sulle cose da fare (e non sul perché farle), si trovavano facilmente delle convergenze. Un’ultima cosa: sono sempre più convinto che tutto ciò che nella vita si apprende, vada a far parte di un bagaglio di esperienze che prima o poi torna utile. Sono altresì convinto che occorra essere sempre pronti, attrezzati, avere grande dimestichezza con gli strumenti cognitivi ed operativi di cui disponiamo. Che occorra essere anche consapevoli di non poterci permettere di ingabbiarci dentro i nostri stessi principi, né nei nostri punti di vista, per il solo fatto che sono quelli che noi conosciamo, poiché molto spesso ciò che ci troveremo ad affrontare sfugge alle logiche precostituite, le persone con cui viviamo sono in buona parte, ed io dico per fortuna, imprevedibili e non esistono ricette per vivere felici. Che per imparare l’altro, occorre ascoltarlo e capirlo. Quindi si deve imparare ad interpretare la realtà in cui ci troviamo ad agire e la persona con cui condividiamo l’esistenza, puntando a ciò che è ragionevolmente possibile e condivisibile, prima che a ciò che riteniamo rigidamente giusto. 30 Giorgio Tavani fin dagli studi universitari si è fatto domande, molte, e ha trovato risposte, poche e provvisorie, al riguardo delle narrazioni dei libri della Bibbia, così come della situazione dell’attuale Medioriente. Dalle aule della facoltà di Sociologia iniziava a coltivare l’interesse per le vicende dei popoli di quelle terre e contemporaneamente per l’archeologia biblica e verso la ricerca del significato originale del racconto biblico. Per tentare di meglio comprendere le une e agli altri, ha studiato la lingua ebraica, da più di quarant’anni si reca ricorrentemente in quei territori per soggiorni finalizzati sia allo studio, alla conoscenza della società israeliana e araba e alla loro evoluzione sociale e politica, sia alle scoperte archeologiche e alla relazione che quest’ultime possono o no avere con il Testo biblico. 31
Scarica