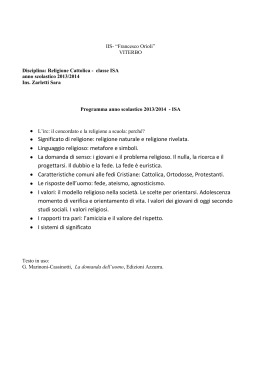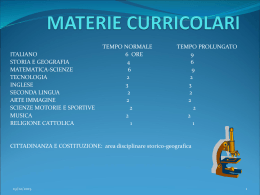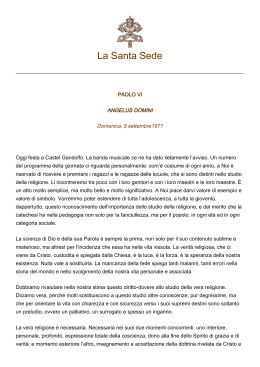La fictio del sacro. Il Theophrastus Redivivus e il fondamento della sovranità politica. di Alfredo Gatto Il Theophrastus Redivivus [1] è un trattato di erudizione ateistica che anticipa il progetto batailliano di dare forma e sostanza ad una “Somme atheologique” da contrapporre al grande magistero tomista. Scritta da un anonimo nella seconda metà del XVII secolo, l’opera sembra abbandonare ogni precauzione barocca fondata sul gioco della dissimulatio [2], proponendosi esplicitamente come un esercizio di moderna ateologia necessaria per rendere, come suggerisce Yves de Paris nell’incipit della sua Théologie naturelle, “la raison humaine indépendante du Ciel [3]”. Il Theophrastus, nel tentativo di delineare una nuova genealogia del pensiero critico, intende quindi consegnare al lettore, grazie ad un vastissimo apparato di conoscenze storiche e filosofiche e teologiche, un’immagine della tradizione affatto differente da quella che si era imposta – grazie alla mediazione della scolastica suareziana e all’impegno dei ‘nuovi’ apologeti [4] – nella temperie culturale del tempo. Accanto ai classici rappresentanti del materialismo antico, l’autore indica come numi tutelari della propria indagine pensatori quali Campanella, Cardano e Bodin, Machiavelli e Pomponazzi, spesso reinterpretati alla luce della ‘sapiente’ mediazione vaniniana, e tutti citati nel frontespizio del volume [5]. I filosofi a cui fa riferimento il Theophrastus per dare forza alla propria interpretazione sono sostanzialmente gli stessi a cui si richiama la polemica anti-libertina. Nella “bibliothèque des libertins” descritta da Francois Garasse sono infatti presenti tutti gli autori che l’ortodossia intendeva dialetticamente (e non solo) eliminare. Ecco che “le premier rang contient le Pomponace, le Paracelse et Machiavel”, mentre “le second rang de la bibliothèque de nos athéistes contient Jérôme Cardan, Charron et Lucilio Vanini”; nel “troisième ordre”, infine, ci sono “des livres qui concernent non seulement la croyance, mais qui touchent aussi les moines et sont des ouvrages d’une si horrible impudicité que j’ai honte d’en parler clairement [6]”. Anche Mersenne, nella sua disamina dei libri pericolosi, capaci di ingenerare sentimenti contrari all’ortodossia (“atheismo scaterent”), menziona nelle Quaestiones in Genesim gli stessi autori e gli stessi testi già analizzati da Garasse: accanto alle classiche opere di Machiavelli “de principe et republica”, al libro di Charron “de sapientia”, troviamo anche i testi di Cardano “de subtilitate et iudiciis astrorum”, senza dimenticare naturalmente “Campanellae, Vanini dialogi [7]”. Il Theophrastus Redivivus appare dunque come la ‘summa’ di tutte le eterodossie che hanno svolto un ruolo decisivo nel conflitto filosofico precedente. Facendo propri alcuni filosofemi classici, già sviluppati dalle correnti più radicali del libertinismo europeo, quali 67 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X la critica dell’antropocentrismo mutuato dall’esegesi biblica, i dubbi circa l’affidabilità storica della Sacre Scritture, fino alla messa in questione della centralità e superiorità dell’uomo sull’animale [8], il trattato si pone come l’esito ultimo e più maturo di un lungo processo critico di cui l’autore intende ora ricostruire le tracce. Da un utilizzo accorto e raffinato delle fonti antiche, fino al recupero dell’eresia mondana e materialista rinascimentale, il Theophrastus prova dunque a delineare un’opera capace di portare alla luce il sottosuolo che ha sempre costituito la linfa vitale di quel gioco di maschere che rappresenta, nelle convinzioni dell’autore, il fenomeno religioso. Ecco allora che l’opera di smascheramento delle proprie intenzioni, ironicamente esemplificata all’inizio del testo [9], fa da contraltare alle dinamiche fittizie e ai processi di consapevole dissimulazione fatti propri da tutti i pensatori precedenti. L’idea portante dell’intero trattato, infatti, è che la posizione atea e materialista, lungi dall’essersi costituita come un’opzione minore nel panorama concettuale del passato, costituisca la linea portante dell’intera tradizione filosofica. Il compito del “Tractatus Primus” [“Qui est de diis”] [10], dedicato al divino e al sistema di credenze che l’hanno storicamente supportato, sarà quindi quello di dimostrare il sostanziale ateismo di tutti i legislatores e i sapientes che si sono succeduti nel corso della storia. Se il proposito di ricondurre autori come Aristotele e Cicerone nell’alveo di una comune tradizione ateistica, pur non essendo così agevole, è comunque possibile – eliminando dal primo ogni mediazione scolastica e rileggendo il pensiero del secondo alla luce del suo De natura deorum –, il tentativo di presentare Platone come un astuto e consapevole eresiarca è un’impresa certo più complessa. Ad ogni modo, l’erudizione come prassi dinamica e corrosiva, necessaria per mettere in crisi un intero sistema di credenze e saperi, manifesta, proprio in questo particolare frangente, la sua utilità pratica e teorica. Il Theophrastus, infatti, attraverso una sottile riconfigurazione di alcuni passi platonici estratti dal loro contesto, intende persuaderci che Platone, “propter ignorantiam plebis” [11], decise scientemente di non consegnare al suo pubblico di lettori la propria personale opinione sulla natura del divino, preferendo rifugiarsi in un coacervo di immagini e racconti mitici, in un pensiero figurale libero da qualsivoglia verifica concettuale. Lo stesso stile dialogico è preda di questa riposta intenzione: utilizzato dall’Ateniese come uno strumento formale capace di dissimulare, nel posticcio conflitto dialettico che si andava inscenando, la propria teoresi, il dialogo consentiva a Platone di indossare svariate maschere senza essere mai individuabile, in modo stabile e definitivo, in una di esse. Il plesso cardine dell’interpretazione proposta nel Theophrastus fa leva sulla Seconda Lettera platonica, un noto falso, che tuttavia l’autore utilizza come grande prologo all’opera di demistificazione a cui si sta per dedicare. Platone, incalzato da Dionigi circa i principi primi della propria filosofia, risponde nel modo seguente: “Tu affermi, a quanto lui mi dice, che non hai avuto sufficiente dimostrazione circa la natura del «primo». Bisogna però che te ne parli per enigmi, in modo che, se per terra o per mare capita qualche incidente a questa lettera, chi la legga non capisca [12]”. La reticenza platonica sull’opportunità di 68 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X rendere presente, con abiti discorsivi, la natura dei principi primi, anziché essere un segno dell’impossibilità costitutiva del linguaggio di dire l’Uno senza contraddirne la natura, come vorrebbe la lettura neoplatonica, o significare una scelta esoterica destinata a rendere inaccessibile ai profani il culmine della propria teoresi, è invece per il Theophrastus la traccia di una pedagogia fondata sull’inganno. Non è infatti un caso che Platone si serva, per dare vita alla sua indagine sull’origine del cosmo, proprio di elementi mitici e favolosi, perfettamente idonei per garantire ai governanti una storia fittizia e priva di ogni fondamento da raccontare al popolo, col fine di giustificare, e così perpetuare, l’esercizio del loro potere. Prestando particolare attenzione alla lettera del testo, è proprio Platone, nel secondo e quinto libro della Repubblica, a giustificare la falsità che può talora farsi largo nelle parole, ponendola in relazione a quelle favole antiche destinate a dare un senso, e quindi un ordine, alla nostra provenienza: “E che dire della falsità delle parole? Quali sono le occasioni e le persone cui essa è utile sì da non attirarsi odio? Non forse nei rapporti con i nemici? E non diventa utile, come un farmaco, anche verso coloro cui si dà il nome di amici, per dissuaderli ogni volta che un accesso di furore o di follia li spinge a qualche cattiva azione? E non la rendiamo utile quando nelle favole antiche or ora ricordate foggiamo il falso quanto più possibile simile al vero, ignoranti come siamo del vero svolgersi di quei fatti antichi? [13]”. Inoltre, visto che i legislatori sono costretti spesso a servirsi di svariati farmaci, “potrà darsi che i nostri governanti debbano ricorrere spesso a menzogne e inganni, nell’interesse dei governati. E abbiamo detto che, se usate come farmaci, tutte queste menzogne e inganni sono giovevoli [14]”. Al termine dell’avventura platonica, nelle pagine aspre e serotine delle Leggi, il giudizio di Platone, lungi dall’essere cambiato, sembra essere ancora più disincantato e favorevole alla necessità di perpetuare l’ordine della polis con miti, favole e canti, comune patrimonio di una fantasia menzognera: al legislatore non resta allora che “indagare e scoprire che cosa deve far credere a una città per procurarle il massimo beneficio [15]”. È proprio dunque il costante richiamo platonico alla necessità di una prassi affabulatoria come strumento politico per garantire la stabilità della polis una delle prove che il Theophrastus adduce per fare di Platone uno dei capostipiti della teoresi ateistica, essendo le favole e i miti e i racconti null’altro che un esercizio retorico privo di ogni positivo riferimento ad una supposta realtà esteriore. All’interno della trame che l’autore del trattato sta intessendo, Platone non è quindi solamente un ateo teorico, ovvero l’autore che è riuscito a nascondere nella dispersione degli attori delle sue rappresentazioni dialogiche le proprie personale convinzioni, ma è anche, e forse soprattutto, uno dei primi pensatori ad aver posto un legame indissolubile fra le menzogna, nobilitata con abiti religiosi, e il suo utilizzo in ambito politico [16]. Operando un simile collegamento, il Theophrastus ripercorre un topos già ampiamente sviluppato da Giulio Cesare Vanini nel suo Amphitheatrum aeternae providentiae. Nella Exercitatio VI, infatti, l’idea che la riflessione platonica costituisse una delle stazioni principali del cammino che ha portato il potere politico a rinsaldare l’esercizio della propria auctoritas attraverso la riconfigurazione 69 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X mondana di tematiche religiose, era un dato oramai acquisito: “Niccolò Machiavelli, che è senza dubbio il principe degli atei [Atheorum facile Princeps], nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e nel pericolosissimo libercolo [perniciosissimo libello] sul Principe, scritti in lingua volgare, ritiene che tutte le profezie siano false e che siano state inventate dai principi per addomesticare lo sprovveduto popolino, affinché la religione lo richiamasse ai propri doveri, dal momento che era affatto sordo alla ragione. Anche Socrate nel II libro della Repubblica, per lo stesso fine, giustifica la menzogna in ciò che concerne la religione e Scevola, come riferisce Agostino nel IV libro del De civitate Dei, cap. 9, era solito dire: «È lecito che in fatto di religione i popoli siano ingannati». Da qui si è diffuso il comune ritornello: «Il mondo ama essere gabbato; dunque lo sia» [17]”. All’origine del tutto vi è dunque una favola, ovvero un apparato di miti e credenze, immagini e racconti, necessario per dare forma al timor del vuoto, e così tracciare dei confini abitabili dalla parola dell’uomo. Questo dispositivo di riempimento, tuttavia, nel progredire storico sembra aver perso, come suggerisce il trattato, la sua presunta innocenza, trasformandosi in un costrutto, sapientemente utilizzato da legislatori e politici, per fondare e giustificare l’esercizio del potere politico. Nel secondo capitolo [“In quo de prima deorum notione agitur et declaratur quomodo ad homines pervenerit”] del “Tractatus Primus”, l’autore, riprendendo la nota etimologia platonica del termine θεός [18], riconduce il piano del divino all’interno di un orizzonte meramente materiale, eliminando qualunque scarto passibile di introdurre una realtà non immediatamente riconducibile all’ambito naturale. Gli dei altro non sono che una proiezione umana, una creatura finita, un figmentum che trova la condizione della propria possibilità nel processo, dinamico e creativo, messo in moto dalla fantasia dell’uomo. È però solo l’ingegno di alcuni astuti legislatori ad aver trasformato questo mito primitivo in uno strumento di coercizione politica, necessario per fornire un fondamento trascendente all’esercizio del proprio potere. In questo processo di smascheramento proposto dal Theophrastus, lo spazio del sacro non è altro che il frutto della fantasia umana, uno strumento figurale di rincalzo che disvela l’essentia politica e polemica della religione. Dopo aver ricondotto l’ambito del divino ad un racconto capace di indagarne la genealogia, si tratterà ora di dare vita ad una fenomenologia critica del religioso, confermando i rilievi svolti in precedenza sulla natura eminentemente politica del sacro. Il “Tractatus Tertius” [“Qui est de religione” [19]] si occuperà di svolgere un tale compito [20]. L’istituzionalizzazione della religione, vale a dire il suo essersi costituita come un apparato teorico e immaginifico, dotato di un ordine intrinseco e di un sistema di regole necessarie alla sua conservazione, è un fenomeno storico riconducibile, nella sua interezza, alla fine dello stato di natura. Fin quando le relazioni umane non furono preda di norme etiche e apparati giuridici, destinati a uniformare le singole azioni ad un ordine positivo frutto di conflitti consumatisi altrove, nei rapporti umani non esisteva alcuna sproporzione, e tutti vivevano in uno stato di sostanziale uguaglianza. Tuttavia, non appena questa situazione edenica venne meno, e la forza dei singoli, unita alla loro 70 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X capacità di costituirsi in gruppi autonomi, iniziò ad emergere, un nuovo sistema di saperi e poteri si impose, scompaginando lo scenario di una comune origine naturale. Ecco allora che la religione, e le norme vincolanti che da essa derivano, diede inizio ad una differente ed inaudita organizzazione civile, funzionale a legittimare il nuovo equilibrio che si andava configurando: “Cum enim natura omnes homines aequali sorte gaudere voluerit, nulli supra alios imperium concessit; sed ambitio quorundam illud inique tam ingenii quam corporis viribus occupavit. Plus equidem sagacitas ingenii, quam corporis vires in hac re primum profuit: nam persuadendo vincere, quam pugnando superare rectius et securius semper fuit, tum praesertim cum prima dominationis insuetae fundamenta ponuntur. Primi igitus quos incessit regnandi libido, ad artes et commenta animum traduxêre et leges ad societatis vinculum condidêre. Deosque excogitaverunt, eo modo quo in tractatu de diis retulimus, et religionem, quae est de rebus ad deos pertinentibus tractatio, instituerunt” [21]. La fine dello stato di natura e la nascita della religione imposero, inoltre, una riflessione sul ruolo fondante della morale. Se la natura non sembra offrire alcun sistema di valori prestabilito, sarà dunque opportuno e necessario dare vita ad una istituzione capace di delineare dei nuovi criteri di comportamento, garantendone la legittimità attraverso un umano racconto, quindi grazie ad una fictio deliberata che sappia ricondurre la loro origine ad un supposto fondamento trascendente. I legislatori, queste piccole divinità creatrici, non dovranno allora far altro che stabilire, ex nihilo, forti del proprio personale interesse, il giusto e l’ingiusto, il bene e il male: “Legislatores iustum iniustumque legibus statuerunt, et bonum malumque definierunt ” [22]. All’interno di una tale contesto, il fondatore di qualunque religione non può essere altro che un astuto politico e un abile legislatore, capace di piegare ai propri fini il sistema di credenze del popolo, giustificandolo attraverso un positivo rinvio ad un qualche fondamento divino. Nel secondo capitolo [“In quo diffuse ostenditur religionem omnino esse artem politicam”] del “Tractatus Tertius”, il Theophrastus Redivivus riconduce le religioni ad un comune schema ermeneutico, tutto incentrato sull’opportunità di delineare un sistema dottrinario che sappia garantire un nuovo ordine politico [23]. La tradizione religiosa, dunque, lungi dall’essere fondata su un evento salvifico che irrompe nel mondo sconvolgendone i tratti, è venuta costituendosi come un’autentica prassi creatrice, perfettamente riconducibile ad interessi e stimoli mondani. La lezione di Machiavelli è, a questo riguardo, determinante: Numa Pompilio, infatti, dopo essere succeduto a Romolo, “trovando un popolo ferocissimo e volendolo ridurre nelle obedienze civili con le arti della pace, si volse alla religione come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà; e la constituì in modo che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in quella republica; il che facilitò qualunque impresa che il senato o quelli grandi uomini romani disegnassero fare (…) Quelli cittadini temevono più assai rompere il giuramento che le leggi; come coloro che stimavano la potenza di Dio che quella degli 71 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X uomini, come si vede manifestamente per gli exempli di Scipione e Mallio Torquato [24]”. Ogni religione, a dispetto della sua specificità, è dunque l’individuazione, storicamente determinata, di una volontà comune, quella, cioè, di imporre un ordine alle fantasmagorie del popolo, così che possano essere coordinate all’interno di un potere costituito, governato da un principio trascendente. L’ampia analisi che il trattato dedica alle tre religioni monoteistiche – “De iudaica sive mosaicâ religione”, “De religione christianâ”, “De sarracenâ seu mahumetanâ religione” [25] – sarà così funzionale a confermare l’origine eminentemente politica del sacro. L’intento dell’autore è infatti quello di smascherare le reali implicazioni e le concrete dinamiche che rendono possibile ogni nuova tradizione religiosa. Ecco che il futuro fondatore di un qualunque credo, dovendo convincere la plebe della bontà e necessità del proprio dominio, si presenterà ai futuri sudditi secondo alcuni schemi prestabiliti: dovrà manifestare la propria vicinanza a Dio, portatore di un messaggio vincolante e veritiero; darà quindi voce ad una cosmogonia inaudita, narrando, con parole proprie, il messaggio divino; e dimostrerà inoltre, per dare corpo alla propria profezia attraverso innumerevoli miracoli, l’estrema potenza della verità di cui è testimone e rappresentante [26]. L’operazione critica che il Theophrastus conduce sui miracoli e sulle profezie, vale a dire su quell’insieme di strumenti necessari per legittimare la reale novitas a cui ogni religione sembra ambire, è di particolare interesse, poiché costituisce l’ultimo tassello di quel lungo processo di naturalizzazione del sacro che aveva avuto origine nell’ambito di alcune correnti rinascimentali. In questo particolare frangente, occupandosi del reale fondamento di eventi all’apparenza sovrannaturali, l’autore del trattato rielabora le considerazioni già svolte a suo tempo da Vanini. Nella sua Exercitatio VIII, l’eresiarca aveva infatti posto a tema, con spirito salace e fintamente apologetico, la questione relativa alla presunta verità dei miracoli, certo fondamentale per dimostrare la “Dei providentiam”. Soffermandosi sulle posizioni di Pomponazzi e Machiavelli, Vanini non si era limitato a ribadirne il contenuto, ma aveva sottolineato alcune sostanziali differenze nell’elaborazione di questa delicata problematica. In effetti, seppur all’interno di una comune volontà demistificatoria, le riflessioni di Pomponazzi non erano intenzionate a negare tout court la realtà degli eventi miracolosi, ma a ricondurre le loro condizioni di possibilità nel dominio di quelle cause naturali che presiedono lo svolgersi dei fenomeni mondani [27]. È invece Niccolò Machiavelli che “risolve questa questione con poca fatica. Egli crede che i miracoli siano escogitati e inventati dai principi per strumentalizzare i sudditi e dai sacerdoti sempre a caccia di guadagni e di onori” [28]. Il miracolo, dunque, ben lontano dal possedere un qualche fondamento divino, è perfettamente integrato nelle logiche di dominio del potere politico [29]. Grazie alla mediazione vaniniana, il Theophrastus Redivivus può così smascherare tanto la logica politica alla base di ogni tradizione religiosa, quanto la violenza ermeneutica che i 72 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X legislatori devono esercitare sulla natura affinché gli eventi del mondo siano predisposti a corroborare e riconoscere la loro legittima, e stra-ordinaria, sovranità. Come è stato già ampiamente rilevato da Gregory, “la connessione tra gli esiti estremi del naturalismo rinascimentale e le tesi machiavelliche – già chiara in un Vanini e sempre polemicamente denunciata da Mersenne e Campanella – costituisce la trame del discorso del Theophrastus Redivivus sulla religione, ove la riduzione dei fenomeni «straordinari» a cause naturali, quindi la negazione di una loro origine divina, dava libero corso alla spiegazione politica: questa infatti permetteva di comprendere come fatti «naturali» fossero stati sfruttati da uomini intelligenti e astuti per creare il «mito» del divino e affermare incondizionatamente il proprio potere sulla credula plebe [30]”. Anche in questo frangente, quindi, la pratica erudita, sempre alla ricerca di trame inaudite su cui ordire nuovi racconti, si rivela un esercizio critico concreto e foriero di infiniti sviluppi, capace com’è di gettare nuova luce su plessi e relazioni che non sembravano poter intrattenere fra loro alcuna relazione. Lontana dall’essere una pratica volta all’accumulo indiscriminato di sapere, l’erudizione all’opera in questa trattato si rivela una pratica corrosiva, essa stessa necessariamente affabulatoria, destinata a dare origine ad una contro-genealogia. Uno degli obbiettivi impliciti che il trattato si propone è infatti quello di mettere in crisi la supposta naturalità del potere politico e religioso. Ecco allora che la religione, quale concrezione storica di figmenta e di fantasie, paure e inganni, si rivela per quello che è, vale a dire una creatura umana, storicamente determinata, necessaria per rendere possibile lo spazio artificiale del ‘politico’ e per dare forma ad un insieme di precetti e divieti su cui edificare una nuova pedagogia. È bene sottolineare, ad ogni modo, che l’artificiosità del fenomeno religioso, ovvero il suo essere una creatura partorita dall’ingegno dell’uomo, priva di ogni rinvio allo spazio silente del sacro, non depone necessariamente a suo sfavore. Infatti, sebbene non possieda alcuna origine divina, l’impianto religioso è comunque, allo stato attuale del cammino evolutivo umano, necessario per la conservazione dell’ordine sociale. Gli abiti religiosi, dunque, nati come strumento politico di coercizione e organizzazione della vita civile, sono ora divenuti necessari: recidere il loro legame significherebbe infatti, alla luce dello sguardo disincantato del Theophrastus, minare alla radice la pace sociale, scompaginando proprio quell’ordine che ha garantito, fino ad ora, il dominio pubblico dell’autorità politica. Date queste premesse, la veridicità della religione – questa seconda natura nata dall’ingegno di alcuni legislatores e sapientes – sarà allora custodita dalla sua tradizione, quindi dalla trasmissione di un insieme di norme la cui origine sfugge alla presa intellettuale della ragione teoretica. Nel sesto capitolo [“In quo omnis religio bona esse ostenditur” [31]] del “Tractatus Tertius”, l’autore, facendo proprio il disincanto del sapiente, ribadisce, in un passaggio che è opportuno riportare per intero, la convinzione che il fondamento della religione, e le condizioni del suo perpetuarsi, trovino nella traditio la loro giustificazione: “Non ipsi non ignoramus, et uniuscuiusque conscientia sibi ipsi testis est, quod religionem sequimur, non tamquam a deo datam, sed instituentium authoritate, locorum consuetudine, usu patrio et educatione, Christianique, vel Mahumetani, vel Iudaei 73 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X dicimur, quemadmodum Academici, Stoici aut Peripatetici, secundum doctrinae et sectae genus cui a pueris addicimur; plerumque etiam metu poenarum aut praemiorum spe, quibus continemur, vel irretimur, aliud vivendi genus, alii mores aliae legislatorum authoritates, alia educationis nostrae institutio, alii metus, aut spes aliae, credulitati nostrae aeque imponerent, et animos nostros ad se pertraherent, ut inde certum sit religionibus nos adhaerere et illarum opiniores amplecti secundum quod unusquisque natus, educatus, institutus atque irretitus fuit. Et saepissime tandem, quia non audent plerique non credere, quae credunt a pueris percepta, timidi paventesque sibi a parentibus traditas servant opiniones prout unusquisque a naturâ est dispositus atque formatus, plus aut minus pertinaciter; senes etiam, pueri et mulieres quia imbecillioris sunt natuare, sunt etiam ut plurimum magis ad conservandam religionem apti atque idonei” [32]. Se ogni religione non possiede alcuna verità che non sia immediatamente riconducibile all’imperio dell’uomo, e se, parimenti, il suo apparato è giustificato solo dall’impossibilità di ritornare alle origini di questa fabula, ogni uomo dovendosi affidare solamente a quello spazio di credenze che si trova ad ereditare, ad essere giudicata necessaria non sarà tanto la religione, quanto le differenti modalità con cui questa fictio originaria è venuta articolandosi. In effetti, nonostante il ceppo ideologico del sacro sia comune, la realizzazione concreta di questa consapevole impostura ha incontrato, nei contesti storici in cui si è insediata ed imposta, diverse forme e contorti, plasmandosi secondo i bisogni e i costumi dei diversi popoli. Chiedersi, dunque, quale religione sia in grado di garantire con più efficacia questo artificio, non ha alcun senso; ogni insieme di credenze, essendosi corroborato nel proprio clima culturale, è infatti nelle condizioni di garantire l’efficacia e la stabilità del suo sistema politico, senza alcuna distinzione. Dato che non esiste alcun criterio per giudicare della verità di una religione, ogni sovrano – a patto che sia saggio e consapevole dell’impostura che sostiene il proprio trono – non dovrebbe avere allora alcuna ragione per escludere di principio una tradizione religiosa a vantaggio di un’altra [33]. Seguendo l’insegnamento che deriva dall’esempio dei Romani [34], dovrebbe anzi garantire ai propri sudditi un’assoluta libertà di scelta, così da eliminare ogni potenziale disputa – possibile anticamera di futuri disordini – all’interno del proprio regno. La tolleranza religiosa diviene in tal modo, e proprio all’interno di un contesto schiettamente ateistico, un ideale pratico da perseguire e difendere, con l’implicito obbiettivo di consentire all’impostura politica di esercitare serenamente il proprio dominio. La genealogia messa in opera dal Theophrastus non ha dunque lo scopo di scalzare il predominio che la religione continua ad esercitare negli organismi politici; solo, intende smascherarne i presupposti, consapevole che una repubblica di atei, sulle cui possibilità si pronuncerà Bayle, non è idonea a garantire la pace sociale. La ‘forma’ della tradizione sembra rimanere intatta. L’esercizio critico proposto dal trattato non ritiene infatti che la religione, quale strumento dei vari regnanti, e massima garanzia dell’ordine sociale, non debba più svolgere alcun ruolo all’interno delle dinamiche del 74 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X potere politico, ma si adopera ‘saggiamente’ per ricondurre il suo supposto fondamento trascendente ad una deliberata fictio umana. L’idea che il potere politico, spinto a salvaguardare la propria legittimità, fosse costretto a custodire un segreto e ad esercitare una consapevole opera di dissimulazione, intrattenendo un necessario commercio con la natura umbratile della menzogna, era un pensiero che aveva già iniziato a farsi strada in tutti quegli autori – intercettati e poi riutilizzati dal Theophrastus – che stavano ponendo le basi per una nuova indagine sul fondamento dell’edificio statuale. Nemmeno la riflessione teologica, e in particolare i suoi rappresentanti, ben accolti nel chiaroscuro di quelle stanze, era immune da queste sirene, consapevole dell’essenza problematica dell’autorità politica e religiosa. Prima che il Theophrastus togliesse definitivamente il velo all’ambiguo rapporto fra la dimensione religiosa e l’autorità sovrana del politico, sottolineando come la menzogna fosse una delle medicine essenziali al funzionamento della macchina del potere, negli ambienti gesuiti si era già consumata una lunga riflessione sulla statuto ontologico della menzogna e sulle sue svariate sfaccettature. Questa indagine, che arriverà fino a Descartes, non senza aver prima impegnato l’ingegno di un fine esegeta come Mersenne [35], era giunta ad alcuni punti fermi, ben esemplificati da autori quali Leonard Leys e, in modo particolare, Gregorio di Valencia [36]: posta l’omnipotenia Dei come criterio ultimo per decidere della liceità delle opzioni chiamate in causa, se era esclusa anche solo l’eventualità che Dio potesse mentire (data l’infinità bontà e perfezione che lo caratterizzava), vi erano tuttavia molti passi biblici che sembravano testimoniare l’utilizzo di alcuni strumenti ‘retorici’ quali l’aequivocatio e la restrictio mentalis. Sebbene rimanesse dunque bel salda l’essentia morale del divino, alcuni teologi gesuiti stabilirono, in taluni casi, “la legittimità dell’uso degli enunciati a doppia intenzione, aequivocatio, o la riserva mentale di una parte dell’enunciato, restrictio mentalis. Tali forme di inganno permettono di sfuggire alla menzogna che comporta, al contrario, la doppiezza interiore di colui che tace quel che pensa vero e dice quel che pensa falso. È proprio a tali forme lecite di inganno che essi riconducono i luoghi della Scrittura in cui i Profeti o Gesù stesso sembrano affermare il falso” [37]. I presupposti di queste considerazioni vennero criticati con particolare durezza dal benedettino John Barnes e dall’oratoriano Charles de Condren. Su diretta richiesta di Richelieu, Condren scrisse un Traité des équivoques [38] in cui si scagliò con veemenza contro la posizione ‘equivocista’, ritenendo più opportuno parlare, anziché di equivoci, di legittime ‘finzioni’ (fictionis). È certo curioso, perlomeno se poniamo in relazione il mandante di questa operazione culturale con le considerazioni svolte dal Theophrastus, che un saggio scritto contro la dottrina degli equivoci, quindi critico nei confronti di un discorso che non assuma la chiarezza e la distinzione come pietre angolari del proprio edificio concettuale, sia stato commissionato proprio da un religioso e uomo di stato. Seguendo le logiche argomentative del Theophrastus, la scelta di Richelieu è infatti perfettamente in linea con quel gioco di luci e ombre che è necessario al potere per 75 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X dissimulare la propria vera natura. Ecco allora che il volto dell’autorità, per continuare a mantenere ben salda la barra del proprio timone, è costretto a consegnare al pubblico dibattito un’immagine di sé che non faccia trasparire nessuna delle sue intrinseche caratteristiche. La moderna ragion di stato rinsalda in tal modo l’esercizio legittimo del proprio potere assumendo i tratti di una moralità univocamente determinatasi, così da sottrarre l’oscenità delle menzogna alla pubblica rappresentazione delle proprie virtù. Nella sua Dissertatio contra aequivocationes [39], John Barnes, consapevole della pericolosità delle tesi avanzate dai teologi gesuiti, rifiutò anche solo l’opportunità di istituire una qualche distinzione fra l’aequivocatio e la restrictio mentalis e la menzogna. Tanto la riserva mentale quanto l’equivocità implicano, nelle considerazioni svolte da Barnes, quella malizia sottesa all’inganno che è propria di ogni discorso menzognero. Un ipotetico ‘Deus aequivocator’ altro non può essere, dunque, che un Dio mendace. Il benedettino è ben consapevole delle possibili ricadute che una tale concessione potrebbe avere nel dibattito culturale del tempo. In effetti, se non si esclude immediatamente l’opportunità che Dio, anche in vista del bene delle proprie creature, possa ricorrere all’inganno, per quale motivo un legislatore – un essere finito e manchevole, sempre libero di poter sbagliare – non potrebbe invocare il diritto legittimo di comportarsi nello stesso modo? Perché anche i governanti non dovrebbero mentire al proprio popolo, con l’intento di garantire ai propri sudditi un bene più grande? Inoltre, se la religione sembra poter ospitare talvolta l’equivoco e altre forme decettive di comunicazione, e questo a detta dei propri stessi rappresentanti, come porre un freno alle genealogie critiche sul fondamento politico e menzognero della religione? Le osservazioni del benedettino Barnes incontreranno nelle pagine del Theophrastus Redivivus la conferma della loro bontà e preveggenza. Nelle pagine anonime di questo testo, le accortezze e i distinguo gesuitici andranno così incontro alla propria nemesi. Prima che questo accada, tuttavia, John Barnes venne condotto nelle prigioni romane, finendo per trascorrere i propri ultimi giorni, come raccontato da Pierre Bayle nel suo Dictionnaire [40], in un ricovero per malati mentali. Prima che le pagine di questo trattato svelassero dunque la natura umbratile e menzognera del potere, narrando con divertita e sottile ironia le sue dinamiche, e proprio nel momento in cui queste stesse logiche, nascoste fra le pieghe barocche della modernità, si stavano intessendo, solo un folle avrebbe potuto portarne alla luce la trama. NOTE: 1. Theophrastus Redivivus (1659), ed. critica a c. di G. Canziani e G. Paganini, II Vol., La Nuova Italia, Firenze 1981-1982. Oltre all’articolo di J. S. Spink, La diffusion des idées matérialistes et antireligieuses au début du XVIIe siècle: le «Theophrastus Redivivus», Revue d’historie littéraire de la France, 1937, pp. 248-355, uno 76 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X degli studi più completi e accurati è quello di T. Gregory, Theophrastus Redivivus. Erudizione e ateismo nel seicento, Morano, Napoli 1979. 2. Su questo tema, cfr. J.-P. Cavaillé, Dis/simulations. Religion, morale et politique au XVIIe siècle. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto, Editions Champion 2002. 3. Yves de Paris, La Théologie naturelle, Vol. I, Paris 1640, p. 5 4. Fra i vari autori che in ambito cattolico cercarono di fermare l’avanzata della tradizione libertina e riformata è opportuno menzionare M. Mersenne, L’impiété des deistes, athées et libertins de ce temps, Paris 1624 e F. Garasse, La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendus tels, Paris 1623 (n. ed. a c. di J. Salem, Éditions Les Belles Lettres 2009). Sul confronto fra libertini e apologeti, T. Gregory, Apologeti e libertini, Giornale Critico della Filosofia Italiana, LXXXIX, 2000, pp. 1-35 e R. H. Popkin, The History of Skepticism (1979), trad. it., Storia dello scetticismo, a c. di R. Rini, Bruno Mondadori, Milano 2000. 5. La riproduzione del frontespizio è contenuta nelle pagine CXXV-CXXVI, fig. 1 (Vol. I), dell’edizione critica del Theophrastus citata in precedenza. 6. F. Garasse, La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendus tels, cit., pp. 1013-1016 (n. ed., pp. 856-858). Oltre alla collocazione dei singoli pensatori, sono i giudizi che l’apologeta rivolge a questi libertini, ‘ou prétendus tels’, ad essere motivo di particolare interesse. Se di Pomponazzi “je n’en puis dire autre chose sinon que c’est un très méchant homme à ce que je puis voir dans le misérable Lucilio”, Paracelso è piuttosto “un rêveur et alchimiste dangereux qu’un athéiste ou libertin”. Inoltre, se Charron non fu altro che “un très pernicieux ignorant qui a voulu parler de ce qu’il n’entendait pas”, sono le considerazioni su Giulio Cesare Vanini ad essere particolarmente dure e senza alcuna possibilità di appello: “Quant à Lucilio Vanini j’en ai dit ici dessus mon avis fort amplement. Je n’ai vu de lui que trois livres différents: savoir son Amphithéâtre, sa Sagesse et ses Dialogues. Dans son Amphithéâtre, il parle en hypocrite; en sa Sagesse, il parle en cynique; en ses Dialogues, il parle en parfait athéiste. Et c’est le plus pernicieux ouvrage qui soit sorti en lumière, il y a cent ans, en matière d’athéisme”, Ibid., pp. 856-858. 7. M. Mersenne, Quaestiones in Genesim, Lutetiae Parisiorum 1623, col. 671-672. Gli stessi autori citati da Garasse e Mersenne si ritrovano inoltre nei testi di G. Naudé, Advis pour dresser une bibliothèque, Paris 1627 e Bibliographie politique, Venetiis 1633. 8. La critica corrosiva che la tradizione libertina riserverà alla superiorità dell’uomo sul mondo animale è particolarmente interessante, e costituisce un leitmotiv di quell’opera di decentramento critico a cui si ispirava tutta la corrente del libertinismo erudito. L’idea che le leggi della natura, scandite dalla nascita e dalla morte, riguardandoci tutti, non permettano all’uomo di ergersi a giudice dei destini altrui, è una tematica molto presente in questa letteratura, come dimostra l’analisi svolta da Montaigne nei suoi Essais: “Noi non siamo né al di sopra né al di sotto del resto: tutto quello che è sotto il cielo, dice il saggio [Eccl., I, XXXVI], è sottoposto a una stessa legge e a una stessa sorte (…). Bisogna piegare l’uomo e costringerlo entro le barriere di quest’ordine. Il miserabile si attenta a scavalcarle di fatto; egli è legato e vincolato, è soggetto agli stessi obblighi delle altre creature della sua specie, e in una condizione assolutamente media, senza alcuna prerogativa, alcuna superiorità vera ed essenziale”, Montaigne, Essais, II, XII, trad. it., Saggi, a c. di F. Gravini, Adelphi, Milano 2007, pp. 594-595. Non è dunque “per un vero ragionamento, ma per una folle superbia e ostinazione che noi ci mettiamo al di sopra degli altri animali e ci isoliamo dalla loro condizione e compagnia”, Ibid., p. 632. Questo plesso concettuale è 77 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X ulteriormente sviluppato da P. Charron, De la Saggesse (1601), I, 8; da C. de Bergerac, Les Estats et Empires du Soleil, in Les Oeuvres libertines de Cyrano de Bergerac, Vol. I, par F. Lacgèvre, Paris 1922, e da Rorarius, Quod animalia bruta ratione utantur melius homine libri duo, Paris 1648. Il testo di Rorarius sarà recuperato da P. Bayle nella voce ‘Rorarius’ del suo Dictionnaire historique et critique (Cinquième édition, IV Vol.), Amsterdam, Leyde, La Haye, Utrecht 1740, trad. it., ‘Rorario’, in Dizionario storico-critico, a c. di G. Cantelli, Laterza, Roma-Bari 1976, pp. 145-215, così da porlo in relazione all’analisi di natura apologetica sviluppata da Descartes (Discours de la methode, 1637, V). Oltre agli autori citati, è opportuno ricordare la polemica anticartesiana di P. Gassendi (AT VII, p. 337) e i dialoghi di Vanini, dedicati ad una totale naturalizzazione della presunta specificità e irriducibililità del fenomeno umano (Dial. 30, “De piscium generatione” e Dial. 37, “De prima hominis generatione”, in G. C. Vanini, Tutte le opere, trad. it. a c. di F. P. Raimondi e L. Crudo, Bompiani, Milano 2010, pp. 1108-1121 e 1162-1167). Il Theophrastus si occupa di queste tematiche nel secondo capitolo del ‘Tractatus Sextus’ (Qui est de vita secundum naturam), in Theophrastus Redivivus, cit., Vol. II, pp. 805-839. La pericolosità di questo rivolgimento concettuale è testimoniata dall’attenzione che a questi problemi dedicarono sia M. Mersenne, Quaestiones in Genesim, cit., col. 234 sia F. Garasse, La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendus tels, cit., pp. 715-720 (n. ed., pp. 652-655). Sull’analisi cartesiana della ‘meccanica animale’, e sull’interpretazione offerta da Bayle, ci permettiamo di rinviare ad A. Gatto (2010). Per una teodicea meccanica. Descartes e il Rorarius di Bayle, Giornale Critico di Storia delle Idee, Vol. 4, ISSN: 2035-732X, pp. 128-144. Un’analisi puntuale e completa delle tematiche presenti nella tradizione libertina è fornita da T. Gregory, Il libertinismo della prima metà dei Seicento. Stato attuale degli studi e prospettive di ricerca, in T. Gregory – G. Paganini – G. Canziani – O. Pompeo Faracovi – D. Pastine (a c. di), Ricerche su letteratura libertina e letteratura clandestina nel Seicento, La Nuova Italia, Firenze 1981, pp. 3-47; cfr. T. Gregory, Éthique et religion dans la critique libertine, in Genèse de la raison classique de Charron à Descartes, Puf, Paris 2000, pp. 81-112. 9. “Hunc librum doctissimis theologis ad atheorum confusionem, divinis illorum argumentis et validis rationibus delendum instruxi atque condidi”, Theophrastus Redivivus, cit., Vol. I, pp. 6-7. 10. Ibid., Vol. I, pp. 27-172. 11. Ibid., p. 28 (corsivo nostro). 12. Platone, Lettera II, 312 D-E, in Lettere, trad. it. a c. di P. Innocenti, Bur, Milano 2001, p. 79, corsivo nostro. Ecco la parafrasi latina del testo fornita dal Theophrastus: “Divinus etiam ille Plato, in secundâ Epistolâ ad Dionysium, dicis, inquit, non satis tibi demonstratum esse de Primi naturâ. Dicendum ergo tibi est per aenigmata, quo, si quid epistolae per ponti aut terrae fortunas accidat, qui legerit non intelligat, et subiungit, illud cavebis, ne umquam haec ad homines ineruditos dilabantur”, Theophrastus Redivivus, cit., Vol. I, p. 27. 13. Platone. Repubblica, II, 382 C-D, trad. it. a c. di F. Sartori, intr. di M. Vegetti, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 141. 14. Platone, Repubblica, V, 459 C-D, cit., p. 325. 15. Platone, Le Leggi, II, 664 A, trad. it. a c. di F. Ferrari e S. Poli, Bur, Milano 2005, p. 201. Platone ritorna su questa problematica anche nel decimo libro delle Leggi: “Anche la politica dicono che partecipi della natura in piccola parte, ma che soprattutto partecipi dell’arte, e così anche tutta la legislazione non è per natura, ma per arte, e le sue disposizioni sono vere (…) Questi dicono innanzitutto, caro, che gli dèi esistono per arte, non per natura ma in base ad alcune leggi, e che essi 78 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X sono diversi da luogo a luogo, nel modo in cui ciascun legislatore ha concordato con se stesso fissandoli per legge; e anche il bello è in parte per natura, in parte per legge [v. Crizia 88 B 25, Dieks-Kranz], e il giusto non è affatto per natura, ma gli uomini discutono continuamente tra di loro e cambiano sempre il giusto, e quel giusto che mutino e quando lo mutino, allora ciascuna di queste forme di giusto ha potere sovrano, esistendo per arte e in base alle leggi ma non per una qualche natura. Tutto questo, amici, è opera di uomini sapienti presso uomini giovani, di prosatori e d poeti, che affermano che la massima giustizia sia ciò in cui uno prevalga con la violenza; da qui si abbattono atti di empietà sui giovani, come se gli dèi non fossero quali la legge impone che si debbano pensare, e per questo motivo sorgono rivolte di coloro che trascinano verso la giusta vita conforme a natura, che in verità consiste nel vivere avendo il potere sugli altri e non essendo schiavo degli altri secondo la legge”, Platone, Le Leggi, X, 889 D – 890 A, cit., pp. 857-859. L’utilizzo della fabula come medicina necessaria per il governo del popolo è confermato dal Theophrastus: “Verum ut tanta authoritas vel a limine frangatur et extirpetur, videte iterum illum scribentem [in 2° de rep.], quia plebs et vulgares homines ad bona opera non trahuntur nisi ex spe praemii, et a malis non retrahuntur nisi timore poenae, fabulas ad instructionem illorum confictas esse et in tali casu quidem licere mentiri et fingere. Et iterum [in 2° leg.], si quid umquam, inquit, ad iuvenum utilitatem mentiri ausus fuerit legislator, non esse utilius mendacium quam quod efficere posset, ut non coacti, sed ultro omnes iustitiam amplectantur. Quare nihil aliud ipsum spectare et scrutari oportet, quam, qua persuasione usus, maximum bonum civitati exhibeat. In hoc autem omne studium ponit ut comperiat quonam modo universa civitas in cantilenis et fabulis per omnem vitam de his unum et idem quam maxime loquatur et sentiat. His verbis manifestum est Platonis authoritatem nullo modo valere posse in iis quae ab illo de diis, de mundo, de animâ et de inferis scripta sunt, utpote haec omnia innumeris fabulis miscuerit”, Theophrastus Redivivus, cit., Vol. I, pp. 29-30. 16. Con l’idea che dietro le favole del mito non vi sia altra verità che l’arbitrio di un sapiente e saggio legislatore cade, come ha suggerito opportunamente Gregory, “tutta una tradizionale esegesi che puntava sulla teoria dell’involucrum o integumentum quale idoneo strumento di iniziazione alla contemplazione di verità riposte sotto il velo del mito e che – in ambiti cristiani – serviva a ‘redimere’ filosofi e poeti antichi, leggendo nei loro miti la prefigurazione di verità cristiane. Per l’autore del Theophrastus Redivivus la fabula è l’espressione del carattere mitico, cioè non vero, di quello che si vuole esprimere; essendo falsa l’esistenza degli dei, ogni discorso sulla divinità non può procedere che con favole e miti”, T. Gregory, Theophrastus Redivivus. Erudizione e ateismo nel seicento, cit., pp. 28-29. 17. G. C. Vanini, Amphitheatrum aeternae providentiae, Exercitatio VI, in Tutte le opere, cit., p. 385. L’idea che i legislatori possano talvolta ricorrere consapevolmente alla menzogna, nell’intento di governare con più facilità il popolo, è affermato e giustificato anche da Montaigne: “Poiché gli uomini, per la loro insufficienza, non possono pagarsi abbastanza con una moneta buona, ci si serva anche della moneta falsa. Questo sistema è stato praticato da tutti i legislatori, e non c’è governo nel quale non vi sia qualche mescolanza o di vanità cerimoniosa o di opinione menzognera, che serva di briglia a mantenere il popolo nel dovere. È per questo che la maggior parte hanno origini e inizi favolosi e arricchiti di misteri soprannaturali. È per questo che ha dato credito alle religioni bastarde e le ha fatte tenere in onore da persone d’ingegno; ed è per questo che Numa e Sertorio, per rendere i loro uomini più devoti, li pascevano di questa sciocchezza, l’uno che la ninfa Egeria, l’altro che la sua cerva bianca gli comunicasse da parte degli dèi tutte le decisioni che prendeva. E l’autorità che Numa dette alle sue leggi sotto il pretesto dei Battriani e dei Persiani, la dette alle sue sotto il nome del dio Oromasi; Trismegisto, degli Egizi, di Mercurio; Zamolxi, degli Sciti, di Vesta; Caronda, dei Calcidi, di Saturno; Minosse, dei Candioti, di Giove; Licurgo, degli Spartani, d’Apollo; Dracone e Solone, degli Ateniesi, di Minerva. Ed ogni governo ha un dio a capo; falsi gli altri, vero quello che Mosè impose al popolo di Giudea uscito 79 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X dall’Egitto. La religione dei Beduini, come dice il signor de Joinville, contemplava fra le altre cose che l’anima di quello di loro che fosse morto per il proprio principe se ne andasse in un altro corpo più felice, più bello e più forte del primo; e in questo modo essi arrischiavano molto più volentieri la loro vita”, Montaigne, Essais, II, XVI, cit., pp. 840-841. 18. Platone, Cratilo, 397 D, trad. it. a c. di E. Martini, Bur, Milano 2000: “Io dunque sospetto suppergiù questo: credo, cioè, che i primi uomini viventi nell’Ellade stimassero iddii quelli soltanto che ora sono ritenuti per tali dalla maggior parte dei barbari: il sole e la luna e la terra e le stelle e il cielo; e in quanto li vedevano tutti andar sempre di corsa e correre, da questa loro natura del thein, del «correre», li avessero denominati theoi; ma che più tardi, avendo concepito gli altri, li chiamassero tutti con questo medesimo nome”, p. 119. 19. Theophrastus Redivivus, cit., Vol. II, pp. 341-555. 20. “Quia multi sunt qui exterioribus solum religionis figmentis decipiuntur existimantque deos esse, non quia illos esse vere sciant, sed quia religionem id docere animadvertant, prohibereque ne aliud homines sciant; cum e contra religione duci non deberent, nisi in quantum deos esse cognoscerent, non praetermittendum censemus quid philosophorum et politicorum opinionibus de illâ dictum sit, ad maiorem de omnibus ad deos pertinentibus cognitionem et certitudinem. Incipiam ergo a religionis origine”, Ibid., p. 341. 21. Ibid., pp. 343-344, corsivo nostro. 22. “Cumque homines tunc in lege naturae adhuc viverent indistincteque perpetuarent quaecumque illis libebat (nondum enim fas et nefas in usu erant, nec vitium, nec virtus erant nota nomina), legislatores iustum iniustumque legibus statuerunt, et bonum malumque definierunt; ita ut ea omnia quae in lege naturae bona erant in bona et mala legibus hominum divisa atque distributa fuêre, docentibus legislatoribus malum esse id quod lege vetitu, esset, et ab illo abstinendum; bonum vero id quod lege praeceptum et sanctium esset, et id faciendum”, Ibid., p. 344, corsivo nostro. 23. “Non praetermittendus est Moses Iudaeorum legislator, qui, ut Diodorus [lib. 2 cap. 3] tradit, ab Iao quem deum vocant acceptas leges dare prae se ferebat: sive putans rem divinam mirandam, maximeque mortalibus utilem leges esse, sive ut citius populi, ob rei excellentiam, deum timore, legibus obtemperarent. Mahometus etiam, ut refert Camapanella [ in atheis. triump. cap. 13], in antro ad montes Arabiae philosophabatur, et finxit leges suas ab angelo Gabriele accepisse, cumque morbo sacro laboraret, simulavit spiritu dei tunc rapi. Cinghus quoque apud Tartaros se filium Solis finxit et signa mirabilia fecit. Nam transire visus est mare Caspium sicco pede, sicut Moses Erithreum transivit, legesque tulit hac ratione, ut idem Campanella refert; non desunt etiam qui Christum se dei filium finxisse asseverent, ut facilius hominum animos religione conciliaret. Eius sectatores post modum divinitatem illi attribuerunt et deum ipsum esse mentiti sunt”, Ibid., pp. 352-353. 24. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, 11, a c. di R. Rinaldi, Utet, Torino 2006, p. 493. L’importanza delle religioni per la prassi politica è ulteriormente confermata dal segretario fiorentino in un passaggio appena successivo: “E vedesi, chi considera bene le istorie romane, quanto serviva la religione a mandare gli exerciti, animire la plebe, a mantenere gli uomini buoni, a fare vergognare i rei. Talché se si avesse a disputare a quale principe Roma fusse più obbligata, o a Romolo o a Numa, credo più tosto Numa otterrebbe il primo grado: perché dove è religione facilmente si possono introdurre l’armi; e dove sono l’armi e non religione con difficultà si può introdurre quella. E 80 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X si vede che a Romolo, per ordinare il senato, per fare altri ordini civili e militari, non gli fu necessario della autorità di Dio; ma fu bene necessario a Numa, il quale simulò di vere domesticheza con una nympha la quale lo consigliava di quello che elli avesse a consigliare il popolo; e tutto nasceva perché voleva mettere ordini nuovi et inusitati in quella città, e dubitava che la sua autorità non bastasse. E veramente mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate. Perché sono molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in sé ragioni evidenti da poterle persuadere a altrui; però gli uomini savi che vogliono tôrre questa difficultà ricorrono a Dio. Così fecie Ligurgo, così Solone, così molti altri che hanno avuto il medesimo fine di loro (…) La religione introdotta da Numa fu intra le prime cagioni della felicità di quella città: perché quella causò buoni ordini, i buoni ordini fanno buona fortuna e dalla buona fortuna nacquero i felici successi delle imprese. E come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle republiche, così il dispregio di quello è cagione della rovina d’esse. Perché dove manca il timore di Dio conviene o che quel regno rovini, o che sia sostenuto dal timore d’uno principe che sopperisca a’ difetti della religione. E perché il principi sono di corta vita, conviene che quel regno manchi presto, secondo che manca la virtù d’esso. Donde nasce che gli regni i quali dipendono solo da la virtù d’uno uomo sono poco durabili, perché quella virtù manca con la vita di quello; e rade volte accade che la sia rinfrescata con la successione”, Ibid., pp. 494-497. 25. Theophrastus Redivivus, cit., Vol. II, pp. 430-529. 26. L’operazione che il Theophrastus sta inscenando è debitrice dell’analisi svolta da Machiavelli nel sesto capitolo del Principe. In quella sede, infatti, l’ingegno del fiorentino aveva accomunato, non senza una dose di raffinata ironia, Mosè, che ebbe certo “sì grande precettore”, agli altri legislatores: “Ma per venire a quegli che per propria virtù e non per fortuna sono diventati principi, dico che e’ più eccellenti sono Moisè, Ciro, Romolo, Teseo e simili. E benché di Moisè non si debba ragionare, sendo suto uno mero esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, tamen debbe essere ammirato, solum per quella grazia che lo faceva degno di parlare con Dio (…) È necessario pertanto, volendo discorrere bene questa parte, esaminare se questi innovatori stanno per loro medesimi o se dipendono da altri: cioè se per condurre l’opera loro bisogna che preghino, o vero possono forzare. Nel primo caso, sempre capitano male e non conducono cosa alcuna, ma quando dependono da loro propri e possono forzare, allora è che rare volte periclitano: di qui nacque che tutti e’ profeti armati vinsono ed e’ disarmati ruinorno. Perché, oltre alle cose dette, la natura de’ populi è varia ed è facile a persuadere loro una cosa, ma è difficile fermargli in quella persuasione: e però conviene essere ordinato in modo che, quando non credono più, si possa fare loro credere per forza. Moisè, Ciro, Teseo e Romulo non arebbono potuto fare osservare loro lungamente le loro consultazioni, se fussino stati disarmati; come ne’ nostri tempi intervenne a fra Ieronimo Savonerola, il quale ruinò ne’ sua ordini nuovi, come la moltitudine cominciò a non credergli, e lui non aveva modo a tenere fermi quelli che avevano creduto né a fare credere e’ discredenti”, N. Machiavelli, Il Principe, VI, a c. di G. Inglese, Einaudi, Torino 2005, pp. 33.36. 27. “Pietro Pomponazzi nell’opuscolo De effectuum naturalium rerum causis, stampato a Basilea, dichiara veri i miracoli della religione mosaica e di quella cristiana. Crede, però, che la causa che li determina sia da identificarsi o con le influenze astrali o con la nostra immaginazione. Ed invero, poiché gli astri sovrintendono all’ordine e al governo dell’universo, regolano anche le istituzioni religiose da cui ogni ordine scaturisce. E siccome i popoli non crederebbero ad un nuovo profeta se non vedessero con i propri occhi che egli è in grado di fare miracoli, gli astri, concentrando in un unico punto tutte le facoltà e le capacità che separatamente impartiscono gli animali, alle erbe e alle pietre, le conferiscono al nuovo profeta che, munito e circondato da una così grande congerie di doni celesti, compirà moltissime cose 81 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X straordinarie”, G. C. Vanini, Amphitheatrum aeternae providentiae, Exercitatio VIII, in Tutte le opere, cit., p. 407. 28. Ibid., p. 405. 29. “Quid vetat caetera miracula istis simila pari modo conficta fuisse existimare? Resurrectio mortuorum sane omnium miraculorum maximum est et creditu difficillimum, utpote sit naturae etiam viribus impossibile; tamen illud miraculum accidisse tam in religione ethnicâ quam in christianâ fingitur, et a multis etiam creditur, quae supra de Apollonio Tyaneo et ex Plinio retulimus, testantur apud Ethnicos id celebrari. Quin etiam Plato [lib. 10 de Rep.] dicit quendam Erum Pamphilium revocatum ex inferis fuisse et incredibilia narravisse. Contra ista miracula Pomponatius [lib. de incant. cap.8 ] asserit 1° ad animalium resurrectiones a Plinio supra allatas, illas eundem Plinium non probare et alibi illas non solum in bestiis negavisse, imo in hominibus, et utraque in quidbuscumque mortalibus. Praeterea dicit qui illud se vidisse retulerunt deceptos fuisse: nam si illis id vere visum est et non sit dictum pro fabulâ, talia animalia non erant vere mortua, sed aestimabantur mortua, veluti multoties etiam visum est temporibus nostris: ut de quodam fure suspenso Bononiae, de mulieribus praegnantibus, de correptis ab epilepsiâ, vel magis ab apoplexiâ, et in talibus casibus non inconvenit tales herbas proficere et multa alia a naturâ ordinata. Quod autem additur de Pamphilo et aliis a mortuis exsuscitatis, dicit idem Pomponatius illa esse fabulosa et poëtice dicta ad hominum instructionem, veluti existimamus illud Pamphilii fuisse. Plato enim ibi instruxit vulgares et plebem, qui ad bona opera non trahuntur nisi ex spe praemii, et a malis non retrahuntur nisi timore poenae. Et secundum eundem Platonem in 2 ° de Republica in tali casu licet mentiri vel fingere. Et Scaevola dicebat expedire in religione civitates falli”, Theophrastus Redivivus, cit., Vol. II, pp. 387-388. 30. T. Gregory, Theophrastus Redivivus. Erudizione e ateismo nel seicento, cit., pp. 113-114. 31. Theophrastus Redivivus, cit., Vol. II, pp. 530-555. 32. Ibid., p. 549. L’idea che l’ordine politico sia garantito solo da quella seconda verità rappresentata dal fenomeno religioso, unita alla persuasione che l’abito religioso abbia ormai, alla luce della tradizione, acquisito agli occhi del popolo uno status perfettamente ‘naturale’, dunque integrato nei meccanismi del suo vivere civile, spinge la critica libertina, e il Theophrastus in particolare, a riconoscere alla religione un ruolo fondamentale per la tutela della pacifica convivenza fra gli uomini. La critica corrosiva a cui il trattato sottopone lo spazio del sacro non comporta, dunque, un’azione volta allo smascheramento di questo sublime inganno. La consapevolezza che l’erudizione garantisce al sapiente rimane allora un affare privato, che non implica alcuna presa di posizione nello spazio pubblico del dibattito. Lo scetticismo è, in tal modo, e ancora una volta nel corso della storia, una posizione che dà vita ad un ideale conservatore, volto alla salvaguardia dell’ordine stabilito: “Nata dall’astuzia di principi e sacerdoti, garantita dalle leggi, convalidata dalla forza della tradizione, la religione indica in tutti i momenti della sua storia che gli uomini, non gli dei, ne sono gli autori: la critica ateistica ha compiuto così la sua opera di dissacrazione, andando molto al di là della ricerca rinascimentale delle «cause naturali» dei «miracoli», perché queste vengono ritrovate non più nei cieli di una cosmologia ormai in crisi ma nella natura umana, nella volontà politica, nell’ignoranza del volgo, nel gioco di interessi e passioni che sta al fondo di ogni forma di vita associata. Ma proprio per questi inerire della religione alle strutture profonde della città terrena, il filosofo non dovrà tentare di modificare uno stato di cose che il «costume» ha reso del tutto naturale. La sua opera di dissacrazione resta un discorso fra sapienti che, consapevoli della vera natura della religione e liberi dai suoi miti, sanno che questi sono essenziali per il volgo: l’educazione del popolo, infatti, si realizza non con il rischiaramento della ragione ma con la conservazione delle 82 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X mitologie religiose. La critica libertina – cui soggiace sempre l’opposizione fra «pubblico» e «privato», fra vulgus e sapientes – si congiunge così ad un aristocratico conservatorismo”, T. Gregory, Theophrastus Redivivus. Erudizione e ateismo nel seicento, cit., pp. 185-186. 33. “Quidam autem omnes promiscue reliones in republicâ admitti et recipi debere contendunt, nec immerito, nam in tantâ quas videmus religionum multitudine, alterum fieri putant, ut plus una vera sit. At usquequaque pontificibus omnium religionum capitali odio inter se discrepantibus, num tutius est, inquiunt, omnes admittere quam de multis unam, quae forsitan falsa sit, optare aut eam, quae forte verissima sit, excludere velle? Sic et illos qui daemones colunt, haud secus ac eos qui deos adorant, admittendos esse axistimant, nam deo nihil contrarium existere posse arbitrantur”, Theophrastus Redivivus, cit., Vol. II, pp. 541-542. 34. Il Theophrastus sottolinea come i Romani abbiano sempre integrato il loro pantheon accogliendo al suo interno anche le divinità dei nuovi popoli conquistati, e questo proprio per continuare a garantire la solidità del proprio dominio. Fra i vari esempi proposti dal trattato, di particolare importanza è quello dell’Imperatore Teodosio nei confronti dell’eresia ariana: “Theodosius maior imperator hâc etiam usus est indulgentiâ; ineunte enim imperio provincias omnes Arianorum plenas reperit, quorum opes ita creverant sub imperatoribus arianis, ut non modo confirmata esset eorum disciplina conciliis octo, quae variis temporibus variisque in locis coacta fuerant, ac potissimum ariminensi synodo, quae sexcentorum pontificum concordibus animis ac sententiis arianam sectam comprobarat, verum etiam poenarum et proscriptionum acerbitate sectas asversariorum punirent: noluit imperator Arianos, quos tamen capitaliter oderat, ullis suppliciis coërceri, sed utrisque Arianis, inquam, et Catholicis sua templa concessit et in singulis oppidis duos utriusque religionis pontifices haberi permisit”, Ibid., p. 543. 35. Su Mersenne e sull’analisi della sua obiezione a Descartes, il riferimento è C. Buccolini, «Contra eos qui deum falsum dicere posse docent». La genesi dell’obiezione di Mersenne sul Dio ingannatore, Giornale Critico della Filosofia Italiana, LXXXV (LXXXVII), fasc. I, 2006, pp. 82-120. 36. A questo proposito, J.-P. Cavaillé, Dieu trompeur, doctrine des équivoques et athéisme: entre Grégoire de Valence et Descartes, in Potentia Dei. L’onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII, a c. di G. Canziani, M: A. Granata e Y. C. Zarka, Milano, Franco Angeli 2000, pp. 317-334. 37. C. Buccolini, «Contra eos qui deum falsum dicere posse docent». La genesi dell’obiezione di Mersenne sul Dio ingannatore, cit., p. 85. 38. C. de Condres, Traité des équivoques, in Oeuvres complètes du P. Charles Condres, ed. par l’abbé Pin, Paris, Guyot et Roidot 1857-1858 (Vol. II). 39. J. Barnes, Dissertatio contra aequivocationes, Paris 1625. 40. P. Bayle, Dictionnaire historique et critique (Cinquième édition, IV Vol.), Amsterdam, Leyde, La Haye, Utrecht 1740, v. J. Barnes, pp. 458-459. 83 GCSI – Anno 3, numero 5, ISSN 2035-732X
Scarica